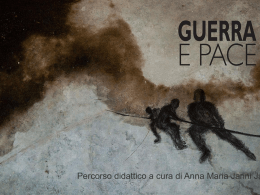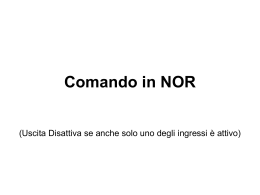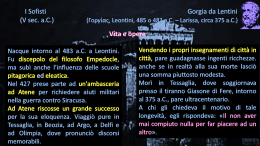Nome file 040325SCA_MDC3.pdf data 25/03/2004 Contesto ALTRO Relatore MD Contri Liv. revisione Pubblicazione Lemmi Erede Figlio Nocività Pensiero Premeditazione Sen, Amartya Soggetto Sottomissione STUDIUM CARTELLO 2003/04 ASSOCIAZIONE CULTURALE “A. ROSMINI” - TRENTO GENITORI, FIGLI, EDUCATORI: UN LAVORO DI COMPETENZE 25 MARZO 2004 Scuola: soggetti o sottomessi? M. DELIA CONTRI SOGGETTI O SOTTOMESSI I figli, gli allievi, ma anche la moglie, il marito, gli amici, i collaboratori sovra- o sub-ordinati sul lavoro, insomma tutti i partner dei propri rapporti possono essere trattati secondo i due corni di una alternativa: come soggetti o come sottomessi. Che si faccia una scelta ragionevole dipenderà anzitutto dal fatto che si veda bene l’alternativa e che si faccia una scelta tra i due corni di essa. Ci vorrà tuttavia un passo ulteriore nella ragionevolezza per arrivare a rendersi conto che trattare i partner come sottomessi o sottomettibili, ovviamente a un comando, è un comportamento dannoso, distruttivo. Così facendo si andrà a distruggere infatti quello che è il vero pozzo di petrolio, la principale risorsa su cui si fonda la produttività di una persona e la sua capacità di rapporto: una produttiva attività lavorativa si mobilita in un soggetto capace di avere in proprio mete di guadagno da raggiungere, in collaborazione con altri e con le istituzioni considerate come patrimonio da far fruttare. E la Dottoressa Cavelli nel suo intervento ci dice cosa succede di una persona quando è arrivata a concludere «io non ho risorse per riuscire». Nella mia esperienza come psicoanalista, ma prima ancora come insegnante, vedo, e ho visto, molto bene quanto il fatto che si sia instaurato in qualcuno il pensiero “non posso” sia “il” problema. E suppongo che se ciascuno di voi ripenserà alla propria vita, troverà che da qualche parte, almeno un po’, quella idea è lì, radioattiva, e pronta ad esplodere laddove si produca un qualche incidente di percorso più o meno grave. Sto leggendo un libretto, di quelli che trovate allegati a un periodico, intitolato Il sonno della ragione [1], che riprende una famosa frase del pittore spagnolo Francisco Goya: «Il sonno della ragione genera mostri». Si tratta di una raccolta di brevi testi di autori diversi che riflettono sulla crisi della ragione a partire da un fatto molto eclatante come la distruzione delle torri gemelle di New York, un fatto preso come esempio di quello che sarebbe qualcosa di specifico dei nostri tempi, quello che sarebbe un male oscuro, una minaccia, che colpirebbe specificamente le nostre società ormai troppo complesse e globalizzate e dunque indifendibili da chi le voglia distruggere. Il sonno della ragione genera mostri Francisco Goya, 1797 Mi sono imbattuta ad apertura di libro nel breve scritto di Amartya Sen, Professore di filosofia all’università di Cambridge, premio Nobel per l’economia e la filosofia. L’attenzione di questo testo è rivolta a catastrofi come le carestie o le distruzioni ambientali, in quanto prevedibili e prevenibili, che sono eventi di cui certo non può che occuparsi un’istanza di governo, locale o nazionale o sovrannazionale. Tuttavia i governanti sono pur tuttavia loro stessi degli individui più o meno sonnolenti, più o meno svegli quanto all’esercizio della ragione e, oltre a ciò, i governanti sono espressione della ragionevolezza dei loro elettori e sono spesso tentati di appoggiarsi alla loro non ragionevolezza. Non si tratta per lo più di eventi, dice Amartya Sen, spiegabili con una esplicita cattiva intenzione di affamare intere popolazioni o col premeditato desiderio di distruggere il mondo, essi vanno piuttosto fatti risalire ad azioni insensate o perseguite senza alcun sensato ragionamento preliminare. Ci sono risultati terrificanti causati da negligenza e umana ottusità, cui poi – dice Amartya Sen - si sovrappone una “sorda testardaggine”. Si vuole ottenere un certo scopo, un certo beneficio e non si mette bene in conto, prima di agire, del costo dei danni che si possono provocare perseguendo in un certo modo quel dato scopo, danni tali che, magari non subito, ma nel tempo renderanno del tutto inutile, azzereranno il beneficio conseguito. Si potrà disboscare una montagna per costruire seconde case e lo si pagherà nel tempo con alluvioni e frane disastrose. Si potrà praticare una diminuzione forsennata dei salari e licenziamenti di massa, e lo si pagherà nel tempo con una diminuzione degli acquirenti dei propri prodotti o con l’aumento dello scontento sociale e del disordine. Lo stesso procedimento Sen lo applica a casi individuali in cui ci si trovi invece di fronte a qualcosa di indisponente o seccante. E’ legittimo, dice Sen, tener in conto la propria reazione irritata di fronte a certi comportamenti altrui, ma poi si tratta di valutarla, di giudicarla questa nostra reazione – può essere che abbiamo ragione, ma anche che abbiamo torto, che siamo degli intolleranti. In altri casi, invece, si tratta di ottenere da altri un certo comportamento. In ambedue i casi si tratta di premeditare con attenzione che cosa pensiamo di fare per far smettere il comportamento che ci risulta sgradevole o per ottenere il comportamento desiderato, in modo tale da non scatenare reazioni peggiori delle azioni che volevamo evitare o più dannose del vantaggio che volevamo ottenere . Come ho già accennato, per un certo periodo ho insegnato e spesso mi è capitato di sentire dei genitori, o anche dei miei colleghi, che dicevano: «Ma no, ma cosa stai lì! A calci nel sedere glielo fai fare!». «A schiaffoni lo fai smettere!». Così si fa più in fretta, pensavano. Ora, questa è la stupidaggine! Si pensa di giungere più in fretta a ottenere un certo comportamento, o a far smettere qualcuno che ti dà fastidio o ti danneggia, pretendendo obbedienza, anche con l’applicazione di forza, manesca o vocale o magari aviotrasportata: «Smettila!», «Fai questo!». Si pretende che quell’allievo o quel figlio o quel dipendente, si sottometta a un puro e semplice comando. Si pensa, cioè, illudendosi stupidamente, di poter ottenere il proprio scopo direttamente. Si può avere l’impressione che sarebbe più economico evitare di dover fare un giro in più, perché sembra un giro di troppo. In economia, certo, l’imprenditore, se vuole avere profitto, deve cercare di ridurre i costi, ma la riduzione di certi costi può provocare disastri. «Ma cosa ci giri intorno!!», dicevano certi miei colleghi, o certi genitori. Di che giro stavano parlando? Il giro del pensiero del figlio, o dell’allievo, che sembrava loro veramente una perdita di tempo: tempo perso sarebbe quello lasciato loro per pensare in proprio «E’ meglio fare così come mi è chiesto» o «E’ meglio non fare così». Mi è sembrato proprio questo l’aspetto più interessante di questo libretto: i danni maggiori si fanno più per stupidità che per cattiveria, si fanno perché non ci si ferma a connettere, non ci si dà il tempo di connettere le proprie azioni con le loro conseguenze, non si osserva abbastanza la realtà che si ha di fronte («Hanno occhi per vedere e non vedono...», annotava già il Vangelo, suggerendo che l’unica scusa possibile nel giorno del giudizio sarà che «Non sanno quello che fanno»): non si premeditano le azioni, non si osservano le conseguenze, e quindi, a cose fatte, non ci si corregge, non si fa tesoro dell’esperienza. Lo scopo di questo corso è di fornire degli elementi di meditazione per diventare più intelligenti sui danni – in certi casi si tratta di vere e proprie catastrofi – che si provocano quando di distrugge la capacità e dunque la libertà del figlio o dell’allievo nel pensare le proprie mete, quando non lo si tratta cioè come soggetto. Si ha fretta e si pensa di raggiungere più rapidamente lo scopo di un corretto comportamento da parte sua pretendendo che obbedisca, che si sottometta a un puro e semplice comando. Sembra che avere allievi o figli sottomessi a dei comandi permetta di risparmiare tempo e fatica, di arrivare allo scopo più direttamente. Si può avere l’impressione che sarebbe più economico evitare di dover fare il giro del pensiero del figlio o dell’allievo. Ci sono persone che addirittura si vantano che per far obbedire i propri figli, o allievi, a loro “Basta uno sguardo”, e magari esaltano, e rimpiangono, per questa che viene considerata una dote eccezionale, i propri genitori, o i propri insegnanti. Volendo ottenere qualcosa dai figli, dagli allievi, ma anche dai propri amici, dai propri colleghi, dai propri subordinati, si ha fretta. Si pensa di far prima passando per la sottomissione anziché per la soggettivazione. Se il modo di trattare i figli è quello di cercare di sottometterli, può darsi che in certi casi non si provochino delle catastrofi. Un po’ perché, fortunatamente, non sempre i genitori sono così rigidi, così sistematici e ogni tanto si distraggono o hanno altro da fare (i genitori che fanno meno danni sono allora quelli che hanno i fatti loro, il loro lavoro, i loro amici, per cui lasciano che i figli abbiano una loro vita), e un po’ perché i bambini hanno sette vite come i gatti e si difendono. Ma quando non c’è questa capacità di difesa, quando questa capacità non la si è lasciata costruire per la fretta sistematica di farsi obbedire, in effetti, si possono provocare delle catastrofi. Sto pensando alla psicosi, all’autismo, vere e proprie catastrofi umane. Ma quel che è certo è che danni se ne fanno sempre. Se si facessero delle statistiche si vedrebbe – ma a dire il vero è un dato di osservazione sotto gli occhi di tutti, ciascuno può cominciare dalla propria stessa esperienza – come mediamente il danno emerga con la fine dell’infanzia e con l’inizio dell’adolescenza. Lo schema più comune per quanto riguarda la carriera scolastica è il seguente: alle elementari va bene, o addirittura brillantemente, alle medie va ancora bene ma si cominciano a perdere i colpi, col passaggio alle superiori le cose cominciano ad andare male. Nel caso di iscrizione all’Università, poi, ci sarà un rallentamento degli esami, esami che vanno male, ciclo di studi che non si conclude. In altri termini, più l’ordine di scuola richiede una capacità di iniziativa personale autonoma, meno ci si riesce: non inganniamoci, non è perché il liceo o l’Università sarebbero più difficili delle elementari che non ci si riesce. Seguendo poi le biografie anche dopo il termine degli studi, si vedrebbero delle difficoltà anche nel mantenere un lavoro, o nello stabilire legami amorosi che tengano. Avete sentito dire nella lezione di Giacomo Contri che trattare il figlio da erede vuol dire trattarlo da libero, cioè da pensante. E trattarlo da libero vuol dire trattarlo da soggetto. Essere trattati da liberi, da soggetti, da eredi, sono tre modalità strettamente connesse. Allora, trattare un figlio da erede che cosa vuol dire? Mi capita a volte di dire a qualche madre o padre che venga da me come psicoanalista: «Guardi che quando si dice che il figlio lo si mette al mondo, si intende che poi ci si deve curare che al mondo ci stia bene». Non vuol dire in altri termini soltanto che si sarà provveduto alle sue necessità o che gli si lasceranno dei beni al sole o che gli si trasmetteranno conoscenze, abilità tecniche o sociali, vuol dire anche poi che lo si deve favorire nelle sue iniziative, nella messa a punto di capacità che gli permettano di far fruttare le proprie risorse e la realtà del mondo a proprio vantaggio. Vuol dire che si dovrà lasciar sviluppare in lui un interesse in proprio a far fruttare l’eredità ricevuta. Senza di questo che cosa succederà? Che il figlio rifiuterà l’eredità, o la dilapiderà, non vedendovi altro che un’imposizione, un comando, un’ipoteca sulla sua vita e non un vantaggio per lui, una dote, un capitale accumulato dai genitori, o dalla società nel suo insieme, da reinvestire. In un certo senso, mettere al mondo un figlio vuol dire che il mondo glielo si lascia in eredità ! “A somiglianza” di Dio che ha fatto il mondo e poi ha detto agli uomini: “Ecco io ho fatto questo e quello, adesso prendetelo e fatelo fruttare”. Ricordate la battuta di Woody Allen che, a chi gli diceva: “Ma chi ti credi di essere? Dio?”, rispondeva: “Bisogna pur darsi dei modelli!”. Qualcuno potrebbe chiedersi a questo punto: ma come si fa a trasmettere al figlio, o all’allievo il sapere, le varie abilità, ma anche l’amore della musica o della lettura o dello sport, o anche delle buone maniere in società, come un’eredità? Cioè come qualcosa da far fruttare per il proprio profitto, per il proprio benessere, per la propria soddisfazione, in modo tale che l’apprendimento, lo studio e successivamente il lavoro non venga vissuto come sottomissione a una sorta di schiavitù. E io dico sempre che il successo di una vita è che anche il lavoro sia soddisfacente, che si riesca a farsi pagare per fare un lavoro che piace, che di per sé dà soddisfazione. Bisogna che questo sia anzitutto vero per l’insegnante, o per il genitore stesso. Non si può lasciare in eredità ciò che non si possiede. E’ una cosa questa su cui non si può mentire. Nessuno può insegnare a un altro quello che lui stesso non sa. Difficilmente un genitore che non guarda al sapere, alla cultura e anche al lavoro come a una fonte di beneficio per sé, ma come a un’imposizione cui penosamente sottomettersi, riuscirà a trasmettere al figlio l’interesse per la cultura e per il sapere o per il lavoro: potrà comandarglielo di studiare e di lavorare, punirlo se non studia, con i risultati che abbiamo detto. Tuttavia fondamentale è avere in mente i due corni dell’alternativa: o trattare il figlio, e l’allievo, come soggetto/erede/libero/pensante o trattarlo come qualcuno da sottomettere a comandi. Per poco che un genitore tratti per conto suo la realtà come fonte di beneficio per sé, lo trasmetterà al figlio. Bisogna però poi che eviti i comportamenti che stroncano quel desiderio, quel gusto di vivere, che lui stesso ha suscitato. Nella mia carriera scolastica ho avuto due allievi che mi hanno fatto da maestri su questo tema: Natalino e Paride. Natalino, un sicilianino con comportamenti da piccolo bullo prepotente, anarchico rispetto alla disciplina della classe, esperto in tecniche di guerriglia tanto da rendere praticamente impossibile un qualsiasi lavoro: era impossibile fare lezione quando c’era lui! Tecniche già messe a punto in famiglia: era in grado di impedire a una famiglia intera di guardare in santa pace la televisione! Natalino poteva di primo acchito parere del tutto privo di interesse per la realtà scolastica e del resto la sua era una famiglia semianalfabeta. Poteva quindi parere che la strada da battere con lui fosse quella della sottomissione, non solo quanto alla repressione del suo comportamento disturbante – cosa che facevo, anche se nel suo caso la repressione si riduceva poi ad espellerlo dalla classe, peraltro con la collaborazione di un forzuto bidello, dato che non bastava certo il comando “fuori!” – , ma anche quanto all’inculcargli il dovere di studiare. Pareva che la strada da battere con lui fosse quella del torchiarlo in modo tale da “ficcargli in testa” che doveva studiare e rispettare le regole della vita scolastica, col comando e la punizione. Pareva che nella sua testa l’interesse per la scuola non ci fosse in nessun modo e si trattasse quindi di inculcargli puramente e semplicemente, ficcargli appunto bene in testa, qualcosa che nella sua testa non c’era. Poi un giorno successe una cosa, una cosa successa ormai trenta anni fa, che fu per me una specie di folgorazione sulla via di Damasco! Avevo dato come compito di scrivere un racconto giallo a partire da alcuni elementi indicati da me. Natalino, che di suo si stava introducendo a una carriera da delinquentello, doveva aver trovato nel tema, come dicono gli inglesi, la sua tazza di tè. Fatto sta che in pochi minuti riempie tre pagine di fitta scrittura e si precipita fuori dal banco per farmele leggere. Naturalmente c’erano duecento errori di ortografia e dal punto di vista della correttezza sintattica era un disastro, però, leggendo, si capiva che c’era una trama sostanziosa e ben congegnata. Al mio commento «Mica male! Buona l’idea !», mi strappa i fogli di mano e corre tra i banchi gridando, a sbandierare il suo successo: «Alla Contri piace!». Questo «Alla Contri piace!» non l’ho più dimenticato. Dimostrava che lui al successo scolastico ci avrebbe anche tenuto, ma che ormai lo considerava un investimento in perdita: in italiano, su duecento parole, c’erano trecento errori di ortografia, non parliamo poi della sintassi. Riteneva di essere rimasto troppo indietro, e tanto valeva battere altre strade, con abbozzi di percorsi delinquenziali. Ma il gusto e l’apprezzamento, il desiderio nei confronti della scuola c’erano ancora, bisognava però interrompere un puro e semplice intervento repressivo. Non che l’iniziale intervento repressivo fosse stato inutile: il fatto che comunque lui dovesse sottostare al mio comando “Fuori!” – peraltro preannunciato normativamente: “Se urli ancora ti sbatto fuori” – , grazie all’intervento del forzuto bidello, mi aveva infatti sicuramente innalzato nella sua stima: non ero una che parlava al vento. Ma era importante che questo ragazzino si imbattesse nel mio apprezzamento di una sua capacità. Per questa via si riaperse per lui l’idea di una possibilità di accesso alla cultura e per noi insegnanti l’idea di una sua trattabilità. Mi misi perciò in seguito d’accordo con una collega per lavorare in questa direzione e, in effetti, pian piano, vedendo che gli si dava anche una mano a recuperare sia in italiano che in matematica, incominciò ad aumentare il suo investimento nel lavoro scolastico e, di conseguenza, a migliorare il suo comportamento. Purtroppo l’anno successivo la famiglia si trasferì in una delle estreme periferie milanesi e mi venne riferito che la sua carriera da piccolo boss a sfondo delinquenziale si era andata precisando. Da Natalino appresi, o meglio mi confermai nell’idea, che in nessun caso lo studio è qualcosa da imporre, come si impone il lavoro a uno schiavo. Allo schiavo il lavoro va infatti imposto: di suo non ha e non può avere alcun interesse per un’attività da cui a lui non viene in tasca niente. Quelle dei miei allievi non erano delle teste in cui bisognava inculcare il dovere di studiare. Loro, almeno un po’, ce l’avevano già il gusto dell’apprendimento, il desiderio della riuscita scolastica, almeno un po’ ne avevano ereditato, ma poi erano stati stroncati, erano rimasti inutilizzati, non trattati come una risorsa, magari rattrappita, ma da mettere in valore e da sfruttare. L’altro mio maestro fu Paride, che era proprio un poverino. Si chiamava Paride, ma era brutto, sembrava un vecchietto, con una di quelle facce che sembrano un po’ una mela cotta tutta raggrinzita. Scolasticamente era un disastro, non stava attento, non faceva i compiti, il suo comportamento era disordinato, restando però isolato e incapace di intercettare e fomentare il disordine di altri. Un giorno la bidella mi racconta: «Sa cosa mi ha detto Paride? Che adesso si è messo a studiare». E alla domanda: «Come mai ti sei messo a studiare?» aveva risposto: «Perché ho capito che la Contri non mi odia!». Io, a dire il vero, non gli avevo prestato neppure una grande attenzione: non gli riusciva neppure di essere un fomite di disordine. Chi catalizza e fomenta il disordine di altri dispone ancora di capacità di difesa e di iniziativa: è a lui che i rappresentanti di un’istituzione prestano più attenzione. Non avevo fatto dunque un granché per lui, se non rispondergli civilmente, ma in fondo abbastanza distrattamente, quando mi chiedeva aiuto su qualcosa che non sapeva fare o riconoscere qualche suo peraltro modesto miglioramento. Che ci fosse qualcuno che lo odiava era vero, ed era la madre. Io stessa l’avevo conosciuta. La sua prospettiva era quella del comando, una prospettiva coltivata con rigidità: era una donna abbastanza ignorante, ma in queste cose non occorre avere la laurea! Le sue idee me le aveva esposte con chiarezza: l’avevo rimproverata, una volta, perché non aveva lasciato venire il figlio a una delle poche gite scolastiche che organizzavo perché ogni tanto vedessero direttamente cose di cui a scuola si parlava soltanto o che si potevano vedere solo in fotografia. La sua risposta fu: se voglio che mio figlio mi obbedisca cosa devo fare? Lo punisco togliendogli le cose che gli piacciono. In casa ormai non c’è più niente che io gli possa togliere. La gita scolastica era ancora una delle poche cose a cui lui tenesse. Era una madre che nell’alternativa tra il trattare il figlio come soggetto o come sottomesso aveva scelto e aveva ormai del tutto scartato l’idea di sfruttare il filone di ciò che al figlio piaceva. Anzi, quando vedeva che c’era ancora qualcosa che lui faceva con piacere, ne prendeva nota per potergliela al momento buono togliere a titolo di punizione per ottenere da lui una maggiore obbedienza. Il figlio aveva ragione a definire ciò come odio: questa madre era lì a scrutare che cosa al figlio piacesse, facendosene un punto di appoggio per ottenere, col sottrarglielo, sottomissione. Che cosa stava facendo questa donna? Stava essiccando nel figlio il pozzo di petrolio del gusto di vivere e di fare le cose, il principio stesso del trattare la realtà come fonte di beneficio. Al momento il figlio era ancora un ragazzino ed era bastato poco perché questo gusto di vivere gli si riaccendesse, era ancora vivace in lui la capacità di chiedere e ricevere aiuto, ma fino a quando avrà ancora resistito? Come qualificare se non come ottusità, accompagnata da sorda testardaggine, per usare le parole di Amartya Sen, una prospettiva che invece di sfruttare il pozzo di petrolio, gli dà fuoco fino ad esaurirlo? NOTE [1] AA. VV., Il sonno della ragione, Reset, Milano 2003. © Studium Cartello – 2007 Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright
Scaricare