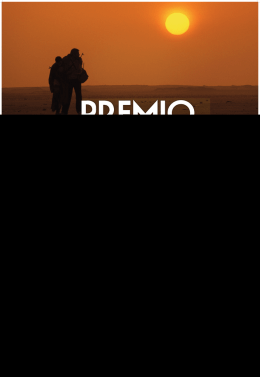Adele Cambria Fantasticamente letteraria, o forse dovrei dir meglio, fantastica, la mia amicizia con Paolo Barozzi: che ha una data lontana nel tempo - forse ci incontrammo a Roma nella redazione de «Il Mondo» di Mario Pannunzio, cui entrambi collaboravamo. Ma certamente, fu Venezia a disegnare le forme letterarie della relazione, una Venezia a settembre che coincise, per me, con la nebbia sottile che mi calò improvvisa sugli occhi: cataratta da fame, diagnosticarono i medici, (ero ripiombata nell'anoressia dell'infanzia, per la rottura del mio matrimonio), ma in quei giorni veneziani mi sembrava che il velo dorato che m'abbagliava dipendesse dalla luminescenza fremente e costante della città, acqua, canali, palazzi e chiese, non una malattia dunque ma un contributo al sogno. Accadde mentre passeggiavamo, al tramonto, lungo il Canal Grande, Paolo, io ed il poeta Francesco Smeraldi; non dissi nulla, non percepii la gravità del fatto, perché Paolo e Francesco, in quella settimana di vacanze a Venezia, si erano assunti molto seriamente il compito di addobbarmi i giorni e le notti del lusso effimero della felicità: come due arcangeli, (bonario, roseo, dolcemente paffuto, Paolo, di cui avrei scoperto dopo la somiglianza con l'attore inglese Dick Bogarde, più insidioso per le sue nevrosi Francesco), o due giocolieri, mi facevano scoprire la città, da cui fino ad allora mi aveva tenuto distante il mio "conformismo dell'anticonformismo" non avevo saputo andare oltre la Venezia delle cartoline illustrate, e questa ovviamente mi ripugnava. Conobbi con loro, il motoscafo, i Murazzi, esplorai il cimitero ebraico di Malamocco, fui invitata alle feste nei palazzi dogali; per anni avevo frequentato, come giornalista di grandi quotidiani, la Venezia del Festival del Cinema, ma introdotta e guidata dai miei due arcangeli sentivo per la prima volta di partecipare davvero al gioco: al grande gioco di cui era stata protagonista, per secoli, Venezia, e di cui forse, in quel finale degli anni Sessanta, si potevano ancora raccogliere gli ultimi splendori. Così, in quel settembre del 1967, i miei due ragazzi giocolieri mi conducevano per Venezia come una Alice nel paese delle meraviglie un po' stremata, mi sembrava di galleggiare sull'acqua, di confondermi con la materia prima della città. In questo quadro letterario che celava, come può capirsi, punte acuminate d'una sofferenza e di un dramma sospesi, (ne scrissi subito dopo nel mio primo romanzo Dopo Didone, di questa parentesi veneziana), l'amicizia con Paolo Barozzi era - ma 1 non l'intuii subito - quella destinata a durare nel tempo. (L'altra ebbe il torto di ravvicinare troppo, fino all'intimità psichica, due nevrosi esistenziali, e si consumò rapidamente, e con qualche amarezza, nei mesi successivi). A Venezia quell'anno fu comunque Paolo ad introdurmi nello studio di Gregorio Sciltian alla Salute (una grotta muschiosa in un tempio greco dell'età ionica, fu la sensazione che ne ricavai), con lui conobbi Gastone Novelli, ed ebbi, da lui, il privilegio di una passeggiata in gondola insieme a Peggy Guggenheim. Dopo quella cruciale vacanza a Venezia - sull'orlo della malattia, sull'orlo della separazione legale da mio marito, eppure i miei due arcangeli erano riusciti a renderla incantata, fiabesca - ho seguito, nonostante tutto, la crescita del personaggio letterario di Paolo Barozzi - aveva circa ventuno anni, quando condividemmo i felici giorni veneziani - ed era come vedere compiersi un disegno presagito, (in fondo, nelle pagine del mio primo romanzo sperimentale, avevo in qualche modo contribuito a fissarlo...). Di lui, confesso, mi sarebbe bastato anche soltanto il profilo di "divino mondano", che era il più evidente, allora, il più facile da cogliersi; ma sarebbe stata, questa, una lettura superficiale. Me ne rendo conto nel riaffiorare, ora, improvviso, di una memoria che avevo cancellata, e ripensando ad un suo aureo libretto, Viaggio nell'arte contemporanea edito da Scheiwiller, e provvisto di una mirabile prefazione di Goffredo Parise che apparentava l'autore a Giovanni Comisso - "...Ha la stessa fattura mezza vegetale, mezza umana, e quella felicità dermica... dell'artista sempre in fieri". Ma cominciamo dall'episodio molto personale che avevo, come si dice ormai nella vulgata psicoanalitica, completamente rimosso, addirittura fino a questo istante. (Mi è venuto in mente, ora, scrivendo di Paolo). Nell'inverno del 1966-67 io ero, con i miei due bambini e la loro "tata" umbra, praticamente in esilio a Londra, dove ero approdata senza conoscere una sola parola di inglese. Paolo - fino a quel momento, per me, nient'altro che un ragazzo divertente e di talento, incontrato una volta o due da qualche parte a Roma - si informò di dov'ero finita e venne a cercarmi. Lui, tanto più giovane di me, conosceva in tutti i suoi incanti la città, dove io vivevo più o meno da "emigrata del Sud" - in quel periodo non scrivevo neanche più sui giornali - Era la Londra magica e 2 trasgressiva dei Beatles, di Bibla, della "purple hearth", dei primi concerti rock e anche delle sontuose aste da Sotheby o da Christie. Fu lui a portarmi da Sotheby per la prima volta nella mia vita, e per un'occasione unica: vidi infatti vendere per tre miliardi, in poco meno di tre minuti, un Picasso del periodo blu, che non ho più dimenticato: era una donna, la moglie del pescatore, credo sia il titolo del quadro, tutta immersa in una trasparenza di colore verde-acqua, che contempla un garofano dello stesso colore, tenuto sul palmo della sua mano aperta. Quando Paolo, dopo qualche giorno, ripartì da Londra, io non mi sentivo più un'emigrata... Il libro Viaggio nell'arte contemporanea mi diede la chiave per mettermi in relazione con l'arte di questi ultimi cinquant'anni, verso la quale non avevo mai trovato una via. "Senza una teoria alla quale riferirsi - scriveva infatti Paolo nell'ormai lontano 1981 - non è possibile vedere un dipinto moderno". E poi: "L'arte moderna è diventata completamente letteraria, i quadri e le altre opere d'arte mi sembrano esistere solo per illustrare il testo". 3
Scarica