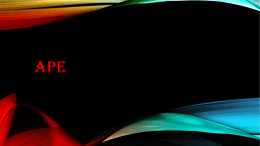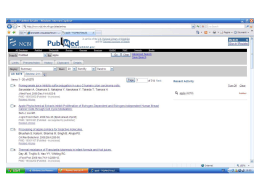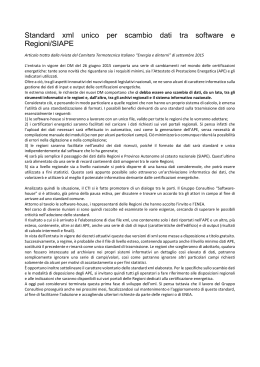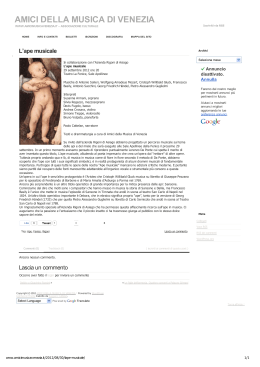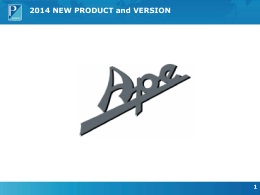domenica 24 aprile 2005 ❖ L’INDIPENDENTE DI P G IANCRISTIANO D ESIDERIO ROVATE a fare questo simpatico e stra- vagante esercizio: contate quanti Ape vedete nel corso di una passeggiata. Cosa è l’Ape? Suvvìa, che lo sapete benissimo. Avete capito perfettamente. Intendo proprio quell’Ape lì: quello strano mezzo di locomozione e trasporto che gli italiani (contadini, artigiani, commercianti, ma anche professionisti) hanno imparato a usare nel corso dei decenni, fino a farne una sorta di casa viaggiante o un’altra stanza della loro abitazione. L’esercizio che vi propongo, naturalmente, l’ho fatto anche io. Nel breve tragitto da via dei Cappellari (una traversa che si diparte da Campo dei Fiori verso il Vaticano) a Piazza del Gesù ho contato la bellezza di ventitré Ape: da quello più piccolo, l’Ape 50, a quello familiare, il cosiddetto Apecar. Il primo l’ho visto dopo aver fatto dieci passi uscendo da casa. Era stracarico di fiori coloratissimi che nascondevano l’Ape fino a farlo sembrare una sorta di giardino mobile. Il secondo era vicino al primo: piccolo, riverniciato con un colore indefinibile a metà strada tra l’indaco e il verde, trasportava bombole che, insieme, dovevano senz’altro pesare più del piccolo Ape. Arrivato a Piazza della Cancelleria ne ho visto tre parcheggiati uno di fila all’altro. Subito dopo c’erano macchino di ogni tipo. Ma chi li ha visti? I miei occhi erano tutti per questi stranissimi e bellissimi animali viaggianti su tre ruote. Come diavolo è possibile che l’Ape cammini veramente su tre ruote? Un tavolino con tre gambe è sempre instabile. Possibile che la Piaggio sia riuscita a mettere su strada un veicolo con tre ruote capace di spostare tutto: piante, animali, uomini, materiali, cose? Lo confesso: l’Ape mi ha sempre affascinato e ho sempre ammirato quei vecchietti del mio paese, Sant’Agata dei Goti, che riescono a guidarlo con disinvoltura, sia in stato di coscienza che in stato di ebrezza. Che spettacolo. Direte. Questo è pazzo. Perché mai? Perché mi affascina l’Ape? E allora che cosa direte mai di Franco La Cecla e Melo Minnella che hanno appena pubblicato un libretto originalissimo con la casa editrice Elèuthera proprio sull’Ape? Titolo: La Lapa e l’antropologia del quotidiano. Sì, proprio così: La Lapa. Un nome che è una favola. Non lo conoscevo, ma mi piace. Ne sapevo un altro, invece: L’Apetiello. Come se fosse un diminutivo o il nome confidenziale che si dà a un componente della famiglia. In fondo, l’Ape, per chi ce l’ha, fa proprio parte della famiglia. Un Ape non si abbandona mai. Lo si passa di generazione in generazione. Un Ape invecchia con il suo padrone o, magari, ringiovanisce con i suoi figli e nipoti. Un Ape ha infinite risorse e infiniti usi. Prendete il caso di Valentino Rossi. Grande pilota su due ruote. Ma ha cominciato con le tre ruote dell’Ape. Ne faceva un uso, diciamo così, sportivo. Ma l’Ape, anche se concepito per il lavoro, ha in sé una filosofia dello sport e della vita all’aria aperta. Qual è il precedente immediato della Lapa? Beh, il carretto siciliano o calabrese. La somiglianza tra il carretto e La Lapa è evidentissima. Non solo nell’uso, ma anche nella forma. Perfino nei cani. Il carretto ha il cane attaccato a seguire con pazienza, mentre nella Lapa il cane, fedelissimo amico del lapista, è a rimorchio che controlla la situazione (altre volte, invece, viene fatto accomodare accanto al lapista e ci sono anche dei casi in cui si racconta che a guidare La Lapa sia proprio il cane, mentre il lapista si limita ogni tanto a dire dove andare). Perché l’antropologia si interessa dell’Ape? E perché me ne interesso anche io (anche noi, l’io non è usato dal bravo giornalista, ma tanto non sono bravo)? Il treruote più famoso al mondo non è roba da intellettualizzare. E’ mondo. Fa mondo. E’ un prodotto dell’esperienza e non della ragione. Ma proprio per questo motivo l’antropologia del quotidiano s’interessa alla quotidianità della Lapa. Gli antropologi non credono nelle statistiche, nelle interviste, nei campionamenti, nei sondaggi. Credono in Trilussa e nella poesia (ma anche nella prosa). Credono nel primato dell’esperienza. Niente ideologia. Molto meglio le cose, le case, gli usi, i costumi, il lavoro, le abitudini, i luoghi, le memorie, i volti, gli amori, le sofferenze, le speranze. Per esempio: si vorrebbe che il mondo fosse così e così e così. E’ la solita storia: il mondo così com’è non va bene, meglio cambiarlo perché dovrebbe essere in un altro modo. Ma se volete conoscere il mondo dovete anche avere l’umiltà di confrontarvi con il mondo e mettere in conto che, magari, il mondo vi possa dire qualcosa che non sapete, che non avete mai visto, né sentito, né gustato. E’ un principio semplice: ascoltare prima di parlare. La Lapa è così. Vi racconta un mondo, più mondi. Perché la La Lapa è un essere anti-ideologico. Se fosse dipeso dalla Lapa non avremmo mai avuto i totalitarismi perché le storie sono l’esatto contrario della filosofia della storia. Le storie degli uomini non si lasciano ingabbiare in nessuna Ideologia. Invece, fanno saltare in aria tutti i castelli di carta di chi crede di avere messo le mani una volta e per sempre sulla natura umana. Figurarsi. ma fatevi un giro in Lapa e la- 5 l’APE IL MONDO VISTO E RACCONTATO SU TRE RUOTE sciateci in pace. La Lapa o Apetiello ci parla di personaggi. Ne voglio ricordare due: uno vivo e uno morto. Entrambi sconosciuti. Inziamo dal morto. Si chiama Alfonso e aveva un “contrannome” o soprannome o nomignolo: il merlo. Detto per esteso il nome suonava così: Fonz ‘o mierul (Alfonso il merlo). Nella vita non ha mai fatto un cavolo, pur facendo un sacco di cose. Non ho mai capito di chi fosse figlio e quanti figli avesse. Viveva con la moglie, i figli e altri parenti. Tutti degli sciagurati. Si arrangiavano e a volte neanche questo. Avevano difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Non erano belli, né curati. Stavano solo al mondo. Il merlo aveva solo una cosa: l’Ape. Di colore arancione, piccolo, con pezzi mancanti, ma comunque sempre su strada. Ci faceva di tutto, tranne che lavorare. Negli spostamenti da un paese all’altro, da Sant’Agata ad Airola o a maddaloni, ma anche nei viaggi più lunghi, fino a Napoli e dintorni, caricava tutta la prole a bordo e a rimorchio e si spostava. Come un esodo. La sua vera casa era l’Ape. Perché una casa vera non l’ha mai avuta. Quella che avevano giù alla villa comunale, sotto un bellissimo portico con sopra una finestra catalana che farebbe la felicità di archietti e di snob alla Daverio, l’avevano ridotta a una grotta. Una stamberga. Mia nonna, donna dall’energia titanica pur essendo piccolina, e dal cuore più grande, in pratica dava loro da campare. ma tra soldi e cibarie ho sempre avuto il sospetto che tutto andasse a finire nel serbatoio dell’Ape. Che strana storia è quella di Alfonso e della sua Lapa. Una storia fuori dalla storia. Una storia senza storia. Una storia vinta. Come quelle di Verga o di Sciascia. Una storia priva di coscienza: tutta natura e chissà se c’era dolore. O forse Alfonso, il povero Alfonso che un brutto giorno fece un volo da sopra a sotto di oltre trenta metri giù dalla villa comunale e si ruppe la testa e diede addio alla vita che lo aveva sconfitto, era così come appariva: sorridente, con la gioia nel cuore anche se aveva la miseria che gli usciva dalle orecchie. Cosa lo rendeva così inutile e spensierato? L’Ape. Chissà che fine avrà fatto La Lapa ora che il suo merlo non c’è più. L’altro personaggio è vivo e vegeto, ma non lo vedo da tempo. Forse è in giro per il mondo con l’Ape. Il suo nome è Pupone e altro non ne conosco. Aveva una moglie e un’amante ufficiale meno bella della moglie. Figli in quantità incerta. Lavoro imprecisato. Unica cosa stabile l’Ape. Il Pupone ne faceva un uso smodato. Era sua abitudine quella di festeggiare il Carnevale come Dio comanda. Soprattutto la morte del Carnevale. Pupone ricorreva a tutta la sua fantasia e attrezzava il suo Ape come una sorta di carro funebre (un uso RACCONTINI ROMANI Era l’espressione della libertà. Un tempo la usavano tutti per farci tutto: contadini, artigiani, professionisti. Ora un libro la celebra e ne tenta un’antropologia. Valentino Rossi ha imparato a correre proprio sulla “Lapa” che nel libretto di La Cecla e Minnella non si mensione e invece converrà tenerne conto), quindi portava in giro per il paese, come in una sorta di processione profana, il Carnevale ormai morto. Pupone usò l’Ape anche per festeggiare i due scudetti del Napoli di Maradona. In quell’occasione l’Ape cambiò colore: era più meno arancione (come quello di Alfonso: i due spesso facevano coppia) e divenne azzurro. Un grande scudetto venne disegnato sulla faccia dell’Ape e Pupone stesso si vestì da giocatore. Cosa che ha sempre fatto nella vita: ha sempre giocato. La stravaganza dei personaggi è uguale alla originalità dell’Ape. Chi guida un’Ape è sempre un “tipo”. I miei sono casi estremi, ma guardate chi usa l’Ape, chi viaggia in Ape, chi lavora con l’Ape, chi vive con l’Ape e vedrete che si tratta sempre di tipi originali. Non riconducibili al solito notissimo e pur sconosciuto italiano medio. Cosa dire ancora? Il rumore e la partenza. E’ vero che il rumore della Lapa è come l’acuto di un tenore di grazia? Canta in falsetto ed è sempre riconoscibile. Sapete sempre quando sta passando un’Ape. Quanto alla partenza è sempra garibaldina: l’Ape parte con uno scatto, come se volesse aggredire il mondo, come se volesse dire “io ci sono, state attenti”. Perché l’Ape è piccola e il mondo è grande, ma un mondo senza l’Ape sarebbe indubbiamente un mondo più povero. La Lapa ha preceduto Andy Warhol. Si tratta di un mezzo pop: «E’ l’avanguardia per cui ciò che è pacchiano diventa invece linguaggio con cui si capiscono gli spiriti eletti, è l’arte su tre ruote, la vita quotidiana senza ipocrisie. Peccato che nessun Warhol abbia pensato a fare una Lapa decorata come una zuppa Campbell». Ecco perché l’Ape è un mezzo popolare, dall’India alla Sicilia, dalla Romania alle Filippine «perché ha l’anima multifunzionale del popolo, ha l’idea che le cose non hanno una funzione precisa ma possono averne tante». Uno spirito creativo ha creato l’Ape che è la creatività della libertà umana su tre ruote. Buon Ape a tutti. DONNE DI CLASSE L ’ DI F ERNANDO ACITELLI ORA IN CUI il poeta Giorgio Vigo- lo usciva di casa adagiandosi non visto nella vita. Quell’imbrunire che proteggeva e che lo faceva sentire ancor più un “eremita di Roma”. Era soprattutto d’estate che in lui la tristezza aveva un’impennata e il cuore pigliava freneticamente a percuotergli il costato. Mi ero sempre illustrato nell’animo questo di lui. Munito di taccuino e confidando nei versi che sarebbero venuti con tutta quella quiete intorno, egli s’avventurava per la città ed i suoi luoghi erano i silenzi di vicolo Scanderbeg, un viottolo da secentesca fuga d’amore dalle parti della Fontana di Trevi, oppure piazza Margana, sotto al Campidoglio; e ancora i luoghi attorno al Foro:“In che luce vidi ier sera/nello strano imbrunire senza lumi/la colonna Traiana.[…] Il colore del giorno, precisamente, era quell’arancio che sta scheggiandosi sollevando pure nello scenario un violetto che poi si sarebbe mutato in blu. Ad adagiarsi in cima alla Trinità de’Monti, si sarebbero ammirate tutte le cupole e in esse immaginato lo sguardo impaurito dello scaccino che si preparava al buio; a quei pensieri, un animo sensibile avrebbe allertato i poteri di difesa avvertendo anche nei rettangoli sacri la paura. Era una sera d’estate ed io, tentando di ricostituire i passi di Giorgio Vigolo e gioendo per quella che doveva essere stata la sua serenità serale, già antica, dalla Fontanella di Borghese mi inoltravo verso quelle vie solenni che conducono a Piazza di Spagna. Nel mio animo il sereno s’era ben disteso ma tentavo di controllare il più possibile questo sentimento perché avevo sempre ritenuto fosse buona cosa “vivere al riparo degli dèi”, rimanendo sempre cauto nel dipingermi sul volto la gioia. Desideravo raggiungere il Pincio dopo crepuscolare scalata alla Trinità de’Monti e così avevo imboccato via de’Condotti svoltando poco dopo per via Belsiana. I negozi stavano chiudendo e s’avvistavano soprattutto donne in età, impaurite d’ogni tramonto. Si trattava di donne ricche, ingioiellate, che di lì a poco avrebbero raggiunto i luoghi delle vacanze, la costa tirrenica, il mare degli antichi padri. Ignoravo perché le collocassi in uno scenario classico: Ponza, il Circeo, addirittura Capri. Le vedevo custodirsi entro dimore che, sebbene a picco sul mare, avevano leso poco il paesaggio. In quelle penombre, l’ambulacro, le statue, le vasche a zampillo avevano il compito di sollevare quel silenzio che sa riparare le crepe dell’animo. Agli angoli tra via Belsiana e via Borgognona s’erano posizionati venditori d’Africa, coloratissimi negli indumenti e con un sorriso allarmato: temendo l’arrivo dei gendarmi, essi erano con lo sguardo sempre all’erta. In terra avevano sistemato un panno e su questo, allineate, stavano delle borse firmate, tratte da una enorme sacca. Gli stilisti, distanti e felici nei loro mausolei, pure sapevano di queste vendite fuori legge ma in quegli istanti erano occupati con cantori, orafi e incisori e non immaginavano quello scorcio di Roma ove s’abusava d’un loro marchio. Nei loro tramonti custoditi, gli stilisti erano in posa per il profilo: quel volto sarebbe stato effigiato su medaglie e così, accanto a Traiano, Gallieno e Probo avremmo ammirato anche… Quell’insperato ben di Dio, apparso d’improvviso agli angoli tra via Belsiana e via Borgognona, migliorò di molto lo stato d’animo di quelle donne che non si risolvevano a far ritorno a casa. Esse presero subito a venerare, sebbene da lontano, quella mercanzia dal marchio contraffatto. Poi che nessuna di loro – ne contai cinque – desiderava esporsi in quell’acquisto sotto lo sguardo delle altre, si delineò in quell’angolo una fase di studio. Che, forse, si conoscevano? Erano forse d’un ramo collaterale della stessa Casata? Alla fine, vinta la presumibile vergogna, s’accostarono a quei coloratissimi venditori e definirono “al volo” l’acquisto di borse che sarebbero state necessarie nello scenario delle loro ville a picco sul mare. Quieto nel mio angolo e recitando attenzione verso capi d’abbigliamento in una vetrina, registrai tre acquisti da parte di quelle donne di classe. Poi, nel violetto che stava cedendo al blu, m’allontanai con i versi di Giorgio Vigolo di nuovo a sostenermi:«Io sono veramente uscito/dal mondo e quando sto/con gli altri vedo quanto/il mio animo è lontano/e che parlo un’altra lingua./[…]».
Scaricare