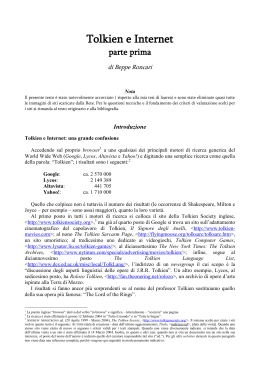JOHN RONALD REUEL TOLKIEN LE DUE TORRI Edizione italiana a cura di Quirino Principe Prefazione alla seconda edizione inglese di J.R.R. Tolkien I LIBRI DI J.R.R. TOLKIEN Titolo originale THE TWO TOWERS Traduzione di VICKY ALLIATA DI VILLAFRANCA Traduzione riveduta e aggiornata in collaborazione con la Società Tolkieniana Italiana ISBN 978-88-452-7075-8 © Fourth Age Limited 1954, 1955, 1966 Edition published by arrangement with HarperCollins Publishers Ltd. 77-85 Fulham Palace Road Hammersmith, London W6 8JB © 2011/2012 Bompiani/RCS Libri S.p.A. Via Angelo Rizzoli 8 – 20132 Milano I edizione Tascabili Bompiani maggio 2012 Prefazione di Quirino Principe La cultura dell’interiorità, cui Tolkien, come ogni narratore di rango, è lietamente estraneo, ci ha convinti che la qualità sia quasi una misura inversa della quantità. Ciò è vero per gli oggetti afferrabili nel mondo quotidiano, solidamente terrestri e terricoli: un’essenza, un colore, un odore, un sapore, spiccano meglio se circoscritti e concentrati. Hanno densità, acquistano scatto, si fanno desiderare. Ma per le realtà inafferrabili e pure immanenti, quelle cui non dobbiamo neppure pensare poiché sono troppo vertiginose e ci smarriremmo nel pensiero, esiste tra quantità e qualità una proporzione diretta, non inversa: la qualità lampeggia e raggiunge la massima intensità se l’estensione o la mole sono immense, tendono all’infinito. L’azzurro del cielo non sarebbe quell’azzurro se non fosse l’incommensurabile cupola che tutto avvolge: il colore deve la propria tonalità all’ampiezza spaziale in cui si muove l’occhio. Lo stesso accade con il violaceo delle distese marine. Il plasma stellare non sarebbe incandescente e inconcepibile nella sua temperatura, spaventosamente contrastante con il gelo cosmico, se la stella non fosse un globo di terrificante grandezza. Sempre, quando ci troviamo per un attimo (di più non reggeremmo) dinanzi al sublime, qualcosa di spaventoso è oltre i confini della nostra sensazione, “poiché il bello,” ha scritto Rilke, “altro non è se non il tremendo al suo inizio”. Esiste nei libri una diversità analoga a quella che riconosciamo tra la qualità concentrata della miniatura o del cammeo e la qualità del cielo o del mare o di un 5 Prefazione ammasso di galassie. Il fascino di un breve, perfetto racconto è anche nella sua brevità; il fascino di un romanzo fluviale è anche nelle migliaia delle sue pagine. Ma ogni scrittore veramente grande (Dante, Goethe, Proust, Musil), purché l’esiguità dell’esistenza terrena non l’abbia amputato sacrificando la giovinezza troncata agli dei cui essa fu cara (Leopardi, Kafka), lascia intendere che le brevi e folgoranti opere d’esordio sono abbozzi, studi, cartoni per il vasto affresco della maturità. Un’opera che narri di lunghi tempi e di spazi sterminati ci richiede spazio e tempo, nell’atto esteriore di leggere e nell’interiorità delle nostre emozioni. Così John Ronald Reuel Tolkien in The Lord of the Rings. Nel romanzo fluviale, il fascino è più intenso se esiste una scansione: bello è leggere a lungo, nel tempo improvvisamente libero di un’intera estate o lungo un anno di letture a blocchi di dieci o venti pagine prima d’addormentarsi, con il libro appoggiato al cuscino, ma d’irresistibile bellezza è concludere una fase del récit e transitare a un’altra, riprendere e continuare, far pausa e ricominciare accostando alla maturità e alla dolce stanchezza dell’aver letto la freschezza del dovere ancora leggere tutto un mondo nuovo in cui però il già noto sarà certamente riconoscibile. A livello altissimo, è questa la seduzione dei cicli di Balzac, in cui Vautrin e Rastignac e Rubempré “ritornano” o si reincontrano; a livello medio o medio-basso, è la tentazione dolciastra dei feuilletons ottocenteschi di una Xavier de Montepin, con il piacevole brivido del “vent’anni dopo” o della “continuazione alla prossima puntata”; a livello volgare, è l’ipnosi ottundente dei serials e delle soap-operas. Prima di capire perché The Two Towers, romanzo centrale del ciclo ternario The Lord of the Rings, abbia la sua luce particolare con “quel” colore derivante dalla sua centralità, domandiamoci: perché il récit tolkieniano è immenso, perché si estende a quasi millecin6 Prefazione quecento pagine? I filosofi della modernità teorizzante se stessa, Kant e Hegel, ci hanno spiegato che l’immensità finita, mare o cielo stellato, è immagine simbolica dell’infinito. Il ciclo di Tolkien è immenso poiché è un universo. Propriamente, un universo parallelo al nostro, che noi chiamiamo “reale” con la stessa presunzione con cui il nostro pianeta è ancora – per consuetudine storica – definito “il mondo” o una qualsiasi delle geometrie possibili e metaeuclidee è definita “la geometria” tout court. La Terra-di-Mezzo non è meno reale del planisfero terrestre, proprio perché essa è una totalità. La totalità della sua creazione consente a Tolkien la fascinosa reticenza che gli conosciamo. Reticenza soprattutto su tre misteri che legano gli uomini (della “nostra” terra, non gli Uomini della Terra-di-Mezzo) al cielo o all’inferno: la religione e il divino, la storia e la politica, la donna e la sessualità. In Tolkien nessuno prega con gli occhi volti al cielo e le mani giunte o le palme levate, nessuno è ministro di un culto, non ci sono né Dio né dei né spiriti né idoli; nessuno allude a ravvisabili metafore o metonimie (né, crediamo, ad allegorie trasparenti “sotto il velame”) in cui si avverta il sentore di qualche ideologia o fazione politica di cui le nostre planetarie res gestae furono incubatrici; non c’è traccia di amplessi, di alcove o di stupri, i quali ultimi sarebbero stati prevedibili in uno scrittore meno trascendente, data la qualità degli elementi guerreschi, avventurosi e selvaggi presenti in The Lord of the Rings (i barbari Orchi, per esempio), e infatti sono presenti nella fantasy posttolkieniana, massimamente in quella cinematografica. Però i misteri incombono da altre parti: si avvertono forze superiori, mai nominate (un dettaglio che esalta il talento narrativo dello scrittore), che risalgono a un numinoso proiettato a distanze inconcepibili; agisce il meccanismo del potere, in forme classiche; l’apparizione, proprio in The Two Towers, di dama Eowyn, il primo oggetto femminile d’irra7 Prefazione diazione amorosa sul piano non elfico (Galadriel) ma terrestre, suscita un eros castissimo e sottilmente insinuante, che troverà il suo compimento alla fine del ciclo, nell’amore quasi preadolescenziale tra la dama di Rohan e l’austero Faramir. Non c’è alcun filo che colleghi i due universi paralleli, il nostro creato dal big bang o da Jahweh e quello creato dal filologo anglo-sudafricano? C’è, lo intuiamo. È un filo che corre non “attraverso”, bensì “sopra”: è un archetipo primario. È il fantasma della letteratura. Distillato in essenza simbolica, il sangue che circola nei tre grandi ambiti letterari che Tolkien prediligeva, il romance bretone, il Lied nibelungico e il fairy tale celtico, filtra anche nell’universo tolkieniano. Tre ambiti, e tre oggetti che cadono casualmente (?) nel testo. Li troviamo proprio all’apertura di The Two Towers, nello scenario della morte di Boromir. Il primo oggetto è il corno di Boromir, che lo ha suonato disperatamente prima di cadere ucciso dagli Orchetti. La scena è parallela alla morte di Roland che suona l’Oliphant fino a farsi scoppiare il cervello, ma anche al combattimento di Sétan nel ciclo irlandese di Candullino. Il corno è così un simbolo carolingio-bretone, che nel passo tolkieniano è accostato a un oggetto, la spada di Aragorn, quella che-fu-rotta, di palese gemellanza con la spada nibelungica di Siegfried, la già spezzata Nothung. Il terzo oggetto è l’onnipresente Anello, magico nucleo di narratologia elementare nella tradizione della fiaba. Sarà un caso che i tre oggetti siano associati in un memorabile evento del teatro wagneriano? È culturalmente indebito associare la lettura di The Lord of the Rings alla musica di Wagner (un crimine analogo è stato commesso nel film Excalibur), ma è un fatto che nel libretto wagneriano di Lohengrin (atto III), il cavaliere del cigno prega Elsa di dare a Gottfried, qualora egli ritorni, “dies Horn, dies Schwert, den Ring”: il corno, la spada, l’anello. 8 Prefazione The Two Towers è il romanzo centrale, si diceva. Tale collocazione dà al récit un carattere particolarmente doloroso e faticoso. È il momento in cui più acuti sono i travagli del parto, in cui la serenità del passato è ormai lontana e irrecuperabile e sembra non essere mai esistita, mentre la liberazione e il riposo e la felicità che Frodo, Sam, Aragorn, Merry, Pipino, Gimli, Legolas si ripromettono (sotto la meditabonda ed enigmatica ala protettiva di Gandalf) sembrano lontanissimi, irraggiungibili e forse inesistenti. Il terreno di The Two Towers è un deserto di spine, così come, in una malattia il cui decorso prevedibile sia di tre giorni, il secondo giorno è il più penoso. Qui, nel romanzo centrale, nel tempo di mezzo della Terra-di-Mezzo, all’ombra delle due torri che condensano in sé il Bene e il Male radici delle res gestae universali, si attuerà il compito di Frodo: gettare l’Anello supremo nel Monte Fato, e distruggerlo per sempre. Questa, alla fine del romanzo, sarà la svolta, la dolente battaglia vinta ad altissimo prezzo che tuttavia condurrà, lentamente, al diradarsi delle plumbee e ferrigne nubi in cui The Two Towers ha il suo colore dominante. La fine di questo secondo romanzo è la katastrophé tragica, in senso aristotelico e di segno rovesciato, dal Male al Bene. Tra il primo romanzo, The Fellowship of the Ring, in cui il clima da fiaba domestica e agreste si trasforma a poco a poco in horror story, e il terzo romanzo, The Return of the King, in cui una sorta di apocalisse con battaglia di Armageddon finale e con tanto di apocalittici cavalieri trascolora alla fine in un paesaggio alla George Eliot, il secondo romanzo del ciclo tolkieniano conserva i riflessi d’acciaio della vera, grande poesia epica. 9 Prefazione alla seconda edizione inglese del Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien La narrazione di questo racconto è cresciuta, fino a diventare una storia della Grande Guerra dell’Anello e a includere molti scorci delle storie ancora più antiche che l’hanno preceduta. Iniziò poco dopo che Lo Hobbit fosse finito, e prima che venisse pubblicato nel 1937; però non continuai con questo seguito, poiché desideravo prima completare e sistemare la mitologia e le leggende dei Tempi Remoti, alle quali da alcuni anni stavo dando forma. Desideravo farlo soprattutto per mia soddisfazione, e nutrivo poche speranze che altri potessero interessarsi alla mia opera, soprattutto dal momento che la sua ispirazione era primariamente linguistica, e che in principio era stata concepita solo per fornire un necessario retroterra di “storia” alle lingue elfiche. Quando quelli cui chiesi consiglio e suggerimenti corressero “poche speranze” in “nessuna speranza” tornai a dedicarmi al seguito, incoraggiato dai lettori che richiedevano più informazioni sugli Hobbit e sulle loro avventure. Tuttavia la storia fu attratta inesorabilmente dal mondo antico, e così divenne un resoconto della fine di quel mondo, prima che l’inizio e lo svolgimento ne potessero essere narrati. Il processo era iniziato scrivendo Lo Hobbit, nel quale c’erano già alcuni riferimenti ad argomenti più antichi: Elrond, Gondolin, gli Alti Elfi e gli Orchi, insieme a scorci di cose più alte, profonde od oscure rispetto alla superficie di quel libro, che si erano presentate inaspettate: Durin, Moria, Gandalf, il Negromante, l’Anello. La scoperta del 11 Prefazione alla seconda edizione inglese del Signore degli anelli significato di questi scorci e delle loro relazioni con le storie antiche svelò la Terza Era, e il suo culmine nella Guerra dell’Anello. Chi mi aveva chiesto più informazioni sugli Hobbit alla fine le ha ricevute, ma ha dovuto attendere a lungo; la composizione del Signore degli Anelli infatti procedette saltuariamente negli anni fra il 1936 e il 1949, un periodo durante il quale avevo molti doveri cui non mi sottraevo, e spesso ero assorbito da molti altri interessi come insegnante e come ricercatore. Il ritardo fu, naturalmente, aumentato anche dallo scoppio della guerra nel 1939; per la fine di quell’anno il racconto non aveva ancora raggiunto la fine del Libro Primo. Nonostante l’oscurità dei cinque anni seguenti, scoprii che la storia non poteva essere abbandonata del tutto, e quindi avanzai faticosamente, per lo più di notte, finché non arrivai alla tomba di Balin a Moria, e lì mi fermai a lungo. Passò quasi un anno prima che riprendessi il cammino, e così nel 1941 arrivai a Lothlórien e al Grande Fiume. Nell’anno successivo scrissi le prime bozze di ciò che ora è il Libro Terzo, e l’inizio dei capitoli I e III del Libro Quinto; e lì, mentre i fuochi di segnalazione ardevano sull’Anórien e Theoden arrivava a Clivovalle, mi fermai. Non sapevo più come andare avanti, e non c’era il tempo per pensarci. Fu durante il 1944 che, mettendo da parte le indecisioni e le perplessità causate da una guerra che era mio dovere combattere, o almeno raccontare, mi sforzai di affrontare il viaggio di Frodo a Mordor. Quei capitoli, che alla fine divennero il Libro Quarto, furono scritti e spediti a puntate a mio figlio, Christopher, che all’epoca si trovava in Sudafrica con la raf. Ciononostante, ci vollero altri cinque anni prima che il racconto arrivasse alla sua fine attuale; in quel periodo ho cambiato casa, cattedra e college, e le giornate anche se meno cupe non erano certo meno laboriose. Poi, quando finalmente raggiunsi la “fine”, l’intera storia dovette essere 12
Scaricare


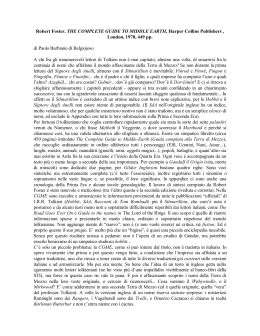



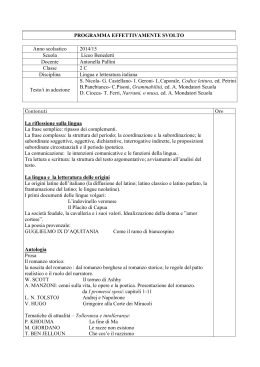

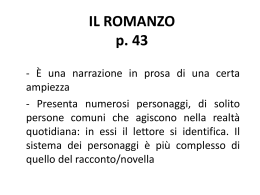
![Italo Calvino [h]](http://s2.diazilla.com/store/data/000054582_1-6f09ede360492035ba514f55116a45aa-260x520.png)