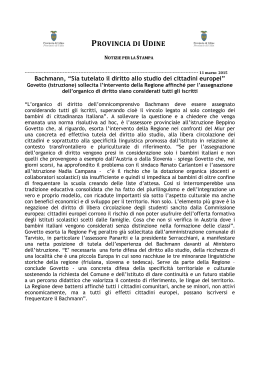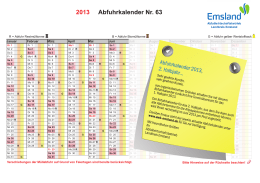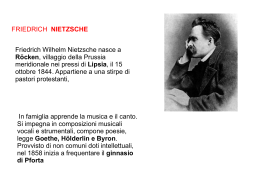studi germanici 3-4 2013 Maria Cristina Lombardi, Kenningar nelle Friðþjófsrímur islandesi, Roma, Aracne, 2012, Lingon. Collana di Lingue e letterature nordiche, vol. 1, pp. 336, € 19. Il volume di Maria Cristina Lombardi è dedicato al genere delle rímur, che finora è stato ingiustamente marginalizzato negli studi di scandinavistica medievale. Prodotto della cultura letteraria islandese del tardo Medioevo (il testo più antico a noi noto, la Óláfs ríma Haraldssonar, risale alle fine del XIV secolo ed è conservato nel codice miscellaneo conosciuto come Flateyjarbók), le rímur sono opere narrative in versi di vario argomento che attingono prevalentemente dall’ampio ed eterogeneo repertorio narrativo delle saghe. In alcuni casi, esse rappresentano addirittura l’unica testimonianza di saghe di cui non abbiamo conoscenza diretta. Sul piano formale, inoltre, le rímur ereditano la tradizione della poesia eddica e della poesia scaldica e recepiscono stimoli e modelli provenienti dal continente europeo. Il lavoro di Lombardi è diviso in sei capitoli e ha come tema principale l’analisi delle kenningar – complesse figure retoriche, tipiche della poesia scaldica – nelle cosiddette Friðþjófsrímur, che rielaborano principalmente la materia narrativa della Fríðþjófs saga hins frækna, appartenente al genere delle fornaldarsögur (“Saghe del Tempo Antico”). Il primo capitolo del volume fornisce un inquadramento del genere delle rímur nel panorama letterario islandese medievale (con particolare riferimento alla questione del rapporto con le ballate della Scandinavia) e un’illustrazione dei principali studi che sono stati dedicati ad esse. Vengono inoltre offerte alcune riflessioni sulle possibili modalità di fruizione delle rímur nel contesto culturale e sociale islandese del tardo Medioevo. Il secondo capitolo è interamente dedicato alla presentazione delle Friðþjófsrímur e della loro tradizione manoscritta, al rapporto con le due redazioni (A e B) della Friðþjófs saga hins frækna, e al confronto tra le edizioni esi- stenti delle Friðþjófsrímur, di cui vengono messe in evidenza le principali divergenze sul piano grammaticale e lessicale. Il terzo capitolo contiene un’ampia disamina dei principali problemi relativi alla definizione delle kenningar come figura retorica. Il discorso prende le mosse dalle testimonianze medievali (Snorri Sturluson nell’Edda e Óláfr Þórðarson nel Terzo Trattato Grammaticale) per poi offrire una rassegna delle definizioni moderne di kenning. Il quarto e il quinto capitolo costituiscono il nucleo analitico dell’intero lavoro. In essi, infatti, viene proposta una classificazione completa e un’indagine linguistica dettagliata delle kenningar – suddivise in determinative primarie e in determinative secondarie – nelle Friðþjófsrímur all’interno del contesto narrativo in cui sono collocate. Il sesto capitolo contiene le conclusioni dell’indagine e mette in evidenza gli aspetti salienti dell’analisi. Chiudono il volume un riassunto in lingua inglese e un’ampia bibliografia aggiornata. Rispetto al tema principale del lavoro – la ricezione e la rielaborazione delle kenningar nelle rímur in quanto forme poetiche tarde 454 – l’autrice osserva che, nonostante si registri un grado di creatività piuttosto limitato rispetto al patrimonio classico delle kenningar scaldiche, dall’analisi delle perifrasi nelle Friðþjófsrímur «è emersa la possibilità che mezzi retorici ormai codificati come le kenningar del XIVXV secolo, non si configurino solo come dettati da semplici esigenze metriche, ma siano portatori di contenuti e connotazioni semantiche che conferiscono forza poetica e descrittiva alle narrazioni» (p. 277). Dallo studio risulta inoltre che l’aspetto di maggiore originalità delle Friðþjófsrímur riguarda la scelta dei sinonimi nel repertorio lessicale scaldico, guidata dal contesto narrativo entro cui si colloca la kenning. Tutto ciò contribuisce a rendere evidente il fatto che le rímur racchiudono in sé, in misura e in combinazione variabile, elementi tradizionali ed elementi innovativi. Un altro aspetto importante del lavoro mi pare risieda nell’attenzione che l’autrice dedica all’intera trasmissione manoscritta delle Friðþjófsrímur, a prescindere dal valore stemmatico dei singoli testimoni. L’analisi include pertanto alcune riflessioni sul ms. AM 606 4to che, in quanto copia settecentesca di un codice esistente (il ms. AM 604 4to), non è preso in esame nelle edizioni precedenti, dove non è nemmeno menzionato. In un’ottica implicitamente ispirata ai princìpi della New Philology, che assegna pieno valore documentario a ogni singolo testimone di un testo, Lombardi osserva giustamente che AM 606 4to rappresenta un’importante attestazione dell’interesse per le Friðþjófsrímur in un contesto cronologicamente molto distante da quello a cui si fa risalire la composizione originale, all’inizio del XV secolo. Un’annotazione a margine riguarda il giudizio espresso dall’autrice sul XIV secolo e la composizione di saghe. Credo sia fuorviante ritenere che questo secolo sia «un periodo in cui la scrittura di saghe andava lentamente declinando» (p. 15). A quel periodo, infatti, risale la redazione di numerose saghe, appartenenti a diversi generi, che recepiscono e rielaborano modelli e stilemi nuovi, importati dalla letteratura continentale principalmente attraverso la traduzione di letteratura cavalleresco-cortese (le cosiddette riddarasögur, o «Saghe dei Cavalieri»), e che contribui- scono a innovare il sistema letterario islandese, come del resto osserva la stessa autrice poco più avanti (p. 20). A prescindere dalla contraddizione, che un lettore attento è in grado di individuare, l’emergere delle rímur come nuovo genere, che dà vita a un reticolo di riferimenti intertestuali e intergenerici che noi oggi siamo in grado di cogliere solo in parte, e la definizione del loro ruolo nel sistema letterario è un fatto che diviene ancora più rilevante se si considera il XIV secolo (e il secolo seguente) nella sua complessità di generi, poetici e in prosa. Questa osservazione non deve tuttavia sottrarre valore al volume di Maria Cristina Lombardi, che per il rigore dell’indagine linguistica, per lo scrupolo filologico e per l’ampiezza delle riflessioni rappresenta senza dubbio un contributo importante e coraggioso allo studio di un genere che attende ancora, nel panorama della ricerca internazionale, di essere analizzato adeguatamente. Per questo credo che una traduzione in una lingua di comunicazione internazionale potrebbe dare all’indagine la visibilità che il progetto merita. Massimiliano Bampi 455 Il marmo, la fontana, il precipizio. Poesie tedesche sull’Italia, a cura di Bernhard Arnold Kruse e Vivetta Vivarelli, Firenze, Le Lettere, 2012, pp. 330, € 28. Il volume dedicato a Ingrid Hennemann-Barale raccoglie ventisette saggi sul mito dell’Italia nella letteratura tedesca a partire dal grand tour settecentesco fino a tutto il Novecento. La seduzione del viaggio in Italia non è legata a un’esperienza reale ma mediata dalla musica e dalle arti figurative: si tratta di un’Italia mitizzata, vicina negli intenti alle statue di Canova che si ispiravano alle sculture greche. Nel periodo classico-romantico predomina l’elemento visivo e la composizione si fa quasi pittorica anche se è la lirica ad assumere il compito di incarnare quella Sehnsucht che si salda con il modello ideale della Mignon goethiana. È con Goethe che si afferma poeticamente un paesaggio italiano stilizzato a partire dalla tradizione letteraria, tracciando una linea evocativa in cui ritroviamo i medesimi topoi (arance, limoni, olivi, viti, palme e fichi) ma calati ogni volta in un contesto nuovo e in una nuova Stimmung: tutti partono dal mo456 dello goethiano o per continuarlo o per superarlo ma il canto della Italiensehnsucht è diverso per ciascun autore, e quindi non si tratta mai del ‘solito viaggio in Italia’. Gli elementi portanti di questa forza simbolica giustificano il titolo della raccolta: il marmo delle statue nelle ville del Palladio, la fontana colma d’acqua e il precipizio rappresentato dal passaggio attraverso le Alpi, rito iniziatico che precede l’approdo al paese dai frutti dorati, sono motivi di un’evocazione arcadica che diventa una sorta di spettacolo primordiale accompagnato talora da una vertigine profonda. Fin dall’inizio la convivenza di incanto e disincanto, mito solare e minaccia notturna convivono, da Goethe a Nietzsche, da Eichendorff a Kaschnitz e oltre. L’Italia come scenario di rinascita ma anche di dissoluzione, la bellezza medusea e mortifera che si coniuga alla potenza rigeneratrice del canto sono al centro del saggio introduttivo di Patrizio Collini che ricostruisce la leggenda nera di Venezia, protagonista di una e vera e propria rivoluzione estetica e mediale nell’Ottocento. Si afferma infatti, a partire dal Geisterseher di Friedrich Schiller, l’immagine della la- guna in rovina e della città musicale, definizione inaugurata da Rousseau e ripresa da Goethe nella sua Italienische Reise a proposito della Barcarola. Nella lirica tedesca di ispirazione veneziana si sviluppa il principio dialogico di questo Volksgesang fino a perdersi e a lasciare il posto a un canto soffocato come quello wagneriano, contro cui polemizza Nietzsche: la progressiva solitudine del cantore si rovescia inaspettatamente in immagine positiva, circonfusa di grazia e beatitudine, ove il canto non ha più bisogno né di pubblico né di interlocutori ma basta narcisisticamente a se stesso. Tornano a Goethe gli studi di Lucia Borghese e Marco Meli. La prima porta il lettore sulle orme del viandante-archeologo protagonista della celebre poesia goethiana Der Wandrer, individuandone il nucleo visionario nell’innesto della Hütte di matrice pietistica all’interno delle rovine di un antico tempio pagano, inserendo così la genialità stürmeriana in una fitta quanto misteriosa rete di corrispondenze fra macro e microcosmo; il secondo indaga invece il carattere lirico innovativo delle Römische Elegien e in particolare La Quinta Elegia, vero e proprio manifesto del nuovo sensualismo goethiano che riesce a coniugare l’apparente osservanza di un canzoniere amoroso sulla scia dei carmina erotica latini con una moderna espressività. Se nel primo saggio alla pienezza erotica della giovane donna che tiene il suo bambino in braccio si combina alchimisticamente il parlare ermetico e figurato della lingua goethiana, letterale e simbolica al tempo stesso, nel secondo viene messo in luce il motivo pigmalionico della creatura artistica che non prende semplicemente spunto dalla realtà ma si vivifica come proiezione dell’energia vitalistica dell’autore. Il viaggio attraverso questo itinerario ideale prosegue con Lucca di Tieck, analizzata da Alessandro Fambrini. La lirica, scritta a ridosso della breve sosta toscana di Ludwig Tieck, rappresenta una importante evoluzione nel senso del fantastico tieckiano che si fa atto di volontà, apertura cosciente a una percezione fantastica del mondo reale, anche a rischio dello smarrimento incarnato in questa lirica dalla demoniaca Nußknackerin. La malìa fatua di questa figura femminile si situa non a caso in una tappa 457 come Lucca che significa di per sé già deviazione rispetto ai percorsi classici dei viaggiatori stranieri in Italia. Ritroviamo questa dinamica aperta della Wanderung anche nelle pagine dedicate da Giovanna Cermelli a Sehnsucht di Eichendorff, la poesia pubblicata per la prima volta nel 1834 nel romanzo Dichter und ihre Gesellen. L’ipotesto goethiano costituito da Wilhelm Meisters Lehrjahre mostra come elemento comune la Sommernacht che fa da cornice, ma con una vistosa differenza: sembra scomparso il carattere dialogico che connotava lo struggente canto di Mignon; ormai la nostalgia stessa è evocata al passato, come uno spettro di questo scenario confuso, indeterminato e al tempo stesso assoluto che è Roma. Spettrale appare anche la valenza utopica del musico ambulante che faticosamente si fa strada nel freddo Nord Europa suonando il suo organetto, protagonista della lirica Der Leiermann di Wilhelm Müller. Patrizio Collini ipotizza una matrice italiana per questo misterioso personaggio che incontra il viandante protagonista della Winterreise: il suonatore, che tanto sembra avere in comune 458 col famoso arpista goethiano, porta avanti, anche nell’inverno perenne di un paesaggio addormentato, una cultura popolare a cielo aperto e il suo incontro con il Wanderer assurge a testimonianza della moderna condizione (in)umana e del sogno romantico di riscattarsi da questa schiavitù attraverso un risveglio collettivo. La riproposta di motivi romantici, primo fra tutti il fascino lagunare che corrisponde a un progressivo distacco dalle fatiche della vita quotidiana, si salda nel ciclo Sonette aus Venedig di August von Platen a una tensione che prelude già alla lirica decadente. Marco di Manno mette in luce la Spannung tra eleganza formale della composizione e tono pessimistico-elegiaco, colto nel momento cruciale in cui il poeta sta per abbandonare Venezia, terra onirica e illusoria, paradigmatica della natura impermanente di tutte le cose. Se Platen offriva una sorta di ‘resoconto’ di viaggio in versi, ancora più inconsueta si dimostra la letteratura odeporica heiniana analizzata da Stefania Acciaioli. La rotta di Heine nei Reisebilder lo porta verso mete costiere non convenzionali e lontane dalle orme goethiane, la Wanderung ormai conduce a un’Italia tutta interiore e nostalgica per poi superare anch’essa in nome di un modernissimo impegno profetico-rivelatore, dove la poesia si emancipa sia dalla plasticità classica sia dalla soggettività romantica pur riconoscendosi debitrice di entrambe. Il saggio di Fabrizio Cambi su Conrad Ferdinand Meyer individua nella lirica Der römische Brunnen il punto d’arrivo di un complesso percorso estetico, poetologico e stilistico. Complesso anche lo sviluppo del testo stesso, che vede passare un ventennio tra la prima stesura e la versione definitiva: questo lungo processo di autoridefinizione approda a un’osmosi tra realismo e simbolismo della proiezione, consegnata al lettore in una forma che coniuga brevità e plasticità. Viene sottolineato l’equilibrio dinamico di quiete e fluire ininterrotto dell’acqua in questo esemplare di Dinggedicht che esclude totalmente la presenza di un Io lirico; il moto costante scandito in rima alternata dagli zampilli d’acqua che si innalzano e ricadono forma un unico flusso liquido-sintattico, denso di riferimenti teologici e mitologici. Cambi sembra ricol- legarsi all’articolo di Enzo Paci del 1946 che compare in appendice al volume, comparando il Brunnen di Meyer con la Römische Fontane di Rilke, mito interiore che realizza quell’identità di visione ed essere che permette all’opera di distaccarsi dal poeta stesso. E proprio a Rilke in Italia sono dedicati i contributi di Elisabetta Terigi, Barbara di Noi e Bernhard Kruse; la prima sottolinea il legame tra i Ding-Gedichte romani e la riflessione rilkiana intorno alla morte e all’immortalità; la seconda invece esplora lo spazio-soglia tra il sogno e il ritorno alla coscienza nel Venezianischer Morgen che tramite il risveglio della città rappresenta uno spettacolo intransitivo, senza spettatori nella Zwischenzeit di quello Zwischenraum che è lo specchio; il saggio di Kruse rimane a Venezia con Rilke ma per indagare le modalità di costruzione del «bel contrappeso del mondo» che nella poesia Spätherbst in Venedig si fonda su un equilibrio precario e ironico di vita e di morte, di decadenza e volontà, di dissoluzione del soggetto e di forza creativa, radiosa e dolce. Torna a riflettere sulla relazione profonda tra parola e lirica 459 il saggio di Paola Gheri sul Nietzsche veneziano: la poesia An der Brücke eleva la città a simbolo dell’ideale musicale mediterraneo contrapposto a quello germanico con toni però assai lontani dalla asciutta serenità agognata. Il motivo del viaggio che porta a confronto Germania e Italia e, nel caso di Stefan George, anche Germania e Grecia, assume poi il valore di una vera e propria utopia palingenetica nello scritto di Mattia Di Taranto, che riconosce l’impossibilità di ridurre il paesaggio incantato dell’Italia a un’immagine univoca: Südliche Bucht mostra una sintesi possibile tra la Venezia tizianesca, la Toscana dantesca e petrarchesca, la Roma delle rovine, degli imperi e della luminosa campagna che la circonda e la costa campana che ispira i versi ermetici georghiani. Il Reiselied di Hugo von Hofmannsthal è letto da Vivetta Vivarelli come testo-chiave che presenta al lettore due situazioni contrapposte e paradigmatiche: un paesaggio minaccioso e inquietante, verticale che convive con un ambiente edenico, solare e disteso in cui domina una visione orizzontale. Questa lettura richiama il modello di Mignon 460 ma anche e soprattutto il Canto del destino di Iperione di Hölderlin, che rappresenta l’effimero abisso che separa la sfera immortale e atemporale abitata dagli dèi dalla sfera umana, contrassegnata dalla caduta, dalla vertigine, dai rintocchi del tempo e dai colpi del destino, abisso che solo l’arte può superare ed esorcizzare. Ancora sul compito del poeta indaga Maria Fancelli nell’ambito della poesia didascalica Mittelmeerisch di Gottfried Benn: essa rimette in discussione il rapporto tra coscienza e natura, tra estetica e responsabilità, ammettendo che di fronte agli eventi sconvolgenti della storia contemporanea la coscienza non può più permettersi di rimanere estranea. Il Süd-Komplex di Benn è una riserva simbolica di elementi mitici tesi alla ricomposizione della civiltà occidentale in un messaggio di conciliazione che, anziché rimodulare il tema di una fuga verso sud, auspica l’accoglimento nel nord della luce e del calore mediterraneo, di cui si fa portatrice la rima messaggera, che viaggia su un piano alto, ben al di sopra degli spazi nazionali. La polarità fra cultura e natura è presente anche, virata però verso una deriva annichilente, nella poesia In Venedig di Georg di un divenire che è già ricordo in Trakl, nata anch’essa in un conte- un ritmo contratto e serrato. L’ulsto cupo che fa da sfondo al tema timo Rom-Gedicht della poetessa, dello Einsame-Heimatlose, al centro Abschied von Rom del 1972, è letto della contrapposizione fra città e da Perrone Capano in chiave di campagna, nord e sud e nella let- osmosi estetica di tempi e luoghi, tura che ne dà Dario Borso già della vita, del ricordo, della storia compare l’asse est/ovest che col- e della descrizione, scritti nel molega Berlino, Vienna e Venezia. mento del congedo che rappreL’immagine malata e antimi- senta il punto di partenza verso tica dell’Italia è centrale nei tre un movimento nuovo. saggi su Marie Luise Kaschnitz Al paradosso di un’eternità che proposti da Giuliano Lozzi, In- invecchia ci riportano le pagine di grid Henneman-Barale e Lucia Giuseppe Bevilacqua su Paul Perrone Capano. La Roma Ewige Celan a Cerveteri: le due poesie Stadt dell’omonima poesia del MITTAGS e DIE EWIGKEIT 1952 rispecchia secondo Lozzi lo fanno riferimento entrambe alla sconcerto di fronte a una città in- visita della necropoli etrusca che quieta e inquietante sopravvissuta segna una svolta esistenziale e alla guerra e teatro di domande poetica per Celan esitante sul consenza risposta che, attraverso il fine fra la vita e la morte, tra l’imgioco dialettico tra l’Io lirico e il pulso al suicidio e l’attaccamento lettore o un alter ego dell’Io lirico spasmodico alla vita. Bevilacqua stesso, irrompono nella tradizione mette in luce il significato della che ancora permane nella lirica volontà precisa da parte del poeta come struttura ritmica e rima al di di visitare non i sepolcri classici o sotto dei frammenti e delle mace- le catacombe bensì le tombe etrurie contemporanee. Torna a par- sche che rappresentano, attralare di tradizione e modernità, di verso il culto mortuario che temi e tecniche espressive calate accompagna i defunti con cibo e in uno scenario mutato Henne- bevande, una frontiera sfumata mann-Barale che coglie nella poe- fra il tempo della vita e una morte sia Genazzano la svolta linguistica e che tarda a venire. poetologica della scrittrice che L’interesse per l’Italia da parte tende a vivere il detto come cifra di Friederike Mayröcker, pur non del non detto e a scandire l’attesa essendo sistematico, è tutt’altro 461 che episodico e affiora in frammenti epifanici come Die Kenntnis eines Dinges erzeugt Liebe zu ihm, je genauer die Kenntnis, desto brennender die Liebe scelto da Sara Barni in quanto esemplare di questa fascinazione per qualcosa che è dentro l’autrice e tuttavia non è mai totalmente posseduto, come appare significativamente già dal titolo attribuito a Leonardo da Vinci ma senza trovare riscontri esatti nella sua opera, rivelandone il carattere composito e frutto di contaminazioni. Continua la metamorfosi dello Italienbild nel Novecento con Ingeborg Bachmann: Camilla Miglio analizza Das erstgeborene Land come canto musicale e come canto della terra primigenia ma anche primogenita e neo-nata, la terra del morso del serpente e dei ricordi del sottosuolo che con i suoi moti incontrollabili aggredisce l’Io poetico. Se da un lato in Bachmann viene decostruita l’Italia idilliaca e mitica, come evidenzia Rita Svandrlik a proposito della poesia Am Akragas, dall’altro viene invece costruita una topografia della soglia mobile e cangiante, fluida come i corsi d’acqua del paesaggio agrigentino evocato dalla poesia, richiamando una dimensione rituale della na462 tura e una lettura circolare del divenire. Si perpetua il dinamismo dei Klangbilder bachmanniani anche nei Lieder auf der Flucht dedicati a Napoli in quello che Giuseppe Dolei definisce “ritratto urbano” in fuga non solo dalla città assediata e sepolta dalla neve ma anche dal verso come forma privilegiata dell’arte. L’Io lirico non trova rifugio in questa Napoli sconfitta nemmeno quando una forza primordiale giunta con l’estate sprigiona riserve vitali mediterranee in grado di ristabilirne l’armonia. Chiudono la raccolta nel segno della contemporaneità i saggi dedicati da Claudia Vitale ed Elena Agazzi rispettivamente a Helga Novak e a Rolf Dieter Brinkmann. La Palermo della poetessa berlinese emigrata in Islanda diviene emblema dello Außenseitertum e di una condizione dis-umana che nella Sicilia degli anni Sessanta si condensa in un’immagine di fame, di corruzione e di vagabondaggio ma al tempo stesso di fierezza della propria solitudine, poiché proprio essa diviene condizione esistenziale in grado di amplificare lo sguardo e di lanciarlo oltre il sistema stagnante. Anche Agazzi con il suo contributo su Brink- mann sembra anticipare le parole di Marianello Marianelli (in appendice) tratte da una trasmissione RAI andata in onda significativamente solo un paio di anni dopo la stesura di Roma die Notte: le sciabolate rivolte all’Italia, vaso di Pandora dell’Europa contemporanea secondo Marianelli, trovano voce nel dissacrante notturno romano dello scrittore che esprime polemicamente e insieme ironicamente il proprio risentimento verso la città inerte e lasciva di fronte a imprese urbanistiche volgari e insostenibili che violentano la natura circostante e diffondono un senso di morte e di rovina. Il viaggio in Italia si conclude dunque con lo smarrimento dell’artista e con una Verwilderung nata dal sentirsi scomodo e dal bisogno di impegnarsi, anche attaccando i miti che egli stesso ha contribuito a fondare: il rapporto con l’Italia da parte di questi scrittori è sempre stato ambiguo e complesso, un innamoramento tutt’altro che cieco, piuttosto un amore che dona all’arte occhi nuovi con cui dare forma al mondo poetico per restituire all’arte la sua innocenza e riscoprirne la verità. Nicola Ribatti, Allegorie della memoria. Testo e immagine nella prosa di W. G. Sebald, Trento, Università degli Studi, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici, 2012, pp. 237, € 12. Nicola Ribatti si pone l’ambizioso compito di analizzare la «relazione interdiscorsiva tra visuale e verbale» nell’opera di W. G. Sebald, studiando un fenomeno che salta all’occhio anche ad una lettura superficiale dell’autore tedesco, ossia la massiccia presenza di immagini all’interno delle sue prose. Il volume è molto ricco e testimonia un’attenta conoscenza dell’opera di Sebald e insieme della letteratura critica che l’accompagna, la quale ha ormai raggiunto dimensioni assai vaste. Il volume è suddiviso in quattro capitoli, dedicati all’analisi delle quattro opere maggiori di Sebald (Schwindel.Gefühle, Die Ausgewanderten, Die Ringe des Saturn, Austerlitz), più uno di introduzione e uno con le conclusioni, tutti molto robusti e ricchi di spunti e riflessioni, in ambito non solo visuale. Molti sono i momenti interessanti e convincenti: penso alle vaste riflessioni sullo statuto ambiguo Diana Battisti della fotografia, sulla razionalità 463 cartesiana e il suo «monocularismo prospettico», a cui Sebald contrappone «uno sguardo multiplo e caleidoscopico» (p. 155); penso all’utilizzo del concetto di iconotesto per definire quell’insieme organico di testo e immagini che è la prosa sebaldiana, o al riportare la strategia narrativa a quella del bricoleur di Levi-Strauss, che utilizza in maniera nuova pezzi disparati di realtà che lo circondano, o ancora alla riflessione, abbondantemente mediata da spunti di Walter Benjamin, sulla conoscenza storica come «un’operazione allegorica che consiste nel raccogliere i frammenti e gli scarti della storia, scioglierli da ogni relazione funzionale e collocarli all’interno di una ‘costruzione sistemica’ che permetta di individuare tra loro inattese coincidenze» (p. 41), effettivamente molto produttiva nel caso di Sebald e della sua strategia estetica fondata appunto sull’iconotesto, «cioè su un dispositivo bimediale a sua volta allegorico perché costruito come un mosaico, come collezione di materiale eterogeneo, in cui i diversi frammenti, entrando in una nuova costellazione semantica, mostrano, anche se in maniera fuggevole e caduca, il senso della 464 storia e della memoria repressa del singolo e della collettività» (p. 218). Nel volume è evidente che Ribatti ha anche frequentato, in maniera direi assai produttiva, molti pensatori-cardine della contemporaneità, da Benjamin a Foucault a Derrida a Jay – eccedendo però a tratti nello zelo di voler riportare Sebald a tutti i costi alle loro coordinate, come se il centro di interesse delle sue opere fosse nell’erudizione che celano e non nelle strategie artistiche che coniugano sapientemente questa stessa erudizione con uno sguardo umanissimo e melanconico. Chi scrive questa recensione, semi-profano di certi argomenti, si è trovato poi a tratti in imbarazzo, senza saper giudicare se di fronte aveva dei ragionamenti molto sottili – che a lui sfuggivano –, oppure dei veri e propri abbagli (propendo per i secondi; e li ascrivo a una sorta di eccesso di zelo, del tipo di cui parlavo prima). Penso per esempio all’idea, di per sé interessante, che Sebald «drammatizz[i] nella sua prosa, proprio attraverso l’interdiscorsività fra visuale e verbale, il recupero e la rielaborazione dei ricordi traumatici rimossi» (p. 47), ‘mettendo in scena’ un processo psichico; mi sembra tuttavia che Ribatti si lasci trascinare e finisca per perdere di vista che quella fra memoria e fotografia è un’analogia, creando così una sfocatura fra il piano psichico, quello reale e quello testuale che nuoce al ragionamento, pur così ricco e stimolante: «L’immagine fotografica, piuttosto che presentarsi come memoria vera e propria, assume i caratteri del sintomo di un’esperienza traumatica rimossa che ritorna in modo vivido quanto compulsivo e necessita di essere abreagita. […] Le fotografie ben lungi dallo svolgere una funzione ingenuamente documentaria, sono il sintomo delle esperienze traumatiche vissute dai protagonisti, incarnano il “ritorno del rimosso”, cioè quelle esperienze traumatiche alle quali la memoria linguistica non ha accesso, ma che continuano a ripresentarsi in modo vivido e inquietante attraverso la memoria eidetica. Le fotografie consentono il ritorno del rimosso, ma allo stesso tempo devono proteggere il soggetto dall’aspetto traumatico degli eventi ivi registrati. Esse sono un esempio di quelle che Freud definisce Deckerinnerungen, cioè ricordi di copertura. In quanto tali, le fotografie sono, alla stregua del sogno, del lapsus e del Witz, delle formazioni di compromesso che consentono al rimosso di emergere, ma allo stesso tempo proteggono il soggetto dall’evento traumatico agendo come “scudo protettivo” nei confronti degli stimoli che l’atto fotografico registra meccanicamente, ma che sono inaccessibili alla memoria linguistica» (p. 83s.; cfr. anche pp. 70 e 209ss.). Le mie basilari conoscenze di psicanalisi mi suggerirebbero che Ribatti confonda qui i piani, e metta al centro degli oggetti (in senso fisico: delle cose, le fotografie), dove invece andrebbe messo un atto psichico, ossia l’interpretazione che ne dà il soggetto, l’immagine interiore che nasce in lui osservando le fotografie stesse, che in nessun caso possono essere considerate un «sintomo». Intendo dire che l’oggetto-fotografia può essere la causa di un evento traumatico, o meglio ancora richiamare alla memoria del soggetto un evento traumatico; e allo stesso tempo il soggetto può relazionarsi con immagini esclusivamente interiori e immateriali, frutto magari dell’incorporazione di un’immagine/fotografia concreta, come accade a Stendhal, che si accorge di aver sempre conservato un ricordo 465 della città di Ivrea mediato da un’incisione, e non un ricordo ‘reale’. Qui potrebbe stare la Dekkerinnerung, a coprire la traccia di qualche trauma, ma non nell’oggetto-fotografia, che evidentemente è solo funzionale al processo di copertura. Riallacciandosi alle riflessioni di Francesco Orlando (che Ribatti cita), potremmo piuttosto dire che sia la letteratura – e dunque anche l’iconotesto sebaldiano – a costituire una formazione di compromesso, ma non le singole immagini fotografiche, soprattutto non nella loro oggettuale concretezza, come si dedurrebbe da affermazioni come quella riportata (se mi fossi impelagato in un’interpretazione di questo genere, avrei piuttosto messo l’accento sull’analogia che corre fra il pensiero ‘quotidiano’, impastato di parole e di immagini – contrapposto per esempio a quello ‘razionale’ della storiografia –, e l’iconotesto, quasi che Sebald volesse opporre alla letteratura della tradizione occidentale, alla narrazione sul filo della razionalità cartesiana, un tipo di scrittura più aderente al funzionamento della mente umana per come lo conosciamo come individui – e non per come quella razionalità ‘vorrebbe che fosse’). 466 Allo stesso modo mi ha lasciato perplesso il giudizio che Sebald darebbe circa il «positivismo» della storiografia, ad esempio nell’episodio di Austerlitz che tenta di leggere il minuzioso saggio storico che Hans G. Adler ha dedicato nel 2001 al lager (p. 185ss.), dal titolo Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwanggemeinschaft. Lo Historismus dei contemporanei di Walter Benjamin (cfr. p. 191), la fiducia di giungere a una verità storica assoluta, in una storia «intesa in senso teleologico, come nesso logico-razionale di causa e conseguenza, come uno sviluppo causale, coerente e consequenziale» (p. 186) mi pare lontano dall’atteggiamento degli storici attuali, soprattutto in un caso come quello di Adler, in prima persona sopravvissuto a Buchenwald e Auschwitz – il che lascerebbe supporre che il tentativo di descrivere il più minuziosamente possibile la realtà del campo di concentramento sia, questo sì, una formazione di compromesso che permetta di esprimere l’inesprimibile, restando fedeli alla «Tatsächlichkeit», e non un mero asservimento alla razionalità moderna. Il nodo centrale mi pare invece lo spavento di Au- sterlitz di fronte a questa «fattualità», di fronte all’evidenza che tutto ciò che descrive Adler da un lato sia realmente accaduto, e dall’altro sia stato un frutto della razionalità strumentale, che governa gran parte della nostra vita e sulla quale ‘grava’ anche un pregiudizio positivo. Non credo che Sebald voglia negare l’importanza ‘scientifica’ di una ricostruzione ordinata dei fatti che, sebbene sempre sommaria, resta comunque necessaria al nostro modo di intendere la storia; ma che piuttosto voglia mettere in guardia dall’eccessiva fiducia in questa ricostruzione, e dall’idea che essa sia sufficiente per ‘spiegare’ un fenomeno come quello dei lager, al di là della massa dei dettagli: lo sgomento di Austerlitz, di Sebald e del lettore nasce dalla consapevolezza che non è possibile assegnare alcun senso all’orrore e alla violenza di cui sono intrise tanto la storia quanto la natura. L’ultima fonte di irritazione è la vasta presenza di refusi del testo, peccato ancora più veniale di quelli appena citati, ma tuttavia un po’ fastidioso in un volume nell’insieme così interessante. Camilla Miglio, La terra del morso. L’Italia ctonia di Ingeborg Bachmann, Macerata, Quodlibet, 2012, pp. 174, € 22. Dal soggiorno in Italia, paese d’elezione scoperto in una sorta di preliminare ricognizione già nel 1952 con la sorella Isolde, Ingeborg Bachmann, che vive a Roma dal 1954 al ’57 e pressoché definitivamente dalla fine del 1965 alla morte, trae ispirazione e sollecitazioni per la sua opera, ma anche indicazioni e chiarificazioni poetologiche. In un’intervista del 1963, alla domanda di Kuno Raeber sui motivi della sua attrazione per l’Italia, Bachmann rispondeva: «Proviamo allora con una delle tante spiegazioni dubbie. In Italia, potrei dire, sono diventata più felice; qui ho imparato a far uso dei miei occhi, ho imparato a guardare. […] Ma dopo che si conosce un paese da tanti anni, questo non basta più a trattenere una persona; sentire e pensare in consonanza con ciò che succede e si muove qui, nella politica, nella letteratura, diventa sempre più importante del sentirsi bene». Nel suo recente studio Camilla Miglio ha condotto Massimo Bonifazio un’esplorazione per molti versi 467 innovativa e una convincente lettura critica di quei testi lirici emblematici della ricezione di Bachmann dell’esperienza italiana, chiarendo e interpretando il “mistero” della sua attrazione per il sud. In Italia la scrittrice in realtà non impara solo «a fare uso dei suoi occhi», ma apprende, come osserva Miglio, «un modo-altro del “vedere”», unito a un percepire e sentire nuovi, animati e mossi da una dimensione sonora e acustica resa possibile anche dal sodalizio con il compositore Hans Werner Henze. Già il titolo del libro scelto da Miglio introduce il lettore a un percorso alternativo alla tradizione canonica dell’immersione nel paesaggio italiano inscritto nella solare e armonica cornice di consonanze classiche. Bachmann sente e vive il sud, fra Napoli, Ischia, la Puglia e Roma, come terra primigenia e primordiale, inospitale e ostile, che reca i segni di un’Italia ctonia in cui si rifrangono le «zone infere del sé». Miglio sottolinea che comunque «dell’Italia non si troverà una referenzialità storico-topografica. […] Il sud si configura, come relazione intertestuale tra scrittura, luoghi, culture materiali, stratificazioni mitiche, an468 tropologiche, e immagini sonore». Qui si coglie una condizione esistenziale e artistica di Bachmann che nella ricerca di un vivere altrove traspone la dimensione topografica, il suo nomadismo di viandante curiosa in una geopoetica, in quell’ «atlante che solo nella letteratura acquista leggibilità», come lei stessa scrive nella quarta lezione di Francoforte. Ciò avviene con l’esperienza berlinese fra il 1963 e il ’65 in cui la produzione letteraria scaturisce dal vivere le conseguenze tragiche della storia e la propria devastata condizione psichica, o con il viaggio a Praga dove la rinascita si configura nell’utopia della lirica Böhmen liegt am Meer, o in seguito nelle escursioni in Egitto e in Sudan. Il concetto di geopoetica, elaborato da Miglio, permette di entrare nei testi lirici per comprendere nell’intertestualità e nei sottotesti le ragioni storiche della «via di fuga verso sud alla ricerca dell’umano dopo il disastro, dopo la guerra e la devastazione» e il percorso nei fondali del proprio io che si combina con una discesa agli inferi, nelle profondità e oscurità ancestrali in cui dimora la «forza ctonia, antica, parente del dolore, della vita pro- fonda dell’umano, e della poesia stessa» (p. 17). La verticalità, la dialettica di immersione-sprofondamento e riemersione, come in Böhmen liegt am Meer, è senza dubbio una componente paradigmatica della scrittura di Bachmann che nelle ‘poesie italiane’ si dispiega nell’intreccio di «materialità antropologica, profondità ancestrale» ed evocazione cifrata. Come premessa, per meglio guidare il lettore nell’itinerario analitico-critico di quattro corpi testuali dati da La terra prima (1956), Canti di un’isola (1954), Apulia (1955), contenuti nella raccolta Invocazione all’Orsa Maggiore, e da alcune poesie del Nachlass, Miglio indica nella ritmicità, nell’«incontro tra parola e musica, tra danza e ritmo» (p. 13) la chiave di comprensione del messaggio ctonio. Con la scansione nei quattro movimenti dello spartito: lento, poi rapido in La terra prima, moderato, poi rapido nei Canti di un’isola, allegro non troppo in Apulia, poi rapido in Alla più umile, alla più umana, alla più sofferente, si rappresenta la viscerale osmosi di telluricità e ritualità popolare nelle cui voci, danze e tarantolate si producono «scosse mitiche e culturali capaci di risvegliare l’umano» (p. 15). Alla scossa violenta, necessaria per entrare nell’«alterità ctonia», Miglio unisce il «morso», quello della vipera in La terra prima su cui occorre premere la bocca come assunzione di dolore, di colpa e di rimorso. L’elemento vitalistico- dionisiaco-musicale, la dimensione arcaica preclassica significano un richiamo alla vita che nella ricezione del sud italiano è raffigurato iconicamente e simbolicamente nei gorghi e nei morsi del dolore, indispensabili per la ‘risalita’ e, attraverso l’esplorazione del male e l’espiazione della colpa, per l’approdo a un nuovo umanesimo. A ognuno dei quattro movimenti Miglio dedica un capitolo, partendo dall’analisi di Das erstgeborene Land di cui è proposta la traduzione La terra prima, frutto di un’articolata elaborazione critica che sottintende i significati di «primigenio», «primogenito» e l’accezione latina di “prima” nello spazio e nel tempo. La probabile influenza degli studi antropologici di Ernesto De Martino e il sodalizio artistico con Henze favoriscono, tramite l’adozione nel testo di registri ritmici e ripetitivi, «un programma di rifondazione poetica attraverso una ritualità geopoeticamente situata». 469 È soprattutto l’analisi, nella terza parte, dei Canti di un’isola a rafforzare l’incisiva e persuasiva interpretazione che il ciclo dei Lieder va letto come «palinsesto culturale e partitura musicale», mosso da quelle dissonanze dodecafoniche che imprimono alla poesia una direzione volta alle profondità del sottosuolo. Nel movimento diretto a una «invisibile verticalità» tempo e spazio, propri della partitura, permettono la rappresentazione di una «memoria culturale» che evoca e celebra la combinazione di arcaicità e presente. Ciò diviene possibile riscoprendo nei suoi ritmi magmatici e nella sua misteriosità la cultura popolare. Miglio coglie qui molto acutamente la reciprocità e la conclusiva osmosi di «atto estetico, etico e politico» stabilendo interessanti collegamenti con i programmi morali e artistici di Morante, Pasolini, Penna grazie al forte contributo intellettuale e musicale di Henze. Il filo conduttore del libro, quello di una «geopoetica musicale», per cui «nella scrittura bachmanniana la musica appare sempre in figura. Soprattutto in figura di canto. E il canto accende la memoria» (87), introduce nel commento di In Apulien ulteriori 470 elementi ctonii che dal paesaggio passano vicendevolmente al corpo e nella tessitura di caratteristiche naturali e simboliche aprono in modalità condizionali orizzonti di utopia. Allargando ancora il contesto polifonico Miglio mette a fuoco l’attrazione improvvisa e irresistibile di Bachmann per Maria Callas, per l’opera lirica, e più in generale per le protagoniste dell’arte canora e scenica, per le arti della voce, rappresentate da Gaspara Stampa e da Eleonora Duse. «La voce femminile – scrive Miglio – , modulata ad arte, entra allo stesso modo nel discorso poetico di Bachmann come rivolta paradossale contro il dominio della violenza e del sopruso nelle relazioni d’amore. In questo senso l’amore, per Bachmann, non smette di essere un politicum» (115). Nel novero delle sequenze topografiche e poetiche qui passate in rassegna il viaggio ctonio di Bachmann rivela versanti finora inesplorati e getta luce nuova, più profonda e problematica sul soggiorno italiano della scrittrice di cui restano nella sua poesia una polifonia vitale e naturale come testimonianza di possibile rinascita e di speranza. Fabrizio Cambi Lebensfluten, Tatensturm, mostra del Goethe Museum di Weimar, catalogo a cura di W. Holler, G. Püschel, B. Werche, Klassik Stiftung Weimar 2012. “Missione impossibile?” si chiede il presidente della Klassik Stiftung Hermann Seeman nella prefazione al catalogo della nuova mostra del Goethe Museum di Weimar, Lebensfluten, Tatensturm, destinata ad accogliere i visitatori per i prossimi anni. È impossibile narrare, rappresentare Goethe in un percorso museale che tenti di dire tutto a tutti senza allo stesso tempo limitarsi all’ultrascontato mito del genio universale? Perché il pubblico che frequenta il museo di Goethe è quanto mai eterogeneo: da signori avanti negli anni e sempre più infastiditi verso l’uso della strumentazione tecnica, a scolaresche più o meno disattente e irrituali, a esperti goethiani o appassionati lettori che, anche se non studiosi della materia, sono informatissimi su vita e opere del grande poeta nazionale. Come allora accontentare tutti? E come non tradire la funzione di un centro di ricerca quale è a Weimar la fondazione dedicata allo studio della Klassik tedesca? I cu- ratori hanno sicuramente impiegato molto tempo ed energie per trovare la ‘formula’ adatta. Lo hanno fatto infine scegliendo la via di un panorama quanto mai ampio – 507 oggetti esposti su una superficie di 800 mq – che, a partire dal titolo tratto dal Faust rievocante i flussi della vita e la turbolenza delle azioni, intende tracciare un percorso tematico fissando alcuni nuclei primari di riflessione. La scelta è stata di concentrare mostra e catalogo su alcuni temi, sette per la precisione, rapportati all’opera e alla cultura dell’epoca di Goethe: Genie, Gewalt, Welt, Liebe, Kunst, Natur, Erinnerung. Non è la linearità della cronologia, di cui pure nella prima sala vengono sinotticamente fornite le tappe essenziali (dalla famiglia Goethe in abiti pastorali dipinta ai tempi di Francoforte dal pittore di Darmstadt Seekatz ad alcune reliquie goethiane che ricordano i viaggi e le ricerche scientifiche), ma la ricorrenza tematica a guidare lo spettatore in una messa in scena che congiunge la sobrietà di vetrine entro pannelli di colore scuro all’illuminazione mirata degli oggetti che acquistano così la loro evidenza estetica e documentaria. Nel percorso che si 471 sviluppa fra due piani del museo ogni tema costruisce un campo di esplorazione che si intreccia con la cronologia, ma non si esaurisce in essa. Fra un tema e un altro il passaggio è discreto, fluido, identificato da una scritta guida e dal colore delle pareti esterne che segna le singole problematiche attinenti il genio, l’amore o l’arte. Se non vi è coincidenza precisa fra la scelta dei colori che limita i confini del campo e la materia trattata (non sarebbe stato possibile probabilmente seguire un criterio del genere con assoluta coerenza), si tratta di tinte familiari al Goethe della Teoria dei colori e quindi indicative anch’esse di una modalità espositiva che circonda immediatamente il visitatore nella luce soffusa e nel silenzio dello spazio dedicato a rappresentare il nesso esistente fra la vita e l’opera del grande scrittore. La soglia della porta che si apre sulla mostra segna per il visitatore l’accesso a un luogo dell’altrove: marcato dall’oscurità delle sale dovuta a ragioni di conservazione (sono molti gli originali che la mostra elargisce), questo passaggio ha anche un chiaro risvolto emozionale. La luce più fioca rievoca la lonta472 nanza temporale e rappresenta nello stesso tempo un invito a lasciarsi andare all’esperienza duplice di osservazione e di lettura che la mostra dispiega dinanzi agli occhi dello spettatore. Inizia così il percorso che, pure nella indubitabile universalità dei temi (si parla di amore, di arte e di mondo), modulati nella prospettiva goethiana e rapportati nei pannelli introduttivi (e nelle sezioni dei cataloghi) alle risonanze attuali, acquisiscono di volta in volta non solo un’identità specifica ma, si potrebbe dire, una propria morfologia. Perché chiunque conosca l’opera di Goethe, sa che gli stessi temi vengono nel corso del tempo ripresi e trasformati. Perciò, quanto più ci si addentra nel cammino tracciato dalla mostra, si leggono le indicazioni, si approfondisce la visita con la lettura del catalogo, quelle parole d’ordine perdono la loro univocità, funzionale a una ricezione semplificata, per divenire via via più sfaccettate, problematiche e stimolanti. È un modo per appellarsi alla diversità dei visitatori e ai vari, possibili livelli di fruizione: ci si può fermare all’elementare evidenza dei temi o a mano a mano inoltrarsi nella sco- perta, approfondire, osservare e riflettere, passare di volata nelle sale o trascorrerci un intero pomeriggio e tornare di nuovo perché tante sono le occasioni di conoscenza che la mostra raccoglie ed espone. Torniamo alla problematicità interna alle tematiche. Lo studioso goethiano ne è cosciente, ma forse anche per chi è già attrezzato può essere utile scoprire nuovi nessi scaturiti da una visione di insieme che uno studio sempre più specialistico fa perdere spesso di vista. Solo due esempi. Nella sezione Kunst, accanto alle reminiscenze del classico o allo schema realizzato per la stesura del saggio sul Laocoonte, appare la copia di Giuseppe Bossi dall’Ultima cena di Leonardo e, nella stessa vetrina, un modello del Duomo di Colonia: tutti aspetti diversi, ma coesistenti, seppure a distanza di tempo l’uno dall’altro. E ancora: in una vetrina poco distante un rotolo di carta espone una tabella costruita dal collaboratore di Goethe e storico dell’arte Heinrich Meyer per il progetto di una storia dell’arte, un modello epistemologico derivato dagli studi della natura e applicato alle arti con cui si andava profilando l’idea assai moderna di una storia della cultura. Così anche il concetto di genio, che chiunque attribuisce alla fase stürmeriana, la mostra lo rapporta invece all’idea più complessa di originalità che va modulandosi in una prassi educativa, volta a fare dialogare il progetto di una formazione individuale con la collettività di voci e modelli giunti dalla tradizione e dalle diverse sfere del sapere. Insomma, temi all’apparenza scontati perdono la loro ovvietà perché la mostra, che volutamente illustra la vastità di piani che intorno a Goethe si muovono, sembra contenere in controluce le linee più attuali della ricerca che proprio a Weimar, in lavori e mostre di poco precedenti il nuovo allestimento del museo, hanno trovato altre occasioni di riflessione. In primo luogo la raffinatissima mostra (con ampio catalogo annesso) sulla Weimarer Klassik Kultur des Sinnlichen in cui, non a caso, fra le altre stimolanti ipotesi di lettura (anche qui venivano esposti schemi e tabelle) si profilava un discorso sulla materialità che ha trovato una propria presenza anche nella mostra del museo goethiano, dove in un piccolo cabinet sono esposti gli strumenti 473 della scrittura, ai quali è poi dedicato un saggio all’interno del catalogo. Lo studio delle fonti, la compilazione di schemi sempre più dettagliati, come spiega nel suo saggio Sabine Schimma, segnano per Goethe la fase preliminare del lavoro che anticipa la stesura vera e propria dei testi, realizzata poi generalmente sotto dettatura (specialmente nell’ultima fase, Goethe dettava anche le lettere private nonché i suoi diari). I fogli di formato in-folio erano ripiegati a metà: nella parte destra compariva il testo, in quella sinistra correzioni e aggiunte. Seguivano le altre fasi della revisione con nuovi inserimenti di parti e schemi appuntati a matita in un continuo sviluppo dei testi fra letture (in cui era coinvolta la cerchia di amici e collaboratori) e nuovi momenti di riscrittura che accompagnavano la riflessione sui testi. E per realizzare tutto ciò Goethe preferiva la matita, fabbricata industrialmente già intorno al 1800, poiché lo infastidivano il rumore stridente e gli spruzzi di inchiostro del pennino. Esporre i materiali significa dunque entrare nel laboratorio della scrittura, segnalare attraverso gli oggetti il farsi e il divenire dei testi. Quei 474 testi che accompagnano poi il visitatore durante tutta l’esposizione, leggibili su pareti leggermente rialzate rispetto ai pannelli esplicativi, che introducono di volta in volta ai diversi temi facendo da trait d’union fra le vetrine e gli oggetti. L’entrata in un museo trasforma, come ha insegnato tempo addietro Krzysztof Pomian, lo statuto di qualsiasi oggetto che, sottratto al valore d’uso, espone la sua sostanza visiva reclamando a sé il senso invisibile della conoscenza. Pure su questo la mostra del museo goethiano implicitamente riflette. Lo fa, non in ultimo, anche in questo caso, grazie a un lavoro di ricerca effettuato in precedenza di cui è espressione non più una mostra, ma un volume, un numero dell’annuario della Klassik Stiftung del 2012 dedicato al tema Literaturausstellen. Oggetto di studio è qui la memoria del museo stesso (la sua creazione a partire dal 1885 fino agli anni della DDR e poi della riunificazione) nonché della casa di Goethe con la quale l’esposizione odierna ha inteso stabilire una continuità aprendo il foyer alla duplice possibilità di visita di casa e museo. Una pubblicazione che dichiara la coscienza di quanto la mostra attuale corrisponda a un percorso storico e la scelta odierna di compendiare ricerca e divulgazione faccia parte di questo cammino che implica necessariamente il momento dell’autoriflessione. Non a caso, in analogia con questo piano che si potrebbe definire come ‘metatestuale’, la mostra si chiude con la sezione Erinnerung che tematizza il problema della memoria – e quindi della storicità – di cui lo stesso Goethe ancora in vita si fa promotore: la serie di ritratti in gesso in una vetrina dell’ultima sala rammenta insieme la diversità che ha segnato la ricezione iconografica del grande di Weimar e il modo in cui Goethe, storicizzando se stesso, diede avvio alla moltiplicazione della sua immagine fino alle forme più scontate del souvenir. Il volume su mostre e musei letterari rifletteva anche sul problema espositivo di qualsiasi museo dedicato alla letteratura. Insieme al percorso tematico scelto, ai modi dell’allestimento, alle vetrine e ai pannelli, anche la diversità degli oggetti che la mostra del museo goethiano propone è una risposta a questi interrogativi. Come si sa, Goethe stesso favorisce la varietà degli aspetti e, non in ultimo, la presenza materiale degli oggetti. I pezzi delle sue collezioni hanno nella mostra un ruolo essenziale, esposti insieme agli armadi fatti appositamente costruire per custodirli. Le pietre e le gemme, i fossili, le stampe e i disegni, le monete o le sculture in bronzo e in gesso, di piccolo e grande formato, costituiscono un indispensabile punto di riferimento perché è qui che l’opera di Goethe appare nella sua forma non scritta come un lascito materiale, di cui è espressione l’identità stessa della casa del Frauenplan, presentata fra l’altro in una animazione in 3D che ne ricostruisce le complesse fasi di costruzione. Se poi ci si sposta dai luoghi al testo del catalogo si trovano riproposti temi e oggetti: ogni sezione ha un suo breve saggio introduttivo a cui seguono singoli punti di vista che fanno apparire la materia di insieme nelle sue diverse sfaccettature. Così il tema dell’arte viene declinato in quello della visione e della storia, del disegno e della politica artistica, delle collezioni e dei progetti architettonici. L’insieme dà vita a una sorta di manuale sull’opera di Goethe a cui hanno partecipato non solo esperti della materia, ma anche scrittori e in475 tellettuali contemporanei dalle provenienze più disparate, dalla musica al teatro, dalla traduzione alla scienza all’etnologia, a cui si cede la parola per dire, nelle forme più libere del loro approccio, il senso dell’opera di Goethe, il modo in cui quest’opera funziona come riferimento imprescindibile della cultura tedesca. Completa invece l’allestimento espositivo, posta al centro come trait d’union fra i due piani, un’installazione del testo del Faust con la possibilità di scegliere singole parole e ritrovarle proiettate a colori sul muro, inserite nei versi del grande poema goethiano: un “gioco serio”, si potrebbe dire, con cui la parola poetica acquista il proprio spazio dando vita a un tocco di leggerezza nel compassato itinerario espositivo. Anche questa passeggera comparsa dei versi del Faust rappresenta un ulteriore invito a considerare l’ultimo allestimento del museo goethiano con tutta l’attenzione che ogni visita a una mostra esige, se si desidera che le ore di una giornata trascorsa a Weimar in quelle sale rimangano nel ricordo confluendo nell’interiorità di un’esperienza. Ines Geipel, Zensiert, verschwiegen, vergessen. Autorinnen in Ostdeutschland 1945-1989, Düsseldorf, Artemis&Winkler, 2009, pp. 288, € 24,90. Quarant’anni di divisione ideologica hanno creato un solco profondo tra le due parti della Germania. «Von einem Land und vom andern /weiss man zu wenig, zu viel», lamentava nel 1990 Karl Krolow. Con la caduta del muro i tedeschi hanno cominciato a raccontarsi, sia con una vasta produzione di autobiografie, soprattutto di autori orientali, sia con una serie di studi specifici, in particolare sulla Ddr. Aperti gli archivi dell’est, sono emersi diversi materiali utili a capire dall’interno quella società, la sua politica culturale, le sue dinamiche di promozione e censura. Il libro di Ines Geipel, in gioventù campionessa di salto, fondatrice dell’ Archiv unterdrückter Literatur der DDR, s’inscrive in questo genere di ricerca. L’autrice predilige la scrittura femminile – il volume presenta dodici Dichterinnen sottoposte a vario titolo ai meccanismi di controllo dell’apparato della Ddr. Il registro dominante è radicalGabriella Catalano mente negativo. Nulla trapela dal- 476 l’analisi della Geipel di quell’adesione alla giovane repubblica, caratteristica di molti intellettuali, quale si legge ad esempio nell’epistolario di Brigitte Reimann (‘Wär schön gewesen!’ Der Briefwechsel zwischen Brigitte Reimann und Siegfried Pitschmann, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 2013). Merito di questa ricerca è tuttavia di illuminare l’esistenza di figure salvo alcuni casi sostanzialmente minori ma capaci di restituire attraverso lettere, diari, colloqui e testi inediti, significativi dettagli di quella che potremmo chiamare una ‘sociologia del consenso e della repressione politica’, innestata nelle retrovie culturali di un paese a lungo vincolato ai dettami di Mosca. Intendiamoci. Non è questo uno studio sui testi che conduce alla scoperta di “poetesse” finora ignote al grande pubblico, e quindi a “un’altra storia della Ddr-Literatur”, come afferma il risvolto, quanto piuttosto restituisce la voce a giovani donne non allineate, dissidenti in una “terra di nessuno”, scomparse dalla scena letteraria tedesca. Sono storie di vita dolorose, narrate con grande empatia (e viceversa qualche gratuito rancore per autrici della Ddr note al grande pubblico). Si avverte qualche eccesso lessicale, ad esempio gli agenti di sicurezza vengono definiti ‘cekisti’, quando non risultano nella Ddr eliminazioni fisiche dei dissidenti. In complesso si tratta però di una lettura che mette a fuoco con dovizia di particolari i meccanismi dell’artigliata sorveglianza politica sugli esordi letterari della gioventù dell’est, tra la caduta di Hitler e il 1989. Opportunamente il libro si apre con il 1945 attraverso un Prologo dedicato a Ricarda Huch. Siamo nell’atmosfera drammatica del dopoguerra: un paese distrutto e sotto tutela degli alleati, fin da subito contrapposti nelle misure di ‘rieducazione’ del popolo tedesco. Huch, ardita figura di vegliarda eletta dai sovietici a rappresentare la Germania integra, lascia Jena e s’impegna in una faticosa tournée di conferenze, appelli e interviste. Raccoglie una ricca documentazione sulla resistenza tedesca, un progetto in tre volumi dedicati ai “martiri della libertà” che tuttavia non vedrà la luce: invitata a Berlino da Becher per il primo Congresso degli scrittori tedeschi (ottobre 1947), l’anziana autrice, sconcertata dalla drastica denazi477 ficazione sovietica e ostile alle diatribe ideologiche che dividono ormai i fronti, decide di passare nella Germania occidentale, dove muore nel novembre dello stesso anno. Con il primo ritratto si profila un’intellettuale proveniente dalla borghesia colta di Berlino. Susanne Harich Kerckhoff (n. 1918), precoce autrice di romanzi d’intrattenimento tra il ’40 e il ’44, spinta da un profondo senso di colpa collettiva, sceglie con slancio il settore sovietico diventando un’affermata redattrice letteraria della «Berliner Zeitung». Tre figli con Kerckhoff, poi la separazione. Susanne siede al vertice di varie strutture della nascente Ddr. Sono gli anni in cui a est l’amministrazione sovietica punta sull’emancipazione femminile con sostegni economici e istituzioni culturali quali il «Deutscher Frauenverlag». Perché? Si chiede Geipel – la risposta, che restituisce il tono di fondo dell’autrice, starebbe nella «tirannica regia del governo Ulbricht», in perenne ricerca di “Erbauer des Sozialismus” – e quindi lesto nell’inquadrare l’enorme potenziale di donne – 22.000 erano le Trümmerfrauen nella sola Berlino – determi478 nando così «l’inesauribile mito dell’emancipazione femminile nella Ddr» (p. 39). Tuttavia nel 1949, con la prima stretta sull’arte formalista, lo spazio per una discussione a tutto campo si riduce. Kerckhoff s’impiglia in una polemica con un comunista olandese reduce dal lager, accusandolo di sentimenti antipolacchi. Le costerà caro. È attaccata sia da Hermlin sia dal fratello Wolfgang Harich – il filosofo vicino a Lukács che cadrà a sua volta in disgrazia nel 1956. Susanne viene isolata. Si dedica alla poesia della natura. Un testo, l’ultimo, comparso sulla «Berliner Zeitung» nel marzo 1950, è riportato a p. 46. Quattro giorni dopo, appena trentaduenne, Susanne si toglie la vita nella sua casa di Berlino Est. Per Edeltraut Ecker scattano nello stesso anno le manette. Studentessa slesiana, fa parte di un gruppo clandestino di dissidenti in contatto con la «Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit», un’organizzazione anticomunista di Berlino Ovest, «mirata a destabilizzare la Ddr», precisa la stessa Geipel. Edeltraut viene condannata a 25 anni e internata in uno degli 11 lager istituiti dai sovietici per ex-nazisti e delinquenti comuni. Con questo capitolo si entra nel sinistro mondo della repressione tra il 1950 e il 1955, anno in cui Edeltraut muore in seguito a un incidente sul lavoro. Di mezzo ci sono i moti del ’53 con le carceri affollate di dissidenti – la divisa contrassegnata da una “X”. Molte donne scrivono poesie, nota Geipel. Di Edeltraut ne restano un centinaio, testi in rima, “litanie” pensate per un canto collettivo, «esemplari della misura, creatività e determinazione di una generazione ostacolata, di una prima scrittura al femminile nella Ddr» (p. 50). Il capitolo successivo propone un parallelo con note vicende letterarie della Rft: anche a est si forma un “Gruppo 47” per opera di Franz Hammer che nel giugno, dunque qualche mese prima di Hans-Werner Richter, convoca a Weimar una ventina di giovani autori per un confronto sulle nuove tendenze letterarie. Il gruppo avrà successo. Vi partecipa, oltre a Ricarda Huch, anche Hans-Jürgen Geerdts, futuro storico della Ddr-Literatur. Ma i documenti di Geipel dicono altro: s’intravede la stretta di un apparato che, dopo l’unificazione di Kpd e Spd sotto l’ala della Sed (1946), mira a vietare qualsiasi contatto con l’occidente. Uno dei fondatori del gruppo, GerhardRolf Wenzel, accusato di cospirare con la Spd di Berlino-Ovest, morirà in carcere nel 1950. Gustav Leuteritz si sottrae all’arresto collaborando con il KGB; di lui si perdono le tracce a Workuta, dove viene deportato nel 1952. Tra le donne c’è Ursula Adam. Dapprima legata a Hammer, ha un figlio con uno studente occidentale. Lui viene perquisito e dal suo zaino saltano fuori i manoscritti di lei, destinati – secondo il verbale della polizia – allo «Spiegel» e alla «Rias». Trattano, tra l’altro, di un argomento tabù, le miniere di uranio nella Ddr: «Una minaccia alla pace del popolo tedesco e del mondo» – si legge nella condanna a 5 anni per lo studente e a 8 mesi di carcere per Ursula. Che nel 1951 passa a BerlinoOvest, dove i suoi testi saranno accolti e trasmessi dalla «Rias» e dalla «SFB». Con Inge Müller, nata Meyer, le pagine si animano nel respiro della poesia, si vedano i pochi versi di Sommer 45 (p. 97). Geipel punta sul ritratto privato inserendo dati meno noti: l’esperienza della guerra come ausiliaria 479 della Luftwaffe, due matrimoni – prima con un postino poi con un esponente della nomenklatura –, infine una convivenza a tre con Heiner, che nel 1953 senza permesso di soggiorno vagava per Berlino Est in cerca di contatti letterari. L’intensa collaborazione che lega Inge a Müller è ben documentata dalla coraggiosa ricerca sulle condizioni di lavoro alla «Schwarze Pumpe» fino alle drammatiche vicende di censura e Korrektur della prima produzione teatrale firmata a quattro mani. Poi il declino psichico di Inge, l’eco del lutto sotto le macerie, l’iterata ricerca di morte. Ma anche il suo sarcasmo: «Geteilter Himmel: Mäusespeck!». Temperamento nomade e ribelle, quello di Eveline Kuffel (n. 1935). Figlia di operai comunisti, ha tutte le carte per una carriera esemplare. Sceglie invece altre strade. Piccoli furti, scorribande a Berlino Ovest, riformatorio. Quando la famiglia si trasferisce in occidente lei resta, convinta che per una donna sia più facile qualificarsi nella Ddr. Ha talento per la scultura, frequenta con successo l’Accademia, ed è premiata con un viaggio in Italia. Ma quello che la ispira è una realtà negativa: nella sua scrittura, a 480 tratti estrema, compaiono relitti umani, vagabondi ubriachi di una Berlino divisa e maledetta, scenari erotici e scurrili, grida nella notte. Vive a Prenzlauerberg, ha un bambino – verrà affidato al padre. Una bohème confusa e disperata, la sua, invisa al suo stesso ambiente. Negli anni Settanta Eveline abbandona il linguaggio e reagisce con l’autolesionismo, marcando la sua rivolta nel volto segnato da croci viola. Esponente di una gioventù perduta, si spegne nel 1979, carbonizzata nel suo letto. Colpisce in questa galleria di ritratti la varietà dei temperamenti. Jutta Petzold (n. 1933), figlia di un nazista e di una partigiana comunista, entra giovanissima nella cerchia di noti intellettuali, tra cui Arnold Zweig, allora presidente onorario degli scrittori di Berlino Est. Ha un tono da vestale ieratica e sacerdotale, Jutta, si definisce «veggente», ovvero «Prinzessin Ligo», esibendo una scrittura in cui risuona il primo Novecento, da Lasker-Schüler a George, con echi di Nietzsche e Heidegger. Un chiaro ‘antiprogramma’ rispetto al realismo di quegli anni, con le sue eroine operaie esemplari e socialiste. A questa prima fase epigonale subentra una sorta di mistico femminismo istintuale, ironico e sprezzante del mondo maschile, qui documentato con ampie citazioni. Poi la drammatica svolta. Dopo un fallito tentativo di fuga a ovest, Jutta si chiude in casa. Vive a letto, sommersa di libri, alla ricerca di una nuova forma. E ingaggia un corpo a corpo con un linguaggio che sembra spappolarsi per riaffiorare in grappoli densi di neologismi, un’esplosione inventiva che disintegra punteggiatura e sintassi. Al centro un io mimetico, “clown” nel vuoto del mondo, femmina di “giocosa rabbia erotica”, “Saffo” che brucia i suoi manoscritti. Ne resta un centinaio di pagine. Jutta vive oggi a Berlin-Buch in una casa per anziani, scandendo su e giù nella sua torre versi di Hölderlin. Con Hannelore Becker (n. 1951) si penetra nel ventre molle di un ambiente intellettuale che si presta alla delazione. Sono gli anni di Honecker, in una Ddr ormai riconosciuta a livello internazionale. Cambia la strategia del controllo, ora la Stasi recluta all’interno dello stesso ambiente intellettuale: oltre alla Becker, aderiscono tra gli altri Gabriele Eckart, Maja Michaela Wiens e Gabriele Barthel. E se negli anni Cinquanta il consenso di Christa Wolf o di Helga Novak era stato di breve durata, Hannelore, poetessa di un certo rilievo, si consegna toto corde al mestiere di spia. Nel 1975 tenta di recedere, abbozza un dramma su Cassandra, rielaborando in poesia il gioco perverso di un io reticolato tra menzogna e silenzio. Le poche citazioni rivelano uno stile contratto e fortemente innovativo, che sembra anticipare la metrica di Barbara Köhler. Nessuna eco, nemmeno a ovest, lamenta Geipel – sparando a zero sul vasto, “artificioso” successo internazionale della Ddr-Frauenliteratur in quegli anni. Attorno a Hannelore il gelo. Tra i pochi amici Karl Mickel, anche lui con il suo passato di informatore. Ed è dalle finestre del poeta che Hannelore si getta, uccidendosi nel 1976 a soli venticinque anni. Diverso il caso di Heidemarie Härtl (n. 1943).Vive un destino di coppia forte, quasi una simbiosi. Lei figlia di un Vopo, lui – Gert Neumann (n. 1942) – di madre comunista e scrittrice. Con loro si legge la resistenza interna, costante e determinata, di due autori in cerca del loro linguaggio generazionale. Allievi di 481 Maurer al Becher-Institut, si appellano al Chandos con testi aperti sul silenzio di un’attesa poetica, contro «la violenza della censura». Ambedue vengono espulsi. Gert lavora come fabbro, da questa esperienza nasce Elf Uhr, un acclamato romanzo pubblicato a ovest da Fischer nel 1981. Vivono a Lipsia sorvegliati – ma rifiutano l’espatrio, anche quando, dopo il caso Biermann, molti intellettuali si trasferiscono a ovest. Geipel ascrive a un cambio di strategia della Stasi la licenza per Heidemarie di pubblicare la sua prosa nel 1977. Il bastone e la carota? Certo è che nel 1986 la coppia è in tournée in occidente. Paradossalmente torna divisa e il finale è romanzesco. In chiesa, nel corso di una dimostrazione nella Lipsia del 1989, Heidemarie conosce Ibrahim Böhme. Ė amore a prima vista. Personaggio di risalto nella Wende, è presidente della Spd-Ost nel 1990. Ma è costretto a dimettersi: dagli archivi emerge la sua ventennale attività di informatore della Stasi. Sotto shock Heidemarie viene ricoverata in una clinica psichiatrica. Gli ultimi diari articolano una “filosofia della solitudine”. Da Böhme, che non rivedrà più, solo 482 telegrammi. Lo stile dei Vip – nota Geipel. Gabriele Stötzer (n. 1953) è la giovane scrittrice che in Was bleibt bussa alla porta di Christa Wolf. Una studentessa nella norma, inquadrata nella FdJ. Ma firma la petizione a favore di Biermann, non recede, viene reclusa. In carcere un intervento sbagliato la rende sterile. Nella sua prosa un Io ferito, muto, lo sguardo «impietrito» (p. 217). Dimessa, è operaia in un calzaturificio. Non si arrende, Gabriele, e a Erfurt in una casa abbandonata fonda una galleria d’arte. Letture, mostre, artigianato, cortometraggi, musica punk: una delle nicchie a margine dello stato che animano la cultura giovanile negli ultimi anni della Ddr. Non priva di infiltrati, quali Sascha Anderson, che nei suoi rapporti la bolla come “fascista”. Con il 1989 la nemesi: sarà Gabriele, alla testa di un gruppo di donne, a impedire la distruzione dei documenti della Stasi di Erfurt. Una storia a lieto fine – con un concerto di Biermann e la pubblicazione tra il 1989 e il 2005, grazie anche alla stessa Geipel, di prose e poesie di Gabriele. Anche gli ultimi casi sfiorano la Wende. Slesiana come Ecker, Sylvia Kabus (n. 1952) cresce a Görlitz. Immatricolata a Berlino ma insofferente della pedagogia marxista-leninista, rifiuta l’insegnamento. Nella prosa di Franz Fühmann trova un modello di stile autentico, contrapposto al tratto legnoso del linguaggio ufficiale. Sylvia lavora per una grammatica diretta che a fatica cerca di introdurre nella redazione di una rivista culturale di Lipsia, “traducendo” gli stereotipati dettami di una burocrazia «in allarme non appena si muove qualcosa di nuovo». Ha successo come sceneggiatrice cinematografica, respinta da Aufbau sarà invece la sua prosa centrata sulla vita quotidiana dei vecchi nella Ddr, un testo pubblicato da Geipel nel 2008. Attiva nella Lipsia della Wende, ne vive anche la delusione: «Corruzione, avidità, gente compromessa, una politica sbagliata, questa la nuova realtà successiva al 1989» (p. 238). Il ritratto finale è dedicato a Raja Lubinetzki, di padre camerunese. Nata nel 1962, viene data in adozione. Ancora a scuola, pubblica versi sul razzismo in America e Sudafrica. A Berlino lavora in una tipografia e si aggrega a una comune di donne. Capelli all’irochese, giubbotto di pelle e guinzagli al collo, frequenta l’ambiente punk, pubblicando come Stötzer sulle riviste clandestine – «Mikado», «Ariadnefabrik» – del Prenzlauerberg. Esponente di una gioventù in polemico congedo dallo stato, Raja scrive poesie che parlano di un doppio sradicamento, da se stessa e dalle origini familiari. Chiede l’espatrio – le verrà concesso nel 1987. Vive oggi a Kreuzberg. Il libro si chiude con un Epilogo autobiografico, datato 19861990. Un compagno di studi dell’autrice, appreso che il padre è stato un ufficiale della Stasi, si lancia dal 17.mo piano di un grattacielo di Berlino Est. Ultimo sigillo di un lutto che investe la storia e la memoria della Ddr. Anna Chiarloni Heinrich Detering, L’Anticristo e il Crocifisso. L’ultimo Nietzsche, trad. di Annamaria Lossi, Roma, Carocci, 2012, pp. 224, € 25,00. La figura di Heinrich Detering, come spesso gli oggetti dei suoi studi e delle sue analisi, travalica i confini di genere: germanista e scandinavista per 483 formazione (a lungo ha ricoperto il ruolo per entrambe le cattedre presso l’università di Kiel, prima di approdare a Göttingen nel 2005), ha assunto più volte de facto il ruolo del comparatista, e specialmente nella prospettiva dei contatti e delle interrelazioni tra il mondo germanico settentrionale e quello meridionale, con opere che hanno esplorato a fondo una costellazione soprattutto otto- e novecentesca di autori e di temi che vanno da Andersen a Strindberg, da Storm a Thomas Mann a Brecht, con escursioni apparentemente eccentriche – ma non troppo – come quella che lo ha portato a pubblicare nel 2007 un libro su Bob Dylan, autore in realtà caro alla generazione di germanisti di cui lui (così come scrive) fa parte. All’orbita degli interessi di Detering appartiene da sempre anche Nietzsche, come trait d’union inevitabile tra i disparati fenomeni del fin de siècle, e al quale il critico tedesco ha dedicato studi che muovono da angolazioni originali, in cui circolano le diverse linfe che compongono la sua figura di studioso, come “Das Ich wird zum Wortspiel”. Nietzsche, Ibsen, Strindberg und das Drama der Abstraktion (in Widerspüche. Zur 484 frühen Nietzsche-Rezeption, hrsg. von Andreas Schirmer und Rüdiger Schmidt, Weimar 2000), in cui il dramma antipsicologico strindberghiano («Geschehen statt Handlung», lo definisce sinteticamente Detering), la sua particolare Umwerthung, trova il suo fondamento teorico in una – sia pur riduttiva e parziale – lettura di Nietzsche, mentre di converso attraverso la stessa lente risulta la svalutazione di Ibsen da parte del filosofo tedesco. Questo Der Antichrist und der Gekreuzigte. Friedrich Nietzsches letzte Texte appartiene al 2010 e affronta l’ultimo capitolo della produzione nietzscheana, includendo in esso non soltanto la serrata sequenza di opere del 1888, ma anche l’ultima corrispondenza, i «biglietti della follia», considerati nella loro qualità di testi che contribuiscono insieme alla produzione ufficiale a creare un tessuto semantico nel quale il pensiero dell’ultimo Nietzsche si dispiega in maniera non affatto ambigua e anzi coerente. Fin dal titolo, del resto (almeno da quello originale), l’accento è posto sulla testualità dell’opera di Nietzsche, e Detering non smette di ribadirlo nelle sue premesse teoriche in cui, sulla scorta di Lyotard che individua lo schema narrativo predominante nella «variante biografica del mito eziologico ovvero la storia formativa nel senso del ‘romanzo formativo’, la narrazione di ‘come si diventa ciò che si è’» (p. 23), viene sottolineata la necessità di affrontare «gli ultimi testi nietzscheani in termini di testi» (p. 23). Il discorso si estende dalla sequenza di opere pubblicate da Nietzsche nel 1888 a quegli ultimi ed estremi materiali – i «biglietti della follia» (da cui anzi tale discorso nasce, come lascia intendere il primo capitolo introduttivo), al cui centro sono personaggi caratterizzati come “Dioniso”, l’“Anticristo” o “il Crocifisso” – che sono o diventano il fulcro di veri e propri miti narrativi. L’uscire da sé di Nietzsche in questo ultimo periodo e il travasarsi in figure archetipiche dicono di un io divenuto insostenibile come istanza psicologica o filosofica, che può riaffermarsi soltanto come istanza narrativa. Ma che significa “narrare” in questo contesto? La definizione di Detering s’inquadra nell’ortodossia: «Narrativi sono solitamente dei testi che soddisfano due condizioni: per prima cosa rappresentano eventi in forma linguistica, causati o vissuti da personaggi. […] Tali eventi sono inoltre co- municati per mezzo del linguaggio da un’istanza narrante, che può essere parte del mondo narrato dai personaggi, ma può anche essere separata da quest’ultimo, intrecciata in modo attivo o affettivo all’accadimento narrato o da questo separata» (p. 22). Se è abbastanza semplice individuare l’istanza narrante all’interno della produzione nietzscheana dell’ultimo periodo, meno ovvio appare il recupero della “catena di eventi” che questa istanza viene a tradurre. Lo sforzo di Detering va in questa direzione, la sua indagine si svolge a partire dai personaggi cui Nietzsche presta la voce e con i quali confonde la propria identità, nella convinzione che dietro questa «retorica dei ruoli» (p. 24) si nasconda il diagramma di una storia. Una storia il cui protagonista coincide, nelle sue varie e proteiformi incarnazioni, con colui che dà il titolo all’Anticristo e che è Nietzsche stesso, nonché, come si vedrà, il suo apparente oppositore e avversario, Cristo appunto. Del resto, dopo aver proclamato la morte di Dio, dopo aver lavorato per anni alla sua particolare versione di un anticristianesimo e «aver portato a termine i lavori dell’antibibbia sull’antiredentore» (p. 30) con lo Zarathustra, 485 Nietzsche si sente legittimato ad assumere la parte del messia/redentore/transvalutatore di tutti i valori (a partire dall’ottobre-novembre 1888 l’Anticristo, com’è noto, surroga e sostituisce il progetto della a lungo meditata Volontà di potenza): il che giustifica l’autocaratterizzazione di Nietzsche come «Il Crocifisso». In termini di narrazione, è una storia che raccontano anche le opere del 1888 dedicate a Richard Wagner, Il caso Wagner e Nietzsche contra Wagner (anche in esse Nietzsche è anticristo, anticristo di Wagner, in quanto apostata oppositore del suo progetto artistico-religioso e promotore di uno nuovo, di «una nuova forma di ‘religione artistica’ dopo la ‘morte di Dio’, dopo la fine di Wagner» [p. 123]), ma che si focalizza in termini sempre più stringenti intorno alla figura di Gesù di Nazareth, con il quale, sulla scorta di frammenti precedenti (come quello, citato da Detering, in KSA 9, p. 324, in cui al cristianesimo è attribuito il valore di decadenza in senso letterale, come perdita di una condizione di pienezza: e quindi come positivo ex negativo), Nietzsche inizia a confrontarsi fornendone un ritratto che «frase dopo frase, a volte parola dopo parola, contrasta con 486 quasi tutto ciò che Nietzsche ha pensato e scritto prima su di lui» (p. 37). L’analisi di Detering segue questa evoluzione, che procede negli ultimi mesi di vita cosciente di Nietzsche secondo conati sempre più rapidi e convulsi, attraverso un’analisi che, senza trascurare l’insieme e i raffronti con il corpus complessivo della produzione nietzscheana, si concentra nel trittico formato da L’anticristo, i Ditirambi di Dioniso e Ecce Homo, in cui vi è una ridefinizione sostanziale del pantheon del pensatore tedesco, un ripensamento e una riscrittura radicali delle figure di riferimento che ne tengono il centro, a partire da quella di Cristo. È innanzitutto nell’Anticristo che Detering ridefinisce la portata e il senso del racconto della vicenda di Cristo in esso inscenata, andando oltre le «intere generazioni di ammiratori di Nietzsche» che hanno letto «la figura di Gesù tratteggiata dall’Anticristo» (p. 82) in chiave di continuità con la condanna secca, operata a partire dalla Genealogia della morale, di Cristo come culmine del cristianesimo, campione del ressentiment e consapevole fondatore della religione della compassione e della decadenza. Centrale diviene ora per Nietzsche non più tanto la degenerazione della religione fondata da Cristo (sempre più involontariamente, sembra) – da lui ampiamente osservata e accertata, fino alla definitiva liquidazione dell’argomento – quanto piuttosto l’esplorazione della possibilità nel presente del tipoCristo in quanto tipo-redentore («il tipo psicologico del redentore […] contenuto nei Vangeli a dispetto dei Vangeli», come scrive Nietzsche ne L’anticristo), categoria nella quale s’inscrive il suo stesso Anticristo. In effetti, l’analisi di Detering dà conto di come nell’Anticristo il racconto della svalutazione e delegittimazione di Cristo si trasformi a poco a poco, attraverso la registrazione delle contraddizioni nel suo “tipo psicologico”, in riscrittura positiva del suo personaggio, fino a superare «perfino Zarathustra, con una certa sorpresa dell’Anticristo, che lo vede quasi acquisire una vita propria dalle sue stesse mani» (p. 55). La definizione di Gesù come «idiota» sulle basi di «una patologia completamente fisiologica» (p. 45) – come tale Cristo appare ancora in alcuni schizzi preparatori all’ Anticristo dell’inizio 1888, in contrasto con la defini- zione di “genio” canonizzata da Renan, termine fisso di confronto per Nietzsche – lascia progressivamente spazio a un’accezione che riconduce «alla trasvalutazione morale dell’‘idiota’ in Dostoevskij e al Parsifal wagneriano, visto alla luce di tale trasvalutazione, ossia il ‘puro folle’ che nella sua stoltezza si trasforma in redentore» (p. 45). È attraverso il processo della scrittura (a esso è assimilato il suo prodotto, ovvero la “novella”, cfr. p. 54) – un processo che abbandona progressivamente i termini della riflessione e acquisisce «una dinamica […] sempre più chiaramente narrativa» (p. 67) – che «Gesù si trasforma in una figura della vita nascente» (p. 52) e, in quanto tale, in quanto attore del superamento della sua stessa decadenza, diviene un artista in senso nietzscheano, colui che attua e realizza in sé «la trasfigurazione della vita, l’eterno sì», come scrive Nietzsche al paragrafo 18 dell’Anticristo. Con ciò, «paragrafo dopo paragrafo, anzi frase dopo frase, Gesù assume i chiari tratti dell’Anticristo» (p. 54), si sovrappone a esso, ne costituisce un’incarnazione archetipa, che rimanda a una deità certo diversa da quella cristiana, e 487 che Detering riconnette a Dioniso: un Dioniso che muove da quello delle prime riflessioni di Nietzsche sul tragico, ma che si evolve fino a integrare «a poco a poco nella sua figura i tratti di colui che nello scritto sulla tragedia gli era stato contrapposto in termini di trasfigurazione apollinea» (p. 57) e a divenire un termine di appagamento e di beatitudine che contiene anche il suo opposto, l’elemento orgiastico, violento ed estatico. Questo Dioniso ridefinito scorre da mitologema estetico a concetto che implica un più generale «rapporto con il mondo e la vita» (p. 59), a catalizzatore per l’«affermazione del tutto-unitario» (p. 58), un paradigma per un’appropriazione fideistica del mondo, «risultato di una mescolanza tra la mitologia greca e una mitologia privata» (p. 59). Nel segno di Dioniso (o di Gesù) si misura in realtà un disegno molto più grande: quello di «pensare un Dio ‘al di là del bene e del male’» (p. 64). Simile a Dioniso, e anzi ricostruito in base alla sua immagine, appare il “nuovo” Gesù nietzscheano, «variante addolcita di un personaggio dionisiaco» (p. 62): entrambi in un certo senso garanzia di una divi488 nità che nega l’equazione “Dio uguale spirito” e che invece è il terminale dell’entusiastico sì alla vita al fondo della filosofia di Nietzsche (numerose sono le formule che ricorrono nell’Anticristo e che fondamentalmente ripetono il concetto espresso al paragrafo 55: «‘Dio’ è la parola per il grande sì a tutte le cose»). Ma “il grande sì” ha luogo al di fuori del tempo, anzi, è esso stesso annullatore e negatore del tempo: come si concilia allora la dimensione extratemporale con la modalità narrativa che sul tempo si fonda? Come può darsi la novella – che già Gaia scienza e Zarathustra annunciavano secondo modelli parabiblici rovesciati in cui la linearità era apparentemente sostituita da una circolarità che altro non era se non linearità ciclica – se niente è nuovo e invece tutto è pre- e coesistente? Detering ricorre alla categoria dell’analogo mitico: la chiave narrativa per la quale passano la scoperta e l’annuncio di un Gesù che resta sempre uguale a se stesso è quella della “motivazione a posteriori”, ovvero «la corrispondenza narrativa di una visione mitica del mondo, in cui ogni accadimento è solo apparentemente aperto, ma in verità è fin dall’inizio determinato da una fine prestabilita» (p. 70). Contro precedenti formulazioni (come quella di Gary Shapiro, ricordata da Detering, che in Nietzsche contra Renan scrive che «‘La vita di Gesù’ raccontata da Nietzsche non è narrativa ed è un vero e proprio attacco al principio narrativo stesso») e tramite l’analogo mitico, Detering individua nella parabola di Gesù raccontata da Nietzsche «il tempo grammaticale […] dell’ora immobile» (p. 78) che culmina nella scena della morte sulla croce, in cui s’inserisce il dialogo tra il redentore e il ladrone al paragrafo 35 dell’Anticristo, in cui il futuro grammaticale di Luca («Oggi sarai con me in paradiso») viene tradotto nel presente del qui e ora («in paradise now», p. 78): «Se tu lo senti – rispose il redentore – tu sei in paradiso, anche tu sei un figlio d’Iddio». Ecco che si chiarisce in termini di contraddizione il rapporto tra l’annuncio dell’Anticristo, racconto fondato su una categoria assolutizzante di tempo-non-tempo, e la tradizionale narrazione della vita di Cristo in termini di tempo lineare che ne tradisce il messaggio al momento in cui pratica un’«immissione nel tempo della lieta novella senza tempo» (p. 85) e che genera a cascata gli errori e le vere e proprie aberrazioni del cristianesimo storico. Nel profilo di questo Cristo cambiato acquisiscono rilevanza centrale la crocifissione e la croce: dire sì alla vita in ogni suo momento comprende anche la morte, non essendovi “tempo” non vi è neppure differenza di stato tra l’essere e il non essere, e “cristiano” può essere definito solo chi «vive così come vive colui che muore sulla croce […], non quindi chi è mite come lui o chi muore stoicamente senza lamentarsi, bensì colui che condivide con lui il rapporto con il tempo, il mondo, con se stesso e con ‘Dio’ che risulta compiutamente visibile sulla croce» (p. 81). La croce, «trasformata simbolicamente nella trasfigurazione» (p. 87), è ciò che restituisce vita al Vangelo: un vangelo che si contrappone al «Dysangelium» della tradizione cristiana in cui il Regno di Dio, nella mistificazione paolina spostandosi dal presente al futuro, viene trasformato in filosofia della storia e con ciò annullato nella sua valenza trasgressiva: e «solo a questo pensiero della storia è diretto […] il grande gesto di rifiuto 489 della legge contro il cristianesimo che l’Anticristo firma alla fine» (p. 88) in nome del proprio simbolismo astorico. Certo, non sfugge l’ambiguità dell’operazione, e anzi la rivalutazione di Gesù avviene all’interno di una contraddizione imperniata su un duplice uso linguistico: «Come il termine ‘L’Anticristo’, a seconda del contesto e della direzione interpretativa, può caratterizzare l’ultimo e più forte avversario di Cristo e del cristianesimo in una finale lotta apocalittica e colui che ripropone la dottrina e la pratica di Gesù, allo stesso modo l’Anticristo parla, ovunque si tratti di gesù, di ‘Vangelo’ e di ‘lieta novella’ esclusivamente in un senso affermativo, e lo stesso vale per ‘fede’, ‘redenzione’ e ‘redentore’, ‘Padre’ e ‘Figlio’. Laddove, invece, si riprenda l’uso linguistico di Paolo e dei discepoli e si parli di chiesa e cristianesimo, quegli stessi concetti mutano in ‘insulti, in marchi di infamia’» (p. 88). Anche la croce acquista così una duplice valenza: di attributo del «redentore dionisiaco» (p. 89) nella prima opzione interpretativa, nella seconda di simbolo esecrato di ciò che il cristianesimo è divenuto nel segno di un ressentiment che nel tempo viene 490 «cancellato completamente dalla figura di Gesù» e «si sposta completamente sui discepoli e prende il nome di Paolo» (p. 92). In entrambi i casi resta valido, e acquista nuove valenze, ciò che scrive Nietzsche nel paragrafo 39 dell’Anticristo: «Il Vangelo morì sulla croce». Come si spiega allora alla luce di tutto questo la frase che chiude l’opera successiva e per molti versi parallela all’Anticristo, l’Ecce homo, e che sembra instaurare di nuovo una dicotomia difficilmente sanabile: «Hat man mich verstanden? - Dionysos gegen den Gekreuzigten...?». Detering risolve la contraddizione iscrivendola da un lato nella logica di verità molteplice così vicina all’ambivalenza dell’ultimo Nietzsche, dall’altra pensando il Crocifisso come duplice citazione dal senso divaricato: quello tradizionale cioè come emblema «degli equivoci della Chiesa», quello del racconto nietzscheano «invece dalla parte di Dioniso» (p. 91). È quest’ultimo a declinare una forma inedita di superuomo che eclissa in parte quello precedente, con sorpresa e forse irritazione dello stesso Nietzsche: mentre il «‘tipo Cesare Borgia’ si ritira in modo impercettibile […] e si can- cella così come avviene alla volontà di potenza che lui stesso incarnava e perfino al grande pensiero dell’eterno ritorno» (p. 96), emerge un profilo che si realizza non più nello sprezzo eroico e nell’atteggiamento tragico, ma nel sì incondizionato alla vita, «che si impone autonomamente a partire dalla forza di una situazione di felicità che non è più attaccabile dal dolore, dal fallimento, dalla potenza né dall’impotenza, in un mondo che si trasfigura in modo meraviglioso» (p. 96). Una transvalutazione che è innanzitutto autotransvalutazione e di cui i Ditirambi di Dioniso danno testimonianza poetica. A essi Detering dedica un capitolo, il nono (Dioniso trasfigurato), che occupa la posizione di perno centrale nel corpo dei diciassette complessivi del suo lavoro, prima dell’ultima parte in cui il modello dell’Anticristo viene verificato sulla scorta di Ecce homo. Ma se nei Ditirambi «si formula nel modo più chiaro e penetrante l’ultima evidente trasformazione del concetto ‘Dioniso’» (p. 102), è in Ecce homo che il percorso di Nietzsche si conclude con una mitologizzazione del sé (già a suo tempo ne aveva parlato anche Giorgio Colli) che diviene trasparente anche attraverso la strategia narrativa, di cui Detering coglie brillantemente i tratti salienti. Accogliendo definitivamente una tendenza che da latente si era in Nietzsche fatta via via più patente, l’istanza narrativa di Ecce homo si identifica apertamente con l’autore: e tuttavia il racconto autobiografico che ne risulta, a partire dall’ambigua frase che conclude il breve testo – ciò che Detering chiama «il poetico prologus ante rem» (p. 132) – contenuto tra il prologo e il primo capitolo («E così mi racconto la mia vita»), mette in scena un io tripartito «a tre facce» (p. 118), un “io uno e trino” che rimanda alla “dottrina della Trinità”, la cui «unità si compie in una dinamica comunicativa» (p. 120) che nella sua prassi estende la propria molteplicità alla vita nel suo insieme e alle sue singole parti. L’autodichiarazione continua di Ecce homo fondata sullo “io sono”, la reiterata proclamazione di essere, mettono in relazione anche formale il ruolo di Nietzsche e quello del redentore, dell’annunciatore di un messaggio di rivoluzionaria portata, trasmesso attraverso un sintagma – il verbo essere appunto – che gli 491 conferisce fondatezza ontologica. La reiterata affermazione dell’essere di Nietzsche si fonde con quella simile di Cristo nei vangeli e persino con lo «io sono colui che sono» dell’Esodo (a esso rimanda il passo del prologo di Ecce homo: «Ascoltatemi! poiché io sono questo e quest’altro»), secondo una strategia retorica piena di oscillanze e ambivalenze, «un gesto di eccesso trionfale che si mette in scena come derisione sfrenatamente blasfema nei confronti della tradizione cristiana, ma che la fa proseguire in questa variante molto ostinata, in termini di controscrittura» (p. 133). In Gesù (nel Gesù dell’Anticristo), il Nietzsche di Ecce homo trova il modello da contrapporre al Wagner della decadenza, alla sua «arte seduttrice […] della vita decadente» (p. 135), e in questo modo trova anche la strada per uscire dalle pastoie della sua stessa decadenza: verso un «concetto Dio» (p. 139) che non è contrario alla vita, ma coincide con essa, nell’orizzonte apocalittico di un «un mondo trasfigurato dalla beatitudine in cui vive il Gesù dell’Anticristo quale unico mondo pensabile ed esprimibile e la cui rivelazione è adesso imminente» (p. 139). 492 Seguendo il modello narrativo-mitologico della via crucis, Nietzsche sente di aver portato a compimento la propria opera di creatore divinizzato tanto nel mondo interiore che in quello reale. Corollario di questo fermento di trasformazioni, trasfigurazioni e transvalutazioni, sono i «biglietti della follia», in cui la riflessione (se di riflessione si può ancora parlare a questo livello: Detering non sottace ovviamente le possibili incidenze di cause psicopatologiche, cfr. pp. 154-55) sul ruolo di Cristo è portata a estremo compimento. Si ricorderà che il 2 gennaio 1889 Nietzsche licenzia in via definitiva il suo Ecce homo con le ultime correzioni inviate all’editore e che il giorno successivo, il 3 gennaio, si firma per la prima volta come «il Crocifisso». In questo processo Nietzsche rende attuali gli attributi che nell’Anticristo aveva individuato in Gesù, andando a tessere una rete in cui si tengono insieme «il Dioniso trasformato nella figura di Gesù e il Crocifisso trasformato in quella di Dioniso» (p. 150) e al cui centro è un io diviso e sovrapposto a diversi personaggi. È uno di essi che alla fine sembra avere il soprav- vento, che li riassume tutti: quello del Dio morto, sulla croce come Cristo o disperso come Dioniso Zagreo, che si diffonde in una teoria di nomi. «In fondo io sono ogni nome della storia», scrive Nietzsche a Jacob Burckhardt nell’ultimo dei quattordici «biglietti della follia», e Detering sottolinea giustamente come il riferimento al “nome” indichi la consapevolezza di avere imbastito ed essere al centro di un gioco linguistico di cui «anche il nome ‘Nietzsche’ è in fondo soltanto una fiche linguistica tra le altre» (pp. 152-153). L’io che è «tutti i nomi della storia» è un io che è letteralmente tutto, che nel suo essere uno e molteplice si è appropriato del mondo, che è Dio. Qui, ritornando agli inizi e al primo capitolo e alla definizione dell’«uomo folle» della Gaia scienza, annunciatore della «morte di Dio», la lettura di Detering si arresta, legittimandosi attraverso la lettura che di questo ultimo Nietzsche hanno dato i suoi contemporanei scrittori, da George a Strindberg a Thomas Mann a – sorprendentemente – Bertolt Brecht: ovvero quella di un Nietzsche filtrato da un pathos religioso. È questo progetto ricostitutivo di una religione antimetafisica e antidecadente che s’indovina dietro il disegno nietzscheano, e una cosa sola con esso appare la modalità di restituzione del pensiero complesso che esso assume: essenzialmente quella di «un grande testo che prosegue dai singoli testi, che inizia con l’Anticristo e va avanti nell’autobiografia successiva e infine nelle lettere siglate da pseudonimi» (p. 165), in cui «si condensano personaggi che portano ogni volta con sé la loro storia particolare, il loro ‘mito’» (p. 149). È il merito principale di questo saggio convincente e profondo, quello di ricostruire la mappa di questo grande testo, e con essa l’ultima stagione nietzscheana, riportando le molte ambiguità e oscurità della sua ultima convulsa esplosione di creatività a un quadro coerente che, se non le risolve tutte, almeno le contiene, in ciò che in fondo – e l’autore ne è consapevole, come dichiara egli stesso nei suoi ultimi paragrafi – altro non è che un’ulteriore narrazione possibile. Alessandro Fambrini 493 Gisela Holfter, Heinrich Böll and Ireland, with a Foreword by Hugo Hamilton, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 200, £ 39,99. Il Nobel Heinrich Böll, considerato cronista della Germania post-bellica e tra i maggiori rappresentanti della letteratura delle rovine, cui aderì programmaticamente nel 1952 con lo scritto Bekenntnis zur Trümmerliteratur, si è affermato come autore di romanzi e racconti che vedono come protagonisti emarginati, oppressi e derelitti. Una certa risonanza hanno avuto anche i saggi in cui egli sottolinea il proprio impegno di artista nonché la critica, da cattolico sincero ed osservante, al conformismo religioso e alla chiesa come istituzione. All’interno della sua produzione lo Irisches Tagebuch (1957) è generalmente visto come una sorta di parentesi amena, se non un corpo estraneo, data la diversità di tono e di atmosfera rispetto alla narrativa. In effetti Böll fu un globe-trotter ante litteram (visitò, tra gli altri, Svezia, Belgio, Francia, Italia e alcuni paesi extraeuropei), autore, oltre che del libro sull’Irlanda, di 494 vari altri scritti, molto più brevi, in cui riporta le proprie esperienze odeporiche. Il volume di Gisela Holfter, autrice di numerosi lavori sullo scrittore di Colonia così come sulla letteratura di viaggio germanofona incentrata sull’Irlanda (si veda ad esempio la sua fondamentale monografia Erlebnis Irland. Deutsche Reiseberichte über Irland im zwanzigsten Jahrhundert, Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 1996), illustra in maniera completa ed organica gli aspetti sia letterari che biografici del rapporto di Böll con l’isola di smeraldo, rapporto sinora indagato in singoli contributi e in maniera alquanto frammentaria. Preceduta da una sintetica ed illuminante introduzione dello scrittore tedesco-irlandese Hugo Hamilton, che si è imposto all’attenzione con il romanzo The Speckled People (London, Harper Perennial, 2003; trad. it. Il cane che abbaiava alle onde, a cura di Isabella Zani, Fazi, Roma 2004) – vera Fundgrube per gli Irish-German Studies –, la trattazione è articolata in cinque parti, ognuna suddivisa in agili capitoletti. La prima sezione traccia un profilo molto stringato delle relazioni tedesco-irlandesi, come si sono sviluppate nel corso dei secoli, nonché della biografia in toto dell’autore; la seconda è incentrata sui primi contatti di Böll con il contesto irlandese, sul suo primo viaggio nell’isola, nel 1954, e sui suoi soggiorni sulla costa occidentale; la terza parte, che costituisce il nucleo del lavoro, illumina lo Irisches Tagebuch nei suoi aspetti formali (struttura, stile, assetto cronologico, intertestualità) e contenutistici, commentandone temi come emigrazione, povertà, tradizioni, religione e soffermandosi quindi sulla ricezione del libro sia in Germania che in Irlanda; la quarta parte si occupa di altri elementi relativi alla ricezione, ossia di traduzioni, recensioni nonché del film per la TV The Children of Eire (1961), il cui copione fu scritto da Böll; l’ultima, brevissima sezione, che consiste di un solo capitolo, si sofferma sull’eredità culturale dello scrittore e sugli enti volti a sostenerla. Nel corso dei suoi viaggi in Irlanda Böll è attratto dalla penisola di Achill Island (originariamente isola, dal 1887 unita alla terraferma da un ponte), per la quale già personalità come ad esempio Charles Lamb e Graham Greene avevano mostrato predilezione, e vi soggiorna per lunghi periodi. Ė proprio qui che l’autore di Colonia, considerato dagli abitanti del luogo – così Holfter riferisce sulla base di testimonianze orali, talvolta a carattere aneddotico, da parte di persone che a suo tempo hanno conosciuto lo scrittore – non come letterato, bensì semplicemente «member of a community which accepted him as one of themselves» (p. 51), scrive il suo capolavoro Ansichten eines Clowns. Il fatto che lo Heinrich Böll Cottage di Achill Island, originariamente dimora dell’autore, sia diventato nel 1992 sede di un’istituzione volta a sovvenzionare e ospitare giovani artisti e scrittori (The Heinrich Böll’s Cottage on Achill Island, ed. by John McHugh, Dooagh, The Heinrich Böll Committee, 1998) è la prova del ruolo fondamentale attribuito a Böll nel panorama culturale irlandese. Holfter rigetta la notissima caratterizzazione fornita da Reich-Ranicki (la notizia della cui scomparsa veniva diffusa proprio mentre la presente recensione andava in stampa) dello Irisches Tagebuch come di un «verstecktes Deutschland-Buch» (Marcel Reich-Ranicki, Deutsche Literatur in West und Ost – Prosa seit 1945, 495 Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1963, p. 135), ritenendo che sempre comunque la prospettiva da cui il viaggiatore osserva la nazione straniera risenta dell’esperienza legata al paese d’origine, dato certo condivisibile: «While the author used his own German background as a frame of reference, there is no question that the book is very much about Ireland» (p. 141). L’autrice dedica un capitolo (Germany: ‘A Cursed Country’ – but I am still a German) al legame dell’artista con la patria, concludendone che «Böll’s is actually neither a specifically German perspective nor one based solely in the 50s, but rather a fequently voiced criticism in the context of industrialisation» (p. 78). Senza dubbio, il fascino dello Irisches Tagebuch deriva dal paese che Böll visita e non dai grigi centri urbani tedeschi che l’autore lascia intendere di voler lasciare alle spalle; tuttavia, una delle principali ragioni per cui il libro ebbe in Germania un grandissimo successo, al punto da dare il via non solo a una serie di scritti letterari sull’Irlanda, ma a un turismo diffuso verso l’isola di smeraldo, risiede nel fatto che molti tedeschi all’epoca si identificarono con l’at496 teggiamento e la prospettiva del viaggiatore Böll, che in maniera palese considera l’Irlanda – come del resto la stessa Holfter implicitamente riconosce – come un rifugio, come «a direct antidote to an irresponsibile and blinkered belief in material growth for its own sake» (p. 157), tendenza che l’autore rinviene appunto nella politica tedesca. Non appare dunque opportuno decontestualizzare totalmente il libro, seppure risulti arduo stabilire in che misura il suo successo fosse dovuto alla dimensione per così dire universale intrinseca alla Reisebeschreibung e in che misura al fatto che fosse pubblicato in un preciso momento storico dello sviluppo industriale della Germania. Innegabile, a parere di chi qui scrive, che, al di là delle delicate descrizioni paesaggistiche, per comprendere le implicazioni weltanschaulich e sociopolitiche dello scritto quest’ultimo vada visto anche – certo non in modo esclusivo, come tende a ritenere Reich-Ranicki – in relazione al paese d’origine, da cui Böll, estraneo a suo tempo alla Exilliteratur, dopo il conflitto bellico, a seguito del deludente sviluppo economico, per lunghi periodi tende ad allontanarsi. In tal modo egli rea- lizza in una sorta di esilio volontario postumo, cercando rifugio in un’isola che si trasforma per lui in un vero e proprio asilo. Nonostante la semplicità espositiva, la mancanza di programmatiche esplicitazioni teorico-metodologiche nonché la prevedibilità degli argomenti trattati, almeno per chi conosce lo Irisches Tagebuch, il volume costituisce un validissimo strumento per esplorare la dimensione ‘esterofila’ del Nobel di Colonia, dimensione familiare solo a una cerchia piuttosto ristretta di critici e appassionati. Forse più ancora che per entrare nel merito del Tagebuch, il libro di Gisela Holfter risulta utile per scoprire i molteplici aspetti dell’ibernofilia diffusa di Böll. Osserva l’autrice che la predilezione per il contesto gaelico si palesa già nel 1942 in una lettera alla fidanzata: qui il giovane scrittore cita un sonetto di Reinhold Schneider in cui compare un’isola sacra abitata da monaci e pervasa da profonda religiosità, evidente allusione all’Irlanda. Anche gli scritti più noti, ad esempio il romanzo Gruppenbild mit Dame (1971), che ebbe un ruolo non indifferente nel determinare l’attribuzione del Nobel all’autore, sono costellati di riferimenti all’Irlanda: lo scrittore preferito della madre della protagonista è William Butler Yeats, inoltre viene menzionato, tra gli altri, Samuel Beckett e si parla dei troubles nordirlandesi. Lo spiccato interesse per l’isola si concretizza nel corso degli anni, oltre che in ripetuti viaggi in Irlanda e nel relativo scritto odeporico, in una serie di articoli, trasmissioni radiofoniche (talora in collaborazione con Alfred Andersch), recensioni e soprattutto traduzioni a quattro mani, con la moglie Annemarie, di testi di grandi autori irlandesi. Pochi sanno che ai coniugi Böll si devono, per citare solo un paio di esempi dai numerosissimi a disposizione, le versioni tedesche di Man and Superman e Candida di George Bernhard Shaw, di The Playboy of the Western World di John Millington Synge, di The Hard Life di Flann O’Brien. Particolare menzione meritano le traduzioni e le recensioni dell’opera di Brendan Behan, artista a Böll congeniale in virtù della problematica religiosa. Di tutto ciò e di molto altro ancora Holfter offre per la prima volta nella Böll-Forschung un quadro esaustivo, stimolando ad approfon497 dire ulteriormente aspetti dell’ibernofilia dell’autore che esulano dal canonico Tagebuch. La componente innovativa dello studio molto deve al sapiente utilizzo da parte dell’autrice, Senior Lecturer in tedesco presso l’Università di Limerick e co-direttrice del Center for IrishGerman Studies che qui ha sede (cfr. in merito Anna Fattori, «The oldest Department’s Chair of German in the world», in «Studi Germanici», 1 (2012), pp. 283-302, spec. pp. 292), di materiale di diverse tipologie: scritti pubblicati recentemente, ad es. la corrispondenza di Böll stampata nella Kölner Ausgabe in 27 volumi ultimata nel 2010; documentazioni varie, talora non edite, reperibili presso lo Henrich Böll-Archiv di Colonia; lettere a lei pervenute da parte di letterati e varie personalità; testimonianze orali che ha avuto modo di raccogliere nel suo soggiorno come writer in residence presso il Cottage di Achill Island. Terminata la lettura e presa coscienza, sulla base dell’analitico profilo dell’ibernofilia bölliana, del ruolo centrale dello scrittore di Colonia nella diffusione della cultura irlandese in Germania e più in generale in Europa, non si può che concordare che, come 498 affermò nel 1992 l’allora Presidente irlandese Mary Robinson in occasione di una visita ufficiale a Dublino del Presidente tedesco Richard von Weizsäcker, «if Ireland did not already have a national saint, Heinrich Böll would be a suitable candidate» (p. 175). Anna Fattori Maurizio Pirro (a cura di), Salomon Gessner als europäisches Phänomen. Spielarten des Idyllischen, Heidelberg, Winter, 2012, pp. 290, € 38,00. Gli Idilli di Salomon Gessner, il “Teocrito elvetico”, hanno avuto nel XVIII secolo una diffusione paragonabile solo al Werther di Goethe e alle Favole di Gellert. Sebbene negli ultimi anni la complessità e l’originalità di Gessner, sia come poeta che come artista figurativo, sia emersa in più di un’occasione (si pensi in particolare alla mostra del marzo 2010 presso il Kunsthaus di Zurigo Idyllen in gesperrter Landschaft. Zeichnungen und Gouachen von Salomon Gessner, documentata dal catalogo omonimo a cura di Bernhard von Waldkirch, Hirmer Verlag – Kunsthaus Zü- rich, München – Zürich 2010), il poeta dell’idillio appare tuttora una sorta di Geheimtipp ed è raramente oggetto d’indagine della germanistica che non sia di matrice elvetica. Desta dunque particolare interesse il volume curato da Maurizio Pirro (già autore della fondamentale monografia Anime floreali e utopia regressiva. Salomon Gessner e la tradizione dell’idillio, Udine, Campanotto, 2003), volume che raccoglie gli atti di un convegno svoltosi a Bari nell’aprile 2006. Il libro si propone di affrontare il dibattito sull’idillio gessneriano nel contesto europeo così come di evidenziare la fitta rete di contatti culturali e rapporti interpersonali che fanno dell’artista zurighese tra i pochi scrittori del Settecento germanofono dalla portata internazionale. La sequenza dei contributi è concepita in modo tale da permettere al lettore di avvicinarsi gradualmente alla dimensione europea di Gessner, spiegata prima a partire da aspetti più generali che fanno riferimento tra l’altro alla Doppelbegabung di MalerDichter e alla biografia, per indagare poi tematiche come lo sviluppo della Bildlichkeit nel corso del tempo, il rapporto con Diderot nonché con la teoria di Sulzer e approdare quindi all’analisi della ricezione dello svizzero in Italia (sia a livello di traduzioni e di antologie sia di discussione critica del sostrato filosofico della sua estetica), nonché a osservazioni sulla sua collocazione nella Aufklärung portoghese. Il volume si conclude con un Ausblick sulla mutata funzione, più che dell’idillio gessneriano, del paesaggio tipico di tale genere in alcuni romanzi dell’Ottocento tedesco. Il contributo di Wolfgang Adam illustra le Gessner-Lektüren – questo il titolo dell’articolo – nelle varie accezioni dell’espressione tedesca: gli autori letti dall’elvetico (Teocrito, Virgilio, Brockes, Hagedorn, Gleim); le letture dei personaggi degli idilli (in tal senso, solo Der Wunsch offre indicazioni, menzionando ciò che il protagonista legge o meglio desidererebbe leggere: Klopstock, Bodmer e Breitinger, Wieland, Ewald von Kleist, Gleim); il pubblico settecentesco delle Idyllen, ossia la diffusione di Gessner nella Confederazione e all’estero (in Germania l’autore era letto, tra gli altri, da Winckelmann, Volkmann, Goethe, Herder, Schiller); infine la (scarsa) 499 presenza di Gessner nella coscienza del lettore moderno, al di là di rare menzioni (ad es. da parte del poeta Nicolas Born, che cita Gessner in una poesia) e di sporadici tentativi di attualizzazione, come quello del regista francese Jacques Sandoz, che nel 1984 ha trasposto cinematograficamente il poema biblico Der Tod Abels con il titolo La Mort d’Abel et le phénomène Salomon Gessner. F. Carlo Schmidt indaga la dimensione europea di Gessner in riferimento alle arti figurative. Nello scritto teorico Brief über die Landschaftsmahlerei l’elvetico mostra la sua ecletticità, richiamandosi a pittori come Claude Lorrain, Nicolas Poussin, Salvator Rosa, J. Philipp Hackert e cercando di valorizzare la pittura paesaggistica, facendola risalire nella gerarchia accademica dei generi dell’arte figurativa; degno di nota l’interesse di Gessner per i pittori olandesi, in particolare per Anthonie Waterloo, ai quali spesso si ispira – sebbene i suoi disegni siano in ogni caso animati da un afflato ideale a loro estraneo – là dove inserisce elementi concreti come capanne, pescatori e simili. Con il passare del tempo, l’artista aggiunge alle sue opere sempre più dettagli di 500 vita quotidiana tipicamente elvetici. Tra gli allievi in ambito artistico, particolare menzione merita Carl Wilhelm Kolbe, che ebbe dalla famiglia l’incarico di riprodurre i capolavori di Gessner, ossia la pittura a gouache. Schmidt sottolinea come i surreali Kräuterblätter di Kolbe, caratterizzati da enormi elementi vegetali rispetto ai quali le figure umane appaiono ridottissime, palesino un procedimento niente affatto estraneo a Gessner, citando in proposito Als ich Daphnen auf dem Spaziergang erwartete (Urfassung di Die Gegend im Gras), in cui lo zurighese – provocando una sorta di effetto di straniamento sul lettore – pone decisamente in secondo piano i personaggi per concentrarsi su piante e insetti. Come l’autore sintetizza, Gessner appare fondamentale elemento di raccordo tra rococò, arte fiamminga e classicismo, aprendo peraltro la via a suggestioni romantiche. Lothar von Laak delinea lo sviluppo della Bildlichkeit gessneriana «von einer allegorischen zu einer symbolischen und von einer rhetorischen zu einer ästhetisch-hermeneutischen Auffassung» (p. 61), processo illustrato prima a livello estetico-filosofico, sulla scorta dei più recenti contributi sul tema, quindi esemplificato con un confronto testuale tra un idillio del 1756 (Tityrus. Menalkas) e uno del 1772 (Der Herbstmorgen), paragone che lascia emergere chiaramente la «Entdynamisierung der Gattung in der Zeit der sich herausbildenden genieästhetischen und modernen Kunstauffassung» (p. 71). L’esito finale di tale processo, riassume l’autore, appare essere la «Entallegorisierung bzw. Entsemantisierung des Allegorischen, mit der aber keine symbol-ästhetische Neuausrichtung einhergeht. Das genetische Potential der Bildlichkeit verschwindet» (p. 77). Nel 1772 uscì a Zurigo il volume Moralische Erzählungen und Idyllen von Diderot und Gessner, pubblicazione considerata dai contemporanei alquanto singolare. Luca Zenobi, cercando di venire a capo delle ragioni che avevano indotto Diderot a prendere lui stesso l’iniziativa per far stampare i propri testi unitamente a quelli del collega zurighese, tocca punti centrali del pensiero settecentesco, in particolare il binomio Herz-Natur che tanta parte ha nella poetica di Gessner e che fece sì che il francese si sentisse attirato da lui. Pubblicando i propri racconti accanto agli idilli di Gessner, egli riteneva che questi ultimi potessero far apparire chiaramente il proprio Anliegen estetico, improntato appunto alla poetica dell’elvetico. Diderot, all’epoca ammirato dal pubblico tedesco come autore di commedie, desiderava ora negli anni Settanta apparire in veste diversa ed era interessato a Gessner non semplicemente perché imitasse la natura, ma perché si trattava di scrittore e artista – Maler-Dichter, appunto – attento alla verità del dettaglio realizzata attraverso «die Wahl des Schönsten» (p. 82). Il francese, volto a individuare un principio generale alla base di tutte le arti, è particolarmente recettivo alla convinzione espressa da Gessner in Brief über die Landschaftsmahlerei: «Die Dichtkunst ist die wahre Schwester der Mahlerkunst» (p. 82). Il recensore Johann Jakob Engel, rappresentante della Aufklärung tedesca (peraltro autore del più significativo saggio sul romanzo, ovvero Über Handlung, Gespräch und Erzählung, prima che, nel 1774, uscisse il trattato di Friedrich von Blankenburg Versuch über den Roman), sottolinea il sostrato filosofico dei racconti di Diderot, 501 valutando tuttavia negativamente – da rigido illuminista ancorato al prodesse et delectare – l’apertura del francese, ossia il venir meno di un chiaro intento pedagogico. Il curatore Maurizio Pirro evidenzia i molteplici collegamenti tra Gessner e l’estetica di Sulzer. Quest’ultimo proveniva, come è noto, dalla scuola di Bodmer, la cui poetica rigida e razionalistica non poteva essere congeniale al Teocrito elvetico. Che il noto teorico svizzero decidesse, dopo aver ricevuto la Daphnis del collega, di attribuire questo nome a un cagnolino, non può certo essere inteso come apprezzamento del poeta dell’idillio. Nel corso del tempo, tuttavia, Sulzer tende a rivedere la propria opinione; infatti nella sua Allgemeine Theorie der Schönen Künste il lemma Hirtengedicht si conclude con un vero e proprio elogio di Gessner, cui Sulzer riconosce il merito di essere riuscito ad affermarsi in un ambito difficile e limitato come quello dell’idillio. Accomunati negli anni Settanta dall’avversione per la Geniebewegung, entrambi si esprimono in modo critico su Herder e Klopstock. Tuttavia, al di là di questa e altre analogie, Pirro non può che constatare – condivisibilmente – che il già citato lemma della Theo502 rie di Sulzer sullo Hirtengedicht a ben guardare disconosce l’essenza della poesia gessneriana, in quanto il teorico considera l’idillio dell’elvetico – e sarà questo un fraintendimento molto frequente nella Gessner-Forschung successiva – semplicemente una forma di escapismo, senza rendersi conto della valenza critica nei confronti del contesto sociale: «Die Idylle ist aus Sulzers Sicht keine erzählerische Vermittlungsinstanz, die den Leser auf die Möglichkeit hinweisen soll, das Bild der durch die Steigerung kapitalistischer Akkumulationsverfahren drastisch veränderten Gesellschaft mit Hilfe von Werten humanistischer Prägung neu zu gestalten, sondern bietet vielmehr dem Menschen den angenehmen Traum einer unbeschatteten Zufriedenheit, die nichts als Kompensationswert besitzt» (p. 110). L’eruditissimo contributo di Giulia Cantarutti è un vero e proprio trattato in nuce di quasi novanta pagine, i cui snodi argomentativi non possono ovviamente essere qui ripercorsi, che illumina molteplici aspetti della ricezione italiana di Gessner: ruolo centrale dell’Università di Pavia nonché di figure come Bertola (Aurelio de’ Giorgi Bertola, poeta e letterato, fu traduttore ed amico dello svizzero nonché autore del notissimo Elogio di Gessner del 1789), Soave, Denina, Cesarotti; tarda ricezione di Kant nel nostro paese e immediato successo di Gessner per il tramite francese; modalità di diffusione in Italia della Populärphilosophie; centralità delle riviste letterarie come organo di divulgazione della cultura tedesca; rifiuto della filosofia kantiana e conseguente contrapposizione Kant-Goethe da un lato e Gessner dall’altro. Se nel Neoclassicismo italiano la filosofia di Kant è giudicata come egoistica in quanto stabilisce, come sostiene Soave, «che ognuno nelle sue azioni non debba proporsi altro fine che sé medesimo, né da altri fuorché da se stesso prender le leggi della sua condotta» (p. 198), gli scritti gessneriani appaiono invece rappresentare quel “senso comune” che la filosofia tedesca del tempo con sottigliezza scolastica aveva messo al bando. Questa tra le principali ragioni del successo dello zurighese nel nostro paese, successo che procede di pari passo con le riserve espresse nei confronti di Goethe e di Kant. Della presenza di Gessner in un’antologia italiana si occupa Jürg-Ulrich Fechner, il quale prende in esame la RACCOLTA | DI | SCELTE PROSE ALEMANNE | CON GLI ELEMENTI GRAMATICALI [sic!] | AD USO | DEGL’ITALIANI uscita a Pavia nel 1789 a cura di Anton Drexl, rappresentante dell’illuminismo cattolico italiano, che, contrapponendosi a vari suoi colleghi, decreta nel suo contributo introduttivo «de[r] Niedergang des Französischen als der führenden Literatursprache», dato questo trascurato – come Fechner a ragione osserva – dalla critica letteraria (senza dubbio, si può immaginare, non da ultimo per la non agevole reperibilità dell’antologia e delle altre fonti qui citate). Drexl propone un’interessante gerarchia degli autori tedeschi del tempo: all’apice Lessing e Wieland, quindi Goethe, Engel e Sturz (quest’ultimo oggi dimenticato), seguiti da Winckelmann e dagli svizzeri Gessner, Haller e Zimmermann, molto noti in Italia così come in vari paesi europei. Il curatore non dimentica del tutto le autrici, anche se invero l’unica rappresentata è Sophie La Roche. Il poeta dell’idillio non appare nell’antologia come l’autore più apprezzato da Drexl, 503 sebbene egli ne riconosca la larga diffusione e riporti, a documentare proprio la valenza europea di Gessner e i contatti con la nostra cultura, due lettere dirette dallo zurighese a Bertola. L’articolo è completato da un’appendice che reca, in originale italiano e in traduzione tedesca, una breve recensione dell’antologia. L’articolo di Wiebke Röben de Alencar Xavier si avventura in una terra incognita o quasi, cercando di ricostruire le varie fasi dell’affermazione di Gessner in Portogallo, dove lo zurighese, che si diffonde inizialmente per il tramite dei francesi, riscuote successo in particolare all’interno della cerchia aristocratica e liberale. La sua ricezione è da collocare all’interno del più vasto contesto della ricezione di quella letteratura svizzero-tedesca, che annovera Haller tra i suoi maggiori rappresentanti, volta a esaltare le bellezze naturali e che pertanto costituisce l’antidoto alla letteratura di ambientazione cortese. Con le recensioni da parte di Padre F. Bernardo de Lima sia dell’epos biblico che degli idilli ha inizio in ambito portoghese «die stilisierende Fremdwahrnehmung Gessners als “Dichter und Maler 504 der Natur”» (p. 247). Le considerazioni di Lima ricalcano molto da vicino quelle dei recensori francesi, con alcune piccole ma significative differenze: mentre i colleghi francesi si soffermano sugli aspetti formali dei testi, Lima, in quanto rappresentante cattolico della Aufklärung lusitana, esalta – ai fini della creazione di una letteratura nazionale portoghese – il carattere esemplare dei valori di cui è portatore l’epos religioso gessneriano. Anche in questo articolo, come nel precedente, in appendice vengono riportati brevi stralci di alcune delle fonti citate dall’autrice. Il saggio conclusivo, di Giovanni Sampaolo, amplia la prospettiva cronologica al periodo successivo, esaminando la trasvalutazione del paesaggio canonizzato da Gessner nella narrativa della prima metà del XIX secolo, in cui lo spazio circoscritto dall’idillio solo in maniera anacronistica, se non grottesca, fa riferimento a «jene Vorstellung einer glücklichen, konfkliktfreien Integration von Natur und Kultur, die man als idyllischen Moment ansehen darf» (p. 267). A dimostrare che nella narrativa della Restaurazione il parco-giardino dell’idillio evoca sempre di più i valori della passata Kunstperiode, Sampaolo prende in esame Die Epigonen di Karl Immermann e l’ormai obsoleto romanzo di Gustav Freytag Soll und Haben, all’epoca divorato da intere generazioni, in cui il parco del castello sta per il conservatorismo e la vecchia poesia classico-romantica. L’autore conclude che il tentativo di continuare la tradizione dell’idillio si rivela vano e conduce solamente «zur Kritik, zur Unmöglichkeit der Re-naivisierung – zur Zerstörung der Idylle» (p. 290). I contributi che compongono il volume si caratterizzano per analiticità e ricchezza documentaria e attingono in più d’un caso a fonti non facilmente reperibili, pervenendo a osservazioni che non potranno non avere seguito negli studi gessneriani. Scopo dei singoli autori non è quello di offrire sottili analisi testuali, bensì di indagare i contesti nazionali e culturali che permettono di evidenziare l’apporto di Gessner alla cultura europea e inoltre di individuare gli stimoli che lo zurighese stesso recepì dalle varie letterature nazionali nonché dall’arte figurativa dei vari paesi. Il libro dunque contribuisce in modo decisivo a rivedere l’immagine, in auge fino a non molto tempo fa, di Gessner come ingenuo e innocuo autore della “ristretta” letteratura svizzerotedesca, “provincia” della letteratura propriamente tedesca. Se il rapporto dello zurighese con l’Italia emerge nelle sue molteplici sfaccettature e implicazioni e se anche in riferimento alla cultura francese il lettore riesce a crearsi un quadro della collocazione del Teocrito elvetico (non si fa qui riferimento alle osservazioni su Gessner in Portogallo in quanto esse non possono che avere un carattere pionieristico, data la mancanza di contributi specifici sul tema), un’importante area linguistico-culturale risulta decisamente in ombra, ossia quella britannica. Sebbene il successo di Gessner in Francia abbia superato qualsiasi aspettativa, la diffusione del poeta dell’idillio in Gran Bretagna non può essere trascurata. Illustri rappresentanti della letteratura inglese quali, ad esempio, Wordsworth e – in misura maggiore – Coleridge hanno essi stessi tradotto Gessner e attinto a piene mani da Der Tod Abels e dalle Idyllen; ambito, questo della recezione britannica, ovviamente scandagliato (per citare solo due tra i contributi canonici: Bertha Reed, The Influence of Solomon [sic!] 505 Gessner upon English Literature, Americana Germanica Press, Philadelphia 1905; John Hibberd, Salomon Gessner: His Creative Achievement and Influence, Cambridge, Cambridge University Press, 1976), ma niente affatto esaurito e che avrebbe ben integrato il quadro della dimensione europea del poeta dell’idillio. Fatta salva tale riserva, il volume curato da Pirro costituisce non solo un apporto fondamentale alla Forschung gessneriana, ma si configura, soprattutto in un periodo in cui si assiste al proliferare, in vari atenei stranieri, di corsi dal titolo European Studies, European Literatures, Global Studies e simili, come un contributo che non può mancare in un’ideale biblioteca critica europea. Anna Fattori Wolfgang Boettcher, Grammatik verstehen, vol. 1: Wort (pp. 287), vol. 2: Einfacher Satz (pp. 312), vol. 3: Zusammengesetzter Satz (pp. 221), Tübingen, Walter de Gruyter (Niemeyer Studienbuch), 2009, € 19,95 a volume. Wolfgang Boettcher, già allievo di Hans Glinz e assistente 506 di Horst Sitta, cattedratico di linguistica tedesca e didattica della lingua presso le università di Aachen e Bochum, ha dedicato lunghi anni di attività all’insegnamento universitario, con particolare attenzione all’insegnamento della grammatica tedesca. L’opera in oggetto rappresenta una summa dell’impegno scientifico e pedagogico dell’autore e un importante punto di arrivo per la sua biografia professionale, ma soprattutto per l’ambito disciplinare entro il quale si colloca. Grammatik verstehen è una grammatica del tedesco contemporaneo di livello universitario, dichiaratamente finalizzata a una didattica innovativa, in grado di risvegliare nei giovani, mediante lo studio della grammatica, consapevolezza e attrazione per le potenzialità espressive e creative della lingua. Come dichiarato nell’introduzione che precede ciascuno dei tre volumi, il manuale è concepito per studenti interessati tanto ad apprendere il corretto uso della lingua, quanto (e soprattutto) a comprenderne regole e scopi funzionali: da qui il concetto chiave di “comprensione” trasmesso dal titolo. Il fine dell’opera viene così formu- lato, in sintesi, dall’autore: «[Studierende] dabei unterstützen, Scheu vor systematischer Grammatik abzulegen und stattdessen grammatische Phänomene mit Vergnügen zu erkunden» (cfr. Einleitung, v. 1, p. XI). La generalizzata “antipatia” per la grammatica non ha secondo Boettcher una motivazione intrinseca alla materia, derivando piuttosto da un approccio didattico spesso inadeguato a coltivare la naturale curiosità, già osservata nei bambini, nei confronti della lingua. Lungi dal favorire la naturale inclinazione dei giovani discenti per la sperimentazione linguistica, l’insegnamento scolastico della grammatica tende a vederne lo scopo nell’apprendimento di norme per il corretto uso della lingua, producendo come suo oggetto un insieme sterile e repulsivo di regole e paradigmi. Boettcher parte da una concezione diversa dell’insegnamento grammaticale e della grammatica in sé. Pur non rinnegando l’associazione, inevitabile a prodursi, tra i concetti di grammatica e di norma linguistica, la sua accezione di norma è ampia e aperta: «Ob eine grammatiche Form korrekt oder angemessen ist, hängt davon ab, in welchem Kontext man sie anschaut und welche Funktionen sie in der Verständigung hat» (cfr. Einleitung, v. 1, p. XIII). Nella descrizione di Boettcher la norma linguistica non è una dimensione assoluta, bensì flessibile e relativa: un qualcosa che viene via via definito da quanto lo contorna. In tal senso, la norma del tedesco contemporaneo si chiarifica nel raffronto con usi ‘altri’, esemplificati nelle boutades, nei testi poetici, retorici e specialistici, nelle asserzioni dei bambini, in determinate regioni del territorio di lingua tedesca, nelle abitudini linguistiche di altre epoche, nelle altre lingue europee. La descrizione grammaticale di Boettcher fa perno sui grandi fenomeni linguistici che danno il titolo ai volumi: la parola (Wort), la frase semplice (Einfacher Satz) e la frase complessa (Komplexer Satz). I tre volumi presentano struttura coerente al modello di seguito illustrato: in apertura la già menzionata introduzione (Einleitung), nella quale l’autore espone i principi che guidano la sua descrizione grammaticale “dalla parte dei discenti”. L’introduzione comprende inoltre annotazioni riguardanti l’approc507 cio metodologico e le fonti, indicazioni per la lettura e, in chiusura, i ringraziamenti. Facendo seguito all’introduzione, il primo volume si articola in due sezioni principali, intitolate rispettivamente alle parti del discorso (Wortarten) e alla formazione di parola (Wortbildung). Il secondo volume, dedicato alla sintassi della frase semplice, è suddiviso in tre capitoli generali che trattano di tipi di frase (Satzformen), costituenti (Satzglieder) e attributi (Attribute). Il terzo volume analizza, in una prima sezione (Erweiterter Satz), quegli elementi che si pongono “in sovrappiù” rispetto alle strutture sintattiche semplici, per esempio apposizioni, incisi, costruzioni participiali, mentre la seconda sezione è dedicata alla frase complessa vera e propria (Zusammengesetzter Satz). Ogni parte dei volumi è corredata di materiale di riflessione sui temi trattati, analisi esemplari, excursus di vario tipo. Tali corredi sono riconoscibili dal carattere minore della stampa. Sono concepiti come ulteriore stimolo per la riflessione individuale sui Textfunde compresi all’interno del testo principale. Ogni volume include un’appendice con il commento dell’autore agli esempi di 508 testo forniti nelle parti centrali (Kommentare zu den Materialien). Seguono le fonti dei testi campione (Quellen) e l’indice degli argomenti (Register). Non vi è bibliografia. L’assenza dei riferimenti bibliografici non dipende unicamente dalla volontà, visibile in tanta letteratura manualistica, di non appesantire il testo. Il rifiuto, da parte di Boettcher, di precisare ogni volta la sua posizione all’interno del dibattito teorico, con rimandi interni al testo o a piè di pagina, documenta apertamente il suo dissenso nei confronti di tendenze egemoni nell’insegnamento grammaticale. Se la scuola, come si è visto, tende a limitare l’insegnamento linguistico all’uso corretto delle norme grammaticali, è altresì prassi comune nelle università focalizzare l’attenzione sulle controversie teoriche, che vengono in tal modo a costituire, a detta dell’autore, lo «Alltags-Geschäft von Hochschulseminaren». Tale prassi distoglie l’attenzione dalla riflessione critica e da ciò che dovrebbe costituire il vero interesse dell’apprendimento linguistico universitario. «Diese Grammatik» – afferma Boettcher – «soll Studierende zunächst einmal dafür gewinnen, ihre eigenen handwerklichen und sprachreflexiven Fähigkeiten an sprachlichen Phänomenen weiter auszubilden» (cfr. Einleitung, v. 1, p. XIV). L’intento di aprire una breccia in una sterile tradizione di insegnamento radicata a tutti i livelli dell’istruzione è particolarmente evidente nel momento in cui Boettcher menziona gli insegnanti in formazione quale interlocutore privilegiato del suo discorso grammaticale. Il confronto di Boettcher con la sconfinata bibliografia dedicata al tedesco contemporaneo avviene pertanto in maniera sotterranea. Le fonti esplicitamente citate dall’autore si riducono a un elenco minimalista di testi visti come esemplari, per gli scopi via via specificati: la terza edizione della Schülerduden-Grammatik, a cura di Peter Gallmann e Horst Sitta (1990), come orientamento grammaticale di base; i due volumi del Grundriss der deutschen Grammatik (1986) di Peter Eisenberg in quanto principale stimolo teorico; il Grammatisches Varieté: oder Die Kunst und das Vergnügen, deutsche Sätze zu bilden (1991) di Judith Macheiner, per il dilettevole approccio alla descrizione grammaticale; il saggio Funktionaler Grammatikunterricht. Tempus, Genus, Modus: Wozu wurde das erfunden? (1983) di Wilhelm Köller come esempio pionieristico di modello didattico che colloca in primo piano la funzionalità cognitiva e comunicativa delle strutture grammaticali; infine il volume Bundesdeutsch – Lyrik zur Sache Grammatik (1974), a cura di Rudolf Otto Wiemer, per la messe di stimolante materiale per la riflessione sulla lingua (cfr. Einleitung, v. 1, p. XV). Nonostante l’intento dichiarato di non lasciarsi coinvolgere nel dibattito teorico (o forse proprio per tale motivo), Boettcher lascia trapelare il suo schieramento fondamentale nel momento in cui menziona Eisenberg, linguista noto agli addetti ai lavori non solo come autore del citato Grundriß der deutschen Grammatik, manuale assai diffuso nelle università di lingua tedesca, ma anche per la lunga collaborazione alla DudenGrammatik, collaborazione che risale alla quinta edizione (1995), realizzata sotto la direzione di Günther Drosdowski. A partire dall’edizione successiva (1998), il nome di Peter Eisenberg viene associato alla grammatica Duden, l’opera di riferimento standard 509 per gli usi del tedesco, in quanto suo principale curatore. Altro indizio utile a collocare la grammatica di Boettcher nei solchi della grammaticografia classica è il riferimento, contenuto nel suo elenco minimo, alla SchülerdudenGrammatik di Gallmann & Sitta. Nell’insieme, l’impianto teorico della grammatica di Boettcher non può essere considerato fortemente innovativo. L’omaggio di Boettcher alla grammaticografia tradizionale sfiora il compiacimento provocativo nella suddivisione della materia, ricalcante la progressione tipica degli insegnamenti scolastici: analisi grammaticale, analisi logica e analisi del periodo. Con la limitazione dell’analisi alla dimensione parola, frase semplice e frase complessa, la grammatica di Boettcher evita, in controtendenza rispetto all’orientamento generale, la menzione esplicita della dimensione testo. Il riconoscimento della nuova prospettiva degli studi grammaticali risalente agli anni Sessanta-Settanta si realizza nella grammatica Duden a partire dalla sua quinta edizione, che introduce una descrizione del livello testo nel capitolo conclusivo della sezione intitolata alla frase (Vom Wort und Satz zum Text – ein Aus510 blick, Duden, 19955, p. 802ss.). Nell’ultima edizione, uscita in coincidenza con l’opera di Boettcher (Duden, 20098), la più nota grammatica del tedesco contemporaneo dà credito ad altre tendenze recenti degli studi grammaticali, inquadrando i due grandi capitoli tradizionali (Das Wort e Der Satz) tra i due capitoli finali, dedicati alla grammatica del testo (Der Text) e della lingua parlata (Gesprochene Sprache), e i due introduttivi, intitolati rispettivamente Phonem und Graphem e Intonation: nel primo si illustrano le differenze tra lingua parlata e lingua scritta, introducendo i cardini della questione ortografica; il secondo è dedicato alla dimensione prosodica del tedesco. In contrasto con la tendenza ecumenica della grammatica Duden, Boettcher rende chiaro il suo oggetto, enunciando ad esempio l’esclusione della lingua dell’oralità: la sua grammatica, realizzando un punto di vista pragmatico e funzionale sulla lingua, si orienta con decisione verso la ricezione del testo scritto. La chiara circoscrizione della materia giova sicuramente alla comprensibilità dell’oggetto: Boettcher decide di ricalcare, tendenzialmente, i solchi di una consolidata tradizione spinto evidentemente dalla volontà pedagogica di riallacciarsi a ciò che i giovani conoscono e sono in grado di riconoscere. Le sue scelte non sono di certo frutto di carente informazione o determinazione critica. Al contrario, Boettcher, laddove lo ritiene necessario, non manca di discostarsi da percorsi terminologici e concettuali tracciati altrove. Valgano per tutti due esempi: il suo concetto di «frase estesa» (erweiterter Satz) e il criterio ordinativo delle classi di parola declinabili di decisa impronta pragmatica, dal quale consegue la precedenza data al verbo. La massima novità del manuale di Boettcher è rinvenibile peraltro nella modalità di presentazione degli argomenti grammaticali. Come già accennato, Grammatik verstehen punta a una descrizione delle strutture della lingua e della funzionalità delle strutture da cui se ne evincano, oltre che le regole, la duttilità e la potenzialità espressiva. Nel perseguire tale scopo, Grammatik verstehen presenta i fenomeni grammaticali non tramite mere definizioni ed esempi, bensì problematizzando la terminologia e illustrando i paradigmi sullo sfondo di casi limite. Innovativo è il registro colloquiale, non tecnico, scherzoso, il ricorso continuo a esempi che mostrano la creatività, non già la restrittività, della norma. Un solo esempio: nel capitolo dedicato ai relativi si propone come lettura stimolante per la riflessione grammaticale la lirica del poeta contemporaneo Peter K. Kirchhof, che fa un utilizzo ridondante delle parole der/die/das, giocando con omografie, diverse funzionalità sintattiche e possibili ambiguità semantiche: der der der zeit sein zeichen einbrannte / der der das mittelmäßige zum maß aller dinge erhob / der der die das fürchten lehrte / die die die köpfe dafür hinhielten / die die der verführung erlagen / die die das geschäft dabei machten / die die das gar nicht gewußt haben / das das das alles ermöglichte / das das die als entschuldigung bringen (v. 1, p. 86). Nella grammatica di Boettcher gli esempi letterari sono moltissimi, come particolarmente copiosa è la presenza di battute, freddure, barzellette. L’intento è chiaro: delectare et prodesse. Gli esempi scelti sono spesso comici, dunque allettanti per lo studio, per uno studio finalizzato alla comprensione di casi “abnormi” da vari punti di vista, ma sempre utili a definire le norme. Particolarmente inso511 lite e interessanti, in questo senso, si rivelano l’ottica contrastiva e quella diacronica. La prima serve a mettere in luce le similarità e le alterità del tedesco nel confronto con altre lingue europee, mentre la prospettiva diacronica è funzionale a comprendere alcune caratteristiche del tedesco contemporaneo, in base al principio secondo cui «l’infrazione alla regola di oggi serve ad annunciare la regola di domani» (Einleitung, v. 1, p. XIV). In conclusione: la grammatica didattica di Boettcher non è certamente l’unica grammatica didattica del tedesco in lingua tedesca esistente sul mercato editoriale. È sicuramente una grammatica che ripensa la metodologia didattica dalle fondamenta e dal cuore, ponendosi dalla parte degli discenti e con uno sguardo particolare per gli studenti dei programmi di formazione per gli insegnanti, ai quali spetterà il testimone della tradizione e la responsabilità di rendere attraente una disciplina essenziale per lo sviluppo del pensiero critico nelle generazioni future. La grammatica di Boettcher è particolarmente adatta per la didattica universitaria, anche perché specificamente articolata 512 in modo da poter essere utilizzata come testo di riferimento: utili consigli per la strutturazione di un corso intensivo bisettimanale sono contenuti nel manualetto Grammatik-Führerschein, a cura dell’autore stesso, scaricabile dal sito della casa editrice Niemeyer (www.niemeyer.de/boettchergrammatik). L’orientamento generale dell’opera, la scelta degli argomenti e dei testi esemplificativi, la semplicità dell’esposizione e il tono leggero rendono il lavoro uno strumento didattico e di studio di sicura efficacia. A chi si occupa di grammatica non solo per l’insegnamento, ma anche dal punto di vista scientifico, dispiace non trovare riferimenti e commenti espliciti alle fonti teoriche, anche se, da docenti, si trova condivisibile e lodevole il principio che motiva tale decisione. Altrettanto comprensibile, dal punto di vista didattico, è la scelta di porre i commenti in appendice, in cui si trovano elencati con riferimento al capitolo e al paragrafo di riferimento. Da una parte ciò ne rende un po’ macchinoso, dunque fastidioso, il rinvenimento. D’altra parte, proprio questo fa sì che gli studenti non siano spinti dalla lettura immediata del commento autorevole ad assimilare acritica- tolare degli insegnamenti di Linguistik des Deutschen als Fremdsprache presso lo Herder-Institut dell’Università di Lipsia, e Maria Thurmair, docente di Deutsch als Fremdsprachenphilologie all’Istituto di Germanistica dell’Università di Regensburg, propone la descrizione esemplare, compiuta su base empirica, di un ampio spettro di generi testuali rappresentativi della nostra epoca, caratterizzata da un grande dinamismo nell’esprimere nuove forme comunicative. Come segnalano gli autori nella prima parte del volume, la Textsortenlinguistik, corrente di studi linguistici che si occupa di teoria e analisi dei generi testuali, ha prodotto, dalla metà degli anni Settanta a oggi, una grande quantità di riflessioni, al fine di elaborare un metodo generale per la Marina Foschi Albert classificazione dei testi. Il dibattito tipologico ha seguito le oscillazioni teoriche degli studi Christian Fandrych, Maria linguistici in generale e della linThurmair, Textsorten im Deutschen. guistica testuale in particolare, Linguistische Analysen aus sprachdi- proponendo diverse procedure daktischer Sicht, Tübingen, Stauf- di definizione delle Textsorten, fenburg (Linguistik, v. 57), 2011, sulla scorta di modelli fondati su pp. 380, € 49,50. criteri via via grammaticali, tematici e interni al testo, oppure Il volume, redatto a quattro prevalentemente pragmatici e mani da Christian Fandrych, ti- funzionali o ancora, nelle tenmente interpretazioni preconfezionate del fenomeno osservato. Un’ultima annotazione: la grammatica di Boettcher è pensata evidentemente per un pubblico di studenti e docenti di madrelingua tedesca, ma può essere utilizzata con profitto anche per la didattica universitaria del tedesco in ambito DaF. In particolare, in Italia potrà servire egregiamente ai suoi scopi anche e soprattutto in vista dell’attuazione della legge che delega in toto la formazione degli insegnanti ai nostri corsi di studio. In generale, l’esigenza da cui prende le mosse l’opera di Boettcher, riassunta nell’invito a conferire piena dignità umanistica all’insegnamento grammaticale, può ben valere anche nella nostra realtà istituzionale. 513 denze più recenti, cognitivi o culturali. Nei suoi esiti attuali, il dibattito teorico-metodologico sembra riconoscere, in ambito di analisi dei generi testuali, l’inevitabile primato dell’empiria. Salvo rare eccezioni, il fenomeno testo è visto come combinazione di caratteristiche varie e non sussumibili in tipologie consistenti; le Textsorten, raggruppamenti ideali di testi dalle caratteristiche omogenee, sono a loro volta considerate combinazioni, ancorché tipiche, di fattori situativi e tratti funzionali e strutturali molteplici. Nella ricerca applicata, il termine Textsorte viene per lo più associato a definizioni autorevoli (ad esempio Brinker 1985; Adamzik 1995; Heinemann 2000), capaci di riassumere e conciliare diversi orientamenti. Ogni proposta classificatoria sembra poter contribuire all’analisi empirica come tertium comparationis; di contro, criteri tassonomici efficaci e generalizzabili appaiono provenire solo dall’osservazione diretta della realtà testuale. Se tale è il bilancio degli studi teorici, di segno opposto lo stato dell’arte. Come sottolineano a ragione gli autori, la ricerca linguistica, a lungo e intensivamente impegnata sul versante teorico-metodologico e 514 nella definizione degli strumenti, ha in parte trascurato l’indagine vera e propria. Considerando l’enorme quantità e varietà di forme comunicative esistenti, non stupisce constatare come il contributo alla conoscenza dei generi testuali, esito dei non moltissimi studi, tendenzialmente incentrati su aspetti privilegiati di testualità e spesso in relazione a un’unica Textsorte, sia tutt’altro che imponente. Dato tale contesto, la descrizione del ricco ventaglio di generi testuali contenuta nel volume in oggetto, empiricamente fondata e derivante da un percorso analitico ad ampio raggio, riesce a colmare un’importante lacuna. L’opera di Fandrych e Thurmair si articola in tre capitoli di diseguale formato: il primo capitolo annovera circa venti pagine, presentando in breve, allo scopo di chiarire la posizione teorica e la scelta di metodo, il complesso stato degli studi di linguistica testuale. L’estrema sinteticità con cui vi si affronta la questione teorico-metodologica non offusca affatto la limpida trattazione degli argomenti. Analoga meritoria coincidenza di sintesi e chiarezza presenta l’ultimo capitolo, che riassume in circa quindici pa- gine gli esiti dell’indagine, illustrando possibili vie per la prosecuzione delle ricerche. Spicca, in questo contesto, l’originale proposta di derivarne una descrizione dei fenomeni grammaticali che includa in modo strutturato e sistematico i parametri della situazione comunicativa e della funzione testuale, ciò che gli autori definiscono una textsortenbezogene Grammatik. Il capitolo centrale, comprendente circa 300 pagine, coincide con la presentazione delle dimensioni principali e delle caratteristiche rilevanti di venti generi testuali altamente diffusi nell’attualità. Il lungo capitolo è suddiviso in venti sezioni articolate, di ampiezza congrua con le singole esigenze descrittive, vale a dire da cinque a venti pagine, a seconda della maggiore o minore convenzionalità e prevedibilità strutturale del genere analizzato. Ogni sezione è intitolata a un diverso genere testuale, identificato, a seconda del caso, mediante la denominazione d’uso quotidiana (es. Horoskope), una denominazione documentata e non ancora standardizzata (es. Vorstellungstexte) o mediante un neologismo adatto a cogliere il minimo comune denominatore tra testi tipologicamente affini (es. sprachspielerische Kurzformen). La selezione dei generi deriva dall’intenzione di raccogliere casi significativi da vari punti di vista, per esempio la situazione comunicativa, l’universo di appartenenza, la funzionalità, l’ambito di diffusione, la medialità o attualità. Si trovano così a essere rappresentati generi quotidiani, specialistici e istituzionali, generi d’uso e generi letterari, generi informativi, persuasivi ed espressivi, generi convenzionali o emergenti. Di seguito l’elenco completo: Vorstellungstexte (autopresentazioni), Reiseführer (guide di viaggio), Audioguides (audio guide), Lexikonartikel (voci lessicografiche), Leserbriefe (lettere dei lettori), Diskussionsforen (forum di discussione), Studienbewertungen (valutazioni di corsi di studio), Wetterberichte (bollettini metereologici), Horoskope (oroscopi), Bedienungsanleitungen (istruzioni per l’uso), Ordnungen (ordinamenti), Arztfragebogen (moduli medici), Beschwerden (rimostranze), Anzeigen (annunci), Beratungstexte (testi di consulenza), Tagebücher (diari), Chats (chat), Kondolenztexte (testi di condoglianze), Glückwunschtexte (testi di auguri), sprachspielerische Kurzformen (brevi testi ludici). 515 La descrizione del genere segue ogni volta lo stesso percorso. Si inizia con la determinazione della situazione comunicativa (autore, destinatario, ambito comunicativo) e della forma di realizzazione (medialità; tendenziale oralità o scritturalità; grado di reciprocità e simultaneità comunicativa), per poi passare a definire la funzione dominante e altre funzioni tipiche del genere, sulla base di un modello euristico originale che prevede le seguenti voci principali: wissensbezogene Texte (testi conoscitivi); handlungsbeeinflussende und handlungspräformierende Texte (testi persuasivi e di consulenza); espressiv-soziale, sinnsuchende Texte (testi espressivi e speculativi). Ogni descrizione procede con la caratterizzazione della struttura formale e tematica del genere, nonché dei suoi mezzi espressivi peculiari sul piano grammaticale, lessicale e stilistico, per poi concludersi con riflessioni concernenti il livello di intertestualità e il rapporto tra genere e prototipo, prestando attenzione a generi affini e alle varianti emergenti. Ogni indagine si configura anche ex negativo, in ragione di tre intenzionali e dichiarate rinunce. A livello operativo non vi 516 è pretesa di raccogliere e descrivere con esattezza corpora ingenti. A livello procedurale si evita di riprodurre il layout originale dei testi e di trattarne la configurazione complessiva. L’ultima rinuncia si compie a livello di sintesi, con la messa in luce di elementi di testualità ‘altri’ rispetto a quelli tipici del genere in questione e la conseguente rinuncia a un modello di classificazione hard dei generi testuali. Questi tre limiti, consapevolmente imposti allo loro opera, documentano la lucidità e il buon senso con cui gli autori hanno affrontato e realizzato l’ambizioso progetto, arrivando a una classificazione attendibile e non restrittiva del dinamico universo testuale dell’era digitale. Le singole descrizioni, qui e là veloci o approssimative per evidenti ragioni di spazio, offrono ciascuna un valido contributo a un risultato complessivo solidamente fondato, sicuramente importante ai fini della discussione metodologica, tanto più interessante, dato il nuovo vigore degli studi testologici, di recente mostrato anche in ambito di didattica delle lingue. La linguistica dei generi testuali può insomma contare, grazie all’opera di Fandrych e Thurmair, su un panorama a tutto tondo dell’odierna, mutevole realtà delle tipologie comunicative in lingua tedesca. Un esito di questo tipo non interessa solo gli studi e la didattica monolingui. La grande quantità di materiale descrittivo relativo a generi in gran parte ancora inediti è di sicura utilità per gli insegnamenti DaF e per l’analisi contrastiva dei generi testuali. In Italia, dove la linguistica del testo e dei generi, in gran parte operante con scopi e obiettivi didattici, è stata a sua volta protagonista negli ultimi anni di una forte crescita di interesse (Hepp 2009), il volume in oggetto costituirà una lettura e un punto di riferimento utile per tutti i docenti e studiosi di linguistica tedesca, uno strumento indispensabile per chi si occupa di testi tedeschi in prospettiva contrastiva-comparativa e per l’insegnamento universitario del tedesco L2. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, L’arte del tradurre, a cura di Eduardo Simeone, Napoli, Edizioni Sparton, 2012, pp. 75, € 14.* Il contributo di WilamowitzMoellendorff Was ist Übersetzen? apparve come Vorwort all’edizione dell’Ippolito euripideo, fu ripubblicato dieci anni dopo come saggio in Reden und Vorträge (Was heisst Übersetzen?) e ancora una volta nel 1924 con il titolo di Die Kunst der Übersetzung. Esso rappresenta un momento chiave nel dibattito sulla Übersetzungstheorie che prese avvio in Germania alla fine del Settecento contemporaneamente alla pubblicazione della traduzione di Omero di Johann Heinrich Voß (1751–1826) e che attualmente si trova al centro di un rinnovato interesse.1 Per la prima volta è stato tradotto in italiano e presentato al pubblico questo opuscolo di Wilamowitz. Il volume è curato da Eduardo Simeone e si articola in Premessa, Introduzione, Traduzione, Marina Foschi Albert la traduzione del Nachruf auf Wi- * Questo breve contributo è dedicato alla memoria di Martin Harbsmaier, collega di studi e di dottorato allo Institut für Klassische Philologie della Humboldt-Universität. 1 Mi riferisco ai lavori del Sonderforschungsbereich 644 Transformation der Antike e, in particolare, al Teilprojekt Übersetzung der Antike; vd. su W. Kitzbichler–Lubitz–Mindt, Theorie, pp. 196-207; Kitzbichler–Lubitz–Mindt, Dokumente. 517 lamowitz di Rudolf Pfeiffer in Appendice e un Indice dei nomi. Nelle note alla traduzione sono presenti anche le ‘varianti’ testuali. La prima domanda da porsi è che senso abbia per il lettore moderno (e italiano) accostarsi oggi a questo testo di Wilamowitz. Simeone ne offre con cognizione le risposte nell’introduzione tratteggiando la biografia di Wilamowitz, contestualizzandone storicamente l’opera e portando in Italia risultati di ricerche d’Oltralpe. Che cos’è la traduzione (di un testo classico) per Wilamowitz? È un’operazione di trasformazione linguistica2 che può essere portata a termine solo da chi dispone delle competenze linguistiche e storiche necessarie a comprendere l’opera (Verstandesarbeit): «Die Übersetzung eines griechischen Gedichtes kann nur ein Philologe machen». In tale asserto è contenuta una presa di posizione molto importante, in quanto rappresenta la risposta ad August Boeckh, secondo cui la traduzione non appartiene all’ambito di competenze del filologo. La traduzione, tuttavia, non si riduce a un mero intervento filologico, bensì abbisogna di sensibilità e di intuizione poetica. Superata la prima ammirazione nel leggere gli esempi di traduzione in greco e in latino offerti da Wilamowitz (e da Simeone tradotti e commentati) si capisce appieno che cosa questi intendesse con il lavoro di comprensione: non solo ovviamente percepire l’esatto significato delle parole, ma anche e soprattutto lo stile, il metro e le forme. Sul piano formale Wilamowitz postula una Wirkungsäquivalenz, vale a dire tradurre in tedesco nella lingua, nel metro e nello stile dei ‘classici’ tedeschi, in primis Goethe, cosicché ne risulti una traduzione fortemente zielsprachenorientiert. Di tale comprensione – e resa in tedesco, in greco o in latino, la lingua non importa – gli esempi migliori sono le traduzioni in greco delle poesie Über allen Wilamowitz - Moellendorff, Was ist Übersetzung?: «Jede rechte Übersetzung ist Travestie. Noch schärfer gesprochen, es bleibt die Seele, aber sie wechselt den Leib: die wahre Übersetzung ist Metempsychose». Sul concetto di Travestie e Metempsychose si vedano Lubitz 2008, per quanto riguarda la posizione dei contemporanei tedeschi (Rudolf Borchardt e il circolo di intellettuali che si radunò intorno a Stefan George) KitzbichlerLubitz-Mindt, Theorie der Übersetzung antiker Literatur in Deutschland seit 1800, Berlin 2009, pp. 209-220 e per l’Italia le critiche di Giovanni Pascoli. 2 518 Gipfeln e Immer und überall di Goethe con cui W. mostra e spiega a chi traduce cosa significhi calarsi nel mondo di un determinato testo e più di ogni altra cosa come trasmetterlo. Leggendo il testo di Wilamowitz si è spinti a meditare sul peso delle Stilübungen nella pratica della traduzione, vale a dire il tipico esercizio di (ri)traduzione in greco o in latino in uso nelle università tedesche, ma abolito sia nella scuola secondaria sia nelle università italiane. Il fine della traduzione non è unico, ma molteplice: essa deve permettere a ciascuno di attingere ai valori di cui i testi classici sono portatori, e porsi quindi come tramite fra il testo e il pubblico. Chi traduce è di conseguenza investito di un compito civile inteso a ridare nuova vita ai moralische Werte presenti nei classici. La traduzione di Simeone dell’opuscolo di Wilamowitz e del Nachruf è scorrevole e piana. L’unico aspetto negativo è costituito dagli errori di stampa, che, seppur limitati in genere alla lingua tedesca, non inficiano certo la validità del lavoro di Simeone, ma disturbano l’occhio del lettore che conosce il tedesco. Concludendo, la lettura del testo di Simeone si rivela inte- ressante e utile sia per il classicista che per il germanista. Essa oltre ad offrire uno spaccato di storia (tedesca) della filologia classica potrebbe invitare a un dibattito interdisciplinare sulla Übersetzungstheorie – ad oggi ancora marginale in Italia – che coinvolgerebbe classicisti, italianisti e germanisti. Pierluigi Leone Gatti Letteratura e geografia. Atlanti, modelli, letture, a cura di Francesco Fiorentino e Carla Solivetti, Macerata, Quodlibet, 2012, pp. 240, € 18,70. Letteratura e geografia sono state sempre rubricate come due discipline separate, incomunicabili e tradizionalmente distinte come settori lontani. Se però si esce dalle rigide griglie disciplinari, non solo si scoprono molti punti di contatto tra i due ambiti, ma ci si accorge di quanto il reciproco scambio tra le due possa rivelarsi particolarmente proficuo e illuminante. Se da un lato la letteratura può attingere al ricco serbatoio di conoscenze della geografia, d’altro lato la geografia può estrarre materiale 519 prezioso dalla miniera dell’immaginario letterario. A ben vedere poi i due settori costituiscono anche due facce della stessa medaglia: il testo letterario è infatti sempre anche un luogo di memoria del vissuto, e il luogo è in qualche modo sempre anche un testo da attraversare con lo sguardo (da leggere). Da questi presupposti muove il volume Letteratura e geografia, uscito recentemente per le edizioni Quodlibet, a cura di Francesco Fiorentino e Carla Solivetti. Il libro costituisce un importante contributo in direzione di un nuovo approccio della critica letteraria, non solo germanistica, perché lo spazio diventa il principio organizzatore delle correnti letterarie. Del resto il germanista Francesco Fiorentino è co-curatore (con Giovanni Sampaolo) di una importante opera Atlante della letteratura tedesca, mentre la slavista Carla Solivetti lavora da tempo sulla letteratura di viaggio e sul motivo topografico del giardino nella poetica russa. Ma questo volume ha una doppia ambizione: se da un lato vuole lavorare sullo spazio utopico di confine tra geografia e letteratura, dall’altro intende smontare la presunta differenza di luoghi classici di 520 oriente e occidente, di Est e Ovest, ribadendo la necessaria rinegoziazione delle identità culturali. Il libro, che raccoglie le comunicazioni proposte al convegno internazionale «Geografia e letteratura» (9-10 gennaio 2011) presso il Dipartimento di Letterature comparate di Roma Tre, presenta un nuovo “paradigma spaziale” rispetto a quella dominante temporale di stampo crociano che ha segnato la riflessione della modernità. Il sottotitolo del volume Atlanti, modelli, letture svela gli strumenti e le categorie proprie del nuovo orientamento critico: un assunto teorico che riconosce nella letteratura anche un medium di produzione della spazio. Se, infatti, per tradizione il nostro approccio alle scienze umane era improntato su un modello temporale, su una impostazione scandita lungo un tracciato storico, si è verificata negli ultimi tempi un’“inversione di rotta”, che ha portato in primo piano la geografia come paradigma critico-letterario e lo spazio come concetto chiave per la sua analisi. Certo – come sottolineano Fiorentino e Solivetti nella loro illuminante introduzione – a fare da cassa di risonanza a questo processo è stato senz’altro il successo dei Cultural Studies, che hanno riportato all’attenzione la strettissima connessione e implicazione tra una determinata opera d’arte e il paesaggio culturale di appartenenza, tra un prodotto intellettuale e lo sfondo geografico che lo sottende, tra un canone artistico e lo spazio in cui si è formato. L’oggetto letterario partecipa alla delineazione di topografie geopolitiche e geoculturali, e comunque prende una posizione spaziale, oltre che storica. Sulla stessa scia, e sempre in risposta a stimoli culturali di provenienza statunitense, si è affermato un “ritorno dello spazio” (per dirla con Karl Schlögel), ovvero una ridefinizione delle proporzioni geopolitiche e leggi culturali d’Europa. La fine della guerra fredda e della contrapposizione tra i due blocchi, e il fenomeno di globalizzazione che ne è scaturito, hanno determinato cambiamenti profondi delle topografie geopolitiche, culturali e mentali, rivelando i limiti di una visione “occidentalistica” della cultura. Merito indiscusso dello spatial turn è stato quello di invitare a una lettura topografica, capace di «accogliere le varie temporalità che si danno contemporaneamente in uno spa- zio», di mettere in relazione i Raumgenosse di quello che Bloch a ragione chiamava il Multiversum. Questa nuova lettura “topografica”, in linea con l’era digitale e globalizzata, richiede una rielaborazione di ordini di esistenza possibili e propone una geografia immaginaria mutevole, che interferisce con quella politica ed economica. Come da una sovrapposizione cartografica di differenti piani del mondo, affiora il panorama di un universo policentrico, dalla fisionomia sfumata. Di qui una continua ridefinizione dei confini, che – in virtù delle continue contaminazioni e incroci ‘meticci’ tra discipline, progettazioni e letture – diventano grazie all’immaginario “liquidi”, frastagliati, mobili. Una prospettiva, questa della fluidità nazionale, tanto più auspicabile e felice in un periodo di rivendicazioni feroci, tragiche e idiote di identità culturali insignificanti, di rinascite di nazionalismi, di chiusure nel medesimo e di sospetto per l’altro. Usando una nota immagine tratta dalle Ricerche filosofiche di Ludwig Wittgenstein si potrebbe pensare alla geografia come a «una vecchia città»: «Un dedalo di strade e di piazze e di case vecchie e nuove, e di case 521 con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade diritte e regolari, e case uniformi» (par. 18). In questo vasto orizzonte di stimoli e suggerimenti muovono i diversi contributi raccolti da Fiorentino e Solivetti nel volume Letteratura e geografia, seguendo percorsi impervi e battendo sentieri nuovi. Ad aprire i lavori sono il saggio di Fiorentino sulla geo-storia della letteratura e sulla definizione delle questioni topografiche, e quello di Gabriele Pedullà che – anche lui co-curatore di un epocale Atlante – segue la “via italiana” e analizza il concetto (warburgiano) di Atlas in una genealogia di lungo periodo delle storie letterarie italiane. Di stampo più prettamente teoretico sono gli interventi della semiologa Isabella Pezzini, così come di Iain Chambers e di Dario Gentili, volti a una definizione di alcuni motivi chiave nella costellazione spaziale. Diversi e ricchi sono i contributi sulla letteratura slava; da Uspenskij a Rita Giuliani, da Laura Piccolo a Lena Szilad e Virolajnev, per non dimenticare il contributo della curatrice Carla Solivetti, dedicato alla cartografia delle Anime morte. 522 Grazie a questo bel volume, il binomio letteratura e geografia dimostra di collocarsi in un punto cruciale: al centro di un transito, di un import-export tra la pluralità delle culture e le molteplici memorie e provenienze. Micaela Latini Marie Luise Wandruszka, Ingeborg Bachmanns “ganze Gerechtigkeit”, Wien, Passagen Verlag, 2011, pp. 157. Ingeborg Bachmanns “ganze Gerechtigkeit” di Maria Luisa Wandruszka è un libro importante e nuovo sotto diversi aspetti, per la nuova luce che gettano soprattutto sull’ultima produzione bachmanniana che, come scrive l’autrice proprio nelle conclusioni, fa rimpiangere una volta di più la fine precoce di una scrittrice che stava probabilmente imboccando una strada estetica veramente nuova. Questo libro si potrebbe anche rinominare Estetica del paria. Altre donne, donne altre. Wandruszka – in un serrato dialogo non solo con i testi di Bachmann ma anche con quelli di molte autrici del pensiero e della scrittura femminile del Novecento (Hannah Arendt, Marguerite Duras, Virginia Woolf, Simone Weil) – cerca di determinare un perimetro estetico che Bachmann traccia proprio misurandosi con questi modelli, indicando un percorso di etica e dello scrivere che la porterà a rivisitare un autore come Hofmannsthal, lo Hofmannsthal capace di ritrarre le voci e gli aspetti più autentici della società viennese, con una forma di ironico “affetto”. Wandruszka rileva innanzitutto un elemento scaturito dalla ricezione bachmanniana di Hannah Arendt, in particolare del saggio sul “paria” come figura chiave della condizione ebraica, ma anche femminile. Rahel Varnhagen dalla sua ambizione di parvenu giunge alla consapevolezza di essere e restare comunque un “paria”, ma proprio da questa cognizione trae forza di scrittura e acutezza di sguardo critico sulla realtà. La condizione di paria è acquisita, già nel caso di Rahel, nella posizione di subalternità nei confronti degli uomini, in particolare degli uomini amati. Parimenti determinante è in Bachmann la condizione delle donne non emancipate, eppure forti di una consapevolezza propria, da una logica-altra che le protegge. Le sue Wienerinnen si muovono, leggere nonostante tutto, negli Schauplätze duri e violenti dei romanzi e dei racconti bachmanniani. Wandruszka riconosce in esse una paradossale possibilità di affrancamento dalla violenza maschile e dai modelli di cui esse sono anche vittime. Rovescia così ogni cliché di pensiero, sia maschile sia femminile. La conquista di questa consapevolezza è un fatto di lunga durata, e Wandruska ne segue le tappe. Usando una categoria mutuata dai post-colonial studies, sotto il titolo Mimikry Wandruszka identifica il valore e/o il senso di una “Männermaske”, per il modo di esprimersi delle donne. Osserva Wandruszka a proposito del primo grande successo narrativo di Bachmann, Das dreißigste Jahr: «Die Helden der darin enthaltenen Erzählungen sind überwiegend Männer, so als ob die Autorin, wenn sie über die “Sprache” (Alles), die Kränkungen im gesellschaftlichen Leben (Das dreißigste Jahr), die “Wahrheit” (Ein Wildermuth), den politisch kommunikativen 523 Engpass Wien, zehn Jahre nach dem Krieg (Unter Mördern und Irren) reflektiert, dies nur unter Männermaske könnte». Una nuova, eccentrica rilevanza assumono le figure di donne non intellettuali, via via che Bachmann approfondisce la sua vocazione di scrittrice, soprattutto in prosa. La loro situazione è paradossale: sono vittime della propria subalternità familiare, ma ricompongono comportamenti e fantasie nel segno del rimprovero, dell’odio, della fantasia di uccisione del marito, e nello stesso tempo il dolore per la perdita dei mariti, nel momento della loro morte (violenta o non violenta che fosse). Osserva giustamente Wandruszka come questa situazione fosse tipica degli anni Cinquanta. Di donne rimaste sole durante la guerra, che si ritrovano, ricacciate nei loro antichi ruoli al ritorno dei mariti dal fronte – e quale fronte. Puntuale è la rilevazione compiuta da Wandruszka sul linguaggio di queste donne, cercando di distinguere un’identità linguistica al di là della «männliche Tarnkappe». Già in questa fase c’è la presenza di donne che, come osserva Charlotte, con le loro 524 “Plaudereien”, con la loro attitudine alla chiacchiera quasi in forma di ghirigoro viennese, sarebbero arrivate ad acquisire, nel sistema dei personaggi bachmanniani, a nuova dignità, ma solo nell’opera tarda. Bachmann intuisce dunque già nelle prose giovanili, come nel Trentesimo anno, alcuni personaggi femminili che nell’opera tarda prenderanno forma più consapevole, dopo il suo “Tremendum” – la crisi personale ed estetica che l’avrebbe portata alla quasi totale rinuncia alla poesia per metter mano alla sua “grande incompiuta”, il Todesartenprojekt. Wandruszka identifica, nella poesia Böhmen liegt am Meer, il zugrunde gehen come voluta morte sociale. Ne è segno e figura poetica l’identificazione con i boemi. Questa denominazione etnica, insieme alla determinazione geografica della Boemia, pur persistendo nel lessico storico, è del tutto zugrunde gegangen negli ordinamenti politici contemporanei, e gode di una leggendaria identità letteraria grazie alle allusioni shakespeariane che rimandano al Winter tale. Identificarsi col vagante, con la gente del porto e della navigazione, con le donne da marcia- piede e con gli uomini di strada assume in sé la vis sovversiva di chi sceglie consapevolmente la marginalità, la vita e le istanze del paria. In questo modo l’esperienza più personale, il dolore psichico, diventa strumento per smascherare la legge scandalosa che regola quella che Robert Altman, scrive acutamente Wandruszka, ha chiamato «l’Arena» – il circo mediatico, sociale, editoriale cui ciascuno viene esposto, ogni volta che “si espone”. Wandruszka osserva come solo dopo la sua «schlechteste Zeit» – il tempo della crisi con Max Frisch 1962-64 – Bachmann riesca a rendere «tutta la giustizia dovuta» alle sue figure femminili. L’osservazione, e anche l’irritazione di Wandruszka, è puntata sulla posizione di Bachmann «prima del suo Tremendum», che resta affascinata, come molti, dall’estetica della sofferenza, per cui, come icasticamente stabilito da Kafka, la buona letteratura è sempre quella che ci procura dolore e ci rende infelici. Inversamente proporzionale alla sua reale infelicità relazionale e psichica, la penna di scrittrice di Ingeborg Bachmann insegue, con intermittenze e contraddizioni, una situazione di “felicità”. In questo senso è paradigmatica la ricezione del Buon Dio di Manhattan. Viene paragonato da molti a Hiroshima mon amour di Alain Resnais/Marguerite Duras, entrambe impegnate in una radicale rappresentazione dell’amore femminile che finisce tragicamente nel destino di distruzione dell’amore, nella morte tragica dell’amante tedesco. Wandruszka osserva con grande intelligenza critica, con un’incursione niente affatto biografistica nella biografia di Ingeborg Bachmann, le reazioni degli uomini di riferimento per la scrittrice (riferimento amoroso non meno che estetico). Paul Celan le telegrafa: «DAS HOERSPIEL IST SO SCHOEN UND WAHR UND SCHOEN DU WEISST ES JA DAS HELLE UND HELLSTE INGEBORG ICH DEN AN DICH IMMER». Max Frisch trae da quell’occasione lo spunto per contattarla, con le note conseguenze (nefaste per la scrittrice austriaca). L’unico a rispondere con qualche perplessità, nonostante tutta l’ammirazione, è Hans Werner Henze – forse l’unico uomo che con tutti i limiti della loro relazione, l’abbia voluta «vedere e capire» nella sua 525 complessità di donna-artista con un diritto alla giusta felicità. Le scrive infatti: «Ausserdem hat mich der Gute Gott der eichhoernchen sehr beeindruckt, zum sterben schön. Du bist großartig, und ich will, daß du auch glücklich und wunderbar und strahlend und tüchtig und ein engel bist» [corsivi miei, C.M.]. La bellezza estetica viene avvertita dall’amico Hans Werner Henze come minaccia alla felicità della donna Ingeborg Bachmann. Gli amanti Paul Celan e Max Frisch sono attratti proprio dalla «unbedingte, notwendig tragische weibliche Liebe». Con l’aggravante – per Frisch –, come scrive Wandruszka, che egli vede nella protagonista del radiodramma un’autorappresentazione della scrittrice, cosa che per Celan, almeno, non entrava in questione. Ma – osserva ancora Wandruszka – un punto distingue le due protagoniste rispettivamente di Hiroshima mon amour e Il buon dio di Manhattan: la protagonista del film è attanagliata dalla «Unmöglichkeit, nicht zu vergessen, Hiroshima und die Liebe», mentre nel radiodramma bachmanniano il «Vergessen» è una delle possibilità del superamento del dolore, 526 ancorché momentanea, e comunque riservata solo agli uomini. Il radiodramma di Bachmann è allegorico, mentre il film/script di Duras Resnais è legato a una ricerca di concretezza nel reale. La scrittura allegorizzante, per esempio quella di Undine, che decide di “andare via” – permette alla stessa Bachmann di reinterpretare non solo il ruolo della scrittura, ma il suo stesso ruolo nell’«arena». Quell’arena mediatica, editoriale, della nascente industria culturale europea che l’aveva trasformata in icona – un fenomeno che nel volgere di quegli anni coinvolgeva altre artiste sovresposte – pensiamo a Maria Callas, ma anche mutatis mutandis, a Marilyn Monroe. Il motto di Celan, la poésie ne impose plus, elle s’expose, assume nel caso di Bachmann, e in generale delle donne artiste, una piega sinistra e mortale, non disgiunta dalla componente di “scherno” che la stessa “arena” riserva loro non appena escano dal cerchio magico descritto dall’aura del loro “personaggio”, della loro “maschera” – per lo più costruita a immagine del desiderio maschile e dei media. E così Marie Luise Wandruszka segue con attenzione il per- corso che comincia con la splendida poetessa universalmente riconosciuta, letteralmente travestita da Ondina-sirena alla prima del balletto Undine, accanto a un forse preoccupato Henze. Non a caso la serata cade nel 1958, agli albori della sua relazione distruttiva con Max Frisch. Qui Bachmann interpreta fino in fondo la sovrapposizione tra aspettative dell’arena (che si sovrappongono con le aspettative dell’uomo – carnefice, in questo caso non certo Henze ma Frisch, anche se il nome invocato ed evocato nel racconto di Undine è... Hans). Nelle figure di identificazione, vere e allegoriche a un tempo, di due “donne-altre”, Gaspara Stampa e della Tosca di Puccini (interpretata da Callas), Bachmann trova una strada per andare oltre alcuni cliché femminili. Lo fa soprattutto nelle poesie “private” ora pubblicate in Non conosco mondo migliore (traduzione italiana di Silvia Bortoli, per i tipi di Guanda, Parma 2004). Entrambe, osserva Wandruszka, sono costruite intorno alla figura dell’ “odio” nei confronti dell’uomo carnefice, rispettivamente l’uomo amato e ingrato che abbandona la poetessa veneziana – Collalto Collatino , e il terribile Scarpia, lascivo e crudele carnefice dell’amato pittore Mario Cavaradossi. La prima capace di “superare”, dimenticare il male, la seconda in grado di perdonare (ma solo “di fronte a Dio”, e dopo avere consumato la sua vendetta). Il motto di Gaspara Stampa, «Vivere ardendo e non sentire il male», viene interpretato e tradotto a suo modo da Bachmann. Il male non è «Schmerz» (dolore) ma «das Böse» (il male come sostantivo assoluto). La questione del male e del perdono – osserva acutamente Wandruska – è, negli anni di Bachmann, al centro della riflessione di un’altra “sorella” in spirito, Hannah Arendt, che nella sua trattazione sulla banalità del male e la sua esplorazione delle soluzioni per superarlo, anche nella memoria e nella coscienza ferita delle vittime, individua un unico rimedio all’Odio: la punizione (Strafe): «Se non siamo in grado di perdonare, non ci resta che punire». Anche Bachmann, in molte poesie, porta in giudizio i suoi imputati. E va oltre la stessa Arendt: riesce a “ent-tabuisieren” l’odio e vendicarsi, da un lato, e a rappresentare la corresponsabilità “Mit-verantwortung” della “vittima” femminile. 527 La strada di una vivibilità del sé «tra pazzi e assassini» è – per esempio – in modo paragonabile a certe scelte di Virginia Woolf – rinunciare a un Io unitario, e disaggregarsi, in diverse funzioni psichiche. Anche in questo caso la lettura di Wandruszka è molto acuta, nel differenziare diverse modalità, modulazioni della disgregazione dell’io. Con una differenza importante: nella narrazione di Woolf in To the Lighthouse la Signora Ramsay è animata da un amore che la porta alla dispersione del sé ma non all’autodistruzione, cosa che accade invece alla protagonista di Malina. L’amore, nella Bachmann di Malina, è legato indissolubilmente alla distruzione, secondo categorie di pensiero che Wandruszka individua come tipicamente maschili. Ma la tarda Bachmann, ed è questo il punto d’arrivo sorprendente del libro di Marie Luise Wandruszka, conosce anche un altro modo di “zugrunde gehen” – che non è “andare a fondo” (come in Malina, come per Franza, e come per la protagonista parabiografica del viaggio in Sudan del Wüstenbuch). Zugrundegehen, già nella poesia di svolta Böhmen liegt am Meer, non 528 è solo andare a fondo, ma andare fino in fondo. E dunque oltre i confini della Boemia geografica, molto lontana dal mare, e procedere fino in fondo, fino al mare. O ancora, come Wandruszka osserva, richiamando Meister Eckhart, un «Auf-den-Grundkommen», alla comprensione del fondo, del fondamento delle cose. È dunque “un segno di forza”: «Quando si vede il mondo senza se stessi, lo si vede meglio» – sono parole di Bachmann a Erich Fried, proprio a proposito della sua poesia “boema”. La via alternativa significa per Bachmann un recupero di modelli “di fondo” della sua stessa identità, in un recupero dell’eredità letteraria austriaca. Per esempio una ripresa di modulazioni hofmannsthaliane, nell’esplorazione del microcosmo della società viennese, dei suoi idioletti, e del linguaggio, della particolare libertà delle donne; soprattutto delle donne in conversazione, donne non emancipate, sottovalutate dagli intellettuali uomini, e dalle stesse scrittrici donne: «Frauen, die auch existieren, waehrend ich mich beschaftige mit den Kontroversen, den Ideen, den Maennern also, die sie haben, in diesen letzen Jahrzehnten». Bachmann pare rendersi conto, nella ricostruzione di Marie Luise Wandruszka, di quanto la sua scrittura si fosse alimentata esclusivamente dal confronto e dall’osservazione delle idee degli uomini. Questa maschera euristica, linguistica e intellettuale, che Bachmann indossa per tutti gli anni Cinquanta e poco oltre, fino al suo Tremendum, veniva compensata con una serie di espedienti performativi: i gesti, l’abbigliamento, gli atteggiamenti iperfemminilizzati, di fragilità e seduzione. In questo libro Wandruska, dopo anni di attenta lettura e confronto con i testi della scrittrice austriaca, ci mette a parte come di una personale agnizione estetica e critica: riesce a trovare in questa aporia il suo senso di “irritazione” verso certi testi, che pare così finalmente spiegato e dispiegato. Le viennesi bachmanniane, invece, non si misurano con gli uomini e trovano in modo molto naturale una misura in se stesse. Per questo sono libere, con ironia, con una vena anzi comica, riconosciuta come carattere originario viennese, con tanto di pedigree che arriva a Bachmann dalle scene primo novecentesche di Hofmannsthal-Strauss. E così se Undine sparisce tra le acque, per la viennese si prospetta un tranquillo e pacificato sonno – che non confina con la morte né col suicidio. La dormiente Beatrix è anche una disperata, però la Bachmann non le fissa un destino tragico. Ingeborg Bachmann, negli anni Cinquanta discesa agli inferi italiani, in molti sensi, cercando altrove una sua via verso le “frasi vere” – da esplorare nelle zone buie del paese del sole, sembra ritrovare nella scrittura in prosa degli ultimissimi tempi della sua vita la via di un ritorno in un luogo abitabile per le istanze femminili. La ricostruzione di Marie Luise Wandruszka ha un doppio valore. Indica una resa dei conti con se stessa di una studiosa che riesce a fare il punto del proprio interesse e delle proprie idiosincrasie nei confronti dell’oggetto della propria ricerca di decenni, e con un approccio in cui essa stessa si mette in gioco come soggetto-lettore, anzi lettrice, riesce a costruire una argomentazione condivisa. A quarant’anni dalla morte della scrittrice appena quarantasettenne ci fa sentire tutta la nostalgia per quei libri non ancora 529 scritti che avrebbero contribuito alla fondazione di una scrittura femminile oltre la mimikry mascolina, rovesciando il mito della felicità, indicando una strada che passa per una consapevolezza della differenza, e rifonda l’idea del male, ma anche della felicità. Camilla Miglio Natascia Barrale, Le traduzioni di narrativa tedesca durante il fascismo, Roma, Carocci, 2012, pp. 307, € 30. Il volume si inserisce all’interno di quel fruttuoso ambito interdisciplinare di studi dedicati ai processi di ingresso in Italia delle letterature straniere, al ruolo dei mediatori culturali e alle relative politiche editoriali. Nello specifico della ricezione della letteratura tedesca, sono da menzionare i lavori di Mario Rubino, Lucia Giusti e Michele Sisto, citati dall’autrice nello stato dell’arte da cui prende le mosse la sua analisi. Nell’introduzione Barrale chiarisce le premesse teoriche del suo studio: da un lato il concetto di «campo letterario» elaborato dal sociologo e filosofo francese 530 Pierre Bourdieu, con cui si intende quel sistema che comprende in sé tutti gli agenti e tutte le istituzioni, con le loro forze reciproche, coinvolti in un dato contesto storico-sociale nella produzione simbolica e materiale delle opere; dall’altro le teorie sulla traduzione esposte, a partire dai primi anni Settanta del secolo scorso, dai Translation Studies, che invitano a leggere la traduzione come «riscrittura» del testo originale scaturita sia dalle scelte individuali del traduttore, col suo patrimonio socialmente condiviso di norme linguisticoculturali, sia da condizionamenti extralinguistici operanti dall’esterno, ovvero sul piano politico-ideologico. In quanto portatrice di modelli e valori provenienti da un contesto “altro”, nonché risultato di una serie di «operazioni sociali» (scelte traduttive, collocazione editoriale, modalità di presentazione ai lettori), ogni traduzione non può che influenzare il campo letterario e, in senso più generale, il «polisistema» socio-culturale d’arrivo (Even-Zohar), introducendo in esso elementi che consolidano o, come accade più spesso, destabilizzano il canone vigente. Ne deriva che l’accogli- mento o il rifiuto, la canonizzazione o meno di un testo straniero siano sempre regolati, sebbene in forme diverse, dall’insieme dei «centri di potere», ovvero delle «persone e istituzioni» (Lefevere) in grado di favorire o ostacolare la diffusione delle opere attraverso il controllo su traduttori, critici e revisori editoriali. Muovendo dalle premesse teoriche esposte, l’autrice si sofferma nel primo capitolo sull’analisi del panorama editoriale italiano in epoca fascista e ricostruisce, sulla filigrana di un’ampia e ragionata bibliografia, le relazioni fra editori e regime. A partire dagli anni immediatamente successivi alla Prima guerra mondiale l’editoria italiana registra un notevole sviluppo, sia per effetto della crescente alfabetizzazione, che dà vita a un largo ed eterogeneo pubblico di lettori avidi d’azione e d’avventura, sia sull’onda della crescente curiosità per le altre culture, incentivata dal rilievo dato alla politica estera. La fiacchezza e il provincialismo del campo letterario italiano, ancora dominato in larga parte da modelli estetici e tematici tradizionali, determina l’apertura – prima di piccoli ma coraggiosi editori come Carabba, Morreale, Slavia, poi di grandi quali Treves, Bemporad e Mondadori – alla letteratura straniera contemporanea, complice l’acuto e lungimirante lavoro di mediazione culturale di una nuova leva di intellettuali attenti alle novità internazionali. La nascita di numerose collane dedicate alle traduzioni è inoltre affiancata dall’attività delle riviste letterarie – tra cui «900», «Solaria», «I libri del giorno» – su cui si sviluppa un vivace dibattito che investe, tra l’altro, anche la prassi traduttiva. La contesa tra i sostenitori dell’apertura alle opere straniere e i suoi oppositori – questi ultimi accaniti assertori del pericolo di un’invasione a danno della letteratura nazionale – si inscrive a sua volta, con l’affermarsi del fascismo, all’interno del confronto sempre più serrato degli editori con il «campo del potere». Se in un primo momento il regime sembra incline all’internazionalismo culturale, in quanto funzionale a supportare la promettente economia delle traduzioni e a veicolare un’immagine liberale di sé, a partire dalla metà degli anni Trenta, con i mutati equilibri politici e in conseguenza della sempre più stretta alleanza con la 531 Germania hitleriana, esso attua una progressiva campagna per l’autarchia culturale e la messa al bando degli autori ebrei. Nascono così organismi preposti allo stretto monitoraggio dell’attività editoriale, quali il MINCULPOP e la Commissione per la bonifica libraria. Consapevoli dei temi sgraditi – innanzitutto quelli di natura politico-ideologica – editori e traduttori si vedono costretti a ricorrere in misura sempre maggiore alla pratica anticipata dell’autocensura, consistente nella modifica o nell’eliminazione dai testi, già in sede traduttiva, degli elementi potenzialmente scomodi. In questo quadro si collocano anche le dinamiche di ingresso in Italia, a partire dagli anni Venti, della letteratura tedesca, a cui Barrale dedica il secondo capitolo del suo studio. È grazie all’intraprendente lavoro di mediazione culturale di intellettuali giuliani come Ervino Pocar, Alberto Spaini ed Enrico Rocca, nonché di Lavinia Mazzucchetti, che il pubblico italiano conosce ora in larga diffusione un inedito repertorio di testi, non più limitato, come invece accadeva nell’anteguerra, prevalentemente alle opere classico-romantiche, 532 circolanti peraltro entro ambiti ristretti e specialistici. Qualche esempio: a inaugurare la collana “Narratori nordici”, ideata e diretta da Mazzucchetti per Sperling & Kupfer, è nel 1929 Disordine e dolore precoce (Unordnung und frühes Leid, 1926) di Thomas Mann; l’anno dopo nella serie “Scrittori di tutto il mondo”, fondata dalla casa editrice Modernissima, appare la traduzione di Spaini del romanzo Berlin Alexanderplatz di Döblin. Autori come Hofmannsthal, Rilke, Feuchtwanger, Schnitzler, Heinrich Mann, Stefan Zweig, Kafka, Joseph Roth, Hesse sono l’occasione per sprovincializzare il clima letterario italiano. Particolare attenzione è dedicata da Barrale, sulla scorta delle fonti critiche, alla ricezione della Neue Sachlichkeit, affermatasi nella Germania del primo dopoguerra come reazione al soggettivismo espressionista. Caratterizzati da un taglio realistico attento al quotidiano sociale e politico, da un impianto narrativo snello e da una scrittura forgiata sui procedimenti della fotografia e del cinema, le opere della Nuova Oggettività aprono «un’accattivante finestra sulla realtà tedesca dell’epoca» (p. 69), rispondendo all’interesse dei lettori italiani per la documentazione. Accanto al romanzo di guerra di natura pacifista à la Remarque giunge in Italia il romanzo metropolitano con protagonista la Berlino degli anni Venti, incandescente e disumanizzante caleidoscopio di una modernità lontana dal tradizionale immaginario degli italiani, fino ad allora abituati a pensare la Germania nei termini angusti dell’ordine e della disciplina. Un ulteriore spaccato della società tedesca è d’altronde veicolato nei romanzi di Vicki Baum, in voga tra le lettrici, catturate dal modello di emancipazione offerto dalla «neue Frau», la donna economicamente autonoma e libera nei costumi sessuali, sebbene sottoposta alle brutture della vita. Facendo riferimento a numerosi pareri di lettura stilati al fine di decidere la pubblicazione o meno dei testi, Barrale entra poi con competenza nel merito dei criteri operanti nella prassi traduttiva e nella norma censoria del tempo, mettendo in evidenza il ruolo fondamentale svolto dagli autori di quei pareri, impegnati ogni volta in una trattativa “dietro le quinte” con la stessa casa editrice. Nel cuore del suo studio, costituito dai successivi tre capi- toli, l’autrice focalizza la propria attenzione sul momento concreto della traduzione, ripercorrendo le vicende editoriali di tre opere pubblicate da Mondadori, esempi dei filoni tematici sopra menzionati. Si tratta del romanzo al femminile Elena Willfüer, studentessa in chimica (Stud. chem. Helene Willfüer, 1928) di Vicki Baum, tradotto da Barbara Allason e pubblicato nel 1932 nella collana “I romanzi della Palma”; del romanzo di guerra La questione del sergente Grischa (Der Streit um den Sergeanten Grischa, 1927) di Arnold Zweig, che apre nel 1930, con la traduzione di Enrico Burich, la collana “I romanzi di guerra”; del romanzo metropolitano E adesso, pover’uomo? (Kleiner Mann - was nun?, 1932) di Hans Fallada, edito nel 1933 con la traduzione di Bruno Revel nella prestigiosa collana “Medusa”, all’interno della sezione tedesca diretta da Mazzucchetti. Attraverso un sistema di tabelle che all’originale tedesco affianca sia una traduzione letterale “di servizio” ad opera della stessa Barrale sia la versione edita da Mondadori, l’autrice propone un interessante e accurato strumento di analisi filologica, volto a ravvisare le trasformazioni subite dai 533 testi in sede traduttiva, con le conseguenti perdite di natura stilistica o narrativa rispetto all’originale, nonché a formulare «ipotesi sulle tendenze e sulle peculiarità della prassi traduttoria del tempo» (p. 30). Dall’analisi emerge come gli interventi attuati siano di natura diversa, così come le ragioni che li hanno determinati. A essere eliminati, corretti, stemperati o addomesticati sono innanzitutto, come esplicita di volta in volta il puntuale commento, tutti gli episodi le cui tematiche contravvengono all’ideologia fascista – e si tratta proprio, nota Barrale, di tutti quegli elementi che hanno determinato il successo delle opere in Germania fino all’avvento del nazismo. Nel romanzo di Vicki Baum, incentrato sulla vicenda di una studentessa in cerca di affermazione professionale, scompaiono o vengono alterati, per esempio, i passi inerenti ai tentativi di aborto e di suicidio della protagonista, in quanto contrari all’ideale femminile casalingo e materno propugnato dal fascismo, così come quelli riguardanti i diritti delle donne, la libertà sessuale, la malattia e l’eutanasia. Se l’Avvertimento che precede il testo di E adesso, pover’uomo? è pensato per 534 rassicurare i lettori italiani (e con loro la censura) circa le inclinazioni politiche non sospette – ovvero estranee al comunismo – del protagonista, impiegato piccoloborghese nella Berlino della crisi economica, gli interventi in sede traduttoria si avvicinano per tipologia a quelli operati sul testo di Baum oppure rivelano l’intenzione di ingentilire le espressioni più audaci e dirette della prosa di Fallada. Può stupire il fatto che i tagli apportati alla Questione del sergente Grischa – storia di un prigioniero russo condannato ingiustamente a morte per una contesa di potere sorta all’interno della burocrazia militare tedesca – siano imputabili solo occasionalmente a motivi politico-ideologici, innanzitutto all’esplicita condanna, contenuta nell’originale, della guerra con le sue atrocità. Accanto alle rimozioni scaturite dall’esigenza autocensoria, Barrale individua infatti nelle opere prese in considerazione numerose modifiche stilistico-formali riconducibili a ragioni diverse, tra cui la volontà di chiarimento o semplificazione di fronte al lettore italiano e nel caso dell’«omissione ingiustificata di ampie porzioni di testo» (p. 125), perlopiù di natura descrittiva, l’intento di ridurre la mole dell’opera. Giudicato inadatto a una traduzione integrale a causa della sua complessa costruzione concentrica, il romanzo di Zweig giunge infatti in Italia ridotto di un quarto. Come avverte Barrale nelle conclusioni del suo apprezzabile lavoro, non sempre è possibile pervenire a un giudizio univoco circa la natura delle alterazioni presenti nelle traduzioni esaminate, anche perché alcune trasformazioni sembrano poter essere imputate unicamente all’«approssimativa elasticità della prassi traduttoria contemporanea» (p. 124). Ragioni di censura, scelte editoriali e decisioni individuali del traduttore si intrecciano come fattori che concorrono nel processo traduttivo dell’epoca. Daniela Nelva Maria Grazia Nicolosi, Il sonnambulismo scenico. Teatro e drammaturgia in Hermann Broch, Pisa, Edizioni Il Campano – Arnus University Books, 2013, pp. 210, € 16. Le opere teatrali sembrano occupare, nella produzione di Hermann Broch, una posizione marginale. L’autore stesso le considerava con un giudizio incerto, o addirittura severamente critico, ed esse appaiono piuttosto neglette, sia dalla critica, sia dall’esercizio teatrale. Nell’ampia letteratura dedicata a Broch non manca, com’è ovvio, qualche articolo dedicato ai suoi testi drammatici, così come non sono mancati i palcoscenici che hanno provato a proporli al pubblico. Un ruolo non secondario è stato svolto, in questo senso, anche dalla cultura italiana: tra i non molti contributi critici dedicati a queste opere si trovano infatti gli interventi di Claudio Magris e di Roberto Rizzo, fatti in occasione della traduzione delle pièces di Broch (a cura dello stesso Rizzo); e tra le rappresentazioni teatrali spicca, per il prestigio della regia e del luogo, la messa in scena al Piccolo della commedia Aus der Luft gegriffen (nel cartellone italiano con il titolo Inventato di sana pianta) a opera di Ronconi nel 2007. Tuttavia, per quanto è dato di sapere, non vi era stata finora, né in Italia, né all’estero, alcuna trattazione sistematica di questa parte dell’opera di Broch. Questa lacuna è ora colmata da Maria Grazia Nicolosi che, dopo essersi 535 occupata già in altre occasioni perseguire tra le altre cose un sedell’autore austriaco, vi ha recen- condo obiettivo, porre cioè in ritemente dedicato un’esauriente lievo «l’estrema coerenza monografia. Frutto di un pe- ideologica dell’autore, riconduriodo di ricerca a Vienna, finan- cendo l’essenza della scrittura ziato dallo «Österreichischer drammatica al fulcro del penAustauschdienst», il libro prende siero brochiano» (p. 11). Coerenin considerazione, accanto ai testi temente ai propositi esposti in presenti nella Kommentierte Werk- apertura, la monografia si artiausgabe curata da Paul Michael cola in quattro capitoli, dedicati Lützeler, alcune corrispondenze ai quattro testi teatrali presi in inedite e altri materiali presenti in considerazione. Si comincia con archivi della capitale austriaca, l’analisi del frammento Kommenpresentandosi come un’analisi at- tar zu Hamlet, risalente al 1918, tenta e dettagliata di questa pro- per proseguire con l’ampio capiduzione letteraria. tolo dedicato al dramma Die EntLo scopo che l’autrice si è sühnung (1932), passando quindi proposta consiste nel «mostrare a indagare la già ricordata comil significato che il teatro assume media Aus der Luft gegriffen (1934), nella poetica di Hermann Broch, per concludersi infine con uno al fine di restituire il giusto rilievo studio sulla farsa Es bleibt alles letterario a opere tenute da sem- beim Alten (1934). pre in scarsa considerazione». Si La riflessione metateatrale tratta insomma di capire se la de- offerta dall’autore con il framfinizione di «Epiker auf Abwe- mento Kommentar zu Hamlet, in gen» (così Bernd Gallop), con cui i personaggi di Amleto e cui la critica ha provato a descri- Ofelia intrecciano un dialogo dai vere la situazione in cui si trova toni per molti versi saggistici, Broch là dove prova a cimentarsi costituisce per Nicolosi l’occacon la scrittura teatrale, sia giu- sione per porre sul tappeto alstificata o meno. A tal fine Nico- cune questioni destinate a losi si affida opportunamente ripresentarsi con le opere sucall’analisi testuale, lasciando “par- cessive. Dall’analisi puntuale lare le pièces” e ricostruendo il delle pagine del frammento contesto che ne accompagnò la emerge infatti un’apertura a genesi e la ricezione, in modo da spunti vari e difformi che carat536 terizza per molti versi, pur nella varietà dei generi teatrali sperimentati negli anni seguenti, l’intera opera teatrale di Broch. Nell’avvicendarsi di toni spontanei e riflessivi, il testo finisce inoltre per apparire come «una piacevole divagazione, un allettante diversivo, che contrasta con la sobrietà talvolta grave della produzione saggistica del periodo» (p. 35) e che non di meno affronta le medesime questioni. Fin da qui, la dimensione teatrale viene allora letta da Nicolosi come il luogo in cui sarebbe stato possibile all’autore veicolare in forme più facilmente accessibili la critica sociale e culturale che sta a fondamento della sua opera saggistica e narrativa. Un intento simile deve aver animato Broch quando, nel 1932, compone il dramma Die Entsühnung, che verrà rappresentato per la prima volta il 15 marzo 1934 allo Schauspielhaus di Zurigo. Si tratta senza dubbio del testo più ambizioso tra quelli che Broch compose per le scene, e l’analisi che Nicolosi vi dedica occupa una posizione in ogni senso centrale nella monografia. Forse proprio la ricchezza dei materiali presi in esame e la necessità di tracciare un contesto storico-biografico assai movimentato (si pensi a quel che succede, nel mondo di lingua tedesca, tra le due date qui ricordate), finiscono talvolta per rendere poco immediata la ricostruzione critica qui offerta: in particolare, trattandosi di un’opera poco nota, sarebbe stato a mio avviso più efficace partire da un’analisi del testo, per passare soltanto in un secondo momento a una ricostruzione del contesto che, muovendo dal piano biografico, procede lungo molteplici direzioni, seguendo l’incerta fortuna del dramma sulle scene di lingua tedesca, confrontando quindi il testo con le premesse teoriche formulate nel saggio Erneuerung des Theaters? (originariamente comparso nel libretto di sala della Uraufführung), e collocandolo nel clima culturale improntato alla Neue Sachlichkeit (p. 59ss.), all’interno di un’epoca che, all’indomani dell’epocale crisi economica, è dominata dal cinismo (e qui Nicolosi, come in altri punti del libro, trova nella Kritik der zynischen Vernunft di Peter Sloterdijk un importante riferimento per la lettura di quella stagione culturale tedesca). Al di là di questa notazione, che riguarda soprattutto la dispositio del 537 discorso critico, all’autrice riesce comunque il non facile compito di offrire un esame dettagliato e tuttavia non dispersivo di un’opera estremamente complessa, caratterizzata da un andamento rapsodico e da un numero assai consistente di personaggi. Ciò è reso possibile incardinando l’analisi del testo attorno ad alcuni motivi portanti come «Politica e denaro» (pp. 68-83), «Violenza» (pp. 83-93) e «Amore» (pp. 93-101). Nella lettura di Nicolosi il dramma, nel succedersi apparentemente caotico dei quadri, fornisce multiforme rappresentazione dello stesso fenomeno che è al centro dell’opera saggistica e narrativa di Broch, e cioè del disfacimento dei valori e delle sue conseguenze sulla condizione umana, là dove le dramatis personae appaiono private di qualsiasi autonomia, ridotte a comparse in un mondo disperato, in cui soltanto l’elemento femminile (per esempio nel personaggio della vecchia signora Filsmann) sembrerebbe lasciare intravedere una qualche, seppur vaga, prospettiva di redenzione (pp. 100-101). Più agile diviene l’analisi nei successivi capitoli, in conformità ai toni più lievi delle opere prese 538 in esame. La commedia Aus der Luft gegriffen oder die Geschäfte des Baron Laborde (1934) appare fin dalla genesi – dettata anche da una malriposta speranza di guadagni economici – un testo meno ambizioso del precedente. Pure, come rileva l’autrice, l’azione teatrale, qui concentrata attorno a un numero minore di personaggi, e incardinata attorno alla figura dell’impostore, non rinnega in alcun modo le istanze critiche che animano l’intera opera di Broch, offrendo una rappresentazione del «potere demoniaco del denaro» a tal punto «brillante» che, secondo l’autrice, sembrerebbe quasi ammiccare «con ostentazione sospetta all’immoralità della speculazione borsistica» (p. 121). All’interno di questo capitolo si segnala inoltre la riflessione sugli echi mitologici e sui significati archetipici che, nella cultura novecentesca, sono stati associati alla figura dello Hochstapler. In una sorta di digressione – di notevole spessore critico, sebbene piuttosto isolata rispetto ai procedimenti interpretativi altrimenti applicati in questo studio – vengono infatti rilevati i tratti mercuriali del protagonista, letto alla luce di una tradizione teorica che si diparte da Carl Gustav Jung. L’opera teatrale di Broch sembra svilupparsi, nel suo complesso, come una sorta di anticlimax: i toni si fanno ancor più leggeri nel terzo testo teatrale che Broch scrive in quegli anni, la farsa Es bleibt alles beim Alten. In questo testo, rimasto inedito fino alla recente edizione critica, Nicolosi riconosce «un componimento simile per molti versi al Kommentar zu Hamlet» (p. 193), e senza dubbio il peso che al suo interno assume il teatro nel teatro (la recita organizzata da alcuni personaggi serve a fare emergere una realtà altrimenti nascosta) non può che far pensare al ruolo, per molti versi analogo, che un simile espediente teatrale ha nella tragedia di Shakespeare. Nel recupero di parlate dialettali, il testo si manifesta d’altronde anche come estrema propaggine di una tradizione popolare che proprio a Vienna era stata particolarmente vivace nel secolo precedente: un aspetto, questo, che forse avrebbe meritato più attenzione, anche perché avrebbe potuto contribuire a spiegare quella scarsa profondità psicologica delle figure che, come rileva l’autrice, rende «più appropriato parlare di silhouettes, anziché di personaggi» (p. 185). Proprio il carattere evanescente di queste figure consente d’altronde di adombrare anche qui «la dissoluzione della società contemporanea» e le conseguenze di questo processo sull’uomo; anche la comicità tradizionale della farsa viene dunque opportunamente ricondotta da Nicolosi alla critica sociale sviluppata da Broch in altre più ambiziose opere. Appare dunque in tutta la sua evidenza, leggendo questo studio, quel nesso tra l’opera teatrale e il fulcro del pensiero di Broch, che l’autrice si era ripromessa di palesare. Più incerto appare forse l’esito dell’altra questione che veniva posta nelle pagine iniziali, riguardante il rilievo letterario di questi testi all’interno dell’opera di Broch. Accanto all’indubbio interesse tematico che essi possiedono, Nicolosi sembra condividere certe riserve riguardo al loro effettivo significato estetico: se infatti Die Entsühnung viene descritto come un dramma che, «a dispetto di qualche innegabile incongruenza, serba una certa compattezza» (p. 62), in Aus der Luft gegriffen viene ravvisata una «negazione dell’etica» che «conferisce all’insieme una freddezza, che malgrado l’accomodamento 539 conclusivo infastidisce e rattrista» (p. 116), mentre un dialogo di Es bleibt alles beim Alten appare all’autrice privo di ritmo, poiché «non sviluppa in maniera adeguata il potenziale satirico» dell’argomento trattato, finendo addirittura per annoiare: «Ne scaturisce un che di tedioso» (pp. 191-192), sicché a distanza di anni dal primo tentativo sembra mancare «ancora la tecnica drammaturgica» (p. 193). I limiti messi così in evidenza sono certo compensati dall’interesse che questi testi assumono come esemplificazioni di quella crisi che Broch ha tematizzato altrove, ma la questione riguardante il loro valore estetico, la domanda su quale possa essere il loro “giusto rilievo letterario” resta in fondo aperta – come d’altronde è inevitabile che sia. Di certo chi, in futuro, si vorrà cimentare con lo studio della produzione drammaturgica di Broch troverà in questa monografia, per la ricchezza delle informazioni qui raccolte (tra cui va ricordata anche la rassegna completa delle reazioni suscitate nella stampa dalle messe in scena di questi testi), un solido fondamento. Theodor Herzl, Vecchia terra nuova, a cura di Roberta Ascarelli, Collana Quaderni di Traduzione, Arezzo, Bibliotheca Aretina, 2012, pp. 238. Theodor Herzl, Feuilletons 1891-1903, trad., introd. e cura di Giuseppe Farese, Milano, Archinto, 2012, pp. 336. Mentre il secolo XIX sta volgendo al termine, un giornalista viennese animato da sacro fuoco interiore dedica le proprie energie alla “soluzione” della questione ebraica in termini innovatori e non senza provocare lacerazioni intellettuali in seno alla stessa comunità ebraica. È Theodor Herzl, che con il suo entusiastico Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage (Lo Stato ebraico. Tentativo di una moderna soluzione della questione ebraica), edito a Vienna nel 1895 e già noto al pubblico italiano da vari anni (Lo stato ebraico, trad. it. di Tiziana Valenti, Prefazione di Gad Lerner, Il Melangolo, Genova 2003), si batte per la causa sionista investendo in proposito tutte le sue migliori capacità intellettuali, diplomatiche e politiche, facendosi promulgatore dell’idea di lasciare l’Europa Marco Rispoli per “ritornare” in Palestina: un 540 progetto che molti ebrei assimilati suoi ammiratori considerano indecente e inaccettabile. Nell’ultimo biennio, il nome di Herzl è tornato – in Italia – d’autorità, grazie a varie iniziative editoriali: la pubblicazione di due monografie a lui dedicate rispettivamente dallo storico Luigi Compagna (Theodor Herzl. Il Mazzini d’Israele, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011) e dalla germanista Paola Paumgardhen (Theodor Herzl tra letteratura e sionismo, Roma, Bonanno Editore, 2012), e l’uscita di vari contributi incentrati sulla sua figura contenuti nella miscellanea Verso una terra “antica e nuova”. Culture del sionismo (1895-1948) (Roma, Carocci, 2011) e nel fascicolo monografico della rivista «Cultura tedesca» dedicato al tema Sionismo (n. 41, dicembre 2011). Ultime tessere del mosaico sono ora la pubblicazione in italiano dell’unico romanzo di Herzl, Vecchia Terra Nuova, al quale egli ha affidato la propria idea di sionismo, e l’edizione della raccolta Feuilletons, che raduna una ventina di articoli, trascelti fra i settanta usciti dal 1891 al 1903 che nel 1904 lo stesso Herzl, quasi presentendo la propria morte prematura, aveva provveduto a far pubblicare in due volumi (settanta nel primo e trenta nel secondo). Nell’originale il romanzo herzliano, ora per la prima volta disponibile in italiano, reca un titolo ardito, Altneuland, non facile da rendere linguisticamente. Va detto che la soluzione adottata da Roberta Ascarelli appare felice, a fronte del francese Terre ancienne, terre nouvelle (Paris 1931) e dell’inglese The Old New Land (1929). Essa riesce infatti a echeggiare la densità dei piani di discorso del progetto sionista, che – com’è noto – rappresenta un fenomeno antropologico, religioso ed estetico sorretto dalla singolare commistione di antico e nuovo e affonda le sue radici in un terreno culturale complesso. Il legame biblico, filtrato dall’humus determinante della cultura austro-tedesca, si proietta – nella sua fase iniziale – verso un’utopia in cui il sogno nazionale è anche vocazione cosmopolitica, idea di tolleranza, umanesimo, convivenza delle identità culturali, linguistiche e religiose. Il romanzo, che – prima di avere il titolo attuale – era stato provvisoriamente intitolato da Herzl Das neue Zion (La nuova Sion), è dedicato dall’autore “alla memoria” del padre, Jakob, e 541 della sorella, Pauline, spentosi il primo nel 1902 e la seconda, prematuramente, nel 1878. Esso è germinato – sul finire dell’Ottocento e all’inizio del nuovo secolo – in un momento di crisi e di insicurezza profonda, allorché il suo “sogno” sionista sta sfumando e incontrando serie difficoltà, per cui il ritorno alla scrittura gli si offre come una soluzione gratificante e compensatrice: «Le speranze di successo nella sfera pratica» – confessa in una lettera del 14 marzo 1901 – «sono sfumate. Adesso la mia vita non è che un romanzo. Sarà dunque un romanzo la mia vita». Redatto fra il 1899 e il 1902, alcuni anni dopo Lo stato ebraico, sull’onda dei ricordi del suo viaggio in Palestina, Vecchia Terra Nuova è così un testo in cui si direbbe vengano tardivamente a sintetizzarsi e ad armonizzarsi le due “vocazioni” di un intellettuale della vecchia Austria che ha oscillato, sino alla fine, tra la politica e la letteratura. In una scrittura scarna e quasi diaristica, distribuita in sei capitoli (Un giovane colto e disperato – Haifa 1923 – La terra in fiore – Pesach – Gerusalemme – Commiato dell’autore) il romanzo herzliano presenta l’evolversi di un destino, 542 una sorta di itinerario di “formazione” (à la Wilhelm Meister): quello di Friedrich Löwenberg, un giovane viennese «colto e disperato» che, in seguito a una crisi identitaria e alla perdita della fidanzata, s’imbatte in uno scontroso antisociale ostile alla società tecnologica (Kingscourt) in compagnia del quale dapprima trascorre un ventennio su un’isola sperduta e poi scopre la «terra dei padri», che sta vivendo la fase dei primi insediamenti ebraici e una considerevole trasformazione tecnica. Il viaggio in Terrasanta è, per il protagonista, l’occasione per incontrare di nuovo le facce di vecchi conoscenti e toccare con mano la trasformazione avviata – in una Gerusalemme moderna e cosmopolita – dalla Nuova Società, che il suo presidente David Littwak guida lungo i sentieri della tolleranza e dell’assenza di conflittualità fra ebrei e arabi e in cui i non-ebrei sono guardati con benevolenza e hanno eguali diritti. Proprio da Kingscourt (l’osservatore prussiano della trasformazione della Palestina) gli viene detto durante il loro comune viaggio in Terrasanta e sul Mar Rosso che agli ebrei stessi spetta il compito di attuare una ri-ap- propriazione (o neo-creazione) del paradossale novum ch’è insieme un anticum (parole che – commenta Herzl – egli udrà «come in un sogno»): «Si sa già tutto quello che serve per rendere il mondo migliore. E Lei sa chi può mostrare il cammino? Voi! Voi ebrei! Proprio perché ve la passate male. Voi non avete niente da perdere. Voi potete creare in questa terra un laboratorio per l’umanità: là, dove noi eravamo, sull’antica terra crearne una moderna. Una vecchia terra nuova» (p. 41). Domina, in questo scritto herzliano che ha accompagnato la nascita e lo sviluppo di un grande movimento come quello sionista, una tonalità utopica. Le sue pagine hanno il carattere di sogno in prospettiva anticipatrice, di una scommessa proiettata sul futuro, che ne fa davvero «un romanzo del passato per una terra del futuro» (Ascarelli). In esse si respira quella stessa dimensione che ad Herzl aveva fatto porre come esergo a Der Judenstaat la frase «Se volete, questo non è un sogno!», un tema ripreso esattamente nel “Commiato dell’autore” introdotto nel finale di Vecchia terra nuova: «Il sogno non è così diverso dal- l’agire come alcuni credono. Ogni azione degli uomini è stata un sogno, e lo ridiventerà» (p. 211). Il padre del sionismo non vi ragiona certamente ‘in piccolo’. Nel romanzo è infatti trasposto il suo disegno di donare una “patria” agli ebrei, l’audace progetto di immaginare per Gerusalemme il destino di una seconda Roma, «non nella prospettiva patriottica e socialista» – come osserva opportunamente Ascarelli – «di Moses Hess, dal quale è pure profondamente influenzato, ma da fedele suddito dell’impero absburgico che sogna Stati multietnici e tolleranti, accoglienti e sicuri per tutti, la patria dei senza patria evocata da Joseph Roth». Non è stato inopportuno che, nella sua illuminante postfazione, la curatrice abbia anche evocato la controversa ricezione di Altneuland, ricordando che il romanzo suscitò un acceso dibattito a proposito del progetto herzliano. Lo stesso Joseph Roth rimase guardingo in proposito, attento a puntualizzare in che modo ritenesse doversi intendere per l’ebreo moderno il concetto di Heimat: in un suo celebre scritto del 1934, Jedermann ohne Pass (Ciascuno senza passaporto), egli definirà l’idea sionista 543 «un’idea tragica» in quanto sconcertato dinanzi al fatto che un popolo dal cui grembo era «sorto il pensiero dell’unità universale» potesse essere «ora costretto a diventare una misera nazione con una patria», confessando di voler vedere sulla terra «nient’altro che una sola patria: la terra di Dio, Padre di tutti noi, in cui ognuno possa spostarsi o restare senza passaporto o identità, così come gli aggrada o come corrisponde alla sua natura». Tornava dunque nel centro dell’osservatorio il problema del sionismo come «grande sfida della volontà di uomini feriti» mossi dall’«esigenza di una metamorfosi» (Ascarelli): un movimento che – nato come risposta all’antisemitismo crescente della seconda metà dell’Ottocento e al processo di assimilazione degli ebrei nel mondo moderno, costituendo un passaggio decisivo della storia novecentesca – aveva visto un dibattito storiografico notevole nella seconda metà dell’Ottocento e che avrebbe mantenuto la sua ricchezza di implicazioni e conseguenze storiche ancora nell’oggi, dopo aver trovato una risposta sia pure decisiva con la nascita dello stato d’Israele nel 1948. Herzl ha pro544 vato a comporre un quadro armonizzante (di pacificazione), prefigurando (e invocando) una «terra antica e nuova», meravigliosamente giusta, democratica e tollerante che rappresenta – come avverrà in Kafka – “l’ultima spiaggia” per uomini che hanno ingiustamente sofferto, facendo risaltare quel legame tra dolore e redenzione che da sempre contrassegna l’esistenza del popolo ebraico, poiché Herzl «è convinto», scrive la curatrice, che esso «può aspirare a una serena armonia solo perché è stato forgiato dal dolore». Un sogno che, come sappiamo, si è a tutt’oggi realizzato solo in parte. Herzl peraltro è stato affascinato dalla scrittura giornalistica, da quelle pagine culturali che lo resero famoso, come documenta con dovizia di dettagli storico-critici Giuseppe Farese nella bella antologia dei Feuilletons da lui curati. Nell’Introduzione al volume, Farese delinea con parole convincenti il rapporto fra lo Herzl sionista e lo Herzl scrittore (che un celebre critico dell’epoca, Raoul Auernheimer, nella prefazione alla seconda edizione della raccolta, edita nel 1911, considerava come un Anatole France in versione viennese, soprattutto per la brillantezza dello stile, la pacata signorilità filosofica e la raffinata ironia che accompagna i suoi resoconti giornalistici), riferendo a tal proposito un’annotazione del diario del 4 giugno 1902 in cui Herzl presenta quasi un’autovalutazione in merito alle due principali componenti del suo impegno esistenziale: «Io, ad esempio, vengo apprezzato in un campo in cui non ho prodotto quasi nulla di intellettuale, ma ho solo mostrato una media capacità politica, raggiungibile da qualsiasi sensale di cavalli, in una faccenda incomprensibile solo agli stolti… Per quanto riguarda il problema ebraico, sono diventato noto nel mondo come agitatore. Come scrittore, invece, soprattutto come drammaturgo, non valgo nulla, meno di nulla. Mi si prende solo in considerazione come bravo giornalista. Sebbene io sento, so, che sono – o ero – uno scrittore di razza che non ha raggiunto il massimo soltanto perché è stato osteggiato e rifiutato». Si tratta di una meritoria scelta di articoli redatti per la liberale «Neue Freie Presse» di Vienna e radunati secondo otto sezioni tematiche (I bambini – Commedie – Atmosfere viennesi –Immagini inglesi nella nebbia – Libri – Storielle allegre del reporter locale – Viaggi – Racconti filosofici). Vi si possono ritrovare talune peculiarità della prosa herzliana: lo stile elegante, persino ricercato ma privo di auto-compiacimenti, certi tratti ironici, il gusto per il frammento e la concinnitas, in evidente polemica con la narrativa epicizzante praticata da non pochi autori della sua epoca. Lo spiccato senso dell’osservazione conduce il giornalista Herzl a soffermarsi con malinconia mista a pietas – in pagine coinvolgenti e, a volte, commoventi – su situazioni umane e sociali indimenticabili. Come quando, ad esempio, nella Camera dei bambini vuota, egli ritrae un padre di famiglia rimasto solo in casa, immerso in malinconiche meditazioni sulla sua situazione, il quale vedendo improvvisamente rientrare allegramente la frotta dei suoi bambini se li stringe al petto con gioia, perché fortunatamente «la camera dei bambini è ancora piena». O come quando, nella Lite per un’eredità, coinvolge addirittura il compositore Johannes Brahms che, non aspirando affatto a voler cedere i propri beni agli eredi, nel caso in questione se la cava con grande nonchalance lasciando che essi bisticcino fra 545 loro finché vogliono. Per non Sono, nel complesso, framdire poi della situazione descritta menti utili a ricomporre l’immacon divertita suspence nella “farsa gine di un mondo e di una civiltà elegiaca” dal titolo Nel vagone ri- attraversati da forti contraddistorante, in cui un forbito ed ele- zioni e in cui la situazione degli gante passeggero conversa ebrei fa da sismografo per comamabilmente con una bella prin- prendere la società nel suo incipessa, che pare invaghirsi di lui sieme. Nel complesso, i feuilletons e che alla fine insiste per voler herzliani si confermano come conoscere il suo nome, salvo poi «un singolare caleidoscopio» – ad andarsene immediatamente, come li definisce Farese – in cui indignata, appena l’uomo le con- «si compongono e si scomponfida di chiamarsi «Kohn»: uno tra gono le più svariate e complesse i più diffusi cognomi ebraici. E immagini di un tempo per noi per continuare nelle segnalazioni, lontano e tuttavia ancora e semsi potrebbe segnalare almeno fra pre umanamente vicino». L’imi tanti testi – per le Stimmungen re- magine di Herzl che emerge da stituite al lettore – Il mercato di questi testi di gradevole lettura è Brünn, la capitale morava che quella di un acuto osservatore ospita la fortezza dello Spielberg, della vita socio-culturale delcollegato alle immagini racca- l’epoca, soprattutto viennese, ma priccianti delle Mie prigioni di Sil- non solo viennese, e di un’umavio Pellico, «pallido ricordo» di nità che può continuare a parlarci alcuni «avvenimenti funesti della con i suoi problemi e le sue mulstoria», e che col suo mercato e tiformi esperienze. insieme con i suoi impianti industriali di stoffe e di tessuti sa ofGiulio Schiavoni frire echi vibranti della “lotta per l’esistenza”. O, infine, si potrebbero ricordare le atmosfere “di Al di là del testo. Critica letteraria viaggio” così pittorescamente e studio della cultura, a cura di Franrese da Herzl ad esempio nel cesco Fiorentino, Macerata, QuoViaggio a Pest oppure in Domenica dlibet, 2011, pp. 308, € 21,25. di luglio al Prater, tutta giocata – quest’ultima – sul divario tra la «La fine della galassia Gutenvoglia d’evasione e la malinconia. berg ha trasformato profonda546 mente lo status della letteratura, e per chi si occupa di studiarla non sembra che esserci una strada da seguire: quella che porta “al di là del testo”»: così si legge sulla quarta di copertina di questo volume che attraverso quattordici contributi documenta un percorso di studio e confronto culminato in due convegni all’Università di Roma Tre nel 2003 e nel 2008, ai quali hanno partecipato studiosi internazionali di diverse discipline, da Terry Eagleton a Cesare Segre, da Friedrich Kittler a Remo Ceserani e Hans-Thies Lehmann. E non poteva esser detto meglio: la discussione, squisitamente accademica, sui rapporti tra studi letterari e cultural studies ha infatti la sua più profonda ragion d’essere in una questione di «status». In un momento storico in cui la letteratura vede ridursi il suo prestigio sociale fin quasi all’irrilevanza, coloro che la producono e amministrano (scrittori, critici, editori, professori) sono indotti a esplorare nuove vie per rilegittimarla e rilegittimarsi, portando lo sguardo «al di là del testo» e volgendo la propria attenzione al mondo intorno. Che questa sia un’esigenza diffusa è testimoniato, anche in Italia, dal cosiddetto “ritorno alla realtà” della letteratura degli anni zero (v. il n. 57 di «Allegoria» e il successivo dibattito), il cui esito più sintomatico è Gomorra di Saviano. Anche la critica letteraria si sente chiamata a rinegoziare la propria posizione nell’ordinamento dei saperi e dei poteri: e dal momento che per condurre qualsiasi negoziato bisogna avere qualcosa in mano, non può esimersi dal fare i conti con il proprio sapere delegittimato e tornare a chiedersi che cosa sia e a qual fine si studi la letteratura (per riprendere l’ironico titolo dato da Cesare Cases nel 1990 alla sua ultima lezione). Naturalmente ci sono svariati modi di farlo, come mostra una piccola ma significativa pattuglia di libri apparsi, insieme a questo, nel solo 2011. Carla Benedetti, in Disumane lettere, pone la questione nei termini estremi di un’«emergenza di specie»: «In pochi decenni il pianeta andrà incontro a un collasso – a meno che non si inverta la rotta, avvertono gli scienziati. E la cultura umanistica? Che cosa ha da proporre al genere umano in una situazione simile?». Nella sua notevole Teoria del romanzo Guido Mazzoni 547 punta invece sull’imprescindibilità sociale di un genere letterario che si offre come luogo privilegiato dell’auerbachiana «mimesi seria del quotidiano»: «Il romanzo è la più importante tra le arti occidentali, quella che raffigura la totalità della vita o, come è stato detto, l’ammiraglia che la letteratura schiera contro il pensiero sistematico, contro la scienza e contro la filosofia». A metà strada fra il discorso pubblico e quello accademico si colloca invece un gruppo di critici (Giancarlo Alfano, Andrea Cortellessa, Davide Dalmas, Matteo Di Gesù, Stefano Jossa e Domenico Scarpa) che si ripropone di indagare i soggetti, le condizioni, le istituzioni e la praticabilità della critica letteraria in un volume a più mani intitolato espressamente Dove siamo? Altra, e altrettanto interessante, è la strada proposta da Francesco Fiorentino, animatore e curatore di Al di là del testo, che pur mantenendosi nei confini del discorso accademico («Questo volume documenta una riflessione sullo statuto degli studi letterari dopo il cosiddetto cultural turn») non è meno esplicito: «Che lo studio della letteratura possa trasmettere un sapere globale, essendo la letteratura una mathesis, 548 una forma di rappresentazione globale del sapere, è un’idea che – osserva nell’introduzione – oggi non possiamo più condividere senza mentire a noi stessi. Perché ormai sappiamo che la tradizione umanistica che assegnava alla scrittura letteraria un posto di assoluta centralità nell’ordine dei saperi appartiene al passato». Che cosa è accaduto? Le cause della perdita di centralità, che del resto riguarda tutti i saperi umanistici, vanno certo ricercate nelle scelte politiche ed economiche fondamentali degli ultimi trent’anni; ma in questo stesso periodo, mentre gli studi letterari al più resistevano all’assedio, i cultural studies conquistavano i dipartimenti di humanities delle università americane, e di lì quelli di mezzo mondo. Non solo: essi hanno esteso enormemente i propri confini (nel Dizionario degli studi culturali curato da Michele Cometa – www.culturalstudies.it – si individuano ben otto “dominanti” della galassia cultural: storico-concettuale, mass-mediologica, mitico-psichica, politicoantropologica, politico-sessuale, storico-sociale, semiotico-sociale, linguistico-istituzionale) fino a presentarsi come una super-disci- plina con pretese egemoniche: se all’inizio degli anni Novanta i cultural studies erano un sottoinsieme (ibridato e innovativo) degli studi letterari, ora al contrario sono i secondi ad apparire come un sottoinsieme (più o meno rigidamente perimetrato) dei primi. Salvo rare eccezioni, i ‘letterati’ hanno guardato con diffidenza, quando non con disprezzo, ai ‘culturologi’, e solo recentemente, messi di fronte alla loro irrevocabile affermazione – basti pensare alla fortuna di parole chiave quali culture, identity, memory o gender nei programmi finanziati dall’Unione europea e delle università britanniche e tedesche – hanno iniziato a fare i conti con l’ormai ingombrante vicino. Ritradotta nella logica propria del campo accademico la questione del declinante prestigio sociale della letteratura può dunque porsi nei seguenti termini: in che misura la sopravvivenza degli studi letterari verrebbe favorita da una loro confluenza negli studi culturali, ovvero dall’accettazione di una posizione subordinata nell’ambito della super-disciplina dei cultural studies? Non si tratta di salire sul carro del vincitore, quantomeno non in Italia, dove gli studi culturali, sebbene in ascesa, sono ancora giovani e largamente minoritari. Proprio questo stato di relativo equilibrio, anzi, fa sì che in Al di là del testo siano rappresentate sine ira et studio posizioni molto diverse, a testimonianza di una sorprendente ricchezza di orientamenti della germanistica italiana, sulla quale vorrei qui in particolare soffermarmi: si va infatti da una concezione ipertestuale (Fiorentino) ad una prevalentemente etnografica (Cometa) degli studi culturali, dalla teoria dei sistemi di Luhmann (Sampaolo) alla scienza delle opere di Bourdieu (Bontempelli) passando per la proposta di integrazione del new historicism di Greenblatt con il formalismo di Adorno sotto il segno di Benjamin (Crescenzi). Ma che cos’è il cultural turn, sul cui terreno si gioca (anche) la partita della rilegittimazione degli studi letterari? In un’illuminante recensione apparsa su «Social Text» nel 1993 Fredric Jameson ne metteva in luce il carattere ambivalente. Da una parte, osservava, i cultural studies sono il frutto di una motivata insoddisfazione nei confronti di discipline accademiche che escludono dai propri orizzonti fenomeni 549 culturali e movimenti sociali la cui rilevanza si fa via via più evidente. Di qui la definizione che egli ne dà come «la politica culturale dei vari “nuovi movimenti sociali”: antirazzismo, antisessismo, antiomofobia eccetera». Formatisi attraverso una progressiva distinzione da altre discipline – storia della letteratura, sociologia, antropologia, teoria della comunicazione – ma allo stesso tempo mutuandone gli oggetti e i codici, gli studi culturali si sono dati uno statuto «postdisciplinare» e come tali si sono fatti interpreti di esigenze nuove e legittime. L’«imperativo geopolitico» di cui sono portatori, ad esempio, invita a mettere in discussione il campanilismo nazionale (parochialism) radicato negli studi letterari; l’attenzione da essi accordata ai più diversi tipi di prodotti culturali induce a intendere gli stessi testi letterari in modo più disincantato, appunto come prodotti (commodities); il loro costituirsi come zona franca di confronto tra diverse politiche identitarie spinge infine a interrogarsi sul punto d’osservazione da cui viene pronunciato l’atto critico e sulle sue condizioni di possibilità, determinate oltre che dall’etnia, dalla nazionalità, dalla 550 classe, anche dal genere. Dall’altra parte, rilevava Jameson, gettando le loro basi teoriche nel post-strutturalismo e nella decostruzione, i cultural studies rischiano di subordinare l’analisi rigorosa delle strutture economiche, di classe e ideologiche propria del materialismo storico a una concezione della cultura fondamentalmente idealistica, che l’uso cerimoniale di parole chiave alla moda (Buzzwords) quali corpo (body) o potere (power) non vale in alcun modo a riscattare. Gli studi culturali gli apparivano dunque come un «surrogato del marxismo», ovvero una sua riformulazione compatibile con l’orizzonte postmoderno, tra rifiuto della grande teoria (come potenzialmente totalitaria) ed esaltazione carnevalesca (di fatto populistica) di culture plurali concepite come espressione di gruppi specifici. Oggi, a vent’anni di distanza, questa ambivalenza degli studi culturali non è venuta meno, anzi. La pluralità dei loro oggetti e metodi non denuncia come illegittima soltanto la pretesa di centralità dei saperi letterari, ma l’idea stessa che lo studio delle attività umane possa e debba avere un centro (sia esso la filosofia in Hegel, la religione in Tolstoj, la sociologia in Bourdieu). Accade così che la super-disciplina in ascesa verso l’egemonia non abbia una proposta egemonica di organizzazione dello studio della cultura, rischiando così di essere un gigante senza testa. Ciò ha conseguenze tutt’altro irrilevanti sugli studi letterari e sul loro statuto, facendo apparire non priva di rischi una loro eventuale confluenza negli studi culturali. Se tutto è cultura, infatti, che cos’è la letteratura? In che cosa si distingue dalle altre forme di rappresentazione culturale? Qual è – se c’è – il suo statuto specifico? Qual è – se c’è – il modo specifico di studiarla? Come si può giungere – se è lecito – a formulare un giudizio di valore estetico e a costruire un canone? È su questi punti che i contributi del volume si dividono, lasciando scorgere le linee di tensione di un salutare e produttivo contrasto. Michele Cometa, uno dei pionieri degli studi culturali in Italia, ne accetta come fattore indiscutibilmente positivo la moltiplicazione degli oggetti, in Italia già introdotta da Umberto Eco con la semiotica, negando di conseguenza alla letteratura una centralità o specifi- cità. Ciò appare evidente anche nella sua suggestiva proposta di un paradigma italiano per gli studi culturali, centrato su tre «etnologi» del presente – Antonio Gramsci, Ernesto De Martino e Pier Paolo Pasolini – che non lasciano inesplorato «nessun ambito della cultura italiana del Novecento, dai media alla moda, dalla sessualità al folklore, dalle culture giovanili ai residui arcaici nella cultura moderna». La stessa «forma rizomatica» della scrittura da essi praticata, osserva Cometa, può offrire un modello agli studi culturali: i Quaderni del carcere, La fine del mondo e gli Scritti corsari condividono infatti, come anche il Passagen-Werk di Benjamin, un «metodo di lavoro» che passa per «le metariflessioni sul metodo combinatorio degli appunti (la relazione testo-nota-appunti), l’attenzione per i dettagli, l’accettazione della dimensione aforistica [...] della progressività del rapporto teoria-prassi, la pratica infine della Umfunktionierung semantica dei testi portati a testimonianza, delle citazioni». Più radicale ancora è Fiorentino, secondo il quale la perdita di centralità della letteratura è sostanzialmente da ascriversi non a 551 fattori esterni ma allo sviluppo autoriflessivo degli stessi saperi letterari, e va quindi considerata senz’altro un progresso. Dipanando il filo di una densa riflessione che ha i suoi nodi principali in Deleuze e Guattari ma anche nella «ragione cartografica» di Franco Farinelli, propone di prenderne atto accettando lo «statuto debole» degli studi letterari e assecondando il loro travaso (e conseguente diluzione) nel più ampio bacino degli studi culturali, alimentati a loro volta dagli afflussi della psicoanalisi, del diritto, della mediologia, delle neuroscienze, della matematica, ecc., e intesi come «un insieme di pratiche epistemiche variamente intrecciate che costruiscono percorsi conoscitivi diversi nell’ipertesto della cultura». Rinunciando non solo alla loro centralità, ma persino al loro «territorio» specifico, i saperi letterari possono vivere produttivamente la loro «condizione diasporica», col risultato paradossale che, «proprio perché non organizzati intorno a un centro, un oggetto specifico, uno specifico letterario, sono capaci di perpetuarsi, di sopravvivere ai cambiamenti di sistema»: «Così persistono, pur cambiando volto». Questo passaggio episte552 mico dalla gerarchia all’«eterarchia» (il concetto risale a Heinz von Foerster), per cui ogni elemento di un sistema, anche il più periferico, riveste la stessa importanza degli altri, ovvero da una concezione piramidale a una reticolare della cultura, ha un indubbio fascino, e anche una sua forza euristica, come mostra, per esempio, l’«universo policentrico» mappato a cura dello stesso Fiorentino e da Giovanni Sampaolo nell’Atlante della letteratura tedesca (2009). Personalmente non sono insensibile a questo fascino, che, se non sovrainterpreto, deriva dal tentativo anarchico di pensare la letteratura al di fuori di ogni paradigma di potere: abolizione del dominio di un uomo (o testo) su un altro; restituzione a ciascun uomo (o testo) della sua dignità individuale; messa in valore delle interazioni orizzontali tra uomini (o testi); sostituzione della storia (letteraria), che non può che raccontare le trasformazioni del dominio sull’asse del tempo (stabilendo un canone), con l’atlante, che registra su una mappa spaziale l’esistenza di singolarità interconnesse (e non gerarchizzate). Credo che questa sia una concezione della letteratura profondamente generosa e democratica. Ma non riesco a non contrapporle una frase di Cesare Cases che dà voce a una concezione del tutto antitetica – e ‘forte’ – degli studi letterari: «Omnis determinatio est negatio», scrive Cases, «l’uomo si definisce solo scegliendo e scartando»; e aggiunge: «Il rischio di sbagliare c’è sempre, ma è meno grave di quello di perdersi nella melma dell’accettazione universale». Mi chiedo, insomma, se il tentativo di sottrarre gli studi letterari alla dimensione del potere non rischi di lasciare il potere – che è anche potere sulla e della letteratura – libero di riprodursi e imporre la propria visione del mondo attraverso gli apparati editoriali, le terze pagine dei giornali, i programmi ministeriali e le altre agenzie che – quelle sì – continuano a «scegliere» e «scartare» secondo i loro criteri del tutto eteronomi. L’«eterarchia» applicata agli studi letterari potrebbe insomma favorire non tanto la dissoluzione del potere nella letteratura quanto, al contrario, la sua alienazione, e dunque, in ultima istanza, la dissoluzione degli studi letterari. Risolvendosi in «un insieme di pratiche epistemiche varia- mente intrecciate», inoltre, la critica letteraria rinuncerebbe alla critica nel senso etimologico del termine, ovvero alla pretesa e al potere di giudicare le opere sulla base di una gerarchia di valori, di selezionarle, e quindi di produrre un canone. Proprio questo contestava il giovane Cases a Leo Spitzer in un saggio del 1954, I limiti della critica stilistica e i problemi della critica letteraria, che mi sembra colga ancora perfettamente nel segno osservando che la critica stilistica – ma lo stesso vale per gli studi culturali – non è un fenomeno casuale, ma si inserisce «organicamente nella generale crisi dell’oggettivismo» (su cui trionfa il soggettivismo, oggi non più elitario ma democraticamente declinato al plurale), e rilevando con franchezza che «la crisi dell’estetica e della critica letteraria è una crisi ideologica che non può essere risolta dall’introduzione di un nuovo metodo» (né, si potrebbe aggiungere oggi, dal passaggio a un paradigma eterarchico). Allora Cases, contrapponendo Lukács a Spitzer (e a Contini), sosteneva che la critica non poteva che fondarsi sulla filosofia (come super-disciplina): «Solo il critico di formazione filosofica 553 può infatti muoversi liberamente in mezzo ai problemi suscitati delle connessioni dell’opera d’arte con la totalità della vita e della società senza cadere da una parte nel formalismo e dall’altra nell’astrazione positivistica degli elementi contenutistici dalla loro funzionalità estetica». Dato il suo stretto legame con il marxismo novecentesco questa concezione dell’arte come «processo di defeticizzazione e di dereificazione, come rifiuto dello smembramento della totalità concreta in specializzazioni astratte, come gioco, come attività capace di auto-fruizione, anticipante in sé la totalità umana da conquistare» (uso qui la sintesi datane da Tito Perlini), è oggi pressoché caduta in prescrizione, e sarebbe arduo riproporla, se non, forse, attraverso un «riorientamento gestaltico» dell’estetica analogo a quello a cui uno degli ultimi interlocutori di Cases, Costanzo Preve, ha sottoposto l’ontologia nel suo recente Il cammino ontologico-sociale della filosofia. A queste proposte di integrazione della critica letteraria negli studi culturali se ne contrappongono, in Al di là del testo, almeno altrettante di segno opposto. La prima è quella di Luca Crescenzi, 554 che nel suo intervento riflette viceversa su «una possibile strategia di assimilazione degli stimoli provenienti dai Cultural studies in ambito critico letterario». Va detto che questa è la strategia dominante tra i ‘letterati’: aprire alle discipline emergenti mantenendo ferma la specificità della propria, e non di rado osservando, come qui fanno con qualche ragione Terry Eagleton e (in un saggio tra i migliori del volume) Gert Mattenklott, che gli studi letterari non si sono mai limitati al testo, ma hanno sempre preso in considerazione una più vasta dimensione di cultura. Nello specifico Crescenzi, contestando ai cultural studies di «aver relegato in second’ordine la questione della rappresentazione e della sua storicità», suggerisce di «sviluppare l’approccio neostoricista alla cultura entro l’orizzonte politico dei cultural studies per riportare la critica tematica alla sfera della sua articolazione testuale». Propone inoltre di recuperare la dimensione assiologica attraverso il formalismo adorniano, che permette di individuare «nei costrutti artistici – nell’uso peculiare del linguaggio, della logica, dell’organizzazione formale – le modalità di un’op- posizione all’ideologia, all’opinione comune, all’autorappresentazione del potere». In una prospettiva analoga Giovanni Sampaolo indaga il contributo portato agli studi letterari (e culturali) dalla teoria dei sistemi di Niklas Luhmann: negli anni Novanta essa si era conquistata in Germania «il rango di una “superteoria” accanto alla decostruzione di Derrida», ma il suo successo ha cominciato a declinare dopo il 2001 proprio in coincidenza con il cultural turn. Tra le ragioni di questo declino, osserva Sampaolo, va annoverato il fatto la teoria di Luhman è del tutto scevra di valutazioni assiologiche e «non dà nessun appiglio per una Weltanschauung», mentre «una “scienza della cultura” fondata su concetti tipicamente etnologici (corpo, spazio, rituale, memoria, ecc.)» soddisfa molto meglio il desiderio di accesso a un’offerta di senso di chi si dedica allo studio delle produzione simboliche. Anche per questo Sampaolo suggerisce un utilizzo libero, a mo’ di bricolage, degli spunti offerti della teoria dei sistemi, senza proporne l’adozione in toto né candidarla a super-disciplina egemonica in alternativa ai cultural studies. È proprio quanto Pier Carlo Bontempelli invece non può non fare con la sociologia di Bourdieu, che si costituisce espressamente come una scienza delle lotte per l’egemonia, anche e soprattutto delle lotte che si combattono tra le discipline e nelle discipline. La dimensione conflittuale, infatti, non va osservata solo laddove la studiano i cultural studies – nella geopolitica (colonizzatori vs. colonizzati), nel genere (maschile vs. femminile) o nella memoria (vincitori vs. vinti) – ma anche in ambiti insospettabili come la letteratura stessa. Secondo Bourdieu, tutti gli attori di un «campo» sociale, ivi incluso quello letterario da lui studiato nelle Regole dell’arte, lottano per la sopravvivenza e per l’affermazione del proprio punto di vista sul mondo. Anche il campo della critica, sottolinea dunque Bontempelli, «è un campo di lotta per il predominio, negato però in quanto predominio, e vissuto soggettivamente (in buona o cattiva fede) come ricerca della corretta interpretazione (basata più o meno sul controllo della filologia). Quando elabora un concetto critico o emette un giudizio, il lettore non ingenuo occupa un punto specifico nel 555 campo di forze esistente per difendere la propria concezione della realtà e il proprio capitale simbolico, la propria eredità (quella ricevuta e quella da trasmettere), la propria scuola, la propria legittimazione a parlare come critico consacrato» ecc. La dimensione del conflitto, sommersa dall’«ipertesto della cultura» di Fiorentino, riemerge così prepotentemente. E con essa ritorna anche la tensione all’oggettivazione, ora rivolta in prima istanza al soggetto stesso dell’oggettivazione, il ‘letterato’ stesso. L’oggettivismo torna così a imporsi, secondo gli antichi auspici di Cases, sul soggettivismo, consentendo perfino di recuperare un orizzonte assiologico. Oggettivando quello che Bourdieu definisce «l’arbitrario culturale» è possibile infatti «comprendere attraverso quali meccanismi si possa affermare l’“universale”, cioè un valore estetico o un principio cognitivo che sopravvivono alla congiuntura storica che li ha generati». Se, come si accennava in apertura, la ragione profonda del confronto qui ripercorso per sommi capi è una questione di «status» della letteratura, l’impostazione di Bourdieu appare 556 quella più efficace, proprio perché mette in questione in primo luogo l’inconscio disciplinare inducendo a interrogarsi nel modo più radicale su che cosa sia e a qual fine si studi la letteratura, anche e a maggior ragione a prezzo di una sua defeticizzazione. Bourdieu stesso, del resto, era pienamente consapevole che la posta in gioco in questa particolare congiuntura storica è la rilegittimazione dei saperi umanistici, dal momento che Le regole dell’arte si conclude con un appello Per un corporativismo dell’universale, ovvero per una «Realpolitik della ragione» che dia maggior forza ai saperi e alle istituzioni universalistiche per contrastare l’affermarsi – così manifesto anche nei ministeri, nella stampa, nell’editoria e nell’università italiane – del liberismo e della sua assiologia. Questo non impedisce, anzi, incoraggia il dialogo con altre impostazioni, dalla culture research di Itamar Even-Zohar a quelle rappresentate in Al di là del testo, che di questo confronto documenta un momento importante. Proprio nella prospettiva di un «corporativismo dell’universale» l’errore più grave che noi tutti, ‘letterati’ o ‘culturologi’, potremmo commettere è conti- nuare a coltivare ciascuno la propria idea di cultura ostentando tolleranza per quelle altrui ma di fatto restando indifferenti – e divisi. Michele Sisto Thorsten Valk, Der junge Goethe, München, C. H. Beck, 2012, pp. 288, € 22,95. Quando Goethe arriva a Lipsia nel 1765 per studiarvi giurisprudenza ha appena sedici anni. Una tappa obbligata, per i giovani poeti che come lui soggiornavano nella metropoli sassone, era una visita al vecchio Johann Gottfried Gottsched. Nonostante la stella del teorico del dramma ispirato al classicismo francese avesse da tempo superato il suo zenit, essa brillava ancora di celebrità letteraria. Recatosi da Gottsched assieme al futuro genero Schlosser, Goethe entrò per errore nell’anticamera dell’erudito quando questi non aveva ancora indossato la sua lunga parrucca allonge. La scena è descritta molti anni più tardi da Goethe nell’autobiografia Dichtung und Wahrheit: «Gottsched sollevò con la mano sinistra la parrucca dal braccio del servitore e, sistemandosela in modo acconcio sulla testa, mollò con la destra un manrovescio al poveruomo che piroettò fuori dalla porta, proprio come si vede nelle commedie, al che il venerando patriarca ci intimò con aria solenne di sederci e, con grande dignità, ci tenne un lungo discorso». Nel suo libro Der junge Goethe, Thorsten Valk menziona questo celebre episodio comico: esso prefigura l’emancipazione del giovane autore dai sistemi estetici razionalistici del primo Illuminismo, non scevri da tendenze moralizzatrici. La parabola degli anni giovanili di Goethe – canonicamente compresa nella decade 1765 1775 – viene letta da Valk dalla prospettiva dell’“invenzione del soggetto”; la grande rivoluzione della seconda metà del XVIII secolo – sociale e culturale prima ancora che politica – risiede, infatti, nell’affermarsi della concezione borghese dell’individuo. La centralità del soggetto comporta una nuova visione della letteratura: emancipata da funzioni di edificazione sociale, essa ambisce a diventare medium dell’espressione del sentire individuale e, conseguentemente, a 557 essere spazio autonomo di sperimentazione. La monografia di Valk, edita da Beck nella fortunata collana dalla copertina cilestrina degli Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte – che annovera il classico manuale di Jochen Schmidt sul Faust, giunto ormai alla terza edizione – si pone esplicitamente l’obiettivo di essere uno strumento di orientamento per docenti e studenti: riesce a centrarlo in pieno, offrendo al lettore chiare proposte di interpretazione complessiva, incastonando puntuali letture di testi-chiave in ampie ricostruzioni del contesto storico-culturale. L’autore ha tenuto conto delle analisi più avanzate, senza perdere d’occhio interpretazioni più tradizionali. Un ammirevole segno dell’ampiezza della sua disamina critica sono le preziose bibliografie ragionate alla fine di ogni capitolo in cui il contenuto di ciascun titolo citato è sintetizzato in tre righe. Venendo incontro a esigenze didattiche, il volume di Valk si apre con una solida ricostruzione della “macroepoca” Aufklärung. Fedele a una concezione storiografica affermatasi in Germania già a partire dagli anni Settanta del Novecento, Valk rifiuta una 558 visione dicotomica dello scorcio finale del Settecento: razionalismo da una parte e riscoperta del sentimento dall’altra. Accomunate all’Illuminismo dai concetti di autonomia del soggetto e di critica di ogni forma di autorità sono correnti estetiche come il Rokoko, l’Empfindsamkeit e lo Sturm und Drang. Una lettura dell’Illuminismo che voglia essere epochengeschichtlich non può, dunque, che mappare le molteplici connessioni fra correnti e tratteggiare la coesistenza di anime diverse all’interno delle correnti stesse. Il Rokoko letterario, ad esempio, predilige i toni lievi e gli accenti anacreontici della schermaglia erotica, allontanandosi così sia dalle ardite oscurità del Barocco, sia dalle severe prescrizioni morali dell’estetica di un Gottsched. In modo analogo allo Sturm und Drang, il Rokoko può essere dunque letto – fa osservare Valk – come fase di «dinamizzazione dell’Illuminismo», soprattutto in virtù della sua attenzione alla sensualità dell’esistenza e della sua apertura allo spazio della comunicazione in società. Il particolare rapporto del giovane Goethe con i modelli e le correnti estetiche della sua epoca – fra influenze innegabili e altrettanto certi “parricidi” – costituisce un elemento importante della seconda parte del volume, dedicata all’analisi delle opere. Il motivo della “resa dei conti” con i modelli classici e moderni è centrale nella poesia: il nuovo canto degli Inni non può essere intonato ad Anacreonte «beato dai fiori», né a Teocrito che «annuisce gioviale» – come recita il Wanderers Sturmlied – è invece nel segno di Pindaro che si compia quella trasformazione dell’Antichità che caratterizza un’intera generazione di giovani cultori del genio individuale. Anche nella sua lettura dei drammi Valk ci consegna l’immagine di una personalità sorprendentemente precoce e complessa, capace di furori da iconoclasta così come di variazioni da virtuoso di forme teatrali consolidate. Anche nelle primissime scene del Faust (Valk rifiuta la posticcia dizione Urfaust) che Goethe compone fra il 1773 e il 1775, l’intenzione di dar vita a un titanico personaggio di ribelle convive con scelte formali volutamente arcaizzanti, come l’uso sapiente del cinquecentesco Knittelvers: è qui operante un’intenzione compositiva motivata da una sensibilità storica matura, conscia delle consonanze esistenti fra le trasformazioni socioculturali della Sattelzeit e le profonde svolte epistemiche che caratterizzano il Rinascimento e la Riforma. Nel percorso analitico di Valk il Werther viene – con scelta originale – accostato ai contemporanei scritti estetici Zum Shakespears Tag e Von Deutscher Baukunst: come questi ultimi teorizzano un’estetica anticlassicistica, il romanzo epistolare racconta una biografia votata a un ideale estetico-esistenziale libero da ogni autorità e alimentato esclusivamente da energie passionali. A questo proposito Valk non manca di rilevare le forti riserve di Goethe sui pericoli sociali e psichici insiti in queste energie, se non opportunamente canalizzate. La terza e ultima sezione del volume si concentra sulla multiforme ricezione dell’opera giovanile del Dichterfürst. Particolare interesse riveste il capitolo sulla poesia: mentre i drammi e il romanzo avevano reso Goethe una celebrità letteraria di rango europeo, le liriche furono all’inizio pressoché ignorate anche perché, in molti casi, pubblicate molto 559 più tardi rispetto al periodo della loro composizione. A renderle celebri furono sovente gli adattamenti musicali: Beethoven e Schubert ne fecero materiale per le loro complesse strutturazioni melodiche e armoniche, ricreandolo nel genere nuovo dei Kunstlieder. La raffinata lettura di Valk mostra, inoltre, come gli adattamenti non siano solo da considerare un capitolo della ricezione in musica dell’opera goethiana; lo stesso Goethe fu talora coinvolto in queste traduzioni intermediali, ricavandone impulsi per la sua poetica. Agli anni degli studi a Lipsia risale l’amicizia con il musicista Bernhard Theodor Breitkopf che, già nell’autunno del 1769, pubblicò i Neue Lieder, la prima raccolta di versioni musicali di liriche goethiane. Per quanto Goethe non vi sia menzionato come autore, è evidente che egli stesso rielaborò le sue liriche in vista di questa pubblicazione. Valk ipotizza che il precoce interesse di Goethe per il Volkslied, approfondito poi negli anni alsaziani attraverso il rapporto con Herder, sia da ascrivere alla frequentazione del salotto dei Breitkopfs e in particolare al contatto, all’interno di questa cerchia, con l’estetica mu560 sicale del compositore Johann Adam Hiller. Il libro di Valk rappresenta una solida introduzione all’opera giovanile di Goethe: impostata come “i buoni manuali di una volta”, essa non manca di rivolgere uno sguardo attento al presente. In un poderoso sforzo di sintesi il volume tiene conto sia della grande quantità di monografie pubblicate negli ultimi anni sia, in un’ottica didattica, della trasformazione di presupposti culturali che caratterizza le ultime generazioni di lettori. Michele Vangi Dieter Richter, Goethe a Napoli, trad. di Antonio Mileo, Napoli, Arte’m, 2012, pp. 96, € 15. Il libro di Richter è assai bene informato e finemente scritto. Fra le tante cose, egli giustamente sottolinea che il viaggio di Goethe in Italia si svolse, almeno per qualche aspetto, all’ombra di quello che il padre aveva compiuto nello stesso paese molti anni prima. I segni del commosso ricordo del figlio sono da Richter segnalati in più punti e molto opportunamente. Io mi contento di ricordare la lettera che scrisse alla madre, pochi giorni dopo essere arrivato a Roma: «Non posso esprimerLe quanto mi senta bene che tanti sogni e desideri della mia vita si sciolgano, che io ora veda gli oggetti originali noti sin dall’infanzia nelle incisioni e dei quali ho sentito parlare tante volte il padre». Il primo e più serio problema che Richter ha dovuto affrontare nell’iniziare a scrivere il suo libro è quello degli studi di Benedetto Croce, che del soggiorno napoletano di Goethe si era occupato in vari saggi, per di più nel suo periodo positivista, quando affogava nella più minuta erudizione e conosceva a menadito la storia napoletana di tutti i tempi. Non era certo facile andare oltre le sue ricerche, tanto più difficile risultava l’impresa, in quanto restano da Napoli solo sette lettere di Goethe, nelle quali solo poche righe di due, una alla signora von Stein del 25 maggio 1787 e l’altra al duca Carl August del 27 maggio, riguardano il soggiorno napoletano. Richter però è riuscito quasi sempre a superarlo, a cominciare dall’individuazione della locanda del signor Moriconi, dove Goethe e Tischbein andarono ad alloggiare al loro arrivo a Napoli. Egli ha sco- vato in un archivio parrocchiale uno Stato delle anime, che gli ha permesso di localizzare la locanda meglio di quanto non fosse riuscito a Croce. Richter raggiunge lo stesso brillante risultato in vari altri aspetti del soggiorno napoletano di Goethe. Dalla metereologia ai costumi popolari, dalle visite ai monumenti più importanti della città alle antichità dei dintorni, attingendo sempre a fonti nuove, giornali contemporanei, riferimenti di viaggiatori stranieri in varie lingue, corrispondenze più tarde dello stesso Goethe e la più varia bibliografia. Alla vexata quaestio dei lazzaroni Croce aveva dedicato un ampio saggio nel 1895, per smitizzare la leggenda che intorno al basso popolo di Napoli si era diffusa nei secoli, a partire almeno dalla rivolta di Masaniello del 1648-49, facendo tesoro dell’accurata indagine che Goethe svolse durante il suo soggiorno napoletano. Il poeta infatti aveva appurato che il popolino di Napoli tanto disprezzato per la sua fannullaggine, invece lavorava intensamente da mane a sera, impegnato in ogni sorta di piccoli lavori che gli permettevano di sopravvivere. I risultati della sua inchiesta sono tanto più apprezzabili, in quanto 561 un altro grande viaggiatore settecentesco, Montesquieu, aveva ripetuto la vecchia solfa sulla miseria, l’ozio e l’accattonaggio dei lazzaroni. Ovviamente un viaggiatore che aveva gli interessi scientifici quali Goethe aveva, non poteva mancare di salire fino alla vetta del Vesuvio, cosa che egli fece ben tre volte, e ogni volta ricavandone osservazioni preziose per i suoi studi geologici. Al Vesuvio Goethe dedicò anche un acquarello che lo coglie in piena eruzione, oltre a una raccolta di pietre vulcaniche che egli si portò nella sua residenza di Weimar. Non meno interesse manifestò verso il tempio di Pozzuoli, dove poté studiare il fenomeno del bradisismo, al quale dedicherà più tardi uno studio a stampa. Di queste esperienze scientifiche fatte a Napoli si possono cogliere alcuni riflessi in varie sue opere, in particolare nel Faust, come ha rilevato Richter. A Roma Goethe aveva voluto conservare il più stretto incognito per evitare ogni minimo contatto con la società romana. In una lettera al duca Carl August del 12 dicembre 1786 scrisse infatti: «L’incognito rigoroso che continuo a mantenere mi è di grandis562 simo vantaggio: sono conosciuto e parlo con chiunque incontro casualmente in questo o in quel luogo, e tuttavia non consento che mi si saluti secondo il mio rango o il mio cognome, non faccio visita a nessuno e nessuno ricevo. Se non fossi stato così rigido, avrei dovuto trascorrere il mio tempo a porgere e ricevere omaggi». La stessa cosa ribadì in una lettera del 21 dicembre 1787 all’amico Knebel, senza dimenticare l’odiato tavolo da gioco: «Per il resto, resisto a tutte le lusinghe del cosiddetto gran mondo: non voglio perdere nemmeno un’ora con persone che non hanno nulla da offrirmi e alle quali io non ho nulla da offrire. Ci sono abbastanza stranieri pronti a dare i loro biglietti da visita e a prendere posto a tavola e al tavolo da gioco». Ben diversamente si comportò a Napoli, per tante ragioni che non posso qui rievocare. Basti ciò che scrisse alla signora von Stein, nella lettera già ricordata: «Ho anche cominciato a fare delle conoscenze, e ciò prende ogni volta tempo e pensieri. Ho pure visto il duca e la duchessa d’Ursel di Bruxelles, l’ambasciatore danese, Hamilton con la sua bella». William Hamilton dal 1764 era accreditato come ambascia- tore inglese presso la corte di Napoli, e come ricorda Goethe era noto anche per la sua bella amante, Emma Hart. Il poeta li frequentò e per due volte fu loro ospite nella splendida dimora che il diplomatico inglese aveva a Caserta per restare in contatto con la corte. Hamilton era un grande collezionista di antichità e invitò Goethe a visitare la sua collezione nei sotterranei dove la nascondeva. Lo faceva perché, come poté constatare Goethe stesso nel corso della sua visita, vi teneva oggetti preziosi di scavo, provenienti da Pompei. Secondo una sua ben fondata congettura, Hamilton aveva rubato due candelabri di bronzo dal museo di Portici. Richter nota che Goethe lo rilevava, perché mosso da una certa invidia. Infatti anche lui era collezionista di oggetti antichi, ma non aveva i mezzi per poterli acquistare. A tal proposito si deve ricordare che a Roma aveva frequentato l’antiquario inglese Thomas Jenkins, un furfante matricolato che ne faceva di tutti i colori per procurarsi ogni sorta di anticaglie che poi rivendeva a prezzi altissimi. Lo scrisse Goethe stesso in una lettera al duca Carl August del 20 gennaio 1787: «Alcuni giorni or sono andammo da Jenkins. Questo intelligente e fortunato briccone possiede cose meravigliose. Cominciando dal nulla, utilizzando abilmente tempo e circonstanze e con l’appoggio dei suoi connazionali ha accumulato un grande patrimonio». Poco dopo, in una lettera alla von Stein, osservò che gli oggetti antichi migliori a Roma li aveva solo Jenkins, «che li vende a prezzi esorbitanti». Ma alla von Stein, nella lettera del 25 maggio 1787, non scrisse che si era anche introdotto negli ambienti dell’aristocrazia locale. Fra i nobili napoletani che il poeta apprezzò di più fu il grande illuminista Gaetano Filangieri, autore di un’importante opera, La scienza della legislazione, che fu tradotta in tedesco ben tre volte, la prima volta ad Anspach in otto volumi che apparvero dal 1784 al 1793, la seconda nello stesso 1784 a Vienna, la terza infine a Lipsia nel 1788. L’opera di Filangieri fu messa all’indice dei libri proibiti della chiesa cattolica, cosa che la rese ancora più interessante agli occhi di Goethe, che con Filangieri s’intrattenne più volte. Di lui, come ha notato Richter, Goethe si ricorderà in una delle sue opere: Gli anni di pelle563 grinaggio di Wilhelm Meister. Fra le pagine più belle del libro di Dieter Richter ci sono quelle dedicate all’incontro di Goethe con la duchessa Giuliana Giovane, una tedesca assai colta, ma anche molto bella, che affascinò il poeta. Trasferitasi a Napoli, vi scrisse testi di inconfondibile sapore illuministico. La scena del colloquio con la finestra aperta dalla quale si vede il Vesuvio in piena eruzione è una delle più incantevoli di tutto il Viaggio in Italia e il commento di Richter appare perfettamente centrato. Per concludere, vorrei solo aggiungere un paio di postille, che si basano sul catalogo della biblioteca personale di Goethe, pubblicato da Hans Ruppert. In esso si nota la presenza di libri e di libretti d’ opera che attirano la nostra attenzione. Il libro è un Notiziario di corte e di città di Napoli e delle Sicilie, stampato a Napoli nel 1788 e di pagine 269. È ben noto che Goethe si fermò a Napoli una prima volta dal 25 febbraio 1787 fino al 29 marzo dello stesso anno. Poi, dopo il viaggio in Sicilia, dal 17 maggio al 2 giugno, per ritornare quindi a Roma, per quello che nel Viaggio in Italia definì il secondo soggiorno romano. Come si spiega 564 allora che nella sua biblioteca compare questo Notiziario del 1788? La risposta può essere una sola: a Napoli era rimasto Tischbein, il pittore con il quale Goethe aveva condiviso il primo soggiorno romano, nella casa dei Collina al corso, e che poi l’aveva accompagnato nel viaggio a Napoli. Si sa infine che Tischbein restò per molti anni ancora a Napoli e che da lì scrisse a Goethe varie lettere nel corso dell’anno 1788. Dovette essere lui, magari su richiesta di Goethe stesso, a mandargli una copia del Notiziario. Sicuro è che questo Notiziario nella sua biblioteca porta impresso il suo ex libris. Evidentemente il poeta, che a Napoli si era già interessato ai costumi della corte, sebbene senza frequentarla, dopo il suo rientro a Roma volle informarsi ancora della corte e della società napoletana, in vista dell’opera, che allora meditava già di scrivere e che sarà poi il Viaggio in Italia. Veniamo ora ai libretti d’opera. Sono due e il primo è registrato con queste precise parole: Laconte. Dramma per musica da rappresentarsi nel Real Teatro di S. Carlo nel dì 30 Maggio 1787... Napoli, Vincenzo Flauto 1787. Purtroppo di questo libretto non si riesce a procurarsi nessuna notizia. Meglio vanno invece le cose con il secondo libretto, registrato nel catalogo di Ruppert in questi termini: Il fanatico burlato. Commedia per musica di Saverio Zini da rappresentarsi nel Real Teatro del fondo di separazione per prim’opera di quest’anno 1787, Napoli 1787. Il «teatro del fondo della separazione dei lucri», detto «del Fondo», fu inaugurato nel 1779. Goethe durante la quaresima del 1787, non assisté al S. Carlo a un melodramma sacro la Distruzione di Gerusalemme di Carlo Serviola con la musica del Giordaniello, cantato dal soprano Roncaglia, dal Monanni e dalla Danzi Lebrun. Si recò invece a vedere un’opera buffa di Cimarosa, Il fanatico burlato, su libretto di Saverio Zini, come riferì alla signora von Stein in una lettera da Napoli il 25 maggio 1787. Nella stessa lettera raccontò di avere assistito a uno spettacolo del «vero Pulcinella (ovvero quello autentico in carne ed ossa) che mi ha fatto ridere per due, tre ore di seguito». Roberto Zapperi SEGNALAZIONI Elena Agazzi, W. G. Sebald. In difesa dell’uomo, Firenze, Le Lettere, 2012, pp. 208, € 18. Hans Blumenberg, L’uomo della luna. Su Ernst Jünger, a cura di Sandro Gorgone, Milano, Mimesis, 2013, pp. 138, € 14. Francesca Brencio, Scritti su Heidegger, Roma, Aracne, 2013, pp. 160, € 10. Claudia Buffagni, Beatrice Garzelli (a cura di), Film translation from East to West. Dubbing, Subtiling and didactic Practice, Bern et al., Peter Lang, 2012, pp. 381, € 90. Elisa Caldarola – Davide Quattrocchi – Gabriele Tomasi (a cura di), Wittgenstein, l’estetica e le arti, Roma, Carocci, 2013, pp. 387, € 39. Raul Calzoni, La letteratura tedesca del secondo dopoguerra. L’età delle macerie e della ricostruzione (1945-1961), Roma, Carocci, 2013, pp. 318, € 27. Liza Candidi T. C., Spazi di memoria nella Berlino post-socialista, Milano-Udine, Mimesis, 2012, pp. 345, € 28. 565 Donatella Capaldi, Kafka e le metafore dei media, Napoli, Liguori, 2012, pp. 119, € 15,99. Margherita Carbonaro, La vita è qui / Das Leben ist hier. Wolfsburg, una storia italiana. Wolfsburg, eine italienische Geschichte, Berlin, Metropol Verlag, 2012, pp. 535, s.i.p. Cesare Cases, Scegliendo e scartando. Pareri di lettura, a cura di Michele Sisto, Torino, Nino Aragno, 2013, pp. LXXX-628, € 40. Riccardo Castellana, La teoria letteraria di Erich Auerbach. Una introduzione a Mimesis, Roma, Artemide, 2013, pp. 190, € 20. Gloria Colombo, Goethe e la trasmigrazione delle anime, BernBerlin et al., Peter Lang, 2013, pp. 264, s.i.p. Terrence des Pres, Il sopravvivente. Anatomia della vita nei campi di morte, trad. dal tedesco di Stefanie Golisch, Milano, Mimesis, 2013, pp. 188, € 16. Heinrich Detering, L’Anticristo e il Crocifisso. L’ultimo Nietzsche, trad. di Annamaria Lossi, Roma, Carocci, 2012, pp. 223, € 25. 566 Elvio Fachinelli, Su Freud, a cura di Lamberto Boni, Milano, Adelphi, 2012, pp. 113, € 12. Giovanni Fenu, La Germania tra le due guerre. Dal Congresso di Versailles al regime Nazista, Buccino, Booksprint Edizioni, 2013, pp. 242, € 16. J. Gottlieb Fichte, Missione del dotto, a cura di Diego Fusaro, Milano, Bompiani, 2013, pp. 477, € 20. Francesco Fiorentino, Carla Solivetti (a cura di), Letteratura e geografia. Atlanti, modelli, letture, Macerata, Quodlibet, 2012, pp. 226, € 22. Francesco Fiorentino (a cura di), Brecht e i media, Roma, Istituto Italiano di Studi Germanici, 2013, pp. 245, € 30. Filippo Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 288, € 24. Marino Freschi, Joseph Roth, Napoli, Liguori, 2013, pp. 273, € 19,90. Marion Füssel, La guerra dei Sette Anni, trad. di Biagio Forino, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 152, € 13. Michael Gehler, Le tre Germanie: Germania Est, Germania Ovest e Repubblica di Berlino, trad. di Sara Quarantani, Bologna, Odoya, 2013, pp. 397, € 20. den Schwierigkeiten eines interkulturellen Lebens. Zu den Südtirolromanen von Joseph Zoderer, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 2012, pp. 355, s.i.p. Bernhard Arnold Kruse – Vivetta Vivarelli (a cura di), Il marmo, la fontana, il precipizio. Poesie tedesche sull’Italia, Firenze, Le Lettere, 2013, pp. 336, € 28. Gustav Landauer, La comunità aTilde Giani Gallino, Viaggio nell’altra Germania, Torino, Ei- narchica, trad. di Nino Muzzi, Milano, Eleuthera, 2012, pp. 187, € 14. naudi, 2013, pp. 231, € 21. Walter G. Langer, La mente di Dorothee Heller, Wissenschaftskommunikation im Vergleich: Fallstu- Adolf Hitler, trad. e cura di dien zum Sprachenpaar Deutsch- Noemi Heike, Bologna, Gingko, Italienisch, Frankfurt a.M., Peter 2013, pp. 272, € 13. Lang, 2012, pp. 147, € 29,95. Alberto Martino, Le metamorEric Kandel, L’epoca dell’incon- fosi del Pícaro. La ricezione della piscio. Arte, mente e cervello dalla caresca nell’area di lingua tedesca Grande Vienna ai nostri giorni, trad. (1555/1562-1753). Saggi di storia dall’inglese di Gianbruno Guer- sociale e comparata della letteratura, rerio, Milano, Raffaello Cortina, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2013, pp. 580, € 120. 2012, pp. 622, € 39. Hagen Keller, Gli Ottoni. Una dinastia imperiale fra Europa e Italia (Secc. X e XI), trad. di Giovanni Isabella, Roma, Carocci, 2012, pp. 148, € 13. Marcello Meli (a cura di), La macina e il telaio. Due carmi mitologici norreni, con un contributo di Paola Mura, Roma, Carocci, 2012, pp. 154, € 17. Winfried Menninghaus, La Bernhard Arnold Kruse, Wider den Nationalismus – oder von promessa della Bellezza, a cura di 567 Salvatore Tedesco, trad. di Da- nen über Zeit, Göttingen, Vandenvide Di Maio, Palermo, Aesthe- hoeck & Ruprecht, Unipress, tica Edizioni, 2013, pp. 291, € 30. 2013, pp. 212, € 37,90. Camilla Miglio, La terra del Eloisa Perone, Dalla terra al morso. L’Italia ctonia di Ingeborg Ba- cielo. Introduzione all’opera di Else chmann, Macerata, Quodlibet, Lasker-Schüler, Torino, Trauben, 2012, pp. 176, € 22. 2012, pp. 215, € 18. Maria Teresa Milano, Regina Jonas. Vita di una rabbina (Berlino 1902 – Auschwitz 1944), introd. di Sarah Kaminski, postfaz. di Piero Stefani, Cantalupa, Effatà, 2012, pp. 144, € 10,50. Federica Ricci Garotti (a cura di), L’acquisizione del tedesco per i bambini parlanti mocheno. Apprendimento della terza lingua in un contesto bilingue di minoranza, Trento, Università degli Studi di Trento, 2012, pp. 235, € 12. Nicola Montenz, L’armonia delle tenebre. Musica e politica nella Paolo Scolari, Nietzsche fenomeGermania nazista, Milano, Ar- nologo del quotidiano, Milano-Udine, chinto, 2013, pp. 329, € 16. Mimesis, 2013, pp. 248, € 22. Brendan Moran, Carlo Salzani Marco Sgarbi, Kant e l’irrazio(a cura di), Philosophy and Kafka, nale, Milano-Udine, Mimesis, Lanham (Maryland), Lexington 2013, pp. 208, € 16. Books, 2013, pp. 291, s.i.p. Xavier Tillette, Vita di SchelMaria Grazia Nicolosi, Il son- ling, a cura di Marco Ravera, Minambulismo scenico. Teatro e dramma- lano, Bompiani, 2012, € 30. turgia in Hermann Broch, Pisa, Edizioni Il Campano - Arnus UniverUta Treder, L’assalto al confine. sity Books, 2013, pp. 210, € 16. Vita e opera di Franz Kafka, Perugia, Morlacchi, 2013, pp. 307, Claudia Öhlschläger, Lucia € 16,50. Perrone Capano (a cura di), Figurationen des Temporalen. Poetische Federica Venier, La corrente di philosophische und mediale Reflexio- Humboldt. Una lettura di lingua 568 franca di Hugo Schuchardt, Roma, Walter Benjamin, Letteratura e Carocci, 2012, pp. 148, € 23. strategie di critica. Frammenti I, trad. di Gabriele Guerra, Milano, MiClaudio Vercelli, Triangoli viola. mesis, 2013, € 14. Le persecuzioni e la deportazione dei testimoni di Geova nei Lager nazisti, Thomas Bernhard, Goethe Roma, Carocci, 2012, pp. 181, € 19. muore, trad. di Elisabetta Dell’Anna Ciancia, Milano, Adelphi, «Viceversa letteratura», Rivi- 2013, pp. 111, € 11. sta svizzera di scambi letterari, n. 6, Bellinzona, Service de Presse Marica Bodrožić, Il mio approdo Suisse-Casagrande, 2012, pp. alle parole, stelle, colori, trad. di Bar292, € 22. bara Ivančić e Valentina Piazzi, introd. di Barbara Ivančić, Roma, Ute Weidenhiller, Fiktionale Aracne, 2012, pp. 195, € 12. Ekphrasis und Imagination in Eduard Mörikes Roman “Maler Arno Camendisch, Dietro la staNolten”, Würzburg, Königshauzione, trad. di Roberta Gado, Rosen & Neumann, 2013, pp. 166, vereto, Keller, 2013, pp. 112, € 12. € 24,80. Veza ed Elias Canetti, Lettere Luca Zenobi, Faust. Il mito dalla a Georges 1933-1959, a cura di tradizione orale al post-pop, Roma, Karen Lauer e Kristian WachinCarocci, 2013, pp. 172, € 14. ger, trad. di Giovanna Agabio, Milano, Archinto, 2012, pp. 328, € 25. TRADUZIONI Bruno Apitz, Nudo tra i lupi, trad. di Agnese Silvestri Giorgi, Milano, Longanesi, 2013, pp. 461, € 18,60. Walter Benjamin, Capitalismo come religione, a cura di Carlo Salzani, Genova, Il Nuovo Melangolo, 2013, pp. 60, € 9. Heinz Czechowski, Il tempo è immobile, a cura di Paola Del Zoppo, Roma, Del Vecchio, 2012, pp. 297, € 13. Hilde Domin, Alla fine è la parola / Am Ende ist das Wort, a cura di Paola Del Zoppo, Roma, Del Vecchio, 2013, pp. 416, € 15. 569 Hans Magnus Enzensberger, Il mostro buono di Bruxelles ovvero L’Europa sotto tutela, trad. di Palma Severi, Torino, Einaudi, 2013, pp. 98, € 10. Johann Wolfgang Goethe, Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister, trad. di Isabella Bellingacci, cura di Elena Sciarra, introd. di Giuliano Baioni, Milano, Mondadori, 2013, pp. XXXII682, € 12. Benjamin Jakobs, Il dentista di Auschwitz: una storia vera, trad. e cura di Alessandro Pugliese, Molinella (BO), Gingko, 2012, pp. 350, € 13. Wladimir Kaminer, Non sono un berlinese. Una guida per turisti pigri, a cura di Antonella Salzano, Milano, Mimesis, 2013, € 14. Hans Keilson, Commedia in minore, trad. di Matteo Ghidotti, Milano, Mondadori, 2013, pp. 136, € 10. Peter Handke, La notte della Morava, trad. di Claudio Groff, Milano, Garzanti, 2012, pp. 338, Harry Kessler, Viaggi in Italia. € 22. Appunti dai diari, a cura di Luca Renzi e Gabriella Rovagnati, MiMartin Heidegger, Ernst Jünger, lano-Udine, Mimesis, 2013, pp. a cura di Marcello Barison, Mila- 435, € 32. no, Bompiani, 2013, pp. 871, € 35. Angelika Klussendorf, La raFranz Hessel, L’arte di andare a gazza, trad. di Matteo Galli, Roma, passeggio, a cura di Eva Banchelli, L’Orma, 2013, pp. 162, € 16. Roma, ellint, 2011, pp. 243, € 14. Christian Kracht, Imperium, Franz Hessel, Marlene Dietrich, trad. di Alessandra Petrelli, Via cura di Alessandra Campo, cenza, Neri Pozza, 2013, pp. 188, Roma, ellint, 2012, pp. 56, € 7,50. € 16. Andy Holzer, Gioco d’equilibrio, Michael Kumpfmüller, La metrad. di Fabio Cremonesi, Rove- raviglia della vita, trad. di Chiara reto, Keller, 2013, pp. 272, Ujka, Vicenza, Neri Pozza, 2013, € 16,50. pp. 237, € 16,50. 570 Denis Lachaud, Imparo il tedesco, trad. dal francese di Sergio Claudio Perroni, Roma, 66thand2nd, 2013, pp. 197, € 15. Else Lasker-Schüler, Le notti di Tino di Baghdad, a cura di Eloisa Perone, Milano, Mimesis, 2012, pp. 108, € 10. Erika Mann, Quando si spengono le luci. Storie del Terzo Reich, a cura di Agnese Grieco, Milano, Il Saggiatore, pp. 267, € 19,50. Thomas Mann-Károly Kerényi, Dialogo. Lettere 1934-1955, trad. di Melani Traini, edizione a cura di Andrea Alessandri, prefaz. di Domenico Conte, Roma, Editori Riuniti, 2013, pp. 223, € 23. Robert Musil, L’uomo senza qualità, a cura di Micaela Latini, trad. di Irene Castiglia, Roma, Newton Compton, 2013, pp. 1152, € 9,80. Robert Musil, Parafrasi, a cura di Enrico De Angelis, Milano, Rizzoli, 2013, pp. 157, € 9. Albert Ostermaier, Il vento ci porterà, trad. di Andrea Anania, Asti, Scritturapura, 2012, pp. 209, € 15. Ursula Poznanski, Cinque, trad. di Anna Carbone, Milano, Corbaccio, 2013, pp. 406, € 16,40. Astrid Rosenfeld, Per coraggio, per paura, per amore, trad. di Elena Broseghini, Milano, Mondadori, 2013, pp. 298, € 18. Joseph Roth, La cripta dei Cappuccini, a cura di Giulio Schiavoni, Milano, Rizzoli-Bur, 2013, pp. 240, € 10. Lou Andreas-Salomé, Rainer Maria Rilke. Un incontro, trad. di Chiara Allegra, postfaz. di Amelia Valtolina, Milano, SE, 2012, pp. 115, € 13. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Professione di fede epicurea di Heinz Widerpost, a cura di Leonardo Amoroso, Pisa, ETS, 2013, pp. 53, € 10. Arno Schmidt, Leviatano o Il migliore dei mondi, trad. di Dario Borso, Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 74, € 10. Kathrin Schmidt, Tu non morirai, trad. di Franco Filice, Rovereto, Keller, 2012, pp. 368, € 16,50. 571 Arthur Schnitzler, Fräulein Else, trad. e introd. di Maurizio Basili, Roma, Portaparole, 2013, pp. 107+114, € 15. Arthur Schnitzler, Reigen. Girotondo. La Ronde, a cura/edited by Gabriella Rovagnati, Pisa, ETS, 2012, pp. 384, € 35. Angelika Schrobsdorff, Tu non sei come le altre madri, trad. di Monica Pesetti, Roma, e/o, 2011, pp. 528, € 12. Ingo Schulze, Noi nella crisi. Chi paga il conto?, trad. di Stefano Zangrando e Valentina Di Rosa, Lugano, Adv, 2013, pp. 129, € 12. W. G. Sebald, Moments Musicaux, trad. di Ada Vigliani, Milano, Adelphi, 2013, pp. 66, € 7. Martin Suter, Il talento del cuoco, trad. di Emanuela Cervini, Palermo, Sellerio, 2012, pp. 333, € 16 Jakob von Uexküll, Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata in mondi sconosciuti e invisibili, a cura di Marco Mazzeo, Macerata, Quodlibet, 2013, pp. 166, € 13,50 572 Urs Widmer, Top Dogs. Manager alla deriva, a cura di Daniele Vecchiato, trad. di Stefania Fusaroli e Daniele Vecchiato, Milano, Mimesis, 2013, pp. 128, € 12. Christa Wolf, August, a cura di Anita Raja, Roma, e/o, 2012, pp. 80, € 12,50. Stefan Zweig, Ventiquattro ore nella vita di una donna, trad. di Vittoria Schweizer, Firenze, Passigli, 2013, pp. 107, € 9,90. Stefan Zweig, Il candelabro sepolto, trad. di Anita Rho, Milano, Skira, 2013, pp. 184, € 15. Osservatorio Critico della germanistica Redazione: Fabrizio Cambi, Alessandro Fambrini, Fulvio Ferrari, Maurizio Pirro Progetto grafico: Roberto Martini Impaginazione: Laura Proietti Tuzia Proposte e manoscritti vanno indirizzati ai componenti della redazione Alessandro Fambrini (tel. 0461 281739; email [email protected]); Fulvio Ferrari (tel. 0461 281724 o 0461 282729; email [email protected]); Fabrizio Cambi (tel. 333-1577439; email [email protected]); Maurizio Pirro (email [email protected]). 573
Scaricare