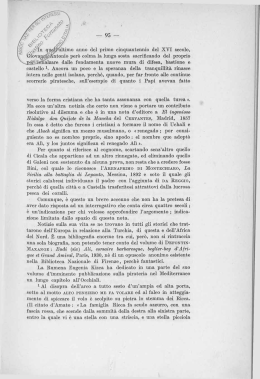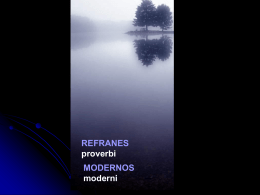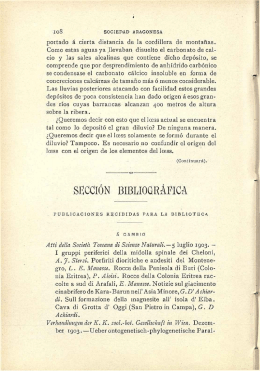Quaderno di comunicazione rivista di dialogo tra culture Quaderno di comunicazione nuova serie Direzione Angelo Semeraro Comitato di Consulenza Scientifica Alberto Abruzzese Marc Augé Egle Becchi Ferdinando Boero Raffaele De Giorgi Derrick de Kerckhove Paolo Fabbri Pina Lalli Michel Maffesoli Roberto Maragliano Mario Morcellini Salvatore Natoli Peppino Ortoleva Mario Perniola Agata Piromallo Gambardella Augusto Ponzio Elena Pulcini Antonio Santoni Rugiu Aldo Trione Ugo Volli Amministrazione e abbonamenti Mimesis Edizioni Redazione via Risorgimento, 33 - 20099 Sesto S.G. - Italy tel/fax +39 02 89403935 www.mimesisedizioni.it [email protected] Sede legale della società MIM Edizioni Srl Via Chiamparis, 94 33013 Gemona del Friuli (UD) [email protected] fax +39 0432 983175 La rivista può essere acquistata rivolgendosi alla casa editrice o alla sig.ra Luisa Fumagalli ([email protected]). Si può comprare la rivista anche on-line: http://www.mimesisbookshop.com/shop/ È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico, non autorizzata. Segretario di Redazione Mimmo Pesare Registrazione presso il tribunale di Roma n. 600/99 del 14/12/1999 Pubblicato con il contributo dell’Università del Salento erogato tramite il Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali Tutti i numeri del Quaderno sono consultabili al sito web: www.quadernodicomunicazione.com Indice p. 5 Questo numero (a.s.) Dire di sé 13 Elena Pulcini, La fatica del dirsi 25 Duccio Demetrio, L’illusione della verità autobiografica 39 Antonio Santoni Rugiu, La tabula non è mai rasa 43 Mimmo Pesare, Narcisismo digitale e tecnologie del Sé 53 Diana Salzano, Le coordinate del Sé nella geografia dei media 61 Alejandro De Marzo, Audiences autonarranti e mediabiografie 67 Monica Ferrari, Lettere a genitori eccellenti nel Quattrocento italiano 77 Egle Becchi, Settantaquattro storie di vita magistrale 87 Flavia Serravezza, Diari pazienti 95 Patrizia Calefato, Raccontarsi con le immagini: “In fabbrica” di Francesca Comencini 105 Silvia Gravili, La comunicazione d’impresa come racconto autobiografico 115 Nieves Sánchez Garre, Lewis Carroll, escritor de maravillas 125 Sergio Duma, Nei labirinti del sé femminile: Peggy Guggenheim, Anaïs Nin e Fernanda Pivano 135 Angelo Semeraro, Il naso di Darwin Reset 149 Salvatore Natoli, L’attimo e il bene Tessiture 157 Bauman Z., L’arte della vita, Laterza, 2009, Sennet R., L’uomo artigiano, Feltrinelli, 2008, Santoni Rugiu A., Breve storia dell’educazione artigiana, Carocci, 2008 (Angelo Semeraro) 159 Ortoleva P., Il secolo dei media, Il Saggiatore, 2009 (Angelo Semeraro) 162 Sassoon D., La cultura degli europei. Dal 1800 a oggi, Rizzoli, 2008 (Giovanni Fiorentino) 163 Lyotard F., Discorso, figura, Mimesis, 2008 (Mimmo Pesare) 165 Buber M. (a cura di Luca Bertolino), Colpa e sensi di colpa, Apogeo, 2008 (Mimmo Pesare) 166 Zambrano M., Per l’amore e per la libertà. Scritti sulla filosofia e sull’educazione, Marietti, 2008 (Mimmo Pesare) 168 Broccoli A., Educazione e comunicazione. Per un’etica del discorso pedagogico, La Scuola, 2008 (Mimmo Pesare) 169 Semeraro A., Hypomnémata. Lessico di comunicazione sensibile, Besa 2008 (Mimmo Pesare) 171 Demetrio D., La scrittura clinica. Consulenza autobiografica e fragilità esistenziali, R.Cortina, 2008 (Flavia Serravezza) 172 Pivano F., Diari (1917-1973, classici Bompiani, Rcs libri, 2008 (Sergio Duma) 173 Stajano C., Maestri e infedeli, Garzanti, 2008 (Maria Ginevra Barone) Questo numero L’esistenza è l’unica cosa che non posso comunicare: posso raccontarla ma non posso condividerla LÈVINAS, Etica e infinito, pag.73 Si chiese perché proprio lei che aveva tanta difficoltà a parlare di se stessa con le persone che incontrava faccia a faccia, riuscisse a rivelare i suoi più intimi segreti con la massima noncuranza a un’accolita di svitati perfettamente sconosciuti in internet. LARSSON, La ragazza dei castelli di carta, p.386 Per millenni le civiltà si sono misurate sulla capacità di affidare alla scrittura le tracce del proprio passaggio. Così è stato fino a quando l’evoluzione dei mezzi di diffusione elettronici non hanno ampliato ben oltre Gutenberg le possibilità narrative, modificando non solo la soggettività narrante che si è fatta molteplice, ma le stesse opportunità tecniche di esposizione personale allo sguardo pubblico. Così, se il Settecento fu il secolo d’oro dei memoriali, dei journal intime, e Rousseau l’indiscusso inventore dell’autoscrittura, che con lui conobbe la sua prima vera maturità; se l’Ottocento problematizzò il valore documentale della memoria nella diaristica, nei reportage di viaggio, nelle esplorazioni scientifiche e nel romanzo di formazione; se il Novecento ha visto svilupparsi per un verso le scritture epistolari (lettere dal fronte, dal confino, dal carcere, dai paesi di emigrazione) e per un altro le stesse forme e i mezzi di comunicazione attraverso l’uso civile delle tecnologie di guerra (radiofonia e telecomunicazioni), il secolomillennio in cui siamo entrati sembra averci definitivamente sollevato dall’onere di affidare l’espressione del pensiero alla carta e alla penna (negro semen seminaba) o ai caratteri mobili, sostituendo alla fatica mentale (e muscolare) dello scrivere – per come per molti secoli l’abbiamo inteso – un’abilità digitale che è sinonimo d’immediatezza e varietà, e che rende possibili scritture veloci di rete e di strada. “Chi un tempo non avrebbe mai osato prendere in mano la penna – sostiene qui Duccio Demetrio – si fa coraggio e si inserisce nel grande anfiteatro mediatico, perché non è più disposto a mettere a tacere la propria esistenza, fosse anche la più banale”. L’ascesa della soggettività non è un fatto recente. Lasciar tracce scritturali fa parte di quella foucaultiana cura di sé, che sempre presupponeva una áskesis. L’esercizio dell’autoformazione, nel passato affidata alla scrittura elaborata della memorialistica e degli hypomnémata cambia modalità e formato, riversandosi nella rete con una disinvolta frenesia digitale. Il fenomeno è interessante, e interessante è osservare non solo le dimensioni di questa confessione pubblica incentrata sul sé, ma gli stessi contenuti narrativi e le loro dinamiche di rete. La scrittura è medium e la sua canalizzazione tecnico-tecnologica non è indifferente sul frame mentale dello scrivente. Siamo tutti d’accordo anzi che lo condizioni profondamente 6 Quaderni di comunicazione 10 e addirittura lo forgi. Sempre e comunque nell’attività scritturale agisce la volontà di signare un passaggio nei territori dell’anima, di certificare una presenza, si tratti di un diario o di un sms che con la levità degli emoticons manda a dire: ci sono, e mi sento così! Ciò che cambia evidentemente è la dimensione temporale. Hypomnémata, zibaldoni, confessioni sono forme di un tempo narrativo simbolicamente mediato dai loro Autori: la consegna di un passaggio e di un messaggio a quelli che verranno se vorranno guardarsi indietro. Facebook e suoi similari di rete sono invece le forme comunicative di un tempo immediato. Più che configurarle come deriva entropica del mostrarsi per come si è (col risvolto del sono come mi vuoi mimetico) – come qui propende qualcuno degli Autori – possiamo assumerle come una demartiniana forma di metastoria, in cui milioni di utenti preservano una presenza, l’unica possibile nel tempo espropriato di un presente a flusso. La fragilità di qualsiasi identità nella volatilità del qui e ora fa sì che ciascuno debba assumersi in proprio l’onere della identificazione. “Se i media sono estensione dell’uomo – ragiona Pesare – essi sono principalmente estensioni del suo Sé”. Gli utenti del web 2.0 non solo annunciano, ma sono già nel mezzo di un grande mutamento antropologico che ha profondamente cambiato il linguaggio (fatto salvo l’onore della grammatica!) e più in generale il loro modo di essere e del sentire. E non v’è dubbio che le foucaultiane tecnologie del Sé apportano profonde e radicali trasformazioni nel gioco russoviano dell’en-soi e del pour-soi riconsiderato qui da Elena Pulcini. Nel loro slancio vitale, le identità mediatiche hanno ampiamente scavalcato quel limite kantiano del controllo razionale e della missione formativa che ha caratterizzato le forme del dirsi e dell’esporsi nel passato. I territori della egolatria si sono estesi, come di recente ha rilevato il Censis (col corollario che il paese dove l’io conta più che altrove sembra essere il nostro). Sappiamo quanto in buona parte i modelli introiettati via cavo abbiano contribuito alle dilatazioni ipertrofiche dell’ego. Il contributo di De Marzo punta il dito proprio sulla “protagonizzazione” dell’autonarrazione post-televisiva. Senza ridere e senza piangere possiamo qui limitarci a considerare che le forme del dirsi e del raccontarsi nell’immediatezza blogger interattiva e multimediale appartengono a un bisogno potenziato di identificazione, nello stadio di un narcisismo oltre se stesso (“Narcisismo senza specchio” fu la formula felice scelta da Jean Starobinski). Tutte le forme di scrittura del resto sono attraversate da dinamiche di riconoscimento, come ricorda Elena Pulcini rifacendo il percorso di Rousseau. L’io mimetico, che sempre si forgia su un Altro (modello e rivale al tempo stesso) sembrerebbe incapace a riportare l’amor proprio competitivo all’amore di sé, e dunque a trovare in se stessi le forme di quella fragile felicità che Salvatore Natoli apre alle beatitudini della gratificazione e del trarre soddisfazione nella propria opera, del darsi norma da sé. La “deriva entropica” già segnalata da Rousseau non sta però in quel narcisismo incanalato nella pratica dell’empatia, ossia in quella cura di sé che si realizza prendendosi cura degli altri nell’amicizia, il sostegno, l’amore compassionevole per il più indifeso. Questa forma di neonarcisimo, che Pesare recupera attraverso Gli esiti del narcisismo “cattivo”, egolatrico, Rousseau li lascia intravedere nella figura del Grande Vegliardo che ha preso congedo dal mondo e si trascina in lunghe passeggiate solitarie. Alla scomunicazione, all’atrofizzarsi dell’Io, si può rimediare non solo attraverso una partecipazione alla vita attiva laddove questa sia ancora possibile e gratificante, ma attraverso l’attività riflessiva che si dispiega più agevolmente per via autobiografica: quella che scrivendo e riscrivendosi reinventa la vita propria, ma anche quella che sa dare voce al racconto delle vite altrui. La biografia, il racconto di un Sé, riconosciuto da un Altro, “funziona da punto fermo per l’identità frammentata” ha scritto Bovone, chiamato a testimone da Elena Pulcini. Si può partecipare allo scambio comunicativo in modo diverso. Internet ha reso possibile l’espansione dell’everyone, il recupero della fisicità negata, il dialogo non irretito dall’ansia dell’ottenimento. Già mezzo secolo fa Goffman aveva visto bene: “in assenza di corporeità, il solo possibile accesso all’identità altrui resta il racconto di sé, l’identità rappresentata, messa in scena, vestita”. Non mancano certo di corporeità le settantaquattro storie di vita magistrale raccontate da Egle Becchi e dalle sue colleghe di ricerca, né i diari degli ammalati di cancro raccontati da Flavia Serravezza, né il racconto di fabbrica di Francesca Comencini scelto da Patrizia Calefato nel suo ricco repertorio di cultura visuale, né l’evocazione delle immagini autorappresentative dei grandi marchi dell’indu- 7 Questo numero Kohut, ha un volto accettabile; è anzi il volto buono dell’umanità, e porta sempre a esiti socialmente costruttivi. Il narcisismo cattivo sta invece in quell’egolatria mai appagata che impedisce di vedere altro da sé e di usare altri per le proprie affermazioni. Nella rilettura del mito operata da Marcuse – richiamato da Elena Pulcini – Narciso coincide con l’assoluta indifferenza per gli altri, alle cui origini c’è “la pretesa di un io disilluso da una società ingiusta, competitiva e inospitale, rispetto alla quale l’unica chance sembra essere ormai quella di proteggere definitivamente la propria interiorità” (Pulcini). La Computer Mediated Communication, su cui la Salzano studia le nuove identità di rete, se da una parte registra “processi di erosione dei riferimenti sociali e culturali che caratterizzano l’identità in real life”, dall’altra deve ammettere che “protetti dall’anonimato, gli individui possono esprimere e sperimentare aspetti della loro personalità che l’inibizione sociale in genere li induce a sopprimere. Gli ambienti virtuali finiscono col rappresentare dei veri e propri identity playground in cui si sperimenta, nella più totale fluidità sociale, una costruzione performativa del sé”. Questo punto mi sembra dirimente. La scrittura di rete, non diversamente da quella dell’antica civiltà del manoscritto, rompe le gabbie dell’io bastevole a se stesso. Gli Internet studies possono dimostrare come la chat sia il luogo più frequentato, e ancora di più lo siano i diversi software di messenger, pronti ad accogliere persone che non hanno alcun motivo di costruirsi un’identità truccata. La rete è dunque il rivelatore ontologico del cammino della specie che non tratta più i media elettronici come protesi post-humane, bensì come luoghi di un’altra agorà, dell’appartenenza e del bisogno di identificazione fuori dalle Grandi Narrazioni smarrite, anzi scomparse. 8 Quaderni di comunicazione 10 stria italiana come Edison, Fiat, Breda, Olivetti, Montecatini e altri, qui ricordati da Silvia Gravili. E non si staccano da questo modulo del dire di sé – dicendo di Altri – le ricostruzioni di medaglioni, nelle scritture di Nieves Sanchez Garre su Lewis Carroll, ecritor de meravillas, di Sergio Duma che presenta tre figure eccentriche della vita culturale del Novecento: Peggy Guggenheim, Anaïs Nin e Fernanda Pivano e di chi scrive sull’Autobiografia di Darwin. Negli ultimi tempi si è posta molta attenzione alla progettualità riflessiva del Sé, al valore del dirsi, alla formatività dell’autobiografia e all’aspetto terapeutico dell’egoscrittura. Sul valore autotoformativo chiede qui attenzione e prudenza Santoni Rugiu, che richiama il significato storiografico del dirsi. Non si scrive, o non si dovrebbe scrivere per indicare agli altri una via o una vita esemplare. Tornano così nell’habeat corpus storico quelle categorie che i media hanno offuscato: in primo luogo il tempo, e – con esso – il valore della memoria, il suo ruolo spesso arbitrario e dispotico, ma imprescindibile nella ricerca identitaria (perché sono la memoria e l’esperienza a dare consistenza all’autobiografia, a costituirne peso e autorevolezza). Per molto tempo la scrittura è stata veicolo educativo; molta educazione “a distanza” passava attraverso la scrittura epistolare di “raccomandazioni” parentali. Raccomandazioni rivolte ai figli in crescita: dalle lettere ad Astrolabium di Abelardo, alle raccomandazioni di Lord Chesterfield, alle Lettere gramsciane preoccupate dell’educazione di Delio. Una bella traccia di un tema da approfondire tra gli storici dell’educazione e i cultori dell’educazione adulta viene offerta in questo QC da Monica Ferrari. Nell’epistolario tra genitori e figli eccellenti nella seconda metà del Quattrocento, che l’Autrice porta in evidenza, emergono pratiche di vita comuni ai signori di Milano, Mantova e Ferrara: l’abitudine di tenere attiva una quotidiana corrispondenza con figli lontani, che giornalmente debbono informarli sui progressi nell’educazione, nell’arte militare e in quella diplomatica: una miniera di informazioni sulla missione del principe, sulle forme del suo formarsi prendendosi cura di sé e degli altri. Non v’è dubbio insomma che l’autoscrittura, anzi “ogni indizio di volontà a cimentarsi con la scrittura” – per dirla con Demetrio – costituisca un’occasione imperdibile di cura educativa. Per Diana Salzano, che mette a fuoco il tema da un’angolatura sociologica, si tratterebbe anzi di tregue pedagogiche, necessarie per ridimensionare il ruolo dell’io dominante in favore di un io tessitore, in grado di “intrecciare le diverse e spesso dissonanti parti del sé in un’architettura cognitiva che gestisca i processi di dispersione e di discontinuità”. Tutt’intorno si moltiplicano “egoscritture” che non accennano ad esaurirsi. Le ultime annate editoriali sono state ricche di confessioni letterarie di chi ha potuto attraversare quasi per intero il secolo “terribile” da cui ci siamo congedati. I tratti di ogni autoscrittura tuttavia sono sempre gli stessi, avverte Demetrio. Narratore di sé o scrittore, chiunque, nel momento in cui si accinge a seminare di negro semen la pagina bianca cartacea o elettronica, genera finzioni. Sembra che non 9 Questo numero possiamo farne a meno. Non del tutto consapevolmente l’autore (che è sempre un attore) camuffa distorce tace e dirotta il lettore a suo piacimento. La questione del vero in autobiografia del resto “non è che un aspetto del più complesso desiderio di dirsi [...] L’ego dispiegato dalla scrittura stabilisce ogni volta confini labili e porosi con le dimensioni inconsce”. Sono considerazioni che si possono leggere nel saggio corposo di Demetrio in questo numero 10 del QC che corrisponde al decimo anno di attività di una rivista che avrebbe già una sua intensa storia da raccontare, e che si affida con questo numero alle buone cure dell’editore Mimesis. “Scrivendo tocchiamo con mano la vita vissuta divenuta immateriale e la rimaterializziamo”, scrive Demetrio. Del resto il raccontarci è già un’altra occasione di viverla, la vita. “Il soggetto che intraprenda tale percorso, con sincerità e apertura critica verso quanto della vita può aver compreso – conclude Demetrio, e noi con lui – non può che imparare ad adottare uno sguardo più relativo e accogliente verso le cose, ad apprezzare la finzione, contro ogni ambizione dogmatica o definitiva”. Écrire, résister. (a.s.) Dire di sè Elena Pulcini La fatica del dirsi Operazione difficile e tutt’altro che immediata quella di dire di sé, laddove allude alla capacità del soggetto di affermare la propria verità, di raccontarsi, di esporre all’altro (si “dice” sempre qualcosa a qualcuno) gli aspetti più opachi e reconditi della propria interiorità. Bisogna infatti presupporre in primo luogo la capacità di riconoscere la propria verità; e ciò richiede che il soggetto metta in atto un processo di disidentificazione dagli altri che gli consenta di liberare la propria singolarità e unicità. Per poter parlare di sé bisogna evidentemente sapere chi siamo; e per sapere chi siamo dobbiamo in primo luogo differenziarci, valorizzare la nostra differenza, individuare almeno quel nucleo di verità che ci rende diversi e irriducibili a qualunque altro. Ma qui incontriamo un primo ostacolo. Non solo perché noi siamo, costitutivamente, esseri mimetici, tesi a costruire la nostra identità a partire da processi di identificazione con l’altro, ma anche perché la dinamica mimetica ha raggiunto oggi, nella nostra società post-moderna, proporzioni tali da erodere la nostra unicità. Conformismo, omologazione, spersonalizzazione sono gli effetti di una cultura dell’esteriorità che si afferma sempre più, rafforzata dalle derive di una “società dello spettacolo” che inghiotte progressivamente ogni sfera del mondo della vita. Noi agiamo, e soprattutto desideriamo, per dirla con Girard, a partire dalle aspettative e dai desideri dell’altro; ci assoggettiamo inconsapevolmente alla tirannia di modelli precostituiti e imperativi, sapientemente veicolati dagli strumenti massmediali, che di fatto ci esonerano da quella che è stata definita “la fatica di essere se stessi” (Alain Ehrenberg, 1999). Essere come l’altro ci vuole; agire e pensare secondo i parametri imposti da un’opinione egemone, sembra essere la risposta inquietante e diffusa di un’identità narcisistica: sempre più desiderosa di riconoscimento in quanto sempre più svuotata dei propri originali contenuti. Dire di sé richiede allora un viaggio nella propria interiorità che contrasti la cultura dell’esteriorità e che consenta al soggetto di accedere alle regioni più profonde e autentiche del Sé. Ma qui ci imbattiamo in un secondo ostacolo. Il concetto di interiorità contiene infatti il rischio di riproporre una prospettiva obsoleta, essenzialistica, irrimediabilmente connotata da una sorta di naturalismo naïf, che rimanda ad una visione trasparente, compatta, coerente e monolitica del soggetto. Come se bastasse 14 Quaderni di comunicazione 10 insomma, rousseauianamente, disidentificarsi dall’altro per accedere alla autentica purezza del proprio Sé. Ma appunto, questo non basta, per almeno due ragioni fondamentali. La prima è che c’è una parte della nostra verità interiore che ci è sconosciuta, che sfugge al chiarore della coscienza per annidarsi nelle zone oscure e difficilmente accessibili dell’inconscio. È strano constatare come questa grande lezione della psicoanalisi stenti ancora oggi ad essere riconosciuta da chi si accinge (filosoficamente, sociologicamente) a riflettere sul Sé. Qualcosa di noi sempre ci sfugge, e quanto più ci sfugge tanto più potentemente orienta, nostro malgrado, il nostro agire, pensare e desiderare. Dire di sé non può allora limitarsi ad esibire i propri contenuti coscienti, ma deve fare i conti con questo “perturbante” che chiede di essere ascoltato, decifrato, pena di fatto la mutilazione del sé, la sua riduzione a ciò che ci è unicamente familiare: e dunque accettabile, comodo, rassicurante, magari anche autocelebrativo. La seconda ragione che impone di ripensare l’idea di interiorità riguarda quella che potremmo definire la sua molteplicità. L’interiorità è il luogo in cui si annidano le nostre passioni, le nostre molteplici passioni, tutte, ai nostri occhi, ugualmente legittime e spesso in contrasto tra loro. In questa molteplicità possiamo cogliere la fonte stessa dei nostri disagi, delle nostre sofferenze: dovuti al fatto che spesso aderiamo contemporaneamente a spinte emotive diverse e conflittuali e ci dibattiamo in una irriducibile ambivalenza. Ci è difficile in altri termini, riconoscere una sola verità del Sé, individuare una parte di sé più autentica delle altre; ci è difficile scegliere, decidere in quanto siamo lacerati dalla presenza di verità complesse e plurali. Se è vero, come ci dice una nota formula sociologica, che il Sé è “multiplo”, lo è in primo luogo nelle sue dinamiche emotive, nel conflitto che si crea tra passioni e desideri a volte inconciliabili. Dire di sé vuol dire allora assumersi l’onere della propria molteplicità, ed aprirsi un varco nella coscienza per farla venire alla luce. Forse la vera autenticità sta proprio nella consapevolezza della propria pluralità e nella capacità di dare senso alle proprie ambivalenze. E raccontarsi vuol dire provare a riconnettere i diversi frammenti della propria identità in una narrazione che ci restituisca il senso del nostro Sé, unico e insostituibile, senza sacrificare nessuno dei suoi molteplici aspetti, laddove ognuno di essi riflette una parte di noi stessi che consideriamo irrinunciabile. Tutto questo però non può essere un processo monologico, al contrario, come accennavo sopra, narrarsi è sempre un interpellare l’altro: chiamandolo a testimone della nostra narrazione. Se è vero che il processo di disidentificazione è necessario per riconquistare la propria unicità, è vero anche che parlare o scrivere di sé presuppone sempre un altro che ascolta: un altro dal quale vogliamo in prima istanza essere riconosciuti. Ciò vuol dire anche che l’altro non ha solo un ruolo passivo di spettatore e di testimone, ma anche il ruolo attivo, appunto, di interlocutore. L’altro è qualcuno che può smontare le nostre verità, o gettare su di esse una luce nuova che ci costringe ad un processo interminabile di disvelamento e di ricostruzione del proprio Sé. La dinamica del riconoscimento, di cui oggi tanto si occupa la riflessione contemporanea, consiste proprio in questo processo di reciproca interazione: attraverso il quale sia il Sé che l’altro si confrontano, si mettono Ritengo che molte di queste tematiche siano presenti, in modo aurorale ma significativo, nella riflessione di Rousseau, la quale malgrado i presupposti inevitabilmente essenzialistici, si rivela ancora fortemente attuale nell’aver colto l’importanza delle nozioni di interiorità e di autenticità. Per questo ripropongo qui un mio scritto su questo autore, imprenscindibile, a mio avviso, per chiunque si accinga oggi a riflettere sul Sé. Interiorità e autenticità in Rousseau1 1. Il tema dell’autenticità e di una cultura dell’autenticità è stato di recente riproposto all’attenzione dalle riflessioni di Charles Taylor che lo assume a momento fondativo dell’identità dell’Io moderno2. Ma non bisogna dimenticare i lavori pionieristici di Lionel Trilling e di Marshall Berman3, come pure l’importanza conferitagli successivamente dalla sociologia attenta alle trasformazioni dell’Io4. In ambito filosofico, il tema gode di una grande tradizione, sebbene ancora tutta da dissodare, che da Rousseau e Goethe si snoda, attraverso Kierkegaard, fino a Nietzsche e Heidegger. Si tratta, in sintesi, di un un ideale soggettivo e morale che, a partire dal XVIII secolo, segna uno spartiacque nel percorso della modernità e nella parabola, molto più complessa di quanto si possa supporre, dell’individualismo moderno5. Merito di Taylor è quello di averne suggerito, con particolare riferimento a Rousseau, una definizione sintetica ed efficace: l’autenticità è essenzialmente “fedeltà a se stessi”, alla unicità e originalità del proprio Io. La nascita dell’ideale dell’autenticità implica dunque una peculiare enfasi sul sé che, come ci ricorda Georg Simmel, era invece ancora estranea alla forma precedente di individualismo: vale a dire all’individualismo universalistico liberale e kantiano, che vede l’Io “come l’Io universalmente umano, uguale e di uguale valore in ognuno”6. In altri termini, mentre l’individualismo universalistico pone essenzialmente l’accento sulla libertà e sull’uguaglianza formale degli uomini, l’individualismo dell’autenticità tende alla valorizzazione della singolarità e della differenza dell’individuo. L’idea — dice Simmel — che anche la diversità dell’elemento umano sia un’esigenza morale e che, per così dire, ciascuno debba realizzare una particolare immagine ideale di se stesso, che non è uguale a nessun’altra, costituiva una valutazione del tutto nuova, un individualismo qualitativo di fronte a quello che poneva ogni valore nella forma dell’Io libero7. 15 La fatica del dirsi Elena Pulcini in gioco, si espongono alla possibilità del cambiamento; accettando, sia l’uno che l’altro, la possibilità della reciproca alterazione. Dire di sé significa dunque accettare anche il rischio dell’imprevedibile verità che può scaturire solo dall’incontro con l’altro; significa accettare l’idea che l’identità non può mai essere un costrutto statico e definitivo, ma un processo aperto e in divenire, sempre ospitale verso la possibilità di nuovi contenuti. 16 Quaderni di comunicazione 10 Ciò vuol dire che il soggetto avanza pretese più radicali (non a caso Berman parla di “individualismo radicale”), non limitate all’affermazione della libertà e dell’uguaglianza o alla kantiana emancipazione da uno stato di minorità, ma estese al diritto ad affermarsi nella propria unicità e nella propria differenza dall’altro. Per usare una coppia concettuale esemplarmente riassuntiva, si potrebbe dire che il soggetto non si accontenta più di conquistare la propria “autonomia”, intesa come la capacità di scelta e di decisione razionale in base a principi universali e uguali per tutti, ma desidera la propria “autorealizzazione”, intesa appunto come possibilità di essere fedeli a se stessi e ai propri percorsi squisitamente singolari8. Qui emerge un primo problema. Il valore dell’autorealizzazione implica infatti una inedita attenzione alla vita emotiva quale tratto distintivo della originalità di ciascuno e del diritto all’affettività. In questo risiede infatti una delle maggiori conquiste dell’individualismo dell’autenticità. L’Io autentico è un Io capace di essere fedele ai propri sentimenti, alle proprie passioni, ai propri desideri — indipendentemente dalle norme sociali e dai valori collettivi — poiché nella vita emotiva risiede la fonte stessa di quell’ideale irrinunciabile che emerge prepotentemente e diffusamente a partire dal XVIII secolo: cioè il bonheur, la “felicità” del singolo. Ma, allo stesso tempo, questa attenzione privilegiata alla vita emotiva apre la possibilità di un conflitto tra l’Io e l’altro, tra l’Io e la società; poiché l’affermazione tout court delle proprie passioni può entrare in contrasto con l’affermazione delle passioni dell’altro. Non a caso il problema della gestione delle passioni, su cui qui non posso soffermarmi, è un aspetto cruciale della riflessione relativa alla configurazione del soggetto moderno9. Il problema si complica tanto più in quanto l’Io, pur nella fedeltà a se stesso, desidera il riconoscimento da parte dell’altro, desidera cioè essere amato, ammirato, stimato dall’altro. È significativo a questo proposito che il tema del “riconoscimento” si sia imposto di recente come un tema fondativo per la riflessione sull’identità10. L’enfasi sull’unicità non deve in altri termini far pensare che l’Io autentico si configuri come un Io isolato e separato dagli altri, che tende a chiudersi in un circuito autarchico e solipsistico. Si tratta, al contrario, di un soggetto che completa la sua autorealizzazione attraverso il riconoscimento, da parte degli altri, della propria unicità. Emerge dunque un secondo problema: come è possibile una relazione di reciproco riconoscimento tra individui unici e singolari, ciascuno animato dal desiderio di affermarsi nella propria differenza e di vedere legittimate le proprie passioni? Entrambi questi aspetti, che rivelano allo stesso tempo il carattere emancipativo dell’ideale dell’autenticità e le sue implicazioni problematiche, trovano, come ora vedremo, in Rousseau, un momento fondamentale di tematizzazione. 2. Ma prima bisogna chiedersi: cosa ha a che fare l’autenticità con l’interiorità? Perché è in prima istanza a questo interrogativo che, più di ogni altro, Rousseau ci consente di dare una risposta. 3. Rosseau introduce di fatto il concetto di autenticità nell’ambito della critica del desiderio di riconoscimento, sviluppata soprattutto nei due Discorsi12. Il desiderio di essere ammirati, stimati, preferiti dall’altro è ispirato dalla più devastante e corruttrice passione che noi conosciamo, che è l’amor proprio: passione sociale e artificiale per eccellenza che ha il potere di produrre uno snaturamento del soggetto e una perdita di contatto con la propria interiorità. Spinti dall’amor proprio, che si declina come “passione della distinzione” e desiderio di eccellenza, noi vogliamo a tutti i costi essere riconosciuti ed entriamo per questo in competizione con gli altri, creando uno stato di conflittualità che somiglia molto allo stato di guerra hobbesiano. Ma non solo. Essere riconosciuti dagli altri significa mostrare un’immagine di sé che gli altri possano apprezzare ed ammirare. E questo spinge gli uomini a simulare qualità che non possiedono, ad apparire diversi da quello che sono, conformandosi alle aspettative dell’altro, incarnato da quel potente soggetto sociale che è l’“opinione”. 17 La fatica del dirsi Elena Pulcini La risposta in sintesi è la seguente: l’autenticità risiede nell’interiorità. O meglio, l’interiorità è la dimensione che ospita, protegge, conserva l’autenticità dell’Io e la sua capacità di essere fedele a se stesso. Nelle zone più intime e profonde del nostro essere si cela la nostra verità (è bene sottolineare che Rousseau parla di “verità” più che di “autenticità”), malgrado le deformazioni prodotte dal progresso e dallo sviluppo della società. Basti pensare alla celebre metafora della “statua di Glauco” che Rousseau ruba a Platone per restituirci l’immagine di una dimensione originaria e incorrotta che giace intatta sul fondo del mare a dispetto delle incrostazioni prodotte dal tempo11. La nostra interiorità è simile al fondo del mare che custodisce la verità della nostra natura incontaminata. Questo ci consente dunque di fare il passaggio successivo: se l’interiorità è sede dell’autenticità in quanto in essa si conserva la nostra natura originaria, ciò vuol dire che l’autenticità equivale all’essere fedeli alla propria natura. Ma la metafora platonica ci dice anche che questa natura non è immediata e trasparente, poiché è stata sfigurata da una serie di successive sedimentazioni che l’hanno resa irriconoscibile. Di conseguenza, l’interiorità si configura in prima istanza come una zona opaca e torbida, che deve essere ripescata e ripulita per poter tornare a rivelare la verità che essa custodisce. La ricerca dell’autenticità corrisponde esattamente a questo percorso di dissodamento dell’interiorità, a questa operazione di recupero simile a quella di un relitto che una volta riportato in superficie e ripulito delle incrostazioni depositate dal tempo, rivela finalmente i suoi tesori nascosti. Un percorso, potremmo dire, che si snoda in due atti: il primo è quello appunto di ritrovare la propria verità, il secondo è quello di presentarsi agli altri nella propria verità e di pretendere dagli altri il riconoscimento della propria originale natura. Ma si tratta, allo stesso tempo, di un percorso accidentato, denso di ostacoli e di ambivalenze che non consente disinvolte semplificazioni e che ci restituisce tutta la complessità della riflessione rousseauiana. 18 Quaderni di comunicazione 10 La scissione tra l’“essere” e l’“apparire”, nella quale risiede una delle più feconde intuizioni rousseauiane, si traduce dunque nella scissione tra una vera e una falsa identità. Il soggetto è sempre sottoposto allo “sguardo” dell’altro e ne diventa dipendente, finendo per agire in altri termini come l’altro lo vuole; egli costruisce una maschera che cela la propria verità, per adeguarsi a un’immagine fittizia di sé che gli garantisca la stima e l’ammirazione collettive. Si potrebbe evocare qui quella dinamica mimetica nella quale René Girard ha individuato il fondamento stesso della costruzione dell’identità13. L’Io mimetico assume l’altro come modello e rivale allo stesso tempo, diventando del tutto dipendente dai suoi giudizi e dalle sue aspettative. Per essere come l’altro lo vuole, l’Io arriva a fare propri non solo i valori dell’altro, ma i suoi stessi desideri. L’Io mimetico desidera qualcosa solo perché quel qualcosa è oggetto del desiderio dell’altro: A desidera B solo perché C desidera B. Ma questo equivale, evidentemente, a tradire la propria verità, per identificarsi, appunto, con la propria maschera, in quanto questa corrisponde a un modello che proviene “dal fuori”, a un modello socialmente condiviso. Siamo dunque di fronte a un paradosso: il bisogno di riconoscimento, che nasce dal desiderio di essere confermato nella sua propria identità, spinge l’Io a costruire una falsa immagine di sé che tradisce la sua vera natura. Da questa denuncia scopriamo anche che le passioni non sono sempre e solo sinonimo di verità; se è vero infatti, come ricordavo sopra, che fedeltà a se stessi significa capacità di aderire alle esigenze della propria vita emotiva, ascoltare i propri desideri, aderire agli appelli che vengono dal sentimento e dalla corporeità, è anche vero che laddove le passioni sono socialmente indotte e la nostra affettività è, per così dire, il frutto della manipolazione e della deformazione collettiva (come nel caso esemplare dell’amour propre), esse diventano un ulteriore fattore di opacità della propria interiorità. Il pericolo intrinseco alle passioni artificiali è quello di corrompere e distorcere la nostra interiorità, rendendo dunque irriconoscibile la nostra verità. La strategia che Rousseau propone è allora quella del ritorno a sé, di una inversione di marcia, di un percorso a ritroso che abbia come obiettivo quello di accedere di nuovo alla propria interiorità, liberandola da tutte le sovrapposizioni impure e fittizie prodotte dalla relazione con l’altro. Dobbiamo diventare noi stessi, o meglio, ri–diventare noi stessi, ritrovando quel nucleo originario sepolto sotto il cumulo delle deformazioni artificiali: Cominciamo dunque a ridiventare noi stessi, a concentrarci in noi, a circoscrivere la nostra anima con gli stessi limiti che la natura ha dato al nostro essere, cominciamo insomma a raccoglierci intorno a ciò che siamo, di modo che, volendo conoscerci, tutto ciò che ci compone ci si venga a presentare tutto in una volta14. Ci troviamo qui di fronte a un postulato granitico che noi oggi, smaliziati eredi del moderno e postmoderno disincanto, possiamo accettare solo con un salutare scetticismo: questo postulato, nel quale si può senza dubbio identificare l’universale presupposto normativo di Rousseau, è la fiducia nella purezza della natura e nella possibilità di accedere alle fonti naturali, vale a dire incorrotte, della nostra interiorità. 4. A partire da queste premesse, si apre una fase della riflessione di Rousseau — che corrisponde essenzialmente all’Emilio e alla Nuova Eloisa — tesa a delineare il percorso che rende possibile il ritorno alla propria interiorità e la riappropriazione della propria verità15. Sia Emilio che Julie devono sostenere l’incontro–scontro con le proprie passioni, e con il rischio a esse intrinseco della perdita di sé, per poter accedere a una nuova identità che sia allo stesso tempo autentica e morale; perché qui appunto emerge la valenza morale dell’ideale dell’autenticità, come ciò che coincide con il perfezionamento dell’Io e la sua liberazione dalla dipendenza prodotta dalle passioni. L’aspetto interessante è che al centro di questo percorso c’è la passione amorosa, su cui Rousseau proietta uno sguardo ambivalente, che è peraltro, sia detto per inciso, esemplarmente rappresentativo della sua teoria delle passioni: l’amore è un sentimento vitale e persino nobilitante, ma diventa distruttivo quando entra in conflitto non solo e non tanto con la norma sociale quanto con altri sentimenti e bisogni che sono altrettanto costitutivi delle esigenze dell’Io. Questo vale in particolar modo per la Nuova Eloisa: quando Julie rinuncia all’amore per l’amato Saint–Preux e accetta il matrimonio con Wolmar, il candidato scelto dal padre, non cede tanto agli imperativi sociali che vogliono il matrimonio libero dalla passione, ma risponde di fatto all’appello della natura (rappresentata dai genitori) e ai suoi stessi desideri, contrastanti con l’amour–passion ma altrettanto vitali: come la durata, l’amore filiale, la conservazione del suo mondo, 19 La fatica del dirsi Elena Pulcini Ma cos’è natura? e cos’è interiorità? Sappiamo bene quanto nel frattempo scienza e decostruttivismo ci abbiamo messi in guardia da ogni essenzialismo! Resta il fatto però che, al di là di ogni ingenuo ottimismo e di ogni anacronistico essenzialismo, Rousseau coglie un aspetto con il quale, dopo di lui, il pensiero moderno non ha ancora smesso di confrontarsi. Basti pensare all’intera e complessa stagione della psicoanalisi e al suo duplice insegnamento: vale a dire il carattere non trasparente della propria interiorità, e la possibilità di un percorso psichico ed emotivo che tenti, nonostante tutto, di liberarsi di quelle sovrastrutture e patologie che spesso ci spingono, appunto, a tradire noi stessi, generando alienazione e sofferenza, dipendenza e illusione. Uno di questi percorsi, forse quello prioritario, è per Rousseau, la possibilità di agire sulle proprie passioni, di ricondurle al loro nucleo originario, riportando in prima istanza l’“amor proprio”, competitivo, falsante ed alienante, all’“amore di sé”, capace di restituire all’Io il contatto con se stesso, di ricentrarlo, potremmo dire, ponendolo sulle tracce della propria verità, lontano dal frastuono del mondo. Ma non solo. C’è un altro aspetto che rende ancora attuale e feconda la lezione rousseauiana ed è l’importanza della lotta e del conflitto interiore. Ridiventare se stessi è tutt’altro che un’operazione indolore, poiché richiede al contrario il confronto con il male attraverso un faticoso cammino che consenta di fare chiarezza, di distillare il male dal bene, di capire dov’è la fonte della propria autenticità. Questo confronto è “sforzo” (effort), è lotta tra passioni contrastanti dalle quali è doloroso dissociarsi, dalle quali non è facile prendere congedo perché, come ancora ci suggerisce la psicoanalisi, ci appaiono tutte a prima vista legittime e irrinunciabili. 20 Quaderni di comunicazione 10 la serenità della famiglia e della comunità nella quale vive (Clarens) e alla quale essa non vuole rinunciare16. È vero che alla fine, al momento della sua morte, Julie rivendicherà l’intensità della passione e del desiderio, ma allo stesso tempo essa riconfermerà la sua scelta in quanto ispirata dalla consapevolezza di restare fedele a parti di sé altrettanto autentiche, e costruttive per il proprio universo relazionale. Appare chiaro dunque come l’autenticità sia il risultato di un conflitto interiore, di una lotta con se stessi, che prevede la sofferenza e il confronto con il male; un conflitto dal quale l’Io esce rafforzato nella sua stessa struttura morale. Emilio, a sua volta, dovrà attraversare una fase di distacco dalla propria passione amorosa e confrontarsi con i mali del mondo — in sintonia con il principio rousseauiano della differenza dei sessi che vuole l’uomo “pubblico” e la donna “privata” —, per poter tornare dall’amata (Sophie), forte di una nuova consapevolezza di sé e pronto a edificare, insieme a lei, una comunità giusta e trasparente. L’autenticità sembra contenere in questa fase un potenziale indiscutibilmente emancipativo, e perfino utopico perché, suggerisce di fatto Rousseau, solo l’Io autentico è capace di costruire una società libera dall’ingiustizia e dalla disuguaglianza, una vera comunità, che trova il proprio fulcro negli affetti e nelle relazioni, nell’amicizia e nella serena convivenza; al riparo dunque dagli egoismi e dalle nefaste competizioni dell’amour propre. Il ritorno a sé dunque non solo non è slegato dalla relazione con l’altro, ma è addirittura il presupposto irrinunciabile di una relazione con l’altro fondata su quei valori della fraternità e dell’uguaglianza, dell’affettività e della giustizia, alternativi a quelli della società corrotta e disuguale, che, come sappiamo anche dalle sue opere politiche, a Rousseau stanno particolarmente a cuore. 5. Rispetto a questo scenario, una svolta radicale si delinea in corrispondenza degli scritti autobiografici, dove l’ideale dell’autenticità assume una torsione soggettivistica che ne inficia in primo luogo la valenza morale. Si pensi al ben noto esordio delle Confessioni: Voglio mostrare ai miei simili un uomo in tutta la verità della propria natura, e quell’uomo sono io. Io solo so leggere nel mio cuore e conosco gli uomini. Non son fatto come nessuno di quanti ho visto; oso credere di non esser fatto come nessuno di quanti esistono; se non valgo di più, sono almeno diverso17. Qui, in primo luogo, l’attenzione si sposta sul proprio Io, sull’Io di chi scrive. Ciò che è in questione non è più la soggettività tout court, ma la soggettività di Jean Jacques che, in preda a una pulsione reattivamente autarchica, vuole affermarsi e imporsi al mondo nella sua radicale verità. Ogni maschera deve cadere, ogni “velo”, potremmo dire evocando una metafora cara a Rousseau, deve essere lacerato, per far emergere la verità dell’Io, per riversare all’esterno ciò che fino ad allora è rimasto celato nelle zone più segrete dell’interiorità: dunque anche le verità meno nobili e più scomode, perché in esse si annida la possibilità di riappropriarsi di se stessi, di sottrarsi al potere estraniante del mondo. Jean Jacques rompe così la dinamica perversa del confronto e della mimesi per dichiarare senza riserve la propria unicità, qualunque essa sia. 6. Nelle Confessioni dunque, non si può ancora propriamente parlare di quella degenerazione dell’autenticità in narcisismo nella quale Charles Taylor ha individuato una delle più inquietanti patologie, o “disagi”, della modernità19. Questo ulteriore slittamento soggettivistico sembra invece compiersi, solo poco più tardi, all’altezza delle Fantasticherie del passeggiatore solitario20, dove il congedo dal mondo diventa definitivo e radicale, e dove l’introversione entropica si assolutizza tanto da escludere l’altro persino nella sua funzione di speculare rispecchiamento: “Son dunque solo sulla terra, senza fratelli, né parenti, né amici, né altra compagnia che me stesso…”21. A questo proposito, Jean Starobinski ha parlato, con una formula molto efficace, di un “Narciso senza specchio”22, restituendoci così l’immagine di un Io chiuso nel circuito definitivamente autarchico di una ritrazione e recinzione solitaria. Il ritorno alla natura si declina come ritorno all’inorganico, al “puro sentimento dell’esistenza” nel quale trovare pacificazione e riparo da un mondo che ha tradito ogni speranza, ogni aspettativa. L’interiorità diventa la zona immunitaria per eccellenza, come testimoniano le ricorrenti metafore del lago e dell’isola, espressioni simboliche di un anelito alla protezione del ventre materno che mette l’Io al riparo da una duplice minaccia: la minaccia che proviene dall’interno, dalle proprie passioni, dal tumulto caotico dei sentimenti manipolati dalla società, e la minaccia che proviene dall’esterno, dagli altri, responsabili di abbandono e di tradimento. 21 La fatica del dirsi Elena Pulcini Mostrarsi dunque come si è. Ma in questo atto coraggioso e provocatorio comincia a emergere una deriva entropica e autoreferenziale che sembra rompere il carattere dialogico della ricerca dell’autenticità, sottraendole la sua valenza morale. L’Io si ritrae in se stesso e si afferma, per così dire, contro gli altri. Il viaggio nella propria interiorità che ha avuto fin qui la funzione emancipativa di costruire una diversa relazione con l’altro, di fondare forme di convivenza tese alla condivisione di un mondo migliore, subisce un’involuzione che sfocia nella rottura del legame con l’altro e nella rinuncia a ogni prospettiva sociale e comunitaria. Si potrebbero a questo proposito richiamare le parole di María Zambrano che più di ogni altro ha colto la svolta soggettivistica delle Confessioni, vedendovi l’inizio di una separazione narcisistica dell’Io dalla relazione oggettuale: “Vita che si erge solitaria, separata da ogni oggetto, poiché si è delineata in principio a immagine e somiglianza dell’Io o confusa con esso...”18. Da momento teso a ricentrare l’Io, a rimetterlo in contatto con le zone più profonde del suo essere per riportarlo nel mondo arricchito di una nuova consapevolezza, la solitudine diventa isolamento, compiaciuta e separata rivendicazione della propria originale verità. Eppure l’altro non scompare dalla scena, in quanto è di fatto chiamato a testimone di questa verità. La scrittura stessa è la prova più eloquente di un irriducibile desiderio di contatto, di confronto: si scrive solo per comunicare agli altri il proprio messaggio. Certo, l’altro conserva qui una funzione puramente speculare, di mero testimone passivo e muto della narrazione autoreferenziale dell’Io, il quale però rivela ancora, nonostante tutto, un potente bisogno di riconoscimento, che lo spinge a lanciare agli altri un accorato appello all’ascolto e all’attenzione. 22 Quaderni di comunicazione 10 Delineandosi come a–patico distacco e solipsistica autocontemplazione, la ricerca dell’autenticità viene a coincidere con quella “introversione della libido” nella quale Sigmund Freud ha indicato la dinamica psichica fondamentale del narcisismo, al di là delle sue possibili e molteplici manifestazioni23. L’immagine del “passeggiatore solitario”, chiuso nello spazio immunitario della propria autocontemplazione, preoccupato del “puro sentimento dell’esistenza” e deciso a nutrirsi di nient’altro che della propria sostanza, sembra effettivamente essere la prima, eloquente espressione di una deriva identitaria destinata a diventare una delle più preoccupanti e pervasive patologie della modernità24: una patologia originata dal fatto che l’Io diventa l’unico oggetto di pathos. “Ridotto a me solo — dice Rousseau — mi nutro, è vero, della mia sola sostanza, che però non si esaurisce; basto a me stesso, benché rumini — per così dire — a vuoto e sebbene l’immaginazione inaridita e le idee spente non forniscano più alimento al mio cuore”25. Eppure, permangono nell’universo rousseauiano due aspetti che non ci consentono di vedervi tout court il momento d’inizio della degenerazione narcisistica dell’autenticità. Il primo aspetto riguarda il fatto che il soggetto della Fantasticherie conserva, malgrado tutto, un anelito relazionale. È vero che gli altri non sono più degli interlocutori con i quali dialogare per costruire un mondo migliore, e non sono più neppure i testimoni della propria autonarrazione. Ma questo dipende dal fatto che il ripiegamento su di sé, il congedo dal mondo, sono la dolorosa conseguenza di una grande delusione nei confronti del mondo, di una rinuncia a ogni speranza di trasformazione. Di qui nasce quell’introversione narcisistica, che scaturisce tuttavia da quello che Herbert Marcuse ha definito, nella sua rilettura del mito di Narciso, “il Grande Rifiuto”26: vale a dire la protesta di un Io disilluso da una società ingiusta, competitiva e inospitale, rispetto alla quale l’unica chance sembra essere ormai quella di proteggere definitivamente la propria interiorità, autoescludendosi dal mondo. Il che vuol dire, ed è questo il secondo aspetto da sottolineare, che il Narciso rousseauiano non ha perso il contatto con la propria interiorità. Il suo limite è semmai quello di un arroccamento difensivo ed esclusivo, che tuttavia ha lo scopo di preservare la propria verità interiore. Siamo dunque ben lontani dalla patologia narcisistica contemporanea che viene invece descritta, soprattutto dalla riflessione psicoanalitica27, come perdita della relazione, dovuta alla confusione di confini tra sé e l’altro, e come svuotamento dell’interiorità, cui corrispondono specularmente manifestazioni di grandiosità e di onnipotenza. L’Io vuoto e grandioso del nostro tempo sembra aver smarrito, in altri termini, quel legame con la propria interiorità che consente ancora, all’Io rousseauiano, di preservare una rapporto autentico con se stessi e di immaginare, sia pure solo attraverso una residuale e struggente nostalgia, una relazione più autentica con l’altro. 1 in G.Mocchi e Marco Piazza (a cura di), Rappresentazioni dell’interiorità e dell’alterità nell’Europa moderna, “Bollettino Filosofico” n. XXIII (2007), Aracne, Roma 2008. 2 TAYLOR (1994). 3 TRILLING (1974), BERMAN (1972). 4 SENNETT (1982), LASCH (1981). 5 Cfr. PULCINI (2001). SIMMEL (1995, p. 34). SIMMEL (1995, p. 36). 8 Cfr. FERRARA (1989). 9 Cfr. PULCINI (2001). 10 HONNETH (2002). 11 ROUSSEAU (1970b). 12 ROUSSEAU (1970a, 1970b). 13 GIRARD (1981). 14 ROUSSEAU (1978). 15 ROUSSEAU (1981, 1992). 16 PULCINI (1990). 17 ROUSSEAU (1983). 18 ZAMBRANO (1995, p. 87). 19 TAYLOR (1994). 20 ROUSSEAU (1979). 21 ROUSSEAU (1979, p. 197). 22 STAROBINSKI (1975). 23 FREUD (1967–80, vol. VII). 24 SENNETT (1982) LASCH (1981). 25 ROUSSEAU (1979, p. 300). 26 MARCUSE (1968). 27 KOHUT (1976), GREEN (1985). 6 23 La fatica del dirsi Note Bibliografia Berman, M., 1972, The Politics of Authenticity: Radical Individualism and the Emergence of Modern Society, New York, Athenaeum. Ehrenberg A., 1999, La fatica di essere se stessi, Einaudi, Torino. Ferrara, A., 1989, Modernità e autenticità. Saggio sul pensiero sociale ed etico di Jean Jacques Rousseau, Roma, Armando. Freud, S., 1967–80, Introduzione al narcisismo 1914, in Id., Opere Complete, Torino, Bollati Boringhieri, 12 voll., vol. VII. Girard, R., 1961, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset; tr.it., 1981, Menzogna romantica e verità romanzesca, Milano, Bompiani. Green, A., 1983, Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Paris, Minuit; tr.it.,1985, Narcisismo di vita, narcisismo di morte, Roma, Borla. Hobbes, T., (1651) 1987, Leviatano, Firenze, La Nuova Italia. Honneth, A., 1992, Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main, Suhrkamp; tr.it., 2002, Lotta per il riconoscimento, Milano, Il Saggiatore. Kohut, H., 1971, The Analysis of the Self, London, Hogarth; tr.it., 1976, Narcisismo e analisi del sé, Torino, Boringhieri. Lasch, C., 1979, The Culture of Narcissism, New York, Norton; tr.it., 1981, La cultura del narcisismo, Milano, Bompiani. Marcuse, H., 1966, Eros and Civilization, Boston, The Beacon Press; tr.it., 1968, Eros e civiltà, Torino, Einaudi. Elena Pulcini 7 24 Quaderni di comunicazione 10 Pulcini, E., 1990, Amour–passion e amore coniugale. Rousseau e l’origine di un conflitto moderno, Venezia, Marsilio. Pulcini, E., 2001, L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale, Torino, Bollati Boringhieri. Rousseau, J.–J., 1970a, Discorso sulle scienze e sulle arti 1750, in Id., Scritti politici, Torino, Utet. Rousseau, J.–J., 1970b, Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza, in Id., Scritti politici, Torino, Utet. Rousseau, J.–J., 1978, Lettere morali, Roma, Editori Riuniti. Rousseau, J.–J., 1979, Le fantasticherie del passeggiatore solitario 1782, Milano, Rizzoli. Rousseau, J.–J., 1981, Emilio 1762, Roma, Armando. Rousseau, J.–J., 1983, Le Confessioni 1781–88, Milano, Garzanti. Rousseau, J.–J., 1992, Giulia o la Nuova Eloisa 1761, Milano, Rizzoli. Sennett, R., 1976, The Fall of Public Man, New York, Norton; tr.it., 1982, Il declino dell’uomo pubblico, Milano, Bompiani. Simmel, G., 1995, Le due forme dell’individualismo 1901–1902, in Id., La legge individuale e altri saggi, Parma, Pratiche. Starobinski, J., 1961, L’oeil vivant, Paris, Gallimard; tr.it.,1975, Jean Jacques Rousseau e il pericolo della riflessione, in Id., L’occhio vivente, Torino, Einaudi. Taylor, C., 1989, Sources of the Self, Cambridge Mass., Harvard University Press; tr.it., 1993, Radici dell’Io, Milano, Feltrinelli. Taylor, C., 1991, The Malaise of Modernity, Toronto, Canadian Broadcasting Corporation; tr.it., 1994, Il disagio della modernità, Roma–Bari, Laterza. Trilling, L., 1974, Sincerity and Athenticity, London, Oxford University Press. Zambrano, M., 1943, La Confesión como género literario y como método, México, Luminar; tr. it., 1995, La confessione come genere letterario, Milano, Bruno Mondadori. Duccio Demetrio L’illusione della verità in autobiografia. Artefatti educativi tra eccedenze e alterazioni 1. Dalla ammissione del vero alla sua imprevedibile scoperta È opinione diffusa, e non solo tra i profani, che dedicarsi alla scrittura della propria vita risponda al bisogno umano di rivelare qualcosa di se stessi, che fino a quel momento si era taciuto volutamente. All’urgenza, finalmente, di rendere pubblici opinioni, fatti, sentimenti a lungo prudentemente celati. L’“impresa” autobiografica, ché di un autentico travaglio interiore o morale sempre si tratta (quando la si intraprenda con serietà e con l’intenzione evocata), avrebbe quindi come scopo prioritario la rivelazione di verità, se non scomode, sovente compromettenti. Talvolta non solo per l’autore. Si scriverebbe perciò per cercare il perdono, un consenso venuto meno, la comprensione altrui, la riabilitazione sociale. Per vendetta, per rimorso, per rivincita. Per riappacificarsi con gli altri e i propri rimorsi. In un assieparsi di vizi e di virtù che, a seconda delle intenzioni dell’autobiografo, rendono in taluni casi la questione della veridicità di quanto scritto piuttosto sospetta. Ma, come accade per ogni manifestazione e artefatto intellettuale ( e ogni scrittura di sé è intrisa di fatiche del pensiero, è un fare e disfare, è fonte di emozioni impreviste, è un atto comunque creativo), anche ogni autobiografia, pur costituendo un gesto individuale, che può sottrarsi ai peggiori condizionamenti, in quanto espressione appunto del privilegio che ci dato di essere soggetti imprevedibili, è pur sempre figlia di situazioni e climi culturali: nei quali essa prende forma e ai quali l’autore intende riconsegnarla. Per ricevere risposte di conforto e plauso o, viceversa, di disapprovazione e indifferenza. Ne consegue, che la storia dell’autobiografismo, delle sue mode, è sovente (quasi) specchio fedele delle concezioni inerenti l‘idea di “io”. Nonché delle enfasi tributate a tale cruciale prerogativa mentale, le cui molteplici implicazioni sono altrettanto spesso inattese. La tecnica che sovrintende alla produzione autobiografica, difatti, tende ad esaltare e a celebrare l’ego del narratore: mentre, in altri casi, la sua presenza si avverte come in un mormorio sommesso, si stempera in pagine che parrebbero scritte da una voce fuori campo. L’io, con le sue ragioni e le ambigue facce con le quali si manifesta anche nello scrivere, è pur sempre l’anima, la causa prima, evidente o sotterranea di ogni gesto autografico. Autoreferenziale, prima ancora che autobiografico strictu sensu. Ogni scrittura di sé è, del resto, un corpo a corpo continuo tra l’io narrante (la prima persona singolare che si espone e si 26 Quaderni di comunicazione 10 cela scientemente o senza saperlo pagina dopo pagina), senza la cui intenzionalità dichiarata nulla accadrebbe, e i dubbi, le censure, le prudenze, le continue revisioni, che tale lavoro su se stessi comporta. Il che ci dice subito molto sulla natura coscienziale dell’impresa. L’autobiografia in senso proprio – una rappresentazione la più ampia e completa della propria esistenza in ogni suo aspetto – non può mai esonerare perciò lo scrittore dalla disamina dello stato di salute del proprio io. Della componente per definizione più razionale della psiche, che sa dettare, in ragione di un’educazione e di una morale ricevuta, pertanto regole e confini al percorso intrapreso; che non può permettersi, come avviene nel diario o nella conversazione epistolare, le libertà e le licenze qui maggiormente possibili. Se in questi casi manca un piano prestabilito, essendo queste due espressioni narrative più autografiche che autobiografiche affidate al momento, all’estro, alla contingenza umorale o passionale, l’autobiografia non può sottrarsi all’onere di darsi un programma veritativo più o meno rispettato in corso d’opera. A ciò occorre aggiungere che l’ego dispiegato dalla scrittura stabilisce ogni volta confini piuttosto labili e porosi con le dimensioni inconsce: si rende sovente un maieuta inconsapevole (un’ eresia per le topiche freudiane) di stati profondi e inconsci senza, fra l’altro, che qualcuno stia accanto al narratore in quest’avventura decisamente autoanalitica. Pertanto, la concezione “rivelativa” sopra citata, che ha sempre potuto contare su un suo pubblico di curiosi, amanti degli intrighi e delle rivelazioni sensazionali, ha avuto nel corso dei secoli grande credito, soprattutto nella versione cosiddetta confessionale o espiatoria del genere. Presente in autori appartenenti sia a tradizioni cristiane, sia laiche e non credenti. Quando, nel primo caso, la scrittura delle proprie colpe, degli errori e dei delitti commessi intendesse confermare la sincerità del pentito dinanzi a Dio, più che agli uomini. Dal momento che lo scrivere è notoriamente un’azione ben più impegnativa e compromettente della parola pronunciata a voce, si è presupposto che il privilegiarla fosse un modo “più alto” per fare ammenda di quanto si ritenesse riprovevole aver commesso. Mentre, nel secondo caso, si trattò per lo più (e si tratta ancora) di motivazioni inerenti ammissioni, più che di misfatti dalle implicazioni ultraterrene, di fragilità e di debolezze umane, di mancanze morali o di ingiustizie perpetrate verso i propri simili. Nella più assoluta solitudine e nel silenzio di qualsiasi divinità, nemmeno cercata e invocata. O di ingiurie rivolte alla vita stessa, quando le confessioni personali riguardassero l’incapacità di rispondere, senza paure e smarrimenti, alle domande che, da che mondo è mondo, sollevano le vicissitudini dell’esistenza o l’assunzione di un certo ruolo adulto (di madre, padre, figlio, amante, cittadino, ecc) non assunto o apertamente evitato. Non la confessione e la speranza di una remissione dei peccati, bensì la riconciliazione con se stessi, senza mediazione sacerdotale e assoluzione ultraterrena, costituiscono – in tale frangente – la ricompensa di chi scelga di scrivere alcunché della propria vita. 2. Le implicazioni autoeducative In entrambe le culture autobiografiche, in ogni caso, non è difficile individuare la presenza, spesso apertamente dichiarata e argomentata, di un io impegnato a 27 L’illusione della verità in autobiografia Duccio Demetrio scrutinare il proprio esistere attraverso ripetuti esami di coscienza, malgrado tale entità dal compito registico sia sospinta a ciò da motivazioni prettamente inconsce. Grazie alla quale la questione delle specifiche verità, finalmente da annunciare a coloro che vorranno leggere quelle pagine rivelatrici, si sarà trasformata in una scoperta di verità impreviste. O perché a lungo sepolte nell’oblio voluto o perché, e propendiamo per questa soluzione, è la scrittura autobiografica, di per sé, che ha il potere maieutico di mostrare a quell’io narrante sembianze, possibilità, risorse ignote. La scrittura si rende, in altri termini, il proprio “direttore di coscienza”. Per alcuni ispirato dalla misericordia e dalla grazia non di questa terra; per altri, o dal buon senso o dalla ricerca di una più matura accettazione e tolleranza verso se stessi. Con il rischio che tale vicenda si risolva in una sorta di autoassoluzione fin troppo compiacente, nel segno di una ritrovata armonia con se stessi, ad altri ancora assai poco raggiungibile. Insomma, la scrittura di sé, quale sia la declinazione di genere, esercita su autori e autrici effetti veritativi che poco hanno a che vedere con singole verità eclatanti e scottanti esposte in evidenza. È la scrittura in quanto tale un esercizio parresiastico che mette a nudo la persona che se ne avvalga e che, ben lungi dal scegliere che cosa scrivere e che cosa tacere, potrà vivere mutazioni cognitive ed emotive ben più significative di quelle connesse alla versioni religiose o laiche richiamate. Non a dei contenuti moralmente riprovevoli va dunque ricondotta la questione: bensì al fatto che quali siano queste mezze o intere verità, si sarà messo in moto un processo di revisione del proprio concepirsi al mondo, al presente e al passato, dalle conseguenze imprevedibili. Ci sono stati e ci sono scrittori che interrompono questo itinerario perché si scoprono non in grado di elaborare simili agnizioni e ci sono stati e ci saranno anche coloro che, invece, accettando una simile sfida con se stessi, si percepiranno più veri ( più radicati e attenti alla vita) innanzitutto ai propri occhi e alla propria disincantata coscienza. Per tale motivo le verità, in questo campo, non sono riducibili a fatti e ad argomenti a lungo nascosti come negli esempi citati. Per questo occorre che tale problema venga fatto affiorare in altri luoghi e momenti di questo indirizzo narrativo, fra l’altro, dalle implicazioni educative recentemente scoperte. Tali non fosse altro per quanto già abbiamo ricordato: la scrittura di sé è infatti generatrice di ripensamenti, ravvedimenti, introspezioni che rimettono in moto la moralità, il pensiero, i compiti sociali del soggetto che decida di scrivere del proprio passato o si dedichi alla scrittura diaristica, purché con sincerità ed autenticità. Poiché altrimenti, anche di questo non potremo non accennare, la scrittura autobiografica da metodo ed esperienza di ricerca della verità, come è sempre accaduto, si trasformerebbe in un’ operazione di palese falsificazione. In una aperta attività di copertura e affossamento del vero, in un gesto di natura spettacolare e pubblicitaria dove sarebbe l’aperto inganno a costituire, allora, il motore di un intento che, più che educativo in senso emancipativo, varrà a manipolare e a frodare le coscienze dei lettori. Anzi, dei quali si voglia proprio raccontare per ragioni che trascendono il piacere di farlo. Poiché lo scrivere un’autobiografia equivale sempre a compromettersi, ad esporsi, a rischiare, quei fatti già hanno in sé un valore, un peso, per chi li voglia rievocare ed annunciare. Ad essi l’autore o l’autrice non potrebbero del resto derogare, essendo la loro esistenza l’unica fonte (materiale, mentale, emoti- 28 Quaderni di comunicazione 10 va – dalle complessità sconfinate o modeste) cui ispirarsi ed attingere, ricorrendo ad interpolazioni, a censure e ad arbitrarie alterazioni, che fanno parte del “gioco autobiografico”. Dove accade paradossalmente di essere sinceri mentendo o di mentire dicendo la verità. Poiché ogni racconto di questa natura è soggettivodipendente, quindi parziale. E non sempre per cattiva e proterva intenzione. Perché al di là di ciò di cui si vuole scrivere, la penna è nelle mani di un individuo che riferirà di una sua versione, immancabilmente parziale ed opinabile. Dove, purché si riferisca di fatti effettivamente accaduti e quindi confermabili da occhi e narrazioni altrui, l’unica tolleranza concessa all’autore di sé (all’egonarratore, altrimenti detto), sarà di carattere estetico e formale; essa consisterà nella scelta – per altro adottabile soltanto dal testimone o primo attore di quegli eventi salienti -, di ricostruirne gli intrecci, i movimenti e gli sviluppi. Ora ricorrendo a scansioni scrupolosamente cronologiche, ora privilegiando e sottolineando le scene e gli sfondi reputati più rilevanti. Ai quali, ancora una volta, in modesta parte possa applicarsi la categoria di oggettività. In questo secondo caso, nella più assoluta discrezionalità di poterne narrare adottando modalità discontinue e disordinate, di anticiparne o di posticiparne l’evocazione, in ragione di criteri ispirati da urgenze e tensioni emotive, personalissime, più che dal rispetto di ogni regola genealogica che sacrificherebbe le autentiche intenzioni dell’autore. Parlare di sé, innanzitutto, farsi conoscere sul piano psicologico, uscire dal silenzio e dall’anonimato, chiedere perdono, rivendicare le proprie convinzioni, esporsi impudicamente, che altro rappresenta tutto ciò se non un travaglio di tono autoeducativo? Quando tale affanno sia generatore di mutamenti interiori, nonché di atteggiamenti innovatori verso se stessi e gli altri. Di volta in volta esperiti con motivazioni diverse, ma nondimeno connesse a giustificazioni e ad alibi, che nella storia complessiva dell’autore potrebbero essere individuate. 3. Oltre l’onere genealogico, pur sempre letteratura In autobiografia la parte, l’episodio, il frammento non sono altro che un sintomo, una traccia. È la visione d’insieme che può spiegare allo scrittore e ai suoi lettori che cosa quella vita sia stata e perché abbia assunto quelle e non altre forme, perché abbia conosciuto quelle e non altre trasformazioni. Tutto ciò si adempie in uno slittamento inevitabile verso una nozione di verità quanto mai discutibile, ammesso che di tale questione esistenziale esistano ancora tesi diverse da quelle addebitabili alla contingenza, all’utile, alla relatività. Secondo la rassicurante via genealogica ogni fatto possiede un antefatto e una conseguenza. Dove quei prima e quei poi che sembrerebbero ordinare ogni vita (e ogni suo racconto) cessarono ad una svolta del pensiero autobiografico di rappresentare l’unico modello temporale cui conformarsi. L’autobiografia “classica”, come è noto apparsa nel ‘700, esigeva che si rispettassero le successioni lineari degli accadimenti, dalla nascita al momento in cui l’autore decidesse di por mano alla parola fine; mentre con il Novecento, una nuova filosofia del tempo, l’avvento della psicoanalisi, la teoria della relatività, una società basata su ben altri ritmi produttivi, emanciparono senz’altro i narratori 29 L’illusione della verità in autobiografia Duccio Demetrio dall’onere di dover rispettare un paradigma che, per lo meno in occidente, aveva fondato la storia umana e le storie di ciascuno. Da quel momento in poi, un’autobiografia pur non cessando di ricostruire radici riconducibili ad un dato tempo storico e sociale, divenne espressione della relazione misteriosa, inafferrabile, inconscia che l’io narrante iniziava a stabilire con l’adempiersi di quei fatti. Se, in precedenza, la natura del passato non suscitava dubbi, tanto quanto non ne sollevavano le traiettorie delle stagioni della vita e le autobiografie si basavano su tali progressioni, ora, tale certezza veniva meno. Con conseguenze non irrilevanti agli effetti della ricostruzione di talune verità fattuali, la cui legittimazione non poteva più poggiare sulla coerenza che era compito della scrittura documentare, ad esempio, tra i passaggi dalla infanzia alla giovinezza, dalla maturità alla vecchiaia. Lo spaesamento di ogni aspirante autobiografo, da allora in poi, iniziò a farsi palese e per questo si assistette ad una crisi profonda del genere, ma anche alla sua crescita ovvero alla messa in crisi di canoni troppo costrittivi. Tuttavia, se l’onere della temporalità cronologica poteva essere infranto, non così accadde e accade se la sfida è costituita dal mostrarsi fedeli (almeno) alla propria verità esistenziale. A tutto quanto vivendo si è imparato vivendo a proprie spese e dove la stessa idea di verità si sostanzia fenomenologicamente con il dato di fatto inconfutabile di aver vissuto e aver attraversato e patito la vita. Di essere stati generati e visti da qualcuno, di essere stati amati, odiati, raccontati… L’aspirazione e il desiderio di mantenersi fedeli a quanto sia accaduto all’autore di esperire vivendo, di incontrare, di patire, nella coerenza con le proprie radici e origini, contraddistingue e differenzia ulteriormente (“dovrebbe”, in linea di principio, essere così) l’autobiografia da altri generi narrativi. La reinvenzione della propria esistenza, fino a mutarla in quella di un altro, in una autentica finzione di sé, non può essere difatti accettata. L’impegno costituito dal rispettare il canone del reality writing (nel ricondursi alla realtà delle esperienze vissute e in parte confermabili da altri) ad ogni buon conto rappresenta uno spartiacque cui, rispetto ad ogni altra fantasiosa maniera di raccontarsi, occorrerebbe sempre ricondursi. Se di autobiografia si tratta. Dichiarando apertamente l’intenzione di oltrepassare quei limiti necessari affinché la propria storia acceda più liberamente alla fascinazione del romanzo. Se ogni scrittura di sé è “libera” per sua intrinseca natura, purché sia dettata da nessun‘altra aspirazione che non sia il bisogno, anzi il diritto, di individuarsi e identificarsi esistenzialmente, è palese che questa necessità si rende tanto più impellente laddove la verità su di di sé si voglia dire e cercare. Uno scritto, pur scarno, stentato o contorto, scaturito da un io narrante che desideri confermare, al presente e al passato, di essere esistito e di esistere ancora ( per il solo motivo di prendere coscienza di ciò scrivendone) cerca, al di là della natura dei fatti dei quali vuole render conto, soprattutto questa verità. Il che, secondo alcuni, esautorerebbe tali prove da ogni apprezzamento di natura letteraria; spostandosi la questione su aspetti di esplicita intonazione psicologica, psichiatrica, filosofica. A meno che il narratore non abbia scelto la propria esistenza per trovarvi l’ispirazione artistica venuta meno, cui l’ascoltare e incontrare le storie altrui più non basti. Modalità verso la quale nessuno autore, e non solo in letteratura, potrà negare – almeno una volta – di esserne stato attratto e sedotto. Né più ne meno di quanto 30 Quaderni di comunicazione 10 non avvenga nel linguaggio dell’autoritratto pittorico, rispetto al quale non vi è critico d’arte che ne possa escludere, in innumerevoli casi celebri o naif, i pregi artistici ed espressivi incontestabili. Tuttavia, indagando ulteriormente in simili pulsioni, se la cronaca di cui gli autori sono stati diretti protagonisti nel corso del “loro” tempo rappresenta senz’altro il “motore di ricerca” prevalente del progetto di scrittura non sarà mai la verità fattuale, in tutta la sua scontata relatività e parzialità ricostruttiva, la vera posta in gioco dell’impresa autobiografica che spinge a scrivere. C’è sempre molto di più in ogni autobiografia; molto di più delle concatenazioni tematiche, degli intrecci e delle singole storie. È questa “eccedenza imprevista” – che sorprende e spiazza gli autori per primi – a rendere, a nostro parere, ogni autobiografia un artefatto materiale, sia esso cartaceo o elettronico, al quale l’attributo “letterario” crediamo invece si addica anche nelle manifestazioni più modeste ed elementari. Dove la dimensione simbolica, l’essere stati indotti a scrivere, a rappresentare gli eventi in un certo modo, ad usare un certo linguaggio piuttosto che taluni criteri compositivi strutturali, piuttosto che disorganici e disomogenei, non è mai assente. Tanto quanto lo sono, fra l’altro, le fantasie che l’autore nutre prima di iniziare a scrivere, durante il cammino o giunto alla fine, rispetto ai destinatari della sua opera. 4. Lo scrivere rabdomante Ogni costrutto autobiografico, realizzato da un bambino alle prime armi o da un narratore sofferente di ogni età, merita quindi un’attenzione non soltanto connessa a quanto costui o costei siano riusciti a dire di sé, ma a quanto non dicono affatto. Per loro scelta o per astensione non voluta. Purché si accetti di accogliere nella “famiglia letteraria” ogni tentativo, anche il più umile, di dare un proprio senso ai propri resoconti di vita e (per altra via) di trovarne uno o più di uno, grazie alla scrittura come già ribadito. La cui ineguagliabile funzione rabdomantica percepisce e fa sgorgare verità impensabili in itinere, poiché lo scrivere è un camminare e un evolvere nella fissità del corpo. Evento che può compiersi in ogni luogo e circostanza, le più difficili e insostenibili umanamente, purché si persegua la sopravvivenza del proprio io cosciente e narrante, oltre alla pulsione autobiografica di lasciare ad altri quello sguardo sulle cose del mondo. Sulle sue bellezze e i suoi orrori. Come ebbe a sostenere Roland Barthes; il quale tenne più volte a ribadire che: “Per letteratura intendo il complesso grafico delle tracce di una pratica: la pratica dello scrivere” (Barthes 1973, p. 97). Qualunque dunque sia questa pratica, degna di eccellenza piuttosto che soltanto di un interesse umano oltre che intellettuale, essa merita che la si apprezzi, in quanto tale. Nel suo “bucare” gli strati inflitti o autodecisi del silenzio, della solitudine imposta, del dolore: nel perseguimento di ciò che riesca a configurare nel più timido o estroverso manifestarsi una soggettività, una voce pur ai margini, che scrivendo voglia gridare o sussurrare la propria disperazione o la sua gioia. Per questo c’è indizio autobiografico, c’è traccia letteraria, anche quando l’autore non intenda affatto attenersi al canone per consuetudine più accreditato: e 5. Finzione dovuta al personaggio e enigmaticità dell’autobiografo Pertanto, occorre semmai chiedere conto del proprio operare non veridico. non a costoro, che si avvalgono inevitabilmente della trasfigurazione letteraria per raccontarsi, semmai, a tutti coloro che la redigano per altri scopi. “La menzogna, nell’arte ha per scopo la verità” (Romano 2006, p. 18 e ssg..), ci rammenta Lalla Romano. Pertanto, se l’arte non è l’ambizione dello scrittore, la verità della vita raccontata non sarà mai assoluta menzogna. La finzione cui dà vita l’autobiografo è diversa da quella cui attende il letterato di professione; è una finzione inevitabile poiché, scrivendo, si dà vita (lo si rianima) ad un personaggio che è esistito per davvero. La cui verità resterà sempre insondabile del tutto, anche perché in movimento. La scrittura autobiografica, a differenza del romanzo, può essere riaggiornata innumerevoli volte e rimaneggiata successivamente. E quando l’autore dovesse lasciare la vita, non potendo entrare a far parte di punto in bianco delle figure della completa finzione, quel personaggio che ha impersonificato continuerà ad essere lacunoso, esposto ad ipotesi interpretative diverse da quelle adottata dall’ermeneutica letteraria. I cui personaggi possono essere esposti a nuove analisi e congetture, ma inevitabilmente all’interno di qualcosa che non è mai nato alla vita. L’autobiografo come protagonista che invece è apparso concretamente nel 31 L’illusione della verità in autobiografia Duccio Demetrio cioè a quell’onere desueto di parlare di sé secondo cronologie, in base al succedersi di scansioni temporali improntate a narrazioni causa-effettuali o prima-dopo. Ci sono narrazioni che si sottraggono al principio di consequenzialità e scelgono la più spontanea accidentalità. Ce ne sono altre, le più sospette se il criterio veritativo è dichiarato il prevalente, che scelgono di dipanare in resoconti ostentati i propri meriti, in cursus honorum autocelebrativi sia di successo che di sconfitte, secondo una inveterata tradizione che apertamente mira a enfatizzare gli eventi per avvantaggiare l’autore o per suscitare consenso e commozione nei suoi confronti. Tali alterazioni inevitabili sono cioè ravvisabili anche quando gli autori, in veridica onestà morale, si diano la briga di esporsi nel “loro libro” senza finzioni e coperture studiate ad arte; ben oltre ogni sforzo pur encomiabile di rendersi attendibili, credibili, presentabili ai propri e altrui occhi. Ben oltre, quindi, la indubbia verificabilità e credibilità storiografica, a testimonianze incrociate, di quanto possa essere accaduto in una storia di vita, la questione del “vero” in autobiografia non è che un aspetto del più complesso desiderio di dirsi. Dove il non riuscire a esporsi in tutta evidenza, il non poter tutto narrare anche volendolo, dà luogo allo status quaestionis più interessante di questo “caso”narrativo dalle infinite tipizzazioni. Quanto pregiudizialmente esposto, non è affatto evidente all’aspirante autobiografo mosso da buona fede e spontaneità, che lo vede spesso confuso in merito agli usi e agli abusi che dell’autobiografia si è soliti fare. Come spergiuri consapevoli o come accorti amministratori di se stessi. Dove in questa categoria, è evidente, non possiamo includere coloro che, una indubbia minoranza, seppero trarre ispirazione letteraria, filosofica e poetica dalla loro storia in una prospettiva decisamente artistica e destinata alle stampe, a filtri editoriali, ad un pubblico. 32 Quaderni di comunicazione 10 tempo, nel suo tempo di vita, sfuggirà dunque ad ogni cattura. Tanto quanto ciascun uomo o donna la cui verità ultima riuscirà a sottrarsi ad ogni categorizzazione anche la più accurata e “scientifica”. Le stesure autonarrative (non diaristiche, quindi giornaliere; se autobiografiche, giocoforza retrospettive), non a caso, sono spesso precedute o seguite da dichiarazioni esplicite e circostanziate degli intenti che costoro si prefiggevano di raggiungere. Di solito, esse sono affidate alle premesse o alle conclusioni che è dato leggere negli esordi o negli epiloghi. Più raramente, ci si imbatte in introduzioni che riguardino gli aspetti stilistici o inerenti le modalità narrative, che ci si riprometteva di adottare nel corso della narrazione. Delle quali l’autore o l’autrice, ai loro esordi, hanno ancora una percezione alquanto vaga; dal momento che in corso d’ opera accade a costoro di migliorare i tratti formali dello scrivere, scoprendo riga dopo riga quale andamento discorsivo possa mostrarsi più consono e in grado di sottolineare quelle verità di cui si vuole informare il mondo. 6. Un patto da riaggiornare dinanzi alle nuove domande di scrittura Il famoso “patto” tra narratore e lettore – nozione preziosa e felice introdotta ormai una trentina d’anni fa da Philippe Lejeune – qualora il destinatario si configurasse ancora senza volto, ovvero siglando con lui un accordo di sincerità, dovrebbe di conseguenza essere subito confermato da dichiarazioni di ricercata trasparenza e autenticità. Nei limiti del possibile, come si è detto. Il che dovrebbe fugare ogni dubbio e sospetto sulla fraudolenta fantasiosità del racconto. Oltre a costituire una sorta di linea di condotta morale, dalla quale il narratore promette a se stesso e al suo indeterminato pubblico di non discostarsi. Lo scopo di un progetto autobiografico, con queste premesse, non dovrebbe pertanto dover lasciar adito ad alcun equivoco: ed anche laddove l’autore scegliesse di narrarsi in terza persona – un artificio spesso adottato, che consente all’io narrante di osservarsi mentre rievoca come fosse un altro da sé ad aver agito – in ogni caso ciò non invaliderebbe la natura ispirata da una predichiarata veridicità dell’impresa. Tale programma, spesso segnalato nelle premesse come accennato, lo si ritrova in numerosi classici e in esempi che è dato reperire in archivi o nei cataloghi di molte case editrici fuori mercato che pubblicano a spese degli autori. Una consuetudine, questa, non soltanto contemporanea: antica quasi quanto l’invenzione della stampa. Come è noto, oggi sono le nuove tecnologie del fai da te autobiografico che incentivano, oltre alle risorse elettroniche dell’autonarrazione, l’espansione di un’attività che è testimonianza inequivocabile di una società sempre più fondata sulle esigenze di mettersi in mostra, di raccontarsi, di farsi conoscere e non solo per ragioni, come al solito, imputate alle culture esibizionistiche dell’immagine e dello spettacolo. Chi un tempo non avrebbe mai osato prendere in mano la penna, contando sull’anonimato delle scritture di rete, si fa coraggio e si inserisce nel grande anfiteatro mediatico perché non è più disposto a mettere a tacere la propria esistenza, fosse anche la più banale e la più vieta. L’autobiografia da privilegio elitario è divenuta un’espressione, per nulla sottovalutabile delle democrazie contemporanee, dei nuovi canali interattivi, globali, 7. La processualità veritativa: una lezione filosofica e di cura Pressocché da sempre, dalle origini di questo genere dalla datazione storica controversa, si scrivono autobiografie (memoriali, resoconti di viaggio, ricordi d’ esperienze vissute) per tacere verità scomode, per costruirsi alibi, per autoconvincersi di aver realizzato quelle imprese. Il confine tra scrittura autobiografica e romanzo d’ invenzione, seppur ispirato ad eventi effettivamente accaduti all’io narrante, è quanto mai fragile. Ancora Lalla Romano, in una delle sue più fulminati intuizioni, non cessava di ribadire nella sua proverbiale lucidità e sottile ironia verso gli aspiranti alla verità in autobiografia, che sempre l’autobiografia “è una menzogna ben congegnata” (ivi, p. 25). La scrittrice estremizza quanto detto in precedenza: chiunque, narratore di sé o scrittore, nel momento in cui prende la penna in mano genera finzioni. Non può farne a meno. All’insaputa sovente del suo autore, ignaro del fatto che il suo scrivere mentre racconta tace, distorce, immagina. La menzogna però è ritenere che l’autobiografo possa mai diventare un personaggio totalmente letterario. Ciò accade perché è insito nella scrittura, come 33 L’illusione della verità in autobiografia Duccio Demetrio dei quali possiamo disporre. Tutti costoro, oggi come un tempo, sono e furono indotti a por mano a tale impresa dal desiderio improrogabile seppur vago, dalla urgenza insolita, dalla chiara volontà emancipativa, di emulare qualche grande narratore o, più spesso, da una sorta di enigmatica urgenza a non essere dimenticati dalla assai ristretta cerchia del proprio prossimo. Si tratta di una spinta sociale, potremmo aggiungere. In molti casi, dichiaratamente pedagogica. Poiché chiunque crede, a torto o a ragione, quale sia stata la sua vita, di aver imparato da essa qualche stratagemma per non restarne travolti, nel corso degli anni maturi è difficile che si sia mostrato indifferente al desiderio di spiegare ad altri quanto appreso a proprie spese. Per sopravvivere alle inevitabili traversie e per conquistare qualche frammento di felicità. E, questo, anche poche istruzioni per l’uso, costui o costei vorrebbero comunicare ai destinatari reali o immaginari con schiette pagine vergate con convinzione o adombrandolo tra le righe. Da Jean-Jacques Rousseau – inventore moderno e indiscusso di un indirizzo che con lui conobbe la sua prima vera maturità -, ai suoi epigoni più recenti, non solo celebri, è dato assistere ad un proliferare di “egoscritture” che non accennano dunque ad esaurirsi, riconfermando alcuni tratti e stilemi intramontabili. I quali non fanno che attestare la possibilità offerta a tutti e tutte di identificare talune tipologie autobiografiche e alcuni “topoi” tematici immancabili in un canone autobiografico. Il che ci consente di adottare nelle analisi testuali alcuni criteri che appartengono alla critica letteraria, anche se certamente di opere letterarie non sempre è possibile parlare, ma come si è detto con Barthes, di letteratura senz’altro sì. Le verità che la tradizione autobiografica documenta, testo dopo testo, in quella sterminata vastità di esempi che nessuno riuscirà mai a enumerare, sono dunque sempre mezze- verità. In una ulteriore miriade di casi, si tratta di esplicite e mendaci verità, sulle quali l’autore o l’autrice sarebbero disposti a giurare il falso. Fino alla smentita plateale ed accusatoria. 34 Quaderni di comunicazione 10 in ogni forma d’espressione artistica, creare qualcosa d’altro dal vero. Un’altra realtà dotata di sue realtà. Non per protervia oculata e colposa, perché lo scrivere, anche nel nostro caso, altera e corrompe, indipendentemente dalla onestà e dalla sincerità attendibile dell’autobiografo, quella congerie di fatti, di emozioni, di vicende che sostiene di aver incontrato e patito lungo il cammino della propria esistenza. Dove la rievocazione indispensabile all’autobiografo non riesce a colmare le innumerevoli lacune, lo scrivere – la sua intrinseca potenza creatrice – getta ponti tra i ricordi, aggiunge o toglie a piacere, crea ambienti dei quali resta soltanto qualche ombra memoriale… In una foga ora compensativa ora trasformativa, senza la quale ogni scrittura personale si ridurrebbe a poco più di una scarna elencazione di episodi, privi di nessi emotivi, di elementi spazio-temporali indispensabili alla produzione di scene, di momenti contemplativi o drammaturgici. Lo scrivere li migliora o peggiora, li imbruttisce o imbellisce, li rende verisimili o li deforma: perché la penna, che pur non persegua minimamente la stesura di un romanzo d’ invenzione, di una favola, di una fantasticheria, non scrive mai “da sola”. Nemmeno nelle mediatiche scritture automatiche, che ci porrebbero in contatto con storie e narratori dell’oltretomba che si avvarrebbero della nostra penna per essere ricordati. La penna, tra le dita di chi la diriga verso una rievocazione o un pensiero, obbedisce allo scrittore, alla scrittrice, i quali se è vero che intenzionalmente scrivono con consapevolezza, di tutto desiderando raccontare, purtuttavia, non sono mai assoluti padroni di quel che vanno facendo. Ostinati e all’inseguimento della pienezza memoriale, si ritrovano dinanzi alla impotenza di non riuscire a piegare l’amnesia ineluttabile del loro fare. Anche in questo lo scrittore, che può permettersi liberamente di inventare, gode di una maggiore libertà “amorale”. È bene, crediamo, che si abbandoni ogni velleità volta ad affidare alla scrittura di sé, e specificamente alla tentazione autobiografica, l’onere di farsi carico delle nostre verità. Assai meglio, è sostituire la nozione con un più modesto concetto fenomenologico e costruttivista, che ci aiuti a capire che, non le verità, ma “i punti di vista” ci sono piuttosto concessi. Proprio questa, parrà curioso, è la grandezza dell’autobiografia. Poiché un mondo personale che si credeva unico, scrivendo, si rivela essere abitato da una sterminata molteplicità di vite, di storie, di opinioni (proprie e chieste in prestito ad altri). Si riapre al possibile. In una versione del mondo decisamente migliore, poiché non monocorde e mononarrativa. La singola voce si avvede delle tante che la abitano, delle coralità che la costringono a ridimensionare toni e ambizioni. Già negli anni novanta da poco trascorsi, il filosofo recentemente scomparso Aldo Giorgio Gargani anticipò quali fossero, cimentandosi più volte nella scrittura autobiografica, le potenzialità generative della scrittura di sé a livello di propagazione dei punti di vista applicabili alla propria storia. Volle e seppe interrogarsi sul nesso ineludibile tra narrazione e autobiografia dimostrandone tutta l’importanza filosofica. Iniziando da semplici domande poste a se stesso, interrogando l’impotenza di raggiungersi, la inconsistenza stessa della idea di identità personale. Per Gargani, la conoscenza fu innanzitutto retrospezione narrativa e autoriflessiva; fu tensione verso la ricerca non di un sé sostanziale, dotato di una qualche Noi abbiamo una nascita che è determinata dall’atto di procreazione dei nostri genitori, e che è poi modellata dalle autorità parentali, famigliari, sociali, culturali e da tutte queste istanze noi siamo resi di colpo responsabili senza per così dire averlo richiesto. Ma poi c’ è una nuova nascita, che non è quella recepita dall’esterno e che è precisamente la nascita che noi ci diamo a noi stessi raccontando la nostra storia, ridefinendola con la nostra scrittura che stabilisce il nuovo stile secondo il quale noi esigiamo di essere compresi dagli altri… la realtà dell’essere nostro deve essere raggiunta attraverso un processo paradossale mediante il quale bisogna reinventarsi per mezzo della scrittura per diventare alla fine quello che si è. (Gargani 1992, pagg 3-5) La lezione che egli ci consegna è quantomai preziosa, agli effetti del discorso fin qui condotto. Per chi abbia individuato le altre potenzialità applicative della scrittura, oltre il gesto spontaneo, libero, pulsionale nei secoli sperimentato da una immensa folla. È indispensabile assumere sempre più lo scrivere autobiografico, in una versione ora educativa, ora clinica e terapeutica delle modalità e degli effetti disvelatori che agiscono sugli autori, non come aspirazione ad un risultato definitivo. Come un divenire esistenziale che impara a farsi domande sempre più complessa sul passato e il presente vissuto. La sua efficacia in simili direzioni si rivela tale se chi si incarica di incoraggiarla, di accompagnarla, di argomentarla in corso d’opera, mira a rimettere in moto processi tanto emotivi quanto cognitivi nelle esistenze di chi si fosse cristallizzato in una sua rassicurante verità o condizione di vita. Nessun sintomo di ripresa educativa sarà possibile rintracciare in simili casi. Ma sappiamo anche, proprio per questo, che ogni indizio di desiderio e volontà di cimentarsi con la scrittura costituisce un’occasione imperdibile di cura educativa. 35 L’illusione della verità in autobiografia Duccio Demetrio essenza metafisica, bensì di una dotazione esistenziale anche la più effimera e quotidiana, banale. Comunque la traccia di una verità soggettiva materialmente incarnatasi nella storia, nel tempo, nello spazio. Al contempo, egli ribadiva che può essere praticabile una ricerca del senso della verità personale soltanto affidandosi alla scrittura, poiché è questo esercizio sempre inconcluso a far affiorare quella che nuovamente Lalla Romano definiva “la propria maniera di essere”. Nella convinzione che una volta che ci si immetta in questa impresa, essa non potrà mai avere fine. Il “ronzio” autobiografico continua nella mente e nel sentire di chiunque si sia cimentato in questa sfida. Con la conseguenza che lo scrivere di sé e il dire di sé sembrano costituire le uniche manifestazioni possibili di autolegittimazione: il possibile orizzonte interpretativo inverante la nostra fisicità. Scrivendo tocchiamo con mano la vita vissuta divenuta immateriale e la rimaterializziamo. Il che, in uno scenario inevitabilmente relativistico, ci permette di riconoscere ciò che di più umano, di più fragile e inverante, ci connota nell’instaurarsi non di un “programma” narcisistico e solipsistico spesso rimproverato agli autobiografi. Poiché il soggetto che intraprenda tale percorso, con sincerità e apertura critica verso quanto della vita può aver compreso, non può che imparare ad adottare uno sguardo più relativo e accogliente verso le cose, ad apprezzare la finzione contro ogni ambizione dogmatica o definitiva. Non come invito alla menzogna. L’autobiografia, il gesto e l’esito inconcluso per eccellenza, può costituire tutt’al più una “conoscenza d’uso”, appunto pratica, che serve per le esigenze temporanee di autodentificazione. Scrisse Gargani ne “Il testo del tempo”: 36 Quaderni di comunicazione 10 Dove “l’illusione” di poter finalmente raccontarsi, aspirando a verità da sempre taciute o al solo piacere di riavvicinarsi ai propri io dispersi e perduti, oltrepassati o ritrovati identici a prima, non può che essere sostenuta e confortata da chi ne abbia compreso il senso. Se la posta in gioco è aiutare (e aiutarsi) a riumanizzare le proprie parole, queste (forse) impareranno ad essere più caute e prudenti, soprattutto quando pretendiamo di giudicare e definire gli altri da noi, senza includerci nelle loro storie. Bibliografia AAVV., 1987, La cultura psicoanalitica, Pordenone, Studio Tesi. AA.VV., 1995, Écrire pour ne pas perdre la main, Paris, L’Harmattan. AA.VV., 1996, Il metodo autobiografico, in “Adultità”, n.4, Milano, Guerini. AA.VV., 1996, Vivre et l’écrire, L’Harmattan, Paris AA.VV., 2001, Enciclopedia of Life Writing, London, Fitroy Dearbor. AA.VV., 2003, La narrazione come ricerca del significato, Napoli, Liguori. AA.VV., 2004, Écrire, un processus. La finction pour se dire, in «Art et Therapie», n.86-87. Arrigoni, M.P., Barbieri, G.L., 1998, Narrazione e psicoanalisi, un approccio semiologico, Milano, Cortina. Barthes, R., 1973, Variazioni sulla scrittura. Seguite da “Il piacere del testo”, tr. it., a cura di C.Ossola,1999, Torino, Einaudi. Id., 1977, Frammenti di un discorso amoroso, tr.it, 1979, Torino, Einaudi. Id.,1953, Il grado zero della scrittura, tr.it., 1982, Torino, Einaudi. Cambi, F., 2002, L’autobiografia come metodo formativo, Roma-Bari, Laterza. Canevaro, A., Chiantera, A., Cocever, E., Perticari, P.( a cura di), 2000, Scrivere di educazione, Roma, Carocci. Canili, A., 1950, Una filosofia come diario, Bari-Roma, Laterza. Chiantera, A., Cocever, E. (a cura di), 1996, L’educatore, la vita quotidiana, l’educazione: elaborare l’esperienza attraverso l’educazione, Bologna, Clueb. Capello, C., De Stefani, B., Zucca, F., 1999, Tempi di vita e spazi di poesia. Percorsi di ricerca psicologica sulla scrittura poetica, Milano, Angeli. Id., 2001, Il Sé e l’Altro nella scrittura autobiografica, Torino, Bollati Boringhieri. Id. (a cura di),1999, Dal colloquio al testo. Ricerca e formazione. La scrittura come risorsa formativa, Torino, Utet. Castiglioni, M., 2002, La ricerca in educazione degli adulti. L’approccio autobiografico, Milano, Unicopli. Id., 2008, Fenomenologia e scrittura di sé, Milano, Guerini. Cavallo, M. (a cura di), 2002, Il racconto che trasforma. Testo e scrittura nella costruzione della personalità, Roma, Edp. Cavarero, A., 2003, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, Milano, Feltrinelli. Chiantaretto, J.F., 1997, Ecriture de soi, écriture de l’histoire. Réflexions du temp présent, Paris, Impress. Id. (a cura di), 1998, Ecriture de soi et trauma, Paris, Anthropos. Id.(a cura di),1999, L’écriture des cas chez Freud, Paris, Anthropos. Id., 2005, Autobiographie, journal intime et psychanalyse, Paris, Anthropos. Delory-Momberger, C., 2000, Les histoires de vie. De l’invention de soi au projet de formation, Paris, Anthropos. Id., 2003, Biographie et éducation, Paris, Anthropos. Demetrio, D., 1996, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Milano, Cortina. Id., 1997, Manuale di educazione degli adulti, Roma-Bari, Laterza. Id., 1998, Pedagogia della memoria. Per sé, per gli altri, Roma, Meltemi. 37 L’illusione della verità in autobiografia Duccio Demetrio Id., 2003, Ricordare a scuola. Fare memoria e didattica autobiografica, Roma- Bari, Laterza. Id., 2003, Autoanalisi per non pazienti. Inquietudine e scrittura di sé, Milano, Cortina. Id., 2003, Filosofia dell’educazione ed età adulta, Torino, Utet. Id., 2007, La vita schiva.. Il sentimento e le virtù della timidezza, Milano, Cortina. Id.; Borgonovi, C., 2007, Scrittura e terapia, “Adultità”, n 27. Id. (a cura di), 2007, Per una pedagogia e didattica della scrittura, Milano, Unicopli. Id., 2008, La scrittura clinica. Consulenza autobiografica e fragilità esistenziali, Milano, Cortina. Derrida, J., 1967, Della grammatologia; tr. it., 1969, Milano, Jaca Book. Id., 1995, Memorie per Paul De Man. Saggio sull’autobiografia; trad.it., 1995, Milano, Jaca Book. Domin, P., 1990, L’histoire de vie comme processus de formation, Paris, L’Hamattan. Dominicè, P., 2000, Learning from our lives. Using Educational Biographies wiyh Adults, San Francisco, Jossey-Bass. Foucault, M., 1983, La scrittura di sé; tr. it., 1985, “Aut Aut”, n.115:195-196. Id.,1992, Le tecnologie del sé; trad. it., Torino, Bollati Boringhieri. Gargani, A. G., 1992, Il testo del tempo, Milano, Il Saggiatore. Lejeune, P., 1983, Il patto autobiografico; tr.it., 1986, Bologna, Il Mulino. Id.,1989, On Autobiography, Minneapolis, Minnesota Press. Id., 2005, Un journal à soi, Paris, Telefax. Oliverio, A.1994, Ricordi individuali, memorie collettive, Torino, Einaudi. Ricoeur, P., 1983, Tempo e racconto; tr. it., 1986, Milano, Jaca Book. Id., 2003, Ricordare, dimenticare, perdonare; tr.it., 2003, Bologna, Il Mulino. Id., 1986, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica, Bologna, Il Mulino. Romano, L. (a cura di Ria, A.; Ferrero, E.), 2006, Vita di Lalla Romano raccontata da se medesima, Torino, Einaudi. Sini, C., 1992, Etica della scrittura, Milano, Feltrinelli. Sini, C., 1994, Filosofia e scrittura, Roma-Bari, Laterza. Antonio Santoni Rugiu La tabula non è mai rasa Un amico di tempi antidiluviani telefona da Roma per dirmi di essere vivamente preoccupato del proprio stato di salute psicofisica perché gli è tornato improvvisamente in testa che noi da ragazzini della combriccola ci chiamavano sempre con un fischio particolare sull’aria di una canzone americana allora in gran voga, cantata da Bing Crosby. Si era ricordato che usavamo quel fischio, ma provando a ripeterlo non lo ricordava più, non gli veniva in mente e quindi ancor meno sulle labbra per ripeterlo. Lì per lì, preso alla sprovvista al telefono, anche io ho cercato di ricordarlo ma ho dovuto sperimentare la stessa frustrazione. Niente da fare, non mi veniva. Poi però in un lampo di memoria mi sono ricordato il titolo di quella canzone, And the angels sing, e un successivo lampo me ne ha rievocato il brano centrale: You speak and the angels sing, you sunrise and the angels sing, you look at me and the angels sing, ecc.… Insomma, secondo la canzone, gli angeli erano in ogni modo vogliosi di cantare, qualunque cosa l’amata dicesse o facesse. L’amico, medico, mi ha spiegato le ragioni neuro-fisiologiche perché alla nostra veneranda età non siamo più in grado di produrre un fischio degno di questo nome. Difettiamo del coordinamento maxillo-facciale in grado di imprimere al fischio la potenza di sibilo necessaria per raggiungere il volume e il tono giusti per farsi sentire anche a relativa distanza. Pazienza, commentava l’amico, una volta appurato che è un episodio di inarrestabile decadimento fisiologico, sia che si abbia della vita una visione prospettica o meno, non c’è che da rassegnarsi. Si può benissimo vivere anche senza fischiare. Il problema però non era soltanto fischiare o non fischiare. Ma subito dopo fra me e me ho fatto un’altra riflessione: in giro non si sente più fischiare. Nessuno usa più il fischio come richiamo, come segnale di un qualcosa, come passatempo, come scherzo o altro. In altri tempi era famoso il fischio dei pastori di pecore che governavano i loro greggi, a volte di grandi dimensioni, lanciando fischi ottenuti a regola d’arte (qualcuno si vantava di poter eseguire con il fischio anche brani musicali) con due dita sulle labbra, diretti ai cani i quali, captato il segnale, con teutonica disciplina raccoglievano e orientavano puntualmente il gregge come voleva il pastore, senza mai sbagliare. Fischi potenti e 40 Quaderni di comunicazione 10 precisi, che non a caso si dicevano “fischi alla pecorara” Oggi anche i più primitivi (se ce ne sono rimasti) pastori calabresi, sardi o siciliani hanno usufruito di tante modernizzazioni dalla tecnologia che il fischio è divenuto un mezzo non più funzionale, e così i contadini i quali per darsi segnali da un poggio all’altro non fischiano più e piuttosto usano il cellulare ultimo modello. La morte del fischio dice un po’ di più dello scontato e ormai logoro “come passa il tempo” o “come sono cambiate velocemente le cose” da una generazione all’altra. Ma queste mutazioni comportano altrettante mutazioni antropo- sociologiche ? La sparizione del fischio fa notare anche che forse, nemmeno nella penna del più pervicace seguace di Lucien Febvre e di Marc Bloch, i fondatori delle Annales di parecchi decenni or sono, i quali affermavano come la storiografia per cogliere l’autenticità di una società dovrebbe sempre “partire dal basso”, nessuno storico oggi è sceso, che io sappia, al basso livello del fischio nel senso qui accennato per descriverne vita e morte nei secoli. Né esiste – salvo mia non improbabile ignoranza – un saggio che tratti del fischio o di altri arcaici segnali e del loro uso e significato sociale. Non soltanto i pastori per il loro quotidiano lavoro, ma anche muratori, imbianchini e simili accompagnavano la loro sudata fatica sulle impalcature cantando e zufolando di continuo, e in qualche misura così si ricreavano. Ma se accettiamo l’invito a scendere in basso per far risaltare elementi storici all’apparenza trascurabili, il non plus ultra per valorizzarli sono le autobiografie. Più di altre forme descrittive o rappresentative esse possono far risaltare minuzie o comunque dati non salienti del comportamento e dei fatti quotidiani nel privato e nel pubblico (che poi, anche se a prima vista lo sembrano, non sono affatto superficiali minuzie bensì in realtà dettagli potenzialmente molto significativi che, connessi fra loro secondo un plausibile filo rosso, possono tessere la fitta rete che tenta di recuperare e fa riemergere la trama di un vissuto profondo di un certo momento o situazione nel corso del tempo, altrimenti ingiustamente destinato a rimanere sepolto o, al contrario, coperto dalle nuvole degli alti valori. Gli empiristi inglesi, insomma, sbagliavano a parlare di tabula rasa, cioè vergine: la tabula non è mai rasa né nell’individuo né, meno che mai nel susseguirsi delle generazioni. A nessuno storico infatti per varie ragioni (ma soprattutto per non scadere di livello agli occhi dei tradizionalisti: de minimis non curat praetor) è mai passato per l’anticamera del cervello di occuparsi del fischio o di altre cianfrusaglie del genere), tanto più che esse sono ormai uscite di scena. Tuttavia, se decidessimo, chissà mai, di scrivere un’autobiografia di noi e della nostra combriccola adolescenziale, credo non potremmo tacerlo, se non altro per il semplice ma importante fatto che per buona parte della nostra generazione adolescente aveva un senso, se non altro quello della sua utilità nell’informazione e nella comunicazione,. E come il fischio, altri infiniti dettagli, dal modo di vestire alle modalità di rapporto fra i due sessi, alla fruizione della musica, alla pratica sportiva e alle regole dei giochi e degli scherzi della sotto-cultura giovanile, e via dicendo. Evviva perciò, da parte di chi ama la “storia dal basso”, agli spezzoni o ai ricordi autobiografici. Ma attenzione: la scrittura autobiografica è facilmente affetta da un insidioso rischio, quello di volere essere traccia pedagogica o per meglio dire di pregiudicare l’avvenire dei più giovani con la mira di far loro realizzare tutte quelle cose che quelli della generazione precedente avevano desiderato e però mai 41 La tabula non è mai rasa Antonio Santoni Rugiu potuto vivere, così traslocando nei figli la realizzazione di esperienze a suo tempo ambite però mai vissute o vissute troppo parzialmente. E se le generazioni anteguerra erano tenute – per dire un solo banale caso – soprattutto le ragazze salvo eccezioni, a rientrare in casa, prima di cena, i più vecchi pensarono, divenuti a loro volta padri e madri, che i loro figli avrebbero salutato a gloria la concessione di potere uscire dopocena a patto di rientrare per le ventitré o al massimo per la mezzanotte, notoriamente fatale a Cenerentola. Padri e madri non tenevano conto che, appunto, la tabula non è mai rasa, come presupponevano. Nessuna nozione, nessun modello comportamentale praticato o soltanto progettato, alto o basso, si trasmette come tale e quale. Nel frattempo, fra una generazione e l’altra, altre motivazioni di fondo sono entrate in ballo: padri e madri nati e formati anteguerra non hanno considerato che alle generazioni nate e in via di formazione nel dopoguerra non interessava tanto strappare poche ore di libera uscita post coenam bensì mettere in discussione (giustamente o meno è un altro paio di maniche) l’autorità di fare o non fare concessioni di sorta. Sono perciò insopportabili e vane le autobiografie che vorrebbero dire ai più giovani: “fate quello che ho fatto e in più vi concedo a priori di fare ciò che io avrei desiderato fare”. Tale volontà di precoce condizionamento mi pare molto poco innocente e il più delle volte anche fallace. Questa è la ragione per cui ogni forma di educazione, anzi direi ogni forma di comunicazione, pure priva di esplicite ambizioni “ suggestive”, genera il sospetto di contenere in sé, anche senza rendersene conto, una certa gradazione di autoritarismo o, peggio, di violenza. La vita non è, alla fin fine, quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda, anzi la vita è come la si ricorda per raccontarla” scrive José Maria Marquez. L’autobiografia è per me una forma di storiografia, non importa se soggettiva. Pensiamo però che “istorìa” e “istorèma” volevano dire racconto, descrizione. Quindi “autobiografia” = narrare di sé, di chi gli è intorno, anche di molte apparenti quisquilie del proprio milieu, del consuetudinario relazionarsi con gli altri nel privato e nel pubblico, perfino della vita delle istituzioni. Occorre però evitare un equivoco mistificante, quel raccontare di sé ha molto spesso il secondo, neppure tanto celato, fine celebrativo, apologetico o qualcosa del genere dell’io narrante. Infatti si “istoriavano” gli obelischi e le colonne per glorificare le imprese dei grandi condottieri, così come poi si affrescano le pareti delle chiese per glorificare gli episodi della vita dei santi. E riflettendo che quelle istoriazioni o quegli affreschi volevano in fondo costituire per i posteri modelli del sentire e del fare, ecco che veniva fuori l’intento pedagogico, la logica un po’ violenta o almeno autoritaria del medaglione esemplare, come minimo del “fa’ come ti dico e ti troverai bene nella vita” diretto prima di tutto ai figli che si volevano condizionare a fare così e cosà. Questo disegno, che si accetti o meno l’accusa di autoritarismo, non tiene conto che il messaggio esplicito non è la sola incisione o, se si vuole, istoriazione come si potrebbe fare sul liscio marmo di una colonna. Al contrario quei messaggi, per fortuna o per disgrazia, subiscono molte interferenze, un tempo si sarebbe detto fino dalla culla e oggi secondo più recenti studi sullo sviluppo in gravidanza, si può con buon fondamento dire che diversi fattori, più o meno intenzionali, interferiscano addirittura prima della nascita, predeterminano non poche caratteristiche della personalità del soggetto. 42 Quaderni di comunicazione 10 Però il carattere autobiografico di cui qui si discorre non è da restringersi soltanto alle autobiografie dichiarate, ai diari personali o di gruppo. Anche opere di carattere letterario, perfino poetico, possono essere espressive di un “raccontare di sé”, intendendo per quel “sé” anche l’ambiente, cioè tutto il suo universo relazionale e le figure che l’hanno popolato e gli hanno dato vita. Penso, per dirne soltanto una, ai versi di Gioacchino Belli, il grande poeta romano, contraddittoria personalità di zelante censore del governo pontificio e dell’élite della sua capitale, e insieme caustico fustigatore in versi romaneschi del mondo curiale vaticano e del pontefice in persona, specie da quando al piatto Pio VIII era succeduto il ben più spinoso Gregorio XVI, tutto dedito a tentare di persuadere i troppo permissivi governi europei che era assolutamente necessario reprimere con ogni mezzo le “parve dottrine” e tornare all’autentico spirito restauratore della Santa Alleanza. L’affresco da lui dipinto di una città gloriosa e stracciona, di un popolo bigotto e materialista, insieme pronto a genuflettersi in pubblico e dire peste e corna in privato di papa e cardinali, la sua visione dell’estrema caducità della vita in pro di un carpe diem per quanto era possibile a gente così povera, e molto altro rivissuto con tanta partecipazione può legittimamente vedersi come un ritratto narrato del “sé” belliano vivente e partecipe in quel contesto. Ai suoi sonetti possono assomigliare per la stessa ragione i versi di Parini sulla società milanese antecedente a quella papalina del Belli. Per non dire dell’omologo milanese di Belli, il Porta. Questo tipo un po’ irregolare di descrizione autobiografica da fonti letterarie può dirsi in buona misura, se non del tutto, esente dal vizio pedagogico di cui si è detto prima. E non è che Belli e soprattutto Parini fossero lontani voler proporre o almeno indicare un nuovo tipo di formazione che generasse ed educasse gente diversa da quella reale, afflitta da tanti pregiudizi e superstizioni radicate, ma quella descrizione non era rivolta ai propri eredi né ai propri figli, bensì genericamente al popolo. Era, se mai, una premessa a una sognata palingenesi sociale moderata. Mimmo Pesare Narcisismo digitale e tecnologie del Sé. Facebook e la soggettivazione Nuovi Self, nuove Net In poco più di due anni, la virulenza con cui il fenomeno Facebook ha monopolizzato l’immaginario collettivo, sembra aver smantellato l’intero impianto con cui tutta la sociologia degli anni Novanta aveva pazientemente ricostruito il rapporto tra media e globalizzazione. Il gotha del sapere sociologico, infatti, pareva aver trovato un punto d’approdo stabile e condiviso nell’analisi sistematica con cui la trilogia di Manuel Castells ha sancito il passaggio tra i due millenni. Lo spazio delle reti e lo spazio dei flussi: una nuova coppia di categorie per la postmodernità; quasi una dicotomia neokantiana che si sbarazzava, una volta per tutte, di un certo armamentario passatista di carattere umanistico, per consegnare le analisi sul novissimum allo studio sulle TCI (Tecnologie di Comunicazione e Informazione). Il senso stesso della globalizzazione culturale, insomma, sarebbe da ricercare all’interno di un non meglio precisato dissidio tra Self e Net, cioè tra il sé degli individui e la Rete, network ipostatizzato nella cosmopedia di Pierre Lévy. Castells, essendo uno scienziato sociale, non ha chiarito, tuttavia, in che modo il dissidio tra flussi e luoghi fisici trovi un compromesso etico: “Le relazioni tra spazio dei flussi e spazio dei luoghi, tra globalizzazione e localizzazione simultanee, non hanno esiti predeterminati” (Castells 1996, p.488). Si limita a dire che chi rimane escluso dallo spazio dei flussi reagisce esternando una battaglia per l’identità combattuta dal Self contro il Net; in altre parole chi rivendica la difesa della propria specificità, contro i fautori del cosmopolitismo “intelligente”, è per forza di cose destinato alla sensazione di disadattamento sociale. La dimensione privilegiata dal sociologo spagnolo, ai fini di una partecipazione democratica e “post-critica” all’informatizzazione planetaria è dunque quella dello spazio dei flussi. Una tale impostazione, cara alla gran parte degli indirizzi di sociologia della comunicazione, accusa una certa obsolescenza, una caduta di freschezza che è portata alla luce ed evidenziata proprio dai palesi cambiamenti antropologici che gli utenti del web stanno tracciando, mese dopo mese, nella geografia dei media. 44 Quaderni di comunicazione 10 A dispetto delle raffinate analisi sulla struttura tecnologica dei mezzi di comunicazione di massa in rapporto ai flussi della globalizzazione, pare di assistere a un ritorno delle humanities per spiegarne la fenomenologia. Una strana sensazione di riverbero: un “ritorno del rimosso” delle scienze umane del Novecento, quelle più continentali...dalle cui pieghe sembra riecheggiare l’aforisma di Heidegger, secondo il quale l’essenza della tecnica non è qualcosa di tecnico. Non solo, l’osservazione attenta degli attuali social network porterebbe a pensare che finanche il concetto di socios sia arrivato a risultare insufficiente per spiegare la diversificazione dei fenomeni che hanno permesso un tale attecchimento. Il Self di Castells, di De Kerkhove, di Featherstone, di Giddens, di Beck, è pur sempre un sé collettivo, spiegato attraverso il rapporto tra il socios e i media. Dell’individuo non ne è più nulla, o quasi; vi sono solo i flussi. Non è un caso, allora, che nelle tendenze più recenti delle scienze sociali internazionali, stiano tornando i contributi di autori che hanno inteso spiegare la società a partire dal sé individuale in rapporto all’alterità; sia nel campo della psicodinamica, come nel caso di Kohut e Lasch, sia in quello della filosofia, come nel caso di Foucault; entrambi riscoperti dall’indirizzo della cosiddetta psychomedia. È come se fosse esploso una sorta di effetto paradosso per il quale – heideggerianamente – i media digitali si lasciano interrogare in maniera più proficua a patto che l’interrogazione non rimanga sul piano della loro struttura socio-tecnologica. Se i media sono realmente estensioni dell’uomo, essi sono principalmente estensioni del suo Sé, dove, con questo termine si intende non solo il rapporto col mondo interno di ognuno di noi, ma anche la struttura antropologica che sottende all’accrescimento, lo sviluppo e la messa in opera di quella che Foucault definiva soggettivazione. Costituirsi come “soggetti”, per il filosofo di Poitiers, significa compiere un percorso che, in un certo senso, permetta all’individuo di sovvertire il monito del “conosci te stesso” in una declinazione semantica che sottende il concetto di souci de soi, di cura di sé, in senso auto-pedagogico. L’imperativo socratico, allora, slitterebbe in un “occupati di te stesso, fonda te stesso in libertà, attraverso la padronanza di te”, dove al concetto di auto-fondazione e di padronanza, Foucault collega anche le dimensioni della “curiosità” e della “futilità”, quali attitudini fondamentali della epimeleia heautou. Le “pratiche di soggettivazione” per eccellenza, secondo Foucault, sono rappresentate dalle tecnologie del sé, ossia da dispositivi culturali che agevolano i processi riflessivi che alimentano la soggettività promettendo forme di autorealizzazione, tra le quali spicca l’écriture de soi, lo scrivere di sé. Ora, è chiaro che l’altissimo grado di fruizione popolare dei social network, permesso dall’architettura del web 2.0, ha amplificato in maniera parossistica ogni possibile intendimento di cosa significhi “scrivere di sé” su Internet. La diffusione dei blog è un esempio di come il diario personale a disposizione della Rete possa essere considerato il segno stesso della trasformazione seminale che i social network hanno portato nelle relazioni online. Quando però, all’interno del loro stesso paniere, si assiste a una impennata così significativa e singolare, come quella rappresentata da Facebook, è interessante chiedersi qualcosa in più sugli elementi di un fenomeno che si va costituendo come un grimaldello dell’immaginario collettivo, non fosse altro che per le dimensioni del suo successo. I numeri di un fenomeno Come noto, Facebook nasce nel 2004, ad opera di Mark Zuckenberg, allora diciannovenne studente dell’Università di Harvard, proprio con lo scopo di consentire alle matricole di orientarsi nel campus e di mantenere i rapporti tra gli studenti dopo la laurea. In poco tempo, però, questa funzione di orientamento e di friendship-driven, grazie alla semplice interfaccia del suo ideatore e a una serie di innovative intuizioni della sua piattaforma, fanno inaspettatamente superare i confini dei campus di Harward, per estendersi al MIT e alla Boston University, prima, e al Canada e alla Gran Bretagna, subito dopo. Poi, nel 2007, sono arrivati gli investimenti di Microsoft, che ha fiutato le potenzialità dell’affare, ne ha implementato alcune applicazioni e ha rilasciato le traduzioni locali in 21 nuove lingue, tra cui l’Italiano. Pochi mesi dopo, solo in Italia, gli utenti FB sono passati velocemente da 100mila a quattro milioni. Gli ultimi dati ufficiali (a luglio 2009) pubblicati dai colossi Comscore e Nielsen Bitrating, lasciano senza parole. Facebook in pochi mesi ha surclassato l’utenza dei blog e degli altri – sia pur frequentatissimi – social network, come Myspace, Flicker, Twitter: gli utenti attivi nel mondo sono 220 milioni (dato aggiornato al 26 luglio 2009), con 600mila nuovi iscritti al giorno; questo significa, fatte le dovute proporzioni, che entro il 2009 FB raggiungerà i 300 milioni di iscritti. Ogni utente ha in media 120 amici (cioè contatti personali attivi), che, in un meccanismo di passaparola senza soluzione di continuità, estendono a loro volta l’utenza del social network, che così è arrivato a diventare il quarto sito più frequentato nel mondo. A oggi, sono disponibili 50 traduzioni di FB e altre 40 sono in via di perfezionamento e arriveranno presto sul mercato web dei rispettivi Paesi. Oltre 30 milioni di utenti si connettono ogni giorno a FB tramite telefonini e dispositivi mobili e altrettanti “aggiornano lo status” (cioè pubblicano sulla homepage personale una frase o un messaggio o una citazione che rende conto dell’umore quotidiano, di un evento, di una confessione o di quant’altro costituisca il mondo personale dell’utente). 45 Narcisismo digitale e tecnologie del Sé Mimmo Pesare Ebbene, la scrittura di sé su FB, a una prima osservazione, potrebbe essere presentata come una sorta di dissidio tra una sua interpretazione “narcisistica” (vedremo in che senso) e, al contrario, come un racconto “di soggettivazione”, alla stregua delle tecnologie del sé foucaultiane. E per non cadere negli ingenui manicheismi di cui molto spesso si macchia un certo sociologismo da rivista patinata, né inciampare nell’eterna palinodia tra media-apocalittici e media-integrati, mi sembra utile presentare i due aspetti che caratterizzano anche questo social network, non in maniera dicotomica o, addirittura, paratattica, ma, in modo laicamente spinoziano. Si tratta di due facce di una stessa medaglia che può monopolizzare il sé della gente, o al contrario, valorizzarlo, a patto di adottare una prospettiva di psico-pedagogia dei media che non si accontenti di rifugiarsi dietro i comodi baluardi del socios, ma che, al contrario, faccia luce sul carattere individuale/relazionale dell’approccio psicodinamico nei media. 46 Quaderni di comunicazione 10 L’Italia, dal canto suo, è una della nazioni col tasso di crescita più alto: quasi 11 milioni di iscritti, vale a dire il 35% della popolazione online, con un incremento mensile del 760%1 e all’interno del quale la fascia di età che ha il trend di crescita più alto è quella degli over 35. Nel nostro Paese FB è il secondo sito più visitato, preceduto solo da Google e si calcola che il numero dei nuovi iscritti tende approssimativamente a un raddoppio annuo. Sul piano tecnologico, Facebook è un applicativo del Web 2.0 (per la precisione un Social Software), ossia della “seconda generazione” del Web, caratterizzata dal concetto-chiave secondo cui la piattaforma non è più il software, ma il Web. Dentro il Web 2.0, il Social Software rappresenta una generazione di applicativi la cui funzione è di rendere possibile la condivisione di contenuti digitali (testi, immagini, video), i propri commenti ad essi, la categorizzazione degli stessi (tagging). Sul piano materiale, invece, Facebook è un album, un portfolio che consente di raccogliere e condividere immagini, filmati, note di testo, messaggi, con altri utenti della Rete. Tuttavia, il fatto che FB abbia pesantemente superato nelle utenze mondiali, tanto i blog, quanto gli altri social network (Myspace su tutti), dipende da una fortunata serie di elementi che rende al suo bouquet multimediale una utilizzabilità e un appeal del tutto speciali. Innanzitutto FB unisce molti elementi all’interno di un’unica piattaforma: vi è la possibilità di scrivere di sé, di attualità, di cultura o di arte e di ricevere commenti a quello che si è scritto (come nei blog); vi è la possibilità di entrare in contatto con persone del proprio entourage semplicemente inserendo il nome e il cognome, senza essere in possesso di complicati indirizzi web (come invece accade nei blog); vi è la possibilità di pubblicare foto e immagini e di commentarle insieme al network di relazioni personali che si possiede (come in Flicker, Twitter e analoghi); vi è la possibilità di pubblicare video (come in Youtube); di costituire una comunità di contatti personali sulla base dei rapporti amicali o professionali e di farne ruotare la comunicazione attorno a gruppi di interesse (come in Myspace). Ma l’utilizzo di FB è molto più immediato perché la sua grafica è essenziale e uguale per tutti: si può costruire in pochi minuti un profilo personale senza conoscere minimamente il Web 2.0 e senza dover necessariamente incollare voluminosi codici HTML (come accade in Myspace). Il tutto è condito da una serie di applicazioni, ovvero di piccoli software all’interno della piattaforma, che la rendono una sorta di rotocalco da interrogare e sfogliare. Ma soprattutto c’è una chat molto spartana che, a differenza delle chatroom canoniche (in cui, “entrando”, non si sa chi si può “incontrare”), permette di essere in comunicazione con tutti gli amici, cioè i contatti personali che ogni utente possiede. Tuttavia, come in una interpretazione gestaltica, il successo di FB probabilmente non è dovuto alla semplice somma di elementi che appartenevano già ad altri social network, ma alla delicata armonizzazione complessiva degli stessi. C’è sicuramente una carica, per così dire, pop, nel senso che l’elevato grado di semplicità e di utilizzabilità ha reso questa piattaforma notevolmente trasversale rispetto ad altre. C’è il fatto che il passaparola ha portato all’iscrizione una serie di persone e gruppi che necessitavano di una visibilità e di una pubblicità (penso ai gruppi musicali, agli eventi culturali, ai gruppi di pressione politica e sociale) difficilmente raggiungibili prima di FB all’interno di un unico canale mediatico. Tra narcisismo e pedagogia del Sé Nel recente e fortunato saggio The cult of amateur (2007), il giornalista statunitense Andrew Keane, che si presenta come un “pentito” della tecnofilia Anni Novanta, stigmatizza la cultura digitale del web 2.0 e dei social sofware, i quali, grazie a un uso incontrollato delle informazioni multimediali, a una fiducia quasi religiosa nell’infallibilità dei motori di ricerca e a una deresponsabilizzazione 47 Narcisismo digitale e tecnologie del Sé Mimmo Pesare C’è l’eterogeneità degli usi, che ha semplificato i flussi di utenza sul web; FB è la quintessenza del multitasking: si può mantenere e alimentare i propri contatti relazionali; si può scrivere un blog e pubblicare/commentare elementi multimediali propri o altrui; si possono pubblicizzare iniziative o eventi ed esserne a nostra volta informati dall’esterno; si possono sottoscrivere gruppi di interesse, di pressione o di sostegno a personaggi pubblici2; si possono pubblicare foto o video di denuncia sociale. Inoltre FB ha raffinato e implementato le funzioni di embedding: si parla di FB anche come di una piattaforma di convocazione mediatica, ossia di un vettore di pressione istituzionale che avviene attraverso la circolazione molto pervasiva delle opinioni nello spazio pubblico. In questo senso il social network più utilizzato nel pianeta rappresenta il veicolo principe di una serie di spinte info-comunicative, quali l’organizzazione del consenso e il movimento di pressione sull’opinione pubblica (come nei casi di apertura di “gruppi” o di lanci di petizioni); e il raccordo e la mobilitazione degli individui e dei gruppi (soprattutto attraverso gli eventi, come il recente caso dello scontro iraniano tra la polizia di Ahmadinejad e i sostenitori di Moussawi). Ma quello che, probabilmente ha decretato il successo di FB è proprio una evoluzione della “confessione da blog”: il cosiddetto messaggio di status, ossia la possibilità di sapere in tempo reale cosa stanno pensando gli amici. Su un campione casuale di 150 utenti FB, il 72% dichiara che proprio questa (insieme alla facilità di ritrovare vecchie conoscenze o compagni del periodo scolastico) è la caratteristica che ne ha fidelizzato l’utenza; una sorta di voyeurismo relazionale, di sbirciatina, attraverso il buco della serratura, sulle emozioni, le esperienze, i consumi culturali (musica e video pubblicati) e le novità nella vita dei nostri conoscenti. Un intervistato, significativamente, ha scritto: “La home page di FB è come un’agorà, in cui ritrovi i tuoi amici, vedi che cosa stanno scrivendo in quel momento, che cosa fanno, che cosa gli passa per la testa. E dopo un minuto è già tutto cambiato, niente rimane uguale, si è in uno stato di veglia perenne, tutti aspettano di postare il loro commento, esprimere il loro pensiero, farsi partecipi, insomma. In questa possibilità, a mio parere, è racchiuso tutto il successo di FB”. Alla luce di questa prospettiva allora, non meraviglia che sempre all’interno dello stesso mini-questionario lanciato su FB, quasi il 60% degli intervistati dichiari di aver migliorato la gestione delle proprie relazioni sociali e il 62% ammette di aver migliorato la comunicazione e la riflessione sui propri stati d’animo. Dunque: narcisismo digitale o scrittura di auto-formazione? Probabilmente il confine tra queste dimensioni è labile quanto osmotico: Facebook risponde in maniera palliativa tanto alle smagliature di una comunicazione autoreferenziale e autistica, quanto a una postmoderna narrazione collettiva. 48 Quaderni di comunicazione 10 dell’atto comunicativo, avrebbero diffuso a livello planetario una autoreferenzialità del sapere e dell’apparenza che ha consacrato il cosiddetto narcisismo digitale. La teoria di Keane, dai toni vagamente neo-francofortesi, è che il web 2.0 avrebbe ucciso la cultura; una nuova versione del baudrillardiano “delitto perfetto”, dunque, secondo la quale il web partecipativo, fatto di blog, video-audio-foto sharing, chat e podcast, facilita la creazione di prodotti autoreferenziali. Questo pulviscolo di autocitazioni è, per il giornalista, la base stessa per la formazione patologica del narcisismo digitale, una particolare forma di narcisismo, legata alle nuove tecnologie e al web, simile per certi aspetti all’egosurfing3, che si caratterizzerebbe per uno smoderato culto della personalità, dell’apparenza e dell’esibizione sul web (complici le applicazioni web 2.0 che consentono a qualsiasi utente di creare contenuti autoprodotti con estrema facilità). Ora, i termini narcisismo digitale e egosurfing sono presenti sull’Oxford English Dictionary già dal 1989, ma il fenomeno del narcisismo online, al di là di facili riproposizioni e neologismi, possiede le stesse basi profonde del narcisismo propriamente detto in termini psicodinamici. Chiaramente non è possibile, in questa sede, presentare un seppur stringato panorama dei contributi teorici sul narcisismo a partire da Freud. È interessante, tuttavia, mettere in relazione una tendenza delle teorie post-freudiane sul narcisismo in rapporto al Sé e l’applicabilità di tali teorie al campo dei social network. Innanzitutto c’è da precisare che il concetto psicoanalitico di narcisismo, nato con Freud (Introduzione al narcisismo, 1914), si basava su una doppia dimensione del fenomeno: vi è un narcisismo primario, ovvero uno stadio precoce in cui il bambino investe tutta la sua libido su se stesso, prima di rivolgerla verso altre persone; e un narcisismo secondario, tipico dell’età adulta, che designa un ritiro della libido dai suoi investimenti oggettuali e un conseguente ripiegamento di essa sull’Io. Freud, dunque, ipotizza una sola linea di sviluppo della libido, che parte dall’investimento narcisistico e arriva a quello oggettuale; quando questo stadio del narcisismo primario (infantile) si arresta o non si sviluppa per traumi o esperienze frustranti, si arriva al narcisismo secondario (adulto), che è sempre patologico. Dopo Freud, questa visione dicotomica ha perso terreno, già a partire da Melanie Klein (1932), secondo la quale il narcisismo avrebbe molto più a che vedere coi concetti di immagine dell’altro e di interiorizzazione, per cui tale termine non designa semplicemente uno stato in cui sarebbe assente ogni relazione intersoggettiva, ma l’interiorizzazione di una relazione (quasi sempre coi genitori) insoddisfacente o frustrante. Ma è con Heinz Kohut che, all’interno della stessa scuola psicoanalitica, si raggiunge una spaccatura vistosa con Freud e, insieme, una innovazione della teoria sul narcisismo, molto più attuale. Kohut (1971), esponente di spicco dell’indirizzo statunitense della Psicologia del Sé, prevede non una, ma due linee di sviluppo della libido, indipendenti l’una dall’altra e determinate non dall’obiettivo dell’investimento pulsionale (se stessi, nel caso del narcisismo, o un oggetto esterno, nel caso dell’amore oggettuale “sano”), ma da qualità intrinseche alle due pulsioni stesse: la libido oggettuale e quella narcisistica. Detto in altri termini, Kohut considera la posizione freudiana sul narcisismo, in un certo senso, come “moralistica”, in quanto contrappone due tipi di amore: l’amore di sé e l’amore per l’altro, considerando Non si può imparare neanche l’arte di vivere, la tékne tou bìou, senza una áskesis, che bisogna pensare come una formazione di sé da parte di se stessi. (…) La scrittura appare regolarmente associata alla “meditazione”, a questo esercizio del pensiero su se stesso, che riattiva quel che sa, attualizza un principio, una regola o un esempio, riflette su di essi. (Foucault 1983, p.203-4) Ma uno dei modi della scrittura di sé, come ad esempio gli hupomnémata (i quaderni di promemoria personali dell’antichità) è di natura 49 Narcisismo digitale e tecnologie del Sé Mimmo Pesare il primo semplicemente patologico. Come si è visto, infatti, per Freud l’unica linea evolutiva possibile, dal narcisismo primario/infantile sbocca all’amore oggettuale maturo o, in caso patologico, deborda al narcisismo secondario/adulto. Kohut, al contrario, postula la presenza di due linee evolutive parallele (la cosiddetta teoria del doppio binario): la prima, che va dal narcisismo all’amore oggettuale; e la seconda, che va dal narcisismo a forme più elaborate di narcisismo. Alla base di questa teoria c’è la convinzione metodologica (di Kohut e di tutta la Psicologia del Sé) che alla base delle ferite narcisistiche non ci siano esclusivamente dei nuclei traumatici infantili da scoprire, ma l’assenza di empatia e di risposte gratificanti da parte degli “oggetti-Sé”, cioè da parte delle persone che costituiscono l’universo relazionale dell’individuo (non solo nell’infanzia ma per tutta la vita). Pertanto, il punto centrale per la costruzione e la coesione del Sé – che per Kohut è il centro della vita psichica e della personalità – è l’importanza delle relazioni. Kohut, dunque (con chiare influenze di Hartmann e di Erikson) pone la struttura dello stesso mondo interiore come interazione tra sé e gli altri, più che come “archeologia del trauma”, e lo studio sul narcisismo ne rappresenta la più compiuta espressione clinica. Alla base delle personalità narcisistiche, quindi, c’è un Sé frammentato e non coeso a causa di una insufficiente risposta empatica e convalidante la propria autostima. La conseguenza più importante di tali assunti, ai fini del nostro discorso, è proprio l’importanza delle “ricostruzioni empatiche” con le quali si ha la possibilità di riscrivere i gap relazionali che hanno amplificato le ferite narcisistiche. Il narcisista, anche secondo Lasch e Lowen, ha un Sé indebolito e una immagine di sé rafforzata e grandiosa e spesso la spettacolarizzazione di quest’ultima rappresenta l’esperienza stessa della dolorosa ferita narcisistica che ne è alla base. Dunque secondo Kohut, una base narcisistica non necessariamente porta all’ineluttabilità di una personalità borderline o psicotica. Molto spesso, al contrario, il “dire di sé” costituisce una semi-elaborazione delle frustrazioni affettive ricevute. E qui ritorna il nesso con l’écriture de soi come “pratica del sé” in senso foucaultiano. Sembra abbastanza lampante la carica solipsistica di chi cerca relazioni sul web; essa appare come una pratica autistica, autoreferenziale, innaturale, tanto che molti critici della comunicazione sui social network hanno parlato di ascesi digitale. Ma se dovessimo operare una analogia tra quella solitudine, che deriva pari pari da una forma di rappresentazione narcisistica, e la narrazione come tecnologia del sé nella lezione di Foucault, potremmo incorrere in una serie di sorprese. Il filosofo francese mutua il concetto di áskesis direttamente dagli scritti di Plutarco, Seneca e Marco Aurelio, spiegando che 50 Quaderni di comunicazione 10 circolare: la meditazione precede le note, le quali permettono la rilettura, che a sua volta rilancia la meditazione. (…) (Essi) Costituiscono un materiale e un quadro per esercizi da effettuare frequentemente: leggere, rileggere, meditare, discorrere con se stessi e con gli altri. La scrittura degli hupomnémata è un relè importante nella soggettivazione del discorso (ivi, p.204-5) Per Foucault, insomma, lo scrivere in solitudine per poi far leggere agli altri quanto elaborato, seppure in frammenti di discorso e brevi promemoria, è una pratica ascetica – in senso etimologico – ; ma tale pratica è alla base della soggettivazione del discorso, è una tecnologia del sé, ovvero una pratica etica che fonda, dal punto di vista pedagogico, la propria autoformazione. Ebbene, non sembra una forzatura l’accostamento degli hupomnémata di Plutarco – ripristinati dall’archeologia del sapere foucaultiana – e la scrittura su Facebook, almeno per una serie di caratteristiche che Foucault enumera e che sembrano appartenere a tutti gli effetti all’architettura info-comunicativa del social network. Foucault parla di “modo circolare”, di “rilettura”, di “discussione con gli altri” sui propri stati d’animo. E ancora All’interno di una cultura profondamente segnata dalla tradizione, dal valore riconosciuto del già detto, dalla ricorrenza del discorso (…) si sviluppava un’etica esplicitamente orientata dalla cura di sé verso obiettivi precisi: ritirarsi in se stessi, raggiungere se stessi, bastare a se stessi, vivere con se stessi, profittare e godere di se stessi. È proprio questo l’obiettivi degli hupomnémata: fare del raccoglimento del logos frammentato (…) un mezzo per stabilire un rapporto di sé con sé, il più adeguato e compiuto possibile. (ivi, p.206) Per il filosofo, lo scrittura di sé, seppure in maniera “frammentata”, “rapsodica”, “citazionista” e stilisticamente ibrida – potremmo dire, oggi, multimediale –, al contrario della sua apparenza non univoca e caleidoscopica, è alla base delle pratiche di soggettivazione; è una tecnologia del sé. Proprio in virtù di questo stare “presso di sé” è possibile la crescita e l’autoformazione. In queste righe il “se stessi” torna a ripetizione, come un mantra, ma la dimensione che ne è alla base sembra molto oltre il semplice narcisismo. O meglio, si tratta di quell’elaborazione del narcisismo fisiologico che Kohut vedeva stemperabile nella pratica dell’empatia – mutatis mutandis, con tutta le differenze possibili tra una pratica “clinica” e una pratica “auto-pedagogica” –. Foucault parla dei quaderni di auto-narrazione come di “una pratica regolata e volontaria del disparato. Una scelta di elementi eterogenei” (ivi, p.207). Nessuna sistematicità, dunque: è come se Marco Aurelio e Plutarco parlassero di multitasking ante litteram. E Foucault insiste proprio su questo elemento di ibridazione tra generi, testi, citazioni, ricordi, immagini e riflessioni, come una tecnica di sedimentazione ethopoietica, cioè come una narrazione che immette la personale esperienza di vita all’interno di un contenitore che rimarrà il filo rosso dell’etica personale. Ma a questa frammentarietà che fonda la soggettivazione, Foucault, sempre nell’ambito delle scritture di sé, aggiunge la pratica della corri- Note Fonte: www.comscore.com. Cfr. il caso di Barack Obama, in merito al quale si stima che il suo personale gruppo FB abbia rappresentato il forcing del 35% rispetto al complessivo insieme degli elementi mediatici che hanno portato alla sua vittoria presidenziale. 3 Per egosurfing si intende la pratica di cercare su motori di ricerca, social network e blog, il proprio nome per avere una dimensione della propria popolarità sul web. 1 2 Bibliografia Bion, W.R., 1962, Learning from experience, London, Heinemann; tr. it., 1972, Apprendere dall’esperienza, Roma, Armando. Castells, M., 1996, The rise of the network society, Oxford, Blackwell Pubblishers; tr.it., 2002, La nascita della società in rete, Milano, EGEA-Università Bocconi Editore Di Marco, C., 1999, Critica e cura di sé. L’etica di Michel Foucault, Milano, Franco Angeli. Foucault, M., 1983, L’écriture de soi, in «Corps écrit», n.5; (1994), Dits et crits, Paris, Gallimard; tr.it., 1998, Archivio Foucault 3. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica, politica, Milano, Feltrinelli. Foucault, M., 1984, Le souci de soi, Paris, Gallimard; tr. it., 1985, La cura di sé, Milano, Feltrinelli. Freud, S., 1914, Einfehrung in die Narcisismus, in ID., 1968, Gesammelte Werke, 18 vol., Frankfurt a.M., Fischer; tr. it., Introduzione al narcisismo, in ID., 1969, Opere, vol. VII, Torino, Bollati Boringhieri. Freud, S., 1921, Massenpsychologie und Ich-Analyse, in ID., 1968, Gesammelte Werke, 18 vol., Frankfurt a.M., Fischer; tr. it., Psicologia collettiva e analisi dell’Io, in ID., 1969, Opere, vol. IX, Torino, Bollati Boringhieri. Gorz, A., 2003, L’immatériel. Connaissance, valeur et capital, Paris, Galilée; tr. it., 2003, L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale, Torino, Bollati Boringhieri. 51 Narcisismo digitale e tecnologie del Sé Mimmo Pesare spondenza, che rappresenta l’altra significativa tecnologia narrativa del sé. Nella corrispondenza si realizza a pieno titolo l’auto-osservazione e l’autoconoscenza. Una pratica che mostra esattamente la dialettica fra potenziamento della soggettività e la sua oggettivazione e apre percorsi di riflessività che stanno alla base della costruzione del soggetto. In questo senso, i social network possono essere immaginati come dispositivi che promuovono una visione multidimensionale e poli-prospettica, sollecitando l’indagine, l’inferenza e la curiosità. Si tratta, probabilmente, di “attrezzi sociali” digitali, nelle cui architetture si impara a interagire con gli altri, intervenendo di volta in volta, sul racconto delle proprie emozioni quotidiane, sulla proposta della propria estetica, sull’adesione a norme, valori, desideri, immagini. Ecco, un’approccio tipico della media-education è volto proprio a questa rilettura degli attuali processi antropologici dei mezzi di comunicazione di massa, senza dare per scontato niente. Facebook può essere interpretato come un panopticon, al cui interno ogni privacy è perduta per sempre, o come una pratica di soggettivazione, per fondare la narrazione del proprio Sé, per raccontarsi la vita in comune, con la curiosità che caratterizza le menti più aperte e la partecipazione al general intellect della Rete. 52 Quaderni di comunicazione 10 Keane, A., 2007, The cult of amateur, New York, Random House, Inc. Klein, M., 1932, Die Psychoanalyse des Kindes, Wien, Internationaler Psychoanalytischer Verlag; tr.it., 1970, La psicoanalisi die bambini, Firenze, Martinelli. Kohut, H., 1971, The analysis of the Self. A systematic approach to the Psychoanalytic treatment of narcisistic personality disorders, Madison, Conn., International Universities Press; tr. it., 1976, Narcisismo e analisi del Sé, Torino, Bollati Boringhieri. Kohut, H., 1977, The restoration of the Self, Madison, Conn., International Universities Press; tr. it., 1980, La guarigione del Sé, Torino, Bollati Boringhieri. Kohut, H., 1978, The search for the Self, Madison, Conn., International Universities Press; tr. it., 1982, La ricerca del Sé, Torino, Bollati Boringhieri. Laing, R.D., 1959, The divided self, London, Tavistock Pubblications Limited; tr. it., 1969, L’io diviso, Torino, Einaudi. Laplanche, J., Pontalis, J.B., 1967, Vocabulaire de la psychanalyse, 2 vol., Paris, Presses Universitaires de France, Paris; tr. it., 1993, Enciclopedia della psicoanalis, Roma-Bari, Laterza. Mortari, L., 2006, La pratica dell’aver cura, Bruno Mondadori, Milano. Roheim, G., 1950, Psychoanalysis and Anthropology, New York, International University Press; tr. it., 1974, Psicoanalisi e antropologia, Milano, Rizzoli. Semeraro, A., 2008, Hypomnémata. Lessico di comunicazione sensibile, Nardò, Besa. Diana Salzano Le coordinate del sé nella geografia dei media Quella che Giddens (1991) definisce la progettualità riflessiva del sé vive, nell’epoca dei media elettronici, la sua più grande sfida. Le possibilità identitarie sono oggi, infatti, caleidoscopicamente moltiplicate, diffuse e distribuite lungo i percorsi reticolari dell’immaginario mediatico. Ombre sintetiche (Colombo 1990), proiezioni virtuali del sé, si stagliano sullo sfondo dei panorami disegnati dall’immaginazione dislocata (Salzano 2003) che, in un mondo globalizzato, porta con sé ed ibrida costantemente risorse simboliche: I mediorami (...) tendono ad essere rendiconti, incentrati sulle immagini e basati sulla narrazione, di porzioni di realtà e quel che offrono a coloro che li utilizzano e modificano è una serie di elementi (...) con i quali è possibile dar vita a sceneggiature di vite immaginate (...). Queste sceneggiature (...) aiutano a costituire narrazioni dell’Altro e narrazioni germinali di vite possibili, fantasie che potrebbero diventare premesse al desiderio di acquisizione e movimento (Appadurai, 1996, pp. 55-56). Nella pausa protetta dell’altrove simbolico mediatico possiamo essere adulteri del nostro Io dominante e vivere le virtualità dei nostri sé desiderati. L’organizzazione riflessiva del sé è arricchita ed enfatizzata dal graduale assorbimento dell’esperienza mediata nel tessuto della quotidianità (Thompson 1995). Il sé come progetto simbolico costruisce il proprio percorso autobiografico introiettando risorse mediate e non e riflettendo sistematicamente sulla propria traiettoria, per ricalibrarla in itinere ed evitare possibili derive identitarie. L’ipertrofia del presente, l’estrema congerie di risorse simboliche, la frammentazione e pluralità di riferimenti rendono, infatti, problematica l’identificazione del soggetto che cerca àncore per permanere e dubita spesso della propria autobiografia (Melucci 1991). La capacità di mantenere in funzione una particolare narrazione è prerogativa essenziale dell’identità. Quest’ultima presuppone una continuità nel tempo e nello spazio ma si definisce come tale continuità interpretata riflessivamente dall’attore sociale. Lo spazio autobiografico, quale dimensione olistica ed ermeneutica, si configura come una modalità privilegiata per circoscrivere, senza chiudere, i confini del sé. L’autobiografia è un costante e meticoloso lavoro di tessitura per ordinare i fili degli avvenimenti e costruire la trama di una sintassi interiore da cui dipende la possibilità di comprendersi e di essere compresi dagli altri. 54 Quaderni di comunicazione 10 L’enigma del sé non chiede di essere svelato quanto piuttosto di darsi come autocoscienza riflessiva che permetta di raccordare l’arcipelago di io abitati durante la vita e perduti nel tempo; io che vagano senza timoniere, testimonianze di trasgressione dalla regia dell’io demiurgo: “triste vita è quella che non ha provato l’ebbrezza della trasgressione nei confronti dell’io principale” (Demetrio 1996, p. 13). È necessaria una tregua pedagogica che non ci colpevolizzi della nostra molteplicità ma che, anzi, ridimensioni il ruolo dell’io dominante a favore di un io tessitore in grado di intrecciare le diverse e spesso dissonanti parti del sé in una combinazione polifonica e armonica, in un’architettura cognitiva che gestisca i processi di dispersione e discontinuità. Il percorso di identizzazione indica il carattere processuale e autoriflessivo della definizione di noi stessi; l’autoidentizzazione richiede la capacità di porsi in un sistema relazionale ed esige un riconoscimento intersoggettivo. L’alterità è, infatti, coessenziale all’identità: il sé riflesso (Bruner 1996), il sé come altro da sé, indica la capacità di riflettersi nell’altro trovando se stessi; solo la relazione con l’alterità consente d’interrompere quel circolo dell’identico in cui si risolve la vita individuale. È la continua tensione tra una medesimezza intesa come sorta di nucleo invariante che permane nel tempo e dà continuità al soggetto, ovvero l’identità come idem, e una dimensione che implica l’alterità come costruttiva del sé: l’identità come ipse (Ricoeur 1990). La natura intrinsecamente sociale del sé si lega dunque alla centralità del riconoscimento. L’identità di un io molteplice si configura come campo piuttosto che come essenza: non è una realtà metafisica ma un sistema dinamico, è identizzazione, processualità, unità come emergenza ossia come configurazione cognitiva transitoria, specifica di una rete disunifi cata (Varela 1995, p. 40). L’identità dipende dall’azione individuale (Remotti 1996, p. 5) ed è quindi responsabilità. La costruzione narrativa della realtà (Bruner 1991) all’interno di un frame teorico interazionista e culturalista, si nutre del patrimonio simbolico come pratica testuale comune attraverso cui il soggetto può organizzare uno spazio nella propria agorà interiore. Sospesi su di una rete simbolica di cui siamo i tessitori (Geertz 1973) ne intrecciamo i fili, nutrendo il nostro sé transazionale di riferimenti culturali e di esperienze intersoggettive e negoziandolo nella relazione interattiva (Gardner 1983) con l’ambiente culturale: “se l’uomo è sospeso su una rete di significati che lui stesso ha tessuto (...), allora i mezzi di comunicazione sono i filatoi del mondo moderno, e utilizzandoli gli esseri umani tessono reti di significato per loro stessi” (Thompson 1995, p. 22). I media, come moltiplicatori di mobilità e come fonte ricchissima di risorse identitarie aprono le nostre biografie a sceneggiature di vite possibili, a metaprogetti identitari, a nuove arene per la sperimentazione del sé; quest’ultimo accentua sempre più la sua natura autoriflessiva e attinge a materiali mediali e non per inserirli in un racconto autobiografico coerente. Tale processo di appropriazione simbolica disegna i confini dell’esperienza soggettiva: “L’atto della soggettività non è tanto ciò che inaugura la comprensione quanto ciò che la compie. Questo atto terminale può essere enunciato come appropriazione” (Ricoeur 1986, p. 51), ovvero come la carica autobiografica della partecipazione alla cultura. nell’ipertrofia e ipotrofia degli eventi mediali la prossimità è ingannevole (...). Posso prendermi cura (...) solo di ciò che mi è vicino; la responsabilità presuppone la vicinanza (...): Ma i media pongono l’altro troppo vicino o troppo lontano per potercene occupare moralmente (...). La tecnologia non annulla la distanza, semmai la trasforma. La connettività (...) è ben altra cosa dalla prossimità e non la garantisce (...). La prossimità dismorfica è quindi una patologia dello sguardo che può comportare un disancoraggio etico (Salzano 2003, p.142). L’impossibilità di agire su eventi lontani nello spazio e nel tempo può rendere l’esperienza mediatica meno rilevante nel progetto di autoformazione dell’individuo ma non può, però, cancellarne l’importanza. L’esperienza di interpolazione spazio temporale resa possibile dai media contemporanei moltiplica, anzi, le narrazioni del sé, offrendo un immenso repertorio di proposte identitarie, ampliato indefinitamente dalla vita nei mondi digitali. La rete rilancia, infatti, il tema dell’identità e della sua natura posizionale, relazionale e performativa. Secondo la prospettiva del postmodernismo radicale la Computer Mediated Communication, priva dei tratti della comunicazione non verbale, di un feedback regolativo e caratterizzata dalla scarsa presenza di segnali sociali incoraggia i processi di erosione dei riferimenti sociali e culturali che caratterizzano l’identità in real life: protetti dall’anonimato e con pochi indizi sul contesto sociale atti ad indicare le modalità di condotta appropriate, gli individui possono esprimere 55 Le coordinate del sé nella geografia dei media Diana Salzano Cosa accade quando l’appropriazione riguarda il patrimonio simbolico mediatico, il sé sperimenta l’incorporeità nei mondi virtuali e la dimensione dell’intersoggettività, di cui il progetto identitario si nutre, chiama in causa l’alterità disincarnata che i nuovi media ci consentono di sperimentare? Gli incontri mediali sono una sorta di appuntamento antitetico che ibrida la presenza audiovisiva con la distanza spazio-temporale. L’altro è costruito a distanza e la sua inaccessibilità è fonte di forza e vulnerabilità. La connettività consentita dai media annulla la distanza metrica ma non può eludere quella psicologica, culturale e sociale; tale connettività è, come nota Tomlison (1999), ben altra cosa dalla prossimità/intimità connessa all’esperienza locale, alla vicinanza fisica e al contatto profondo: si configura piuttosto come un’ intimità non reciproca a distanza (Thompson 1995).. La crescente impersonalità e oggettività delle relazioni rende l’esperienza del mondo sempre meno diretta (Magatti, Bichi 2000, p. 71) e, probabilmente, la necessità di esperire direttamente le cose, di personalizzare i rapporti sociali è uno dei motivi per cui gli individui allucinano le esperienze perdute e desiderano immedesimarsi in quelle altrui. Il progetto riflessivo del sé includerebbe, quindi, progressivamente le proposte identitarie dei media e porzioni crescenti di immaginario simbolico per reagire al sequestro d’esperienza (Giddens 1991) tipico del mondo contemporaneo, surrogando l’esperienza concreta, fisica, delle cose con quella fantasmatica offerta dagli universi finzionali mediatici. Libero dai doveri di reciprocità il soggetto non vive però, nei confronti dell’alterità mediata, un’esperienza di coevità etica, di responsabilità vincolante, non si sente impegnato moralmente; cambia cioè la qualità del contatto (Silverstone 1994, p. 58). La prossimità mediatica è, infatti, dismorfica perchè altera le forme della distanza: 56 Quaderni di comunicazione 10 e sperimentare aspetti della loro personalità che l’inibizione sociale in genere li induce a sopprimere (Reid 1991). Gli ambienti virtuali rappresentano dei veri e propri identity playground in cui sperimentare, nella più totale fluidità sociale, una costruzione performativa del sé: Libero dal corpo biologico, l’individuo può ricreare completamente se stesso, manipolando ogni aspetto della propria riconoscibilità. Attraverso pratiche di gender-switching, di riarticolazione degli stereotipi e di creazione di nuove convenzioni linguistiche e sanzioni sociali (netiquette), il corpo simulacrale può librarsi nei mondi virtuali, alleggerendo la dimensione identitaria dal peso gravitazionale del mondo off-line (Salzano 2008, p. 126). Adottando le posizioni interazionali dell’Altro, il soggetto può vivere un inedito feedback interazionale (inteso come insieme di risposte, pre-giudizi e stereotipi che l’interlocutore attiva nell’interazione), appropriandosi dell’alterità e acquistando così una sorta di ubiquità sociale. In The Second Self del 1984 Sherry Turkle riflette sull’impatto socioculturale delle tecnologie informatiche, evidenziando come nei mondi telematici il sé diventi fluido e molteplice. I MUD si configurano come spazi di moratoria psicosociale in cui il soggetto, protetto dall’anonimato, vive in modo disinibito aspetti repressi della propria identità (Turkle 1995, p. 299). Libero dai vincoli del corpo e dalle norme della vita sociale offline l’individuo può dislocare i diversi aspetti del sé in molteplici persone, sviluppando sapere riflessivo sulla modularità e fluidità della propria identità. I sistemi operativi multitasking a finestre permettono di giustapporre gli aspetti sociali dell’identità su un piano sincronico, decentrando il sé e dando vita ad una sorta di ubiquità elettronica. Nella prima metà degli anni novanta nascono linee di ricerca che attribuiscono un ruolo alle caratteristiche socioculturali degli attori impegnati nella Computer Mediated Communication. Il testo telematico può caricarsi di indizi sociosimbolici che vanno a surrogare la presenza del corpo, consentendo la reciproca classificazione. L’organizzazione di questi indizi in veri e propri sistemi stilistici pone l’urgenza di un approccio di studio sociolinguistico, oltre che sociologico e psicologico (Salzano 2008). L’identità in rete, come nota Donath (1999), mette in gioco l’inganno e la persuasione, è negoziata e dipende dalla disponibilità a credere dell’interlocutore. Ciò ribadisce la natura sociale della costruzione identitaria e il ruolo fondamentale dell’alterità. Attualmente si registra un’inversione di tendenza rispetto all’approccio del postmodernismo radicale; lo dimostra l’enfasi posta sulla riproduzione telematica degli stereotipi sociali e sul permanere, negli ambienti virtuali, di tratti di riconoscibilità degli aspetti sociobiologici degli utenti. L’attenzione è focalizzata sulle pratiche situate di fruizione della rete, considerata, nell’ottica di un’ etnografia connettiva (Hine 2000), non come spazio altro bensì come ambiente integrato agli altri spazi della vita offline. È inoltre recuperata all’analisi l’importanza teorica della relazione, anche se tecnologicamente mediata, ai fini della costruzione identitaria dell’attore sociale. Il legame instaurato dalla comunicazione è riconosciuto 57 Le coordinate del sé nella geografia dei media Diana Salzano come necessaria condizione della fondatività ontologica del sé online piuttosto che come un vincolo cui sottrarsi: “L’assunto cartesiano ‘cogito ergo sum’ non si applica alle relazioni di rete; chi non comunica, chi non manifesta la sua esistenza attraverso l’interazione (...) non esiste da un punto di vista sociale” (Paccagnella 2000, p. 83). La tendenza attuale degli internet studies è quella di individuare la continuità tra l’identità offline e le strategie di presentazione del sé in rete, sempre più orientate alla sincerità (lo dimostra il recupero della dimensione visiva resa possibile dall’uso della webcam, degli avatar grafici e delle fotografie digitali) e alla costruzione di un’immagine di sé armonica e coerente anziché disomogenea e dislocata (Cheung 2000). Piuttosto che di invenzione si può dunque parlare di rielaborazione dell’identità digitale, a partire da qualche tratto liberamente scelto (Giaccardi, Magatti 2003). Già lo pseudonimo, il nickname usato online mira a costruire una reputazione e ad orientare la percezione degli interlocutori su alcuni aspetti personali che si intende enfatizzare. Ogni sito personale può essere inoltre considerato una forma di narrazione del sé, un testo che prevede nel suo modello enunciazionale un lettore modello inteso come precomprensione dell’utente empirico (Cosenza 2004, p. 134). Il Web si presenta allora “come il piano di iscrizione di una serie di politiche e ideologie di rappresentazione dell’identità, che trascendono ogni possibilità decostruttiva dell’utente” (Tosoni 2004, pp. 147-148). Studi recenti dimostrano che la chat è il luogo della rete più frequentato e ancora di più lo è messenger che accoglie al suo interno persone che già si conoscono e che, pertanto, non hanno alcuna ragione per fingere. In molti casi, anzi, la rete è vissuta come uno strumento di potenziamento, di libera espressione e di scoperta delle dimensioni del sé più profonde; diventa un rivelatore ontologico, un demaquillant volto a depotenziare la cosmesi identitaria a cui la reciprocità delle interazioni dirette off-line sembra obbligare. L’attore in relazione può costruire la propria identità sulla trama delle reti sociali in cui si inserisce, attraverso pratiche narrative e comunicative. Le strategie performative di autorappresentazione costituiscono solo un momento della storia relazionale dell’attore sociale che è portatore di una memoria dell’altro e di sé al cospetto dell’altro: “la confusione circa l’identità di un partecipante distrugge l’interazione sociale e le relazioni interne al gruppo” (Kendall 2002, p. 138). La fiducia, medium indispensabile alla relazione, implica il poter collocare l’identità nella storia della relazione in cui questa ha avuto origine. L’accesso agli orizzonti simbolici di una determinata subcultura di rete non elimina le altre appartenenze sociosimboliche che costituiscono, anzi, frame interpretativi e regolativi per le identità costruite online. I percorsi di costruzione identitaria devono essere, pertanto, contestualizzati entro particolari relazioni tra i soggetti e interpretati in relazione a specifici contesti. La costruzione discorsiva del sé in rete cerca di ricostruire semanticamente le coordinate di una corporeità assente che si vuole e si deve evocare. Narrarsi consente di esternare le pratiche della consapevolezza, elaborare la memoria ricollocandola nel presente e presentare “una identità ormai riflessiva agli altri, per averne conferma. La biografia, raccontata a se stessi e poi riconosciuta dagli 58 Quaderni di comunicazione 10 altri, funziona da punto fermo per l’identità frammentata” (Bovone 2005, p. 8). In assenza della corporeità, il solo possibile accesso all’identità altrui non resta che il racconto di sé, l’identità rappresentata, messa in scena, vestita. L’effetto drammaturgico (Goffman 1959) dell’apparenza che non può più servirsi della corporeità per attingere l’interiorità altrui, si gioca in rete sull’unica possibilità della narrazione di sé: l’importanza del racconto dell’identità “si rivela palesemente nei mondi digitali e ci consegna un’identità culturale (Hall, Du Gay 1996) intesa come identità personale/sociale narrata” (Bovone 2005, p. 17)1. Emblema di una costruzione discorsiva dell’identità volta a creare relazione e capitale sociale sono i social network che servono a combattere i buchi strutturali, i vuoti di connessione tra gruppi diversi di individui e di reticoli relazionali (Burt 1992) e sono testimonianza di una relazionalità diffusa, di una discorsivizzazione della relazione che crea uno spazio di confronto, aumenta la narrazione condivisa ed alimenta la memoria del gruppo. La narrazione del sé diviene luogo di costruzione di relazionalità e la relazione, fondata dai processi comunicativi, si rivela determinante ai fini della edificazione del sé. Partecipare allo scambio comunicativo significa legittimare la propria identità, definendola attraverso il confronto con l’alterità; significa immergersi in un processo di sociazione (Simmel 1908) che crei un senso condiviso. I processi sociali cooperativi fondano un capitale sociale secondario (Donati 2003) necessario a sfidare il rischio di anomia che vive l’uomo contemporaneo. I network relazionali io-centrati (Castells 2001, p. 126), le comunità personalizzate di cui parla Wellman, si configurano come la base delle relazioni terziarie tardo-moderne che vedono il primato di legami deboli (Granovetter 1973) centrati sull’individuo e sui suoi personali portafogli di socialità. L’identità performativa, narrata, si presenta, dunque, sempre più come il frutto di una negoziazione semantica, di un processo discorsivo: “Essere e diventare un Sé significa inserirsi in reti di interlocuzione (...) intrecciare narrazioni e fedi contrastanti in una biografia irripetibile” (Benhabib 2002, pp. 36-37). L’identità come immagine offerta, narrazione riflessiva, processo non pianificato è a proprio agio nei mondi virtuali dove la provvisorietà, l’indeterminatezza sono la regola e soprattutto sono svelate come componenti costitutive di quel processo di continua autoidentificazione la cui natura processuale dà luogo a “manifestazioni socialmente situate del sé, prese come tappe di un itinerario personale o come momenti di un’identità personale frammentata” (Bovone 2005, p. 7). Nota 1 La “narrazione, come pratica eminentemente sociale, è il punto d’incontro tra identità individuali e collettive, è là dove l’identità individuale si fa sociale” (Bovone, 2005, p. 8). Bibliografia Appadurai, A., 1996, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis-London; tr. it., 2001, Modernità in polvere, Meltemi, Roma. 59 Le coordinate del sé nella geografia dei media Diana Salzano Baldini, E., Moroni, F., Rotondi, M. (a cura di), 1995, Nuovi alfabeti. Linguaggi e percorsi per ripensare la formazione, FrancoAngeli, Milano. Benhabib, S., 2002, The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, Princeton University Press, Princeton, N.J.; tr. it., 2005, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, Il Mulino, Bologna. Bovone, L., 2005, Vestire l’identità. Relazione presentata al convegno “Comunicare le identità”, Bolzano, 23-24 settembre. Bruner, J., 1991, “La costruzione narrativa della realtà”, in Ammaniti, M., Stern, D.N., a cura di, Rappresentazioni e narrazioni, Laterza, Roma-Bari. Bruner, J.,1996, The Culture of Education, Harvard University Press, Cambridge, MA; tr. it., 1999, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano. Burt, R.S., 1992, Structural holes, Harward University Press, Cambridge, Massachussetts Castells M, (2001), Internet galaxy, Oxford University Press, Oxford; tr. it., 2002, Galassia Internet, Feltrinelli Milano. Cheung, C., 2000, “A Home on the web: Presentation of Self on Personal Homepages”, in Gauntlett, D., eds., Web Studies, Arnold, London. Colombo, F., 1990, Ombre sintetiche. Saggio di teoria dell’immagine elettronica, Liguori, Napoli. Cosenza, G., 2004, Semiotica dei nuovi media, Laterza, Roma-Bari. Demetrio, D., 1996, Raccontarsi. L’autobiografia come cura del sé, Raffaello Cortina Editore, Milano. Donath, J., 1999, “Identity and deception in the virtual community”, in Smith, M.A., Kollock, P., eds., Communities in Cyberspace, Routledge, London, New York. Donati, P., 2003, “La famiglia come capitale sociale primario”, in «Famiglia e capitale sociale nella società italiana» Ottavo rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003. Gardner, H., 1983, Frames of mind. The theory of multiple intelligences, Basic Book, New York; trad.it., Formae mentis. Saggio sulla pluralità della intelligenza, Feltrinelli, Milano 1987. Geertz, C., 1973, The Interpretation of Cultures, Basic Book, New York; tr. it., 1987, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna. Giaccardi, C., Magatti, M., 2003, L’Io globale. Dinamiche della società contemporanea, Laterza, Bari. Giddens, A., 1991, Modernity and Self Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Stanford University Press, California; tr.it., 1999, Identità e società moderna, Ipermedium libri, Napoli. Goffman, E., 1969, Strategic Interaction, University of Pennsylvania Press, Philadelphia; tr. it., 1999, L’interazione strategica, Il Mulino, Bologna. Goffman, E., 1959, The presentation of self in everyday life, Doubleday, Garden city, New York; tr. it., 1993, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna. Granovetter, M., 1973, “The Strength off Weak Ties”, «American journal of sociology», n. 78. Hall, S., du Gay, P., 1996, Questions of cultural identity, Sage, London Thousands Oaks, New Delhi. Hine, C., 2000, Virtual Ethnography, Sage, Thousand Oacks, CA. Kendall, L., 2002, Hanging Out in the Virtual Pub. Masculinities and Relationships Online, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London. Magatti, M., Bichi, R., 2000, “Soggettività e globalizzazione”, in Cesareo, V., a cura di, Globalizzazione e contesti locali. Una ricerca sulla realtà italiana, Franco Angeli, Milano. Melucci, A., 1991, Il gioco dell’Io, Feltrinelli, Milano. Paccagnella, L., 2000, La comunicazione al computer, Il Mulino, Bologna. Reid, E., 1991, “Electropolis: Communication and Community on Internet Relay Chat”, «Intertek», n. 3. Remotti, F., 1996, Contro l’identità, Laterza, Roma-Bari. Ricoeur, P., 1986, Du texte à l’action. Essai d’herméneutique II, Le Seuil, coll. «Esprit», Paris; tr.. it., 1994, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica, Jaca Book, Milano. Ricoeur, P., 1990, Soi-meme comme un autre, Seuil, Paris; tr.it., 1993, Sè come un altro, Jaca Book, Milano. Salzano, D., 2003, Lo sguardo disancorato. Società globale e comunicazione, Editoriale Scientifica, Napoli. 60 Quaderni di comunicazione 10 Salzano, D., 2008, Etnografie della rete. Pratiche comunicative tra on line e off line, FrancoAngeli, Milano. Silverstone, R., 1994, Television and everyday life, Routledge, London; tr. it., 2000, Televisione e vita quotidiana, Il Mulino, Bologna. Simmel, G., 1908, Soziologie, Untersuchungen uber die formen der vergesellschaftung, casa ed, Duncker Humblot; tr. it., 1989, Sociologia, Edizione di comunità, Milano. Thompson, J.B., 1995, The media and modernity. A social theory of the media, Polity press, Cambridge; tr. it., 1998, Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, Il Mulino, Bologna. Tomlison, J., 1999 Globalization and culture, The University of Chicago Press, Chicago; tr. it., 2001, Sentirsi a casa nel mondo. La cultura come bene globale, Feltrinelli, Milano. Tosoni, S., 2004, Identità virtuali. Comunicazione mediata da computer e processi di costruzione dell’identità personale, FrancoAngeli, Milano. Turkle, S., 1995, Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, Simon & Schuster, New York; tr. it., 1997, Vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di internet, Apogeo, Milano. Varela, F., 1995, “Scienze cognitive e formazione” in Baldini, E., Moroni, F., Rotondi, M., a cura di, Nuovi alfabeti. Linguaggi e percorsi per ripensare la formazione, FrancoAngeli, Milano. Alejandro De Marzo Audiences auto-narranti e media-biografie Anni addietro, quando già si cominciava a parlare di talune innovazioni di linguaggio televisivo nei termini di Real-Tv e Tv-verità (Cavicchioli-Pezzini 1993), è probabile anche che si fosse già potuto immaginare lo sviluppo attuale di tali prodromiche tendenze della comunicazione mediatizzata, nella fattispecie del genere “reality” con le sue sotto-ripartizioni. Inaugurata la pratica di offrire una rappresentazione del reale praticamente sempre meno dipendente dalla soggettività di sguardo ed interpretazione della mediazione televisiva – ma ad ogni modo solo illusoriamente neutra e asettica nel restituire gli eventi e le persone oggetto d’interesse – non si trattava, tutto sommato, che di fare solo un altro piccolo pezzo di strada per arrivare a concepire una trasmissione “non-stop” della vita umana quale quella odiernamente esperibile con Grande Fratello o i suoi molteplici derivati e surrogati di sorta. Se le versioni primordiali della Real-Tv sapevano ancora di un gusto “neo-televisivo” (tanto da non risultare troppo destabilizzanti per l’audience, sia sotto l’aspetto morale che sotto quello dell’impegno temporale impiegato nella relativa fruizione), le sue derivazioni ultime, invece, ricadono pienamente all’interno dei confini della posttelevisione e, dunque, si caricano anche delle specifiche caratterizzazioni (e inquietudini) tecnologico-formali di questa recentissima fase di evoluzione del medium domestico. La differenza, in breve, si attua nel solco della pervasività, della interattività e personalizzazione del consumo culturale dell’audience, esaltandone l’intrinseca istanza di auto-determinazione della dieta mediale, un fenomeno che essa ha dato prova di possedere da sempre, nonostante sia stato riconosciuto e adeguatamente apprezzato solo da qualche decennio grazie al filone di ricerca facente capo all’approccio dei Cultural Studies. È proprio alla luce di tale autonomia ed auto-diretto “attivismo” dell’audience, infatti, che sovente si levano accuse, giudizi e critiche relative alla degradazione e all’immoralità del prodotto televisivo (e naturalmente non sempre senza tutti i torti nel sostenerlo), in quanto la possibilità di selezionare tra diverse opzioni costruendosi un palinsesto tarato a misura dei propri gusti ed interessi di visione apre legittimamente la strada alla libera e parimenti rispettabile percorribilità di un menù di offerte non più automaticamente “impegnate” e culturalmente “alte” (quali erano quelle obbligatoriamente espresse dalla istituzionale e pedagogizzante paleo-tv del monopolio o quelle, poche a dir la verità, variamente divulgative-seriose della successiva neo-televisione duopolistica). Ma questo non è un problema nuovo (era affiorato già in concomitanza con l’ampliamento dei canali di trasmissione e la competizione delle emittenti commerciali con la Tv di Stato all’inizio degli anni Ottanta). Il vero punto di criticità, insomma, continua a risiedere nel grado di “fiducia” che si accorda alla tele-platea consumatrice (ed anche a ciascun singolo utente). In altri termini manca ancora la maturazione di un atteggiamen- 62 Quaderni di comunicazione 10 to di più positiva considerazione nei confronti del pubblico e le sue potenzialità auto-educative (certamente però non aspettandosi nemmeno che tale capacità di miglioramento personale attraverso le decisioni di consumo mediale sia un attributo così tanto diffuso e generalizzato!). Si è comunque già accertato che per l’audience non sia preferibile restare assoggettata ai regimi di offerta prestabiliti dalle direzioni editoriali o dagli uffici marketing delle emittenti, dato che: a) ciò che può esser prediletto da una qualsiasi dirigenza televisiva risulterà in fondo sempre l’espressione di una progettualità politica (più o meno evidente o consapevole) che ad ogni modo si pone per così dire in maniera costitutivamente “esterna” ai processi cognitivi del pubblico; b) quanto il marketing delle reti commerciali si prefigge di fare (cercare di intercettare la sensibilità comune e assecondare di conseguenza le tendenze di consumo così individuate) è un’operazione delicata che viene meglio avvantaggiata ed insperatamente ottimizzata proprio dalla odierna libera auto-selezione dei fruitori. Come per ogni altro atto di consumo, d’altronde, le scelte televisive “parlano” inequivocabilmente di chi le compie (“non si può non comunicare” direbbe Watzlawick), e l’atto del telespettatore (ma difatti sarebbe meglio dire del prosumer) di delinearsi un percorso di visione autonomo e personale comunica agli altri (ma soprattutto a sé stesso) la sua peculiare identità. Questa particolare proprietà di mettere in risalto l’espressione identitaria dei fruitori si palesa in maniera più evidente nel caso dei media non-mainstream, come evidenziato da Michele Sorice (2005). Restando nell’ambito della fruizione televisiva (dove le scelte di consumo rivestono una importanza culturale cruciale), è principalmente sul versante dei contenuti veicolati che si concentrano nuove riflessioni. Si pensi ai concorrenti nella casa del Grande Fratello. Nonostante il canovaccio generale stabilito dagli autori (che riguarda soprattutto situazioni, giochi, regole) tutti gli inquilini vivono la loro vita, il che televisivamente significa inscenare l’imprevedibilità e l’incontrollabilità delle dinamiche della vita reale. Solo così la post-tv riesce a restituircene, nella quasi-integrità, l’identità vera. Quello che avviene in qualsiasi reality ha dunque, a ben vedere, molto più a che fare con l’autoespressione del Sé (di chi vi partecipa e paradossalmente di chi guarda) piuttosto che con il fantomatico voyeurismo dei telespettatori collegati da casa – come si è sempre andati affermando utilizzando spesso obsolete categorie interpretative che non consentono di cogliere lo spostamento psicologico oggi ravvisabile. Sebbene si faccia un gran parlare delle situazioni e degli avvenimenti che accadono ai tanti reclusi volontari nella casa del Grande Fratello, ciò che l’audience in realtà assapora senza darsene conto è l’identità e i tratti di personalità dei protagonisti che segue con così tanta attrazione e curiosità. Non è tanto, quindi, una voglia di vedere persone nelle azioni in cui son coinvolte (come, per esempio, nel caso più estremo del voyeurismo sessuale dei film porno), bensì di acquisire ed interiorizzare marche caratteriali ed identitarie (come è stato più tacitamente appurato da tempo per la musica pop e le rockstars – si vedano gli studi di S. Frith). I meccanismi di fandom che oggigiorno si innescano in modo crescente, allora, vanno assunti ad indizio di un soggiacente processo di auto-educazione dell’audience che restava sommerso e ancora “invisibile” in quanto era limitato alla sfera – potente sì, ma non cruciale – dell’immaginario cinematografico e musicale; è soltanto con 63 Audiences auto-narranti e media-biografie Alejandro De Marzo il passaggio alla “domesticità” della televisione (e dunque alla quotidianità totale del suo linguaggio) che viene ad essere maggiormente percepita l’“interdipendenza esistenziale” degli individui (l’uno dagli altri). Le obiezioni morali, quindi, si sustanziano contro l’esibizione di identità vere (“reali-nella-realtà”) che non sempre però sarebbero garanzia di una testimonianza univoca ed esemplare come accadeva invece alla Tv precedente (la quale pur dissacrando formalmente i canoni tradizionali si muoveva comunque all’interno di una logica rispettosa di valori consolidati e votata all’esemplarità nel suo pubblico riferire). Ma a parte questo, un altro elemento da sottolineare nell’ambito delle modalità di “attivismo” dell’audience è la scoperta di una nuova competenza specifica che possiamo definire “auto-narrante”. Per spiegarla efficacemente, torniamo anzitutto alle forme primordiali di Real-Tv e Tv-Verità cui si diceva in apertura. In esse si manifestava già quella tendenza a parlare di sé e del proprio vissuto esistenziale ed orientamenti di vita che contraddistingueva, ad esempio, la casalinga alla prese con l’omosessualità del figlio, oppure un malato allo stadio terminale. Vincendo naturali ritrosie a chiudersi in sé, essi si raccontavano mediante una trasmissione televisiva o radiofonica con un valore di exemplum per gli ascoltatori (perché potevano trovarsi nelle stesse condizioni o perché prima d’allora non avevano mai sentito parlare di questi temi, e dunque serviva possedere strumenti informativi per affrontarli), senza comunque detenere consapevolezza “professionistica” della propria auto-rappresentazione mediale (Gasparini et al. 1998). Riferire di sé stessi, allora, assumeva piuttosto quella più semplice e al contempo vantaggiosissima valenza psico-terapeutica di cui parla Demetrio (2006), mirando a conoscersi nel profondo (e chi meglio di noi stessi può spingersi così in profondità?). Per capire la diversa natura dell’auto-narrazione post-televisiva, invece, bisogna rifarsi alla riflessività esistenziale tipica della modernità (Beck et al. 1994) che indirizza un ben preciso paradigma teorico (Abercrombie-Longhurst 1998). L’audience contemporanea, in base a esso, viene descritta come “diffusa”, cioè in grado di auto-percepirsi come “audience” per via di un circuito narcisistico-esibizionistico (e non solo limitatamente ai suoi atti di fruizione). Il pubblico, quindi, si fa “performer” che scrutina le proprie performances quotidiane in ottica spettacolare, e a seguito di questo atteggiamento, altresì chiamato di vetrinizzazione sociale (Codeluppi 2007), ridimensiona le coordinate di interpretazione dei prodotti culturali che consuma (vedi anche Sfardini 2009). Anche la storia della televisione italiana dimostra questa progressiva protagonizzazione dell’audience. La costruzione, infatti, di un asse privilegiato con i propri beniamini (attori di una fiction o semplici concorrenti del Grande Fratello), rivela quali siano le “fonti umane” cui si alimenta la formazione del Sé, sempre in un meccanismo di espressione dialogica: l’audience esprime la costante attenzione alle performances dell’identità televisiva presa a riferimento, fino a convincersi di essere identità pronta per proporsi a riferimento per gli altri (le “identità mediatiche” di cui parla Fanchi 2002). Che i media si pongano ormai a strumenti per la costruzione preminente di biografie umane poste sotto i riflettori lo dichiarano implicitamente anche alcuni format televisivi internazionali. Si prenda il caso del game-show Affari tuoi. In questo format si può constatare come la parte prevalente sia costituita dalla conoscenza umana dei concorrenti. Oltre ad una prima presentazione generale 64 Quaderni di comunicazione 10 di tutti loro, infatti, via via che il gioco prosegue, il pubblico viene a scoprire meglio la vita personale di quelli che si stanno affermando superando le varie fasi di eliminazione, ma attraverso una messa in scena di sé davvero specifica. Non è tanto l’auto-presentazione che ciascuno faceva all’inizio del gioco, o le risposte sulla propria vita in base alle domande del conduttore nel corso delle fasi, o il momento della fatidica lettera (scritta dai concorrenti in precedenza ma di cui viene data lettura solo se si resta a correre da soli in finale), bensì la peculiare modalità di racconto del proprio modo di ragionare. Rispetto ai telequiz del passato, in cui la lunga attesa della risposta del concorrente era accompagnata dal silenzio del pubblico in studio (ed eventualmente dal ticchettìo inquietante del cronometro a scandire il tempo rimanente), nei game-show odierni è evidente che il concorrente di turno esplicita i meccanismi di pensiero che lo portano a dare una certa risposta compiendo i suoi ragionamenti (giusti i sbagliati che siano) in pubblico, “pensando ad alta voce”, senza inibizioni a che da tale vulnerabilità comunicativa si possa ricostruire la sua mentalità e carpire la sua “anima”. In altre parole, delineando pubblicamente i criteri e i collegamenti operati di fronte alle circostanze che si incontrano, il soggetto si dà a conoscere agli altri, “dice di sé” in una modalità assai delicata. I sentieri logici che la mente umana percorre nell’elaborazione di concetti e soluzioni, lungi dal restare interessanti per i soli psicanalisti e fisiologi, risultano invece inconsciamente il vero centro d’attenzione cui ci dedichiamo inavvertitamente nella comunicazione quotidiana con i nostri simili (Anolli 2002). Da essi traiamo infatti indirettamente i tasselli informativi della personalità e del carattere di chi stiamo ascoltando, all’interno di un processo cognitivo inferenziale e rapido che si basa certamente anche sul bagaglio di esperienze e riferimenti culturali di noi che decodifichiamo. Ciononostante, l’istanza “auto-narrante” non deve essere ritenuta una qualità positiva dell’audience limitatamente alle possibilità espressive che assicura al singolo, perché potrebbe al contrario essere anche la leva che l’individuo offre ingenuamente agli altri per consentire l’accesso malintenzionato alla propria interiorità esposta (in questo senso essi potrebbero comportarsi come “manipolatori”). Scegliendo di sottrarsi a questa esternazione delle proprie “architetture culturali” (Mongelli 2009), nello specifico dell’accorto occultamento dei procedimenti mentali di produzione di risposta al quiz, ad esempio, il bel protagonista del pluripremiato film di D. Boyle The Milionarie (2008) riuscirà a destreggiarsi nelle avventure che lo coinvolgeranno. Rifacendosi al famoso game-show televisivo Chi vuol essere milionario?, il film si sviluppa attorno alla partecipazione di un giovane (originario di uno slum periferico di Bombay) alla versione indiana del format. Tale partecipazione diventa sorprendentemente vincente grazie al fatto che il giovane, per rispondere alle sempre più difficili domande, attinge alla propria storia di vita, alla memoria delle sue esperienze personali, quale risorsa originale e controversa. In parallelo alla sua partecipazione al game-show, infatti, si snodano gli eventi che lo vedono prima separato e alla fine felicemente ricongiunto alla sua beneamata, raggiungendo così il successo da lui più desiderato, e il conseguimento della vincita al game-show. Abercrombie N.-Longhurst B., Audiences, Sage, London 1998 Alasuutari P., Researching culture: qualitative method and Cultural Studies, Sage, London 1999 Anolli L., Psicologia della comunicazione, Il Mulino, Bologna 2002 Aroldi P.-Colombo F., Le età della Tv. Indagine su quattro generazioni di spettatori italiani, Vita e Pensiero, Milano 2003 Atkinson R., L’intervista narrativa, Raffaello Cortina, Milano 2002 Beck U.-Giddens A.-Lash S., Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge University Press, Polity, 1994. Bird E., The Audience and Everyday Life. Living in a Media World, Routledge, London 2003 Bühler K., Teoria dei linguaggi. La funzione rappresentativa del linguaggio, Armando, Roma 1983 Cavicchioli S.-Pezzini I., La Tv verità. Da finestra sul mondo a panopticon, VQPT/Eri n. 118, Roma, 1993 Clifford J.-Marcus G. E., Scrivere le culture, Meltemi, Roma 1997 Codeluppi V., La vetrinizzazione sociale, Bollati Boringhieri, Torino 2007 Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina, Milano 2006 Fanchi M. G., Identità mediatiche, Franco Angeli, Milano, 2002 Gasparini B.-Ottaviano C.-Simonelli G.-Vittadini N., Confidarsi a voce alta. Televisione, radio e intimità, VQPT/Eri n. 157, Roma 1998 Geertz C., Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 1987 Giddens A., Fondamenti di sociologia, Il Mulino, Bologna 2006 Gillenspie M., Media Audiences, Open University Press, Maidenhead 2005 Gillespie M.-Toynbee J., Analysing Media Texts. Maidenhead: Open University Press 2006 Grodin D.-Lindlof T. R., Constructing the Self in a Mediated World, Sage, London 1996 Guidicini P., Questionari, interviste, storie di vita, Franco Angeli, Milano 1995 Gunter B., Media Research Methods, Sage, London 2000 Hall S.-Du Gay P., Questions of Cultural Identity, Sage, London 1996 Jedlowski P., Memoria, esperienza e identità, Franco Angeli, Milano 1989 Kershaw B., “The Politics of Postmodern Performance” in Campell (ed.), Analysing Performance: a Critical Reader, Manchester University Press, Manchester 1996, pp. 133-152 Lasch C., La cultura del narcisismo, Fabbri e Sonzogno, Milano 1991 Mantovani G., Comunicazione e identità, Il Mulino, Bologna 1995 Mongelli A., Architetture culturali, Franco Angeli, Milano, 2009 Scannel P., Media e comunicazione, Mulino, Bologna 2008 Schrøder K. C.-Drotner L.-Kline S.-Murray C., Researching Audiences, Arnold, London 2003 Sfardini A., Reality Tv. Pubblici fan, protagonisti, performer, Unicopli, Milano 2009 Silverstone R., Perché studiare i media, Il Mulino, Bologna 2002 Sorice M., Gli “altri” media. Ricerca sui media non mainstream, Vita e Pensiero, Milano 2005 65 Audiences auto-narranti e media-biografie Bibliografia Alejandro De Marzo Volendo, pertanto, determinare una considerazione conclusiva sull’auto-narratività dell’audience contemporanea, diremo che oggi per i membri dell’audience l’elaborazione della propria storia di vita assurge ormai fondamentalmente a binario interpretativo di strutturazione dell’immaginario sociale, così come attestano i risultati emersi dalla ricerca sui target generazionali della televisione italiana (Aroldi-Colombo 2003) e, da una prospettiva sicuramente meno scientifica ma di certo non meno affascinante, le vicende di The Milionarie. Monica Ferrari Lettere a genitori eccellenti nel Quattrocento italiano. Un’autobiografia del quotidiano come esercizio etopoietico Il Quattrocento italiano presenta momenti e contesti per così dire “genetici” quanto ai processi formativi delle élites nell’ambito di un più vasto ripensamento delle forme del potere nelle corti. Per una cospicua serie di principi e principesse in divenire vengono scritti testi che ridisegnano i ruoli di allievi e di maestri, inaugurando, pur nel rispetto di pratiche formative che vengono dal passato e che permangono nelle costellazioni discorsive (Foucault 1969-1971; Waquet 1998-2004) pensate per chi deve reggere gli altri (Garin 1949; Id. 1958; Id. 1996; Ferrari 2000), proposte educative e materiali di lavoro dal carattere decisamente peculiare. Una larga quota di “testi”, “tessuto” di parole (Segre 1985, pp.28-29) che fanno significato nella vita dei principi e delle principesse in divenire, non sono trattati del dover essere che indicano la via da seguire secondo una peculiare struttura argomentativa ove si media la forma degli Specula medievali con i modelli classici, da poco riscoperti e valorizzati nell’Europa dell’umanesimo “civile”, per dirla con Garin. Nel Quattrocento italiano, Guarino veronese, maestro di Leonello d’Este, scrive lettere esemplari, Enea Silvio Piccolomini predilige la forma epistolare per l’educazione dei principi che poi esprime al meglio nel suo Tractatus de liberorum educatione dedicato a Ladislao d’Ungheria (Garin 1958) e sono famose le missive del Filelfo a Matteo da Trevi, precettore di Gian Galeazzo Sforza (Firpo 1967). La presenza di tanti epistolari fatti per essere conservati dalle cancellerie dei principi (e dai posteri) testimonia della forza di un apparato burocratico preposto alla conservazione e alla produzione di testi (Leverotti 1994; Soldi Rondinini 1995), di una estesa rete di cavallari pronti a recapitare la corrispondenza con estrema velocità ed, anche e soprattutto, di un peculiare uso della lettera che, da privata, diviene pubblica, in funzione dei mittenti e dei destinatari, del loro ruolo politico e sociale. La lettera, insomma, è una peculiare tipologia di “testo” che nel XVI secolo troverà più compiute sistematizzazioni, in vista di una fortuna che ne farà, sulla scorta di esempi classici, tra cui spiccano le Lettere a Lucilio di Seneca, una delle forme più accreditate dello scambio culturale nei secoli successivi ed anche uno dei dispositivi formativi più importanti per le élites nella società europea di antico regime (Petrucci 2008; Lazzarini 2009). 68 Quaderni di comunicazione 10 Le lettere ai genitori tra Milano, Mantova e Ferrara nella seconda metà del Quattrocento Milano, Mantova e Ferrara rappresentano nella seconda metà del Quattrocento un interessante osservatorio delle pratiche didattiche e dei costumi educativi della società di corte in relazione alle vicende formative di famiglie fortemente legate l’una all’altra. Quanto a Milano, sappiamo che la generazione dei figli di Francesco I Sforza e di Bianca Maria Visconti, quasi si imparenta con Ludovico Gonzaga e Barbara del Brandeburgo. Ludovico il Moro sposa poi Beatrice d’Este, mentre Francesco Gonzaga, sul finire del Quattrocento, Isabella d’Este. Anche la Napoli degli Aragona, che consegna Eleonora ad Ercole I d’Este e che accoglie come sposa Ippolita Sforza, una delle più brillanti allieve di Baldo Martorelli da Serra de’ Conti (Cingolani 1983), è parte integrante di questo circuito (Luzio, Renier 1900-2005; Mazzi 2004), come la città dei Montefeltro, Urbino, il cui princeps, Federico, fu allievo, secondo la tradizione, del Vittorino. Non mancano alleanze matrimoniali con altri Stati: i Gonzaga cercano spesso in Germania le loro spose (Malacarne 1997). Alleanze private tra le famiglie (Lazzarini 1996) disegnano nuove forme di gestione del potere e saperi condivisi, a formare una koiné culturale destinata a lasciare poi un segno profondo nelle arti e nelle lettere della società europea di antico regime. Genitori e figli si scrivono tra Milano, Mantova e Ferrara per molte ragioni. I loro scambi epistolari, a eminente finalità etopoietica per i più giovani (Foucault 1983), non sono affatto “privati”, ma, al contrario, fanno parte di un più ampio circuito che comprende medici, governatori, precettori, maestri, oratori-ambasciatori, cortigiani e che, di recente, inizia a riemergere per singoli tasselli1. I genitori scrivono ai figli anzitutto per sollecitare le loro risposte ed obbligarli così all’esercizio della scrittura anche manu propria, pratica faticosa e difficile eppure messa in atto sovente dai più piccini con l’aiuto e l’ispirazione dei precettori, dei maestri e dei governatori. Al proposito ecco una missiva del 9 agosto 1458 firmata dal Marasca, precettore presso i Gonzaga che invita la madre ad apprezzare, per lettera, il lavoro epistolare delle figlie: Pertanto prego la prefata illustre signoria vostra laude lo suo scrivere azio ge cresca l’animo quare virtus laudata crescit2. Negli stessi giorni seguono le lettere delle bambine, Dorotea e Cecilia, rispettivamente di nove e sette anni, che, infatti, chiedono il maestro di ballo, pretesto di un esercizio del comporre e nel contempo ossequio alla madre3. Anche Francesco I Sforza nutre le stesse preoccupazioni del Marasca e il 20 agosto 1464 scrive a Franchino Caimi, governatore dei figli, per esortarlo a far sì che i bambini compongano personalmente le proprie lettere ed evitare che maestri, precettori e governatori siano responsabili dell’inventio: Franchino de Caymis aulico, Habiamo ricevute et intese le toe lettere de 17 del presente per la quale ne scrivi de la diligentia per ti usata acciò che li incliti nostri figlioli se adoptano in scrivere et in dictare et faciano bono proficto in quelli studij, el che tuto ne è piaciuto intendere […]. Sarimo ancora contenti che tu li inciti ad scrivere qualche Illustris fili nostri carissime, havemo inteso et cum despiacere la inconvalescentia del […] Guidone da Bagno perché amandolo nui come faciamo non possiamo far che non ne rencresca sentire alcuno suo sinistro perho te ne condolerai seco in nome nostro e tu non gli lassarai manchare cosa alcuna conferente ala liberatione et salute sua. Non se extenderemo altramente in ricordarti [… ] tu habi advertentia ali facti tuoi et te governi discretamente et cum prudentia perché sei horamai in tal etate che si persuademo da te stesso debi saperti regere senza altro maistro et cussì te confortamo a far aciò che correspondi ala opinione nostra di te…5 I genitori scrivono dunque anche per dare “istruzioni” circa il comportamento dei figli lontani e non solo dei più giovani. Di particolare interesse, a mio avviso, le istruzioni di Francesco I Sforza al figlio Galeazzo Maria, ora perdute nell’originale, trascritte da Domenico Orano, ove lo Sforza ricorda al figlio i suoi doveri proprio perché è uscito dall’infanzia e dunque si viene inaugurando tra loro un nuovo rapporto. Si tratta di documenti trasmessi ad Orano dallo zio Domenico Berti e provenienti, come lui stesso afferma, dai Registri delle missive ducali, anzi, per la precisione “ incastrati fra una minuta di una lettera ducale del 26 luglio 1457 ed un’altra che ha la data del 27 luglio dello stesso anno” (Orano 1901, p.14). Ancora la lettera, dunque, come veicolo di formazione e di corrispondenza pedagogica tra padre e figlio, in questo caso, forse, su modello delle “istruzioni” che il duca scriveva ai suoi “oratori” presso altre corti. Ecco quanto scrive Francesco I Sforza al figlio Galeazzo Maria: Galeazo, tu say che fino adesso nuy non te correzassemo may con ti, né may te daessemo pur uno solo boffeto, et questo havemo facto: prima perché tu sey stato fin qui ne li anni de la pueritia et poy per videre li costumi et modi che tu pigliavi, cossì li vicij. Et per tanto, consyderato che hormay ti sey in etate de cognoscere el bene e lo male, et che nuy ancora havemo conosciuto tucti li costumi et modi toy, deliberamo non expectare più ad dirti li modi quali volemo tu observi; ad ciò che tu non possi may per alcuno tempo dire de non essere stato admonito et represso de li vicij et mali costumi, et che non te sia stato dato l’ordine de la vita et costumi et modi, che tu hay ad tenere (Orano 1901, pp.16-17). Non di minor interesse, sempre in questa prospettiva, le lettere di Eleonora d’Aragona alla figlia Isabella, giovane e reticente sposa di Francesco Gonzaga, che, ancora dopo il matrimonio, deve apprendere i suoi doveri di Signora di uno Stato. Il 15 aprile 14916, a pochi mesi dal matrimonio avvenuto tra Ferrara e Mantova con grande sfarzo per la più bella tra le figlie degli Este, Eleonora invia alla figlia da Ferrara una lettera molto citata (Chiappini 1956; Mazzi 2004; Ferrari 69 Lettere a genitori eccellenti nel Quattrocento italiano I genitori, entrambi spesso lontani dai loro figli per ragioni di governo del territorio o per la guerra (nel caso dei padri), eppure impegnati in un intenso compito formativo, scrivono anche per presentificarsi, per farsi sentire, in taluni casi attraverso una probabile lettura ad alta voce delle loro missive da parte dei maestri e dei governatori dei figli. Ecco quanto scrive Federico Gonzaga al figlio Francesco il 14 febbraio 1483: Monica Ferrari volta de soa mano: et de suo dictate perché n’è pur parso che quella de Filippo non è facta de sua farina…4. 70 Quaderni di comunicazione 10 2009), vero e proprio “programma di istruzioni”, secondo uno stile ed un sistema di pratiche formative che potremmo dire comune ai signori di Milano, Mantova e Ferrara sul finire del XV secolo. Eccola: […] et se bene ni persuadiamo che siati prompta et usati diligentia in expedirle come se conviene, tutavia essendo desiderose che in ogni vostra actione conseguiati honore et laude vi racordamo ad essere solicite et diligente circa quanto sii necessario et expediente, non vi gravando la fatica et pigliandovi ogni cosa per piacere perché ne sentireti mancho et stareti più cum l’animo riposato quando le habiati expedite. Che ben sapeti che chi ha marito et stato bisogna che anche habi de le fatiche, reducendovi a memoria che anche havete ad haver de li figlioli et che bisogna attendere a mantenerli et conservarli la roba et stato et fare le cose che siano necessarie ali subditi et citadini suoi secundo accade. Et optime valete. A queste lettere i figli – tutti i figli, dai più piccini che lavorano alla loro educazione con governatori e maestri, ai più grandi, anche dopo il matrimonio che fa le figlie femmine signore di uno Stato oppure, per i maschi, dopo la morte del padre, quando cambiano gli equilibri politici nelle corti e il fratello maggiore diviene paterfamilias – rispondono, tra Milano, Mantova e Ferrara, con solerzia, nella seconda metà del Quattrocento. Tutti devono render conto di sé e, in taluni casi, dei fratelli e delle sorelle più giovani o comunque di coloro di cui devono imparare a prendersi cura, in quanto prendersi cura degli altri è uno dei doveri e delle competenze di chi deve reggere gli altri; i figli rispondono anche perché devono mostrare di progredire negli studi o perché non devono deludere i genitori. In quest’epoca e per un lungo arco temporale nella società occidentale, l’esercizio dello scrivere degli altri e di sé ha un’importanza essenziale per chi è chiamato dalla nascita a ruoli di potere. La lettera insegna un governo della pagina e della parola, aiuta a riepilogare la giornata e a rendere conto ai propri maggiori dell’impiego del tempo, presentifica l’assenza di genitori e maestri e dunque guida il processo di interiorizzazione delle istanze parentali, aiuta a comprendere i meccanismi del controllo sociale e delle gerarchie che danno ordine alla pagina, al mondo di carta ma anche al mondo reale. Attraverso la scrittura, i più giovani ordinano cose, parole ed emozioni nello spazio di una carta che ha valore perché unica in un’epoca in cui si è ben lontani dalla riproducibilità tecnica, specie se il documento viene composto manu propria, con la fatica della postura e la difficoltà meccanica connessa all’uso dell’attrezzo che esercita la manualità fine. Anche così si costruisce il gesto del potente, che lo fa diverso dagli altri, nell’impossibile impresa di legittimare quasi naturalmente la diversità tra gli esseri umani, uomini o donne che siano. Per un “grande”, la lettera è un espediente pedagogico che muove etopoieticamente il soggetto in direzione del proprio avvenire di princeps che dovrà siglare trattati, corrispondere con altri pari dislocati altrove per decidere delle sorti della gente, gestire in pubblico l’immagine di chi amministra la giustizia e accoglie le suppliche, consolare il popolo e sedurlo, abbagliandolo con lo spettacolo di sé, convincendolo della necessità della sua preminenza. Tra le diverse tipologie di lettere che in queste corti i genitori inviano ai figli sullo scorcio del XV secolo, merita di essere ricordato l’esercizio di riepilogo della propria giornata, quando la lettera diviene resoconto autobiografico integrale, L’esercizio che passa attraverso la lettera ai genitori non cessa con la fine dell’infanzia. Nelle diverse età della vita uomini e donne appartenenti alle diverse famiglie qui ricordate – gli Sforza, i Gonzaga, gli Este – non cessano di scrivere ai loro genitori dapprima e al loro fratello maggiore poi, divenuto paterfamilias dopo la morte del padre. Nel ricapitolare a delle istanze sovraordinate, manu propria o attraverso l’aiuto della mano di un altro – il copialettere –, l’impiego del proprio tempo, principi e principesse ottemperano ad un dovere di ossequio e nel contempo compiono per tutta la vita un esercizio che si intreccia, negli anni e nel loro divenire adulti, con altre pratiche e con altri testi, con la relazione diplomatica, ad esempio. Vediamo quanto scrive Ludovico il Moro alla madre da Cremona il 30 aprile 1467: Illustrissima Madona, vostra Illustrissima Signoria per mie lettere heri fu avisata del mio giungere a Lode et de quanto era seguito in quella hora, per questa mo restarà avisata come heri sira dopoy fu cenato d’uno pezo insieme col Illustrissimo Signore duca vostro figliolo et mio fratello tolse licentia da soa Signoria per poterme questa matina ad bona hora aviarme al camino mio come ho facto, et anday ad allogiare et dormire ad casa de Gabriele […] cittadino de quella vostra cità dal quale fuy per respecto de vostra Signoria ben veduto et acarezato et honorato. Poy questa matina, oldita la messa, venne ad disnare ad Pizighitone dove fuy similmente ben veduto […]. Essendo poi circa le XVIIII hore, montato ad cavallo per venire verso questa vostra devotissima cità nela quale giunse circa le XXII hore, sano et de bona voglia, havendo incontrato Iohanne Francesco Stangha de la daqua negra7 […] tutti questi vostri officiali [… ] tutti recolti da mi con una bona cera et con quello megliore modo me sia possibile me fecero compagnia fin qua al castello quale ho trovato ornato de tanti belli et ampi zardini chel me pare essere tutto renovato et intrato nel paradiso terrestre, et quando vostra Excellentia lo vederà non dubito serà in questo de quello medesmo apparere sonno io…8 Sappiamo che Ludovico il Moro ha quindici anni quando si reca a Cremona nelle vesti di luogotenente del fratello o, meglio, della madre. Il Moro si prepara alla gestione del potere grazie anche a queste missioni che lo vedono lontano dalla famiglia, a dover decidere da solo e per il meglio in diverse circostanze (Dina 1886; Ferrari 2003). Gli viene, insomma, affidata un’intera città e in questo periodo non sono infrequenti le missive alla madre, cui chiede consiglio e conforto per sopportare una solitudine necessaria a un principe. L’apprendistato al comando, all’atto decisionale ultimo e individuale, passa anche da qui, dall’essere luogotenente a quindici anni nel Castello di Cremona, circondato solo da sudditi. 71 Lettere a genitori eccellenti nel Quattrocento italiano Resoconti del quotidiano a diverse età Monica Ferrari se pure per un arco di tempo relativamente breve. Qui la lettera, strumento per eccellenza del diplomatico e del politico (Arisi Rota in corso di stampa), assume caratteristiche che esasperano il suo carattere etopoietico, mentre i meccanismi di selezione delle informazioni per i propri maggiori aiutano l’interiorizzazione di un ruolo sociale, di un’immagine di sé, di un prendersi cura che significa essenzialmente in prima istanza essere compos sui. 72 Quaderni di comunicazione 10 Strumento perfetto per presentificare l’assenza, il resoconto del quotidiano alla madre tramite la lettera si rivela anche il terreno ideale del confronto politico e dello scambio di informazioni. Sempre nel 1467, il 3 maggio, il Moro scrive dal Castello di Cremona: Illustrissima madona, per seguire el stilo mio che è de darli continuo aviso de quanto me acade fare ala giornata aviso quella come questa matina insieme con questi officiali si per devotione de Sancta Catherina da Siena la cui festa è celebrata hogi, sì anche per fare uno poco de exercitio ad pede et vederme da questa vostra devotissima citadina da li quale per reverentia de la vostra Excellentia sono tanto ben veduto, quanto al mondo più dire si possa, anday ad oldire messa ad Sancto Domenico dove se è celebrata dicta festa et oldita la messa volse ancora andare ad torre la indulgentia in domo. Dopoy el disnare duno pezo havendo preso de varij piaceri, lexi una lectione de Terrentio, secundo la consuetudine mia da qui, et anday poy ad oldire vespero ad la chiesa de Sancta Croce, quale è qua presso el castello. Montay dopoy chio fu cenato ad cavallo con questi vostri officiali et andassimo uno bon pezo per la cità a la bona guardia de la quale se attende dì e nocte et d’ogne hora con ogne diligentia et sollecitudine. Et similemente se fa ad questa vostra bella et inespugnabile forteza…9 Ma il Moro, come del resto il fratello Galeazzo Maria, erano stati abituati, per non dire obbligati, al resoconto della loro giornata ai genitori; lo si comprende dalla lettura di questa lettera di Galeazzo Maria Sforza, scritta manu propria da Lodi il 23 settembre 1458, all’età di quattordici anni10: Illustrissima princeps et excellentissima domina Mater et domina mea precolendissima, quantunche per el spectabele cavalero Mesere Francesco de Becharia, presente portatore, la Excellentia vostra possa a pieno intendere de l’essere nostro, non di mancho per non manchar da instituito ordine mio, aviso essa a la quale sommamente mi ricomando che lo Illustrissimo Signore mio honorandissimo padre mi et tuti li nostri qui dio gratia stasemo benissimo. E ancora, sempre da Lodi, il giorno dopo: Illustrissima princeps et excellentissima domina Mater et domina mea precolendissima, per ciò ch’el debito mio et in prima il comandamento di vostra Excellentia richedeno che ad dì per dì tegna quella chiara del ben stare de lo Illustrissimo Signore mio honorandissimo patre mio et tuti li nostri, l’aviso che Dio gratia tuti stasemo bene11. L’obbligo del rendere conto di sé, degli altri membri della familia e delle comuni giornate si coniuga poi, in qualche rarissimo caso eccezionale, con un resoconto autobiografico ancora più dettagliato che, quando è fatto manu propria, si configura come vera e propria penitenza per un’azione compiuta, talora proprio a danno del padre. Da questo punto di vista la lunghissima lettera che Sforza Secondo12, coinvolto in una congiura, indirizza a Francesco I, suo padre, il 3 luglio 1461, testimonia di un uso dell’epistola a sfondo autobiografico che diviene confessione e pena al tempo stesso per l’errore compiuto. Scrive Sforza Secondo: Illustrissimo Signore mio padre, como per Tristano et anche per una mia avea scrito a Vostra Signoria nelle quale scripture io non li avea scripto ne a boccha mandatovi a dire el vero: et cognoscho essere licito et honesto dire el vero a Vostra Illustrissima Illustrissimo princeps et Excellentissime domine Genitor et domine mi singolarissime. A di XII del mese presente date ad Excellentia vostra l’aviso nui dal canto de qua star bene,[…] il simele intenderà prefata Excellentia vostra cioè Illustrissimo Signore mio patre qua et Madona mia madre etiam Excellentissimo signore Marchese Alberto stare benissimo. Andemo adeso quasi oni di a caciar li cervi et è certo uno bello apiacer pigliargli a l’aqua quando sono stanchi […] benissimo me adapto a la voluntà de questi Signori, non facendo se non quello conosca essere di loro intento. Se a prefata Excellentia li pare habia a fare altro, me ne dia aviso, lo farò de bona voglia…14. Questo confronto con lo stile di un’altra corte, non traumatico per il Gonzaga, concerne in alcuni casi molto interessanti, a mio avviso, i maschi nel loro percorso formativo, quando sono ancora sotto la tutela dei genitori, ma, soprattutto e in ogni caso, le femmine che si maritano altrove. Specie le donne sono destinate ad andarsene dopo il matrimonio dalla corte che le ha allevate e cresciute a certi costumi e dunque rappresentano di fatto un tassello importante non solo delle alleanze matrimoniali ma anche dello scambio culturale nell’Europa medievale e moderna (Giallongo 2005; Arcangeli, Peyronel 2008). Infine, nelle loro lettere di spose, talora dolorose e tragiche, ai genitori e ai famigliari lontani, traspaiono anche i segni dei conflitti culturali di una società che, fuori d’Italia, non sempre condivideva quella koinè in cui si erano formate. Qualcuna di loro, tuttavia, sarà destinata, proprio negli stessi anni in cui alcune rimpiangevano i propri cari lontani – come Paola Gonzaga che soffriva per la lontananza da Mantova e per l’impossibilità a condividere nella nuova corte uno stile del vivere per lei irrinunciabile (Antenhofer 2007)-, a giocare, come Beatrice d’Aragona, ad esempio, un ruolo strategico importante negli equilibri politici internazionali. In ogni caso la lettera, in cui si riferisce ai propri genitori e poi al marito lontani, gioca un ruolo essenziale nella vita delle donne. Colpiscono, tra le tante missive in cui figlie parlano al padre e alla madre, le lettere di Chiara Gonzaga che media il rapporto tra la madre, Margherita, morente e il padre Federico (Ferrari 2008) e le lettere accorate che sempre Chiara, giovane sposa, scrive a Mantova al termine della sua gravidanza, nel maggio 1482. In una di queste (14 maggio 1482) racconta la fatica dei suoi ultimi giorni, prima di ricevere la lettera e la benedizione paterna: “ davante era meza morta e non manzava carne el vin e l’aqua non me piasiva el pan nol posia 73 Lettere a genitori eccellenti nel Quattrocento italiano Ma senza arrivare all’estremo limite del figlio che tradisce il padre e che deve chiedere indulgenza, la lettera diviene resoconto autobiografico dalle molteplici valenze politiche e diplomatiche per quei figli maschi che vengono mandati all’estero a imparare il mestiere delle armi. È il caso di Gianfrancesco Gonzaga che si reca appunto presso i suoi parenti in Baviera, ove apprende il tedesco oltre che lo stile di vita di un’altra corte. Il 27 agosto 1458, a dodici anni, scrive al padre lontano, dicendo: Monica Ferrari Signoria como segnore et patre e ho deliberato aprire el pecto e dire formalemente el vero a quella la quale son certo della sua solita clementia che ver altri che simele manchamenti et magiore anno fatto verso Vostra Signoria non gliene sto avara sì anche che ver me l’usarà che ne sonno servo et figliolo in la quale spero non per meriti ma per vostra infinita bontà ma haverà per recomandato et darà perdono ai mie falli et manchamenti13. 74 Quaderni di comunicazione 10 vedir e pur se me sforzava di manzar qualche cosa subito el rendia […] e adeso manzo…”. Il padre le invia una sua effigie (“la sua propia figura”) “la quala me pare tanto cara […] e non faza vista da me senza lacrime15”. Sono note le lettere di Beatrice d’Este a Ludovico il Moro, in occasione del viaggio compiuto, già sposa, a Venezia, nel 1493, insieme alla madre, al fratello Alfonso, alla cognata Anna, alla sorella Isabella e a Francesco Gonzaga (Mazzi 2004; Ferrari 2008), ora presso l’Archivio di Stato di Milano. La giovane sposa rende conto di ogni dettaglio delle sue giornate veneziane al marito e pater. Mi preme ricordare qui, in chiusura, la fortuna in antico regime della lettera etopoietica tra genitori e figli come dispositivo pedagogico, fortuna dovuta forse anche alla commistione (sempre più marcata in età moderna) con altri generi, specie con il Journal, con il diario della vita quotidiana dell’individuo in formazione, scritto da lui stesso o da altri. Di particolare interesse le lettere del piccolo Luigi XIII, conservate nel Journal del suo protomedico: Jean Héroard (Ferrari 1995). In un romanzo d’educazione scritto secoli dopo il diario sopra ricordato (Adèle et Théodore ou lettres sur l’éducation, 1782), Madame de Genlis, una donna che ebbe un ruolo d’eccezione nell’entourage educativo dei giovani principi d’Orléans (Julia 2006), cita, a mo’ d’esempio, le notissime lettere di Lord Chesterfield al figlio e, grazie al personaggio del conte di Roseville del suo romanzo, mostra l’importanza del tema. Al conte di Roseville viene affidata, nella finzione letteraria della De Genlis, l’educazione di un giovane principe: egli scrive il journal delle sue azioni e alla fine di ogni giornata lo commenta con l’allievo, ma, nel contempo, ne riferisce per lettera al suo corrispondente all’interno di un romanzo d’educazione a carattere epistolare. Note 1 Su queste corti mi permetto di rinviare ad alcuni dei miei contributi: Ferrari 1997; Ead. 2000; Ead. 2001; Ead. 2005; Ead. 2006, Ead. 2008; Ead. 2009. Cfr. l’intervento inedito di Isabella Lazzarini ad un convegno pavese del 2007 sul tema dei costumi educativi nelle corti europee, dal titolo Un dialogo fra principi. Rapporti parentali, modelli educativi e missive familiari nei carteggi quattrocenteschi (Mantova XV secolo). Ed inoltre: Antenhofer 2007; Bologna 1980; Cappelli 1894; Crisciani 2006; Dina 1886; Firpo 1967; Giordano 2008; Guerra 2005; Luzio, Renier 2005; Malacarne 1997; Mazzi 2004; Signorini 1985; Shemek 2003. 2 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga (d’ora in avanti ASMn, AG), b. 2392, c. 242r. Cfr. Ferrari 2009b. 3 ASMn, AG, b. 2095bis, c.543r. 4 Archivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Visconteo-Sforzesco, Carteggio Sforzesco (d’ora in avanti ASMi, Sforzesco), Potenze Sovrane, Francesco I Sforza, b. 1457, c.391r-v. Cfr. Ferrari 2000, p. 102. 5 ASMn, AG, b. 2105bis, c. 382r. 6 ASMn, AG, b. 1185. 7 Ci si riferisce al paese di Acquanegra, oggi in provincia di Cremona 8 ASMi, Sforzesco, Potenze Sovrane, Ludovico Maria Sforza, b. 1468, c.18r 9 ASMi, Sforzesco, Potenze Sovrane, Ludovico Maria Sforza, b. 1468, c. 19r. 10 ASMi, Sforzesco, Potenze Sovrane, Galeazzo Maria Sforza, b. 1462, c. 44r. 11 ASMi, Sforzesco, Potenze Sovrane, Galeazzo Maria Sforza, b. 1462, c. 46r. 12 Sforza Secondo (nato secondo alcuni nel 1433 e morto nel 1493) è figlio di Francesco I Antenhofer C., 2007, Briefe zwischen Süd und Nord, Innsbruck, Universitätsverlag, Wagner. Arisi Rota A., a cura di, Formare alle professioni. Diplomatici e politici, Milano, Franco Angeli, in corso di stampa. Arcangeli L., Peyronel S., a cura di, 2008, Donne di potere nel Rinascimento, Roma, Viella. Bologna G., a cura di, 1980, Libri per una educazione rinascimentale, Milano, Comune di Milano, Biblioteca Trivulziana, 3 voll. Cappelli A., 1894, Guiniforte Barzizza maestro di Galeazzo Maria Sforza, «Archivio storico lombardo», serie III, vol. I, a. XXI, pp. 399-442. Chiappini L., 1956, Eleonora d’Aragona, Rovigo, Ster. Cingolani D., 1983, Baldo Martorello da Serra de’ Conti, Comune di Serra de’ Conti, Biblioteca comunale. Crisciani C., 2006, Cura e educazione a corte: note su medici e giovani principi a Milano (sec. XV), in Ferrari M., a cura di, I bambini di una volta. Problemi di metodo. Studi per Egle Becchi, Milano, Franco Angeli, pp.41-48. Dina A., 1886, Ludovico il Moro prima della sua venuta al governo, «Archivio storico lombardo», serie II, a. XIII, pp. 736-776. Ferrari M., 1995, Insegnare a scrivere al re: l’alfabetizzazione di Luigi XIII bambino, in Becchi E., Antonelli Q., a cura di, Scritture bambine, Roma- Bari, Laterza, pp. 61-81. Ferrari M., 1997, Lettere di principi bambini del Quattrocento lombardo, « Mélanges de l’Ecole Française de Rome, Italie et Mediterranée», 109, 1, pp.339-354. Ferrari M., 2000,“Per non manchare in tuto del debito mio”. L’educazione dei bambini Sforza nel Quattrocento, Milano, Franco Angeli. Ferrari M., 2001, Il piccolo principe e il suo dover essere, in Becchi E., Semeraro A., a cura di, Archivi d’infanzia, Milano, RCS libri- La Nuova Italia, pp.251-270. Ferrari M., 2003, Lettere sforzesche dal castello di Cremona, in La Scuola classica di Cremona, Annuario 2003, pp. 141-152. Ferrari M., 2005, Percorsi educativi al femminile tra Milano e Mantova alla metà del Quattrocento, in Giallongo A., a cura di, Donne di palazzo nelle corti europee, Milano, Unicopli, pp. 99-112. Ferrari M., 2006, Stralci di corrispondenza famigliare nella seconda metà del Quattrocento: il caso dei Gonzaga e degli Sforza, in Ferrari M., a cura di, I bambini di una volta. Problemi di metodo. Studi per Egle Becchi, Milano, Franco Angeli, pp.15-40. Ferrari M., 2008, Un padre e il suoi figli. Segni dell’affetto e ruolo sociale nell’ambito di una familia del XV secolo, in Becchi E., a cura di, Figure di Famiglia, Palermo, Fondazione Vito Fazio-Allmayer, pp. 51-69. Ferrari M., 2009, Un’educazione sentimentale per lettera: il caso di Isabella d’Este (1490-1493), «RM Reti medievali-Rivista», X. Ferrari M., 2009b, Lettere, libri e testi ad hoc per la formazione delle élites: uno studio di casi fra Quattrocento e Settecento, in Paoli M. P., a cura di, Saperi a confronto nell’Europa dei secoli XIII-XIX, Pisa, Edizioni della Normale, pp. 27- 55 (in corso di stampa). Firpo L., a cura di, 1967, Francesco Filelfo e il “Codice Sforza” della Biblioteca Reale di Torino, Torino, Utet. Foucault M., 1969, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard – trad. it. 1971, L’archeologia del sapere, Milano, Rizzoli. Foucault M., 1983, L’écriture de soi, «Corps écrits», 5, pp. 2-23. Garin E., 1949, L’educazione umanistica in Italia, Bari, Laterza. 75 Lettere a genitori eccellenti nel Quattrocento italiano Bibliografia Monica Ferrari Sforza e di Giovanna d’Acquapendente; per aver congiurato contro il padre nel 1461 fu imprigionato nella Rocchetta di Porta Romana. Savy 2005; Ferrari 2006. 13 Bibliothèque Nationale de France, ms. it. 1589. 14 ASMn, AG, b. 2095bis, c. 521r. 15 ASMn, AG, b. 2105bis, c. 348r. 76 Quaderni di comunicazione 10 Garin E., 1958, Il pensiero pedagogico dello umanesimo, Firenze, Sansoni-Giuntine. Garin E., 1996, L’immagine del bambino nella trattatistica pedagogica del Quattrocento, in Becchi E., Julia D., a cura di, Storia dell’infanzia, Roma-Bari, Laterza, vol. I, pp. 182-203. Giallongo A., a cura di, 2005, Donne di palazzo nelle corti europee. Tracce e forme di potere dall’età moderna, Milano, Unicopli. Guerra E., 2005, Soggetti a “ribalda fortuna”. Gli uomini dello stato estense nelle guerre dell’Italia quattrocentesca, Milano, Franco Angeli. Giordano L., a cura di, 2008, Beatrice D’Este. 1475-1497,«Quaderni di artes/2». I “Suggerimenti di buon vivere” dettati da Francesco Sforza per figliuolo Galeazzo Maria, pubblicati a cura di Domenico Orano, Roma, Forzani e c., Tipografia del Senato, s.d. [1901] Julia D., 2006, L’imperium di una governante:Madame de Genlis e l’educazione dei principi d’Orléans, in Ferrari M., a cura di, I bambini di una volta. Problemi di metodo. Studi per Egle Becchi, Milano, Franco Angeli, pp. 143-173. Lazzarini I., a cura di, 2009, I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di comunicazione in Italia fra tardo medioevo o prima età moderna, «RM Reti medievali-Rivista», X. Lazzarini I., 1996, Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell’età di Ludovico Gonzaga, Nella sede dell’istituto, Palazzo Borromini, Roma. Leverotti F., 1994, ‘Diligentia, obedientia, fides, taciturnitas…cum modestia’. La cancelleria segreta nel ducato sforzesco, «Ricerche storiche», a.24, n.2, pp.305-335. Luzio A., Renier R., 1900, La coltura e le relazioni letterarie di Isabella d’Este Gonzaga, «Giornale storico della letteratura italiana», XXXV, ora ripubblicato a cura di Albonico S., Milano, 2005. Malacarne G., 1997, Barbara Hohenzollern del Brandeburgo. Il potere e la virtù, Rezzato, Magalini Editrice 2. Mazzi M. S., 2004, Come rose d’inverno. Le signore della corte estense nel ‘400, Ferrara, Edizioni Comunicarte. Bartholomaei Platinae, De Principe, a cura di G. Ferraù, Palermo, il Vespro, 1979. Petrucci A., 2008, Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Roma-Bari, Laterza. Savy P., 2005, Un début dans la vie: Sforza Secondo jusqu’en 1467, «Médievales», 48, pp.15-38. Segre C., 1985, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi. Shemek D., 2003, “Ci ci” and “pa pa”: script, mimicry and mediation in Isabella d’Este’s letters, «Rinascimento», 43, pp.75-91. Signorini R., 1985, Scritti e voci puerili di figli del marchese Ludovico II Gonzaga e un luttuoso 24 maggio 1452, «Civiltà mantovana», n.s. 8, pp.25-42. Soldi Rondinini G., 1995, Cancellieri sforzeschi esecutori o ispiratori della politica ducale? in AAVV, Politica, cultura e lingua nell’età sforzesca, Milano, Istituto lombardo di scienze e lettere, 1995, pp.32-49. Waquet F., 1998, Le Latin ou L’empire d’un signe. XVIe-XXe siècle – trad. it. 2004, Latino. L’impero di un segno (XVI-XX secolo), Milano, Feltrinelli. Egle Becchi Settantaquattro storie di vita magistrale Il testo che vi propongo fa parte di un discorso più lungo, depositato in un libro sui servizi educativi del Comune di Pistoia, volume che sta uscendo, a mia cura, dall’Editore Franco Angeli di Milano, con il titolo Una pedagogia del buon gusto, in cui cerco di prospettare le ragioni teoriche di una “pedagogia” che nasce dalla pratica e non ha inteso, in questi lunghi tempi di sua attivazione, derivare da pregiudiziali teoriche. Una serie di questioni di filosofia dell’educazione, quindi, anche se da questi temi mi sono sempre tenuta lontana; ma l’esperienza di anni di lavoro comune con i servizi educativi della città toscana mi hanno persuaso che dimensioni “pedagogiche” – e quindi teoriche se non speculative – e non solo didattiche, educative, di professionalità formativa e capacità organizzativa, possono essere indagate anche partendo “dal basso”, dal fare e dai progetti che questo fare guidano e in esso vengono messi in atto. Da dove iniziare? Con quale scelta di specifico oggetto di analisi e di opzione metodologica accostarmi a una realtà che da anni sempre di più vengo istituendo a terreno di riflessione più che di ricerca empirica, e dove intendo definire, analizzare, se possibile spiegare fenomeni, tendenze, discorsi oltre che fatti operativi? Un ritorno alla scrittura di sé – dopo aver attraversato velocemente i territori delle autobiografie della prima età1 e dei diari d’ infanzia2 – mi è sembrato quasi ovvio, sia perché nelle mie precedenti ricerche nelle prescuole pistoiesi avevo fatto attenzione a eventi, istituzioni, modi educativi3, scorgendo, sotto queste dimensioni osservate, anche un cospicuo capitale di parole, frasi, espressioni emozionali, poco perspicui e talora solo accennati, spie di dinamiche psichiche proprie dei singoli soggetti che incontravo, e che nel suo insieme contribuiva a costituire quella pedagogia del buon gusto che a mio avviso vige negli asili nidi, nelle scuole dell’infanzia, nelle altre occasioni istituzionalizzate per i più piccini che nella città toscana si sono venute realizzando e perfezionando lungo il filo di quasi dieci lustri. Si trattava di informazioni che per essere colte e elaborate richiedono strumentazioni e modi di avvicinamento sui generis. Approcci, pertanto: e approccio significa non solo messa a fuoco di oggetti di indagine da conoscere e interpretare, ma anche e soprattutto ponderata scelta di 78 Quaderni di comunicazione 10 metodo e indicazioni delle ragioni fondanti di tale scelta. Due erano soprattutto i problemi cui avevo fatto progressiva attenzione in questi anni di preparazione al volume: che in ogni accadere educativo oltre al livello fenomenologico, osservabile e indubbiamente da studiarsi, ci sono delle dimensioni meno appariscenti ma non meno importanti, di ordine vario, non ultima quella della soggettività di coloro che sono impegnati in tale accadere. E che tale soggettività ha una sua storia individuale e collettiva, è fatta di un ‘ infinita serie di variabili concresciute nel tempo, non sempre memorabili, in ogni caso difficili da esprimere verbalmente, ma senz’altro presenti nei vissuti di ogni soggetto sociale. Un sondaggio sulla soggettività poteva venir fatto- secondo modi abbastanza tradizionali – grazie a questionari costruiti in maniera raffinata, con domande esplorative e questioni che servivano a confermare o invalidare le risposte (ma verso tale tecnica avevo comunque una diffidenza di lunga data); oppure per mezzo di una delle tante procedure di intervista, di colloquio non direttivo – lunghe da applicare e costose in termini di tempo e di mezzi, perché abbisognano di personale professionalmente provetto per eseguirle, e, una volta realizzate, di trascrizione e di decodificazione -; o ancora – e questa è stata la scelta definitiva – con la composizione scritta di storie di vita, da farsi su consegna, da leggersi e interpretarsi da parte del committente della ricerca. Storie di vita quindi, attrezzo amato da sociologi, antropologi del lontano e del vicino e storici dell’oralità. Questi – l’oggetto e la procedura per il suo sondaggio – i punti forti del mio lavoro, da cui speravo – e non sono stata delusa – di ricavare informazioni che nel plurimi soggiorni pistoiesi non ero riuscita a ottenere fino allora con quella ricchezza di particolari e di sfumature che mi ripromettevo. Ma la strada che ho intrapreso ha avuto anche i suoi irrisolti interrogativi. Vorrei brevemente renderne ragione in questo saggio. 1. Soggettività magistrali Di soggettività si parla da lustri secondo plurimi punti di vista: il costrutto ha per tradizione un posto centrale nel discorso filosofico, ma viene anche usato, più di recente, da prospettive interessate a affermarsi sul piano teorico, nella considerazione che fanno di quote di umanità diverse, di soggetti –altri li si è chiamati- di cui poco o per nulla si è parlato e che ancor meno hanno detto di sé in forma socializzata; ma anche di figure nuove, e non per questo eterogenee al nostro mondo, cui si viene riconoscendo un ruolo irrinunciabile. Incroci con la oral history soprattutto inglese, con approcci di antropologia culturale, con studi di letteratura e di linguistica, con impostazioni di ricerche politiche, con i saperi del femminismo hanno portato a definizioni varie di tale termine, via via denotato in base alle apposizioni e ai genitivi con cui si cerca di precisarlo e degli intenti per cui lo si studia. Un saggio di Paola di Cori “Soggettività e storia delle donne”4, ne fa la storia fino agli anni Novanta, vedendone le articolazioni, gli intrecci con altri saperi, nonché le aporie. Nel lavoro della di Cori si tenta una denotazione del vocabolo, e lo si considera oscillante fra un’ accezione forte (esso significherebbe volontà, intenzionalità, consapevolezza. Come un’esperienza eminentemente e profondamente conoscitiva che non è intuitiva, non avviene attraverso una sensibilità tutta pratica e pre-riflessiva, ma avviene invece soprattutto attraverso gli strumenti della ragione, continuamente verificati nella pratica ed è fondata su di una serie di vie di acquisizione della conoscenza della società8. Soggettività operaia è stata intesa anche come coscienza collettiva, per gruppi omogenei per tipo di lavoro, conoscenza riflessa circa il contesto in cui si produce, rischi cui si è esposti, propria collocazione individuale. Da questi pochi spunti, soggettività, fuori da quadri ideologici precisi e da intenti di cambiamento dell’assetto societario, può venir intesa quindi come sapere di sé e del proprio mondo, sapere le cui dinamiche si muovono a livello di coscienza, ma hanno anche radici a livelli più profondi; il tutto con intenti di operatività pratica. E questo per insiemi di figure diversamente determinati: da categorie denotabili in via biologica quali le donne e i vecchi9, più di recente gli omosessuali10, in via biologico- istituzionale, quali i genitori11; da un punto di vista storico, quali gli operai, i contadini, coloro che popolano aree storico – geografiche particolarmente interessanti ai nostri tempi (gli immigrati delle grandi città e gli ex-lege della Bassa padana di Montaldi e Alasia, i vinti di Nuto Revellli, i contadini del Sud di Rocco Scotellaro, tanto per fare gli esempi più “classici”). Di questi si è fin qui parlato con intento di indagarne le qualità specifiche, di coglierne denotazioni peculiari, lasciando lasca la categorizzazione, di volta in volta affidata alla responsabilità del ricercatore. 79 Settantaquattro storie di vita magistrale La di Cori non fa cenno alle riflessioni fatte da parte politica e sindacale sul termine, riflessioni che hanno animato indagini, messo in discussione procedure di ricerca, fatto conoscere nuove dimensioni della realtà operaia. Nel linguaggio sull’operaismo, che continua ad arricchirsi di contributi sui fenomeni del lavoro in fabbrica dei nostri anni6, si può rilevare una progressione dall’equivalenza della soggettività del lavoratore con il costrutto di coscienza di classe ad una sua denotazione che non esiterei a chiamare psicologica. Soggettività sembra quindi equivalere “ a che cosa la gente ha in testa”, specialmente alle interpretazioni che il singolo dà della società e dei propri comportamenti. Incipit e telos delle inchieste sul mondo operaio, ricche, dialettiche, proceduralmente importanti specie negli anni Settanta, funzionali a uno scopo trasformativo politico e sociale, il costrutto assai pregnante di soggettività ha un significato strumentale, serve certamente a indicare quanto si vuole conoscere, ma anche a esprimere quanto, a livello di mondo lavoratore, si intende modificare. Sulla definizione di soggettività da intendersi soprattutto come politica e/operaia si impegna, alla metà degli anni Settanta, Giovanni Jervis in un paragrafo del suo Manuale critico di psichiatria7, dove il termine viene denotato come Egle Becchi coscienza di sé) e una debole (legata alla poca perspicuità e scarsa fondatezza di tali termini), fino a parlare di “crisi del soggetto” nella cultura contemporanea. Fra questi opposti, l’Autrice propende per il primo gruppo di denotazioni e sottolinea il senso di “forte valenza di autoconsapevolezza, di una poderosa intenzionalità e di espressione di incontenibile protagonismo”5, proprio della soggettività in senso femminista. 80 Quaderni di comunicazione 10 Nel perimetro concettuale della soggettività credo sia quindi possibile definire ulteriori gruppi, ognuno con i suoi tratti, i suoi modi di assumere coscienza, di esprimerla, di orientarla al mondo dell’esistere; non si tratta- e vale la pena sottolinearlo- necessariamente di gruppi che arrivano oggi a forme di agentività se non di protagonismo sociale, ma di insiemi di figure di cui si dice e soprattutto di cui si vorrebbe – e dovrebbe – saperne di più. Per tutto questo credo che non sia fuori tempo e fuori luogo parlare di soggettività magistrale, – dove si esprime il senso di coscienza, e – à la Freire – di coscientizzazione di un gruppo professionale numericamente non esiguo della nostra società, per essa importante, poco sondato nella sua cultura non solo didattica, ma anche politica, nella sua Weltanschauung esistenziale.Massa professionale ormai rilevante, con destini lavorativi fra i più esposti alla precarietà e al turnover rapido e deprofessionalizzante, la popolazione insegnante italiana non è stata quasi mai studiata per questa sua dimensione, appunto di “esperienza eminentemente e profondamente conoscitiva/ che/ non è intuitiva, non avviene attraverso una sensibilità tutta pratica e pre-riflessiva, ma avviene invece soprattutto attraverso gli strumenti della ragione, continuamente verificati nella pratica” come dice Jervis12. Né, in questa negligenza, si sono fatti dei distinguo fra docenti non solo per sesso, ma per grado di scuola, per regione, per età, per modalità di formazione, per espulsione definitiva e/o ritorno nel mercato del lavoro magistrale. Gli insegnanti sono stati progressivamente dimenticati dalla ricerca e sono, di fatto, quasi solo una serie di titoli che le notizie della stampa trattano globalmente nella drammatica presentazione dei numeri del non accolti in- o estromessi dalle- istituzioni formative. Eppure si tratta di personaggi responsabili di trasmissione e produzione culturale rilevante per il mondo delle giovani generazioni, testimoni di aspettative, di forme di autoprofessionalizzazione e di professionalizzazione sul lavoro non certo inimportanti nella nostra società. Visti sempre di più come masse in via di proletarizzazione, e quindi considerati attraverso categorie troppo en gros, coloro che costituiscono la popolazione magistrale italiana avrebbero dovuto essere più studiati già da una ventina d’ anni, da quando hanno iniziato a diventare sempre meno stabili nella loro collocazione lavorativa, meno garantiti nella loro preparazione di base e nella loro ricerca di un posto. Il libro sui servizi educativi pubblici pistoiesi non vuol mettere riparo a questa che ritengo una vistosa lacuna: si avvale di questa categorizzazione per trovare un ubi consistam da cui guardare in modo meno fenomenologico e descrittivo alle istituzioni per piccoli e piccolissimi della città toscana. Anche per questo oltre alla scelta di oggetto andava, al suo interno, fatta una selezione più mirata: non insegnanti di scuola, ma insegnanti e educatori di prescuola e di quel setting sui generis che con la scuola dove si insegna, si apprende e si valuta il profitto non ha quasi nulla a che fare, ma è pur sempre un’ istituzione educativa extradomestica organizzata, volta a trasmettere e esercitare pratiche culturali, che è l’asilo-nido. Soggettività magistrale pertanto, racchiusa entro i confini della prescuola; e ancora, soggettività magistrale di un contesto – Pistoia appunto – dove la permanenza nel luogo di lavoro è alta, dove ci sono state lungo gli anni delle assunzioni fatte per via concorsuale con scadenze ordinate, dove ci sono iniziative di aggiornamento e di ricerca che concorrono a rinsaldare una coesione fra il personale, te- 2. Storie di vita Raccontarsi, quindi. E qui, di nuovo, si prospettano scelte di metodo. La soggettività operaia, fin dalla metà degli anni Sessanta è stata terreno elettivo di inchieste a forte impronta ideologica, dove l’intento di sondare vissuti e rappresentazioni si coniugava con la necessità di raccogliere informazioni de facto, notizie su circostanze, modificazioni o persistenze strutturali, essendo pur sempre cauti nei confronti di pratiche di indagine cifrate in termini di “sociologia borghese”. Al di là di diffidenze ideologiche, e oltre il perimetro della realtà operaia, laddove ci si è mossi in mondi di esclusi, emarginati, “socialmente” diversi, si è proceduto – e non solo agli esordi – grazie a narrazioni fatte oralmente, simili a interviste, dove molti parlano (anche se perlopiù uno alla volta), e ascoltano, alcuni ascoltano soltanto e registrano, non di rado qualcuno scrive quanto è stato detto, o – e questo 81 Settantaquattro storie di vita magistrale Il costrutto di soggettività magistrale l’ho usato specificandolo per quanto riguarda l’esperienza educativa istituzionalizzata, come presa di coscienza che si acquisisce nell’ambito lavorativo, come insieme di professionalizzazione specifica e di comprensione delle variabili contestuali in cui tale professionalizzazione si è appresa e si viene esercitando, e, insieme, come coscientizzazione e memoria delle componenti esistenziali, deontiche, emozionali e sociali di tale esperienza. Nel lessico che impiego, alla soggettività non viene ascritto nessun intento di modificare radicalmente il mondo produttivo e societario in cui il soggetto opera – anche se pur sempre di soggettività magistrale si tratta, quindi di soggettività impegnata in un’ opera trasformatrice –, semmai di meglio comprenderlo e di meglio agirvi, in vista di scopi dichiarati o allusi, ma sovente non prossimi nella loro realizzazione. Soggettività magistrale quindi, come progressiva presa di consapevolezza critica, come riflessione sulle condizioni, sugli scopi, sulle motivazioni che animano il proprio operare nelle dimensioni professionali che lo caratterizzano, cercando di individuare in questa pratica anche gli elementi della propria storia privata, e, al contempo, le variabili di contesto che la connotano e l’hanno connotata nel passato. Si tratta di un’acquisizione che in quanto tale viene appresa con gradi diversi di chiarezza, dove la dimensione comunicativa, di confronto e di esplicitazione interindividuale è irrinunciabile. Dimensione collettiva, allora, che rende tale soggettività condivisa, non solo perché con essa si indica un fare comune, ma anche perché la consapevolezza nasce da processi di discorso ad altri e da altri, da un riflettere interpersonale, che, nel caso pistoiese, prende le mosse dalla natura cooperativa della professione che si esercita e dei processi di raffinamento professionalizzante che vi si esperiscono – che nella fattispecie sono di natura magistrale–. Non basta: la soggettività – e non solo quella magistrale – si costruisce avvertendone progressivamente e esprimendone gli ingredienti: il momento della dichiarazione è indispensabile. Soggettività è pertanto, comunicazione, altrimenti rischia di decadere a confessione o a vissuto intimo e ineffabile. Egle Becchi nuta viva da transazioni culturali tra generazioni – consigli, indicazioni, verifiche, apprezzamenti, esemplificazioni – frequenti, cordiali, responsabili. 82 Quaderni di comunicazione 10 lo fanno pochi –, prende degli appunti e costruisce, ex post facto, delle pagine: brani, testimonianze di un sé che vive nel mondo, che in qualche caso – le prime paradigmatiche indagini di Alasia, Montaldi, Revelli, Scotellaro ne sono testimonianza – hanno dato origine a dei testi che in fondo sono delle storie di vita. Narrazioni dove c’ era, forte, la presenza di chi questi racconti li aveva tradotti dalla voce alla penna. A livello di saperi dotti la storia di vita è diventata progressivamente un capitolo centrale dell’indagine sociologica13, non ha avuto un ruolo marginale nelle indagini della oral history, è stata importante negli studi “classici” di antropologia culturale, ma è stata contenuta in questo territorio per così dire accademico, anche se mosso da tendenze epistemologiche diverse, ed è qui che vanno cercati i suoi esordi come “genere” metodologico oltre che letterario. Tenendo presenti soprattutto queste indagini io definirei – in via affatto provvisoria – la storia di vita nei termini di un documento diacronico di esistenza evocato da un committente che al narratore propone la consegna. Preciserei tale definizione – a costo di renderla più complessa e meno persuasiva, ma a fini di lavoro ritengo che questa polisemia denotatoria mi sia consentita – con le parole seguenti: storia di vita è la narrazione fatta in prima persona, dove, su richiesta, un soggetto dice di sé, memorizzando e scegliendo nel groviglio dei ricordi del proprio passato più o meno lontano e secondo una linea più o meno coerente, degli eventi, talora commentandoli, e presentandoli a chi di tali racconti si dichiara interessato lettore, sovente il committente della loro produzione, non di rado l’interprete di essa. La storia di vita sta nel grande perimetro dell’autobiografia, ma non è journal intime, né diario in divenire, steso in pagina ma non ancora concluso ; è comunque racconto di sé cui l’autore dà un incipit e un termine. Genere scarsamente denotato a livello di classificazione letteraria, la storia di vita attende un suo attento e empatico studioso che la emancipi dall’esclusivismo dell’indagine sociologica e della fiction antropologica14, facendola approdare sul solido terreno di analisi narratologiche originali e attendibili. La storia di vita di solito nasce da brani messi insieme, non necessariamente secondo una linea cronologica continua; è un insieme di parole organizzate in discorso da un autore, l’io narrante. A monte di chi dice su invito c’è quasi di regola chi ha invitato a tale performance, chi ascolta e/o legge tale dire registrato come testo e lo disambigua. Laddove il soggetto che racconta è ogni volta unico, committente, lettore, interprete non sono necessariamente lo stesso individuo. Che poi la parola sia affatto libera o segua un filo tracciato da altri, che venga prodotta in intervista o in racconto orale, la differenza non è, tradizionalmente, sottolineata. Pertanto – sempre nel grande perimetro della ricerca fatta grazie a storie di vita da parte delle scienze umane – c’è, non solo per quanto attiene la tecnica del domandare, sollecitare, agevolare, in qualche modo guidare la parola, la figura di chi induce a parlare, ascolta, registra, tiene in mano in fondo l’organizzazione del discorso; in poche parole tra i due partner della vicenda, c’è sempre un soggetto egemone che se rassicura il parlante, lo fa sentire autorizzato, lo aiuta – se non sottilmente condiziona – nella scelta di quanto va detto, nella sottolineatura di quello che è – o appare significativo-, nella individuazione del momento, del luogo, del rapporto. Occorre Più raro e prossimo nei tempi a noi è il racconto della propria vita fatto su consegna, ma realizzato per iscritto dal soggetto narrante15, dove l’ordine temporale lo mette l’autore, la selezione e successione di fatti l’organizza chi scrive. E al committente spetta la funzione di invitare al compito, precisarlo, dare delle idee guida, dei punti da non trascurare, leggere, decodificare, fare uso nobile delle informazioni ottenute. Fare, ancora una volta, attento esercizio di prudenza. Fuori di dubbio, ancora una volta, la storia di vita si colloca nella zona di tensione di due soggetti, e dipende dalle modalità della committenza, dal rapporto di fiducia che si instaura fra il committente e chi si presta a eseguire il compito, dall’uso che del prodotto risultato da questa committenza fa il committente- che quasi sempre è anche l’interprete e l’utilizzatore della storia di vita nata in questo modo-. Ma se la relazione fra committente e persona cui si chiede il compito narrativo in chiave di sé, non è trascurata, se occasione e finalità della performance, sono negoziati, i difetti di sperequazione di grado tra committente, lettore/ interprete, utente della storia di vita vengono attutiti e ne dovrebbe trovare giovamento la stessa narrazione di sé. È questo il problema più importante che mi sono posta, nell’affrontare il compito pistoiese, per motivare, rendere più complessa, libera, la composizione di questi récits de vie da cui mi aspettavo non solo un arricchimento di informazioni, ma anche la scoperta di modi di soggettività per me inaspettati. 3. Un esempio di consegna, una vicenda di restituzione, un prodotto variegato Nella mia esperienza a Pistoia prima dell’avvio del libro, c’era stata un’ indagine di evaluation della qualità educativa dei servizi comunali16, dove l’applicazione di una scala di valutazione era stata fatta, attraverso intrecci dialogici, da ricer- 83 Settantaquattro storie di vita magistrale Egle Becchi pertanto che si instauri una relazione di fiducia e di correttezza, il parlante deve sapere che chi ascolta non sarà indiscreto, capirà che quanto viene sentendo sono cose preziose e ne farà buon uso. Ma l’ascoltatore- committente ( o suo incaricato) sarà lì, forte e legittimato in vario modo, a garantire che la voce non va persa e che quanto il parlante esprime sarà utilizzato, e soprattutto che è bene, è interessante, ed è indispensabile che egli racconti; l’ascoltatore – committente sarà legittimato e legittimante insieme. Non basta: laddove non sia l’autore a stendere sulla pagina quanto intende dire, sarà l’ascoltatore colui che scrive quanto viene detto oralmente. È probabile allora che avvengano degli inquinamenti, delle sovradeterminazioni di senso da parte di chi evoca, suscita, riceve e fa uso della storia di vita, sovradeterminazioni che solo indagini tecnicamente testuali agguerrite possono individuare e ponderare, una volta messe in testo. Non basta: la stessa consegna è elemento critico nella realizzazione di una storia di vita, perché in quanto variabile condizionante in ordine pregiudiziale del comportamento narrante, potrà eccedere nelle indicazioni di bene fare, oppure essere evasiva e destare inibenti perplessità. 84 Quaderni di comunicazione 10 catori e da insegnanti, che avevano valutato il contesto educativo di non poche sezioni di scuole comunali dell’infanzia, espresso i valori seguendo una griglia preordinata, poi confrontato e discusso, con i tecnici dell’indagine, gli indici quantitativi emersi dal loro lavoro. Questo modus aveva contribuito non solo a perequare scompensi di ruolo, eterogeneità di sapere, ma a evocare commenti alle informazioni metrologiche, accenni al proprio punto di vista, ai propri ricordi, alla propria vita affettiva, alla propri esistenza passata, quasi un corredo alla stringatezza quantitativa della valutazione. Si trattava di dati che vivevo come preziosi, perché insoliti o marginalizzati nella ricerca scientifica che si avvaleva di strumenti standardizzati e esclusivizzava risultati definiti metrologicamente: tracce di altre dimensioni non irrilevanti nella comprensione di fenomeni complessi quali la vita in un’ istituzione educativa. Già questa pratica dialogica, del suscitare erogazione di informazioni, confronto, reciproca restituzione e discussione17, aveva contribuito a creare un clima di maggior pervietà della parola tra ricercatori e soggetti su cui e con cui veniva fatta la ricerca, che la decisione, presa da me assieme ai responsabili del sistema di istituzioni educative prescolari di Pistoia, di fare un libro a più mani, insegnanti, membri del coordinamento pedagogico e me- appunto Una pedagogia del buon gusto –, aveva confermato. La consegna – sotto forma di lettera inviata nel gennaio del 2006 – a ognuno degli insegnanti di ruolo dei servizi educativi comunali – si ispirava a queste pregiudiziali relazionali, ne teneva conto, le sfruttava, chiedendo a tutti gli insegnanti a tempo indeterminato di nidi, scuole dell’infanzia e istituzioni formative per la prima e primissima infanzia, di scrivere una propria storia di vita, da cui estrarre informazioni utili alla costruzione del libro. Si indicavano inoltre, in modo non cogente, alcuni tratti della storia di vita che sarebbe stato bene fossero presenti nei racconti e che avrebbero dovuto consentire un assemblaggio di tutti i testi, funzionale a una raccolta di temi, costituire spunti di discussioni ulteriori e occasioni per un lavoro di analisi del contenuto più raffinata 18. Nel maggio dello stesso anno erano arrivate 62 storie, e sulla base della loro lettura ne avevo riferito a tutti gli insegnanti, in una riunione collettiva, e a gruppi minori, dove il dialogo si era confermato e ravvivato. Dal giugno al novembre ne sono arrivate altre 12, per un totale di 74, pari al 47% della popolazione degli insegnanti di ruolo cui era stato mandato l’invito. Si trattava, secondo me, di un esito affatto positivo non solo dal punto di vista numerico, ma anche per qualità di composizione della pagina, variegatezza testuale, ricchezza di informazioni, spunti di memorie esistenziali, di vita affettiva, di esperienze sociali, politiche e soprattutto professionali che ne sono risultate, di cui vorrei qui mettere in evidenza qualche aspetto significativo. Anzitutto in ogni caso il testo era stato scritto, non dettato al registratore; il che per soggetti per cui la scrittura è piegata ad altri scopi – emerografie di singoli bambini nella loro giornata al nido o alla scuola dell’infanzia, descrizione della singola istituzione, didascalie e brevi testi stampati su depliant e libretti che il Comune stampa con ricche illustrazioni, non di rado disegnate dal grafico Andrea Rauch19 – è una specie di metabasis eis allo genos, costituisce il passaggio da un modo discorsivo a un altro, e questo in un mondo professionale dove il far vedere, il costruire e presentare immagini costituiscono uno strumento comunicativo che, se anche accompagnato Note 1 Cfr. Becchi, E., Ferrari, M., Scibilia, G., 1990, Autobiografie d’ infanzia tra letteratura e film, Milano, Franco Angeli. 2 Rimando a Becchi, E., Diari d’infanzia: proposta per l’organizzazione di un archivio, in Becchi, E., Semeraro A. (a cura di ), 2001, Archivi d’infanzia. Per una storiografia della prima età, Milano, La Nuova Italia, pp. 289-310. 3 Si veda Becchi, E., Bondioli A. (a cura di ), 1997, Valutare e valutarsi nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pistoia. Un modello di formazione degli insegnanti, Azzano S. Paolo (Bergamo), Junior. 4 In Palazzi, M., Scattigno, A. (a cura di ), 1990, Discutendo di storia, Torino, Rosenberg &Sellier, pp. 23-44. 5 Ivi, p. 29. 85 Settantaquattro storie di vita magistrale In questa variegatezza i testi appaiono ricchi, mai uguali, ma difficili da classificare dal punto di vista narratologico e, talora anche ai fini di un’analisi tematica. Un capitale insperato, quindi, da dove desumere certamente informazioni aggiuntive a quelle che avevo raccolto negli anni passati, fermandomi a osservazioni per così dire fenomenologiche e/o messe insieme grazie a strumenti più o meno standardizzati. Da non sfruttare però solo come insieme di notizie ai fini dello studio sui servizi educativi pistoiesi;l’eterogeneità dei temi presenti in ogni storia, la loro collocazione in punti diversi della pagina e il coefficiente di importanza differente che ognuno di essi assume nella narrazione, tanto da rendere difficile un’analisi sistematica dei temi, mostravano che si trattava di produzioni libere e generose, affatto poietiche secondo i canoni dell’autobiografia, che è sempre creazione, mai resoconto e cronaca. Ma produzioni pur sempre difformi non solo perché esprimevano mondi esistenziali affatto idiosincratici, ma anche perché la loro produzione aveva seguito le indicazioni forse troppo vaghe della consegna, che ogni autore aveva vissuto in modo diverso. Tra la vaghezza di un titolo solo brevemente enunciato e la definitezza di scelte da seguire, la via giusta era ancora da trovare e un “controllo” degli effetti della consegna andava fatto previamente. La consegna si dimostrava, quindi, fattore di fondo nella produzione di storia di vita, elemento da studiare pregiudizialmente, con strumenti testuali e con verifiche della sua comprensione, in una vicenda futura che non farà parte della mia personale “storia di vita”, ma che affido con interesse e attesa a specialisti di produzioni di quella letteratura dell’io tanto affascinante quanto aperta a sempre nuove ricerche. Egle Becchi da parole dette, è pur sempre predominante. Scrittura, quindi, e piegata a costituire testi, dove in ogni caso ci sono incipit e conclusione, dove la pagina appare composta senza fatica20, dove la struttura è assai diversificata- e si va dal racconto che inizia dalla propria infanzia per concludersi con quella dei figli, alla lettera rivolta a me, al piccolo “poema in prosa” a celebrare una professione quasi sacrale, alla narrazione delle vicende politiche e organizzative che hanno accompagnato la propria vita lavorativa, intrecciata a quella delle istituzioni dove questa si è svolta, alla storia della propria vicenda privata e ai suoi nessi con quella dell’occupazione-, dove la scrittura – e l’uso dei pronomi, dei tempi, e la funzione dei personaggi sono diversi da caso a caso –. 86 Quaderni di comunicazione 10 6 Per un panorama recente si veda il testo a cura di Borio, G., Pozzi, F., Roggero, G., 2005, Gli operaisti, Roma, DeriveApprodi. 7 Milano, Feltrinelli,1975. 8 Ivi, pp. 215 sg. 9 Cui Rudolf Schenda ha dedicato anni fa un bel libro, che raccoglie le storie di vita di ospiti di un’istituzione per anziani. Cfr. Schenda, R. (hrsg.), 1982, Lebzeiten. Autobiografien der Pro Senectute Aktion, Zürich. Unionsverlag. 10 Si veda di Burgio, G., 2008, Mezzi maschi. Gli adolescenti gay dell’Italia meridionale. Un’ indagine etnopedagogica. Sesto San Giovanni (MI), Mimesi. 11 Al sondaggio dei quali, grazie a storie di vita, è stato dedicato un capitolo nel testo Una pedagogia del buon gusto; hanno risposto all’invito sia mamme che babbi che coppie di genitori, i quali hanno steso insieme la loro storia parentale. 12 Ci sono stati, negli ultimi anni, degli studi sulla mente e sulla cultura magistrale, dove però l’attenzione a livelli pre e subconsci non ha costituito oggetto di indagine e l’impegno dei ricercatori si è polarizzato sulla psicologia culturale e sulle peculiari modalità epistemiche della personalità docente. Per un panorama significativo, rimando a Manuale della scuola dell’obbligo: l’insegnante e i suoi contesti, a cura di Zambelli, F. e Cherubini, G., 1999, Milano, Franco Angeli. 13 Cfr., per tutti, Ferrarotti, F., 1981, Storia e storie di vita, Roma-Bari, Laterza. 14 Penso ai testi di O. Lewis, dove l’indagine antropologica viene presentata sotto forma di romanzo, quali I figli di Sanchez, 1966, Pedro Martinez, 1968, tutti tradotti per Mondadori. 15 Il testo di Schenda che ho avuto occasione di citare, è, a mio avviso, il più originale e significativo. 16 Si veda il già citato Becchi, Bondioli (a cura di ), Valutare e valutarsi (…). 17 Per questi aspetti di valutazione con reciproca restituzione, rimando al mio saggio Per un’etica della ricerca educativa; il paradigma della restituzione in Corradini, L. (a cura di ), 2000, Pedagogia, ricerca e formazione. Saggi in onore di M. Laeng, Formello, SEAM, pp. 200-210. 18 Nella lettera di invito a comporre una storia di vita si precisava ai potenziali autori che nel “raccontare quanto per voi costituisce quel grande romanzo individuale che è la propria vita. Si tratta di racconti anonimi; che hanno una data di inizio diversa da persona a persona; Dicono di alcuni fatti che chi narra ritiene significativi, mentre tali non lo sono per una persona diversa, anche se la vita di questa ha avuto delle vicende simili;Che comunque – anche se si tratta di un relativo limite alla libertà espressa ai punti precedenti – accennano – e certamente in modo diverso da persona a persona – al proprio incontro con il nido e la scuola dell’infanzia comunale; Che non intendono essere né compitini né brevi – o meno brevi- romanzi autobiografici. Appunti coerenti e comprensibili a chi li legge sono anche una forma possibile di storia di vita; Che possono essere sia dettati al registratore – negli uffici si provvederà alla loro trascrizione – oppure scritti a mano o anche scritti con il computer. Vi si chiede di farlo – cioè scrivere o dettare al registratore la vostra storia di vita – e consegnarla entro la fine di febbraio (2006) a: Egle Becchi 19 Di Andrea Rauch si veda: Graphic design, 2006, Milano, Mondatori e sulla sua opera a Pistoia: A.A.V.V., 1999, L’immaginario bambino. Le esperienze educative del Comune di Pistoia nella grafica di Andrea Rauch 1979-1999, Azzano San Paolo(BG), Junior. 20 Non mancano affermazioni quali: “Mi è subito piaciuta l’idea di poter fissare su carta i miei ricordi, perché penso che possa anche questa essere un’esperienza che mi arricchirà interiormente – “e la conclusione di una storia di vita: “grazie per l’opportunità che ci è stata offerta”. Flavia Serravezza Diari pazienti La scrittura come terapia Scrivere è un modo di reagire all’evento-malattia che all’improvviso piomba nella propria quotidianità. Succede così che, giorno dopo giorno, razionalità ed emotività si alternano, domande e tentativi di risposte prendono forma. Un diario diventa allora il mezzo per ricostruire il senso della propria esistenza e un dono per gli altri, per testimoniare che la vita, nonostante la malattia, è ancora vita, e continua. Il diario di una malattia è vissuto come un viaggio all’interno di un corpo che cambia e fa cambiare la propria l’immagine. Attraverso la scrittura, si intraprende un cammino nella consapevolezza, verso l’accettazione della patologia come parte di sé. Alla fine del percorso, la propria esistenza ne esce ridefinita, con i limiti che la malattia e la cura impongono, ma con la speranza e il desiderio di vivere a pieno ogni singolo giorno. Questo viaggio rivela quanto sia importante ascoltare e credere al paziente, rispettare la sua autonomia decisionale per facilitarne il processo di guarigione. Da oltre vent’anni sono in corso, in tutto il mondo, esperimenti di scrittura cosiddetta espressiva o creativa, realizzati nei modi e con gli strumenti più diversi, alcuni dei quali nell’ambito di specifici progetti di ricerca rivolti a varie patologie cronico-degenerative. Ma è nell’ambito dell’Oncologia che questa singolare forma di terapia sta trovando maggiore applicazione. Diversi studi hanno dimostrato che riportare su una pagina, sia essa cartacea o virtuale, quanto si sta vivendo mentre si affronta la difficile battaglia contro il tumore, aiuta anche a rinforzare le difese immunitarie e a diminuire il dolore. Parlare e poi scrivere, raccontare, mettere nero su bianco i pensieri, le angosce, le ansie, ma anche le speranze, i miglioramenti, i sogni: anche così si migliora la qualità della vita, soprattutto dal punto di vista psicologico, di un malato di cancro. Perché la scrittura è come un ponte, lo si attraversa e si arriva sempre da qualche parte. C’è bisogno di silenzio, per passeggiare dentro di noi, per raggiungere le emozioni, anche quelle più difficili, ed iniziare a raccontarle. Così la scrittura diventa terapia e antidoto al dolore. Un mezzo efficace per addomesticare la sofferenza. In questo senso, un diario può aiutare a guarire. 88 Quaderni di comunicazione 10 La narrazione come strumento di cura Negli ultimi anni, si sta facendo strada sempre più prepotentemente un nuovo filone nella scienza medica, detta “Medicina narrativa”, che pone attenzione alle storie di malattia come modo per ricollocare e comprendere le persone nel proprio specifico contesto. Il New York Times del 15 maggio 2007 ha riportato il resoconto di un importante workshop di Medicina narrativa che si è tenuto alla Columbia University, dove si afferma: “Raccontare e ascoltare le storie mediche e non solo dei pazienti è un metodo efficace per migliorare il rapporto medicopaziente e facilitare diagnosi e cure”. La narratività compare sulla scena proprio nel momento in cui la medicina “giunta a straordinari traguardi di sviluppo tecnologico” sembra perdere la sua efficacia nel rapporto con il paziente. Il modello concettuale della Narrative-Based Medicine (Nbm) è stato sviluppato nella metà degli anni Novanta dalla dottoressa Rita Charon della Facoltà di Medicina della Columbia University di New York. Già negli anni Ottanta, però, grazie al contributo della scuola di Antropologia medica di Harvard, i cui esponenti più famosi sono gli psichiatri e antropologi Arthur Kleinman e Byron Good, si comincia a parlare di “vissuto di malattia” che può essere conosciuto soltanto attraverso processi interpretativi (Masini 2005). La Nbm nasce negli Usa dalla constatazione che, a fronte di tecnologie di diagnosi e analisi sempre più sofisticate, è passata in secondo piano la capacità da parte dei medici di ascoltare i pazienti leggendo nelle loro parole quegli elementi indispensabili per il trattamento e la cura della malattia. Nelle università statunitensi e canadesi si sono così sviluppati corsi specifici di narrative medicine, sia in connessione allo sviluppo dell’antropologia medica di Byron Good e di Hurwitz, sia attraverso l’originale coniugazione della medicina con gli studi umanistici e letterari. Appaiono infatti, accanto ai testi di anatomia, opere come La morte di Ivan Il’ic di Tolstoj o La montagna incantata di Thomas Mann, o ancora saggi come Malattia come metafora di Susan Sontag. Pazienti-scrittori La scrittura viene “rappresentata” infatti come una “via” di comunicazione tra i pazienti seriamente ammalati e i medici curanti. L’atto dello scrivere può aiutare i pazienti a comprendere se stessi e i propri bisogni: il paziente “narratore” o “scrittore” mette a disposizione la propria esperienza della malattia, che solo lui conosce fino in fondo, per aiutare a personalizzare il processo di cura. Per verificare l’efficacia dell’approccio narrativo in Oncologia è stata effettuata di recente un’indagine guidata dalla professoressa Soledad Cepeda del TuftsNew England Medical Center di Boston, i cui risultati sono stati pubblicati nel mese di luglio del 2008 sul Journal of Pain & Symptom Management. Lo studio è stato realizzato su 234 pazienti neoplastici assegnati a tre diversi gruppi: al primo è stato chiesto di narrativizzare la propria esperienza, a un secondo gruppo è stato somministrato un questionario standard sulla sintomatologia del dolore e al terzo, invece, si è continuato a fornire il trattamento usuale. Tutti i partecipanti 89 Diari pazienti Flavia Serravezza soffrivano a causa del decorso del tumore. Al gruppo “narrativo” è stato chiesto di trascorrere 20 minuti a settimana, per tre settimane, a scrivere in che modo il cancro stesse modificando la loro vita di tutti i giorni. All’inizio dello studio e poi ogni settimana, per otto settimane, tutti i 234 pazienti sono stati sottoposti a un questionario riguardante il loro benessere e la loro percezione del dolore. Dai risultati dell’indagine è emerso che i partecipanti al gruppo di scrittura si sono dimostrati più aperti rispetto alle loro emozioni, meno sensibili al dolore e con un umore, lungo il corso delle otto settimane, migliore rispetto ai partecipanti degli altri due gruppi. Questi effetti non erano peraltro previsti nei pazienti che, nello scrivere, si dimostravano non particolarmente coinvolti. Il rilascio emozionale prodotto dalla scrittura è quindi ciò che aiuta i malati nella gestione del dolore causato dal tumore. Al di là di questi risultati, il team della Cepeda ha evidenziato come cambia lo scenario per i malati terminali. E come possa essere che per tali malati sia più difficile, e a volte niente affatto favorevole, scrivere delle proprie sensazioni. Servono ulteriori studi, dunque, per confermare in maniera certa se l’incoraggiare i malati terminali a rivelare le proprie emozioni determini realmente un miglioramento nella percezione generale di se stessi. È opportuno quindi usare la massima cautela nel sottoporre i pazienti a questo tipo di trattamenti apparentemente “innocui”. Tuttavia molti (ex-) malati hanno messo in evidenza che comunicare sul cancro fa bene. In particolare, per una gran parte dei pazienti è la scrittura che aiuta (Michel Foucault non a caso ha parlato della scrittura come una “tecnologia del sé”). È interessante notare anche come la narrazione del vissuto soggettivo del cancro non assolva solo una funzione terapeutica, ma anche sociale. Tantissimi malati oncologici hanno scritto libri sulla loro esperienza e diverse case editrici hanno aperto collane sulla malattia, fino al punto da far pensare che stia emergendo un nuovo genere letterario (che nome potrebbe avere?). È come dire che, mentre l’individuo cerca di riappropriarsi della dimensione intima della malattia, comunicandola, la trasforma nuovamente in modo diverso (non medico), in dimensione sociale. Il fatto che la comunicazione letteraria accolga di buon grado questo nuovo genere, indica in primo luogo che il tema della malattia (come prospettiva per comunicare sulla vita) è un tema scottante per la semantica attuale. Ma mostra anche il bisogno di istituzionalizzare (attraverso un genere appunto, quindi con un nome, un’etichetta) le esperienze dal basso. È la dialettica fra individuo e società che continua incessantemente ad emergere. Sono diverse, tra l’altro, le scritture possibili: poesie, versi, pitture, disegni sono tutte forme che raccontano stati d’animo, dubbi, paure, aspettative, attese, domande e progetti di vita. Non tutti i malati, però, sono naturalmente portati a scrivere e descrivere percorsi di vita. Alcuni per problemi oggettivi di salute (psichica o fisica), altri per età o per scelta, possono esprimersi solo attraverso alcune parole, versi oppure un disegno (come accade per i bambini). «La scrittura scioglie l’irrequietezza. La scrittura incarna e produce comunque qualcuno che non c’è finché non nasce dalla nostra penna. [...] La scrittura semina e genera. Ci guida sempre altrove. Comunque lo scrivere ci ferma ci fa sentire ancora più fisicamente presenti. [...] non ci sentiamo più liquidi. Lo eravamo pensando ma la stilo, la matita, i tasti ci restituiscono la sensazione di non galleggiare nel vuoto» (Demetrio 2003). 90 Quaderni di comunicazione 10 Perchè scrivere? Scrivere è un modo per prendere parola, raccontarsi, con calma, al di fuori della fretta di un colloquio o dagli schemi rigidi di un questionario. Il paziente scrive per comunicare un vissuto, per raggiungere quanti per mille motivi diversi si trovano in difficoltà ad “uscire fuori”, non hanno il supporto di un’associazione, di relazioni significative. La scrittura restituisce al malato la centralità; offre agli operatori la possibilità di avere una visione più completa dei problemi e a quanti si occupano di costruire progetti di salute pubblica di avere una visione più realistica e sensibile ai bisogni della gente. Va sottolineato, però, che scrivere e ascoltare esperienze richiede riflessione e impegno da parte di tutti gli attori coinvolti. Le narrazioni, infatti, pur conservando la loro unicità, non devono assumere il carattere di uno sfogo liberatorio o di denuncia gridata. Descrivere situazioni di bisogni inevasi e di diritti violati, raccontare la propria sofferenza, le proprie difficoltà, deve essere fatto in modo costruttivo. Occorre quindi distinguere tra il momento esclusivamente emotivo, che ha la sua giusta ragion d’essere in determinati momenti, e la rielaborazione di ciò che è accaduto o della situazione che si vive nel presente. Le narrazioni non sono da confondersi con le denunce, sono piuttosto la testimonianza di un’esperienza vissuta e rielaborata. Sophie Van der Stap. La ragazza dalle 9 parrucche Occhi verdi grandi ed espressivi, capelli biondi curati che arrivano quasi alle spalle. Sophie van der Stap oggi ha ventiquattro anni, è una bellissima ragazza olandese e una scrittrice di successo, e non ha più bisogno di parrucche. È “pulita”. Chemioterapia, iniezioni di vincristina, etoposide, ifosfamide, radioterapia, nausee, sudorazioni incontrollate, non fanno più parte della sua quotidianità. Sophie ha ucciso il cancro – un rabdmiosarcoma, una rara e aggressiva forma di tumore al polmone – che si è presentato all’improvviso quando aveva ventun’anni, affrontandolo con forza di reazione, consapevolezza e tanta ironia. Cercando comunque di vivere, godere delle piccole cose, intessere relazioni amorose. E raccontando tutto ciò, sotto forma di diario, in un libro divertente (sì, divertente) e intenso, che in Olanda ha venduto 65 mila copie, altrettante in Germania, è stato tradotto in otto Paesi ed è uscito di recente in Italia: La ragazza dalle 9 parrucche. Nove sono infatti le nuove Sophie che hanno convissuto con lei nell’anno e mezzo di malattia e cure, dal febbraio 2005 al giugno 2006, mentre riusciva a colorire l’esperienza ospedaliera con fantasie rosa sui vari dottori e cercava di vivere nonostante quel tremendo male. In lei e sulla sua “testa da cancro”, come scrive senza mezzi termini, hanno vissuto Stella, Daisy, Sue, Blondie, Platina, Uma, Pam, Lydia e Bebè. Daisy, ad esempio, è la Shophie maliziosa, con i lunghi ricci biondi da Barbie, ama i frullati e ride a ogni battutina stupida. Sue, con i capelli rossi e selvaggi, può dare nell’occhio facilmente, “senza dover ridere per stupide battute o far danzare i riccioli”. Anche se inizialmente per Sophie non è stato facile accettare la malattia e il suo capo pelato da chemio: «Una parrucca ce l’ho, ma non ho ancora deciso chi trovo più brutta: Sophie con una grigia testa da sfigata o Sophie skinhead. Quindi ho semplicemente indossato un fazzoletto e ora non mi si distingue più dalla cameriera». 91 Diari pazienti Flavia Serravezza A chi le chiede cosa ha significato per lei scrivere questo libro e per chi lo ha scritto, per sé o per altri malati di cancro, Sophie oggi risponde: «L’ho scritto per me. Semplicemente perché in quel momento mi faceva bene, era un passatempo e mi dava uno scopo. Quando uno è malato l’unico scopo è sopravvivere. Se si può essere anche creativi, con il sogno di scrivere, questo ti dà anche un altro scopo». Nel libro parla del cancro con ironia, forza e franchezza. E tuttavia, La ragazza dalle 9 parrucche non è solo un libro-confessione del genere che si scrive “a grazia ricevuta”, per far sapere a tutti che è possibile vincere la malattia e la sofferenza. Il diario di Sophie racconta sì, la lotta quotidiana, la guerra che si combatte da un letto d’ospedale, ma parla anche di emozioni e sentimenti, della sua famiglia, degli amici vecchi e nuovi, di innamoramenti fugaci e di sesso, di ricordi, dello sforzo continuo per far sì che – anche se dovesse essere l’ultimo anno della sua vita – non sia un anno perduto nelle secchiate di vomito causato dalla terapia. La voce di Sophie conquista subito il lettore perché non nasconde nulla. Non la gravità del suo male, non le sue paure, sia dell’immediato sia del futuro. E tuttavia c’è sempre, nella sua voce, come un tintinnare di campanelli che riesce a comunicare un senso di allegria, o almeno di speranzoso buonumore, anche nelle situazioni più gravi. Con l’entusiasmo con cui Sophie studiava Politologia, ad un certo punto inizia ad apprendere, con puntigliosa attenzione, in che cosa consista il suo tumore, come vada trattato, quali sono le scadenze della terapia, quali i macchinari usati, che cosa c’è da aspettarsi, come sorvegliare le reazioni del suo corpo. Chiama Qui Quo e Qua le macchie tumorali visibili sul polmone con la Tac. E mette a nudo così le difficoltà di relazionarsi col suo medico: «Parlare con i dottori presenta dei problemi. Fino a sei mesi fa avevo un’immagine parecchio diversa di un ospedale. Vedevo entrare persone malate che poi se ne uscivano fuori felici e guarite. Ora vedo campioni di sangue che vanno persi, aghi delle flebo inseriti male da un anestesista per ben tre volte consecutivamente, dossier smarriti e decisioni affidate al caso. Dottori che la pensano ognuno in modo differente. L’uno ancora più convinto dell’altro. Ciò non fa che rendere piuttosto difficoltosa la comunicazione fra medico e paziente. Una lezione sul linguaggi dei dottori quindi non può far male». A volte Sophie parla del cancro come di un amico che le ha fatto riscoprire la vita, provare intensamente, gustare le piccole cose, apprezzare gli affetti. Altre volte fa addirittura fatica a vedersi diversa e lontana dall’anno e mezzo di chemio e ospedali. Il tempo sgocciola via, i giorni vengono barrati da un tratto di penna, i capelli cadono a manciate, e lei è persino capace di ridere quando scompaiono non solo ciglia e sopracciglia, ma i suoi peli pubici. Ed ecco la trovata: le parrucche. Si badi bene, non la parrucca a cui purtroppo si devono di solito rassegnare i pazienti che hanno fatto una chemioterapia. No, tante parrucche, che finiranno per essere nove. «Le parrucche sono molto di più che un cespuglio di capelli. Producono in me notevoli cambiamenti, non soltanto sul mio cranio ma anche sulla mia coscienza femminile. Apparire in modo diverso mi fa sentire diversa e suscita reazioni diverse». Così anche Sophie, che non può più essere la Sophie che era prima che tutto iniziasse, potrà essere nove ragazze diverse. Vuole essere un po’ provocante e seducente? Ecco Sue, dai ciuffi rossi. Scuotere “riccioli biondi da elfo”? Appare Daisy, “perchè gli uomini preferiscono le bionde…”. C’è poi Stella, un po’ rigida, 92 Quaderni di comunicazione 10 sempre sulle sue, e Blondie e Platina (tutta bianca, la invecchia un poco) e Uma (una delle sue preferite, la fa sembrare la Uma Thurman del film) e altre ancora… È vero che non tutti gli uomini si sentono a proprio agio ad andare a letto con una ragazza che può finire con i capelli di sghimbescio prima della fine della notte, così come non tutti apprezzano il piccolo congegno che i medici le hanno applicato sopra un seno e che Sophie chiama “la mia tetta in più”, ma il suo piglio vitale, il calore, la sua simpatia conquistano molti. Sophie compie ventun’anni durante i mesi di terapia e si innamora, o crede di innamorarsi, o fantastica amorosamente, sugli uomini. Sui camici bianchi che sono i suoi salvatori, il dottor K e il dottor C, e poi c’è Rob, e il soprannominato Cravatta, e Jur, il ragazzo che ha avuto un’esperienza simile alla sua. Ma il suo cerchio di affetti è vasto – la famiglia, l’amica Annabel, i compagni di studio, e Chantal, infine, che perde la battaglia contro il tumore. Questa è la forza di Sophie, la sua arma vincente: l’amore per la vita che diventa amore per gli altri e per se stessa, di conseguenza. Che non può morire. Sembra impossibile che un libro che parla di cancro e presenta lo spettro della morte possa essere brillante e divertente. Ma tant’è. La storia di questa giovanissima ex malata di cancro ha fatto il giro del mondo: trasmissioni televisive, siti web e giornali hanno parlato di Sophie. Con le sue parrucche, l’acidità di stomaco, le lacrime, gli intrighi medici e i sogni. La sua “terapia a base di scrittura” continua ancora oggi. È già uscito in Olanda il secondo libro di Sophie con il seguito della sua esperienza da malata di cancro: racconta quello che capita dopo una malattia così grave, «perché anch’io, come tutti mi dicevano, sono caduta in un buco. Esci dal nido caldo che è l’ospedale, l’agenda è vuota, c’è il vuoto… Devi prendere decisioni ed è molto difficile. Il mio secondo libro è però diverso dal primo, che era spontaneo. Certamente è più pensato perché ho voluto comunicare che la mia vita è cambiata: ci sono momenti in cui tutto è stravolto, e quando c’è questo stravolgimento bisogna viverlo, creando così spazio per nuove belle idee». Blog e forum, dimore di sicurezza Una delle prime cose che un soggetto fa quando gli viene diagnosticato un tumore è consultare internet per scoprire cosa si nasconde sotto la voce “cancro” e per informarsi, tra un sito e l’altro, sulla propria malattia. Il web, nel bene o nel male, è diventato il migliore amico di ogni paziente. “Nel bene o nel male” perché diversi studi hanno dimostrato che otto su dieci persone vanno sul web per cercare informazioni e spiegazioni circa la propria malattia ma soltanto il 45 per cento dei siti ai quali accedono contengono informazioni corrette. Tuttavia in rete si possono trovare servizi molto utili per i pazienti oncologici come lo Sportello Cancro del sito Corrieredellasera.it realizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi: una guida su web ai centri di diagnosi e terapia più adatti ai singoli casi. Spiega il professore Veronesi: «I media, i nuovi media – Internet in testa – sono strumenti straordinari per sensibilizzare, informare, formare e aggiornare in tempo reale la comunità civile e scientifica. E possono anche aiutare concretamente a non sentirsi come “una barca alla deriva” di fronte ad una diagnosi di cancro. Internet è uno strumento importante che non deve snaturare il rapporto 93 Diari pazienti Flavia Serravezza “sentimentale” medico-paziente, quel legame fortissimo e imprescindibile fra la persona che ha bisogno e l’altra che cerca di aiutarla. Anzi, se capìto e utilizzato con coscienza, lo rafforzerà. Medico e paziente devono cogliere le opportunità di un mondo tecnologicamente sempre più avanzato, apparentemente freddo e sterile, ma in grado veramente di collegare, per la prima volta nella storia, i due universi della malattia e la sua cura». Nei tantissimi forum della rete dedicati al tema dei tumori, il malato oncologico va alla ricerca di dimore di sicurezza: consigli, informazioni, supporto da parte di chi ci è già passato. In questi luoghi di incontro virtuali, si sente meno solo e può condividere con altri malati l’esperienza del cancro, certo di poter trovare la giusta dose di comprensione. Sul social network Facebook, centinaia di migliaia di persone, malati di cancro ma anche familiari e amici, scrivono quotidianamente e fondano gruppi con l’intenzione e la speranza di dar voce a chiunque sia coinvolto nella malattia, così da dare poi il giusto rilievo e supporto alla marea di casi italiani, purtroppo divisi dalle loro urgenze e disperazioni. Anche le campagne di informazione o prevenzione contro il cancro utilizzano Facebook come mezzo di comunicazione. Internet offre al malato oncologico un universo disparato di informazioni più o meno veritiere sui tumori: articoli scientifici, sportelli informativi virtuali, siti web di oncologi, psicologi e altri esperti più o meno stimati. Difficile per chiunque capire su chi si può fare affidamento, anche perché le cose cambiano molto velocemente nel mondo del cancro. Tanto che i pazienti spesso preferiscono rivolgersi a chi ci è già passato per chiedere informazioni, consigli, supporto o più semplicemente per farsi una risata magari attraverso un nuova risorsa informatica: il blog. Come quello di Jeanne Sather (Sather’s Assertive Cancer Patient), che da più di sei anni convive con un tumore alla mammella. Nel suo diario virtuale racconta quotidianamente la sua esperienza, gli incubi, i trattamenti e esprime le sue opinioni sui progressi della ricerca scientifica. Attraverso il blog ha intessuto una rete di oltre 35mila contatti in tutto il Mondo con i quali condivide, oltre a una diagnosi, anche amicizia e supporto. Tra questi blogger c’è addirittura chi, con un po’ di amara ironia, desidera che l’indirizzo del suo diario virtuale venga inciso sulla “propria” lapide. Proprio l’ironia è ciò che contraddistingue i pensieri che tantissimi malati di cancro lasciano ogni giorno sulle pagine web. Insomma, dal diario al blog, sempre raccontare per guarire. E si moltiplicano anche in Italia le esperienze di scritturaterapia on line. Numerosi i laboratori, i diari virtuali, blog appunto, e le raccolte di testimonianze. Narrazioni che spiegano, che sentono, che curano. Parlare e poi scrivere, raccontare, esprimere i pensieri, le angosce, le ansie, ma anche le speranze, i miglioramenti, i sogni: riportare su una pagina (cartacea o virtuale) quanto si sta vivendo mentre si affronta la difficile battaglia contro un cancro aiuta a rinforzare le difese immunitarie e a diminuire il dolore. Lo dimostrano gli studi che da oltre vent’anni sono in corso in tutto il mondo: esperimenti di scrittura cosiddetta espressiva o creativa, realizzati nei modi e con gli strumenti più diversi, alcuni dei quali nell’ambito di specifici progetti di ricerca rivolti a varie patologie cronico-degenerative. Ma è nell’ambito dell’Oncologia che questa singolare forma di terapia sta trovando la sua massima realizzazione. Oltre ai progetti su carta, molti sono quelli 94 Quaderni di comunicazione 10 realizzati in rete. Tra le tante iniziative italiane realizzate in tal senso, va segnalata quella ideata da Manuela Bilingardi (http://sottolavocecancro.myblog.it), un vero e proprio blog nel quale i malati raccontano ciò che stanno vivendo e confrontano le proprie esperienze; e il progetto UCare della Fondazione Giancarlo Quarta, avviata di recente con un apposito sito (www.ucare.it) nel quale i malati possono esporre la propria storia o leggere quella degli altri pazienti che hanno scelto di raccontarsi. La parola d’ordine di ogni blog è, come accennato in precedenza, l’ironia. Che si rivela già dal titolo: “Silvia e il cancro. Non è il mio segno zodiacale” (http:// blog.libero.it/silviaeilcancro/). E questi diari sembrano suscitare molto l’interesse dei navigatori. È il caso del blog di Samantha Hughes, che ha appena 2 anni e una grave forma di cancro. La sua lotta contro la malattia è raccontata dal padre. Ma la storia è narrata come se a parlare fosse lei: “Ho perso l’appetito. Le uniche cose che mi vanno sono latte e yogurt”. Il diario, all’indirizzo www.samanthahughes. info, è stato letto da oltre 13 mila persone. In tanti ricorderanno poi il blog sul cancro che commosse il mondo, quello di Ivan Noble, il giornalista della Bbc che ha raccontato giorno per giorno gli ultimi tre anni della sua lotta con un tumore al cervello in un seguitissimo blog-diario. È morto all’età di 37 anni. Le sue riflessioni, i racconti delle tappe della sua lotta per la vita, hanno conquistato l’attenzione di migliaia di persone di tutto il mondo: alcuni volevano condividere le loro esperienze simili, altri volevano prendere forza dal coraggio di Ivan, altri ancora volevano offrirgli aiuto. A novembre del 2004 purtroppo la sua malattia è entrata in una fase critica, e con l’inizio del 2005 Ivan Noble è entrato in un hospice londinese per essere assistito negli ultimi giorni della sua vita. Pete Clifton, direttore di BBC News Interactive, ha spiegato: “Il diario di Ivan è stato una fonte di ispirazione per tutti noi: per i tanti lettori in giro per il mondo e per noi colleghi della BBC. Ci ha chiesto di aprire la sua rubrica subito dopo la prima infausta diagnosi. Voleva parlare apertamente di cancro, demistificando questa terribile malattia e aiutando gli altri malati a fare altrettanto: il dialogo che aveva aperto con i suoi lettori era incredibile. Ivan mancherà a tutti noi, e ci mancheranno il suo diario, il suo umorismo, il suo coraggio, la sua compassione”. Nel suo ultimo intervento pubblicato, Noble scriveva che presto sarebbe stato troppo debole per continuare a scrivere, ma ringraziava tutti i suoi lettori spiegando che il loro affetto gli aveva permesso di resistere più a lungo. Bibliografia Charon, R., 2006, Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness, Oxford University Press. Fioretto, L., Cheli, S., 2008, Appunti di viaggio per pazienti e caregiver, «Onconews», n.2, p.6. Marchionne, A., 2008, Il paziente narratore. Nuovo approccio alla comunicazione medicopaziente, in Arcipelaghi, luglio. Masini, V., 2005, Medicina narrativa. Comunicazione empatica ed interazione dinamica nella relazione medico-paziente, Milano, Franco Angeli. Muratore, M., 2008, La medicina narrativa, «Salento medico», Lecce, n.4, pp. 3-4. Van der Stap, S., 2008, La ragazza dalle 9 parrucche, Milano, Bompiani. Patrizia Calefato Raccontarsi attraverso le immagini: “In fabbrica” di Francesca Comencini Racconto di sé, memoria collettiva, cultura visuale Il racconto di sé non può prescindere dal racconto collettivo, dalla memoria che la “scrittura”, intesa in senso ampio e non solo come trascrizione, riesce a vivificare e a mettere in moto. Certo, la memoria è un dispositivo semiotico spesso privo di referenzialità, molto più capace di articolare dei vuoti1 che dei pieni. In questo articolo mi occuperò principalmente del dire di sé attraverso le immagini: un territorio di racconti inestinguibile, che contribuisce a comporre quella cultura visuale intesa come possibilità di pensare criticamente il mondo e se stessi attraverso il vedere, non solo con gli occhi. A dispetto della dittatura delle immagini nella nostra società, la visibilità è, come scrive Italo Calvino nelle sue Lezioni americane (1988, p. 83), un valore: dobbiamo preservarci, dice Calvino, dal pericolo di perdere la capacità di pensare per immagini. Dobbiamo invece tenere vivo quel “cinema mentale” che è la basilare capacità immaginativa umana. Una capacità che, certo, esiste da ben prima che nascesse il cinema come arte riproducibile, ma che proprio con il cinema in quanto tale si è potenziata enormemente. Mi concentrerò qui in particolare sul film In fabbrica, diretto nel 2007 dalla regista italiana Francesca Comencini. Non si tratta di un film narrativo o autobiografico in senso canonico, ma di una sorta di “meta-documentario” realizzato attraverso il montaggio di materiali filmici d’archivio, forniti in gran parte dalla RAI e dalle organizzazioni sindacali, che “scrive” per immagini la storia di oltre mezzo secolo di lavoro in fabbrica nella Italia che va dalla fine degli anni ’50 al giorno d’oggi. I materiali originali usati dalla regista consistono di storie, interviste, immagini “corali”: il tutto montato in una sequenza coerente accompagnata dalla voce narrante fuori campo di Francesca Comencini. La regista dedica questo film a suo padre, il grande regista Luigi Comencini scomparso lo stesso anno di uscita del film. In questo senso, interpreto il film come una sorta di ricostruzione di sé, sia pure indiretta, della stessa regista, nata nel 1961, debitrice verso suo padre anche della straordinaria capacità che egli ebbe di raccontare l’Italia dal dopoguerra agli anni ’90 attraverso i suoi film e le sue inchieste per la televisione. 96 Quaderni di comunicazione 10 Cinema e traduzione culturale Nel suo libro Primitive Passions, dedicato al cinema cinese degli anni ’90, Rey Chow sostiene che il cinema sia una forma di etnografia entro cui si produce la traduzione tra culture (Chow 1995, pp. 175-202). Il suo punto di partenza è costituito da uno dei testi cardine degli studi visuali e femministi, Visual Pleasure and Narrative Cinema di Laura Mulvey (1975), laddove Mulvey attribuisce alla condizione di “guardare” e di “essere guardati” due posizioni gerarchicamente disuguali, la prima assegnata al maschile, la seconda al femminile. Spostandosi sul piano dello studio delle culture, Chow estende questo modello della visione al modo in cui le culture occidentali entrano in relazione con quelle non-occidentali: l’Occidente guarda e il “non-Occidente” viene guardato. Non basta però solo questa constatazione: secondo Chow bisogna dire anche che la condizione dell’essere guardati non solo è costruita nel modo in cui le culture nonoccidentali sono visionate da quelle occidentali; più significativamente, essa è parte della maniera attiva in cui tali culture rappresentano – etnografizzano – se stesse (Chow 1995, p. 180)2. Questa ipotesi permette a Chow di affrontare il problema del rapporto tra l’“originale” e la “traduzione” tra culture affermando che il presunto “originale” delle culture è una costruzione fondata sulla condizione dell’essere guardati (to-be-looked-at-ness) che agisce come un “inconscio ottico”. L’autrice riprende quest’ultima espressione da Walter Benjamin, che la usò a proposito della fotografia e del cinema (Benjamin 1931 e 1936, pp. 42 e 62-63), tecniche in grado di produrre, al posto di uno “spazio elaborato consapevolmente dall’uomo”, “uno spazio elaborato inconsciamente”. Tale spazio emerge attraverso i mezzi tecnici che permettono di rallentare, ingrandire, scendere e salire nell’inquadratura, ridurre, ampliare e contrarre il processo del vedere. La visione si costruisce così come “proiezione”, nel senso composito che questa parola attinge sia alla psicanalisi – nel senso di un trasferimento all’esterno di “impulsi, sentimenti e stati interiori che il soggetto rifiuta o non riconosce come propri, attribuendoli ad altre persone o oggetti” (De Mauro) -, sia alla tecnica, nel senso di qualcosa che viene proiettato come un film sullo schermo. A questo duplice, ma complementare senso della parola “proiezione” Rey Chow ha dedicato il saggio Brame fasciste tra noi (The fascist longings in our midst, 1995, ora in Chow 2004), dove, in un interessante passaggio, scrive: Ciò che è “interiorizzato” nell’era del film è proprio il meccanismo proiettivo della proiezione. Se gli individui sono “interpellati” per usare il termine di Althusser, lo sono non solo come osservatori di film ma anche in quanto film. Essi “conoscono” se stessi non solo come soggetto, audience, ma come oggetto, spettacolo, cinema (Chow 2004, p. 99). Il meccanismo della proiezione è dunque un meccanismo esso stesso traduttivo e “auto-traduttivo”: la riproduzione delle immagini non avviene tra un “originale 97 Raccontarsi attraverso le immagini: In fabbrica di Francesca Comencini Patrizia Calefato di partenza” e una “copia” in cui tale originale si “traduce”, ma lo stesso presunto “originale” già contiene in sé la condizione dell’essere tradotto in quanto essere guardato. In fabbrica conferma alcuni aspetti della traduzione culturale sottolineati da Chow in un duplice senso: in un primo senso, perché nella raffigurazione visiva vengono “tradotte”, cioè trasferite in forma di immagini attraverso la macchina da presa, i corpi e le voci degli operai industriali italiani. In un secondo senso, perché il film monta insieme dei testi già esistenti, cioè i documentari televisivi d’epoca che attraverso il montaggio ricevono un’interpretazione, seguono un punto di vista, si aprono a un commento, in altre parole a una traduzione inter- e intrasemiotica. Il film ha come protagonisti gli operai delle fabbriche italiane, in gran parte immigrati dal Sud durante il ventennio 1950-1970, ed è dunque, in un certo senso, un testo attraverso cui degli “informanti nativi” (per usare un’espressione tipica dell’etnologia che la critica postcoloniale ha risemantizzato)3 offrono la loro testimonianza, guardati attraverso il duplice congegno semiotico della macchina da presa “originaria” che registrava per la televisione dell’epoca, e del montaggio più recente realizzato invece dalla regista per il film. Gli operai – ex contadini o braccianti del Sud – “in viaggio”, spostati, migrati, al Nord sono nella stessa condizione culturale delle società “non-occidentali” raffigurate attraverso il cinema, nel senso in cui ne parla Chow. “Arcaico”, “primitivo”, “arretrato”, sono aggettivi-stereotipi che il senso comune, ancora oggi, attribuisce a tutti i “Sud” del mondo. Ad essi non è estraneo il Mezzogiorno d’Italia, come dimostrano vicende non solo relative agli anni della migrazione delle “braccia”, ma purtroppo ancora vive nell’Italia della fine del primo decennio 2000, quando la migrazione dal Sud al Nord è soprattutto una migrazione intellettuale. Il cinema permette però, in quanto forma di traduzione culturale, di mostrare sia la fallacia che l’ambivalenza di questi stereotipi, dando vita a nuove narrazioni. Nel cinema gli sguardi si incontrano e divergono; le posizioni sociali e i caratteri individuali dei personaggi possono essere colti secondo prospettive molteplici; il tempo può venire dilatato, contratto, ripercorso all’indietro, proiettato in avanti. 98 Quaderni di comunicazione 10 Macchine e migrazioni La “fabbrica”, cui fa riferimento il titolo del film di Comencini, rappresenta il centro di attrazione per milioni di emigrati che, dalla fine degli anni ’50 ai primi ’70, si spostarono dalle regioni del Mezzogiorno d’Italia verso le grandi città del Nord del Paese e dell’Europa. L’Italia venne così irreversibilmente a perdere, in quella fase della storia del capitalismo, la sua connotazione di società agricoloindustriale – dove la componente agricola era concentrata soprattutto al Sud e quella industriale al Nord – per diventare un paese industriale a tutti gli effetti. L’agricoltura costituì un bacino enorme di forza lavoro per l’industria, con i contadini e i figli dei contadini che lasciarono la terra per trasferirsi in città. Gli stessi prodotti agricoli vennero trasformati dall’industria poiché entrarono nel circuito della produzione conserviera e alimentare, nonché della grande distribuzione, attività che in Italia si concentrarono quasi esclusivamente al Nord almeno fino alla fine degli anni ’80. La prima parte del film In fabbrica è dedicata a questa migrazione di esseri umani, attirati dalle due grandi capitali industriali italiane Milano e Torino. La voce fuori campo della regista si introduce con un taglio di genere femminile su uno scenario che, soprattutto nelle parti dedicate ai decenni dai ’50 ai ’70, è fondamentalmente abitato da soggetti maschili. Il modo di fare televisione in quegli anni assumeva come soggetto il maschio adulto che assurgeva a genere “universale” neutro sia dell’enunciazione audiovisiva che del “racconto” realizzato in quella enunciazione. Le donne compaiono pertanto solo episodicamente nella componente “enunciata” del film, cioè nelle interviste, mentre compaiono come madri, sorelle e mogli degli emigrati maschi nelle parti più “oggettive”, cioè nelle riprese fatte in terza persona e prive di interlocuzione. Per le donne del Sud la migrazione rappresentò in realtà in quella fase anche un’occasione di emancipazione nel lavoro di fabbrica e diede comunque loro occasioni di libertà nella vita urbana e nella casa “automatizzata”. Seleziono qui tre elementi essenziali – la macchina, la lingua e la città – che permettono di interpretare in particolare la prima parte del film, quella La lingua In quanto tale, la macchina generava un linguaggio, una lingua, per essere più specifici. In Italia, come il film dimostra con molti esempi, fu la parlata “settentrionale” lombardo-piemontese a fungere da koiné linguistica per gli immigrati dal Sud, che prontamente la acquisirono in forme a volta ibride a volta perfettamente imitate, e ne fecero il sostituto del vecchio dialetto abruzzese, pugliese o siciliano. 99 Raccontarsi attraverso le immagini: In fabbrica di Francesca Comencini Patrizia Calefato che arriva fino ai primi anni ’70, come una forma di autobiografi a corale simbolizzata attraverso alcuni segni-chiave. La “macchina” è proprio la metafora della migrazione dal Sud al Nord Italia negli anni del boom economico. La intendo sia come il mezzo attraverso cui si realizza l’automazione nella fabbrica fordista con la catena di montaggio, sia come il prodotto del lavoro di fabbrica: l’automobile, gli elettrodomestici e tutti gli strumenti tecnici della nuova produzione industriale. Gli immigrati costituirono la gran parte degli operai dell’industria meccanica del Nord, che ebbe come emblema e come modello di riferimento la Fiat di Torino. Questi operai e queste operaie della grande industria o i manovali immigrati che lavoravano come dipendenti di piccole aziende meccaniche svolgendovi anche le mansioni più umili, “amavano” la macchina. Amavano la semplificazione del lavoro che la macchina permette; amavano la perfezione della macchina, in entrambi i sensi in cui qui la concepisco; amavano la modernità della macchina. Il lavoro nei campi del Mezzogiorno d’Italia, in opposizione a ciò che la macchina rende possibile, è ricordato invece come duro, manuale, sporco, arcaico. Sono questi gli anni in cui il neocapitalismo realizza la trasformazione della natura del valore da quantitativa in qualitativa. Come profeticamente aveva scritto Marx nel Frammento sulle macchine dei Grundrisse, è ora il sapere incorporato nelle macchine a fornire la misura del valore della merce, non più la quantità di ore di lavoro impiegate per la produzione di questa. Certo, la giornata lavorativa in fabbrica è lunga, ma non è paragonabile alla giornata nei campi; certo, la fabbrica è un luogo terribile, con i ritmi e le condizioni di lavoro che impone, ma il confronto con la miseria del passato è per gli emigrati incommensurabile. La macchina è anche metafora della promozione sociale. La “vetturetta”, la 600 Fiat, venne presentata al palazzo delle esposizioni di Ginevra nel 1955 e nel giro di pochi anni divenne l’utilitaria popolare e di massa per eccellenza in Italia. Essa rappresentò il simbolo del boom economico e della trasformazione dell’auto da bene di lusso in “oggetto del tutto comune” come la definì Roland Barthes (1963). L’auto conteneva in sé il sapere tecnico sociale; il lavoro manuale umano; i valori comunicativi legati al design e alla pubblicità; i valori sociali che facevano dell’utilitaria il primo oggetto di proprietà del nuovo proletariato urbano immigrato e della nuova piccola borghesia; i valori pratici collegati alla trasformazione del concetto di viaggio e di mobilità, nonché dell’idea di comodità. La macchina si rendeva dunque, in entrambe le accezioni cui faccio qui riferimento, un sistema segnico per eccellenza. Quaderni di comunicazione 10 100 Tre giovani operaie giunte dalla Puglia raccontano nel film i loro gusti in fatto di innamorati replicando un quasi-perfetto accento nordico, con il “ne” piemontese di rigore. Manovali e operai a Torino e a Milano raccontano le loro vicende personali contraendo le parole, accelerando il ritmo del discorso, mutando tonalità e inflessioni: si realizza un processo di mimesi4 da parte degli immigrati che un po’ si vergognano di evidenziare attraverso l’accento del Sud la loro condizione, un po’ cercano un codice veloce di comunicazione con i residenti, e si camuffano così linguisticamente da “settentrionali”. Secondo il linguista Louis Hjelmslev, “parlare con un accento” consiste nel formare una materia dell’espressione secondo predisposizioni suggerite da fatti funzionali che appartengono alla lingua materna del parlante (Hjelmslev 1968, p. 62). L’accento riguarda la familiarità che un parlante ha con il sistema funzionale della lingua, cioè con il rapporto tra espressione e contenuto che costituisce, secondo la teoria hjelmsleviana, la funzione segnica vera e propria (p. 63). Questo aspetto materiale e strutturale della lingua è direttamente connesso alla dimensione sociale del linguaggio, dal momento che l’accento è un elemento di forte caratterizzazione che denuncia sia la provenienza geografica che quella sociale di chi parla. Negli anni del boom economico in Italia, l’accento meridionale degli immigrati nelle grandi città del Settentrione non faceva che rimarcarne la subordinazione e l’emarginazione socio-culturale in un contesto in cui la lingua “settentrionale” aveva l’accento del potere e della tecnocrazia. Ecco perché la stragrande maggioranza degli operai meridionali al Nord cancellavano l’accento, lo mascheravano con una parlata ibrida, inventando in quegli anni un italiano regionale lombardo o piemontese del tutto nuovo che a volte permise loro di comunicare meglio con i “residenti”, a volte invece non fece che realizzare una piccola Babele. Questo ibrido linguistico tuttora è parlato dalle generazioni più anziane, mentre i figli e nipoti degli immigrati, nati al Nord, ne hanno assunto completamente l’accento. Si realizzò così in quella fase in Italia, dal punto di vista linguistico, qualcosa di molto simile a quanto si andava consolidando nello stesso periodo in Germania o in Belgio dove gli immigrati dal Sud Italia “inventavano” un tedesco e un francese di contatto. Questa vicenda linguistica accomunò in quel momento molte realtà europee: su analoghe modalità sociolinguistiche presero vita infatti i pidgin generati dal tedesco degli immigrati turchi e, ancor prima, dall’inglese degli indiani e dei pakistani migrati in Gran Bretagna a cavallo della fine dell’Impero coloniale. La città, la lotta operaia Tra la lingua e la “macchina”, anche metaforicamente intesa, si costituisce una simbiosi essenziale, in particolare nel caso dell’italiano, che è oggetto nei primi anni ’60 di una appassionata polemica animata da due intellettuali fondamentali per la storia del nostro paese: Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino. I due scrittori intervenivano da posizioni opposte, ma in realtà complementari, sui cambiamenti avvenuti nella lingua italiana ormai unificata dalle tecnologie industriali. L’italiano era stato impoverito e imbastardito dalla nuova realtà industriale, sosteneva La lingua tecnologica di cui parla Calvino è una lingua metropolitana. È la grande città il luogo in cui le relazioni tra Sud e Nord si incrociano e si mostrano. In fabbrica documenta le immagini delle grandi stazioni di Milano e di Torino, dove giungono i treni dal Sud carichi di immigrati di entrambi i sessi e di ogni età: dai più piccoli alle più vecchie. Gli oggetti e le atmosfere di quei luoghi così cruciali, in quegli anni, per la circolazione delle merci e dei corpi sono descritti visivamente nei dettagli: i valigioni legati con lo spago; gli abiti delle donne anziane che arrivano dal paesino meridionale con i loro fazzoletti in testa legati “alla contadina” e le loro gonne lunghe. Sembra quasi di poter sentire gli odori, dalla campagna, al vagone del treno, alla stazione, alla strada urbana: quegli stessi odori che i “residenti” delle grandi città rifiutavano con atteggiamento razzista. Una donna, per esempio, dice in un’intervista che i meridionali cucinano piatti dall’odore nauseante, che vivono in tanti nella stessa casa, che sono sporchi. Compaiono su molti portoni delle città cartelli con scritte del tipo “Non si affitta ai meridionali”. A un giovane operaio in tenuta elegante – giacca e cravatta perfette – appena uscito dalla Fiat viene chiesto dove stia andando, e lui risponde che va a dormire in stazione, perché le case sono care e perché per gli immigrati sono poche quelle disponibili. Uno stato di cose che non venne per sempre accettato supinamente dagli operai. Nel film è ampiamente dimostrato infatti come l’immigrazione dal Sud abbia Raccontarsi attraverso le immagini: In fabbrica di Francesca Comencini 101 In tutta Italia ogni pezzo della macchina ha un nome e un nome solo (fatto nuovo rispetto alla molteplicità regionale dei linguaggi agricoli; meno nuovo rispetto a vari lessici artigiani), ogni operazione ha il suo verbo, ogni valutazione il suo aggettivo. Se questa è la lingua tecnologica, allora io ci credo, io ho fiducia nella lingua tecnologica (Calvino 1965, p. 157). Patrizia Calefato Pasolini, che evocava invece i dialetti come patrimonio perduto della ricchezza linguistica legata al mondo agricolo. L’italiano era però anche rinnovato e pronto per cosmopolitismi venturi, come invece sottolineava Calvino: Quaderni di comunicazione 10 102 costituito la risorsa da cui presero vita le lotte operaie iniziatesi sin dai primi anni ’60 e culminate nell’autunno caldo del ’69, che portarono a conquiste sul piano dei diritti, primo tra tutti lo Statuto dei lavoratori del 1970. Della città, della macchina, della fabbrica, perfino della lingua, le lotte operaie denunciarono il carattere profondamente alienato. Gli anni ’80 sancirono invece la fine del modello della fabbrica fordista, parallelo alla sostanziale sconfitta del movimento di classe degli operai, che venne anche simbolicamente rappresentata in Italia dalla “marcia dei quarantamila” della Fiat. Il 24 ottobre del 1980, 40.000 “colletti bianchi” della Fiat scesero in piazza a Torino per protestare non contro l’azienda, ma contro gli operai impegnati in quella fase in una dura lotta per la difesa del posto di lavoro dalle feroci ristrutturazioni che la Fiat stava realizzando. Anche legittimata da quella “marcia”, l’azienda portò a termine i licenziamenti, decretando una significativa sconfitta del movimento sindacale. Questa vicenda storica è stata raccontata al cinema da un’altra regista italiana, Wilma Labate, nel film Signorinaeffe, anch’esso del 2007. Il titolo richiama a sua volta il film-documentario diretto da un’altra donna, Giovanna Boursier, nel 2001, Signorina Fiat. È interessante notare questa spiccata propensione di diverse registe italiane verso le vicende della storia del secondo Novecento, viste attraverso occhi “realistici”, e realizzate attraverso generi ibridi tra il cinema narrativo, come in Signorinaeffe, e quello che ho definito “metadocumentario”. A quest’ultimo filone appartiene infatti anche un bellissimo film del 2008 diretto da Alina Marazzi, Vogliamo anche le rose, dedicato alla condizione femminile e alle lotte delle donne tra gli anni ’50 e ’70. Marazzi utilizza anche lei, come Comencini, materiali originali, anche se più amatoriali che d’archivio istituzionale, e propone una narrazione corale di genere molto coinvolgente. Realizza, inoltre, un montaggio particolarissimo, nel quale alle immagini filmiche si accompagnano elementi spuri, come la scrittura, il fumetto, il cartone, lo spot pubblicitario. Dalla stessa Marazzi ricordo qui anche un’opera precedente, Un’ora sola ti vorrei Negli anni ’90 cominciò a comparire in Italia un altro “Sud”, incarnato nei corpi dei migranti extra-nazionali provenienti dai paesi dell’Est Europa dopo la caduta del Muro di Berlino, dall’Africa, dall’Asia e dall’America latina. “Si è sempre a sud di qualcosa o di qualcuno”: questa espressione è diventato un modo di dire comune dal momento in cui il mondo vissuto, cioè quello di cui facciamo quotidianamente esperienza, ci è apparso nella sua dimensione planetaria e non più limitata a una ristretta comunità. Nella sua semplicità, questa immagine connota il Sud come alterità radicale, mai riconducibile a un’“essenza”. Come metafora, è sempre possibile rilanciarla, all’infinito. Esistono sempre nuovi “Sud”, dunque: oggi quegli stessi discorsi razzisti allora rivolti agli immigrati dal Mezzogiorno d’Italia vengono pronunciati da “residenti” italiani, magari figli e nipoti di chi 40 o 50 anni addietro seguì il percorso della speranza verso il Nord, pronipoti di chi nel primo Novecento inseguì quella speranza oltre l’Oceano. Oggi sono le stazioni e i treni italiani a riempirsi di immigrati dei vari “Sud”. E questo accade nel Nord come nel Mezzogiorno italiani: accade nella Torino post-industriale rinata negli anni 2000 come città della cultura; accade nelle cittadine del Veneto, oggi ricco “Nordest”, che fu invece solo fino agli anni ’70 una sorta di “Sud” all’interno del Nord, sacca di emigrazione e di povertà; accade nelle nuove metropoli meridionali. L’ultima immagine di In fabbrica è quella nella quale un operaio africano in una industria del Nord Italia richiama, rivolto a chi lo sta intervistando e a tutto il pubblico che lo sta guardando e ascoltando, una importante idea di responsabilità e di collaborazione: È l’andamento del mondo ora che ci impone l’immigrazione. È un processus irreversibile. Quindi bisogna collaborare: non gridarci, ma provare a vedere insieme a noi come fare per gestire questo fenomeno che non è nuovo, fa parte della storia del mondo. NOTE 1 Mi piace qui rimarcare che Vuoti di memoria è il significativo titolo di una serie di documentari ideati dalla regista Loredana Rotondo e realizzati dal 2001 al 2004 per Rai Educational. Tra le figure cui ciascuna puntata è stata dedicata, ricordo qui in particolare quelle della filosofa e femminista Carla Lonzi e della scrittrice Goliarda Sapienza. 2 La traduzione italiana dei passaggi di Chow 1995 è mia. 3 Sull’informante nativo, v. Spivak 1999. Per la critica della ragione postcoloniale di Spivak, “nativo” è una parola che in realtà designa il non-nativo-europeo, che “informa” su di sé conformandosi alla lingua dominante. 4 Sul concetto di mimesi, v. Bhabha 1994. Raccontarsi attraverso le immagini: In fabbrica di Francesca Comencini 103 Nuove migrazioni: le“fabbriche”del 2000 Patrizia Calefato (2002), struggente film dedicato a sua madre morta suicida quando lei era bambina e realizzato interamente montando i filmini famigliari girati da suo padre e dai suoi nonni. Quaderni di comunicazione 10 104 Bibliografia Barthes, R., 1963, “La voiture, projection de l’Ego”, “Réalités”, ottobre, 213; trad. it., 1998, “L’automobile: un “aggeggio del tutto comune”, in Scritti. Società, testo, comunicazione, a cura di G. Marrone, Torino, Einaudi, pp. 41-50. Benjamin, W., 1931 e 1936, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit, „Zeitschrift für Sozialforschung“, Paris; trad. it. 1966, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi. Bhabha, Homi K., 1994, The Location of Culture, Routledge, London-New York; trad. it. I luoghi della cultura, Meltemi, Roma 2001. Calvino, I., 1965: L’antilingua, in Saggi 1945-1985, Mondadori, Milano. Calvino, I.,1988, Lezioni americane, Milano, Garzanti. Chow, R., 1995, Primitive Passions, New York, Columbia University Press. Chow, R., 2004, Il sogno di butterfly. Costellazioni postcoloniali, Roma, Meltemi. De Mauro, T., 1999, Grande Dizionario italiano dell’uso, Torino, Utet, versione online www. demauroparavia.it Hjelmslev, L., 1943, Prolegomena to a Theory of Language, a c. di F. J. Whitfield, Madison, University of Wisconsin Press, 1961; trad. it. 1968, I fondamenti della teoria del linguaggio, Torino, Einaudi. Mulvey, L., 1975, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, “Screen”, 16: 6-18. Spivak Chakravorty, G., 1999, A Critique of Postcolonial Reason, Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press; trad. it. 2004, Critica della ragione postcoloniale, Roma, Meltemi. Silvia Gravili La comunicazione d’impresa come racconto autobiografico Ricordate come si costruiva, pezzo dopo pezzo, una Lambretta? E come fu presentata la Fiat 500 nel 1957? E come fece la Montecatini a rendere di uso comune (con il nome di “Moplen”) il polipropilene isotattico, materiale inventato da Natta che gli valse il nobel per la chimica nel 1963? E lo sapevate che il “Programma 101”, costruito dall’Olivetti nel 1965 (in anticipo di quasi 15 anni rispetto al Macintosh della Apple) era un personal computer ante litteram, programmabile, con sistemi per inserire i dati e stampare i risultati, oltre che con memorie fisse e rimuovibili? Queste, e tante altre, sono le storie che ci raccontano Lambretta, Fiat, Montecatini, Olivetti, Borsalino, Eni, Innocenti, Breda, Edison con i cortometraggi che, a partire dagli inizi del secolo scorso, hanno realizzato a scopo divulgativo e promozionale, per far conoscere l’attività delle loro fabbriche. Un immenso patrimonio di immagini e suoni (circa 30.000 rulli di pellicola, oggi raccolti nell’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa di Ivrea), a firma di registi del calibro di Michelangelo Antonioni, Alessandro Blasetti, Paolo e Vittorio Taviani, Silvio Soldini, Nelo Risi, Valentino Orsini, Ermanno Olmi, Bernardo Bertolucci. Filmati importanti, perché ricostruiscono i momenti più significativi della storia industriale italiana e perché testimoniano che, sin dai suoi primissimi anni di vita, l’impresa ha sempre sentito l’esigenza di raccontarsi: lo ha fatto attraverso i cartelloni (“un cartellone o una marca può essere la fortuna di un prodotto o di una Ditta”, scriveva Fortunato Depero nel 1937), ma anche attraverso il cinema industriale, che ha rappresentato dagli anni ‘30 agli anni ‘80 un settore importante della politica aziendale. Ma se consideriamo la comunicazione d’impresa un racconto autobiografico, che differenze ci sono tra le sue forme “tradizionali” e quelle più innovative, legate al multimediale e al virtuale? Per cercare di rispondere a questa domanda, chiariamo innanzitutto che con l’espressione “comunicazione d’impresa” oggi intendiamo l’insieme dei processi che permettono a un’azienda di entrare in contatto con i suoi pubblici (target) di riferimento e di costruire con loro una relazione duratura nel tempo, allo scopo di Quaderni di comunicazione 10 106 raggiungere gli obiettivi fissati nella vision e nella mission aziendale, e articolati nel piano di comunicazione e nel piano di marketing. Gli strumenti (mezzi) attraverso cui l’impresa (si) comunica sono quanto mai eterogenei e versatili, e fondamentalmente si classificano secondo due assi principali: – i target di riferimento (comunicazione esterna vs. comunicazione interna) – il canale (scritto vs. orale, a cui oggi si aggiungono le moderne frontiere del virtuale) Ma che cosa l’impresa comunica di sé? Come costruisce oggi tale racconto? E che caratteristiche ha (o dovrebbe avere) il contenuto di tale comunicazione? Nuovi paradigmi di consumo La società post-moderna è la società dell’informazione per eccellenza: i mezzi di comunicazione che permeano il nostro mondo lo controllano e lo modellano. Ma basta “parlare di sé” ed “emettere informazioni” per comunicare? Non possiamo non considerare, infatti, accanto al fenomeno del proliferare dell’informazione (che rende la società più complessa, reticolare, eterarchica, acronica, atopica, fluida) anche la parallela esigenza degli individui di riuscire a orientarsi in un oceano informativo ricco sia di possibilità che di vincoli, legati alla difficoltà di distinguere le informazioni inutili o ridondanti da quelle utili e innovative, “le sole in grado di divenire opportunità per le persone, innovazione per le aziende, conoscenza per la società” (Fichera, 2002). E questo vale soprattutto nel contesto socio-economico contemporaneo, contrassegnato dal passaggio dai “consumatori” ai “consumattori” (Fabris, 2008) o, più genericamente, agli utenti: il consuma(t)tore che le aziende devono soddisfare oggi è un essere profondamente evoluto, mutato e complesso, alla continua ricerca non di meri “prodotti” ma di “esperienze appaganti”, emozioni e coinvolgimento fattivo. La sua scelta di consumo è fatta di una gestalt ipercomplessa, intrisa di quotidianità, valori, cultura. Inoltre, il consuma(t)tore non è più tale solo nel momento della scelta, ma è costantemente legato (potremmo usare il termine “embedded”) in uno o più network (“comunità” o “tribù”) di persone che hanno interessi, orientamenti, pulsioni affettive in comune (ma non esattamente coincidenti), condivisi in maniera virtuale e consolidati nel mondo reale (pensiamo, ad esempio, alle comunità di interesse che proliferano sul web, e ai “meeting” che ogni tanto organizzano i suoi membri per incontrarsi dal vivo). Si passa, quindi, da un rapporto “impresa – consumatore” del tipo “uno a molti”, tipico della distribuzione e con le relative forme statiche di segmentazione (con tutto ciò che, a livello di deduzione e generalizzazione, essa comporta), ad un rapporto “impresa – consumAutore (o “consumatoRe”) del tipo “uno a uno”, secondo le forme della relazione: ogni utente è un individuo con i propri gusti, bisogni, valori, esperienze, ecc., individuati attraverso l’active profiling, cioè la ricostruzione dello stile di vita dell’utente secondo le informazioni personali da lui Quando si parla di comunicazione si ricorda spesso un famoso assioma della Pragmatica della Comunicazione umana (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967), che afferma: “Non si può non comunicare”, poiché qualunque comportamento è comunicazione, e qualunque azione prevede un feed-back da parte di un interlocutore. E tuttavia, soprattutto nel mondo dell’impresa, questo assioma non è sempre valido: analizzando i messaggi emessi (e, anzi, nonostante la notevole quantità d’informazioni scambiate), non sempre è lecito parlare di “comunicazione”. L’impresa, infatti, deve collocarsi in una prospettiva di “sistema”, che possiede un certo livello di complessità, che adotta comportamenti e autoregolazioni particolari, in grado di contrastare le modificazioni ambientali e quindi di evolversi e/o adattarsi all’ambiente. Tali adattamenti, però, sono possibili solo se l’eccesso di informazioni lascia il campo alla conoscenza, capace di individuare e affrontare problemi cruciali: “ciò significa accrescimento dell’interazione tra soggetti specifici” (Calvani, Riotta, 2001). Considerato in quest’ottica, dunque, un processo di comunicazione avviene sempre in una situazione di “asimmetria informativa”: all’idea di “comunicazione” si lega strettamente il concetto di “apprendimento”, o “tensione verso l’apprendimento” (Greco, 2002). La comunicazione (e quella d’impresa non fa certo eccezione) va infatti intesa come un processo nel quale due o più interlocutori stabiliscono delle interazioni nel tentativo di mettere in comune dei concetti o dei pensieri che preludono a un’azione o un comportamento in grado di modificare in qualche maniera lo stato dei pensieri o dei comportamenti degli interlocutori che intervengono nel processo. Insomma, la comunicazione è il preludio a un cambiamento o a una modificazione. In questo modo la comunicazione riacquista un significato più autentico etimologicamente, a indicare l’azione del mettere in comune, della condivisione. Estremizzando il discorso, potremmo affermare che le informazioni più significative sono quindi quelle che in qualche modo risultino per il sistema ricevente totalmente “ignote”, ma che riescono ad acquistare significato mentre vengono “messe in comune”. Le informazioni sconosciute perturbano il nostro sistema di pensiero permettendo che questo si riorganizzi in maniera nuova, creando così nuova conoscenza. Viceversa, in un processo di comunicazione le informazioni totalmente “note” non hanno nessun valore: rafforzano un concetto o un’idea, ma sostanzialmente non “comunicano” nulla (Fichera, 2002). È questa una della grandi trappole in cui l’impresa, nella costruzione del suo racconto di sé, oggi rischia di cadere: risultare ripetitiva, priva di appeal e di distinzione, e quindi destinata a cadere nel mare grigio e indifferenziato dell’oblio. Sostanzialmente il problema, osservato da vari punti di vista in termini di mez- La comunicazione d’impresa come racconto autobiografico 107 Nuovi paradigmi di comunicazione Silvia Gravilli stesso direttamente o indirettamente fornite. Si passa dalla definizione del luogo della fruizione e del consumo come “negozio” a quello di “palcoscenico”. Quaderni di comunicazione 10 108 zi scelti o strategie perseguite, resta sempre lo stesso: riuscire a trasmettere un messaggio il più sintetico possibile in grado, da un lato, di veicolare la massima quantità d’informazione, e, dall’altro, di produrre significati e concetti sempre nuovi con un numero limitato di risorse (economiche, segniche, linguistiche, di tempo, cognitive, di attenzione). Si tratta, in sostanza, di riuscire ad applicare il principio di economia al racconto (fortemente evocativo di sé) che l’impresa costruisce nel tempo: Economia in una lingua si può chiamare [la] ricerca permanente dell’equilibrio fra bisogni contraddittori che devono esser soddisfatti: bisogni della comunicazione da un lato, inerzia della memoria e inerzia articolatoria dall’altra, queste ultime due in conflitto permanente, mentre il gioco di tutti i fattori è limitato da tabù diversi che tendono a fissare la lingua eliminando ogni innovazione troppo evidente (Martinet,1967). In altri termini, l’economia sta nel rapporto tra il bisogno di comunicazione tipicamente umano (che necessita di ridondanza) e l’inerzia (della memoria, dell’articolazione, ecc.), secondo il principio del minimo sforzo (Fichera, 2005). Sappiamo tuttavia che il messaggio comunicativo non può essere “telegrafico”: innanzitutto perché esso si sviluppa in condizioni non ideali (vedi la presenza del rumore); poi perché deve cogliere le sfumature di nuove situazioni. Nel primo caso, cioè quando il contesto si rivela particolarmente sfavorevole perché turbato dalla presenza di altri elementi, sarà sufficiente la ripetizione totale o parziale del messaggio. Nel secondo caso, invece, occorrerà introdurre unità più numerose e specifiche. In ogni caso, ci saranno dei costi e delle spese, che varieranno a seconda del numero degli elementi costitutivi che compongono l’unità e della frequenza con cui essa ricorre in un certo contesto: più un’unità è frequente, meno costi comporta, ma meno è significativa. Ammettiamo pure di essere stati così bravi da costruire un messaggio “economicamente vantaggioso” (cosa, del resto, non facile): ci basta questo per avere successo nella comunicazione? No, perché se il consumatore è diventato un individuo con cui l’impresa è in relazione, non basta che questa gli parli di sé: è ancor più necessario che l’impresa dialoghi con lui, lo ascolti, interagisca con lui, in modo tale da costruire insieme il racconto stesso dell’impresa, che arriva così ad integrare le esperienze personali, i valori e le percezioni dei suoi singoli utenti (Levine, Locke, Searls, Weinberger, 2000). Se, quindi, con i mezzi tradizionali la comunicazione d’impresa ha fondamentalmente carattere di tipo “push”, nel contesto contemporaneo deve assumere carattere prevalente di tipo “pull”. “Spinte” e “tirate” Cerchiamo di comprendere meglio quello di cui stiamo parlando. In una strategia di tipo “push” (efficace nel caso di beni di consumo, con ampi segmenti di mercato, o quando la catena distributiva è lunga, se non esclusiva) l’azienda concentra i suoi sforzi sulla distribuzione, accordandole incentivi e condizioni Una comunicazione di tipo “pull”, che trova sul web i suoi mezzi ottimali, è fortemente personalizzata e “user-centrica”: per fare un esempio, non posso costringere gli utenti ad andare il visitare il mio sito, a meno che essi non vogliano farlo. E perché dovrebbero volerlo? Perché sono convinti di trovarci (e ci devono trovare, a meno di non voler disperdere tutto il capitale di fiducia e di relazione accumulato nel tempo) tutto ciò di cui hanno bisogno: una risposta alle loro domande, una soluzione ai loro problemi, la soddisfazione dei loro bisogni. Ovviamente, per conoscere questi bisogni (e le passioni che vi sottendono), queste domande, questi problemi, e per fornire una soluzione altamente personalizzata, l’azienda deve entrare in contatto diretto con il consumat(t)ore: dev’essere abile a costruire relazioni basate sul dialogo, piuttosto che puntare alla vendita di un singolo prodotto, e ascoltare i consigli che da questo dialogo scaturiscono. Da queste continue conversazioni, infatti, l’impresa trae doni preziosi: non solo nuovi spazi d’interazione con il proprio utente finale, necessari a fornire nuove informazioni pertinenti e nuovo appagamento (ci riferiamo, ad esempio, all’integrazione nel proprio sito di blog, forum, Frequently Asked Questions e user generated content), ma anche indicazioni sull’evoluzione dei gusti degli utenti e spunti per la definizione delle caratteristiche estetiche del prodotto o della sua connotazione valoriale, oltre che nuovi linguaggi espressivi (pensiamo al marketing innovativo: guerrilla, ambient, viral, tribal, ecc.) e nuove forme di promozione indiretta e a La comunicazione d’impresa come racconto autobiografico 109 Se, però, cambiano le caratteristiche dello scenario di riferimento (ad esempio perché il segmento di mercato è più ristretto, o perché il canale distributivo è più corto, o perché il prodotto ha una natura più “sofisticata”, o perché gli utenti sono più esigenti, “smaliziati” e/o più finemente segmentati, o perché l’impresa vuole cercare di diminuire il potere contrattuale del canale distributivo), risulta più conveniente per l’azienda adottare una strategia di tipo “pull”, dove la pressione informativa e di comunicazione avviene direttamente sulla domanda finale: i consuma(t)tori vengono persuasi a cercare gli articoli nei punti vendita, costringendo di fatto i distributori ad acquistarli presso l’impresa che li produce (la produzione, quindi, è attivata dagli ordini della clientela, Ferrandina e Carriero, 2005). A livello di costruzione del messaggio, però, questo comporta uno sforzo (creativo, oltre che economico), maggiore: esso non deve solo essere altamente distintivo e ben riconoscibile, ma anche coerente nel tempo, fortemente evocativo, e in grado di confermare la promessa dell’impresa di apportare benefici (materiali e/o soprattutto immateriali) al proprio target. Le sue forme e i suoi contenuti dovranno attirare l’attenzione e coinvolgere il consumat(t)ore in un’azione interattiva, che risulti non solo “utile” (le informazioni contenute nel messaggio sono giudicate pertinenti), ma anche divertente ed “appagante”. Silvia Gravilli favorevoli, in virtù dei quali il distributore è spinto a promuovere la vendita del prodotto in questione presso i suoi clienti finali, preferendolo a quello dei concorrenti. In questo caso, la comunicazione dell’impresa al consumatore ha una natura fortemente standardizzata, “di massa”, con un contenuto statico che non implica necessariamente un’interazione, quanto piuttosto una fruizione. Quaderni di comunicazione 10 110 costo zero: l’esempio tipico è quello degli user generated contest, dove l’impresa decide di fornire il proprio sostegno a iniziative nate fuori di essa, sul web e per iniziativa degli utenti. In questo senso, si può affermare che il consumat(t)ore partecipa all’attività dell’impresa come prosumer (Toffler, 1980) e diventa partner dell’azienda. Certo non possiamo non considerare che il rapporto così stretto che si è venuto a creare tra impresa e consuma(t)ore non è privo di contrasti o distorsioni: Calvani e Riotta (2001) rendono conto della visione della società dell’informazione che emerge dagli studi del sociologo spagnolo Javier Echeverria, secondo il quale l’attuale tessuto produttivo è basato sull’informazione e l’intrattenimento, così intrecciati tra di loro che si avviano a diventare un unicum. Ma da cosa è determinato, in questo scenario, il valore dell’informazione? Secondo la logica dei pubblicitari, il valore dell’informazione, nella sua accezione estesa all’intrattenimento multimediale, sta nell’audience che genera e nella conseguente possibilità di vendere inserzioni a prezzo più alto. E questo è vero al punto tale che, siccome il valore di un banner non si calcola più a forfait o in base al numero dei visitatori della pagina che contiene l’inserzione, ma secondo il contatore della homepage dello sponsor, negli Stati Uniti alcuni pubblicitari hanno offerto una percentuale in denaro agli webnauti disposti a cliccare sul “consiglio” pubblicitario, incrementandone in questo modo il valore. Echeverria, quindi, provocatoriamente conclude che il destinatario dell’informazione così intesa si può considerare a pieno titolo parte integrante del processo produttivo, perché genera un plusvalore spendendo tempo, il suo tempo: leggere, guardare, navigare, per molti utenti è una scelta gratificante, ma per altri è, nella visione del sociologo, parte di una quotidianità tanto alienante quanto una catena di montaggio. Indipendentemente dal fatto che si condividano o meno le conclusioni di Echeverria, è tuttavia innegabile che buona parte del rapporto tra impresa e consumat(t)ore ruoti proprio intorno al messaggio che essa confeziona, messaggio che deve comprendere e orchestrare elementi di carattere razionale, emozionale ed esperienziale, che nel complesso restituiscano un’immagine coerente e positiva dell’impresa e costruiscano un vero e proprio universo fatto di valori e di esperienze, reso riconoscibile dal brand (Kotler, 2004). Legami e non più merci In effetti il brand è il mezzo storicamente più antico (accanto al nome, ovviamente) attraverso cui l’impresa si definisce a livello identitario sia al suo interno che al suo esterno, ed è andato incontro a una trasformazione della funzione d’uso tale da poter essere assunto come esempio delle differenze che intercorrono tra le forme del raccontarsi “classiche” e quelle “multimediali”: la marca “è diventata un veicolo per esprimere filosofia e posizione, non solo come mezzo di identificazione, ma anche come mezzo di comunicazione” (Morgan, 1998). Il brand quindi, evocando dei valori e delle emozioni, invita il consumatore a condividere con l’impresa una storia, un racconto costruito insieme giorno dopo giorno, in una sorta di relazione amorosa: nell’ambito di prodotti che dal punto di vista meramente tecnico sono pressoché affini, scelgo questo brand piuttosto che un altro perché condivido l’universo di valori che esso mi suggerisce, mi affilio alla tribù che lo anima e, attraverso l’acquisto, mi lego ad essa (ovviamente, questo discorso non vale per tutte le scelte di consumo, ma solo per quegli acquisti a cui ogni individuo, per un motivo o per un altro, attribuisce un significato/valore emotivo particolare). Proprio il concetto di “senso di appartenenza” (in termini tecnici, parliamo di “fidelizzazione”) è il cardine intorno a cui si costruiscono i messaggi e le campagne di comunicazione nel mondo multimediale: se il valore veicolato da un determinato bene o servizio conta più del bene o servizio stesso, l’impresa con il racconto di sé nel mondo virtuale prima, e in quello reale poi, offre legami, e non più merci. Offre riti che rinnovano e vivificano la fede dei membri del gruppo nei valori comuni. E, per farlo, usa Internet come mezzo privilegiato. Sorvolando sulla prassi ormai consolidata di ogni campagna di comunicazione, tale per cui a ogni evento promozionale di rilievo è associato un sito web su cui reperire tutte le informazioni principali dell’evento, postare le proprie foto, lasciare commenti, scaricare wallpapers, ecc., le principali attività promozionali e di racconto dell’impresa sul web si svolgono oggi sui social network. Prendiamo ad esempio Facebook: non più soltanto un “libro di facce”, esso è un modo per tener traccia dei propri interessi, di scambiarsi messaggi e farsi nuovi amici gratis. È un luogo di svago dove le persone trascorrono il loro tempo con piacere, oltre che (grazie alle applicazioni che permettono collegamenti a La comunicazione d’impresa come racconto autobiografico 111 Silvia Gravilli Se, infatti, quando era semplicemente considerato “marchio d’impresa”, aveva unicamente una funzione distintiva utile a far riconoscere in maniera univoca i prodotti o servizi che un’impresa produce e mette in commercio (accezione, del resto, tutt’ora conservata dall’Ufficio Brevetti e Marchi del nostro Paese), oggi il brand definisce l’identità complessiva dell’impresa in termini di consapevolezza, reputazione e rilievo che caratterizza il prodotto/servizio da esso identificato (Keller, Busacca, Ostillio, 2003): si carica di uno specifico bagaglio di attese, appeal e differenziazione, in virtù della percezione complessiva sviluppata dai consumatori in merito alle sue caratteristiche, al nome che lo identifica e al suo significato, oltre che ovviamente al valore (brand equity) assegnato all’immagine complessiva dell’azienda attraverso di esso (Keller, Busacca, Ostillio, 2003). In funzione di ciò, il brand è una sorta di “valore aggiunto” rispetto al prodotto stesso, soprattutto perché (Kotler, 2000) in molti mercati (e sicuramente in quelli del mondo Occidentale) quasi tutte le imprese in competizione hanno acquisito la capacità tecnica per garantire la mera soddisfazione del bisogno: la concorrenza, quindi, si è spostata dal piano materiale (rappresentato dal cosiddetto “expected product”) a quello valoriale (“augmented product”, cioè il prodotto connotato dal valore percepito della marca e della relazione che essa ha instaurato con i suoi utenti). Quaderni di comunicazione 10 112 mail, chat e siti esterni ai quali si accede mediante la stessa password) una sorta di “community nella community” e una porta sempre aperta sul mondo. Per questo motivo, più che farsi pubblicità mediante i banner a pagamento, le imprese preferiscono fare comunicazione attraverso i “gruppi” (pagine dedicate al proprio marchio all’interno delle quali è possibile iscriversi ed aprire discussioni. E siccome i fan del marchio possono scegliere di far parte di tale gruppo e partecipare alle discussioni, i gruppi sono anche un modo per condurre analisi di marketing e capire quale tipo di marchi e prodotti interessano agli utenti) e, soprattutto, attraverso le “applicazioni”. Queste sono piccoli programmi, sostanzialmente con funzione ludica, da inserire nella propria pagina personale, talvolta anche con elementi da personalizzare. A livello di marketing, le applicazioni hanno la caratteristica di essere strumenti di monitoraggio dei contatti e di active profiling: dicono all’impresa quanti sono gli utenti che utilizzano tale applicazione ogni giorno e la percentuale rispetto al totale delle persone che hanno quell’applicazione, permettendo di trarre attivamente informazioni sui contatti stessi attraverso le descrizioni presenti nella propria pagina personale (età, titolo di studio, luogo, interessi, ecc.). La loro caratteristica principale, però, è la viralità, che esplode con il buzz e percorre il tessuto virtuale del web. La diffusione capillare del messaggio pubblicitario avviene attraverso due modalità. Il primo tipo di viralità s’innesca invitando i propri amici a usare la stessa applicazione e/o a partecipare allo stesso gruppo, a volte invogliati da agevolazioni nell’utilizzo delle applicazioni, quali oggetti o punti bonus; questo tipo di viralità a volte degenera in un vero e proprio spam, ma fa conoscere le applicazioni a molti utenti contemporaneamente. Il secondo tipo di viralità avviene visitando i profili dei propri amici: si vedono con i propri occhi quali sono le applicazioni e i gruppi più interessanti, e cliccando ci si appropria degli stessi. In virtù di queste caratteristiche, la pubblicità su Facebook esce dal mondo virtuale e si sposta in quello reale. Un esempio è l’iniziativa promossa all’inizio dell’anno da Burger King: tramite l’utilizzo dell’applicazione “Whopper Sacrifice”, l’utente registrato a Facebook può scegliere di rinunciare a dieci amici on line in cambio di un coupon che dà diritto a un sandwich gratuito presso i punti vendita della catena. Il panino, rivisitazione moderna della mela biblica, è il Whopper, prodotto di punta dell’azienda. Ma chi confida nelle leggi della privacy sbaglia: il traditore verrà pubblicamente smascherato perché, nella pagina principale dei suoi contatti, comparirà un feed aggiornato del tipo “Tizio ha sacrificato Caio per un panino gratis”. E sebbene Burger King si sia voluta cautelare rendendo noto che ciascun profilo Facebook potrà ricevere un solo Whopper in omaggio, l’effetto è stato dirompente. Si poteva, infatti, scegliere di eliminare i classici volti non noti, che abbiamo pigramente accettato, o addirittura, scherzare con i contatti più intimi, eliminandoli dalla cerchia dei “facebook friends” e invitandoli ad assaporare insieme un panino al gusto del ‘tradimento’. E voi, che avreste fatto? La comunicazione d’impresa come racconto autobiografico 113 Calvani, A., Riotta, M., 2001, Comunicazione e apprendimento in Internet, Trento, Erickson. Depero, F., 1937, L’arte del cartello: arte del tempo e mezzo di propaganda infallibile, «Il Brennero», 1 giugno. Fabris, G. P., 2008, Societing. Il Marketing nella società postimoderna, Milano, Egea. Ferrandina, A., Carriero, F., 2005, Il piano marketing, Assago, Ipsoa. Fichera, G., 2002, Si può non comunicare: effetti paradossali della comunicazione nel mondo della complessità, «Ticonzero», n. 27, Milano, Università Bocconi. Fichera, G., 2005, Comunichiamo in maniera economica? L’economia del processo comunicativo, «Ticonzero», n. 65, Milano, Università Bocconi. Gilli, A., 2000, Manuale di Sociologia, Milano, Bruno Mondadori. Greco, G. (a cura di), 2002, ComEducazione. Conversazioni su comunicazione e educazione, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino. Guida al deposito delle domande di marchio nazionale, 2008, Ufficio Brevetti e Marchi Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce. Keller, K. L., Busacca, B., Ostillio, M. C., 2003, La gestione del brand. Strategie e sviluppo, Milano, Egea. Kotler, P., 2000, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, X ed., Englewood Cliffs, Prentice-Hall. Kotler, P., 2004, Ten Deadly Marketing Signs. Signs and Solutions, Hoboken, NJ, Wiley John & Sons Inc. Levine, R., Locke, C., Searls, D., Weinberger, 2000, The Cluetrain Manifesto, Cambridge, MA, Perseus Books; trad. it. 2001, Cluetrain Manifesto, Roma, Fazi Editore. Martinet, A., 1967, Elementi di linguistica generale, Bari, Laterza. Marrone, G., 2007, Il discorso di marca. Modelli semiotici per il branding, Bari, Laterza. Morgan, C. L., 1998, Logos: logo, identify, brand, culture, Beverly, MA, Rockport Publishers Inc.; trad. it. 2000, Logos. Logo, immagine, marchio, cultura, Milano, Progetto Editrice. Toffler, A., 1980, The third wave, London, Collins. Volli, U., 1994, Il Libro della Comunicazione, Roma, Il Saggiatore. Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D., 1967, Pragmatics of Human Communication, New York, W.W. Norton; trad. it. 1971, Pragmatica della Comunicazione Umana, Roma, Astrolabio. Silvia Gravilli Bibliografia Nieves Sánchez Garre Lewis Carroll, escritor de maravillas Los artistas más inventivos, los más sorprendentes, los más excéntricos en sus concepciones, son a menudo hombres cuya vida está serena y minuciosamente ordenada. Ch. Baudelaire Hombre de ciencia y de letras, de docencia y de iglesia, invirtió el orden de sus nombres, Lutwidge Charles, y los tradujo al latín con el resultado de Ludovico Carolus, dándole posteriormente las formas inglesas más afines, que son las conocidas de Lewis Carroll. A partir de entonces y como escribe Santiago Rodríguez Santerbás (1990: 13): Charles Lutwidge Dodgson y Lewis Carroll convertirán, como el doctor Jekyll y mister Hyde, en un solo organismo biológico, pero ejercerán funciones dispares, derivadas de sus respectivas actitudes vitales: el reverendo Dodgson se resignará a envejecer entre los muros del Christ Church; Carroll se negará instintivamente a perder los ambiguos privilegios de la infancia. Así, el creador de dos clásicos de la literatura universal, Alicia en el País de las Maravillas (Alice’s Adventures in Wonderland) y A Través del Espejo (Through the Looking Glass), firmaba las obras de matemáticas con el nombre de Charles L. Dodgson y las obras de imaginación y los libros sobre lógica como Lewis Carroll, Pionero en el arte de la luz y escritor de cuentos “sinsentido”, ha pasado a ser una de las figuras del imaginario colectivo por el enorme interés universal que ha suscitado tanto por su obra como por su personalidad, capaz de interesar a la vez a Russell y a Breton, a Artaud y a Strawson, a Deleuze y a Eddington, a Ryle y a Cortázar. Mostró su interés por el estudio del latín, las matemáticas, las lenguas clásicas y la literatura, además de tomar como modelo a su progenitor, en cuanto a las enseñanzas en materia cristiana. Redactó poemas y relatos cortos y humorísticos con un espíritu observador, crítico, e independiente para entretenimiento de su familia, cosa muy habitual en la época victoriana y, por supuesto, era de esperar que el joven Dodgson se encargara de impulsar la revista familiar. Debemos destacar que el teatro representó una gran pasión a lo largo de su vida y esa capacidad inventiva, no sólo la literaria sino también la mecánica o la lúdica, no le abandonará jamás, e incluso, se la atribuirá él mismo en términos caricaturescos, a algunos de sus seres de ficción. El teatro era comunicación y también un medio educativo, pues consideraba que este tipo de género era muy apropiado para el aprendizaje. De hecho, asistía a él en la compañía de niñas. Con el paso del tiempo, utilizó esta modalidad para defender los valores morales y el debido respeto a la religión. En 1882 dirigió una circular a sus amigos expresándolo de la siguiente manera como nos ha dejado escrito su sobrino Jean Cattègno (1991: 361): Quaderni di comunicazione 10 116 El teatro como lo puede figurar cualquier aficionado, disfruta de una influencia incalculable sobre la sociedad; me parece que cualquier esfuerzo que permita purificarlo y ennoblecer sus objetivos merece el apoyo moral de las más altas autoridades y el apoyo material de las personas de fortuna. Pero también pueden aportar su contribución quienes no son célebres ni ricos… Por tanto, no es de sorprender que en 1880 y con el seudónimo, Lewis Carroll, apareciesen en un periódico para señoras, los textos que se convertirían en “Un Cuento Enredado” estructurado en diez pequeños relatos autónomos, pero vinculados entre sí. Entre la ficción y las matemáticas, las palabras que eran ciencia se convirtieron en juego utilizando las proyecciones de la linterna mágica a la manera de un teatro de títeres con la esperanza de divertir y quizá de instruir a las lectoras de esta revista. El reverendo Dodgson siempre se mostró a favor del progreso y de cualquier avance técnico. Sus creencias religiosas y la manera de llevarlas a la práctica, nos demuestran que era un religioso atípico, ya que por mostrar un ejemplo, no concebía la idea del castigo eterno del infierno. La vida puritana implicaba la renuncia al teatro y éste fue un pasatiempo que jamás dejaría de frecuentar. El matemático y lógico simbólico Se dice de él que como profesor de matemáticas sus clases eran bastante grises y aburridas, aunque se ocupaba de manera eficiente de sus alumnos y el horario que tenía le dejaba tiempo para dedicarse a sus múltiples actividades creativas. Puso sus conocimientos de matemático al servicio de la pedagogía redactando glosarios y libros de ejercicios, de una manera humorística sirviéndose de un lenguaje que no sólo llegaba a los especialistas; tenemos el ejemplo de Euclides y Sus Rivales Modernos, donde describe un proceso en los infiernos en el que Minos y Radamantes juzgan a los antieuclidianos y, de una forma dramática, son enviados por Carroll al infierno de las matemáticas, (Gattègno, 209-210): Si [este libro] se presenta en forma de obras de teatro es, en parte, porque esta forma me parece más apta para exponer de manera alternada los argumentos de los dos bandos existentes. Pero es también para que yo me sienta libre de tratar este tema en un estilo más ligero que el que exige un ensayo, y para que, de este modo, los lectores no científicos se fastidien menos y lo encuentren más aceptable. En ciertos aspectos este libro es un experimento que amenaza fracasar: quiero decir que no he creído necesario mantener de principio a fin el estilo solemne que adoptan generalmente los escritores científicos y que se ha llegado a considerar inseparable de la enseñanza científica. Esta ley inmemorial no me ha parecido nunca particularmente razonable: es verdad que existen temas que por esencia son demasiado serios para permitir la ligereza a quien los trata, pero yo no colocaría la geometría entre ellos. Polifacético autor simultaneaba conocimientos matemáticos, estéticos y artísticos unido con todo aquello que supusiera conjugar la praxis con la fantasía. Para Marina Warner, novelista y ensayista de historia, mitología y arte (1998:21): Carroll transformó el material más cercano de sus propias experiencias en alegres escenas capaces de divertir en cualquier cultura. Y si pudo hacerlo fue debido a su arraigo en otra Lo que las obras lógicas de Carroll muestran es la contradicción entre la exposición rigurosa de una ciencia que es la ciencia del sentido, y la filtración, desde lo subterráneo hasta la superficie, de la corriente del sinsentido. La lógica de Carroll muestra por lo menos dos cosas: que la lógica, obedecida hasta sus últimas consecuencias, lleva a la locura; y que la trasgresión de los principios lógicos constituye una purificación, una cura de sueño. Lógica masturbada por una parte, y violación de la lógica, por otra. Nos sugiere dos ejemplos de la primera acepción, con los diálogos que entabla Alicia con el Caballero Blanco en “A través del Espejo”, y nos invita a reparar en la aplicación inexorable del principio lógico de tercio excluso. La literatura del disparate es una ventana al misterioso reino infantil. Para Lewis Carroll fue algo así como el entorno natural que rodeó su infancia, ya que su padre lo practicó y él mismo lo usó en las revistas familiares para entretener a sus hermanos como hemos venido diciendo. El estilo de Alice’s Adventures in Wonderland, sería el “nonsense”, un campo difícil y resbaladizo, pero el que mejor conocía su autor. Como al respecto escribe Andrè Breton (1972: 117): Extrae su importancia del hecho de que constituye para él la solución vital de una profunda contradicción entre la aceptación de la fe y el ejercicio de la razón, por una parte. Por otro lado, entre una aguda conciencia poética y los rigurosos deberes profesionales. La particularidad de esta solución subjetiva es el doblarse en una solución objetiva, precisamente de orden poético: el espíritu, ante cualquier clase de dificultad puede encontrar una salida ideal en el absurdo. La afirmación de que Alicia en el país de las maravillas es lo que es porque ha sido construido por un lógico, se repite una y otra vez en la mayoría de los libros que se refieren a Carroll. Sin embargo, son muy pocos los que profundizan en ella. W. H. Auden nos dice que uno de los personajes principales de las novelas de Carroll es el idioma inglés. Alicia antes de llegar al País de las Maravillas y antes de pasar Al otro Lado del Espejo, pensaba que las palabras eran objetos pasivos y, de repente, descubre que poseen una vida y una voluntad propias, una variedad infinita tanto de significados como de disfraces. (1) Lewis Carroll se sintió atraído por casi todos los aspectos del lenguaje; es un maestro de los juegos de palabras y del uso de lenguas técnicas. Daniel Kirk (1962:70-137) afirma que es: Lewis Carroll, escritor de maravillas 117 Aunque integró las matemáticas en su vida cotidiana, le corresponde un lugar menor que a la lógica. El cuento creado por Carroll responde no sólo al “nonsense” o falta de sentido, sino también, a un juego matemático de muchas interpretaciones. Recreó algunos de los aspectos más dolorosos de la vida con exquisitos juegos basados en las reglas de la lógica, como la pérdida de la juventud, el miedo a la muerte o la angustia existencial. Percibió el mundo de una manera inocente, infantil, para poner en evidencia lo absurdo e incoherente de la vida de los adultos a través de la obra de Alicia quien descubre que el mundo de los adultos está poblado por locos, o como escribe en el prólogo de su obra Alfredo Deaño (Lewis Carroll: 15): Nieves Sánchez Garre estructura mucho más fundamental, si bien abstracta: las matemáticas y la lógica formal. Jugando continuamente con las reglas del propio lenguaje, y llamando constantemente la atención sobre su ruptura, Lewis Carroll logró que sus fantasías se constituyeran en una burla metafísica del propio significado: el estimulante y liberador disparate. Quaderni di comunicazione 10 118 Un semiólogo desde un doble punto de vista. En primer lugar, porque su vida transcurrió rodeada de signos y su profesión consistía en reflexionar sobre esos signos y su entretenimiento para jugar con ellos: “Dodgso’s everyday life consisted of Thinking about words and mathematical symbols, rules and axioms, postulates and theorems, proofs and manipulation of sings. His everyday world was the meta-linguistic environment of a semeiotician, wether at work or play”. (La vida diaria de Dodgson consistía en pensar sobre las palabras y los símbolos matemáticos, sobre las reglas y axiomas, los postulados y teoremas, sobres las pruebas y la manipulación de signos. Su mundo diario era el entorno metametalingüístico de un semiótico bien fuera trabajando o jugando). En segundo lugar, Kirk da el calificativo de semiólogo a Carroll porque considera que toda la obra escrita por éste refleja esa actitud, como un continuum que tiene sus polos opuestos en la obra técnica sobre las matemáticas y las narraciones infantiles: “at one end of de continuum is the Oxford lecture hall and condensation of determinants, and at the other is the quiet stream an Alice. But connecting the two in a tightly linked chain are all the other pieces Dodgson Wrote. In each his uncommon semeiotic character is to be found”. (En uno de los extremos del discurso está la sala de clases de Oxford y la conservación de determinantes y el otro, es la corriente silenciosa de Alicia pero, conectados los dos en una cadena fuertemente unida, representan todas las obras sobre las que escribió Dodgson. En cadena se encuentra su carácter semiótico poco común). De lo que no cabe duda, es que Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo, se han convertido en un clásico, ocupando un puesto muy destacado en la literatura infantil y también en la literatura universal. A partir de estas dos obras maestras, Lewis Carroll escribió otras obras creativas como La caza del Snark, Rhyme? and reason?, y Silvia y Bruno, al tiempo que publicaba poemas, así como cartas y artículos en periódicos como el Illustrated Times, además de opúsculos, inventivas y folletos; juegos y rompecabezas en prosa y en verso, concebidos para instruir y enseñar. El fotógrafo en la búsqueda de la inocencia Con la economía asegurada Carroll pudo llevar a cabo su manifiesto interés por la fotografía. Redactó un texto titulado Photography extraordinary, en el que aplicó la noción técnica del revelado a la literatura. Se trataba de tres páginas en torno a un juego de palabras, en la que las fotografía le sirvió de pretexto para desarrollar parodias literarias. El 22 de enero de 1856, (2) Carroll pidió a su tío que le consiguiera una cámara fotográfica, para dedicarse a otra ocupación aparte de la lectura y la escritura. El 18 de marzo de ese mismo año adquirió en Londres su primer equipo de fotografía dejando constancia en su diario que estaba preparado para comenzar con este arte incipiente que apenas llevaba diecisiete años de existencia. Además, esta nueva práctica estaba tan en consonancia con la atracción que sentía por el orden y la disciplina, que ordenó sus fotografías en álbumes con sus correspondientes índices, numeró los negativos y las copias; así como conservó un registro fotográfico. Como muchos fotógrafos, utilizó un servicio de revelado que le diese la suficiente confianza y calidad puesto que revelar las placas de cristal llevaba mucho tiempo. Hasta 1864 había reunido alrededor de 2.465 placas al colodión húmedo, aunque no todas han sobrevivido. Cuando se instaló definitivamente en Oxford (1872) se le permitió que levantara un estudio fotográ- A través del visor de su cámara su visión del mundo se podía invertir. Lo que estaba en primer plano ocupaba el lugar del cielo; lo que estaba a la derecha aparecía a la izquierda; las personas aparecían suspendidas cabeza abajo, las cosas grandes quedaban reducidas a escala. Si ajustaba la cámara podía agrandar los objetos pequeños. Giraba el objetivo de la lente y los contornos de los objetos sólidos se disolvían hasta desaparecer. A la luz roja de la habitación oscurecida actuaba otro tipo de magia. La alquimia de las soluciones de revelado hacia que las imágenes aparecieran de la nada; lo invisible se hacia visible, las tres dimensiones se reducían a dos. Ver cómo se revelaba la placa de vidrio constituía una especie de acertijo de tonos contrarios en el que el blanco se convertía en negro y el negro en blanco. Lo positivo se había convertido en negativo; lo negativo en positivo. En el mundo de la fotografía lo pasajero era permanente y lo establecido transitorio. Nada era del todo lo que parecía. El reverendo Dodgson tuvo la posibilidad de relacionarse con los círculos más elevados de la sociedad oxoniense, gracias a la amistad con el poeta Alfred Tennyson y su familia. Con sus álbumes fotográficos que llevaba casi siempre con él, podía mostrar sus habilidades creativas y dar testimonio de sus contactos sociales en el mundo del arte, la literatura y el teatro. Las fotografías de los pintores Arthur Hugues, Henry Holiday, J. Holman Hunt, John Everett Millais, D. G. Rossetti; los escritores Lord Tennyson, John Ruskin, Christina Rossetti y las actrices Ellen, Kate y Marion Terry, eran la excusa perfecta para sus tarjetas de presentación en sociedad y le servían para entablar conversaciones, descubrir nuevos modelos o hacer amigos; algunos de los cuales perduraron toda su vida. Se interesó por la belleza de las personas e intentó explorar y definir la personalidad de sus modelos a través de sus posturas, expresiones y puesta en escena. Entre 1856 y 1880 realizó importantes retratos de obispos, arzobispos, profesores de Oxford, artistas, escritores, actores y actrices. También fotografió a príncipes, cardenales y políticos. Pero sin duda, sus retratos de niñas son los que más le distinguen de sus contemporáneos. Dedicaba mucho tiempo a una sesión fotográfica procurando que Lewis Carroll, escritor de maravillas 119 Nieves Sánchez Garre fico de cristal encima de sus habitaciones, con la seguridad de que lo mismo podía fotografiar a plena luz que con tiempo desapacible. Retrató a sus amigos y sobre todo niñas, en su mayoría las hijas de éstos. Uno de los modelos más distinguidos que fotografió en este recinto fue al príncipe Leopoldo, hijo menor de la reina Victoria, que realizó sus estudios en Christ Church. Este estudio le permitió tener los negativos en su poder sin necesidad de asistir a ningún laboratorio profesional. Con las placas, el cuarto oscuro y a mano, fue capaz de imprimir y revelar de nuevo, algo que no había podido hacer desde sus comienzos. Lewis Carroll descubrió en la fotografía una salida idónea para manifestar sus cualidades en las artes visuales ya que tenía buen ojo para captar la belleza que le rodeaba y un excelente sentido de la composición. La fotografía representaba el equilibrio perfecto entre la ciencia y el arte, la química y la estética, entre la parafernalia de los artilugios y lo práctico; por lo que convirtió esta nueva actividad en su forma de hacer arte. Este molesto y costoso método lo practicó con infinita paciencia y con resultados extraordinarios. El marco conceptual de la fotografía era equiparable a la tendencia de Carroll a lo surrealista y a quien le debió de resultar tremendamente atractivo para la mente de una persona como él (Roger Taylor, 1998:12): Quaderni di comunicazione 10 120 sus modelos se sintiesen a gusto y adoptasen una postura natural y relajada. Con los niños utilizaba su locuacidad y sus anécdotas para distraerles de la complicada mecánica de la toma de las fotografías. Huyó del retoque y convirtió la fotografía en otro medio más para expresarse artísticamente, además de mantener unas prolongadas y afectuosas relaciones con niñas. Conocido es su punto de vista al preguntarle si las niñas no le impacientaban, hecho que resumió Irene Gracia (1999: 60): “Adoro a los niños, con excepción de los niños”; “las niñas “son las tres cuartas partes de mi vida”. Érase una vez un profesor de matemáticas, amante de las niñas, a quienes le gustaba fotografiar, para apresar el tiempo con su cámara y conseguir que aquél instante fuera eterno; quien soñó que su amiguita favorita caía por un agujero negro, que pasaba por el centro de la Tierra al otro extremo del mundo, donde las personas andaban boca abajo y, sobre todo, donde Alice Liddell tendría siempre diez años. Lewis Carroll admiró todos los aspectos de la infancia, pensaba que los niños eran seres puros, que no estaban contaminados por el pecado. Nadie como él fue capaz de captar de forma tan perfecta la esencia de la infancia en la época victoriana, donde disfrazarse y escenificar situaciones era uno de los pasatiempos preferidos. Para él la infancia era mágica y la apreciaba por encima de las demás cosas. Utilizaba juegos de magia y de entretenimiento para conseguir las fotos que deseaba, además de llevar todo tipo de vestimentas y accesorios teatrales para que las niñas se disfrazasen como los personajes de sus cuentos infantiles. Empleaba su cámara para hacer retratos de niñas con una gran sensibilidad y belleza, desarrollando técnicas especiales, además de contarlas con verdadera destreza narrativa (Morton Cohen: 1998: 208): No podía ver a las niñas vestidas de tiros largos. Nunca las dejaba posar a su gusto y no le importaba un comino que tuvieran el cabello alborotado; de hecho, lo prefería. “Me parece que usted no sabe sujetar a una niña inquieta para fotografiarla, escribió el 2 de octubre de 1893 a su amiga la ilustradora Gertrude Thomson”. “Yo la arrincono en la esquina de una habitación, si la fotografío en posición vertical; o en el extremo de un sofá, si está echada”. Sin lugar a dudas, la preferida entre sus pequeñas modelos fue la misma Alice Pleasance Liddell (foto 2) a quien dedicó su novela. Alicia es una pequeña mendiga no demasiado hambrienta ni con frío. También, con unas flores blancas es una princesa de nieve. Todo lo que hacía era traducido en juego y las niñas estaban encantadas con las atenciones que Carroll les otorgaba. También dejaba que entrasen con él en el cuarto oscuro para que observasen la magia que allí sucedía al preparar y revelar las placas. Alice Liddell lo dejó escrito ya de adulta (Luis Maristany, 1987:250): (...) Pero aún resultaba mucho más apasionante poder entrar en la cámara oscura y observarle mientras revelaba las grandes placas de cristal. ¿Podía haber algo más emocionante que ver cómo gradualmente tomaba forma el negativo mientras él lo mecía suavemente de un lado a otro en el baño de ácido? Además, la cámara oscura era tan misteriosa que, para nosotras, allí podía ocurrir cualquier aventura. ¡A todo el encanto de la preparación y la realización se unia el sentimiento de que asistíamos a un secreto (...) Hoy en día no puedo aspirar una sola bocanada del fuerte olor del colodión sin ser transportada inmediatamente en el vuelo mágico del recuerdo al cuarto oscuro de Lewis Carroll, donde, reducida a las proporciones de la infancia, me veo contemplando, boquiabierta, el misterioso proceso de recubrir la placa con la emulsión, o, valiéndome de una caja, sacada de debajo de la pila, apropiada a mis pequeñas dimensiones, el todavía más misterioso proceso del revelado. El serio profesor de Oxford continuaba jugando al teatro como había hecho desde pequeño. Recurría a los disfraces para crear un mundo de fantasía. Portaba un gran baúl lleno de trajes de todo tipo y así las niñas podían disfrazarse de chinas, de campesinas búlgaras, de romanas, de caperucita roja, etc. Agnes Grace Weld, sobrina del poeta Tennyson la disfrazó de caperucita roja (foto 3) y a Xie Kitchin (foto 4), de reina, de china o de rusa. Pero también se atrevió a escribir con una visión crítica de lo que estaba bien y lo que no era tan bueno en el diario Illustrated Times, aparte de publicar en 1857 una divertida parodia titulada Hiawatha’s Photographing (Hiawatha Tomando Fotos), de Longfellow sobre la moda victoriana por la fotografía, inspirada en el héroe indio del poema para transformarlo en fotógrafo. Igualmente escribió The Lady’s History en 1858, donde una dama cuenta cómo un artista que poseía una cámara fotográfica que los hombres la llaman “Quimera”, es decir, una cosa fabulosa y del todo increíble; quiso hacer su retrato y, al no lograrlo, fue arrojado a un calabozo, donde murió y más tarde se transformó en fantasma. En esta obra el héroe describe la belleza de su amada en términos de técnica fotográfica y se supone que Carroll intenta justificar su pasión cuando escribe (Cattègno, 1991:128): Se dice de nosotros los fotógrafos que somos, cuando mucho, una raza de ciegos, que tiene la costumbre de ver en los rostros más hermosos únicamente un juego de sombra y de luz; que admiramos muy rara vez, y nunca llegamos a amar. Se trata de una ilusión que me muero por destruir. Nadie como él fue capaz de captar de forma tan perfecta la esencia de la infancia en la época victoriana. Para Carroll, la infancia era mágica, estaba en el centro mismo de su ser y la apreciaba por encima de las demás cosas, como dejó escrito (Cohen, 1998:264): Cualquiera que haya amado a un verdadero niño conocerá la admiración que uno siente en presencia de un espíritu recién salido de las manos de Dios, sobre el que todavía no ha caído... ninguna sombra de pecado. Lewis Carroll, escritor de maravillas 121 Sin embargo, no todas sus jóvenes amigas querían ser fotografiadas como recuerda Isabel Standel, que le parecía una auténtica “tortura” el posar delante de ese artilugio, según cuenta su biógrafo Morton Cohen (1998: 210-211. Sin embargo, otra de las niñas, Ethel Arnold, sí se dejó retratar y nos lo describe de esta manera: Nieves Sánchez Garre ritual reservado para los adultos! Luego, una vez reveladas las placas, se añadía una emoción nueva, la de ver cómo habíamos quedado en una foto. Viendo ahora estas fotos, es evidente que Mr. Dodgson estaba muy avanzado para su tiempo en el arte de la fotografía y en el de elegir y emplazar a sus modelos. Quaderni di comunicazione 10 122 Artistas de diferentes disciplinas han recreado la obra de este autor multidisciplinar a quien le gustaba beneficiarse con el progreso técnico de la sociedad victoriana y que aun sigue refrescando la vida con su encanto en pleno s. XXI. El estreno de la obra del cineasta Tim Burton que veremos en marzo de 2010, puede servir de pretexto a la exposición fotográfica titulada, “Aprender a mirar el mundo mágico de Lewis Carroll” (3), donde utilicé las fotografías de las niñas que el reverendo realizó para servirme de las actuales tecnologías en la creación de imágenes fotográficas, y dar una nueva interpretación artística a las fotografías obtenidas hace ya un siglo, (foto 5) con el objetivo de confirmar que la ciencia, la tecnología y el arte son propulsores de la evolución cultural, y diferentes maneras que tienen los seres humanos de manifestarse e intentar salir de la caverna de Platón. Foto 1. Lewis Carroll (Óscar Rejlander 1857) Foto 2. Alice Liddell (Lewis Carroll 1858) Lewis Carroll, escritor de maravillas 123 Nieves Sánchez Garre Foto 3. Agnes Grace (Lewis Carroll 1857) Foto 4. Xie Kitchin (Lewis Carroll 1873) Foto 5. “De la iniciación al conocimiento”. Fotomontaje (Nieves Sánchez 1999/2009) Quaderni di comunicazione 10 124 Note 1 Gutiérrez Vega, Hugo: Alicia en la Casa del Poeta y en la Casa de la Paz. [En línea] en http:www. Jornada.UNAM.mx/1999/may/99/990523/sem-columnas.html, p, 4. [Fecha de consulta: 09/ 10/ 2002]. 2 Sanchez Garre, Nieves: Evolución de la fotografía a través de la obra de Lewis Carroll: Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo. Madrid, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, 2004. 3 Exposición fotográfica (1998) realizada con motivo de la celebración del centenario de la muerte de Lewis Carroll. Posteriormente (1999-2002) se desarrolló la exposición itinerante e interactiva “Aprender a mirar el mundo mágico de Lewis Carroll” en un espacio-tiempo de representación, gracias a las ayudas recibidas de instituciones públicas y privadas, a partir de un proyecto pedagógico en el que participaron tanto alumnos como profesores de colegios e institutos de enseñazas públicas y concertadas, desembocando más adelante, en tesis doctoral (2003) dado su carácter científico. Bibliografia Breton, A., 1972, Antología del Humor Negro, Barcelona, Anagrama. Carrol, L., 1971, El Juego de la Lógica y Otros Escritos, Madrid, Alianza Editorial. Cohen, M. N., 1988, Lewis Carroll, Barcelona, Editorial Anagrama. Gattègno, J., 1991, Lewis Carroll México, D. F, Fondo de Cultura Económica. Gracia, I., 1999, Las 1.001 Alicias, Madrid, Diario El Mundo. Kirk, D. F., 1962, Charles Dodgson Semeiotician, Estados Unidos, University of Florida Press. Maristany, L., 1987, Cartas a Niñas, Barcelona, Plaza & Janés. Rodríguez, S. S., 1990, Lewis Carroll: Espejo Deformante de la Inglaterra Victoriana, Madrid, Revista Clij, año 3, nº 22. Taylor, R., 1998, Lewis Carroll y la Fotografía “Esa Otra Ocupación”, Madrid, Catálogo Exposición Centenario de la Muerte de Lewis Carroll. Madrid, Círculo de Bellas Artes, British Council. Warner, M., 1998, El Disparate es Rebelión: el Juego de Niños de Lewis Carroll, Madrid, Impresiones, Revista British Council. Sergio Duma Nei labirinti del sé femminile: Peggy Guggenheim, Anaïs Nin e Fernanda Pivano L’esistenza, con gli avvenimenti che si dipanano nel corso del tempo, può essere considerata un labirinto dai complicati meandri (almeno per ciò che concerne vite particolarmente intense). Anche le narrazioni, da questo punto di vista, nei loro esiti più riusciti, potrebbero essere definite nello stesso modo. E le autobiografie, in particolare, costituiscono veri e propri labirinti narrativi. Leggendoli ci addentriamo nelle anime tortuose di coloro che li hanno scritti. L’immagine del labirinto è rilevante se pensiamo ai surrealisti che alle intricate strutture dei mondi interiori hanno dedicato particolare attenzione. E quando si parla di surrealismo non si deve solo pensare a Max Ernst o a Salvador Dalì, tanto per fare qualche nome, ma anche ad interessanti personaggi femminili che con il surrealismo (e con il dire di sé) hanno avuto molto a che spartire. Questo breve intervento, quindi, si concentrerà su tre donne diverse ma, come vedremo, con collegamenti e analogie. Donne che, al di là delle loro molteplici attività, sono ricordate anche per aver scritto affascinanti autobiografie. La Musa dei Surrealisti Quando si ragiona sulle arti figurative del Novecento e sulle rivoluzioni estetiche, espressive e comunicative rivoluzionarie che hanno rappresentato, è inevitabile nominare l’americana Peggy Guggenheim. Nata nel 1898 da una ricca famiglia ebrea di industriali americani, entrò in giovane età, per una serie di vicissitudini familiari, in possesso di un ingente patrimonio. Inquieta, ribelle, stravagante, decise di abbandonare gli studi e di recarsi in Europa, sulla scia di numerosi compatrioti, i cosiddetti ‘espatriati’, rappresentanti della ‘Lost Generation’, che vedevano nella più disinvolta società europea una via di fuga dal conformismo e dal moralismo statunitensi. In Europa vi rimase circa vent’anni, facendo la spola tra Londra e Parigi, e frequentando nomi leggendari del panorama artistico dell’epoca. Di tali ambienti divenne presto la regina e investì le sue fortune dedicandosi alla collezione di opere d’arte. Ma collezionò, in un certo senso, anche artisti, divenendo amante di molti di essi, comportandosi da autentica ‘musa inquieta’, come in seguito venne soprannominata. Nel 1941, momenta- Quaderni di comunicazione 10 126 neamente ritornata negli Stati Uniti, organizzò con la sua collezione la mostra ‘Art of this Century’, diventata presto internazionalmente famosa, in quanto costituiva l’unica raccolta esauriente delle correnti d’avanguardia degli inizi del secolo scorso fino agli anni quaranta. Quando in seguito, nel 1948, espose tale collezione alla Biennale di Venezia, si innamorò della splendida città e vi si stabilì perennemente, acquistando il Palazzo Venier dei Leoni, affacciato sul Canal Grande, e ne fece una vera e propria casa-museo, aperta al pubblico tre giorni alla settimana. E da allora la Guggenheim fu definita, da coloro che la conoscevano e frequentavano, ‘l’ultima dogaressa’. Tuttavia, se Peggy non avesse scritto nel 1946 un libro, ‘Out of this Century’, forse, al di là di qualche aneddoto, non avremmo saputo molto della sua personalità. Il testo è in effetti importante perché ci fa comprendere non solo gli sviluppi artistici dei primi decenni del Novecento ma anche l’evoluzione caratteriale ed esistenziale di una donna indubbiamente fuori dal comune. Una donna che, già adolescente, dimostra di sopportare a malapena la rigida educazione ricevuta, e tale insofferenza la spinge a frequentare personalità eccentriche, almeno secondo la mentalità corrente dell’epoca, e che la porta a farsi deflorare minorenne da colui che diventerà il suo futuro marito, lo scrittore Laurence Vail. Va detto che molte parti di ‘Out of this Century’ andrebbero prese con il beneficio del dubbio, dal momento che, sin dal principio, la Guggenheim dichiara di avere una pessima memoria e di non ricordare quasi nulla del suo passato (e forse tale ambiguità vale per ogni autobiografia). Ma, stranamente, la musa surrealista dalla memoria corta descrive con dovizia di particolari i primi flirt, le ribellioni, le discussioni con i genitori e anche episodi come la perdita della verginità, al punto che ci si può chiedere cosa sia vero e cosa non lo sia. Sullo sfondo, però, del labirinto narrativo, si intravedono squarci di una società privilegiata, vero e proprio mondo dorato (specie se consideriamo che lo spettro delle prime crisi economiche era alle porte) rispetto al resto degli Stati Uniti. Dopo il matrimonio, Peggy, tra un aneddoto e l’altro, descrive l’ambiente artistico legato al surrealismo e il testo serve a comprendere la nascita e lo sviluppo di tale movimento. I personaggi che si avvicendano nelle pagine del libro sono incredibili: Max Ernst, Salvador Dalì, Man Ray, Yves Tanguy, e così via. Ma non ci sono solo surrealisti. Non esente dal gusto per il pettegolezzo, Peggy ci descrive un James Joyce perennemente ubriaco, un Ezra Pound scontroPeggy Guggenheim so, un giovane e timido Samuel Beckett Nei labirinti del sé femminile: Peggy Guggenheim, Anais Nin e Fernanda Pivano 127 Sergio Duma innamorato di Lucia, la figlia pazza di Joyce, e così via. E, dietro la superficie dell’aneddoto curioso, Peggy, in un certo qual modo, si tradisce, rivelando, suo malgrado, personali difetti e idiosincrasie, simpatie ed antipatie. Dimostra di non apprezzare Nora Joyce, la moglie del celebrato autore di ‘Ulysses’ (1922), da lei considerata volgare. Detesta le stravaganze di Dalì e il servilismo della sua compagna Gala. A tratti si lascia sfuggire di non sentirsi attraente, quando ha a che fare con l’amante di Max Ernst, la modella Kiki De Montparnasse. E, più in generale, confessa di non sopportare l’egocentrismo degli artisti e arriva a scrivere che una persona che intende organizzare una mostra con personaggi così pieni di sé dovrebbe essere rinchiusa in manicomio. Ma in ‘Art of this Century’, in effetti, si riscontra una contraddizione che, evidentemente, era parte della sua personalità: la Guggenheim era una donna certamente affascinata dalla trasgressione; ma nello stesso tempo indispettita dalla mancanza di forma che spesso molti artisti rivelavano. E, in seguito, uno scrittore acuto come William Burroughs (che avrà pessimi rapporti con Peggy) dirà che è ridicolo frequentare artisti geniali e fuori dagli schemi e pretendere che si comportino come lord inglesi (la Guggenheim, nei tardi anni sessanta, aveva scacciato da Palazzo Venier dei Leoni il poeta beat Allen Ginsberg e il suo compagno Peter Orlovsky perché quest’ultimo, a tavola, aveva gettato un tovagliolo a Ginsberg invece di porgerglielo normalmente!). Dalla sua autobiografia, inoltre, ricaviamo un altro importante aspetto del suo carattere: la gelosia. Malgrado le sue bizzarrie, Peggy si rivela simile a una donna qualsiasi, sconvolta dai continui tradimenti del marito, pronta a spiarlo, in poche parole, comportandosi come una qualunque moglie frustrata e non come la collezionista disinibita che andava a letto con Max Ernst o, negli anni cinquanta, con Jackson Pollock e altri. Ed era capace di fare dispetti meschini. Il secondo matrimonio con Max Ernst è significativo. Peggy scrive pagine e pagine sul suo conto, esprimendo tutta l’ammirazione che prova nei confronti dell’artista, ma non risparmiandogli frasi al vetriolo, in particolare quando si addentra nella descrizione della relazione che Ernst avrà con la donna che successivamente sarà la sua nuova compagna, Dorothea Tanning (altra figura celebre del surrealismo), che si presenterà una sera a una festa con i lunghi capelli di color turchese e il seno nudo ricoperto da foto che ritraggono il pittore. Il divorzio e le innumerevoli controversie legali che ne seguiranno sono narrati con una cura maniacale dei dettagli ed è esilarante leggere della causa che Peggy intenterà a Max Ernst per il possesso di alcuni barboncini (aneddoto che sembra uscito da un racconto surrealista!). Tuttavia, al di là di questi aspetti che costituiscono il ritratto di una donna intelligente ma a volte insicura, in ‘Art of this Century’ si intravedono altri particolari. Il suo lato materno, per esempio. Anche se dei figli parla poco e a volte anche con distacco, si intuisce l’apprensione che, in diversi momenti della sua vita, la Guggenheim prova nei confronti dell’infelice figlia Pegeen, affetta da depressione (e che, anni dopo l’uscita dell’autobiografi a, si suiciderà). È qui che si percepisce il lato più umano, oserei dire intimo, di Peggy. E tale umanità è presente nell’ultima parte dell’autobiografia, dedicata a Venezia. Forse le pagine che descrivono le lagune, gli antichi palazzi, l’architettura veneziana, le gondole, sono le più suggestive ed è in questa sezione che la Guggenheim dimostra di possedere notevoli capacità di scrittura (la prima Quaderni di comunicazione 10 128 edizione di ‘Out of this Century’ non fu accolta favorevolmente dalla critica, che liquidò l’opera come il passatempo di una ricca viziata capace solo di descrivere cene, feste e storie di sesso e solo in seguito è stata rivalutata). Malgrado sia ancora oggi ricordata come la donna fotografata da Man Ray che sfoggia assurdi orecchini inventati da Tanguy, avvezza a guidare automobili abbellite da sculture di Giacometti e che si spostava a Venezia su una gondola appositamente costruita per lei, in realtà Peggy Guggenheim ci ha donato, con la sua autobiografia, il ritratto di una donna eccezionale ma spesso fraintesa. Curiosamente, anche Peggy era capace di fraintendere e non riuscì a comprendere la grandezza di un’altra importante personalità femminile del Novecento, la scrittrice Anaïs Nin, che scrisse opere surrealiste, e che ancora oggi alcuni ricordano come amante di Henry Miller (senza sapere che l’autore dei ‘Tropici’ era stato influenzato ed aiutato da lei e non viceversa, come molti si ostinano ad affermare, e che per giunta era stata sua amante solo per un breve periodo). Nell’introduzione all’edizione italiana di ‘Out of this Century’, pubblicata con il titolo ‘Una Vita per l’Arte’, lo scrittore Gore Vidal, amico di entrambe, narra di una conversazione avuta con Peggy proprio riguardo ad Anaïs. Ed è sempre Vidal a rivelarci che la Guggenheim definì in quell’occasione la Nin, ‘una stupida’. Dal canto suo, nemmeno la Nin, nel suo monumentale diario in sei volumi, esprimerà grande simpatia per Peggy, descritta come un’egoista pronta a sostenere solo gli artisti disposti ad adularla (e bisogna aggiungere che, nell’autobiografia della Nin, Peggy Guggenheim viene citata pochissimo, trattata alla stregua di una figura secondaria nell’ambito dell’arte del Novecento). Ma se tale atteggiamento è prova di un carattere difficile come e più di quello di Peggy, il suo diario non è assolutamente il prodotto di una stupida. E ciò mi conduce alla seconda donna da me scelta per questo intervento: Anaïs Nin, appunto. Figlia dell’Incesto Se Peggy Guggenheim fu a volte fraintesa, lo stesso si può dire per la bellissima Anaïs Nin, da molti considerata più erotomane che scrittrice (o, peggio ancora, pornografa). Questo a causa della sua vita trasgressiva e della spregiudicatezza sessuale che la caratterizzava. In realtà, fu trascurata anche perché la sua raccolta di racconti, ‘Under A Glass Bell’ (1950), nonché i romanzi ‘The House of Incest’ (1936), ‘Cities of the Interior’ (1959), ‘Ladders to Fire’ (1946), ‘A Spy in the House of Love’ (1954), e altri, non erano di facile leggibilità, influenzati dal surrealismo che non aveva mai veramente catturato l’attenzione dei critici americani e del pubblico statunitense in generale. Ed è curioso notare che i libri a tutt’oggi più letti (e venduti) della Nin sono ‘Delta of Venus’ (1977) e ‘Little Birds’ (1979), due raccolte di racconti pornografici, scritti dalla Nin per motivi economici, su richiesta di un ricco mecenate, e che l’autrice non aveva mai pensato di pubblicare (saranno infatti i suoi editori a stamparli dopo la sua morte, avvenuta nel 1977) e che non rendono giustizia al suo talento di scrittrice. Esotica, affascinante, la Nin era conosciuta per essere stata l’amante di Henry Miller (e di una delle sue mogli, June), dello psicanalista Otto Rank e di svariati Nei labirinti del sé femminile: Peggy Guggenheim, Anais Nin e Fernanda Pivano 129 Sergio Duma artisti; ma fu un nome di spicco degli ambienti artistici parigini frequentati dai surrealisti. In verità, la sua opera fondamentale è costituita dalle oltre quindicimila pagine del suo diario, scritte in un arco di tempo che va dai primi anni venti fino ai tardi anni sessanta. Per molto tempo, tuttavia, nessuno ne saprà nulla e la Nin non farà altro che pubblicare i suoi romanzi di scarso successo; solo in seguito, però, diventata celebre per i suoi comportamenti scandalosi, si verrà a conoscenza del diario che verrà pubblicato, come ho già scritto, in sei volumi tra il 1966 e il 1976, che narrano la sua vita dal 1931 al 1966 (le sezioni relative agli anni venti sono state omesAnaïs Nin se). Ovviamente questi sei volumi non sono stati pubblicati integralmente; fu la stessa Nin a selezionare le pagine, tralasciandone diverse per non mettere in imbarazzo persone all’epoca ancora vive. Può anche darsi (e se ne discute ancora al riguardo) che il diario sia stato rimaneggiato dal revisore Gunther Stullmann e peraltro lo scrittore Gore Vidal, come abbiamo visto, amico della Guggenheim (nonché uno degli innumerevoli amanti della Nin), nel suo ‘Palimpsest: A Memoir’ (1995), afferma che Anaïs tendeva, anche a parecchi anni di distanza, a riscrivere varie pagine dei diari, adattandole al suo mutevole stato d’animo. Anche in questo caso, quindi, l’autobiografia di Anaïs, come quella della Guggenheim è ambigua; e ci si può legittimamente chiedere dove finisca il ricordo e dove incominci la fiction. Ci sono però particolari che differenziano l’opera della Nin da quella della Guggenheim. Innanzitutto, lo stile. Pur brillante, la Guggenheim non è assolutamente paragonabile ad Anaïs Nin. La scrittura di quest’ultima è musicale e poetica, specie nei primi volumi del diario, e, in un certo senso, potrebbe far pensare agli esiti migliori della cosiddetta prosa d’arte. Per giunta, non mancano, naturalmente, influssi surrealisti, suggestioni della psicoanalisi, giochi di parole, influenze dello ‘stream of consciousness’, una miscellanea di stili, insomma, che ben descrivono i meandri della psiche dell’autrice. Effettivamente Anaïs Nin ricorre spesso alla metafora del labirinto per rappresentare il flusso dei ricordi. Se l’autobiografia della Guggenheim, infine, è ricca di aneddoti e pettegolezzi, non si può dire lo stesso del diario della Nin. Non mancano, certo, pagine dedicate a scrittori, artisti, poeti, amanti; ma il lettore che vorrebbe conoscere particolari piccanti della vita di una donna chiacchierata rimarrebbe deluso. Nel diario, in definitiva, la Nin descrive la sua anima, esprimendo opinioni sull’arte, sul ruolo della donna nella società, sulla psicoanalisi, sull’esistenza in generale. Di tanto in tanto, però, appare a più riprese una figura importante, quella di Joaquin Nin, suo padre. Se si leggono i sei volumi del diario, non si riesce a comprendere molto di lui. Ma la reticenza della Nin è già una forma significativa di confessione: si Quaderni di comunicazione 10 130 intuisce che il rapporto con Joaquin non è stato facile e l’argomento non è gradito alla scrittrice. Basandoci sul diario, si sa che il padre, celebre pianista e donnaiolo incallito, aveva abbandonato la famiglia quando Anaïs era bambina e tale abbandono le aveva provocato un trauma. Effettivamente, Anaïs, nel diario, esprime tra le righe la sofferenza di una ragazza costretta a crescere priva di guida paterna. Ma, come si scoprirà nel 1992, le cose erano più complicate. È in quest’anno infatti che viene pubblicato ‘Incest’, libro che costituisce un’altra sezione dei diari, che la Nin, forse comprensibilmente, aveva a suo tempo omesso. In questo volume la Nin scrive del suo incontro con Joaquin, avvenuto quando ormai Anaïs non è più bambina, ma una bellissima e smaliziata donna già avvezza a fare innumerevoli esperimenti di tipo sessuale. I due si riavvicinano e Anaïs, ancora piena di rancore, deciderà di sedurre il genitore, per poi vendicarsi abbandonandolo. La cronaca impietosa di questo incesto getta nuova luce sulla figura già discussa della Nin e anche il romanzo surrealista ‘House of Incest’ viene riletto, quindi, con il senno di poi, come metafora di un incesto realmente accaduto. Anaïs Nin, dunque, è stata, anche più della Guggenheim, una donna che non ha nascosto quasi nulla di sé e che ha usato la scrittura per esprimere ogni sfaccettatura della sua personalità. E se Peggy era una donna che, malgrado il rigido ambiente di provenienza, amava le stravaganze; e se la Nin fu cresciuta da una madre fervente cattolica e, non curandosi di ciò, visse un’esistenza anticonvenzionale, c’è una terza donna che vorrei citare. Una donna borghese, figlia di facoltosi borghesi, ma che non ha vissuto da borghese, pur non raggiungendo i livelli di trasgressione di Peggy e di Anaïs. Una donna che, guarda caso, ha incontrato entrambe (nonché numerosi artisti e scrittori). Una donna conosciuta per la sua attività di traduttrice e divulgatrice della letteratura americana e che, recentemente, ha pubblicato il primo volume della sua autobiografia: Fernanda Pivano. Signorina Anticonformista di Buona Famiglia Fernanda Pivano Nei tardi anni sessanta, Fernanda Pivano incontra Anaïs Nin in una libreria di New York. Parlano per un po’, specialmente dei poeti beat, e la Nin si comporta, come dichiara la stessa Pivano (rammaricata per il fatto di non avere avuto in seguito occasione di rivederla), con estrema simpatia e cordialità. Anni dopo, in compagnia del marito, l’artista Ettore Sottsass, la Pivano conosce la celebre Peggy Guggenheim, affascinata dai quadri di quest’ultimo. Gli chiede un quadro in regalo ma, sfortunatamente, tale quadro è il preferito di Fernanda che impedisce al consorte di donarlo a Peggy. Si rivelerà un grave errore poiché la Guggenheim si offende e non si occuperà più di lui. Questi sono solo due degli Nei labirinti del sé femminile: Peggy Guggenheim, Anais Nin e Fernanda Pivano 131 Sergio Duma aneddoti che Fernanda Pivano ha raccontato nel corso della sua incessante attività letteraria. Allieva di Cesare Pavese, grazie a lui si innamora della letteratura americana (in un periodo in cui il fascismo aveva proibito le opere degli scrittori statunitensi) e, in particolare, di Fitzgerald e di Hemigway. Sarà proprio il suo contratto per la traduzione di ‘Farewell to Arms’ (1929) per conto dell’Einaudi a metterla nei guai con i nazisti che spadroneggiano in Italia. E solo dopo la guerra, Nanda, come è affettuosamente chiamata dagli amici e dagli estimatori, riesce ad incontrare il maturo scrittore americano, dando vita a un sodalizio che si protrarrà fino alla tragica morte dell’autore. E negli anni cinquanta, oltre alle traduzioni di Hemingway, Faulkner o Dos Passos, Fernanda Pivano sarà la prima in Italia a far conoscere la ‘Beat Generation’, movimento che allora nessuno comprendeva; e da quel momento il suo nome sarà indissolubilmente legato a quello dei beat. Per anni frequenterà un tormentato e alcolizzato Kerouac, un Allen Ginsberg sotto l’effetto degli allucinogeni, un Gregory Corso tormentato da gravi problemi di droga, tanto che ci si potrebbe chiedere, ma cos’ha a che spartire una signora borghese con personaggi di questo genere? Delle sue origini borghesi Fernanda Pivano, nel primo volume del suo diario, non fa mistero. In un certo senso, rivendica l’educazione da ricca signorina di buona famiglia impartitale da un padre autorevole e una madre tradizionalista, consapevole del suo ruolo di moglie, nella Genova dei primi del Novecento. Ma, al di là di ciò, sin da bambina la Pivano rivela quell’anticonformismo che, a conti fatti, la porterà, crescendo, a frequentare e a sostenere artisti stravaganti e sempre attaccati dall’establishment dell’epoca. La sua insaziabile curiosità l’aiuterà a comprendere la grandezza e la validità di determinate esperienze artistiche. Come nel caso della Guggenhein e della Nin, anche il suo diario è però fonte di perplessità; nel senso che la Pivano, nelle sue pagine, rivela una maniacale tendenza a descrivere infinitesimali dettagli relativi alle pietanze gustate da Hemigway, all’arredamento delle abitazioni dei vari scrittori, e così via. Potremmo quindi pensare che sia stato scritto con l’ausilio di appunti conservati nel corso degli anni; se non fosse che già nel suo ‘Amici Scrittori’ (1995), la Pivano iniziava il libro affermando di non aver mai posseduto un diario poiché un giorno, negli anni cinquanta, mentre si accingeva a redigerne uno, fu sarcasticamente rimproverata da Eugenio Montale perché ‘troppo giovane per scrivere un diario’. Qual è la verità, allora? La Pivano ha una memoria prodigiosa? O forse, probabilmente, i ricordi sono trasfigurati da una notevole capacità inventiva e narrativa? Sia come sia, il diario della Pivano è avvincente. Partendo dall’infanzia nella Genova umbertina, con i primi interessi artistici, rappresentati soprattutto dalle lezioni di pianoforte, la Pivano ci descrive la sua vita piena di vicissitudini, non tutte allegre. L’orrore della guerra è ricorrente nelle pagine dell’opera; in particolare la tragedia del periodo fascista e dell’alleanza con i nazisti è espressa dalla Pivano con grande intensità. E sono forse questi orrori a spingerla verso il pacifismo, caratteristica che la contraddistinguerà per tutta la vita, e che la porterà a sostenere in seguito la rivoluzione non violenta dei suoi amici beat. Nel diario, comunque, la Pivano non descrive solo l’evoluzione della sua personalità, ma anche i mutamenti della società italiana del Novecento, dalla relativa tranquillità dei primi anni del secolo, alla dittatura del ventennio, agli anni difficili della ricostruzione di Quaderni di comunicazione 10 132 un paese che ha perso la seconda guerra mondiale, fino al boom economico degli anni sessanta. Lo stesso vale per la società americana che la Pivano ha avuto la fortuna di osservare in prima persona, partendo dal suo primo soggiorno statunitense negli anni cinquanta, in un paese che già iniziava ad essere sconvolto dalle trasgressioni beat. Con l’evolversi dell’America, si evolve anche la stessa autrice. Pur rimanendo sempre una signora borghese, passa in maniera disinvolta dai discorsi sofisticati con Hemigway alle sfrenate serate parigine con Ginsberg, Corso e Orlovsky, fino ai concerti di Bob Dylan, alla Londra dei Beatles, agli happening della generazione hippy a San Francisco in piena era ‘Flower Power’. In ogni occasione, la Pivano non dà mai giudizi; anzi, cerca di comprendere gli atteggiamenti spesso sopra le righe degli artisti da lei frequentati, peraltro riuscendoci. Non mancano pungenti aneddoti sui funzionari delle case editrice nostrane, non sempre pronte a capire la validità di determinati scrittori, o del mondo accademico italiano (le università, è noto, non sono mai andate a genio alla Pivano). Il diario ci presenta una galleria di personaggi celeberrimi della cultura e dell’arte, ma sempre con una particolare attenzione al lato umano: il tormentato Cesare Pavese, perseguitato dai fascisti, che le farà leggere Edgar Lee Masters, facendole comprendere la differenza tra letteratura americana e letteratura inglese; l’ironia sarcastica di William Faulkner, ospite nella villa di un’aristocratica; la disperazione di Tennesse Williams, il più grande autore teatrale americano del Novecento; i tormenti di Ernest Hemingway, da lei affettuosamente chiamato ‘Papa’; la gentilezza di Alice B. Toklas, segretaria e compagna di Gertrude Stein, morta in miseria in una fredda casa parigina; gli sbalzi di umore di Jack Kerouac; la tranquillità quasi zen di Henry Miller; la calma serena di Allen Ginsberg; la freddezza scostante di William Burroughs; le terribili sfuriate di un irrefrenabile Gregory Corso; l’ostentata sicurezza di sé di Norman Mailer; la severità e la diffidenza di Ezra Pound. Ma questi sono solo alcuni dei nomi citati e analizzati nell’autobiografia. Ma ci sono anche altri personaggi che hanno rivestito un’importanza fondamentale nella sua vita. Innanzitutto, il padre di Nanda, donnaiolo e grande uomo di cultura, letteralmente idolatrato dalla figlia; il fratello Franco, morto a causa di una grave malattia; la madre di Nanda, che lentamente muore di malinconia, segnata dalla perdita del figlio; e infine il geniale artista Ettore Sottsass, suo marito, l’uomo che però la farà soffrire con i suoi tradimenti. Le pagine riguardanti il lento deteriorarsi del matrimonio sono le più intense e autentiche e in queste sezioni del diario la Pivano si confessa, senz’altro in maniera più estrema e sincera della Nin o della Guggenheim; così come autentiche sono le pagine dedicate agli straordinari viaggi compiuti dalla coppia, in posti allora ancora esotici, sulla scia degli instancabili beat che viaggiavano in continuazione. Le descrizioni della Valle dei Re a Luxor, per esempio; di Bangkok, Singapore, Bali, Samoa, Tahiti e delle zone più inaccessibili del Marocco, dove la Pivano e Sottsass cercano di emulare la celebre coppia di coniugi scrittori Paul e Jane Bowles, possono, a mio avviso, essere accostate alle migliori pagine degli scrittori anglosassoni di viaggi, forse modelli inconsapevoli della Pivano. Anche se, lo ripeto, Peggy Guggenheim, Anaïs Nin e Fernanda Pivano, malgrado le analogie, restano comunque donne diverse tra loro, possono essere messe in relazione per la sincerità che le ha spinte a dire tutto (o quasi) di sé, con una Guggenheim, P., 1946, Out of this Century, New York, Universe Books; trad.it., 1998, Una Vita per l’Arte, Milano, Rizzoli. Nin, A., 1966, The Diary of Anaïs Nin 1931-1934, Washington, Harvest Books; trad.it., 2001, Diario I – 1931-1934, Milano, Bompiani. Nin, A., 1967, The Diary of Anaïs Nin 1934-1939, Washington, Harvest Books; trad.it., 2001, Diario II – 1934-1939, Milano, Bompiani. Nin, A., 1969, The Diary of Anaïs Nin 1939-1944, Washington, Harvest Books; trad.it., 2001, Diario III – 1939-1944, Milano, Bompiani. Nin, A., 1971, The Diary of Anaïs Nin 1944-1947, Washington, Harvest Books; trad.it., 2001, Diario IV – 1944-1947, Milano, Bompiani. Nin, A., 1974, The Diary of Anaïs Nin 1947-1955, Washington, Harvest Books; trad.it., 2001, Diario V – 1947-1955, Milano, Bompiani. Nin, A., 1976, The Diary of Anaïs Nin 1955-1966, Washington, Harvest Books; trad.it., 2001, Diario VI – 1955-1966, Milano, Bompiani. Pivano, F., 1995, Amici Scrittori, Milano, Mondadori. Pivano, F., 2008, Diari 1917, 1973, Milano, Bompiani. Vidal, G., 1995, Palimpsest: A Memoir, New York, Penguin; trad.it., 2000, Palinsesto, Roma, Fazi. Nei labirinti del sé femminile: Peggy Guggenheim, Anais Nin e Fernanda Pivano 133 Bibliografia Sergio Duma schiettezza superiore a quella di qualsiasi scrittore uomo (ma di questo si potrebbe discutere a lungo) e senz’altro possono essere annoverate tra coloro che hanno avuto il coraggio di addentrarsi nel labirinto intricato della propria anima. Angelo Semeraro Il naso di Darwin C’è sempre qualche ardente allievo di Lavater, il padre della fisiognomica, sulla strada di ogni età verde, la più propizia per spiccare il volo dal nido familiare e avventurarsi nel mondo. Capitò anche a Darwin quando, mosso dal desiderio di imbarcarsi sul Beagle per una forte propensione all’osservazione e all’avventura, si trovò innanzi a un fermo divieto paterno, convintosi anche lui che il naso di Charles rivelasse con tutta evidenza la mancanza di “energia e determinazione sufficienti per quel viaggio” (Giorello, in Intr. alla Autobiografia). Quale foggia e proporzioni debba avere un naso per esprimere determinazione è questione che attende più precise indagini. Sta di fatto però che il dr. Robert, figlio a sua volta di Erasmus, uno dei precursori della moderna teoria dell’evoluzione, avvalendosi di quella perentoria affermazione dell’anonimo allievo del Lavater (un amico di famiglia o un parente, probabilmente), trasse ulteriori argomenti per vietargli quel viaggio. Ci sarebbero volute mediazioni forti e influenti per farlo poi desistere da quella prima energica ingiunzione. Altri segni negativi sembravano scoraggiare l’ardente vocazione scientifica di Charles. Non solo il naso, ma la stessa conformazione della testa fu oggetto di osservazione di esperti frenologi, pronti a scommettere – a beneficio degli orientamenti paterni – che in essa fosse così tanto sviluppato il bernoccolo della religione “che sarebbe stato sufficiente per dieci preti”. L’amor paterno – si sa – è di per sé temibile, tanto almeno quanto una vituperabile negligenza nell’accudimento materiale e spirituale dei figli. Sta di fatto, che pur di sottrarre Charles ai rischi di una vita oziosa, e per bene inclinare quella giovane vita che sembrava promettere solo vagheggiamenti e dissolutezze, il dr. Robert maturò la decisione di farne un buon pastore evangelico. Fallendo in quell’intento, tentò successivamente di incanalar- Quaderni di comunicazione 10 136 lo nel suo stesso ramo, avviandolo agli studi di medicina. Fortunatamente però l’interesse per le scienze naturali prevalsero tanto sui dogmi della chiesa anglicana che su quello stesso mestiere a cui, più o meno confessatamente, ogni genitore tende di inclinare i propri figli, rendendone tuttavia incerti gli esiti professionali, e assai spesso insoddisfatte le loro vite ripetitive. Una teoria su cui lavorare Senza quel viaggio sul Beagle che ne avrebbe fatto un “eroe per caso” e che si sarebbe rivelato la scelta “più importante” della sua vita, ossia la rivendicazione della sua piena libertà nei confronti delle tradizioni nazionalistiche e utilitaristiche del XVIII sec. che avevano condizionato la sua educazione, la genialità di Charles non si sarebbe affermata, e la teoria dell’evoluzione sarebbe forse rimasta al livello in cui l’avevano lasciata Lamarck, le cui teorie sull’adattamento, l’evoluzione della specie e le cause di questa evoluzione non avrebbero mai convinto Darwin, o al livello conciliatorio del nonno Erasmus, che era stato il portavoce di quel periodo di grandi euforie in cui l’Europa era stata trasportata dai viaggi e gli scambi ultraoceanici, dalla conoscenza di animali e piante sconosciute. L’Autobiografia, insieme al Journal, i taccuini del Beagle Diary su cui annotava le prime impressioni durante le escursioni sulla terra ferma, e il corposo epistolario rappresentano quindi, al di là di ogni altra considerazione sul valore del lavoro di osservazione condotto progressivamente a metodo, il cammino progressivo della emancipazione di Charles dai paralleli interessi familiari. La rivendicazione di una decisa indipendenza intellettuale tanto dal nonno Erasmus che “aveva alzato in Europa la bandiera dell’evoluzione”, secondo Nora Bardow, curatrice dell’edizione completa dell’Autobiography pubblicati solo nel 1958, quanto dalla forte personalità del padre, incline alla speculazione su ogni argomento, lo spinsero “istintivamente” alla ricerca delle “prove tangibili” di una teoria dell’evoluzione. L’emancipazione dai condizionamenti di un ambiente familiare protettivo non poteva che passare attraverso una rottura, che per sua indo- Se avessi lavorato come ha fatto Lyell nel campo della geologia, cioè raccogliendo tutti i fatti che hanno avuto relazione con la variazione degli animali e delle piante sia allo stato domestico sia in natura, avrei potuto portare qualche luce sull’argomento. (Autobiografia p.101). Ogni indizio assume valore straordinario, e Charles è sempre pronto con uno scatto di penna ad annotarlo. Per il momento è l’occhio che lavora e si affina, educandosi alla non prevaricazione del campo visivo oltre il visibile e constatabile. Non ignora il dibattito sulle “scienze induttive” che si stava svolgendo tra filosofi e scienziati; sa bene che ogni generalizzazione va lasciata da parte, o quanto meno passata al setaccio di un meticoloso controllo sperimentale. Sa che la selezione è “la chiave con cui l’uomo era riuscito a ottenere razze utili di animali e piante”, ma gli resta ancora da capire l’incomprensibile, il come “si potesse applicare a organismi viventi” il principio della selezione naturale (p.101). Monta e smonta ipotesi per circa un anno e mezzo in quel “lungo ragionamento”, finché “l’illuminazione decisiva” non gli arriva il 28 settembre del 1838 – data che puntualmente annotata – dal saggio sulla Popolazione di Malthus. Nella lotta per l’esistenza cui ogni essere è sottoposto [...] le variazioni vantaggiose tendono a essere conservate, e quelle sfavorevoli a essere distrutte. Ecco l’uovo di Colombo! Ecco ora pronta “una teoria su cui lavorare”. Ci vorranno venti anni di incubazione. L’Origine della specie viene alle stampe nel 1859, in coincidenza col suo cinquantesimo compleanno. Il naso di Darwin 137 Angelo Semeraro le Charles cercò di attenuare il più possibile evitando di pubblicare qualsiasi cosa riguardasse l’evoluzione prima della morte del padre. L’Autobiografia conserva intatto il clima interiore del giovane scienziato che a quell’evoluzionismo che già “si respirava nell’aria” avrebbe recato il valore aggiunto del principio di “selezione naturale”, la più audace e innovativa tra le sue teorie, a proposito della quale Nora Barlow evocò l’immagine di una freccia che indicava la via per raggiungere una meta. L’Autobiografia costituisce per ciò non solo un interessante documento dei progressi compiuti da Darwin nella conquista di uno sguardo scientifico, che avrebbe affinato un metodo di ricerca in aperto contrasto con la tradizione del deduttivismo logico. Ciò che ne rende ancora oggi avvincente la lettura, è quel dire di sé dicendo degli infiniti incantamenti che via via si aprono innanzi a un occhio che non cerca immediate conferme alle sue congetture, né risultati pratici, secondo un rigoroso principio baconiano. Quando nel 1831, poco più che ventenne, Charles s’imbarca sulla nave britannica Beagle è animato da un prevalente interesse per la geologia, ma ben presto quel viaggio attorno al mondo e in particolare nelle acque del sud America si sarebbe trasformato in un’avventura delle idee. Gli scenari che generosamente la natura squaderna innanzi agli occhi del naturalista giorno dopo giorno, per sessanta lunghi mesi, costituiscono un laboratorio per il quale, una volta tornato all’amata casa di Downe, a 16 miglia da Londra, gli occorrerà “un lungo ragionamento”. La raccolta empirica dei dati che annota con cura meticolosa nel suo giornale di bordo lo rimanda a un lavoro di più lunga lena: Quaderni di comunicazione 10 138 Editorialmente attivo L’Autobiography è però qualcosa in più di un documento scientifico. Scritto in tre mesi, dedicandovi un’ora pomeridiana quasi ogni giorno, dal maggio all’agosto del 1876, le 121 pagine iniziali, a cui negli ultimi sei anni di vita se ne aggiunsero altre 67, riescono ancora oggi ad attrarre e un po’ sedurre lettori di palato diverso. Cliccando su Google la voce darwin/autobiography si ottengono 1.320.000 risultati (45.000 nella corrispettiva voce italiana), come dire insomma che quelle pagine conservano un loro interesse, anche se al disotto dei 4.170.000 contatti che può vantare l’opera pangenetica, On the Origin of Species (272.000 nella sitografia italiana). Le ragioni di tanto successo, non tutte legate all’industria-Darwin del secondo centenario, ricco di eventi internazionali, furono già messe in evidenza, e sarà sufficiente qui riferirsi ai prefatori italiani delle quattro edizioni Einaudi: Giuseppe Montalenti e Giulio Giorello, e più remotamente alla prima curatrice, Nora Barlow, per invitare il pubblico giovanile a una lettura diretta del testo nella bella traduzione italiana di Luciana Fratini. Quando scrive Darwin ha 65 anni, e può parlare di sé col disincanto di un decano privo di autoindulgenze: affetti, amicizie, simpatie, idiosincrasie, stati d’animo, tempeste polemiche, tenerezze, impennate, pudori, reticenze: l’intera gamma di chi osserva oramai il tempo disteso di una vita dedicata all’osservazione, mettendo a fuoco se stesso attraverso la lente sempre insidiosa della memoria. Sono pagine di partecipazione morale e sentimentale, in cui “si guadagnano contatti più diretti, visioni più intime di episodi svolti nella cerchia dei familiari e degli amici, che recano a noi l’eco delle tempeste suscitate dalla teoria rivoluzionaria negli animi di uomini e donne ligi alla tradizione” Così scriveva già Giuseppe Montalenti, genetista e storico della scienza,– poco meno di mezzo secolo fa (1962) – consigliandone la lettura “a tutti coloro che hanno curiosità intellettuale di problemi scientifici e storici”, aggiungendo che chi ad esse vi si fosse accostato con lo stesso spirito di umiltà e amore del vero che vibrano in quelle note d’indagine introspettiva, ne avrebbe tratto senz’altro vantaggio per una valutazione “storicamente e scientificamente” più precisa di Darwin, della sua teoria e del suo tempo. Questo perché circa cinquant’anni fa, specialmente in Italia e nei paesi in cui era più forte l’influenza del cattolicesimo romano, si combatteva la figura un po’ fittizia di un Darwin immiserito dai testi scolastici, che ne schematizzavano e non di rado distorcevano ad arte l’evoluzionismo. Perfino in alcuni circoli intellettuali – e non solo in Italia – le sue idee venivano considerate non dimostrate, oppure superate, e perciò abbandonate anche dai biologi. In realtà, come già Montalenti Le qualità morali Già Montalenti, nella prefazione del ’62, aveva segnalato nei dettagli quelle che gli sembravano le indubbie qualità morali dell’Autobiografia: “lo sforzo per rimanere fedele a se stesso” e “la forza di un’analisi rigorosa, precisa, obiettiva, sempre sotto spietato controllo”. Una forza morale che consente all’Autore di “applicare fino in fondo, senza remore o pentimenti, il ragionamento scientifico più limpido e rigoroso, anche quando tagliava nel vivo delle convinzioni tradizionali, delle credenze religiose, tanto da recar fastidio e dolore alle persone amate”(p.XXI). L’edizione curata da Nora Barlow aveva fatto giustizia, con non poca fatica, di un testo – quello pubblicato cinque anni dopo la morte di Charles dal figlio Francis -, controllato e censurato in non pochi passaggi dalla famiglia, sui punti in cui l’Autore non aveva saputo tacere. Presentando al pubblico– correva l’anno 1958 – il lavoro di restauro e di recupero del testo, la curatrice aveva fatto notare come autobiografie del genere avevano il giusto merito di rivelare “sia l’ambiente che influisce sull’uomo, sia l’uomo in se stesso”. Osservava pure, in quella stessa occasione, che il permanente pre-giudizio sul darwinismo andava visto nel quadro della “tempesta scientifico-religiosa che si era scatenata tra il 1860 e il 1880, con una violenza oggi (1958) difficilmente immaginabile”. Giulio Giorello, che riporta questo passaggio della Barlow nella nuova edizione Einaudi del 2006, vi aggiunge che l’Autobiografia non è soltanto una “preziosa testimonianza circa la genesi di una concezione e sulla personalità dell’uomo che l’ha prodotta, ma anche un insegnamento civile di libertà” (p.XVII), facendo tuttavia presente che al momento in cui redigeva quella nota introduttiva (2006) “il rigurgito di un antidarwinismo che non esita ad abbassare gli standard del rigore scientifico ben sotto i criteri di un Herschel o di un Whewell (gli stessi che avevano animato la “tempesta scientificoreligiosa, a cui allude la nota della Barlow) e Il naso di Darwin 139 Angelo Semeraro poneva poi in evidenza vent’anni dopo, in una prefazione successiva (1982), la vitalità dell’evoluzione targata Darwin aveva trovato più largo credito nella genetica, che aveva contribuito a darle nuovo sviluppo, portandola anche sul terreno sperimentale. Coi suoi problemi in parte risolti, in parte ancora sotto indagine, la teoria darwiniana era ed è viva e operante, e lo dimostra una sterminata bibliografia che a una rinnovata curiosità per la personalità del naturalista, registra la vitalità del dibattito ancora in corso (cfr.www. darwin-online.org.urk). Quaderni di comunicazione 10 140 l’arroganza di un creazionismo aggressivo che persiste nel riproporre il Progetto Intelligente. Ragioni che danno più forte rilievo ad alcune pagine dell’Autobiografia, più segnatamente in quel paragrafo in cui Darwin si occupa delle “opinioni religiose”. Felicità e dolore Era andata proprio così: il ventiduenne Charles si era imbarcato sul Beagle ben formato in un ambiente di perfetta ortodossia. La conoscenza di culture e di sentimenti religiosi differenti, la presenza di tanto dolore tra i popoli e le tribù con cui veniva a contatto, lo mossero a considerazioni diverse da quelle suffragate dal libero arbitrio col suo corollario di impotenza di un dio a intervenire sulle cose umane, per alleviare le infinite forme di sofferenza elargite a larghe mani dalla natura. Ma quel dolore – si tormenta Charles – doveva avere altra origine, altre spiegazioni, e – soprattutto – doveva essere inscritto in un ordine naturale. Darwin pecca certamente di ottimismo quando pensa che l’argomento di un Disegno Intelligente avrebbe ceduto il passo a una convinzione più matura dell’evoluzione, ossia all’opinione che tutti i viventi sono frutto di una variazione e della selezione naturale. “Tutto ciò che esiste in natura – scrive – è il risultato di leggi determinate” (p.69). Qui era la vera pietra dello scandalo; la vera rottura col passato, della scienza e delle ortodossie religiose: la dottrina della selezione naturale tenda a dare a ogni specie il massimo delle possibilità di successo relativamente ad altre specie nella lotta per l’esistenza, e che la tendenza alla piena realizzazione (che definisce “felicità”) prevalga decisamente, benché sia molto difficile dimostrarlo. Il passo trascritto, avvalora quella tendenza alla felicità con cui si è aperto il nostro Quaderno, con il saggio assai denso di Salvatore Natoli. Tornerebbe utile richiamare quanto il tema della felicità stesse a cuore a Darwin, e quanto, a tale riguardo, ebbe a dire in uno dei passaggi più interessanti dell’Autobiografia Alcuni autori, profondamente colpiti dalle molte sofferenze che esistono nel mondo, si domandano se fra tutti gli esseri sensibili sia maggiore il dolore o la felicità, se il mondo nel suo complesso sia buono o cattivo. Io credo che la felicità prevalga decisamente, benché sia molto difficile dimostrarlo (s.n.). Se vera, questa conclusione concorda con i risultati che si possono prevedere dalla selezione naturale. Se tutti gli individui di una specie soffrissero sempre molto intensamente, essi trascurerebbero la propagazione, [...] Inoltre qualche altra considerazione può farci ritenere che in generale tutti gli esseri sensibili siano stati costruiti in modo da poter godere la felicità (pag.70) Nessuno tuttavia potrebbe negare che nel mondo vi sia un dolore e una sofferenza diffusa che sembrano sopraffare tanto l’aspirazione al pieno appagamento individuale quanto la più vaga idea di una felicità pubblica, e ciò non poteva sfuggire all’osservatore scientifico, in procinto di suggerire un’ipotesi pangenetica all’umanità. Il concetto di felicità pubblica aveva guadagnato spazio nella progettazione filosofico-politica del XVIII secolo, com’è noto. Rousseau e il pensiero giusnaturalista non erano passati invano, e ad essi si ispiravano i principi illuminati d’Euro- Intelligent Design Resta questo il vero punto di rottura ineludibile di Darwin rispetto alle concezioni finalistiche della natura, per la verità già oggetto di molte discussioni nelle comunità di fisici e scienziati dell’epoca sua. Variazione e Selezione costituivano i due principi di non ritorno. Oggi, dopo la scoperta della legge della selezione naturale, vale il vecchio argomento di un disegno della natura, argomento che nel passato era sembrato decisivo. Non si può più sostenere, per esempio, che la cerniera perfetta di una conchiglia bivalve debba essere stata ideata da un essere intelligente, come la cerniera della porta di un uomo. Un piano che regoli la variabilità degli esseri viventi e l’azione di selezione naturale, non è più evidente di un disegno che predisponga la direzione del vento. Tutto ciò che esiste in natura è il risultato di leggi determinate (p.69) E più avanti: Oggi gli argomenti più comuni a favore dell’esistenza di un dio intelligente sono tratti da profonde convinzioni personali e dai sentimenti provati dalla maggioranza delle persone. Ma è certo che gli indù, i maomettani, e altri popoli di religione diverse, potrebbero, con ragionamenti analoghi e altrettanto validi, affermare l’esistenza di un Dio o di molti dei, oppure, come i buddisti, l’inesistenza di Dio. Vi sono anche molte tribù di popoli barbari che non hanno la stessa nostra idea della divinità: esse credono negli spiriti o fantasmi e Tyler ed Herbert Spencer hanno dimostrato come si possa spiegare il sorgere di simili credenze. In passato, sentimenti come quelli citati, mi avevano portato a credere fermamente nell’esistenza di Dio e nell’immortalità dell’anima (benché non abbia mai avuto un sentimento religioso molto forte). A proposito delle impressioni che provai nella grandiosità della foresta brasiliana, scrissi nel mio diario: “Non è possibile dare un’idea adeguata dei sentimenti sublimi di meraviglia, ammirazione e devozione che s’impadroniscono del nostro spirito e lo elevano”. Ricordo bene la mia convinzione, che nell’uomo ci fosse qualcosa oltre la semplice vitalità corporea. Ma per me oggi non v’è più spettacolo, per quanto grandioso, che possa suscitare convinzioni e sentimenti simili. Si può obiettare che potrei essere paragonato a un uomo che fosse diventato cieco per i colori, il cui difetto non Il naso di Darwin 141 Molti hanno voluto spiegarla [la felicità] per l’uomo, considerandola necessaria al suo perfezionamento morale. Ma il numero degli uomini è niente al confronto con tutti gli altri esseri dotati di sensibilità, i quali spesso soffrono molto, senza alcun perfezionamento morale. Per la nostra mente limitata un essere potente e sapiente, come un Dio capace di creare l’universo, deve essere onnipotente e onnisciente; e sarebbe addirittura rivoltante per noi supporre che la sua benevolenza non sia anch’essa infinita; infatti quale potrebbe essere il vantaggio di far soffrire milioni di animali inferiori per un tempo praticamente illimitato? Questo antichissimo argomento che si vale del dolore per negare l’esistenza di una causa prima dotata di intelletto, mi sembra molto valido; mentre, come è stato giustamente notato, la presenza di tanto dolore concorda bene con l’opinione che tutti gli esseri viventi si siano sviluppati attraverso la variazione e la selezione naturale. Angelo Semeraro pa e del Nuovo mondo. Tema dunque ineludibile anche per la scienza e per un naturalista di professione come Darwin. Eccone un passaggio notevole nella sua Autobiography: Quaderni di comunicazione 10 142 avrebbe alcun valore di prova, contro l’universale assicurazione da parte di tutti gli altri uomini, dell’esistenza del rosso. Questo argomento potrebbe valere se tutti gli uomini, di tutte le razze, avessero la stessa intima convinzione dell’esistenza di un Dio: ma sappiamo che ciò non è affatto vero. Perciò non riesco a capire come tali convinzioni intime e simili sentimenti possano avere il minimo valore di prova di ciò che esiste realmente. Le condizioni di spirito che un tempo le grandi visioni naturali risvegliavano in me, e che erano intimamente connesse con la fede in Dio, non differivano sostanzialmente da ciò che spesso si indica come sentimento del sublime; e ciò, nonostante sia difficile spiegarne la genesi, non può essere presa come prova dell’esistenza di Dio, più che non lo siano i sentimenti analoghi, forti ma indefiniti, suscitati dalla musica (pp.72-73). Altrettanto interessanti le considerazioni che seguono sulla immortalità dell’anima e altre questioni legate all’educazione religiosa ricevuta, che Emma Darwin e il figlio Francis avrebbero volentieri lasciato fuori dalla pubblicazione per non comprometterlo e non compromettere la famiglia con il senso comune borghese della capitale londinese. Emma Darwin scrive a Francis per chiedergli di omettere nell’edizione del 1885 dell’Autobiography il passo che stiamo per riportare, aggiunto successivamente da Charles alle 121 pagine iniziali del manoscritto. Il passo incriminato Il pensiero di una Causa Prima, dotata di intelligenza, pari o superiore a quella dell’uomo, gli valse, all’epoca della Origine della Specie, l’appellativo di teista. Un argomento a favore dell’esistenza di Dio (“connesso con la ragione più che col sentimento”) l’aveva intravista nella difficoltà e anzi nell’impossibilità di leggere l’universo (“e l’uomo con la sua capacità di guardare verso il passato e verso il futuro”) come “il risultato di un mero caso e di una cieca necessità”. Questa concezione, ben radicata – lo ripetiamo – ai tempi in cui scriveva On the Origin of Species, ossia prima del 1859, si era tuttavia incrinata nel tempo. Il dubbio aveva compiuto il suo lento viaggio sotterraneo nella mente di Charles e “dopo alti e bassi” quella fiducia nel Disegno Intelligente si era “gradualmente indebolita”. [...] quale fiducia si può avere in queste alte concezioni che sono formulate dalla mente umana, la quale, secondo il mio fermo convincimento, si è sviluppata da una mente semplice, uguale a quella degli animali inferiori? Non può darsi che esse siano un rapporto fra causa ed effetto, che ci appare indiscutibile, ma che forse è soltanto frutto di una scienza ereditata? Nè si deve trascurare la probabilità che l’inculcare una fede religiosa nei bambini produca un effetto così forte, e forse ereditario, sulle loro menti ancora non completamente sviluppate, da rendere loro difficile liberarsi dalla fede in Dio, così come è difficile per una scimmia liberarsi dalla paura e dall’odio che nutre istintivamente per il serpente. (pp.74-75) Scrive Emma Darwin al figlio Francis: Nell’Autobiografia c’è una frase che io desidererei vivamente che fosse soppressa, sia perché l’opinione di tuo padre che tutta la moralità si sia sviluppata per evoluzione mi è indubbiamente sgradita, sia anche perché quando si arriva a questo punto si rimane E non solo ai devoti amici paterni la omissione di “quella frase” sarebbe tornata gradita! Ma anche ad omettere quel passaggio, Charles aveva detto chiaro della sua “maturazione”: Il mistero del principio dell’universo è insolubile per noi, e perciò, per quel che mi riguarda, mi limito a dichiararmi agnostico. Mi sembra che per un uomo che non abbia la costante certezza dell’esistenza di un Dio personificato o di una vita futura con relativa ricompensa, l’unica regola della vita debba essere quella di seguire gli istinti e gli impulsi più forti o che gli appaiono migliori. (p.76). Darwin qui parla degli impulsi sociali, quelli per i quali l’agire non si lascia condizionare dall’approvazione degli altri uomini e la conquista dell’amore delle persone con cui vive. Si tratta di una virtus diversa, pari a quella che già Rousseau aveva voluto sottrarre al teatro delle opinioni, alla tirannia della reputazione. Si tratta di quell’istintività che diventa un “impulso superiore” a perseguire il dettato della coscienza, che letterariamente richiede un agire consapevole, cum scientia, in pienezza di conoscenza. È il metodo scientifico che assicura questa felicità. Felicità: una lezione di metodo Giunto nell’età vegliarda della vita (l’Autobiografia come si è detto è del 1876 e l’autore lascerà questo mondo sei anni dopo, nel 1882) Darwin può inventariare senza veli i suoi punti deboli, insieme alle orgogliose rivendicazioni di merito di una vita dedicata alla scienza. Vi sono perciò nelle sue ultime pagine i segni premonitori di un’esistenza che si conclude: quella “dolorosa attenuazione del sentimento”, insieme alla caduta del gusto estetico, come se si fosse atrofizzata una parte del suo cervello. La perdita di gusto per la poesia e la musica, che equivale – scrive – a una perdita della felicità, “in quanto indebolisce la parte emotiva della natura umana”. Il naso di Darwin 143 Angelo Semeraro scossi in quanto la frase in questione può far credere, ingiustamente, che tuo padre considerasse tutte le fedi religiose alla stessa stregua delle avversioni o delle simpatie ereditarie, come la paura delle scimmie per i serpenti. Credo che il tono irriverente scomparirebbe se la prima parte delle supposizioni si interrompesse prima dell’esempio delle scimmie e dei serpenti. Mi sembra che questa omissione non altererebbe il senso dell’Autobiografia [...] Desidererei, se fosse possibile, non dare un dolore a quegli amici religiosi di tuo padre, i quali hanno conservato una serena affezione per tuo padre e che immagino sarebbero profondamente colpiti da quella frase...(p.75n) Quaderni di comunicazione 10 144 La compagnia dei simili gli procura “attacchi di vomito” e ha manifesta insofferenza per gli amici scienziati: quelli che parlano troppo, i misantropi, i buoni conversatori un po’ ciarlatani. È tollerante invece coi suoi recensori (“tranne quelli privi di conoscenze scientifiche”). In tutto il viaggio autobiografico, a parte l’elogio della singolare figura della moglie (“saggia consigliera e serena consolatrice di tutta la mia vita), non appaiono altre figure femminili nel suo racconto, tranne che un cenno alla “graziosissima” moglie dello storico Lord Mahon che si era tanto divertita quando gli era stato chiesto per quali ragioni si ostinasse a occuparsi di quelle “sciocchezze” della geologia e zoologia” e non traesse più frutto col dedicarsi alle scienze occulte. La modestia del ricercatore non è mai affettata. Dice di sè: “Non ho quella grande rapidità di apprendere o quell’agilità di spirito che sono così notevoli in alcune persone intelligenti” (a faceva l’esempio di Huxley). Dice ancora “la mia memoria è vasta ma confusa” e più avanti “così debole”. Lamenta l’incapacità di disegnare, cosa che raccomanderà a tutti i giovani. Condivide con Lyell, di cui parla a lungo e che frequentò più di ogni altro, che tutti gli scienziati dovessero morire non oltre i sessant’anni, “perché poi si oppongono senza eccezione a ogni nuova dottrina”. È prodigo di buoni consigli per i giovani, a cui consiglia lo studio personale più dell’ascolto passivo delle lezioni in classe e, insieme, lo studio del come anziché il perché delle cose (col corollario della nocività della speculazione al pensiero scientifico). “L’attitudine a teorizzare va tenuta a freno”. Invita ad evitare le polemiche, che sempre comportano perdita di tempo e dispiaceri (col corollario di evitare a ogni costo la competizione tra scienziati). L’Autobiografia è anche il racconto diretto di ogni sua pubblicazione, dei tempi di incubazione e di stesura e dei tempi in cui i libri sono stati lasciati nel cassetto, anche per più anni, non per opportunismo, ma per maturare quella giusta distanza e soppesare la sfida del tempo ai propri giudizi. Otto anni ad es. intercorrono tra la raccolta dei suoi appunti su Le variazioni degli animali e delle piante allo stato domestico, già disponibili nel 1860, e la loro pubblicazione (1868): nel frattempo gli era parso più urgente occuparsi della fecondazione di lombrichi e cirripedi, di orchidee inglesi e dei movimenti dei viticci di una cucurbitacea. Anche Le Piante insettivore, pubblicato nel 1875, attesero ben sedici anni dalle prime osservazioni. Più breve – ma intenso – fu invece il tempo di stesura dell’Origine della specie, a cui lavorò tredici mesi e dieci giorni di fila. Il lavoro più importante della sua vita, quello che nel primo giorno di pubblicazione avrebbe venduto 1250 copie e ancora 3000 copie pochi giorni dopo, con la prima ristampa, venne alla luce più presto degli altri. Quel naso insomma, che ad alcuni era apparso privo di energia e determinazione, aveva dimostrato quanto meno di possedere un buon fiuto. Tutte le genialità tuttavia sono vulnerabili al paradosso. Vogliamo dire che ogni genio ha diritto a incorrere almeno in una contraddizione. E ciò capitò anche al padre dell’evoluzionismo. Evoluzione in natura ma innatismo nell’educazione. Darwin pensava che l’educazione e l’ambiente avessero scarso effetto sull’educazione mentale degli individui, e che la maggior parte delle nostre qualità siano in- Testamento per il buon ricercatore Nelle ultime pagine dell’Autobiografia Darwin fissa in quattro punti quelle che riteneva le doti essenziali dello scienziato: amore per la scienza; una “infinita pazienza” nel riflettere lungamente su ogni argomento; una grande diligenza nell’osservare e raccogliere dati di fatto; una certa dose d’immaginazione e di buon senso (p.126). Doti “modeste”, che tuttavia si erano rivelate sufficienti a trasformare la sua mente in “una specie di macchina” capace di estrarre leggi generali da una vasta raccolta di fatti. In una orgogliosa dichiarazione finale di indipendenza intellettuale, dice di sé: Ho sempre cercato di tenermi libero da ogni preconcetto, in modo da poter rinunciare a qualunque ipotesi, anche se molto amata non appena mi si dimostri che i fatti vi si oppongono [...]. Non mi è dato di agire diversamente [...] anche se per gli scienziati una buona dose di scetticismo è consigliabile... (p.123). Il metodo Darwin consegna al mondo scientifico brevi regole a cui egli si era attenuto nel corso della sua lunga esistenza di ricercatore scientifico. Regole tanto preziose quanto attuali, considerate le profonde trasformazioni involutive che il lavoro intellettuale e più in generale quello di ricerca hanno subito e continuano a subire. Sembra infatti irreparabilmente perduta quell’“infinita pazienza” del riflettere, non meno della necessaria diligenza nell’osservazione e la fiducia nell’immaginazione come motore dell’ingenium. Non ci rimane che un po’ di buon senso, ma anche quello, come diceva Manzoni, se ne sta ben acquattato, timoroso del senso comune. Ciò che può ancora germogliare, attraverso una paziente cura educativa, è l’amore per la scienza, che conserva fortunatamente il suo appeal anche presso le generazioni mediatizzate dell’evenemenziale, e che si trasmette per contagio diretto. Il naso di Darwin 145 Angelo Semeraro nate. Fu, in questo, un seguace delle idee del cugino Francis Galton antropologo e patrocinatore dell’eugenetica, termine da lui coniato per primo. Sulla questione dell’innatismo molto si è già detto e molto si potrebbe ancora dire. Oggi propendiamo a dare più peso all’ambiente, come forte correttivo dell’imprinting genetico: più peso insomma a un altro tipo di condizionamento, che è quello della trama dei rapporti che il cucciolo d’uomo sviluppa nel proprio habitat naturale e sociale. Ma ogni genio, come si diceva, ha diritto ad almeno una contraddizione. Al Darwin scienziato premeva di restare aderente ai fatti. Erano i fatti che gli suggerivano le teorie; non faceva teorie per poi cercarne conferma nei fatti. Anzi, cercava di falsificarle e, non riuscendoci, le manteneva valide (come chiede Popper). Quaderni di comunicazione 10 146 Reset Salvatore Natoli L’attimo e il bene L’attimo immenso La felicità è attimo, momento che passa. In effetti nella nostra vita ci è capitato di vivere “stati di grazia”: il sobbalzare dell’animo all’incontro con una persona da tempo attesa, un qualsiasi evento improvviso a noi favorevole, un successo inaspettato, lo sbocciare di un amore. E così avanti. Ebbene, quanto sperimentiamo come stato d’eccezione di norma è causato dallo scarto tra la tensione del desiderio – e perciò la sofferenza della mancanza – e la scarica che subentra quando si perviene alla sua soddisfazione. Ora, è del tutto evidente che la percezione dello scarto tra carica e scarica non può che essere momentanea. Per questo da tempo si discute se la felicità stia esattamente nell’acme – donde il suo carattere di istantaneità – o nelle quiete che subentra alla scarica. Per molti risiede nella cessazione dello sforzo, come dire nella pace conseguente. Ambiamo alla pace: per questo alcune culture ritengono che l’uomo può pervenire ad una perfetta felicità non tanto attraverso la realizzazione del desiderio – che una volta soddisfatto riemerge più potente di prima – ma solo liberandosi da esso. Resta da chiedersi quanto questa pace differisca dalla morte. Non affronto qui il tema, ma non v’è dubbio che il modello freudiano dello scarto tra carica e scarica fornisce una spiegazione a suo modo plausibile del perché gli uomini normalmente sperimentano la felicità come un “evento transitorio”. Per altro verso il sentimento di felicità può essere di natura assolutamente fisica: il contatto con gli elementi, l’aria, l’acqua, la terra, gli odori. La nostra memoria consapevole non trattiene tutte queste percezioni, ma esse rimangono inscritte nel corpo. Non ricordiamo quando, dove quel vento ha sfiorato la nostra pelle, né la carezza dell’aria, né il caldo del sole, né gli odori della natura. Di tutto ciò non ricordiamo né il giorno, né l’ora, ma il corpo ricorda ed è grato. Ed è cosi che in noi si viene mano a mano stratificando “una memoria immemorabile di piacere”, un inconscio sentimento di soddisfazione che senza alcuna intenzione si trasforma in puro e semplice piacere di vivere. La felicità ci prende, ci sconvolge, ci lascia. Quante volte e in quante cose la ricerchiamo e non la troviamo. Poi, all’improvviso, arriva. Apparentemente senza motivazioni. Ma non le ha davvero? A quest’interrogativo cercherò di dare risposta nel seguito, ma non v’è dubbio che lo stato di felicità, almeno prima Quaderni di comunicazione 10 150 facie, corrisponde con il sentimento della nostra illimitata espansione. Dunque la felicità risiede esattamente in questo, è solo interpretabile come un sentimento? O al contrario ha un’estensione infinitamente più ampia del piacere e dunque, per comprenderla, non bisogna ridurla ad esso? Certo, un’attenta fenomenologia mostra che non v’è felicità senza piacere, ma è anche possibile che vi sia un piacere senza felicità. Nella storia dell’umanità spesso si è fatto coincidere la felicità con il piacere e, in particolare, con quello sessuale. Non a caso Platone, nel Filebo, scriveva: «Partiamo da Afrodite». D’altra parte il piacere sessuale, per la sua dinamica ascendente, per la sua intensità, pervasività e fusività offre una percezione diretta del proprio espandersi. Per queste ragione è stato ritenuto il piacere per eccellenza. Ma il piacere d’amore non si risolve solo nel sesso, è anche “piacere d’amare”. Nell’esperienza amorosa, infatti, gli amanti si perdono l’uno nell’altro. Ma cos’è questo perdersi? Cosa significa? E, a partire da qui, che cosa si sente quando ci si sente felici. Abbiamo parlato finora di attimo, ma non abbiamo descritto in modo sufficiente la natura propria di quest’esperienza. Ora quel che accade quando ci si sente felici è dato dal fatto che, in qualche modo, vien meno il tempo. O comunque si sospende. Si pensi all’esperienza del tempo nel colloquio d’amore o a tutte quelle situazioni in cui si attinge una sensazione di pienezza: le ore passano e non ci si accorge e, quando ci si congeda, sembra che il tempo non sia neppure trascorso. Tutta la storia letteraria – e non solo – è piena di lunghi addii. Nella pienezza dell’attimo il tempo si fa spazio e svanisce la percezione del suo trascorrere. È un’esperienza che più di altri fanno i mistici. Non a caso nel Cantico dei Cantici l’amore è metafora dell’esperienza di Dio. Ci s’inabissa. È un’esperienza difficile da spiegare, ma se prestiamo attenzione ai nostri vissuti la possiamo afferrare. Rilke usa un’espressione bellissima: la pura durata. Esistono alcune musiche caratterizzate da una “nota tenuta”. È un fluire senza variazione; il tempo scorre e tuttavia sembra fermo. D’altra parte, quando i Greci dicevano che gli dei – a differenza degli uomini – vivono felici, usavano l’espressione reia zoontes: la loro vita non patisce interruzioni, scorre senza ostacoli, in un continuo fluire privo di quegli scarti che danno la percezione del tempo e perciò stesso del consumarsi delle cose. E Aristotele per spiegare la vita di Dio diceva che è come quella degli uomini quando si sentono felici: solo che Dio lo è sempre, gli uomini solo qualche volta. Quando gli uomini entrano nel senza tempo dell’attimo vivono una sorta d’eternità. In effetti, se la felicità è il sentimento della propria illimitata espansione, in essa si tende a liberarsi dal limite, ad oltrepassarlo. Da qui, anche, una singolare forma di dolore: non certo il dolore di chi soffre, quello che lega, che come si suol dire inchioda, ma il dolore del tendersi, quasi ad uscire dal perimetro del proprio corpo. È il dolore che vediamo sul volto dell’atleta nel massimo del suo sforzo. Così nei momenti di felicità siamo tratti fuori di noi, ma abbiamo nel contempo il presagio di non reggere. La parola che meglio caratterizza questo stato d’animo è struggimento. Siamo, infatti, una quantità di potenza finita. Ecco perché quel momento in cui ci sentiamo infiniti – e che ha una sua verità – è anche un inganno. Ci illude di essere divini. Per questo la felicità ci può fare perdere la testa, tanto che i Greci ritenevano che se gli dei volevano distruggere gli uomini li rendevano felici. Per illuderli di onnipotenza. Ma giunti all’acme non reggono a lungo, cedono e rientrano nel ritmo abituale del tempo che, come è noto, consu- Felicità e virtù La parola stessa felicità deriva, come è noto, dalla radice indoeuropea fe-, da cui i termini latini ferax – terra ubertosa, che dà molti frutti – e felix – l’annata buona. Dalla medesima radice derivano foemina – in quanto generatrice – e il verbo felo che vuol dire allattare: di qui filius, proprio in quanto «allattato». L’etimologia del termine credo indichi a sufficienza come la felicità sia originariamente implicata con l’idea di crescita, di potenziamento dell’essere, in breve con il bene. Ma cos’è il bene? È la piena realizzazione di ogni ente secondo la sua propria natura: l’albero nasce e attinge il suo bene se cresce robusto, fiorisce e dà frutto. E così anche l’uomo: nasce, cresce, si potenzia nel corpo e nella mente, nell’intelligenza. In questo suo continuo svilupparsi è la felicità. Nel descrivere il nostro sentirci felici abbiamo mostrato come la felicità coincida con il sentimento della nostra illimitata espansione. Ebbene, potenziare le nostre capacità non è forse un modo di espanderci? Non solo, ma di conquistare, per dirla con Eliot, il tempo con il tempo. La felicità, considerata in questa luce, cambia di profilo e viene a coincidere, come ben sapevano gli antichi ma anche i grandi moderni, con la virtù: non certo intesa nell’accezione moralistica corrente, ma come capacità di realizzare se stessi in qualsiasi condizione. Come è noto, virtù in greco si dice aretê, dalla radice ar, da cui il latino ars. La virtù, così intesa, ha poco a che fare con la conformità a norme, ma caso mai risiede nelle capacità di darsele, nell’abilità ad esistere, nel sapersela cavare anche in situazioni sfavorevoli. Per questo la virtù è la via regia L’attimo e il bene 151 Salvatore Natoli ma. Per questo in molti hanno ritenuto e tutt’oggi ritengono che la felicità non sia di questo mondo. Ma allora di quale mondo è? Intanto, non potremmo neppure parlare di felicità se non ne avessimo fatto esperienza. Che è quella che ho appena descritta. Ma dove l’abbiamo fatta? Certamente, qui, in questo mondo. D’altra parte non potremmo neppure sperimentare la perdita se, in qualche modo, non avessimo conosciuto la pienezza. Come dice Eliot: «Lì sono stato». Per questo il dolore può essere anche più frequente della felicità, ma certo non è originario. Possediamo, infatti, una memoria originaria di soddisfazione. Freud la definirebbe «anamnestica»: il primo piacere, che può essere il seno materno, o altro. Comunque l’imprinting di un’originaria soddisfazione. D’altro canto nessun uomo potrebbe mai nascere, svilupparsi, crescere se non ci fosse all’origine un atto d’amore. Non importa che sia dei genitori o di altri, la vita non sboccerebbe se non ci fosse un atto d’amore che la genera e la custodisce. Si spegnerebbe subito o non avrebbe corso. All’origine dell’esistenza v’è un piacere o una gioia che genera e senza della quale nulla potrebbe mai schiudersi. In fondo, si potrebbe dire che la felicità non tanto ci afferra, ma ci precede: ci afferra perché ci precede. È la vita che di per sé ama se stessa. Alla felicità, dunque, si perviene perché ad essa si appartiene. Quanto qui si vien dicendo mostra che la felicità attiene alla vita intera. Infatti soccomberemmo al dolore – anche piccolo – se non fossimo radicati in una felicità originaria, che ci permette di tollerarlo. Se ciò è vero, il nostro sentirci felici è qualcosa di più di un sentimento, esprime qualcosa di più originario e profondo. Quaderni di comunicazione 10 152 per procurarsi la felicità. Per la medesima ragione, non ci può essere felicità se non c’è attività. Dunque non più, o non solo, l’attimo immenso, ma al contrario la capacità di catturare ad ogni attimo la sua gioia essendone all’altezza. Qualunque cosa la sorte o il destino ci possano riservare. In questo quadro, l’essere felici non si risolve nel possedere e, neppure, nello stesso fruire, ma nella capacità di cogliere il momento ad ogni momento. L’unico tempo che serve è quello necessario per essere in pari con il tempo, per trovare la soluzione giusta al tempo giusto. Per raggiungere queste condizione bisogna lavorare su di sé e, soprattutto, potenziare le nostre capacità per se stesse. Non si può fronteggiare l’imprevisto se si ha vista corta, se ci si limita all’utile immediato. Al contrario, solo se valorizziamo le nostre capacità in quanto tali possiamo scoprire in noi dimensioni ignote che non avremmo mai scoperto se ci fossimo limitati alla sola utilità. Non condivido il luogo comune secondo il quale la felicità sta “nelle piccole cose”, anzi la felicità sta nelle grandi, perché solo misurandoci con ciò che è grande possiamo valutare quello che è in nostro potere fare o non fare, quel che è alla nostra portata e quello che ci è dato solo contemplare. Ma è solo in queste sfida che possiamo guadagnare una misura realistica del nostro valore, senza pretendere d’essere di più di quel che siamo, ma anche senza rinunciare ad essere quel che possiamo. Michelangelo non sapeva affatto d’essere Michelangelo prima di diventarlo. E così tutti grandi geni dell’umanità. E così gli uomini comuni. Ma per capire quel che siamo e quanto valiamo bisogna applicarci su noi stessi, praticare quel che si chiama virtù. Non è affatto un caso se un grande pianista o un acrobata sono definiti virtuosi. La virtù non è una qualità ma un abito, diciamo pure una buona abitudine che rende facili le cose difficili, che trasforma le difficoltà in stimoli. E si guadagna con il tempo. Per questa via la felicità diventa una condizione stabile dell’anima. La felicità, come bene stabile è dunque qualcosa di più e di diverso dallo stato di grazia che irrompe e ci rapisce: coincide invece con la nostra capacità di aprirci al mondo, di trovarci così in uno stato di costante meraviglia. La felicità sta nella circolarità tra sé e il mondo. Un mondo non da divorare, ma da custodire, perché se riduciamo il mondo a noi stessi incontreremo in esso sempre ed egualmente noi stessi e ci verrà inevitabilmente a noia. Se ci apriamo al mondo, il mondo resterà per sempre aperto innanzi a noi, spazio di una sperimentazione illimitata. E questo vale ancor di più nel rapporto con gli altri. Gli uomini spesso sono infelici, perché hanno un’idea egoistica della felicità, che alla fine diventa solipsistica e autodistruttiva. Per potere fruire del mondo l’uomo deve sentirsene parte: custode e mai padrone. Non a caso, la felicità è sempre stata rappresentata nella letteratura, nella pittura come locus amenus, figura che rinvia ad un’esperienza di grande, profonda sintonia con la natura tutta. La felicità è armonia mundi. Infatti quando siamo felici sentiamo il mondo come lo spazio del nostro espanderci, che non può, però, coincidere con la sua occupazione e conquista. Se mi espando, ma abbatto gli alberi, inaridisco le terre, devio le acque, le inquino, le spreco, questa mia espansione è povertà, è distruzione dell’ambiente e perciò stesso della possibilità del mio personale sviluppo. E sarebbe questa la felicità? La felicità, al contrario, è un andare incontro al mondo ed insieme un sentirsi accolto in esso, ospitato. Abbiamo perduto la curiosità per il mondo, forse anche per il peso delle delusioni che spesso ci dà. In effetti, nel mondo si vede così tanto orrore che viene L’attimo e il bene 153 Salvatore Natoli naturale chiudere gli occhi. Ci sono molte buone ragioni per distogliere lo sguardo. In taluni casi si è tentati gnosticamente di distruggerlo. E tuttavia vale la pena interessarsi ad esso e prenderlo a cuore. Certo ci vuole una maggiore attenzione, ma così è possibile intravedere il bene, che, come è noto, non si coglie mai a prima vista. Lo si sa, non fa rumore. Se fa rumore vi è da sospettare che sia bene. La tradizione talmudica ha ragione: il mondo è tenuto in piedi da trentasei giusti nascosti. Nessuno sa chi sono. Io sono convinto che se il mondo finora non è crollato e proprio perché i giusti nascosti esistono. Ma per intravedere il bene è necessario educarsi a ad uno sguardo superiore. Bisogna farsi l’occhio: il bene lo si esperisce al plurale e la felicità è un arazzo fatto di molti fili: è lievito nella pasta, è pasta che lievita nella madia, che lentamente cresce. La felicità è capacità di creare e sviluppare di continuo vita. Per questo non si può essere mai felici da soli. D’altra parte – e lo si capisce d’intuito – come si può essere felici in un mondo devastato? In un mondo siffatto non resta che difendersi, cresce la paura e si è sempre in allarme. Ho detto all’inizio che la felicità è illimitata espansione di sé; mi sembra di aver mostrato che per espandersi davvero bisogna liberarsi dalla ristrettezza miope del proprio io. È necessario ritrovare un nuova innocenza. Mi sembra, per questo, più che mai pertinente la sentenza evangelica: «Lasciate che i bambini vengano a me…Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà» (Lc. 18, 15-17). Per entrare nel regno bisogna credere nel suo avvento. Allo stesso modo non si potrà mai attingere la felicità se non si opera gratuitamente per essa. In questo la felicità è davvero grazia. Come si vede, è molto di più che un sentimento: è la misura del nostro valore, è il valore degli altri per noi, di noi per gli altri. Tessiture Zygmunt Bauman The Art of Life Polity Press, Cambridge 2008, tr.it. L’arte della vita di Marco Cupellaro, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp 179, 15,00. Richard Sennet The Craftsman University Press, NewHaven & London, 2008, tr.it. L’uomo artigiano di Adriana Bottini, Feltrinelli, Milano, 2008, pp120, 25,00. Antonio Santoni Rugiu Breve storia dell’educazione artigiana Carocci, Roma, 2008, pp.179, 15,50 Tornano i discorsi sulla felicità. Ne parla nel suo bel saggio L’attimo e il bene che Natoli ha scritto in questo QC, ne parlano due recenti libri che sembrano richiamarsi l’un l’altro, di Bauman e Sennet, e diremo subito in che senso. Ne parla ancora, per un altro verso Santoni Rugiu che da anni scava tra i modelli della civiltà artigiana non stancandosi di segnalarne le virtù formative che purtroppo si sono perdute e per larga parte dismesse, rievocando il valore di quella Bildung che fiorì tra le botteghe artigiane nella nostra civiltà comunale e rinascimentale. C’è da chiedersi come mai Autori di così diversa formazione si incontrano in libreria per affrontare questo grande tema della felicità e delle forme umane della sua realizzazione nel mondo contemporaneo. Il più esplicito nell’offrircene una spiegazione è Bauman, che subito si pone una domanda: che cos’è che non va della felicità nella nostra società liquido-moderna? C’è, sostiene, che la ricerca della felicità sembra potersi muovere tra le ristrette offerte di una società di mercato: ossia tra marchi, etichette e Topshop, e per larga parte sembra affidata alla pubblicità e ai grandi negozi (p.31); c’è ancora che gli oggetti di cui ci circondiamo perdono il loro valore d’uso a vantaggio del loro status symbol. E che rapidamente essi cedono il loro splendore e perciò abbandonati e sostituiti. All’infinito. Ma la felicità non è in relazione alla crescita del prodotto interno lordo. Non c’è nessun nesso tra felicità e la quantità e la qualità del consumo (p.13). Bauman cita Robert Kennedy: “il pil misura tutto, tranne quello che rende la vita degna di essere vissuta”. Marchi, etichette, loghi sono i termini del linguaggio del riconoscimento. Torna nelle pagine di Bauman la “preoccupazione” dell’identità, che da progetto di tutta una vita, è diventata un attributo del momento, “continuamente montata e smontata”. L’identità non è più ciò che connota la nostra opera, l’orgoglio per un lavoro ben fatto, per la propria abilità, destrezza, per essere riusciti a fare qualcosa di difficile e aver superato un ostacolo formidabile. Non è più il rispetto di sé (p.10). Non si forgia Quaderni di comunicazione 10 158 più in quell’arte del vivere che significa ogni volta cose diverse per la vecchia e la nuova generazione. Ognuno resta artifex di se stesso. Contro questa forma immiserita e illusoria di felicità c’è L’arte della vita, creazione sempre nuova e rinnovabile, che come ogni arte è anche sofferenza, dolore, rinuncia e ricerca. Come ogni artista, dovremmo perciò proporci sfide difficili, scegliere obiettivi oltre la nostra portata e gli standard di eccellenza che si ostinano a stare sempre un po’ più in là di ciò che abbiamo saputo fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. Ri-scoprirsi artefici ci dà un brivido di onnipotenza. Ma nell’epoca in cui solo i ricchi possono comprarsi una fragile quanto illimitata felicità di consumo, in cui solo essi, come ammoniva Diderot nel secolo illuminato, possono permettersi di essere stupidi e per tutti gli altri la competenza è necessità e non una opzione (dal momento che toccherà sempre più al talento giocare la gara in un mondo accelerato), torna utile il rilancio dell’Homo Artifex (arbitro della sua fortuna) in quest’ultimo ampio e godibile saggio di Richard Sennet, allievo di Hannah Arendt (che seppe trasmettergli tutte le inquietudini dell’animal laborans), che lancia insieme storia e attualità per ri-orientarci in un tempo in cui il lavoro ha cambiato pelle e richiederà sempre più forti sinergie mente-mano-desiderioragione. È lo stesso tema su cui si è fatto specialista Santoni Rugiu, ed entrambi gli autori possono maneggiare con abilità la lunga durata storica dell’uomo artigiano, popolata da ingegneri romani, orafi rinascimentali, tipografi parigini del Settecento, di fabbriche nella Londra protoindustriale: un lungo percorso storico attraverso cui si ricostruiscono i legami ma anche le distanze tra tecnica ed espressione. creazione e applicazione, fino a indicare, nel libro di Sennet, il gruppo che ha messo al mondo Linux, come miglior esempio di “saper fare” moderno. Torna, a quanto pare, questo desiderio della perizia, dell’eccellenza contro la mediocrità dell’approssimazione, del “basta che sia fatto”. Ma i criteri di eccellenza sono in conflitto tra loro, segnala Sennet: il desiderio di svolgere bene un compito, per il piacere che questo comporta, può essere ostacolato dalla pressione alla competitività, dalla frustrazione e dall’ossessività. Perciò un richiamo alla civiltà delle arti, ai suoi statuti, alla intensità dell’ethos che animava il fare umano è più che opportuno, anche se per riscoprirlo dobbiamo sempre riferirci alle icone dell’illuminismo, che seppe catalogarne le forme in cui essa si svolse a partire dalle prime corporazioni medievali. Quella memoria torna utile oggi per ripensare insieme la qualità del lavoro e quelle dell’addestramento. Saper fare bene le cose per il proprio piacere fu per molto tempo una regola di vita semplice e rigorosa che avrebbe consentito lo sviluppo di tecniche raffinatissime e la nascita della conoscenza scientifica moderna. Dal momento che il termine maestria sembra rimandare ai maestri artigiani del Medioevo e del Rinascimento, una realtà tramontata dopo l’avvento della società industriale, Sennet propone una nuova definizione del termine maestria (“il desiderio di svolgere bene il lavoro per se stesso”). Questo tipo d’attività riguarda tutti: il medico e il meccanico, l’informatico come l’artista, ma anche il sempre più difficile mestiere di genitore. Ma è sufficiente la motivazione, quella spinta energetica che viene dal di dentro e su cui ancora oggi puntiamo per costruire menti virtuose e braccia operose? Per Sennet la motivazione non sembra sufficiente: ciò che gli sembra che serva è invece un contesto organizzativo favorevole e valorizzare le persone, investendo su di loro sul lungo termine. Il modello artigiano del passato ci insegna una cosa importante: il senso del tempo. Per diventare maestri ai tempi antichi ci volevano anni. La regola delle diecimila ore di addestramento per diventare esperti di qualche cosa – un lavoro o una professione – fa leva su una trascurata pedagogia dello sforzo e della fatica (anche muscolare, precisava Gramsci nelle sue lettere alla moglie sull’educazione dei figli), senza la quale non si crea innovazione o, se si vuole, creatività: un termine tuttavia che entrambi gli autori maneggiano con estrema cautela. Angelo Semeraro Peppino Ortoleva Il secolo dei media. Riti, abitudini, mitologie Il Saggiatore, Milano, 2009, pp.334, 19,00 Questo nuovo libro di Ortoleva riesce più semplice raccontarlo che recensirlo. Censirne o re-censirne l’insieme, verrebbe a scapito dei tanti sentieri che ha saputo battere analizzando il secolo in cui la comunicazione ha assunto la massima rile- vanza, dispiegando la sua potenza mediatica e problematizzando se stessa. Siamo la prima generazione, ebbe a dire Mc Luhan, che ha preso consapevolezza di questo fuoco degli déi che gli uomini maneggiano, a volte con disinvoltura e tra molti equivoci, e l’Autore porta questa consapevolezza sul doppio registro, diacronico, analizzando il rapporto media-comunicazione, e sincronico, seguendone l’evoluzione per ciascuno dei media che hanno profondamente modificato le nostre forme del comunicare. Riti e miti sono nuclei riflessivi diacronici che danno spessore a questo ritorno alla mediastoria come osservatorio, più che disciplina: un osservatorio privilegiato, in cui gli aspetti più eccentrici della comunicazione (l’onore perduto della parola, la pornografia, il fenomeno della violenza negli stadi, ecc.) sono analizzati come prodotti sociali intrisi di macchinico, di interna trasformazione dei mezzi e degli strumenti che la comunicazione produce riproducendo se stessa. Diversità e comunione: la comunicazione vive di una tensione tra questi due poli apparentemente oppositivi e incompatibili tra loro. Lo aveva visto già visto Hannah Arendt, che opportunamente Ortoleva richiama, per la quale il paradosso della comunicazione interumana sta nel fatto che essa presuppone la loro diversità – altrimenti non si sarebbe molto da comunicare -, ma anche l’eguaglianza: un linguaggio comune, un universo simbolico condiviso, senza il quale non ci si potrebbe mai intendere. Questo doppio aspetto della comunicazione costituisce il suo paradosso: è presente nei media, i quali – afferma Ortoleva – connettono soggetti e gruppi “per ciò che li accomuna e insieme per ciò che li separa”. In altri termini, essi fanno tanto da tramite che da confine: tanto da veicolo quanto da sbarramento. E porta l’esempio del telefono, che ci consente un’intimità anche più forte del vis-á-vis ma al contempo rende più struggente l’assenza di fisicità, così come la connessione in rete è sì una porta aperta sul mondo ma può diventare una “porta chiusa rispetto alla relazione col più vicino e contiguo”. Una visione teoricamente avvertita dei poteri e dei limiti del medium Tessiture 159 Fabbri, orafi, liutai univano conoscenza materiale e abilità manuale: mente e mano funzionavano rinforzandosi, l’una insegnava all’altra e viceversa. E non è il solo lavoro manuale a giovarsi della sinergia tra teoria e pratica, perché chi sa governare se stesso e dosare autonomia e rispetto delle regole, sostiene Sennett, non solo saprà costruire un buon violino, un orologio perfetto o un ponte capace di sfidare i millenni, ma sarà anche un cittadino giusto. La questione è generalizzata per tutti i profili del lavoro umano: cuochi, medici, infermieri, musicisti, lavoratori del web e, come si è detto, da parte dei genitori, nell’arte difficile di tirar su i propri figli. Il lavoro, qualsiasi lavoro fatto a “regola d’arte” è “il fondamento della cittadinanza” (p.276). La stessa vita umana in quanto opera d’arte (Bauman) conosce le resistenze e le difficoltà della trasformazione e si esercita per tutto l’arco della vita stessa a controllare l’autoformazione incrementando la tempra morale. Tornano utili oggi queste riflessioni su un modello di apprendimento che prendeva corpo in un lungo apprendistato di autoapprendimento, ricco di occasioni per la conquista di una tecnica e una competenza, ma anche di un comportamento (Kultur + Aufklärung), perché la virtù della mano implica sempre la conquista di un autocontrollo “rilassato”. E altrettanto richiede l’arte della vita. Quaderni di comunicazione 10 160 non può trascurare insomma di fare i conti con questa doppiezza; questo “carattere bifronte della nostra modernità mediatizzata”. Doppiezza che è anche ambiguità. Ai benefici della liberazione dagli aspetti più ossessivi e non di rado ipocriti della vita comunitaria (la contiguità dei vicini) nel tempo andato, sono subentrate da una parte le ansie da prestazione nello spazio aperto della comunicativa illimitata, che consente di raggiungere e farsi raggiungere ewerytime, everyweare; dall’altra la ricerca di una privacy posta a suprema difesa dei propri spazi di interiorità. Come effetto della sovraesposizione mediatica va infatti crescendo un bisogno di solitudine fisica; il diritto di “essere lasciati stare” (left alone) che resta la più inclusiva delle libertà da. Un’ambiguità, che rafforza due esigenze contraddittorie ma entrambe radicate nella vita psichica, dal momento che pur essendo la solitudine un bisogno intimamente intenso, l’essere esclusi dai simili è, come ben sapeva Cechov, chiamato a testimone dall’A., “la più terribile delle condanne”. Della comunicazione se ne sono esaltate e se ne esaltano tutte le profezie apocalittiche o utopiche, di grande fascino per chi le enuncia e per il pubblico che le accoglie: fine dell’uomo gutenberghiano, intelligenza collettiva, trionfo del cyborg, ecc. ecc. Meno seducente invece l’immersione nella quotidianità, produttrice di banalizzazioni e riduttrice a routine di quegli aspetti della vita una volta protetti: dall’onore della parola alla rappresentabilità pubblica della sfera erotica. Non disponiamo più, nell’èra della comunicazione illimitata, di spazi di vita protette dal dominio dei media. All’ambiguità andrebbe poi aggiunta la vaghezza dello stesso termine medium. Occorrerebbe – secondo l’Autore – entrare dentro lo spessore dei media intesi come realtà fisica e come presenza sociale e simbolica, e insieme andare oltre i media stessi, per interrogarci sulle relazioni contraddittorie che hanno con i loro utenti, con gli altri media, con se stessi e le proprie diverse potenzialità (di comunicazione e non solo). A seconda dei contesti infatti, precisa l’Autore, quando diciamo televisione indichiamo una tecnologia, anzi un insieme di tecnologie (tv analogica e digitale, via etere, via cavo o satellitare) e un’istituzione, anzi una pluralità di istituzioni (tv pubblica, commerciale, ecc.); un linguaggio (i generi propri della tv) e perfino un luogo e un oggetto: dicendo televisione diciamo pure un luogo (e un bisogno) di rilassamento, proprio come dicendo cinema pensiamo a un luogo che può darci delle emozioni. Questa sovrapposizione di significati vale per tutti i media, tutti ugualmente carichi di implicazioni tecniche e culturali, sociali, operative, e sarebbe perciò sbagliato pretendere di separare rigidamente le diverse componenti che li costituiscono, anche se è stata forte, nel corso del Novecento, la tentazione a tenere scissi il fatto sociologico da quello tecnico, gli aspetti economici da quelli culturali, in omaggio alle diverse scienze umane che dei media si occupano. Sbagliata pure una rigida contrapposizione tra processi esterni ed interni rispetto al mondo della comunicazione. La storia dei media – sostiene l’A.- è solo uno degli strumenti di conoscenza dei processi di trasformazione della contemporaneità, e qualsiasi pretesa di isolare ed escludere i fattori esogeni porterebbe con sé una “inaccettabile ambizione egemonica, basata sulla pretesa che la comunicazione diventi il motore dell’intera storia contemporanea”. Se è indubitabile dunque il peso dei media nella storia del Novecento, si tratta di riconoscere che la loro dinamica si è intrecciata con lo sviluppo di altri aspetti della vita sociale e del progresso tecnico-scientifico del secolo. Il fenomeno della pornografia, ad es., su cui Ortoleva si concentra nella seconda parte del libro, fa corpo esso stesso con quella “spirale della crescita” della comunicazione che egli esamina nella prima parte (la comunicazione come processo che si autoalimenta, che non basta mai; il bisogno di comunicazione perennemente insoddisfatto, ecc.). La caduta dei limiti tradizionali del dicibile (l”onore” della parola perduto) e del rappresentabile (il corpo svelato) costituisce per l’Autore una delle spie “attraverso cui possiamo misurare quanto gli strumenti e i modi del comunicare influenzino la vita personale, dei gruppi, delle collettività”. Certo, per chi è nato dopo i Settanta, sono Una forma di scissione se possibile ancora più estrema è alla base della pornografia, a cui Ortoleva dedica molte pagine centrali di questa ricca ricerca, sottoposta a tensioni apparentemente contrastanti: da un lato la tendenza a rivolgersi al mondo dei media per soddisfare domande strettamente legate alla sfera del corpo (dal sesso alla vita salutare, al fitness, ecc.), dall’altro il consumo del corpo umano in immagine, in sostituzione-compensazione di un contatto fisico. I media elettronici, e in particolare la televisione, hanno rotto le barriere invisibili che separano i diversi ambienti comunicativi, in particolare hanno fatto cadere ogni separazione tra dentro e fuori. La televisione ”ha lacerato i veli, ha rotto gli argini rituali di ogni segretezza”. Quest’opera di disvelamento compiuto dalla televisione e ampliato con l’avvento delle reti, ha fatto cadere quella che “per molto tempo era stata la caratteristica distintiva dell’universo erotico nel quadro della comunicazione mediatica, ossia il suo confinamento in “musei segreti”, circuiti morbosi dello spettacolo vietato ai minori”. Da raro e costoso oggetto di consumo, la pornografia sarebbe diventata in poco tempo un contenuto transmediale, ”banalizzato e diffuso in tutti i comparti della cultura di massa; un consumo mobile e contrattabile non su norme etiche quanto su regole di costume o di gusto”. Negli anni Ottanta e Novanta la pornografia avrebbe ridotto la propria visibilità pubblica, mentre il mercato si andava consolidando con la individuazione di target differenziati di consumo privato. Ma il “carnevale moderato” di quegli anni, di cui gli analisti sociali parlano come di vero e proprio brodo di coltura del berlusconismo, avrebbe profondamente modificato il quadro delle relazioni più profonde, ossia quello della comunicazione. Altre ricche riflessioni aggiunge Ortoleva nella terza parte di un libro da gustarsi fino in fondo sullo sport, sulla canzone nella cultura di massa, sulla stampa in questo nostro tempo di immersione della notizia nelle compatibilità delle aziende televisive. Ecco infine la domanda cruciale: sono ancora utili i giornali? Avranno un futuro? E qui l’autore preferisce dare la parola a Tocqueville, un testimone che merita attenzione se si vogliano approfondire i nessi tra media e democrazia: “sono tanto più necessari, quanto più l’individualismo si fa temibile”. Una lettura, anzi uno studio attento, di queste pagine che costituiscono il secondo tempo di un’altra nota e importante indagi- Tessiture 161 incomprensibili i tabù che hanno gravato sulla parola (il rispetto della parola data, fondatrice della onorabilità delle persone) e sull’intimità. Come è avvenuto questo brusco mutamento di regole, anzi di regime della parola e della rappresentazione, rimasto intatto fino ad almeno il primo decennio della repubblica? Come si è arrivati dalla sacralità dell’onore e della parola all’elogio della rettifica continua? E come siamo passati dal tabù all’esibizione del sesso “dal massimo terrore per lo scandalo, alla sua irrilevanza”? Ortoleva ci fa capire come una delle cause della caduta dell’onore connesso alla parola detta o data, è dovuta alla scissione del messaggio dal contesto, alla perdita di senso dei tabù connessi al giuramento. A questo atto di comunicazione infatti è stato per millenni conferito un valore “che andava oltre qualsiasi contenuto comunicato, proprio in forza del contesto rituale un cui veniva effettuato, al legame esistente tra la parola pronunciata e lo spazio-tempo che l’accoglieva e ipso facto la consacrava”. Ma ecco che nel momento in cui il messaggio (qualsiasi tipo di messaggio) acquista una sua autonomia dal luogo e dal momento in cui è emesso, la parola ritualizzata perde ogni valore. È un altro aspetto della globalizzazione su cui non avevamo riflettuto abbastanza: un parlare senza luogo e senza tempo nel mentre amplifica un messaggio, alleggerisce proprio a ragione dell’everywheare, everyone, everytime, che costituiscono le nuove categorie di una comunicazione illimitata, la responsabilità connessa agli atti linguistici. La parola affidata al mezzo, alle piattaforme comunicative, gode insomma di un nuovo statuto di leggerezza rispetto alla parola detta in situazioni in cui la fisicità delle persone si contestualizza in un ambiente. Quaderni di comunicazione 10 162 ne di Ortoleva, (Mediastoria, Il Saggiatore 2002), non dovrebbe assolutamente mancare in un programma di studi di scienze della comunicazione che si rispetti. Angelo Semeraro D. Sassoon La cultura degli europei. Dal 1800 a oggi Milano, Rizzoli, pp.1600, 45 Nella metropolitana di Londra gli occhi annoiati di un paio di viaggiatori si posano sulla pubblicità affissa alle pareti. Alcune donne sfogliano riviste patinate, altri scorrono le pagine degli opuscoli “Poesia in metropolitana”. Chi ha la fortuna di essere seduto legge magari un quotidiano, ci sono il popolarissimo «Sun», il liberale «Guardian», il «Financial Times», molti sfogliano «Metro» e potrebbero essere in qualsiasi città europea. C’è anche chi legge un libro, un classico come un romanzo contemporaneo, un racconto rosa oppure un saggio scientifico. Una persona anziana completa le parole crociate, un ragazzo gioca con il Nintendo DS, un paio di ragazze hanno auricolari all’orecchio, con il filo dell’iPod che scompare nella borsa e i piedi che battono il tempo. La scena potrebbe ripetersi in qualsiasi metropoli del vecchio continente. Oggi, molto più che nel passato, produrre e consumare cultura è un’occupazione centrale nella vita degli europei, le opportunità di una comune commessa – negli spazi pubblici e privati, per strada, in metropolitana o in casa – sono straordinariamente più alte di un qualsiasi aristocratico di fine Settecento. In sintesi, e semplificando, la storia si sviluppa in questi termini: nell’Ottocento nasce la cultura e il modello di consumo borghese, nutrito da giornali, romanzi e spettacoli metropolitani. Nel Novecento il cinema, la musica registrata, la stampa popolare e i libri economici danno vita alla cultura di massa. Con la radio e la televisione si costruiscono comunità nazionali che ascoltano e guardano programmi simili nel privato dei salotti. In questo scenario mediale che cambia, dominano un numero limitato di centri culturali. I romanzi erano prevalentemente inglesi e francesi, poi russi e americani. La musica era italiana, tedesca e francese, più tardi diventerà americana, inglese e sudamericana. Il cinema, come il commercio internazionale di programmi televisivi, diventerà presto di dominio americano. Oggi, applicando a nuovi prodotti tecnologie e modelli americani, la frammentazione e la varietà tende ad aumentare, il globale si avvicina al locale e il consumatore diventa sempre più produttore. Se questa è la sintesi, la storia dettagliata della straordinaria espansione del consumo culturale nell’arco degli ultimi due secoli costituisce il tema principale del monumentale La cultura degli europei. Dal 1800 a oggi, (Rizzoli, 1600 pagine, 45 euro). Appunto 1600 pagine che valgono una enciclopedia, realizzate dallo storico inglese Donald Sassoon, professore di Storia europea comparata presso il Queen Mary College di Londra, nell’arco di dieci anni di studio e ricerche ed accolto alla sua uscita britannica da Eric Hobsbawm come uno dei libri più importanti dell’anno. Un viaggio attraverso le forme dell’industria culturale che hanno attraversato due secoli, e in larga parte sono sopravvissute pur cambiando e rigenerandosi, raccogliendo una quantità smisurata di dati e informazioni che vive di una tensione cumulativa e propone un’analisi comparativa mettendo insieme uno sguardo economico e uno geografico, ed entrando nei meccanismi dell’industria culturale, dal romanzo al film, dall’illustrazione alle reti. «“L’industria della cultura è un’industria del piacere che si alimenta di se stessa ed è illimitata», spiega Sassoon, e si gioca sui canoni di continuità e innovazione, ripetizione e cambiamento, standardizzazione e rischio. Le rivoluzioni tecnologiche vengono accompagnate da un atteggiamento conservatore nella produzione di generi e modelli narrativi che approdano nel Novecento dei media audiovisivi, fino alle più recenti narrazioni digitali. Lo storico ricostruisce gerarchie dei consumi che sono magari rintracciabili direttamente negli indici Giovanni Fiorentino Jean-François Lyotard Discorso, figura Mimesis, Milano, 2008, pp. 521, 23,00 L’Editrice milanese Mimesis, da meritoriamente alle stampe un robusto saggio di Lyotard edito in originale nel 1971 e mai pubblicato in Italia. La fortuna mediatica del filosofo francese è immediatamente associata al più noto La condition postmoderne (1979); in realtà Discours, figure è la prima opera di ampio respiro di Lyotard e rappresenta una sorta di nucleo teorico e di organizzazione preliminare di una serie di questioni che sono poi confluite in opere quali Dérivé à partir de Marx et Freud (1973), Des Dispositifs pulsionnels (1973) e, soprattutto, Economie libidinale (1974). Ma fondamentalmente Discours, figure costituisce un grande passaggio teoretico di allontanamento dalla prima opera filosofica di Lyotard, La phénoménologie, datata 1954 e, per inciso, la sua personalissima transizione filosofica dalla fenomenologia al post-strutturalismo. Di formazione fenomenologica, passato attraverso l’esperienza politica di Socialisme ou barbarie, Jean-François Lyotard (19241998) è, a ragione, considerato il padre del postmodernismo filosofico. Tuttavia, già tra la fine degli anni Cinquanta e la metà degli anni Settanta si muoveva in piena atmosfera filosofica poststrutturalista, con un recente passato militante di esperienza marxista-eterodossa e con una spiccata vocazione all’eclettismo negli studi e nelle produzioni saggistiche. Con La condizione postmoderna, infatti, si è esplicitamente avviato un tipo di riflessione filosofica, le cui tematiche sono state importate dall’America dopo che gli Stati Uniti, a loro volta, avevano già mutuato dal clima filosofico europeo problematiche e nozioni (Kristeva, Hassan). In effetti, il volume-manifesto del 1979 nasce dalla quasi casuale commissione dello Stato del Quebec di una ricerca sull’assetto del sapere nelle società più sviluppate.. La fortunata nuova epistemologia di La condition postmoderne, che presuppone una società dominata dai criteri della prestazione, della velocità, e della retroazione, nella quale anche la figura dell’intellettuale risulta marcatamente modificata rispetto ai tratti della tradizione del passato, è però fortemente debitrice di un complesso di questioni che trovano la propria cornice proprio nella delicata transizione filosofica di Discours, figure, la cui importanza, Tessiture 163 sterminati. Basta guardare quello dei nomi ad esempio. Sono il riflesso di uno sguardo che si concentra largamente sull’Ottocento e sulla natura seriale, industriale, di una macchina produttiva che ruota intorno a libri e giornali finalmente a prezzi bassi, e fa emergere figure come l’autore, l’editore, il tipografo, il libraio e personaggi, appunto gli scrittori e i drammaturghi accanto a cantanti e attori. Eccoli i nomi più citati: sono quelli di grandi scrittori ottocenteschi, Dickens insieme a Victor Hugo, Balzac e Dumas padre insieme a Eugene Sue. L’inclinazione letteraria del percorso è forte, la natura visiva dell’Ottocento, che pure è forte, quasi sparisce nell’economia del testo. Emerge un’Italia che soffre in questo panorama, non riuscendo a maturare una sua macchina produttiva autonoma. In una storia che vede prima dominare le due grandi capitali europee, Londra e Parigi innanzitutto, poi lasciare sempre più spazio alla preminenza degli Stati Uniti, si arriva, ad esempio alla fine del Novecento, al consumo bassissimo di stampa degli italiani rispetto agli altri paesi europei. Eppure l’Italia ritorna, e con una certa forza, persino nell’indice dei nomi. Giuseppe Verdi come la Bbc, Vincenzo Bellini accanto al «Times», la via italiana alla cultura popolare è segnata dal melodramma, Rossini e Puccini, vengono esportati a Parigi ancora più che Londra, sulla scena del teatro dell’Opera da una parte e Covent Garden dall’altra. Nel mutamento dei mercati culturali, l’Italia dunque trova spazio, almeno – o solo – fino a un certo punto, nelle principali piazze europee attraverso la forza di parole in musica. Quaderni di comunicazione 10 164 pertanto, è ancora più significativa per comprendere l’intero percorso del filosofo francese. Percorso che, a partire dalla fenomenologia, conduce verso una sua peculiarissima decostruzione ad opera del desiderio e dell’inconscio freudiani. Leggere Discorso, figura, in questo senso, rappresenta un’operazione ermeneutica indispensabile per comprendere la progettualità completa di un percorso di pensiero che negli esiti postmoderni ha visto semplicemente una parentesi para-sociologica, ma che è molto più lineare di quanto non possa apparire a una osservazione poco profonda. Dalle oltre cinquecento pagine si evince subito una tensione prettamente estetica rispetto a un ripensamento dell’elemento “figurale”. I referenti di questa fase sono ancora di ispirazione fenomenologica (Merleau-Ponty, Dufrenne, Ricoeur), ma lo scenario che si offre è già quello dell’esercizio della differenza a opera di una metodologia della decostruzione, che non ha nulla a che fare col celebre concetto di Destruktion di Heidegger (mai citato da Lyotard), così di moda nel post-strutturalismo francese degli anni Settanta. La decostruzione di Heidegger e delle scuole ontologico-ermeneutiche era pensata come “modalità tetica”, ovvero come un modo “positivo”, dialettico, di comprendere la realtà e l’uomo all’interno di una logica dell’opposizione. Lyotard, al contrario, sposta la decostruzione dal piano dialettico al piano energetico, virando dunque dalla logica oppositiva dell’ermeneutica alla differenza dei maestri del sospetto: Freud, Marx e Nietzsche. Lyotard vuole “partire” da Marx e Freud per presentare una diversa nozione di soggetto, scevra da ogni possibile inibizione teologica, che riconosce non solo alle ontologie ma anche – e soprattutto – a certi tic della Scuola di Francoforte (in particolare ad Adorno). L’ipotesi di partenza del filosofo francese è quella secondo la quale, di fronte alle nuove forme di capitalismo contemporaneo (che non è più quello “tragico” di Adorno e Marcuse, ma piuttosto un capitalismo “energico” e “cinico”) sia necessario un armamentario filosofico meno nostalgico è più raffinato. Il capitalismo “energumeno” che Lyotard esamina, va analizzato con una spinoziana ricerca della comprensione, piuttosto che criticando la società e rimuovendone tutti i grumi di senso. Non ha utilità, dunque, la ricerca di uno Spirito o di un Sistema (come per i Francofortesi), ma occorre disvelare un inganno, una lusinga (une léurre) che è alla base delle filosofie del logos e della ratio. Il desiderio di ordine, di armonia, di logicità di tali filosofie occidentali, viene da Lyotard sovvertito e capovolto da un estetica del “figurale”, dalla visione fluttuante dello strumento “occhio” come macchina demitologizzante che, al contrario, interpreta la storia attraverso le “figure cattive” dei rovesciamenti, dei desideri, del disordine sociale e culturale dei periodi di mezzo della storia stessa. I nuovi rebus della società, insomma, non si offrono alla “lettura”, ma semplicemente alla “visibilità”, la cui carica figurale ha altrettante gradazioni e specificazioni di quante non ne possano avere le categorie kantiane. Questo spostamento di interpretazione dal logos all’occhio, allora, non può che servirsi di una nuova mappa di ricerca che deve necessariamente fare i conti anche col mondo del sensibile per eccellenza, quello dell’arte e della letteratura. I concetti filosofici, da soli, sono insufficienti a comprendere la realtà e le metafore del mondo artistico sono preziose, e passano attraverso la lente privilegiata di interpreti quali Cézanne, Masaccio, Klee, Mallarmé, Claudel, Mantegna, Breton, Apollinaire, Pollock. Interpreti che riescono a suscitare la rêverie, ossia la capacità di interpretare non solo i segni ma anche i sogni che compongono lo spazio figurale dell’umanità, in una tensione che Lyotard stesso definisce apaideutetica, cioè di dis-apprendimento per un nuovo apprendimento sensibile, prima che intellettuale. Un testo denso e di solidissimo impianto filosofico, ma attraversato da una levità di figure e proposte che ne sdrammatizzano ogni possibile gravità teoretica. Mimmo Pesare Apogeo, Milano, 2008, pp. 207, 13,00 Siamo di fronte a un altro esempio di importante operazione editoriale: come nel caso del testo di Lyotard, si tratta anche qui dello scritto di un grande filosofo, per la prima volta tradotto in italiano a distanza di molti anni dalla sua pubblicazione originale. Il libro raccoglie una miscellanea di contributi a corredo del testo originale di Buber, Colpa e sensi di colpa (Schuld und Schuldegefühle), che è poi una conferenza tenuta da Buber alla Washington School of Psychiatry nell’aprile del 1957 e pubblicata nello stesso anno dalla rivista tedesca “Merkur”. In quell’occasione, il filosofo, massimo esponente dell’ebraismo europeo del Novecento, spiegava la sua posizione critica nei confronti della psicoanalisi e delle psicoterapie dando la sua personale visione del rapporto esistente tra una oggetività della “colpa” e una soggettività dei “sensi di colpa”. In altre parole, la posizione di Buber era quella di una rivendicazione oggettiva della realtà ontologica della “colpa”, che è insita nella struttura etica e trascendente dell’essere umano e che, pertanto, è irriducibile alla dimensione psicologica del “senso di colpa”, dal quale le psicoterapie promettono una liberazione eudeimonica e di benessere personale. Sebbene Buber non sia stato mai uno psicoterapeuta, si era interessato alla malattia mentale fin dalla pubblicazione della sua opera principale, Io e Tu (1923-1958), dopo la quale (e in coerenza con la sua “filosofia dialogica”) era arrivato a sostenere che “le malattie dell’anima sono malattie della relazione”. In questo periodo, tuttavia, il filosofo ebraico aveva pubblicamente e ripetutamente criticato in maniera aspra le teorie di Freud e di Jung, che considerava amorali per la loro concezione della religione e della trascendenza. Soltanto nel 1957, con la pubblicazione di Colpa e sensi di colpa, Buber diede forma definitiva alla sua idea: il bersaglio principale del saggio è la concezione immanente e psicopatologicodeterminista di Freud e Jung (in particolare il primo) rispetto al sentimento della colpa. Questa non potrebbe venire estirpata da una cura psicologica perché non sempre è il frutto di un gap nevrotico. Al contrario, essa possederebbe una valenza esistenziale della quale non solo va tenuto conto, ma che, addirittura, sarebbe essa stessa portatrice di senso. La colpa esistenziale, insomma, non rappresenterebbe un lago di angoscia da prosciugare, bensì una miniera di significato fisiologico dell’antropologia filosofica, causata dalla “violazione” di imperativi morali fondamentali e validi a prescindere dalla cultura, dall’epoca storica e dalla geografia. Ora, il compito di chi recensisce un libro è quello di rendere conto della portata scientifica di un lavoro di ricerca, ma anche quello di consegnare la propria responsabilità di lettore ad altri lettori e quindi di “dare un nome alle cose”. Diamo un nome alle cose, dunque. Il pensiero di Buber è uno dei grandi frutti del Novecento filosofico europeo e chi si occupa di antropologia filosofica non può che riconoscergli una enorme ricchezza di spunti e un ventaglio di questioni trattate con analisi raffinatissime e rara acribia metodologica. Il fatto è che, evidenziate le dovute distanze temporali e culturali con un filosofo che non ha mai fatto mistero della sua tensione al trascendente, l’operazione editoriale di Apogeo pare quasi voler utilizzare la conferenza di Buber come corroborazione alla causa della – ormai celebre – consulenza filosofica. Abbiamo avuto modo di parlare, in precedenti numeri di questo Quaderno della progressiva affermazione della Philosophische Praxis; di tutte le pubblicazioni alle quali negli ultimi anni ha dato luogo e del fatto che, all’interno dello statuto disciplinare del counselling vi sia ancora una impossibilità di avanzare una proposta teoretica unanime (tra le diverse scuole) sulle linee guida che dovrebbero rappresentarne gli assunti di massima. Fondamentalmente, più che sui dettagli della metodologia tecnica del dialogo, esiste una certa ambiguità sui campi di applicabilità del counselling: quanto un counsellor può “osare” nel dialogo socratico, non esercitando la professione Tessiture 165 Martin Buber (a cura di Luca Bertolino) Colpa e sensi di colpa Quaderni di comunicazione 10 166 di psicologo e non avendo le competenze per impedirsi di confondere un semplice dilemma esistenziale con una sofferenza psicopatologica? Lo scritto di Buber, in questo senso, porta acqua al mulino di chi crede di poter sbarazzarsi di buona parte dell’aiuto che le psicoterapie possono dare, in quanto si reitera la colpa non come un sintomo nevrotico che può essere lenito ma come una sorta di marchio ontologico la cui portata è necessaria perché esistenziale. Va come merito al curatore quello di aver presentato una rosa di contributi che rende conto della polimorfia delle voci sull’argomento e dei diversi punti di vista scientifici: vi sono, oltre che consulenti filosofici (Bertolino, Poma e Lahav), filosofi e psicoanalisti (Galimberti, Francesetti) e psicologi (Quaglino). Tuttavia il punto finale del discorso viene offerto all’opinabile teorizzazione del già criticato Ran Lahav, che ancora una volta radicalizza e legittima posizioni teoriche poco dimostrabili e che possiedono un pericoloso gradiente iper-cognitivo, dal vago sapore conservatore. La colpa, in questo senso potrebbe essere analizzata attraverso una vera e propria ricetta di razionalizzazione della propria esperienza profonda di vita, che comprende una serie di passi precisi e ripetibili, non tenendo conto del vissuto emozionale del singolo. Non solo, nella interpretazione di Lahav, sostenuta per altri versi anche dal curatore del volume, la colpa possiederebbe addirittura i caratteri di una “chiamata” esistenziale, con tutto l’ingombrante armamentario di termini che tale concetto si tira dietro (“peccato”, “espiazione”, “riconciliazione”). Alla luce di questa lettura, secondo la quale la colpa non sarebbe la manifestazione di un malessere da lenire ma una realtà oggettiva dell’esistenza umana, consegue dunque – nelle intenzioni di questo collettaneo che il curatore definisce una “opera di scuola” – che la sua fenomenologia non possa essere affidata alla psicoanalisi, in quanto disciplina non legittimata a occuparsene per ovvi “limiti”, ma alla consulenza filosofica. Proprio con quest’ultima proposizione Bertolino costruisce un impegnativo discorso, fatto di logica aristotelica e artifici retorici kantiani, che ha come fine la dimostrazione di come lo scritto di Buber sia una sorta di vera e propria “fondazione” della consulenza filosofica, la quale, in questi termini, si autolegittimerebbe come una “alternativa” alle psicoterapie. Questi passaggi paiono però altamente parziali, se non addirittura poco percorribili, almeno per la poca esaustività con la quale viene presentata la metapsicologia freudiana e l’opera di Jung, intese come “controparte” del discorso. Mimmo Pesare Marìa Zambrano Per l’amore e per la libertà. Scritti sulla filosofia e sull’educazione Marietti, Genova, 2009, pp. 193, 24,00 Marìa Zambrano è stata una di quelle pensatrici per le quali è più corretto parlare di “opera intellettuale” piuttosto che di “pensiero filosofico”. Il suo contributo alla storia della filosofia, infatti, non è limitato alla messa a punto di un sistema di idee e alla pubblicazione di saggi, come pure è successo per tanti grandissimi maestri del pensiero. La Zambrano è un esempio della misura in cui il fuoco del sapere non sia scindibile dalle vicende personali, dalla vita vissuta, al cui interno la filosofia non rappresenta solo l’esercizio del pensiero critico e creativo ma possiede anche una valenza di guida pratica nello sviluppo completo della persona. Proprio per questo, al di là delle declinazioni eclettiche dei suoi scritti (dall’estetica alla poesia, dai temi sociopolitici alle questioni squisitamente etiche), il collante della sua produzione si può considerare raccolto attorno al concetto di educazione. L’educazione, per Marìa Zambrano, non è un sotto-tema delle discipline pedagogiche, tout court, ma la cartina di tornasole per la vocazione filosofica della Zambrano e il suo continuo lavoro di cesello per la strutturazione di una originale filosofia dell’educazione, sono sempre accompagnati da un’esigenza – pedagogica – di comunicazione. I suoi scritti sono lo specchio della sua esperienza biografica, dalla quale emerge sempre forte una tensione alla condivisione del sapere, che anche quando rimane all’interno di un pensiero alto, aristocratico delle aretai filosofiche, ugualmente si declina su un piano di disponibilità alla trasmissione, di dono della cultura che è trasversale alle classi socio-culturali e ai segmenti didascalici delle istituzioni scolastiche. Si tratta di una vera e propria congiunzione tra vocazione intellettuale e vocazione pedagogica, che, dunque, dà senso tanto alla sua portata “pratica”, carica di valenze sociali, quanto alla profonda preoccupazione per una analisi raffinata dei temi educativi intesi come Grundwort, “parole fondamentali” del pensiero. Il corollario pedagogico, alla luce di questa metodologia di lavoro intellettuale, appare in tutta la sua pregnanza: educazione come dimensione “intera” della persona, che nell’esperienza limite dell’insegnante – e dell’insegnante di filosofia in particolare – tiene necessariamente fermo il legame tra cultura e responsabilità. Probabilmente a ragione di questa ricerca dei caratteri carsici e immutabili del rapporto tra educazione e persona, le pagine della Zambrano sulla gioventù e sulla sua delicatissima dimensione ontologica, possiedono una freschezza e un’attualità molto più suggestive delle recentissime analisi sociologiche sullo stesso argomento. La sua lente d’ingrandimento avvicina una sorta di antropologia emozionale dei giovani che pare resistere alle epoche storiche e alle mode, proprio perché poggia la sua attenzione sulle dinamiche profonde, più che sulle rappresentazioni sociali. Il risultato è un panorama a largo spettro che restituisce con rara lucidità un percorso di pensiero originale e allo stesso tempo divulgativo. Mimmo Pesare Tessiture 167 comprensione dell’intero comparto delle scienze umane. Riflettere sull’educazione, nella sua accezione più vasta – potremmo dire: ontologica – equivale, nella proposta della pensatrice spagnola, a ri-programmare una sorta di nuovo umanesimo che prende contatto con l’essere umano in quanto scandaglia le sue radici politiche (in senso etimologico) ed economiche (in senso etimologico). In questa raccolta di saggi – alcuni dei quali inediti – della Zambrano, sebbene vi sia una polimorfia degli argomenti trattati e una distanza anche temporale tra di essi, il filo del discorso è proprio costituito dalla trattazione profonda della questione educativa. Si tratta di scritti tratti dalle riviste “Semana”, “Escuela” e “Educaciòn” attraverso le quali si alternano meditazioni sulla pedagogia e sul suo legame con la società; sulla figura del maestro e sul suo ruolo epistemico, politico e intellettuale; sui caratteri della giovinezza, alcuni dei quali variano col variare delle epoche storiche, mentre altri sono, per così dire, sincronici, come l’irrequietezza e il disorientamento. Ma soprattutto è interessante soffermarsi sulla trattazione di una serie di concetti meta-filosofici che assumono una connotazione trans-disciplinare nel momento in cui vengono risemantizzati alla luce della filosofia dell’educazione della Zambrano: la libertà, l’efficacia, la comunicazione dei sensi, la delicatezza, la vocazione, il segreto, la realtà. Il crinale disegnato è quello per cui, da una parte emerge la necessità di lavorare sul tema filosofico dell’educazione e sui caratteri dei giovani di ogni tempo; dall’altra, l’Autrice tenta di mostrare alcuni guadagni della sua filosofia incarnata nella prassi di un tempo – la Spagna franchista – in cui l’intellettuale non può permettersi di restare esterno alla realtà storico-politica. L’insegnante non può rappresentare semplicemente una professione “mansionaria” in quanto la sua struttura interna è definita dalla vocazione a farsi “mediazione vivente” e corrisponde a un’attitudine più profonda a interpretare criticamente la “crisi della realtà” e farsene carico nella quotidianità dell’insegnamento. Altro elemento centrale della raccolta: la Quaderni di comunicazione 10 168 Amelia Broccoli Educazione e comunicazione. Per un’etica del discorso pedagogico Editrice La Scuola, Brescia, 2008, pp. 255, 21,50 Nella produzione saggistica delle scienze umane, quando si compie il tentativo di accostare in maniera programmatica (fin dal titolo) due concetti eccessivamente carichi di senso e di implicazioni teoretiche, si corre concretamente il rischio di cadere nella inutilità di un ennesimo manuale compilativo. A maggior ragione, nell’accostare termini come educazione – con tutto il portato filosofico-pedagogico insito nelle sue pieghe semantiche – e comunicazione – forse il concetto più abusato degli ultimi trent’anni dalle discipline sociologiche – tale rischio costituisce quasi una eventualità ineluttabile. A meno che non si scelga di seguire un percorso che offra una personale traccia di interpretazione e che si smarchi da un tuttologismo sempre più ricorrente in operazioni editoriali di carattere manualistico. È il caso del testo di Amelia Broccoli, che si mantiene su una linea del discorso caratterizzata da uno sforzo originale e anche quando è chiamato a rispondere dei leit motiv della letteratura istituzionale su questo binomio, lo fa rendendo conto di una proposta di ricerca autonoma e fresca. Educazione e comunicazione delinea un tracciato critico che parte dal secondo dei due termini per ricostruire ed evidenziare alcuni degli elementi nascosti del primo e lo fa mettendo in cortocircuito le epistemi della filosofia greca nel suo periodo classico con alcune teorizzazioni del Novecento. Partendo dalla considerazione umanistica della impossibilità di identificare la comunicazione con le tecniche comunicative, l’Autrice compie un – legittimo e infastidito – allontanamento dal mainstream culturale-aziendale che restituisce il concetto di comunicazione esclusivamente alla “comunicazione pubblica”; gli strumenti fi- losofici sono quelli della migliore tradizione ermeneutica, come nel caso dei dissoi logoi di Heidegger in merito alla contraddittoria questione della comunicazione come chiacchiera che poi è alla base della riflessione sulla inautenticità (Uneigentlichkeit) del “si dice...si pensa....si fa” (in Essere e tempo). In un’epoca storica all’interno della quale tutto il dibattito sociologico è concentrato sul come si deve comunicare, non si può correre il rischio di smarrire definitivamente una tensione etica che sia preoccupata, ancora, del cosa comunicare, dei contenuti che stanno alla base della condivisione della cultura e dei suoi simboli e valori. Tale preoccupazione pertiene fondamentalmente a un approccio di carattere pedagogico-teoretico, in quanto solo se ci si muove nella convinzione che la comunicazione e la conoscenza siano strettamente legate, vi è una possibilità di attribuire alla seconda quel senso che la prima dovrebbe trasmettere. E l’intersezione tra la conoscenza e la comunicazione è proprio rappresentata dallo sfondo dell’educazione. Più che uno sfondo, quest’ultima, si configura come un fondo (Bestand, per usare un’altro suggestivo concetto-chiave di Heidegger), a cui attingere strumenti e risorse per educare la conoscenza a declinarsi sull’infosfera dei media digitali. È a questo punto che la proposta della Broccoli si rende esplicita: analizzare la biforcazione storica tra la comunicazione come trasmissione e la comunicazione come relazione attraverso un tracciato analitico che individua l’eziologia seminale di questa transizione nell’accostamento dialettico tra il mondo greco e le filosofie dialogiche del Novecento (in particolare Lévinas, Buber e Ricoeur). A questo viene praticato un interessante innesto con autori apparentemente lontani, come Ebner (e la cosiddetta “pneumatologia della parola”), come Frankl (il fondatore della scuola psicoterapica della Logoterapia, di matrice onto-fenomenologica); per arrivare addirittura a un sorprendente, quanto puntuale contributo di Wittgenstein, che non è “solo” verificazionismo e Circolo di Vienna, ma presenta una profonda ricchezza all’interno dei – poco studiati – Diari Segreti, all’interno dei quali, come Mimmo Pesare Angelo Semeraro Hypomnémata. Lessico di comunicazione sensibile Besa Editrice, Nardò, 2008, pp. 220, 15,00 All’interno di un fascicolo monografico dedicato al racconto di sé, un volume che già nel titolo evoca le tecniche narrative del mondo antico rappresenta una traccia privilegiata per ragionare sull’attualità di tale esperienza di scrittura. “Tecnologie del Sé” ante litteram, come Foucault ricordava nelle ultime lezioni dei suoi corsi al College de France, gli hypomnémata costituivano particolari esempi di diari di viaggio, all’interno dei quali non c’era solo il racconto di quanto l’osservazione del viaggiatore isolava sulla carta, ma anche tutto il suo universo emotivo, tutta la serie di suggestioni, sinestesie, riverberi, ricordi, citazioni che il viaggio stesso produceva. In questo senso gli hypomnémata potrebbero essere immaginati come la prima forma di ipertesto, la dimensione seminale di una scrittura di auto-formazione multitasking e, in qualche modo, multimediale, data dalla varietà di generi letterari che vi si mescolavano al suo interno. In questo Lessico di comunicazione sensibile, Semeraro sceglie di seguire tale traccia, affidando al lettore un peculiarissimo Moleskine sorretto da un’antologia di voci che rendono conto di un percorso intellettuale e formativo. Tuttavia, in una moltitudine di spunti e suggestioni in rigoroso ordine alfabetico, solo apparentemente Hypomnémata si presenta alla lettura con i belletti di un blog cartaceo; dietro la parvenza di uno zibaldone di ricordi e letture che l’autore, ammiccando, consegna all’esperienza delle più giovani generazioni, Hypomnémata, nasconde l’organicità di un tracciato teorico che ha caratterizzato gli ultimi anni della ricerca di Semeraro. In questo senso, tra i sapori di lemmi quali Cioccolata, Aquiloni, Ninfe, Uomo porcospino, Donne fatali – tanto per citare alcuni dei più stuzzicanti – Tessiture 169 egregiamente ha messo in luce Gargani, palpita una inimmaginabile tensione etica (la “comunicabilità della parola”). Per un verso, allora, un’attenta analisi della civiltà classica nella filosofia e nella letteratura, evidenzia il passaggio dal logos al dia-logos attraverso la comparazione dell’esperienza sofistica e delle opere di Protagora e Gorgia con la successiva lezione socratica. Per un altro – paradossalmente compiendo un grande salto, lungo quanto tutta la Modernità – il Novecento, in qualche modo, riattiva questi “sintomi dialogici” e li ripropone in maniera matura in filosofi come Buber, e in particolare in scritti antropologici come Il problema dell’uomo (meno ricordato dei più fortunati L’Io e il Tu e Il principio dialogico), dalle cui pagine trasuda tutta la crisi europea postbellica di una umanità “non più presso di sé” (Heimatlosigkheit). A corroborare l’assenza di una ricerca di sistematicità compilativa di questo saggio, la parte conclusiva, che rende conto in maniera interlocutoria di una questione che recentemente toglie il sonno a chi si occupa – filosoficamente – di comunicazione: quali caratteri dovrebbe avere una auspicabile “etica della comunicazione”? La questione è volutamente provocatoria: probabilmente il tempo presente ha consegnato a una certa obsolescenza anche il Grund della premiata ditta Habermas-Apel e la logica del Discours e della comunità pare un po’ invecchiata. Molto più attuale sembra l’Eraclito della logica degli opposti, che l’Autrice ci regala nelle pagine di chiusura. Gli opposti e le opposizioni di un pensiero che non pretende e non può pretendere di dare risposte esaustive e definitorie ma che si abbandona al dialogo degli intelletti e dei saperi. Ma questo è il terreno dell’educazione. Quaderni di comunicazione 10 170 troviamo gli elementi che hanno contraddistinto il Denkweg di Semeraro, enucleati in opere precedenti, quali Omero a Baghdad, Del sensibile e dell’immaginale e Pedagogia e comunicazione. Mi riferisco ai rodati topoi di voci quali Cura di sé, Efficacia, Mixofilie, Paideia omerica, Pensiero laterale, Reincanto, Caverne, Estropia, tutti in armonico dialogo tra i loro semantemi e la loro archeologia culturale. E accanto a essi, immersi nelle voci del lessico, troviamo anche i nomi di autori che hanno accompagnato tale percorso, come Günther Anders, Platone, Salvemini, Isidoro di Siviglia, Foucault, Spinoza, per citarne solo alcuni. Più che un semplice diario di viaggio, dunque, una biografia intellettuale per idee, un ventaglio di quel sapere immaginale che l’Autore raccoglie con freschezza di spunti e suggestioni. Le “voci aperte” di Hypomnémata indicano il vettore esistente tra l’immaginario collettivo e i modi di trasformare le sue folgorazioni e i suoi aforismi in patrimonio educativo e narrazione del Sé sociale attraverso il Sé individuale. Da una parte, la produzione culturale del nostro occidente, dunque, dall’altra l’operazione euristica della scelta e della sistemazione dei suoi contenuti all’interno di un contenitore che ne indica le possibilità di attualizzazione e di rinnovato consumo. Da Gramsci a Pasolini, è patrimonio comune l’idea secondo la quale nessuna opera intellettuale, che possa dirsi tale, può essere asettica e neutra: c’è sempre una volontà di proporre una interpretazione, una ri-creazione del mondo sociale, uno sguardo poietico sul vissuto quotidiano e sulle dinamiche culturali della collettività. E proprio lo sguardo continua a essere il leit-motiv: lo sguardo come reale possibilità di cogliere le modificazioni della cultura e della società per liberare le potenzialità che le immagini esterne detengono sul nostro modo di sintonizzarci col tempo presente, pur nel caleidoscopico vortice di pixel umani che affollano le nostre vite. Lo sguardo come fenomeno di riscoperta del Sé in quanto auto-.narrazione, insomma, che riecheggia in un nuovo modo di intendere il concetto di epistemologia educativa, attraverso l’attenzione a un ritorno forte e assolutamente attualizzato di motivi spinoziani e foucaultiani. “Écrire, résister”, esorta Semeraro: lo scrivere di sé attraverso le immagini e gli sguardi della propria epoca culturale per reificare una forza tellurica che, in tempi in cui il frastuono info-comunicativo sembra avere dato preminenza agli aspetti freddamente cognitivi e logici della mente, può essere considerata un’occasione preziosa per decifrare i caratteri e per scorgere i sintomi di una società. I sintomi sono ciò che appare, ciò che necessita di comprensione e metabolizzazione, e nella scrittura di sé, andando oltre al mero racconto narcisistico della propria persona, ricordare i consumi culturali della propria vita equivale a depositarne il peso specifico. Questo intende Semeraro quando, per esempio, parla del concetto di immaginario: nella trasformazione di codici, di paradigmi, di semiotiche e di stilemi artistici, architettonici, visuali, resta, salda, una lente collettiva che percepisce i grandi mutamenti sociali già quando essi sembrano essere solo disegnati sulle individualità delle nostre vite quotidiane, e invece già sottolineano una tendenza, un umore del tempo. Hypomnémata cerca di cogliere questo umore, e lo fa accostando tra loro i testi che possono suggerire una possibile lettura del presente, una possibile chiave di interpretazione del quotidiano. Come si conviene tanto alle buone antologie, quanto alla pratica orientale dell’ikebana, l’arte giapponese della disposizione dei fiori recisi, la cui traduzione letterale è “cammino dei fiori viventi”. Le voci di questo lessico assomigliano infatti ai fiori recisi – i testi che descrivono – che, tuttavia, essendo disposti insieme, continuano a vivere in nuovi percorsi di senso, decodificano tendenze collettive e dispongono un “cammino” intellettuale rinnovato, ogni volta. Mimmo Pesare Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008, pp. 467, 29,50 Da secoli si scrive per superare i momenti di sconforto, per ritrovare se stessi. La scrittura, se adottata con metodo e regolarità, come ha chiarito per primo Freud, è uno straordinario mezzo di riparazione, di ricucitura simbolica di quanto si è lacerato e rotto dentro di noi. Un mezzo, fra l’altro, sempre a portata di mano. Un trauma, uno stress prolungato, una separazione, la rottura di un legame, un insuccesso professionale o un lutto, sono spesso all’origine di penosi vissuti di perdita e di vuoto esistenziale. Di fronte al dolore mentale, di cui anche il corpo spesso si fa portavoce, ci si sente impotenti e disorientati. Nasce così il bisogno di raccontarsi, di affidare le emozioni alla parola scritta per sopportare l’angoscia o per addomesticare, se possibile, la sofferenza. Si scrive allora per darsi coraggio, per lenire il dolore, per reagire a stati depressivi e alla solitudine, in definitiva si scrive per prendersi cura di sé. Ne è convinto Duccio Demetrio, docente di Filosofia dell’Educazione all’Università di Milano Bicocca, autore del recente “La scrittura clinica – Consulenza autobiografica e fragilità esistenziali”, dove il termine “clinica” sta a significare l’atteggiamento mentale del prendersi cura di sé e non la cura come risultato o processo di un trattamento psicoterapeutico. Il suo ultimo lavoro, infatti, è dedicato alle persone che attraversano momenti di fragilità e sentono di poter scrivere riconoscendo alla scrittura di sé un significativo potere maieutico. Dopo “Raccontarsi, autobiografia come cura di sé” e “Autoanalisi per non pazienti, inquietudine e scrittura di sé”, Demetrio ha raccolto in una complessa e ricchissima opera i risultati di oltre un decennio di studio e di lavoro in tema di autobiografia. Un’esperienza condotta attraverso innumerevoli laboratori, oltre che presso la Libera Università di Anghiari, che ha consentito di raccogliere migliaia di pagine, non di rado manoscritte, su cui si basano le riflessioni e le indicazioni pratiche raccolte e sintetizzate nel libro. Un’ampia sezione è dedicata alle testimonianze di donne e uomini intenzionati a scrivere di se stessi per reagire alla sofferenza. Si tratta di persone vittime di disagi definiti dall’autore “esistenziali”, per distinguerli da ben più gravi e vere patologie: stress, insuccessi professionali, perdite, abbandoni, lutti, invecchiamento. Un libro, dunque, che a partire da esperienze concrete, relazionali si va strutturando una vera e propria filosofia della scrittura autobiografica che diviene conoscenza di sé e, mediante una relazione professionale competente e rigorosa, può diventare un vero e proprio intervento di cura, nel senso di incrementare in chi scrive il benessere, l’autonomia, la ricognizione delle risorse spesso trascurate o dimenticate. Come ci mostra Demetrio, l’autobiografia è una guida per conoscere se stessi attraverso la narrazione di sé: nelle sue varie forme (diario, appunti, memorie, confessioni e altro) ci induce a scandagliare con “inconscio presentimento” nuclei profondi di sofferenza tenuti silenti per anni. Scrivendo, aggiunge Demetrio “avvolgiamo il male in una rete di parole”. Ma perché scrivere? Perché non limitarsi a riflettere su di sé? Ascoltarsi dentro, dice Demetrio, non è sufficiente: “il quotidiano esercizio introspettivo è circolare: i pensieri tornano ossessivamente su se stessi mentre la scrittura quasi li sbalza fuori dal corpo”. È l’“effetto esternalizzante” della narrazione, che fa sì che il problema non coincida con la persona, ma appaia come oggetto a se stante, quindi visibile e potenzialmente affrontabile. Scrivere di sé mette ordine nel caos, produce significati e metafore ma non conduce alla guarigione, non è una medicina né serve a dimenticare, tutt’altro. Ciononostante ha una funzione terapeutica perché rappresenta una forma di auto aiuto, una ricerca di senso: è un “automonitoraggio” che va a sondare blocchi emotivi e ci segnala se è giunto il momento di chiedere un aiuto professionale. Ci indica il confine tra il “fai da te” ed il lavoro clinico, perché sappiamo che la possibilità di guarigione spetta ad una Tessiture 171 Demetrio, D. La scrittura clinica. Consulenza autobiografica e fragilità esistenziali Quaderni di comunicazione 10 172 pratica all’interno di una relazione umana. Penso per questo che il libro di Demetrio non possa mancare nella biblioteca di chiunque abbia compiti professionali di cura. L’autobiografia, infatti, può diventare strumento di cambiamento, punto di svolta nella vita attraverso la consulenza autobiografica: un modo “di trattamento e di analisi di malesseri, mancanze e ferite esistenziali non riconducibili a stati patologici conclamati, come il problema del dolore, la morte nel suo avvicinarsi ineluttabile, il perseguimento della verità o di una vita sufficientemente felice, la ricerca della saggezza, la solitudine”. Consulenza che si prefigge di restituire l’individuo “alla materialità del suo essere stato al mondo: al senso di dignità di avere comunque vissuto, amato, contato qualcosa; di potere ancora essere utile a sé e agli altri”. Perché le pratiche di scrittura personale – tanto più se stimolate, incoraggiate e assistite – sono una risposta alla solitudine di chi soffre, quale ne sia la causa. Il metodo della scrittura, che si avvale di criteri sia anamnestici che diagnostici per studiare insieme agli autori le loro resistenze a ricordare e a scrivere, è un’attività solitaria che proietta sul foglio evocazioni del passato e momenti del presente. Ma il consulente scrive a sua volta di sé mentre accompagna la persona che gli si affida, in uno scambio umano, oltre che clinico, profondo. La soddisfazione che vive un autore nel consegnare al consulente la propria storia terminata è tra i momenti più significativi di questo metodo. Non meno importante è che scrittura di sé risveglia la voglia di dedicarsi all’ascolto degli altri e il suo potere curativo sta anche in questo. Diventa una portentosa “medicina” della quale non si può fare a meno. Col vantaggio che è poco costosa ed è sempre a portata di mano. Flavia Serravezza Ferrnanda Pivano Diari (1917-1973) Milano, Bompiani, 2008, pp. 1726, 50,00 Quando si parla di diffusione della letteratura americana in Italia, non si può non pensare a Fernanda Pivano, traduttrice di Hemingway, Faulkner, Dos Passos e degli scrittori della Beat Generation, nonché amica e confidente di molti di questi autori. Fu Cesare Pavese a farle capire la differenza tra letteratura inglese e americana e a influenzare le sue scelte professionali. La Nanda, come gli amici scrittori e i numerosi estimatori sono abituati a chiamarla, è stata la prima ad introdurre nel nostro paese poeti e romanzieri non sempre compresi dall’establishment letterario e culturale nostrano, come Kerouac, Burroughs, Ginsberg, ma anche gli scrittori più giovani degli anni ottanta come Bret Easton Ellis o Jay McInerney. Ma ciò che colpisce il lettore dei libri della Pivano non è solo la grande capacità di comprensione degli scrittori statunitensi, ma anche l’abilità nel descrivere il lato umano di persone dal carattere non facile e dagli atteggiamenti a volte sopra le righe e trasgressivi, diversi da colei che si definisce, con un pizzico, forse, di vanità, ‘una signora borghese’. In verità, come si intuisce leggendo il primo volume dei suoi Diari, pubblicato da Bompiani, certamente la Pivano nasce in un ambiente colto e, appunto, borghese e viene educata come una tipica signorina snob nella Genova umbertina. Nei primi capitoli della sua autobiografia, in effetti, la Pivano descrive l’ambiente dell’epoca, piuttosto lezioso e che sembra uscito da un romanzo dell’ottocento, con le frequentazioni del collegio, le lezioni di pianoforte, il rigido conformismo dei genitori, in particolare del padre, grande uomo di cultura, adorato dalla Pivano e dalla madre, la classica signora raffinata di buona famiglia. Ma già dai primi capitoli emergono due tratti del suo carattere: innanzitutto, l’insofferenza per gli usi e le convenzioni del suo mondo, e la curiosità nei confronti di ogni manifestazione artistica, specie straniera. Ben presto, la guerra rilevante del libro è rappresentato dagli artisti incontrati dalla Pivano. La galleria di ritratti è impressionante: un bizzoso e mutevole Hemingway; l’ironico Faulkner; gli attori Spencer Tracy e Katherine Hepburn; Henry Miller alle prese con un doloroso divorzio; l’altezzosa collezionista d’arte Peggy Guggenheim; una splendida Anaïs Nin; l’anziana segretaria di Gertrude Stein, Alice Toklas, ridotta a vivere in miseria in un freddo appartamento parigino; un disperato e alcolizzato Jack Kerouac; il poeta Allen Ginsberg, esaltato dalla droga e dalle sue utopie pacifiste; uno scostante e minaccioso William Burroughs; la raffinata Susan Sontag, coinvolta nel femminismo; un sospettoso Ezra Pound, internato in manicomio per evitare di essere processato per alto tradimento nei confronti del governo degli Stati Uniti; un cupo e silenzioso Cesare Pavese; Mario Praz, il più illustre anglista italiano, che le provocherà molti guai, e, in questo caso, non mancano sarcastici commenti al mondo universitario, mai amato dalla Pivano; così come non mancano commenti sugli editori italiani che, con le uniche eccezioni di Arnoldo Mondadori e Leo Longanesi, non sempre, a detta dell’autrice, hanno intuito la grandezza di determinati scrittori. Ovviamente i diari non sono solo questo e non si limitano a raccogliere una serie di aneddoti. Sono più che altro il ritratto di una donna che ha attraversato decenni di cultura e di mutamenti sociali e che li ha raccontati con una straordinaria mescolanza di stili e con una capacità di comprensione che lascia sbalorditi. Sergio Duma Corrado Stajano Maestri e infedeli Milano, Garzanti, 2008, pp.368 20,00 Un giornalista di qualità rare, di posizione netta e granitica, saggista acuto e provocatorio, parlamentare di sinistra nella XII Tessiture 173 sconvolge la tranquilla vita della Pivano. Le descrizioni della tragica situazione sociale segnata dal fascismo prima e dal secondo conflitto mondiale poi, rappresentano, forse, la parte più intensa del volume; e saranno probabilmente gli orrori bellici a far nascere le idee pacifiste che tanta importanza avranno per lei in seguito e che la spingeranno a sostenere autori anti-militaristi come Ginsberg o Mailer. Ovviamente, non mancano, in questa autobiografia, nomi leggendari della cultura statunitense e non: Cesare Pavese, prima di tutto, che la Pivano considera il suo maestro; Ernest Hemingway, per lei una vera e propria figura paterna (e le pagine relative ai fastidi che la Pivano ha con i nazisti per aver firmato il contratto di traduzione presso Einaudi di ‘Addio alle Armi’, libro proibito dal regime fascista, sono drammatiche e commoventi); e soprattutto Ettore Sottsass, l’unico, vero, grande amore di Fernanda. Pittore, designer, artista geniale, è forse il personaggio più importante del libro. Il racconto della loro vita matrimoniale, tra momenti di serenità, liti e tradimenti, è come un romanzo e costituisce la sezione più malinconica e autentica del libro. Ma ovviamente in questo testo c’è altro: in un arco di tempo che va dal 1917 al 1973, la Pivano registra anche i cambiamenti delle società italiana e statunitense nel corso dei decenni. Dai timidi conformismi dei primi del Novecento alla seconda guerra mondiale, dal difficile periodo post-bellico ai fermenti beat dell’America degli anni cinquanta segnata dal maccartismo, dal boom economico degli anni sessanta alle proteste studentesche nelle università, con inquietanti segnali che anticipano il buio periodo del terrorismo, la Pivano non trascura nulla, in un viaggio affascinante che ha la capacità di appassionare e coinvolgere il lettore. Non meno interessanti sono le pagine degli straordinari viaggi compiuti insieme al marito, e non solo in America, ma anche in luoghi esotici, all’epoca non ancora toccati dal turismo di massa e trascurati dalle compagnie di viaggio internazionali. Le descrizioni delle isole Samoa o di Bali, per esempio, non hanno niente da invidiare a quelle dei grandi autori di viaggio anglosassoni (forse influenze inconsce della Pivano). Ma l’elemento più Quaderni di comunicazione 10 174 legislatura, Corrado Stajano, firma autorevole e sempre priva di contraddizioni, ha prestato la sua collaborazione alle maggiori testate italiane, compreso il “Corriere della Sera”, abbandonato nel 2003, dopo sedici anni, “per protesta in difesa del giornalismo libero”. Uno scrittore che condivide coi suoi lettori le esperienze vissute e riferisce con disinvolta fedeltà e scrupoloso rigore momenti, incontri, dettagli, riflessioni e sfumature, senza mai scostarsi da uno stile fluente, facile, immediato, d’impronta gradevole e coinvolgente. Noto anche come autore televisivo, Stajano ha pubblicato numerosi saggi su avvenimenti politici e culturali italiani del secondo Novecento, “un secolo terribile”, come lo ha definito nel volume edito da Garzanti nel 2008, Maestri e infedeli. Sessanta interviste pubblicate dal 1968 al 1999 su diversi giornali, tra cui “Il Giorno” e lo stesso “Corriere della Sera”, compongono il libro di Stajano che presenta una galleria di personaggi particolarmente significativi del secolo scorso, sia per la loro incisiva partecipazione agli eventi storici o politici, sia per la carismatica presenza nel mondo della cultura e dell’arte, sia per la loro vicinanza ad alcuni personaggi della cronaca italiana il cui nome è legato a tragiche e misteriose vicende del nostro Paese. Tra questi ultimi Licia Pinelli, vedova dell’anarchico Giuseppe che, fermato dalla polizia in seguito alla strage di piazza Fontana, morì nelle circostanze tragiche che conosciamo; o Rachele Torri, zia di Pietro Valpreda, ritenuto l’esecutore materiale di quella strage; o ancora Nando Dalla Chiesa, che ricorda l’assassinio del padre Carlo Alberto per mano della mafia e una sua frase dai toni taglienti che denunciava come “in questo Paese una tessera di partito conta più dello Stato”. Maestri e infedeli consegna la selezione di trent’anni di attività giornalistica di Stajano, proponendo l’incontro con scrittori, critici letterari, pittori, designer, registi, uomini politici, economisti, banchieri, giornalisti, storici, filosofi, musicisti, ai quali si affianca, rubando spesso la scena, il contesto storico e politico del tempo, del quale Stajano non disdegna di offrire il proprio inequivocabile punto di vista. Gli anni Settanta, durante i quali le stragi terroristiche innescano il timore di un nuovo fascismo, la sensazione di un golpe imminente e il conseguente affiorare di disperate posizioni antifasciste, inaugurano il percorso del giornalista nell’Italia di fine secolo che lo conduce, attraverso gli anni Ottanta e lo scandalo della P2, all’inchiesta di “Mani pulite” degli anni Novanta, “anni della conoscenza, della memoria ritrovata, oltre che della rottura degli equilibri”. Arricchite da una corposa sezione fotografica, realizzata con scatti di Paola Agosti e Giovanna Borgese, le interviste sono anch’esse fedeli ritratti dei personaggi incontrati, immagini laconiche ma dense di espressione che restituiscono anche l’aspetto dei protagonisti, le movenze, gli atteggiamenti e, con tratti minimi ma efficaci, addirittura il carattere. Gli stessi ambienti sono oggetto d’osservazione nitida e precisa, ricchi di fascino e suggestioni. “Capitoli del libro della vita di una comunità”, le interviste proposte da Stajano permettono di conoscere meglio, tra gli altri, il partigiano Nuto Revelli, che suggerisce la commemorazione della data dell’armistizio nelle scuole; il democristiano Giorgio La Pira, amico degli operai, “profeta della pace, del disarmo, della rottura delle frontiere, dell’attenzione verso il terzo mondo”; il socialista Riccardo Lombardi, il pittore Aldo Carpi, deportato nei lager di Mauthausen e Gusen, e la scrittrice Edith Bruck, anch’essa vittima delle persecuzioni razziali; il comunista Umberto Terracini, Ugo La Malfa, segretario del Partito repubblicano, il presidente partigiano Sandro Pertini che denuncia quale peggior scandalo italiano quello di soffocare gli scandali; il narratore Primo Levi, che definisce i lager “piramidi dell’economia nazista”; il regista Gillo Pontecorvo e la sua fiducia nella possibile aggregazione tra forze politiche diverse per una comune volontà di cambiamento radicale; padre Camillo de Piaz, “voce cristiana di un protagonista della Resistenza”; Camilla Ravera, prima donna nominata senatore a vita che racconta il suo incontro con Lenin; Antonio Giolitti, nipote del celebre statista e politico egli stesso, che ricorda episodi inediti legati alla figura del nonno; e ancora il presidente dell’Azio- Fo, i giornalisti Italo Pietra e Giuseppe Fiori, il dirigente industriale Piero Malvezzi, più noto come autore di Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, l’economista Paolo Sylos Labini, l’esperto di giochi Giampaolo Dossena, lo storico della filosofia Eugenio Garin, il direttore d’orchestra Gianandrea Gavazzeni, “uomo pieno di contraddizioni in cui vive benissimo”, Ambrogio Donini, comunista professore di Storia del cristianesimo, un altro comunista come Pietro Ingrao, intervistato negli anni del “ribaltone” di Achille Occhetto, Gherardo Colombo, il magistrato che lega il suo nome alle inchieste sulla P2 e soprattutto a quelle del pool di “Mani pulite” e lo scrittore Claudio Magris, in cui convivono felicemente la professionalità critica e l’estro narrativo. Dei ritratti del Novecento di Stajano incuriosisce il titolo, Maestri e infedeli. È l’autore stesso a spiegarne il senso: “sono stati maestri eminenti nei loro saperi e sono stati infedeli rispetto al tempo storico in cui hanno vissuto, anomali, disubbidienti, non conformisti, ribelli, eretici”. E benché Stajano nelle interviste raccolte preferisca visibilmente dar risalto a questo secondo aspetto, all’anticonformismo dei suoi interlocutori, alla loro infedeltà e insubordinazione, al coraggioso, spesso eroico, dissenso, seduce forse più la semplice nobiltà del loro insegnamento, laddove “maestro”, come ha dichiarato lo storico Carlo Ginzburg nell’intervista raccolta da Stajano, “è chi sa comunicare la sua passione”. Maria Ginevra Barone Tessiture 175 ne cattolica Vittorio Bachelet ucciso nel 1980 dalle Brigate rosse; il banchiere Raffaele Mattioli, uomo straordinariamente colto che “ha conservato il rispetto e l’umiltà del dubbio”; Ferruccio Parri, il conservatore avvicinatosi ai comunisti perché “unica forza conservatrice rimasta in Italia”; il giornalista Alberto Cavallari, che arrivò a dirigere il “Corriere della Sera” quando il giornale era coinvolto nel “bubbone” della P2 e sembrava “deteriorato da una conquista barbarica, roso, tarlato, slabbrato”. Numerosi sono gli scrittori, gli storici della letteratura e i critici letterari intervistati da Stajano: da Giorgio Bassani a Franco Antonicelli, da Paolo Volponi a Franco Fortini, da Attilio Bertolucci a Piergiorgio Bellocchio, da Cesare Segre ad Anna Maria Ortese, da Carlo Dionisotti a Romano Bilenchi, da Cesare Garboli ad Andrea Zanzotto. Tra questi, particolarmente suggestivi sono gli incontri con David Maria Turoldo, dalla “voce roboante, smisurata come i piedi e le mani”, il quale confessa di aver avuto la tentazione di rinunciare alla vocazione negli anni di Pio XII; con Mario Tobino, che racconta la sua lunga esperienza da psichiatra, triste e affascinante; e con Leonardo Sciascia, “svelto e ilare”, che a proposito della funzione dello scrittore dichiara sia “quella, oggi, di arrivare ad essere a Dio spiacenti ed a’ nemici suoi”. Un “andamento epico”, infine, come lo definisce lo stesso Stajano, è il timbro che caratterizza l’intervista con Carlo Emilio Gadda, uomo “segnato da un’infinita stanchezza”: un incontro durante il quale anche l’intervistato prendeva appunti, “per curiosità o sospetto”. Particolarmente toccante l’immagine di Gadda che legge, ma in realtà recita a memoria, dagli Ossi di seppia, edizione Ribet, Valmorbia discorrevano il tuo fondo, unica lirica di Montale sulla prima guerra mondiale. Maestri e infedeli non trascura figure di artisti e designer, quali Bruno Munari o Altan, né registi, come Marco Bellocchio, Mario Soldati e Francesco Rosi, né gli storici, come Alessandro Galante Garrone, Franco Venturi e Aldo Garosci. E non meno interessanti sono i colloqui con Oreste Del Buono, i sindacalisti Vittorio Foa ed Emilio Pugno, il premio Nobel Dario Autori Egle Becchi, già ordinario di Pedagogia all’Università di Pavia, si è occupata di storia dell’infanzia e di diari d’infanzia in numerose pubblicazioni. Ha n corso di pubblicazione con Franco Angeli (uscita prevista inverno 2009) Una pedagogia del buon gusto, Esperienze e progetti dei servizi educativi per l’infanzia del Comune di Pistoia, in collaborazione con Annalia Galardini, Sonia Jozzelli, Tonina Mastio, Donatella Giovannini, Anna Bondioli, Monica Ferrari e Loana Boccaccini. [email protected] Patrizia Calefato, semiologa, insegna Sociolinguistica, Linguistica informatica e Analisi socio-antropologica del prodotto di moda nell’Università degli Studi di Bari. Le sue ricerche comprendono studi sulla dimensione sociale del linguaggio, sociolinguistica e sociosemiotica, studi culturali, di moda, femministi, studi sul linguaggio dei mediaaudiovisivi. Tra le sue ultime pubblicazioni: Sociosemiotica 2.0, Bari, B.A. Graphis, 2008. On myths and fashion: Barthes and cultural studies, “Sign System Studies” 36, 1; pp. 71-81. designis 12, publicación de la Federación Latinoamericana de Semiótica (FELS), Traducción/Género/ Poscolonialismo, Coordinadoras: Patrizia Calefato y Pilar Godayol. Mass moda. Linguaggio e immaginario del corpo rivestito, nuova ed., Roma, Meltemi, 2007. Il piacere del ritorno. Citazione, arti visive, comunicazione, Bari, Progedit, 2007 (a cura, in coll. con M.R. Dagostino). [email protected] Alejandro De Marzo è docente a contratto all’Università di Bari dove insegna Sociologia della comunicazione e Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa. Si è dottorato in Teorie dell’Informazione e della Comunicazione all’Università di Macerata con una tesi sulla qualità televisiva, avendo conseguito la laurea in Scienze della comunicazione e un master di II° livello in Programmazione e produzione televisiva all’Università “La Sapienza” di Roma. Si occupa di storia dei linguaggi televisivi, marketing dei media, comunicazione politica e sociologia della cultura. Ha finora svolto ricerche sull’immaginario collettivo e sui consumi mediali, ed attualmente è impegnato in uno studio sulla comunicazione liturgica. [email protected] Duccio Demetrio è professore ordinario dell’Università La Bicocca Milano. Insegna Filosofia dell’educazione. Le sue ricerche promuovono la scrittura di se stessi, sia per lo sviluppo del pensiero interiore e autoanalitico, sia come pratica filosofica e terapeutica. Ha Quaderni di comunicazione 10 178 fondato e dirige la rivista Adultità e la Libera Università dell’autobiografia di Anghiari. Tra le sue ricerche più recenti: L’educazione non è finita, R. Cortina 2009; La scrittura clinica. Consulenza autobiografica e fragilità esistenziali, R.Cortina 2008; La vita schiva. Il sentimento e le virtù della timidezza, R.Cortina 2007; Filosofia del camminare. Esercizi di meditazione mediterranea, R.Cortina 2005. [email protected] Sergio L. Duma è professore a contratto di Lingua e Traduzione Inglese nel corso di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi del Salento. Si occupa prevalentemente di letteratura inglese e americana. Suoi saggi sono apparsi nel volume Maturandosi (1993) e Commonwealth Literary Cultures. Di recente ha pubblicato Contamination corruption, Lecce, Icaro 2008 [email protected] Monica Ferrari è professore straordinario di Pedagogia generale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Pavia, dove insegna anche Storia della pedagogia. Si occupa di storia dei processi formativi con particolare riguardo alle élites, di studio e valorizzazione della documentazione scolastica, nonché di valutazione dei contesti educativi e di formazione alle professioni. Tra le sue pubblicazioni: La paideia del sovrano. Ideologie, strategie, materialità nell’educazione principesca (1996); “Per non manchare in tuto del debito mio”. L’educazione dei bambini Sforza nel Quattrocento (2001); Insegnare riflettendo. Proposte pedagogiche per i docenti della secondaria (a cura di, 2003); I bambini di una volta. Problemi di metodo. Studi per Egle Becchi (a cura di, 2006); I saperi del tirocinio. Formare gli insegnanti nelle SSIS (a cura di, con A. Bondioli, M. Marsilio e I. Tacchini, 2006); Documenti della scuola tra passato e presente. Problemi ed esperienze di ricerca per un’analisi tipologica delle fonti (a cura di, con M. Morandi, 2007); SASIS, Strumento di Autovalutazione della Scuola Infanzia-Secondaria (a cura di, con D. Pitturelli, 2008); Formare alle professioni. Sacerdoti, principi, educatori (a cura di, con E. Becchi, 2009). Con M. Morandi ed E. Platé ha curato la mostra La lezione delle cose. Oggetti didattici delle scuole dell’infanzia mantovane tra Ottocento e Novecento (2008). [email protected] Silvia Gravili è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università del Salento e specia- lizzata in comunicazione d’impresa. Dopo essersi occupata di marketing e comunicazione per il settore business to business negli Stati Uniti, lavora come consulente di comunicazione per enti pubblici, privati e del terzo settore. Collabora con la facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università del Salento per l’aggiornamento del sito web e con l’Ufficio Comunicazione e Knowledge Management dell’IFC – CNR di Lecce. Ha curato la voce “Baccanti” per l’Enciclopedia Momentanea a cura di S. Cristante (2002). [email protected] Salvatore Natoli è ordinario di “Filosofia teoretica” presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Insegna “Filosofia della tecnica e teoria dell’azione” presso l’Università Vita-Salute, San Raffaele di Milano. Tra le sue ultime pubblicazioni: Edipo e Giobbe. Contraddizione e paradosso, Morcelliana, Brescia 2008; Guida alla formazione del carattere, Morcelliana, Brescia 2006; Sul male assoluto, Morcelliana, Brescia 2006; Parole della filosofia o dell’arte di meditare, Feltrinelli, Milano 2004; Stare la mondo, Feltrinelli, Milano 2002; La felicità di questa vita, Mondadori, Milano 2000; Mimmo Pesare è dottore di Ricerca in “Etica e Antropologia” e assegnista in “Pedagogia Sociale della Comunicazione” presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell’Università del Salento, dove collabora alla didattica nel Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. È redattore della rivista “Krill” e segretario di redazione del Quaderno di Comunicazione. Tra le sue pubblicazioni, la cura del libro Rifrazioni. Luoghi superstiti della postmodernità (Manni, Lecce), La dimora dei luoghi. Saggi sull’abitare tra filosofia e scienze sociali (Icaro, Lecce) e Abitare ed esistenza. Antropopaideia dello spazio relazionale (Mimesis, Milano). [email protected] Elena Pulcini è professore ordinario di Filosofia sociale presso il Dipartimento di filosofia dell’Università di Firenze. La sua ricerca verte su temi di antropologia filosofica e di filosofia sociale e politica. Al centro dei suoi interessi è il tema delle passioni nell’ambito di una teoria della modernità e dell’individualismo moderno, con un’attenzione anche al problema della soggettività femminile. Tra le sue pubblicazioni più recenti: L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale, Bollati Boringhieri, Torino 2001/ristampa 2005 (“menzione speciale” al Premio Internazionale di filosofia Salvatore Valitutti; “menzione speciale” al Premio Internazionale di filosofia Viaggio a Siracusa). La traduzione tedesca è stata pubblicata presso l’editore Diaphanes, Berlino 2004.È inoltre co-autrice (con E.Skaerbaek, D.Duhacek, M.Richter) del libro Common Passion, Different Voices. Reflections on Citizenship and Intersubjectivity, Raw Nerve Books, York 2006 (pubblicato nell’ambito delle attività del gruppo “Travelling Concepts”, afferente al network europeo di Gender Studies “Athena”). Sulla teoria del soggetto femminile ha pubblicato, oltre a numerosi saggi, Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura, Bollati Boringhieri, Torino 2003. Le sue ricerche vertono di recente sulle trasformazioni dell’identità e del legame sociale in età globale. Su questi temi ha curato (con D.D’Andrea) il volume collettivo Filosofie della globalizzazione, ETS, Pisa 2001; e (con M.Fimiani e V.Gessa Kurotschka) il volume Umano post-umano. Potere, sapere, etica nell’età globale, Editori Riuniti, Roma 2004. In corso di pubblicazione (in libreria a settembre 09) La cura del mondo. Paura e responsabilità in età globale, Bollati Boringhieri, Torino 2009 [email protected] Diana Salzano è ricercatore confermato in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università degli Studi di Salerno dove insegna: “Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa” e “Teoria e tecniche dei nuovi media” (corso di laurea in Scienze della comunicazione) e “Sociologia dei processi culturali” (corso di laurea in Editoria e pubblicistica). È docente a Napoli presso il Master in Media Education (Università Suor Orsola Benincasa e I.P.E.- Istituto per ricerche ed attività educative) Tra le sue ultime pubblicazioni: Etnografie della rete. Pratiche comunicative tra on line e off line, Franco Angeli, Milano 2008; “La poetica dell’esplorazione: giovani surfers nel mare della rete”, in Ammaturo N. (a cura di), Il consumo culturale dei giovani, C.E.I.M. Editrice, Mercato San Severino (Sa) 2008; “Reti di senso e pratiche comunicative in ambienti digitali”, in Piromallo Gambardella A., Lando A., Salzano D. (a cura di), Comunicazione & Significazione. Fenomeni culturali e rappresentazioni sociali tra mass media e new media, QuiEdit, Verona 2007; Piromallo Gambardella A., Paci G., Salza- Gli autori 179 È presente nella redazione di varie riviste, non solo filosofiche. Collabora a quotidiani ed è ampiamente presente nel dibattito filosofico e culturale contemporaneo. [email protected] Quaderni di comunicazione 10 180 no D., Violenza televisiva e subculture dei minori nel meridione, Franco Angeli, Milano 2004; “L’immagine assolta” in Piromallo Gambardella A. (a cura di), Violenza e società mediatica, Carocci, Roma 2004; Lo sguardo disancorato. Società globale e comunicazione, Editoriale Scientifica, Napoli 2003: [email protected] Nieves Sánchez Garre, es Doctora en Ciencias de la Información (Imagen y Publicidad) y Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con experiencia profesional como periodista y fotógrafa en prensa diaria, revistas de información general, gabinetes de comunicación y publicidad, así como medios audiovisuales. Es profesora de Teoría y Técnica de la Fotografía, Documentación y Fotoperiodismo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España). Su especialización y líneas de investigación se centran en la documentación audiovisual, análisis de imágenes, fotografía, memoria histórica y medios de comunicación. Se inició en la investigación en el ámbito de la Historia de la Fotografía (1995/97) con la recopilación de material documental relativo al trabajo fotográfico de Lewis Carroll. Los primeros resultados de esta investigación se presentaron en una obra de divulgación que se hizo pública a través de una exposición fotográfica (1998-2002), y en el año 2003 efectuó su tesis doctoral titulada, “Evolución de la fotografía a través de la obra de Lewis Carroll: Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo”. Tiene diversas publicaciones y ha participado en congresos e impartido conferencias sobre la obra de Lewis Carroll. Actualmente trabaja en la exploración de nuevas tecnologías para impulsar la interacción entre diversos medios de expresión que contribuyan a narraciones visuales con nuevas e innovadoras propuestas, que proporcionan el resurgimiento de un debate visual completamente nuevo. [email protected] Antonio Santoni Rugiu già ordinario di Storia dell’educazione, è stato direttore dell’Isti- tuto di Pedagogia e poi del Dipartimento di Storia dell’Università di Firenze. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui le più recenti: Breve storia dell’educazione artigiana, Roma, Carocci, 2008; La lunga storia della scuola secondaria Roma, Carocci, 2007; Maestre e maestri. La difficile storia degli insegnanti elementari, Roma, Carocci, 2006. [email protected] Angelo Semeraro è ordinario di Pedagogia sociale della comunicazione nel corso di Scienze della comunicazione dell’Università del Salento che ha fondato e di cui è presidente. Tra le sue ultime pubblicazioni: Hypomnémata. Lessico di comunicazione sensibile, Nardò, Besa 2008; Pedagogia e comunicazione. Paradigmi e intersezioni, Roma, Carocci 2007; Del sensibile e dell’Immaginale, Lecce, Icaro 2006; Omero a Baghdad. Miti di riconoscimento, Roma, Meltemi 2005 (“Stilo d’oro” 2006, Premio internazionale “Raffaele Laporta”), Lo stupore dell’Altro, Bari, Palomar 2004, Calypso, la nasconditrice. L’educazione nell’età della comunicazione illimitata, Lecce, Manni 2003; Altre Aurore, La metacomunicazione nei contesti di relazione, Lecce, I Liberrimi 2002. [email protected] Flavia Serravezza è giornalista pubblicista. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Media e Giornalismo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze con una tesi sul giornalismo d’inchiesta nella tv generalista, si è specializzata in Scritture giornalistiche e Multimedialità presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento. Ha svolto uno stage presso il TgR Rai di Firenze. Dal 2006 collabora con il quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” per il quale si occupa di cronaca, sanità e cultura. Gli autori 181 È redattrice del trimestrale “Lega contro i tumori di Lecce”. Collabora inoltre con diverse riviste di approfondimento, tra le quali il magazine pugliese “Articolo Ventuno” e il mensile d’inchiesta “Il Tacco d’Italia” [email protected]
Scaricare