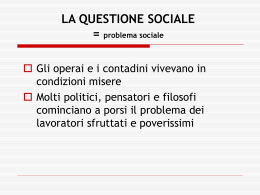EDITORIALE bassi salari, scarsa domanda crisi dei mercati 1. Apparenza e realtà della crisi el dibattito sulle origini della tempesta finanziaria che sta abbattendosi sui mercati, la grande stampa si sofferma generalmente sugli aspetti immediatamente evidenti del fenomeno, trascurandone le cause più profonde. Accade cioè che l’attenzione si concentri sulla sequenza strettamente monetaria e creditizia della crisi: la grande espansione del credito al consumo negli Usa, la moltiplicazione dei cosiddetti crediti subprime, l’incapacità di onorare i debiti da parte di intere masse di lavoratori americani, le ricadute di ciò su banche e intermediari finanziari, fino al credit crunch: l’interruzione nelle concessioni di credito. Questa sequenza è ormai piuttosto chiara, ma limitarci a essa nel descrivere l’origine della crisi comporterebbe una grave banalizzazione, impedendo di cogliere i nessi causali con l’economia reale. In particolare, non si comprenderebbe che la crisi affonda le radici nell’economia della precarietà e dei bassi salari che ha sempre più in questi ultimi anni caratterizzato l’insieme dei Paesi industrializzati. Occorre insomma spostare l’attenzione sulla caduta progressiva della quota del prodotto sociale destinata ai salari – dunque all’ampia redistribuzione a favore di profitti e rendite – a cui abbiamo assistito negli ultimi 25 anni, particolarmente in Europa e negli Usa. N 2. Una crisi da mancata regolamentazione? Le vicende strettamente finanziarie e creditizie che hanno portato alla crisi sono piuttosto chiare nelle loro linee fondamentali. La forte espansione del credito al consumo negli Usa co- * UNIVERSITÀ DEL SANNIO R ICCARDO R EALFONZO * mincia già nel 2001, all’indomani dello sgonfiarsi della bolla della new economy e poi a seguito dell’11 settembre, quando la Federal Reserve Bank vara una politica di progressiva contrazione del costo del credito. Il tasso di sconto statunitense viene abbattuto in due anni e mezzo, dal gennaio 2001 al giugno 2003, dal 6,5% fino all’1%. La riduzione dei tassi porta a una elevatissima spinta alle concessioni di credito, in particolare del credito al consumo, in linea con lo slogan «tutti proprietari di casa» sbandierato da Bush junior nella corsa alla presidenza. L’espansione del credito al consumo cui si assiste in questi anni – che riguardi i mutui per l’acquisto di case o le carte di credito – si volge inizialmente a favore dei lavoratori con redditi sicuri e garanzie solide. Successivamente, a seguito del clima di ottimismo alimentato dalle ripetute contrazioni dei tassi e della continua crescita dei valori immobiliari, la qualità del credito peggiora. Le banche statunitensi moltiplicano le concessioni di mutui subprime: crediti a tassi variabili erogati a lavoratori sempre più deboli, perfino a soggetti senza lavoro, senza reddito e senza alcuna garanzia reale da offrire. Naturalmente, le banche sono le prime a sapere che queste concessioni di credito sono ad alto rischio, e infatti anche i tassi a cui vengono concessi questi crediti incorporano spread elevati rispetto a quelli praticati alla clientela migliore. E d’altra parte le banche cominciano ben presto a cartolarizzare quelle concessioni di credito e, spesso introducendole all’interno di pacchetti con altre obbligazioni (le cosiddette obbligazioni collaterali di debito), a cederle in tutto il mondo, alimentando anche la piramide dei derivati. Tuttavia, la forte espansione dei consumi statunitensi alimenta le importazioni dall’Europa e dall’Asia, determinando un sensibile peggioramento della bilancia commerciale, che giunge a toccare nel 2006 un passivo che sfiora i mille miliardi di dollari. Per questa ragione la Fed 1 2 rivede la politica monetaria e già dall’estate 2003 riprende ad aumentare il tasso di sconto, riportandolo fino al 5,25% nella metà del 2007. Lo scopo della banca centrale americana è presto detto: contrastare il passivo della bilancia commerciale rallentando la crescita dei consumi e alimentando l’afflusso di capitali dall’estero, mentre la svalutazione del dollaro viene utilizzata per rilanciare le esportazioni. Ma evidentemente l’aumento dei tassi si scarica sulle rate contratte a tassi variabili e ciò manda immediatamente in crisi i lavoratori indebitati, cominciando dai più deboli, quelli cui erano stati concessi i subprime. Allorché l’insolvibilità dei lavoratori comincia a diventare un fenomeno di massa, e si moltiplicano sofferenze bancarie e pignoramenti, il valore delle obbligazioni nate sui subprime comincia a calare rapidamente, fino a che quei titoli divengono poco più che carta straccia. Da qui si manifestano gli effetti più macroscopici, dal caso Bear Stearns fino a Lehman Brothers, passando per la nazionalizzazione britannica della Northern Rock e per le nazionalizzazioni statunitensi di Fannie Mae e Freddie Mac. E poiché nel frattempo le aspettative di profitto sono diventate negative e la fiducia tra le banche è ormai scomparsa, le borse crollano. E come si vede a poco è valso che la Fed abbia da oltre un anno ripreso a contrarre i tassi. Così come a poco sono valse le nazionalizzazioni e i meccanismi di garanzia sui depositi. La crisi si avvita su se stessa e sfocia nella depressione. La crisi finanziaria giunge dunque a seguito di una espansione del credito che progressivamente diviene sempre più speculativa. Si badi bene che il problema non sta tanto nella dimensione della espansione creditizia, bensì nel progressivo peggioramento della sua qualità e la conseguente crescente fragilità finanziaria. Il che conferma, come è facile notare, le interpretazioni del ciclo proposte da Hyman Minsky – in classici come Can it happen again? del 1963 – secondo cui nella fase crescente del ciclo economico le posizioni delle imprese si fanno sempre più speculative e quindi la struttura finanziaria siste- mica diviene sempre più fragile. Il nesso con la teoria di Minsky c’è tutto, anche se nel caso attuale la fragilità finanziaria ha riguardato in primo luogo le famiglie lavoratrici. Ma le vicende attuali rimandano anche alla meno nota ma interessante tradizione statunitense di inizio Novecento della «qualitative credit theory» di James Laurence Laughlin e Henry Parker Willis. Tuttavia, se ci limitassimo alla descrizione della sequenza finanziaria che dalla espansione del credito ha condotto alla crisi non potremmo comprendere i fattori reali che hanno messo in moto la sequenza. E ciò darebbe spazio a quanti affermano che la crisi si sarebbe evitata regolamentando di più e meglio i mercati finanziari e il sistema bancario. Naturalmente, nessuno nega che le regolamentazioni servano e che le tesi di Alan Greenspan a favore dei meccanismi di autoregolamentazione dei mercati finanziari si siano rivelate del tutto infondate. Tuttavia, per comprendere l’origine della crisi bisogna andare più a fondo ed esaminare il nesso con la progressiva contrazione della quota dei salari sul Pil cui abbiamo assistito negli ultimi venticinque anni negli Usa e in Europa. 3. Una crisi redistributiva e da domanda La sequenza che ci ha portato alla crisi finanziaria trova infatti la sua causa ultima nel processo di redistribuzione del reddito, a sfavore dei salari e a vantaggio dei profitti e delle rendite, cui abbiamo assistito a partire dagli anni ’80. Intanto è bene chiarire che l’ampiezza del processo redistributivo appena citato è ormai testimoniata da numerosissimi studi. Se qualcuno avesse dubbi a riguardo EDITORIALE potrebbe consultare il World Economic Outlook. Globalization and Inequality dell’International Monetary Found, pubblicato nell’ottobre 2007; oppure leggere lo studio Income Inequalities in the Age of Financial Globalization dell’International Labour Organization, uscito quest’anno; o ancora esaminare il recentissimo lavoro dell’Organization for Economic Co-Operation and Development dal titolo Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries. Tutti questi studi confermano inequivocabilmente che l’indice di Gini – che misura la divaricazione tra i redditi esistente all’interno di un Paese – è cresciuto in questi anni in tutti i Paesi industrializzati. Gli Usa sono in testa alla classifica, mostrando i valori massimi e ancora crescenti dell’indice, e dunque la più grande divaricazione tra redditi dei ricchi e dei poveri. Anche in Europa l’indice di Gini è costantemente aumentato, segnando in Italia valori particolarmente elevati. Complessivamente, per utilizzare ad esempio i dati dell’Ilo, nei Paesi industrializzati la quota dei salari sul pil è crollata di oltre nove punti percentuali nel periodo 1980-2005. Ma che relazione sussiste tra la caduta dei salari (come quota del prodotto complessivo, ma in qualche caso anche in termini assoluti) e la crisi? Per cominciare, bisogna ricordarsi che per assistere a una espansione prolungata del credito ci vogliono almeno due condizioni. Da un lato, serve che gli agenti preposti alle concessioni di credito, le banche, siano disponibili a espandere significativamente i prestiti. E questa disponibilità evidentemente c’era tutta dopo il 2001, allorché la Fed diede il via alla stagione di contrazione dei tassi. La seconda condizione è che ci sia una sostenuta domanda di crediti ai tassi di interesse di mercato. E negli Usa questa domanda esisteva, anzi vi era una vera e propria sete di credito. E questa sete di credito dipendeva proprio dai bassi livelli dei salari e dalla precarietà dei rapporti di lavoro che sempre più ha caratterizzato il sistema americano negli ultimi decenni. Nel momento in cui le banche si sono rese disponibili ad assecondare le richieste anche dei più diseredati il credito è esploso. È insomma chiaro che l’espansione del credito al consumo cui si è assistito negli Usa trovava nella miseria diffusa il suo alimento principale. Dal 2000 al 2006 le famiglie Usa si sono indebitate per 18200 miliardi di dollari nel sogno di comprare la casa o semplicemente di accedere ai beni di consumo mediante carte di credito. Un sogno destinato a franare rapidamente. D’altra parte bisogna riflettere sul fatto che l’espansione del credito al consumo negli Usa ha trainato la domanda interna e con essa il pil statunitense. Ma non solo. Direttamente o indirettamente l’esplosione dei consumi ha sospinto in alto la domanda americana di importazioni, e quindi ha alimentato le esportazioni europee e asiatiche. Insomma, grazie all’espansione del credito gli Usa hanno funzionato da locomotiva dell’economia mondiale, assorbendo le eccedenze di produzione di un intero mondo a bassi salari. Non c’è dubbio infatti che senza la domanda di importazioni americane l’economia europea avrebbe messo a segno in questi anni risultati ancora più desolanti, a causa della asfittica domanda interna. 4. Dalla crisi finanziaria alla depressione E ora la crisi finanziaria sta schiudendo la strada alla depressione. Questa appare inevitabile alla luce degli indicatori macroeconomici degli Usa e degli altri Paesi industrializzati. La situazione si prospetta estremamente grave per l’economia europea che viene a trovarsi stretta tra: 1) il calo della domanda statunitense, con conseguente riduzione anche delle importazioni e quindi della domanda di prodotti europei; 2) l’ulteriore contrazione della domanda interna, aggravata dalla totale stasi degli investimenti e dalla stretta bancaria alle concessioni di credito; 3) l’incapacità di catturare quel po’ di domanda internazionale che ancora c’è, anche per la competizione da costi dei Paesi asiatici che si fa sempre più feroce. Quest’ultima affermazione risulta poi particolarmente vera e grave per il sistema produttivo italiano, considerato che la gran parte dei nostri imprenditori ha ormai da decenni puntato prevalentemente sulla competitività da costi: prima approfittando delle svalutazioni competitive e poi, dopo la stipula del Trattato di Maastricht, sfruttando le contrazioni dei salari garantite dalle leggi sulla flessibilità del mercato del lavoro. Come ha insegnato Keynes, la crisi nasce da una caduta della domanda e delle prospettive di profitto, si manifesta con una indisponibilità a concedere crediti e a far circolare la moneta, e genera progressivamente una caduta 3 4 dei livelli di attività dell’economia. E il prezzo più salato, come già accadde dopo il 1929, lo pagheranno i lavoratori: l’effetto principale della caduta dei livelli di attività sarà infatti una crescente disoccupazione. Se l’analisi presentata nelle righe precedenti è corretta a poco valgono le contromisure adottate sinora da banche centrali e governi. Sin qui abbiamo infatti principalmente assistito: 1) a una contrazione concertata dei tassi di sconto da parte di alcune banche centrali, con la Bce che stabilisce di rifinanziare illimitatamente le banche al tasso di riferimento (3,75%); 2) ad alcune nazionalizzazioni di banche, soprattutto in Inghilterra e Stati Uniti, e a manovre di acquisto da parte degli Stati dei titoli-spazzatura; 3) all’introduzione o al rafforzamento di meccanismi di assicurazione dei depositi per evitare le «corse agli sportelli». Si tratta di misure finalizzate a ridurre il panico nei mercati, ma che certo non alimentano la domanda aggregata, aprendo un’uscita dalla crisi. In altri termini, tutti gli squilibri di fondo tendono a persistere. Lungo questa strada le uniche cose certe sono la depressione e l’intervento sempre più incisivo dei fondi sovrani stranieri nella proprietà delle imprese occidentali. Di ciò abbiamo già avuto un recentissimo assaggio proprio in Italia, allorché fondi libici hanno rafforzato significativamente la loro presenza in Unicredit. 5. Come uscire dalla crisi? Le vicende di questi giorni confermano ampiamente ciò che numerosi economisti progressisti e antiliberisti hanno detto in questi anni (a cominciare dal convegno Rive Gauche, i cui materiali sono stati pubblicati nel 2006 a cura di Sergio Cesaratto e mia). Si pensi alle reiterate critiche al quadro macroeconomico di Maastricht, che rappresenta una attuazione letterale dei principi ultraliberisti della tradizione neoclassico-monetarista. E si pensi alle ripetute critiche alle teorie e alle politiche di deregolamentazione del mercato del lavoro. In Italia queste battaglie si sono concretizzate principalmente nell’appello contrario alla politica del cosiddetto «risanamento» e a favore della stabilizzazione del debito pubblico rispetto al pil (www.appellodeglieconomisti.com), e nella critica alle politiche di precarizzazione del lavoro (a riguardo rinvio in particolare al convegno organizzato con il quotidiano il manifesto su L’economia della precarietà, i cui atti sono stati appena pubblicati da manifestolibri, a cura di Paolo Leon e mia). Iniziative che sin qui non hanno inciso efficacemente sulle linee di politica economica governativa, soprattutto a causa del fatto che il mondo del lavoro risulta sempre più privo di una rappresentanza politica. Eppure la crisi manifesta con evidenza quanto sia pericoloso il quadro macroeconomico e istituzionale disegnato a Maastricht. La totale e sconsiderata apertura dei mercati, nonché i vincoli alla spesa pubblica e le politiche monetarie restrittive hanno palesemente aperto la strada al quadro di crisi e di recessione appena descritto. Non stupisce che il palinsesto di Maastricht sia sottoposto ad attacchi quotidiani, come mostrano le richieste di attenuare il Patto di Stabilità e gli sforamenti più o meno espliciti ed evidenti che stanno verificandosi nelle diverse periferie di Europa; e come mostrano le pressioni sulla Bce per una politica più espansiva e il moltiplicarsi di istanze favorevoli a forme di protezionismo. C’è dunque una esigenza di rivedere quel palinsesto, restituendo spazio all’intervento pubblico in economia, ridefinendo il ruolo della Bce da arbitro del conflitto distributivo – quale essa in realtà è stata in questi anni – ad accomo- EDITORIALE dante sostenitrice delle politiche di sviluppo, e aprendo nuovi ragionamenti sulla limitazione della circolazione di capitale e sul ridimensionamento e la regolamentazione dei mercati finanziari. E bisognerebbe invertire radicalmente direzione di marcia rispetto alle politiche del lavoro di questi ultimi anni, che hanno visto in tutta Europa una riduzione del grado di centralizzazione della contrattazione salariale, un abbassamento delle tutele dei lavoratori e una conseguente grave compressione salariale, con effetti negativi sui livelli della domanda aggregata. Quanto appena affermato ci fa comprendere quanto sia fuori strada l’azione del governo italiano. Non solo perché ha deciso di intervenire in eventuali salvataggi evitando le nazionalizzazioni e puntando piuttosto su forme di intervento che lascino intatti gli assetti proprietari e i consigli di amministrazione. Non solo perché ha scelto solo pochi mesi fa la strada di un azzeramento dell’ICI sulla prima casa includendo anche i proprietari più abbienti, quando invece quelle risorse andavano interamente destinate al mondo del lavoro. E non solo perché si guarda bene dal muovere il minimo passo nel contrastare le condizioni di precarietà del lavoro. Ma anche perché solo pochi mesi fa, quando il deteriorarsi della congiuntura macroeconomica italiana e globale era già evidente, ha ribadito una politica generale delle finanze pubbliche finalizzata all’abbattimento del debito e all’obiettivo di pareggio del bilancio per il 2011. In tempi di recessione questa è la politica più sconsiderata che si possa fare. Bisognerebbe piuttosto rivedere drasticamente il carico fiscale – spostando buona parte del peso dal lavoro al capitale – e rilanciare la spesa pubblica perseguendo nel medio periodo un obiettivo di stabilizzazione del debito rispetto al pil. L’eventualità di una crisi di bilancio infatti dipende in misura del tutto secondaria dalla dimensione del debito pubblico, mentre molto di più contano il grado di competitività del Paese e lo stato dell’indebitamento con l’estero. E soprattutto, di fronte al rischio eventuale di piombare in una situazione di illiquidità, la prevenzione non si fa certo con la politica restrittiva ma con la garanzia che il banchiere centrale faccia il suo dovere, agendo da prestatore di ultima istanza. 5 LIMITARE I MOVIMENTI DI CAPITALE NOAM CHOMSKY La liberalizzazione finanziaria ha effetti che vanno ben oltre l’economia. È noto da tempo che essa rappresenta un’arma molto potente contro la democrazia. Il libero movimento dei capitali crea quello che qualcuno ha chiamato un parlamento virtuale di investitori e prestatori che analizzano i programmi dei governi e votano contro se li considerano irrazionali, cioè se fanno gli interessi degli elettori invece che quelli di una forte concentrazione di potere privato. Chi investe e chi presta può votare attraverso la fuga di capitali, gli attacchi alle valute e altri strumenti finanziari. È una delle ragioni per cui il sistema di Bretton Woods, istituito da Stati Uniti e Gran Bretagna dopo la seconda guerra mondiale, prevedeva dei controlli sui capitali e regolamentava le valute. John Mainard Keynes riteneva che il risultato più importante di Bretton Woods fosse l’acquisizione, da parte dei governi, del diritto di limitare i movimenti di capitale. Invece, nella fase neoliberista che si è aperta negli anni Settanta dopo l’abolizione di quel sistema, il tesoro americano considera il libero movimento dei capitali come un diritto fondamentale. L’ovvia conseguenza di questa idea di libertà assoluta dei capitali è che la democrazia si è ridotta. la crisi virtuale della finanza e quella reale delle risorse 6 a cosiddetta crisi del credito, rimandata dall’estate 2007, alla fine è deflagrata. La finanza ipercreativa dei mutui subprime ha finalmente esalato l’ultimo respiro dopo aver contagiato il pianeta, e ora le banche non si fidano più nemmeno delle altre banche e l’intero sistema creditizio rischia di fermarsi. Per questo i decisori politici si affrettano a rassicurare i risparmiatori e gettano fiumi di denaro in un immenso buco le cui dimensioni sono ancora da valutare. In realtà, come sempre accade con la storia ufficiale, questa è una verità molto parziale per nascondere il fallimento sistemico di un meccanismo entrato in fase terminale già dal 2000. Un sistema basato sui soldi facili che si possono fare una volta che viene smantellato ogni controllo (con la Fed in testa a incitare gli spiriti animali), ogni frontiera (grazie alla libera circolazione dei capitali) e perfino i limiti temporali (basta un doppio clic del mouse e, sul mercato parallelo, si gioca in borsa con i ritmi frenetici di un videogioco). Per decenni alle imprese è stato consigliato di gettare sempre più denaro nel mondo virtuale lasciando colare a picco quello materiale fatto del lavoro delle persone e di innovazione. La deindustrializzazione degli Stati Uniti dimostra quanto si possa andare avanti lungo questa china. L Non solo credito e non solo banche Che la questione dei mutui americani sia solo uno dei molti settori interessati dalla crisi è molto facile da dimostrare: Bear Stearns, la prima banca a fallire nel marzo scorso, è colata a picco per via della crisi di un settore – i prestiti a breve termine – considerato più che sicuro. Ai subprime bisogna quindi aggiungere una lunga lista di * GIORNALISTA S ABINA M ORANDI * prodotti finanziari dai nomi astrusi e dai significati ancora più sfuggenti: i suddetti short-term loans, mercato che si aggira da solo sui 5 trilioni di dollari; i CDO (da collateralized debt obbligation) che hanno affondato Crédit Suisse; i Cds (da Credit Default Swaps o derivati) che hanno mandato a picco Lehman Brothers, solo per citarne alcuni. Prima della crisi il mercato finanziario dei prodotti derivati, cioè dei titoli e contratti emessi su mercati secondari che si appoggiano su titoli sottostanti, i cui derivati scommettono sul prezzo e l’andamento futuro, ammontava a circa 600 trilioni di dollari, ben 12 volte il Prodotto interno lordo mondiale e 4 volte il totale dei soldi investiti in titoli o azioni legate all’economia reale. E tutto senza voler menzionare i paradisi fiscali dove, sembra, stazionano qualcosa come 11.500 miliardi di dollari. Sta in queste cifre la consistenza del castello in aria costruito dai geni di Wall Street. L’altra mistificazione riguarda il ruolo delle banche, com’è noto oggetto dell’intervento governativo di questi giorni e di innumerevoli disquisizioni sul socialismo dei banchieri. In realtà tali dibattiti dimostrano, come minimo, la scarsa conoscenza della finanza di oggi nella quale le banche recitano un ruolo abbastanza marginale quali intermediari tradizionali del credito. La realtà è che da tempo le banche sono state surclassate da attori finanziari ben più aggressivi e potenti, anche se è innegabile che, negli ultimi anni, hanno cercato di colmare il gap di «aggressività». Il grande business della finanza funziona insomma su vari livelli e quello bancario è solo il primo e certamente il meno importante, se si considera la quantità di denaro che vi circola. Esiste infatti un mercato creditizio non bancario (i grandi investitori istituzionali, per esempio), un mercato della finanza strutturata – certamente il più ricco, dove appunto si scambiano freneti- EDITORIALE camente i prodotti finanziari di cui sopra – e un mercato dei capitali. Perché le autorità si sono concentrate solo sul primo livello? La spiegazione è semplicissima: né il Tesoro americano né le banche centrali sparse per il mondo hanno strumenti per intervenire sugli altri livelli – e in realtà nemmeno su questo visto che nessuno può costringere una banca a concedere prestiti a chi non vuole. L’altra ragione, ancora più spaventosa, è che nessuno al mondo ha ancora capito fino a che punto sia compromesso il sistema ai livelli più alti, livelli nei quali i bei soldi promessi dalle autorità sono come gocce nel mare. I piani di salvataggio ovvero: fallimenti annunciati Se la medicina non abbassa la febbre, la terapia è sbagliata. Nel caso del mercato finanziario non c’è esempio migliore della rapidità con cui le borse hanno digerito i miliardi di dollari che sono stati dati loro in pasto. Prima di tutto, agendo al solo livello bancario, le autorità rischiano di affossare ancora di più gli attori presenti sugli altri livelli, che infatti stanno già presentando reclami – negli States – per i favori che consentiranno alle banche più o meno nazionalizzate di sbaragliare la concorrenza del capitale privato. L’idea era che, una volta riempito il buco con i capitali pubblici, i capitali privati sarebbero seguiti, ma era un’idea abbastanza ingenua e infatti non ha funzionato. Stessa cosa per i grandi attori non bancari – come i colossi dei mutui Fannie Mae e Freddie Mac – che sono stati nazionalizzati in fretta e furia ma non hanno certo attirato quella messe di capitali privati che ci si aspettava. Del resto è abbastanza irrealistico anche aspettarsi che le banche appena finanziate prestino generosamente i loro capitali alle imprese invece di impiegarli per sistemare le loro posizioni individuali. In ogni caso, anche senza fare la lunga lista degli stanziamenti effettuati dai vari Paesi, peraltro in costante aggiornamento, tutti hanno aderito entusiasticamente a questa strategia – anche chi, come gli europei, ha meno possibilità degli americani di battere impunemente carta moneta – che consiste sostanzialmente nel concentrarsi su di un unico problema (quello del credito) e a un unico livello (quello bancario) rimuovendo tutto il resto. Questo tipo di strategia si basa in sostanza sull’obiettivo di impedire alla bolla del debito di esplodere, tentativo che anche il massimo esperto di bolle mai esistito, Alan Greenspan, non ha mai tentato. L’ex presidente della Fed, considerato da molti l’inventore dell’attuale bolla speculativa – a lui si deve una tale profusione di prodotti finanziari e cartolarizzazioni – quando scoppiò la bolla di internet riuscì a dirottare i capitali speculativi sui mutui senza troppi scossoni, ma non ha mai nemmeno pensato di impedire lo scoppio della bolla cercando di salvare le migliaia di piccole imprese nate a ridosso del boom informatico. Cercare di allontanare il rischio d’insolvenza sistemica dando un po’ di miliardi alle banche equivale, letteralmente, a svuotare il mare con un cucchiaio. Oltretutto questa pratica comporta il rischio di allargare l’infezione dei titoli spazzatura anche al bilancio pubblico, trasformando il medico – lo Stato – in malato. La crisi reale Confindustria è stata rapidissima ad approfittare della crisi per attaccare a testa bassa il pacchetto clima di Bruxelles. Brandendo come una mazza ferrata le paure più in voga del momento – crisi finanziaria e pericolo giallo – ecco che anche le timide misure dell’Unione europea per la riduzione delle emissioni di gas serra diventano una minaccia per l’industria italiana. La quale è notoriamente in agonia e avrebbe invece estremamente bisogno di un riammodernamento in chiave ambientale e non solo – ridurre le perdite di un sistema elettrico fatiscente può favorire la concorrenza asiatica? E quale sarebbe la politica industriale italiana? Continuare a buttare via quantità significative di energia e contemporaneamente fo- 7 8 raggiare la costruzione di centrali nucleari e rigassificatori? Niente di nuovo sotto il sole, diranno in molti, a proposito di questa capacità di digerire ogni disastro per trasformarlo in profitto. Del resto è questo il limitato panorama nel quale si muove il «capitalismo dei disastri»: le emergenze rendono molto più della programmazione, come ben si evince dalla vicenda dei rifiuti tossici in Campania. Quello che colpisce, se mai, è la nostra totale incapacità di approfittare delle occasioni, delle difficoltà e perfino delle sconfitte dell’avversario pur disponendo di un’agenda estremamente articolata delle misure da prendere. È abbastanza incredibile che nessuno dei nostri politici, nemmeno chi dice di avere a cuore una sinistra che sappia accogliere anche istanze più moderne, di fronte alla crisi finanziaria si sia ricordato della questione ambientale. Eppure abbiamo alle spalle venti o trent’anni di studi, proposte e progetti per affrontare la vera emergenza, che non è quella della scomparsa dei soldi virtuali ma è quella della scomparsa della base materiale della nostra esistenza: terra, acqua, aria e una quantità impressionante di materie prime (quasi tutte) che stanno semplicemente esaurendosi, come era ovvio che accadesse prima o poi. Lasciamo perdere l’intreccio diabolico che lega il costo quasi nullo delle materie prime allo sfruttamento del Sud del mondo e veniamo alla crisi che incombe. Accade insomma che il nemico storico di ogni tentativo di programmazione economica, cioè la finanza speculativa, sia entrato in una crisi terminale. Questa dovrebbe essere una buona notizia così come il fatto che i dogmi del fondamentalismo liberista (sposati in modo suicida dal centro-sinistra mondiale) siano stati messi da parte nel breve spazio di un paio di settimane. Il gotha degli organismi economici internazionali è stato costretto ad ammettere che lo spietato darwinismo sociale non è valido per le banche, cui è concesso di sopravvivere anche se sono «meno adatte» di altre. È probabile che, in questa rapida conversione, abbia inciso il fatto che gli attuali decisori provengono proprio dalle banche che devono salvare – due esempi illustri sono Mario Draghi e Henry Paulson, entrambi cresciuti nella Goldman Sachs. Si è capito insomma che lo Stato deve tornare in campo perché tutta la fantasmagorica ricchezza degli ultimi decenni era appunto solo virtuale: non ha riconvertito un sistema produttivo fatiscente né ha creato nuovi posti di lavoro ma, siccome i bonus dei manager erano veri e sono stati pagati, adesso ce li ritroviamo sulle spalle. L’altra buona notizia è che, stavolta, il gioco deve avveni- re a carte scoperte, almeno nei Paesi dotati di uno straccio d’opposizione. Evidentemente non è il caso dell’Italia se il governo Berlusconi non è nemmeno stato costretto a dare qualche cifra il che, oltre a garantire che nessuno dovrà rendere conto di niente, dà ai mercati speculativi esattamente il tipo di messaggio che bisognerebbe evitare: continuate a speculare. Ciò che sta accadendo è abbastanza chiaro: quel che resta dell’economia reale sta venendo rapidamente sacrificato dagli Stati per finanziare qualche altro giro di roulette a fondo perduto in Italia e in Usa, con la speranza di mettere parola almeno sugli stipendi dei dirigenti in Gran Bretagna e Germania. Funzionerà? Ovviamente no: basta la logica a dire che, se gli Stati rinunciano alla produzione vera e propria per entrare nel mondo del denaro virtuale e riempirsi i bilanci di titoli spazzatura, il disastro è solo rimandato nel tempo caricandone i costi sulle spalle della collettività. Lo scenario che si prospetta è quindi abbastanza prevedibile visto che ripercorre le tappe di tutte le grandi crisi economiche. È molto probabile che la finanza resti in piedi – e con essa l’illusione che tutto va per il meglio – al prezzo di continue costosissime trasfusioni di risorse dall’economia presente e futura, visto che di riconversione non si parla più da nessuna parte, ma senza riconversione la produttività italiana non sopravvive al prossimo decennio... Il vero problema è che la catastrofe della finanza virtuale cancella completamente dalla vista la catastrofe vera, quella ecologica. Rifiuti, desertificazione, riscaldamento globale premono per ricordare a finanzieri e politici che il mondo è molto meno virtuale di quello che le redazioni, i consulenti finanziari e le segreterie di partito pensano, e presentano conti sempre più salati di giorno in giorno. In questo scenario un conflitto allargato sembra abbastanza probabile (a proposito: smettiamo di prenderci in giro: la Grande depressione non è finita con il New Deal ma con la Seconda guerra mondiale) così come l’aumento della conflittualità sociale dovuto alla crisi economica e ai tentativi di farla pagare esclusivamente ai soliti noti. L’unica incognita in questo percorso tristemente noto è il ruolo che il dissesto dell’ecosistema giocherà, ma è assai facile che renda le cose ancora più complicate. Lo scenario numero due è tutto da costruire, ma gli strumenti sono a disposizione. Si tratta di aggregare realtà locali, movimenti, imprenditori (veri), società civile, sindacati e quant’altro (anche i partiti, se non hanno altri impegni…) su di un unico obiettivo: evitare una guerra globale e avviare la ricostruzione prima, non dopo il conflitto. Si tratta di pretendere che l’incredibile quantità di EDITORIALE soldi promessi alle banche non vada agli speculatori ma alle imprese (Confindustria sarebbe d’accordo) a patto però che queste ultime facciano della riconversione ecologica il proprio obiettivo principale, il che sarebbe anche logico se uno vuole che la propria attività economica abbia un futuro. L’efficienza energetica, ad esempio, non è solo un modo per ridurre le emissioni di gas serra ma anche un modo per risparmiare sulla bolletta. Se le nostre imprese non fossero giganti che vivacchiano di prebende ed esenzioni fiscali, avrebbero da tempo imboccato questa strada anche senza esservi obbligate. Di piani – progetti, iniziative, strategie di recupero, riciclaggio e riconversione – ne sono stati prodotti a bizzeffe da generazioni di ambientalisti, attivisti locali e ricercatori. Scommetto che anche il più piccolo comune d’Italia ha nel cassetto un piano commissionato a qualche associazione, Università o centro studi magari solo per ottenere uno straccio di finanziamento dall’Unione europea. Del resto abbiamo anche liste interminabili di procedure d’infrazione che ci costano un capitale in multe e la situazione cambierà di poco anche se Berlusconi riuscirà a boicottare il pacchetto europeo sul clima. Insomma, invece di lasciare che lo Stato compri titoli spazzatura senza emettere un fiato dovremmo chiedere – anzi, pretendere – che i nostri soldi vengano investiti in quelle migliaia di progetti «alternativi» che languono nei cassetti da decenni perché bisognava lasciar fare alla mano invisibile del mercato. È abbastanza evidente che la battaglia di retroguardia che la sinistra si accinge a fare in difesa dei servizi che verranno inevitabilmente tagliati è destinata alla sconfitta semplicemente perché la crisi ambientale e quella finanziaria combinate sono destinate a distruggere l’economia reale. L’unico modo di non perdere questa battaglia è puntare alla vittoria, cioè rilanciare tirando fuori dai cassetti quell’altro mondo possibile che, oltretutto, è anche l’unico in grado di durare. Basta recuperare un po’ della memoria a breve che è andata perduta nella troppa dimestichezza con il potere – penso alle Giunte, non solo al Governo – e nei più recenti psicodrammi congressuali, e ripensare agli ultimi dieci anni. Ricordate Seattle 1999? Cancun 2003? Hong Kong 2005? Fra l’altro, nel frattempo avevamo anche vinto. Peccato non essersene resi conto. LA GENESI DELLA CRISI VLADIMIRO GIACCHE’ 9 L’8 aprile scorso è comparso sul Financial Times un importante articolo, annunciato da questo richiamo in prima pagina: «Ritorno agli anni Venti. Il ritorno a un mondo disuguale». L’articolo cominciava con queste parole: «La disuguaglianza tra i redditi negli Stati Uniti ha raggiunto il punto più alto dai tempi dell’anno del disastro: il 1929». E proseguiva così: «la caratteristica più notevole dell’era della disuaglianza e del libero mercato che è iniziata negli anni Ottanta è rappresentata dal fatto che si siano avute così poche reazioni alla stagnazione dei guadagni della gente comune in una così larga parte dell’economia del mondo sviluppato». In effetti i dati sono impressionanti. Tra il 1979 e il 2005 i redditi prima delle tasse delle famiglie americane più povere sono cresciute dell’1,3% annuo, quelli del ceto medio di meno dell’1% annuo, mentre quelli dell’1% più ricco della popolazione sono cresciuti del 200% annuo prima delle tasse e addirittura del 228% dopo le tasse. Risultato: nel 2005 il reddito dopo le tasse del quinto più povero della popolazione era di 15.300 dollari annui, quello del quinto mediano di 50.200 dollari, mentre quello dell’1% più ricco era superiore al milione di dollari. In definitiva, negli anni tra il 2002 e il 2006 all’1% più ricco della popolazione americana sono andati quasi i tre quarti della crescita del reddito complessiva. Nel 2005, secondo dati dell’US Census Bureau, l’indice della disuguaglianza tra i redditi, ha raggiunto il massimo storico. Lo stesso vale per la Gran Bretagna, ove questo si è verificato dopo l’andata al potere dei laburisti di Blair nel 1997: anche qui, secondo gli stessi dati governativi, la forbice della disuguaglianza è la più alta di sempre. Ma, più in generale, la riduzione della quota del prodotto interno lordo che va ai salari, e per contro la crescita della quota destinata ai profitti, è una tendenza che investe tutti i Paesi a capitalismo maturo, come ha evidenziato una ricerca della Banca dei Regolamenti Internazionali del 2007. torna Rifondazione, torna la sinistra 1. Una fase di transizione 10 on è azzardato affermare che stiamo vivendo, nel nostro Paese, una fase di transizione politica che si pone all’epilogo di processi di profonda modificazione della struttura del capitalismo italiano. Nelle linee essenziali – e seguendo lo schema del ragionamento assai condivisibile contenuto nella nuova edizione dell’ultimo lavoro di Alberto Burgio, Per Gramsci – possiamo dire che assistiamo al passaggio da una fase che gramscianamente definiamo di «rivoluzione passiva» a una fase di vera e propria «rivoluzione conservatrice». Da un’epoca apertasi simbolicamente con la controffensiva dei colletti bianchi della Fiat di Torino dell’ottobre 1980 e con il decreto sulla scala mobile del governo Craxi quattro anni più tardi (all’interno di un quadro internazionale che vedeva trionfare le politiche anti-operaie e di potenza di Thatcher e Reagan) a una nuova fase il cui tratto determinante sembra essere la commistione perversa tra elementi di liberismo spinto ed elementi di reazione e autoritarismo. In altre parole: da un processo ventennale, governato dalle classi dominanti, di restrutturazione dei processi produttivi e di ridefinizione e riorganizzazione della composizione sociale e dei rapporti tra le classi approdiamo a un nuovo contesto che non si limita a reiterare la sconfitta del movimento operaio (nella forma del più gigantesco movimento di redistribuzione della ricchezza verso il capitale della storia moderna) ma che, a essa, affianca l’attitudine violentemente repressiva delle fasi fascistiche del capitalismo. Siamo un passo oltre ciò che ci eravamo abituati a denunciare e rispetto a cui avevamo imparato, in lunghissimi N * SIMONE OGGIONNI – DIREZIONE NAZIONALE PRC ** FRANCESCO D’AGRESTA – SEGRETERIA PROVINCIALE PRC PESCARA S IMONE O GGIONNI * E F RANCESCO D’A GRESTA ** anni di resistenza, a prendere le misure. Oggi il governo Berlusconi, complice un contesto internazionale di crisi e di diffusa recessione (che l’amministrazione neo-liberista di George W. Bush ha affrontato con il più corposo intervento statale dalla Grande Depressione del 1929 a oggi: quasi 1000 miliardi di dollari), sta conducendo il nostro Paese in una fase in cui gli elementi caratterizzanti della rivoluzione passiva neo-liberista si sviluppano parossisticamente sino a sconfinare nel quadro sopra descritto. Solo così si spiega la coesistenza – in un disegno organico di attacco alla democrazia e ai diritti dei ceti deboli – dei progetti di privatizzazione della pubblica amministrazione, di riscrittura del modello contrattuale, di ridefinizione del ruolo stesso delle organizzazioni sindacali, finanche di messa in discussione del diritto di sciopero da un lato e, dall’altro, di provvedimenti legislativi di chiara impronta xenofoba e razzista (dalla schedatura delle comunità rom, indipendentemente dalla nazionalità, alla proposta di istituire classi separate alle scuole elementari per i figli dei migranti) e delle recenti repressioni poliziesche delle manifestazioni universitarie contro i tagli alla ricerca. 2. La «sonnolente fragilità» delle istituzioni democratiche La cifra di questo cortocircuito tra politiche economiche anti-popolari e voga repressiva è ben rappresentata dal complesso dei provvedimenti varati dal governo in materia di istruzione e università. Perché se l’abbassamento dell’obbligo scolastico a 14 anni, i tagli di 8 miliardi in quattro anni (che sanciranno l’esubero di 87.000 docenti e 43.000 lavoratori dell’amministrazione), la riduzione del 60% dei fondi per l’inserimento degli adulti anal- EDITORIALE fabeti o immigrati nonché, ovviamente, il disegno di legge Aprea che incentiva le scuole a trasformarsi in fondazioni di diritto privato dotate di propri CdA, che avranno il potere persino di determinare i salari dei docenti posti sotto contratto, definiscono classicamente un quadro di feroce indebolimento del carattere pubblico del sistema formativo nazionale, l’introduzione del voto di condotta valevole per la bocciatura e la immediata punibilità penale di qualunque azione compiuta dagli studenti e ritenuta non conforme dal Consiglio d’Istituto puntano a reintrodurre, anche nella scuola, quel modello autoritario e anti-egualitario che il movimento studentesco nel 1968 aveva messo sotto accusa. Sta in questo (e nelle cifre del drammatico impoverimento di settori sempre più estesi di società italiana: 7 milioni di lavoratori che vivono con meno di 1000 euro al mese, 270mila giovani che ogni anno emigrano dal Sud al Nord in cerca di lavoro, 4 milioni e mezzo di lavoratori precari e sottopagati e 6 milioni e mezzo di lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale) il cuore della rivoluzione conservatrice di cui si è parlato. È questo l’«allarmante incipit», di cui scrive Eugenio Scalfari, «verso una dittatura che si fa strada in tutti i settori sensibili della vita democratica, complici la debolezza dei contropoteri, la passività dell’opinione pubblica e la sonnolenta fragilità delle istituzioni». Cos’altro sono il progetto di riforma in chiave federalistica del sistema fiscale, l’impunità assegnata alle più alte cariche dello Stato (quella legge Alfano rispetto a cui il tribunale di Milano ha sollevato presso la Corte costituzionale l’eccezione di costituzionalità), nonché la stessa rivalutazione del fascismo storico rivendicata con orgoglio da autorevoli esponenti del governo, se non il segno di questa «sonnolente fragilità» delle istituzioni democratiche? Quel che è certo è che una tale involuzione (schematizzando: un tale spostamento a destra del quadro politico) è tanto profonda in quanto ha saputo modificare l’ethos di una società antropologicamente mutata e il suo senso comune, al punto che oggi il governo può godere di un consenso crescente e diffuso, e in primo luogo in quei settori (si pensi all’azione di Brunetta contro il pubblico impiego) che emblematicamente rappresentano questa regressione culturale e politica. Ed è tanto più tragica negli effetti materiali in quanto si innesta – lo si accennava in precedenza – all’interno di un ciclo economico di contrazione. Dedichiamo all’argomento alcune brevi considerazioni. 3. Crisi del sistema Ci pare di poter dire che non siamo di fronte a una «semplice» crisi finanziaria dentro il sistema capitalismo, originata – secondo la vulgata diffusa anche a sinistra – dal crollo dei mutui subprime negli Stati Uniti d’America. Una crisi che, producendosi sul piano delle attività finanziarie, non toccherebbe la struttura reale dell’economia e della produzione e che, di conseguenza, non ne metterebbe in discussione la bontà intrinseca e la intrinseca capacità di autoregolamentarsi. La crisi a cui stiamo assistendo è una crisi del sistema capitalistico e, nello specifico, delle sue regole di produzione. Di una economia reale che pone l’indebitamento di massa, la tutela del saggio di profitto e l’ampliamento della schiera dell’esercito industriale di riserva come condizioni necessarie per la sua riproduzione. E cosa sono l’indebitamento di massa e l’accumulazione di plusvalore a danno dell’esercito operaio attivo se non le cause immediate della crisi finanziaria in atto (accelerata e aggravata dalla riduzione delle riserve liquide del sistema bancario, causata dai costanti ritiri di contante)? Questa crisi finanziaria ha, al contempo, una sua seconda logica materiale. Come mette in luce Emiliano Brancaccio1, il tasso interbancario è troppo alto rispetto a quello applicato dalla Bce sulle operazioni di rifinanziamento perché non si ipotizzi, con fondamento, che sia in atto un 11 12 tentativo da parte dei grandi operatori bancari di trattenere la liquidità soffocando gli operatori che necessitano di prestiti. In altre parole: il capitale «forte» centralizza autocraticamente e punta a sbaragliare il capitale «debole», in una competizione inter-capitalistica in cui gli Stati nazionali continuano a giocare un ruolo rilevantissimo. Da questo cosa ne deriva in relazione alla natura del modo di produzione capitalistico? Che esso si regge su di una contraddizione irresolubile: la speculazione finanziaria garantisce il capitalismo – perché ne determina l’esistenza, ne consente la riproduzione – e al contempo lo distrugge, lo porta ciclicamente alla crisi. Come è evidente, la recentissima affermazione di Barack Obama alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America non muta il quadro strutturale, né indica ricette risolutive adeguate alla natura del crollo. Tuttavia, sarebbe ingeneroso non valorizzare una vittoria (per di più nettissima) avvenuta a dispetto del pregiudizio razzista diffuso in larghi strati della società nord-americana e a dispetto di un sistema elettorale che nel recente passato ha dato prova di non essere immune da irregolarità (non solo i brogli, ma anche la sistematica esclusione dalle liste di decine di migliaia di afro-americani, soprattutto nel Sud). L’affermazione di Obama è quindi, qualsiasi saranno le azioni che concretamente ne caratterizzeranno il mandato (a oggi è problematico, e puramente ipotetico, prefigurare quali potranno essere gli elementi di continuità e quelli di rottura), l’affermazione di un candidato democratico e la chiusura dell’epoca cupa di George W. Bush2. 4. «L’inconveniente della società», la sfida dei comunisti Rimane sempre in campo, a ogni modo, quello che, con il Marx della Miseria della filosofia, potremmo definire l’«inconveniente della società»; e in questa contraddizione si comprende il senso e la necessità di quella ipotesi di radicale alternativa sistemica che chiamiamo «comunismo». E che oggi – ma sfioriamo così temi e ragionamenti davvero impervi, ancor di più se affrontati in termini sintetici – passa per la proposizione di interventi statali volti a collocare la proprietà pubblica al centro dei processi economici. Non regali alle banche o alle imprese né semplici interventi risarcitori per i lavoratori, ma un impegno strutturale che espunga progressivamente il lucro privato dalla gestione dei gangli strategici delle diverse economie nazionali e macro-regionali. A questa altezza prende corpo, nel nostro Paese, la sfida della sinistra e dei comunisti. Analizziamo ora il quadro politico interno. EDITORIALE 5. Il quadro politico Il governo di destra – come dicevamo – fa politiche di destra, con l’aggravante di una solida popolarità. Il Pd, principale partito dell’opposizione parlamentare, non fa né opposizione né, tantomeno, opposizione di sinistra. Nei mesi scorsi il suo segretario, Walter Veltroni, ha ripetutamente criticato il governo per non aver mantenuto fede alle promesse elettorali e per una presunta inerzia nei confronti dei problemi del Paese (quando, come è evidente, la questione sta in termini esattamente opposti, e cioè nell’iperattivismo decisionista che dà forma ai contenuti reazionari). Più recentemente il Pd ha scelto una linea emendativa, di dialogo permanente, di confronto e correzione. Un approccio che considera Berlusconi un avversario normale, con buona pace di quanti (da Bocca ad Asor Rosa, per citare soltanto due delle voci autorevoli levatesi in queste settimane) hanno messo in guardia rispetto alla eccezionalità e alla profondità della modificazione intervenuta nel Paese per mezzo del governo in carica. Il che significa, anche sul piano logico, che la scelta di fondo di accettare l’agenda politica e l’ordine delle priorità avanzati dalla destra è ormai compiuta. Con il corollario immediatamente politico dell’apertura – a tutti i livelli – all’Udc di Casini che, nelle intenzioni di Enrico Letta e di una parte importante del Pd, dovrebbe sostituire in una alleanza «strategica» il rapporto con la sinistra d’alternativa. A questo si aggiunga che, se è vero che nel Partito democratico esiste una dialettica tesa tra pulsioni differenti, e se è vero che questa dialettica vive anche sul nodo specifico del rapporto con la sinistra, è altrettanto fondata la valutazione secondo la quale è l’intero Pd ad avere assunto una conformazione liberaldemocratica e un impianto neo-centrista. Ne è prova il fatto che se sulle riforme istituzionali il dibattito interno al Pd è acceso (ed è evidente che non si può essere equidistanti tra il modello veltroniano del maggioritario con i collegi a doppio turno e l’ipotesi dalemiana del proporzionale alla tedesca), sulle politiche economiche e sociali il Partito democratico parla con una sola voce. Una voce che, per citare una emblematica dichiarazione di Cesare Damiano, considera la riforma del modello contrattuale (nel senso di concedere ai contratti collettivi nazionali il solo obiettivo di recuperare l’inflazione programmata) «un obiettivo importante per il Paese e per le imprese»3. Vi è poi un secondo livello di contraddizioni all’interno del Pd che, in prospettiva, potrebbe essere ben più rilevante e che, a dire il vero, ha già mostrato in almeno due circostanze di essere potenzialmente deflagrante. È la distonia tra base popolare (la cui forza oggettivamente si è mostrata con la riuscita dell’appuntamento del 25 ottobre) e vertici: tra un base che chiede «opposizione» politica, sociale, morale al governo delle destre e un gruppo dirigente in larga misura indisponibile a svolgere il proprio compito. E questa distonia, quando si è prodotta contestualmente allo svilupparsi di sommovimenti sociali rilevanti, ha mostrato tutto il proprio potenziale critico: si pensi all’esempio più recente, quando Veltroni, in occasione del comizio finale dell’iniziativa del 25 ottobre, ha rivendicato a nome del Pd l’inedito obiettivo di giungere al ritiro del decreto Gelmini sull’istruzione. Una simile presa di posizione sarebbe stata difficile da immaginare in assenza di lotte sul terreno della formazione e della conoscenza come quelle che si sono prodotte in queste settimane. Questo cosa ci dice? Che il Partito democratico può riconquistare un ruolo di opposizione (e dunque Rifondazione Comunista può ricominciare a stringere un dialogo con quel partito) a condizione che nel Paese si moltiplichino mobilitazioni e conflitti. E che questo (la modifica dei rapporti di forza nella società, prima ancora che nella politica) è il presupposto che ci può consentire di relazionarci programmaticamente nei prossimi mesi con il Partito democratico. Senza elemosinare, da una posizione di subalternità, rapporti di «buon vicinato», ma forti dell’innalzarsi, in ogni realtà del Paese, del livello del confronto e dello scontro sociale. 6. Un autunno di mobilitazioni È in questo contesto, appunto, che si colloca l’iniziativa del nostro partito e delle altre forze della sinistra d’alternativa. C’è lo spazio per una opposizione intransigente e per un progetto di alternativa. E, a pochi giorni dalle straordinarie manifestazioni di Roma dell’11, del 17 e del 30 ottobre, nel vivo di un fermento studentesco inedito, ne cresce nel Paese anche la voglia. Cosa ci indicano le oceaniche manifestazioni del mese scorso? Che la sinistra esiste e che il governo delle destre deve tornare a fare i conti con il popolo della sinistra e con il popolo comunista. Al contrario di quanto sostenuto da alcuni compagni (tra cui Maurizio Zipponi, in un articolo apparso lo scorso 23 settembre su Liberazione con cui proponeva di congiungere le piazze e partecipare all’iniziativa di fine ottobre del Partito democratico), la manifestazione dell’11 ottobre non è stata né la «scimmiottatura» del 20 ottobre 2007 né un «momento di protesta inefficace». Al contrario, è stata il battesimo del nostro rinnovato protagonismo politico. L’irruzione sulla scena di una sinistra 13 7. Il ruolo dei comunisti 14 che, ridotta ai minimi termini dalle ultime elezioni (e ulteriormente lacerata dai rispettivi congressi), è di nuovo in piedi: in grado di sfidare la censura – già sperimentata all’indomani della grande iniziativa del partito del 14 settembre – a cui la condannano i mezzi di informazione e soprattutto in grado di sfidare il governo, raccordando in un unico grande corteo le diverse soggettività e le diverse esperienze di lotta attive nel nostro Paese. Che quella dell’11 non sia stata una manifestazione «identitaria» (intendendo con questo la degenerazione del vizio classico dell’autonomia della politica) lo ha dimostrato il 17 ottobre, un corteo di proporzioni inedite per il sindacalismo di base che ha riportato in piazza il popolo «dei partiti» insieme ai lavoratori e al conflitto di classe in carne e ossa. E lo ha dimostrato l’irrompere, in queste stesse settimane, di una radicalità e di una capacità di mobilitazione del movimento studentesco e universitario che ha pochi precedenti nella storia degli ultimi quarant’anni. Mettiamola in questi termini: la sinistra sta compiendo passi enormi (a dispetto di tempi drammaticamente contingentati) verso una sua riconnessione con i movimenti e le tante vertenze diffuse che, nelle piazze di queste settimane, si intrecciano e sovrappongono. Il rischio è che questi movimenti e queste vertenze non riconoscano fino in fondo la fecondità dell’abbraccio con la politica e con i nostri partiti (Prc e Pdci in primis) e la schivino, percorrendo strade parallele o, peggio, divergenti. Un ruolo decisivo lo giocheremo noi. Non genericamente la sinistra, ma noi comunisti. Perché la rilevanza oggettiva dei comunisti all’interno della sinistra di classe (verificata in ultimo proprio lo scorso 11 ottobre) ci indica che non esiste e non sta nelle cose alcun processo di ricostruzione del conflitto sociale che pretendesse di prescinderne, consegnando alla sfera astratta dei rapporti tra pezzi di ceto politico il compito di escogitare la soluzione salvifica. Nessun progetto costituente, quindi, come ha sancito definitivamente il nostro congresso nazionale. Nessuna retorica dell’«oltre» e della «sinistra senza aggettivi», come al contrario suggerirebbe il percorso sin qui seguito dalla maggioranza (sempre meno trionfante, sempre più risicata) dei Giovani Comunisti, i cui timori prevalenti in questi mesi sembrano essere quello di autonomizzarsi irreversibilmente dal partito (in maniera tale che sia possibile produrre una scelta autonoma, sul tema della costituente della sinistra, rispetto a quella del partito) e di non scontentare l’Unione degli Studenti, soggetto ormai marginale all’interno delle mobilitazioni studentesche e notoriamente orientato verso posizioni «compatibiliste», come dimostra la scelta di chiedere, dopo nemmeno due giorni dall’avvio delle occupazioni in tutto il Paese, l’apertura di un tavolo di confronto e di dialogo con il governo (Pd docet). Nessun progetto costituente, dicevamo. Ma il recupero di un lavoro di organizzazione e di iniziativa sociale che faccia di Rifondazione comunista non solo il cuore di un progetto di rafforzamento e riorganizzazione della presenza dei comunisti nel quadro politico italiano ma anche il motore delle mobilitazioni sociali in campo nel Paese. I due livelli si tengono. Se la sinistra oggi torna a respirare grazie alla presenza dei comunisti è anche perché i comunisti pongono all’ordine del giorno il tema della ricostruzione del conflitto sociale. Se la Sinistra l’Arcobaleno EDITORIALE ieri ha fallito (e ha spianato il deserto dal quale cerchiamo di ripartire) è perché, al governo e nei programmi, finanche nell’impianto ideologico e nel profilo identitario con cui si è presentata agli elettori, essa è stata percepita come separata dalla società e, in particolare, dai bisogni delle classi subalterne. 8. Mettere in moto Rifondazione In virtù di questa convinzione e di questa autocritica (che, come sappiamo, chiama in causa i compagni e le compagne con diversi livelli di responsabilità), dobbiamo rilanciare Rifondazione Comunista. Mettendo in moto la Rifondazione Comunista di Chianciano: un partito dotato innanzitutto di una linea politica chiara, elaborata sulla base di un’analisi della società e della fase seria, rigorosa, equilibrata (non retorica né auto-assolutoria né auto-consolatoria, come accadeva quando le colpe erano sempre dell’avversario e il Paese permanentemente attraversato da pulsioni pre-rivoluzionarie); un partito che rifugge, come si diceva, le scorciatoie politiciste delle «costituenti» e che investe strategicamente sulla nostra comunità organizzata e sulla sua ricostruzione; un partito che, in quanto «a vocazione sociale», sceglie la strada del conflitto e della internità alle lotte e quindi, a monte, pone la sfida della sua utilità sociale, provando a elaborare una risposta collettiva (generale, politica) al dramma sociale percepito come individuale e soggettivo. Un partito che, infine, si determina come soggetto autonomo dal Partito democratico e dalle altre forze della sinistra e che in questo fonda la ragione della sua autonomia elettorale, lavorando perché alle prossime elezioni amministrative ed europee esso sia presente ovunque con il proprio simbolo, i propri candidati e il proprio programma. E che, anche in presenza di una riforma della legge elettorale che, in virtù di uno sbarramento molto alto, imponesse di costruire convergenze, manterrebbe al contempo una propria chiara riconoscibilità e un profilo marcatamente differente dalle opzioni arcobaleno tristemente note. 9. Note finali Sono sfide gravose e che, in quanto tali, consegnano al Prc e all’area Essere Comunisti (oggi più che mai suo perno decisivo) due ulteriori necessità. La prima è lavorare perché si compia realmente l’obiettivo della gestione unitaria e della direzione collegiale. Rimaniamo convinti che qualsiasi esito che non consegnas- se al partito una maggioranza solida e ampia tradirebbe una logica maggioritaria che la nostra area contrasterebbe fermamente. Perché non ci sfugge che è questa la logica che ha portato in tutti questi anni alla cristallizzazione delle componenti interne, intese non come sensibilità politico-culturale ma come correnti, e di conseguenza all’affermazione del primato dell’appartenenza ai gruppi di pressione e del principio di fedeltà che tanto male ha fatto al partito, logorando le trame della nostra comune appartenenza. Il che – beninteso – vale a condizione che ciascuno riconosca nel Prc (e non in altri soggetti in fase di costituzione) la propria casa e il proprio partito. La seconda necessità, infine, deve possedere il respiro dei «pensieri lunghi». È urgente, non più prorogabile che il nostro partito connetta il proprio rilancio organizzativo a un lavoro di approfondimento teorico sulla natura del partito che vogliamo costruire a questa altezza dello sviluppo capitalistico. Un partito comunista, come si diceva, a «vocazione sociale», che riconosce l’essenzialità dell’auto-organizzazione dei soggetti del conflitto e prova a mettersi, con la cassetta degli attrezzi consegnataci da una storia ben più antica di quella del Prc, al servizio di una ipotesi di trasformazione progressiva e molecolare della società. Dal «soggetto della trasformazione» (e dalla sua lotta, dal suo antagonismo) dovrà nascere la forma del partito all’altezza dei tempi e il contenuto di uno strumento egemonico di politicizzazione e di consolidamento della coscienza della nuova classe. Non è poca cosa. Hic Rhodus, hic salta! 1. Si legga su www.esserecomunisti.it il testo dell’intervento pronunciato nel corso di un Seminario dedicato alla crisi finanziaria promosso dalla Direzione nazionale del Prc il 10 ottobre scorso. 2. Affronteremo approfonditamente il tema delle elezioni presidenziali Usa nel prossimo numero della rivista. 3. È una nota dell’Ufficio stampa del Pd dell’8 settembre scorso. 15 il sarto di Ulm 16 IL PRESENTE ARTICOLO, COMPARSO SUL NUMERO DI MAGGIO/GIUGNO 2008 DELLA «NEW LEFT REVIEW», ANTICIPA TEMI CHE SARANNO PIÙ DIFFUSAMENTE TRATTATI IN UN LIBRO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE. RINGRAZIAMO LUCIO MAGRI PER AVERCI AUTORIZZATO A PRESENTARLO IN TRADUZIONE ITALIANA. L UCIO M AGRI I n una delle affollate assemblee che dovevano decidere se cambiare nome al Pci un compagno rivolse a Pietro Ingrao una domanda: dopo tutto ciò che è successo e sta succedendo, credi proprio che con la parola comunista si possa ancora definire un grande partito democratico e di massa come noi siamo stati, ancora siamo e che vogliamo rinnovare e rafforzare per portarlo al governo del Paese? Ingrao, che già aveva ampiamente esposto le ragioni del suo dissenso e proposto di seguire un’altra strada, rispose, scherzosamente ma non troppo, usando un famoso apologo di Bertolt Brecht, «il sarto di Ulm», quell’artigiano fissato nell’idea di apprestare un apparecchio che permettesse all’uomo di volare. E un giorno, convinto di esserci riuscito, si presentò al governatore e gli disse: eccolo, posso volare. Il governatore lo condusse alla finestra dell’alto palazzo e lo sfidò a dimostrarlo. Il sarto si lanciò e ovviamente si spiaccicò sul selciato. Tuttavia – commenta Brecht – alcuni secoli dopo gli uomini riuscirono effettivamente a volare. Io, che ero presente, trovai la risposta di Ingrao non solo arguta, ma fondata. Quanto tempo, quante lotte cruente, quanti avanzamenti e quante sconfitte, furono necessari al sistema capitalistico – in una Europa occidentale all’inizio più arretrata e barbarica di altre regioni del mondo – per trovare alla fine una efficienza economica mai conosciuta, darsi nuove istituzioni politiche più aperte, una cultura più razionale? Quali contraddizioni irriducibili marcarono per secoli il liberalismo tra ideali solennemente affermati (la comune natura umana, la libertà di pensiero e di parola, la sovranità conferita dal popolo) e pratiche che li smentivano in modo permanente (schiavismo, dominazione coloniale, espulsione dei contadini dalle terre comuni, guerre di religione)? Contraddizioni di fatto, ma legittimate nel pensiero: l’idea che alla libertà non potessero né dovessero accedere se non coloro che avevano per censo e cultura – perfino per razza e colore – la capacità di esercitarla saggiamente; e l’idea correlativa che la proprietà dei beni era un diritto assoluto e intoccabile e dunque escludeva il suffragio generale? Tutte contraddizioni che non tormentarono solo la prima fase di un ciclo storico, ma si erano riprodotte in forme diverse, nelle sue successive evoluzioni e gradualmente si erano ridotte solo per l’intervento di nuovi soggetti sociali sacrificati e di forze contestatrici di quel sistema e di quel pensiero. Se dunque la storia reale della modernità capitalistica non era stata lineare né unicamente progressiva, anzi drammatica e costosa, perché dovrebbe esserlo il processo del suo superamento? Questo appunto voleva Ingrao rispose usando un famoso apologo di Bertolt Brecht, «il sarto di Ulm», quell’artigiano fissato nell’idea di apprestare un apparecchio che permettesse all’uomo di volare ANTICIPAZIONI significare l’apologo del sarto di Ulm. Tuttavia, sempre scherzosamente ma non troppo, proposi subito a Ingrao due interrogativi che quell’apologo, anziché superare, metteva in luce. Siamo sicuri che se il sarto di Ulm fosse sopravvissuto storpiato alla rovinosa caduta sarebbe rapidamente risalito per riprovarci, e che i suoi amici non avrebbero cercato di trattenerlo? E comunque, quel suo azzardato tentativo, quale contributo effettivo aveva portato alla successiva storia della aeronautica? Questi interrogativi, in relazione al comunismo, erano particolarmente pertinenti e ostici. Anzitutto perchè nella sua costruzione teorica esso pretendeva di non essere un ideale cui ispirarsi ma parte di un processo storico già in corso, di un movimento reale che cambia lo stato di cose esistenti: comportava quindi, in ogni momento, una verifica fattuale, una analisi scientifica del presente, una realistica previsione sul futuro, per non evaporare in un mito. In secondo luogo perché tra le precedenti sconfitte e gli arretramenti delle rivoluzioni borghesi in Francia e in Inghilterra, e il crollo recente del «socialismo reale» occorre vedere una differenza pesante. Una differenza che non si misura nel numero di morti o nell’uso del dispotismo, ma nel risultato: le prime hanno lasciato eredità, magari molto più modeste delle speranze iniziali, dovunque sono avvenute, comunque immediatamente evidenti; del secondo è invece difficile decifrare e misurare il lascito e individuare degni continuatori. Venti anni dopo, questi interrogativi non solo non hanno trovato una risposta, ma non sono neppure stati seriamente discussi. O meglio, delle risposte le hanno trovate in una forma molto superficiale e dettata dalle convenienze: abiura o rimozione. Una esperienza storica e un patrimonio teorico che hanno segnato un secolo sono stati così affidati – per usare una espressione di Marx – alla «critica roditrice dei topi», che come si sa sono voraci, e, in un ambiente adatto, si moltiplicano velocemente. La parola comunista torna certo ancora, in modo ossessivo e caricaturale, nella propaganda della destra più rozza. Resta nei simboli elettorali di piccoli partiti europei per conservare il consenso di una minoranza affezionata a un ricordo, o per indicare genericamente un’avversità al capitalismo. In altre regioni del mondo partiti comunisti continuano a governare piccoli Paesi, soprattutto a difesa della propria indipendenza dall’imperialismo, e in uno, grandissimo, dove serve però per sostenere uno straordinario sviluppo economico che va in altra direzione. La rivoluzione di Ottobre è generalmente considerata una grande illusione, in qualche momento e agli occhi di pochi utile, ma nel complesso sciagurata (identificata con lo stalinismo e in una sua versione grottesca), comunque condannata dal suo esito finale. Marx ha riconquistato un certo credito, come pensatore, per le sue lungimiranti previsioni sul capitalismo del futuro, ma del tutto amputato dalla ambizione di porvi fine. Ancora peggio, la dannazione della memoria tende ormai a procedere oltre: a estendersi all’intera vicenda del socialismo e, su per li rami, alle componenti radicali della rivoluzione borghese e alle lotte di liberazione dei popoli coloniali (che, come si sa, anche nel Paese di Ghandi, non poterono sempre essere pacifiche). Insomma, «il fantasma che si aggirava» sembra finalmente sepolto: da alcuni con onore, da altri con odio non dimenticato, dai più con indifferenza perché non ha più nulla da dirci. L’orazione più graffiante, ma a suo modo più rispettosa, a questa definitiva sepoltura l’aveva anticipata uno dei maggiori cervelli avversari, Augusto del Noce. Quando, anni fa, disse in sostanza dei comunisti: hanno perduto e vinto. Hanno perduto rovinosamente nella loro prometeica ambizione di rovesciare il corso della storia, di promettere agli uomini libertà e fratellanza, anche senza Dio e riconoscendosi mortali. Ma hanno vinto come potente e necessario fattore di accelerazione della globalizzazione della modernità capitalistica e dei suoi valori: il materialismo, l’edonismo, l’individualismo, il relativismo etico. Uno straordinario fenomeno di eterogenesi dei fini, che egli, cattolico conservatore e intransigente, pensava di aver previsto, ma del quale aveva poche ragioni per compiacersi. 17 Ci sono buone ragioni e condizioni adatte per riaprire oggi criticamente una discussione sul comunismo, anziché archiviarla? A me pare di sì 18 Chi però al tentativo del comunismo ha creduto, in qualche modo vi ha partecipato, e solitamente senza dare segnali di allarme, ha il dovere di renderne conto, anche a se stesso, di chiedersi se quella sepoltura non sia troppo frettolosa, se non occorre un altro certificato sul rigor mortis. Abbiamo tutti molti argomenti per aggirare l’ostacolo. Del tipo: sono stato un comunista italiano perchè era prioritario per combattere il fascismo, difendere la democrazia repubblicana, per sostenere rivendicazioni sacrosante dei lavoratori; oppure, sono diventato comunista quando il legame con l’Unione Sovietica o l’ortodossia marxista erano ormai in discussione, oggi posso aggiungere una circoscritta autocritica al passato e una forte apertura al nuovo. Non basta? A mio parere non basta: perché non rende conto di una impresa collettiva che, nel bene e nel male, ha coperto molti decenni, va considerata e compresa, nel bene e nel male, nel suo insieme. Non basta soprattutto per trarne una lezione utile per l’oggi e per il domani. Da troppa gente sento ormai dire: era tutto uno sbaglio ma sono stati i migliori anni della nostra vita. Per alcuni anni, sotto botta, questo misto di autocritica e di nostalgia, di dubbio e di fierezza, soprattutto tra le persone semplici, mi è sembrato giustificato, anzi una risorsa. Ma col passare del tempo, e soprattutto tra intellettuali e dirigenti, mi pare oggi ormai un accomodante compromesso con se stessi e con il mondo. E torno di nuovo e di più a chiedermi: ci sono argomenti razionali e convincenti per opporsi all’abiura e alla rimozione? O quanto meno ci sono buone ragioni e condizioni adatte per riaprire oggi criticamente una discussione sul comunismo, anziché archiviarla? A me pare di sì. Da quel fatale Ottantanove molta acqua è infatti passata sotto i ponti, turbolenta. Le novità che quella cesura storica esprimeva e ratificava sono emerse più chiare e definitive, e altre se ne sono aggiunte, rapide e inattese. Dal loro insieme è risultato un nuovo assetto dell’ordine mondiale, della società e della coscienza di chi ci vive. Ciò che restava in campo, vincente, non era solo il capi- talismo. Ma un capitalismo cui la vittoria permetteva di riaffermare senza più condizionamenti cogenti i suoi valori e meccanismi fondanti, e cui una nuova rivoluzione tecnologica e un salto nella globalizzazione sembravano promettere espansione economica impetuosa e duratura, stabilità delle relazioni internazionali sotto la guida, condivisa o subita, di una sola soverchiante potenza. Si poteva certo ancora discutere nel valutare il contributo che i conflitti e la competizione tra due sistemi del secolo scorso avevano dato alla democrazia e al progresso, o di ciò che erano costati a ciascuno e a tutti. Si poteva anche discutere dei correttivi da apportare al nuovo assetto per ridurne le peggiori conseguenze sociali, o per garantire al mercato restaurato trasparenza e correttezza, o per temperare l’unilateralismo della potenza dominante. Ma il sistema era ormai questo, non poteva essere contestato, anzi andava sostenuto a fin di bene e in coerenza con i suoi princìpi. E se mai, un giorno lontano, avesse anch’esso esaurito il suo compito e dovesse essere superato, ciò non avrebbe avuto comunque niente in comune con ciò che le sinistre ANTICIPAZIONI avevano fatto o pensato. Tale la realtà, e ogni politico di buon senso doveva riconoscerla, o abbaiare alla luna. Nel giro di pochi anni però il quadro è profondamente mutato. Anche questo è un fatto difficilmente contestabile. Si sono ripresentate – in forma nuova e in molti casi crescente – disuguaglianze di reddito, di qualità della vita, di potere, tra varie aree del mondo e all’interno di ciascuna di esse. Si è misurata l’incompatibilità tra il nuovo funzionamento del sistema economico e il permanere di grandi conquiste sociali da tempo acquisite: welfare universalistico, piena e stabile occupazione, democrazia partecipata nelle società più avanzate, il diritto all’indipendenza nazionale e qualche tutela dall’intervento armato, per i popoli sottosviluppati e i Paesi più piccoli. Sono emersi, ovunque e in tutta la loro urgenza, problemi nuovi incombenti: degrado dell’ambiente naturale, che accelera il suo corso; e degrado morale che con individualismo e consumismo, anziché riempire con nuovi valori e nuove relazioni umane un vuoto aperto dalla crisi irreversibile e in sé liberatrice di istituzioni millenarie, lo approfondisce e lo trasforma nella dicotomia tra sregolatezza e neoclericalismo. Altrettanto evidente e nuova avanza una crisi del sistema politico: reso impotente dal declino degli Stati nazionali surrogato da istituzioni estranee al suffragio popolare, a sua volta svuotato dalla manipolazione mediatica del consenso e dalla trasformazione dei partiti in macchine elettorali di riproduzione di un ceto. Anche sul piano produttivo i tassi di sviluppo per ora declinano, e gli equilibri appaiono instabili, qualcosa di più di una congiuntura: la finanziarizzazione genera come figlia naturale la rendita, e come sorella la ricerca esasperata del profitto immediato; e quindi toglie allo stesso mercato un criterio sul cosa produrre e sul come verificare la propria efficienza. Infine, e come conseguenza di tutto ciò, un declino di egemonia, una moltiplicazione di conflitti, una crisi dell’ordine mondiale, cui è naturale supplire con l’impiego della forza, fino alla guerra, che a sua volta anziché risolvere aggrava ogni problema. Ammettiamo pure che il quadro così disegnato in poche righe sia eccessivamente fosco e soprattutto unilaterale, che tali tendenze preoccupanti siano ancora ai primi passi. E ammettiamo anche che altri elementi – ad esempio le risorse dell’innovazione tecnologica, o l’ancor più sorprendente irruzione di nuovi e grandissimi Paesi e i loro attuali successi – compensino o frenino tali tendenze. Ammettiamo infine che la nuova ampiezza della base sociale che ha beneficiato di una precedente accumulazione diffusa, o altrove spera di beneficiare di un benessere finora negato, garantiscano quindi tuttora il consenso o generino comunque un timore per mutamenti radicali ma non sicuri. Molte volte i comunisti hanno compiuto l’errore di analisi catastrofiche, di cui hanno pagato il prezzo. Ciò non toglie che una svolta si è compiuta, più e prima di quanto chiunque temesse o sperasse. Non solo in minoranze riottose o sofferenti, ma nel senso comune di massa, in una intellettualità diffusa, perfino in alcuni settori della classe dominante, il futuro del mondo e della civiltà sembra promettere poco di rassicurante. Non siamo nella temperie del Novecento, ma non si respira aria di Belle époque (che peraltro, sappiamo, non finì affatto bene). Non a caso dunque, in pochi anni sono apparsi sulla scena movimenti di lotta sociale e di contestazione ideale, sorprendenti per estensione, durata, pluralità di soggetti e novità di tematiche. Movimenti dispersi e intermittenti, privi di un progetto unitario e di una organizzazione, movimenti perciò sociali e culturali più che politici? Certamente, perché nascono da situazioni e soggettività le più diverse tra loro, e rifiutano organizzazione, ideologia, politica per come le hanno conosciute e soprattutto per come si presentano oggi. E tuttavia comunicano incessantemente tra loro, riconoscono avversari comuni cui danno nome e cognome, coltivano ideali e sperimentano pratiche che si contrappongono radicalmente all’ordine di cose esistenti, ai valori, alle istituzioni, ai poteri che lo incarnano; su ogni terreno, il modo di produrre, di consumare, di pensare, il rapporto tra le classi, tra i sessi, i Paesi, le religioni. In certi momenti, e su certi temi – come la guerra «preventiva» in Iraq – essi sono riusciti a mobilitare una parte larga dell’opinione pubblica. In questo senso sono pienamente politici e pesano. Possiamo perciò sentirci rassicurati? La «vecchia talpa» – finalmente liberata dal peso di dottrine e da discipline che potrebbero frenarla – ha ripreso a scavare e, nel lungo periodo, ci farà trovare in un «mondo nuovo»? Mi piacerebbe crederlo, ma ne dubito. Anche qui i fatti parlano abbastanza chiaramente. Da un lato occorre vedere in faccia, senza cupezza ma senza infingimenti, come per ora evolve la situazione reale. Non è lecito dire che volga gradualmente al meglio, né che la lezione delle cose stia producendo uno spostamento generale dei rapporti di forza a favore della sinistra. Per accennare a qualche riferimento concreto: il matrimonio di convenienza tra l’economia asiatica e quella americana ha permesso alla prima un sorprendente decollo e garantito alla seconda di assicurarsi profitti imperiali e continuare a consumare al di sopra dei propri mezzi, ma nel contempo ha contribuito alla stagnazione europea, ed è difficile capirne le dinamiche più di lungo periodo, costi ed esiti. La guerra anziché stabilizzare il Medio Oriente ha «incendiato la prateria». L’unità europea, anziché progredire come forza autonoma, ha ripreso e accentuato la sua subalternità al modello economico anglosassone. E alla sua politica internazionale. In America Latina dopo molti anni sono al governo di molti Paesi forze popolari e antimperialistiche, ma tra molte difficoltà, e nell’Asia centrale, come nell’Est europeo si moltiplicano invece i clienti degli 19 20 Stati Uniti. In Europa ha vinto Zapatero, e in Italia stentatamente una larga coalizione di centro sinistra, che presto è crollata perché molto moderata ed eterogenea, in Germania i democristiani sono tornati alla guida, in Francia la gauche intera è in confusione, in Inghilterra il newlabour resiste sulla sua linea e probabilmente perderà a vantaggio dei conservatori. I sindacati, dopo qualche segno di ripresa, si trovano quasi ovunque inchiodati a una difensiva perenne, e le condizioni reali dei lavoratori sono sotto la pressione di questo quadro politico e il ricatto della crisi economica e dei deficit di bilancio. Complessivamente, si può forse prevedere che dalla ammaccata politica del tipo Bush si torni a una politica più prudente di tipo Clinton: poco a che fare con una vera svolta adeguata ai nuovi e pressanti problemi del mondo. Nell’economia come nella politica non c’è nessun newdeal in cammino, il riformismo è da tutti invocato, in tutte le versioni, e del tutto pallido e sfuggente. E tuttavia, quando ci riesce, è in questa versione che resta al comando, per necessità o per scelta. Quanto alle forze che si oppongono e contestano il sistema, anche qui si può e si deve fare un bilancio veritiero. E non è per ora molto confortante. È certo importante che i nuovi movimenti sociali restino in scena, in certi casi si estendano a nuove regioni o contribuiscano a produrre qualche ricambio politico, e comunque abbiano portato all’attenzione problemi decisivi e sempre rimossi: l’acqua, il clima, la tutela dell’identità culturale, le libertà civili per le minoranze come immigrati e gay. Sarebbe dunque sbagliato parlare di riflusso o di crisi. Ma lo è altrettanto parlare, come in un certo momento si è fatto, di una «seconda potenza mondiale» in atto o in via di allestimento. Perché sulle grandi battaglie in cui erano unitariamente impegnati – la pace e il disarmo, l’abolizione del Wto o del Fondo Monetario, la Tobin Tax, l’energia al- ternativa – i risultati sono stati irrilevanti e l’iniziativa è declinata. Il pluralismo ha mostrato di essere oltre che una risorsa anche un limite. L’organizzazione, ripensata fin che si voglia, non può per troppo tempo ridursi a internet o alla replica dei forum. Rifiuto della politica, il potere dal basso, la rivoluzione senza potere, anziché tappa di un percorso, verità parziali cui non rinunciare, rischiano di trasformarsi in una subcultura cristallizzata, in una retorica ripetitiva che ostacola una riflessione su se stessi e ogni definizione impegnativa delle priorità. Infine e soprattutto, certo non per colpa loro, ai nuovi movimenti si è affiancato un altro tipo di opposizione radicale alla modernità capitalistica, quello animato dal fondamentalismo religioso o etnico, che nel terrorismo trova la forma estrema, ma coinvolge e influenza masse imponenti. Se poi, tra le forze di opposizione, vogliamo concentrare lo sguardo sulle forze politiche organizzate dell’estrema sinistra che coraggiosamente hanno resistito al collasso del dopo ‘89, si sono impegnate in tentativi di rinnovamento, hanno fiancheggiato nuovi movimenti e lotte sindacali, il bilancio appare ancora più magro. Dopo anni di lavoro, in una società in ebollizione, queste forze restano marginali, divise tra loro e al loro interno, in termini elettorali si collocano tra il 3 e il 10% e sono quindi costrette nel dilemma tra radicalismo minoritario o intese elettorali di cui subiscono il vincolo pesante. Insomma, a voler essere sinceri, si può dire – parafrasando alcuni classici del marxismo – che ci troviamo di nuovo di fronte a una fase nella quale «il vecchio mondo può produrre barbarie ma un mondo nuovo non appare in grado di sostituirlo». La ragione di questa impasse non è difficile da vedere, anche se è molto difficile da rimuovere. In estrema sintesi la potrei definire nel modo seguente. Neoliberismo e unilateralismo, contro cui in questa fase si combatte giustamente, sono l’espressione e una delle varianti di qualcosa di più profondo e permanente che è intervenuto nel sistema portando all’estremo la sua originaria vocazione. Dominio dell’economia su ogni altra dimensione della vita individuale e collettiva; dominio nell’economia del mercato globalizzato, e nel mercato delle grandi concentrazioni finanziarie sulla produzione e, nella produzione, dei servizi rispetto all’industria, e di beni immateriali per consumi indotti rispetto ai bisogni reali; declino invece della politica, nella forma degli Stati nazionali, sovrastati da compatibilità che la travalicano, e insieme svuotata dalla frammentazione e dalla manipolazione di quella volontà popolare che doveva orientarla e sostenerla; infine unificazione del mondo ma nel segno di una precisa gerarchia al cui vertice permane una soverchiante potenza. Un sistema dunque in apparenza decentrato, ma nel quale in ultima analisi le scelte decisive sono concentrate nelle mani dei pochi che detengono decisivi monopoli: in ordine crescente, quello tecnologico, quello sulle comunicazioni, quello finanziario, quello militare. A reggere il tutto – come sempre più di sempre – la proprietà nella forma di capitale alla ricerca incessante e irrinunciabile del proprio accrescimento, processo che ha conquistato piena autonomia rispetto al territorio in cui si colloca e a ogni diversa finalità che lo vincoli; che attraverso l’industria culturale può direttamente conformare bisogni, coscienze, stili di vita; che può selezionare il ceto politico e intellettuale; che può condizionare politica estera, spese militari, indirizzi della ricerca; che, infine ma non per ultimo, può anche rimodellare i rapporti di lavoro scegliendo il dove e come reclutarlo e le forme più adatte a minarne il potere contrattuale. La novità più rilevante in tutto ciò – rispetto alle fasi precedenti – sta dunque nel fatto che, anche nei ANTICIPAZIONI Sono diventato comunista perché credevo, come ho continuato poi a credere, a un progetto di cambiamento radicale della società di cui occorreva sopportare i costi momenti e per gli aspetti in cui entra in crisi o segna un fallimento, il sistema riproduce comunque le proprie basi di forza e di interdipendenza e riesce a destrutturare o ricattare i propri antagonisti. Evoca e insieme seppellisce il proprio becchino. Per contrastare e superare tale sistema occorre sempre più definire un sistema a sua volta coerente, la forza per imporlo, la capacità di gestirlo, un blocco sociale che può sostenerlo, tappe e alleanze adeguate all’ambizione. Quanto più ci si può e ci si deve liberare dal mito di una precipitazione catastrofica e della conquista del potere statuale da parte di una minoranza giacobina che approfitta dell’occasione, tanto meno ci si può affidare a una successione di rivolte disperse o di piccole riforme che spontaneamente si compongono in una grande trasformazione. Ecco perché a me pare che le cose stesse impongano a una sinistra che oggi naviga in una grande confusione una riflessione sulla «questione comunista». Non uso a caso entrambe queste parole. Dico riflessione – non recupero, né restauro – per sottolineare il fatto che una fase storica si è conclusa, e la fase nuova impone una innovazione radicale di questa – come di ogni altra – tradizione teorica o pratica (delle sue origini, dei suoi sviluppi, dei suoi esiti). Dico comunista, perché mi riferisco non solo o non tanto a testi variamente interpretati nei quali riscoprire verità offuscate ma permanenti, né nobili intenzioni da cui si è tralignato. Ma mi riferisco specificamente e nel suo insieme a una esperienza storica che ha posto esplicitamente il tema di una rivoluzione anticapitalistica, guidata dalla classe operaia organizzata in un partito, ha raccolto intorno a tale impresa per decenni milioni e milioni di uomini, ha combattuto e vinto una guerra mondiale, ha governato grandi Stati plasmandone la società e indirettamente influito sulle vicende del mondo e alla fine, certo non a caso, è degenerata ed è stata duramente sconfitta. Nel bene e nel male ha segnato quasi un intero secolo. Farne un bilancio – quali che siano le convinzioni da cui si parte o le conclusioni cui si arriva – ma con spirito di verità, senza contraffazione dei fatti, senza giustificazioni e senza separarlo dal contesto. Distinguere il grano dal loglio: il contributo dato a decisivi e permanenti avanzamenti storici, e i costi tremendi che hanno comportato, le verità teoriche intuite e gli abbagli del pensiero. Distinguere le varie fasi di un’evoluzione e cercare in ognuna non solo gli errori compiuti e i successivi elementi degenerativi, ma le loro cause soggettive e oggettive e anche le occasioni che si offrivano realmente per imboccare strade diverse per raggiungere il fine perseguito. Insomma ricostruire il filo di una impresa titanica e di un declino drammatico, senza esibire una neutralità impossibile e senza sconti, ma cercando un’approssimazione alla verità. Per affrontare questa agenda abbiamo tutti, oggi, lo straordinario privilegio di sapere come la vicenda si è conclusa, e altrettanto lo stimolo che nasce dalla consapevolezza di trovarci di nuovo in una crisi di civiltà. Usare il presente per capire meglio il passato, e capire bene il passato per orientarsi nel presente e nel futuro. Se si evita questo tipo di riflessione, se si considera il Novecento un cumulo di ceneri, se vi si espungono le grandi rivoluzioni, le aspre lotte di classe, i grandi conflitti culturali che l’hanno attraversato, il socialismo e il comunismo che lo hanno animato; o anche solo se si riduce il tutto a uno scontro tra «totalitarismi» e «democrazia» (senza distinguere diverse origini e diverse finalità dei «totalitarismi» e prescindendo dalla politica concreta della «democrazia») io credo che non solo si alteri la storia ma vengano a mancare alla politica passioni e argomenti per affrontare sia drammatici antichi problemi che oggi si ripresentano, sia i nuovi che emergono ed esigono cambiamenti profondi e un discorso razionale. Il tipo di ricerca che ho voluto preliminarmente proporre e propormi – tanto più le intenzioni che dovrebbero orientarla – è tremendamente difficile. Perché il «secolo breve» è un’epoca grande e complicata, attraversata da drammatiche contraddizioni ciascuna delle quali rinvia ad altre, reclama perciò una visione generale del contesto. Perché è ancora tanto vicino nella memoria collettiva da ostacolare il necessario distacco critico. Perché va controcorrente rispetto a un senso comune oggi prevalente, che non solo considera quel capitolo chiuso, ma 21 22 più in generale nega che la storia possa essere complessivamente e nel lungo periodo decifrabile, e quindi nega l’utilità di collocarvi il presente e di apprestare categorie interpretative adeguate a farlo. Infine, di conseguenza, perché, per contrastare questo senso comune, occorrerebbe più che non in altri momenti una rottura della continuità, essere capaci di far emergere già in partenza dalla lettura critica del passato i primi abbozzi di un’analisi calzante del presente e un progetto di azione futura (questo fu il punto di forza del marxismo, anche negli aspetti che presto si rivelarono caduchi). Ora, so benissimo di non avere affatto il tempo di vita, le competenze, le risorse di intelligenza per portare a una impresa di questa portata un aiuto importante. Ma sento la responsabilità, non solo individuale ma per una intera generazione, di contribuirvi con quel poco di cui dispone. Il primo passo per me può essere un lavoro di ricostruzione e di indagine su alcuni nodi cruciali della storia del comunismo italiano, cui questo saggio sarà appunto dedicato. La scelta non ha motivazione autobiografica, e non è provincialmente restrittiva. Al contrario, infatti, proprio in questa scelta – circoscritta per poter parlare di un oggetto concreto – è implicita una ipotesi di lavoro che già va controcorrente, che costringe e forse alla fine permette qualche conclusione generale. Mi spiego. Oggi prevalgono due letture diverse del comunismo italiano, opposte tra loro e ciascuna con finalità molteplici e mosse da diversi versanti. La prima lettura sostiene, in forma più o meno grezza, che il Pci, almeno dalla fine della guerra, è sempre stato, nella sostanza, un partito socialdemocratico, pur senza volerlo dire e forse senza neppure saperlo; la sua storia è stata una lunga marcia, troppo lenta ma costante di autoriconoscimento; quel ritardo gli è costata la lunga esclusione dal governo del Paese, ma quella identità sostanziale gli ha assicurato la forza e poi garantito la sopravvivenza malgrado la crisi. La seconda sostiene che malgrado la Resistenza, la Costituzione repubblicana, il ruolo avuto nell’ampliamento della democrazia, malgrado alcune prove di autonomia e l’ostilità a ogni ipotesi insurrezionale, in ultima istanza il Pci era una articolazione della politica sovietica e portava in cuore la prospettiva di quel modello: solo verso la fine ha dovuto arrendersi a cambiare identità. Io credo invece che entrambe queste letture siano non solo contraddette da troppi fatti, ma cancellino ciò che di più originale e interessante c’è stato in quella vicenda. La tesi che vorrei sostenere e verificare in concreto è invece che il Pci ha rappresentato – in modo intermittente e senza svilupparlo pienamente – un tentativo – il più serio in una certa fase storica – di aprire la strada a una «terza via»: di coniugare cioè riforme parziali, ricerca di ampie alleanze sociali e politiche, uso convinto della democrazia parlamentare, con aspre lotte sociali, con una esplicita e condivisa critica della società capitalistica; di costruire un partito fortemente coeso, militante, ricco di quadri ideologicamente formati, ma di massa; di ribadire la propria appartenenza a un campo rivoluzionario mondiale subendone i vincoli ma conquistando una relativa autonomia. Non si trattava di una semplice doppiezza: l’idea strategica unificante era che il consolidamento e la evoluzione del «socialismo reale» non costituiva un modello che un giorno sarebbe stato possibile applicare anche in Occidente, ma il retroterra necessario per realizzare in Occidente, e nel rispetto delle libertà, un altro tipo di socialismo. È questo tentativo che serve a spiegare la crescita della sua forza in Italia – che continuò anche dopo la modernizzazione capitalistica – e della sua influenza internazionale anche dopo i primi e vistosi segni di crisi del «socialismo reale». Ma, reciprocamente, il suo successivo declino e il finale dissolvimento in una forza liberal-democratica più che socialdemocratica, obbligano a spiegare come e quando quel tentativo sia fallito. Permettono cioè di individuare le ragioni oggettive e soggettive di una parabola e anche di chiedersi se, come e quando si sono offerte strade migliori per correggerla. ANTICIPAZIONI Se questo è vero, e si riuscisse a dimostrarlo concretamente, allora la storia del comunismo italiano potrebbe non essere solo la storia di un partito, ma potrebbe dirci qualcosa di importante sulla vicenda complessiva sia dell’Italia repubblicana sia del movimento comunista in generale, valutarla nella versione migliore e cogliere a fondo i limiti invalicati. (Forse lo stesso interesse, in un contesto del tutto diverso, e per chi ne fosse capace, potrebbe avere l’altrettanto specialissima vicenda cinese, oggi tanto ammirata per i suoi successi economici, ma del tutto inspiegata nel suo passato e indecifrabile nel suo futuro). La seconda ragione in base alla quale concentro l’attenzione sul comunismo italiano è meno importante ma non trascurabile. Sulla storia dei comunisti, italiani compresi, molti storici hanno lavorato: con molta serietà e ricchezza di informazione riguardo al periodo tra la rivoluzione russa e il secondo dopoguerra, in modo più episodico e pieno di lacune e di pregiudizi per quello successivo, fino a oggi. Nell’un caso e nell’altro, comunque, un bilancio complessivo e un giudizio equilibrato restano carenti. Colpiscono non tanto le controversie, più che giustificate, quanto la divaricazione tra la accurata esplorazione della documentazione disponibile, e la pamphlettistica faziosa. Non c’è da stupirsene, ovviamente, perché nel loro lavoro, sia in passato che di recente, hanno pesato prima un clima di scontro politico aspro, poi l’improvviso e inatteso crollo: l’uno o l’altro suggerivano ad alcuni la sobrietà dello specialista, o permettevano ad altri comode semplificazioni. Ma al di là di tutto ciò, un ostacolo si oppone alla ricerca e alla riflessione anche dello storico più scrupoloso e più acuto: la limitatezza e la difficile interpretazione delle fonti. I partiti comunisti infatti – per ideologia, forma organizzativa, e per le condizioni in cui si trovavano a operare – sono stati assai poco trasparenti. Il dibattito sui temi fondamentali si concentrava in sedi molto ristrette e spesso informali, i cui membri erano vincolati alla riservatezza e anche tra loro si esprimevano in termini cauti, compatibili con la preoccupazione unitaria. Le scelte politiche tenevano in serio conto gli orientamenti dei militanti e gli stimoli di un dibattito spesso vivace e partecipato ma erano da tutti infine accettate e difese sia pure con diverse sfumature. La selezione dei gruppi dirigenti valutava le capacità realmente dimostrate, ma poi avveniva con la cooptazione dall’alto, in cui pesava anche il metro della fedeltà. In certi Paesi e in certi momenti la comunicazione esterna o verso la propria stessa base non esitava a censurare i fatti né a fornire spiegazioni molto sommarie sulla politica adottata, perché dominava l’obiettivo di consolidare la mobilitazione e il consenso seppure a danno della verità. Ma anche quando e laddove, come in Italia, a partire dagli anni ‘60, crescevano gli spazi di tolleranza per qualche dissenso, ad esempio nei Comitati centrali, esso veniva espresso con un linguaggio prudente e in parte cifrato. Il lavoro di archiviazione, per tutti i livelli, era molto accurato, ma anche molto sobrio e spesso, volutamente o per dovere d’ufficio, autocensurato. Negli stessi momenti di «svolta» il principio sempre vigente è stato quello del «rinnovamento nella continuità». Chi invece veniva allontanato, o si allontanava dal partito – essendo il partito, per scelta propria e per imposizione dell’avversario, una comunità di vita – pativa un isolamento umano pesante che alimentava a lungo una reciproca faziosità. Non basta dunque una lettura seria dei giornali e dei documenti dell’epoca; qualche intervista postuma né l’accesso agli archivi finalmente aperti per ricostruire la storia reale, senza equivoci e senza censure. Occorre dunque anche la mediazione della memoria di chi ha partecipato come protagonista, o come osservatore direttamente informato, e può dire qualcosa di più su ciò che i documenti tacciono o interpretarne oltre la lette- ra il significato e il peso di ciò che dicono. Pensiamo, per fare un esempio estremo, quanta luce avrebbe potuto portare, alla storia dell’ultimo quindicennio dell’Unione Sovietica, un autentico resoconto dei fatti e delle discussioni, e un giudizio meditato da parte di Gorbaciov, quando ormai aveva tutte le condizioni per farlo (altro che i documenti di Mitrokin su banali e scontatissimi finanziamenti al Pci, o le testimonianze che attribuiscono a Togliatti la volontà di far scomparire anziché salvare i quaderni di Gramsci sottraendoli alle mani del Kgb). Sappiamo tutti però quante insidie comporta la memoria individuale: perché declina con l’età, o perché aver condiviso responsabilità rilevanti o aver subìto un torto immeritato può renderla selettiva o tendenziosa. Anziché parlare della storia che la nostra vita ci consente di conoscere per avvicinarsi alla realtà, è facile rileggere questa storia con gli occhiali del proprio vissuto. Niente di male certo. Anzi, quando è fatto e dichiarato onestamente, anche questo uso della memoria può essere di grande aiuto. Proust, Tolstoj, Mann o Roth hanno contribuito alla comprensione della storia della loro epoca più acutamente degli storici loro contemporanei. Io ho però parlato di «mediazione della memoria» in senso diverso. Per scelta e per necessità. Il mio vissuto non lo trovo molto interessante e se lo fosse non avrei la capacità di comunicarlo. La mia incidenza nella politica è stata inoltre limitata, si è concentrata in precisi e rari momenti, si è esercitata più attraverso alcune idee, spesso troppo in anticipo ma ricorrenti, che in azioni dall’esito felice. Ciò di cui sento il bisogno e l’utilità è dunque una memoria disciplinata con qualche verifica documentata dai fatti, con il confronto di memorie diverse, il più possibile oggettivizzata, come si trattasse della vita di un altro, per avvicinarsi a una interpretazione plausibile di ciò che realmente è accaduto o poteva accadere. L’autobiografia la vorrei 23 24 far intervenire solo se strettamente necessaria. Da questo punto di vista credo di avere una condizione di vantaggio. Sono infatti diventato comunista, per ragioni di età, quando la temperie del fascismo e delle Resistenza si era chiusa da un decennio, anzi dopo il XX congresso del Pcus e i fatti d’Ungheria, e dopo aver letto oltre a Marx, Lenin e Gramsci, anche Trotzky e il marxismo occidentale eterodosso. Non posso dunque dire: l’ho fatto per combattere meglio il fascismo, oppure dello stalinismo e delle «purghe» non sapevo nulla. Ci sono entrato perché credevo, come ho continuato poi a credere, a un progetto di cambiamento radicale della società di cui occorreva sopportare i costi. Devo quindi spiegare anzitutto a me stesso se avevo ragione di farlo. Ho militato in quel partito, in ruoli modesti, ma casualmente e forse per qualche merito, in diretto rapporto con il gruppo dirigente, durante quindici anni di un dibattito vivace e di esperienze importanti, cui ho partecipato con posizioni di minoranza ma con qualche influenza, e con piena conoscenza di ciò che vi accadeva. Anni decisivi, sui quali si sa ancora troppo poco, o troppo è rimosso e posso invece aggiungere qualcosa. Sono stato radiato dal partito nel 1970, con altri compagni, perché avevamo dato vita a una rivista, il manifesto, considerata inammissibile perché di per sé incrinava il centralismo democratico, e perché esplicitamente sollecitava una più netta critica del modello e della politica sovietica, infine perché chiedeva di ripensare la strategia del partito accettando suggerimenti dei nuovi movimenti operai e studenteschi. Nessuno quindi può sospettarmi di aver taciuto né di coltivare vecchie ortodossie. Ma a mia volta sono obbligato a chiedermi perché, per quali errori e limiti, tante buone ragioni a analisi spesso lungimiranti siano rimaste isolate e abbiano mancato l’obiettivo. Sono tornato con numerosi compagni nel Pci all’inizio degli anni 80, consapevole dei limiti di un estremismo sul quale ci eravamo illusi, ma non da pentito, perché la svolta dell’ultimo Berlinguer sembrava comporre molti dei contrasti che ci avevano divisi. Trovandomi questa volta nella direzione del partito conservo conoscenza diretta del processo che ha prima limitato, poi svuotato quella svolta, mostrandone anche il ritardo e i limiti. Un periodo sul quale la reticenza è tuttora grande, e la autocritica smodata non trova contrasto. Ho partecipato, questa volta in prima fila, alla battaglia contro la scelta di sciogliere il Pci, non perché troppo innovatrice, ma perché innovava in modo e direzione sbagliata, liquidava cioè senza discernimento una ricca identità, apriva la strada non solo a una socialdemocrazia a sua volta già in crisi, ma a una forza liberaldemocratica e moderata, mandava a casa un esercito non ancora allo sbando, suppliva con velleitario «nuovismo» a un vuoto di elaborazione. Dopo tutto ciò che è seguito, resto tra i pochi a credere che quell’operazione era del tutto infondata, ma sono tanto più costretto a chiedermi perché ha prevalso. Ho partecipato infine, con qualche dubbio, alla costruzione di Rifondazione comunista perché temevo che mancassero le idee, la volontà e la forza per prendere sul serio quel nome: temevo cioè una deriva massimalista e poi un accomodamento politicistico. Me ne sono allontanato, perché a quel progetto continuo a credere, ma non riconosco in quella organizzazione, come nella diaspora della sinistra radicale, sufficiente determinazione e capacità di portarlo avanti. Di questa più recente tormentata vicenda quasi nessuno sa o capisce molto, e anche solo parlarne onestamente può perciò essere utile. Sono così un particolare archivio vivente e in soffitta. Per una persona ormai anziana l’isolamento è dignitoso, ma per un comunista è il peccato più grave, di cui rendere conto e rendersi ragione. L’«ultimo dei mohicani» può essere un mito, il comunista solo, e arrabbiato, rischia il ridicolo se non si tira da parte. Ma se il peccato (perdonate questa ironica concessione alla moda e alla convenienza che oggi spinge tanti all’improvvisa ricerca di Dio) apre la via del Signore, proprio l’isolamento potrebbe aiutare nel lavoro cui mi accingo, permettere un utile distacco. Non posso affermare «io non c’ero», non sapevo; qualcosa anzi l’ho detta quand’era scomodo, ho perciò la libertà di difendere ciò che non va ripudiato, e di chiedermi ciò che si poteva fare o si potrebbe ancora fare al di là del bric e brac della politica di ogni giorno. Non è vero che la storia passata, dei comunisti e di tutti, era già tutta predeterminata, così come non è vero che il futuro è tutto in mano ai giovani che verranno. La «vecchia talpa» ha scavato e continua a scavare, ma, essendo cieca, non sa bene da dove viene e dove va, o se gira in circolo. Chi non vuole o non può affidarsi alla Provvidenza deve pur fare ciò che può per capirlo e così aiutarla. ECONOMIA E LAVORO conflitto e sindacato nella proposta di Confindustria una analisi degli obiettivi strategici del padronato italiano R OBERTO C ROCE * Non bisogna sorprendersi più di tanto se Confindustria, forte dei mutati equilibri politici e con l’arroganza di chi pensa che ormai tutto le sia possibile, abbia rilanciato e portato alle estreme (ma logiche) conseguenze i principi contenuti nella proposta confederale, producendo un documento che spazza via la timida piattaforma sindacale * GIUSLAVORISTA È un quadro a tinte sempre più fosche quello che ci consegnano gli ultimi atti della politica sindacale italiana. Meno spazio alla contrattazione nazionale, che viene spogliata definitivamente dal compito di strappare aumenti salariali superiori all’inflazione, e centralità della contrattazione decentrata, dove il salario diventa variabile della remunerazione del capitale. Erano questi, in estrema sintesi, i contenuti della proposta intitolata «Linee di riforma della struttura della contrattazione» avanzata da Cgil, Cisl e Uil a Confindustria, nell’ambito del confronto sul nuovo sistema di relazioni sindacali che dovrebbe sostituire quello introdotto dal Patto del luglio del 1993. Viste le premesse, non bisogna sorprendersi più di tanto se Confindustria, forte dei mutati equilibri politici e con l’arroganza di chi pensa che ormai tutto le sia possibile, abbia rilanciato e portato alle estreme (ma logiche) conseguenze i principi contenuti nella proposta confederale, producendo un documento che spazza via la timida piattaforma sindacale. L’analisi della proposta confindustriale del 12 settembre 2008 contenuta nel documento intitolato «Ipotesi di accordo fra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil sulle relazioni industriali per il rilancio della crescita del Paese attraverso la maggiore produttività, per il miglioramento della competitività delle imprese e delle retribuzioni dei lavoratori e per lo sviluppo dell’occupazione» è utile perché consente di individuare, con nettezza, gli obiettivi strategici che il padronato italiano si è dato in questa fase e che possono così essere sintetizzati: 1) realizzare la totale subalternità dei diritti (sindacali, economici e normativi) dei lavoratori alle esigenze dell’impresa; 2) criminalizzare il conflitto capitale/lavoro, invischiando il sindacato in sistemi neocorporativi di cogestione delle relazioni industriali; 3) polverizzare, attraverso la centralità della contrattazione di secondo livello, il principio costituzionale di «sufficienza» della retribuzione (art. 36 Cost.) e, per questa via, impedire il miglioramento generalizzato e uniforme delle condizioni economiche e normative della classe lavoratrice, producendo una gravissima lesione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). 2. Il primo obiettivo è esplicitato fin dalla «Premessa» della proposta confindustriale. In essa si legge che «le parti riconoscono che la contrattazione collettiva, nelle diverse sedi, è lo strumento principale per adattare alle esigenze di maggiore competitività i principali istituti che regolano la prestazione lavorativa». Ed ancora, sempre nella «Premessa», si precisa che la contrattazione collettiva «non deve essere esercitata come strumento di vincolo all’iniziativa economica». Il contratto collettivo, dunque, abdicando alla sua funzione storica, cessa di essere uno strumento di progresso e di miglioramento generalizzato delle condizioni materiali (sia economiche che normative) dei lavoratori, per tra- 25 26 sformarsi in un congegno giuridico finalizzato a imbrigliare e a sottomettere alla legge del Capitale sia lavoratori che sindacato. La disciplina dei «principali istituti» del contratto collettivo, sia quelli che attengono alle relazioni sindacali (diritti di informazione, concertazione e contrattazione) sia quelli che regolano la parte economica (es. scatti di anzianità, 14 mensilità) e normativa (orario di lavoro, forme di lavoro flessibile ecc.) del contratto di lavoro, non potrà più essere oggetto di una libera negoziazione, fondata sui «rapporti di forza» tra le parti, ma subirà il costante condizionamento «esterno» delle «esigenze di maggiore competitività» delle imprese, sul cui altare saranno costantemente sacrificati gli interessi dei lavoratori. La proposta confindustriale, dunque, rischia di cancellare la capacità del sindacato di svolgere, attraverso quel fondamentale elemento di solidarietà tra tutti i lavoratori che è il contratto collettivo nazionale, la sua storica funzione di riunificazione del lavoro e di realizzazione di avanzamenti significativi delle condizioni di vita dell’intera classe lavoratrice. In coerenza con questo impianto non c’è da sorprendersi se la principale funzione del contratto collettivo nazionale rimane quella, invero limitata e notarile, di determinare «l’aumento dei minimi tabellari in coerenza con l’indicatore della dinamica inflattiva» (paragrafo 2.1), secondo un complesso procedimento di salvaguardia del potere d’acquisto (basato sul concetto di «importo medio di aumento dei minimi tabellari» che viene determinato «applicando l’indice previsionale a un valore retributivo medio assunto quale base di computo») che dovrebbe sostituire l’insufficiente parametro dell’inflazione programmata introdotto dopo l’abolizione della scala mobile. 3. Il secondo obiettivo è strettamente collegato al primo. È, infatti, evidente che dalla totale sottomissione degli interessi dei lavoratori alle esigenze dell’impresa deriva la messa al bando del conflitto capitale/lavoro. Nel paragrafo 2.5 della proposta confindustriale si legge che durante la fase di rinnovo del contratto collettivo nazionale «le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette». Il che equivale alla «neutralizzazione» dello sciopero e di tutte le altre forme storiche di autotutela e di lotta sindacale (sciopero bianco, occupazione di fabbrica, blocco delle merci, rallentamento concertato della produzione ecc.). Ma il documento confindustriale non si ferma qui. Si spinge anche oltre: il conflitto non solo è messo al bando, ma addirittura «criminalizzato», attraverso un complesso sistema di sanzioni private in funzione di «polizia economica» e di salvaguardia dell’ordinato svolgimento dell’attività d’impresa. Non a caso, sempre il paragrafo 2.5 prevede che «ogni azione da chiunque attuata in violazione della tregua sindacale sopra definita, si configura come inadempimento ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. legittimando la parte che l’ha subita a chiedere l’immediata revoca o sospensione dell’azione e comunque il pagamento di una penale». E non basta: sempre la violazione della tregua sindacale comporta a carico dei lavoratori «lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale». Se poi il conflitto dovesse sorgere in fase di rinnovo di un contratto collettivo di secondo livello (aziendale o territoriale), il paragrafo 3.6 della proposta confindustriale giunge persino a estendere a carico dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali l’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 146/1990 in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ossia: sospensione dei permessi sindacali retribuiti e dei contributi sindacali ed esclusione dalle trattative del sindacato «ribelle». L’eutanasia del conflitto è (apparentemente) «compensata» dall’instaurazione di una complessa rete di «organismi paritetici», il cui unico fine è quello di invischiare il sindacato, in posizione ovviamente di subalternità, in un sistema di gestione neocorporativa dei principali aspetti delle relazioni industriali. Architravi di siffatto sistema neocorporativo sono il «Comitato paritetico Confindustria – Cgil, Cisl e Uil» disciplinato dal paragrafo 6 e i «Fondi per la gestione paritetica di servizi» previsti dal paragrafo 2.3. Al Comitato paritetico è assegnato il compito di cogestire, nel rispetto della scala di priorità imposte dal padronato, «l’andamento dei principali aspetti delle relazioni industriali quali, ad esempio, il costo del lavoro, la dinamica della produttività del lavoro, i tassi di occupazione e la gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai regimi di impiego, al collocamento, alla mobilità, alla cassa integrazione, alle pari opportunità ecc.». Quello che si delinea, dunque, è un modello di relazioni industriali nel quale al sindacato viene ritagliato un ruolo aconflittuale di mera collaborazione, in funzione della salvaguardia dei dogmi di maggiore produttività e competitività delle imprese da perseguire attraverso dosi sempre più massicce di flessibilità del lavoro. Una forma di cogestione che, ben lungi dall’essere accompagnata da ampliamenti effettivi del potere decisionale, nasconde una radicale sottomissione del lavoro alla dittatura del mercato e della competizione. Messo al bando il conflitto, il sindacato diventa così – secondo la filosofia da sempre cara alla Cisl – una organizzazione burocratica di servizi, destinata a sopravvivere attraverso quote di servizio obbligatorie che renderanno via via ininfluenti quelle associative, fondate su una adesione politica volontaria. Non a caso il paragrafo 2.3 della proposta confindustriale attribuisce ai contratti collettivi nazionali di ECONOMIA E LAVORO Quello che si delinea, dunque, è un modello di relazioni industriali, nel quale al sindacato viene ritagliato un ruolo aconflittuale di mera collaborazione, in funzione della salvaguardia dei dogmi di maggiore produttività e competitività delle imprese categoria la competenza in materia di «sviluppo di fondi per la gestione in forma paritetica di servizi a favore dei lavoratori in materia, ad esempio, di collocamento, ammortizzatori sociali, formazione continua, sanità integrativa, salute e sicurezza nel lavoro, certificazione dei contratti». Con effetti anche paradossali e al limite del conflitto di interessi. Ad esempio: mentre, a livello confederale, quale componente del Comitato Paritetico, il sindacato è chiamato alla cogestione dei regimi di cassa integrazione e di mobilità, contestualmente, a livello federale, quale membro dei Fondi di Gestione Paritetica, è tenuto a organizzare e a offrire, dietro il pagamento delle relative quote, i servizi concernenti l’utilizzo dei predetti ammortizzatori sociali. Dunque: criminalizzazione del conflitto, da un lato, e forme di cogestione neocorporativa, dall’altro. Di fronte a un tale quadro è difficile non rinviare a quel luogo di «Americanismo e Fordismo» nel quale Antonio Gramsci invitava a non «trascurare il fatto che l’indirizzo corporativo non ha avuto origine delle esigenze di un rivolgimento delle condizioni tecniche dell’industria e neanche da quelle di una nuova politica economica, ma piuttosto dalle esigenze di una polizia economica, esigenze aggravate dalla crisi del 1929 e ancora in corso» (2155-2156). In questo contesto, ovviamente, il senso della centralità democratica della lotta sindacale e del conflitto capitale/lavoro si smarrisce e con esso rischia di perdersi definitivamente la libertà dei «produttori» di agire e di non ridursi a mera variabile dipendente della crescita economica delle imprese. 4. Il terzo obiettivo – ossia la cancellazione del principio costituzionale (art. 36 Cost.) di «sufficienza» della retribuzione – è perseguito attraverso il potenziamento della contrattazione decentrata di secondo livello (aziendale o territoriale) e, in tale ambito, attraverso la riduzione del salario a mera variabile della remunerazione del capitale. In ciò la proposta confindustriale si pone sul medesimo solco tracciato dai recenti interventi legislativi in tema di detassazione degli straordinari e dei premi aziendali. E ciò a conferma, ove ve ne sia bisogno, del definitivo consolidamento – processo al quale non sono estranei alcuni spezzoni del sindacato (Cisl in testa) – del legame tra un preciso blocco sociale che fa capo agli industriali e il governo di centro destra. Il paragrafo 3.1 prevede espressamente che «le parti, con il presente accordo interconfederale confermano l’opportunità che vengano incrementate e rese strutturali le scelte operate col Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, attuate con il D.m. 7 maggio 2008 e gli interventi normativi di cui all’art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 2008, volti a incentivare la contrattazione di secondo livello che colleghi aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, crescita ecc.». Trattasi di interventi accomunati dalla finalità di tutelare, attraverso un aumento di quello che Marx definiva «il saggio del plusvalore assoluto», la cronica incapacità del padronato italiano di «rivoluzionare da cima a fondo i processi tecnici del lavoro», di investire e di introdurre innovazioni sia di processo che di prodotto. Nel paragrafo 3.1 della proposta confindustriale si precisa, infatti, che «la maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello» non nasce da una esigenza di allargamento degli spazi di agibilità democratica e di confronto sindacale, bensì dalla necessità del padronato di «rilanciare la crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali dei lavoratori, permettendo alle imprese di rispondere con tempestività alle mutevoli esigenze dei mercati anche attraverso una migliore organizzazione del lavoro». La ricetta confindustriale, in sintesi, è la seguente: gli aumenti retributivi sono eventuali e «non determinabili a priori» (cfr. paragrafo 3.3), passano per massicce dosi (certe) di flessibilità e per profondi processi di riorganizzazione del lavoro e, infine, sono (sempre) subordinati al perseguimento del risultato della maggiore remunerazione del capitale. Il paragrafo 3.1 della proposta confindustriale, sul punto, è fin troppo esplicito: «il conseguimento di retribuzioni più elevate sarà reso possibile solo dal collegamento con livelli di maggiore efficienza e con la redditività, produttività e competitività dell’impresa»; non 27 28 meno chiaro è il paragrafo 3.3. nel quale si precisa che «la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un premio variabile calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia e, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legali all’andamento economico dell’impresa». L’obiettivo di collegare, in sede di contrattazione di secondo livello, «il salario al merito» costituisce un ulteriore profilo di beffa della proposta confindustriale fin qui analizzata. Innanzitutto perché, come i più recenti studi hanno dimostrato (cfr. lo studio dell’Ires Cgil intitolato «Salari in Difficoltà»), se è vero che la crescita della produttività nel nostro Paese è più lenta che nel resto di Europa, è anche vero che la causa principale di questa mancata crescita deriva non già dalla scarsa produttività del lavoro, ma da quella capitale, che non sa né vuole introdurre innovazioni sia di prodotto che di processo. In secondo luogo perché, così facendo si finisce col trasferire in capo ai lavoratori anche il cosiddetto «rischio di impresa», ossia le conseguenze negative di scelte organizzative e gestionali alle quali sono per definizione estranei. Una simile scelta si pone in palese contrasto con l’art. 36 della nostra Costituzione, per il quale, non a caso, non basta che la retribuzione sia «proporzionata» alla quantità e qualità del lavoro prestato, dovendo la stessa «in ogni caso» essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. In terzo luogo perché la centralità della contrattazione di secondo livello finisce col determinare un mutamento «ontologico» della funzione stessa del sindacato, che rinuncia a mettere al centro della propria iniziativa la promozione di aumenti salariali generalizzati e accetta di rendere la retribuzione una variabile dell’andamento dell’impresa, da negoziare, secondo un andamento «a macchia di leopardo», esclusivamente laddove i rapporti di forza lo permettono, ossia nelle imprese più grandi, più sindacalizzate e più forti economicamente. In questo quadro, dunque, il problema non è la contrattazione collettiva di primo livello – che anzi va tenuta ferma e rinnovata con meno ritardi per non indebolire il potere di acquisto dei salari e per garantire uniformità di trattamenti – bensì il declino tecnologico di un sistema gestito da imprese miopi e inadeguate. Da ciò la necessità di intervenire quantomeno in due direzioni: «a monte» arginando le cause (concorrenziali) che determinano precarietà e bassi salari, prime fra tutte le varie forme di lavoro flessibile introdotte dalla legge 30; e «a valle» introducendo meccanismi di salvaguardia del potere di acquisto dei salari (una nuova scala mobile) e, al contempo, operando una ridistribuzione più equa della ricchezza prodotta attraverso un utilizzo della leva fiscale orientata sulla tassazione delle rendite e dei profitti. All’opposto di quanto delineato dalla proposta confindustriale, la realizzazione di tali obiettivi implica, oltre all’esistenza di una forte sinistra politica antagonista, la permanenza nell’attuale sistema di relazioni industriali di un sindacato di classe (e non di servizi), che ponga il conflitto (e non la cogestione) come ragione unica ed esclusiva della propria azione e che persegua obiettivi di miglioramento generalizzato e uniforme delle condizioni economiche e normative della classe lavoratrice. ISTITUZIONI legge elettorale, federalismo, presidenzialismo ne discutiamo con Gianni Ferrara* I N VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE, TORNA DI ATTUALITÀ IL TENTATIVO DI D IEGO L A S ALA ** RIFORMARE LA LEGGE ELETTORALE1. SI PARLA DI ALZARE LA SOGLIA DI SBARRAMEN- TO, NEL TENTATIVO NON TROPPO VELATO DI AZZERARE LE «ALI» DELLO SCHIERAMENTO POLITICO ED ESCLUDERE LE FORZE DELLA SINISTRA DA QUALSIASI RAPPRESENTANZA. A COSA PUÒ PORTARE QUESTA PROSECUZIONE FORZATA DI UNA TENDENZA BIPOLARE, CON- è dal 1993, dal referendum SegniBarbera, che la democrazia italiana viene colpita con rigorosa coerenza da questo pertinace disegno criminoso. Riuscire a bloccarlo dovrebbe essere il compito primario dei democratici di ogni tendenza * ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA ** SEGRETERIA PRC – PISTOIA SIDERANDO ANCHE L’ESITO DI QUINDICI ANNI DI TENTATIVI DI QUESTA NATURA? Il centro-destra con la riforma della legge elettorale europea mira: 1) a trafugare il diritto della sinistra italiana a essere rappresentata nell’unica istituzione europea a carattere democratico, qual è il Parlamento; 2) a neutralizzare fin da ora e a disperdere per il futuro i voti che potrebbero aggregarsi in una formazione idonea a contribuire a una sua futura sconfitta; 3) a delegittimare definitivamente la rappresentanza politica, cioè l’ineliminabile strumento della democrazia, aggiungendo agli elettori ed alle elettrici che già si astengono nelle elezioni europee per la scarsità dei poteri di cui dispone il Parlamento, quegli altri elettori e quelle altre elettrici che, in assenza di candidati credibili come rappresentanti dei loro bisogni e dei loro ideali, diserterebbero le urne. Si tratta, com’è evidente, di tre obiettivi perversi, perché compressivi del pluralismo politico, riduttivi della libertà e dell’eguaglianza dei cittadini nei loro diritti politici, costituzionalmente eversivi. È dal 1993, dal referendum Segni-Barbera, che la democrazia italiana viene colpita con rigorosa coerenza da questo pertinace disegno criminoso. Riuscire a bloccarlo dovrebbe essere il compito primario dei democratici di ogni tendenza. A me pare invece che, delle forze politiche in campo, solo Rifondazione comunista in questi quindici anni ne ha avuto piena coscienza, anche da ultimo, battendosi per riformare le leggi elettorali vigenti per la Camera e il Senato. Ma per evidente insipienza non è stata sostenuta in questa lotta da tutte le componenti dell’Arcobaleno, anzi. Le conseguenze inesorabili che ne sono derivate sono catastrofiche. Sul piano politico: per la prima volta dai tempi di Andrea Costa, la sinistra è stata esclusa dal Parlamento. Sul piano istituzionale: la rappresentanza politica risulta mistificata. Mistificata perché si è eletti deputati o senatori a seconda della collocazione in lista dei candidati, collocazione decisa dal leader di ciascun partito o coalizione. Gli eletti lo sono perché scelti sostanzialmente dal leader. Rappresenteranno non il corpo elettorale, ridotto a un compito ausiliare, ma il … leader. Se questo leader diventa premier l’eletto deriva la sua posizione dalla decisione del premier. Il rovesciamento della rappresentanza nel suo opposto è totale. Lo è anche della democrazia trasformata in monocrazia. I L GOVERNO BERLUSCONI VUOLE INSISTERE SULLA STRADA DELLE RIFORME COSTITU«STELLE PO- ZIONALI: FEDERALISMO E PRESIDENZIALISMO SEMBRANO ESSERE LE DUE 29 La forma di governo presidenziale è stata rifiutata nettamente dal costituzionalismo europeo. La Francia, e solo la Francia, ne ha recepito un elemento importante, l’elezione popolare del Capo dello stato, provando a sposarlo con la forma parlamentare di governo LARI» DI UN VERO E PROPRIO DISEGNO DI MUTAMENTO DELL’ASSETTO COSTITUZIONALE 30 COSÌ COME ERA STATO ORIGINARIAMENTE PENSATO. COME CAMBIEREBBE IN CONCRETO L’ARCHITETTURA REPUBBLICANA? Cambierebbe radicalmente. Sarebbe trasmutata nel suo opposto, quanto a forma di Stato e quanto a forma di governo. Il federalismo storicamente e concettualmente si identifica nella tensione all’unità di separati e differenti aggregati umani. Mira ad attenuare prima e a superare poi la separazione, a trasformare le differenze in distinzioni, magari riconoscendole ma eliminando le disparità di trattamento, assicurando solidarietà, promuovendo comunanza di destino. Quello italiano no. Nasce come rivolta fiscale delle regioni (e delle classi) agiate, come progetto volto a far sì che l’estrazione territoriale del gettito fiscale coincida con la sua ricaduta come spesa pubblica nello stesso ambito territoriale. La sua attuazione in Italia, attraverso la sciagurata modifica del Titolo V della Costituzione, finirà col determinare effetti nefasti proprio sul piano costituzionale. Evaporerà la solidarietà politica, economica e sociale prescritta con l’articolo 2, si incrinerà il vigore e si ridurrà la portata dell’eguaglianza sostanziale sancita con l’articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Maschererà il conflitto di classe in conflitto territoriale. Soltanto una forte sinistra potrà contrastarne le conseguenze più nefaste. La forma di governo presidenziale è stata rifiutata nettamente dal costituzionalismo europeo. La Francia, e solo la Francia, ne ha recepito un elemento importante, l’elezione popolare del Capo dello stato, provando a sposarlo con la forma parlamentare di governo. Il risultato non ha convinto nessuno degli Stati che si sono dati una Costituzione negli scorsi anni ’90 nell’Europa dell’Est. Si aggiunga che la più avvertita dottrina costituzionalista francese non è affatto soddisfatta della forma di governo della V Repubblica. Recepirla in Italia come tale o adottare la forma presidenziale di governo del tipo vigente negli Usa senza la garanzia del common law e magari con leggi elettorali mistificatorie della rappresentanza politica equivarrebbe a sopprimere la democrazia in Italia. C ON LA SCOMPARSA DELLA SINISTRA DAL PARLAMENTO, IL pubblicano». A cominciare dalla decisione sciagurata di Occhetto di sostenere la raccolta delle firme per il referendum che avrebbe instaurato il sistema maggioritario, e via via, ricordando la Bicamerale di D’Alema, non dimenticando l’approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, non tralasciando il favore dichiarato da Veltroni per il sistema costituzionale e per quello elettorale francese, a finire con il voto favorevole al Trattato di Lisbona che ribadisce come principio fondante dell’Ue l’«economia di mercato aperta e in libera concorrenza» e non attenua il deficit di democrazia che coinvolge l’intero ordinamento europeo. È di questi giorni, inoltre, il silenzio fragoroso sulla «riforma» del contratto collettivo che la Confindustria vuole imporre per svuotarlo di contenuti e ridurne l’efficacia. Va però riconosciuta alla base di quel partito la fedeltà alla democrazia e alla causa dei lavoratori. Va tenuto in gran conto, all’opposto, quel che implica, comporta, realizza, nasconde e prefigura il berlusconismo quanto a visione della convivenza e concezione dei rapporti di lavoro. Dalla storia della sinistra, che è peraltro la stessa della democrazia in Italia, ci deriva l’insegnamento che, in certe circostanze, ci si deve alleare addirittura con i «badogliani». Tanto più quindi lo si può con il Pd. Certo, per obiettivi condivisi. PARTITO DEMOCRATICO DOVREBBE ASSUMERE IL RUOLO DI PRINCIPALE FORZA DI OPPOSIZIONE ALL’ATTUALE GOVERNO. SUI TEMI AFFRONTATI PRECEDENTEMENTE, PERÒ, IL SPONSABILITÀ LEGISLATIVE PASSATE (SI PENSI ALLA RIFORMA PD HA CONSISTENTI RE- COSTITUZIONE NEL 2001). OGGI COSA FA? RITIENE CHE LE POSIZIONI ODIERNE SIANO ALL’ALTEZZA DELL’ATTACCO DEVASTANTE LANCIATO DAL CENTRODESTRA AGLI ASSETTI ISTITUZIONALI DEMOCRATICI? DEL TITOLO V DELLA Al partito democratico si possono imputare non poche cadute di «spirito re- 1. La presente intervista è stata rilasciata prima che conclamate difficoltà politiche sopraggiungessero a intralciare la strada di una «controriforma» elettorale. Restano comunque del tutto valide le argomentazioni addotte a commento di tale ricorrente tentativo. SOCIETÀ Milano, città aperta o coprifuoco? B RUNO C ASATI * Legge e ordine. E tira una brutta aria, più per altri soggetti che non per i criminali, quelli veri. Le destre, che la alimentano, affermano così la loro cultura secondo cui i forti comandano e le masse devono solo ubbidire e, a chi sgarra, bastonate * ASSESSORE AL LAVORO PRC – PROVINCIA DI MILANO T utto oggi è declinato sulla sicurezza, non quella sul lavoro, ma quella a contrasto del crimine, vero o presunto. Legge e ordine. E tira una brutta aria, più per altri soggetti che non per i criminali, quelli veri. Le destre, che la alimentano, affermano così la loro cultura secondo cui i forti comandano e le masse devono solo ubbidire e, a chi sgarra, bastonate. E danno esempi, lo testano sui più deboli con leggi speciali, esercito, impronte: siamo a un passo dal coprifuoco e dall’adunata sediziosa. E sono molto avanti nel progetto. Lo sono anche perché le sinistre o gli stessi liberal-democratici, che dovrebbero sostenere una propria identità positiva con ben altra cultura, quella della risposta ai bisogni e a sostegno dei diritti per tutti, nel migliore dei casi tentennano (le sinistre), nel peggiore si agganciano al carro repressivo delle destre. Dove sono finiti i cattolici e gli eredi del Socialismo? Sono le destre in Italia che dettano l’agenda della politica. Talvolta i liberal-democratici, addirittura e penosamente, tentano di anticiparle, come il sindaco di Firenze con l’editto sui lavavetri (e non è il solo) perché, così essi sostengono, «i cittadini, se si vogliono vincere le elezioni, è questo che chiedono alle istituzioni». Di fatto questi amministratori sono andati in ostaggio volontario alle destre. Ricordano quel soldato della barzelletta che, mandato fuori dalla trincea di pattuglia, grida rivolto ai suoi: «signor tenente ho fatto due prigionieri». Al che il tenente risponde: «Bene, portali qui!». «Non posso, replica il soldato: non mi lasciano andare». Solo che c’è poco da sorridere perché siamo proprio a questo: al capolavoro della destra che, senza sforzo, vede la sua strategia meccanicamente assunta, con la determinazione dei neofiti, da un ex centro sinistra non più sinistra e nemmeno centro. Ma, sulla sicurezza, ridotta così a giro di vite sugli immigrati e i poveri cristi, si sappia che si prepara un percorso futuro in due tappe precise, già annunciato del resto. Secondo cui, prima tappa, il declino delle metropoli non è colpa di palazzinari voraci, politici ed amministratori incapaci, ma di straccioni, «negri e zingari». E giù botte. Il primo capro espiatorio è a portata di mano, ed è servito a reti unificate. Ma la seconda tappa è ancora più insidiosa perché con essa, affermato chi è il primo colpevole, si procede al passaggio successivo secondo cui la responsabilità della grave crisi economica non è di questo Governo Confindustriale – che è lo zerbino della «casta degli avidi» non solo nostri ma anche di oltreoceano il cui capo, Alan Greenspan, viene definito, non da Diliberto ma da Tremonti, il Bin Laden dell’economia planetaria – ma è attribuita (la responsabilità) ora ai lavoratori di Alitalia che hanno vampirizzato la compagnia, ora ai dipendenti pubblici che rubano lo stipendio, ora alle maestre che con il tempo pieno allontanano i bambini dalle famiglie. Se però le due tappe si saldano, addio, comincia il ventennio. Anzi per sinistre e democratici si riannuncia la Repubblica di Weimar con sede ad Arcore. E si bastona lo zingaro per far capire che aria tira all’operaio. Prima o poi toccherà ai comunisti. 31 bufera». Perché se quella strategia si afferma prima o poi tocca a noi, lo ripeto. La domanda, quella vera, perciò è una sola: la sicurezza è un problema vero o è un falso problema? 32 Con applausi da critica e pubblico. E, a Milano, l’aria è pesante. Ma c’è una novità. L’omicidio in via Zuretti di «Abba» Abdul, un nero cittadino italiano, ha segnato nelle ore successive il fatto nuovo, la svolta. Gli immigrati si sono ribellati, è la prima volta che succede, al grido di «siamo esseri umani, esigiamo rispetto», e non si accodano più alle manifestazioni antirazziste dei «bianchi buoni», ne assumono la testa, mostrano la faccia, non hanno più paura. Così anche a Castelvolturno, in una situazione completamente diversa, spaventosa comunque l’assenza dello Stato, dove l’autodifesa dalla dittatura militare della «camorra bianca» può anche aver costretto all’organizzazione di gruppi di «camorra nera». E c’è la strage indiscriminata, esemplare. Ma, anche qui, il fatto nuovo, parallelo: i lavoratori neri supersfruttati dai padroncini bianchi, alzano la testa e levano lo stesso grido straziante «siamo esseri umani e non carne da macello». A Milano e a Castelvolturno si invoca lo Stato di Diritto. Ascoltiamo quelle grida. E ragioniamoci anche noi, i comunisti. Analizziamo con il nostro contro-metodo la questione sicurezza, uscendo dalle chiuse stanze dei vaniloqui post-congressuali, dove funzionari deprivati dello scranno parlamentare si accapigliano sulla forma dello strumento-partito, mentre fuori «soffia il vento e infuria la Dovessimo guardare ai famosi dati, che rappresentano la realtà quella vera e documentata del crimine, registreremmo come i fatti di sangue a Milano, da venti trent’anni a questa parte, siano diminuiti e di molto. Oggi Milano è più sicura rispetto ai tempi in cui Turatello e Vallanzasca, la mala del mitra che aveva soppiantato la generazione nobile dei professionisti della rapina di via Osoppo, facevano ogni sera mattanza per la conquista dei quartieri. Non è più nemmeno la Milano dei terribili «anni di piombo», quando ogni settimana si faceva il conto dei morti ammazzati: magistrati, giornalisti, poliziotti, militanti politici. Oggi la gran parte degli omicidi avviene, ce lo conferma Don Gino Rigoldi cappellano di Opera, all’interno delle famiglie. La famiglia è un posto molto pericoloso mi verrebbe da dire, dai tempi della Rina Fort a oggi. In quanto alle rapine, ora ai bar, ora agli orefici, ci sono sempre state, solo che oggi sono diventate per davvero più pericolose, perché in campo operano i tossici, persone devastate che «delinquono perché devono» e, quando in crisi di astinenza escono dal giardinetto, non li ferma più nessuno e sparano. Ci vuole altro che non l’esercito per contrastarli. Ma i dati sono questi. Dovessimo ora chiedere ai cittadini milanesi di mettere in fila le loro priorità – questa indagine è stata fatta, ma il suo esito rapidamente occultato – otterremo questa sequenza di risposte. La priorità uno è il lavoro, Milano è la città più precaria d’Italia, il lavoro così come c’è, così ti è sottratto, non è una certezza, e nei cantieri si muore: in un anno, il 2007, ci sono stati più morti sul lavoro in Lombardia che non in tutta la Germania e le neoplasie da asbesto (l’amianto) continuano a sgranare il loro rosario di morte: alla sola ex Breda Fucine siamo all’83° decesso ma il picco tragico sarà nel 2015. Ma il lavoro non è merce mediatica, per fare notizia l’operaio deve morire bruciato. La priorità due è la casa: mancano 60mila alloggi popolari ma sorgono quartieri di lusso, blindati, come il Santa Giulia di Zunino dove il metro- SOCIETÀ Il fatto nuovo, parallelo: i lavoratori neri supersfruttati dai padroncini bianchi, alzano la testa e levano lo stesso grido straziante «siamo esseri umani e non carne da macello». A Milano e a Castelvolturno si invoca lo Stato di Diritto. Ascoltiamo quelle grida. E ragioniamoci anche noi, i comunisti quadro è schizzato a 8mila euro, mentre l’algida sindaca guarda in alto verso i grattacieli sghembi dell’Expo. La priorità tre è il costo della vita con il prezzo del pane più alto d’Europa, lo riconosce anche l’Ocse e, in tutta la Provincia sono attive (nessuno pare rendersene conto) ben 959 mense dei poveri, dove in fila ogni santo giorno gli italiani hanno oggi sorpassato gli stranieri: in quelle file è rappresentato il popolo metropolitano del «non accesso», le periferie sociali, dove i penultimi sono in fila con gli ultimi per il pane, mentre la sindaca resta a guardare ai suoi grattacieli e la sinistra… la sinistra non è pervenuta. La priorità quattro è il traffico e l’inquinamento, dove bisogna mettere mano a progetti forti e non alla burla dell’Ecopass. Ma guai a toccare il dio-automobile. Com’è lontana l’Europa da questa città? Quinta e ultima priorità è data, e siamo al punto, dal problema degli immigrati, che arrivano e non sono accolti, è data dai terribili lavavetri vero incubo semaforico, dagli arabi cui si nega anche lo spazio per pregare mezz’ora a settimana perché le moschee sono covi di terroristi (a me non risulta che le chiese siano luoghi in cui si progettano omicidi anche se le frequentava il pio Totò Riina), dai Rom ai quali si può anche bruciare un campo con le taniche di benzina, come a Opera, e non succede niente. Certo che lo scippo dà fastidio, lo spaccio ancora di più ma si sappia che l’immigrato che spaccia è solo il «cavallino» del pusher della n’drangheta che a Milano, la sua capitale, controlla usura, azzardo, prostituzione, cantieri. Sta nella mafia la radice avvelenata da estirpare. Componendo dati e inchiesta, la questione sicurezza che è reale, si ricolloca però nella sua dimensione vera. Purtroppo non è sufficiente, perché è stata fatta avanzare, pompata, la famosa realtà percepita, che è altra cosa. E la classifica è stata scalata e ribaltata. E se sulla realtà, quella vera, della sicurezza si può intervenire (forze dell’ordine, volontariato, associazioni lo stanno facendo), su quella percepita è difficile farlo: sfugge al buon senso, è dominata dalla dittatura mediatica che esaspera o cancella. La notizia c’è solo se lo decide chi impugna il telecomando centrale e decide come confezionarla. Ed allora gli operai dell’Innse di Via Rubattino, che vogliono lavorare mentre uno speculatore vuol fare affari sulla loro pelle, possono essere fatti apparire come il flagello dell’economia meneghina, mentre Tronchetti Provera e Colaninno apparire come benefattori da Ambrogino d’Oro. Si pensi un’attimo all’omicidio del povero Abba: se invece dei due assassini italiani, gli sprangatori fossero stati due romeni, magari appena rilasciati per condono e che avessero colpito un ragioniere del Gallaratese appena uscito dalla discoteca Alcatraz, ma ve le immaginate le ronde armate guidate dai Borghezio del Ticinese, il ribollire dei talk show televisivi dove vieni chiamato solo per far sfogare su di te (il comunista o lo stesso Don Colmegna) il livore di un plebeismo che negli anni si è consolidato? Sparate senza pietà su costui che difende i rom. Anche perché i comunisti quando sono stati al Governo – due volte in dieci anni – non sono riusciti, se mai ci hanno provato, a spostare il tiro dalla sicurezza cosidetta percepita alla risposta ai bisogni concreti e al sostegno ai diritti. Non hanno fatto capire chi sono e sono stati cancellati. Dalla sicurezza bisogna avviare un operazione verità e, su questa, ricostruire l’identità dimenticata. La sicurezza fa capire, indica il che fare. Dovessimo porre mano con tutti quelli che ci stanno ai famosi primi quattro punti – lavoro, casa, prezzi, traffico e inquinamento – toccheremmo, si sappia, i nervi scoperti del profitto e della rendita, individueremmo il nemico e lo indicheremmo ai cittadini, faremmo insomma lotta di classe. E circoscriveremmo il quinto punto a questione non fondamentale, che diventa non fondamentale solo se si affrontano gli altri. Di converso diventa fondamentale quando, in assenza del resto, il pensionato deve stare attento a uscire di casa perché, nell’assenza, gliela occupano e allora ha paura e odia tutti, particolarmente quelli che competono con lui per un tetto. E così il precario italiano che deve competere per il posto di lavoro in un cantiere o all’Ortomercato, in un’asta al ribasso per il pane, con il precario straniero e lo odia. E così 33 34 via in una catena di Sant’Antonio in cui ultimi e penultimi si contrappongono. Su un punto però si trovano d’accordo: nel dare legnate agli ultimissimi, gli intoccabili zingari, e se un’istituzione (come la Provincia di Milano) prova con un Villaggio Solidale a dar loro alloggio e formazione-lavoro viene giù il mondo. Sullo sfondo, indisturbati nel loro procedere al saccheggio dei territori, Cabassi, Caltagirone, Ligresti, Tronchetti Provera, Zumino guardano deliziati. «Avanti con la guerra tra i poveri che lascia in pace noi ricchi». E gettano benzina sul fuoco. Il guaio è che la fanno gettare anche a chi dovrebbe opporsi al degrado, alle ruberie, alla speculazione. Sintesi: Milano è città dove è diventato difficile convivere, il clima è di sospetto, incomprensioni e la scintilla scatta ora per il colore della pelle, ora per questioni di religione ma anche per una discussione al semaforo. E si teme il diverso, dal nero all’omosessuale. Tutto ciò origina la tendenza all’autodifesa. Si ricordi però che, in questa metropoli, i processi di integrazione sono sempre costati fatica, anche negli anni ’60 con l’arrivo di decine e decine di migliaia di meridionali. Poi il Dna ambrosiano, il «coeur in man», prevalse e fece superare le incompren- sioni. Ma allora c’era – ecco il punto – una rete fitta di controllo sociale che consentiva di svelenire il clima, c’erano mille e mille occasioni di socialità e conoscenza, date dalle sedi dei partiti e dei sindacati, dalle case del popolo, dagli oratori, dalle associazioni laiche e religiose, fino alle balere di quartiere e alle bocciofile. E c’erano grandi sindaci che non guardavano ai grattacieli di una Milano che solo lucida il disagio, ma alle case popolari, alle scuole civiche, all’Umanitaria. E c’erano le grandi fabbriche dove si faceva fatica ma si socializzava. La sicurezza (anche la sicurezza) fa perciò capire che oggi siamo a un bivio: o si subisce la strategia di lor signori e, quindi, avanti con il coprifuoco mentre i palazzinari spolpano la città, oppure si mette in campo l’altra strategia, quella dei primi quattro punti, dove si risponde ai bisogni e ai diritti con l’iniziativa e la riprogettazione degli spazi di socialità nella città cambiata e non con la spranga, come in Via Zuretti, o con l’olio di ricino mediatico che tutte le sere a un popolo oppiato propinano le Tv. Su le maniche compagni e compagne perché la vedo brutta anche per noi. OPINIONI A CONFRONTO perché ci diciamo comunisti P AOLO F ERRERO * La parola sinistra ha storicamente un significato positivo nel nostro Paese. Ha a mio parere un difetto e cioè che si tratta di una coperta che copre molte cose * SEGRETARIO NAZIONALE DEL PRC D a un po’ di tempo Liberazione pubblica con grande rilievo articoli che chiedono di abbandonare il nome comunista. Al fondo la tesi riproposta in varie salse è che la parola comunismo è inutilizzabile perché l’esperienza storica concreta ne ha stravolto il significato. Tra chi propone di abbandonare il nome comunista vi è chi si pronuncia a favore del nome sinistra, chi a favore del socialismo, chi non propone nulla. Tutto questo si intreccia con un altro filone di dibattito che propone di andare oltre il Partito della Rifondazione Comunista, per fare un altro partito, per fare un’altra cosa che non sia un partito ecc. Le argomentazioni portate mi pare ripropongano un po’ stancamente quanto già sostenuto da Occhetto e dai suoi sostenitori dopo l’89 ma tant’è, come si sa la prima volta la storia si presenta come tragedia, la seconda come farsa. Per quanto mi riguarda io la penso così: il concetto di comunismo ha una storia che travalica le vicende del secolo breve. Non voglio qui affrontarlo. Mi pare invece utile sottolineare come in Italia il gruppo dirigente comunista alle origini si è formato nella vicenda dell’occupazione delle fabbriche e valorizzando la costruzione dei consigli di fabbrica. Nel corso della guerra ha saputo dar vita a un movimento di resistenza antifascista unitario e democratico che ha contribuito a liberare l’Italia e a dare al nostro Paese un assetto democratico strutturato attorno a una Carta costituzionale assai avanzata. Successivamente i comunisti hanno variamente lottato e con una certa efficacia contro lo sfruttamento e per la giustizia sociale. Un terzo degli elettori italiani è arrivato a dare fiducia a un partito che si chiamava comunista e che poneva la questione morale come punto non secondario della riforma della politica. Rifondazione comunista nel suo piccolo è stata presente nei vari conflitti che hanno percorso il Paese ed è stata in grado di collocarsi positivamente nella grande stagione del movimento no global. Il tutto cercando di intrecciare le lotte per i diritti sociali con quelle per i diritti civili, lotte operaie e lotte ambientali, lotte per la redistribuzione del reddito con le lotte contro la mercificazione delle persone, dell’ambiente, delle relazioni sociali. In altri termini la parola comunismo in Italia è legata alle battaglie per la giustizia e la libertà. Dopo l’era craxiana non mi pare si possa dire lo stesso per la parola socialismo. La parola sinistra ha storicamente un significato positivo nel nostro Paese. Ha a mio parere un difetto e cioè che si tratta di una coperta che copre molte cose. Ad esempio all’interno del partito democratico vi sono persone e posizioni che si definiscono di sinistra che sono però anche variamente confindustriali e per nulla anticapitaliste. La parola sinistra – da sola – non definisce una posizione chiara dal punto di vista della divisione di classe della società né dal punto di vista della volontà di superare il capitalismo; tant’è che negli anni scorsi abbiamo giustamente detto che esistevano due sinistre, 35 36 quella moderata e quella radicale o alternativa o antagonista. Da questo punto di vista il definirsi di sinistra e comunisti mi pare rappresenti un modo chiaro per dire da che parte si sta. Siamo di sinistra ma siamo anche comunisti, cioè lottiamo contro lo sfruttamento, quando serve anche contro il Vaticano e ci battiamo per il superamento del capitalismo. Dirsi comunisti è quindi una risorsa per qualificare il nostro essere di sinistra. Porre il tema del comunismo significa porre il nodo della rivoluzione, del cambiamento radicale dello stato di cose presenti. Tant’è che quando taluni esponenti del centrosinistra affermano di non voler mai più fare accordi con liste che contengano la falce e il martello lo dicono non certo per la nostra storia ma perché siamo concretamente, politicamente, qui e ora, anticapitalisti. Questo per quanto riguarda l’Italia. I comunisti però, in particolare quando hanno preso il potere, hanno anche fatto grandi disastri. Lo stalinismo ha contraddetto radicalmente le aspirazioni di giustizia e libertà del movimento comunista. Per questo ci siamo chiamati Rifondazione Comunista. Non solo il nome di un partito ma un progetto politico: rifondare il comunismo avendo fatto fino in fondo i conti con lo stalinismo. Riconosciamo che la storia dei comunisti e delle comuniste è la nostra storia, ne abbiamo analizzato gli errori e gli orrori al fine di non ripeterli. Rifondazione e comunista sono quindi due termini che si qualificano a vicenda, ci parlano della persistenza ma anche della discontinuità, ci parlano della contraddittorietà del nostro tentativo di andare oltre il capitalismo nel nostro essere fino in fondo uomini e donne di questo tempo. La rifondazione del comunismo è quindi il progetto politico che abbiamo scelto quando Achille Occhetto ha sentenziato che il comunismo era solo un cumulo di macerie. Nulla vieta che altri oggi la pensino come Occhetto ma a me francamente pare che i guai che abbiamo avuto negli anni scorsi non siano derivati dal nostro nome ma piuttosto dai nostri errori politici, in primo luogo la scelta di andare al governo. Io penso quindi che oggi sia più necessario di ieri dirsi comunisti, di Rifondazione comunista. È il nome che meglio di qualunque altro definisce qui e ora il nostro anticapitalismo e la nostra autonomia da un ceto politico che si definisce di sinistra ma con le cui prospettive politiche abbiamo poco a che spartire. È evidente che si potrebbe continuare ad argomentare a lungo ma voglio utilizzare lo spazio che mi resta per sollevare un paio di quesiti. In primo luogo, è evidente che la discussione dovrebbe cominciare da qui, cioè dalla rifondazione comunista. Si tratterebbe di aprire una discussione non a negativo ma a positivo. Si tratterebbe di ragionare su come rendere al meglio oggi la prospettiva comunista. Di come la nostra azione non si possa situare solo al livello politico della rappresentanza. Di come si ridefinisca la politica comunista in relazione ai movimenti, alle mille vertenzialità, alle forme di mutualismo. Di come si intreccino oggi i diversi conflitti e come possano interagire in una prospettiva di superamento del capitalismo. Di come si possa affrontare la crisi capitalistica proponendo il tema del controllo sociale dell’economia ed evitando la guerra tra i poveri. Di come si intrecci la lotta per il salario con quella per il reddito sociale con la lotta contro la mercificazione di ogni ambito sociale, e così via. Il dibattito di cui avremo bisogno non riguarda la ripetizione dell’occhettismo ma l’approfondimento della prospettiva della rifondazione comunista. Purtroppo però Liberazione non si cimenta sul terreno della rifondazione comunista ma su quello del suo superamento. In secondo luogo, è bizzarro che il giornale del Partito della rifondazione comunista metta in prima pagina il dibattito sul superamento del comunismo e a pagina 19 gli articoli in cui alcuni dirigenti del partito avanzano proposte politiche e cercano di far avanzare il progetto di rifondazione comunista. In altre parole, la vera novità non mi pare il dibattito sul comunismo, ma il fatto che oggi Liberazione, il giornale del Prc, sia il soggetto che con maggiore costanza e determinazione chiede il superamento del Prc e del suo progetto politico. Devo dire che questa novità non mi pare molto utile. OPINIONI A CONFRONTO comunismo: un’istanza feconda G IANLUIGI P EGOLO * Se le forme della produzione sono cambiate, lo sfruttamento – che è alla fin fine la categoria essenziale del confitto capitale/lavoro – nelle stesse aree a sviluppo maturo non viene meno ed anzi tende ad accentuarsi * SEGRETERIA NAZIONALE DEL PRC P er quale motivo ci si può definire oggi comunisti? La risposta è molto più complessa di quanto si possa immaginare e il dibattito che – meritevolmente – la rivista «essere comunisti» ha promosso lo sta a dimostrare. In primo luogo c’è da chiedersi, quando parliamo di «comunismo» a cosa ci riferiamo? La domanda non è in sé banale, dato che per esempio negli interventi fino a ora pubblicati vi è una giustapposizione di piani di analisi che, benché interconnessi, finiscono con il rendere difficile un confronto puntuale. Per comodità, credo sia utile ripartire dalle argomentazioni con cui Di Siena sostiene l’inattualità del comunismo novecentesco come teoria della trasformazione sociale. Tale convinzione muove da un’analisi dei processi di globalizzazione. Se ho ben compreso, il superamento della grande industria che ha caratterizzato come modello produttivo gran parte del secolo scorso (con l’affermarsi di modelli di produzione flessibili, cui si accompagnano processi di deterritorializzazione della produzione e una tendenza pervasiva alla precarietà), insieme alla crescente spersonalizzazione del capitale, metterebbe in discussione il concetto tradizionale di classe, farebbe prevalere istanze individuali che si potrebbero connettere alla domanda di libertà, anziché di eguaglianza, e che per questa via potrebbero congiungersi con altre istanze sociali il cui sviluppo prescinde dal rapporto di produzione in senso stretto. Il conflitto capitale/lavoro, sulla base di questa analisi, a me pare, tenda oggettivamente a perdere centralità, ma per amor del vero questo Di Siena non lo sostiene esplicitamente. In premessa, devo riconoscere a Di Siena il merito di aver posto a tema una questione di prima grandezza e cioè quella del «soggetto antagonista». È vero che il «problema dei problemi», in questa fase storica, è rappresentato dalla difficoltà a mettere in campo una soggettività sociale di cambiamento. Ed e’ ancora vero che la classe operaia in senso stretto si è ridotta, almeno per quanto riguarda il proletariato classico delle aree capitalistiche mature, e che la stessa subisce come non mai il ricatto derivante dalla presenza di un cospicuo esercito industriale di riserva (oggi in larga misura costituito da lavoratori immigrati). Se solo volgiamo lo sguardo alla trasformazione sociale prodottasi in questi anni nel nostro Paese non possiamo che riconoscere la drammaticità della situazione e la difficoltà che questo stato di cose comporta per un’azione di cambiamento. Il mondo del lavoro conosce un mutamento senza precedenti e la stessa efficace rappresentazione di Steri del «consiglione» di Mirafiori negli anni ruggenti della lotta operaia ci dice dell’arretramento subito nell’ultimo periodo, anche in termini di coscienza collettiva. Il punto, tuttavia, è se l’analisi impietosa della realtà sociale, con particolare riferimento alla condizione del lavoro, giustifichi l’assunto di Di Siena secondo cui vengano meno oggi le condizioni di un esteso conflitto capitale-lavoro fondato sul protagonismo di un soggetto collettivo, unificato su obiettivi egualitari. 37 38 A me pare di no. Soffermiamoci sulla struttura del mondo del lavoro. È un dato di fatto che se misuriamo il proletariato, anziché su base nazionale, su base internazionale il quadro muta non poco. La globalizzazione reca con sé una dilatazione del lavoro produttivo anche nella sua forma «materiale». Questa dilatazione geografica ha risvolti diretti anche nelle modificazioni dei comportamenti sociali. Certamente occorrerebbe un’analisi molto accurata di cosa sia la classe operaia nelle nuove aree emergenti, ma i segnali sono già abbastanza indicativi e gli effetti già rimbalzano nelle aree mature. Si considerino le modalità di organizzazione del lavoro che si affermano nei Paesi di nuova industrializzazione, molto simili a quelle novecentesche se non a quelle precedenti. Si considerino, a titolo di puro esempio, le conseguenze che i processi di nuova sindacalizzazione nei Paesi dell’est hanno in termini di tendenziale crescita del costo del lavoro e riduzione dei profitti delle aziende ivi insediatesi. Questi fatti sono noti e si potrebbe al limite sostenere, ironizzando, che il fondamento sociale del comunismo andrebbe ricercato più nei Paesi in via di industrializzazione più che in quelli più sviluppati. Ma anche questo argomento si presta a contestazioni. In primo luogo, per la natura concreta dei rapporti di produzione. Se le forme della produzione sono cambiate, lo sfruttamento – che è alla fin fine la categoria essenziale del confitto capitale/lavoro – nelle stesse aree a sviluppo maturo non viene meno ed anzi tende ad accentuarsi, divenendo una componente pervasiva del lavoro odierno. Né il proliferare di forme di lavoro nominalmente autonome fa venir meno il carattere viepiù subordinato ed etero-diretto della prestazione di lavoro. La mia opinione, pertanto, è che le indubbie modificazioni nella struttura sociale non facciano venir meno la nozione di «conflitto di classe», che le contraddizioni che animano il mondo del lavoro siano anzi più acute, che una prospettiva egualitaria conserva un’evidente rilevanza e che senza il protagonismo del proletariato non vi sia possibilità di cambiamento. Su quest’ultimo punto si potrebbe discutere, data l’evidente frantumazione dei conflitti e la difficoltà a riunificare i vari soggetti intorno a obiettivi comuni. E, tuttavia, a me pare che nell’esperienza recente del nostro Paese questa centralità del mondo del lavoro sia testimoniata – forse prima che dalla capacità dello stesso di farsi promotore di un’iniziativa adeguata – dalla verificata incapacità degli altri soggetti sociali a incidere, in assenza di un’iniziativa operaia. Se riflettiamo sulle vicende degli scorsi anni, e in particolare sulla stagione del movimento no global, è evidente che l’idea di poter sostituire la centralità del lavoro con altre centralità non abbia trovato conferma. Valgono qui le osservazioni di Brancaccio circa il carattere strumentale di alcune teorizzazioni (penso ad esempio a quella sul «movimento dei movimenti») formulate in quegli anni nel tentativo di catturare la simpatia di alcuni interlocutori, di fronte all’incapacità di costruire una propria effettiva presenza – in primis – nel mondo del lavoro. È ragionevole ritenere, quindi, che non già sia in crisi la nozione di conflitto capitale/lavoro, o la centralità che tutt’ora conserva il proletariato come soggetto antagonista, quanto la capacità sull’onda di tale conflitto e in forza del ruolo di tale soggetto, di determinare un processo di cambiamento in grado di operare una trasformazione radicale della struttura sociale e dell’assetto politico/istituzionale. Questa osservazione è certamente pertinente, ma fino a che punto mette in discussione la legittimità di un punto di vista comunista? A meno di non ricadere nel vizio deterministico di considerare l’evoluzione dei processi sociali come prodotto automatico delle contraddizioni, le difficoltà che in una determinata fase storica si incontrano nell’organizzazione dell’iniziativa di classe (e più in generale nell’iniziativa sociale) non sono A ben vedere ciò che maggiormente caratterizza ancora oggi un’opzione comunista in alternativa ad approcci di altra ispirazione è appunto questo: il riconoscere in questo assetto economicosociale l’origine del riprodursi di contraddizioni che ne giustificano il superamento OPINIONI A CONFRONTO di per sé dimostrazioni dell’irrilevanza o del venir meno delle contraddizioni stesse. Il problema in realtà è diverso e attiene alle «forme» della soggettività politica e sociale, della sua capacità a rispondere alle nuove sfide indotte dai mutamenti. Ciò vale ad esempio per il sindacato, sempre più condizionato nella sua azione da una dimensione internazionale dei processi, o per i partiti posti di fronte all’esigenza di formulare un progetto di società che contrasti frammentazione, crescente differenziazione sociale e processi di marginalizzazione. Vero è che senza una soggettività politica forte e strutturata, capace di dare sponda ai conflitti e favorirne l’unificazione in una prospettiva di cambiamento generale, vi è oggi più di ieri una difficoltà a promuovere il cambiamento. Questa constatazione, però, ci dice più che dell’impossibilità – in assoluto – del rilancio di un’opzione di classe, della responsabilità storica della sinistra nel nostro Paese. Il richiamo, nello scritto di Steri, sugli effetti dell’interiorizzazione della sconfitta da parte delle organizzazioni del movimento operaio e dell’assunzione da parte delle stesse del punto di vista dell’avversario è, a tale proposito, più che pertinente. In ogni caso, benché la questione del soggetto antagonista sia centrale e indubbiamente costituisca uno dei fondamenti dell’opzione comunista, è evidente che tale opzione si legittima anche sulla base di altri elementi. Fra questi valgono in particolare la critica profonda alla società capitalista e un’idea del cambiamento come trasformazione radicale degli assetti politici, istituzionali e socio-economici. A ben vedere ciò che maggiormente caratterizza ancora oggi un’opzione comunista in alternativa ad approcci di altra ispirazione è appunto questo: il riconoscere in questo assetto economico-sociale l’origine del riprodursi di contraddizioni che ne giustificano il superamento. Che oggi vi sia bisogno di una rinnovata critica anticapitalista non mi pare possa essere indubbio. Gli stessi feno- meni della globalizzazione indicano in modo inequivocabile l’attualità del tema del superamento del sistema capitalista. Vale per la riproduzione di squilibri regionali di dimensioni amplissime (inter e intra-nazionali), che mettono in discussione l’illusione di una dilatazione sincronica e omogenea dello sviluppo, vale per il riemergere di nuove tensioni politico-economiche fra le potenze in campo con il rilancio dei conflitti locali, vale per l’esplodere di una crisi economico-finanziaria di proporzioni drammatiche che ricolloca la comunità internazionale nella prospettiva di una recessione che comporterà dissoluzione di risorse ed enormi costi sociali. Nessuno, penso, obietterà che la contraddizione fra disponibilità di risorse e insoddisfazione dei bisogni sia oggi più acuta che mai e che l’irrazionalità del sistema capitalista sia giunta a un punto tale da porre il problema della sua compatibilità con lo sviluppo del genere umano. Qualcuno, invece, obietta che le nuove gigantesche contraddizioni del sistema mettono in ombra categorie centrali dell’analisi marxista – come quelle del conflitto capitale-lavoro e della proprietà privata dei mezzi di produzione – che in virtù dei nuovi processi tenderebbero ad assumere un peso minore. Ne sono la dimostrazione i ricorrenti riferimenti, nel dibattito, alla crescente incidenza dei beni immateriali, al carattere diffuso della pro- 39 40 prietà, all’affermarsi di contraddizioni che poco hanno a che vedere con il conflitto capitale-lavoro in senso stretto. In realtà, c’è più di una ragione per dubitare di queste argomentazioni solo che si indaghino approfonditamente i processi in atto. Si pensi all’importanza che assume nell’attuale divisione internazionale del lavoro la questione del suo costo e delle condizioni del suo sfruttamento, o alla rilevanza che tutt’ora assume la questione dell’appropriazione delle materie prime, fattore non ultimo della ripresa di conflitti armati, o infine all’incidenza nella crisi economica del controllo privato del capitale finanziario. Anzi, proprio alla luce dell’inarrestabilità della crisi dei mercati finanziari, la questione della necessità della proprietà pubblica di alcuni comparti strategici, fra cui il credito, torna oggi alla ribalta, di fronte alla verificata inefficacia dei sistemi di regolazione messi in campo dalle autorità internazionali per prevenire le crisi. Non solo, ma il fatto che l’attuale sviluppo del capitalismo ponga ormai il problema della sua compatibilità con la riproduzione della specie sta a dimostrare, come ha giustamente sottolineato Brancaccio, che su una moderna critica anticapitalista possano convergere movimenti sociali che si sviluppano a partire da contraddizioni diverse da quella fra capitale e lavoro. Penso all’ambientalismo e al femminismo. Nei vari contributi che si sono succeduti sulle pagine di «essere comunisti» un elemento è risultato comune. Una critica esplicita all’esperienza del socialismo reale. Per molti versi vi è stato un generale ritorno a Marx, quanto mai opportuno. La sostanza di queste posizioni è, in larga misura, condivisibile. Il recupero di un’ispirazione e di una pratica comuniste oggi non può prescindere da un bilancio di quella storia. È per esempio evidente che la statizzazione integrale dei mezzi di produzione costituisce un’opzione non riproponibile, così come una concezione autoritaria e centralizzata del potere. Per molti versi non ha neppure senso ribadirlo. Queste critiche al socialismo reale sono il prodotto di una riflessione che in Italia, prima di altri Paesi, hanno visto protagonisti sia il Pci che la sinistra critica. E, tuttavia, una volta prese le distanze dagli aspetti discutibili di quella esperienza, non si può ridurre il ‘900, come purtroppo si è fatto anche in Rifondazione comunista, a un mucchio di macerie. E non solo perché nella stessa esperienza dell’Ottobre vi sono grandi meriti storici che non possono essere negati, ma perché il ‘900 ha visto il movimento comunista essere protagonista di un’azione di cambiamento che sarebbe prima che ingeneroso, illogico disconoscere. E benché molte di quelle esperienze siano datate, vi sono aspetti che vanno recuperati anche nella prospettiva di una moderna teoria del cambiamento ( su questo punto il mio pensiero si differenzia esplicitamente dalle posizioni espresse da Di Siena). Penso a una certa concezione della lotta di massa, a un’idea della militanza e del ruolo del partito, ma anche ad alcune esperienze fallite, ma che non per questo vanno semplicemente rimosse, essendo comunque meritevoli di una critica puntuale. Penso al ruolo della pianificazione, seppellita dallo statalismo, ma non per questo totalmente derubricabile nella prospettiva di un’organizzazione sociale razionale e non lasciata all’arbitrio del mercato, o al controllo dei processi di accumulazione che se non ha trovato adeguata soluzione nella semplice gestione pubblica dell’economia, nondimeno resta un’esigenza inderogabile. Si pensi ai danni che questo modello di sviluppo produce sul piano ambientale, o in tema di scelte di consumo. In questo contesto l’esperienza italiana è ineguagliabile. Ci si può definire comunisti per più ragioni, ma certamente i comunisti italiani qualche ragione più di altri ce l’hanno per rivendicare un’appartenenza. Con troppa leggerezza ci si vuole oggi liberare del lascito di un’espe- OPINIONI A CONFRONTO rienza che ha avuto il suo punto di forza in una concezione non dogmatica dell’azione politica, nella capacità di saldare lotta di classe a influenza sull’insieme della società, nella capacità – più che in altre esperienze – di cogliere la ricchezza dell’intreccio fra contraddizioni strutturali e sovrastrutturali, superando una concezione rozza e schematica del marxismo. Il paradosso del dibattito che da vent’anni attraversa la sinistra italiana intorno all’attualità o meno del comunismo, sta in primo luogo in questo. Dalla Bolognina in poi, il comunismo a sinistra è stato considerato una opzione superata, fino al punto di considerarlo impedente un’azione di cambiamento, quando non responsabile di opzioni contrastanti con le aspirazioni alla liberazione umana. Il risultato banale è che, partendo da questi approcci, non solo si è liquidato un grande partito, si è rotta una comunità (come ricorda Vinci), ma si è avviata la marginalizzazione dell’intera sinistra, da un lato traslata verso lidi genericamente «democratici», dall’altro verso opzioni radical-massimaliste. Nel caso specifico del nostro Paese, allora, rivendicare l’attualità di un punto di vista comunista è prendere atto che senza questo, non già si liberano forze, o si alimenta un nuovo protagonismo sociale, ma semplicemente ci si rassegna all’impotenza politica, alla subordinazione alle opzioni moderate, all’ininfluenza sul piano sociale. Nell’esperienza del nostro Paese, poi, a prescindere dal grande ruolo giocato dal Pci, il movimento di massa, anche in virtù di quella presenza ma non solo, ha saputo produrre livelli di coscienza ineguagliati. L’egualitarismo con la sua critica alla divisione del lavoro, la contestazione delle nuove forme dell’organizzazione del lavoro, la critica alla neutralità della scienza, la critica alla democrazia formale hanno costituito riferimenti per milioni di lavoratori, studenti, intellettuali. E ancora oggi, a ben guardare e nonostante l’indebolimento dell’iniziativa di massa, quelle idee riaffiorano, seppure segnando una distanza molto più profonda di un tempo dai soggetti politici organizzati. Ispirazioni la cui connessione con l’opzione comunista è del tutto evidente. Senza questi riferimenti la «cassetta degli attrezzi» di cui abbiamo bisogno – alla quale ci richiama op- portunamente nel suo articolo Burgio – dubito sarebbe in grado di far fronte alle nostre esigenze. Questi elementi vanno ripresi e rielaborati nella condizione data. Definirsi comunisti oggi, nel nostro Paese, ha senso se si riparte da qui, non per nostalgia, ma per la fertilità di un approccio che va recuperato. Più che di un ricettario sulle caratteristiche che deve possedere la società futura abbiamo bisogno di un approccio rispondente alla natura della società in cui viviamo. Ci aiuta l’esperienza storica, una certa pratica di massa, ma anche alcune ispirazioni di fondo che conservano una loro validità ai fini di una moderna critica anticapitalista. Dubito che – a tale proposito – al di fuori del comunismo vi sia oggi un punto di vista altrettanto fecondo. 41 oggi, perché essere comunisti «In Lenin la conoscenza della società era rivolta in ogni momento all’agire che proprio allora era socialmente necessario, perché la sua prassi era sempre la conseguenza necessaria della somma e del sistema delle vere conoscenze accumulate in quel momento. La sua vita è un agire continuo in cui non esiste situazione senza scampo, né per lui né per l’avversario. Perciò il suo metodo di vita è questo: essere sempre preparati all’azione, all’azione giusta». György Lukács, Lenin 42 D OMENICO M ORO * «Il vero limite della produzione capitalistica è proprio il capitale, cioè è che il capitale e la sua autovalorizzazione si presentano come punto di partenza e punto di arrivo, come motivo e fine della produzione; che la produzione è soltanto la produzione per il capitale e non invece i mezzi di produzione sono semplici mezzi per il costante allargamento del processo vitale per la società dei produttori». Karl Marx, Il Capitale, libro III 1. Specificità del comunismo moderno C hiedersi perché essere comunisti dovrebbe essere naturale per un comunista, eppure è domanda che fa tremare i polsi e mette a disagio per varie ragioni. Tra queste sicuramente pesano come un macigno la caduta dell’Urss, e la storia del comunismo del 900, entrambe ancora non elaborate. Pesa, inoltre, l’attuale situazione di difficoltà che, comprensibilmente ma ingiustificatamente, ci schiaccia sul livello della sopravvivenza immediata. Ma c’è anche un’altra importante ragione: definire «il perché» implica sempre definire «il che cosa» e c’è sempre stato un certo «pudore» a definire il comunismo in una scuola di pensiero il cui fondatore si è dichiarato, da subito, contro le definizioni utopistiche da «osteria dell’avvenire». Eppure, niente sarebbe più sbagliato del pensare che Marx non abbia detto cose fondamentali al proposito e che soprattutto, oggi, sulla scorta di una secolare esperienza pratica, non sia necessario entrare nel merito, portando avanti la riflessione di Marx alla luce degli avvenimenti passati e presenti. Se è vero che non siamo comunisti perché abbiamo letto il Capitale, è altrettanto vero che, se lo siamo in un certo modo, cioè nel senso moderno del termine, è solo perché abbiamo letto il Capitale. E per letto non intendo che ciascun individuo che si riconosca nel movimento comunista lo debba aver letto effettivamente, bensì in una accezione più ampia, nel senso di farlo proprio. La spinta profonda e iniziale a essere comunisti credo che provenga da una insofferenza, da un senso di profonda inaccettazione per quanto vediamo e sperimentiamo ogni giorno nella nostra vita e, per quanto riusciamo a vedere e sentire, nella vita dei nostri simili. È il rifiuto dell’ingiustizia e dell’ineguaglianza, che è tanto più forte in quanto questa ingiustizia e questa ineguaglianza le sentiamo essere ingiustificate, a muoverci. Eppure, molti (per fortuna!) sono coloro che, mossi da una simile intolleranza, operano o Si arriva infine al paradosso estremo: quanto maggiore è la ricchezza accumulata tanto più grande è la povertà prodotta. E si assiste alla crescita della povertà in mezzo all’abbondanza * ECONOMISTA E MEMBRO DEL CC DEL PDCI OPINIONI A CONFRONTO ritengono di operare contro l’oppressione, lo sfruttamento, e persino l’ineguaglianza senza per questo essere o dichiararsi comunisti. Seguaci di religioni e confessioni diverse, aderenti a partiti e movimenti filosofici variegati cercano di operare in tal senso. Nessuno di questi, però, ha la nostra stessa idea di società futura o i nostri stessi metodi di analisi e di intervento sulla realtà o, soprattutto, ritiene che, per risolvere i problemi sociali, sia necessario trasformare la società alla sua radice, cioè a partire dai rapporti di produzione. In effetti, noi non siamo neppure i primi comunisti della storia né il comunismo è stato inventato da Marx. L’aspirazione a ristabilire la situazione di eguaglianza tra gli uomini esistente nello status quo ante il sorgere delle classi, è probabilmente vecchia quanto l’esistenza delle classi stesse. Comunisti erano i primi cristiani, prima che il cristianesimo diventasse instrumentum regni dell’impero romano in crisi. Comunisti erano i seguaci di Thomas Müntzer che nel XVI secolo guidavano le armate contadine contro i principi tedeschi al grido di «omnia sunt communia!». Comunisti erano gli «uguali» capeggiati da Babeuf, la cui sconfitta chiuse la Rivoluzione francese, suggellando la definitiva affermazione del dominio politico della borghesia. E dal fallimento degli «uguali» scaturì per tutta l’Europa un fiorire di sette, anche grazie all’opera di quel grande pioniere italiano del comunismo che fu Filippo Buonarroti. Il comunismo moderno, il nostro comunismo, pur figlio delle lotte degli sfruttati di ogni tempo e luogo, è qualcosa di altro e diverso. È, come disse Marx al momento di costituire la Prima Internazionale, il superamento della fase delle sette e dei progetti utopistici del passato, generosi ma impotenti. Essere comunisti «moderni» è soprattutto la consapevolezza che oggi, per la prima volta nella storia, il comunismo è possibile. Perché oggi l’esistenza delle classi, derivata dallo sviluppo della divisione del lavoro e necessaria allo sviluppo della capacità produttiva del lavoro umano, non solo non è più necessaria, ma è anzi di ostacolo al libero e ulteriore sviluppo delle forze produttive della società. In buona sostanza, nella fase storica caratterizzata dall’affermazione definitiva del capitale e dalla contraddizione lavoro salariato – capitale si sono create le condizioni per l’abolizione delle classi e quindi dello sfruttamento e dell’ineguaglianza. È in questo senso che Marx scrisse: «il comunismo non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà deve conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti. Le condizioni di questo movimento risultano dal presupposto ora esistente»1. Il «presupposto» è il movimento del capitale stesso. Essere comunisti implica, quindi, una specifica concezione del mondo, un determinato metodo di analisi della Storia e della Società e una certa prassi di lotta. 2. Il comunismo è necessario e possibile Il comunismo è possibile perché è necessario. Il capitalismo produce insieme il massimo di razionalità e il massimo di irrazionalità, il massimo di ricchezza e il massimo di povertà, il massimo delle possibilità di sviluppo dell’individuo e il massimo della frustrazione e dell’oppressione individuale. In nessuna altra società del passato la scienza ha avuto un così grande ruolo e soprattutto un così grande influsso sulla produzione, attraverso la tecnologia. Ma la scienza non permea veramente né la comprensione della vita, né la gestione complessiva della società. Eppure il modo di produzione capitalistico si presenta come razionale. Quanto più l’azienda è grande tanto più è governata da un piano razionale in base al quale viene stabilita la suddivisione del lavoro. L’obiettivo di tale pianificazione è ridurre il tempo di lavoro necessario alla produzione della merce. Per ottenere questo risultato la forza produttiva del lavoro viene incrementata e vengono introdotte le macchine. Ma la riduzione del tempo di lavoro necessario e l’introduzione di macchine e tecnologie sempre più avanzate non si traduce in maggiore ricchezza e minore fatica per tutti. Il principio del movimento del capitale, infatti, non è la soddisfazione dei bisogni umani ma la massimizzazione dei profitti, l’accumulazione fine a se stessa, attraverso l’aumento dello sfruttamento del lavoratore, mentre la riduzione del tempo di lavoro necessario è finalizzata alla competizione tra i capitali. Così alla razionalità della divisione del lavoro nelle singole unità di capitale corrisponde l’irrazionalità anarchica della divisione generale del lavoro nella concorrenza che caratterizza il sistema economico complessivo. E il sogno di una umanità libera dalla fatica e dal bisogno si traduce in un incubo per la maggior parte della popolazione: sovrapproduzione di mezzi di produzione, di merci, di lavoratori, orari di lavoro che si allungano, intensità del lavoro che aumenta. Si arriva infine al paradosso estremo: quanto maggiore è la ricchezza accumulata tanto più grande è la povertà prodotta. E si assiste alla crescita della povertà in mezzo all’abbondanza. Anzi, il fenomeno dei «poveri che lavorano» non è un effetto imprevisto e accidentale dell’economia del capitale, ma ne è ragione d’esistenza, obbligo ai bassi salari e causa di alti profitti. Fatti questi di cui abbiamo testimonianza proprio nel Paese più ricco e potente del mondo, gli Usa, dove, accanto a una immane ricchezza, si allungano le file dei senza casa e cresce una umanità lavoratrice senza diritto alla salute, a una vecchiaia dignitosa, a una infanzia educata e protetta. Il lavoratore, però, col capitale non perde solo il controllo sulla ricchezza prodotta, ma anche sulla sua stessa attività lavorativa, sempre più parcellizzata, ripetitiva, esecutiva, mentre la razionalità della pianifica- 43 è in antitesi alla natura caotica, irrazionale, anarchica e indipendente dal controllo dei produttori che il comunismo è «dicibile» 44 zione aziendale si manifesta come costrizione, dispotismo sui lavoratori. Non sono gli uomini, i produttori, a dominare le forze produttive, controllandole e dirigendole, ma sono le forze produttive a dominarli, come se, anziché il prodotto dell’attività umana, fossero forze naturali che incombono, minacciando di scatenarsi con tutta la loro furia cieca sulla società. Come avviene in tutta la sua devastante evidenza proprio nel corso delle crisi che immancabilmente e periodicamente scuotono la società del capitale e il cui superamento è possibile, entro i rapporti di produzione dominanti, solo attraverso immani distruzioni di ricchezza, che ristabiliscono le condizioni per la ripresa del processo d’accumulazione. La distruzione di ricchezza diventa così necessità, allo scopo di produrre altra e sempre più grande ricchezza. Una logica irrazionale anima il capitale, la quale raggiunge il suo apice nella guerra, fenomeno sorto con la civiltà e le classi, ma che con il capitalismo assume una necessarietà e una violenza mai viste e crescenti. È in antitesi alla natura caotica, irrazionale, anarchica e indipendente dal controllo dei produttori che il comunismo è «dicibile». Il comunismo si sostanzia proprio come razionalità, pianificazione e controllo delle forze produttive. Ma non si tratta dell’applicazione di una razionalità meccanica, deterministica alla realtà da parte di una intelligenza o di una elìte superiori. Il comunismo è, per Marx, la riconduzione delle forze produttive della società sotto il controllo dei produttori liberamente associati, secondo un piano razionale2. Quindi, il comunismo non è soltanto (neanche nella sua fase iniziale, quella socialista) proprietà collettiva (e tantomeno soltanto statale) dei mezzi di produzione, come invece si è troppo spesso sottolineato e praticato nelle esperienze del socialismo realizzato. È, soprattutto, gestione collettiva delle forze di produzione della società. E questo significa non solo il controllo della distribuzione dei risultati del lavoro, cioè del plus-prodotto, ma anche la ricomposizione della scissione tra lavoro intellettuale e manuale, cioè tra direzione ed esecuzione. La questione centrale, dunque, è quella del come si esercita tale controllo. E il come riguarda il rapporto tra la classe lavoratrice e lo Stato, ovvero la trasformazione dello Stato da entità separata e contrapposta alla maggioranza della società civile, i lavoratori salariati, in un organismo sempre più partecipato dalle masse e quindi sempre meno «Stato». È in questo senso che Marx e Lenin parlano di «abolizione» dello Stato. Il comunismo è, dunque, l’unica vera democrazia possibile, basata sulla libera associazione tra gli individui produttori e orientata alla liberazione delle loro potenzialità e inclinazioni. È il contrasto stridente tra quanto è in potenza e la realtà effettiva della società attuale a fornire le basi materiali, il presupposto del comunismo. Mentre nelle società e nei modi di produzione precedenti la povertà e il dominio di classe apparivano «inevitabili», oggi lo sviluppo delle forze produttive consentirebbe la soddisfazione dei bisogni dell’umanità, rendendo inutile e perciò ancora più intollerabile l’oppressione di classe. Ma, «lo sviluppo delle forze produttive che rappresenta la missione storica e la ragion d’essere del capitale«3 trova un limite nel capitale stesso e «questo specifico limite testimonia del carattere ristretto, meramente storico, transitorio, del modo di produzione capitalistico; attesta che esso [il capitale] non costituisce affatto l’unico modo di produzione in grado di generare ricchezza, ma, al contrario, arrivato a un certo punto entra in conflitto con il suo stesso ulteriore sviluppo«4. Lo sviluppo delle forze produttive, insieme alla organizzazione razionale della produzione complessiva, che permetterebbe di impiegare tutte le forze di lavoro e di evitare gli sprechi, renderebbero possibile ridurre l’orario di lavoro per tutti. E in questo modo si libererebbe tempo vitale sia per la partecipazione alla direzione della vita economica e sociale, che nella società attuale viene monopolizzata dal ceto politico legato alla classe dirigente nell’economia, sia per il libero e multilaterale sviluppo di ogni individuo. A questo proposito, va notato che il capitale, estendendo il modello organizzativo della grande industria a tutti i settori dell’economia, distrugge la vecchia divisione del lavoro con le sue specializzazioni fossilizzate. Se questo, da una parte OPINIONI A CONFRONTO «impone la necessità di riconoscere il cambiamento dei lavori e la più grande versatilità dell’operaio quale legge sociale della produzione», dall’altra «impone la necessità di rimpiazzare l’individuo parziale, semplice esecutore di una funzione di dettaglio, con l’individuo integralmente sviluppato, per il quale differenti funzioni sociali sono modi che si scambiano liberamente»5. Sulla base della grande industria si crea anche il presupposto alla proprietà collettiva dei mezzi di produzione, attraverso il processo di centralizzazione dei capitali, sollecitato dalla concorrenza, che porta «all’espropriazione di molti capitalisti da parte di pochi», fino alla realizzazione dei monopoli. Infatti, osserva Marx: «l’accentramento e la socializzazione del lavoro arrivano a un punto in cui entrano in contraddizione col loro rivestimento capitalistico. Ed esso viene infranto. Suona l’ultima ora della proprietà privata capitalistica. Gli espropriatori vengono espropriati.» Ed è così che si determina la possibilità «della trasformazione della proprietà capitalistica, che già si basa in pratica sull’andamento sociale della produzione, in proprietà sociale»6. Ma l’elemento che Marx pone alla base della possibilità del comunismo è soprattutto la realizzazione del mercato mondiale. Il comunismo è possibile solo se è universale e ciò richiede relazioni «empiriche» universali, possibili solo sulla base del mercato mondiale. «Altrimenti», avverte Marx già nell’Ideologia tedesca «1) il comunismo potrebbe esistere solo come fenomeno locale, 2) le stesse potenze dello scambio non si sarebbero potute realizzare come potenze universali…3) ogni allargamento delle relazioni sopprimerebbe il comunismo locale»7. Parole queste che forse possono dire qualcosa sulla fine dell’esperienza del comunismo novecentesco, coincidente con la ricostituzione del mercato mondiale e sulla fase storica che si sta aprendo. Del resto, lo stesso Lenin intendeva la Rivoluzione russa solo come primo passo di una rivoluzione che sarebbe dovuta essere almeno europea. 3. Il comunismo è pensare e praticare il futuro Essere comunisti oggi vuol dire riconoscere la necessità e la possibilità del comunismo in quanto detto fino a ora. 45 Vuol dire rintracciare le basi del comunismo nella società odierna, nella quale, se da una parte il capitale si contrappone ai lavoratori come potenza sempre più grande e ostile, dall’altra crea, molto più che nel passato, i necessari presupposti per la sua trasformazione in una forma sociale superiore. La progressiva concentrazione monopolistica dei capitali, l’aumento delle differenze sociali, la finanziarizzazione dell’economia, la crisi generale di sovrapproduzione e soprattutto la creazione del mercato mondiale sono, in questo senso, elementi determinanti della possibilità del comunismo. Certo nessuno può parlare di «immediata» attuabilità del comunismo. Numerose sono le «mediazioni» che questo richiede. Ma, cerchiamo di intenderci, sarebbe un errore relegare la necessità del comunismo in una lontana prospettiva da raggiungere chissà quando. Intenderla come una specie di faro che brilla alla fine di un percorso chissà quanto lungo. La questione del comunismo non può che informare di sé l’azione odierna dei comunisti, perché già oggi le contraddizioni del capitale vengono impietosamente allo scoperto e pongono delle domande cui si può rispondere solo andando alla radice, ai rapporti di produzione. Appare chiaro cioè che il mercato e il privato non sono più in grado di sostenere i compiti posti dallo sviluppo delle forze produttive in questa fase di nuova mondializzazione dei mercati e di riproposizione della crisi generale. L’involucro costituito dai rapporti privati di proprietà viene lacerato in più parti e lo Stato è di nuovo invocato, dagli stessi capitalisti, a sostegno dell’economia. In tale si- 46 tuazione si rivela tutta la fragilità di un sistema che si pretendeva, fino a ieri, come eterno. Si ripresenta così non solo la possibilità di proporre di nuovo il superamento del capitalismo, ma si riacquista anche la legittimità a parlare di regolazione, di pianificazione razionale dell’economia, di proprietà pubblica dei mezzi di produzione. Elementi questi non da interpretare come «programma massimo» o da tenere come prospettiva per il futuro, ma da far vivere, anche parzialmente, nelle lotte e nelle proposte della vita politica di ogni giorno. È fondamentale chiarire questo concetto in un momento, seguente alla sconfitta del tentativo iniziato con l’Ottobre, in cui i mass media insistono nell’ossessiva damnatio memoriae di quel tentativo e di tutti coloro che vi si sono richiamati nel XX secolo. Del resto, non è casuale tale perseveranza da parte del capitale, conscio della spada di Damocle che continua a pendergli sul capo. La rottura che l’Ottobre operò nel dominio mondiale del capitale, realizzatosi con la «prima globalizzazione» all’inizio del 900, è riuscita, pur con tutti i suoi limiti, a rappresentare per molti decenni un punto di riferimento alternativo reale e perciò pericoloso. Oggi l’integrazione del mercato mondiale e le contraddizioni del capitale si ripresentano, e in una modalità tanto più grande che una eventuale rottura in qualche punto provocherebbe reazioni molto più estese e profonde. Ma nessuna trasformazione sociale può avvenire in modo deterministico, cioè come portato spontaneo delle contraddizioni del capitale. Essere comunisti oggi vuol dire, per questo, comprendere la necessità dell’elemento soggettivo e della volontà cosciente. Non basta essere coscienti della realtà del capitale. Solo se tale coscienza si organizza e conquista le masse diventa una forza materiale che può trasformare la realtà. E condizione necessaria per arrivare a questo sono il partito e la lotta politica. A pensare tutto questo ci si sente piccoli e inadeguati, specie se si guarda al nostro stato attuale, me ne rendo conto. Ma la forza di un movimento di trasformazione sta nella capacità di elevarsi dall’immediato, senza perdere il contatto con la realtà, per immaginare il futuro. Se la fantasia è sogno staccato dalla realtà, l’immaginazione è capacità di pensare una realtà diversa, a partire dalla realtà stessa, e dunque capacità di agire in modo alternativo. Ed è di immaginazione e coraggio che abbiamo bisogno, il coraggio di mantenere posizioni «estreme», non estremiste, perché in una situazione in cui i margini di mediazione si riducono e la lotta di classe viene inasprita dal capitale solo in questo modo si può assolvere al compito principale dei comunisti: indicare la direzione. Essere comunisti, dunque, vuol dire avere coraggio, il coraggio di pensare e praticare il futuro. 1. K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 1979, p. 25. 2. «La figura del processo vitale sociale, ossia del processo materiale di produzione, getta via il suo mistico mantello di nebbie solo quando sta, come prodotti di uomini liberamente uniti in società, sotto il loro controllo consapevole e attuato secondo un programma», K. Marx, Il Capitale, Newton Compton, Roma 1996, p. 82. 3. Ibidem, p. 1091. 4. Ibidem, p. 1077. 5. Ibidem, p. 358. 6. Ibidem, p. 548. 7. K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma, 1979, p. 25. IDEE i manoscritti economico-filosofici del 1844 G IORGIO N EBBIA * « Nell’ambito della proprietà privata ogni uomo s’ingegna di procurare all’altro uomo un nuovo bisogno, per costringerlo a un nuovo sacrificio, per ridurlo a una nuova dipendenza e sospingerlo a un nuovo modo di godimento e quindi di rovina economica. Con la massa degli oggetti cresce quindi la sfera degli esseri estranei, ai quali l’uomo è soggiogato, e ogni nuovo prodotto è un nuovo potenziamento del reciproco inganno e delle reciproche spoliazioni. L’uomo diventa tanto più povero come uomo, ha tanto più bisogno del denaro, per impadronirsi dell’essere ostile, e la potenza del suo denaro sta giusto in proporzione inversa alla massa della produzione; in altre parole, la sua miseria cresce nella misura in cui aumenta la potenza del denaro». Una lucida analisi delle nostre condizioni attuali, di cittadini-lavoratori-consumatori dei Paesi industriali, schiavi di bisogni e di merci, inventati da abili specialisti per costringerci a diventare schiavi di un crescente numero di oggetti, per spingerci a qualsiasi sacrificio pur di conquistare i nuovi «esseri ostili«? I creatori di mode sempre nuove ed effimere, i fabbricanti di merci e macchinari di breve durata, i teorici della società usa-e-getta, si propongono di soggiogare ciascuno di noi, di renderci più poveri proprio in quanto siamo spinti a possedere più oggetti. Gli organizzatori delle nuove servitù e miserie – imprenditori, proprietari dei mezzi di comunicazione, ormai essi stessi nostri governanti – ci spiegano che si può uscire dalla crisi economica soltanto consumando di più. Anzi che questo incremento dei consumi è indispensabile per la conservazione e l’aumento dei posti di lavoro, per cui i lavoratori-consumatori sono oppressori e oppressi di se stessi, dal momento che, per acquistare le merci da essi stessi prodotte, devono lavorare e farsi sfruttare sempre più intensamente. Ma chi è l’autore delle righe iniziali di questo articolo? Il filosofo Marcuse? lo scrittore Baudrillard? o Vance Packard nella sua denuncia dei persuasori occulti? Ralph Nader, l’avvocato americano dei consumatori? i sociologi della fine degli anni sessanta del Novecento? Nessuno di loro. La citazione si trova nel terzo di quattro quaderni incompiuti scritti a Parigi dal marzo al settembre 1844, da un giovanotto ventiseienne, Karl Marx (1818-1883). Quella del 1844 fu un’estate fondamentale per Marx che a Parigi incontra Engels; da qui comincia la grande avventura dei due giganti. I quaderni in cui furono raccolti i pensieri di Marx di quella primavera-estate, dopo aver girato a lungo, furono pubblicati per la prima volta a Berlino nel 1932, proprio alle soglie dell’avvento del nazismo, col titolo: «Manoscritti economico-filosofici del 1844». I «manoscritti» furono tradotti in italiano, indipendentemente, da Delio Cantimori, da Galvano Della Volpe e da Norberto Bobbio fra il 1947 e il 1949. La * UNIVERSITÀ DI BARI – [email protected] 47 traduzione ed edizione critica di Norberto Bobbio furono pubblicate da Einaudi nel 1949 e poi di nuovo nel 1968, con varie ristampe. Negli anni sessanta del Novecento, sull’onda della contestazione giovanile ed ecologica, i «Manoscritti del 1844» divennero un libro di culto per la freschezza e attualità della critica della società dei consumi e per la lucidità con cui è impostato il rapporto uomo-natura. Per buona memoria delle più giovani generazioni di ecologisti vorrei ricordare queste poche righe: 48 «L’uomo (come animale) vive della natura inorganica, e quanto più universale è l’uomo dell’animale, tanto più universale è il regno della natura inorganica di cui egli vive. Le piante, gli animali, le pietre, l’aria, la luce, ecc. costituiscono anche praticamente una parte della vita umana e dell’umana attività. L’uomo vive fisicamente soltanto di questi prodotti naturali. Che l’uomo viva della natura vuol dire che la natura è il suo corpo, con cui deve stare in costante rapporto». Ma poco dopo, sempre in questo «primo» manoscritto, Marx ricorda che «l’animale costruisce seconda la misura e il bisogno della specie, a cui appartiene, mentre l’uomo sa produrre secondo la misura di ogni specie; l’uomo costruisce anche secondo le leggi della bellezza». Un tema che Marx riprenderà nel 1867, nel quinto capitolo del primo libro del «Capitale» nel celebre passo che distingue fra il lavoro dell’ape e quello dell’architetto. Non si dimentichi che il 1844 appartiene a un periodo fecondissimo per lo sviluppo delle scienze naturali. Negli anni 40 Liebig getta le basi delle leggi della nutrizione vegetale e introduce la «legge del minimo»; Darwin era tornato da poco dal suo viaggio intorno al mondo con la nave Beagle (1831-1836) e stava meditando, nella sua casa nella campagna inglese, sui rapporti fra le specie viventi e il loro ambiente che troverà compiuta espressione nel 1859 con il libro «Sull’origine delle specie». Il 1844 precede di molto la prima edizione, del 1864, del celebre libro di George Marsh su «L’uomo e la natura» e la pubblicazione, nel 1866, della conferenza di Haeckel in cui viene usata per la prima volta la parola «ecologia». Nella primavera-estate del 1844 il pensiero di Marx si svolge così dalla analisi, di influenza hegeliana, della posizione dell’uomo nella natura, un uomo che è un animale, in quanto appartiene alla natura, ma è un animale «speciale». Passa poi a considerare come la società basata sulla proprietà privata metta gli esseri umani uno contro l’altro, per la conquista delle merci e per la sopraffazione. L’origine, la fonte, e, nello stesso tempo, il prodotto, il risultato e la conseguenza necessaria del lavoro alienato è la proprietà privata, il cui carattere e ruolo sono ripresi nel secondo, il più breve, dei «Manoscritti». Come la proprietà privata condizioni non solo il lavoro, ma anche i bisogni umani è descritto in modo suggestivo nel terzo dei «Manoscritti», di cui riproduco alcuni passi nella traduzione di Norberto Bobbio (i corsivi sono nel testo). «Abbiamo visto quale significato abbia, facendo l’ipotesi del socialismo, la ricchezza dei bisogni umani, e quindi tanto un nuovo modo di produzione quanto anche un nuovo oggetto di produzione... Nell’ambito della proprietà privata il significato opposto. Ogni uomo s’ingegna di procurare all’altro uomo un nuovo bisogno, per costringerlo a un nuovo sacrificio, per ridurlo a una nuova dipendenza e spingerlo a un nuovo modo di godimento e quindi di rovina economica. Ognuno cerca di creare al di sopra dell’altro una forza essenziale estranea per trovarvi la soddisfazione del proprio bisogno egoistico». «Con la massa degli oggetti cresce quindi la sfera degli esseri estranei, I creatori di mode sempre nuove ed effimere, i fabbricanti di merci e macchinari di breve durata, i teorici della società usae-getta, si propongono di soggiogare ciascuno di noi, di renderci più poveri proprio in quanto siamo spinti a possedere più oggetti IDEE ai quali l’uomo è soggiogato, e ogni nuovo prodotto è un nuovo potenziamento del reciproco inganno e delle reciproche spogliazioni. L’uomo diventa tanto più povero come uomo, ha tanto più bisogno del denaro, per impadronirsi dell’essere ostile, e la potenza del suo denaro sta giusto in proporzione inversa alla massa della produzione; in altre parole, la sua miseria cresce nella misura in cui aumenta la potenza del denaro. Perciò il bisogno del denaro è il vero bisogno prodotto dall’economia politica, il solo bisogno che essa produce». «Così si presenta la cosa anche dal punto di vista soggettivo: in parte l’estensione dei prodotti e dei bisogni si fa schiava – schiava ingegnosa e sempre calcolatrice – di appetiti disumani, raffinati, innaturali, e immaginari.... Il produttore, al fine di carpire qualche po’ di denaro e di cavare gli zecchini dalle tasche del prossimo cristianamente amato, si adatta ai più abietti capricci dei propri simili, fa la parte di mezzano tra i propri simili e i loro bisogni, eccita in loro appetiti morbosi, spia ogni loro debolezza per esigere poi il prezzo dei suoi buoni uffici». Lo stile e i termini sono quelli di uno scrittore di un secolo e mezzo fa, ma l’immagine che viene data della società corrisponde perfettamente a quella che abbiamo sotto gli occhi anche oggi: vengono inventate merci non per soddisfare bisogni, ma per asservire ogni persona a nuovi acquisti; vengono creati con le più raffinate tecniche, nuovi bisogni per mettere in concorrenza gli esseri umani fra loro, fin dalla più tenera età, colpendo in questo maggiormente le classi meno abbienti che sono costrette a cercare più guadagni, leciti e illeciti, per ridursi a sempre nuove dipendenze. Nel terzo «Manoscritto» seguono poi alcuni passi sulla città e sulle abitazioni, che spiegano bene come la conquista della casa non solo debba essere pagata, ma pagata a caro prezzo dalla speculazione che assicura case in zone affollate, con l’aria e le acque contaminate; il tema del degrado urbano si ritroverà tante volte nelle opere di Marx e di Engels, fino all’«AntiDühring» di Engels del 1878. «Lo stesso bisogno dell’aria aperta – continua il terzo dei «Manoscritti del 1844» – cessa di essere un bisogno nell’operaio; l’uomo ritorna ad abitare nelle caverne, la cui aria però è ormai viziata dal mefitico alito pestilenziale della civiltà, e ove egli abita ormai soltanto a titolo precario, rappresentando esse per lui ormai una estranea potenza che può essergli sottratta ogni giorno e da cui ogni giorno può essere cacciato se non paga. Perché egli questo sepolcro lo deve pagare. «La casa luminosa, che, in Eschilo, Prometeo addita come uno dei grandi doni con cui ha trasformato i selvaggi in uomini, non esiste più per l’operaio. La luce, l’aria, ecc., la più elementare pulizia, di cui anche gli animali godono, cessa di essere un bisogno per l’uomo. La sporcizia, questo impantanarsi e putrefarsi dell’uomo, la fogna (in senso letterale) della civiltà, diventa per l’operaio un elemento vitale. Diventa un suo elemento vitale il complesso e innaturale abbandono, la natura putrefatta». Dopo aver esaminato come l’economia politica governa e orienta i bisogni umani al servizio del guadagno e del profitto dei capitalisti, Marx parla dell’organizzazione della produzione. «Il senso che la produzione ha relativamente ai ricchi, si mostra manifestamente nel senso che essa ha per i poveri: verso l’alto la sua manifestazione è sempre raffinata, dissimulata, ambigua, pura e semplice 49 apparenza; verso il basso è grossolana, scoperta, leale, vera e propria realtà. Il bisogno rozzo dell’operaio è una fonte di guadagno assai maggiore che il bisogno raffinato del ricco. Le abitazioni nel sottosuolo di Londra rendono ai loro padroni più che i palazzi, cioè rappresentano per loro una ricchezza maggiore, e quindi per usare il linguaggio dell’economia politica, una maggiore ricchezza sociale». 50 «E così, come l’industria specula sul raffinamento dei bisogni, specula altrettanto sulla loro rozzezza; sulla loro rozzezza in quanto è prodotta ad arte, e di cui pertanto il vero godimento consiste nell’autostordimento, che è una soddisfazione del bisogno soltanto apparente, una forma di civiltà dentro la rozza barbarie del bisogno. Le bettole inglesi sono perciò una rappresentazione simbolica della proprietà privata. Il loro lusso mostra il vero rapporto del lusso e della ricchezza dell’industria con l’uomo. E sono quindi anche a ragione i soli divertimenti domenicali del popolo trattati per lo meno con mitezza dalla polizia inglese». Sono tutti temi che Marx riprenderà molte volte nelle sue opere, ma che qui mi sembra vengano formulate con un’ironia e un vigore che non sempre si trovano nelle opere più mature. C’è una soluzione? Il giovane Marx l’individua nel «comunismo come soppressione positiva della proprietà privata intesa come autoestraniazione dell’uomo, e quindi come reale appropriazione dell’essenza dell’uomo mediante l’uomo e per l’uomo; perciò come ritorno dell’uomo per se’, dell’uomo come essere sociale, cioè umano. Questo comunismo... è la vera risoluzione dell’antagonismo fra la natura e l’uomo, fra l’uomo e l’uomo, ... tra la libertà e la necessità, tra l’individuo e la specie... L’essenza umana della natura esiste soltanto per l’uomo sociale; infatti soltanto qui la natura esiste per l’uomo come vincolo con l’uomo, come esistenza di lui per l’altro e dell’altro per lui, soltanto qui essa esiste come fondamento della sua propria esistenza umana... Dunque la società è l’unità essenziale, giunta al proprio compimento, dell’uomo con la natura, la vera risurrezione della natura, il naturalismo compiuto dell’uomo e l’umanismo compiuto della natura». Le analisi degli ultimi decenni hanno mostrato bene che la radice della crisi ecologica sta proprio nello sfruttamento privato della natura, bene collettivo per eccellenza, per ricavarne quantità sempre maggiori di merci, progettate e propagandate non per soddisfare bisogni umani, ma per costringere sempre più vaste fasce della popolazione umana a vendere il proprio lavoro per ottenere il denaro necessario per acquistare l’«essere estraneo» di cui parla Marx. Proprio alla nostra epoca è toccata la sorte di vedere attuata l’anticipazione di Marx, grazie all’asservimento di uno straordinario mezzo di comunicazione come la televisione – un mezzo che avrebbe potuto essere liberatorio, stru- Non si dimentichi che il 1844 appartiene a un periodo fecondissimo per lo sviluppo delle scienze naturali. Darwin era tornato da poco dal suo viaggio intorno al mondo con la nave Beagle (18311836) e stava meditando, nella sua casa nella campagna inglese, sui rapporti fra le specie viventi e il loro ambiente IDEE mento di diffusione di conoscenze e di solidarietà – alla pubblicità e alla vendita delle merci, alla moltiplicazione dei bisogni, alla creazione di bisogni inutili sempre meno duraturi. E non destano meraviglia le lotte per la conquista di una maggiore fetta del potere televisivo, il più efficace strumento che oggi consente di incantare sempre nuovi acquirenti di merci, capace di creare nuovi miti e modelli da scimmiottare moltiplicando le merci inutili a scapito della conoscenza, della attitudine critica, dei rapporti sociali, tarpando le ali a qualsiasi lotta per l’emancipazione. Si pensi alla «perfezione» delle tecniche per produrre rumore che sovrasta le parole, alle chat lines in cui vengono scambiate banalità per indurre a evitare di parlare (chat lines immaginate già nel 1951 da Ray Bradbury in «Fahrenheit 451», come strumento inventato dal «Governo» per impedire la lettura, per impedire di pensare «ai fiori dei campi, ai gigli sereni»). E poiché la crisi ecologica è proprio il risultato dell’espansione dei bisogni artificiali e dei consumi, non c’è da meravigliarsi che i governi di destra rimuovano i controlli e i divieti sui rifiuti, sull’inquinamento, sulla speculazione sui suoli, su qualsiasi cosa che possa rallentare i consumi e gli sprechi. La rilettura dei «Manoscritti» marxiani di un secolo e mezzo fa potrebbe fornire anche qualche nuova idea sulle linee di lotta di un efficace movimento ambientalista. Certo: è possibile sporcare un po’ meno il mare costruendo depuratori, o smaltire un po’ di rifiuti con qualche inceneritore, o salvare qualche milione di uccelli disturbando i cacciatori, e ciascuna di queste azioni è in sé lodevole, anche se alcune si limitano a spostare la violenza alla natura da una zona all’altra, dall’aria al suolo, dai Paesi ricchi a quelli poveri. Un diverso rapporto con la natura si può cercare soltanto in una critica profonda dei rapporti di proprietà, di produzione, di lavoro, di uso della scienza e della tecnica. Una rivoluzione culturale tutta da inventare e di cui non abbiamo finora modelli a cui riferirci. Le poche società che dicevano di essere socialiste e comuniste sono state spesso segnate da catastrofi ecologiche e da violenze umane perché, in realtà, esse operavano secondo le stesse regole – dell’espansione della produzione e del potere – «copiate» dalle società capitalistiche. La grande svolta a destra dei Paesi vetero-capitalistici e di quelli neo-capitalistici, sorti dalle ceneri del «comunismo reale» e dall’avvio all’emancipazione del Sud del mondo, sta rapidamente aggravando la crisi delle risorse naturali, la pressione demografica, la carica di egoismo, violenza e competizione che mette popoli contro popoli, persone contro persone. È difficile combattere le battaglie ecologiche quotidiane – che cercano di fermare gli inquinamenti, la contaminazione dovuta ai rifiuti, l’erosione del suolo, i mutamenti climatici e la perdita della biodiversità, se non si riconosce chiaramente chi è il nemico. La separazione degli esseri umani dalla natura, la competizione e la sopraffazione di ciascun uomo e di ciascun gruppo di esseri umani su altri, vanno cer- cati nelle leggi dell’attuale economia, della proprietà privata, del profitto. Forse un giorno, forse presto, la situazione ambientale dei terrestri sarà così grave da indurli a ripensare al proprio futuro in termini completamente nuovi e diversi dagli attuali: forse la rilettura di Marx, un giorno, ci aiuterà a ricordare e capire le radici della crisi e ci suggerirà qualche soluzione. E speriamo che non sia necessario aspettare un altro secolo e mezzo! 51 il terrorismo di sinistra in Italia una storia tra «affinità e divergenze»1 52 G IANNI F RESU * L ’eversione armata di matrice marxista, comparsa nel nostro Paese negli anni Settanta, ha un retroterra politico e culturale che non può certo essere ritenuto totalmente estraneo alla tradizione della sinistra e in particolare del suo più importante partito. Si è parlato spesso di «album di famiglia», ciò che è certo è che la militarizzazione della sinistra rivoluzionaria si muove e sviluppa entro un canone piuttosto tradizionale. Questo nonostante una storia, quella dei comunisti, postasi in conflitto con la concezione stessa del terrorismo e malgrado il fatto che Lenin, nella sua elaborazione e battaglia politica, abbia a più riprese combattuto la tendenza a confondere lotta rivoluzionaria e terrorismo, mostrandone differenze e incompatibilità. Un dibattito assai concreto quello tra le forze rivoluzionarie russe a cavallo tra Ottocento e Novecento, proprio per le implicazioni politiche nel rapporto tra azione e rapporti sociali. Per Lenin la lotta di classe rivoluzionaria non aveva nulla da spartire con il modo di concepire il rapporto tra politica e violenza proprio del terrorismo, frutto di una concezione individualistica che si esprimeva nella mistica del «gesto». Così, nei fatidici anni tra 1904-1905, Lenin era netto nel contrapporre lotta di classe e rivoluzione proletaria al metodo terroristico, da egli definito il «metodo specifico di lotta degli intellettuali» che non hanno alcuna fiducia nella vitalità e nella forza delle masse popolari e dunque pretendono di sostituirsi a esse attraverso l’atto individualistico: Quanto più pieno fu il successo dell’impresa terroristica, tanto più essa confermò l’esperienza fornitaci da tutta la storia del movimento rivoluzionario russo, un’esperienza che ci mette in guardia dai metodi di lotta quali il terrorismo. Il terrorismo è stato e rimane un metodo di lotta specifico degli intellettuali. E, comunque si valuti l’importanza del terrorismo, in quanto integrazione e sostituzione del movimento popolare, i fatti attestano in modo inconfutabile che gli attentati politici individuali non hanno da noi nulla in comune con gli atti di violenza della rivoluzione popolare. Ogni movimento di massa è possibile nella società capitalistica solo come movimento operaio classista. (...) Non fa meraviglia se tanto spesso, da noi, si trova tra i rappresentanti radicali (o radicaleggianti) dell’opposizione borghese gente che simpatizza per il terrorismo. Né fa meraviglia che tra gli intellettuali rivoluzionari siano particolarmente attratti dal terrorismo proprio quelli che non credono nella vitalità e nella forza del proletariato e della sua lotta di classe2. Sull’internità o estraneità del fenomeno terroristico alla storia comunista e * RICERCATORE IDEE alla tradizione del Pci, si sviluppò tra il 1977 e il ’78 un vivacissimo dibattito a sinistra, ospitato in un confronto serrato tra le pagine de «il manifesto». In uno di questi articoli, emblematicamente intitolato I figli dei bolscevichi? Rossana Rossanda contestava la tesi emergente, specie tra le fila di Lotta Continua, secondo cui in realtà il terrorismo sarebbe stato «l’ultimo figlio del Pci perché da bravo figlio lo imita e, da bravo figlio, tanto più lo imita quanto più il padre lo delude». «Quel che oggi è in atto in Italia e di cui si discute non è la violenza, ma il terrorismo, e sono due cose diverse. I partiti comunisti furono sempre violenti, fino alle ultime edizioni, quasi mai terroristi. Fra tutte le pratiche di lotta, usarono il terrorismo raramente, con circospezione e grandissimo controllo. Per due buone ragioni: la prima è che il terrorismo privilegia l’individuo (e quindi gli riconosce un potere e un ruolo e il gesto), mentre la tradizione comunista privilegia il collettivo e l’azione come tessera d’un mosaico complesso e subordinato al partito e alla sua strategia, il cui asse fondamentale è sempre altrove; in secondo luogo perché concepisce la violenza come momento terminale e transitorio d’una azione politica, le restituisce insomma un senso brutalmente ma puramente strumentale. Non si troverà, nell’agiografia comunista, nessun «eroe» ritagliato sullo schema della violenza come valore; e quanto al terrorista che ha operato contro il partito, la sua sorte è di scomparire, non solo come gesto, dalla storia»3. Nel terrorismo, scriveva ancora la Rossanda, al centro non sta né il partito né il popolo ma il gruppo con la sua capacità tecnico-militare, il terrorismo italiano insomma non puntava a costruire un soggetto politico ma a bloccare l’avversario. Dunque Lenin non c’entrava niente, e limitarsi ad «annegare» il terrorismo nell’idea della violenza, anziché considerarlo come specifica tecnica e idea della politica, avrebbe significato dare una lettura superficiale del fenomeno e soprattutto non comprendere le differenze profonde tra le manifestazioni dello scontro di classe in Italia dal dopoguerra in poi. Ritornare su questa elaborazione è importante anche se poi bisogna tener conto che la lotta armata nel suo comparire in Italia si considera tutto tranne che esperienza terroristica. Questo, se vogliamo, è un primo elemento di contraddizione che merita di essere approfondito. Il riferimento costante alla Resistenza armata contro il nazifascismo, l’idea della continuità di una la lotta di liberazione nazionale ancora da completare, la convinzione di un tradimento di quella esperienza nel suo epilogo unitario e democratico, sono alcuni dei temi più ricorrenti nel formarsi del clima culturale e delle prime esperienze organizzate di lotta armata nella sinistra italiana. Del resto non è certo un mistero che tra le pieghe del movimento partigiano comunista vi fossero consistenti aree desiderose di proseguire lo scontro armato per la creazione di una repubblica socialista. Così come non lo è il mantenimento di una struttura armata pronta a riprendere lo scontro o comunque a servirsi delle armi anche a scopo difensivo. Un esempio di questo tipo viene dalla famosa Volante rossa, nata dalla sezione del Partito comunista di un quartiere operaio di Milano, la sezione «Martiti oscuri» a Lambrate, non un gruppo clandestino autonomo ed esterno al Pci. In proposito, così ricordava Primo Moroni: «Sotto il nome della sede c’era scritto in grande Volante rossa. Questi compagni, provenienti da una brigata partigiana, sfilavano nei cortei del Partito comunista come servizio d’ordine – nel 1947-48 – con il giubbotto che portavano in montagna e la pistola personale. Sfilavano in pieno centro a Milano sotto gli occhi di tutti. Ne ho conosciuto alcu- 53 Per Lenin la lotta di classe rivoluzionaria non aveva nulla da spartire con il modo di concepire il rapporto tra politica e violenza proprio del terrorismo, frutto di una concezione individualistica che si esprimeva nella mistica del «gesto» 54 ni, mentre ero un giovane operaio alla OM nel 1950, mentre una parte dei loro dirigenti era già scappata in Cecoslovacchia. Fra questi Alvaro che era il loro comandante (…). La Volante rossa ha effettuato nella zona di Milano e del Nord più di 150 omicidi politici. C’è stata poi un’altra formazione che operava a Reggio Emilia, che ha forse operato un numero ancora maggiore di esecuzioni. C’è persino una leggenda che circola nella Bassa emiliana, secondo cui un pullman di fascisti partito da qualche Paese in provincia di Reggio Emilia per andare a onorare la tomba di Mussolini, a Predappio, non sarebbe mai giunto a destinazione (…) In realtà 35 fascisti scomparvero davvero, e di ciascuno si ha nome e cognome: questa non è leggenda4. Al tema della «Resistenza tradita» – articolatasi poi nell’idea brigatista secondo cui, con la fine della guerra, al dominio nazifascista si sarebbe sostituito quello dello «Stato Imperialista delle Multinazionali» – si aggiunge quello dell’esigenza, da parte di questi gruppi, di fronteggiare il clima venutosi a creare con il «tintinnar di sciabole» e l’avvio di una «strategia della tensione» che coinvolge apparati di sicurezza dello Stato italiano e di quello americano, congiuntamente all’eversione neofascista. Il salto di qualità si ebbe con il comparire, nelle loro forme più eclatanti, delle trame golpiste, che indussero, specie dopo la strage di Piazza Fontana, la «sinistra rivoluzionaria» allo scontro militare. I primi organismi clandestini armati, come i GAP (Gruppi di azione partigiana) guidati da Giangiacomo Feltrinelli e altri, posero nei loro documenti la necessità della resistenza armata, in rapporto ai sempre più probabili esiti golpisti della politica italiana. In questo contesto vennero costituiti i primi nuclei semiclandestini delle BR e tutte le organizzazioni politiche extraparlamentari si dotarono di servizi d’ordine e di strutture semiclandestine armate, nell’eventualità di doversi difendere da un attacco armato dello Stato. Non casualmente uno dei primi documenti delle BR venne intitolato Nuova Resistenza. Dietro questa argomentazione, ricorrente nelle analisi del fenomeno da parte degli ambienti più prossimi a quell’esperienza, sono presenti però sia elementi oggettivi di quella fase, sia tesi giustificazioniste che interpretano a posteriori la nascita della lotta armata in chiave esclusivamente difensiva. Insomma una tesi «autoassolutoria» che, per quanto plausibile, non può essere considerata soddisfacente sul piano dell’indagine storica. Un’analisi più dettagliata dovrebbe necessariamente sorreggersi su tutta la documentazione esistente del periodo che va dal 1967 al 1973, per separare quanto c’è in essa di originario e quanto di rielaborato, ma soprattutto per mettere a fuoco il posto che veniva attribuito alla violenza politica nelle concettualizzazioni del tempo e individuarne, fino in fondo, la matrice offensiva o difensiva. In proposito estremamente utili si rivelano le riflessioni contenute nell’intervista5 a una figura emblematica come Giambattista Lazagna, partigiano decorato con la medaglia d’argento e poi dirigente e amministratore del Pci. Arrestato una prima volta nel 1972, nel corso delle indagini per la morte di Giangiacomo Feltrinelli, è più volte chiamato in causa e quindi arrestato, senza alcuna prova concreta, come presunto fiancheggiatore o addirittura come eminenza grigia delle BR. In questa intervista Lazagna – impegnato negli anni Sessanta in battaglie sociali, nel sostegno ai movimenti ri- IDEE voluzionari in Asia e America Latina, e soprattutto nel riaffermare un’idea militante di antifascismo che sfuggisse alle retoriche celebrative patriottiche – parlava della sua personale esperienza e del rapporto di amicizia fraterna con Feltrinelli. Nella narrazione Lazagna spiegava due aspetti particolarmente interessanti: anzitutto il forte condizionamento esercitato dal rischio di un imminente colpo di Stato sulle riflessioni di Feltrinelli, e il fatto che l’«editore rivoluzionario» fosse tutto tranne che un dissidente antagonista rispetto alla tradizione del Pci e alla sua impostazione filosovietica. Ovverosia, Feltrinelli non era certo un corpo estraneo rispetto al Pci. Partendo dal primo punto, Lazagna ricordava quanto per Feltrinelli fosse inevitabile il colpo di Stato e come ritenesse che non ci fosse molto da fare rispetto a un colpo militare analogo a quello verificatosi in Grecia. Il problema per Feltrinelli era semmai di organizzare la resistenza dopo, attraverso la costituzione di piccole bande partigiane che attraverso la guerriglia facessero riemergere la lotta popolare. Feltrinelli era molto conosciuto in America Latina come a Cuba; e a sua volta era un profondo conoscitore di quelle esperienze di guerriglia. Dunque la sua idea era di riproporre il modello guevarista in caso di colpo di Stato, ma per predisporsi a quella ipotesi oramai inevitabile bisognava prepararsi alla resistenza armata, prima e non dopo il golpe. Secondo Lazagna invece il colpo di Stato andava contrastato anticipatamente, attraverso scioperi, manifestazioni e occupazioni, cercando il coinvolgimento popolare di massa, perché nella guerra partigiana solo i grandi scioperi avevano reso possibile l’avvio della resistenza con l’appoggio delle popolazioni. Le bombe di piazza Fontana non fecero che accrescere questa intima convinzione di Feltrinelli come di numerosi altri militanti, spingendo una intera generazione alla decisione di prendere l’iniziativa. Rispetto al secondo punto, Lazagna sottolineava i legami di Feltrinelli con la sinistra tradizionale, primo tra tutti Pietro Secchia, con i suoi miti e valori: la Resistenza e l’Unione Sovietica. «Quante volte l’ho sentito ribattere a chi criticava l’Unione Sovietica che l’Urss aveva un ruolo insostituibile di contenimento dell’imperialismo americano! L’Urss, diceva, ha questa funzione essenziale; «tutto il resto tocca a noi». (…) Feltrinelli non era antisovietico, come invece di solito veniva dipinto. La rivoluzione culturale non lo aveva commosso e proprio quando la Cina godeva di grande popolarità nella sinistra, non gli ho mai sentito fare aperture significative verso il maoismo. E non è un caso, mi pare, che l’uomo politico che gli era più vicino fosse Pietro Secchia, ossia quello che veniva indicato come l’ultimo grande rappresentante del vetero-comunismo»6. Sulla necessità di una risposta armata a un eventuale colpo di Stato, così come sull’esigenza dell’autodifesa dai gruppi neofascisti, c’era una quasi totalità di consensi, dalla sinistra rivoluzionaria agli stessi militanti del Pci. Tuttavia la continua escalation degli avvenimenti si scontrava con la sempre più diffusa consapevolezza, confermata dallo stesso Secchia, che il Pci avesse da tempo dismesso sul terreno della vigilanza quelle strutture che dalla lotta partigiana si erano conservate per il primo decennio del dopoguerra. L’angoscia provocata da questa consapevolezza, e la necessità di rispondere colpo su colpo alle provocazioni neofasciste, portarono al formarsi di servizi d’ordine sempre più militarizzati, che trovarono nella vecchia Volante rossa una fonte di ispirazione fondamentale, oltre al comparire di diverse esperienze organizzative di «Soccorso rosso» tra i vari gruppi. Certo, oltre al mito della Resistenza tradita e all’esigenza di autodifesa da neofascisti e apparati dello Stato, c’è un vero e proprio clima politico culturale che dalla contestazione degli anni Sessanta si specializza incanalandosi sempre più Nella narrazione Lazagna spiegava due aspetti particolarmente interessanti: anzitutto il forte condizionamento esercitato dal rischio di un imminente colpo di Stato sulle riflessioni di Feltrinelli, e il fatto che l’«editore rivoluzionario» fosse tutto tranne che un dissidente antagonista rispetto alla tradizione del Pci e alla sua impostazione filosovietica 55 56 in un preciso processo di definizione ideologica e di selezione militante, portando i gruppi più politicamente definiti a separarsi dalle correnti controculturali e avviare un proprio percorso di strutturazione nelle reti della sinistra rivoluzionaria. Se gli anni Sessanta erano stati contraddistinti da un fermento culturale che investì la società nel suo complesso, con un’esigenza di rinnovamento e democratizzazione a 360°, dopo il biennio ‘68-69 si ebbe un separarsi dei gruppi più politicizzati e una sempre più decisa radicalizzazione ideologica. Secondo Ermanno Gallo le radici del movimento di ispirazione rivoluzionaria in Italia, tra i Sessanta e i Settanta, andavano ricercate in due elementi: una prima radice storica e ideologica peculiare del nostro Paese, l’antifascismo; una seconda radice legata alla «composizione di classe e al tipo di produzione esistente in Italia basata sulla centralità produttiva della grande fabbrica». Rispetto al primo elemento, Gallo ripropone la tesi sopra delineata; quanto al secondo elemento, esso si ricollega alla tradizione della centralità operaia, che in Italia aveva una lunga e articolata tradizione risalente all’esperienza ordinovista nel Biennio rosso. Così per Gallo le BR nascevano su un terreno classico per la storia comunista italiana, ruotando attorno a due perni (antifascismo militante e centralità operaia) di certo non nuovi nelle pratiche e nel lessico del movimento operaio italiano. La differenza rispetto al biennio ‘68-69 si ha nelle forme perseguite più che nei riferimenti ideali. Con l’inizio dei Settanta, per un gruppo come le BR la scelta dell’invisibilità al potere, della clandestinità divenne strategica. Su questo si ebbe il superamento delle modalità organizzative tradizionali della sinistra. «Questo elemento è nuovo e importante perché ripropone aspetti presenti nella resistenza ma in una forma inedita rispetto alla metropoli. È il movimento armato che agisce all’interno dei punti nevralgici della produzione e della città, configurando per la prima volta la “guerriglia metropolitana”»7. Detto di questo mutamento però, anche le prime BR si mossero, almeno fino al 1973, su un terreno per molti versi tradizionale. Esse portarono il nucleo armato all’interno delle strutture produttive, tuttavia, l’«inchiesta operaia» restava il vero strumento ideologico con cui si cercava un radicamento e la riaffermazione della centralità operaia. Sul versante militare vero e proprio, i primi gruppi armati ancora interpretavano la funzione della violenza formale sul piano del «significato simbolico», come «azioni esemplari» che nelle forme e nel linguaggio si ricollegavano nuovamente all’immaginario dell’antifascismo militante e della lotta partigiana. «Le azioni violente di questo periodo, da parte delle formazioni lottarmatiste sono simboliche, emblematiche, a contenuto sociale forte, ma mai cruente». Il vero spartiacque che portò i gruppi dell’eversione armata, le BR in particolar modo, ad abbandonare le azioni violente dimostrative, ad alto valore mediatico-simbolico, per adottare lo scontro militare vero e proprio, il «muro contro muro», si ebbe nel biennio 1974-75 trovando la sua base essenziale nelle profonde trasformazioni che investirono il ciclo produttivo, e dunque anche la cosiddetta «composizione di classe», nel 1973. In quell’anno prendeva il via la più grande ristrutturazione produttiva dal dopoguerra che puntava a sostituire i vecchi metodi tayloristi e a realizzare una frammentazione della produzione attraverso il decentramento produttivo (o delocalizzazione) e la creazione di tante piccole unità produttive. È la premessa fondamentale del lavoro in conto terzi che ha poi segnato i decenni successivi. Tutto questo aveva delle conseguenze immediate sulla soggettività politica della classe operaia e la sua capacità di incidere sui reali processi sociali e politici. Con la produzione fordista, lungi dal diventare il «gorilla ammaestrato» IDEE (Gramsci lo aveva ampiamente previsto nelle note sull’Americanismo), l’operaio raggiunse i livelli più alti di coscienza, capacità organizzativa, compattezza politica. Con la grande fabbrica la classe operaia strappò i suoi più importanti risultati in termini di condizioni di vita e lavoro, e divenne, attraverso il conflitto, un soggetto realmente determinante per gli equilibri del Paese. Nella lettura della sinistra rivoluzionaria, la ristrutturazione produttiva più che obiettivi di razionalizzazione, efficienza ed efficacia produttiva, avrebbe perseguito obiettivi politici: frammentare la classe operaia per fiaccarla e indebolirla. Separare i diversi passaggi della produzione per dividere anche materialmente gli operai, introdurre stratificazioni molteplici tra figure e tipologie lavorative, ridurre il livello di sindacalizzazione e politicizzazione delle masse operaie. In sostanza l’obiettivo sarebbe stato espungere il conflitto sociale e realizzare un nuovo equilibrio – a proprio vantaggio – tra economia e politica nel Paese. Il periodo storico 1973-78 rappresenta appieno quella che negli ambienti della sinistra rivoluzionaria era definita «l’offensiva padronale». Tutto questo portò i gruppi semiclandestini della sinistra rivoluzionaria a cercare una risposta militare a questa offensiva. «Un’organizzazione come Prima linea decide che, per mantenere l’autonomia, la democrazia e il potere operaio già raggiunti in fabbrica, è necessario alzare il livello dello scontro e organizzarsi anche militarmente per reggere l’attacco padronale. Contemporaneamente nel tessuto sociale nasce e prende forza l’Autonomia operaia, organizzata o diffusa, che pur praticando la violenza non è strutturata in organizzazioni clandestine e insegue il capitale sul territorio, là dove si scompone in nuove forme di potere. Da quel momento le risposte assumono diverse forme. Quella di Pl e altri organismi come la «Walter Alasia», sostengono, per esempio, che bisogna essere presenti all’interno della fabbrica e avere contemporaneamente strutture semiclandestine. Altri movimenti di massa come l’Autonomia operaia danno risposte diverse sul territorio continuando a legare tra loro soggetti difformi anche al di fuori della fabbrica, nei luoghi più dispersi della metropoli»8. Se per un verso dunque si può dire che l’orizzonte ideologico della lotta armata di sinistra non è estraneo ai valori tradizionali e alla storia stessa della sinistra italiana, per un altro invece si deve tener conto della crisi di egemonia vissuta dal Partito comunista nel corso del dopoguerra. Non a caso la radicalizzazione del decennio ‘68-78 è stata efficacemente definita come la manifestazione di un conflitto nel quale i figli non riconoscevano più e ripudiavano i propri padri, nel quale la divaricazione delle strade porta a una incomunicabilità radicale priva di mediazioni. Trattando di questa crisi di egemonia si individuano solitamente nel 1956 e nel biennio ‘68-69 i punti nodali: probabilmente, però, bisognerebbe allargare ancora la visuale storica e comprendere le resistenze con le quali venne accettata da una parte consistente del movimento comunista il mutamento di prospettiva della «Svolta di Salerno». Con essa il Pci intraprendeva la strada dell’unità di tutte le forze antifasciste, comprese quelle stesse forze che avevano reso possibile e agevolato l’ascesa del fascismo (monarchia, esercito, liberali), rinviando la questione istituzionale su forma di Stato e forma di governo a liberazione avvenuta. Questa svolta, decisiva nel processo di liberazione dal nazifascismo, impegnava i comunisti nella ricostruzione del quadro democratico senza alcuna ambiguità tattica o «doppiezza», si trattava di una scelta strategica destinata a mutare il ruolo del Partito comunista italiano nella storia del Paese. Come è noto però, per una lunga fase la scelta democratica del Pci venne interpretata come un «abile espediente tattico», dietro la quale si sarebbe articolata la necessità di ac- 57 58 cumulare forze in vista del momento decisivo dello sbocco rivoluzionario. A tal fine intere divisioni partigiane rimasero armate, e la stessa struttura di sicurezza di cui il Pci era dotato per molti versi aveva contribuito a sviluppare l’equivoco della «doppiezza comunista». In tal senso gli accadimenti successivi all’attentato a Togliatti nel 1948 furono un primo svelarsi di quell’equivoco. L’immediato sciopero generale, le agitazioni insurrezionali spontanee, lo scontro con le forze dell’ordine, intere città che finirono immediatamente sotto il controllo delle divisioni partigiane armate: insomma «l’ora X», il fatidico momento della rivoluzione oramai giunto. L’intervento del Pci per far rientrare le agitazioni in un alveo democratico, la decisione di smobilitare la resistenza in armi per intraprendere la strada del confronto democratico – il tutto dopo le fatidiche elezioni dell’aprile che, per ragioni interne e internazionali, avevano dimostrato l’impossibilità di una via elettorale al socialismo – costituirono un brusco ritorno alla realtà sbarrando il passo alle speranze residue di una prosecuzione della lotta di liberazione nazionale verso il fine ultimo, in fasce non marginali di intellettuali, militanti e di parte degli stessi gruppi dirigenti comunisti. Un altro segnale venne in tal senso con i fatti del giugno/luglio 1960, dove però per la prima volta la contestazione esplose spontaneamente senza che il Pci potesse intervenire efficacemente nell’esercizio della sua direzione. Un episodio nel quale l’opposizione sociale superò a sinistra il partito, premessa fondamentale senza la quale difficilmente potrebbero essere comprese le peculiarità del ‘68 italiano. Ma prima di questo episodio i due momenti essenziali che segnarono la crisi di egemonia del Pci a fronte di un processo di radicalizzazione dei movimenti giovanili si ebbero con il XX Congresso del Pcus nel febbraio del 1956 e l’VIII del Pci nel dicembre successivo, nei quali venne avviata la fase della destalinizzazione affermatasi non senza resistenze tra i comunisti. Con la Conferenza sui problemi internazionali dei partiti comunisti del 1960 si determinò la rottura del fronte socialista e la divisione tra Urss e Cina. In questa spaccatura i gruppi stalinisti del Pci, delusi dalla svolta di Kruscev, trovarono un punto di riferimento internazionale dando vita a una gemmazione propria, destinata a segnare profondamente il dibattito a sinistra negli anni successivi, pur senza diventare mai grande fenomeno di massa capace di impensierire la forza del Pci. Nel 1962 il gruppo di Padova guidato da Ugo Duse ed Enzo Calò fece uscire il primo giornale di ispirazione marxista-leninista in contestazione aperta verso il Pci. Esso si riallacciava anche – nella testata – alla polemica russo-cinese chiamandosi «Viva il leninismo», così come la celebre pubblicazione dei cinesi nella quale veniva denunciato il revisionismo dell’Urss. La frattura formale si ebbe nel X Congresso del Pci, tenutosi nella fine del 1962, al quale partecipò una delegazione del partito cinese. In quel Congresso Togliatti attaccò duramente la politica del partito di Mao, che a sua volta replicò aspramente contro il segretario del partito italiano. Ne nacque, ai primi del 1963, un celebre opuscolo delle Edizioni estere di Pechino intitolato Ancora sulle divergenze fra il compagno Togliatti e noi, ampiamente diffuso tra i militanti italiani. Per la prima volta esponenti di primo piano del socialismo internazionale contestavano Togliatti presso i suoi stessi militanti, per la prima volta l’autorità del Pci veniva così profondamente messa in discussione di fronte ai comunisti italiani. In tutto questo dibattito si è formata la base ideologica dei cosiddetti gruppi m-l, i quali hanno trovato un primo momento di centralizzazione con la nascita del gruppo Edizioni Oriente nell’estate 1963. Questa prima vicenda, a cui va affiancata la nascita di Quaderni rossi, segnò un colpo fortissimo alla capacità egemonica del Pci e alla sua aspirazione a rappresentare in via esclusiva il mondo comunista in Italia. Con queste vicende si formarono, per la prima volta, gruppi e partiti a sinistra del Pci che ne contestavano il «revisionismo, l’imborghesimento, la socialdemocratizzazione». Senza l’approfondimento di queste vicende anche le peculiarità italiane del Bibliografia Aa.Vv., Dimensioni del terrorismo politico, Angeli, Milano 1979. Aa.Vv., La guerra dei sette anni, Dossier sul bandito Giuliano, Rubettino, Arcavacata di Rende (Cs) 1997. Aa.Vv., Le parole e la lotta armata. Storia vissuta e sinistra militante in Italia, Germania e Svizzera, a cura di Primo Moroni, Universale Shake, Milano 1999. Aa.Vv., Sulla violenza: politica e terrorismo, Savelli, Roma 1978. F. Battistelli, Gli italiani e la guerra, Carocci, Roma 2004. E. Bettini, Gladio la Repubblica parallela Ediesse, Roma 1996. L. Bonanate, La politica internazionale fra terrorismo e guerra, Laterza, Roma-Bari 2004. A. M. Dershowitz, Terrorismo, Carocci, Roma 2003. S. Casilio, Il cielo è caduto sulla terra! Politica e violenza nell’estrema sinistra in Italia, Edizioni Associate, Roma 2005. L. Castellano, a cura di, Aut. Op. La storia e i documenti dell’Autonomia organizzata, Savelli, Perugia 1980. C. Carr, Terrorismo, Mondadori, Milano 2002. G. De Lutiis, Il lato oscuro del potere, associazioni politiche e strutture paramilitari segrete al 1946 ad oggi, Editori Riuniti, Roma 1996. D. della Porta, Il terrorismo di sinistra, Il Mulino, Bologna 1990. M. Flores, Tutta la violenza di un secolo, Feltrinelli, Milano 2005. I. Fetscher, Terrorismo e reazione, Il Saggiatore, Milano 1979. M. Fossati, Terrorismo e terroristi, Bruno Mondadori, Milano 2003. W. Laqueur, Il nuovo terrorismo, Corbaccio, Milano 2002. A. Natoli, a cura di, Antifascismo e partito armato. Crisi di egemonia ed origini del terrorismo, Ghiron, Genova 1979. M. Juergensmeyer, Terroristi in nome di Dio, Laterza, Roma-Bari 2003. L. Napoleoni, La nuova economia del terrorismo, Marco Troppa, Milano 2004. C. Reuter, Storia e psicologia del terrorismo suicida, Longanesi, Milano 2004. Umberto Santino, La democrazia bloccata. La strage di Portella della Ginestra e l’emarginazione della sinistra, Rubettino, Arcavacat di Rende (Cs) 1997. G. Vettori, a cura di, La sinistra extraparlamentare in Italia, Newton Compton, Roma 1974. D. Barbieri, Agenda nera: trent’anni di neofascismo in Italia / Daniele Barbieri, Coines, Roma 1976. IDEE 59 biennio ‘68-69 e i rapporti durissimi tra Pci e gruppi della sinistra rivoluzionaria negli anni Settanta sarebbero difficilmente comprensibili. Il 1968, preceduto da un decennio intenso, carico di significati politici, oltre che dal movimento dei lavoratori è stato segnato dalla crescente radicalizzazione dei ceti medi. Il movimento studentesco ha trovato quali suoi punti di riferimento la rivoluzione cubana, la resistenza vietnamita, la rivoluzione culturale. Come è stato abbondantemente scritto, si è trattato di un’esplosione sviluppatasi al di fuori delle previsioni dei partiti tradizionali e dello stesso Pci. Le difficoltà di rapporti tra movimento e Pci, accentuatesi ulteriormente con le svolte di Berlinguer nella metà degli anni Settanta, sono il segno più evidente di quella crisi di egemonia. Da un lato il Pci bollava con sempre più facilità il radicalismo del movimento con aggettivi come diciannovismo, sovversivismo piccolo-borghese, sinistrismo; dall’altra il movimento vedeva sempre più nel partito una controparte più che il suo alleato naturale. In questa distanza si è creato un cortocircuito come quello che ha investito la sinistra in Italia negli anni Settanta, con gli esiti drammatici che tutti conosciamo. Tra gli approfondimenti che bisognerebbe approntare un posto di rilievo spetta all’analisi delle teorizzazioni, dei documenti e delle prese di posizione (ufficiali e non) del Pci sul movimento prima e sulla lotta armata poi. Uno studio che metta in luce alcune contraddizioni particolari, che hanno reso possibile il comparire del terrorismo all’interno di un quadro politico che, come abbiamo visto, non era al di fuori della tradizione comunista o che, sicuramente, non era riconducibile alle aree controculturali di contestazione movimentista. I primi nuclei delle BR si formarono infatti tra operai ed ex militanti del Pci (tipico il caso di Franceschini) o comunque si coagularono tra quadri ben poco coinvolti dal clima di contestazione se vogliamo libertaria del ’68. Chiaramente, per comprendere tutto questo e affrontare le contraddizioni ivi presenti, non ci si può limitare all’analisi endogena della storia della sinistra, ma è necessario allargare il campo alla storia d’Italia del secondo dopoguerra affrontando il tema del rapporto tra violenza e politica in riferimento alle classi dirigenti italiane e al fronte che, proprio sul terreno più propriamente militare, si è opposto alla crescita della sinistra, e segnatamente del movimento comunista, nel nostro Paese. Ovverosia, è necessario indagare sui rapporti tra istituzioni, forze economiche, aree politico-culturali conservatrici e gruppi neofascisti, perché se è vero che da un certo momento in poi a sinistra esplode il problema del rapporto tra violenza e politica, lo è ancora di più il fatto che, sull’altra barricata, l’opera di contrasto per il mantenimento dello Status quo economico sociale in Italia si sia avvantaggiata dell’utilizzo sistematico della violenza, sia mirata, sia indiscriminata, oltre che di tutti gli apparati egemonici connessi all’esercizio del potere. 1. Il presente saggio costituisce un primo ragionamento nell’ambito di un’indagine più ampia a carattere storico, che verrà pubblicata col titolo Violenza, politica e potere in Italia nel secondo dopoguerra. 2. Lenin, Opere Complete, Editori Riuniti, Roma, 1976, Vol. VIII, pp. 12, 13. 3. R. Rossanda, I figli dei bolscevichi?, «il manifesto», 25 gennaio 1978. 4. Le parole e la lotta armata. Storia vissuta e sinistra militante in Italia, Germania e Svizzera, a cura di P. Moroni, Shake edizioni, Milano, 1999, pag. 26. 5. Antifascismo e partito armato. Crisi di egemonia ed origini del terrorismo. A cura di A. Natoli, Ghiron, Genova, 1979. 6. Intervista a G. B. Lazagna, Ivi, pag. 23. 7. E. Gallo, in Le parole e la lotta armata, op. cit. pag. 59 8. Ivi, pag. 54. 60 MANUELE BONACCORSI INTRODUZIONE L’AUTUNNO È ARRIVATO CE N’EST QU’UN DÉBUT Mentre scriviamo lo sciopero generale è nell’aria. Tutte le più importanti categorie (pubblico impiego, commercio, metalmeccanici, scuola, università) hanno indetto giornate di mobilitazione. Il primo scorcio d’autunno ha già riempito le piazze, con un livello di partecipazione che non si vedeva da anni. Un colpo di reni che rimette in piedi l’intera società italiana, insperato perché giunto dopo una dura sconfitta politica, dopo anni di arretramento, nel bel mezzo di una crisi profonda e devastante nei suoi influssi per l’economia reale. L’onda degli studenti ha riempito le piazze, gridando con un’intensità difficile da ritrovare nel passato (a meno di non voler fare un passo indietro ad alcuni decenni fa); la sinistra politica ha riaperto uno scenario di opposizione, con due immense manifestazioni. Il pubblico impiego ha rotto l’assedio della vergognosa campagna contro i fannulloni. I lavoratori del commercio, vittime di un durissimo contratto separato che li spoglia della possibilità di contrattare gli orari e rende la domenica un giorno di lavoro come gli altri, hanno manifestato a Roma. E anche i metal- CE N ’ EST QU ’ UN DÉBUT meccanici, pur messi in ginocchio dall’ondata di cassa integrazione che sta investendo il sistema produttivo del Paese, hanno proclamato una giornata di sciopero, il 12 dicembre: una data che potrebbe diventare una serrata dell’intero Paese, dalle università occupate alle scuole, fino al pubblico impiego. Uno sciopero generale, punto di arrivo di un movimento crescente, che mette insieme studenti e operai, dipendenti pubblici e lavoratori del terziario. Con l’obiettivo di imporre la propria agenda a un Paese fino a poche settimane fa frastornato, e di cambiare in profondità, nel suo cuore rappresentato dalla legge finanziaria, la politica economica del governo. Lo slogan di tutti potrebbe essere proprio quello degli studenti, noi la crisi non la paghiamo. Perché è proprio la crisi a dare corpo e sostanza a questo autunno caldo. È questa la più grande sorpresa: si lotta proprio nel momento in cui sembrerebbe più difficile farlo, dinanzi a una recessione, quando – direbbe qualcuno. non c’è nulla da distribuire. Invece è proprio la crisi la goccia che fa traboccare il vaso di un Paese in ginocchio. Dicono gli studenti, i metalmeccanici, i lavoratori del terziario e del commercio, gli assistenti di volo di Alitalia, i precari di Stato e gli impiegati, che altri sacrifici non possono essere più accettati. Che una diversa distribuzione della ricchezza è una necessità ormai impossibile da rinviare. La crisi dei mercati, che ha presto esteso il contagio alla già debilita- ta economia reale del Paese, rafforza questa richiesta, contiene nelle sue parole d’ordine il bisogno di una trasformazione radicale. Il Paese conquistato dalla destra, che con forza prova a imporle il suo dettato – interessi privati, guerra tra poveri, stretta autoritaria – è meno facile da domare di quanto immaginato. Prova a imporre un’uscita dalla crisi opposta a quella offerta da chi vorrebbe far pagare ai più i disastri di pochi. In questo numero della nostra rivista proviamo a fare un punto di alcuni tra i tanti conflitti in corso. Quelli che riguardano i servizi: scuola, università, pubblico impiego e trasporti. A scrivere sono i diretti interessati, sindacalisti e rappresentanti dei lavoratori. Raccontano da dentro le loro battaglie, ne spiegano l’origine e le prospettive. Forniscono un quadro unitario, spiegando come i singoli conflitti siano parte di un disegno unitario di assoggettamento del lavoro, di distruzione del welfare e dei servizi sociali. Come una singola battaglia può far parte di un conflitto più ampio. Quello che, insieme, stiamo costruendo in questo autunno. 61 62 MARCO TRASCIANI (segretario circolo Alitalia Prc) ALITALIA: SIAMO LA BRACE SOTTO LE POLTRONE DELLA CAI Dietro la vicenda Alitalia c’è il tentativo di sferrare un attacco a tutto il mondo del lavoro, affondando le relazioni sindacali e comprimendo salari ormai ai limiti della sussistenza.La risposta dei lavoratori è stata dura e decisa: l’azienda siamo noi, non il capitalismo speculativo che ha preso in mano la compagnia di bandiera. Quando ci riferiamo alla vicenda Alitalia come a un laboratorio sociale e politico denso di implicazioni, intendiamo alludere alle numerose questioni che essa ha posto e continua a porre all’intera comunità nazionale, ai suoi cittadini, ai suoi lavoratori. Questioni nelle quali si intrecciano, in modo anche drammatico, politiche governative, obiettivi dell’imprenditoria italiana, prospettive della condizione lavorativa nel nostro Paese. Governo e capitalismo speculativo Innanzitutto, su un piano generale, la vicenda della privatizzazione e vendita del gruppo conferma la disponibilità dell’attuale governo a favorire iniziative imprenditoriali prive di respiro strategico, anzi caratterizzate da una spiccata propensione alla speculazione finanziaria. Questo tipo di visione dell’attività di governo risulta ancora più odiosa quando, come in questo caso, sono in gioco «asset strategici» fondamentali. Non può essere poi trascurato il fatto che, per portare a compimento l’intera operazione, si è costantemente realizzata una forzatura CE N ’ EST QU ’ UN DÉBUT della legislazione vigente, costruendo regole utili all’occorrenza, operando nel convincimento che la legalità possa essere violata senza conseguenze preoccupanti. Nel corso di meno di un mese il governo ha prima modificato la legge che regola la ristrutturazione e gestione dei gruppi industriali che versano in gravi condizioni finanziarie, poi ha spinto il Cda di Alitalia a dichiarare lo stato di insolvenza, evento propedeutico al commissariamento dell’azienda. A questo punto è stato nominato un commissario che – invece di bandire una vera gara di vendita, come sarebbe stato lecito aspettarsi – ha preso a trattare con un gruppo di imprenditori, da più parti indicati come l’unica soluzione possibile, mostrando, nell’esercizio del suo operato, di non essere assolutamente in grado di muoversi in modo imparziale e indipendente. Ovviamente la carta dell’imminente fallimento aziendale è stata costantemente giocata per minimizzare il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali. In questo quadro si è venuto compiendo un disegno, messo a punto da Berlusconi fin dalle prime battute della trattativa intavolata dal governo Prodi con Air France, che dietro la copertura della necessità di mantenere la «italianità» della compagnia, mirava a favorire una cordata di imprenditori amici e a regalare alla Lega Nord una soluzione che consentisse di rimettere in discussione il ruolo che il mercato e l’evoluzione del trasporto aereo nazionale avevano nell’ultimo quinquennio assegnato a Fiumicino. Nel totale silenzio della stampa e delle forze politiche, salvo rare eccezioni, quello che comunque poteva e doveva essere considerato ancora un gruppo industriale pubblico di notevoli dimensioni ed enorme rilievo simbolico e strategico, è stato offerto in vendita attraverso un meccanismo di valutazione assolutamente non trasparente. Il primo punto oscuro è quello che ha visto Banca Leonardo, scelta quale advisor per stabilire il valore di Alitalia, essere presente, sotto altre vesti, tra i potenziali acquirenti. Per non parlare della norma che ha consentito di sezionare il corpo aziendale in parti «buone», quelle su cui la cordata ovviamente ha concentrato le sue mire di acquisto, e parti «cattive» cui accollare tutti i debiti, da scaricare poi sui cittadini. Basti pensare che secondo quanto è dato apprendere, visti i contorni oscuri dell’operazione, la cifra offerta per la parte «buona» della compagnia varrebbe di 300 milioni di euro, a fronte di una valutazione della sola flotta, secondo il bilancio certificato del 2007, di circa 1,7 miliardi. Va ribadito che non si tratta solo di una «svendita» abilmente camuffata, ma di un’operazione che, da un punto di vista strettamente industriale, penalizza l’intero sistema Paese sotto molti punti di vista. Innanzitutto, come ha ben messo in luce un gruppo di studiosi dei sistemi di trasporto dell’Università Bicocca, dalla fusione delle due maggiori aziende di trasporto aereo in Italia, Alitalia e Air One, risulterebbe una diminuzione dell’offerta di posti disponibili sul territorio nazionale di circa il 30%. Una cifra enorme, che testimonia il carattere di semplice «maschera» dell’operazione assunta dalla proclamata difesa dell’italianità. Tale contrazione di attività è in grado di produrre un effetto distruttivo devastante sull’intero trasporto aereo nazionale, determinando una gravissima crisi occupazionale, poichè ai circa 10.000 cosiddetti esuberi, derivanti dal piano di ristrutturazione, devono aggiungersi tutti quelli relativi alle attività dell’indotto (aeroporti, fornitori ecc.) Ad esempio, la sola scomparsa delle attività Cargo Alitalia da Fiumicino, cioè di un segmento di attività che impiega 500 lavoratori diretti, determinerebbe la chiusura di 200 aziende di spedizione presenti nel territorio attorno al «sedime aeroportuale», traducibili in circa 3000 occupati. Poi, nella visione fin qui esplicitata, diverrebbero superflue le attività più qualificate legate alla navigazione aerea, tipo la manutenzione pesante, che necessitano di un grande Hub internazionale per essere generate, cancellando un’attività tecnica specialistica nella quale esiste una tradizione invidiabile. Capitalismo senza rischi né responsabilità sociale Il laboratorio Alitalia, abbiamo detto, ci racconta di cosa sia oggi il capitalismo italiano. La cosiddetta Cai, cioè la cordata di imprenditori che, grazie ai favori del governo, ha acquistato Alitalia per pochi spiccioli, si è mossa cercando di conseguire un duplice successo. Innanzitutto su un piano simbolico, generale, negando all’azienda di trasporto aereo nazionale qualsiasi orizzonte futuro di azione che non fosse legato alla ricerca di un profitto da conseguire nel breve periodo, mistificando il carattere di bene comune che l’Alitalia, come azienda pubblica, manteneva. Inoltre, sul piano delle relazioni industriali, attraverso lo stile del diktat ultimativo, prendere o lasciare, ha cercato in un colpo solo di superare il contratto collettivo nazionale di lavoro introducendo un contratto aziendale, al fine di mettere nell’angolo il sindacato, comprimere i salari ed affermare la natura non negoziabile della direzione di impresa. Tutta la trattativa ha messo in luce come fosse importante stabilire il primato della direzione di azienda e della valorizzazione del capitale. Ovvia- 63 mente, quale contraltare di una tale impostazione, è stata costantemente palesata la indisponibilità a considerare le competenze acquisite dai lavoratori nel corso della loro esperienza lavorativa come fattore decisivo per il funzionamento della futura azienda. In sostanza la nuova proprietà ha fatto il possibile per negare il valore del «fattore umano» come componente fondamentale del funzionamento dell’impresa, nel tentativo di liberarsi dei «lacci» che un «patto» con il lavoro, o i suoi rappresentanti sindacali, comunque implica. Alitalia siamo noi 64 È in questo contesto che si è innescata la miccia della mobilitazione contro il piano di ristrutturazione e il contratto unico aziendale proposto da Cai e si è prodotto quel sentimento di autorappresentazione dei lavoratori come corpo vivo dell’impresa che ha caratterizzato le giornate più intense di partecipazione e di lotta. Questo sentimento, espresso nei cori che scandivano «Alitalia siamo noi», è stato nutrito da due istanze, tra loro peraltro fortemente connesse: da un lato il rifiuto della logica della divisione tra bad company, quella che muore gravata dal debito, e good company, quella che può vivere se sfrutta di più e meglio i lavoratori; ben riassunto dallo slogan: «meglio falliti che in mano a ‘sti banditi»; dall’altro i lavoratori hanno rappresentato l’azienda come un bene di chi ci lavora: un sentire fortemente contraddittorio, ma non per questo debole, basato sulla constatazione che i lavoratori sono stati i soli a manifestare un senso di responsabilità invece assente nei nuovi acquirenti, nel vecchio management e nella classe politica. Sulla trama di questi elementi un ruolo determinante è stato svolto dalla questione salariale. Con un elemento simbolico fortissimo anche in questo caso. Non era chiaramente proponibile il vecchio logoro argomento degli alti salari quale fattore di scarsa produttività cui imputare la crisi aziendale. Infatti l’incidenza del costo del lavoro sul fatturato Alitalia è del 19%, un valore di ben 7 punti percentuali più basso rispetto ad Air France o Lufthansa, dove il costo del lavoro incide per il 26%. L’obiettivo dichiarato era di rompere un complesso di relazioni strutturate e consolidate tra impresa e organizzazioni dei lavoratori. Il tentativo, poi parzialmente rientrato, di comprimere ulteriormente salari appena superiori al livello di mera sussistenza (1200-1300 euro, tanto per capirci) mirava a questo, ma ha determinato reazioni estremamente dure, tali da far intendere che si stesse oltrepassando un limite non valicabile, quello oltre il quale la disponibilità della forza lavoro non era più garantito. C’è ancora da sottolineare alcuni aspetti di novità delle mobilitazioni su cui vale la pena riflettere e consegnare a un ragionamento collettivo di più ampio respiro. Innanzitutto la maggior parte delle mobilitazioni è stata vissuta scarsamente su una preparazione sindacale e ha dovuto il suo successo molto di più all’utilizzo di canali informali spontanei che a un’attivazione preordinata. Inoltre, si è sperimentato un tentativo di coinvolgere gli utenti del servizio. Da un lato, il servizio era garantito, sia in volo che a terra; dall’altro, cortei più o meno spontanei percorrevano l’aeroporto di Fiumicino, stimolando la solidarietà dei passeggeri. Infine, di nuovo, la matura consapevolezza che l’azienda rappresenta il prodotto dell’attività di cooperazione tra tutti i singoli agenti, dell’intelligenza e del lavoro delle persone, del carico di passioni e di emotività che i lavoratori si portano dietro e che nel lavoro trovano modo di esprimere. L’esito della vicenda proprietaria e sindacale ha generato un senso di frustrazione, che però è auspicabile possa costituire l’humus da cui ripartire per ipotizzare scenari futuri di liberazione e di lotta. La speranza è che da Alitalia, nonostante l’enorme costo umano e sociale finale, soffi un vento nuovo, capace di ostacolare la reazione confindustriale, la quale usa il tempo della crisi come occasione per un’ulteriore compressione dei salari. Che il piano della nuova compagnia di bandiera non sia affatto accompagnato dal consenso dei lavoratori, proprio perché estorto sull’orlo della minaccia del fallimento, è un fatto che lascia accesa la brace sotto le sedie dei «capitani coraggiosi» della cordata Cai. CE N ’ EST QU ’ UN DÉBUT 65 MARIA CRISTINA ROSSI (presidente del Comitato Insegnanti Precari di Roma) LA RIFORMA DEL MINISTRO UNICO Tagli indistinti per racimolare otto miliardi di euro. Migliaia di docenti precari rischiano di perdere il posto di lavoro. Ma l’assalto del governo non si ferma qui. In altri due disegni di legge si apre alle fondazioni anche nelle scuole, si sostituiscono i consigli d’istituto con Consigli d’amministrazione, si dividono i docenti in classi di merito, si cancella la rappresentanza sindacale d’istituto. La ministra Gelmini è riuscita a far approvare la sua prima legge: la 169/08. L’approvazione ha una data significativa: 29 ottobre 2008. Il ddl 137 è stato presentato il primo settembre, quindi la legge 169, che ha convertito il ddl 137, è arrivata in tempo utile per la sua definitiva conversione, in extremis possiamo dire. Il governo ce l’ha fatta, malgrado due scioperi (di Unicobas il 3 ottobre e dei Cobas, Cub, Sdl, il 17 ottobre) e diverse manifestazioni (scuole e università occupate, sit-in di protesta e un sempre più forte movimento di opposizione all’interno della scuola e dell’università). È giunto in ritardo, invece, lo sciopero generale della scuola proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda per il 30 ottobre, proprio il giorno dopo la conversione del decreto. Eppure, lo sciopero ha avuto una vasta adesione, come testimonia la partecipazione ai cortei e alle manifestazioni su tutto il territorio nazionale, e in particolar modo, a Roma. Occorre chiedersi dunque come mai il personale della scuola e dell’università abbia aderito a uno sciopero che è arrivato a legge approvata, malgrado ci fosse già stata una 66 larga adesione allo sciopero del 17 ottobre (una buona parte del personale della scuola ha dunque sostenuto il peso di ben due giornate di sciopero nello stesso mese). Per dare una spiegazione adeguata di questa partecipazione, però, non mi limiterò a esporre i contenuti del ddl 137 – oramai ben noti alla cronaca – ma mi riferirò principalmente a un altro capitolo importante dell’iter della legislazione di questo governo in materia di scuola, scritto con la stessa eccessiva rapidità: il ddl 112 del 25 giugno, convertito in legge il 6 agosto. La legge 133/08 è una vera e propria Finanziaria, pertanto riguarda proprio tutti e tutto, anche la scuola, ma non certo per aumentare le risorse a essa destinate. Basta leggere l’articolo 64, che dice tutto sui tagli che si preannunciano per il prossimo triennio. Per brevità cito il comma 6 come esempio di chiarezza espressiva: «Dall’attuazione dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1650 milioni per l’anno 2010, a 2538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012». In totale circa otto miliardi di tagli, annunciati come «disposizioni in materia di organizzazione scolastica». In che consistono nello specifico queste disposizioni, in questi giorni di protesta, lo abbiamo saputo solo in parte, proprio perché la protesta si è incentrata principalmente contro il ddl 137. Ma, sempre riferendoci all’art. 64 della 133/08, apprendiamo che c’è molto di più: – comma 1: incremento graduale, di un punto, del rapporto alunni/docente, da realizzare entro l’anno scolastico 2011/2012; – comma 2: riduzione complessiva del 17% della consistenza numerica del personale Ata determinata per l’anno scolastico 2007/08; – comma 3: il ministro si attribuisce una serie di deleghe per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso al fine di raggiungere una maggiore flessibilità per l’impiego dei docenti; per la ridefinizione dei curri- cola vigenti nei diversi ordini di scuola; per la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; per la rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria; per la revisione dei criteri vigenti per la determinazione degli organici Ata; per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica; – comma 4: l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale. La riforma attraverso i tagli, dunque, prevede non soltanto il ritorno al maestro unico, ma uno stravolgimento completo dell’intero sistema scuola da attuarsi attraverso: – l’accorpamento di classi di concorso (ma non avevano fatto sì che fosse il servizio specialistico a essere privilegiato finora nella carriera di ciascun insegnante?); – la riduzione oraria delle ore di frequenza settimanale per ciascun ordine di scuola (ma la società non ci porta a saperi sempre più complessi e specialistici e di conseguenza a programmi sempre più vasti? Un esempio è proprio la legge Gelmini, che introduce l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione per un monte ore di 33 annue senza però aumentare le ore di insegnamento di storia); – l’aumento del numero di alunni per classe senza curarsi né delle ripercussioni sulla didattica, né della L.626/94 sulla sicurezza negli edifici scolastici; – la poca considerazione della formazione per gli adulti e delle scuole serali sempre al fine di ridimensionare il più possibile la rete scolastica; – la formazione professionale come sostitutiva dell’obbligo scolastico, un cavallo di battaglia dell’ex ministro Letizia Moratti. Queste misure draconiane non sono nemmeno presentate per quello che effettivamente sono: tagli indistinti e poco ponderati per racimolare otto miliardi di euro. L’art. 64 è chiarissimo: si parte dalla cifra da risparmiare per poi individuare di volta in volta, aiutati anche dalla mancata applicazione della legge Moratti, cosa, dove e CE N ’ EST QU ’ UN DÉBUT Tagli al personale docente Anno scolastico Decreto Legge Finanziaria 2008 Totale 2009/10 32.105 10.000 42.105 2010/11 15.560 10.000 25.560 2011/12 19.676 20.000 19.676 2009/10 14.167 1.000 15.167 2010/11 14.167 1.000 15.167 2011/12 14.167 2.000 14.167 Totale 67.341 87.341 Tagli al personale ATA Anno scolastico Decreto Legge Finanziaria 2008 Totale quanto risparmiare. Il governo vuole farci credere che dietro c’è una riforma e che i tagli sono addirittura funzionali alla sua realizzazione. Malgrado si scopra che in Italia i nostalgici del maestro unico siano molti, l’acceso dibattito che si scatena su grembiulini, voto in condotta e maestro unico/prevalente alle elementari non riesce, alla lunga, a nascondere l’evidenza dei fatti, ben riassunti dalla tabella che compare nel piano attuativo della L.133/08 e che viene riconfermato fedelmente nel piano integrato Gelmini presentato il 19 settembre 2008. Si guardi alla tabella qui sopra riportata. Soffermiamoci su questa tabella per chiederci: a chi si riferiscono i tagli? Più volte esponenti del governo e la stessa ministra hanno dichiarato che nessun docente e personale Ata di ruolo riceverà una sola lettera di licenziamento. Eppure quelli riportati nella tabella sono tagli in pianta organica. E allora chiediamoci: a quale categoria appartengono i lavoratori che usciranno dalla pianta organica? La risposta è fin troppo facile. Da anni il sistema scuola è predisposto a una politica di tagli senza licenziamenti, in virtù del fatto che la scuola occupa anche personale con contratto a tempo determinato. Docenti assunti il 1 settembre e licenziati il 30 giugno o il 31 agosto, che finora hanno garantito che la specializzazione in possesso del docente fosse davvero quella di ogni singola disciplina da insegnare, che il rapporto alunni/insegnante fosse perlomeno quello che una normale capienza di un’aula scolastica italiana può permettere. Certo tutto questo ha presentato enormi difficoltà, pagate a caro prezzo dai docenti iscritti nelle diverse graduatorie (quelle «di merito», in seguito al superamento del concorso ordinario, e le «ex permanenti», ora a esaurimento, per i docenti precari in possesso o di un’abilitazione conseguita tramite scuole di specializzazione – Ssis – o di concorsi riservati a chi aveva avuto modo di lavorare nella scuola senza abilitazione, o agli stessi abilitati nei concorsi ordinari). Ebbene un altro articolo importante della 133/08 è l’art. 66, comma 7, esso afferma: «le ammini- Totale 42.500 44.500 strazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell’anno precedente». Ciò significa che, sia nella scuola che nell’università, per ogni 10 unità di personale che andrà in pensione, verranno assunte solo due unità (nelle ultime tornate di assunzioni, è da precisare, si è assunto sul 50% dei posti disponibili). La condizione di precario è la diretta conseguenza di una politica sempre più tesa al risparmio sugli investimenti per la scuola e la ricerca, e sempre meno disposta a investire sulla qualità della scuola e dell’università pubblica. In tal senso Berlinguer, Moratti e Fioroni hanno tutti dimostrato di essere ministri con un portafoglio sempre meno gestito in proprio e sempre più gestito direttamente dal ministro dell’Economia. La Gelmini quindi non viene scelta a caso. È nota la sua manifesta inesperienza: non occorre che il ministro sia un interlocutore, anzi meglio che sia una comparsa, tanto non è con la trasparenza che questo governo intende operare. L’esempio più efficace è quello di un altro decreto che si occupa di tagli alla scuola: il ddl 154/08, o meglio l’art.3 del ddl 154/08. Questo decreto del 7 ottobre dovrebbe occuparsi di: «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali». Cosa c’entra dunque con la scuola? Andiamo all’art.3, Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali. Questo piano di dimensionamento si riferisce sempre all’art. 64 della 133/08 e alla citata necessità di ridimensionare la rete scolastica, la cui distribuzione in alcune zone specifiche del territorio nazionale non corrisponde affatto ai criteri di «razionalizzazione della spesa» del governo, come, ad esempio, tutte le zone collinari e montane con 67 68 piccoli Paesi. Che spreco: come si può accettare che qui le maestre debbano avere pochi alunni? E se c’è una maestra c’è anche un bidello, e magari anche un custode, e poi le spese dello stesso edificio scolastico. Uno sciupio senza fine! Pertanto si pensa di trasportare i bambini delle scuole con meno di 50 alunni nelle scuole dei comuni limitrofi più grandi con lo scuolabus messo a disposizione da questi ultimi e per il quale i comuni più grandi dovranno sostenere le spese. Conosciamo bene però la situazione finanziaria degli enti locali in Italia, quasi tutti in forte deficit. Sulla mozione sulle «classi ponte» presentata alla Camera dal leghista Roberto Cota il 16 settembre è il caso di spendere qualche parola: dobbiamo chiederci a questo punto a quali alunni si farà quel poco di scuola che rimarrà dopo la riduzione delle ore e lo snellimento dei programmi. Essenzialmente a studenti selezionati per nazionalità: una scuola che finora ha visto l’incremento del numero di alunni soprattutto grazie agli immigrati è una scuola che preoccupa. La scuola non è più quel posto dove imparare la storia e l’orgoglio nazionale, anzi meglio regionale. Rischia di diventare un luogo di incontro e di confronto. Con la scusa che i bambini immigrati non parlano adeguatamente l’italiano, dunque, li si separano dagli altri. Quale più efficace metodo per insegnare ai nostri bambini che le classi servono a separare? Io bianco nella classe di coloro che sanno, e tu nero o giallo nella classe di coloro che non sanno. Così le premesse per la società del futuro sono poste. Ma non è ancora tutto. La parte meno nota dell’intero corpus legislativo in materia di scuola di questo governo è il dl 953 a firma Valentina Aprea, presidente della Commissione Cultura. La proposta Aprea delinea un nuovo governo delle istituzioni scolastiche che come cita l’art. 1 al comma 2 comprende: «Il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, i rappresentanti degli enti locali e, su deliberazione delle singole istituzioni scolastiche, i rappresen- tanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, secondo i princìpi della presente legge». Questi dunque i nuovi protagonisti che si assumono il compito di governare la scuola, ma attraverso quale istituto? Art. 2, comma 1: «Ogni istituzione scolastica può (...) costituirsi in fondazione, con la possibilità di avere partner che ne sostengano l’attività, che partecipino ai suoi organi di governo e che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e a innalzare gli standard di competenza dei singoli studenti e di qualità complessiva dell’istituzione scolastica». E ancor meglio al comma 3: «Le istituzioni scolastiche trasformate in fondazioni definiscono gli obiettivi prioritari di intervento, prevedono le necessarie risorse economiche e individuano, mediante appositi regolamenti interni, le funzioni e gli strumenti di indirizzo, di coordinamento e di trasparenza dell’azione didattica e finanziaria». Che fine fanno dunque gli organi delle istituzioni scolastiche così come li conosciamo oggi? Il dirigente scolastico, il collegio docenti e il consiglio di istituto? Il consiglio di istituto scompare e si trasforma in consiglio di amministrazione (Art. 5 e 6) che è composto delle rappresentanze di tutte le figure citate all’art. 1, comma 2, dura in carica tre anni e tra gli altri compiti si propone di individuare i docenti esperti. Badate bene: a stabilire chi sia da considerarsi docente esperto è il Consiglio di amministrazione e non il Collegio docenti. Quali sono quindi i compiti del collegio docenti? Art. 7, comma 1: «Il collegio docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, all’elaborazione del piano dell’offerta formativa». Si limita quindi a formulare la proposta didattica. Compiti che sono da ritenersi del tutto insufficienti se andiamo a considerare la grande trasformazione che il dl Aprea si propone di operare sullo stato giuridico della figura dell’insegnante. Art. 17, comma 1: «La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di do- CE N ’ EST QU ’ UN DÉBUT cente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata». Attraverso questo istituto si potrà realizzare ciò che il governo dichiara in questi giorni: la necessità di pagare meglio gli insegnanti e, contemporaneamente, di «razionalizzare la spesa» attraverso una politica dei tagli che si traduce in una drastica riduzione delle assunzioni. A essere retribuiti meglio saranno gli insegnanti «esperti» individuati dal Consiglio di amministrazione! Non solo, al comma 4 leggiamo: «L’attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un’apposita commissione di valutazione, in ordine a: a) l’efficacia dell’azione didattica e formativa; b) l’impegno professionale nella progettazione e nell’attuazione del piano dell’offerta formativa; c) il contributo fornito all’attività complessiva dell’istituzione scolastica o formativa; d) i titoli professionali acquisiti in servizio». Un’altra considerazione importante è in riferimento al reclutamento degli insegnanti iniziali (art. 13). È prevista la formazione iniziale nei corsi di laurea magistrale (triennale) e nei corsi accademici di secondo livello (specialistica). A seguito del conseguimento di questa formazione si viene inseriti in un albo regionale sulla base del voto conseguito (art. 14), ma per svolgere l’anno di straordinariato – l’assunzione di responsabilità all’insegnamento – occorre svolgere un anno di applicazione, attraverso un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro (art. 15). In questo anno si insegna regolarmente con un contratto di formazione e l’assistenza di un docente tutor. Alla fine di questo anno un comitato di valutazione delibererà se si è conseguita o no l’assunzione di responsabilità all’insegnamento. Il docente così abilitato dovrà partecipare ai concorsi di istituto per poter accedere alla titolarità in quella data scuola. Ogni singola scuola quindi potrà o autonomamente, o in concorso con altri istituti, istituire concorsi pubblici ogni qualvolta avrà bisogno di ricoprire le carenze d’organico (art. 16). L’ultimo importantissimo punto è l’art. 22 che prevede la soppressione della rappresentanza sindacale unitaria nell’istituzione scolastica (le Rsu così come le conosciamo oggi), sostituita dalla «Rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area, composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell’area dei docenti», (comma 2). Questi sono, a mio avviso, i punti salienti del quadro legislativo del governo sulla scuola. Si tratta di provvedimenti che qualificheranno la scuola italiana, che la salvaguarderanno dai «docenti fannulloni», dalle clientele e dai favoritismi? Siamo sicuri che i nuovi «docenti esper- ti», saranno tali in virtù delle loro riconosciute capacità didattiche? E una scuola senza la Rsu di istituto – dalla quale è definitivamente escluso il personale Ata – quali garanzie avrà nei confronti dell’arbitrio di alcuni dirigenti, ai quali siamo fin troppo abituati? 69 70 ARMANDO PETRINI (ricercatore presso l’Università di Torino) L’UNIVERSITÀ IN BILICO La distruzione dell’università pubblica è iniziata negli anni Novanta, nel culmine dell’egemonia neoliberista, che ha sottomesso gli atenei alle logiche d’impresa. La prima vittima è stata la qualità. Oggi il decreto Tremonti è il colpo di grazia, che colpirà insieme ricerca e divulgazione Quando Veltroni afferma che il governo Berlusconi manca di un vero e proprio progetto politico non si sa bene se pensare al famoso «mente sapendo di mentire» o a una carenza nell’analisi politica. Si tratta probabilmente di entrambe le cose. A guardare i primi provvedimenti del governo, tutto sembra potersi dire tranne che non ci sia un preciso e robusto disegno che li giustifichi e li supporti. I casi della scuola e dell’università sono assolutamente emblematici. Fermiamoci ai provvedimenti che riguardano gli atenei. La Legge 133, il cosiddetto decreto Tremonti, prevede in particolare tre norme gravissime che rischiano seriamente di mettere in ginocchio in modo irreversibile l’università pubblica. In primo luogo viene decisa un’ul- teriore, devastante, diminuzione del Fondo di Finanziamento ordinario: 500 milioni di euro in meno per il 2009, che peggioreranno gravemente una situazione finanziaria già a dir poco drammatica. In secondo luogo è prevista la limitazione delle nuove assunzioni del personale docente e non docente al 20% dei pensionamenti. Una norma gravissima, che ingigantirà a dismisura il precariato all’interno delle università italiane, e i cui effetti saranno ancora più devastanti laddove è ben noto –per ciò che riguarda il personale docente- che nei prossimi cinque-sei anni un’alta percentuale degli attuali professori ordinari andranno in pensione. Infine, forse la norma più grave di tutte: viene introdotta la possibilità per gli Atenei di trasformarsi in fondazioni private, con tutto ciò che questo comporta in termini di ulteriore accelerazione del processo di privatizzazione dell’università italiana. Si capisce dunque come fra i temi caldi dell’autunno ci sia anche la difesa dell’università pubblica, la cui sopravvivenza è messa seriamente a rischio da questi provvedimenti. Allo stesso tempo è bene capire in quale quadro si collocano le norme del governo Berlusconi. Si scoprirà così che la Gelmini non inventa tutto. Anzi, inventa ben poco. Poiché ciò che sta accadendo è per alcuni versi l’ultimo, rovinoso, passaggio di una sciagurata politica universitaria che data almeno ai primi anni Novanta. Ma tutto ciò è naturalmente ben nascosto dai mezzi di comunicazione di massa (e dai grandi quotidiani in testa), che accreditano l’immagine di un’università roccaforte CE N ’ EST QU ’ UN DÉBUT di privilegi (l’università dei «baroni»), che questi ultimi si ostinerebbero a voler mantenere e a difendere con le unghie nonostante l’abnegazione «modernizzatrice» del Ministro. Le cose in realtà stanno in modo ben diverso. E uno sguardo più approfondito dentro l’università e anche retrospettivo nel tempo ci aiuterà a capire meglio. La privatizzazione dell’università Dalla fine degli anni Ottanta a oggi si è assistito nelle Università italiane a un imponente processo di privatizzazione. Intendiamoci: non si è trattato tanto dell’introduzione diretta del privato nelle cose universitarie (circostanza pure presente, soprattutto per ciò che riguarda le discipline scientifiche: basti pensare al finanziamento da parte di alcune aziende di interi Corsi di studio). Si è trattato in realtà soprattutto dell’introduzione della logica del privato nella conduzione degli atenei, che sono – o dovrebbero essere- cosa pubblica. Un processo molto più surrettizio e pericoloso. Prima con l’avvio dell’autonomia finanziaria, poi con il varo della «riforma» della didattica, il famigerato «3+2», si è lentamente ma inesorabilmente cercato di piegare la vita degli atenei, la progettazione della loro offerta formativa, la discussione sui loro indirizzi strategici a criteri desunti dalla logica del mercato. Così è avvenuto per la concorrenza fra le sedi universitarie (costrette spesso a inseguire gli studenti, trattati sempre più esplicitamente come «clienti» da allettare e lusingare), così è avvenuto per una malintesa domanda di efficienza (che naturalmente ha significato tagli ingentissimi alle spese, spesso essenziali, nonché una sempre più forte precarizzazione del lavoro all’interno dell’Università), o per la logica dei «crediti formativi» (in base alla quale si può quantificare ciò che non è quantificabile, secondo una prospettiva di riduzione a cosa tipico del mercato), oppure ancora per la torsione della formazione in semplice informazione (come preten- de un’ottica in cui prevale il saper fare più che il capire perché fare ciò che si vuol fare). Il tutto naturalmente è avvenuto spesso in modo soft, o per così dire mascherato. Allo stesso modo in cui le imprese nel corso degli anni Novanta hanno imparato a produrre «esuberi» piuttosto che «licenziamenti», gli atenei hanno imparato a «sviluppare sinergie con il territorio»: il che ha voluto spesso dire, naturalmente, con ciò che domina sul territorio: le logiche d’impresa. Uno sguardo più ampio Ma naturalmente sbaglieremmo a leggere i processi di trasformazione dell’università al di fuori del più ampio panorama di trasformazione della cultura e della società nello stesso periodo di tempo. Gli anni Novanta sono stati molto complessi e anche molto difficili: gli anni del pieno dispiegamento del craxi-berlusconismo, del trionfo del neoliberismo, della massima egemonia del postmoderno. Fine della storia, fine delle ideologie e fine del conflitto: intorno a questi punti cardine abbiamo ascoltato ripetere sin dagli anni Ottanta (ma appunto in un crescendo fino ai primi anni Novanta) che non si trattava più di pensare a mondi e scenari diversi e altri ma di amministrare l’esistente. Non più ingenue utopie ma scaltra realpolitik. La Dichiarazione europea di Bologna del 1999 sull’università e sulla ricerca (che auspicava un’«armonizzazione» del sistema universitario dei Paesi del vecchio continente sul modello del «3+2») va collocata per l’appunto nel momento culminante di questo clima e ha riflettuto con molta precisione quell’ideologia. I giornalisti e gli intellettuali che oggi sui quotidiani si strappano le vesti contro le clientele universitarie e i «baroni», auspicando un’americanizzazione morbida degli atenei in nome di un ambiguo e perciò dubbio criterio di efficienza, sono spesso quegli stessi giornalisti e intellettuali che hanno contribuito negli anni passati al trionfo 71 72 del cosiddetto pensiero unico. Qualcuno, cioè, che omette colpevolmente di rilevare come ciò che accade nelle università sia un riflesso (e allo stesso tempo naturalmente uno dei motori) di qualcosa che riguarda la cultura nel suo insieme: che ha dunque a che fare con il suo progressivo indebolimento, il suo svuotamento, la lenta perdita del suo ruolo di pungolo critico della società. Ma con la fine degli anni Novanta si moltiplicano i segnali di una prima incrinatura dell’egemonia del postmoderno e si riaccende la presenza del conflitto (basta citare i fatti di Genova del 2001: qualcosa che ha comunque rappresentato -pur nelle incertezze e nelle debolezze politiche dimostrate- il segno di un clima in via di cambiamento). Il dibattito delle idee torna a interrogarsi criticamente sul significato della fine della storia e delle ideologie. Romano Luperini pubblica nel 2005 un libro che riflette questo clima, il cui titolo, La fine del postmoderno, forse troppo ottimista, annuncia però il lento e faticoso ritorno a una presenza del pensiero critico (almeno nell’ambito, ancora ristretto, della discussione intellettuale). E l’Università? Ma nel frattempo uno dei risultati di quel processo di trasformazione degli atenei (qui richiamato inevitabilmente per sommi capi) è che l’Università italiana -fino a una ventina di anni fa una delle migliori al mondo (almeno in alcune discipline scientifiche e in molte umanistiche)- versa ora in condizioni drammatiche. Non per colpa solo delle «riforme» degli anni Novanta, naturalmente, ma del clima culturale complessivo in cui quelle riforme sono maturate e di cui sono state parte. Il vertiginoso abbassamento del livello delle Università è sotto gli occhi di tutti: corsi rapidi e compressi, mancanza di un vero rapporto formativo fra studenti e docenti, «tesine» finali spesso affrettate e scarsamente meditate. Anche qui bisogna intendersi. Non è che manchino corsi che prevedono autentici approfondimenti, docenti che impostino un rapporto autenticamente formativo con gli studenti, lavori di tesi molto buoni: è che si tratta ormai di vere e proprie eccezioni all’interno di uno standard ormai rivolto in tutt’altra direzione. Come ha scritto recentemente Massimo Raffaeli a proposito della critica: «non mancano affatto i singoli critici di valore; a mancare, semmai, è più generalmente lo spirito critico». Come sempre in questi casi ci sono spie linguistiche molto significative. Alcuni studenti iniziano a chiamare «scuola» l’università e «classe» l’aula. E in fondo è difficile dar loro torto. Ciò che ancora gli studenti universitari della fine degli anni Ottanta chiamavano «università» non ha nulla a che vedere con ciò che oggi l’università è diventata. Uno studioso come Raul Mordenti ha scritto recentemente che stiamo andando verso una «semplificazione distruttiva» che rasenta «l’abolizione dell’università». D’altra parte, e con buona pace dell’idea di un sicuro allargamento del numero di coloro che avrebbero dovuto accedere all’Università grazie alla «riforma», i dati Istat più recenti rivelano una diminuzione del numero complessivo delle immatricolazioni negli atenei italiani per gli ultimi due Anni Accademici per cui disponiamo dei dati. Dopo tre-quattro anni di crescita (dovuti anche alla «novità» della riforma), nel 2004-2005 le immatricolazioni calano dell’1.5%. Con l’Anno Accademico 20052006 la diminuzione si fa più consistente, raggiungendo il 4,5%: 16.000 studenti in meno. I motivi del calo, sempre secondo l’Istat, sono ben chiari agli studenti. Il 54,1% dei quali giudica ormai negativamente la qualità dell’offerta formativa delle Università italiane, e ben il 62,4% di loro -sono sempre i dati Istat a rivelarlo- ritiene che il nuovo sistema formativo stia peggiorando la preparazione complessiva dei laureati. Una questione etica Ma i processi culturali e sociali non sono mai ineludibi- CE N ’ EST QU ’ UN DÉBUT li. Non vedere la direzione in cui quei processi si muovono porta all’incapacità di reagire. Scambiare però la direzione di un determinato percorso per il suo avvenuto compimento conduce a un’analoga, ancorché apparentemente opposta, incapacità di reazione. Bisogna guardare negli occhi questa semplificazione distruttiva, proprio perché ha ancora senso provare a mutarne la rotta. Naturalmente non sarà mai solo la legislazione a migliorare i destini degli atenei (così come – lo si è detto – non è stata solo la legislazione a peggiorarli). E men che meno lo potrà essere la legislazione specifica, poiché il problema della formazione lo si deve necessariamente affrontare nel suo insieme, procedendo dunque dai primi gradi dell’istruzione fino agli ultimi e più alti. E dunque, e prima di tutto, ciò di cui abbiamo bisogno è un ritorno all’etica. Non alla deontologia, che è un’altra cosa, ma proprio all’etica. Qualcosa –anche qui- che riguarda la società tutta, e la cultura nel suo insieme. Ancora una volta, non è questione di corporazioni. L’attacco dei media alla «casta» dei politici è un fatto moralistico, non etico, che ha come obiettivo l’attacco alla politica, non ai politici corrotti, non agli sprechi, ma proprio alla politica, e cioè alla possibilità di incidere nei cambiamenti, al tentativo di organizzarsi politicamente per cambiare le cose. Nell’ultima Legge Finanziaria, approvata in Parlamento dal governo Prodi, sono previsti dei tagli ai compensi dei consiglieri provinciali e comunali. Compensi che consentono oggi a un consigliere provinciale – prendo a esempio il caso di Torino – di arrivare alla cifra mensile di circa 1.500 euro netti (che è certo più della busta paga di un operaio ma che altrettanto certamente non costituisce una cifra che giustifichi l’idea di una «casta»). La decurtazione prevista dalla Finanziaria ammonta, nella sua interpretazione restrittiva, circa al 50%, in quella più ‘generosa’ al 20%. Il compenso mensile di un consigliere provinciale si aggirerebbe dunque intorno ai 750 euro (o ai 1.200 nella migliore delle ipotesi). Sarebbero questi i cosiddetti privilegi della politica? (Senza tenere conto poi che alcune forze politiche prevedono statutariamente che i propri eletti versino una quota consistente al partito stesso; ma questa considerazione lasciamola pure da parte perché riguarda una autoregolamentazione dei consiglieri: eppure anch’essa, per qualcuno, incide). La campagna mediatica sollevata ad arte da alcuni quotidiani – e da fortunati bestseller scritti da giornalisti di quegli stessi quotidiani – ha dunque l’obiettivo non di colpire i veri e propri sprechi (che sorreggono vasti e articolati sistemi clientelari e che andrebbero perciò ben altrimenti contrastati) messi in atto da alcuni politici, semplicemente di colpire la politica tout court, la possibilità stessa cioè che, soprattutto alcuni partiti (meno organici o addirittura ostili ai cosiddetti «poteri forti»), riescano ad avere e a mantenere i propri rappresentanti nelle istituzioni. Tornando perciò all’Università, ciò di cui abbiamo bisogno non è un atteggiamento moralistico, ma un rinnovato spirito etico, profondamente morale, che consenta di indirizzare e regolare la vita universitaria non in base a logiche clientelari e nepotistiche ma a ragioni culturali e di merito. Perché non vi è dubbio che il nepotismo e la logica della clientela siano fortemente presenti all’Università. Ma altrettanto certamente è evidente che questo argomento viene utilizzato da molti – soprattutto dai mezzi di comunicazione di massa – in modo specioso. Con l’obiettivo non di aggredire il problema ma di incoraggiare forme di qualunquismo che rischiano unicamente di prefigurare scenari peggiori. Così come la cosiddetta «antipolitica» non è in realtà altro che uno strumento per rafforzare una pessima politica, allo stesso modo il sentimento banalmente «antiaccademico», alimentato ad arte, finisce per risolversi in un modo ancora più discutibile di proporre la gestione dell’accademia. Didattica e ricerca L’Università dovrebbe avere la forza di rimettere al cen- 73 74 tro del proprio operare la complementarità (e, di più, l’unità) di didattica e ricerca. Dimenticare la crucialità di quel nesso costituisce infatti un pericolo. La buona didattica, anche quando sia prevalentemente concentrata sugli aspetti più «divulgativi», può trovare radici solide solo in un’attività di ricerca seria e rigorosa. Ma anche qui la situazione è complicata dalla cesura delle «riforme» degli anni Novanta. Un conto infatti è il caso degli studiosi più anziani, cioè di chi, maturata ormai una lunga esperienza di studi e una robusta consuetudine con la ricerca, può scegliere di fare buon viso a cattiva sorte e accettare la sfida che questo momento di transizione verso una nuova università comporta, decidendo perciò di distinguere –pur senza mai separare del tuttoil piano degli studi approfonditi da quelli più divulgativi. Un conto sono invece i futuri studiosi o gli studiosi più giovani. Questi ultimi rischiano di non avere più il tempo della ricerca – che è un tempo quantitativo ma anche qualitativo – se quella distinzione verrà accentuata ulteriormente. E rischierà di venire meno la loro solidità di studiosi. E tutto ciò non potrà che riverberarsi (in negativo) anche negli studi più «divulgativi». Se ci poniamo un obiettivo ambizioso e proviamo a pensare all’università di domani e a come sarà, la questione si presenta molto delicata. Se i futuri studiosi verranno formati e dovranno lavorare da subito in una università che non prevederà più la saldatura fra ricerca e didattica tutto probabilmente peggiorerà. Sarà verosimilmente più difficile fare ricerca seria e, di conseguenza, si sarà sempre meno in grado di fare della buona «divulgazione», finendo per realizzare forme semplicemente scadenti di divulgazione, poiché banalmente ripetitive. In questo senso la proposta legislativa sulla «terza fascia docente» – il cui significato vuole essere l’abolizione della figura del ricercatore in nome di una equiparazione del suo ruolo a quello di un professore di terza fascia – mi sembra piena di insidie e credo andrebbe valutata con maggiore attenzione. Insomma, proprio perché l’obiet- tivo non può che essere quello di mantenere la qualità degli studi e più complessivamente la qualità del livello della formazione universitaria – perfino il dio-mercato non credo ci perdonerebbe leggerezze in questo senso – mi pare sarebbe necessaria la consapevolezza che proprio nell’equilibrio delicato e complesso fra didattica e ricerca si gioca il futuro di entrambe. Tutto questo, alla luce degli indirizzi previsti nel decreto Tremonti, risulterà ancora più arduo. I vigorosi tagli alle risorse finanziarie, la drastica riduzione del personale a tempo indeterminato e l’aumento dei contratti precari, la progressiva introduzione dei privati direttamente all’interno del governo delle università rischieranno di assestare un colpo definitivo agli atenei e di rendere in prospettiva l’università pubblica debolissima. Dietro l’angolo naturalmente fanno già capolino le università private. Ci avviamo a grandi passi verso un sistema universitario frammentato, fatto di un gran numero di università pubbliche scarsamente sovvenzionate e qualche centro cosiddetto «d’eccellenza» con tasse di iscrizione molto alte e lautamente finanziato, soprattutto dai privati. Anche se il decreto Tremonti è già legge dello Stato, dobbiamo fare ogni sforzo, sin dalla prossima Finanziaria, per contrastare il progetto complessivo che lo informa, le cui origini – lo abbiamo visto – corrono parallele ai prodromi di quel neoliberismo di cui in queste settimane scopriamo la drammatica e profondissima crisi. CE N ’ EST QU ’ UN DÉBUT 75 MASSIMO BRIGUORI (responsabile RdB Inpdap) DIETRO I FANNULLONI DI BRUNETTA, LE FORBICI DI TREMONTI Una campagna creata ad arte, per nascondere gli attacchi al salario e ai diritti dei dipendenti dello Stato. Con l’obiettivo di giungere a una privatizzazione della pubblica amministrazione. Prima di affrontare alcuni aspetti specifici del decreto 112, che passa sotto il nome di «decreto Brunetta», convertito successivamente dal Parlamento nella Legge 133, è bene sottolineare che tale provvedimento costituisce di fatto la legge finanziaria del Governo Berlusconi attualmente in carica. Per far passare la principale legge dello Stato, il Governo ha introdotto per la prima volta una modalità che utilizza lo strumento di un decreto legge, approvato in pochi minuti dal Consiglio dei Ministri: per la sua approvazione, il Governo ha posto in Parlamento il voto di fiducia, rendendolo immediatamente operante. Un’altra novità di tale iter di approvazione è costituita dal fatto che il decreto stabilisce interventi che coprono l’arco di tre anni, dal 2009 fino al 2011. Trattandosi della Legge Finanziaria, la parte principale dell’intervento concerne ovviamente il dato economico e, in particolare, i tagli da operare sul bilancio pubblico per rispettare i vincoli europei. È sufficiente leggere le prime righe del provvedimento per comprendere chiaramente tale impostazione. All’Art.1, comma 1, si legge: «Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare un intervento organico diretto a conseguire un obiettivo di indebitamen- 76 to netto delle pubbliche amministrazioni che risulti pari al 2,5% del Pil nel 2008, al 2% nel 2009, all’1% nel 2010, allo 0,1% nel 2011». Semplificando, si taglia la spesa della Pubblica Amministrazione passando dal 2,5% del 2008 allo 0,1% del 2011, ovvero un taglio di 2,4 punti percentuali rispetto al Pil: un intervento per circa 30 miliardi di euro. Questo era l’obiettivo, concordato tra il Ministro dell’Economia Tremonti e il Ministro della Funzione Pubblica Brunetta, che è possibile rintracciare nello stesso «piano industriale» presentato da quest’ultimo in anteprima rispetto alla stessa approvazione del decreto 112, che finirà appunto per essere chiamato il «decreto Brunetta». Il pesantissimo intervento sulla Pubblica Amministrazione è stato accompagnato dall’apertura simultanea di un’imponente campagna di (dis)informazione sui cosiddetti «fannulloni», abilmente studiata dal Ministro Brunetta e sostenuta dai mezzi di comunicazione, Tv e giornali, che hanno bombardato l’opinione pubblica per mesi, facendo leva sulla insoddisfazione dei cittadini rispetto alla qualità e alla celerità del servizio pubblico. Del resto, già durante la scorsa legislatura, le stesse rappresentanze sindacali confederali Cgil,Cisl,Uil avevano preparato un terreno favorevole a tale intervento, approvando il cosiddetto «memorandum», al centro del quale era posto il concetto di meritocrazia: a esso si faceva riferimento quale strumento per l’erogazione del salario dei dipendenti pubblici, e in particolare per il trattamento accessorio legato alla produttività. Forte di questa apertura, il Ministro Brunetta è intervenuto con mano pesantissima sia sul piano delle risorse che su quello della modifica di alcune norme. Sul piano delle risorse i due Ministri Tremonti e Brunetta hanno predisposto un intervento che taglia per tutte le P.A. le risorse destinate a premiare la produttività per una percentuale pari al 20% e, in aggiunta, elenca una serie di cosiddette «norme speciali» che dovranno essere disapplicate e che costituivano una delle voci più importanti del finanziamento del Fondi Incentivanti di Inps e Inpdap. Ciò comporterà rispettivamente una perdita di 161 milioni di Euro per i lavoratori dell’Inps e 40 milioni di euro per l’Inpdap, solo per il 2009. Un provvedimento quindi che azzera di fatto le risorse destinate a premiare la produttività dei due Enti Previdenziali e che fa saltare, come ricaduta, la stessa contrattazione integrativa, che al contrario il Governo dice di voler valorizzare anche per il settore privato. Il taglio dei fondi incentivanti comporterà una perdita secca di circa 6.000 euro pro capite annui, sia per i dipendenti Inps che Inpdap, rispetto alla retribuzione annuale, mettendo in serissima difficoltà le loro famiglie, magari alle prese con l’impennata dei mutui o degli affitti. Come si è detto, oltre a questo gravosissimo taglio sulle retribuzioni, il decreto interviene anche per modificare CE N ’ EST QU ’ UN DÉBUT alcune norme, che erano state conquistate con anni ed anni di battaglie dei lavoratori. Facendo leva sulla campagna mediatica sui «fannulloni», il decreto prevede che nei primi 10 giorni di assenza per malattia venga decurtata per ogni giorno tutta la retribuzione accessoria. Rispetto a questo provvedimento lo stesso Ministro si è vantato di aver determinato così un «effetto Brunetta», tanto che le assenze per malattia farebbero registrare da subito una rilevante diminuzione. Sottolineando che i dati riportati dal Ministro si basano su rilevazioni parziali, fatte a campione solo rispetto ad alcune Amministrazioni, c’è soprattutto da dire che, se chi abusava del permesso di malattia si asterrà dal continuare in questa pratica, la norma rimarrà comunque in vigore anche dopo che fossero eliminati tutti gli abusi e chi pagherà veramente saranno i malati veri. Ancora più odioso è poi l’intervento a modifica della Legge 104, la legge che stabiliva tutele per i lavoratori portatori di Handicap e per i lavoratori nel cui nucleo famigliare ci fosse la necessità di assicurare l’assistenza ai congiunti. Mentre sui primi non si è avuto il coraggio di infierire, lo stesso riguardo non è stato riservato ai secondi e si è operata una stretta sui relativi permessi dal lavoro. Così, quel dipendente pubblico che deve assentarsi dal lavoro per assistere il figlio, la moglie, il marito, i genitori – portatori di handicap – supplendo alle gravissime carenze del sistema sanitario, dovrà ricorrere alle ferie o chiedere un permesso che, come quello per la malattia, prevede il taglio del trattamento accessorio per i primi 10 giorni. Da questi, che sembrano essere solo aspetti specifici del cosiddetto «decreto Brunetta», si può comunque ricavare la tesi, neanche tanto sottaciuta, che informa tutto il provvedimento e che ci riporta alle considerazioni iniziali: l’intervento predisposto per il miglioramento dell’efficienza della Pubblica Amministrazione si risolve solo in un peggioramento delle condizioni economiche e lavorative dei dipendenti pubblici, sui quali viene scari- cato il costo dei vincoli europei e dei relativi tagli di bilancio, con il risultato di aggravare le già precarie condizioni operative della Pubblica Amministrazione e con l’inconfessabile intento di poter poi eventualmente giustificare l’ulteriore passo verso la privatizzazione di pezzi del suo funzionamento. Con quello che sta accadendo nel mondo della Scuola, dell’Università e della Ricerca – con i provvedimenti del tutto analoghi di taglio delle risorse e licenziamento dei lavoratori precari che da anni garantiscono la didattica – il cerchio si chiude. Al contrario, banche e imprese invocano e ottengono onerosissimi aiuti di stato, per far fronte alla gigantesca crisi finanziaria che liberisti e sacerdoti del mercato hanno prodotto, con i loro comportamenti degli ultimi quindici anni. 77 OMAGGIO A UN POETA 78 Il 13 settembre scorso, in un incidente stradale, è venuto a mancare Italo Evangelisti. A CHE SERVE? A CHE SERVE UNA NUOVA COLLANA Poeta e critico, oltre che comunista, era nato DI POESIA? a Roma dove viveva e lavorava svolgendo parallelamente l’attività poetico-letteraria e quella di critico d’arte. Certo non a costruire un futuro migliore, di cui pure Come critico d’arte è autore di saggi, in parti- avremmo tanto bisogno. Figuriamoci! colare, sulla «scuola romana» e l’«astratto- E neanche a progettare un futuro qualunque… la poesia, lo sappiamo, non ha mai fatto la rivoluzione; ma a testiespressionismo»; nonché di presentazioni al moniare questo presente con la luna storta e pensarlo e catalogo e interventi critici sull’opera di immaginarlo e sognarlo un domani umanamente compaalcuni tra i più importanti artisti italiani. tibile cercando e trovando le parole giuste per dirlo, queCome poeta e critico letterario, nel 1985 ha sto sì; anche perché, come ha detto qualcuno che di costruzioni se ne intende, «il futuro è l’unico posto dove fondato e diretto la collana di poesia delle possiamo andare». Edizioni del Giano; ha fatto parte delle giurie «La luna storta»! Ecco perché un biglietto da visita cosi di numerosi Premi letterari con Alberto politically incorrect ma truly politic per questa nuova collana di poesia di cui la Editrice Terre sommerse mi ha imMoravia, Dario Bellezza, Elio Pecora, Vito prudentemente affidato la direzione. Riviello, Valerio Magrelli , curando anche la Per quanto attiene poi la scelta critico-stilistica, diciamo prefazione al volume antologico del Premio che essa è dettata dalla convinzione che siamo in una fase Rebibbia 87, Il turbine segreto del vociare non- in cui è necessario ed urgente tentare di dare una risposta, senza illusioni ma con fermo e paziente impegno, alla ché autore, insieme al poeta Plinio Perilli, dei crisi che attraversa la creatività poetica. saggi introduttivi all’antologia di testi poeti- Una poesia, che, in generale e fatte ovviamente le signici frutto dei laboratori condotti nel carcere ficative eccezioni, si presenta stretta in un abbraccio mortale, da cui non riesce a liberarsi, tra la «parola innaromano di Rebibbia nel triennio 2004-2006. morata» e la «parola stuprata». L’intreccio tra il pathos poetico e la crudezza L’una, innamorata di se stessa, narcisa e spalmata come del vivere era nato dall’incontro con Pier melassa sulla pagina, con le labbra truccate dal rosso di Paolo Pasolini, personaggio significativo improbabili tramonti, accarezzata dal volo dei gabbiani, saprofita di «eterne» passioni, profumata d’incenso per nella sua vita intellettuale e artistica. un Cristo da catechismo consolatorio; insomma, la sagra Per ricordarlo, riportiamo la sua presenta- dei buoni sentimenti, cioè, l’ipocrisia sublimata in versi zione della collana «Nuova poesia-La luna o, al massimo, la cronaca minimalista di un soggettivismo miope e asfittico. storta» per l’ Editrice Terre Sommerse, di cui Sull’altro versante, una poesia stuprata da uno sperimennel 2007 aveva assunto la direzione. talismo sterile che sopravvive a se stesso in un gioco au- OMAGGIO A UN POETA toreferenziale che è tautologia lirica, tecno-estetismo di una anarchia solipsistica che è spia di una impotenza creativa dove le assonanze-dissonanze godono a stridere nel non sense. Lì dentro, soffocata tra queste due pareti d’ombra, sta la parola poetica che, come buona parte della creatività artistica contemporanea, non solo ha perso il contatto con la «realtà», fagocitata dal «virtuale», ma, per dirla con Paul Virilio, «ha smarrito la capacità di vedere» e quindi di comunicare. Insomma, è cieca figlia di una «estetica della sparizione». Che fare? Intanto, prendendo atto che la crisi della parola poetica nasce dalla crisi più generale del «pensiero»; cioè, dalla sua stessa «natura» e «qualità» e non dalle forme e modi della sua comunicazione. Basti pensare, tanto per esemplificare a tutto campo, alla evidenza plastica dei fotogrammi e alla scansione ritmica del montaggio del cinema digitale, alla destrutturazione nevrotica della coreografia – new dance, alla nuova scrittura pubblicitaria di «suggestione» onirico-fantasmatica di caratura astratto-concettuale e alla deregulation logico-sintattica della nuova letteratura. Il problema, quindi, nasce dal nuovo modo di pensare, non più organizzato sul piano «orizzontale» dello sviluppo logico e progressivo di un concetto ma sul piano «globale» della immediatezza e contemporaneità; di un pensiero, quindi, che percepisce e comunica simultaneamente appercezioni sensibili e immagini, evocazioni memoriali e sonore con pezzi di concreta matericità e di quotidiano consumo. Un pensiero che necessita, per essere pensato, metabolizzato e trasmesso, di un linguaggio capace di declinare la categoria interpretativa della contemporaneità, la «velocità», nella sua corretta accezione di «intensità del sentire» e non in quella deviata e deviante di «rapidità dell’agire». Per la poesia, in questo contesto, il problema sta nel come recepire diversamente e, quindi, elaborare e restituire efficacemente la parola immediata e mediata da sti- moli diversi, in una fusion tra «parola parlata» e «parola scritta» che riesca a superare la falsa dicotomia tra «banale» e «sublime»,«quotidiano» ed «eterno» e, conseguentemente, a produrre, in questa fase di «non pensiero», almeno un embrione di un «linguaggio nuovo» perché coerente col «nuovo pensiero» nutrito dalla contemporaneità di percezione e comunicazione. Lo so, lo so, l’impresa è difficile. Ma se grandina il poeta non può starsene con l’ombrello aperto aspettando che spiova gingillandosi coi giochini verbali e i languori sentimentali. Senza presunzioni, of course, convinti come Pessoa che «noi non facciamo più rumore al mondo / di quanto ne facciano le foglie degli alberi / o i passi del vento». Tuttavia, sapete che vi dico? A me basterebbe che la poesia di questa collana riuscisse, anche solo qualche volta, a farli sentire i passi di quel vento tra le foglie. Forse non riuscirà a raddrizzare questa luna storta ma almeno ci abbiamo provato. Italo Evangelisti 79 80 Comitato editoriale Maurizio Acerbo Gianni Alasia Marco Amagliani Pierfranco Arrigoni Antonio Assogna Jone Bagnoli Giorgio Baratta Imma Barbarossa Katia Bellillo Riccardo Bellofiore Piergiorgio Bergonzi Maria Luisa Boccia Manuele Bonaccorsi Vittorio Bonanni Bianca Bracci Torsi Nori Brambilla Pesce Emiliano Brancaccio Giordano Bruschi Tonino Bucci Alberto Burgio Maria Rosa Calderoni Maria Campese Luigi Cancrini Luciano Canfora Guido Cappelloni Gennaro Carotenuto Bruno Casati Luciana Castellina Giulietto Chiesa Francesco Cirigliano Fausto Co' Cristina Corradi Aurelio Crippa Roberto Croce Marco Dal Toso Walter De Cesaris Peppe De Cristofaro Josè Luiz Del Roio Tommaso Di Francesco Giuseppe Di Lello Finuoli Piero Di Siena Rolando Dubini Gianni Ferrara Guglielmo Forges Davanzati Gianni Fresu Mercedes Frias Alberto Gabriele Haidi Gaggio Giuliani Francesco Germinario Orfeo Goracci Roberto Gramiccia Claudio Grassi Dino Greco Margherita Hack Alessandro Leoni Lucio Manisco Fabio Marcelli Giovanni Mazzetti Maria Grazia Meriggi Enzo Modugno Sabina Morandi Raul Mordenti Franco Nappo Giorgio Nebbia Saverio Nigretti Alfredo Novarini Simone Oggionni Angelo Orlando Franco Ottaviano Gianni Pagliarini Valentino Parlato Armando Petrini Gianmarco Pisa Michele Pistillo Felice Roberto Pizzuti Giuseppe Prestipino Marilde Provera Riccardo Realfonzo Alessandra Riccio Paolo Sabatini Giuseppe Sacchi Luigi Saragnese Marco Sferini Vincenzo Siniscalchi Massimiliano Smeriglio Bruno Steri Antonella Stirati Mario Tiberi Nicola Tranfaglia Fulvio Vassallo Paleologo Mario Vegetti Massimo Villone Luigi Vinci Pasquale Voza Maurizio Zipponi Stefano Zolea Stefano Zuccherini Stefano Zuccherini direttore – Bruno Steri direttore editoriale – Mauro Cimaschi direttore responsabile – Bianca Bracci Torsi redazione – Mauro Belisario, Silvia Di Giacomo, Simone Oggionni email: [email protected] diffusione e abbonamenti email: [email protected] editore associazione culturale essere comunisti via Buonarroti 25 – 00185 Roma stampa tipografia Jacobelli – Pavona (Roma) chiuso in tipografia il 12 novembre 2008 grafica progetto grafico, impaginazione e service editoriale: DeriveApprodi registrazione Tribunale di Roma n. 170/2007 del 08/05/2007 anno II, numero 8, settembre 2008 bimestrale Poste Italiane s.p.a. – spedizione in A.P. 70% Roma n. 96/2007 www.esserecomunisti.it l rischio che corre un sito internet (in primo luogo un sito di informazione e orientamento politico) è di faticare nello stare al passo con il tempo della rete che, come è noto, si consuma con una velocità esponenziale. Il rischio, quindi, è che le buone intenzioni cedano alla stanchezza e, via via, perdendo la capacità di rinnovarsi, il sito sia sempre meno in grado di offrire al lettore telematico un prodotto utile, maneggevole, interessante. Il contatore dei contatti quotidiani al nostro sito, www.esserecomunisti.it, ci indica una tendenza contraria. Il sito cresce ogni giorno proponendo ai lettori nuove sezioni (a partire da quella multimediale, arricchita frequentemente di nuovi audiovisivi), un doppio aggiornamento quotidiano e già in mattinata articoli e commenti sui fatti del giorno. E ancora: più attenzione alla cultura, una rassegna stampa più completa e articolata, un numero sempre crescente di interventi, commenti e interviste redazionali, molti dei quali provenienti dai circoli e dalle federazioni del nostro partito. Ma non è ancora sufficiente. E per crescere ancora, abbiamo bisogno dello sguardo critico dei nostri lettori (una media di settemila al giorno, negli ultimi due mesi). In questi anni ce l’abbiamo fatta anche e, forse, in primo luogo perché la critica (insieme alla fiducia) non è mai venuta meno. Aspettiamo il vostro contributo, confidiamo nella vostra capacità di coinvolgere sempre nuovi compagni: facendo loro scoprire la nostra rivista e il sito internet. Scommettiamo che non rimarranno delusi? I credits sulle immagini da pagina 60 a pagina 77 immagini di Paolo Canevari UN ESEMPIO DA IMITARE Cari compagni, stamani come circolo Prc «Franco Bertini» di Ponte a Egola (PI) abbiamo pagato un bollettino postale di euro 100,00 che alleghiamo scansionato. 50,00 euro sono da intendersi come sottoscrizione alla nostra rivista. Gli altri 50,00 per due abbonamenti ordinari da mandare al circolo. Grazie! Elena e Pilade
Scaricare