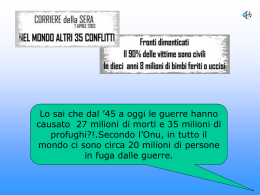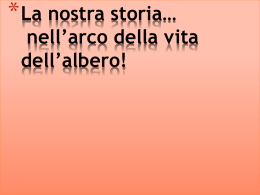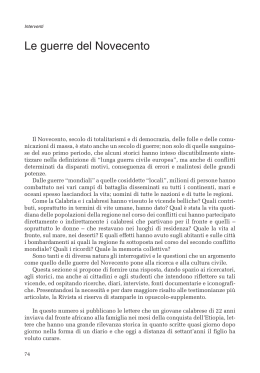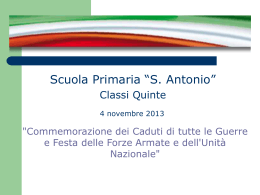Le forme nuove della guerra Anno scolastico 2011-2012 Indice PREMESSA 4 IL CONTESTO PLANETARIO 6 Scipione Guarracino, Storia degli ultimi cinquant’anni, Sistema internazionale e sviluppo economico dal 1945 a oggi, Bruno Mondadori, Milano 1999, pp. 32 – 42. 6 Michael Hardt – Antonio Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano 2001, pp. 171-174; 235-237. 10 Mary Kaldor, Le nuove guerre. La violenza organizzata nell’età globale, Carocci, Roma 2001, pp. 27- 41 14 Eric J. Hobsbawm, Intervista sul nuovo secolo, a cura di Antonio Polito, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 9-17 19 Renzo Guolo, Movimenti islamisti e jihad, in Michelangelo Bovero ed Ermanno Vitale (a cura di), Gli squilibri del terrore. Pace democrazia e diritti alla prova del XXI secolo, Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, Robenserg & Sellier, Torino 2006, pp. 131-137 24 IL TEATRO MEDIORIENTALE 29 Vittorio Emanuele Parsi, I paradossi della guerra al terrorismo, Limes 2004-3 Monografia, Il nostro Islam, pp. 299-306. 29 David Polansky, Grande medio oriente o araba fenice? Limes 2005-3 Monografia La potenza di Israele, pp. 175-182 34 Tahar Ben Jelloun, La rivoluzione dei gelsomini – Il risveglio della dignità araba», Bompiani, Milano 2011, pp. 13-17. 41 Salvatore Santangelo, Imperi e moltitudini, Limes online, 05/08/2011 42 Nima Baheli, L’Iran vuole guidare la primavera araba, Limes online, 14/10/2011 45 GUERRA, PACIFISMO E DIRITTI UMANI 49 Aldo Capitini, Aspetti dell’educazione alla nonviolenza, Pisa, Pacini Mariotti, 1959, pp. 1-3. 49 Norberto Bobbio, Pacifismo, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Dizionario di politica, Utet, Torino 1983 52 Eric J. Hobsbawm, Intervista sul nuovo secolo, cit., 17-22. 56 Michael Walzer, Il trionfo della teoria della guerra giusta (e i pericoli del suo successo) (2002), in Sulla guerra, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 8-24. 59 2 L'ITALIA SULLA SOGLIA 65 Roberti Rivello, Il ripudio della guerra (art. 11), in Guido Neppi Modona (a cura di), Stato della Costituzione, Il Saggiatore, Milano 1995 65 Gianfranco Pasquino, Commento alla Costituzione italiana, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2011, p. 48. 66 Don Lorenzo Milani, Lettera ai cappellani militari, 22 febbraio 1965, in Lettere di Don Lorenzo Milani, Priore di Barbiana, a cura di Michele Gesualdi, San paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2007. 67 Gian Enrico Rusconi, Guerra e intervento umanitario. L’Italia alla ricerca di una nuova affidabilità internazionale, in W. Barberis, Guerra e pace, Storia d’Italia, Annali 18¸ Torino, Einaudi, 2002, pp. 834 - 838 71 Bibliografia essenziale 75 3 Premessa Il corso si pone in stretta continuità con attività seminariali o laboratoriali realizzate negli scorsi anni scolastici e rappresenta insieme una ripresa e un’ideale continuazione del ciclo proposto ormai circa dieci anni fa nella drammatica situazione internazionale determinata dalla tragedia dell’11 settembre. Nella premessa del fascicolo documentario realizzato in quella occasione si legge, tra l’altro: “La storia di questi ultimi tempi si presenta […] carica di pesanti contraddizioni. Per citarne soltanto alcuni: la tendenza alla globalizzazione e all’inclusione si scontra con la rinascita di nazionalismi o di localismi sempre più pressanti e tendenzialmente esclusivi; alla modernizzazione e laicizzazione di settori sempre più ampi della società si oppongono, con una problematicità per certi versi inattesa, il riemergere di nodi irrisolti legati agli stessi processi di modernizzazione in atto da anni nei paesi del Terzo mondo e la complessità del fondamentalismo religioso. Il quadro complessivo che ci pone innanzi risulta ben lontano dalla situazione prospettata da chi vedeva nella fine del bipolarismo la spinta verso lo sviluppo di progetti di integrazione internazionale e la realizzazione di un felice e rassicurante mondo rappacificato sotto l’egida di istituzioni nazionali e internazionali sempre più ispirate alla “democrazia di tipo occidentale.” L’attuale situazione dei rapporti internazionali rende ancora attuali quelle considerazioni e anzi i recenti avvenimenti che hanno interessato e tuttora drammaticamente interessano l’Africa Settentrionale e il Medio Oriente restituiscono un quadro complessivo ancora più problematico e di più complessa interpretazione. Come sempre, il ciclo di lezioni che viene presentato non pretende di affrontare in modo esauriente tutte le tematiche indicate, quanto piuttosto di individuarne i “nodi strutturali” e i momenti fondamentali. La scelta antologica che segue, pur ripercorrendo tutte le problematiche indicate nei titoli delle quattro sezioni, non ha alcuna pretesa di esaustività, operazione sempre difficile da realizzare per temi così complessi, ma la cui realizzazione sarebbe stata tanto più complessa nelle poche pagine a nostra disposizione; si è pensato piuttosto di dare dei suggerimenti, delle suggestioni su cui fondare un possibile ulteriore lavoro di approfondimento da svolgere con le classi o con gruppi più ridotti, anche con l’eventuale aiuto dei mezzi audiovisivi presente presso i locali del CeSeDi e dei curatori del ciclo seminariale. A tale scopo si è pensato di offrire alcuni fondamentali strumenti concettuali necessari per tentare di comprendere le caratteristiche peculiari delle “operazioni belliche” determinatasi con il mutamento rivoluzionario nella conduzione degli affari militari, il crollo dell'Urss, l’affermazione delle “nuove guerre” e dell'iperterrorismo. Non verrà però dimenticato l’altro corno della questione: la nascita e la diffusione di un sempre più profondo “spirito pacifista”, che ha costretto a riproporre i vecchi ma sempre attuali problemi della inevitabilità o meno della guerra, della sua legittimità, dell’esistenza o meno della “guerra giusta” e, per quanto riguarda l’Italia, della conformità della partecipazione alle varie iniziative di intervento internazionale alle norme costituzionali I dati e gli esempi concreti saranno nel caso forniti durante le singole lezioni, 4 ma sono stati qui volutamente sottaciuti, sia per le già richiamate esigenze determinate dallo spazio limitato, sia perché sempre persuasi che un’adeguata analisi della situazione non possa fare a meno dell’applicazione di più ampie categorie esplicative che si possano di volta in volta calare nel caso specifico. Tali categorie sarebbero però scarsamente significative se non sufficientemente argomentate e discusse dagli stessi autori che le propongono come chiave per interpretare i fatti. Perciò, dove possibile, si è deciso di presentare poche ma più estese porzioni di testo per consentire appunto una più larga ricostruzione delle argomentazioni probatorie dell’Autore, piuttosto che tanti brevi brani tratti da un numero maggiore di opere. Il lavoro di selezione, come sempre opinabile, è stato perciò più faticoso, complesso e talora doloroso giacché ha costretto a lasciar fuori opere indubbiamente degne di massima attenzione, ma, a parere dei curatori meno efficaci per il conseguimento degli obiettivi indicati sopra. Si rinvia comunque alla sagacia dei docenti l'eventuale delucidazione o approfondimento delle tematiche affrontate. Francesco Scalambrino Nota: nei brani riprodotti, oltre ai tagli segnalati come di consueto con la parentesi quadra, sono state eliminate le note, generalmente di carattere bibliografico 5 Il contesto planetario Scipione Guarracino, Storia degli ultimi cinquant’anni, Sistema internazionale e sviluppo economico dal 1945 a oggi, Bruno Mondadori, Milano 1999, pp. 32 – 42. Le origini e le cause della guerra fredda Se accettiamo la denominazione usuale di “guerra fredda” per descrivere i rapporti che per anni sarebbero intercorsi fra Usa e Urss, resta da chiedersi quando questa guerra sia cominciata, cioè in quale momento esattamente vada collocata la svolta che fece precipitare dalla grande alleanza antinazista alla creazione di due blocchi politico-militari minacciosamente contrapposti e quali furono le sue cause di fondo. La fortuna ottenuta da una felice espressione giornalistica non dimostra ancora che siamo di fronte a un vero e proprio concetto, valido e utile per le scienze sociali; successivamente andrà perciò esaminata la questione decisiva dei caratteri e dell’originalità del sistema internazionale che corrispose al periodo della guerra fredda, mentre ci sarà modo di tornare più volte su un’ultima domanda: quando è finita la guerra fredda e quali diverse fasi ha attraversato, senza cambiare sostanzialmente di natura? Alla prima domanda (l’inizio) si può ovviamente rispondere che la guerra fredda era in atto durante il blocco di Berlino, quando entrambe le parti svilupparono le ostilità reciproche lasciando capire che c’erano limiti che non avrebbero superato (forzare il blocco terrestre o chiudere i corridoi aerei). Ma quanto indietro bisogna risalire per trovare il vero e proprio inizio? L’allarme lanciato a Fulton da Churchill (che in quel momento agiva da privato cittadino, non essendo più capo del governo) appare ex-post profetico, ma è in effetti troppo precoce: al principio del marzo 1946 molto restava ancora da decidere sul futuro dell’Europa e comunque non ci si era discostati in maniera drastica dagli accordi presi a Mosca nell’ottobre del 1944 fra Churchill stesso e Stalin. Ancora più precoce sembra la data del 23 aprile 1945, quando, appena undici giorni dopo la morte di Roosevelt, il ministro degli esteri sovietico Molotov fu ricevuto dal nuovo presidente Truman e trattato con modi incredibilmente villani e ingiuriosi per chi restava il rappresentante di una potenza alleata in un momento in cui la guerra non era ancora finita. È necessario soffermarsi un momento sulle ragioni della sfuriata. Secondo Truman i sovietici non stavano rispettando gli accordi di Jalta sulla Polonia e perciò gli Stati Uniti si sarebbero rifiutati di ammetterla alle Nazioni Unite. In realtà Truman sapeva di non avere del tutto ragione chiedendo la sostituzione del governo filosovietico allora esistente; la formulazione faticosamente concordata a Jalta diceva che si doveva giungere alla costituzione di «un nuovo governo provvisorio polacco», ma precisava poi che questo non comportava che il governo filosovietico dovesse essere sostituito, ma solo «riorganizzato su più ampie basi democratiche con l’aggiunta di personalità democratiche nella Polonia stessa e di emigrati», cioè inserendo alcuni rappresentanti di partiti non comunisti ed esponenti del secondo governo polacco allora esistente 6 (quello che si era formato in esilio a Londra sin dall’inizio della guerra) e procedendo poi a libere elezioni. Pur convinto che Stalin non avesse alcuna intenzione di rispettare lo spirito dell’accordo, di fatto Truman lasciò ancora spazio alle trattative: gli Usa riconobbero il governo polacco (allargato dalla partecipazione del partito contadino, mentre il governo in esilio a Londra perse ogni appoggio) e votarono a favore dell’ammissione della Polonia all’Onu. Per quanto riguarda la seconda questione (le cause), possiamo prima di tutto procedere per via empirica e ripercorrere gli eventi cercando di soppesare le rispettive responsabilità, a cominciare da quelle quasi-dichiarazioni di guerra che furono nel 1947 da una parte la dottrina Truman (12 marzo) e dall’altra la dichiarazione di costituzione del Cominform (5 ottobre). Non c’è dubbio che nel 1946-48 gli Stati Uniti e i loro alleati violarono gli accordi di Potsdam sul mantenimento dell’unità tedesca, ma già nel 1946-47 l’Urss aveva violato gli accordi di Jalta sulle libere elezioni in Polonia. Ma prima ancora, nel 1944-45, non era già accaduto che la Gran Bretagna trattasse come propria zona d’influenza la Grecia e anche l’Italia? Prevalendo ormai (come si è già notato) una logica ben diversa da quella del nuovo ordine mondiale, a Stalin in fin dei conti importava ben poco dell’Italia e anche della Grecia, ma allora il dittatore sovietico non poteva più ammettere che gli occidentali stabilissero condizioni sulla Polonia. Quanto al Giappone, a Jalta Roosevelt, prevedendo che la guerra del Pacifico sarebbe durata diversi mesi, aveva ancora bisogno dell’intervento sovietico e perciò gli accordi allora stipulati stabilivano che questo sarebbe avvenuto entro due o tre mesi dalla resa della Germania. L’Urss dichiarò guerra l’8 agosto 1945 attaccando le truppe giapponesi dislocate in Manciuria, ma Truman aveva già optato per l’uso della bomba atomica (il lancio su Hiroshima era avvenuto il 6 agosto e quello su Nagasaki fu effettuato il 9), anche allo scopo di chiudere subito la guerra e stabilire un pieno controllo sul Giappone prima che i sovietici ottenessero vantaggi significativi e quindi il diritto di far sentire la loro voce nell’area del Pacifico. Eppure Truman, così come aveva già fatto Roosevelt, chiedeva a Stalin di contentarsi di un governo amico in Polonia e non di farne una zona di esclusiva influenza. Per questa via, ricercando un preciso evento allo stesso tempo inizio e causa e anche moltiplicando gli eventi e tenendo conto del clima di sospetto reciproco e dell’eventuale erronea valutazione delle intenzioni altrui, non si riuscirà ad arrivare a una conclusione definitiva sulle origini della guerra fredda. Sorge allora, in alternativa, una risposta completamente diversa, cioè che vi era qualcosa di inevitabile nella fine dell’alleanza fra Usa e Urss, potenze portatrici di interessi strategici divergenti e di sistemi politici e modelli economici assai lontani fra di loro: il futuro economico del mondo stava per gli Stati Uniti nella crescita del commercio internazionale, nella libertà di accesso ai mercati e alle risorse degli altri paesi; il sistema sovietico della pianificazione rispondeva a una logica del tutto diversa e, dopo aver preso in considerazione per un breve momento sia Bretton Woods che il piano Marshall, l’Urss tornò alla sua visione dello sviluppo economico, sostanzialmente autarchica. A ciò occorre però aggiungere che le due potenze erano portatrici anche e soprattutto di visioni del mondo universaliste contrapposte, che implicavano la volontà di applicare ovunque i rispettivi modelli e che conducevano a denominare “imperialismo” e “totalitarismo” il modello altrui. Pur essendo vero che i comportamenti effettivi degli attori della politica sono in parte determinati dalle ideologie, questa risposta dà l’impressione di sopravvalutare la loro importanza (e non riesce a distinguere fra ideologie e propaganda) e 7 dovrebbe condurre a concludere, come diversi studiosi hanno fatto, che la guerra fredda era cominciata molto prima: se non proprio dal 1917, almeno dal momento in cui si era concluso lo scontro diretto fra comunismo e capitalismo, con il duplice fallimento della rivoluzione mondiale e della controrivoluzione bianca appoggiata dagli stati capitalisti. Se vogliamo cogliere l’originalità del fenomeno della guerra fredda – che non aveva in effetti alcun precedente nella storia del sistema internazionale degli ultimi secoli –, a fianco (e ovviamente non in sostituzione) degli interessi strategici e delle ideologie dobbiamo mettere altri fattori e diventa assai proficuo riflettere sul diverso concetto di bipolarismo, considerando la guerra fredda solo una sua conseguenza. È utile notare qui il doppio piano che orientò il discorso pronunciato da Stalin il 9 febbraio 1946. Da un lato il dittatore sovietico considerava, in base alla teoria leninista della guerra, la seconda guerra mondiale, non diversamente dalla prima, conseguenza delle contraddizioni interne del sistema mondiale capitalistico e lasciava quindi intendere che finché esisteva il capitalismo restava alto il rischio di una nuova guerra: fin qui c’era l’ideologia dell’inevitabilità del conflitto. D’altro canto Stalin diceva anche che la seconda guerra mondiale era stata ben diversa dalla prima, perché aveva visto sorgere una coalizione antifascista e alla fine era stata vinta da «noi assieme ai nostri alleati». Le forze in gioco erano infatti state molteplici e ben distinte (l’Asse, la Gran Bretagna e la Francia con i loro imperi, gli Stati Uniti, l’Urss). Gli esiti della guerra avevano fatto degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica le due sole grandi potenze mondiali, ponendole a diretto contatto in Europa lungo la “cortina di ferro” e annientando o relegando in secondo piano le altre che esistevano in precedenza. Nell’Europa del XVIII e XIX secolo e anche dei primi decenni del XX aveva dominato un sistema multipolare tendente all’equilibrio o al “concerto”, nel quale l’egemonismo di una delle potenze poteva essere compensato dal mutevole gioco delle alleanze e alla fine dal ricorso alla guerra. In un sistema del genere (a definirlo basta l’esistenza minima di tre membri, ma più ce ne sono e meglio funziona) i contrasti politici difficilmente assumevano una veste ideologica, perché continuamente avvenivano rimescolamenti nelle alleanze e le grandi potenze non mettevano in dubbio la loro appartenenza alla comune civiltà europea; è notevole il fatto che la Grande guerra, con il suo iniziale gran dispiegarsi di motivazioni ideologiche, venne al seguito della semplificazione delle alleanze negli anni attorno al 1900 e del loro irrigidimento bipolare, con i due blocchi dell’Intesa e degli Imperi centrali. In un sistema ancor più bipolare o tendenzialmente tale (consacrato nel nostro caso dalla rinuncia della Gran Bretagna, nel febbraio 1947, a svolgere una parte autonoma nel Mediterraneo) il ruolo dei mutamenti liberi di alleanza da parte dei soggetti statali minori diventa poco rilevante. Le due grandi potenze si fronteggiano da sole e l’alternativa a una guerra apocalittica è la guerra fredda; questa è “inevitabile” in quanto conseguenza del bipolarismo. La guerra fredda inerente al bipolarismo resta un fenomeno ben diverso dalla formale cortesia diplomatica che in altre epoche aveva coperto i conflitti fra potenze e anche ben diversa dalle fasi di più gravi tensioni che di tanto in tanto si manifestavano restando entro il gioco diplomatico o dalla stessa corsa agli armamenti degli anni antecedenti al 1914. La guerra fredda è una vera guerra già in atto, orientata ad annientare la potenza dell’avversario, con tutti i mezzi diretti e indiretti che stanno al di qua della soglia fatale. Prima di tutto i mezzi della guerra psicologica, quali la propaganda e le false notizie; ma la guerra fredda non fu solo una guerra di parole, perché com8 portò i tentativi di sovversione nel campo altrui e, come vedremo, tanto la strumentalizzazione di ogni situazione di tensione mondiale, qualunque fosse la sua origine, quanto il ricorso al confronto bellico indiretto nelle molteplici occasioni di conflitti locali. Benché a rigore sarebbe ancora necessario stabilire se in genere il bipolarismo possa evolvere verso una “coesistenza pacifica”, resta vero che se il bipolarismo produce la guerra fredda, a maggior ragione questa avrà una forte valenza ideologica. Come ha scritto Richard Crockatt (Cinquant’anni di guerra fredda, 1995, p. 129), accentuando l’elemento di paradosso inerente alla tesi “realista”, «il conflitto ideologico diede certamente alla guerra fredda la sua caratteristica intensità quasi religiosa, ma è difficile credere che la relazione fra Stati Uniti e Unione Sovietica sarebbe stata al riparo da conflitti, anche qualora entrambi avessero posseduto sistemi politici e valori sociali simili». Questo ci riconduce a considerare il significato della conferenza di Jalta. Nel febbraio 1945 l’Urss aveva già vinto la sua guerra. Gli accordi di Jalta prendevano atto di una divisione dell’Europa già avvenuta e non ne erano la causa diretta, ma allo stesso tempo cercavano di portare i “grandi” (tre, contando ancora la Gran Bretagna) a guardare da un punto di osservazione più alto delle loro zone d’influenza e ad associarsi in una gestione comune della pace e dell’ordine mondiale: «unità per la pace come per la guerra», si intitolava il capitolo IX della dichiarazione finale, mentre il capitolo V, la «Dichiarazione sull’Europa liberata», vedeva le tre potenze fiduciose nella possibilità di superare i problemi del dopoguerra garantendo ai popoli pace, libertà e democrazia. Che probabilità di successo aveva questo progetto, caldeggiato soprattutto da Roosevelt? Ciò che è veramente essenziale notare è che, tuttavia, nel 1945 come anche nel 1947 il bipolarismo era ancora imperfetto e limitato solo all’Europa. Accanto alla portata già realmente mondiale della supremazia degli Usa esisteva soltanto una Unione Sovietica gravemente colpita dalle distruzioni belliche e desiderosa di procurarsi una fascia di sicurezza in Europa orientale. La stessa espressione “bipolarismo” rischia di anticipare troppo i fatti e fa scivolare erroneamente verso l’epoca successiva, quella dell’equilibrio del terrore fondato sul possesso delle armi atomiche da parte di entrambe le potenze. Più che di bipolarismo puro e semplice sarebbe forse meglio parlare di bipolarismo asimmetrico, reso possibile da una particolare circostanza geopolitica. Usa e Urss non avevano frontiere comuni e il loro punto di incontro e tensione si verificava in Europa: alla minaccia sempre più globale (e per diversi anni unilateralmente atomica) che gli Stati Uniti furono in grado di esercitare contro l’Urss, questa poteva rispondere, meglio che con la sovversione o le guerriglie in Asia e più tardi in Africa e in America Latina, con la sola minaccia nei confronti dell’Europa occidentale esercitata soprattutto con un esteso dispiegamento di truppe convenzionali, che manterrà la sua superiorità per quarant’anni. Se si mettono a parte il caso della Polonia, vittima prima di tutto della sua collocazione geopolitica, e quelli della Romania e della Bulgaria, meno contestali da Stati Uniti e Gran Bretagna, l’Urss mostrò però di credere ancora fino a buona parte del 1946 che la sua sicurezza poteva essere compatibile con il progetto di ordine mondiale. La guerra comunista in Grecia fu poi interpretata dagli Stati Uniti come un tentativo direttamente provocato dall’Unione Sovietica di forzare gli equilibri quali si erano costituiti in Europa. È molto probabile che il discorso di Truman intendesse drammatizzare la situazione allo scopo di isolare con il tema dell’anticomunismo le tendenze isolazioniste; queste erano tornate prevalenti nel Congresso dopo la vittoria repubblicana alle elezioni del novembre 1946 e pote9 vano opporsi alla “dottrina” presidenziale che comportava una netta fuoriuscita da quelle che erano considerate zone di interessi vitali per gli Stati Uniti (l’America centrale e meridionale, il Pacifico). Mettere anche il Mediterraneo e l’Europa fra queste zone era veramente un fatto nuovo. Ma la Grecia fu in gran parte un pretesto: la dottrina Truman e il piano Marshall costituivano indubbiamente già atti di guerra fredda, una sfida lanciata all’altro elemento del bipolarismo europeo, che venne da questo immediatamente raccolta: conformemente alla sua natura di sistema monolitico e dispotico, ma anche in difesa dei propri interessi, l’Urss ridusse a vassalli e vittime senza voce i paesi europei sotto il suo controllo, compresa la Germania orientale. Ma non si può neppure attribuire alla dottrina Truman tutta la responsabilità di primo e unilaterale atto della guerra fredda e dare un ruolo determinante al passaggio da Roosevelt al suo successore. Essa fu piuttosto una nuova presa d’atto, certo meno lungimirante e coraggiosa di quella che faceva da presupposto al grande disegno proposto da Roosevelt ai suoi interlocutori a Jalta (e che fu in seguito considerata un atto di ingenuità se non una resa): cioè che il nuovo sistema delle relazioni internazionali prodotto in Europa dalla guerra era e poteva essere solo un sistema bipolare. Questo era soltanto l’inizio della guerra fredda. Lanciata in Europa, la sfida del bipolarismo si sarebbe successivamente estesa al mondo intero, con tutti i confitti politici, sociali, ideali che si venivano manifestando in tutti i continenti, rafforzando le condizioni che affidavano alla guerra fredda stessa il mantenimento dell’equilibrio. Michael Hardt – Antonio Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano 2001, pp. 171-174; 235-237. Nel corso della guerra fredda, quando gli Stati Uniti adottarono ambiziosamente le insegne imperialiste, subordinarono le vecchie potenze colonialiste al loro comando. La guerra fredda, finanziata dagli Stati Uniti, non aveva sconfitto il nemico socialista, ma probabilmente questo non era neppure l’obiettivo primario. L’Unione Sovietica è infatti crollata sotto il peso delle sue contraddizioni interne. Al massimo, la guerra fredda aveva prodotto uno stato di isolamento che, riverberandosi all’interno del blocco sovietico, funzionò da moltiplicatore delle sue contraddizioni. L’effetto più importante della guerra fredda fu quello di riorganizzare le linee dell’egemonia nel mondo imperialista, accelerandone il declino, e facendo contemporaneamente crescere l’iniziativa americana indirizzata alla creazione di un ordine imperiale. Gli Stati Uniti non avrebbero vinto la guerra fredda se non avessero preventivamente approntato un nuovo genere di iniziativa egemonica. […]. Nell’epoca di crisi che seguì la fine della guerra fredda, la responsabilità di esercitare un potere di polizia gravò pesantemente sulle spalle degli Stati Uniti. La guerra del Golfo costituì la prima occasione per attivare questo tipo di potere nella sua pienezza. In realtà, la guerra consisteva in un’operazione di repressione assai poco interessante dal punto di vista degli obiettivi strategici, degli interessi regionali e delle ideologie politiche che vi erano implicate. Abbiamo visto molte guerre simili condotte dagli Stati Uniti e dai loro alleati. L’Iraq fu accusato di aver violato il diritto internazionale e, dunque, andava giudicato e punito. L’importanza della guerra del Golfo derivava, piuttosto, dalla dimostrazione che gli Stati Uniti era10 no l’unica potenza in grado di dirigere la giustizia internazionale non in relazione a motivazioni d’ordine nazionale, ma in nome del diritto globale. Molte potenze avevano già preteso di agire in nome di un interesse universale, ma il ruolo degli Stati Uniti è sostanzialmente diverso. Anche il loro richiamo all’universale è naturalmente falso, ma lo è in un modo del tutto particolare. La polizia mondiale americana agisce nell’interesse dell’impero, non dell’imperialismo. In tal senso, come ha affermato George Bush, la guerra del Golfo ha annunciato la nascita di un nuovo ordine mondiale. La legittimazione dell’ordine imperiale non può essere basata solo sull’efficacia delle sanzioni legali e della forza militare che le impone. Deve crescere, di pari passo, con la produzione delle norme giuridiche internazionali che formalizzano il potere dell’attore egemonico in termini durevoli e legali. Il processo costituzionale che era iniziato con Wilson raggiunge qui la maturità. Tra la prima o la seconda guerra mondiale, tra il messianismo di Wilson e l’iniziativa economico politica di respiro internazionale del New Deal […] fu creata una serie di organismi internazionali che avevano il compito di produrre ciò che, nel gergo contrattualistico tradizionale del diritto internazionale, è definito un surplus di normatività e di efficacia. A questo surplus venne assegnata una base che aveva una vocazione espansiva e tendenzialmente universale, così come era nello spirito degli accordi di San Francisco che diedero vita alle Nazioni Unite. Questo processo di unificazione fu interrotto, ma non completamente bloccato, dalla guerra fredda. Negli anni della guerra fredda ci fu una moltiplicazione di organismi internazionali capaci di produrre diritto e, nel contempo, di ridurre le resistenze alla loro azione. Nel primo capitolo della Parte Prima abbiamo sottolineato che la proliferazione di queste differenti organizzazioni internazionali e il loro consolidamento in un complesso di relazioni simbiotiche – come se ognuna chiedesse alle altre di essere legittimata – ha comportato un superamento del diritto internazionale, inteso in termini negoziali e contrattuali e ha dato notevoli indicazioni sull’avvento di un’autorità centrale, un motore dell’azione giuridica legittimato a livello sovranazionale. Le grandi istituzioni internazionali, che erano sorte nella limitata dimensione dei negoziati e degli accordi, hanno prodotto una proliferazione di organismi e attori che hanno cominciato ad agire come se ci fosse un’autorità centrale a sanzionare il diritto. Con la conclusione della guerra fredda, gli Stati Uniti furono chiamati a garantire e ad aumentare l’efficacia giuridica del processo di formazione di un nuovo diritto sovranazionale. Così come, nel secolo avanti Cristo, i senatori chiesero ad Augusto di assumere le prerogative imperiali per l’amministrazione del bene comune, allo stesso modo, anche oggi, le organizzazioni internazionali (le Nazioni Unite, gli organismi finanziari internazionali e le organizzazioni umanitarie) chiedono agli Stati Uniti di assumere il ruolo centrale nel nuovo ordine mondiale. In tutti i conflitti regionali della fine del XX secolo, da Haiti al Golfo Persico e dalla Somalia alla Bosnia, agli Stati Uniti è stato richiesto di intervenire militarmente si tratta infatti di autentiche e sostanziali richieste, e non di manovre propagandistiche per mettere a tacere il dissenso interno agli Stati Uniti. Anche se erano riluttanti, i militari americani avrebbero risposto alle chiamate in nome della pace e dell’ordine. Questa è una delle caratteristiche determinanti dell’impero: esso risiede in un contesto mondiale che lo invoca di continuo. Gli Stati Uniti sono la polizia della pace, ma solo in ultima istanza, quando le organizzazioni sovranazionali per il mantenimento della pace richiedono un’attività organizzativa e un complesso articolato di iniziative giuridiche. 11 Ci sono molte ragioni che giustificano la posizione privilegiata degli Stati Uniti nella nuova costituzione mondiale dell’autorità imperiale. Essa corrisponde, in parte, alla continuità del ruolo svolto dagli Stati Uniti (in particolare, quello militare) a partire dalla leadership nella lotta contro l’URSS sino al posto centrale occupato nello scenario del nuovo ordine unificato del mondo. Dal punto di vista della storia costituzionale, il privilegio degli Stati Uniti è determinato in termini ancora più decisivi da una tendenza imperiale immanente alla Costituzione. La Costituzione degli Stati Uniti, come diceva Jefferson, è la meglio calibrata per un vasto Impero. Occorre sottolineare, ancora una volta, che questa Costituzione è imperiale e non imperialista poiché (al contrario del progetto imperialista che si muove sempre in linea retta entro spazi chiusi e che invade, distrugge e sussume i paesi sottomessi alla sua sovranità) il progetto costituzionale americano è concepito per realizzare un programma di articolazione di uno spazio aperto e di continua reinvenzione di molteplici e, a un tempo, singolari relazioni che si intramano in reti attraverso un campo illimitato. L’idea contemporanea di Impero è nata nel corso dell’espansione su scala globale del progetto interno alla Costituzione americana. È infatti nel corso dell’espansione dei processi costituzionali interni che inizia la fase costituente dell’impero. Il diritto internazionale è sempre stato negoziato nella forma di un processo contrattuale tra parti esterne - dall’epoca descritta da Tucidide nel dialogo tra gli Ateniesi e i Meli, ai tempi della ragion di stato, sino al sistema delle relazioni tra gli stati moderni. Oggi, il diritto implica, piuttosto, un processo istituzionale costitutivo e interno. La rete degli accordi e delle associazioni, i canali di mediazione e le risoluzioni dei conflitti, il coordinamento tra le differenti dinamiche degli stati: tutto viene istituzionalizzato nell’ambito dell’impero. Siamo così giunti alla prima fase della trasformazione della frontiera globale nello spazio aperto della sovranità imperiale. […] La guerra fredda ha dominato lo scenario mondiale durante il periodo della decolonizzazione e della decentralizzazione produttiva e, tuttavia, oggi si ha la netta sensazione che il suo ruolo fu piuttosto secondario. Benché le opposizioni speculari della guerra fredda abbiano indubbiamente ostacolato i progetti imperiali americani e la modernizzazione socialista sostenuta dal progetto stalinista, questi ultimi risultano elementi tutto sommato minori. Il fattore realmente rilevante, il cui significato va ben al di là della storia della guerra fredda, è costituito dalla gigantesca trasformazione postcoloniale del Terzo Mondo, trasformazione che è avvenuta assumendo le sembianze della modernizzazione e dello sviluppo. In realtà, la decolonizzazione fu un fenomeno relativamente indipendente dalle dinamiche e dai vincoli della guerra fredda, tanto che post factum si può avanzare l’ipotesi che, nel Terzo Mondo, la competizione tra i due blocchi abbia accelerato i processi di liberazione. Le élite che guidarono le lotte anticoloniali e antimperialiste nel Terzo Mondo erano ideologicamente legate all’uno o all’altro dei due blocchi che si fronteggiavano durante la guerra fredda; a prescindere dal loro schieramento, esse ritenevano che la liberazione dal colonialismo si sarebbe realizzata soltanto introducendo la modernizzazione e lo sviluppo. Per noi, che ci troviamo agli estremi limiti della modernità, non è difficile riconoscere la tragica mancanza di prospettive che comportava la traduzione della liberazione nei vincoli della modernizzazione. I miti della modernità – la sovranità, la nazione e il disciplinamento – erano prati12 camente l’unica ideologia di quelle élite, ma questo non è stato il fattore più importante. Il processo rivoluzionario della liberazione dal colonialismo spinto in avanti dalle moltitudini, di fatto, andava ben oltre l’ideologia della modernizzazione, rivelandosi così come un’enorme produzione di soggettività irriducibile al bipolarismo USA-URSS e alla competizione tra i due regimi, che si limitavano a riprodurre le modernità come esclusiva modalità del dominio. Quando Nehru, Sukarno e Chou En-lai si riunirono alla conferenza di Bandung nel 1955 o quando, negli anni Sessanta, nacque il movimento dei paesi non allineati, ciò che emergeva con grande chiarezza non era tanto l’enorme miseria di quelle nazioni, e neppure la speranza di emulare le conquiste della modernità, quanto piuttosto lo straordinario potenziale di liberazione prodotto dalle stesse popolazioni subalterne. La prospettiva dei non allineati fece intravedere la realtà di un nuovo e generalizzato desiderio. La domanda su cosa si sarebbe dovuto fare dopo la decolonizzazione per non cadere sotto il dominio di uno dei due schieramenti della guerra fredda rimase senza risposta. Ciò che era invece evidente e ricco di potenzialità erano le soggettività che premevano per oltrepassare i limiti della modernità. Le immagini utopistiche, della rivoluzione sovietica e di quella cinese, viste come modelli alternativi di sviluppo, svanirono nel momento stesso in cui quelle rivoluzioni non furono più in grado di avanzare e dunque quando, alla fine, fallì il tentativo di tracciare una strada che portasse al di fuori della modernità. Nello stesso tempo, anche il modello di sviluppo promosso dagli Stati Uniti risultava bloccato poiché, a partire dal dopoguerra, questi si erano comportati più come forza di polizia del vecchio imperialismo che come corifei di una nuova speranza. Le lotte delle popolazioni subalterne continuavano quindi a rappresentare un’incontrollabile miscela esplosiva. Verso la fine degli anni Sessanta, queste lotte - la cui influenza avrebbe risuonato in ogni angolo dello spazio mondiale - avevano assunto una forza, una mobilità e una plasticità tali da trascinare la modernizzazione capitalistica (sia nella versione liberale che in quella socialista) in mare aperto, dove infine fu perduto ogni orientamento. Dietro la facciata della rivalità bipolare tra americani e sovietici, le lotte di liberazione avevano saputo riconoscere un comune modello disciplinare, che fu contrastato da enormi movimenti, in forme più o meno ambigue, più o meno mistificate, ma, nondimeno, assolutamente reali. Queste nuove ed enormi masse di soggettività indicavano - e, a un tempo, rendevano necessario un mutamento di paradigma. A questo punto divenne evidente l’inadeguatezza della teoria e della prassi della sovranità moderna. Negli anni Sessanta e Settanta - anche se il modello della modernizzazione disciplinare era stato imposto in tutto il mondo, anche se le politiche welfariste, dettate dai paesi dominanti, erano diventate ovunque pressoché irreversibili e venivano ingenuamente rivendicate dai leader dei paesi subalterni, anche se ci si trovava in un nuovo mondo ormai innervato dai media e dalle reti della comunicazione - i dispositivi della sovranità moderna non erano più sufficienti a governare le nuove soggettività. Inoltre, nel momento in cui il paradigma della sovranità moderna perdeva la sua efficacia, anche le teorie classiche dell’imperialismo e dell’antimperialismo smarrivano definitivamente ogni residua risorsa euristica. In linea generale, per queste teorie, il superamento dell’imperialismo significava aderire pedissequamente ai modelli della modernizzazione e della sovranità moderna. Accadde però esattamente l’opposto. Masse, popolazioni e classi oppresse, nel momento stesso in cui facevano ingresso nei processi di mo13 dernizzazione, iniziarono a trasformarli e, perciò, a superarli. Le lotte di liberazione, una volta proiettate nel mercato mondiale in posizione subalterna, si resero definitivamente conto della tragica inservibilità della sovranità moderna. Non era cioè più possibile imporre le forme moderne dello sfruttamento e del dominio. Nel momento stesso in cui si scrollavano di dosso la colonizzazione per conquistare la modernizzazione, queste enormi masse compresero ben presto che l’obiettivo fondamentale non era quello di entrare nella modernità, bensì quello di uscirne. Mary Kaldor, Le nuove guerre. La violenza organizzata nell’età globale, Carocci, Roma 2001, pp. 27- 41 Clausewitz definiva la guerra come «un atto di forza che ha per scopo di costringere l’avversario a seguire la nostra volontà». Questa definizione presuppone che sia “noi” che il nostro “avversario” siamo stati, e che sia possibile definire chiaramente la “volontà” di uno stato. Per Clausewitz, dunque, la guerra è guerra tra stati per un fine politico definito, vale a dire per l’interesse dello stato. In realtà, l’idea che la guerra sia un’attività dello stato si è affermata stabilmente solo alla fine del diciottesimo secolo. L’unico precedente di questa idea può essere ritrovato nell’antica Roma, ma si tratta anche in questo caso di un precedente parziale, dal momento che lo stato - cioè Roma - combatteva contro barbari che non avevano alcuna nozione della separazione tra stato e società. Secondo van Creveld, neanche le guerre tra le città-stato dell’antica Grecia erano guerre tra stati, perché non c’era in esse nessuna chiara distinzione tra lo stato e i cittadini: le guerre venivano combattute da milizie cittadine, e i resoconti contemporanei tendevano a parlare di guerra tra “gli ateniesi” e “gli spartani” piuttosto che tra “Atene” e “Sparta”. Tra la caduta dell’impero romano e il tardo medioevo, le guerre erano combattute da una varietà di attori – la Chiesa, i baroni feudali, le tribù barbariche, le città-stato – ciascuno dei quali con le sue caratteristiche formazioni militari. Così, il modo di combattere dei barbari era in genere basato sui culti guerrieri, con il singolo guerriero come unità militare chiave. I baroni feudali dipendevano dai cavalieri, con i loro codici di onore e cavalleria, a loro volta supportati dai servi della gleba. E le città-stato dell’Italia settentrionale dipendevano per lo più da milizie cittadine molto simili a quelle dell’antica Grecia. Nelle prime fasi della formazione dello stato europeo, i monarchi davano vita a eserciti che erano coalizioni di baroni feudali (un po’ come se oggi il segretario generale delle Nazioni Unite sollecitasse contributi volontari dei singoli stati per dar vita a una forza di pace). A poco a poco, essi usarono tuttavia il loro crescente potere economico - derivato dai dazi doganali, da diverse forme di tassazione e dai prestiti dell’emergente borghesia - per costituire eserciti mercenari che assicuravano un certo grado di indipendenza dai baroni, consolidando in tal modo i confini territoriali e il potere centrale. Ma gli eserciti mercenari si rivelarono poco sicuri, in particolare dal punto di vista della fedeltà. Essi si scioglievano dopo le guerre o durante l’inverno, e i costi di questa dispersione e di un nuovo reclutamento erano spesso proibitivi. Non di rado, inoltre, nei periodi di pace i mercenari trovavano modi non molto ortodossi per guadagnarsi da vivere. Essi finirono così per essere sostituiti da eserciti permanenti che consentirono ai monarchi di creare forze militari specializzate e professionali. L’introduzione dell’addestramento e delle esercitazioni, anticipata da Gustavo Adolfo di Svezia e dal principe Guglielmo d’Orange, fece sì che l’esercito fosse occupato anche nei periodi in cui 14 non c’erano combattimenti. Secondo Keegan, l’istituzione di truppe permanenti di fanteria e la creazione di reggimenti o compagnies d’ordonnance fu «l’espediente per assicurare il controllo delle forze armate da parte dello stato». Le truppe vennero concentrate in guarnigioni che divennero vere e proprie «scuole della nazione». Si introdussero uniformi per distinguere i soldati dai civili. «Il soldato - come ha scritto Michael Roberts - divenne l’uomo del re perché indossava la divisa del re», e ciò sempre più in un senso letterale, dal momento che i re cominciarono a indossare sempre più spesso uniformi militari per evidenziare il loro ruolo di comandanti delle forze armate. Il nuovo tipo di organizzazione militare esemplificava bene il crescente assetto amministrativo caratteristico della società moderna. Il soldato divenne l’agente di quella che Max Weber ha definito autorità razionale-legale […]. L’istituzione di eserciti permanenti sotto il controllo dello stato era parte integrante del processo, essenziale per lo stato moderno, che conduceva al monopolio della violenza legittima. L’interesse dello stato divenne la giustificazione legittima della guerra, sostituendo le concezioni della giustizia tratte dalla teologia (jus ad bellum). L’insistenza di Clausewitz sulla guerra come strumento razionale per il perseguimento dell’interesse dello stato - «la continuazione della politica con altri mezzi» - rappresentò una secolarizzazione della legittimità che andava di pari passo con quanto accadeva in altre sfere di attività. Una volta che l’interesse dello stato divenne la principale fonte di legittimazione della guerra, la rivendicazione di giuste cause da parte ili attori non-statali non potè più essere sostenuta con l’ausilio di mezzi violenti. Nello stesso spirito, si svilupparono regole concernenti la legittimità della guerra, che dovevano essere più tardi codificate nelle leggi di guerra. Tutti i tipi di conflitti sono caratterizzati da regole; il fatto stesso che la guerra sia un’attività sanzionata socialmente, che debba essere organizzata e giustificata, richiede delle regole. C’è però una sottile linea di demarcazione tra un omicidio socialmente accettabile ed uno ostracizzato dalla società. E questa linea di demarcazione è definita in modi diversi nelle diverse epoche. Nel medioevo, le regole della guerra jus in bello - erano derivate dall’autorità papale. Con lo stato moderno, si sviluppò un nuovo insieme di regole mondane. Come scrive van Creveld: Per distinguere la guerra dal semplice crimine, la si definì come qualcosa che poteva essere intrapreso dagli stati sovrani e da essi soltanto. I soldati furono definiti come personale che aveva licenza di impegnarsi nella violenza armata per conto dello stato. [...] Per ottenere e conservare questa licenza, i soldati dovevano essere accuratamente registrati, contrassegnati e controllati, così da escludere ogni atto arbitrario. Essi potevano combattere solo se indossavano l’uniforme, se portavano le loro armi “apertamente” e se obbedivano a un comandante responsabile delle loro azioni. Non potevano far ricorso a metodi “vili” come violare un armistizio, prendere di nuovo le armi dopo che erano stati fatti prigionieri e simili. La popolazione civile doveva essere lasciata da parte, nella misura in cui lo consentivano le “necessità militari”. […] Nell’opera di Clausewitz c’è una continua tensione tra l’insistenza sulla ragione e l’enfasi sulla volontà e l’emozione. Uomini di genio ed eroi militari sono personaggi centrali di Della guerra; sentimenti come il patriottismo, l’onore e il coraggio sono parte integrante della struttura del libro. Altrettanto significative, tuttavia, sono le conclusioni circa la natura strumentale della guerra, l’importanza dei rapporti numerici e il bisogno di un’analisi concettuale della guerra. In effetti, la tensione tra ragione ed emozione, arte e scienza, logoramento e manovra, difesa e offesa, strumentalismo ed estremismo costituisce una componente chiave del 15 pensiero di Clausewitz. E si può dire che questa tensione abbia raggiunto il suo punto di rottura nel ventesimo secolo. Innanzitutto, le guerre della prima metà del ventesimo secolo sono state guerre totali, che hanno comportato una vasta mobilitazione delle energie nazionali sia per combattere, sia per sostenere il combattimento attraverso la produzione di armi e beni necessari. Certo, Clausewitz non poteva nemmeno immaginare la spaventosa combinazione di produzione di massa, politica di massa e comunicazione di massa finalizzata alla distruzione di massa. Nonostante ciò, è difficile pensare a qualcosa di più vicino alla sua idea di guerra assoluta della guerra nel ventesimo secolo, culminata con la scoperta di armi nucleari capaci in teoria di provocare una distruzione totale senza “attrito”. Allo stesso tempo, le guerre totali del nostro secolo anticipano alcune delle caratteristiche delle nuove guerre. In una guerra totale, la sfera pubblica tende ad incorporare l’intera società, eliminando ogni distinzione tra pubblico e privato, e di conseguenza affievolendo la distinzione tra militare e civile, tra combattenti e non combattenti. Nella prima guerra mondiale, gli obiettivi economici erano considerati obiettivi militari legittimi. Nella seconda, lo sterminio degli ebrei fece sì che il termine “genocidio” entrasse nel lessico giuridico. Da parte alleata, il bombardamento indiscriminato di civili, che produsse devastazioni di proporzioni simili al genocidio (anche se non delle dimensioni degli stermini nazisti), fu giustificato come strumento per distruggere il morale nemico: come una “necessità militare”, per usare il linguaggio delle leggi di guerra. In secondo luogo, nella misura in cui la guerra coinvolgeva un numero crescente di persone, la sua giustificazione in termini di interesse dello stato, se anche aveva avuto una sua validità, diventava sempre più vuota. La guerra, come afferma van Creveld, è la dimostrazione che gli uomini non sono egoisti. Nessun calcolo individuale «li tipo utilitaristico può giustificare il rischio della morte. La ragione principale per cui gli eserciti mercenari erano così insoddisfacenti è che l’incentivo economico è per sua natura inadeguato a motivare alla guerra. Lo stesso dicasi per l’“interesse dello stato”, un concetto che deriva dalla stessa scuola di pensiero positivista che ha dato origine alla moderna economia. Gli uomini vanno in guerra per una varietà di ragioni individuali: avventura, onore, paura, cameratismo, protezione della “patria” e del “cuore”; ma la violenza legittima organizzata socialmente ha bisogno di uno scopo comune in cui il singolo soldato possa credere e che egli condivida con gli altri. Se i soldati vanno trattati come eroi e non come criminali, è necessaria una giustificazione eroica per mobilitare le loro energie e per persuaderli ad uccidere e a rischiare di essere uccisi. Nella prima guerra mondiale, il patriottismo rappresentò una ragione sufficientemente forte per chiedere un sacrificio, e milioni di giovani partirono volontari per combattere in nome del re e del paese. Ma l’esperienza terribile di quella guerra produsse delusione e disperazione, nonché un’attrazione per cause astratte più forti (quelle che Gellner chiama religioni secolari). Per le nazioni alleate, la seconda guerra mondiale fu letteralmente una guerra contro il male. Intere società furono mobilitate, ben sapendo, a differenza dei loro predecessori della prima guerra mondiale, che cosa c’era in gioco nella guerra: la lotta contro il nazismo e la difesa del proprio stile di vita. Esse combatterono contro il fascismo in nome della democrazia o del socialismo. Con la Guerra fredda, queste stesse ideologie vennero chiamate in causa per giustificare la continua corsa agli armamenti. Per giustificare la minaccia della distruzione di massa, la Guerra fredda venne presentata come una lotta del bene contro il male, in modo non troppo dissimile dall’esperienza del tempo di guerra. Ma questa giustificazione era ormai poco 16 convincente o insufficiente, ed è questa forse la spiegazione principale del fallimento degli interventi militari del dopoguerra, in particolare dell’intervento americano in Vietnam e di quello sovietico in Afghanistan. Le difficoltà incontrate da questi interventi di controinsurrezione sono state più volte analizzate, ma il punto centrale è che i soldati non si sentivano più eroi. Vietnam e Afghanistan erano paesi lontani, e non era poi così evidente di chi fossero i torti e le ragioni. Nel migliore dei casi, quelli che presero parte alla guerra si sentirono come pedine di un gioco di alta politica che non potevano comprendere; nel peggiore, si sentirono assassini. Negli Stati Uniti (ma non in Russia, che doveva ripetere lo stesso errore in Cecenia) questa esperienza ha prodotto una profonda riluttanza a rischiare vite americane, anche grazie alla forte influenza dell’opinione pubblica sui leader politici. La conseguenza è stata lo sviluppo di strategie basate per lo più sulla potenza aerea, con cui è possibile usare la forza senza rischiare grandi perdite (ciò che Edward Luttwak ha definito «guerra post-eroica»). Nel suo monumentale lavoro sulla guerra nel ventesimo secolo, Gabriel Kolko ha sostenuto che a dare inizio alle guerre è sempre un «manipolo di uomini» affetti da una «cecità socialmente autorizzata». I leader politici operano all’interno di una élite del consenso che esclude i dissenzienti, e ciò favorisce la trasmissione di false informazioni e illusioni fuorvianti circa le conseguenze di una guerra. Una simile argomentazione fornisce un forte sostegno alla tesi secondo cui le democrazie sono più difficilmente coinvolte nelle guerre. Senza dubbio, leader politici più affidabili sarebbero meno propensi ad imbarcarsi in avventure impossibili. Nel caso della prima guerra mondiale, tuttavia, la cecità dei leader fu condivisa dalle persone comuni; e nella seconda, almeno in Gran Bretagna, l’opinione pubblica fu probabilmente molto più bellicosa dei suoi leader. Ma cominciare una guerra è solo il primo passo: ciò che conta per sostenerla è che lo scopo della guerra sia riconosciuto come legittimo da parte di coloro che vi partecipano. La guerra è un’attività paradossale. Da un lato, è un atto di coercizione estrema, che comporta ordine, disciplina, gerarchia e obbedienza socialmente organizzati. Dall’altro, presuppone fedeltà, devozione e convinzione da parte di ogni individuo, ed è diventato sempre più chiaro nel dopoguerra che sono pochissime le cause che costituiscono uno scopo legittimo della guerra e per cui le persone sono pronte a morire. Di fatto, l’idea che la guerra sia illegittima cominciò a farsi strada già dopo il trauma della prima guerra mondiale. Il patto Kellogg-Briand del 1928 rinunciò alla guerra come “strumento della politica”, eccetto che per i casi di autodifesa; e questa proibizione venne rafforzata dai processi di Norimberga e di Tokyo, in cui i leader tedeschi e giapponesi vennero accusati di «aver pianificato una guerra di aggressione». Oggi, dopo che quella proibizione è stata codificata nella Carta delle Nazioni Unite, sembra generalmente accettato che l’uso della forza è giustificabile solo in casi di autodifesa o se è sanzionato dalla comunità internazionale, in particolare dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. In terzo luogo, le tecniche della guerra moderna si sono sviluppate fino al punto da ridurre fortemente la loro utilità. Le grandi battaglie navali della fine del secolo scorso si rivelarono più o meno irrilevanti nella prima guerra mondiale, dove contava piuttosto un potere di fuoco prodotto su larga scala. La prima guerra mondiale fu una guerra difensiva di logoramento, in cui masse di giovani - dirette da generali addestrati alla strategia ottocentesca di un uso senza risparmio della forza - vennero falcidiate dal fuoco dei cannoni. Verso la line della guerra, l’introduzione di carri armati e aerei consentì uno sfondamento offensivo che rendeva possibile il tipo di guerra di manovra che avrebbe caratterizzato anche la se17 conda guerra mondiale. Nel dopoguerra, la maggiore pericolosità e accuratezza delle munizioni, almeno in parte dovuta alla rivoluzione elettronica, hanno fortemente accresciuto la vulnerabilità di tutti i sistemi di armamenti. Le piattaforme armate della seconda guerra mondiale sono diventate straordinariamente complesse e costose, diminuendo così la loro utilità sia a causa delle spese e delle esigenze logistiche, sia a causa dei sempre minori progressi nelle prestazioni. I problemi della mobilitazione e della inflessibilità, così come i rischi del logoramento, sono stati esaltati per tutto il periodo post-bellico, rendendo quasi proibitiva qualsiasi operazione militare che non fosse diretta contro un nemico manifestamente inferiore, come nella guerra delle Falkland/Malvive del 1982 o nella guerra del Golfo del 1991. Il logico punto d’arrivo del percorso tecnologico della guerra moderna sono ovviamente le armi di distruzione di massa, in particolare le armi nucleari. Una guerra nucleare sarebbe una guerra in cui una forza estrema verrebbe sprigionata nel giro di pochi minuti. Ma quale scopo razionale potrebbe mai giustificarla? Nel dopoguerra molti esperti di strategia si sono confrontati proprio con questo problema: le armi nucleari non cancellano forse il presupposto stesso della guerra moderna, vale a dire l’interesse dello stato? Infine, nel dopoguerra le alleanze si sono irrigidite in modo da erodere la distinzione tra interno ed esterno. Già nel corso della seconda guerra mondiale divenne chiaro che i singoli stati nazionali non potevano combattere le guerre da soli, e questa lezione venne applicata nella costruzione delle alleanze post-belliche. Sistemi di comando integrati istituirono una divisione militare del lavoro in cui solo le superpotenze avevano la capacità indipendente di intraprendere guerre su larga scala. Sostanzialmente, i paesi europei rinunciarono ad uno degli attributi essenziali della sovranità, il monopolio della violenza legittima organizzata, e almeno in Europa occidentale quella che era di fatto una società civile transnazionale si estese ad un intero gruppo di nazioni. C’è un’ampia discussione nelle scienze sociali sul fatto che le democrazie non si fanno la guerra tra di loro. È interessante però che non si sottolinei come l’integrazione delle forze militari su base transnazionale costituisca un ostacolo pratico alla guerra. Claus Offe ha fatto una considerazione simile per le rivoluzioni del 1989 in Europa orientale: la ragione per cui sono state così pacifiche, egli afferma, risale all’integrazione delle forze militari nel Patto di Varsavia, il che spiega anche l’eccezione rumena. Al di là delle alleanze vere e proprie, si stabilì inoltre una rete di rapporti militari che prese la forma di alleanze meno rigide, commercio di armi, fornitura di sostegno e addestramento militare, e che creò un insieme di relazioni protettore/cliente che contribuì a ridurre la capacità di entrare in guerra unilateralmente. Dopo il 1945, c’è stato un numero molto ridotto di conflitti tra stati, e quelli che hanno avuto luogo (India e Pakistan, Grecia e Turchia, Israele e stati arabi) sono stati in genere tenuti sotto controllo dall’intervento delle super- potenze. L’eccezione che conferma la regola è la guerra tra Iran e Iraq. Questa guerra è durata otto anni ed è stata intrapresa dai due stati grazie alla disponibilità di entrate derivanti dal petrolio. Alla fine, entrambe le parti hanno appreso l’inutilità della moderna guerra convenzionale. Per citare ancora van Creveld: Dopo un milione o quasi di perdite umane, i belligeranti si sono ritrovati al punto di partenza. Gli iraniani hanno imparato che di fronte ad una massiccia potenza di fuoco assistita dai gas, le loro giovani truppe di fanatici non sarebbero state in grado di portare un attacco se non alla porta del paradiso. Gli iracheni hanno appreso che la superiorità convenzionale è incapace, da sola, di infliggere una sconfitta significativa ad un 18 grande paese con una popolazione quasi tre volte maggiore. Entrambe le parti sono state costante- mente condizionate dalla paura che una seria interruzione del flusso di petrolio avrebbe attirato sul loro conflitto l’intervento delle superpotenze. Entrambe volevano un cessate il fuoco, e furono sollevate quando ne venne siglato finalmente uno. L’erosione delle distinzioni tra pubblico e privato, militare e civile, interno ed esterno rende in ultima analisi problematica la stessa distinzione tra guerra e pace. La seconda guerra mondiale fu una guerra totale che realizzò una completa fusione tra guerra, stato e società (fusione che continuò a caratterizzare le società totalitarie). La Guerra fredda favorì una sorta di permanente psicosi di guerra, basata sulla teoria della deterrenza ben riassunta dallo slogan di Orwell in 1984: «La guerra è pace». Essa tenne viva l’idea della guerra, nel momento stesso in cui ne teneva lontana la realtà. Si riteneva che la conservazione di vasti eserciti permanenti integrati in alleanze militari, la continua corsa alle armi tecnologiche e il livello di spese militari mai raggiunto prima in tempo di pace fossero sufficienti a garantire la pace, perché nessuna guerra del tipo schematicamente descritto in questo capitolo era scoppiata sul suolo europeo. Allo stesso tempo, molte guerre avevano avuto luogo in tutto il mondo, inclusa l’Europa, in cui erano morte più persone che durante la seconda guerra mondiale. Ma poiché esse non corrispondevano alla nostra concezione della guerra, non se ne teneva conto. Le guerre irregolari e informali della seconda metà del ventesimo secolo – a partire dai movimenti di resistenza del periodo bellico e dalla guerriglia di Mao Tse-tung e dei suoi successori – costituiscono i precursori delle nuove forme di guerra. Gli attori, le tecniche e le contro-tecniche che emersero dalle crepe della guerra moderna dovevano fornire le basi per nuovi modi di organizzare socialmente la violenza. Durante la Guerra fredda, il loro carattere fu oscurato dal predominio del conflitto est/ovest, ed esse vennero concepite come un elemento periferico del conflitto centrale. Già prima della fine della Guerra fredda, quando iniziò davvero ad affievolirsi la minaccia di un’altra “guerra moderna”, abbiamo cominciato a prendere coscienza di quella che Luttwak chiama la nuova bellicosità. Eric J. Hobsbawm, Intervista sul nuovo secolo, a cura di Antonio Polito, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 9-17 D[omanda]. Il Novecento si è chiuso con una guerra, esattamente come il Secolo breve cominciò con la catastrofe della Grande Guerra. Di nuovo l’incendio è nei Balcani. Come se il tempo non fosse passato, l’esplodere della questione nazionale mette di nuovo alla prova la potenza degli imperi. La Storia si ripete, dunque? Come siamo arrivati dalla fine della Guerra Fredda al ritorno della guerra calda? Come è possibile che il mondo abbia oggi il più gran numero di rifugiati dalla fine della seconda guerra mondiale? R[isposta]. È vero, per alcuni aspetti la guerra nei Balcani è davvero una guerra dai tratti antichi. E la continuazione delle guerre balcaniche, o, più in generale, delle guerre prodotte dal sistema internazionale dei poteri del XX secolo, e ancora prima del XIX secolo. La guerra nei Balcani è, se vuole, l’ultima conseguenza, l’ultimo prodotto collaterale della Grande Guerra. Quel conflitto vide il collasso degli imperi multinazionali preborghesi. La fine degli Asburgo e degli Ottomani produsse la mappa nazionalista dell’Europa sud-orientale. La Rivoluzione d’ottobre preservò, invece, l’unità di quello che era stato l’impero degli zar. 19 Oggi che quel regime è crollato, assistiamo ad analoghe conseguenze anche in quell’area del mondo. Ma, a mio parere, è più importante analizzare la natura generale della guerra e della pace per come è cambiata alla fine del XX secolo. Il carattere generale della guerra è problema più rilevante delle ragioni specifiche che la determinano. Per esempio, è più importante che domandarsi se si sia trattato o no di una guerra giusta. Questo ci è apparso chiaramente come un enorme e urgente problema mentre la guerra infuriava, nella primavera 1999. Ma agli storici del futuro che la studieranno, appariranno molto più interessanti altre domande, perché esse definiscono il tratto distintivo di questa fine di secolo e danno indicazioni sul secolo che si apre. La cosa che m’interessa di più capire è dunque questa: come è cambiata la guerra? Nel doppio senso, politico e tecnologico. Mi pongo così tre domande, cui tento di dare altrettante risposte. Primo: è ancora possibile una guerra tra i grandi poteri mondiali? La risposta è: no, finché l’America rimane l’unico superpotere. E possibile che, prima o poi, la Cina raggiunga il livello militare degli americani per poter effettivamente rivaleggiare con loro. Non voglio qui discutere se accadrà o no. Ma mi sembra certo che, finché non accade, una nuova guerra mondiale non è probabile. Secondo: è possibile una guerra nucleare? Da un lato la scarsa probabilità di una guerra mondiale rende improbabile anche una guerra nucleare. Ma, tecnicamente parlando, l’uso di armi nucleari in una guerra è secondo me possibile e non improbabile, perché la tecnologia le ha rese sempre più facilmente disponibili e producibili, e più rapidamente trasportabili. Dunque, escludere il rischio di una guerra mondiale non vuol dire eliminare il rischio di guerre in cui armi nucleari possano essere usate. Terzo: sono possibili guerre tra gli Stati, quelle vecchio stile, alle quali siamo più abituati? La risposta è che non sono mai finite. Eccetto che per le aree del mondo dove le due grandi superpotenze si fronteggiavano direttamente e stavano dunque ben attente ad evitare il rischio di una catastrofe nucleare, abbiamo avuto conflitti in Sud Asia, tra India e Pakistan, ci sono state guerre nel Medio Oriente, tra Iran e Iraq. Insomma, le guerre sono continuate anche nel periodo dell’incubo nucleare. La possibilità che ce ne siano ancora è dunque alta. Certo, ci sono regioni del mondo in cui ciò è assai improbabile. Per esempio, noi tendiamo facilmente a dimenticare che ci sono stati luoghi, come l’America Latina, dove nel XX secolo mai un esercito ha varcato la frontiera di uno Stato nemico, con l’unica eccezione della guerra del Chaco tra Bolivia e Paraguay (1932-35). C’è stata, sì, abbondanza di massacri e di guerre civili, ma non guerra tra gli Stati. Fino a che punto sarà lo stesso per l’Europa nel XXI secolo? Non lo sappiamo. In ogni caso, questo tipo di guerre nel mondo del futuro non possono essere escluse. Eppure, forse non saranno più così importanti come lo sono state nel XX secolo. D. Ma allora qual è la novità della guerra nei Balcani? R. Io credo che la novità della situazione creatasi nei Balcani è che la linea di divisione tra conflitti interni e conflitti internazionali è scomparsa, o tende a scomparire. E questo vuole dire che la differenza tra guerra e pace, stato di guerra e stato di pace, s’è anch’essa affievolita. 20 La situazione jugoslava ne è un esempio tipico. Da un lato, nasce da una tensione che i serbi considerano affare interno; ma, dall’altro, c’è stato un intervento esterno. Nel XIX secolo, e sino alla fine della Guerra Fredda, sarebbe stato impossibile vedere eserciti stranieri che traversano le frontiere per risolvere un conflitto interno a uno Stato. È successo addirittura che una delle due parti in combattimento ha rifiutato di riconoscere che una guerra era in corso. Sembra impossibile negare che bombardare un altro Stato sia un atto di guerra; eppure, ufficialmente, la guerra non è stata dichiarata, e ce stato dunque chi ha potuto sostenere l’inesistenza di uno stato di guerra. Questa è la novità sconvolgente della situazione. Siamo chiaramente di fronte a una conseguenza della fine della Guerra Fredda. Durante quel periodo, la stabilità relativa del mondo era basata sulla regola aurea del sistema internazionale: nessuno traversava le frontiere di un altro Stato sovrano, perché l’effetto sarebbe stato la rottura dell’equilibrio. All’indomani della Guerra Fredda abbiamo invece assistito alla fine di questa autolimitazione. Africa centrale, Jugoslavia, Kosovo, Iraq: non è per niente chiaro se queste siano state guerre oppure no. Il fatto stesso che si sia a lungo discusso per accertare se erano giuste o ingiuste, è un altro modo di esprimere la nostra perplessità, il nostro stupore davanti a un fenomeno del tutto nuovo. Norberto Bobbio, abbastanza logicamente, dice: io non voglio nemmeno affrontare questo problema, perché la vera domanda è se quella del Kosovo è stata una guerra legale secondo le regole del passato. La risposta è no. Le vecchie regole di guerra e pace, che distinguevano i conflitti interni da quelli internazionali, sono state erose e non mi sembra affatto probabile che saranno presto restaurate. D. Ci sono però anche differenze nel modo in cui la guerra è combattuta... R. Sì, e sono enormi. Alcune impreviste, altre meno. La prima differenza sta in come l’alta tecnologia ha trasformato la guerra. Abbiamo tutti temuto, agli inizi, che essa avrebbe provocato conflitti più sanguinosi e devastanti. Ma, dalla guerra del Golfo in poi, sappiamo invece che l’alta tecnologia produce una capacità di distruzione molto più precisa e discriminante. Le bombe intelligenti sono in grado di scegliere particolari obiettivi e di evitarne altri. Tralasciamo pure gli incidenti tecnici e i rischi del «fuoco amico». È importante questa novità: l’alta tecnologia ripristina la distinzione - scomparsa nel XX secolo, quando sempre più le guerre furono dirette contro i civili - tra combattenti e non combattenti. Ciò ha consentito alla Nato, per esempio nella guerra del Kosovo, di dire: noi non abbiamo nel mirino i civili, ma solo i militari e le loro installazioni. E quasi un ritorno alle vecchie regole della guerra. Almeno in linea di principio. Ma, d’altra parte, il progresso tecnologico consente un ricorso più frivolo, e più frequente, alla distruzione. Chi pensa di essere così potente da poter scegliere con accuratezza ciò che vuole distruggere, può essere più facilmente portato a tentare di risolvere i problemi bombardando, come è successo, per esempio, nel caso dell’Iraq. In questo senso, l’alta tecnologia accresce il rischio di conflitti armati, almeno da parte delle nazioni che ne dispongono. Inoltre, sottovaluta i rischi di quelli che sono chiamati «danni collaterali». Non intendo la gente uccisa per errore, ma gli enormi danni arrecati alle infrastrutture attraverso le quali una comunità vive e produce. Poiché non c’è il rischio di uccidere troppi esseri umani, si può pensare: bene, è un modo più civilizzato di fare guerra. Ma ci sono stime secondo le quali l’economia serba, in poche settimane, ha subito distruzioni maggiori di quelle che patì nell’intero 21 corso della seconda guerra mondiale. E gli effetti non ricadono solo sulla Serbia: la distruzione dei ponti sul Danubio, per esempio, colpisce in modo grave l’intera economia di un’area che va dalla Germania meridionale fino al Mar Nero e oltre. Infine, al livello più basso, quello dei popoli che non dispongono dell’alta tecnologia, si crea un’enorme discrepanza tra la guerra condotta dagli aerei che volano a quindicimila metri di altezza con bombe altamente sofisticate, e quello che succede sul terreno, dove la gente fisicamente uccide altra gente, magari con il machete o con i coltelli, come è accaduto in Africa centrale. Il fenomeno è apparso assai evidente nel Kosovo, dove due differenti guerre sono state combattute simultaneamente, senza contatti tra l’una e l’altra. Nel passato i guerriglieri erano armati con fucili o mitragliatrici, oggi hanno a disposizione lanciarazzi e armi contraeree portatili. E questa è un’altra eredità della Guerra Fredda, che inondò il mondo di sofisticati strumenti di morte. In quel periodo della storia senza guerre, l’industria degli armamenti ha operato a pieno regime, come se fosse in corso una mobilitazione generale. Ovviamente, la fine della Guerra Fredda rese subito disponibile un immenso arsenale. Le faccio un esempio: la conclusione della guerra civile in Salvador riversò subito sul mercato ingenti quantitativi di fucili automatici, che si potevano acquistare per 100 dollari l’uno al confine, da dove venivano poi trasportati in Colombia e rivenduti per 500 dollari. Un buon affare per molta gente. Il mondo è oggi pieno di armi. E ciò crea una nuova situazione in cui spuntano gruppi di free-lance della guerra. Gente non necessariamente legata a un governo, ma in condizioni di combattere. D. Ma qui lei parla di guerre private, non più di guerra. R. Non è esatto, perché io vedo in questo il segno di un’altra innovazione: il nuovo rapporto, cioè, che si va definendo tra le guerre degli Stati, o di movimenti organizzati, e le guerre private gestite da privati. E uno sviluppo potenzialmente fondamentale. Nel secolo che si chiude, con qualche eccezione, si assumeva che i conflitti armati fossero condotti dagli Stati, o da organizzazioni quasi statuali (i movimenti della Resistenza in Italia o in Jugoslavia, l’African National Congress, movimenti di liberazione nazionale). Non erano organizzate da imprese private, come avveniva ancora in Italia nell’età dei «condottieri». Fino al XVII secolo, in Europa gli eserciti erano presi in affitto dagli Stati. Nella guerra dei Trent’anni, per esempio, Wallenstein fu l’ultimo imprenditore che affittava il suo esercito agli Stati in conflitto. Oggi abbiamo un ritorno all’iniziativa privata in guerra. Ciò è molto chiaro in aree del mondo dove gli Stati si disintegrano, come in Africa, e dove corpi di mercenari sono utilizzati talvolta dalle fazioni in lotta, talvolta dai governi. Ma a questo bisogna aggiungere recenti tendenze, che riguardano anche le guerre direttamente legate e condotte dai governi, come quella di eliminare la coscrizione generale, anche da parte di paesi che finora avevano basato il loro esercito sul servizio militare obbligatorio. La tendenza generale è di concentrarsi sull’uso di militari di professione e ad alta qualificazione. Questo processo apre senza dubbio uno spazio ad attività private. Anche nei paesi più avanzati, si può ormai osservare una zona grigia dove operano insieme personale altamente specializzato in funzioni militari e imprese private che forniscono servizi di protezione e sicurezza. In Gran Bretagna, spesso i militari che provengono dai commando dei reparti speciali d’assalto, una volta lasciato l’esercito, ottengono lavori analoghi in aziende di fornitura di servizi tecnici e di 22 consulenza ai governi in materia di guerra o di antiterrorismo. C’è già una messe di studi, per esempio da parte dell’istituto di studi strategici di Londra, sulle prospettive di forze armate private nelle guerre del futuro. Alcuni pensano che non abbiano grandi prospettive, soprattutto perché poco affidabili. Ma, d’altra parte, abbiamo già potuto osservare, per esempio nella guerra del Golfo, un ampio ricorso all’impresa privata per assicurare la logistica della guerra. Un po’ come avvenne in campo civile nel periodo thatcheriano, quando servizi prima forniti direttamente dal governo vennero trasferiti in appalto esterno. Io credo che l’armamento, i trasporti, l’approvvigionamento, l’abbigliamento delle truppe, sempre più verranno appaltati a ditte private. D. E così già in Macedonia, dove un’impresa statunitense segue le truppe Nato e ne cura la logistica. R. Appunto. È un fenomeno nuovo, rispetto al XX secolo. Caratteristico di una nuova era. Scaturisce anche da una relativa disintegrazione del potere degli Stati in alcune aree del mondo. E resuscita figure nuove, che di fatto almeno in Europa non esistevano più dal XV e XVI secolo: i «signori della guerra». Gente che era in grado d’influire nella vicenda politica grazie all’organizzazione di un proprio esercito privato. Mi viene in mente la situazione che c’è stata in Cina, per cinquant’anni, dopo il collasso dell’impero e prima della rivoluzione, quando di fatto non c’era un governo ma solo il potere assicurato dagli eserciti dei «signori della guerra». Alcuni erano ex banditi, come per esempio Chan Tso Lin, che resse la Manciuria, trasformandosi in un generale. Mi pare che la situazione attuale, la commistione tra guerra privata e guerre degli Stati, renda questo fenomeno di nuovo probabile in zone di forte disintegrazione statuale. Il fenomeno è rafforzato da un altro elemento nuovo: la straordinaria ricchezza che è ora disponibile nelle mani privati. È oggi possibile, per singoli individui o per corporations, possedere tanto denaro quanto gli Stati. Anche grazie alle dimensioni che hanno assunto gli affari illegali, come il commercio di droga e il contrabbando. Per quanto ne so, nessun singolo governo ha finanziato l’esercito di liberazione del Kosovo (UCK). Anche perché credo che l’ultima cosa che i governi occidentali vorrebbero vedere è la nascita di un Kosovo indipendente. Né credo che il governo albanese li abbia significativamente aiutati, perché non penso che sia in condizione di concedere aiuti finanziari a chicchessia. Dunque ciò che tiene in piedi l’UCK è, quasi certamente, l’industria dei traffici illegali della mafia kosovara e albanese, così come è accaduto in Cecenia. Non dico che siano soldi spesi per una causa ingiusta. Sostengo che gruppi i quali altrimenti non avrebbero avuto rilevanza politica, l’acquistano ricorrendo a risorse in precedenza non disponibili. Questo è molto evidente in Colombia, dove il governo ha in pratica perso il controllo di ampie aree del paese, perché le bande che le dominano sono sufficientemente finanziate per resistere e combattere. Non c’è davvero carenza di risorse, in questo momento, nel mondo. Questi aspetti, secondo me, diventeranno sempre più rilevanti nelle guerre del futuro. E forse, almeno in parte, tale fenomeno è anche una risposta alla sua domanda sul numero di rifugiati, eccezionalmente alto, oggi presente nel mondo. È molto facile per 300 miliziani, ben armati, in teoria non controllati direttamente da nessuno Stato o governo, scorrazzare in vaste aree e ripulirle dei «nemici». Come abbiamo visto in Kosovo, non ci vogliono poi molti uomini per bruciare case e 23 villaggi, per provocare una deportazione. Meno i conflitti armati sono strutturati, statuali, e più pericolosi diventano per le popolazioni civili. Conosco una persona che ha lavorato per alcuni anni con le Nazioni Unite in Sudan, paese tormentato da una lunga guerra civile. Mi ha raccontato che, per aver accesso umanitario alle zone del Sud, all’inizio si rivolgevano ai leader del movimento di liberazione. Poi il territorio da loro controllato si è spezzato in una serie di principati retti da singoli generali, che diventarono anche i padroni della sorte dei rifugiati, perché era con ognuno di loro che l’Onu doveva negoziare per soccorrere i profughi. D. Meno male, allora, che c’è la televisione, a mostrarci il dramma dei profughi. R. Nel cambiamento del carattere della guerra è senza dubbio decisivo il nuovo ruolo assunto dall’opinione pubblica. O, come meglio potremmo definirlo, l’«effetto Cnn». Notizie selezionate su quello che accade diventano immediatamente disponibili. Anche questo è un fenomeno del dopo-Guerra Fredda. Intanto perché il controllo governativo e la censura sull’informazione sono molto minori che nel passato, e talvolta addirittura impossibili. Non era così durante la guerra del Vietnam, e ancor meno negli anni immediatamente successivi. Il dominio straordinario della televisione rende oggi impossibile per i governi gestire una crisi internazionale nei modi in cui erano abituati a fare. Ma è anche uno strumento a loro disposizione per mobilitare le opinioni pubbliche, con una rapidità incomparabile rispetto al passato. Pensi a quanto tempo fu necessario per trasformare l’affondamento del Lusitania o l’incidente del Golfo del Tonchino in un casus belli. L’effetto televisivo è invece immediato; ma anche non più controllabile. Lo si è potuto constatare osservando il modo in cui sia Saddam che Milosevic hanno consentito alle troupes televisive dei paesi in guerra contro di loro di restare e di filmare ciò che essi volevano mostrare all’opinione pubblica occidentale; mentre in passato la reazione naturale sarebbe stata uno staliniano oscuramento degli schermi. Questo fenomeno ha effetti molto importanti sulla politica della guerra. Renzo Guolo, Movimenti islamisti e jihad, in Michelangelo Bovero ed Ermanno Vitale (a cura di), Gli squilibri del terrore. Pace democrazia e diritti alla prova del XXI secolo, Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, Robenserg & Sellier, Torino 2006, pp. 131-137 5. La rete delle reti Dopo l’11 settembre al-Qa 'ida «storica», quella che abbiamo conosciuto nel «video delle grotte» circolato dopo l’attacco all’Afghanistan, non esiste più. Parte del gruppo dirigente originario è stato catturato o ucciso. I suoi leader riconosciuti, bin Làdin e al-Zawàhiri, sono nascosti e immobilizzati ai confini tra Afghanistan e Pakistan. Altri militanti storici sono confluiti nel gruppo di al-Zarqawi. Il tempo e nuovi fronti hanno accelerato la trasformazione di al-Qa 'ida in poco più che una sigla. Una sorta di copyright del terrore che accomuna cellule sparse nel mondo che 24 non hanno nemmeno bisogno di coordinarsi tra loro nella scelta degli obiettivi, tanto le unisce un’ideologia condivisa e la comune figura del Nemico: il «partito di Satana» tra i cui ranghi sono collocati «crociati e sionisti», oltre che i «governanti empi» dei paesi musulmani alleati dell’Occidente. Al-Qa 'ida è oggi, più che mai, struttura a rete. Anzi, rete di reti, sempre più transnazionali e fondate sul principio del networking. Ovvero su un principio di flessibilità nell’azione e nella comunicazione che esula dalle tradizionali forme di azione e di aggregazione delle organizzazioni terroristiche nazionali. La miriade di sigle che rinviano ai militanti coinvolti a vario titolo nelle diverse stragi rivela forme di aggregazione mobili e «collaborazioni a progetto» che non necessitano più di un input proveniente da una struttura centrale. Ijihàdisti si spostano tra un paese e un continente e l’altro, sfruttando gli snodi delle reti. Si appoggiano a reseaux non riconducibili alla fissità ambientale e territoriale tipica del terrorismo nazionale che riproduceva su scala micro i modelli macro e pesanti delle grandi organizzazioni dell’era fordista. In questo senso il cosiddetto «partito al-Qa 'ida» è quanto di meno vicino ci sia alla forma-partito classica. Gli attentati del luglio 2005 a Londra, oltre a segnare la definitiva inclusione dell’Europa nel teatro della guerra asimmetrica, confermano la nuova forma assunta dall’organizzazione del jihàd globale. Gli stessi, ricorrenti, video di alZawàhiri sigillano quella trasformazione. La leadership storica di al-Qa 'ida appare ormai come un attore che legittima ideologicamente a posteriori le operazioni messe in atto da cellule locali. Un sigillo che costituisce allo stesso tempo una sorta di richiamo all’unità operativa e alla definizione di una gerarchia degli obiettivi. Per evitare che la molecolare diffusione del jihàdismo si trasformi in spontaneismo armato efficace nel creare panico ma incapace di fissare le priorità strategiche indicate dalla leadership storica. Non a caso, con i suoi messaggi al-Zawàhiri ricorda, anche, che il qa'idaismo non può prescindere da al-Qa 'ida. 6. Forme di guerra asimmetrica: le «operazioni di martirio» Gli attentati terroristici di Madrid e Londra rivelano assonanze e dissonanze, nelle modalità d’azione e nella composizione dei gruppi operativi, tipiche di una rete di reti dotata di larga autonomia come quella del jihàdismo post al-Qa 'ida. In Spagna un’operazione dall’enorme valore simbolico - portare la guerra dentro «l’Europa crociata» e colpire il paese che, oltre a combattere «l’autentico islam» in Iraq, aveva infranto il sogno di El Andalus, uno dei miti di fondazione dell’immaginario neocaliffale di bin Làdin - è stata condotta senza shahid. Eppure dall’11 settembre in poi tutti i grandi attentati del network al-Qa'ida sono stati compiuti dai cosiddetti «martiri» suicidi. Questa specifica forma di guerra asimmetrica è particolarmente «produttiva» per chi la mette in atto. I costi umani per l’organizzazione sono ridotti, data l’ampia disponibilità di «martiri», mentre l’efficacia è spesso superiore a quella di un attacco terroristico «convenzionale». La deterrenza non funziona nel caso di attentati suicidi, perché lo shahid ha già deciso di sacrificare sé stesso. La sua unica preoccupazione è non farsi individuare prima di raggiungere l’obiettivo; ma anche in tal caso lo shahid può farsi comunque esplodere, causando vittime e seminando paura. Nella penisola iberica i jihàdtsti hanno agito secondo modalità tipiche del «terrore senza martirio». Una discontinuità rilevante: lo stragismo da timer è stato 25 sin qui più consono alle forme classiche del terrorismo secolarizzato di matrice nazionalista o ideologica. Terrorismo che, in nome del superiore interesse dell’organizzazione, cercava di salvaguardare i suoi membri dal «sacrificio». Nel caso degli attentatori di Madrid il «sacrificio» è intervenuto solo per sfuggire alla cattura. Una prassi che, nella specifica circostanza, ha modificato l’approccio qa 'idista. Anche perché il radicalismo islamista cerca sempre di conferire legittimazione religiosa alle proprie azioni. Magari reinterpretandole attraverso quella «giurisprudenza della necessità», o «diritto dinamico», che permette di fondare una «nuova tradizione» e giustificare atti inauditi per un credente. E il caso della mortifera neotradizione che trasforma il suicidio, proibito religiosamente, in «martirio» e questo in jihàd. La progressiva perifericità di al-Qa 'ida storica, però, fa venire meno anche il controllo ideologico sulle forme del jihàd e la necessità di una pur distorta legittimazione religiosa sancita dal corpo smembrato dello shahid. Producendo così una sorta di soggettivizzazione del jihàd dove alle «operazioni di martirio» si affianca ora lo stragismo da timer. Favorita dall’allargamento del bacino di reclutamento, la soggettivizzazione del jihàd incide anche sulla dimensione temporale dell’azione. Le «operazioni di martirio» pianificate da al-Qa'ida storica erano fondate su una lunga preparazione. L’attentato dell’11 settembre ha richiesto, tra progettazione, infiltrazione, preparazione, alcuni anni per essere realizzato. Non è escluso che in futuro questo possa accadere ancora. Ma i mutamenti intervenuti nella struttura a rete rendono oggi più problematici attentati programmati sul lungo periodo. I gruppi che fanno parte della «nuova» al-Qa 'ida possono avere priorità e scadenze diverse da quelle della leadership storica. L’agenda politica internazionale, ma ancor più quella interna dei singoli stati possono imporre a quei gruppi di agire a breve. Una crisi regionale, o elezioni politiche in un determinato paese, possono indurre a mettere rapidamente in cantiere campagne del terrore mirate a condizionare le scelte di un paese o del suo elettorato, come è avvenuto nel caso spagnolo. E il gruppo locale a decidere su tempi e modalità d’azione. E non sempre il gruppo locale riceve impulsi esterni. Individuare quali obiettivi vadano colpiti in un dato momento per ottenere il massimo dell’effetto politico e mediatico può essere frutto di una valutazione del tutto autonoma. 7. Il fronte interno: le nuove reclute I jihàdisti di primo livello, militanti di formazioni storiche del radicalismo politico, con un passato, anche recente, di pratica del jihad in Afghanistan o in Iraq, si spostano spesso da un paese o un continente all’altro, alla ricerca di contatti operativi che possono essere attivati anche coinvolgendo soggetti che vivono in paesi occidentali. È il caso del gruppo di cittadini britannici di origine pakistana che ha agito il 7 luglio 2005 a Londra. Si tratta di musulmani di seconda generazione, i cui padri miravano a una piena integrazione sociale nel loro nuovo paese. Nella maggior parte dei casi, la prima generazione di immigrati musulmani ha privatizzato la sfera religiosa, relegandola in ambito familiare. O ha comunque vissuto un islam di tipo etnico, che tende a riprodurre nella nuova realtà pratiche e stili di vita tipici di una certa area geografica. Non è così per la seconda o la terza generazione, cresciute nel tempo del risveglio islamico e nell’era della comunicazione globale 26 Queste generazioni hanno raggiunto un maggiore grado di integrazione che può apparire loro, talvolta, soddisfacente sul piano sociale ma non su quello culturale. Questa percezione può talvolta sfociare in reazioni identitarie anche di matrice radicale. Le seconde generazioni sono in grado di decodificare le categorie della politica, i simboli, i linguaggi dei due mondi vitali di appartenenza. E attraverso una mobilità spazio-temporale molto più accentuata che in passato, fisica o virtuale, possono mantenere facilmente i contatti con le comunità d’origine. L’islam radicale, ultima grande ideologia universalista totalizzante, sembra fornire risposte a questi musulmani in Occidente, incapaci di vivere una non facile identità plurima. Gli islamisti radicali ne interpretano le pulsioni individuando come Nemico quella stessa struttura sociale e di valore cui essi attribuiscono sovente la loro insoddisfazione esistenziale. E attraverso una concezione ideologica della religione, o meglio la sua reinterpretazione secondo i canoni della nuova tradizione islamista, divenuta fonte di identità da utilizzare nel momento in cui è necessario marcare una differenza antagonista, cercano di convertirli all’islam politico. Quello che induce i giovani musulmani della diaspora al passaggio tra la «gente del fronte» è in primo luogo l’odio verso l’Occidente. Verso un sistema di valori, di istituzioni sociali, di regole, che rifiutano dopo averle sperimentate direttamente. Le società occidentali, nonostante l’adozione di diversi modelli di integrazione, continuano a produrre marginalità culturale per i non autoctoni. E questa marginalità è terreno di coltura per il radicalismo islamista. L’adesione alle dottrine dell’islam radicale è un passo che sistematizza e inquadra in una precisa visione del mondo quell’odio ancora prepolitico. Quando giovani musulmani in Occidente optano per una simile scelta di campo, il loro obiettivo non è tanto la nascita o la liberazione di una nazione ma la ricostituzione della comunità. O meglio di una neocomunità. Una neocomunità tanto agognata quanto impossibile da ricostituire, minata com’è in partenza dal suo essere contaminata dalla quotidianità e dal contatto con l’Occidente divenuto globale. Il «martirio» diventa così, anche, l’inconscio tentativo di sfuggire alla morte della comunità impossibile; di spargere lutto per evitare di elaborare, nuovamente, il lutto. Quando questa «infelicità con desiderio» incontra la filiera organizzativa che la mette in forma, come nel caso londinese, il risultato è spesso il dare la morte. All’Altro e a sé. 8. Integrazione e sicurezza Mobilità e logistica del jihàd non possono prescindere totalmente dal rapporto con reti territoriali. Rapporto che, in Occidente, viene costruito attraverso l’utilizzo strumentale delle reti migratorie. La trasformazione delle società occidentali in società multietniche permette infatti ai jihàdisti un certo grado di mimetismo sociale in ambienti omogenei etnicamente, culturalmente e religiosamente. Questo intreccio tra mobilità attiva e stanzialità complice, in alcuni casi solo passiva per effetto delle norme sociali relative all’ospitalità o a forme premoderne di solidarietà come le comuni appartenenze di città o villaggio riprodotte nell’esperienza migratoria in Europa, crea un humus difficilmente controllabile con i classici strumenti usati in passato per affrontare il terrorismo interno. Quella del mimetismo sociale dei jihàdisti nelle comunità immigrate è una variabile sempre più rilevante per le strategie di contrasto al terrorismo. In questo panorama in continua trasformazione le politiche di contrasto al jihàdismo moleco27 lare non possono che articolarsi su due livelli. Quello indispensabile della prevenzione e dell’intelligence, che ha come orizzonte il breve periodo. E quello più difficile, ma altrettanto indispensabile, di lungo periodo, che investe gli orientamenti delle comunità islamiche in Europa. Flussi migratori e demografia dicono che nei prossimi decenni i paesi europei saranno sempre più multietnici; e che larga parte degli immigrati verrà dal Nordafrica, dal Medioriente, dal Pakistan. Aree in cui il radicalismo islamico è diffuso e gode di consenso. Le seconde e le terze generazioni di cittadini europei, o residenti, di religione islamica, saranno dunque già comparse all’orizzonte. La possibilità di arruolare militanti, o di contare su una vasta area grigia di simpatizzanti, capaci di mettere a disposizione un retroterra logistico attivo o passivo, aumenta il rischio che l’Europa si trasformi in terra del jihàd. La politica dell’immigrazione diventa così, sempre più, componente decisiva della politica di sicurezza, europea e nazionale. Ma per esserlo davvero deve implementare modelli di integrazione capaci di rendere fisiologici, e non patologici, i fenomeni di devianza jihàdista nelle comunità islamiche. Frange radicali alligneranno ancora a lungo al loro interno. Almeno sino a quando il ciclo politico del «risveglio» e il livore antioccidentale verrà meno. Le comunità islamiche in Europa non sono che lo specchio, dal punto di vista religioso, politico, etnico, della grande umma musulmana, con tutte le sue differenze di orientamento ma anche con le medesime fratture interne. Il peso di simili frange può essere contenuto non solo da scelte di politica internazionale, ma anche nazionale. Di fronte agli attentati di Madrid e Londra la reazione di alcuni settori politici è stata quella di adottare severe politiche di restrizione migratoria e di mettere in discussione il modello di società aperta tipico delle democrazie occidentali. Ma queste posizioni si limitano più a indicare un potenziale pericolo, o gli eccessi xenofili di alcuni modelli di integrazione, che soluzioni reali. Una politica inclusiva pare più efficace di una esclusiva anche sul piano della sicurezza. Attribuzione di cittadinanza e integrazione culturale possono giungere là dove nessun panopticon poliziesco, anche il più sofisticato, può gettare il suo sguardo. Benché nel caso inglese questa politica non abbia, di per sé, garantito totali effetti di contrasto, la sua assenza avrebbe probabilmente amplificato a dismisura il rischio di reazioni identitarie potenzialmente destinate a sfociare nell’adesione al jihàdismo. Uno sviluppo da scongiurare con ogni mezzo. Anche perché, a causa della presenza, in tutta Europa, di attivi imprenditori politici della xenofobia antislamica, simili derive potrebbero sfociale in conflitti politici e sociali assai duri. Integrare le comunità musulmane, farle diventare parte del tessuto nazionale aiutandole, e obbligandole, a uscire dalla ghettizzazione culturale in cui vogliono rinchiuderle, per realizzare i loro obiettivi, anche taluni attori islamisti dell’islam organizzato, diventa così, sia un contributo alla riaffermazione della società aperta, sia un contributo alla sicurezza collettiva. 28 Il teatro mediorientale Vittorio Emanuele Parsi, I paradossi della guerra al terrorismo, Limes 2004-3 Monografia, Il nostro Islam, pp. 299-306. Tra la fine della seconda guerra del Golfo (1990-1991) e il conflitto che ha portato alla caduta del regime di Saddam Hussein lo scenario internazionale è andato precisandosi e, bisogna aggiungere, in una direzione per nulla favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Tanto nella percezione quanto nella realtà si è passati dall’opportunità di un nuovo ordine mondiale fondato sull’egemonia americana a un sistema sostanzialmente instabile, nel quale nessuno appare credibilmente in grado di ergersi per bilanciare la sola iperpotenza rimasta sul pianeta, ma dove d’altronde la «superpotenza solitaria» deve constatare la propria incapacità a garantire non solo un ordine internazionale passabilmente pacifico, ma persino la sua stessa sicurezza nazionale. Gli anni che separano la presidenza di George Bush da quella del figlio George W. sono tutti inscritti nel progressivo fallimento di un disegno realmente egemonico (e quindi in una certa misura «condiviso» con vecchi e nuovi partner: principalmente Europa e Russia), fallimento che ha finito col lasciare spazio a due pseudoalternative in realtà accomunate dalla loro impraticabilità: il ritiro dal mondo, in una sorta di riedizione dell’isolazionismo sovente praticato e teorizzato nella storia americana e quell’ambizione imperiale che forse nessuno desidera meno degli americani stessi. A circa un quindicennio dalla caduta del Muro di Berlino, se sono venute meno le premesse per un ordine internazionale fondato sull’equilibrio del terrore e per la conseguente «pace d’equilibrio», non si sono però concretizzati i presupposti sufficienti a realizzare un ordine capace di trasformare il «momento unipolare» del sistema politico internazionale in una «pace egemonica». Non v’è dubbio alcuno che a rendere il progetto di un’egemonia americana condivisa, «benigna» e «costituzionalizzata» sempre meno probabile siano stati i crescenti malumori europei e, sia pure in misura minore, la resistenza russa ad entrare in uno schema che riservava a Mosca non molto di più rispetto al ruolo che essa comunque detiene già nei fatti. Anzi, si può persino affermare che le spaccature europee di fronte all’atteggiamento e al comportamento da tenere nei confronti di Washington hanno sortito una serie di effetti non adeguatamente sottolineati da tutti gli osservatori. Va rilevato, in primo luogo, che l’aspra contrapposizione tra i principali paesi europei sul sostegno alla guerra contro Saddam ha consentito di velare temporaneamente altri più profondi dissidi sull’assetto interno dell’Unione e sul suo futuro: grazie al catalizzatore della «guerra americana» è stato possibile scaricare verso l’esterno dell’Unione la dinamica della frattura, in tal modo depotenziandone almeno in parte gli effetti dirompenti. In secondo luogo è necessario sottolineare che la spaccatura europea, se rischia di mettere in pericolo il futuro di quel «bene necessario» che l’Unione rappresenta per gli europei, allo stesso tempo rende monco fin dall’inizio qualunque serio progetto egemonico da parte degli Stati Uniti. L’idea che all’egemonia americana sia funzionale una debolezza strutturale europea è infatti semplicistica. Essa riposa su una visione statica delle dinamiche e dei rapporti di forza in politica 29 internazionale, oltremodo eurocentrica (assai poco attenta al ruolo crescente assunto o atteso da paesi come Cina, India, Pakistan, Brasile). Contemporaneamente sposa un’idea di egemonia sostanzialmente schiacciata sulla dimensione imperiale, finendo con il negare la stessa esperienza storica. Essa non tiene conto di una delle caratteristiche più peculiari della leadership americana: il fatto che per circa mezzo secolo l’egemonia dell’America è stata esercitata con successo sull’Occidente grazie a istituzioni multilaterali come la Nato, l’Fmi, la Banca mondiale e il Gatt. Ma soprattutto essa ignora che questo periodo abbia fornito un «paradigma» assai più che un esempio di come solo una leadership in cui il ruolo egemonico è accettato nel reciproco vantaggio (e parzialmente condivisa) può aspirare a un successo duraturo. In questo senso, la crisi del rapporto transatlantico priva l’America di quella solidarietà occidentale che non è solo il retrovia per qualunque aspirazione globale della sua leadership, ma che rappresenta la prova stessa che la legittimazione dell’egemone da parte degli egemonizzati ne è un elemento costitutivo. In terzo luogo, proprio l’oggettivo «sfilarsi» dell’Europa come tale dal disegno egemonico americano ha fornito alla Russia di Putin quella sponda che le era necessaria per resistere alla presunta «inevitabilità» dell’ingresso nella sfera d’influenza americana. La Russia ha cioè potuto ricominciare a elaborare una propria politica estera e una sua posizione internazionale non meramente reattiva (per non dire «adattiva») rispetto alle mosse americane. La novità dischiusa dalla posizione europea alla Russia acquista poi un rilievo ancora maggiore, se solo si ricorda come per anni, e su questioni non certo trascurabili per la sicurezza e per la suscettibile concezione russa della propria sovranità (dall’allargamento della Nato all’accettazione della presenza militare americana in Asia centrale e nel Caucaso), Mosca abbia sistematicamente acconsentito a tutte le mosse di Washington. Conseguenze non volute della guerra al terrorismo L’incapacità di Washington di «saldare» in un coerente disegno egemonico Europa e Russia rischia di decretare la fine del disegno stesso o, peggio, l’impossibilità di una sua realizzazione effettiva accompagnata però dall’incapacità di riconoscerlo. Significativamente, gli eventi che segnano l’origine, la ripresa potenziata e il declino del progetto egemonico si scatenano tutti nell’area mediorientale. La grande coalizione realizzata da George Bush contro Saddam Hussein per liberare il Kuwait segnò il varo di un progetto per il nuovo ordine mondiale nel quale, per usare una metafora organizzativa, un chairman executive officer autorevole era assistito da vice chairmen dotati di potere delegato. Ampio spazio era esplicitamente riconosciuto a Russia, Europa e Nazioni Unite. Quell’architettura, ancorché poco più che abbozzata, non solo nasceva sulle ceneri di un conflitto mediorientale, ma prevedeva esplicitamente l’inclusione al suo interno del Medio Oriente. La sconfitta di Bush e gli anni successivi caratterizzati sia dal riemergere di una nuova centralità europea (guerre balcaniche, allargamento della Nato e trasformazioni in ambito Ue) sia dalla volontà americana di riequilibrare il peso della propria attenzione strategica tra Atlantico e Pacifico resero piuttosto intermittente la concentrazione di Washington sul Medio Oriente, almeno fino agli ultimi anni del secondo mandato di Bill Clinton, quando il presidente giocò la carta dell’intermediazione attiva nel processo di pace israelo-palestinese. L’avvento di George W. Bush sembrò persino accentuare la deriva verso il Pacifico e verso una mag30 giore introversione degli Stati Uniti, almeno fino all’11 settembre e alla trasformazione del terrorismo di matrice fondamentalista nella principale minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Sull’onda dello shock rappresentato da questa minaccia l’America rilanciò il proprio disegno egemonico, e ottenne in Afghanistan l’appoggio determinato dei vecchi e nuovi alleati europei e della Russia, il beneplacito delle istituzioni internazionali, la condiscendenza cinese e persino un certo discreto sostegno da parte di molti Stati musulmani, non solo arabi. Nel giro di meno di due anni gran parte di questo è venuto meno, dissolto nei mesi della preparazione alla guerra in Iraq e in quelli successivi alla chiusura ufficiale della campagna. Contravvenendo a un’impostazione assai «scolastica» eppure sempre incredibilmente in voga, l’emergere del terrorismo internazionale di matrice fondamentalista non ha rinsaldato le file dell’alleanza americana, né ha fornito all’egemonia americana un nuovo supplemento di legittimità. Al contrario, da quando la war on terror è stata dichiarata, la disunione ha preso il posto dell’unità di intenti. Certo, è chiaro che gli Stati Uniti hanno subìto il colpo più duro e inaspettato. Ma è noto che il fondamentalismo terrorista costituisce una minaccia mortale anche per molti dei regimi al potere nei paesi islamici. Ed è innegabile che per questioni di mera contiguità geopolitica il successo della proposta fondamentalista nelle società musulmane rappresenta un’oggettiva minaccia alla sicurezza europea. Sulle conseguenze di un simile fatto nelle vicende della politica russa, poi, gli eventi ceceni sono fin troppo evidenti. Le ragioni di un simile insuccesso politico sono normalmente fatte risalire al cosiddetto unilateralismo americano. A mio avviso, però, ciò ha solo reso più pesanti le conseguenze di un vero e proprio shift nell’elaborazione strategica e concettuale con cui l’America interpreta il mondo. La dottrina della «guerra preventiva», con il suo corollario di categorie «politico-operative» come «Stati canaglia» e «Stati falliti», «asse del Male» e quant’altro non ha ovunque lo stesso suono. Non c’è forse regione al mondo che sia stata investita dalle conseguenze dell’11 settembre come il Medio Oriente. L’attentato alle Twin Towers ha prodotto l’adozione di una nuova dottrina sull’uso della forza da parte dell’amministrazione di George W. Bush, e non c’è dubbio che questo passo abbia implicazioni di carattere strategico e di portata generale. Essa è stata associata a una vera e propria nuova visione del sistema politico internazionale, delle sue istituzioni e delle norme che lo presiedono. Ma questo ulteriore passo nella direzione del revisionismo assertivo dell’architettura e delle regole di funzionamento del sistema operato dagli Stati Uniti ha avuto un impatto tutt’altro che teorico proprio in Medio Oriente. Ciò non deve sorprendere, considerata la matrice mediorientale dell’attentato sia in termini della provenienza degli attentatori e dell’organizzazione cui erano affiliati, sia in termini dell’ideologia che li ispirava. E non è certo una novità dell’amministrazione Bush quella che individua nel terrorismo fondamentalista la principale minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma è questa amministrazione ad avere determinato che il terrorismo fondamentalista è la nuova minaccia sia alla sopravvivenza delle democrazie sia alla pace generale del sistema (raggiungendo vertici di pericolosità che nemmeno il comunismo sovietico si era visto attribuire) e, soprattutto, è questa amministrazione che ha voluto ricavare dall’esperienza americana in Medio Oriente dei nuovi paradigmi interpretativi ritenuti validi per l’intera politica internazionale. Ma per capire di che razza di rivoluzione si tratta, dobbiamo fare un salto all’indietro di oltre trecento anni, e tornare alla genesi del sistema politico internazionale in termini concettuali. 31 La vera fine di Vestfalia Com’è noto, l’idea di sistema politico internazionale (allora definito spesso come comunità internazionale) è fatta risalire, convenzionalmente, alla pace di Vestfalia, che nel 1648 mise fine alla guerra dei Trent’anni. Quella pace sancì anche la conclusione delle guerre di religione in Europa e contemporaneamente fornì ai nuovi protagonisti assoluti della politica internazionale, gli Stati, la possibilità di definirsi ad un tempo «assolutamente sovrani» eppure legati gli uni agli altri dal riconoscimento reciproco alla propria «legittima esistenza». La guerra non veniva certo «abolita», ma veniva riservata ai casi estremi la teorizzazione che un regime politico o un attore territoriale potesse essere messo «al bando» da parte degli altri. Vestfalia fu così all’origine sia delle categorie giuridiche con le quali si procedeva alla teorizzazione del sistema «politico-istituzionale» internazionale sia delle categorie politiche con le quali si precisavano le regole di funzionamento e di condotta del sistema «politico-politico» internazionale. Lo «Stato moderno europeo», grazie alla sua duplice natura di poderosa invenzione politica e di straordinario artificio giuridico rappresentava lo snodo tra i reami del diritto e della politica. In maniera analoga il suo «monopolio della violenza legittima», almeno in via di principio, ne faceva il giunto concettuale tra arena interna e arena internazionale. A partire da questa raffinata elaborazione teorica, qui molto semplificata, le categorie interpretative elaborate sulla scorta dell’esperienza europea iniziarono progressivamente a egemonizzare il mondo, seguendo l’espansione dell’Europa e del «suo» sistema internazionale nei secoli successivi. Per più di un aspetto l’epoca della guerra fredda segnò l’apice dell’espansione del sistema politico internazionale e della pretesa capacità euristica globale delle categorie che potremmo definire in senso ampio «occidentali». L’ipotesi che suggerisco è che a partire dalla fine del bipolarismo, con la sua capacità inglobante universale, siano in corso una serie di rotture rispetto a questo movimento appena descritto. In primo luogo siamo di fronte a una contrazione del sistema politico internazionale nella sua dimensione unitaria. La parte di mondo per il quale riusciamo ancora ad applicare in maniera «indolore» le nostre categorie si sta restringendo nuovamente all’Occidente e a qualche sua propaggine. Dal Medio Oriente all’Africa, all’Asia, compaiono sottosistemi regionali differenziati per regole, aspettative, comportamenti e caratteristiche degli attori, probabilità del ricorso alla violenza eccetera. Questa contrazione, ecco la seconda rottura, lascia spazi vuoti che progressivamente assumono le vesti dello «Stato fallito», cioè di territori contraddistinti da due caratteristiche: l’assenza di una qualche autorità in grado di monopolizzare la violenza legittima e l’irresponsabilità nei confronti della comunità internazionale. Ne deriva un sistema internazionale assai poco unitario nelle regole e nei comportamenti, ma segmentato in sottosistemi spesso uniti solo per via violenta, durante le crisi, gli attentati alla bin Laden e le guerre. In tali sottosistemi, i cui confini sono però sfrangiati e mobili, sono presenti alcuni attori globali o pluriregionali, i quali sono condannati all’incoerenza o all’ipocrisia: perché se vogliono mirare all’appropriatezza nei confronti delle regole del sottosistema in cui intervengono devono per forza rinunciare a qualunque coerenza interna rispetto ai propri canoni. L’esempio classico è quello della politica americana nel Medio Oriente, che tutte le volte che vorrebbe essere appropriata si espone alla denuncia nel foro interno da parte della pubblica opinione occidentale (e di quanti si riconoscono nei valori occidentali), ma che quando cerca di ap32 plicare uno standard «liberaldemocratico» finisce però col prestarsi all’accusa di imperialismo culturale. Più in generale, si pensi alla questione del rapporto tra religione e politica. Nell’esperienza occidentale la neutralizzazione della religione dall’arena della politica internazionale ha rappresentato la chiave di volta per l’edificazione dello Stato moderno e del sistema internazionale. E quindi è ovvio che nel sottosistema occidentale essa venga difesa come punto irrinunciabile. Meno ovvio è che gli attori di questo sottosistema se ne facciano paladini intransigenti quando agiscono nel Medio Oriente. D’altronde, per molti degli attori di questa regione è semplicemente inaccettabile l’idea che religione e politica debbano essere ambiti rigorosamente separati. Né più né meno di quanto sarebbe inaccettabile, per chiunque fosse cresciuto nella tradizione e nella pratica della politica americana, l’idea che la sovranità nazionale degli Stati Uniti, che appartiene ai cittadinielettori, possa essere in qualunque misura trasferita a istituzioni sovranazionali. L’ultima e più pericolosa rottura è quella introdotta alla fine del precedente paragrafo, secondo la quale, invertendo una tradizione di secoli, gli strateghi della sola superpotenza globale rimasta hanno ricavato dall’esperienza americana in Medio Oriente dei nuovi e rivoluzionari paradigmi interpretativi che sono ritenuti validi per l’intera politica internazionale. Siamo così passati dalla progressiva espansione del sistema politico internazionale alla sua progressiva contrazione e frammentazione. E stiamo assistendo a un’inversione ancora più grave in termini concettuali. Se in precedenza tutto il mondo era inquadrato attraverso categorie ricavate dall’esperienza europea, oggi si pretende che la medesima operazione avvenga al contrario, attraverso un’elaborazione teorica che parte dall’esperienza mediorientale. Ciò rischia di rappresentare un errore ancora più grave nelle conseguenze di quello che, durante la guerra fredda, dal teatro europeo proiettava la logica Est-Ovest, comunismo-liberaldemocrazia, in ogni angolo del pianeta, finendo con il conculcare altre dinamiche probabilmente euristicamente e politicamente più significative. La maggior pericolosità di questo scenario, a mio avviso, deriva dal fatto che la logica bipolare dell’equilibrio del terrore produceva un «sistema di pieni» e soprattutto vedeva la principale minaccia all’ordine nell’eccesso della potenza disponibile e non certo in una sua insufficienza. Mentre oggi, all’interno di questo sistema che è unipolare ma non riesce a essere compiutamente egemonico, e in cui abbondano i «vuoti», tutta la concentrazione di potenza è comunque insufficiente ad assicurare una stabilità accettabile. Conclusioni Significativamente è proprio nel teatro mediorientale che, in termini di politica operativa, gli Stati Uniti si ritrovano a incorrere in una vera e propria schizofrenia. Da un lato pretendono di ergere a unico stipite di legittimità politica il modello di Stato occidentale contemporaneo: laico, fondato sulla libera competizione elettorale e su diritti a base individuale. Dall’altro ricavano dalla propria particolare esperienza con la politica mediorientale delle categorie interpretative valide per l’intero sistema: dalla guerra preventiva (che Israele pratica per lo meno dal 1956 e senza mai ottenere un successo risolutivo e duraturo), allo Stato fallito (del quale, per un certo numero di anni, il Libano ha fornito un esempio), allo Stato canaglia (l’Iraq di Saddam Hussein, la Siria, l’Iran…). Proprio ora che hanno deciso di trasformarsi, almeno temporaneamente, in una potenza «anche» mediorientale, gli Stati Uniti dovrebbero muoversi nei confronti degli Stati della regione con una 33 maggiore attenzione ai «comportamenti» (le policies) e con una minore ossessione per gli «atteggiamenti» (i princìpi di legittimazione del potere politico e le forme organizzative che assumono). Piuttosto che perseguire troppo ambiziosi disegni di esportazione militare della democrazia in tutto il Medio Oriente, e di ritenere quindi non pienamente legittimi la quasi totalità dei governi della regione, gli Usa farebbero meglio a concentrarsi sui parametri della rappresentatività interna dei regimi (non definibile in termini esclusivamente elettivo-rappresentativi) e sulla loro responsabilità verso la comunità internazionale (nei termini di non prestare assistenza ai gruppi terroristici e di trasparenza rispetto ai programmi di armamento non convenzionale). Non solo. Sarebbe negli interessi degli Stati Uniti e dell’efficacia della loro politica in Medio Oriente che questa fosse più aderente alle regole di comportamento e funzionamento del sottosistema mediorientale. Continuare ad agitare la minaccia del conflitto nei confronti dell’Iran, solo per citare il caso dell’attore regionale probabilmente più importante dopo Israele, appare poco produttivo. Almeno tanto quanto lo è l’illusione di poter influenzare dall’esterno e con questi strumenti quel corso moderato e riformatore che pure riscuote l’ovvia simpatia di noi occidentali. È probabile che la «lezione» impartita a Saddam Hussein abbia spinto alcuni regimi, come quello della Siria, a più miti consigli, dimostrando che, per gli Stati Uniti, la vecchia massima attribuita a Theodore Roosevelt «speak softly and carry a big stick» è sempre valida. Ma una progressiva uscita dalle condizioni di «stato d’emergenza permanente» che caratterizza il Medio Oriente è decisiva affinché la febbre mediorientale non contagi tutto il sistema e, come pure rischia di avvenire attraverso la dottrina Bush, lo stato d’emergenza non si faccia «planetario». E per scongiurare una simile eventualità sembra determinante anche la capacità di interagire con quegli attori in un recente passato identificati come esponenti dell’«axis of evil ». Sulla definizione del terrorismo occorre infine una dolorosa ma necessaria precisazione. Rispetto all’obiettivo di sconfiggere il «terrorismo fondamentalista globale» (del tipo di al-Qå‘ida) è controproducente assimilarlo con quello delle organizzazioni palestinesi che combattono una guerra di liberazione nazionale (in sé legittima) attraverso strumenti inaccettabili (come gli attentati suicidi). È del tutto evidente che, seppur si decida di combattere gli uni come gli altri, la confusione non giova. Se infatti contro il primo tipo di terrorismo si può sperare di ottenere l’appoggio degli Stati islamici e arabi (come del resto già in parte si verifica), contro il secondo è impensabile che ciò avvenga: per lo meno fino a quando il conflitto israeliano-palestinese non si sarà avviato sulla strada della pace nella reciproca sicurezza per i due popoli. Una strategia che accettasse l’equiparazione tra terrorismo globale e terrorismo palestinese (legittimamente sostenuta da Israele per evidenti motivi attinenti alla sua sicurezza) finirebbe col perfezionare la saldatura tra due fenomeni diversi che purtroppo negli ultimi anni si sono fin troppo avvicinati l’uno all’altro, con grave danno per la sicurezza complessiva del sistema internazionale, non escluso Israele. David Polansky, Grande medio oriente o araba fenice? Limes 2005-3 Monografia La potenza di Israele, pp. 175-182 1. Che cos’è il Grande Medio oriente? Secondo l’amministrazione Bush è una larga fascia del pianeta che comprende 27 paesi più i Territori palestinesi, per lo più ma non interamente musulmana, estesa dal Nordafrica al Golfo Persico e ancora 34 più a est al Pakistan. La sua demarcazione costituisce il culmine di un’evoluzione messa in moto dagli eventi dell’11 settembre. Sebbene disomogenea sia dal punto di vista geografico che politico-culturale, questa regione è tuttavia accomunata dalla minaccia dell’esportazione del terrorismo islamico, presumibilmente cresciuto all’ombra delle sue innegabili carenze democratiche. L’amministrazione americana intende disinnescare la minaccia jihadista ed evitare futuri attacchi attraverso una serie di misure volte a sollecitare riforme democratiche in tutta la regione. Questa la politica dichiarata. Ma è anche una strategia? È sufficiente a fornire una struttura coerente che consenta di gestire e integrare i vari interessi americani nella regione? Può dar vita a una politica di raccordo che impedisca la ricaduta l’uno sull’altro dei diversi problemi economici, militari e geopolitici? Per comprendere meglio il punto in cui siamo, prima di tornare alla situazione attuale analizziamo la strategia perseguita nel corso della guerra fredda nei confronti del Medio Oriente, per vedere quanto essa sia stata utile agli interessi Usa. Perché, prima di allora, gli Stati Uniti non avevano quasi esperienza di quella parte del mondo. 2. La strategia della guerra fredda aveva in Medio Oriente due obiettivi fondamentali, collegati fra loro: assicurare quel poco di stabilità nella regione necessaria per garantire un flusso continuo di petrolio verso l’America e controbilanciarvi l’influenza dell’Unione Sovietica. All’epoca gli Usa non erano tanto preoccupati dalla natura dei governi al potere nell’area quanto dalle loro tendenze filoamericane o filosovietiche. In seguito alla crisi di Suez e alla proclamazione della dottrina Eisenhower a sostegno dei paesi in pericolo di finire sotto l’egemonia sovietica (rispettivamente nel 1956 e nel 1957), un equilibrio della potenza venne raggiunto con lo schieramento filoccidentale di Giordania, Libano, Iran e Turchia in contrapposizione all’Iraq, alla Siria e all’Egitto, antioccidentali, mentre gli Stati del Golfo cercavano di mantenere una neutralità economicamente vantaggiosa. Tale equilibrio fu reso precario dall’ascesa di un socialismo di tipo sovietico a livello panarabo: tale movimento, impersonato da Gamal ‘Ab al-Nasir (Nasser), poteva contare sull’appoggio politico dell’Urss e su quello intellettuale dell’intelligencija araba. I suoi obiettivi messianici rivolti ai fratelli arabi al di là delle frontiere gli assicurarono il temibile potere di influenzare i mutamenti geopolitici più di quanto potessero le Forze armate dei diversi Stati arabi. Infine, l’escalation nel conflitto arabo-israeliano con la conseguente guerra dei Sei giorni, nel giugno del 1967, inserì nell’area l’ultima grossa pedina del gioco regionale. Questa guerra, in cui gli Usa fecero poco o nulla, segnò il punto di svolta nella storia della regione: fu l’occasione in cui i sovietici si schierarono contro Israele, e in cui la sbalorditiva vittoria militare dello Stato ebraico ne fece una grande potenza regionale. Fu anche un punto di svolta nella percezione americana dell’area. Di fronte al crescente radicalismo che indeboliva il controllo dei regimi arabi, gli Usa si scoprirono a considerare un Israele stabile e militarmente predominante, non più uno Stato bisognoso ma un alleato potenzialmente utile. Nella guerra dello Yom Kippur del 1973 gli Stati Uniti scorsero l’opportunità di bloccare i sovietici una volta per tutte. Dimostrando l’impotenza dell’espansionismo arabo supportato dall’Urss a perseguire i propri obiettivi (nonché la volontà dell’America di controllare l’Urss al livello nucleare), gli Usa riuscirono a usare il conflitto arabo-israeliano per infrangere l’impasse e portare (benché lentamente) un recalcitrante Egitto dalla parte dell’Occidente senza neppure mettere piede sul quel suolo. 35 Insomma, quella strategia riunì gli obiettivi geopolitici ed economici degli Usa sostenendo un equilibrio dominato da Israele, che respingeva l’autorità regionale dei sovietici, e al contempo frenava la miriade di rivalità e faide regionali tra gli arabi. Quanto alla causa della Palestina, il nazionalismo palestinese incarnato dal movimento di Yasser Arafat, Fath, costituiva una minaccia diretta per i regimi di Egitto, Giordania e Libano. Sostenere tale causa in quegli anni sarebbe equivalso a sostenere il rovesciamento dello status quo in gran parte del mondo arabo e a sostituirlo con un radicalismo politico senza direzione, in gran parte sovvenzionato dall’Unione Sovietica. Da parte araba, i governi essenzialmente autocratici di quei paesi furono spinti a cooperare per paura di Israele o l’uno dell’altro, mentre agli Stati del Golfo produttori di petrolio veniva garantita sicurezza e una relativa stabilità in cambio della vendita del loro prezioso prodotto. Era una stabilità fondamentalmente precaria ma resistente, anche durante la guerra civile in Libano e la rivoluzione iraniana. Dopo la fine della guerra fredda, l’ordine fu mantenuto respingendo l’invasione del Kuwait ad opera di Saddam Hussein e consentendo ad Hafiz al-Asad di consolidare il proprio controllo sul Libano, secondo il dettato di Henry Kissinger: consegnare il Libano alla Siria per avere pace in Medio Oriente. Nel complesso non fu una strategia perfetta, tuttavia riuscì a mantenere un equilibrio tra i diversi interessi americani nella regione. Se ha avuto la debolezza di considerare l’area essenzialmente nei termini del più ampio conflitto globale in corso, ha anche avuto la grande forza di evitare il riduzionismo, rifiutando di guardare ai molti problemi e ai conflitti attraverso il prisma di una singola questione, come il conflitto israelo-palestinese (post-guerra fredda) o la promozione della democrazia (post-11 settembre). La sua maggiore debolezza è consistita nel fatto che, considerando l’area fondamentalmente al livello dei suoi Stati, non è riuscita a riconoscere le varie tendenze interne o sopranazionali in atto, soprattutto la crescita del radicalismo religioso. In molte occasioni, come in Libano o in Arabia Saudita, questa linea ha comportato una capitolazione di fronte al terrorismo, finendo per raccogliere tempesta dopo aver seminato vento. Infine, gli statisti americani dell’epoca, che avevano a che fare con i leader di nazioni i cui confini geopolitici erano spesso illusori nella migliore delle ipotesi, rimasero delusi perché ritenevano che gli interlocutori arabi avessero il potere e la competenza per trattare al meglio i propri affari. Soprattutto, gli americani non furono in grado di comprendere che, vedendo indebolirsi la propria autorità, per i regimi arabi non sarebbe più stata la medesima cosa preservare se stessi e servire gli interessi americani e che, costretti a scegliere, i leader arabi avrebbero sempre optato per la prima a scapito della seconda. Il periodo seguito alla fine della guerra fredda fino agli attacchi dell’11 settembre è stato essenzialmente un periodo opaco, da cui non è scaturita alcuna regola strategica. Gli attentati terroristici hanno cambiato tutto. Il terrorismo come tattica è sempre esistito, ma solo dopo l’11 settembre è stato riconosciuto come minaccia globale, e solo dopo di allora è stato trattato come uno dei fattori più importanti – in effetti quello determinante – nel forgiare la politica degli Stati Uniti nei confronti del Medio Oriente. 3. Ma cosa è veramente cambiato e cosa è rimasto lo stesso? Se il progettato Grande Medio Oriente è l’ultima (finora) evoluzione del nuovo approccio, cominciare dalla superficie può essere utile. Come è stato già notato, tale entità comprende le 22 nazioni della Lega araba oltre ad Israele, i Territori palestinesi, la Turchia, l’Iran, il Pakistan e l’Afghanistan. Partendo dalla geografia, questo grup36 po contiguo di paesi abbraccia l’intera area circostante il Golfo interessata dalla strategia della guerra fredda, e oggi molto più estesa. Cosa ci indica la carta geopolitica di questi paesi? Curiosamente, non solo la presenza delle cellule terroristiche islamiche. Molti, ma non tutti, posseggono il petrolio; gli Usa hanno, o cercano di avere, basi militari in molti di essi; alcuni, ma assolutamente non tutti, fronteggiano un’instabilità interna. Nessuno, eccetto Israele e la Turchia, è una democrazia. Si potrebbe dire che il Grande Medio Oriente è la più ampia regione contigua comprendente tutti i suddetti fattori, tuttavia la sua vastità e dilatazione la rendono una chimera geopolitica. Le monarchie affacciate sul Golfo sono molto meno preoccupate da Israele e dalle sue potenzialità militari che dall’Iran. Sia le monarchie del Golfo che l’Iran sono impensierite dal futuro sviluppo dell’Iraq, mentre l’Egitto non è tanto preoccupato dalle possibili future minacce territoriali da parte di un Iraq riunificato quanto da Israele, dalla sua politica nei confronti dei palestinesi, dalla sua potenza militare e dalla posizione che avrà nella regione una volta raggiunto un accordo. Algeria e Marocco, d’altra parte, si guardano l’un l’altro con una preoccupazione maggiore di quanto guardino Israele, l’Iraq o l’Iran. Parte del problema è la vera natura della potenza americana: con un campo d’azione e interessi estesi su scala globale, è spesso difficile stabilire dove tracciarne i limiti nei casi specifici. […] Mentre gli Stati Uniti hanno senz’altro interessi nell’Africa settentrionale e orientale, i paesi di queste aree, a parte l’Egitto, sono molto diversi dagli altri. La geopolitica del Golfo o del Levante non li riguarda, e soprattutto sono lontani dalla posizione centrale dell’America in Iraq. Basta osservare la passività degli Usa nella crisi del Sudan per capire la distanza che li separa. Il Marocco costituisce un’importante base per le cellule terroristiche attive in Europa, ma non per quelle in America o in Iraq. Ironicamente, la Libia – a lungo esportatrice di terrorismo – ha ottenuto un autentico successo quando Gheddafi ha ammesso l’esistenza di un proprio programma nucleare in seguito all’invasione dell’Iraq. Eppure gli Usa non hanno cercato di sfruttare questa novità come stanno attualmente facendo con la Siria dopo il suo ritiro dal Libano. La Turchia, democratica e non araba, sta fronteggiando l’Occidente con più forza che mai. Data la cultura e la storia dell’Afghanistan, sarà necessaria una grande opera di modernizzazione prima che si possa parlare di riforme. Il Pakistan è al momento l’epicentro della caccia a ciò che rimane di al-Qa‘ida; il suo esercito e il suo governo non possono sopportare una forte pressione in favore delle riforme, essendo sottoposti ad altre pressioni per catturare bin Laden. Restiamo con un Medio Oriente curiosamente simile al campo di gioco dei tempi della guerra fredda: dall’Egitto verso il Levante e gli Stati del Golfo, fino all’Iran. È qui che si concentreranno più pesantemente le iniziative americane nel Grande Medio Oriente, per moltiplicarne l’efficacia. La versione allargata del Medio Oriente serve a diluire la retorica e a sfocare l’obiettivo, lasciando aperta la possibilità di un’applicazione su più larga scala. Tuttavia, visti i loro limiti di risorse e di potenza, gli Usa devono fissare delle priorità, almeno per il momento. Forse il modo migliore per comprendere il piccolo Grande Medio Oriente è considerare come esso rompa con la passata politica americana in un terreno più o meno simile. Se le ovvie costanti geopolitiche sono il petrolio e Israele, le discontinuità sono: una presenza militare molto accresciuta, che unisce spiegamenti di truppe a intelligence e mobilità, richiedendo nuove basi in aree di cronica instabilità; un impalpabile quasi-Stato palestinese, le cui frontiere devono ancora essere stabilite; una forte anche se temporanea presenza militare nell’Iraq del dopo37 Saddam, il centro geografico del piccolo Grande Medio Oriente; un’accresciuta diffidenza dei regimi una volta amici dopo l’11 settembre; e la paura di un terrorismo islamico globale con reti di appoggio molto estese in tutta la regione. Insomma, ogni aspetto dell’ex Medio Oriente ha acquistato una nuova dimensione. E si è molto complicato. Con l’eccezione dell’Iran (su cui ritorneremo), il problema di un equilibrio geopolitico al livello degli Stati non sussiste più. La potenza predominante nella regione è l’amico Israele. Il problema sta nello smantellare le reti terroristiche, arginando nel contempo l’instabilità sopranazionale in un’area economicamente vitale. L’amministrazione ha deciso che il nocciolo del piano volto a contrastare il terrorismo sta nella riforma democratica della regione. Come in qualunque altra zona del mondo, gli Usa devono fare i conti con un Medio Oriente in cui non esiste più un ruolo sovietico. In paesi come il Libano, la Turchia, la Giordania, l’Arabia Saudita e il Pakistan (tra gli altri), l’Urss aveva creato un equilibrio della paura che ha contribuito a spingerli verso gli Stati Uniti; con la caduta dell’Unione Sovietica, tale equilibrio è andato in pezzi. I regimi che sono rimasti in buoni rapporti con gli Usa lo hanno fatto disinteressatamente, ma mentre ciò è stato più che sufficiente per assicurare relazioni economiche, il quadro appariva inevitabilmente più complicato. Sparita l’Unione Sovietica, gli scontenti (e ce ne sono molti) della regione hanno adesso un obiettivo in meno contro cui rivolgere la propria collera. Nel caso del radicalismo islamico gli obiettivi si sono ora ridotti a tre: Israele (un perenne favorito), i governi corrotti dei rispettivi paesi e gli Stati Uniti. Il caso saudita illustra il fenomeno meglio di qualunque altro: con le reti jihadiste sempre più estese da una parte e la dinastia ål-Sa‘ûd nel mezzo, gli Usa si sono ritrovati sul piatto sbagliato della bilancia della paura. Incapace di distruggere le reti terroristiche e temendole più degli Usa, la famiglia reale saudita ha chiuso un occhio quando non è riuscita a liquidarle. Per anni gli autocrati arabi hanno favorito l’instabilità interna con il malgoverno: incoraggiando la crescita del radicalismo, sia secolare che religioso, e incanalandone le energie contro l’America e Israele, hanno evitato la rivoluzione e prolungato la propria esistenza. La realizzazione del progetto del Grande Medio Oriente equivale a ribaltare la situazione, impiegando i loro stessi mezzi contro di loro. Dopo che molti regimi arabi hanno a lungo sostenuto che «la colpa dei problemi della povertà, della repressione politica, della mancanza di istruzione, per non parlare delle violenze vere e proprie e delle guerre civili non è nostra, ma dell’America e di Israele», l’amministrazione Bush ha replicato con vigore: «No, il problema sta nei vostri governanti che devono essere sostituiti dai meccanismi della moderna democrazia». È un argomento potente, che va a genio sia alla tradizione americana dell’eccezionalismo che agli autori di discorsi sempre alla ricerca di un linguaggio elevato. Gode del vantaggio machiavellico dello slancio, dell’occupazione del terreno, pur non essendo effettivamente un progetto machiavellico. Allontanando da sé i riflettori, l’America ha evitato (finora) di diventare un facile obiettivo di ripetuti attacchi, ponendo al contempo l’accento sugli elementi che dividono la regione. Washington ha anche in una certa misura capovolto la propaganda degli anni passati, che poneva la questione israelo-palestinese al centro di tutti i problemi del Medio Oriente. […] Le elezioni irachene e palestinesi e le dimostrazioni libanesi che hanno condotto al ritiro della Siria dimostrano il desiderio di autodeterminazione di quei popoli. Un altro importante vantaggio del progetto è la sua natura soggettiva. Adam 38 Garfinkle ha rilevato come, poiché non è considerata una variabile dicotomica (cioè che o esiste o non esiste) ma cardinale (cioè che può esistere in una misura maggiore o minore), la democrazia può essere al tempo stesso difficile e facile: facile da desiderare e perseguire, difficile da raggiungere velocemente o totalmente. In altre parole, in una certa misura il successo è a portata di mano. Ma esistono anche fattori meno soggettivi che equivalgono a difetti fondamentali. Per cominciare, gli Usa, facendo appello alla rappresentanza politica di quei popoli, non hanno posto limiti, cosa pericolosa in una regione in cui l’appartenenza tribale e comunitaria ha sempre contato più dello Stato. Si prenda per esempio la richiesta di creare uno Stato arabo indipendente in Palestina: ne consegue che dovrebbe esserci una simile richiesta per un Kurdistan indipendente o uno Stato maronita in Libano? Mentre cercano di sradicare una cultura autoritaria (operazione la cui influenza sul terrorismo è nel migliore dei casi inconcludente), gli Usa stanno potenzialmente scardinando uno strumento importante con cui combattere la minaccia più immediata delle cellule terroristiche ancora esistenti. Se, dopo l’invasione dell’Iraq, il governo saudita ha cominciato a intensificare la guerra al terrorismo interno, potrebbe non essere una buona cosa metterlo sotto pressione affinché si riformi. In effetti gli Stati Uniti sono alla ricerca di alleanze con governi e quindi chiedono loro di riformarsi. Quando hanno a che fare con regimi meno che desiderabili, ogni amministrazione americana spera di trovare un suo Gorbacˇëv; quando hanno a che fare con le amministrazioni americane, tali regimi ricordano la sorte toccata alla Russia e pregano che non capiti anche a loro. I regimi saranno meno disposti a cooperare con l’America se la vedono come una minaccia mortale. È vero che la struttura di potere di molti regimi qui è fondamentalmente traballante e difettosa. Regimi non abbastanza forti per esercitare un potere assoluto non possono negare per sempre i diritti politici alla maggioranza della loro popolazione. […] Guardando al Medio Oriente sulla scala degli Stati, vi è inoltre un’entità che costituisce ancora un problema strategico: l’Iran. L’Iran ha il più grande movimento democratico di qualunque altro paese della regione, fatta eccezione per Israele. Tuttavia sta attivamente perseguendo un programma nucleare che rappresenta una minaccia strategica per gli interessi statunitensi sia dentro che fuori del Golfo, nonché una minaccia per l’esistenza di Israele. Il suo regime ha una lunga storia di legami con il terrorismo globale. Mentre il regime gode di scarso appoggio da parte di una popolazione tormentata, il programma nucleare e la sicurezza dello Stato possono contare su un maggiore sostegno popolare. Se gli Usa dovessero scegliere il ricorso a un’opzione militare per difendere i propri interessi e la propria sicurezza, trasformerebbero in acerrimo nemico qualsiasi democrazia in via di sviluppo nella regione. I negoziati israelo-palestinesi restano ampiamente fuori dal progetto. Ciò è in parte dovuto al fatto che una delle due parti è un grande alleato degli Usa. Malgrado il sostegno apertamente dichiarato degli Stati Uniti alla creazione di uno Stato palestinese, Bush è stato piuttosto vago nello specifico. Sharon intende lasciare Gaza e creare la più larga cintura di sicurezza possibile nel cuore di Israele. I palestinesi sono troppo assorti dai contrasti interni per cominciare a pensare in modo strategico ai propri confini. Gli Usa hanno finora saggiamente evitato di «dominare» il processo come Clinton aveva cercato di fare. Ma i palestinesi privi di uno Stato sono una fonte di perenne disturbo per i vicini arabi, in Libano, in Giordania e altrove, per non parlare di Israele, e occorrerà creare uno Stato auto39 sufficiente per frenarli. Se gli Usa decidono che è nel loro interesse ottenere un risultato, si troveranno a un certo punto a imporre limiti non ad una, ma a due democrazie. Come sta scoprendo Sharon con il ritiro da Gaza, i desideri e la sovranità di un popolo libero talvolta impongono soluzioni predeterminate ai progetti altrui. 4. Tuttavia quella geopolitica è solo una delle dimensioni degli interessi strategici americani nella regione. L’esercito statunitense sta affrontando cambiamenti rivoluzionari dalla fine della guerra fredda, ma le sue basi avanzate non sono guarnigioni romane: la loro esistenza richiede il consenso dei paesi che le ospitano. L’amministrazione Bush può sperare di replicare la natura non imperialista delle basi americane in Europa, contando sul riconoscimento che una presenza americana aiuta a scoraggiare possibili minacce in un’area pericolosa e a garantirne la sicurezza. Tuttavia le democrazie nascenti e immature, anche quando riescono a sopravvivere, possono non rivelarsi così ragionevoli come le loro controparti europee, o così dipendenti come i loro confratelli iracheni. Ma se gli Usa intendono perseguire simili interessi ad ogni costo, allora cercheranno di ricorrere a montature e intimidazioni per convincere gli alleati – un parziale ritorno alla politica latinoamericana del XIX secolo – o cercheranno di arginare l’espansione della rivoluzione democratica. Economicamente, vale lo stesso principio. Gli Stati Uniti non danno segno di volersi esimere dalla propria dipendenza dal petrolio. Con la Cina che svolge un ruolo sempre più importante nel Medio Oriente e insegue la propria sete di petrolio ovunque la conduca, chi può dire che Stati indipendenti e democratici, storicamente antiamericani, non voltino le spalle agli Usa, sia geopoliticamente che economicamente? Anche se tali Stati dovessero scegliere di mantenere i propri legami con l’America, questa potrebbe dover affrontare veri shock economici durante periodi di forte instabilità, in modo particolare negli Stati del Golfo. E non ha ancora mostrato di voler ricorrere al dominio imperiale per gestire la transizione. 5. Infine, con una Cina in crescita, una Russia in disintegrazione e un’Europa miope, il Medio Oriente è solo una delle regioni del pianeta che solleva difficoltà strategiche agli Stati Uniti. A differenza di quanto accadeva durante la guerra fredda, essi non hanno una minaccia cui ricorrere per riunire interessi globali. Ma né il progetto del Grande Medio Oriente, né altro che esuli da esso offre una visione di collegamento tra i loro interessi nelle varie regioni, né è in grado di stabilirne il peso proporzionale. Così, gli interessi americani nel Grande Medio Oriente sussistono su tre livelli primari, ma scollegati tra loro: il livello geopolitico, quello militare/della sicurezza e quello economico. Tali interessi sono vecchi di decenni, però Bush ne ha dato un’interpretazione propria. Il progetto del Grande Medio Oriente, alla fine, equivale a una via di mezzo. Si deve ammettere che un’alternativa plausibile non è ancora stata proposta. Data la varietà di problemi sollevati e gli effetti imprevedibili ma sicuramente destabilizzanti di un processo di modernizzazione atteso da lungo tempo, può darsi che una vera strategia sia impossibile. A quanto pare Bush sta cercando di tenere a freno la crisi israelo-palestinese, di controllare l’equilibrio geopolitico, di continuare ad acquistare petrolio, ad espandere la presenza militare americana, a dare la caccia ai terroristi e a spingere verso autentiche riforme democratiche. La capacità di destreggiarsi in questa miriade di politiche si misura sia in giorni – ciascun giorno in cui l’edificio rimane in piedi senza nuovi attacchi contro gli Usa – che in decenni: la possibilità di un Me40 dio Oriente molto più stabile e democratico, che produca petrolio ma non terrorismo. La sua natura inconcludente è politicamente utile all’interno, ma geopoliticamente nebulosa. Se non esiste modo di riunire le varie politiche, l’attuale approccio non può essere definito una strategia. Il che ci riporta alla domanda: che cos’è il Grande Medio Oriente? Tahar Ben Jelloun, La rivoluzione dei gelsomini – Il risveglio della dignità araba», Bompiani, Milano 2011, pp. 13-17. Questa primavera in pieno inverno non assomiglia a nulla nella storia recente del mondo. Potrebbe far pensare alla rivoluzione dei garofani in Portogallo (novembre 1974), ma è diversa. I popoli arabi hanno subìto e sono rassegnati da molto tempo. In generale, però, il Maghreb e il Machrek hanno questo in comune: l´individuo non è riconosciuto come tale. Tutto è organizzato in modo che l´emergere dell´individuo in quanto entità singolare e unica sia impedito. È la rivoluzione francese che ha permesso ai cittadini di Francia di diventare individui dotati di diritti e doveri. Nel mondo arabo, ciò che viene riconosciuto è il clan, la tribù, la famiglia, non la singola persona. L´individuo invece sarebbe una voce, non un soggetto da sottomettere. Un individuo è una persona che ha da dire la sua e che la dice andando a votare liberamente e senza falsificazioni. In questo sta la base della democrazia – una cultura basata sul contratto sociale; si elegge qualcuno per rappresentare un popolo in un determinato periodo e poi o lo si rinnova nelle sue funzioni o lo si rispedisce a casa. Nel mondo arabo, i presidenti della repubblica si comportano come dei monarchi assoluti al punto che restano al potere con la forza, attraverso la corruzione, la menzogna e il ricatto. Bashar al-Assad è succeduto al padre Hafez al-Assad; Seif al-Islam è ritenuto il successore di suo padre Gheddafi, quando questi morirà; Mubarak ha ovviamente cercato di imporre suo figlio alla successione, ma con la rivoluzione di gennaio tutti i suoi piani sono saltati. Il principio è semplice: quando arrivano al potere, pensano di essere lì per l´eternità, che il popolo lo voglia o no. Per non indisporre troppo gli occidentali, instaurano una sorta di “democrazia formale”, giusto una maschera per gli occhi di chi li osserva. Ma è tutto nelle loro mani e non tollerano alcuna contestazione, alcuna opposizione. Il resto del tempo, considerano il Paese come una loro proprietà privata, dispongono delle sue entrate, fanno affari, si arricchiscono e mettono i loro beni al sicuro in banche svizzere, americane o europee. Quello che è successo in Tunisia e in Egitto è una protesta morale ed etica. È un rifiuto assoluto e senza mezzi termini dell´autoritarismo, della corruzione, del furto dei beni del Paese, rifiuto del nepotismo, del favoritismo, rifiuto dell´umiliazione e della illegittimità che è alla base dell´arrivo al potere di questi dirigenti il cui comportamento prende a prestito molti metodi dalla mafia. Una protesta per stabilire un´igiene morale in una società che è stata sfruttata e umiliata fino all´inverosimile. È per questo che non è una rivoluzione ideologica. Non c´è un leader, non c´è un capo, non c´è un partito che porta avanti la rivolta. Milioni di persone qualunque sono scese in strada. È una rivoluzione di tipo nuovo: spontanea e improvvisata. È una pagina della storia scritta giorno per giorno, senza una pianificazione, senza premeditazione, senza intrallazzi, senza trucchi. E come una poesia che 41 sgorga dal cuore di un poeta che scrive sotto dettatura della vita, che si ribella e vuole giorni migliori. La responsabilità dei dirigenti europei è importante nel mantenimento di questi regimi impopolari e autoritari. Essi tacciono e lasciano fare usando due scuse: 1. pensano che Mubarak, come Ben Ali, sia lì per impedire che si stabilisca una repubblica islamica in stile iraniano; 2. pensano che non dicendo loro che devono rispettare i diritti dell´uomo, si assicureranno succosi affari. Su entrambe le cose si sbagliano. La rivoluzione iraniana è stata possibile perché lo sciismo è strutturato gerarchicamente (himam, mollah, ayatollah ecc.). Per gli sciiti, l´islam è politico o non è (è questo che aveva dichiarato Khomeini al suo arrivo a Teheran). L´islam sunnita non ha mai pensato la pratica religiosa in modo gerarchico. Nel Corano si dice che nell´islam non ci sono sacerdoti. Né preti, né rabbini, né ayatollah. Sul piano politico, la società araba è attraversata da diverse correnti islamiche; la corrente fondamentalista non è il solo movimento presente in Egitto. Non c´è ragione di pensare che i fondamentalisti arrivino al potere, a meno che non si verifichi un colpo di Stato militare, il che vorrebbe dire che tutto l´esercito è fondamentalista, cosa assurda. Se c´è una democrazia, questo vuol dire che c´è multipartitismo, che ci sono differenze e opinioni diverse che si fronteggiano in un campo politico libero. Quanto al secondo punto, gli occidentali chiudono gli occhi ovunque possano fare affari, che sia in Cina, in Libia o in Algeria. Ma da quando Barack Obama ha invocato il rispetto dei diritti dell´uomo davanti al suo ospite cinese, nel gennaio 2011, non è più possibile anteporre gli affari ai diritti dell´uomo. Tutto ciò è avvolto da ipocrisia e accondiscendenza. Abbiamo appena saputo che alcuni ministri francesi accettavano inviti in Tunisia, in Egitto, e facevano coppia perfetta con dittatori di cui sapevano tutto, compreso il modo in cui torturavano e facevano sparire gli oppositori del governo. Queste rivoluzioni di oggi avranno almeno un vantaggio: più niente sarà come prima, né all’interno del paese, né all’esterno. Quanto agli altri Stati arabi in cui sussistono gli ingredienti affinché qualcosa si muova e ci si ribelli, credo che riformeranno il loro sistema e saranno più vigili sul rispetto dei diritti della persona. Il cittadino non sarà più un soggetto sottomesso ad un potere arbitrario e sprezzante; diventerà un individuo con un nome, una voce e i suoi diritti. Salvatore Santangelo, Imperi e moltitudini, Limes online, 05/08/2011 Su google map si può trovare una carta in cui sono segnalati i disordini, le manifestazioni, i rovesciamenti di governi già avvenuti o che si stanno verificando nel mondo (“Inflation riots and protests 2011”): vedere il “mappamondo” costellato di incendi ci restituisce la vera portata di quanto sta accadendo. A cavallo tra il 2010 e il 2011 - quindi ben prima dell’esplosione della primavera araba - abbiamo assistito a un moltiplicarsi di rivolte in ogni angolo del pianeta: migliaia di persone hanno manifestato a Nuova Delhi contro il governo per i rincari dei generi alimentari; in Iraq contro la corruzione del governo AlMaliki, contro la disoccupazione e la mancanza di servizi elementari; in Iran con42 tro il regime degli ayatollah, ma anche per i salari non pagati. Nella provincia cinese di Guizhou si sono registrati gravi disordini studenteschi dovuti al rincaro delle mense scolastiche. Siria e Giordania hanno aumentato (con risultati diversi) i sussidi sui generi alimentari per mantenere i prezzi artificialmente bassi. I greci hanno protestato in modo estremamente violento contro l'austerità; si sono rivoltati gli abitanti di Madison nel Wisconsin, così come gli “indignati” spagnoli e gli studenti inglesi contro i rincari delle tasse universitarie. In particolare in Gran Bretagna sono sempre di più cittadini, organizzati in un movimento di base, che occupano sedi di banche e di multinazionali per protestare contro quella che percepiscono come una sorta di evasione fiscale legalizzata di cui godono le imprese globali, mentre alla popolazione vengono imposti aggravi insopportabili. Mutuando la famosa metafora di Toni Negri, ci troveremmo di fronte a un rifiuto viscerale contro il capitalismo globale: una “moltitudine molecolare” contro “l’impero globale”, con le masse protagoniste della crisi della democrazia e della sua radicale trasformazione nello strumento di una vera liberazione dell’umanità. Il fatto che la protesta si rivolga contro governi e regimi sarebbe la conseguenza del fatto che questi ultimi si sono messi in stato di virtuale bancarotta per aiutare le banche, invece che sostenere i cittadini colpiti dalla crisi provocata dalla finanza globale. L’intensità e la portata di questi fenomeni hanno colto per lo più impreparati la maggior parte degli osservatori; non che fossero mancati avvertimenti, anche autorevoli, ma non erano riusciti a superare il conformismo mediatico. Già nel dicembre 2008, la Bank for international settlements (Bis) aveva messo in guardia contro ulteriori giganteschi salvataggi di banche, spiegando che tali operazioni stavano di fatto trasferendo i rischi dalle ricche entità private agli Stati, con il pericolo di trasformare la crisi finanziaria in una crisi sociale e politica: le Banche centrali, accollandosi i problemi degli istituti di credito in difficoltà a causa dei derivati e dei titoli tossici, hanno di fatto messo in pericolo i loro rispettivi paesi. Proprio l’aumento della massa monetaria emessa, in particolare da parte della Federal reserve e delle Banche centrali cinese e indiana, insieme alle operazioni speculative, sarebbe la causa primaria dei rincari dei generi alimentari a livello globale. Le popolazioni sono dunque strette tra i rincari da inflazione e le misure di austerità che i governi impongono per affrontare la crisi. Nel febbraio 2009 Moody’s parlava di imminenti social unrest in vari paesi. E nel novembre del 2010 uno studio dell’Army war college avvertiva che le forze armate dovevano prepararsi ad affrontare «violent, strategic dislocation inside the United States», con «widespread civil violence» e «loss of functioning political and legal order», causati da «economic collapse». Dennis Blair, il capo della National intelligence, dal canto suo ha parlato di «instabilità capaci di minacciare i regimi nei paesi in via di sviluppo», anche queste dovute alla «global economic crisis». Nel giugno 2010 Zbigniew Brzezinski ammoniva che: «ci saranno conflitti crescenti fra le classi, e se la gente è disoccupata, si potranno avere rivolte». E aggiungeva: «viviamo in un momento storico in cui l’umanità nel suo complesso è divenuta politicamente più cosciente, e politicamente attiva a un livello prima sconosciuto, e questa condizione provocherà grandi disordini internazionali». Queste posizioni sono ora riassunte e accolte nell’ultimo rapporto dell’Onu, in cui si afferma che le ricette del liberismo globale applicate in modo dogmatico finiscono appunto per produrre - recita testualmente The global social crisis - Report on the world social situation, 2011: «Un'insurrezione sociale globale», di cui i governi devono tenere conto: «le 43 politiche economiche attualmente applicate hanno effetti sulla sanità, l’istruzione e l’alimentazione, che penalizzano la crescita a lungo termine». I rincari degli alimentari e dei carburanti, in parte provocati dalla speculazione selvaggia, hanno aumentato il numero di affamati nel mondo, che nel 2009 erano un miliardo, e stanno ancora crescendo. Nel 2010 il numero dei disoccupati nel mondo è salito a 200 milioni, rimasti senza aiuti e assistenza. Per contrastare tutto ciò servirebbero «politiche socialmente inclusive» proprio per recuperare gli esclusi e i perdenti. Tutto ciò ha chiaramente subito una poderosa accelerazione dopo l’esplosione delle piazze arabe. Un evento di fronte al quale si sono cristallizzate tre posizioni. Secondo la prima, espressa dall’autorevole analista di politica internazionale Robert D. Kaplan, lo scompaginamento del Medio Oriente sarebbe appena all’inizio: in Yemen, Giordania, Bahrein e Arabia Saudita le rivolte democratiche potrebbero rivelarsi nefaste per gli Usa. Si può criticare la monarchia saudita quanto si vuole, ma chi e cosa potrà sostituirla? Recare aiuto agli sciiti in Bahrein o agli oppositori del regime nello Yemen rischia di alienare alleati chiave: «Prospettive ben più incerte si profilano altrove nella regione, negli Stati che si ritroveranno sostanzialmente indeboliti non appena il guscio della tirannide si sarà sgretolato. Al di là del caso contingente della Libia, nuove e cruciali prove si profilano in futuro. Gli Stati Uniti sono una democrazia, ma anche una potenza fondata su determinati rapporti di potere, la cui posizione globale si regge sul presupposto che il mondo resti così com’è». La sua conclusione è che «l’ordine è sempre preferibile al disordine. Ricordiamo cosa è accaduto in Iraq quando è caduto Saddam Hussein». Si starebbero quindi aprendo profonde crepe all’interno del sistema globale, che starebbe perdendo il controllo e l’influenza su ampie fette del mondo. A questa visione apocalittica si contrappone quella di Fukuyama, secondo cui l’aspirazione delle masse in fermento sarebbe quello di aderire ai nostri valori: modernità, democrazia e libero mercato. Gli fa eco Michael Leeden, affermando che ci troveremmo di fronte «a un’insurrezione globale che chiede più libertà e meno governo». Un’ulteriore posizione è quella di quanti vedono la primavera araba come qualcosa di analogo alle rivoluzione colorate nei paesi dell’Est. In particolare il giornalista Marcello Foa ha scritto che Obama, con altri metodi, combatterebbe la stessa guerra di Bush per esportare la democrazia. «Come si vincono le guerre nell’era della globalizzazione? Muovendo gli eserciti? Talvolta sì, ma il risultato non è sempre soddisfacente e i costi spesso risultano superiori ai benefici. Ne sa qualcosa George Bush, che nel 2001 si scagliò contro i talebani in Afghanistan e nel 2003 contro Saddam in Iraq. Siamo nel 2011, quei conflitti durano ancora e la vittoria finale non è assicurata. Se l’America avesse usato altri metodi, probabilmente avrebbe risparmiato migliaia di vite e molti miliardi di dollari, e avrebbe ottenuto risultati più concreti e duraturi. È la lezione che ha appreso Barack Obama, che in realtà sta combattendo la stessa guerra di Bush, nel senso che ne condivide le finalità strategiche. Che cosa voleva George W? Esportare la democrazia e, soprattutto, sostituire in Medio Oriente regimi decadenti, retti da leader impopolari, con regimi più rispettabili e leader più affidabili. Pensateci bene: è esattamente quel che si propone Barack Obama in Egitto e Tunisia. A cambiare è il metodo». Quindi l’attuale inquilino della Casa Bianca starebbe optando per il proseguimento delle tecniche usate in Ucraina, Georgia e Serbia nella prima metà degli anni Duemila. «Ricordate la protesta degli studenti di Belgrado che costrinse Milosevic alla fuga? E l’emozionante Rivoluzione arancione di Kiev? E quella rosa contro Shevardnadze? 44 Allora i media si emozionarono, esaltando la rivincita del popolo; oggi sappiamo - documenti alla mano - che quelle rivolte non furono affatto spontanee, ma preparate con cura e sapientemente attizzate da società private di pubbliche relazioni, che agivano per conto del Dipartimento di Stato. Washington aveva capito che, agendo con la dovuta cautela, la piazza poteva essere usata a proprio vantaggio. Lo stesso sta avvenendo in queste settimane in Tunisia e in Egitto. Non limitatevi alle dichiarazioni ufficiali, alcune sono obbligate e rientrano in un gioco delle parti. Chiedetevi, piuttosto... Chi ha deciso la rivolta prima a Tunisi e ora al Cairo? L’esercito, che si è rifiutato di sparare sulla folla, legittimando le richieste dei manifestanti. E a chi sono legati i vertici militari egiziani e tunisini? Saldamente agli Stati Uniti. Chi comanda ora al posto di Ben Ali? I generali, democratici, nelle intenzioni, ma pur sempre generali. (…) Tutto quadra. Oggi. Domani, chissà; perché in Tunisia l’influenza dei fondamentalisti islamici è impalpabile, mentre in Egitto i Fratelli musulmani sono molto popolari e in passato hanno dimostrato di saper muovere le piazze, all’occorrenza usando le armi. Questo rende il finale più incerto, ma non cambia l’analisi complessiva». Proprio per condizionare questo finale di partita, il summit del G8 nella proustiana città di Deauville ha dato una chiara indicazione geopolitica. Il presidente francese Sarkozy ha infatti annunciato un gigantesco “piano Marshall” di aiuti finanziari ai paesi del Maghreb e delle “primavere arabe”, con un impegno di 20 miliardi di dollari, mentre altri 20 potrebbero arrivare dai paesi arabi del Golfo e dalle banche di sviluppo. Nima Baheli, L’Iran vuole guidare la primavera araba, Limes online, 14/10/2011 A ben dieci mesi dall’inizio della primavera araba, finalmente la leadership iraniana è riuscita a dare una definizione ufficiale ed univoca dell’evento. Inizialmente sorpresa dalla quasi totale assenza di slogan anti-americani, si era deciso di prendere in prestito la visione di Noam Chomsky secondo cui 'le potenze imperialiste' avevano voluto cambiare i loro 'lacché arabi' oramai vecchi ed obsoleti. Nel caso libico, gli Stati Uniti desideravano rovesciare un Gheddafi diventato oramai 'ingovernabile'. Quando divenne chiaro che questa tesi non era più credibile, giocando sulle analogie tra Mubarak e lo scià, si cominciò a paragonare le rivolte arabe alla propria, etichettandole come un risveglio islamico ispirato alla rivoluzione iraniana del 1979. “Gli eventi di oggi nel Nord Africa, Egitto, Tunisia e in altri paesi hanno un significato speciale per la nazione iraniana. Questo è lo stesso risveglio islamico che ha portato alla vittoria della grande rivoluzione della nazione iraniana”, disse la Guida Suprema durante il sermone di venerdì 4 febbraio. A marzo rincarò la dose affermando che “sulle questioni regionali la nostra posizione è chiara: noi difendiamo i popoli e i loro diritti e ci opponiamo alle potenze arroganti, ai dittatori, a coloro che cercano un dominio malevolo e ai predoni di tutto il mondo". Condannando la brutalità del regime di Gheddafi, ribadiva la propria opposizione all’intervento occidentale affermando “Non siete lì per difendere le persone; volete il petrolio della Libia e desiderate utilizzarla come un luogo dal quale monitorare le attività dei futuri governi rivoluzionari in Egitto e Tunisia”. 45 Questa chiave di lettura venne però rigettata, a stretto giro di posta, dalla stessa Fratellanza islamica egiziana che, tramite il proprio sito web, affermò: “Le proteste egiziane non sono una sollevazione ‘islamica’, ma una protesta di massa contro un ingiusto regime autocratico che include egiziani di tutti i ceti sociali e di tutte le religioni e sette”. A metà aprile la situazione divenne ancora più complicata quando Esfandiyar Masha’i, il controverso braccio destro di Ahmadi-Nejad, mise in guardia dalle valutazioni troppo ottimistiche degli eventi in corso nei paesi arabi: “Non dobbiamo pensare che il cambiamento sarà necessariamente nel nostro interesse”. Queste considerazioni vennero rilanciate a fine aprile da una analisi pubblicata dal Majles, il parlamento iraniano. In esso si reputava che l’Egitto e la Tunisia, grazie alle loro rispettive forze armate, avrebbero mantenuto la propria linea di politica estera filoccidentale e che Teheran doveva puntare, al momento, solo a ristabilire i rapporti diplomatici con le due nazioni nordafricane. Sempre in Nord Africa, si reputava che in Libia si sarebbe insediato un governo filostatunitense rigettando però l’idea di sostenere militarmente ed economicamente Gheddafi. Il testo continuava affermando invece come fosse necessario dare supporto strategico al regime siriano per schiacciare la rivolta popolare. In tale contesto il ruolo di Hezbollah era di particolare importanza essendo esso chiamato a “rafforzare la nostra zona di influenza in Libano”. Nella malaugurata ipotesi in cui il regime siriano fosse caduto, l'analisi suggeriva di “rafforzare le relazioni con il governo di Nuri al-Maliki” in Iraq e di “ampliare e approfondire le relazioni” con il Qatar come un mezzo per dividere i paesi arabi del golfo Persico. Ma è a metà di settembre che la Repubblica islamica ha dato la propria definitiva dichiarazione di intenti ospitando la Conferenza internazionale sul risveglio islamico. Frequentata da 500 fra intellettuali, leader spirituali e attivisti politici provenienti da 80 paesi del mondo islamico e non, l’incontro ha registrato nel discorso inaugurale della Guida Suprema una chiave di lettura chiara e succinta della visione e della dottrina iraniana in relazione ai recenti avvenimenti. Neanche la tempistica della conferenza è stata casuale, in quanto coincideva con la visita dei leader occidentali in Libia e con la presenza al Cairo del presidente turco Erdoğan. Ambedue gli eventi sono stati percepiti come una minaccia all’auspicato tentativo di predominio regionale di Teheran. Nel suo discorso la Guida inquadra il risveglio islamico su un cardine di tre fattori: le radici storiche e l'identità ideologica dei movimenti di protesta araba; i pericoli e le minacce che incombono su questi movimenti rivoluzionari; l’efficace contrasto a queste minacce, alla luce della trentennale esperienza della rivoluzione islamica iraniana. Per quel che riguarda le radici storiche di questi movimenti, Khamenei li ricollega al secolo e mezzo di lotte di consapevolezza dei movimenti islamici in Medio Oriente, stando ben attento a tenerli distinti dai movimenti nazionalisti arabi nati nel secondo dopoguerra. Khamenei distingue accuratamente i movimenti islamici, portatori di istanze di massa, i quali hanno coinvolto milioni di persone, dai movimenti post-coloniali che erano espressione esclusiva di piccole élite militari. Collegando l’attuale primavera araba alle lotte islamiste, la Guida non fa nient’altro che cercare di inserire ulteriormente questi movimenti nel binario della rivoluzione islamica. Secondo Khamenei, i manifestanti sono motivati da quattro aspirazioni di base: far rivivere l'onore nazionale, dopo decenni di dominio tirannico e filoccidentale; ricercare una giustizia sociale e uno sviluppo economico au46 tentico, ovvero inserito nella cornice della legge islamica; resistere all'influenza politica e culturale occidentale e infine unirsi alla lotta contro il “governo fantoccio sionista” di Israele, descritto da Khamenei come uno stato crociato estraneo inserito nel corpo politico della regione. Per quel che riguarda le minacce che le rivoluzioni arabe si troveranno ad affrontare, Khamenei le divide in due grandi categorie: quelle provenienti dai ranghi dei rivoluzionari stessi e quelle pianificate dai nemici esterni. Riguardo ai primi la Guida sottolinea come l’autocompiacimento circa i progressi effettuati e l’ambizione personale di alcuni leader possano minare i risultati fin qui raggiunti. Alla luce dell'esperienza iraniana, egli sconsiglia di moderare gli obiettivi della rivoluzione di fronte alle minacce o ai tentativi di corruzione delle 'potenze arroganti', termine usato dalla leadership iraniana per riferirsi agli Stati Uniti e ai suoi alleati. “Non fidatevi mai degli Usa, della Nato e di regimi criminali come la Gran Bretagna, la Francia e l'Italia, perché l'Occidente complotta per sabotare i risultati del risveglio islamico che ha dato vita alle rivoluzioni e alla rivolte tra Nord Africa e Medio Oriente” ha sottolineato. Per quel che concerne le minacce esterne, Khamenei ribadisce come, dopo “l’inevitabile caduta dei suoi tirapiedi”, l’Occidente tenterà comunque di penetrare nella rivoluzione al fine di impedirne la piena fruizione dei risultati. L’intervento militare a guida Nato in Libia viene inserito in questa ottica. Dopo averlo fermamente condannato in quanto “responsabile di irreparabili perdite tra i civili” e consapevole del fatto che anche senza la Nato il movimento popolare libico avrebbe “raggiunto, anche se solo più tardi, i suoi obiettivi”, Khamenei ribadisce come questo non sia nient’altro che un tentativo finalizzato a creare un caposaldo occidentale nel cuore del Nord Africa. Khamenei ha quindi ricordato come il più grande compito che i rivoluzionari si trovano ad attuare è la progettazione e la costruzione di nuovi sistemi, garanzia assoluta contro la contaminazione intellettuale e politica del liberalismo e secolarismo occidentale. “L’Occidente organizza complotti per imporre Costituzioni non basate sulla Shari’a che possono causare dipendenza economica dall’Europa e dagli Stati Uniti”. È indispensabile quindi “scrivere i principi del Corano nei nuovi ordinamenti” ha continuato la Guida. Finalità ultima, e qui è chiaro l’ulteriore tentativo di portare questi movimenti nell’alveo della politica estera iraniana di lungo termine, è la creazione di una Umma islamica unificata con la nascita di una nuova civiltà islamica basata sulla “religione, sulla logica, sulla scienza e sull'etica”. A tal fine Khamenei mette in guardia contro l'estremismo religioso e chiede il riconoscimento e la gestione delle differenze di culto nel mondo islamico. Suggerisce come l'islamizzazione non debba essere accompagnata da tendenze reazionarie o da fanatismo religioso e sciovinismo, che al contrario sono in grado di portare a cieca violenza. Queste ultime parole riflettono l’acuto senso di 'solitudine strategica' che l’Iran, sia esso monarchico o islamico, ha sempre sofferto essendo l’unica nazione persiana e sciita in una regione dominata da sunniti e arabi. Sempre nella stessa ottica rientra l’idea di sostituire l'organizzazione della conferenza islamica, a predominio saudita, con un nuovo organismo chiamato Movimento del risveglio islamico. La nuova istituzione avrà 12 membri con a capo Ali Akbar Velayati, ex ministro degli Esteri e ora consigliere di politica estera della Guida Suprema. Insignito del ruolo di apostolo di questa nuova idea è stato il presidente Ahmadi-Nejad che, al ritorno dal suo discorso presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha visitato la Mauritania e il Sudan. 47 Il Sudan riveste un'importanza strategica non indifferente trovandosi ai confini con Egitto e Libia. Emblematico il suo discorso a Khartoum incentrato sull’esistenza di un progetto coloniale finalizzato ad indebolire il Sudan, avendone separata la porzione meridionale il 9 luglio a seguito del referendum tenutosi lo scorso gennaio. In conclusione sembrerebbe che la leadership iraniana, accusata da molti funzionari di scarsa presenza sullo scenario della primavera araba, abbia deciso di entrare nel gioco impegnando i propri pezzi da novanta. La Repubblica islamica punta, nel breve e medio termine, a sfruttare a proprio vantaggio l’instabilità e la divisione attualmente presenti fra i propri avversari e fra i rivoluzionari. Non a caso uno dei principali punti di forza della leadership islamica in questi anni è stato quello di pazientare e sviluppare la propria potenza in un clima di instabilità e caos. Emblematico il fatto che dalla guerra del 2003 in Iraq, passando per gli avvenimenti dell’estate del 2006 in Libano e del Natale del 2009 a Gaza, l’influenza regionale iraniana sia andata, gradualmente e costantemente, crescendo. 48 Guerra, pacifismo e diritti umani Aldo Capitini, Aspetti dell’educazione alla nonviolenza, Pisa, Pacini Mariotti, 1959, pp. 1-3. Quando si parla di una progressiva sostituzione della nonviolenza nello sviluppo della società italiana si pensa subito che un tale compito debba essere adempiuto in gran parte dall'educazione, educazione degli adulti e specialmente degli adolescenti. Io, che ho studiato una parte della vastissima letteratura sull'argomento, che ho partecipato a molti convegni sulla nonviolenza, ed ho anche organizzato una riunione di studio sul tema "La pedagogia e la psicologia in rapporto con la nonviolenza", vorrei succintamente esporre alcune idee in proposito. L’utilizzazione degli indirizzi attivi, democratici, cooperativi così sviluppati nella pedagogia degli ultimi decenni, è un modo educativo, che tende ad eliminare gli elementi coercitivi, le chiusure nazionalistiche, razziali e classiste; la stessa sostituzione di un imparare facendo e in libera ricerca all’apprendere passivo di schemi fissi, giova a svegliare e incoraggiare le capacità creatrici, ad offrire il mezzo di affermarsi normalmente e quindi ad eliminare la violenza, sia dell'imposizione da parte dell'educatore, sia della reazione da parte dell'educando. L’educazione alla lealtà, alla sincerità, alla libera discussione, al rispetto delle minoranze, dei refrattari, degli eretici, la attenzione a chi è fuori del gruppo, gli scambi di scolari, i campi estivi internazionali, rientrano in questo àmbito. Alcuni sono convinti che se i grandi blocchi attuali politico-militari si scambiassero per lunghi periodi di soggiorno, migliaia e migliaia di giovani lavoratori e studenti, un conflitto bellico diventerebbe più difficile. Perciò le agevolazioni offerte al libero sviluppo costruttivo, con le soddisfazioni che questo porta, e le molte possibilità di " dialogo " e di conoscenza reciproca, rafforzano il desiderio di una convivenza priva di violenza, e fanno sentire il piacere di esercizio della razionalità e del sentimento di simpatia umana in vasti gruppi, nell'essere insieme. Un altro modo è quello offerto dal diritto. E' certo che la legge crea un certo ordine, impedisce molte manifestazioni violente della società, difende da sopraffazioni, offre garanzie di pace. Tuttavia questo modo presenta due grosse difficoltà: la prima, che la legge è accompagnata quasi sempre, nella teoria e nella pratica, dalla coazione; la seconda, che la legge difende un certo ordine già stabilito, che può risultare meno giusto rispetto ad un ordine da fondare. Perciò la legge, per tendere alla nonviolenza, deve portare con sé stessa due correttivi 1, la riduzione dell'elemento coattivo mediante misure umanitarie; 2, la possibilità di sostituire, senza violenza, leggi nuove e migliori alle leggi vecchie. Chi è per la nonviolenza non può avere simpatia per i conservatori duri, perché è appunto il loro atteggiamento che alimenta la violenza dei rivoluzionari. Dice il Dewey: " Il ribelle è il prodotto di una estrema cristallizzazione e immobilità inintelligente. La vita si perpetua solo rinnovandosi: se le condizioni non permettono al rinnovamento di aver luogo in modo continuo, esso avrà luogo in modo violento e esplosivo. 49 Il prezzo delle rivoluzioni deve essere addossato a coloro i quali hanno voluto per i loro scopi fermare il costume invece di riadattarlo " (J. Dewey, Natura e condotta dell'uomo, trad. it. ed. La Nuova Italia, Firenze, 1958, pag. 177). Al modo dell’attivismo partecipativo e al modo della legge rinnovantesi è necessario fare aggiunte perché essi progrediscano intensamente verso la nonviolenza. L'educazione attiva potrebbe rischiare di rimanere sollecitazione e svolgimento delle energie in direzione prevalentemente amministrativa, come difesa di ciò che si è, come continuazione della vita, se non si aggiungesse un senso del valore come intima trasformazione. Solo i valori trasformano intimamente; ciò che è utile serve a far continuare la vitalità. Ci vuole questa direzione verticale per dare una qualità all'attivismo educativo. Esso deve esser portato a creare il bello. il vero. il bene, cioè a svolgere le intime categorie creatrici di tali valori. In essi c'è un rafforzamento contro il pericolo di passare alla violenza. Se i fanciulli non esercitano la creatività di quei valori, pur in un metodo, nel resto, attivo, potrebbero vedere nella violenza qualche cosa di supremo, perché i fanciulli - non dimentichiamolo - vogliono moltissimo. L'aggiunta alla legge rinnovantesi è la coscienza della realtà di tutti. La storia è il progressivo dilatarsi del senso di […]; mai, come in questa epoca, dopo l'Illuminismo e lo Storicismo, il senso di tutti è stato tanto vivo. Bisogna pronunciare il termine "tutti " con la stessa reverenza con cui si pronunzia quello di Dio. L'apertura a tutti deve essere coltivata quotidianamente, sì da diventare un riferimento evidente e un costume. Allora si comprende l'intimo rapporto tra il diritto e la realtà di tutti, tra l’universalità di fatto e l'universalità di diritto. Sarebbe un limitarlo congiungere il diritto alla legge morale, come se questa riguardasse la coscienza dell'individuo, e non ci fosse altro: si trascurerebbe l'avvertimento kantiano: “noi dobbiamo sempre obbedire alla legge morale; e in ciò si aggiunge anche il dovere di operare con tutte le forze affinché un tal rapporto (un mondo, cioè, conforme a supremi scopi morali) esista” […]. Porre accanto al diritto la religiosa realtà di tutti vale continuamente ad integrarlo. A questo punto possiamo esplicitamente definire la nonviolenza come unitàamore verso tutte le persone nella loro individualità singola e distinta, persona da persona, con vivo interesse anche alla loro esistenza, in un atto di rispetto ed affetto senza interruzione, con la persuasione che nessuna persona è chiusa nel suo passato, e che è possibile dire un tu più affettuoso e stabilire un'unità più concreta con tutti. Come tale dunque, la nonviolenza è tutt'altro che passiva, anzi è attiva e inventiva, aperta ad una trasformazione della realtà e della società, in ciò che esse sono violenza, oppressione, morte, e pesce grande che mangia il pesce piccolo. La nonviolenza è perciò, iniziativa di qualche cosa di diverso, auspicante una trasformazione. Sarebbe un errore educare i fanciulli alla conoscenza della realtà e della società attuali come perfette, e non avvisare – corrispondendo del resto, ad una intima loro esigenza – che esse possano trasformarsi in meglio, ad un migliore servizio versa la realtà di tutti. La categoria della trasformabilità della realtà e della società va coltivata attivamente e ricondotta sempre ad esigenze etico-sociali, non individualistiche e fantastiche. La pedagogia della nonviolenza, ha, dunque, una forma indiretta ed una forma diretta: l'indiretta che consiste nello esercizio dello sviluppo individuale e del dialogo democratico, la diretta che è nella esplicita fede in un atto di unità 50 amore verso tutti, che si aggiunge, come da un centro di vita religiosa, alla creatività circostante. La stessa distinzione può trovarsi nella considerazione psicologica. Trasformare le energie combattive in attività fisica nel mondo esterno (lavoro, sport, gare, imprese rischiose), in distruzione di oggetti, in sfoghi mediante scritti, in soddisfazione per mezzo di rappresentazioni e di immagini, o assistendo alle lotte altrui; portare la lotta a forme indirette; addestrare al controllo di proprie tendenze inferiori; indirizzare l'energia combattiva a lotte contro i mali della società: questi suggerimenti che gli psicologi danno, non dovrebbero trarre nell'errore che sia nativo nel fanciullo un istinto di lotta: nativo è un impulso, un’energia, e sta a noi e all'ambiente l'indirizzo, l'incanalamento, la qualificazione di tale energia che potrebbe anche rivolgersi ad una crescente e attiva, fraterna simpatia con gli esseri vicini e lontani, in attenzione a salvare, materialmente e con l'animo, i limitati, i colpiti, gli affranti, e in inesauribile cortesia e ferma gentilezza verso tutti. La forma indiretta è quella dello " sfogo " in altro dalla violenza, la forma diretta è quella della tensione non per un eroismo qualsiasi, purché nonviolento, ma in quello della rivoluzione contro l’attuale realtà e società; per un sentimento di amore verso tutti, che ha trasformato l'intimo dell'individuo in una specie di: “metànoia”, di capovolgimento interiore evangelico (termine che malamente è tradotto con "fate penitenza" nei Vangeli, mentre si tratta di una trasformazione interiore nelle valutazioni e in attiva apertura a Dio, a tutti, ad una nuova realtà imminente). Anche qui vediamo che la nonviolenza è intimamente attività positiva, e non negazione, come il termine potrebbe suggerire. Perciò non è soltanto importante che il fanciullo sia circondato da un ambiente e da occasioni che lo tengano lontano dalla violenza; che egli veda armonia tra i genitori, per avere l'uno alleato nell'affetto verso l’altro (il dramma di Amleto è di non avere la madre alleata nella reverenza verso il nobile padre; da cui la violenza); che egli non sia vittima inerme della scarica su di lui dei complessi degli adulti, che gli siano offerte biografie eroiche non nel senso della violenza. Ma importa, e anche più, che la disposizione che il fanciullo avrebbe ad una vicinanza con tutti gli esseri, sia confermata dagli adulti, arricchita di sapere e di tecniche, posta al centro della vita stessa, per cui diventa gioia ogni estensione di affetto, e dolore ogni eccezione che si debba fare per stretta necessità di difesa o di giustizia, eccezione che si augura non sia più necessaria in seguito. Su questo tronco dell'unità amore con tutti gli esseri, cominciando dalle persone, e possibilmente con la libertà e la esistenza del maggior numero di esseri viventi sempre ampliando, si innestano, per potenziarne il carattere attivo e positivo, iniziative, e due possono essere quella dell'unità di Occidente e Oriente, e quella dell'alimentazione vegetariana. E' bene, non solo con adulti, ma anche con adolescenti, discutere della situazione attuale del mondo, del peso crescente dell'Asia, nella necessità di un incontro tra Occidente ed Oriente, anzi di una compenetrazione nonviolenta, al posto di guerre, di imperi e di contro-imperi. Non può non entusiasmare la visione di un nuovo compito religioso, di una nuova impostazione paolina, questa volta, unificante tutta l'umanità. Anche per evitare che la nonviolenza sia vista nell'aspetto di una casistica angusta e individuale, tutti casi, come è noto a chi sia addentro alla cosa, che si risolvono con un più o un meno di sacrificio o di intervento di forza, quanto più valide siano le ragioni per questo o generose le intenzioni per quello. Si deve tener presente che la nonviolenza è una direzione, e non un codice, è 51 una creazione come tutti i valori (visto che la sostanza della nonviolenza è unità amore), e perciò ognuno la concreta storicamente. Una cosa sono le " eccezioni " di chi sia già in questa direzione, eccezioni che egli vorrà ben giustificare davanti a sé stesso, altra cosa è l'uso della violenza, che non si pone nemmeno il problema. Dice il Dewey: " E' immenso, il debito che abbiamo. verso William James per il solo titolo del suo saggio: Gli equivalenti morali della guerra. Esso rivela con uno sprazzo di luce la vera psicologia.... Il suggerimento di un equivalente della guerra richiama l'attenzione sulla confusa mescolanza d'impulsi che per caso si sono raccolti sotto il titolo di impulso bellicoso, e richiama l'attenzione sul fatto, che gli elementi di questa mescolanza confusa si possono intrecciare insieme in molti tipi diversi di attività, alcuni dei quali possono mettere in funzione gli impulsi nativi in modi molto migliori che non abbia mai fatto la guerra. Sono le condizioni sociali piuttosto che il vecchio e immutabile Adamo che hanno generato le guerre; gli impulsi irriducibili che vi sono utilizzati possono essere convogliati in molti altri canali. Il secolo che è stato testimone del trionfo della dottrina scientifica della convertibilità delle energie naturali, non dovrebbe rifiutare le prospettive del miracolo meno grande delle equivalenze e delle sostituzioni sociaIi." (J. Dewey, Natura e condotta del- l'uomo, trad. it. ed. La Nuova Italia, Firenze, 1958, pagg. 120-22). Ma, prosegue il Dewey, come operare questa sostituzione? " Hinton aveva senza dubbio ragione quando scrisse che il solo modo di abolire la guerra era quello di rendere eroica la pace " (pag. 124). Il che non si può ottenere lasciando immutato il resto: sarebbe una pazzia " ogni sforzo di eliminare la guerra con azioni che lascino del tutto immutate le altre istituzioni della società " (pag. 124). Mi pare che questi pensieri del Dewey confermino ciò che dicevo prima, sul dover dare una interpretazione attiva, della nonviolenza, .e sul dovere inserire questa, perché vi ,sia concreta ed efficace educazione, in un insieme critico verso gli attuali modi di essere della realtà e della società: la nonviolenza è educativa quando sorge dall’insoddisfazione della presente realtà (che dà la morte) e della presente società (che dà l'ingiustizia e l'oppressione). Attraverso la pedagogia un'osservazione psicologica conduce ad un programma religioso e sociale. Dio dice tu, non io. Bisogna educare al tu. Norberto Bobbio, Pacifismo, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Dizionario di politica, Utet, Torino 1983 Definizione Per pacifismo s’intende una dottrina, o anche soltanto un insieme di idee o di atteggiamenti, nonché il movimento corrispondente, contrassegnati da questi due connotati: a) condanna della guerra come mezzo idoneo a risolvere le controversie internazionali; b) considerazione della pace permanente (o perpetua) tra gli Stati come fine possibile e desiderabile. Il pacifismo è contrario sia al bellicismo, cioè a tutte quelle dottrine che esaltano la guerra come fattore di progresso vuoi morale vuoi sociale vuoi tecnico, sia all’imperialismo, cioè alla dottrina che non esclude la pace anche permanente ma la vuole raggiunta attraverso la conquista o la soggezione dei più deboli politicamente o economicamente da parte dei più forti. Il pacifismo a sua volta si distingue tanto dal cosmopolitismo che è affermazione di universalismo più nel campo delle idee che delle istituzioni e rivendica il superamento di ogni barriera nazionale per i singoli individui e non per gli 52 Stati, quanto dall’internazionalismo che proclama l’unità supranazionale di persone appartenenti allo stesso gruppo, o classe, o partito, allo scopo di rafforzarne la coesione e l’influenza, non necessariamente a scopi pacifici. Breve storia delle correnti pacifiste II pacifismo moderno è nato sotto forma di dottrina filosofico-giuridica nel sec. XVIII con II Progetto per rendere la pace perpetua in Europa dell’abbé Charles Frené Castel de Saint-Pierre (1658-1743), apparso nel 1713, fondato sul principio di un’alleanza perpetua tra gli Stati sovrani che s’impegnano con un trattato internazionale a sottomettere ogni loro controversia al giudizio di tutti gli altri Stati riuniti in assemblea permanente. Ha avuto la sua prima grande elaborazione dottrinale nel trattatello kantiano Per la pace perpetua (1795), il quale s’ispira al principio che la tendenza della storia umana è di realizzare una società giuridica sempre più vasta, inteso ii diritto come ¡’Insieme delle condizioni che rendono possibile la coesistenza pacifica delle libertà esterne: fine che può essere raggiunto da una federazione di liberi Stati allorché ogni Stato si sia data una forma repubblicana (in cui il potere di decidere della guerra e della pace non spetti più al monarca, ma al popolo). Nel 1814 SaintSimon, insieme con lo storico Thierry, scrisse un opuscolo Della riorganizzazione della società europea, in cui auspicava la formazione di un parlamento generale europeo fatto a immagine e somiglianza del parlamento inglese che fosse «posto al di sopra di tutti I governi nazionali, Investito del potere di giudicare le loro controversie». Nel sec. XIX i progetti individuali, legati a singole personalità, cedono il passo alla formazione di associazioni per la pace, primamente di carattere religioso come la Società della pace di New York (1815), fondata dal quacchero David Dodge, la Società americana per la pace (1828), fondata da William Ladd, la prima società pacifista europea fondata in Svizzera nel 1830, dal conte di Sellon; in un secondo tempo, ispirate alla dottrina economica del libero scambismo, di cui fu animatore Riccardo Cobden, nei primi grandi congressi per la pace (Londra, 1843; Bruxelles, 1848; Parigi, 1849); in un terzo tempo, promosse da gruppi democratici e radicali, che miravano alla pace attraverso il trionfo dei principio di nazionalità, l’abbattimento dei vecchi imperi, e l’instaurazione di governi fondati sulla sovranità popolare (da ricordare In questo orientamento il congresso di Ginevra del 1867, organizzato dalia Lega permanente della pace di Federico Passy, cui partecipò con grande strepito Garibaldi; quindi i congressi di Berna, 1868, e di Losanna, 1869). Con la costituzione della Seconda Internazionale socialista (1889), una delle maggiori manifestazioni del pacifismo internazionale fu rappresentata dai congressi socialisti. Le varie forme di pacifismo Le varie correnti pacifistiche si possono distinguere in base al diverso modo con cui spiegano le origini delle guerre e di conseguenza in base ai diversi mezzi che propongono come necessari a eliminarle. Per il pacifismo etico-religioso, le cause delle guerre debbono essere ricercate soprattutto nell’indole stessa o nella natura dell’uomo, e pertanto il rimedio non può essere che di carattere spirituale. Versione secolarizzata di questa interpretazione individualistica della guerra sono le varie teorie psicologiche (e ora anche psicoanalitiche) che connettono la guerra all’aggressività istintiva dell’uomo, e propongono come rimedio modi alternativi (meno nocivi) di soddisfare e sfogare l’istinto di aggressione. Il pacifismo economico, che furoreggiò coi liberisti, riteneva che la principale causa delle guerre fosse il protezionismo economico costringente gli 53 Stati a procurarsi con la conquista quel che non riuscivano a procurarsi con il libero commercio: l’idea di Cobden che, attraverso la liberazione delle frontiere economiche, il mercante avrebbe a poco a poco sostituito il guerriero andava di pari passo con la filosofia della storia di Spencer per il quale le leggi fatali dell’evoluzione avrebbero trasformato le antiche società militari che vivevano di guerra e sulla guerra in pacifiche società industriali. Già Voltaire aveva scritto che la guerra, uno dei flagelli più terribili dell’umanità, deriva «dalla fantasia di tre o quattrocento persone sparse sulla superficie del globo terracqueo sotto il nome di principi o governanti». Che la guerra fosse dovuta al «capriccio dei principi» e quindi a cause essenzialmente politiche, e che pertanto l’unica speranza di eliminare la guerra fosse nel passaggio dal dispotismo alla democrazia, fu, come si è visto, anche un’idea di Kant. Questa forma di pacifismo, che si può chiamare politico (dalla causa) o democratico (dal rimedio), ebbe corso soprattutto nei movimenti democratici del secolo scorso: Mazzini nello statuto della Giovane Europa aveva proclamato che «l’umanità non sarà veramente costituita se non quando tutti i popoli che la compongono, avendo acquistato il libero esercizio della loro sovranità, saranno associati in una federazione repubblicana» (art. 19). Nell’ambito delle varie correnti socialiste la guerra è sempre stata considerata un prodotto non tanto di un certo tipo di regime politico quanto di una certa forma di produzione, com’è appunto quella capitalistica, la cui sopravvivenza dipende dalla conquista di sempre nuovi mercati e ha come conseguenza, da un lato, le guerre di conquista coloniale e, dall’altro, le guerre ancor più terribili tra le stesse potenze coloniali per la spartizione delle colonie, secondo le teorie della fase imperialistica del capitalismo, di cui sono note le due diverse versioni di Rosa Luxemburg e di Lenin. In base a questa interpretazione della storia la pace internazionale non potrà essere realizzata se non in seguito alla eliminazione del capitalismo. Mozioni di orientamento pacifista si possono leggere negli ordini del giorno approvati dai vari congressi della Seconda Internazionale: «Le guerre tra gli Stati capitalistici – si legge nella dichiarazione finale del congresso di Stoccarda del 1907 – sono in generale la conseguenza della loro concorrenza sul mercato mondiale», cui segue la conclusione che «le guerre cesseranno col venir meno del capitalismo». La Terza Internazionale, impegnata a difendere le conquiste della rivoluzione sovietica, fu costretta a rinviare a tempi migliori il pacifismo finalistico, e si limitò a smascherare il falso pacifismo della Società delle Nazioni (bollata come Santa Alleanza degli Stati capitalisti). Pacifismo giuridico, o della pace attraverso il diritto, Infine, è quello che attribuisce le guerre alla permanente anarchia della società internazionale e vede come unico rimedio l’eliminazione della sovranità assoluta dei singoli Stati e la creazione di organizzazioni internazionali sempre più vaste e sempre più accentrate sino al limite del Super-Stato o dello Stato universale: secondo questo punto di vista occorre ben distinguere la nozione di conflitto da quella di guerra. La guerra è soltanto un modo (caratterizzato dall’uso della forza organizzata) di risolvere i conflitti internazionali: ragioni economiche, politiche e sociali servono a spiegare l'origine dei conflitti, ma solo la sovranità assoluta degli Stati e la debolezza di un diritto come quello internazionale – che è paritetico e non gerarchico – spiega perché i conflitti tra gli Stati non possano essere risolti alla lunga se non con la guerra. Nel 1947 un disegno di costituzione dello Stato universale fu elaborato da un Comitato per la costituzione mondiale: altri progetti e comitati seguirono anche negli anni successivi, ma senza alcun effetto sulla politica degli Stati e con debole eco sulla pubblica opinione. 54 Pacifismo passivo e pacifismo attivo Con altro criterio di distinzione le dottrine pacifistiche si possono distinguere in passive ed attive, secondoché considerino la meta finale, la pace, come prodotto di un'evoluzione fatale della società umana oppure come il risultato dello sforzo intelligente e organizzato dell'uomo diretto allo scopo voluto. Si riproduce in tal modo nell’ambito del pensiero pacifistico la stessa distinzione che divide i movimenti socialistici della Seconda Internazionale, ispirati a una concezione deterministica delia storia, da quelli che prendono forza e nome dalla teoria leninista del partito rivoluzionario. Gran parte delle correnti pacifistiche del secolo scorso erano guidate dall'idea che la guerra fosse destinata (come lo Stato) a scomparire con lo sviluppo della società industriale (teorie liberali), con l’allargarsi e il rafforzarsi degli Stati nazionali e popolari (teorie democratiche), oppure con la graduale scomparsa delle società divise in classi. Il pacifismo passivo aveva esaurito il suo compito quando era riuscito a dimostrare che la guerra non era più necessaria per io sviluppo dell’umanità. Il pacifismo attivo si propone, invece, di dimostrare che la guerra è un evento negativo o dannoso che deve essere impedito. La caratteristica delle correnti pacifistiche di oggi, nell’era della guerra atomica, è di essersi convertite al pacifismo attivo: di fronte al pericolo della distruzione di ogni traccia dell’uomo sulla terra la pace è un bene troppo importante perché non vi si debba tendere con sforzi tenaci e congiunti. Pacifismo strumentale, istituzionale e finalistico Questi sforzi possono essere rivolti in direzione dei mezzi dì cui ci serve per fare le guerre, o delle istituzioni che le rendono possibili, o dell’uomo stesso: onde la distinzione tra pacifismo strumentale, istituzionale e finalistico. Ciascuna di queste tre forme di pacifismo attivo ha a sua volta due facce. Nel pacifismo strumentale conviene distinguere l’azione rivolta alla distruzione o alla drastica limitazione degli strumenti bellici (dottrina e politica dei disarmo), dall’azione rivolta a sostituire i mezzi nonviolenti ai mezzi violenti e pertanto a ottenere con altri mezzi lo stesso risultato (teoria e pratica della non-violenza, in particolare la dottrina del Satyagraha dì Gandhi). Al pacifismo istituzionale sì ricollegano tanto le teorie che mirano alla costituzione dello Stato universale quanto quelle che mirano all’abolizione delio Stato, cioè tanto il pacifismo che abbiamo chiamato giuridico quanto, in ultima istanza, la dottrina comunistica e quella anarchica. Nel pacifismo finalistico infine confluiscono sia il pacifismo etico-religioso che mira alla conversione e trasformazione morale dell’uomo, all'uomo nuovo, sia il pacifismo scientifico, che mira a neutralizzare o a incanalare in altre direzioni l’istinto di aggressione; tanto il pacifismo dei sacerdoti e dei moralisti quanto quello degli scienziati. Le tre forme dì pacifismo si dispongono in un ordine progressivo di maggiore complessità e di maggiore profondità: la prima si arresta al piano delle tecniche specifiche, la seconda si allarga al piano dell’organizzazione sociale globale, la terza s'inoltra fino all'uomo, cioè all’inventore e fruitore delle tecniche e delle varie forme dì organizzazione sociale. Poiché l'attuabilità è in relazione inversa alla complessità, e l'efficacia è in relazione diretta alla profondità, si può anche dire che ciascuna delle tre vie alla pace è tanto più attuabile quanto meno efficace, e viceversa, il che permette di disporle secondo l’ordine decrescente di attuabilità e crescente di efficacia, che procede dalla via del disarmo, che è la più attuabile ma anche la meno efficace, alla via della riforma morale dell’uomo che è certamente la più efficace, se pure, realisticamente, la meno attuabile. 55 Eric J. Hobsbawm, Intervista sul nuovo secolo, cit., 17-22. D. Lei ha tratteggiato i caratteri nuovi che la guerra tende ad assumere alla fine del Secolo breve. Ma, tra questi, c’è l’ingresso sulla scena del concetto di “guerra giusta” o “etica”. È giusto –secondo lei — che le democrazie muovano guerra ai dittatori in nome dei diritti universali dell’uomo? R. Su questo sono un po’ scettico. Non mi sembra che i governi facciano le guerre perché sono giuste o ingiuste. Tendono, questo sì, a legittimarle, a raccogliere il sostegno popolare, sostenendo che sono giuste. È estremamente importante convincere le opinioni pubbliche, è decisivo presentare la guerra in un modo tale che la gente la consideri legittima e giusta. Ma è molto difficile trovare nella storia esempi di governi che vanno alla guerra per qualcosa d’altro che non siano gli interessi nazionali. Ci sono ovviamente eccezioni. Una di esse è costituita dai regimi rivoluzionari, espressione cioè di una rivoluzione, che talvolta hanno mosso guerra per differenti motivi, morali, o ideologici, o di liberazione nazionale. Ma anche questi regimi ben presto, non appena si stabilizzano, assumono gli atteggiamenti di politica estera propri degli Stati, e prendono ad agire sulla base degli interessi nazionali. A questo proposito, noi dobbiamo sempre ricordare che gli Stati Uniti d’America sono, entro certi limiti, un potere ideologico, che proviene, esattamente com’era per l’Unione Sovietica, da una rivoluzione, e che dunque sentono l’imperativo di guidare il mondo secondo i propri princìpi come parte essenziale della loro politica estera. Questo può essere molto pericoloso. Non ho dubbi che gli Stati Uniti vorrebbero cambiare il mondo, e che la tutela dei diritti umani faccia parte della loro ambizione. Ciò nondimeno, non mi sembra di poter identificare un solo episodio in cui di Usa siano andati in guerra esclusivamente per fare il Bene, e cioè non erano in gioco anche rilevanti interessi nazionali. Certo, oggi si discute in maniera sincera sull’importanza lei diritti umani, per accertare fino a che punto la loro difesa possa essere garantita con l’uso della forza militare. Ma io rimango della mia convinzione: che né la Nato né gli Stati Uniti hanno pensato davvero di andare in guerra per ragioni meramente etiche, di principio. Neanche la seconda guerra mondiale, in definitiva, è stata combattuta per questo. Naturalmente gli Alleati stavano dalla parte giusta, e la loro vittoria ha salvato il mondo dal nazismo, ma le democrazie europee e l’Unione Sovietica vi furono trascinate da Hitler, e gli Stati Uniti dal Giappone. D. Lei ha conosciuto l’antisemitismo in Germania, perché di origine ebrea. Il 30 gennaio 1933 per lei non è solo la data in cui Hitler è diventato cancelliere del Reichstag, ma - così lo ricorda - «è un pomeriggio d’inverno a Berlino, all’età di quindici anni, mentre con la sorella più piccola tornavo a casa ad Halensee dalla scuola che si trovava a Wilmersdorf, e da qualche parte lungo la strada vidi il titolo di un giornale. Riesco ancora a leggerlo, quasi fosse un sogno». Sente dunque anche lei, come Elie Wiesel, che bisogna fermare l’odio etnico perfino con la forza, prima che possa mettere a segno i suoi colpi? Crede che la pulizia etnica di Milosevic configuri un reato di genocidio, o che sia paragonabile all’Olocausto? 56 R. Non mi pare. «Genocidio» è diventato un termine troppo usato, e dunque svalutato, un po’ quello che è successo alla parola «fascismo». Il genocidio è un progetto di eliminazione totale di un’etnia. In qualche modo è un’estensione logica, ed estrema, della pulizia etnica. Oggi, per esempio, emergono informazioni che ci fanno ritenere che la pulizia etnica a Srebenica si avvicinò al genocidio. Nondimeno c’è una differenza fondamentale tra cacciare un popolo dalla propria terra, dir loro «andatevene da qualche altra parte», costringerlo con la forza a farlo, e praticarne invece la totale eliminazione. I nazisti uccisero uomini, donne, vecchi, bambini ebrei. Nella pulizia etnica si deportano donne, vecchi e bambini, e si selezionano gli uomini in età da combattimento per imprigionarli o eliminarli fisicamente. In nessun senso questo riduce la gravità morale della pulizia etnica, ma io credo che dobbiamo saper distinguere. La pulizia etnica è un fenomeno che si manifesta secondo vari e diversi livelli di gravità, e può essere spinta fino agli estremi del genocidio. E cosa già abbastanza orribile di per sé, non c’è davvero bisogno di peggiorarne il senso identificandola con il genocidio. Il fatto è che, per quanto a nessuno piaccia parlarne in pubblico, in privato generali e politici non esitano ad affermare che spesso, nella storia, la pulizia etnica aiuta a semplificare i problemi. Ecco un’altra ragione del mio scetticismo sulle motivazioni morali della guerra in Kosovo. Se i tedeschi non fossero stati cacciati dalla Slovenia, quel paese non sarebbe forse oggi il posto tranquillo e quieto che conosciamo. Alla fine, il conflitto in Bosnia fu risolto e chiuso separando le diverse popolazioni che l’abitavano in diverse aree del paese. Personalmente, penso che sia sbagliato accettare che questo accada, anche solo in linea di principio. Non dovrebbe neanche essere discusso in via teorica, come una possibile soluzione. Ma viviamo in un mondo molto violento, e accade. D. Ma allora, se non è stata l'istanza morale a muovere la Nato, qual è stato l’interesse che ha spinto i paesi che ne fanno parte a bombardare la Serbia? R. Per alcuni paesi dell’Alleanza atlantica l’obiettivo essenziale è stato di non perdere il contatto con gli Stati Uniti. È il caso di Stati come la Polonia, che non hanno uno specifico interesse nel Kosovo, e che certo non pensavano di dover partecipare a una guerra all’indomani della loro adesione alla Nato. Molti altri paesi hanno avuto le loro particolari priorità, come l’Italia e la Francia. Per la Gran Bretagna, vale il principio storico di una politica estera che le impone di essere al cento per cento schierata con gli Stati Uniti. Il resto è, non voglio dire ipocrisia, perché c’è gente che crede sinceramente in quello che dice, ma certo non una seria motivazione per la guerra. Per gli americani, invece, la guerra del Kosovo è una questione più complicata. All’inizio s’interessarono ai Balcani perché l’Europa aveva drammaticamente fallito nell’obiettivo di stabilizzare l’area all’inizio degli anni Novanta. Gli americani dovettero entrare nella partita, perché in quel momento compresero che, come unica superpotenza mondiale, non potevano restare fuori. Almeno una parte dei Balcani rappresenta un’area strategica, anche geograficamente troppo rilevante per la struttura della Nato da pensare di poterla trascurare. Infatti gli americani furono i primi a inviare truppe in Macedonia, già nel 1992, e dichiararono con Bush esplicitamente alla Jugoslavia il loro interesse strategico, che comprendeva la sorte del Kosovo. Dovettero farlo per molte ragioni, non ultima la consapevolezza che le Nazioni Unite, non essendo un potere indipendente ma basato sulla autorità che gli conferiscono le superpotenze, non avrebbero saputo affrontare e risolvere 57 la crisi bosniaca. Così, dopo la fine della guerra in Bosnia, gli Stati Uniti si trovarono in una situazione da cui non potevano estraniarsi, ma in cui non potevano agire da soli, senza il sostegno dell’Alleanza. A mio parere, videro anche la crisi bosniaca come l’occasione – aspirazione che ancora non comprendo completamente – di dare un nuovo ruolo alla Nato, di ricostituirne la funzione e il senso dopo la fine della Guerra Fredda. Gli Stati Uniti si considerano oggi il potere cui spetta il compito di stabilizzare il mondo, ricorrendo quando è il caso a operazioni di polizia internazionale. Dimostrando dunque il proprio potere dovunque risulti necessario, per tenere a freno i potenziali nemici al di fuori dell’area Nato. E per questo penso che la sorte della Nato sia la ragione vera dell’intervento Nato. Non bisogna dimenticare che, quando Clinton elencò i motivi per cui aveva deciso di avviare i bombardamenti sulla Serbia, per primo indicò la difesa della credibilità della Nato, e dunque degli Stati Uniti. Non penso che l’abbia difesa molto bene e con grandi risultati, ma è chiaro che la Nato avvertì la necessità di fare qualcosa. Per risolvere la crisi umanitaria, insomma, c’erano molti altri modi per agire. D. Ma, allora, che cosa si può fare per fermare un dittatore che dispone a piacimento del suo popolo? L’intervento armato è da escludere a priori? R. Ci sono eccezioni, naturalmente. E la Bosnia era, senza dubbio, un caso del genere. D’altra parte, però, bisogna seguire alcuni criteri. Ci sono stati due importanti casi di intervento militare che hanno avuto successo nel fermare crimini contro l’umanità e nel cacciare dittatori sanguinari. Il primo fu l’intervento del Vietnam in Cambogia, per rovesciare il regime di Pol Pot. E l’altro quello della Tanzania in Uganda, governata da Idi Amin. Io penso che furono entrambi giustificati. Ma la vera ragione per cui non ho riserve su queste due guerre è che esse ebbero successo, furono efficaci nel raggiungere il loro obiettivo e si conclusero in un lasso di tempo relativamente breve. Una delle ragioni delle mie riserve sull’intervento in Kosovo è che non è stato condotto in questo modo, perché era chiaro fin dall’inizio che scaricare un po’ di bombe sulla Serbia avrebbe peggiorato e aggravato la situazione dei profughi. Devo aggiungere che, per molti anni dopo che il Vietnam aveva messo fine al regime di Pol Pot, Stati Uniti e Cina continuarono ad aiutare le forze del dittatore, a dimostrazione ulteriore che la politica degli Stati e delle potenze non è determinata in primo luogo da considerazioni etiche. Allo stesso modo penso che l’intervento umanitario in Bosnia non fu concepito per essere realmente tale. E dunque non fu efficiente. Annunciarono che avrebbero protetto le enclaves musulmane, ma non prepararono le azioni che avrebbero potuto garantire quell’obiettivo. Credo che, proprio a causa della nuova commistione tra politica interna e politica internazionale, l’intervento negli affari interni di uno Stato debba rispondere a regole e criteri ben definiti. Bisogna aprire una discussione su questo punto: quali sono le nuove regole del sistema internazionale dei poteri? Bisogna ripristinare una situazione in cui l’azione militare non può essere intrapresa da nessuno senza che ci sia un consenso ampio e basato su ragioni gravi. Non può funzionare un mondo in cui qualcuno dice: sono forte abbastanza per agire, dunque agisco. 58 Michael Walzer, Il trionfo della teoria della guerra giusta (e i pericoli del suo successo) (2002), in Sulla guerra, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 8-24. Negli anni Cinquanta e nei primi Sessanta, quando andavo all’università, il realismo era la dottrina imperante nel campo delle «relazioni internazionali». Il riferimento standard non era alla giustizia ma all’interesse. Gli argomenti di tipo morale andavano contro le regole standard di quella disciplina, anche se alcuni autori difendevano l’interesse sostenendo che fosse quello la nuova morale. In quegli anni c’erano molti studiosi di politica che si immaginavano di essere dei Machiavelli moderni e sognavano di poter sussurrare all’orecchio del principe; e un certo numero di questi, abbastanza alto da eccitare le ambizioni degli altri, ci era effettivamente riuscito. […] La teoria della guerra giusta era relegata nei dipartimenti di religione, nei seminari di teologia e in poche università cattoliche. E anche in questi luoghi, isolati com’erano dal mondo politico, la teoria veniva spinta verso posizioni realiste; forse per spirito di autoconservazione, i suoi difensori lasciavano cadere parte di ciò che si trovava sul suo risvolto critico. Il Vietnam ha cambiato tutto, anche se c’è voluto un po’ perché il cambiamento venisse registrato a livello teorico: le cose sono cambiate prima nella pratica. La guerra era divenuta un tema del dibattito politico: era ampiamente osteggiata, soprattutto da persone di sinistra, fortemente influenzate dal marxismo: parlavano anch’esse un linguaggio improntato all’interesse e condividevano con i prìncipi e i professori della politica americana il disdegno per il moraleggiare. Eppure, l’esperienza della guerra li spinse verso argomenti di tipo morale. Naturalmente, ai loro occhi la guerra era estremamente avventata: non poteva essere vinta e i suoi costi, anche se gli americani avevano badato soltanto a se stessi, erano di gran lunga troppo elevati; era un’avventura imperialista che non si addiceva neanche agli imperialisti; poneva gli Stati Uniti contro la causa della liberazione nazionale, il che avrebbe alienato loro il Terzo mondo (e parti significative del Primo). Ma queste affermazioni erano del tutto inadatte ad esprimere i sentimenti della maggior parte degli oppositori alla guerra, sentimenti che avevano a che fare con la sistematica esposizione dei civili vietnamiti alla violenza della guerra americana. Quasi contro la sua volontà, la sinistra è caduta nel discorso improntato alla moralità. Tutti noi, che eravamo contro la guerra, improvvisamente abbiamo cominciato a parlare il linguaggio della guerra giusta – anche se non sapevamo di farlo. Può sembrare strano ricordare gli anni Sessanta in questa maniera, dato che oggi la sinistra sembra fin troppo disposta a fare ricorso ad istanze morali, anche di carattere assoluto. Ma questa descrizione della sinistra di oggi mi sembra errata. Un certo moraleggiare politicizzato, strumentale ed altamente selettivo, sta diventando sempre più comune tra gli autori di sinistra, ma non è una argomentazione morale seria. Non è ciò che abbiamo imparato, o che avremmo dovuto imparare, dagli anni del Vietnam. In quel periodo le persone di sinistra, e anche molte altre, stavano cercando un linguaggio morale comune, e quello più a portata di mano era il linguaggio della guerra giusta. Tutti noi eravamo un po’ impacciati, non avevamo l’abitudine a parlare di morale in pubblico. Il predominio del realismo ci aveva rubato le parole di cui avevamo bisogno, e a poco a poco ce ne siamo impadroniti nuovamente: aggressione, intervento, giusta causa, autodifesa, immunità per i non combattenti, proporzionalità, prigionieri di guerra, civili, doppio effetto, terrorismo, crimini di guerra; e abbiamo imparato che queste parole avevano un loro significato. Certo, potevano essere usate in modo strumentale, il che è sempre ve59 ro quando si tratta di termini politici e morali. Ma se ci fossimo attenuti al loro significato, ci saremmo trovati in una discussione dotata di una propria struttura. Come i personaggi di un racconto, i concetti di una teoria danno forma alla narrazione o alla tesi in cui fanno la loro comparsa. Terminato il conflitto in Vietnam, quella sulla guerra giusta divenne una discussione accademica: gli studiosi di politica e i filosofi scoprirono la teoria, se ne scrisse sulle riviste e venne insegnata nelle università – e, in America, anche nelle accademie militari e nelle scuole di guerra. Un piccolo gruppo di veterani del Vietnam giocò un ruolo importante nel rendere la guerra giusta una materia centrale nei curricula militari. Avevano brutti ricordi, ed accolsero con favore la teoria della guerra giusta proprio perché ai loro occhi era una teoria critica; anzi, lo era doppiamente: sulle ragioni e sulla condotta delle guerre. Ho il sospetto che ai veterani interessasse soprattutto il secondo aspetto. Non volevano soltanto evitare che in guerre future potessero succedere cose simili al massacro di My Lai: volevano, come i soldati di professione in tutto il mondo, distinguere la loro attività dalla bassa macelleria e, per effetto della loro esperienza in Vietnam, credevano che ciò dovesse essere fatto in modo sistematico: non ci voleva soltanto un codice di comportamento, ma anche una teoria. Una volta, immagino, il codice d’onore aristocratico era alla base di quello militare; in un’età più democratica ed egualitaria, il codice doveva essere difeso attraverso la discussione argomentata. E così ci trovammo a discutere. Le discussioni e i dibattiti erano di ampio respiro anche se, una volta finita la guerra, per lo più limitati all’accademia. È facile dimenticare quanto sia vasto il mondo accademico negli Stati Uniti: ci sono milioni di studenti e decine di migliaia di professori. E stato così che molte persone, futuri cittadini e ufficiali dell’esercito, vi si sono trovate coinvolte, e che la teoria è stata presentata prevalentemente, anche se non senza obiezioni, come un manuale per la critica alla guerra proprio in tempo di guerra. I casi e gli esempi venivano tratti dal conflitto in Vietnam, ed erano presentati in modo da invitare alla critica. Era una guerra che non avremmo dovuto combattere, e che avevamo combattuto male, con brutalità, come se non ci fossero limiti morali, e così essa divenne, retrospettivamente, l’occasione per tracciare una linea di confine. […] Tornando a considerare ciò che era successo in Vietnam, tuttavia, eravamo più propensi a negare autorizzazioni che a fornirle, continuando a dire che quello che era stato fatto non doveva accadere. Ma c’era anche un altro aspetto del Vietnam che dava una forza particolare alla critica della guerra: era una guerra che avevamo perso, e la brutalità con cui l’avevamo combattuta aveva certamente contribuito alla nostra sconfitta. In una guerra combattuta più per «i cuori e le menti», piuttosto che per la terra e le risorse, la giustizia si rivela un elemento chiave per la vittoria. […] E questa, penso, è stata la causa più profonda dell’attuale trionfo di questa teoria: ora ci sono ragioni di Stato per combattere con giustizia. Si potrebbe quasi dire che la giustizia sia divenuta una necessità militare. Probabilmente, ci sono state in precedenza guerre nelle quali la deliberata uccisione di civili, e anche la normale indifferenza militare per l’uccisione di civili, si sono dimostrate controproducenti. Un possibile esempio è la guerra boera. Ma per noi, quella del Vietnam è stata la prima guerra nella quale è divenuto evidente il valore pratico dello jus in bello. A dire il vero, di solito si parla della «sindrome del Vietnam» in riferimento ad un’altra lezione: ossia che non si dovrebbero combattere guerre impopolari in patria e per le quali non sì vogliono impegnare le risorse necessarie alla vittoria. Ma di fatto vi è stata un’altra lezione, ad essa colle60 gata ma diversa: che non dovremmo combattere guerre sulla cui giustizia nutriamo dubbi, e che, se vi siamo coinvolti, dobbiamo combattere con giustizia, in modo da non renderci ostile la popolazione civile, il cui appoggio politico è necessario per la vittoria militare. In Vietnam, i civili in questione erano gli stessi vietnamiti: abbiamo perso la guerra quando abbiamo perso «i loro cuori e le loro menti». Ma quest’idea del bisogno di appoggio da parte dei civili si è rivelata variabile in qualità e in estensione: oggi per condurre una guerra serve l’appoggio di diverse popolazioni civili, oltre a quella immediatamente a rischio. Comunque, la considerazione morale per i civili a rischio è di importanza critica per ottenere un appoggio più consistente alla guerra... a qualsiasi guerra odierna. Chiamo questo aspetto «utilità della morale»: il suo riconoscimento diffuso è qualcosa di radicalmente nuovo nella storia militare. Ecco allora lo strano spettacolo di George Bush (padre) che, durante la guerra del Golfo, parlava come un teorico della guerra giusta. Beh, non proprio: perché i discorsi di Bush e le sue conferenze stampa mostravano una vecchia tendenza americana, ereditata poi dal figlio, di fare confusione, tra guerre giuste e crociate, come se una guerra potesse essere giusta solo quando le forze del bene sono schierate contro quelle del male. Ma è sembrato anche che Bush capisse - e questo punto veniva costantemente ribadito dai portavoce militari americani - che la guerra è propriamente uno scontro tra forze armate, una lotta tra combattenti, dalla quale la popolazione civile deve essere protetta. Io non credo che i bombardamenti sull’Iraq nel 1991 soddisfacessero i requisiti della guerra giusta: proteggere la popolazione civile avrebbe certamente dovuto comportare di non distruggere reti elettriche e impianti di depurazione delle acque. Le infrastrutture urbane, per quanto necessarie a fare la guerra, sono necessarie all’esistenza dei civili in una città moderna, e la loro distruzione è definita moralmente da questa seconda caratteristica. Comunque, la strategia americana nella guerra del Golfo fu il risultato di un compromesso tra quello che avrebbe richiesto la giustizia e i bombardamenti indiscriminati delle guerre precedenti; tutto sommato, la definizione dei bersagli è stata molto più limitata e selettiva di quanto non fosse stata, ad esempio, in Corea o nel Vietnam. Le ragioni di tutto ciò erano complicate: in parte, esse riflettevano un impegno (che non si è dimostrato molto forte) verso il popolo iracheno, nella speranza che quest’ultimo avrebbe rifiutato la guerra e rovesciato il regime che l’aveva avviata; in parte, esse riflettevano le necessità politiche della coalizione che aveva reso possibile la guerra. Queste necessità erano a loro volta definite dalla copertura mediatica della guerra - ossia, dall’immediato accesso deÌ media ai campi di battaglia e di tutto il mondo ai media. Bush e i suoi generali credevano che tutte queste persone non avrebbero tollerato un massacro di civili, e probabilmente avevano ragione (ma non era affatto chiaro, come non lo è neanche oggi, entro quali limiti andasse inteso ciò). Così, anche se molti dei Paesi il cui apporto era cruciale per il successo della guerra non erano democrazie, la logica dei bombardamenti fu dettata, sotto aspetti importanti, dalle dimostrazioni. Ciò continuerà ad essere vero: i media sono onnipresenti, e tutto il mondo li segue. La guerra deve essere diversa, in queste circostanze; ma ciò vuol dire che deve essere più giusta o che deve soltanto dare l’impressione di esserlo, oppure ancora che deve essere descritta in termini di giustizia in modo un po’ più persuasivo di quanto sia stato fatto in passato? Il trionfo della teoria della guerra giusta è abbastanza evidente: è stupefacente quanto fossero pronti i portavoce militari, durante le guerre del Kosovo e dell’Afghanistan, ad utilizzarne le categorie, fornendo all’occorrenza ricostruzioni di eventi che giustificavano la guerra e resoconti 61 delle battaglie che enfatizzavano la moderazione con cui venivano combattute. Gli argomenti (e le razionalizzazioni) del passato erano molto diverse: normalmente provenivano dall’esterno delle forze armate - religiosi, avvocati e cattedratici, ma non generali - e di solito mancavano di specificità e dettaglio. Ma che cosa significa l’uso di queste categorie, di queste parole giuste e morali? Forse ingenuamente, sono incline a dire che la giustizia è divenuta, in tutti i Paesi occidentali, uno dei criteri che qualsiasi strategia o tattica militare deve rispettare - solo uno dei criteri, e forse neanche il più importante, ma ciò dà, in ogni caso, alla guerra giusta un posto e un rango senza precedenti. Oggi è più facile di quanto non sia mai stato immaginare un generale che dica: «No, non possiamo farlo: farebbe troppi morti tra i civili. Dobbiamo trovare un altro sistema». Non sono sicuro che ci siano molti generali che parlino così, ma immaginiamo per un momento che ce ne siano, che le strategie siano valutate da un punto di vista tanto morale quanto militare, che le perdite tra i civili siano ridotte al minimo, che siano progettate nuove tecnologie per evitare o limitare i danni collaterali, e che queste tecnologie siano davvero efficaci nel raggiungere il loro scopo. La teoria morale sarebbe incorporata nella tecnica militare come un vincolo di cui tenere conto davvero rispetto a quando e come combattere le guerre. Si tratta, ricordiamolo, di un’ipotesi, ma è anche in parte reale, e costituisce un argomento di gran lunga più interessante rispetto all’affermazione più frequente, per cui il trionfo della guerra giusta sarebbe una semplice ipocrisia. Il trionfo è reale: ma allora, che resta da fare ai filosofi e ai teorici? Questa domanda è tanto presente alla nostra coscienza da far sì che alcuni vadano alla ricerca di risposte. Ce ne sono due che voglio descrivere e criticare qui. La prima risposta viene da quella che potremmo chiamare la sinistra postmoderna, la quale non ritiene ipocrite le affermazioni sulla guerra giusta, dal momento che l’ipocrisia implica l’adozione di un criterio; invece a suo dire non ci sono criteri, e dunque nessun possi- bile uso obiettivo della teoria della guerra giusta9.1 politici e i generali che adottano queste categorie si illudono - anche se non più dei teorici che le hanno elaborate per primi. Forse le nuove tecnologie uccidono meno persone, ma non ha senso discutere su chi siano queste persone e se ucciderle sia più o meno giustificato. Non è possibile nessun accordo sulla giustizia, sulla colpa o sull’innocenza. Questo punto di vista si riassume in una frase che riflette la nostra situazione presente: «chi è un terrorista per qualcuno, secondo altri è un combattente per la libertà». Detto ciò, teorici e filosofi non possono fare altro che scegliere da che parte stare, e non ci sono teorie o princìpi che possano guidare la loro scelta. Ma questa è una posizione impossibile, perché stabilisce che non possiamo riconoscere, condannare e contrastare attivamente l’uccisione di innocenti. Un’altra posizione è invece quella che prende molto sul serio il bisogno morale di riconoscere, condannare e opporsi, e poi alza la posta in gioco a livello teorico - ossia, rafforza i vincoli imposti dalla giustizia alla guerra. Per i teorici che si vantano di vivere, per così dire, sul risvolto critico, questa è una risposta ovvia e comprensibile. Per molti anni, abbiamo utilizzato la teoria della guerra giusta per criticare le azioni militari americane, e ora se ne sono appropriati i generali, che la usano per spiegare e giustificare queste stesse azioni. Ovviamente, dobbiamo resistere. Il modo più semplice per farlo consiste nel rafforzare progressivamente la regola dell’immunità per i non combattenti, fino a farla diventare qualcosa di simile ad una regola assoluta: ogni civile ucciso equivale a un assassinio (o qualcosa di simile); perciò ogni guerra che comporti l’uccisione di civili è ingiusta; e perciò ogni guerra è ingiusta. Così il pacifismo rispunta dal cuore della teoria che 62 era stata pensata per sostituirlo. Questa è la strategia adottata, ultimamente, da molti oppositori alla guerra in Afghanistan. Le marce di protesta nei campus americani portavano striscioni con lo slogan «Fermate i bombardamenti!» e l’argomento utilizzato per fermarli era molto semplice (e di una verità ovvia): i bombardamenti mettono in pericolo e uccidono i civili. Sembrava che i manifestanti non avessero bisogno di aggiungere altro. Dal momento che credo che la guerra sia ancora, a volte, necessaria, questo mi sembra un cattivo argomento e, più in generale, una cattiva risposta al trionfo della teoria della guerra giusta. Esso sostiene il ruolo critico della teoria rispetto alla guerra in generale, ma le sottrae il ruolo critico che ha sempre preteso, che è interno all’impresa bellica ed esige dai suoi oppositori di seguire da vicino ciò che i soldati cercano di fare e di non fare. Il rifiuto di fare distinzioni di questo genere, di prestare attenzione alle scelte tattiche e strategiche, suggerisce una dottrina basata sul sospetto radicale. Questo è il radicalismo di persone che pensano di non poter esercitare il potere o utilizzare la forza, in nessun caso, e che non sono preparate a pronunciare i giudizi richiesti da questo esercizio e da questo utilizzo. Per contrasto, la teoria della guerra giusta, anche quando richiede una forte critica di atti bellici specifici, è la dottrina di persone che pensano di poter esercitare il potere ed utilizzare la forza. Possiamo pensarla come una dottrina di responsabilità radicale, in quanto ritiene i leader politici e militari responsabili, prima di tutto, del benessere del loro popolo, ma anche degli uomini e delle donne innocenti che si trovano dall’altra parte. I suoi sostenitori si pongono in contrasto con quelli che non penserebbero realisticamente alla difesa del Paese in cui vivono e anche contro quelli che rifiutano di riconoscere l’umanità dei loro avversari; secondo loro, ci sono cose che non è moralmente permesso fare, nemmeno al nemico. Ma sostengono anche che a livello morale non si può vietare il conflitto in quanto tale. Una guerra giusta vuole, e deve, essere una guerra che sia possibile combattere. Ma c’è un altro pericolo, posto dal trionfo della teoria della teoria della guerra giusta - non il relativismo radicale, né il quasi assolutismo che ho appena descritti, ma semmai un certo indebolimento del pensiero critico, una tregua tra teorici e soldati. Se gli intellettuali sono spesso intimoriti e zittiti dai leader politici che li invitano a cena, quanto possono esserlo da generali che parlano nella loro lingua? E se i generali stanno effettivamente combattendo guerre giuste, se inter arma le leggi parlano, che utilità può avere ciò che abbiamo da dire noi teorici della guerra giusta? In effetti, però, il nostro ruolo non è poi cambiato granché. Dobbiamo ancora ribadire che la guerra è un’attività moralmente ambigua e difficile. Anche se noi (in Occidente) abbiamo combattuto guerre giuste nel Golfo, in Kosovo e in Afghanistan, ciò non è una garanzia, e nemmeno un indizio significativo, del fatto la prossima sarà altrettanto giusta. E anche se per i militari riconoscere l’immunità per i non combattenti è divenuto moralmente necessario, ciò è ancora in contrasto con altre, più pressanti, necessità. La giustizia ha ancora bisogno di essere difesa: le decisioni sul quando e sul come combattere richiedono un esame costante, allo stesso modo di sempre. Allo stesso tempo, dobbiamo estendere il nostro concetto di «quando e come», al fine di comprendere le nuove strategie, le nuove tecnologie e le nuove politiche di un’epoca globalizzata. Le vecchie idee possono non essere adatte alla realtà che sta emergendo: la «guerra al terrorismo», per fare l’esempio più attuale, richiede un tipo di cooperazione internazionale che è ancora in gran parte da sviluppare, tanto in teoria quanto nella pratica. Dobbiamo accogliere con favore i militari nelle discussioni teoriche: le renderanno migliori di quello che sarebbero se 63 solo gli accademici se ne interessassero, ma non possiamo lasciare l’intera discussione nelle loro mani. Come dice il vecchio adagio, la guerra è troppo importante per essere lasciata ai generali; e la guerra giusta lo è ancora di più. L’attuale critica del modo di fare la guerra è un’attività democratica di importanza centrale. […] È importante non fossilizzarsi in nessuna delle due modalità, difesa o critica. In effetti, la teoria della guerra giusta ci richiede di mantenere il nostro impegno nei confronti di entrambe allo stesso tempo. In questo senso, la guerra giusta è come il buon governo: c’è una tensione profonda e permanente tra nome e aggettivo, senza alcuna contraddizione necessaria. Quando i riformatori arrivano al potere e migliorano il governo (ad esempio, riducendo la corruzione), dobbiamo essere in grado di ammettere che c’è stato un miglioramento. E quando restano al potere troppo a lungo, e imitano i loro predecessori, dobbiamo essere pronti a criticare il loro comportamento. La teoria della guerra giusta non è una scusa per una guerra in particolare, né una rinuncia alla guerra in quanto tale. Essa e stata elaborata per sostenere un esame costante e una critica immanente. Ne abbiamo ancora bisogno, anche quando i generali parlano da teorici della giustizia, e sono sicuro che ne avremo bisogno sempre. 64 L'Italia sulla soglia Roberti Rivello, Il ripudio della guerra (art. 11), in Guido Neppi Modona (a cura di), Stato della Costituzione, Il Saggiatore, Milano 1995. Già prima della seconda guerra mondiale si erano avute, in particolare con il patto Briand-Kellog stipulato a Parigi nel 1928, importanti assunzioni di impegni internazionali di rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale e di risoluzione dei conflitti interstatali. Ma fu soprattutto dopo il secondo tragico conflitto mondiale che la comunità internazionale maturò ed espresse un chiaro rifiuto della guerra e dell’uso della forza, costituendo, con la Carta delle Nazioni Unite stipulata a San Francisco nel 1945, un sistema internazionale di sicurezza collettiva per la tutela della pace, al fine di salvare le generazioni successive dal flagello della guerra e assicurare la stessa sopravvivenza del genere umano minacciata dall’utilizzo dei mezzi di distruzione di massa. Particolarmente indicativo è l’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, che pone l’obbligo per gli Stati membri di «astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite», eccettuato il caso, previsto dall'art. 51 della Carta, della legittima difesa, e solo fino al momento in cui «il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie» per il mantenimento della pace. Questi principi, inizialmente vigenti solo per gli Stati fondatori delle Nazioni Unite, hanno trovato in seguito ampio sviluppo nel diritto internazionale e si può oggi considerare esistente una consuetudine internazionale, cogente per ogni Stato, in base alla quale l’indebito uso della forza costituisce crimine internazionale. Nella prospettiva di un ingresso dell’Italia fra i membri delle Nazioni Unite, e sulla spinta di una convinzione pacifista diffusissima nel Paese e su cui si manifestò un’ampia convergenza di tutte le forze politiche, il nostro Costituente introdusse fra i principi cardine del nostro ordinamento il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, condannando il recente passato fascista, contraddistinto dalla promozione di conflitti imperialisti e nazionalisti, e impegnandosi a evitare ogni futuro comportamento analogo. La garanzia, prevista in altre norme della Costituzione (v. artt. 78 e 80), del controllo parlamentare sulla deliberazione dello stato di guerra e sui momenti salienti della politica estera, è volta anch’essa ad assicurare maggiormente l’impegno pacifista: il Parlamento, diretto rappresentante del popolo, dovrebbe prestarsi meno facilmente del Governo ad assumere qualsivoglia iniziativa bellica, sempre in realtà lesiva, di per sé, degli interessi della popolazione. Sulla base del disposto costituzionale lo Stato italiano è pertanto impegnato in generale a perseguire attivamente una politica di carattere pacifista, e in particolare a non muovere guerra ad altri Stati, eccetto nel caso di legittima reazione all’attacco armato altrui già in atto o minacciato, e a non stipulare intese con altri Stati che possano in futuro obbligare l’Italia a muovere guerre di carattere non difensivo. Il divieto di muovere guerra ad altri Stati va esteso anche alla guerra nei con65 fronti di altri popoli: così, per esempio, deve considerarsi vietato per l’Italia venire militarmente in aiuto di uno Stato al cui interno sia in corso una guerra civile. Gianfranco Pasquino, Commento alla Costituzione italiana, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2011, p. 48. No alla guerra, sempre e comunque? Le guerre che non si possono e quelle che si possono fare. La Seconda guerra mondiale non poteva non imporre una riflessione profonda in tutti quelli che l’avevano vissuta ed erano sopravvissuti. L’enormità degli orrori, in particolare il genocidio degli ebrei, sarebbe stata scoperta progressivamente, ma la distruzione complessiva e, persino, non pochi crimini furono visibili fin da subito. Che, in nessun modo, si dovesse più accettare la guerra era pertanto consapevolezza comune nell’Assemblea costituente, a maggior ragione poiché il fascismo italiano era da considerare pienamente responsabile di una guerra d’aggressione. L’articolo 11 è il prodotto di quei tempi e di quelle riflessioni. L’interpretazione del suo contenuto non si presenta particolarmente problematica. Molto problematiche sono, invece, le sue implicazioni per comportamenti concreti nella situazione internazionale del terzo millennio. L’articolo 11 esclude categoricamente qualsiasi guerra di aggressione. Nel periodo della Guerra fredda (1946-89) e dell’equilibrio del terrore (nucleare) nessuna guerra di quel tipo era plausibile. Due tipi di guerra sono, invece, chiaramente consentiti da un articolo che non può in nessun modo essere letto né in chiave di pacifismo assoluto né in chiave di neutralismo. È consentita la rappresaglia militare purché non intesa alla conquista di territori e purché limitata, ovvero proporzionata ai danni causati dall’attacco/aggressione a cui dà una risposta. Non è, sicuramente, contemplata nessuna rappresaglia preventiva, cioè nessun intervento che contempli la forza per sventare un attacco prevedibile, ma non ancora verificatosi. La seconda parte dell’articolo è di interpretazione più complessa e ha destato non poche controversie. Gli interrogativi che emergono sono, infatti, molti e molto rilevanti. Le «limitazioni di sovranità» possono essere tali che l’appartenenza dell’Italia a organizzazioni sovranazionali comporti anche il ricorso ad azioni di guerra. Certamente l’obbligo di ciascuno e di tutti i partner della Nato di rispondere in maniera solidale in caso di attacco a uno chiunque di loro significa che l’Italia ha assunto l’obbligo politico di partecipare ad azioni di guerra. Stessa conclusione appare necessario trarre se l’azione di guerra viene decisa dalle Nazioni unite, più precisamente dal Consiglio di sicurezza. A questo proposito, è lecito interrogarsi se il Governo e il Parlamento italiani non violino l’articolo 11 quando le azioni svolte dalle truppe degli Stati autorizzati dal Consiglio di sicurezza a intervenire, compresa l’Italia, vadano oltre il loro mandato. Non vi furono eccessi nella prima Guerra del golfo (1991) contro l’Iraq di Saddam Hussein, responsabile di avere invaso il Kuwait, mentre la partecipazione italiana alla seconda guerra con66 tro l’Iraq (2003), mai autorizzata dal Consiglio di sicurezza, costituisce una probabile violazione dell’articolo 11. Gli interventi umanitari. Sia l’intervento in Bosnia, ufficialmente sotto l’egida della Nato, sia l’intervento in Afghanistan, anch’esso con comando Nato, ma in coordinamento con gli Stati Uniti, sono in buona misura giustificabili da un punto di vista umanitario. Tuttavia il problema oggi ineludibile è interrogarsi se interventi militari con obiettivi umanitari (per esempio sventare il genocidio di un popolo, di un’etnia, di un gruppo religioso) siano sempre e comunque consentiti alla luce dell’articolo 11. Appare probabile che una risposta positiva dovrebbe sottostare a una serie di condizioni: nessun intervento deciso semplicemente dal Governo italiano dovrebbe essere intrapreso; i fini umanitari dell’ingerenza dovrebbero essere chiaramente delineati e i limiti dell’impiego delle armi ugualmente definiti nella maniera più precisa, stringente e vincolante possibile, anche se qualsiasi intervento militare contiene elementi di notevole aleatorietà; la natura internazionale dell’ingerenza umanitaria dovrebbe essere certificata da organismi internazionali, preferibilmente dall’Onu (oppure dalle organizzazioni di Stati dell’area coinvolta); qualora l’Unione europea si dotasse, come già può e forse deve, di una forza militare di pronto intervento, saranno gli organi direttivi dell’Unione europea a stabilire il se, il come, il quanto, entro quali limiti, con quali obiettivi. Non è accettabile che la pace venga fatta regnare sulle macerie di uno Stato e sui cimiteri dei suoi cittadini. Soltanto in determinati e limitati casi la guerra serve a creare condizioni di giustizia sociale, fra gli Stati, fra i popoli, fra i cittadini. Don Lorenzo Milani, Lettera ai cappellani militari, 22 febbraio 1965, in Lettere di Don Lorenzo Milani, Priore di Barbiana, a cura di Michele Gesualdi, San paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2007. […] Non discuterò qui l’idea di Patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla Curia, di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente anzi eroicamente squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi: le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero e il voto. Abbiamo dunque idee molto diverse. Posso rispettare le vostre se le giustificherete alla luce del Vangelo o della Costituzione. Ma rispettate anche voi le idee degli altri. Soprattutto se son uomini che per le loro idee pagano di persona. Certo ammetterete che la parola Patria è stata usata male molte volte. Spesso essa non è che una scusa per credersi dispensati dal pensare, dallo studiare la storia, dallo scegliere, quando occorra, tra la Patria e valori ben più alti di lei. Non voglio in questa lettera riferirmi al Vangelo. È troppo facile dimostrare 67 che Gesù era contrario alla violenza e che per sé non accettò nemmeno la legittima difesa. Mi riferirò piuttosto alla Costituzione. Articolo 11. « L’ Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli...». Articolo 52. « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Misuriamo con questo metro le guerre cui è stato chiamato il popolo italiano in un secolo di storia. Se vedremo che la storia del nostro esercito è tutta intessuta di offese alle Patrie degli altri dovrete chiarirci se in quei casi i soldati dovevano obbedire o obiettare quel che dettava la loro coscienza. E poi dovrete spiegarci chi difese più la Patria e l’onore della Patria: quelli che obiettarono o quelli che obbedendo resero odiosa la nostra Patria a tutto il mondo civile? Basta coi discorsi altisonanti e generici. Scendete nel pratico. Diteci esattamente cosa avete insegnato ai soldati. L’obbedienza a ogni costo? E se l’ordine era il bombardamento dei civili, un’azione di rappresaglia su un villaggio inerme, l’esecuzione sommaria dei partigiani, l’uso delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, la tortura, l’esecuzione d’ostaggi, i processi sommari per semplici sospetti, le decimazioni (scegliere a sorte qualche soldato della Patria e fucilarlo per incutere terrore negli altri soldati della Patria), una guerra di evidenti aggressioni, l’ordine d’un ufficiale ribelle al popolo sovrano, le repressioni di manifestazioni popolari? Eppure queste cose e molte altre sono il pane quotidiano di ogni guerra. Quando ve ne sono capitate davanti agli occhi o avete mentito o avete taciuto. O volete farci credere che avete volta volta detto la verità in faccia ai vostri «superiori» sfidando la prigione o la morte? Se siete ancora vivi e graduati è segno che non avete mai obiettato a nulla. Del resto ce ne avete dato la prova mostrando nel vostro comunicato di non avere la più elementare nozione del concetto di obiezione di coscienza. Non potete non pronunciarvi sulla storia di ieri se volete essere, come dovete essere, le guide morali dei nostri soldati. Oltre a tutto la Patria, cioè noi, vi paghiamo o vi abbiamo pagato anche per questo. E se manteniamo a caro prezzo (1000 miliardi l’anno) l’esercito, è solo perché difenda colla Patria gli alti valori che questo concetto contiene: la sovranità popolare, la libertà, la giustizia. E allora (esperienza della storia alla mano) urgeva più che educaste i nostri soldati all’obiezione che alla obbedienza. L’obiezione in questi 100 anni di storia l’han conosciuta troppo poco. L’obbedienza, per disgrazia loro e del mondo, l’han conosciuta anche troppo. Scorriamo insieme la storia. Volta volta ci direte da che parte era la Patria, da che parte bisognava sparare, quando occorreva obbedire e quando occorreva obiettare. 1860. Un esercito di napoletani, imbottiti dell’idea di Patria, tentò di buttare a mare un pugno di briganti che assaliva la sua Patria. Fra quei briganti c’erano diversi ufficiali napoletani disertori della loro Patria. Per l’appunto furono i briganti a vincere. Ora ognuno di loro ha in qualche piazza d’ Italia un monumento come eroe della Patria. A 100 anni di distanza la storia si ripete: 1’ Europa è alle porte. La Costituzione è pronta a riceverla: «L’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie... ». I nostri figli rideranno del vostro concetto di Patria, così come tutti ridiamo della Patria Borbonica. I nostri nipoti rideranno dell’ Europa. Le divise dei soldati e dei cappellani militari le vedranno solo nei musei. La guerra seguente, 1866, fu un’altra aggressione. Anzi c’era stato un accordo con il popolo più attaccabrighe e guerrafondaio del mondo per aggredire 1’Austria insieme. 68 Furono aggressioni certo le guerre (1867-1870) contro i Romani i quali non amavano molto la loro secolare Patria, tant’è vero che non la difesero. Ma non amavano molto neanche la loro nuova Patria che li stava aggredendo, tant’è vero che non insorsero per facilitarle la vittoria. Il Gregorovius spiega nel suo diario: «L’insurrezione annunciata per oggi, è stata rinviata a causa della pioggia». Nel 1898 il Re «Buono» onorò della Gran Croce Militare il generale Bava Beccaris per i suoi meriti in una guerra che è bene ricordare. L’avversario era una folla di mendicanti che aspettavano la minestra davanti a un convento di Milano. Il Generale li prese a colpi di cannone e di mortaio solo perché i ricchi (allora come oggi) esigevano il privilegio di non pagare tasse. Volevano sostituire la tassa sulla polenta con qualcosa di peggio per i poveri e di meglio per loro. Ebbero quel che volevano. I morti furono 80, i feriti innumerevoli. Fra i soldati non ci fu né un ferito né un obiettore. Finito il servizio militare tornarono a casa a mangiare polenta. Poca perché era rincarata. Eppure gli ufficiali seguitarono a farli gridare «Savoia» anche quando li portarono a aggredire due volte (1896 e 1935) un popolo pacifico e lontano che certo non minacciava i confini della nostra Patria. Era l’unico popolo nero che non fosse ancora appestato dalla peste del colonialismo europeo. Quando si battono bianchi e neri siete coi bianchi? Non vi basta di imporci la Patria Italia? Volete imporci anche la Patria Razza Bianca? Siete di quei preti che leggono la Nazione? Stateci attenti perché quel giornale considera la vita d’un bianco più che quella di 100 neri. Avete visto come ha messo in risalto l’uccisione di 60 bianchi nel Congo, dimenticando di descrivere la contemporanea immane strage di neri e di cercarne i mandanti qui in Europa? Idem per la guerra in Libia. Poi siamo al ‘14. L’ Italia aggredì 1’Austria con cui questa volta era alleata. Battisti era un Patriota o un disertore? È un piccolo particolare che va chiarito se volete parlare di Patria. Avete detto ai vostri ragazzi che quella guerra si poteva evitare? Che Giolitti aveva la certezza di poter ottenere gratis quello che poi fu ottenuto con 600.000 morti? Che la stragrande maggioranza della Camera era con lui (450 su 508)? Era dunque la Patria che chiamava alle armi? E se anche chiamava, non chiamava forse a una «inutile strage»? (l’espressione non è d’un vile obiettore di coscienza ma d’un Papa). Era nel ‘22 che bisognava difendere la Patria aggredita. Ma l’esercito non la difese. Stette a aspettare gli ordini che non vennero. Se i suoi preti l’avessero educato a guidarsi con la Coscienza invece che con 1’obbedienza «cieca, pronta, assoluta» quanti mali sarebbero stati evitati alla Patria e al mondo (50.000.000 di morti). Così la Patria andò in mano a un pugno di criminali che violò ogni legge umana e divina e riempiendosi la bocca della parola Patria, condusse la Patria allo sfacelo. In quei tragici anni quei sacerdoti che non avevano in mente e sulla bocca che la parola sacra «Patria», quelli che di quella parola non avevano mai voluto approfondire il significato, quelli che parlavano come parlate voi, fecero un male immenso proprio alla Patria (e, sia detto incidentalmente, disonorarono anche la Chiesa). Nel ‘36 cinquantamila soldati italiani si trovarono imbarcati verso una nuova infame aggressione. Avevano avuto la cartolina di precetto per andar «volontari» a aggredire l’infelice popolo spagnolo. Erano corsi in aiuto d’un generale traditore della sua Patria, ribelle al suo legittimo governo e al popolo suo sovrano. Coll’aiuto italiano e al prezzo d’un milione e mezzo di morti riuscì a ottenere quello che volevano i ricchi: blocco dei 69 salari e non dei prezzi, abolizione dello sciopero, del sindacato, dei partiti, d’ogni libertà civile e religiosa. Ancora oggi, in sfida al resto del mondo, quel generale ribelle imprigiona, tortura, uccide (anzi garrota) chiunque sia reo d’aver difeso allora la Patria o di tentare di salvarla oggi. Senza l’obbedienza dei «volontari» italiani tutto questo non sarebbe successo. Se in quei tristi giorni non ci fossero stati degli italiani anche dall’altra parte, non potremmo alzar gli occhi davanti a uno spagnolo. Per l’appunto questi ultimi erano italiani ribelli e esuli dalla loro Patria. Gente che aveva obiettato. Avete detto ai vostri soldati cosa devono fare se gli capita un generale tipo Franco? Gli avete detto che agli ufficiali disobbedienti al popolo loro sovrano non si deve obbedire? Poi dal ‘39 in là fu una frana: i soldati italiani aggredirono una dopo l’altra altre sei Patrie che non avevano certo attentato alla loro (Albania, Francia, Grecia, Egitto, Jugoslavia, Russia). Era la guerra che aveva per l’Italia due fronti. L’uno contro il sistema democratico. L’altro contro il sistema socialista. Erano e sono per ora i due sistemi politici più nobili che l’umanità si sia data. L’uno rappresenta il più alto tentativo dell’umanità di dare, anche su questa terra, libertà e dignità umana ai poveri. L’altro il più alto tentativo dell’umanità di dare, anche su questa terra, giustizia e eguaglianza ai poveri. Non vi affannate a rispondere accusando l’uno o l’altro sistema dei loro vistosi difetti e errori. Sappiamo che son cose umane. Dite piuttosto cosa c’era di qua dal fronte. Senza dubbio il peggior sistema politico che oppressori senza scrupoli abbiano mai potuto escogitare. Negazione d’ogni valore morale, di ogni libertà se non per i ricchi e per i malvagi. Negazione d’ogni giustizia e d’ogni religione. Propaganda dell’odio e sterminio d’innocenti. Fra gli altri lo sterminio degli ebrei (la Patria del Signore dispersa nel mondo e sofferente). Che c’entrava la Patria con tutto questo? E che significato possono più avere le Patrie in guerra da che l’ultima guerra è stata un confronto di ideologie e non di Patrie? Ma in questi cento anni di storia italiana c’è stata anche una guerra «giusta» (se guerra giusta esiste). L’unica che non fosse offesa delle altrui Patrie, ma difesa della nostra: la guerra partigiana. Da un lato c’erano dei civili, dall’altro dei militari. Da un lato soldati che avevano obbedito, dall’altro soldati che avevano obiettato. Quali dei due contendenti erano, secondo voi, i «ribelli» quali i «regolari »? È una nozione che urge chiarire quando si parla di Patria. Nel Congo per esempio quali sono i «ribelli»? Poi per grazia di Dio la nostra Patria perse l’ingiusta guerra che aveva scatenato. Le Patrie aggredite dalla nostra Patria riuscirono a ricacciare i nostri soldati. Certo dobbiamo rispettarli. Erano infelici contadini o operai trasformati in aggressori dall’obbedienza militare. Quell’obbedienza militare che voi cappellani esaltate senza nemmeno un «distinguo» che vi riallacci alla parola di San Pietro: «Si deve obbedire agli uomini o a Dio?». E intanto ingiuriate alcuni pochi coraggiosi che son finiti in carcere per fare come ha fatto San Pietro. In molti paesi civili (in questo più civili del nostro) la legge li onora permettendo loro di servire la Patria in altra maniera. Chiedono di sacrificarsi per la Patria più degli altri, non meno. Non è colpa loro se in Italia non hanno altra scelta che di servirla oziando in prigione. Del resto anche in Italia c’è una legge che riconosce una obiezione di co70 scienza. È proprio quel Concordato che voi volevate celebrare. Il suo terzo articolo consacra la fondamentale obiezione di coscienza dei Vescovi e dei Preti. In quanto agli altri obiettori, la Chiesa non si è ancora pronunziata né contro di loro né contro di voi. La sentenza umana che li ha condannati dice solo che hanno disobbedito alla legge degli uomini, non che son vili. Chi vi autorizza a rincarare la dose? E poi a chiamarli vili non vi viene in mente che non s’è mai sentito dire che la viltà sia patrimonio di pochi, l’eroismo patrimonio dei più? Aspettate a insultarli. Domani forse scoprirete che sono dei profeti. Certo il luogo dei profeti è la prigione, ma non è bello star dalla parte di chi ce li tiene. Se ci dite che avete scelto la missione di cappellani per assistere feriti e moribondi, possiamo rispettare la vostra idea. Perfino Gandhi da giovane l’ha fatto. Più maturo condannò duramente questo suo errore giovanile. Avete letto la sua vita? Ma se ci dite che il rifiuto di difendere se stesso e i suoi secondo l’esempio e il comandamento del Signore è «estraneo al comandamento cristiano dell’amore» allora non sapete di che Spirito siete! Che lingua parlate? Come potremo intendervi se usate le parole senza pesarle? se non volete onorare la sofferenza degli obiettori, almeno tacete! Auspichiamo dunque tutto il contrario di quel che voi auspicate: auspichiamo che abbia termine finalmente ogni discriminazione e ogni divisione di Patria di fronte ai soldati di tutti i fronti e di tutte le divise che morendo si son sacrificati per i sacri ideali di Giustizia, Libertà, Verità. Rispettiamo la sofferenza e la morte, ma davanti ai giovani che ci guardano non facciamo pericolose confusioni fra il bene e il male, fra la verità e l’errore, fra la morte di un aggressore e quella della sua vittima. Se volete diciamo: preghiamo per quegli infelici che, avvelenati senza loro colpa da una propaganda d’odio, si son sacrificati per il solo malinteso ideale di Patria calpestando senza avvedersene ogni altro nobile ideale umano. Lorenzo Milani sac. Gian Enrico Rusconi, Guerra e intervento umanitario. L’Italia alla ricerca di una nuova affidabilità internazionale, in W. Barberis, Guerra e pace, Storia d’Italia, Annali 18¸ Torino, Einaudi, 2002, pp. 834 - 838 […] Si può dire che, nella loro dinamica decisionale, gli interventi armati [italiani] degli anni Novanta rispecchiano una cultura politica ancora insicura e divisa sui grandi temi della guerra contemporanea. A livello operativo, invece, le forze armate hanno mostrato un buon livello di prestazione limitatamente alla qualità e quantità degli impegni loro richiesti. Esiste un consenso maggioritario circa le buone ragioni degli interventi umanitari che non si discosta molto dalle linee generali del dibattito internazionale che abbiamo illustrato. È un consenso trasversale rispetto alle stesse maggioranze politiche di volta in volta esistenti, con il risultato che i governi devono spesso ricorrere al sostegno dell’opposizione per attuare le loro decisioni di intervento. Questo fatto non è considerato tanto grave da mettere a repentaglio l’equilibrio politico esistente, ma mostra grande incertezza nella definizione delle norme e delle procedure da attivare per discutere, approvare, finanziare e realizzare le Operazioni di sostegno della pace. Sinora è prevalso un certo pragmatismo sia nel rapporto tra gli organi istituzionali (governo, ministeri competenti, commissioni parlamentari 71 interessate e parlamento), sia a livello delle vere e proprie procedure implementative. Questa insicurezza nasconde in realtà un deficit più profondo di cultura politico-strategica che si traduce, presso buona parte del ceto politico e intellettuale italiano, in diffidenza verso le tematiche militari. E infatti ancora radicata in molti (particolarmente tra gli intellettuali) l’opinione che una cultura democratica possa fare a meno di ogni serio interessamento per questioni strategico-militari che sono lasciate – non senza qualche residuo sospetto – a tecnici specialisti. Da qui l’assenza di una chiara ridefinizione del concetto di sicurezza nazionale nel quadro delle alleanze internazionali consolidate; l’assenza soprattutto di una ben argomentata politica degli “interessi nazionali” nel contesto di un nuovo dinamismo internazionale. Ne discende la carenza di una politica militare all’altezza dei compiti che tale nuovo dinamismo impone alla forze armate. Una democrazia matura dovrebbe sentirsi corresponsabile dell’ambiente geopolitico che la circonda ed essere disposta a impegnarsi affinché questo ambiente risponda ai criteri di libertà, benessere e liberalismo politico, che sono in sintonia con i suoi stessi valori. Questo è il suo primo interesse nazionale. Quando l’ambiente geopolitico che la circonda cade in preda a crisi autodistruttive che si materializzano nelle “nuove guerre”, una democrazia sicura di sé può e deve ricorrere alla misura estrema dell’intervento armato. Questo riporta di nuovo al quesito se le forze armate italiane siano state sin qui all’altezza del nuovo compito o meno. La risposta è affermativa, compatibilmente con le risorse a disposizione e nelle proporzioni dell’impegno atteso. Inutile dire che, dal punto di vista tecnologico, nel loro insieme le forze armate italiane non sono né protagoniste né beneficiarie privilegiate di quella rivoluzione tecnicomilitare di cui abbiamo parlato, che tocca invece direttamente la superpotenza americana e le altre grandi nazioni in grado di affiancarsi a essa. Le forze armate italiane godono dei benefici dell’innovazione tecnologica soltanto in modo derivato, in quanto inserite in una costellazione tecnico-militare definita dai membri maggiori dell’alleanza Nato di cui l’Italia fa parte. Anche per questo la forza militare italiana si trova spesso in condizioni di subordinazione strategica e di dipendenza tecnica particolarmente esposta alle difficoltà incontrate da tutti i contingenti multinazionali in azioni combinate (incompatibilità di materiali, barriere linguistiche, differenze di addestramento ecc.). Questo non impedisce, tuttavia, che i militari italiani siano in grado di svolgere bene i compiti specifici che sono loro affidati. Possiamo aggiungere che è in atto anche una maturazione a livello di identità professionale. A torto o a ragione molti militari italiani hanno sofferto per anni di un’accettazione soltanto condizionata del loro ruolo da parte di molti settori dell’opinione pubblica, soprattutto quelli influenzati dalla Sinistra. Si è trattato di un’accettazione condizionata dalla necessità per l’Italia di essere parte della difesa integrata del Patto atlantico, verso il quale a lungo (a Sinistra) si sono sollevate obiezioni di principio. Questa fase è stata superata non solo con il venir meno delle riserve di principio verso la Nato (salvo che in gruppi marginali) ma, soprattutto, quando le forze armate italiane sono riuscite a presentarsi, nel corso degli ultimi decenni, anche come un’affidabile organizzazione di “protezione civile”, pronta a intervenire efficacemente in casi di grave emergenza pubblica. Gradualmente, poi, a questa nuova immagine positiva delle forze armate, derivata prevalentemente dalla loro funzione civile, si è affiancata quella altrettanto positiva delle missioni umanitarie che forniscono una nuova legittimazione al ruo72 lo squisitamente militare della forza armata e della sua professionalità. A questo punto si profila la necessità di una cultura integrata civile-militare, che rafforzi le Operazioni di sostegno della pace e accompagni la nuova affidabilità militare dell’Italia nella comunità democratica internazionale. Questa cultura dovrebbe essere il naturale completamento della nuova sensibilità per i temi dell’identità nazionale e del patriottismo costituzionale che, con qualche incertezza e timidità, ha caratterizzato gli anni Novanta in Italia. Nel corso del decennio, infatti, il dibattito su patria e nazione in Italia, sul patriottismo costituzionale, è uscito dalla cerchia degli studiosi per diventare discussione pubblica. Dapprima con qualche resistenza passiva, e persino con punte di ironia, da parte di alcuni settori della Sinistra (ma non solo da parte loro) che consideravano il tema irrimediabilmente obsoleto e politicamente pregiudicato. Poi la situazione è lentamente cambiata: è tornato in circolazione un morbido lessico patriottico sia pure senza intima convinzione. La Destra, da parte sua, che non ha minimamente contribuito a innovare il dibattito concettuale sulla nazione, lo ha frainteso come una “rivincita”, senza comprendere il nuovo forte nesso tra democrazia e nazione, assente nella tradizionale idea di nazione di destra. La sfida oggi, infatti, non è quella di riscoprire la patria-nazione come un buon vecchio valore dimenticato, ma di rendersi conto che anche nel nostro Paese la democrazia, per funzionare, ha bisogno di riferimenti identitari che traggono alimento dalla riflessione critica sull’identità nazionale e sulla sua storia criticamente rivista. Non patriottismo di ritorno dunque, ma affermazione di un nuovo patriottismo costituzionale. Con patriottismo costituzionale intendiamo l’adesione a una Costituzione nella quale lo statuto della cittadinanza è qualificato non soltanto dal catalogo dei diritti e dei doveri individuali, ma dal riconoscimento che i vincoli imposti dall’essere cittadini presuppongono e riportano a una comunanza di storia e cultura, chiamata sinteticamente nazione. La Costituzione repubblicana riassorbe in sé e sintetizza, per cosi dire, in forma di norme il punto d’arrivo della storia della nazione. In questo senso l’affetto per la nazione diventa amore per la Repubblica, diventa patriottismo repubblicano o costituzionale, appunto. Questo patriottismo non si alimenta di particolari motivi di orgoglio per presunti caratteri di primato, di grandezza o per altri ipotetici talenti speciali del popolo italiano. E piuttosto il ritrovarsi in una storia comune fatta anche di errori e di brutali contrasti sociali e politici - una storia, tuttavia, che a un certo momento trova il suo punto fermo in un patto democratico tra i cittadini. Questo patto assume la forma della Costituzione democratica, diventa la base di una convivenza civile, nella quale si ricrea un nuovo senso di appartenenza. Per arrivare a questo risultato - è importante ricordarlo in prospettiva storica - alcuni italiani si sono attivamente impegnati civilmente e militarmente (la Resistenza antifascista) altri no, anche se tutti ne hanno goduto i vantaggi. E alla fine oggi tutti i partiti (alcuni ancora con qualche riserva) riconoscono il senso fondante di quell’evento. In quest’ottica il patriottismo costituzionale accoglie in sé e invera il patriottismo tradizionale. Alcuni storici obiettano che queste argomentazioni hanno una funzione di pedagogia civile, ma un debole fondamento storico. È un’obiezione che merita attenzione, anche se è singolare che provenga da chi sistematicamente sviluppa la sua analisi storica sull’accusa alla cultura politica democratica italiana di non aver saputo forgiare un’identità nazionale, ma poi, davanti a tentativi di farlo, si rifugia nel pessimismo storico. Certamente, il compito della pedagogia civile e quello del lavoro storico sono di natura molto diversa, ma non sono incompatibili; al con73 trario, ci si deve attendere una tensione positiva tra essi. In particolare, per tornare al nostro tema, davanti all’evoluzione delle forze armate italiane e delle loro funzioni, dinanzi alla loro graduale trasformazione da esercito di massa, e di coscrizione generale, a corpo armato altamente professionale, diventa necessario che i cittadini che scelgono il mestiere delle armi abbiano un convinto grado di lealtà repubblicana e democratica. Solo cosi affidabilità tecnica professionale e patriottismo costituzionale trovano la loro sintesi. 74 Bibliografia essenziale B.R. Barber, Guerra santa contro McMondo, Pratiche Editrice, Milano, 1998 W. Barberis (a cura di), Guerra e pace, Storia d’Italia, Annali 18¸ Torino, Einaudi, 2002 T. Ben Jelloun, La rivoluzione dei gelsomini – Il risveglio della dignità araba», Bompiani, Milano 2011 L. Bimbi (a cura di), Not in my name, Editori Riuniti, Roma, 2003 A. Bolaffi-G. Marramao, Frammento e sistema. Il conflitto-mondo da Sarajevo a Manhattan, Donzelli, Roma, 2001 G. Bosetti (a cura di), L’ultima crociata? Ragioni e torti di una guerra giusta, Reset, Roma, 1999 M. Bovero - E. Vitale (a cura di), Gli squilibri del terrore. Pace democrazia e diritti alla prova del XXI secolo, Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, Robenserg & Sellier, Torino, 2006 R. Brubaker, I nazionalismi nell’Europa contemporanea, Editori Riuniti, Roma 1998 Z. Brzezinski, Il mondo fuori controllo. Gli sconvolgimenti planetari all’alba del XXI secolo, TEA, Milano 1995 R. W. Bulliet, La civiltà islamico-cristiana. Una proposta, Laterza, Roma-Bari 2005 A. Capitini, Le tecniche della nonviolenza, Linea d'ombra, Milano, 1989 G. Carpinelli-C. Vercelli, Israele e Palestina: una terra per due. Le radici della guerra, le parole del conflitto, EGA editore, Torino, 2005 G. Codovini¸ Storia del conflitto arabo israeliano palestinese, B. Mondadori, Milano, 2002 R. Crockatt, Cinquant’anni di guerra fredda, Salerno, Roma 1997 N. Chomsky, 11 settembre. Le ragioni di chi?, Tropea, Milano, 2001 R. Dahrendorf, Dopo la democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2001 F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano, 1992 M. K. Gandhi, Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi, Torino, 1996. S. Guarracino, Storia degli ultimi cinquant’anni, Sistema internazionale e sviluppo economico dal 1945 a oggi, Bruno Mondadori, Milano, 1999 J. Habermas, Fede e sapere, in “Micromega”, 5-2001, pp. 7-16 M. Hardt-T. Negri, Impero, Rizzoli, Milano, 2002 E. J. Hobsbawm, Intervista sul nuovo secolo, a cura di Antonio Polito, Laterza, Roma-Bari, 2000 N. Janigro, L’esplosione delle nazioni. Il caso jugoslavo, Feltrinelli, Milano, 1994 M. Kaldor, Le nuove guerre. La violenza organizzata nell’età globale, Roma, Carocci, 2001 N. Labanca, Guerre vecchie, guerre nuove. Comprendere i conflitti armati contemporanei, B. Mondadori, Milano, 2009 S. Latouche, L’occidentalizzazione del mondo. Saggio sul significato, la portata e i limiti dell’uniformazione planetaria Bollati-Boringhieri, Torino, 1992 G. Marramao, Dopo il Leviatano, Bollati-Boringhieri, Torino, 2000 A. Marzo Magno, (a cura di), La guerra dei dieci anni. Jugoslavia 1991-2001: i fatti, i personaggi, le ragioni dei conflitti, il Saggiatore, Milano, 2001 Qiao Liang e Wang Xiangsui. Guerra senza limiti. L’arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2002. J. Pirijevec, Le guerre jugoslave. 1991-1999, Einaudi, Torino, 2001 75 A. Rashid, Talebani. Islam, petrolio e il Grande scontro in Asia centrale, Feltrinelli, Milano, 2001 U. Rapetto-R. Di Nunzio, Le nuove guerre. Dalla Cyberware ai Black Bloc. Dal sabotaggio mediatico a Bin Laden, Angeli, Milano, 2001 G. E. Rusconi, (Guerra e intervento umanitario. L’Italia alla ricerca di una nuova affidabilità internazionale, in W. Barberis, Guerra e pace, Storia d’Italia, Annali 18¸ Torino, Einaudi, 2002 A. Salvatore, Il pacifismo, Carocci, Roma, 2010. G. Scotto-E. Arielli, La guerra del Kosovo: anatomia di un’escalation, Editori Riuniti, Roma, 1999 D. Smith, Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, Bologna, 1998 M. Walzer, Sulla guerra, Laterza, Roma-Bari, 2004 D. Zolo, Chi dice umanità, guerra, diritto e ordine globale, Einaudi, Torino, 2000 76
Scarica