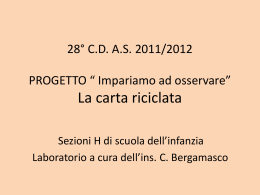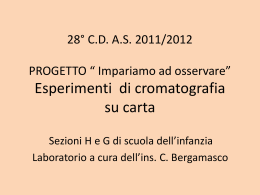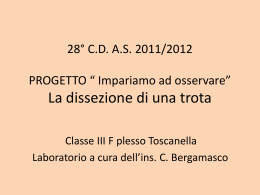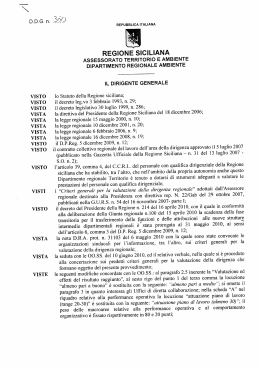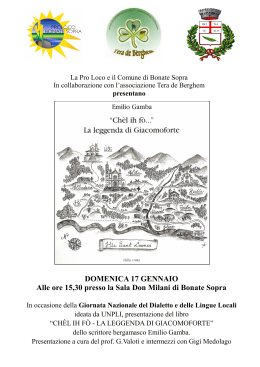A Bèrghem gh’è l’ària fina. Gli uomini colti della nostra terra negli anni Cinquanta del Novecento amavano ancora parlare in bergamasco, possedendo la nostra lingua popolare una forza espressiva che non può assolutamente essere raggiunta dall’ibrido e sdilinquito italiano standardizzato diffusosi in questi ultimi decenni. Ricordo un patrizio bergamasco che mi onorava della sua amicizia: sapeva di greco e di latino e parlava l’italiano dei “Promessi Sposi” con qualche indulgenza per vocaboli aulici e disusati che tradivano il suo assiduo studio dei classici della nostra letteratura nazionale. Appena l’argomento glielo consentiva, alternava però all’italiano un bergamasco saporito, perentorio, fiorito di squisiti paradossi e di efficaci similitudini. Si conversava un giorno con un gruppetto di amici milanesi, i quali si compiacevano dei progressi compiuti nel dopoguerra della nostra città quando il sindaco era Ferruccio Galmozzi e Giacinto Gambirasio presiedeva la Camera di Commercio. Ed ecco l’amico patrizio commentare argutamente: Eh, a Bèrghem gh’è l’ària fina…. Non ho più sentito dire così. Come si potrebbe, con l’inquinamento atmosferico provocato dal traffico su gomma? Pare ormai assodato, sulla scorta di rilevazioni scientifiche, che l’inquinamento atmosferico associato a quello acustico provochi nelle giovani generazioni una diminuzione della capacità di attenzione, di concentrazione e di apprendimento. Altro che ària fina, locuzione usata per indicare acutezza d’ingegno, accortezza e perfino astuzia! Se ritornasse al mondo, il mio nobile amico ripeterebbe quanto allora sosteneva e cioè che occorre incrementare il trasporto su rotaia e favorire la produzione di automobili ad energia elettrica. Era uno di quei bergamaschi lungimiranti che aveva l’aristocrazia nello spirito prima ancora che nel sangue. Temo che ormai se ne sia perduta perfino la nozione. A dàga scólt a la zét. Si sa che cosa succede se si dà ascolto alla gente. Non sempre il nostro prossimo parla con assennatezza e a volte dimostra di nutrire sentimenti plebei. Soccorre in proposito la storiella del padre, del figlio e dell’asino, vecchia fin che si vuole ma sempre istruttiva. Un padre aveva messo il figlioletto a cavallo dell’asino. Procedendo lungo la strada il ragazzo aveva sentito alcuni passanti mormorare: “Che tempi sono mai questi? Guarda quel giovincello che fa andare il padre a piedi! Così onora il genitore?”. Allora il figlio scese e disse al padre di salire in groppa all’asino. Ma la gente disse: “Guarda che bella umanità ha quell’uomo: fa andare a piedi quel povero ragazzino. È proprio un egoista!”. Allora il padre scese dall’asino e andò anch’egli a piedi. Udì di lì a poco alcuni passanti che dicevano: “Guarda come sono stupidi quei due: hanno un asino e vanno a piedi”. A questo punto il padre e il figlio salirono in groppa all’asino. Non passò molto tempo che udirono commentare: “Povera bestia, costretta a sopportare il peso di quelle due persone senza cuore… Che bella coscienza!”. Da quel momento il padre e il figlio decisero di fare quel che volevano senza più badare ai blateramenti del volgo. Agn de gàtole. Le gàtole sono grossi bruchi pelosi che divorano le foglie degli alberi; vengono così chiamati perché per il loro pelo e i movimenti flessuosi richiamano vagamente il gatto (latino catula, ‘gattina’). Gli anni di carestia erano tremendi per i contadini: un’infestazione degli alberi da frutta significava la fame e la disperazione. Ecco perché in bergamasco quando si vuol indicare un tempo non breve di privazioni e di penuria se non di miseria si suole esclamare: Che agn de gàtole! Chi ha vissuto nei suoi primi anni di vita l’immediato dopoguerra, quando l’Italia, occupata da eserciti stranieri, si era ritrovata con le città bombardate e l’economia distrutta, le am-lire e le tessere annonarie, i reduci e i profughi, l’inflazione e l’impoverimento dei ceti popolari, non può non associare al ricordo di quel tempo la locuzione bergamasca, che ormai si ode poco, forse perché ci si è abituati troppo a un benessere fittizio e ingannevole. Gli anni delle gàtole possono sempre ritornare anche se non arrivano le guerre e le carestie. Basta continuare a trascurare l’habitat come si sta facendo da tanto tempo, basta ad esempio non aver cura dei nostri boschi, che difendono il territorio dalle valanghe, dalle alluvioni e dalle frane. Se il bosco dà ossigeno, filtrando l’atmosfera inquinata dai fumi e dai gas di scarico, se con la sua umidità riequilibra il clima, se protegge la fauna selvatica perché non considerarlo un patrimonio da difendere, da mantenere e da incrementare? Quando ci si inoltra anche per poco in un bosco ci si rende conto dell’inciviltà dei cialtroni che vi disseminano ogni sorta di rifiuti. E si vorrebbe augurare a certa gente di vivere qualche anno di gàtole. Ai tép de Carlo Códega. Il valente e indimenticato poeta milanese Luigi Medici (ricordato per aver inviato a Mussolini una composizione in sestine ambrosiane intitolata “La gloria di dialett” nell’intento di arginare la dialettofobia del regime fascista) scrisse il poemetto “I fioeu de Carlo Codega”, nel quale ricordò come si viaggiava un tempo e sostenne che tutte le genti di Lombardia si capirono sempre benissimo pur parlando dialetti lievemente diversi (ma sostanzialmente simili nel lessico, nella morfologia, nei sintagmi). Vero è che chi ciancia di “babele dei dialetti” ostenta uno snobistico disprezzo della cultura popolare, un disprezzo tipico del peggior provincialismo, quello degli sradicati, degl’incolti e degli esterofili. Il progresso umano dovrà forse qualcosa ai vari Carli coronati, che hanno conquistato un posto nella storia per aver saputo mandare a morire migliaia di giovani sui campi di battaglia. Ma dovrà forse qualcosa di più a tutti i Carlo Códega che per tante decine di generazioni hanno lavorato crescendo i loro figli, fecondando la terra con il loro sudore, ricostruendo ciò che gli eserciti distruggevano, contribuendo alla vita della comunità. Ogni Carolus quidam che ci ha preceduto ha lavorato per noi e solo un anonimo schernitore in vena di spiritosaggini può avergli affibbiato il soprannome di Códega, che vuol dire ‘cotenna’, una parte poco appetibile, usata tutt’al più per la pasta coi fagioli. I Carlo Códega più lontani nel tempo, quelli della preistoria, non dovevano essere tanto rozzi e primitivi se a loro dobbiamo l’introduzione del fuoco, l’uso del sale come condimento e del ghiaccio per la conservazione dei cibi, l’invenzione della leva e della ruota, l’innesto degli alberi da frutta, la canalizzazione dell’acqua per l’irrigazione dei campi, e ancora l’addomesticamento degli animali, la tosatura delle pecore per la ricrescita del vello e la mungitura delle mucche dopo lo svezzamento dei vitelli, la seminagione del grano da farina per il pane, la scoperta della relazione fra le lunazioni e il taglio degli alberi. Il condizionamento delle categorie ha indotto a definire “secoli bui” quelli del Medio Evo ma l’arte detta per disprezzo gotica (cioè barbara) dagli umanisti diede all’Europa cattedrali meravigliose, castelli, palagi, broletti ed arengari; la cattedrale del pensiero costruita dall’Aquinate e quella della poesia elevata da Dante illuminano di luce perenne l’umanità. La storia non è stata scritta soltanto da chi ha fatto le guerre. L’assenza di pensiero organico, le mistificazioni e la superficialità stanno inducendo le giovani generazioni alla cancellazione del passato e alla deriva intellettuale, etica e spirituale. Ma siamo proprio così sicuri che i nostri avi fossero dei Carlo Códega? A la buna de Dio. Vale: ‘Alla grande’, ‘A tutto spiano’, ‘A spron battuto’. I francesi dicono: À la grande vitesse. A l’àsen che te sé. Si completa così: t’é parlàt fina a’ tròp bé. Traduzione: ‘Considerando che sei un asino, hai parlato fin troppo bene’. Era un modo per non far inorgoglire troppo i figli quando dicevano qualcosa di sensato. Un tempo, se le circostanze lo richiedevano o lo consentivano, era facile dare dell’asino al prossimo: molte famiglie contadine possedevano almeno un esemplare del quadrupede ragliante, cocciuto ma paziente. À là té che ègne a’ mé. Traduzione letterale: ‘Vai là tu che vengo anch’io’. È la risposta degli sfaticati, dei poltroni e degl’infingardi a chi li invita a recarsi al lavoro: “Incomincia ad andarci tu, io poi ti raggiungerò”. Dice un proverbio ambrosiano: Sott a la dòbbia se aquista nò renomansa, ‘Stando a poltrire sotto le coperte non ci si procura una buona fama’. Si narra che Gioppino, inviato al fronte durante la guerra, fosse stato colto mentre se ne allontanava dirigendosi verso le retrovie. Sorpreso da un graduato e invitato a giustificarsi, il famoso burattino bergamasco, maestro nel fingersi tonto, rispose: ’Ndó a ciamà chèi che i è restàcc indré per mandài inàcc, ‘Vado a chiamare quelli che sono rimasti indietro per mandarli avanti’. I nostri nonni indicavano uno scansafatiche con l’appellativo schéna de fó, ‘schiena di faggio’, albero dal legno molto duro e dai rami non flessibili. Al de là del püdì. Mai andare oltre le nostre possibilità. Ho udito una volta in Valle Brembana dire: La cavra che l’è ’ndàcia al de là del püdì l’è piö turnada indré. E mi sono rammentato di un passo di Teocrito, che nell’Idillio XIV scrive: “Il toro andò una volta nella selva”, alludendo alla favola greca del toro che s’inoltrò nella foresta e non ne ritornò. La saggezza popolare ha radici remote che affiorano in tempi e in luoghi diversi. Alégher, che ’l diàol l’è mórt! Dice un proverbio bergamasco: Mèi grignà che löcià, ‘Meglio ridere che piangere’. Buon per noi se talora ci è dato di stare un po’ in allegria. Ma che il diavolo sia morto è argomento invocato soltanto per invitare al riso e al divertimento i più restii. Alì öna cica. È modo di dire lombardo. Se un oggetto non ha alcun valore si dice che l’ val öna cica. Si potrebbe tradurre: ‘non vale un mozzicone di sigaretta’. Ma cicca è la forma plurale latina di ciccum, voce usata da Plinio in senso traslato per dire ‘un bel niente’. E dunque la locuzione a l’ val öna cica va tradotta ‘non vale alcunché’. Non è strano peraltro che il mozzicone di sigaretta, non avendo alcun valore, sia stato chiamato cica. Alì öna pitaca. Di un oggetto privo di valore si dice che l’ val öna pitaca. La voce patacca di lingua, forse da un’analogo termine provenzale, designava originariamente una moneta di non minute dimensioni ma di scarsissimo valore. Alì tat ór quat che s’ pisa. ‘Valere tanto oro quanto si pesa’. L’espressione è assai lusinghiera e manifesta incondizionato apprezzamento per le virtù della persona lodata. Solitamente sono gli uomini che si rivolgono alle donne con questa locuzione. A giudicare dalla qualità del complimento si direbbe che gli uomini bergamaschi siano fra i più galanti, gentili e garbati nei confronti del gentil sesso. Naturalmente rivolgendo questo complimento ad una donna è bene riferirsi ai valori intramontabili e naturali che attribuiscono alla famiglia un ruolo centrale nella società e alla donna una funzione fondamentale in seno alla famiglia. Una donna ben educata, assennata e virtuosa vale davvero tanto oro quanto pesa ed anche assai di più, poiché l’oro in certi frangenti da solo non ha alcun valore, non potendo sostituire i buoni sentimenti, non surrogando l’amore, la generosità, la dignità, la magnanimità, la nobiltà dell’animo. Non sempre di una donna si riesce a dire che vale tanto oro quanto pesa. Ma i complimenti, se sono sinceri, bisogna saperseli meritare. Le donne che mortificano la loro femminilità riducendola ad un orpello da esibire per acquisire notorietà e ottenere denaro possono anche ricevere gli osanna di questa povera e squallida società di massa, che si regge sull’inganno di valori fittizi, ma non sono che effimeri idoli di cartapesta. A l’ la èd gna töta. Di un uomo che si sia perdutamente invaghito di una donna si dice che l’ la èd gna töta, ‘non la vede neanche tutta’, sottintendendo che ritiene troppo grande l’oggetto delle sue attenzioni e dei suoi desideri. Si può proferire questa locuzione (a l’ la èd gna töt) anche per indicare una madre che straveda per il proprio figlioletto. A l’ l’à ris-ciada a’ ’l Mantüì. Dice la locuzione completa: A l’ l’à ris-ciada a’ ’l Mantüì, che l’à ciapàt vint’agn de galéra. Essa viene proferita scherzosamente quando si deve assumere una decisione che comporta un rischio ed è stata originata da un fatto di cronaca accaduto tanto tempo fa, forse attorno alla fine dell’Ottocento, in un paese vicino alla città. Era accaduto che un macellaio soprannominato Mantüì (forse appartenente ad una famiglia proveniente dal Mantovano) si fosse fidato a porre in commercio della carne avariata provocando intossicazioni gravi. Dietro segnalazione del medico condotto i carabinieri si recarono nel negozio del Mantüì, dove rinvennero la parte di carne avariata che il macellaio non aveva ancora esitato. Arrestato e condotto innanzi al giudice, il Mantüì fu condannato, non certo a vent’anni di carcere, come vorrebbe il detto popolare. Ma dovette comunque trascorrere qualche tempo nelle patrie galere. Durante il processo egli fu invitato a discolparsi ma non trovò di meglio che dire: Pòta, siùr giödes, a l’ó ris-ciada!, ammettendo così di non possedere una coscienza propriamente limpida. Il fatto fece scalpore e la peregrina risposta dell’imputato fece sbellicare la gente dalle risa. A l’òrba fósca. Significa: ‘In un buio pesto’, ‘Nel buio più fitto’, ‘Nella tenebra più densa’. Troàs a l’òrba fósca e ’Ndà ’n giro a l’òrba fósca sono locuzioni che sottintendono un atteggiamento di prudenza e che indicano una sensazione di smarrimento innanzi all’incognita del buio. Occorre pensare ai ritmi e alle abitudini dei nostri antenati, i quali non disponevano della luce elettrica e dovevano orientarsi al debole chiarore delle candele e delle lanterne. La sopravvivenza della locuzione pare provvidenziale perché fa capire che ci si può smarrire anche in pieno giorno, si possono perdere i punti di riferimento anche fra lo sfolgorio di mille luci artificiali. I disturbi del sonno, lo scarso appetito, la paura di dover prendere delle decisioni, il tentativo di fuggire dalle responsabilità, la scarsa stima di sé e la mancanza di fiducia in se stessi a volte non dipendono da ragioni biologiche bensì da stati depressivi dovuti al modo di vivere dei nostri giorni, alla caduta dei valori, alla perdita del senso dell’assoluto. La forza d’animo affonda infatti le sue radici negl’ideali, nei princìpi che guidano le azioni fondamentali della vita, nella saldezza di un carattere che sa affrontare a pié fermo sacrifici e privazioni. Una luce interiore illumina la via di chi non ha smarrito i valori nei quali è indispensabile credere. I nostri vecchi non avrebbero mai immaginato che un giorno sarebbero esistite persone tanto stupide e spavalde da andare in giro a l’òrba fósca alle tre del mattino a duecento all’ora ubriache e drogate mettendo a repentaglio la vita propria e quella altrui. A l’ piöv ol formài söi macarù. Se piove il formaggio sui maccheroni significa che accade un fatto insperato e fortunato, un evento prospero e felice. Amàr come ’l tòssech. Questo paragone spontaneo indica che la nostra gente di un tempo nutriva un’idea piuttosto generica del veleno, assunto a simbolo del sapore amaro. In realtà i veleni usati nelle corti rinascimentali non solo italiane ma dell’intera Europa per togliere di mezzo un avversario erano per lo più insapori. Con l’aiuto di un alchimista privo di coscienza era agevole procurarsi dell’acido arsenioso, che aveva l’aspetto innocuo della farina di grano e che poteva essere mescolato ad ogni altro ingrediente senza alterarne il sapore. Questo ed altri veleni potevano essere aggiunti con facilità ai cibi e alle bevande; somministrati al malcapitato, ne garantivano la morte, spesso ritardata di giorni e perfino di mesi, così da allontanare ogni sospetto. Dal paragone spontaneo si arguisce che la società bergamasca era estranea a simili pratiche raffinate, criminose e tremendamente immorali. Da noi ci si limitava a rifuggire dal sapore amaro di qualche bacca o di qualche erba dall’effetto tossico. Probabilmente per riconoscere se un cibo era velenoso si ricorreva preventivamente all’assaggio di una noce o di un fico secco o meglio ancora si masticava una foglia di ruta, essendo rimasta viva la locuzione mangià la fòia, che usiamo quando vogliamo dire che ci siamo accorti dell’inganno o del male che qualcuno sta tramando a nostro danno. A m’ sè mia töcc istèss. Non siamo tutti eguali. Infatti non abbiamo tutti la stessa costituzione fisica, la stessa resistenza alle fatiche, gli stessi anticorpi per difenderci dalle malattie. Neppure abbiamo la medesima forza d’animo, la medesima padronanza dei sentimenti e delle azioni. Un bambino domandò alla nonna: “Perché mio fratello quando corre è più svelto di me?”. La nonna rispose: “Perchè m’ sè mia töcc istèss”. Il filosofo Konstantin Leont’ev (1891-1931) previde lucidamente i pericoli insiti nella globalizzazione: un conto è l’eguaglianza e un altro l’eguagliamento. Se l’eguaglianza è sinonimo di giustizia e di democrazia, l’eguagliamento conduce all’ingiustizia e alla demagogia. Con la globalizzazione si vuole imporre ad ogni costo un tipo medio di essere umano, livellato verso il basso, privo di connotazioni qualitative e di peculiarità culturali, quindi anodino rispetto ai valori religiosi, agl’interessi politici, al senso dell’appartenenza ad un’etnia, ad una nazione e ad una comunità, insomma un essere il più possibile spersonalizzato, che abbia perduto la consapevolezza della storia e delle radici, che abbia smarrito la coscienza individuale, che sia schiavo di una morale comune molto superficiale e che abbia perduto ogni capacità critica. Che sia degno di essere ancora chiamato uomo chi accetta di ridurre la sua identità a quella anagrafica e chi condivide il regresso generalizzato della vita sociale è da vedere. Una società in cui tutti indossino lo stesso abito e seguano rigidi comportamenti collettivi sarebbe disumana. Un uomo non vale solo per il suo conto in banca, per il suo reddito e la sua capacità di consumare: prima delle esigenze e delle leggi della tecnica, dell’economia e del mercato globale vengono quelle della metafisica, della trascendenza, dell’etica, della libertà. Altrimenti i costumi si massificano e s’impoveriscono e predomina una visione totalitaria del mondo, che tende a cancellare la consapevolezza della differenza fra il bene e il male, fra la giustizia e l’ingiustizia, fra l’intelligenza e l’ignoranza. Guardiamoci dai fautori dell’egualitarismo: sono i peggiori nemici dell’uomo. A m’ se salva piö. Ho nostalgia di un’attempata signora del patriziato bergamasco che, quand’era in vita, di quando in quando mi telefonava. Aveva una bella cultura e la lingua assai sciolta. Amava parlare in bergamasco ed era un piacere ascoltare la sua loquela fresca e immaginosa. M’intratteneva sui più svariati argomenti dell’attualità. Paventava il pericolo d’identificare i modelli di comportamento nella virtualità piuttosto che nella realtà e sosteneva che occorresse tracciare un confine ben preciso fra il mondo fittizio e quello vero per non diventare schiavi della finzione informatica. Diceva che il mondo giovanile è allo sbando perché tratto alla mercé di una società che non vuole proporre ideali e valori certi e deplorava che televisioni e giornali facciano a gara per dare notizie sensazionali, tragiche e scandalistiche, ritenendo che i buoni comportamenti non interessino ad alcuno (la gente invece ha piacere di sapere che si compiono ancora atti di onestà e gesti di generosità). Da nonna qual era, lamentava la totale inadeguatezza degli spettacoli televisivi per i bambini, spettacoli lontani dalla poesia e dalla positività delle fiabe che si raccontavano un tempo. La gentildonna concludeva ogni volta le sue considerazioni esclamando: A m’ se salva piö! In cuor mio le davo ragione ma non me la sentivo di alimentare il suo umor nero con qualche considerazione pessimistica. Pensavo alla leopardiana contrapposizione fra scienza e poesia: la scienza, fondata sulla ragione, segue le sue leggi; la poesia, fondata sulla natura, lascia uno spazio all’indeterminato, all’indefinito, perciò alla fantasia e al sentimento. Allora le dicevo di avere fiducia nell’avvenire e la rincuoravo. Invero non è detto che non ci si possa più salvare ma la ragione, pur tanto preziosa per l’essere umano, non deve invadere lo spazio riservato alla poesia e all’immaginazione. Il progresso tecnico-scientifico ha dei meriti enormi ma non può andare contro l’uomo; se lo fa, non c’è più posto per la speranza. Tutto rimane allora riservato al denaro, all’egoismo e alla solitudine. Andà in óca. Só ’ndàcc in óca, ‘Mi sono dimenticato’. Povere oche, tanto ingiustamente disprezzate! Anima méa! L’esclamazione ora non si ode più ma un tempo era molto usata, soprattutto quando si temeva per la propria vita. Nei momenti del pericolo si pensava all’anima e se ne implorava dal cielo la salvezza. Narra Plutarco che Pitagora, il quale si era dato all’atletica, sentì un giorno un filosofo parlare dell’immortalità dell’anima rimanendone tanto impressionato da dedicarsi interamente allo studio della filosofia. Ancora da Plutarco si apprende ciò che Socrate diceva ai suoi allievi: “Se questa nostra anima è immortale conviene istruirla non solo per il tempo della vita presente ma anche per il tempo avvenire, cioè per l’eternità”. I nostri avi non avevano forse studiato filosofia ma, non avendo posto il denaro e i beni materiali al vertice della scala dei valori, erano certamente più vicini a Pitagora e a Socrate di quanto lo sia l’uomo contemporaneo. Ansàs bèl. È locuzione figurata, che indica amarezza e delusione per un mancato guadagno o per un’impresa non andata a buon fine. Me só ansàt bèl, ‘Mi sono proprio avvantaggiato’, detto in senso ironico, per far intendere il contrario. Àntes, caàgna, che ’l mànech l’è rót! In tutti i dialetti lombardi la voce cavagna designa oggetti di vimini intrecciati, come il canestro, il paniere, la cesta. Anche a Bergamo fino alla metà del Settecento si diceva cavagna, poi la consonante v dileguò per l’intrinseca debolezza della sua posizione intervocalica. Una cesta che abbia il manico rotto non serve più e viene abbandonata in soffitta o in cantina. Se una persona che non ha alcun valore si dà delle arie e millanta chissà quali meriti la si paragona ad una cesta che si vanti avendo il manico rotto. Se il mondo non fosse pieno di omuncoli presuntuosi e vanagloriosi la fantasia popolare non avrebbe creato questa locuzione. Si pensi solo all’infinità dei premi letterari, per la gran parte inutili e dannosi perché riconoscono meriti inesistenti e attribuiscono valore ad opere insignificanti. Nel “Dizionario delle idee sbagliate” (Milano, 1955) di Renzo Sertoli Salis alla voce premio letterario si legge: “Effimera celebrità che i donatori d’una certa somma e la giuria da essi nominata acconsentono a procurare a una terza persona, pur di rendere noti i loro nomi sui giornali”. A parlà del diàol i compàr i córegn. Se si parla del diavolo ne compaiono le corna. Si dice quando arriva a noi la persona della quale stavamo parlando. Aqua, frà, che ’l convènt a l’ brüsa! Se il convento andasse a fuoco, ci si rivolgerebbe ad un frate chiedendogli di porgere un secchio d’acqua e si esclamerebbe: “Acqua, frate, perché il convento brucia!”. È modo arguto di postulare un intervento rapido e deciso nell’imminenza di un pericolo o quando già s’intravedono i primi segni negativi di una situazione alla quale occorre immediatamente porre un riparo. È il caso della lingua italiana, aggredita e rovinata quotidianamente da chi non la sa parlare e da chi non la sa scrivere. Già nel 2007 il giornalista Beppe Severgnini in un suo libro (“L’italiano. Lezioni semiserie”) denunziava i traviamenti e le violenze alle quali è sottoposta continuamente la nostra lingua nazionale. Soprattutto dalle televisioni ci viene rovesciata addosso senza riguardo alcuno una caterva di anglicismi inutili che finiscono con il sopprimere i corrispondenti termini italiani; sempre dalle televisioni arriva la cancellazione del congiuntivo nonché la diffusione di improprietà incredibili e di locuzioni di sapore snobistico per non dire da villani rifatti. Ciò che ancora non si è rilevato in tutta la sua negatività è la pronunzia plebea e trasteverina di gran parte dei mezzi busti e dei vari guitti del piccolo schermo, una pronunzia cialtronesca che è indice di sciatteria, di pigrizia mentale e di mancanza di rispetto per la buona lingua. Non si dice penziero ma pensiero, non si dice scinguanda ma cinquanta. Possibile che l’italiano sia storpiato così villanamente proprio durante le trasmissioni della televisione nazionale? Se vogliono parlare così, vadano a Teletrastevere! Ara berara. La conta è una strana filastrocca che durante un gioco veniva proferita o cantilenata da un gruppo di bambini onde stabilire chi dovesse ‘star sotto’, cioè chi dovesse essere escluso dal gruppo e cercare di rientrarvi secondo le regole del gioco. Ricordo di aver giocato a tóch da bambino: chi ‘stava sotto’ doveva rincorrere gli altri fino a quando riusciva a toccarne uno: ciò gli consentiva di rientrare nel gruppo. Per secoli e secoli ci si è divertiti così. Dice questa conta: Ara berara / bicéra cornara / òcol beròcol / và föra té pitòcol. Se ci soffermiamo a considerare le parole di questa conta, tutt’altro che incomprensibile, ci avvediamo che si tratta di parole latine volgarizzate. Il primo verso si riferisce ad un’ara usata in epoca pagana per un sacrificio (‘altare, bell’altare’), un’ara sulla quale sono posti degli oggetti acconci (i neutri plurali bicéra e cornara si riferiscono appunto a coppe e a frammenti corporei come bucrani di bovidi). Nel terzo verso addirittura compare un occhio sull’altare e la pronunzia è sempre latina (oculus, bellus oculus). Giunti alla catastrofe, il più piccolo (pitoculus) è indicato come quello che ‘sta sotto’ e che viene perciò escluso dal gioco. Alle formule dei giochi fanciulleschi praticati dalle generazioni che ci hanno preceduto occorre accostarsi con il rispetto dovuto a tutto ciò che rappresenta il mondo popolare. Anni fa i genitori costruivano i giocattoli con le loro mani e i bambini sopperivano con la fantasia alla povertà degli oggetti, imparavano presto a relazionarsi con gli altri, a seguire determinate regole comunitarie e non temevano di giocare all’aria aperta, a contatto immediato con la natura. Allora non c’erano i cartoni animati giapponesi e i videogiochi, le conoscenze non erano virtuali, i ragazzi non erano passivi, ricettivi e appiattiti (così almeno si esprimono i sociologi). Può essere che l’apprendimento delle nozioni sia facilitato dal piccolo schermo e dai videogame ma dietro i giochi fanciulleschi di un tempo non si nascondeva alcun business. Ardàga dét in di edrine di orées. Da ragazzo una volta osservai una scenetta che mi è rimasta impressa nella memoria. Passavo per la via di un borgo della città dove al piano terreno di alcune case si aprivano delle botteghe; fra queste era il fondaco di uno straccivendolo, assai noto allora fra la gente di Bergamo per il suo richiamo, che diceva: “Strassér! Òss e strass e piómbo!”. Noi ragazzi a volte lo schernivamo rifacendogli il verso così: “Strassér! A l’ vènd i strass per tö moér!”. La rima era innocente ma l’uomo faceva un gestaccio minaccioso e noi si fuggiva con le ali ai piedi. Ebbene, quella volta lo straccivendolo stava scaricando dalla sua carretta i vari oggetti che aveva raccolto nel suo giro. Lì accanto un tale si era messo a guardare quel che faceva lo straccivendolo. Questi, infastidito, gli si rivolse così: “Cosa gh’ìv pò de ardà? Ív mai vèst negót?”. L’altro senza scomporsi rispose: “Né, lü! A s’ ghe àrda dét in di edrine di orées, a l’ mancherèss a’ chèla che s’ pödèss mia àrdaga dét a’ ’n di bütighe di magnà!”. Fu davvero una bella risposta: se si può guardare nelle vetrine degli orefici si può guardare anche nelle botteghe dei calderai. Lo straccivendolo non replicò, forse onorato di essere stato compreso nella categoria dei calderai. Il detto ricorda che gli occhi sono fatti per vedere. Ma un conto è vedere, un altro scrutare con insistenza. Succede a volte d’imbattersi in gente ignorante e maleducata che mette gli occhi addosso al prossimo squadrandolo a lungo da capo a piedi senza rendersi conto di quanto sia fastidiosa e indisponente. Al giorno d’oggi non si sa più che cosa sia la riservatezza (parola italiana che i politici ignorarono quando fecero una legge sulla privacy). Ci spia il “grande fratello”, ci spiano le “cimici”, ci spiano le telecamere a circuito chiuso, ci spia chi carpisce i nostri dati personali promettendo di utilizzarli solo nei modi consentiti dalle legge, ci spiano i giudici quando ascoltano le nostre conversazioni telefoniche, che in barba al segreto istruttorio escono dalle loro aule senza che nessuno mai sia chiamato a rispondere (perché tutti in questo Paese sono eguali innanzi alla legge ma qualcuno è più eguale degli altri e può commettere impunemente una mascalzonata). Come sottrarsi all’invadenza di un sistema che di virtuale ha soltanto il nome? Ci si lamentava del controllo sociale che veniva esercitato tanto tempo fa nelle nostre comunità, quando ci si limitava a guardare nelle vetrine degli orefici e nelle botteghe dei calderai. Che cosa si dovrebbe dire oggi innanzi a tanta mancanza di rispetto per i diritti della persona? Ardàs in del cül ü con l’óter. L’intento morale della locuzione ne scusa e ne attenua l’evidente volgarità: si tratta in effetti di un severo e duro richiamo all’autocontrollo e all’autocritica. Prima di guardare e di giudicare il comportamento altrui, si deve badare al proprio, a come ci si atteggia e a come si opera. Chi impiega il suo tempo nell’occuparsi del prossimo sperando soltanto di coglierne i difetti e le miserie è un pettegolo e un invidioso. Dovrebbe vergognarsi della sua meschinità: si comporta come gli animali, che non sanno volgere gli occhi al cielo e che badano soltanto alle loro necessità materiali. Ardél bé, ardél töt l’òm sènsa sólcc come l’è bröt! È un detto diffuso in gran parte della Lombardia e suona: ‘Guardatelo bene, guardatelo tutto l’uomo senza soldi come è brutto’. I clerici vagantes amavano dire: Homo sine pecunia imago mortis. Gli antichi sentenziarono che il denaro non ha odore (non olet). Secondo i moderni non si può vivere senza denaro e alcune ideologie, naturalmente in nome della giustizia, non si peritano di giustificare e di incoraggiare, anche con mezzi violenti, il furto del denaro altrui. A té bambo! Al prossimo non si dà del bambo, ossia dello ‘sciocco’, senza una ragione. Se ci si rivolge a una persona con questo termine in segno di riprovazione, esso può suonare come un insulto. Nel caso della nostra locuzione, ancora molto diffusa nella formulazione qui esposta, più che un insulto è un benevolo rimprovero, rivolto esclusivamente a persona con la quale si sia in confidenza e alla quale si dia del tu: la può rivolgere un padre al figlio, un fratello al fratello, un amico all’amico se ne esiste la ragione e non è proprio il caso di offendersi. La vocale eufonica iniziale vale a conferire un tono colloquiale alla locuzione. A té s-ciòpa! Dice un antico adagio che vale assai di più un solo insulto sulle labbra di un bergamasco che le mille ciance dei fiorentini. Dal che si evince che la loquacità è sorella dell’esteriorità: contano dunque di più poche parole appropriate che tanti blateramenti sconclusionati. La laconicità attiene alla stringatezza: occorre essere capaci di esprimere un concetto elevato e complesso senza scialo di parole. Pochi parlari italici hanno saputo come il bergamasco ritenere un’eco dell’aulica concisione del latino anche nell’invettiva e nell’insulto. Non s’intende qui esaltare la villania e la scurrilità: già vi provvedono a iosa, in questi tempi di maleducazione diffusa, la televisione, il cinema, le canzonette, certo teatro cosiddetto d’avanguardia che hanno imposto l’abuso e l’ostentazione della parolaccia. Alcuni idoli della televisione nazionale, che sia pubblica o privata non c’è gran differenza, sono irrimediabilmente cialtroni e burini ma sono imposti (più che proposti) come modelli di comportamento ad un popolo che con lo smarrimento della memoria ha perduto il senso dell’etica. Così la buona educazione è bandita e derisa, le maniere da cafoni sono ammirate e applaudite, comici da strapazzo, critici insulsi, opinionisti penosi, canzonettari scialbi, pseudointellettuali ignoranti con gravi problemi psichici si vantano di ricorrere disinvoltamente alle parolacce, giustificate, invocate e ostentate in quanto liberatorie (non si sa bene da che cosa). In realtà ogni lingua ha locuzioni da taverna, da trivio e da lupanare e il bergamasco non fa eccezione. Tutto dipende dall’uso che di tali locuzioni si fa. Ricordo in proposito un episodietto di tanti anni fa, quando un noto giornalista bergamasco nel pomeriggio di una bella stagione era seduto al tavolino di un caffè e stava scrivendo. Una giovane donna che era seduta al tavolino accanto lo osserva per un tratto e poi gli domanda: “È un letterato anche lei?”. Il giornalista risponde: “Oh, non proprio. Sto scrivendo una cronaca teatrale”. E poi, come per compiacere l’interlocutrice, domanda: “Lei che genere letterario pratica?”. La donna esita un attimo e risponde giuliva: “Ci scrivo le lettere al mio moroso”. E il giornalista, franco e risoluto: “A té sciòpa!”. Ecco, se c’è una locuzioncella bergamasca candida, innocente e irreprensibile è proprio questa, solo all’apparenza cruda e temeraria. Quante volte si dice: A té s-ciòpa! Eppure non ci si sogna minimamente di augurare del male al prossimo. Lo si dice a chi fa un discorso strano, a chi dà una risposta assurda, magari anche spiritosa, a chi suscita in noi un tenue senso di risentimento o di compatimento per una parola di troppo. Proporre al prossimo di scoppiare non è certo la manifestazione di un sentimento bonario e caritatevole ma è un modo per togliersi d’imbarazzo senza la minima intenzione di recare offesa. Se confrontata con il ridondante turpiloquio disgustoso che ci viene doviziosamente propinato dalla televisione, dal cinema e da certa stampa, questa laconica e flebile locuzione bergamasca suona quasi indulgente se non cerimoniosa. Badà mia a töt. Non badare a tutto: è il consiglio che si dà a chi se la prende troppo anche per cose di poco conto. Si dice giustamente che tutto è relativo. Una volta in uno scritto usai la parola disparato ma quando l’articolo fu stampato per una svista del correttore delle bozze l’aggettivo era diventato disperato. Espressi il mio rammarico al redattore, che credette di consolarmi dicendomi: “Ah, bàdega mia: dòpo ü dé l’ ghe pènsa piö nissü!”. Avrei voluto vedere lui… Bagnà ’l nas. Esempio: A l’ t’à bagnàt ol nas, ‘Ti ha superato’. Si vuole che nelle scuole torinesi si fosse diffusa l’abitudine di rivolgere la stessa domanda a due allievi: se uno solo dei due sapeva rispondere, poteva umiliare l’altro bagnandogli il naso con il dito inumidito della propria saliva. Strano metodo educativo! Fatto sta che la locuzione bagnare il naso è diventata popolare nel significato di ‘superare’, ‘vincere’. In bergamasco si usa soprattutto per indicare una persona che abbia più cultura o più capacità di un’altra. Bambo di Müre. Si tratta di un insulto generico, nel quale la compassione supera di gran lunga il disprezzo. Ma perché ‘sciocco delle Mura’? La nostra gente si sarà ispirata a una delle tante macchiette, clochards e bohémiens che nell’Ottocento si aggiravano per le vie di Bergamo. Si può solo congetturare. Penso a Prassitele Deleidi, che aveva combattuto nell’esercito piemontese contro gli austriaci e che a causa di una ferita alla testa aveva perduto il ben dell’intelletto. Pazzoide del tutto inoffensivo, veniva fatto uscire ogni giovedì dal manicomio di Astino e godeva di passeggiare sul viale delle Mura vestito – diceva lui – da generale giapponese. Portava al fianco una spada di legno, sul capo un berretto dal quale pendevano fronzoli colorati, a tracolla una borsa ripiena di cinciafruscole, di scartafacci e di rotoli di carta bisunta. “Qui dentro ci sono i miei piani di battaglia”, diceva indicando la borsa. Si appoggiava al muricciolo degli spalti, scrutava la piana sottostante con un binocolo, gesticolava e gridava impartendo ordini ad un fantomatico esercito che soltanto lui credeva di scorgere, mentre i passanti lo compativano e la ragazzaglia lo scherniva e lo sbertucciava chiamandolo “Celeste Impero”. D’altro canto egli sembrava fatto apposta per essere deriso: si dava infatti un sacco di arie ed incedeva per le vie di Bergamo Alta come un misirizzi, con passo solenne, il busto eretto e il portamento marziale, come un autentico militare di carriera. Chi sembrava prenderlo sul serio era Francesco Bosisio, noto come ol mat Bosisio, altro pazzoide innocuo che vestiva – lui diceva – “in costume romano”, ossia in maniche di camicia anche d’inverno, sugli occhi una visiera legata con una cordicella attorno alla testa, i pantaloni stracciati sotto le ginocchia, gli zoccoli ai piedi scalzi; aveva con sé un cesto di ferro contenente dei libri, che di notte gli fungevano da cuscino, cosicché – egli asseriva – il sapere gli entrava direttamente nel cervello. Si autodefiniva “la voce della posterità universale”; aveva perfino scritto e pubblicato qualche libro per distillare al volgo la sua visione del mondo in pagine assurde e illeggibili, intrise di astruserie demenziali. Quando il Celeste Impero e il Bosisio s’incontravano, si salutavano con grandi inchini e s’intrattenevano disquisendo del futuro delle nazioni e dei popoli, come se il destino dell’umanità fosse dipeso dal loro colloquio. Indi si salutavano con deferenza, inchinandosi ripetutamente. E ciascuno dei due non vedeva l’ora di raggiungere qualche sfaccendato che aveva osservato la scena per dichiarare scandalizzato: “Ma come s’ fài a lassà ’ndà ’n giro ü mat come chèl lé? A l’ fà de chi ragiunamèncc che l’è pròpe mat matènt!”. E sia l’uno che l’altro avevano ragione. Ma il privilegio di essere definito bambo di Müre, salvo errore, doveva appartenere al Celeste Impero per quel suo affacciarsi al parapetto della Mura e gesticolare impartendo ordini ad eserciti immaginari. Basta ìga fam. Quando Gioppino incontrava un amico che gli domandava come stesse di salute, invariabilmente rispondeva: Basta ìga fam, ‘Basta aver fame’. L’appetito è ritenuto segno di buona salute e perciò l’arguta risposta di Gioppino, per quanto appaia rustica, esprime un realistico buon senso. Capitò un giorno allo scultore Cesare Archenti, nostro valido artista un po’ bohémien, di non aver denaro per il companatico. Invitato a pranzo da gente facoltosa, indossò l’abito da cerimonia e si recò dai suoi anfitrioni. Strada facendo, mentre avvertiva un forte languore allo stomaco, passò davanti ad un gruppo di operaie in sciopero (era il 1919); queste, vedendolo tanto ben vestito, lo scambiarono per un riccone e gli rivolsero delle male parole, allusive anche ai raffinati desinari ai quali doveva essere avvezzo. L’Archenti per un attimo si sentì lusingato, sorrise soavemente, passò una mano sulla scarsella vuota, accennò ad un saluto alzando di poco il cilindro e sospirò dicendo a se stesso: Ma se l’è de iér che mange mia!, ‘Ma se è da ieri che non mangio!’. Bastià contrare. Di una persona che faccia sempre il contrario di ciò che vorrebbe il buon senso si dice in alcuni dialetti dell’Alta Italia che è un Bastian contrario (o che fa il Bastian contrario). La locuzione da noi non è di uso frequente ma di uno che prenda tutte le cose dalla parte sbagliata può capitare talora di sentir dire che l’è ü Bastià contrare. Chissà chi era quel tal Bastiano che per il suo comportamento sempre contrario a quello altrui ha legato il suo nome al detto. Io non posso che trascrivere qui a titolo di esempio una storiella popolare del Panjab che traggo dal saggio “The adventures of the Panjáb Hero Rájá Rasálu and other Folk-Tales of the Panjáb, collected and compiled from original saources”, pubblicato nel 1884 a Calcutta dal reverendo Charles Swynnerton. Ecco dunque il simpatico episodietto: “Una volta una improvvisa inondazione dell’Indo portò via molta gente e fra essa anche la moglie di un certo Banèyri. Il marito impazzito andava vagando lungo il fiume in cerca del cadavere, quando un suo compaesano gli si avvicinò dicendo: O amico, mi hanno detto che tua moglie è stata portata via dal fiume; essa deve essere stata trascinata in giù dalla corrente insieme alle altre vittime. E tu invece rimonti la corrente. Rispose allora lo sventurato Banèyri: Ah, mio caro, tu di certo non hai conosciuto mia moglie. Essa faceva sempre il contrario degli altri. Ed anche ora che essa è annegata, io so benissimo che se gli altri cadaveri sono andati all’ingiù, essa ha sicuramente risalito il fiume”. Bat la sèla per fàga capì a l’àsen. Le locuzioni dei padri sono pagliuzze d’oro che riaffiorano dalla sabbia del fiume; ritornano alla memoria per vie strane e misteriose; a volte è un’associazione d’idee, altre volte l’identità di un suono, il ripetersi di una circostanza o qualche altra causa remota, fatto sta che all’improvviso esce spontaneamente di bocca il modo di dire nella formulazione udita chissà quanto tempo prima, come nel caso di questa locuzione, che fa riferimento ad una situazione ben definita, quella che si verifica quando ci si rivolge ad una persona perché un’altra, che è presente, capisca. Il contadino si limita a battere la sella per far capire all’asino come deve muoversi e da che parte deve andare: altrettanto si fa quando si dice a nuora perché suocera intenda. Nel “Satyricon” (cap. XLV) di Tito Petronio Arbitro si legge: Sed qui asinum non potest, stratum cædit, ‘Ma chi non può bastonare l’asino, percuote il basto’. Bèrghem de sass. È un motto assai caro ai nostri alpini perché esprime la forza e la compattezza del carattere dei bergamaschi. Un tale un giorno credette di fare il saccente dicendomi che sass non apparterrebbe al bergamasco puro. Gli risposi che in una poesia di Giuseppe Mazza detto Felìpo si trova la voce sassetì; un sostantivo con la doppia alterazione deve per forza essersi ottenuto su quello originale, ossia sass. Esiste peraltro la voce sassada (es.: l’ gh’à tràcc öna sassada). Perché non dovrebbe esistere sass, che è cosa diversa da plòch o da préda? Mi vengono in mente i réss, che sono i ciottoli di fiume usati per selciare le strade, oppure quei bei borlanti messi a spina di pesce a comporre muri a secco confinari. E poi, chi stabilisce la purezza di una lingua e con quale autorità, posto che essa è un corpo vivo in continua trasformazione? C’è peraltro chi riferisce il motto alla presunta durezza del linguaggio dei bergamaschi. Qualcuno si diverte ancora a riportare i giudizi che delle parlate lombarde Dante diede nel “De vulgari eloquentia”. Nel suo lungo soggiorno veronese egli ebbe sicuramente occasione d’intrattenersi in conversazione con persone provenienti dalla vicina Lombardia (ma pare anche sia stato ospite dei Lantieri a Paratico e che si sia recato a Milano sotto mentite spoglie per sfuggire ai sicari del governo fiorentino, che lo voleva morto). Il sommo poeta udì qualche nostro antenato dire növ per ‘nove’ e viv per ‘vivo’ e tanto gli bastò per fare pollice verso. Ma i detrattori del bergamasco sanno che Dante disse peste e corna anche degli altri volgari italici? Il romanesco, che la televisione nazionale non si perita d’infliggerci notte e giorno nelle sue forme più plebee, fu da lui definito “fetido e sconcio” (ne ebbe conoscenza diretta nel suo lungo soggiorno romano). Diceria vecchia e stantia, questa che vorrebbe confinare il bergamasco fra i linguaggi più irsuti, diceria di gente di poca cultura e di scarso rispetto della cultura altrui. Pensando piuttosto al motto alpino, ci si rammarica ancor oggi che Bergamo negli anni Venti del Novecento si sia fatta sottrarre una caserma del V Alpini (che si trovava in Via San Tomaso, davanti all’Accademia Carrara). Bergamo città alpina per eccellenza non ha militari alpini. Non farebbero bene al carattere e alla salute dei nostri giovani tre mesi di servizio militare obbligatorio sulle Alpi Orobiche? Quanti boschi cedui da ripulire e da sfrondare, quante mulattiere dissestate da riselciare!... Tre mesi d’estate all’aria pura delle nostre belle montagne. Da farci la firma, ragazzi! Bèrghem de sura e Bèrghem de sóta. A Bergamo non si dice e non si è mai detto così ma ovunque andiate, se sanno che siete di Bergamo, ecco che si sentono in dovere di rivolgervi la solita domanda cretina: “Lei è di Bèrghem de sura o di Bèrghem de sóta”? Qualcuno crede di fare sfoggio di eruduzione e d’intelligenza pronunziando hura e hóta ed aspirando le iniziali con selvaggia violenza, senza sapere che nel dialetto cittadino non esiste alcuna spirantizzazione (peraltro fenomeno fonetico interessantissimo, che coinvolge parte del territorio bergamasco e bresciano e che non è mai stato rilevato e studiato scientificamente). Qualcun altro suppone di dimostrare a quale alto grado possa arrivare l’intelletto umano storpiando rozzamente il nome della città, che diventa (chissà perché?) Bìrgum o Bìrgom. Avete un bel compatirli e dire loro che la domanda non ha senso, che è sciocca e penosa, che noi bergamaschi siamo stanchi di essere perseguitati da una simile idiozia: loro ti guardano gongolanti e nel sorriso beota che devasta il loro volto leggete un’espressione di compiaciuta felicità. Si legge in uno scritto dell’avvocato Davide Cugini (in “Giopì”, 17 aprile 1955): “La prima volta che mi si mosse questa domanda fu a Piacenza quando ero recluta del 10° Reggimento Artiglieria da Fortezza e la domanda mi fu poi ripetuta le mille volte, sotto tutte le latitudini, ogni qualvolta io avevo occasione di nominare il mio luogo di provenienza. Per le prime volte mi affannai a dimostrare con validissimi argomenti come la spiritosaggine fosse insulsa e inconsistente ma dovetti convincermi che era fatica sprecata. Tutti, vecchi e giovani, colti od ignoranti, ripetevano la frase con la beata soddisfazione di dire chi sa quale finissima arguzia. E molti non solo non avevano mai visto Bergamo ma avevano anche idee molto misere sulla sua ubicazione. Decisi di prendere il toro per le corna rispondendo a tono. Ogni volta che il solito spiritoso mi rivolgeva la barbosa domanda rispondevo imperterrito: Mé só de Bèrghem de mès, tra gnach e petàch!”. Bèrghem pórt de mar. Di un luogo frequentato da gente sconosciuta che va e che viene senza controllo si dice che è un porto di mare. Strano ma vero: il mare è lontano da Bergamo ma sembra, a giudicare dalle locuzioni, che la nostra gente abbia confidenza con esso. Per indicare una cosa inutile si dice: ’ndà a scuà ’l mar. Si usa il termine mar nel senso di ‘gran quantità’ (ü mar de dèbecc, ü mar de guai). Si dice sircà per mar e per tèra per dire ‘cercare dappertutto’. Esiste il proverbio: Chi l’ völ mia bagnàs a l’ vaghe mia al mar, ‘Chi non vuol bagnarsi non vada al mare’. Di una promessa che non verrà mantenuta si dice che l’è öna promèssa de marinér e un marinaio che abbia navigato assai poco è ironicamente definito marinér d’aqua dólsa. Qualche confidenza con il mare tanti giovani di Bergamo l’ebbero certamente entrando a far parte nei secoli passati della marina militare o mercantile veneziana. Ma è un fatto che ancora alla fine dell’Ottocento si udiva la locuzione Bèrghem pórt de mar pronunziata con un certo sarcasmo ogni volta che qualcuno prospettava un progetto grandioso e avveniristico che valesse a collegare la città con le grandi vie di comunicazione stradale, fluviale o ferroviaria. La locuzione risale al Cinquecento, quando il Comune di Bergamo dichiarò che avrebbe conferito un premio a chi avesse proposto un progetto per la realizzazione di un canale navigabile atto a collegare la città all’Adriatico. Nel secolo precedente il Colleoni aveva vagheggiato di sfruttare le acque del Brembo e l’idea aveva esercitato un certo fascino sui patres conscripti del tempo. Gl’ingegneri idraulici presentarono progetti interessanti e perfino arditi (uno di questi prevedeva lo sbocco a Rimini e la navigazione lungo la costa fino a Brindisi); sbolliti gli entusiasmi iniziali, il Comune di Bergamo nicchiò innanzi ai costi e alle difficoltà burocratiche. Non se ne fece nulla e la città rimase per secoli prigioniera del suo isolamento. Riguardo al senso corrente della locuzione porto di mare, è bene riprodurre quanto Cicerone scrisse nel “De republica” (II, 4): “Nelle città di mare esiste una sorta di degenerazione dei costumi: esse infatti prendono familiarità con le nuove lingue e le nuove usanze perché non vi s’importano soltanto le merci ma anche i costumi stranieri; sicché niente delle istituzioni antiche rimane integro. Quanti abitano in queste città peraltro non rimangono legati alle proprie abitazioni ma da una speranza fantasiosa e volubile sono sospinti sempre più lontano dal loro luogo natio!”. Biv ol cichèt. Le lingue popolari non dispongono di molti vocaboli per esprimere i concetti ma abbondano di termini relativi agli oggetti. Chi parla preferibilmente in dialetto non ha tempo per le speculazioni fllosofiche, dà per scontato che la sua conoscenza abbia basi essenzialmente empiriche, elude così i problemi teoretici e giorno per giorno affronta la realtà sul campo. Del resto, non possiamo essere tutti pensatori. La lingua italiana dispone di due vocaboli per indicare una famosa bevanda alcolica ottenuta dalla distillazione delle vinacce o di altre sostanze fermentate: acquavite e grappa. A ben considerare, i termini non sono intercambiabili perché l’acquavite (dal latino medievale aqua vitæ, ‘acqua di vita’, come dicevano gli alchimisti) può anche derivare dalla distillazione di frutta o di cereali mentre la grappa, che è sempre ad alta gradazione alcolica, si ottiene mediante distillazione delle vinacce. La voce grappa è derivata dall’incrocio del francone raspon con grappolo. Il vocabolario bergamasco del Tiraboschi ha ben cinque lemmi per designare la grappa: Aquaéta, Grapa, Racagna, Rabiusa, Snap. Meglio non addentrarci in avventure filologiche, semantiche, etimologiche e semasiologiche davanti a tanta abbondanza (quod abundat non vitiat). Per pura associazione d’idee penso a quando i nostri contadini producevano di frodo qualche litro di grappa con l’alambicco (ol làmbech) prima che l’abuso fosse perseguito dalla guardia di finanza con un accanimento incredibile, mentre in altre parti d’Italia la piovra del crimine organizzato proliferava pressoché indisturbata. Non era male, quella grappa: migliore di quella che si produce industrialmente e che ci tocca bere la volta che desideriamo fare il resentì (latino recentare, ‘risciacquare’), da ottienere mettendo qualche goccia di grappa nel tazzina del caffè appena bevuto. Lasciamo il cichèt, ‘grappino’, a chi a stomaco forte e buon fegato. Il dizionario italiano dello Zingarelli ammette la voce grappino nel senso di ‘bicchierino di grappa’. Ma volete mettere l’italianizzazione di cichèt? Avevo un amico anni fa che ogni tanto diceva: “Andiamo a bere un cicchetto”. Non ci sarei andato anch’io se avesse detto: “Andiamo a bere un grappino”. Non è la stessa cosa. Bóca, tas! Si ricorre a questa esclamazione quando si è quasi sul punto di pronunziare un giudizio temerario o di riferire una notizia grave sul conto di qualcuno. Si dice anche: Bóca, fa sito che te n’ paghe ü mès, ‘Bocca, taci: ti pago mezzo litro di vino’. Meglio cioè impiegare la bocca a bere piuttosto che scadere nel pettegolezzo. Borlà zó del mónd di nìoi. ‘Cadere dal mondo delle nuvole’. Si dice anche in italiano per indicare lo stupore di chi apprende una notizia che non sospettava minimamente. Borlà zó ’l camì. I cultori della poesia in bergamasco ricorderanno che fra le composizioni di Giuseppe Mazza detto Felìpo (1879-1949) esiste uno spassoso componimento in settenari intitolato “La quistiù del nòm”, nel quale è riprodotto un dialogo fra il Tóne e la Rösa, marito e moglie, che discutono sul nome da imporre al loro nascituro. In quella composizione figura la locuzione borlà zó ’l camì, che ho sempre sentito tradurre letteralmente ‘cadere il camino’ o ‘cadere il comignolo’. Non capivo che nesso intercorresse fra l’attesa di un figlio e la caduta di un comignolo. Tempo fa in un manoscritto inedito del professor Achille Mazzoleni, scomparso nel 1934, ho letto: “Borlà zó ’l camì: aspettare un bambino, nascere un figlio”. Finalmente l’arguzia del passo del Mazza mi parve chiara. Ma non saprei dire perché una volta i nostri vecchi ricorressero a questa locuzione. Mi sono lambiccato il cervello, ho domandato a destra e a manca e non sono giunto a capo di un’acca. Ho pensato alle cicogne, che secoli fa si vedevano anche nelle nostre campagne e che nidificavano sui comignoli ma non mi è parso indizio tale da trovare una connessione fra la nascita di un figlio e la rovina di un comignolo. E mi sono rassegnato a dare ragione a quel sant’uomo di Isidoro di Siviglia, erudito saggio e virtuoso, il quale nel VI secolo scrisse un’opera importante, intitolata “Etymologiæ sive Origines”, nella quale si legge fra l’altro: “Molte etimologie non possono più essere identificate in quanto certe parole non hanno mantenuto il loro significato originario ma lo hanno mutato radicalmente e si sono trasformate secondo il capriccio dei parlanti”. Bötà i sólcc de la finèstra. ‘Gettare i soldi dalla finestra’ è come concludere un affare sbagliato, investire una somma di denaro senza la necessaria ponderatezza o fare una spesa pazza. In tempo di consumismo si sente dire che i soldi sono non di chi li fa bensì di chi li spende. In realtà sono di chi li sa spendere bene. Bröt piöcc iscapàt a la lissìa. Una persona egoista e avara, che si sia arricchita disonestamente e che non dimostri alcun sentimento di umanità, può ben essere paragonata a un pidocchio sfuggito alla disinfezione della lisciva, che veniva usata un tempo per il bucato. Brüsà ’l paiù. Questa locuzione è ormai caduta in disuso ma ancora nella prima metà del Novecento era possibile sentir dire: Te m’é brüsàt ol paiù, nel senso di ‘Non hai mantenuto la promessa’, ‘Mi hai mancato di parola’ ovvero ‘Non ti sei presentato all’appuntamento’. Letteralmente brüsà ’l paiù significa ‘bruciare il pagliericcio’. Nelle nostre campagne anticamente i materassi erano pieni di paglia o di cartocci di granoturco, quelli di lana e di crine essendo costosi. Secondo la consuetudine la sposa doveva portare in dote i pagliericci. Talora, dopo che i fidanzati si erano scambiati la promessa di matrimonio, accadeva che il futuro sposo venisse meno alla promessa e rompesse il fidanzamento per rivolgere le sue attenzioni a un’altra ragazza. In questo caso i giovani del paese o della contrada bruciavano nottetempo un pagliericcio davanti alla porta della fanciulla abbandonata dal fidanzato per simboleggiare che la promessa di matrimonio era andata in fumo. Altri eventuali pretendenti erano così messi in guardia e si domandavano quale ragione avesse indotto il fidanzato a mancare alla sua promessa. Gode sempre di grande considerazione chi l’è de paròla, ‘chi mantiene la parola data’. Buì fò ’l lacc del pignatì. Quando il latte bolle e tracima dalla pentola si corre a spengere il fuoco del fornello. A una persona che stia correndo o che si precipiti a fare qualcosa possiamo domandare meravigliati: A l’ te bói fò ’l lacc del pignatì? Oggi c’è gente che va di gran carriera, che non tollera d’incontrare ostacoli sulla propria strada e che travolge tutto e tutti senz’alcuna plausibile ragione. In un suo romanzo, intitolato “The valorous years”, Cronin mise in guardia la società americana dal pericolo di perseguire il successo ad ogni costo, facendo dire al protagonista della vicenda, un medico che intendeva la professione come una missione: “Avere successo significa prendere a calci l’uomo che vi precede e calpestarlo”. A proposito del latte che bolle, si dice: I dòne i ghe la fà al diàol ma ol pignatì del lacc a l’ ghe la fà ai dòne, perché non sempre la donna è pronta a spengere il fornello un attimo prima che il latte bollendo tracimi. Che poi la donna sia tanto astuta da mettere nel sacco anche il diavolo, è asserzione non veritiera: la progenitrice fu tanto ingenua da lasciarsi lusingare dal serpente, il quale fece leva sulla sua vanità e sulla sua ambizione. L’aforisma insegna che basta la distrazione di un attimo per provocare dei disastri. Caà sangh di ràe. Chi s’illude di ottenere sangue dalle rape, che distillano un succo rossiccio? Eppure non poche persone si affidano ai cartomanti, agl’indovini, ai ciarlatani, ai maghi, alle fattucchiere, che ingannano la buona fede con i loro trucchi. Smarrito il senso dell’assoluto, si cade nel relativismo e le cronache dicono a quali raggiri si espongono i creduloni. Occorrerebbero leggi severe e interventi giudiziari decisi per stroncare un giro d’affari ingente alle spalle degl’ingenui. Resta il fatto che se dovete salvare una persona con una trasfusione sanguigna, a gh’ì issé òia de caà sangh di ràe… Cà de tréfola. Ho sentito dire qualche volta di una persona che l’è ü cà de tréfola per significare che ha buon fiuto e che non perde tempo, come fa il cane ammaestrato per la ricerca dei tartufi: quando arriva con il suo padrone nella tartufaia (trifoléra in bergamasco) incomincia a fiutare con ansia sparmodica e continua in tal modo finché non trova qualche tartufo. Cerchereste invano il corrispettivo della voce tréfola nei dialetti delle regioni in cui non esistono i tartufi. Si sa che i migliori sono quelli bianchi di Alba. Ma ne esistono tipi diversi, di vario colore. In Bergamasca si possono trovare i tartufi neri. Come esistono i funghi velenosi, si possono trovare anche tartufi tossici: meglio non andare a cercarli se non si conoscono bene. Esistono peraltro leggi severe che regolano la raccolta dei tartufi: occorre essere muniti di patente ed aver pagato una tassa annuale. E questo è il male minore, perché la natura non è mai abbastanza rispettata e protetta. Ed ora un po’ di etimologia: tréfola (o trifola) da un tardo latino territùful(um), evidentemente contratto in terrìful(um). Da un composto di terra e di tuber, ‘tubero di terra’, si formò un rustico territufer, che si contrasse nell’italiano tartufo per influenza del suono iniziale di tartaruga. In bergamasco il vocabolo si presenta privo dell’incrocio con la voce tartaruga ed appare quindi più fedele alla forma latina volgare territufulum, diminutivo di territufer. Resta da vedere perché da neutro il genere diventi femminile. Ma non sono pochi i mutamenti di genere nel plurisecolare passaggio dal latino parlato ai volgari. Calcà la pèna. Si dice per significare che si è ecceduto in alcunché, soprattutto riferendo un avvenimento o descrivendo una situazione o ancora dando un giudizio su di una persona o una cosa. L’à calcàt la pèna, ‘ha ecceduto’, come se scrivendo avesse premuto sul pennino tanto da abradere il foglio di carta. Un tempo si diceva così soprattutto per indicare che una contabilità era stata alterata e che si presentavano dati manipolati, non attendibili perché eccessivi, “gonfiati”. Oggi la locuzione fa meditare sulla responsabilità connessa con l’atto dello scrivere. Lo scrittore dev’essere onesto e veritiero; può anche premere la penna se occorre, ma non deve mai venir meno ai princìpi etici. Allora la parola scritta è luce nelle tenebre, scuote lo spirito, risveglia la ragione, è lievito dell’anima. Alte risuonano le parole della lettera scritta da Nicolò Machiavelli a Francesco Vettori dal confino sull’Appennino Toscano: “Venuta la sera mi ritorno in casa, et entro nel mio scrittoio; et in su l’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, et mi metto panni reali et curiali; et rivestito condecentemente entro nelle antique corti degli antiqui uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio, poi che io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro, et domandarli della ragione delle loro azioni; et quelli per loro humanità mi rispondono”. Fra chi scrive e chi legge si dipana un dialogo muto, benefico e ricco di fermenti. La parola scritta non ama il chiasso, vive nel silenzio e lo pervade. Viviamo anni di bailamme e di stordimento, prodotti apposta per impedire di riflettere, di meditare. Ma la parola scritta reclama i suoi diritti. Mario Luzi una volta disse: “Che cosa sarebbe l’umanità senza la poesia di Dante e di Leopardi?”. E a chi gli domandava come avrebbe dovuto prepararsi l’umanità al secondo millennio Italo Calvino rispose: “Imparando qualche poesia a memoria”. Cal e póch. La filanda de Ghisalba / l’è öna triste filandina: / cal e póch a la matina / e ’l pruì dòpo ’l mesdé. È la prima strofa di un canto che si diffuse nella seconda metà dell’Ottocento nelle nostre campagne, un canto delle filandaie, le operaie addette alla raccolta della seta. Il cal e póch era la verifica della quantità di seta ottenuta dai bozzoli e dell’entità dello scarto: il rapporto fra i due dati valeva a stabilire se tutta la seta era stata recuperata dai bozzoli. Il pruì era invece il controllo della qualità del filo di seta. Nel suo dettato dialettale dimesso ma autentico il canto denunziava la sofferenza delle donne mal pagate e dalla salute precaria costrette a lavorare in ambienti insalùbri, incitate ad avvolgere il più velocemente possibile il filo di seta sull’aspo, sottoposte al rigido controllo del cal e póch e del pruì. Poche persone ormai ricordano il canto della Filanda de Ghisalba e tanti altri canti spontanei, poetici ed espressivi, nati dal popolo e sopravvissuti fino alla seconda metà del Novecento. Sono mutati i presupposti sui quali si crede di fondare la società. Si è convinti che il valore della vita dipenda dal successo che si ottiene nel mondo e si pensa che la perdita della memoria costituisca un vantaggio. Ma non siamo una tabula rasa e non c’è il nulla dietro di noi. Il più grande torto che possiamo fare a noi stessi consiste nella cancellazione del nostro passato. Cambià èla. Il navigante cambia vela a seconda della direzione del vento. In bergamasco si chiama èla anche la banderuola che si poneva un tempo sulle cime delle torri o dei campanili e che si muoveva cambiando posizione secondo la corrente atmosferica. Per ampliamento dell’accezione originaria la locuzione indica il mutamento di un pensiero o di un’opinione, quando non il passaggio da un partito ad un altro. Cambià müsica. Se una situazione che presenta aspetti negativi, dannosi e insopportabili, si protrae nel tempo, invochiamo il cambiamento dicendo che l’è ura de cambià müsica. A proposito di musica, occorre domandarsi perché in questo Paese s’incontrino spesso ingegneri, avvocati, magistrati, medici privi delle minime nozioni della musica colta: non si pretende che conoscano bene la Missa Papæ Marcelli del Palestrina, i madrigali del Monteverdi e le Quattro Stagioni o il Gloria di Vivaldi; tuttavia succede che si parli con persone che occupano una posizione sociale di rilievo e che non hanno mai ascoltato il sestetto della Lucia, il quartetto del Rigoletto, il notturno di Martucci o un poema sinfonico di Respighi. È desolante dover constatare che nella patria di Guido d’Arezzo, di Frescobaldi, di Corelli e di Scarlatti esista ormai soltanto la musica leggera, esaltata e portata alle stelle ma in realtà priva spesso di qualunque valore e ridotta a merce di consumo: se esiste una richiesta di musica in questo Paese, quasi sempre trova nelle istituzioni e negli enti risposte degradanti, banali e commerciali nel senso più vieto del termine. Un grande violinista italiano in una intervista di qualche tempo fa denunziava l’impreparazione e l’ignoranza musicale di tanti pubblici reggitori, lamentava la scarsità di teatri e di sale da concerto, compiangeva la perdita del senso dell’acustica, rovinata dall’uso indiscriminato e insensato di strumenti elettronici e di amplificatori assordanti, deplorava infine i contenuti rozzi e beceri di tanta musicaccia propinata da mane a sera da radio e televisione, con grave danno dell’educazione musicale delle nuove generazioni, praticamente all’oscuro dei capolavori che i grandi musicisti hanno composto ad elevazione dello spirito umano. La musica, affermava il grande virtuoso, serve per aprire la mente, non per ottunderla con il gran baccano di percussioni, di rumori a pieno volume e di versacci. E protestava che siamo ormai il fanalino di coda in fatto di educazione musicale: autori quali Verdi e Puccini, Rossini e Donizetti, Paganini e Bellini sono popolari presso i giovani giapponesi, che a sei anni suonano già il violino o il pianoforte, mentre da noi, se non si correrà presto ai ripari, saranno solo appannaggio di una ristretta élite. Il famoso violinista concludeva l’intervista invitando i giovani a rifuggire dalla musica globalizzata, fatta per rincretinire la gente e chiedendo a chi detiene il potere di provvedere all’educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado. Non resta che concludere: l’è ura de cambià müsica. Del resto, non si suona la marcia funebre nei momenti di gioia e non s’intona il peana nell’ora della trenodia e dell’epicedio. Si adegua la musica alle circostanze e alle necessità. Sempre che ci s’intenda di musica e che non si voglia fare la figura dell’ignorante. Cambià regìster. La locuzione dimostra che un tempo la nostra gente aveva dimestichezza con la musica e con gli strumenti. Se avessimo mostrato un foglio di musica a un contadino che stava lavorando nei campi, questi probabilmente avrebbe riconosciuto le note e il loro valore, avrebbe indicato la tonalità della composizione. Non pochi un tempo facevano parte della schola cantorum o della banda musicale del paese. Entrati in un’osteria, avremmo potuto domandare agli avventori se conoscevano un coro d’opera e ci saremmo sentiti intonare il “Va’ pensiero” o il coro dei Lombardi. La gente sapeva cantare con voce vibrante e impostata e possedeva un ampio repertorio di canti popolari (canti d’amore, canti religiosi, canti narrativi, canti di montagna, ecc.), eseguiti spesso a voci miste. E molti sapevano suonare uno strumento a corde o a fiato. La Bergamasca è pur sempre la terra degli Antegnati, dei Bossi e dei Serassi, la terra di Giovanni Legrenzi, di Pietro Antonio Locatelli e di Gaetano Donizetti, la terra dei baritenori che calcarono le scene dei teatri più importanti d’Europa, da Rubini a David, da Nozzari a Donzelli. Ma da troppi anni in Italia la grande musica è reietta, i teatri vengono incendiati, le orchestre liriche e sinfoniche vengono chiuse, si cancella l’insegnamento della musica dai programmi scolastici. Sarebbe davvero tempo de cambià regìster. Can de la Martina! Dice Carlo Porta in un suo famoso sonetto ambrosiano che per il poeta le parole sono come i colori per il pittore: se il quadro è bello, ciò non dipende dai colori bensì dalla bravura del pittore. Così la bella poesia nasce dall’estro del poeta, che sa usare bene le parole. Queste sono in sé flatus vocis e non sono né belle né brutte. Non si possono applicare i canoni estetici alle strutture linguistiche. Una lingua non è bella o brutta in sé ma lo diventa a seconda della persona che la parla. La lingua italiana, tanto nobile e incomparabile nelle pagine dei suoi classici, diventa un’orribile favella sulle labbra dei cialtroni. Da anni ormai se ne fa scempio in tanti programmi irradiati dalle stazioni televisive a diffusione nazionale. Insieme con la moria dei dialetti si assiste purtroppo alla rovina sistematica della lingua italiana, pronunziata spesso in modo infame e inzaffardata dall’uso di termini volgari. Chi sostiene che i dialetti siano volgari probabilmente conosce soltanto persone volgari; io ho avuto il piacere di conversare in dialetto con persone educate e gentili che davano al loro idioma la dignità di una lingua. Trovo molto volgare non il bergamasco che ancor oggi ho la possibilità di parlare con amici e conoscenti ma l’italianese povero e imbastardito dei mass media, quello dalle strutture morfologiche e sintattiche tanto semplificate da essere ridotte quasi ad un linguaggio primitivo, rinvigorito – si fa per dire – dal ricorso sistematico a imprecazioni, a intercalari triviali, a parolacce proferite ad ogni pié sospinto, senza alcuna ragione e soprattutto senza alcuna scusante. Anche i nostri nonni sbottavano in qualche esclamazione; di solito tuttavia ricorrevano ad interiezioni eufemistiche non raffinate ma sopportabili. Quando s’inquietavano uscivano a dire: Can del diàol!, Can de l’öa!, Can de la malura!, Can de l’òstrega!, oppure (la più gettonata) Can de la Martina!, espressioni tutto sommato innocue e perdonabili se paragonate con le scurrilità e le trivialità che si sentono al giorno d’oggi. C’è chi se la prende con i giovani, che proferiscono un sacco di parolacce. Purtroppo queste parolacce io le sento dire da tanti anni dalla generazione passata tutt’altro che indenne attraverso il disastroso e inconcludente putiferio della “contestazione”, le sento dire da gente che la televisione, il cinema, i giornali e le discoteche propongono addirittura come modelli da imitare. Invero non sono affatto da imitare il turpiloquio e la cafonaggine, che rimangono tali anche quando sono ben pagate perché fanno spettacolo e cassetta. Attila era un re ma la sua regalità non attenuava il fatto che fosse un essere rozzo, volgare, sordido e sconcio, che non si peritava di emettere rumori sconvenienti durante in banchetti. Dietro la volgarità, dietro le parolacce si avverte il disagio di una società in crisi etica profonda. Ma non si dica che è colpa della lingua, perché non hanno colpa né la grande lingua nazionale né la nostra millenaria lingua bergamasca se certe persone anziché migliorarsi preferiscono abbandonarsi al becerume. E chiediamo scusa alla Martina e al suo cane, che i ghe èntra mia. Cantà come ü canarì de fòss. Di chi canta con una voce stridula e sgraziata si dice che l’è ü canarì de fòss, letteralmente ‘un canarino di fosso’, ossia una rana. Cantà in müsica. Di chi presso una o più persone abbia fatto valere le sue buone ragioni esprimendosi con qualche animosità ma anche con molta capacità di persuasione diremo che l’ gh’i à cantade in müsica. Sia detto con tanta nostalgia per la propensione delle vecchie generazioni al canto spiegato, soprattutto quello corale nelle aie, nei cortili e sui prati (ma la nostra gente sapeva anche cantare il gregoriano, che in certe pagine raggiungeva bellezze sublimi). Ora, dopo tanto chiasso di percussioni e di amplificatori a pieno volume, la gente non canta più. Ed ecco che da qualche anno sull’onda di una retorica più patriottarda che patriottica si è riscoperto l’inno di Mameli e si cerca di farlo cantare in ogni circostanza, anche quando non esiste alcuna seria ragione celebrativa che attinga all’ufficialità e alla solennità. Un inno nazionale, bello o brutto che sia, non è una musichetta da jukebox, una canzonetta da balera o la sigla di un programma televisivo. Va riservato ai momenti alti e solenni. Sembra quasi che i gestori del centralismo patiscano di una intrinseca debolezza identitaria e che non si rendano conto delle grandi risorse culturali della nazione italiana, la quale in verità meriterebbe un inno meno povero ed esteticamente meno scarso sul piano poetico e musicale. Esistono altri inni patriottici molto più belli e molto più significativi (basterebbe pensare alla “Leggenda del Piave” di E. A. Mario, buon poeta e musicista partenopeo, al quale si deve fra l’altro quel piccolo capolavoro che s’intitola “Santa Lucia luntana”). Una nazione non può sostenersi unicamente sulla retorica degl’inni e dei simboli, se appare lacerata e divisa al suo interno da palesi ingiustizie e se non riesce a trovare ragioni unitarie in alti valori etici e civili condivisi da tutti. Cantà ’l mütéo. È locuzione ironica ormai caduta in disuso: veniva riferita ad una persona la quale, trovandosi in compagnia di altri che conversavano, non riuscisse a proferire un solo motto e rimanesse ostinatamente muta. Capì l’antìfona. Si dice anche in lingua italiana. L’antifona era un breve canto premesso ad un salmo; dal primo accenno alle sue parole e alla linea melodica i fedeli capivano subito quale fosse il salmo. Così da come s’incomincia un discorso, a volte si capisce già a che conclusione si vuole arrivare. Capì ol Bèrgamo. Significa: ‘Capire l’antifona’. È locuzione di provenienza forese, sorta sulla fola della presunta incomprensibilità della parlata bergamasca. Capì Róma per tóma. Lo si dice quando si constata un fraintendimento. Dire che una persona l’à capìt Róma per tóma (esiste il sostantivo tóma, ‘caduta’, ed esiste il verbo tomà, ‘cadere’, ‘precipitare’, ‘rovinare’) vale a significare che ha capito una cosa per un’altra. Il patrocinatore legale Benvenuto Trezzini, poeta estemporaneo attivo a Bergamo nella seconda metà dell’Ottocento e noto come Tressì, una volta si trovava seduto fra il pubblico del tribunale ad ascoltare la concione di avvocato. Quando questi pronunziò le parole: “E io dico altresì…”, il Trezzini si levò di scatto e disse: Cosa ghe èntre pò mé?, ‘Che cosa c’entro io?’. Cara gràssia del Signùr. Si dice a commento di un evento fortunato quando la persona beneficata dalla sorte non si dichiara del tutto soddisfatta ritenendo di meritare di più. La locuzione si addice agl’incontentabili, ai quali occorre raccomandare che i pórte a cà (letteralmente: ‘che portino a casa’) ovvero che accettino quanto di positivo il destino elargisce loro. Cargà ’l mut. ‘Caricare il monte’. Lo dicevano i pastori e i mandriani quando, con il ritorno della bella stagione, conducevano il gregge o la mandria ai pascoli alti, che verdeggiavano dell’erba novella. Mut significa ovviamente ‘monte’ ma per le condizioni dell’economia che nel Medio Evo caratterizzò tutto l’arco alpino il termine finì per assumere anche il senso di ‘pascolo’. Cargàs de lègna érda. La legna verde brucia male (quando brucia) e fa molto fumo. Perciò chi mette della legna verde nel camino è uno stolto perché affumica la casa anziché riscaldarla. Se si pensa alla fatica che si deve sostenere per procurarsi la legna da ardere (abbattere con la luna propizia un albero vecchio e inutile, sradicarlo, diramarlo e scortecciarlo, ridurre il tronco in toppi e accatastare i pezzi nella legnaia), come non compatire chi pretende di bruciare la legna senz’averla fatta stagionare? Di solito si ode la locuzione imperativa Càrghes mia de lègna érda!, ‘Non caricarti di legna verde!’, che raccomanda di non procurarsi dei fastidi, di non sobbarcarsi oneri pesanti quando non ne vale la pena. Ma un conoscente di Azzano San Paolo mi assicura di aver sempre sentito proferire la locuzione nella forma seguente: Càrghem mia la cossiènsa de lègna érda! Si rivolge questa esortazione a chi vorrebbe indurre un altro a compiere un’azione della quale domani potrebbe pentirsi. Come non possiamo pretendere di bruciare della legna non ancora stagionata, così dobbiamo consentire alla nostra coscienza di ribellarsi a qualunque coartazione e di respingere proposte che non ci convincono o compromessi che non siano limpidi. Per il resto, la legna non la si conosce mai abbastanza. Dice infatti un proverbio: La lègna érda la gh’à öna pèca: che no la lüs se no l’è sèca; la lègna sèca la ghe n’à ün’ótra: che no la lüs se no l’è cólda. Carlo schinta. Nelle nostre vecchie comunità accadeva talora che si qualificasse una persona aggiungendo al suo nome di battesimo la terza persona singolare del presente indicativo del verbo che più le si attagliava per indole e comportamento. Se una ragazza di nome Maria era nota per essere un po’ chiacchierona e un po’ pettegola, diventava per tutti la Maréa ciàcola (letteralmente ‘Maria chiacchiera’) e il soprannome le rimaneva addosso per tutta la vita. E se una donna di nome Rosa si spaventava per un nonnulla mettendo in allarme il prossimo anche quando non c’era ragione, diventava la Rösa spaènta. Così se un tale di nome Giacomo le sparava grosse e l’istàa in pé a bale, ‘si sosteneva raccontando frottole’, diventava il Giàcom bala. Non diciamo poi di chi si chiamava Carlo e non brillava per garbo: evocando per dileggio la memoria dell’imperatore Carlo V, veniva definito Carlo schinta perché schintà significa ‘strappare grossolanamente’, ‘lacerare’. Con lui faceva il paio il Gioàn incióda (la voce verbale era qui usata in senso traslato, per significare la rapidità e l’inesorabilità con la quale Giovanni sapeva colpire). Pietro a sua volta non sapeva mai che partito prendere e si giustificava dicendo che doveva pensare al da farsi: diventava allora il Piéro pènsa. C’era poi il Tóne scapa, che si dileguava al minimo sentore di pericolo. E il Lüìge stöfa, che non la finiva mai d’importunare il prossimo ripetendo continuamente ciò che aveva già detto. Volendo, si potrebbe continuare. Sufficit. Cassà fò i öcc. Letteralmente: ‘Cacciar fuori gli occhi’. Ai distratti è lecito rivolgere l’esortazione: Cassa fò i öcc!, ‘Osserva attentamente!’. Chi intende abbondare può ricorrere alla locuzione: Cassà fò sènto-méla öcc. Fa il paio con l’invito a fà balà l’öcc. Caterina di corài. Si dice scherzosamente ad una ragazza che curi la propria immagine adornandosi con collane e che sia svogliata e dormigliona. Dice la canzone popolare: Caterina di corài, lèa sö che i canta i gai, canta i gai e la galina, lèa sö, che l’è matina. Questa benedetta ragazza, che veniva invitata ad alzarsi al canto del gallo (tanta salute!), non faceva shopping e non andava in discoteca a ballonzolare fino alle ore piccole bevendo superalcolici. Unico suo vezzo era una collana di coralli. Al giorno d’oggi, tutto sommato, Caterina sarebbe una brava figliola un po’ ingenua e tuttavia con la testa sulle spalle. Ma se n’è perduto il ricordo e si perde ormai anche la canzone, che un tempo si cantava nelle aie, nei cortili, in aperta campagna, quando il canto corale spontaneo aiutava a socializzare. Ogni anziano che va all’altro mondo porta con sé un fastello i ricordi, un tesoro di umanità, un patrimonio di cultura orale che non viene più trasmesso alle nuove generazioni. Che bèla gràssia a ìga fam! Si stenta a credere che un tempo non lontano vi fossero persone quotidianamente assillate dal problema di come sbarcare il lunario, persone che mangiando a mezzogiorno un pezzo di pane o una fetta di polenta non erano sicure di potersi cibare anche di sera. Eppure la penuria di cibo era diffusa un tempo nei nostri ceti popolari, tanto che ai bambini i quali si rivolgevano alla loro madre dicendo: Mama, gh’ó fam!, la mamma rispondeva: Che bèla gràssia a ìga fam! Significava che in casa al momento non si disponeva di cibo. La risposta era necessariamente elusiva e consolatoria: la fame era una grazia, un segno di buona salute perché chi avvertiva i morsi della fame possedeva un organismo sano. Ma il dolore represso della madre che non poteva dare un po’ di cibo ai figli era immenso. Quando la gente ha fame i bei discorsi non servono e il ceto dirigente di una società afflitta da un simile problema deve fare tutto quanto è in suo potere per risolverlo. Se si pensa al problema della fame nel mondo si capisce bene che questa locuzione bergamasca è ancora di piena attualità. Che féra! È un’esclamazione che indica frastuono, confusione, caos, come avveniva nelle vecchie fiere annuali, tanto affollate che per aggirarsi fra le baracche occorreva talora farsi strada con i gomiti. Ora si potrebbe usare la stessa esclamazione pensando al caos di una globalizzazione pressoché indiscriminata, che degrada l’uomo a semplice consumatore e che impone surrettiziamente le sue brutali regole mercantili ai governi e ai popoli. Presentata come una sorta di panacea economica che avrebbe aumentato il potere di acquisto del ceto medio, potenziato le capacità produttive e moderato le rivendicazioni sindacali, non ha fatto altro che complicare i problemi. Basterebbe ricordare a questo proposito il saggio “L’orrore economico” di Viviane Forrester (1996), che denunziava l’uso distorto delle nuove tecnologie e le sue conseguenze sul piano economico e sociale. Si ha un bel dire che la globalizzazione va guidata. Nessun governo, nemmeno quello dello Stato più potente, appare in grado di affermare la preminenza delle scelte politiche su quelle economiche. Che fét, che fói? Durante le conversazioni in bergamasco si può talora udire la seguente locuzione interrogativa: Che fét, che fói? Esiste la variante Che fìv, che fói? A titolo di esempio traggo da “Suertèra” di Giuseppe Mazza detto Felìpo la seguente sestina: Fina ’n del mör col cóld / l’à fàcc öna capèla: / chèl taramòt bunànima / a l’à ’mbociàt gna chèla; / che fét che fói, consöm / de sólcc e de perföm. Letteralmente la locuzione suona in italiano: ‘Che fai? Che faccio?’. Oppure: ‘Che fate? Che faccio?’. Equivale al napoletano E mò che facimmo?, che tuttavia esprime incertezza e smarrimento. La nostra locuzione possiede invece un intento risolutivo: essa prelude infatti ad una considerazione conclusiva. Del resto, è nello spirito dei bergamaschi di arrivare ad una decisione, sia pure dopo essersi interrogati sul da farsi. L’interrogazione ha radici millenarie: sembra infatti riecheggiare il latino Quid faciam? Oppure Quid agam? D’altra parte, ricordiamoci dell’esortazione latina Queritate et invenietis, ‘Domandate e troverete’. Come trovare se non s’interroga? Poiché ruit hora, ‘l’ora incalza’, occorre sempre ègnen a öna, ‘addivenire ad una conclusione’. Così ecco che lo spirito dei bergamaschi, a cui non piace menare il can per l’aia, dopo aver detto Che fét, che fói?, pretende che si accantoni la retorica delle vuote parole e che si dia corso alla concretezza delle opere. Perché si sa che coi bèle paròle a s’ mangia mia. Chèl che böta böta. Bötà, ‘Germogliare’. Se non si semina non si raccoglie. Non è detto che si raccolga sempre e comunque: le avverse condizioni atmosferiche o le epidemie delle piante possono falcidiare le speranze. Ma occorre comunque seminare. Poi, quel che germoglia è sempre da accogliere con lieto animo. Così in ogni intrapresa esiste sempre un margine di rischio, che può dipendere dalla fatalità. Ecco perché si dice che quel che germoglia germoglia. Chèl del formài. Si legge in Sant’Isidoro di Siviglia che di certe parole non si conosce l’etimo in quanto con l’andare del tempo ci si è dimenticati della ragione per la quale sono state introdotte nell’uso. La stessa cosa vale per le locuzioni caratteristiche. Se riferendoci ad un villano o ad un tracotante diciamo che o prima o dopo a l’ troerà chèl del formài, ‘troverà quello del formaggio’, intendiamo dire che anche per lui arriverà il momento del redde rationem, quando uno più forte e più potente di lui gli assesterà una bella batosta o una salutare scardassata. Ma perché si dice così? Perché proprio ‘quello del formaggio’? Per quanto abbia scartabellato, non ho mai rinvenuto un solo accenno a questa simpatica e diffusa locuzione, che attesta indirettamente quanto importante sia stata (e sia tuttora) l’arte casearia nella pianura padana, arte rifiorita nell’evo di mezzo grazie alle aziende agricole dei cistercensi, i quali nelle loro biblioteche custodivano e consultavano i trattati di agricoltura del mondo antico. L’epopea anonima del lavoro dei nostri contadini che di generazione in generazione (nonostante tutti gli stranieri in armi arrivati per uccidere, distruggere, rubare e gozzovigliare) per tanti secoli hanno fecondato con il loro sudore la terra resa ferace dal Po e dai suoi molti affluenti evoca una lunga teoria di opere letterarie insigni che dalle “Georgiche” e dalle “Bucoliche” di Virgilio arriva fino al “Mulino del Po” di Riccardo Bacchelli, opera magistrale e magnificente di un autore sommo lasciato morire in estrema povertà perché troppo grande per poter essere capito dalle grette e ottuse camarille politiche e culturali italiane ed europee. Comunque, chi fosse quello del formaggio non si sa. Ma avendo domandato qua e là e dopo aver vagliato tutte le risposte mi sono fatto questa idea: a) che un formaggio come il grana, dal sapore eccellente e imitato invano, se lo sognano in tutto il mondo; b) che occorre avere una mano esperta per aggiungere alla pasta asciutta il formaggio grattugiato, perché il difetto e l’eccesso guastano irrimediabilmente il sapore del piatto; c) che essendo il formaggio di buona qualità abbastanza costoso, occorre grattugiarne poco ogni volta e saperlo spargere uniformemente sulla pasta. Chèl del formài sarebbe dunque una persona di grande rettitudine, un benefico riequilibratore, che insegnerebbe a non sprecare e che non esiterebbe a ricorrere a qualche metodo brusco pur di costringere certa gente a comportarsi bene e ad avere rispetto del prossimo. Se è davvero così, ben venga. Coi tempi che corrono… Chèl che l’ passa ’l convènt. Si vive nel mondo, immersi nelle vanità. Talora però accade di pensare ad una serena vita claustrale che anteponga la spiritualità alle cose corruttibili e finite, una vita nella quale i bisogni materiali si riducano allo stretto indispensabile, rifuggendo dal lusso e dall’ostentazione, che conducono all’orgoglio e alla superbia. Il convento fa bene a non dare di più di quanto sia riconosciuto dalla regola, accettata e condivisa da chi vive nella claustralità. Chi invece è nella mondanità avverte le privazioni come dei sacrifici e se gli pare scarso quanto riesce ad ottenere dice con rassegnazione che deve accettare ciò che passa il convento. Esistono però regole anche per chi vive fuori del convento e occorrerebbe farle rispettare. Se è vero che mediamente gli italiani trascorrono tre ore e mezza davanti al teleschermo, ci si sorprende che ci sia gente tanto priva di risorse da non sapere in quale altro modo trascorrere il proprio tempo. Anche se la diffidenza nei confronti dei sondaggi e delle statistiche è ampiamente giustificata, il dato sarebbe comunque abnorme anche se si trattasse di tre ore o di due ore e mezza, visto lo squallore della generalità dei programmi televisivi. La possibilità di cambiare canale non costituisce un’alternativa, data la pessima qualità di quasi tutta la programmazione. Ai telespettatori non resterebbe dunque che rassegnarsi ad accettare quel che passa il convento. Ma siamo proprio sicuri che la gente desideri vedere scene disgustose o irrispettose per quanto sensazionali, immagini crude e violente, programmi in cui si faccia sfoggio di insulti e di risse, trasmissioni condotte all’insegna della più odiosa e provocatoria faziosità, spettacoli in cui predominino insulsaggini, fatuità, pettegolezzi, vuoto mentale? Giustamente il noto epistemologo Karl Popper (1902-1994) accusò in un suo saggio la televisione di produrre violenza portandola nelle case, la definì una tremenda forza usata per il male e la stigmatizzò come un pericolo per la civiltà. Nessuno difende i diritti dei telespettatori, che per non accettare chèl che l’ passa ’l convènt anziché guardare la televisione per tre ore e mezza al giorno farebbero bene a non guardarla neppure per un minuto. Chèl che s’ vèd a s’ vèd. L’evidenza dei fatti non può essere negata. Voi potete ben argomentare ricorrendo ad ogni espediente dialettico ma se un fatto o un oggetto è lì da vedere non è il caso di tirare troppo la corda nel tentativo controproducente di alterare la realtà o di darne una rappresentazione diversa da quella reale. C’è un limite a tutto, compreso l’atto di tirar l’acqua al proprio mulino. Se ad esempio consideriamo la pubblicità televisiva, soprattutto quella che appare sulle reti a diffusione nazionale, risulta davvero difficile giustificare l’abbondanza dei glutei e di altre parti del corpo femminile, ostese come evidente richiamo sensuale; potranno arrampicarsi sui vetri nel vano tentativo di giustificare tanta ostensione ma chèl che s’ vèd a s’ vèd. Così lo sfruttamento a scopo pubblicitario dei bambini, usati per propagandare questo o quel prodotto, magari in modo diseducante (come se tutti i capricci dovessero essere soddisfatti), lascia davvero contrariati. È ben vero che il commercio va sostenuto e incrementato nell’interesse economico generale ma est modus in rebus: è proprio da come si è capaci di fare pubblicità che si mettono in luce l’intelligenza e il buon gusto (quando ci sono). Si vedono di quando in quando anche spot pubblicitari gradevoli e validi per tecnica e creatività, rispettosi dei sentimenti delle persone e dei valori della nostra civiltà. Del resto, la gente vede e giudica: se un programma non garba cambia canale e se non trova qualcosa di suo gusto, spenge il televisore. E fa bene. Ciò va detto anche per il modo con il quale si fa informazione: la gente vuole obiettività e completezza ma alcune notizie non vengono date, altre sono sfacciatamente manipolate e tutto è condito con una faziosità indigesta, che spesso ha toni rozzi e aggressivi. Si crede che la gente sia disposta ad accettare acriticamente ogni sorta di corbellerie. Ma la gente non è affatto cretina. Chèl sura i cóp. Si dice anche: Chèl sura i tècc. I nostri cugini lodigiani dicono: Nun comandem dai tècc in giù, dai tècc in su el comanda semper Lu. Il ricorso ad una locuzione eufemistica per indicare la divinità è antico quanto l’uomo, risale al tempo in cui l’uomo ebbe la nozione del timore di Dio, ossia del non fare cosa contraria ai comandamenti divini. La locuzione pone il buon Dio nel cielo ed assegna all’uomo la terra; il riferimento al tetto, alle tegole e ai coppi, sa di concretezza lombarda, di gente che ama la chiarezza in ogni rapporto, compresa la relazione fra spirito e materia, fra ciò che è di Dio e ciò di cui l’uomo dispone. Ma il detto sottintende i limiti del potere e della volontà dell’uomo, il quale deve rassegnarsi al destino, accettando ogni evento, anche il più doloroso, senza mai perdere la fiducia in Dio. I nostri vecchi possedevano una visione del mondo completa e ricca di risposte appaganti, avevano ben chiaro il concetto dei limiti umani, non si sognavano di divinizzare l’uomo e di privarsi dell’idea di Dio. Collocavano il Creatore sura i cóp perché avevano il senso della fralezza e della finitudine umana; da questa consapevolezza e dall’accettazione del divino traevano la forza per fronteggiare le difficoltà dell’esistenza padroneggiando le situazioni. Si è diffusa l’etica del finito, si crede da tempo nell’onnipotenza della tecnica e ci s’illude che, rimuovendo l’idea del dolore e della morte, si possa vivere senza mai pensare a Chèl sura i cóp, salvo finire poi totalmente spersonalizzati nelle ubriacature collettive. Ciapà di racc. I milanesi hanno un modo sbrigativo di togliersi dagl’impacci: mandano le persone importune a catturare topi. Ma và a ciapà di ratt! È la metaforica e perentoria esortazione con la quale infatti troncano un discorso inutile, inopportuno o sgradito. Forse perché l’acchiappare ratti è mestiere da gatti. Ma sottovalutano o non considerano la destrezza e la rapidità felina necessarie per afferrare un topo, cosa che i bergamaschi invece hanno ben presente. Tanto è vero che di uno che sia tonto o stordito dicono ironicamente: A l’ ne ciaperà tance de racc, chèl lé! E per un bergamasco che nutra un giusto concetto del lavoro è quasi disonorevole essere apostrofato in siffatto modo. Si è diffuso da alcuni decenni, caparbio e mendace come ogni diceria, il luogo comune che farebbe del bergamasco (ma anche del bresciano e del brianzolo) un lavoratore tanto ottuso quanto accanito: scansafatiche e parassiti (che non mancano in questa Italia dove non sempre esiste una grande disposizione al lavoro) si divertono a dipingerci come dei mangiatori di polenta e dei provincialotti rozzi, chiusi in un arcaico isolamento e tutti tesi soltanto a far denaro. Luogo comune falso e offensivo. Veniamo nostro malgrado annoiati e disgustati da chi blatera di una provincia ricca e opulenta, dove non si fa altro che accumulare il risparmio, dove si nuota in un benessere sfacciato e si sciala come a Bengodi: tutta colpa, dicono i saccenti osservatori, dell’eccessivo peso che avrebbe ancora la proverbiale laboriosità della nostra gente. In realtà c’è sempre qualche smargiasso il cui faticoso impiego consiste unicamente nell’osservare ciò che fanno gli altri nel tentativo di coglierne un sia pur minimo difetto e ciò dimostra che anche nel nostro tempo, come già in passato, c’è chi lavora tanto e chi non fa niente. Capita spesso che il nullafacente, oltre che farsi mantenere, salga in ringhiera con la pretesa d’insegnare come si debba lavorare. Possono mutare i sistemi politici ed economici, possono cambiare i mercati e le occupazioni ma l’intraprendenza e la voglia di lavorare non possono essere messe in discussione, soprattutto dagl’incapaci e dai lavativi. Non occorre una laurea in economia per capire che se si vuol prendere un topo bisogna darsi da fare e non stare con le mani in mano. Diceva Confucio: “Se dai un pesce a chi ha fame lo salvi per un giorno ma se gl’insegni a pescare è come se tu gli dessi da mangiare per tutta la vita”. L’unica vera materia prima di cui disponiamo è il lavoro e ringraziamo i nostri vecchi che ci hanno insegnato a lavorare. Di un imbambolato o di un lavativo, scuotendo la testa, loro dicevano ironicamente: A l’ ne ciaperà tance de racc, chèl lé! Ciapà i laùr sóta gamba. Si sa che non si deve prendere alcuna cosa sotto gamba. Come si può lavorare tenendo le mani sotto le gambe? È da irresponsabili, da persone vanesie e vanitose, che presumono di affrontare ogni problema con la sufficienza degli sciocchi e degli spacconi. La locuzione ben si attaglia, ad esempio, a quanti credono di poter gabbare le leggi della natura. Una pubblicazione dedicata al parco nazionale del Gran Paradiso detta le seguenti regole da rispettare: 1) lasciare in pace gli animali selvatici; 2) non entrare nel parco con cani, nemmeno al guinzaglio; 3) non toccare e non asportare minerali, fiori e insetti; 4) non spargere al suolo eventuali rifiuti ma portarli con sé; 5) accendere fuochi e installare tende solo nei luoghi autorizzati; 6) non lanciare grida, evitare i rumori e non fare musica ad alto volume; 7) stare sui sentieri e sulle mulattiere e non entrare nei boschi. È triste e avvilente, compiendo un’escursione sulle nostre montagne, dover constatare la diffusa maleducazione e il menefreghismo di chi prende sotto gamba la natura gettando al suolo mozziconi di sigarette, cartacce, bottiglie di vetro e di plastica, lattine e scatolette metalliche, piatti e sacchetti di plastica. Incoscenti e villani potrebbero trasformare il mondo in un’immensa pattumiera. Speriamo che le nuove generazioni siano sensibilizzate ad un comportamento civile e responsabile così da prendere le cose sul serio rispettando e amando la natura, che non manca mai di vendicarsi quando viene offesa. Ciapà i sólcc coi mà de dré de la schéna. Sembra di poter cogliere in questa locuzione un vivo senso della realtà, un tratto di arguta e sottile psicologia nel rassegnato e disarmante gesto di chi, non potendo concludere un affare a suo vantaggio, si trova costretto ad accettare il poco che gli verrà elargito. Corre una bella differenza fra il ricevere del denaro stendendo una mano davanti a sé e l’appoggiare le mani aperte dietro la schiena senza poter vedere ciò che vi viene posato. Ma quando si è costretti ad accettare un’offerta bassa, quasi che ci si debba affidare al buon cuore altrui, non resta altro che far bel viso a brutto gioco; a volte la necessità immediata di denaro liquido costringe infatti alla svendita. Può anche accadere che un debitore non sia più in grado di far fronte al suo impegno e che l’entità della somma non sia tale da comportare un recupero aleatorio gravato dall’onere delle spese giudiziarie. Oppure che il debitore sia fallito e che sia già una fortuna riuscire a recuperare una minima parte del credito. Non sempre i conti tornano e la giustizia va a farsi benedire. Fatto sta che non di rado accade a questo mondo che s’ ciape i sólcc coi mà dedré de la schéna. E per dirla in bergamasco, l’è mia ü bèl ciapà. Ciapà ü stremésse. Si traduce letteralmente: ‘prendere uno spavento’. In bergamasco coesistono spaènt (da expavere) e stremésse (da extremiscere, che ha generato anche il castigliano estremecer e il provenziale estrementir). Còl de furca. Letteralmente ‘collo da forca’, ossia, secondo il buon italiano, ‘pendaglio da forca’ o ‘arnese da forca’, perché un tempo per impiccare i condannati a morte veniva eretta sul patibolo una vera e propria forca. ’Ndà sö la furca è locuzione popolare ormai caduta in disuso, perché la civiltà ha cancellato una pena tanto barbara quale l’impiccagione, che la corte di Vienna si ostinò ad applicare fino alla sconfitta della prima guerra mondiale: l’impiccagione di Cesare Battisti, avvenuta nel 1916 presso il castello del Buon Consiglio di Trento, rimane come una macchia d’infamia sulla fosca memoria di Francesco Giuseppe e del suo retrivo governo. La locuzione còl de furca è riferita sempre a persona prepotente, ladra e ingannatrice, che creda di potere a suo piacimento travolgere chiunque incontra sulla propria strada. Gente simile a volte fa carriera finendo per fare danni enormi; altre volte invece viene fermata e paga il suo conto con la giustizia. Le cronache dei secoli passati documentano l’eccessiva severità e la crudeltà delle pene inflitte. Ora invece prevalgono non di rado sentimenti di buonismo ipocrita, che inducono a pene eccessivamente miti rispetto all’efferatezza e alla brutalità dei delitti commessi. I nostri vecchi mandavano volentieri sulla forca (soltanto in senso figurato) chi li contristava o chi li infastidiva. Il Tiraboschi nel suo vocabolario ottocentesco riporta la locuzione imperativa Mandà sö la furca ed esemplifica così: Và sö la furca! e Và ’mpìchet! E richiama il francese Va te faire pendre!, ‘Vai a farti impiccare!’. Come dàga i biscòcc a l’àsen. Si dice quando non vale la pena di aiutare, anche solo con buoni consigli, persone rozze e ignoranti. Sarebbe come dare i biscotti all’asino, che preferisce un cibo molto meno raffinato quale l’erba o il fieno. Perché sprecare il fiato ed affannarsi a spiegare certi concetti a chi non è in grado di capirli? Ne “Il cane di terracotta” (1954) Concetto Marchesi scrisse: “Nessuno ascolta per intero un discorso; e se sta attento, si ferma a un punto e di là comincia a riflettere o a fantasticare per proprio conto. Non bisogna far lunghi discorsi a nessuno. La gente, anche quando ci rivolge una domanda, pensa già a un’altra cosa e vuole parlare, non ascoltare. Se volete saziare il cuore degli uomini fingete di ascoltarli, se volete raddrizzarne le orecchie adulateli oppure offendeteli: e non date consigli, soprattutto gratis: chi dà un consiglio gratuito è un pazzo che farnetica davanti a un sordo”. Come i è lónghe i nòcc de Milà! È una forma esclamativa alla quale si ricorre per indicare che un discorso, uno spettacolo, una faccenda si stiano protraendo oltre il consentito o il dovuto. L’origine del detto è scherzosa. Si narra che Gioppino si fosse recato una volta a Milano ed avesse pernottato in una locanda con la Margì, sua moglie. Svegliatosi di buon mattino com’era suo costume, Gioppino pregò la consorte di alzarsi e di affacciarsi alla finestra per vedere se gh’éra egnìt ol ciàr, ‘se il cielo si era schiarito’. La Margì, donna buona e virtuosa ma un po’ sempliciotta, anziché la finestra aprì per sbaglio l’anta dell’armadio e disse: Gh’è amò töt fósch, ‘È ancora tutto buio’. Al che Gioppino replicò: ’É ’n nana che m’ dórma amò ’mpó, ‘Vieni a letto e dormiamo ancora un poco’. Risvegliatosi dopo qualche tempo, Gioppino disse alla Margì: Té, Margì, ‘n piassér, próa àrdega se adèss a gh’è egnìt ol ciàr, ‘Margherita, per piacere, prova a vedere se adesso il cielo si è rischiarato’. La donna, muovendosi al buio, anziché aprire la finestra, aprì ancora l’anta dell’armadio e disse: Gh’è amò töt fósch. Infine, questa scena avvenne per la terza volta e Gioppino allora esclamò: Come i è lónghe i nòcc de Milà!, ‘Come sono lunghe le notti di Milano!’. Come l’è bassa la tèra! In realtà la terra non è bassa ma se ci dobbiamo chinare a raccogliere un oggetto che ci è caduto e se non abbiamo più la scioltezza dei vent’anni ci vien fatto di credere che lo sia. Come l’è lónga l’Italia! L’esclamazione è usata per indicare quanto sia lungo l’oggetto di cui si sta parlando, per lo più una cosa fisica (ma può anche alludere ad una situazione o ad una vicenda caratterizzata da una lunghezza estenuante). Il detto sottintende la consapevolezza della realtà geografica della Penisola, la ricchezza della sua storia e dei suoi monumenti, la varietà delle sue culture regionali e municipali. Il nome Italia è documentato per la prima volta dalle monete federali dei latini durante la guerra sociale e significherebbe ‘terra dei vitelli’: gli autori romani sostengono che ίταλος era il nome del vitello nella lingua delle colonie greche d’Italia; in Varrone si legge: Boves græca vetere lingua ίταλοί vocitati. Elia Lattes, noto etruscologo, volle invece avvicinare il toponimo Italia al latino vitis (cosa foneticamente insostenibile), pensando al nome Italo, mitico primo re degli Enotrii, antichi abitatori dell’Oenotria, ‘terra del vino’, nome di stampo greco. In realtà l’ipotesi più convincente è ancora e sempre quella di una forma greca νταλία (o ίταλία per effetto del dileguo della iniziale debole), che i cittadini della Magna Grecia dovettero derivare dall’osco Viteliu- o da una più antica voce italica Vitalia e chissà che prima dell’arrivo dei celti, scesi in massa dai valichi alpestri per contendere agli etruschi la pianura padana, le tribù umbroliguri stanziate nell’Italia Settentrionale usassero anch’esse questa parola. L’origine dotta dei termini Italia e italus ne determina l’uso prevalentemente letterario e aristocratico durante tutta la latinità. La nozione d’Italia come entità fisica e culturale sopravvive alla caduta dell’Impero Romano ed è ben presente ai re barbarici: alcuni di loro vorranno cingere la corona di re d’Italia in San Michele a Pavia e Dante indica i confini geografici della nazione italiana. Con la sua autorevolezza egli dà vigore e forza all’uso del latinismo Italia e lo proietta dal Medio Evo al Rinascimento attraverso i pionieri dell’Umanesimo. Così l’idea dell’Italia non si estingue più e diventa patrimonio comune di tutte le contrade e di tutte le genti che popolano la Penisola, fiera ciascuna delle proprie tradizioni municipali e della ricchezza della sua storia ma tutte affratellate nell’insofferenza alla dominazione straniera. Goethe s’imbarca a Torbole per attraversare il Garda e si commuove all’idea che sulla bellezza dei monti e sull’incanto delle acque si sia posato un tempo lo sguardo del sommo poeta latino (“Poche cose sono cambiate e lo stesso vento agita il lago nobilitato dal verso di Virgilio”). Lunga e meravigliosa Italia, desiderata e amata da uno stuolo di poeti e di scrittori: Byron, Chateaubriand, Flaubert, la Sand, Lamartine, Sthendal, Taine, Heine, Shelley, Saint-Beuve, Pound, il Gabriel Faure delle “Heures d’Italie”… De Musset cantò: Aimable Italie, / Sagesse ou folie, / Jamais ne t’oublie / Qui t’a vue un jour. Anche i bergamaschi sono grandi viaggiatori e conoscono bene l’Italia. In ogni città è traccia di un loro passaggio, di un loro soggiorno, di una famiglia che lasciando la terra orobica nei secoli passati vi si stabilì facendo fortuna. Come ’l mülì de la Petós. Petós (da pronunziare con l’accento tonico sul suono chiuso della o per rispetto dell’autenticità della toponomastica spontanea) è una località del Comune di Sorisole, all’imbocco della Valle Brembana. Dante Olivieri nel suo “Dizionario di toponomastica lombarda” ipotizzò una derivazione da una famiglia de Petosis. Ma generalmente è la famiglia a prendere il nome da quello del luogo e non viceversa. Pèta è un’antica voce lombarda, forse prelatina, che denomina sempre strade, percorsi o luoghi in salita. Accanto alla Petós si trova la frazione Petosino, che all’origine doveva essere un piccolo abitato, altrimenti non si spiegherebbe la forma diminutiva. Toponimi a parte, il mulino esisteva davvero ed è documentato da carte dei secoli passati. Era mosso dalle acque, per il vero esigue, della Quisa, un torrentello che discende dalle pendici del Canto Alto e che s’immette nel Brembo dalle parti di Ponte San Pietro. Accanto al mulino esisteva una bettola piuttosto malfamata, frequentata da gente losca e da donne di malaffare. La bettola fu oggetto di dure contese fra il Comune di Bergamo e quello di Ponteranica più per questioni daziarie che per ragioni di ordine pubblico e di buon costume. Ma a noi interessa il mulino, che doveva essere un impianto di modeste capacità produttive: macinava quantitativi piuttosto bassi di granaglie perché la spinta dell’acqua era debole. Ecco perché è nato il detto: Come ’l mülì de la Petós ó fàcc a’ mé chèl póch che pòss, ’Come il mulino della Petós ho fatto anch’io quel poco che posso’. Udii questa locuzione dal dottor Giacomo Alessandro Gavazzeni, primario emerito del nostro ospedale civile. Mi aveva mandato una copia dei suoi “Sonetti bergamaschi” e gli avevo telefonato per ringraziarlo. Alle mie espressioni di compiacimento, con la sacrosanta ritrosia e la signorile modestia dei bergamaschi di un tempo rispose pronunziando la locuzione del mulino della Petós. Gentiluomo e signore dei vecchi tempi, di uno stampo che si è perduto nel mare odioso delle albagie e delle presunzioni, delle ambizioni stolte e dei dilettantismi volgari. Come robà ’l lard a la gata. Se dobbiamo dare un giudizio negativo su un affare che viene ingenuamente prospettato come vantaggioso e che in realtà è destinato miseramente a fallire lasciando a mani vuote chi lo intraprende, possiamo dire: L’è come robà ’l lard a la gata. Quando la gatta ha rubato il lardo, nessuno più riesce a sottrarglielo. Come s’ fà a parlà. Bisogna sempre sapere come adoperare le parole, che, considerate una per una, sono soltanto flatus vocis, pure e semplici combinazioni di suoni. La parola in sé non è né bella né brutta ed è assurdo pretendere di applicare categorie estetiche alle lingue e ai suoni del loro lessico. È invece possibile capire l’indole di una persona da come si esprime, dalle parole che usa quando parla. Sulla questione della lingua disse magistralmente la sua il milanese Carlo Porta, al quale riferirono le insulse parole di un certo Gorelli, un quidam del popolo senese che si era impiegato presso il tribunale di Milano: costui si era stracciato le vesti sentendo dire che il Porta scriveva le sue poesie in milanese anziché in italiano. Il grande poeta ambrosiano lo dileggiò trattandolo da persona stolta, incapace di distinguere il valor estetico di un’opera indipendentemente dalla lingua usata. Dell’arte di esporre i concetti con parole acconce sono edotti gli uomini di legge. In alcuni luoghi della Bergamasca si suole ironicamente sostituire il verbo parlà con il verbo baià, ‘abbaiare’. Una volta un vecchio gandinese, a proposito di una questione che avrebbe potuto prendere una piega favorevole o sfavorevole a seconda di come sarebbe stata esposta, mi disse: A l’ dipènd töt de come s’ fà a baià… Come sircàga la pistóla ai frà. Si dice quando si pretende di poter ottenere da qualcuno ciò che non ha. Si sa bene che i frati non hanno rivoltelle e che non si va da loro per imparare a sparare. Cöntà come l’ómbra d’ün àsen. Di una persona che non goda di alcuna considerazione e che non abbia alcuna voce in capitolo si dice che conta come l’ombra di un asino. Da che mondo è mondo, questo animale è disprezzato; figuriamoci che valore potrà essere attribuito alla sua ombra. Cocciuto ma paziente, l’asino ha tenuto compagnia all’uomo per millenni. Nel passaggio dall’economia prevalentemente agricola a quella industriale il rapporto con gli animali è assai mutato: molti ragazzi, privi di contatti con la natura, avranno un’idea dell’asino per averne visto degli esemplari seguendo i programmi televisivi. In compenso si è formata da tempo una sensibilità verso gli animali: si sono levate voci contra la caccia, contro l’utilizzo dei tori nelle corride, contro l’abbandono dei cani e dei gatti nelle ferie estive, contro la cattività degli animali degli zoo e dei circhi equestri. È un fatto che quando Noè costruì l’arca per scampare al diluvio universale, non abbandonò gli animali al loro destino ma si preoccupò di salvarne le specie. Così gli uomini si giudicano anche da come trattano gli animali, che a volte subiscono dei torti senza potersi né lagnare né difendersi. Perché negare un sentimento alle bestie se la colomba ritornò a Noè recando nel becco un ramoscello d’ulivo e se il gatto riesce ad esprimere la sua gratitudine con le fusa all’uomo che gli dà del cibo? Cöntà come Pilato ’n del Credo. Significa ‘non contare alcunché’: nella formula del Credo il richiamo a Ponzio Pilato ha infatti un valore puramente temporale. Recita il testo latino: Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Vuol dire che Gesù affrontò la sua passione e fu sepolto essendo Ponzio Pilato governatore della Palestina. In realtà il legato di Tiberio si rese conto che Gesù era innocente e tentò di sottrarlo al supplizio della croce ma cedette innanzi all’ostinazione dei sacerdoti del sinedrio e alla canea urlante dei loro sostenitori. Impensierito dal ricatto dei sacerdoti, che minacciavano di riferire l’ingerenza di Pilato all’imperatore, il procuratore romano compì il gesto plateale di lavarsi le mani per non coinvolgere nell’ingiusta condanna la sua carica e il potere che rappresentava e per lasciare tutta la responsabilità della decisione agli stessi sacerdoti e ai loro accoliti. Cöntàla sö. Vuol dire ‘fare conversazione’, esigenza sociale primaria. C’è gente scorbutica o impacciata che rifugge dal comunicare con il prossimo. Ma c’è anche gente che non sa conversare. Quanto è seccante imbattersi in persone che fanno il catalogo di tutti i loro malanni e del modo di curarli! Dopo aver descritto meticolosamente i loro disturbi fisici, si dilungano sull’efficacia delle cure e sembra quasi che ti augurino di avere le stesse malattie per avvalerti delle stesse cure. A volte succede di trovarsi coinvolti, a tavola o in salotto, in discussioni su argomenti intorno ai quali è lecito avere opinioni diverse. C’è purtroppo gente che crede di saperla lunga in politica soltanto perché legge un giornale di un certo colore o perché segue un telegiornale truffaldino che dà notizie manipolate a favore di questo o di quel partito. Bisogna allora sudare le sette camicie per far capire all’interlocutore che è meglio dirottare la conversazione verso altri orizzonti per non essere costretti a litigare. C’è anche chi parla soltanto di se stesso, delle sue faccende, dei suoi viaggi, del film che ha appena visto o del libro che ha appena letto, del gioco che preferisce, del mestiere che fa, proponendosi come modello per l’intera umanità. Si tratta di individui miseri, aridi e scialbi, assolutamente noiosi e fastidiosi, come sanno essere anche quanti monopolizzano la conversazione con un profluvio incessante di parole impedendo agli altri di pronunziare una sola frase. Desolante e catastrofico è poi il dover sopportare una persona che pretenda d’infliggere al prossimo le mille astrusità e le infinite scempiaggini dell’astrologia, argomento superficiale, insignificante e avvilente quanto l’indugio sulla meteorologia (possiamo parlarne fino a domani ma ol tép a l’ fà chèl che l’ völ e se ne infischia dei nostri blateramenti). Non si dice poi dei maleducati, degl’ingrati e dei villani che con la levità di un elefante o di un ippopotamo si ostinano a parlar male della città nella quale sono capitati a vivere, dicendo peste e corna degli abitanti: se ci si trovano tanto male, perché non tolgono l’incomodo liberandoci della loro presenza? Fare conversazione, insomma, non è da tutti ed è un’autentica fortuna il potersi intrattenere con persone colte, garbate e amabili, che sappiano trovare per ogni argomento le parole adatte. Anche il motto di spirito va contenuto entro il lecito ed è tanto più apprezzato in quanto attinga all’arguzia piuttosto che al sarcasmo. Fecero scuola nell’antichità gli ateniesi, i quali, saputo che il tiranno Diogene era morto di gioia per il premio conferito ad una sua commedia proprio ad Atene, dissero: “Se lo avessimo immaginato, lo avremmo premiato vent’anni fa…”. C’è modo e modo, dunque, de cöntàla sö. La conversazione dovrebbe sempre comportare un arricchimento interiore e costituire una ricreazione dello spirito. Ma forse si pretende troppo. Cöntà sö di bale. Di uno che vada raccontando frottole diciamo che l’ cönta sö di bale; se viene a raccontarci le sue fole per farci credere il falso diciamo che l’ me té a bale e se vuol far credere di essere quel che non è diciamo che l’istà ’n pé a bale. Di un bugiardo che le va sparando grosse diciamo che l’è ü balù, che equivale al balista dei milanesi. Certi etimologi ritenevano che balla nel senso di ‘panzana’ fosse voce longobarda ma come tale non risulta attestata. Si sa però che il verbo altotedesco bollen significa ‘favoleggiare’ e nel suo “Glossarium mediæ et infimæ latinitatis” il Dufresne annotò la voce franca bal per ‘falso’. Segno che al tempo del regno dei Franchi l’arte de cassà di bale rendeva. Da allora ad oggi l’alfabetizzazione è progredita e la cultura si è diffusa; ciò nonostante, oggi più di allora trova credito chi sa trarre profitto dall’arte de cöntà sö di bale. Basta considerare il successo incontrato in questi anni dai libri e dai film ispirati agli esoterismi, alle vicende dei templari, alle suggestioni massoniche e alle fandonie narrate da personaggi discussi come Joséph Péladan, che non si peritò di proclamarsi discendente degli antichi re di Babilonia e di alimentare la leggenda del Sacro Graal. Così gli eroici cavalieri templari, i quali si erano assunti il gravoso compito di proteggere i pellegrini che si recavano al Santo Sepolcro dalle razzie e dalle stragi dei musulmani, sono stati erroneamente raffigurati come una sorta di società segreta ricchissima e dedita a chissà quali riti esoterici. La realtà storica è assai lontana dalle falsità spudorate e dalle grossolane mistificazioni con le quali si è creduto di poter romanzare le vicende di un glorioso ordine cavalleresco. Contro ogni evidenza i templari sono stati dipinti nel peggior modo possibile e si è quasi aureolato il loro criminale persecutore, l’ambiguo e spregiudicato Filippo il Bello, che li calunniò accusandoli di eresia al solo scopo di confiscare i loro beni. Allo stesso modo, sull’onda di un confuso e superficiale medievalismo, Dan Brown ha scodellato un’indigesta brodaglia di menzogne e di fantasticherie che fanno a pugni con i documenti storici abusando oltre ogni limite della credulità e dell’impreparazione di troppi lettori, digiuni di studi severi. Con quale incredibile leggerezza si è alterata e tradita la verità storica per sostenere tesi false e tendenziose! Dal che si evince come la capacità de cöntà sö di bale possa assai giovare economicamente all’autore e agli editori, anche se travisa ed offende la verità ingannando i lettori. Ma che cosa volete che importi della verità a chi l’ gh’à interèss a cöntà sö di bale? È un fatto però che s’ pöl mia stà sèmper in pé a bale. O prima o poi la verità smaschera la frode. Cöntà sö ’l ròn e ’l còn. ‘Narrare per filo e per segno’. È locuzione caduta da tempo in disuso. Sopravvive: Cöntà sö (o saì) ’l percóme e ’l perchè, che ricorda il francese: Se rendre compte du pourquoi et du comment. Ho però udito una volta una signora dire che voleva sapere tutto di una certo avvenimento invitando la sua interlocutrice a narrare ogni cosa col ròndom e ’l quòndom. Nel poemetto “Olter desgrazi de Giovannin Bongee” di Carlo Porta alla LVIII ottava si legge il verso: …che innanz dì la saveva el comm el romm… Copà ’l pöles per vènd la pèl. Uccidere la pulce per venderne la pelle: è il colmo dell’avidità e dell’avarizia. Il detto si attaglia a persona avara ed esosa, intenta soltanto ad accumulare beni e sostanze che dovrà inesorabilmente abbandonare al momento della morte. Se di un tale diciamo che l’ cópa ’l pöles per vènd la pèl intendiamo deprecarne la sordidezza dell’animo e l’abiezione dell’intelletto, stigmatizzarne la paradossale taccagneria, esprimere una condanna senza appello per uno dei vizi più riprovevoli che possa degradare un essere umano. L’idolatria dell’oro indusse nella Milano spagnola un nobile della ricchissima famiglia degli Archinto ad entrare ogni giorno nella cameretta nella quale egli aveva adunato i suoi tesori per trascorrere un’ora nella contemplazione delle monete, dei gioielli e di tutti gli altri oggetti preziosi che vi aveva adunato. Una volta però, dopo aver richiuso la porta della stanza, non riuscì più ad aprirla e fu assalito dal terrore. A tarda notte fu liberato da un domestico, il quale aveva notato la sua assenza. Ma lo spavento fu tale che il giorno dopo il nobile ne morì. Cör alégher, vià ’l magù. Se il cuore è allegro, l’accoramento viene accantonato. Condizione privilegiata dello spirito, il cuore allegro sa fare di necessità virtù ed accetta il vivere quotidiano con tutti i suoi problemi e i suoi grattacapi. Un persistente umor nero fiacca il carattere e avvelena l’anima. Chi è ottimista dispone sicuramente di risorse interiori, può contare su di una forza d’animo che gli consente di affrontare le difficoltà e di superare gli ostacoli. La serenità è parente del buonumore. A volte basta una garbata battuta di spirito per rasserenare l’atmosfera e rinvigorire il morale. I nostri vecchi all’occorrenza erano motteggiatori arguti e solo se presi per i capelli ricorrevano agli strali dell’ironia e del sarcasmo. Ma la capacità di motteggiare implica la disposizione ad osservare e a riflettere, doti sempre più rare quando dominano la fretta e la superficialità. Costà ün öcc del có. Letteralmente: ‘Costare un occhio della testa’. Si dice quando un costo appare molto spropositato. In Val di Scalve si dice: Costà la lüs d’ün öcc. Crapa de àsen. Significa ‘testa d’asino’ e non è un complimento. Con questa locuzione ci si riferisce a persona ottusa, incompetente e testarda. La mitologia greca ha tramandato la leggenda della gara musicale fra il dio Apollo, che suonava la cetra, e il dio Pan, che suonava la siringa. Lo strumento di Pan poteva solo eseguire melodie mentre quello di Apollo era più evoluto, poteva infatti sostenere la linea melodica con il ricorso agli accordi e quindi si avvaleva dell’armonia. Il giudice Temolo conferì la palma della vittoria al musagete e il nume dalle zampe caprigne accettò di buon grado il verdetto, considerando un onore l’essersi potuto esibire con il nume di Delo. Chi volle contraddire la sentenza fu Mida, il favoloso re di Tracia, presente alla gara. Si atteggiò a critico, esaltò l’esecuzione di Pan ed ebbe parole di disprezzo per Apollo, il quale, adontatosi fieramente, gli disse: “Le tue orecchie insensibili non sono degne della mia musica”. E si vendicò trasformando le orecchie del re in quelle di un asino. Crapa de cünì. È un insulto generico, che intende significare le scarsissime capacità intellettuali della persona alla quale ci si riferisce. Da una testa di coniglio non c’è molto da aspettarsi. Non di rado simili cervici si annidano negli anfratti del mastodontico, costoso e inefficiente apparato burocratico pubblico. Si sa che il linguaggio della burocrazia centralista è distaccato e involuto, evidentemente perché lontano dallo spirito di servizio di cui dovrebbe essere permeato. Ebbene, tempo fa qualche mente non propriamente eccelsa dettò la sua ricetta emanando raccomandazioni lesive dell’intelligenza e del buon senso: si credette infatti di semplificare il linguaggio della burocrazia vietando l’uso del gerundio e della consecutio temporum nelle comunicazioni al pubblico. Che bisogno c’è di ridurre l’italiano ad un linguaggio da plebei? Ci vuol altro perché la pubblica amministrazione capisca che esiste in quanto esistono i cittadini, dei quali è al servizio. Crapa del Gòti. Se di un tale, dopo averne soppesato i discorsi o valutato il comportamento, diciamo, certamente con poca indulgenza, che l’è öna crapa del Gòti oppure che l’ gh’à sö la crapa del Gòti intendiamo riferirci alla sua scarsa capacità di comprendonio. In italiano si potrebbe tradurre ‘testa di legno’ o meglio ‘testa di burattino’. Nella seconda metà dell’Ottocento il burattinaio Giuseppe Gotti teneva spettacoli di burattini in un locale delle vecchie Beccarie, nell’attuale Via Mario Lupo a Bergamo Alta. Oggi non si sa più quanto fosse popolare allora il teatro di figura e come fossero abili i burattinai, i quali provvedevano non soltanto ad imbastire i canovacci e ad inventare le battute di spirito con le quali ravvivare i dialoghi dei vari personaggi ma costruivano inoltre la baracca, dipingevano le quinte ed intagliavano nel legno i loro fantocci. La rappresentazione raggiungeva il culmine quando Gioppino risolveva gl’intrighi a suon di randellate, che calavano inesorabili sulle crape dei prepotenti. Il burattinaio Gotti ricavava i suoi burattini dal legno di noce, che per la sua durezza poteva resistere senza scheggiarsi alle sonore bastonate di Gioppino. Circa il fatto che esistano autentiche teste di legno, si deve sempre considerare che il buon Dio, nella sua infinita imperscrutabilità, non ha dato a tutti la stessa intelligenza. Altrimenti avrebbe creato un mondo di geni, di persone sagge, colte e intelligentissime. Come avremmo allora potuto distinguere le persone gentili, sapienti e riguardose dagl’ignoranti, dai prepotenti, dagli avidi, dagli spregiudicati, da tutti quelli che usano male la loro intelligenza? Non è importante essere dotati di un’intelligenza enorme. Ciò che conta è saper usare bene quella che si ha, tanta o poca che sia. Crèd de saìghen. Credere di saperne: è l’eterno dualismo pratica-grammatica. Un conto infatti è l’erudizione libresca e un altro la conoscenza diretta, per experientia. Se l’intellettuale non mantiene un contatto costante con la realtà, che senso ha per lui l’avere studiato? Se una persona fornita di altisonanti titoli di studio non sa piantare un chiodo o sostituire una lampadina si dice che l’à stödiàt issé tat che l’ crèd de saìghen, ‘ha studiato tanto che crede di saperne’. La cultura nozionistica ha i suoi limiti: ci vuol altro per saper innestare un albero, per capire se un cavallo è ammalato, per concimare la vite, per affilare una falce fienaia. La cultura contadina si prendeva così la sua rivincita sulla spocchia degli eruditi. Ora, mutati i tempi, l’intellettuale è chiamato a rivendicare il primato della persona sullo Stato, a difendere la democrazia e la libertà, a sostenere la verità, a diffondere la solidarietà, a salvare le identità culturali. Altrimenti a che cosa serve la sua cultura? A pretendere di illuminare l’universo con un fiammifero? Crèpa pansa ma mia ròba ànsa. Questa forma imperativa appare più perentoria della versione che dice: Piötòst crepà che ròba ansà, ’Piuttosto crepare che avanzare qualche cibo’. Il motto è retaggio dei tempi della fame, quando una lauta imbandigione era evento tanto raro da indurre i commensali a rimpinzarsi a più non posso. Per creanza non si rifiutava alcuna portata e si mangiava a quattro palmenti, divorando anche le briciole. Dice un proverbio: A tàola gh’è mia de fàs pregà, ‘A tavola non ci si deve far pregare’. Sovviene un motteggio di Gioppino, il celebre burattino bergamasco, il quale, provvisto di una fame insaziabile, credeva di giustificare la sua pantagruelica voracità esclamando: Con piö che mange con piö che l’ me ’é fam!, ‘Più mangio e più mi vien fame!’. Autoironia delle generazioni di un tempo, che della fame avevano un’esperienza diretta? Mi disse una volta un tale fra il serio e il faceto: “Da ragazzo ho provato molte volte la fame perché la mia famiglia viveva di stenti: la nostra miseria era tanto nera che quando finalmente ce ne liberammo e riuscimmo a riempire la dispensa festeggiammo l’evento mangiando e bevendo per un giorno intero”. Ora, in tempi di consumismo e di sprechi, di anoressiche e di schizzinosi, forse solo chi ha provato i morsi della fame o chi ha guardato negli occhi la gente affamata può capire questa locuzione all’apparenza paradossale. Crèss la paga ai sifuladùr. Riferendosi a chi fischietta per lungo tempo si dice: I gh’à cressìt la paga ai sifuladùr, ’Hanno aumentato la paga ai fischiatori’. Si sa che al tempo del passo degli uccelli chi esercitava l’aucupio con il roccolo poteva avvalersi di persone la cui abilità consisteva nel richiamare i volativi imitandone perfettamente il verso con il fischio. Crus e medaie. La locuzione si completa aggiungendo: ciócc e picaie. Croci e medaglie vogliono chiodi e appendini, chiodi per appendere le croci e appendini per attaccare le medaglie. Le croci rappresentano i dolori e le medaglie i riconoscimenti dei meriti acquisiti. Ma i dolori non si possono riporre come si fa con le medaglie. Il detto ricorda che ai piaceri e ai complimenti seguono fatalmente le ambasce e i rimproveri. Dà d’intènd che ün àsen a l’ vule. Anche in italiano si censura la credulità dicendo: Vola l’asino e tutti corrono a vedere. Perché proprio l’asino? Bella domanda! Perché dice il proverbio: Chi nass àsen a l’ mör möl, ‘Chi nasce asino muore mulo’. Qualcuno stizzito domanderà: Che risposta è mai questa? Non è altro che il rimando allo spirito di osservazione e di riflessione dei nostri antenati, che amavano l’ironia bonaria, mite e serena. Leggo fra i pensieri che Ugo Ojetti pubblicò nel 1937: “L’ironia è un fiore che non può sbocciare nel vento e nel turbine d’oggi. L’ironia è la figlia del senno e della calma”. Donde il piacere sottile di dar dell’asino a ragion veduta ma con il sorriso sulle labbra, senza cattiveria o malizia, con aria innocente e dunque senza intento offensivo. Sentite questa. Alla fine dell’Ottocento un sellaio analfabeta di Bergamo, avendo riparato i finimenti di alcuni asini usati per il trasporto dei réss, i ciottoli di fiume con cui si lastricavano le strade, si rivolse ad un amico fabbro, il quale per un calicetto di vino gli compilava la notula della richiesta di pagamento. Forse i calici saranno stati due o tre perché il documento presentato quella volta agli uffici comunali recitava: “Per aver riparato le finimenta agli asini del Comune, lire 28 e 30”. Quelli del Comune l’avranno presa senza troppo risentirsi, abituati com’erano a sentirsi dare dell’asino. Sapevano bene che quando per la Corsarola di Bergamo Alta passava la scaalcada di àsegn con le some colme di ciottoli per i rappezzi delle strade, c’era sempre chi motteggiava. Uno diceva: “I passa i àsegn del Cümü”. E un altro, indicando la fraterna asinina: “Ol sìndech in tèsta e i sò assessùr de dré”. L’ironico motteggio era ben risaputo nel civico palazzo ma né il sindaco né gli assessori se ne adontarono mai. Vox populi… Dà d’intènd piö bö che àche. A questo mondo non si è mai abbastanza accorti e s’mpara sempre a diventare diffidenti a proprie spese. O prima o poi succede di avere a che fare con persone che ti fanno vedere lucciole per lanterne oppure che i te dà d’intènd piö bö che àche. Dare ad intendere più buoi che vacche non è certamente atto onesto perché non corrisponde alla realtà: in nessuna azienda agricola si è mai trovata abbondanza di buoi e penuria di vacche. A che pro infatti tenere tanti buoi quando un paio bastavano per arare e per tirare i carretti pesanti? Chi presenta le vicende, i fatti e le situazioni in modo falso e distorto per trarne illecito vantaggio esercita l’arte del raggiro. Narra Cicerone nel “De Officiiis” che un cavaliere romano, tale Caius Canius, si fosse fitto in capo di acquistare a Siracusa una villa che desse sul mare, così ch’egli potesse comodamente pescare in barca senz’allontanarsi troppo dall’abitazione. Un certo Pitius, argentiere che a Siracusa possedeva appunto una villa in riva al mare, invitò Canius a cena e fece in modo che diversi pescatori approdassero innanzi alla sua proprietà con le loro barche stracolme di pesce appena pescato al largo della costa. A quella vista Canius s’ingolosì. “Le pesche qui sono sempre così abbondanti?”, domandò. E Pitius rispose: “Se qui c’è il mare, ci sono anche i pesci”. Canius allora chiese a Pitius di vendergli la villa ma questi rispose che era troppo affezionato al luogo per alienare la proprietà. “Ti ospiterò ogni volta che verrai a Siracusa”, promise Pitius. “Non è la stessa cosa”, replicò Canius. Ed insistette tanto nelle sua richiesta che l’astuto Pitius, recitando fino in fondo la sua commedia, alfine con gran rammarico accettò di vendere a Canius la villa, beninteso a un prezzo esorbitante. Concluso l’affare e sborsato il denaro, Canius si avvide che il luogo era deserto, dei pescatori non v’era l’ombra e il mare era tutt’altro che pescoso. Sospettò che con la messinscena dei pescatori Pitius gli avesse fatto vedere piö bö che àche e si querelò ma il giudice non ammise il dolo di Pitius e diede risolutamente torto a Canius, ritenendo che si fosse comportato come uno sprovveduto e che pertanto meritasse di scontare le conseguenze della sua dabbenaggine. Evidentemente il diritto romano non andava tanto per il sottile nel distinguere le vacche dai buoi o, per dirla alla toscana, le lucciole dalle lanterne. L’inganno è arte antica, che l’uomo pratica ab immemorabili. Il detto bergamasco ci mette sull’avviso e c’insegna a non farci turlupinare. Dà fò come l’Òi. Significa ‘dare in escandescenze’. L’atto di sbraitare e d’inveire è associato alla violenza delle alluvioni del fiume Oglio, che desolò più volte la Val Camonica provocando morti e distruzioni di ponti e di edifici. Dà fò de mat. Si dice quando occorre indicare un comportamento pazzesco e violento: l’à dàcc fò de mat, ‘ha dato in escandescenze’, ‘ha perduto il lume della ragione’. Non è facile tradurre rendendo appieno la pregnanza semantica della locuzione. Certo ci si riferisce a persona che abbia smarrito, anche solo momentaneamente, il ben dell’intelletto e che trascenda con le parole, i gesti, gli atti così da sembrar perfino pazzo violento e pericoloso. La società sta ancora pagando a caro prezzo i guasti di una certa corrente di pensiero secondo la quale il pazzo non esisterebbe (ma per colmo d’ipocrisia l’infermità mentale è ammessa nelle aule giudiziarie quando il crimine sia stato commesso). Si riaffaccia il problema dell’appannamento della ragione e del predominio della forza, esercitata singolarmente o collettivamente. Problema vecchio come l’essere umano. La storia è piena di gente che la dà fò de mat, soprattutto di gente capace di tenere nell’ignoranza le masse popolari per galvanizzarle ed usarle come forza d’urto o come strumento di minaccia. La storia abbonda di demagoghi dai discorsi infuocati, di tiranni abilissimi nel mandare gli altri a scannarsi sui campi di battaglia o a farsi esplodere in nome di qualche ideale fittizio che cela ambizioni, smania di potenza, bramosia di denaro. Da un singolo individuo che la teorizza e che la predica, la violenza si trasferisce come un contagio a vasti gruppi di persone, si organizza in reti terroristiche, in squadre d’assalto o in eserciti aggressivi. Ecco allora che l’atto de dà fò de mat diventa terribilmente sconvolgente. Sovvengono gli sconsolati esametri di Virgilio nella IX egloga delle “Bucoliche”, là dove il poeta dice che innanzi alla brutalità e alla barbarie la voce della poesia ha lo stesso valore delle colombe all’approssimarsi dell’aquila. Quando si distrugge non si pensa all’ingegno e alla fatica di chi ha costruito. Raramente appare un barlume di ragione in tanta violenza: entrando in Tebe conquistata, Alessandro Magno ordina di radere al suolo la città e di risparmiare tuttavia la casa appartenuta al poeta Pindaro. Ma durante la seconda guerra mondiale nessuno ebbe scrupoli: le bombe caddero sulle abitazioni civili provocando migliaia di vittime e distrussero tesori d’arte inestimabili. La cultura, l’arte, il pensiero sono impotenti davanti alla barbarie, alla violenza cieca e bieca, quella aperta e dichiarata della guerra come quella subdola e ingannevole del potere esercitato senza scrupoli. Talvolta poi finisce che l’ daghe fò de mat chi si sente vittima di un sopruso, chi si ribella ad una prepotenza. Allora la spirale della barbarie aumenta le sue volute e la ragione riprende il suo predominio soltanto dopo enormi disastri, che fatalmente sopportano quelli che i dà mia fò. Dàga öna s-ciafa al diàol. Significa ‘assumere una decisione senza badare troppo ai pro e ai contro’. Si sa che il diavolo è abilissimo nell’ingenerare dubbi e sospetti. Ecco perché chi deve prendere una risoluzione senza poter perdere tempo in dubbi e in esitazioni è come se prendesse a sberle il diavolo respingendone le insinuazioni. Dà öna stongiada. Stongià significa ‘potare’, l’atto che si fa quando si tagliano i rami degli alberi, a novembre o a febbraio, per diradarli e aiutarne la crescita. Esiste un senso figurato che stranamente non è registrato nei repertori lessicali. Ho sentito proferire più volte espressioni minacciose come Ghe la dó mé la stongiada a chèl lé, oppure: A l’ gh’avrèss bisògn d’öna bèla stongiada. Nei “Nuovi sonetti bergamaschi” (1941) di Sereno Locatelli Milesi trovo una composizione intitolata “Stongiadüra”, nella quale un massaro si lagna dei suoi di casa, che dovrebbero essere stongiàcc perché i gh’à sbagliàt la crapa, ‘hanno la testa matta’. Non è troppo pretendere dai lessicografi una buona conoscenza della letteratura. Dà i dìcc in di öcc. Non è un bel modo di esprimere il proprio ringraziamento e di riconoscere il dovuto per un lavoro ben eseguito quello di ficcare le dita negli occhi alla persona che aspetta invece un complimento e una ricompensa. Ma non di rado nella vita accade anche di constatare che il bene elargito sia ricambiato con la più impudente ingratitudine. Dà i nömer. Se una persona fa un discorso strano e dice cose poco sensate, a un bergamasco viene spontaneo domandarle: Sét dré a dà i nömer? La locuzione è registrata nel dizionario italiano dello Zingarelli: “Dare i numeri, di persona che dice cose strane, vaghe o di senso oscuro”. Nel dizionario bergamasco del Tiraboschi si legge: “Tö fò ü nömer de la gàbola, rilevare un numero, guardare nel libro dei sogni che numero fa una tal cosa”. Già, uno sogna una certa cosa e poi corre a giocare al lotto il numero che corrisponderebbe a ciò che ha sognato. Se non sa quale sia il numero appropriato, può sempre consultare opere di alta scientificità quali “Il libro dei sogni”, “La nuova cabala”, “La felicità raggiunta” e altre simili amenità. Il sogno, si sa, è irrazionale. Tentare la sorte affidandosi all’irrazionalità significa proprio dà i nömer, compreso il numero del mórt che parla. Non è un caso che di uno che parli a vanvera si dice che l’ s’è ’nsognàt di sò póer mórcc. Si sono proibiti in pubblico i giochi della morra e della tombola. Quello del lotto no perché rende fior di quattrini alle casse dello Stato. Napoleone fu informato che nel Regno Italico, del quale egli aveva cinto la corona, il gioco d’azzardo rendeva ogni anno un milione e seicentomila lire, cifra per quel tempo ingentissima. Ed egli osservò: “Che bisogno abbiamo di raccogliere tutti questi soldi con le tasse, che ci costano in termini di burocrazia, quando i cittadini sono tanto stupidi da correre a versarli nelle nostre casse giocando al lotto? Che continuino a giocare e a darci il loro denaro senza che noi si faccia il minimo sforzo per rastrellarlo”. I numeri dovrebbero sempre essere considerati seriamente. Quelli che noi usiamo, i cosiddetti numeri arabi, sono in realtà di origine indiana e furono introdotti in Europa da un commerciante di Pisa, Leonardo Pisano, detto Fibonacci perché figlio di un certo Bonaccio (latinamente filius Bonacci). Nel 1202 Leonardo Pisano pubblicò il “Liber Abaci” con l’intento di semplificare le operazioni aritmetiche, che allora si basavano ancora sui segni grafici romani e che risultavano piuttosto complicate sulle grosse cifre. Il numero è il fondamento della scienza. Sembra il colmo che possa assumere un significato irrazionale. Eppure quando s’ dà i nömer è proprio così. Dà la paga. È locuzione fortemente ironica ed è usata nel senso di ‘percuotere’, ‘dare le busse’, ‘maltrattare’, con riferimento a persona che avanzi con sicumera una pretesa indebita. Così un tempo i ragazzi che avevano combinato una marachella si sentivano dire dal padre o dalla madre: Tè la dó mé la paga! Se poi una persona che abbia assolto male e in modo del tutto insufficiente ad un compito che le è stato affidato accampa pretese, ecco che può sentirsi dire: Te la dó mé la paga! Alle parole si può anche accompagnare un gesto della mano che simboleggi busse e ceffoni per far intendere il tipo di paga. Occorre però valutare bene le situazioni perché può accadere che un lavoro sia stato eseguito a regola d’arte e che il committente si avvalga di pretesti per pagare di meno di quanto era stato pattuito. È il caso del principe romano Agostino Chigi, il quale commissionò a Raffaello alcuni dipinti. All’atto della consegna delle opere sorse una questione fra l’artista e il committente per il pagamento. Si addivenne ad un arbitrato e il Chigi, sapendo che fra Michelangelo e Raffaello non correva buon sangue, propose come arbitro il Buonarroti. Raffaello accettò per non offrire al rivale il destro di parlar male di lui. Michelangelo fu all’altezza della situazione: appena vide le opere di Raffaello le magnificò con argomentazioni tecniche appropriate e inconfutabili sentenziando che, per sua valutazione, quelle opere valevano ben di più di quanto il principe si era dichiarato disposto a pagare. Si potrebbe dire metaforicamente che Michelangelo “diede la paga” al principe Chigi, il quale si affrettò ad accordarsi con Raffaello per non sborsare la somma favolosa indicata dal Buonarroti. Dà la petenada. Si dice in senso figurato quando s’intende richiamare all’ordine una persona con un forte rabbuffo o con un salutare castigo: uno scarmiglione necessita sempre di una buona pettinata. Ancora in senso figurato si dice: Dà öna resentada, ‘Dare una risciacquata’, comprendendo nella risciacquatura una energica strizzatura… Dà ’l pà in piassa. Se si vuole compiere un gesto caritatevole, lo si deve fare con discrezione e in silenzio per non offendere il beneficato. Chi dà il pane in piazza a qualcuno umilia davanti a tutti la persona che soccorre e si fa criticare per la sua ostentazione odiosa. Occorrerebbe far leggere ai ragazzi d’oggi qualche pagina di “Cuore” del De Amicis. Chissà perché non si insegna più a non offendere la povertà, a non ostentare la ricchezza, come fanno gli smargiassi e i tracotanti, a non dileggiare chi è costretto a vivere di stenti? Certo, c’è poco da pretendere in una società dominata dal denaro, in una società nella quale è diffusa l’opinione che sia lecito qualunque mezzo pur di potersi arricchire e che il lusso vada sbattuto in faccia agli altri come se quello fosse l’unico modo per farsi rispettare e stimare. Ma io non mi identifico in ciò che posseggo, tanto o poco che sia. Quel che ho non conta perché lo perderò tutto quando dovrò andarmene. E so che verrò chiamato anche a rendere conto del pane che avrò dato in piazza. Dà la strögia. Letteralmente: ‘Dare la striglia’, ossia ‘strigliare’. È locuzione minacciosa che si ode ormai raramente. In anni lontani ho udito dire: Ghe la dó mé la strögia a chèl lé!, ‘Penso io a dare una buona strigliata a quello lì!’. E ricordo di due che questionavano; non mi sovviene la ragione del discutere ma ho ancora in mente che uno dice all’altro: Se te mètet mia a pòst i laùr a te la dó mé la strögia a té!, ‘Se non sistemi le cose ti do una bella strigliata!’. Dàn öna cólda e öna frègia. Letteralmente: ‘Darne una calda e una fredda’. È il contegno insulso di chi un giorno ti sorride e l’altro ti sta in cagnesco, di chi un giorno ti dà una notizia lieta e l’altro una notizia infausta, un giorno ti favorisce e l’altro ti si oppone. Dàn öna fèta. Significa ‘infliggere un discorso lungo e noioso’. Sembrerebbe dal diminutivo del latino offa, ‘focaccia’, donde anche la voce italiana fetta. Ma non si spiegherebbe allora il senso accresciuto. Forse dovremmo ricorrere ad un’altra derivazione (latino fictus, ‘finto’, ‘inventato’, usato con accezione ampliata). Comunque, non sembra il caso di diffondersi in disquisizioni etimologiche per dàn öna fèta al paziente lettore. Dà öna girada. Si dice per indicare l’atto di rivolgere un rimprovero assai aspro o un rabbuffo solenne che ottenga un pieno ravvedimento e un completo mutamento di condotta, come se la persona cambiasse orientamento per essere stata fisicamente girata dalla parte opposta. Dà öna góga. In un recente glossario bergamasco rilevo la voce góga con rimando a còcola, ‘colpetto leggero sulla guancia’. Ma la góga non è affatto il buffetto che si dà sulla guancia per vezzo o per complimento. La lessicografia non è da intendersi in modo tanto dilettantesco e fuorviante. La góga è il colpo che s’inferisce a una biglia o un qualunque altro oggetto appoggiando il dito indice (o il medio) al pollice e facendolo scattare. In mantovano si dice pitagòss. È voce intraducibile in italiano, lingua nella quale può essere resa solo con una circonlocuzione. Il suo ricordo è per me associato al gioco infantile delle biglie, che si chiamavano ciche: quando si doveva tirare per far avanzare la cica, si dava ad essa una góga. Ma la locuzione dà öna góga era anche rivolta in tono di minaccia ai bambini più piccoli per farli stare quieti. Una signora che conosco mi ricorda che quando da bambina faceva i capricci, suo fratello, che aveva qualche anno più di lei, le diceva: Se te la móchet mia, te dó öna góga söl copì, ‘Se non la smetti, ti do un colpetto sulla nuca’. E un amico mi dice che da bamino si divertiva a far dispetti ai coetanei dando loro una góga sulle orecchie. Dà öna ùs. Letteralmente: ‘dare una voce’. Presuppone il senso dello spazio e della quiete della campagna. Per richiamare l’attenzione di chi era intento al suo lavoro in fondo a un campo occorreva una voce forte e alta, che si udisse bene nel silenzio contrappuntato soltanto dal cinguettio di un passero, dal frinire di una cicala, dallo stormire di una fronda. Una voce chiara, timbrata, non velata dal malefico vizio del fumo e non arrochita dall’aria inquinata, si diffonde echeggiando e perdendosi nella vastità della campagna. Basta il richiamo di una voce lontana, udita distintamente nel silenzio circostante, perché l’uomo risponda all’altro uomo. L’udito si affina nella calma campestre, dove non sfugge il gorgoglio di un ruscello, un frullo d’ala, l’alitare del vento. Nella pace estatica della campagna si riscopre la poesia del creato. Il senso pieno dei suoni si riacquista nella maestà assorta della natura, non nella violenza degli amplificatori, nel fracasso frastornante di ritmi ossessivi, nel fragore delle musicacce volgari che rovinano l’udito e che stordiscono la mente. Come si può comunicare, come si può stabilire una relazione non effimera con un proprio simile nelle bolge chiassose e assordanti delle discoteche? Non erano certo alienate e sapevano leggere nel gran libro della natura le nostre contadine di un tempo, che avevano i loro richiami per gli animali da cortile. Ecco come i ghe dàa öna ùs: le galline venivano chiamate con il richiamo iterato pine pine (contrazione di puìne, ‘gallinelle’, ‘pollastre’), i pulcini con pì pì (semplificazione di pülzì, ‘pulcini’), le anatre ane ane, le oche chéo chéo, i tacchini pulì pulì. L’affaccio sul cortile era già un modo per trovarsi en plain air: la voce umana si propagava nello spazio. Dàs la sapa söi pé. C’è gente che fa il proprio danno, gente che parla e che si comporta senza alcun discernimento come farebbe uno zappatore che usasse tanto male la zappa da ferirsi i piedi. Chi non ha mai provato a zappare non si rende conto appieno del senso della locuzione. Se si vuole sterrare, se si vuole dissodare e scassare un terreno, onde metterlo a coltura, occorre saper usare bene la zappa, la cui lama forma un angolo di 90 gradi all’attacco con il manico di legno (mentre la vanga è fatta apposta per penetrare diritta nel terreno). Per certi luoghi in pendio, incolti da anni, non c’è che la zappa. Il suo uso farebbe passare i grilli in capo a certi giovani che finiscono nelle spire della droga. Imparerebbero a mia dàs la sapa söi pé! Purtroppo la nostra società è dominata da un’accanita volontà masochistica e ne è esempio lampante la cacciata del latino dalle scuole, atto funesto che ha determinato l’arretramento della formazione culturale della nostra gioventù. Fu un grossolano errore il dare retta a quanti predicavano l’inutilità dello studio del latino, ritenuto a torto appannaggio dei ceti dominanti. Un bene che andava esteso a tutti per il suo valore formativo, un prezioso strumento che aiutava a conoscere la nostra storia e i fondamenti della cultura occidentale, è stato ripudiato e gettato alle ortiche; si è così perduto il senso dell’universalità insito nell’uso della lingua latina e si è smarrita la chiave della conoscenza della lingua italiana, che in poche decine d’anni si è appiattita e imbarbarita. Non è chi non veda come la svalutazione degli studi classici abbia rappresentato per la nostra cultura un atto di masochismo, né più né meno del contadino inesperto o distratto che danneggia se stesso colpendosi i piedi con la zappa. L’ignoranza non può essere invocata a scusante. Diceva giustamente l’umorista Luigi Bertelli detto Vamba: “Va bene essere ignoranti ma non si dovrebbe mai abusarne”. De guarì se n’ parla gnach. Di una persona che si faccia disapprovare per la sua indole e i suoi comportamenti e che sia ritenuta irrecuperabile si dice, con una ironia vicina al sarcasmo: A l’ pöderà ’ndà a stà mèi ma de guarì se n’ parla gnach, letteralmente ‘Potrà anche andare a star meglio ma di guarire non se ne parla neanche’, come a dire che qualunque cura sarebbe inefficace. Denante al pòpol e al Cümü. Occorre rifarsi ad una spassosa composizione in sestine settenarie di Giuseppe Mazza detto Felìpo intitolata “In pretüra” per trovare traccia di questa locuzione: una donna si querela davanti al magistrato perché i vicini di casa le hanno ucciso il gatto. Il pretore le domanda le generalità e la donna, che non ha piacere di far sapere la sua età al pubblico presente in sala, protesta di dover dichiarare la sua data di nascita pròpe denante al pòpol e al Cümü, ‘proprio davanti al popolo e al Comune’. L’appartenenza ai ceti popolari è stata da tempo fortemente svalutata: si assumono a criteri di giudizio la situazione reddituale e il grado d’istruzione scolastica per dichiarare, come fanno certi sociologi, che il livello culturale del popolo sarebbe “medio-basso”. In realtà se si studia la cultura popolare ci si rende conto della sua netta alternatività e del suo profondo radicamento. Ma oggi la società non presenta più una fisionomia facilmente decifrabile in ordine ai mestieri, alle professioni, alle arti e di conseguenza ai ceti che la componevano ai tempi del Felìpo, quando anche una popolana possedeva un vivo senso comunitario e identitario. Oggi il corpo sociale si presenta frammentato e instabile; per effetto dello sradicamento il popolo degenera nella massa, perde la sua cultura e smarrisce i suoi punti di riferimento. Venendo meno il senso dell’identità e dell’appartenenza alla comunità e al territorio, cresce il disagio innanzi ai repentini mutamenti imposti dalla globalizzazione e si assiste ad una sorta di fuga individuale dai problemi della collettività, che affonda nel mare magnum dell’uniformità. Lagnandosi di dichiarare la sua età davanti al pubblico in sala, al giorno d’oggi la popolana in questione non si appellerebbe alla privacy? Dèrv fò cantina. La lettura di un sonetto di Sereno Locatelli Milesi (1884-1946), intitolato “I gh’à dervìt cantina” (da “Sonetti bergamaschi”, 1938), ricorda l’uso che un tempo si faceva in tante cascine di “aprire la cantina” nei pomeriggi del sabato e della domenica. Con l’arrivo della bella stagione gli avventori trovavano nel cortile (la curt) della cascina sedie e tavoli, non di rado in pietra. A poco prezzo potevano bere il vino novello servito in una scodella; di solito non mancava qualche pagnotta da accompagnare alle fette di salame e di stracchino. Quando arrivava il momento di “aprire la cantina” il contadino poneva una frasca all’esterno della cascina o sul cancello di accesso e da quel segnale si capiva che si poteva accedere al cortile per il modesto asciolvere pomeridiano e per trascorrere qualche tempo in lieta compagnia con gli amici. Non so quanti oggi mi capirebbero se usassi la locuzione: ’Ndà a la frósca. Dèrves, tèra! Càsses dét! Capitare in un pomeriggio del 1919 o del 1920 al Mercato del Fieno, entrare al Café de la Baössa e incontrare gli spiriti eletti di Ciro Caversazzi e di Luigi Angelini che discutono della valorizzazione del centro monumentale di Bergamo Alta, della salvaguardia dell’incantevole chiostra dei colli e della tutela della sublime veduta della città come appariva allora dalla pianura. Chiedere rispettosamente venia per l’intrusione e dire: “Sappiano lor signori che fra un secolo a Bergamo Bassa sorgeranno case d’abitazione di dieci e perfino di quindici piani a precludere la veduta dell’acropoli”. Non posso immaginare la reazione addolorata dell’ingegner Angelini, che conobbi nei miei giovani anni e che ricordo come la personificazione della signorilità e del garbo. Ma immagino che l’eruditissimo commendator Caversazzi, avvezzo alla lettura dei classici latini ma amante della parlata bergamasca, prorupperebbe nell’esclamazione: “Dèrves, tèra! Càsses dét!”. Appunto, che si apra la terra e che ci si cacci dentro piuttosto che vedere per sempre rovinato e imbruttito uno dei panorami più suggestivi d’Italia, quello che mandò in visibilio Anatole France, il quale giudicò Bergamo più bella di Firenze. C’è chi presume di poter gabellare per moderna e progressiva una visione gretta e grossolana della città e del suo territorio, come se Bergamo fosse Manhattan, come se la tetragona e angosciante immanenza di enormi sagome incombenti non deturpasse per sempre la visione dolcissima di un paesaggio ammirato e apprezzato in tutto il mondo, come se l’aberrante idea di consistenti insediamenti abitativi posti in verticale non prospettasse l’aggravamento irrimediabile di una circolazione già molto problematica e il peggioramento della qualità della vita in un contesto urbano il cui impianto risale a molti secoli addietro, quando le notizie e le merci viaggiavano a piedi o a cavallo. Da parte di certuni si sono posti da tempo gli occhi sulle aree più appetibili e si smania di far denaro vendendo, magari ai cinesi, diverse centinaia di appartamenti in una città che non è affatto da ripopolare e che per il suo rapporto con il territorio è cresciuta anche troppo divorando gli ultimi lembi di verde rimasti. Ci siano almeno risparmiate l’albagia e la sfacciataggine di chi viene da fuori a spacciare l’orvietano nelle nostre contrade senza sapere alcunché di noi, della nostra storia, della nostra cultura e dei nostri problemi. Che tutto vada alla malora, essendo stato così deciso. Ma almeno si abbia il pudore di non insultare con la falsa e odiosa accusa di provincialismo chi si rammarica per gli oltraggi che si arrecano ad un patrimonio sfregiato e deturpato per sempre. Per il resto, chi fa i soldi sulla pelle della città non porterà nella tomba il becco di un quattrino. Desbergamascàs. È l’infinito presente di un verbo assai raro, che ho udito proferire una volta sola da un uomo di una certa età, che avevo incontrato durante una escursione su di un sentiero di montagna e con il quale mi ero trattenuto per qualche tempo a conversare. Da giovane era andato a lavorare all’estero e si era messo da parte il gruzzoletto; poi, vinto dalla nostalgia, dopo diversi anni era ritornato al suo paese natale. In Francia e in Germania aveva visto tante belle cose (“tace bèi laùr”) ma nulla che avesse potuto indurlo a dimenticare la sua terra. Dopo le prime battute in italiano, la conversazione continuò speditamente in bergamasco. L’uomo ad un certo punto mi disse: “Bergamàsch a m’ sè, bergamàsch a m’ resterà, mai a m’ se desbergamascherà”. Voce, quest’ultima, non facilmente pronunziabile e non registrata dai lessici nostrani, sommari, incompleti, talora fuorvianti, voce che va tradotta con una circonlocuzione. Come dire: mai rinunzieremo alla nostra identità bergamasca. Si sa che l’identità è anzitutto nella lingua. Ed oggi tanti bergamaschi non sanno parlare in bergamasco. Non è racconsolante l’idea che al bergamasco si sia sostituito l’italiano, anzitutto perché le vecchie generazioni, anche se poco scolarizzate, erano sostanzialmente bilingui e poi perché oggi si parla un italiano penoso, quello radiotelevisivo storpiato da pronunzie burine e borgatare, inzaffardato da anglicismi, lessicalmente povero e strutturalmente miserando, che svillaneggia e oltraggia le regole sintattiche. Si continua a dire con immensa banalità che il bergamasco sarebbe “difficile” o “incomprensibile”, si odono grevi espressioni presuntuose e pretestuose, tipiche dei colonialisti più rozzi, che tendono a offendere e a sopprimere ogni cultura che non sia la loro. Così noi italiani, per far piacere ad una supponente e ottusa minoranza di monoculturalisti, stiamo barbaramente distruggendo anche gli ultimi lacerti dell’immenso patrimonio linguistico costituito dai nostri dialetti, dei quali la lingua nazionale si è sempre giovata nel corso dei secoli per non deperire. E stiamo gettando alle ortiche le ultime sopravvivenze delle nostre culture popolari, alle quali la nostra cultura nazionale è spesso ricorsa alla ricerca di autenticità. Del resto, solo i mondialisti più fanatici e ideologizzati, i quali non possiedono sufficienti conoscenze storiche, non sono in grado di capire che essere e sentirsi bergamaschi significa appartenere ad una terra che ha sempre mantenuto legami vivissimi con la cultura nazionale e con quella europea. De sfrós. Il verbo sfrosà corrisponde all’italiano ‘frodare’ ma è dotato di una iniziale consonanante sorda rafforzativa generata dal prefisso latino ex usato in funzione privativa. Esso indica l’atto di chi elude un obbligo fiscale. Era usato soprattutto per riferirsi a chi si sottraeva alla corresponsione del dazio, gabella che gravava sulle merci in entrata e in uscita. In una organizzazione statale fortemente centralizzata come quella sabauda, imposta negli anni immediatamente successivi a quelli del Risorgimento, i Comuni godevano di scarsa autonomia e ricevevano pochissimi aiuti economici dall’amministrazione centrale dello Stato: l’esazione dei dazi sulle merci costituiva dunque per i bilanci comunali una boccata di ossigeno. Era detta de sfrós una merce sfuggita al pagamento del dazio. Oggi si dice ancora cassadùr de sfrós di chi caccia negli stagione proibita e pescadùr de sfrós di chi pesca senza la prescritta licenza. Cadute le barriere doganali, mutati i rapporti economici, illanguidisce anche il ricordo degli spalù, i contrabbandieri di montagna che attraversavano il confine svizzero portando a spalle le bricolle piene di merce frodata; avevano dato vita a molti aneddoti, la cui memoria va pure svanendo. A volte, inseguiti da finanzieri zelanti, rischiavano la vita e qualcuno la perdette davvero. Oggi alle frontiere i controlli sono meno fiscali di un tempo. Tanti anni fa – mi si perdoni il ricordo personale – ebbi qualche problema con un doganiere teutonico il quale, trovando nella mia valigia alcuni libri di poesia freschi di stampa, stentava a credere che li portassi con me semplicemente per leggerli; l’intervento di un suo collega che conosceva il francese fu determinante. In fondo quel funzionario non faceva che il suo dovere. A volte non si vorrebbe essere nei panni di chi esercita un controllo. Alla guardia confinaria della Mesopotamia, che gli domandava che cos’avesse da dichiarare, il greco Apollonio, maestro di eloquenza, rispose: “Esporto la saggezza, la giustizia, la virtù, la temperanza, la fierezza, la disciplina”. Avrei voluto vedere la faccia di quel doganiere… Desquarcià i altarì. L’esteriorità è in sé poca cosa ma è fuor di dubbio che alla casa del Signore siano dovuti rispetto e decoro. In altri tempi i fedeli si facevano un merito di contribuire all’abbellimento della loro chiesa, dotandola di opere d’arte che noi oggi possiamo contemplare ammirati. Lo facevano perché sentivano di appartenere ad una comunità che viveva non soltanto in quanto polis ma anche in quanto ecclesia, comunità di credenti che osservano le stesse norme di vita. Vi furono però anche tempi, situazioni e luoghi nei quali qualche edificio sacro poté essere trascurato, poiché non sempre gli uomini sanno essere all’altezza dei loro doveri (questo purtroppo avviene in qualunque campo e con qualunque incarico). Leggendo gli atti delle visite apostoliche dei secoli passati ci si avvede che non sempre le chiese erano rette con la cura dovuta: qualche volta il visitatore trovava i templi disadorni e trascurati ed in particolare gli altari laterali disusati, in abbandono, coperti con drappi perché non s’impolverassero. A volte il visitatore faceva rimuovere il drappo e scoprire l’altare per constatare in che condizione fosse, se pulito e in buono stato o se polveroso e ricoperto da ragnatele. Nacque così questa locuzione arguta e ammonitrice. Tutti noi abbiamo qualche altarino coperto, qualche zona d’ombra di cui non possiamo proprio menar vanto. Nessuno è perfetto: sotto il drappo annoso, che vorremmo non fosse mai rimosso, soltanto noi sappiamo che cosa c’è. Un giorno, senz’alcun preavviso, arriva però il visitatore, al quale non possiamo tener nascosto alcun altarino. De stresura. È locuzione caduta in disuso, chiaramente derivata dal latino de extra hora. Potremmo tradurre: ‘fuori orario’. Di uno che sia arrivato tardi o ad ora insolita possiamo infatti dire che l’è riàt de stresura. Ecco affacciarsi alla memoria il ritmo blando dei quinari di una poesiola bergamasca di Pietro Nicòli (1870-1943) intitolata “La pendola”: Tich! Tach! la pèndola / d’ura e stresura… Ed ecco un’altra bella locuzione bergamasca, d’ura e stresura, che non si ode più e che vuol dire ‘a tutte le ore’, ‘senza alcun orario’. Quanto prezioso il tempo per i bergamaschi! Siamo gente avvezza ad economizzarlo, perfino a centellinarlo per non dissiparne le ore, i minuti, gli istanti. Il dono della vita è irripetibile e non c’è reincarnazione che tenga: l’idea di un supremo ente creatore che, potendo trarre il mondo dal nulla, sarebbe poi così a corto di energia vitale da essere costretto a riciclare le anime è puerile e perfino ridicola. A scorno di certe insostenibili credenze orientali, deboli e confuse, non abbiamo altra vita se non questa appesa a un filo, vita che ci è dato vivere senza sapere quando verrà la morte fisica. Tempora labuntur, diceva il poeta. Il tempo scorre e per vivere bene lo si deve impiegare bene. Le meridiane che venivano dipinte sui muri delle ville signorili ammonivano sulla fugacità delle ore: esse misuravano non solo il corso del sole ma anche la vita dell’uomo ed il memento era eloquente. Fugit irreparabile tempus, diceva ancora il poeta. Osservando il movimento degli astri e riflettendo sul trascorrere degli anni, l’uomo ha suddiviso il giorno in vari momenti. Dopo aver misurato la direzione dell’ombra formata da un bastone infisso nel suolo egli si è avvalso di strumenti sempre più precisi e già nell’antichità i giudici ricorrevano all’uso delle clessidre per limitare le arringhe degli avvocati. Ma non tutti sanno che nel Settecento due fratelli di Miragolo, Giacomo Antonio e Carlo Gritti, si dedicarono alla fabbricazione di orologi da muro che divennero famosi in tutto il mondo. Alcuni di questi orologi, contrassegnati sul quadrante dalla scritta Opus Miraguli, compaiono talora nelle più quotate aste antiquarie. Alla meditazione sul transeunte e all’arte di misurare meccanicamente lo scorrere del tempo anche Bergamo ha dato dunque un fattivo contributo con l’opera preziosa di alcuni suoi geniali artigiani. Dì del bu. Conversando una lingua vive. Non c’è come dialogare per ridare vitalità ad una lingua che si vada assopendo. Penso al mio bergamasco, che sento vivo quando ripercorro le strade dell’acropoli e dei borghi storici: ricordo le voci e le parole di un tempo e mi pare che i selciati delle vie, le pietre delle case, i portali, i balconi riecheggino voci e parole; perfino le chiese, onuste di storia e di gloria, mi sembra ripetano sommesse al vedermi le antiche orazioni latine ma con l’accento bergamasco, con le è dolci e larghe e le ó cupe e chiuse, una musica di vocali che ho ancora nella memoria e che udivo da bambino inerpicarsi sicure sulle vette sublimi del gregoriano, ora abbandonato e negletto con incosciente disinvoltura; musica di un eloquio che poteva gareggiare con quelli dei fiorentini e dei leccesi per l’originalità e la singolarità dei suoni. Qualcuno potrebbe domandarmi: Ma digherét del bu?, ‘Ma dirai davvero?’. Strana interrogazione, rispettosa e pensosa, ben diffusa da noi, con il garbo e la delicatezza del futuro semplice ad esprimere stupore e incertezza. Sì, dico davvero, perché la moria delle piccole lingue è una tragedia immensa, una perdita incalcolabile per il patrimonio culturale dell’umanità. Il World Watch Institute prevede che entro il secolo XXI da 3.000 a 6.500 lingue spariranno dalla faccia della terra in conseguenza degli sconvolgimenti etnico-antropologici della nostra epoca e a causa della forza di attrazione delle lingue sostenute dalle economie forti. Nelle Hawaij la lingua nativa, il cui uso era stato proibito nel 1898, viene ora insegnata nelle scuole: è avvenuto un recupero memoriale che consente a migliaia di hawaiani di parlare la lingua degli avi. Ma digherét del bu? Sorge spontanea la domanda quasi incredula. Sì, davvero. Ma da noi ci si balocca ancora con l’antinomia dialetto-lingua e lo spirito nefasto di un centralismo burocratico autoritario e ottuso continua a mortificare le culture locali e a cancellare ogni autentica espressione dell’anima popolare. Dio de l’ài. Strana esclamazione, a un dipresso dalla blasfemia. Eppure la locuzione dice proprio così: Dio de l’ài, che vita è mai ìga ’l murùs e non vederlo mai? Strana commistione di italiano e di bergamasco per esprimere celiosamente l’infelice condizione di una fanciulla innamorata che non ha mai l’occasione o la possibilità di vedere il fidanzato. Al detto si ricorre quando si vuole manifestare un senso vago e indeterminato d’insoddisfazione, un sentimento di disagio e di delusione per un obiettivo che non viene mai raggiunto o per una condizione agognata e tuttavia negata. Sarà forse la suggestione della rima in –ai ad avere indotto la nostra gente di un tempo a formulare quest’altra locuzione, anch’essa strana e originale: Trai trai trai, come saràla mai che gh’ó piantàt i sìgole e l’ m’è fiurìt sö l’ài? Anche in questo caso un obiettivo che non è stato raggiunto e l’amarezza di una delusione, soltanto un poco attenuata dall’arguzia bonaria e volutamente ingenua della forma interrogativa. Autoironia tipica dell’indole bergamasca. Dio ne guarde! Era esclamazione abituale un tempo e veniva proferita quando s’intendeva scongiurare un malanno, una sciagura, un evento funesto. I nostri nonni impetravano da Dio la buona sorte perché lo sentivano vicino ed avevano fiducia nella Provvidenza. Ora si stenta a volgere gli occhi al cielo: nel Novecento l’uomo, essere relativo e finito, ha presunto di dichiarare la morte dell’infinito, dell’eterno, dell’assoluto: filosofi, pensatori, politicanti hanno combattuto l’idea di Dio, che è risorta propriò là dove le più grossolane e violente persecuzioni dettate dal pensiero materialistico volevano sradicarla dal cuore dell’uomo intendendo far credere che la coscienza della natura umana non fosse altro che povera inerte materia mortale. Basta l’evocazione di un modo di dire che qualche volta era pronunziato dai nostri nonni per ricordare che una visione del mondo di tipo egheliano e illuminista, se intesa in senso radicale, conduce all’individualismo, a una società senza valori e senza identità, dove ognuno cerca di eludere le norme etiche e sociali. I nostri vecchi non avevano letto molti libri ma avevano scrutato il creato e ne avevano compreso le leggi e l’armonia profonda, custodivano nel loro animo l’idea del trascendente e non si sarebbero mai lasciati ingannare dagli esoterismi o confondere dai sincretismi delle sette. Si cammina sulla strada delle opere e dei giorni. Ma un conto è camminare soli e altro avvertire sul nostro percorso una presenza rassicurante, una guida alla quale affidarsi fino all’ultimo passo. Discórs de ciòch. ’Discorsi da ubriachi’. Purtroppo càpita non di rado di udire discorsi insensati e sconclusionati anche da persone che non hanno confidenza con gli alcolici. La modica voluptas di cui parla Seneca nel “De ira” non è traguardo facile, a giudicare dalla diffusa mancanza di autocontrollo e di autodisciplina, che finisce per compromettere la serenità dei rapporti sociali. Disgràssia, fèrmes lé! Traduzione italiana: ‘Disgrazia, férmati lì!’. Si dice quando è accaduto qualcosa di spiacevole che può tuttavia essere rimediato senza troppo affanno. È opinione comune che le disgrazie non siano mai troppe e che non vengano mai sole: ecco perché il bergamasco ricorre a questa locuzione. Se poi la disgrazia prosegue con altre sciagure che inducono alla disperazione, si ricorre ad un proverbio che recita: La consolassiù di disperàcc l’è de èd i óter a ’ndà in malura. Magra consolazione sapere che Atene piange quando Sparta non ride. Distanse de montagna. Si sa che le indicazioni della gente di montagna sui tempi di percorrenza dei sentieri e delle mulattiere sono poco affidabili: se vi dicono che con un buon passo potete impiegare mezz’ora per raggiungere una determinata località, fate conto che in realtà potreste impiegare un’ora perché non ci s’intende mai sulla velocità dell’andatura. D’altra parte non è un caso che il bergamasco faccia uso della locuzione specificativa de montagna. Qualche esempio: zét de montagna, ària de montagna, tèra de montagna, strada de montagna, sentér de montagna, perfino èrba de montagna (che è diversa dall’èrba de pianüra), oppure aqua de montagna (che è diversa dall’acqua delle risorgive di campagna). Si coglie alcunché di aspro e di faticoso nello specificativo, l’invito fermo a commisurare le energie con le difficoltà dell’ascesa, poiché nella vita occorre osservare e meditare prima di scegliere il miglior partito: la montagna come scuola di vita, dalla quale apprendere a distinguere i percorsi agevoli dai passi difficili. S’impara a superare le asperità con la prudenza e con l’esercizio: per aspera ad astra. L’ascesa conduce alla vetta e lassù la vista spazia su panorami insospettati: la vittoria ha il suo premio nella contemplazione dell’incanto del creato. Lassù la pietà degli alpini ha eretto croci ferree che sembrano simboleggiare la sete di trascendenza dell’uomo: attorno ad esse nei giorni di vento pare di udire i cori angelici del Paradiso. C’è chi fugge dal bailamme della città, dal caos brutale della massa e dalle aggregazioni innaturali e spersonalizzanti del consumismo per rifugiarsi in qualche contradella delle nostre Alpi Orobiche, non per isolarsi ma per ritrovare se stesso in una dimensione umana di poche persone buone e solidali, lontano dai miti effimeri di una società drogata dalla fame del denaro, che sa solo spingere l’uomo alla perdita di sé. Per salvare la nostra società occorrerebbe educare i giovani ad amare la montagna, a compiervi delle salutari escursioni anziché andare a rincretinirsi nell’alienazione e nel vuoto fragoroso delle balere. Domandà Piéro e respónd Pàol. A volte succede che ci si senta rispondere in modo assolutamente non pertinente: voi chiedete una cosa e ve ne rispondono un’altra. È come se a chi domanda di Pietro venga indicato Paolo: comportamento assurdo, che può essere provocato da un fraintendimento ma che può anche celare l’intenzione di uno sviamento o di un inganno. Non è necessario rifarsi alle idee espresse da Samuel Huntington nel suo “Scontro delle civiltà”(1996) per capire che le linee di faglia tra le civiltà sono rappresentate dalle etnie, dalle lingue e dalle religioni, dai più robusti caratteri identitari. Appare invece utile domandarsi se il modello statunitense del melting pot debba valere in tutto anche per la vecchia Europa, madre della civiltà occidentale. Le risposte che spesso vengono date non sono confacenti e appaiono contraddittorie. C’è chi giustamente domanda se la società multietnica sia proprio la panacea di tutti i mali o se non sia meglio salvaguardare l’identità culturale nazionale limitando e guidando i processi integrativi. C’è per converso chi risponde che occorre accogliere tutti senza badare alla condizione di clandestinità e al numero delle persone, fossero anche un miliardo e finissero per camminarci sulla testa. E allora si domanda dove sia finito il criterio, se esista ancora la nozione del buon senso o se ormai il caos totale e l’anarchia più pazza debbano prevalere. Le repliche sono agghiaccianti: si dà per scontato che a livello planetario siano in atto processi inarrestabili di unificazione (il che non è affatto vero sul piano ricettivo per gran parte dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina) e si sono coniati termini spregiativi e offensivi quali localismo, razzismo, xenofobia, per non voler affrontare il problema, in perfetto (pur se inconsapevole) accordo con le forze economiche interessate a delocalizzare i centri produttivi. Ecco che a legittimi e sacrosanti motivi di preoccupazione si risponde in modo del tutto inadeguato eludendo il problema, rinunziando a individuarne le soluzioni più confacenti e scaricandone le conseguenze sulle generazioni future, che pagheranno in termini di qualità della vita tanta demagogia e tanta irresponsabilità. Drissàga i gambe ai cà. È davvero una bella pretesa quella di voler raddrizzare le gambe ai cani. Una parte del pensiero moderno è irrimediabilmente dominata dal relativismo e dal nichilismo e non c’è verso di trovare punti di accordo. Non vale ridurre il problema ontologico allo stupore innanzi al grande spettacolo del mondo, considerato come una radura nella quale ogni cosa emerge e prende forma, secondo la suggestiva immagine di Martin Heidegger. Se non si elabora il concetto di verità, si rimane fermi al palo, come i pensatori analitici, per i quali non esiste azione buona o cattiva in sé: viene proclamata la soggettività, ma questa è priva di guida morale essendo relativa al tempo e al luogo nonché alle attitudini e alla cultura dell’individuo. Si capisce bene come questo modo di pensare conduca dritto al nichilismo, alla negazione dell’esistenza di valori assoluti, alla riduzione dei concetti del bene e del male a contingenze di tempo e di luogo. Innanzi al problema della ricerca della verità, si è dunque più arretrati di Ponzio Pilato, che da buon romano domanda a Gesù: “Che cos’è la verità?”. Se non esiste virtù possibile che valga per tutti, a che scopo continuare a speculare? La filosofia dovrà dunque morire? Sergio Quinzio, tormentato dall’attesa del regno di Dio, constatò per parte sua il senso di sufficienza, di presunzione e di superiorità di tanta parte della cultura contemporanea nei confronti del cristianesimo e delle sue prospettive escatologiche e ravvisò nel “ritardo” dell’adempimento della promessa del giudizio e della redenzione finale la causa delle scelte relativistiche. Ma spetta all’uomo stabilire i tempi apocalittici. Du de agóst. Si dice scherzosamente che il 2 agosto sia la festa degli uomini. Si è perduta però la memoria del detto celioso, che risale al tempo dell’invasione napoleonica. Si sa che i soldati francesi indossavano pantaloni molto attillati, che lasciavano intravedere le forme degli attributi virili. Un comandante dell’esercito francese, ossessionato dal concetto dell’uniformità e infastidito dal fatto che passando in rassegna le truppe notava che alcuni soldati disponevano tali attributi a sinistra e altri a destra, si dice abbia impartito l’incredibile ordine di disporli à la gauche, a sinistra. Dal che si evince che i microcefali non perdono occasione per manifestare la loro pochezza intellettuale. Du piö du, trentadù. Si dice quando si ha a che fare con una persona che vuole investire poco per ottenere molto o con uno strozzino che non sa che cosa sia un guadagno onesto. Due più due non può che fare quattro ma nella vita può succedere d’incontrare gente avida ed esosa, che ha imparato male a fare i conti e che pretende d’imporre al prossimo un concetto errato dell’aritmetica. La smania di possesso induce sempre alla disonestà e all’imbroglio. Aveva ragione San aolo: Radix omnium malorum cupiditas, ‘La cupidigia è la radice di tutti i mali’. Viviamo in una società nella quale si predica che sia più importante l’avere, ossia il possedere, che l’essere. Si sono visti spot pubblicitari molto diseducativi, secondo i quali le cose che contano nella vita sarebbero le donne, il potere, il denaro e un’automobile di lusso, come se non esistessero valori alti da testimoniare. Se non si crede in niente, se si nutre un concetto volgare della vita si finisce per credere che due più due faccia trentadue. Ma questo modo balordo di fare i conti conduce la società alla rovina. Durmì de la quarta. Indica un sonno lungo e profondo. Da migliaia di anni il filugello (in bergamasco caalér), che si nutre di foglie di gelso, è utilizzato dall’uomo per ottenere la seta dei bozzoli (in bergamasco galète). Molto vorace, il filugello aumenta progressivamente di dimensioni e di peso e cambia quattro volte l’involucro, fa cioè quattro “mute” (in bergamasco müde) e in corrispondenza di questi mutamenti cutanei fa quattro dormite (in bergamasco durmide), tutte ben osservate e controllate dai contadini, i quali dicevano che i bachi i durmìa de la prima per il primo sonno, de la segónda per il secondo, de la tèrsa per il terzo e infine de la quarta per il quarto sonno, che era il più lungo e dal quale dipendeva la mutazione definitiva del filugello. Durmì de la quarta vuol dire dunque ‘dormir della grossa’, ‘dormire come un ghiro’. Quando il baco aveva dato compimento al bozzolo, questo veniva distaccato per ottenerne la seta. La bachicoltura da noi è durata fino agli anni Quaranta-Cinquanta del secolo scorso e molti contadini ogni anno i metìa zó i caalér, adibivano una stanza riscaldata alla coltura dei filugelli per guadagnare qualche soldo con la vendita dei bozzoli, che venivano mandati alle filande. In Lombardia si produceva una seta di ottima qualità ma una forte concorrenza estera determinò in pochi anni l’abbandono della bachicoltura come nei primi vent’anni del Novecento la coltivazione del lino era stata soppiantata dall’arrivo del prodotto americano, molto meno costoso. Così vanno le cose a questo mondo. Ècc a l’è chi mör. Gli eufemismi sono spesso frutto dell’ipocrisia. Se dico negro per indicare una persona di colore trovo sempre qualche snob (latino sine nobilitate) che presume di potermi correggere. Perché mai si dovrebbe dire nero? Tutta la nostra letteratura conosce la forma negro per ‘persona di pelle nera’, dal latino niger, giustamente riversato in bergamasco nella forma arcaica nìgher perché i romani arrivati nella Gallia Cisalpina nel I secolo dopo Cristo al seguito delle legioni vittoriose possedevano ancora una pronunzia gutturale. Non vedo perché dovrei riformare il mio vocabolario quando in esso non esiste alcunché d’irriguardoso nei confronti di una persona che ha la pelle di colore diverso dalla mia. La stessa cosa è accaduta alla voce italiana vecchio, che è parsa a taluni irrispettosa e che è stata sostituita da anziano, senza pensare che vecchio è contrazione del latino vetulus, ‘vecchietto’, vezzeggiativo affettuoso che fa il paio con un’altra forma italiana presente in un noto incipit del Petrarca (“Movesi il vecchierel canuto e bianco”). Non parliamo della voce vecchiaia, sostituita dalla scipita locuzione terza età, che di preciso non vuol dir niente. Se si badasse un po’ di meno all’esteriorità e un po’ di più alla sostanza anche le lingue non tralignerebbero. Per fortuna non cede alle ipocrisie il bergamasco ècc (la forma arcaica vècc resiste se è preceduta da consonante, come ad esempio tat vècc, ‘tanto vecchio’). Ma il bergamasco ècc non ha in sé alcuna accezione spregiativa, che tuttavia si ritrova in qualche pittoresca e saporosa alterazione (es.: egina, egiòta, egiassa, egiassina, egèt, egiassì, egiàbol, egiù). Del resto, il bergamasco possiede la sua filosofia, un po’ spiccola se si vuole ma corroborata dal buon senso e dall’esperienza. Se è vero che l’è bröt a deentà ècc, è anche vero che l’è mèi ü vècc in d’ü cantù che sènto zùegn col gonfalù, ‘è meglio un vecchio (saggio) in un angolo che cento giovani (sprovveduti) col gonfalone’. Ecco riflesso in bergamasco il rispetto che della vecchiaia aveva la società greca (si scorrano in proposito gli “Opuscoli morali” di Plutarco). E poi, ècc a l’è chi mör, ‘vecchio è chi muore’. Ècc come Matüsalèm. Si dice di un uomo molto anziano che è vecchio come Matusalemme, uno dei più longevi patriarchi biblici. Di un vegliardo mentalmente indebolito si dice che l’è ècc bacöch, voce che richiama il nome del profeta Abacuch. Sentii dire una volta da una signora di Bergamo Alta questo bel paragone spontaneo: ècc come ’l Barla. Le domandai allora chi fosse questo Barla e la signora mi rispose che così diceva la sua nonna: da bambina anche lei aveva domandato alla nonna chi fosse il Barla ma anch’ella le aveva risposto di aver appreso a dire così dalla nonna. E ché comande mé. “Nóter de Bèrghem” è il titolo di una canzone bergamasca assai nota, che risale con ogni probabilità alla seconda metà dell’Ottocento, una canzone spiritosa che si avvale di un ritornello spassoso: E ché l’è la mé cà, e ché comande mé, òi saì chi và e chi vé, só mé ’l padrù. Coi tempi che corrono questo ritornello assume un particolare significato perché sembra rispondere alla odierna richiesta di identità da parte dei singoli individui e dei gruppi sociali. ‘Questa è casa mia’, dice la canzone, ‘qui comando io e voglio sapere chi va e chi viene’. Non c’è niente di male se si possiede una casa e se si vuol sapere chi va e chi viene; è stolto chi non si cura di sapere chi entra e chi esce da casa sua. Così anche la comunità è bene che non rinunzi mai a determinate regole, fondamentali per il vivere civile. I cittadini non possono stare tranquilli quando regnano il disordine e la prepotenza, quando la libertà non viene garantita, quando c’è gente che non ha rispetto dei diritti altrui, quando chi compie il crimine rimane impunito o non è adeguatamente sanzionato. Stiamo rinunziando a troppi princìpi e stiamo sacrificando troppi valori sull’altare del consumismo e della globalizzazione. Il processo di matrice economica che abbatte le frontiere degli Stati e che privilegia la circolazione delle merci, dei capitali e delle risorse presenta certamente aspetti positivi. Ma il rovescio della medaglia prospetta un consumismo sfrenato, una produttività ritenuta prioritaria rispetto all’ambiente, spesso deturpato e compromesso irreparabilmente dallo sfruttamento smodato delle risorse: è il trionfo di una concezione materialistica e utilitaristica, che lusinga l’uomo e che ne impoverisce l’interiorità. L’essere umano è ridotto alla condizione di consumatore, ergo non un essere pensante bensì un automa, un burattino acefalo, una marionetta mossa da chi bada esclusivamente al business e ai fatturati. C’è chi crede di reagire a questo stato di cose tentando d’imporre un mondialismo esasperato, per contrapporre agli sfruttatori gli sfruttati di ogni lingua e di ogni razza. Ma si tratta di un’utopia dissennata e il prezzo da pagare è altissimo: uomini senza radici, rimescolamento confuso delle culture e delle etnie, cancellazione delle tradizioni e delle lingue, predominio delle culture forti e soffocamento delle minoranze. All’omologazione degli sfruttatori non si fa altro che contrappone l’omologazione degli sfruttati. Non ci siamo. Abbiamo ancora una identità da difendere, una cultura radicata, ricca di storia, di umanità e di valori, che possiamo offrire in segno di amicizia a chi ci vuole conoscere, a chi viene da noi con intenzioni pacifiche. Perché dovremmo perdere la nostra identità, perché dovremmo ripudiarla? Èdela ströcia. Esempio: Me la só ésta ströcia. Potremmo tradurre: ‘Me la sono vista brutta’. Ma non è la stessa cosa perché lo ströcc è la fuliggine (traduce bene lo Zappettini nel suo vocabolario del 1859). Dunque, èdela ströcia significa vederla tanto brutta da temere di essere imbrattati di una materia nera, densa e lercia. Èd i ochì a tetà. Si traduce letteralmente: ‘Veder poppare le ochette’. La locuzione è usata soltanto se riferita ad una richiesta impossibile da soddisfare. Durante la seconda guerra mondiale, al tempo della Repubblica Sociale, due militari tedeschi entrarono nella casa del professor Spartaco Minelli, noto e stimato medico bergamasco, intento in quel momento a visitare i pazienti nel suo ambulatorio. Avendo notato presso l’ambulatorio l’automobile del medico, i militari fecero intendere di volere della benzina per il loro automezzo. Senza scomporsi, il professor Minelli accolse gli intrusi con questa domanda: Lur, siòre, ài mai vést i ochì a tetà? I teutoni ripeterono la loro richiesta: “Benzina, benzina!”. E il medico, imperterrito: Ghe domande se i à mai vést i ochì a tetà. Come Dio volle, gli alemanni, confusi e come interdetti, dopo un attimo di esitazione tolsero il disturbo andandosene a mani vuote. Èd ol diàol in de spècc. Un tempo le ragazze vanerelle che indugiavano ad osservare la loro immagine riflessa dallo specchio erano dette stimagète perché i se stimàa tròp, ‘si stimavano troppo’. E dalle loro madri si sentivano ammonire così: Te ederé ol diàol in de spècc, ossia ‘Vedrai il diavolo nello specchio’. Un proverbio insegnava infatti che a ardà tròp in de spècc a s’ vèd ol diàol, ‘se ci si specchia troppo si finisce per vedere il diavolo’. Si viene infatti tentati dalla vanità, si smarrisce il senso della modestia, si attribuisce valore più all’apparenza che alla sostanza. Forma bonum fragile, scrisse un grande poeta latino. La bellezza fisica non dura ed affidarsi alla sua precarietà significa essere interiormente poveri. Più si è vuoti dentro, più ci mette in mostra alla ricerca di consensi che possono soltanto lusingare la propria vanità. Èd ol lüf. Di una persona che appaia spaventata e sconvolta si può dire che l’à ést ol lüf, ‘ha visto il lupo’. Lo si diceva un tempo anche per le persone mute, presupponendo che le avesse rese tali lo spavento per aver incontrato un lupo sulla loro strada. Il detto risale ai secoli passati, quando le nostre montagne e i boschi della pianura erano infestati da branchi di lupi famelici che costituivano un serio pericolo per le persone. Non di rado i viandanti, anche se non erano soli, venivano assaliti e sbranati dai lupi, come le cronache attestano ad abundantiam. Alcuni nostri Comuni dovettero ricorrere al conferimento di premi ai cacciatori per diradare il numero delle fiere, che assalendo gli armenti infliggevano danni enormi ai pastori e agli allevatori e che a volte osavano perfino addentrarsi negli abitati costringendo le persone a rifugiarsi nelle case e a sprangare porte e finestre. Trovare sulla propria strada un lupo affamato non era dunque un bell’incontro. Ancor oggi si possono fare cattivi incontri, sebbene da tempo il pericolo dei lupi sia stato debellato. Ègia, sà che m’ bala! Nel vocabolario ottocentesco del Tiraboschi è registrata la locuzione esortativa: Ègia, balém!, ‘Vecchia, balliamo!’. Ma in Val Cavallina mi è capitato di udire: In mancansa de la zùena, ègia, sà che m’ bala! Il significato evidente è che ci si deve accontentare di ciò che si ha o di ciò che si riesce ad ottenere in una certa situazione senza poter pretendere di più ma la locuzione possiede un icastico senso di arguzia fra il bonario e il rassegnato che soltanto la freschezza sorgiva della lingua popolare riesce ad esprimere. Possiamo pedissequamente tradurre: ‘In mancanza della giovane, vecchia, vieni qua che balliamo!’. Insomma, piuttosto che rinunziare allo svago del ballo ci si accontenta anche di una donna anziana. Ma la traduzione appare sciatta, scipita, incolore ed ogni perifrasi italiana è praticamente improponibile. Ègn a la dé. Se dico di una persona che l’è egnida a la dé intendo dire che è arrivata. E se dico: Sét dré a tirà a la dé cosè?, devo tradurre: ‘Che cosa stai architettando?’. La voce dé, ‘dì’, ‘giorno’, in bergamasco è normalmente maschile. Dico infatti: Che dé él incö?, ‘Che giorno è oggi?’. Oppure: Quace dé m’ ghe n’à ’ndomà?, ‘Quanti giorni abbiamo domani?’. Oppure ancora: Incö l’è mia stàcc ü bèl dé, ‘Oggi non è stato un bel giorno’. Se però devo indicare la prima luce del mattino, ecco che la voce dé acquisisce il genere femminile. Per dire che spunta l’aurora (o l’alba, che precede l’aurora), devo ricorrere alla locuzione A l’ vé la dé, ‘Sta nascendo il giorno’, ovvero ‘Sta per sorgere il sole’. Posso dire anche: La dé la spónta, ‘Spunta il giorno’, oppure, nello stesso senso: La dé la compàr. Se si è in montagna e si sta godendo lo spettacolo del sole che sorge facendo capolino da una cresta di monte, il ricordo della locuzione bergamasca favorisce la coniugazione dell’estetica con la teologia e l’abbandono alla laudesi francescana. Ègn a tir. ‘Venire a tiro’. È locuzione minacciosa, di chi spera che uno gli giunga a poca distanza così da poterlo colpire con una fucilata o con un colpo d’archibugio o di balestra. Trovo scritto in un mio vecchio taccuino di appunti una frase udita chissà quando e da chi, che suona: Se l’ me ’é a tir chèl lé, a l’ mète apòst mé!, ‘Se mi càpita a tiro quello lì, lo metto apposto io!’. Non è sempre facile amare il prossimo… Ègn baslèta. Nei “Sonetti bergamaschi” di Sereno Locatelli Milesi si legge il verso: A ü tracc, sö l’öss, a gh’éra egnìt baslèta. È una locuzione ormai caduta in disuso: ègn baslèta, ‘svenire’, ‘sentirsi mancare’. Il Tiraboschi nel suo vocabolario registra le voci basièta, baslèta e basiöla, alle quali tutte attribuisce il significato di ‘svenimento’ e specifica: vègn basièta o basiöla: ‘venir meno’, ‘perdere gli spiriti’. La voce andrà messa in relazione con basgòt, parola usata dall’Assonica nel significato di ‘malfermo’, ‘vacillante’. Ed anche con il verbo basgà, ‘vacillare’, ‘tentennare’, e quindi ‘farneticare’, ‘uscir di mente’. Ègnen a öna. Arrivare ad una conclusione dopo aver tanto discusso. La logica impone che le disamine non siano mai vane e che dopo tanto argomentare e tanto valutare si giunga ad un punto fermo, ad una proposizione finale. Ma è sempre possibile? Se si pensa ai grandi temi dell’origine del cosmo e del senso dell’esistenza umana, sorge spontanea la domanda: S’ pöderà mai ègnen a öna?, ‘Si potrà mai giungere ad una conclusione?’. Incalzano gl’interrogativi. Come si è formato l’universo? Perché si è formato? Chi lo ha creato? E l’uomo che compito ha in questo disegno? Tutte le risposte scientifiche e filosofiche non hanno nulla di definitivo e di rassicurante. La tecnologia astronomica aggiunge mistero al mistero ampliando con le sue ricerche le nostre conoscenze e ci ritroviamo talora a sorprenderci sgomenti come i contadini di tanto tempo fa, che nelle notti stellate scrutavano meravigliati il firmamento percependo l’esistenza di un universo sterminato e mettendo a confronto l’esiguità e la finitezza della vita umana con le prospettive immense e sconfinate del creato. Se ci s’illude di poter escludere la fede dai problemi cosmologici ci si allontana ancora di più dalla verità. Ègn fò di öcc. Quando la vista prolungata di un luogo, di uno spettacolo o di una persona infastidisce si dice: A l’ me ’é fò di öcc, letteralmente: ‘Mi esce dagli occhi’. Ègn fò di orège. Chi è stanco di ascoltare una musica banale e ripetitiva (come sono le canzonette in voga oggidì) può dire che la ghe é fò di orège, letteralmente ‘gli esce dalle orecchie’. Altrettanto si può dire di un discorso o di un concetto che sia stato ripetuto a iosa tanto da riempire la testa di chi ascolta. Ègn la pèl de póia. Letteralmente: ‘Venire la pelle di gallina’. È similitudine spontanea che vale: ‘rabbrividire’. Esempio: L’ m’è egnìt la pèl de póia, ‘Mi si è accapponata la pelle’. Ègn sö ’l fiàt. È la locuzione di chi, dopo essersi allarmato, apprende una notizia che lo rassicura sull’infondatezza dei suoi timori. L’ m’è egnìt sö ’l fiàt, si dice in questi casi: è come se, dopo aver trattenuto il respiro per il momentaneo spavento, il fiato uscisse in un sospiro di sollievo udendo la notizia rassicurante. Ègn zó a caàl d’öna bóra. Oltre la Goggia la Valle Brembana ha estesi boschi di conifere. Un tempo i taglialegna (borelèr secondo la pronunzia altobrembana) recidevano gli alberi, li diramavano e li scortecciavano: il tronco così ottenuto (ossia sradicato, diramato e scortecciato) è detto in bergamasco bóra per la sua forma cilindrica (il tema prelatino bor- è espressivo di rotondità). La bóra veniva fatta rotolare lungo il pendio del monte fino al fiume (questa è l’origine del verbo bergamasco borlà zó, ‘cadere rotolando’). La corrente del Brembo trasportava le bóre fino all’ansa di Villa d’Almè, dove si arenavano; riconosciute da segni o marchiature apposite, erano recuperate e avviate a vari usi. È solo il caso di ricordare che tante finivano a Venezia negli squeri, gli arsenali dove si costruivano le navi o profondamente infitte nel fondo dei canali per legarvi le gondole. Di uno che sia grossolano, ingenuo e gonzo (in una parola intréch) diciamo che l’è egnìt zó a caàl d’öna bóra. Diamo un esempio storico. Nel 1913 Vittorio Emanuele III fu a Bergamo per inaugurare il monumento a Cavour, collocato nelle aiuole che fronteggiano il palazzo degli uffici comunali nel centro di Bergamo Bassa. Il monumento è costituito da una figura femminile, rappresentante l’ideale di libertà che animò e sorresse lo statista piemontese. All’atto dello scoprimento del monumento, un quidam de populo che stava vicino al gruppo delle autorità proruppe nella seguente esclamazione: Avrèss mai piö pensàt che Cavour a l’éra öna dòna!. Le cronache del tempo riferiscono un altro particolare curioso, che vale la pena di riferire. Recatosi in Palazzo Vecchio, dove allora aveva sede la biblioteca comunale, il re si attardò ad ammirare alcuni codici antichi; un contadino, il quale si trovava in Piazza Vecchia fra la folla in attesa che il sovrano si affacciasse al balcone, con quanta voce aveva in corpo si mise a urlare: Vé fò, dóca! Cosa sét vegnìt a Bèrghem a fà? Fàs vèt!. E quando il re d’Italia si affacciò al balcone per salutare la folla il buon uomo si commosse tanto da scoppiare in lacrime. Ègn zó de la pianta. ‘Scendere dall’albero’. Si usa in modo esortativo (es.: ’É zó de la pianta!, ‘Scendi dall’albero!’) per invitare utopisti e sognatori a non perdere il senso della realtà e a tenere i piedi per terra. Ègn zó di bréch. Certi luoghi sono in realtà dei “non luoghi”, sono il contrario dei luoghi. Un campo fiorito a primavera è un luogo, partecipa del risveglio della natura, è autentico, presenta il miracolo delle prime corolle che oscillano dischiuse al vento sugli steli. Il greto di un fiume, una pineta, una mulattiera, una contrada, una piazza sono dei luoghi. Un megacentro commerciale, una discoteca, un aeroporto, un’autostrada, una periferia urbana devastata dalla speculazione edilizia sono dei “non luoghi”, nei quali si smarrisce e si avvilisce il senso dell’esistenza. La nostra montagna, nonostante l’antropizzazione diffusa e gl’interventi che qua e là l’hanno deturpata, riserva ancora veri e propri luoghi di un’autenticità unica: boschi, radure, sorgenti, sentieri, pascoli, malghe, vette, strapiombi, pareti di roccia, ruscelli, laghetti, nevai sono tutti luoghi per eccellenza che meritano di essere conosciuti e praticati con il necessario rispetto. Sovviene il termine bergamasco bréch, ‘dirupo’, a indicare le asperità dell’alta montagna. Ci si divertiva un tempo a dire, di una persona un po’ goffa e tendenzialmente chiusa, che la egnìa zó di bréch, ‘che discendeva dai luoghi dirupati nei quali abitava’ (una volta ho anche sentito dire la forma ègn zó di grébegn, ‘discendere dai grebani’, luoghi rocciosi, alti e scoscesi, perché il linguaggio popolare ama l’iperbole). E tanto tempo fa, quando i montanari capitavano in città per sbrigare qualche faccenda, si rassegnavano a sentirsi domandare senz’alcuna ironia dai loro parenti e amici di città: Alura, come àla sö ’n di vòs’ bréch? Voce ritenuta celtica da tutti i più autorevoli filologi, brich- (o bréch-) indica sempre un’altura dirupata ed è testimoniata da molti toponimi in un’area vastissima: si pensi solo a Briga, l’italianissima cittadina della Alpi Marittime che l’avida Francia, accampando pretesti meschini, riuscì a rubarci alla fine del secondo conflitto mondiale. I bréch ogni anno ci attendono con il loro fascino incontaminato. Sono i luoghi dello spirito e della vita, antidoto alla crisi dei valori e dei comportamenti, agli smarrimenti etici, all’alienazione e all’angoscia. Leggiamo che le polveri sottili minano la salute di migliaia di persone: per disintossicarsi, niente di meglio che starsene un po’ in montagna nella bella stagione. Avendo le montagne a portata di mano, tanti giovani potrebbero recarvisi per qualche salutare escursione anziché andare a ballonzolare e a impasticcarsi nelle balere. Leggiamo che i ragazzini a undici anni si sborniano, vediamo ragazzine di dodici anni che s’illudono di essere disinvolte fumando sigarette, i giornali e le televisioni informano che la droga si è diffusa spaventosamente fra gli studenti. Il conformismo vanesio della trasgressione dilaga nella gioventù di questa società alla deriva, fondata sulle sabbie mobili dell’esteriorità. Non è facile far capire alle nuove generazioni che il frastuono di una discoteca – che è un “non luogo” – non riempie il vuoto interiore e che l’emozione di veder sorgere il sole dalla cima di un monte – che invece è un luogo autentico – può aiutare a capire il mistero della vita. Elemènt del löster. Si sa che la malavita era detta popolarmente lingéra. Appartenevano alla lingéra i perdigiorno, gli sfaticati, i giramondo che campavano di espedienti, di furterelli, di imbrogli e di raggiri frequentando i mercati e le fiere, dove trovavano sempre qualche credulone da ingannare, qualche merce da trafugare, qualche portafogli cui far cambiare tasca. Quei bei signori della lingéra erano soliti dire: “Con l’arte e con l’inganno si campa mezzo anno, con l’inganno e con l’arte si campa l’altra parte”. Alcuni di loro erano abili imbonitori e vendevano ogni sorta di mercanzia. Il mantovano Arturo Frizzi, che trascorse parte della sua vita girovagando da un paese all’altro e spacciando patacche nelle fiere, in un suo libro intitolato “Il ciarlatano” ricordò, fra tanti episodi della sua vita errabonda e non proprio esemplare, che una volta, da venditore ambulante, riuscì a esitare centinaia di scatolette di un impasto senza valore da lui gabellato per lucido da scarpe. Il commercio durò poco: i primi acquirenti, accortisi del raggiro, stavano prendendo d’assedio la sua bancarella ed egli dovette levar le tende in gran fretta e battere in ritirata. Ecco dunque che la nostra locuzione ha una sua ragion d’essere, perché un venditore che inganni l’acquirente è a dir poco ün elemènt, che in bergamasco non è un termine complimentoso (e se si dice ü bèl elemènt è ancor peggio, perché l’aggettivo, usato in senso ironico, rafforza il significato negativo del nome). Se dunque di una persona diciamo che l’è ün elemènt del löster esprimiamo in modo pittoresco tutte le nostre riserve sul comportamento e sull’affidabilità di quella persona. E non si creda che la locuzione non debba più essere usata perché oggi più nessuno spaccia per lucido da scarpe qualche intruglio. Purtroppo c’è ancora gente che commette frode in commercio affibbiando prodottacci al prossimo e che la passa liscia. Tutti elemèncc del löster, degni della lingéra! Él tò ’l tréno? Traduzione italiana: ‘È tuo il treno?’. La locuzione interrogativa era rivolta a persone invadenti, prepotenti e villane, che non si curavano di rispettare i diritti altrui. Sulle nostre linee ogni tanto capitava il maleducato che, avendo pagato un biglietto solo, metteva una valigia qua, uno zaino là e magari, accanto a sé, sul sedile, ü bel caagnöl, una bella cesta di vimini intrecciati. A proposito di treni, occorre ricordare che al tempo dei nostri nonni esistevano in Bergamasca diverse strade ferrate, ad incominciare dalla Bergamo-Clusone e dalla Bergamo-Piazza Brembana, che soltanto per la incredibile miopia degli ambienti ministeriali romani e per la imperdonabile negligenza dei rappresentanti politici bergamaschi negli anni Sessanta del Novecento furono soppresse anziché essere assunte dallo Stato, rammodernate e potenziate. Prima della guerra esistevano anche delle tramvie a vapore, treni con binari a scartamento ridotto, che collegavano Bergamo con Soncino, con Sarnico e Lovere, con Treviglio, Caravaggio, Lodi e Milano. Il collegamento con Monza, quello del famoso Gambadelègn, finì negli anni Cinquanta, quando fu soppresso anche il tram rosso che da Albino raggiungeva Bergamo facendo capolinea alle Muraine. Avessimo adesso quelle linee, con treni non inquinanti e viaggianti su sedi autonome! Dire che mancò la lungimiranza nell’eliminazione di quella rete di trasporti su rotaia è poco. È sempre per insipienza che si piange sul latte versato. Ènd ol sul per comprà l’öle. Come c’è gente che ha il bernoccolo per gli affari c’è anche chi, credendo di fare chissà quali investimenti, combina solo disastri e dilapida interi patrimoni. Si dice dunque giustamente che per imperizia o per stupidità c’è chi preferisce rinunziare alla luce del sole per ridursi a quella molto più debole del lume ad olio. Per invitare a fare economia ci si riferiva un tempo all’uso di andare a dormire appena tramontato il sole dicendo: Me n’à zamò endìt assé de sul per comprà l’öle, ‘Abbiamo già venduto abbastanza sole per dover comperare l’olio’. Entrà sö. Solitamente in bergamasco l’atto di entrare si esprime ricorrendo al verbo integrato ’ndà dét o ’ndà de dét (es.: só ’ndàcc de dét, ‘sono entrato’, l’è egnìt dét, ‘è entrato’), ma esiste anche il verbo entrà, usato per lo più con l’aggiunta della congiunzione sö nel senso di ‘capire’, ‘comprendere’,’afferrare il significato’. Se io dico che só entràt sö voglio significare che finalmente sono riuscito a capire un fatto o un concetto. Entrà sö implica, a seconda dei casi, l’oggettiva difficoltà di comprendere una lettura, un discorso, un comportamento, oppure l’oggettiva ottusità della persona che la ghe rìa mia a entrà sö, ‘non riesce a capire’, ‘non è in grado di comprendere’. Succede, per esempio, che certe persone leggano senza capire il senso di ciò che leggono. Se chiedono lumi, non sempre li ottengono e rischiano anzi di essere sbertucciati. In uno scritto risalente al 1926 Dino Provenzal ricordò che ad un suo amico burlone un tale si era rivolto per essere delucidato su di un passo della “Partita a scacchi” di Giuseppe Giacosa, là dove il paggio Fernando dice al padre della sua bella: “Non conobbi che l’ire, non conobbi che i pianti”. Il tale domandò: “Che significa ire? Ho guardato nel vocabolario e ho trovato ire per andare”. “Appunto”, rispose l’amico burlone, “il paggio dice Non conobbi che l’ire per mostrare la sua miseria, perché non avendo né carrozza né cavallo, poveretto, doveva ire a piedi!”. Sempre a proposito de mia entrà sö, ancora il Provenzal ricordò il caso di un insegnante d’italiano che per colpa di un errore tipografico aveva fatto imparare a memoria ai suoi allievi un verso del Carducci in modo sbagliato. Nella nota poesia “Davanti San Guido” si legge: “E il dì cadente, con un ghigno pio, / tra i verdi cupi roseo brillò”: L’edizione posseduta dall’insegnante recava non verdi bensì vedri e agli alunni che gli domandavano che cosa fossero mai i vedri l’insegnante rispondeva che, essendo il Carducci maremmano, doveva trattarsi di alberi che si trovavano nella parte meridionale della Toscana… Certo il fatto de mia entrà sö può portare talora a fraintendimenti dalle conseguenze inimmaginabili. È il caso di una liceale distratta alle prese con una versione dall’italiano al latino: dovendo tradurre una locuzione tanto ovvia quanto candida come io sono stato, la ragazza sbadatamente scrisse: ego sum res publica. Si possono immaginare le sghignazzate dei compagni di classe quando il professore di latino le chiese conto di una versione tanto peregina. So bene che in questo caso per püdì entrà sö occorre sapere di latino. Ma non è colpa mia se la lingua più importante del mondo antico, quella che sta alla base della nostra lingua nazionale come dei nostri dialetti, è ormai privilegio di pochissime persone. Ergóta de mèt sóta i décc. In questo caso ergóta, ‘qualcosa’ (lat. vere gutta, ‘almeno una goccia’) suona a sinonimo di ‘cibo’. Richiama il proverbio: Quando s’ gh’à fam, l’è bu töt, ‘Quando si è affamati qualunque cibo è buono’. Èsga amò mercàncc in féra. Lo dicevano un tempo i nostri contadini quando dovevano vendere un animale al mercato del bestiame o un prodotto agricolo al mercato della frutta e della verdura. Intendevano dire che recandosi alla fiera delle merci speravano di poter ottenere un buon guadagno rivolgendosi a mercanti onesti. Se si vuole esprimere un sentimento di fiducia si può dunque dire: Gh’è amò mercàncc in féra. Ebbene, facciamo voti che il detto si attagli alle fortune dell’esperanto, la lingua della fratellanza universale, inventata dall’oculista polacco Lejzer Ludovik Zamenhof (1859-1917), il quale visse a Byalistok, una città nella quale esisteva una convivenza difficile fra polacchi, russi, tedeschi ed ebrei, che abitavano in quartieri separati e che comunicavano malvolentieri fra loro. Zamenhof si fondò sulle lingue romanze, anglosassoni e slave escogitando un sistema grammaticale e sintattico di straordinaria semplicità. L’apprendimento dell’esperanto non prospetta infatti alcuna difficoltà: molti esperantisti l’hanno imparato con il solo ausilio di un manuale e di un vocabolario e comunicano normalmente fra loro a voce e per iscritto come si fa con qualunque altra lingua. Purtroppo molti interessi e l’orgoglio smodato di alcune nazioni (Stati Uniti d’America, Gran Bretagna, Francia, Germania, Cina, Russia) si oppongono alla diffusione dell’esperanto. Non è detto però che l’egemonia dell’angloamericano duri in eterno: grandi nazioni emergenti potrebbero presto ridurne o soppiantarne l’uso. Il primato di una lingua sulle altre possiede sempre un tratto colonialistico essendo indice di supremazia economica e culturale. Ciò che non si dà con l’esperanto, il quale possiede intatte le sue chances. Èsga dét ol gioanì. È credenza popolare che dopo il 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista, all’interno delle ciliege si trovi un piccolo baco, detto appunto gioanì. Ecco perché è bene gustare le ciliege nel mese di maggio, sempre che il loro prezzo non sia proibitivo. Ricordo i seguenti versi di Giovanni Pascoli tratti da “La mietitura” (in “Nuovi Poemetti”): “Le ciliege erano andate: / per San Giovanni avevano i giannelli”. Èsga gna sancc e gna madóne. Si dice per significare che non si può sfuggire a un determinato obbligo. Un esempio? Potrete rivolgervi a tutti i santi del Paradiso e supplicare la Vergine in tutti i suoi santuari ma non riuscirete e a sfuggire alle malefiche spire della burocrazia e ai tentacoli mortiferi del fisco. Èsga piö de religiù. Viviamo in tempi nei quali predomina l’egoismo, il rispetto dei diritti altrui è spesso ignorato e l’etica pubblica e privata è alle corde. Tutto ciò non può che essere effetto di un diffuso indebolimento del sentimento religioso. Le nostre nonne direbbero: Gh’è piö de religiù. Di Zaleuco, legislatore di Locri e discepolo di Pitagora, vissuto cinque secoli prima di Cristo, è rimasto solo un frammento, il preambolo al suo codice delle leggi. In quel preambolo si legge: “I cittadini devono essere persuasi dell’esistenza di Dio. L’ordine e la bellezza dell’universo non sono opera della mano dell’uomo né sono effetto del caso. Dunque i cittadini rendano omaggio alla divinità con le opere buone e con la pratica della virtù”. Queste parole non sono ancora attuali dopo duemila e cinquecento anni? Èsghen öna futa. ‘Essercene una gran quantità’. Il corrispondente italiano del bergamasco futa è fottìo, termine popolaresco ritenuto volgare dai lessicografi e di uso prevalentemente centromeridionale. Dà l’idea della moltitudine di gente o della caterva di oggetti. Strano a dirsi ma in un dizionario bergamasco recente trovo che la voce futa può voler dire ‘collera’ oppure ‘inezia’, entrambi significati arcaici. E non è registrato l’unico senso nel quale io ho sempre sentito usare il vocabolo, quello del gran quantità. Èss a bolèta. I vecchi bergamaschi sanno che ìga di bóle vuol dire ‘avere del denaro di grosso taglio’, forse perché il sigillo (lat. bulla) veniva apposto su diplomi o missive, che avevano solitamente dimensioni tutt’altro che insignificanti. Erano definiti bolète i tagli di denaro di minore formato e naturalmente di minor valore. Èss a bolèta ha finito per significare la condizione di chi non ha soldi. Èss a bolèta sparada indica la miserevole condizione di chi non possiede neppure il becco di un quattrino. Èss al cap di sich pèrghe. I contadini di un tempo sapevano bene che un campo di sole cinque pertiche non bastava per mantenere una famiglia, essendo il terreno troppo esiguo e i raccolti del tutto insufficienti. Ancor oggi quando non si vede la risoluzione di un problema si dice che s’ sè amò al cap di sich pèrghe, ‘si è ancora al campo delle cinque pertiche’. Il detto offre il destro per considerare quanto problematico sia lo spopolamento delle campagne: in un secolo diverse città sono diventate megalopoli ma coloro i quali vi si sono stabiliti non hanno quasi mai migliorato la loro condizione economica e sociale. Come se si trovassero a campare ancora con un terreno di cinque pertiche, vivono da indigenti in un degrado impressionante, in quartieri-ghetto proibiti a chi appartiene ad altre etnie (altro che società multietnica!), nella sporcizia, nella miseria e nell’alienazione. Si ritrovano così poveri e affamati com’erano prima di lasciare la loro terra. Sono sorte in ogni parte del globo enormi megalopoli ingestibili, caratterizzate da sterminate periferie nelle quali allignano la delinquenza e la corruzione, nelle quali la vita di una persona ha pochissimo valore e il concetto della dignità umana spesso non ha alcun diritto di cittadinanza. Fra i disastri provocati dal mito della ricchezza monetaria caro agli usurai che dominano l’economia e la finanza mondiale occorre considerare anche l’abbandono di vasti territori rurali e montani e l‘urbanizzazione sfrenata e disordinata del pianeta. Èss al vérd. Non è una piacevole situazione perché indica l’assenza di denaro. La locuzione, di origine popolare, si è diffusa anche in italiano: di una persona priva di denaro si dice infatti che è al verde. In epoca comunale gli statuti obbligavano chi aveva contratto un debito ad aggirarsi con un copricapo di color verde, cosicché tutti sapessero che si trattava di un debitore e badassero bene a non accordargli un credito purchessia. Vi fu inoltre un tempo in cui un pubblico incanto durava quanto una candela accesa, della quale si tingeva di verde l’ultimo tratto, che doveva essere infisso nel candeliere; quando la fiamma aveva ridotto la candela al verde, si dichiarava chiusa l’asta ed era ritenuta valida l’ultima offerta pervenuta. Èss amò al mónd. Un modo assai rustico, ironico e quasi indisponente di salutare o di accogliere una persona che non si vedeva da molto tempo consiste nel domandargli a bruciapelo: Sét amò al mónd?, ‘Sei ancora nel mondo dei vivi?’. Sarebbe come dire: Non sei ancora morto? Èss ampiùs. Aggettivo da àmpia, che non è propriamente l’‘ansia’ di lingua, perché in bergamasco non posso dire: só in àmpia, per rendere l’italiano ‘sto in ansia’. Ampiùs è chi ha voglia di fare, chi non vede l’ora di mettersi all’opera, chi quasi si strugge se viene impedito di realizzare un suo proposito. Per fortuna nella vita s’incontrano persone così naturalmente dotate, capaci e volitive, che attendono solo il destro per manifestare le loro attitudini. Ne ho conosciute tante. Mentre scrivo ricordo Gianni Colleoni, ottimo fotografo, uomo dal carattere franco e aperto, spirito positivo e gioviale, eclettico e intraprendente: documentò per tanti anni la cronaca locale con i suoi scatti netti e infallibili; nella mansarda di un edificio della Celadina nel 1977 incominciò da pioniere le trasmissioni della prima stazione televisiva bergamasca e ricordo ancora che la sera di Natale di quell’anno volle che con due poeti amici, Martino Vitali e Luigi Gnecchi, leggessi in studio alcune poesie ispirate alla grande festività cristiana. Fu editore di libri fotografici e promotore instancabile di manifestazioni culturali. Era un trascinatore e se si prefiggeva un obiettivo, lo perseguiva fino a raggiungerlo. Si concedeva una debolezza quando fra il serio e il faceto affermava di essere discendente di Bartolomeo Colleoni. A volte per divertirsi lo diceva in tono serioso e qualche sprovveduto finiva per credergli. Èss assé a’ mès. Facciamo un esempio: L’à ciapàt ü stremésse tal che l’éra assé a’ mès, ‘Ha preso uno spavento tale che mezzo bastava’. Ci si riferisce perciò a qualcosa di eccessivo, di spropositato quando si dice che la metà era sufficiente (e magari ce n’era d’avanzo). È locuzione tipicamente bergamasca, di gente avvezza a fare i conti e a non sprecare le risorse, di gente provvista del senso delle proporzioni e che sa distinguere un comportamento di moderazione e di buon senso da un altro trasmodante, teatrale, chiassoso. Altro esempio: L’à dàcc fò in d’öna manéra che l’éra assé a’ mèsa, ‘Ha sbraitato tanto scompostamente che sarebbe bastata la metà’. Ecco il senso della misura e dell’autocontrollo, che sembra essere stato smarrito i tempi come i nostri, con le televisioni che da anni e anni fanno a gara nel propinare alterchi e zuffe, nel diffondere la maleducazione e la villania, la trivialità e il turpiloquio, senza che alcuna costosa authority (mancava anche questa scimmiottata!) si senta mai d’intervenire a ricordare il dovere del rispetto e della buona educazione, perché i telespettatori non sono affatto villani, rozzi e screanzati come presumono i guitti e i saltimbanchi che pontificano dai teleschermi. È un fatto che quando tutti parlavano in dialetto c’era molta più creanza e lo spirito comunitario sapeva manifestarsi nella comprensione e nella solidarietà. All’espansione economica e al progresso tecnologico è purtroppo corrisposto un preoccupante regresso sul piano etico e civile. Èss bu de tègn la pèna ’n di mà. La stima e la considerazione che si nutrivano per le persone dotte nella società contadina sono bene simboleggiate da questo detto, che suona a lode di chi sapeva maneggiare la penna con onestà e competenza. La versione negativa della locuzione riguardava chi, non vantando confidenza con le belle lettere, l’éra gna bu de tègn la pèna ’n di mà. Evoluta la società e alfabetizzata la gente, ogni giorno si leggono sulla stampa cose turche scombiccherate da saccenti, astuti e ben pagati pennaioli privi di onestà e di competenza. Così va il mondo. Èss bu per i cai. Non è piacevole avere i calli ai piedi. Si può pertanto immaginare con quale interesse fossero accolti un tempo nelle fiere e nei mercati i ciarlatani che spacciavano rimedi miracolosi per fà passà i cai. Quasi sempre però si trattava di rimedi fasulli, di unguenti che non guarivano assolutamente i calli e che valevano solamente ad alleggerire i portafogli degl’incauti acquirenti. Il detto è diffuso in tutta la Lombardia e ciò si spiega con il fatto che i ciarlatani, dovendo evitare di ritornare in uno stesso luogo per non essere riconosciuti e aggrediti dai clienti buggerati, agivano su di un territorio molto vasto. Se un farmaco non è efficace si dice dunque che l’è bu per i cai. Lo stesso si può dire di una cura sbagliata o di un oggetto inutile. La locuzione sottintende la necessità di distinguere fra apparenza e realtà. Se una persona vince un telequiz o riesce a risolvere un cruciverba non è detto che sia colta: c’è una bella differenza fra nozionismo e erudizione come c’è una bella differenza fra erudizione e cultura. Allo stesso modo se per la salute fisica dobbiamo ricorrere a rimedi efficaci, per la salute interiore non ci si deve affidare ai maghi e alle fattucchiere, alle sette e a certi movimenti pseudofilosofici e pseudoreligiosi che i è bu per i cai. Èss chèl del tóch. Questa locuzione è ormai caduta da tempo in disuso ma nell’Ottocento la si udiva correntemente. Se di una persona si diceva che l’éra chèla del tóch significava che era molto sfortunata. La locuzione traeva lo spunto dal gioco fanciullesco del tóch, che rifletteva un’antica pratica liberatoria connessa con le ancestrali credenze magiche: il gioco simboleggiava infatti la necessità di liberarsi da un incantesimo o da una fattura trasferendone gli effetti negativi ad un’altra persona. Si sa che nel gioco del tóch chi “stava sotto”, chi cioè doveva rincorrere gli altri, era come se dovesse liberarsi da alcunché di negativo. Quando finalmente chi l’éra restàt sóta riusciva a toccare con la mano un altro compagno di gioco, ecco che si sentiva liberato; doveva però fuggire come gli altri per non essere a sua volta toccato. Èss come ’l pedersèm. Il prezzemolo si trova in tutti gli orti perché la credenza popolare attribuisce ad esso poteri curativi (fluidifica il sangue e combatte la tosse, il raffreddore, le flatulenze e le intossicazioni). Se di una persona si dice che è come il prezzemolo si vuol significare che la si trova in ogni luogo e in ogni circostanza (oggi, con brutto neologismo, si dice che è presenzialista). È omologa la seguente locuzione: Èss conossìt come la betònega, ‘Essere conosciuto come l’erba bettonica’. I detti evocano la medicina pauperum affidata alle erbe, note e sfruttate ab immemorabili per le loro proprietà terapeutiche. Chi non conosce i fiori di camomilla, le bacche di ginepro, le foglie di menta, le radici di ginseng? Dall’uso popolare delle foglie di salvia (in bergamasco èrba sàvia) e di rosmarino (osmanì) per sbiancare i denti e renderli brillanti all’impiego che facevano i monaci delle erbe coltivate nei giardini dei loro monasteri per la preparazione dei cordiali e delle acquaviti, si ricava una lunga casistica che presenta effetti a volte impensabili: si sa, ad esempio, che fu un infuso di tabacco a calmare le nevralgie di Caterina de Medici. Non si dice poi dell’impiego delle erbe aromatiche nelle ricette di cucina, dal basilico all’aglio, dall’origano al peperoncino. Le credenze popolari sono numerosissime: un forte consumo di ravanelli favorirebbe la crescita dei capelli e si esalterebbero le capacità amatorie mettendo sotto il materasso delle foglie di ortica mentre la ruta e la maggiorana le deprimerebbero, il timo combatterebbe la malinconia e il trifoglio allontanerebbe le fatture maligne. In realtà non sempre la vox populi è veritiera ma è assodato che il luppolo sia diuretico, che la polvere di papavero concili il sonno e che il sambuco calmi la tosse. La riscoperta in epoca moderna della conoscenza dei poteri curativi delle erbe ha fatto la fortuna delle erboristerie. Èss cül e braga. Letteralmente: ‘Essere culo e braca’. Si dice di due persone che siano in grande confidenza. In altri dialetti lombardi si dice Èss cül e camisa. La locuzione è greve ma icastica. Èss de buna famèa. Si dice così per indicare l’appartenenza ad una famiglia stimata e onorata. Quando eravamo ragazzi era gratificante sentirci dire che facevamo parte di una famiglia ben considerata. Ora arrivano messaggi disgreganti, concepiti per ridicolizzare e svilire i valori sui quali si è sempre fondata la famiglia. I nostri vecchi testimoniavano l’impegno e la donazione di sé: l’amore era la forza che teneva unita la famiglia e grazie ad esso si sapevano affrontare e superare le difficoltà. Quando non si vuol costruire e si dà prova d’immaturità pensando che i figli siano solo degl’inciampi e che non si debba mai sopportare un sacrificio, che senso ha andare all’altare e che senso hanno le formule del codice civile? Locuzioni bergamasche come questa contengono insegnamenti profondi e perenni, restituiscono all’etica il ruolo che ad essa compete, ripristinano la scala dei valori e allontanano dal livido pelago dell’individualismo e dell’egoismo. Il matrimonio non è un retaggio oscuro del passato: l’essere umano è uscito dal branco ed ha incominciato a vivere civilmente quando ha costituito la famiglia. Se si vuole edificare per il futuro occorre ritornare ai punti fermi rappresentati da locuzioni come questa. Èss dét che s’ néga. Dal latino necare, ‘uccidere’, usato anche per indicare l’atto di affogare. A m’ sè dét che m’ néga, ossia ‘stiamo annegando’, mi diceva qualche tempo fa un amico insegnante il quale, avendo tastato il polso ai suoi allievi in fatto di cultura locale, si era accorto che non sapevano chi furono Bartolomeo Colleoni e Gaetano Donizetti, non avevano idea dell’epoca di costruzione delle Mura, ignoravano il nome del santo rappresentato dalla statua dorata che sovrasta la cupola della Cattedrale, non conoscevano il significato di alcune parole bergamasche di uso corrente. Per troppo tempo si è considerata stoltamente la cultura locale come una radice da estirpare, una “mala pianta” da far morire per “sprovincializzarsi”. Le lingue locali sono state avvertite non come una ricchezza da salvaguardare e da tramandare, non come il patrimonio più immediato e vivo di una comunità, grande o piccola che sia, bensì come resti ingombranti di un passato del quale – chissà perché? – ci si dovrebbe addirittura vergognare. Esistono tuttora correnti politiche e di pensiero le quali – alla faccia di quanto dettato in un suo importante documento dal Consiglio d’Europa – non fanno mistero di professare simili disastrose idee, spacciate per progressiste ed avanzate. Strano: le generazioni che ci hanno preceduto ci hanno lasciato un patrimonio storico, artistico e culturale invidiabile e di prim’ordine, gli stranieri arrivano in massa a visitare le cento città d’Italia apprezzandone la cultura millenaria che si è spesso irradiata in altre terre e presso altri popoli e noi ci dovremmo vergognare della nostra cultura e delle conquiste spirituali, etiche, civili e sociali dei nostri antenati. Se si è tratti al punto di disprezzare l’immenso valore della memoria, significa che si sta proprio annegando nel grande mare dell’ignoranza. Èss dré a ’ntirlà. Si diceva un tempo della frutta che stava quasi giungendo a maturazione. Per traslato la locuzione si usa ora per dire che si sta avvicinando un temporale: L’è dré a ’ntirlà, ‘Sta arrivando’ (soggetto sottinteso: ‘il temporale’). Di una persona molto arrabbiata, che stia quasi per perdere le staffe, si dice che l’è marüt (letteralmente: ‘è maturo’). Èss dré a ragiunà. Il verbo ragiunà può essere tradotto letteralmente ‘ragionare’ ma nel suo vocabolario il Tiraboschi giustamente lo rese così: ‘favellare’, ‘parlare’, ‘discorrere’. Aggiungiamo pure ‘discutere’, perché se io dico: A m’ sè dré a ragiunà, intendo dire non solo che stiamo discorrendo ma che stiamo anche discutendo. Non parliamo tanto per parlare ma stiamo argomentando, stiamo usando la dialettica, stiamo impiegando la logica, come si fa in un dialogo per arrivare ad una conclusione plausibile. Insomma, stiamo esercitando la ragione, grazie alla quale si può evitare la guerra. Il ragiunà dei bergamaschi è atto di disponibilità altamente civile e consiste nell’esporre le proprie idee all’interlocutore e nell’ascoltare le idee dell’interlocutore. È anche atto di libertà, che riafferma il diritto sacrosanto di esprimere il proprio pensiero (c’è sempre chi vorrebbe impedire o perseguitare la libertà di pensiero, magari usando qualche vecchio codice da stato di polizia). I nostri avi ci hanno tramandato il sano costume di sedersi attorno ad un tavolo e di mètes dré a ragiunà per giungere insieme a capo di qualcosa confidando nelle risorse dell’intelletto: per quanto limitata, la ragione, se usata con assennatezza, fa progredire l’uomo. Éss fàcc in bandéra. Essere fatti su misura, essere fatti apposta. Per confezionare una bandiera non occorre aver grandi nozioni di taglio e di cucito: basta sapere che cos’è un rettangolo e tagliare bene la tela in modo che poi il drappo sventoli e faccia bella mostra di sé. Dunque èss fàcc in bandéra significa essere perfettamente squadrato come una bandiera, fatta per garrire al vento in tutta la sua evidenza. La locuzione è diffusa anche fuori Bergamo; una volta a Verona una signora con la quale stavo conversando mi disse: Quando se trata de fare del ben, mi son fata in bandiera. Per il nostro detto non trovo relazione con una locuzione del furbesco della malavita, che suona èss in bandéra per dire ‘essere al bando’. Èss fò de có. Di uno che abbia smarrito il ben dell’intelletto si dice che ‘è fuori di testa’, traduzione letterale del bergamasco l’è fò de có, espressione sottilmente eufemistica per ‘fuori di sé’ ovvero ‘impazzito’. Se uno non è in sé, si può ben dire che sia fuori di sé e visto che la sede dell’intelletto è nel cervello, che si trova nella testa, di uno che non ragiona è giusto dire che l’è fò de có. Nello stesso significato adesso si sente anche dire semplicemente: è fuori. La locuzione mi si è affacciata alla mente leggiucchiando qua e là un saggerello di Giorgio Bertolizio, per trent’anni primario ospedaliero, il quale si è divertito a mettere alla berlina alcune delle menti più acute della filosofia occidentale. Sapevo che Immanuel Kant, maestro del criticismo trascendentale, vissuto da metodico nevrotico, trascorse penosamente i suoi ultimi anni: gli si era spenta l’intelligenza, devastata dalla demenza senile. Ma non potevo immaginare che Platone fosse, a seconda delle circostanze, un pavido, un borioso e un opportunista, che Epicuro fosse un presuntuoso e un megalomane, che Aristotele fosse uno scialacquatore, che Seneca fosse un doppiogiochista il quale lodava l’imperatore cospirando alle sue spalle. Sapevo che Rousseau, ertosi a pedagogo, fu in realtà persona detestabile perché, padre assai snaturato, abbandonò i suoi figli negli orfanatrofi per non avere il fastidio di crescerli e di educarli, sapevo che Schopenauer era uno scontroso che soffriva di manie di persecuzione e che Marx non si peritò di esporre coscientemente la sua famiglia alla miseria. Ma non sapevo che Nietzsche fosse “un caso clinico interessante” e che la sua morte fu motivo di “grande sollievo per chi lo conosceva”. Il saggio del dottor Bertolizio s’intitola “Nevrosi, idiozie e malefatte dei grandi filosofi” e insegna che la virtù della coerenza è assai poco praticata e che occorre sempre stare attenti a mia ’ndà fò de có. Èss fò del lècc. Letteralmente: ‘Essere fuori dal letto’. Significa: ‘Essere in salute’. Se un bergamasco si sente chiedere come sta, può rispondere in tono sospensivo: ’Ntat che m’ sè fò del lècc… Èss fò di strass. ‘Essere furente’. Si dice di una persona talmente irata che possa da un momento all’altro andare fuori dai gangheri e prorompere in escandescenze. La locuzione raggiunge un effetto caricaturale riducendo a strass, ‘stracci’, l’abito dell’iracondo. Èss in bal. La traduzione letterale ‘essere in ballo’ dice e non dice. Se penso ai balli insignificanti del giorno d’oggi, di gente che si agita ritmicamente con movenze strane e improvvisate, che non hanno alcun senso, allora la locuzione bergamasca non mi dice niente. Ma se penso ai balli di un tempo, quelli del cavaliere e della dama, con i ritmi e i passi obbligati che svariavano dal valzer al tango, dalla mazurca alla giava, dal fox-trot allo shimmy, dalla rumba alla samba, dall’habanera allo slow, allora ecco che tutto si chiarisce. Usciti con le ossa rotte e le città bombardate da una guerra lunga e terribile, che nessuno si era augurato, costretti a fare i conti con la svalutazione galoppante e con le tessere annonarie, si voleva dimenticare le ansie, le paure, i lutti, le rovine. I giovani ballavano dappertutto, nei cortili, nelle aie, con un vecchio grammofono a molla e pochi fragilissimi dischi a 78 giri, lasciati magari da qualche soldato americano. Il ballo era quasi una condizione di vita e per qualche tempo servì a riconquistare un po’ di spensieratezza e di serenità dopo tanto dolore. Così la locuzione bergamasca èss in bal richiama la fatalità degli eventi e la necessità di reagire alle prove del destino. Quando m’ sè in bal, me tóca a balà, si dice per indicare la necessità di adeguarsi alle situazioni e di sottostare alle regole del gioco che ci viene imposto dalla sorte. Forse è un richiamo atavico alle danze che tracciarono sulle rocce gli artisti primitivi, quando la tribù si ritrovava nelle carole comunitarie di valore propiziatorio. Dai balli di corte alle festicciole in famiglia, dai veglioni ai balli mascherati è tutta una tradizione d’incontro e di socializzazione, che valeva ad esaltare la galanteria e le buone maniere. Sono ormai sepolte nei ricordi le feste danzanti nei circoli, quando i nostri bisnonni vestivano la marsina, l’abito di gran gala noto ora con il nome di frack (usato ormai soltanto dai concertisti di musica classica e dai direttori d’orchestra), nessuno più ricorda i balli-cotillon, durante i quali si distribuivano doni agl’invitati. Ora tutto è livellato e relegato alle infime bassure del rincretinimento di massa, quello dei party chiamati rave, nei quali si ascolta musicaccia riprodotta a volumi demenziali, si bevono superalcolici e si assume droga fino allo sballo, massima espressione dell’imbecillità collettiva. Vien fatto allora di ricordare un’altra locuzione bergamasca, che suona trà in bal o tirà in bal, usata quando si deplora la contestualizzazione di cose prive di nesso o di fatti estranei a una determinata situazione. Cosa sìv indàcc a tirà in bal?, si dovrebbe domandare ai quei poveri balordi che si stordiscono nei raves, ammesso e non concesso che fossero in grado di dare una risposta sensata. Come antidoto, si potrebbe loro raccomandare un corso di balletto classico: a estremi mali, estremi rimedi. Èss in di bune mà. ‘Essere in buone mani’. Non è modo di dire tranquillizzante se detto in senso ironico, soprattutto quando si dipende da un potere superiore che sia avverso. Esempio: A m’ sé pròpe ’n di bune mà!, ‘Siamo proprio in una pessima situazione!’. Èss in d’öna bòta de fèr. Indica una situazione che dia la massima sicurezza o le più ampie garanzie. Se diciamo che m’ sè in d’öna bòta de fèr intendiamo significare che godiamo della massima protezione, come se fossimo non all’interno di una botte costruita con le doghe in legno bensì dentro una botte di ferro, resistente ai colpi e agli urti. Sarà per spirito di contraddizione ma ogni volta che sento pronunziare questa locuzione penso che non esista tanta sicurezza da giustificarne l’uso. E mi sovviene l’episodio della visita di Solone a Creso, come lo narrò Erodoto nelle sue “Storie”. Dopo aver mostrato a Solone tutti i suoi tesori, Creso, ricchissimo re di Lidia, gli domandò se avesse mai conosciuto un uomo veramente felice. Si attendeva che Solone lo adulasse dicendogli essere lui l’uomo più felice della terra. Ma il sapiente ateniese gli narrò di un certo Tello, che conobbe la felicità perché, morendo sul campo di battaglia, fece in tempo a vedere che i nemici soccombevano e fuggivano. Poi menzionò due fratelli che erano atleti forti e famosi, per i quali la madre chiese ad una dea il bene maggiore concesso ai mortali. La dea la esaudì facendole morire i due figli nel sonno. Indi Solone invitò Creso a non sentirsi sicuro e appagato di tanta ricchezza, essendo il fato invidioso dell’umana felicità. Le parole del saggio ateniese furono profetiche. Ciro, re dei persiani, invase il regno di Creso e ne saccheggiò i tesori. Innanzi al rogo che avrebbe dovuto arderlo vivo, Creso gemendo invocò a gran voce il nome di Solone. Ciro gliene chiese ragione; appreso quanto Solone aveva detto a Creso, Ciro pensò alle alterne vicende della vita e fece spengere il rogo provando pietà di Creso, che un tempo si era illuso di essere felice in grazia della sua temporanea ricchezza. Il re persiano, divenuto il più potente e ricco signore della terra, si augurò in quel momento di non dover un giorno sopportare le conseguenze dell’invidia del fato, non volle sentirsi felice e ordinò che Creso avesse salva la vita. Èss indré ü car de rèf. Si pensi a quanto filo di refe può stare su di un carro per aver un’idea del senso di arretratezza che dà questa bella locuzione bergamasca, riaffacciatasi alla memoria mentre leggevo tempo fa i dialoghi di Platone dedicati alla figura di Socrate. Consideravo la fallacia del metodo eristico, la precarietà della tecnica confutatoria di opporsi ad un assunto perdendo di vista lo scopo fondamentale dell’indagine speculativa, ossia la ricerca della verità. Basta leggere il “Fedone” e il “Simposio” per rendersi conto che le menti più illuminate che Atene vantava fra la metà del IV e la metà del III secolo avanti Cristo i éra indré ü car de rèf quando sostenevano che l’anima preesistesse al corpo senza interrogarsi sull’origine dell’anima. Così la trovata che, una volta morta la persona, l’anima trascorresse un certo tempo nell’Ade per poi reincarnarsi in un altro corpo e recuperare l’antica conoscenza attraverso un’anamnesi del tutto intuitiva, non può che fare il paio con le fantasticaggini sulla cosmogonia e sulla natura dei numi d’Olimpo, divinità primitive che possedevano difetti ben peggiori di quelli degli uomini. Che Alcibiade si presenti ubriaco al convito non è certo edificante ma che Aristofane proponga come oro colato la fanfaluca degli uomini tagliati in due da Giove per ottenere il maschio e la femmina è ridicolo. Davvero l’immagine del carro di refe giunge a proposito quando si confrontano le idee e le credenze manifestate nei dialoghi di Platone con la concezione del mondo e della vita che si desume dalla lettura dei profeti biblici (basta pensare al terzo Isaia, pressoché coevo). Fuori discussione appare invece la tensione morale di Socrate, che tutti sopravanza con il suo costante anelito alla saggezza e alla virtù. Èss in fastöde. ‘Trovarsi in imbarazzo’. Oggi diciamo che ci troviamo in imbarazzo se dobbiamo riferire una notizia sgradevole a un amico. Ma i vecchi bergamaschi dicevano tranquillamente: “Sono in fastidio”. Rendeva meglio l’idea. Èss infularmàt. Il verbo infularmà è di uso raro e designa l’atto proprio di chi in una discussione si accalora e trascende, di chi avendo qualcosa da compiere lo fa con un impeto fuori luogo, con una veemenza irragionevole: è il lasciarsi trascinare dalla foga e dalla passione, il dedicarsi ad una causa con eccessivo trasporto. Scrive Sant’Agostino che il teatro del suo tempo era tanto tralignato da suscitare passioni insane: egli ricorda che l’amico Alipio si compiaceva degli spettacoli più cruenti e feroci offerti nel circo dai gladiatori che combattevano all’ultimo sangue. Trascinato dall’urlo della folla degenerata e impazzita, Alipio si esaltava allo vista di uno spettacolo immorale e disumano. E Procopio nelle “Carte segrete” narra a quale abbrutimento era giunto il popolo di Bisanzio; parteggiando nelle corse dei cocchi per questa o per quella fazione, gli spettatori degli opposti fronti si assalivano, venivano alle mani e si abbandonavano ad atti criminosi. Nonché dai ricordi di letture come queste ora richiamate, il riflessivo infularmàs può essere evocato dai comportamenti trasmodanti di chi prende troppo a cuore un’idea o un partito o anche solo uno sport o uno spettacolo. Che sono mai gli strilli di certe ragazzine che idoleggiano un cantante rock? E i fanatismi di certa tifoseria che confonde la sportività con i comportamenti della teppaglia? E le scritte facinorose tracciate da qualche esaltato mentecatto sulle facciate delle case? Il verbo bergamasco deriva dalla locuzione folle armato ed indicava all’origine ciò che di pericoloso può compiere un folle il quale giunga a brandire delle armi. Il buon senso dice che le furie del paladino Orlando stanno bene e sono ammirevoli soltanto nella descrizione che ne seppe dare l’Ariosto con le sue inimitabili ottave. Èss in gianda. ‘Essere in miseria’. Le giande erano le sofferenze inflitte con gli strumenti di tortura per far confessare i rei sospetti. Con il passare del tempo il significato si è ampliato alle condizioni economiche lagrimevoli di chi versa nella miseria più nera. Èss in sentùr. Significa: ‘Essere ben presenti’, ‘Avere la mente lucida e sgombra’. Èss la mata. Nel gioco della canasta la carta della matta prende tutto. È quel che si dice un colpo di fortuna. Se una persona sta vivendo un momento felice diciamo che l’è la sò mata, ‘è il suo giubilo’, ‘è la sua bazza’. Non si trova traccia di questa locuzione negli usuali repertori lessicali bergamaschi. Èss mia de Credér. Per significare di non essere creduloni si dice scherzosamente de èss mia dre Credér, ‘di non essere di Credaro’. Nonostante questa locuzione celiosa i credaresi non patiscono di alcuna ingenuità. Èss mia s-cècc de nissü. Chi si sente svalutato e umiliato da considerazioni ingenerose e da giudizi malevoli può replicare in tono risentito: Só mia s-cèt de nissü, mé!, ‘Non sono figlio di nessuno, io!’. La locuzione ricorda le dure condizioni di vita che un tempo dovevano affrontare i trovatelli. Èss nassìt col cül in del bötér. Talora l’efficacia delle locuzioni popolari attinge allo scurrile ma raggiunge un’espressività icastica. È il caso di questo modo di dire (che in italiano suona: ‘essere nato con il posteriore nel burro’), al quale si ricorre per indicare chi abbia avuto natali agiati e fortunati. Dice un proverbio lombardo: De zùen in del bötér, de ècc in di pensér, ‘Giovane ozioso, vecchio bisognoso’. Èss ol ròcol di bòte. Di un ragazzino troppo vispo, che veniva spesso percosso per le sue monellerie, si diceva che l’éra ’l ròcol di bòte, era il richiamo delle busse. Il roccolo, per chi non lo sapesse, era un impianto per la cattura degli uccelli di passo. Anni fa i centri abitati non producevano quantità enormi di immondizia, nelle campagne non si usavano fertilizzanti chimici e pesticidi, l’aria e l’acqua non erano inquinate e nella stagione autunnale il cielo era solcato da grandi stormi di uccelli migratori, che dalle terre settentrionali d’Europa, seguendo rotte aeree misteriose, andavano a svernare sulle coste africane del Mediterraneo. I nostri contadini, non potendo catturare la selvaggina stanziale, riservata al feudatario o al proprietario del fondo, s’ingegnavano di catturare gli uccelli di passo, sui quali nessuno poteva vantare diritti di sorta, perché quelli i a mandàa ’l Signùr… Fin dal Medio Evo si ha notizia dell’apprestamento di impianti fissi per l’aucupio, chiamati, a seconda delle zone, roccoli, bressane o paretai (è giusto che la lingua italiana si sia impossessata di queste voci di provenienza dialettale e se oggi essa sta paurosamente decadendo è perché non può più giovarsi della preziosa risorsa lessicale dei nostri dialetti, tanto ricchi di cultura e di storia e tanto stupidamente perseguitati). Molti di questi impianti sono ancora ben visibili in tutta la fascia delle colline lombarde, se ne incontrano percorrendo i sentieri di montagna e si riconoscono per la presenza di una torretta in muratura (detta in bergamasco casèl, ‘casello’), prospiciente ad uno spiazzo contornato da alberi di carpine disposti a ferro di cavallo, con i rami fittamente intrecciati per nascondere la vista delle reti usate per la cattura. Mutato (e guastato) l’habitat, i migratori sono talmente pochi che non vale più la pena di tenere in efficienza gl’impianti. Da tempo i roccoli sono stati abbandonati e la legge ne consente l’uso soltanto ai cultori della scienza avicola e per esclusivo scopo sperimentale. Èss ol ròcol di disgràssie Si dice di una persona (o di una famiglia) che sembri attirare su di sé le disgrazie, tanto è afflitta da continui dispiaceri e da tristi vicissitudini. Il roccolo, si sa, era strumento di aucupio e gli uccellatori più accaniti vi si trasferivano per alcuni mesi dell’anno trascorrendovi i giorni e le notti come in una normale abitazione. Èss öna beghina. La voce, assai diffusa, ha assunto da tempo un’accezione negativa. Erano infatti così qualificate le donne nubili che si distinguevano per il loro bigottismo. Ma all’origine le beguines erano donne di un certo riguardo che nel secolo XIII si trovavano nel Nord della Francia e delle quali dà notizie un poema di Jakes d’Amiens (riesumato da un vecchio codice della biblioteca di Dresda e pubblicato a Lipsia nel 1868 da Gustav Körting). Si trattava di donne di buona posizione sociale, molto pulite e di bell’aspetto, che vestivano abiti eleganti, che calzavano scarpe costose, che avevano modi garbati e gentili e che pranzavano con cibi prelibati e vini di qualità. Queste signore si differenziavano dalle popolane perché si recavano di buon mattino in chiesa per assistere alla prima Messa, erano dedite alla preghiera e osservavano i precetti religiosi. Èss öna grima. Ho udito più volte la voce grima e non mi capacito che essa non sia registrata dai repertori lessicali. Che competenza hanno i compilatori? Comunque, con questa voce (imparentata con l’aggettivo tedesco grimm, ‘feroce’, ‘truce’, ‘fiero’) ci si riferisce sempre a una donna cipigliosa, energica, risoluta, che nei modi ricordi un generale prussiano e che sappia fare il proprio interesse. Èss öna müssina. Müssina significa ‘salvadanaio’. Qualche volta si sente la variante büssina. Non ci si deve stupire del vasto fenomeno che i filologi definiscono diacronia e che attiene alle alterazioni fonetiche e alle mutazioni cui è sempre sottoposta una lingua fintanto che sia correntemente parlata da consistenti gruppi sociali. Basta leggere una canzone del Petrarca o una novella del Boccaccio per rendersi conto delle enormi trasformazioni della lingua italiana, che peraltro ha sempre avuto una tradizione scritta di prim’ordine. Figuriamoci dunque se i fenomeni diacritici non debbono investire le lingue locali, che possono presentare, a seconda delle zone, forme fonetiche differenti per uno stesso vocabolo. La müssina designa un contenitore di terracotta o di ceramica a forma di maialino con una fenditura nella parte alta per l’inserimento delle monete o delle banconote. L’uso della müssina valeva ad infondere nei bambini il senso del risparmio, che non sarebbe male recuperare dopo tanto consumismo e tanto scialo di futilità, dopo tanto malgoverno e tanta irresponsabilità perfino nella conduzione della cosa pubblica, penalizzata da sprechi vergognosi, da irrimediabile inefficienza e da costi spropositati. Per gli ebrei e gli arabi il maiale è simbolo di sordidezza e di scurrilità, non così per gli europei, i quali hanno conservato del maiale l’idea che avevano i germani e i celti; questi ultimi consideravano addirittura sacro il maiale, simbolo di prosperità e di abbondanza per la sua carne saporita, nutriente, ricca di calorie. Non ci si deve dunque stupire se ancor oggi si vendono salvadanai a forma di maiale. C’è da augurarsi che si ritorni ad insegnare ai bambini a risparmiare usando il salvadanaio. Una persona capace di accumulare un gruzzoletto ragguardevole o di combinare un affare lucroso era definita dai nostri vecchi öna müssina. Non si dice di privarsi del necessario e di vivere da pitocchi, come fanno gli avari ma neppure di abbandonarsi al lusso e agli sprechi. Si confida infine che quanti gestiscono la cosa pubblica s’impegnino a spendere bene il denaro della comunità, coniugando la lungimiranza con la parsimonia. Èss ön’arma de còl. Dovendo aver a che fare una volta a Zogno con uns certa persona, volli disporre di qualche informazione sul suo conto. Domandai ad un conoscente e fui messo sull’avviso con queste parole: “L’istaghe bé atènt perchè l’è ön’arma de còl”. Non avevo mai sentito una simile locuzione e ne chiesi conto. Mi fu spiegato:“L’è ü gran margnifù”. Dunque, si trattava di persona assai astuta, capace di mettere nel sacco chicchessia. Ma perché arma de còl? Ed ecco il vecchio buon Tiraboschi con il suo vocabolario del 1867 che ci soccorre traducendo alla voce còl ‘scaltritaccio, drittone, drittaccio, furbo in chermisi’. Se arma vale per ‘alma’ o ‘anima’, se ne conclude che arma de còl vale per ‘quintessenza della furberia’. Sbrigai la mia faccenda senza danno perché non ve ne sarebbe stata né l’occasione né la ragione ma quel tale aveva proprio occhi da faina. Èss öna sanguèta. Staremmo freschi se al giorno d’oggi si applicassero ancora le sanguisughe per curare l’ipertensione. I viscidi animaletti avidi di sangue, che un tempo erano molto diffusi nelle acque stagnanti, furono impiegati a scopo terapeutico fin quasi alla fine dell’Ottocento ma già da molto tempo erano nominati in senso figurato per indicare persone senza scrupoli intente a spillar denaro con ogni pretesto. Italiano e bergamasco in questo caso si trovano d’accordo: se nella lingua nazionale diamo della sanguisuga ad uno che sia esoso e che s’ingegni a cavar denaro dagli altri, in quella di Bergamo diciamo che l’è öna sanguèta. È ben vero che la voce bergamasca sta cadendo in disuso ma anche la corrispondente italiana si ode sempre di meno. Il bello soccombe per l’invadenza di ciò che è brutto ed ecco andare in crisi non solo i dialetti, così freschi e sinceri, ricchi di storia e di umanità, ma anche il buon italiano, rovinato dai canzonettari e massacrato dai blateratori televisivi. Rassereniamoci rievocando un ameno fatterello occorso parecchio tempo fa nella Prussia renana. Un contadino si presentò al farmacista della cittadina di Berkenfeld chiedendogli delle sanguisughe. Il farmacista osservò che da tempo ormai non si usavano più le sanguisughe in medicina ma il contadino non intendeva ragione. “Volete proprio trovare delle sanguisughe? Andate all’ufficio delle imposte e vi troverete le migliori sanguisughe della nazione”, tagliò corto il farmacista, che dovette pronunziare queste parole senza tradire alcuna ironia perché il contadino le prese sul serio. All’ufficio delle imposte il funzionario si adontò fieramente della richiesta del contadino, il quale si giustificò dicendo che era stato il farmacista a indirizzarlo colà. In breve, l’agente delle tasse, furibondo per essere stato definito sanguisuga, denunziò il farmacista. Il giudice, condividendo in cuor suo l’opinione che il farmacista nutriva dei funzionari del fisco, ebbe la manica larga e condannò il farmacista al pagamento della modesta somma di venti marchi. Il farmacista a sua volta inviò la sentenza ad un giornale umoristico, che la pubblicò in bella evidenza attribuendogli un premio di settanta marchi. Non pago, il farmacista si divertì a scrivere al funzionario delle imposte per chiedergli come dovesse dichiarare al fisco il guadagno netto di cinquanta marchi. Che soddisfazione sbertucciare chèle sanguète de l’öfésse di tasse! Èss öna sbéra. Troppo comodo cavarsela dicendo che si tratterebbe del femminile del sostantivo sbér, ‘sbirro’, molto usato al tempo della dominazione asburgica. In realtà la voce designa una donna bella e appariscente, che occhieggi civettuola, che sappia mettersi in vista con disinvoltura e che non manchi d’intraprendenza e di astuzia. Si diranno öcc de sbéra due begli occhi femminili incantatori, vividi e accesi. La voce sbéra non è registrata dagli usuali repertori lessicali. Èss öna stòfa de braghér. La voce braghér può derivare da un latino altomedievale bracarius, aggettivo di braca, parola celtica assunta dal latino per indicare l’indumento indossato dai maschi delle popolazioni barbariche che andavano spesso a cavallo e che ignoravano l’uso della tunica. Con la latinizzazione la braca celtica andò a far parte dei pluralia tantum e non c’è da stupirsi che abbia originato il termine bergamasco braghe, ‘pantaloni’. Il dizionario dello Zappettini (1859) alla voce braghér traduce: ‘brachiere’, ‘cinto’, con evidente allusione alla cintura di contenimento dell’ernia inguinale. Ma lo stesso dizionario aggiunge il significato traslato di ‘seccatore’, ‘importuno’, ‘persona molesta’ e poi ancora ‘imbroglione’, ‘intrigatore’, e specifica: ‘persona che volentieri s’intriga in ogni cosa, massime in quelle che tengono un po’ dell’imbroglio’. Non so con che stoffa si confezionasse il cinto di contenimento dell’ernia ma è evidente trattarsi, secondo la locuzione bergamasca, della stoffa dell’imbroglio. Se abbiamo a che fare con un braghér ricordiamoci che tenterà di carpire la nostra buona fede promettendo mari e monti. Ergo, non fidiamoci, non perdiamo il nostro tempo con lui e allontaniamolo al più presto. Èss öna mèsa calsèta. Ho udito qualche volta i dialettofoni della città proferire questa locuzione per indicare persone dappoco. Chèl lé l’è öna mèsa calsèta: se di un tale vi dicono così state pur certi che non vi sarà di grande aiuto, come sarebbe di scarsa utilità una calza ridotta a metà. Il detto è diffuso in tutta la Lombardia ed è entrato da tempo nell’uso comune dell’italiano regionale. Èss öna pèl. Di uno che abbia carattere duro e ostinato e che non esiti a commettere azioni cattive si dice che l’è öna pèl: un brutto soggetto, dunque, con il quale è meglio non avere a che fare. Trovo tuttavia in un dizionario bergamasco che la locuzione èss öna pèl vorrebbe dire ‘essere coraggioso’ e non mi capacito che l’accezione corrente risulti travisata in modo tanto stridente. Èss piasìcc. Una signora che non sia eccezionalmente bella può sempre dire che l’è piasida. E anche un uomo sposato, se non è proprio quel che si dice un Adone, può dire che l’è piasìt. Si fanno sempre troppe considerazioni sulla bellezza fisica. Secondo certe fonti d’informazione al giorno d’oggi gli uomini spenderebbero di più delle donne per le cure estetiche (sarà ma non ci credo). D’altra parte è vero che c’è chi raccomanda costosi interventi di chirurgia plastica al solo scopo di migliorare l’aspetto fisico (ma quelli che diffondono queste idee per invogliare gli altri a sottoporsi a simili interventi non si sono mai guardati allo specchio?). Un aspetto esteriore piacevole conta non poco in una società come la nostra, tutta dedita all’apparenza, schiava della superficialità e della fretta. Eppure l’esteriorità è quasi sempre fuorviante. Prima che essere belli fuori dovremmo cercare di esserlo dentro, nell’animo nostro. Èss piasìcc non vuol dire che grazie al nostro aspetto fisico una persona si è invaghita di noi e ci ha sposato, vuol dire invece che quella persona si è innamorata di noi perché in noi ha trovato delle qualità che le sono piaciute. Se una donna l’è piasida, sarà stata anche molto bella ma l’uomo che l’ha sposata deve aver trovato in lei delle virtù e delle doti interiori che ha apprezzato moltissimo. Questa è una locuzione da tramandare alle nuove generazioni per il suo sottinteso magistero morale. Èss poarèt come San Quintì. Di uno che sia ridotto in miseria si dice che ‘è povero come San Quintino’, il quale visse in Gallia al tempo dell’imperatore Massimiano e secondo la leggenda aurea di Jacopo da Varallo fu crudelmente martirizzato durante una persecuzione ordinata dallo stesso imperatore. Non si hanno notizie sicure della vita di questo santo ma di lui è rimasta leggendario il disprezzo dei beni materiali, che lo indusse a vivere in estrema povertà. Èss sofìstech. Quando domandai che cosa volesse dire èss sofìstech mi fu risposto: Sofìstech a l’è ü che l’ ghe à mai bé negót, ‘uno al quale non va mai bene niente’. Dunque, se ü l’è sofìstech lasciatelo perdere perché qualunque cosa facciate, non sarà mai contento e troverà sempre qualche difetto. In simili casi si dice ironicamente che l’è brao dóma lü, ‘è bravo soltanto lui’. Èss sóta balansì. Chi mi dice che il balansì è una traversa di legno alla quale si attacca il cavallo, chi invece mi dice essere il giogo che unisce la coppia di buoi. In ogni caso la locuzione indica chiaramente la condizione di chi deve obbedire ed eseguire senza discutere ciò che gli è richiesto. Nell’italiano colloquiale: ‘bere per non annegare’. Èss teàt. Ancora nella prima metà dell’Ottocento si sarebbe detto taiàt ma evidentemente la mutazione fonetica che prevede la semplificazione del dittongo ai nella vocale e ha buona resistenza. Si dice che l’è teàt (letteralmente ‘è tagliato’) uno che ci sappia fare, non solo perché esperto ma anche perché astuto. In ogni caso è persona con la quale non è il caso di cimentarsi, come non era il caso di provocare gli schermidori (scrimadùr in bergamasco) che avevano superato diverse sfide a duello, delle quali serbavano evidente traccia in una cicatrice sul volto. Èss teàt zó col corlàss. Di una persona molto rozza, che abbia modi rustici ed eloquio plebeo, si dice che l’è teàt zó col corlàss, ossia squadrato alla bell’e meglio, come si fa quando si deve tagliare una grossa forma di cacio con un coltellaccio e non si può andare molto per il sottile. La voce corlàss infatti non è che l’equivalente italiano di ‘coltellaccio’, formatosi sul latino cultellus, avvertito dalle popolazioni dell’Italia Settentrionale come cortellus per effetto di una certa intercambiabilità delle consonanti liquide. Se si aggiunge a cultellus il suffisso spregiativo –aceus si ottiene cultellaceus, donde il coltellaccio della lingua italiana. Tuttavia il suffisso –aceus era troppo lungo, ambiguo e divagante per la pronunzia bergamasca, che lo semplificò in –ass; quindi, cortelàss. Ma per i bergamaschi, che non amano perdere tempo in blateramenti e menare il can per l’aia, la voce cortelàss poteva benissimo essere ridotta a cortlàss. Poi si pensò di contrarre ulteriormente la voce fino a corlàss: si risparmia il fiato di una sillaba, che è sempre meglio di niente, e ci si capisce comunque. Si dice anche: Èss teàt zó co la sgür, ‘Essere tagliato con la scure’. A Treviglio si dice: Èss teàt zó col fursèt (tardo latino falcettus), ‘Essera tagliato con la roncola’. Èss tecàcc a ü fil. Quante volte ci si rattrista apprendendo che muoiono nel fiore degli anni persone assalite da malattie che non perdonano. Si dice allora che m’ sè ché tecàcc a ü fil, ‘su questa terra siamo appesi ad un filo’ e senza rendercene conto alludiamo al mito classico delle tre Parche, le quali filavano e recidevano a loro piacere il filo della vita di ogni essere umano. È detto risalente al mondo antico. Èss tra l’incösen e ’l martèl. Si sente dire anche: Èss tra ’l martèl e l’incösen, che è la stessa cosa e che vuol dire essere fra due fuochi, poter essere colpiti da una parte e dall’altra. L’incudine, si sa, è strumento di lavoro dei ciabattini e dei calzolai, che vi appoggiano la suola per batterla con il martello. La locuzione si attaglia alla situazione dell’uomo contemporaneo, costretto, per non soccombere, a barcamenarsi fra il desiderio di certezze durevoli e l’impellenza di aggiornarsi, di stare al passo con il progresso tecnologico. È l’omeostasi di cui parlano gli psicologi, che con questo termine indicano l’equilibrio fra i numerosi stimoli al cambiamento che quotidianamente sono offerti dal mondo esterno e la costante richiesta di norme stabili e di valori assoluti proveniente dalla nostra interiorità. Si corre il rischio di essere emarginati ed occorre adeguarsi ai mutamenti, che talora sono consistenti e repentini. E l’aggiornamento non basta perché l’homo interior pretende risposte esaurienti, che le conquiste tecnologiche non sanno dare. Èss ü bagià. Nei secoli passati i bergamaschi identificavano i milanesi per mezzo di questo appellativo più compassionevole che schernevole e canzonatorio, come ben attesta il Manzoni nei “Promessi Sposi”, là dove Bortolo avverte Renzo di rassegnarsi in terra orobica ad essere definito baggiano. Si tratta di un traslato popolare scurrile della voce lombarda bagià, ‘baccello della fava’. L’uso di questo termine è ormai caduto in disuso. Sta tramontando anche il malvezzo di qualificare i milanesi con il termine büsecù, letteralmente ‘mangiatori di trippa’ (da bösèca, ‘trippa’). Èss ü balabiót. Nel 1797 l’esercito francese giunse a Bergamo e con uno stratagemma varcò le porte delle Mura, s’impossessò della piazzaforte, depose il rettore veneto e fece issare in Piazza Vecchia l’albero della libertà, presso il quale i rivoluzionari fecero sostare delle donne di malaffare che con moine e gesti scurrili attiravano i giovinastri della città. Alla notizia che Bergamo era stata occupata dai francesi parecchi valligiani della Valle Brembana, della Valle Imagna e della Val San Martino si concentrarono a Ponte San Pietro armati di vecchi archibugi quando non di bastoni, di zappe e di tridenti e si diressero alla volta di Bergamo per manifestare il loro attaccamento al simbolo del Leone di San Marco. Furono attesi dall’esercito francese, che a Longuelo li disperse a cannonate. I cadaveri degl’insorti furono trasportati a Bergamo Alta e ammassati intorno all’albero della libertà. Alcuni giovani spavaldi ebbri di vino, che portavano in capo il rosso berretto frigio, festeggiarono a modo loro la facile vittoria delle armi straniere danzando nudi attorno ai corpi dei poveri montanari uccisi. Il fatto suscitò la più viva riprovazione del popolo bergamasco, che coniò il vocabolo spregiativo balabiót per indicare una persona tanto scimunita da giungere a denudarsi in pubblico. Il fenomeno delle insorgenze, molto più diffuso di quanto non si creda, fu uno spontaneo moto popolare avverso all’esercito napoleonico e al suo violento e rapinoso spirito di conquista; si manifestò in diverse province dell’Italia Settentrionale, da Verona a Bergamo, da Pavia a Brescia, dal Tirolo alla Valtellina. Tutte le insorgenze furono stroncate nel sangue con l’intervento massiccio dell’esercito. È un fatto che i francesi giunsero da noi con intenti ladreschi e che trattarono l’Italia alla stregua di una colonia requisendo tesori d’arte inestimabili, confiscando, taglieggiando, rubando a man salva, imponendo l’ammasso dei prodotti agricoli e la coscrizione obbligatoria, dalla quale trasse origine il fenomeno del banditismo. Le idealità che animarono la rivoluzione francese non furono testimoniate che in minima parte dal regime napoleonico instaurato in Italia; dopo la cruenta avventura imperialistica del Buonaparte le nostre terre si ritrovarono assai più povere e desolate che al tempo dell’antico regime. C’è però chi sostiene che la parola balabiót sarebbe più antica e che risalirebbe ai tempi di carestia, quando scarseggiavano perfino i panni per coprirsi. “Vigné una gran carestia e comincé a balabiot”, dice un documento luganese dei secoli passati. Ma può ben essere che la parola sia ritornata in auge in epoca napoleonica. Èss ü balòss. Di una persona inaffidabile si può dire che l’è ü balòss. Se un tale non ispira fiducia negli affari si può dire che l’ gh’à del balòss. Il termine balòss è così tradotto dal Tiraboschi: ‘birbone’, ’briccone’, mariuolo’, ‘furfante’. A questi appellativi non proprio da galantuomo lo Zappettini aggiunge questi altri: ‘sciagurato’, ‘scellerato’, ‘ribaldo’, ’truffatore’, ‘giuntatore’. E aggiunge: céra de balòss, ‘ceffo di birbone’, sima de balòss, ‘schiuma di sciagurato’. Giacomo Devoto accosta balosso a balogio nel significato di ‘birbante’, ‘rompicollo’, voce dalla quale fa derivare balordo; ne indica l’etimo nell’antica voce franca balle, che può significare anche ‘fola’, ‘panzana’ e quindi ‘narrazione bugiarda’. La diffidenza che suscita un balòss è pienamente giustificata. Dal saggio intitolato “Discussione economica del Dipartimento d’Olona”, pubblicato nel 1803 da Melchiorre Gioia, si apprende che le campagne di Milano, Pavia, Monza e Garbagnate erano infestate in quel tempo dalla presenza dei balossi, giovinastri oziosi, lavoranti stagionali che, conclusa la raccolta dei bachi da seta o la produzione del formaggio, minacciavano i fittavoli per farsi consegnare il vitto quotidiano, poltrivano per ore all’osteria architettando qualche bravata o dandosi al gioco d’azzardo, svuotavano i pollai quando non diventavano ladri di strada e perfino teppisti, giungendo a danneggiare le colture di chi osava rifiutare la loro protezione. Arrestati dalla polizia, spesso uscivano subito di galera per l’eccessivo zelo dei giudici nella ricerca delle prove. Nihil sub sole novi… Èss ü baraba. È sinonimo di delinquente incallito e ripete il nome del malfattore giudeo condannato a morte e liberato da Ponzio Pilato a preferenza di Gesù Cristo per le insistenze dei sacerdoti del sinedrio e dei loro sostenitori. Un tempo i ragazzi riottosi che venivano accolti in un istituto educativo erano chiamati barabìcc, ‘piccoli barabba’. Scrive il Tiraboschi nel suo vocabolario: “Dicesi di quei ragazzi o giovinastri che si vedono birboneggiare per la città”. Èss ü barlafüs. Non è un complimento dire di una persona che l’è ü barlafüs. Si appioppa infatti questa qualifica a chi è del tutto disutile e inetto. Si tratta, manco a dirlo, di un traslato. Infatti all’origine barlafüs è un vecchio oggetto di pochissimo conto, ormai tanto mal ridotto da non poter quasi essere più usato; di solito giace polveroso e abbandonato in un solaio o in una cantina. Èss ü bèl artìcol. Letteralmente: ‘Essere un bell’articolo’. Negl’inventari che vengono redatti annualmente per valutare la consistenza delle giacenze dei magazzini di casalinghi, di chincaglierie, di prodotti di merceria e di altri generi in commercio può capitare che esistano voci di alcuni vecchi articoli non più richiesti perché passati di moda o superati: il grossista non può che pentirsi di averli acquistati perché non li venderà e sarà costretto ad eliminarli. La valutazione negativa dell’articolo non più commerciabile, che rappresenta una perdita in termini economici, è estesa con questa locuzione agli esseri umani: se di una persona dico che l’è pròpe ü bèl artìcol, intendo riferirmi a un tipo quanto meno strano e molto originale, che nessuno accosta volentieri e del quale è bene non fidarsi. Èss ü bèl originàl. Bell’originale fu, a mio modo di vedere, il professor Pasino Locatelli. Nato il 10 ottobre 1822 e morto il 3 agosto 1894, si laureò in giurisprudenza a Pavia. Nel 1848 partecipò ai moti milanesi delle Cinque Giornate combattendo sulle barricate, si arruolò nella guardia civica di Bergamo, fece parte della colonna bergamasca accorsa in aiuto ai rivoltosi di Brescia e fu allo scontro del Tonale. Espatriato in Svizzera, fu riammesso nel Lombardo-Veneto dopo una sua discolpa non proprio limpida, con la quale aggravò la posizione dei fratelli Camozzi. Va ascritto a suo merito di aver continuato dopo la morte del Facchinetti la compilazione, peraltro assai diligente, dell’almanacco annuale delle “Notizie Patrie”. Nel 1856 fu nominato segretario della Società Bergamasca per l’Incremento Agricolo e Industriale. Nel 1859 si arruolò ancora nella guardia civica. S’intestardì a voler tenere un’orazione durante un rito funebre nella chiesa di San Bartolomeo in suffragio dei caduti di Solferino e San Martino: sebbene diffidato dall’autorità diocesana, scavalcò il cancelletto che impediva l’accesso al pulpito e pronunziò con animosità non un elogio funebre, come ci si aspettava, bensì un discorso tanto vibrato e politicamente caratterizzato che monsignor Pierluigi Speranza, vescovo di Bergamo e sant’uomo zelante e pio, presente al fatto, non poté che ordinare l’interdetto temporaneo del tempio, provvedimento che fu di pretesto per tumulti e violenze da parte degli anticlericali. Nel 1862 il Locatelli ebbe la cattedra di letteratura italiana al liceo cittadino (il che lo risarcì solo parzialmente dello smacco subìto al Politecnico di Zurigo, dove gli era stato preferito il De Sanctis). Si accostò agli ambienti luterani e tradusse in bergamasco il Vangelo di San Matteo. Lasciò tre volumi dedicati agli artisti bergamaschi (pagine preziose ma con notizie non sempre attendibili). Per una trentina d’anni esercitò la critica d’arte sulla stampa locale, non nascondendo, lui, patriota risorgimentale, una spiccata simpatia per l’arte neoclassica in voga al tempo della dominazione austriaca e suscitando accese polemiche per le sue assurde stroncature (basti dire che Ermenegildo Agazzi, disgustato per una pedante critica del Locatelli, si trasferì a Milano). Sulla sua lapide volle che fosse incisa la seguente iscrizione: “Per il poco appreso – visse soverchio – la religione del dovere non gli fu ignota – stimò la virtù senza saperla praticare – dall’infanzia amò la patria – dell’arti belle appassionatissimo – per esse solo invidiò le ricchezze – una cosa desidera ed implora – di essere qui dentro creduto sincero”. Bell’originale, se non altro per questa epigrafe. Lo affermo cordialmente e non me ne voglia lo spirito di Pasino Locatelli, se mai dovessi incontrarlo per iter tenebricosum. Èss ü bèl sacramènt. Si dice così di una persona molto originale, con una sua personalità ben rilevata ma quasi indefinibile per la sua singolarità. Se devo pensare a un bèl sacramènt mi viene alla mente per la sua tipicità inimitabile un autore insolito, cólto ma eclettico e non privo di stravaganza errabonda, di velleitarismi e di cedimenti, com’era Geo Renato Crippa, uomo pieno di sé, abilissimo parlatore dalla lingua sciolta e dall’eloquio aulico e solenne, provvisto di un cumulo incredibile di nozioni delle più disparate discipline, nozioni disordinate, catturate a prezzo di molte letture e impresse in una memoria prodigiosa. Caravaggino di nascita, amico di artisti e di letterati, frequentò il mondo dell’aristocrazia e dell’alta borghesia pur disponendo di mezzi limitatissimi: egli stesso si vantava pubblicamente della sua povertà e sosteneva essere la miseria il suo più alto elogio. Gli difettava il senso degli affari ed aveva un’opinione smagata del denaro. A partire dagli anni Trenta del secolo scorso pubblicò diversi libretti ed opuscoli, operucce di mole modesta, ponendo in copertina la dicitura “Il povero bibliofilo” dove solitamente appare il nome dell’editore. Ricordava con una punta di nostalgia e di orgoglio le sue origini caravaggine, il tempo in cui una linea di tram a vapore collegava la sua cittadina a Treviglio e a Bergamo, quando la Bassa d’inverno era avvolta da una nebbia impenetrabile: dai suoi ricordi emergevano, volutamente indistinti, il maglificio di Giuseppe Crippa, il teatrino della Filodrammatica Tadini, le vecchie osterie graveolenti di vino, le serenate al chiaro di luna, le figure indimenticabili della vecchia Caravaggio, dal garibaldino Giovanni Defendi all’abate Felix Baronio, dal musicista Francesco Lupi allo scrittore Giovanni Banfi. Pur avendo sicura contezza della grammatica e della sintassi, il Crippa scriveva talora con un’ardita trascuratezza, con una disinvolta sbadataggine tirando giù le frasi alla buona, senza curarsi troppo delle concordanze dei generi e dei tempi; talaltra si divertiva invece a comporre periodi tronfi, roboanti, disagevoli, cervellotici e macchinosi, irrobustiti da paroloni inconsueti per il gusto tutto suo di épater le bourgeois. Si compiaceva di chiamarsi Geo e per farlo inferocire bastava giocare sull’equivoco e chiamarlo geometra: allora si stizziva, alzava la voce, in altri tempi sarebbe partito all’assalto lancia in resta. Piccola debolezza di un uomo che per tutta la vita e con le sue sole forze aveva lottato per dimostrare a se stesso, prima ancora che agli altri, di essere non ü bèl sacramènt ma quel che a Bergamo si dice ün òm d’inzègn. Èss ü bilòfer. Questa locuzione, che ormai da tempo non si ode più, era usata per indicare una persona di fede protestante. La voce deriva con buona probabilità da Bilhofer, cognome di una delle prime famiglie luterane stabilitesi a Bergamo in epoca napoleonica, quando i terreni e gli altri beni immobili sequestrati agli ordini monastici soppressi erano stati messi all’incanto per ricostituire gli erari pubblici saccheggiati o dissanguati dai rimborsi delle spese sostenute dall’armata francese. I cittadini cattolici si astennero dal presentare le loro offerte e fu così che ai bilòfer, privi di remore di natura religiosa, furono assegnati i beni al costo molto conveniente delle basi d’asta. Èss ü bocalù. Leggendo la cronaca di una truffa architettata da una sedicente veggente ai danni di diversi creduloni mi è tornata alla mente la voce bocalù (al femminile bocaluna), allusiva alla forma del boccale (la pinta che si usava un tempo per mescere il vino nelle osterie), voce che deride l’atteggiamento di chi sta a bocca aperta ad ascoltare ogni panzana. Si è afflitti da una caterva di astrologi, d’indovini, di maghi, di cartomanti, di chiromanti, di oroscopari, di dispensatori dei numeri del lotto, di fattucchiere, di streghe e di altri simili ciarlatani che spacciano l’orvientano e che ingannano la buona fede degl’ingenui. Divinatori del futuro e venditori di fumo millantano inesistenti poteri occulti (proprio perché occulti, dovrebbero essere per definizione ignoti e inconoscibili) ed elargiscono consigli su materie delicate come i rapporti fra coniugi, fidanzati, genitori e figli, senza le necessarie conoscenze etiche e psicologiche. I nostri vecchi non credevano nelle bocce di cristallo e nelle zingare che leggono la mano e chiamavano bocalù quei pochi che per mancanza di risorse interiori si affidavano ai maghi, agli astrologi e ad altri individui di questa risma. Si ha l’impressione che al progresso scientifico e tecnologico abbia corrisposto un pauroso regresso morale ed intellettuale se esistono al giorno d’oggi tanti bocalù. Esiste pure un testo unico che vieta le pratiche di ciarlataneria. Ma dovrebbe essere fatto rispettare. Èss ü caìno. Lo si dice di una persona molto malvagia, capace di compiere azioni criminali e delittuose. Se di un tale vi dicono che l’è ü caìno è come se volessero mettervi in guardia perché evitiate di frequentarlo. Il buonismo induce oggi a coartare il senso della giustizia, che non deve smarrire la sua severità; il perdonismo a sua volta finisce per svilire il concetto dell’equità della pena e per farsi beffe della dignità della parte offesa. Occorrerebbe rileggere la pagina del Genesi che narra la vicenda del primo assassinio della storia dell’umanità per capire che prima dei diritti del fratricida viene il diritto di Abele alla vita. Non si continui ingenuamente a dire: Nessuno tocchi Caino. Si dica invece: Nessuno tocchi Abele. Èss ü canù. Di una persona che eccella in una disciplina si dice che l’è ü canù perché un tempo il cannone era l’arma più potente di cui potesse disporre un esercito. Chi ama satireggiare aggiunge: L’è ü canù de la stüa, alludendo alla canna fumaria della stufa. Èss ü capo. La voce italiana capo si diffuse nei dialetti lombardi al tempo dell’industrializzazione, quando gli operai incominciarono a riferirsi con questo appellativo al responsabile del loro reparto o della loro squadra. Da tempo viene usata come vocativo rivolto a persona che appare provvista di autorevolezza. Non ha alcunché di servile e non è pertanto accostabile a locuzioni del tipo voscienza, eccellenza e similari; rappresenta soltanto il riconoscimento dell’appartenenza ad un rango sociale superiore e vale ad introdurre un discorso (ad esempio: Nè, lü, capo...). Una volta un tale mi disse: Da come l’ parla, lü l’ gh’à de èss ü capo. Tentai inutilmente di schermirmi perché quello replicò: Nò, nò, lü l’ me la cönta mia sö a mé: ghe dighe che lü l’è ü capo perchè mé i capi i conòsse söbet. Beato lui, che riconosceva subito i capi. Ora, essendo entrate da molto tempo nell’uso comune del bergamasco voci come capo-repàrt, capo-öfésse e capo-squadra, mi sto rassegnando all’idea che o prima o poi anche l’orrenda voce barbarica leader finisca per avere cittadinanza nel lessico orobico, che pur essendo in fase fortemente regressiva manifesta tuttavia ancora una certa vitalità. Del resto, per quanto con molta riluttanza, i dialetti italiani non fanno che seguire il modello decadente e perfino rovinoso della lingua nazionale, abbrutita da un cumulo osceno e cretino di angloamericanismi inutili e dannosi, messi in circolazione dagl’incolti e dai microcefali della radio e della televisione, dai giornali, dalle reti informatiche, tutti affetti da un’inguaribile forma di vile esterofilia, dovuta all’assenza di una salda identità culturale. Chi è privo di una sua identità, chi non ama la sua patria, chi non conosce la sua terra, chi disprezza la sua gente, chi non ha il senso della storia finisce per scimmiottare la cultura altrui, ad incominciare dalla lingua, che è sempre lo specchio di una identità e di una cultura. Naturalmente finirà per essere assunto dal lessico bergamasco anche il barbarismo leadership perché ormai i rapporti sociali sono condizionati dalla competitività, che spesso, in assenza di regole morali, sconfina nella slealtà, nell’aggressività, nella prevaricazione. Ci si è dimenticati che l’esercizio del potere è un servizio reso al prossimo e che il vero capo (o leader che dir si voglia) sa essere autorevole senza essere autoritario ed è sempre chiamato a dare il buon esempio. Èss ü che ghe n’ sà. Anni fa il nostro popolo definiva in questo modo una persona tanto istruita da essere considerata sapiente. Essendo da stimare per la sua erudizione, uno ‘che ne sapeva’ era fatto oggetto di particolare riguardo nel tempo in cui l’analfabetismo era assai diffuso nei ceti umili e disagiati. Gli spiriti illuminati si sono sempre doluti della scarsa istruzione della gente comune. In un suo diario Giovanni Cena (1870-1907) scrisse: “Una nazione di analfabeti non dà sostrato per la coltura intellettuale, fa vita anemica a tutti gli organi della coltura. I letterati e gli artisti dovrebbero convincersi che un popolo analfabeta, non assurgendo ad un tenore di vita decente, non popolerà teatri, sale di concerto, esposizioni, non comprerà libri né quadri, obbligherà gl’intellettuali ad un vita meschina, quale rimane infatti quella degli uomini colti d’Italia”. Trascorso più di un secolo da quando il Cena scrisse queste parole, a fronte di un’alfabetizzazione generalizzata si registra la decadenza della lingua nazionale, fortemente impoverita e privata di solide basi culturali, imbastardita da anglicismi che puzzano di snobismo da gente nova o da cafone ’e fora. Èss ü coercì. Letteralmente: ‘Essere un coperchietto’. Si dice di persone insicure e instabili, che danno ragione ora a questo e ora a quello, persone che cambiano bandiera ad ogni mutar di vento, prive di coscienza e di credibilità perché sono paragonabili ai coperchi che si adattano a tutte le pentole e a tutti i tegami. Èss ü grass de ròst. Si sa che la parte grassa dell’arrosto è indigesta. Per ampliamento si definisce grass de ròst una persona particolarmente fastidiosa e ben poco raccomandabile, della quale si deve diffidare. Èss ün Antecrést. Sul termine bergamasco Antecrést i lessici usuali appaiono sbrigativi se non reticenti. Se di un tale diciamo che l’è ün Antecrést intendiamo attribuirgli una irreligiosità pervicace e aggressiva, una congenita e ostentata propensione al male. La nostra gente credeva un tempo che l’Anticristo si sarebbe manifestato subdolamente, nascendo da una monaca e da un frate. Invero chi ha confidenza con le scritture neotestamentarie e con la letteratura cristiana dei primi secoli sa che il termine fu usato iniizialmente per indicare quanti intendevano sottomettere il messaggio di Cristo al pensiero pagano, a filosofie e visioni del mondo che, dalle premesse teoriche alle conseguenze pratiche, erano inconciliabili con quanto predicato da Gesù. Ben presto però l’Anticristo divenne l’incarnazione del male, un essere demoniaco che opererebbe anche all’interno della Chiesa e che si presenterebbe sotto le mentite spoglie di un taumaturgo carismatico allo scopo di screditare l’incarnazione e la resurrezione di Cristo: egli compirebbe prodigi sensazionali per attrarre a sé le moltitudini e confonderebbe i cristiani ingannandoli, traviandoli, spingendoli ad allontanarsi dalla loro dottrina; comparirebbe prima della fine dei tempi, precedendo di poco il ritorno del Messia sulla terra per il giudizio finale. Indurrebbe le genti a praticare il male allettandole con sottile abilità, si avvarrebbe della sua autorità per sradicare la carità dal cuore degli uomini e per immettervi l’egoismo, diffonderebbe una mentalità grettamente materialistica e condurrebbe le anime alla perdizione assuefacendole al peccato, da lui presentato come piacevole e ambita necessità. La profezia e il mito dell’Anticristo sono stati sinteticamente ma lucidamente avvertiti dalla gente come presenza nefasta del male perennemente in agguato. Chi nega l’esistenza di Dio con spirito fortemente polemico e intollerante, che si scaglia fanaticamente contro i simboli e gl’insegnamenti della religione cristiana, chi perseguita la Chiesa, chi induce a compiere azioni delittuose presentandole come belle e fascinose non può che essere ün Antecrést. La terribile maestà di questo essere infernale era associata a quella dei cavalieri dell’Apocalisse, il che diede origine alla locuzione l’Antecrést a caàl, spesso mutata in altre locuzioni similari (es.: l’Antiquàter a caàl) per evitare di nominare l’entità demoniaca. Naturalmente si può credere o non credere e ognuno ha il diritto di regolarsi come vuole. Il bene e il male esistono comunque, per chi crede come per chi non crede, poiché l’idea del bene e del male è data dal senso morale, che distingue l’uomo dall’animale. Per la nostra gente l’Antecrést è sempre stato l’espressione più falsa, violenta e pericolosa del Maligno. E una delle ingiurie più brucianti. Èss ü margnifù. Davanti a certi termini la lessicografia tradizionale non sembra essere esaustiva. Dire di una persona che l’è ü margnifù indica sicuramente un alto grado di astuzia ma io mi sentirei più tranquillo traducendo ‘furbastro’, ‘sornione’, perché ho sempre sentito attribuire questa parola a gente che ti osserva di sottecchi con finta indifferenza e che poi in men che non si dica te la accocca lasciandoti di stucco. Sono i navigatori della critica letteraria ufficiale, sono i bordeggiatori che fanno carriera dandosi delle arie, quelli accreditati presso gli uffici editoriali e i redattori della pagine culturali dei quotidiani, quelli che se non sei allineato e se non fai parte del giro ti ignorano, quelli che appartengono ad una consorteria e che scrivono solo se interessati, quelli che se non sei della loro idea non sanno neppure se esisti. In realtà lo sanno bene e ti evitano perché ti temono ma fanno finta di niente ed osservano strettamente la consegna di non parlare di te e dei tuoi meriti perché se osassero stroncarti saresti capace di fare loro il pelo e il contropelo scardassandoli a dovere e smascherando la loro faziosità, la loro arroganza, la loro incompetenza. Così in questo Paese si osannano Eco e Fo e si ignora Bacchelli, ultimo grande della letteratura italiana, come si oscura Eugenio Corti perché è sempre stato fuori del coro. E di Papini, di Rebora e di Ungaretti chi parla più? Èss ün indivìduo. Mentre in filosofia il termine individuo vale come sinonimo di persona, in bergamasco assume tutt’altro significato. Di un signore compito e rispettabile, di buone maniere, non diremmo mai: Chèl lé l’è ün indivìduo. Lo diremo invece di chi abbia modi poco urbani, di chi sia pretenzioso e mostri poco rispetto degli altri. Tanti anni fa un avvocato mi disse di aver dovuto difendere un cliente accusato di aver ingiuriato un’altra persona e di non essere riuscito ad evitare la condanna perché gl’insulti proferiti erano inequivocabili. Dopo la sentenza l’avvocato, che era più contrariato dell’imputato, gli si rivolse così: Cosa gh’él vegnìt in mènt de dàga zó del cretino e del farabutto? Se l’ ghe dàa de l’indivìduo, ol giödes a l’ ghe troàa dét negóta de mal e de sigür a l’ la assolvìa. Èss ün indormét. Un ragazzo pigro e imbambolato, che non era lesto ad apprendere un mestiere e che non si affrettava a compiere quanto gli era stato ordinato, un tempo era apostrofato con il termine indormét, forma participiale che dovrebbe rispondere all’italiano ‘dormente’. In realtà dormente è colui che dorme; indormét invece indica non solo chi è assopito ma chi non si accorge di quanto accade attorno a lui. Chi si rivelava indormét era invitato ad uscire dal suo torpore mentale e si sentiva rivolgere l’imperativo: Dèsdes fò!, ‘Svégliati!’. Mutati i tempi, ci si affida alla tecnica, con grave discapito della fantasia e dell’inventiva. In particolare, la fatica intellettuale è sempre meno praticata e i ragazzi d’oggi per la gran parte si acculturano per immagini. Ma la televisione, i fumetti e i cellulari non aiutano a far funzionare il cervello: sono le letture e i dibattiti a stimolare il pensiero, ad invitare alla meditazione e all’introspezione. Le immagini non possono sostituire le parole se non a detrimento del raziocinio e dell’attitudine alla ricerca. Si va verso la negazione della creatività, verso la paralisi della fantasia, verso l’isolamento, ascoltando musica (si sa bene che razza di musica) con gli auricolari: è il rifiuto implicito a un contatto con il prossimo, è l’individualistico richiudersi in se stessi da parte di chi per implicita paura o intrinseca debolezza teme l’incontro con gli altri. Non c’è proprio bisogno di anestetizzare il cervello dei nostri giovani, ai quali i genitori farebbero bene a rivolgere di quando in quando il bonario invito a svegliarsi, a desdàs fò. Quale futuro avrebbe la nostra civiltà se crescessimo generazioni di indormécc? Èss ün òm de pis. Un uomo importante in bergamasco diventa un òm de pis, ‘uomo di peso’, come se la sua autorevolezza possa essere gettata sul piatto della bilancia. In ogni tempo e con ogni società esistono persone che credono di potersi estollere molto al di sopra delle altre. Diceva Confucio che dove esistono educazione e garbo non c’è distinzione di classe. Scipione l’Africano è passato alla storia per avere sconfitto Cartagine. Non tutti sanno che era anche un autentico uomo di cultura: partecipava spesso agl’incontri organizzati da un senatore suo amico, il quale radunava attorno ai tavoli del suo triclinio l’intellighenzia romana del tempo. In quel cenacolo di elette persone Scipione non si gloriava mai delle sue strepitose imprese belliche e si faceva premura di mettere a loro agio quanti si trovavano davanti a lui. Èss ün òm d’inzègn. Nessuno ha mai scritto il poema che merita il verbo riflessivo ’nzignàs, cui la traduzione italiana ‘ingegnarsi’ sottrae parte del senso. Infatti la voce italiana non pare contemplare il guizzo di fantasia e la tenacia espressa dalla corrispondente voce bergamasca. C’è nel verbo italiano la buona volontà, c’è l’intraprendenza, c’è la sagacia. Ma la tenacia bergamasca è altra cosa. Ed altra cosa è soprattutto la fantasia sottile, acuta, capace di impennate eroiche e di accensioni fulgide. Soccorre un episodietto che traggo da un romanzo modesto e ormai dimenticato, scritto da quell’esteta nevrastenico che fu Guido da Verona, il quale per esasperato individualismo apparteneva alla categoria dei viveurs scettici e disincantati in auge negli anni Dieci e Venti del Novecento. Ebbene, questo scrittore, che non valeva molto ma che piaceva alla piccola borghesia nazionalistica, riferì di un colloquio intercorso fra Edgar Allan Poe e il milionario Pierpont Morgan. I due passeggiavano un giorno sul ponte di Brooklin e Morgan accennò al fatto di essere enormemente ricco. Poe gli disse: “Mio povero Morgan, voi credete davvero di essere molto ricco? Ebbene, ora io vi descriverò quale sarebbe il cancello che metterei all’ingresso della mia villa, se avessi abbastanza denaro per costruirmi una villa”. E gli descrisse un cancello talmente favoloso che tutto il patrimonio di Morgan non sarebbe bastato a pagarlo. Poe concluse: “Mio caro Morgan, immaginate quali magnificenze racchiuderebbe la mia villa se ciò che vi ho ora descritto non ne fosse altro che il cancello”. Un vero guizzo di fantasia, quello attribuito a Poe, autore del resto quanto mai fantasioso. Ma la fantasia, dote meravigliosa dell’intelligenza, non basta: occorre anche una scorta inesauribile di tenacia, quella rocciosa dei nostri antenati, che dissodavano, che terrazzavano, che ricostruivano, senza cedere mai alla disperazione. Come la fantasia è dote dell’intelligenza, così la tenacia è dote dello spirito. Èss ü rampì. Di una persona molto cavillosa, che si attacchi ad ogni pretesto per questionare si dice che l’è ü rampì. Due autori poco accreditati e dal piglio palesemente dilettantesco scrissero in una loro “guida” (c’è da star freschi a farsi guidare da simili “esperti”) che in tutta la Lombardia la voce rampì avrebbe due significati traslati, ossia ‘poco astuto’ e ‘ladro’. Non ho mai sentito usare a Bergamo la voce rampì con simili accezioni. E Bergamo, salvo errore, è in Lombardia. Èss ü saltadùr de strada. Siamo quotidianamente assillati da cronache efferate, che provano di quale crudeltà e di quale dissennatezza sia purtroppo capace l’essere umano: terroristi, rapinatori, assassini, ladri, stupratori, taglieggiatori, millantatori, abusivi e prepotenti di ogni risma (chi più ne ha più ne metta), tutto un campionario perverso di gentaglia dedita al crimine. Era così anche un tempo ma i misfatti, stando alle cronache dei secoli passati, accadevano molto più raramente e la mano della giustizia era generalmente più puntuale e più severa. Un solo conforto: questo non sembra più essere il tempo dei banditi e dei grassatori, quelli che i nostri antenati chiamavano saltadùr de strada, letteralmente ‘assalitori da strada’. Viene subito alla mente il Pacì Paciana, il sanguinario bandito Vincenzo Pacchiana, che terrorizzò per una decina d’anni la Valle Brembana al tempo del governo napoleonico. Spia al soldo del declinante Leone di San Marco, si piccava di parlare in veneziano in odio agli occupanti francesi, i quali avevano desolato le nostre contrade con le loro ruberie ed erano deprecati per avere introdotto l’ammasso dei prodotti agricoli e la coscrizione obbligatoria. Un’aura popolare di leggenda avvolge la figura del Pacì come quella di ogni altro bandito che si rispetti, da Robin Hood a Fra Diavolo, ritenuti benefattori dell’umanità perché secondo il popolino rubavano ai ricchi per dare ai poveri. Non si sa che cosa avrebbero mai potuto rubare alla povera gente, che viveva di stenti, ridotta com’era a soffrire la fame. I documenti storici dicono che il Pacì si macchiò di diversi delitti a scopo di rapina e la stessa cosa vale per il brigante Musolino, per Ghino di Tacco ed altri bei soggetti di tale risma, saltadùr de strada che a volte sapevano compiere azioni generose, come quando Stefano Pelloni detti il Passator Cortese si prestò a guidare nel territorio romagnolo Garibaldi in fuga da Roma, o come quando il Pacì, che non era il solo bandito ad aggirarsi in Valle Brembana, volle scortare nottetempo fino a San Giovanni Bianco un medico che risaliva da solo a suo rischio e al buio la strada di fondovalle. Alle Chiavi della Botta nell’oscurità più fitta all’improvviso il Pacì con il suo cappellaccio e lo schioppo a tracolla era comparso davanti al medico e gli aveva domandato: “Dove sié drio a ’ndar, dotor, a st’ora de note per vostro conto?”. “Turne a cà”, gli aveva risposto il medico, che lo aveva riconosciuto. E il bandito: “Alora ve compagno mi: la note la xè fosca e ghe son i giro i saltador de strada”. Lui, il Pacì, malfattore e assassino, saltadùr de strada per antonomasia, capace di compiere una nobile azione!... Chi può mai conoscere fino il fondo il cuore dell’uomo? Èss ü setimì. Era un tempo credenza diffusa che le persone nate prematuramente, nel settimo mese di gravidanza, fossero dotate di poteri divinatori e che guarissero con l’imposizione delle mani. Èss ü siòr vaca. In bergamasco il grado assoluto del superlativo non si ottiene con l’uso di suffissi ma con l’aggiunta di un aggettivo, di un participio o di un sostantivo. Se voglio dire che sono ‘stanchissimo’, aggiungo all’aggettivo strach, ‘stanco’, la voce mórt (participio passato del verbo mör, ‘morire’) e ottengo strach mórt, che vuol dire appunto ‘stanchissimo’. Per dire ‘magrissimo’ dico màgher ischéss oppure màgher impéch. Se voglio dire che un oggetto è in tutto identico a un altro dico che l’è stèss isquataràt. I dialetti sanno ottenere un’espressività che non sempre è raggiunta dalla lingua nazionale, la quale deve talora ricorrere agli stessi procedimenti delle lingue popolari. Tanto è vero che il superlativo assoluto di ubriaco, ossia ubriachissimo, non si ode mai perché suona come una nota stonata: l’italiano deve dire ubriaco fradicio. Ma il bergamasco non la cede affatto e al vecchio ciòch desfàcc aggiunge ciòch intranàt, risalente alla fine dell’Ottocento, quando si diffusero le mescite del vino di Trani. Qualche altro esempio del superlativo in bergamasco? Di uno che sia intirizzito dico che l’è frècc isténch tanto è irrigidito dall’algore. Di un bicchiere colmo dico che l’è pié ras per indicare che il liquido giunge fino all’orlo. Di uno che sia caduto per tutta la sua lunghezza dico che l’è borlàt zó lóngh tirét (una volta di diceva lóngh tràcc). Un colore rosso acceso in bergamasco è róss foghét, letteralmente ‘rosso infuocato’. Un villanzone diventa vilàn quàder e uno che sia completamente fuori di senno l’è mat matènt (come ‘bellissimo’ diventa bèl belènt, nel qual caso il bergamasco arriva ad estrarre un participio presente da un aggettivo). Un superlativo assoluto di sapore rusticale ma di efficacia straordinaria è quello che si ottiene con il ricorso all’aggiunta del sostantivo vaca, ‘vacca’. Un ignorantaccio diventa allora ü gnorànt vaca e uno tanto ricco che non sa più neppure quanti ne ha diventa ü siòr vaca. Ma perché proprio vaca? Un amico un giorno mi diede questa spiegazione: “I panni del ricco contano come quelli del povero davanti a Dio ma mentre al povero non si può togliere niente, il ricco può perdere le sue ricchezze. E se perde il siòr rimane solo un vaca…”. Èss ü sterlöch. Significa ‘tardo di comprendonio’, ‘stordito’, ‘babbeo’. È insulto generico che i bergamaschi hanno appreso dai milanesi, i quali a loro volta dicono tarluch (da pronunziare con il suono turbato della ü celtica, presente anche in francese e in tedesco) nello stesso senso perché udivano gli spagnoli apostrofare i tonti con il termine tarugo, ‘pezzo di legno’. Èss ü stròlegh. A un amico che si stia lambiccando il cervello possiamo domandare: Cosa sét dré a strolegà? Il verbo strolegà vale per ‘stillarsi il cervello’, ‘arrovellarsi’ e più semplicemente ‘almanaccare’, ‘escogitare’. Ma nell’Ottocento aveva ancora corso il significato originario di ‘astrologare’, ossia ‘divinare il futuro’. Strolegà è verbo denominale, derivato da stròlegh, che letteralmente suona ‘astrologo’, ‘indovino’ ma che con il tempo ha finito per indicare una persona alquanto originale nei comportamenti e nei ragionamenti. Antonio Tiraboschi nel suo dizionario specifica che stròlegh è anche il ‘chiromante’, ossia colui il quale crede di predire il futuro di una persona osservandone le linee della mano. L’abate Giuseppe Rota (1720-1792), poeta che i più non conoscono e che meriterebbe di essere stimato come uno dei più interessanti e significativi poeti dialettali d’Italia, in un suo lungo componimento in terzine paragona i miscredenti e gli esprits fortes agl’indovini che nelle fiere gabellavano i gonzi predicendo il futuro dalla lettura della mano. Non altro che inganno sono la chiromanzia e l’astrologia. Non ha alcun fondamento scientifico la divinazione del futuro sulla base dei segni zodiacali e di conoscenze astronomiche ferme a molti secoli or sono. Si tratta purtroppo di una pratica radicata nel costume, una pratica assimilabile nelle sue manifestazioni più irrazionali alla superstizione e riconducibile ad un concetto deterministico della vita umana, come se attitudini e comportamenti dipendessero dai segni e dalle ascendenze astrali. Niente di più falso. Éss ü tóne. Non saprei dire perché il nome Antonio, che in bergamasco suona Tóne, sia usato in significati traslati quali ‘testa dura’, ‘persona di scarso comprendonio’, ‘sempliciotto’. Per dire ‘tedesco’, ma in senso molto spregiativo, diciamo tognì, e in questa parola associamo alla scarsa intelligenza anche la testardaggine, l’ostinazione. Una lingua fin tanto che sia viva è un corpo in movimento e le parole mutano accezione da un giorno all’altro ma le origini dei fenomeni non di rado ci sfuggono. Ricordo l’ironica nenia fanciullesca Tóne bilóne / ’n fónd a la scala / ciapa la bala / ciapa ’l balù / Tóne pissù, dove questo Antonio, definito giocherellone (arcaico bilì, ‘giocattolo’), è ubriaco (lombardo bala, ‘sbronza’) e non trova di meglio, da sempliciotto qual è, che orinare in fondo alla scala. E rammento anche la quartina “Al Tóne, belèssa del mé paìs” di Pietro Ruggeri da Stabello, quartina fortemente ritmata e scandita da suoni iterati: O Tóne, töt Tóne dal có féna ai pé, / te cómpre, te vènde per quèl che te sé; / te tègne tat Tóne de tal qualità / che ü Tóne piö Tóne de té no l’ sa dà, ossia: ‘Antonio, tutto Antonio dal capo fino ai piedi, / ti compero e ti vendo per quel che sei; / ti considero tanto Antonio di tale qualità / che un Antonio più Antonio di te non si dà’. È invece uno scioglilingua il detto popolare: Tò, Tóne, töt tat ài. / Sé, tata, töró tat ài, ossia: ‘Prendi, Antonio, cómperati tanto aglio. / Sì, babbo, comprerò tanto aglio’. A dispetto dell’accezione traslata, ocorre dire che il nome Antonio è uno dei più belli e amati della cristianità, che ricorda due santi esemplari e famosi, entrambi molto cari ai fedeli. Èss ü vagabónd. Dagli antichi nomi delle piante coltivate dall’uomo gli studiosi di paleolinguistica hanno arguito non essere mai esistita una sola e unica lingua originaria. Fin dalle origini gli esseri umani hanno parlato lingue diverse; si ritiene che i ceppi linguistici fondamentali siano dodici e si presume che tali lingue primitive si siano sviluppate grazie a popolazioni stanziali, le quali al nomadismo legato alla caccia preferirono l’agricoltura, che consentiva una dieta più variata. Un ragione in più perché abbiano ragione di essere e perché vantino diritto di cittadinanza i nostri dialetti, che sono a loro modo delle lingue e che costituiscono una straordinaria ricchezza culturale per la nostra nazione. Purtroppo appena si parla di dialetti sbuca sempre qualche retrogrado intollerante che parla di “Babele dei dialetti” (quante volte abbiamo letto questa espressione superficiale e beota nei titoli della stampa cosiddetta “progressista”!): è la mania preoccupante della monocultura, dell’egualitarismo ad ogni costo, come se fossimo tutti fatti con lo stampino. La deriva razzista è appena dietro l’angolo. Chissà perché si vuole negare l’evidenza di un’Italia policentrica e si vuole ostinatamente soffocare la grande risorsa di culture regionali e provinciali che si integrano fra loro? Quale oltranzismo fascista e centralistico induce a sradicare culture millenarie costitutive della nazione? I dialetti italiani sono figli del latino, dei ducati longobardi e dell’economia curtense dell’alto Medio Evo. Niente è più stanziale di una lingua locale, che riflette una comunità territoriale regolata da norme, da usi e da costumi fortemente sentiti e condivisi. In bergamasco esiste il pelegrì, ‘pelegrì’, esiste il sénguen, ‘zingaro’, non esistono né il nomade né il migrante. La voce emigrànt è acquisizione relativamente recente, del tardo Ottocento. Esiste invece vagabónd ed è naturale che il termine abbia un’accezione piuttosto spregiativa in una società tendenzialmente statica sotto il profilo economico e sociale. Qualificare una persona con la voce vagabónd significa attribuirle una certa inaffidabilità. Un conto è viasà, ‘viaggiare’, altro è andà girandolét, ‘gironzolare qua e là senza una meta fissa’. Il viasadùr o prima o poi ritorna, il vagabónd non si sa. Dice il marinaio Sindbad a Shéhérazade: “Ho cercato il grande segreto in paesi lontani, presso popoli stranieri. Penso che sia stato un errore. Perché cercare altrove le risposte che possiamo trovare nella terra dei nostri avi? Perché parlare una lingua straniera quando nella nostra abbiamo tutto ciò che occorre per decifrare il mondo?”. Èss ü vilàn quàder. C’è villano e villano: è giusto distinguere fra chi è naturalmente rozzo ma privo di malanimo e chi invece è prepotente. Se il primo è röstech, ‘rustico’, il secondo è decisamente vilàn (o vilànch, come qualche volta ho sentito dire fuor di città). A seconda del grado di villania, il bergamasco distingue fra ü bèl vilàn, che non è affato un complimento, ü vilanù, ‘un villanzone’, e ü vilàn quàder, ‘villano squadrato, fatto e finito’, forma superlativa assoluta innanzi alla quale voci come paino, cafone, burino, tamarro e buzzurro, pur tanto diffuse, devono cederla in efficacia. Amara constatazione: i villani e i maleducati c’erano anche un tempo perché anche un tempo esistevano parole atte a definirli. Amara constatazione e magra consolazione. Meglio sempre avere a che fare con persone ingenuamente rozze che con individui spavaldi, arroganti, prepotenti e sfacciati. Éss zó de córda. La locuzione indica uno stato d’animo depressivo, che traspare dall’aspetto fisico. Deriva per estensione dall’indicazione dell’esaurimento della carica dei pendoli a corda. Probabilmente avrà concorso all’uso di questa locuzione anche l’idea dell’allentamento delle corde di strumenti musicali quali il violino, la viola e la chitarra. Il sostenere che la locuzione sia stata concepita come contrario dell’esortazione latina sursum corda (intesa nell’aberrante senso di ‘su di corda’) è un’amenità puerile. Èss zó de squàder. Salta subito all’occhio una raffigurazione che non sia disegnata o dipinta nel riquadro stabilito (gl’impaginatori lo chiamano gabbia). Così è anche per una cornice che non abbia gli angoli perfettamente retti. Per traslato èss zó de squàder, indicando ciò che sfugge alla normalità dei disegni, dei programmi e dei comportamenti, ha finito per significare una situazione particolare dell’umore o dell’animo di una persona. Si dice perciò che l’è zó de squàder chi è di malumore, chi è abbacchiato perché afflitto da un dispiacere. Non si sa mai a che cosa possa portare un simile stato d’animo. A volte una delusione può essere tanto cocente da indurre a un gesto disperato. È noto che il giovane poeta inglese Thomas Chatterton, assillato dalla povertà, si tolse la vita perché, dopo aver scritto pagine originali e stupende, non fu creduto e venne accusato di averle rubate a Turgot, un monaco del X secolo. Ruggiero Leoncavallo dedicò un’opera d’impronta verista alla figura di Chatterton, al quale nell’atto III fa pronunziare l’invettiva: Ah patria infame, tu sii maledetta, / bieca matrigna perversa e crudel / e l’addio che ti mando, o terra abietta, / è l’anatema che invoco dal ciel. Il momento culminante dell’opera è nell’arioso Tu sola a me rimani a Poesia, buona pagina melodicamente ispirata. Ma ormai chi si piega più sulla partitura del “Chatterton” di Leoncavallo? Peccato che tanta parte del nostro patrimonio musicale sia conosciuta solo da pochi studiosi. Eviva chi gh’à i dèbecc! Un motto di spirito diffuso nell’area trevigliese recita: Eviva chi gh’à i dèbecc, bambòss chi no ghe n’à; i dèbecc i consula e i mantègn la sanità. Esso depreca con l’arma dell’ironia l’imprudenza che conduce alla contrazione di un debito, fatto che la saggezza di un tempo giudicava negativamente. In effetti una volta il debitore non si dava pace fintanto che non aveva restituito quanto gli era stato prestato. Ma in qualche raro caso il debito era contratto a cuor leggero: ecco perché il motto dice che i dèbecc i consula e i mantègn la sanità, ‘consolano e mantengono in salute’. Non si sono dati molto pensiero i governanti italiani, che amministrando la cosa pubblica senza il dovuto rigore hanno accumulato un deficit disastroso. Forse a chi faceva loro presente le cifre astronomiche del debito pubblico qualcuno di loro avrà detto: “Abbiamo tutti questi miliardi di debito? Bene, incominciamo a spenderli”. Alla fine però i debiti vanno pagati e chi ci va di mezzo è sempre Pantalone. Fà aqua de töte i bande. Si dice di una impresa mal gestita o di un negozio mal condotto. Il paragone con una barca che rischi di affondare a causa delle troppe falle dimostra una certa confidenza dei bergamaschi per la navigazione sui fiumi e sui laghi lombardi. Fà amò bèl vèd. “Ma lü l’ fà amò bèl vèd!”, mi disse qualche giorno fa una signora gentile e buona alla quale in un momento di debolezza senile svelai nel corso della conversazione i miei dati anagrafici più preoccupanti e compromettenti, quelli cioè riguardanti la data di nascita. Mi sono però riproposto, stando più attento e più riservato, di non dichiarare la mia età se non in caso di stretta necessità: non è detto infatti che si trovi sempre la persona educata, comprensiva e caritatevole, disposta a dire una pietosa bugia come questa che farèss amò bèl vèd, cioè che avrei ancora un aspetto piacente. Anche il mediatore Pietro Astolfi detto Giópa (1886-1961), simpatico aedo dialettale, aveva un bell’aspetto. Quando diceva quanti anni aveva, trovava sempre chi per complimento gli diceva: A l’ pórta bé i sò agn. E lui con ironia rispondeva: I a pórte tat bé che i bórla mai zó!. Fà a parì. Diversi autori bergamaschi scrivono fà parì o fà aparì ma la forma più diffusa e più sensata, che ha una sua precisa ragion d’essere e che rispetta le esigenze della grammatica, è fà a parì, perché la preposizione che segue il verbo fà introduce una proposizione di natura finale. Fà a parì vuol dire ‘far finta’, ‘dare ad intendere’, ‘fare le viste’ ed è atteggiamento per lo più ingannevole, di chi ritiene utile o conveniente far credere una certa cosa oppure di chi si trova a far buon viso a brutto gioco e medita già in cuor suo la rivincita. Fà a parì negót è invece il partito di chi fa lo gnorri o il finto tonto, di chi vuole indurre a far credere di non vedere e di non sapere perché gli conviene comportarsi così. Ma non sempre è una scelta giusta. Di questi tempi, ad esempio, si continua a rovinare il territorio, ad inquinare aria, acqua e terra e poi si pretende che la natura non presenti mai il conto dei danni che le vengono arrecati. Si distruggono le foreste e si trasforma il pianeta in una serra umida e buia e si finge di non badare allo scioglimento dei ghiacciai, all’inalzamento del livello dei mari, alle alterazioni climatiche, al degrado dei centri monumentali e alla diffusione delle malattie dell’apparato respiratorio. Gli scienziati da tempo denunziano questo stato di cose, diffondono allarmi ed invitano i governi a favorire lo sfruttamento di fonti di energia meno inquinanti, si fanno convegni, si stipulano accordi e si assumono impegni per il futuro ma poi, seppure in misura minore rispetto al passato, si continua ad inquinare facendo finta di non sapere che ogni sfregio arrecato ai delicati equilibri della natura si ritorcerà contro la specie umana. Gli antichi Romani, senza disquisire di geofilosofia, avevano già capito che natura non facit saltus. Ma il patrimonio di idee e di esperienze del passato non conta se i calcoli egoistici prevalgono sul buon senso. Il modo di dire è comune ad altri dialetti lombardi. Nella terza parte del “Lament del Marchionn di gamb avert” (XVIII strofe) Carlo Porta scrive: Ma lee, franca franconna, la spergiura / el ciel, la terra; la me fa parì / ch’el traditor sont mi… Fà balà i giopì. Se dico: Stassira i fà balà i giopì, posso tradurre: ‘Questa sera si darà uno spettacolo di burattini’. Si sa che il teatro di figura, assai economico e popolare, un tempo era diffusissimo. Imprenditore e attore, scenografo e regista, il burattinaio (nel bergamasco ottocentesco böratinésta o giopinésta) provvedeva a tutte le incombenze, dalla costruzione della baracca all’intaglio dei fantocci di legno, dalla dipintura delle quinte all’invenzione della trama, dalla stesura del canovaccio all’azione scenica con l’animazione dei fantocci. Esiste in proposito una letteratura storico-critica ma gli aspetti più lontani della vicenda del teatro dei burattini in Bergamasca rimangono indefiniti, vaghi e quasi leggendari per mancanza di documenti e per l’affievolirsi della tradizione orale. Così di tanti maestri burattinai che con le loro rappresentazioni al chiuso e all’aperto hanno deliziato generazioni di grandi e di piccini non rimane che qualche labile ricordo. Nel loro genere erano davvero maestri ed artisti consumati, come il Carlo Sarzetti di Bergamo Alta o il Bigio Milesi di San Pellegrino o il Benedetto Ravasio di Bonate Inferiore, che avrebbero potuto fare scuola. Esilaranti, travolgenti, con un dialetto vivo, fresco, accattivante, sapevano divertire con trovate geniali, colpi di scena, battute effervescenti, frizzi irresistibili senza mai scadere nel volgare, senza mai attingere al triviale (mentre gli spettacoli di certe emittenti televisive nazionali, diventate cattedre di cafoneria, di turpiloquio e di scurrilità, offendono l’intelligenza e il buon gusto!). Gioppino per la tradizione orobica è il burattino per antonomasia: il suo nome ha assunto valore collettivo soppiantando nell’uso il termine böratì, ancora usato nell’Ottocento. Fra i fantocci del burattinaio si annoverano il re, la principessa, il mago, la strega, il diavolo, il gendarme, il bandito, l’oste, la morte; ad essi si sono aggiunti in tempi lontani i personaggi della Commedia dell’Arte (Arlecchino, Brighella, Truffaldino, Rosaura, Tartaglia, Capitan Fracassa, Meneghino, Pantalone, Colombina, Lindoro). Ma è Gioppino il protagonista indiscusso, finto sempliciotto, che trovandosi in guerra diceva ai suoi commilitoni: ’Ndì inàcc vóter, che mé adèss a ’ndo a ciamà chèi che i è restàcc indré…, ‘Andate avanti voi, io adesso vado a chiamare quelli rimasti nelle retrovie…’. Ai bambini piace Gioppino per la sua bonomia che a volte sconfina nell’ingenuità ma anche per la sua onestà, la sua generosità, ai grandi per la comica insaziabilità pantagruelica della sua fame e della sua sete. Da certi segni par di capire che questo tipo di spettacolo, che vanta radici antichissime e che intreccia la sua storia con quella della cultura popolare, abbia ancora un seguito. Ad multos annos! Fà balà l’öcc. Questa locuzione meriterebbe la riflessione degli epistemologi per il tesoro di esperienza che l’ha generata. L’occhio va fatto balà, va fatto muovere altrimenti non si vede tutto ciò che si deve vedere. Non lo diciamo solo noi bergamaschi, lo dicono anche i milanesi e i brianzoli, gente sveglia. Il motto è divenuto tanto popolare che pur di abbreviare alcuni pronunziano solo le iniziali: Effebielle. Significa osservare ogni cosa ed essere lesti a cogliere le opportunità, pronti ad affrontare gli ostacoli, a dominare le situazioni, ad intervenire prima che sia troppo tardi (oggi si dice darsi una mossa ma è italiano rozzo e plebeo). Non è facile rinvenire in altri dialetti italiani locuzioni che stiano alla pari di questa. In piemontese si dice: fati fürbu!, ma la furbizia sconfina nell’illiceità, nell’illegalità quando non nell’infingardaggine. Viene alla mente un raccontino di Luca Goldoni (in “Cioè”, 1981), quello del piccione viaggiatore che non voleva più volare perché su un certo balcone trovava sempre cibo e acqua in una scodellina. Che differenza fra le due locuzioni! L’occhio roteante e vigile è sinonimo di accortezza d’ingegno. Si ha bisogno di generazioni capaci de fà balà l’öcc, non di giovani che evitino i sacrifici e le responsabilità, eterni bambini cresciuti nella bambagia, ai quali non sia stata illustrata la parabola dei talenti. Fà bói ol pignatì per sò cönt. Quando un figlio è già abbastanza cresciuto da potersela cavare da solo e tuttavia non si accasa accampando magari qualche pretesa presso i genitori, i quali ad una certa età hanno tutto il diritto di respirare in santa pace (de trà ’mpó ’l fiàt, si dice in bergamasco), il padre, spazientito, potrebbe domandargli: Quando te faré bói ol pignatì per tò cönt? L’atto di provvedere da solo a cucinare mettendo la pentola sul fuoco simboleggia infatti l’autonomia dell’unità familiare, che un tempo veniva identificata nel focolare domestico. Nel nostro mondo industrializzato il tradizionale ruolo dei genitori, ai quali competerebbe di educare i figli, indicando loro i valori da perseguire e i princìpi in cui credere, è stato messo in crisi. Con un’abile regia i grandi mezzi di comunicazione di massa persuadono a vestirsi e a cibarsi allo stesso modo, ad ascoltare la stessa musica, a seguire le stesse abitudini: una visione individualistica della vita ha preso il sopravvento e il matrimonio non è inteso come impegno personale dei contraenti l’uno nei confronti dell’altro. Certi giovani rimangono così eterni adolescenti, evitano volentieri di assumersi le responsabilità delle persone adulte e mature, non sono disposti ad affrontare i sacrifici compiuti dai loro genitori, concepiscono il matrimonio e la prole come un fastidio o un impedimento. In effetti il dialogo fra le generazioni è quasi venuto meno e i padri, con grave danno della società, non riescono più a trasmettere il loro patrimonio di cultura e di esperienza ai figli. Far bollire la pentola per conto proprio significa aver comperato la pasta, il sale, i piatti, le posate, il condimento, il detergente per il lavaggio delle stoviglie, significa sapere il tempo di cottura, significa pagare le bollette dell’acqua e del gas… Un figlio maturo si pone la seguente domanda: “Se mio padre sa fare tutte queste cose, perché non dovrei essere capace di farle io?”. Fàcia de mamalöch. La propensione a specificare il tipo di faccia del nostro prossimo evoca la fisiognomica, disciplina oscillante fra la scienza e i luoghi comuni, che òpretende di cogliere e di definire le caratteristiche salienti dell’indole di una persona, la sua psicologia e la sua tipologia comportamentale dall’aspetto del volto, dai lineamenti facciali, dalla configurazione della fronte, del naso, degli occhi, delle labbra, delle gote e del mento. Vero è che i grandi artisti nei loro ritratti, basandosi sui tratti morfologici, hanno saputo esprimere l’interiorità delle persone in posa davanti al loro cavalletto. Ma è anche vero che l’eccessiva sottolineatura di determinati aspetti corporei ha indotto, al tempo della diffusione delle tesi positivistiche, uomini di scienza a scorgere frenastenici e criminali in persone innocue e sanissime e ad elaborare teorie discriminatorie e assurde. Ciascuno ha la sua faccia, bella o brutta che sia: i canoni estetici non sfuggono alla soggettività e non esistono volti belli o brutti in assoluto. Dare agli altri della ‘faccia da mammalucco’ non è il massimo della bontà d’animo. Non dobbiamo mai dimenticarci che come noi guardiamo in faccia il nostro prossimo, anche il nostro prossimo vede che faccia abbiamo noi. Fàcia de tóla. In italiano esiste la locuzione faccia di bronzo ma fàcia de tóla è tutt’altra cosa. La nostra voce tóla, come il francese tôle e il veneto tòla, deriva dal latino tabula. Era chiamato tóla il crepitacolo, una tavoletta sulla quale erano applicati dei martelletti e che si usava durante la settimana santa per dare il segnale del mezzogiorno o dell’Angelus o della Messa nei giorni in cui erano legate le campane. Alla tóla è perciò associata l’idea del rumore, un rumore secco, forte e penetrante, come un crepitio. Ma vi è associata anche l’idea del metallo, perché senza i martelletti di ferro montati sulla tavoletta di legno non si produrrebbe alcun frastuono. Carlo Castellaneta nel suo romanzo “Un’infanzia italiana” usa la locuzione menare le tolle per ‘andarsene subito’, ‘togliersi dai piedi’. E Domenico Manzella, curatore dell’edizione Mursia, così annota: “È espressione di origine dialettale. Venivano chiamate tolle le speciali catene appese al centro del camino che sorreggevano il paiolo per la cottura della polenta; siccome il fuoco di legna le incrostava di fuliggine, dovevano essere pulite periodicamente, e lo si faceva trascinandole e sbattendole sul terreno”. Si può immaginare il fragore prodotto dal trascinamento. Ecco perché dall’antico significato di ‘crepitacolo’ la voce bergamasca tóla è passata a indicare la latta, il ferro leggero, che fa molto rumore appena è mosso o urtato. Senza ricorrere alla fuliggine delle catene da sbattere sul terreno, le nostre latte, soprattutto se svuotate del loro contenuto (pelati di pomodoro, tonno sott’olio, sardine, ananas e pesche sciroppate, ecc.), non danno certo un’immagine di nettezza. Dunque, le facce di bronzo non sono belle a vedersi perché il bronzo si ossida e diventa verdastro ma le face de tóla non scherzano: sono sporche e fanno un baccano infernale. Ecco perché gli sfacciati e gli spudorati meritano di essere chiamati così. Tanto è vero che di uno che sia spavaldo e privo di ritegno diciamo ironicamente che l’ gh’à sö öna bèla tóla. Un esempio? Al momento d’impalmare la principessa Clotilde, che era una creatura dolce e angelica, Girolamo Napoleone, che stava in piedi innanzi all’altare con aria arrogante guardando qua e là e ostentando noncuranza della cerimonia religiosa, si fece ripetere la domanda rituale perché distratto; la seconda volta se la cavò dicendo: “Mais oui, oui, certainement!”. E il celebrante lo fulminò con una lunga occhiata severa. Fà ciamà. In caso di contestazione o di litigio un disputante può dire all’altro: Te fó ciamà. Non ha senso tradurre letteralmente: ‘Ti farò chiamare’. Con questa locuzione s’intende infatti dire che la controparte verrà chiamata legalmente a rispondere dell’offesa arrecata o del danno provocato. A volte non basta aver ragione per vedere riconosciuti i propri diritti. Fà come chèi de Careàs. Fare come quelli di Caravaggio, che quando l’ piöv i la lassa ’ndà al bass, ‘che quando piove la lasciano scendere’. Si dice quando non si può far nulla per cambiare un fatto o modificare una situazione. Fà come chèi de Faènsa. Sta a indicare una rinunzia forzata. Infatti a chi domanda come fanno quelli di Faenza si risponde che quando ghe n’è piö i fà sènsa. Fà come chèi de la Savòia. La rima vuole che si completi la frase così: che i laùra quando i ghe n’à òia. E fa un torto ai savoiardi, che non sono affatto indolenti. Fà come chèi de Tiöl. Sarà proprio vero che gli abitanti di Tiolo prima danno e poi rivogliono ciò che hanno dato? Eppure il detto, udito in Valle Brembana, suona proprio così: Fà come chèi de Tiöl che prima i dà e dòpo i völ. Tiolo, divisa in Alto e Basso, è un’amena frazioncina di Zogno, sorta sul percorso della vecchia Strada Priùla, così chiamata perché fatta aprire dal rettore veneto Alvise Priùl attorno al 1592. Fà come i mantoà. Fare come i mantovani, che chèl che i fà mia incö i la farà ’ndomà. Leggo nei “Pensieri e frammenti inediti” (Torino, 1928) di Giovanni Cena, poeta e novelliere piemontese (1870-1917): “Domani, tu dici, domani! Parola d’indolenza, d’infermità incurabile, come un lento morire. Domani non esiste”. Che poi davvero i mantovani siano soliti rimandare a domani quel che non fanno oggi risponde solo ad amor di rima. Fà come i pötane de Brèssa. Secondo questo detto le meretrici bresciane promettevano e non mantenevano. La similitudine è da usarsi in caso di mancanza grave. Se la promessa non mantenuta si riferisce a cosa di scarsa importanza non sembra il caso di ricorrere ad un paragone tanto scortese. Fà come i surcc de Pontiröl. Si dice per significare la volontà di sentire soltanto quel che fa comodo. Il detto che riguarda i sordi di Pontirolo si completa infatti così: che i sènt quando che i völ, ‘che odono quando vogliono’. I pontirolesi, che vengono tirati in ballo da questa locuzione soltanto per esigenze di rima, sono sicuramente persone di spirito e non si offendono per così poco. Per quanto attiene al detto, esso richiama il motto latino: Ubi non est auditus, noli effundere verba, ‘Non sprecare le tue parole se hai a che fare con gente che non ti ascolta’. Infatti non v’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Fà come San Tomàs. La locuzione completa è: Fà come San Tomàs che l’ gh’à picàt dét ol nas. Richiama l’episodio evangelico dell’incredulità di San Tommaso, che volle toccare con le proprie mani le tracce delle piaghe del costato di Gesù. Picà dèt ol nas indica appunto l’atto concreto di constatare un fatto o una situazione per convincersi della sua veridicità. Che poi lo si debba fare con l’impiego del naso è da vedere ma l’espressione paradossale, generata dal fantasioso realismo popolare, richiama il valore pragmatico della sperimentazione. Dice un noto passo del “Dialogo dei massimi sistemi” di Galileo: “Fànnosi liti e dispute sopra l’interpretazione del testamento d’un tale perché il testatore è morto, che, se fosse vivo, sarebbe errore il ricorrere ad altri che a lui medesimo per la determinazione del senso di quanto egli aveva scritto. Ed in simil guisa, è semplicità l’andar cercando i sensi delle cose della natura nelle carte di questo o di quel filosofo più che nell’opere della natura la quale vive sempre ed operante ci sta sempre innanzi agli occhi, veridica ed immutabile in tutte le cose sue”. Fa cór la ùs. Quando si vuole che una notizia si diffonda, occorre propalarla. Si diceva una volta: La ùs la cór, ‘La voce corre’. Con i mezzi di un tempo la diffusione era assai lenta e le nuove, se non scritte ma riferite a voce, potevano giungere distorte. Ora le notizie viaggiano ad una velocità eccezionale ma non di rado sono manipolate e travisate. Inoltre arrivano al pubblico soltanto quelle che si vogliono far sapere. Fà da Zane. ‘Far da Zani’ è locuzione che si ritrova nelle vecchie carte del Cinquecento. Dal nome proprio Giovanni sono derivati molti cognomi italiani. In Valle Brembana il nome si abbreviò in Zane, donde il cognome Zani. Qualcuno che aveva questo cognome dovette possedere buone qualità attoree se l’attor comico della Commedia dell’Arte fu chiamato sic et simpliciter Zani (e non Zanni, come si sente dire oggi a causa della mania tutta italica di complicare le cose semplici, anche raddoppiando le consonanti dove non occorre). Gli Zani si caratterizzavano per una certa loro rusticità spassosa, espressa non solo con le movenze goffe ma anche con una parlata “ridiculosa”, che fu detta genericamente bergamasca. Si sa che dai nostri paesi brembani andavano a Venezia a far fortuna giureconsulti, ingegneri, architetti, pittori, commercianti e uomini d’arme ma anche facchini e scaricatori portuali, disciplinati da mariegole o matricole aventi valore di statuti. Costoro parlavano certamente un linguaggio meno ricercato di quello dei patrizi veneziani che passeggiavano sul Liston d’oro. Rapidamente si propalò la diceria del bergamasco come linguaggio aspro e incomprensibile. Sulle scene i buffi che sostenevano la parte dello Zani improvvisavano a loro talento le battute e le situazioni recitando a soggetto, ossia sulla scorta di un semplice canovaccio, cosicché la Commedia dell’Arte fu detta anche Improvvisa. Accanto a bravi attori certamente bergamaschi ne seguirono altri che bergamaschi non erano e che, vestendo i panni di Arlecchino, di Brighella, di Scapino, di Pedrolino e di Truffaldino, preferirono parlare in veneziano, lingua per loro di facile apprendimento e immediatamente compresa dal pubblico al quale si rivolgevano. Del resto, quando si parla di letteratura zanesca o arlecchinesca occorre sempre tenere presente che si tratta di testi che presentano spesso un bergamasco spurio, approssimativo; gli autori, molti dei quali si celavano dietro pseudonimi scherzosi, non erano bergamaschi bensì felsinei, patavini, ferraresi… Orecchiavano il bergamasco e lo scrivevano così: A tal che seri tónd / alor quande m’ partì de la valada / tornànd faró stüpì mò la brigada. Fa de scagna banca. Letteralmente: ‘Trasformare una sedia in una panca’. Vale per: ‘Divertirsi oltre misura’. Fà dét córda d’ògne strigòss. Suona in italiano: ‘Utilizzare ogni straccio per fabbricar corda’. Significa: Commetterne di tutti i colori a proprio vantaggio a costo d’ingannare il prossimo. La locuzione appare al verso 56 della traduzione bergamasca del V canto dell’Inferno di Dante compiuta da Bortolo Belotti (“perchè d’ògne strigòss l’à fàcc dét córda”). Fà dét di inturciade. È linguaggio figurato per indicare fatti intricati o situazioni tutt’altro che limpide, non estranee alla disonestà e all’imbroglio. Esempio: I à fàcc dét ön’inturciada, ‘Hanno combinato un imbroglio’. Il bergamasco turciù indica il ‘vortice’ di lingua e il verbo intorcià (o inturcià) indica l’atto dell’avvolgere. Un recente dizionario bergamasco-italiano non reca traccia del sostantivo turciù (arcaico torciù). Strabiliante. Fà de tirapé. Si dice di chi si adatti a compiere lavori meschini e umilianti, che non tutti si sentono di fare, com’era quello dell’aiutante del boia: dopo l’esecuzione a lui toccava di tirare i piedi all’impiccato per far sì che, stringendosi attorno alla gola, il nodo lo strozzasse. Fà de tirapé è locuzione spregiativa che indica chi serve una persona in tutte le incombenze più vili. Fà di acc. Letteralmente: ‘Fare degli atti’. Ma che genere di atti? L’accezione più comune della locuzione è: ‘amoreggiare’, senza specificare se si tratta di due fidanzati che si stanno baciando o se s’intende un rapporto di natura sessuale. Ma può anche riferirsi a chi combina uno scherzo, a chi fa una scenata, a chi assume un comportamento inusuale gesticolando o imitando la voce e le movenze di qualcuno. La genericità della locuzione è dettata non tanto da scrupoli attinenti alla morale quanto piuttosto dal senso dell’osservanza delle norme del buon comportamento. Fà di asnade. ‘Fare asinerie’. Fra le opportune raccomandazioni che un tempo i genitori rivolgevano ai figli c’era anche questa: Fà mia di asnade, ‘Non fare asinerie’. Talvolta all’esortazione si aggiungeva l’eloquente massima: Sèrte asnade a l’ ria ’l dé che s’i paga, ‘Arriva il giorno in cui certe asinerie si pagano’. Fà di maiarée. Nel “De coniuratione Catilinæ” Sallustio confessa che da giovane si sentì per ambizione attratto dalla vita pubblica, rimanendone molto deluso. Già prima di lui Platone nella settima epistola aveva ricordato di essersi in gioventù dedicato alla vita politica e di essersi indignato nell’accorgersi che ogni città greca del suo tempo soffriva per governi costituiti da gente che badava più al proprio interesse che a quello generale. Si sa che il malcostume provoca degenerazione: la monarchia scade a tirannia, la democrazia a demagogia quando non a olocrazia (ovvero il potere della massa incolta, quella che oggi si lascia guidare dalla propaganda e condizionare dalle manipolazioni degli strapagati mistificatori della televisione). Non è una novità che in politica si trovi anche gente dedita al proprio tornaconto. Altrimenti non esisterebbero in bergamasco i termini maiaréa e malindà. Di pubblici amministratori che si servono del potere per fini contrari al pubblico bene si dice che i fà dét di maiarée, che si può ben tradurre: ‘si danno alle mangerie’. E quando gli atti amministrativi e la gestione pubblica non seguono criteri di legalità e di trasparenza si dice che gh’è del malindà, che si può tradurre: ‘c’è un brutto andazzo’. Che fare? Silio Italico, che nella sua splendida villa campana, dopo una vita di studi e di pubbliche responsabilità, si lasciò stoicamente morire d’inedia era anziano e stanco. Ma chi ha ancora energie e vita davanti a sé non dovrebbe spogliarsi delle sue prerogative di cittadino. Occorre sempre rifarsi allo spirito del mos maiorum, del mos antiquus, del costume e della moralità dei nostri avi, spirito presente nella cultura dotta come in quella popolare. Nell’orazione pronunziata da Cicerone in difesa di Sestio si legge: “Amiamo la patria, aiutiamo gli onesti, non badiamo al profitto dell’oggi, pensiamo alla gloria del domani”. Sante parole, che non sempre ispirano l’azione politica. Altrimenti la diffidenza e la sfiducia non sarebbero tanto radicate nell’anima popolare. Fà di giopinade. Significa ‘fare sciocchezze’ o ‘fare balordaggini’, come quelle di Gioppino, il quale diceva che una volta in guerra aveva circondato quattro soldati nemici ma che non gli era stato possibile imprigionarli perché i la lassàa mia ’ndà. La locuzione viene talora usata a sproposito, come nella circostanza della posa, nel 2011, ai limiti territoriali del Comune di Bergamo, di alcuni innocui cartelli toponomastici recanti il nome storico autentico della città, ossia Bèrghem, essendo Bergamo forma italianizzata. Le scombiccherature manichee apparse su qualche testata locale sono state veementi come levate di scudi. Si è definita infatti l’iniziativa “una gioppinata” e si sono risfoderate le solite argomentazioni trite e ritrite contro il dialetto, che non avrebbe la “dignità” della lingua, argomento penoso e specioso, perché ogni linguaggio storico ha il sacrosanto diritto di essere tutelato e salvaguardato, come ha indicato in un suo fondamentale documento il Consiglio d’Europa. Ma evidentemente l’europeismo oggi professato e ostentato da chi anni fa osannava il patto di Varsavia e il militarismo d’Oltrecortina è piuttosto tiepido e opportunistico se non si vuol tenere conto degl’indirizzi e delle normative europee a difesa delle culture autoctone minoritarie e minacciate. Del resto, certi difensori dell’italianità dell’ultima ora, che adesso ostendono ovunque il tricolore, lo sputacchiavano anni fa e lo bruciavano in piazza sventolando, da bravi servi dello straniero, la bandiera sovietica. Il dire che i cartelli toponomastici in dialetto non sono di alcuna utilità equivale a dire che andrebbero tolti anche quelli recanti la scritta “Città dei Mille” (ma i bergamaschi della prima spedizione erano centosettantotto!) e l’effige di Garibaldi arieggiante quella del simbolo del Fronte Popolare del 1948, fatti apporre da una giunta comunale ben caratterizzata dal punto di vista politico e ideologico. L’uso di toni polemici viscerali rivela scarso o nullo rispetto per la cultura e per la storia come rivela disprezzo per il territorio e per la gente che lo abita. Il voler ad ogni costo cancellare ogni simbolo identitario autoctono è del resto proprio di chi ha poca contezza del retaggio etico della storia della comunità in cui vive ed opera, è proprio di chi, cianciando a sproposito di populismo, dimostra la sua totale ignoranza dei valori delle culture locali radicate nel tessuto culturale e sociale dei popoli europei: è l’egualitarismo ottuso degli omologatori, è il provincialismo incolto degli esterofili, che odiano la propria gente. Gioppino, da loro chiamato in causa, saprebbe bene come trattarli. E insegnerebbe un po’ di storia a certi saputelli, incominciando da quanto disse Francesco Nullo, uno dei Mille, alla presa di Palermo: “Só contét per Bèrghem!”. E allora, viva Bèrghem! Fà di operine. Un tempo nelle scuole, negli oratori e anche in famiglia in certe circostanze si davano piccole recite, commediole, monologhi, scenette, dizioni di poesie che coinvolgevano i ragazzi. Leggo in un vecchio testo scolastico che i fanciulli dell’antica Roma solevano divertirsi con fischietti, sonagli, burattini, bambole di terracotta, di legno e d’avorio fatte muovere per mezzo di molle o di rotelle; giocavano con l’altalena, il cerchio, la trottola. Si divertivano anche nella corsa e nelle finte battaglie fra schiere nemiche. I fanciulli greci si dilettavano al gioco della palla; durante le lunghe sere d’inverno le nutrici narravano loro piacevoli favole e fantastiche novelle. Ora tanti ragazzi trascorrono ore intere davanti alla televisione o all’informatizzatore e tengono le cuffie incollate alle orecchie per ascoltare musica rozza e banale: non comunicano, non socializzano, non sono educati all’incontro, al dialogo e al confronto, non vengono preparati a partecipare alla vita comunitaria. Al tempo dei nostri nonni non era affatto così. Tanto è vero che questa locuzione coglie l’aspetto più vistoso della recitazione, quello dell’enfasi retorica. Infatti se dico che l’è mia ’l caso de fà sö tate operine (oppure l’è mia ’l caso de fà di pantomine) intendo dire che è inutile esprimersi con eccessivo trasporto, con parole roboanti e gesti caricati, come fanno a volte gli attori sulle scene. L’indole bergamasca non ama agghindarsi di fronzoli, rifugge dalle perifrasi e dalle prosopopee, evita la noiosa loquacità e va diritta allo scopo.
Scaricare