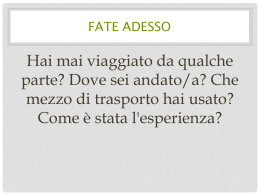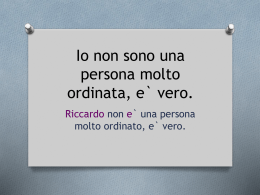- BlaBlaCar Storie di Viaggio Questo libro raccoglie le opere dei vincitori del Premio Letterario BlaBlaCar Storie di Viaggio organizzato da BlaBlaCar in collaborazione con La Stampa Fondata nel 2006 e con sede a Parigi, BlaBlaCar opera tramite siti web in dieci lingue in Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Russia e Ucraina. BlaBlaCar è network che mette in contatto automobilisti con posti liberi a bordo con persone in cerca di un passaggio. La community BlaBlaCar è formata da più di 6 milioni di iscritti e conta decine di migliaia di destinazioni in tutta Europa. Per il Premio Letterario, la Community di BlaBlaCar è stata invitata a raccontare le proprie esperienze di viaggio più importanti e significative. - Introduzione Dopo poche battute, Dania Dibitonto, autrice di “Solo un passaggio”, racconto vincitore del premio “Storie di Viaggio”, fa guardare negli occhi i due protagonisti. È uno sguardo che dura “qualche secondo”, il tempo di un’indecisione, di un pensiero che attraversa la mente, di una breve valutazione sulla domanda, sul contesto, sulla persona che si ha di fronte. È in quello sguardo che si decide una storia, in questo caso quella di un passaggio in auto offerto da un ragazzo diretto a Genova a una barista intenzionata ad andare nella stessa direzione. I racconti arrivati in risposta alla chiamata di BlaBlaCar sono pieni di sguardi. Ci sono gli sguardi di coloro che si soffermano a osservare il paesaggio attorno, per stampare nella memoria ogni singolo chilometro visto e attraversato. E ci sono gli sguardi di coloro che frugano nei visi, sui corpi, tra i vestiti, dentro le parole della persona con cui sanno di dover condividere un pezzo di strada. Sono in cerca di indizi, li vedi annusare, prendere appunti immaginari. È in quell’incrocio di occhiate fugaci che si decide se fidarsi di quella persona e partire. E allora ecco che i racconti si riempiono di descrizioni dense di fascino, fatte di dettagli e sensazioni, di impressioni e fantasie. “Il primo è un tipo tutto preciso e magrolino… la seconda è una laureata in Agraria dai pantaloni cortissimi e larghi, le scarpe aperte e un top verde come gli occhi” scrive Alessandro in “da Sud a Sud”. “Sulle gambe non ha peli e indossa scarpe sportive” racconta Joele Viganò incontrando per la prima volta il suo conducente. Tommaso Ruggeri fa di un piccolo e sorridente vizio vocale il soprannome con cui continuerà a ricordare la sua compagna di viaggio: “voce rotta dal sonno”. “Notai subito le scarpe del ragazzo: doveva essere lui” dice a un certo punto Giulia. Cosa ci avrà visto in quelle scarpe, si chiede il lettore. Eppure è un dettaglio che sembra essere sufficiente per aprire un varco sul micro mondo che ciascuno racchiude in sé. Werner Travagliati, secondo classificato del concorso, in “Viaggiare viaggiando” fa di quell’universo personale un mare in cui tuffarsi. Nel suo racconto ogni passeggero a bordo diventa l’occasione per esplorare il Paese da cui provengono: e allora, appena gli occhi si appoggiano su Helen, una ragazza dal “viso delicato e armonioso”, ricercatrice all’Università di Shanghai, la mente si ritrova nel bel mezzo del “traffico assassino e spregiudicato” di una metropoli del sud-est asiatico mentre dai finestrini è l’immensa distesa della Pianura Padana a farla da protagonista. Gli immaginari si schiudono come ostriche. Lo sguardo si perde a sognare “la vita nascosta” dell’altro e la curiosità tenta di colmare il buco tra ciò che è solo immaginato e ciò che è reale. “Abbiamo parlato di musica, lavoro e automobili, ci siamo consigliati ristoranti e pub in Toscana e Lombardia, e sono stato tra i primi a sapere che lui e la sua ragazza aspettavano una bambina” dice Andrea Paraboschi nel suo racconto “Crescere a quattro ruote”. Sembra non casuale, allora, il titolo scelto da Gladiola Mocka, “Con gli occhi di una bambina”, terza classificata: la presenza di immagini sfuocate e annebbiate provoca la sensazione che il mondo avvenga “senza un apparente nesso logico”. Come se la mancanza di dettagli chiari, in presa diretta, provocasse smarrimento. Guardare il mondo e le persone che lo vivono non è solo un modo per sentirsi parte di un’umanità, ma è anche l’opportunità più grande che abbiamo per ricostruire i fili della consapevolezza del nostro tempo. Continuiamo a dotarci di strumenti e meccanismi con i quali ci riserviamo l’ambizione di controllare il mondo. Ci sentiamo rassicurati, garantiti, preservati dalla possibilità di osservare senza essere guardati. Gli autobus, i treni, le sale d’aspetto, le strade sono piene di occhi abbassati su schermi in cerca di altri occhi che forse non si incroceranno mai. I racconti che andrete a leggere parlano invece di occhi che si muovono veloci, di sensazioni che le interfacce non possono trasmettere, di particolari che nessun profilo sarà in grado di restituire. Viaggiare in compagnia di qualcuno che non conosciamo è un po’ come accettare di incrociare lo sguardo di quell’uomo o quella donna sull’autobus che evitiamo di guardare preferendogli il selfie di qualche supposto amico su Facebook. La differenza sta nella bellezza della storia che solo quella persona, vera, attraverso la sua voce, è in grado di raccontarci. STORIE DI VIAGGIO - Solo un passaggio di Dania Dibitonto «Mi dai un passaggio fino a Genova?». Resto con la tazzina del caffè a mezz’aria, appoggiato al bancone del bar, mentre fuori il benzinaio mi sta facendo il pieno. Ci guardiamo per qualche secondo, e immagino che ora tocchi a me dire qualcosa. «Ci passi da Genova per andare in Francia, no? A me serve solo un passaggio.» La barista mi guarda sorridendo, come se la sapesse molto lunga. Me lo fa sempre lei il caffè, da un anno tutti i mesi, ogni volta che lascio Firenze per venire da te. «Se ci passi, stacco adesso... » Sale in macchina e io ancora non ho detto una parola. La accetto o la subisco, non riesco a distinguere. «Si può fumare qui dentro?» Rolla due sigarette e ce le fumiamo insieme. È così lunga che sembra non starci tutta intera nel sedile davanti. Se non dovessi guidare fisserei il suo profilo. È perfetto, sembra disegnato. Non come il mio, che... «Mettiamo un po’ di musica?» Si mette a rovistare fra i miei cd. «Di tutta questa roba si salva solo Bob Marley... » Inizia a canticchiare e a muoversi dentro la cintura di sicurezza, mentre fuori comincia a piovere forte, e dentro c’è una nebbia al tabacco che sfuma i contorni delle cose e mi pesa sulla testa. «Com’è?» «Chi?» «La tua ragazza.» «Forse non è più la mia ragazza». Asfalto, grigio, pioggia, campi di girasole e nuvole giganti. Tutto scorre veloce mentre Genova si avvicina e fra poco su quel sedile ci sarà di nuovo solo il tuo fantasma. Per adesso devi dividerlo con Gaia. «Anch’io viaggio per amore. Faccio una sorpresa al mio fidanzato. Ti assomiglia un po’, sai.» La luminosità del suo sorriso che intravedo di lato mentre guido squarcia il velo di nebbia delle mille sigarette che ci stiamo fumando. È finito il tabacco. «E tu che ci fai in un autogrill?» «Facevo la modella prima.» «Si vede... » «Preferisco fare caffè.» Ride forte quando parlo troppo toscano, dice che non mi capisce, ma non è vero, lo fa apposta a esagerare. Con te davvero ci abbiamo messo un paio d’anni a capirci, ma adesso io insegno francese e tu canti allo stadio per la Fiorentina. «Dividiamo le spese?» Si allunga a darmi un bacio sulla guancia, mentre metà del suo lungo corpo di sirena è già fuori dalla macchina. Chiude lo sportello piano e sparisce verso il porto. Stringo fra le mani venti euro e il bigliettino col suo numero di telefono. Scendo a respirare l’aria di mare che respiro quando sono con te, la cerco ovunque quando tu non ci sei. Rimango un po’ qui ad aspettare prima di ripartire. Magari viene qualcun altro a chiedermi un passaggio. - Viaggiare viaggiando di Werner Travagliati Il sole è brillante, l'asfalto bollente. Fine luglio milanese caldo e afoso. L'utilitaria bianca sbuca dall'angolo in fondo alla via. Scendono, ci presentiamo, ripartiamo. Christine è una italo-francese sui cinquanta. Rilassata e paciosa con un sorriso largo ed accogliente. Helen è tedesca, 27 anni, slanciata, il viso delicato ed armonioso incornicia il profondo blu degli occhi grandi. Vive in Cina ed è fidanzata con un italiano di origine pakistana. Adoro la diversità e sono già innamorato di questa donna minuta che vive e si divide fra due continenti lontani di chilometri e passioni. La lingua franca è l'inglese. Christine riposa sul sedile posteriore. Sono curioso e mi tuffo nella voglia di raccontare. Dentro la piccola utilitaria vedo la Cina. Dipinta e tratteggiata sul parabrezza, scolpita nel cielo, disegnata nei riflessi dello specchietto retrovisore. Helen lavora come ricercatrice all'università di Shanghai. Dipartimento di sociologia. Sono a Shanghai ed il traffico assassino e spregiudicato vortica, puzza e mi fa girar la testa. Investe un poveraccio in bici e dopo averlo insultato sgomma e sfreccia via. Ecco vedi l'arricchito, l'eroe del miracolo economico che sputa sulla vita. Siamo in riva al lago. Sta affogando e nessuno l'aiuta. Un peruviano si butta. Gli altri no. Penserebbero che è colpa tua se l'aiuti, non lo fare. Il lago immaginario davanti a me si ghiaccia come il mio cuore pensando alla tragedia culturale che si portano appresso. Dentro l'autobus affollato l'umanità è rumorosa e nessuno si cura di non recar danno, disturbo o fastidio. Faccio quello che mi pare, sembra urlare il ragazzo vestito alla moda con lo smart-phone super moderno segno distintivo da cittadino della grande metropoli, dove la bocca sta nascosta sotto la mascherina. Sempre. Non si può vivere a Shanghai se non hai la mascherina. L'aria è talmente inquinata da oscurare il cielo. Non ci si abbronza. A Shanghai non c'è il sole. È coperto dallo smog. Incredulo. Ti prego ora raccontami qualcosa di bello dell'immensa Cina. Le parole cadono lentamente come granelli di sabbia dentro ad una clessidra di curiosità. Paesaggi lontani sono un'immensa cartolina di colori e sfumature, suoni ed odori che passano e svaniscono. Gli occhi curiosi e luccicanti di questa mia compagna di viaggio lasciano intravedere il suo mondo, mentre mi racconta e si racconta lievito ed esco dalla scatoletta su ruote per volare sopra i cieli sconfinati della Cina. Mi metto la mascherina anti-smog e soffro del rumore del traffico asfissiante ma un attimo dopo sto ammirando il paesaggio ad acquarello in riva al lago, colorato dallo sbocciare dei mille fiori e profumi. Sono in un ingorgo di auto puzzolenti trasformato in un'oasi di meraviglia con il viaggiare del cuore e della mente. Quando arriviamo mi spiace salutare le compagne del viaggio di un giorno. Grazie. Abbi cura di te. Un abbraccio di sconosciuti. Un momento di disinteressata, nuda, umanità. - Con gli occhi di una bambina... di Gladiola Mocka Vi racconto la storia di un “ viaggio sognato”. Badate bene però, non sto parlando di quei viaggi tanto desiderati per i quali metti da parte tutti i tuoi risparmi. No, il mio viaggio è un sogno. Se chiudo per un attimo gli occhi riesco solo a ricordare immagini sfocate, luoghi e persone che cambiano improvvisamente, situazioni che si spostano da un episodio ad un altro senza un apparente nesso logico. Desiderosa dunque di capire se quelle immagini erano solo frutto della mia fantasia, ho chiesto alla mia mamma: “Mamma perché ricordo che da bambina correvo scalza tra la sterpaglia? E per quale strana ragione tu, Ana di soli due anni ed io che ne avevo appena sei, eravamo chiuse in una cella?” No, non era un sogno. Se lo fosse stato ora io non sarei qui, davanti al mio computer a scrivere di questa storia. Probabilmente sarei sposata con uomo conosciuto appena una settimana prima, magari con un matrimonio combinato (come spesso accade dalle mie parti) e anziché battere la tastiera del mio computer sarei stata intenta ad allattare i miei figli, nulla di strano per una ragazza di soli ventitré anni. Eppure per mia fortuna o sfortuna (non saprei quale sorte prediligere) la storia è andata diversamente. Questo è il viaggio del mio super papà chiuso in un barile. Sì, ho scritto proprio barile, uno di quei grossi contenitori cilindrici creati per trasportare prodotti allo stato liquido e non di certo uomini che remano a tutta forza nel bel mezzo del mar Adriatico. Fortuna ha voluto che quel barile è stato poi ritrovato da un peschereccio che ha offerto cibo e acqua a questi uomini impavidi. Questa è la storia della mia coraggiosa mamma che sola con due bambine a carico, ha lasciato le coste balcaniche con un visto per raggiungere suo marito nel “ Bel Paese”. Sfortuna però che quel visto era falso e dunque, quella nave una volta arrivata in Italia, ci ha portate in Grecia. Quindi sole, senza più soldi ( poiché derubate) ci siamo ritrovate chiuse in una cella. A farci compagnia solo un delizioso croissant che ci avevano generosamente offerto e che ho ceduto alla mia sorellina che piangeva per la fame. Ora questa storia viene spesso usata per ricattare la mia dolce sorellina quando ad esempio desidera indossare una delle mie gonne: “ Sai Ana quando io avevo solo sei anni nonostante la tanta fame, ti ho ceduto il mio croissant, dunque te la puoi scordare adesso la mia gonna!” Ma questa è sola una parte del mio viaggio verso la tanto sognata Italia, paragonabile quasi al sogno americano. Eppure, dopo il visto falso e il nuovo viaggio a bordo di un piccolo scafo sul quale ho perso le scarpette che immaginavo quando chiudevo gli occhi. Dopo i primi anni di sacrifici, di stenti, posso dire che il mio viaggio, seppure sfocato dai pochi ricordi, mi ha portato a fare ciò che più amo: scrivere. È con gli occhi di una bambina che ricordo il mio viaggio come un sogno, è con gli occhi di una donna che ora posso sognare qualsiasi viaggio. - Uluru di Adalberto Fornario VENTISEI ORE! Tanto è durato il viaggio per andare a vedere quella ‘pietra’ ! A parte gli scherzi, il monolito di Uluru, al centro del continente australiano era una meta che c’eravamo prefissi da qualche tempo. Ci avrebbe riportato alle popolazioni aborigene che abitavano quelle terre da tempo immemorabile, ben prima degli australiani… Così ci organizzammo bene. Partenza alle 7 di mattina da Napoli, arrivo alle 21 del giorno dopo a Brisbane. E’ vero, c’è il fuso orario, ma le sedici ore della tratta Roma-Singapore erano reali! Dopo un paio di settimane in giro per l’Australia, ci ritroviamo ad Ayers Rock, al centro di quell’immensa landa quasi desertica, in un resort costruito apposta. Ed era strano leggere quel cartello all’uscita del Parco SE VI STATE METTENDO IN VIAGGIO, APPROVVIGGIONATEVI DI: ACQUA – PILE PER IL CELLULARE – PIENO DI BENZINA PER L’AUTO. IL PROSSIMO CENTRO RIFORNIMENTO E’ A 500 KILOMETRI Bene, alle quattro di mattina c’è la sveglia e dopo poco si parte per il monolito. Siamo molto ansiosi e pieni di emozioni: stiamo andando a visitare un luogo unico, spirituale, magico. Arrivati, ci rendiamo conto, a malincuore, della spiacevole sorpresa: il posto è stracolmo di pullman, auto, moto, biciclette e altri mezzi di trasporto. E una fiumana di persone! Ma dove siamo? Sembra Disneyland! Banchetti con caffè e tè caldo, panini, briosce e altro per rifocillare i visitatori/turisti. Colpo di scena ! Il momento clou della visita: due anziane aborigene ci illustreranno gli avvenimenti sviluppatisi intorno al monolito. Nel loro tipico abbigliamento aborigeno: gilet di pelle e gonna di jeans! A questo punto, come spesso accade, sorge un problema: il finale! Come finirà il racconto? Nel frattempo, spedisco il nostro protagonista a sdraiarsi sui sedili in fondo al pulmino che l’ha condotto qui. Magari per recuperare il sonno perduto per l’alzataccia della mattina, poi si vedrà… In ogni caso, buona visione! - Rosso di Alessandra Catalano E mi immagino ancora li tra quella terra rossa mentre mi muovo a fatica tra quei cespugli intricati e quei cactus imponenti. Cerco di prendermi il mio spazio e di isolarmi con il resto del mondo per ammirare semplicemente in silenzio la Natura. Solo io e lei. Solo io e il soffiare del vento. La natura che ti parla.. che ti mostra la sua forza, orgogliosa e fiera ti mostra la sua terra. E tu ti senti quasi un estraneo in mezzo a tutto questo. È come se la tua presenza rompesse un po’ quell’equilibrio. Ma alla fine capisci di essere parte di quel tutto. Solo dopo aver passato ore ed ore a contatto con quella terra rossa capisci di essere fatto tu stesso di quella terra.. di essere rosso tu dentro.. e cerchi di immortalare qualche foto, per cercare di racchiudere in una foto tutti quei ricordi, quegli odori e quei profumi, ma sai che tutto questo ti potrà rimanere solo dentro, e che solo tu puoi sapere come ci si sente ad essere fatti di terra.. ad aver vissuto quell’emozione immensa.. ed ora è come se quella terra mi scorresse nel sangue.. sarà che è rosso per questo? - Il mio grande viaggio spremuto di Alessandra Quintavalla Alle volte capita di accorgersi solo dopo e all’improvviso della bellezza di ciò che accade in ogni istante, a poca distanza dagli occhi. Un viaggio breve. Momenti quasi interminabili. Roma - Milano. E poi indietro, da Milano a Roma. Bla Bla Car: un modo creativo per condividere divertendosi. Un chilometro dopo l’altro. Quattro persone sconosciute si incontrano, e forse non si vedranno mai più. Eppure, mai più, dimenticheranno le storie che hanno ascoltato. L’auto di Filippo è stata un luogo su cui sostare per un po’, per poi ripartire più sicuri, più ricchi di qualcosa che non trova parole. Uno spazio che si muove, dove poter essere presenti, veri e finalmente fuori da un nido troppo stretto. Accanto a me c’è la mia amica Valentina. Anima autentica. Milano ci aspetta per un intreccio di motivi. Al centro, c’è la voglia di partecipare a un’attività della Soka Gakkai. È un’organizzazione buddista. Ne facciamo parte. La Soka Gakkai andrebbe protetta con cura, poiché in ogni dettaglio di ciò che fa si nasconde sempre qualcosa di più profondo. Le cose però non vanno mai come ti aspetti che vadano, e infatti niente di ciò che doveva accadere è accaduto. L’amica che doveva portarci al luogo dell’incontro ha un attacco di panico e ci molla in mezzo alla città. Qualcuno a quel punto abbandona la sfida. Noi, non sappiamo dove andare. E ancora: le chiavi della stanza che mi ero fatta prestare non si trovano. E poi, multe, mal di piedi, zanzare. Tante parole ma sempre le stesse: - Da non crederci. Non ce la faccio più! - E invece non puoi far altro che credere, aver fiducia e farcela ancora. Sono giorni distratti, tinteggiati di incontri di ogni genere. Sui tram, sui marciapiedi, tra gallerie d’arte, in macchina. Milano è globale, è altera. È anche romantica. C’è il sole e ovunque tutto cambia, senza tregua, davanti ai nostri occhi. Vale dorme da Renata. Aveva offerto ospitalità anche a me, io avevo rifiutato per non disturbare. Adesso però non ho scelta e mi intrufolo nel suo monolocale. La discussione fra me e Renata ha l’effetto di una palla da bowling sui birilli dello strike. Malintesi e incomprensioni. Dopo, confuse, cerchiamo una soluzione. Siamo sbigottite. Tutt’intorno la realtà ci risponde come un’eco. Non serve a niente litigare. Ci chiariamo. Renata ha un bambino che sorride sempre. È mattina presto quando ci riempie di dolcezza. Abbiamo fatto bene a decidere così. Lasciarci vivere. Essere dove tutto è solo ciò che è. Provare ad ascoltare e farsi contaminare, senza aver paura di accorgersi che non c’è niente di irreale. Un posto difficile da immaginare. Se avessimo seguito la solita strada, non avremmo vissuto gli abbracci affettuosi, gli spaghetti, le nuove verità e le storie da ascoltare. A volte mi torna ancora in mente quel posto. Mi capita come di ritornarci; perché nonostante sia invisibile riesco a trovarlo. Quando decido di sgretolare la mia resistenza, lui c’è. Allora lascio che saltino in aria tutti i limiti e le congetture della mente. Che volino lontano. Poi c’è il ritorno. L’autostrada del Sole, di nuovo Bla Bla Car. La luna illumina l’asfalto e anche gli occhi stanchi di Salvatore. - Sal, per gli amici. -Buonasera Signor Sal. Cellulari scarichi. L’adrenalina è nel petto, la notte rimane immobile. Noi siamo salve. Da Milano a Roma. La nostra corona dorata. - Da sud a sud di Alessandro Cocorullo Alle 22.30, secondo programma, partiamo da Ercolano. In auto abbiamo due ragazzi, Luca e Maria, conosciuti su blabla car e che sembrano a posto: il primo è un tipo tutto preciso, occhiali e magrolino, si presenta con un trolley e un pacco di cibarie: studia Scienze Politiche a Pisa ed è di Nocera, come l’accento sottolinea. La seconda è una laureata in Agraria dai pantaloni coloratissimi e larghi, le scarpe aperte e un top verde come gli occhi: zainone sulle spalle con tenda annessa, e confezione di mozzarelle in mano, con birra fatta in casa. Ci carichiamo questi due micromondi e partiamo. La strada per Sala è scorrevole, e conferma della bontà dell’idea di partire di notte. Film, politica, religione, esperienze personali, università, tu dove vai? Si parla molto. Luca va a Gibellina, dal coinquilino di Pisa; terra degli Elimi, il popolo che strinse patti coi Cartaginesi per resistere ai Greci che da oriente si espandevano. Storie lontane. Oggi vi è il sudario in pietra di Burri a ricordare, come solo la pietra può in modo permanente, la tragedia del terremoto. Archeologia dell’archeologia. Maria va ad Alcamo dal ragazzo, nell’interno tra Palermo e Trapani. E’ terra di vigneti, formaggi e di poeti, tra tutti Cielo, che una rosa regalò alla sua amata. Da Napoli a Villa si può apprezzare il cambiamento di accenti. La strada è vuota, solo qualche auto e alcuni tir. Qualcuno di questi, forse a causa di consegne che non ha potuto espletare nei tempi previsti, sfreccia oltre i limiti, traballando sotto il peso del container. In sei ore siamo a Villa San Giovanni. Mai attraversato all’alba. Il sole sorge alle spalle della Calabria, e irraggia la Sicilia a circa tre chilometri di distanza. Un braccio di mare in cui le acque, molto tranquille, si scontrano lungo la faglia che divide la crosta europea da quella africana, di cui la Sicilia fa parte. Qui si creano dei piccoli mulinelli, e il livello del mare è leggermente diverso: la parte europea è più alta, e ricade su quella africana. Che strano a vedersi: due correnti ad altezze diverse e che vanno in direzioni diverse; un tempo erano terrore di chi attraversava lo stretto, anche per esperti navigatori come i Greci. Entrando nel porto di San Raineri, ricordo il nome che i Greci diedero a Messina: Zankles, ovvero falce, perché il porto si estende come una mezzaluna, e sembra avvolgerti mentre vi entri. E’ l’alba, e schizziamo sulla Messina – Palermo. Due ore e siamo alle porte di Palermo, e poi un’ora fermi nel traffico. La strada, se carente di stazioni di servizio, offre una lunga striscia di mare per tutto il percorso, con le ombre delle Egadi che ti seguono, e i Peloritani prima, i Nebrodi dopo, come giganti in pietra per ricordarti che sei in un microcontinente, non su un’isola. Palermo è già sveglia quando lasciamo i nostri compagni ai loro amici. Io ho sonno, sonno da morire: dieci ore di viaggio no-stop. Voglio andare a dormire, quanto prima, perché ho sognato così bene, che ora sono stanco. - Gita al lago di Alessandro Moscato Mi sveglio una mattina di ottobre e so che devo partire. È un viaggio, quello che mi aspetta, che ho organizzato da tempo. E non perché decidere il percorso, il mezzo sul quale andare o l’albergo in cui soggiornare abbia richiesto particolari riflessioni, ma solo perché dovevo convincere mio padre. Lui, infatti, gira soltanto per casa ed esclusivamente a bordo della sua carrozzella. L’ho pregato per settimane e alla fine si è lasciato convincere. «Vorrei solo portarvi al lago, a te e alla mamma». Gli ho detto. «Potremmo passare insieme un giorno fuori casa prima…» «Prima di cosa?» Allora mi ha detto. «Prima che io non ci sia più?» «Sì, anche questo». Mentre quel giorno parlavamo mia madre se ne stava seduta alla sua solita poltroncina ad ascoltarci. Faceva finta di leggere. Aveva l’aria attenta di chi non spera, ma che dentro vuole che quel miracolo finalmente possa accadere. E così, quando proprio non ci speravamo più, è avvenuto. Una volta incassato il sì di mio padre sono andato a casa di mia sorella. Quando le ho detto che papà aveva accettato lei non ci ha creduto, mi ha chiesto perfino se non avessi frainteso o se me lo fossi addirittura sognato. Ma la circostanza era vera, perdio se era vera! «Allora sì parte». Mi ha detto, con gli occhi che le brillavano come quando era bambina. «Sì, fra due settimane circa. Il tempo di organizzarci e andremo al lago». Così oggi finalmente andiamo. Staremo via solo un giorno. Torneremo in serata. Ma già assaporo il piacere della strada che si srotolerà sotto le nostre ruote, piano e senza nessuna fretta. E poi il fatto che ce ne staremo lì, tutti insieme, come non accade da anni in un’auto, mentre si viaggia diretti verso un posto che è solo meta: fine di un piacere. L’importante sarà stare insieme per vedere cose nuove o semplicemente una porzione di mondo messo in vetrina dietro i lunotti della nostra macchina. Le bambine sono già arrivate, sento il trapestio dei loro passi. Mia madre è già in cucina che prepara la colazione per tutti e mio padre è già di là che borbotta, come al solito, per i problemi che ogni mattina deve affrontare anche solo per sedersi. Intanto mio cognato apre il garage e tra un po’ accenderà l’auto. Controllerà che tutto sia in ordine. Dopo che finalmente saremo tutti saliti in quella specie di furgoncino a nove posti che abbiamo preso a nolo, partiremo con l’alba che starà ancora svegliandosi, piano alle nostre spalle. - Io non viaggio sola di Alessia Gilardo “Rosa!”: nessun dubbio alla domanda come avrei voluto la mia bicicletta. Avrò avuto circa 5 anni, ultimo anno dell’asilo, perché è stato quello il mio periodo a tinta unica. Il modello non me lo ricordo, ma ho ancora nella testa (e se ci penso anche nelle gambe) la gran fatica che facevo per pedalare e muovermi in circolo nel cortile di mia nonna. La procedura era sempre uguale: l’uscita della bicicletta dalla cantina nelle mani di mia nonna che la teneva ferma mentre ci salivo, le prime pedalate traballanti e assestanti e poi via, incominciava il viaggio che conoscevo ormai a occhi chiusi. Iniziava vicino al tavolo con la macchina da cucire da cui mia nonna mi teneva d’occhio lavorando, poi mi avvicinavo al grande vaso con i fiorellini viola che mi divertivo a strappare in segno di ribellione quando mi arrabbiavo, facevo un girotondo intorno alla vecchia cassapanca in legno in cui conservavo i giocattoli che amavo di meno, per raggiungere infine le sedie pesanti su cui venivano fatti accomodare gli ospiti, graditi e non, che venivano a far visita. Il giro sempre uguale e sempre con la stessa velocità, dopo le prime settimane, iniziò ad annoiarmi. Avrei voluto uscire dal cortile, fare come i grandi: usare la bicicletta per andare da qualche parte, avere una meta. E’ così che la mia bicicletta rosa fu sempre meno usata e stava per finire vicino alla cassapanca in legno nell’angolo del cortile. Ma poi i viaggi diventarono più interessanti. Prima che la bicicletta sorgesse dalla cantina al cortile, scendevo le scale per andarla a trovare in anteprima. Con rotoli di filo che usava mia nonna per cucire allacciavo Giusy, la mia bambola vestita con una tutina rosa, tra il manubrio e la sella. Quando l’operazione, non semplice, era terminata, chiamavo mia nonna che con pazienza portava tutto il fagotto al blocco di partenza del mio tour. Ora salire era ancora più difficile, raggiungere l’equilibrio era un’impresa non da poco, ma la mia gioia, appena la pedalata diventava più stabile e spedita, ricompensava tutto. Pedalavo, mi affaticavo, sudavo, ma quanto era affascinante andare a cercare con Giusy la gatta della vicina che entrava sempre di soppiatto dal cancello della casa, mentre provavo a superare il record di giri attorno alla fioriera intonando canzoncine, oppure durante un racconto a voce alta per la mia compagna di viaggio. E’ da quel momento che ho capito quanto è piacevole viaggiare in compagnia e condividere le emozioni che continuo a racchiudere nel mio quaderno dei viaggi, sempre più grande e spesso, difficoltoso da portare con me, ma con la copertina ancora lucida e pulita, intonata perfettamente alla mia grande valigia rosa. - Allegrina means happy di Andrea Marcolongo Palmiro, Giuseppe, Andrea, Gianni, Felice, Alberto, Teresa, Dina, Ettore... Al vecchio Dino, il decimo nome non viene in mente. Tutti fratelli Allegrina questi, ripete, stringendo tra le mani l’album di famiglia, fotografie sbiadite, sorrisi sghembi e forti. Mike piange. Anche lui è un Allegrina, figlio di quelli là andati a far fortuna in America, col bastimento. Nelle foto di Dino c’è anche Mike bambino, sulle ginocchia di nonno Felice, partito da Dernice nel 1926 e sbarcato in una Detroit che mantenne le promesse. Quelle foto arrivavano direttamente dall’America ogni Natale. Anche venti dollari mandava Felice, ma Dino non ha mai saputo come cambiarli e se li è tenuti così, ancora dentro la busta, perché non si sa mai. Felice means happy, dico io, che di questo incontro sono la traduttrice. Tutti siamo qui per caso. Allegrina means happy too, che combinazione. Ricapitolando: Mike e la moglie Kathy, i loro amici Brett e Dena vengono dall’Ohio, ma, per l’estate, hanno affittato una casa nel Chianti. Quella casa è mia, ereditata da una madre che non ho più. Dove possiamo trovare una guida turistica? Mi chiedono. Eccomi, rispondo io d’azzardo, che guida non sono, ma ho tanto viaggiato. Si parte, stipati nella mia macchinetta con l’aria condizionata a mille, Venezia e i cicchetti, Roma e il vino dei Castelli. Mike sogna Dernice e me lo dice così, come stesse dicendo New York, il centro del mondo. Mai sentito, dico io, però m’informo e ti ci porto. Caldo, autostrada, stiamo stretti. Il cartello dice Dernice e le montagne della val Curone sono rugose come vecchie. Ho visto queste montagne cento volte, nei racconti di mio nonno, dice Mike. Ci siamo. Non ci aspettavamo niente. Mike non ha un indirizzo cui bussare, non sa una parola d’italiano se non felice. Ma Dernice è come uno spillo, trenta anime che si stringono in un’unica via. L’occhio cade su un campanello: Allegrina. La vecchia signora che ci apre è sospettosa, non capisce. Intervengo io, chiama il marito, uno moment. Poi è tutto un abbraccio e un cugino mio. La casa è quella giusta, penso, e piango anch’io. Elsa, la polenta! chiede Dino, togliendo il budello ad un salame. L’ha fatto lui, così come il vino e il formaggio. Si schermisce per il pranzo frugale, solo per sopravvivere, eppure mangiamo da re. La prossima volta gli agnolotti, e racconta di essere l’unico Allegrina rimasto a Dernice, gli altri tutti in giro per il mondo, America, Canada, Argentina. Racconta di una vita a fare il contadino, non ha studiato. Una moglie buona, due figli partiti e poi tornati a fare i contadini pure loro, ma con Slow Food. Ora sei un Allegrina anche tu, mi dice Mike, e così ho guadagnato un’altra famiglia, che si unisce a tutte quelle che ho per il mondo. A casa torniamo con due chili di patate ed una forma di formaggio. Alla prima curva, nello specchietto intravedo Dino che ci rincorre. Mi fermo, bussa al finestrino e dice: “Fausto, si chiamava Fausto il decimo Allegrina”. - Crescere a quattroruote di Andrea Paraboschi Pietro è salito sulla mia auto il Venerdì 16 Novembre 2012 a Pisa. La tratta, sempre la stessa: Pisa- Milano il venerdì pomeriggio e ritorno la domenica sera. Condividere la mia auto è diventato indispensabile da quando mi sono trasferito come ricercatore a Pisa e Pietro è stato uno dei miei primi passeggeri. Abbiamo subito legato, in comune avevamo le stesse abitudini di viaggio nel weekend. Ha dieci anni in più di me ed entrambi ogni venerdì tornavamo a trovare la ragazza al nord, io a Milano e lui vicino a Bergamo. Di solito il mio viaggio terminava a Milano in Piazzale Lodi, quando c’era lui allungavo fino alla stazione di Lambrate per fargli prendere il treno in tempo. Giudare l’auto in carpooling è totalmente diverso da essere tassista: appena il passaggero sale in macchina si apre, ti racconta come va il lavoro, la famiglia. Si instaura subito un rapporto di fiducia reciproca e si diventa facilmente amici. Ho viaggiato con Pietro circa venti volte, il venerdì eravamo entrambi stanchi ma felici di riabbracciare i nostri cari, la domenica con un po’ di tristezza in corpo dopo averli salutati. Abbiamo parlato di musica, lavoro e automobili, ci siamo consigliati ristoranti e pub in Toscana e Lombardia, e sono stato tra i primi a sapere che lui e la ragazza aspettavano una bambina: per l’occasione, visto che non c’erano altri passeggeri, abbiamo festeggiato trasformando la mia auto in discoteca mentre percorrevamo l’Autostrada della Cisa. Durante l’inverno e i tanti viaggi insieme ho condiviso con Pietro le preoccupazioni di diventare padre, i dubbi su dove fosse meglio vivere, la gioia e l’attesa di formare una famiglia. Ogni viaggio si trasformava per me in un momento di crescita oltre che di piacevole conversazione: non avevo idea si cosa accadesse quando si sta per diventare padre, parlando con Pietro lo stavo scoprendo. Appena tornato dalle vacanze, ho scritto a Pietro per sapere se avesse bisogno di un passaggio. Mi ha ringraziato ma ha rifiutato: era nata Martina e sua moglie si era trasferita in Toscana. Dentro di me ero felice come se conoscessi Pietro da una vita. Condividendo la mia auto ho scoperto cosa significhi diventare padre, un pezzo di vita che ancora non conoscevo. - Nei suoi panni di Aos (pseudonimo) Un viaggio, che si è scelto, può essere rinuncia? A mangiare e dormire quando vuoi, a un tetto sotto cui ripararti, ai panni comodi, alle abitudini? Ha senso diventare, da persona "normale", un artista di strada girovago x sette giorni (e notti), senza un soldo in tasca e con la propria arte (nel dire, nel muoversi e muovere) unico mezzo per mangiare? Si! Se la necessità del contatto, della comunicazione, della "testimonianza" che un altro "modo" sia possibile, è abbastanza forte. In Sardegna quindi, per strada. Una settimana. Domenica: sbarco a Santa Teresa di Gallura, ore 13. La piazza centrale occupata! Allora saremo a Palau, in serata. In autostop, economico e pure coerente: non prendi un altro mezzo (=eco-friendly), conosci altri (=comunichi), dando e ricevendo fiducia. La prima volta facciamo un salotto. Passa un bambino, ci guarda incuriosito. "Vuoi sentire una storia?" "Sì". Chiama un amico, poi altri tre. la prima volta è per loro. La notte è una pineta, l'ululato del vento, un pino che non cade. Lunedì: L'alba è una piazzoletta rocciosa, quattro cormorani frikkettoni e un gabbiano tutto fiero, discosto. La mattina è la nonna dello scoglio “A ottantaquattro anni le mie amiche sono quasi tutte morte, mio marito non c’è più, non mi capita mai di poter chiacchierare con qualcuno”, è condividere un po’ di bello, perché... fa bene. Poi il diluvio, la nostra tendina-casa sbatacchiata dagli elementi e la sera di nuovo a raccontar storie Palau. Martedì: Sole a picco, autostop, tutti (gli altri) al mare o a pranzo e noi sotto zaini himalayani. Se non scappi dalla vita, la vita ti viene incontro, ti cambia e “scorre” il cambiamento: passaggio da una coppia che ha cambiato vita da vent’anni, trasferendosi ed aprendo a Palau una scuola di sub. La sera è gente che si ferma, ascolta, lascia una moneta, se ne va, sente cosa facciamo, ci fa i complimenti, ci offre un passaggio fino a Cagliari sulla sua barca. Trenta ore di navigazione, solitarie e dense come le stelle. Giovedì: a Villa Simius grazie al passaggio di Alessio e Tito, artisti di strada. Aperti, gentili. Condividiamo il cibo, il viaggio, le nostre arti, ma soprattutto, condividiamo. 23: 30: Quattro chilometri, carichi e stanchi, per il “Grande Bello”: la spiaggia con la Luna quasi piena. Venerdì e Sabato: è stato un vento veloce, carico come l'inizio di primavera. Ritorno, con gli inviati del destino: Un taxista filosofo ci offre anche due birre e il consiglio di andare a Lourdes, un ragazzo dagli occhi azzurrissimi ci salva dall’Aurelia, un regista televisivo ci porta a Piacenza e torna indietro per "girarci dalla parte giusta", un autista serbo ci offre vino e prugne e racconti di camion, un veterano boyscout ci porta all’una di notte sotto casa, che a quell’ora non ci son più mezzi... E’ finita. Resta la voglia di continuare, di raccontare la storia di un viaggio di sorriso e forse d’incoscienza, della leggerezza e della voglia di incontrare anime vaganti sotto il cielo. Anna Comparini Più Kenya possibile Coloro che ci sono già stati provano a dirti cos’hanno provato, cos’hanno visto, cos’hanno imparato, come l’hanno vissuto, tentano di farti capire come e cosa sarà il famoso mal d’Africa che inevitabilmente proverai dopo, ma la realtà è che non si è mai abbastanza preparati per non sentirsi invadere e sconvolgere dentro dal Kenya che ho visto io. E forse non lo si vuole nemmeno evitare. Si è pronti a dare tutto, come si è pronti a ricevere tutto. Perché è così che va, è così che non se ne va, il Kenya che ho visto io. Il Kenya che ho visto io entra prepotentemente dalle narici appena si aprono le porte dell’aereo. Invade ogni centimetro esposto della pelle, e anche i centimetri ancora coperti dagli indumenti pesanti che s’indossano dall’Italia. L’aria è profondamente diversa, impone di respirare ad un ritmo più rapido, riempie i polmoni della sua densità. L’aria del Kenya entra in te, e lì rimane. Forse avrei dimenticato, pian piano, quella prima sensazione, se avessi trascorso le mie due settimane keniote in un villaggio turistico. Quei mondi ovattati, perfetti, preparati e infiocchettati appositamente per le persone in cerca di relax, mare e sole. Quei mondi così finti, così contrastanti dal mondo vero che si mostra se solo hai il coraggio di guardare un po’ più in là. No, meno male la mia visita al Kenya ha incluso molto di più. Mi sono sentita in un altro mondo non appena ho respirato in terra africana, e l’immersione è proseguita durante le due ore di viaggio dall’aeroporto di Mombasa alla città di Malindi, dove si trovano la scuola e l’orfanatrofio presso i quali si è svolta interamente la mia esperienza. Quelle due ore all’interno di quel piccolo e malmesso monovolume sono quasi più pesanti, a livello fisico e psicologico, delle otto ore appena trascorse in aereo: il caldo umido è asfissiante, i fastidiosi ed alti dossi sulla strada sono numerosissimi, l’intervallarsi dello scorrere fuori dal finestrino di foreste e villaggi trafficatissimi è inspiegabile, per chi è cresciuto nel mondo occidentale. Mi aspetto di fare un incidente ad ogni metro, di investire quasi sicuramente uno di quei bambini piccolissimi che vagano da soli per le strade, oppure uno di quei giovani che, con la divisa scolastica sgargiante, torna da scuola scherzando con gli amici e non presta molta attenzione alla strada. Lì, gli uomini che trascinano pesantissimi carretti pieni di tutto e le donne che trasportano sulla testa chissà quali carichi si alternano a qualche macchinone di grossa cilindrata, il tutto porta come sfondo prima una fitta vegetazione di un verde a noi sconosciuto, poi innumerevoli negozietti coloratissimi e bancarelle fatte di sterpi che vendono ogni sorta di merce. A un certo punto, quando ormai manca poco all’arrivo alla scuola, smetto di tentare di capire, ed inizio ad accettare. Devo accettare. Perché capire come, e perché, quel mondo sia così diverso dal mondo a cui siamo abituati sembra impossibile. La mia immersione è completa e totale quando arriviamo alla scuola: i bambini non mi hanno mai vista prima, ma mi corrono incontro, mi abbracciano, mi chiedono come mi chiamo in quel loro linguaggio mezzo inglese, italiano e swahili, mi toccano i capelli, gli orecchini, vogliono che giochi con loro. I miei primi cinque minuti con quei bambini hanno segnato tutta la mia esperienza, e non se ne andranno mai dalla mia testa. Hanno un paio di vestiti ciascuno, ed i primi giorni sono l’unico metodo che mi permette di distinguerli. Poi, invece, imparo a riconoscerli da quel meraviglioso sorriso: c’è chi ce l’ha aperto e completo, chi riesce a sorridere solo dopo qualche ora che ti ha vicino, chi sorride senza mostrare i denti, chi sorride ogni minuto con gli occhi. Quando arriviamo alla scuola, al mattino e dopo pranzo, non si stancano mai di correrci incontro, di farci sentire a casa. Li accompagniamo in chiesa, che è anche la scuola di alcuni di loro, e la strada è un sentiero nella foresta, creato dagli abitanti del villaggio coi loro stessi piedi. Attorno a noi qualche casetta di fango, galline, capre, tutto il resto è vegetazione all’apparenza sempre uguale. I bambini dicono che la chiesa è vicino, ma in Kenya s’impara subito che il concetto di vicinanza italiano è molto lontano da quello keniota: i bambini infatti non hanno difficoltà a ricordare e riconoscere la strada, nonostante non ci siano apparenti punti di riferimento, ma avverto che i nostri occhi non vedono ciò che vedono i loro. Arrivati alla chiesa, la signora che dice messa è entusiasta di avere dei muzunghi che l’ascoltano, e parla durante tutta la messa in inglese, proprio per farci capire. È una funzione cantata, ballata, così bella che mi viene da pensare che se anche le nostre fossero così, forse andrei a messa più di una volta l’anno. Ci capita anche di portare dei vestiti alle famiglie dei villaggi nei pressi dell’orfanatrofio: una delle esperienze che maggiormente sono impresse nella mia mente. Ci facciamo accompagnare dalla ragazza più grande che vive in orfanatrofio perché conosce i sentieri, le distanze e alcune famiglie. Non dobbiamo muoverci molto: appena raggiunta la prima famiglia, infatti, i più giovani corrono a chiamare tutto il vicinato, e in pochi minuti ci ritroviamo decine e decine di persone di tutte le età attorno. Sono lì per noi, e noi siamo lì per loro. Il loro atteggiamento nei nostri confronti può sembrare scontroso, strafottente, assolutamente non grato, in quanto non ringraziano dei vestiti che gli regaliamo, si spingono l’un l’altro per raggiungerci, tanto che nella foga urtano persino noi, che ci sentiamo ballonzolare corpi, cervelli e cuori, cercano di prendere più di un vestito ciascuno, cercano di fregarci. Ma poi capiamo, capiamo che non dev’essere facile essere quelli che ricevono, capiamo che noi abbiamo il nostro mondo da poter confrontare a quello, loro hanno solo il loro. Una notte decidiamo di dormire in orfanatrofio con i bambini: vediamo le mama offrirci il cibo che loro consumano quasi ad ogni pasto: riso e fagioli, con un po’ di pane e della loro polenta bianca. Si mangia con le mani. Da bere c’è the bollente. Capiamo che in Italia si dice “l’ospitalità è sacra” ma è qui in Kenya che questo principio viene effettivamente applicato: ci guardano in un modo che ci sentiamo in colpa se non finiamo tutto ciò che abbiamo nel piatto. “We we lala apa?”, ci gridano ogni cinque minuti. – “Si”, bambini, dormiamo qui con voi stanotte. Nei weekend cerchiamo di vedere altri luoghi che quella terra ci offre, tentiamo di fare i turisti: vediamo la magnifica e brillante spiaggia dorata, ricca di fossili di stelle marine, andiamo al mare di Watamu, uno dei più famosi per la villeggiatura. La realtà è che sebbene anche questo sia Kenya, nelle ore da turista mi sento strana, quasi colpevole, perché so com’è mondo là fuori, a pochi metri dalle lussuose ville sulla spiaggia. I viaggi giornalieri in tuk-tuk non mi stancano mai, pur percorrendo sempre le stesse strade. Ogni volta vedo cose diverse, volti diversi, ogni volta provo emozioni contrastanti l’una con l’altra, ogni giorno sento quel mondo che come un chiodo si pianta dentro di me, sempre più a fondo. Mentre sono là penso poco a casa, forse perché quelle visioni, i pensieri che il Kenya mi crea, mi riempiono quasi fino in fondo, e una delle cose che vorrei sarebbe poter portare tutti i miei parenti e amici con me, in quel viaggio dell’anima, vorrei che le foto rendessero un po’ di più, appena un po’ di più. Vorrei portarmi a casa più emozioni possibile, più Kenya possibile. Quando sono tornata ho provato a raccontare a tutti della mia esperienza: qualcuno si commuove, qualcuno mi guarda con occhi ammirati, altri hanno sguardi smarriti, ma ad ogni parola mi rendo tuttora conto che non sto dicendo niente. Che il Kenya bisogna provarlo, vederlo, portarsene un po’ a casa. Che quei sorrisi bisogna sentirseli nell’anima. Mi basta chiudere gli occhi e concentrarmi per riuscire a rivederli e a sentire di nuovo quei gridolini misti d’italiano, inglese e swahili. In effetti, la cosa più bella che il Kenya mi ha insegnato è che la lingua non c’entra, perché sono gli occhi che parlano. E poi, tutti sorridiamo nella stessa lingua. - Fughe di Annalisa Dolzan Ha la testa ovale e la tiene sempre un po' inclinata, come certi animaletti sciancati. Ti guarda da sotto in su e ride. Ride, sogghigna, sorride; tutto insieme. Anche con gli occhi. E sembra tutto lì, fra gli occhi caldi e birichini e le parole a mezza voce - dette per esserci senza troppo rumore, smorzate per sparire senza perdersi niente. Ma oggi. Oggi, quella luce è più fioca, negli occhi. La faccia è gonfia e nella tuta blu c'è un corpo grosso e dilatato; quasi ingombrante. Forse sono l'unica a farci caso. O a non riuscire a fare finta di niente. Ma lui è contento di essere qui. Di esserci tutto. Di esserci perfino di più. Io lo guardo. Io lo osservo. Io lo fisso. Col fastidio che provo io, ogni volta che ingrasso, non mi capacito che se ne freghi di quella pancia così gonfia da spingere in fuori la maglietta. Ma non è grasso quel gonfiore, e in aula lo sappiamo - «Sono stato male, ma ho visto che ero ancora iscritto al corso, allora oggi sono venuto». Siamo nella nuova aula computer, ognuno ha già il suo posto e lavora a ciò che vuole. Lui il computer non lo sa usare, però ha voglia di imparare, ci scegliamo un tavolo e mentre lo schermo si accende mi parla. Parla. Mi parla. Con me parla sempre tanto. Con me parla sempre piano. Come fosse il mio fidanzato, stiamo seduti lì vicini. Come se fosse tutto per me, per lui, per noi, questo tempo che abbiamo nell'aula e gli altri non fossero che un disturbo o una distrazione a cui ogni tanto devo rispondere. Lo guardo tutto mentre schiaccia un tasto alla volta con un dito solo. È un dito grosso, un dito lento, ma voglio che scriva. Che aggiunga ancora una parola, quando esco voglio quando esco voglio andare Voglio che scriva, così lo guardo. La cicatrice che ha in testa non l'avevo mai notata, e sì che oggi ha i capelli più lunghi. Vorrei sapere che cosa è successo: chi ti ha spaccato la faccia e perché? andare in vacanza quando esco voglio andare in vacanza in «come si fa la virgola?» Una traccia pesante che la pelle ha ricucito e provato a confondere fra resti di acne e un inizio di rughe, rimane una faccia fatta a pezzi. «come si fa a andare a capo?» Mentre spiego come andare a capo, sposta un accento e dietro una virgola tramonta il sole. C'è un'acqua limpida, un mare bello, dentro quel file - con un sacco di pesci, di musica e relax. Sorride – sorrido – Sarà che anch'io soffoco, nel mio paesello sotto ai monti, ma il suo sogno è uguale al mio. A fine lezione siamo già in Africa; o forse in Tailandia? Comunque fa caldo, si sta bene, la notte non si dorme e di giorno ci si diverte A fine lezione, gli insegno a salvare il file. Poi, io esco dal carcere. - Se il viaggio è… rivelazione! di Antonella Priori Un percorso assolutamente ordinario, come il tragitto quotidiano casalavoro-lavoro-casa, se per alcuni non contiene in sé che l’ovvietà e la noia, e dunque nulla con cui allietare chicchessia, per molti rappresenta un buon momento di riflessione, di sana solitudine, di bilancio, di fantasie… Io sono tra questi ultimi. All’andata, guidare mi carica e mi prepara per la giornata che verrà: formulo proposte, elaboro idee che poi – nel corso delle ore – verificherò, analizzerò, studierò. Al ritorno, riordino e impacchetto tutto, pensieri, dati, impressioni e metto al sicuro in un angolo di memoria che m’impongo di non riaprire fino all’indomani. Il viaggio dell’andata ha il sapore del caffè: è quello che mi porto in bocca fin da casa e mi accompagna nel passaggio – non sempre senza traumi – dalla morbidezza del letto, dal calore familiare, dalle coccole del cane al primo respiro fuori dal portone – freddo, tagliente in inverno; fresco, frizzante con l’arrivo della primavera. A volte è dura, a volte è piacere puro. Ed è con quel sapore di caffè che affronto il viaggio, da sola. Adatto le membra – che conservano la memoria delle soffici ore notturne – a nuove forme: quelle del sedile, essenzialmente, assai più impegnative. Man mano che il corpo – dapprima rigido, composto, concentrato – si accomoda, recupero la confidenza tattile di sempre: le mani sul volante (le dita scorrono veloci, morbide, sicure); i piedi sui pedali (sempre più rilassati, le gambe molli, ben riposate); infine la nuca adagiata contro il poggiatesta, con il collo morbido a mano a mano che macino chilometri. La mente è così avanti, i concetti così veloci che l’auto sembra camminare con le idee più che con la benzina. La sento, la spinta, la forza: i pensieri (positivi) sono carburante, energia pura! Il viaggio di ritorno, non posso negarlo, è spesso una fuga: una liberazione dalle carte, dallo schermo, dalle mille voci, dal trillo continuo del telefono. E ho la viva impressione che, esaurita la spinta delle idee, ciò che fa andare l’auto, stavolta, sia la voglia di casa, di famiglia, di parole care, di confidenze: insomma, viaggia con il cuore la mia auto, con il mio cuore che pompa amore per tutti coloro che ho una voglia matta di rivedere e le cui sembianze, intanto, vedo stagliarsi lungo i paesaggi fuori dal finestrino. E il bello è che tutto questo – sembra incredibile – lo provano migliaia di persone simultaneamente ogni giorno. L’ho imparato per caso, cominciando a condividere i miei viaggi solitari con altre persone, scoprendo storie, situazioni, episodi e momenti così diversi tra loro eppure così simili, con in comune la scoperta di una nuova voglia di partecipare, di conoscersi, di fidarsi, di essere solidali. Va bene, dirà qualcuno, il viaggio come scoperta non è una mia idea, e questo è vero: è così da secoli, forse da sempre. Ma la rivelazione, in questi anni difficili, è che ci si può ancora fidare, si può credere, si può sperare, si può perfino essere ottimisti. - Gli occhi di Agata di Antony Grinaus E’ una sera d’estate normalmente calda, qui al sud. Per descriverla un po’… la luna piena illumina le increspature delle onde, le stelle sono occhi, tutti rivolti verso questa spiaggia in cui mi ritrovo a camminare dopo oltre trent’anni dall’ultima volta che gli ho lasciato le impronte dei miei piedi. Era una sera d’estate calda quando poco più che adolescente, mi sono ritrovato con te, Agata. Quella sera, in quella spiaggia c’erano tutti gli ingredienti… noi seduti sulla chiglia di una barca rovesciata, lontano una canzone che arrivava per riempire in nostri brevi silenzi assordanti, la luna, le stelle, la tua pelle profumata e che sapeva un po’ di sale, il tuo vestito a fiori leggero che si muoveva al più piccolo alito di vento, la tua mano nella mia... mi dici: Ora ti racconto di un viaggio speciale… Quando le persone entrano in te passando dagli occhi il rischio è evidente. Perché subito dietro gli occhi, appena svoltato l’angolo ci sono i pensieri e lì si installano. Poi, pochi passi ancora si scende, si arriva subito al cuore. Cosi, non te le togli più di torno le persone che entrano dagli occhi. Si crede che le cose emozionanti siano legate alla pelle, invece no, la pelle è in superficie, chi passa per la pelle è come il vento, sono brividi che durano poco. Ma gli occhi, gli occhi sono strade, gallerie, ponti, sottopassi, cavalcavia, ponti tibetani e altre vie. Bisogna percorrerli, non ci si deve smarrire, è importante guardarsi bene attorno, capire dove si sta andando. Gli occhi spaventano, la strada spesso è buia, non sai dove ti porterà e non sai quando arriverai. Ma, appena hai oltrepassato il buio vedi benissimo. Non ci sono più sensazioni ma soltanto consapevolezze. Superati gli occhi scivoli verso la mente e come per incanto riesci a leggere. Quando arrivi al cuore capisci che il viaggio meritava di essere vissuto per intero, con le paure, le ansie, con l’ incertezza di ciò che avresti potuto trovare. Ma, attenzione, se hai fatto questo viaggio e sei riuscito ad arrivare non hai vinto, sei solo all’inizio. Per vincere dovrai convincere l’altro che stavi cercando di arrivare proprio lì e che non vuoi più andartene per niente al mondo. L’altro ti lascerà fare, perché aveva gli occhi ben aperti quando sei arrivato... ti stava aspettando. Mi guardò negli occhi mi strinse le mani e mi baciò. Del bacio di Agata conservo ancora il suo sapore. - Live in Nabire di Antony Grinaus Dopo quattro scali internazionali, tre fusi orari e oltre 24 ore di volo filate, arrivo in questo posto giusto in tempo per beccarmi secchiate d’acqua. Sono le due del pomeriggio. A queste latitudini piove sempre per trenta minuti giusti nelle ore pomeridiane, ne mancano dieci minuti prima che smetta. In attesa sbrigo le pratiche doganali in questa piccolo “terminal” che è grande quanto il soggiorno della mia casa in Europa. Il poliziotto mi chiede cosa ho da dichiarare… nothing, I have only a few dollars… apro la borsa della mia macchina fotografica… and my camera equipment! Mi chiede il motivo del mio arrivo in Papua: I came here to photograph Mr. Mutin your political. Con un cenno mi fa passare.. okay! Mentre vado oltre, noto che in fondo alla sua perfetta divisa, cioè ai suoi piedi porta le ciabatte infradito. Accenno un sorriso. Esco dall’aeroporto, ho la borsa della macchina su una spalla e il mio fedele zaino sull’altra. Vengo assalito dai tassisti, salgo sul primo e gli do un biglietto con su scritto l’indirizzo dell’albergo. La cittadina piccola e graziosa, è circondata da una mini foresta pluviale, nel suo porticciolo sono ammassate barche multicolore coi bilancieri ai lati. Il mio albergo, l’hotel Anggek si trova proprio fronte mare, su una spiaggia di sabbia corallina finissima. La sistemazione è decorosa, un bel letto matrimoniale king size, un frigo bar ben rifornito, l’aria condizionata, c’è persino una bottiglia di brut australiano, chissà com’è. C’è tutto quello che serve per passare una notte qui. Mi spoglio e m’ infilo sotto il getto d’acqua calda, ne ho proprio bisogno. Sto li sotto senza muovermi, poi mi siedo a terra e mi lascio massaggiare dalle gocce d’acqua che cadono instancabili… Ok! Vado a fare un giro per il mercato che ho visto arrivando, com'è la gente del posto lo si vede nei mercati. Poi, magari vado direttamente a cena. M’asciugo e mi metto un paio di pantaloni in tessuto leggero e una camicia di lino grigio scuro. Qui l'umidità è alta. Esco, nel taschino una piccola macchina fotografica. Se ti trovi tra i meridiani vicini all’equatore, hai giusto dodici ore di luce e dodici di buio. I venditori delle bancarelle hanno acceso delle piccole fiaccole per illuminare la mercanzia. C’è di tutto, pesci freschi o secchi, grandi, e piccoli, radici, spezie, frutta, verdura, ventilatori, collanine, attrezzi per la casa e tante altre cose utili e meno utili.. Mentre guardo attraverso l’obbiettivo, la vedo. In tutto il mercato siamo gli unici occidentali. Mi avvicino -mi aveva già visto- le sorrido e con un guizzo di sfacciataggine le dico: it's just you and me... Lei mi risponde: Si! Ci siamo solo noi. Per un momento sono stato colto di sorpresa della sua risposta, ma ho rimediato con: poco male troveremmo sicuramente un tavolo libero per cena. Il sorriso di lei è complice…È giorno, il piccolo aereo si stacca dalla pista, un bellissimo panorama è sotto i miei occhi… A queste latitudini è più facile intercettare i sogni. - Viaggio nella memoria di Antony Grinaus Il rumore ovattato del rotolamento dei pneumatici mi accompagna in questo viaggio di ritorno verso Milano. L’asfalto asciutto scivola veloce sotto la sagoma della mia auto, la radio ha completato la play list di notizie e piano piano una canzone prende spazio nell’abitacolo della mia auto. Donatello canta: Io Mi Fermo Qui. Era l’estate 1972. In Sardegna si sa che quando il sole picchia scalda davvero, il caldo aiuta la miscelazione dei profumi dell’aria - mi piace pensarlo -. Vivevo in un piccolo paese vicino al mare, potevo andarci a piedi, in bici oppure col mio CIAO color senape. La mia famiglia numerosa faceva parte delle normalità di quei tempi. Avevamo una casa grande, un cortile e un grande orto. Dalla mia stanza si vedeva il mare, ma anche il grande impianto di raffinazione del petrolio con le sue ciminiere che vomitavano fumo nero e le fiaccole sempre accese. Gran parte della popolazione era composta dai “continentali” così venivano chiamati quelli che arrivavano dalla penisola, appunto dal continente. Venivano nel nostro paese per lavorare nell’impianto di raffinazione perché erano operai specializzati; tubisti, saldatori, montatori. I ragazzi del mio paese, non avevano nessuna qualifica perciò facevano i manovali. Finito il corso di specializzazione, questi operai venivano scaraventati in questa terra con moglie e figli. Le loro auto si vedevano da lontano arrancare sulla salitella del paese. FIAT 1100, FIAT 500, SIMCA1000, tutte con l’imperiale zeppo di mercanzie. Valige, borsoni, scatole di cartone, e un telo che cercava di coprire il tutto. Le ruote posteriori abbozzavano un divaricamento, tant’era il carico che dovevano sopportare. Queste piccole famiglie, avevano la faccia stravolta dal viaggio, la maggior parte venivano dal Veneto, dall’Emilia e dalle Marche. Auto, nave, auto. I loro figli sarebbero diventati compagni di scuola e di giochi di molti bambini del paese (me compreso). Oppure erano coppie appena sposati, la loro fede nunziale brillava sotto i raggi del sole della Sardegna. Spesso capitava che mi fermassero per chiedermi informazioni su qualche affitta case. Mi tornano alla mente le loro facce, si leggeva chiaramente la paura di trovarsi in un posto nuovo, senza punti di riferimento, un posto che non era il loro. Chissà di cosa temevano. Tra i ragazzini che arrivarono ricordo bene Giampaolo. Nella mia auto il tempo si è frizzato a quegli anni, la radio suona una canzone dei Nomadi: Io Vagabondo, estate 1972. La E35 lambisce Arezzo. Giampaolo era un ragazzino toscano, molto più alto di me e con le orecchie molto più visibili delle mie. Fu subito amicizia, anche perché aveva una sorellina che a me piaceva perché aveva il “fascino” della continentale. Però, non è che ci pensavo molto a sua sorella. Sto passando ora da San Giovanni Valdarno, il paese d’origine di Giampaolo. Solo ora realizzo che la radio è spenta, forse ho solo creduto di aver ascoltato quelle musiche. Ma il viaggio nella memoria è stato reale. - Samarcanda: le Zighuli e i sogni chiusi nel bagagliaio di Antonio Vetrò La sveglia alle 5 a Tashkent non è traumatica: a quell'ora il sole è già alto, ci sono parecchie auto per strada e non è stato difficile fermarne una per farmi portare in stazione. Qui in Uzbekistan le auto si fermano puntando l'indice verso il basso, quasi tutti si fermano, si contratta il prezzo e se si giunge ad un accordo con poche migliaia di Sum (2-3 €) si arriva ovunque. Ma attenzione qui nessuno conosce gli indirizzi, bisogna dei punti di riferimento come palazzi, stadi, teatri, ospedali. Ciononostante è un modo comodissimo per spostarsi in città, una sorta di car pooling sociale. L'uomo che mi porta in stazione ha una bellissima Zighuli bianca: si tratta in tutto e per tutto di una Fiat 124, e la guida pazza dell'autista mi catapulta in uno di quei film italiani degli anni '70 dove la 124 era protagonista di spettacolari inseguimenti. A conferma del mio viaggio nel passato, non appena l'autista capisce che sono italiano inizia a cantare Cotugno e Celentano. Salgo sul treno per Samarcanda e la scenografia non cambia: nonostante mi sia concesso il lusso della prima classe per l'esiguo prezzo, rimango negli anni '70. Di fronte a me siedono una giovane donna in vestito rosa e fiocco ocra con accanto il probabile padre: brizzolato, denti dorati (altra particolarità uzbeka) e occhiali da sole veramente kitch. Non fa di meglio la coppia seduta accanto a me: lui elegante con pantaloni grigi, camicia bianca e scarpe nere lucidissimi, chissà perché quando è entrato aveva sulle spalle uno zaino da militare. Lei, occhi orientali, è vestita da bambola come la figlioletta di un anno o poco più. Le tendine bianche col pizzo sui finestrini sono il tocco di classe finale. Dopo poco più di tre ore di viaggio un'enorme scritta su una collinetta preannuncia Samarcanda, la perla dell'Asia Centrale. Ho appuntamento con Bobur davanti alla statua di Tamerlano, che qui chiamano Amir Temur e che è stato alla guida di un vasto impero sul finire del XIV° secolo: dal Caucaso all'India e ovviamente nelle nostre scuole non se ne parla. Mentre lo aspetto noto con piacere che anche Samarcanda è piena di Zighuli che corrono pazze tra i minareti e le madrase. Bobur è molto più giovane di me, ha solo 23 anni. Sono entrato in contatto con lui postando il mio itinerario di viaggio su Couchsurfing, con la speranza di incontrare i locali e approfondire la conoscenza di questo Paese dalla storia così convulsa. Ci sediamo su una panchina in un parco non lontano dallo stupendo mausoleo di Gur-e- Amir (dove è sepolto Amir Temur) attendendo Nadira, una studentessa di vent'anni che si è proposta di farci da guida in questi due giorni. Bobur e Nadira non hanno vissuto il socialismo e probabilmente non sanno nemmeno che il loro attuale presidente Islam Karimov c'era già prima del crollo dell'URSS, detenendo il potere con spietate pratiche dittatoriali. Ma sono convinto che proprio questi giovani, con l'accesso alle lingue straniere, a Internet e alla cultura, possano in un vicino futuro provocare gli stessi scossoni che la Primavera Araba ha dato ai palazzi dei dittatori del Nord Africa. Approfitto così di ogni possibile pausa tra le visite delle perle di Samarcanda per fare loro domande, cercare di capire cosa pensano, e soprattutto intercettare i loro sogni. Con mio grande dispiacere, però, mi accorgo dell'assenza di spirito combattivo e della frivolezza dei loro desideri. Bobur è un ragazzo in gamba, fa il tester free lance per le aziende che fanno softwar. E' già stato all’estero ( in Russia) e pare che si informi attraverso internet: stranamente non c'è ancora la censura qui, ma pare che non ce ne sia troppo bisogno dato che nessuno ha voglia di leggere. Ho l'impressione che Bobur sappia o almeno intuisca com'è il mondo al di fuori dell'Uzbekistan. Lo noto dall'umorismo amaro con cui ammette e commenta alcune singolarità del suo Paese: ad esempio l'assenza di ATM per prelevare (ve n'è un paio solo nella capitale, funzionano a singhiozzo), oppure la necessità di registrarsi od avere il permesso per spostarsi da una città all'altra. Eppure dietro agli occhi intelligenti di Bobur c'è una piatta rassegnazione: la sua aspirazione più grande è diventare ricco e body builder. C'è una stonatura insopportabile tra questo suo desiderio e l'intelligenza di cui è dotato. Una distorsione che mi irrita e che, forse superficialmente, addito ad una società che ha vissuto il più spersonificante dei regimi e che quando se ne è liberata ha preferito la soluzione facile della guida forte che offre sicurezza in cambio della libertà. Non trovo le ali nemmeno nei sogni di Nadira, forse ancora troppo giovane, e nemmeno in quelli di Elior, studente in Medicina anche lui di 23 anni, che mi ospita insieme ad Obur nelle due sere che spendo a Samarcanda. Elior vive assieme ad altri quattro studenti in un palazzone in stile sovietico di un quartiere decentrato. Nel quartiere non ci sono molte luci la sera, le strade non sono asfaltate e sono piene di enormi buche che gli autisti cercano di evitare con improvvise sterzate. Le Zighuli sono le più agili in questo slalom gigante. L'interno del palazzo in cui Elior vive è sconfortante per bruttezza e mal curanza, la casa ancora peggio. Non riuscirò né ad usare il gabinetto né a mangiar un pasto cucinato nelle loro luridissime pentole. Gli studenti sono però davvero gentili e lasciano una camera tutta per me e Bobur, mentre loro dormono stretti sui tappeti dell'altra camera. Nelle case qui in Uzbekistan si dorme per terra, ma abituarmi non è stato un problema data la stanchezza che accumulo viaggiando con lo zaino in spalle. Il mio incontro con i sogni di Elior avviene nel parchetto vicino casa sua. Anche il parco ha quel misto di noncuranza e kitch che rendono questi posti così brutti ma anche così irresistibilmente affascinanti. Sulla riva di uno dei tanti laghetti nel cemento che qui tanto piacciono, Elior mi racconta di voler andare all'estero a fare un PhD dopo la laurea in medicina per poter guadagnare più soldi (lo stipendio medio in Uzbekistan è l'equivalente di circa 250-350 dollari). Ma me lo dice parlandomi in uzbeko, c'è bisogno della traduzione di Bobur e quando gli faccio notare che il primo passo è studiare l'inglese protesta dicendo che il libro è troppo spesso. Non sopporto questa totale mancanza di dedizione e spirito di sacrificio, e per fortuna presto la conversazione finisce e ci prepariamo per la serata. Alle dieci qui tutti i locali devono chiudere, ordine del Presidente, allora i disco pub spengono tutte le luci e aprono il retro: è ridicolo ma per cercare l'entrata nel retro di un locale Bobur ed Elior chiedono ad un poliziotto! Passiamo il resto della notte a bere birra, fumare narghilè e danzare al ritmo di una strano musica disco con ritmi arabeggianti. Sono contento di aver conosciuto questi ragazzi così ospitali e generosi, ma sono molto deluso dalla mancanza di sogni e voglia di raggiungerli. Sarà stato un caso? Oppure è colpa di più di un secolo passato tra comunismo, socialismo e ora questa finta socialdemocrazia che hanno appiattito l'animo di questo popolo ? E se fosse invece nell'indole di queste genti che storicamente sono contadini e commercianti, e pertanto l'unico loro interesse potrebbe essere quello di coltivare il loro piccolo giardino per sé? Queste domande mi rimbalzano in testa mentre cerco di far fare le capriole di fumo dopo la boccata di narghilè. Alle due abbandoniamo il locale e fermiamo un'auto che ci lascia a poche centinaia di metri dal palazzone. Nel buio inciampo più volte nelle buche. Penso alle agili Zighuli che evitano le buche, e ripongo in loro la mia ultima speranza: che i loro bagagliai siano colmi dei sogni dei giovani Uzbechi, e che questi siano più splendenti delle tessere del Registan al tramonto. - Da New York alla Nova Scotia on the road di Arianna Serra Ancora oggi, a quasi un anno di distanza, a volte mi ritrovo a guardare incantata il vuoto mentre nella mia mente ripercorro i 3.200 km di viaggio in auto, rivedo le scogliere a strapiombo sull’oceano, i cartelli di avviso di attraversamento orsi (!) e alci e risento le urla dei gabbiani che hanno accompagnato me e mio marito Cristian la scorsa estate nel nostro road trip da New York alla Nova Scotia, l’ultimo lembo di terra con clima mite prima della ben meno ospitale Terranova e del circolo polare artico. L’avventura inizia il 2 agosto 2012 con l’attraversamento della parte nord dell’isola di Manhattan in direzione Newport, Rhode Island, a bordo di una quantomeno ingombrante Lincoln, soprannominata quasi subito Freccia nera: un crocevia di sopraelevate, ponti, rotonde, gremito di macchine strombazzanti, insomma, quanto di meglio Cristian potesse sperare dopo un volo intercontinentale. Raggiungiamo Newport dopo “solo” 4 ore di macchina (in condizioni di traffico “normale” sarebbero state sufficienti solo un paio di ore) e ce ne innamoriamo subito. Siamo ospiti della Marshall Slocum Inn, deliziosa sistemazione ricavata in una delle tipiche abitazioni in legno colorato, che ci fa sembrare di essere tornati ai tempi di Jane Austen. Newport è famosa per le splendide “mansion”, le dimore estive dei miliardari di fine ‘800 e inizio ‘900. Ne ammiriamo la bellezza percorrendo una parte del Cliff Walk, la camminata che costeggia le ville da una parte e l’oceano dall’altra, luogo ideale per scattare foto uniche. Dopo pranzo ripartiamo per il Massachusetts, alla volta di Boston, a circa 120 km di distanza. La quinta area metropolitana americana per estensione ha occupato e tutt’oggi occupa un ruolo di primo piano nel panorama intellettuale, culturale e scientifico del paese. Ne apprezziamo progressivamente lo stile europeo percorrendo il Freedom Trail, percorso di 2 miglia e mezzo che consente di ammirare i principali siti storici della città. Il giorno dopo, partiamo alla volta di Salem, ancora inconsapevoli del fatto che per tutta la giornata saremmo stati accompagnati dallo “spirito” di Stephen King. Nota anche come “la città delle streghe”, dall’infausta caccia alle streghe che risale al lontano 1692, di Salem abbiamo visitato il Maritim National Historic site, che comprende il molo e una decina di luoghi storici (la dogana ed altri edifici), memoria dei tempi in cui la città era famosa per l’industria navale e la più antica azienda dolciaria degli USA: la Ye Olde Pepper Companie, fondata nel 1806 da una signora inglese, Mrs Spencer, sopravvissuta ad un naufragio e costretta ad inventarsi un modo per sbarcare il lunario avendo a disposizione solo un sacco di zucchero. Certi che nonostante un piccolo inconveniente tecnico nelle prenotazioni avremmo in ogni caso trovato una sistemazione in quel di Portland, nel Maine, là ci dirigiamo, scoprendo ben presto, però, che un’orda di americani, attratti dai suoi bellissimi boschi, l’aveva invasa occupando qualsivoglia tipo di struttura ricettiva disponibile. Così, dopo una breve sosta a Freeport, cittadina consacrata interamente allo shopping, divenuta famosa perché sede di L.L. Bean, mega negozio di articoli sportivi, aperto 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno e frequentato abitualmente dai numerosi vip come John Travolta, risaliamo su Freccia Nera che ci conduce sino a Bangor, un tempo capitale del legname (di nerboruti boscaioli in effetti era pieno il locale dove abbiamo cenato!), oggi il più grande centro commerciale e culturale dell’entroterra del Maine, forse anche perché qui ci vive il famoso scrittore Stephen King. Memorabile il commento di Cristian quando percorriamo la Main Street: stasera sono davanti a casa di Bill Tartaglia e temo di vedere spuntare da un momento all’altro un pagliaccio dai Barren! Mi presto malvolentieri ai desideri ai limiti dello stalker di Cristian, che non vuole rinunciare a fare 2 foto all’abitazione noir dell’amato romanziere, e poi di nuovo in macchina alla volta di Bar Harbour, punto di partenza per l’esplorazione del Mt. Desert e Acadia National Park, un vero paradiso per gli amanti del trekking. Per quanto consci di deludere un po’ i miei genitori, che di certo, viste le spettacolari vedute costiere, si sarebbero tramutati in camosci sparendo per almeno una settimana nella fitte foreste di abeti rossi, ci limitiamo ad una passeggiata di mezza giornata tra Sand Beach e Otter Cliffs, che ci fa pregustare in ogni caso quanto ci aspetterà, in termini di vita all’aria aperta e a contatto con la natura, al nostro arrivo in Nova Scotia. Rientrati, visitiamo l’animato centro cittadino di Bar Horbour, un susseguirsi di bellissimi negozi di souvenir, gelaterie e ristorantini, e ammiriamo la baia al tramonto, percorrendo lo Shore Path, un sentiero che offre incantevoli vedute sulle dimore storiche che sorgono in riva all’oceano e sulle vicine Porcupine Islands. L’indomani all’alba Freccia nera percorre veloce i 400 km che ci separano dal traghetto per la Nova Scotia, contorniati da foreste di conifere sempre più fitte, inquietanti cartelli di segnalazione attraversamento orsi e dall’urlo “Icebeerggg” che a turno Cristian ed io emettiamo per tenerci svegli e per sdrammatizzare un po’ l’ansia che ci attanaglia all’idea di non arrivare in tempo al porto di Saint John. Non appena preso il largo, le preoccupazioni lasciano spazio alla prima ricerca delle balene, purtroppo infruttuosa, tanto che in breve tempo preferiamo ritirarci al coperto e chiacchierare con 2 coppie di italocanadesi che intendono visitare il Pier 21, porta dell’immigrazione in Canada sul molo di Halifax, oggi toccante museo, ad oltre 50 anni dal loro arrivo in quelle acque da emigranti. Pare infatti che la principale, se non l’unica, motivazione che spinge le persone a visitare la Nova Scotia sia la ricerca sul proprio passato o su quello dei propri cari. Ne ho conferma non appena arriviamo a Yarmouth, la cittadina più grande della Nova Scotia meridionale, una volta attracco del traghetto che collegava la provincia a Bar Harbour. Un vecchietto, vedendomi intenta a leggere la storia del faro, unica attrattiva locale, mi si avvicina incuriosito e mi chiede alla ricerca delle tracce di quale parente fossimo. Dopo un rifocillante riposo ed una fantastica english breakfast nel delizioso Harbour’s Edge B& B, partiamo alla volta di Halifax, capoluogo della provincia, lungo la scenografica Lighthouse Route. Lungo il tragitto ci fermiamo per pranzo nella deliziosa Luneburg, uno degli insediamenti coloniali britannici meglio conservati nel Nord America, e poco prima di raggiungere la nostra meta ci fermiamo a Peggy’s Cove, piccolissimo villaggio di pescatori, il cui simbolo è un suggestivo faro sempre sferzato da impetuose onde dell’oceano. Ad Halifax, cittadina non certo da ricordare per le bellezze architettoniche, ma in cui è percepibile immediatamente la qualità della vita, visitiamo il museo marittimo, che contiene alcuni interessanti reperti del Titanic, affondato al largo delle sue coste, e poi ammiriamo la movida che ne anima il porto, dove è tutto un susseguirsi di spettacoli teatrali e musicisti di strada. Lasciata di buon mattino la Waverley Inn, dove soggiornò persino Oscar Wilde nel corso di una serie di conferenze in America, ci dirigiamo sempre più a Nord, sull’isola di Cape Breton, a Louisbourg, capitale della regione acadiana e famosa per l’immensa fortezza di metà ’700, fedelmente ricostruita e popolata di attori in costume. Di colpo è più facile sentire parlare francese che inglese e tutto ha una connotazione più europea. Il giorno dopo ci aspetta la Cabot trail, il scenografico percorso di oltre 300 km che corre lungo il Cape Breton Highlands National Park, risalendo versanti montuosi e valicando alture costiere. Entrambi abbiamo grandi aspettative: Cristian si immagina di fare la foto del secolo, sporgendosi lungo qualche dirupo, io mi immagino di incrociare alci a profusione e di avvistare una marea di balene. Sino a Meat Cove, estrema punta dell’isola, i paesaggi e la flora ci lasciano senza parole, ma non sono nulla in confronto a quanto ci attende una volta iniziata la discesa verso Chéticamp. A Pleasant Bay assistiamo infatti dall’imbarcazione di Captain Mark, lupo di mare profondo conoscitore della zona, al passaggio di un gruppo di balenottere e dei loro piccoli di un mese. Un’emozione fortissima che quasi non ci fa accorgere di quanto la barca sia in balia delle onde. Tornando verso la riva avvistiamo anche alcune foche, che ci guardano incuriosite, e persino un’imponente aquila reale. Deliziati da questi incredibili incontri, rientriamo a Louisbourg a notte fonda, rischiando di falciare un’intera famiglia di procioni, che schiviamo solo grazie alla prontezza di Cristian e agli ottimi freni di Freccia nera. L’indomani rientrando ad Halifax le meravigliose terre della Nova Scotia ci riservano l’ultima sorpresa: quasi per caso capitiamo a Sherbrook e veniamo catapultati nella vita di un villaggio di 125 anni fa, con tanto di dimostrazioni e figuranti in costume. Soddisfatto ampiamente il nostro desiderio di vita all’aria aperta e a contatto con la natura, siamo pronti ad immergerci nell’elettrizzante atmosfera metropolitana di New York. Ma questa è un’altra storia. - A volte non è necessario partire di Azzurra Saviano A volte non è necessario partire. Puoi restare qui, fotografare i paesaggi e i volti di tutti i giorni come fossero stranieri (che poi non è che in Grecia o in Giappone la gente e i palazzi siano più fotogenici!). Perché suvvia, diciamocelo, fotografiamo le città in cui ci dirigiamo a vacanzeggiare, centinaia di noi sorridenti con altrettante fontane, piazze, musei, tramonti, chiese, artisti di strada che altrove ci sembrano “fighi” e fanno tanto vacanza e qui ai nostri nemmeno uno spicciolo; e poi delle nostre fontane, piazze, musei, tramonti, chiese nemmeno uno scatto. Tanto li abbiamo a due passi, sotto il naso proprio... e ci riduciamo che forse ai Templi saremo andati una volta in gita scolastica. E ci riduciamo che muori e hai conosciuto migliaia di stranieri e poi non sai manco chi cazzo sei tu: l'unico straniero che valeva la pena di conoscere! E allora puoi restare qui e alla sera cenare in una di quelle trattorie che altrove ti sanno tanto di turista e qui ti sanno tanto di ordinario e chiedere solo piatti tipici, si, il piatto del giorno per favore, e farti servire la pasta alla norma che da tutta una vita ti hanno presentato per il pranzo della domenica ma che, siccome sei in viaggio, avrà un sapore diverso. Diverso dall'ordinario. Perché tutto al viaggiatore sembra più straordinario. E via così vortici di mozzarella si abbracciano e slacciano a tocchetti di melanzana bollente che galleggiano su un fiume rosso di salsa al pomodoro... e mandi giù un pezzo di terra sicula... Che esperienza mistica! Puoi fare amicizia con il proprietario, un settantenne panciuto in grembiule, e fermarvi a bere un bicchiere perché ne avrà anche lui di storie affascinanti da raccontare sai? Anche lui come il proprietario francese, spagnolo e americano ha fatto la guerra, sposato la ragazza che lo ha aspettato reduce dal fronte, adesso è bisnonno e può impartirti una lezione di vita su come conquistare una ragazza! Puoi viaggiare o non viaggiare affatto. Dipende dalle prospettive, dal modo in cui guardi. Dipende da te. - Torino 2007 Di Azzurra Saviano Non aveva cielo, la Città. Una trama fitta fitta Senza inizio né una fine Di fili grigi la copriva E (in)seguiva chiunque camminasse. Fumi si levavano alti Da fabbriche E camini tutti uguali E tazze d'una porcellana finissima: Di lavoro odoravano E di umido, di legno, di Nocciole. Al sicuro dei portici Ho percorso viali lunghissimi Leggendo parole appese a luminarie, Attraversando l'Egitto Per poi ritornare E incontrare il Signore Su di un lino funerario. L'ombra Monumentale Fu richiamo di una sosta: Sogno una vecchia pellicola Di una Marilyn prodigiosa. Tra i fumi (di) Torino si dissolve In un giro di tacco Su testicoli d'oro! Buona fortuna al poeta E a chiunque passi di lì. - Storie di viaggio di Brunella Paolillo Ero felice, quasi incredula: esisteva il car-sharing! Soli e sconsolati guidatori, traffico allucinante, aria irrespirabile, passeggini ad altezza gas di scarico, strombazzate a ogni ora del giorno, sarebbero rimasti solo un brutto ricordo. Una nuova allegria illuminava le strade grigie di sempre, e un arcobaleno fatto di consapevolezza sociale ed ecologica le colorava, finalmente. Viaggiare, su percorsi brevi o per lunghe distanze, ognuno chiuso nella sua scatola, mi sembrava assurdo da sempre. Così, avevo realizzato piccoli gesti di attenzione all’ambiente e a me stessa: macchina a metano, passeggiate a piedi, treno per andare a lavorare. Evitavo di inquinare, facevo nuove amicizie, leggevo molto di più, curiosavo nei comportamenti degli altri viaggiatori. Bastava organizzarsi, proprio come col car-sharing: collaborare è un gioco, utile a sopportare la fatica del vivere. Per esempio in un viaggio, la parte difficile dello stare fermi seduti, diventa leggera, fatta insieme. E niente malignità: condividere non equivale ad utilizzare gli altri, ma piuttosto pensare che “aver compagno al duol…scema la pena” Passo ai fatti, metto alla prova il nuovo sito di condivisione-auto: mi iscrivo, e organizzo una visita a mio figlio residente a Genova, partenza da Salerno. Trovo subito C, che offre un passaggio nel giorno giusto, ad un costo più conveniente di treno, pullman, aereo. Last but not least, C è un guidatore del tipo “bla”, perfetto per me che amo la condivisione, ma anche le pause di silenzio. Siamo al giorno del viaggio: appuntamento alla stazione di Napoli. Io arrivo in anticipo; C, con macchina rosso fiammante, in orario perfetto. Si parte. Accordi sul programma di viaggio: chiedo di fare un pisolino, C si mostra comprensivo. Dopo il relax, cominciamo a scambiare due parole, poi altre due, e fino alla prima sosta è tutto un parlare, soprattutto di musica. Abbiamo gusti simili. C, in verità, molto più raffinati dei miei: è musicista, anche di una certa importanza. In auto sembra di essere ad un concerto. Sono senza parole: si poteva chiedere di più? In autogrill, senza farmi notare, lo seguo con lo sguardo, temo quasi di vederlo scomparire e che l’incanto svanisca. Tutto fila liscio, invece, il viaggio dura un attimo, siamo quasi a Genova. La conversazione ha ora toni amichevoli, si parla della vita, dei desideri, perfino di vecchi e nuovi amori. Anche la differenza d’età si annulla, in viaggio è come muoversi dentro una bolla senza tempo, diventare amici è più facile. Ancora qualche chiacchiera, e sono addirittura sotto casa di mio figlio! Ci sentiamo, allora? – chiedo timida a C – diventiamo amici anche in rete? – sì, certo. Dopo qualche giorno lo risento, una piccola amicizia è nata, fatta di gentilezze e scambi musicali. - “Se vuoi andare veloce, parti da solo. Se vuoi andare lontano, parti in compagnia” Per me è stato così, come dice il proverbio africano: condividendo, sono arrivata ben oltre la meta che avevo, ho conquistato pure un nuovo amico! - L’arte dello stupore di Carlotta Boni Cinque passeggeri uniti verso una meta comune e immediatamente la condivisione di un mezzo di trasporto assume un rilievo poetico da non sottovalutare. La destinazione che unisce per i motivi più disparati: Monica sogna Lione da mesi per riabbracciare il fidanzato, Louis e Agatha sono ospiti di un amico incontrato in erasmus ed io Gabrielle ed Antoine siamo in quella macchina un po’ per caso e un po’ per esplorare, sognare e scoprire. Quella vecchia Citroën sporca diventa un microcosmo di condivisione, interessi e nuovi sguardi sull’altro. Mi sono affacciata al mondo del “trasporto condiviso” grazie ad amici spagnoli e francesi per i quali è ormai l’unico mezzo possibile per muoversi. Il concetto è talmente semplice da essere divenuto la moda della generazione low-cost: il proprietario della macchina mette un annuncio sul web per trovare passeggeri che condividano con lui il viaggio, il costo della benzina e dell’autostrada, la scoperta di inebrianti luoghi sconosciuti. Il finestrino aperto, le sigarette sempre fumanti, l’aria gelida che ci brucia gli occhi divengono improvvisamente casa, amici. La musica non è mai stata così varia e bella e ogni pausa tra un pezzo e l’altro lascia spazio a speranze e pensieri. Ci aspettano solo quattro ore di viaggio ma il viaggio che ci aspetta ci regalerà quasi una giornata intera di condivisione. Il traffico ci rallenta, Parigi è bloccata e ci trattiene all’interno delle sue mura per ore così Lione smette improvvisamente di essere meta comune, cominciando a rappresentare la fine di un viaggio, ricordandoci che ad ogni bella canzone segue un minaccioso silenzio di pausa. “Levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate, sognate, scoprite”. Quando l’idea di partire inizia a far paura, quando il viaggio fa rima con solitudine, con ignoto allora penso alle poche e preziose parole di Mark Twain. Mi piace pensare che aldilà del proprio porto sicuro ci si possa sentire sicuri senza un porto, che talvolta sia indispensabile perdersi per ritrovarsi. Per quanto il racconto del mio viaggio assuma spesso grottesche dimensioni, e per quanto mi sforzi di dipingerlo come un percorso di spiritualità, di inedite profondità; la Francia proprio non ce la fa ad essere una meta estrema o esotica. Ma cosa importa? Il viaggio estremo è quello interiore, il limite oltre il quale non mi autorizzavo ad esistere, il confine geografico, sociale e psicologico oltre il quale non ho mai pensato di poter essere. Il viaggio nella cultura di un paese che è una città e di una città che è un mondo. Perché Parigi è il mondo, ed è il mondo dal quale partiremo. Un casuale susseguirsi di inebrianti profumi, di un disordine che riposa la mente e di un caos talmente incomprensibile da non perdere mai il suo fascino. È il calore dell’Africa, il mistero dell’Oriente e la cultura dell’Europa. A Parigi l’anonimia della Cina prende forma, ha un viso, un’arte: tutto assume un’identità potente nell’oceano di masse indistinte che si sfiorano incuranti. Parigi è rumore, e rumore è vita quando impari ad apprezzare che la confusione non sempre è disturbante. Ma nessuno incontra nessuno a Parigi, le persone non si conoscono, o meglio non entrano in contatto, mai. Ed ecco che Parigi diventa incarnazione della tragedia metropolitana del post-moderno. Il dibattito filosofico è troppo complesso per me, ma mi offre la possibilità di parlare dell’uman ingegno. Einstein ha scritto una splendida apologia della crisi, a cui dovremmo pensare più spesso, soprattutto oggi. “La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.” Credo che il concetto di covoiturage risponda precisamente a questa esigenza di superare un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Ma la crisi non è solo quella economica, la crisi è fatta di pensieri piccoli, limitatissimi rispetto all’ampiezza globale, la crisi è resistenza alle esperienze che la vita ci offre, al contatto umano, è la crisi dell’invidualismo. Crisi di viaggio: l’istituzione stessa dell’agenzia di viaggio nasce per dare un ordine e una sicurezza all’esperienza più sacra che esista al mondo, rispondendo all’esigenza di addomesticare il vero vivere. Viaggiare per me è potere e dovere guardare altrove, prima di tutto al di là degli altri e poi, con un po’ di fortuna, oltre se stessi. Osservare senza pregiudizi non è possibile, ma è possibile stupirsi nello scoprire di averne una quantità che non ci permette di vedere altro che cliché. Il problema è che non ci sappiamo più stupire davanti a nulla, siamo circondati da troppe sicurezze, continuamente rassicurati dall’omologazione, da persone esattamente uguali a noi. E il vero paradosso del viaggio è che tornare da un susseguirsi di stupori ti fa realizzare che il vero timore è quello di essere esattamente come gli altri. Il punto è che se non ci si sposta la vera paura non la si prova mai. Se non si è mai provata la sensazione di sentirsi stranieri allora non si è mai avvertita la necessità di integrarsi davvero in una realtà diversa dalla nostra. Il desiderio di integrazione ci porta a spogliarci di tutti i preconcetti e i pregiudizi che talvolta non abbiamo consapevolezza di avere. Il desiderio ci avvicina all’altro, ci aiuta a rimetterci in discussione, ad ascoltare e ad ascoltarci. Decidiamo di prenderci qualche ora di riposo a Beaune, nel cuore della splendida Borgogna. Formaggio, pane e vino non sono mai stati così buoni. La Francia non è mai stata così ospitale. Ci siamo uniti per meri motivi economici e guardaci un po’? Sdraiati sull’erba, un po’ esausti e sporchi ma felici, inebriati da quella follia e da quella ricerca che ci ha fatto andare oltre. Lione è stato un viaggio nel viaggio, una gita fuori porta, la scoperta di una città diversa da Parigi durante la mia scoperta di Parigi e del mondo. Ma Lione non si racconta, Lione è un altro viaggio, un'altra storia. - Il viaggio che volevo. Riscoprire me stessa aiutando gli altri di Chiara Brandi Scendo dall'aereo ancora intontita per il viaggio che mi è parso durare un'eternità: 12 ore e mezza passate cercando di dormire, guardando film e osservando gli altri passeggeri sono una vera tortura per chi come me non è in grado di stare fermo nella stessa posizione per più di 5 minuti. Dal gelo dell'aria condizionata passo alla più piacevole temperatura interna all'aeroporto. In tutto sull'aereo saremo stati più o meno 5 occidentali il che fa intendere la lontananza della mia destinazione. Non che tutto sia filato liscio come l'olio... all'imbarco a Venezia l'hostess di terra mi guarda e con viso angelico mi dice che le dispiace, ma che il biglietto che mi è costato la bellezza di circa mille euro non me lo può stampare per intero, dato che il volo che dovrò prendere ad Amsterdam è in overbooking, e che quindi per il momento si tratta di arrivare la e poi vedere. Ecco, cercavo di stare calma e fare la “zen”. E invece vorrei tirarle una sberla su quel suo sorriso di circostanza, e vorrei scoppiare in lacrime. Perchè in realtà me la sto facendo sotto da un paio di giorni, ho il groppo in gola e il cuore che batte con una frequenza tale che se non fossi un atleta e non facessi ogni anno l'elettrocardiogramma sotto sforzo, penserei di avere un malore. Invece no è solo fifa. Pura e semplice. Ma sono una donna ormai, e, come si dice.. .big girls don't cry (che poi è proprio una cazzata). Ritornando a noi, il fatto che io ora mi trovi con i piedi a terra, e non ancora in volo in giro per il mondo sta a significare che il famoso aereo alla fine l'ho preso. Aspetto la ragazza che si occupa della mia accoglienza. È in ritardo. Beh nessun problema, a parte il fatto che non so neanche che faccia abbia. Ma lei di sicuro mi riconoscerà dato che sono l'unica occidentale nella sezione arrivi. Esco a fumare una sigaretta, sono più di 15 ore che non ne fumo una e ne ho proprio voglia. Vento caldo, afa che mi attacca all'istante i vestiti addosso, e cielo grigio. Mi manca l'aria. Rientro ed eccola la che corre verso di me con un sorriso enorme sul viso dai lineamenti asiatici, storpia il mio nome (ma anni di viaggi mi hanno insegnato a riderci sopra) e dopo un bell'abbraccio di quelli che ti fanno sentire a casa mi urla “Welcome to Taiwan”. Taiwan... . ho letto molto sull'isola prima di venirci per un viaggio all'insegna del volontariato internazionale. Soprattutto ho letto un sacco di cose positive riguardanti l'ospitalità della sua gente e devo dire che la realtà di primo impatto non tradisce l'immaginario comune. Donna, questo il suo nome inglese, mi fa accomodare sull'auto dello zio dove quattro ragazzini eccitati mi accolgono con risate, qualche parola in inglese e mille domande. Taiwan è così, come non te l'aspetti. Con la gente timidissima, che si vergogna di rivolgerti la parola, che ti osserva, ti fotografa. Ma con dei sorrisi che scaldano il cuore, del cibo che riempie lo stomaco e un sacco di premure che noi occidentali non riserviamo nemmeno al più illustre dei nostri ospiti. Ogni esigenza è un obbligo da esperire nel più breve tempo possibile, ogni desiderio un dono. Al punto che è quasi imbarazzante. Il più delle volte non sai come ricambiare. Si tratta di accettare ed esserne grati, e loro sono contenti così. Ormai sono passate tre settimane dal mio arrivo. Vivo con una famiglia ospitante in un villaggio nell'area di Taichung. Io adoro viaggiare, adoro conoscere persone, sentire gli odori di un posto, incontrane la gente, palparne la cultura e la storia. Taiwan ti travolge con il suo traffico caotico, con i colori e gli incensi dei suoi mille templi, con gli sguardi curiosi della sua gente. Ti entra nell'anima. Al punto che, mentre cavalco la mia bicicletta diretta alla scuola dove insegno inglese, mi salgono quasi le lacrime agli occhi. “Ci credi” penso tra me e me osservando la distesa di campi di riso spazzati dal vento autunnale “che ce l'hai fatta un'altra volta?”. Perché so che sono esattamente dove devo e dove volevo essere. Chiaro, non so dove mi porterà quest'avventura. Di certo mi ha già portata lontana, in mezzo all'Asia vera. I vagabondi lo sanno, a volte stare lontani per mesi non è semplice, un pizzico di nostalgia si fa sentire e non tutte le giornate sono uguali. Però mi basta guardare fuori dalla finestra della mia stanza per farla passare in un istante. Perché sono dove ho voluto essere. Perché mi sento fedele a me stessa, perché dopo anni di indecisione ho finalmente avuto il coraggio di fare ciò che da tempo ormai era solo un sogno nel cassetto. Perché non ho paura dei momenti di solitudine, delle sfide e delle difficoltà. Perché vivo per tutti quei momenti magici che solo se nella vita hai coraggio di rischiare hai l'opportunità di vivere. Osa. - Il giro del Sud-Est asiatico in 120 giorni di Marchina Chiara Sono una reduce di viaggio. Anzi, di Viaggio. Quello con la maiuscola, che tanti nemmeno provano a immaginare, alcuni sognano e pochi sperimentano. Sì, sono una fortunata reduce di viaggio. Quattro mesi on the road dall’altra parte del mondo, dove le lancette corrono sei ore avanti, in quel misterioso lembo di terra che è il Sud-Est asiatico. Un volo di andata, uno di ritorno e nel mezzo 119 giorni con zaino in spalla, 5 mutande, un sacco lenzuolo e poco altro, coi piedi per terra o in acqua. Sui più svariati mezzi pubblici a risalire la Thailandia dei templi; su improbabili barchette a percorrere le sinuose arterie fluviali di un verdeggiante Laos; sulle due ruote di un motorino di seconda mano a ridiscendere il frenetico Vietnam in tutta la sua lunghezza fino alla Cambogia, giovane e accogliente. Lasciare a malincuore il mezzo con 3000 km in più e qualche anno di vita in meno. E poi rimettere piede in Thailandia, verso il sud infuocato delle isole, la Malesia del progresso e Singapore, città-stato e città modello. Un viaggio in cui quel che ti serve lo trovi strada facendo e presto scopri che è ben poco quello di cui hai bisogno. Un viaggio in cui sai sempre di essere a posto e nel posto giusto senza sapere che giorno è. Un viaggio che ti apre gli occhi: il mondo è migliore di come lo dipingono. Lo scopri quando, febbricitante in un paesino sui monti, la proprietaria dell’albergo e sua figlia ti offrono assistenza, medicinali, una camera e ti accompagnano dal dottore, senza chiedere nulla. Si prendono cura di te, e ti senti un po’ a casa. O quando, disorientato sul ciglio della strada con motorino spento e mappa in mano, qualche buon uomo dal sorriso perenne si avvicina a darti indicazioni. O in un bar sperduto, dove stringi mani e abbracci sconosciuti davanti a una tazza di the condivisa, e scopri che, in mancanza dell’inglese, la gestualità condita da qualche espressione in lingua locale è un ottimo modo per comunicare. Un viaggio per sperimentare sulla propria pelle l’intensità del vivere, bruciante anche a distanza di mesi. Un viaggio in cui non importa dove arrivi, ma come ci arrivi. E con chi. Con me si è lanciato all’avventura il mio compagno di strada, colui che un giorno per primo ridendo ha dato forma e forza a un’idea strampalata. Da soli si va veloce. In due si va piano, sì, ma si va più lontano. E chi ci ferma più, dopo una convivenza estrema superata a pieni voti? Sono una viaggiatrice a riposo e la nostalgia è mia compagna, così come certe abitudini difficili da abbandonare: aguzzare l’occhio in camera in cerca di scarafaggi, sputar fuori con cura l’acqua lavando i denti, stupirmi dell’assenza della terza classe sul treno, scambiare passanti vestiti in arancione per monaci buddisti di passaggio e, lasciando una camera di hotel, chiedermi se la carta igienica possa tornarmi utile... Un’abitudine, in particolare, proprio non mi si scolla di dosso: andare a letto e sorridere a occhi chiusi, immaginando quale sarà la prossima tappa. - Il Tour organizzato di Chiara Pedrazzi 17 novembre 2012 – Nicaragua Ieri sono andata al Cañón de Somoto, al Nord del Nicaragua. Volevo andare sola e mi ero già preparata tutto il viaggio, ma come sempre qualcuno si è accodato. Mi studio il percorso, chiedo info sui bus, cerco di avere sempre i prezzi più bassi… ma soprattutto parlo spagnolo perfettamente. Sanno che non si perderanno! Stavolta mi è toccata una compagna d’avventura americana che, da brava americana, manco si è portata una guida del Nicaragua ed è venuta qui senza sapere una parola di spagnolo. Poco avventuriera ma simpatica! Dopo SETTE ore di bus (ovviamente cambiandone non uno, ma quattro) arriviamo in questo paesino sperduto tra le montagne nicaraguensi, al confine con l’Honduras. Siccome era già tardi abbiamo trovato un hotel (non un ostello!) che ci ha dato una camera per soli 8 $ in due!! Fantastico! Ho chiesto info per poter arrivare da sole a questo Canyon, ma mi han detto che serviva una guida. Vada per la guida quindi! Prenotiamo il tour e andiamo a letto. La mattina alle 8 ci aspettavamo una macchina davanti all’hotel, ma invece abbiamo trovato solo un ragazzo. Si è presentato come la nostra guida e ci conduce a piedi verso un taxi, che, con ben 7 persone a carico, ci porta a casa della guida. La guida vive giusto all’inizio del Canyon, in una casa con non so quante persone, galline, maiali e tacchini. Prima volta in vita mia che vedo tacchini così da vicino! Ci spiega un po’ di cose e ci dice che con lui faremo il percorso più lungo e meno turistico. Io non avevo la più pallida idea in che cosa consistesse realmente il tour, l’altra non capiva una parola.. quindi.. ho accettato! Pronte per la partenza! Ci dà il giubbetto di salvataggio e mette la mia macchina fotografica nella borsa impermeabile. Nel frattempo mi chiede quanti anni ho, se sono sposata e se volevo rimanere a vivere con lui e diventare guida. Io, allucinata, fingo indifferenza. Ricominciamo a camminare per arrivare ad una stradina praticamente impraticabile, io avevo i sandali a strappo e mi sono vista rotolare giù nel burrone milioni di volte. E’ stato un incubo! Proprio io che non vado nemmeno in montagna per pigrizia!! E poi arriva il meglio! La stradina finisce e si arriva al Canyon.. dove ci sono solo rocce e acqua. La guida inizia ad arrampicarsi sulle rocce e poi ci dà la mano, il mio piede scivola, Hannah cade in acqua battendo il sedere, io perdo un sandalo, le rocce si muovono, non capiamo dove possiamo camminare senza scivolare… insomma un incubo! E così per almeno 1 km! Poi arriva il momento in cui c’è solo acqua… e lì ci si dimentica di tutte le fatiche fatte per arrivare! L’acqua è freddissima ma la corrente ci porta verso la fine del Canyon e io con i piedini in su mi sono lasciata trasportare. Una sensazione unica. Niente pensieri. Solo un cielo blu sopra di me. - Un regalo del cielo Di Chiara Pedrazzi 4 novembre 2012 – Nicaragua Da 2 giorni viaggio sola e ieri é stato un inferno. Ho incontrato solo persone che invece di aiutarmi, cercavano solo di fregarmi. Stamattina quindi non volevo partire, stanca di essere bianca. Ma oggi qualcosa è andato diversamente. Il viaggio per Playa La Boquita é stato in un microbus ed io come sempre ero l’unica gringa*, come mi chiamano qui. Per la prima volta ho viaggiato seduta…in un bussino di 12 posti in cui eravamo in 19, stipati come galline. Arrivata a destinazione, non sapevo come trovare la spiaggia e siccome se chiedi fanno pagare l'entrata (di cosa non lo so) (e solo per i gringos)... per poter passare ho fatto finta di essere con una famiglia nica. Ma siccome la famiglia ad un certo punto si stava chiedendo chi cavolo fosse quella chela** che camminava con loro.. ho dovuto presentarmi. Mentre camminavamo mi hanno chiesto di pranzare con loro. Ho spiegato che non avevo abbastanza soldi ma che potevo comunque sedermi con loro, ma la loro risposta é stata: 'Si Dios hizo que cruzara camino con nosotros.. sos un regalo del cielo'***. Ho accettato. Erano padre, madre e da una bella bimbetta di 8 anni, Genesis, che non vedeva l'ora di raccontare alle sue amichette di questa straniera con gli occhi blu. Presuntuosetta! Alle 2 però fu ora di andare. Alle 4 avevo l'ultimo bus per Granada e prima di arrivare a quel bus avrei dovuto cambiarne altri due. Durante il primo tragitto, tra gli sguardi dei curiosi e le domande a bruciapelo di chi mi stava appiccicato, ho conosciuto 3 fantastiche ragazze di Managua. Era la prima volta in un mese che delle ragazze mi rivolgevano la parola! Probabilmente perché essendo della capitale non mi vedevano come un'aliena. Grazie a loro la prima parte del viaggio é stata divertente. Ma eccomi ad aspettare l'ultimo bus per Granada in un posto sperduto chiamato Jinotepe. Ma naturalmente il bus non arriva. Panico. Non avevo soldi ne' per un taxi, ne' per rimanere una notte in questa cittadina. Non avevo un cellulare ne' un numero di un amico. Insomma... una pazza! Girare da sola per il Nicaragua senza niente di tutto questo! Aspetto.. e aspetto.. sola sulla mia panchinetta in mezzo ad un gruppo di uomini che cercano di rifilarmi qualsiasi tipo di trasporto per raggiungere Granada. Mi offrono persino di portarmi in bici! Io muta e detto francamente.. impaurita. Ma ecco che arriva il mio regalo del cielo: una signorotta obesotta che doveva andare a Granada. - No hay buses mi amor? - Pues.. creo q no... Y no sé como volver a casa! - No te preocupes.. vamos a buscar otra manera! - Vale... pero.. puedo ir con Usted? No me deje sola por favor! - No te dejo sola mujer! A lo mejor te quedas en mi casa!**** Non potevo crederci! Mi sono illuminata! Questa sì che mi era caduta dal cielo! Durante il viaggio, lunghissimo ed estenuante, cambiando bus vari, aspettando di qua e di là sotto la pioggia, chiedendo info, sempre sotto la pioggia.. , mi sono comunque dovuta cuccare la pappardella cristiana. Sapevo che sarebbe arrivata. Una delle prime cose che ti chiedono é se sei cristiana. Sempre. La signoraregalodelcielo ha esordito con il dirmi che l'altra gringa che aveva conosciuto, una canadese, non credeva in Adamo ed Eva.. ma nel fatto che noi derivassimo dalle scimmie. Blasfemia e sacrilegio! Io ovviamente ho assentito falsamente contrariata. *Americana. Se sei bionda con gli occhi blu lo sei per forza. **Bionda ***Se Dio ha voluto che ci incontrassimo… sei un regalo del cielo ****- Non ci sono bus cara? Credo di no.. e non so come tornare a casa! Non ti preoccupare.. troveremo un altro modo! Ok…però.. posso venire con Lei? Non mi lasci sola per favore! Non ti lascio sola ragazza! Male che vada ti fermi a casa mia! - Friendsurfing: in viaggio con Meryem di Chiara Peri Se penso all’inizio del nostro viaggio, vedo il mattatoio di Testaccio, un levriero afghano che trotterella e il sorriso radioso della mia amica Annamaria, monaca buddhista: “Pensa a quante esperienze farete!”. Le avevo appena raccontato il mio programma per le vacanze con mia figlia Meryem, 6 anni, e ho avuto la sua piena approvazione. Il “friendsurfing” (così l’avrei chiamato in seguito, sui social network) ci avrebbe portato in varie località di campagna, mare e montagna. Avevo scelto una manciata di amici, tutti conosciuti in rete o riacchiappati dal passato grazie ad essa, e avevo chiesto ospitalità per due-tre giorni. Il criterio di selezione, oltre alla loro disponibilità, era stata l’affinità “annusata” dai rapporti virtuali e la presenza di bambini potenzialmente compatibili con mia figlia. La congruità geografica delle mete era relativa: da Nizza abbiamo soggiornato in Provenza, poi abbiamo toccato varie località della Liguria, per poi spingerci a Salò, a Trento e infine a Brisighella (Romagna). Mi ero data una regola: niente programmi, niente guide turistiche, niente desideri (con l’unica eccezione dell’Acquario di Genova). Ci siamo affidate completamente a chi ci accoglieva. Se il couchsurfing consiste nel cercare un letto dove si è deciso di andare, nel friendsurfing le persone prevalgono sui luoghi. Ci si sposta per visitare amici, non si cercano nuovi amici per poter visitare dei posti. Naturalmente di luoghi speciali ne abbiamo visti a bizzeffe. Ma a volte ci siamo solo godute il relax e la compagnia. Annamaria aveva ragione: di esperienze ne abbiamo fatte moltissime. Sono state tre settimane di sorprese e di scoperte. Siamo rimasti in panne in mezzo al mare e abbiamo esplorato una grotta; abbiamo guadato il Lago di Garda e ascoltato favole sotto le stelle in cima al monte Bondone. Tornate a casa, Meryem ha protestato: “Che noia, dormiamo sempre nella stessa casa!” Al nomadismo puro non siamo ancora arrivate. Ma tanti nuovi amici hanno lasciato il segno: un cerchietto rosicchiato ci ricorda il cagnolino Flash, un vestito luccicante di tulle ci fa pensare allo gnocco fritto e ai cupcake colorati sbocconcellati sul binario di una piccola stazione immersa nel verde. “Ma come farai, senza macchina?”. Se avessi un centesimo per ogni volta che ho sentito questa frase sarei ricca. Non guido, ma la fantasia non mi manca. Abbiamo preso treni regionali, autobus urbani, corriere, un furgone preso in prestito da un amico sudanese e persino una motonave. Gli spostamenti sono stati parte dell’avventura. Lo zaino che ci ha accompagnato era lo stesso che portavo da adolescente nelle prime gite da sola. Pochi vestiti, costumi, una tigre e un coniglio di peluche (a cui a Genova si è aggiunta una foca). Un quadernino con incollata sopra una cartina su cui segnare, con i pennarelli, i nostri spostamenti. Insomma, l’indispensabile. So già che il prossimo agosto lo riempiremo ancora. - Verso Tapachula di Daniela Lozza San Cristóbal de las Casas se ne sta arroccata sulla montagna, fiera come i suoi abitanti. Le case dai muri colorati nascondono patìos tranquilli che ti coccolano dopo una giornata passata a visitare mercatini. Ogni settimana gli indigeni vengono dai paesi vicini ed espongono le loro mercanzie. E’ un mondo arcaico di colori e odori. Il tempo sembra che si sia fermato e questo non mi dispiace. Stanotte ho sentito degli spari, almeno credo. Sarà stata la mia immaginazione oppure l’eccitazione per il viaggio che mi aspetta domani. Domani è già oggi. Sono le 7, lo zaino è pronto, i documenti a posto. Pago la camera e scendo in strada. Ha piovuto stanotte e le strade lastricate di sassi brillano al primo sole che sta nascendo timido in mezzo alla nebbiolina. Alle 7.30 salgo sull’autobus che mi porterà a Tapachula, al confine con il Guatemala. I passeggeri sono gente del luogo e turisti. Nessuno parla. Siamo ancora un po’ tutti addormentati. L’autobus parte con qualche minuto di ritardo. Saranno tre ore di discesa lungo tornanti a non finire. La nebbiolina ormai si sta diradando e il giorno esplode piano, con quella lentezza che ho imparato ad accettare in questi paesi del Sud del mondo. L’autobus è confortevole ma non lussuoso altrimenti la gente del luogo non potrebbe permettersi il biglietto. Non mi sono mai curata di questi aspetti durante i miei viaggi. L’importante è partire, andare e visitare nuovi posti. Stasera, se Dio vuole, sarò a Città del Guatemala. Dopo un paio d’ore, l’autobus si anima. Gruppi di turisti provenienti per lo più dall’Europa hanno aperto le loro cartine e stanno già pregustando le loro mete finali. La ragazza che siede vicino a me fa parte di uno di questi gruppi. Viene dalla Francia e la sua meta finale è il lago di Atitlán. Già il nome evoca un’atmosfera magica ed antica. Ci andrò anch’io ma prima mi fermerò nella capitale guatemalteca. Per fortuna che ho scelto di sedermi vicino al finestrino. La natura qui è rigogliosa nell’umidità della foresta pluviale. Acqua, acqua, acqua. Acqua limpida, fredda che fa del Chiapas un posto appetibile per l’economia messicana. Ma il progresso ai Lacandoni non interessa. E li capisco, godendo della tranquillità di questi luoghi. Ma è tempo ormai di raccogliere le mie cose. La frontiera con il Guatemala è a pochi chilometri. L’autobus ci lascia all’ufficio emigrazione messicano da dove ci spostiamo con un taxi collettivo. I miei compagni di viaggio ora sono spagnoli. L’impatto con la frontiera è quanto mai cinematografico: una sbarra divide i due paesi ma la gente e le abitudini sono uguali. Gente che cambia la valuta, che ti vende da mangiare, bambini che chiedono l’elemosina e galline in quantità industriale che sgambettano qua e là. Nell’ufficio immigrazione un impiegato mi chiede il passaporto e scrive i miei dati su un foglio. Usa ancora una macchina da scrivere modello Olivetti 32. Sorrido. Io sono abituata ai terminali che non funzionano mai quando servono. L’impiegato mi sorride e mi dice “Bienvenida Señorita Daniela”. Sono ufficialmente in Guatemala e so già che me ne innamorerò. Un tipo alto, magro e brizzolato si muove freneticamente urlando “Guate, Guate” indicando un autobus. Mi avvicino a lui e chiedo se l’autobus va a Città del Guatemala. La risposta è affermativa. Prende il mio zaino e lo carica sul tetto preoccupandosi di legarlo e subito dopo mi fa il biglietto. Mi conferma quasi sette ore di viaggio. Salgo e mi siedo di nuovo vicino al finestrino. Scelta quanto mai felice perché da lì potrò osservare il paesaggio. Altri viaggiatori stanno occupando gli altri posti. L’autobus non è ancora pieno ma si parte. Non c’è un orario preciso. La precisione europea qui svanisce. La strada è sterrata, le sospensioni non esistono. Arriverò dopo 7 ore con le ossa indolenzite. Eros Ramazzotti che canta in spagnolo riempie subito l’atmosfera. Incontriamo diversi villaggi sperduti nei boschi da dove scendono i contadini. Stanno sul ciglio della strada e se trovano posto salgono sull’autobus, riempiendolo all’inverosimile. Il bigliettaio, il tipo di prima che ha caricato il mio zaino, fatica a passare tra i passeggeri per reclamare il biglietto. Ma nessuno si lamenta. I contadini guatemaltechi sono le persone più tranquille che abbia mai conosciuto. Si animano solo ai crocevia quando l’autobus si ferma per scaricare e caricare altra gente. Dei venditori improvvisati salgono per quei pochi minuti sufficienti per offrire alimenti e bevande. Ma dopo qualche ora di viaggio, neanche la musica non anima più nessuno. Alcuni passeggeri si sono addormentati. Io resto vigile. Mi piace osservare la strada che corre lungo uno strapiombo. I guardrail qui non esistono. Una certa inquietudine mi assale ma poi mi dico che mi trovo in uno dei paesi più emozionanti al mondo e niente di brutto mi potrà accadere. Sono già successe cose tremende qui negli anni passati. Il Guatemala ha ora bisogno di tranquillità e serenità. Mi guardo intorno ed osservo i visi dei contadini: sono visi millenari che portano su di sé le tracce di un passato glorioso. I tratti spigolosi rendono l’idea di un popolo che non ha mai rinunciato alla propria dignità nonostante i soprusi che ha dovuto subire. Fa caldo. Ovviamente l’aria condizionata non esiste sull’autobus, uno scuolabus americano sbarcato qui dopo essere stato dismesso dagli Stati Uniti. Ho sentito dire che il Messico è la pattumiera del Nord America, nemmeno il Guatemala scherza. Eppure è tutto pulito e a posto. I campi coltivati a mais rendono il paesaggio ordinato e gli alberi da frutta lo colorano. L’autobus prosegue velocemente in mezzo alle montagne. L’autista parla e scherza con il bigliettaio, sempre più magro e brizzolato. Al prossimo crocevia, mi dice, dovrò scendere e cambiare autobus. Questo va dritto a Quetzaltenango. Quello che prenderò io andrà a Città del Guatemala. Il trasbordo è veloce ed efficiente. Il bigliettaio sale sul tetto dell’autobus e mi dà, anzi mi lancia, lo zaino. Ed io salgo sull’altro che mi sta aspettando. Qui non ci sono più turisti ma gente del luogo che va in città. Stesse facce, stessi visi. I contadini sono un po’ più eleganti: gli uomini in pantaloni scuri e camicia bianca, le donne in gonne colorate. La strada migliora velocemente e si comincia a vedere l’asfalto. Niente più scossoni. Oddio, mi sbagliavo. Un contadino, appisolato sulla mia spalla, si sveglia ad un sobbalzo. Si guarda intorno un po’ stranito. Mi chiede timidamente da dove vengo. Gli rispondo “Dall’Italia”. “E te ne vai sola per il Guatemala?”, mi chiede. Ed io “Sì, sola”. - La vera esistenza dell’intraducibile “Saudade” di Debora Lucchetti Partì il 2 novembre, di Venere e al posto n.17. La madre e la sorella piangevano come se stesse per partire per il fronte. Le premesse non erano delle migliori. Ma allo scalo a Madrid già l’umore era migliorato…il sogno sudamericano si stava per avverare. Era il suo primo vero viaggio lontano e soprattutto…da sola. Era arrivata a Rio de Janeiro. Una donna bionda sulla trentina(poco tempo le servì per capire che è impossibile dare un’età alle donne brasiliane)la accolse con un cartello con il suo nome. Irna, un’amica di un conoscente brasiliano, la ospitò per la prima settimana. Un viaggio di 15 ore e qualche ora di jet lag non erano sufficienti secondo Irna, che voleva accoglierla nella vera”manera brasile ira”. La portò nel fulcro della vita notturna carioca e le offrì due bicchieri di cachaça. Trovò Rio una città magica, una metropoli che cresceva all’interno di una giungla, una città dalle mille contraddizioni, dove povertà e ricchezza convivevano ogni giorno, così promettente e così tragicomicamente disorganizzata. Si innamorò del quartiere di Santa Tereza, della samba e della farofa. Giocò per settimane sulle spiagge di Copacabana. Ma i progetti per il quale aveva raggiunto la città non erano andati a buon fine, tanto valeva approfittare al meglio dei tre mesi del visto e vedere un pezzetto di Brasile in più. Aveva fame di quella terra. Voleva conoscere tutto quello che c’era da scoprire, mangiarselo a manciate, assaggiare la frutta, vedere i colori, perdersi, cambiare, sperimentare, buttarsi, viverla. Con il suo zainone in spalla salutò le 15 studentesse con le quali conviveva in un vecchio appartamento di non più di 60 mq e lasciò Rio alla volta del litorale nord-est. Preparava percorsi dettagliati prima di ogni tragitto, ma l’itinerario cambiava continuamente perché i consigli degli anziani che conosceva nelle varie tappe le sembravano più accattivanti delle pagine della guida. Viaggiò prevalentemente in pullman, ma non disdegnò passaggi da sconosciuti. Una sana dose di fiducia nelle persone, condita con un pizzico di incoscienza, fu occasione di risparmio e allo stesso tempo di arricchimento personale. Dormì un po’ in tenda, un po’ ospite di qualche angelo custode dei viaggiatori, un po’ in spiaggia, un po’ in soffitte di case popolari. Si sentì sola…ma poi al calar del sole, nel corale applauso fragoroso per lo spettacolo offerto dalla natura, si ricordò che sola, comunque, non lo sarebbe stata mai. Si innamorò di un ritrattista senza dimora e fu grata a quella fetta di popolazione che era stata, anche solo per un momento, sua compagna di viaggio. Capì che l’essenza di un viaggio non sta nella destinazione vera e propria, ma nel viaggio stesso, in quanto spostamento, evoluzione, sublimazione. Capì che ogni tassello che si aggiungeva a quel puzzle colorato non andava a completare semplicemente il ricordo di un viaggio splendido; quell’esperienza l’aveva colpita nel profondo, l’aveva plasmata. Quella ventiduenne ero io, e ora che ho scoperto quanto è bello viaggiare, spero di non fermarmarmi mai. - El Desierto Di Denis Strickner Paura, incoscienza, panico. Questo è il mio deserto. Non si scherza con la natura, non a 20.000 Km da casa. Non a 200 Km dal luogo abitato più prossimo. E pensare che solo alcune ore fa pensavo alla grande avventura, all’adrenalina, ai paesaggi. Ora mi trovo in mezzo ad un mare di sabbia, di polvere. Il vento piano piano sempre più imponente. Sarei dovuto tornare indietro prima di quel maledetto bivio. E ora? Il buio incombe e la notte nel deserto non è certo consigliabile a uno sprovveduto come me. Non ho nemmeno una tenda e il mio furgone finirebbe per imprigionarmi come in una cella ghiacciata. 40 gradi di escursione termica, 4000m di altezza. Le montagne di sabbia, familiari e amichevoli durante la giornata, tutt’a un tratto appaiono invalicabili e ostili rivali. Sono contornato dal nulla, solo il vento continua imperturbabile la sua corsa. Il panico sta bussando alla mia porta, ma non voglio aprirgli; non ora. Accendo il mio furgoncino e prendo la decisione di partire. Il colore predominante passa dall’arancione bruciato al nero più cupo. I fari del mio pick-up non possono nulla contro l’oblio della notte di quest’oceano di sabbia. La visibilità scarseggia e le mie ruote innalzano nubi di polvere che al mio occhio risultano insormontabili. Sbando. Più volte. Non posso superare i 30Km/h su un terreno così infimo. Curve improvvise, cumuli di sabbia e massi impediscono il mio avanzamento in questo maledetto deserto. Sterzo bruscamente, lambisco la parete laterale di una duna. Esco per vedere il danno e… mi accorgo che sulla sinistra c’è un dirupo. Ho rischiato veramente grosso. Cieco e impotente è quello che sono di fronte alla natura. Spengo il furgone per un attimo cercando di riflettere. Dormire li? Morire di freddo? Andare avanti e sperare di trovare quel rifugio che potrebbe essere a 10 come a 150Km? Perso. Infreddolito. Forse la mia spossatezza, la mia mancanza di lucidità, la mia difficoltà nel mettere a fuoco è dovuta anche dall’altitudine. 4000m non sono facili da sfidare. “Pazzo Denis. Sei un pazzo!” Non so come affrontare la situazione. Bevo un po’ d’acqua che si trova sul cassone del mio pick-up, a lato delle taniche di benzina di riserva e del mio zaino sommerso da un velo di sabbia infinito. Osservo le stelle, mi rincuorano. Quando un miraggio mi coglie impreparato. “Una luce.” Non credo ai miei occhi! Ad una distanza non comprensibile ai miei sensi, laggiù scorgo un sottilissimo bagliore. La luce della speranza. Non so cosa sia, ma qualcosa mi dice che devo raggiungerla. Rincorro quella luce, la vedo sempre più vicina, riesco quasi a toccarla con la mano… Batte forte il cuore quando decido di bussare a quella porta. Quel cumulo di legname e lamiere tutto sembra meno che una casa; un riparo nel cuore del deserto. Un cane abbaia quando la porta si apre. Una vecchietta si avvicina e mi dice cose a me non comprensibili. Non mi era ancora capitato di sentire parlare in quechua e non me lo sarei mai nemmeno immaginato. Salvo, per ora. - Pachamama di Denis Strickner Quella casa. Un miraggio nel mezzo della notte. “Has tenido suerte” sussurra quell’anziana signora versandomi una tazza di tè. Non è facile capire cosa mi stia raccontando, d’altronde non capita tutti giorni di sentir parlare una lingua così longeva, il quechua. Strascicando qualche parola in castellano, mi racconta una vita agli argini della civiltà. Prima di coricarmi, esco da quella baracca e mi confronto con il cielo. Così come ogni notte quelle stelle mi colgono totalmente impreparato. Stupore e incredulità fanno parte ormai da mesi delle mie emozioni quotidiane. Mi fa sempre un certo effetto scorgere “Las 3 Marias” – per noi La Cintura di Orione – sottosopra… Sorrido. Raggiungo i miei genitori con il pensiero e rincaso. Le luci soffuse di quelle che una volta si potevano considerare candele mi guidano nella “stanza” dove passerò la notte. Cerco un posto dove non recare troppo disturbo allo svariato pollame che mi circonda e ripongo il mio sacco a pelo tra la pungente paglia e uno scampolo di gommapiuma che per stasera sarà il mio nido. Sono circa le sei quando sua maestà il gallo mi fa capire chi comanda. Quell’odore di paglia mi rievoca ricordi lontani. Quell’acqua riposta in un barile invece – tanto gelida quanto sporca – al contatto con la mia pelle, mi ricorda che sono vivo. Declino l’invito ad usare la toilette, ovvero un buco nel terreno, con una specie di entrata contornata da panni… La partenza è vicina. A colazione acqua bollita e quello che fino ad alcuni giorni prima poteva essere pane. Prima di andarmene, lascio sul tavolo pan carré, affettati e della frutta. Sono sicuro che apprezzerà più lei di quanto potrei mai apprezzare io. Mi sorride, mi dà la sua benedizione tracciandomi una croce in fronte con le dita come soleva fare mia nonna una vita fa. Le sue mani… quante storie potrebbero raccontare. Esco e mentre la luce del sole si adagia sopra le dune di sabbia che mi circondano, mi accorgo che quel rifugio altro non è che un ammasso di lamiere e legname. Ho giusto il tempo di fare rifornimento al mio pick-up. Nell’adagiare le labbra su quel tubo di plastica odori molesti e gusti nauseabondi passano dapprima nella mia bocca per poi riporsi dentro il serbatoio. Fare benzina a bocca è pur sempre un esperienza. Nella mia incredulità, un signore baffuto accompagnato da un asino appare dal nulla. È il figlio della signora, di rientro dalla “vicina” miniera. Saluto e finalmente si riparte. Il deserto di giorno è incantevole. Quel color sabbia trasformato in oro dalla luce solare. Le nubi di sabbia alzate dal mio furgoncino oggi mi sembrano più familiari, quasi innocue. La strada tutta curve mi porta sulla cima di un passo a più di 4000 metri d’altura quando… Non credo ai miei occhi. Di fronte a tale splendore il mio respiro è in affanno. Laggiù, ai piedi della valle, l’incanto della Laguna Santa Rosa. Gli eleganti fenicotteri, i buffi guanachi sembrano aver trovato la loro terra promessa. Riparto. La destinazione è quell’ illusione chiamata Laguna Verde, 150 Km più a Nord. Mi accompagnano fiumi inconcepibili, saline immense, vulcani dormienti e il mitico Cerro 3 Cruzes che domina il deserto dall’alto dei suoi 6749 metri. Dal mio CD le stesse canzoni da 667 km quando, pochi attimi prima di quella curva sulla destra… Non riesco a fare pressione sull’acceleratore, a stento riesco a credere ai miei occhi… La tanto sospirata Laguna Verde si scopre in tutto il suo splendore. Scendo dalla vettura. Un urlo nel vuoto riecheggia in tutta la vallata. Ce l’ho fatta. Ho le lacrime agli occhi quando mi siedo per ammirare quel paradiso. Si, il mio paradiso lo disegnerei proprio così. Faccio fatica a trattenere le mie emozioni. Il cielo che si specchia su quella tavola d’acqua, di un azzurro turchese fino ad oggi nemmeno immaginabile. Quella calma. Una pace infinita. Il lago sembra fermo nel tempo. È il colore del cielo riflesso nell’acqua o è il colore dell’acqua riflesso nel cielo? Magia. Se bastasse una foto, se bastasse un testo a recitare questo sottile confine tra sogno e realtà allora sarebbe un posto, come tanti altri… Pachamama. - La conoscenza di una nemica, la scoperta della sorpresa Di Doroty Scisci “Ma ce la farò ad andare in auto con lei?” pensavo tra me e me. Intanto, il mio trolley non aveva nessuna intenzione di chiudersi. Troppa roba che di sicuro non avrei messo! Una tazza di latte di soya con 70 grammi di avena e poi dritto verso la stazione, dove mi attendevano le ragazze. Destinazione: Festival Internazionale del Giornalismo. Un vero atto di coraggio per me affrontare quasi 170 chilometri con lei, Alice, la ragazza più odiosa ed arrogante! Un sole dolcemente tiepido, una brezza primaverile invitante. Fatto il pieno per l'auto, ho preso in prestito lo zaino di Tenerella per le mie scarpe (come se dovessi prendere il volo per la Nuova Zelanda, avevo praticamente svuotato la mia scarpiera!). Giusto cinque minuti, e via in autostrada. Alla guida Rachele, la nostra chauffeuse per eccellenza, ci illustrava per intero il programma di quei quattro giorni: conferenze, workshops, interviste, meetings. Mentre gustavo l'ottimo succo ai frutti di bosco preparato da Virginia (Tenerella perchè dolcissima e altruista), sceglievo quale tra i suoi cd ci avrebbe accompagnato in quel paio d'ore di chiacchiere e discussioni su come il giornalismo possa aiutare la diplomazia. Frattanto, nella mia fantasia già assaporavo la dolce idea di trovarmi finalmente face to face con Harper Reed! Ecco: l'ultimo album dei leggendari Cypress Hill faceva proprio al caso nostro. Alice mi lanciava spesso occhiatacce dal sedile anteriore, ma io fingevo la più totale noncuranza. Fino a quando, addentando un morso della sua crostata di mele e frutta secca, Virginia non si è sentita male. Shock anafilattico. Nessuna di noi sapeva della sua allergia alle mandorle. La prossima fermata dell'autogrill era ancora troppo distante: sulla destra, solo campi di ridenti girasoli, null'altro. Fermi sulla piazzola di sosta a metà strada, Alice ha posizionato Virginia supina con le gambe sollevate e le ha somministrato adrenalina e antistaminico. Terrorizzate, abbiamo atteso l'arrivo dei soccorsi. Proprio lei, la persona che avevo detestato per un battibecco durato ben due anni, è stata la salvezza della nostra amica. Con il suo santo kit di studentessa di medicina, ha avuto la freddezza e la prontezza d'azione, al contrario di me e Rachele che osservavamo impietrite il terrificante pallore di Virginia che perdeva conoscenza. Abbracciarla è stato l'unico gesto che l'impulso mi ha dettato! Se non mi fossi trovata in auto con lei in quel giorno, non avrei scoperto la sua vera personalità, e avremmo seguitato nel nostro reciproco rancore forse per sempre. Ma il destino ha voluto che questo terribile evento ci avvicinasse. Anche se lo spavento provato non ci ha più permesso di ripartire per Perugia assieme, ho imparato che non si conosce mai davvero una persona se non le si vive strettamente accanto, pure semplicemente per un breve viaggio di condivisione forzata. Dopotutto, l'occasione migliore per capire realmente qualcuno è nel vederlo come si comporta quando è assolutamente libero di scegliere. La conoscenza di una nemica, la scoperta della sorpresa Ma ce la farò ad andare in auto con lei?” pensavo tra me e me. Intanto, il mio trolley non aveva nessuna intenzione di chiudersi. Troppa roba che di sicuro non avrei messo! Una tazza di latte di soya con 70 grammi di avena e poi dritto verso la stazione, dove mi attendevano le ragazze. Destinazione: Festival Internazionale del Giornalismo. Un vero atto di coraggio per me affrontare quasi 170 chilometri con lei, Alice, la ragazza più odiosa ed arrogante! Un sole dolcemente tiepido, una brezza primaverile invitante. Fatto il pieno per l'auto, ho preso in prestito lo zaino di Tenerella per le mie scarpe (come se dovessi prendere il volo per la Nuova Zelanda, avevo praticamente svuotato la mia scarpiera!). Giusto cinque minuti, e via in autostrada. Alla guida Rachele, la nostra chauffeuse per eccellenza, ci illustrava per intero il programma di quei quattro giorni: conferenze, workshops, interviste, meetings. Mentre gustavo l'ottimo succo ai frutti di bosco preparato da Virginia (Tenerella perchè dolcissima e altruista), sceglievo quale tra i suoi cd ci avrebbe accompagnato in quel paio d'ore di chiacchiere e discussioni su come il giornalismo possa aiutare la diplomazia. Frattanto, nella mia fantasia già assaporavo la dolce idea di trovarmi finalmente face to face con Harper Reed! Ecco: l'ultimo album dei leggendari Cypress Hill faceva proprio al caso nostro. Alice mi lanciava spesso occhiatacce dal sedile anteriore, ma io fingevo la più totale noncuranza. Fino a quando, addentando un morso della sua crostata di mele e frutta secca, Virginia non si è sentita male. Shock anafilattico. Nessuna di noi sapeva della sua allergia alle mandorle. La prossima fermata dell'autogrill era ancora troppo distante: sulla destra, solo campi di ridenti girasoli, null'altro. Fermi sulla piazzola di sosta a metà strada, Alice ha posizionato Virginia supina con le gambe sollevate e le ha somministrato adrenalina e antistaminico. Terrorizzate, abbiamo atteso l'arrivo dei soccorsi. Proprio lei, la persona che avevo detestato per un battibecco durato ben due anni, è stata la salvezza della nostra amica. Con il suo santo kit di studentessa di medicina, ha avuto la freddezza e la prontezza d'azione, al contrario di me e Rachele che osservavamo impietrite il terrificante pallore di Virginia che perdeva conoscenza. Abbracciarla è stato l'unico gesto che l'impulso mi ha dettato! Se non mi fossi trovata in auto con lei in quel giorno, non avrei scoperto la sua vera personalità, e avremmo seguitato nel nostro reciproco rancore forse per sempre. Ma il destino ha voluto che questo terribile evento ci avvicinasse. Anche se lo spavento provato non ci ha più permesso di ripartire per Perugia assieme, ho imparato che non si conosce mai davvero una persona se non le si vive strettamente accanto, pure semplicemente per un breve viaggio di condivisione forzata. Dopotutto, l'occasione migliore per capire realmente qualcuno è nel vederlo come si comporta quando è assolutamente libero di scegliere. - Focus di Emanuele Mussara Suonare in una band è un costante essere on the road. Noi on the road ci eravamo andati veramente. Un minivan, in quattro. Pronti, partenza, via. Musica: RHCP, Road Trippin'. Ecco, me l'hanno fatto apposta. Lo sanno che 'sto pezzo per me è un colpo al cuore. Glielo dico. Niente, anzi la cantano pure: lezgò ghellost rait ir inde iuesei. Stiamo andando a Londra, faccio notare. - È lo stesso - mi dicono. Appoggio la testa al finestrino, occhi al tramonto, pensando a lei. Tastiere ci stressa col fatto che bisogna andare a filo di acceleratore perché sennò si consuma troppo. Tastiere, chissenefrega. Su iniziativa di Tamburo ci fermiamo a mangiare dopo meno di cento chilometri. Il bestione ha fame. Si, fatequellochevolete. Nave da Palermo a Genova, imbarcato il minivan saliamo a dormire sulle poltrone della nave. Si abbassano le luci. Tamburo scoreggia. Quasi quasi, scendo. Tanto lo so, a loro non è mai piaciuto come suono il basso. Mi giro da un lato. Buio. Luce. Buongiorno. Sembra tutto ok. A parte Chitarra che non riesce a fare la cacca. Rovisto nella borsa frigo: quasi vuota. Guardo Chitarra e lui fa lo sguardo angelico. Chitarra, vai a cagare. Le facce d'angelo ti tradiscono sempre. Tastiere mette ansia: e se in Inghilterra la presa non va e si brucia tutto? Lo mando a quel paese. Che non è l'Inghilterra. Tamburo fa un rutto. Altre dieci ore e scendiamo. Sbarchiamo. Mentre guido, sento che il viaggio vero inizia adesso. Dobbiamo arrivare da Genova a Londra in meno di 48 ore. Siamo tutti più calmi, forse perché stanchi, forse per la coscienza che adesso non è più la nave a portarci ma siamo sulle nostre gambe, anzi, sulle stesse ruote. Val D'Aosta: strada in salita e natura incontaminata. Intorno, silenzio. Bello. Senza dirlo a nessuno, sollevo poco il piede per andare a filo di acceleratore. Nevica. Ci fermiamo in un'area di sosta, l'ultima prima del traforo del Monte Bianco. Ceniamo con scatolette. Una. Tamburo sbuccia per tutti la frutta rimasta. Un'arancia. Me la passa. Io decido di darla a Tastiere come segno di pace. Lui la prende e la dà a Chitarra, che magari l'aiuta ad andare al bagno. Chitarra dice che tanto è inutile e la passa a Tamburo, che se la merita. Tamburo ringrazia a modo suo: - Sucate. Ridiamo. Dormiamo in auto da questa parte del confine, che non si sa mai. Apro gli occhi. Ancora buio. Dal vetro appannato, mi appare una figura sfocata, nella neve, illuminata dalla luna. È Chitarra. Sono contento per lui. Chiudo gli occhi. Mi sveglio, sotto una coperta che non avevo quando mi sono addormentato. Dietro di me dormono tutti, rannicchiati. Metto in moto per attivare il riscaldamento. Prendo la coperta e copro i ragazzi. Dormono come angioletti. Visto che il motore è acceso, tanto vale muoversi. E' l'alba sul Monte Bianco. Inizio a guidare, con gli occhi verso il sole e la musica a palla. Mentre ascolto Road Trippin' ho come la sensazione di essermi scordato qualcosa. Non so. Sarà un gran tour, è l'unica cosa a cui riesco a pensare. - Il sole che non si leva dalla mente di Fabio Giagnoni Fuori dall’Europa per la prima volta. E così lontano. Il desiderio di toccare con mano ciò che avevo conosciuto solo indirettamente era così profondo che si trattava solo di una questione di tempo…dopo quindici anni di paziente attesa la mia passione ha potuto essere corrisposta, ho dedicato un mese e mezzo alla mia nazione d’elezione: il Giappone. Le mete: Tokyo e Kyoto, a confronto le due anime dell’arcipelago, post-moderno e tradizione. La prima è una metropoli sorprendente. Così ricca di vita. Pulsante. Luminosa. Sconfinata. Le ore di punta la rendono spaventosa, fagocitante, labirintica. Mite. Paradossalmente ordinata, con parcheggi multilivello anche per le biciclette, che se lasciate in sosta vietata vengono multate e rimosse. La seconda, antica capitale medievale, è ridente, solare, più a misura d’uomo, ricca d’antichi, straordinari complessi templari delle due religioni principali, lo shinto e il buddhismo. I giapponesi sono gentili, disponibili, rispettosi, educati (sia in senso lato che scolastico), amichevoli e ospitali. Non ho mai assistito a una singola discussione, né tantomeno a una rissa da strada. Piuttosto che sbatterti in faccia un chiaro no, ti propongono diplomaticamente un’alternativa o, nel caso manchi, un “non sì”, cordiale e sibillino. Sono ben curati nell’aspetto, amano profondamente la pulizia, cosa riscontrabile nella diffusione degli onsen e dei sento, stazioni termali e bagni pubblici molto frequentati, ma anche nella raccolta differenziata capillare che gli ha permesso di eliminare i cassonetti dalle strade; pulizia anche morale: i crimini sono poco diffusi, la polizia non ha bisogno della rivoltella. Sono tenaci lavoratori: l’appezzamento di terreno di fronte al mio hotel in poco più d’un mese è stato occupato da una costruzione a due piani fatta e finita. Dulcis in fundo, pare che gli italiani siano il loro popolo preferito. Infatti i miei ciceroni dagli occhi a mandorla sono stati il piatto forte, molto più del delicato fritto giapponese, il tempura o del mitico sake, le cui qualità variano come quelle dei vini nostrani. Avevo già conosciuto Miho in Portogallo, ritrovarla più vispa che mai è stato un piacere, abbiamo fatto una gita a Kamakura, paese del Daibutsu, colossale statua in bronzo del Buddha. Yuji e Ai mi hanno portato alle falde del sacro monte Fuji, sulla riva del lago Yamanaka, lei mi ha poi raggiunto a Kyoto e anche a Roma un mese dopo il mio ritorno. Infine Toshi, il mio gemello degli antipodi, mi ha introdotto nella sua cerchia di amici, ho dormito da lui più d’una volta, nella sua sala concerti ho suonato i taiko, tamburi tradizionali e infine mi ha accompagnato all’aeroporto con la promessa che m’invierà il biglietto aereo per la sua festa di nozze. L’espressività del teatro kabuki, gli irezumi, straordinari tatuaggi tradizionali, la grinta delle band punk underground, la bellezza serafica delle donne, ma soprattutto il sorriso degli amici... il mio cuore è rimasto là. - Partire, ora. di Fabrizio Bagnerini Estate finita, routine autunnale alle porte. Quando la pioggia rigava i vetri dell’aula dissi a Gianluca: “Ne ho già abbastanza, credo sia arrivato il momento.” Il momento di partire all’istante e di lasciare tutto, di aprire gli occhi e non pensare. Avevo voglia di staccare la spina e attaccarne una nuova con coraggio, trovando quella spinta iniziale che spesso tarda ad arrivare ma che quando arriva ti accende come un tizzone ardente. Partire, partire subito. “Ci stai?” Chiesi. “Ci sto, amico.” Gianluca c’è sempre stato. Una giornata per motivare tale scelta, un’altra mezza per salutare, due ore per le valigie e cinque minuti per fare il pieno dal benzinaio. Le idee non erano mai state così chiare, la meta mai così vicina. Un sorriso mi si aprì quando lessi il nome della mia città sbarrato dalla riga rossa sul cartello autostradale. Eravamo finalmente partiti? Ebbene sì, eravamo in viaggio, improvvisamente, con la musica alla radio e i terreni grigi e bagnati che scorrevano via dal finestrino appannato. La strada davanti. Solo chilometri, tanti chilometri da correre a perdifiato con la gioia nel cuore come in sella ad un purosangue che sfreccia sul bagnasciuga. La strada era mia amica, le sue linee così decise mi guidavano verso la novità. Io e Gianluca cantammo durante il viaggio. Cantammo a squarciagola alle colline, ai boschi, alle stazioni di servizio, alla luna, alle città ed ai paesi che visitavamo; cantavamo e sognavamo. Mai come allora mi sentii libero di urlare ed esprimere quello che volevo. Ero solo io, Gianluca e i chilometri. Nonostante le file ai caselli, il dormire in macchina presso Bologna, il cambiare una ruota sotto il temporale della Pianura Padana, la macchina fotografica persa in un bar e molto altro ancora, la nuova desiderata esperienza si andava facendo e non c’è nulla di più bello che vivere senza sapere cosa ti accadrà il giorno dopo, chi incontrerai e cosa farai. Avevamo una meta, questo sì, ma la strada che ci separava da essa ogni giorno si colorava di esperienze vere, autentiche e vitali. Ricordo con piacere l’odore di carta da parati di quell’ostello a Venezia, il buio dei suoi corridoi infiniti, il cornetto delle sei di mattina vicino il Ponte degli Scalzi, la chiacchierata con delle ragazze di Parigi in un pub in provincia di Belluno. “Eccoci qui.” Dissi, prima di mordere il mio panino, seduto su una roccia del monte Civetta. “Siamo stati grandi.” Mi ha risposto Gianluca. Poi, guardando l’orizzonte innevato tingersi di rosa, ha aggiunto: “Ma ora metti via il quaderno e sbrigati a finire quel panino, dobbiamo coronare il nostro viaggio!” Mentre scrivo queste righe qualche mollica di pane cade sul foglio, una marmotta lontana canta, una nuvola copre il sole, un soffio di vento agita il mio impermeabile. Smetto di scrivere, devo andare a “coronare il viaggio”, già vedo Gianluca che paga la nostra cioccolata con panna e cannella. Siamo a 2123 metri sopra il livello del mare e a 768 chilometri da casa. - Quadrifoglio di Fabrizio Bagnerini “Ma come abbiamo fatto ad arrivare fin qui?” mi chiese Alice, con gli occhi che le sorridevano e facendo piccoli saltelli sul posto. Io guardai i suoi capelli muoversi al vento e arricchirsi dei riflessi del tramonto. Eravamo sotto una torretta che si affacciava sulle scogliere di Moher e il sole lentamente entrava nell’oceano. Le scostai una ciocca, la abbracciai con forza. “Siamo partiti un mese esatto fa ed ora eccoci qui, esattamente dove abbiamo sognato di essere per tanto tempo ma…” dissi odorando il caldo profumo del suo collo. Poi, allontanandoci un poco, ci guardammo negli occhi fino a quando non scese l’oscurità. Ricordo ancora molto bene ogni dettaglio del nostro lunghissimo viaggio. Ricordo ad esempio il giorno prima di partire, trascorso da lei, quando la aiutai a sistemare la valigia; ricordo quel paesino vicino Milano dove facemmo la nostra prima tappa, le sue vie strette e logorate dal tempo, i suoi alberi, i suoi scorci. A Strasburgo ci saremmo dovuti incontrare con degli amici di Parigi conosciuti sei mesi prima nella nostra Roma e quel pomeriggio vicino alla cattedrale centrale ci fecero aspettare due ore in un bar a due piani, dai mobili di legno scuro e intagliato a regola d’arte. Ho due ricordi di questa città: la pioggia fitta e silenziosa che ci colse appena usciti da una libreria del centro e la cioccolata calda del bar. In quattro in macchina, alternandoci alla guida, siamo saliti fino a Coblenza e poi alla colorata Amsterdam; da qui abbiamo letteralmente abbandonato la macchina e spiccato il volo verso Dublino. La vera avventura iniziò in terra d’Irlanda, con il freddo pungente e pochi soldi in tasca. Alloggiammo per tre notti in un modestissimo Hotel della capitale e poi prendemmo il treno. Cabina solo per noi, i vetri che si appannavano, le colline verdi e il cielo grigio fuori: tutto bellissimo. Ci stringevamo nei nostri larghi maglioni e bevevamo cioccolate calde ad ogni cittadina che visitavamo. Ora ci spostavamo in treno, ora in pullman. Un giorno abbiamo fatto l’autostop: l’irlandese dalla pipa in bocca che si fermò si dimostrò molto simpatico e tranne qualche ovvia difficoltà di comunicazione il tragitto con lui è stato riempito di descrizioni e storie semileggendarie della sua terra. Giunti poi cinque giorni dopo al parcheggio delle scogliere non eravamo più stanchi: i chilometri e il freddo sembravano non toccarci. “Dai su, andiamo che è buio” mi disse lei, poggiando la testa sul mio petto. E ancora, lentamente: “Loro già sono al pullman…” Inspirai a fondo e mi riempii le narici oltre che del suo odore anche di quello dell’erba bagnata e di terra, di fiori e quadrifogli. “Ti amo, lo sai vero? Conterò ogni giorno che mi separerà da te” dissi. “Ti amo anche io, tanto. Dai, sono solo cinque mesi, facciamoci forza. Tornerai. Ti serve questo lavoro, stai su!” disse. E io: “Grazie di avermi accompagnato amore.” - Abhay di Fabrizio Bagnerini L’estate scorsa io e Lorenzo siamo andati a Milano per assistere ad un concerto. Partimmo alle sei di mattina per sfruttare l’intera giornata e già da subito iniziammo ad ascoltare a tutto volume le canzoni dei nostri idoli sempre più vicini. Senza soste arrivammo a Firenze alle otto e trenta e poiché eravamo in anticipo sulla tabella di marcia decidemmo di uscire dall’autostrada per fare colazione. La città ancora non si era svegliata e le vie erano molto silenziose. Entrammo in un bar che emanava un forte odore di caffè. Fuori ci fermò un ragazzo indiano che stava ad una fermata dell’autobus. Dopo aver fatto delle considerazioni sul tempo ci disse che il gruppo musicale mostrato dalle nostre magliette era forte e che la loro musica era una cosa buona. Ci presentammo. Abhay ci parlò di Firenze, di economia e di un certo Rocco. Quando poi iniziò a chiedere di più su Milano e sul modo per arrivarci capimmo che forse avrebbe desiderato un passaggio. Lui non lo chiese apertamente ma accettò con gioia quando Lorenzo glielo propose. Insieme salimmo in macchina, lasciandoci Firenze alle spalle. Sedeva dietro Abhay, ma con le braccia si poggiava ai nostri sedili e si sporgeva spesso con la testa in avanti, per scherzare e parlare con più facilità. Ci ringraziò per la nostra gentilezza più volte, poi volle ascoltare qualche canzone. In realtà non conosceva affatto il gruppo e tantomeno non era mai stato a Milano, come me d’altronde. A Parma ci fermammo in un autogrill per pranzare; dopo aver comprato qualcosa da mangiare sedemmo su delle panchine in un’area verde lì vicino. Abhay ci raccontò la sua storia. Aveva ventitré anni ed era in Italia da quando ne aveva sedici; la sua famiglia era rimasta in India e lui, insieme ad un amico, si era dovuto trasferire e stabilirsi nel sud del nostro Paese. Vicino Catanzaro furono ingaggiati in un cantiere dove lavorarono duramente per la costruzione di un complesso di edifici popolari. Ci disse che le paghe erano bassissime e i turni di lavoro improponibili. Rocco, il capocantiere, era un uomo dispotico e insensibile. Non poteva restare ci disse; così, nonostante la consapevolezza di andare incontro alla fame lasciando un lavoro più o meno sicuro, decise di partire alla volta del nord, con l’idea di rinnovarsi. Bharat, il suo amico, restò giù e si lasciarono con la speranza di ritrovarsi un giorno a Roma in un ristorante di lusso. Nella grigia periferia di Milano salutammo il nostro amico, augurandogli buona fortuna e dandogli appuntamento anche noi a quel ristorante. Abhay annuì silenziosamente facendo un cenno col capo e ci strinse le mani; i suoi occhi neri erano già altrove. Scese lentamente dall’automobile e poi iniziò invece ad allontanarsi con una fretta inaspettata. Noi, prima di rimettere in moto, consultammo la cartina. Poi ci voltammo: in fondo alla strada due uomini salutarono Abhay e lo fecero poi salire a forza su un furgone. - Australia mood di Federica Brunini Niente e nessuno ti prepara all’incontro con la tua prima mandria di mucche. Nemmeno Randall the drover, il mandriano che mi aiuta a montare a cavallo offrendomi non la mano o la staffa, ma un gradino –sì, un gradino portatile- di plastica arancione e una manciata –scarsa- di consigli più adatti ad affrontare un disastro che un successo. Scruto l’orizzonte appena bagnato dall’alba dalla groppa del fido e canuto Daylight –sì, ce l’ho fatta, grazie al gradino-: i dorsi scuri delle mucche in attesa s’inerpicano l’uno contro l’altro come in una catena montuosa. E s’indorano alla luce del sole che cresce e tinge di giallo la terra bruna, la staccionata bianca, i jackaroos (i cowboys) che si scaldano in lontananza, come comparse -e invece sono i protagonisti-, i loro cappelli Akubra, i radi alberi che segnano il cammino. E poi si parte. Con un gesto, Randall dà il via alla Great Australian Outback Cattle Drive (lo spostamento della mandria). E nel teatro di Anna Creek, la tenuta più grande di tutta l’Australia, spalleggiata dal paese più piccolo (William Creek, 10 abitanti e un motel che funge da ristorante, bar, piazza, negozio di souvenir e ufficio postale nel nord del South Australia, oltre 170 chilometri da Coober Pedy e dalle miniere di opale), mucche e cowboy avanzano lungo la pista che non c’è, dentro il nulla che c’è: sabbia rossa, roccia, batuffoli di cespugli. E rami secchi e sinistri, spuntati, più che dalla terra, dalla matita di Bonelli & Galep. Porto le mucche davanti a me, poi di lato. Le lascio dietro di me quando seguo lo swagman aborigeno dall’andatura timida. Non sono riuscita a scambiare una parola con lui. Mi spiegano che, con le donne, gli swagman non osano parlare. E nemmeno con gli uomini, noto, se non sono jackaroos fatti e finiti. Mi sono svegliata alle quattro. Nel buio e nel freddo della tenda mi sono spogliata e rivestita: i pantaloni beige pelle di talpa A.R. Williams, i riding boots con il tacco che sposa la staffa, la t-shirt e la camicia a maniche lunghe per scongiurare il prurito delle mosche, il caschetto di sicurezza invece del cappello: non sono (ancora) una cowgirl, io. Anzi, una jilaroos, come dicono qui. E la rete che mi copre la faccia, a dispetto dai moscerini che tenteranno di avvicinarsi (la toglierò poco dopo, meglio i moscerini della vista a quadretti!). Sono tutto tranne che una donna da ranch. O da tenda. E da tutte e due le cose insieme. Ma, mentre cavalco, penso che “la vita, l’amore e le vacche” (dal titolo del celebre film di Ron Underwood) hanno qualcosa in comune, o almeno dovrebbero: la voglia- e la possibilità- di sconfinare lontano, con il cuore in gola che sale e scende al ritmo degli zoccoli, la capacità di lasciar correre (i cavalli, la mandria, i pensieri e sì, anche le mosche), la necessità di avanzare insieme, senza che ognuno rinunci alla propria voce (anche quando si tratta di un muggito nemmeno troppo elegante e di un ronzio irritante). Ed è allora che capisco le parole di Randall the drover, il mandriano: “mani ferme, briglie morbide, piedi nelle staffe, culo sulla sella. So far, so good». Proprio così: so far so good, fin qui tutto bene. A cavallo. E aggrappata alla vita. - Scozia di Federica Frascolla 20 maggio. Il treno corre veloce sulla tratta Newcastle -Edinburgo. Testa abbandonata contro lo schienale, immancabile Blackberry in mano, sono stanca, ho dormito poche ore per stare attaccata a quel maledetto whatsapp, che come tutte le droghe ti dà euforia al momento ma….ma poi il giorno dopo, quando hai un martello pneumatico che ti rimbomba contro le tempie e gli occhi cerchiati di scuro come un panda ti chiedi “ma perché?”. Già, perché hai passato ore e ore a chattare con quel ragazzo, il barista, consapevole del viaggio che iniziava il giorno successivo? Bella domanda. Guardo fuori dal finestrino e mi emoziono nel vedere il cielo azzurro, punteggiato da nuvolette bianche, innocue, non l’eterna lastra di granito che minaccia di scaricare una cascata d’acqua da un momento all’altro. Pioggerellina inglese? Semmai diluvio inglese sarebbe più adatto. Prima tappa: Edinburgh, solo qualche ora, non sono una gran fan delle città, ad essere onesti. Inizia il viaggio, quell’avventura da sola, insieme allo zaino che mi ha prestato Nico. Una nuova avventura per me, un nuovo cruccio per i poveri genitori che aspetteranno morbosamente notizie di quella figlia vagabonda che ha deciso di esplorare la Scozia da sola, con uno zaino in spalla. Scotland, I’m coming! Ore 12.00. Stesa su un prato verde quasi fosforescente, a godermi il sole, l’agognato sole. Non entrerò mai a visitare il Castello all’interno, i castelli mi piacciono da fuori, così imponenti, che dominano le città ma dentro…. Cosa ci sarà mai di così interessante nel vedere qualche stanza in cui, secoli fa, abitò qualcuno di a me sconosciuto? Ciao Castello, sei affascinante, fiero e maestoso sulla tua collina, ma preferisco mantenere il nostro rapporto su un piano superficiale. Molto più interessante (e decisamente faticoso) è stato salire sullo Scott Monument. 286 scalini a chiocciola con uno zaino più grande di me non sono proprio rilassanti, ma la vista da lassù ripaga la fatica. Meritato riposo e poi si va, destinazione Stirling. Willy Wallace Hostel. Eccomi a Stirling! Sono nella sala comune dell’ostello, un melting pot di persone assurde. C’è un tedesco che scrive serafico su un grosso diario. Un ciccione stravaccato sul divano che guarda la tv a tutto volume. Uno spagnolo che mi fissa. Altri tipi poco interessanti che vanno e vengono. E io? Faccio parte anche io di questo variegato mondo? Pare di sì. Ora….andiamo a esplorare Stirling! Cimitero sulla collina, con vista sul castello. Che pace… I cimiteri non mi fanno paura. Forse perché giocavo nel cimitero di Bellante mentre le altre bambine giocavano a Barbie? Intorno a me tanto verde… A volte mi dimentico di quanto sia bello questo colore. Stirling Bridge. La famosa battaglia di Stirling…. Io ne ignoravo l’esistenza fino ad oggi, ma il posto è molto bello. Einaudi nelle orecchie, sole, erba, il fiume che cammina pigramente…. Che pace, che pace. Ogni tanto penso a L., a come il nostro incontro abbia cambiato la mia vita… Ma no, non voglio pensarci, godiamoci questa pace!!! Ci sarebbe ancora il Wallace Monument da visitare ma…. Sento un dolorino alla gamba destra e nonsiamaimitornaildolore! Meglio avviarsi in ostello, la stanchezza si fa sentire…. Sono uscita a parenti con lo spagnolo. Non c’è niente da fare, gli spagnoli sono sempre gli spagnoli. Quando finisce di lavorare andiamo a farci un giro, a bere una cosa… Intanto chiacchiero con il tedesco dello zibaldone, è in viaggio per la Scozia qualche settimana, domani parte, mi ha dato un consiglio su un castello da visitare. Carino? Nah… Ecco. Non sono arrivata neanche da un giorno e già mi trovo in una situazione paradossale. Perché sono in un pub scozzese, con un 40enne pelato e sua moglie, sbronzi, a tracannare Whisky scozzese insieme a Pedro? O mio dio questo è alcol puro…. Se lo butto per terra ci lavo il pavimento, poco ma sicuro. Lo butto giù tutto insieme e la gola prende fuoco! Ecco qua, iniziamo. Inizio a sentirmi le palpebre pesanti, la mia bocca si schiude in immensi sorrisi con estrema facilità, la musica mi rimbomba nella testa. Ma dove sono? Chi è Pedro? Mi sento così allegra…. Via i pensieri, su i bicchieri! Barcollo per Stirling con il singhiozzo, a braccetto con Pedro, con troppi bicchieri di scotch in corpo. Se non mangio qualcosa gli vomito in faccia, giuro. Intravedo il primo posto lurido da post-discoteca, postsbornia, post-serate improbabili. Mi ingozzo con un veggie-burger e sì, me ne frego che le mani di quello che l’ha preparata non vedono il sapone dalla seconda guerra mondiale, e nemmeno mi interessa sapere cosa sto ruminando. Sta di fatto che dopo mi sento meglio. Ma…. O Cristo come faccio a levarmi di dosso Pedro? Si aspetta una notte fuoco e fiamme ma non ne ho nessuna intenzione. Ok, bene, sono fuggita in camera dopo averlo respinto per mezz’ora. La testa gira e gira e gira… E come sempre, in queste situazioni, una sola domanda nella mia testa: perché???? Bus Stirling – Perth. Chiacchiero con due vecchietti seduti dietro di me. Mi hanno adottato, come se fossi una nipotina. Ma come, viaggio tutta sola? Sì. Combatto con i postumi della prima notte scozzese e mi godo il paesaggio. Che sonno… Eccomi a Perth. Prima destinazione: Hungtintower Castle. Sì, mi sono persa. Ma che cavolo mi ha detto l’autista del bus? Mah. So soltanto che non sono mai arrivata a questo castello e ora sono sotto un sole cocente alla fermata del bus, mangiando una banana aspettando il bus per tornare indietro, bus che arriva tra più di mezz’ora. Ottimo! Scone Palace. Oddio ma questa strada non finisce mai! Sì, bello tutto questo verde, carine le mucche ma… dov’è l’ingresso del palazzo? Lo zaino mi pesa, fa caldo… Finalmente arrivoooo! Migliore amica con il bigliettaio, che mi lascia tenere lo zaino nel suo baracchino, mentre io giro. Bello Scone Palace, verde e curato… Un giro non troppo lungo, dato che mi aspetta il bus per Pitlochry. Chiedo a una coppia di vecchi di accompagnarmi alla fermata del bus, dato che non ce la posso fare a farmi anche il ritorno. Per fortuna mi scarrozzano. Bus, stazione, attesa del CityLink per quest’altra cittadina sperduta. Let’s go! Pitlochry. Un piccolo gioellino in un paesaggio da sogno. O è più da sogno quel biondo che ho intravisto alla reception?? Meglio se usciamo a fare una passeggiata. La diga. Sono incantata a vedere il lago a destra della diga, gli alberi che si riflettono sulle acque, le colline verdi che lo incorniciano… Rimango per non so quanto tempo in contemplazione. C’è talmente tanta bellezza nel mondo che mi manca l’aria. Costeggio la “scala dei salmoni”, ma sono più interessata al fiume e alla natura circostante. Mi siedo sul bordo del fiume e mi innamoro definitivamente di Pitlochry. Così verde, così rilassante, così pura. Mi irritano dei pescatori di salmoni sulla riva opposta. Guardo i salmoni saltare felici, nel loro ambiente e penso a come dev’essere ritrovarsi con un amo che ti trapassa la gola, mentre stavi semplicemente nuotando liberamente… Sono ancora più convinta di essere vegetariana. Ora torno in ostello, e prima mi compro qualcosa da mangiare. Attaccata alla wifi dell’ostello, eccomi lobotomizzata al cellulare, whatsapp con le amiche lontane. Ed ecco che entra nella sala comune il biondo. Oh Jesus Christ. Insieme a un altro tipo che non mi interessa. Lo scruto aldilà del blackberry e….dio mio se merita. Alto, gran fisico, biondo, ha l’aria un po’ rude e da stronzo. Io attacco bottone va bene? “Where are you from?”. Canada. Stiamo parlando da un bel po’, io lui e il fratello. Si sono laureati, hanno fatto questo viaggio in Scozia e Irlanda, domani tornano a casa. Io non sento nulla di quello che mi dicono, sono troppo ipnotizzata. Decidiamo di andare a berci qualcosa insieme, ok, corro a farmi una doccia, see you later. Ed eccomi di fronte a un momento estremamente difficile. Non ho niente da mettermi! Ma non come dico a Napoli, qui davvero ho tre magliette. Quella che ho addosso puzza, quella di Cip e Ciop che eviterei e una rosa. Per fortuna ho portato per ogni evenienza un jeans. Per fortuna c’è la matita nera altrimenti mi suicidavo. Eccolo. Perché si è messo questo orribile cappello in testa? Vaaaabbè. Seduti a un pub sotto l’ostello. Io sorseggio vino rosso, loro birra. Si chiacchiera, si ride, si scherza, serata molto piacevole. Oddio sto già al secondo bicchiere di vino. Si avvicina il cameriere, stanno chiudendo. Fair enough, andiamo. Seduta sulle scale a chiacchierare con il canadese. Il fratello si è volatilizzato. Mi propone di andare in camera. Ho un stanza condivisa con 6 persone e io sono l’unica ad occuparla. Si chiama caso o destino? Non ho tempo per farmi queste domande, l’unica cosa che vedo è il canadese seduto vicino a me sul letto con la testa a 5 centimetri da me. Ha voglia di baciarmi… OMMYGODDD. E’ la notte perfetta. La sa lunga il canadese, eh sì. Sa perfettamente come agire, come muoversi, quando spegnere la luce, quali tasti suonare. Io mi sento in balia delle onde, mi lascio cullare da quel movimento dolce ma deciso, accarezzando nella penombra il suo corpo marmoreo, quelle braccia muscolose, mentre mi sussurra le parole giuste nel tono giusto nel momento gius…. Sì, è tutto tremendamente giusto e perfetto e…. oh my god. Non esiste più nulla intorno a me, non mi importa che ho il ciclo, non mi importa che non lo rivedrò mai più, quello che voglio e che sto facendo è vivermi questa notte come se fosse l’ultima che mi rimane al mondo. Se n’è andato. Ho aperto gli occhi, lui non c’è. Ho cercato un biglietto, ce n’era uno proprio vicino la porta ma era una locandina senza senso. Hanno bussato alla porta, mi sono lanciata ad aprire ma era quello delle pulizie. Sono accasciata sul letto, confusa. Mi sento come dopo una sbornia, quando cerchi di ricucire i pezzi della serata in un unico racconto coerente. Se n’è andato. Volatilizzato, sparito. Si è preso quello che si è voluto prendere e se n’è andato soddisfatto. Posso essere volgare? Fuck off. Mi potresti dire il cognome di quei due ragazzi canadesi, perché gli vorrei mandare le foto che abbiamo fatto ma non me lo ricordo? Dico queste parole al tipo della reception e mi rendo conto di quanto sono ridicola. Ovviamente ci manca poco che mi fa una risata in faccia. Avallo le sue canzonature e rido, ma dammi quel fottuto cognome brutto idiota. Viva la privacy dell’ostello, ho il cognome! Sì ma… che gli scrivo a fare? E’ sparito senza lasciare traccia, quindi non vuole avere nessun contatto con me. Non gli scrivo. E prego di trovare la prossima Wifi il più tardi possibile. Certe notti somigliano a un vizio che non voglio smettere, smettere mai…. Bus Pitlochry – Inverness. Il paesaggio diventa sempre più bello, sempre più verde. Ma in quella collina vedo un ciuffo di capelli biondi. In quel prato in mezzo alle pecore degli addominali scolpiti. E in quel fiume un sorriso smagliante. Maledetto Canadese. Inverness. Ostello brutto, gente brutta. Ovvio, in questo momento voglio solo la piccola Pitlochry e… Sì, andiamo alla stazione, Lochness mi aspetta! Sento parlare italiano. Una coppia improbabile con zaini più grandi del mio e Lonelyplanet in mano. Siete italiani? Sììì anche tu? Lei con trucco osceno alla Amy Winehouse, lui decisamente più vecchio. Diventiamo migliori amici prima ancora che arrivi il bus. Il tragitto è bellissimo. Si costeggia Lochness, che non è una pozza grigiastra con mille negozi intorno che vendono pantofole a forma di mostro e roba simile. E’ una lago enorme, uno zaffiro incastonato in una corona di smeraldi. Mi sento rapita dalla bellezza di quello scenario. Beh, il mostro se l’è scelta bene la propria casa! Urquhart Castle. Il posto è suggestivo, magico. Cerco di immaginarmelo deserto, magari al tramonto o all’alba, senza turisti cretini che fanno foto a ogni pietra (me compresa). L’idea del “mostro” nel lago è affascinante, potrebbe esserci o forse no, chissà. Ogni leggenda ha un fondo di verità e, come tutte le leggende, si autoalimenta. Anche io, guardando le acque, vedo strani gorgoglii e ombre misteriose. Il potere della suggestione… La coppia italiana (milanese) è fantastica. Lui, che ha quasi 50 anni, conosce l’Asia come io conosco il mio quartiere ed ha ancora l’energia di girare la Scozia con lo zaino sulle spalle. Lei 34 anni, un po’ pazza ma simpatica. Sono felice di averli incontrati, ci stiamo divertendo molto. Mi hanno adottato come la loro figlioletta. Beh, di sicuro figlia di lui potrei esserlo. Bene, ho appena perso l’autobus delle 5 e il prossimo è alle 7. Tutto questo per mangiare patatine al bar! Ben fatto. Loro partono alle 5.30. Ah si? Cerco qualcuno che va a Inverness per scroccare un passaggio. Dopo 3-4 no, ce l’ho fatta. Una coppia di americani (lei altamente irritante, lui gentile e carino) mi hanno caricato su! Castello di Inverness. Il Castello non mi convince, ma la vista da qui mi piace tanto. Il fiume sotto, il verde intorno. Le costanti di questa vacanza. Mi godo l’ultimo sole da qui, ascoltando la musica, mentre i pensieri volano… Che beatitudine davvero. No vabbè, questo non posso sopportarlo. Camerata da 10 da dividere con….un indiano con piedi luridi che potrebbe essere mio padre?? E poi perché continua a parlarmi? Mi sto irritando. No io con questo da sola non ci dormo. Ora vado in reception a farmi cambiare la stanza perché così non dormo. A costo di dormire nella sala comune!!! Stanza cambiata. Ciao ciao indiano!!! Bus per Dornie, per visitare il Castello di Eilean Donan. Me l’ha suggerito il tedesco di Stirling, ha detto che dovevo vederlo! Quindi ho aggiunto questa tappa. Mi godo le Highlands scozzesi dal bus… Amo questi paesaggi, mi incanto a guardarli ogni giorno di più. Ecco Eilean Donan. Davvero bellissimo, sono felice di essere venuta anche qui. Forse sarebbe stato ancora più affascinante sotto un uggioso cielo grigio? Il sole è troppo bello per porsi questi interrogativi. Ci sono dei cani e mi manca Iris. Quand’è il prossimo bus per Fort William? Ore 16.39. Cosa?? E’ mezzogiorno e mezza. Cosa faccio in questo castello in the middle of nowhere per 5 ore? Mi sento male. Ore 16.30, aspetto il bus. Non so come sono riuscita a passare queste ore. Ammirato il castello, mangiato, preso il sole, passeggiato, scritto, letto, ascoltato musica, pensato. Ho fatto amicizia con uno strano tipo americano che mi ha fatto delle foto sotto al castello con la sua macchina fotografica super professionale. Ho buttato 1£ per avere 20 minuti di connessione. Sì, era per vedere se il canadese mi aveva scritto lo ammetto. E no, non lo ha fatto. E’ in viaggio, non ha visto facebook, ecco. Chilometri e chilometri di Scozia, dal mio Citylink giallo e blu mi godo i paesaggi scozzesi. Colline verdi a perdita d’occhio, dove brucano greggi di pecore soffici e bianche. Vedo tanti agnellini che vorrei abbracciare e coccolare e sono felice di non mangiare più animali morti. Il sole continua a splendere. Forse non è la Scozia convenzionale, ma a me questa indigestione di verde brillante piace tanto. Fort William, Backpackers hostel. Siamo ai piedi del Ben Nevis, il monte più alto d’Inghilterra. L’ostello (carinissimo) è pieno di alpinisti fomentati e sportivi di ogni genere. Ho scoperto che la gente usa Fort William come base per escursioni, scalate, giri in bicicletta ecc. Io mi sento una pigrona in mezzo a tanti atleti. La posizione dell’ostello è bellissima. Ancora verde, verde, verde, ancora pace dei sensi. Ho fatto amicizia con le mie compagne di stanza. Una ragazza argentina che studia in Svezia. Due ragazze francesi di Parigi in viaggio on the road. Due tedesche. Mi fanno i complimenti per il mio francese e mi sento fiera. Cerco di vedermi dai loro occhi. Un’italiana laureata fuggita a Newcastle per qualche mese che gira da sola per la Scozia con una tuta e uno zaino. Wow. Ore 10.10, salgo a bordo del trenino a vapore di harry potter. Mi sono fatta fregare da una trappola per turisti? Mi sono dissanguata per farmi fottere? C’è una ragazza seduta vicino a me. Viaggia da sola anche lei? Compagni di viaggio improbabili quanto simpatici. Liselott, Svezia, e Jack & Lynn, una coppia di mezza età in giro con il camper. Il treno è caro, ma ammetto il suo fascino. Lo sbuffo della locomotiva a vapore, la fuliggine che entra e i paesaggi…. Mi sento come se questo treno mi stia portando indietro nel tempo… Ci avviciniamo al mare, che è azzurro cosparso di pagliuzze dorate del sole che si riflette sulla superficie. Siamo passati sul Glennfinnan Viaduct e mi sembra di poter vedere Harry Potter da un momento all’altro che passeggia per il treno. Ammetto che anche io ho fatto la turista esaltata che scattava diecimila foto prendendosi a pugni per ritagliarsi uno spazio vicino al finestrino. Direzione Mallaig… Lynn sta facendo un servizio fotografico a me e Liselott. Io, vicino alla sua pelle candida mi sento un camionista con la pelle bruciata dal sole. Mallaig. Sembra un piccolo villaggio di pescatori, non c’è nulla da fare, se non respirare aria di mare, godersi il sole e prepararsi alle altre 2 ore nel trenino. Il ritorno è decisamente più pesante. Fa caldissimo nel treno ed il paesaggio è lo stesso dell’andata. Io e Liselott iniziamo a sognare il teletrasporto. Ostello. Liselott è stata qui un’oretta prima di andare a prendere il treno per Edinburgh. Sto chiacchierando con Rachel, un’altra compagna di stanza. Paragonata a lei mi sento banale e scontata. Viene dal Canada (un posto a caso), ha 19 anni e fa un viaggio tipo me…. Ma molto più lungo e a tratti in autostop. Mamma hai sentito? Al peggio non c’è mai fine. Qui c’è un suo amico del Canada, che lavora per una compagnia che organizza attività sportive. Sto chiacchierando con lui, Dan, è simpatico. Ormai è quasi buio, abbiamo acceso un falò nel terrazzo dell’ostello e c’è un’atmosfera magica. Il sole sta scomparendo dietro le colline e una notte soffice come il velluto sta inglobando tutto. Amo vedere il fuoco crepitare. Dan mi sta fissando. Ecco che si siede vicino a me, dice che era controvento per il fumo… Ci hanno improvvisamente lasciati da soli. Chiacchieriamo, la notte è magica in quel pasino sperduto tra le highlands scozzesi. Siamo rimasti a parlare fino all’1.00, poi siamo andati a dormire, mi ha abbracciato e nulla di più. Forse questo ha reso la serata ancora più magica. Una tipa con cui divido la stanza russa come un trombone, o come la locomotiva di oggi, e non riesco a dormire. Sto per commettere un omicidio, giuro. Se le tiro una scarpa in testa come reagisce? Loch Lomond. Ultima breve tappa, si torna a casa. Con quel senso di tristezza che si impossessa di me ogni volta che finisce un viaggio. Quando hai la consapevolezza che hai vissuto un’esperienza unica, irripetibile. Quando sai che tutte quelle situazioni, quelle persone, quelle coincidenze, non si ripeteranno mai più. Cammino con i piedi nell’acqua, giocherellando con i sassi. Ripenso a tutte le persone incontrate, dai personaggi più importanti agli incontri sugli autobus, sui treni, nei luoghi più disparati. Ogni posto, ogni persona adesso fa parte di me, in qualche modo. E’ così che mi sento, adesso. Un mosaico di 24 anni, fatto di tutte le esperienze, di tutte le persone incontrate, che mi hanno reso, nel bene e nel male, la persona che sono adesso. Un’onda più forte si infrange sulle mie gambe, bagnando il bordo della tuta arrotolata sulle ginocchia. Guardo l’orologio, tra poco arriva il pullman per Glasgow, è ora di andare. Rimetto lo zaino sulle spalle, il mio compagno di viaggio, e mi avvio verso la fermata. E adesso, più che mai, ripenso alle parole di quel Proust, che piace tanto a papà: “L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi”. Grazie, Scozia. - I treni di Tozeur di Federico Carpino Non ho mai ascoltato la musica di Franco Battiato. Non so nemmeno dire se LEI sappia chi sia. Conosco un paio di sue canzoni, ma di certo “I treni di Tozeur”, rimarrà per sempre legata al nostro viaggio in Tunisia, da nord a sud, da ovest a est perché come ripetiamo spesso: “Le giornate qui non finiscono mai, ci sono ancora chilometri da fare e cose da vedere”. Condividiamo gli auricolari del lettore mp3, uno ciascuno. Lei appoggia la testa sulla mia spalla e inizia la canzone. L’avevo scelta prima di partire, con l’intento di ascoltarla quando saremmo stati sul treno. Ora siamo su quel treno, da Tozeur direzione Kasserine. Prendo posto accanto al finestrino, c’è un luogo da raggiungere, il sole alto, vetri opachi che si aprono su una terra sconosciuta e c’è LEI seduta accanto a me. Tutto è esattamente come avrei voluto che fosse. Potrebbe sembrare scontato, ma non lo è. Il treno si muove, ci guardiamo attraverso gli occhiali da sole senza sentirci obbligati a fare conversazione. Mentre Battiato canta, realizzo quanto sia lento il treno di Tozeur che ferma a ogni stazione e in ognuna raccoglie uomini, donne, bambine con lo smalto mangiato sulle unghie, venditori di fiori, vincitori e perdenti. Non è il momento migliore per muoversi in Tunisia: la guerra civile ci sfiora e così il fantasma della Rivoluzione dei Gelsomini del biennio precedente. Tunisi è costellata da militari e lungo tutta Avenue Bourguiba i fili spinati costringono a scegliere strade alternative. Di fronte, una donna sulla cinquantina tiene braccio una bimba addormentata nonostante il vociare degli altoparlanti alle stazioni, cullata dal movimento sussultorio del treno. Per terra, sui marciapiedi ci sono vetri, macerie e file di sacchetti traboccanti di sporcizia lungo tutta la tratta dei binari. La donna è scalza e questo mi colpisce, mi osserva e dice qualcosa che non capisco. LEI mi siede accanto e traduce senza indugio: “Vuol dire Rivoluzione”. “Revolution” replica in francese la straniera scandendo ogni sillaba. “Questa è solo una conseguenza della Revolution, le strade non le puliscono più. I soldi se ne sono andati”. Il vagone si riempie, un bambino trova posto tra il bracciolo e le mie gambe fissando un sacchetto di pistacchi che sporge dalla tasca dello zaino. Pochi istanti dopo è nelle sue mani e la straniera scomparsa. La gente parla lingue che non mi sforzo di capire, mi soffermo sulle persone in abiti colorati, sulle file di alberi che accanto ai finestrini schizzano via veloci, mentre i campi all’orizzonte rimangono più a lungo davanti agli occhi. Qual è lo scherzo della mente che fa dimenticare persone, eventi, date, ma fissa nitidamente un viaggio in treno simile a tanti altri? Il suo essere semplice e desiderato, un viaggio-rifugio per gente complicata come me, quando musica, parole e persone si combinano toccando le corde giuste dell’animo e l’eco del ricordo vince la sfida del tempo e della memoria. - Monument Valley di Federico Carpino Al confine tra Utah e Nevada c’è la Monument Valley, icona west caratterizzata da cime di pietra rese celebre dalla cinematografia western americana. Avevo ventuno anni, Andrea diciannove ed era il primo lungo viaggio di due amici che si sono sempre sentiti fratelli senza essere nemmeno parenti. Eravamo partiti da San Francisco, sognavamo l’arrivo a Santa Fe, mentre New York ci aspettava con le sue luci e le sue guglie. Nella cittadina di Bluff, in Utah, ci imbattiamo in un gruppo di turisti europei, facciamo conversazione, uno di loro scherza sul fatto che mancano italiani al gruppo e ci offre un passaggio. L’autista del pullmino guida lungo l’US 163 Scenic Byway, sessanta miglia che gli americani definiscono “dramatic views”, una strada lunga e dritta nel cuore del territorio Navajo. Là è dove devono andare loro e dove vogliamo arrivare noi, per trascorrere la notte sotto il cielo stellato sulla sabbia calda e rossa. Accanto a me siedono Andrea e una signora olandese, Wilma, una di quelle facce di chi ha trentacinque anni, ma ne dimostra cinquanta. Parliamo, inciampo sulla pronuncia di alcune parole, ma l’entusiasmo vince e la conversazione s’infittisce. Guardare fuori dal finestrino ascoltando lingue diverse offre una sensazione liberatoria: osservo quei volti capitati per caso nella vita sapendo che sarà per poco tempo e mi sforzo di imprimerne il ricordo senza badare troppo ai nomi. Fuori è un enorme set western: terra rossa, sole implacabile e pietre cotte dal sole, le ruote affondano lente nella sabbia con lievi sbandate che ci fanno dondolare. Le ombre si allungano, il pullmino si ferma: da lì in poi il nostro viaggio si divide. Andrea ed io ci affidiamo a un gruppo Navajo che ci condurrà a cavallo nel cuore della Valle. Il pullman carico di bagagli, persone e tende si allontana sollevando un polverone brillante, qualcuno si ferma e quelli che hanno preferito sistemazioni più comode, forse li rivedremo domani. In alternativa, il mio amico ed io troveremo un altro passaggio e tutto ricomincerà da capo con la sensazione di poter inventare il viaggio giorno per giorno. E’ difficile descrivere cosa accadde quella sera sopra le nostre teste nel cielo della Valle, ho perso il conto delle stelle, mentre la Via Lattea sembrava una secchiata di vernice bianca su una quinta di velluto nero. La terra era il mio letto e il deserto il mio cuscino. Mentre mi giravo e chiudevo gli occhi, un Indiano che muoveva le braci sul fuoco disse semplicemente: “Guarda questo cielo e queste rocce. Una notte come questa non la rivivrai mai più”. A vent’anni il mai più suona diverso rispetto a oggi. Sono passati molti anni da quell’estate, ho visto altri cieli stellati, altre albe, altri deserti, ma spesso, quando preparo le valige e guardo le foto sbiadite sulla parete, la mia mente ritorna là, a me e Andrea con uno zaino sulle spalle e in faccia la leggerezza dei vent’anni. - Erasmus: un viaggio chiamato vita. di Francesca Aveta Spesso penso alla mia vita come ad un puzzle in cui ogni tassello rappresenta una persona, un incontro, un’emozione, un viaggio, un obiettivo da perseguire. Ci sono tasselli che si scelgono, che si reputano fondamentali, essenziali, alcuni che si cercano disperatamente. Basta perdere uno di essi per sentirsi incompleti, indifesi e talvolta è come se tutto ciò che si è costruito risultasse insensato. Altri tasselli, invece, hanno l’incastro giusto come il “mio Erasmus” e restano per sempre lì, iniziano a dar forma a quell’immagine, quel percorso chiamato Vita. Tutto è iniziato quattro anni fa, nel settembre 2009, quando vincitrice del bando Erasmus - ricerca tesi, partii per Barcellona ignara di vivere un’esperienza unica ed indimenticabile che mi avrebbe cambiato la vita. Molti miei amici, ex erasmusiani, mi avevano raccontato della loro esperienza ma soltanto vivendo la quotidianità tutto iniziò ad avere senso, a prender forma e quella paura e solitudine iniziale che mi aveva assalita nei giorni pre partenza si stava trasformando come per magia in una voglia irrefrenabile di vivere, di emozionarmi, conoscere nuove persone e condividere con loro qualcosa a me ignoto che non riuscivo a spiegare a me stessa. Cresceva in me giorno dopo giorno una grande desiderio di conoscere il mondo, quello che mi circondava, di emozionarmi, di incuriosirmi per ogni piccola cosa, e settimana dopo settimana tutto acquistava valore ed apprezzavo cose alle quali prima neanche pensavo. Condividere casa con ragazze e ragazzi, spesso anche più maturi della mia età e provenienti da tutto il mondo, mi ha insegnato ad ascoltare, conoscere culture, usi e costumi diversi, condividere nuove aspettative ma principalmente vivere qualcosa di magico ed indescrivibile a parole che in tutti è nascosto in fondo al cuore, di cui probabilmente si ignora l’esistenza ma che ognuno necessita del proprio tempo per scoprirlo al momento al giusto e trasformarlo in una risorsa preziosa. Un viaggio perfetto, il mio viaggio perfetto, un susseguirsi di emozioni, di profumi, un esempio di mera condivisione che porto e porterò sempre nel cuore perché mi ha cambiato la vita nel vero senso della parola, mi ha aperto gli occhi insegnandomi nel guardare al mondo con un’altra luce, abbattendo i pregiudizi di cui ciascuno di noi è ahimè prigioniero e proprio come accade per migliori film a lieto fine, l’Eramsus mi ha regalato anche l’Amore. Napoli, 30 Ottobre 2013 - Moon River di Francasca Battisti Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end waiting 'round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Il viaggio era iniziato all’alba. Cantavamo canzoni sciocche, ridevamo di niente, cercavamo di stare al passo della persona che avremmo voluto prendere per mano… e si dimenticava la fatica, inseguendo desideri. Qualche ragazzina ricamava discorsi da donna che qualche ragazzino trasformava in scherzi da bambino. Il bivacco era sulla vetta, senza elettricità né gas. Avevamo cenato a lume di candela: salsiccia e polenta abbrustolite sul fuoco vivo erano un piacere più intenso da gustare. Di tanto in tanto qualcuno doveva uscire a pompare l’acqua alla fonte, riparato solo da una trapunta di stelle, odorosa di fieno. Improvvisamente, e continuamente, mi accorgevo. Di tante cose che la repentina quotidianità ti strappa dagli occhi non appena le incontri con lo sguardo. Per dire… quella sera di dieci anni fa mi accorsi che mi erano occorsi diciott’anni per scoprire le stelle: succede, quando nasci nella brumosa e confusa pianura. Palpitavano attorno a uno sbuffo di luce celeste che esalava come se l’universo da qualche parte si stesse spegnendo dopo un incendio lontano: la Via Lattea. Una trentina di ragazzetti si stringevano nei sacchi a pelo esitanti, mentre una voce raccontava storie e ognuno di noi assaporava la propria. Intrufolandosi nella mia, una mano inattesa, segretamente, la fece nostra. Non era più freddo là fuori, eppure tremavo: traboccarono comete, come commossi fuochi d’artificio e la notte si fece giorno, folgorandomi l’anima di estasianti promesse. Su quella cima del mondo, avevo raggiunto la vetta della mia vita: l’istante prima della Felicità. C’è solo un istante così nella vita, chissà se tutti hanno la fortuna di coglierlo: il mondo si paralizza per godersi lo spettacolo e tu ti prepari ad assaporarlo il più lentamente possibile, non sai come, ma vuoi guardarlo negli occhi quel momento, guardarci dentro il più a lungo possibile fino a che la tua anima non esploderà in mille pezzi perché quell’energia è più forte di lei, più forte di tutto…non ci sarà nulla più di quello, e va bene così, perché è tanto più di ciò che avresti immaginato. Arrivare esattamente dentro quel momento, quella è la tua storia; tutto il resto che accadrà dopo, non avrà nessuna importanza. Quel viaggio fu le più belle lacrime mai piante, le corse per mano giù al torrente, dove noi, solo noi… Albachiara sussurrata tra i baci eterni, gli abbracci distesi sul ponte di legno fino a che la luna non lasciava posto al sole, soffocanti come se a sentire un po’ di dolore, almeno quello, potesse marchiarti il cuore e non svanire mai. In quel pezzo di mondo, due anime gemelle attraversavano l’arcobaleno. Lontano, un carillon aspettava, sullo scaffale di un negozio, di poter suonare la loro storia. - Paris: la vie en.. Blanc! di Francesca Cataldo 19 gennaio 2013. 6 persone ed un piccolo cuore che scalciava in grembo. Partenza ore 8.30. Destinazione Parigi. Nessun racconto o narrazione può rivelare a pieno le emozioni e le sensazioni che provavamo durante il check in. Il viaggio atteso da mesi che tardava ad arrivare, il viaggio tanto agognato soprattutto da noi 3 fanciulle desiderose di vivere il sogno parigino più di ogni altra cosa, il viaggio di condivisione, di esperienza, di crescita, di romanticismo. Atterriamo a Beauvais sfiorando i 2 gradi e con gli occhi colmi di stupore: davanti a noi uno spettacolo senza eguali. Era tutto innevato, bianco e soffice come un mantello. Giunti in centro, armati di reflex e telecamera, Parigi continuava a coprirsi di candidi fiocchi bianchi, assumendo una veste sempre più pittoresca e candida. Né il freddo gelido, né la strada scivolosa, né la bufera di neve, né i tanti km macinati sotto i piedi, hanno ostacolato la nostra avventurosa vacanza. Come mai abbiamo scelto proprio gennaio per visitare Parigi? Forse perché la neve la rende più bella e romantica? O perchè avevamo giorni di ferie? E No! Semplicemente perché per 6 giovani ragazzi trovare volo e hotel ad un prezzo così vantaggioso è un’occasione da non perdere! (Ora comprendiamo il perché di quei prezzi). Ma Parigi in quella veste di dama bianca non è uno spettacolo per tutti, è riservato a quei pochi che pur con le temperature sottozero hanno assaporato quella vacanza in ogni più piccola sfumatura, con la certezza di aver vissuto un’esperienza irripetibile. E come dimenticare l’odore delle baguette che le boulangerie sfornano ad ogni ora, dei polletti arrosto con contorto di pommes frites che attirano qualsiasi passante anche il più vegetariano, la splendida Basilica du Sacre Coeur a cui piedi sorge tutta Parigi, Montmartre e la suggestiva via degli artisti, la mini crociera sulla Senna con pranzo a bordo sotto i fiocchi di neve, Il Museo del Louvre e la sua maestosa bellezza, il Quartiere Latino e la movida parigina, i ristoranti italiani con proprietari e chef giapponesi, la giostra di Ameliè tra favola e realtà, Notre Dame e la favola de ‘la Bella e la Bestia’, la Reggia di Versailles e la sua spettacolarità, e poi c’è lei.. Bellezza indiscussa e simbolo della Francia: la Torre Eiffel. Passi anni a sognare di salire fin lì su a qualsiasi costo e poi ti accorgi di aver diritto addirittura al biglietto ridotto, perché minore di 25 anni. Da lì su ai tuoi piedi.. la capitale indiscussa dell’amore! “Parigi racchiude da sempre dentro di sé un mito, o meglio è essa stessa mito: il mito di una capitale eterna ed eclettica, di una metropoli cosmopolita e pulsante, di un luogo dove ogni cosa diventa possibile; il mito di una città aperta e moderna in cui i sogni sembrano più concreti, a un passo da noi, quasi da poterli sfiorare con un dito”. 5 giorni. 6 cuori +1 che battevano felici. Questo è il mio viaggio, il mio racconto che ha suscitato ricordi, sorrisi ed un pizzico di nostalgia, il viaggio vissuto come arricchimento e scoperta, il viaggio inteso come realizzazione di un sogno.. verso quella città che ha regalato talmente tante emozioni da non vedere l’ora di andarla a ritrovare. - Il capitolo mancante di Francesca Mereu LʼAsia: Cina, Giappone... quanto se ne parla! E la Corea del Sud? Il non conoscerla ci ha richiamato come un canto di sirene. Noi, gli irriducibili delle vacanze con formula “gruppo organizzato con accompagnatore” fin dal viaggio di nozze, e votati alla prudenza: ma non questa volta. Tour verso la Corea del Sud? Pochi e costosi. I coreani parlano poco lʼinglese, comunicano in lingua coreana e con il misterioso alfabeto hangul. “Andiamo!” Scelto lʼhotel, studiato le Guide turistiche, interrogato il web, e via, in volo verso Seoul: una città che ci ha spalancato le porte mostrandoci la bellezza dei suoi luoghi, delle sue persone e conquistandoci fin dal primo inchino gentile che ci è stato rivolto appena scesi a terra. Le Guide di viaggio descrivono il connubio tra tradizione e modernità caratteristico di Seoul: tutto vero. Come da copione, abbiamo incontrato il fascino dellʼantico nei templi, nei giardini, nelle case tradizionali Hanok dove si cammina scalzi. E abbiamo trovato la modernità nei palazzi di Gangnam, nei centri commerciali avveniristici, nellʼimpronta tecnologica che pervade la città. Come raccomandato, abbiamo vissuto anche lʼemozione della visita alla zona demilitarizzata tra le due Coree. Le Guide però non dicono tutto: forse il capitolo sul popolo coreano manca per non rovinare la sorpresa! Nei coreani abbiamo trovato: GENTILEZZA, ORGANIZZAZIONE, ACCOGLIENZA, anche nei gesti più semplici, come quello di offrirci in omaggio sorrisi, materiali informativi e bottigliette dʼacqua per dissetarci durante la visita allʼassolato villaggio Hanok. RISERVATEZZA e TRANQUILLITAʼ, che fuori casa ci hanno fatto sentire a casa. Eravamo tra i pochi italiani a Seoul, ma non abbiamo suscitato curiosità inopportuna: nessun occhio a mandorla si è soffermato un attimo di troppo su di noi, se non per aiutarci in caso di necessità. IMPEGNO e ABNEGAZIONE. Che ammirazione: i coreani studiano e lavorano sodo. Impossibile, per noi, non tifare per il futuro degli studenti, immersi nei libri nei locali, e non provare tenerezza di fronte agli impiegati assopiti sui tavoli, vinti dalla stanchezza prima del rientro in ufficio dopo la pausa pranzo. ORIGINALITAʻ. Particolari, gli amici coreani, La loro vena di “follia buona” risulta di una simpatia disarmante: abbiamo osservato con interesse il loro amore per il cibo da strada, il loro affollare le strade, mai chiassosi, sorseggiando gli amati bibitoni, con i grandi cellulari sempre stretti in mano, qualunque cosa accada. Questo popolo dalla forte personalità celata dietro un agire pacato, ci ha conquistato, arricchito e un poʼ contagiato. Oggi siamo più tolleranti e più fiduciosi negli altri. Per esempio, abbiamo creduto al commesso coreano che a gesti ci assicurava che quegli strani cellulari avrebbero funzionato anche in Italia. E funzionano! Quindi, sapete? I 9.300 Km e più che separano lʼItalia dalla Corea non sono tanti: una volta che ci sarete andati, anche voi sentirete la Corea molto vicina. - Storia di Zaya, signora delle renne di Francesca Spatola “Ben arrivata”, dice Zaya. Su di un telo per terra ci sono due tazze d’infuso d’erbe e piccole forme di formaggio di renna. É pieno agosto. A più di 2.000 metri di altezza, nell’incanto dei monti Sayan in Mongolia, ci arrivi cavalcando per nove ore attraverso la palude, la foresta e il ghiacciaio. I cavalli mongoli alla fine quassù ti portano, ma non prima di avere cercato di liberarsi dalla stretta del morso ogni 10 metri: non sono abituati a essere domati, di solito trascorrono i giorni correndo per conto loro nella steppa. Zaya è sotto la sua tenda. E’ un tepee fatto di tela che riesce appena a proteggere dal vento estivo ma gelato; al centro arde una stufa di ferro, e sopra c’è una pentola con dentro del pane. Lei ha 25 anni, è robusta, con la pelle segnata dal sole. Porta una felpa di pile rossa. Parla l’inglese molto bene. “Dove l’hai imparato?”. “Non sono di qui - spiega - sono nata in una famiglia benestante, di Ulan Bataar, la capitale e ho studiato antropologia in una università privata degli Stati Uniti”. Non è proprio quello che ti aspetti da una persona che vive su una montagna della Mongolia. “Cosa ci fai qui?”. E racconta, come se non fosse niente di straordinario: “Sono venuta per studiare il popolo Tzaatan, che in mongolo vuol dire ‘uomini renna’. Mi sono innamorata di questa comunità che vive in simbiosi con la natura, lontana da tutto quello che per voi è ‘tutto’: i negozi, gli uffici, internet”. Arrossisce un po’ e prosegue: “Poi, mi sono innamorata di un ragazzo, sì un ‘ragazzo renna’, e ho sposato questo modo di vita. Non è facile. Siamo poco più di cento, e senza aiuti statali abbiamo difficoltà a sopravvivere. Ogni anno ci chiediamo se supereremo l’inverno”. Si soffia fra le mani, screpolate, e aggiunge: “Le renne sono la nostra unica fonte di sostentamento, qui ne abbiamo un centinaio ma ogni anno diminuiscono; si ammalano e diventano preda dei lupi”. Ti porge una fetta di pane e va avanti: “Riusciamo a scendere a valle raramente, quando qui arriva qualche turista, gli vendiamo i nostri pugnali ricavati delle ossa e così possiamo permetterci qualche medicina per noi e per gli animali”. Il posto è incantevole, ma come può non mancare l’effervescenza di una città o la sicurezza scontata di un appartamento in muratura? Zaya risponde con un’altra domanda, dietro il sorriso lieve: “Tu sei mai stata felice, ti sei mai sentita parte del tuo ecosistema?”. “Raramente”. Ti fissa, ti capisce, e dice: “Qui sono felice tutti i giorni dell’anno, e sento di essere utile alla difesa di questo territorio. I miei genitori non hanno mai approvato la mia scelta; non mi parlano più ma io sono convinta di quello che ho fatto”. E’ incinta. In autunno dovrà scendere a valle, come da tradizione, per partorire in una casa di legno e non di tela. Tornerà a primavera, madre. L’infuso di erbe è ancora tiepido, sa di montagna, rigenera. Fuori dalla tenda c’è un silenzio sovrumano. Tranne quel fruscio. Il gruppo di renne che passa accanto. - Strani suoni a Berlino di Francesco Tescione Una mattina di dicembre 1989. Freddo. Pollice ghiacciato. Servirebbe un guanto, ma... Fantolino (che sarei io) e Pupona (la mia cara compagna di viaggio) sono sulla strada, fanno l'autostop sul GRA di Roma, come meta hanno Berlino. Son più di 2000 km! I primi passaggi vanno bene, arriviamo “giù” a nord in serata. Poi più nulla. Siamo in un autogrill, ci riempiamo di caffé e altre bevande calde, ma nessuno ci prende su, anche se chiediamo a tutti gli automobilisti. Decidiamo così di provare a dormire arrangiandoci in un locale in costruzione, semi aperto, senza vetri alle finestre. Inutile dire del freddo, sensazione che ci accompagnerà per tutto il viaggio... Mentre noi tribolavamo 'on the road', alcuni conoscenti pugliesi, che studiavano a Roma e con i quali avevamo realizzato un video non proprio riuscito, sarebbero arrivati qualche giorno dopo a Berlino con l'auto. Erano come noi dei 'permanent vacation' ma con più soldi. Ci svegliamo da un 'sonno' guardingo e non sereno, torniamo al bar dell'autogrill, finalmente troviamo un passaggio fino a Salisburgo. Mozart ci assiste! Poi altre ore a vuoto, finché... la pupona mi chiama, il suo pollice ha colpito ancora. Un austriaco alla guida di un furgone un po' scassato è disposto a portarci fino alla nostra meta. Giuro che “Berlin” è stata l'unica parola da lui pronunciata in tutto il viaggio! Dicevamo 'un' austriaco, ebbene: quando la mia amica fa per entrare, quasi le viene un colpo: sdraiato sui sedili posteriori giaceva un morto. Cioè, no... non era ancora morto, russava... era il secondo austriaco. Così la pupona si accomoda davanti e a me tocca il tipo in coma. L'autista guidava, guidava e non parlava. Dopo un po' di km la pupona mi chiama e mi dice di avere freddo: ci credo, c'era un buco sotto il cruscotto e da lì entrava un'aria gelida. Quei due erano proprio fuori, o sotto acido. Cambiamo posto, ora sono io a gelare e lei a cuccarsi il crucco. Finalmente arriviamo alla dogana di Berlino, lì perdiamo un sacco di tempo e cominciamo a sospettare di quei due, dei loro documenti e... un momento: e se fossero i nostri a non andare bene? Per fortuna poi ci lasciano passare. Non ricordo bene se l'autista rispose al nostro saluto e ai vari 'dankschen'. Chissà se il suo amico si è mai svegliato... Eccoci a camminare in mezzo alla neve, dopo due giorni di viaggio, stanchi morti, entrare in una apoteke e con gesti e circonlocuzioni in italiano e in inglese da viaggio provare a spiegare il problema della pupona: “the girl has a problem on the bottom” e altre cose del genere. Ad un certo punto il farmacista esclama: “ahh, emorroid!” e ci dà una pomata. Paradossale! Ricordo ancora le risate a sganascia. Subito dopo presso un'agenzia troviamo una stanza per la notte, non ci andava di rimanere a casa dell'amico tedesco dei baresi, che eravamo andati a salutare, avendo in tasca il suo indirizzo. Ci avviamo verso la metro e lì avviene l'irreparabile: dopo due treni pieni che lasciamo passare, ne arriva un altro e lei, stanca, stressata e dolorante, lo prende, mentre io stavo dicendo: “aspettiamo ancora, è pie... cazzo! Si erano già chiuse le porte. Le metro tedesche sono implacabili... Vedo andar via la mia amica e penso come nel film “Sliding doors” come sarebbe andata se io mi fossi infilato nel vagone o lei mi avesse ascoltato... Fra l'altro ci eravamo scambiati gli zaini, visto che il suo era più pesante e lei non stava proprio bene. Lei quindi aveva i miei documenti, tutti i nostri soldi e le mie mutande... non ricordo più chi avesse l'indirizzo della pensione. Comunque lei non ci andò, come mi avrebbe raccontato il giorno dopo, ma passò la notte allo zoo di Berlino, cioè alla stazione, dove fu anche importunata. Piccolo particolare: non esistevano ancora i cellulari. Io dopo aver inutilmente tentato di convincere un addetto del metrò un po' nazista a comunicare un messaggio per la mia amica perduta, dopo aver aspettato invano diverse metro, con la speranza che lei sarebbe tornata indietro, cominciai a vagare per la città, affamato e stanco. Decisi di andare dal berlinese, mi ricordavo la strada, ma non lo trovai in casa. Davanti a un pub mi si parano davanti degli stronzi ubriachi che mi provocano in tedesco, sfottendomi penso per il mio aspetto e la faccia disperata. Io mi fermo, li guardo e con un gesto li mando a cagare! Loro, incredibilmente, invece di pestarmi mi fanno passare. A quel punto con i pochi marchi che ho in tasca entro in quel fottuto pub e mi prendo una birra. Indovinate dove ho trascorso la notte? In un portone dentro il sacco a pelo di pupona. Mi ero appena addormentato che si apre il portone e chi ti entra? Il padrone del pub! Ci guardiamo nella penombra dell'androne, io accenno qualche scusa, lui se ne va per le scale. Non penso che mi avesse riconosciuto come un suo cliente, comunque non chiamò la polizei. Io mi rimisi a dormire. Il mattino dopo, qualche vicino dell'amico dei baresi, che nel frattempo erano arrivati in città, pensò invece di chiamare la polizia, per l'auto con targa italiana parcheggiata un po' male. Delatori! Inutile dire la gioia nel ritrovare la pupona sana e salva, che per fortuna era tornata là anche lei. Poi il viaggio avrebbe riservato piacevoli sorprese: la casa in affitto a Kreutzberg, il nostro sganciarci dopo i litigi con gli altri italiani, l'incessante ticchettio degli scalpellini del muro, di cui forse non si voleva che restasse traccia (fra l'altro io non presi nessun pezzo di quel maledetto muro, visto ciò che rappresentava e il sangue che lo ricopriva, più persistente dei colori dei graffiti; la pupona ne comprò un frammento: è il business, bellezza!). Che dire della gioia immensa nel vedere i berlinesi dell'est abbracciare quelli dell'ovest, i soldati in lacrime, la festa infinita di quei giorni. E poi la passeggiata oltre la porta di Brandeburgo, la desolazione triste dei quartieri di Berlino est, i grandi palazzi antichi che ci osservavano, la cioccolata scaduta, le lettere che io inviai a due donne importanti della mia vita e che pensai di avere scambiato mettendole nelle buste, perché al mio ritorno la ragazza con cui stavo mi guardò con durezza e poi aggiunse: è una lettera fredda! In effetti quella calda l'avevo scritta all'altra e questo mi fece capire che l'amavo ancora. Infine, il ritorno. A causa del freddo decidemmo, dopo aver 'autostoppato' fino a Innsbruck, di prendere un comodo e confortevole treno, pagando il biglietto con gli ultimi soldi rimasti. É stato sicuramente il viaggio più folle, incredibile e divertente che abbia mai fatto. La pupona sarebbe diventata la mia migliore amica e anche se negli ultimi anni ci siamo visti poco, le voglio molto bene e le dedico questo racconto. Tolfa, 27 settembre 2013 - Solo per la Libertà d’essere essenza. di Gaia Di Benedetto Vedersi vivere, senza legami, senza invenzioni. Fare parte del vero, del vivo, di ciò che è. Ecco perché decisi di partire. Le parole che scrissi ai miei amici prima di cominciare il viaggio furono “It’s Summer time and Leaving is Easy!” . Sentivo profondamente da un po’ di giorni che il momento si era avvicinato, facendosi così tanto prossimo a me, che ormai vi ero già dentro, senza che me ne accorgessi, giusto vivendo. Ho deciso di seguire la sensazione, che non si sbaglia mai. Io, ragazza toscana di 20 anni, ho dato seguito alla mia vocazione del momento, finendo per essere considerata incosciente da molte persone (tra cui alcuni dei miei stessi amici), molto coraggiosa per altre. Il 2 Agosto 2013, alle tre del pomeriggio, ero in Arcidosso (GR) a fare l’autostop da sola, con 2 zaini e tanta voglia di libertà. La Meta: Trento. Il percorso “programmato”: costa della Toscana verso Nord, fino a Viareggio, Sarzana, 5 Terre, Parma, Brescia, Trento, il tutto in 10 giorni di puro autostoppismo e solitudine. Il ritorno, la Vita mi avrebbe suggerito come compierlo! Fatto sta, che la stessa Vita, alla quale piace giocare con gli eventi, aveva in serbo per me qualcosa di molto particolare. Bene, mi metto sulla strada, davanti alla caserma dei carabinieri di questo piccolo paesino dell’Amiata di 1000 abitanti e sfodero il mio prezioso dito pollice, in direzione Grosseto. Chissà con chi avrei condiviso la prima parte del mio viaggio? La prima macchina si ferma, le vado incontro: un signore sulla quarantina, con occhiali scuri mi dice: ”Dove vai?”, “Per ora a Grosseto” rispondo io, “Perché, dove dovresti andare?” ribatte il signore, “A Trento” … ecco e in un attimo lo stupore nei suoi occhi “Impossibile, sto andando a Trento anch’io!”. L’alta improbabilità di questo evento l’ho letta come un chiaro messaggio della Vita per me “Gaia, fai bene a farlo, prego, continua pure!”. E così ho deciso di andare diritta verso Trento, improvvisando, insieme con ciò che arrivava, facendolo mio. Dopo due giorni a Cassana (TN) nella baita di una mia cara amica, mi sono messa di nuovo sulla strada a fare autostop. NO, non in direzione Sud, per tornare indietro. Prossima tappa era Traunstein, Germania. Con 8 cambi di passaggi e 8 ore di viaggio, ero a Traunstein, dove sono rimasta per 2 giorni, dopodiché ho fatto autostop per Udine e invece sono arrivata fino a Lignano Sabbia d’Oro (da lì in poi però ho dovuto sempre continuare il viaggio col treno). Il giorno dopo mi sono goduta Venezia, ho fatto tappa a Verona per la notte e il giorno dopo sono andata sul Lago di Garda a Desenzano. La stessa sera ero a Brescia, da una mia compagna di corso. Il giorno 9 Agosto ho impiegato un’intera giornata per raggiungere Sarzana, dove ho pernottato da un mio carissimo amico che definisco un “Leopardi dei giorni nostri!”. Il 10 Agosto ero a Viareggio e ho passato una serata molto alternativa a confronto con realtà forti, quelle dell’omosessualità, del trans gender e dell’amore proibito. Infine l’11 Agosto in due ore, col treno Viareggio-Grosseto, ero di nuovo nella mia provincia. Da lì ho fatto l’autostop per arrivare fino a casa mia a Santa Fiora. Durante il ritorno verso casa era come se un bellissimo incantesimo si stesse dissolvendo. Avevo dentro di me le immagini della Alpi del Trentino, dei laghi della Baviera, della terribile nottata passata a Lignano a dormire in una casetta di legno per bambini in mezzo ad un parco giochi, l’Atlantide ritrovata che è Venezia, il caldo afoso di Verona, la grossa pesantezza del Lago di Garda, la fortezza di Sarzana, le stranezze dell’ultima notte a Viareggio. E ogni momento di ciascun giorno sarebbe da raccontare, perché ognuno raccoglieva dei significati profondi che quando si è così esposti agli eventi, arrivano dritti come coltelli! In quei giorni ho vissuto a stretto contatto con questa entità più volte citata: la Vita. Ho compreso che nulla succede per caso, che l’imprevedibilità va colta, che quando si sta bene con se stessi, si accolgono gli alti e i bassi con costruttività. Ho imparato a gioire delle piccole cose. Alla fine tutti questi insegnamenti, introiettati durante un viaggio, sono gli ingredienti per una vita felice. D’altronde cos’è la Vita se un Viaggio Meraviglioso? P.S. Per quanto riguarda quel senso di libertà che tanto cercavo e desideravo… beh, l’ho provato, sì, fortemente, ma solo nel tragitto di strada che mi ha portato dal punto in cui il mio amico, prima che cominciassi il viaggio, mi ha lasciato con la macchina, al punto in cui ho fatto il primo autostop. E’ stato strano provare quella forte euforia ed adrenalina all’interno di un paese visto e rivisto e conosciuto come le mie tasche… - Due nazioni, tre mesi, otto sconosciuti. di Gaia Gasparetto < Gaia hai vinto una borsa di studio per l’Inghilterra, starai là tre mesi!> < Chi? io? ma non conosco nessuno, ma non conosco la famiglia dove andrò a vivere, ma…> < Poche storie! Sarà una esperienza bellissima, vedrai> . Iniziò così il mio viaggio in terra inglese, con tanti dubbi e dei volti nuovi da individuare al check-in dell’aeroporto. Noi nove vincitori partivamo da diversi aeroporti italiani, un'unica meta: London Gatwick. Impermeabilizzati contro il rainy weather eccoli tutti e otto lì, i miei nuovi, sconosciuti compagni d’avventura. Il ragazzo un po’ timido toscano, la spavalda laureata calabrese, la chimel’hafattofareamedipartire sempre con la sigaretta in mano, la simpaticona di turno, la nostalgica in una furiosa ricerca della rete wi-fi e così via. Trascorsi le prime due settimane di questa nuova avventura a Cardiff, in Galles, ospitata da una famiglia composta da madre e figlio. La famiglia mi accolse informandomi che la cena si sarebbe tenuta ogni sera alle 18. L’orario non fu nulla a confronto del contenuto della cena, spesso rimasugli di scatolette abbandonate in frigo o, peggio ancora, surgelati di dubbia provenienza. Almeno però il the era buono: “sicuramente non morirò di sete”, pensai. Trovarsi a Cardiff in occasione delle partite di rugby fa parte di quelle esperienze indimenticabili di vita. Bimbi, donne, uomini, giovani, anziani mascherati, vestiti rigorosamente in rosso, mezzi nudi, con copricapi dalla curiosa forma, birra-muniti e urlanti per le vie della città. I restanti due mesi e mezzo li passai a Bristol, vivendo da una signora indiana, Reethah, ormai cittadina inglese. La casa più arredata ed organizzata che io abbia mai visto, con tanto di enorme gong (da suonare solo quando la cena era pronta) e chiavi appese all’ingresso recanti la scritta “IN” o “OUT”, per capire chi c’era o non c’era dentro casa. Casa in cui vivevano altre quattro persone provenienti da, nell’ordine: Cina, Africa, Francia e Italia. Una di queste era suora, l’altra aveva i capelli blu, per la cronaca. Le mie giornate le trascorrevo invece in un ufficio dove mi occupavo di marketing & varie ed eventuali. Erano buffe le espressioni del mio collega di fronte al mio entusiasmo per l’omaggio aziendale ogni venerdì, augurio di buon weekend ai dipendenti, e il mio interesse per i piedi dei colleghi, tutti rigorosamente in calzini (se non addirittura scalzi) per non rovinare la moquette. Tzè, italiani, avrà pensato. Potrei raccontare dei miei maldestri approcci alle strisce pedonali inglesi, delle disperate traduzioni di fronte alle scatole di bastoncini di pesce (ma merluzzo si scrive così?), delle commesse spazientite nel tentativo di interpretare le mie richieste ecc. Ma ogni singolo episodio, ogni sguardo e frase scambiati, ogni situazione vissuta non saranno mai narrabili, nella loro essenza. Si perderebbero le sfumature che le hanno rese, una dopo l’altra, uniche e che mi hanno regalato una ricchezza interiore che mi conserverò, eh sì, per sempre. - Con il mare in ascolto di Gaia Gulizia La nuova mattina è bagnata nella luce, come un gioiello che stia per rinascere a nuova vita, dopo un’immersione nell’oro. Ed è proprio così che, ormai da tempo, mi propongo di vivere ogni risveglio: come un nuovo viaggio carico di doni preziosi e inaspettati. Sono in corsa sulla schiena robusta del mare; socchiudo gli occhi, e ascolto la sensazione esaltante di una nuova partenza: questo è un Viaggio, è un nuovo inizio, è un camminare calmo e sicuro verso la realizzazione in arte della mia vita. E sono i miei occhi, a scrivere le emozioni a cui mi riprometto di dare forma. F. partirà fra qualche ora, e stanotte accarezzeremo le stesse acque, profonde come la forza della nostra amicizia. Io e lei abbiamo da tempo deciso di unirci in un’avventura di viaggio che sia innanzitutto simbolica, e che ci porti spunti fertili per rafforzare i nostri obiettivi di vita e il valore che ad essi abbiamo dato. La scelta del luogo di destinazione è lunga, ma alla fine lo individuiamo con chiarezza: un’isola da raggiungere via mare, partendo ognuna da un porto diverso, e solcando in contemporanea acque che si uniranno e ci uniranno, fino al momento dell’arrivo. Il viaggio per mare rappresenta qualcosa di forte e potente: sarà un tragitto da vivere con lentezza, pronte in ogni istante all’ascolto attento, pieno di Presenza; un meta-viaggio, un viaggio nel viaggio che, come una matrioska affamata, assapora con le labbra increspate in un sorriso ogni bagliore del tempo che abbiamo deciso di concederci per arrivare ad una solo apparente “destinazione”, in realtà nuovo punto di ri-partenza. Respiro con occhi e polmoni spalancati la luce profumata del mare, e lascio che i miei desideri si purifichino e fluiscano con la naturalezza delle onde, che cullano e proteggono dal freddo del dubbio ombroso. Sia io che F. ci sentiamo pronte a guardare in faccia le tappe di questo viaggio verso noi stesse, sicure che solo così daremo loro la possibilità di distendersi, fino a poterci sollevare in volo verso una rinnovata fertilità di vita. Ho davanti a me una valigia aperta: quali indumenti scelgo di portare ancora nel mio cammino, e quali sono ormai abiti logori e non più utili? Lascio andare il senso di inadeguatezza, la paura paralizzante di far sentire la mia voce, il dubbio che verrà mai accolta da orecchie calde che abbiano voglia di ascoltarla fino in fondo. Ma porto con me ancora e sempre lo sguardo puntato verso le tre A: Amore, Armonia, Abbondanza. Amore da versare in ogni istante che vivo, da spandere ad ogni passo perché possa essere condiviso da chi si trovi così vicino da essere “oltre pelle”, Armonia nel respiro che crea questi stessi passi, e permette di esprimermi In Amore; Abbondanza di occasioni utili a modellare la mia vita nella direzione che la renda la mia peculiare opera d’arte, di amore dato e ricevuto, di ricchezze impagabili con carta e metallo. Questo viaggio per mare sarà fatto di ore stese le une sopra le altre, a formare una coperta morbida sulla quale mi adagerò per essere comoda nel riordinare i miei pensieri. Osservo con amore la sinuosità del mare nero di notte, e intanto lucido pensieri e immagini interiori che mi porteranno verso la Realizzazione. Seduta su una piccola sedia, affacciandomi alla balaustra che tuffa lo sguardo in mare, mi sembra di aver conquistato un piccolo e prezioso posto d’onore per godermi questo transito meta-fisico: ora e sempre, sono un’Anima che viaggia in un corpo universale. - Cosa occorre di Gaia Gulizia Cosa occorre? Occhi, innanzitutto. Occhi svegli, energici, entusiasti. Poi gambe: forti, sane, allegre. Energia, una penna e un taccuino, una macchina fotografica, magari. Ah, e una giacca per coprirsi, inizia a fare freddo. Ho tutto? Sì, ho tutto con me. Apro la porta, e da quando metto il primo piede fuori, ha inizio il viaggio. Ho deciso di essere straniera qui, oggi, e di fingere con sincerità di conoscere il meno possibile di questa città. L’aria punge, e mi bacia con la ruvidezza della barba incolta di un uomo ombroso ed affascinante. Respiro, e mi sento piena. La strada scivola sotto i miei piedi, ne ascolto la consistenza…. è liscia, granulosa, accidentata. Mi piacerebbe sapere che tipo di torta sarebbe, e quante fette riuscirei a mangiarne. Cerco di far rimanere in movimento i miei occhi il più possibile, facendoli danzare su ogni frammento di immagine che mi viene incontro: volgo lo sguardo verso l’alto, e assaporo le forme dei palazzi, scrutando dentro alla bocca aperta delle finestre, poi lo faccio tornare dritto davanti a me, ad aprirmi la strada come un cane libero dal guinzaglio che mi precede nell’esplorazione dei nuovi passi. Ora i miei occhi planano in battuta verso il basso, e io ne ho la guida, come il pilota esperto di un aliante veloce e fiammante. Voglio perdermi, e scoprire ciò che ho trascurato nella vita distratta di chi si affanna per nulla, tralasciando il vivere vero. Questa città mi apre le braccia, o meglio, sono io che mi tuffo in ogni suo pertugio per scivolarle furtivamente sotto la testa, e rintanarmi in un abbraccio cercato, dal quale subito mi tuffo, di nuovo e ancora, sulla strada. Ciò a cui non avevo mai prestato attenzione va progressivamente ad ingrossare l’elenco che non immaginavo di redigere, semplicemente perché il mio pensiero non si era mai allargato a tal punto da abbracciare l’estensione che va dal noto a ciò che è (ancora) ignoto. Cammino, cammino ancora, e i miei piedi sono barche che traghettano la mente verso dimensioni nuove da conquistare. C’è una macchia vicino a quella finestra, che dà forma ad un simbolo quasi esoterico; fantastico su come sia nata accanto alla vita delle persone che abitano al di là dei vetri: mi domando se i nostri pensieri e la nostra energia plasmino in qualche modo impercettibile la fisionomia delle case che abitiamo, oltre che dei tratti del nostro volto. Mi fermo davanti a un nugolo di gente che mi rimanda all’immagine di un gomitolo aperto e poi arruffato su se stesso in modo caotico e fantasioso: scopro fino in fondo il sapore autentico di un mercato rionale, accanto al quale sono passata più di una volta. Ora però voglio perdere con gioia il mio tempo, e so che provare questa sensazione mi dirà che sono sulla strada giusta. Assaporo colori, profumi, suoni. Osservo le persone che mi passano accanto, e che sfiorano con il loro il mio corpo sottile. Non lascio passare inosservato alcunché della loro fisionomia, del loro modo di muoversi, del timbro delle loro voci che si mescolano le une alle altre creando un pot pourri di suoni. Ancora cammino, e il viaggio procede, senza soluzione di continuità. Tengo lo sguardo alto, a leggere il nome delle strade individuandone l’origine, che mi si svela come la chiave di accesso ad un giardino segreto. Alla fine della strada c’è una panchina. Mi siedo, e ascolto il canto indistinto di tutti i suoni, le forme e gli odori che mi hanno affiancata in questa giornata nuova. C’è una voce, in particolare, che ha qualcosa da dirmi. Mi fermo, e ascolto. Ha inizio il viaggio. - 1, 10 e 100 viaggi di Viganò Gioele Amos Ogni riferimento a fatti e persone è da ritenersi puramente casuale. “Alle 16 fuori dalla stazione di Prato, ho una Ds3 bianca. A dopo”. Sono le 15: 50, telefono scarico, 40 gradi e zone in ombra tutte al completo. Ho uno zaino pieno di vestiti sporchi ed emozioni forti, sono molto stanco e sudato. Mi accorgo che intorno a me la maggior parte della gente proviene dalla Cina, sono discreti, si vestono bene e poi non sudano. A cinque minuti dall’incontro la stanchezza emozionata si trasforma in un’ansiosa curiosità. Con chi passerò le prossime tre ore della mia vita? Chi ci sarà in quella Ds3 bianca? Dovrò sforzarmi per dribblare conversazioni formali e silenzi imbarazzanti o ci sarà un tacito feeling? Insomma saranno tre ore veloci o tre ore infinite? Mentre sforno questi pensieri sudati una Ds3 si ferma proprio davanti a me. Mi ha riconosciuto nonostante non mi abbia mai visto. Tacito feeling? O forse è perché sono l’unico italiano sudato in mezzo a cinesi asciutti. Dalla macchina esce un uomo: capelli corti neri, maglietta bianca come l’auto e pantaloni corti. Sulle gambe ha pochi peli e indossa scarpe sportive. E’ sportivo. Pulito, preciso. Anche la macchina nella quale sto entrando è pulita e precisa. C’è l’aria condizionata e una radio commerciale. Inizio il dribbling contro il primo silenzio imbarazzante e lui sembra disposto a dribblare quanto me. Dribbliamo bene, un po’ io e un po’ lui. Dopo poco ci rendiamo conto dell’inutilità di questo dribblamento forzato e accogliamo con serenità l’insorgere di un tacito feeling. Ora siamo più rilassati, tanto che alla prima sosta mi chiede di comprargli una Coca Zero. Riprendendo il viaggio mi accorgo di come la stanchezza che provavo alla stazione si sia volatilizzata e al suo posto si è materializzata una curiosa energia. Lui inizia a parlarmi di alcuni viaggi che ha fatto per lavoro. Racconta di Messico, auto noleggiate e fiumi sotterranei in cui faceva il bagno. Mi accenna una canzone che sentiva sempre al carnevale di Rio e mi dice che ha due figli ai quali sta insegnando lo spagnolo. Mi mostra un tatuaggio che ha sul bicipite: una corona con scritto “Pride”, è banale ma su di lui suona bene. Lo ha fatto sua moglie. Sua moglie lui la ama, il fatto è che viaggia molto allora la vede poco, e così i suoi bambini. Lei fa la tatuatrice, è specializzata in trucco permanente: fa tatuaggi sulle palpebre della gente, righe nere, quelle che di solito si fanno con la matita per gli occhi. Io penso che deve fare un male cane e che le donne hanno modi strani di esprimere la loro essenza. Ho capito il lavoro della moglie ma ancora non riesco a capire di cosa si occupi lui. Sono curioso ma cerco di fare il discreto. Parlando mi rendo conto che è una persona molto intelligente e acuta. Dice che fa spesso la tratta Milano-Prato perché si sta trasferendo al Nord e nel contempo frequenta un corso universitario a Perugia. Mi parla di altri viaggi, mi racconta di quella volta che doveva andare in Colombia facendo scalo in Brasile. Lì si era addormentato e aveva perso la coincidenza. Per qualche strana ragione sembra ricevere trattamenti particolari durante questi viaggi. Mi dice che ha un passaporto speciale che gli permette di saltare le code e alcune volte addirittura lo vengono a prendere in macchina sotto l’aereo. Mi accorgo che quando mi descrive questi viaggi parla sempre di qualcuno con cui deve viaggiare, ma questo qualcuno è sempre piuttosto indefinito e lui sembra voler appositamente tralasciare i particolari. Io sono sempre più curioso ma esito a chiedergli direttamente di cosa si occupi, forse perché ho come l’impressione che stia scoprendo le carte pian piano e che poi arriverà da solo all’outing finale, così: spontaneo e libero. Continuo ad ascoltare i suoi racconti come un bambino che ascolta una fiaba prima di andare a nanna. Come un bambino ho anche i miei attimi improvvisi in cui mi distraggo completamente pensando per un attimo a qualcosa che non c’entra niente. Mi sta raccontando di un viaggio in Perù e la mia mente si assenta per un attimo ritrovandosi l’immagine della mia ragazza che mi fa l’occhiolino con linguaccia mentre studia per l’esame, è bellissima ma non glielo dico che poi si deconcentra e si lamenta che ha fame. Improvvisamente però il viaggio in Perù torna in primo piano quando sento la parola “ammanettato”. Aveva dovuto ammanettare il personaggio con cui stava facendo il viaggio. L’outing, come avevo previsto, è spontaneo: è un poliziotto. Per sicurezza chiedo (e ricevo) conferma. Siamo a metà viaggio. Ora che ha apertamente dichiarato la sua professione mi sento libero da quella discrezione che mi frenava. Parto con le domande. Chiedo di descrivermi un po’ il tipo di individui con cui viaggia. Scopro che il suo ruolo nella polizia è quello di rimpatriare immigrati criminali con un mandato di espulsione, tradotto in soldoni scorta spacciatori, papponi, prostitute e maniaci in lunghi viaggi aerei diretti alle loro madri patrie. Io rimango affascinato dalla lucidità delle sue descrizioni. È stoico. Mi racconta di prostitute nigeriane che si ribellano violentemente e virilmente tentandole tutte per evitare il rimpatrio: lanci di assorbenti, calci e pugni, spogliarelli… Poi dice che alcuni criminali si tagliano per protesta e che lui che non ha un medico nella scorta, come è d’obbligo negli altri paesi europei in queste circostanze (ah, Italia!), usa lo scoatch per fermare le emorragie. Mi confessa poi come, costantemente, al termine del viaggio egli si senta psicologicamente abbattuto, sconfitto. Per 10/20 ore di aereo assorbe disperazione e disgrazia, ascolta storie di errori, sorvola richieste di redenzione e perdono. Pianti, lamenti e grida di gente che raschia il fondo, chi per scelta chi per necessità. È un uomo felice, lui, ma fa trapelare dai suoi discorsi una punta di frustrazione, di sofferenza. Forse perché nello stare a contatto con questa gente sei costretto a partecipare alla loro realtà, che tu lo voglia o no. Ed è un compito duro. Lui scherzoso dice che in fondo è come un BlaBlacar, che non sai mai con chi andrai a condividere il viaggio. Dopo aver ascoltato i suoi racconti mi sento un cretino per avergli detto quanto fosse fortunato ad avere un lavoro che gli permettesse di viaggiare cosi tanto. Mi accorgo che mi è tornata una forte stanchezza. Anche lui se ne accorge e dice: ”Se sei stanco dormi pure tanto tra un po’ dormo anche io…”. Ridacchio e chiudo gli occhi. Crollo. Mentre dormo faccio degli scatti, di quelli che fai quando sogni di cadere nel vuoto. Mi risveglio poco dopo e lui commenta: “Hai dormito profondamente, continuavi a fare dei movimenti epilettici, eri inguardabile!” e ride. Rido anche io. Siamo arrivati all’uscita dell’autostrada. Tra 10 minuti siamo al punto d’arrivo. Mi accorgo che è stanco, vuole arrivare, andare ad abbracciare i suoi bimbi e baciare sua moglie. Mi confessa che è stato contento di questo viaggio e che la chiacchierata ha alleggerito il peso di quella tratta autostradale che proprio non sopporta più per l’enorme numero di volte che l’ha percorsa. Sono contento anche io. Tacito feeling. Arriviamo al punto di arrivo: un parcheggio di un Mac Donald dove il mio gentile babbo mi viene a raccattare. C’è una luce bellissima, quella del tramonto. Una luce in grado di rendere poetica anche la grossa “M” che sta sopra di noi. Scendo io e scende lui. Prendo lo zaino pieno di vestiti forti ed emozioni sporche. Lo pago. Gli do la mano e gli dico: “È stato un piacere”. Anche per lui. E so che entrambi non mentivamo. Tacito feeling. - Un viaggio con il cuore di Giorgio Agostinelli Possono essere tanti i motivi per iniziare un viaggio. Quella mattina, prima ancora di aprire completamente gli occhi, nella mia testa avevo un solo pensiero: dovevo arrivare a Roma per rivedere la ragazza dei miei sogni quello stesso giorno, volevo farle una sorpresa. Da Venezia non è così difficile, pensai. C’era solo un piccolo ma non trascurabile problema, le mie finanze erano ai minimi termini. Non mi importava. Ce l’avrei fatta a tutti i costi. Dovevo solo escogitare un modo e le alternative non erano molte. Il treno e l’aereo erano inaccessibili. L’auto non ce l’avevo. Bene. Dovevo trovare un passaggio. Di persone ne conosco abbastanza, ma trovare qualcuno con la mia stessa esigenza non era semplice. Decisi di tentare con la tecnica più antica, l’autostop. Ho viaggiato molto ma non avevo mai provato l’emozionante sensazione del braccio teso con il pollice verso l’alto. L’idea mi esaltava, per questo pensai che avevo bisogno anche di un messaggio accattivante per riuscire in poco tempo a trovare un passaggio. Scrissi un cartello: “IL MIO CUORE É A ROMA, PER FAVORE AIUTATEMI!!”. Ora ero veramente pronto. Zaino sulle spalle e cappellino per proteggermi dal calore stradale. Una volta arrivato nel punto prescelto, iniziai il rituale del perfetto autostoppista: cartello ben in vista e pollice ad indicare la direzione desiderata. Passarono una, due, tre, dieci, trenta automobili. Non ero abbastanza convincente. Stavo perdendo la speranza e la mattinata stava quasi per terminare. Non bisognava scoraggiarsi però, perché proprio quando meno me lo aspettavo un’auto gialla si fermò a pochi metri da me, il passeggero abbassò il finestrino dicendomi: “Vai a Roma?”. I miei occhi si illuminarono e annuendo mi avvicinai. Mi fecero cenno di salire. Ce l’avevo fatta. Erano due ragazze che avevano deciso di passare il fine settimana nella Capitale. Perfetto. Dopo un primo momento di imbarazzo, entrammo immediatamente in confidenza. I straordinari paesaggi appenninici accompagnano discorsi di ogni tipo. Le mie due nuove amiche erano molto simpatiche. Parlammo della nostra vita, degli studi e di interessi vari. Erano di Verona, tra l’atro una delle due anche molto carina. Io ero un concentrato di felicità. Stavo per raggiungere la ragazza dei miei sogni. Il viaggio sembrò rapidissimo, con una sola sosta in Toscana. Furono talmente gentili che mi accompagnarono fino a casa di lei. Avevo conosciuto due persone splendide. Ci scambiammo i numeri di telefono e ci salutammo dicendoci che ci saremmo rivisti un giorno, chissà. I miei sforzi erano stati ripagati, ma non sapevo quello che mi aspettava. Mentre mi avvicinavo alla meta vidi due persone sulla porta che si scambiavano tenerezze. Una delle due era la ragazza dei miei sogni. Non ci potevo credere. Ma quindi non sempre queste cose hanno un lieto fine. Invece si. Non era la meta che mi avrebbe fatto felice. Fu il viaggio a farmi conoscere la ragazza con cui tuttora condivido la mia vita. - La piccola vagabonda e il suo zainetto di Giovanna Muzzetta Vi sarete mai chiesti: cosa vuol dire viaggiare? Viaggiare è una delle passioni che accomuna l’uomo dai tempi della preistoria. La voglia di scoprire, conoscere, sperimentare oggetti, assaporare cibi e sapori, sentire odori nuovi e incontrare nuovi popoli. Questa azione iniziò anni orsono e continua senza fermarsi, oggi per vie telematiche con un semplice clic! Chi meglio di me non può esprimere cosa vuol dire viaggiare. Nipote di ferroviere e figlia di ferroviere, due figure paterne che hanno avuto da sempre nel sangue la voglia di viaggiare lavorando sui treni e a contatto con persone sempre nuove e diverse per cultura razza e religione. Il nonno sin da giovane, amante del mondo e dell’avventura partiva in compagnia di colleghi e amici; ha raggiunto persino Mosca in treno e sposato mia nonna una fantastica olandesina di Amsterdam. E che dire del mio papino.? Ferroviere e amante dei viaggi anche lui, ha acquistato e riverniciato un piccolo furgone dopo essersi sposato e avuto 2 BIMBE: me e mia sorella all’età di vent’anni. Da allora abbiamo cambiato e comprato due o tre camper nel corso degli anni e scoperto tutti insieme quasi tutta l’ Italia e l’Europa. È a mio papi infatti che voglio dedicare questo racconto. Lui pur essendo nata prematura a 5 mesi, del peso di 800 grammi e con alcuni problemi motori, mi ha sempre trasmesso la gioia di non fermarmi e di viaggiare. Il suo motto ormai è diventato anche una mia filosofia di vita. “il viaggio allunga la vita, chi viaggia vive due volte!” Questa frase ormai accompagna tutte le mie avventure e dall’età di 22 anni ho iniziato anche io a viaggiare da sola con un piccolo zainetto per la comodità di riuscire a portare il minimo indispensabile spostandomi da sola. Grazie all’Università che mi ha permesso, con un piccolo rimborso spese, di svolgere un corso di 3 settimane di Spagnolo Avanzato presso L’UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (SPAGNA) ho migliorato le mie competenze linguistiche e iniziato nuove fantastiche avventure in giro per il mondo. Ed eccomi qua. La piccola vagabonda del titolo sono io. Quasi trentenne ma minuta e bassa per questo sempre la piccola di casa. Bisogna avere voglia di intraprendere nuove strade e immergersi in una realtà diversa se vogliamo sentirci cittadini europei e vivere una scommessa con noi stessi. Durante la mia carriera universitaria ho avuto la possibilità di poter svolgere 2 tirocini in Spagna a Sevilla e a Corugna, regno di tapas, flamenco e cultura gitana. L’Europa mi ha conquistato: Germania, Francia, Olanda, Croazia ….. Viaggiare è imparare, condividere e vivere!... e allora io piccola vagabonda con lo zaino in spalla mi preparo al mio prossimo viaggio: destinazione Valencia!!!!!!! - Ogni giorno in viaggio di Giulia Ameruoso I miei primi passi; le mie prime scarpe; il mio primo viaggio? No! Viaggiare. È di questo che voglio parlare. Ogni giorno è un viaggio. Il primo passo che fai subito dopo aver aperto la porta di casa è un viaggio. Sbagliare il bus che porta a scuola è un viaggio. Le deviazioni per "lavori in corso" mentre vai all'università è un viaggio. Il passaggio dato ad un anziano che fa l'autostop; tornare indietro perché hai dimenticato la patente nei jeans; la vicina che ti coglie di sorpresa con la busta della spesa e che abita al quinto piano senza ascensore è un viaggio. Viaggiare è sbagliare strada ma anche prendere quella giusta. Ci spostiamo da un posto all'altro perché amiamo la dinamicità; necessitiamo di conoscere gente diversa; abbiamo bisogno di vivere una nuova quotidianità, senza sapere che ciò che in apparenza è uguale, ci cambia la giornata. Abbiamo voglia di nuovi suoni, odori e sapori. La buona musica l'ascolto ogni giorno, quando l'uomo dal volto a me sconosciuto, suona la sua fisarmonica, augurandomi il buon giorno, mentre la persiana è ancora semichiusa. Ed è triste scendere troppo tardi per poterlo ringraziare. L'odore del sughetto nel pianerottolo, che non avrai il tempo di assaggiare, mentre corri al lavoro. La sensazione che qualcuno ti abbia ascoltato, quando all'ora di pranzo, il proprietario del locale da cui hai acquistato un panino al volo, gentilmente, ti offre il dessert. L'incontro inaspettato che ti farà perdere il treno; il turista disorientato che ti farà maledire il tuo pessimo inglese. Viaggiare significa arricchire il proprio bagaglio socio-culturale ma per farlo abbiamo bisogno di un mezzo di paragone: bisogna conoscere per conoscere di più. Quando mi trovo in posti nuovi, immagino cosa stia accadendo, in tempo reale, tra le strade di casa mia. Lo stesso buon giorno, avrà un suono diverso. Lo stesso cielo, sarà di un colore diverso. Lo stesso uomo, suonerà uno strumento diverso. Lo stesso sughetto, avrà un odore diverso. Negli stessi jeans, dimenticherai il biglietto della metro. La stessa vicina rompiscatole, si farà aiutare a portare le buste della spesa e probabilmente, anche lei, abiterà al quinto piano senza ascensore! Lo stesso incontro inaspettato, ti farà perdere un treno diverso e questa volta sarai tu il turista disorientato che si maledirà nuovamente per il suo pessimo inglese. Guardiamoci intorno con gli occhi di un turista, che sia dietro l'angolo di casa o dall'altra parte del mondo. Facciamo in modo che il nostro bagaglio, non smetta mai di essere pieno. - Una meta comune di Giulia Ameruoso Dalla lista delle "cose in cui riesco meglio" non posso di certo spuntare: propensione per le lingue straniere; ottimo senso dell'orientamento. Una volta mi sono persa in autogrill! Da allora ho deciso di trattenerla ogni qualvolta sono in viaggio. Ma questa storia non interessa a nessuno. Andiamo avanti! Dicevo!? Ah. Non ho una grande propensione per le lingue e ho la fobia dell' autogrill. Questo in un certo senso mi rende timorosa nell'addentrarmi in territori sconosciuti. Londra. Era una giornata uggiosa (ovviamente). Dal finestrino dell'aereo vedevo grigio ma stranamente non mi turbava. Non ho mai capito perché Londra fosse una meta tanto ambita. La definivano la "piccola America". In sostanza tra il "nulla" e il "troppo" nel mezzo si trova Londra. È abbastanza palese il fatto che io sia partita prevenuta. "Partita" nel vero senso della parola, intendiamoci. Appena atterrai, (oltre ad essermi maledetta per non aver avuto un ombrello a portata di mano), incontrai la prima "simpaticissima" signora addetta agli sbarchi - che detta così suona proprio male - la quale, con un tono altrettanto "simpatico", esordì dicendo: «Jhkbngijptgipnk?» What!?? Ma non ero in Inghilterra? Perché parlavano in coreano misto al tedesco? Tentai di focalizzare le sue labbra e lessi, (insieme al pollo fritto che non era sicuramente riuscita a digerire la sera prima): «Where are you from?» ITALY! ITALY! ITALY! - Guardare tutte quelle serie in streaming, non mi era servito a niente. Tutta colpa dei sottotitoli. Finalmente fuori! Ovviamente occorreva prendere un secondo mezzo per arrivare a Londra centrale. Eccolo lì, il primo omaccione dalla pelle scura e dal sorriso accecante che sembrava amare profondamente la vita e che, ti faceva chiedere il motivo per cui tu fossi così tanto anemica e perché il tuo dentifricio non funzionasse come il suo! Comunque, mi indicò il bus e mi diressi alla volta della "piccola America". Alla fermata ci aspettava - me e altre due mie amiche - il best friend (italiano) della mia amica (italiana) che, ahimè, non aveva ancora perso il suo accento siciliano. «Cumpari!» - appunto. Dopo il breve giro turistico, arrivammo all'ostello che avevamo prenotato. Lì ci accolsero i receptionist più belli che avessi mai visto. Desiderai con tutta me stessa flirtarci ma alla fine, passai la parola al mio ibrido amico che sicuramente avrebbe detto qualcosa di meglio di uno squallidissimo: I love you! Dopo esserci rinfrescate e aver riabbracciato la nostra amica, ormai sera, ci dirigemmo verso la famigerata "Piccadilly Circus". Fu in quell'esatto momento, quando il mio piede uscì fuori dalla metro e toccò terra che il mio cinismo volò via da dov'era venuto: in Italia! Era tutto bellissimo. Piovigginava ma sembrava che a nessuno importasse, non c'erano ombrelli in giro. Luci colorate dipingevano i palazzi intorno, che sembravano delimitare la zona dei "balocchi" come quella di pinocchio. Uomini vestiti nei modi più bizzarri cercavano clienti per i negozi. Insegne pubblicitarie stile giapponese e autobus rigorosamente rossi che prepotenti ridisegnavano le strade come fossero padroni. E poi lì, al centro della piazza - forse Channing Tatum versione Step up 1? No, era solo l'ormone che aveva preso il sopravvento! - Un artista di strada intratteneva e incantava i passanti, sulla rumorosa quanto piacevole musica Hip Hop. Mi trovai in una spirale di suoni e colori e di gente dal viso sfocato, forse dalla pioggia, o forse, dal fatto che non so come, stavo ballando, al centro di Piccadilly Circus, con quel ragazzo. È così che Londra decise di accogliermi. Se tutto questo è accaduto solo il primo giorno, vi lascio immaginare cosa sia potuto succedere nei giorni a seguire! Non voglio certo annoiarvi, per cui, a parte: la quasi aggressione di uno scoiattolo; l'effetto domino nella metro se per poco sbagli direzione e l'uomo a cui ho schiacciato il piede, sempre nella metro, (perché è lì che si passa la maggior parte del tempo) che continuava a ripetermi, invano: «Foot!Foot!» ed io, per qualche sbagliatissima associazione capivo «food!». Il resto è andato più che bene. Forse, ho compreso perché Londra è una meta tanto comune. Forse, ho compreso perché, ogni tanto, si ha la necessità di spezzare la quotidianità e partire. Ho capito che: uova e bekon non sono la stessa cosa di latte e cereali; che attraversare con il verde non è la stessa cosa di farlo con il rosso e che essere a contatto con persone di etnie e religioni differenti non può altro che farci bene. Quindi: che sia Londra, che sia Parigi o Berlino, che sia Tokyo... Non smettete mai di viaggiare! - In Sardegna da Mandas a Esterzili - Diario di un viaggio a piedi lungo la ferrovia di Giulia Lai (Monserrato)-Mandas-Orroli Giorno 1 Questo è il racconto di un viaggio a piedi, senza sentiero prestabilito o mappe che indichino la via più semplice per raggiungere la meta. É anche il racconto di quanto è bello scegliere volta per volta quale via scegliere, come accorciare (se possibile) e anche di come a volte bisogna arrendersi all'evidenza di aver calcolato male i tempi e i chilomentri, e allora bisogna affidarsi alla strada e alla gente. La scelta del cammino a piedi è scaturita in maniera talmente naturale che a pensarci adesso mi sembra non potesse essere diversamente: l'idea iniziale era di fare un viaggio con il Trenino Verde della Sardegna, e di visitare a piedi solo i paesini dove lo stesso si sarebbe fermato. Purtroppo (o per fortuna) il convoglio turistico non passa nei giorni che noi avevamo disponibili. La decisione è quindi quella di fare lo stesso percorso a piedi, seguendo i binari della ferrovia fino a Esterzili (km più km meno), piccolissimo paesino dell'isola e meta finale del nostro viaggio. Partiamo dalla stazione di Monserrato: alle 10.00 in punto tra sferragliamenti e sbuffi vari (che purtroppo ci accompagneranno per tutto il tragitto) partiamo alla volta di Mandas, punto di partenza vero e proprio del cammino. Arriviamo dopo un ora e mezzo rumorosa, ma che almeno ci ha regalato un bel panorama tra le campagne. La "mappa" è quella creata da Danilo e ricavata da Google Maps: c'è segnato solo il percorso della ferrovia sino al Borgo dei Carbonai (dove dormiremo la seconda notte) a 7 km da Esterzili. E seguiamo la mappa camminando proprio sui binari di quel treno che non abbiamo preso, e che ci ha dato l'opportunità di trasformare il nostro viaggio in un'avventura diversa. Le prime ore di cammino passano abbastanza veloci in equilibrio a volte sulle traverse di legno tra i binari, a volte affianco ai binari stessi. Raccogliamo more, fichi e passeggiamo, fermandoci a volte per qualche scatto ai vecchi caselli abbandonati, altre volte alle pietre miliari che scandiscono lo spazio del nostro andare. La prima sosta dopo circa tre ore è quella per il pranzo, finalmente poggiamo gli zaini a terra e ci sediamo con le spalle poggiate a una delle tante cataste di tronchi che incontriamo lungo tutta la linea ferroviaria. Mangiamo in silenzio, contemplando le ombre delle nuvole che corrono veloci sulle colline sotto e di fronte a noi. Il paesaggio è quello tipico di una Sardegna agricola e allo stesso tempo selvaggia: i vigneti e le querce da sughero spogliate della corazza sono segno del passaggio umano, così come le case dei pastori che a volte si scorgono in lontananza. In realtà però non incontriamo nessuno, percepiamo soltanto una sorta di aura misteriosa data dal fatto stesso di percorrere un binario di cui non vedi la fine che si snoda tra le rocce e gli alberi che amplificano il suono del vento. Nel primo pomeriggio ci ritroviamo in aperta campagna, il paesaggio sarà lo stesso per ore e ore, camminare sui binari inizia a rivelarsi una scelta sbagliata a causa della difficoltà, e il vento freddo nonchè la stanchezza che inizia a pesare sulle gambe rallentano il cammino. Io mi scoraggio perchè il sole dietro di noi inizia a scendere, ormai sono quasi le sei di sera, e di Orroli nemmeno l'ombra. Danilo con la sua incrollabile fiducia e perseveranza mi esorta ad andare avanti e a stringere i denti, e continuiamo a camminare presi per mano, io con l'umore sotto i piedi, trascinata da questa guida che non si arrende mai. Dopo mezz'ora o poco più finalmente appaiono le prime case di Orroli in lontananza, entriamo nel paese sotto gli sguardi incuriositi di chi passa di lì, e avvisiamo la padrona del b& b che stiamo (finalmente) per arrivare. Arriviamo alla Domus Birdi, sul cancello ci aspetta il marito della proprietaria, signor Piero, che ci fa sedere al tavolo della cucina quasi fossimo amici che aspettava da un po'. Subito dopo arriva anche signora Giovanna, che inizia subito a preparare il caffè mentre ci racconta della sua famiglia, dei figli che abitano lontano da casa e ci mostra le foto della sua famiglia raccontando di un nipote di cui va particolarmente orgogliosa. Piccola parentesi: sono quattro anni che quando siamo in viaggio soggiorniamo prediligendo la formula del B& B (bed and breakfast), e devo dire che ogni volta rimango sempre più stupita da queste persone che decidono di accogliere dei completi sconosciuti sotto il proprio tetto. La maggior parte delle volte queste persone ti rendono subito parte dell'ambiente di casa, ti raccontano della loro famiglia e della loro vita quasi a voler diminuire l'attrito provocato dal fatto di avere degli estranei in casa. Anche noi in realtà godiamo sempre di quest'accoglienza e delle persone particolari e sempre diverse che arricchiscono e impreziosiscono il nostro viaggio come elementi della nostra avventura. Danilo inizia a sbadigliare e io colgo al volo il segnale; ci congediamo dai nostri ospiti e andiamo al piano di sopra a cucinare.Con fornellino e pentoline di alluminio alla mano ci prepariamo un piatto di pasta, anche il mangiare diventa emozionante quando usi un fornello da campeggio.La giornata si è conclusa, andiamo a dormire presto. Domani sarà un lungo cammino. Orroli-Borgo dei Carbonai Giorno 2 Sveglia alle 8, colazione condita da marmellate e biscotti fatti in casa (i migliori del vicinato afferma la padrona di casa, ma dopotutto anche il suo b& b sembra essere l'unico degno di questo nome a suo parere) e dopo aver preparato lo zaino usciamo in giardino a salutare i padroni di casa. Qui la scena è memorabile: mentre il marito sta in piedi a osservare, signora Giovanna è chinata su una bacinella di plastica piena di quelle che in sardo si chiamano "sizzigorrusu" ( per il lettore peninsulare sono lumache giganti che si raccolgono in campagna dopo la pioggia). Mischia e getta sale e mischia ancora con le mani nude immerse nel liquido verdognolo, mentre ci spiega che il sale serve per far spurgare la bava. Non siamo signorini di città, ma una scena del genere subito dopo colazione non è esattamente quello che ci aspettavamo. Un lavaggio veloce di mani e via a stringere le nostre; appena voltiamo l'angolo ci lasciamo sfuggire quella risata a lungo trattenuta, e iniziamo la nuova giornata di cammino sconcertati e divertiti da quanto siano stupefacenti le persone che incontriamo sulla nostra via. Prima scelta (sbagliata?) della giornata: abbandonare la ferrovia: il percorso del giorno precendente si è rivelato tanto bello quanto disagevole. Vista la difficoltà del camminare su pietre e rotaie scegliamo un percorso che prevede il passaggio su stradine e sentieri che attraversano campagna, collina e persino qualche montagna. La prima sosta prevista è a Nurri per fare rifornimento di viveri, e dopo un oretta sulla statale raggiungiamo il paese. Mentre ci avviciniamo all'ingresso di un piccolo supermercato, un'anziana signora vestita di nero da testa e piedi, con tanto di scialle avvolto sotto il mento non appena ci vede si fa il segno della croce. È vestita di un nero profondo, scuro e senza il minimo ornamento, trasmette rigore e rispetto e vogliamo sperare che questo gesto simbolico dal valore religioso sia per noi un segno di buon cammino. Usciamo dal paesello e prendiamo un sentiero sterrato che sale per circa 300 metri sulla collina. Arrivati (faticosamente) in cima ci accorgiamo che il sentiero si interrompe alla base di una piccola costruzione che sembrerebbe essere un nuraghe, ma nessun cartello ci da conferma di ciò. Dalla mappa satellitare vediamo che per continuare il cammino bisogna arrivare alla base della montagna che sta di fronte a noi, dalla quale secondo le previsioni di Danilo dovremo vedere la nostra meta per il pranzo, ovvero il lago di Flumendosa. Nessun sentiero visibile però arriva dall'altra parte, e decidiamo di scendere in mezzo agli alberi e agli arbusti, mentre Danilo apre il passaggio a colpi di bastone e recide i rovi spinosi di more con le forbicine del coltellino svizzero. Sbagliamo spesso direzione, perchè talvolta sembra ci sia una via aperta tra i cespugli, che poi puntualmente si perde nel nulla. Perdiamo due ore per scendere di circa 200 metri, ormai sono le 16.00 e stiamo camminando da sei ore. Una volta arrivati di nuovo sull'asfalto della statale per Esterzili vediamo in lontananza quello che doveva essere il nostro stop per il pranzo, ovvero la diga del lago, ma è ancora a più di un'ora di cammino, e noi iniziamo a perdere le speranze di arrivare in tempo al Borgo dove soggiorneremo per la notte. Tentiamo di andare avanti ancora per qualche chilometro e ci spingiamo fino a vedere in alto alla nostra sinistra Villanovatulo. È inutile, non faremo mai a tempo ad arrivare prima che faccia buio. E così, per la prima volta nella nostra vita, decidiamo di sperimentare una nuova esperienza non prevista dai nostri piani, ma che è chiaramente l'unico modo di arrivare a destinazione: AUTOSTOP. Quante volte ho visto persone con il pollice alzato che chiedevano, per scelta o necessità, un passaggio in auto. Persone che si affidavano alla bontà di chi passava veloce in macchina, persone fiduciose del fatto che, prima o poi, qualcuno o qualcuna avrebbe accostato e si sarebbe fermato. E così anche noi, prima Danilo un po' titubante e poi anche io, alziamo un pollice quando sentiamo arrivare qualche auto in questa strada dove la media è di dieci automobili all'ora. La prima ci passa affianco veloce suonando il clacson; non sappiamo se in segno di scherno o di saluto. La numero due si rivela essere un trattore, quindi nemmeno ci proviamo. La terza auto che passa dopo circa 15 minuti è un fuoristrada che fa un segno con la mano, come a dire che si fermerà poco più avanti, e infatti la rincontriamo poche centinaia di metri dopo; poco distante un uomo che lavora in una vigna. E quando ormai sembra tutto così ridicolo e inutile tentiamo per l'ennesima volta e... . eccola, si è fermata. I due uomini sono pastori e ci dicono che si fermeranno qualche chilometro più avanti al ponte che attraversa il lago per controllare le pecore lasciate al pascolo, ma per noi è sufficiente, accettiamo con estrema gratitudine il passaggio e saliamo in macchina. Superiamo il ponte e l'auto continua ad andare avanti, quando si ferma uno dei due uomini scende, ci dice che si fermerà lui a controllare gli animali, il suo compagno invece ci accompagnerà sino al Borgo. Increduli e stupefatti ringraziamo di cuore, e man mano che procediamo ci accorgiamo di quanta strada ancora avremo dovuto fare, e ci rendiamo conto di aver sbagliato completamente i calcoli per quanto riguardava ore di cammino e ora di arrivo. Ci addentriamo nel bosco, percorrendo una strada sterrata in mezzo agli alberi. Chiacchieriamo con il nostro benefattore della crisi, del lavoro che manca, della pensione che non basta e dei politici che migliorano la situazione. Ma tutto questo non ha importanza adesso, siamo troppo felici di aver incontrato quest'uomo gentile, e le nostre risposte sono di circostanza, perchè vorremo solo dirgli mille volte grazie. Dopo i saluti e i ringraziamenti l'uomo riparte per raggiungere il suo amico e i suoi animali, noi restiamo soli. E quando dico soli, intendo proprio che in questo piccolo agglomerato di casette ristrutturate, in questa piazzetta con archi e volte non c'è nessuno. Cerchiamo qualcuno che ci accolga, ma troviamo solo un numero di telefono da chiamare in caso di necessità; i cellulari però qui non prendono. Mentre Danilo inizia a preparare i panini del pranzo (sono le 17.30) mi avventuro alla ricerca di un un segnale di vita, e apro una porta che sembra essere quella della sala da pranzo. Poco convinta urlo "c'è nessuno?" e quasi mi spavento quando dall'ombra proviene un "sì, eccomi". Dall'oscurità spunta un omino piccolo e dall'accento un po' strascicato, che si era dimenticato della prenotazione e quindi non aspettava nessuno. Ci accompagna in una delle stanze (siamo gli unici ospiti, quindi ci accompagna in una delle più belle anche se non l'avevamo prenotata) e ci aspetta per il caffè una volta sistemati. Ci invita persino a cenare con lui, ma siamo troppo stanchi e decliniamo gentilmente l'offerta; preferiamo andare in camera a riposare, oggi non abbiamo molta voglia di chiacchiere. Facciamo una passeggiata fino al leccio secolare (l'unico lasciato dagli antichi carbonai) e torniamo in camera. Ci addormentiamo presto, il viaggio non è ancora finito e il giorno seguente ci aspetta l'ultima fatica. Borgo dei Carbonai-Esterzili Giorno 3 Ci svegliamo con il sole che entra dalle finestre, le nuvole dei giorni precedenti sembrano sparite.Facciamo colazione in una sala completamente apparecchiata come per un grande pranzo, ma la polvere copre le stoviglie e si capisce che sono sistemate lì in attesa di qualcuno da parecchio tempo. Finita la colazione e preparati gli zaini saliamo sull'auto di signor Ercole (mai nome fu meno appropriato) che ci accompagnerà qualche chilometro più avanti in modo da accorciarci leggermente la strada. Camminiamo sotto il sole fino ad arrivare ad un ruscello, attraversiamo (io attraverso sul passaggio di pietre gentilmente costruitomi da Danilo) e camminiamo in salita per ben 7 chilometri. Per me è la salita (e la tappa) più faticosa di tutte, il sole cocente non aiuta, e quando dopo due ore arriviamo finalmente a Esterzili siamo sudati fradici. Siamo sempre accompagnati da sguardi incuriositi, dobbiamo avere l'aspetto di due esploratori pazzi. Facciamo la foto di fine viaggio al murales del piccolo paesino e ci avviamo verso l'ultima meta. Nella piazzetta del paese ci aspetta la mia famiglia, sono venuti a prenderci e a passare la giornata con noi prima di tornare a casa. Andremo a fare un pic-nic con tanto di barbecue sul monte Santa Vittoria, dove si concluderà la nostra giornata. Dopo due giorni di fatica e sudore tutto ci sembra più buono. Apprezziamo diversamente una bistecca al fuoco con pane e verdure grigliate, la compagnia della famiglia. Guardiamo dai 1200 metri di altezza tutto il percorso fatto, e con grande soddisfazione pensiamo già alla prossima avventura, magari di nuovo in Sardegna, magari chissà dove. Solo una cosa è sicura: nessun viaggio sarà mai uguale, nessuna strada simile all'altra, e all'arrivo non saremo mai le stesse persone che sono partite. - Viaggio di ritorno di Giulia Tiozzo La vacanza stava per finire, era ora di tornare a casa. In campeggio eravamo rimasti in pochi, perciò decidemmo di non noleggiare un pullman, ma di scendere dalle montagne fino a Ferrara direttamente con i nostri pulmini e le macchine. Era stato un anno strano, un anno triste per alcuno versi e molto teso per altri. Le due settimane appena trascorse non avevano dato a nessuno la calma e la tranquillità che di solito andavamo a cercare nella solitudine del gruppo fra i monti del Trentino. Era ora di salire nelle vetture e io ancora non avevo dove andare. C’erano due pulmini, uno da 8 posti e uno solo da 3, perché aveva tutte le valigie, e un paio di macchine. Sarei potuta andare nel pulmino delle ragazze, a sparlare un po’ e dormire tanto, ma io non riesco a dormire in macchina e l’idea di farmi un viaggio in compagnia solo di me stessa e dell’autista che non conoscevo troppo non mi entusiasmava, avrei potuto andare in macchina con qualcuno, a parlare e sentire moltissima musica, ma sembrava che i posti lì fossero già tutti prenotati, perciò mi rimase un posto sul pulmino da 3. Ero curiosa, in realtà non era stata una scelta obbligata la mia, ma avevo proprio voglia di conoscere meglio le persone che erano lì. Il fidanzato di mia cugina era per me ancora un grande punto interrogativo, certo, lo conoscevo, ma non ci avevo mai parlato più di tanto e non lo avevo inquadrato bene e volevo farlo. Con noi salì Valentina. “Che sollievo!” pensai, mi avrebbe aiutato nella conversazione. Non sono una di molte parole, certo, lo sanno tutti, adoro scrivere, ma far uscire la voce a volte mi risulta difficile. Mirko, il fidanzato di mia cugina, al contrario adora parlare e solo durante quel viaggio me ne resi conto. Anche Valentina non parla troppo, ma questo io, quando mi infiali nel pulmino, proprio non lo immaginavo. Dovevano essere circa tre le ore di viaggio e io speravo di non pentirmi della mia scelta. All’inizio un sacco di imbarazzo era fra di noi, eravamo stati due settimane nello stesso campeggio, ma non avevamo mai parlato, poi Mirko iniziò a parlare: “Allora, quest’anno che ne pensate del campo?”. Era ora di rispondere, dovevamo dire qualcosa, ma dato che la risposta non era molto entusiasta io e Valentina ci guardammo e nei nostri sguardi vedemmo le stesse cose. Mirko se ne accorse e parlò lui per primo. Ci disse che secondo lui non era andato proprio bene, che c’erano stati un po’ troppi litigi e troppe cose irrisolte. Mi sentii in dovere di dire qualcosa, ero d’accordo, ma comunque per fortuna c’erano stati anche momenti di spensieratezza che, per quanto rari, avevano aiutato tutti a resistere. Anche Valentina disse che non era andato troppo bene il campeggio, ma che era una cosa prevedibile perché anche a casa già c’era una situazione tesa e la convivenza l’aveva solo fatta emergere di più e aveva fatto scattare le reazioni. Iniziammo così a parlare, un po’ io, un po’ Valentina, ma soprattutto Mirko. Ci raccontò dei suoi primi anni di campeggio delle sue scappatelle in paese, delle gite più lunghe e delle mangiate più pesanti. Era divertente, le ore passavano e noi non ce ne accorgevamo, troppo presi a immaginare o rivivere le avventure passate di Mirko. Alla fine del viaggio mi sentivo molto in colpa, mi sembrava di aver preso parte della vita di Mirko, ma in cambio mi rendevo conto che non gli avevo dato nulla di mio, se non qualche rara opinione. Glielo dissi, ma mi rispose che a lui parlare piaceva e che era contento di aver fatto il viaggio con noi perché gli avevamo tenuto compagnia e aveva avuto modo di conoscerci. Era così, era stato il viaggio di ritorno, il viaggio in cui tutti si davano l’arrivederci, ma per noi era stato soltanto l’inizio di un’amicizia nuova ancora tutta da vivere. - “V” di Viaggio, “V” di Vita di Graziella Migliorino “Ti amo. Prima di incontrarti non sapevo cosa significasse vivere appieno.” Oggi voglio dedicarti questa frase, perché tu sei il viaggio che mi ha fatto conoscere nuove realtà, nuove persone, ma soprattutto mi ha fatto conoscere meglio l’unica persona che non mi abbandona mai: me stessa. Chissà quante cose non so ancora di me, io che credevo di conoscermi! Giungo a Granada senza sapere una parola di spagnolo, da sola su un aereo, con la paura di non farcela. Poi decido di andare oltre, di non fermarmi alla prima tappa, perché se lo facessi potrei perdermi qualcosa di interessante e non scoprire mai cos’era. Supero la mia pigrizia e inizio a conoscere persone speciali, tra cui Laura, tedesca, che un bel giorno dice: “partiamo, esploriamo l’Andalucia”. Lei ha un’auto, quindi basta accordarsi, dividere la benzina e il gioco è fatto. La proposta è allettante: i viaggi in macchina hanno sempre un non so che di affascinante, sanno di famiglia, di Natale, ma al tempo stesso anche d’avventura. L’unione che si crea tra le persone che lo condividono è inconcepibile a uno sguardo esterno. Laura mi presenta Lejla, slovacca. Partirà con noi e per tutto il viaggio cercherà di migliorare il suo spagnolo, chiedendomi di ripeterle parole nuove fino alla nausea. Nonostante ciò continuerà a pronunciarle in maniera sbagliata, dicendo che ha dolore al cappotto (abrigo) anziché alla pancia (barriga)! E poi c’è Raffy, italiano, lui mi ha insegnato che è meglio trovare il coraggio di cambiare quando c’è qualcosa che non va piuttosto che accontentarsi della mediocrità. È come se all’improvviso un uragano ti travolgesse per darti una scossa. Finalmente esci dalla prigione che avevi costruito con le tue insicurezze; come un vulcano quiescente da troppo ormai, ti svegli dal sonno in cui eri caduto. Inizi a godere fino in fondo di ogni singolo momento, che sia triste, felice, giusto o sbagliato, purché sia fatto di emozioni vere. Nel mio cuore ora c’è Cadiz e il suo travolgente Carnevale, dove abbiamo imparato a prenderci meno sul serio; Tarifa, col suo mare che d’inverno era tutto nostro. Potevamo sentire la sabbia fresca sotto i piedi, cantare al suono della chitarra di Laura; di sera ascoltare musica dal vivo, apprezzando il coraggio di una donna che pur non potendo vedere il mondo come lo vediamo noi, lo racconta meglio di chiunque altro attraverso la sua voce. E poi una dimensione nuova: un attimo prima siamo in Spagna, subito dopo…Gibilterra, sul trattore di Edu nonostante la pioggia, per vedere le scimmie! E ancora Malaga, l’odore di terra bagnata, le nostre canzoni da urlare in tutte le lingue, abbracciati per strada o cercando di imparare balli slovacchi sotto la direzione di Lejla. Poi il ritorno, ma non la fine del mio viaggio, che continua nei volti delle persone che ho incontrato, nelle storie che ho da raccontare, in ciò che ho imparato lungo la strada e in quello che devo ancora scoprire…magari si nasconde dietro la prossima curva! - "Come spesso accade con le più belle avventure della vita, anche questo viaggio cominciò per caso... ” di Ilenia Buinoni Irlanda, Clongowes college (Dublin), tra il verde infinito e nuvole sfuggenti… L'immagine iniziale e finale che si ha di un soggiorno è quella di un gruppo di ragazzi sullo sfondo di un college da sogno: esiste tuttavia una straordinaria metamorfosi intercalata proprio tra questi due 'scatti' e che vede come protagonisti le persone che si lasciano travolgere dalla magia del soggiorno stesso, i ragazzi. Ogni inizio è fatto da gruppi, da piccoli gruppi, da piccole persone spaesate e diffidenti, unite solo da un aeroporto di partenza comune o da una conoscenza interpersonale antecedente la partenza stessa. Ogni inizio è fatto da tutto ciò che portiamo con noi da dove veniamo; indumenti, pregiudizi, timori ed aspettative. Si è diffidenti nei confronti di coetanei provenienti da altri paesi e regioni, si è fortemente attaccati ai propri ritmi ed alle proprie abitudini, si è infine legati ad un cordone ombelicale invisibile che ci ancora alla nostra vita quotidiana. Nel soggiorno, a poco a poco tutto cambia. Si conosce casualmente una persona perchè costretto a starci in stanza insieme meravigliandosi col tempo di quanto quell’estraneo ci diventi così familiare. Si gareggia con un avversario sul campo di calcio e si riscopre la bellezza di una rivalità pulita e onesta. Ci si affianca nello sconforto innanzi al cibo inglese fino a trovarsi a ridere a crepapelle con qualcuno che fino al giorno prima avremmo considerato un perfetto sconosciuto. Si iniziano a saldare dei legami meravigliosi che saranno poi il più bel ricordo che ciascuno porterà indietro. A mano a mano non esistono più differenze geografiche, non esistono diversità. Non esiste più il bello e il brutto, lo stupido e l'intelligente. Non esiste più il "coatto di Roma", il "napoletano furbo" o "il secchione veneto": tutto è un fantastico legame di rispetto e fratellanza tra genti tanto diverse eppure tanto simili. Non si evidenziano più gli aspetti negativi di una persona ma si presta attenzione a ciò che di buono c'è in essa. Non si emargina più il ragazzo timido ma lo si coinvolge in tutto. L'odiata mensa diventa un momento di ritrovo imperdibile e la tanto schernita stanza assegnataci diventa la NOSTRA camera. Ci si sente un'unica grande famiglia che vive alla giornata in attesa di quali sorprese porterà il giorno successivo. Ognuno apre il cuore all'altro. Chiunque sia stato protagonista in un modo o nell'altro di un soggiorno, provi a contemplare questi "due scatti" della vacanza, quello iniziale e quello finale; sfido io a "riconoscere" le stesse persone... . Infine, ogni racconto termina con una frase: io ho scelto questa. "Come spesso accade con le più belle avventure della vita, anche questo viaggio cominciò per caso... " Dott. Valerio Olivieri - Alla scoperta dell’est.. ate di Laura Bonini Quest’estate, in preda alla noia, il mio amico C. ed io decidemmo di trascorrere qualche giorno a Parenzo, Croazia. La vacanza “on the road” mi aveva sempre affascinata, dunque C. si offrì di impiegare la sua scattante Mini Cabrio non solo per esaudire questo mio piccolo desiderio, ma anche per raggiungere la meta. Partimmo di buon’ora; il viaggio durò all’incirca sei ore. Fra canzoni urlate al vento, racconti di vita vissuta e qualche sosta alle aree di servizio, non ci accorgemmo del tempo trascorso. Attraversammo la Slovenia scivolando e risalendo lungo i dolci pendii naturali del paese e finalmente arrivammo in Croazia. Il nostro ingresso in città fu verso le quattro pomeridiane: il sole era ancora alto, faceva caldo e non v’era una sola nuvola in cielo. Girovagando oziosamente, osservai il paesaggio circostante, il quale mi ricordava vagamente l’entroterra siciliano: v’erano ampie distese brulle, cui lo sguardo si perdeva all’infinito mentre avvicinandoci verso il centro città, bianchi villini componevano lo scenario urbano e potevano essere affittati da viaggiatori come noi. Tutto ciò mi appariva così naturale e selvaggio, lontanissimo dal panorama grigio e freddo in cui vivo quotidianamente. Costeggiammo il lungomare, quindi parcheggiammo l’automobile e ci inoltrammo a piedi nella radura. Poco distante, v’era una distesa d’erba occupata da alcuni villeggianti e più in là, una lingua d’asfalto costituiva l’accesso in acqua mediante una scaletta. Il mare sconfinato brillava in lontananza e con lo sguardo potevamo abbracciarlo quasi interamente; sulla sinistra, uno scorcio dell’antica Parenzo dominata dal campanile. Rientrammo in città. Stava calando la sera. Nella piazza principale, furono allestiti un bar e un palco sul quale si esibirono alcuni musicisti in onore della festa del paese. L’atmosfera era frizzante, gioiosa e alle volte si levavano grida festose: la gente appariva allegra e serena. Belle ragazze passeggiavano per strada vendendo rose adagiate su grandi cestini di vimini; C. ed io, sorridenti, brindammo con la dolce grappa locale. Infine, a mezzanotte, scoppiò lo spettacolo pirotecnico. Così si concluse la prima notte croata e seguirono più o meno allo stesso modo anche quelle successive. Ripartimmo con una grande tristezza nel cuore. Di quei giorni spensierati, conservo il ricordo delle splendide persone che conoscemmo, ora curiosi viandanti, ora studentesse universitarie impegnate in progetti europei. L’ebbrezza dei liquori, la musica alta, l’ospitalità della popolazione locale, tutto questo concorse alla scoperta di una realtà che non immaginavo potesse esistere. Ripenso a quell’esperienza, e mi chiedo se la magia non fu creata dal nostro entusiasmo oppure dalla stessa Parenzo, la città caleidoscopica. Ma in fondo, è un quesito che non necessita di risposta: la cosa fondamentale è avere il coraggio di provare, soprattutto insieme. - Ci sono Viaggi di Laura Fabbri Siamo sempre inondati di consigli su un’ipotetica destinazione verso la quale camminiamo, ma niente e nessuno, ci fa chiedere il come o il perché del nostro andare. Eppure esiste un’opera nella vita che noi chiamiamo viaggiare; eppure esistono Viaggi che noi chiamiamo Vita. Le ginocchia al petto, la testa piena di pensieri, per questa meta che tarda ad arrivare. Fuori dal treno il paesaggio intrecciato mi abbandona, come a spiegarmi che un viaggio è più importante del luogo in cui mi porterà. Di fronte il mio bagaglio è pieno; che siano vestiti e un gruzzolo di soldi è comunque un sacco che ti metti in spalla e che ti segue fino alla fine dell’avventura… Sì, perché in fondo è tutta un’avventura questa corsa verso l’ignoto che ogni tanto sentiamo l’esigenza di percorrere. Il problema è che il mio zaino pesa di dolori da risanare e risa da coltivare. Prima dell’arrivo spero che un po’ di orgoglio sia andato perso e che la rabbia abbia ceduto a quella canzone che parla di pace. Le mani stringeranno un po’ la paura, un po’ l’adrenalina. Gli occhi ripeteranno nuove parole e i sogni balzeranno ancora dentro me, ma aspetto il ritorno per vederli realizzati… Nell’attesa coloro questo quaderno; forse un po’ inutile per provare a cambiare le proprie abitudini, ma lasciarlo a casa sarebbe stato come dimenticare una parte di me, e in viaggio bisogna portare tutti se stessi. La fotocamera ha già immortalato qualche immagine, ma non c’è niente che l’anima non sappia ricordare dopo essere stata trafitta dal nuovo. Una torcia è utile al posto dei fari spenti nella notte, per non farti confondere, ma non c’è direzione sbagliata: ovunque vai cammina verso una nuova luce. Cammina, corri finchè i piedi non cederanno, finchè hai la possibilità tu buttati! È vero, ognuno ha la sua storia, ma se guardi in su, sotto a quelle costellazioni, siamo tutti un gruppo di anime alla ricerca del miglior futuro, non degli oscuri rimpianti del passato. Non pretendo di sapermi orientare senza bussola e cartina, ma ogni cosa dentro me freme dal desiderio di raggiungere dritta il traguardo: la vita che si desidera. Prima di partire per lunghi viaggi porta con te la voglia di non tornare più e il coraggio di accettare i cambiamenti; porta la voce che tra la folla sporcherà i tuoi silenzi. Per un viaggio non c’è nessun manuale, ognuno è pilota del proprio. D’altra parte tutto va così: il mondo è una sfera gravitazionale che ti tiene ancorato su questo fondo di meraviglia; comunque vada ogni passo è un volo per rinascere qui… Caro cuore randagio, non c’è carburante migliore della curiosità e della consapevolezza che non ci sono limiti per migliorare. Sei indeciso? Sorteggia la meta e mal che vada… “Destinazione Paradiso”. - Sono gelosa di Marco Polo di Leandra Cazzola Con gli occhi segue l'ultima frase di quel libro che l'aveva lasciata senza fiato. Cristina chiude il libro. Rimane con "Il Viaggiatore" di Gary Jennings stretto tra le mani, come se debba trasmetterle tutto ciò che aveva sentito tra quelle pagine, in quelle parole. “Sento i pensieri, le emozioni, le usanze persino gli odori di quei paesi lontani che Marco Polo ha conosciuto, vissuto, attraversato e io mi sento attraversata da tutto.” É distesa, sulla punta estrema della prua di un caicco nel Mar Egeo. É la sua giornata di riposo, tra quelle isole greche dove si é persa. Toglie gli occhiali da sole e chiude gli occhi. Inizia a ripercorrere il suo di viaggio. Partita da Viareggio, Toscana, Italia con le tre amiche del cuore. Tre amiche, un auto, una meta: la Grecia. Avevano percorso l'Italia dall'alto in basso fino ad arrivare a Brindisi ed imbarcarsi per Patrasso. Da lì fino al Pireo per girare tutte le isole. Una vacanza risolta, almeno per ora, in una permanenza per lei. Finita la vacanza post-laurea, il loro premio degnamente meritato e goduto con intensità; Anna, Emma e Sara hanno fatto ritorno a casa, lei no. Ha trovato questo lavoro su un caicco che organizza crociere nel Mar Egeo, in quel mare dove sta cercando di capire cosa vuole, cosa si aspetta dalla vita. Oltre che perdersi tra quelle magiche isole si é persa tra quelle righe e ogni pausa che aveva, leggeva avidamente le imprese e non solo, di Marco Polo. Ha letto la passione delicata per Hui- Sheng, il suo grande amore. “Ho bisogno di essere amata anch'io, di fare l'amore, ho bisogno di sesso!” questo pensiero invade la mente di Cristina, stringendo ancora più forte tra le mani, sul ventre quel libro. Una leggera brezza si alza in quel caldo pomeriggio estivo mentre il caicco fa ritorno al porto di Santorini. L'andamento del caicco e le sciabordio delle onde é una ninna nanna per Cristina, che si assopisce. Sogna Marco Polo, in quel libro così reale; un grande viaggiatore, strabiliante. Cristina si sveglia richiamata da una voce che non conosce. «C'é nessuno in barca?» Si alza in piedi e guarda intorno. Il caicco ha attraccato, ma nessun'anima in giro. “Una voce che parla italiano” - stordita dal sonno “ma non vedo nessuno!” «Ehi, della barca! Sono nell'acqua!» Cristina si sporge e vede un ragazzo con la maschera appoggiata sulla fronte con un braccio fuori dall'acqua e qualcosa in mano. «Monta a bordo!» facendogli cenno di andare alla scaletta. Gli va incontro. Allunga un braccio per aiutarlo e a metà scaletta, lui le porge il libro. «É volato giù: l'ho preso! "Il Viaggiatore", bel tomo!» strizzandole l'occhio. «Christian, il mio nome é Christian.» «Piacere, Cristina. Grazie mille! Ho appena finito di leggerlo. Jennings scrive: "Noi viaggiatori abbiamo di solito una meta e uno scopo che ci induce a raggiungerla, e ogni sosta lungo il cammino non è altro che una nuova pietra miliare del viaggio" e io sono gelosa di Marco Polo!». - Londra per pensare di Leila Zoia 21-24 settembre2012 “Everybody needs a place to think” così recitano le targhe collocate nelle panchine sulle rive del Tamigi, a Londra. Perché è vero tutti hanno bisogno di un posto per pensare. E i londinesi devono pensare spesso e bene, perché lì le cose sembrano funzionare. L’attitudine all’organizzazione permette loro di pensare a soluzioni per utilizzare al meglio le risorse disponibili. Come per esempio utilizzare le stanze del College lasciate vuote dagli studenti nel periodo estivo e adibirle ad albergo. E proprio in uno di questi studentati abbiamo alloggiato io e la mia compagna di viaggio. Una bella stanza a South Kensington, nella zona 1 di Londra a un prezzo modico. Stando nel College ci siamo calate nella realtà degli studenti universitari londinesi. Fare colazione assieme a loro e vedere il loro stile di vita, ci ha fatto perfino venire la tentazione di rimanere lì per fare un dottorato. Segnali positivi! Appena entrati nella stanza, accanto al tradizionale bollitore per il the delle cinque, troviamo delle bustine di zucchero del commercio equo solidale. Sulla bottiglietta d’acqua in dotazione c’è scritto che i profitti sono destinati a finanziare progetti per portare l’acqua potabile alle famiglie dell’Africa. Sulle salviettine al motto di “piccole azioni collettive possono fare la differenza” ci sono scritti dei suggerimenti: “Ecco un’idea: spegni il tuo computer di notte” o ancora “Ricicla il vetro, la carta e le bottiglie di plastica”. Per non parlare della “Student switch off competition” una gara fra le diverse hall dello studentato a chi riduce di più i consumi energetici. Chi risparmia di più vince un party! Vivere bombardati da questo tipo di messaggi credo renda naturale pensare la quotidianità in maniera sostenibile e produca effetti sulla consapevolezza ecologica e sociale di questi ragazzi, che siano cittadini britannici oppure no. Perché il college è frequentato da un ampio numero di studenti provenienti dalle più svariate origini culturali. Per rendersene conto basta gettare un occhio al menu della mensa, in cui accanto alle tradizionali pietanze british, è possibile ordinare un ottimo pollo tandoori o un falafel. Nelle vicinanze del College è inoltre facilissimo incontrare gruppi di ragazze che indossano l’hijab. A Londra è facile vedere donne con il velo ovunque, anche nei front office degli uffici, o signore inglesi in età vicina alla pensione lavorare con grande padronanza degli strumenti informatici. Cosa che in Italia capita di vedere raramente; purtroppo. Un contesto culturale stimolante: centinaia di installazioni, mostre fotografiche, pannelli informativi, mercatini, oltre alla straordinaria ricchezza di teatri e musei ad ingresso gratuito. La possibilità di immergersi in questa incredibile disponibilità di cultura, a mio giudizio, facilita la propensione al cambiamento, ad aprire i propri orizzonti, ispirarsi e pensare a soluzioni sostenibili in grado di migliorare la qualità della vita. - A Istanbul, con la 2CV, in due e mezza: ricordo vintage. di Letizia Lusini Era l'11 maggio 1979, avevamo quarantacinque anni in due, io e Andrea, e ci si era sposati il giorno prima. Nella mia pancia appena accennata alloggiava Giulia, bionda e occhi azzuri, che sarebbe nata a settembre. Il 2CV verdolino carico di piccoli bagagli, una dispensa fornita, sacchi a pelo e felicità, ci portò a Istanbul. Io non avevo mai passato il confine italiano; la Jugoslavia prima e la Grecia poi, furono scoperte per i miei occhi aperti, che vedevano l'estero, le diversità, le similitudini (ricordo l'impressione provata per le prime scritte in una lingua lontana, gli sguardi curiosi sugli abiti della gente); per le mie narici, che entravano in ristoranti e trattorie catturate dai nuovi odori, e per il mio palato, che assaggiava titubante i piatti di quei paesi. Anche il mio giovanissimo marito fu una scoperta; solo cinque mesi che ci conoscevamo.. Dividemmo per la prima volta la tavola (spesso cucinavamo noi, con il nostro amico fornellino a gas), e il letto: non il “nostro” lettone che ci aspettava al ritorno, ma ogni sera, o ogni due, un letto diverso, in diversi alberghetti e locande. Dividemmo per la prima volta, e continuammo a farlo per anni, il nostro desiderio di scoperta di posti sconosciuti, appagammo il nostro interesse comune per il viaggio nei significati più diversi; le foto, che ora riguardo un po' giallognole e in bianco e nero, furono il nostro diario: Sarajevo com'era, una festa balcanica in costume nelle campagne intorno a Beograd, una gomma a terra della 2CV vicino a un Monastero in Banja Luka (ora distrutto); poi in Grecia, un tripudio di isole e isolette, caffè di soli uomini in nero all'aperto, un'insalata di olive verdissime e tzaziki su una tovaglia a quadrettini bianchi e azzurri.. E infine lei, Istanbul la grande, il Bosforo, io con un vestito premaman a fiorellini chiari appoggiata al ponte, dietro gabbiani che planano sulle guglie di Santa Sofia... La 2CV fu la nostra amata compagna di viaggio, si rivelò affidabile e sicura, instancabile; vegliò sui nostri sonni sui suoi sedili di vilpelle nera, si offrì come desco ai nostri mangiari semplici, e ci portò fino a quella città strepitosa. Non sapevo, allora, che il ricordo di quel viaggio sarebbe stato così palpabile ora, dopo più di trenta anni; mi sembra di sentire, anche da qui, lo sghignazzare dei gabbiani sulle acque scure di quello spartiacque tra oriente e occidente; e io, che in Istanbul (il nome Costantinopoli mi piaceva anche di più) coi miei pochi anni ingenui ci cercavo “Le mille e una notte”, ebbi una delusione. Istanbul mi apparve bella, ma vicina a noi; molta europa, troppa per me, che solo nel suo souk colorato e luccicante sentivo un pò appagata quella voglia... Avrei dovuto aspettare di vedere il Marocco, l'anno a seguire... Ma questa è un'altra storia. - Mini-travel 2.0. Toglieteci tutto tranne il viaggiare! di Letizia Neri Il paese è in declino, dicono. Lo si percepisce, oltre che da quotidiani e tv, da indici di natalità, aumento del consumo di antidepressivi, dall'inquinamento, dai giovani disoccupati e sempre più sfiduciati e scoraggiati. Il “tutto bene” è ormai stato sostituito dal “mah, insomma” nei discorsi di circostanza. Non c'è più spazio per i sogni. Non c'è più spazio per la fiducia verso gli altri, perché la gente ti vuole fregare o farti del male. Ma è davvero così? Io non ci voglio credere. Penso che la nostra epoca sia anche piena di opportunità, per chi ha la volontà di coglierle. Così un bel giorno di inizio estate, decido mettermi alla prova organizzando un mini viaggio low cost (questo passa il convento) basato sulla sharing economy. Una parola magica per me e il mio ragazzo che vogliamo passare una settimana a Parigi spendendo poco.Una vacanza a minimo impatto ambientale, 2.0 e, ingrediente fondamentale, ad alta fiducia nel prossimo! Acquistiamo un tgv Milano-Parigi, costo praticamente inferiore a qualsiasi viaggio in treno Firenze-Milano. Un vero colpo di fortuna! Cercando su internet con un po' di fatica troviamo un posto per dormire a Milano, “surfando” sul divano di una ragazza polacca che lavora nella capitale lombarda. Sempre online troviamo un piccolo appartamento a due passi dal Sacre Coeur. La coppia che ci vive si trova a Londra in quei giorni e lo affitta via internet. Mancava un piccolo tassello per completare il nostro viaggetto a Paris: come raggiungere Milano da Pistoia? In treno? Costo improponibile. E poi non c'è tempo, il treno per Parigi parte alle 8, 45 da Porta Garibaldi. Auto? Nemmeno. Dove la lasciamo? Quanto costa? Quanto è stressante guidare?! Niente. Poi mi sono ricordata di BlaBlaCar, il carpooling poteva essere un'ottima soluzione! Già iscritta, entro nel sito, cerco: Firenze-Milano, inserisco la data e tadaaan! Trovato! Eccolo il nostro autista che renderà tutto possibile! Ci accordiamo con Domenico per partire da Firenze intorno alle 22, al telefono sembra una persona a posto e poi ho visto che ha il massimo dei punti nelle recensioni. Domenico è pendolare e rientra proprio quando noi torniamo da Parigi. Perfetto! Abbiamo un passaggio anche per il ritorno! Il top! Alle 22 in punto saliamo in auto. Ci sono giusto due posti per noi insieme ad altri ragazzi che vanno a Milano, tutti pendolari. Il viaggio va molto bene, parliamo di noi, del più e del meno e il tempo vola. Arrivati paghiamo la nostra quota, ringraziamo Domenico e lo salutiamo con la promessa di vederci tra qualche giorno per raccontargli la nostra avventura. Tutto va oltre le aspettative. Abbiamo speso poco, conosciuto persone nuove, ci siamo messi alla prova. Un' esperienza memorabile, da raccontare tutte le volte che sentiamo parlare male di questo mondo. Il viaggio di ritorno è ancora più bello perché siamo pieni di entusiasmo e voglia di condividerlo con i nostri compagni di viaggio. -Un viaggio di Loredana Balocco Codice Corsica del sud Savona - Portovecchio: partenza 5, 45, in perfetto orario, totale ore di sonno 2, 30 scarse; Max è riposatissimo, io mi sento la classica barca nel bosco, però, dopo una non troppo lunga attesa, sono sul ponte con un piccolo bagaglio alla ricerca di una sdraio che si tramuta in una comoda sedia per il mio meritato riposo…... Ma…., tutta questa nave…, e il mare…., e le persone…, e i cani persino.…, tutti vanno esaminati, controllati uno ad uno: è un faticoso dovere che svolgo brillantemente ma il mio proposito si vanifica: neanche un minuto di sonno! Bastia già si allontana; tre ore di viaggio: l’ideale per dormire un po’…. Ma…, Max parla…, la strada va controllata…, , senza le mie lucide indicazioni, si perde di sicuro, e poi… i castelli.…, il temporale…: bisogna essere ben svegli fino a casa: residence Village Marine a pochi KM da Portovecchio. Accasarsi non è facile, i padroni arrivano come falchi a ritirare il dovuto; si vede che a Saronno il complimento non va di moda. Max è stanco e la cosa lo mette di malumore, io ho dimenticato il sonno: là in fondo, dopo la piscina che ignoro, c’è il mare ad attendermi! Max rovescia il suo orgoglio ferito sulla spiaggia piccola e terrosa che rende l’acqua un po’ torbida ma il mio entusiasmo acquatico alla fine lo contagia e sguazza anche lui facendosi passare ogni ombra; la cena al porto di Portovecchio, cioè nel ristorante in assoluto più vicino, a base di tagliatelle con aragosta e gateaux al torroncino, gli consentirà il buonumore per parecchio . Palombaggia è la spiaggia della nostra casa, vicinissima, con kilometri e kilometri di sabbia fine e bianca, protetta da una duna che, come recita il cartello, è un’ oasi ecologica preziosa e delicata; mentre Max attende l’atavico ordine del bagno, io entro nell’acqua meravigliosa e il mare mi avvolge, lo avvolgo, lo vivo, mi vive Questa suggestione permane anche se la sera si cambia scenario: per la cena si sale alla montagna, la montagna di U Spidali, verso il massiccio della Bavella; ogni scusa è buona per fermarsi: il cartello indicante il sentiero dei tafoni: cosa sono i tafoni? e la Cascata Piscia di gallo: chissà perché? ecco, guarda, le guglie della Bavella: sembrano guardiani! Mangiamo nel poco francese, molto corso e genovese, un po’ sardo, ristorante U funtanone che Max ha magicamente estratto dalla sua guida Lolly planet: piatti ottimi e conoscenza col giovane cuoco umbro lì da poco tempo e davvero stupito di cucinare così all’italiana; usciamo soddisfatti così tanto che, per avere la scusa di tornare, Max dimentica les lunettes. Domani telefoneremo. Domani ….. , arriveranno le nostre amiche: questa casa con cinque posti, in cui a malapena stiamo in due, andrà bene per quattro? La preoccupazione non è poi così grande da turbare il nostro sonno, il programma alletta: sveglia di buon’ora per andare alla Rondinara, tanto non arriveranno prima delle tredici; invece no: ore 11.30 alla fermata dell’autobus a Portovecchio; ma…. dove è la stazione? Lolli planet entra in azione e ci spinge per le salite di Portovecchio in un gradito giro turistico, scandito da infruttuosi contatti di informazioni Non è il mio carente francese…., è che….. proprio che non lo sanno…, è ….. proprio che non è lì, ma al porto: finalmente qualcuno svela l’inganno della Lolly! L’attesa, che si protrae fino alle 12, per me che ho già nuotato al mare e fatto relax in piscina, è piacevole: fresco il vento nei capelli mi fa sentire bella, bellissimo è il tipo che sbuca fuori dall’ufficio d’informazioni, occhi azzurri illuminano la pelle di bronzo dorato: una vera icona estiva. Marina e Nadia arrivano, stanche e, ma la nostra ospitalità e la sabbia fina della spiaggia di Palombaggia, dove dormono sotto strane e protettive nuvole per il pomeriggio intero, le rifrancano e alla sera sono pronte per andare a recuperare les lunettes. Cena di terra un po’ meno entusiasmante della prima, forse il cuoco umbro è di riposo, ma tutto è piacevolissimo guardando il mare illuminato dalla luna mentre si torna alla casa con quattro comodi posti. Oggi è il giorno del turismo di massa, pazienza.. ! quasi rimarrei a casa, ma ho voglia di stare con loro. L’ispirazione non può essere migliore: la traversata in barca delle bocche di Bonifacio mi lascia incantata, l’sola di Lavezzi, dove ti senti un naufrago solitario anche in trecento, è uno splendore di atmosfera primitiva che ti fa godere le gioie della pietra e dell’acqua. Sarà per questo che Marina, adducendo la scusa di tornare col traghetto prima per vedere un po’ la città, mi coinvolge in una calda ma bellissima avventura esplorativa che si conclude con un bagno di congedo a pochi metri dall’attracco: Max e Nadia neanche fanno finta di essere sorpresi. Stasera niente cena al ristorante per me che riesco a sentirmi perfettamente appagata consumando le inesistenti riserve del frigo sulla sdraio del giardino e guardando la luna. Le suggestioni della sera mi convincono a passare la giornata successiva lì’; Nadia si accoda piuttosto volentieri e insieme ci godiamo le risorse del posto e quelle molto più limitate del frigo. Max e Marina, accidenti.. , riescono a tornare dal loro giro verso il massiccio della Bavella, per l’impegno della cena a Bonifacio: siamo gente di parola noi! Detto, fatto: ci troviamo immersi in una…. surreale, mistica, vista sull’anima: il cimitero marino ha davvero uno spazio che non appartiene all’umano, una fotografa orientale dalle finestre di un antico palazzo invita sincera alla solidarietà come un carismatico imam, nel Bazar orientale la gente pullula rumorosa, ne vicoli di quell’ operosa Genova medievale i mercanti seducono il turista. Bonifacio è entusiasmante: negozi fatti per te, ristoranti su misura, piazzette nate per il mercato, vicoli scoscesi nei quali punti panoramici apparentemente casuali consentono viste mozzafiato: nulla stona. Torniamo a casa, contenti della cena ristorante Lolly e della lezione mistico filosofica, sentendoci davvero in pace col mondo. Forse la fotografa dell’antico palazzo parlava anche di questo. Io e Nadia in questo viaggio non ci siamo ricordate spesso di essere donne d’intelletto ma sul bordo piscina la descrizione riportata da Lolly del sito archeologico di Filitosa ha evocato un’isola di Pasqua corsa del 6000 a.C che vogliamo assolutamente vedere e con fine approccio psicologico,.. è il mio mestiere, Nadia ha convinto Massimo, che si è già anche appassionato al progetto e rimane un po’ deluso dalla variazione di programma. Forse…. è un po’ per specialisti, forse…. non ne ricaveremmo molto; in realtà nessuno ha voglia di farsi tanta strada in macchina: Rondinara, Santa Giulia, la spiaggia confortevole di casa ammiccano sorridendo: Filitosa al prossimo viaggio! L’ ultima cena, quella del commiato, è per me e Max quasi rituale, stesso ristorante, stesso menù buonissimo e raffinato ma la partenza imminente aleggia rendendo lo shopping inutille: Marina, tra mille cappelli, rimane senza cappello, come io rimango senza un nuovo vestito o camicia o scarpe, o collana e andiamo a dormire un po’ meno serafici del solito. Il risveglio di Marina che io scambio per Nadia, non è un’ allucinazione…, è che è ancora buio…, dà inizio ai laboriosi preparativi: immancabile colazione completa, pulizia sommaria della casa, saluti ai padroni molto gentili, non sembrano neanche gli stessi! Nella nostra nuvola vacanziera non abbiamo previsto il traffico del sabato e, se Marina esorcizza la noia con le chiacchiere, di solito non è così, tutti troviamo lungo il viaggio verso Bastia, soprattutto Max che guida e io per empatia. Arrivati al traguardo, i ritmi cambiano: parcheggio facile, pranzo buono in un centro commerciale, attesa lunga ma non troppo al porto c’è il solito vento vivace nel sole dei 40 gradi, compagno di un viaggiodi ritorno spettacolare: il mare è una distesa di luce tranquilla che ci trasporta verso uno stesso mare, un po’ più nostro. Eccolo, ci saluta fascinoso e amico al giungere della sera. E’ sempre la stessa storia: non sono ancora partita da Savona, non l’ho ancora lasciato che già mi manca…, succede sempre così! Torno a casa volentieri con un po’ di mondo nell’anima: voglio scrivere quello che questo viaggio mi ha lasciato. Da sempre sono convinta che i viaggi, brevi e vivaci, lunghi e tranquilli, esotici o rilassanti insegnino la vita e gli altri e te stesso e lascino orme che orientano, se esiste la voglia di seguirle. Scoprirò ciò che ho appreso piano piano: conoscersi è un processo interessante e perenne, un’ avventura da vivere con saggezza. Mentre rifletto contrastando testardamente il sonno, Il mare, nella sua gigantesca, luminosa consapevolezza, guarda con benevole e superiore ironia i miei pensieri e impietoso illumina mio sereno e assonnato rimpianto. “orme”l Grande creatura, che si vorrebbe catturare, almeno con un disegno per qualcuno, con una foto per altri; rimane scolpita nella memoria e concentra in sé il sapore atavico di questa terra: è la quercia da sughero che domina lo spazio dividendo la propria saggezza con le gigantesche pietre che costellano la foresta. Fin dal primo impatto si comprende che il mare, splendido, terso, dalle mille sfumature dell’ azzurro, è da sempre lo sfondo di una esistenza umana di dura terra, presto allontanatasi da una costa insidiosa di paludi e di inaccessibili falesie. Il mare è risorsa ma anche pericolo da sorvegliare, fortezze e opere difensive disseminate ovunque non sono mai bastate a difendere dal nemico sempre nuovo.QQ Forse gli uomini di Filitosa, attraverso i giganti antropomorfi, che ci parlano dal 6000 a.C., avevano intuito un’ indiscutibile verità: quello che qui si respira non è lo spazio, non è il tempo degli uomini, ma è la dimensione molto più vasta della terra, a sua volta minima nell’universo. O forse le stele, sempre più umane e sempre più grandi, erano una sfida, non un ringraziamento, per quei rifugi scaturiti dalle rughe di saggezza della montagna. In essi i il tempo ha plasmato forme che anche oggi l’uomo, come l’antico uomo, legge come sue: dita, profili, volti dalle mille espressioni, cavalli, superbi leoni: la natura è saggia e qQQui gli alberi e le pietre lo sanno e lo insegnano. Sul “sentiero dei tafoni”, è la foresta dell’Ospedale, insieme ai giganti di pietra, a riportare l’uomo alla propria finitezza, unica dimensione che gli consenta la paceQQ; e allora può ammirare il grigio possente di Sartene che nei vicoli tortuosi e scoscesi non consente mai di dimenticare la sua forza, come a sfidare anche lei gli infiniti e i sublimi orizzonti del mare di Roccapina. E proprio qui, in una bettola cieca alle suggestioni del mare, biechi uomini ricordano che neppure qui il rispetto è scontato e che anche oggi i baluardi di difesa devono fronteggiare nemici ben presenti. QQ Ma su questi luoghi la foresta vigila: non è mai una massa di verde indistinto, i suoi netti contorni si estendono fino allo svettare grigio del massiccio della Bavella, fino agli azzurri avvolgenti delle baie Portovecchio . Improvvisamente, a sorpresa, la falesia scolpisce l’anima, più selvaggia e definitiva, diversa da quella del nord Europa; da essa Bonifacio rievoca ironicamente, con la sua imponenza, il marchese toscano che le ha dato il nome, e parla con autorità di un uomo che non lotta con la natura, sa che non avrebbe la minima possibilità, ma che cerca, e spesso trova, con essa una complice adesione. Dal mare, verso le isole Lavezzi, in una traversata che ha il sapore di un viaggio nel tempo, dove sono ancora le pietre a coinvolgere con l’alfabeto delle loro forme in un sacrale e inevitabile rispetto, la falesia non suggerisce alcuna possibilità abitativa. Eppure antichissima è stata l’intuizione che qui era possibile vivere e mangiare e costruire le città e divenire preda ambita di popoli conquistatori che non sempre avevano imparato dalla loro terra la saggezza. Genova, gli Aragonesi, la Francia, i Papi hanno conquistato ma mai domato gli uomini testardi e forti che vivevano con la pietra e con il mare; della loro determinazione parla la Scala degli Aragonesi con i suoi 168 scalini, scolpiti nella roccia, che da Bonifacio scendono diritti nel fianco di pietra a immergersi nel mare. E parla di loro anche il cimitero marino dove al tramonto, splendido e grande, ti avvolge la pace surreale di una musica lontana, in una armonia di luce e colore che non può essere soltanto la scelta azzeccata del ristorante vicino; è il sole roseo e tenue ma non pallido che ti invita ad avvicinarti con lui quietamente al bordo della roccia per salutare il mare e trovare riposo. Bonifacio è la fortezza medievale, è il fondaco genovese, è il bazar che evoca l’oriente esotico: è l’uomo che mette in atto tutte le sue risorse e sopravvive e non dimentica il bello con cui nutrire l’anima. La macchina fotografica, come le antiche armi di conquista, cerca di imprigionare nell’obiettivo lo spazio ma le dimensioni si susseguono e si accavallano nell’impossibilità di afferrare la bellezza e diventarne padrone; soltanto quella fotografa proveniente da una terra lontana che le ha forse insegnato la vita con le stesse parole, trasformando le finestre del grande palazzo abbandonato in un suggestivo trompe l’oeil, catalogo di visi umani, di sentimenti e sofferenze e gioie, ha saputo impossessarsi, pur per un momento, di quei luoghi e da essi parlare della dimensione infinita dell’universo dove anche il piccolo uomo è protagonista se consapevole portavoce di solidarietà. - Le nuvole di Lorella Catuzzi Il mio Kenya non è solo un ricordo, quello che nasce e si colora con le foto e le parole, è una forte nostalgia e tornerei in Kenya anche subito. Là, dove il cielo è più vicino, le stelle più luminose, le nuvole sospese, gli infiniti silenzi e la natura selvaggia baciata dai tramonti color arancio. I sorrisi e la dilatazione dei tempi e degli spazi estranianti ma accoglienti. Il tempo rallenta e il cuore cammina... Mi chiedo cosa ci spinge a viaggiare. Forse per superare quella sensazione di nudità che si avverte quando ti spogli del superfluo e ti avvicini fino ad accogliere l’altro in te stesso. Partiamo vuoti, vuoti anche di noi stessi, di ciò che di noi vogliamo cambiare perché il viaggio ci aiuterà a farlo. Il mio Kenya è una giostra di colori, sapori, sorrisi, è una calma dinamica, un presente perpetuo. E’ il mio Kenya dell’Hakuna Matata sempre, del Pole Pole ad oltranza. E’ il ritmo africano che ti contagia fino a chiederti, ma perché prima correvo? Il mio Kenya l’ho scoperto con la volontà di abbandonarmi a riti ancestrali, spogliandomi di retaggi troppo moderni e ritornando nell’embrione del mondo. Il mio Kenya l’ho scoperto oggi e lo porterò nel cuore per sempre e sarà per me da monito quando dovrò rinunciare a qualcosa nel mio sfavillate mondo progredito. Quando il mio primo impulso sarà quello di arrabbiarmi, scaccerò la rabbia e sfodererò un raggiante sorriso ripensando ai sorrisi che ho ricevuto gratis da chi non ha nulla, rifuggirò dalla frenesia pressante ripetendo mentalmente pole pole e hakuna matata per apprezzare più pienamente quello che oggi accade, non sarò più parca di abbracci e affettuosità risentendo il calore degli abbracci così generosamente dispensanti, senza alcun motivo, saluterò l’alba del nuovo giorno cantando Jambo Bwana. Il mio Kenya è anche vostro, l’Africa è già dentro di noi perché ognuno di noi discende da una donna di colore vivente in Africa 150 mila anni fa e il mal d’Africa non è una malattia ma la consapevolezza che il nostro cuore è tornato a casa. Il Kenya che voglio raccontare è visto attraverso gli occhi di una giovane donna dagli occhi celesti e un sorriso innocente. Inizia il viaggio con la ingenuità e curiosità di una bambina e la determinazione di un’ avventuriera. “Parto dall’Italia con la mia valigia carica più che di vestiti di tanti medicinali, cibo italiano, utensili, limette per unghie e il mio foulard. Dovremmo passare diverse notti in tenda, la notte prima non ho chiuso occhio al solo pensiero. Però sento una forza che mi attrae e mi fa pronunciare quasi involontariamente, Safari. Il mio gruppo è composto da 16 persone che conoscerò in terra africana. Mi soffermo a guardarli e in ognuno di loro scorgo una parte che ho in me stessa. Neanche un giorno e già siamo tutti amici, felici e benevoli verso quest’avventura. Dormiamo poche ore a Nairobi in un Hotel piuttosto pittoresco soprattutto per i servizi. Di prima mattina ci accolgono, con uno splendente e sincero sorriso, i nostri autisti e un bus sgangherato color havana. Quei sorrisi tanto spontanei mi hanno infuso un’immediata serenità e fiducia tanto da scoprirmi sorridente inconsapevolmente. Ci ripete Sawa sawa? Eh? Ma si, bene bene! Rispondiamo ok. Ma ripete “Sawa Sawa” insistendo e in coro “Sawa Sawa”. L’orgoglio linguistico è una virtù e lo apprezzo. Nairobi è una città vivace che non deve essere scambiata per confusione, ognuno ha il proprio spazio. Pole Pole mi ripete il nostro autista, ovvero piano piano. Iniziamo già con le lezioni di swahili che incalzeranno per tutto il viaggio tra un misto di curiosità e spaesamento . Partiamo alla volta di Namanga ai confini con la Tanzania per avvicinarci ad una delle riserve più visitate l’Amboseli National Park. Prima notte in tenda. E’ divertente montare ognuno la propria tenda e comporre un accampamento variopinto, ciò mi suggerisce che il campeggio non sarà poi così tremendo. Cuciniamo tutti insieme le provviste portate dall’Italia. Il primo giorno di Safari inizia sotto un cielo plumbeo, gran freddo e tanta polvere. Mi copro con il mio foulard per non sporcare i capelli e ripararmi la bocca. Appena entrati ecco scorgere degli animali, riconosco zebre, elefanti e giraffe. Ma quanto sono alte! Ci sono antilopi, gazzelle, gerenuk, dik-dik, gnu, ma quante razze, sono quasi disorientata. Mi protendo verso l’esterno dal tettuccio del bus per cercare l’inquadratura migliore. Saluto le giraffe che, piegando l’orecchio, sembra che ricambino il saluto tra una brucata e l’altra. Alzo gli occhi per un attimo e qualcosa cattura i miei occhi, nuvole, nuvole tridimensionali, nuvole immense e rotonde. Il cielo sembra disegnato da acquarelli e in mezzo a quel disegno ci sono io. Dopo una serie di sussulti, mi accorgo che il mio foulard svolazza e con disinvoltura lo ripongo sul sedile. La terra, il sole, che fa capolino tra le nuvole, non mi danno fastidio. In lontananza si intravede un groviglio di bus e jeep, ci avviciniamo e notiamo una iena. Non è possibile tutto questo casino per una iena. Infatti l’assembramento è per dei leoni che però si vedono in lontananza. Con il binocolo cerco di scorgerli, provo e riprovo e li centro. Una leonessa dagli occhi color ambra che guarda verso di me. All’improvviso mi sento una preda, come se potesse assalirmi in un momento, ma dura un attimo essendo protetta nel mio bus. Notte in campeggio a raccontarci dell’esperienza fantastica vissuta e siamo solo al secondo giorno. Chissà quante ne vedremo. Il gruppo è molto coeso sebbene viaggiamo in tre minibus. Ci rincorriamo per le piste e facciamo a gara per vedere chi avvista più animali da vicino. Gli sfottò rallegrano le fredde serate intiepidite da un tenue fuoco. Anche questa notte si campeggia su di un pezzo di terra polverosa. E pensare che all’arrivo al campeggio, in cui un’imponente acacia trionfava, dopo aver attraversato strade sterrate facendoci scorgere animali e paesaggi mozzafiato, il mio primo ingenuo pensiero è stato: “Meno male, così posso fare una bella foto!”. Ma quando gli autisti scendono e cominciano a scaricare i nostri bagagli capisco che quel fazzoletto polveroso di savana in mezzo al nulla sarà il nostro campeggio. I servizi non ispirano all’igiene personale e quasi tutti decidono di non usufruirne. Notte passata insonne per via di sinistri rumori che giustifichiamo a noi stessi dicendo: “E’ solo il vento!” Ma chissà chi ci ha creduto davvero pensando, piuttosto, che fossero le scimmie che erano venute a disturbare. Ci svegliamo all’alba per iniziare un nuovo Game Drive. Il sole sta nascendo e ammiriamo l’alba che tinge di color rosa arancio il panorama intorno. Ed ecco che in un attimo il sole è già sopra l’orizzonte. Eh bè, siamo sull’equatore. Ancora tante varietà di specie, felini, volatili, mammiferi. Ed ogni avvistamento è un sussulto. Sembro una bambina nel parco giochi ed è buffo scoprire che lo stesso sentimento è uguale per tutti. Lasciamo l’Amboseli con il carico di foto e di emozioni e ci dirigiamo verso il Samburu N.P. Lungo la strada incontriamo paesaggi lussureggianti, bambini festosi che ci salutano allegramente. I raggi del sole che filtrano dai finestrini infondono un dolce calore che culla il corpo intorpidendolo; gli occhi si socchiudono e il petto si gonfia di animosi sospiri. Un senso di benessere mi pervade, ma sgrano gli occhi improvvisamente, voglio imprimere nella mia memoria ogni cosa. Ogni singolo movimento di oggetti, animali e persone. Voglio assaporare ogni attimo. Il Samburu si presenta a noi intimo, selvaggio, tutto nostro. Gli alberi di acacia disegnano un paesaggio incontaminato e selvatico. Il nostro bus scorrazza agilmente lungo le piste del parco strattonandomi continuamente come a ricordarmi che tutto questo non è un sogno. I miei occhi sono talmente ricettivi che ormai la polvere non è più un disturbo, il mio sguardo è sempre proiettato all’orizzonte, lentamente mi giro e un tuffo al cuore mi fa spalancare la bocca. Un branco di leonesse proprio ad un palmo dal naso. Fisso quegli occhi che mi scrutano, sembrano degli enormi gatti, non fanno paura. Abbasso lo sguardo e noto la possentezza degli arti. Una zampata potrebbe distruggermi. Mi capita spesso di trovarmi in bilico tra il reale e l’immaginazione. Un’unione di mondi possibili non empiricamente mostrabili. Anche questa è Africa, anche questo è il safari. Il silenzio è l’unico assordante rumore udibile. Un silenzio profondo, per noi innaturale, spezzato da qualche necessaria battuta, come se non fossimo abituati a convivere con il silenzio. Eppure il silenzio parla, descrive, culla. E nel momento in cui avverto questa sensazione di profondo misticismo primordiale siamo di nuovo pronti a partire. La nostra cellula moderna non può soggiogarsi al ritmo tribale del lentamente scorre. Stasera siamo in un campeggio ben attrezzato, molto confortevole. Tra noi erba secca gialla e alberi di acacia. Cammino su un sentiero dritto e polveroso, pochi passi e devo ordinare alle gambe di fermarsi, non è sicuro allontanarsi, così i rangers hanno sentenziato. Ma stranamente non avverto alcun senso di pericolo ma solo una profonda pace e un benessere diffuso. Baciata dagli ultimi raggi del giorno, mi perdo nella magia di un tramonto che è al tempo stesso infinito e veloce. E’ già buio ed è ora di preparare la cena. La nostra cara pasta ci aspetta. Tra chiacchiere e aneddoti divertenti le stelle bussano prepotentemente e inaspettatamente scopro che il cielo d’Africa non è solo il giorno brillante e lussuoso ma uno stuolo di punti luminosi che emergono su di una coperta nera e una splendente scia luminosa: la via lattea. Quando ho guardato in alto ho visto uno spettacolo e ho pensato che doveva essere quel cielo che Dante aveva immaginato uscendo dall’Inferno. Doveva essere quella magia e doveva aver provato la stessa sensazione che provavo io in quel momento: un’immensità tranquillizzante e calma che infondeva serenità e pace, che fa respirare a pieni polmoni come la prima volta. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Di buona lena ci alziamo dai nostri giacigli e ripartiamo alla volta di un villaggio tipico. Appena fuori dal cancello una schiera di donne ci accoglie intonando la canzone di benvenuto. Benvenuti ad Umoja. La nostra guida è una bellissima ed elegantissima donna che con fare pacato ci illustra la sua città delle donne. La particolarità di questo villaggio è che ci vivono solo donne con bambini piccoli, fuggite da mariti troppo violenti e animate dalla ricerca di pace, serenità e giustizia che pare abbiano effettivamente trovato. Passeggio tra le polverose viuzze e case di quel villaggio trasportata da una profonda ammirazione per un coraggio razionalmente scontato ma straordinariamente attuato. I bambini di Umoja sono i bambini delle strade che giornalmente incontriamo, sorridenti con la bocca e con gli occhi. Poveramente vestiti e magri nei fisici non sembrano mostrare patimento ma solo una luce che irradia i loro tondi occhi color pece. E’ ora di andare, mi volto un’ultima volta. Oggi è giornata di incontri, sono costanti, cadenzati, sicuri e quando sembra che gli animali che ieri non conoscevi oggi ti salutano come amici e sono diventati familiari ecco una scioccante visione, una cheeta. Un maestoso ed elegante ghepardo. I suoi occhioni ci scrutano ma non sembra essere disturbato. Il suo covo cespuglioso è per noi inaccessibile e lui lo sa. I nostri game drive continuano incessanti ed ognuno è fonte di nuove scoperte, fenicotteri rosa abitanti di laghi salati e caldi, rapaci, ippopotami e coccodrilli, rinoceronti, leoni e leonesse con cucciolate, struzzi, manguste. Qualcuno mi ricorda che c’è ancora un animale tanto raro quanto straordinario da vedere, il leopardo. In cuor mio spero di poterlo vedere ma se così non fosse sono già talmente paga di emozioni che non la vivrei come mancanza. Oltretutto abbiamo dormito con gli ippopotami e i coccodrilli, un’esperienza forte e intensa che mi ha fatto tremare di paura. Quella paura che è istinto di conservazione. Irrazionale ma umana. I sussulti ai guaiti sono scosse elettriche. Un tourbillon di emozioni africane. E proprio mentre scatto le mie foto impressionata dal “passaggio degli gnu” che innumerevoli dal Serengeti si spostano verso la Riserva del Masai Mara, uno scatto repentino del bus ci proietta vicino un albero isolato in mezzo alla savana. “Look there”, fa il nostro autista. Non vedo nulla, ma, ma, ma quelle sono zampe? Zamponi maculati. E’ un giovane leopardo in siesta. Ti prego “leo” volta il musetto, micione bello dai! Girati orsù. Niente da fare, non collabora. Provo un senso di delusione, quasi frustrazione. Mi guardo intorno e vedo orde di bus con bazooka giapponesi mirati. Mi sento accerchiata. Ripenso alla solitudine del Samburu e la rimpiango. Mi volto nuovamente verso il leopardo e compassionevolmente gli lancio l’ultimo sguardo e mi siedo. Il mio safari è finito e l’ultimo ricordo non voglio che sia così, un animale accerchiato e bersagliato come in uno zoo. Rivivo mentalmente gli attimi più struggenti. Il mio Kenya è stato altro. Quando alzo gli occhi siamo già ripartiti e ritrovo le mie nuvole tonde appese al cielo, la savana color oro, i raggi che filtrano prepotenti, gli uccelli che ci rincorrono, gli animali che ci attraversano la strada salutandoci con le orecchie. Eccolo il mio Kenya. E mi scopro a sorridere beata. In campeggio passiamo l’ultima sera. La nostra avventura è volta al termine. Nella giara dei miei ricordi conserverò con forza e ardore ogni emozione provata, ogni sguardo incrociato, ogni sorriso ricevuto, ogni odore sentito ed ogni rumore udito. Mi rimbombano in testa frasi sconnesse, provo ad ordinarle e casualmente pronuncio queste parole: le nuvole, il sole, l'odore e il sapore, i ricordi che si animano di intenso calore, tu lo chiamavi viaggio e non sapevi perché, solo ora puoi dire il viaggio che cos'è. Sento che il mio viaggio non si è concluso. Il Kenya non l’ho mai abbandonato, è rimasto con me. Quell’aereo che decollava trasportava solo il mio corpo, il mio cuore è rimasto lì, a giocare con i bambini orfani della missione di S. Martin. Quei bambini figli di un’Africa dalle mille contraddizioni ma così generosa, un’Africa così maestosa e regale nello spirito ma non nelle vesti, un’Africa selvaggia e addomesticata all’occorrenza. Non so se rimpiango qualcosa, forse nulla o forse tutto. Ma stranamente il mio viaggio non mi ha lasciato un senso di incompletezza, mi ha dato tutto ciò che gli ho chiesto e se avessi chiesto di più l’avrei ricevuto. Ora capisco coloro che nel viaggio vedono una crescita ed io ho imparato a crescere, ad essere prima di tutto un viaggiatore e non un turista. Ho imparato ad accogliere l’altro in me stesso e a donarmi all’altro. Sono partita carica di alimenti e vestiti, in realtà ero vuota e il mio Kenya mi ha riempito” - Da Tirana col furgone di Luigi Dapoli Di solito noi due partiamo in macchina. Questa volta siamo partiti con un furgone. Da Tirana. Tanto per cominciare a Tirana il furgone è un mezzo istituzionalizzato di trasporto: si paga per il viaggio, tutti sanno dove andare a prendere il furgone, dove ti lascia, dove si ferma o dove, certe volte, se ci si mette d’accordo, ti può far scendere. Ma il furgone non è un mezzo pubblico: niente biglietto, niente ricevuta, niente fermate segnalate, niente percorso da consultare... guida lui, il furgonista, il furgone è suo! Quello del viaggio tra Tirana e Kruja ne aveva dodici di posti, e trattabili perché per strada sono salite fino a sei persone altre, sedute nel corridoietto tra i sedili su degli sgabelli di ferro in dotazione. L'autista-proprietario cerca urlando i passeggeri in giro per la piazza e non parte fino a quando il furgone non è pieno. Per il prezzo del viaggio ci si accorda col furgonista e quando l'accordo è fatto vale più di una tariffa. Funziona così in tutta l'Albania che abbiamo esplorato. Noi il furgone da Tirana l’avevamo preso a Zogu Zi, il capolinea, e stavamo apposto, seduti, e per 100 lek a testa saremmo arrivati fino al castello di Kruja. Non male. Tutti e diciotto sudiamo attraverso un'autostrada da Willy il coyote fino a... Fushe Kruja. In albanese l'autista ci spiega, o noi capiamo, che dobbiamo prendere un altro autobus, più avanti, lì... dopo l'incrocio? il semaforo? il camion? Ci salvano due ragazze che parlano inglese. Ci accompagnano da una loro amica e andiamo dal padre di questa che ha una bottega di non so bene cosa proprio su quella strada e finalmente capiamo, o ci spiegano, che autobus prendere e dove. Kruja is up there! Tutt'ora non riusciamo a capacitarci di come abbia fatto quell'autobus di linea a portarci tutti intatti su per quei tornanti micidiali. Ma per 30 lek arriviamo. Kruja. Skanderberg. Panino! Di quando al ritorno, dopo tutti i tornanti di prima fatti insieme, un poliziotto col latte in mano continua a chiacchierarci in albanese fino all'accordo di 2000 lek che trova per noi con un tassista legale che ci avrebbe portato fino a Tirana, ma che noi, a fronte dei soli 100 spesi all'andata, rifiutiamo avviandoci lungo la via del ritorno sperando di essere di quelli che salgono sui furgoni strada facendo, invece fermiamo un nonfurgone che ci chiede 1500 lek, quanti ce ne chiede un altro tassista che si avvicina nel frattempo, che sono comunque troppi come ha capito anche il ragazzo con la cardarella in mano che si mette a gesticolare in direzione della strada buia dalla quale sbuca una donna che ci spiega in inglese che non parla inglese ma che suo figlio sì... allora lo chiama... e quello arriva in una smart ed è gigante e si mette a parlare con gli altri quattro e alla fine il tassista smonta la scritta del taxi e ci accompagna sull'autostrada e aspetta con noi finché non troviamo un furgone sul quale un ragazzo ci paga il biglietto di 400 lek, magari te lo raccontiamo un'altra volta. - Finding Kruja di Luigi Dapoli Di solito partiamo sempre più in ritardo anche delle nostre previsioni e di solito partiamo con brUno, una Uno del ’96. Stavolta partiamo con un furgone invece, né nostro né guidato da noi e in soli 20 km l’imprevedibile surclassa il solito che già di per sé, comunque, non è normale. In Albania il furgone è un mezzo istituzionalizzato di trasporto tanto per cominciare. Ciò vuol dire che si paga per il viaggio e che tutti sanno dove andare a prendere il furgone dove ti lascia di solito dove si ferma o dove, certe volte, se glielo chiedi e vi mettete d’accordo, ti può far scendere. Di solito è un furgone a 6-9 posti che l’autista cerca di riempire raccattando passeggeri in giro e che parte solo quando è pieno. Il viaggio non ha un prezzo fisso, ci si accorda, come per tutto. Il furgone del viaggio tra Tirana e Kruja ha dodici posti trattabili e per strada salgono fino a sei persone altre, sedute nel corridoietto tra i sedili su sgabelli di ferro in dotazione. Arriviamo a Fushe Kruja con la netta sensazione di aver sbagliato qualcosa, ma in albanese l'autista ci spiega, o noi capiamo, che dobbiamo solo prendere un altro autobus, più avanti, lì... dopo l'incrocio... lì! Ci salvano due ragazze che parlano inglese. Kruja is up there! Arriviamo dopo mezz’ora di tornanti affrontati incredibilmente senza danni. Ok. Si va di là. Dobbiamo salire a piedi. Allora prima panino e sigaretta. Kruja è la città di Skanderberg, l’eroe albanese che sfidò i turchi per trent’anni. Ci perdiamo in storie medievali, passaggi segreti e patate fritte in un ristorante con vista sul baratro. Dalla terrazza del castello puoi vedere tutto fino al mare, ma il cielo è coperto così il mare è solo un lontano sbriluccichio della macchina fotografica. Al ritorno, ancora ubriachi di storia, arriviamo fino alla rotonda di Fushe Kruja e realizziamo che non ci sono furgoni per Tirana. Stavolta oltre che per partire, siamo pure in ritardo per ritornare. Un poliziotto con una bottiglia di latte in mano continua a chiacchierarci in albanese fino all'accordo di 2000 Lek che trova per noi con un tassista che ci avrebbe portato fino a Tirana, ma che noi, a fronte dei soli 100 spesi all'andata, rifiutiamo, avviandoci lungo la sconusciuta via del ritorno sperando di essere tra quelli che salgono sui furgoni strada facendo, invece fermiamo un non-furgone che ci chiede 1500 lek, quanti ce ne chiede un altro tassista che si avvicina nel frattempo, che sono comunque troppi come ha capito anche il ragazzo con la cardarella in mano che si mette a gesticolare in direzione della strada buia dalla quale sbuca una donna che ci spiega in inglese che non parla inglese, ma che suo figlio sì... allora lo chiama... e quello è un tizio gigante e arriva in una Smart e si mette a parlare con gli altri quattro e alla fine il tassista smonta la scritta del taxi e ci accompagna sulla superstrada e aspetta con noi finché non troviamo un furgone che ci carica. E sul furgone, ancora increduli, dondolando su Attenti a Lupo, un ragazzo ci paga pure la corsa. - Il millenario velo di Iside: Reportage dall’Egitto di Luttine Ilenia Buioni 30 Settembre 2012. Dopo due giorni di navigazione, il porto di Alessandria mi accoglie col fascino degno di un’antica capitale. All’orizzonte, l’azzurro del cielo si fonde con la trasparenza del mare, a disegnare lo scorcio di un Egitto sconosciuto. Lo si percepisce fin dal primo momento in cui gli occhi e il paesaggio si sfiorano, impazienti di conoscersi. Duecento chilometri di autostrada separano Alessandria dalla megalopoli del Cairo. Inizia il mondo arabo, dal sapore autentico, e Giza mi attende sulla riva occidentale del Nilo. Le mie mani tastano il granito di Aswan e le Piramidi riflettono nella loro magnificenza l’ombra di un regno per cui spazio e tempo cadono nell’oblio. A custodia della Piramide di Chefren intravvedo il copricapo faraonico della Sfinge, dalle zampe protese in avanti. E poi loro. I bambini dal capo leggermente inclinato, pronti a vendere soprammobili di plastica, e i padroni dei cammelli, che parlano un arabo mescolato ad una manciata di vocaboli inglesi. Davanti a noi la sagoma indefinita del Cairo, avvolta dalla foschia beige di un cielo che porta le stesse sfumature della sabbia. È uno spettacolo di fronte al quale qualsiasi commento sarebbe un nonsenso. All’ora di pranzo giungiamo al ristorante che ci accoglie con canti e danze locali, ma già aspetto con ansia la passeggiata tra le vie del Cairo, nei quartieri interni e nelle piazze che sono state il palcoscenico della Rivoluzione. Una marea umana si confonde nel traffico congestionato delle arterie metropolitane; a bloccare le auto un allevatore che trasporta le sue pecore. Meraviglia e silenzio: due espressioni della sorpresa che avverto più volte, percorrendo la debolezza della civiltà che incaglia le vite di milioni di persone in un’ ignobile miseria. Incrocio lo sguardo di chi è nato in quell’apparente normalità, ma sento la necessità di confrontarmi con chi potrebbe darmi delle risposte, per comprendere quell’esistenza che va in frantumi. Ma pur sempre vita. Nanà, la guida, è una donna intelligente e disponibile. Risponde alle mie domande ed io - attraverso le sue parole ed i commenti solo accennati - mi sento pronta a guardare davvero donne riservate, uomini che fumano il narghilè e bambini che giocano nelle strade sommerse da cumuli di macerie. Con gli occhi dei suoi abitanti e attraverso le sue strade Il Cairo mi parla di sé, si racconta senza tralasciare scomode sconfitte che fanno morire il sorriso sulle labbra. Nanà mi starà sempre vicina, ai musei e al bazar, quando cercherò di mettere insieme le testimonianze di coloro che incontro; vorrei che condividessero con me le loro impressioni. Il ritorno al porto è lento e le parole di Nanà allietano due ore e mezza di viaggio. Poi silenzio, per fermare l’emozione di una giornata intera. Ed una foto, l’ultima, per non dimenticare il colore del cielo e del mare, che si perdono ancora in un abbraccio infinito. - Il valore della condivisione 02 Agosto 2013. di Luttine Ilenia Buioni Group Leader Liverpool junior III Alle 8: 30 mi trovo all’aeroporto di Fiumicino, c’è giusto il tempo di una colazione veloce e poi raggiungo l’imbarco del charter diretto a Manchester. Più di cento ragazzi si preparano per una summer school a Liverpool, l’affascinante città dei Beatles e non solo. Saranno emozionati? Sì, alcuni mi spiegano che la vacanza studio è l’occasione da non perdere, per cui si deve studiare un intero anno scolastico, perché il regalo di mamma e papà saranno proprio due settimane all’estero; altri mi dicono che a scuola non hanno molti amici, ma il soggiorno dell’estate precedente è stato indimenticabile! Salgo sull’aereo e seguono le presentazioni con i colleghi. Mi chiedo per quanti di loro sia la prima volta e … non è difficile darsi una risposta: quasi tutti! Il tempo vola assieme a noi e Manchester è già pronta ad accoglierci con il primo “Welcome!” da parte dello staff inglese. Dopo quarantacinque minuti di autobus ecco Liverpool. Liverpool che ha fatto sognare generazioni intere con la musica dei Beatles e che da sempre guarda al di là del mare la terra d’Irlanda. È stato il giorno precedente la partenza che, ancora incantata dall’Albert Dock che non avrei voluto lasciare, mi chiedevo perché avessi scelto di partire. Tanta voglia di fare e di mettermi in gioco, sempre e comunque: peccato che con un gruppo – peraltro piuttosto eterogeneo – di adolescenti non l’avessi mai fatto prima. Ma in fondo era proprio ciò che aspettavo. Da un lato il desiderio di conoscerli, ascoltarli e mettermi in comunicazione con loro, tentando di fare del mio meglio. Dall’altro il timore di non essere abbastanza preparata per rispondere alle curiosità di un quindicenne che mi chiede perché alcune cose accadano e basta, senza giustificazione; perché un sentimento profondo debba essere schernito da una leggerezza disarmante – o ancora - perché la felicità ondeggi inesorabilmente tra noia e dolore. Insieme abbiamo parlato, giocato, scherzato e riso fino alle lacrime. I giorni passavano, ed io raccoglievo i loro “Grazie”, sempre più numerosi e talvolta inaspettati. In due settimane li ho visti cambiare, li ho sentiti diventare parte di un gruppo in cui ognuno era chiamato ad esprimere la sua unicità, il suo ruolo prezioso ed insostituibile. Ed io, osservandoli, scoprivo la meravigliosa spontaneità con cui si impara a costruire assieme. Senza nemmeno saperlo, anche solo con un abbraccio o con due parole che da sole spezzavano l’ingenuità di una conversazione, mi hanno insegnato tanto. Hanno permesso alla mia vita di arricchirsi, di imparare da quell’impercettibile spettacolo che per loro era semplicemente la quotidianità. Niente di più che la naturalezza con cui si disegna il desiderio di essere felici, insieme … Anche solo per due settimane. Le parole non sono tante, ma spero di averle modellate nel migliore dei modi per esprimere sinceramente il mio: GRAZIE A VOI, RAGAZZI! -Eravamo cinque amici in car: “L'occupazione dei seggi vacanti grazie al movimento BlaBlaCar”di Carlotta Marchi Sono ormai sei lunghi anni che percorro assiduamente, ogni week-end, l’autostrada A1 da Milano a Bologna. Fino a marzo 2012 viaggiavo da sola tutti i venerdì sera, in una direzione, e tutte le domeniche sere, nell’altra direzione. Una tratta monotona e soporifera, 220 km quasi completamente senza curve, dove la probabilità di un colpo di sonno è un’ipotesi da prendere in seria considerazione. I treni purtroppo costano eccessivamente, sono perennemente in ritardo ed il servizio lascia spesso a desiderare. Tuttavia, da sempre mi pesa contribuire all’inquinamento atmosferico e riflettevo su quale soluzione potessi adottare. Poi, questa primavera, scherzando con una collega è saltato fuori BlaBlaCar. Ne aveva sentito parlare alla TV, sembrava funzionare benissimo all’estero e si stava diffondendo anche sulla nostra Penisola. L’idea mi incuriosiva e quello stesso giorno misi il mio primo annuncio per Milano–Bologna. Mi divertii già solo ad iscrivermi al sito internet, con tutte quelle opzioni sulle informazioni generali e personali, tra le quali la possibilità di allegare la foto della macchina, ma soprattutto scegliere se essere blabla, ascoltare la musica, oppure permettere di fumare e addirittura trasportare animali. Dunque, partiva tutto come un mero tentativo. Non sapevo assolutamente cosa aspettarmi e se fidarmi davvero, partendo dal fatto che sono una ragazza; chi avrei incontrato? quali sarebbero stati i margini di pericolo? avrebbero trovato la mia guida adeguata? sarei riuscita a far coincidere facilmente luogo/orario di ritrovo? Oggi per me BlaBlaCar è una rivelazione, un successo, un’esperienza insostituibile sotto molteplici punti di vista! Sto conoscendo persone nuove, di sesso, età e nazionalità differenti, che hanno sempre qualcosa da raccontare e così il tempo vola piacevolmente. Si parla di qualunque cosa: sport, musica, lavoro, cucina, cultura e tradizioni del proprio Paese. Non è raro che accadano pure cose inusuali e buffe: un giorno potresti ritrovarti a caricare l’inseparabile bicicletta pieghevole di un ragazzo che ama girare per le piste ciclabili bolognesi, o alcune casse di vino di un imprenditore francese alla ricerca di prodotti delle colline bolognesi, o le chiavi di casa di una ragazza che le aveva malauguratamente dimenticate dalla sorella la settimana precedente, o dei vicini di casa che inspiegabilmente non avevi mai incontrato prima di allora. Infine – ciliegina sulla torta – sono davvero entusiasta di avere anche dei compagni di viaggio abituali, persone che con il tempo potrebbero diventare degli amici. Il servizio offerto da BlaBlaCar è in definitiva impagabile! Da un punto di vista materiale, permette di tagliare i costi nonché di ridurre l’impatto dell’auto sull’ambiente e, da un punto di vista strettamente personale, consente di arricchire le proprie conoscenze e di trascorrere il tempo in allegria e leggerezza. - Un viaggio indimenticabile di Maria Letizia Gangemi Amara sorpresa all'arrivo a Marsiglia. Il tapis roulant che rigetta le valigie non risputa il mio bagaglio! -Dai, vedrai che te lo restituiscono, mi consolano le amiche di viaggio. Denunciamo l'accaduto all'ufficio preposto, ritiriamo l'auto presa a nolo e ci rechiamo in albergo. -Io disfo la valigia, dice Eugenia. -Anch'io, replica Teresa. Ed io? Non ho nulla da disfare né da mettermi, bella prospettiva per una vacanza. Ed è qui che scatta la solidarietà delle amiche. Chi tira fuori una crema per il viso chi un vestitino chi uno slip. E già, perché ora sono anche senza biancheria! La Provenza intanto ci ha accolto con i suoi profumi e i suoi colorati paesini. Siamo di base ad Aix en Provence da cui effettueremo le escursioni. Arles, prima tappa al mitico Caffè Van Gogh, dove l'artista dipinse Terrazza del caffè di notte, un'esplosione di colori smaglianti che dal caffè si riverbera sulla strada sotto un cielo di stelle vorticose. A Grasse, visita da Fragonard, la fabbrica di profumi, dove le commesse ci sommergono di bastoncini di carta, per scegliere la fragranza più gradita. Ad Avignone ci attende il Palazzo dei Papi. Eugenia scatta foto ricordo sotto l'imponente mole dell'edificio, e immortaliamo il Ponte D' Avignon, dove ci mettiamo a cantare la celebre aria On y danse tous en rond. -Ragazze, come sto col vestito di Teresa? -Una meraviglia, sembra fatto apposta per te. Mi sembra quasi di assumere un'identità non mia, indossando abiti altrui, ma il mio trolley non arriva. Fa caldo, e camminando sotto il sole, avevo proprio bisogno di un cambio.L'abbazia di Senanque si mostra nel suo splendore, in un completo contrasto tra il silenzio all'esterno, dove il vento smuove i filari di lavanda, e l'interno, dove il canto gregoriano dei monaci si leva tra le volte dell'edificio. Si prosegue per Valensole, dove un festoso campo di girasoli ci accoglie con un dilagare di giallo. Ancora giornate d'afa. Visitiamo la casa di cura dove si rifugiò Van Gogh. A Marsiglia lasciamo l'auto in un tortuoso parcheggio sotterraneo per dirigerci a Notre-Dame de la Garde, dove giungiamo con un colorato trenino per vie strette e tortuose, da cui si gode, salendo in alto, un panorama mozzafiato. Pranzo in un locale arabo, a base di cous-cous. I giorni volano, tra escursioni foto ricordo e mangiate in posti caratteristici. S'avvicina la partenza, con la temperatura ancora alta. In albergo mi lamento. -Questo vestito è ormai tutto sudato. Eugenia mi guarda, apre il suo trolley, e tira fuori per me bermuda e canotta. -Così puoi affrontare il ritorno. Amiche care, sinceramente disponibili verso un profugo senza vestiti, come sono stata in questi giorni: abbiamo condiviso insieme tutto, persino l' abbigliamento!Senza la vostra solidarietà, sarei stata a disagio in questo viaggio. Indimenticabile esperienza, unica per i suoi paesaggi, i posti meravigliosi, ma, soprattutto, per il vostro caloroso affetto! - Il volo Di Zucco Maria Margherita Driiin.. Driiin.. Driiin.. ore 6.00 Presto, presto, Rinaldo, Simone è ora di alzarsi!! Presto, sono già le 6.15, facciamo tardi. Per capire tutto questo trambusto, occorre andare indietro nel tempo. Siamo a Settembre il giorno 12, grande festa: 25 ANNI INSIEME!! Tanti auguri, tanti amici, tanti regali, tra cui un viaggio in Olanda, ospiti di simpaticissimi amici. Passano i giorni, passano i mesi, finalmente si avvicina il giorno della partenza. Si stampano i biglietti, tutte le condizioni di viaggio sono scritte in inglese, ma abbiamo due traduttori eccezionali, i figli: ”non vi preoccupate, c’è scritto che potete portare un bagaglio a mano (10kg) ed un bagaglio da spedire (15kg), niente forbici, coltelli, etc.” Bene, sembra tutto molto semplice, a parte la mia paura di volare, visto che non ho mai preso l’aereo e non so cosa aspettarmi; anche Rinaldo non sa ma fa finta di niente. Comunque sono tutti bravi a dare raccomandazioni di ogni tipo. Il giorno prima della partenza controllo ancora una volta i biglietti, tra l’altro siamo nella fila priority, i documenti sono pronti, comincio a preparare le valigie. Per un fine settimana in Olanda una giacca a vento ci vuole, un paio di maglioni, un paio di scarpe in più, ma a pensarci bene un bagaglio di 15kg più 10kg a mano sembrano veramente troppi. A fine giornata le valigie sono pronte, inauguriamo anche quella che ci hanno regalato proprio per il nostro anniversario!!!! Ed ecco che…Driiin….Driiin….Driiiin….Riprendiamo il racconto. Ore 8.00 si parte da Bassano Romano, Simone ci accompagna a Ciampino, verso le 10.00 siamo arrivati, baci e abbracci(?), comportatevi bene, ti mando un messaggio quando siamo arrivati. Un brivido di emozione mi corre lungo la schiena… siamo a Ciampino, da soli in mezzo a centinaia di persone; c’è un bar, dei negozi, prendiamo un caffé. Rinaldo esce per fumare una sigaretta, io mi guardo le vetrine: c’è un negozio di biancheria, poi un tabaccaio, che vende anche giornali, giocattoli, valigie… boh! In aeroporto chi ha bisogno di una valigia? Sorpresa abbiamo diritto ad un solo bagaglio, che fare?? Ah, ecco a cosa serve il negozio di valigie… compro una borsa che passi da bagaglio a mano; detto fatto, la compro, andiamo in toilette e facciamo il cambio, abbiamo una valigia da buttare; “e mi raccomando”come ci ha detto la commessa del negozio “lontano dall’aeroporto, altrimenti per paura di una bomba bloccano tutto per molto tempo. Siamo sull’aereo, chiudono il portello, l’aereo rulla sulla pista, un rumore assordante un’accelerazione elevatissima, il cuore nello stomaco, il decollo, tutto gira, i piedi sospesi nel vuoto, mi sembra di cadere, chiudo gli occhi sento la gente che parla, sembra lontana. Rinaldo mi stringe la mano, la sento forte vicina. Comincio ad aprire gli occhi, Rinaldo è tranquillo e allora anch’io mi calmo. Dopo circa due ore arriviamo a Eindhoven, naturalmente siamo partiti con il sole e arriviamo che è nuvolo, ventilato, forse pioverà. - Era l’estate del 2003 di Marina Lo Blundo Era l’estate del 2003. All’epoca non esisteva lo smartphone, la fotocamera digitale era un lusso che solo in pochi si potevano permettere, riuscivamo a fare a meno di internet e nessuno di noi pensava che un giorno neanche troppo lontano avrebbe potuto affidare alla rete i suoi pensieri e le sue esperienze, condividerle con altri e da altri trarre ispirazione e consiglio. Era l’estate del 2003; l’estate in cui per la prima volta avrei messo il naso fuori dai confini italiani, in cui per la prima volta avrei fatto un viaggio – e che viaggio! – con amici, la prima volta in cui avrei conosciuto l’amore, quello che viene idealizzato perché impossibile da coltivare, quello che si accende come un fuoco, fa fiamme alte e vibranti, ma poi inevitabilmente si consuma e si dilegua, quello che lo sai che non è amore vero, ma che ti piace pensarlo così. Era l’estate del 2003 quando in 3 partimmo per l’Europa. L’inter rail! Quante volte in treno avevo visto ragazzotti mal vestiti e puzzolenti che sonnecchiavano tra uno zaino troppo pesante per le loro spalle e scarponi troppo logori per i loro piedi… Questa volta toccava a noi, 2 ragazze poco più che ventenni che non avevano esperienza del mondo fuori della porta di casa e un ragazzo che arrivava dal Brasile e che voleva a tutti i costi vedere quanto più possibile dell’Europa prima di rientrare in SudAmerica. Era il suo entusiasmo a trascinarci da una capitale all’altra, su treni, in ostelli, a casa di amici suoi… Ho in mente rapide immagini, sensazioni fugaci, stazioni improbabili alle 4 di notte, pranzi a base di mele e succo di frutta, ma una cosa non dimentico: i miei sensi perennemente all’erta, per non perdere nessun dettaglio, neppure il più insignificante. Di giorno esploravamo la capitale di turno – Vienna, Berlino, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Madrid, e poi il Portogallo, e di ritorno Siviglia, Granada e Barcellona – e di notte, sul treno che ci accompagnava nella città successiva, scrivevo il mio diario. Lo scrivevo a penna, su un blocchetto malconcio che sarebbe diventato il mio oggetto più prezioso in quel mese di avventura. Perché per noi era un’avventura. Quel diario, una volta tornata a casa, lo avrei copiato su un quaderno più grande, lo avrei corredato di fotografie, biglietti dei musei, scontrini, sabbia della spiaggia di Nazaré – il mio primo bagno nell’Atlantico – lo avrei letto e riletto chissà quante volte nel corso degli anni, ogni qualvolta un minimo di nostalgia per la spensieratezza di quei giorni mi avesse assalito. Se prima non l’avevo mai fatto, da lì in avanti viaggiare divenne un’esigenza. Non ho più viaggiato con i compagni di quei giorni felici, ma ho trovato un’altra persona con la mia stessa passione, se non più forte. È mio marito, e nei suoi riguardi ho solo un cruccio: che non fosse con me durante quell’inter rail. Ma, se non altro, con lui ho visto e sto continuando ad esplorare il resto del mondo. E ho trovato l’amore, quello vero questa volta. - Il treno di Martina Dei Cas Da piccola pensavo che viaggio fosse sinonimo di luoghi esotici, tesori perduti, lingue differenti e cibi strani. Avrei potuto raccontarvi di avventure per terra e per mare, di lande desolate o di carovane sotto il sole del deserto, di abeti siberiani e piantagioni di caffè. E invece crescendo mi sono resa conto che il mio viaggio con la V maiuscola ha il sapore di casa e non è lungo neanche quaranta chilometri. Eppure sui binari della Ferrovia diretta al Brennero non ci si annoia mai. C'è il viaggio del primo giorno di Superiori, venticinque minuti di puro Far West, e quello prima di un esame, che vale quanto un mese sull'Orient Express. C'è il treno delle 13.10, che ogni venerdì è carico di studenti universitari, militari e valigie. E quello delle 14.25, che ogni sabato porta le comari del paese in città per gli acquisti e a livello locale aggiorna più del telegiornale. Ci sono i treni estivi, senza aria condizionata e con le biciclette dei turisti stipate ovunque. E quelli invernali, dove tra gli scompartimenti affollati sembrano brillare ancora le luci dei mercatini natalizi. Ci sono i viaggi immersi nel caos e quelli nel più totale silenzio, quelli con i finestrini rotti e i macchinisti in sciopero. Ci sono i compaesani che ti danno uno strappo fino alla stazione, le corse all'ultimo minuto in sella alla bicicletta di un amico più in ritardo di te. Ci sono controllori che guardano impietositi la tua borsa pesante e gli occhiali spessi da studente e altri che ti vedono solo come un piantagrane in più. Ci sono gli stranieri che ritornano dopo una breve permanenza in patria, le targhette dell'aeroporto sulla valigia ad indicare la provenienza e lo sguardo perso nel vuoto. Ci sono anziane signore dall'aria aristocratica che ti snocciolano la loro intera esistenza, perché in fondo, come ogni buon film insegna, a volte è più facile confidarsi con un perfetto sconosciuto. C'è la frustrazione per l'ennesimo treno in ritardo al termine di una lunga giornata di lezione e la gioia nel ritrovare sullo stesso binario un compagno che non vedevi da anni. E poi c'è il caffè bollente del bar cinese a fianco alla stazione: due parole tra pendolari, uno sguardo al giornale... pago io o paghi tu? E via... a scuola o al lavoro: un'altra giornata è appena cominciata! Ed è cominciata nel migliore dei modi, con uno scambio di convenevoli umano, quasi d'altri tempi, con una levataccia, ma anche con un tempo per sé stessi, un'attesa mai vuota. Prossima fermata: Ala. Come vedete, il treno serve anche per scrivere, per riflettere, per unire le città, ma soprattutto le persone, le idee, le speranze. La gente inizia a muoversi, la locomotiva fischia, le porte si aprono: è ora di scendere. Addio caro lettore, anzi arrivederci alla prossima corsa! - Al Ponte di Spagna, tra lunghe passeggiate e scalate verso la libertà… di Martina Cirillo Ho sempre preferito i posti di mare caotici e rinomati per passare le vacanze estive, ma non ricordo di aver fatto tesoro di alcuna esperienza particolare passata in quei luoghi. Invece è stato proprio quel viaggio di comitiva che toccava varie mete italiane e francesi a lasciarmi ancora adesso un ricordo piacevole. L'occasione che mi ha portata fin laggiù alla completa esplorazione di quella affascinante realtà è stato un viaggio organizzato da una parrocchia in periferia di Napoli. Tra i partecipanti non c'erano solo amici ma anche persone a me particolarmente care come mia madre e mia zia. Ricordo che tutti furono d'accordo a viaggiare in pullman, in questo modo allungammo i tempi di percorrenza ma guadagnammo anche maggiori possibilità di stare riunitit a chiacchierare, ballare, pregare, mangiare e guardare film. Il nostro viaggio prevedeva di effettuare svariate soste lungo il percorso per raggiungere la meta principale, il posto per il quale eravamo tutti insieme in quel pullman, cioè la nota cittadina spirituale di Lourdes. Tuttavia, ogni sosta prevedeva una gita e proprio mentre sostavamo a Lourdes ci proposero di allontanarci per qualche ora a "scalare" le montagne della pace e del relax nel Ponte di Spagna, una tranquilla località immersa nel verde dei Pirenei. Io e mia madre volevamo assolutamente vivere questa esperienza unica che ci avrebbe permesso di fermare il tempo ossigenandoci con l'aria pulita, una condizione che, tra l'altro, è rara per lo stile di vita che conduciamo a Napoli quotidianamente. Ecco perché in pochissime ore mi concentrai in delle attività impensabili dal mio punto di vista di abitante di città. Mi avvicinai alle pecore al pascolo, raccolsi sassolini nei pressi dei torrenti, mi sedetti tra i sassi sporgenti delle vallate, osservai stupefatta le casette di legno disperse tra chilometri e chilometri di distese verdi, non mancò nemmeno l'occasione di veder mungere le vacche! In quei brevi istanti immaginai di essere l'eroina dei miei cartoni animati preferiti che aveva riempito le giornate della mia infanzia a sorridere alle caprette e a rotolarsi tra l'erba. Devo ammettere che, è attraverso quei respiri che ho riconquistato me stessa, la mia libertà e la mia possibilità di rinascita. Da allora ho sempre pensato che, semmai dovessi rinascere altrove, lo rifarei tra le montagne, cioè dove è ancora possibile vedere il sole risplendere all'alba e oscurarsi al tramonto e toccare con mano quella natura talmente sconfinata da far spavento. Quella natura che a Napoli sta perdendo ogni forma e sta purtroppo svanendo dietro la puzza, il degrado e l'inciviltà delle persone. - Un gruppo di amici che sognava di nascosto la libertà. di Martina Cirillo Eravamo un gruppo di amici che sognava di nascosto la libertà. Un giorno decidemmo di incamminarci senza una meta fissa, volevamo vivere per la prima volta l'ebbrezza dell'avventura. Michelle stava alla guida, era l'unica a conoscere il posto dove eravamo diretti. Angelo era un curiosone e proprio non sopportava l'idea di non sapere nulla, così si sporgeva di tanto in tanto dal finestrino per leggere i nomi delle città segnalate, ma la sua confusione aumentava ogni volta che un imbocco veniva superato e si proseguiva dritti. Quando uscimmo da Napoli e prendemmo la direzione verso Roma ci accorgemmo che eravamo davvero in partenza per un lungo viaggio. Allora Laura ed io ridemmo al solo pensiero di allontanrci, ma in fondo mi spaventava non sapere dove eravamo diretti. Michelle sembrava conoscere a enadito quelle strade e non sentiva mai l'esigenza di fermarsi a chiedere informazioni. Ricordo che per l'occasione fittammo uno di quei pullman che dispongono di un piccolo numero di posti a sedere. Eravamo in cinque e circa tre posti restavano vacanti, in tre avevamo pagato le spese di viaggio, gli altri due si erano invece offerti di portare da mangiare. Verso l'ora di pranzo eravamo giunti nei dintorni della capitale, dove, non molto lontano scoprimmo un'immensa distesa verde. Fu in quel punto, di cui non ricordo il nome, dove io, Michelle, Angelo, Laura e Giorgia mangiammo.. Durante il viaggio Michelle ci accennò qualcosa riguardo un certo "ritrovo" ma non eavamo in grado di capire bene di cosa si trattava. A suo parere stavamo per incontrare qualcuno, ma solo quando riconobbi due sagome in lontananza capìi di chi si trattava. Né io, né Laura, né Angelo avevamo mai visto quelle simpatiche ragazze dai tratti orientali, loro erano in partenza proprio come noi, ma non potevano permettersi molte spese, Michelle le fece salire lo stesso e poi le presentò a tutti quelli che non le conoscevano. Una di loro prese posto accanto a Giorgia, le diede un bacio sulla guancia, la ringraziò e senza esitazioni tirò fuori dal suo borsone un grosso sciarpone rosso fuoco per appoggiarlo sulle sue gambe. L'altra arrossì, prese posto in fondo al pullman, durante il tragitto raggiunse Michelle, le sussurrò dove era diretta, credo, e le offrì una mela che poggiò sul cruscotto. Le due ragazzi cinesi ci avevano completamente distratti dal nostro intento. Durante il tragitto chiacchierai un po’ con Xiao Lu, scoprìi che era una studentessa di italiano ed era venuta in Italia da due anni e adesso lavorava come commessa in un negozio di giocattoli. Dell'altra sentì dire che era un'appassionata di musica. Le ragazze ci lasciarono poco dopo aver imboccato l'uscita di Firenze, Angelo aveva regalato la sua chitarra a quella cinese appassionata di musica, lei in cambio, fuori dal pullman ancora dispensava ringraziamenti agitando nervosamente le mani. Solo dopo scoprimmo dove eravamo diretti. - Cosa c’è a Bologna? di Marzia Rota La prima volta che sono venuta in questa città è stato con il cuore pieno di elio appeso a un filo e la testa esplosa. Avevo appena detto ai miei genitori che io, Marzia, amavo Serena. Sicura e inequivocabile come solo a 18 anni puoi essere. Lanciai la bomba in una tranquilla cena della vigilia di Natale e due giorni dopo eccomi lì sul treno, a valicare i confini regionali da sola per la prima volta. Bergamo-Bologna. Ricordo che quella mattina partii presto dalla stazione di Bergamo. Mi parevano tutti amici; tutti contenti di stare lì, sul regionale puzzolente delle 7 e qualcosa. Fino a Milano guardai fuori dal finestrino in silenzio, ancora incredula per tutto ciò che mi era successo. La rivelazione, l'affetto di mia madre, lo sconcerto di mio padre. Il Natale con i parenti ancora ignari, il sorriso mal contenuto, il viaggio in macchina. L'amore corrisposto, e nuovo. La stazione di Milano Centrale mi apparì immensa. Non avevo mai fatto un cambio di treno prima di quel momento. Credevo di non esserne capace, ma nello stesso tempo non volevo chiedere a nessuno per una sorta di orgoglio timido. Camminavo lungo la banchina velocemente, avevo fretta di prendere il treno, fretta di arrivare, fretta di vederla. E anche un po' di ansia, sì. Col naso all'insù cercavo di scorgere da lontano la destinazione del mio regionale, dando calci alle valigie che non si curavano del mio stato d'animo. Poi, improvvisamente, ecco la rovinosa frana di minuti che scorrono. Un treno era partito, un altro era arrivato. Il tabellone degli orari di Milano Centrale cambiò volto, con quel suo scrosciare di cartellini plastici. Mi fermai. Era la mia prima volta. Era uno spettacolo solleticante, mi faceva sentire libera. Quel turbinio di orari e geografia incarnava per me una vertigine che non avevo mai assaporato prima; dai monti di Bergamo non avevo mai viaggiato molto da sola, e mai con il treno. Tutte le volte che un tabellone mi ticchettava la sua filastrocca, io sorridevo. Anche quella mattina lo feci, principalmente perchè era comparso il binario a cui mi dovevo recare. Ci andai spedita e mi sedetti in un posto vuoto, infilando lo zaino sul portapacchi come da etichetta. Sicuramente parlai con qualcuno, era troppa l'euforia per starmene zitta. Forse dissi anche che ero innamorata, forse raccontai la mia storia. Le due ore abbondanti di tragitto trascorsero velocemente. Ogni stazione in cui ci fermavamo aumentava in me la voglia di scendere e correre. E poi arrivò la stazione di Bologna. Bologna si annuncia in largo anticipo, con la grande matassa di rotaie che si allargano. Sassi rossicci, muri pieni di graffiti. Il treno rallenta sempre molto prima, quasi dovesse salutare con deferenza la città. E finalmente il binario. Finalmente il treno rallentò e si fermò, a quello stramaledetto binario. Inutile dire che io ero già in piedi davanti alla porta da un pezzo. La carrozza era stracolma di gente, il 26 dicembre ci sono pochi treni e così tanti parenti da ritrovare. Si aprirono le porte; mi sarebbe tanto piaciuto bloccare tutti quanti per trovare lei per prima e dirle, nel silenzio, che ce l'avevo fatta. Nonostante la banalità del viaggio, io partivo da molto più lontano, dentro la mia testa, le mie paure e le mie radici. Ma ce l'avevo fatta. Scesi dal treno tra la corrente della folla. Lei arrivò camminando in direzione contraria, e ostinata, ovviamente. Quando la vidi, sopra di lei c'era un piccolo fuoco d'artificio colorato. Quando la vidi, qualcosa in me fece una capriola all'indietro e poi perse peso. Lei, quando la cercavo tra la folla, aveva sempre sopra la testa un piccolo scoppio cangiante a segnalarmela, visibile solo a me. Una specie di aureola, un brillare sfumato. Culmine di questo piccolo spettacolo pirotecnico, profumo. Tiaré, e qualcosa in più, di suo. Semplicemente, il suo profumo. Così per tutte le volte che l'ho cercata ad un binario. Infine l'abbraccio, il calore, le labbra, gli orecchini impigliati nella mia sciarpa. Ci sono cose che non cambiano mai: sciarpe voluminose e orecchini importanti. Questo primo viaggio da Bergamo a Bologna diventò due anni e mezzo di viaggi. Su e giù per l'Italia. Bergamo-Bologna, Bologna-Bergamo. Dei viaggi di andata ricordo l'euforia e l'impazienza. Dei viaggi di ritorno la stanchezza soddisfatta del pendolare amoroso. Per aiutare il tempo e il treno a correre un po', cercavo di leggere. E puntualmente venivo interrotta da strani personaggi che volevano dialogare con me. A pensarci bene forse scappavano fuori dalle pagine che non giravo abbastanza velocemente. Non mi è mai riuscito di leggere per più di 20 minuti filati. Ogni volta che ti racconti a un estraneo sul treno è come se rinascessi. Sono stata sempre me stessa, e anche tante altre persone. Sono stata sempre innamorata, in quei racconti. Per la vecchina che mi offrì i biscotti, ero innamorata di un bel giovanotto con i capelli folti. Per il drogato ero innamorata di un uomo, molto più grande di me. Per lo studente ero innamorata di una ragazza bellissima, per il distinto signore ero innamorata e non lo dicevo, ma lui lo capiva. Per il bimbo ero solo qualcuno da guardare intensamente, per l'africano ero un enigma incomprensibile, oltre che una sposa mancata. Per il musicista ero bellissima, per la ragazza ero coraggiosa, per la professoressa con gli occhiali ero un'ispirazione. Ero sempre innamorata, e potevo scegliere come. Se hai fantasia e ti porti il cuore legato a un polso, viaggiare in treno in Italia è un'avventura incredibile. Hai sempre un certo spirito d'avventura quando poi lo racconti agli amici. Due anni e mezzo di tratte ferroviarie tra Lombardia ed Emilia equivalgono per lo meno a un safari. E così ti imbatti in ritardi epocali che tramutano un euro star in un vagone bestiame per passeggeri sudati e iracondi. Scioperi non annunciati che ti costringono ad aspettare giornate intere in stazioni invisibili. Ultras che bloccano i binari perchè l'arbitro è cornuto. Ritardi per motivi tecnici. Camion incastrati in passaggi a livello, suicidi sulle rotaie, scenate al capotreno, treni che ti chiudono le porte a un centimetro dal naso, capotreni che tentano di spingerti giù dai gradini perchè "non potevi prenderlo era già in movimento". Ritardi per maltempo. Ritardi per motivi tecnici. Inseguimenti tra capotreno e trasgressori privi di biglietto, militari che sbagliano binario e accolgono turisti indignati invece che tifosi esagitati, code infinite e biglietterie intasate, ritardi per ritardo nella preparazione del treno. Ritardi per motivi tecnici. Intercity con il tetto sfondato per la neve, porte ghiacciate, aria condizionata siberiana e cimici morte che piovono dalle tende. Ritardi per lavori sulla tratta. Ritardi per motivi tecnici. Puzza di urina e sedili lugubremente macchiati di scuro. Ritardi per motivi tecnici. E per concludere, un treno che si incendia sotto i tuoi piedi, mentre il capotreno cerca di dartela a bere raccontandoti che le rotaie, in estate, fanno sempre puzza di bruciato. Si scusano per il disagio, comunque. Se non altro ho imparato ad aspettare. Spazientita, soprattutto nei viaggi di andata, ma alla lunga divertita dall'intreccio di personaggi. Banchine ferroviarie come palcoscenici. A ripensarci ne sarebbe potuto uscire un gran bel servizio fotografico. Invece ho pochissime foto di quei viaggi, o meglio di quel viaggio costante su e giù per la pianura Padana. Non ho assolutamente immagini di quei treni, di quei paesaggi incorniciati dal finestrino. Anche se la cosa che mi ricordo più intensamente, non si può fotografare. Evocatore di ricordi inconfondibile è l'odore, dei treni. "Odore di treno", è l'etichetta sulla mia ampolla mentale. Puzzo di urina misto a stoffa intrisa di sudore, metallo, polvere e esseri umani di passaggio. Quell'odore mi restava attaccato addosso per ore anche dopo essere scesa. Non erano viaggi sconvolgenti, era quanto di più banale ci può essere per un qualsiasi pendolare abituato al lavoro interregionale. Eppure mi cambiarono profondamente. Sono sicura che ogni volta che sono salita e scesa da quei treni ho lasciato un pezzetto di me sulle rotaie. Una briciola per volta mi trasformai, e non me ne resi conto. Ero troppo impegnata a seguire, col naso all'insù, le evoluzioni del mio cuore pieno di elio. Chi se ne accorse furono i miei amici, ma me lo vennero a dire solo dopo. Alcuni con gioia, altri con disappunto. Conobbi la diversità della città, io che ero nata tra due cuscini di boschi. Conobbi il mescolarsi di persone differenti, che sarebbe poi una minestra di idee. Conobbi la libertà di essere un po' come ti pare. E anche tante maschere dietro cui rifugiarsi, diverse da quelle che avevo giudicato fino a quel momento. E più di tutti conobbi la distanza, sempre colmata e incolmabile, dell'amore altrove. Un viaggio così ti cambia anche quando non lo fai più. La storia d'amore finì, in una bella giornata di maggio. Ricordo un campo immenso di fiori gialli, appannato. Un capotreno gentile mi si sedette di fianco, offrendomi il suo orecchio. Piangevo, non ricordo altro a parte la macchia gialla che si ripeteva, magnifica. Nei giorni seguenti pensai che non avrei più rivisto Bologna, né Serena. Iniziai a correre per allontanarmi il più possibile da quell'idea, ma questa è un'altra storia. Invece, la vita e i viaggi si rigirano sempre a modo loro. E così, non solo finii per rivedere Serena, ma finii persino per volerle bene. Bologna diventò per me il simbolo dell'amore che supera sé stesso. Dentro di me nacque il pensiero di un filo doppio che ci legava, e che congiungeva le nostre due città. Se mi chiedevano di Bologna, io con entusiasmo rispondevo che era un città stupenda, da vedere assolutamente. Non sapevo specificare altro, era un sapore quello che cercavo di descrivere. Senza molto risultato, come quando parlo di me e Serena. C'è un colore che non riesco mai a dire, quando parlo del tessuto che ci lega. E già questo viaggio, composto di tanti piccoli viaggi, sarebbe una bella storia da raccontare. Ma non finisce qui. Passano gli anni, passano le donne. Io mi innamoro spesso, sono sempre innamorata quando mi racconto. E anche quando taccio. Mi succede in continuazione e questa volta è toccato a Francesca. Accadde in una mattina di primavera, al mercato di Bergamo. Faceva caldo, e lei era vestita con un passo fiorito che mi catturò. E come avvenne per quel singolo viaggio coraggioso, quella mattina di stupore si è tramutata in tre anni di meraviglia. Camminare con Francesca assomiglia a una specie di cammino di Santiago dentro al labirinto di Arianna, ma con un panorama mozzafiato. Praticamente procedi per fede cieca e smisurata, senza sapere troppo precisamente dove vai, incantata da quello che vedi. Io da tre anni non vedo altro. Francesca è un lago tranquillo che tappa la bocca di un vulcano. Lo sentivo vibrare sotto le piante dei piedi, da un po' di tempo a questa parte. Molte cose attorno a lei sono difficili: famiglia, persone, situazioni. E lei leggera, pacifica come l'acqua dolce e pesante del lago di Lecco. Sembra una farfalla lei, che volteggia districandosi tra cumuli di cenere. Ma se appoggi una mano, la senti vibrare. Il vulcano, sepolto sotto l'acqua, non si può sfogare così facilmente. Normalmente basta uno sputacchio di lava e morta lì, per un po' di tempo. Francesca no. Lei ribolle, sotterranea e malinconica. Non c'è modo di aiutare la sua colata lavica a sfogarsi. Deve trovare la strada da sè. E io mi aspettavo qualcosa che finalmente ponesse fine a questo suo ribollire doloroso. Doloroso anche per me. Mi aspettavo una decisione, un gesto autonomo di cambiamento. E' arrivato una mattina, di ritorno dalle vacanze. Francesca è un'attrice. Lo è già, ma lei è convinta di volerlo diventare. Così, mi comunica che ha deciso di iscriversi a un'Accademia di Teatro. "Benissimo, finalmente una decisione che la porterà altrove", penso io. Quello che viene dopo è assolutamente ironico e sconcertante. L'accademia era la G.G., a Bologna. Bologna, di nuovo. "Ma cosa c'è a Bologna per me?" è stato il mio primo, inaspettato, pensiero. Ancora prima di parlare io sapevo che sarei andata con lei. Per seguire il mio filo di Arianna, innanzitutto. E per non ripetere l'epopea sulle Ferrovie Italiane, per secondo. Per terzo, ero e sono curiosa di sapere perchè la vita mi ha riproposto questo luogo, di nuovo. Così, nel giro di un mese e mezzo, ci siamo trasferite. Senza sapere niente, tranne che c'era, forse, un'Accademia ad aspettarla. Il viaggio fin qui è stato molto diverso. Andandomene da casa ho sentito il leggero stridore della malinconia impossessarsi di me. Amo la mia terra come chiunque se ne vada. Eppure non andavo in un luogo diverso da casa mia. Più mi avvicinavo a Bologna, e più sentivo che mi aspettava. Un po' come una fidanzata che desidera il tuo arrivo, ma non te lo fa sapere. Nell'orecchio avevo ancora l'urlo di Serena nel sentire che mi sarei trasferita lì. "Donna, è una notizia meravigliosa!"; ci sono allegrie che non cambiano mai. La nostra macchina stracolma di valigie mi faceva sentire come un'emigrante, ma più fortunata. Il viaggio è stato lento e incredibilmente tranquillo. Faceva caldo, a fine settembre. Ho ripercorso i paesi in cui il treno si fermava attraverso i cartelli verdi dell'autostrada. Mi piaceva cercare di ricordare la stazione successiva quando ero sul vagone. Mi faceva sentire un po' meno straniera. Finalmente arriva la nostra uscita: Borgo Panigale. Vedo San Luca dall'autostrada, seduta sulla sua collina. La saluto come tutte le volte che passo qui davanti, ma stavolta sorrido di più. Lei si chiede perchè ho questa faccia stralunata. Tutto questo è molto surreale, penso in tutta risposta. Arriviamo sotto casa di Serena, che ci ospiterà per questa prima notte. Salgo le scale del suo palazzo, dietro di me c'è Francesca, davanti a me c'è Serena. Entriamo in casa sua, con le sue gatte e i suoi disegni sparsi qua e là. Ci sediamo al tavolo. Sorridiamo, tutte e tre, tutte e tre un po' incredule per ciò che sta realmente accadendo. Io le guardo, e ho una vertigine colorata. "Sta succedendo davvero?", è ciò che penso. C'è un grande, immenso, incrociarsi di strade, di donne, di amori, di storie, a questo tavolo. Non credo ci sia nella mia vita, finora, qualcosa di più riuscito di questo intreccio. - Italy coast to coast di Matteo Benci Ore 11: Il telefono cominciò a vibrare. Guardai il numero: strano. Lo guardai meglio: non è un numero italiano. Risposi. Dall’altra parte una voce giovanile: “Hi! I’m Albert. We are looking for someone who can help us to go to Padova leaving from Trieste. We saw your announcement on blablacar. Do you still have enough seats?”.Nonostante l'inglese scolastico in un paio di secondi capii che cosa mi stavano chiedendo e senza troppi indugi risposi un bel YES. Ci trovammo in piazza Oberdan. Stranamente quel giorno c’era una protesta davanti al palazzone della regione. Data la confusione, cominciai ad abbandonare le speranze. Provai a telefonare, nulla, errore; ma ecco che, quasi colto dalla disperazione, da lontano vidi una coppia dall'abbigliamento un po' "particolare". Notai subito le scarpe del ragazzo: doveva essere lui. Fu un attimo. I nostri sguardi s’incrociarono. Ci stavamo aspettando. Caricate le valige riuscimmo subito a rompere il ghiaccio e cominciammo a parlare del più e del meno. Quel giorno erano di ritorno dal Marocco, un particolare viaggio ad ovest passando per la penisola Iberica. Un viaggio low cost, programmato fino al dettaglio, sfruttando internet e la rete, spendendo un decimo di quello che in media chiedono le agenzie. Eravamo circa a metà viaggio, e in macchina si respirava già un bel clima. Poiché li vedevo abbastanza affiatati, chiesi loro da quanto tempo stavano assieme. Mi rispose Albert dicendomi che erano già diversi anni che erano fidanzati e lo disse giocherellando con un anello. In confidenza, domandai loro scherzando, se fossero sposati. Ahi…forse ho esagerato, pensai . A quelle parole fece seguito un silenzio imbarazzante. Le guance di Ewa cominciarono a dipingersi di un leggero rossore mentre Albert si girò verso di lei con un dolce sorriso: “Sì, ci siamo sposati” disse Ewa con gentilezza, e questo è il nostro viaggio di nozze! Un po’ incredulo e sorpreso feci loro i complimenti. Giovanissimi e già sposati. Wow! Da quel momento in poi la conversazione assunse un nuovo tono, più colorato e spensierato. Mi raccontarono molte cose: come si conobbero, delle passioni che condividono e coltivano, delle cose belle ma anche delle difficoltà che hanno due giovani laureati come loro, nel trovare lavoro nel proprio paese per costruirsi una vita. Cominciammo allora a discutere sul ruolo dell’università e di come il modello polacco e quello italiano in fin dei conti non sono poi così diversi. La prima parte del viaggio stava per finire. Arrivammo alla stazione di Padova. Ci scambiammo i contatti con l’intenzione di risentirci e magari di ritrovarci a Cracovia, loro ospite. Accettai volentieri e promisi loro che un giorno sarei passato da quelle parti, magari con la mia futura sposa. Chissà… Scendemmo dall'auto, con un po’ di tristezza . Ci salutammo. In quello suonò il telefono. Alla stazione mi aspettava Carolina per continuare il viaggio fino a Imperia. Stava per cominciare un’altra storia. - NY, Nov. 2011 di Mattia Coluccia Mi ritrovo ad avere il tempo per scrivere della mia esperienza a NY a JFK, un’ora prima della mia partenza per tornare in Italia. Bene, penso che questo sia un chiaro segno del fatto che abbia saputo sfruttare il tempo al meglio, lasciandomi coinvolgere e trasportare dal ritmo della città. So che il mio tempo non è stato sprecato, riflessioni inaspettate mi sono giunte insieme ad esperienze che ancora una volta mi hanno arricchito dentro. Ripenso a tutte le vite che mi sono scivolate accanto e a quanto ognuno abbia involontariamente contribuito ad indirizzare le mie percezioni verso un senso di stasi ed empatia con lo spirito della città, almeno quello che ho percepito io. La frenesia della metropoli era paradossalmente in contrasto con la velocità che richiedeva il mio io per sviluppare ed imprimere le immagini nella sua camera oscura. La mia riflessione parte da uno dei simboli di NY: il “train”, anche conosciuto come subway, e passa attraverso la tube londinese. Dopo settimane di spostamenti tramite l’ MTA, ho avuto modo di sentire discorsi, di vedere volti e personaggi, di viaggiare con la mente a qualsiasi ora del giorno e della notte, di incrociare sorrisi e sguardi. Proprio dalla metro ho cominciato a percepire un’atmosfera di produttività, una dignità di appartenenza ad un luogo che mi ha fatto pensare a come l’assenza di questa, da me percepita nella metro londinese, mi renda tutto più grigio e negativo. A NY invece i colori sono a tinte chiare, non solo quelli dei graffiti o degli hipster di Williamsburg, delle opere del MOMA o di un tramonto assaporato da una panchina sulla high lane, ma i colori di una città che è in fermento, dove intuisci che c’è da fare. C’è sempre qualcosa da fare. Vedere la Columbia University e conoscerne alcuni suoi studenti, mimetizzarsi facendo colazione alla hungarian pastry, o percepire la possibilità di lavoro e di opportunità quasi dappertutto tra Manhattan e Brooklyn non mi ha reso depresso, scuro in volto, corpo estraneo, a pensare a quello che avrei potuto fare se fossi vissuto qui, ma mi ha comunque dato una sensazione di intorpidimento cerebrale, una voglia di non fermarmi a quello che ho già raggiunto, a non piangersi addosso ma a tenere lo sguardo alto, verso obiettivi altri che prima pensavo ormai persi, irraggiungibili. NY ha funzionato quasi come la sveglia sul comodino di una sit-com, dove il suono è formato da un insieme di fattori, umani e non. La fisionomia tutta di questa città, a partire dai grattacieli, passando per Central Park, i locali underground, le caffetterie, le zone tipicamente american movie, fino ai piccoli luoghi segreti, parchi che sembrano dei gioielli o palazzi decrepiti che in realtà nascondono un mondo di arte. Tutto a NY contribuisce a rendere l’atmosfera produttiva e positiva, neanche la pioggia o il freddo sviliscono la città e chi ci si muove dentro, non c’entra se si è residenti o solo di passaggio, si può essere Newyorchesi anche solo per tre settimane. - Dai 4 Venti di Maurizia Falone Percivale Quella mattina il cielo di Torino era particolarmente grigio, il suo salvadanaio zeppo di spiccioli e la nostalgia delle risate di Giorgio sempre piu' tagliente. Come fare per raggiungerlo a Roma? Laura si sentiva grande nei suoi 19 anni. Ma i 700 chilometri di distanza la atterrivano. Dall'appartamento affianco arrivavano colpi di martello di una coppia che stava festeggiando il sabato con piccoli lavori di manutenzione. Uhm... Impossibile rimanere in casa. "Coraggio. Devi solo trovare il coraggio" le ripeteva Michele, un asciutto e minuto amico torinese. Se lo disse da sola per qualche minuto, tentando di scacciare la paura. Poi tutto inizio' ad andare veloce. Preparo' un piccolo zainetto (forse le ricordava il fagotto di Ukberry Finn), scelse con cura un bel paio di pantaloni dall'armadio, una camicia a righine rosa, un pulloverino blu; apri' la porta di casa, ascensore, e via, quasi di corsa, verso il tram 10 che passava sottocasa. Non era certa di aver chiuso bene la porta e fu tentata di rientrare ma lo sferragliare del tram in arrivo la dissuase dal farlo. Erano gia' le 8 e 30 e raggiungere Roma, nel 1973, restava... . Non so come raggiunse l'imbocco dell'autostrada. Ma, spigliatamente, come quando lo aveva fatto per andare al lago, con 2 amiche, qualche anno prima, allungo' il braccio e fece uscire dalla mano solo un dito: il pollice. Ecco. Stava andando a Roma con l'autostop. Chissa' dove sarebbe arrivata, quando e soprattutto... come. Il primo vento. Il Maestrale. Una grande automobile scura. Un uomo, da solo, con una espressione del viso particolarmente rassicurante. Occhi e capelli chiari. O perlomeno, cosi' le parve. "Vado a Milano". Laura istintivamente si fida - "anche perche' e' un bel tratto di strada", si confessa nella mente - "ma devi stare attenta ad ogni suo gesto, ad ogni dettaglio" dicevano le istruzioni che aveva letto su un opuscolo di autoaiuto inglese. Inizia con una raffica di parole; quasi per stordirlo. Poi si calma ed inizia ad ascoltare. Purtroppo l'uomo non parla molto di se' ma lei sente una tristezza di base, una vita gettata, le pare di capire. Lui accenna ad errori da evitare; che se commessi non ti lasciano scampo. Lei lo osserva. Tra il volto dell'uomo e le sue parole vi e' discrepanza. E' un uomo triste dal viso allegro. Forse era una persona allegra che ha vissuto cose tristi. Le fa capire che occorre prudenza nella vita. E lei si sente raggomitolare, dentro, come un gatto... . Milano e' arrivata. Deve scendere. Le dispiace in quanto vorrebbe imparare piu' cose ma il casello e' li', davanti ai loro nasi. La saluta. E si presenta: "Mi chiamano Faccia d'Angelo". Il secondo vento. Il Grecale. E' ancora emozionata dal primo incontro. Sente incise dentro di se' le parole: "Prudenza. Occorre prudenza". Dovra' aggiungerle a quelle di Michele e trasformare la frase in "Occorre coraggio ma con prudenza". Beh! Le pare un buon inizio. All'inizio della vita. Nuovamente una grande auto. Questa volta si tratta di una casa importante, lussuosa e confortevole. La tecnica di Laura non muta. Inizia con la raffica di parole. Poi ascolta. Altro stile. Altra classe. Altri sentimenti. Un uomo solido. Ricco. Privo di paure come se fosse nato con la stella della fortuna sul capo. Ne' felice ne' triste. Determinato. Ma anche solo. Una solitudine contenuta ma presente. Lei palpa la sua anima. E' come un grande orsacchiotto. Da amare profondamente come un orsacchiotto. La voce tradisce un accento straniero. "Vado a Bologna" le aveva detto al casello. Verso Parma inizia a sciogliersi. Sta andando ad Ancona. Per imbarcarsi per la Grecia. Laura e' tranquilla. Si distrae un attimo guardando fuori dal finestrino quando nelle parole di lui capta, pesante come una spada, la parola "Colonnelli". "Accipicchia. Perche' non ho ascoltato meglio il telegiornale. C'era una notizia sui colonnelli in Grecia. Sta' andando li'". Laura e' inquieta ed insieme delusa da se stessa quando lui, con calma, prende un respiro piu' profondo e poi, con un candore assoluto, senza guardarla, le mani sempre sul volante, correttissimo come il primo, aggiunge: "Perche' non viene con me?" Il corpo di Laura si immobilizza sul sedile. Il suo imbarazzo e' palese. "Oddio! Che gli rispondo?" Trentasettemila pensieri si rincorrono nella sua mente. L'ha guardato bene prima. E' proprio bello. Giovane, con un bel viso. Avra' pochi anni piu' di lei. "Deve essere la mia camicetta. Mi sta particolarmente bene, " si dice. "Ma io non sono ricca, ho un amico che mi piace e che mi fa ridere, a Roma". Prudenza, viene a galla dal pozzo della sua mente. Prudenza, confermano i suoi neuroni. Rinuncia. Scende a Bologna con una tristezza inesprimibile. L'auto riparte lenta, quasi sperando in un ripensamento. Che in effetti continua a turbarla. "Avro' fatto bene? Avro' fatto male?" Il terzo vento. Il Libeccio. E' cosi' assorta in questo agglomerato di sentimenti che quasi non si accorge che una nuova auto si e' fermata al casello di Bologna. Il finestrino viene abbassato ed una voce le chiede: "Dove va?" Automaticamente risponde "Roma" (ma vorrei aver detto Ancona... ) ". "Allora salga. Fino a Firenze la porto io". Sale e questa volta non parla. Non le esce una parola. D'altra parte sara' lui a parlarle in continuazione. Ed ogni frase pare una lezione. In poche decine di chilometri ha gia' catturato la sua attenzione mentale. Parla, parla, parla e dice, dice, dice. Cultura, sagacia, commenti curiosi ed irriverenti. Le piace. Cioe'... piace alla sua mente. E' un signore "adulto". Magro con un viso un po' allungato. Non si puo' fare a meno di ascoltarlo. "E' quasi una imposizione della sua mente sulla mia". Dopo un' ora lei e' completamente "rapita di mente". Ci voleva proprio dopo quello scivolone sentimentale che ancora la lascia perplessa. Arrivano al casello di Firenze e lui gentimente ma perentoriamente conclude: "E, signorina, si ricordi: tra una donna che parla ed una che non parla, c'e' una bella differenza!" Lei sorride e lui conclude con una espressione sorniona sul volto: " Sono il marito di Donna Letizia" ed al suo sguardo interrogativo: "scrive su un giornale... " Il quarto vento. Il vento Reale. "Sono gia' arrivata a Firenze. Non ci posso credere." Laura e' felice. Il cielo, ancora luminoso, ha qualche striscia rosa che lo attraversa. Si guarda intorno. Il traffico e' rallentato. Ed anche la sua voglia di viaggiare. "Forse saro' stanca ma non riesco a trovare nessuno che mi dia sicurezza. Quello e' troppo giovane, quell'altro mi guarda con troppa insistenza... Si', va bene prudenza, ma si sta facendo tardi". Ad un tratto arriva una grande auto al casello. Laura osserva l'interno con attenzione. Sono due uomini. "Uhm... Fidarmi o non fidarmi. L'aspetto e' rispettabile ma il fatto che siano in due mi intimorisce". Vanno a Roma. Per portarla a Campo de Fiori - dove abita Giorgio - devono fare una deviazione. Lei e' infinitamente incerta. Il primo vento Maestrale ed il suo monito, prudenza, soffia con vigore. Ma i loro volti, preoccupati per lei, la incoraggiano e... fra poche ore diventera' buio. Va bene. Rischiera'. Sale dietro. "Finalmente potro' dare una occhiata al paesaggio". Dopo le prime domande: "Ma dove va? Da un uomo? Ma non ha paura di fare l'autostop?" tornano a dialogare tra loro. Sente citare nomi e luoghi conosciuti, Marina D., Aosta, il Borro ma lei non si interessa alla loro conversazione. La Toscana si offre al suo sguardo con la dolcezza di un cane che guarda il padrone. Le luci rosate nel cielo accompagnate dal verde brillante della campagna creano uno spettacolo incantato. Il viaggio procede senza scosse. Ad un tratto la persona al volante le dice che dovranno accompagnare prima il suo amico. La ragazza entra in allarme. "Ecco. E' finita la pacchia. Ora mi trovero' a dover lottare od a scappare". Si accorge che il suo terrore e' stato avvertito ed anche loro sembrano in profondo imbarazzo. Da li' pare che il suo cervello sia entrato in un girone dantesco. Ogni curva, viottolo la terrorizza. Ecco un cancello. Il secondo passeggero scende e lei e' in pre attacco di panico e pertanto... parla e parla e parla. Ma intanto osserva con cura i luoghi sconosciuti che attraversano. Quasi magicamente, dopo un lungo tragitto, la sagoma di Giordano Bruno si staglia al centro di una piazza. "Eccoci. Siamo arrivati". La persona al volante ferma il motore e mentre Laura sta per scendere la voce ferma dell'uomo la blocca. "Aspetti un attimo". "Cosa mi chiedera', cosa vorra' da me" si domanda con un tasso di adrenalina fuori controllo. Lui mette la mano in tasca, prende il portafoglio, lo apre, estrae 50 mila lire, glieli da' e le dice - mentre lei e' oramai nel panico e nell'incomprensione massima-: "Per favore, per tornare a Torino, prenda il treno". La ragazza e' sbalordita. "Ma, e come faccio per restituirgliele?" "Saro' a Torino, a Villa Sassi la prossima settimana. Mi telefoni li'." le dice con voce tranquilla dandole un bigliettino con un numero di telefono. Laura scende dall'auto. Arriva sotto casa di Giorgio. E' ancora in studio. Lui non sa che e' arrivata. Rimarra' due ore sotto casa prima di vederlo comparire. Quando gli raccontera' del signore con la barba, che l'ha accompagnata da lui, sentenzia: "Le cose sono due: o e' un pervertito oppure un gran signore. Tu comunque prendi il treno per tornare a Torino". Ed il lunedi', per tornare a Torino, lei prendera' il treno. Qualche giorno dopo telefona al numero di Villa Sassi. E' molto preoccupata. "Pronto, buonasera. Le devo restituire i soldi che mi ha prestato". Dall'altro capo del filo la voce, diventata paterna, si materializza: "Come sta? Ha preso il treno per tornare a Torino?" "Si, grazie" risponde con un filo di voce. "Bene, ne sono contento. Va bene cosi'. Buonasera". La conversazione e' terminata. Mentalmente Laura lo ringrazia. Ha saputo aiutarla, farla riflettere sui potenziali pericoli di un viaggio senza programmazione, senza chiederle strane cose in cambio. Con gran classe. Passeranno diversi anni prima che Laura possa dare un nome ai suoi compagni di viaggio. Li vedra' passare in telegiornali, in trasmissioni televisive; ne leggera' articoli e libri. Ma, per lei, loro resteranno i "suoi 4 venti". - Una giornata di 36 ore di Michele Lorenzi Premessa Questo 'racconto' non é altro che un piccolo diario di viaggio che ho tenuto più di un anno fa, mentre stavo andando da Trento, la città dove abitavo, a Strasburgo, in autostop. L'intero tragitto in realtà é stato molto più lungo e mi ha portato in Inghilterra, non solo chiedendo passaggi, ma anche utilizzando treni, navi, bus e anche il carpooling. In queste pagine descrivo però solo quello che mi é successo la prima giornata, e spero che questa lettura possa invogliare qualcuno a considerare l'autostop come possibile mezzo di trasporto, in quanto é assolutamente economico ed ecologico: inoltre dà l'opportunità di conoscere, anche se per poco tempo, persone gentili e generose, che spesso fanno rivalutare in positivo l'idea che abbiamo della gente. Ottobre 2013 Bolzano sud, 26 aprile 2012, ore 1: 10am Dopo una sosta fortunatamente breve al primo autogrill (mezz’ora circa, in quello di Paganella Est, poco sopra Trento) eccomi nei pressi di Bolzano, a cercare di fermare quelle poche vetture o camion che transitano per questa minuscola stazione di servizio. Il primo passaggio, anche se non lungo, è stato incoraggiante: una ragazza bionda tutta piercing, italiana, con un grosso cane sui sedili dietro. Ho voglia e fretta di lasciare l’Italia: la stupida legge – che a quanto ne so esiste solo da noi – che vieta l’autostop anche nelle aree di sosta mi fa stare all’erta per non farmi beccare (di nuovo) dagli sbirri. Il tempo è ottimale, non c’è nemmeno il venticello fastidioso di Trento, ma la situazione è anche troppo tranquilla; non so se riuscirò a passare il Brennero prima che si alzi il sole. La sensazione che dà lo sguardo incredulo dell’automobilista che mi squadra è sgradevole, mi fa sentire come se fossi un criminale, o un pervertito. Stubaital, 26 aprile, ore 4.26 E’ ancora notte, fa anche un discreto freddo, ma sono in Austria! Nemmeno la sosta a Bolzano è durata molto, un’oretta o poco più. Verso le 2 ero abbastanza abbattuto perché in pochi passavano e nessuno si fermava. Allora mi sono fatto coraggio ed ho chiesto a voce un passaggio ad un camionista che procedeva lentamente: “Brenner?” “Ja” “Innsbruck?” “Ja”. Ottimo. Un gran bel camion, comodo, spazioso, con un autista che sembra a prima vista simpatico e che, quando mi presento mi dice di chiamarsi come me, Michele! Ma il suo italiano è molto stentato, infatti mi informa che è rumeno (il suo nome in realtà è Mihai). Innsbruck quindi, faccio fatica a crederci! Il viaggio con lui è molto piacevole: ha voglia di parlare – in un inglese dignitoso – ed è molto ma molto gentile. La conversazione spazia dai problemi del suo camion, alla disoccupazione in Italia ed in Romania, alla prostituzione nell’ambiente dei trasporti internazionali. Gli chiedo se può lasciarmi all’ultima stazione di servizio prima di Innsbruck ed allora eccomi qui, in anticipo su quanto pensavo, in un piccolo negozietto autostradale con bar annesso. Ho intenzione di aspettare che albeggi, devo abbandonare l’autostrada per ritrovarla poi in Germania e voglio farlo con la luce del giorno. Mi sento abbastanza stanco, anche per la pedalata da Trento all’autogrill Paganella Est: penso siano stati circa 10 km, la bici l’ho poi lasciata (legata) in una specie di cisterna metallica abbandonata che ho trovato vicino all’autogrill. Buone possibilità di essere per stasera a Strasburgo. Kempten, 26 aprile, ore 11.47 Grandi progressi, ma sono ad un punto morto. La mia sosta a Schönberg in Stubaital mi ha riservato alcune sorprese: il freddo in primo luogo, e la polizia austriaca che mi ha avvisato che anche oltre il Brennero l’autostop è vietato in ambito autostradale (?). Per queste due ragioni ho deciso di “barare” e di prendere l’autobus. Così, con una spesa di 9, 30 euro, ho superato il difficile nodo costituito dalla città di Innsbruck e sono sceso, ormai di mattina fatta, nel paese di Telfs, su una strada statale. Lì dopo cinque minuti una signora di mezza età mi raccoglie e mi porta a Mieming, un altro centro nella valle che porta al confine germanico, testando la mia presenza di spirito dopo una notte insonne e il mio misero tedesco, parlandomi nella sua lingua. Altra sosta, altro passaggio: un ragazzo ferma la sua auto e mi dice in un ottimo inglese che mi porta nei pressi di Füssen, nei pressi della frontiera tedesca e quindi vicino al rientro in autostrada. Conversazione piacevole – è professore d’inglese – mi lascia a 4 km dal centro abitato. Una signora poi mi dà uno strappo e così arrivo nella cittadina di Füssen, dove estraggo il mio cartone e ci scrivo Kempten ben visibile. Passano solo dieci minuti ed un polacco dice di essere diretto proprio lì: perfetto, mi va bene anche stavolta – penso. Peccato però che non ci siano autogrill prima di quella città. Mi faccio lasciare all’uscita dell’autostrada con la speranza di ritornarci subito. Ma è un postaccio. Macchine troppo veloci, e neppure dirette a nord. Decido di entrare in città e tentare l’autostop in un altro luogo. Quasi giunto in centro, decido di fermarmi su una panchina e continuare a scrivere le mie memorie. Le gambe, sembra che abbiano fatto la Roubaix, il Fiandre e la Vuelta. Anche lo spirito è un po’ infiacchito. Fame. Poco prima di Memingen, 26 aprile, ore 15.23 Adesso si fa… poco dopo Ulm, 26 aprile, ore 16.12 Ah, il bello dell’autostop! Non ho neppure fatto in tempo a finire la frase che stavo scrivendo quando ho visto una macchina passare, ho mostrato il cartone, con su scritto Ulm questa volta, che ho trovato un buon passaggio. Più di 120 km di sicuro, un ragazzo di 28 anni, a cui piace il reggae, con un buon inglese – proprio quello che ci voleva. Nella sosta precedente stavo per scrivere: Adesso si fa interessante! In effetti sono ad un buon punto, ma l’obiettivo è quello di essere a Strasburgo stasera. Ne va della possibilità di dormire, almeno stanotte. Ho trovato nei giorni scorsi in Internet una specie di incontro di couchsurfers anche a Strasbourg, ed ho intenzione di capitare lì e chiedere ospitalità per la notte a qualcuno. Ho bisogno di un giaciglio: le ore di veglia consecutive sono diventate 26, un record per il sottoscritto. In ogni caso sono vittima di uno slancio di positività: quest’ultimo passaggio, il tempo atmosferico perfetto, la gentilezza a volte spiazzante degli automobilisti, tutto questo mi fa dire, come il soldato Joker in Full Metal Jacket: “Sono vivo, e non ho paura”. Pforzheim, 26 aprile, ore 18.00 Non avevo intenzione di tirare fuori il diario prima di sera, ma devo annotare un numero: 259. Sono i km orari che ho raggiunto col mio ultimo passaggio. E che cazzo! Non riesco ancora a spiegarmi perché nelle vicinanze di Stoccarda mi ha caricato una Boxster S, voglio dire, una Porsche Boxster S! Il tipo, un uomo di mezza età, di quelli che si possono definire (non a torto) signorili, mi ha visto mentre scrivevo Karlsruhe sul mio cartello. Mentre camminavo verso l’uscita dell’area di sosta mi ha suonato e mi ha fatto salire. La conversazione è stata, potrei dire, essenziale ma anche raffinata. Lui mi ha voluto impressionare e se non ci fosse stato molto traffico mi sa che sarebbe andato anche più forte. Io l’ho fatto sorridere con qualche battutina lusinghiera sulla sua auto sportiva. Strasbourg, 27 aprile, ore 2.56 La serata è stato il giusto coronamento di quella che senza alcun dubbio posso chiamare “la giornata più lunga della mia vita”. Anche a me pare assurdo, ma ricordo benissimo di non aver dormito da quando mi sono svegliato alle 14.30 del 25 aprile, 36 ore fa. La partita di quella sera tra Real e Bayern mi sembra che sia stata giocata decenni fa. Eppure è proprio per vederla tutta fino ai rigori che sono rimasto a casa fino alle 23.30, e poi sono partito in bicicletta. Ma riprendiamo il racconto del viaggio: come si vede dall’intestazione di questo paragrafo c’è un lieto fine: sono a Strasburgo, e in condizioni tali da poter scrivere anche questo capitoletto. Ma la serata è stata anche drammatica. Devo dire che dopo l’episodio della Porsche ero carico di ottimismo – ma quanto sono sprofondato nell’amarezza poi! Un’ora e mezza di attesa facendo autostop a Karlsruhe e poi la botta di fortuna: tre rumeni mi vogliono portare a soli 20 km da Strasburgo. Poco mi interessa delle loro domande indiscrete e del loro tentativo di farmi convertire alla loro religione, quella pentecostale. Ormai lo considero solo uno dei tanti incontri, piacevoli o no, ma sempre interessanti, che capitano all’autostoppista. Il fatto è che a causa di un enorme cantiere stradale e della loro (e mia) sbadataggine, mancano l’uscita a cui avrebbero dovuto lasciarmi e mi scaricano a lato dell’autostrada qualche centinaia di metri dopo. A piedi e con la carta stradale in mano provo a rintracciare l’uscita e con essa la strada di soli 20 km che ormai mi separa da Strasburgo. Saranno le otto e mezza di sera, il tempo è sempre clemente e c’è ancora molta luce per vederci. Non dovrebbe essere difficile trovare quella strada eppure, passano i minuti, passa un’ora, ne passano due, mentre vago nei boschi acquitrinosi e nei campi della zona, ma della strada nessuna traccia. Vedo delle luci, è un camping, chiedo aiuto ad una coppia di anziani gallesi – senza risultati. Lì vicino due cuochi di un ristorante mi indicano una direzione, non molto convinti. Per mancanza di altri stimoli seguo il loro consiglio. Finisco in un villaggio fatto solo di case lussuose, cerco un bar – non lo trovo. Non ho idea di dove mi trovo, disperato provo l’autostop, ma ormai è buio, non funziona. Anzi sì, un’auto si ferma, ma solo per entrare nel garage di casa. Ormai disposto a qualsiasi cosa, li raggiungo e chiedo aiuto a loro prima che entrino: madre sui quarant’anni e figlio sui quindici mi spiegano che mi conviene andare in un paese vicino e prendere un treno per Strasburgo. Ci sono treni ora? Il figlio sale in casa per controllare. Ce n’è uno tra quattro minuti; la madre si propone di portarmi alla stazione che dista due km, viene anche il figlio. Accetto, e ne sono commossamente grato. Alla piccola stazione però scopriamo che il treno, l’ultimo della giornata, è appena passato. I due mi portano allora ad altri 10 km di distanza, in una stazione di autobus alla periferia di Strasburgo. Non so cosa dire, se non ci fossero persone con la loro gentilezza, le persone come me si troverebbero spesso in situazione assai brutte. Sono le nove e mezzo di sera, l’ora a cui comincia il ritrovo, ma a questo punto sono solo a breve distanza dalla mia destinazione. Prendo un autobus per il centro, arrivo ad una fermata intermedia e ne attendo un altro, arrivo infine nel cuore di Strasburgo verso le 11. Cerco il bar sede dell’incontro, lo trovo: sulla porta trovo un couchsurfer, posso tirare un sospiro di sollievo. Il ritrovo è bello e vivace, dominato da italiani e spagnoli, a base di birra locale. La mia serata prosegue tra chiacchiere e cantate in romanesco con Luigi, il solito irresistibile personaggio da’a Capitale, Silvio, palermitano esile che rischia di prenderle da un buttafuori, Isabel, metà francese metà cilena che si cimenta con l’italiano, un nerd impacciato di cui non ricordo il nome, e Paolo, che mi ospita per la notte in casa sua. Una volta nel suo appartamento mi prepara il divano letto e mi fa sentire come se non avessi fatto un metro dalla casa dei miei genitori. Per lui ho tutto il rispetto e la gratitudine, assieme alla speranza che al mondo esistano molte persone come lui. Adesso mi metto a letto, e ho come l'impressione che non ci metterò molto ad addormentarmi. - #agosto13 di Nadia Afragola Alcuni viaggi devi essere pronta a farli prima nella testa. Perché potrai non avere scelta, né avere nessuno che ti possa dire una parola, dare il cambio, farti riposare, tenere sveglia. Non lo so, se lo rifarei ma è stato quanto di più intimo e bello potessi sperare di vivere. Estate 2013, la prima da single dopo un po’ di tempo, la prima in cui nulla era organizzato: tutta Italia mi aspettava, senza un momento ben preciso ma sapevano che sarei arrivata. Ho attraversato lo stivale. Sono partita da Torino, in macchina: io e la mia Yaris, una bella dose di buona musica e gli occhi aperti per non far preoccupare troppa gente. La prima tappa era prevista a 700 km dal via: Roma. Poi altrettanti per raggiungere quella provincia di Lecce che mi diede i natali. Uno stop lungo, bello, una madre mai vissuta così intensamente nei suoi contorni e poi ancora in macchina per 1000 fottutissimni Km per raggiungere la sorella, i suoi bambini, amici che son diventati famiglia e tramonti che non dimenticherò. Tutto questo da sola, tutto questo perché volevo vivere appieno le fermate e avere il tempo di riordinare, nel viaggio, le idee. La sera prima della partenza capitai in un localino dei tanti a Torino, in Borgo San Salvario. Una lavagna affissa al muro lanciava un messaggio chiaro: “Le cose belle prima si fanno e poi si pensano”. Credo sia andato proprio così il mio. Amici sparsi per l’Italia, origini da rintracciare nel profondo sud. Un amore viscerale per Roma e una nuova vita fiorita all’ombra della Mole. C’è tutto, forse troppo. Per strada mi sono innamorata di un camioncino vecchio stile della Coca Cola. L’ho fotografato, istagrammato e poi ho proseguito. Si narra che se ti avvicini a Roma rischi di bruciarti e in effetti quei 46° gradi all’ombra la dicevano lunga sul calore che avrebbe avuto la mia settimana capitolina. Ero da un’amica, una di quelle che ritrovi dopo averle perse, come certe rette vie: Francesca, in arte fonico di doppiaggio. Fu così che mi ritrovai catapultata nell’ultima serie di Dexter: quel mattacchione di Jack lo squartatore in chiave moderna e sanguinaria. Fu li che incontrai dei romani senza accento. In quella settimana è successo di tutto. Ci sono state delle prime volte con qualcuno che avevo sottovalutato. Salvo ricredermi nel giro dell’estate. Ci sono state promesse strappate e scuse che non servivano. Cavallucci marini senza nome, maglie a strisce che profumavano di mare, borse dove dentro ci stava tutto, anche i ricordi. Tatuaggi che hanno fatto male e amicizie che son scoppiate. Ci sono state giornate intere passate in un museo, al MAXXI ad agosto, a Roma. E siamo italiani mica turisti ma volevamo “vedere come se fosse la prima e l’ultima volta”: almeno è così che recitava quel manoscritto. Ho capito che a Roma lo spritz lo fanno con il limone dentro, al posto dell’arancia o semplicemente è andata di sfiga a me. Prima di andare son tornata di corsa in quel lido “Settimo Cielo” a vedere se tutto era in ordine, e ancora un giro in giostra a Castel Sant’Angelo poi son partita e ho amato. Amo quando per dirmi “ciao”, “arrivederci”, “ti voglio bene”… usano libri, una dedica, delle parole buttate li. Quasi a caso ma mai così tanto studiate. - #agosto13_II di Nadia Afragola A Lecce mi sono avvicinata pensando a quello che è stato e a quello che sarebbe stato. Ci sono cose, in quel posto, che nulla potrà mai cambiare o cancellare. Sono figlia unica ma ho una sorella pelosa, la mia gatta di 14 anni. È venuta a trovarmi anche a Torino quando palleggiavo tra un ospedale e l’altro ed è stato bello vederla venirmi incontro come a dirmi: “Ben tornata vecchia mia!”. Ci sono cose che riesco a fare solo li, in quel posto: a casa. Andare per sagre, ballare la pizzica, uscire spettinata, andare a un concerto degli Africa Unite e subito dopo ad uno di Alborosie e nel mentre concedersi ancora Vinicio Capossela, fare il bagno alle 3 del mattino, indossare la maglia al contrario, sistematicamente. Ci sono cose che trovi invece solo li, come il disco orario da 240’ che ti permette di visitare tutta Otranto. E poi ci sono quelle cose che capitano solo a me: conoscere a Torino in primavera una donna, e che donna Stefania, durante una sfilata di moda, passare insieme Pasqua (si era sole entrambe) al mare, in Liguria e darsi appuntamento per l’estate. E rispettare il programma perché noi alle parole si da sempre un peso specifico. Una che ama Bob Marley e chiama il cane Rebel. Ho ritrovato Minni, il miglior pizzaiolo di tutta la Puglia. Abbiamo frequentato lo stesso liceo, poi lui ha fatto la guerra, quella vera, quella dove in mano ti mettono un mitra e devi decidere se sparare o lasciare che lo facciano altri, usandoti come bersaglio. Io ho solo attraversato l’Italia. Lui alla fine si è preso il suo sogno per mano e ne ha fatto un’arte, io con la mia ci convivo. Sono quei volti che mi legano a quella terra come quello di mia madre, l’unico che posso guardare dritta per dritta e abbassare la guardia. Lei si chiama VITA. Come quella che mi ha dato. Mi hanno regalato un rosario, per strada… avrei voluto dirle che se entro in chiesa l’acqua santa prende fuoco ma ho preferito un sorriso, uno dei miei. Che poi a decifrarlo ci vuole un attimo. Ci sono cose che non voglio imparare: a me quel viso bruciato dal sole piace e ci sono posti migliori di altri per sentirsi a casa. Questo: Tricase. La terza tappa del mio viaggio, dopo Roma e Lecce è stata la più lunga delle tre. Toscana, Castagneto Carducci. Ero felice e pensavo facesse rumore da quanto fosse forte il sentimento. Ero in casa con Anita, 4 anni, Guglielmo 2 anni, il cane Poldo, una nonnina di quasi 90 anni, la mia sorellina e un po’ di gente ancora. Ho capito la differenza che c’è tra una felicità “fortuita” e una “essenziale”: la prima accade, la vivi una volta. La seconda è resa tale, “essenziale” dalle persone che contano, dai luoghi che rivivi a distanza di anni, dai colori, dai sapori, anche dalle spine che sai di trovare. A me è toccata la seconda. A Bolgheri, piccola frazione di Castagneto Carducci è stato amore: è li che la mia sorellina si è sposata. Alla Zattera, furono sfaceli anni addietro: è lo stabilimento balneare dove si veniva a far finta di preparare esami universitari e dove ora si è scelto di crescere figli. E’ sempre tutto un po’ uguale. Come in certi affreschi di Renoir. Al Nano Verde, nel Parco Della Sterpaia, sembra che non ti ci vogliano portare. Le indicazioni stradali sono inesistenti, poi arrivi e capisci il perché del mistero: è speciale, ti fa sognare di lavorare in un chiringuito, fa felice la gente con poco: ho ballato al tramonto scalza, in spiaggia, bevendo birra e dimenticandomi di ogni mancanza in atto. Ho incontrato una casa sull’albero in costruzione. Avrei voluto completarla, metterci lo zampino. Era l’ultimo giorno concesso. Anita, guardando il mare dice: “Zia, guarda le onde… sono gratis”. Mi piace. Mi piace vedere le persone belle e capire che non capitano ma si formano come certi colpi d’aria. Più di tremila km in viaggio, da sola, sono serviti per fissare ogni singolo momento di questa estate. Ecco, questi sono i viaggi dei quali non potrei mai essere sazia. Questi sono i viaggi che avrei voluto condividere con qualcuno. Ora l’ho fatto, finalmente. Condividere per andare lontano Natalia Pazzaglia Dicono sempre che quando parti perdi te stesso. Oppure lo ritrovi. Slow boat da Huay Xai a Luang Prabang: un viaggio lento, due giorni in battello con hawaiani, francesi e australiani. Tante ore insieme, niente wi-fi ne’ rete mobile: sul Mekong contano solo le parole, le storie condivise in un viaggio interiore. Celine e' francese, ama disegnare, vuole aprire una gioielleria. Marc e' australiano: dopo tre anni in JP Morgan ha mollato tutto ed è diventato reporter. Ellie viene dall'Australia: a 35 anni ha deciso che era ora di un gap year ed è partita per un viaggio intorno al mondo. Un silenzio confortevole culla parole altrimenti difficili, e i pensieri si riordinano, si scende a patti con i problemi lasciati a casa ma che continuano a bussare alla porta. Ci si ritrova a condividere la propria vita con perfetti sconosciuti che diventeranno presto veri amici. “Di cosa si ha bisogno per essere felici?” Mi domanda Marc, pensando alla corsa al successo di tanti suoi ex colleghi. "In queste settimane ho fatto una patto con me stessa" gli rispondo: "Per ogni oggetto aggiunto al mio bagaglio ne avrei lasciata un altro. Così ho capito che sono davvero poche le cose di cui ho bisogno, e che tornando all’essenziale posso andare lontano. Alla fin fine quello che conta e' la tua storia, e con chi l'hai condivisa". Arriviamo a Luang Prabang: un’oasi di tandem, biciclette e monaci buddisti. La barca dalla Thailandia attracca ogni sera: poco distante dal porto un nuovo quartiere offre caffè e dance clubs, laundry services e wi-fi hotels, tour operators e scuole di aromaterapia: l’altra faccia di una città di templi, monaci e montagne. Camminammo tanto in quei giorni, Marc, Ellie, Celine e io, ormai inseparabili compagni d’ avventura. Insieme visitammo grotte sotterranee e nuotammo in baie nascoste, seguimmo motociclisti nella giungla e vagammo su precarie canoe, tra casette colorate e ponti di bambù. In quella preziosa condivisione risolvemmo paure e condividemmo problemi, comprendendo che solo accettando altri modi di vita, seppur diversi, avremmo trovato la strada. Grazie a loro trovai il coraggio per guardare l’alba a mezz'aria, con loro mi addormentai tranquilla al suono della pioggia, per una volta senza preoccupazioni (e senza tappi!). In quei giorni scoprii che condividendo il cammino il mio bagaglio si faceva più leggero, e più lontano potevo arrivare. Così scoprii che qualche volta posso accettare di perdere il controllo e posso, devo, affidarmi agli altri. Grazie a quel viaggio capii che la gioia è piena solo se condivisa. - Gabbiani come aerei di Ornella Catuogno Sono in aeroporto, ferma dietro i vetri della sala ristoro e guardo gli aerei che si muovono sulla pista. Penso che gli aeroplani sono proprio come i gabbiani: bellissimi ed eleganti in volo, poco più di una gallina spaventata e impacciata quando si muovono a terra. Sono in aeroporto da più di un ora, aspetto, sono agitata e intanto faccio pensieri del cavolo per distrarmi. Ho preso un caffè, ho vagato per gli inutili traboccanti negozi, ma il tempo non passa. Mi sono anticipata come se quell’aereo, invece di aspettarlo, avessi dovuto prenderlo io per un volo intercontinentale. Nella borsa che porto a tracolla ho il biglietto che ho ricevuto con la data e l’ora dell’arrivo dell’aereo. Ne sento quasi il peso e mi debbo frenare per non riprenderlo ancora una volta, per una ennesima conferma di quanto conosco a memoria. Improvvisamente mi sento molto stanca eppure la mente lavora e lavorando ripesca nella memoria il viaggio di andata, quello fatto insieme, l’inizio della storia, tanto tempo fa. Giovanissimi, zaino in spalla, partimmo all’alba: ricchi di speranze, carichi di aspettative, poveri di denaro. Il viaggio aereo ci sembrò brevissimo. Il nuovo lavoro ci entusiasmò all’istante. La splendente città ci accolse affettuosa. I nuovi amici colmarono le assenze. Le strepitose esperienze ci diedero la carica. Gli inattesi guadagni ci regalarono benessere. Eravamo felici, mi ricordo, di assaporare quella diversa vita, di condividere la conoscenza di posti e usanze sconosciute, di gioire insieme per un novello aroma o un paesaggio inusuale, di spartirci equamente i nuovi affetti. Con tutto quel nuovo continuava il nostro viaggio e distratti ci accorgemmo tardi che stavamo andavamo verse mete diverse. Quando entrambi ce ne rendemmo conto non trovammo l’umiltà di fare un passo indietro. Continuammo a viaggiare, ma da soli. E quando la mia solitudine diventò più forte di tutto quanto avevo fino ad allora realizzato, non ci pensai due volte e feci il viaggio all’incontrario. Dubbi, rimpianti non me ne ricordo, un po’ di nostalgia forse, ma della gioventù svanita. Le notizie ricevute mi facevano capire che se io ero tornata, il suo viaggio invece continuava. Nuove tappe, nuova vita, nuovi amori ma anche distacchi e poi l’ultima fermata. Dal piccolo monitor sospeso, pennellate di azzurro in movimento mi annunciano che l’aereo è atterrato. Mi dirigo all’uscita passeggeri seguendo i segnali incollati alle pareti. Mi confondo fra la gente stranamente intimidita. I primi ad uscire un’hostess e un bambino che si tengono per mano. È il mio turno, mi avvicino e consegno un documento in cambio del bambino. Usciamo veloci, vicini ma senza guardarci mentre un aereo rumoroso ci passa sulla testa. Un gabbiano traslocato dalle scogliere vicine si alza in volo e lo guardiamo entrambi. Lui lo indica col dito e dice “bello, sembra un aeroplano!”. Stringo forte la sua mano, sento subito che è amore. Gli sorrido, mi sorride: iniziamo un nuovo viaggio. - In viaggio con un amico di Paolo Borsoni «Questa è la parte più bella del sentiero!», (è la tua voce che sento mentre attraversiamo il bosco di faggi). Salendo ancora sfioriamo betulle, larici, abeti, pini mughi, alcuni slanciati verso l’alto a sfidare il cielo, altri con foglie aghiformi strette a pugno ad accarezzare il suolo. Ci arrampichiamo su pietraie, cenge, ghiaioni fino a una lastra di basalto scuro dove la vista si apre su un orizzonte di cime innevate. Guardo queste montagne con un senso di leggerezza, di stupore. Sfilo il sacco dalle spalle, lo poso a terra; e mentre scartoccio il sacchetto del pranzo vengo sorpreso ancora dalla tua voce: «Ci fermiamo qui?!». Dallo spigolo del precipizio mi guardi, hai un’espressione spavalda. «Qui è piatto» replico quasi scusandomi. «Qui è una passeggiata da pensionati!» sentenzi con un sorriso beffardo. In fretta sfili lo zaino, togli la maglia zuppa di sudore e non lasciando il tempo al tempo scattante come un gatto stai già arrampicandoti ancora più in alto nella tua sfida infinita al cielo. Io distendo la mia stuoia al suolo. Sgranocchio con gusto il mio panino e crogiolandomi al sole, rallegrandomi a riconoscere come vecchie amiche le cime innevate più alte, ringraziando gli dèi per la grazia leggera di essere giunto qui quasi in cielo, ti auguro: “Buona scalata, amico mio!”. Quando saltellando da un masso all’altro ricompari, hai il viso illuminato da una soddisfazione solare e un sorriso ironico sulle labbra per il mio dolce far niente. «Allora?!... » domandi con fare sornione (quasi ti fossi debitore da ore di una risposta). «Allora cosa?!» chiedo sorridendo, rialzando appena gli occhi dal libro. «Allora niente!», (naturalmente). ‘Allora’… era la fine di giugno, l’inizio dell’estate. ‘Adesso’… è pieno inverno e sta nevicando. Inerpicandomi sul sentiero a ogni passo sprofondo nel manto di neve fresca; rabbrividisco eppure il bosco è ancora più magico di sempre in questo silenzio intenso, nel suo lucore quasi lunare. E mentre avanzo sul costone col cuore in gola dico: «Carissimo amico mio, come vorrei tu avessi avuto ragione: questa passeggiata io e te dovevamo ripeterla per anni, per decenni ancora insieme tra boschi magici di faggi e cenge sottili sospese sul vuoto». Quando riesco ad inerpicarmi sul lastrone di basalto su in alto, i paesi del fondovalle sono già sprofondati nel buio. Il ghiacciaio di fronte è plumbeo, dà i brividi. Mi batte a velocità folle il cuore. «T’assicuro, amico mio, che è stata pura incoscienza oggi arrampicarsi fin qui: sta nevicando così fitto che non si vede più nulla». Poi… non dico più una parola. Non ho nessuno oggi vicino a farmi compagnia con la sua arguzia, la sua spavalderia e l’amicizia che non potrà essere sostituita. Tiro via il cappello fradicio di sudore. Mi passo il dorso della mano sullo zigomo per asciugare. E, mentre mi si calma lentamente il respiro, resto così in silenzio per il mio amico. Poi mi riavvio, riprendo la mia passeggiata da solo sul ciglio del precipizio e del gelo in inverno. - In viaggio con un impiastro di Polo Borsoni Indossa una maglietta a chiazze e buchi con la scritta in grande sul petto MOBIL. Da ore mi cammina vicino. Non indossa i calzoncini né le mutandine, solo la maglietta bucherellata e con il visetto rivolto all’in su mi ripete: «Tetetedollagnao? Tetetedollaleo!?». Me lo sta ripetendo… da ore! Il fanciullino me la canta inseguendomi per le strade di questa città formicolante. Così io continuo ad andare in giro per Rangoon, inseguito da un piccolo indigeno dal piglio tosto e gagliardo che implacabile mi bersaglia «Tetetedollagnao?! Tetetedollaleo!?», con la sua maglietta a chiazze e buchi, con una scritta grande sul petto MOBIL, le ciabattine, ma senza i calzoncini (né le mutandine). Mi guardo in giro impensierito, scruto agli angoli allarmato: “La Polizia? La Buon Costume? L’Esercito della Salvezza? Agenti Segreti? Pedofili Bavosi e Invidiosi?!”. Il fanciullino cerca di circuirmi, tenta di farmi cadere in fallo! Continua a camminarmi vicino e con spietata inesorabilità mi bersaglia: «Tetetedollagnao?! Tetetedollaleo!?». Sopraffatto da tanta lagna, immaginandomi una giornata intera passata in giro in questa maniera inseguito fino a sera per mia sfortuna nera dalla tremenda tiritera in una lingua forestiera mi fermo, lo guato: strozzarlo? o spiaccicarlo sul muro? o spaccargli in testa con dolcezza una statuetta sacra di Buddha?... Invece gli sbatto con un sorriso in mano... un fragrante bigliettone da 1 dollaro. L’impiastro s’Illumina d’Immenso. Gli occhi gli sfavillano di contentezza! Sprizza scintille di limpida ebbrezza! Se ne va via leggero al vento col suo bel bigliettone statunitense, vola via come un roseo angioletto dalle chiappette impertinenti, compiaciuto per essere riuscito a farsi alla fine capire anche da questo sbiadito e un po’ tonto turista arrivato da chissà dove e che ora, immobile sul marciapiede, spossato dal soffocante calore, l’osserva andar via quasi con nostalgia, accarezzando nella tasca più interna della sua giacchetta stazzonata rotoletti morbidi, rotoletti palpabili di migliaia di palpabilissimi dollari, provando nella mente e nel cuore nel suo inquieto viaggiare un senso di stralunato stupore. - In viaggio con un vicino di Paolo Borsoni Aspettando una sera il mio treno il volto di un viaggiatore in piedi sul binario simmetrico al mio continuava a ricordarmi qualcuno. Mi venne in mente un ragazzo che abitava nella porta simmetrica alla mia da bambino. Anche lui mi fissava esitando. «Caldo, eh?!» gli gridai allegro ridendo. (Una cappa di ghiaccio tremendo si avvinghiava ad artiglio da giorni sulla pianura gelando il respiro). «Come ai Tropici!» ghignò lui accigliato, quasi qualcosa di amaro gli fosse appena capitato. Eppure, io vedevo ancora in quel volto l’ombra velata di spensieratezza del ragazzo che aveva condiviso con me tanti giorni della mia giovinezza. Ammiccando e sorridendo gli dissi: «Sei andato in pensione!», per suscitare in quel viso il balenio di un sorriso. «No, alla pensione non sono arrivato. - replicò lui curvo, imbronciato, quasi l’avessi appena ora deriso. - Anzi se sei così interessato…». Ma in quel lampo sfrecciò fra di noi il frastuono di un treno. «È andata così…» gli dissi ammantandomi dell’aria più mesta quando, sfilati a uno a uno i vagoni, lo rividi con le lacrime agli occhi (malgrado non avessi per niente capito di cosa diavolo si fosse lagnato). E per suscitare un sorriso in quel viso tanto abbacchiato gli gridai: «Salutami… come diavolo si chiama?... tua moglie!». «Quel diavolo è sparita tre anni fa coi miei figli» replicò e stava per aggiungere una parola adirata quando s’infilò fra di noi un convoglio che faceva tremare la terra. Mentre vedevo scomparire l’estremo vagone nel buio cunicolo nel sottosuolo sorridendo gli dissi: «Ti sembrerà di sicuro impossibile… ma non mi ricordo più dove abiti!». «Per una volta non devi scusarti» sibilò con un che di minaccia, «da tre anni non ho casa o dimora», e mi guardava con un’aria di sfida… in attesa della mia ultima indelicatezza. E io lo osservavo indeciso se aggiungere… che neppure il suo nome mi ricordavo! Ma con stridore e martellio di respingenti e di freni si arrestarono insieme due treni: provenivano da simmetriche linee, avevano destinazioni contrarie. Salimmo sui nostri opposti vagoni accennando entrambi a un saluto svagato col capo mentre svaniva sugli specchi delle due pensiline ogni ombra, ogni riflesso, ogni afflizione, ogni traccia di un perduto sfiorarsi. In quell’anonima, grigia stazione non restava né il pianto né il riso né la gioia né la disperazione solo il vuoto e il gelo d’inverno di quel mio incrinato io diviso. - Sai almeno che faccia ha? di Pamela Pelatelli Compongo il numero di telefono e una voce maschile dal leggero accento pugliese risponde. Sento il vociare di persone in sottofondo che lentamente si dissolve. Deve essere in un locale e si sta allontanando dalla mischia per rispondere alla telefonata, penso. Almeno è uno con una vita sociale, penso subito dopo. “Ciao, sono la ragazza che ti ha scritto per quel passaggio in macchina sabato mattina.” “Ah ciao, si certo. Allora, ti passo a prendere sabato alle sette e mezzo. Ci dovrebbe essere anche un'altra persona in macchina, ma deve darmi conferma.” “Ah ok. Si va bene. Perfetto…ecco, poi, volevo chiederti…” “Allora, ciao.” Ha chiuso la chiamata. Fisso lo schermo per qualche minuto. Mi rendo conto di non sapere quasi nulla di questa persona. Mi chiedo quali sono quelle risposte che dovrei avere per sentirmi sicura. Dove abita? Che lavoro fa? Ha una fidanzata? Torno a guardare il suo profilo sulla piattaforma Blablacar.it e cerco informazioni che mi aiutino ad avere qualche indizio in più. L’account email non contiene un nome e cognome. Non c’è ancora una foto a identificarlo. Si è iscritto da qualche giorno e non ha dato ancora passaggi. Quindi, nessuna recensione. “Ehi, come stai?” “Ho appena chiamato il ragazzo con cui dovrei scendere a casa in macchina nel week end.” “E allora? Che impressione ti ha fatto?” “Mah, non so. Non sono riuscita a fargli neanche una domanda.” “Ah. Questo ti preoccupa?” “Non particolarmente anche se non ci sono molte informazioni su di lui online. Non che voglia fare una lettura lombrosiana dei suoi lineamenti ma un ritratto aiuterebbe.” “Stai serena. Dai che andrà bene” “Si, lo penso anche io. Mi ha poi parlato di un altro ragazzo che dovrebbe aggiungersi. Non mi ha dato un nome e cognome, non so nulla neanche di lui.” Sono le 18: 30. L’ufficio è quasi vuoto e alla spicciolata arrivano le due persone che stavo aspettando. Mi stringono la mano e tra un convenevole e l’altro mi dicono che un terzo collega sta arrivando. Come va? È molto freddo oggi, eh? Avete trovato facilmente parcheggio? Per fortuna che è venerdi… Dopo aver passato in rassegna tutti gli argomenti utili a riempire l’attesa, decido di usare quella momentanea platea per raccontare il mio prossimo viaggio in condivisione alla volta di Ancona. Con una sottile retorica che vorrebbe promuovere l’empatia nei confronti di questa apparentebizzarra modalità di viaggiare - glielo leggo negli occhi ‐, descrivo la piattaforma e il suo funzionamento. Fino alla domanda: “Ma sai almeno che faccia ha?” Rimango sospesa. In silenzio. Il terzo collega arriva. …. “E che macchina ha questo tipo?” I suoi due colleghi continuano a farmi domande, curiosi e perplessi, al contempo. “Una Giulietta nera” “Poteva andarti peggio” “E a che ora hai l’appuntamento?” “Alle sette e trenta mi passa a prendere sotto casa.” Il terzo collega si sfila la giacca. Si siede. Ascolta il rimpallo di domande e risposte. Mi sento in dovere di riepilogare la conversazione. “Anche io parto in carpooling con un tipo a bordo di una Alfa Giulietta nera, alle 7: 30 per andare a Porto Dan Giorgio” dice al termine del mio riassunto. Sorrido. È lui il terzo uomo. Scendo di corsa le scale. Infilo le chiavi nella tasca. Esco dal portone. Una Alfa Giulietta nera è lì che aspetta. Due ragazzi sono appoggiati alle portiere. Stanno chiacchierando. Ridono. Sorrido anche io. “Piacere Pamela.” “Ciao, sono Michele.” “Sei tu che guiderai quindi.” “Si, ti fidi?” - Il mio inno di gioaia a Lanzarote di Paola Raimondi Ricordo…un giorno di sole, di vento, di mare: l’isola di Lanzarote dalla sabbia nera e la presenza-radice- del vulcano da cui è nata: un fiotto di terra che erutta vita. Terra bruna lavica densa; atavica di memoria. Sono scesa alla spiaggia, minuscola, forse ritagliata dal paesaggio di una cartolina, in un mattino colorato, l’aria calda da terme benefiche, l’acqua giocherellona…riverberava il sole; e i raggi come bambini facevano girotondo. I miei piedi, sensuali come gatti, si stordivano, si saziavano di calore. Braccia mani viso quasi si abbacinavano, avvicinandosi al sole. Non ho mai posseduto un’isola. Quel giorno ero felice, di una felicità superstite -ora lo so-, superstite dopo un naufragio: un dolore così duro, così cocente da togliere il fiato e addensare nel bottone del mio cuore, tutto il bruciore del sole. Come chi è quasi per annegare ed ha immerso la testa sul buio silenzioso e definitivo del fondo-acqua; così nel mattino di sole, trascolorato di luce, ho sentito (forse, non so, lo presumo), lo decifro adesso: la mia isola, il mio spazio vitale. Ho preso il pareo –un ventaglio di colori- e poi l’ho disteso, allargandolo nell’erba dell’aria…girando girando girando: un cerchio, due cerchi…mi girava la testa, girasole di terra e di mare. Ero un sasso buttato nell’acqua della vita che partorisce cerchio su cerchio. E nel bagno di luce, approdando alla meta di un viaggio sotterraneo ed oscuro: la gioia, infine, di vivere ancora. - Nel porto Di Paola Raimondi Abbiamo passeggiato per il porto. Il mio sedere all’aria -benedetto dall’acqua- era la conchiglia rovesciata delle barche all’ormeggio: i fili delle vele come alberi bianchi, annodati…aste del gioco di “Shangai” da cogliere piano…Attenzione, ho le dita troppo grosse, alt, di qui non si passa, paletta di vigile, attenta! Attenta!... . Il bastoncino è crollato, soldato inefficiente, più non si rialza. Sul far del mezzogiorno passa un treno, rotolando sull’acciaio; breve fischia. Mi giro, già è passato. Restano le onde, giocherellone, amiche…qui sulla riva hanno bianco il sorriso. Il mare fuori stagione si prepara alla grande estate -invadente eclatante- che non guarda in faccia nessuno, prepotente persona; e al suo apparire si esce dalle case per gli applausi. Le grandi barche ormeggiate rivelano per me oracoli di parole, messaggi e rimembranze che ri/leggo alla luce sfacciata del sole: Lulù, Prince, Obsession, Suspiria, Alex Primo. E il “prima o poi” finale, sulla bianca vernice dell’ultima imbarcazione della fila, suggella un lungo discorso interiore con l’apertura al possibile. Sono grata all’amica che mi ospita, che mi ha tratta da Milano col suo invito; i giorni qui hanno lancette veloci e nel con/tempo sento di appartenere ad un’altra me stessa, scardinate le abitudini di giorni e giorni di città. Vagheggio isole abbastanza grandi da offrirmi spazio e sufficientemente piccole da poter essere conosciute dai miei passi; e dai miei sguardi. “Ho visto tutto?” mi domando; e ritorno a questa irriducibile necessità da soddisfare; una pianta carnivora che si traveste da sete di conoscenza, curiosità, cultura; ed è invece un tranquillante che placa le mie ansie e recita ( come una madre la fiaba della buonanotte al suo bambino): “Hai avuto tutto, non hai dimenticato nulla, il tuo pancino è pieno, non potrai avere fame-senza cibo-, puoi stare al caldo adesso, se vuoi rumina, digerisci, domani ti preparerò un altro buon pasto! Buon appetito, bimba!”. E’ vedere e catturare; è collezionare, è assaggiare a tavola di tutto, è vincere al gioco della dama: non lasciare andare, non saper nuotare…e così…Via! Le rocce sott’acqua attendono i bagnanti…, ma non è vero. È imperturbabile la natura e non abbisogna di noi; respira le ferite che le infliggiamo, tutti i soprusi, i tagli, le sconcezze; silenziosa sofferenza, fino al lamento ultimo. Allora si leveranno gli alberi -feriti sventrati tagliati- e ne udremo la voce. Dove io sia vissuta non so. E chissà se ricorderò un giorno questa mia vita a me stessa come Paola dalla voce bella, gli occhi castani grandi, le gambe snelle, il sorriso solare, le fossette sulle guance, i capelli tanti, le mani robuste, il corpo dalle forme accentuate. Mi sceglierò di nuovo, sono abituata a me. Rivediamoci tra cent’anni, come canta una canzone. Abiterò in un faro, dove scrivere appieno e inventare giornalieri viaggi per mare e abbracciare nello sguardo spaziosità liquide e inafferrabili. Oppure sarò una fioraia, all’angolo della strada che vende fiori e bellezza e sa suonare una fisarmonica a bocca per tutti i passanti; o sarò un’imperatrice su un trono d’oro e una corona regale poggiata sulla testa. E se fossi di nuovo un’un’aquila che cerca l’altura, la solitudine e il potere; e che vede dall’alto lo scorrere delle cose e si sente sovrana? Piccolo passerotto, ma è te che amo, quando zampetti attorno, gli occhietti vividi; e rubi bricioline di pane cadute dalla mensa: una brioche, un cracker, granelli di zucchero dal piattino del caffè. - Viaggio nel presente di Paola Zan Voi dite sicurezza. Certo: questa è una priorità. La gente ha bisogno di sentirsi tutelata e sicura nella propria casa, per strada, in treno. Certi episodi fanno riflettere. Ad esempio: ero salita sul Milano-Varese delle 10.36 quando improvvisamente si sente del trambusto. Una porta di intercomunicazione tra due vagoni sbatte con rumore di lamiera doppia e sibilo di corrente. Quattro o cinque ragazzotti alti come giraffe e con i capelli scompigliati tipo parrucca arruffata, passano quasi di corsa in mezzo ai sedili vociando in modo incomprensibile tra scoppi di risa. Sono albanesi, fa una signora che ha l’aria della habitué con il suo grande culo che lascia l’impronta fissa sul sedile in ecopelle. Non hanno pagato il biglietto come al solito… Ah, ecco! faccio io, che vivo il viaggio in treno come un’avventura occasionale sempre densa di magia e mistero anche se non succede alcunché e scorrono semplicemente le immagini del paesaggio come cartoline belle e brutte messe in fila e ad un certo punto qualcuno passa indolente e ti fora il cartoncino. Sentivo crescere l’eccitazione. Sono dentro la cronaca! pensavo. Domani i giornali… parleranno del fattaccio! Insomma, questi percorrono il treno a balzi rincorsi dal controllore alto un tappo: un bel visetto italico, basettoni da ferroviere, divisa blu, borsa a tracolla che tira di lato la giacca, piedi piatti . Obliteratrice luccicante impugnata come una rivoltella. Ma non lo è. Adesso li fa scendere alla prossima… fa la stessa di prima. Sì, sì… conferma un anziano, li fa scendere, ‘sti delinquenti… Assistiamo alla scena. Piccola stazione deserta. In ordine e pulita, per essere una stazione. Alcune ormai abbandonate sembrano latrine. Questa no. C’è qualche vaso con delle foglie che spuntano. La fontanella. La pensilina di ferro di cento anni fa. Intorno, le ville d’epoca. Alcune, non ancora ristrutturate, del colore del muschio, parrebbero buone per un adattamento padano di Psycho. Nei fazzoletti di giardino, più recenti, altrettanto poco rassicuranti villette bianche. Dall’altro vagone qualcuno informa: son scesi! Il convoglio riparte lentamente con uno scossone. E quelli, rispuntano! Saltano sulle passerelle, scoperte in quel tipo di treno, con le protezioni laterali a losanghe telescopiche e le piastre metalliche forate e mobili su cui camminare, che col treno in corsa si prende il vento come nel lontano ovest. Replay: i ragazzotti, fieri della loro impresa saltano spavaldi tra i sedili. Questa volta a rincorrerli sono in due: si è aggiunto uno più anziano, il capotreno. Che ha lasciato la postazione di comando ed è intervenuto a rinforzo del collega. Ha l’aria più minacciosa del primo e agita le mani per dimostrare quel che gli farebbe, lui, se ne acciuffasse uno. Tutti corrono come se il treno fosse una giostra circolare. Uno spettacolo. Finalmente scendono gli irregolari senza titolo di viaggio, giunti a destinazione, presumo. Sennò risalivano ancora! A noi che proseguiamo il viaggio, rimane il tempo dei commenti. Una bella manganellata! si sente ripetere, ecco cosa ci vorrebbe! La reazione non si fa attendere: macchè manganellate, cosa dice? Servissero a qualcosa! Lavori forzati semmai, a pulire ‘sti vagoni, a raccogliere l’immondizia! Bravo! si aggiunge la solita voce femminile al coro di attempati viaggiatori. Un momento. Ragioniamo per fasce d’età, qui? Gli anziani mescolano le carte del loro vissuto. Chissà se hanno dimenticato che anche loro, da qualche parte, sono stati belli giovani forti e… sono scappati! - Un concerto lungo un viaggio di Paolo Simonetta L'idea era partire da Torino per andare fino a Barcellona in macchina. Obiettivo live degli AC DC. 8‐9 ore di macchina in cambio di 2 ore di concerto. Ci sta. Non ci abbiamo pensato nemmeno troppo a lungo. ‐Però solo in due sai quanto costa?‐ Problema risolto: qualche annuncio e tre telefonate e raggiungiamo il numero magico di 4 passeggeri, proprio il giorno prima della partenza. Io e mio fratello incontriamo gli altri due ragazzi all'imbocco dell'autostrada verso Savona. Sono le 11. Loro, i passeggeri aggiunti, non li abbiamo mai visti prima. Car Pooling? Al tempo non sapevamo che dare passaggi avesse un nome così evocativo. Ma sapevamo che era la nostra prima volta: per il passaggio a degli sconosciuti, per un viaggio in macchina così lungo, e anche per gli AC DC. Kilometri e paesaggio iniziano subito ad essere scanditi dal ritmo sempre uguale della musica degli AC DC. Ritmo perfetto per l'autostrada. Battiti al minuto spaventosamente simili ai kilometri orari. Così finisce che i discorsi non possono che essere in tema con il live che ci attende, e la diffidenza finisce subito nascosta dietro chiacchiere musicali. E quando capiamo che la discografia degli AC DC ci basterà fino a Barcellona, creiamo un modo nuovo di viaggiare: trasformiamo il vaggio in musica. Un po' a testa, in modo naturale, ribattezziamo i luoghi e i paesaggi che attraversiamo con i nomi di brani, le zone con quelli degli album. Così la prima galleria della Liguria prende il nome dell'album più recente della band e le prime città della Francia finiscono per chiamarsi con i titoli di un album del 1985. Cannes viene ribattezzata Sin City, perchè il cartello lo avvistiamo quando inizia il pezzo omonimo. In Provenza facciamo scorrere l'Highway to Hell e quando alla stazione di servizio di Perpignan sentiamo un pezzo degli AC DC in radio, ci guardiamo tutti e quattro. E ci accorgiamo che il nostro viaggio è molto diverso da come ce lo saremmo immaginati. La tappa successiva la facciamo appena le ruote toccano il territorio spagnolo. Un'ultima sgranchita alle gambe e poi dritti allo Stadio Olimpico di Barcellona. Ma quando rientriamo in macchina ecco la scoperta: gomma a terra. Non bucata. Tagliata. Guardiamo l'ora e valutiamo il da farsi. Alla fine tra lo sconforto e le peggiori previsioni, decidiamo di mettere il ruotino di scorta e farci gli ultimi 200 kilometri alla velocità che ci è consentita. Una gara contro il tempo, la più lenta che si sia mai vista. Tra un clacson e l'altro dei camion che ci superano, ci sproniamo a vicenda a trovare un passaggio. Almeno due di noi. Almeno uno. Qualcuno questo live lo deve vedere. E intanto parliamo. Questa volta di tutto. Iniziamo a conoscerci, sciogliamo le diffidenze. Completamente. Il tempo scorre e alla fine vince lui. Gli AC DC non li abbiamo sentiti, quella sera. Non siamo arrivati in tempo al live. Ma a Barcellona ci siamo arrivati. Ed è stata una serata indimenticabile. - Congedo di Paolo Vanini Ci incontriamo nella piazza dietro l'ostello, fra una segmentata scultura di metallo e una filiale bancaria tendente all'opaco. L'auto è blu, il ragazzo alla guida alto e castano, spalle senza incertezze e occhiali spartani. Ci presentiamo e metto lo zaino nel baule, accanto a una sacca verde con sopra il logo dell'esercito. Fa il militare, e scende verso Roma perché ha due giorni di permesso; io, invece, studio filosofia e vado a Roma per trovare un'amica – modi diversi per arrivare al medesimo punto. Così, dovendo aspettare per mezzora altri due compagni di caserma che si uniscono al viaggio, fumiamo qualche sigaretta in una sorta di piacevole tabagismo socratico, ognuno a raccontare gli imperativi categorici della propria quotidianità. All'appello si presentano una ragazza occhi verdi e un commilitone rasato, entrambi stanchi e dello stesso reparto. Lasciano sedermi davanti, mentre iniziano a discutere di topografie normative e coercizioni gerarchiche – gergo che non so decodificare e che estromette ogni mio interesse al dialogo. Tuttavia, fra le improbabilità che legano le contingenze di un effetto a quelle di una causa, non credevo di poter condividere percorso e benzina con tre militari per la grazia di un messaggio informatico: a riprova dell'insufficienza del mio cervello, o delle previsioni metafisiche che lo illudono di una parvenza di sostanza. Occhi verdi mi chiede da dove vengo, aspettandosi come risposta il nome di un presidio o il numero di una compagnia. Fraintendo le intenzioni, riferendomi semplicemente a un domicilio su campo neutro; le sue pupille tradiscono perplessità e ripete ostinata la domanda, finché colui che guida non le spiega coinciso che sono “un civile”. Delusa, confessa di avermi creduto un portatore di divisa, ipotesi che mi colloca davanti alla patria e all'onore, petto in fuori e fucile alla mano. Mi guardo allo specchietto retrovisore, barba incolta da oltre un mese e ricci anacronistici che sembrano digiunare contro l'inutile guerra del Vietnam, quando nessuno di noi era nato; senza contare la scoliosi che smussa verso il basso la spalla destra e che testimonia del mio pacifismo da sedentario. Non c'è nulla del mio aspetto che non provocherebbe l'astio di un sergente; inoltre, le ultime tre notti mi sono sbronzato – che Anna mi ha mandato a cagare in qualche trincea d'astinenza – e al massimo potrei confondermi con un disertore onanista che puzza di rum. Faccio notare alla nuova amica e futura criminologa che ha appena arruolato il peggiore dei soldati possibili – e che solo per questo l'ho già perdonata. Poco importa che non ricordi il suo nome e che probabilmente non abbia colto la battuta. Ci siamo addormentati a metà viaggio e risvegliati poco prima dell'arrivo. C'era il tramonto e tutto andava per il meglio. Tranne il traffico. - Agua Caliente di Patrizia Tenda Alla piccola stazione ferroviaria di Merced fa capolinea l’autobus turistico per Yosemite Park. Il treno da Oakland arriva a mezzogiorno. Scende una comitiva di bambini neri, con le madri obese, poi scende una giovane bianca, zaino a tracolla. La ragazza si ferma all’ufficio informazioni ed esce sul piazzale a parlare con l’autista dell’autobus. Una turista europea, coi vestiti in tinta, le scarpe di pelle e le movenze fluide di un parigina. No, non può prendere l’autobus per Yosemite oggi, dice l’autista, deve prenotarsi un giorno prima. La giovane si guarda intorno, in cerca di un taxi che la porti in paese, dove ha fissato una camera al Best Western. C’è un’altra donna che aspetta il taxi, con le valigie a terra. Capelli biondo platino, gran sorriso dentato, scarpe da ginnastica e tuta sportiva fosforescente. La giovane si avvicina, si presentano. Françoise. Piacere, JoAnne. Sono dirette allo stesso albergo e aspettano insieme un taxi che non arriva. Anche Jo-Anne è venuta per vedere Yosemite Park e insieme prenotano per il giorno dopo, la corsa di prima mattina. C’è movimento alla stazione di Merced. Uomini con giacche di pelle da aviatori vanno e vengono, finché la signora Jo-Anne, con gran disinvoltura, ne interpella uno, un bel giovane bruno dentro una Pontiac arrugginita. “Scusi tanto, ci dà un passaggio in paese? Questa è la mia amica Françoise. Che ci fanno a Merced tutti questi aviatori?” Il giovane bruno fa posto dentro l’auto e spiega che c’è in effetti un raduno di aviatori, volati fin qui con piccoli aerei d’epoca. L’auto fiancheggia la rete metallica del campo d’atterraggio e il giovane fa segno verso alcune carlinghe biposto. All’entrata del piccolo aeroporto c’è un caravan con l’insegna della Hertz. Jo-Anne si fa fermare per affittare un’auto e i bagagli passano dalla Pontiac all’auto noleggiata. La giovane Françoise, che ha perso qualche battuta del dialogo durante il breve tragitto, sta a guardare senza capire. “Il signore non ci accompagna all’hotel?” “No, ci andiamo da sole”, risponde Jo-Anne e saluta l’aviatore ringraziando. Françoise è confusa: perché affittare un’auto se domani andiamo al Parco in autobus e stiamo fuori tutto il giorno …. L’esuberanza della signora bionda è accattivante, sarà un po’ matta, ma è certo una brava persona. Jo-Anne siede al volante, soddisfatta di avere una compagna di viaggio esotica, che parla inglese con la erre moscia. “Lo sai, noi americani non sappiamo vivere senza un’auto sotto il culo! Ci servirà oggi per andare a fare la spesa.” La spesa? Françoise è frastornata dalla familiarità di questa estranea. E’ abituata a viaggiare da sola, e l’incontro fortuito la incuriosisce. Ora che osserva Jo-Anne da vicino, mentre guida, vede la maschera di rughe fitte che le segnano il volto. A prima vista pareva una quarantenne, ma una faccia così conciata non può averne meno di sessanta. La vitalità delle matriarche americane. Corpo in forma perfetta, jeans e maglietta attillati, voce squillante, entusiasmo contagioso, un po’ infantile. Al suo confronto, Françoise sente la posatezza dei chili di troppo, del proprio temperamento riflessivo, e una noia profonda di sé le fa desiderare la compagnia di questa donna impulsiva. Il Best Western è un motel a due piani, con le scale e le balconate scoperte. Le due donne si danno appuntamento e vanno a rinfrescarsi, JoAnne al piano terra, Françoise al piano di sopra. La stanza è grande, spaziosa, con TV, frigorifero e cucinotto. Ora Françoise comprende: la spesa! Ma come faceva Jo-Anne a sapere che questo albergo aveva la cucina in camera? Dentro il forno a microonde c’è una confezione di mais pronta da cucinare. Dopo la doccia, Françoise si fa un caffè. Poi, curiosa e affamata, fa saltare il mais dentro il microonde. Accende la tv e, seduta sul letto, divora il popcorn caldo mentre ascolta le notizie dell’ultima misteriosa epidemia nelle riserve indiane dei Four Corners. Il telegiornale non parla dell’Europa, del resto del mondo, e neppure dà le notizie nazionali. E’ una rete locale e trasmette solo quel che può interessare gli abitanti di questo villaggio a ridosso della Sierra Nevada, i furti, le violenze, gli scandali della San Joaquin Valley. Questo pomeriggio sprecato, questa tappa forzata a Merced deprime Françoise, sempre in marcia verso località famose e stimolanti. Non sa aspettare. Le sembra di avere atteso in eterno prima di poter evadere dalle montagne di casa sua, dal paesotto, molto simile a questo, dove niente succede a niente, e la gente si svaga nel pettegolezzo crudele della provincia. Françoise spegne la TV e cerca di dormire. Fuori dalla finestra il sole torrido brucia la sterpaglia ai bordi della strada. Le montagne della Sierra sono lontane, invisibili, ma l’aria scende fresca verso sera e porta le nuvole e l’odore dei boschi e delle sequoie. Françoise dorme e sogna di avere perso l’aereo. E’ arrivata al check-in troppo tardi, l’aereo per la Francia è decollato. Il trillo del telefono la sveglia, è la voce allegra di Jo-Anne che la chiama. Allora ricorda che il volo da Los Angeles è fra una settimana. Scende alla reception, dove trova un assembramento di aviatori. “Hanno occupato l’hotel!” grida Jo-Anne con le mani levate. E’ sempre di buon umore, la matriarca. Prendono l’auto e girano a vuoto per le strade di Merced, in cerca del “centro città”. Si perdono invece in una periferia di capannoni e negozi con vetrate protette da enormi inferriate. Il paese, nel crepuscolo, è più spettrale di Oakland. Françoise tenta di convincere Jo-Anne a cercare un ristorante, o un Diner. Ha bisogno di un pasto caldo, lo stomaco risente del pasto saltato. Jo-Anne sembra vivere d’aria. “Ma li vedi tu i ristoranti? Non ce ne sono, qui. E’ già tanto se troviamo un supermercato”. Vicino a un distributore di benzina trovano finalmente un negozio di alimentari, barrato da saracinesche. “Ma è chiuso”. “No, no, Françoise, le luci dentro sono accese”. Una porta-inferriata immette nel grande interrato. Jo-Anne vaga lungo le corsie di scatole e scatolette e riappare con una confezione di yogurt e un po’ di frutta. Françoise non sa cosa comprare per cena, non sa cosa potrebbe cucinare nel minuscolo microonde dell’hotel. Pensa alla colazione di domani, cerca piccole confezioni di latte, di aranciata e di alimentari che possa consumare in un giorno. Non può portarsi queste cose nello zaino e odia sprecare, ma trova solo confezioni enormi, familiari, che le basterebbero per una settimana. Jo-Anne la vede arrivare col carrello pieno e la guarda incredula. “Hai intenzione di invitare gli aviatori?”, dice, e sorride, per la prima volta materna. Salgono in auto che è già buio fitto. Jo-Anne è ora silenziosa. La notte sembra intimorirla. Non vuole cercare un cinema, né altri svaghi. Françoise è delusa. “Hai affittato l’auto solo per fare la spesa?”, le chiede. “Potremmo andare a Yosemite domani con l’auto, invece che con l’autobus”. Jo-Anne guida guardando davanti a sé lungo le strade vuote. Poi si volta a guardare la giovane francese, che potrebbe essere sua figlia, e parla con voce fessa, quasi baritonale. “L’auto mi serve dopodomani, per andare a Chowchilla a trovare mia figlia”. Jo-Anne aspetta una reazione, poi si rende conto che la francese non sa di Chowchilla, e non può capire. Potrebbe fermarsi qui, non aggiungere altro, ma la compagnia inaspettata di questa ragazza per bene le scalda il cuore. “Non sai cos’è Chowchilla, vero? E’ il penitenziario femminile di massima sicurezza a sud di Merced. Mia figlia ha la tua età e sconta la pena per aver ucciso un uomo”. Jo-Anne si volta a guardare Françoise “Ti ho scioccato?” Françoise è senza parole. Si sente proiettata dentro un telefilm americano. Non era necessario andare al cinema. Il dramma è nelle strade, dentro i supermercati. Suspence e adrenalina in un incontro casuale, in una cittadina anonima, dove la quotidianità è drammatica fino alla noia. “Sei sconvolta, vero?” “No, no”, improvvisamente Françoise sente la voce preoccupata della donna e intuisce la sua immensa pena. Vorrebbe dirle qualcosa, ma cosa? “Beh, sono sorpresa. E mi dispiace, per te e per tua figlia”. Françoise cerca di pensare, in fretta, in fretta, di localizzare con la mente il dolore della compagna di viaggio, per poterla incontrare e riconoscere, per trovare le parole. Jo-Anne, giunta al parcheggio dell’hotel, sembra temere quanto lei la solitudine della sua stanza. Rimangono un po’ in silenzio, sedute dentro l’auto, a luci spente. Jo-Anne tira fuori il portafogli e le mostra una foto della figlia, una giovane alta e bruna, viso allungato, grandi occhi, grande sorriso californiano. “E’ una donna bellissima”, dice Françoise con l’amarezza che le sale in gola. “Sì”, Jo-Anne sospira. “Ha ucciso il suo amante sotto l’effetto della droga. E’ stato lui ad iniziarla. Del resto sono anch’io colpevole. Io l’ho iniziata all’alcool, e dopo il divorzio da suo padre, ho portato in casa dei disgraziati che si sono approfittati di lei. Dio mi perdoni”. Françoise allunga la mano per toccarla, sente che il dramma è al suo culmine e che ora la donna piangerà. Ma Jo-Anne non piange. Scrolla le spalle e la congeda, dandole il bacio della buona notte. Françoise sale in camera e non riesce a dormire. Fissa la parete in fondo al letto e non può concepire una vita così violenta, una colpa così pesante da portare. La JoAnne allegra che ha incontrato in stazione fa buon viso a cattiva sorte. L’autobus per Yosemite passa a prenderle davanti all’albergo alle sette di mattina. Il cielo è coperto e cade una pioggia sottile. Jo-Anne ha indosso un impermeabile di plastica trasparente, Françoise una giacca di pelle messicana. Si siedono insieme vicino all’autista, eccitate come due ragazzine. L’autobus si ferma alla stazione del treno, dove i turisti sono in attesa, al riparo della grande tettoia di legno. L’autobus si riempie di impermeabili e ombrelli, dell’odore di vestiti e terra bagnata. Ora si parte davvero verso le montagne nere a est, verso la Sierra. Dopo il lungo rettilineo a valle, iniziano le alture ed i boschi di abeti. Enormi massi rocciosi incombono sulla strada ripida che costeggia il fiume, ora un torrente impetuoso di spuma bianca. Jo-Anne armeggia nella borsa ed estrae una videocamera. “Questo è il mio diario”, dice a Françoise. “Marsha, la mia analista, me lo ha prescritto come cura quotidiana. Devo registrare tutte le cose significative della mia giornata”. Accende la videocamera, senza imbarazzo parla mentre filma. “Mattina del due giugno. Eccoci sull’autobus per il parco di Yosemite. Questa è Françoise, la mia nuova amica, ciao Françoise! Questo è l’autista, buongiorno! Questi qua dietro sono i nostri amici di viaggio. E quello minaccioso laggiù è il fiume Merced. Dall’altra parte della costa si possono vedere i vecchi sentieri dei minatori. Eccolo là, un ponte di legno crollato, e più su le impalcature della miniera abbandonata. Dietro di noi si è formata una fila di auto. C’è un bel traffico di turisti per Yosemite. Ah! Visto quel gommone color arancio sul fiume? Ma che fanno, le gare sulle rapide?” L’autista fa un cenno affermativo. Anche Françoise è ora in piedi nello stretto corridoio dell’autobus, con la macchina fotografica in mano. Inquadra i finestrini, ma il fiume è appena visibile tra le rocce e le curve della strada. I vetri sono appannati e gocciolanti di pioggia, è impossibile fotografare, ma Jo-Anne continua a filmare. L’autobus scarta improvvisamente contro il garde-rail, facendo finire le due donne in braccio alle coppie di turisti seduti. Segue un urto violento contro la fiancata sinistra. Un’auto in discesa ha imboccato la curva invadendo la corsia dell’autobus. L’autista apre la portiera anteriore e scende a controllare il danno. Jo-Anne scende di corsa dietro a lui per filmare l’accaduto. “Avevo la videocamera accesa quando è successo!”, grida, eccitata nel ruolo sacro del testimone. Fuori dall’autobus l’aria è fredda, aria d’alta montagna. Françoise resta sulle scalette, protetta dalla pioggia, e guarda su, alle nuvole che coprono le cime dei monti. Teme per questa sosta imprevista e per il cattivo tempo, che le impedirà di vedere le meraviglie naturali del Parco. Jo-Anne sembra incurante della pioggia e si muove intorno all’autobus come un vero cameraman, ci manca solo che intervisti qualcuno. Sembra felice, contenta di sé, col suo giocattolo che dà significato e vita al più stupido incidente. I danni alla fiancata dell’autobus sono minimi. L’auto che lo ha investito invece ha il fanale sinistro schiacciato, il cofano deformato e la fiancata ammaccata dal contraccolpo. Françoise mette la macchina fotografica nella custodia. Non c’è nulla che sia degno di nota qui. Si consola pensando che la bellezza del Parco la esalterà, liberandola dal proprio peso, dalla propria pelle. Visitare luoghi famosi le dà sempre un senso di compiutezza e finalità. Poi tornano i giorni grigi, la vita che non merita di essere fotografata, come questo incidente stradale sotto la pioggia. Jo-Anne è ancora fuori, sul ciglio della strada, a filmare un fiore in macro. “Questo è un bell’esemplare di Indian paintbrush, rosso fiammante. Finalmente ti sei lavato via la polvere della strada, eh?” La sosta forzata si protrae per un’ora, col traffico bloccato, finché JoAnne rientra, seguita dall’autista, e si parte. L’autobus imbocca la stretta valle di Yosemite, e qui la nebbia è così fitta da posarsi sulle cime degli alberi, impedendo la vista delle montagne. L’autobus devia verso Glacier Point, sale tra boschi di abeti altissimi e si ferma sul passo che domina la valle. Piove ancora, ma stavolta i passeggeri scendono. L’autista li raccoglie intorno alla piattaforma che regge la mappa del Parco, con grafico e nomi dei picchi più alti. “Ecco, dal grafico potete vedere come sarebbe Yosemite in un giorno di sole. Ora la nebbia e la pioggia coprono tutto, ma se vi sforzate un po’, potete vedere laggiù in fondo, sulla destra, la parte bassa della cascata, mentre sulla sinistra si intravede la parete a perpendicolo dell’Half Dome”. Il gruppo si stringe intorno alla mappa, poi si disperde in silenzio, chi sotto gli ombrelli, chi sotto i cappucci colorati degli impermeabili. Come un sortilegio bianco, la bruma ricopre la valle dei grandi monoliti di Yosemite. Gli uccelli tacciono. Si ode soltanto lo scrosciar della pioggia tra gli alberi. Jo-Anne e Françoise contemplano in silenzio. Anche senza la vista panoramica, la Sierra incute un sacro timore. Tra la nebbia, l’occhio della mente coglie le due imponenti catene rocciose che chiudono la valle come le fauci di un immenso drago. I visitatori, ammutoliti dal silenzio fra gli alberi, tornano all’autobus, stretti nei loro impermeabili bagnati. Si scende a valle, e la visione scompare tra il fitto sottobosco. Le costruzioni del parco, ristorante, negozi, museo, sono sommersi nel verde cupo. L’autobus si ferma davanti al sentiero stretto che conduce alla cascata. “Avete mezz’ora di tempo, poi andremo al ristorante.” Jo-Anne e Françoise scendono con videocamera e macchina fotografica. L’incidente e il ritardo causato dal traffico hanno scombinato i tempi del giro turistico. Françoise ha deciso che tornerà l’indomani. Non può rassegnarsi a questa visita fugace sotto la pioggia. La cascata è per metà coperta dalla nebbia. L’effetto vertiginoso dell’altezza è perduto, ma la potenza dell’acqua che si infrange sulle rocce è tale da intrattenere un folto gruppo di visitatori. Non c’è modo di fotografare l’acqua libera dalla presenza di teste, braccia e ombrelli. Neppure lo scroscio assordante della cascata riesce a sommergere le grida. Nel salone del ristorante la calca e il vociare sono insopportabili. Le due donne, sedute al tavolino, non riescono a sentire la propria voce. Consumano velocemente il pasto e si separano davanti alle vetrine dei negozi di souvenir. Anche i negozi sono assediati. Con la pioggia battente, dove altro andare? Françoise contempla i gioielli di argento e pietra e i tappeti colorati dei Navajos, ma compra solo cartoline. I prezzi sono proibitivi. Jo-Anne, al rientro sull’autobus, mostra un solo acquisto, per la figlia: orecchini d’argento a forma di ragnatela, con la pietruzza turchese incastonata al centro. Accende la videocamera e li inquadra: “Sono gli acchiappa-sogni. Hai visto quelli in pelle, grandi così? Gli indiani li appendono al soffitto, sopra il letto. La ragnatela fa impigliare i sogni, così la mattina se li ricordano. I sogni sono importanti: sono le istruzioni in codice del Grande Spirito.” Françoise pensa al sogno del giorno prima. Quando è in viaggio, sogna spesso di perdere l’aereo. Cosa vorrà dire? Che non vuol tornare a casa? O che ha paura di non poter tornare? L’autista si ferma in una piccola radura: “Avete solo quindici minuti per El Capitan, siamo in ritardo”. Tra gli alberi alti si intravede la roccia a perpendicolo del grande monolito, liscio e luccicante di pioggia, il dente “canino” del drago. La cima è nascosta fra le nuvole, ma vista da sotto in su, la grande montagna di granito dà le vertigini. Jo-Anne parla concitata con la videocamera accesa. “Che mostro! Un blocco unico di roccia compatta. Impressionante. E’ stabile, vero? Non ci cascherà addosso?” El Capitan è minaccioso, non sembra granito, piuttosto un meteorite caduto dallo spazio. Françoise immagina la violenza con cui si è proiettato fuori dalla crosta terrestre, come un missile, e quanta parte di esso sia nascosta nelle viscere della terra. Un orrendo cataclisma geologico ha formato questo ammasso di giganti. L’energia tellurica che li ha sprigionati è ancora visibile sulla faccia della roccia. Tutti rientrano puntuali. Hanno trascorso solo quattro ore nel parco, ma anche i più giovani sono stremati. Durante il viaggio di ritorno tutti dormono nell’autobus, anche Jo-Anne. Françoise nel dormiveglia vede squarci di luce nel cielo ad ovest, sulla piana di Merced. Il temporale è rimasto impigliato nelle montagne. I campo dorati di San Joaquin Valley brillano sotto il sole. Arrivate in albergo, Jo-Anne è di nuovo piena di energia e propone una gita in auto per la campagna. Raggiungono un piccolo lago a nord di Merced, e si fermano sulla breve spiaggia. Sulla collina che sovrasta il lago c’è un ristorante col parcheggio pieno di auto sportive. Dalle finestre aperte esce il martellare di una musica rock. Françoise, preoccupata per la cena, propone di andare a esplorare. Salgono a piedi il lieve pendio a prato inglese, entrano nell’edificio di legno scuro e trovano il locale gremito di giovani coppie che ballano. Un signore vestito da cow-boy si avvicina alla porta: “Mi spiace, oggi siamo chiusi al pubblico. Questa è una festa privata”. Françoise resta un attimo sulla soglia a guardare. La musica è cambiata. Ora le coppie volteggiano al ritmo di una nuova musica country che Françoise ha sentito già, durante il suo soggiorno californiano. “Questa canzone mi piace”, dice a Jo-Anne. “Come vorrei saper ballare così”. Guarda con invidia i ballerini con i cappelli e le camicie da cow-boys, poi segue l’amica all’aperto. “Oh, se vieni a trovarmi a San Bernardino, ti porto in una discoteca dove insegnano a ballare il toush-push e la line-dance”. E lì, sul prato, JoAnne si mette a ballare seguendo il ritmo della musica. Cinge Françoise alla vita e le mostra i passi più facili. Ridono e ballano fin sulla sabbia della riva, dove, affannate, si accasciano. “Hai energia da vendere, tu!”, dice Françoise, piena di ammirazione. “Avresti dovuto vedermi quando ero giovane. Una vera peste. Sempre in cerca dello sballo. Adesso è diverso, però. Adesso è gioia di vivere”. “Sei coraggiosa”. “No, è la fede che mi dà coraggio. Da sola non potrei mai”. Françoise volge lo sguardo sull’acqua, infastidita. “Io credo in me stessa”. “Beh, anch’io facevo di testa mia, e mi sono cacciata in un bel guaio. Ora ringrazio Dio ogni giorno per tutto quello che mi manda”. “Anche per tua figlia in prigione?” Jo-Anne ignora il tono provocatorio di Françoise “Se non fosse dentro, sarebbe morta di eroina, o anche peggio”. “Cosa c’è di peggio della morte... ” “Peggio della morte? Una vita senza amore, ecco cosa c’è di peggio. La vita che facevo prima. Ma è acqua passata, ora abbiamo una vita nuova, io e mia figlia”. Françoise tace. Non sa più cosa dire, e non vuole provocare prediche religiose. Ecco un’altra fanatica, pensa. Ma, in fondo, dove mai potrebbe trovare conforto Jo-Anne? Un uomo non basterebbe per dimenticare. Come potrebbe dormire la notte, se un Dio non le chiudesse gli occhi? A nord il cielo si è coperto di nuovo e tira un vento che muove il fronte cupo delle nubi. Sedute in riva al lago le due donne decidono di aspettare il tramonto sull’acqua, mentre la pioggia si scarica sui monti vicini. Sul lago, ancora per poco, splende il sole. Velocemente il sipario d’acqua invade l’orizzonte e costringe le due donne dentro l’auto. La superficie del lago si frange sotto uno scroscio violento. L’oscurità scende all’improvviso, senza tramonto. Il ristorante accende le luci nel patio e la musica impazza. Jo-Anne guida verso Merced nel buio, senza parlare. Quando si salutano sulla porta dell’albergo, Jo-Anne augura a Françoise una migliore giornata al Parco, poi, imbarazzata, le chiede: “Quando torno da Chowchilla domani, posso venire a salutarti in camera? Ho paura di star male”. Françoise l’abbraccia: “Sicuro. Ti aspetto. Saluta tua figlia per me”. La mattina dopo l’autobus per Yosemite è già pieno quando raccoglie Françoise all’hotel. L’aria è fredda ma sta sorgendo il sole. Françoise trova posto accanto a una ragazza orientale, dalla carnagione scura, forse filippina. Non si scambiano parole durante il viaggio. Françoise non è socievole, e stamane si è svegliata col mal di gola. Ha indosso una sciarpa di seta bianca, che risalta sul colore rossiccio della giacca di pelle. Nonostante i jeans e la giacca messicana, quel tocco di seta la fa sentire consapevolmente europea. Anche se avesse al collo un fazzoletto annodato come quelli dei cow-boys, il modo di portarlo la tradirebbe. Un americano, del resto, può coprirsi di Armani fino alla testa, la stoffa gli sta sempre stretta. La giovane “filippina” non ha il sofisticato languore europeo, né il portamento atletico americano. È così remissiva e timorosa che non può appartenere alla razza dei dominatori, né a quella vecchia né a quella nuova. È figlia di servi, il suo modo di guardare, con gli occhi bassi, lo rivela. A Yosemite piove, ancor più di ieri. All'entrata del parco, il ranger dalla garitta dice all'autista che nella notte è nevicato sui passi e che Glacier Point è impraticabile. L'autista fa tappa davanti ai negozi di artigianato, e Françoise scende. Si aggira incerta davanti alle vetrine, poi controlla sulla piccola mappa che porta con sé i luoghi più vicini da poter visitare senza bagnarsi troppo. Decide per il museo di fotografia e attraversa i sentieri del bosco con la giacca in testa. Il museo è una modesta costruzione in legno, con un grande negozio di libri, posters e diapositive. Françoise gira fra i banchi in cerca di un libro fotografico del parco. Trova un bel portfolio di Ansel Adams, con immagini della valle sotto la neve. Lo mostra alla ragazza della cassa per pagare e riconosce la filippina. Anche la filippina l'ha riconosciuta e indica la sua sciarpa con gli occhi: “Lei era sull'autobus con me”. Françoise sorride. Anche la filippina sorride, ma è un sorriso triste, pieno di nostalgia. Forse la mia sciarpa le ricorda qualcuno del suo paese. Oppure è triste per il brutto tempo, per il lavoro monotono, sempre in piedi. Per la calca, la confusione, la responsabilità della cassa. Le cassiere in America sono nevrotiche, scorbutiche. Questa ragazza non lo è, ma sembra infelice come un fiore mal trapiantato. Françoise si rassegna a visitare la mostra. Vorrebbe essere fuori, al sole, camminare per i sentieri in mezzo ai boschi, ma ormai si è messa il cuore in pace. Vedrà Yosemite solo in fotografia. Le foto della mostra sono belle, in bianco e nero, panoramiche da Glacier Point, e foto macro di felci, fiori e roccia. Solo paesaggi naturali, senza la presenza dell'uomo. Come sono nobili e incorruttibili le montagne. Anche sotto la neve, la terra mostra i segni della vitalità ciclica, la vita eterna. Se il dio di Jo-Anne esiste, è sicuramente nascosto tra questi alberi altissimi, dentro queste rocce. Solido, inalterabile. Françoise ha fame. Non vuole ritornare al ristorante di ieri, troppo caotico. Chiede alla ragazza della cassa se c'è un self-service vicino, o un piccolo bar. La ragazza le mostra sulla mappa un luogo di ristoro vicino: “Pizzèria!”, dice, ammiccando con gli occhi. Françoise chiede un passaggio a una signora con l'ombrello e poi corre da sola lungo il viottolo che la separa dal self-service. È vero, vendono pizze al taglio, insieme a sandwich e insalate. Il locale è piccolo, con qualche tavolino, e c'è la fila al banco. Il pavimento è un pantano di cartacce bagnate. Françoise si accoda alla fila di impermeabili gocciolanti. Dietro di sé, sente parlare la propria lingua. È una coppia giovane, appena entrata, lei bionda, lui moro. Indicano i tabelloni alti sopra il banco, con le foto delle portate. Non sanno cosa mangiare. Ripetono “junk food”, con la bocca stretta. Françoise ordina un'insalata di riso e pollo, e un caffè lungo. Miracolosamente trova un tavolo libero e si siede. I due francesi ordinano una grande pizza rotonda, tagliata a spicchi. Il moretto, con in mano le bibite e i bicchieri di carta, cerca fra i tavoli, vede Françoise sola e le chiede, in inglese, se può sedersi. Françoise fa cenno con la testa. Non vuole parlare francese. Arriva la biondina col piatto della pizza e, nell'agitazione, rovescia il piatto. La pizza vola sul pavimento sporco. Il giovane, premuroso, corre in soccorso, ma non può far altro che andare a ordinare un'altra pizza, mentre l'inserviente accorre con segatura e scopa. I due francesi, imbarazzati, si siedono. Il giovane, socievole, rivolge la parola a Françoise, sempre in inglese. “Conosce la direzione per Mono Lake?” Françoise si presenta, nella lingua materna. I due giovani non sembrano entusiasti di aver incontrato una connazionale. Sono in viaggio di nozze, fly and drive. Hanno visto Canyon de Chelly, dice il giovane, estasiato. “Sublime. Un'esperienza sublime”. È evidente che lui ha progettato il viaggio di nozze, è lui il patito dei parchi naturali. La biondina sembra troppo fragile, nervosa. Non interviene nella conversazione, non sembra condividere l'entusiasmo del marito per l'Arizona. Françoise non è stata a Canyon de Chelly e prova una fitta acuta di gelosia. Vorrebbe far mostra di conoscere l'America meglio di loro, più di ogni altro francese, ma ora non può. “La strada per Mono Lake è questa – punta il dito sulla propria mappa – ma siete certi che non sia bloccata dalla neve?” “Neve? A giugno la neve?” “Stanotte è nevicato qui, e so per certo che il passo di Glacier Point è chiuso al traffico”. “Mio Dio, - la biondina è sbiancata – dobbiamo arrivare all'hotel di Death Valley stasera. È prepagato. Se lo saltiamo, perdiamo le altre tappe del viaggio. A meno che non saltiamo Death Valley... ” “Death Valley no!” grida risentito il marito. “Meglio allora saltare Disneyland”. La giovane sposa tace, indispettita. “Non c'è altro modo di aggirare il Parco”, spiega Françoise, che pensa di saper leggere le mappe come un esperto navigatore, anche se in quei luoghi non c'è mai stata. “Dovreste riscendere verso Los Angeles e poi tagliare per Barstow... ” “No, così non arriveremo mai.” Il giovane scuote la testa, allarmato. Death Valley, ecco un altro luogo che Françoise non ha visto. Adesso però non invidia più i due sposini. Guidare l'auto tutti i giorni, saltando da un posto all'altro, senza fermate extra, senza spazio per l'imprevisto. Che strano viaggio di nozze. Saranno così stanchi ogni sera che avranno appena la forza di darsi la buona notte. I due giovani mangiano in fretta e si congedano. Françoise augura loro buona fortuna e resta ancora un po' al tavolino. Studia la mappa e non può rassegnarsi a lasciare la Sierra senza averla vista col sole. Decide che l'indomani scenderà a Fresno e visiterà il parco delle sequoie giganti. Passerà lì gli ultimi giorni prima della partenza. Uscita dal self-service, Françoise trascorre qualche ora vagando per i negozi di artigianato indiano e infine, conquistata dai colori intensi di un tappetino, lo compra. È di un turchese vivo, con decorazioni geometriche rosse, nere e gialle. Una commessa dal grande viso scuro le dice: “Sono i quattro colori sacri. Nero è il nord. Rosso è l'est. Blu è il sud e il giallo è l'ovest.” “Io amo il color turchese”, dice Françoise, come se non le importasse il significato recondito dei colori. Nel viaggio di ritorno sull'autobus, Françoise srotola il nuovo acquisto e ricorda: turchese vuol dire sud. Ora, stringendo il pesante tappeto di lana grezza, Françoise sente che non vuol tornare a casa, che vorrebbe prolungare indefinitivamente il proprio stato peregrino, di turista senza obblighi e radici. Anche se la sera soffre di solitudine ed è piena di dubbi sul futuro. Stasera Jo-Anne vorrà essere consolata, dopo la visita al carcere. Françoise sbuffa tra sé, non le va proprio di vederla. Jo-Anne è eccessiva nell'allegria come lo è nella depressione repentina. Cosa può mai dirle Françoise per tirarla su. Non ha esperienza di queste cose. E poi nessuno ha mai consolato Françoise, lei non lo permetterebbe. Autosufficiente fino in fondo. Françoise non sopporta l'idea di dover chiedere aiuto a qualcuno, di dover ammettere una debolezza. Ha ammirato Jo-Anne, all'inizio, per la sua forza d'animo di fronte alla tragedia. Poi però è rimasta sorpresa quando Jo-Anne le ha chiesto aiuto. Il suo dio non è poi così potente, se deve far ricorso a un'estranea incontrata per caso. Di nuovo in camera, Françoise consuma la sua cena con gli avanzi della spesa, poi prepara lo zaino, mentre aspetta. Ma Jo-Anne non arriva. Françoise accende la TV e si mette a letto. Finalmente squilla il telefono. “Ciao, Jo-Anne. Che succede?” “Sono stata poco bene, Françoise, scusami ma non me la sento di salire. Ho vomitato quando sono tornata. Mi sento troppo debole.” “Come sta tua figlia?” “Era contenta di vedermi, e sta benino. Ha ancora tanta rabbia in corpo, però. Ci vorrà del tempo perché si calmi. È consumata dall'odio. Per fortuna il carcere la protegge da se stessa.” “Che cosa le fanno?” “Sedativi, e quando è violenta, l'isolamento. Poi terapia di gruppo, messe, preghiere. Ogni tanto si calma e piange. Oggi con me ha pianto e pianto. Se si deprime troppo, le danno dei farmaci per tirarla su, ma è pericoloso, perché poi si scatena. È posseduta da una furia senza fondo.” Ora si sentono rumori soffocati. Jo-Anne ha coperto il ricevitore. Françoise la chiama: “Pronto, sei ancora lì?” “Scusami Françoise, non volevo rattristarti. Torni giù con me domani a San Bernardino?” La voce è tornata quella energica di sempre. “Mi piacerebbe venire a trovarti, ma anche oggi ho perduto la vista della Sierra. Domani voglio tentare al Kings Canyon e Sequoia National Park. Se ho tempo, al rientro, passo a salutarti.” “Françoise, ci conto. Se vieni, ti porto a visitare la Faglia del terremoto, e la sera andiamo a ballare. Ok? Domattina ti porto in stazione. A che ora parti?” “Non ho gli orari. Quando sei pronta, andiamo.” “Va bene, ti chiamo io domattina. Buonanotte.” Ciao, Amy. Oggi è il sei giugno. Sono le cinque di mattina e tutti dormono. Non ho avuto il tempo di registrarti nulla da quando son tornata. La ragazza francese che avevo conosciuto a Merced è venuta a trovarmi e l'ho portata a Palm Springs e al Yoshua Tree Monument. Quando sono tornata da Merced, ho trovato tua zia Kate, che aveva preso due giorni dal lavoro per stare con me. Ha ancora paura che io cada in depressione, che so, magari che m'impicchi a questi soffitti bassi! Mi ha detto di darti i suoi cari saluti. Il prossimo mese viene a trovarti. Ora sono in giardino. Non potrei registrare in casa, la nonna sente ogni più piccolo rumore. Non ha perso il brutto vizio di venire a ficcare il naso in quel che faccio, ma lei non teme per me, è il suo bisogno di controllare. Non l'ho mai sopportata. Per questo forse ti ho lasciata libera, troppo libera. Perdonami, Amy, se puoi. Io e te abbiamo fatto del nostro meglio, non c'è mai stata malizia nelle nostre azioni, solo cecità e sventatezza. Basta, ti ho fatto questi discorsi fino alla noia, ma la colpa che mi porto è senza fine, e anche se so che Dio mi ha perdonato, non sono mai sicura che tu potrai. Quel che è stato è stato e non si può cambiare. L'alcool è responsabile per buona parte della nostra storia, a cominciare da tuo padre. Ma possiamo fargliene una colpa? Eravamo due ragazzini, come te, scatenati, sbandati. I nostri genitori non ci avevano insegnato il vero timor di Dio. Ancora tua nonna non sopporta di vedermi in ginocchio, con le mie devozioni. Dice che faccio la puttana pentita. Ti garantisco, Amy, che il solo sopportarla ogni giorno, senza reagire, porterebbe un altro al manicomio. Io matta sono già! Françoise è venuta a trovarmi l'altro ieri. Ero da poco tornata che è squillato il telefono. Era lei che chiamava da Fresno. Voleva andare a visitare il parco di sequoie, ma ancora non l'hanno aperto. Così ha preso il treno fino a Bakersfield, e poi l'autobus fin qui. È arrivata in stazione che era buio. Io e Kate siamo andate a prenderla in auto con un po' di ritardo, sai, ancora faccio fatica ad essere puntuale. Quando devo uscire, non mi sbrigo mai, sembra che la mia mente vada in tilt. Ho paura di aver dimenticato questo e quello, e torno indietro a controllare. Sicché siamo arrivate che Françoise aspettava già da un po' fuori dalla stazione. Insieme a lei c'era una coppia di signori, marito e moglie. Uscendo dalla stazione l'avevano vista sola, straniera, tutta in ghingheri, e si erano rifiutati di lasciarla lì sola ad aspettare. Che gente per bene c'è ancora nel mondo, ma questo il telegiornale non lo dice. Françoise non aveva paura di aspettare da sola. Ha chiesto perché non c'era l'ombra di un taxi. Non si rendeva conto, la poverina. Poi, dall'insistenza della coppia, ha capito, e ha cominciato a guardarsi intorno. Una stazione ferroviaria che di giorno sembra innocua, di notte si riempie di malvagità. Gli uomini sono stati per noi come le stazioni, non trovi? Dove ce n'è più una sicura e tranquilla? Forse in Europa ce ne sono, visto che Françoise è così ingenua. Ma qui, ormai, quando cala il sole è il coprifuoco. Io sto chiusa in casa anche di giorno. Guidare nel traffico di Los Angeles è diventata un'impresa. Tanti incidenti e nessun assicurato. Pirati dappertutto. Tu sei al sicuro dove sei, tesoro. Lo sai quale sarebbe il tuo destino se ora fossi fuori. Lì sei protetta da tutti i demoni, tranne quelli che ti porti dentro. Prega, Amy, per tutte le persone che ti hanno fatto del male. Solo così ti libererai dall'odio che ti divora. Prega anche per tua madre, che non ha saputo essere una buona madre. Sono andata a registrare il reverendo James Flynn. Quella trasmissione in TV è la mia salvezza. Peccato che io non possa mandarti le registrazioni video. Meglio le cassette audio che niente. Vedrai i video quando torni. Tengo tutti i filmati qui, numerati e datati. Non sono mai stata così precisa e organizzata! Prima, in giardino, con la schiena appoggiata all'albero e gli occhi chiusi, ho ascoltato “Questo è il giorno che Dio ha creato”, quella bella musica che ti ho mandato, coi violini e il pianoforte. Quando l'ascolto dimentico tutto e mi pare che il paradiso in terra sia ancora possibile. Se tu fossi qui con me, non vorrei altro. Non desidero neppure un uomo vicino, ormai. Ne ho abbastanza di quell'amore lì. Per te è diverso, lo so, ma ogni cosa nei tempi di Dio. Françoise dorme nel divano della stanza di passaggio. Ieri sera abbiamo fatto tardi, è stata una giornata estenuante, nel deserto. La mattina, mentre mi preparavo, le ho fatto vedere la trasmissione del Reverendo Flynn, ma lei guardava sempre l'orologio, non è pronta per il messaggio. Non sta male abbastanza. Il Reverendo Flynn dice che a volte l'amore di Dio deve spezzare la nostra corazza di indifferenza con la violenza, con la disgrazia, con un gran dolore. Françoise è una brava ragazza, ma non è stata temprata dal fuoco, ha avuto una vita facile, e allora, quando tutto è facile, ti sembra di non aver bisogno di nessuno. Terribile illusione che noi non abbiamo più. Kate ci aveva suggerito di andare alla riserva di Agua Caliente, dove neppure io ero stata. Si era messa la tuta da pompiere, e Françoise era molto meravigliata che una donna di cinquant'anni facesse il pompiere. Sono così tradizionali, le donne europee. Bambini, casa e chiesa. Forse hanno ragione, ma io non potrei mai limitarmi così. Se non avessi lavorato e fossi rimasta a casa con te, forse ti avrei seguito di più. Mia madre mi ha seguito fin troppo e non è servito, anzi, è stato controproducente. Lo sai quanto io sia conservatrice in politica, ma le donne americane non si faranno più relegare in casa, su questo ci puoi scommettere. Ieri, per la mia abitudine di procrastinare, siamo partite tardi, con Kate che ci faceva fretta. Era già mezzogiorno e Françoise non voleva partire senza andare prima a un ristorante. Voleva pagarci il pranzo. È come un orologio, la francese, le viene fame a ore fisse, e se non mangia, sviene! Io non volevo che pagasse il pranzo, a me bastava la colazione fatta in casa, ma lei insisteva che se non mangiava qualcosa di caldo stava male. Allora le ho indicato il negozietto “Deli” oltre la curva e lei è andata di corsa. Poi Kate ci ha accompagnato alla Hertz e se n'è andata al lavoro. Ha detto che, quando la francese se ne va, torna a stare da me per qualche giorno. Alla Hertz, Françoise ha affittato un'auto rossa fiammante e ha voluto anche pagare tutta la benzina del viaggio. Lei ha paura di guidare in America, dice, pur avendo la patente, così ho guidato io per tutto il giorno. L'auto era nuova di zecca, con l'aria condizionata. Prima di andare a sud, siamo salite sui monti qui dietro e le ho mostrato la faglia aperta dall'ultimo terremoto. Oggi, quando si sveglierà, ho promesso di mostrarle il video del terremoto. L'ho filmato dentro casa, con tegami e tazze che cadono, soprammobili che volano e io che parlo con la fifa addosso: “È fatta! Questa è la volta buona!” E invece sono ancora qui a riderci sopra. Insomma, ci siamo dirette verso Palm Springs e Françoise, che non aveva mai visto il deserto, non poteva capacitarsi che le montagne brulle sorgessero così all'improvviso dietro le ville e a un passo dai giardini tropicali dei Country Club. Il contrasto è innaturale, dice. È una città finta, come quelle degli Universal Studios. Io ho replicato: “Questa è l'America, tesoro. Qui coi soldi puoi far fiorire anche il deserto.” “Ma da dove prendono l'acqua per tutte quelle fontane?” È vero, c'è uno spreco pauroso d'acqua a Palm Springs. Un'ostentazione di cascatelle e spruzzi, più che al Ceasar Palace di Las Vegas. Le spiego che hanno deviato l'acqua del fiume Colorado, un'opera di alta ingegneria in pieno deserto. “Qui abitano gli uomini più ricchi d'America. Possono comprare tutta l'acqua che vogliono.” Françoise non è impressionata dalla nostra ingegneria idraulica. “Puoi avere soldi all'infinito, ma l'acqua non è infinita”. Ci è venuta una sete tremenda. Ci siamo fermate a un bar sul rettilineo per Coachella, sai quelle ricostruzioni tematiche, come a Disneyland: il caffè tipico italiano, o sudamericano. Questo bar era un atollo hawayano, con piante e fiori rampicanti dappertutto, orchestrina in costume primitivo, tavoli e lampioni di finto bambù. Per due bicchieri d'acqua ci hanno spellato. Françoise criticava tutto, trovava offensiva l'artificialità. Per fortuna non siamo capitate in un caffè alla francese, sennò chissà quanto avrebbe avuto da ridire! Anch'io a quel punto non vedevo l'ora di andare alla riserva di Agua Caliente. “Lì è tutto originale, garantisco!”, le ho detto per calmarla. Pensa che colpo di fortuna, per quegli indiani che si sono tenuti la terra della riserva. È zona desertica, con poche palme e pochissima acqua, ma con quel che vale adesso la terra intorno a Palm Springs! La superstrada di Coachella brilla come un nastro nero tra le colline rosse del deserto. La deviazione per la riserva indiana è una strada sterrata sulla destra, quasi invisibile, sabbia su sabbia. L'auto sfreccia nell'aria torrida meridiana. Jo-Anne mostra col dito a Françoise le sontuose ville degli attori famosi che punteggiano le colline. Il miraggio di Palm Springs svanisce nel colore uniforme del deserto. “Maledizione, abbiamo mancato l'uscita”. Jo-Anne ferma l'auto ai bordi della superstrada. Non può fare inversioni sulla Highway 10. Studia la mappa e si immette di nuovo nel traffico. Al primo incrocio con semaforo svolta a sinistra e torna verso Palm Springs. All'incrocio con l'affollata Frank Sinatra Drive, svolta ancora a sinistra e, dopo aver controllato tutte le uscite a destra, vede finalmente il cartello, sommerso dalle frecce multicolori dei country club. Le torrette spagnole in mattoncini e coppi, le immacolate facciate in barocco arabo lasciano il posto alle costruzioni basse, scalcinate e senza tetto degli immigrati messicani. L'auto leva dietro di sé una lunga scia di polvere mentre sale verso i monti della riserva. Sul fianco sinistro, tra le colline, c'è un piccolo cimitero, cintato da rete metallica. Sembra abbandonato. Dalle croci di ferro pendono fiori di carta sbiancati dal sole. Poco più oltre, Françoise scende al cancello della riserva e paga l'ingresso a un giovane indio. “Il Trading Post è lassù in cima al monte. Parcheggiate lì, poi seguite a piedi il sentiero che scende alla sorgente”. Una striscia verde di canneti e palme nasconde il ruscello, mentre la strada si inerpica tra massi di pietre bianche. Dalla spianata del parcheggio si domina la valle di Coachella e le colline intorno. Nessuna costruzione umana disturba la distesa ondulata del deserto. Il sole è a picco, e la terra scotta sotto le suole. Jo-Anne e Françoise corrono a ripararsi sotto la tettoia del trading post. È una baracca di legno, piena di souvenirs indiani, tamburi, pipe, cachinas, tappeti, pietre dure, anelli, bracciali e scheletri di serpenti a sonagli. Il locale è basso, buio e fresco come una tana. Dalle casse di un registratore, sospese al muro, esce la nenia di un flauto indiano. Françoise chiude gli occhi e si lascia portare dalla nostalgia della musica, come un uccello sopra le montagne riarse, dentro i canyons profondi. Jo-Anne è fuori che aspetta, e sventola una copia della cassetta con la musica del flauto. Scendono a piedi lungo un sentiero di sterpi e rocce, verso una piccola oasi di palme verdi. La sorgente sgorga da un cumulo di enormi massi bianchi, che l'acqua ha perforato nel tempo, creando un labirinto di grotte levigate e cascatelle limpide. Due bambini giocano a nascondino dentro le grotte, mentre il padre a piedi nudi guada il ruscello sottostante per raggiungerli, inviando inutili appelli alla prudenza. Le palme si levano alte sul presepio di roccia. L'atmosfera è raccolta, quasi mistica, esaltata dalle voci gioiose, angeliche, dei bambini che si spruzzano nell'acqua. Jo-Anne, senza staccar le mani dalla videocamera, si libera dalle scarpe scalciando coi piedi, e corre a bagnarsi nella corrente. Grida con voce stridula: “Ah, che sollievo! Che acqua limpida! Aaah! Ma è gelida!” I bambini tacciono e fanno capolino dalle cavità della pietra. Jo-Anne non sa contenersi, guada il ruscello strillando, incurante dei jeans che si bagnano fin sopra le ginocchia, e corre verso la sorgente tra le rocce. I bambini, spaventati, si ritraggono. Jo-Anne si arrampica agile sulle rocce, si accovaccia con la videocamera puntata ed entra nei cunicoli scavati dall'acqua. Salgono nuove grida di stupore e di gioia. Le cavità della sorgente rimandano un'eco cristallina alla sua voce, che risuona portata dall'acqua. Françoise, rimasta immobile sull'altra sponda a contemplare, getta le scarpe e guada il ruscello in un impeto di ritrovata vitalità. Balla nell'acqua, e gli spruzzi, trafitti dal sole, scintillano come diamanti. JoAnne, sentendola gridare, si affaccia dalla bocca ovale della roccia e filma la scena. Poi scende e si unisce alla danza, ricoprendo di spruzzi l'amica. Françoise sente cadere addosso le gocce gelide, insieme refrigerio e pena. Sente gli spasimi di gioia sgorgarle dal petto, quasi come un dolore. Dopo i giochi nell'acqua, a malincuore le due donne lasciano l'oasi. È pomeriggio inoltrato, e devono ancora visitare il parco di Joshua Tree. Si fermano al trading post a bere, sulla terrazza che sovrasta il piccolo canyon di Agua Caliente. Un breve giardino di piante grasse si annida fra le rocce del sentiero. All'ombra della tettoia è fiorita una piccola pianta di melograno. Col bicchiere ghiacciato alle labbra, Françoise osserva i fiori rossi e un batter d'ali intorno alla pianta. È un minuscolo colibrì azzurro, il corpo immobile nell'aria, le ali invisibili nel moto, davanti alla bocca del fiore. “L'uccello azzurro della felicità!” grida Jo-Anne, e spaventa il pennuto, quasi un insetto, che vola via. Dopo Agua Caliente, l'arsura del deserto aperto è insopportabile, l'asfalto della Highway 10 è una liquida striscia nera, e i monti a sud, verso l'Arizona, ondeggiano, sospesi nel miraggio d'acqua. Da nord, una catena di montagne azzurre invade lentamente l'orizzonte e sulla strada appare il grande cartello d'entrata al parco di Joshua Tree. Una vegetazione bassa di arbusti e piante grasse punteggia i bordi rocciosi della strada sterrata. Si apre a est una vallata che non sembra aver fine, tra le Eagle e le Pinto Mountains. Le montagne sono lontanissime, di un azzurro cupo, e il deserto tutt'intorno è un'immensa distesa grigio-verde, il colore dei licheni sulle rocce. Jo-Anne guida in silenzio, mentre il sole cala all'orizzonte. L'auto fila veloce, ma le montagne sono sempre ferme laggiù, come se il moto dell'auto fosse un'illusione ottica. Da quando sono entrate a Joshua, non hanno incrociato neppure una motocicletta. Françoise non è mai stata dentro tanto spazio, tanta solitudine e silenzio. Le sembra un'eternità da quando sono entrate, il deserto si stende all'infinito davanti a loro, dietro di loro, da ogni parte. Anche gli arbusti più bassi gettano ora lunghe ombre sulla strada. Un timor panico coglie Françoise all'improvviso, paura di perdersi, di un guasto all'auto, di morire per fame, per sete, per disidratazione. La faccia del deserto è quasi buia ormai, ignara della sua microscopica presenza. Jo-Anne, oppressa dal silenzio, accende l'autoradio e inserisce il nastro con la musica del flauto indiano. “Sottofondo perfetto”, dice ironica. La musica ipnotica non annulla il silenzio, sembra popolarlo di presenze mute. Il cielo, ancora acceso dal tramonto, ritaglia le sagome degli alberi di Joshua, i rami grassi e le lunghe spine, contro il rosso e l'arancio dell'orizzonte. Jo-Anne ferma l'auto davanti a un gruppo di cactus più alti e scende con la videocamera. Lascia la portiera aperta e alza il volume della musica, per averlo come sottofondo alle immagini filmate. Françoise avanza sulla strada ormai buia e scatta qualche foto ai Joshua Trees, guardandosi intorno apprensiva. “Il tramonto nel deserto è magico”, sussurra Jo-Anne, temendo di rompere l'incantesimo, o di coprire la musica con la voce. Tornano verso l'auto e, nella semioscurità, come evocato dal flauto indiano, un grosso animale appare sulla strada accanto all'auto. Le due donne si arrestano, senza fiato, fissando il coyote. È vicinissimo. Françoise distingue le orecchie appuntite, il muso lungo e il corpo asciutto. L'animale le osserva, immobile, poi emette un guaito, levando il muso. “Ha fame!” bisbiglia Jo-Anne, che non ha spento la videocamera. “È pericoloso?”, chiede Françoise con un fil di voce. “No, non credo”. Ma nessuna delle due donne osa muoversi. “Con questo buio, la videocamera non lo riprende. Ho l'automatica col flash in macchina”. Lentamente JoAnne tenta una manovra di avvicinamento all'auto. Il coyote si allontana trotterellando sulla strada. È prudente, si ferma a debita distanza. Jo-Anne e Françoise ne approfittano per entrare veloci nell'auto. Jo-Anne spegne l'autoradio, e il silenzio della notte è spettrale, disumano come il deserto. Le due donne confabulano, incerte. Il coyote prende l'iniziativa e si avvicina di nuovo all'auto, fin sotto la portiera di guida. Col muso lungo e gli occhi tristi della fame, guarda Jo-Anne e aspetta. È così vicino che JoAnne potrebbe allungare la mano dal finestrino aperto e toccarlo. Non c'è niente di commestibile in auto, solo la tanica d'acqua. Temendo che l'animale si allontani, Jo-Anne alza al viso la piccola automatica nera e fa scattare il flash. Il coyote, accecato, distoglie il muso infastidito, e in muta rassegnazione si allontana col suo trotto leggero, senza fretta. “Che sguardo!”, dice Jo-Anne sospirando. “Gli mancava solo la parola... ” Accende i fari dell'auto per vederlo un'ultima volta, mentre svanisce tra la sterpaglia. Françoise è rimasta immobile, gli occhi persi nel buio. ”Non ho avuto il coraggio di fotografarlo”. “Se la foto col flash è venuta bene, te ne faccio una copia”, dice JoAnne per consolarla. Ma la memoria dell'incontro è indelebile più di una esposizione al nitrato d'argento. È ormai buio fitto quando arrivano alle grandi rocce rosa di Joshua Tree. Con i fari accesi dell'auto puntati sulle rocce, salgono carponi fino alla più alta, a contemplare il deserto di notte. Nel silenzio profondo, il vento porta un gemito lontano, la voce del coyote. Il cielo è ora nero come la terra, e le stelle sono vicinissime, pulsano come cuori accesi. “Non ascolterò mai più quel nastro di sera”, dice Jo-Anne mentre guida verso le luci di San Bernardino. Cara Marsha, ho ripensato a quel che mi hai detto nella seduta di ieri. Oggi ho telefonato a Chowchilla e ho avuto la conferma alle mie paure. Dopo la mia visita, Amy ha dato i numeri. All'ora di pranzo ha aggredito la vicina di tavolo con la forchetta. L'altra deve averle detto qualcosa che l'ha provocata, ma ormai lo so che basta solo guardarla perché Amy si senta provocata. Ha una soglia di tolleranza quasi inesistente, non regge la minima frustrazione. Insomma, Amy ha infilzato la forchetta nel braccio dell'altra. Prima che arrivassero le guardie, le compagne l'hanno pestata. Adesso è in isolamento, con contusioni multiple e, immagino, con iniezioni da addormentare un cavallo. Tu dici che devo farla finita coi sensi di colpa, che non l'ho ucciso io Robert. Ma avrei dovuto farlo, adesso forse starei meglio. Avrei dovuto far fuori Frank prima di ogni altro, prima che violentasse la mia bambina. Come posso perdonarmi questo? Lo so, non sono responsabile delle azioni degli altri, solo delle mie. Me lo ripeto continuamente e sono consapevole del mio valore, del fatto che ho cambiato vita, che non mi faccio più, non bevo più e cerco di emendarmi con l'aiuto di Dio. Ma Amy è come una montagna sulla mia strada, la mattina quando mi sveglio vorrei che avesse ucciso me, vorrei essere morta e sepolta. Non desidero più tornare agli stupefacenti, vorrei solo la pace definitiva della morte. Se io non esistessi più, forse Amy si calmerebbe. Quando reagisce così alle mie visite, penso che il suo odio non finirà mai. A momenti è docile, quando è depressa. Poi la sua furia ritorna, tutto quello che fa è per ferirmi. È come se avesse ucciso Robert per me, per dirmi: lo vedi che cosa oscena hai partorito? Conosce tutti i miei tasti deboli, sa come manipolare la mia colpa, e rigira il coltello nella ferita. Sì, sento che mi vuole morta, umiliata e sconfitta. Ha ucciso il suo uomo, ma è a me che pensava, al padre che le ho dato, al maniaco che le ho portato in casa, al mondo di merda in cui l'ho fatta nascere. Non l'avessi mai partorita. Tu dici che quel cordone ombelicale tra noi non è mai stato tagliato, e ora va in cancrena. Va bene, non tornerò più a trovarla. Non le spedirò più le cassette registrate per un po'. Dirò a mia sorella Kate di rimandare la visita. Distacco, distacco, distacco. Cercherò di non ossessionarmi più, di non pensarla continuamente. È malsana questa dipendenza emotiva, lo so, è come attaccarsi a una bottiglia di veleno. Povera figlia mia. Tutto il mio essere, la pancia, l'anima, si rifiuta di accettare che non posso far niente per lei. La mia impotenza è un'oscenità contro natura. Me lo ripeto: Non puoi far niente, Jo-Anne, molla la presa! Ma dentro si ribella ogni atomo di sangue. Sono sua madre, Marsha! Questa settimana dopo il rientro non ho avuto la mia solita crisi depressiva, anche Kate si è meravigliata. Ora penso che il merito sia della ragazza francese che è venuta a trovarmi. L'ho scorrazzata qua e là per due giorni, l'ho portata a ballare al country disco e mi sono totalmente distratta. Ogni tanto, quando io e Françoise ci sentivamo più in sintonia, mi prendeva un languore allo stomaco. “Perché non è lei mia figlia”, pensavo. Dolce, aggraziata, un po' scontrosa e repressa, devo dire, ma che sollievo! Se solo Amy imparasse a reprimersi un po'... Sono stati giorni felici, NORMALI. Era una vita che non andavo in discoteca, non mi ricordavo proprio che la gente normale si può divertire con così poco, un po' di musica, stivali a lustro, cappello e camicia nuovi. Avevo dato a Françoise una camicia a due colori, con le frange, e la cintura argentata. Non avevamo stivali e cappello, ma abbiamo ballato lo stesso. Ci siamo divertite un mondo, abbiamo riso fino a star male, e io avevo ordinato solo acqua tonica. Sì, se volevo la prova che la mia vita è cambiata, l'ho avuta. Da tanto avevo paura di ritrovarmi nella folla, tra la gente che si sa divertire, mentre io, senza lo sballo, mi deprimevo e basta, mi sentivo un aborto di natura. L'altra sera invece è stato come tornare nel mondo dei vivi e sentirmi bene nella pelle. Questa non te l'ho raccontata. Ieri mattina ho accompagnato Françoise alla stazione dei Greyhounds. Sull'autobus per l'aeroporto l'ho abbracciata, come se non volessi più farla partire. Le ho detto: “Grazie per l'amicizia che mi hai dato”. Lei si è commossa e mi ha detto: “Vorrei avere avuto una madre come te”. Sono scesa dall'autobus come uno zombi, e in auto, per tutto il tragitto fino a casa, ho pianto. - Oceano di Patrizia Tenda La nebbia era salita dall’oceano all’improvviso, insieme al buio. Sulla strada che costeggiava la spiaggia, le case di legno erano pian piano svanite nella lanugine bianca che avvolgeva ogni cosa. Si distingueva appena il bordo della strada seguendo gli aloni gialli dei lampioni. L’uomo aveva acceso gli antinebbia e guidava piano, teso in avanti sul volante. “La pensione dovrebbe essere sulla destra”, disse la donna che gli sedeva accanto. “Con questo tempo ci passeremo davanti senza vederla”, disse lui. La donna pulì il vetro davanti a sé col palmo della mano, ma il vapore era fuori. Aprì allora il finestrino e lasciò entrare l’aria salmastra e pungente della sera. Poco più avanti c’era l’insegna di un albergo, e la donna scese a chiedere. Salì le scale dell’hotel e si guardò intorno prima di entrare, come per orientarsi. Oltre la fila di arbusti dall’altra parte della strada, intravedeva il chiarore delle dune di sabbia contro il nero indistinto dell’oceano. Lo avevano sentito, senza vederlo, per tutto il pomeriggio, guidando lungo la costa. La donna rimase immobile nella nebbia ad ascoltare. Non sentiva il rumore del motore, coperto dal fragore delle onde. L’auto era a pochi passi da lei, coi fari accesi, ma la nebbia li rendeva distanti. Tutto era remoto, separato. Respirò l’aria marina dilatando le narici. Entrò nella hall dell’albergo e chiese informazioni a un cameriere. La pensione era due miglia più oltre, verso il centro del paese. La riconobbero per un neon color viola acceso che lampeggiava nella nebbia. Una signora dai capelli bianchi li fece entrare e indicò loro una stanza al primo piano. La stanza era piccola ma ben messa. Le travi di legno scricchiolavano sotto i piedi, e c’era un odore di biancheria pulita e di mobili vecchi. L’uomo scostò le tendine di una delle due finestre e guardò giù. “Siamo a est. Dovremmo avere l’oceano di fronte.” La donna si accostò all’altra finestra e guardò fuori. Non si vedeva neppure la cancellata d’ingresso. Solo il neon viola che li aveva guidati fin lì. L’uomo si era staccato dalla finestra ora, e stava telefonando. “Sì, stasera alle nove. Ci sarò.” “Posso accompagnarti?”, chiese la donna. L’uomo aveva ripreso la giacca e stava per uscire. “Andiamo a mangiare qualcosa. Poi tu dovrai tornartene qui da sola.” Scesero in strada. Il buio si era fatto più fitto. Avviandosi verso il centro del paese, trovarono un ristorante, Cape Codder, specialità pesce fresco. L’uomo ordinò filetto di pesce spada. La donna, una zuppa di vongole. Il ristorante era decorato interamente con reti da pesca, che pendevano dal soffitto insieme a cimeli e trofei di pesca d’altura. Davanti al piatto caldo il volto dell’uomo perse le linee cupe e la stanchezza del viaggio. “Questo è un ristorante portoghese”, disse sporgendosi sul banco di legno verso la donna, che centellinava una zuppa color latte, colma di vongole giganti. “D’estate qui è pieno di turisti, ma fuori stagione al Cape trovi solo i pescatori portoghesi, o qualche pittore squattrinato.” “Perché portoghesi?” “Questa era una zona di caccia alle balene e al merluzzo. I portoghesi si spingevano fin qui per pescare, e qualcuno c’è rimasto.” Il pesce era freschissimo, e cucinato deliziosamente. L’uomo aveva ritrovato la loquacità. “Domani ci facciamo una bella aragosta. Qui costano niente, e sono grosse così.” L’uomo guardò l’orologio. Doveva andare. La donna avrebbe desiderato restare nel locale caldo e illuminato, ma guardandosi intorno vide persone con cui non avrebbe voluto restar sola. In fondo alla stanza c’erano due marinai braccio-di-ferro, uno coi capelli biondi legati a treccia, come un vichingo, l’altro bruno, coi baffi a uncino. Erano entrambi tatuati per tutta la lunghezza delle braccia, che sporgevano nude dai giacchetti imbottiti. Quelle braccia incise d’azzurro e incuranti del freddo avevano qualcosa di felino, di non addomesticato. Vicino all’entrata c’era un vecchio col naso paonazzo e lo sguardo malevolo, seduto davanti a un boccale di birra vuoto. L’uomo e la donna uscirono insieme e la nebbia li avvolse come un’ottusità del pensiero. L’uomo perse di nuovo la socievolezza e nessuno dei due disse più nulla finché si salutarono davanti ad una casa-palafitta vicino al molo del porto. “Per tornare alla pensione non devi fare altro che seguire quella strada rettilinea che costeggia la spiaggia. Tornerò fra due ore.” La donna si allontanò sovrappensiero. Non temeva la solitudine della strada. Era quasi contenta di essere sola. La nebbia e il buio non la rattristavano. C’era qualcosa di speciale in quel brutto tempo, un dolce irretimento dei sensi. La nebbia impenetrabile e persistente diceva agli uomini e alle cose: “Dormi! Riposati!” Il sole domattina avrebbe gridato: “Alzati! Svegliati!” La donna non trovava deprimente il maltempo. Si lasciava andare, ci si abbandonava. Era una forza maggiore da assecondare, non da contrastare. L'uomo, invece, non ne accettava il dominio. Non voleva riposare quando il buio lo costringeva, o alzarsi quando il giorno lo chiamava con i suoi rumori. Voleva seguire un ritmo proprio. Adeguare il tempo ai propri umori. Ma il mare e il cielo non si adeguavano. L’uomo doveva arrendersi. O soccombere, come il capitano Achab a caccia di Moby Dick, la balena che lo avrebbe ucciso. La donna camminava dal porto verso un limbo denso di vapori d’acqua marina. Melville era stato qui e aveva fatto camminare il marinaio Ishmael attraverso questi banchi di nebbia, incontro al suo destino. Raggiunta la pensione, la donna salì in camera. Era bello starsene a letto con quel tempo. Accese la lampada a muro accanto al letto. Si spogliò e s’infilò sotto le coperte pensando di dormire, ma gli occhi si posarono sulla lampada accesa. Sul fondo bianco del paralume c’era, stampata in azzurro, l’immagine di un veliero sul mare. Il cielo e il mare sembravano infiniti, in quel triangolo di colore, le vele alte e gonfie della nave evocavano i pirati, le prime scoperte e avventure sui mari. Cacciar balene a quei tempi voleva dire mesi di viaggio sull’oceano aperto, senza la certezza di toccare terra sani e salvi. Che cosa provavano quei marinai per tutto quel tempo passato in costrizione? Senza poter far nulla, come in una prigione, o un convento galleggiante, aspettando il trascorrere dei giorni e delle notti, come un trapasso, un purgatorio fatto dell’orizzonte infinito, sempre uguale, di cielo e mare. L’uomo rientrò verso mezzanotte e le scarpe umide fecero scricchiolare il pavimento. La donna non si svegliò, persa nelle nebbie dei suoi sogni. Sognò che l’uomo se n’era andato, lasciandola sola un’altra volta. Quando il sogno finì era già mattino. Le due finestre davanti al letto svegliarono gli ospiti con un ricamo di rami, cielo e sole. Di là dalla strada ora si vedeva l’oceano, qualche barca dondolante ancorata vicino alla breve spiaggia. L’uomo e la donna si vestirono in fretta ed uscirono. L’uomo aveva con sé una borsa nera e portava a tracolla una grossa macchina fotografica. Con passo rapido percorsero la strada dritta che conduceva al porto. C’era ancora della nebbia sospesa tra le case. La distesa azzurra era libera dai vapori e risplendeva come argento fuso nell’alba. All’attracco del molo attendeva un peschereccio con i marinai indaffarati intorno alle gomene. L’uomo li salutò con la mano, passò loro la borsa e saltò deciso dentro l’imbarcazione. La donna era rimasta indietro sul molo, incerta, a guardare il dondolio della carena. Un membro dell’equipaggio si fece avanti e allungò la mano. “Forza! Non guardi sotto. Guardi dove mette il piede.” La donna saltò. Sull’acqua era più freddo che sulla terraferma. La donna entrò in cabina dove era riunita la maggior parte del personale di bordo. Stavano osservando una carta marina e il capitano illustrava su un monitor alcune fasi dell’operazione che sarebbe fra poco iniziata. Altre apparecchiature, radar e sonar, occupavano la stanza. Alle pareti pendevano tavole illustrate con tutti i tipi di cetacei che popolano l’alto Atlantico. Il marinaio che l’aveva aiutata a salire a bordo porse alla donna una pastiglia bianca. “È per il mal di mare”, disse. “C’è una perturbazione che sale dalle Bermuda e al largo farà mare mosso.” L’uomo con la macchina fotografica sempre a tracolla stava discutendo col capitano. Passò ancora del tempo prima che togliessero gli ormeggi. Il cielo non accennava a coprirsi. La donna si era seduta a poppa, per godersi lo spettacolo dell’aurora. Avrebbe voluto chiamare l’amico perché fotografasse quegli splendidi colori sull’acqua, ma ebbe un ripensamento e rimase immobile a guardare l’orizzonte. Il più piccolo movimento, il più piccolo pensiero, l’avrebbero distratta. Voleva invece l’assorbimento totale. Annullarsi nell’azzurro dell’orizzonte. Quell’abbandono nella natura non era come l’abbandono per una persona. Non consumava. Rigenerava. Dava un senso di libertà e pace insieme. Col suo amico non riusciva a sentirsi libera e in pace. Il pensiero di lui la metteva in un continuo stato di agitazione. L’imbarcazione diede un sobbalzo improvviso e cominciò a muoversi. Stormi di gabbiani si levarono verso prua, volando in cerchio intorno alla barca, come a trattenerla, o a darle il benvenuto sul mare aperto. Le case di legno lungo la riva si fecero pian piano più piccole, e la torre bianca del faro fu l’ultima a sparire dall’orizzonte, insieme al profilo ricurvo di dune e canneti della costa. L’uomo armeggiava con gli obiettivi e le lenti della sua macchina, completamente assorto. Dall’interno della cabina arrivavano i suoni elettronici degli scandagli acustici. Dopo un’ora di navigazione costante verso est, l’oceano cominciò a incresparsi. La superficie non interrotta di verde e azzurro cupo si ricamava di crespe sempre più fitte, che incrociavano la barca facendola beccheggiare. Non erano grandi onde, ma la donna sentì subito un malore alla bocca dello stomaco. La pasticca non aveva fatto effetto, pensò. Dopo un’altra ora di navigazione verso est, l’imbarcazione puntò a nord-est, tagliando diagonalmente le onde, ora più ampie e profonde. Il sole intanto era sparito dietro nuvole basse che da sud si erano pian piano estese su tutto l’orizzonte. La donna cominciò ad aver freddo, e il mal di mare non accennava a diminuire. L’amico la vide pallida e le chiese se si sentiva male. Era la prima volta che le rivolgeva la parola da quando si erano svegliati. “Quando torniamo indietro?”, chiese lei. “Dopo che avrò finito il lavoro.” “Mio Dio, non ce la faccio più.” L’uomo la guardò con l’occhio fisso, inespressivo. Mi sei d’intralcio, pareva dire. Sempre in cerca di attenzioni. Non ti avevo chiesto di venire. La donna distolse lo sguardo, rassegnata a tenere il suo male per sé. L’uomo si allontanò e tornò poco dopo con una busta di plastica bianca. “Per ogni evenienza”, le disse porgendogliela, “e ricordati di guardare verso la linea dell’orizzonte. Non guardare le onde. Guarda un punto fermo.” Sembrava comprensivo ora, o forse voleva compensare la propria freddezza ogni tanto, con un’illusione di intimità. La donna si mise d’impegno a guardare l’orizzonte, ma la linea immobile e appena curva dell’oceano le aumentava il senso di nausea, e dovette far uso della busta di plastica bianca. Provò a sedersi a poppa, ma le dissero che lì il beccheggio era più forte. Si spostò lentamente a prua. Ora ogni piccolo movimento le causava vertigine. A prua tirava troppo vento e il freddo, sommato al mal di mare, era insopportabile. Si riparò nella cabina, dove stava la maggior parte degli uomini. Appena si sedette, le parve che l’impatto dell’onda si ripercuotesse dal sedile direttamente sullo stomaco. Dovette accostare repentina la busta di plastica. Appena si riebbe, uscì dalla cabina. Non voleva compagnia in quel momento. Pensò che stare in piedi le avrebbe giovato, perché molleggiandosi sulle caviglie – già infiacchite e tremanti – avrebbe smorzato i contraccolpi delle onde. Venne un’altra ondata. No, ormai non c’era più sollievo, né in piedi, né seduta. Non faceva differenza. Si strinse a un palo metallico al centro dell’imbarcazione e decise stoicamente di aspettare. Le pareva un secolo da quando erano partiti, e ancora la barca continuava ad avanzare. E il mare a farsi più mosso. E il cielo più scuro. Vedeva seduto a prua l’amico che controllava l’intensità della luce con l’esposimetro, impermeabile a ogni sguardo e insensibile alla potenza degli elementi. L’orizzonte si distingueva a mala pena, grigio su grigio. La donna aveva lo stomaco vuoto, ormai. Forse i conati sarebbero finiti. Le girava la testa e si teneva stretta al palo con le mani arrossate e gelide, la busta di plastica penzolante col suo triste peso. Che vacanza orribile. Aveva deciso di divertirsi, di non lasciarsi turbare da risentimenti e paure, ma anche il suo stomaco l’aveva tradita. Continuava tenace a guardare l’orizzonte. Era l’unico punto di fuga. Tutto quel che poteva vedere intorno a lei ora era sgradevole. Nessuna delle altre persone in plancia stava male come lei. L’amico, dopo il primo soccorso, l’aveva ignorata, come si ignora un bambino capriccioso che finga di star male. Le onde intorno alla barca erano odiose a vedersi, piene di cupa minaccia. Da ogni parte la circondava una distesa di elementi senza sostanza, acqua e aria, che non avrebbero retto il suo peso ed erano causa del suo male. Il punto di fuga dell’orizzonte non era che un’altra trappola, altre onde e altro cielo e forse una tempesta in arrivo dalle Bermuda. A quel punto erano fuori sull’oceano da quattro ore, e ci sarebbe voluto altrettanto per tornare a terra. Mio Dio! La donna si sentì mancare le forze. Non avrebbe retto così a lungo. Non avrebbe retto un minuto di più. L’insofferenza del fisico si era così protratta che tutta la sua persona era un unico grande dolore, un unico grande “BASTAAA!” L'oceano non sentiva, il capitano non sentiva. Il fotografo meno degli altri avrebbe ascoltato o fatto tornare indietro la barca, o fatto apparire un’isola o un lembo di terraferma, o fatto cessare per magia il liquido rollio sotto i piedi. Come un’eco del suo grido interiore, qualcuno da prua gridò: “Le balene! Le balene!” La donna si sentì morire. Ora non avrebbe fatto in tempo a salvarsi. La barca avrebbe inseguito le balene per un’altra eternità. Tutti accorrevano sui fianchi della barca. Vide il fotografo che saltava qua e là dal palchetto di prora lungo i corrimano dell’imbarcazione come uno stambecco impazzito. Clic. Clic. Clic. Lei non guardava le balene. Guardava l’orizzonte. Avrebbe voluto morire, tanto era insopportabile il senso di nausea, di trappola infinita. Qualcuno gridò alla sua sinistra. Un ultimo guizzo d’istinto la fece voltare in tempo per vedere un’enorme megattera inabissarsi sotto la carena della barca e poi riemergere d’impeto fuor d’acqua e ricadere, mostrando la incredibile estensione della sua coda. Mentre la coda si immergeva fra mille spruzzi, la donna notò altri dorsi scuri intorno alla barca, e vari sbuffi dagli sfiatatoi. Era un grosso branco quello che avevano finalmente incontrato. Avrebbe voluto affacciarsi anche lei per vedere meglio, ma non osava allontanarsi dal suo palo di tortura. Aspettava lì, immobile, come un’offerta sacrificale. Nessuno comunque faceva più caso a lei. Il capitano stava puntando il braccio verso un punto sul fianco destro dell’imbarcazione. La donna guardò, senza spostare la testa. Una rigida pinna nera tagliava l’acqua in linea retta e si avvicinava allo scafo. Non era difficile immaginare quel che c’era sotto. La pinna dorsale avanzava sicura e lenta. La donna era ipnotizzata da quella presenza animale in caccia. Le balene erano imponenti, ma giocose. La determinazione di quel vorace libero nel suo elemento le fece dimenticare per un attimo il malessere interno. Le sembrò di essere capitata per sbaglio dentro un brutto sogno. Lei, i marinai, la barca, erano fuori posto. Non erano nel proprio elemento. Sarebbe bastata una scrollata del dorso di una balena, o un colpo della sua possente coda per rovesciarli in acqua, in pasto allo squalo. Tutti erano eccitati a bordo. Per ore avevano inseguito col sonar i gridi acuti delle megattere. Parevano voci di animali minuscoli, ultraterreni. Ora la barca era circondata dai loro immensi dorsi scuri, ed era una miniatura di barca in balìa di mostri preistorici. Nessuno sembrava rendersi conto delle sproporzioni. Erano alla mercé di tutti gli elementi, con l’abisso aperto sotto le assi di legno, e la morte violenta in agguato lì accanto. La donna fissava la scena incredula. Le balene stavano davvero giocando intorno alla barca. Si inabissavano e poi riemergevano passando sotto la chiglia dell’imbarcazione. La loro mole era tale che ogni movimento sollevava colonne d’acqua e di spruzzi. Per un istante la donna intuì l’indole degli animali. Non erano predatori. Amavano la compagnia e il gioco. Erano addirittura ospitali con gli umani, la specie sterminatrice. Ah, gli animali! Niente risentimenti e rancori sopiti. Non avevano memoria del male, oppure sapevano perdonare come Dio. La donna contemplava la vitalità dei loro movimenti nell’acqua, il corteggiamento danzante con cui accoglievano la barca, e capì di essere caduta da tanto stato di grazia. Lontano dalla terra degli uomini, nel profondo dell’oceano, esisteva ancora un paradiso di innocenza, inesorabilità e bellezza. Ciò che avveniva là sotto era fuori della giurisdizione umana del tragico e del morale. Lo squalo in attesa avrebbe compiuto il suo pasto nella totale indifferenza del mondo circostante, e le grida umane sarebbero state soffocate da un’acqua inconsapevole e azzurra. Così com’erano affiorate all’improvviso dal mare, le megattere scomparvero ad una ad una, inabissandosi. Le divinità marine rientravano alle loro dimore dopo essersi miracolosamente concesse ad occhi mortali. Quando la superficie dell’oceano fu di nuovo uniforme, l’incantesimo era rotto. Il cielo era quasi sgombro delle nubi e anche il mal di mare della donna si era attenuato, come se la turbolenza del tempo e il dolore fossero l’indispensabile iniziazione alle apparizioni divine. Ora che l’imbarcazione stava tornando verso la terraferma, il disturbo non aveva più motivo di essere. Il viaggio di ritorno fu breve. La donna aveva dimenticato il suo compagno, assorta con lo sguardo sulle acque lontane. Quando giunsero in vista della costa, lui si avvicinò, toccandole il braccio. La donna era ancora con gli animali, la mente sott’acqua, a immaginare colori e forme mai viste, e immensi spazi di terre sommerse. Risalì lentamente alla superficie e lo riconobbe. L’uomo era di buon umore, per il lavoro concluso. La guardava apprensivo: dove sei? Perché non parli? La memoria della donna ricordò qualcosa di triste e di crudele che l’uomo le aveva fatto. Tutta la nausea di quel viaggio in barca le ricordò all’improvviso il dolore intollerabile di un altro viaggio. Capì, con un senno antico, che quell’uomo non era il suo elemento, non era la terraferma che lei cercava. Ma, stranamente, non provava rancore, o rabbia. La soluzione era dunque così semplice, così indolore? O quel viaggio in barca aveva sommato tutto il dolore che lei poteva tenere? In vista del molo d’attracco, la donna si sentì presa da un’improvvisa euforia. Saltò a terra d’un balzo e provò il desiderio irresistibile di baciare il cemento del molo. Aveva temuto di non riuscire più a tornare indietro. A liberarsi. Dopo un veloce pasto, tornarono alla pensione all’imbrunire per ritirare i bagagli. Mentre l’uomo preparava l’auto, la donna scese di corsa verso il tratto di spiaggia che aveva visto la mattina dalla finestra. Le barche erano in secca per la bassa marea, adagiate su un fianco come animali morti. Attendevano, nel loro docile abbandono, l’arrivo della sera, quando l’oceano, nel buio, sarebbe tornato a resuscitarle. - Àcoma di Patrizia Tenda Ero appostato sulla Mesa Encantada quando vidi arrivare da Albuquerque un’auto bianca e lucente contro la terra rossa. C’era una coppia a bordo, che si fermò sotto il grande monolito di pietra. Un uomo grasso dal pelo rosso scese dall’auto, la camicia hawaiana tesa sul pancione. L’uomo sbatté la portiera. Il colpo risuonò nel silenzio del deserto come una fucilata. La donna, una bionda pasciuta, raggiunse la parete a picco e gridò: “Paul, inquadra fino in cima.” L’uomo puntò quel che pareva un’arma di precisione. Non hanno più occhi per le storie che la terra racconta. Devono usare macchine. La coppia salì in auto senza guardare i campi, dove pascolavano cavalli bradi, o l’orizzonte a est, dove svettava il profilo azzurro di Mount Taylor, la montagna sacra ai pellerossa. I due Mericanos arrivarono al Trading Post nella pianura polverosa e assolata, battuta dal vento caldo del mezzogiorno. Mi spostai veloce sull’altopiano di Acoma ad aspettar l’arrivo dei turisti. Acoma è una fortezza naturale. I nativi caricavano otri d’acqua sulla schiena e s’arrampicavano sulle rocce. Col progresso si sono rammolliti. Il pulmino accelerò sulla rampa e raggiunse la cima. I turisti scesero con Erika, la guida indiana, capelli corvini, occhi irrequieti. La vista panoramica provocò commenti in varie lingue, poi lei parlò: “Viviamo su queste rocce da mille anni. Siamo discendenti degli antichi Anasazi di Chaco Canyon e di Mesa Verde.” Paul il grassone puntò il dito verso i capanni di legno sul bordo della mesa: “Chi abita in quei tuguri?” “Sono gabinetti. Qui non c’è acqua corrente né luce elettrica per scelta dei residenti, per preservare il pueblo com’era.” Un mormorio si levò fra i turisti. Erika li portò fra le case di fango e paglia fin davanti a una costruzione bassa e rotonda, senza finestre. “Questo è un Kiva, luogo sacro di preghiera, accessibile solo dal buco sul tetto. Noi crediamo d’esser nati da un buco nella terra.” Paul rise: “Di sicuro veniamo tutti da un buco!” Entrarono in San Esteban del Rey, la grande chiesa dei missionari spagnoli, con statue di santi scolpite nel legno dagli indiani 400 anni fa. Fuori dalla chiesa, nella canicola meridiana, Erika radunò i turisti. “Vedete questa finestra? Ha una lastra di mica, al posto del vetro.” Paul l’interruppe: “Perché non avete inventato il vetro, la ruota, l’elettricità, mentre noi bianchi abbiamo inventato tutto?” I turisti lo guardarono sbigottiti. Il viso bronzeo di Erika era duro come i santi di legno della chiesa. “Le lastre di mica, sotto il sole, lanciano riflessi dorati. Un frate pensò fosse oro. Il conquistador Coronado guidò una spedizione armata, ma non lo trovò. Ora ammirate i nostri artisti. Il pulmino parte fra mezz’ora.” Sulla via erano apparse bancarelle con ceramiche e monili d’argento e turchese. Erika prese il sentiero fra le rocce, per sbollire la rabbia. Volai sopra di lei. Alzò gli occhi e mi vide: “Lasciami stare, Corvo.” Non farti avvelenare il cuore da chi ha il buio negli occhi. Krah! - C’é posto per te! di Raffaele Vergnani Ho percorso la distanza che separa Reggio Emilia da Lione per diversi anni. Il motivo? Ragioni sentimentali, ça va sans dire. Eppure, nonostante l'origine e la destinazione di ogni viaggio fossero sempre le stesse, spinto dalla mia innata curiosità non ho mai esitato a cambiare, nel limite del possibile, mezzi di trasporto e provare esperienze nuove. Treni regionali, intercity, Frecciarossa, Tgv, oppure opzioni multimodali treno+pullman, treno+aereo, o ancora il mezzo privato. Nell'agosto del 2011, dopo diversi mesi di allenamento, ho inforcato la mia bici e ho coperto i 750 km che separavano casa da Lione in sette giorni e altrettante tappe. La via del ritorno non é stata meno avventurosa, fra treni regionali e pedalate. Insomma, parafrasando una nota pubblicità di qualche anno fa, potrei affermare tranquillamente di "averle provate tutte". Quando, poco più di un anno fa, un caro amico mi offre un passaggio in auto fino a Lione poiché diretto proprio li per lavoro, non esito un attimo ad accettare questa proposta. Innanzitutto perché questa opzione di viaggio ancora mi manca. E poi perché sono curioso di provare questo "car pooling", causa che Luca ha sposato da tempo, elogiandone pregi e virtù in ogni occasione possibile. Ogni suo viaggio di lavoro ormai si ripete secondo questo copione, sia come conducente che come passeggero. “E’ troppo deprimente viaggiare da solo” – ripete con convizione. Partiamo un lunedi mattina di fine estate. Primo pit-stop nei pressi di Parma dove carichiamo Andrea, studente diretto a Torino. Poco prima di Alessandria tocca a Filippo, diretto invece a un convegno a Chambéry. Facciamo conoscenza, c’é subito feeling tra noi, il tempo vola. E visto che nessuno ha i minuti contati, evitiamo il Traforo del Frejus e allunghiamo l’itinerario di qualche km percorrendo la strada deserta che conduce al Colle del Moncenisio, dove le acque cristalline dell’omonimo lago riflettono le vette e gli alpeggi d’alta quota. L'esperienza si rivela al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Una sorta di autostop in salsa 2.0 dove, al caso e all'improvvisazione, si sostituiscono efficacia e precisione. Grazie alla rete diventa possibile visionare in anticipo la domanda e l’offerta di viaggi a disposizione e, ove possibile, calibrarla sulle proprie esigenze. La macchina non é più un mezzo privato ma diventa una vera e propria auto di servizio, capace di girare (finalmente) a pieno carico e trasformarsi in una navetta in grado di trasportare persone anche su lunghe distanze. Il tutto a costi più che competitivi, con un impatto ambientale ridotto e, soprattutto, con una convivialità inaspettata. E forse é proprio quest’ultimo il valore aggiunto, che dà un tocco di vivacità e allegria che sugli altri mezzi pubblici é sempre più difficile trovare. Morale della favola? Da allora, ho cominciato a guardare l’auto con occhi diversi e a metterne in risalto non solo i difetti ma anche le qualità. Fate come me, quindi. Lasciatevi trasportare (e trasportate!) - Viaggio nel quotidiano di Raffaella Ferrari «Teresa oggi non viene al lavoro – Disse Laura arrivando in stazione in ritardo, come sempre – E’ ammalata, me l’ha detto ieri sera al telefono.» Aveva le mani gelate e continuava a riscaldarle con l’alito caldo. Era inverno e faceva freddo. Laura ed io eravamo come ogni mattino immobili vicino alla linea gialla, guai a oltrepassarla diceva la solita voce al microfono. «Un giorno cambierò lavoro e mi farò assumere in un ufficio sotto casa…» Era la nostra frase di rito, il nostro buongiorno da pendolari. Salimmo in silenzio sulla carrozza di seconda classe in coda al treno, ma era troppo calda e i miei occhiali di colpo si appannarono. A stento riuscivo a vedere i sedili. Avevo memorizzato con il tempo ogni singolo dettaglio di quel treno quindi andai sicura nei nostri soliti posti, quelli vicini al finestrino. Quando eravamo in tre, facevamo sempre il gioco del pari e dispari per quei sedili! «Venezia nelle prime ore del mattino è adorabile…» Laura starnutì soffiando rumorosamente il naso; guardava fuori dal finestrino e già immaginava la nostra città preferita. «Una signora seducente e capricciosa!» Le risposi sottovoce sorridendo. Il tempo sul treno correva veloce; noi eravamo impegnate a leggere e a raccontarci la nostra vita, i nostri segreti. Poi saliva lui, il ragazzo biondo che profumava di bagnoschiuma al sandalo e dopobarba. Era una voce fuori dal coro, la puzza a volte era davvero insopportabile in quei vagoni, lui era meglio di un cappuccino fumante. Il biondo compiva un silenzioso rituale: apriva la borsa, prendeva il tablet, richiudeva la borsa, la riponeva con cura nel portabagagli e si sedeva guardandosi attorno e, quando incontrava il nostro sguardo, sorrideva arricciando il naso timidamente. «Quanto è bello!» Non poteva mancare la frase di Laura, tra una soffiata di naso e uno stranuto. Amavo il silenzio del viaggio in treno il mattino presto. Non erano molte le persone che parlavano, tutti guardavano fuori dal finestrino sbadigliando, solo il controllore con il suo biglietto, prego! Risvegliava i pendolari. Io guardavo il rapido passaggio del treno vicino alle case, ai campi coltivati e alle strade, erano immagini familiari e rassicuranti. «Ci siamo Gloria, sei pronta?» Guardai Laura sorridendo. Lei aprì il finestrino e un’ondata d’aria gelida riempì lo scompartimento facendo rabbrividire tutti i presenti. Ci alzammo in piedi sporgendo le nostre teste dal finestrino. «Laura è troppo freddo - dissi ritraendo velocemente il viso - ci prenderemo una bronchite!» La mia amica mi sorrise invitandomi a contare. «Uno, due, tre, libertà… libertà…» Urlammo ridendo come matte. Il nostro passaggio sopra al Ponte della Libertà era seguito da quel gesto scaramantico. Ora nulla poteva andare storto. Ci sedemmo felici attendendo di raggiungere la signora. Venezia era lì, bella e addormentata pronta ad accoglierci come ogni mattina. L’alba rosata sembrava averla truccata con un tenue rossetto. L’acqua risplendeva luccicando. - Je suis désolé monsieur di Romano Bertolino “Je suis désolé monsieur, votre réservation n'est pas acceptée, nous sommes complets”. Ma come, al completo? E me lo dici così? Con quella faccia carina che non riesco nemmeno a provare ad incavolarmi? “vous pouvez essayer avec les autres hôtels dans le pays, ils sont tous là, autour de la place”. Vabbè, proviamo. Ciao faccina carina, ok, provo dalla concorrenza. Quale concorrenza? Qui sono tutti al completo, neanche una tana da topi è rimasta. Un cugino motard mi consiglia di tornare indietro, verso l’altro villaggio dove gli hotel sono meno congestionati. No, non se ne parla nemmeno, piuttosto mi butto a dormire su un prato ma sono venuto fin qui per il canyon e non intendo tornare indietro. Riparto in direzione canyon. Fa caldo ma la strada è piacevole, le curve che sfiorano le rocce a strapiombo e qualche albero che si sporge oltre il suo possibile limite fanno contenta la mia vecchia moto, la sento dondolare leggera sotto i polsi. Cos’è quella? Un’aquila? I due turisti francesi fermi con la loro vetusta R4 ne sono convinti, è troppo alta per poterlo capire veramente ma loro sorridono come bambini e ripetono “aigle, aigle!”. La strada ora esce dal budello delle rocce e si apre su un pianoro, la moto è meno contenta di fare questi tratti rettilinei, ma io vedo un hotel! Avete una cameruccia, piccola piccola per questa notte? Si? E’mia, mollo le borse, mi disseto sotto il glicine del dehor e riparto per il mio traguardo di giornata. Il paesaggio cambia, quasi all’improvviso. È tutto più arido, aspro, e la strada sale arrampicandosi tra le rocce del bordo dell’orrido. Certo che siamo alti rispetto al fondo! Il torrente che paziente ha scavato queste rocce sembra scivolare via con indolente indifferenza ai due turisti parcheggiati sul bordo del costone. Il turista meccanico ticcheteggia raffreddandosi mentre l’umano perde lo sguardo attorno. Aigle, si, diamine, è proprio un’aquila. No due, tre aquile. Mi passano davanti tuffandosi nello strapiombo. Resto paralizzato e senza fiato, la macchina fotografica mi scivola dalle dita come sapone. La prima dello stormo traccia traiettorie eleganti tra le invisibili correnti d’aria. Le altre la seguono come bambini che si fidano dei loro sogni. Ne arriva un’altra e si accoda, con le piume collega le molecole dell’aria come puntini da raccordare, le stesse molecole toccate dalle ali delle sue compagne. Non sbagliano proprio, sono le stesse molecole che vengono passate e ripassate dal gruppo, che scivola d’ala, staziona e risale leggero, spinto dalla corrente ascensionale che la roccia del dirupo scaldata dal sole emette a fine giornata. Ho gli occhi stupiti del bambino davanti alla casa del babbo con le renne. Mi sento aquila ma ho i piedi di roccia. Non posso seguirle, scendono sotto la mia quota, giocano, virano, di colpo cambiano senso e risalgono alte, troppo alte per me, terrestre senza ali. Roccioso fortunato, rimborsato nell’animo per le fatiche del fisico. E’ ora di tornare, si ma, dov’è la moto? - Il mio indimenticabile blablaviaggio di Sabrina Maroccoli John Lennon diceva: "La vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altri programmi”. E proprio mentre ero intenta a pianificare minuziosamente il giorno successivo a quello che stava per volgere al termine, accompagnato da un meraviglioso tramonto estivo, la vita mi ha “chiamata”. Non è stata affatto una bella chiacchierata. Ho saputo che mio padre era in un ospedale, a 600km di distanza dal posto in cui ero io, in condizioni abbastanza gravi. Ogni progetto si è dissolto davanti ai miei occhi escluso il desiderio di raggiungere mio padre in fretta. Ho dato un’occhiata ai vari servizi di trasporto, un fallimento. I costi del viaggio erano nettamente superiori rispetto alle mie possibilità e gli orari non consoni alle mie esigenze. Ero inerme. Nel massimo momento di sconforto la vita mi ha richiamata, comportandosi quasi come un fidanzato che decide di scusarsi per essere stato troppo duro nella chiamata precedente, e mi ha fornito una formidabile notizia. Ho scoperto il sito bla bla car, inserito le varie località negli appositi spazi e aspettato che comparissero le diverse opzioni. La prima era formidabile, conveniente, l’orario di partenza ottimo e il conducente era un ragazzo che aveva lo stesso nome di mio padre. Sarà stato un segno? Non ho potuto che scegliere lui e impulsivamente l’ho chiamato. Mi aspettava un lungo viaggio in compagnia di tre ragazzi, due miei coetanei venticinquenni e un uomo di trentasei anni. La diffidenza, i dubbi e la paura hanno cercato più volte di prendere il sopravvento su di me, ma mi è bastato guardare in viso i ragazzi e in faccia la realtà per rendermi conto che non avevo motivo di essere agitata. Eravamo “tutti sulla stessa barca” con obbiettivi diversi, ma una meta e tante altre cose in comune. Tre persone formidabili, generose e attente. Non solo mi hanno fatta sorridere, ma sono riusciti a rendere speciale ogni attimo di quel viaggio che non dimenticherò mai, come non si scorda mai un primo amore. La nostra complicità e ironia ci ha anche portato a comprare un gratta e vinci in comune e a vincere una somma trascurabile di denaro ma cospicua di felicità. Ci siamo fermati a vedere il mare, abbiamo pranzato condividendo ogni cosa che avevamo e il tempo è volato. I ragazzi con estrema gentilezza mi hanno accompagnata proprio davanti all’ingresso dell’ospedale e poi sono andati via. Sono arrivata sana, salva e con qualcosa in più rispetto a prima dentro me. Ho capito che aveva ragione Leo Buscaglia quando diceva che: “Il rischio più grande nella vita è non rischiare nulla”. Bisogna farsi sempre forza, qualunque cosa accada e liberarsi dalla diffidenza e dai preconcetti. Si ottengono solo vantaggi. Viaggiare con bla bla car non significa solo muoversi fisicamente ma spostarsi con la mente e con il cuore. Ps. Vi comunico che ora mio padre sta bene e che vedere gli occhi lucidi di un genitore emozionato perché non si aspettava di vederti è la cosa più bella del mondo. GRAZIE INFINITE BLA BLA CAR! - “Il viaggio più caldo” di Samuel Opkpokpo L’itinerario che porto nel cuore è stato una vacanza con la mia famiglia. Mio padre è Nigeriano e circa 10 anni fa andammo a trovare e conoscere i parenti. Il percorso che mi cambiò il modo di vedere le cose fu da Lagos, città in cui si trova l’aeroporto, ad Amizi, il piccolo villaggio in cui mio padre è cresciuto. La Nigeria è un paese del terzo mondo a regime militare il che comporta innumerevoli posti di blocco posti nelle strade principali che esigono pagamenti. Questa nazione subisce il fenomeno di neo globalizzazione da parte dell’Europa a causa del petrolio presente nel terreno. Infine, a quel tempo, non era ancora scoppiata la guerra, ma le tensioni si sentivano. Prima di affrontare il viaggio prendemmo la jeep di mio zio e “affittammo” un membro dell’esercito. In pratica pagammo un maggiore, che si presentò con tanto di divisa ufficiale, in modo che guidasse per tutta la tratta così da evitarci problemi. Partimmo la mattina presto, l’aria era ricca di spezie, difficile da respirare, afosa e umida. Prima di entrare in autostrada attraversammo tre baraccopoli. Le immagini di bambini piccoli ricoperti di fango e mosche, e di adulti menomati e denutriti, mi rimarranno per sempre nella mente. Ancora non concepivo il disprezzo e, in qualche caso, il razzismo nei nostri confronti. Io, alla fine, sono un ragazzo mulatto chiamato “nero” in Italia e “bianco” in Nigeria. Il viaggio continuava. I miei occhi erano intenti a fotografare paesaggi che fino allora avevo solo visto nei libri. Le palme spiccavano sopra a piante di ananas, ad alberi di mango e papaya e a mercati fatti di legno, fango e fieno. La bellezza dei panorami si scontrava con la durezza della vita. A circa metà tragitto ci fermammo imbottigliati nel traffico. Il percorso prevedeva l’attraversamento del “Niger bridge” che collega la regione “Abia” con la regione “Enugu” e la strada si restringe molto. A un certo punto, vidi un uomo correre verso una capanna tra la strada e la riva del fiume. Rubò qualcosa da un banco che esponeva cibo e bevande. In pochi secondi si sentirono le urla da parte del proprietario del negozio che agitarono i militari e uno di loro sparò alla gamba del ladro. Ricordo benissimo l’asfalto sporco di sangue e la risposta di mia madre, che chiuse i finestrini della macchina, come se i proiettili non potessero entrare. Non credo di essermi sconvolto più di tanto, a 13 anni il mio film preferito era “arma letale”, ma rimasi colpito dal fatto che le altre persone reagirono come se nulla fosse successo, scocciate dal rumore provocato dalla pistola. Pochi minuti dopo passò una carovana composta da jeeps dell’esercito che scortavano un ambasciatore e, noi, le seguimmo e ci allontanammo dalla “zona calda”. La città prima dell’arrivo era “Umuahia” che ci stupì proponendo due cadaveri messi in mezzo la carreggiata, come fossero un dosso umano, per rallentare le macchine. Alla fine arrivammo sani e salvi, un po’ acciaccati nel fisico e confusi nella mente. - Fuori è un’altra storia di Sara Balleroni Quando Lara mi dice che lei e suo padre non possono accompagnarmi a Spalato mi innervosisco. Potrai mettere una ragazzina di 17 anni su un pullman a Sarajevo e farle attraversare da sola due nazioni? Lara non capisce quale sia il problema. “È un pullman”, mi dice in inglese. “Sali, e ti porta a destinazione”. In stazione mi allunga qualche kuna croata: “Se hai bisogno di qualcosa prima del traghetto”, dice. Io la ringrazio, e poi ci abbracciamo, e aspettiamo ancora, ascoltando la musica con un auricolare a testa. Poi siamo in piedi vicino al finestrino, per il nostro secondo e definitivo addio: quando ci siamo conosciute, dieci anni fa, lei era una bambina che aveva visto la guerra. Io avevo visto il film delle Spice Girls. Mi sono trasformata in una ragazzina coi capelli arancioni e la vescica che sta per esplodere, su un pullman che non sembra far altro che curve. Se è prevista una sosta per il bagno, io non lo so. Davanti a me c’é una coppia, picchietto sulla spalla di lui. Ha sulla guancia un neo grande come un’oliva e manda odore di fritto; butto lì due parole in inglese: “Ci si ferma per il bagno?”. L’uomo parla bosniaco e le vecchiette attorno a noi anche: capisco solo Split, Spalato. Sorrido e senza farmi vedere slaccio il bottone dei jeans. Poi il pullman rallenta. Entra in una stazioncina, uno sputo di cemento in mezzo a un campo. Ah, dire la gioia nel vedere il cartello scrostato su cui è scarabocchiata la dolce parola: «WC»! Sgomito e mi fiondo lì davanti a tutti. C’è da pagare qualche kuna e io cerco i soldi che mi ha lasciato Lara, imprecando contro il monopolio dei bagni. Metto gli spicci sul banchetto. La custode mi guarda come se avessi minacciato la sua famiglia: Bosnia, abbaia. Siamo ancora in Bosnia. Non posso pagare con i soldi croati. Corro fuori e farnetico “money change” ai passeggeri che si sgranchiscono. L’uomo col neo-oliva mi guarda come fossi un programma tv, gli altri neanche quello. Attorno alla stazione solo campi e piuttosto che farla all’aperto sfido a duello la custode. Poi vedo una donna sulla cinquantina, capelli a caschetto: mi guarda. “Money toilet”, riprovo. Lei sorride, e mi allunga le kune che servono. Io le do le mie, ma lei rifiuta: «Go, bus leave». Il pullman parte! Corro in bagno, lancio i soldi alla vecchia avara e, finalmente, finalmente, faccio pipì. Mai bagno rancido è sembrato più accogliente. Neanche a dirlo, fuori è un’altra storia. La vecchia è in realtà una donna rispettabile che campa scrostando bisogni altrui, l’uomo con l’oliva sorride, il conducente mi aspetta per ripartire. E anche Lara, in piedi vicino al finestrino nella stazione di Sarajevo, è un’altra persona, è la ragazzina che mi ha ospitato a casa sua, che per due settimane ha fatto dormire i genitori sul divano letto, pur di farmi posto. Passo trionfante fra i sedili del bus, e alla donna col caschetto sussurro: «Thank you». - Castello di Casteldarne – Le mura che bisbigliano di Sara Guerriero Dicono che il viaggio conti più della destinazione. Dopo 211 chilometri in auto, raggiungo Val Pusteria, in Trentino Alto Adige. Se questo spettacolo fa parte del mio viaggio, allora non potrei essere più d’accordo. Piove. Secondo i miei compagni di avventura, dovrei crogiolarmi nella disperazione, ma se fossero questi i problemi della vita, sarei la donna più felice al mondo. Dall’alto dei miei diciannove anni, propongo una meta non spesso condivisa. Un castello. « Ma dai, Sara! Siamo in vacanza, è agosto, e tu vuoi rinchiuderti in un castello per l’intera giornata? » « Ragazzi, a meno che non vogliate girare la parodia del video di “Singing in the rain”, io vado a visitare il Castello di Casteldarne! » Mi accoglie l’inebriante profumo della regalità d’altri tempi, sapori tradizionali, abiti immensi, sfarzo e corruzione, intrighi, passioni. Percorro un il sentiero fino a varcare il portone di legno. Giungo al cortile del castello. Mi sento una semplice ragazza del 1700, di umili origini, segretamente innamorata del Principe della famiglia Künigl. Mi lascio subito abbagliare dal Salotto Azzurro, così chiamato perché è tutto azzurro, dalle pareti, alle sedie, alla stufa di maiolica. Mi immergo nello stile orientale, il must have del XVII secolo. Strabiliante la lavorazione di un arazzo nero con fantasia orientale e ricami d’argento. La sala degli antenati. Soffitto originale del 1532. Quando scorgo una tralasciabile stanzetta, mi sorprendo ad immaginarmi nascosta sotto lo stupefacente scrittorio della bisnonna Marta, per non farmi scoprire dai Conti Künigl. Rimango lì immobile, affascinata dalla geniale combinazione a incastro dei cassettini dello scrittorio, con al centro una splendida stella in madreperla. Mi pare di sentire i passi dei Conti che si allontanano. Riemergo timidamente dal mio nascondiglio improvvisato e ricomincio a vagare tra le mura di Casteldarne, immersa nello sfarzo e nella meraviglia. Alice mi avrebbe invidiata… altro che Bianconiglio! Impressionante l’ingegno dell’orologio nella Stanza della Caccia! È costruito come una cassettino contenente una candela che consente di proiettare l’ora sul muro. Il ritratto del fidanzamento tra Sissi e Francesco Giuseppe, risalente al 1854, cattura la mia attenzione, ma temo che le domestiche del castello stiano per arrivare. Me le immagino vestite di nero, con una cuffietta bianca a coprire il capo. Sulla parte esterna del castello, sento profumo di bambini. Potrei portarci Luca, il fratellino più straordinario che potessi desiderare. Ha due anni. Si divertirebbe molto sul bellissimo cavallino a dondolo in legno, accuratamente intagliato e dipinto. Un sorriso mi si scolla dalle labbra alla vista della versione settecentesca del passeggino per gemelli. Era stato costruito per le due sorelle gemelle del vescovo. Ideato con estremo ingegno nel prevedere le loro mosse. All’apparenza risulta come una culla di legno, dipinta di rosso, con sotto due grandi ruote e il manico pe trainarla. A metà, un’ asticella di legno per dividere le due gemelline. Se si comportavano bene venivano poste una di fronte all’altra; se litigavano, una dietro l’altra; e se si tiravano i capelli, una di schiena all’altra. Da far invidia ad Einstein! Nella Sala delle Udienze cala l’inquietudine dovuta al ritratto del Vescovo dipinto in modo da dare l’illusione che ti segua costantemente con lo sguardo. Una sorta di onnipresenza da brivido. Quando ascolto gli aneddoti della Famiglia Künigl, mi immagino seduta in Chiesa ad assistere alle nozze fra la sorella più bella del Vescovo e il suo promesso sposo, un conte ungherese. Quando il conte la vede per la prima volta all’altare, muore d’infarto da quanto lei è in realtà orribile! Assurdo come un’ umile fanciulla timorata di Dio quale sarei stata, possa trattenere le lacrime di fronte ad un simile episodio. Probabilmente se avessi riso loro in faccia, mi avrebbero fatta bruciare viva! Incuriosita e tremante mi appresto a raggiungere la camera da letto del Vescovo. Prima di sentire dei rumori e darmela a gambe, riesco solo a notare un dettaglio: il letto irrimediabilmente matrimoniale per accogliere… gli ospiti d’onore! Scendo frettolosamente una scalinata fino a raggiungere nuovamente il cortile nel quale si possono ammirare oggetti casalinghi alquanto singolari. La stiratrice portata dalla Sassonia da Marta, in cui per stirare le lenzuola bisognava girare una manovella di legno. La tipica aspirapolvere dell’epoca. E una zangola per produrre il burro. Per concludere, il cortile accoglie numerose fotografie della Famiglia Künigl, il menù di un pranzo di nozze, una serie di chiavi molto grandi e alcune raffinate borsette di perle. Se mi fossi sposata col Vescovo, prima delle nozze avrei senz’altro inventato l’eye- liner, il mascara, il primer e il correttore per evitare che il mio futuro marito seguisse l’amico conte ungherese nell’oltretomba. Avrei indossato uno di quegli abiti esageratamente pomposi. Rosso fuoco. I capelli rigorosamente raccolti in un qualche miliardo di trecce. E Lady Gaga come stilista personale per gli accessori. Poi avrei ingaggiato Madonna come wedding planner. Leggermente esagerato? Questa esperienza mi ha fatto riflettere sull’importanza di stravolgere tutto nella vita. È vero, sicuramente una passeggiata in montagna risulta più salutare di una visita ad un castello. Ma la pioggia è così suggestiva che ritengo eretico non apprezzare il suono delle goccioline che si infrangono sulla Torre del Castello, risalente al 1190. Location perfetta per il fantasma di Canterville. Un mix di inquietudine, brivido, avventura, mistero, curiosità, fascino. La fantasia è ciò che non sapremo mai definire. Perché ne dimentichiamo la preziosità nel momento in cui entriamo a contatto col mondo degli adulti. Questo è solo un castello. Sono solo mura. Ma sono mura che bisbigliano, impregnate di storie e segreti, tradimenti e amori impossibili, falsità e lacrime, morti e nascite. Mi piace pensare che le anime dei Künigl aleggino ancora per queste stanze, invidiando i telefoni cellulari e i passeggini dei visitatori contemporanei. Quando esco dal castello, mi accolgono quegli altri associali con un: «Allora? Hai incontrato il Principe William? » E io: «Ovvio! Ha deciso di lasciare Kate per me! » Non m’importa se questa avventura è durata solo due ore. Ho lasciato una parte di me nascosta sotto lo scrittorio della bisnonna Marta. E spero che un giorno quelle incantevoli mura racconteranno anche di me. - Viaggi e miraggi di Serena Lena ‘Mi raccomando, Serena, sta’ attenta; se ti senti in pericolo, telefona’. Le ultime parole di mia mamma, prima che metta in moto la macchina. Non si dimentica mai di dirle, da quando sa che ho scelto di condividere il mio metro cubo di aria in movimento con altre persone. Sconosciute. Sono riuscita, nel tempo ad abbattere le sue ansie con i racconti entusiasti dei viaggi in compagnia, il mio sguardo vitale, i sorrisi; ma quella frase lì, quella detta sul portone di casa, beh, credo rimarrà in eterno. Metto in moto la macchina, dallo specchietto retrovisore do un’occhiata alla gatta, che sbircia sospetta dalla sua gabbietta. E’ il nostro linguaggio in codice, siamo pronte. Sono sempre un po’ emozionata prima di andare a prendere i miei compagni di viaggio: fantastico su quali saranno i loro volti, i loro racconti. Il viaggio non è lungo, sono sempre i soliti 300 chilometri, quelli che mi separano dal mio mare o, in senso inverso, che mi riportano alla realtà. Ma è incredibile come 300 chilometri siano sufficienti ad entrare in sintonia con chi, fino ad un attimo prima, era un perfetto sconosciuto. Ogni volta è un’opportunità unica. Stavolta sono un po’ tesa. Non faccio grandi indagini sui partecipanti, mi fido dei loro profili e dei loro messaggi; d’altra parte, la fiducia reciproca è fondamentale in un’esperienza simile. Ma nelle poche parole scambiateci via sms c’era qualcosa di, non so, strano, misterioso. Sono due amici, uomini; con loro sono al completo, la mia macchina è piccola e Miciu occupa un posto pieno. ‘Sono vestito di nero’, unica indicazione. Lo individuo, è lui, barbone lungo e sguardo serio. L’altro ragazzo è dalla parte opposta del marciapiede, biondo, occhi azzurri, sorridente, si vede subito che non è italiano. Presentazioni, salgono in macchina. Scopro subito che i miei timori erano infondati: l’“uomo nero” è un prete giovanissimo ed il “principe azzurro” un ragazzo israeliano da poco arrivato a Roma per uno scambio universitario. Parliamo in italiano e parliamo in inglese, parliamo di religione e di culture, di usi e costumi e di economia, di studio e di svago, di cibo e di profumi, di impressioni e dei diversi modi di intendere la vita. C’è traffico, ma non ce ne accorgiamo: i nostri discorsi ci entusiasmano e travolgono completamente. Tre ore che passano veloci, giunti a destinazione ci si accorge che ci sarebbero ancora moltissime altre storie. Torno a casa con il sorriso sul volto e le loro parole nel cuore, con la promessa di risentirsi presto e con quella di andare insieme in Africa a Natale, per un progetto di volontariato negli orfanotrofi di Nairobi. Erano anni che volevo fare questa esperienza; pare sia arrivato il momento, perché nulla accade per caso. D’altra parte, come cantava De Gregori, “dietro a un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare”. Con la consapevolezza che sarà un nuovo viaggio di condivisione. - Il sapore di lei di Sharon Galano Avere il cuore leggero. Per viaggiare bisogna avere il cuore leggero. Non devono esserci radici. O meglio, radici non troppo robuste e spesse. Bisogna avere la mente libera da ogni preoccupazione. Lasciare a casa le parole non dette, i ricordi infelici e i sogni dismessi. Non c’è spazio in valigia per una mente in travaglio, per un cuore in subbuglio. Viaggiare. C’è gente che ne è entusiasta. Tu no. Sei un mollusco da scoglio. Puoi muovermi solo entro una data superficie. Oltre c’è il buio del mare inesplorato, troppo impervio, troppo minaccioso. Ma hai dovuto lasciare gli ormeggi e partire, volente o nolente. Stai per rispondere alla chiamata del destino. Sperando che non ti metta in attesa. Due anni sono già troppi. Fino a qualche tempo fa avevi un’ancora che ti teneva ben saldo al tuo piccolo mondo. Era una zavorra leggera e piacevole. Sapevi di poter volare anche nonostante quel peso. L’Amore non ti tira mai a fondo. Ti mette le ali e ti fa volare. Sei una mongolfiera in cima al tuo piccolo scoglio. Sì, è sicuramente così. O almeno dovrebbe esserlo. Il vero Amore dovrebbe essere così. Dovrebbe lasciarti libero di viaggiare. Ma non sempre va così. E te ne rendi conto sin dal primo passo che muovi fuori casa. Ti senti una stretta al cuore. Qualcosa ti punge all’altezza del petto: è una fitta di dolore misto ad angoscia. Non sai trovare una spiegazione istantanea a questo malessere improvviso. Pochi giorni e tornerai da lui o da lei. Perché farsi prendere dalla disperazione? La risposta è semplice: l’amore fa male quando è insicuro. Arrivi sul porto e già ti senti mancare l’acqua sotto i piedi. A breve toccherai la terra ferma, sbarcherai sul continente. Lascerai la tua isola. “Ma solo per pochi giorni!”, non fai altro che ripetere a te stesso. Eppure pensi già al giorno in cui sarai di ritorno. Prendi il tuo taccuino e metti giù un paio di pensieri veloci. Sembra quasi che tu abbia intenzione di non perdere la tua bussola interiore. Scrivi qualcosa sul quel mare, su quel monte, su quella casa. Stai dicendo addio alla tua isola. Ti hanno sempre deriso. Non hai mai voluto prendere il largo. In fondo tu ti sei sempre trovato a tuo agio su quello sputo di terra. Ti hanno detto che non hai mai viaggiato. Ma che ne sanno?! Tu sei un marinaio di quel piccolo vascello. Sai come affrontare le burrasche, fiuti l’odore della tempesta a kilometri di distanza, guardi in faccia il sole senza paura di bruciarti. Cosa ne sanno questi uomini di città?! Sono troppo presi dal loro essere perfettamente imperfetti. Veloci, distratti, malinconici, nostalgici, desiderosi della roba altrui, competitivi, superbi, arroganti. A te invece basta una casetta. A te un piccolo orto. A te un piccolo lembo di spiaggia, dove riposare nelle notti estive. A te la vita ordinaria dell’uomo comune. Sta qui la tua felicità. Ma per inseguire il tuo sogno, sei costretto a viaggiare. Affidi le vele e il timone a un amico. Gli chiedi di aspettarti. Tornerai quando il maremoto avrà smesso di mietere vittime. E stai lì sul porto, immobile a scrutare quel mare, a osservare il profilo di quel monte, a desiderare un’altra notte in quella casa. Lei dorme. Non hai voluto svegliarla. Sorrideva e sognava. Chissà cosa sognava? Non è dato che tu lo sappia. Puoi solo immaginarlo. E speri che sogni te. Amore. Due anni sono troppi, anche per un vero amore. Le stai dicendo addio. Le hai scritto una lettera. Vorresti vederla mentre la legge. Ma non ne reggeresti il colpo. Lasci lei e l’isola. Questa la tua decisione. La lasci dopo aver dormito con lei un’ultima notte. Hai il suo sapore sulle labbra: brucia come il sale del mare, ma non ne puoi fare a meno. È questo il ricordo che porterai con te. - La Terra che non va via di Silvia Colombo Potrei parlare dell’Africa come la musica nelle orecchie mentre percorri millemila chilometri e incroci continuamente mani che si affacciano al tuo finestrino. Potrei parlare dell’Africa come la lacrima che togli in cambio di un sorriso più bianco della luna. Potrei parlare dell’Africa come la terra che mi è scivolata via dalla doccia, ora, dopo due settimane. Potrei parlare dell’Africa come i sacchi di sabbia e cemento portati a fatica, come i muretti costruiti con filo e spatolina. Potrei parlare dell’Africa come ritorni a casa sul retro di un camion, persi in una galassia di stelle. Potrei parlare dell’Africa come gli infiniti viaggi in matato, a correre tra i dossi e strombazzare a suon di ‘Jambo’ tutti i passanti. Potrei raccontare dell’Africa come Collins, Nelson, Francis, Andrew, David, Amis, Cristopher, Nicholas, John. Potrei raccontare dell’Africa come i banchetti di legno, le baracche colorate, la frutta esposta in modo perfetto, i mercati trionfanti di rumore e magheggi. Potrei raccontare dell’Africa come una manina che ti tira giù i pantaloni pur di trattenerti e la stessa che appena ti riconosce, qualche giorno dopo, ti sussurra ‘Mami’ con gli occhi sgranati a giorno. Potrei raccontare dell’Africa come una Chiesa di quelle Vere, quelle fatte di Persone, Carne e Cuore in un unico momento che cantano, ballano, alzano gli Occhi e le mani al Cielo per ringraziare quel Dio tanto buono. Potrei raccontare della canzone dei bambini più piccoli, tutti ordinati, con maglietta bianca e maglioncino blu, capaci di farmi scendere lacrime davanti a centinaia di persone. Potrei parlare dell’Africa come il “quando torni?” che tutti vogliono chiederti.Potrei parlare dell’Africa come quella certezza che hanno tutti, i bambini, i giovani.. quella certezza di credere che, comunque vada la Vita, comunque sia la Vita, tu non devi smettere mai e poi mai di credere che tutto è possibile. E allora, mi sento in dovere di credere nei miei sogni, per loro che rappresentano, pur non sapendo, parte del mio sogno. Glielo devo. E lo devo a me. - Compagni di viaggio di Silvia Mazzocchin Dopo un Erasmus ci si ritrova con tante cose... scatoloni di ricordi, pensieri volanti, pagine con manciate di parole straniere, promesse e foto di sorrisi, frammenti istantanei di un viaggio di incontri e dentro di sé... e una bicicletta. Ma soprattutto: cosa fare di questa fedele compagna di viaggio? E la risposta è lì, lungo la scia di un'avventura che non vuole finire, che ci deve ancora portare lontano... partendo da lassù al Nord, dritti attraverso la pianura irrequieta, con negli occhi il nostro compagno da raggiungere, imponente e maestoso, antico e placido signore di queste terre tedesche: il Reno. Inizia il viaggio, inizia l'avventura, con tanta curiosità, un pizzico di sprovvedutezza, una via segnata dalle acque, pronti a risalirle per tornare in Italia. La nostra guida sono le nostre due biciclette, spinte dalla voglia di entrare dentro a questa terra, lasciando che i nostri occhi si aprano per lo stupore di un mondo in continuo cambiamento. In sella il vento lambisce forte te e i tuoi bagagli abbarbicati sul portapacchi, ma ti spinge anche, ti porta gli odori delle campagne attraversate, dei pascoli, delle panetterie. La strada si snoda e tu da semplice spettatore entri nell'esperienza travolgente e avvolgente, le mani che stringono forte il manubrio, i sapori di ogni fetta di torta, di ogni panino tedesco, di ogni bicchiere di vino dorato, i colori delle vigne verdi che ammantano le colline e quelli degli antichi muri intarsiati con legni variopinti. Scopriamo che viaggiare così non è semplicemente attraversare un posto, ma è viverlo davvero, scoprirlo nella sua essenza e bellezza più profonda, svelata dietro l'angolo, in fondo a un vicolo nel borgo più sconosciuto di tutta la contrada, oppure sulla soglia di una porta, dove anche quella notte abbiamo vissuto la meraviglia dell'accoglienza. E così il nostro viaggio non è più solo Dortmund, la Valle del Reno, l'Alsazia, la Foresta Nera, il passo del S. Gottardo, tutti i nostri progetti, le cartine, i luoghi tra il magico e l'impossibile che affollano il nostro diario... ma è soprattutto Nicholas e i croissant croccanti francesi dopo una notte nel suo garage con un topolino, Sabine e Klaus e l'incontro notturno con i cinghiali nel loro giardino, Doro e la sua Sachertorte, Matteo con una prelibata pastasciutta dopo esserci persi nella notte in un bosco paludoso, i pastori nella Foresta Nera e i doni di latte fresco marmellata e uova, gli abitanti di un'antica cittadella fortificata, un castello fiabesco sulle cime dei vigneti, una fattoria di mucche corridore gatti e altalene, persone dai nomi persi che ci offrono un pezzo di prato e ci regalano cetrioli del proprio orto. Finché davanti a noi ci sarà solo un’ultima salita, un’ultima fatica. E le parole di una canzone cantano con noi, giocano con la nostra emozione, con il ricordo dei nostri compagni di viaggio: “Quanti passi fatti assieme, allegria di una fatica. Ancor più meravigliosa perché… fatta con te”. - Luce del nord di Silvia Mazzocchin Chi l'avrebbe mai detto che, ormai abituati a girovagare con bicicletta o mezzi pubblici, ci saremmo trovati a guidare una macchina su questo suolo straniero? Chi mai avrebbe pensato di spingersi al Nord, in cerca di terre ancora più fredde e spazzate dai venti? O che da una risata e da una proposta audace avremmo davvero trovato il coraggio di partire, così, leggermente, dopo una battaglia a palle di neve nella notte, una fugace raccolta di beni di prima necessità e tante sciarpe con noi? E invece eravamo lì, stretti in una macchina, con il sole che per oggi aveva deciso di non comparire, ma solo di farci intravedere rarefatti fiocchi di neve e la strada nera già imbiancata... Fatima, impudente e frizzante galiziana. Serkan, turco enigmatico e ammiccante. Silvia, Davide e Gianluca, italiani incontrati per caso. Solo qualche settimana di vita da studenti in terre lontane ci aveva condotto fin lì, per quello che avevamo soprannominato “Il Viaggio verso San Pietroburgo”, tale era il freddo e le condizioni estreme della terra a cui ci avvicinavamo sempre più. E la nostra meta non era certo meno ambiziosa, guglie d'oro innalzate con scalinate verso il cielo, canali nella città colorati di barche, un quartiere folle, culla di nostalgici e forse di sognatori, le acque del Mare del Nord che lambiscono una piccola statua, e ovunque quella luce così particolare e unica dei cieli del Nord. Copenaghen ci aspettava così, e noi pazzi a volerla raggiungere proprio quando il sole lo puoi seguire solo guardando basso all'orizzonte, e presto scompare, nel freddo dei giorni più corti dell'inverno. Ma un viaggio non è solo la meta, è soprattutto la strada per raggiungerla. La strada che scorre fuori dal finestrino, intravista dai vetri ghiacciati per il vento gelido, mentre noi complici e divertiti ci stringiamo al caldo, curiosi di dove quest’auto ci porterà, di come ci unisce fisicamente e di come ci unirà, alla fine, e di cosa ci farà scoprire. Che ci accompagna in fugaci visite tra casette e musicanti di Brema, ci sospinge fin sulle rive dell'Elba, tra mercatini di Natale, odore di spezie, laghetti ghiacciati e gabbiani di Amburgo, ci conduce alla più magica delle città, la Lubecca dalla luce dall'incanto fatato come le tue mani e le tue ciglia gelate, e poi ancora più su, a Kiel porto di mare, sede di misteriosi ascensori dal moto sempiterno. È rifugio e ristoro quando la morsa del freddo ci impedisce di compiere anche solo un passo in più, ed è lei per prima, passato il confine, a portarci gli aspri suoni di una lingua sconosciuta. Ma ancora c'è strada prima che ci riporti a Dortmund, scherzi e risate nella stretta vicinanza, un diario a cinque voci, 2000 km, scontri con il felice popolo danese, pupazzi di neve e arditi attraversamenti sul ghiaccio, e qualcosa che per sempre si forgia attorno a noi, ci unisce, insieme ad altro che, con il freddo che porta a stringersi, un parco candido e due sguardi che si incontrano, porterà ancora più lontano. - Viaggio intorno a me stessa di Simona Gianoni Tbilisi - Georgia marzo 2013: La testa appoggiata al finestrino, mentre osservo l’affascinante e misteriosa Tbilisi. Il moderno e l’antico si fondono, le luci e la notte la rendono magica. È notte e con altri trenta ragazzi di tutto il mondo siamo seduti su un bus sgangherato diretto a Bakuriani. È mattina, siamo arrivati. Le vette del Caucaso intorno a noi sono cosparse con poca neve timida e osservo il contrasto fra gli hotel turistici e le casette dei contadini. Frammenti di immagini, cani abbandonati, volti, cibo e musica georgiana. Ho assistito a un ballo tipico georgiano e me ne sono innamorata. Il ritmo, la forza e l’energia dei ballerini. Ho ballato con i miei amici tutte le sere, persone con cui ho stretto un legame in soli dieci giorni. Sono attratta da una bellissima melodia che proviene dal piano suonato da una ragazzina nella scuola. Abbracci e balli di gruppo con i bambini. Era il mio primo scambio interculturale e tutto ciò che mi circondava, era nuovo. Un microcosmo di persone non divise da confini. Una mattina appena sveglia guardo dalla finestra, è tutto completamente bianco, nevica. Almelo-Olanda agosto 2013: Papere che scorazzano nell’erba e altalene. Mi trovo in un centro richiedenti asilo e per due settimane sarò l’animatrice di piccoli monelli dai 2 ai 10 anni di età. Mi vesto colorata, mi sembra di esser tornata bambina. Gioco con la sabbia, con il pongo, con i pennarelli e con la fantasia. I bambini mi riempiono di abbracci e di risate, i loro sguardi ormai fanno parte di me. Sono invitata, insieme ad altri volontari, a cena da una famiglia curda e i sorrisi, i ringraziamenti e le foto in bianco e nero che la signora ci mostra ci fanno passare una serata indimenticabile. Ultimo giorno, una grande festa, una grande partita di calcio. Siriani, afghani, iracheni, somali, albanesi, eritrei insieme a giocare una semplice partita di calcio. 1 gennaio 2013 Italia: Devo dare l’addio a una persona che mi ha insegnato la forza di vivere e reagire. Cresco in un colpo, la vita vola via, ma gli insegnamenti restano. Avevo necessità di partire, di viaggiare intorno al mondo, e soprattutto dentro me stessa. Georgia, Romania, Polonia, Spagna e Olanda nel giro di pochi mesi. Dodici aerei presi. Nessuna paura di volare, ma pace interiore in mezzo alle nuvole filtrate dai raggi del sole. 22 settembre 2013 Italia: Mi chiamo Ponf, sono il clown Ponf. Ho il naso rosso e due codine. Ponf cade, ma si rialza sempre. Sono diventata un clown di corsia per gli ospedali, le carceri e le case di riposo. È iniziato un altro viaggio, che mi cambierà sicuramente la vita. - Parola d’ordine di Simona Italiano Partire. Questa era la parola d’ordine. In sette giorni ho deciso; tanti quanti quelli impiegati dai miei datori di lavoro per licenziarmi. Il mio primo lunedì da disoccupata l’ho trascorso a cercare offerte per voli internazionali. La meta non era importante, ciò che contava era partire. Partire lontano dall’Italia, che bloccava la mia capacità di sognare, quella che a vent’anni nessuno deve negarti. Trovai il mio volo, quello adatto a una ventiquattrenne italiana, disoccupata e con un lavoro precario alle spalle. Milano - Melbourne 900 euro. Il prezzo per due mesi dedicati a me stessa. Affascinante, multiculturale, provocante: Melbourne l’ho amata per la sua capacità di creare FUTURO. Quello vero, quello che ti fa sentire parte del mondo. Un mondo in cui il nero si accosta al bianco, a volte si mescolano, creando tonalità stupende. Un futuro in cui l”’altro “non fa così tanta paura. Diventa arricchimento e scoperta. I giovani a Melbourne hanno ancora la voglia di comprendere. Avevo tanto bisogno di comprendere, lontano da una crisi economica che lacera la mente, da un lavoro che toglie la possibilità di pensare a un futuro. Il caffè in Australia è stato un ottimo compagno di viaggio; non è un semplice ordinare. Impari la bellezza di fare conversazione, di interessarti all’altro anche se sai che non lo rivedrai ma più. Non so il motivo preciso, ma in un bar, il cameriere chiede sempre “Hi, how are you?”. Sarà per gentilezza? O dovere? Non so, ma da li, iniziavano sempre lunghe conversazioni. Se poi, per tua fortuna ti trovi in Lygon street, la via “degli Italiani”, come un flash, vengono in mente i libri di storia, quelli con le immagini in bianco e nero in cui uomini e donne, apparentemente più grandi dell’età che hanno, si mettono in posa, per quella foto d’addio, che sarà l’ultimo ricordo della loro terra. Poi, in Lygon street, osservi il tuo interlocutore, e ti accorgi che ha la tua età, ti mostra le foto sul suo I-phone della sua città, degli amici e parenti. Non più navi e mani tese a salutare quel familiare che non rivedrai per molto tempo. Siamo nel 2013 e questa è un’altra storia, un’altra storia d’Italia, un’altra immigrazione. E così, nel mio lungo viaggio, giovani camerieri, commessi, cuochi, sono stati i miei maestri; sembrava volersi bene fin da subito, pur non conoscendosi. Eravamo italiani. Questo bastava. E com’era bello essere italiani in Australia: il nostro passato diventava eroico e quasi leggendario. Ho amato l’Australia per la sua capacità di far pensare e sognare. Puoi farlo in un bar affollato in centro, al Victoria Market, al quartiere Ebreo, Africano, Italiano, Tedesco, Irlandese, Thailandese, Cinese ecc.. puoi farlo ovunque, perché ogni strada racconta di un pezzo di mondo. È un po’ come vivere contemporaneamente in tutti i continenti. Il luogo però, in cui mi sono più persa, in cui i miei pensieri erano ancora più liberi, è stato vicino al mare, all’oceano Australiano, dove rocce imponenti cadono in acque impazienti di avvolgerle con la loro potenza. Tutto ancora così stupendamente naturale e rispettato. Da togliere il respiro. Ho amato quell’apnea, quella sensazione si infinito, di grandezza. Non mi sono sentita piccola, anzi.. mi sono sentita parte di quella natura. Ho capito di fronte a quei paesaggi, che se ritroviamo noi stessi, non potremmo mai sentirci troppo piccoli di fronte a nulla. Se rispettiamo i luoghi in cui camminiamo, in cui viviamo, essi rispetteranno noi. Ho conosciuto l’armonia con la natura e con le persone. Ho capito che un viaggio non è solo un semplice “partire”. È incontro, speranza, conoscenza. La mia parola d’ordine ora si è trasformata in “libertà”. Ho voglia di sentirmi libera, come davanti al mare.. Ho voglia di avere un lavoro che non sia una gabbia, ma la libertà per creare il mio futuro. Ho voglia di vivere nel mio paese, per essere libera di stare con i miei cari. Ho voglia di cambiare questa triste storia d’Italia, per essere libera di sognare anche qui. Ho voglia di conoscere il mondo, e tutti i commessi, camerieri, baristi che ne fanno parte, per essere libera di sapere la storia di chi ha deciso di andarsene. Ho voglia di conoscere il mondo, per essere libera di sapere. - Polvere dorata Sonia Pizzurro Se state leggendo, vuol dire che questa storia di viaggio valeva la pena di essere raccontata, nero su bianco. Sono donna e cristiana e peccatrice sì, di innocue bugie bianche per lo più. Grazie a Dio. Per 312 ore pellegrina. Non per redimermi dai peccati anche se, errando di luogo in luogo, la preghiera stringe a braccetto i pensieri ma per trovare una risposta a delle inquietudini esistenziali. Ed è all’ingresso della “Via Crucis”, un sentiero tortuoso abitato da croci fatte a mano con rami di rovo, che inizia questa storia che non è la mia storia ma quella di doña Navar. Un cognome che ricorda Pamplona e la corsa dei tori non certo il Texas, patria di questa donna dai natali messicani. Ci siamo incontrate nella tappa del Cammino di Santiago che da El Ganso porta a Rabanal del Camino. Ci siamo attese, abbracciate, confidate e consolate. Abbiamo camminato stanche e divertite fino ad una cerveza dal gusto fresco di champagne e ad un bocadillo dal sapore di banchetto nuziale. Da dove iniziare il racconto? Dal volto direi, che più della lingua inglese o spagnola, meglio esprime il mutare del cuore e gli affanni del corpo. Un viso un po’ troppo tondo, indice di un appetito voluttuoso per Burritos, Chili, Fajitas. Capelli corti nascosti da un cappellino a visiera. Un sorriso contagioso e due occhi comunicativi segnati da piccole rughe a raggiera. Chissà cosa leggerebbe Marguerite de Surany in quei segni espressivi e nelle piegoline che le incorniciavano le orecchie. Io vi ho visto tutte le emozioni di una donna dalle grandi emozioni. Indossava calzoni corti e scarpe alte da trekking che nascondevano piedi callosi e dolenti e lasciavano intravedere i polpacci colorati dal sole e da macchie bluastre, segno di una cattiva circolazione per il peso eccessivo sulle spalle. Perché questo lungo viaggio dagli States senza confort e con scarso bagaglio? Per la nostalgia di un figlio trasferitosi in un college californiano. Per alleggerire la sua figura appesantita dai chili di troppo. Per il desiderio di trovare un nuovo lavoro, ora che quello promesso a Las Vegas si è dissolto come il Samsara. Per dare la desiderata sepoltura all’amato fratello. Questa storia di vita si intreccia ora con un’altra storia, di vita e di morte. Quella di Pedro. Brillante medico cinquantenne amante dello sport, della vita all’aria aperta, delle escursioni in mountain bike. Fu nello Utah che, raggiunto il picco del monte Paraiso, egli si addormentò per sempre scendendo dalla sua Grisly. Se chiudo gli occhi, vedo l’immagine di un lui che non conosco, con la luce del tramonto intrappolata fra i capelli e l’ombra di un sorriso rimasta sul volto. Le sue ceneri erano state raccolte in un semplice sacchetto di plastica trasparente che, volando sull’oceano, erano giunte in Spagna. L’ultimo volo di Pedro per trovare dimora in un paesaggio spettacolare. Ogni pochi chilometri si incontravano recinti di bovini, ovini, equini che cedevano il passo ai punti di ristoro dei pellegrini. Qui, al riparo di eucalipti cinguettanti, io e Navar ci sedevano nel silenzio delle nostre parole e nel gorgoglio delle nostre risate. E’ proprio vero. Camminando ogni giorno si raggiunge un vero stato di benessere e non vi è pensiero così gravoso che, per pochi magici attimi, non possa essere lasciato alle spalle. Passo dopo passo e dopo fatica, dolore, sudore ecco primeggiare davanti a noi il punto più elevato del cammino giacobeo; 1500 metri di altitudine. Sul picco del monte Irago si respirava un’aria limpida e pungente. Lo sguardo sfiorava l’infinito. Qui, ai piedi della Cruz de Hierro (Croce di Ferro), un emblematicamente semplice palo di legno con una piccola croce di ferro in cima, le mani aggraziate di Navar hanno aperto il sacchetto. Mille granelli di polvere, dorata dai primi raggi del sole, sono rimasti sospesi nel pulviscolo atmosferico per poi depositarsi ai piedi della croce. Immedesimandomi in quel senso di perdita, i miei occhi non sono riusciti a trattenere le lacrime. Il nodo che avevo in gola si è sciolto in una preghiera sussurrata al vento, nella consapevolezza che ciò che ho visto è ciò che siamo. Granelli di sabbia illuminati dalla scintilla divina. 30.10.2013 - Via degli dei racconto di Stefania Muzzarelli Ci sono alcune esperienze che la vita te la cambiano e si può proprio dire che la nostra avventura sia stata una di quelle: abbiamo trascorso quattro giorni intensi e totalizzanti lungo la Via degli Dei, durante la quale abbiamo percorso a piedi circa 120 km da Bologna a Firenze vivendo in armonia con la natura, lontani dal tram tram, dalle regole e dai percorsi prestabiliti della quotidianità. Abbiamo passato momenti difficilissimi affrontando imprevedibili ed avverse condizioni meteo sempre a testa alta, con coraggio e determinazione prendendo spesso decisioni meno comode rispetto ad altre, sempre insieme, uniti, con un sorriso costante sulle labbra, quel sorriso sincero, vivo, spontaneo, capace di trasformare i momenti bui in luce. Ore e ore di cammino passate in condizioni pessime, stremati, infreddoliti, indeboliti lungo sentieri fangosi simili a paludi, deviazioni improvvise e allungamenti di percorso. Ci siamo anche persi alcune volte ma siamo sempre riusciti in qualche modo a ritrovare la nostra via. Perdersi e ritrovarsi, il bello di questa esperienza è stato anche questo, il distaccarsi completamente dai ritmi della quotidianità per affrontare la natura con la sola forza delle proprie gambe, della propria testa e del proprio cuore: le gambe possono cedere, la mente pure, ma quando si affrontano le esperienze con il cuore inteso come entusiasmo, passione, amore per la natura, per se stessi, per la vita, per il mondo che ci circonda, allora si può arrivare ovunque. Firenze è stata solo la meta reale del viaggio, perché i traguardi più importanti sono stati raggiunti dentro noi stessi. Il triste e destabilizzante rientro alla realtà ci ha fatto rendere ancora più conto di quanta superficialità, egoismo e banalità circolino nella società che ci circonda e da lì l'irrefrenabile voglia di fuggire di nuovo per viverci quel mondo che per alcuni giorni è stato un po' nostro e che ci ha donato tanto, di tornare a godere del piacere delle piccole cose come il diminuire della pioggia, l'intravedere un debole raggio di sole oltre le nuvole, il potersi sedere anche solo pochi minuti per una breve sosta e per poter annusare il profumo della natura. Molto spesso i programmi sono fatti per non essere rispettati, così nel cammino della Via degli Dei come nel più complicato e lungo cammino della vita durante il quale gli imprevisti, le difficoltà, le deviazioni di percorso non vengono mai a mancare ma in cui non bisogna mai perdere la forza di andare avanti con determinazione, coraggio, con la curiosità di un bambino, la voglia di gioire e godere di ogni attimo, a volte senza troppi calcoli seguire il proprio istinto, le proprie passioni, pensare a quanto splendida sia la vita e a quanto dobbiamo fare tesoro di tutto ciò che ci accade. La Via degli Dei non ha fatto che accrescere quello che già siamo, le nostre idee, la nostra energia nei confronti del mondo e del prossimo. Perché come diceva Mahatma Gandhi "La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”... - In Sri Lanka con Michael di Stefano Casacca A volte l'austerity apre nuove strade. Le rupie stanno finendo: bisogna arrangiarsi. Sulla strada per Tangalle, al bordo della carreggiata, c'è la tenda di Michael. Professione fruttivendolo. La fermata del bus è vicina: passo di lì una sera, quella dopo, ora siamo amici. Ancora devo arrivare e già vedo Michael – ragazzo con la risata contagiosa e il corpo da fantino – saltare agile tra le cassette, afferrando questo e quel frutto. Accomodato su una sedia di plastica, io più che comprare assaggio e mi formo un’opinione in tema. Cocchi, banane ma anche durioni, graviole, rambutan, guave, mangostani. "Prova questa maracuja", dice. "A Weligama fanno schifo e le pagheresti il doppio". È buonissima: ne mangio altre due. Un capitolo a parte meritano le banane. La prima sera proprio quelle volevo: "I get two bananas". No, troppo vago. Come se entrassi da un salumiere a Milano e dicessi "vorrei del cibo". Qui ci sono red banana, a buccia rossa. Lemon banana. Yogurt banana. Michael me lo spiega, poi mi lancia una milk banana, la varietà più apprezzata, e io l’afferro mentre – con la coda dell'occhio – ammiro delle giant banana dalla dura scorza verde, lunghe quanto il mio avambraccio. Poi è la volta della honey banana, un nome che al massimo avrei pensato potesse essere lo pseudonimo di una pornostar asiatica. Tra questi frutti dall'odore carico di umidità tropicali hanno sede le mie cene low-budget, e non è un brutto modo di mangiare né di trascorrere il tempo. Un papà smonta dal motorino, fa scendere la bimba e compra una fetta di durione, zucca ipertrofica e spinosa. Passano donne, monaci. E poi, siccome siamo due maschi seduti a osservare la strada, lanciamo commenti su tutte le ragazze. Michael lo fa da sbruffone, finché non passa Nulani, la favorita. Lei passa tutte le sere alle otto con un bel vestito rosso, l'ombrello come un vezzo visto che non c'è sole né pioggia, a braccetto con un tizio che porta baffetti curati per apparire più grande. Nulani non volge mai lo sguardo verso la tenda. Michael dice che va con quello solo per i soldi, di certo non s’accompagnerebbe a un fruttivendolo. Intimidito, nascosto dietro un cespo di giant banana, un coltellaccio sinistramente conficcato nel fusto verde, Michael con quel viso scuro e gli occhi come opali sembra un vietcong nella boscaglia. La ragazza non è bellissima ma, si sa, anche a queste latitudini la cosa che si desidera di più è quella che non si può ottenere. Due minuti dopo che Nulani è passata, però, il suo profumo torna ad essere soverchiato da quello della frutta: "Steven, mango bianco?" E giù a tagliare la polpa a striscioline. Vorrei suggerirgli di offrirle un frutto, una sera. È un'idea stupida. Però lui ha così tanta passione per ciò che vende (mangia continuamente frutta, dovrebbe odiarla dopo quattordici ore di lavoro) e per lei, quindi... Le serate finiscono sempre allo stesso modo: "Michael, vado. Quanto ti devo?" "Non so. A dire la verità, amico mio, non mi ricordo più cos'hai mangiato". - Incontro di Stefano Casacca Il villaggio è un saliscendi di sterrati strettissimi, tra case imbiancate a calce e composte di un solo ambiente dove s’affolla la famiglia: logico trascorrere la giornata all’aperto. Le donne, dall’uscio, osservano con i bambini in braccio, alcune capre dal pelo nero e setoloso vagano indisturbate. Il villaggio è attraversato da una strada asfaltata lungo la quale proliferano commerci di ogni sorta. Vedo uomini preparare fritture e dolci in padelle ampie come la ruota di un trattore. Fisso la porta scardinata di un’abitazione come tante. Un uomo e una donna c’invitano con un gesto. Il sole scotta con crudeltà perpendicolare: sognando un po’ di frescura, tolgo i sandali ed entro con Laura. Magri e silenziosi, i due non parlano inglese, in cambio sorridono. La donna va sul retro e, curva, immerge un mestolo in una cisterna. Ci allunga due bicchieri d’acqua cerimoniosamente, innescando il dilemma del viaggiatore in qualità di ospite: bevo? Laura non se la sente: non la biasimo, le carezzo la spalla per rincuorarla. Io butto giù mezzo bicchiere. L’acqua è fresca, il suo aspetto nebbioso rinfranca molto meno. Rischio il colera? Rischio di rendere felice chi ha aperto le porte della sua abitazione? Conosco l’unica risposta ad entrambe le domande. Orgoglioso d’avere accettato, mi sento nella posizione di rifiutare l’offerta successiva: un bicchiere di latte appena munto, denso di crema grassa che galleggia. Declino l’offerta, però me ne vergogno subito. La casa non è ammobiliata, i pochi oggetti spuntano da nicchie. Dal muro penzolano fili che terminano dopo alcuni centimetri, tristi come zampe di un insetto stecchito. Un cono di luce giunge da fuori e spezza la penombra della stanza, irradiandosi su una stuoia adagiata sul pavimento dell’uscio: vi asciugano sassolini giallo ocra accanto ad altri, più numerosi, color frumento. Servono per decorazioni e tinture: il lavoro di tanti abitanti del villaggio. Marito e moglie capiscono che vorrei fotografarli. In un angolo della stanza, periferici come il loro villaggio, si mettono in posa. Nel suo sari rosso la donna è disinvolta; l’uomo invece, vestito all’occidentale con pantaloni di fustagno e camicia a due tasche, chiede tempo con un gesto. Stira i vestiti con il palmo aperto: tiene al fatto di non apparire in una fotografia, lui povero, con indumenti gualciti. Arriccia le punte dei baffi con le dita. È pronto: rigido come un soldato, mani tese lungo i fianchi, spalle dritte, un volto fiero sulla cui pelle scura s’inseriscono due occhi lucidi come perle nere. L’uomo, non abituato alle fotografie, per errore guarda altrove. Mentalmente sgrano i chilometri che, da casa, ci hanno portato su queste strade d’India. Perché noi quattro in questa stanza? Nello spazio di un respiro inquadro e scatto: una foto soltanto, fuori fuoco per giunta, la più bella del viaggio. - Quiero donar ropa di Stefano Casacca Antigua è una delle città più belle del Guatemala. Tre vulcani – Volcán de Agua, Volcán de Fuego, Acatenango – la vegliano da lontano con le loro costanti fumarole. Per le vie del centro passeggiano studenti e turisti, osservando l’architettura barocca, le chiese spagnole, sfiorando muri di case basse e colorate e oltrepassando posadas dai giardini verdissimi e riposanti. Solo una quarantina di chilometri separa Antigua da una delle metropoli più pericolose del mondo: la capitale Guatemala City. Che, oltre alla densità criminale, sconta il fatto di essere un orrore urbanistico. Gli stessi abitanti, nel fine settimana, l’abbandonano per raggiungere Antigua. Così pure facciamo io e i miei amici: meno di un’ora d’auto e ci siamo. A breve il viaggio americano finirà: ci dispiace. Non so se a fin di bene, o per dar concretezza al desiderio di lasciare qui una parte di noi, decidiamo di regalare quasi tutti i nostri vestiti. Magliette, pantaloncini, sandali, quello che c’è. Custoditi in sacchetti di plastica, li portiamo alla chiesa di Nuestra Señora de la Merced. È una giornata di sole pieno, e il canto degli uccelli rende piacevole la passeggiata. Nell’ufficio amministrativo della parrocchia, fresche mura bianche avvolte dal silenzio, c’è una donna corpulenta e diffidente, seduta alla scrivania. Un cancelletto chiuso a chiave protegge l’ufficio e ci separa, neanche fossimo nel caveau di una banca. “Quiero donar ropa”, dico in spagnolo afferrando le sbarre. E sperando si capisca. La signora è a tre metri da me, però urlo: il ferro arrugginito che ci divide mi fa temere d’essere inascoltato prima ancora di parlare. E invece, strano potere dell’ignoranza delle lingue, degli accenti sbagliati, improvvisamente appaio inoffensivo – che in Guatemala è già qualcosa – e l’impiegata si distende in un sorriso. Infila la chiave nella serratura del cancelletto, due giri secchi e rumorosi, apre e mi offre la mano. Quella che ci scambiamo non è una stretta formale: ha anima e cordialità, la donna sembra attendermi, o forse è solo sollevata. Entrando, m’accorgo della presenza di un secondo impiegato. Le cose che porto, ben accette, finiscono in un grosso contenitore di plastica dove altri vestiti attendono successivi proprietari. “Li donate ai pobres, vero?”, domando. Ora sono io quello dubbioso. “Beh, più che altro ci occupiamo di carcerati”, chiarisce lei. Bene. Più tardi, la chiesa alle spalle, ricorderò come tra le magliette che ho lasciato ce ne sia una verde che sul petto reca la scritta, a caratteri fumettosi, “Do the right thing!”, fà la cosa giusta. La indosserà un carcerato: moralismo involontario. Purtroppo quale sia la cosa giusta da fare, a questa come ad altre latitudini, la t-shirt lo tace. - Odissea nel Mediterraneo di Stefano Grosso La passione per i viaggi mi aveva portato a visitare alcune città costiere della regione di Maresme, vicino a Barcellona in Spagna. Dopo 6 giorni di intenso lavoro, svaghi, serate fuori e visite culturali, la mattina di giovedì 10 ottobre riparto dall'albergo con meta l'aeroporto di Barcellona El Prat. Arrivo con due ore di anticipo ed effettuato il check-in decido di mangiare un boccone controllando di tanto in tanto il pannello delle partenze. Sono le ore 13.05. Dopo un po' di tempo noto che è stato cancellato un volo, direzione Bologna, ed altri sono in ritardo di un'ora. Anche io devo rientrare in Italia, ma a Torino. Il mio volo sembra in orario. Quando mancano 30 minuti all'imbarco mi dirigo verso il gate, dove c'è una coda non indifferente. “Siamo tutti italiani, è evidente” penso. Ascoltando un po' di discorsi capisco che il volo di Bologna è stato dirottato sul mio aereo, e subito intuisco che qualcosa non va, siamo in troppi, non ci saremmo mai stati tutti. Cinque minuti prima dell'imbarco il volo scompare, tre minuti più tardi il fatidico annuncio: “Il volo FR 9111 da Barcellona per Torino è stato cancellato”. E' qui che ha inizio l'odissea mediterranea. La coda si disperde in un attimo, diretti chissà dove. I pochi tenaci si avvicinano agli addetti all'imbarco (forse con la speranza di salire ugualmente) dove steward sorridenti spiegano gentilmente che a causa di uno sciopero dei controllori di volo francesi, anche il nostro volo è stato cancellato. Un gruppo di ragazzi italiani della mia età si trova nella mia stessa identica situazione. Anche loro avevano impegni per la serata in Italia, anche loro dovranno comunicare che per colpa di uno sciopero il volo era stato cancellato e che non avrebbero avuto alcuna possibilità di rientrare in Italia in giornata. Mi aggrego al gruppo, non so che altro fare. Ci è stato detto di chiedere allo sportello eventuali soluzioni, e in quel gruppo c'è una ragazza che parla molto bene lo spagnolo, fondamentale in queste situazioni. Mentre si è, nuovamente, in coda per poter parlare con un addetto si vagliano altre soluzioni. Volare diventava impossibile, gli altri voli per l'Italia sono stati cancellati e prenotare un volo il giorno seguente non si poteva prendere in considerazione. I treni avrebbero effettuato circa 5 cambi, e prevedevano il passaggio da Parigi e, come i pullman, ci avrebbero impiegato circa 26 ore. Si vocifera di una nave in partenza da Barcellona per Civitavecchia, sembra quasi ridicolo che io, che devo andare a Torino, debba prendere una nave per Civitavecchia. La soluzione della compagnia aerea era quella di dirottarci su altre destinazioni e poi farci rientrare il giorno seguente, forse, perché lo sciopero poteva durare anche due giorni e, sempre forse, il primo volo lo garantivano nella giornata di sabato. E' allora che una compagnia di 12 ragazzi parte con la speranza di trovare una nave che li riporti in Italia. Dopo tre ore perse in aeroporto, ed un'altra ora persa nel tragitto dall'aeroporto al porto, arriviamo alla biglietteria del traghetto, sette minuti dopo che chiudessero le prenotazioni. Sono le ore 19.37 di giovedì, e con estrema gentilezza spieghiamo il problema e ci viene concesso l'imbarco (In Italia non sarebbe mai potuto succedere). Saliamo a bordo, consapevoli che saremmo dovuti rimanerci per venti ore. Siamo senza rete cellulare ed ovviamente senza internet. Sarà così per tutte e ventuno le ore del viaggio, ma un'ora prima di attraccare la connessione riprende a funzionare in quanto vicini alla terraferma. Sono le 19.15 di venerdì sera. Consapevoli che ci saremmo dovuti dividere controlliamo gli orari dei treni e scopriamo che non ce ne sarebbero stati, almeno nella serata, in grado di ricondurci a casa. Mi viene in mente BlaBlaCar, il sito di car sharing. Mi era capitato più volte di consultarlo, ma forse per timore non avevo mai provato. Io sono l'unico a dover andare in direzione nord, verso la Liguria, quindi avrei anche affrontato l'ultima parte del viaggio da solo. Contro ogni mia aspettativa trovo un ragazzo che partiva alle 18 da Roma, in direzione Genova. Per me era perfetto. Un po' emozionato lo contatto telefonicamente. La prima volta non risponde. Il secondo tentativo è quello buono, mi comunica che stava partendo ma che purtroppo era già pieno. Gli spiego la situazione, e lui molto gentilmente mi dice che se fossi riuscito a trovare il modo di arrivare a Grosseto, lì avrebbe lasciato due ragazzi che viaggiavano con lui e avrebbe potuto prendermi. Attacco e controllo i treni, ce n'è ancora uno che finisce la corsa proprio a Grosseto, è l'ultimo della serata. Richiamo Marco (nome di fantasia) e gli comunico che sarei arrivato a Grosseto circa 20 minuti dopo di lui. Lui gentilmente mi spiega che aveva trovato traffico ad uscire da Roma e che si sarebbe fermato a far cena durante il tragitto. Ci diamo appuntamento alle 20.40 fuori dalla stazione di Grosseto, il tutto telefonicamente, senza conoscerci, senza alcuna certezza. Saluto i miei fantastici compagni di viaggio, quasi 24 ore insieme attraverso mezza Europa, via mare, solo con la voglia di tornare a casa. Eravamo Italiani e ci siamo adattati come ben pochi al giorno d'oggi sarebbero riusciti a fare. Il viaggio in treno in solitaria è durato un'ora. Fuori tutto è buio e la carrozza è completamente deserta. Arrivo a Grosseto imbrocco l'uscita e chiamo Marco. “Siamo appena arrivati, sei tu quello?” mi chiede. Ed ecco Marco, che viaggiava in compagnia di due ragazzi stranieri, e che ha appena lasciato in un agriturismo due ragazzi tedeschi. Erano partiti tutti da Roma, tutti con lui e tutti grazie a BlaBlaCar. Fatte le presentazioni di rito si riparte, musica bassa, i ragazzi che parlano tra loro dietro, e una chiacchierata semplice, essenziale per fare conoscenza. Lui viaggia per lavoro, fa spesso questa tratta e quando riesce cerca di diminuire i costi offrendo un passaggio. Si mette a ridere quando gli dico che mi ha salvato la vita. Forse non si rende conto, ma se non ci fosse stato lui, l'aspettativa era quella di una notte passata a dormire su una panchina in una stazione ferroviaria. E le temperature non erano quelle miti ed accoglienti di Barcellona. Il viaggio prosegue senza intoppi, senza soste. Per gentilezza mi offro di guidare nel caso fosse sopraggiunta stanchezza, ma Marco mi dice che era abituato e che non sarebbe stato un problema. Arriviamo a Genova alle 00.50. Scendo anche io a Piazza Principe, per non pesare oltre a Marco, che sarebbe ancora dovuto tornare indietro un pezzo. Ognuno paga la sua tratta, che è comunque inferiore ad un biglietto ferroviario. Ci si saluta e qui le strade si dividono. Ho condiviso un pezzo di strada con uno sconosciuto, che dopo il viaggio sconosciuto più non era. Appena arrivo a casa lascio il feedback del viaggio, ovviamente a cinque stelle. Il giorno dopo ricevo quello di Marco anche il suo con il massimo delle stelle. Ospitato una notte a Genova rientro il mattino dopo a casa mia. I miei compagni di viaggio, invece, sono arrivati sani e salvi a casa verso l'ora di pranzo. Verrò poi a sapere che i passeggeri che avevano accettato di essere dirottati, dalla compagnia aerea verso altre mete, non sarebbero rientrati nemmeno la giornata di sabato, ma solamente di domenica. Finisce qui questo viaggio, che in realtà è l'inizio di un'altra storia. Quello era il mio primo viaggio in car sharing. Dopo questa esperienza ho iniziato ad offrire passaggi durante i miei viaggi di lavoro ed ogni volta che devo prendere un treno controllo prima di tutto BlaBlaCar. Ho conosciuto un signore della mia città che, come me, viaggia parecchio per lavoro ed abbiamo già viaggiato due volte insieme. Così i miei viaggi sono meno noiosi, conosco nuove persone e risparmio qualcosa. Anche questo è BlaBlaCar! - Angeles di Stefano Nicoletti Il motore quattromila della nostra Cadillac Seville si spense davanti al Motel con la leggerezza di un sospiro di sollievo. Dopo aver accarezzato la costa sibillina amata dagli hippies, le campagne punteggiate di frutti accesi, i pascoli infiniti e il deserto rosso del Nevada, quell'auto che sentivo amica si meritava riposo. Che gruppo bizzarro, avresti pensato vedendoci scendere. Tre donne adulte che avresti detto amiche, di età diverse: mia sorella Silvia, nostra cugina Antonella, sua cognata Valeria. E poi io: sedicenne sbarbatello con bandana, uscito di casa solo per qualche gita parrocchiale, incredibilmente grato per esser lì e quindi osservatore maniacale di tutto. Dettagli, che oggi si aprono a fiore mentre una macchia di dolore si spande al ricordo di qualcuno che lì c'era e felice, ma ora non più. Dal parcheggio, lo scorcio di vegetazione eterna del Sequoia National Park ci faceva sentire passeggeri come polvere, eppure sereni. Tra di noi, l'atmosfera era una miscela di stanchezza per la strada percorsa ed eccitazione per quella che rimaneva. Ci assegnarono uno stanzone da quattro in uno chalet di legno odoroso. Mentre le alte ombre della foresta scacciavano la luce del giorno, cenammo in allegria con i panini comprati per strada in un bar stile anni cinquanta con un ingrato menu italiano. Antonella provò il letto e non lo trovò affatto adatto alla sua mole. “Ma sono talmente stanca che dormirei per terra” “Basta che non russi... ” chiosò Silvia. “Io non russo... ma se russo mi sveglio da sola” Valeria, sua abituale compagna di stanza doppia, fece capire di avere qualcosa da ridire. Silvia e Antonella continuarono per un po' l'allegro battibecco sul tema, poi giocammo a carte, infine accesi la TV. Come prevedibile, di lì a poco ebbe inizio il concerto di ronfi di Antonella. “Stanotte la vedo dura... ” confessai. “Io la sveglio” “Magari smette” “Quando spegniamo la TV, io la sveglio” D'un tratto, di colpo, un ronfo di Antonella raggiunse un picco di decibel da Boeing 747, lei si scosse, si alzò sui gomiti ed aprì gli occhi. Biascicò con voce impastata: “Visto? Mi sono svegliata da sola” e poi perse di nuovo conoscenza. Mi venne sete e stappai una Cherry Cola, ma al secondo sorso decisi che l'acqua del rubinetto del bagno poteva andar più che bene. Crollarono anche Valeria e Silvia e anch'io mi buttai a letto, implorandomi di dormire. Solo allora mi accorsi che il frigorifero era silenzioso come la friggitrice di un Kentucky Fried Chicken. Avvolto in uno scomodo dormiveglia, minuti o ore dopo vidi Antonella alzarsi, percorrere pochi passi decisi e assestare al frigo un cazzottone che rimbombò come un tuono e svegliò tutti. “Ora si può dormire”. La mattina successiva ci accolse un sole caldo che sfiorava piano le finestre. Fuori c'erano sfumature di verde che mai avrei creduto di poter mettere insieme in un'unica vista. La grande, eterna foresta ci chiamava. Cominciava un altro giorno, altra stanchezza da buttarsi sulle spalle per crescere ancora un po'. Il motore quattromila della nostra Cadillac Seville si spense davanti al Motel con la leggerezza di un sospiro di sollievo. Dopo aver accarezzato la costa sibillina amata dagli hippies, le campagne punteggiate di frutti accesi, i pascoli infiniti e il deserto rosso del Nevada, quell'auto che sentivo amica si meritava riposo. Che gruppo bizzarro, avresti pensato vedendoci scendere. Tre donne adulte che avresti detto amiche, di età diverse: mia sorella Silvia, nostra cugina Antonella, sua cognata Valeria. E poi io: sedicenne sbarbatello con bandana, uscito di casa solo per qualche gita parrocchiale, incredibilmente grato per esser lì e quindi osservatore maniacale di tutto. Dettagli, che oggi si aprono a fiore mentre una macchia di dolore si spande al ricordo di qualcuno che lì c'era e felice, ma ora non più. Dal parcheggio, lo scorcio di vegetazione eterna del Sequoia National Park ci faceva sentire passeggeri come polvere, eppure sereni. Tra di noi, l'atmosfera era una miscela di stanchezza per la strada percorsa ed eccitazione per quella che rimaneva. Ci assegnarono uno stanzone da quattro in uno chalet di legno odoroso. Mentre le alte ombre della foresta scacciavano la luce del giorno, cenammo in allegria con i panini comprati per strada in un bar stile anni cinquanta con un ingrato menu italiano. Antonella provò il letto e non lo trovò affatto adatto alla sua mole. “Ma sono talmente stanca che dormirei per terra” “Basta che non russi... ” chiosò Silvia. “Io non russo... ma se russo mi sveglio da sola” Valeria, sua abituale compagna di stanza doppia, fece capire di avere qualcosa da ridire. Silvia e Antonella continuarono per un po' l'allegro battibecco sul tema, poi giocammo a carte, infine accesi la TV. Come prevedibile, di lì a poco ebbe inizio il concerto di ronfi di Antonella. “Stanotte la vedo dura... ” confessai. “Io la sveglio” “Magari smette” “Quando spegniamo la TV, io la sveglio” D'un tratto, di colpo, un ronfo di Antonella raggiunse un picco di decibel da Boeing 747, lei si scosse, si alzò sui gomiti ed aprì gli occhi. Biascicò con voce impastata: “Visto? Mi sono svegliata da sola” e poi perse di nuovo conoscenza. Mi venne sete e stappai una Cherry Cola, ma al secondo sorso decisi che l'acqua del rubinetto del bagno poteva andar più che bene. Crollarono anche Valeria e Silvia e anch'io mi buttai a letto, implorandomi di dormire. Solo allora mi accorsi che il frigorifero era silenzioso come la friggitrice di un Kentucky Fried Chicken. Avvolto in uno scomodo dormiveglia, minuti o ore dopo vidi Antonella alzarsi, percorrere pochi passi decisi e assestare al frigo un cazzottone che rimbombò come un tuono e svegliò tutti. “Ora si può dormire”. La mattina successiva ci accolse un sole caldo che sfiorava piano le finestre. Fuori c'erano sfumature di verde che mai avrei creduto di poter mettere insieme in un'unica vista. La grande, eterna foresta ci chiamava. Cominciava un altro giorno, altra stanchezza da buttarsi sulle spalle per crescere ancora un po'. - Il mio viaggio con Jack di Tiziana Luisa Carcagni Sono 1.057 i chilometri che separano Bergamo, dove vivo oggi, dal Salento. Il mio Salento, dove sono nata e cresciuta, fino a quando il destino mi ha trapiantata al nord. Una distanza che, soprattutto in agosto, si traduce in viaggi costosissimi. Più o meno l’equivalente di una settimana di soggiorno. Quando ero giovane e i soldi erano pochi (non che oggi siano molti), si viaggiava gratis. Bastava alzare un pollice e aspettare. Era un frullatore di esperienze, perché non c’era alcuna certezza sul reale momento della partenza e sul numero di tappe. Ma quelli erano gli anni Settanta, ci si fidava e, per dirla tutta, anch’io avevo una quarantina di anni in meno. Come potrei, nel 2013, sedermi all’ingresso dell’Autosole sul mio trolley strapieno e aspettare un’anima buona disposta a portarmi a destinazione? Tra tanta immondizia che intasa la posta elettronica, ecco però arrivare un suggerimento. Il carpooling non è solo la soluzione per chi vuole far quadrare i conti e sceglie la condivisione di un’auto per andare in ufficio. Si dice funzioni anche per impieghi più frivoli, anche per andare in vacanza. Il Salento non sembra essere solo nei miei pensieri, le proposte per la tratta sono numerose, ed ecco spuntarne una inattesa: 25 euro tutto compreso, anche la “consegna” all’indirizzo scelto. Inutile aspettare, un rapido scambio di email e l’affare è fatto. Una volta concordati i dettagli, però, spuntano i dubbi. Perché mai si accontenta di così poco? Se ne sentono tante... Una settimana in più di vacanze vale tuttavia qualche incognita e un pizzico di incoscienza, eredità non cancellata dell’epoca dell’autostop. In attesa dell’ora X, ho immaginato quali avrebbero potuto essere i pericoli dai quali avrei dovuto difendermi, ma il muro di diffidenza ha iniziato a sgretolarsi quando ho incontrato quello che già avevo cominciato a immaginarmi come il cugino di Jack lo squartatore. Un bell’uomo in camicia bianca e pantaloni blu di buon taglio, alto, curato, al volante di un SUV, che i miei 25 euro se li berrà prima ancora di arrivare a Parma. Scopro che siamo a pieno carico, con altri tre compagni di viaggio attirati da quel prezzo Fino a Lodi ognuno di noi sta sulle sue, ma a Bologna conosciamo già tutto o quasi del presente degli altri occupanti. Per il passato c’è tempo, ancora un migliaio di chilometri, vale a dire almeno 10 ore di convivenza e condivisione. Al confine tra Romagna e Marche abbiamo la consapevolezza che pur con esperienze ed età diverse abbiamo tutti una conoscenza comune. Luciano, il nostro benefattore, per esempio, scopro essere il “fratellino” di una cara amica d’infanzia. Quando entriamo in Puglia temo l’esperienza sia ormai alla fine, ma per fortuna la mia regione è lunga, e c’è ancora il tempo per scavare tra i ricordi. Siamo partiti alle 10, e poco prima di mezzanotte, proprio come Cenerentola, sono alla meta. Ripenso a Jack lo squartatore e sorrido. D’ora in poi i miei viaggi da ricordare saranno sempre e solo condivisi. - Voce rotta del sonno andata e ritorno di Tommaso Ruggeri Tutto accade tra un venerdì notte e una domenica notte milanesi, un’andata ed un ritorno. Eccoci, partiti, con la medesima rassegnazione mista a incredulità: partire alle 3 del mattino chi per Pescara, chi per Foggia e chi per Bari, senza mai essersi visti prima! Qualche minuto e già si scambiavano opinioni su passioni, lavoro e del perché affidarsi a sconosciuti per raggiungere mete di vacanza, amore o famiglia. All’unanimità si conveniva sull’economicità della soluzione “condivisa” mista al crescente desiderio di “condividere” in generale e di fiducia diffusa verso il prossimo senza età e senza pregiudizi. Laura ed Elisa riprendono il loro sonno, non Ale che decide di raccontarmi la sua vita di cantante celtica, cantautrice nonché danzatrice del ventre, fino all’alba quando si accascia pensando a tutto quello che avrebbe voluto dirmi e che non ha detto. Elisa dorme fino a Pescara e mai saprò se il medico abruzzese, stanziato a Bergamo, ha gradito o meno il sedile del passeggero più importante. Laura, dolce incontro che rivedrò anche al mio ritorno, mi parla allungandosi dal sedile posteriore e diventa subito il mio guru, battezzata Voce Rotta dal Sonno, parla e dorme tirando su e giù la testa.. che ridere! Lavora in radio ma lei diventa la mia consulente dispensando il decalogo del perfetto amante. E così, Voce Rotta dal Sonno parla e dorme anche al ritorno quando, da vera leader, offre il cibo della mamma ai nuovi compagni di viaggio e al suo conducente preferito. Voce Rotta dal Sonno, fa amicizia con Alfredo, consulente in carriera che pendola da Rimini a Milano per amore, e con Lorenza che da Milano pendola su Pesaro, anche lei per amore. In verità volevo che Voce Rotta dal Sonno si sedesse accanto a me, tuttavia, c’è l’altra Laura, lei vive a qualche civico di distanza sulla stessa strada di Milano di Voce Rotta dal Sonno. È lei ad occupare il sedile del passeggero più importante, milanese di Milano, fidanzata a Lecce, dipendente comunale che, nel tempo libero, dà da mangiare alle persone meno fortunate e trascorre i Natali in Stazione Centrale a sfamare senza tetto. E pensavo come l’Altra Laura sia ciò che tutti noi vorremmo essere e che non siamo. Ritornati a Milano! La radio era spenta perché non serviva, non serviva essere informati del traffico o sentire stupide colonne sonore di un’estate ormai andata, avevo le storie di Lorenza, l’altra Laura e di Voce Rotta dal Sonno. Solo, ripensavo a quanti viaggi avessi fatto e a quanti ne ricordassi.. nessuno. Non ho condiviso solo un viaggio, ma ho condiviso in un’andata e in un ritorno la mia vita con quella di 9 persone, 9 storie personali una più emozionante dell’altra, 9 modi di intendere la vita. Sicuramente quel viaggio non sarebbe stato lo stesso senza le fantastorie di Ale, i consulti d’amore di Voce Rotta dal Sonno o senza l’operaio Michele che scende da Ancona a Foggia ogni fine settimana dalla propria famiglia.. e se la “condivisione” fosse l’occasione per un mondo migliore? - Stay car, stay pooling di Ubaldo Spina Koknese, Lettonia Ottobre 2011 Musica consigliata: Sigur Rós – Vaka Ci sono un italiano, un tedesco e una lettone. C’è un’intrusa baltica e manca un francese per completare la rosa di una tipica barzelletta dello stivale. Gita, la lettone, lo cerca da più di un’ora sulla rotta aeroportostazione di Riga. La pecorella è smarrita, perderemo sicuramente l’inaugurazione del campo, ma da buon pastore Gita ha il dovere di cercarla. E noi con lei in questo abitacolo condiviso che si anima lentamente e diviene focolare mobile dedicato a intime conversazioni comunitarie. Gita ha il nome di un viaggio breve, guidare è nel suo nome di battesimo, penso. Preleva i volontari ambientali giunti da tutta Europa con una vecchia utilitaria dell’est per condurli al “Giardino del Destino”, un parco da ripulire per ridare sollievo al passato, forza al presente e ispirazione ai sogni futuri. Questo nelle intenzioni del popolo lettone e del visionario paesaggista giapponese che ne ha curato il rifacimento. Il tedesco avrebbe dovuto fare l’ingegnere. Anni di imposizioni e di richiami da parte dei genitori, fino a quando non si è scoperto body painter. Oggi trascorre il suo tempo a dipingere corpi di donna come fossero tronchi d’albero, lasciando tracce di germogli verdi sul palmo delle mani protese verso il cielo. Gita guida serenamente tra le sue foreste e mostra involontariamente ai passeggeri un tatuaggio sulla schiena. L’inchiostro ha meno di un mese e ricalca perfettamente un soffione, quei fiori a forma di globo piumoso e di argenteo nulla che esplodono silenziosamente alla prima folata di vento primaverile. Le piace il contrasto tra la precarietà di quel fiore e l’eternità di un tatuaggio sulla pelle. Un ragazzo cammina ai margini di una lingua di asfalto in mezzo a fitte guance verdi. E’ lui, il francese, vestito di tutto punto, come se fosse stato invitato a una festa di gala. Ci sentiamo un po’ in imbarazzo nell’aver indossato abiti sportivi e scarpe da trekking. Sale a bordo, occupa l’ultimo spazio disponibile curvandosi sotto il tetto che si ribassa improvvisamente per congiungersi al lunotto, riempie le nostre timidezze con la sua vitalità. Il francese racconta che la gente attende sempre un’occasione importante per indossare l’abito migliore. E per molti quell’attesa non è mai terminata. Oggi è un giorno importante per lui, per l’Europa, per l’ambiente. Cosa importa se gli toccherà rastrellare le foglie d’autunno in camicia azzurra e giacca di tweed! E’ una splendida lezione da parte sua, che cancella ogni nostro pregiudizio sul borghesuccio spaesato e lo investe di una sensibilità superiore. Valeva la pena lasciare il gregge all’ascolto della banda per accendere l’ultima lanterna alla ricerca di quest’uomo. La radio passa la notizia che Steve si è spento. Come fanno ogni giorno tanti dei suoi dispositivi. Un mondo intero si ferma al pensiero che la morte sia stata capace di mordere anche lui. Oggi, stranamente, ho risolto il mio conflitto con l’automobile e non mi si sono anchilosate le gambe. Stay car, stay pooling. Tratto da una storia guidata. - Oslo Oslo noi di Valentina Casagrande Non dormirò, mi succede sempre quando so che manca poco alla sveglia e alla vigilia di ogni novità. Per il mio compleanno mio fratello mi ha regalato un biglietto per Oslo! Sento quel brivido di quando sto per raggiungere uno scopo! Mi si è già chiuso lo stomaco per la trepidazione! “Voglio provare a pisciare in aereo” dice mio fratello! Il volo procede piacevolmente ed arriviamo puntuali ad Oslo Torp, fra due ore di autobus raggiungeremo il fiordo.Saliamo e lui si siede vicino al finestrino, siamo stanchi, ma la curiosità ha la meglio, non riposiamo.Alla vista del cartello di pericolo attraversamento renne potrei già prendere il volo per rientrare! Mi sembra di aver appena visto molto più di quanto mi aspettassi! Le renne volano! Non attraversano la strada col pericolo di finire magari sotto al nostro pullman! La vista è appagante, tutto verde intorno, solo natura, c’è molto poco di artificiale.Arriviamo in città e la stazione Busterminal è esorbitante! Apriamo la cartina, mi vergogno sempre quando lo faccio, mi fa sentire un bersaglio e tonta insieme.Ci dirigiamo verso il Palazzo Reale, da cui si vede tutta la Karl Johans gate. Io che sono cresciuta a pane e principesse sono impressionata dall’idea che lì abiti la famiglia reale! Passiamo due giorni insieme, dopo tanto tempo, camminiamo lungo tutta la città ed usufruiamo di ogni mezzo di trasporto disponibile: l’autobus per andare al Vigeland, il tram nella zona centrale, la metropolitana fino al Munch museet, il traghetto per Bygdøy, il museo delle navi vichinghe e il Museo Fram. Sfruttiamo la Oslo Pass per fare gratis una minicrociera sul traghetto, non scendiamo raggiunto il porto, restiamo seduti ancora e ancora, fino a quando non abbiamo fatto nostro quello che stiamo vivendo, per ricordarlo. Nella zona del Municipio, del centro Nobel per la pace, della fortezza di Akershus ci sentiamo a nostro agio. Abbiamo trascorso lì la mattina, il pomeriggio, la sera, quando fino alle 22 la luce rendeva tutto volentieri vivibile. Da una panchina del centro ascoltiamo “miss american pie” cantata da una ragazzo, la sua voce calda ed esperta e la chitarra. Un momento di pace che sembra infinito, ma è lungo un tramonto. Ci accorgiamo di osservare le stesse persone, le stesse situazioni, i nostri sguardi verso gli stessi orizzonti. Forse perché siamo fratelli, forse perché siamo italiani e attratti da ciò che vediamo diverso dal nostro consueto. La mattina della partenza, prima di trascinarci di malavoglia verso la stazione degli autobus, torniamo all’ Aker Brygge. In strada nessun rumore ci accompagna oltre a quello delle ruote dei nostri trolley.Accomodati sulle panchine del porto, calmati dall’aria fresca e salmastra, in una giornata piacevolmente mite di Maggio, ammiriamo il celeste di un cielo incredibilmente terso e pulito, ci dissetiamo con il succo di mela e stiamo vicini, in silenzio, godendo delle nostre presenze, del paesaggio, dei gabbiani, assaporando ogni sensazione. - Una casa in cima al mondo. di Valentina Tatti Tonni Viaggio: da Roma a Poggioprimocaso, Fraz. Cascia (PG) – Italia. Il viaggio di cui scriverò è iniziato a luglio dello scorso anno e ha portato me e la mia famiglia a trasferirsi in un piccolo paese avvolto dalle montagne, senza negozi e a volte senza passanti. Ricordo di aver letto che la pressione industriale, almeno un secolo fa, permise agli operai di esportare i propri prodotti, mentre sempre più famiglie dovettero spostarsi nelle metropoli e riadattare le loro abitudini. Oggi invece, nell’era avanzata del capitalismo, i cittadini rientrano nelle campagne verso il riappropriarsi di una condizione considerata primitiva. Noi ci ritrovammo catapultati in un altro presente, con idee opposte o diverse e, un paesaggio che da solo ti consola senza però ridarti minima stabilità. Con tre borsoni e il ricordo stropicciato di una casa che avevamo dovuto lasciare, con le foto del mobilio e dei libri che non avevamo potuto trasportare, siamo arrivati disperati. L’apparente arretratezza di quella frazione sembrava essersi rinchiusa in un pozzo di banale semplicità, rispetto all’eccentrica innovazione a cui ero stata abituata a pormi in città. Tuttavia, Con sorpresa nei mesi a seguire mi resi conto che era proprio quella semplicità e quella gentilezza che non ci era stato permesso di avere in una metropoli così emancipata, tanto da renderci cinicamente impassibili. Paradossalmente, proprio mentre i suicidi avvolti dalla miseria aumentavano perché incapaci di pagare debiti personali e la nostra povertà si dimenava nelle note di una musica triste, la nostra cittadinanza fu arricchita da personalità con un estremo senso del cuore che in mezzo al nulla, sia in senso letterale che figurato, ci avevano insegnato accogliendoci a riappropriarci della nostra storia. I rapporti interpersonali limitati in città, come un saluto pronunciato per sbaglio che può rimanere aggrappato ai raggi di luce per anni senza essere ascoltato, non trova riscontro in un paese con poco più di quindici famiglie: durante le nevicate più folte, ricordo che la maggior parte di loro si accertò delle nostre precarie condizioni, come ad esempio il fatto non trascurabile che non avevamo previsto di dover vivere in una casa senza riscaldamenti a più di ottocento metri sul livello del mare. Grazie alla clemenza delle montagne e alla premura di quelle persone, diventate poi amiche, il nostro soggiorno obbligato si trasformò, con lievi picchi di umore in contrasto, in una piacevole esperienza che in ogni momento porto con me. Le parole che utilizzo sono sincere, perché non devo nasconderle dietro credenze e stereotipi che cancellano e traducono tutte le frontiere, senza la paura che, dovendole scoprire, le persone scambino il proprio ruolo e i cieli si combinino con più colori. La loro autenticità permane nella notte dei tempi e questo mi consola, perché in qualche modo rende più vera la condivisione di quella vita che non credevamo di possedere ancora. - Agata di Valeria Bartone Conobbi Agata in treno, entrambe annoiate da quel viaggio e dai nostri vicini che non facevano altro che dormire pesantemente a causa del lungo tragitto, dell’enorme ritardo, dell’aria condizionata malfunzionante e del clima afoso. : - Povera me- A bassa voce sussurrò la ragazza sedutami di fronte. La osservavo da quando ero salita. Lei era già esausta, più avanti avrei scoperto che viaggiava da molte ore. Occhi scuri, carnagione olivastra, anonima nell’abbigliamento, si muoveva con una tal grazia che non potevo a fare a meno di guardarla. Aveva con sé un manuale per la costruzione degli aquiloni. Eravamo le uniche a star sveglie, con il desiderio di raccontarci. Iniziò a parlarmi della sua vita. Raggiungeva Milano e suo marito, era partita la mattina molto presto da Siracusa, con quel trenaccio ed i vari cambi, quindici ore se tutto fosse andato bene; suo marito aveva lasciato la Sicilia per lavoro. Agata prima di cinque figlie femmine, aveva venticinque anni. In Sicilia lavorava in un negozio di scarpe, che era stato del padre, prima ancora del nonno e andando indietro nel tempo, un proprietario era sempre stato il nonno di qualcuno. Lei aveva ereditato per uno strano caso al quale nessuno si era opposto, nonostante non fosse un maschio per poter a sua volta tramandare il cognome. Oltretutto aveva tre figlie femmine e rideva tanto quando mi raccontava questa storia dell’ereditarietà al maschile sui beni di famiglia. Ancora di più quando affermava che lei oltre al negozio di scarpe aveva anche ereditato la dote tutta ricamata a mano. La casa invece l’aveva portata il marito. I soldi sempre pochi, con tre bimbe da crescere e con suo marito, maresciallo dei carabinieri, trasferito a Milano. La motivazione del trasferimento non le era stata molto chiara, ma sapeva solo che voleva riportarlo a casa, a costo di fargli cambiare lavoro. Altrimenti l’avrebbe lasciato. : - Ancora giovane e gli uomini mi corteggiano, da sola troppo a lungo non posso stare, Carmelo lo rivoglio con me!- : - Non credo sia semplicissimo-le risposi -Visto che mi hai detto che il trasferimento l’ha chiesto solo qualche mese fa-. Ma lei replicò: - A lui in fondo non gli piace neanche portare la divisa o usare la pistola, può sempre decidere di lavorare al negozio con me, alle donne che entrano nel negozio di scarpe, piace di più che ci sia un uomo a servirle. Certo io dovrei stare con gli occhi aperti sempre, ma almeno lo vedrei. Così invece mi sento di non potere nulla e da tre mesi che lui sta a Milano non sono riuscita mai a vivere serena. So come convincerlo, ma lui mi continua a dire che facendo il carabiniere abbiamo almeno uno stipendio assicurato. Non tiene torto ma tiene anche una moglie e tre figlie… e siamo tutte femmine! Com'è possibile che io gli stia facendo questa sorpresa, che io abbia chiuso il negozio per quattro giorni? Ho sistemato le bambine da mia madre e adesso sono su questo treno che parlo con una sconosciuta che mi guarda come se fossi pazza, tutto questo per raggiungerlo, il mio Carmelo. Invece, lui viene da me solo alle feste comandate. Ecco, io adesso ho paura. Io credo che forse lui con questa storia dello stipendio, che dice di metterne metà alla posta, in realtà non ci vuole più a noi quattro, o forse si è fatto un'altra… Senti io mi chiamo Agata, mi dici il tuo nome?: - Anna. : - Anna, senti, ma tu che pensi che c'ha un'altra a Milano, una di quelle che parlano con il “ne” ogni parola che dicono?: - Agata io non lo posso sapere. : - Lo so che non lo puoi sapere, ma io infatti ti ho chiesto cosa pensi tu, perché secondo te non viene mai a trovarci, però ci telefona diecimila volte al giorno, tanto che a me mi fa uscire pazza. Io non me ne faccio niente di tutte quelle telefonate… Io adesso vado a Milano e me lo ripiglio, però se penso che io sono la donna, forse è il caso che torno indietro. Senti io alla prossima fermata scendo, chi me la fa fare di proseguire per altre cinque ore e magari ritrovarmelo con un'altra, e magari sentirmi dire che non mi vuole più o che ne so io, magari mi dice che sta con me per le bambine e perché a Siracusa pare brutto separarsi. Anna io scendo. Il cellulare, il meraviglioso oggetto che ti rende sempre rintracciabile iniziò a squillare e Agata rispondeva a tutti, era la madre che si assicurava che tutto andasse bene, erano le figlie che le dicevano che sentivano la sua mancanza, era il padre che le ricordava che lei è una femmina e che a quel debosciato era meglio lasciarlo a Milano, era sua sorella che era rimasta senza soldi e le chiedeva un prestito, era Carmelo che le faceva un saluto e lei si chiedeva come mai non si accorgesse che i rumori erano diversi, che non erano quelli del negozio dove lui sapeva lei si trovasse. Agata voleva tornare indietro, voleva tornare a Siracusa, suo padre forse aveva ragione, la femmina era lei, le sue bimbe sentivano la sua mancanza, il negozio era chiuso, eppure aveva fatto tanta strada finora. : -Andare o tornare? Il dilemma è la soluzione- suggerisce Anna. Agata guarda il libro che ha con sé, sorride e sussurra ancora: -Povera me, ma hai ragione io a Milano ci arrivo. Gli aquiloni costruiti bisogna farli volare.- - One day in England di Valeria Pecora Ci siamo messi a pranzare tutti insieme sull’erba. Faceva un caldo pazzesco. Strano per la piovosa e umida Inghilterra. Questo perché la vita non finisce mai di sorprenderti. Nelle grandi come nelle piccole cose. Eravamo in escursione. Tutto il giorno a Stratford Upon Avon. A visitare la casa di Shakespeare. Dopo pranzo Emanuele, Federico e Arianna si sono alzati. Hanno chiamato tutti quanti. Tutti i nostri ragazzi. Abbiamo cominciato un gioco. Ci siamo disposti tutti in cerchio. Poi al battere delle mani e del tempo, di una parola senza senso abbiamo colto il ritmo. Abbiamo formato una coda umana. Erano braccia intrecciate, erano gambe in moto. Erano cuori pulsanti, vicini. Facce piene di sole. Erano sorrisi che rendevano ancora più luminosa quella giornata. Tra urla e battiti di piedi e di mani quella coda umana si faceva sempre più stretta, più gioiosa. In quel momento il tempo si è fermato. Siamo diventati lo spettacolo di una piccola cittadina inglese. Le famiglie, i ragazzi, gli anziani nel parco. Tutti si sono voltati. Guardavano loro. I nostri ragazzi. Guardavano NOI. Si è creata un’atmosfera magica. Surreale. Una bellezza dell’anima ci teneva inchiodati…ad un tratto….da estranei, stranieri, turisti ci siamo ritrovati improvvisamente tutti vicini, uniti dalla stessa armonia del cuore. Alla fine del gioco un applauso scrosciante si è riversato nell’erba, tra i fiori, volteggiava tra i rami degli alberi. E’ stato perfetto. Indimenticabile. Ho capito in quel momento cosa vuol dire far parte di un gruppo. Di una cosa sola. Granelli che insieme formano spiagge infinite. - Nous autres di Valeria Pecora Marsiglia te la senti dentro. Nella pelle. Nei polmoni. Negli occhi. All’inizio la vedi e ti stordisce. Non ti affascina. Ti stordisce. Marsiglia è piena. Ubriaca. Ti fa pensare ad una vecchia prostituta dai mille amanti. E’ lurida ma fascinosa. Ti viene voglia di attraversarla tutta. Le sue stradine ti accolgono come la pancia di un pesce. Te lo senti negli occhi il suo mare blu cobalto. Le barche a vela che ti regalano miraggi di sogni lontani. Le sue rocce nere. Tane di bagnanti anche in una splendida domenica di ottobre. Marsiglia è bassofondo e luna. E’ luce che riverbera nel suo porto. Lì mi sono seduta. Ho avuto compagni silenziosi e intimi in una serata che andava via. Senegalesi, tunisini, marocchini, algerini. Tutti insieme. Vicini ma distanti. Ognuno con i suoi pensieri. Stavamo seduti lì. A Port Vieux, riparati dalla barche. Guardavamo il sole calare. Felici e malinconici insieme. Ho visto un padre insegnare il figlio a pescare. Passeggi nei suoi mercati. Senti l’odore di spezie, couscous, kebab, polli arrostiti sulle strade. Pesci sbattuti sotto i tuoi occhi. E in quei mercati tu viaggi. Non sei più a Marsiglia ma ad Algeri, a Tunisi, a Tangeri. Marsiglia ti fa venire voglia di fare l’amore. - Maturità condivisa di Valerio Boni Il decennio arrivato dopo i favolosi anni Sessanta non era poi così diverso da quello che stiamo vivendo. La crisi era palpabile, come oggi, solo che a quell’epoca non si conosceva il significato di termini come spread o default. L’unica parola proveniente dall’altra parte della Manica era “austerity”, che si traduceva in cassa integrazione e domeniche a piedi. Eppure, anche in quegli anni bui, la voglia di viaggiare e di scoprire persone e luoghi nuovi era viva. Io ero tra i fortunati che avevano avuto l’opportunità di visitare Spagna e Yugoslavia con i genitori. Ma un conto è essere un bagaglio al seguito in età prescolare, un altro fare i conti con il desiderio di scoprire in autonomia le capitali europee, che si sarebbe manifestato qualche anno più tardi. Più precisamente nel 1978. Cinque anni di buona condotta alle superiori, mi erano valsi un premio. Un ciclomotore nuovo di zecca, che i miei genitori hanno avuto l’imprudenza di consegnarmi prima della maturità. Una leggerezza di cui si sono pentiti ben presto, poiché da quel momento ha preso forma un progetto sul quale non avrebbero avuto alcun controllo. Un ciclomotore uguale era stato regalato negli stessi giorni a Paolo, un amico di un anno più giovane. I nostri coetanei scorrazzavano in città, ma a noi le tavole del Tuttocittà di Milano stavano troppo strette, siamo passati direttamente all’atlante stradale d’Europa. E in un paio di giorni è nato un itinerario di 5.000 chilometri attraverso Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, Germania e Austria. Tra i dettagli non mancava la data di partenza: una domenica di giugno. Un giorno come un altro, ma per me corrispondeva a due settimane prima dell’inizio dell’esame di maturità. Furono giorni di duri scontri, ma alla fine riuscii nell’impresa di convincere i miei, e alle 7 di mattina partimmo da Milano, puntando verso il Lago Maggiore. Ci si prospettava una grande avventura, alternativa a quella del viaggio condiviso in voga in quel periodo, vale a dire l’autostop. Eravamo certi che sarebbe stata un’impresa da condividere e ricordare, e in effetti ancora oggi, a 35 anni di distanza Paolo e io abbiamo ancora ben scolpito nella mente il video di quel viaggio. La scalata del Sempione pedalando come ciclisti, per aiutare il povero motore di 49 cc a portare in quota noi e i bagagli. Ma anche la prima notte in tenda, sotto il diluvio, l’arrivo sotto la torre Eiffel, la prima “frühstück” a base di uova, il parcheggio dei ciclomotori nella hall del B& B di Ulm, la bellissima Brigitte conosciuta a Vienna che entrambi abbiamo sognato potesse diventare la madre dei nostri figli, il transito nella Carnia con le evidenti le ferite del terremoto... Senza dimenticare il successo di avere concluso il viaggio in 13 giorni con meno di 50.000 lire in benzina. E l’esame? Ricordo molti meno dettagli, ma ho ben presente il debutto: un tema che chiedeva di immaginare un’Europa senza frontiere. Una passeggiata per chi nelle ultime due settimane ne aveva passate sette. - Valentina, Sole, Neve e io. di Yvonne Bindi Eravamo pronte per partire. La macchina, sotto il sole del mattino di agosto, era una grossa lumaca blu, impolverata e sorridente, pronta per strisciare via. Ci montammo sopra, facendoci spazio tra scatole e sacchi, come se sapessimo veramente dove andare. Alle nostre spalle avremmo lasciato una scia di bava rilucente, fatta di idee e stupore, che il caldo avrebbe presto cancellato, prosciugandone ogni traccia. Al momento della partenza io ero al posto di guida, tenevo il lumacone per le corna e mi guardavo attorno per assicurarmi che fosse tutto in ordine. Niente era in ordine, ma uno strano equilibrio meritevole di fiducia, teneva tutte le cose insieme. Dietro il posto di guida era seduta Neve, pelle chiara, occhi da uccello e le unghie molto lunghe. Sarà una maga, avevo pensato la prima volta che le avevo viste. Aveva molta musica con sé e stava scegliendo cosa farci ascoltare. Accanto a Neve si era accomodata Valentina, scura come un’oliva matura del sud, con i capelli neri, lisci e lucenti. Era una stella danzante che aveva preso per il collo il suo caos e lo aveva ficcato in un sacco di iuta, per poi lanciarlo su una nuvola che a suo, dire se l’era portato lontano, fino in Cina. Alla mia destra, al posto del navigatore si era incastonata Sole, luminosa come un’agata. Il suo viso parlava di mille posti lontani e diversi tra loro. Conosceva molte lingue e modi di vivere e non si stancava mai di sorridere. E poi c’ero io, che avevo avuto la fortuna di incontrarle. Quando le vidi per la prima volta erano attorno ad una macchina con tutti gli sportelli aperti. La stavano riempiendo di roba, anzi a dire il vero la macchina era già piena, ma la metà delle cose non riusciva a trovare una collocazione ed era ancora lì sull’asfalto. “E’ troppo piccola questa macchina!” stava dicendo Sole. “O forse pretendiamo di farci entrare troppe cose! - rispose Neve e guardando Valentina aggiunse - ad esempio tutte quelle code di fata, dobbiamo proprio portarle?” “Senza code di fata non si va da nessuna parte! - sentenziò Valentina sono belle, piacciono ai bambini e di certo portano fortuna! Piuttosto, cosa c’è in quella sacca grigia che sembra un porcospino?” “Il piccolo trapano, la piccola mola, le pinze e qualcos’altro di molto piccolo e necessario” assicurò Sole strizzando gli occhi. “E in quella scatola enorme che schiaccia le perle di cartapesta?” insistette Valentina speranzosa di scovare qualche intruso. “La cucina: fornello, pentole, postate. Non vorrai cenare fuori tutte le sere!” disse Neve facendo volteggiare le mani nell’aria. Le ascoltavo già da un po’ quando decisi di avvicinarmi e proposi: “Io ho una macchina molto più spaziosa e possiamo caricarla pure sopra. Che ne dite se partiamo con la mia?” Non parlammo mai di una meta. Il nostro viaggio non ne aveva bisogno. Saremmo andate a sud. Gli umori, gli odori, gli incontri, il mare, la danza e la pancia ci avrebbero di volta in volta indicato la via. AFORISMI DI VIAGGIO #BlaBlaStorie SingerFood Fra @SingerFood #BlaBlaStorie Moldavia, Agosto 2004. Il sorriso sdentato dei dell'orfanotrofio e quella sensazione di averci lasciato il cuore. bambini Elisa Gioia @elisagioia New York, una valigia piena di sogni e di shopping, foto da stampare e nel cuore. Un viaggio meglio di un film di Woody Allen! #blablastorie Stefano Martini @MartinnStefano Orari strettissimi. Ultima corsa in partenza alle 23: 11. In macchina la fiducia nel nuovo amico. Ho preso il treno al volo. #BlaBlaStorie Claudia Bertuzzi @ClaBertuzzi1 #BlaBlaStorie Senegal. Bambini gioiosi circondano la jeep nel deserto. Poi via giú dalla duna fin sull'Oceano. Emozione, mi escono lacrime. Claudia Bertuzzi @ClaBertuzzi1 Zara. Tutti sdraiati con l'orecchio a terra per ascoltare l'organo del mare di Bazïç. Di quelli in piedi si notano le scarpe #BlaBlaStorie Alle Bolo @AlleBolo #BlaBlaStorie La Scozia sotto la mia pelle Edimburgo un perfetto vestito sopra... Teresa Manuzzi @Terramanu l'autostrada è l'unica certezza nell'infinito gelo biancastro delle colline innevate... le tue parole nuove mi riscaldano #blablastorie Teresa Manuzzi @Terramanu #BlaBlaStorie scoprire cosa nasconde la linea dell'orizzonte... scoprirlo stando gli uni accanto agli altri Teresa Manuzzi @Terramanu viaggiare è scoprire che lo sconosciuto ti somiglia, e che ci sono parti di te che non conoscevi #blablastorie Teresa Manuzzi @Terramanu Il viaggio comincia quando si accetta di partire #blablastorie Alina Gnerre @AlinaGnerre Viaggio nella variopinta India: una finestra sempre chiusa che si spalanca illuminando i colori del mio mondo in bianco e nero. #BlaBlaStorie Antonella Romani @anto1889 @blablacarIT @la_stampa Le #Cicladi traghettando in moto. Isole che parevano occhi blu, verdi e neri... mi hanno ipnotizzata. #BlaBlastorie Jerry Drake @JerryDrake02 #BlaBlaStorie grossglockner, sulle tracce di antiche strade romane negli Alti Tauri Austriaci, incroci di civiltà. pic.twitter.com/pgqbD3Qc2G Nicola di Monaco @pianadicaiazzo @blablacarIT Si. Bowen, Queensland: bassa marea. Tempo, spazio, out. Realtà più bella qualsiasi fantasia. Viaggio nel magico mondo dei coralli. Solo Marina @stellamarina76 #BlaBlaStorie assolate campagne d'agrumi e pomodorini, con i fichi d'India a veglia di stradine polverose che si buttano in scorci mozzafiato Happymilan @GmaHappymilan #blablastorie periferia Lima tanta immondizia e tantissime persone che cercavano da mangiare. La condivisione di ciò che si ha con i poveri Rock'n'grohl @docworld @blablacarIT 3 mesi downunder, tra le coste delle città australiane e i Maori della New Zealand. Impagabile ed Imperdibile. #BlaBlaStorie FiammaDegl'Innocenti @f_degli 8ore di bus tra le valli nepalesi con un 60enne tedesco ex galeotto improvvisatosi per 20anni fitness trainer in Tailandia #Blablastorie Claudia Bertuzzi @ClaBertuzzi1 #BlaBlaStorie Spiaggia del Villa Rosetta a Zambratta (HR). Il luccichío della luna sul mare. Fila di cubetti di ghiaccio fra seno e ombelico Solo Marina @stellamarina76 #blablastorie nurburg: L'odore di pneumatici e carburante si mischia al rombo assordante, in un paesaggio di ameni paesi nel verde distesi Solo Marina @stellamarina76 #blablastorie le case pugliesi abbracciate in bianchissimi borghi, abbacinanti su sfondi di mare turchese e terra rossa sotto secolari ulivi Elena Solito @elesolito Direzione Flamands le case bianche sulla spiaggia fino alla baia di StJean e ad ovest la sera e il silenzio di le Colombier. #BlaBlaStorie Antonio Serra @Green1059 #BlaBlaStorie Le porte si aprono, fuori una leggera pioggia. E' arrivata la tua fermata, avrei voluto essere io la tua fermata. Teresa Manuzzi @Terramanu #BlaBlaStorie lasciarsi guidare imparare a perdersi senza farsi confondere FiammaDegl'Innocenti @f_degli Tutti i posti presi su @blablacarIT, costretta a tornare da Budapest su treno carico di sopravvissuti a festival psichedelico #blablastorie Anna Bene @ondivaga #BlaBlaStorie America Latina 2001 Asuncion, cascate Iguazu, Montevideo, Colonia del Sacr., Buen. A., incrociare popoli sotto la Croce del Sud Daniela Genovese @superdani77 @blablacarIT #BlaBlaStorie India Gennaio 2008. Colori, odori, sapori e l'immensa dignità e l'immancabile sorriso di gente che non ha nulla! A.Consorti @Anto_Consorti @blablacarIT #BlaBlaStorie India del Sud 1984: La vita, la morte, la povertà, la bellezza, la malattia, la cultura, i colori, gli odori... I SORRISI! Monica Berardinelli @be_monica @blablacarIT addio al nubilato a #Budapest della mia più cara amica... abbiam replicato quello fatto 15 anni prima da studenti #BlaBlaStorie Maria Lucia Riccioli @MLRiccioli @blablacarIT #BlaBlaStorie Croazia, Bosnia-Erzegovina: isole e montagne, città ferite ma splendide di mura e mare, fiumi e cascate. Spirito. Massi Persichella @bacicch #BlaBlaStorie Cuba: musica, tradizione, umiltà, accoglienza solare e revoluciòn. Hasta la victoria! Siempre! Antonio Serra @Green1059 #blablastorie Treno, nave, camion, El Alamein1943.Un lungo viaggio per arrivare al capolinea, in un altro mondo. Cosi pensò mio padre. Renato Piazza @renatopiazza1 #blablastorie Rep. domenicana, escursione alle piantagioni di canna, i tagliatori thaitiani ci guardano con disprezzo ed odio, provo disagio Antonio Serra @Green1059 #blablastorie Arrivare a Istanbul è magico, è come essere in una dimensione di tecnologia e tradizioni arcaiche perfettamente mescolate. Patricia Scioli @CasaDiPatty #blablastorie Nord della Spagna con 4 amici e la nostra Lucia 18 mesi, natura, enogastronomia, ospitalità poi scoprire di aspettare Davide! Daniele Morelli @Daniele8Morelli @blablacarIT #BlaBlaStorie si taceva, pioveva, cercavamo una farmacia lontana, per capire se con paura dover dire d'aver amato e aver creato Nicoletta Scano @NicolettaItalia #BlaBlaStorie controvento, calpestando mozziconi di sigaretta e ricordi, il vento salato mi ha schiaffeggiato gli occhi assonnati. Viviana Governi @govi47 #BlaBlaStorie Con il sapore dei fichi ritorna l'odore del prato il sudore di un abbraccio rugoso una mano dolce e callosa Giorgio Gotra @GiorgioGtr #BlaBlaStorie /// Un viaggio #Parigi-#Salisburgo con due giovani metallari. 12 Ore di cultura musicale e viaggio risparmiando 140$; ) #Yalla Alessia Gilardo @AlessiaGilardo #BlaBlaStorie Nessuna mappa mi affascina come quella che disegno con i ricordi dei miei viaggi: non ci sono confini, solo volti incontrati. Antonella Greco @grecanto #BlaBlaStorie Storie di partenze insperate, compagni di viaggio che ti resteranno dentro sempre. Tu pensi di viaggiare, e invece sei viaggiato Barbara @Barbara919w #blablastorie il 1° viaggio alle Isole Incoronate in barca a vela nel 2001 Alessandra De Paola @amedepaola #BlaBlaStorie ho visto una pianta di Calafate in Tierra del Fuego, quindi so che ci tornerò, secondo la leggenda. Viviana Governi @govi47 #BlaBlaStorie Quella mattina portavo sulle mie spalle solo la libertà, vedevo orizzonti e papaveri stringendo la sua grande mano forte... Antonio Serra @Green1059 #blablastorie 20ore di volo 4aerei 4fusi 5scali 15400km ci prepariamo per gli ultimi 200km. Ahe Island e gli squali balena non sono lontani Carla.c @piccolocali #blablastorie il ritorno a casa: la vecchia strada alle spalle, ho ricominciato ricominciato da zero ma felice. Valeria Anfuso @ValeriaAnfuso Estate 2011, io e il mio ragazzo abbiamo macinato un numero indefinito di km a piedi a Berlino Mitte #BlaBlaStorie jHeA LuMINAriAS @moy186 Sa school ang daldal, sa bahay ang tahimik. yan tayo eh! #TAMangTambAYlAngsaBahay #makaBorig #BlaBlaStorie Antonio Serra @Green1059 #blablastorie Papà quando arriviamo? Ancora pochi colpi di remi è siamo arrivati. Qui figlio mio potrai sognare e sperare... siamo in Italia. Luisa Gavazza @luzluisaluz #BlaBlaStorie La città divisa, un ricordo. Ho abbracciato le case, le strade, la gente. Ho sentito la storia passarmi dentro, il suo frastuono. Enrico Pegoraro @enrichio #BlaBlaStorie 45 giorni di navigazione attraverso 2 oceani in tempo di guerra sulla m/n Saturnia nel dic 1942 (da Berbera a Brindisi). Cinzia @CinziaBaCi Quello che non ho ancora fatto... #BlaBlaStorie Galleria Piziarte @GPiziarte #blablastorie Anni fa in Piemonte vedo dal treno filari di alberi allineati come soldati e penso agli ulivi pugliesi come folla disordinata Roberto Carlini @Carlini92 #BlaBlaStorie viaggio nel cuore? #Monaco maggio 2013, #ViaggioStudio #Birrra Nuove Amicizie #Happiness, #memoria #cidevotornare! #Munchen Giulia Raciti @ViaggiLowCostIT @blablacarIT 2004- 2 mesi in marocco zaino in spalla e da sola.Da Tanger al Sahara con i mezzi pubblici. #BlaBlaStorie *MoMMa* @before2000 #blablastorie la #scozia i castelli i fantasmi: ))) Lara Lanzeni @LanzeniLara @blablacarIT A suon di valzer #Vienna sono stata sommersa da quell'atmosfera idilliaca tra storia e sogni #elegante #raffinata #BlaBlaStorie Monica Penitenti @PenitentiMonica #BlaBlaStorie Santa A112 con il pieno, fino a Vienna. Lui vide la sua prima nevicata che gli rimase impigliata nel sorriso. O ero io? Veronica Romani @Veronica_Romani Ottobre 2009: prima volta a #Parigi, visitata da cima a fondo, assaporando ogni momento. Un'emozione indescrivibile! #BlaBlaStorie Antonio Serra @Green1059 #blablastorie dai finestrini appaiono spaccati di campagna, la luce che batte nel mio finestrino rileva una scritta fatta col dito... tvtb *MoMMa* @before2000 #londra il pub e la figura di merda nell'ordinare una media #blablastorie Giulia Raciti @ViaggiLowCostIT @blablacarIT Marocco zaino in spalla in solitaria prima di Internet... #marocco #avventura #viaggiare #BlaBlaStorie Antonio Serra @Green1059 #blablastorie zaino in spalla, i piedi nelle mie scarpe nuove. Dopo aver camminato tanto, mi fermo a guardare altri piedi che camminano... Daniela Marinaro @DanielMarinar #BlaBlaStorie tre nanetti e papà ridon da matti ascoltando strambe storie blablate da mamma in auto su strada di sole. arrivi, mare? Punto Congressi @PuntoCongressi @blablacarIT #BlaBlaStorie #Giordania e le sue pietre rosa... Marco Ferri マルコ・フェルリ @marcomamiko @blablacarIT #BlaBlaStorie La prima volta a Londra. Dovevo starci qualche mese... ci sono rimasto 4 anni! Daniele G. @Fuliggine73 2005: con la mia bella, lungo l'Ibarska Magistralija, nel sud della #Serbia, alla scoperta dei #monasteri, sino a #Studenica #BlaBlaStorie Luca Roveda @Snowofapril Nel cuore un estate in Portogallo in particolare Sintra, come sentirsi un principe in una favola #BlaBlaStorie Antonio Serra @Green1059 segni.. di viaggio.. #blablastorie pic.twitter.com/8HlGfB7Ie2 Sara_Sweet ♫ @miss_misticfall #BlaBlaStorie in Spagna cantabria per vedere dove é stato girato il granhotel telefilm spagnolo! Bellissimo, un posto che fa emozionare Ayublue @ayublueorchids talking to him #blablastorie Patrizio Greco @PatrizioGreco1 #BlaBlaStorie Arenzano 1° blabla, 3 brasil. diluvio. siete voi: SI, apro baule, acqua ke ci fradicia saluti in car! Poi suadade brasileira Liset Garay @LGLiset Compartir tus pringles con un extraño y tener al menos un conocido el primer día de clases #ForeverAlone #blablastorie Antonio Serra @Green1059 #blablastorie spingi la tua vecchia bicicletta finché decidi di fermarti all’ombra dell'ulivo che potrebbe avere il triplo di tuoi anni... Antonio Serra @Green1059 #blablastorie L'autostrada davanti a me, km da percorrere, il sole in faccia e sulla destra coppie di trattori spargiletame... Gregorio Previato @previatgreg Adoro le dicerie che non stanno ne in cielo e ne in terra... l'unica cosa che odio é non poterle verificare... #blablastorie FelixKidA. @FelixNoises Il lento migrare verso sud percorrendo quella spina dorsale che è l'Adriatica mentre la forza di gravità ti spinge verso casa #blablastorie Roberto Red Rossi @Red_Milano @blablacarIT #blablastorie grazie a #blablacar abbiamo trovato altri utenti che ci sono venuti a prendere e ci hanno portato a destinazione Roberto Red Rossi @Red_Milano @blablacarIT #blablastorie sn partito da Milano il 9 agosto verso Lamezia con un ragazzo e una ragazza ma a piacenza si è rotto il motore... Pollodigomma @estibi Un viaggio Modena Milano, un passeggero che cercava casa, una vicina che affittava ora ho un vicino compagno di viaggio fisso. #BlaBlaStorie Emanuele Mancusi @ErSupposta Sarebbe stato un viaggio piacevolissimo se quel l'accompagnava non soffriva di meteorismo!!! #BlaBlaStorie Un amico Frizz @amico_frizz #BlaBlaStorie L'India non ti cambia, ma ti toglie la sabbia dagli occhi. cane che Gianluca Rizzo @gg_rizzo #BlaBlaStorie Vidi l'airone, continuai dritto sulla strada; dovevo tornare indietro, lo volevo. Il viaggio, il pensiero incessante all'uccello. Claudio Cimmelli @claudio_cim Adriano e Luigi, attivista no global e agente di polizia, volevano soltanto rientrare a casa spendendo poco. #BlaBlaStorie Claudio Cimmelli @claudio_cim Adriano e Luigi, attivista no global e agente di polizia, volevano soltanto rientrare a casa spendendo poco. #BlaBlaStorie Antonio Vitale @antonio vitale Mettemmo le nostre storie sulla stessa strada, risparmiando sulla solitudine e arricchendo la multinazionale della Condivisione #BlaBlaStorie Antonio Serra @Green1059 #blablastorie ... un profumo, una canzone, un sapore, un tramonto, una parola, un gesto, uno sguardo, una città, un viso... ricordi... viaggi. Cecilia Vigilanti @cecivigilanti Cielo e laguna si fusero saldati dai raggi lunari a contenere la nostra fuga.Cuori in piena nel silenzio scivolando su Venezia #BlaBlaStorie Paolo @Hell_Dorado #BlaBlaStorie La forma del viaggio è l'imprevisto. Sperare di evitarlo è come andare a scuola sperando di non imparare assolutamente nulla Alfonso @fonzobreaker "Il modo migliore per cercare di capire il mondo è vederlo dal maggior numero possibile di angolazioni." Ari Kiev #BlaBlaStorie Scamorza81 @scamorza81 #BlaBlaStorie viaggiare ti cambia, ti migliora, ti fa essere te stesso, ti dona sapienza e ti fa apprezzare la vita. Enrico Anedda @EnricoAnedda Quella corsa quando fuori era tutto buio. Il treno all'ultimo secondo. E quell'odore di mattino, misto a brioche calde e caffè. #BlaBlaStorie Miguel Velez @Miguel80Velez #BlaBlaStorie #1annosenzasoldi, per cambiare me stesso e il mondo. Un viaggio, una sfida, un'avventura di condivisione. Luca Perin @Perinermejo Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato. Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma. Viaggiate! #blablastorie Maurizio Giuntoni @ziotonycabaret #BlaBlaStorie un giorno grigio un giallo mi ha fatto una striscia rossa sull'auto blu, ero verde dalla rabbia e l'ho lasciato in bianco. Paola Caboni @pacaboni Ogni percezione della nostra presenza al cospetto dei misteri dell'esistenza è un passo verso la conciliazione con il mondo. #BlaBlaStorie Happymilan @GmaHappymilan #blablastorie Natale a Toleza Malawi quando ho fatto da madrina x il battesimo di Flaminia una bimba africana di 5 anni... ora una signorina Ibrahim Younis @SalutMeImIbra Meeting new people is always cool! #friendly #blablastorie Silvia Colombo @VillaggePower E allora, mi sento in dovere di credere nei miei sogni, per loro che rappresentano, pur non sapendo, parte del mio sogno. #BlaBlaStorie Antonio Serra @Green1059 #blablastorie @Green1059 scritto un pò di tempo fa.Nonostante la #montagna di morti in #mare sono ancora convinto che potrà essere cosi. Luke @corraxu #BlaBlaStorie Sali pure Pero' devi stare nel baule, insieme al cane; sai è difficile trovare 1 passaggio qui. E' pieno di gente strana Appunto Paolo Borsoni @adversadiligere #BlaBlaStorie I viaggi veri sono quelli che conducono non più lontano ma più vicino Paolo Borsoni @adversadiligere #BlaBlaStorie Naviga pure in mare aperto senza nozioni di nautica se il mare è calmo. Nel mare in burrasca si va a fondo (come nella vita) Paolo Borsoni @adversadiligere #BlaBlaStorie Viaggiare vuol dire semplicemente che accade qualcosa, che nulla è uguale a prima, che nulla è puro ripetersi Serena Puosi @serenapuosi Parto con una valigia vuota, la riempirò di storie, sguardi e sorrisi strada facendo, imparerò qualcosa da ognuno. #BlaBlaStorie Federica Giuliani @TraveltoTaste Non si può dire di aver conosciuto davvero un luogo senza averlo anche assaggiato. #BlaBlaStorie Simone Rattenni @SimoneRattenni Ho fatto carriera nell'esercito, studiato a Granada è fatto mattina nei botigliodromi, poi un erasmus in Grecia e il [segue] #blablastorie Simone Rattenni @SimoneRattenni Globe-trotter per l'Europa: ascoltarvi è stato come vivere 2, 3, 10 volte! Grazie #blablastorie Happymilan @GmaHappymilan #blablastorie oggi in metro.a Roma un anziano extracomunitario recitava senza vergogna il rosario. La fede che dovremmo gridare con la vita Alessandra Rossi @alessandrarossi #BlaBlaStorie - studente, geologo, violinista, ing. aerospaziale, danzatrice, avvocato: i miei compagni di viaggio con blablacar. Siamo l'Italia. Gianluca Orlandi @orlandigianluca #BlaBlaStorie viaggiare, conoscere altre culture, condividere storie e... ricominciare! Sempre con la testa al prossimo viaggio... Elisabetta Lazzarotto @BettyLazzarotto Caro #BlaBlaStorie ho trovato un posto dove ho messo in carica il mio corpo e ho alleggerito la mia anima: New York. Vivere merita felicita' Denis Strickner @strickyplanet Se fosse sufficiente un tweet, non sarebbe un viaggio poi tanto fantastico... #BlaBlaStorie Paolo Tonon @Rinnoviamoci Ho incontrato persone aperte e semplici, magari fossero tutti così! il fulcro non è risparmiare, ma stare bene #BlaBlaStorie Maria Fossarello @MariaFossarello @BlaBlaStorie #viaggiare è bello ma #condividereviaggiando lo è ancora di più! Maria Fossarello @MariaFossarello @BlaBlaStorie P& U mi chiamano per sapere l'esito del mio colloquio e io mi propongo come baby-sitter dei loro figli nei weekends Favolazione @pennaEcaramelle #BlaBlaStorie Sul treno della mia fantasia, viaggio attraverso paesi di storie, boschi di personaggi, laghi di magia e montagne di lieti fine Luisella Nicastri @contropendoli #BlaBlaStorie estate '69 zaino in spalla 3 amiche California dreaming and doing: come nascere di nuovo, anche oggi ogni volta a pensarci li'. Jack Torrance @JackTorrance62 Posacenere con piantina di mentuccia, sedile graffiato da micio Tyson mordace dalle fusa rumorose come un Guzzi, strada perduta #BlaBlaStorie Fabio Giagnoni @FabioGiagnoni Ultima gita col mio amore, la vecchia Corfù nel tardo settembre: isola di confine, melange culturale, immersione mediterranea. #BlaBlaStorie Giovanni Ruggiero @juan_r In auto uno stagista, un precario, un'architetto non pagato. Il conducente con l'indeterminato: lo fissiamo come un panda #BlaBlaStorie Viaggiverdi @viaggiverdi il mio viaggio più bello è quello che devo ancora compiere viaggerò con la mia fantasia, dove mi porterà? #BlaBlaStorie Emanuele Musarra @emanuelemusarra L'odore di New York è come quello di alcune ragazze: non sai esattamente cosa sia, sai solo che ti fa sentire a casa. #BlaBlaStorie Arianna @cursilla #BlaBlaStorie Quando parti per un lungo viaggio, sei hai fede, più parti vuoto più torni ricco. Piera Lo Noce @PieraLonoce #BlaBlaStorie Ho provato a scrivere qualche mio pensiero sul viaggio, spero abbia la forza di partire! Altrimenti fai tu, io ci ho provato. Piera Lo Noce @PieraLonoce #BlaBlaStorie Guardare fuori da un finestrino aiuta a capire che la vita va sempre oltre! Paola Caboni @pacaboni Ogni percezione della nostra presenza al cospetto dei misteri dell'esistenza è un passo verso la conciliazione con il mondo. #BlaBlaStorie Annalisa Dolzan @a_dolzan #BlaBlaStorie Progetti falliti per viaggiatori malinconici. Serve portarsi il cuore da casa? Antonio Serra @Green1059 #BlaBlaStorie le ruote sull’asfalto creano quel mood che fa diventare l’abitacolo un confessionale. Un viaggio di km ma anche dentro noi. Atti O Scene @attioscene #BlaBlaStorie Ho viaggiato per levare panni, abitudini. In vesti scomode incontrai fatiche. Ma ballando con miei simili, la mia anima ha cantato. Leandra Cazzola @leandracazzola Vibrante Intenso Amato Grandioso Geniale Immenso Ora. #BlaBlaStorie Leandra Cazzola @leandracazzola Viaggiando InGlobo Ancora Grandi Gioie Intense e Oltremisura. #BlaBlaStorie Matteo Marin @MatteoMarin79 #BlaBlaStorie L'abbraccio di 2 utenti che si reincontrano... 90000km/anno di compagnia... razze& idee diverse x andare insieme verso il futuro! Ringraziamenti Un'iniziativa blablacar.it in collaborazione con La Stampa Un ringraziamento e un augurio speciale a tutti i partecipanti che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto.
Scaricare