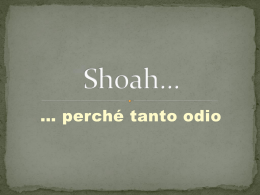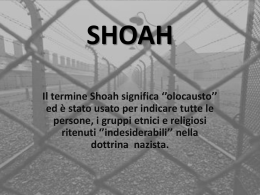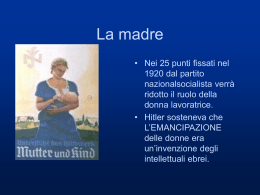27 Gennaio 2016
GIORNO DELLA MEMORIA
TESTI SULLA SHOA
Etty Hillesum
Volevo solo dire questo: la miseria che c’è qui è veramente terribile – eppure,
alla sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi capita
spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato, e allora dal mio
cuore s’innalza sempre una voce – non ci posso far niente, è così, è di una
forza elementare -, e questa voce dice: la vita è una cosa splendida e grande,
più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo. A ogni nuovo
crimine o orrore dovremo opporre un nuovo pezzetto di amore e di bontà
che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire ma non dobbiamo
soccombere. E se sopravviveremo intatti a questo tempo, corpo e anima ma
soprattutto anima, senza amarezza, senza odio, allora avremo anche il
diritto di dire la nostra parola a guerra finita. Forse io sono una donna
ambiziosa: vorrei dire anch’io una piccola parolina.
( da Auschwitz luglio-agosto 1943)
Anche oggi il mio cuore e' morto piu' volte, ma ogni volta ha ripreso
a vivere. Io dico addio di minuto in minuto e mi libero da ogni
esteriorità. Recido le funi che mi tengono ancora legata, imbarco
tutto quel che mi serve per intraprendere il viaggio. Ora sono seduta
sulla sponda di un canale silenzioso, le gambe penzolanti dal muro di
pietra, e mi chiedo se il mio cuore non diventera' così sfinito e
consunto da non poter piu' volare liberamente come un uccello. (luglio 1942)
PRIMO LEVI
Se questo è un uomo
“Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.”
(Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1976, p.1)
Si può ottenere secondo lei l’annullamento dell’umanità dell’uomo?
Purtroppo si, purtroppo si. E direi che è proprio la caratteristica del lager nazista - degli altri non so
, perché non li conosco, forse in quelli russi avviene altrettanto - è di annullare la personalità
dell’uomo, all’interno e all’esterno, e non soltanto del prigioniero, ma anche del custode del Lager
perde la sua umanità; sono due itinerari divergenti, ma che portano allo stesso risultato: Direi che è
toccata a pochi la fortuna di conservarsi consapevoli durante la prigionia; alcuni hanno riacquistato
la consapevolezza di cosa era stata questa esperienza dopo, ma durante l’avevano persa. Molti
hanno dimenticato tutto, non hanno registrato le loro esperienze mentalmente, non le hanno incise
nel nastro della memoria, per così dire. Quindi avveniva si, sostanzialmente in tutti una profonda
modificazione delle personalità, con una attenuazione della sensibilità, soprattutto, per cui della
casa, le memorie della famiglia, passavano in secondo piano di fronte al bisogno urgente , alla fame,
al bisogno di difendersi dal freddo, al difendersi dalle percosse, al resistere alla fatica. Tutto questo
portava a delle condizioni che si potevano chiamare animalesche, come quelle degli animali da
lavoro. […]
( “La Stampa”, Torino, domenica 26 gennaio 2003, p. 19)
PAUL CELAN
FUGA DI MORTE
Nero latte dell'alba lo beviamo la sera
lo beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo la notte
beviamo e beviamo
scaviamo una tomba nell'aria là non si giace stretti
Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive
che scrive all'imbrunire in Germania i tuoi capelli d'oro Margarete
lo scrive ed esce dinanzi a casa e brillano le stelle e fischia ai suoi mastini
fischia ai suoi ebrei fa scavare una tomba nella terra
ci comanda ora suonate alla danza.
Nero latte dell'alba ti beviamo la notte
ti beviamo al mattino e a mezzogiorno ti beviamo la sera
beviamo e beviamo
Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive
che scrive all'imbrunire in Germania i tuoi capelli d'oro Margarete
i tuoi capelli di cenere Sulamith scaviamo una tomba nell'aria là non si giace stretti
Lui grida vangate più a fondo il terreno voi e voi cantate e suonate
impugna il ferro alla cintura e lo brandisce i suoi occhi sono azzurri
spingete più a fondo le vanghe voi e voi continuate a suonare alla danza
Nero latte dell'alba ti beviamo la notte
ti beviamo a mezzogiorno e al mattino ti beviamo la sera
beviamo e beviamo
nella casa abita un uomo i tuoi capelli d'oro Margarete
i tuoi capelli di cenere Sulamith lui gioca con i serpenti
Lui grida suonate più dolce la morte la morte è un maestro tedesco
lui grida suonate più cupo i violini e salirete come fumo nell'aria
e avrete una tomba nelle nubi là non si giace stretti
Nero latte dell'alba ti beviamo la notte
ti beviamo a mezzogiorno la morte è un maestro tedesco
ti beviamo la sera e la mattina beviamo e beviamo
la morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro
ti colpisce con palla di piombo ti colpisce preciso
nella casa abita un uomo i tuoi capelli d'oro Margarete
aizza i suoi mastini contro di noi ci regala una tomba nell'aria
gioca con i serpenti e sogna la morte è un maestro tedesco
I tuoi capelli d'oro Margarete
I tuoi capelli di cenere Sulamith.
ELIE WIESEL
Mai potrei dimenticare quel silenzio notturno che mi privò, per
tutta l’eternità, del desiderio di vivere. Mai dimenticherò quei
momenti che uccisero il mio Dio e la mia anima, e ridussero i miei
sogni in polvere.
( da LA NOTTE, Giuntina editore)
Durante un raid aereo. Vicino alla cucina erano stati lasciati due
calderoni mezzi pieni di zuppa fumante. Due pentoloni di zuppa,
nel bel mezzo del sentiero, e nessuno a sorvegliarli!…
All’improvviso, vedemmo la porta della baracca 37 aprirsi
impercettibilmente. Apparve un uomo che strisciava come un verme
in direzione dei pentoloni.
Centinaia d’occhi seguirono i suoi movimenti. Centinaia d’uomini
strisciarono con lui, sbucciandosi i ginocchi insieme ai suoi
sulla ghiaia. Ciascun cuore batteva all’impazzata, ma d’invidia
sopra a tutto. Quest’uomo aveva osato.
Raggiunse il primo calderone. I cuori accelerarono: gliel’aveva
fatta. La gelosia ci consumava, ci bruciava come paglia.
Non pensammo nemmeno per un attimo di ammirarlo. Povero eroe,
suicidarsi per una razione di zuppa! Nei nostri pensieri, lo
stavamo uccidendo.
Sdraiato accanto al pentolone, cercava ora di sollevarsi verso il
brodo. Per debolezza o per paura, se ne stette lì, cercando senza
dubbio di chiamare a raccolta le ultime forze. Alla fine riuscì a
sporgersi sulla superficie della pentola. Per un attimo sembrò che
si guardasse, cercando il suo riflesso spettrale nella zuppa. Poi,
apparentemente senza ragione mandò un grido terribile, un rantolo
quale mai avevo udito prima, e, a bocca aperta, spinse il capo
verso il liquido fumante. L’esplosione ci fece sobbalzare.
Ricadendo all’indietro sul terreno, con viso macchiato dalla
zuppa, l’uomo si contorse per pochi secondi ai piedi del
calderone, poi non si mosse più.
( da LA NOTTE, Giuntina editore)
Le tre vittime montarono insieme sugli sgabelli.
I tre colli furono infilati nei cappi allo stesso momento.
“Viva la libertà!” gridarono i due adulti.
Ma il ragazzo rimase in silenzio.
“Dov’è Dio? Dov’è?” chiese qualcuno dietro di me.
Ad un segno del comandante del campo, i tre sgabelli rotolarono…
Cominciò la marcia dinanzi alle forche. I due grandi non vivevano
più. Le lingue cianotiche penzolavano gonfie. Ma la terza corda si
muoveva ancora; così leggero, il ragazzo era ancora vivo…
Stette là per più di mezz’ora, lottando tra la vita e la morte,
morendo d’una lenta agonia sotto i nostri occhi. E lo dovemmo
guardare bene in faccia. Era ancora vivo quando io passai. La
lingua ancora rossa, gli occhi non ancora vitrei. Dietro di me,
udii lo stesso di prima domandare:
“Dov’è Dio adesso?”
E udii una voce dentro di me rispondergli:
“Dov’è? Eccolo lì – appeso a quella forca…”
Quella notte la zuppa sapeva di morto.
( da LA NOTTE, Giuntina editore)
Martin Niemoeller
" Prima vennero per gli ebrei
e io non dissi nulla perché
non ero ebreo.
Poi vennero per i comunisti
e io non dissi nulla perché
non ero comunista.
Poi vennero per i sindacalisti
e io non dissi nulla perché
non ero sindacalista.
Poi vennero a prendere me.
E non era rimasto più nessuno
che potesse dire qualcosa."
Martin Niemoeller, oppositore del nazismo ed internato in un campo di
concentramento dal 1937 al 1945, l'uomo che Hitler chiamava "il suo prigioniero
particolare", ci ha lasciato questa testimonianza: «non posso esprimere ciò che
la Bibbia ha significato per me durante i miei lunghi anni di prigionia e soprattutto
negli ultimi quattro che ho passato in una cella di Dachau.
La Parola di Dio fu per me consolazione, forza, guida, speranza, padrona delle mie
giornate, compagna delle mie notti, il pane che mi nutriva e l'acqua che mi
rinfrescava l'anima. La mia finestra era troppo alta perché potessi guardare fuori
ma non troppo alta per chiamare chi passava per strada e dargli
qualche incoraggiamento tratto dalla Bibbia, come granelli di frumento seminati
dall'alto della mia finestra e afferrati dai passanti. In seguito, quando mi fu
permesso di passeggiare un'ora al giorno nel cortile, trovai altre finestre per
inviare il messaggio della Parola di Dio a qualc he fratello prigioniero». "La Parola
di Dio non è incatenata" (2 Timoteo 2:9). Oggi siamo posti continuamente in
mezzo ad un mondo che aspetta la pace di Dio. Il nostro compito è quello di far
conoscere all'uomo queste pagine meravigliose della Parola di Dio e di annunciare
ad un'umanità sofferente il messaggio dell'amore di Dio. Noi tutti possediamo un
libro dato da Dio, la Bibbia. Apriamolo, leggiamolo e condividiamo con gli altri i
tesori che esso di volta in volta ci rivela.
-------------Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller (Lippstadt, 14 gennaio 1892 –
Wiesbaden, 6 marzo 1984) è stato un teologo e pastore protestante tedesco,
oppositore del nazismo.
Comandante di U-Boot nella Prima guerra mondiale e decorato con Croce di Ferro,
fu inizialmente attivista a favore di Hitler. Nel 1934 Niemöller cominciò a opporsi al
nazismo ma, grazie alle sue amicizie e ai suoi rapporti con uomini d'affari ricchi e
influenti, venne "salvato" fino al 1937. In quell'anno fu arrestato dalla Gestapo su
diretto ordine di Hitler, infuriato per un suo sermone.
Rimase per otto anni prigioniero in vari campi di concentramento nazisti, tra i
qualiSachsenhausen e Dachau, finché non venne liberato. Sopravvisse per
diventare il portavoce della piena riconciliazione della popolazione tedesca dopo
la Seconda guerra mondiale.
È famoso per la poesia Prima vennero... a lui attribuita (anche se spesso viene
erroneamente citato come autore Bertolt Brecht), sul pericolo dell'apatia di fronte
ai primi passi dei regimi totalitari. La poesia è ampiamente citata, tuttavia la sua
origine è incerta e le parole precise rimangono controverse.
BONHOEFFER
9 aprile 1945-2015. Il cristiano che sfidò Hitler
Marco Roncalli
7 aprile 2015
«Ditegli che questa è la fine per me, ma anche l’inizio. Insieme a lui credo nel principio
della nostra fratellanza universale cristiana che si eleva al di sopra di ogni interesse
nazionale e credo che la nostra vittoria è certa...». Così Dietrich Bonhoeffer, l’8 aprile
1945, – giorno prima della sua impiccagione – nel messaggio affidato a un
compagno di prigionia e destinato all’amico George Bell, vescovo anglicano di
Chichester, conosciuto nel 1933. Era un saluto sprigionatosi di domenica, dal cuore di
un uomo libero, calato nel mondo e nella signoria di Gesù Cristo, un cristiano consapevole
di un destino di eternità.
Era una domenica quando le pronunciò e Bonhoeffer era in viaggio verso il lager di
Flossenbürg. L’indomani dopo l’alba fu subito giustiziato: nato a Breslavia, nel 1906, non
aveva neanche quarant’anni. Ci fu anche un testimone oculare che raccontò quelle ultime
sequenze di vita, settant’anni fa. Era il medico del campo. Uno che di lui non sapeva
niente. E che ha lasciato scritto altre parole capaci di commuoverci: «Attraverso la porta
semiaperta in una stanza delle baracche vidi il Pastore Bonhoeffer, prima di levarsi la sua
divisa carceraria, inginocchiarsi sul pavimento per pregare Dio con fervore. Fui
profondamente toccato dal modo in cui questo uomo amabile pregava, così devoto e
sicuro che Dio udisse la sua preghiera». E ancora: «Sul posto dell’esecuzione, disse
un’altra breve preghiera e quindi salì gli scalini verso il patibolo, coraggioso e composto.
La sua morte seguì dopo pochi secondi. Nei quasi cinquant’anni di professione medica,
non ho mai visto un uomo morire così totalmente sottomesso alla volontà di Dio».
Bonhoeffer, «teologo, cristiano, contemporaneo», per usare la sintesi del suo biografo
Eberhard Berthge, certamente è stato uno dei rari uomini di Chiesa che – senza
dimenticare una fugace simpatia nel 1920 per il nazionalismo che fu presto in grado di
spazzare via–, ben presto scese direttamente nell’agone politico e nella resistenza al Male
hitleriano. Bonhoeffer, però, è stato l’uomo che, soprattutto, ha motivato con il suo essere
cristiano quelle sue scelte. Come aveva scritto nel 1934 a Valdemar Ammundsen, il
vescovo danese direttore del Weltbund für internationale Freundschaftsarbeit der
Kirchen (la Federazione mondiale per la promozione dell’amicizia internazionale fra le
Chiese): «Qui, anche proprio nella nostra posizione verso lo Stato, si deve parlare in modo
del tutto franco, per amore di Gesù Cristo e della causa ecumenica. Dev’essere chiaro –
per quanto terribile sia – che di fronte a noi sta questa decisione: o nazionalsocialisti
oppure cristiani».
Da quella data alla morte sarebbero passati per Dietrich altri dodici anni costellati di scritti
densi (molti quali resi pubblici solo recentemente), che rendono conto del suo impegno
nel Kirchenkampf, nella lotta fra la Chiesa confessante antinazista e la Chiesa
dei Deutsche Christen (i cristiano-tedeschi sostenitori del nazionalsocialismo), ma che
pure offrono uno spaccato storico- politico e le direttrici di un dibattito teologico- culturale
ben oltre la sua figura . Un periodo fitto di lettere, specie dall’inizio degli anni Quaranta, a
testimoniare una vasta rete di interlocutori e di conoscenze, ma anche un’ampia
irradiazione di pensiero sulla premessa di una profonda riflessione esistenziale.
Ben documentata, ad esempio, nella silloge arrivata in libreria a cura di Alberto (Scritti
scelti 1933-1945, Queriniana, pagine 920, euro 93) dedicata proprio all’“ultimo
Bonhoeffer”, lavoro che conclude la serie dei dieci volumi delle Opere meritoriamente edita
da Queriniana. Dove trovano spazio tanti elementi del suo impegno. La questione
ecumenica, che assorbì Bonhoeffer sia sul piano del dialogo fra le Chiese sia su quello
dell’elaborazione teologica. L’approfondimento biblico, centrale, dal periodo nel seminario
clandestino di Finkenwalde a quello – diciotto mesi sino all’ottobre ’44 – nel carcere
berlinese di Tegel, prima di essere internato a Buchenwald. E, ancora, la riflessione
sull’etica sempre più urgente (con la scelta personale della cospirazione) e la questione
della sequela di Cristo in una condizione storica intrisa di violenza. Oppure la riflessione
sul significato di una fede personale declinata nel mondo divenuto adulto che ha eliminato
l’ipotesi del «Dio tappabuchi».
Pagine e pagine innervate da una fede spesa a dare concretezza alla Parola dentro la
storia, a servire la verità che «rimane pur sempre il servizio più grande che si possa
tributare all’amore nella comunità di Cristo». Quanto basta per spiegare il pastore teologo
del confronto con la modernità, della fedeltà alla terra, dell’obbedienza al Vangelo,
della caritas ancorata alla trascendenza, che si fa cospiratore, convinto che la Rivelazione
comporta più una fede che una religione, e comunque esige una responsabilità personale
nel farsi carico dei destini di ogni persona. Se necessario assumendo la Croce. Per gli
altri. Per amore.
Dietrich Bonhoeffer
Durante la nostra vita non parliamo volentieri di vittoria: per noi è una parola troppo grande. Nel
corso degli anni abbiamo subito troppe sconfitte. Troppi momenti di debolezza e colpe troppo gravi
ce l’hanno preclusa. Tuttavia lo spirito che è dentro di noi vi anela, desidera il successo finale
contro il male, contro il timore della morte. Nemmeno la parola di Dio ci promette che vinceremo il
peccato e la morte, ma afferma con tutta la sua forza che qualcuno ha ottenuto questo risultato. Se lo
considereremo nostro Signore, Egli vincerà anche noi. Non siamo noi a trionfare, ma Gesù. Noi
oggi annunciamo e crediamo queste cose in contrasto con tutto quello che vediamo intorno, contro
le tombe del nostro amore, contro la natura morente, contro tutto il dolore che la guerra ci sta
portando.
Constatiamo che la morte si afferma, ma crediamo che il Messia l’abbia superata e lo testimoniamo.
«La morte è stata inghiottita nella vittoria» (1Cor 15, 54). Egli è il vincitore. Resurrezione dei morti
e vita eterna. La Sacra Scrittura riporta una sorta di canzone satirica dal tono trionfalistico: «Dov’è,
o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?» (1Cor 15, 55). Si vantano la morte e il
peccato, incutendo timore all’uomo, come se fossero loro i signori del mondo, ma è solo apparenza.
È da tempo che hanno perduto il loro potere: è il Salvatore che glielo ha sottratto. Da allora nessun
essere umano che rimanga accanto a Lui deve temere questi oscuri padroni. Il pungiglione con cui
la morte ci colpisce non ha più nessun potere. Ma allora, ci chiediamo, perché nella nostra vita non
sembra che sia davvero così, perché vediamo così pochi segni di questa vittoria? Perché il peccato e
la morte incombono su di noi? È la stessa domanda che Dio ci pone: io ho fatto tutto questo per voi
e voi vivete come se non fosse accaduto! Vi sottomettete alla paura, come se poteste ancora farlo!
Perché la vittoria non è visibile nella vostra esistenza? Perché non volete credere che Cristo è il vero
e unico vincitore. La mancanza di fede è causa della vostra sconfitta.
26 novembre 1939
Lo sguardo dal basso
Resta un’esperienza di eccezionale valore l’aver imparato infine a guardare i grandi
eventi della storia universale dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei sospetti,
dei maltrattati, degli impotenti, - degli oppressi e dei derisi - in una parola: dei
sofferenti. Se in questi tempi l’amarezza e l’astio non ci hanno corroso il cuore; se
dunque vediamo con occhi nuovi le grandi e le piccole cose, la felicità e l’infelicità,
la forza e la debolezza; e se la nostra capacità di vedere la grandezza, l’umanità, il
diritto e la misericordia è diventata più chiara, più libera, più incorruttibile; se, anzi,
la sofferenza personale è diventata una buona chiave, un principio fecondo nel
rendere il mondo accessibile attraverso la riflessione e l’azione: tutto questo è una
fortuna personale. Tutto sta nel non far diventare questa prospettiva dal basso un
prender partito per gli eterni insoddisfatti, ma nel rispondere alle esigenze della vita
in tutte le sue dimensioni; e nell’accettarla nella prospettiva di una soddisfazione più
elevata, il cui fondamento sta veramente al di là del punto di vista dal basso e
dall’alto.
Resistenza e resa
Ciò che mi preoccupa continuamente è la questione di che cosa sia veramente per noi, oggi, il cristianesimo, o anche
chi sia Cristo. È passato il tempo in cui questo lo si poteva dire agli uomini tramite le parole – siano esse parole
teologiche oppure pie –; cosí come è passato il tempo della interiorità e della coscienza, cioè appunto il tempo della
religione in generale. Stiamo andando incontro ad un tempo completamente non-religioso; gli uomini, cosí come ormai
sono, semplicemente non possono piú essere religiosi. Anche coloro che si definiscono sinceramente “religiosi”, non lo
mettono in pratica in nessun modo; presumibilmente, con “religioso” essi intendono qualcosa di completamente diverso.
Il nostro annuncio e la nostra teologia cristiani nel loro complesso, con i loro 1900 anni, si basano però sull’“apriori
religioso” degli uomini. Il “cristianesimo” è stato sempre una forma (forse la vera forma) della “religione”. Ma se un giorno
diventa chiaro che questo “apriori” non esiste affatto, e che s’è trattato invece di una forma d’espressione umana,
storicamente condizionata e caduca, se insomma gli uomini diventano davvero radicalmente non religiosi – e io credo
che piú o meno questo sia già il caso (da che cosa dipende ad esempio il fatto che questa guerra, a differenza di tutte le
precedenti, non provoca una reazione “religiosa”?) – che cosa significa allora tutto questo per il “cristianesimo”?
Vengono scalzate le fondamenta dell’intero nostro “cristianesimo” qual è stato finora, e noi “religiosamente” potremo
raggiungere soltanto qualche “cavaliere solitario” o qualche persona intellettualmente disonesta. Dovrebbero essere
questi i pochi eletti? Dovremmo gettarci zelanti, stizziti o sdegnati proprio su questo equivoco gruppo di persone per
smerciar loro la nostra mercanzia? Dovremmo noi aggredire qualche infelice colto in un momento di debolezza e per
cosí dire, violentarlo religiosamente? Se non vogliamo niente di tutto questo, se alla fine anche la forma occidentale del
cristianesimo dovessimo giudicarla solo uno stadio previo rispetto ad una totale non-religiosità, che situazione ne
deriverebbe allora per noi, per la Chiesa? Come può Cristo diventare il signore anche dei non-religiosi? Ci sono cristiani
non-religiosi? Se la religione è solo una veste del cristianesimo – e questa veste ha assunto essa pure aspetti molto
diversi in tempi diversi – che cos’è allora un cristianesimo non-religioso?
Barth, che è stato l’unico ad aver cominciato a pensare in questa direzione, non ha poi portato a termine e pensato fino
in fondo queste idee, ma è pervenuto invece ad un positivismo della rivelazione (Offenbarungspositivismus) che in fin
dei conti s’è ridotto ad una sostanziale restaurazione. Qui l’operaio non-religioso o l’uomo in generale non hanno
guadagnato nulla di decisivo. Le risposte cui bisognerebbe rispondere sono invece: che cosa significano una Chiesa,
una comunità, una predicazione, una liturgia, una vita cristiana in un mondo non-religioso? Come parliamo di Dio –
senza religione, cioè appunto senza i presupposti storicamente condizionati della metafisica, dell’interiorità ecc. ecc.?
Come parliamo (o forse appunto ormai non si può piú “parlarne” come s’è fatto finora) “mondanamente” (weltlich) di
“Dio”, come siamo cristiani “non-religiosi-mondani”, come siamo ek-klesía, cioè chiamati-fuori, senza considerarci
religiosamente favoriti, ma piuttosto in tutto e per tutto appartenenti al mondo? Cristo allora non è piú oggetto della
religione, ma qualcosa di totalmente diverso, veramente il signore del mondo. Ma che significa questo? Che significato
hanno il culto e la preghiera nella non-religiosità? Acquista forse una nuova importanza a questo punto la disciplina
dell’arcano, ovvero la mia distinzione (che tu già conosci) tra penultimo e ultimo?
[...]
Spesso mi chiedo perché un “istinto cristiano” mi spinga frequentemente verso le persone non-religiose piuttosto che
verso quelle religiose, e ciò assolutamente non con l’intenzione di fare il missionario, ma potrei quasi dire
“fraternamente”. Mentre davanti alle persone religiose spesso mi vergogno a nominare il nome di Dio – perché in
codesta situazione mi pare che esso suoni in qualche modo falso, e io stesso mi sento un po’ insincero (particolarmente
brutto è quando gli altri cominciano a parlare in termini religiosi; allora ammutolisco quasi del tutto, e la faccenda diventa
per me in certo modo soffocante e sgradevole) – davanti alle persone non-religiose in certe occasioni posso nominare
Dio in piena tranquillità e come se fosse una cosa ovvia. Le persone religiose parlano di Dio quando la conoscenza
umana (qualche volta per pigrizia mentale) è arrivata alla fine o quando le forze umane vengono a mancare – e in effetti
quello che chiamano in campo è sempre il deus ex machina, come soluzione fittizia a problemi insolubili, oppure come
forza davanti al fallimento umano; sempre dunque sfruttando la debolezza umana o di fronte ai limiti umani; questo
inevitabilmente riesce sempre e soltanto finché gli uomini con le loro proprie forze non spingono i limiti un po’ piú avanti,
e il Dio inteso come deus ex machina non diventa superfluo; per me il discorso sui limiti umani è diventato
assolutamente problematico (sono oggi ancora autentici limiti la morte, che gli uomini quasi non temono piú, e il peccato,
che gli uomini quasi non comprendono?); mi sembra sempre come se volessimo soltanto timorosamente salvare un po’
di spazio per Dio; – io vorrei parlare di Dio non ai limiti, ma al centro, non nelle debolezze, ma nella forza, non dunque in
relazione alla morte e alla colpa, ma nella vita e nel bene dell’uomo. Raggiunti i limiti, mi pare meglio tacere e lasciare
irrisolto l’irrisolvibile. La fede nella resurrezione non è la “soluzione” del problema della morte. L’“aldilà” di Dio non è
l’aldilà delle capacità della nostra conoscenza! La trascendenza gnoseologica non ha nulla che fare con la trascendenza
di Dio. È al centro della nostra vita che Dio è aldilà. La Chiesa non sta lí dove vengono meno le capacità umane, ai limiti,
ma sta al centro del villaggio. Cosí stanno le cose secondo l’Antico Testamento, e noi leggiamo il Nuovo Testamento
ancora troppo poco a partire dall’Antico. Attualmente sto riflettendo molto su quale aspetto abbia questo cristianesimo
non-religioso, e quale forma esso assuma; te ne scriverò presto ancora e piú a lungo. Forse a questo proposito a noi
che ci troviamo al centro tra est ed ovest tocca un compito importante.
D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, Paoline, Milano, 1988
TESTIMONIANZA DI SAMUEL MODIANO
https://www.youtube.com/watch?v=7tBFAJvrIL0
https://www.youtube.com/watch?v=nP6Z_QXqyho
Mio padre a Birkenau mi disse:
«Vado via, ma tu devi resistere»
Sami Modiano, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti,
racconta 70 anni dopo: «Io salvo grazie a un carico di patate»
«Perché mi salvai proprio io? I miei incubi dopo il lager»
di Antonio Ferrari e Alessia Rastelli
A otto anni Sami Modiano era uno dei bambini più vivaci e brillanti della scuola elementare italiana di Rodi.
Forse era in assoluto il primo della classe, come sostenevano i genitori dei suoi compagni, con quell’ammirazione
espressa e così insistita da poter sconfinare facilmente nell’invidia. Sì, perchè Sami, alunno eccellente, non aveva
di sicuro l’aria e il comportamento del secchione. Nuotava, correva, giocava a calcio, scherzava, si divertiva, però
a scuola gli bastava studiare il minimo per meritare il massimo.
Quella mattina, quando fu chiamato alla cattedra, si sentiva persino più sicuro e disinvolto del solito. Era pronto
a rispondere alle domande del maestro ma il suo sorriso si spense subito perché l’insegnante, invece di
interrogarlo, lo guardò come mai lo aveva guardato e gli disse: «Samuel Modiano, sei espulso dalla scuola!». Un
ceffone morale umiliante, un vero choc, le gote di Sami si tingono di porpora, la gola si chiude. Con un filo di
voce: «Ma che colpa ho?», «Che cosa ho fatto? dove ho sbagliato?». Per far capire a quel bambino sbigottito e
improvvisamente spaventato che non aveva fatto nulla di male, e che quel provvedimento non riguardava né il
profitto né la condotta, l’imbarazzato maestro gli pose affettuosamente una mano sul capo e aggiunse a bassa
voce: «Ora tornatene a casa, tuo padre ti spiegherà».
Sami Modiano, che oggi ha quasi 83 anni e che per decine di volte si è salvato per puro caso nella più efferata
partita a scacchi con la morte, ha scritto un libro che ha per titolo la risposta – abbastanza ermetica – alla domanda
che per decenni lo ha tormentato: Per questo ho vissuto. Che cosa voglia dire in realtà, Sami lo scrive nelle pagine
della sua tremenda odissea. Pagine che grondano dolore, orrore, sevizie, umiliazioni, morte, torture, sterminio.
All’inizio del racconto, ecco il punto da cui tutto ha avuto origine: «Quella mattina, a Rodi, mi ero svegliato come
un bambino. La sera mi addormentai come un ebreo».
La storia del bambino-ebreo di Rodi trafigge il cuore e ferisce l’anima. È una storia che Sami, come quasi tutti i
sopravvissuti all’Olocausto, aveva taciuto per quasi tutta la vita perché, nel raccontarla, la sofferenza era come
raddoppiata: non bastava l’infarto emotivo della cronaca e dei ricordi incancellabili delle sofferenze patite; il
veleno aggiuntivo era provocato dall’incredulità espressa da molti di coloro che lo ascoltavano. «Guardandoli,
sembrava mi volessero dire che non credevano alla mia storia. E questo, ancora una volta, mi feriva a morte». Alla
fine, dopo molte titubanze, ha prevalso il dovere: di trasmettere ai giovani la vissuta testimonianza di quello che è
stato l’Olocausto, nel cuore dell’Europa colta ed evoluta; e poi di onorare chi fu annientato dall’odio razziale degli
aguzzini nazisti.
«Ero mor
Leggi razziali a Rodi. Sami si è speso e si spende con generosità, passione, sdegno, ma
anche con la lievità di chi non ha perduto il senso dell’umorismo. La sua storia si apre
con le immagini di un’infanzia felice, in una famiglia felice, su un’isola felice, Rodi –
conquistata dagli italiani, che l’avevano strappata ai turchi all’inizio del ’900 –. Immagini
trasformate in poche ore, in quel maledetto 1938, in un incubo, costringendo le vittime a
dover convivere da subito con l’ansietà, l’angoscia, la paura. E con la consapevolezza di
essere il “diverso” che gli altri cercano di evitare, magari voltando il capo dall’altra parte.
Il padre di Sami che perde il lavoro, la madre uccisa da una grave malattia, la
necessità di procurare cibo per il genitore e la sorella, la generosità che i soldati italiani nutrono per quel ragazzino
nonostante le leggi razziali, la disoccupazione e la discriminazione che colpisce come una frustata la minoranza
ebraica dell’isola. Chi poteva, dopo la promulgazione delle leggi razziali del ’38, lascia l’italiana Rodi per andare
a vivere e a trovare un approdo più sicuro in America, in Argentina, in Canada, in Africa. In quattro anni, metà
degli israeliti erano espatriati: gli ebrei rimasti superavano di poco i 2.000. Sami non capiva, era ancora un
bambino, e non pensava che dopo qualche tempo avrebbe benedetto la prematura scomparsa della sua mamma.
Morendo nel suo letto di dolore, la donna non avrebbe visto e patito il picco dell’orrore, a differenza del marito e
dei figli. Il racconto dell’ingannevole convocazione degli ebrei di Rodi si raccorda subito con il calvario della
deportazione. Un calvario simile a quello di tutti i correligionari dei Paesi occupati dalla macchina da guerra di
Adolf Hitler, ma – nel caso dell’isola del Dodecaneso – con una feroce sofferenza aggiuntiva, il doppio viaggio
verso la morte: il primo in mare, stipati su una chiatta maleodorante riservata al trasporto degli animali, sotto lo
spietato sole di agosto, fino al porto di Atene; il secondo viaggio sul treno dell’infamia, nel buio soffocante dei
vagoni per il bestiame. Destinazione la Polonia, i campi di sterminio.
Sami ormai ha poco più di 13 anni, ma ne dimostra alcuni di più. La famiglia, giunta a Birkenau, supera la
prima brutale selezione: il cenno a sinistra del medico nazista, che giudicava a vista, voleva dire camera a gas e
forno; il cenno a destra indicava i “privilegiati”, risparmiati perchè giudicati adatti ai lavori più duri. In pochi
giorni di internamento, quasi tutto diventa chiaro, anche nello sguardo ancora innocente di un ragazzino. La
fugace e quotidiana visione di sua sorella, oltre la cortina di ferro attraversata dalla corrente, conforta Sami fino al
giorno in cui non la vede più, e comprende che è andata all’infermeria, anticamera della morte. Suo padre,
prostrato dal lavoro massacrante, dal freddo, dalla fame e dalle torture gli rivela, una sera, che ha deciso di farsi
visitare, metafora che significa “non ce la faccio più”. Ma prima di consegnarsi agli assassini, impone al figlio di
tenere duro. «Sami, tu sei forte. Devi farcela. Ce la farai!». E così il ragazzino di Rodi, diventato adulto, resta solo
a combattere per la vita.
Salvo grazie alle patate. Racconti e dettagli agghiaccianti.
Una volta Sami ha un cedimento, ha la tentazione di farla finita, è pronto a lanciarsi contro il filo spinato, davanti
al quale ogni giorno veniva obbligato a raccogliere i cadaveri delle persone che, una notte dopo l’altra, decidevano
di morire. Lo trattiene l’accorata imposizione di suo padre: “Devi farcela!” Ci riesce, almeno fino a quando,
affamato, indebolito e ridotto ad uno scheletro, non riesce a superare la nuova selezione. Vuol dire camera a gas. Il
suo destino è segnato. Lo chiudono, assieme ad un gruppo di altri sventurati, nell’anticamera della finta doccia
dove le conduttore del letale Zyklon B sputano veleno a getto continuo. Ma non succede nulla. Una nuova forma
di tortura, sperimentata dai nazisti? Passano le ore in un silenzio irreale, poi si spalanca una porta, ma non è quella
della camera a gas. Un ufficiale tedesco dà ordine di uscire all’aperto, perchè si è prodotta un’emergenza. Sami
racconta l’emergenza con un sorriso amaro: «Sono vivo grazie ad un carico di patate». Chissà quante volte avrà
raccontato questo incredibile episodio. «Proprio patate, sissignore! Era infatti arrivato un treno carico di patate,
ma non vi erano abbastanza prigionieri per scaricarlo. Era quasi mezzogiorno, e quasi tutti i deportati si trovavano
fuori dal campo, al lavoro. Bisognava scaricare le patate in fretta perchè un altro treno della morte, carico di ebrei,
attendeva il turno per arrivare alla rampa di Birkenau. Io e gli altri candidati al gas ci siamo guardati, stupefatti:
non era ancora il momento di morire. Fummo condotti a scaricare le patate, sistemandole a piramide su assi di
legno. Alla fine, ci fu un’animata discussione fra due ufficiali nazisti: uno diceva che dovevamo andare al gas
subito; l’altro invece – visto che già indossavamo il pigiama a righe e avevamo preso confidenza con le leggi, la
disciplina e le punizioni del lager – sostenne che era meglio rimandarci nelle nostre baracche. Per il gas sarebbero
stati pronti i passeggeri del treno che stava sopraggiungendo. Prevalse il fanatismo organizzativo del secondo. Per
noi, quindi, morte rinviata».
La marcia della morte. Sami ha un carattere forte, ma rivivere quei momenti gli provoca una smorfia dolorosa.
«A Birkenau avevo perso la fede, bestemmiavo il dio che non faceva nulla per impedire quell’atrocità. Poi, Dio
l’ho ritrovato. Mi ha fatto sentire la sua presenza anche alla fine di quell’atroce sofferenza. Mentre stava arrivando
l’Armata rossa sovietica per liberarci, i nazisti ci misero in fila per la fuga notturna, dopo aver fatto saltare i forni
e distrutto le prove più evidenti dello sterminio, cercando di cancellare quel che ormai tutto il mondo sapeva.
Durante il trasferimento, che i sopravvissuti ricordano come la marcia della morte, chi cadeva, scivolava o
zoppicava veniva ammazzato immediatamente con una raffica di mitra. Ero sfinito, mi piegai sulle ginocchia. Ero
morto, sì ero morto, sapevo e sentivo che nessuno avrebbe potuto far più nulla. Invece, due miei sconosciuti
compagni di sventura mi presero, uno per le braccia l’altro per le gambe, e mi salvarono, alla fine della marcia,
lasciandomi svenuto – ma vivo – accanto ad una montagna di cadaveri. Non ho mai conosciuto i nomi di chi mi ha
salvato. Li ho cercati ma non ho mai ritrovato quei due angeli che erano stati più forti della volontà di
sopravvivere, una forza che imponeva a ciascuno di pensare egoisticamente a se stesso, a farcela. E poi Dio si è
ricordato di me, dandomi la fortuna di incontrare mia moglie. Vivere con un sopravvissuto non è facile. Occorre
pazienza, generosità e amore. Io l’amore vero lo ho trovato. Sono stato fortunato». È incredibile sentir parlare di
fortuna da un uomo che ha visto e patito le sofferenze più indicibili. Doppiamente incredibile perchè, anche dopo
dopo la liberazione, la vita di Sami Modiano, salvo per caso, non è stata facile. La fuga dal villaggio dove erano
dislocati i soldati sovietici che lo avevano salvato. Fuga dettata dal piano di un amico, che temeva di essere
inviato sul fronte russo, e dal desiderio di tornare a casa, nonostante i sovietici trattassero i sopravvissuti con
molta umanità. Altre settimane di marcia notturna, ma questo – racconta Sami – «per me, come si può
immaginare, non era il principale problema». Alla fine, l’arrivo a Roma. Ero italiano a tutti gli effetti, ma non
avevo mai visto il mio Paese.
Dall’Africa a Ostia. Modiano aveva perduto tutto. Rodi era lontana. E così è andato a cercare parenti e amici,
prima a Ostia, dove vive tuttora, poi in un altro esilio, nel Congo Belga, dove altri si erano trasferiti e avevano
intrapreso con successo attività commerciali. L’intraprendente ragazzino, diventato adulto combattendo con la
morte, non ci pensa due volte. Sbarca dall’aereo nel cuore dell’Africa, prende confidenza, si impegna, viene
colpito più volte dalla malaria ma si riprende, mette in piedi una piccola impresa. Finalmente è quasi un
benestante. Si sposa e si convince che la vita è tornata finalmente a sorridergli. Ma non è così. La brutale
conquista del potere da parte di Mobutu e la caccia agli stranieri, depredati di tutto, lo spinge ad abbandonare il
suo ultimo esilio. Un medico belga gli dice: «Sami, ti sei salvato ad Auschwitz-Birkenau. Mica vorrai morire qui».
E così, assieme alla moglie, torna in Italia e ricomincia daccapo, inventandosi una terza o una quarta vita. Che
carattere straordinario! Adesso Sami si divide tra Ostia e Rodi. D’inverno sta a casa, nella sua casa sul litorale, e
va a raccontare nelle scuole, nei licei e nelle università di tutta Italia cosa è stato l’orrore dei campi di sterminio,
quanto è stato facile instillare e alimentare il più feroce odio razziale, quanti (in Italia) hanno venduto gli ebrei ai
nazisti, e quanto sia velenosa e infame la campagna negazionista. D’estate si trasferisce a Rodi, per tener viva la
memoria di quella terribile deportazione e per cementare la minuscola presenza della comunità ebraica sull’isola.
Dalla fine della guerra, Rodi è greca. Ma quando chiedo a Sami se si senta più greco o italiano, quest’uomo fiero,
salvo per caso, non ha un attimo di indecisione: «Sono italiano, e mi sento italiano».
ALCUNE POESIE DEI BAMBINI DI TEREZIN
La farfalla
L’ultima, proprio l’ultima,
Così ricca, smagliante, splendidamente gialla.
Se le lacrime del sole potessero cantare contro una pietra bianca…
Quella, quella gialla
E' portata lievemente in alto.
Se ne è andata, ne sono certo, perché voleva dare un bacio d’addio al mondo.
Per sette settimane ho vissuto qui,
Rinchiuso dentro questo ghetto
Ma qui ho trovato la mia gente.
Mi chiamano le margherite
E le candele che splendono sull’abete bianco nel cortile.
Solo che io non ho visto mai un’altra farfalla.
Quella farfalla era l’ultima.
Le farfalle non vivono qui, nel ghetto.
Pavel Friedmann. 4-6-1942
Voi, nuvole grigio acciaio
Voi, nuvole grigio acciaio, dal vento frustate,
che correte verso mete sconosciute
Voi, portatevi il quadro dell’azzurro cielo
Voi, portatevi il cinereo fumo
Voi, portatevi della lotta il risso spettro
Voi, difendeteci! Voi, che siete fatte solo di gas.
Veleggiate per i mondi, semplicemente, spazzate dai venti
come l’eterno viandante aspettando la morte
voglio una volta così come voi – i metri misurare
di lontananze future e non tornare più
Voi, cineree nuvole sull’orizzonte
Voi, siate speranza e sempiterno simbolo
Voi, che con il temporale il sole coprite
Vi incalza il tempo! E dietro a voi è il giorno!
Vedem, Hanu_ Hachenburg (1929 morto nel 1944)
Sono Ebreo
Sono ebreo ed ebreo resto
anche se dalla fame morirò
così al popolo non recherò sconfitta
sempre per il mio popolo sul mio onore combatterò
Orgoglioso del mio popolo sono
che onore ha questo popolo
sempre sarò appresso
sempre di nuovo vivrò
Franta Bass
Nostalgia della casa
E’ più di un anno che vivo al ghetto,
nella nera città di Terezin,
e quando penso alla mia casa
so bene di che si tratta.
O mia piccola casa, mia casetta,
perché m’hanno strappato da te,
perché m’hanno portato nella desolazione,
nell’abisso di un nulla senza ritorno?
Oh, come vorrei tornare
a casa mia, fiore di primavera!
Quando vivevo tra le sue mura
io non sapevo quanto l’amavo!
Ora ricordo quei tempi d’oro:
presto ritornerò, ecco, già corro.
Per le strade girano i reclusi
e in ogni volto che incontri
tu vedi che cos’è questo ghetto,
la paura e la miseria.
Squallore e fame, queste è la vita
che noi viviamo quaggiù,
ma nessuno si deve avvedere:
la terra gira e i tempi cambieranno.
Che arrivi dunque quel giorno
in cui ci rivedremo, mia piccola casa!
Ma intanto prezioso mi sei
perché mi posso sognare di te.
1943 Anonimo
Lacrime
e dopo di loro la rassegnazione giunge,
lacrime
senza le quali la vita non è,
lacrime
ispirazione alla tristezza
lacrime che scendono senza tregua
Alena Synkovà
Una volta
Una volta una volta arriva
Una volta la consolazione appare
Una volta compare la speranza
Una volta terribilmente si sfoga
Una volta una brocca di lacrime scoppia
Una volta alla morte dice “Taci ormai”
Una volta arriva il giorno giusto
Una volta d’acqua sarà il vino
Una volta di piangere smettiamo
Una volta le ferite si rimarginano
Una volta Giuseppe, Dio questo
vincolo di schiavitù getta
Una volta anche Erode
muore impazzendo dal terrore
Una volta Davide pastore
di porpora si colorirà la tunica
colui che lo inseguiva
diventa storpio il vecchio Re Saul.
Una volta ha fine anche il dolore
della malinconica esistenza
una volta arriva il salvatore
per levare il giogo ai soggiogati
Una volta saremo se vuole il Signore
A Canaan portati
Una volta l’aloe fiorirà
Una volta la palma i frutti dà
Una volta tutto quello che è paura
Una volta passa la nostra povertà
Una volta entriamo nella tenda di Dio
Una volta, una volta per noi germoglierà.
Ivo Katz
Lettera a papà
Mammina ha detto, che oggi debbo scriverti
ma ho avuto tempo, nuovi bimbi sono arrivati
dagli ultimi trasporti e giocare volevo
non mi accorgevo come fugge l’istante.
Mi sono sistemato, dormo sul materasso
per terra, per non cadere.
Almeno non c’è bisogno di farsi il letto
ed al mattino dalla finestra vedo il cielo.
Ho un po’ tossito, ma non voglio ammalarmi
così sono felice quando corro in cortile.
Oggi da noi una veglia si terrà
proprio come in estate al campo degli scout.
Canteremo canzoni conosciute
la signorina suonerà la fisarmonica.
So che ti meravigli di come stiamo bene
e che sicuramente ti rallegreresti di stare qui con me.
Qualcos’altro, papà: vieni qui presto
e sia più lieto il tuo volto!
Quando sei triste, mammina allora si dispiace
e dei suoi occhi mi manca lo splendore.
E hai promesso di portarmi i libri
che veramente da leggere non ho nulla,
per favore vieni domani prima che sia buio
del mio grazie puoi essere sicuro.
Ormai debbo finire. Da parte della mamma ti saluto
con impazienza aspetto il suono dei tuoi passi
nel corridoio. Prima che di nuovo con noi sarai
ti saluta e ti bacia il tuo fedele ragazzo.
Hajn
E’ così
In quella che è chiamata la piazza di Terezin
è seduto un piccolo vecchio
come se fosse in un giardino.
Ha la barba e un berretto in testa.
Col suo ultimo dente
mastica un pezzo di pane duro.
Mio Dio, col suo ultimo dente:
invece d’una zuppa di lenticchie
povero superstite!
"Koleba": M. Kosck nato il 30.3.32 morto il 19.10.44 ad Auschwitz
H. Loewy nato il 29.6.31 morto il 4.10.44 ad Auschwitz
Bachner (dati anagrafici non accertati)
Tutti questi bei momenti
si son persi senza rimedio
la mia vita non ha una meta
e per cercarla non ho più le forze.
Ancora una volta soltanto
la tua testa nelle mie mani, prendere
poi chiudere gli occhi
e nelle tenebre andarsene in silenzio.
Anonimo
Paura
Oggi il ghetto prova una paura diversa,
Stretta nella sua morsa, la Morte brandisce una falce di ghiaccio.
Un male malvagio sparge il terrore nella sua scia,
Le vittime della sua ombra piangono e si contorcono.
Oggi il battito di un cuore di padre narra del suo terrore
E le madri nascondono la testa tra le mani.
Adesso qui i bimbi rantolano e muoiono di tifo
Il loro sudario sconta un’amara tassa.
Il mio cuore batte ancora nel mio petto
Mentre gli amici partono per altri mondi.
Forse è meglio – chi può saperlo? –
Assistere a ciò oppure morire oggi?
No, no, mio Dio, voglio vivere!
Senza vedere dissolversi i nostri numeri.
Vogliamo avere un mondo migliore,
Vogliamo lavorare – non dobbiamo morire!
Eva Pichová, dodici anni, Nymburk
Il giardino
Un piccolo giardino,
Fragrante e pieno di rose.
Il viale è stretto,
Lo percorre un piccolo bambino.
Un piccolo bambino, un dolce bambino,
Come quel fiore che sboccia.
Quando il fiore arriverà a fiorire
Il piccolo bambino non ci sarà più.
Franta Bass
IL GHETTO DI TEREZIN
Il ghetto di Terezin durante la seconda guerra mondiale fu il maggiore campo di
concentramento sul territorio dello Cecoslovacchia. Fu costruito come campo di passaggio
per tutti gli ebrei del cosiddetto "Protettorato di Boemia e Moravia", istituito dai nazisti
dopo l'occupazione della Cecoslovacchia, prima che gli stessi venissero deportati nei campi
di sterminio nei territori orientali. Più tardi vi furono deportati anche gli ebrei della
Germania, Austria, Olanda e Danimarca. Nel periodo in cui durò il ghetto - dal 24
novembre 1941 fino alla liberazione avvenuta l'8 maggio 1945 - passarono per lo stesso
140.000 prigionieri. Proprio a Terezin perirono circa 35.000 detenuti. Degli 87.000
prigionieri deportati a Est, dopo la guerra fecero ritorno solo 3.097 persone.
Fra i prigionieri del ghetto di Terezin ci furono all'incirca 15.000 bambini, compresi i
neonati. Erano in prevalenza bambini degli ebrei cechi, deportati a Terezin insieme ai
genitori, in un flusso continuo di trasporti fin dagli inizi dell'esistenza del ghetto. La
maggior parte di essi morì nel corso nel 1944 nelle camere a gas di Auschwitz. Dopo la
guerra non ne ritornò nemmeno un centinaio e di questi nessuno aveva meno di quattordici
anni. I bambini sopportarono il destino del campo di concentramento assieme agli altri
prigionieri di Terezin.
Dapprima i ragazzi e le ragazze che avevano meno di dodici anni abitavano nei
baraccamenti assieme alle donne; i ragazzi più grandi erano con gli uomini. Tutti i bambini
soffrirono assieme agli altri le misere condizioni igieniche e abitative e la fame. Soffrirono
anche per il distacco dalle famiglie e per il fatto di non poter vivere e divertirsi come
bambini. Per un certo periodo i prigionieri adulti riuscirono ad alleviare le condizioni di
vita dei ragazzi facendo si che venissero concentrati nelle case per i bambini.
La permanenza nel collettivo infantile alleviò un tantino, specialmente sotto l'aspetto
psichico, l'amara sorte dei piccoli prigionieri. Nelle case operarono educatori e insegnanti
prigionieri che riuscirono, nonostante le infinite difficoltà e nel quadro di limitate
possibilità, a organizzare per i bambini una vita giornaliera e perfino l'insegnamento
clandestino. Sotto la guida degli educatori i bambini frequentavano le lezioni e
partecipavano a molte iniziative culturali preparate dai detenuti. E non furono solo
ascoltatori: molti di essi divennero attivi partecipanti a questi avvenimenti, fondarono
circoli di recitazione e di canto, facevano teatro per i bambini. I bambini di Terezin
scrivevano soprattutto poesie. Una parte di questa eredità letteraria si è conservata.
L'educazione figurativa veniva organizzata nelle case dei bambini secondo un piano
preciso. Le ore di disegno erano dirette dall'artista Friedl Dicker Brandejsovà. Il
complesso dei disegni che si è riusciti a salvare e che fanno parte delle collezioni del
Museo statale ebraico di Praga, comprende circa 4.000 disegni. I loro autori sono per la
gran parte bambini dai 10 ai 14 anni.
Utilizzavano i più vari tipi e formati della pessima carta di guerra , ciò che potevano
trovare, spesso utilizzando i formulari già stampati di Terezin, le carte assorbenti. Per il
lavoro figurativo i sussidi a disposizione non bastavano e i bambini dovevano prestarseli a
vicenda.
Sotto l'aspetto tematico i disegni si possono suddividere in due gruppi fondamentali: da
una parte di disegni a tematica infantile, in cui i piccoli autori tornavano alla loro infanzia
perduta. Disegnavano giocattoli, piatti pieni di cose da mangiare, raffiguravano l'ambiente
della casa perduta.
Disegnavano e dipingevano prati pieni di fiori e farfalle in fiore e farfalle in volo, motivi
di fiaba, giochi di bambini. La maggior parte della collezione comprende questo tipo di
disegni. Il secondo gruppo è formato da disegni con motivi del ghetto di Terezin.
Raffigurano la cruda realtà in cui i bambini erano costretti a vivere. Qui incontriamo i
disegni delle caserme di Terezin, dei blocchi e delle strade, dei baraccamenti di Terezin
con i letti a tre piani, i guardiani. Ma i bambini disegnavano anche i malati, l'ospedale, il
trasporto, il funerale o un'esecuzione.
Nonostante tutto però i piccoli di Terezin credevano in un domani migliore. Espressero
questa loro speranza in alcuni disegni in cui hanno raffigurato il ritorno a casa. Sui disegni
c'è di solito la firma del bambino, talvolta la data di nascita e di deportazione a Terezin e
da Terezin. La data di deportazione da Terezin è anche in genere l'ultima notizia del
bambino. Questo è tutto quanto sappiamo sugli autori dei disegni, ex prigionieri bambini
del ghetto nazista di Terezin. La stragrande maggioranza dei bambini di Terezin morì. Ma
è rimasto conservato il loro lascito letterario e figurativo che a noi parla delle sofferenze e
delle speranze perdute.
Dr. Anita Frankovà Direttore del museo ebraico di Praga
GIORGIO PERLASCA
Il racconto di Giorgio Perlasca è una storia vera, l’incredibile vicenda di un commerciante
padovano che, nell’inverno 1944, a Budapest riuscì a salvare dallo sterminio migliaia di ebrei,
spacciandosi per il console spagnolo.
Era un fascista entusiasta e aveva combattuto in Spagna come volontario per Franco. L’8
settembre 1943 lo trovò lontano da casa, ricercato dalle SS. Avrebbe potuto mettersi in salvo.
Dal suo Diario, emerge l’azione straordinaria di un uomo solo, aiutato da uno sparuto gruppo
di persone, che sforna documenti falsi, organizza e difende otto “case rifugio”, trova cibo,
strappa ragazzi dai “treni della morte” di Adolf Eichmann inganna nazisti tedeschi e
ungheresi.
30 dicembre, sabato
La notte scorsa è successo un fatto terribile. Hanno preso un
gruppo di ebrei del ghetto e li hanno trucidati in piazza Ferenc
Liszt e in via Eötvös. Abbiamo prima udito le grida e le suppliche
di centinaia di persone, e poco dopo gli spari.
All’alba mi sono recato sul posto e ho visto che i morti erano per
la maggior parte donne e bambini. La mattina sono andato all’hotel
Hungaria per incontrare il delegato della Croce Rossa
Internazionale, Weyermann. Improvvisamente mi si è avvicinato un
ufficiale ungherese, pregandomi di andare con lui in riva al
Danubio. I miei carabinieri hanno tentato di mandarlo via, temendo
un attentato. Poi si sono limitati a rimanermi vicino, ma con i
mitra puntati sull’ufficiale.
Tutta la riva del fiume era ricoperta da neve, ma davanti ai caffè
Hungaria e Negresco il colore era diventato rosso sangue. Nel
fiume si vedevano i corpi nudi di centinaia di morti, che l’acqua
non aveva potuto trascinare con sé a causa della presenza di
blocchi di ghiaccio. Queste persone erano state ammazzate durante
la notte e poi gettate in acqua.
Ho detto all’ufficiale che avevo visto qualcosa di simile vicino
al ponte Margherita e gli ho chiesto perché mi avesse invitato
qui. Il suo scopo era quello di convincere gli stranieri che
l’esercito era estraneo a questi fatti. E’ vero, gli ho risposto,
ma l’esercito serve per far rispettare la legge e tutelare i
diritti dei cittadini, non per assistere a simili atrocità. Mi
hanno raccontato che le vittime erano state costrette a camminare
per circa due chilometri, in fila per due, con le mani legate, a
piedi scalzi e completamente svestite. Le avevano poi fatte
inginocchiare sulla riva del fiume e avevano sparato loro alla
nuca.
L’ufficiale mi ha consegnato una donna che si era salvata per
essere caduta in acqua prima degli spari. L’avevano slegata e la
stavano frizionando con della canfora. L’ho portata con me
all’ambasciata.
Da: Enrico Deaglio, LA BANALITA’ DEL BENE Storia di Giorgio Perlasca, Tempo
ritrovato, Feltrinelli
76603
Il mio numero era 76603. Mentre agli ebrei glielo tatuavano sul braccio a noi politici davano il
numero inciso su un bracciale; pagando una minestra, te lo incidevano su un bracciale di cuoio
anziché di ferro.
(tratto da "C'era una volta la guerra" a cura di Sonia Brunetti e Fabio Levi. Silvio Zamorani
editore, Torino 2002.)
Rudolf Höss
(…) A Sachsenhausen vi erano parecchie personalità, e anche alcuni prigionieri speciali. Erano
indicati come “personalità” quei prigionieri che avevano sostenuto a suo tempo un certo ruolo nella
vita pubblica. Erano considerati per lo più prigionieri politici, e nel campo erano messi insieme ad
altri del loro tipo, senza particolari privilegi (…).
Desidero parlare ora più diffusamente di un prigioniero speciale, perché il suo comportamento in
prigionia fu del tutto peculiare, e io ebbi modo di osservarlo in ogni circostanza. Era il pastore
evangelico Martin Niemoeller. Durante la guerra era stato un famoso comandante di
marina; dopo la guerra divenne pastore. La Chiesa evangelica tedesca era suddivisa in numerosi
gruppi, tra i quali rivestiva particolare importanza la Bekenntniskirche, guidata da Niemöller. Il
Führer, volendo riunificate e raccogliere tutti i diversi tronconi, nominò un vescovo evangelico di
Stato, ma molti dei gruppi evangelici non lo riconobbero e lo osteggiarono violentemente, e tra essi
anche Niemöller. La sua congregazione era a Dahlem, un sobborgo di Berlino; qui si radunava tutta
l’opposizione reazionaria evangelica di Berlino e di Potsdam, tutta la vecchia aristocrazia imperiale
e tutti gli scontenti del regime nazionalsocialista. Ad essi Niemöller predicava la resistenza, e fu
questa appunto la causa del suo arresto. Venne condotto nel cellulare di Sachsenhausen, dove
godette di tutti i privilegi possibili. Poteva scrivere alla moglie a suo piacere, e la moglie fargli
visita ogni mese e portargli tutto ciò che desiderava quanto a libri, tabacco e viveri. Se lo
desiderava, poteva passeggiare nel cortile del cellulare, e la sua cella non era sfornita di comodità.
Insomma, gli fu concesso quanto era possibile. Il comandante era tenuto ad occuparsi di lui di
frequente e ad informarsi dei suoi desideri.
Era interesse personale del Führer riuscire a ottenere da Niemöller che rinunziasse alla sua
resistenza; personalità di primo piano si recarono a Sachsenhausen per convincerlo, perfino il suo
vecchio superiore e seguace della sua Chiesa, l’ammiraglio Lans, ma tutto fu vano. Niemöller non si
scostò d’un filo dal suo punto di vista, che cioè nessuno Stato ha il diritto di emanare leggi sulla
Chiesa, tanto meno, poi, leggi che la riguardino da vicino, poiché ciò è una faccenda di mera
pertinenza delle congregazioni ecclesiastiche. La Bekenntniskirche continuò così a prosperare e
Niemöller divenne ufficialmente il suo martire (…).
(…) Quando nel 1941, per ordine di Himmler tutti i religiosi dovettero essere trasferiti a Dachau,
anch’egli subì la stessa sorte (…).
(…) Himmler esigeva l’adempimento del dovere, l’impegno dell’intera personalità, fino al
sacrificio di sé. Ciascuno in Germania doveva impegnarsi fino in fondo perché potessimo vincere la
guerra. Per sua volontà, i campi di concentramento erano diventati vere fabbriche belliche, e a
questa attività si doveva subordinare ogni cosa, di fronte ad essa dovevano cadere tutte le
considerazioni di qualsiasi genere.
Era sintomatica, a questo riguardo, la sua assoluta e consapevole indifferenza verso le condizioni
generali dei campi, divenute ormai intollerabili. Lo sforzo bellico era la prima cosa:tutto ciò che
intralciava la strada doveva essere eliminato.non mi era lecito pensare diversamente; dovevo farmi
sempre più duro, più freddo, più inesorabile verso le sofferenze dei prigionieri. Vedevo ogni cosa
molto chiaramente, spesso anche troppo, ma non potevo lasciarmi vincere, non potevo permettere
che i miei sentimenti mi arrestassero. Ogni altra cosa era superflua di fronte allo scopo finale: la
vittoria in guerra. Così, a quel tempo, io vedevo il mio compito. Non potevo andare al fronte:
dunque, dovevo fare in patria il massimo sforzo per sostenere il fronte. Oggi mi accorgo che
nonostante i miei frenetici sforzi per lavorare e far lavorare, non potevamo comunque vincere la
guerra; ma a quel tempo credevo con assoluta convinzione nella vittoria finale, e ritenevo di dover
lavorare per questo fine, senza trascurare la minima cosa.
Per volontà di Himmler, Auschwitz divenne il più grande centro di sterminio di tutti i tempi.
Allorché, nell’estate del1941, mi comunicò personalmente l’ordine di allestire ad Auschwitz un
luogo che servisse allo sterminio in massa, e di realizzare io stesso tale operazione, non fui in grado
di immaginare minimamente la portata e gli effetti. In effetti, era un ordine straordinario e
mostruoso, ma le ragioni che mi fornì mi fecero apparire giusto questo processo di annientamento.
A quel tempo non riflettevo: avevo ricevuto un ordine ed era mio dovere eseguirlo. Non potevo
permettermi di giudicare se questo sterminio in massa degli ebrei fosse o no necessario, la mia
mente non arrivava tanto in là. Se il Führer in persona aveva ordinato la “soluzione finale della
questione ebraica”, un vecchio nazionalsocialista, e tanto più un ufficiale delle SS, non poteva
neppure pensare di entrare nel merito. “Il Führer comanda, noi obbediamo”, non era certo una frase
né uno slogan, per noi. Era un concetto preso terribilmente sul serio.
Dal momento del mio arresto, mi è stato detto ripetutamente che avrei potuto benissimo rifiutare di
eseguire questi ordini, che avrei potuto perfino assassinare Himmler. Non credo che, tra le migliaia
di ufficiali delle SS, ve ne fosse anche solo uno capace di formulare un simile pensiero.
Semplicemente, non sarebbe stato possibile.
Nel luglio del 1942, Himmler venne a visitare il campo. Gli feci percorrere in lungo e in largo il
campo degli zingari, ed egli esaminò attentamente ogni cosa: le baracche d'abitazione sovraffollate,
i malati colpiti da epidemie, vide i bambini colpiti dall'epidemia infantile Noma, che non potevo
mai guardare senza orrore e che mi ricordavano i lebbrosi che avevo visto a suo tempo in
Palesatine: i loro piccoli corpi erano consunti, e nella pelle delle guance grossi buchi permettevano
addirittura di guardare da parte a parte; vivi ancora, imputridivano lentamente.
Rudolf Höss ricorda un dialogo con Eichmann sulla gestione della
soluzione finale
Quindi passammo a discutere le modalità per attuare il piano di
sterminio. Il mezzo non poteva essere che il gas, perché sarebbe
stato senz’altro impossibile eliminare le masse di individui in
arrivo con le fucilazioni; e, oltretutto, sarebbe stata una fatica
troppo pesante per i militi delle SS incaricati di eseguirle.
( Tratto da: Comandante ad Auschwitz. Memoriale autobiografico di Rudolf Höss
1960 Giulio Einaudi editore)
LA TESTIMONIANZA DI PIERINO TREZZI
https://www.youtube.com/watch?v=9jHCb5Y6
Dew
Regione di cattura: Lombardia
Pierino Trezzi
Nato il 17.08.1924 a Gaggiano (MI)
Intervista del: 10.09.2003 ad Abbiategrasso (MI)
TDL: n. 185 – durata: 53’ circa
Arresto: ad Abbiategrasso il 12.08.1944
Carcerazione: a Legnano(MI); San Vittore (MI)
Deportazione: Bolzano; Dachau; Bad Gandershein
Liberazione: il 13 aprile 1945, fuga durante marcia della mo
Nota sulla trascrizione della testimonianza:
L’intervista è stata trascritta letteralmente. Il nostro intervento si è limitato all’inserimento dei
segni di punteggiatura e all’eliminazione di alcune parole o frasi incomplete e/o di ripetizioni.
D: Come ti chiami?
R: Pierino Trezzi. Sono nato a Gaggiano, provincia di Milano, il 17.8.1924. La
mia storia: il 30 agosto del 1943 sono chiamato a militare.
GovernoBadoglio, questa è storia. Dopo otto giorni, 8 settembre, tutti a casa.
Ce l’ho fatta ad arrivare a casa.
D: Dov’eri?
R: Ero a Cividale del Friuli. Ce l’ho fatta, ci ho messo sei giorni ad arrivare a
casa, a piedi, rischiando col treno. Insomma, ce l’ho fatta. Siamo a casa. Dopo
due mesi che sono a casa il richiamo alle armi. Io non ci vado, anzi vado. Che
cosa succede? E’ una decisione che bisogna prendere con le dovute… Perché
rischi forte, non puoi dormire più in casa, devi dormire nelle cascine, d’estate
nei fossi e d’inverno di sopra nel solaio, perché ogni tanto venivano i carabinieri
a controllare, a cercarmi. Perché loro sanno che non ho… Allora saltiamo un
pezzettino adesso. Per tutti i quindici giorni ero ricercato dai carabinieri, in casa
non c’ero perché ero via. Ci stufiamo di fare questa vita, cerchiamo di andare
in montagna. Andiamo a Lecco. Arrivati a Lecco, arrestati subito.
D: Quando questo?
R: Questo circa nel ‘44 in aprile.
D: E perché Lecco, Pierino?
R: Lecco perché per andare in montagna era la via più… Non so perché.
D: Non avevate un compagno?
R: Sì, eravamo accompagnati da uno che hanno fucilato quando l’hanno preso.
Lì arrestati, dieci giorni di carcere.
D: Ma chi è che ti ha arrestato a Lecco?
R: I repubblichini. Portati in carcere dieci giorni, poi mi hanno portato a Milano
e mi hanno fatto firmare un mucchio di documenti per il volontariato. Da
Milano mi hanno portato a Novara. Da Novara sono scappato a casa.
D: Ma a Novara in carcere?
R: No, era una caserma, era un carcere ma era una caserma.
D: Solamente te o gli altri tuoi compagni che hanno portato a Lecco?
R: Eravamo in tre, sì.
D: Sempre di Gaggiano erano?
R: No, sono nato a Gaggiano, ma abitavo qui ad Abbiategrasso.
D: Abitavi già ad Abbiategrasso?
R: Sì, sì.
D: Voi tre che vi hanno arrestato a Lecco…
R: Mi hanno portato a Milano.
D: Poi a Novara.
R: Poi a Novara. Da Novara siamo scappati subito. Naturalmente lì siamo
ricercati sempre, una vita da cani. Allora decidiamo di andare in montagna, ci
troviamo in un bosco. Spia, circondati, sparatoria, tutti a casa. Ce l’abbiamo
fatta ad arrivare tutti a casa. In quel periodo hanno arrestato uno, dopo un
mese ha cantato. Lì mi hanno fatto il giochetto con la polizia politica, è venuto
qua, ci troviamo al bar e così, ci mettiamo d’accordo quando partiamo in
montagna. Quelli là erano della polizia segreta della Repubblica di Salò.
D: L’UPI, l’Ufficio della Polizia Politica.
R: L’Ufficio della Polizia Politica. Anzi, io ho dei documenti che comprovano la
motivazione del mio arresto. Li ho qui. Ad ogni modo arrestati e portati,
circondati.
D: Arrestati dove, Pierino?
R: Al bar, il bar della Lea, di fronte al bar della Lea. Eravamo in dieci compreso
il padrone.
D: Qui ad Abbiategrasso?
R: Qui ad Abbiategrasso, qui, qui. Arriviamo là, ci portano a Legnano, al
carcere di Legnano.
D: Scusami, Pierino, quando ti hanno arrestato?
R: Il 12 d’Agosto 1944. Poi portati a Legnano, a Legnano carcere. Dopo
quindici giorni ci portano a San Vittore in raggio tedesco, perché eravamo dei
politici. La destinazione era già scritta: Dachau. Raccontare le avventure, gli
episodi di Legnano è un obbrobrio. Ho visto delle torture, addirittura impazzire.
Hanno torturato i capi, poi li hanno uccisi sulla strada.
D: Ma quelli che torturavano lì a Legnano erano italiani o germanici?
R: Erano italiani. Allora faceva parte dell’Italia ancora, capito? Il raggio politico
era un paradiso, il raggio politico e i tedeschi rispettosi, ci davano un mucchio
da mangiare, una cosa che non davano gli italiani. Qui a San Vittore al quinto o
sesto raggio, non ricordo. Siamo stati lì un quindici, venti giorni, poi col
pullman ci hanno portati a Bolzano. A Bolzano ci hanno fatto lavorare, gli
episodi non raccontiamoli.
D: Lavorare dove a Bolzano?
R: Spostare delle cose.
D: Ma dentro nel campo o fuori?
R: Ci portavano anche fuori a lavorare, a spostare. Poi c’è un episodio
addirittura scioccante, ho cercato di salvare un ebreo e ho preso tante di quelle
botte.
D: Dentro nel campo?
R: Nel campo, perché era un vecchietto e non ce la faceva a lavorare, allora ho
cercato di aiutarlo. Botte. C’era un tedesco, sarà stato di sedici, diciassette
anni, l’ha ucciso a legnate. Sanguinava dappertutto, ha ucciso quell’ebreo là. Io
ho preso la mia razione, però ero talmente giovane io che…
D: Ma, Pierino, quell’ebreo, quell’anziano ebreo che dici te è quello che era
partito con te da San Vittore?
R: Mi pare, adesso non so di preciso. Sul pullman eravamo ebrei e politici,
capito? C’era un po’ di casino.
D: Ma lì a Bolzano ti hanno immatricolato?
R: No, no. Mi hanno dato la tuta blu con una croce rossa dietro.
D: Ti ricordi il tuo blocco qual era a Bolzano?
R: No, non ricordo.
D: Il triangolo ce l’avevi?
R: No, lì no. C’era la croce sulla tuta blu.
D: Il periodo in cui tu arrivi a Bolzano qual è? Te lo ricordi?
R: Posso grosso modo dire verso la fine di settembre, a metà settembre,
principi d’ottobre. Mi ricordo un particolare, io ho fatto l’attraversamento della
frontiera del Brennero la seconda domenica d’ottobre, che era la festa di
Vigevano allora. Tutto lì.
D: Allora, sei stato a Bolzano, uscivate, collaboravate nel campo a spostare…
R: Sì, a spostare delle cose.
D: Cose di questo genere. Lì c’è quest’episodio di quest’anziano ebreo. Come
fai a dire che era ebreo? Te l’aveva detto?
R: Ebreo perché eravamo insieme, si lavorava insieme purtroppo, gente che
aveva dei possedimenti non indifferenti. Lei sa benissimo che l’ebreo si salvava
per le possibilità economiche.
D: I tuoi compagni di Abbiategrasso, quelli arrestati con te…
R: Sì.
D: Hanno fatto il tuo stesso percorso?
R: Sì, fino a Dachau sì.
D: Fino a Bolzano siete assieme?
R: Sì, poi fino a Dachau sì.
D: Poi lì a Bolzano rimani quanto tempo più o meno?
R: Venti giorni, venticinque, non so bene. Grosso modo.
D: Poi un bel giorno vi chiamano?
R: Chiamano. Vagone, vagonetto, ci hanno caricati, vanno. Tanto per tagliare,
tre giorni e tre notti ci abbiamo messo. Ci hanno scaricati a Dachau.
D: Ascolta, ti ricordi più o meno, Pierino, da dove siete partiti da Bolzano?
R: Dalla stazione.
D: Dalla stazione?
R: Dalla stazione.
D: Sul tuo Transport, sul tuo vagone in quanti eravate più o meno?
R: Sessanta, cinquanta o sessanta a vagonetto.
D: Eravate in tanti?
R: Tantissimi, tantissimi.
D: Solamente uomini o anche donne?
R: Donne e uomini, tutti insieme.
D: La stazione, cos’è che ti fa ricordare la stazione?
R: Tanti binari.
D: Poteva essere anche uno scalo ferroviario?
R: No, per me era la stazione. Naturalmente non proprio al centro della
stazione dei passeggeri, spostato su un binario morto c’era quella fila di…
D: Dal campo alla stazione?
R: A piedi, ci hanno caricati a legnate. Lì c’era tutto, il bagno, doccia su quel
vagone.
D: Ti ricordo se c’erano anche dei religiosi? Dei sacerdoti?
R: Ho trovato a Dachau un religioso, a Dachau sì.
D: Dopo tre giorni e tre notti di viaggio arrivate in un posto che voi non
sapete…
R: No.
D: Non lo sapevate, no? Però è Dachau.
R: Dachau, grandioso. Forse centomila persone c’erano state dentro lì. Io
avevo il numero, 113.577, di Dachau. Lì siamo stati…
D: Quindi lì vi hanno spogliato?
R: Spogliato, la doccia, ci hanno disinfettato, rasati tutti e hanno dato la
divisa.
D: La zebrata?
R: Zebrata. L’immatricolazione.
D: Assieme al numero ti hanno dato anche il triangolo?
R: Sì, un triangolo di panno rosso con sopra il numero.
D: E poi in baracca?
R: In baracca.
D: Ti ricordi qual era la tua baracca?
R: 17.
D: Lì a Dachau cosa facevate?
R: A un dato momento ci portavano a migliaia fino alla stazione di Monaco a
costruire le ferrovie che erano state bombardate. Si partiva alle tre di mattina
e si arrivava alla una di notte. Ho fatto per quindici giorni quella vita lì.
D: Da Dachau a Monaco…
R: C’erano trenta chilometri, venticinque.
D: Come vi portavano?
R: Treno.
D: Nella stazione i civili vi vedevano?
R: Sì, strada facendo ci giravano le spalle, non potevano guardarci, giravano le
spalle. I bambini tiravano i sassi, i ragazzini. Ci giravano le spalle, quando si
passava giravano, capito?
D: E l’incontro con quel religioso a Dachau?
R: A Dachau è stata una cosa così, non ho avuto una motivazione religiosa, no,
no. Niente, si aspettava la fine, la fine della guerra, non di morire. Sono stato lì
circa un mese. Ho detto: “Dove mi hanno portato tre giorni e tre notti?”. Mi
hanno diviso dai compagni, io sono stato insieme con uno di Abbiategrasso, gli
altri sono andati a lavorare nella zona di Dachau. Io sono andato a lavorare
invece a Bad Gandershein .
D: Questo tuo compagno di Abbiategrasso te lo ricordi chi era?
R: Malles Carlo. Morto, fucilato, il primo gruppo della fucilazione. Il 6 Aprile del
‘45.
D: Poi un certo giorno vi chiamano lì a Dachau, vi dividono dagli altri e vi
portano su un treno?
R: Un treno, tre giorni e tre notti. Arriviamo a Bad Gandershein L’avevo saputo
dopo che era Bad Gandersheinnaturalmente. Lì non ci sono baracche, c’è una
chiesa sconsacrata, si dormiva sulla paglia. Ad ogni modo si doveva costruire
baracche. Io ho scritto che facevo il falegname. Tutto l’inverno del nord l’ho
preso io fuori. Invece a quelli che lavoravano in fabbrica è andata bene, erano
coperti almeno. Io l’ho presa tutta. Allora l’episodio della vita dei campi per me
è caduto nell’oblio, è passato. Non mi dimentico, non posso dimenticare
la marcia.
D: Ma lì arriviamo dopo. Allora, siete in questa chiesa sconsacrata…
R: Sì, dormire sulla paglia, un po’ di paglia, una coperta in due.
D: In quanti eravate più o meno?
R: Penso mille, mille e cento.
D: I germanici erano con voi? I tedeschi?
R: Quelli che lavoravano in fabbrica sì.
D: Loro dove dormivano?
R: Loro erano a casa loro, finito il lavoro alla fabbrica, la fabbrica era una
fabbrica di assemblaggio di carlinghe, loro finito il lavoro andavano a casa. Noi
dove andiamo? Là alla chiesa sconsacrata.
D: Voi eravate addetti a costruire le baracche?
R: Costruire le baracche.
D: E il campo.
R: E il campo.
D: E il materiale dov’è che andavate a prenderlo?
R: Il materiale era là pronto, perché si sapeva, era predisposto già. Quando
arriviamo facciamo questo lavoro. Per costruire le nostre baracche, le baracche
per noi, capito?
D: Di legno?
R: Sì, di legno.
D: Quindi avete costruito le baracche e poi andavate in fabbrica a lavorare?
R: No, io ho dormito dieci giorni in baracca, perché quando hanno costruito le
baracche è arrivata la famosa marcia. Capito?
D: Ti ricordi quante baracche erano che avete costruito?
R: Erano divisi, italiani russi, metà italiani e metà russi. La maggioranza erano
francesi, polacchi, greci, spagnoli.
D: Di italiani chi ti ricordi?
R: Ricordo il mio amico con cui sono partito da Abbiategrasso, ha fatto una
brutta fine, fucilato perché non ce la faceva più a camminare. Parliamo della
marcia. La vita lì nel campo si sa.
D: Quanto tempo siete rimasti in quel campo?
R: In quel campo lì ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e
aprile.
D: Lì non ti hanno rinumerato?
R: Sì. Lì mi hanno dato il numero di Buchenwald 94.565, detto dal tedesco
poi era una cosa…
D: Te lo ricordi?
R: Madonna, no, …….
D: Quindi sette mesi.
R: Sette mesi.
D: Avete costruito quante baracche, dicevi?
R: Una baracca per i francesi perché erano in maggioranza, poi a divisione,
russi, italiani e tutto.
D: Il campo era recintato?
R: Recintato, torrette, fili spinati. Di notte si andava al bagno, bello questo. Si
andava in bagno fuori e le sentinelle si divertivano a sparare. Bel divertimento.
Tutto lì, ecco.
D: Dopo sette mesi?
R: Succede…
D: Arriva l’ordine di evacuazione.
R: L’ordine di evacuazione, cosa dice l’interprete? Chi non è capace di
camminare lo portiamo in camion. Una cinquantina, sessantina sono usciti.
Quell’interprete ha visto me, ha schiacciato l’occhio e ha detto: “No, eh”. Di
fatto mi ha avvisato, li hanno fucilati tutti.
D: Anche il tuo amico?
R: No.
D: Non lì?
R: No, non lì. Cominciamo la marcia.
D: Cosa vi hanno dato per la marcia?
R: Cosa avevano dato…
D: Avevate una coperta?
R: Niente.
D: Avevate da mangiare?
R: Niente.
D: Avevate da bere?
R: Niente, la neve che si trovava facendo le colline. Ad ogni modo comincia la
marcia, chi si ferma è morto. Di fatti quelli che crollavano, gli davano un colpo
in testa e li lasciavano là. Quelli che tentavano la fuga subito via. Arriviamo al
6, comincia la fucilazione in gruppi.
D: 6 di aprile, no?
R: 6 di aprile. E’ stato quando hanno ucciso… li portavamo io e il mio amico.
Quando hanno chiamato li hanno portati fuori, hanno buttato indietro, li hanno
messi sul ciglio della strada, venticinque, trenta, li hanno fucilati tutti. Così
pomeriggio e sera. Quante volte sono uscito io, non mi volevano morto. Fino al
12 aprile. Il 12 aprile tentiamo la fuga in quattro, io, uno di Corbetta. Sono
morti tutti. Naturalmente scappiamo, quelli là sparano, il milanese è stato
colpito. Basta. Le pallottole attraversavano i vestiti, in mezzo alle gambe. C’era
la campagna, era come se fosse un gioco di bocce, liscia. Tutte le pallottole che
passavano per le gambe, stracciavano i vestiti, niente. Appena viste due
piante, ci siamo messi dietro alle piante. Arriva un tedesco, mi spara a
cinquanta centimetri. Siamo in piedi ancora. In totale mi hanno arrestato
ancora sei volte, però avevano paura a tenerci, avevano paura anche a
ucciderci. Allora cercavano di liberarsene, si andava avanti, dopo cinquecento
metri altro arresto, fino a quando arriviamo al punto che passata una colonna
di mongoli prigionieri di guerra ci hanno incolonnati e portati in una baracca. Lì
sono arrivati gli americani.
D: Questo posto dov’era, te lo ricordi più o meno? Vicino a quale città grossa?
R: Vicino a Halle, mi pare.
D: Ascolta, prima di queste fucilazioni, prima del 6 aprile del ‘45, quando voi
eravate in marcia della morte camminavate di giorno?
R: Di giorno, di sera. Di notte ci si fermava in un pagliaio. Prima di partire dal
pagliaio si mettevano là dieci tedeschi, perché sapevano che si nascondevano
nella paglia.
D: E sparavano?
R: Sparavano.
D: E mangiare?
R: Niente, l’erba.
D: Bere?
R: Bere la neve che s’incontrava, c’era ancora la neve là, in Austria c’è una
temperatura differente.
D: Eravate solo uomini lì?
R: Sì, solo uomini.
D: Donne non ce n’erano?
R: No, no.
D: Avete attraversato durante la marcia della morte dei paesi abitati?
R: No, non mi ricordo questo, no. Una volta abbiamo dormito in una chiesa. Il
giorno prima della prima fucilazione in massa. Quella volta mi ricordo che
abbiamo dormito al riparo.
D: Sempre durante la marcia della morte sono arrivati degli aerei?
R: No. Gli aerei li abbiamo trovati… Quando siamo scappati dalla marcia, dove
si va? Si va dove i tedeschi scappano.
D: Voi incrociavate i tedeschi?
R: Sì, sì. Ci siamo salvati… L’emozione della Liberazione non si può descriverla.
D: Questo quando eri dentro con i mongoli?
R: Sì, sì.
D: Lì con i mongoli dove siete andati? In un campo?
R: C’era una specie di villetta con il capannone dove si dormiva, perché lì
lavoravano. C’era una cava. Lì è arrivata una camionetta.
D: Di russi?
R: No, era zona russa, però hanno liberato gli americani.
D: Ah, sono arrivati gli americani?
R: Sì, era ad est di Lipsia, capito? Sono gli americani che hanno liberato.
D: Voi non sapevate niente, arriva questa camionetta…
R: Sì, c’era una sparatoria vicino. I tedeschi sono scappati.
D: E lì cos’è successo?
R: Lì è successo che i mongoli … e noi eravamo scheletriti, proprio una cosa…
Hanno cominciato a fare razzia, razzia nelle cascine vicino perché la fame era
questa. Noi mangia, mangia, mangia, sono stato quindici giorni col mal di
cuore. Sono scoppiato, capito?
D: Ma avevate ancora la vostra zebrata?
R: Sì, dopo loro mi hanno visto così e i mongoli mi hanno dato un paio di
pantaloni e una camicia.
D: Poi gli americani?
R: Gli americani quando mi hanno liberato sono rimasti scioccati, perché là
erano omoni, noi invece eravamo tre scheletri. Continuavano a domandarci:
“Ma da dove venite? Cosa hai fatto per essere così?”. Tra l’altro poi c’era
disprezzo tra noi e i russi, la croce. Cannibali eravamo, sporchi. Come diceva
Gianni, scabbia, orticaria, tutte le malattie della pelle addosso.
D: Ascolta, solamente voi tre siete stati messi con questi mongoli? Altri
deportati?
R: Non li ho visti.
D: Ti ricordi più o meno in quanti siete partiti all’inizio della marcia della
morte?
R: Della marcia mille e qualche cosa.
D: E ti ricordi più o meno quanti sono arrivati a destinazione?
R: No perché sono scappato prima io.
D: Però ti ricordi delle molte fucilazioni di massa.
R: Quelle sì, perché sul ciglio della strada era una sparatoria continua, mattino
e pomeriggio.
D: Quindi il tuo periodo di deportazione, oltre a lavorare, a fare certi lavori,
recupero e spostamento macerie a Bolzano o a Dachau che andavi alla ferrovia
a ripristinare le stazioni dopo i bombardamenti di Monaco, è stata la
costruzione di quel sottocampo di Buchenwald?
R: Sì, sì. Là a Bad Gandershein.
D: Esatto. In fabbrica non sei andato tu?
R: No, non ho fatto tempo ad andare.
D: Poi hai fatto però la marcia della morte?
R: La marcia sì, siamo partiti e quelli che sono arrivati, pochi….
D: Piccola parentesi, lasciamo perdere adesso un attimo il discorso della
deportazione tua, ci racconti quei due episodi di Abbiategrasso?
R: E’ scioccante ritornare indietro nel tempo, non so. Via De Amicis, ragazzini,
si cantavano le canzoni, “Ven chi, Ninetta, sotta l’umbrelin”. Si avvicina una
vecchietta: “Non cantate questa canzone”. Noi siamo andati via. Perché? Poi un
episodio che mi ha colpito è stato: uno viene fuori di galera, l’ho saputo dopo,
Via Noli, arriva il Colombini, era prigioniero politico. Tutta la gente si spostava
quando arrivava lui, uno solo ha avuto il coraggio di abbracciarlo, un certo
Franco. Uno solo. Noi avevamo una mentalità, una cultura della prigione un po’
particolare. La prigione come delinquenza, non si capiva la motivazione
politica. Pochi anni, capito?
D: Ma il fatto della fabbrica lì?
R: No perché era stato portato via prima di noi.
D: E’ stato arrestato prima?
R: Quelli sono stati arrestati prima per uno sciopero. Per uno sciopero, la Sato.
Sato, adesso è una sigla che non so… Una fabbrica di chiodi che ho detto
prima.
D: Sono stati arrestati?
R: Non è venuto a casa nessuno di quelli lì.
D: Ma li hanno portati via?
R: A San Vittore, poi hanno fatto la nostra fine.
D: Qui invece ad Abbiategrasso è stato fucilato anche qualcuno?
R: Due. Dicevano che uno aveva ucciso il tabaccaio di San Vito di Gaggiano per
una rapina, era tutta una propaganda. E uno invece l’hanno ucciso qui, dove
l’hanno preso? L’hanno preso alla fossa, stava fuggendo.
D: Ma chi è che fucilava lì?
R: Fucilava là, io non potevo assistere, dico la verità. Sentivo. Io so che il capo
della sezione qui di Abbiategrasso dava il colpo di grazia. Poi non so chi.
D: Il capo della sezione di?
R: Dei repubblichini.
D: Quindi italiani?
R: Italiani. Quello lì dava il colpo di grazia.
D: Quando è avvenuta questa fucilazione? Ti ricordi?
R: Guarda, ti dirò. Forse nel mese di aprile, maggio, giugno. I due fucilati.
D: Di che anno?
R: Sempre del ‘44.
D: Poi altri episodi che sono avvenuti, tipo quello di Robecco? Di Cassinetta?
R: Sì, sì. Allora ogni tedesco ucciso, dieci condannati a morte. Lì a San Vittore
l’episodio più eclatante, lì uccisero qualche tedesco, l’hanno portato fuori in
venti, l’hanno messo davanti al muraglione con dietro il plotone d’esecuzione.
Eravamo là ad aspettare che sparavano. A un certo momento contro ordine. La
reazione si fa dopo però, in quel momento non ci si crede, non ci credi.
Possibile? E’ una cosa impossibile questa. Non abbiamo fatto niente.
D: Ascolta, Pierino, quando tu eri a Legnano, nelle carceri di Legnano, o a San
Vittore sei riuscito a parlare con i tuoi o a scrivere ai tuoi familiari?
R: No, mi hanno preso il 12 agosto del ‘44, sono tornato il 30 agosto del ‘45,
niente scrivere.
D: Cioè i tuoi non sapevano più niente?
R: Niente, niente.
D: Come hai fatto a tornare?
R: Tornare…
D: Dal campo.
R: Siamo stati là qualche mese da soli noi tre, perché a un dato momento è
stato così. Io non so le faccende politiche. A un dato momento arrivano gli
americani col camion, a botte hanno caricato tutti i mongoli sul camion. Noi
siamo rimasti là così tutti e tre. Adesso cosa facciamo? Siamo andati a …
qualche mese, poi se stiamo qui non andiamo più a casa. Ci siamo avvicinati a
un paese e abbiamo trovato lì degli italiani. Gli italiani poi mi hanno portato col
camion a Lipsia, una frazione che adesso sarà proprio Lipsia, Tauka. E’ un
paese che era un campo di concentramento. Siamo stati là fino a quando
siamo partiti. A metà giugno, luglio ho fatto cinquantaquattro giorni sul treno.
Siamo andati da Lipsia, penso che sia a 800 chilometri dalla frontiera italiana,
siamo andati fino a Odessa. Di qui il libro di Primo Levi “La tregua”. Ad un certo
momento ci hanno fatti tornare indietro, la trafila era naturalmente Ucraina,
Ungheria, Austria, Italia.
D: Dall’Italia sei rientrato da dove? Dal Tarvisio o da Bolzano?
R: Da Bolzano. Perché ci siamo fermati ad Innsbruck, ci hanno disinfettato,
come ha spiegato Gianni.
D: Anche voi?
R : Sì, disinfettato tutto, il DDT. Ci hanno riempito di DDT. Poi siamo arrivati a
Bolzano, c’era la Croce Rossea, come ha spiegato. Ma io sono arrivato a Milano
in treno, lui in camion. Io da Bolzano in treno sono arrivato a Milano. Lui è
arrivato in camion, capito?
D: Ascolta, Pierino, in questi cinquantraquattro giorni in treno come hai
mangiato? Chi vi dava da mangiare?
R: Diciamo la verità, avremo mangiato forse, hanno dato il pane per quattro o
cinque giorni. Altri si fermavano ai paesi, si vendeva una camicia, si dava il
pezzo di pane. Tutti così. Però c’era un fatto, che noi su settanta vagoni
eravamo quindici deportati politici, non quindici vagoni, quindici persone
salvate in quella zona. Dove la gente, quando ci vedeva, ci dava ogni ben di
Dio. Noi non abbiamo patito la fame, ma quegli altri sì. Quegli altri erano
prigionieri di guerra.
D: Ascolta, gli americani quando ti hanno liberato…
R: Il 13.
D: Il 13?
R: Aprile.
D: Ti hanno rilasciato un certificato, un documento, un qualcosa?
R: No, niente.
D: Neanche quando sei rientrato in Italia a Bolzano ti hanno dato un
certificato?
R: Niente, niente.
D: Sempre, scusami, gli americani quando vi hanno liberato hanno preso i
vostri nomi?
R: No.
D: Hanno dato comunicazione via radio?
R: No, no. Niente.
D: Neanche a Bolzano?
R: Niente neanche a Bolzano.
D: A Bolzano nessuno ti ha chiesto…?
R: No, no. Niente.
D: Come ti chiami, da dove vieni?
R: No, no, niente.
D: E quando sei arrivato a Milano?
R: A Milano avevo un paio di stivali, un paio di pantaloni e nudo. Sono arrivato
a casa così. Sono arrivato lì, allora a Porta Ticinese c’era il tram. Lì mi hanno
riconosciuto.
D: E anche lì a Milano non è che hanno preso le tue generalità?
R: No, ti dirò di più. Io vado a scuola e ci vogliono i documenti per passare di
ruolo. Allora vado al distretto, a botte mi hanno buttato fuori perché sulla
scheda io ero fascista. Quelle carte che ho firmato precedentemente sono
rimaste là. Io ero un militare della Repubblica di Salò. A pedate eh. Ma cosa ho
fatto io? Poi ho cominciato a racimolare documenti comprovanti. Quando hanno
scoperto che io veramente non ero così sono rimasti male.
D: Sono rimasti solo male?
R: Hanno chiamato i capitani, i graduati del distretto. Hanno voluto sapere,
sempre la solita storia. Come ti sei salvato? Tutto lì è stato. Dopo hanno
cominciato a trattarmi molto bene, avevo i documenti di cui avevo bisogno.
Infatti quando abbiamo fatto la domanda per la pensione se non c’erano quei
documenti…
D: Una domanda così, Pierino. Campo di Bolzano, cioè Lager di Bolzano, Lager
di Dachau, Lager di Bad Gandershein, che è un nome difficilissimo per me da
pronunciare, marcia della morte, come ti sei salvato? A cosa pensi?
R : Una fortuna sfacciata. Ti dirò di più, io sono stato odiato dai parenti dei
miei amici perché mi sono salvato. Che cosa ha fatto quello lì per salvarsi? Io
ancora adesso non ho mai avuto autostima in me stesso, un umile proprio.
Cosa si poteva diventare nei campi di concentramento? La firma per andare
dalle SS non si poteva, fare il Kapò erano i delinquenti comuni, triangolo verde
chi faceva il Kapò e picchiavano. Adesso sono compreso, hanno capito che io
non ero… Se ero così intraprendente nella vita avrei fatto… Invece sono stato…
D: Dopo che sei tornato e dopo la brutta esperienza, per esempio quando sei
andato a chiedere i documenti e risultava che tu eri uno della RSI e non che
venivi dai campi di concentramento, hai iniziato a raccontare la tua storia?
R: Un po’ all’ITIS.
D: In che anni?
R: Io ho fatto dal ‘63 fino all’87. In principio sì, ma c’erano i fascistelli. Io non
avevo niente da nascondere, la realtà era così.
D: Quindi hai raccontato un po’ ai ragazzi così?
R: Sì.
D: E agli altri a casa, ai tuoi amici?
R: Ho lì delle poesie fatte dai ragazzi che sono toccanti, guardi.
D: Ma raccontare la tua esperienza agli adulti, ai tuoi amici di una volta…
R: Più che raccontare la mia vita, racconto magari qualche episodio, ma non la
mia vita. Ho detto che non la sa neanche casa mia la mia vita. Potrei cercare di
liberarmi perché io urlo ancora di notte adesso. Basta?
D: No. Un attimo di pausa. Tu sei ritornato però a Dachau?
R: Sì, sono andato. No, a Dachau no.
D: A Buchenwald?
R: A Mauthausen.
D: A Mauthausen? A Buchenwald non sei andato?
R: No, no.
D: A Dachau non sei ritornato?
R: No, mi spiegavano gli amici sapendo che ero stato là, mi raccontavano, ma
non sono mai andato. Sono andato a Mauthausen, Linz, quelle zone lì,
Salisburgo.
D: Cos’è che ti frena a ritornare a Dachau?
R: I ricordi, non riesco a sopportare. Sono andato due volte poi, è un fattore
masochistico andare là a soffrire da matti, piangere disperatamente quando si
vedono quei campi lì. Capito?
D: Il contatto con i tuoi ex compagni di deportazione l’hai mantenuto però
quando sei tornato?
R: No, ci siamo persi. Il Manzoni Ferruccio di quella zona lì, di Corbetta è morto
l’anno scorso. Quando l’ho saputo, che l’ho letto sul giornale, ho telefonato, ma
non rispondeva più nessuno, quindi…
D: E prima non vi siete più…?
R: Sì, qualche volta c’erano dei problemi e allora ci sentivamo, qualche volta,
uno solo però. L’altro è morto quasi subito però.
D: Volevo chiederti, dicevi delle carceri di Legnano, erano proprio delle carceri
o erano edifici…?
R: Carceri, carceri monumentali. Faceva parte sempre di San Vittore, ho qui
dei documenti io.
D: Però gestite da italiani?
R: Gestite da italiani, sì. Gestito dai tedeschi è stato San Vittore al secondo
raggio, che è un raggio comune. Dopo due giorni ci hanno portati al quinto,
sesto raggio, non ricordo. Sezione politici. Poi al secondo raggio eravamo
sempre in cella, invece là alle otto fuori dalla cella, tutti in corridoio, quindi è
un paradiso il raggio tedesco, ci tenevano buoni.
D: Qui però a Legnano ti hanno interrogato?
R: Sì. Abbiamo cercato di salvare il padrone dell’osteria allora dicendo che le
nostre riunioni si facevano a Castelletto. Capito? Invece le riunioni non si
facevano. Di fatti l’hanno liberato, meno male. Come si chiamava? Non mi
ricordo più adesso.
D: Perché non ci vuoi raccontare un po’ del campo? Di Dachau? O di Bad
Gandershein?
R: Ti dirò…
D: Sette mesi in quel campo lì cosa hanno significato per te? Sette mesi sono
tanti.
R: Sette mesi… Il calorifero umano, era freddo. Per riscaldarsi ci si sbatteva
tutti contro la parete, tutti, una massa di cento persone si dondolava per
scaldarsi. Si cambiava, quelli sotto venivano sopra.
D: Facevate la stufa umana?
R: Stufa umana.
D: Eravate tutti politici lì nel campo?
R: Sì. Tutti politici.
D: Di diverse nazionalità?
R: Lì a Dachau sia a Bad Gandershein, tutto una terra… Il linguaggio è
universale, quando si parlava una parola tedesca, una polacca, una russa, una
greca.
D: Ti ricordi episodi di solidarietà?
R: No. Non ce ne sono. L’unica speranza era sentire gli americani vicino, la
solidarietà no. Non c’è. Erano bestie, la lotta per la sopravvivenza è una cosa
che rende bestiale la gente. Anche ho notato una cosa in particolare, davanti a
certe disgrazie uno invoca Dio? No, uno invoca la mamma, non Dio.
D: Neanche l’ideologia, la fede politica?
R: No, no. Parlare neanche di politica, di speranza… No, si vegetava. Per quello
che io nel campo sette mesi là a Bad Gandershein ho un po’ d’oblio, la vita era
monotona, stancante. Uno stava morendo. Un episodio, c’era a terra una creta,
quando pioveva diventava… Uno cadeva. Io ho provato a stare male, uno stava
là tutto il giorno, metà dentro e nessuno che ti aiutava. Sei solo. Sai che
cos’era? Avevo vent’anni e allora lo spirito di conservazione prendeva il
sopravvento.
D: Cioè tu sei rimasto un giorno con metà…?
R: Metà dentro nella creta e metà fuori, nessuno ti aiuta. Sei solo. Brutto
questo.
D: Devi contare solo su te stesso, sulle tue forze.
R: Nel ‘44 io avevo 19 anni, 20 anni. Sono stato liberato, li compio in agosto,
in aprile del ‘45 avevo 20 anni ancora. La voglia di vivere c’è sempre. Guai
levarsi i pantaloni, perché se vedevi la magrezza uno andava giù di morale.
Allora i pantaloni non li levavo più. L’ho fatta lunga.
D: Quindi se ho ben capito a Bad Gandershein avete costruito più o meno
cinque o sei baracche?
R: Sì.
D: Più o meno. Avete costruito anche la baracca del capo campo?
R: No, era una zona legata sempre, però isolata per loro, per il Kapò.
Naturalmente l’episodio, quello che colpiva nel campo di concentramento era…
Noi eravamo dei luridi, i Kapò erano tutti gay. C’era una margherita in mezzo al
nero, quello lì era l’amante del Kapò. Si distingueva, era una cosa addirittura…
Colpiva, una persona pulita in mezzo ad una fila di straccioni proprio. Colpiva
molto.
D: Durante la tua deportazione a Bad Gandershein ti sei ammalato o non ti sei
ammalato?
R: Quella volta che mi sono sentito male… Noi eravamo forgiati di quella che è
la miseria anche a casa nostra, quindi eravamo preparati, capito? Casa mia,
mio padre più che lavorare non poteva fare, però era una vita di stenti. Allora
ho guadagnato, ho avuto il vantaggio di soffrire meno di quelli che stavano
bene. Se andasse là uno adesso col tenore di vita che facciamo, là due giorni
ed è morto quello là. Capito?
D: Vuoi aggiungere qualcosa? Ti è venuto in mente qualche episodio?
R: Non so. Bisogna spingere un camion, là centinaia addosso al camion,
cinquanta che spingono, dietro il tedesco con la frusta. Per aiutare ad aizzare la
forza, che la forza non c’era. La fame… Ho provato ad andare a rubare dalla
pattumiera della mensa dei tedeschi. Sono episodi che… Preso, botte, fuggito e
tutto il resto. Era un problema generale più che particolare. Particolare fa male.
ETTY HILLESUM
Il cuore pensante del Lager
di Davide Perillo
15/01/2014 - È morta ad Auschwitz, «cantando». Era nata cent’anni fa, il 15 gennaio 1914. Ci ha lasciato un diario
e una raccolta di lettere. Ma soprattutto, un percorso umano, nel dialogo continuo con Dio (da "Tracce" di gennaio)
Etty Hillesum nel 1940.
La cartolina la trovò un contadino. Era sui bordi della ferrovia che attraversava la brughiera, fuori da
Nieuweschans. Niente immagini, solo la data (7 settembre 1943), l’indirizzo («a Christine van Nooten, Deventer»)
e un testo scritto con una grafia fitta e tonda. «Apro a caso la Bibbia e trovo questo: “Il Signore è il mio alto
ricetto”. La partenza è arrivata inaspettata, nonostante tutto. Abbiamo lasciato il campo cantando.
Arrivederci». Era di Etty Hillesum, 29 anni, olandese, ebrea. L’aveva lanciata dal vagone numero 12 del treno che
la portava ad Auschwitz. Morirà lì due mesi dopo. Era nata giusto cent’anni fa.
Si può andare verso la camera a gas cantando? Si può vivere l’orrore della Shoa dentro la pelle - veder
morire gli amici, i parenti, i progetti, i sogni - e salire sul treno che ti porta incontro al sacrificio con il
cuore lieto? In quella cartolina c’è il sigillo di una vita breve che a ripercorrerla mette i brividi, perché apre questa
domanda e tante altre. E lo fa un po’ alla volta, passo per passo, raccontando ciò che scopre lei stessa
osservandosi. Etty ci ha lasciato un diario e una raccolta di lettere. Tutto concentrato nell’arco di tre anni, tra il
1941 e il ’43. Il primo è diventato un caso, non solo editoriale (centocinquantamila copie vendute e studi, tesi,
rilanci continui). Le seconde sono appena uscite nella versione integrale, per Adelphi, a completare la lettura di
un’esistenza piena come poche.
Esther “Etty” Hillesum nasce a Middelburg, sul mare del Nord, in una famiglia borghese. Padre preside di
liceo, madre russa e di carattere vulcanico, due fratelli di intelligenza brillante quanto la sua (Mischa sarà
uno dei pianisti più promettenti d’Europa, Jaap a 17 anni si trova la strada spianata verso la carriera di medico per
aver scoperto una nuova proteina), Etty si laurea prima in Giurisprudenza, poi in Lingue slave. Studia anche
psicologia, ma per imboccare una strada è già tardi: i Lager stanno aprendo i cancelli, l’Olocausto è iniziato. Etty
vorrebbe fare la scrittrice, lo ripete spesso agli amici e a se stessa. Non sa che, di fatto, lo è già.
Contro-dramma
In quel diario, scritto nella stessa città e nello stesso periodo di Anna Frank, c’è molto più di trame e romanzi. C’è
un percorso umano potentissimo, un cammino di allargamento della ragione e dei sensi e del cuore, incontro dopo
incontro, sofferenza dopo sofferenza. Qualcosa che le permette, negli anni in cui tutta l’Europa vive la tragedia, di
«scrivere un contro-dramma», come dice Jan Gert Gaarlandt, il curatore del diario. Lo fa con una lucidità e una
forza d’animo - non uno sforzo: proprio una consapevolezza sempre più netta di come stanno davvero le cose che interrogano. Da dove arriva questa forza?
La prima risposta sta in un cuore inquieto. Molto. Un cuore che le fa amare Rilke e Agostino, Leonardo e
Dostoevskji. Che le fa dire di continuo e in mille modi «voglio qualcosa e non so cosa». E che si spalanca quando
incontra l’uomo che le segnerà la vita. Si chiama Julius Spier, ha il doppio dei suoi anni, ha studiato con Jung ed è
il padre della «psicochirologia»: analisi e terapia della persona partendo dalle linee della mano. Può far sorridere;
di certo, Spier ha un carisma e una profondità fuori dalla norma. E un ascendente forte su quella ragazza, di cui
diventerà l’amante (non l’unico): «Mi ha preso per mano e mi ha detto: ecco, devi vivere così», scrive nel
diario, probabilmente iniziato proprio su input di Spier. In quelle pagine, lui sarà presente di continuo. Ma avrà
soprattutto un merito: «Sulla mia persona ha svolto una grande opera: ha dissotterrato Dio dentro me e lo ha
portato alla vita. E adesso sarò io a continuare, scavando alla ricerca di Dio nel cuore di tutti gli uomini che
incontrerò».
Una compagnia e una strada. Strane entrambe, accidentate, come è la vita, ma reali. Legandosi a Spier e ai
suoi amici, e restando tenacemente attaccata all’esperienza («è l’unica realtà che non si possa annullare con le
discussioni: le immagini possono venire insudiciate e distrutte»), Etty attraversa i dubbi che affiorano dall’anima e
dalla tragedia intorno: «Paura di vivere su tutta la linea. Cedimento completo. Mancanza di fiducia. Repulsione»,
sintetizza in una riga il 10 novembre 1941. Ci sono, e torneranno. Ma non sono un ostacolo: sono passi di un
cammino.
Etty lo percorre usando tutta se stessa, svelando in azione una ragione “larga” che sarebbe piaciuta a Benedetto
XVI (non a caso il Pontefice emerito l’ha citata nell’ultima Udienza da Papa, a febbraio scorso): dice che occorre
«pensare con il cuore» perché «forse possediamo altri organi oltre la ragione» e sono questi che ci
permettono di affrontare e capire - cioè abbracciare - cose che non avremmo creduto possibili. E vede tutto il
compito che una sensibilità del genere le affida: «Lasciatemi essere il cuore pensante di questa baracca»,
scrive. Non è presunzione: è la certezza che solo un cuore che pensa e vede e ama può reggere alla follia della
guerra e della Shoa: per sé, e per gli altri.
Il pozzo
Un po’ alla volta, le sue pagine diventano una preghiera, un dialogo continuo con Dio («prendimi per mano, ti
seguirò da brava, non farò troppa resistenza»), uno scavo in quel «pozzo molto profondo dentro di me. E Dio c’è
in quel pozzo. Talvolta mi riesce di raggiungerlo, più spesso pietra e sabbia lo coprono: allora Dio è sepolto.
Bisogna proprio che lo dissotterri». Ogni giorno svela una ricerca accanita dell’essenziale. Trasforma il modo in cui
Etty guarda a tutto e si lega a tutto. «“Sono così attaccata a questa vita”. Cosa vuoi dire con “vita”. La vita
comoda che fai adesso? Si vedrà se sei veramente attaccata alla vita nuda e semplice, in qualunque forma
essa si presenti». Comincia a cercare ciò che serve davvero per vivere. Anche aspettando il Lager.
Fa impressione vedere il fiore che sboccia da questa fede sempre più reale, personale. È un distacco che ti fa
possedere le cose, conoscerle davvero: «Si deve essere capaci di vivere senza libri e senza niente. Esisterà pur
sempre un pezzetto di cielo da poter guardare e abbastanza spazio dentro di me per congiungere le mani in una
preghiera». È un’apertura sempre più grande alla realtà: «Se si comincia ad accettare, non si deve accettare tutto,
allora?». E ancora: «A un certo punto non si può più fare, ma soltanto essere e accettare». È un amore gratuito a
quello che c’è perché c’è, non perché può o dovrebbe essere nostro. C’è una pagina bellissima in cui
descrive questa scoperta, raccontando di una passeggiata al tramonto. «Una volta, se mi piaceva un fiore, avrei
voluto premermelo sul cuore, o addirittura mangiarmelo (provavo un desiderio troppo fisico per le cose che mi
piacevano, le volevo avere)... Ma quella sera, solo pochi giorni fa, ho reagito diversamente. Ho accettato con gioia
la bellezza di questo mondo di Dio, malgrado tutto. Ho goduto altrettanto intensamente di quel paesaggio tacito,
ma in modo per così dire “oggettivo”. Non volevo più possederlo».
Umiliazione
In termini cristiani, la chiameremmo verginità. E colpisce che proprio intorno a questi passi spuntino citazioni del
Vangelo di Marco («non preccupatevi del domani…») e delle lettere paoline. Ma questo atteggiamento è la
sorgente e insieme l’espressione di una libertà interiore sempre più potente, che le fa dare giudizi accorati
su quello che vede intorno («per umiliare qualcuno si deve essere in due: colui che umilia, e colui che è umiliato e
soprattutto: che si lascia umiliare. Se manca il secondo, l’umiliazione evapora nell’aria») senza sfuggirlo, anzi.
Etty non resta fuori dall’inferno, ad osservare: ci entra. Nel luglio del 1942 trova un lavoro da dattilografa al
Consiglio Ebraico, l’organismo che fa da intermediario tra i tedeschi e la comunità ebraica: media, tutela, tratta. Ma
di fatto gestisce il flusso degli ebrei che vengono raccolti nel campo di Westerbork, da dove ogni martedì partono i
treni per Auschwitz. Saranno più di centomila a transitare da qui per finire nella camere a gas: Etty sceglie
di andarci e di restarci. Anche quando si presenta la possibilità di nascondersi, o gli amici le propongono un finto
rapimento. In quel campo, assiste i malati e le famiglie, organizza l’arrivo dei pacchi di alimenti e fa compagnia ai
bambini. Si spende, tutta. Ma intanto si spinge sempre più verso l’orlo del baratro, in qualche modo
volontariamente. Liberamente.
«Devo partire»
C’è molto di Westerbork nelle sue pagine. Descrizioni che aprono spaccati su grandezze e miserie di chi vive
aspettando la morte: le baracche, l’attesa, le lotte per i timbri che possono regalarti un’altra settimana di vita, la
preoccupazione per i genitori e i fratelli. Ci sono brani che tolgono il fiato («Una ragazzina mi chiama. È seduta
sul suo letto, con gli occhi spalancati. Ha i polsi sottili, il faccino magro e diafano. È parzialmente paralizzata,
aveva appena ricominciato a camminare. “Hai sentito? Devo partire”, sussurra: “Che peccato, eh? Pensare che
quanto hai imparato nella tua vita è stata fatica sprecata”»). C’è molta ironia, anche. Come quando le dicono che
deve partire pure lei e poi no, che «è stato un errore»: «È un po’ strana questa espressione: “un errore”, come
se non lo fosse per tutti gli altri...».
Ma c’è anche uno sguardo vero sugli aguzzini. A cercarne ogni angolo di umanità, anche il più nascosto. È uno
sguardo puro, privo di odio: «So che chi odia ha fondati motivi per farlo. Ma perché dovremmo sempre
scegliere la strada più facile e a buon mercato?». E poi: «Questa terra potrebbe ridiventare un po’ più abitabile
solo grazie a quell’amore di cui l’ebreo Paolo scrisse agli abitanti di Corinto». È l’“inno alla carità”.
È in questo «strano stato di addolorata contentezza» che si fa spazio una necessità misteriosa e immensa: aiutare
Dio. Non solo perdonarlo per il male assurdo che vediamo accadere («il fatto è che si ha tanto amore in sé da
riuscire a perdonare Dio», scrive nell’agosto 1942), ma proprio servirlo, collaborare alla Sua opera misteriosa: «Se
Dio non mi aiuterà più, allora sarò io ad aiutarlo». Non è una bestemmia: è il desiderio che l’uomo resti uomo,
che non smarrisca se stesso nella tragedia. E solo se non recide il legame può esserlo. Etty vuole che non si
smarrisca Lui, per salvare se stessa e gli altri: «Partirò sempre dal principio di aiutare Dio il più possibile e se
questo mi riuscirà bene, allora vuol dire che saprò esserci anche per gli altri».
Il balsamo
L’approdo, alla fine, è questo: una gratuità diventata totale, senza condizioni. Un amore radicale per l’altro, che
sgorga dall’essere arrivata al fondo di sé («quando prego, non prego mai per me stessa, prego sempre per gli
altri... Se si prega per qualcuno, gli si manda un po’ della propria forza»). In fondo è questa la nota che colpisce
leggendola. Perché sale, è un crescendo continuo. L’ultima frase del diario racconta tutto, in otto parole: «Si
vorrebbe essere un balsamo per molte ferite».
Ecco, Etty Hillesum ha vissuto in questo modo. «Una vita bella, proprio così!», racconta da quel campo di attesa.
Perché «la gratitudine sarà sempre più grande del dolore». Fino a scrivere, negli ultimi giorni: «Il cielo è pieno di
uccelli (...) il sole splende sulla mia faccia, e sotto i nostri occhi avviene una strage, è tutto così incomprensibile. Io
sto bene».
L’ordine di partire arriva la sera prima. Su quel treno salgono Etty, i genitori e il fratello Mischa. L’ultima parola
che le sentono dire è un «ciaoooo» allegro, gridato dal vagone numero 12 in partenza da Westerbork.
«Siamo andati cantando». Era vero.
Alcune pagine dal Diario
[pp. 32 - 35]
Domenica, le undici. [ ... ] L’ordine gerarchico all’interno della mia vita è un po’ cambiato. ‘Una volta’ preferivo
cominciare a stomaco vuoto con Dostoevskij o con Hegel, e a tempo perso, quand’ero
nervosa, mi capitava anche di rammendare una calza,
se proprio non si poteva fare altrimenti. Ora comincio con la calza, nel senso più letterale della parola,
e poi pian piano, passando attraverso le altre incombenze quotidiane, salgo verso la cima, dove ritrovo i
poeti e i pensatori. Dovrò ancora sbarazzarmi faticosamente di queste espressioni patetiche se vorrò mai
fare una figura decente, però credo che si tratti soprattutto di pigrizia nel cercare le parole giuste.
Le dodici e mezzo, dopo la passeggiata che è già diventata una bella tradizione. Martedì mattina, studiando
Lermontov, scrivevo che dietro la sua testa
spuntava sempre quella di S., che avrei voluto rivolgermi a quel caro viso, parlargli e accarezzarlo, che
così non riuscivo a lavorare. È passato molto tempo
da allora, è già tutto un po’ diverso. Il suo volto c’è
ancora, mentre lavoro, ma non mi distrae più, è diventato come un paesaggio amato e familiare che
sta sullo sfondo, i suoi tratti sono sfumati, non vedo più un volto preciso - s’è dissolto in atmosfera, spirito, o altro
che sia. E con ciò ho toccato un punto importante. Una volta, se mi piaceva un fiore, avrei voluto premermelo sul
cuore, o addirittura mangiarmelo. La cosa era più difficile quando si trattava di
un paesaggio intero, ma il sentimento era identico.
Ero troppo sensuale, vorrei quasi dire troppo ‘possessiva’: provavo un desiderio troppo fisico per le cose
che mi piacevano, le volevo avere. È per questo che
sentivo sempre quel doloroso insaziabile desiderio,
quella nostalgia per un qualcosa che mi appariva irraggiungibile, nostalgia che chiamavo allora «impulso
creativo». Credo che fossero queste forti emozioni a farmi pensare di esser nata per fare l’artista.
Ora, d’un tratto, non è più così, anche se non so dire
per quale processo interiore. Me ne sono appena resa conto stamattina, ripensando a una piccola passeggiata
intorno all’Ijsclub qualche sera fa. Era il crepuscolo: tenere sfumature nel cielo, misteriose sagome delle case, gli
alberi vivi col trasparente intreccio dei loro rami, in una parola era un incanto. Mi
ricordo benissimo di come sentivo ‘una volta’: trovavo tutto talmente bello che mi faceva male al cuore.
Allora la bellezza mi faceva soffrire e non sapevo che
farmene di quel dolore. Allora sentivo il bisogno di
scrivere o di far poesie, ma le parole non mi volevano mai venire. E mi sentivo terribilmente infelice.
In fondo io mi ubriacavo di un paesaggio simile, e
poi mi ritrovavo del tutto esaurita. Mi costava un’enorme quantità di energie. Ora chiamerei questo
comportamento «onanismo».
Ma quella sera, solo pochi giorni fa, ho reagito diversamente. Ho accettato con gioia la bellezza di questo mondo
di Dio, malgrado tutto. Ho goduto altrettanto intensamente di quel paesaggio tacito e misterioso nel crepuscolo,
ma in modo per così dire ‘oggettivo’. Non volevo più ‘possederlo’. Sono tornata a
casa rinvigorita, al mio lavoro. E quel paesaggio è rimasto presente sullo sfondo come un abito che rivesta la mia
anima - tanto per dirla con paroloni -,
ma non m’impacciava più, non era più ‘onanismo’.
E così è con S., come del resto con tutti. Anche la
crisi di quel pomeriggio, quand’ero rimasta seduta
a fissarlo tutta rigida e incapace di aprir bocca, era
probabilmente dovuta a un atteggiamento ‘possessivo’. Mi aveva raccontato varie cose della sua vita personale:
della moglie da cui è separato ma con cui è rimasto in corrispondenza, dell’amica con cui vuol sposarsi ma che si
trova a Londra - «è sola e soffre» -,
e poi ancora di un’altra amica che aveva avuto una
volta, una bellissima cantante con cui pure è rimasto in corrispondenza. Più tardi, mentre facevamo di
nuovo la lotta, io avevo sentito la suggestione del
suo grosso corpo attraente.
E poi, quando mi ero seduta di nuovo di fronte a
lui ed ero ammutolita, forse avevo avuto la stessa reazione di quando attraverso un paesaggio che mi tocca
l’anima. Lo volevo ‘possedere’. Volevo che S. fosse
anche mio. Per quanto io non lo desideri come uomo - non mi ha ancora veramente colpita, sessualmente
parlando, anche se sento sempre quella tensione in sottofondo -, S. mi ha toccata nel profondo
del mio essere, e questo è ancora più importante. E
così lo volevo avere in un modo o nell’altro, provavo
odio o gelosia per tutte le donne di cui mi aveva raccontato e forse mi chiedevo, sia pur inconsciamente,
se sarebbe rimasto qualcosa per me e me lo sentivo
sfuggire. Erano sentimenti piuttosto meschini, non
certo elevati, ma me ne rendo conto soltanto ora. In
quel momento io mi sentivo infelicissima e sola, cosa che adesso capisco benissimo, avrei voluto andar
via e mettermi a scrivere. Credo di capire anche questo. È un altro modo di ‘possedere’, di attirare le cose a sé
con parole e immagini. L'impulso che mi spingeva a scrivere dev’essere stato soprattutto il desiderio di
nascondermi agli altri con tutti i tesori che avevo accumulato, - di annotare ogni cosa e di goderla
tenendomela per me. E adesso, improvvisamente, questo atteggiamento che per ora chiamo «possessivo» è
cessato. Mille catene sono state spezzate, respiro di
nuovo liberamente, mi sento in forze e mi guardo intorno con occhi raggianti. E ora che non voglio più
possedere nulla e che sono libera, ora possiedo tutto
e la mia ricchezza interiore è immensa.
S. è completamente mio adesso, anche se domani
dovesse partire per la Cina: me lo sento intorno e
vivo nella sua sfera, se lo rivedrò mercoledì mi farà
piacere ma non sto più a contare nervosamente i
giorni, come facevo la settimana passata. E non chiedo più a Han* cento volte al giorno: «Mi vuoi ancora bene?»,
«Mi vuoi ancora tanto bene?», «Sono
proprio il tuo tesoro?». Anche questo era un modo
di aggrapparsi, un aggrapparsi fisico a ciò che fisico
non è. Ora vivo e respiro con la mia anima, sempre
che mi sia concesso usare questo termine screditato.
*Han Wegerif
[pp. 74 - 75]
Martedì mattina, le nove e mezzo. Qualcosa mi sta
succedendo e non so se si tratti di un semplice stato
d’animo o di un fatto importante. Mi sembra di reggermi di nuovo su me stessa. Sono un po’ più autonoma e
indipendente. Ieri sera pedalavo per la fredda e
buia Larissestraat - se solo potessi ripetere tutto quel
che ho borbottato allora:
Mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò da brava,
non farò troppa resistenza. Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita,
cercherò di accettare tutto e nel modo migliore. Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace. Non
penserò più, nella mia ingenuità, che un simile momento debba durare in eterno, saprò anche
accettare l’irrequietezza e la lotta. Il calore e la sicurezza mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al
freddo purché tu mi tenga per mano. Andrò dappertutto allora, e cercherò di non aver paura.
E dovunque mi troverò, io cercherò d’irraggiare un
po’ di quell’amore, di quel vero amore per gli uomini
che mi porto dentro. Ma non devo neppure vantarmi di questo ‘amore’. Non so se lo possiedo. Non voglio essere
niente di così speciale, voglio solo cercare
di essere quella che in me chiede di svilupparsi pienamente. A volte credo di desiderare l’isolamento di un
chiostro. Ma dovrò realizzarmi tra gli uomini, e in
questo mondo.
E lo farò, malgrado la stanchezza e il senso di ribellione che ogni tanto mi prendono. Prometto di vivere
questa vita sino in fondo, di andare avanti. Certe volte
mi viene da pensare che la mia vita sia appena all’inizio e che le difficoltà debbano ancora cominciare, altre volte
mi sembra di aver già lottato abbastanza. Studierò e cercherò di capire, ma credo che dovrò pur lasciarmi
confondere da quel che mi capita e che apparentemente mi svia: mi lascerò sempre confondere,
per arrivare forse a una sempre maggior sicurezza. Fin
quando non potrò più smarrirmi, e si sarà stabilito un
profondo equilibrio - un equilibrio in cui tutte le direzioni saranno sempre possibili. Non so se potrò essere
un’amica per gli altri. E se non potrò esserlo perché non è nel mio carattere, bisogna che affronti anche
questo. In ogni caso non devi mai illuderti. Devi aver
misura. E tu sola puoi essere misura a te stessa.
È come se ogni giorno io sia scaraventata in un gran
crogiolo e ogni giorno io riesca a uscirne.
Certe volte mi capita di pensare: la mia vita è completamente sbagliata, c’è un errore: ma questo capita
solo quando ci si fa una determinata idea della vita,
rispetto a cui può apparire sbagliato come realmente
viviamo.
[pp. 101 - 102]
27 febbraio, venerdì mattina, le dieci. [...] Mi sembra presuntuoso affermare che un uomo possa determinare il
proprio destino dall’interno. Quel che invece un uomo ha in mano è il proprio orientamento
interiore verso il destino. I fatti esterni non bastano
per capire la vita di una persona: bisogna conoscerne
i sogni, il rapporto con la famiglia, gli stati d’animo,
le delusioni, la malattia e la morte.
[...] Mercoledì mattina presto, quando con un gruppo numeroso ci siamo trovati in quel locale della Gestapo, i fatti
delle nostre vite erano tutti uguali: eravamo tutti nello stesso ambiente, gli uomini dietro la
scrivania come quelli che venivano interrogati. Ciò
che qualificava la vita di ciascuno era l’atteggiamento
interiore verso quei fatti. Si notava subito un giovane
che camminava su e giù con un’espressione palesemente scontenta, assillato e tormentato. Cercava in
continuazione pretesti per urlare a quei disgraziati
ebrei: «Mani fuori dalle tasche per favore... », ecc.
Per me era da compiangere più di coloro a cui stava
urlando; e questi, a loro volta, facevano pena nella
misura in cui erano impauriti. Quando mi sono presentata davanti alla scrivania, mi ha urlato improvvisamente:
«Che ci trova di ridicolo?». Avrei risposto volentieri: «Niente, tranne lei», ma per diplomazia m’è parso meglio
lasciar stare. «Lei ride tutto il
tempo» continuava a urlare lui. E io in tutta innocenza: «Non me ne accorgo proprio, è la mia faccia
normale». E lui: «Per favore non dica scemenze, vada fuori», con una faccia che voleva dire: tra poco
mi sentirai. Credo che questo fosse il momento psicologico in cui avrei dovuto spaventarmi a morte, ma
quel trucco l’ho capito troppo in fretta.
In fondo, io non ho paura. Non per una forma di
temerarietà, ma perché sono cosciente del fatto che ho
sempre a che fare con degli esseri umani, e che cercherò di capire ogni espressione, di chiunque sia e fin
dove mi sarà possibile. E il fatto storico di quella mattina non era che un infelice ragazzo della Gestapo si
mettesse a urlare contro di me, ma che francamente io
non ne provassi sdegno - anzi, che mi facesse pena,
tanto che avrei voluto chiedergli: hai avuto una giovinezza così triste, o sei stato tradito dalla tua ragazza? Aveva
un’aria così tormentata e assillata, del resto
anche molto sgradevole e molle. Avrei voluto cominciare subito a curarlo, ben sapendo che questi ragazzi
sono da compiangere fintanto che non sono in grado
di fare del male, ma che diventano pericolosissimi se
sono lasciati liberi di avventarsi sull’umanità. È solo
il sistema che usa questo tipo di persone a essere criminale. E quando si parla di sterminare, allora che sia
il male nell’uomo, non l’uomo stesso.
Un’altra cosa ancora dopo quella mattina: la mia
consapevolezza di non essere capace di odiare gli uomini malgrado il dolore e l’ingiustizia che ci sono al
mondo, la coscienza che tutti questi orrori non sono
come un pericolo misterioso e lontano al di fuori di
noi, ma che si trovano vicinissimi e nascono dentro di
noi. E perciò sono molto più familiari e assai meno
terrificanti. Quel che fa paura è il fatto che certi sistemi possano crescere al punto da superare gli uomini e da
tenerli stretti in una morsa diabolica, gli
autori come le vittime: così, grandi edifici e torri, costruiti dagli uomini con le loro mani, s’innalzano sopra di noi, ci
dominano, e possono crollarci addosso e
seppellirci.
[pp. 116 - 117]
Venerdì sera, le sette e mezzo. Oggi pomeriggio ho guardato alcune stampe giapponesi con Glassner. Mi sono
resa conto che è così che voglio scrivere: con altrettanto spazio intorno a poche parole. Troppe parole mi danno
fastidio. Vorrei scrivere parole che
siano organicamente inserite in un gran silenzio, e
non parole che esistono solo per coprirlo e disperderlo: dovrebbero accentuarlo, piuttosto. Come in
quell’illustrazione con un ramo fiorito nell’angolo in basso: poche, tenere pennellate - ma che resa dei minimi
dettagli - e il grande spazio tutt’intorno, non un vuoto, ma uno spazio che si potrebbe piuttosto definire ricco
d’anima. Io detesto gli accumuli di parole. In fondo, ce ne vogliono così poche per dir quelle quattro cose che
veramente contano nella vita. Se mai scriverò - e chissà poi che cosa? -, mi piacerebbe dipinger poche parole su
uno sfondo muto. E sarà più difficile rappresentare e dare un’anima a quella quiete e a quel silenzio che trovare le
parole stesse, e la cosa più importante sarà stabilire il giusto rapporto tra parole e silenzio - il silenzio in cui
succedono più cose che in tutte le parole affastellate insieme. E in ogni novella, o altro che sia, lo sfondo muto
dovrà avere un suo colore e un suo contenuto, come capita appunto in quelle stampe giapponesi. Non sarà un
silenzio vago e inafferrabile, ma avrà i suoi contorni i suoi angoli la sua forma: e dunque le parole dovranno servire
soltanto a dare al silenzio la sua forma e i suoi controni, e ciascuna di loro sarà come una piccola pietra miliare, o
come un piccolo rilievo, lungo strade piane e senza fine o ai margini di vaste pianure. È buffo: potrei riempire dei
volumi su come vorrei scrivere, ma può darsi benissimo che a parte le ricette io non scriverò mai nulla. Però le
stampe giapponesi mi hanno fatto capire a che cosa io aspiri, e mi piacerebbe camminare un a volta attraverso
paesaggi giapponesi, per capirlo ancor meglio. Del resto credo che un viaggio in Oriente lo farò, in futuro - per
trovare in quei luoghi, vissute ogni giorno, quelle cose in cui qui ci si sente soli, in dissonanza.
[pp. 126 - 127]
Sabato sera, mezzanotte e mezzo. [...] Per umiliare
qualcuno si dev’essere in due: colui che umilia, e
colui che è umiliato e soprattutto: che si lascia umiliare. Se manca il secondo, e cioè se la parte passiva
è immune da ogni umiliazione, questa evapora nell’aria. Restano solo delle disposizioni fastidiose che
interferiscono nella vita di tutti i giorni, ma nessuna
umiliazione e oppressione angosciose. Si deve insegnarlo agli ebrei. Stamattina pedalavo lungo lo Stadionkade e
mi godevo l’ampio cielo ai margini della
città, respiravo la fresca aria non razionata. Dappertutto c’erano cartelli che ci vietano le strade per la
campagna. Ma sopra quell’unico pezzo di strada che
ci rimane c’è pur sempre il cielo, tutto quanto. Non
possono farci niente, non possono veramente farei
niente. Possono renderci la vita un po’ spiacevole,
possono privarci di qualche bene materiale o di un
po’ di libertà di movimento, ma siamo noi stessi a privarci delle nostre forze migliori col nostro atteggiamento
sbagliato: col nostro sentirci perseguitati,
umiliati e oppressi, col nostro odio e con la millanteria che maschera la paura. Certo che ogni tanto si
può esser tristi e abbattuti per quel che ci fanno, è umano e comprensibile che sia così. E tuttavia: siamo
soprattutto noi stessi a derubarci da soli. Trova
bella la vita, e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e negli
uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma non è grave. Dobbiamo cominciare a prendere sul
serio il nostro lato serio, il resto verrà allora da sé: e «lavorare a se stessi» non è proprio una
forma d’individualismo malaticcio. Una pace futura
potrà esser veramente tale solo se prima sarà stata
trovata da ognuno in se stesso - se ogni uomo si sarà
liberato dall’odio contro il prossimo, di qualunque
razza o popolo, se avrà superato quest’odio e l’avrà
trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in
amore se non è chiedere troppo. È l’unica soluzione
possibile. E cosi potrei continuare per pagine e pagine. Quel pezzetto d’eternità che ci portiamo dentro
può esser espresso in una parola come in dieci volumoni. Sono una persona felice e lodo questa vita, la
lodo proprio, nell’anno del Signore 1942, l’ennesimo
anno di guerra.
[pp. 136 - 137]
La sofferenza non è al di sotto della dignità umana. Cioè: si può soffrire in modo degno, o indegno
dell’uomo. Voglio dire: la maggior parte degli occidentali non capisce l’arte del dolore, e così vive ossessionata da
mille paure. E la vita che vive la gente
adesso non è più una vera vita, fatta com’è di paura,
rassegnazione, amarezza, odio, disperazione. Dio mio,
tutto questo si può capire benissimo: ma se una vita
simile viene tolta, viene tolto poi molto? Si deve accettare la morte, anche quella più atroce, come parte
della vita. E non viviamo ogni giorno una vita intera, e ha molta importanza se viviamo qualche giorno
in più, o in meno? Io sono quotidianamente in Polonia, su quelli che si possono ben chiamare dei campi di
battaglia, talvolta mi opprime una visione di
questi campi diventati verdi di veleno; sono accanto
agli affamati, ai maltrattati e ai moribondi, ogni giorno - ma sono anche vicina al gelsomino e a quel
pezzo di cielo dietro la mia finestra, in una vita c’è
posto per tutto. Per una fede in Dio e per una misera fine.
Si deve anche avere la forza di soffrire da soli, e
di non pesare sugli altri con le proprie paure e coi
propri fardelli. Lo dobbiamo ancora imparare e ci
si dovrebbe reciprocamente educare a ciò, se possibile con la dolcezza e altrimenti con la severità. Quando dico:
in un modo o nell’altro ho chiuso i conti
con la vita, non è per rassegnazione. «Tutto quel
che si dice è malinteso». Se mi capita di dire una
cosa del genere, viene intesa altrimenti. Non è rassegnazione, non lo è di certo. Cosa voglio dire? Forse, che ho
già vissuto questa vita mille volte, e altrettante volte sono morta, e dunque non può più
succedere nulla di nuovo? È un modo di esser blasé?
No, è un vivere la vita mille volte minuto per minuto, e anche un lasciare spazio al dolore, spazio che
non può essere piccolo, oggi. E fa poi gran differenza se in un secolo è l’Inquisizione a far soffrire gli
uomini, o la guerra e i pogrom in un altro? Assurdo,
come dicono loro? Il dolore ha sempre preteso il suo
posto e i suoi diritti, in una forma o nell’altra. Quel
che conta è il modo con cui lo si sopporta, e se si è
in grado di integrarlo nella propria vita e, insieme,
di accettare ugualmente la vita. Sto teorizzando dietro la mia scrivania, dove ogni libro mi circonda con
la sua familiarità, e con quel gelsomino là fuori? È
solo teoria, non ancora messa alla prova da nessuna
pratica? Non lo credo più. Tra poco sarò messa di
fronte alle estreme conseguenze. Le nostre conversazioni sono già infarcite di frasi come: spero che egli
possa ancora godere di queste fragole con noi. So che
Mischa, col suo corpo delicato, sta per recarsi a piedi
alla Centraal Station, penso ai visini pallidi di Mirjam e Renate, alle preoccupazioni di molti, so tutto,
tutto, in ogni momento; a volte devo chinare il capo
sotto il gran peso che ho sulla nuca, e allora sento il
bisogno di congiungere le mani, quasi in un gesto
automatico, e così potrei rimaner seduta per ore so tutto, sono in grado di sopportare tutto, sempre
meglio, e insieme sono certa che la vita è bellissima,
degna di essere vissuta e ricca di significato. Malgrado tutto. Il che non vuol dire che uno sia sempre
nello stato d’animo più elevato e pieno di fede. Si
può esser stanchi come cani dopo aver fatto una lunga camminata o una lunga coda, ma anche questo fa
parte della vita, e dentro di te c’è qualcosa che non
ti abbandonerà mai più.
[pp. 169 - 170]
Preghiera della domenica mattina. Mio Dio, sono
tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta
ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano,
davanti a me passavano immagini su immagini di
dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto
una piccola cosa: cercherò di non appesantire l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani
- ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni
giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso
promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non
puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare
te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica che
veramente conti, è un piccolo pezzo di te in
noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio
Dio, sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali ma anch’esse
fanno parte di questa vita. lo non chiamo in causa la
tua responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore,
cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all’ultimo la tua
casa in noi. Esistono persone che all’ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri,
forchette e cucchiai d’argento - invece di salvare te,
mio Dio. E altre persone, che sono ormai ridotte a
semplici ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo. Dicono: me
non mi prenderanno. Dimenticano
che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è
nelle tue braccia, Comincio a sentirmi un po’ più
tranquilla, mio Dio, dopo questa conversazione con
te. Discorrerò con te molto spesso, d’ora innanzi, e
in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Con
me vivrai anche tempi magri, mio Dio, tempi scarsamente alimentati dalla mia povera fiducia; ma credimi, io
continuerò a lavorare per te e a esserti fedele e non ti caccerò via dal mio territorio.
[pp. 230 - 231]
In me non c’è un poeta, in me c'è un pezzetto di
Dio che potrebbe farsi poesia.
In un campo deve pur esserci un poeta, che da poeta viva anche quella vita e la sappia cantare.
Di notte, mentre ero coricata nella mia cuccetta,
circondata da donne e ragazze che russavano piano,
o sognavano ad alta voce, o piangevano silenziosamente, o si giravano e rigiravano - donne e ragazze
che dicevano così spesso durante il giorno: «non
vogliamo pensare», «non vogliamo sentire, altrimenti diventiamo pazze » -, a volte provavo un’infinita tenerezza,
me ne stavo sveglia e lasciavo che mi
passassero davanti gli avvenimenti, le fin troppe impressioni di un giorno fin troppo lungo, e pensavo:
«Su, lasciatemi essere il cuore pensante di questa baracca». Ora voglio esserlo un’altra volta. Vorrei essere il
cuore pensante di un intero campo di concentramento. Sono coricata qui con tanta pazienza e
di nuovo calma e già mi sento assai meglio; leggo
le lettere di Rilke Über Gott e ogni sua parola è carica di significato per me, avrei potuto scriverle io
stessa, se le avessi scritte io le avrei scritte così e
non diversamente. Mi sento anche la forza di partire, non penso più a far progetti e a correre rischi, andrà come
andrà e sarà per il meglio.
Alcune pagine dalle Lettere
18. A Osias Kormann
Amsterdam, mercoledì 4 novembre 1942
4 novembre 1942
Mercoledì pomeriggio
Kormann, mio Kormann, qui abbiamo già un tempo così piovoso e freddo, chissà come state voi, con quella
scarsità di cibo e coperte. Oggi il mio cuore è così, così triste
pensando a voi. Ma chissà, forse voi non c’entrate affatto, e sono piuttosto io a essere un po’ depressa e
impaziente perché la tiro tanto per le lunghe. E allora come stai, mio caro? Hai già traslocato e hai avuto molte
seccature per questo?
Durante una delle nostre passeggiate attorno al campo giallo di lupini abbiamo parlato di desideri e del loro
adempimento. Te ne ricordi ancora?
In una lettera del mio poeta Rainer Maria Rilke c’è un passo splendido su questo tema. Forse il tuo collega
Haussmann ribadirebbe amaramente: «Non è tempo di poeti e di filosofi». Io non so se abbia ragione, in ogni caso
ti trascrivo quelle poche frasi, forse ti faranno piacere in un momento di calma (se mai ti succede di averne): «Mi
capita spesso di domandarmi se la realizzazione ha davvero a che fare con i desideri. Certo, quando il desiderio è
debole, è come una metà che, per essere qualcosa di autonomo, necessita della realizzazione, la quale funge
appunto da seconda metà. Ma i desideri possono crescere meravigliosamente, sino a diventare qualcosa di intero,
di compiuto, di integro, che non necessita di completamento, che cresce, prende forma e si riempie attingendo
esclusivamente da se stesso. Talvolta verrebbe da pensare che proprio questa doveva esser stata la causa della
grandezza e dell’intensità di una vita, l’aver accondisceso a desideri troppo grandi, che dall’interno, quasi fossero
spinti da un meccanismo a scatto, si gettavano fuori nella vita, azione dopo azione, effetto dopo effetto, non
sapendo nemmeno più qual era in origine la loro meta e tramutandosi, in modo puramente elementare, alla
stregua di un’impetuosa cascata d’acqua, in esistenza immediata, in lieto coraggio, così come gli eventi e le
occasioni le mettevano in circolo».
Questo è tutto, per oggi. Salutami per favore il dottor Petzal per cui provo tanta simpatia.
Rivedo spesso il suo viso, segretamente malinconico sotto una maschera d’ironia. Non credo che avrà la vita
facile nella sua casupola sovraffollata.
Ahimè, forse la vita non sarà facile per nessuno di voi… Vorrei tanto ritornare presto per sapere come ve la
cavate.
lo credo che dalla vita si possa ricavare qualcosa di positivo in tutte le circostanze, ma che si abbia il diritto di
affermarlo solo se personalmente non si sfugge alle circostanze peggiori. Spesso penso che dovremmo caricarci il
nostro zaino sulle spalle e salire su un treno di deportati.
La prossima volta altra musica. Arrivederci, mio caro.
Etty
37. Presumibilmente a Han Wegerif e altri
Westerbork, martedì 8 giugno 1943
Martedì mattina, le dieci
Miei cari,
non è rimasta molta brughiera dentro al recinto di filo spinato, le baracche diventano sempre più numerose. Ne è
rimasto un pezzetto in un estremo angolo del campo, ed è lì che sono seduta ora, al sole, sotto uno splendido
cielo azzurro e fra alcuni bassi cespugli. Proprio di fronte a me, a pochi metri di distanza, vedo un’uniforme
azzurra e un elmo nella torretta di guardia sui pali.
Un gendarme raccoglie lupini violetti con aria estasiata, il fucile gli penzola sulla schiena. Se guardo a sinistra
vedo innalzarsi bianche nuvole di fumo e sento sbuffare una locomotiva. La gente è già stata caricata sui vagoni
merci, le
porte si chiudono. In giro c’è molta polizia verde, che stamattina è sfilata lungo il treno cantando e a passo di
marcia, e c’è pure molta gendarmeria olandese. Il totale previsto di quanti devono partire non è stato ancora
raggiunto.
Poco fa mi sono imbattuta nella responsabile dell’orfanotrofio, aveva un bambino piccolo in braccio: pure lui deve
partire, da solo. Hanno portato via anche alcuni malati dalle baracche dell’ospedale. Oggi si lavora sodo, ci sono in
visita dei pezzi grossi dall’Aia. Fa un effetto molto curioso poter osservare il loro comportamento da vicino. Dalle
quattro di stamattina ho avuto di nuovo neonati e bagagli da portare. In quelle ore si potrebbe accumulare
malinconia per una vita intera. Il gendarme amante della natura ha intanto messo insieme il suo mazzo violetto,
con cui forse farà la corte a una contadinella dei dintorni. La locomotiva manda un fischio terribile, tutto il campo
trattiene il fiato, partono altri tremila ebrei. In quei vagoni merci giacciono diversi bambini piccoli con la polmonite.
A volte è proprio come se ciò che accade non fosse affatto vero. Qui io non sono inquadrata in un ruolo preciso e
mi pare che sia la cosa migliore. Vado in giro e trovo il mio lavoro da sola.
Stamattina ho parlato per cinque minuti con una donna che veniva da Vught, e che in tre minuti mi ha raccontato le
sue ultime vicissitudini. Quante cose si possono dire in pochi minuti soltanto. Siamo arrivate a una porta che non
mi
era permesso oltrepassare, e lei mi ha abbracciata dicendo: «Grazie per l’aiuto che mi hai dato».
Sono salita un momento su una cassa che si trova fra i cespugli per contare il numero dei vagoni merci, erano
trentacinque, preceduti da alcuni vagoni di seconda classe per la scorta. I vagoni merci erano completamente
chiusi, ma qua e là mancavano alcune assi, e dalle aperture spuntavano mani a salutare, proprio come le mani di
chi affoga.
Il cielo è pieno di uccelli, i lupini violetti stanno là così principeschi e così pacifici, su quella cassa si sono sedute a
chiacchierare due vecchine, il sole splende sulla mia faccia, e sotto i nostri occhi avviene una strage, è tutto così
incomprensibile.
Io sto bene.
Affettuosamente
Etty
53. A Maria Tuinzing
Westerbork, sabato 10 luglio 1943
10 luglio
Maria, ciao, a decine di migliaia sono già partiti da questo luogo, vestiti e nudi, vecchi e giovani, malati e sani - e io
ero ancora in grado di vivere e pensare e lavorare ed essere lieta.
Adesso anche i miei genitori dovranno partire, se non questa settimana per virtù di un qualche miracolo,
certamente la prossima - e io devo imparare ad accettare anche questo.
Mischa vuole accompagnarli e mi sembra che debba farlo, perderà la testa se li vedrà partire. lo non lo farò, non
posso. È più facile pregare per qualcuno da lontano che vederlo soffrire da vicino. Non è per paura della Polonia
che non voglio seguire i miei genitori, ma per paura di vederli soffrire. E dunque, anche questa è viltà.
La gente non vuole riconoscere che a un certo punto non si può più fare, ma soltanto essere e accettare. Io ho
cominciato ad accettare già da molto tempo, ma si può farlo solo per se stessi e non per gli altri, ed è per questo
che sto passando un momento terribilmente difficile, qui.
La mamma e Mischa vogliono ancora fare qualcosa e mettere il mondo sottosopra, e io sono del tutto impotente di
fronte al loro atteggiamento. lo non posso fare nulla, non l’ho mai potuto, posso solo prendere le cose su di me e
soffrire. In questo consiste la mia forza, ed è una grande forza - ma per me stessa, non per gli altri.
Etty
«Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile ma non è grave: dobbiamo
cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio, il resto verrà da sé. Una pace futura potrà
essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso; se ogni uomo si sarà
liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo; se avrà superato quest'odio e
l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo. È
l'unica soluzione possibile. È quel pezzetto d'eternità che ci portiamo dentro. Sono una persona
felice e lodo questa vita, nell'anno del Signore 1942, l'ennesimo anno di guerra».
“Salva Dio in te stesso”. Un messaggio di Etty Hillesum
Maria Giovanna Noccelli
(NPG 05-01-41) http://www.cnos.org/
“Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al
buio con gli occhi che mi bruciavano, davanti a me passavano immagini su immagini
di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di
non appesantire l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani – ma anche
questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di
aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso
promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu
non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo
noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica che
veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. Forse possiamo
anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio,
sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali ma anch’esse
fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità, più tardi
sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore, cresce la
mia certezza: (…) tocca a noi aiutare te, difendere fino all’ultimo la tua casa in noi.
Esistono persone che all’ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo
aspirapolveri, forchette e cucchiai d’argento – invece di salvare te, mio Dio” (Etty
Hillesum, Diario 1941-1943, Adelphi, pp. 169-170).
Così scriveva Etty Hillesum, un’ebrea olandese di Amsterdam, una domenica mattina del 1942,
mentre fuori infuriava la persecuzione nazista.
Etty (Esther) Hillesum era nata il 15 gennaio 1914 a Middelburg (Paesi Bassi) da famiglia ebrea,
figlia di un insegnante di lingue classiche e di una russa scampata ai pogrom. Laureata in
giurisprudenza e iscrittasi poi alla facoltà di lingue slave, coltivò la passione per la lettura e gli studi
di filosofia e psicologia. Ad Amsterdam, in cui passò la maggior parte della sua vita, Etty insegnò
russo e condusse un’intensa vita relazionale, vissuta comunque come arricchimento e ulteriore
stimolo di una intensissima vita interiore. Di quest’ultima sono testimonianza i suoi diari (dal marzo
1941 al settembre 1943), e le lettere scritte agli amici, in gran parte da Westerbork, campo di
smistamento e anticamera per Auschwitz, situato al confine tra i Paesi Bassi e la Germania, dove
Etty si trovò come prigioniera dal giugno del ’43 (dopo avervi lavorato con possibilità di
allontanamento e avere avuto quindi più volte l’occasione, da lei rifiutata, di fuggire). Il 7 settembre
1943 si trovò anche lei come tutti sul treno merci per Auschwitz, assieme ai genitori e ad uno dei
due fratelli.
Da una informazione della Croce Rossa risulta che Etty morì ad Auschwitz il 30 novembre 1943;
aveva ventinove anni.
Chi era Etty Hillesum? Il punto di partenza di Etty è quello di una donna fragile, inquieta, instabile
affettivamente. Depressione, paura e repulsione marcano l’umanità di questa donna all’inizio della
sua autotestimonianza. Etty è una donna che ha avuto un’intensa vita sentimentale e un’altrettanto
intensa vita spirituale, una donna che cercò con molta difficoltà di trovare un equilibrio tra la sua
sete spirituale, di leggere, di conoscere, di scrivere, di esprimersi, di pregare e il suo desiderio di
vivere un rapporto d’amore con un uomo. Nei suoi scritti troviamo una grossa capacità introspettiva
e una ricerca acuta, piena di alti e bassi, con intuizioni profonde e ingenuità, con rabbie, delusioni,
angosce e scoppi di ottimismo: stati d’animo questi e sentimenti propri di ogni individuo sensibile
alla ricerca di identità.
L’itinerario interiore di Etty Hillesum si svolse contemporaneamente ai fatti storici esterni che
andarono coinvolgendo in maniera sempre più drammatica la gente ebrea: questo dramma la
sollecitò fortemente alla ricerca di un atteggiamento da tenere sia di fronte alla propria storia
personale che alla “grande” Storia, l’abisso di assurdità e ingiustizia che si compiva sotto gli occhi
di quella generazione di ebrei. Ma Etty chiede di essere un “cuore pensante”, e si oppone tanto
all’incapacità di pensare come violenza nell’atteggiamento dell’aguzzino quanto alla non volontà di
pensare come reazione al dolore che si evidenzia nelle vittime, attorno a lei. In ascolto di se stessa,
Etty si fortifica sempre più in benevolenza e fiducia verso la vita mentre all’esterno la situazione
storica precipita in orrore, così che verso il termine del suo itinerario interiore, quella vitalità
inquieta e sofferente si è come illuminata e pacificata, saldata attorno ad un ancoraggio interiore:
Dio.
Etty non invoca consapevolmente il Dio di una particolare tradizione religiosa; il “suo” Dio è,
semplicemente e immediatamente, il Dio che ciascuno porta al fondo della propria anima. Ciò che
allora riappare è semplicemente l’uomo che custodisce Dio nel segreto, un Dio che “va salvato”
proprio perché lo si tiene nell’intimo del proprio cuore. C’è dunque una parte della creatura più
profonda e intangibile, una parte divina, che patisce senza subire violenza, che è Dio in noi. “Dentro
di me c’è una sorgente molto profonda – scrive Etty – e in quella sorgente c’è Dio. A volte riesco a
raggiungerla, più sovente essa è coperta di pietre e sabbia: allora Dio è sepolto. Allora bisogna
dissotterrarlo di nuovo”.
La vita di Etty, la sua reazione al dolore alla morte, il suo grande amore a oltranza per la vita,
appaiono così come la manifestazione della profezia di Isaia: “Sarai come un giardino irrigato,
come una sorgente le cui acque non inaridiscono”.
In un luogo e in un momento storico in cui tutto proclamava e anzi urlava la morte di Dio e
dell’uomo, Etty intuisce l’intimo legame tra le sorti dell’uno e quelle dell’altro, riscopre in se stessa
la verità dell’uomo come luogo in cui sopravvive la presenza di Dio, e si dà il compito di custodire,
preservare, più che la propria vita fisica, il proprio nucleo interiore più profondo, un piccolo pezzo
di Dio in noi stessi, con un’intuizione di verità profondissima, che ritrova Dio per una strada altra,
personale e universale insieme, l’uomo come solo tempio possibile di un Dio vivente. E
disseppellire Dio nel cuore dell’uomo è “rintracciare il minuscolo essere umano, sepolto sotto la
barbarie dell’insensatezza e dell’odio”. Così Etty può arrivare a dire: “Amo così tanto gli altri
perché amo in ognuno un pezzetto di te, mio Dio”.
E a Dio scrive: “Discorrerò con te molto spesso e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi”.
Etty tiene vivo Dio in sé come relazione da alimentare, e parla con lui come ad una persona
diventata importante, qualcuno che non si vuole più lasciare andare. Parla a Dio come a un
qualcuno la cui permanenza nella nostra vita è più importante delle proiezioni e delle attese che
possiamo avergli costruito attorno. Lei fa un’operazione di “ritiro delle proiezioni” con tutti gli
attori più importanti della sua scena esistenziale, il suo uomo, il suo nemico, il suo Dio. In questo
modo diventa capace di relazioni libere e liberanti con tutti, anche con Dio, da cui arriva a non
pretendere niente, nemmeno che sia Dio, con tutte le immagini e le implicazioni di potenza che
caricano questo nome.
Etty manifesta questa idea commovente, originale, profondamente umana: trattenere Dio presso di
sé col dialogo, con l’attenzione, con la cura di una relazione: “Discorrerò con te”; parlerò io nel tuo
silenzio e farò essere la relazione anche nell’assenza, nell’apparente assenza di te. Vorrò crederci, e,
credendoci, ti farò essere; parlando con te renderò viva e operante la tua presenza invisibile,
seppellita e silente nel cuore dell’uomo.
Poiché, scrive Etty: “Una volta è un Hitler; un’altra è Ivan il Terribile, per quanto mi riguarda; in
un caso è la rassegnazione, in un altro sono le guerre, o la peste e i terremoti e la carestia. Quel
che conta in definitiva è come si porta, sopporta, e risolve il dolore, e se si riesce a mantenere
intatto un pezzetto della propria anima”. Un pezzetto della propria anima che è “la parte più
profonda di sé”, quella in cui lei “si riposa” e che chiama “Dio”.
Lei, di Dio, comprende e vive le cose essenziali: la sua presenza familiare e non estranea al cuore
dell’uomo, una sorta di sua profonda solidarietà e compromissione con l’uomo, con la sua
debolezza e impotenza e crocifissione nelle contraddizioni e nell’estremo dolore dell’esistenza; il
suo tacere di fronte ai giochi tragici con cui l’uomo mette in scena il suo profondo inganno su di sé;
il suo tornare a farsi avanti sempre e ancora attraverso l’uomo, con la stessa fedeltà ostinata della
vita. Verso Dio, come verso la vita, Etty mantiene un atteggiamento di apertura e di disponibilità le
cui perturbazioni non mette mai sul conto di Dio ma, con grande dignità e libertà e responsabilità,
ascrive al proprio limite umano. Etty “scagiona Dio” e lo considera la prima vittima dell’odio e
della violenza che infierisce attorno a lei.
Per Etty Hillesum, il “Dio lontano”, che spesso appare sordo e indifferente alle drammatiche
situazioni della nostra vita, è un Dio prossimo, come nella vicenda evangelica del Buon Samaritano
(Lc 10,25-37): Dio è il suo prossimo e del prossimo ha la vulnerabilità, una vulnerabilità che,
ribaltando i tradizionali termini religiosi, fa di Dio un supplice di aiuto e liberazione da parte
dell’uomo, un bisognoso di soccorso. E il soccorso è l’impegno che Etty volle assumersi,
disseppellire Dio nell’interiorità dell’uomo, inaridita come nel devastato campo di ossa sparse –
immagine perfetta dei campi di sterminio – che viene presentato agli occhi del profeta Ezechiele (Ez
37,1-14): una visione disperatamente desolata sui cui la domanda – “Figlio dell’uomo, potranno
queste ossa rivivere?” – suona già come l’annuncio, quasi la sfida, della forza sconcertante della
Vita dal profondo dell’abisso della desolazione.
Etty invoca un organo oltre la ragione per “capire una realtà sconcertante”; organi – dice – che
crediamo di non conoscere, o che non abbiamo mai avuto modo di scoprire, e che invece sono
dentro di noi. Il dolore, la morte, la sventura, la crudeltà, la persecuzione; in una parola, la
sofferenza. Ci sono dei “duri fatti” che dobbiamo irrevocabilmente affrontare; la nostra sfida è farli
diventare fattori di crescita e di comprensione, oppure soccombere. Poiché è dai pozzi della nostra
miseria e desolazione, è dalla trasformazione della sofferenza che ci accade personalmente che
possiamo attingere un senso nuovo, da offrire a noi stessi ma anche agli altri.
“Non diventate apatici e insensibili”. In ognuno di voi – scrive Etty ai suoi colleghi del Consiglio
ebraico di Amsterdam (uno strumento di apparente collaborazione con gli ebrei, creato dai nazisti) –
esiste “una parte migliore”. Questo lo dice anche San Paolo: “Sono convinto che in ognuno di voi
vi siano cose migliori”; la parte migliore, di cui parla anche Gesù a Marta, dicendo di Maria che si è
scelta la parte migliore – questa parte migliore è dentro di te, è una sorgente nel tuo cuore, seppellita
di pietre e sabbia.
Etty scopre questa sorgente e ne fa il cuore del proprio essere, o meglio, apprende a vivere a partire
da questa sorgente che è il cuore del proprio essere; significa che pone la sua mente, qui intesa
come ragione giudicante, nel cuore, in questo nuovo (o antico) centro del suo essere e si scopre ad
attingere da lì i giudizi più profondi che dà sulla realtà: una realtà in cui c’erano dei fatti molto duri
da sopportare – la persecuzione – e in cui c’era un nemico. E i giudizi che lei sceglie di dare non
sono giudizi di condanna della vita, della malasorte, di Dio, e nemmeno dell’altro, il nemico. Dare
giudizi col cuore, porre la mente nel cuore, non significa buonismo, perdonismo, così come non
vuol dire chiudere gli occhi sul male, non distinguerlo dal bene; significa, per Etty, qualcosa che lei
stessa non riesce a spiegare bene, a far intendere ai suoi amici, ai suoi interlocutori, a meno di non
chiarirlo progressivamente a se stessa: significa avere uno sguardo dilatato – un cuore appunto
dilatato – sulla vita. Riuscire a ricomprendere in essa, e nella sua bellezza, anche il dolore come
parte integrante: il dolore, non il male che lo provoca. Il dolore, anche se è provocato dal male
subito, dall’ingiustizia, può essere trasformato e giungere a contribuire al senso della vita;
soprattutto, agli occhi di Etty, il dolore non arriva a vanificare, a nascondere, a distruggere, la
bellezza della vita.
Dal treno che la portava ad Auschwitz, Etty lanciò una cartolina postale, indirizzata ad un’amica;
qualcuno la raccolse dalla strada ferrata e la spedì.
Vi si legge: “Christien, apro a caso la Bibbia e trovo questo: Il Signore è il mio estremo rifugio.
Sono seduta sul mio zaino nel mezzo di un affollato vagone merci. Papà, mamma e Mischa sono
alcuni vagoni più avanti. Abbiamo lasciato il campo cantando”.
Questo “lasciare il campo cantando” di Etty, la sua cartolina all’amica, mi fa tanto pensare ad una
strofa di una bellissima canzone di R. Vecchioni:
“La vita è qualcosa di talmente forte
Che quando sarai sul punto di morire
Pianterai un ulivo
Convinto ancora di vederlo fiorire”.
HANNAH ARENDT
LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO
Il totalitarismo é un fenomeno " essenzialmente diverso da altre forme conosciute di oppressione
politica come il dispotismo, la tirannide e la dittatura. Dovunque é giunto al potere, esso ha creato
istituzioni assolutamente nuove e distrutto tutte le tradizioni sociali, giuridiche e politiche del paese.
A prescindere dalla specifica matrice nazionale e dalla particolare fonte ideologica, ha trasformato
le classi in masse, sostituito il sistema dei partiti non con la dittatura del partito unico ma con un
movimento di massa, trasferito il centro del potere dall'esercito alla polizia e perseguito una politica
estera apertamente diretta al dominio del mondo ".
"Estraniazione, che é il terreno comune del terrore, l'essenza del regime totalitario e, per l'ideologia,
la preparazione degli esecutori e delle vittime, é strettamente connessa allo sradicamento e alla
superfluità che dopo essere stati la maledizione delle masse moderne fin dall'inizio della rivoluzione
industriale, si sono aggravati col sorgere dell'imperialismo alla fine del secolo scorso e con lo
sfascio delle istituzioni politiche e delle tradizioni sociali nella nostra epoca. Essere sradicati
significa non avere un posto riconosciuto e garantito dagli altri; essere superflui significa non
appartenere al mondo " .
"Quel che prepara così bene gli uomini moderni al dominio totalitario é estraniazione che da
esperienza al limite, usualmente subita in certe condizioni sociali marginali come la vecchiaia, é
diventata un'esperienza quotidiana delle masse crescenti nel nostro secolo. L'inesorabile processo in
cui il totalitarismo inserisce le masse da esso organizzate appare come un'evasione suicida da questa
realtà "
“Il tentativo di rendere superflui gli uomini riflette l’esperienza delle masse moderne, costrette a
constatare la loro superfluità su una terra sovrappopolata. La società dei morenti – in cui la
punizione viene inflitta senza alcuna relazione con un reato, lo sfruttamento praticato senza un
profitto e il lavoro compiuto senza un prodotto – è un luogo dove quotidianamente si crea
l’insensatezza. Eppure nel contesto dell’ideologia totalitaria, nulla potrebbe essere più sensato e
logico: se gli internati sono dei parassiti, è logico che vengano uccisi col gas; se sono dei
degenerati, non si deve permettere che contaminino la popolazione; se hanno un’”anima da
schiavi”, non è il caso di sprecare il proprio tempo per cercare di rieducarli. Visti attraverso le lenti
dell’ideologia, i campi hanno quasi il difetto di aver troppo senso, di attuare la dottrina con troppa
coerenza”
”L'ideologia totalitaria non mira alla trasformazione delle condizioni esterne dell'esistenza umana
né al riassetto rivoluzionario dell'ordinamento sociale, bensí alla trasformazione della natura umana
che, così com'è, si oppone al processo totalitario. I Lager sono i laboratori dove si sperimenta tale
trasformazione, e la loro infamia riguarda tutti gli uomini, non soltanto gli internati e i guardiani.
Non è in gioco la sofferenza, di cui ce n'è stata sempre troppa sulla terra, né il numero delle vittime.
È in gioco la natura umana in quanto tale; e anche se gli esperimenti compiuti, lungi dal cambiare
l'uomo, sono riusciti soltanto a distruggerlo, non si devono dimenticare le limitazioni di tali
esperimenti, che richiederebbero il controllo dell'intero globo terrestre per produrre risultati
conclusivi.”
"La preparazione è giunta a buon punto quando gli individui hanno perso il contatto coi loro simili e
con la realtà che li circonda; perché insieme con questo contatto, gli individui perdono la capacità di
esperienza e di pensiero. Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il
comunista convinto, ma l'individuo per il quale la distinzione tra realtà e pensiero, fra vero e falso,
non esiste più"
"I campi di concentramento e di sterminio servono al regime totalitario come laboratori per la
verifica della sua pretesa di dominio assoluto sull'uomo".
“I lager servono, oltre che a sterminare e a degradare gli individui, a compiere l’orrendo
esperimento di eliminare, in condizioni scientificamente controllate, la spontaneità stessa come
espressione del comportamento umano e di trasformare l’uomo in oggetto, in qualcosa che neppure
gli animali sono; perché il cane di Pavlov che, com’è noto, era ammaestrato a mangiare, non
quando aveva fame, ma quando suonava una campana, era un animale pervertito”
"La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme"
Nel libro "La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme" la Arendt raccoglie gli articoli che
aveva pubblicato sul giornale statunitense New Yorker, quando assistette, nel 1961, al processo di
Eichmann. Questi era stato un tedesco che, dopo aver aderito al nazionalsocialismo, aveva diretto la
sezione B della GESTAPO, IV ufficio del RSHA (servizio principale per la sicurezza del Reich),
che si occupava dei problemi ebraici. Eichmann organizzava quindi i treni che conducevano gli
ebrei ai campi di sterminio. Cercando di capire l'uomo che aveva di fronte e i suoi comportamenti,
la Arendt cambia la posizione sul male radicale che aveva espresso nel libro "le origini del
totalitarismo". Di fronte alla superficialità di Eichmann, né malvagio né stupido, l'autrice elabora
l'idea del male come mancanza di pensiero: il male non è più qualcosa di eccezionale ma fa parte di
noi e delle persone che ci sono vicine. Di fronte al giudice che lo accusava dello sterminio degli
ebrei, Eichmann sostenne che non aveva fatto altro che obbedire agli ordini. Ad Eichmann mancò
quello che lei chiama "lo spazio pubblico", cioè lo spazio per giudicare quello che avviene. Tutta
la vita di Eichmann è un esempio di impossibilità di esprimere un giudizio. È la singolarità che
permette che permette che vi sia uno spazio pubblico ed egli non la ha mai raggiunta. Ed infatti la
sua è una esistenza impostata nell'obbedienza agli ingranaggi burocratici di potere, qualsiasi essi
siano. Dunque il suo non è un vero agire, ma una ripetizione degli ordini ricevuti. La sua incapacità
di arrivare alla singolarità si manifesta anche nel linguaggio adoperato, burocratico, intessuto di
luoghi comuni, con frasi fatte. Sono queste le radici del male, un male molto quotidiano. Le frasi
fatte sono modi di sottrarsi alla realtà. Il male è l'assenza, il rifiuto del pensiero. Pensare è infatti
dialogare con se stessi, cioè di porsi di fronte alla scelta fra il giusto e l'ingiusto.
"Eichmann ebbe dunque molte occasioni di sentirsi come Ponzio Pilato che con il passare dei mesi
e degli anni non ebbe più bisogno di pensare. Così stavano le cose, questa era la nuova regola, e
qualunque cosa facesse, a suo avviso la faceva come cittadino ligio alla legge."
"Ciò che più colpiva le menti di quegli uomini che si erano trasformati in assassini, era
semplicemente l'idea di essere elementi di un processo grandioso, unico nella storia del mondo ("un
compito grande, che si presenta una volta ogni duemila anni") e perciò gravoso. Questo era molto
importante perché essi non erano sadici o assassini per natura; anzi, i nazisti si sforzarono sempre,
sistematicamente, di mettere in disparte tutti coloro che provavano un godimento fisico
nell'uccidere. (.). Perciò il problema era quello di soffocare non tanto la voce della loro coscienza,
quanto la pietà istintiva, animale, che ogni individuo normale prova di fronte alla sofferenza fisica
degli altri. Il trucco usato da Himmler ( che a quanto pare era lui stesso vittima di queste reazioni
istintive) era molto semplice e molto efficace: consisteva nel deviare questi istinti , per così dire,
verso l'io. E così, invece di pensare: che cose orribili faccio al prossimo!, gli assassini pensavano:
che orribili cose devo vedere nell'adempimento dei miei doveri, che compito terribile grava sulle
mie spalle!"
"Il meccanismo dello sterminio era stato progettato e studiato in tutti i particolari.(.) All'inizio,
quando la gente poteva ancora avere una coscienza, le defezioni negli alti gradi e soprattutto tra gli
ufficiali superiori delle SS furono molto rare; cominciarono ad avere un peso soltanto quando ormai
era chiaro che la Germania avrebbe perso la guerra.Ma anche allora non assunsero mai proporzioni
tali da pregiudicare il funzionamento del meccanismo; furono atti individuali, dettati non dal
rimorso ma dalla corruzione, ispirati non dalla pietà ma dal desiderio di salvare un po' di denaro o di
crearsi un alibi per l'oscuro avvenire."
“Il guaio del caso Eichmann era che uomini come lui ce n'erano tanti e che questi tanti non erano né
perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali.
“Non era stupido, era semplicemente senza idee[...]. Quella lontananza dalla realtà e quella
mancanza di idee, possono essere molto più pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse sono
innati nell'uomo. Questa fu la lezione di Gerusalemme. Ma era una lezione, non una spiegazione del
fenomeno, né una teoria.”
“E' anzi mia opinione che il male non possa mai essere radicale, ma solo estremo; e che non
possegga né una profondità, né una dimensione demoniaca. Può ricoprire il mondo intero e
devastarlo, precisamente perché si diffonde come un fungo sulla sua superficie. E' una sfida al
pensiero, come ho scritto, perché il pensiero vuole andare in fondo, tenta di andare alle radici delle
cose, e nel momento che s'interessa al male viene frustrato, perché non c'è nulla. Questa è la
banalità. Solo il Bene ha profondità, e può essere radicale.”
I RAGAZZI DELLA ROSA BIANCA
«Non dovrebbe ogni uomo, in qualunque epoca viva, ragionare continuamente
come se un istante dopo dovesse essere portato davanti a Dio per il giudizio?»
Sophie Scholl
La Rosa Bianca è il nome di un gruppo di studenti tedeschi che pagarono con la vita la
loro opposizione al regime nazista. La Weiße Rose era composta da Hans Scholl, sua
sorella Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf, tutti poco più
che ventenni, cui si unì successivamente il professor Kurt Huber.
Hans Scholl nasce il 22 settembre 1918 a Ingersheim, da Robert Scholl, sindaco della
cittadina, liberale, pacifista e anti-nazionalista, e Magdalene Müller, infermiera. Un anno
prima era nata Inge, e successivamente alla famiglia si aggiungeranno Elisabeth, nel
1920, Sophie, nata a Forchtenberg il 9 maggio 1921, Werner, nato nel 1922, Thilde, nata
nel 1925 e vissuta pochi mesi. Agli Scholl appartiene di fatto anche il piccolo Ernst,
rimasto orfano di madre.
Il protestantesimo convinto della madre porta i figli ad avvicinarsi alla religione e a
frequentare la chiesa.
Nel settembre 1930, alle elezioni per il Parlamento, il Partito Nazionalsocialista ottiene il
primo di una serie di successi, che l'avrebbero portato in meno di tre anni a conquistare il
potere. Sono tempi di crisi economica, che provoca una disastrosa inflazione, la
svalutazione del marco e un'altissima disoccupazione.
Nel 1932 la famiglia si trasferisce a Ulm.
Nonostante la contrarietà del padre, anche Hans, Inge e Sophie Scholl subiscono il
fascino della propaganda del regime e iniziano a partecipare alle attività delle
organizzazioni giovanili naziste, a cominciare dalla Hitler-Jugend, la Gioventù
Hitleriana. Tuttavia, dopo un paio di anni, se ne allontanano, avendo compreso che non
sono quegli spazi di realizzazione personale e comunitaria che avevano inizialmente
immaginato.
Hans si accosta quindi alla dj.1.11, fondata da Eberhard Köbel, detto Tusk, un gruppo
giovanile vietato dal regime, che coltiva il mito dei popoli del grande nord, dei lapponi e
dei russi, e propone il lungo viaggio come strumento di ricerca della propria dimensione.
Ciò porta, nel 1937, all'arresto di Hans, Inge, Werner e Sophie, che verranno poi
rilasciati, non potendosi provare la loro appartenenza ai movimenti vietati.
All'allontanamento degli Scholl dalle idee naziste contribuisce la vasta preparazione
culturale che acquisiscono nel loro cammino di ricerca umana e spirituale. Leggono
Platone, Aristotele, Agostino, Anselmo di Canterbury, Abelardo, Tommaso d'Aquino,
Pascal, Kierkegaard, Newman, Maritain, Bernanos, Nietzsche, Dostoevskij, Tommaso
Moro, Lao-Tze, scritti buddhisti e confuciani, il Corano, e tanti altri testi. Ma al centro
della loro attenzione restano il Vangelo e le ragioni di un cristianesimo depurato dai
compromessi con il potere. La lettura degli autori del rinnovamento cattolico francese,
sarà alla base del loro progressivo avvicinamento al cattolicesimo.
Ad influenzare le loro scelte è anche l'amicizia con Otto (Otl) Aicher, che vive a
Söflingen, un quartiere in cui è presente una forte resistenza cattolica al nazismo,
animata dal parroco Franz Weiss. Otl diffonde le idee del Quickborn (Sorgente di vita),
un movimento cattolico guidato da Romano Guardini, che si propone di rinnovare la
liturgia e la concezione della Chiesa, vede solo in Cristo la guida della gioventù e
proclama il triplice diritto dei giovani nella formula «Gioventù, Libertà e Gioia».
Nel 1937 comincia il rapporto sentimentale ed epistolare tra Sophie e Fritz Hartnagel,
allievo della scuola ufficiali di guerra a Potsdam e poi ufficiale in servizio attivo su
diversi fronti della seconda guerra mondiale. Pur volendo rimanere fedele al suo
compito, Fritz condivide lo stesso desiderio di giustizia e libertà di Sophie, che lo porterà
ad abbracciare idealmente le ragioni della resistenza.
Il 12 marzo 1938 le truppe tedesche entrano in Austria, che viene annessa al Reich. In
maggio Hitler minaccia la Cecoslovacchia, reclamando il territorio dei Sudeti. In
settembre le potenze europee firmano l'accordo di Monaco, che dà il via libera
all'annessione dei Sudeti. Il 1° ottobre comincia l'occupazione dei territori da parte delle
truppe tedesche. Il 15 marzo 1939 la Germania invade la Cecoslovacchia. Il 23 agosto
1939 viene firmato il patto di non aggressione Hitler-Stalin e il 1° settembre, con
l'invasione della Polonia, comincia la seconda guerra mondiale.
La primavera del 1941 è l'anno dell'incontro dei membri della futura Rosa Bianca con
Carl Muth e Theodor Haecker, due intellettuali cattolici anti-nazisti, il cui pensiero
influenzerà molto le scelte di resistenza del gruppo.
A dare ad Hans l'idea dei futuri volantini è probabile che sia stato l'arrivo in casa Scholl
dei fogli clandestini con le prediche e le lettere pastorali del vescovo cattolico di
Münster Clemens August von Galen, che si schiera coraggiosamente contro il nazismo.
Nel giugno 1941, inizia l'attacco all'Unione Sovietica.
Nel gennaio 1942 il padre degli Scholl, Robert, è denunciato da una sua impiegata per
aver definito Hitler «un flagello di Dio» e per aver detto che la guerra alla Russia è un
massacro insensato e che i sovietici avrebbero finito per conquistare Berlino. Prelevato
dalla Gestapo e interrogato, viene rilasciato, ma successivamente verrà condannato a
quattro mesi di carcere, che significheranno anche la rovina economica della famiglia.
All'inizio di maggio 1942, Sophie Scholl si trasferisce a Monaco per iniziare a
frequentare l'Università, e qui conosce le persone con cui condividerà le sorti della Rosa
Bianca: i commilitoni di suo fratello nella seconda compagnia studentesca Willi Graf e
Alexander Schmorell, l'amico di quest’ultimo Christoph Probst, e il professor Kurt
Huber, che tiene un corso di filosofia su Leibniz.
I primi quattro volantini della Rosa Bianca sono scritti a macchina da Hans Scholl e
Alexander Schmorell, ciclostilati e spediti in qualche centinaio di copie, tra il 27 giugno
e il 12 luglio 1942, a indirizzi scelti a caso negli elenchi telefonici, privilegiando
professori e intellettuali, o lasciati in locali pubblici, alle fermate dell'autobus, nelle
cabine telefoniche, o gettati dai tram di notte.
Subito la Gestapo si mette a indagare sugli autori degli scritti, senza esito.
Nell'estate 1942, Hans Scholl, Schmorell e Graf partono per un tirocinio medico di tre
mesi sul fronte russo, un viaggio attraverso la Polonia che li rende ulteriormente
consapevoli degli orrori della guerra, e fa loro conoscere la grandezza del popolo russo e
dei suoi intellettuali.
Rientrati a Monaco, nelle notti del 1, 8 e 15 febbraio 1943, i membri della Rosa Bianca
scrivono sui muri dell'Università e di altri edifici un'ottantina di slogan anti-hitleriani.
Distribuiscono un quinto volantino, firmato «Movimento di resistenza in Germania», cui
collabora anche Kurt Huber, l'unico professore di Monaco che osa fare commenti antinazisti nelle sue lezioni, autore anche del volantino successivo.
Il 18 febbraio 1943 Hans e Sophie Scholl si recano all'Università con una valigia
contenente 1500 copie del sesto volantino, da distribuire clandestinamente. Dopo averli
diffusi per i vari piani dell'edificio, Sophie dà una spinta ad una risma di volantini
appoggiata sulla balaustra del secondo piano, che volano nell'atrio. Un impiegato
dell'Università li nota e li ferma, portandoli dal rettore, senza che essi oppongano
resistenza. Vengono arrestati. Nel giro di pochi giorni, la stessa sorte tocca agli altri
membri della Rosa Bianca e a circa ottanta persone ad essi anche lontanamente
collegate.
I funzionari della Gestapo che interrogano Sophie rimangono sorpresi dal coraggio e
dalla determinazione con cui la ragazza rivendica le proprie ragioni di dissenso dal
nazismo e ammette le responsabilità sue e del fratello, che pure ha confessato, cercando
di attribuirle interamente ad entrambi per scagionare gli altri membri della Rosa Bianca.
I fratelli Scholl e Cristoph Probst vengono processati a Monaco il 22 febbraio 1943.
Dichiara Sophie durante il processo: «Sono in tanti a pensare quello che noi abbiamo
detto e scritto; solo che non osano esprimerlo a parole». Dopo cinque ore, il giudice
Roland Freisler emette il verdetto: «In nome del popolo tedesco. Nel processo contro 1)
Hans Fritz Scholl 2) Sophia Magdalena Scholl 3) Christoph Hermann Probst attualmente
detenuti in attesa di giudizio in questo processo per favoreggiamento antipatriottico del
nemico, preparazione di alto tradimento, demoralizzazione delle forze armate, il
tribunale del popolo, prima sezione [...], riconosciuto in diritto che: Gli imputati, in
tempo di guerra, attraverso volantini hanno propagandato idee disfattiste, fatto appello al
sabotaggio dell'organizzazione militare e all'abbattimento del sistema di vita
nazionalsocialista del nostro popolo e insultato il Führer nel mondo più infame e con ciò
favorito il nemico del Reich e demoralizzato le nostre forze armate. Essi vengono perciò
puniti con la morte. Essi hanno perduto per sempre i loro diritti civili».
Christoph riceve il battesimo, la comunione e l'estrema unzione dal cappellano cattolico
Heinrich Sperr, e scrive alla madre: «Ti ringrazio di avermi dato la vita. A pensarci
bene, non è stata che un cammino verso Dio». Anche Hans e Sophie avrebbero voluto
un prete cattolico, ma poi si confessano e celebrano la santa cena con il cappellano
evangelico Karl Alt, cui Hans chiede di leggere il Salmo 89 («Rendici la gioia per i
giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura») e il passo della prima
Lettera ai Corinzi (13, 1-12): «Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma
non avessi la carità...». Ai fratelli Scholl viene permesso un ultimo e breve incontro con i
genitori.
Racconterà uno dei secondini: «Si sono comportati con coraggio fantastico. Tutto il
carcere ne fu impressionato. Perciò ci siamo accollati il rischio di riunire ancora una
volta i tre condannati, un momento prima dell'esecuzione capitale. Volevamo che
potessero fumare ancora una sigaretta insieme. Non furono che pochi minuti, ma credo
che abbiano rappresentato un gran regalo per loro».
«Fra pochi minuti ci rivedremo nell'eternità», dice Christoph Probst. Poi vengono
condotti alla ghigliottina, senza battere ciglio. Il boia dirà di non avere mai veduto
nessuno morire così. «Viva la libertà», grida Hans Scholl mentre lo portano al patibolo.
Il 19 aprile 1943 vengono processati Alexander Schmorell, Willi Graf e Kurt Huber, che
saranno condannati a morte e ghigliottinati nei mesi successivi. Amici e colleghi, che li
avevano aiutati nella preparazione e distribuzione degli opuscoli, e avevano raccolto
fondi per la vedova e i figli di Probst, vengono condannati al carcere per periodi
oscillanti tra i sei mesi e i dieci anni. Robert Mohr, il funzionario della Gestapo che ha
condotto l'interrogatorio di Sophie, e che in seguito si dimetterà e rientrerà nella polizia
criminale, dichiarerà dopo la guerra: «Fino alla loro amara fine Sophie e Hans Scholl
conservarono un atteggiamento che può definirsi eccezionale. Entrambi in sintonia
dichiararono il senso delle loro azioni: avevano avuto come unico scopo evitare alla
Germania una sventura ancora più grande e contribuire forse, da parte loro, a salvare la
vita di centinaia di migliaia di soldati tedeschi, perché quando si tratta della salvezza o
della rovina di un intero popolo non c'è mezzo o sacrificio che possa apparire troppo
grande. Sophie e Hans Scholl furono sino all'ultimo convinti che il loro sacrificio non
era stato inutile». La piazza dove è ubicato l'atrio principale dell'Università LudwigMaximilian di Monaco è stata chiamata Geschwister-Scholl-Platz in memoria di Hans e
Sophie Scholl.
Sophie Scholl Martire
Forchtenberg, Germania, 9 maggio 1921 – Monaco di Baviera, Germania, 22 febbraio 1943
Nella primavera del 1940 Sophie Scholl consegue la maturità e trova impiego come insegnante
d’asilo presso il Fröbel Institute a Ulm-Söflingen. Nel maggio 1942 si iscrive all'Università di
Monaco, dove si unisce al fratello Hans e ai suoi amici. Frequenta con loro ambienti culturali che si
oppongono al nazismo. Durante le vacanze estive dello stesso anno deve prestare servizio di guerra
in un impianto metallurgico di Ulm. In quel periodo diviene membro attivo della Rosa Bianca.
Viene arrestata, insieme ad Hans, il 18 febbraio 1943, mentre distribuiscono il sesto volantino della
Rosa Bianca all'Università di Monaco. Il 22 febbraio 1943 è processata, condannata a morte e
giustiziata, insieme ad Hans e a Christoph Probst.
Viso piccolo, sguardo vivace e fiero, capelli alla maschietto non conformi alla moda dell’epoca.
Così si presenta Sophie Scholl nelle foto che la ritraggono. E già da lì si capisce che si tratta di un
personaggio fuori dalla norma. Una particella «impazzita» in un regime che tende a mettere in riga
tutti, che inquadra e domina azioni e pensieri.
Stupisce, nella sua biografia, la sua vita intellettuale fin da giovanissima, la vivacità del suo
intelletto, la curiosità, gli interessi, il suo profondo amore per la musica e per la natura.
Quando Hitler va al potere lei ha 12 anni e, come la stragrande maggioranza dei ragazzi tedeschi,
subisce la pressione della propaganda pedagogica ma anche il fascino e l’attrazione di un richiamo
che è anzitutto quello della patria.
È una ragazza come tante, Sophie, ultima figlia di una famiglia numerosa e unita. Educata al valore
dell’indipendenza e dell’onestà di pensiero, in un primo tempo cresce seguendo il nazionalismo
imperante. Partecipa ai gruppi in cui i ragazzi venivano «irreggimentati» dal Nazismo di «prima
maniera». Ama il suo paese e vuole farne parte attiva. Questo anche andando contro le idee del
padre che da subito si era reso conto della pericolosità dell’ideologia hitleriana. C’è dunque un
confronto vivace nella famiglia Scholl, poiché anche il fratello maggiore di Sophie, Hans, sosteneva
apertamente il nuovo regime. Si tratta di un confronto e non di uno scontro però, poiché questa è
anche la storia di una famiglia che ha avuto il coraggio di contrapporre il proprio essere comunità
morale, ad una comunità, quella tedesca degli anni ’30, che sembra essere asservita all’assenza di
morale, una famiglia in cui ciascuno era libero da condizionamenti e poteva crescere con la
massima autonomia di pensiero.
Così, in maniera graduale e del tutto autonoma, ben presto in Sophie matura il dissenso. Non è un
processo repentino. È piuttosto una lenta presa di coscienza, frutto di osservazioni, valutazioni e
analisi della realtà circostante. Per prima cosa si allontana da quei gruppi di cui aveva fatto parte
con tanto entusiasmo solo poco tempo prima. Le sue scelte di studi e professionali per alcuni aspetti
sono scelte obbligate, e d’altronde non poteva essere diversamente nel regime nazista. Ma da un
certo punto in poi i tirocini e le esperienze preparatorie all’università le vive male. E la cosa
stupisce. Dalle prime pagine della sua biografia Sophie, infatti, ci appare come una ragazza di
grande vitalità, appassionata. Eppure le esperienze che vive prima di iscriversi all’università la
incupiscono. Si rende sempre più conto dell’assurdità dei metodi nazisti e del fanatismo che la
circonda. Non trova nulla in comune con le sue compagne di studi e di esperienze. Forse è in questa
fase, durante il periodo di lavoro obbligato, che apre veramente gli occhi e prende il via quella sua
maturazione spirituale che la porterà a riconoscere la cecità di tutti gli altri.
Il diario di Sophie si arricchirà progressivamente di invocazioni a Dio nella scia di S. Agostino e
Pascal, vocazioni liriche, riflessioni, e preghiere. Anche le lettere di quel periodo contengono spesso
riflessioni metafisiche e la confessione di un faticoso momento esistenziale: «Mi sento così
impotente, e certo lo sono. Non posso pregare per niente altro che di essere capace di pregare».
La meditazione sul Creatore e sulla natura la conduce al riconoscimento della libertà dell’uomo
come supremo dono divino e alla visione della giustizia di Dio contrapposta all’ingiustizia del
mondo: «Non è anche questo un mistero, che tutto sia così bello? Nonostante l’orrore, continua ad
essere così. Nel mio godere della bellezza si è inserito un elemento sconosciuto, un presagio del
creatore, che ogni creatura innocente loda la sua bellezza. Per questo soltanto l’uomo è capace di
essere veramente crudele, perché è libero di dissociarsi da questo canto di lode. E adesso si potrebbe
spesso pensare che lo faccia, coprendo questo canto col rumore di cannoni, di maledizioni e di
bestemmie. Ma il canto di lode ha il sopravvento… ed io voglio fare tutto quello che è possibile per
associarmi alla sua vittoria».
Come tutte le ragazze della sua età, anche Sophie ha un amore, un fidanzato che il destino ha voluto
essere ideologicamente (almeno all’inizio) opposto a lei. Anche in questo caso, come era stata
abituata dall’ambiente familiare, non scontro ma confronto. Certo Sophie non è tipo da tenere
taciute le sue idee e i suoi pensieri. Nello scambio di lettere tra lei e Franz (questo il nome del
ragazzo), che era al fronte, leggiamo spesso non solo frasi e parole d’affetto verso l’amato, ma
anche lucide analisi della situazione politica, poiché si propone di essere per lui la sua spina contro
l’indifferenza facendolo ragionare sull’assurdità della guerra.
I concetti di partecipazione e di responsabilità erano radicati nel suo essere. L’eguaglianza delle
razze umane, la pace come scopo della politica erano invece concetti che traeva da autori banditi dal
regime. Gli stessi che ispirano Hans Scholl e il suo amico Schmorrell per la creazione di un gruppo
di resistenza pacifica la «Rosa Bianca» (Weiße Rose), di cui farà presto parte anche Sophie.
Un ciclostile per la libertà
Giovani cristiani che dalla fede traevano forza e sostegno, questi ragazzi cercano di raggiungere la
coscienza del popolo tedesco solo attraverso sei volantini, poiché non avevano altro che la forza
delle parole e un ciclostile. I fratelli Scholl e i loro amici scelgono una via pacifica e si sacrificano
liberamente pur di non cedere ad un potere che non riconoscevano.
Tra il 27 giugno e il 12 luglio 1942 distribuiranno, in centinaia di copie, 4 fogli scritti a macchina
spedendoli a indirizzi scelti a caso dagli elenchi telefonici, lasciandoli nelle fermate degli autobus,
gettandoli dai tram di notte o abbandonandoli nelle cabine telefoniche.
Quei volantini esprimono una sofferta e convinta testimonianza cristiana, un’obbedienza alla legge
della coscienza, ma anche un atteggiamento di opposizione culturale al nazismo, un esplicito rifiuto
del militarismo e un appello diretto ad una concreta azione di resistenza al regime.
I membri della Rosa Bianca si rivolgono a tutti i tedeschi, accusando ognuno, per il silenzio
condiscendente, di complicità per i crimini del nazismo e incitando alla resistenza non violenta. Una
scelta controcorrente di fronte alle stragi del regime, ma l’unica, ai loro occhi, capace di riscattare
l’onore di un’intera nazione, capace di pulire la coscienza di un popolo da colpe tanto infamanti.
L’invito alla resistenza viene offerto non solo attraverso indicazioni pratiche, ma anche tramite
citazioni classiche, richiami biblici, filosofici, letterari. Il linguaggio è volutamente élitario e
altisonante, perché i messaggi sono esplicitamente destinati a professori, intellettuali, studenti
universitari e all’avanguardia del popolo tedesco, profondamente decaduto se rinuncia a reagire
contro la perdita della propria libertà: «Non dimenticate che ogni popolo merita il governo che
tollera!». Sophie e i suoi compagni sono infatti assertori della corresponsabilità individuale e
collettiva rispetto alla dittatura: «Ognuno vuole liberarsi da questa complicità, ciascuno cerca di
farlo ma poi ricade nel sonno con la più grande tranquillità di coscienza. Ma egli non può
scagionarsi: ciascuno è colpevole, colpevole, colpevole!».
Nei volantini si trova anche una sorta di autoritratto della Rosa Bianca: «La Rosa Bianca non è al
soldo di nessuna potenza straniera. Pur sapendo che il potere nazionalsocialista deve essere spezzato
militarmente, noi cerchiamo un rinnovamento dall’interno dello spirito tedesco, così gravemente
ferito». «Noi non taceremo, noi siamo la voce della vostra cattiva coscienza; la Rosa Bianca non vi
darà pace».
Le argomentazioni riportate nei fogli propagandistici sono sempre intense e appassionate. Il quarto
volantino per esempio possiede una intensa enfasi religiosa che dà anche una chiave di lettura
teologica alla resistenza e fa appello esplicito al cristiano: «Non ti ha forse Dio stesso dato la forza e
il coraggio di combattere? Dobbiamo attaccare il male là dove esso è imperante, ed esso è
imperante proprio nel potere di Hitler».
Il quinto volantino è invece un appello alla coscienza morale dei tedeschi e anche il più esplicito
progetto politico della Rosa Bianca: «Libertà di parola, libertà di fede, difesa dei singoli cittadini
dall’arbitrio di stati criminali fondati sulla violenza: queste sono le basi della nuova Europa».
L’appello finale del volantino è solenne: «In nome della gioventù tedesca esigiamo dallo stato di
Adolf Hitler la restituzione della libertà personale, il bene più prezioso dei tedeschi che egli ci ha
tolto nel modo più spregevole».
Sophie e i suoi compagni erano consci del rischio, ma la loro coscienza gli intimava di non cedere a
nessun compromesso: «La libertà è il più prezioso tesoro che abbiamo», sostenevano nei loro
volantini.
Il film: gli ultimi sei giorni
Di quei giovani che hanno pagato con la vita l’obbedienza alla verità oggi si torna finalmente a
parlare grazie al film di un regista tedesco, Marc Rothemund, La Rosa Bianca – Sophie Scholl.
Il ritmo della pellicola è incalzante e riesce pienamente a trasmettere la grandezza del sacrificio di
quegli studenti universitari che, in virtù dei loro valori cristiani, pacificamente ma con grande
determinazione si opposero alla cultura di morte nazista, rimanendo fedeli alla massima che era il
loro motto: «Bisogna avere uno spirito inflessibile e un cuore tenero».
Il film ripercorre gli ultimi sei giorni di vita di Sophie in particolare: l’arresto, il processo farsa, la
condanna a morte.
Sophie infatti sapeva che i volantini della Rosa Bianca erano opera di suo fratello e di Schmorrell, e
la crescente consapevolezza del dovere cristiano di opporsi alle potenze del male, maturata nelle
discussioni dei gruppi a cui partecipava e nei «salotti dell’opposizione», la spinge a chiedere di
partecipare alla creazione di una nuova serie di volantini. Distribuito il quinto volantino, gli studenti
avevano deciso di alzare il tiro, non perché cercassero il martirio, ma perché ritenevano che il
momento fosse favorevole a una rivolta studentesca.
Era tempo di tradurre il pensiero in azione, di trasformare le parole in opere. Decidono dunque di
diffondere proprio all’interno dell’Università e in pieno giorno, durante l’ora di lezione, quello che
sarebbe stato il loro ultimo volantino su cui era scritto senza mezzi termini o giri di parole: «Ogni
parola che esce dalla bocca di Hitler è una menzogna…». Ma la fortuna non doveva essere dalla
loro quel giorno. Traditi dal suono di una campanella e da un bidello troppo attento e curioso, Hans
e Sophie che si erano incaricati dell’impresa vengono scoperti e condotti presso la sede della polizia
politica per l’interrogatorio.
Dal film, ma anche dai documenti storici rimasti (verbali della polizia e testimonianze) appare
chiaro il coraggio di Sophie durante l’interrogatorio, nel rivendicare i motivi della propria scelta.
Nel colloquio di fronte all’ufficiale della Gestapo appare straordinariamente più forte di lui pur
essendo in una condizione di difficoltà e pericolosità estrema. La sua è la forza dell’anima che sfida
e supera quella della violenza. Sophie di fronte al poliziotto Mohr come Antigone di fronte a
Creonte.
L’ufficiale, che alterna intransigenza ad atti di umanità, è colpito dal suo straordinario coraggio e le
offre anche una via d’uscita. Ma ad un prezzo per lei altissimo: tradire i suoi ideali, tradire i suoi
amici. Sophie rifiuta l’offerta: «Non rinnego nulla. Sono convinta di aver agito nell’interesse del
mio popolo. Non mi pento e ne accetterò tutte le conseguenze», risponde senza tentennamenti
rivelando tutta la forza morale e d’animo che l’hanno sostenuta in questa battaglia contro il male.
Nemmeno per un attimo pensa di usufruire della scappatoia che le viene offerta per alleggerire la
sua posizione: bastava che dicesse che non si rendeva conto di ciò che faceva e che era plagiata da
suo fratello. Ma lei non accetta. Ammette completamente tutte le sue responsabilità.
Dichiara all’ufficiale, orgogliosa e fiera: «Ripeterei quello che ho fatto, perché non io, ma lei ha una
falsa visione del mondo».
La sua fede profonda e incrollabile le dà la forza per sacrificarsi per gli altri. Così aveva scritto nel
suo diario: «Meglio un dolore insopportabile che un apatico vegetare. Meglio una sete bruciante,
preferisco chiedere dolore, dolore, che sentire un vuoto. Non è forse anche il dolore un dono di
Dio».
Il coraggio è raro. Deve poter essere più forte della morte. Di coraggio Sophie ne ha da vendere
quando con estrema fermezza, di fronte alle accuse dell’ufficiale di aver disobbedito alle leggi
naziste, dichiara: «Le leggi cambiano, la coscienza resta».
Per questo la giovanissima Scholl è stata più volte accostata ad Antigone, a Socrate, e agli altri eroi
della coscienza, donna del secolo per le lettrici di una rivista tedesca. La notte prima della sua
esecuzione Sophie fa un sogno: sta portando un bambino a battesimo, si sente sprofondare, ma lo
mette in salvo, mentre lei cade nel baratro. Essa stessa ne dà un’interpretazione: « Il bambino
simboleggia le nostre idee… trionferanno dopo la nostra morte».
Non si sbagliava Sophie, una ragazza di 21 anni, che sapeva disegnare e suonare il pianoforte, che
studiava scienze e filosofia, che amava la libertà e ascoltava la propria coscienza più di qualsiasi
altra cosa.
Sophie Scholl
Forchtenberg 1921 - Monaco di Baviera 1943
«Strappate il mantello dell’indifferenza che avvolge il vostro cuore! Decidetevi prima che sia troppo
tardi»
(da uno dei volantini della Rosa Bianca)
Sophie Scholl aveva meno di 12 anni quando i nazisti presero il potere; seguendo il fratello Hans,
ed insieme alle sorelle Inge ed Elisabeth, entrò a far parte, contro la volontà paterna, della
Hitlerjugend (Gioventù Hitleriana). Nel 1933 l’iscrizione era ancora volontaria.
Come tutti i giovani, anche i fratelli Scholl furono contagiati dall’entusiasmo e aderirono al
nazionalismo; tuttavia, 4 anni dopo, già disillusi, erano uniti contro il regime nazista, trovando, ora
sì, l’approvazione paterna.
Gli ultimi anni di scuola, prima dell’università, erano diventati duri per Sophie; ogni lezione era
intrisa di ideologia nazionalsocialista e lei assumeva un atteggiamento “privo di partecipazione ”.
Fu avvertita dal direttore della scuola: se non avesse cambiato atteggiamento non avrebbe ottenuto
il diploma.
Sophie, però, non cambiò atteggiamento e nel marzo del 1940 prese l’Abitur, a dispetto di tutto.
Dopo il diploma, lo Stato chiedeva a tutte le diplomate di lavorare per il RAD per almeno 6 mesi.
Da Monaco, il fratello Hans cercò di ottenere un’esenzione per Sophie e un posto all’università,
senza successo.
Sophie entrò nell’istituto per l’infanzia Fröbel di Ulm, sperando di evitare l’impegno per il RAD,
ma nel marzo del 1941 fu assegnata a un castello fatiscente trasformato in un campo di lavoro per
giovani donne. Erano 2000 i campi come quello in Germania, vi alloggiavano donne tra i 18 e i 25
anni. Le ragazze indossavano le uniformi e avevano sessioni di addestramento ideologico condotte
da insegnanti fanatiche. I pasti consistevano per lo più in patate bollite con tanto di buccia
«..viviamo come prigioniere, non solo il lavoro ma anche le pause di piacere sono doveri. Qualche
volta vorrei urlare: il mio nome è Sophie Scholl. Non dimenticatelo!». Successivamente venne
inviata per altri 6 mesi nei pressi di Blumberg - costretta dal Programma di Assistenza in Guerra - in
un asilo a ridosso di una fabbrica di munizioni. Nel Maggio 1942 Sophie si recò a Monaco, dal
fratello, per studiare all’università.
Il fratello Hans, nel frattempo, insieme all’amico Alex Schmorell, aveva deciso di impegnarsi in
un’aperta opposizione al regime nazista, senza coinvolgere, però, la sorella in cospirazioni o
pericoli.
Lui e i suoi amici progettavano di scrivere, stampare e distribuire volantini a Monaco per informare
un pubblico selezionato di studenti, professionisti e intellettuali del male che li circondava,
profetizzando che Hitler avrebbe perso la guerra. La sera in cui Sophie arrivò a Monaco, Hans e i
suoi amici festeggiarono il suo compleanno senza raccontarle niente.
«..Ogni singolo deve coscientemente difendersi con ogni sua forza, opporsi in quest’ultima ora al
flagello dell’umanità, al fascismo e a ogni simile sistema di stato assoluto. Fare resistenza passiva,
resistenza; ovunque vi troviate; non dimenticate che ogni popolo merita il governo che tollera!...»
(dal primo volantino della Rosa Bianca).
I volantini della Rosa Bianca iniziarono ad apparire a Monaco verso la metà di giugno del 1942.
Ne uscirono 4, uno dopo l’altro; vennero spediti come stampe a tutta la cittadinanza.
Alcune centinaia arrivarono anche alla Gestapo. Dopo alcune settimane di indagini, gli autori
dell’iniziativa restavano ignoti.
Nel 1942 l’università appariva perfettamente integrata nel sistema nazista. Le classi erano infestate
da spie dell’Associazione degli studenti nazionalsocialisti che prendevano nota di quel che si
diceva, in cerca di battute inopportune durante le lezioni che i professori tenevano con non poco
disagio.
Con quei 4 volantini, all’università cominciavano a circolare voci sulla comparsa di materiale
antinazista. Leggere tali volantini senza avere l’autorizzazione della Gestapo era un reato.
Un giorno, durante la lezione, Sophie notò un foglietto sotto il banco, lo raccolse, lo lesse «Per un
popolo civile non vi è nulla di più vergognoso che lasciarsi governare senza opporre resistenza, da
una cricca di capi privi di scrupoli e dominati da torbidi istinti….»
Sophie comprese che altri, dentro l’università, la pensavano come lei. Si facevano chiamare “la
Rosa Bianca” e agivano. Piegò il volantino e andò nella stanza del fratello per mostrarglielo. Hans
non c’era. Cominciò a rovistare sulla scrivania e girando le pagine di un libro trovò i passaggi citati
nel volantino, parola dopo parola, sottolineati. Quando Hans entrò nella stanza fu il momento della
verità per Sophie.
Alla fine del semestre estivo, mentre il fratello e gli altri della Rosa Bianca erano stati chiamati in
Russia, Sophie tornò a casa, a Ulm, dove la attendevano due mesi di lavoro in una fabbrica di
armamenti. Non molto tempo dopo il suo arrivo, suo padre fu processato e condannato a quattro
mesi di reclusione perché, in un momento d’ira, aveva urlato che Hitler era un flagello dell’umanità.
Sophie allora si affrettò a tornare a Monaco, nella stanza sua e del fratello per mettere ordine ed
essere certa che la Gestapo non trovasse alcuna prova contro di loro, ora che tutta la famiglia era a
rischio di arresto.
Nel mese di agosto, Sophie cominciò ad andare in fabbrica. Talvolta la sera si recava alla prigione,
il più possibile vicino alle finestre sbarrate dove sperava di vedere il padre. Si portava dietro il
flauto e intonava Die Gedanken sind frei (I tuoi pensieri sono liberi), una canzone rivoluzionaria del
1848, simbolo della Germania liberale e contraria al dispotismo.
In fabbrica Sophie diede inizio a una sorta di sabotaggio improvvisato: svolgeva lentamente le sue
attività. Questo le attirava i rimproveri del caporeparto, ma lei rispondeva che non poteva fare
diversamente, che era maldestra.
Tornati dalla Russia e reincontratisi a Monaco, i membri della Rosa Bianca sentivano che dovevano
unirsi al movimento di resistenza nazionale. A Sophie fu assegnata la responsabilità della cassa:
distribuiva il denaro e cercava di tenere una sorta di contabilità.
Nel giro di due mesi, dal novembre del 1942 agli inizi di gennaio del 1943, l’operazione della Rosa
Bianca si era trasformata da azione isolata di alcuni studenti idealisti, in una rete in espansione che
andava diffondendosi nella Germania sud-occidentale, fino alla Saarland, e fino ad arrivare al nord,
verso Amburgo e, soprattutto, verso Berlino.
Le copie dei volantini venivano stampate una alla volta, notte dopo notte, con una macchina che
doveva essere azionata a mano con una manovella. Per restare svegli, e lavorare durante il giorno,
prendevano degli eccitanti dalle cliniche militari dove lavoravano come medici.
Sophie fece i suoi viaggi nell’area di Augusta, Ulm e Stoccarda, da dove spedì circa 800 volantini.
Il 18 febbraio, a Monaco, poco dopo le 10 del mattino, Hans e Sophie lasciano il loro appartamento
a Schwabing e si incamminarono verso l’università portando con sé una grossa valigia. Arrivati
all’università, mentre le lezioni erano ancora in corso, cominciarono a mettere una grande quantità
di volantini davanti alle porte delle aule, sui davanzali e sulle grandi scale che conducevano
all’entrata principale. Distribuirono dai 700 ai 1800 volantini. Finito tutto, stavano per lasciare
l’edificio quando si accorsero che erano rimasti dei volantini; risalirono le scale fino all’ultimo
piano, e dalla balaustra gettarono gli ultimi fogli. Nello stesso istante le porte delle aule si
spalancarono e gli studenti cominciarono a uscire. Scoperti, Hans e Sophie furono condotti
nell’ufficio del rettore Wüst. Non opposero resistenza.
Arrivò Robert Mohr che comandava la squadra della Gestapo, ordinò agli agenti di raccogliere tutti
i volantini; stavano perfettamente nella valigia vuota! Mohr diede ordine di portare i due al quartier
generale della Gestapo.
Hans e Sophie ammanettati e condotti al quartier generale, furono interrogati per 17 ore in stanze
separate. Così come prevedeva il piano del gruppo in caso di cattura, entrambi sostennero di essere
loro, e soltanto loro, i responsabili delle azioni della Rosa Bianca.
I fratelli Scholl erano accusati di alto tradimento e il processo venne fissato per il giorno seguente,
lunedi 22 febbraio, al Palazzo di Giustizia di Monaco. Il giudice che presiedeva il processo sarebbe
stato Roland Freisler. Lunedi 22, alle 7 del mattino i detenuti furono prelevati nelle celle. Quando
Else, la compagna di cella di Sophie, tornò nella cella vuota, trovò sul letto ben rifatto di Sophie un
foglio di carta; era l’atto di incriminazione e sul retro Sophie aveva scritto la parola “libertà”.
L’aula del Palazzo di Giustizia era gremita di persone, tutti “invitati”, quasi tutti in uniforme. Non
c’era nessun membro della famiglia; non erano stati informati ufficialmente né degli arresti né del
processo.
Il giudice, Freisler, apparve con una toga scarlatta, luccicante.
Il processo iniziò alle 10: Freisler cominciò con la sua invettiva, Sophie cercò di contestarlo
«qualcuno doveva farlo. Ciò che abbiamo detto e scritto è quello che pensano molte persone; solo
non osano dirlo a volte alta!».
Furono condannati a morte e portati alla prigione di Stadelheim.
In prigione si era sparsa la voce su come si erano comportati i giovani studenti nella mani della
Gestapo e durante quel processo infame. Il personale del carcere li ammirava, gli impiegati non
erano membri delle SS o della Gestapo; si consideravano normali funzionari statali che eseguivano
compiti sgradevoli. Le guardie infransero le regole; fecero uscire i fratelli Scholl dalle loro celle e li
portarono nella sala visite per incontrare i genitori. Sophie accettò i dolci che la madre aveva
portato, dicendo che aveva fame.
E poi la ghigliottina.
Sophie fu la prima. Camminò eretta attraverso il cortile, scortata dalle guardie. Erano le 5 del
pomeriggio. Erano trascorse 3 ore dalla conclusione del processo.
Notizie sulla Rosa Bianca raggiunsero anche il pubblico americano e i loro volantini furono
ristampati, a migliaia di copie, e lanciati dagli aerei alleati sulle città tedesche.
La piazza di fronte all’edificio principale dell’ateneo ora è intitolata a Hans e Sophie Scholl; nel
cortile dell’università c’è una rosa bianca intagliata nel marmo.
Il busto di Sophie è entrato nel Walhalla, il tempio degli eroi tedeschi.
È stato bandito un premio letterario annuale, il Geschwister-Scholl, da assegnare a un libro che
riveli un pensiero originale e indipendente, promuova il coraggio morale e intellettuale e stimoli la
coscienza pubblica su temi attuali di grande interesse.
L'IMPORTANZA DELLA "ROSA BIANCA" PER IL FUTURO DELL'EUROPA
Conversazione tenuta a Belluno il 5.2.1996
di Franz Josef Mueller [1]
Con l'inserimento di questa testimonianza desideriamo focalizzare uno dei "punti luce" presenti
nella storia del nostro tempo, perché riteniamo sia importante che, insieme al non abbassare la
guardia di fronte al pericolo e all'orrore della crudeltà - pensiamo con profonda condivisione e
rispetto al "Giorno della Memoria" - venga alimentata anche la speranza sulla capacità dell'uomo di
scegliere per la Vita e non per la morte e il ricordo incida veramente nelle coscienze e non rimanga
confinato negli angusti confini della giornata di commemorazione o in momenti staccati dalla vita e
dalla storia di ogni giorno sulla quale si intesse la storia dei popoli. È importante, soprattutto per le
nuove generazioni, la conoscenza e la denuncia del male, ma occorrono anche modelli positivi.
Quindi, oltre alla memoria del male, è bene venga tenuta desta anche quella di chi non si è allineato
con i carnefici; molte persone e vicende in questo senso sono conosciute collettivamente: è per
questo che Israele riconosce e fa memoria de "I Giusti tra le Nazioni".
Discorso tenuto da Romano Guardini
Università di Monaco il 12 luglio 1958
Commemorazione dei giovani antinazisti
Tubinga, 4 novembre 1945
È una lettura del passato che contiene profonde riflessioni emblematiche e significative anche per il
nostro tempo. Può essere interessante scoprire che nell’opposizione al Terzo Reich confluirono i
principali filoni del cattolicesimo tedesco di inizio ’900: l’associazionismo caritativo, la teologia
'sociale' di Guardini e i difensori dello Stato di diritto come Von Galen
[2]
Sono un sopravvissuto del gruppo della "Weisse Rose", un condannato dal "Volksgerichtshof"
(Tribunale della rivoluzione di Berlino), che da solo ha condannato a morte cinquemilatrecento
persone. I membri della Rosa Bianca sono stati processati a Monaco e Amburgo. Quindici
appartenenti al gruppo sono stati condannati a morte e trentotto incarcerati. Alla fine della guerra
siamo stati liberati dagli americani.
Sono della città di Ulm, la città della famosa cattedrale gotica. Ulm è anche la città di Hans e
Sophie Scholl e di sei altri giovani che con noi frequentavano il ginnasio classico, con lo studio del
latino e del greco. Era un ginnasio che non aderiva allo spirito nazional-socialista e questo era molto
importante per noi allievi. Voglio introdurvi subito nell'argomento della mia relazione e citare un
passo sorprendente del nostro volantino n° 5 che tratta dell'Europa - questo volantino è stato scritto
nel gennaio del 1943 - è un passo straordinario perché in esso i miei amici svilupparono il senso del
futuro dell'Europa:
"Che cosa ci insegna la fine di questa guerra che non è mai stata nazionale? L'idea imperialista del
potere, da qualunque parte essa provenga, deve essere resa innocua per sempre. Un militarismo
prussiano non deve più giungere al potere. Solo attraverso un'ampia collaborazione dei popoli
europei si può creare la base su cui sarà possibile una costruzione nuova. Ogni potere centralizzato,
come quello che lo stato prussiano ha cercato di instaurare in Germania e in Europa deve essere
soffocato sul nascere. La Germania futura potrà unicamente essere una federazione. Solo un sano
ordinamento federalista può oggi ancora riempire di nuova vita l'Europa indebolita. La classe
lavoratrice deve essere liberata mediante un socialismo ragionevole dalla sua miserabile condizione
di schiavitù. Il fantasma di un'economia autarchica deve scomparire dall'Europa. Ogni popolo, ogni
individuo hanno diritto ai beni della terra! Libertà di parola, libertà di fede, difesa dei singoli
cittadini dall'arbitrio dei criminali stati fondati sulla violenza: queste sono le basi della nuova
Europa"[3].
Sorprende trovare un'affermazione di questa natura in una Germania che ha portato violentemente
la guerra nel centro dell'Europa. In questo volantino viene espresso un chiaro rifiuto ad ogni sorta di
centralismo, a Berlino, un rifiuto anche all'atteggiamento morale dei tedeschi, che ci provocò grandi
disgrazie e che si esprimeva nell'espressione diffusa: "Il comando è comando: gli ordini provengono
da Berlino e vanno eseguiti." Noi diciottenni del ginnasio e i due Sophie e Hans Scholl,
rispettivamente più anziani di noi di tre e cinque anni, provenivamo da una libera città del Reich.
Fino al 1806 Ulm era stata infatti amministrata autonomamente, e un po' di quello spirito
indipendente era ancora presente. La Rosa Bianca era molto conosciuta nella città, ma a Ulm
c'erano altri tre gruppi di giovani oppositori che tentarono persino una forma di resistenza ancor
nell'anno 1944. Ulm era dunque ancora un centro di spiritualità libera e liberale e in opposizione a
Berlino e alla Prussia.
Questa riflessione è un presupposto per comprendere il contesto ambientale nel quale è sorto il
nostro gruppo. Ulm era una città riformata, vale a dire che la maggioranza degli abitanti era
protestante. Anche la minoranza cattolica a Ulm operava molto intensamente. Il nostro gruppo di
giovani ricevette impulsi determinanti per opera di tre giovani sacerdoti cattolici. Nella scuola non
c'era la lezione di religione, ma noi ci incontravamo in privato, si può dire in gran segretezza, di
notte, utilizzando gli ingressi posteriori. Il gruppo era costituito da quasi 20 giovani che non si
esercitavano contro il nazionalsocialismo bensì nella lettura dei documenti della grande spiritualità
tedesca: Goethe, Schiller, Hoelderling, Thomas Mann, Lessing e in particolare un dramma che in
Germania era severamente vietato, "Nathan der Weise", il grande dramma di Lessing. Dunque
leggevamo il dramma di un ebreo che si rivela come il fratello, il prossimo e che noi leggevamo
interpretando i diversi ruoli. Quelli furono i primi passi verso la resistenza che inizialmente era solo
opposizione; più tardi si arrivò alla vera e propria resistenza.
Un'altra fonte che ci rese immuni al nazionalsocialismo fu il nostro antico ginnasio. Esso era stato
fondato nell'anno 1293 - oggi sono oltre 700 anni e noi ne siamo orgogliosi -. Studiavamo greco e
al secondo anno traducevamo i dialoghi giovanili di Platone. In questi dialoghi viene trattato
frequentemente il problema della giustizia nella polis, nella città, e Socrate che conduce il dialogo
confuta ai suoi discepoli l'affermazione che ciò che è di vantaggio alla città sia allo stesso tempo
buono. Socrate afferma invece che bisogna porsi l'interrogativo se ciò che è di vantaggio sia anche
giusto, se a lungo termine possa essere di utilità alla polis. Un giorno - avevamo letto in classe
questa traduzione - usciti dalla scuola vedemmo affisso un manifesto di Josef Goebbels, il ministro
della propaganda uomo molto capace dei nazisti: nel manifesto, diffuso in tutta la Germania, c'era
scritto: "Bene è ciò che ci aiuta a vincere".
Dunque l'obbiettivo immediato era quello della vittoria. Attraverso i dialoghi che ci aveva
tramandato Platone noi potevamo capire che in quel momento si stava producendo un pericoloso
corto circuito che incitava e giustificava i cittadini a compiere qualsiasi tipo di misfatto se essi
credevano che potesse tornare di utilità alla vittoria. Tutto questo generò conflitti fra di noi studenti
e ciò si fa spiegare dal fatto che noi avevamo allora anche una istituzione educativa d'influenza
negativa, risoltasi tuttavia positivamente per alcuni di noi, vale a dire la "Hitlerjugend".
L'adesione alla "Hitlerjugend" non era volontaria, dal '38 noi dovevamo per legge e senza eccezioni
entrarvi a far parte, esclusi erano naturalmente i paesi decentrati , non raggiunti dai nazisti. Molto
presto cademmo in situazioni conflittuali con noi stessi e con altri perché non condividevamo le
punizioni inflitte e di cui si sentiva parlare. Il comportamento dei nazisti e dei Führer della
Hitlerjugend fu quello di picchiarci ed io, in uno di questi episodi, ne sono uscito con la clavicola
rotta.
Tutto questo non alimentava certo la nostra amicizia per i nazisti e fu un ulteriore fattore che ci
spinse lentamente all'ostilità verso di loro.
La nostra esperienza della Hitlerjugend fu solo negativa, perché vissuta come imposizione.
Organizzammo un furto presso la centrale della Hitlerjugend di Ulm, sottraendo la nostra
documentazione cosicché il nostro gruppo divenne per loro inesistente.
Negli ultimi tre anni la Hitlerjugend non fu più attiva e da quel momento iniziò la nostra azione di
opposizione e di resistenza. Dopo aver tracciato per voi questo retroscena, vorrei arrivare al tema
dell'Europa così come noi la concepivamo, nella nostra esperienza di guerra.
Dapprima la Germania venne invasa da milioni di prigionieri che provenivano da vari paesi:
inizialmente dalla Russia, dalla Francia, poi dalla Jugoslavia, dalla Polonia e a partire dall'agosto '43
anche dalla Italia. Erano in parte prigionieri condannati a lavori forzati. Con questi uomini, che
secondo l'ideologia nazista provenivano da razze inferiori, cercavamo contatti: per primi con i
polacchi, che erano persone molto gentili. Discutevano con noi, erano cattolici come noi, venivano
con noi in chiesa alla domenica. Nella fattoria di mio zio c'era poi una famiglia russa, di
Leningrado. Erano persone straordinariamente cortesi, sedevano a tavola con noi, e a Natale
ricevevano regali; li trattavamo da persone. Non erano né più saggi, né più stupidi di noi. Il figlio
unico di questi russi frequentava la scuola tedesca del paese ed era il migliore nella sua classe. Voi
potete capire cosa tutto questo potesse significare se ci confrontavamo con la teoria razzista,
secondo la quale la razza germanica era superiore e generatrice di cultura.
Per quanto mi riguarda, nell'anno 1942 raccoglievo spesso la frutta nella nostra fattoria e un giorno,
cadendo da un albero, mi fratturai un piede. Nelle sei settimane di convalescenza lessi undici opere
di Dostojeski, la più amata fra le quali era il racconto dei fratelli Karamazof . Da allora in poi per
noi divenne assurda ogni affermazione nazista che voleva i russi come razza culturalmente
inferiore.
Nel frattempo venimmo a trovarci in una situazione assai difficile. In Germania il nazionalismo
assunse i connotati assolutistici anche del militarismo. Questi nazionalismo e militarismo
dirompenti diedero poi, per nostra disgrazia, via libera al nazionalsocialismo. Molti tedeschi, con
cui parlavamo, dicevano di sostenere non i nazisti, ma la Germania, perché bisognava essere dei
"buoni tedeschi". Essi non riuscivano a comprendere che gli obiettivi del nazismo e dei "buoni
tedeschi" erano i medesimi e conducevano alla guerra. Chi andava in guerra e combatteva per Hitler
però, non combatteva per la Germania, bensì per il nazionalsocialismo.
Dopo il 1943, era per tutti ormai evidente che la guerra era perduta ed era solo una questione di
tempo: essa sarebbe durata fintanto che sopravvivevano i nazisti. Sophie Scholl afferma, come
risulta nella nostra documentazione: "... Noi dobbiamo perdere la guerra, altrimenti non torneremo
mai più liberi..." . Ed è molto difficile dire a un popolo "dobbiamo perdere la guerra" perché
altrimenti non ci sarà più la libertà. Noi diciottenni dovevamo porci di fronte a questa spaventosa
alternativa.
Noi tutti dovemmo andare soldati. Io arrivai a Epinal, in Francia, per i primi tre mesi di servizio. Là
seppi dell' imprigionamento e della condanna a morte di Sophie e Hans Scholl. Tentai di entrare, pur
soldato tedesco, in contatto con la Resistenza francese. In quelle circostanze mi resi conto di come
eravamo considerati noi tedeschi nel resto dell'Europa. La Resistenza francese mi respinse, benché
io avessi detto che mi sarei consegnato, portando con me un'arma. Io per loro potevo essere un
agente provocatore e comunque con i tedeschi non si voleva aver nulla a che fare.
A Epinal venni poco dopo arrestato, tradotto a Monaco e sottoposto a processo[4]. Questa era la
situazione di un diciottenne tedesco, antinazista attivo per formazione cristiana e per convincimento
filosofico e politico, convinto che Hitler avrebbe portato tutti alla rovina, e che in nessun posto in
Europa avrebbe potuto trovare aiuto: non in Francia, non da parte dei prigionieri russi di religione
cristiana. La realtà di un individuo nella Resistenza tedesca era di abbandono, solitudine e soltanto
all'interno di un gruppo di amici - e la Rosa Bianca era costituita solo da amici - si poteva parlare e
sentire come esseri umani. Noi affermavamo che il nazionalismo e il centralismo tedeschi erano
stati il presupposto per il nazionalsocialismo e la sua guerra.
Noi riflettevamo sul come tutto ciò si fosse potuto evitare e qui torno a fare riferimento alla lettura
introduttiva sul federalismo europeo, sulla Germania federalista: uno fra i nostri convincimenti più
importanti era infatti quello che gli stati nazionali mettessero a rischio il futuro dell'Europa se
nazionalisti e militaristi. Bisognava trovare altre soluzioni. Noi tedeschi e, forse, anche voi italiani,
non abbiamo molte difficoltà in questo senso, perché siamo diventati stati nazionali molto tardi. La
Germania ha molte regioni, oggi la Germania ha quindici Laender, in parte autonomi: la Baviera, ad
esempio, è autonoma a tal punto da poter essere costituzionalmente autorizzata, ad uscire dalla
federazione germanica.
Questo federalismo è per noi tedeschi, ma io credo per tutta l'Europa, la più importante garanzia che
queste spaventose guerre e conflitti nazionalisti che ha avuto il passato non si ripetano. Non serve
che io parli del nazionalismo: noi tutti abbiamo sotto gli occhi qui vicino, nella Jugoslavia, che cosa
esso significhi ... Vorrei dire, rapportandomi alla realtà attuale, che se si persegue soltanto
un'Europa dell'economia, dell'efficienza economica, questa non è l'Europa che noi della resistenza, e
altri ancora, volevamo.
Se l'Europa non farà riferimento alla sua cultura, alla sua storia spirituale non sarà un'Europa in
grado di lasciare una eredità buona e utile per gli uomini. Jean Monnet, che assieme ad Adenauer e
De Gasperi fu uno dei padri della prima comunità europea, quella del carbone e dell'acciaio,
affermò, poco prima di morire: "Se io dovessi rifondare l'Europa, proverei ad iniziare dalla cultura
europea".
L'anno scorso, ho visto una trasmissione da Bruxelles su un tribunale dell'eurocrazia, un tribunale
amministrativo. Vi sono impiegate complessivamente trentunomila persone, dislocate a Bruxelles,
in Lussemburgo e a Strasburgo. Sapete invece quanto grande è il dipartimento cultura presso la
Commissione Europea a Bruxelles? Quanti uomini ci lavorano? Ventisette in tutto! Questa non è
soltanto una cifra insignificante, questo è un segnale che questa Europa che sta sorgendo non è sulla
buona strada.
Non intendo richiamare genericamente il concetto di cultura europea senza tracciarne il contenuto;
voglio enunciarvi un punto determinante, senza il quale l'Europa non sarà quella che noi vorremmo:
si tratta dei Diritti dell'uomo, formulati per la prima volta in Europa, da parte di popoli diversi,
scritti, proclamati, diffusi attraverso la Rivoluzione francese. Noi li abbiamo denominati "Diritti
fondamentali" e nella nostra Costituzione tedesca troviamo scritti al primo posto i "Diritti personali
del cittadino". Questi diritti non sono solo proclamati bensì essi sono appellabili direttamente
davanti al giudice: si può, ad esempio, ricorrere al giudice affermando di essere stati lesi nel diritto
fondamentale alla salute e denunciare lo stato, il Land ecc. È importantissimo che questi siano diritti
positivi e che il diritto di un popolo li garantisca.
Di recente ero in Olanda a parlare con Hugo Degrot il quale affermava che a fondamento della
Europa ci sono gli umanisti europei, come ad esempio l'italiano Benedetto Croce e altri, e che non
possiamo permettere venga cancellato dalle discussioni su nazionalismo, economismo, euro e
marco, ecc. Dobbiamo chiederci come sia allo stato attuale praticata l'osservanza dei diritti
dell'uomo in questo continente perché solo attraverso il rispetto di essi questo continente diverrà in
futuro più umano e vivibile.
Voglio concludere questi miei pensieri e riflessioni con un'ulteriore espressione di speranza per
l'Europa richiamando ancora la Resistenza europea: per i diritti fondamentali dell'uomo la
Resistenza europea ha combattuto nei vari paesi. Voi avete ascoltato le nostre rivendicazioni
contenute nel volantino n°5: libertà di pensiero, libertà di fede religiosa. Per questi diritti sono
morte migliaia di persone in tutta l'Europa, in Italia come anche in Germania.
In questo secolo abbiamo posto le basi per una Europa migliore attraverso il processo difficile e
drammatico della Resistenza europea. Oggi non dobbiamo comportarci come se questo passato
fosse superato: in Germania oggi questo certamente non accade. Il 27 gennaio, due settimane fa, è
stata istituita per la prima volta in Germania, una giornata nazionale di commemorazione di tutte le
vittime del nazionalsocialismo. Non dobbiamo dimenticare!
Vorrei ancora aggiungere due considerazioni: non si sa molto della Resistenza tedesca, gli stessi
tedeschi per venti, trent'anni non ne hanno quasi parlato a causa della cattiva coscienza per aver
voluto seguire Hitler. Oggi le cose sono cambiate ed io posso fornire a voi dati storici raccolti da
qualche anno a questa parte. La Resistenza tedesca non è stata così piccola come si potrebbe
supporre e ci risulta il contrario dalle dalle cifre che ci provengono dall'Istituto di Storia
contemporanea di Monaco. I nazionalsocialisti ed i loro alleati uccisero più di 130.000 tedeschi,
rinchiusero alcune centinaia di migliaia di persone in campi di concentramento, penitenziari, carceri
sottoposero ad interrogatori della Gestapo più di un milione di persone.
Nel 1933 si contavano in Germania 66 milioni di abitanti .
La Gestapo torturò Sophie Scholl per quattro giorni, dal 18 al 21 febbraio 1943. Sophie Scholl era
la persona più forte all'interno del gruppo della Weisse Rose, la più determinata, la più sincera e la
più attiva. Era una giovane donna e fu ghigliottinata a ventun anni. Il cappellano del carcere che la
vide poco prima dell'esecuzione testimonia che era senza paura, calma. L'uomo della Gestapo che
conduceva l'interrogatorio le chiese alla fine: "Signorina Scholl, non si rammarica, non trova
spaventoso e non si sente colpevole di aver diffuso questi scritti e aiutato la Resistenza, mentre i
nostri soldati combattevano a Stalingrado? Non prova dispiacere per questo?", e lei rispose: "No,
al contrario! Credo di aver fatto la miglior cosa per il mio popolo e per tutti gli uomini. Non mi
pento di nulla e mi assumo la pena!"
Note
[1]
Franz Josef Mueller è l'attuale presidente della fondazione "Weisse Rose", fondata nel 1986 a
Monaco di Baviera da componenti e superstiti del gruppo e da parenti e amici dei membri
giustiziati. Vicepresidenti sono: Anneliese Knoop-Graf e Marie Luise Schultze -Jahn. Obiettivi della
Fondazione, alla quale tutti possono aderire, sono:
1) Diffondere la conoscenza della Rosa Bianca attraverso mostre e pubblicazioni,
2) promuovere la ricerca di fonti e notizie in archivi,
3) creare un luogo di informazione e documentazione nonché un archivio della Rosa Bianca,
4) Curare i contatti con insegnanti e alunni delle scuole attraverso relazioni e discussioni presso
tutte le istituzioni culturali,
5) Cooperare - soprattutto con il Goethe Institut - per diffondere all'estero la conoscenza della Rosa
Bianca e promuovere uno studio differenziato della storia tedesca,
6) Collaborare con gruppi e istituzioni - soprattutto ebraiche - che operano contro il razzismo e ogni
forma di intolleranza.
[2]
La registrazione della conferenza è avvenuta in data 5 febbraio 1996 all'Auditorium di Belluno.
La presenza di Franz Josef Mueller a Belluno è avvenuta in concomitanza con la Mostra sulla "Rosa
Bianca" - "Die Neinsager" Tedeschi contro Hitler, ospitata presso il Liceo Classico "Tiziano" di
Belluno, dall' 1.2 al 18.2. 1996. (Deregistrazione, traduzione e adattamento di Giovanna Padovani)
[3]
I testi dei volantini della Rosa Bianca sono contenuti nell'opuscolo della Mostra: La rosa Bianca:
La resistenza degli studenti contro Hitler, Monaco 1942/43. L'opuscolo può essere richiesto presso
la Biblioteca civica di Belluno
[4]
Franz J. Mueller fu processato nel secondo processo ai membri della Rosa Bianca, tenutosi il 19
aprile 1943 a Monaco. I tre principali accusati di alto tradimento, poi condannati a morte, erano
Alexander Schmorell, Willi Graf e il prof. Kurt Huber, F.J. Mueller venne condannato a pena
detentiva, assieme ad altri 11 amici "per aver diffuso volantini e non aver denunciato, per quanto a
conoscenza, l'impresa di alto tradimento".
I volantini della "Rosa Bianca"
Il primo volantino
Non c’è nulla di più indegno per una nazione civilizzata che lasciarsi “governare” senza alcuna
opposizione da una cricca di irresponsabili dominati dai propri istinti. Certamente ogni onesto
tedesco oggi si vergogna del suo governo.
Chi tra di noi riesce a concepire le dimensioni dell’infamia che un giorno cadrà su di noi e sui
nostri figli quando dai nostri occhi cadrà il velo e il più orribile dei crimini - crimini che
infinitamente hanno superato ogni umana misura - sarà dinanzi a tutti alla luce del sole?
Se il popolo tedesco è già così corrotto e così spiritualmente distrutto da non saper alzare una
mano, se avventatamente si trova immerso nella fede sconsiderata che nutre verso la storia
come ordine legittimante, se ha rinunciato alla propria libera volontà che è principio supremo
dell’uomo e che lo eleva al disopra delle altre creature di Dio, se ha abbandonato la volontà di
compiere l’azione decisiva e di girare la ruota della storia assoggettandola alla propria razionale
volontà, se ha rinunciato alla propria individualità e ha percorso la strada che lo conduce ad
essere ormai una massa vile e priva di spirito, allora sì il popolo tedesco merita la propria
rovina.
Goethe parla dei tedeschi come di un popolo tragico, come gli ebrei ed i greci, ma oggi questo
sembra piuttosto un popolo privo di spina dorsale, gregge ubbidiente di parassiti, che ora
succhiato sino al midollo, privato del suo centro di stabilità sta attendendo di essere condotto
alla sua distruzione. Così sembra ma così non è.
Attraverso un graduale, ingannatore e sistematico abuso il sistema ha rinchiuso ogni uomo in
una prigione spirituale. Soltanto ora ha scoperto di essere stato ridotto in catene ed è
diventato cosciente del suo destino. Soltanto pochi hanno riconoscito l’incombente minaccia
della rovina ed il premio per il loro eroico allarme è stata la morte. Avremmo molto da dire sul
destino di queste persone.
Se ognuno aspetterà che sia l’altro uomo ad iniziare la lotta i messaggeri della Nemesi
vendicatrice si avvicineranno e allora l’ultima vittima sarà stata gettata inutilmente nelle fauci
del demone insaziabile. Per questo ogni singolo individuo cosciente della propria responsabilità
come membro della civiltà cristiana e occidentale, deve difendersi con tutte le sue forze sino
all’ultimo, deve lottare contro il flagello dell’umanità, contro il fascismo e contro ogni simile
sistema totalitario.
Resistete, opponete la resistenza passiva ovunque voi siate, impedite il funzionamento di
questa ateistica macchina da guerra prima che sia troppo tardi, prima che le altre città come
Colonia siano ridotte ad un cumulo di macerie, prima l’ultimo giovane della nazione versi il
proprio sangue su qualche campo di battaglia per l’orgoglio folle di un subumano (1).
Non dimenticate che ciascun popolo merita il regime che accetta di sopportare.
Da La legislazione di Licurgo e Solone di Friedrich Schiller
«La legislazione di Licurgo è un modello di politica e psicologia in relazione al fine che si
propone. Egli voleva uno stato potente, fondato su se stesso ed indistruttibile; forza politica e
durata erano gli obiettivi a cui egli mirava, e questo fine lo ha raggiunto nel grado che era
possibile nelle sue condizioni.
Ma quando si raffronti lo scopo che si proponeva Licurgo, agli scopi dell'umanità, una profonda
disapprovazione deve subentrare all' ammirazione che ci ha avvinti ad un primo superficiale
sguardo. Ogni cosa deve essere sacrificata al bene dello stato non è mai in se stesso un fine,
ma esso è importante solo come una condizione attraverso la quale può essere raggiunto il fine
dell'umanità non è altro che l'espressione di tutte le risorse dell'uomo, il progresso.
Se un ordinamento statale ostacola lo sviluppo di tutte quelle risorse che si trovano nell'uomo,
se esso impedisce lo sviluppo dello spirito, esso è deprecabile e dannoso, per quanto possa
essere elaborato e perfezionato nella sua forma. a sua stessa durata diventa più un motivo di
rimprovero che di successo; esso è solo un prolungamento del danno; infatti più dura nel
tempo, più danni comporta.
...Il merito politico e l' attitudine alla politica vennero sviluppati a scapito di tutti i sentimenti
morali. A Sparta non esisteva né l'amore coniugale, né l'amore materno, né l'amore filiale, né
l'amicizia. Esistevano soltanto dei cittadini e delle virtù civiche.
...Una legge di stato imponeva agli spartani di essere disumani verso i loro schiavi; in queste
infelici vittime delle guerre veniva insultata e maltrattata l'umanità. Nello stesso codice
giuridico spartano veniva insegnato il principio pericoloso di considerare gli uomini come mezzo
e non come fine. In tal modo i fondamenti dei diritti essenziali della legge naturale e della
morale venivano legalmente infranti.
...Quanto più bello fu l'esempio dato dal rude guerriero Caio Marcio nel suo accampamento
davanti a Roma, allorquando sacrificò la vendetta e la vittoria perché egli non poteva vedere
scorrere le lacrime della madre!
...Lo stato [di Licurgo] poteva sopravvivere ad una sola condizione: che lo spirito del popolo si
fosse estinto. Avrebbe potuto quindi durare solo se esso avesse mancato al più alto e unico
scopo dello stato».
Da Il risveglio di Epimenide di Goethe - Atto secondo, scena quarta
I
G e n î
Quello che audacemente è uscito fuori dall'abisso,
può per un ferreo destino
soggiogare metà della sfera terrestre,
ma nondimeno nell'abisso deve tornare.
Già minaccia un terribile timore:
egli invano cercherà di resistere!
E tutti coloro che a lui sono legati
dovranno perire con lui.
L a
s p e r a n z a
Ora incontro i miei valorosi,
che si radunano nella notte,
per tacere, non per dormire;
e la bella parola "Libertà"
viene bisbigliata e sussurrata,
fino a che con insolita novità
sui gradini dei nostri templi
grideremo ancora con nuovo entusiasmo:
"Libertà! Libertà!".
Per favore fai più copie puoi di questo volantino e distribuiscilo.
Junge T., “Fino all’ultima ora”
Non possiamo correggere a posteriori la nostra biografia
Due anni fa ho conosciuto Melissa Miiller. Venne a trovarmi per fare a me, testimone di un’epoca,
qualche domanda su Adolf Hitler e sulle sue preferenze in campo artistico.
Fu la prima di molte conversazioni che avevano per tema la mia vita e l’effetto che, nel lungo
periodo, l’incontro con Hitler aveva avuto su di me. Melissa appartiene alla seconda generazione
del dopoguerra, il suo sguardo è segnato dalla conoscenza dei crimini del Terzo Reich, ma non fa
parte di quella categoria di persone che, col senno di poi, pretende di sapere tutto. Non crede che sia
così semplice. Ascolta ciò che abbiamo da raccontare noi, testimoni storici, un tempo ammaliati dal
Fuhrer, e tenta di indagare sulle origini di quanto è accaduto.
«Non possiamo correggere a posteriori la nostra biografia, siamo costretti a conviverci.
Possiamo però correggere noi stessi.» Questa citazione di Reiner Kunze, tratta da “Am Sonnenhang.
Tagebuch eines Jahres” (Sul pendio assolato. Diario di un anno), è diventata un principio importante
della mia vita. Continua così: «Solo non ci si aspetti sempre la pubblica umiliazione. Esiste una
vergogna silenziosa che è più eloquente di qualsiasi discorso, e talvolta più sincera.»
Alla fine, comunque, Melissa mi ha convinto a concedere l’autorizzazione a pubblicare il mio
manoscritto. Se sono riuscita a far capire a lei quanto sia stato facile cedere al fascino di Hitler e
quanto sia difficile vivere con la consapevolezza di aver servito l’autore di uno sterminio, ho
pensato, dovrebbe essere possibile renderlo comprensibile anche ai lettori. O almeno questa è la mia
speranza.
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 5
La macchina da discorsi
Tutto lo stato maggiore doveva trasferirsi a Berchtesgaden, ossia nell’Obersalzberg, dove Hitler
desiderava trascorrere un periodo di riposo al suo Berghof e al tempo stesso ricevere alcune visite
ufficiali.
Così, negli ultimi giorni di marzo dell’anno 1943, assistei alla partenza e al trasferimento di un
gigantesco apparato. Era previsto un soggiorno di diverse settimane e fu sorprendente vedere i
preparativi svolgersi tranquillamente e senza difficoltà in un arco di tempo brevissimo.
Noi segretarie preparammo le valigie con i nostri effetti personali, ma dovevamo anche portare il
nostro ufficio da viaggio. Al Fuhrer poteva benissimo venire in mente di scrivere qualcosa lungo il
percorso e dunque ciò doveva essere possibile anche in treno. Impacchettammo pertanto nelle
apposite casse due macchine da scrivere Silenta, due con le maiuscole e una macchina da discorsi
(una macchina con caratteri da circa un centimetro per leggere meglio il dattiloscritto di un
discorso), perché al Berghof non ce n’erano. Un grosso baule conteneva la carta da lettere
occorrente e altro materiale da ufficio disposto in molti cassettini e scomparti.
Dovevamo fare attenzione a impacchettare tutti i tipi di carta da lettere, perché potevamo essere
certe che sarebbero serviti proprio quelli che avessimo dimenticato. C’erano, per esempio, i fogli
che Hitler usava per tutta la corrispondenza personale in qualità di capo di stato. Fogli bianchi con
l’emblema della nazione (l’aquila con la croce uncinata) nell’angolo in alto a sinistra e sotto
stampato in oro «Der Fuhrer». Per tutte le lettere di carattere privato, invece, si serviva di fogli
molto simili, con la differenza che sotto l’emblema della nazione spiccava il nome «Adolf Hitler» in
lettere maiuscole. Per ogni evenienza, dovevamo portare anche i fogli per gli affari di partito, con
l’impressione in rilievo, nonché alcuni fogli per la corrispondenza militare con la normale stampa in
nero.
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 57
Fumare fa male
Il professor Blaschke, un signore sulla sessantina, era il tipo dello studioso. Aveva le tempie
ingrigite, mentre le folte sopracciglia e i baffi curati segnavano il suo volto pallido e sottile come
delle travi scure. Era un uomo di natura introversa e taciturna. Nelle ore passate davanti al camino,
tuttavia, di quando in quando veniva coinvolto da Hitler in una conversazione ed era uno dei pochi a
difendere con determinazione il proprio punto di vista, sebbene il suo parere fosse opposto a quello
del Fuhrer. Il professor Blaschke era anch’egli vegetariano, ma per un altro motivo. Sosteneva che
la dentatura umana fosse fatta per gli alimenti vegetali e che tale nutrimento fosse il più digeribile.
A questo proposito, dunque, concordava pienamente con Hitler, anche se spesso «danneggiava» il
proprio corpo con cibi a base di carne e non riteneva che il pollame rientrasse nella categoria
«carne». Ma quando Hitler pretese che il professor Blaschke gli confermasse che il fumo era uno
dei vizi più dannosi e che produceva effetti negativi soprattutto sui denti, incontrò un’opposizione
molto decisa. Blaschke era egli stesso un fumatore accanito e, forse per questo, più tollerante di
quanto non avrebbe dovuto essere sotto il profilo medico. Riteneva che il fumo fosse addirittura
benefico, in quanto disinfettava il cavo orale e stimolava l’irrorazione sanguigna, e che, in
condizioni normali, non fosse affatto nocivo. Hitler, però, non gli dava ascolto: «Il fumo è e rimane
una delle passioni più pericolose; al di là del fatto che personalmente trovo disgustoso l’odore del
fumo di sigaro e di sigaretta, non offrirei mai una sigaretta o un sigaro a una persona che stimo o
amo, perché gli renderei un cattivo servizio. È stato inequivocabilmente dimostrato che i non
fumatori vivono più a lungo dei fumatori e che sono molto più resistenti alle malattie».
Gretl Braun dichiarò di non volere affatto invecchiare se non poteva fumare, la vita non sarebbe
stata bella neanche la metà e in ogni caso lei era sana anche se fumava da anni. «Sì, Gretl, ma se
non fumasse, sarebbe ancora più sana, e vedrà che quando si sposerà non avrà bambini. E poi,
l’odore del tabacco non dona proprio alle signore. Una volta ero a Vienna al ricevimento di un
artista. Accanto a me sedeva Maria Holst (un’attrice viennese), davvero una bellissima donna.
Aveva dei magnifici capelli castani, ma quando mi chinai verso di lei, dalla sua chioma mi
arrivarono zaffate di nicotina. Le dissi: ma perché lo fa, dovrebbe cercare di mantenere la sua
bellezza e non fumare». Quando poi Hitler affermò che l’alcool era meno dannoso della nicotina,
suscitò l’opposizione compatta di tutti i fumatori, e non erano pochi nel suo entourage. Io dissi:
«Mio Fuhrer, l’alcool distrugge matrimoni, provoca incidenti e crimini. La nicotina, invece, al
massimo danneggia un poco la salute di chi fuma». Lui, tuttavia, non si lasciò convincere dalle
nostre argomentazioni e stabilì che nei pacchi di Natale distribuiti a suo nome ai soldati della
Leibstandarte fossero messi cioccolata e acquavite, ma non sigarette. Tentammo di spiegargli che
probabilmente, alla prima occasione, i soldati avrebbero scambiato la loro cioccolata con del
tabacco: fu tutto inutile. Himmler provvide poi personalmente a distribuire pacchetti di tabacco alle
truppe, altrimenti l’efficienza bellica delle SS ne avrebbe sofferto di sicuro.
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 91
Hoffmann il buon compagno di lotta mai sobrio
Hoffmann, il buon compagno di lotta, anche nei suoi momenti migliori non aveva mai disdegnato
un goccetto; Hitler stesso, infatti, narrò alcuni aneddoti che provavano che Hoffmann non era mai
stato astemio.
Dall’inizio della guerra Hoffmann aveva avuto poche occasioni di incontrare il Fuhrer. Al quartier
generale non aveva motivo di recarsi, il Berghof, dunque, era la loro unica occasione d’incontro.
All’inizio il Fùhrer era sempre contento di rivedere, dopo lunghi mesi, il suo fedele sostenitore, ma
in poco tempo questi riusciva a irritarlo. «Hoffmann, il suo naso sembra una zucca andata a male;
credo che se si mettesse un fiammifero davanti al suo respiro, lei esploderebbe. Presto nelle sue
vene scorrerà vino rosso al posto del sangue» gli disse il giorno in cui si presentò a tavola senza
poter nascondere nemmeno al Fuhrer di avere alzato un po’ troppo il gomito, cosa che almeno,
prima, non aveva mai fatto. Era sempre apparso sobrio davanti a Hitler, che rimase impressionato e
sconvolto nel vedere il suo vecchio amico e confidente lasciarsi andare così.
Alla fine Hitler ordinò ai suoi aiutanti Schaub e Bormann: «Vi prego di provvedere che il professor
Hoffmann si presenti sobrio da me. L’ho invitato per conversare con
lui e non perché si desse alle sbronze». Da allora il buon Hoffmann ebbe qualche difficoltà a trovare
qualcuno che bevesse in sua compagnia. Improvvisamente, nessuno nell’entourage di Hitler aveva
la possibilità di procurargli una fiaschetta, né di tenergli compagnia con il vino. Più tardi, si portò
egli stesso l’occorrente, irritando Hitler a tal punto che non venne quasi più invitato.
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 101
Un silenzio imbarazzante circa le persecuzioni degli ebrei
Di sera, davanti al camino, con Hitler si parlò a lungo dei galleristi e delle mostre allestite da
Hoffmann, un vecchio compagno di lotta di Monaco, presso la Haus der Deutschen Kunst. La
conversazione annoiò tutti tremendamente, ma Hitler amava la pittura e Hoffmann conosceva i suoi
gusti e, soprattutto, il valore materiale degli antichi maestri.
Un giorno era presente anche la figlia di Hoffmann, la moglie di Baldur von Schirach. Era una
viennese graziosa e schietta dalla conversazione incantevole, ma dovette interrompere molto presto
la sua visita per aver creato una situazione incresciosa durante una conversazione alla casa da tè. Io
non ero presente, ma me lo riferì Hans Junge. Mentre Hitler era seduto davanti al camino con i suoi
ospiti, a un tratto disse: «Mio Fuhrer, di recente ad Amsterdam ho visto un treno di ebrei deportati.
È terribile osservare l’aspetto di quelle povere persone, sono certamente trattate malissimo. Lei lo sa
e lo permette?».
Vi fu un silenzio imbarazzante.
Poco dopo Hitler si alzò, si congedò e si ritirò. Il giorno dopo la signora von Schirach tornò a
Vienna, e nessuno accennò più all’accaduto. Apparentemente, aveva oltrepassato il limite dei propri
diritti di ospite e non aveva adempiuto il suo compito di intrattenere il Fuhrer.
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 102
Hitler racconta del suo viaggio in Italia ospite di Mussolini
«Il Duce è un eccellente statista. Conosce la mentalità del proprio popolo ed è davvero sorprendente
cosa sia riuscito a fare dell’Italia con il suo popolo pigro in così breve tempo. Ma non è in una
posizione facile, si trova tra la Chiesa e la Casa reale. Il re è un imbecille, ma ha molti seguaci.
Comunque è stato meraviglioso a Roma. L’Italia è un paese incantevole, però ha una popolazione
molto pigra.»
Hitler raccontò poi con entusiasmo delle grandi manifestazioni e dei fastosi allestimenti che il Duce
aveva preparato in onore dell’ospite. La popolazione fascista aveva tributato infinite ovazioni allo
statista alleato, mostrando molto temperamento e un entusiasmo incredibile. In seguito, Hitler definì
tutto quell’entusiasmo semplicemente un fuoco di paglia e disse che gli italiani erano gentaglia
priva di carattere. A quel tempo era stato con Mussolini all’opera e la disattenzione del pubblico nei
confronti degli interpreti lo aveva fatto inorridire. «La gente sedeva nei palchi e nelle gallerie
abbigliata in sontuose toilette e s’intratteneva in pettegolezzi personali mentre i cantanti davano il
loro meglio. Arrivammo solo a metà del secondo atto e non riuscivo a credere alle mie orecchie
quando all’improvviso, nel bel mezzo della rappresentazione, si interruppero per suonare l’inno
nazionale italiano, quello della Germania e lo Horst-Wessel-Lied [l’inno ufficiale del Partito
nazista, che dal 1933 veniva sempre cantato dopo l’inno nazionale]. Ero proprio imbarazzato e ho
trovato la faccenda molto sgradevole per gli attori.»
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 103.
La prima asserzione da megalomane che sentivo da Hitler
Un giorno, si parlava ancora di matrimonio e di nozze e domandai: «Perché non si è sposato, mio
Fuhrer?». Sapevo bene quanto gli piacesse combinare matrimoni. La risposta fu alquanto
strabiliante: «Non sarei un buon padre di famiglia e ritengo irresponsabile formare una famiglia se
non posso dedicarmi a mia moglie come si deve. Inoltre non vorrei avere dei figli miei. Credo che,
di solito, i discendenti dei geni abbiano una vita molto difficile. Da loro ci si aspetta la stessa
grandezza del famoso genitore e non se ne perdona la mediocrità. E poi, spesso diventano dei
cretini».
Era la prima seria asserzione da megalomane che sentivo da Hitler. Finora avevo avuto di tanto in
tanto l’impressione che fosse megalomane nella sua ideologia e nel suo fanatismo, ma la sua
persona era sempre stata esclusa dal gioco, mentre sottolineava piuttosto: «Sono uno strumento del
fato e devo percorrere il cammino predisposto per me da una volontà superiore». Ora, tuttavia, mi
disturbava enormemente l’idea che un essere umano si considerasse un genio.
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 123
La convincente eloquenza di Hitler
A volte nascevano anche interessanti discussioni sulla Chiesa o sull’evoluzione dell’umanità.
Definirle discussioni forse è esagerato; partendo da una nostra domanda o osservazione cominciava
a sviluppare il proprio pensiero, e noi stavamo ad ascoltare. È un peccato che io rammenti ormai
solo minuscole schegge di queste teorie e purtroppo non possiedo neppure la convincente eloquenza
con cui Hitler ci esponeva le sue idee.
Tornando alle nostre baracche parlammo tra noi della conferenza di Hitler ed ero ben decisa a
riflettere ancora su queste cose e tenerle a mente. Purtroppo, già il giorno dopo, dovetti constatare
che riuscivo a riferire agli amici solo in maniera confusa e poco chiara tutto ciò che la sera
precedente mi aveva impressionato e persuaso. Ah, se fossi stata matura ed esperta come lo sono
oggi, non mi sarei semplicemente lasciata trascinare, non avrei subìto l’influsso di Hitler così, senza
scrupoli né sospetti! Mi sarei dovuta preoccupare del pericolo insito nella forza di una persona che
riusciva, con la propria oratoria e il proprio potere di suggestione, a stregare gli altri soffocandone la
volontà e le convinzioni.
Talvolta vidi consiglieri di Hitler, generali e collaboratori, uscire con espressioni perplesse da una
riunione con il Fuhrer, masticando grossi sigari e lambiccandosi il cervello. In seguito ho avuto
occasione di parlare con alcuni di loro e, sebbene fossero più forti, più saggi e più esperti di me,
spesso era capitato loro di presentarsi al Fuhrer armati di un fermo proposito e di documenti e
argomentazioni ineccepibili per convincerlo dell’impossibilità di un comando, dell’irrealizzabilità
di una disposizione, ma, ancor prima che avessero finito, lui attaccava a parlare e tutte le loro
obiezioni svanivano, perdevano senso di fronte alla sua logica. Sapevano che non poteva
funzionare, ma non riuscivano a trovare il bandolo della matassa. Lo lasciavano disperati,
scombussolati, resi insicuri delle proprie opinioni, prima tanto salde e irrefutabili, come ipnotizzati.
Credo che molti abbiano tentato di opporsi a questa influenza, ma tanti si sono stancati, arresi, e
hanno lasciato semplicemente perdere fino all’amaro epilogo.
Tuttavia ci sono voluti la completa e totale disfatta, un’amara fine e molte profonde delusioni
perché acquistassi lucidità e sicurezza.
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 125
Un’ebrea nello staff di Hitler
In primavera partimmo di nuovo alla volta del Berghof, mentre nella Prussia orientale le costruzioni
dovevano essere sottoposte a ulteriori opere di fortificazione. Hitler voleva fare realizzare alcuni
bunker molto stabili e a prova di bomba.
Marlene von Exner non era della partita. Era rimasta nella Tana del Lupo per fare le valigie,
chiudere casa e tornare a Vienna. Il suo destino ebbe un che di tragicomico. Sebbene non potesse
soffrire i prussiani e odiasse le SS, si era innamorata del giovane aiutante delle SS Fritz Darges.
Anche Gretl Braun si era innamorata di lui, ma per il piccolo Fritz questo amore era un po’ troppo
pericoloso e troppo poco privato, dunque non aveva saputo decidersi ad accettarlo. Tuttavia c’era
qualcosa che non quadrava con gli avi di Marlene. All’inizio del servizio da Hitler, lei aveva
accennato al fatto che i documenti di sua madre non fossero a posto. La nonna era una trovatella e
non era possibile verificarne la discendenza. In virtù dei provati sentimenti nazionalsocialisti
dell’intera famiglia, Hitler aveva attribuito poca importanza alla faccenda, fino a quando l’efficiente
e solerte SDP constatò che effettivamente nella linea materna era presente del sangue ebraico. Lo
sgomento di Marlene fu grande, non tanto per il rischio di perdere il posto di lavoro, quanto per
l’impossibilità di sposare un soldato delle SS.
Hitler ebbe un colloquio con la signora von Exner, durante il quale disse: «Mi dispiace moltissimo
per lei, ma capirà che non posso fare altro che licenziarla dal mio servizio. È impossibile che io
faccia un’eccezione per me personalmente e annulli le mie stesse leggi quando mi fa comodo. Ma
quando sarà di nuovo a Vienna farò arianizzare tutta la sua famiglia e le pagherò lo stipendio per
altri sei mesi. Inoltre, prima di lasciarmi, la prego di venire una volta al Berghof come mia ospite».
E fu così che Marlene prese congedo. Il Reichsleiter Bormann ricevette in mia presenza l’incarico
di procedere all’arianizzazione della famiglia Exner. Era un compito che Bormann accettò
controvoglia, perché aveva tentato di corteggiare l’affascinante viennese e non le avrebbe mai
perdonato di averlo fatto invano.
La sua vendetta non mancò di colpire; alcune settimane più tardi, infatti, ricevetti da Vienna una
lettera molto infelice, secondo la quale ai membri della famiglia erano state ritirate le tessere del
partito e si trovavano tutti in grandi difficoltà. Quando interrogai Bormann in merito, dichiarò che
se ne sarebbe occupato lui. Trascorsero ancora settimane e settimane e alla fine ricevetti un
resoconto impressionante su quanto fosse diventata dura la vita per gli Exner. Marlene dovette
lasciare la clinica universitaria, sua sorella non poté studiare medicina, il fratello fu costretto a
chiudere il suo studio medico e il minore non ebbe la possibilità di intraprendere la carriera di
ufficiale.
Ero talmente furiosa e indignata che mi sedetti alla macchina da scrivere con i caratteri grandi,
trascrissi la lettera parola per parola e mi recai dal Fuhrer. Diventò tutto rosso dalla rabbia e
convocò Bormann. Anche il Reichsleiter era tutto rosso quando uscì dalla camera di Hitler e mi
squadrò furibondo. In marzo, però, ricevetti buone notizie: era tutto a posto, l’intera famiglia Exner
mi ringraziava moltissimo, finalmente l’arianizzazione era stata portata a termine. Quattro settimane
più tardi gli alleati erano a Vienna.
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 135
Hitler ammalato
Qualche giorno più tardi ci fu comunicato: «Il Fúhrer si scusa, mangerà da solo». E anche il tè fu
sospeso. Finché, un giorno, Hitler rimase a letto. L’avvenimento fece scalpore. Nessuno lo aveva
mai visto giacere a letto. Perfino il suo cameriere lo svegliava restando dall’altra parte della porta
chiusa e appoggiava i fogli con le notizie del mattino fuori, su un tavolino. Il Fúhrer non aveva mai
ricevuto nessuno dei suoi collaboratori in vestaglia. A un tratto si era ammalato e nessuno sapeva
perché. Non era uscito indenne dall’attentato? I medici ritenevano che potesse forse essere l’effetto
ritardato di una commozione cerebrale che si manifestava soltanto ora. In ogni caso non lo
vedemmo per giorni. Gli aiutanti erano disperati. Il Fuhrer non voleva ricevere nessuno. Un giorno
Otto Gunsche venne a raccontarmi: «Il Fúhrer è completamente indifferente, non sappiamo cosa
fare. Nemmeno la situazione sul fronte orientale lo interessa, anche se lì siamo proprio messi male».
Dalla degenza, Morell impartiva al suo assistente istruzioni telefoniche sulle cure per Hitler. Ed
ecco che all’improvviso la sua vitalità si risvegliò, impartì ordini dal letto, chiese rapporti sulla
situazione e, dopo qualche giorno, riprese perfino l’abitudine del tè notturno. Credo che ricevere i
propri ospiti in camera, coricato, sia stato un evento unico nella sua vita. Devo dire che era molto
scomodo.
La stanzetta del bunker era ammobiliata in maniera squallida. Proprio come l’alloggio di un soldato
in una caserma. Inoltre Hitler aveva in camera anche una gigantesca cassa di legno per Blondi e la
sua famiglia, sicché lo spazio era davvero esiguo. Mi venivano in mente le preoccupazioni di Eva
Braun, che non sapeva mai cosa regalare a Hitler per il suo compleanno o per Natale. Lui indossava
una modesta vestaglia di flanella grigia, nessuna cravatta colorata, solo dei brutti calzini neri,
nemmeno il pigiama era moderno. Giaceva nel suo letto, ben pettinato e rasato, in una camicia da
notte bianca, così semplice che poteva essere stata disegnata solo dalla Wehrmacht. Non aveva
abbottonato le maniche perché l’avrebbero stretto e quindi vedevamo la pelle bianca delle sue
braccia. Un bianco cereo! Potevamo ben capire che non andasse volentieri in giro in pantaloni corti!
Davanti al letto era stato collocato un tavolino, intorno al quale ci riunivamo con fatica avvicinando
alcune sedie. Se uno degli ospiti (non erano molti, a parte le due segretarie, l’aiutante Bormann e
Hewel) voleva uscire, tutti dovevano alzarsi, e servire era difficoltoso.
Hitler non parlava ancora molto. Si fece raccontare cosa avevamo fatto negli ultimi giorni. Non
avevamo grandi novità da riferire. La nostra principale attività era consistita nel copiare intere pile
di comunicazioni sulle perdite. Era stato un lavoro avvilente e ci era parso inutile; negli ultimi
giorni Hitler non aveva nemmeno guardato i resoconti. Era terribile vedere l’unico uomo che
avrebbe potuto mettere fine a ogni miseria con un solo tratto di penna giacere nel suo letto quasi
indifferente e guardare fisso davanti a sé con occhi stanchi, mentre intorno si scatenava l’inferno.
Avevo l’impressione che il suo corpo avesse compreso all’improvviso la vanità di tutti gli sforzi
della sua mente e della sua forte volontà e avesse dichiarato sciopero, si fosse semplicemente
coricato dicendo: «Non ci sto più». Hitler non si era mai imbattuto in una simile insubordinazione e
si era lasciato cogliere di sorpresa.
Poco tempo dopo, tuttavia, ogni debolezza fu superata. La notizia che i russi sarebbero penetrati
nella Prussia orientale lo rimise in piedi e lo fece guarire in un amen.
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 164
Il medico di Hitler faceva anche esperimenti medici sui detenuti dei campi di concentramento
e sull’eutanasia
Dal punto di vista professionale, nel frattempo, le si prospettano buone opportunità. A trent’anni
non ha ancora un obiettivo preciso, ma finisce sempre per imbattersi in persone che la stimano e
l’aiutano. Willi Brust, un conoscente che lavora come grafico per «Quick», la raccomanda alla
rivista, a quel tempo un apprezzato periodico di reportage, noto per le inchieste e gli accurati
servizi, spesso anche su persone con un passato nazista. Sebbene i reporter e i redattori di «Quick»
conoscano il passato della loro collega, non la interpellano mai sulle sue esperienze durante il Terzo
Reich.
Ricordo che, un martedì grasso, la redazione stava lavorando a un grande servizio su diversi
processi per crimini di guerra ed esecuzioni capitali a Landsberg. Allora, per la prima volta, ho
saputo che cosa avveniva dietro le quinte del Terzo Reich. E soprattutto ho conosciuto la vera natura
di quelle persone che ricordavo cortesi e raffinate. Il dottor Karl Brandt, per esempio, uno dei
medici al seguito di Hitler, che avevo considerato un uomo colto e umano. Nel 1948 fu impiccato
per aver partecipato agli esperimenti medici sui detenuti dei campi di concentramento e
sull’eutanasia. Ero esterrefatta.
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 243
Il confronto con una martire della “Rosa bianca”
Racconta Traudl Junge
:«A quel tempo, a Monaco, devo essere passata spesso senza farci caso davanti alla
targa in memoria di Sophie Scholl in Franz-Joseph-Strasse [Sophie Scholl (19211943) partecipò con il fratello all’attività di propaganda antinazista del piccolo
gruppo di resistenti della Rosa bianca.]. Un giorno l’ho notata e, quando mi sono resa
conto che è stata giustiziata nel 1943, proprio nel momento in cui stava cominciando
la mia vita accanto a Hitler, ne sono stata profondamente scioccata. Anche Sophie
Scholl all’inizio era stata una ragazza del BDM, di un anno più giovane di me, e
aveva capito benissimo di avere a che fare con un regime criminale. La mia scusa
perdeva ogni consistenza.»
Anni di presa di coscienza. Lunghe fasi depressive e colloqui terapeutici che non
portano alcun miglioramento, apatia anche nel lavoro. Tra il 1967 e il 1971 Traudl è
responsabile della rivista di settore «Drogerie Journal» per la casa editrice Wort und
Bild.
«A un tratto non riuscivo più a scrivere. Anche la frase più semplice mi creava delle
difficoltà. Al pensiero di non essere più in grado di svolgere la mia professione le mie
condizioni si erano ulteriormente aggravate. Volevo fuggire in Australia, cercare
rifugio da mia sorella. Ho dato le dimissioni e ho affittato il mio appartamento.»
Per quanto possa suonare paradossale, Traudl Junge ha preso radicalmente le distanze
dal nazionalsocialismo, un sistema al quale non ha mai sentito di appartenere, ma
che, ciononostante, ha condiviso. Non si è costruita un’esistenza fittizia, bensì si è
sforzata di essere sincera con il suo prossimo. Gli anni del tormentoso confronto con
se stessa hanno avuto un senso: l’hanno fatta maturare. «Mi sono ritirata e ho
trangugiato i sensi di colpa, il lutto e il tormento. All’improvviso sono diventata
interessante perché sono una testimone della storia; ciò mi ha fatto entrare in un
pesante conflitto con i miei complessi di colpa. Perché in questi colloqui non si è mai
parlato della colpa, ma soltanto di fatti storici, e quindi potevo riferire senza dovermi
giustificare. Questa circostanza mi ha oppresso ancora di più e mi ha fornito ulteriore
materia di riflessione. Oggi rimpiango due cose: il destino di quei milioni di persone
che sono state assassinate dal nazionalsocialismo e la ragazza Traudl Humps, alla
quale è mancata la sicurezza di sé e l’accortezza di saper dire no al momento giusto.»
Junge T., “Fino all’ultima ora”, Mondadori, pag. 251
VIAGGIO APOSTOLICO
DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
IN POLONIA
DISCORSO DEL SANTO PADRE
VISITA AL CAMPO DI AUSCHWITZ
Auschwitz-Birkenau, 28 maggio 2006
Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro
l'uomo che non ha confronti nella storia, è quasi impossibile – ed è particolarmente
difficile e opprimente per un cristiano, per un Papa che proviene dalla Germania. In un
luogo come questo vengono meno le parole, in fondo può restare soltanto uno sbigottito
silenzio – un silenzio che è un interiore grido verso Dio: Perché, Signore, hai taciuto?
Perché hai potuto tollerare tutto questo? È in questo atteggiamento di silenzio che ci
inchiniamo profondamente nel nostro intimo davanti alla innumerevole schiera di coloro
che qui hanno sofferto e sono stati messi a morte; questo silenzio, tuttavia, diventa poi
domanda ad alta voce di perdono e di riconciliazione, un grido al Dio vivente di non
permettere mai più una simile cosa.
Ventisette anni fa, il 7 giugno 1979, era qui Papa Giovanni Paolo II; egli disse allora:
"Vengo qui oggi come pellegrino. Si sa che molte volte mi sono trovato qui… Quante
volte! E molte volte sono sceso nella cella della morte di Massimiliano Kolbe e mi sono
fermato davanti al muro della morte e sono passato tra le macerie dei forni crematori di
Birkenau. Non potevo non venire qui come Papa". Papa Giovanni Paolo II stava qui
come figlio di quel popolo che, accanto al popolo ebraico, dovette soffrire di più in
questo luogo e, in genere, nel corso della guerra: "Sono sei milioni di Polacchi, che
hanno perso la vita durante la seconda guerra mondiale: la quinta parte della nazione”,
ricordò allora il Papa. Qui egli elevò poi il solenne monito al rispetto dei diritti dell'uomo
e delle nazioni, che prima di lui avevano elevato davanti al mondo i suoi Predecessori
Giovanni XXIII e Paolo VI, e aggiunse: “Pronuncia queste parole […] il figlio della
nazione che nella sua storia remota e più recente ha subito dagli altri un molteplice
travaglio. E non lo dice per accusare, ma per ricordare. Parla a nome di tutte le nazioni, i
cui diritti vengono violati e dimenticati…”.
Papa Giovanni Paolo II era qui come figlio del popolo polacco. Io sono oggi qui come
figlio del popolo tedesco, e proprio per questo devo e posso dire come lui: Non potevo
non venire qui. Dovevo venire. Era ed è un dovere di fronte alla verità e al diritto di
quanti hanno sofferto, un dovere davanti a Dio, di essere qui come successore di
Giovanni Paolo II e come figlio del popolo tedesco – figlio di quel popolo sul quale un
gruppo di criminali raggiunse il potere mediante promesse bugiarde, in nome di
prospettive di grandezza, di ricupero dell'onore della nazione e della sua rilevanza, con
previsioni di benessere e anche con la forza del terrore e dell'intimidazione, cosicché il
nostro popolo poté essere usato ed abusato come strumento della loro smania di
distruzione e di dominio. Sì, non potevo non venire qui. Il 7 giugno 1979 ero qui come
Arcivescovo di Monaco-Frisinga tra i tanti Vescovi che accompagnavano il Papa, che lo
ascoltavano e pregavano con lui. Nel 1980 sono poi tornato ancora una volta in questo
luogo di orrore con una delegazione di Vescovi tedeschi, sconvolto a causa del male e
grato per il fatto che sopra queste tenebre era sorta la stella della riconciliazione. È
ancora questo lo scopo per cui mi trovo oggi qui: per implorare la grazia della
riconciliazione – da Dio innanzitutto che, solo, può aprire e purificare i nostri cuori;
dagli uomini poi che qui hanno sofferto, e infine la grazia della riconciliazione per tutti
coloro che, in quest'ora della nostra storia, soffrono in modo nuovo sotto il potere
dell'odio e sotto la violenza fomentata dall'odio.
Quante domande ci si impongono in questo luogo! Sempre di nuovo emerge la domanda:
Dove era Dio in quei giorni? Perché Egli ha taciuto? Come poté tollerare questo eccesso
di distruzione, questo trionfo del male? Ci vengono in mente le parole del Salmo 44, il
lamento dell'Israele sofferente: “…Tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai
avvolti di ombre tenebrose… Per te siamo messi a morte, stimati come pecore da
macello. Svégliati, perché dormi, Signore? Déstati, non ci respingere per sempre! Perché
nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione? Poiché siamo prostrati
nella polvere, il nostro corpo è steso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto; salvaci per la tua
misericordia!” (Sal 44,20.23-27). Questo grido d'angoscia che l'Israele sofferente eleva a
Dio in periodi di estrema angustia, è al contempo il grido d'aiuto di tutti coloro che nel
corso della storia – ieri, oggi e domani – soffrono per amor di Dio, per amor della verità
e del bene; e ce ne sono molti, anche oggi.
Noi non possiamo scrutare il segreto di Dio – vediamo soltanto frammenti e ci
sbagliamo se vogliamo farci giudici di Dio e della storia. Non difenderemmo, in tal caso,
l'uomo, ma contribuiremmo solo alla sua distruzione. No – in definitiva, dobbiamo
rimanere con l'umile ma insistente grido verso Dio: Svégliati! Non dimenticare la tua
creatura, l'uomo! E il nostro grido verso Dio deve al contempo essere un grido che
penetra il nostro stesso cuore, affinché si svegli in noi la nascosta presenza di Dio –
affinché quel suo potere che Egli ha depositato nei nostri cuori non venga coperto e
soffocato in noi dal fango dell'egoismo, della paura degli uomini, dell'indifferenza e
dell'opportunismo. Emettiamo questo grido davanti a Dio, rivolgiamolo allo stesso
nostro cuore, proprio in questa nostra ora presente, nella quale incombono nuove
sventure, nella quale sembrano emergere nuovamente dai cuori degli uomini tutte le
forze oscure: da una parte, l'abuso del nome di Dio per la giustificazione di una violenza
cieca contro persone innocenti; dall'altra, il cinismo che non conosce Dio e che
schernisce la fede in Lui. Noi gridiamo verso Dio, affinché spinga gli uomini a
ravvedersi, così che riconoscano che la violenza non crea la pace, ma solo suscita altra
violenza – una spirale di distruzioni, in cui tutti in fin dei conti possono essere soltanto
perdenti. Il Dio, nel quale noi crediamo, è un Dio della ragione – di una ragione, però,
che certamente non è una neutrale matematica dell'universo, ma che è una cosa sola con
l'amore, col bene. Noi preghiamo Dio e gridiamo verso gli uomini, affinché questa
ragione, la ragione dell'amore e del riconoscimento della forza della riconciliazione e
della pace prevalga sulle minacce circostanti dell'irrazionalità o di una ragione falsa,
staccata da Dio.
Il luogo in cui ci troviamo è un luogo della memoria, è il luogo della Shoa. Il passato
non è mai soltanto passato. Esso riguarda noi e ci indica le vie da non prendere e quelle
da prendere. Come Giovanni Paolo II ho percorso il cammino lungo le lapidi che, nelle
varie lingue, ricordano le vittime di questo luogo: sono lapidi in bielorusso, ceco,
tedesco, francese, greco, ebraico, croato, italiano, yiddish, ungherese, neerlandese,
norvegese, polacco, russo, rom, rumeno, slovacco, serbo, ucraino, giudeo-ispanico,
inglese. Tutte queste lapidi commemorative parlano di dolore umano, ci lasciano intuire
il cinismo di quel potere che trattava gli uomini come materiale non riconoscendoli come
persone, nelle quali rifulge l'immagine di Dio. Alcune lapidi invitano ad una
commemorazione particolare. C'è quella in lingua ebraica. I potentati del Terzo Reich
volevano schiacciare il popolo ebraico nella sua totalità; eliminarlo dall'elenco dei popoli
della terra. Allora le parole del Salmo: "Siamo messi a morte, stimati come pecore da
macello" si verificarono in modo terribile. In fondo, quei criminali violenti, con
l'annientamento di questo popolo, intendevano uccidere quel Dio che chiamò Abramo,
che parlando sul Sinai stabilì i criteri orientativi dell'umanità che restano validi in eterno.
Se questo popolo, semplicemente con la sua esistenza, costituisce una testimonianza di
quel Dio che ha parlato all'uomo e lo prende in carico, allora quel Dio doveva finalmente
essere morto e il dominio appartenere soltanto all’uomo – a loro stessi che si ritenevano i
forti che avevano saputo impadronirsi del mondo. Con la distruzione di Israele, con
la Shoa, volevano, in fin dei conti, strappare anche la radice, su cui si basa la fede
cristiana, sostituendola definitivamente con la fede fatta da sé, la fede nel dominio
dell'uomo, del forte. C'è poi la lapide in lingua polacca: In una prima fase e innanzitutto
si voleva eliminare l'élite culturale e cancellare così il popolo come soggetto storico
autonomo per abbassarlo, nella misura in cui continuava ad esistere, a un popolo di
schiavi. Un'altra lapide, che invita particolarmente a riflettere, è quella scritta nella
lingua dei Sinti e dei Rom. Anche qui si voleva far scomparire un intero popolo che vive
migrando in mezzo agli altri popoli. Esso veniva annoverato tra gli elementi inutili della
storia universale, in una ideologia nella quale doveva contare ormai solo l'utile
misurabile; tutto il resto, secondo i loro concetti, veniva classificato
come lebensunwertes Leben – una vita indegna di essere vissuta. Poi c'è la lapide in
russo che evoca l'immenso numero delle vite sacrificate tra i soldati russi nello scontro
con il regime del terrore nazionalsocialista; al contempo, però, ci fa riflettere sul tragico
duplice significato della loro missione:hanno liberato i popoli da una dittatura, ma
sottomettendo anche gli stessi popoli ad una nuova dittatura, quella di Stalin e
dell'ideologia comunista. Anche tutte le altre lapidi nelle molte lingue dell'Europa ci
parlano della sofferenza di uomini dell'intero continente; toccherebbero profondamente il
nostro cuore, se non facessimo soltanto memoria delle vittime in modo globale, ma se
invece vedessimo i volti delle singole persone che sono finite qui nel buio del terrore. Ho
sentito come intimo dovere fermarmi in modo particolare anche davanti alla lapide in
lingua tedesca. Da lì emerge davanti a noi il volto di Edith Stein, Theresia Benedicta a
Cruce: ebrea e tedesca scomparsa, insieme con la sorella, nell'orrore della notte del
campo di concentramento tedesco-nazista; come cristiana ed ebrea, ella accettò di morire
insieme con il suo popolo e per esso. I tedeschi, che allora vennero portati ad AuschwitzBirkenau e qui sono morti, erano visti comeAbschaum der Nation – come il rifiuto della
nazione. Ora però noi li riconosciamo con gratitudine come i testimoni della verità e del
bene, che anche nel nostro popolo non era tramontato. Ringraziamo queste persone,
perché non si sono sottomesse al potere del male e ora ci stanno davanti come luci in una
notte buia. Con profondo rispetto e gratitudine ci inchiniamo davanti a tutti coloro che,
come i tre giovani di fronte alla minaccia della fornace babilonese, hanno saputo
rispondere: "Solo il nostro Dio può salvarci. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re,
che noi non serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto"
(cfr Dan 3,17s.).
Sì, dietro queste lapidi si cela il destino di innumerevoli esseri umani. Essi scuotono la
nostra memoria, scuotono il nostro cuore. Non vogliono provocare in noi l'odio: ci
dimostrano anzi quanto sia terribile l'opera dell'odio. Vogliono portare la ragione a
riconoscere il male come male e a rifiutarlo; vogliono suscitare in noi il coraggio del
bene, della resistenza contro il male. Vogliono portarci a quei sentimenti che si
esprimono nelle parole che Sofocle mette sulle labbra di Antigone di fronte all'orrore che
la circonda: "Sono qui non per odiare insieme, ma per insieme amare".
Grazie a Dio, con la purificazione della memoria, alla quale ci spinge questo luogo di
orrore, crescono intorno ad esso molteplici iniziative che vogliono porre un limite al
male e dar forza al bene. Poco fa ho potuto benedire il Centro per il Dialogo e la
Preghiera. Nelle immediate vicinanze si svolge la vita nascosta delle suore carmelitane,
che si sanno particolarmente unite al mistero della croce di Cristo e ricordano a noi la
fede dei cristiani, che afferma che Dio stesso e sceso nell'inferno della sofferenza e soffre
insieme con noi. A Oświęcim esiste il Centro di san Massimiliano e il Centro
Internazionale di Formazione su Auschwitz e l'Olocausto. C'è poi la Casa Internazionale
per gli Incontri della Gioventù. Presso una delle vecchie Case di Preghiera esiste il
Centro Ebraico. Infine si sta costituendo l'Accademia per i Diritti dell'Uomo. Così
possiamo sperare che dal luogo dell'orrore spunti e cresca una riflessione costruttiva e
che il ricordare aiuti a resistere al male e a far trionfare l’amore.
L'umanità ha attraversato a Auschwitz-Birkenau una "valle oscura". Perciò vorrei,
proprio in questo luogo, concludere con una preghiera di fiducia – con un Salmo
d'Israele che, insieme, è una preghiera della cristianità: "Il Signore è il mio pastore: non
manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi
rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi
camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo
bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza … Abiterò nella casa del Signore per
lunghissimi anni" (Sal 23, 1-4. 6).
VISITA ALLA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA
PAROLE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
Sinagoga di Roma
Domenica, 17 gennaio 2010
“Il Signore ha fatto grandi cose per loro”
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia” (Sal 126)
“Ecco, com’è bello e com’è dolce
che i fratelli vivano insieme!” (Sal 133)
Signor Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma,
Signor Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,
Signor Presidente della Comunità Ebraica di Roma
Signori Rabbini,
Distinte Autorità,
Cari amici e fratelli,
1. All’inizio dell’incontro nel Tempio Maggiore degli Ebrei di Roma, i Salmi che
abbiamo ascoltato ci suggeriscono l’atteggiamento spirituale più autentico per vivere
questo particolare e lieto momento di grazia: la lode al Signore, che ha fatto grandi cose
per noi, ci ha qui raccolti con il suoHèsed, l’amore misericordioso, e il ringraziamento
per averci fatto il dono di ritrovarci assieme a rendere più saldi i legami che ci uniscono
e continuare a percorrere la strada della riconciliazione e della fraternità. Desidero
esprimere innanzitutto viva gratitudine a Lei, Rabbino Capo, Dottor Riccardo Di Segni,
per l’invito rivoltomi e per le significative parole che mi ha indirizzato. Ringrazio poi i
Presidenti dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Avvocato Renzo Gattegna, e
della Comunità Ebraica di Roma, Signor Riccardo Pacifici, per le espressioni cortesi che
hanno voluto rivolgermi. Il mio pensiero va alle Autorità e a tutti i presenti e si estende,
in modo particolare, alla Comunità ebraica romana e a quanti hanno collaborato per
rendere possibile il momento di incontro e di amicizia, che stiamo vivendo.
Venendo tra voi per la prima volta da cristiano e da Papa, il mio venerato Predecessore
Giovanni Paolo II, quasi ventiquattro anni fa, intese offrire un deciso contributo al
consolidamento dei buoni rapporti tra le nostre comunità, per superare ogni
incomprensione e pregiudizio. Questa mia visita si inserisce nel cammino tracciato, per
confermarlo e rafforzarlo. Con sentimenti di viva cordialità mi trovo in mezzo a voi per
manifestarvi la stima e l’affetto che il Vescovo e la Chiesa di Roma, come pure l’intera
Chiesa Cattolica, nutrono verso questa Comunità e le Comunità ebraiche sparse nel
mondo.
2. La dottrina del Concilio Vaticano II ha rappresentato per i Cattolici un punto fermo a
cui riferirsi costantemente nell’atteggiamento e nei rapporti con il popolo ebraico,
segnando una nuova e significativa tappa. L’evento conciliare ha dato un decisivo
impulso all’impegno di percorrere un cammino irrevocabile di dialogo, di fraternità e di
amicizia, cammino che si è approfondito e sviluppato in questi quarant’anni con passi e
gesti importanti e significativi, tra i quali desidero menzionare nuovamente la storica
visita in questo luogo del mio Venerabile Predecessore, il 13 aprile 1986, i numerosi
incontri che egli ha avuto con Esponenti ebrei, anche durante i Viaggi Apostolici
internazionali, il pellegrinaggio giubilare in Terra Santa nell’anno 2000, i documenti
della Santa Sede che, dopo la Dichiarazione Nostra Aetate, hanno offerto preziosi
orientamenti per un positivo sviluppo nei rapporti tra Cattolici ed Ebrei. Anche io, in
questi anni di Pontificato, ho voluto mostrare la mia vicinanza e il mio affetto verso il
popolo dell’Alleanza. Conservo ben vivo nel mio cuore tutti i momenti
del pellegrinaggio che ho avuto la gioia di realizzare in Terra Santa, nel maggio dello
scorso anno, come pure i tanti incontri con Comunità e Organizzazioni ebraiche, in
particolare quelli nelle Sinagoghe a Colonia e a New York.
Inoltre, la Chiesa non ha mancato di deplorare le mancanze di suoi figli e sue figlie,
chiedendo perdono per tutto ciò che ha potuto favorire in qualche modo le piaghe
dell’antisemitismo e dell’antigiudaismo (cfr Commissione per i Rapporti Religiosi con
l’Ebraismo, Noi Ricordiamo: una riflessione sulla Shoah, 16 marzo 1998). Possano
queste piaghe essere sanate per sempre! Torna alla mente l’accorata preghiera al Muro
del Tempio in Gerusalemme del Papa Giovanni Paolo II, il 26 marzo 2000, che risuona
vera e sincera nel profondo del nostro cuore: “Dio dei nostri padri, tu hai scelto Abramo
e la sua discendenza perché il tuo Nome sia portato ai popoli: noi siamo profondamente
addolorati per il comportamento di quanti, nel corso della storia, li hanno fatti soffrire,
essi che sono tuoi figli, e domandandotene perdono, vogliamo impegnarci a vivere una
fraternità autentica con il popolo dell’Alleanza”.
3. Il passare del tempo ci permette di riconoscere nel ventesimo secolo un’epoca davvero
tragica per l’umanità: guerre sanguinose che hanno seminato distruzione, morte e dolore
come mai era avvenuto prima; ideologie terribili che hanno avuto alla loro radice
l’idolatria dell’uomo, della razza, dello stato e che hanno portato ancora una volta il
fratello ad uccidere il fratello. Il dramma singolare e sconvolgente
della Shoah rappresenta, in qualche modo, il vertice di un cammino di odio che nasce
quando l’uomo dimentica il suo Creatore e mette se stesso al centro dell’universo. Come
dissi nella visita del 28 maggio 2006 al campo di concentramento di Auschwitz, ancora
profondamente impressa nella mia memoria, “i potentati del Terzo Reich volevano
schiacciare il popolo ebraico nella sua totalità” e, in fondo, “con l’annientamento di
questo popolo, intendevano uccidere quel Dio che chiamò Abramo, che parlando sul
Sinai stabilì i criteri orientativi dell’umanità che restano validi in eterno” (Discorso al
campo di Auschwitz-Birkenau: Insegnamenti di Benedetto XVI, II, 1[2006], p. 727).
In questo luogo, come non ricordare gli Ebrei romani che vennero strappati da queste
case, davanti a questi muri, e con orrendo strazio vennero uccisi ad Auschwitz? Come è
possibile dimenticare i loro volti, i loro nomi, le lacrime, la disperazione di uomini,
donne e bambini? Lo sterminio del popolo dell’Alleanza di Mosè, prima annunciato, poi
sistematicamente programmato e realizzato nell’Europa sotto il dominio nazista,
raggiunse in quel giorno tragicamente anche Roma. Purtroppo, molti rimasero
indifferenti, ma molti, anche fra i Cattolici italiani, sostenuti dalla fede e
dall’insegnamento cristiano, reagirono con coraggio, aprendo le braccia per soccorrere
gli Ebrei braccati e fuggiaschi, a rischio spesso della propria vita, e meritando una
gratitudine perenne. Anche la Sede Apostolica svolse un’azione di soccorso, spesso
nascosta e discreta.
La memoria di questi avvenimenti deve spingerci a rafforzare i legami che ci uniscono
perché crescano sempre di più la comprensione, il rispetto e l’accoglienza.
4. La nostra vicinanza e fraternità spirituali trovano nella Sacra Bibbia – in ebraico Sifre
Qodesh o “Libri di Santità” – il fondamento più solido e perenne, in base al quale
veniamo costantemente posti davanti alle nostre radici comuni, alla storia e al ricco
patrimonio spirituale che condividiamo. E’ scrutando il suo stesso mistero che la Chiesa,
Popolo di Dio della Nuova Alleanza, scopre il proprio profondo legame con gli Ebrei,
scelti dal Signore primi fra tutti ad accogliere la sua parola (cfr Catechismo della Chiesa
Cattolica, 839). “A differenza delle altre religioni non cristiane, la fede ebraica è già
risposta alla rivelazione di Dio nella Antica Alleanza. E’ al popolo ebraico che
appartengono ‘l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le
promesse, i patriarchi; da essi proviene Cristo secondo la carne’ (Rm 9,4-5) perché ‘i
doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!’ (Rm 11,29)” (Ibid.).
5. Numerose possono essere le implicazioni che derivano dalla comune eredità tratta
dalla Legge e dai Profeti. Vorrei ricordarne alcune: innanzitutto, la solidarietà che lega la
Chiesa e il popolo ebraico “a livello della loro stessa identità” spirituale e che offre ai
Cristiani l’opportunità di promuovere “un rinnovato rispetto per l’interpretazione ebraica
dell’Antico Testamento” (cfrPontificia Commissione Biblica, Il popolo ebraico e le sue
Sacre Scritture nella Bibbia cristiana, 2001, pp. 12 e 55); la centralità del Decalogo
come comune messaggio etico di valore perenne per Israele, la Chiesa, i non credenti e
l’intera umanità; l’impegno per preparare o realizzare il Regno dell’Altissimo nella “cura
del creato” affidato da Dio all’uomo perché lo coltivi e lo custodisca responsabilmente
(cfr Gen 2,15).
6. In particolare il Decalogo – le “Dieci Parole” o Dieci Comandamenti (cfr Es 20,117; Dt 5,1-21) – che proviene dalla Torah di Mosè, costituisce la fiaccola dell’etica, della
speranza e del dialogo, stella polare della fede e della morale del popolo di Dio, e
illumina e guida anche il cammino dei Cristiani. Esso costituisce un faro e una norma di
vita nella giustizia e nell’amore, un “grande codice” etico per tutta l’umanità. Le “Dieci
Parole” gettano luce sul bene e il male, sul vero e il falso, sul giusto e l’ingiusto, anche
secondo i criteri della coscienza retta di ogni persona umana. Gesù stesso lo ha ripetuto
più volte, sottolineando che è necessario un impegno operoso sulla via dei
Comandamenti: “Se vuoi entrare nella vita, osserva i Comandamenti” (Mt 19,17). In
questa prospettiva, sono vari i campi di collaborazione e di testimonianza. Vorrei
ricordarne tre particolarmente importanti per il nostro tempo.
Le “Dieci Parole” chiedono di riconoscere l’unico Signore, contro la tentazione di
costruirsi altri idoli, di farsi vitelli d’oro. Nel nostro mondo molti non conoscono Dio o
lo ritengono superfluo, senza rilevanza per la vita; sono stati fabbricati così altri e nuovi
dei a cui l’uomo si inchina. Risvegliare nella nostra società l’apertura alla dimensione
trascendente, testimoniare l’unico Dio è un servizio prezioso che Ebrei e Cristiani
possono e devono offrire assieme.
Le “Dieci Parole” chiedono il rispetto, la protezione della vita, contro ogni ingiustizia e
sopruso, riconoscendo il valore di ogni persona umana, creata a immagine e somiglianza
di Dio. Quante volte, in ogni parte della terra, vicina e lontana, vengono ancora
calpestati la dignità, la libertà, i diritti dell’essere umano! Testimoniare insieme il valore
supremo della vita contro ogni egoismo, è offrire un importante apporto per un mondo in
cui regni la giustizia e la pace, lo “shalom” auspicato dai legislatori, dai profeti e dai
sapienti di Israele.
Le “Dieci Parole” chiedono di conservare e promuovere la santità della famiglia, in cui il
“sì” personale e reciproco, fedele e definitivo dell’uomo e della donna, dischiude lo
spazio per il futuro, per l’autentica umanità di ciascuno, e si apre, al tempo stesso, al
dono di una nuova vita. Testimoniare che la famiglia continua ad essere la cellula
essenziale della società e il contesto di base in cui si imparano e si esercitano le virtù
umane è un prezioso servizio da offrire per la costruzione di un mondo dal volto più
umano.
7. Come insegna Mosè nello Shemà (cfr. Dt 6,5; Lv 19,34) – e Gesù riafferma nel
Vangelo (cfr.Mc 12,19-31), tutti i comandamenti si riassumono nell’amore di Dio e nella
misericordia verso il prossimo. Tale Regola impegna Ebrei e Cristiani ad esercitare, nel
nostro tempo, una generosità speciale verso i poveri, le donne, i bambini, gli stranieri, i
malati, i deboli, i bisognosi. Nella tradizione ebraica c’è un mirabile detto dei Padri
d’Israele: “Simone il Giusto era solito dire: Il mondo si fonda su tre cose: la Torah, il
culto e gli atti di misericordia” (Aboth 1,2). Con l’esercizio della giustizia e della
misericordia, Ebrei e Cristiani sono chiamati ad annunciare e a dare testimonianza al
Regno dell’Altissimo che viene, e per il quale preghiamo e operiamo ogni giorno nella
speranza.
8. In questa direzione possiamo compiere passi insieme, consapevoli delle differenze che
vi sono tra noi, ma anche del fatto che se riusciremo ad unire i nostri cuori e le nostre
mani per rispondere alla chiamata del Signore, la sua luce si farà più vicina per
illuminare tutti i popoli della terra. I passi compiuti in questi quarant’anni dal Comitato
Internazionale congiunto cattolico-ebraico e, in anni più recenti, dalla Commissione
Mista della Santa Sede e del Gran Rabbinato d’Israele, sono un segno della comune
volontà di continuare un dialogo aperto e sincero. Proprio domani la Commissione Mista
terrà qui a Roma il suo IX incontro su “L’insegnamento cattolico ed ebraico sul creato e
l’ambiente”; auguriamo loro un proficuo dialogo su un tema tanto importante e attuale.
9. Cristiani ed Ebrei hanno una grande parte di patrimonio spirituale in comune, pregano
lo stesso Signore, hanno le stesse radici, ma rimangono spesso sconosciuti l’uno
all’altro. Spetta a noi, in risposta alla chiamata di Dio, lavorare affinché rimanga sempre
aperto lo spazio del dialogo, del reciproco rispetto, della crescita nell’amicizia, della
comune testimonianza di fronte alle sfide del nostro tempo, che ci invitano a collaborare
per il bene dell’umanità in questo mondo creato da Dio, l’Onnipotente e il
Misericordioso.
10. Infine un pensiero particolare per questa nostra Città di Roma, dove, da circa due
millenni, convivono, come disse il Papa Giovanni Paolo II, la Comunità cattolica con il
suo Vescovo e la Comunità ebraica con il suo Rabbino Capo; questo vivere assieme
possa essere animato da un crescente amore fraterno, che si esprima anche in una
cooperazione sempre più stretta per offrire un valido contributo nella soluzione dei
problemi e delle difficoltà da affrontare.
Invoco dal Signore il dono prezioso della pace in tutto il mondo, soprattutto in Terra
Santa. Nel mio pellegrinaggio del maggio scorso, a Gerusalemme, presso il Muro del
Tempio, ho chiesto a Colui che può tutto: “manda la tua pace in Terra Santa, nel Medio
Oriente, in tutta la famiglia umana; muovi i cuori di quanti invocano il tuo nome, perché
percorrano umilmente il cammino della giustizia e della compassione” (Preghiera al
Muro Occidentale di Gerusalemme, 12 maggio 2009).
Nuovamente elevo a Lui il ringraziamento e la lode per questo nostro incontro,
chiedendo che Egli rafforzi la nostra fraternità e renda più salda la nostra intesa.
[“Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode,
perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre”.
Alleluia” (Sal 117)]
DAL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO IN VISITA ALLA
SINAGOGA DI ROMA IL 17 GENNAIO 2016
Quella di una ecologia integrale è ormai prioritaria, e come cristiani ed ebrei possiamo e
dobbiamo offrire all’umanità intera il messaggio della Bibbia circa la cura del creato.
Conflitti, guerre, violenze ed ingiustizie aprono ferite profonde nell’umanità e ci chiamano
a rafforzare l’impegno per la pace e la giustizia. La violenza dell’uomo sull’uomo è in
contraddizione con ogni religione degna di questo nome, e in particolare con le tre grandi
religioni monoteistiche. La vita è sacra, quale dono di Dio. Il quinto comandamento del
Decalogo dice: «Non uccidere» (Es 20,13). Dio è il Dio della vita, e vuole sempre
promuoverla e difenderla; e noi, creati a sua immagine e somiglianza, siamo tenuti a fare
lo stesso. Ogni essere umano, in quanto creatura di Dio, è nostro fratello,
indipendentemente dalla sua origine o dalla sua appartenenza religiosa. Ogni persona va
guardata con benevolenza, come fa Dio, che porge la sua mano misericordiosa a tutti,
indipendentemente dalla loro fede e dalla loro provenienza, e che si prende cura di quanti
hanno più bisogno di Lui: i poveri, i malati, gli emarginati, gli indifesi. Là dove la vita è in
pericolo, siamo chiamati ancora di più a proteggerla. Né la violenza né la morte avranno
mai l’ultima parola davanti a Dio, che è il Dio dell’amore e della vita. Noi dobbiamo
pregarlo con insistenza affinché ci aiuti a praticare in Europa, in Terra Santa, in Medio
Oriente, in Africa e in ogni altra parte del mondo la logica della pace, della riconciliazione,
del perdono, della vita.
Il popolo ebraico, nella sua storia, ha dovuto sperimentare la violenza e la persecuzione,
fino allo sterminio degli ebrei europei durante la Shoah. Sei milioni di persone, solo perché
appartenenti al popolo ebraico, sono state vittime della più disumana barbarie, perpetrata
in nome di un’ideologia che voleva sostituire l’uomo a Dio. Il 16 ottobre 1943, oltre mille
uomini, donne e bambini della comunità ebraica di Roma furono deportati ad Auschwitz.
Oggi desidero ricordarli con il cuore, in modo particolare: le loro sofferenze, le loro
angosce, le loro lacrime non devono mai essere dimenticate. E il passato ci deve servire da
lezione per il presente e per il futuro. La Shoah ci insegna che occorre sempre massima
vigilanza, per poter intervenire tempestivamente in difesa della dignità umana e della
pace. Vorrei esprimere la mia vicinanza ad ogni testimone della Shoah ancora vivente; e
rivolgo il mio saluto particolare a voi, che siete qui presenti.
Cari fratelli maggiori, dobbiamo davvero essere grati per tutto ciò che è stato possibile
realizzare negli ultimi cinquant’anni, perché tra noi sono cresciute e si sono approfondite la
comprensione reciproca, la mutua fiducia e l’amicizia. Preghiamo insieme il Signore,
affinché conduca il nostro cammino verso un futuro buono, migliore. Dio ha per noi
progetti di salvezza, come dice il profeta Geremia: «Io conosco i progetti che ho fatto a
vostro riguardo – oracolo del Signore –, progetti di pace e non di sventura, per concedervi
un futuro pieno di speranza» (Ger 29,11). Che il Signore ci benedica e ci protegga. Faccia
splendere il suo volto su di noi e ci doni la sua grazia. Rivolga su di noi il suo volto e ci
conceda la pace (cfr Nm 6,24-26). Shalom alechem!
Ester, la speranza oltre la Shoah
di Elena Dini
Ha perso i genitori nello sterminio; un suo nipote è stato ucciso dai palestinesi a
Jenin. Eppure crede in una memoria che apre alla riconciliazione
CI SONO STORIE che, una volta raccontate, non lasciano il sapore amaro della
tristezza che le accompagna. Sono storie in cui l'amore che le ha guidate e la
speranza nel futuro giocano un ruolo fondamentale. Storie come quella di Ester
Go¬lan (nella foto), ebrea che ha vissuto sulla sua pelle le ferite della Shoah,
«troppo brutta per essere adottata in America e troppo magra per andare in
Palestina». Oggi ha qualche chilo in più rispetto alla sua adolescenza e una
bellezza che passa attraverso gli occhi di chi ne ha viste tante nella vita. A
ottantasei anni in Israele incontra gruppi di ogni religione (musulmani compresi)
per raccontare il dramma del¬l'Olo¬causto. E a rendere unica la sua
testimonianza è la capacità di trasformare la memoria in un'occasione di dialogo.
Nata in Germania nel novembre 1923, Ester Golan è sopravvissuta alla Shoah
emigrando in Gran Bretagna; ma entrambi i suoi genitori, Arno e Else
Dobrowsky, sono morti nei campi di sterminio. «Mia madre era sionista, so¬no
cresciuta con il sogno di andare in Palestina», racconta Ester. Fino al 1932, la
vita della famiglia Dobrowsky trascorreva in maniera abbastanza tranquilla ma
con l'ascesa al potere di Hitler la vita cambia drasticamente: «Un giorno sono
ar¬rivata a scuola - ricorda Ester - e la maestra mi ha detto: "Alzati, tu sei ebrea.
Vai a sederti all'ultima fila". Da quel giorno in poi nessuno mi ha più parlato».
Mamma Else cerca di far adottare la figlia negli Stati Uniti ma senza successo:
«Nessuno vuole adottare una bambina brutta», fu la risposta. A 15 anni Ester
parte per un campo di Youth Aliyah, un'associazione nata con lo scopo di
preparare i ragazzi e le ragazze a emigrare in Pale¬stina. Ma, alla prova medica
finale, Ester viene scartata perché sottopeso. Solo nell'aprile 1939 riesce a partire
per Whitin¬ge¬hame, la casa di Lord Balfour in Scozia, dove venivano ospitati
bambini ebrei in fuga dalle persecuzioni. Le ultime parole della mamma che
ancora risuonano nelle sue orecchie sono: «L'anno prossimo a Gerusalemme». Nel
1942 la coppia Dobrowsky è spedita al campo di Theresienstadt dove Arno muore
nel febbraio 1943. Mamma Else verrà trasferita ad Auschwitz dove morirà nel
luglio 1944.
FINITA LA GUERRA Ester si stabilisce nel nascente Stato di Israele. Per anni
condivide il silenzio di molti sopravvissuti alla Shoah; finché non arriva la svolta.
«È stato quando i miei figli hanno lasciato casa e ho avuto tem¬po per occuparmi
della mia formazione - racconta -. Mi sono iscrit¬ta all'università, dove ho
studiato psicologia educativa e sociologia. Ed è stato a quel punto che ho
raggiunto la maturità emotiva necessaria per fare qualcosa sulla Shoah».
Prendere coscienza del passato, rielaborarlo e anche raccontarlo è stato per Ester
un nuovo punto di partenza. Inseparabile dalla volontà di impegnarsi nella
conoscenza dell'altro, che in una terra come Israele ha il volto del¬l'arabo,
cristiano e musulmano. «Ho cominciato a essere coinvolta nel dialogo
interreligioso nel 1960 quando ero una guida turistica: studiavo religioni
comparate e mostravo alle persone di fedi differenti i loro luoghi sacri».
Da una parte, dunque, Ester comincia a lavorare all'interno della comunità
ebraica per mantenere la memoria di ciò che è stata la Shoah. Ma Ester è anche
ben cosciente di vivere in una società che ha tremendamente bisogno di pace e
riconciliazione. Nel 2000 Ester si unisce ad un gruppo di donne ebree, cristiane,
musulmane e armene per il dialogo interreligioso. Si in¬contrano mensilmente, si
scambiano visite, si telefonano. «Per vivere in pace la gente ha bisogno di
conoscersi. Deve sentire di avere qualcosa in comune con l'altro - insegna Ester e la base per una maggiore comprensione è la fiducia reciproca».
UN'APERTURA al¬l'altro particolarmente si¬gni¬ficativa in chi ha vissuto tan¬to
dolore. Ma anche questo atteggiamento do¬veva di nuovo essere messo alla prova.
Nel 2002 nello Yom Ha-Shoah - il giorno in cui Israele ricorda le vittime della
Shoah - Ester è allo Yad Va¬shem. Una telefonata di suo figlio le dà una nuova
notizia terribile: c'è stato un combattimento a Jenin, tredici soldati israeliani sono
morti. Suo nipote, Eyal Yoel, è uno di questi. «Per me la Shoah non era solo lì e
allora, ma qui e oggi - commenta Ester a sette anni di distanza da quel 9 aprile
2002 -. Non è stato semplice per me tornare alle mie attività. Ma le don¬ne del
mio gruppo di incontro mi hanno incoraggiata a farlo».
La sua conclusione è che bisogna lavorare ancora di più per il dialogo: «Prima
dell'intifada c'erano molti tentativi di incontro fra palestinesi e israeliani e fra
ebrei, cristiani e musulmani. Ma dopo, tutto sembrava bloccato». Ester incontra
padre Emile Shoufani, sacerdote greco-melchita e direttore di una scuola
cristiana a Nazareth, e Nasir Ma¬gali, un gior¬nalista musulmano. «Sono
un'israeliana, ebrea, sionista, so¬pravvissuta alla Shoah - si presenta Ester -. E
mi chiedo co¬sa conoscano gli altri in questo paese della Shoah. Secondo me
molto poco». Così parte una nuova avventura per Ester: parlare della Shoah non
solo al mondo ebraico, ma anche al di fuori.
Così, insieme a padre Shou¬fani e a Nasir Magali, Ester ha potuto organizzare nel
2003 un viaggio ad Auschwitz per una de¬legazione che ha visto unite 250
persone fra ebrei, cristiani e musulmani. È stata la prima vol¬ta che arabi cristiani e mu¬sulmani - ed ebrei hanno visitato insieme un campo di
concentramento. Per Ester, «ovunque la gente è incline a dimenticare ciò che
l'uomo è capace di fare all'altro». Per questo la sofferenza della Shoah può ancora
oggi insegnare tanto e parlare alle generazioni presenti anche di un conflitto come
quello israelo-palestinese. Conoscere l'altro, farsi conoscere da lui, ascoltarlo e
così scoprire qualcosa in più di noi stessi: questa è la strada per Ester, ieri come
oggi. E non c'è dolore, per quanto grande sia stato, che la chiuda di fronte alla
sfida di incontrarsi con chi è «pericolosamente» differente. «Se cristiani ed ebrei,
tedeschi e israeliani possono parlarsi dopo tutto quello che è successo fra di loro conclude Ester -, allora sicuramente anche palestinesi e israeliani, musulmani e
ebrei possono farlo. Bisogna solo volerlo».
I GIUSTI FRA LE NAZIONI
chi salva una vita salva il mondo intero
La storia dei Giusti è nella tradizione ebraica.
Si racconta che in qualsiasi momento della storia dell'umanità ci siano
sempre 36 Giusti al mondo. Nessuno sa chi siano, nemmeno loro
stessi, ma sanno riconoscere le sofferenze e se ne fanno carico, perché
sono nati Giusti e non possono ammettere l'ingiustizia. E' per amor
loro che Dio non distrugge il mondo.
Nel buio della barbarie nazista, molte migliaia di non ebrei rischiarono e spesso
persero la vita per salvare quella di un ebreo, di una famiglia ebraica, o di
intere comunità.
Donne e uomini come tanti, che sapevano perfettamente a che cosa andavano
incontro, ma il cui senso di giustizia e di amore per i loro simili fu più forte
della paura e della morte. Ai Gentili (cioè non ebrei) Giusti, gli ebrei d'Europa
devono dunque particolare riconoscenza, poiché è anche merito loro se il piano
nazista di fare di loro una "razza estinta" non è riuscito fino in fondo.
Nel 1953 il Parlamento Israeliano ha incaricato l'Istituto Yad Vashem di
Gerusalemme, il museo-monumento dedicato alla Shoah, di accordare il
termine di "Giusti tra le Nazioni" agli uomini che rischiarono le loro vite per
salvare gli ebrei, come gesto di riconoscimento e ringraziamento a nome di
tutto il popolo ebraico.
Un giudice della Corte Suprema presiede un comitato di personalità pubbliche
che assicura che i nominati abbiano agito interamente a loro discrezione, in
territori controllati dalle truppe tedesche o da loro alleati e collaboratori, e
mettendo a rischio la propria libertà e la propria vita, senza ricevere
remunerazioni o compensi di sorta.
Nel 1962, presso lo Yad Vashem è stato inaugurato il "Viale dei Giusti", dove
vengono tutt'oggi piantati alberi in loro onore e memoria. Dal 1963 al 2001
sono stati proclamati circa 20.000 Giusti. Fino al 2002, gli italiani erano 295.
Giorgio Perlasca
Commerciante padovano ex fascista convinto,
fingendosi diplomatico di Spagna a Budapest,
nell'Ungheria occupata dai tedeschi, salvò
migliaia di ebrei ungheresi nell'inverno del
1944, rilasciando loro dei salvacondotti e
creando otto case rifugio, protette
dall'Ambasciata Iberica.
Coprendo ogni sua azione con la bandiera
spagnola, quindi di una nazione neutrale,
Perlasca recitò la parte del diplomatico
internazionale dal 1° dicembre 1944 fino alla
liberazione dell'Ungheria, il 16 gennaio 1945.
Tutto ciò, però, avveniva senza che Madrid ne fosse al corrente. Così, grazie
alle difficoltà di comunicazione dovute alla guerra e all'intraprendenza di un
uomo, migliaia di ebrei ungheresi vennero sottratti a morte certa. Perlasca
lasciò Budapest il 29 maggio del 1945, tra una piccola folla di salvati e il
ricordo di un giornale locale che salutava con affatto.
Perlasca venne rintracciato nel 1988 da alcuni ebrei ungheresi e per la sua
opera fu insignito dell'Ordine della Stella d'Oro in Ungheria. Il 25 settembre
1989 non solo venne nominato "Giusto tra i Giusti", ma gli fu conferita la
cittadinanza israeliana e infine, per decreto del Re Juan Carlos di Spagna, fu
nominato "Commendatore di numero dell'Ordine di Isabella"
Marcella Girelli
Nata a Roma il 13 maggio 1921, in una
famiglia borghese, Marcella Girelli
frequentò tutte le scuole presso le
Suore di Sion, dove prese i voti poco
più che maggiorenne, assumendo il
nome di suor Luisa. Nel 1940 l'Italia
entrò in guerra, ma la vita del convento
continuò a scorrere nei suoi binari di
sempre, anche quando nel 1942 il
Vaticano affidò all'Ordine di Sion il
compito di trasformare in veri e propri
moduli le innumerevoli richieste di
aiuto nella ricerca di dispersi che
arrivavano da tutta Italia.
Nell'ottobre del 1943, dopo che Roma fu occupata dalle truppe naziste, si ebbe
una svolta radicale. Il 16 di quel mese si presentarono alle prote del convento
alcune famiglie di ebrei scampati al primo tragico rastrellamento del ghetto,
che quella mattina aveva condannato oltre mille persone, bambini e vecchi
compresi, alla deportazione ad Auschwitz.
La Madre Superiora non ebbe esitazioni: il convento doveva accogliere e
proteggere tutti i fuggiaschi.
Iniziò così una convivenza molto speciale. Ai rifugiati venne destinata una
parte del convento per dormire e cucinare, quando arrivavano nazisti o fascisti
a perquisire il convento, le suore avevano ideato un ingegnoso sistema
d'allarme per avvisare gli ebrei nascosti, dar loro il tempo di far sparire le
proprie tracce e nascondersi.
Al momento della Liberazione, nel 1945, le Suore di Sion erano riuscite a
proteggere e salvare 140 ebrei fra cui molti bambini. Per questo loro atto di
coraggio e abnegazione, hanno ricevuto il riconoscimento di "Giuste tra le
Nazioni". A ritirarlo, a nome di tutte, suor Luisa.
Odoardo Focherini
Carpigiano di nascita e trentino di
origine, uomo acuto, sensibile,
estroverso, sostenuto da una grande
fede, Focherini ha vissuto intensamente
la sua vita, dedicandosi con passione al
lavoro, agli amici, al giornale
"L'Avvenire d'Italia", all'Azione Cattolica
e, soprattutto alla sua famiglia: la
moglie e i sette figli.
Grazie al lavoro per la Società Cattolica
di Assicurazioni di Verona, che lo
portava a muoversi per molte province
del nord-est d'Italia, poteva vedere
come si stava evolvendo la situazione
italiana, quali le difficoltà del Paese
sotto la dittatura.
Nel 1942 incontrò degli ebrei scappati dalla Polonia e riuscì ad organizzare per
loro una via di fuga. Da quel momento capì che poteva fare qualcosa, che
disponeva di contatti e di persone fidate che avrebbero potuto aiutarlo nel caso
in cui, anche in Italia, la situazione per la minoranza ebraica fosse precipitata.
Con l'8 settembre 1943, arrivò la conferma ai peggiori timori. Focherini, con
l'aiuto del sacerdote Don Dante Sala, riuscì a mettere in piedi una struttura
segreta per organizzare l'espatrio di ebrei in Svizzera.
Le persone che lo hanno conosciuto in quel periodo lo ricordano come una
persona serena e sorridente, che sapeva incoraggiare i profughi terrorizzati,
che aveva sempre una buona parola per loro. Il rischio era alto e lo sapeva:
erano in gioco la sua vita e quella della sua famiglia.
Proprio al capezzale di un ebreo da salvare, in ospedale a Carpi, venne
arrestato l'11 marzo 1944.
Fu portato prima in Questura a Modena, poi in carcere a Bologna, dove rimase
fino al 5 luglio, quando venne trasferito a Fossoli: non era più prigioniero, ma
deportato.
A Fossoli sentiva ogni giorno di più che la situazione non si poteva risolvere
così velocemente come aveva sperato; infatti, i primi di agosto il campo si
trasferì a Bolzano, pericolosamente a nord.
Il 5 settembre varcò il confine e arrivò al campo di Flossemburg, in Germania;
da qui venne trasferito al sottocampo di Hersbruck, dove morì il 27 dicembre
1944.
Tante volte aveva sperato e promesso ai propri famigliari il suo ritorno, ma la
macchina nazista lo ha intrappolato, togliendo a lui la vita e a noi il prezioso
ritorno di un Giusto.
Aldo Brunacci
Nato nel 1914 da una povera famiglia di contadini,
Aldo Brunacci aveva studiato a Roma, nell'ambiente
delle organizzazioni giovanili cattoliche. All'interno
dell'Azione Cattolica imparò a pensare con la propria
testa, senza subire la propaganda del fascismo.
Tornato ad Assisi, assistette ai pestaggi degli
oppositori al regime, alle violenze e agli arbitri,
anche nei confronti dei giovani cattolici di cui si
occupava assiduamente.
Con l'Armistizio, nel settembre 1943, Assisi si riempì di ebrei in fuga, italiani e
rifugiati dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia. I frati e il vescovo di Assisi,
monsignor Giuseppe Placido Nicolini, non ebbero esitazioni. Più di trecento
ebrei vestiti da frati e da suore, nascosti nei sotterranei e nelle cantine,
mimetizzati tra li sfollati (italiani provenienti dalle città bombardate) con
documenti falsi, trovarono asilo nell'antica cittadina di San Francesco. Padre
Brunacci, come collaboratore principale del vescovo, si trovò a gestire questa
massa di gente, a nutrirla, proteggerla, procurare documenti falsi, affrontare i
nazisti e i fascisti, spostare quelli più a rischio, curare gli ammalati, occuparsi
dei non pochi bambini.
Una rete di solidarietà si estese a parroci e sacerdoti di altre zone dell'Umbria;
i cittadini di Assisi collaborarono in ogni modo; i fratelli Brizzi, proprietari di
una tipografia stampavano documenti falsi per tutti. In una giornata concitata,
il vescovo di Assisi, insieme a Brunacci, si trasformò in muratore con calce e
cazzuola, per murare nei sotterranei del Vescovado libri di preghiere, oggetti
rituali e preziosi appartenenti agli ebrei.
Padre Brunacci fu arrestato dalle autorità fasciste, ma grazie all'intervento del
Vaticano poté essere rilasciato dopo un periodo di detenzione. Il vescovo lo
spedì a Roma, al sicuro, alla Segreteria di Stato vaticana.
Padre Brunacci è stato riconosciuto come "Giusto tra le Nazioni" dai Yad
Vashem e due alberi, per lui e per il vescovo Nicolini, ormai scomparso, sono
stati piantati nel Viale dei Giusti.
Giovanni Palatucci
Come commissario aggiunto di polizia a Fiume,
salvò molti ebrei, disattendendo alle procedure
di arresto per motivi razziali nell'Italia occupata
e non ottemperando agli ordini superiori
provenienti dai nazisti. Si hanno notizie del fatto
che nel 1939 riuscì a far fuggire 800 ebrei
tedeschi verso la palestina.
Quando dopo l'8 settembre 1943 i tedeschi
annessero parte del nord Italia, facendola
diventare Adriatische Kustenland, Palatucci
restò al suo posto, continuando a contraffare i
documenti degli ebrei e permettendo loro di
scappare.
Fu arrestato dalla Gestapo il 13 settembre 1944 e venne deportato a Dachau,
dove morì il 10 febbraio 1945, pagando con la sua vita la "colpa" di aver
salvato persone colpevoli solo di esistere, secondo le leggi del Reich.
Il giovane Stato di Israele lo proclamò in breve tempo "Giusto tra i Giusti" e
solo nel 1995, in Italia fu conferita una medaglia al valor civile alla memoria.
Il caso della Danimarca
La Danimarca è l'unico caso di nazione a cui venne conferita l'onoreficenza di
"Giusta tra le nazioni". Tutto il popolo danese - compreso il Re Cristiano X e i
capi delle chiese - si oppose in modo non violento ed efficace alla deportazione
degli ebrei e alla loro ghettizzazione. Pur essendo la Danimarca una nazione
sotto l'influenza del Reich, non solo non vi furono applicate le leggi razziali, ma
non venne mai imposta la stella gialla ai cittadini ebrei, poiché il Re aveva
minacciato di portarla lui per primo in segno di solidarietà.
Quando i nazisti organizzarono la deportazione degli ebrei residenti in
Danimarca per l'1 e il 2 ottobre 1943, le autorità danesi sottrassero alla cattura
7906 persone con un esodo via mare verso la neutrale Svezia.
Quest'impresa coinvolse cittadini d'ogni genere e fece sì che di tutta la
comunità ebraica danese venissero catturati dalle truppe del Terzo Reich solo
circa 500 anziani, per la maggior parte deportati a Terezin e sopravvissuti grazie alle
continue pressioni delle autorità danesi.
L’EREDITÀ DI MOSHE BEJSKI E LA MEMORIA DEI GIUSTI NELLA SCUOLA
I nostri percorsi di storia sui Giusti iniziano con la lettura e la riflessione di un testo base della
memoria del bene: Il Tribunale del Bene, scritto da Gabriele Nissim, che narra la storia di Moshe
Bejski, uno dei salvati da Oscar Schindler e Capo della Commissione dei Giusti di Yad Vashem dal
1970 al 1995.
Moshe Bejski ha dedicato la propria vita a fare il pescatore di perle. I Giusti, come delle preziose
perle, devono essere ricercati, vanno osservati con un occhio speciale perché ognuno di loro ha una
storia che è unica e vale la pena di essere ricordata. Moshe Bejski ha saputo trarre dalla sua
personale esperienza un significato universale e ne ha ricavato una missione per la propria vita.
Moshe Bejski nacque nel Gennaio del 1921 a Dzialoszyce vicino Cracovia. Il primo settembre
1939 i tedeschi attaccarono la Polonia e iniziò per lui un periodo di fuga fino al settembre del 1942,
quando ci fu la deportazione degli ebrei dal suo paese. Fuggì dal primo campo di lavoro e si rivolse
ad un amico polacco, che però lo respinse. A Cracovia Marian Wlodarczyk, un suo ex collega, lo
accolse in casa sua; dopo poco, Moshe, per non metterlo in pericolo, decise di tornare al campo di
lavoro. Nel Gennaio del 1943 venne trasferito al campo di prigionia di Plaszow, la cui esperienza fu
per lui decisiva. Infatti “l’esperienza nel campo di Plaszow - come racconta Nissim - gli aveva
regalato una sensibilità che non tutti gli uomini possiedono. Di fronte al buio e alle macerie si era
abituato a cogliere con rinnovato stupore la minima scintilla di bene, la più fragile parvenza di
umanità”.1
Decisivo per lui fu l’incontro con Oscar Schindler, nella cui lista riuscì fortuitamente ad entrare. Per
Moshe fu molto difficile ottenere il riconoscimento di giusto per Schindler, lui che aveva salvato più
di mille ebrei. Schindler non corrispondeva a quell’ ideale di giusto che la Commissione di Yad
Vashem ricercava. Non era moralmente ineccepibile e coerente; spesso si ubriacava, sperperava i
suoi soldi ed andava a donne. Era difficile comprendere che in una persona come Schindler era
potuto intervenire un cambiamento, un’inversione di rotta.
Quando Bejski divenne Giudice dei Giusti e esaminava ogni singolo caso,racconta Nissim che
“…Considerava soltanto un elemento: la loro responsabilità nei confronti di un altro essere umano.
Era l’unica forma di bene che contava che per quel tipo particolare di giudice, ed è forse l’unica
che ogni uomo può rintracciare in un altro uomo.”2
Moshe così dedicò la propria esistenza alla memoria del bene, che rischiava di venire annullata
dall’oblio dei contemporanei. Egli non ha dimenticato il male,di cui è stato vittima e testimone, ha
semplicemente fatto vincere il Bene.
Il “profilo” del Giusto è dovuto al lavoro svolto da Moshe Bejski negli anni in cui fu presidente
della Commissione di Yad Vashem. Egli cercava uomini normali, non degli eroi e voleva
sottolineare i piccoli passi che i Giusti avevano compiuto.
Gli uomini che hanno ricevuto questo riconoscimento non sono persone perfette, ma uomini con i
loro limiti e difetti, che di fronte ad eventi oscuri hanno deciso di agire in modo differente rispetto
alla maggioranza. Non si sono voltati dall’altra parte.
Giusto è “colui che non rinuncia ad essere uomo e non vuole accettare, per un meccanismo
misterioso e indecifrabile, di rimuovere il sentimento interiore di compassione per l’altro.”3
Partendo dalla riflessione sulla banalità del male di Hannah Arendt,abbiamo identificato questo
“misterioso meccanismo” che spinge i Giusti ad agire. Essi, con le loro azioni, aiutano a capire cosa
accade dentro all’uomo quando pensa e cosa spinge un uomo a dire “Questo non posso farlo”,così
anche noi abbiamo potuto comprendere meglio noi stessi. “
La memoria è un compito ed una responsabilità. Conoscere il passato serve per capire che ognuno
di noi ha un ruolo nella storia. I Giusti sono stati uomini normali che con gesti, verrebbe da dire
usuali e ordinari, hanno fatto grandi cose per l’umanità,anche se con le loro azioni non sono riusciti
a fermare il male di cui sono stati contemporanei. Ma se ci poniamo delle domande sulla nostra
responsabilità morale di fronte agli avvenimenti, se reagiamo di fronte ad ogni espressione del
Male, ad ogni accenno di disumanizzazione degli esseri umani, noi li facciamo rivivere e il loro
insegnamento non è andato perduto.
Quest’anno a Cracovia in un incontro pubblico che si è svolto il 9 di Aprile siamo riusciti a
raccontare questa nostra esperienza, a portarla in Polonia. In questa occasione abbiamo voluto
commemorare Moshe Bejski ad un anno dalla morte.
Praticamente sconosciuto nel suo paese di origine,è ritornato attraverso di noi,che con il nostro
impegno e la nostra passione siamo la migliore dimostrazione della verità della sua felice intuizione
della memoria del Bene.
LA STORIA ESEMPLARE DI GIOVANNI PALATUCCI
La storia di Giovanni Palatucci è esemplare per comprendere a fondo le caratteristiche dell’uomo
giusto. Il suo carattere straordinario non dipende dalla particolarità delle vicende di cui fu
protagonista, ma dal modo in cui egli le ha vissute e in cui ha operato. Solo se collocata nel suo
contesto essa può assumere il suo adeguato rilievo.
1
G. Nissim il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski l’uomo che creò il giardino dei giusti, Mondadori,p.
147.
2
3
Ivi, p.144
AA. VV Storia di uomini giusti nel gulag, Mondadori, Milano, 2004,p.4.
Giovanni Palatucci nacque a Montella in provincia di Avellino il 31 Maggio 1909 da una famiglia
agiata. Certamente è fondamentale l’aspetto religioso nella formazione di Palatucci: i principi
cristiani che sono radicati in lui fin dalla primissima infanzia determinarono il codice di
comportamento che lo contraddistinse rispetto a tanti altri italiani durante il fascismo e gli
avvenimenti drammatici della seconda guerra mondiale. Da Genova, dove era stato assegnato al
ruolo di vice commissario aggiunto,venne trasferito nella città di Fiume dove ricoprì gli incarichi di
commissario e poi di questore reggente. Diventato responsabile dell’ufficio stranieri, entrò in
contatto con la realtà degli ebrei di Fiume. Nel 1938 vennero emanate in Italia ( e a Fiume) le leggi
razziali.
Di fronte alla svolta antisemita Palatucci fu costretto a scegliere:come uomo e come cristiano
rigettava queste disposizioni, ma come funzionario dello stato era obbligato a rispettarle. Egli decise
di non essere partecipe dell’evolversi in senso razzista del fascismo. Palatucci riuscì a mantenere il
suo ruolo,e a sfruttare le possibilità che gli venivano offerte dalla sua posizione per la sua opera di
salvataggio. Lo aiutò in questo lo zio monsignor Giuseppe Maria Palatucci vescovo di Campagna.
A Fiume egli continuò la sua opera di salvataggio e soccorso anche dopo l’entrata in guerra
dell’Italia nel 1940 a fianco della Germania. In Iugoslavia le zone di occupazione italiana
diventarono ricettacolo di profughi,in gran parte ebrei, da tutto il Centro Europa e Fiume passaggio
obbligato per la fuga in Italia,Palestina,la Svizzera. L’azione di Palatucci si rivelò decisiva per il
salvataggio di migliaia di persone.
Decise di legarsi proprio a quegli uomini che il regime desiderava eliminare,e unendosi ai
perseguitati, non si limitò a salvar loro la vita, ma restituì loro la dignità necessaria per vivere, con
la convinzione che anche loro avevano un ruolo e un posto nel mondo.
L’azione di Palatucci è testimoniata dai salvati. Nel suo racconto Miriana Tramontina ci trasmette le
sensazioni che le suscitava quell’uomo straordinario,non si limita a raccontare quello che faceva. La
sua fede religiosa commuoveva chi lo circondava e manteneva viva in lui la coscienza e, quindi, la
forza di continuare la sua opera. La Tramontina termina così il suo racconto: “Partecipava al dolore
degli altri in prima persona. Il giudizio di mia madre per quest’uomo era che solo chi vive momento
dopo momento il Vangelo della vita può diventare così importante per gli altri, perché una forza e
un coraggio del genere si possiedono soltanto credendo in Dio”.
Palatucci ha messo in gioco la sua persona. La sua scelta, la spinta irrefrenabile di compiere il bene,
il suo impegno nell’opera di salvataggio era categorico, nato dal cuore. Questo dimostra che in lui
l’evidenza del bene era dovuta a quell’abitudine di dialogare con se stessi che si chiama pensiero.
Questo steso dialogo gli ha consentito di riscoprire come vere le sue convinzioni cristiane e di
riconoscere il suo Dio in ogni circostanza. E’stato dunque possibile per noi scoprire quel
meccanismo misterioso per cui un uomo, anziché voltarsi dall’altra parte, si fa carico del dolore
altrui..
Certamente le iniziative di Palatucci non avrebbero avuto buoni esiti se al suo fianco non ci fossero
stati individui disposti come lui a fare il bene come la guardia di finanza Giuseppe Veneroso e
l’agente Americo Cucciniello, Cucciniello riferisce le parole con cui Palatucci gli affidava le
persone da salvare:“trattale con spirito di umana solidarietà.
Nonostante la segretezza che accompagnava il suo agire, Palatucci venne arrestato nella notte tra il
12 e il 13 settembre 1944 “per aver mantenuto contatto col servizio informativo nemico” ,non per
aver salvato degli ebrei. Lo arrestarono con un pretesto, probabilmente perché non trovarono prove
della sua opera di salvataggio, e lo deportarono a Dachau, dove morì poco dopo.
Palatucci con il suo agire ha dimostrato che compiere il bene è sempre possibile, ma anche che non
esistono scorciatoie , perché la via del rispetto e della giustizia richiedono senso di responsabilità,
coraggio e costante senso di servizio verso gli altri esseri umani. Come afferma Roszi Neumann
“egli è andato oltre il comandamento ama il prossimo tuo come te stesso. Palatucci ha amato il suo
prossimo più di sé stesso”.
LA MEMORIA DEI GIUSTI E LA NOSTRA
IDENTITÀ EUROPEA
Editoriale di Gabriele Nissim
Il 10 maggio il Parlamento di Strasburgo ha approvato la Dichiarazione scritta che istituisce il 6
marzo come Giornata europea in memoria dei Giusti.
Il concetto di Giusto, nato dall’elaborazione del memoriale di Yad Vashem per ricordare i non ebrei
che sono andati in soccorso degli ebrei, diventa così patrimonio di tutta l’umanità.
Il termine “Giusto” non è più circoscritto alla Shoah ma diventa un punto di riferimento per
ricordare quanti in tutti i genocidi e totalitarismi si sono prodigati per difendere la dignità umana.
Il significato di questa decisione richiama uno degli elementi fondanti della cultura europea: il
valore dell’individuo e della responsabilità personale.
Quanto affermato nella Bibbia, “chi salva una vita salva il mondo intero”, alla base della legge sui
Giusti del Parlamento israeliano del 1953, trova molte somiglianze nella filosofia stoica antica.
Epitteto, ripreso poi da Kant, richiamava gli uomini ad accettare serenamente situazioni non
dipendenti dalla volontà, come la malattia o la morte, ma a essere intransigenti nella difesa del loro
carattere morale. Era questa la grande libertà del singolo, che se non poteva modificare il mondo, né
cambiare il passato, né prevedere il futuro, poteva sempre e comunque difendere la propria dignità e
il prossimo vicino a lui nel suo spazio sovrano e nel tempo presente.
E anche il principio enunciato da Yad Vashem - è “giusto” un uomo che per aiutare un perseguitato
si assume un rischio, persino quello della propria vita - ci rimanda all’esempio di Socrate disposto a
morire per la difesa del bene e della virtù morale, piuttosto che tradire la propria coscienza. Lo
aveva bene evidenziato Sallustius Sereno, un neo platonico del IV secolo, il quale osservava che il
bene trascende l’essere e per questo motivo “le anime di valore disprezzano l’essere a causa del
bene, quando affrontano spontaneamente il pericolo per la propria patria, per le persone che si
amano, o per la propria virtù.”
E perché un uomo si comporta da “Giusto” non solo in una vita normale, ma nei momenti difficili,
nelle dittature e nei totalitarismi, quando si perseguitano gli ebrei o altri esseri umani?
Non per un piacere effimero, ma per la ricerca di una felicità profonda, come scriveva Plutarco
citando Diogene il Cinico: “Un uomo dabbene non celebra forse una festa ogni giorno? È una festa
splendida se siamo virtuosi.”
Naturalmente, poi, chi difende la virtù può andare incontro a situazioni difficili, come capitò a Jan
Patočka, il grande filosofo di Charta 77, durante gli anni della dittatura comunista a Praga. In uno
storico appello alla Nazione, Patocka scrisse che era una festa per i cittadini ritrovare il gusto di
difendere la verità di fronte ad un potere ottuso e pagò poi con la vita la sua attività di resistente
morale, soccombendo a un attacco cardiaco dopo un pesante interrogatorio da parte della polizia.
Tanti soccorritori degli ebrei hanno agito con lo stesso spirito. Il loro motto era simile a quello di
Patočka: “ Le stesse cose per cui vale la pena di vivere, sono quelle per cui vale la pena di soffrire.”
Si intuisce come, dopo questa Dichiarazione del Parlamento europeo, la riflessione ebraica sui
Giusti si possa collegare in modo straordinario ai valori più alti della cultura europea. Sarebbe
veramente un peccato se questa possibilità di dialogo non venisse raccolta da Yad Vashem, qualora
prevalesse l’idea di un concetto di "Giusto" limitato alla sola memoria della Shoah.
Ma non è questa la sola posta in gioco.
Il suo valore è prima di tutto politico, nella crisi morale che vive l’Europa.
Oggi improvvisamente di fronte ai problemi economici della Comunità sono molti quelli che hanno
la tentazione di chiudersi nei nazionalismi e smarriscono il senso di definirsi europei.
Ricordare i “Giusti” che hanno lottato contro le leggi razziali, avviato il processo della caduta del
muro di Berlino, si sono impegnati per la prevenzione dei genocidi o hanno difeso la verità e la
memoria nei sistemi totalitari, significa tramandare degli esempi morali che sono il pilastro della
nostra identità. Il gusto della democrazia e del pluralismo, il gusto dell’altro come parte di noi, il
piacere di difendere il vero, senza per questo cadere nella supponenza, il riconoscimento del
perdono come valore nelle relazioni umane, non sono enunciazioni astratte che animano il dibattito
dei filosofi, ma sono stati modi di essere di quanti hanno creduto nella costruzione europea. Come
disse Socrate, stando a quanto riportato nei Memorabili di Senofonte, l’etica non si trasmette con le
parole, ma con gli esempi concreti. “ In mancanza delle parole, faccio vedere cosa sia la giustizia
con le mie azioni.”
Ecco allora il senso della memoria del bene, incarnata dalle storie dei Giusti.
Riportarle alla luce e farne oggetto di narrazione significa farle rivivere nel tempo presente e
trasmettere così ai giovani l’idea di una staffetta morale di cui loro possono diventare protagonisti.
In momenti di crisi vale di più la forza dell’esempio morale che la filippica moralistica
dell’inquisitore di turno che bacchetta la folla e propone la “ghigliottina” per i corrotti.
I giusti non offrono soluzioni e neanche trasmettono testamenti, ma poiché sono stati capaci, come
Antigone, di sfidare le leggi degli uomini per difendere la giustizia, insegnano alle nuove
generazioni che la salvezza e la terapia contro il male nascono dall’abitudine e dalla capacità di
pensare da soli.
Come rendere effettiva la Giornata europea dei Giusti dopo l’approvazione del Parlamento di
Strasburgo?
Non ci sono regole, né si può pensare a una imposizione dall’alto, né a un istituzione europea che
definisca i Giusti da commemorare, come ha fatto per mezzo secolo la Commissione di Yad
Vashem. Dobbiamo immaginare una pluralità di esperienze.
È compito, invece, di ogni Paese impegnarsi per ricordare di volta in volta le proprie figure morali,
piccole o grandi che siano. Importante però, e questo è il segno europeo, che ogni Paese non guardi
solo alla propria storia, ma ricordi figure di altri Paesi, di diverse esperienze. Il Giusto è un cittadino
del mondo e non ha una sola patria. Ecco perché sarebbe bello che nel giardino di Yad Vashem si
ricordasse anche chi ha salvato delle vite in altri genocidi, che a Parigi, Londra, o a Praga
sorgessero dei giardini per ricordare esempi morali non solo della resistenza al fascismo, ma anche
di chi si è impegnato per difendere gli armeni o ha sofferto per la libertà nel comunismo. I Giusti
uniscono l’umanità e ci fanno sentire partecipi dello stesso destino. Ci insegnano il piacere della
virtù.
I GIUSTI, INTERVISTA A PIETRO KUCIUKIAN
Con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, il Parlamento italiano ha istituito il "Giorno
della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
Tra le numerose manifestazioni promosse per l'occasione merita di essere ricordato il
convegno su tutti i genocidi dal titolo Il volto oscuro della modernità: l'ideologia del
genocidio tenutosi nella facoltà di giurisprudenza della Terza Università degli studi di
Roma, promosso dalla stessa università e dall'Associazione culturale identità europea.
Accanto all'olocausto ebraico si delineano le storie di altri genocidi, spesso dimenticati,
il filo rosso che lega i grandi genocidi dell'età moderna.
Adolfo Moranti ha illustrato le radici ideologiche del razzismo moderno.
Sono seguiti gli interventi del prof. Pietro Kuciukian e di Marco Pirna, che hanno
rispettivamente posto l'accento sul genocidio degli armeni e gli italiani di Istria e
Dalmazia, della prof.ssa Daniela Braceschi che si è soffermata sul ruolo della scuola
nel recupero della memoria descrivendo nuovi percorsi e nuovi strumenti didattici che
permettono di recuperare la tradizione e rivalutano l'importanza dello studio della
storia.
Ogni genocidio è unico nella sua dinamica di orrore, nei suoi procedimenti, nelle sue
conclusioni. Ma ogni genocidio è simile agli altri perché la Macchina del Male ha molti
volti, molte metamorfosi, ma un'unicità di fondo, dovuta al fatto che il male è
monotono, innaturale, chiuso entro spazi definiti. È costruito come una macchina
d'acciaio, e posa sulla negazione. (Antonia Arslan in Hushèr: la Memoria – Voci
italiane di sopravvissuti armeni, 2000 ed. Guerini Associati)
Figlio della diaspora armena Pietro Kuciukian è nato in Italia nel 1940 dove ha
intrapreso la carriera di chirurgo dentista. Profondamente legato alla memoria dei suoi
avi si è recato in Armenia dopo il terremoto del 1988 per lavorare alla costruzione di
un ambulatorio dentistico, a Spitak, e di due scuole nella città di Stepanavan.
Nell'ambito del suo impegno per la promozione della causa armena, ha pubblicato
diverse opere edite da Guerini e Associati tra le quali Le terre di Nairi. Viaggi in
Armenia (1994); Viaggio fra i cristiani d'Oriente. Comunità armene in Siria e in
Iran;Dispersi.Viaggio fra le comunità armene del mondo (1998); Voci nel deserto.
Giusti e testimoni per gli Armeni (2000); Giardino di tenebra (2003). Ha realizzato con
una troupe della RAI il documentario Destinazione il nullaper girare il quale si è recato
in Armenia ed in Siria. Nel gennaio del 2003 gli è stato conferito dal Comune di Milano
“L’”Ambrogino d’Oro” per la sua attività nella ricerca nell'ambito del Comitato
promotore della Foresta dei Giusti.
Di fronte ad un gran dolore c'è chi cerca di dimenticare sperando che il tempo
guarisca le ferite, c'è chi, invece, vuole ricordare perché?
Per quanto riguarda il caso armeno perché la negazione del genocidio da parte della
Turchia ci stimola; si tratta di un dovere verso i nostri padri.
Si ricordano spesso le vittime dei genocidi e le atrocità commesse dagli
oppressori, ma c'è una terza categoria quella dei Giusti chi sono?
I Giusti sono quelle persone che di fronte al male estremo agiscono. Il Giusto è colui
che non perde la propria identità e dignità, si sente costretto ad intervenire: chi non lo
fa può avere più danni della vittima stessa. Ma per quanto riguarda il caso armeno i
Giusti sono anche i testimoni attivi che hanno mostrato al mondo ciò che avveniva e
tra questi sono da annoverare anche dei turchi. Ogni anno cerco un Giusto e porto le
sue ceneri a Dzidzernagapert (N.d.R. monumento dedicato ai martiri del genocidio) in
Armenia; il primo Giusto ad esservi stato sepolto è stato Armin Wegner, un ufficiale
tedesco che, a rischio personale, ha consegnato al mondo le prove fotografiche del
genocidio degli armeni. Le sue ceneri erano ancora in casa dei familiari, a Roma, così
nel 1996 con il figlio Misha, accompagnati da una troupe televisiva, le abbiamo
trasportate in Armenia dove sono state tumulate nel "Muro della Memoria" a lato del
monumento dedicato al genocidio di Dzidzernagapert. In seguito vi sono stati portati
Johannes Lepsius, missionario della Chiesa evangelica, fondatore della Missione
d'Oriente, nata per dare rifugio e aiuto agli scampati, che fu il primo a denunciare la
strage che si stava perpetrando con il Rapporto segreto sui massacri degli armeni;
Franz Werfel, lo scrittore tedesco che aveva raccolto le testimonianze dei sopravvissuti
ne I 40 giorni di Mussa Dagh. Tra i Giusti bisogna annoverare anche Giacomo Gorrini,
allora console a Trebisonda, in Turchia, dal 1911 al 1918, testimone oculare della
deportazione e dei massacri degli armeni. Insieme alle lapidi viene piantato un albero,
che contribuirà a formare la foresta dei Giusti.
Quali sono gli obiettivi del Comitato per la Foresta dei Giusti?
La creazione di parchi, boschi, giardini in ogni parte del mondo, per formare un'ideale
foresta senza confini che ricordino il valore dei Giusti per la storia dell'umanità, in
alcuni luoghi-simbolo, come Yerevan in Armenia, Sarajevo in Bosnia Erzegovina, dove
si sta seguendo l'esempio del primo giardino dei Giusti creato a Gerusalemme presso
il memoriale di Yad Vashem, per onorare i non ebrei che si sono opposti alla Shoah. Il
Comitato si occupa, anche, di finanziare ogni anno borse di studio per tesi di laurea o
dottorati di ricerca relativi ad un Giusto ancora ignoto. Stiamo lavorando per la
presentazione al Parlamento della Repubblica d'Armenia di una proposta di legge del
"Progetto sui Giusti per gli armeni" (N.d.R. la sede ufficiale del comitato internazionale
dei Giusti per gli armeni si trova presso il Museo del genocidio sulla collina di
Dzidzernagapert)
La prima generazione successiva al genocidio del popolo armeno si è
preoccupata d'inserirsi nelle società degli Stati ospitanti per dare un futuro
dignitoso ai propri figli, la seconda si è mobilitata – e lo sta facendo tuttoraperché il genocidio sia riconosciuto in tutto il mondo e lavora contro il rischio
di assimilazione e la terza?
La terza generazione continuerà e probabilmente anche la quarta, quinta, sesta,
perché il riconoscimento del genocidio degli armeni è un fatto morale che continuerà a
riempire di sogni la vita anche delle future generazioni.
Nella memoria i Giusti continuano a esistere
Antonia Grasselli
Shoah
Attraverso il progetto di storia “I Giusti tra le Nazioni. Per una nuova memoria della Shoah” una nuova ipotesi
interpretativa della storia e della nostra cultura
«Proprio l’altro giorno ho ricevuto la sua cartolina (da Israele), e ho provato una forte emozione nel sapere
che il nostro lavoro continua a svilupparsi anche “senza di noi”… come mi ha scritto, ha fatto un passo in
avanti, un enorme passo avanti a mio parere… uno scambio culturale (a Yad Vashem) che sicuramente le
avrà dato nuove idee e nuovi spunti per continuare questa iniziativa. La ringrazierò sempre per avermi fatto
vivere la storia, per essere riuscita a trasmettermi l’importanza della memoria e per aver così rinnovato
l’insegnamento di questa importante disciplina… Con sincero affetto. Enrica» (20 settembre 2005). Il lavoro
a cui allude Enrica è quello per il progetto di storia “I Giusti tra le Nazioni. Per una nuova memoria della
Shoah”, che ci ha consentito, studiando, non solo di assimilare una nuova ipotesi interpretativa della storia e
di tutta la nostra cultura, ma soprattutto un modo di sentire noi stessi nel mondo, aprendo così la strada al
cambiamento di sé. Il compito della memoria
Dalla storia di Moshe Bejski (presidente della Commissione dei Giusti di Yad Vashem), a cui si deve il grande
merito di aver trasformato il suo destino personale (lui, un salvato di Oskar Schindler) in un esempio
universale, siamo giunti agli altri Giusti, a Odoardo Focherini, di Carpi, morto a Hersbruck nel dicembre
1944, di cui abbiamo ricostruito la vita, fino ad arrivare a tutti noi, chiamati a essere testimoni a nostra volta,
assumendoci la responsabilità di un giudizio morale sugli avvenimenti. Abbiamo capito che fare memoria è
un lavoro e un compito. La scuola può svolgere un ruolo decisivo in questo senso, perché nella relazione
educativa la riscoperta del passato diviene esperienza presente e questa è esattamente la dinamica di
trasmissione della memoria. Dal progetto sui Giusti che ha prodotto un importante convegno, a cui hanno
partecipato diverse scuole di Bologna e provincia, alla costituzione della rete regionale “Storia e Memoria. La
partecipazione della società civile agli eventi della Seconda Guerra mondiale”, al film Dalla memoria alla
storia. Normandia: i luoghi dello sbarco.
Lavoro straordinario
In poco tempo, un lungo cammino. Ma dove l’origine? L’anno 2003/2004 mi ero avventurata, per la prima
volta, in un progetto sulla applicazione a Bologna della legislazione antiebraica del 1938. Lavoro
straordinario, i cui risultati e materiali sono stati appena pubblicati (Stranieri in patria. Gli ebrei bolognesi
dalle leggi antiebraiche all’8 settembre 1943, Pendragon), che mi ha consentito di incontrare e di conoscere
la comunità ebraica di Bologna. Ho conosciuto dei testimoni delle persecuzioni razziali, dei salvati da Giusti
senza titolo. Ho condiviso il loro dolore, che si rinnova ogni volta che scelgono di raccontare, e la gratitudine
piena di commozione per chi li ha salvati. Sono diventati parte di me. Ho conosciuto, per la prima volta, degli
ebrei e qui è iniziata un’altra avventura, inaspettata, che mi ha condotto nel settembre scorso a
Gerusalemme, a parlare dei Giusti in un Seminario per educatori italiani organizzato dalla Scuola
Internazionale per gli studi dell’Olocausto di Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto voluto dal Governo
israeliano. L’amicizia con alcuni di loro, in Italia e in Israele, ma anche il semplice riferimento per il lavoro che
insieme svolgiamo, ha la capacità di ricordarmi chi sono, mi dà forza e certezza. Siamo gente che si
appartiene e che si può riconoscere reciprocamente, perché ognuno rimanda alla verità dell’altro e questo
riconoscimento ci porta davanti a Dio.
I Giusti e la Memoria del Bene
Chi salva una vita salva il mondo intero
a cura di Antonia Grasselli - Sante Maletta Numero speciale di Lineatempo
Edizione Cusl Milano
E 17,00
I contributi e le esperienze pubblicate in questo libro sono la documentazione del grande rilievo che, a ogni
livello, può assumere la riflessione sui Giusti e la Memoria del Bene.
Nella prima parte gli interventi di Gabriele Nissim, Moshe Bejski, Sante Maletta, Liliana Picciotto e Matteo
Luigi Napolitano sono un contributo alla riflessione delle implicazioni morali, filosofiche e storiche della
problematica dei Giusti. Nella seconda viene descritto nei suoi contenuti, metodologia e risultati un progetto
didattico realizzato al liceo scientifico “E. Fermi” di Bologna. La terza parte contiene gli articoli pubblicati su
Avvenire dal settembre 2005 al gennaio 2006, importanti per gli elementi di riferimento al contesto italiano
che essi offrono.
Per informazioni:
> sito: www.lineatempo.org
> e-mail: [email protected];
[email protected]
SU YOUTUBE
IL GIUDICE DEI GIUSTI:
https://www.youtube.com/watch?v=yQGG-cDV7fE
OLOCAUSTO:
https://www.youtube.com/watch?v=g05lEvu88Mo
Auschwitz:
https://www.youtube.com/watch?v=i09CO4Ml2dQ
Il processo Eichman:
https://www.youtube.com/watch?v=8T5rSiR5Uek
La ROSA BIANCA:
https://www.youtube.com/watch?v=aykEuqx5COU
Perlasca:
https://www.youtube.com/watch?v=PS5TyhaG_gk
https://www.youtube.com/watch?v=dGclgu41Kg0
Il racconto di Liliana Segre:
https://www.youtube.com/watch?v=cYPJxgERlsU
Il racconto di Nedo Fiano:
https://www.youtube.com/watch?v=YPLr0UVVyDM
MI RICORDO DI ANNA FRANK:
https://www.youtube.com/watch?v=Y-tFqyxiirg
Traudl Jungle - La segretaria di Hitler:
https://www.youtube.com/watch?v=UZ4X6XEejG8
https://www.youtube.com/watch?v=B50gspVDNZA
La storia delle SS:
https://www.youtube.com/watch?v=TArTuenh06I
Gli uomini di Hitler:
https://www.youtube.com/watch?v=umzYjHyjkNM
Gli uomini di Hitler: https://www.youtube.com/watch?v=Cy2rZcuLR0
Hitler: https://www.youtube.com/watch?v=JDhun54MHBU
Ultimi giorni di Hitler:
https://www.youtube.com/watch?v=m27-KNnGNJE
LA CADUTA:
https://www.youtube.com/watch?v=nxzNxF3k9Qs
OPERAZIONE VALCHIRIA:
https://www.youtube.com/watch?v=-rZV7vPupTc
Giovanni Palatucci:
https://www.youtube.com/watch?v=_wi0eFaTD30
Guccini e i Nomadi: Auschwitz:
https://www.youtube.com/watch?v=nTYXY6JXchQ
Claudio Chieffo: Auschwitz:
https://www.youtube.com/watch?v=FYrSML2Nm4M
Battiato Edith Stein:
https://www.youtube.com/watch?v=E5Zntmo7lRo
SAMUEL MODIANO
https://www.youtube.com/watch?v=jXlSHYkqqGM
FILM SULLA SHOAH
LA TREGUA
Anno: 1997
Nazione: Italia - Francia - Germania - Svizzera
Durata: 127 m
Regia: Francesco Rosi
Dal libro (1963, premio Campiello) di Primo Levi (1919-87), sceneggiato da F. Rosi, S. Rulli, S. Petraglia con
l'apporto di Tonino Guerra. Il 27-1-1945 i soldati russi arrivano a Buna-Monowitz (Polonia), una delle
trentanove sezioni del lager di Auschwitz (Oswiecim). Alla fine di febbraio il chimico ebreo torinese Primo Levi
(J. Turturro) comincia il lungo viaggio di ritorno che dura quasi otto mesi tra destinazioni incerte, derive, soste
obbligate, peripezie, vagabondaggi. Dopo un viaggio in treno di 35 giorni il 19-10-1945 arriva a casa, a Torino.
Era assai difficile cavare un film da un libro rapsodico e frammentario di 159 pagine con pochi dialoghi e
trasferire in narrazione audiovisiva una scrittura precisa, concreta, sostenuta da riflessioni da un'alta tenuta
morale, in continua oscillazione tra luce e tenebra, allegria e gravità, io e noi. Rosi e i suoi non ci sono riusciti.
Quando segue il libro, il film è spesso impacciato o banale. Quando inventa, si sente il calcolo mercantile.
Dove non c'è calcolo, subentra il formalismo lirico. Due volte trova la corda dell'epica, ma per rendere la
dimensione di gaiezza, arguzia, gioia persino puerile che in Levi esiste si ricorre agli stereotipi della commedia
italo-romanesca. Tra i personaggi le note positive sono il greco Mordo Nahum di R. Serbedzija, il Daniele di S.
Dionisi e il Primo di Turturro, nonostante la differenza di età e di altezza e il fuoco interiore che cova,
meridionale più che piemontese. Musiche di Luis Bacalov. Dedicato alla memoria di Pasqualino De Santis
(fotografia) e di Ruggero Mastroianni (montaggio), morti durante la lavorazione e sostituiti da Marco
Pontecorvo e Bruno Sarandrea.
SCHINDLER'S LIST
Anno: 1993
Nazione: Stati Uniti
Durata: 195 m
Regia: Steven Spielberg
Dal libro dell'australiano Thomas Keneally La lista. L'industriale tedesco Oskar Schindler, in affari coi nazisti,
usa gli ebrei dapprima come forza-lavoro a buon mercato, un'occasione per arricchirsi. Gradatamente, pur
continuando a sfruttare i suoi intrallazzi, diventa il loro salvatore, strappando più di 1100 persone dalla
camera a gas. E il film più ambizioso di S. Spielberg e il migliore: prodigo di emozioni forti, coinvolgente, ricco
di tensione, sapiente nei passaggi dal documento al romanzesco, dai momenti epici a quelli psicologici. La
partenza finale di Schindler è l'unica vera caduta del film, un cedimento alla drammaturgia hollywoodiana, alla
sua retorica sentimentale. L. Neeson rende con grande efficacia le contraddizioni del personaggio. L'inglese R.
Fiennes interpreta il paranoico comandante del campo Plaszow come l'avrebbe fatto Marlon Brando 40 anni fa.
Memorabile B. Kingsley nella parte dell'ebreo polacco, contabile, suggeritore e un po' eminenza grigia di
Schindler. 7 Oscar: film, regia, fotografia di Janusz Kaminski (in bianconero, tranne prologo ed epilogo),
musica di John Williams, montaggio, scenografia e sceneggiatura. Quel rosso del cappottino della bambina che
cerca di sfuggire al rastrellamento è una piccola invenzione poetica, un esempio del modo con cui gli effetti
speciali possono diventare creativi.
TRAIN DE VIE
Anno: 1998
Nazione: Francia - Belgio - Paesi Bassi
Durata: 101 m
Regia: Radu Mihaileanu
Nel 1941, per evitare la deportazione, gli abitanti di uno shetl (villaggio ebraico dell'Europa centrale) romeno
allestiscono un finto convoglio ferroviario sul quale alcuni di loro sono travestiti da soldati tedeschi e partono
nel folle tentativo di raggiungere il confine con l'URSS e di lì proseguire per la Palestina, Eretz/Israel, la terra
promessa. Ci riescono, dopo tragicomiche peripezie tra cui l'incontro con un gruppo di gitani che, a bordo di
autocarri, hanno avuto la stessa idea. 2? film del romeno Mihaileanu, attivo in Francia, è una tragicommedia di
viaggio sotto la triplice insegna dell'umorismo yiddish (condito di una grottesca ironia critica verso gli stessi
ebrei, i tedeschi, i comunisti), di una sana energia narrativa e di un ritmo di trascinante allegria cui molto
contribuisce Goran Bregovic, il compositore preferito di E. Kusturica, che attinge alla musica klezmer ebraica
dell'Europa orientale. Fotografia del greco Yorgos Arvanitis, l'operatore di Anghelopulos e di Laurent Daillant.
Colorita galleria cosmopolita di interpreti, dialoghi italiani di Moni Ovadia. Non manca una dimensione poetica,
incarnata in Schlomo (L. Abelanski), lo scemo del viaggio che funge da narratore. L'inquadratura finale può
essere la chiave di lettura a ritroso. Grande successo di pubblico e premio Fipresci alla 55a Mostra di Venezia
1998.
LA VITA E’ BELLA
Anno: 1997
Nazione: Italia
Produzione: Cecchi Gori
Distribuzione: Cecchi Gori
Durata: 120 m
Regia: Roberto Benigni
Guido Orefice, toscano montanino ed ebreo, s'innamora sul finire degli anni '30 della maestrina Dora, la
corteggia in modi stravaganti, la sposa. Sei anni dopo nell'intervallo sono venute le leggi razziali (1938), la
guerra e le deportazioni Guido con il figlioletto Giosuè parte per il campo di concentramento. Dora, che ebrea
non è, li segue volontariamente. Per proteggere il figlio dall'orrore, Guido gli fa credere che quel che stanno
vivendo è un gioco a premi con un carro armato in palio. 6? film di Benigni regista, è il più ambizioso, difficile
e rischioso e il migliore: 2 film in 1, o meglio un film in 2 parti, nettamente separate per ambientazione, tono,
luce e colori essenziali i contributi della fotografia ma complementari: la 1a spiega e giustifica la 2a. Una bella
storia d'amore, scritta con Vincenzo Cerami: prima tra un uomo e una donna, poi per un figlio, ma l'una è la
continuazione dell'altra. Il frenetico dinamismo di R. Benigni è felicemente sfogato, la sua torrentizia oralità
ora debordante ora dimezzata. Un'elegante leggerezza distingue G. Durano nel più riuscito dei personaggi di
contorno. 5 Nastri d'argento, 7 nomination agli Oscar e 3 statuette (film straniero, attore per Benigni, musica
per Nicola Piovani).
LA SETTIMA STANZA
Anno: 1996
Produzione: Italia - Francia - Polonia - Ungheria
Durata: 110' (colore)
Regia: Marta Meszaros
Film biografico che narra la vicenda di Edith Stein, ebrea convertita al cattolicesimo divenuta suora, uccisa in
un Lager nazista nel '42 ed elevata agli altari da Giovanni Paolo II nel 1987. Un film pulito e appassionato,
attento ad evitare le trappole della retorica.
JONA CHE VISSE NELLA BALENA
Anno: 1993
Produzione: Italia
Regia: Roberto Faenza
In Jona che visse nella balena il regista sceglie di osservare il mondo in una fase
particolarmente drammatica della storia attraverso gli occhi di un bambino, Jona Oberski,
ebreo olandese, deportato a quattro anni insieme ai genitori, sopravvissuto alla
persecuzione antisemita e oggi autorevole scienziato, autore di Anni d’infanzia, in cui
narra le sue memorie.
ROSENSTRASSE
Anno: 2003
Produzione: Germania
Regia: Margarethe von Trotta
Rosenstrasse, il nome della via in cui nel '43, quando le sorti della guerra erano ormai segnate,
furono rinchiusi centinaia di ebrei provenienti dai matrimoni misti con ariani.
Di fronte all'edificio, trasformato in prigione, i loro coniugi hanno dimostrato finché non sono
riusciti ad ottenere la scarcerazione dei loro cari, o almeno dei sopravvissuti (incredibile!).
Per rivivere questa drammatica pagina della storia, la regista, ci presenta Ruth Weinstein (Jutta
Lampe) ormai settantenne che a New York, dove si è trasferita al termine della guerra, ha
appena seppellito il marito. L'evento la riavvicina in maniera traumatica alla sua religione e per
prima cosa decide di opporsi alle nozze della figlia, Hannah (Maria Schrader), con un uomo di
religione non ebraica.
Questo improvviso cambiamento della madre preoccupa Hannah che inizia ad indagare sul suo
passato scoprendo come la nonna fosse stata una delle vittime della Rosenstrasse e di come
sua madre fosse stata adottata da Lena (Katja Riemann) una delle tante anime disperate che
lottava per la liberazione del marito.
Lena, di estrazione nobiliare, vive con ancor maggior orrore gli eventi del nazismo. Ripudiata
dal padre, fervente portabandiera degli ideali del Fuehrer, allontanata da una società che fino a
pochi anni prima l'aveva idolatrata come una delle più promettenti pianiste della Germania, si
trova a patire la fame e le umiliazioni di migliaia di altri disperati.
I film sull'Olocausto hanno sempre una carica emotiva devastante, come potrebbe essere
altrimenti, e questo della von Trotta non fa certo eccezione. Tra l'altro va ascritto alla cineasta
di essere l'unica tedesca ad aver affrontato questo tema, che è particolarmente spinoso per i
teutonici. La visione di Margarethe non è assolutamente parziale e mostra i due lati della
Germania, quella oltran-a-zista e quella della gente comune che vede deportare persone con
cui ha condiviso la vita fino a pochi giorni prima, senza spesso sapere quale fosse il reale
destino di quegli sventurati.
Un grande affresco realizzato con un budget hollywoodiano che si muove continuamente ed
abilmente tra passato e presente, ma sofferente di una lunghezza eccessiva che allunga
l'agonia dello spettatore per poi dargli lo zuccherino finale.
JAKOB IL BUGIARDO
(Jakob the Liar)
Regia: Peter Kassovitz
Produzione: USA
Interpreti: Robin Williams, Alan Arkin, Mathieu Kassovitz
Anno: 1999
Durata: 114' (col)
Tratto dal romanzo di Jurek Becker , è una fiaba sul tema tragico della ghettizazione degli
ebrei dell’Europa orientale ad opera dei nazisti. In un ghetto polacco, Jakob, nell’ufficio
della Gestapo, ascolta per caso alla radio la notizia dell’avanzata dell’Armata Rossa.
Quando comunica il fatto ai suoi conoscenti, tutti credono che egli abbia una radio
nascosta. Nel tentativo di far nascere la speranza nel ghetto egli decide di dare via via
delle notizie completamente inventate sull’esito positivo della guerra
KAPO'
Regia: Gillo Pontecorvo
Produzione: Francia/Italia
Interpreti: Susan Strasberg, Laurent Terzieff, Emmanuelle Riva, Didi Perego, Gianni Garko.
Anno: 1960
Durata: 116' (b/n)
Durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, Edith, una giovane ebrea francese, viene
deportata in un campo di sterminio. Dopo aver assistito all’uccisione dei genitori, decide di
sopravvivere diventando la responsabile di una baracca. L’amore per un prigioniero russo le farà
ricordare i valori dimenticati nella battaglia quotidiana per la vita.
SWING KIDS - GIOVANI RIBELLI
Regia: Thomas Carter)
Produzione: USA
Interpreti: Robert Sean Leonard, Christian Bale, Frank Whaley, Kenneth Branagh,
Barbara Hershey
Anno: 1993
Durata: 114' (col)
Ci si può opporre al nazismo ballando? E’ successo a un gruppo di giovani legati da
una forte amicizia e dalla comune passione per il Swing, la musica americana che
venne proibita perché degenerata. Il film offre una convincente descrizione della
condizione dei giovani, di fronte al tentativo di nazificazione della società tedesca,
nella Germania degli anni ’30.
ARRIVEDERCI RAGAZZI
(Au revoir les enfants)
Regia: Louis Malle
Interpreti: Gaspard Manesse, Raphael Fejto, Francine Racette, Philippe MorierGenoud, François Berléand.
Produzione: Francia
Anno: 1987
Durata: 103' (col)
E’ un ricordo di scuola dello stesso Malle. Francia, Collegio del Bambin Gesù di
Fontainebleau, gennaio
del ’44. Tra il ragazzo Louis Malle (Gaspard Manesse) e Jean Bonet (Raphael Fejto ),
ebreo nascosto sotto falso nome, si stabilisce un delicato rapporto di amicizia che
viene, però, stroncato sul nascere dalla deportazione del Padre rettore del Collegio
insieme ai piccoli ebrei che aveva nascosto.
L’ arrivederci straziante si rivelerà un irrimediabile addio.
(Leone d'Oro alla Mostra di Venezia)
L’AMICO RITROVATO
(Reunion)
Regia: Jerry Schatzberg
Produzione: Gran Bretagna/Francia/Germania
Interpreti: Jason Robards, Christian Anholt, Sam West, Françoise Fabian.
Anno: 1989
Durata: 110' (col)
Liberamente tratto dall'omonimo libro di Fred Uhlman (pubblicato in Italia dalla casa
editrice Feltrinelli). Germania, anni ’30. Due adolescenti, uno figlio di uno stimato
medico ebreo, l’altro rampollo di una famiglia aristocratica, gli Hohenfelds,
frequentano lo stesso prestigioso ginnasio di Stoccarda. L’appassionata amicizia che
nasce tra i due verrà stroncata dalla dilagante piaga dell’antisemitismo nazista.
L'UOMO DEL BANCO DEI PEGNI
(The Pawnbroker)
Regia: Sidney Lumet
Produzione: USA
Interpreti: Rod Steiger, Geraldine Fitzgerald, Brock Peters
Anno: 1965
Durata: 116' (b/n)
Sol Nazerman (Rod Steiger), un ebreo polacco sopravvissuto allo sterminio nazista, vive in
America gestendo un Banco dei Pegni. Ossessionato dal ricordo, vive chiuso in se stesso. Un
evento traumatico scuoterà la sua apparente incapacità di soffrire e di amare. il film è ritenuto una
delle poche produzioni holliwoodiane che abbiano affrontato il tema della Shoah con rigore, sia
tematico che formale.
DOTTOR KORCZAK
Regia: Andrzej Wajda
Interpreti: Wojciech Pszoniak, Ewa Dalkowska, Piotr Kozlowski.
Produzione: Polonia/Germania/Francia
Anno: 1990
Durata: 113' (b/n)
La tragedia di un gruppo di 200 orfani ebrei nel Ghetto di Varsavia, affidati alle cure
del Dottor Korczak, fino alla loro deportazione, nell’agosto del 1942, nel campo di
sterminio di Treblinka
IL CIELO CADE
Regia: Andrea e Antonio Frazzi
Interpreti: Isabella Rossellini, Lara Campoli, Veronica Niccolai, Jeroen Krabbé, Barbara
Enrichi, Gianna Giachetti, Luciano Virgilio.
Produzione: Italia
Anno: 2000
Durata: 101' (col)
Una storia liberamente tratta dalla vicenda vera di Alfred Einstein (cugino del grande
fisico) e dei suoi, vittime delle SS in ritirata dopo aver rifiutato di fuggire "per rispetto
della propria dignità" nei giorni successivi al 25 luglio 1943.
IL GRANDE DITTATORE
Regia : Charlie Chaplin
Produzione: USA
Interpreti: Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardiner, Grace
Hale.
Anno 1940
Durata 126 ‘ (b/n)
Un grandissimo Charlie Chapiln nel doppio ruolo del dittatore Hynkel (Hitler) e di un
barbiere ebreo che lotta contro le persecuzioni antisemite e che, camuffato da nazista,
viene scambiato per il primo e in questa veste pronuncia un grande discorso
umanitario. Fu quasi l’unico film americano ad attaccare il nazismo prima di Pearl
Harbor. Coraggiose le analogie, mai camuffate (Hering/Goering, Napoleone/Mussolini),
così come le sequenze realistiche del Ghetto. A Chicago, città che contava una forte
comunità tedesca, fu censurato
IL PIANISTA
Anno: 2002
Durata: h 2.28
Nazionalità: Francia/Germania/Polonia/Gran Bretagna
Regia: Roman Polanski
Il pianista sta suonando il Notturno in do diesis minore di Chopin, quando i bombardamenti
interrompono l’esecuzione. I tedeschi occupano Varsavia.
La famiglia ebrea Szpilman decide di non lasciare la città, fiduciosa nell’intervento degli alleati.
Presto si comprende che i francesi non hanno intenzione di sfondare la linea Siegfried, come gli
inglesi di bombardare Amburgo.
È il settembre del 1939. Iniziano le violenze, le misure restrittive, i rastrellamenti. Gli Szpilman
restano compatti e difendono, quanto possibile, la loro dignità. L’insensatezza degli eventi sembra
garantirne la fine. S’impara che un calcio o un insulto da parte di un tedesco non è un’ignominia, è
la regola.
I cancelli del ghetto di Varsavia vengono chiusi il 15 dicembre del 1940. Nell’agosto del 1942,
nell’Umschlagplatz, centro di raccolta ai confini del ghetto, Wladyslaw viene salvato da un membro
della polizia ebrea, e dice addio alla famiglia che scompare su un carro bestiame. D’ora in avanti
l’unico obiettivo è sopravvivere.
Scappato dal ghetto, si sposta di rifugio in rifugio, finendo per aggirarsi, come il primo uomo, tra le
macerie di una Varsavia rasa al suolo, alla ricerca di un tozzo di pane ammuffito.
Il capitano della Werchmacht Wilm Hosenfeld scopre il suo nascondiglio, ma, dopo averlo sentito
suonare, gli salva la vita.
È il 1945, Varsavia viene liberata dall’Armata Rossa. A causa del pastrano nemico che indossa per
ripararsi dal freddo, il pianista rischia di essere grottescamente ucciso dai soldati polacchi che
inizialmente lo scambiano per un tedesco.
Finita la guerra, Wladyslaw riprese a suonare per Radio Varsavia, che inaugurò la trasmissione col
brano di Chopin che era stato eseguito dal vivo quell’ultimo giorno, come se la guerra e Hitler
fossero stati soltanto un funesto intervallo.
A nulla valse l’appassionata intercessione di Szpilman per aiutare il suo salvatore. Hosenfeld morì
in un campo di concentramento a Stalingrado nel 1953, dopo sette anni di prigionia.
“Ho iniziato la mia carriera di pianista durante la guerra, al Café
Nowoczesna, che si trovava in via Nowolipki, proprio nel cuore del
ghetto di Varsavia. Quando nel novembre del 1940 i cancelli del ghetto
vennero chiusi, la mia famiglia ormai da molto tempo aveva venduto
tutto quello che si poteva vendere, persino quello che noi
consideravamo il nostro bene più prezioso: il pianoforte. La vita, alla
quale quei tempi avevano tolto ogni valore, mi costrinse tuttavia a
vincere la mia apatia e cercare un modo per guadagnarmi da vivere."
Ufficiale della Wehrmacht, Wilm Hosenfeld.
Scrive Hosenfeld: “Perché è dovuta scoppiare questa guerra? Perché bisognava mostrare
all’umanità dove la stava conducendo la sua mancanza di fede. Innanzitutto il Bolscevismo ha
ucciso milioni di uomini col pretesto di introdurre un nuovo ordine mondiale. Ma i bolscevichi
potevano agire in questo modo solo perché si erano allontanati da Dio e dall’insegnamento
cristiano. Ora il Nazionalsocialismo sta facendo lo stesso in Germania. Vieta alla gente di
praticare la propria religione. I giovani vengono cresciuti senza fede, la Chiesa viene
combattuta, espropriata dei propri beni. Tutti coloro che la pensano in modo diverso sono
perseguitati. Lo spirito libero del popolo tedesco viene avvilito, uomini e donne sono ridotti a
schiavi terrorizzati. La verità è bandita. Nessuno conta più nulla nel destino del proprio Paese.”
APPARTAMENTO AD ATENE
Tratto dal romanzo di Glenway Wescott "Apartment in Athens" del '45 ed edito in Italia da
Adelphi solo nel 2003, Appartamento ad Atene, opera prima del regista Ruggero Di Paola
(avvocato di professione e cineasta per hobby) con Laura Morante, Richard Sammel,
Gerasimos Skiadaressis, Vincenzo Crea e Alba De Torrebruna.
"Nel 1943, ad Atene, un appartamento viene requisito per ospitare un ufficiale tedesco.
Nell'appartamento vivono gli Helianos, una coppia di mezza età un tempo agiata. Hanno un
ragazzo di dieci anni, animato da melodrammatiche fantasie di vendetta, e una bambina di
dodici.
Con l'arrivo del capitano Kalter, tutto è cancellato. Metodico, ascetico, crudele, Kalter è un diosoldato che impone il terrore. E gli Helianos si sottomettono, remissivi. Sono servi, adesso,
senza altra identità che la loro acquiescenza. La volontà del dio-soldato è il loro unico assillo.
L'appartamento li avvolge come un'epidermide. Poi, di colpo, l'assenza. Il padrone parte per la
Germania, e i servi scoprono che la libertà non ha alcun senso, che la tortura continua.
Quando Kalter torna, è un sollievo. E' cambiato: più gentile, indulgente. Di un'indulgenza che
disorienta. Ma è un fragile equilibrio. Correnti sotterranee di odio agiscono in segreto e
preparano un'agghiacciante vendetta"
Dachau, baracca 8, numero 123343: la
testimonianza di un sopravvissuto
FILM DOCUMENTARIO Gli orrori del campo nazista di Dachau nei ricordi di Enrico
Vanzini
LA CHIAVE DI SARA
La chiave di Sara è un film del 2010 diretto da Gilles Paquet-Brenner. Tratto dall'omonimo
romanzo di Tatiana de Rosnay e interpretato da Kristin Scott Thomas e dalla "bimba-prodigio"
Mélusine Mayance,
Regista: Gilles Paquet-Brenner
Anteprima nazionale: 16 settembre 2010
Data di uscita DVD: 22 novembre 2011
Scritto da: Tatiana De Rosnay
Cast: Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Niels Arestrup, Aidan
Quinn,
VENTO DI PRIMAVERA
1942. Estate. Dopo l’invasione da parte delle truppe della Germania hitleriana gli ebrei sono
stati prima obbligati a portare la Stella di David sugli indumenti, e poi sono stati
progressivamente esautorati dai loro impieghi e impediti ad accedere a scuole e luoghi
pubblici. Ma ora Hitler ha deciso di procedere allo sterminio di massa e vuole che il governo
collaborazionista insediato a Vichy gli procuri dalla sola Parigi almeno 20.000 dei 25.000 ebrei
residenti. I suddetti verranno dapprima condotti in campi di raccolta in territorio francese e
poi, una volta ultimati i lavori per i forni crematori nei lager, avviati a morire. Il maresciallo
Pétain aderisce senza difficoltà alla richiesta e la notte del 16 luglio (i tedeschi avevano chiesto
il 14 dimenticando la festa nazionale) la retata si svolge. Tredicimila uomini, donne e bambini
ebrei vengono prelevati dalle loro abitazioni e portati nel Vélodromo d’Hiver, prima tappa del
loro calvario.
Il punto di vista che il film assume è quello di alcuni bambini che vivono nel quartiere di
Montmartre e, in particolare quello del decenne Joseph. Vogliamo concentrarci sull’invito a
vedere il film superando l’atteggiamento che è stato purtroppo fatto proprio da alcuni di quelli
a cui il produttore Ilan Goldman si è rivolto perché partecipassero all’impresa. “È storia antica”,
“Non importa a nessuno”. Non è storia antica e la regista Rose Bosch è riuscita nell’intento di
farcela percepire come purtroppo attuale. Intendiamoci: tutto è filologicamente coerente con
l’epoca con cui si sono svolti i fatti. Fatti che il cinema francese non aveva mai affrontato con
tanta precisa e documentata forza se non in un documentario televisivo e che ora riemergono
come memoria del passato ma anche come monito sul presente.
La Bosch lavora su una tripartizione narrativa. Da un lato Hitler nel suo buen retiro del Berghof,
dall’altro Pétain, Laval e i loro accoliti e, nel mezzo, le famiglie ebraiche colte nella loro
quotidianità all’interno della quale sono stati inoculati ad arte (anche grazie al media più
diffuso all’epoca, la radio) i germi del più irrazionale ma efficace disprezzo per l’altro.
Alimentandolo con la ripetizione delle menzogne in modo da assuefare le menti all’idea della
‘normalità’ dell’emarginazione. Il film non accusa ‘i francesi’ tout court e anzi sottolinea il fatto
che se dei 25.000 ebrei 12.000 sono sfuggiti alla retata lo si deve a parigini che li hanno aiutati
mettendo a repentaglio la propria esistenza. Ma resta comunque impressa nelle retine la
gestione dell’intera operazione da parte di uomini che non indossano le divise delle SS o della
Wehrmacht ma quelle delle forze dell’ordine e militari francesi. Allora per quegli sguardi
infantili diventa ancor più difficile anche solo tentare di darsi una spiegazione di quanto
accade. Così quando si assiste alle scene delle migliaia di esseri umani ammassati con
pochissime cure e senz’acqua nel Velodromo non possono non tornare alla mente le immagini
dello stadio di Santiago del Cile dopo il colpo di stato di Pinochet.
Ma c’è un momento in cui si percepisce lo iato che si è insediato tra realtà e pregiudizio.
Quando il dottor Sheinbaum (interpretato da unJean Reno in cui solidità fisica e morale
formano un tutt’uno) grida dinanzi all’ennesimo sopruso: “Non ne avete il diritto!” è la
coscienza civile, è un’umanità vinta ma non piegata, è la Ragione che grida con lui. Ma in
quello stesso istante lo spettatore ‘sente’ che si tratta di un appello irricevibile da chi sta
dall’altra parte. Una parte per la quale la parola diritto ha perso qualsiasi valore, qualsiasi
possibilità di confronto in cui essa torni a individuare un senso che sia davvero comune.
Chiediamoci se questo svuotamento di significati fondamentali non abbia trovato anche nella
nostra società contemporanea una sua consistenza. Chiediamocelo riflettendo sulla risposta
che ci siamo dati e ringraziando questo film per avere suggerito la domanda
L’UOMO CHE VERRA’
Alle pendici di Monte Sole, sui colli appenninici vicini a Bologna, la comunità agraria locale
vede i propri territori occupati dalle truppe naziste e molti giovani decidono di organizzarsi
in una brigata partigiana. Per una delle più giovani abitanti del luogo, la piccola Martina,
tutte quelle continue fughe dai bombardamenti e quegli scontri a fuoco sulle vallate hanno
poca importanza. Da quando ha visto morire il fratello neonato fra le sue braccia, Martina
ha smesso di parlare e vive unicamente nell'attesa che arrivi un nuovo fratellino. Il
concepimento avviene in una mattina di dicembre del 1943, esattamente nove mesi prima
che le SS diano inizio al rastrellamento di tutti gli abitanti della zona.
Quella di Monte Sole (BO) è la più grave delle stragi fatte dalle truppe tedesche dopo l'8-91943: 771 civili (216 bambini) massacrati dalle SS tra il 22-9 e il 5-10-1944 per aver aiutato
i partigiani della Brigata Stella Rossa. Al centro del 2° film _ prodotto e diretto dal
bolognese Diritti dopo Il vento fa il suo giro _ c'è la bambina Martina che fa da filtro alla
vicenda storica. Da quando le è morto in braccio un fratellino, ha smesso di parlare. Tiene
un diario. Nel dicembre 1943, la sua mamma rimane ancora incinta: quando il fratellino
nasce in settembre, Martina s'impegna a salvarlo: è lui l'uomo che verrà. Il film si chiude
sulla ninnananna che lei gli canta. È un'altra storia di una comunità montana, ma in tempi
tragici. L'assillo del realismo spinge Diritti a far parlare le 2 attrici professioniste e gli altri
interpreti nel dialetto bolognese di allora. Un film sulla Resistenza così non si era mai
visto: senza eroi né eroismi, senza una divisione netta tra "buoni" e "cattivi", con un
impianto antropologico che diventa epico: la guerra raccontata dal basso, dalle sue vittime.
Non mancano gli spunti fantastici, un'ombra di fiabesco in una favola tragica. Non c'è
traccia di militari italiani della Repubblica di Salò. Il puntiglio di verità retrospettiva
permea la mobilissima fotografia di Roberto Cimatti e i costumi "invisibili" di Lia
Francesca Morandini. Come in Olmi, il senso del sacro è profondamente legato alla cultura
contadina e al rapporto con la Natura, ma con una netta dimensione femminile. Scritto con
Giovanni Galavotti, Tania Pedroni. Prodotto da Aranciafilm/Rai Cinema. 3 David di
Donatello: miglior film, produttore e fonico in presa diretta. Distribuito da Mikado. 200
giorni in cartellone al Mexico di Milano.
DALL’ALTRA PARTE DEL MARE
….Sono un essere umano, un essere umano, sono un essere umano che vuole vivere…un essere
umano. E' questo il grido disperato di Ka-Tzetnik 135633 nel suo libro dal titolo "Shiviti". E' la
storia di un sopravvissuto ad Auschwitz (Yehil De-Nur) con il numero marchiato nella carne del
braccio sinistro, arrivato all'estremo limite di degradazione umana che dopo 30 anni ha
accettato di rivivere l'esperienza del campo di concentramento con una terapia a base di LSD,
sottoponendosi a 5 sedute chiamate Cancelli della Memoria. E' uno dei due deportati di
Auschwitz nella messa in scena sulla shoah da parte di una compagnia teatrale, l'altra è Tosca
Marmor, ebrea-polacca intervistata all'inizio del film da Clara che aveva fatto un documentario
su di lei a Parigi, dove entrambe vivevano ed erano diventate intime amiche. Tutto comincia ai
giorni nostri quando Clara che vive ancora a Parigi, viene chiamata dal regista Abele a Roma per
collaborare a questa messa in scena. Si porta con sé il vecchio documentario girato nel '79 e
incontra altri attori che stanno provando. Insieme cercano di impostare i personaggi ma ben
presto sorgono dei contrasti tra Abele e Clara sul modo di fare la rappresentazione: lei vorrebbe
entrare dentro le esperienze singole, lui invece mantenere un tratto oggettivo. A Trieste dove
dovrebbe effettuarsi la messa in scena Clara ne approfitta per cercare suo padre scomparso
quando lei aveva 8 anni. Viene a sapere di un suo passato oscuro. Abele intanto cerca i luoghi
adatti per il suo teatro itinerante, ma non trova più i segni del passato e l'orrore provato
visitando San Sabba, lo fa desistere dall’impresa: non si può esprimere l'inesprimibile e neanche
rappresentarlo. Clara con il padre ritrovato riesce a lasciarsi alle spalle i suoi fantasmi e può
finalmente guardare dall'altra parte del mare…
GENERE: Drammatico
REGIA: Jean Sarto
ATTORI:
Galatea Ranzi, Vitaliano Trevisan, Viviana Di Bert, Alessandra Battisti, Fulvio Falzarano, Tony
Allotta,Paolo Summaria, Dino Castelli
DEFIANCE
Nel 1941 gli ebrei dell'Europa Orientale vengono uccisi a migliaia da nazisti. Tre fratelli polacchi
(interpretati da Daniel Craig, Liev Schreiber e Jamie Bell) riescono a sfuggire alla cattura
nascondendosi nei boschi della vicina Bielorussia, dove si uniranno alla resistenza russa e
costruiranno un villaggio che permetterà di salvare la vita a più di 1200 ebrei. Presto però tra
due dei tre fratelli scoppierà una forte rivalità per la leadership del gruppo che hanno costituito
mentre il terzo rimarrà nel mezzo di questa lotta intestina. Diretto da Edward Zwick, Defiance è
tratto da una storia realmente accaduta.
GENERE: Drammatico, Guerra
REGIA: Edward Zwick
SCENEGGIATURA: Clayton Frohman, Edward Zwick
ATTORI:
Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos, George McKay, Tomas Arana, Mark
Feuerstein,Allan Corduner, Jodhi May, Mia Wasikowska
OPERAZIONE VALKIRIA
1944: tornato in Germania dalla campagna d'Africa, dove è stato ferito gravemente, il colonnello
Claus von Stauffenberg, un aristocratico tedesco, si unisce alla Resistenza ed entra a far parte
dell'operazione Vakyrie, un piano che mira alla presa del potere da parte di un governo ombra
una volta morto Hitler. Von Stauffenberg assumerà un ruolo centrale nel piano: sarà proprio lui a
dover portare avanti il colpo di stato, uccidendo di sua mano il Führer. Il film è ispirato a fatti
realmente accaduti: il vero von Stauffenberg fu a capo di un piano – noto come il Complotto del
20 luglio – che mirava ad abbattere il nazismo e a porre fine alla guerra assassinando Adolf
Hitler.
GENERE: Biografico, Drammatico, Storico
REGIA: Bryan Singer
SCENEGGIATURA: Christopher McQuarrie, Nathan Alexander
ATTORI:
Tom Cruise, Kenneth Branagh, Carice van Houten, Eddie Izzard, Bill Nighy, Terence
Stamp, Thomas Kretschmann, Kevin McNally, David Bamber, Halina Reijn, David
Schofield, Werner Daehn, Christian Berkel, Matthias Freihof, Gerhard HaaseHindenberg, Jamie Parker, Florian Panzner, Manfred-Anton Algrang, Karl-Alexander
Seidel, Tom Wilkinson
HANNAH ARENDT
Hannah Arendt (id.)
Germania 2013, 113′
Genere: Drammatico
Regia di: Margarethe Von Trotta
Cast principale: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, Michael Degen, Ulrich Noethen
La filosofa ebrea Hannah Arendt, seguendo il processo di un criminale nazista a Gerusalemme, elabora le
teorie alla base del saggio “La banalità del male” che suscitano scalpore e aspre critiche per la loro
originalità nell’approcciarsi a un tema delicato come quello dell’Olocausto
Il titolo del film può trarre in inganno: non siamo infatti di fronte a una vera e propria biografia della filosofa
tedesca Hannah Arendt, ma al racconto di un preciso momento della sua vita, quello che va dal 1961 al
1964. Gli anni in cui la donna elaborò e pubblicò “La banalità del male”, celebre opera che contiene alcune
delle sue più originali e controverse considerazioni sull’Olocausto. Il film prende le mosse dalla cattura a
Buenos Aires del criminale nazista Adolf Eichmann ad opera del Mossad e dall’avvio del suo processo a
Gerusalemme per crimini contro l’umanità. Nel 1961 Hannah Arendt, ebrea tedesca scampata durante la
guerra a un campo di concentramento francese e poi trasferitasi a New York dove vive e insegna come
docente universitaria, è una stimata intellettuale, punto di riferimento per la comunità ebraica e non solo. Per
questo motivo il noto periodico New Yorker accetta la sua richiesta di assistere come inviata al processo che
lei considerava un’occasione unica per conoscere da vicino l’origine di quel male mostruoso che tanto dolore
aveva inflitto a lei e al suo popolo. L’immagine dell’ex gerarca nazista, accusato di essere uno dei principali
responsabili dello sterminio, è affidato a immagini di repertorio (già proposte una quindicina di anni fa da un
notevole documentario, Uno specialista – Ritratto di un criminale moderno di Eyal Sivan) che ne immortalano
l’atteggiamento impassibile dinnanzi alle accuse della corte, dalle quali si difende sostenendo di avere
solamente eseguito degli ordini dai quali era impossibile sottrarsi: nessuna richiesta di perdono, nessun
apparente pentimento, solo una serie di numeri e rimandi a sigle e carteggi, come se si stesse trattando di
merce e non di uomini condotti a una fine tragica. Un atteggiamento da impiegato, quello di Eichmann, che
stupisce la filosofa, che si era preparata a incontrare l’incarnazione del male ideologico, feroce e bestiale,
mentre scopre un uomo mediocre che “se ne sta seduto nella sua gabbia di vetro, ha pure il raffreddore e
parla da burocrate. È il nulla”. Questa considerazione diventa il cardine del suo pensiero e del lungo articolo
che scriverà per il New Yorker: il male introdotto in Occidente dal totalitarismo non è più radicale e profondo
ma frutto dell’opera di gente priva di pensiero che ha rifiutato di essere umana, non si spiega quindi con
l’egoismo di chi lo compie ma con la volontà di privare l’uomo di senso e di renderlo superfluo: la mediocrità
dei carnefici non coincide con la profonda malvagità delle loro azioni. Parte del suo resoconto, inoltre,
contiene un’aspra critica ai “capi” della comunità ebraica e alla loro commistione con i nazisti: se gli ebrei
non avessero avuto gerarchie, sostiene espressamente la Arendt, il numero di morti accatastati nei campi di
concentramento non sarebbe stato così alto. Si tratta di concetti duri da digerire per un popolo che ancora
sentiva bruciare le ferite della Shoah e che vedeva nella posizione della donna (già in passato criticata per la
sua relazione con il pensatore Martin Heidegger) un’assoluzione del criminale, quando invece la Arendt
condannò sempre fortemente Eichmann, ma fu solo colpevole di guardarlo da un punto di vista filosofico,
senza pregiudizi e sete di vendetta ma ponendosi delle domande per capire di più l’uomo e il senso del
male. Quando la rivista newyorkese, dopo diversi dubbi, pubblicò due anni dopo gli articoli (che costituirono
poi la base per il libro della Arendt), si levarono da più parti dure critiche e attacchi che portarono la reporter,
accusata di essere arrogante, priva di sentimento e nemica del popolo ebraico, a dover lottare contro amici e
nemici per affermare le sue idee coraggiose e originali. Lo stile didascalico, che pure a tratti risulta quasi
eccessivo per il suo rigore, ha il pregio di affrontare con chiarezza un tema delicato e di delineare
nitidamente i tratti di una donna acuta e risoluta (impersonata da un’ottima Barbara Sukova). E se mentre
poco incisive appaiono le finestre che si aprono sul passato della Arendt e del suo rapporto con Heidegger,
la sottile ironia che più volte affiora, specchio di un altro aspetto saliente della donna, riesce a rendere lieve il
tratteggiare un’importante pagina di uno dei più grandi drammi della storia.
Conspiracy: Soluzione finale (2001)
Titolo originale: "Conspiracy"
Durata | 96 min | Genere: Drammatico, Guerra, Storico, Olocausto
Regia: Frank Pierson |
Protagonisti: Kenneth Branagh, Clare Bullus, Stanley Tucci |
Trama: Il 20 gennaio 1942, sulle sponde del lago Wannsee, a pochi chilometri da Berlino, viene indetta una
riunione a cui prendono parte alcuni alti esponenti del partito nazista, ognuno in rappresentanza di un
ufficio, un'istituzione o un alto esponente del reich. A presiedere la riunione è il generale Heydrich, mentre
l'organizzazione e gestione dell'evento sono affidate al colonnello Eichmann. La riunione è stata indetta per
ordine di Hitler, e su mandato di Goering, per discutere la soluzione finale della questione ebraica.
Sunshine (1999)
Titolo originale: "Elle s'appelait Sarah"
Durata | 181 min | Genere: Drammatico, Guerra, Storico, Campi di concentramento
Regia: István Szabó |
Protagonisti: Ralph Fiennes, Rosemary Harris, Rachel Weisz |
Trama: Il film segue tre generazioni di una famiglia ebrea durante i cambiamenti nell'Impero AustroUngarico dall'inizio del XX secolo al periodo dopo la Seconda guerra mondiale. Il protagonista centrale di tutte
e tre le generazioni è rappresentato da Ralph Fiennes per mettere in evidenza il legame tra padre, figlio e
nipote.
Senza destino (2005)
Titolo originale: "Sorstalanság"
Durata | 140 min | Genere: Drammatico, Guerra, Storico, Campi di concentramento
Regia: Lajos Koltai |
Protagonisti: Marcell Nagy, Béla Dóra, Bálint Péntek |
Trama: Basato sul romanzo autobiografico di Imre Kertész, il film racconta la prigionia dello scrittore
ungherese ebreo deportato, da bambino, nei campi di concentramento di Auschwitz e Buchenwald. Quella che
era un'infanzia felice e spensierata si trasforma presto in una maturità dolorosa, vissuta in un vortice di
crudeltà e degenerazione.
La zona grigia (2001)
Titolo originale: "The Grey Zone"
Durata | 108 min | Genere: Drammatico, Guerra, Storico, Campi di concentramento
Regia: Tim Blake Nelson |
Protagonisti: David Arquette, Velizar Binev, David Chandler |
Trama: La zona grigia è un film di Tim Blake Nelson del 2001 in parte basato sul racconto "Auschwitz: A
doctor's eyewitness account" di Miklos Nyiszli. Nel famoso campo di concentramento ad Auschwitz si
sterminano numerosi ebrei. In esso sono operanti anche gli Sonderkommando, squadre particolare di
internati giudei che vengono costretti dagli aguzzini nazisti ad attendere al regolare funzionamento delle
camere a gas. Se si rifiutavano morivano, altrimenti avrebbero vinto qualche mese di vita in più. Nonostante
questo tentano di mettere in piedi una rivolta, la sola mai tentata nel campo
L'ultimo treno (2001)
Titolo originale: "Edges of the Lord"
Durata | 95 min | Genere: Drammatico, Guerra, Storico, Olocausto
Regia: Yurek Bogayevicz |
Protagonisti: Haley Joel Osment, Willem Dafoe, Liam Hess |
Trama: Ambientato a Cracovia durante l'occupazione nazista della seconda guerra mondiale, racconta la
storia di un bambino ebreo che viene nascosto come il nipote cattolico di un agricoltore locale, grazie anche
all'aiuto di un prete compassionevole.
L'ultimo degli ingiusti
Film (2013)
Data di uscita: 26 gennaio 2014 (Italia)
Regista: Claude Lanzmann
Durata: 3h 40m
Sceneggiatura: Claude Lanzmann
Cast: Claude Lanzmann, Benjamin Murmelstein
Nomine: Premio César per il miglior documentario
The Reader - A voce alta
Film (2008)
The Reader - A voce alta è un film del 2008 diretto da Stephen Daldry, adattamento cinematografico del
romanzo di Bernhard Schlink del 1995 A voce alta - The Reader. Il film è interpretato da Kate Winslet, Ralph
Fiennes e David Kross.
Data di uscita: 20 febbraio 2009 (Italia)
Regista: Stephen Daldry
Durata: 2h 4m
Musica composta da: Nico Muhly
Scritto da: Bernhard Schlink
Ogni cosa è illuminata
Film (2005)
Ogni cosa è illuminata è un film statunitense uscito nel 2005. Si tratta della trasposizione cinematografica
dell'omonimo libro autobiografico di Jonathan Safran Foer, in cui racconta il suo viaggio
Prima data di uscita: 16 settembre 2005 (Stati Uniti)
Regista: Liev Schreiber
Durata: 1h 46m
Scritto da: Jonathan Safran Foer
Musica composta da: Paul Cantelon, Sergey Shnurov
Perlasca - Un eroe italiano
Miniserie televisiva
Perlasca - Un eroe italiano è una miniserie televisiva che narra le vicende di Giorgio Perlasca.
Data di uscita: 28 gennaio 2002 (Italia)
Regista: Alberto Negrin
Durata: 3h 17m
Prima puntata: 28 gennaio 2002
Musica composta da: Ennio Morricone
Adam Resurrected
Film (2008)
Data di uscita: 27 gennaio 2010 (Italia)
Regista: Paul Schrader
Durata: 1h 46m
Musica composta da: Gabriel Yared
Scritto da: Yoram Kaniuk
Adam Stein è degente, in Israele, presso la clinica psichiatrica Seizling per il trattamento dei sopravvissuti
all’Olocausto. È un paziente particolare, con una certa influenza sugli altri ricoverati, soprattutto perché
sembra in grado di leggere nel pensiero e, per questa sua attitudine, impegna non poco l’equipe medica
guidata dal dottor Nathan Gross. A Berlino, prima della Seconda guerra mondiale, Adam era stato un
acclamato entertainer, proprietario di circo, illusionista e musicista, amato dalle folle come dai gerarchi
nazisti. Fino a ritrovarsi, un giorno, in quanto ebreo, deportato in un lager, a tu per tu con il comandante
del campo, il sadico Klein. Per resistere al lager, era diventato il “cagnolino” di Klein. Così facendo, però,
Adam non era riuscito a salvare dalle camere a gas la sua famiglia, cioè l’amata moglie e l’adorata figlia.
Quando, allora, nella clinica Seizling, scopre una cella segreta in cui è rinchiuso un ragazzo che si
comporta come un cane, il dolore esistenziale di Adam ritorna a farsi lancinante.
IL LABIRINTO DEL SILENZIO un film di GIULIO RICCIARELLI
Se in Germania nel '58 si fosse chiesto cos'era Auschwitz, nessuno avrebbe risposto. E non
per omertà. E' quello che racconta Il labirinto del silenzio di Giulio Ricciarelli, in sala dal 14
gennaio con la Good Film e candidato agli Oscar per la Germania. Un gran bel pezzo di storia,
poco conosciuta, che mostra le difficoltà di arrivare a quel processo che, nel '63, porto' in aula
211 sopravvissuti a Auschwitz e 19 Ss e, soprattutto, porto' una nazione alla coscienza di un
terribile recente passato. L'opera di Ricciarelli, milanese di nascita e tedesco d'adozione, tra film
di genere e inchiesta, vuole raccontare questa smemoratezza mettendo inevitabilmente in campo
tutti i temi legati alla Shoah: la responsabilità di chi partecipo' a quell'orrore, diviso tra
coscienza e dovere di soldato, le suggestioni del revisionismo storico, la banalità del male di
Hanna Arendt e soprattutto la volontà di un paese che, in fondo in fondo, non vuole davvero
sapere la verità. Protagonista un giovane pubblico ministero (Alexander Fehling) che, con
l'aiuto di un giornalista (Andre' Szymanski), s'imbatte in alcuni documenti che permettono di
avviare il processo contro i membri delle SS che hanno commesso crimini nei campi di
concentramento. La storia, basata su fatti reali, racconta appunto gli sforzi di quest'uomo, puro e
duro, per rompere la coltre di silenzio e assicurare i responsabili alla giustizia. Nel cast anche la
bella Friederike Becht, ragazza del giovane procuratore; Johann von Blow, collega del
procuratore; Johannes Krisch e la leggenda del teatro tedesco Gert Voss nella parte del Pubblico
Ministero Generale Fritz Bauer, vero motore dei processi di Auschwitz. ''Fritz Bauer - ha
spiegato il regista - è un po' un eroe dimenticato. Era il procuratore generale e, non a caso,
affido' la lista dei responsabili a due giovani colleghi perche' sicuramente non coinvolti nel
nazismo''. Sulla responsabilità di quell'eccidio, spiega ancora Ricciarelli:''non e' importante
quando si e' nati, prima o dopo Auschwitz. Anche se non si e' colpevoli resta comunque la
responsabilità di quello che e' successo allora''. Comunque da parte di neo-nazisti nessuna
minaccia durante la lavorazione del film e neppure dopo:''non abbiamo avuto nessun problema,
anzi abbiamo avuto aiuti dalla Stato e dalle forze politiche. Per quanto riguarda i neonazisti,
loro sono lontani dal mondo della cultura, non gli viene neppure in mente di ostacolare un film
cosi'''. La corsa agli Oscar? ''Certo anche per me e' un mito, ma il giorno in cui si sapevano le
candidature ho preferito spegnere il cellulare''. Comunque, ci ha tenuto a dire il regista:''non è
un film sulla Shoah, ma sulla Germania degli anni Cinquanta e anche un film su una memoria
dimenticata. Su Der Spiegel, per fare solo un esempio, il racconto di quegli anni ha occupato
ben cinque pagine e invece solo poche righe per Il labirinto del silenzio'''.
Scarica