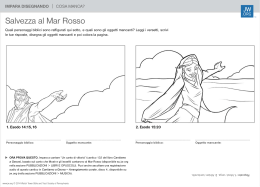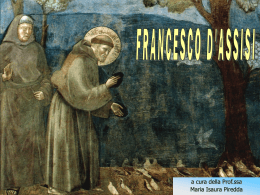Anno XLIV | Dicembre 2011 ORGANO DI STAMPA DELLA RICERCA CRISTCATTOLICA “ Dio è morto ” “Dio è morto” aveva detto Nietzsche più di un secolo fa. Mai come in questo momento storico salta agli occhi la Sua mancanza. Il cristianesimo ridotto a pura dottrina ininfluente nella vita di ciascuno. Eppure mai come in questo momento la gente sente il bisogno di un ‘salvatore’ capace di garantirla rispetto ad un futuro oltremodo incerto, di proteggerla da un orizzonte su cui si addensano nubi che annunciano tempeste non solo economiche e che mettono in risalto la precarietà della sua esistenza. Appiattirsi sul quotidiano lasciandosi trascinare dal vortice degli eventi senza chiedersi il perché o rinchiudersi nella cerchia degli amici senza alzare lo sguardo sul mondo che ci circonda, sono tentazioni legittime, ma non gratificanti per tutti coloro che si dichiarano esseri umani. Nelle storie dell’Antico Testamento, quando il popolo incontrava momenti di pericolo, Dio mandava i suoi profeti per ammonire, esortare, ricondurre gli uomini sulla retta via, ma se Dio non esiste più a chi rivolgersi? L’illuminismo e il conseguente sviluppo scientifico molto si sono prodigati per lo smascheramento dei pregiudizi e per liberare gli uomini dalle superstizioni e dalla paura. il dialogo dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 1 Questi movimenti hanno però condotto gli uomini verso un sempre maggiore materialismo e al delirio di onnipotenza misurato esclusivamente sulla capacità individuale di accumulazione economica. Sparito ogni senso di trascendenza, altri idoli hanno preso il posto di Dio e l’altro, non più prossimo, è diventato il potenziale nemico. Negata la religione ‘oppio dei popoli’, polverizzata l’etica laica, abbattuta ogni ‘credenza’ basata su abitudini e tradizioni, il mondo è diventato il deserto in cui si aggirano fantasmi assetati di dominio, il dominio inteso come strumento per confermare la propria esistenza. Giustamente gli uomini hanno voluto affrancarsi da ogni principio di autorità sentita come soffocante già dal cinquecento, ma sono diventati perciò più adulti e maturi? Già nel settecento Kant aveva sostenuto che “l’illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso”. Quanta strada dobbiamo invece ancora percorrere per raggiungere la consapevolezza di essere spiriti incarnati bisognosi gli uni degli altri, quanto lavoro ci attende per sviluppare la coscienza che da ben altro dipende il senso di sicurezza e di serenità che non dall’appropriazione infinita di capitali, quanta sofferenza per capire che l’oltre è una realtà che possiamo costruire insieme attraverso il perdono, la faticosa accettazione del diverso, la fiducia in se stessi e negli altri e l’impegno personale e comunitario? Ma quando Cristo tornerà, troverà la fede? Antonia Dagostino 1 dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 2 il dialogo “ Cerchiamo una religione di autorità o siamo pronti per una religione di chiamata? ” Marcel Légaut, professore di matematica alle università di Renne e Lyon, ha abbandonato questo campo di ricerca per dedicarsi alla ricerca religiosa. Egli, da laico, distingue tra religioni d’autorità e religioni di appello (o di invito, di chiamata). Le religioni d’autorità considerano la verità come un patrimonio soltanto da custodire, difendere. Vedono gli uomini come gregge da dominare, sottomettere. Per arrivare più sicuramente - e senza rischi - allo scopo, si appoggiano al potere e tendono a condizionare la società (mantenendo legami di complicità con qualsiasi autorità costituita). Ogni cambiamento viene considerato come una minaccia alla loro vocazione immobilista e conservatrice. Ogni dissenso eliminato, ogni critica giudicata una mancanza di fedeltà. Hanno le risposte già confezionate per qualsiasi problema. Non devono più cercare. Si sentono incaricate soltanto di dare, fornire, non ricevere. Detengono le chiavi, e non hanno bisogno di farsi aprire da nessuno. Preferiscono semmai, quando è il caso, «sfondare». Il fedele viene costruito dall’esterno (comportamenti, pratiche, regolamenti rigorosi). Viene minuziosamente indottrinato su tutto ciò che deve fare ed evitare (moralismo, divieti, imposizione di fardelli insostenibili). La religione di chiamata, invece, mette l’uomo in piedi, ne fa una creatura di movimento. Si rivolge alla coscienza e sollecita la libera e gioiosa adesione degli individui. Costruisce l’uomo dal di dentro. Lo risveglia, lo sollecita, gli apre gli occhi... e la bocca, gli dà fiducia, stimola la sua creatività, lo responsabilizza, gli fa intravvedere le sue possibilità. Gli dice ciò che è, ciò che può essere, ciò che è chiamato a diventare, più che ciò che deve fare. Insomma, è una religione liberatrice. Mentre la religione d’autorità è statica, ripetitiva, l’altra è dinamica, sempre sorprendente. Abramo, «nostro padre nella fede», è un modello ineguagliabile di una religione d’appello. La sua vicenda diventa lo specchio in cui sia Israele che la Chiesa devono confrontarsi. Abramo scopre che Dio ha l’abitudine di fuggire in avanti. Il «paese» che Dio gli indicherà è avanti, è un “dentro di sé”, non indietro. Per cui il desiderio deve avere la meglio sul ricordo nostalgico, l’attesa anticipatrice sui mugugni o i piagnucolamenti, la fantasia sulla memoria, la speranza sulla nostalgia, le aperture profetiche sulle recriminazioni. Osserva Snoopy, il celebre cane dei fumetti di Charles Schulz: «Un’intera montagna di ricordi non uguaglierà mai una piccola speranza». Dio è il Dio della promessa, non del rimpianto. Dobbiamo imparare a sospirare «verso», piuttosto che sospirare voltandoci indietro. Il «mal di strada» deve lasciare il posto al «gusto della strada». Occorre smetterla di sfogliare le cipolle (come si sfoglia 2 l’album dei ricordi) per spremere qualche lacrima nostalgica. (Sarà per questo che sono allergico alle cipolle?) Le cipolle, più che farci piangere, dovrebbero farci ridere. Il credente è uno che, come Abramo, ogni giorno decide di incamminarsi. Guardiamoci dentro, intorno, avanti. E’ giunto il momento di voltare qualche pagina? Adesso basta guardare con nostalgia al passato senza la fede di poter vivere il presente con l’aiuto di Cristo. Ci accontentiamo di far parte di una religione di autorità o ci sentiamo parte di una religione di chiamata? Paolo Iotti “ Tu cosa vuoi ” Una sera a cena con amici, parlando degli argomenti più svariati, mi sono accorta del fatto che più volte sia stata usata la parola “volontà”: volontà di fare qualcosa , volontà di cambiare, volontà di risolvere una data situazione. La volontà, dice il dizionario, è la disposizione ad agire in un certo modo, la propensione; la capacità di decidere e agire in modo da raggiungere il proprio scopo. Ogni giorno le scelte fatte possono essere messe in discussione e in ogni momento dobbiamo intraprendere quel viaggio all’interno di noi stessi che ci permette di prendere una decisione. Diventa importante capire dove nasca la nostra “volontà”: la scelta fatta è stata presa in modo autonomo, valutando attentamente quello che è il proprio pensiero, i propri valori, la propria inclinazione e sensibilità, oppure la decisione è stata influenzata da altri, dal pensare comune o dall’etica. Siamo capaci di fare scelte che siano veramente nostre, indipendentemente dal fatto che possano sembrare impopolari o andare contro a quello che è il pensiero, le aspettative di che ci vive accanto? Mi viene in mente a questo proposito quel brano che dice: “Il Signore disse ad Abram: “Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. 2Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione.” (Gen 12, 1-2) La prima cosa che Dio dice ad Abramo è “lech lechà”, che vuole dire “vai a te, a te stesso”, “vai dentro di te”, vai verso la tua interiorità profonda(1). Dio invita Abramo ad iniziare un viaggio che porta alla scoperta di se stesso, di chi sia veramente coi propri pregi, e i propri difetti, doni e capacità, mettendosi in un atteggiamento di ascolto verso se stesso, prendendo le distanze da genitori, da parenti, da figli e da tutte quelle persone che possono influenzare il suo modo di pensare, le sue decisioni. È una presa di coscienza che diventa necessaria per poter crescere, maturare e per non essere vittime di frustrazioni e invidia. La parola chiave in questo caso è: silenzio. dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 3 il dialogo In ebraico “Ra” significa “male” ed è la radice della parola “Ra’ash” che significa “rumore”: il male, quindi genera rumore, mancanza di armonia e di equilibrio. È la confusione che si crea nella mente a causa di quell’enorme vociare di pensieri che si ripetono costantemente e incessantemente senza lasciare un momento di pausa, un momento di silenzio, impedendo così di riuscire ad entrare realmente in contatto con se stessi, perché quella che si percepisce altro non è che l’immagine che si vuole dare del proprio io. Il silenzio è quel vuoto che può far paura, perché lì incontriamo noi stessi per come siamo realmente, ma è anche quel momento di vuoto che permette di ascoltare e accogliere la Parola di Dio, quel momento di vuoto che permette di ascoltare e accogliere gli altri. È Dio stesso che ci indica la via da seguire e la prima cosa da fare è abbandonare l’egoismo e quello stato di chiusura in sé stessi in cui ci si ritrova quando, da un lato si pensa di non aver bisogno di nessuno, dall’altro si ha talmente paura di affrontare il mondo che si preferisce rimanere chiusi nel proprio “orticello” per paura di essere feriti. Dio aiuta a vincere quella povertà d’animo che si genera quando i pensieri e le preoccupazioni sono rivolti solo a se stessi e al proprio benessere materiale e a quella sorta di quieto vivere che deriva dall’uniformarsi al pensiero comune, al modo di vivere della società, senza indagare su noi stessi. Solo indirizzando i pensieri e la mente verso Dio si può cambiare direzione abbandonare l’egoismo e la ricerca del proprio benessere volgendo lo sguardo verso gli altri. Passiamo quindi dall’egoismo all’altruismo; dal pensare di non aver bisogno di nessuno allo sperimentare la propria povertà, o per meglio dire, la propria umiltà, al sentire di dover chiedere aiuto perché le proprie forze non ce la fanno. È un invito a prendere coscienza del proprio IO, delle proprie reali capacità, dei propri limiti e difetti. È uno stimolo a intraprendere il cammino che permette di elevare noi stessi dalla mediocrità. Tale crescita è possibile se lasciamo aperta la porta del nostro cuore a Dio perché possa entrare e ri-creare noi stessi ogni giorno, e noi dobbiamo fidarci di Lui. Dobbiamo voler compiere il cammino che ha disposto per noi e non lasciarci fermare dalle nostre paure, dalla pigrizia o dall’apatia. Dio ci invita a camminare, a crescere, ad accogliere i doni dello Spirito Santo e lasciare che questi ci trasformino. A fare silenzio per poter ascoltare la Sua Parola, per accoglierla e irradiare la sua Luce. Grazie a questo percorso di crescita, o di “ri-creazione” da parte di Dio, la nostra vita si riempie di novità, di nuovo coraggio, di volontà e sicurezza, si riempie dell’essenza di Dio. A noi la scelta: aprire la porta che conduce dentro noi stessi e dare voce e speranza ai nostri sogni e desideri oppure lasciarla chiusa rinunciando ad essi? Laura Bondioli (1) da Il Dialogo, dicembre 2005: “Ascolto: da dove cominciare” di Paolo Iotti “ Disfunzioni pulsorie ” “Abiti del male”, così Aristotele più di 2300 anni fa, usava definire quelle alterate inclinazioni di taluni individui a ripetere eccessivamente determinati tipi di azioni, tanto da crearsene un modus vivendi. Nell’antica Grecia questa costante pratica di ciò che è male o viene ritenuto tale, altrimenti definita vizio, andava a interferire con l’armonico andamento sociale, costituendosi come un chiaro oltraggio alle leggi civili. Con il diffondersi del Cristianesimo, viene, però, a operarsi una sostanziale trasformazione nell’interpretazione del vizio: il comportamento vizioso non si contrapponeva più semplicemente alle leggi civili, ma andava a ostacolare il cammino individuale verso il divino. Nel IV secolo, l’eremita nel deserto, Evagrio Pontico, fu il primo a stilare una lista di eccessi cui un monaco non doveva abbandonarsi per non intralciare il proprio percorso di purificazione e purezza verso Dio. Enunciando “gli otto spiriti di malvagità” (gola, lussuria, avarizia, tristezza, ira, accidia, vanagloria, superbia), Evagrio abbozzò quella che, in seguito, sarà propagandata come la dottrina dei vizi capitali, dove il termine “capitali” andava a sottolineare quelle disdicevoli azioni (vizi, appunto), da cui si riteneva nascessero tutti gli altri peccati.(1) Questo sistema di riferimento venne, in seguito, riconfermato da un discepolo di Evagrio, Giovanni Cassiano, che riconobbe nell’evitamento dei vizi capitali un processo di purificazione personale, coinvolgente anima e corpo, che trova la sua spontanea conclusione allorché il monaco raggiunge il completo controllo di sé, dei suoi impulsi e desideri. In tale contesto è chiaro che i comportamenti viziosi non interessano le situazioni relazionali dell’uomo nella società, ma solo i rapporti con se stesso e con Dio, segno di un’etica puramente individuale. La dottrina dei “peccati capitali” ebbe, però, inizio con Papa Gregorio Magno (VI secolo), il quale, operando una modifica della vecchia enumerazione, unì la tristezza all’accidia e aggiunse l’invidia: il numero dei vizi elencati nella lista rimase otto, ma con uno schema di 7+1, considerato che il pontefice riconosceva la superbia come la radice di tutti gli altri. L’ottica morale, qui, si allarga assumendo nel contempo anche una valenza più collettiva: i vizi non denotano più solo i possibili smarrimenti di chi ha voluto intraprendere un cammino spirituale verso Dio (il monaco), ma squilibri interiori che possono accadere in ogni singolo uomo. Nel 1215, dopo che il Concilio Lateranense IV sancì, per i fedeli, l’obbligo della confessione annuale, si rese necessaria una classificazione e una conoscenza più dettagliata dei peccati: fu in questo clima che il sistema “septenario”(2) di Gregorio Magno conobbe il suo successo: andando ben al di là delle sue iniziali intenzioni, il modello gregoriano venne, così, a costituirsi come un vero e proprio proto- 3 dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 4 il dialogo collo, necessario ai confessori per interrogare i “peccatori” e ai penitenti per rendere conto delle proprie “colpe”. Il septenario gregoriano impose il suo trionfo tardo-medievale sicuramente grazie alla sua semplicità, versatilità, facile rappresentazione iconografica ed efficace capacità tassonomica; nel contempo si distinse come un valido strumento che, rintracciando nella moralità individuale l’origine di tutte le mancanze, permetteva di identificare i “peccati” consumati nel segreto della propria vita interiore con una chiara ripercussione sulla scena comunitaria. La teoria dei vizi capitali, tende, qui, a tradire il sapore di una morale spiccatamente sociale, con cui regolamentare soprattutto i comportamenti e le relazioni degli uomini con gli uomini, lasciando, però, in penombra la dimensione spirituale del singolo. Lentamente, però, il septenario iniziò a conoscere il proprio declino. Nel riconoscergli una generale incompletezza nel descrivere esaustivamente l’universo del male, già nel corso del XIII secolo si accentuarono i tentativi di classificare i peccati in diversi modi e soprattutto il perno dell’etica cristiana iniziò a riconoscere nel peccato una violazione della legge e della giustizia divina. Quello che, qui, ci preme considerare non è tanto la natura dei peccati e i modi per poterli efficacemente identificare(3) quanto rivalutare lo schema dei sette vizi capitali come strumento per diagnosticare gravi alterazioni nell’equilibrio dell’unità mente-corpo-spirito di ogni singolo uomo. Se ripercorriamo la storia del “protocollo” sui sette vizi capitali, non può sfuggire come questo sia passato da essere uno strumento per favorire la propria ascesi al divino (Evagrio e Cassiano), a un’immediata sintesi per interpretare e migliorare il proprio mondo interiore (Gregorio Magno), a un maneggevole prontuario per sanzionare i comportamenti sociali peccaminosi degli uomini. Pur con approcci e finalità differenti, lo schema dei vizi capitali, sia in Evagrio-Cassiano che in Gregorio Magno riguarda una dinamica psicologica-individuale tipicamente introspettiva, mentre acquista una dimensione di alto spessore relazionale, teso a regolare i comportamenti sociali. Ogni comportamento relazionale inadeguato, prima di essere palesato, trova la sua origine in un mal-andamento sistemico, interno all’individuo. Quante volte ci comportiamo in modo sgarbato o inappropriato nei confronti del prossimo, solamente perché siamo nervosi? Molto spesso non siamo nemmeno così consapevoli che molte nostre “cattive azioni” siano la manifestazione di qualcosa che in noi stessi non sta operando come di dovere: il funzionamento di molti dei nostri apparati (endocrino, nervoso, digerente…) influenza spiccatamente la nostra vita di relazione. Il più delle volte gli squilibri nei nostri rapporti interpersonali hanno una dimensione di transitorietà, ma può, altrimenti, accadere che diventino dei veri e propri schemi comportamentali consolidati nella personalità dell’individuo. Nel momento, in cui possiamo escludere disfunzioni organiche croniche a carico dei sopraccitati sistemi, possiamo andare a verificare la funzionalità di un altro “apparato”: quello psicologico. Immaginiamo di trovarci di fronte a un individuo che abitualmente si rapporta in modo litigioso con le persone, ci dovremmo sicuramente chiedere se qualcosa, nel suo sviluppo psicologico, non si sia incespicato. 4 Magari ha condotto una vita infantile in cui ha conosciuto solo soprusi o ha odorato un clima famigliare violento o è stato vittima di vessazioni in ambienti amicali o sono frutto di un trauma più o meno consapevole o sono espressione di un insano rapporto con una figura genitoriale o … Ciò che stiamo, in quel momento, tentando di rintracciare sono alterazioni tipiche dell’assetto psicologico. Come abbiamo, però, più volte sottolineato anche in altre sedi l’essere umano è “un’indisgregabile unità mente-corpo-spirito e ogni alterazione in ciascuna di queste sue componenti avrà necessariamente ripercussioni sulle rimanenti, destabilizzando l’armonia del tutto”(4): alterazioni organiche possono determinare un risvolto psicologico e, viceversa, sofferenze psicologiche possono creare disfunzioni fisiche. L’unità umana non sarebbe completa se non considerassimo anche un terzo e importantissimo fattore, strettamente interrelato con i due precedenti: il sistema energetico. Ci siamo già, altrove, occupati di quest’ultimo sottolineando che i suoi componenti sono dei “pulsori”(5), responsabili del movimento dell’energia propria di ogni individuo, instradata in particolari canali (i meridiani). Abbiamo, inoltre, specificato che esiste uno svariato numero di questi “pulsori”, tra cui se ne distinguono molti secondari e solo sette principali. Fin dalla nascita l’individuo si affaccia sul mondo già corredato di tutti questi pulsori funzionanti, compresi quelli principali, che, però, non vibrano tutti, fin dall’inizio, al completo della propria potenzialità. “Ogni periodo della vita evolutiva è determinato da una maggior attività di un centro pulsore rispetto agli altri, secondo un ordine che procede dal primo all’ultimo. Molto spesso può accadere che si rimanga ancorati all’attività predominante di un centro pulsore per un lungo periodo della vita, a volte persino tutta un’esistenza, senza lasciare che gli altri centri trovino la loro più completa espressione o, ancora più frequentemente, si può assistere a un alterato funzionamento di uno o più centri, creando disarmonie o vere e proprie patologie”(6) sia sul piano organico, psicologico e spirituale. I comportamenti viziosi di cui ci stiamo, qui, occupando sono proprio espressione di alterazioni o, meglio ancora, di “fissazioni” energetiche nel consueto sviluppo di uno di questi pulsori: la supremazia esercitata da un pulsore sugli altri condiziona e determina la manifestazione delle azioni e del comportamento dell’individuo. Quando abbiamo a che fare con una persona che, nelle sue relazioni, “indossa abiti di avarizia, lussuria…”, possiamo dire che sta soffrendo di una malattia dello spirito. Ma andiamo a scorrere più in particolare questi squilibri, individuando, per ciascuno di questi, il malfunzionamento del pulsore corrispondente. - Grazie al nostro primo pulsore, noi iniziamo, fin dalla nascita, a relazionarci con il mondo esterno e a trarre da questo la soddisfazione dei nostri primordiali istinti di sopravvivenza. Rafforzando man mano la capacità di esprimere i nostri bisogni, acquistiamo sicurezza in noi stessi, affermiamo la nostra posizione nel mondo e produciamo, un senso di armonia fisico-mentale nei confronti di ciò che ci circonda. Se lo sviluppo di questo pulsore incontra, però, qualche difficoltà nella realizzazione del proprio percorso, creando fissità energe- dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 5 il dialogo tica, potremmo veder estrinsecato il primo “abito vizioso”: l’avarizia. L’avaro è colui che, non riuscendo mai a soddisfare i propri bisogni ed essendo divorato da un irrefrenabile desiderio di beni temporali, maschera la propria insicurezza nell’accumulare cose materiali solo per il gusto di farlo e senza averne reale necessità. L’inettitudine ad avere controllo su stesso lo induce a sostituirla con la capacità di aver potere sulle cose, andando inevitabilmente incontro a una depersonalizzazione; ama a tal punto le cose possedute che dimentica di amare non solo gli altri, ma soprattutto se stesso. Tutto questo lo conduce a vivere una realtà relazionale fatta di finzione e rapporti interpersonali superficiali, tentando di mimetizzare il proprio “vizio” con opere generose e nobiltà d’animo. - Se il nostro secondo pulsore non ha incontrato gravi impedimenti al raggiungimento del suo equilibrio, ci farà sentire bene con noi stessi, facendoci sperimentare accettazione e consapevolezza del nostro corpo e della nostra identità di genere e ponendoci nella condizione di instaurare relazioni emotive sane e positive. Al contrario, se il suo sviluppo è traumatizzato tanto da essere “bloccato”, l’individuo sperimenta un sentimento di paura nella conoscenza di se stesso e inizia a oggettivare il suo disagio focalizzando la sua attenzione sul proprio corpo e su quello altrui, giungendo a interpretarlo come unico mezzo di confronto col prossimo. Ci troviamo, qui, di fronte a un individuo lussurioso, sempre torturato da un’insaziabile brama di piacere fisico, che reputa come unico stimolo capace di porlo a contatto con se stesso e con gli altri. Nel condurre la sua esistenza, sempre alla ricerca di esperienze e relazioni che gli donino l’immediatezza del piacere sessuale, non conseguendo mai, suo malgrado, l’appagamento della sua smania ed essendo, per questo, condannato a soffrire per ripetute delusioni, incontra il vuoto dietro alle cose, non riuscendo ad assaporare l’essenza della vita. - Il raggiungimento di un positivo carattere volitivo, di un adeguato livello di autostima e di capacità decisionale avviene quando il terzo pulsore ha portato a termine la sua crescita. Come per gli altri pulsori, in genere, il suo sviluppo avviene in modo abbastanza armonico, anche se talvolta la realizzazione finale può non essere sempre così completa ed esaustiva come si vorrebbe. Quando, però, il suo percorso viene notevolmente arrestato da fattori endogeni o esogeni, il suo funzionamento reitera sempre la stessa dinamica: quella di procedere verso l’appropriazione del controllo su stessi senza mai pervenire al suo ottenimento. Non riuscendo ad avvertire la soglia di una simile conquista, l’individuo inizia a incamerare quanto più gli è possibile dal mondo esterno e gli alimenti diventano un mezzo per tentare di realizzare la “pienezza” di sé. Ci troviamo di fronte alla personalità del goloso(7), il quale è condannato a sperimentare, sempre, una sensazione di appagamento alquanto effimera e transitoria. Non conoscendo mai la sazietà, il goloso è in continua ricerca di qualcosa da ingurgitare che gli conceda soddisfazione, ma questa spasmodica necessità gli rivela la sua incapacità di avere potere su se stesso: si perpetua, così, un inarrestabile circolo vizioso. - Quando il nostro quarto pulsore non ha incontrato grossi intralci alla sua piena realizzazione, noi siamo in grado di sentirci in pace con noi stessi, godere di un positivo livello di autostima e siamo, di conseguenza capaci di provare empatia, accoglienza, amore, pietà e comprensione per il prossimo. Ma se il traguardo “della buona immagine di sé” non è raggiunto appieno e il livello di autostima risulta scarso o comunque inadeguato, l’individuo può sviluppare un persistente e radicato sentimento di profonda sofferenza per non possedere cose, che altri posseggono e lui no, o un concitato desiderio che altri perdano cose che anche lui stesso possiede(8): siamo di fronte al vizio dell’invidia che condanna la persona a una vita, imperniata sul “rovinoso” confronto con gli altri. - Un quinto pulsore che abbia ottenuto il suo equilibrio ci apre alla “comunicazione”, ovvero ci pone nella favorevole condizione non solo di ascoltare sé stessi e il prossimo, ma anche di concretizzare un’interazione di tutte le nostre potenzialità discernitive, qualitative e direttive, facendoci, nel contempo, sperimentare la partecipazione all’energia divina. Ma se lo sviluppo di questo pulsore rimane incastrato nella sua dinamica, entrando in un circolo imperfetto, ecco affacciarsi il pericolo dell’insinuarsi della superbia. Questo è il vizio per il quale il soggetto, catapultato in un mondo interiore, in cui conosce solo amore esagerato per se stesso e una convinzione di superiorità assoluta sul prossimo, viene indotto a sperimentare disprezzo per qualsiasi genere di regola o legge: l’individuo non si percepisce più solo come partecipe della stessa energia divina, ma sentendosi a sua volta un Dio, non ammette di dover ulteriormente completare il suo cammino. La sostanziale differenza tra gli altri vizi e questo è proprio insita nel fatto che in tutti gli altri “stati energetici alterati”, la persona è consapevole di essere vittima di un malfunzionamento interno a sé e per questo prova sofferenza e conflitto interiori, mentre nella dimensione di superbia, l’individuo non avverte minimamente la propria inabilità, ritenendo che siano gli altri a essere disagiati e difettosi. - Dobbiamo al fatto di aver conquistato uno stato di equilibrio del sesto pulsore, la possibilità di entrare in pieno contatto con noi stessi, corroborando, nel contempo, la nostra capacità concentrativa di trasformazione e purificazione dei nostri pensieri, nonché l’opportunità di addentrarci in stati meditativi e mistici,. Al contrario, se la persona non è riuscita in questo suo intento creando in questa dinamica fissità energetica può sviluppare quello che è comunemente conosciuto come il vizio dell’ira. Quest’ultima condizione, da non confondersi con il sentimento più o meno transitorio della rabbia, è caratterizzata da un’alterata condizione psichica: l’iracondo è un individuo che non è più in grado di calibrare con ponderatezza le sue scelte né di tollerare le possibili conseguenze negative di queste. Stazionando in una situazione di non raggiunta consapevolezza di sé e, per tale motivo, non essendo in grado di maturare un positivo grado di autocontrollo, l’iracondo vive costantemente in una contingenza di profonda avversione verso qualcosa, qualcuno e/o verso addirittura sé stesso, divorato da un incessante desiderio di vendicare il suo disagiato stato d’animo. 5 dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 6 il dialogo - Il nostro viaggio di esseri umani non sarebbe completo se non riuscissimo anche almeno a lambire una più profonda conoscenza di noi stessi per assaporare quella tranquillità spirituale, in piena armonia con l’espressione dell’amore divino. Se l’essere umano si arrendesse all’evidenza del reale, disdegnasse l’impegno verso una maggior conoscenza di sé, accettando di aver conquistato già tutto nel suo percorso di vita, in poche parole se si negasse la possibilità di una continua “ricerca” interiore conoscerebbe senza alcun dubbio l’ultimo dei vizi capitali: l’accidia. Questo stato di torpore e di indifferenza verso sé e verso tutto è una condizione estrema, in cui si incontrano depressione, noia, scoraggiamento, abbattimento…: è lo smarrimento più totale, che un uomo possa mai conoscere! Cristina Caroppo (1) si noti come la lista dei comportamenti viziosi da evitare sia qui rivolta ai monaci, ovvero a coloro che, rinunciando al mondo, intendevano instradarsi sul viatico di purificazione ed espiazione per avvicinarsi a Dio (2) un sistema basato sulla potenza e consacrazione del numero sette, teologicamente utilizzato per designare la perfezione dell’eternità: sette le virtù, sette i doni dello spirito santo, sette le beatitudini…) (3) in altra sede ci siamo occupati del peccato e del modo in cui poterlo interpretare: Il Dialogo, giugno 2008: “Qual è la tua colpa ?” di Cristina Caroppo (4) da Il Dialogo, giugno 2011: “Forza terapica dei Sacramenti” di Cristina Caroppo (5) il termine “pulsore” è altrimenti conosciuto, secondo la dicitura orientale, come “chakra” (6) da Il Dialogo, giugno 2011: “Forza terapica dei Sacramenti” di Cristina Caroppo (7) si può esprimere la propria golosità indiscriminatamente verso ogni alimento o verso un particolare e determinato cibo o ancora verso una bevanda (vino, liquori….) (8) l’invidia può non essere necessariamente indirizzata verso cose materiali ma anche doti fisiche, caratteriali, spirituali.. “ E Dio disse: «Facciamo l’uomo (adam) a nostra immagine,a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo…». Dio creò l’uomo a sua immagine: a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. L’amore tra l’uomo e la donna ” Una parola ha detto Dio due ne ho udite Salmo 62, 12 Il Cantico dei Cantici ha 8 capitoli e 117 versetti: la sua stesura si colloca tra il sec. VI e IV a. C., lo si attribuisce a Salomone, ma l’estensore è probabilmente un oscuro poeta che ha attinto a fonti già esistenti e molto antiche. Quasi certamente il testo proviene dalla Mesopotamia o dall’Egitto paesi dove vigeva la ierogamia, ovvero il matrimonio sacro o sigizia, congiunzione tra due divinità, insomma i famosi riti della fertilità che si celebra- 6 vano in primavera per rinnovare la vita umana e rigenerare la Natura. Il testo molto diffuso e sentito a livello popolare venne inserito nella tradizione biblica profetico-sapienziale dopo un lungo processo di rielaborazione. Il libro ha sempre suscitato imbarazzo presso la classe sacerdotale e i teologi. Nel campo ebraico fu Rabbi Shalomon, Ben Isaac, meglio conosciuto con l’acronimo Rashiv, a dare un’interpretazione letterale al Cantico e a leggere la Scrittura tenendo presente il versetto del salmo 62: “la Scrittura in quanto parola di Dio ospita molti sensi ed è irriducibile a un unico senso, e questo giustifica i molti midrash ( midrash significa “cercare”, cercare il significato attuale di un testo).“ Rashiv rende profetico il Cantico e lo contestualizza nella storia del popolo Ebraico. Israele è in esilio, ma il suo legame con Dio è indissolubile ed per questo che piange la sua separazione da Dio - suo Sposo - come una vedova che piange il marito vivente ma separato, lontano. Non è stata ripudiata e suo marito ritornerà da lei. Anche i commenti cristiani seguiranno questa traccia. Mentre la tradizione ebraica si è preoccupata di risalire al senso teologico del Cantico, affinità con la tradizione profetica, i cristiani vedono il Cantico attraverso 1 Cor. (gelosia) e Ef. 5 (rapporto sponsale tra Cristo e la Chiesa).(1) Il Cristianesimo riprese dall’ebraismo l’interpretazione allegorica del Cantico per giustificarne la canonicità; il dialogo Dio-Israele venne riveduto e corretto come rapporto Cristo-Chiesa, ovvero, interpretato come amore spirituale, e tutto ciò per mascherare quelle che sono in realtà espressioni prettamente materiali: ovvero un gioco d’amore tra due innamorati. Anche se il poema insiste sulla passione sconvolgente dei due amanti, il tutto è inserito in un contesto “sacrale”. Il Cantico celebra l’amore e lo pone al centro dell’esistenza cosmica, poiché Dio è il Tutto e l’Uomo, adam,è fatto ad immagine di Dio, quindi è parte del cosmo e partecipa al divenire del cosmo: Gn 1,26s Il Libro dello splendore o Zohar riconosce nel Cantico l’intera rivelazione di Dio: «Questo cantico comprende tutta la Torah; comprende tutta l’opera della creazione; comprende il mistero dei Padri; comprende l’esilio d’Israele in Egitto e il canto del mare; comprende l’essenza del Decalogo e il patto del monte Sinai e il peregrinare d’Israele nel deserto, fino all’ingresso nella terra promessa e alla costruzione del Tempio; comprende l’incoronazione del santo nome celeste nell’amore e nella gioia; comprende l’esilio d’Israele fra le nazioni e la sua redenzione; comprende la risurrezione dei morti fino al giorno che è il sabato del Signore» (Libro dello splendore. Teruma 144°).(2) Nella tradizione cristiana il Cantico gode di una stima non minore: «Beato chi comprende e canta i cantici della dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 7 il dialogo Sacra Scrittura -afferma Origene-, ma ben più beato chi canta e comprende il Cantico dei Cantici» (Omelia sul Cantico l,l: Pg 13,37). Attraverso l’uso dell’interpretazione allegorica, tutto il Cantico appare come un paradigma del Cristo: così, l’Amato che viene saltando sopra i monti di Ct 2,8 è riconosciuto sin dal primo commento cristiano come «il Verbo, saltato dal cielo fin nel corpo della Vergine, dal sacro ventre sul legno della Croce, dal legno negli inferi, di là nella carne (della risurrezione)... infine, dalla terra al cielo» (Ippolito di Roma, Commento al Cantico, XXI, 2). Le descrizioni del Cantico vengono interpretate come metafore della vita della Chiesa: «Se tu senti nominare le membra dello sposo, cerca di capire che in realtà sono evocati i membri della Chiesa» (Origene, Commento al Cantico, libro II, su Ct). (4) Muovendo dal Cantico sviluppa la sua riflessione sui gradi della «violenta carità» Riccardo di San Vittore, combinando genialmente teologia ed esperienza spirituale per sottolineare come il rapporto d’amore con Dio non lasci nessuno come lo ha trovato, ma al contrario segni in modo indelebile la sua anima: «Grande è la forza dell’amore, meravigliosa la potenza della carità» (I quattro gradi della violenta carità, 2). Al Cantico si ispira la mistica cristiana, celebrando il rapporto d’amore con Dio: basti pensare ai versi di San Giovanni della Croce: «In una notte oscura / con ansie di amor tutta infiammata, / o felice ventura!, / uscii, né fui notata, / stando già la mia casa addormentata. / ... / Notte che mi guidasti! /oh, notte amabile più che l’aurora / oh, notte che hai congiunto / l’Amato con l’amata / l’amata nell’Amato trasformata» (San Giovanni della Croce, Noche oscura, Strofe l e 5).(3) Eloquente e ispirativo nelle più diverse stagioni della tradizione ebraico-cristiana, il Cantico continua a parlare anche oggi: «Questo – afferma Guido Ceronetti – è un Cantico di oggi, per il presente, per servirgli restando quel che è, un punto lontano» (Il Cantico dei Cantici, Adelphi, Milano 1975. 2005, 114). E aggiunge: «Colpisce la somiglianza delle sue parole coi gradi più alti del silenzio; è una musica cessata in ogni suo suono, che affiora come pura memoria» (115). La forza evocativa per ogni uomo, per ogni tempo, di queste poche parole (1250: 117 versetti), continua a essere riconosciuta: «Per esprimere l’Assoluto in una visione umana è bastato questo arco breve» (115).(4) A riportare il Cantico nella sua dimensione umana come canto puramente amoroso, ci pensano, tra gli altri, due teologi: Brevard S. Childs, teologo anglicano e Vito Mancuso, teologo “scomodo” per il cattolicesimo. Il primo sostiene senza mezzi termini che il Cantico “non appartiene al genere midrasico. Non interpreta un altro testo, ma si ricollega piuttosto in maniera diretta all’esperienza umana dell’amore.” Quindi non si può intendere il Cantico allegoricamente come descrizione dell’amore di Dio per Israele o per la Chiesa, ma piuttosto “espressione sapienziale, sia testimonianza di una presenza reale dell’amore carnale nell’universo dell’umana esperienza.”(5) Mancuso, in una conferenza tenuta il 3 giugno 2007 nella Sinagoga di Casale, senza mezzi termini stronca il “goffo tentativo” operato dalla Chiesa e dall’Ebraismo di allegorizzare il testo riconducendolo al concetto di agape, ovvero a una sorta di amore di benevolenza, di amore universale, in modo da giustificare l’interpretazione del Cantico come amore tra Dio-Israele e Cristo-Chiesa. L’amore vissuto tra i protagonisti del Cantico, prosegue Mancuso, è eros, pura tensione erotica, Questo, solo questo, è il messaggio del Cantico. Basta considerare quanto sia presente il corpo, soprattutto nelle parti che sono oggetto delle attenzioni amorose: bocca, seni, curve dei fianchi, ventre, gambe. E poi un diluvio di carezze, baci, persino facendo uso di vino aromatico (8, 2) e afrodisiaci (riferimento alla mandragola in 7, 14).(6) Il Cantico, quindi celebra un momento di estasi terrena, di gioia carnale vissuta in modo innocente e per niente consapevole del peccato che in questo poema non è nemmeno adombrato. Uno scambio senza inibizioni d’amore e di energie vitali che, a mio avviso, pone il rapporto amoroso tra uomo e donna nell’immenso divenire della forza cosmica. Mario Matera Frassese (1) A. ZANI, Il Cantico dei Cantici, esegesi, teologia e mistica nei primi commenti cristiani: Origene e Ippolito. Corso di storia della teologia (2) BRUNO FORTE, Il Cantico dei cantici: La più bella canzone d’Amore, in “FIDAE” (3) Idem. (4) Idem (5) BREVARD S. CHILDS, Teologia dell’Antico Testamento in un contesto canonico, Edizioni Paoline, Torino 1989. (6) VITO MANCUSO, Erotismo e amore: il Cantico dei Cantici, Intervento nella Sinagoga di Casale, 3 giugno 2007. “ La montagna luogo ” di incontro con il sacro L’uomo ha da sempre avvertito il fascino misterioso del sublime e vissuto le più svariate forme di estasi. Uno degli spazi del pianeta dove si possono provare simili ebbrezze ed incanti è senza dubbio la montagna. Radicate nell’uomo, ci sono generali motivazioni antropologiche che hanno portato all’identificazione dei luoghi sacri: la montagna, la grotta, la foresta, la sorgente che sono così diventate sedi privilegiate del sacro. La montagna e la spiritualità ad essa legata ha da sempre assunto moltissimi significati nella storia delle idee, delle credenze e della produzione letteraria. La montagna con la sua natura spesso incontaminata diventa luogo preferito per il colloquio con l’eterno, per un rapporto con la dimensione del divino, per cui l’uomo, salendo, è, tra l’altro, portato alla meditazione ed alla riflessione spirituale. Il monte così può significare ascesi, distacco dal materiale, e simboleggiare la tensione dell’uomo verso la divinità che abita i cieli. E’ per questo che 7 dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 8 il dialogo tradizioni religiose di tutte le culture e di tutti tempi, alimentate da una inesauribile fantasia, hanno conferito a tante montagne un senso ed un valore sacro, spazio di un possibile legame tra cielo e terra. Tutte le culture hanno ritrovato nel profilo verticale della montagna un’immagine della tensione verso l’oltre e l’altro rispetto al limite terrestre e tutte le religioni vi hanno letto un segno dell’Oltre e dell’Altro divino. Alcune religioni ed alcuni popoli, poi, con le loro credenze, hanno immaginato ed immaginano le cime delle vette proprio come la residenza della divinità. La montagna con il suo potente carico simbolico ha, in ogni tempo, ispirato una sterminata produzione letteraria e pittorica. La cima di un monte quasi ci obbliga anche fisicamente ad alzare gli occhi verso l’alto là dove ha sede l’invisibile, l’irraggiungibile, il trascendente. Con queste premesse si può tentare di comprendere anche perché l’uomo esplora le montagne, le sale a volte in condizioni ambientali e climatiche estreme sino al rischio della vita. Forse è proprio la dimensione della ascesa che consente, seppure allo stato inconscio, la ricerca dell’Assoluto. L’uomo nell’ascendere lascia il peso della materialità, della monotonia, della quotidianità, e forse ha l’intuizione del mistero che abita nell’Alto, nell’Oltre; ne prova struggente desiderio, ne assapora l’insopprimibile bisogno. E’ lassù sul monte che si sperimenta la contemplazione, anche tra fatica e sofferenza, che permette di uscire da sé per conoscere l’Altro. Nella Bibbia la montagna è luogo della presenza di Dio, quindi della bellezza, del silenzio meditativo, della perfezione e della prova. Si fa così simbolo dell’elevazione dell’uomo. Oggi, così pieni e sicuri del nostro sapere scientifico, sorridiamo di tutto ciò, ma chi è più attento alla nostra umana avventura sente con nostalgia che il perdersi allo sguardo di un fulmine a ciel sereno poteva essere, e perché no, la coda di un drago incastonata da innumerevoli diamanti; la forma di una nuvola il volo di un animale fantastico; l’urlo del vento il lamento senza posa delle anime dei defunti; le frane, le valanghe, i crolli delle torri, la punizione della divinità offesa. E l’asciugarsi di una fonte lo scherzo di uno gnomo; il tremore delle foglie degli alberi, i giochi degli elfi; il prosciugarsi dei laghetti o la scomparsa di un pastore la cattiveria delle streghe. Le montagne con le loro vette che si innalzano verso il cielo appaiono la dimora visibile del Dio invisibile, la cui maestà è nascosta dalle nubi. La fede biblica, a differenza di altre che finiscono per “divinizzare” il monte, afferma però con fermezza il primato di Dio su tutto il creato e quindi anche sui monti. Per la religione ebraica e la cristiana il monte è sacro perché in quel luogo, dove si immagina più vicino il creato al Creatore, è meno difficile l’adesione a Dio: la montagna con la sua natura spesso incontaminata è luogo privilegiato per il colloquio con l’eterno, con ciò che non si può vedere e non si può dire, con il più profondo della nostra anima per un rapporto con la dimensione del divino, pensiamo ai monasteri, agli eremi ai luoghi di silenzio in Dio. Nella Bibbia il Monte, è un luogo dove si svolgono avvenimenti speciali, rivelatori, è luogo di particolare vicinanza di Dio, Mosé, la trasfigurazione, le beatitudini, la 8 crocifissione e Dio stesso è identificato come montagna rocciosa e come rocca, (salmo 17: “Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. luogo inaccessibile di rifugio; terreno solido su cui costruire fortezze, sicurezza protettrice in cui appoggiare la propria esistenza”). Lo sguardo rivolto verso l’alto è lo sguardo rivolto a Dio. Quando Mosé col suo gregge giunge al monte Horeb e vuole vedere da vicino il prodigio del roveto ardente, Dio gli dice: Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. Ma anche noi salendo sulle nostre montagne con il salmista possiamo dire: “Salmo 121 (120): “Alzo gli occhi verso i monti: da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto è dal Signore che ha fatto cielo e terra” (vv. 1-2). Ecco che ancora con la bibbia si può dire “ Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli della cerva e sulle alture mi fa camminare. (Abacuc 3,19) Fa’, o Signore, che non perda mai il senso del sorprendente. Concedimi il dono dello stupore! Donami occhi rispettosi del tuo creato, occhi attenti, occhi riconoscenti. Signore, insegnami a fermarmi: l’anima vive di pause; di stupore; di attese, insegnami a tacere come le tue montagne tacciono e ascoltano; solo nel silenzio si può capire ciò che è stato concepito in silenzio. Vittorio Cappozzo RACCONTIAMOCI Riflessioni, emozioni, storie di vita e… quant’altro “MI RICORDO DI VITANGELO” San Mauro Torinese, 25 febbraio 2010 Cara Maria Pia, mi rivolgo a te, perché ho bisogno di un interlocutore per tirare fuori dal baule della memoria la gran massa di pensieri che mi tormenta, in questo periodo. Tu sei stata vicina a Vitangelo per molti anni, forse più anni di quanto lo abbia frequentato io, sua sorella. Non ho assistito agli ultimi penosi giorni della sua vita. Lilli e Corrado ne sono stati sconvolti. Sempre la morte di qualcuno ci turba profondamente; forse perché non possiamo fare a meno di pensare alla “nostra” morte. E non ci prepariamo ad essa mai abbastanza, perché “non sappiamo il giorno e l’ora”. Certo, quando il 22 maggio scorso sono andata a trovarlo a Milano, ero così sottosopra, che invece di leggere “Ospedale S.Paolo” la prima cosa che vidi fu:“Camera mortuaria”. Mi ricordavo di quando andammo, Giovanni dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 9 il dialogo ed io, al Policlinico di Bari e, invece di trovare Giulia ancora viva, fummo inviati all’obitorio. Per fortuna, invece, a Milano, trovai Vitangelo ancora vivo, ma irriconoscibile. E dire che Fiorenza, che l’aveva incontrato a Molfetta, mi aveva già descritto, con profondo dolore, le gravi trasformazioni del suo aspetto. Per fortuna potei, in quell’occasione, parlare abbastanza con lui. Mio fratello mi raccontò, con le lacrime agli occhi, di quel bambino del Togo, nato prematuro, che era riuscito a salvare, creando una rudimentale incubatrice. Riscaldò la coperta dell’aereo col ferro da stiro e insistette per ore e ore in quell’operazione. Poi mi fece vedere i suoi scritti, un po’ autobiografici, un po’ di fantasia, con i quali cercava di spiegare agli altri e forse a se stesso, come gli era venuto il grande amore per l’Africa. Lo lasciai, pregandolo di non farmi lo sgarbo di andarsene prima di me, perché toccava a me, dopo Chiara e Maria, di lasciare questo mondo ed io avrei voluto vivere ancora per un bel po’. Si mise a ridere e così ci lasciammo. Nel periodo successivo, gli ho mandato ogni giorno un trattamento REI-KI a distanza. Si tratta di una canalizzazione di energia, sulla quale lui era piuttosto scettico. Già qualche tempo prima, quando andava da Graziella la sera, in un periodo in cui aveva avuto dei seri problemi, glielo avevo fatto sperimentare. Mi diceva, tanto per accontentarmi quando io insistevo per conoscere le sue reazioni, che sentiva una gran cappa di sonno che gli calava addosso (la stessa reazione che ho io) e che però dopo si sentiva “rigenerato”. Comunque considerava troppo “mistico” questo genere di cose. Ho avuto, in seguito, il piacere di sentire la sua voce al telefono con un volume quasi normale. Anzi mi telefonò lui – cosa che non faceva quasi mai – per raccomandarmi di non fare la vaccinazione antinfluenziale, perché, sia io che lui eravamo già immunizzati. Lo rassicurai, ero già convinta della cosa. Poi mi parlò con entusiasmo di una nuova cura per l’osteoporosi, grazie alla quale sentiva che le sue vertebre si erano rafforzate. Qualche giorno dopo fui io a richiamarlo, per conoscere il nome preciso di quei medicinali e ancora sentii un bel timbro di voce. Pensai, con sollievo, che forse la migliorata atmosfera familiare stava dando i suoi frutti e che probabilmente avrebbe potuto reggere ancora per un bel po’. Dopo tutto mio padre era vissuto fino ad 88 anni. Ma si tratta di cose che “sono scritte in cielo” e la morte è un mistero, cara la mia Pia. Quando penso a Vitangelo, senza volerlo, non posso non pensare a me. E’ una sensazione che forse ho sempre provato, ma le ultime vicende mi hanno fatto riflettere molto sulle situazioni della nostra famiglia. Ogni tanto ne parlo con le figlie: io mi sento la “versione femminile” di questo mio fratello. Un poco sento la stessa cosa anche con Corrado, ma molto meno. Era con le mie sorelle che avvertivo “la grande distanza”. Una volta Chiara, infastidita da alcune mie considerazioni, mi chiese: ”Ma a te, chi ti ha educato?” Non sapevo cosa rispondere. Mi ero educata da me, pensavo, prendendo modelli di comportamento qua e là, dove li trovavo. Mi modellavo su mio padre, piuttosto che su mia madre. La condizione femminile mi sembrava troppo triste e limitata. Ho fatto una fatica enorme a riconoscere, negli ultimi tempi, che era un bene per me essere nata femmina ed è un lavoro che sto ancora facendo. Tu sai che da noi c’è un proverbio: mala nottata e figlia femmina, cioè al danno della mala nottata, si somma quello di avere una figlia femmina. Per tutto questo io sentivo il mio stato come una menomazione. Ti ho già raccontato che la mia nascita non fu accolta con gioia. Le condizioni economiche erano tristi; mia madre, con tre figli sulle spalle, fu costretta a lasciare un lavoro che le piaceva moltissimo e di cui parlava con molta nostalgia. Lei insegnava dattilografia nella Scuola tecnica di Molfetta e ricordava i suoi “discepoli” che ancora la salutavano con piacere quando la incontravano. La mamma, poi, sentiva dolorosamente la perdita del primo figlio, il primo Vitangelo. Aveva i capelli ricci – ci diceva - e intanto nel cimitero indicava il luogo dove l’avevano seppellito. Era successo questo: era fresca sposa e, timida e pudibonda com’era, quando ebbe la perdita delle acque, non ne parlò con nessuno e rimase ad aspettare per qualche giorno. Mio padre si disinteressò della cosa, anzi – lei diceva – quando ebbe sentore delle prime doglie, scappò via di casa. Probabilmente, più che egoismo, fu la paura della sofferenza altrui a farlo comportare così. Quando il bambino nacque, ”era tutto viola” e morì subito. A tuttora mi chiedo come mai non intervennero in quel caso altre donne, le sorelle di mia madre per esempio, ma non so molto di quella vicenda. In seguito il babbo si rammaricava di avere dichiarato il bambino come “nato morto”, perché in realtà per un attimo era vissuto. Il fatto è che le famiglie numerose, durante il fascismo, erano premiate con uno sgravio delle tasse. Con sei figli, quanti eravamo noi, si pagavano mezze tasse, con sette, le tasse non si pagavano più.. Quando nacque Vitangelo, io avevo due anni e mezzo. Si vede che la cosa mi colpì molto, nonostante la giovanissima età. Ricordo ancora un grande canestro di cavolfiori e cime di rape che i colleghi di mio padre, che allora lavorava alla Singer, gli mandarono, al posto dei fiori, per congratularsi della nascita dell’attesissimo figlio maschio, futuro ingegnere. Un altro ricordo, abbastanza netto, è quello dei miei nonni paterni, venuti a vedere il neonato. Il nonno Vitangelo era seduto sulla poltrona, che adesso si trova nella camera di Nicola, figlio di Fiorenza. Il tutto era abbastanza eccezionale, e credo che cominciò per me allora il periodo, tipico in questi casi, della gelosia per “l’intruso”. Per questo, quando Vitangelo mi raccontava, nella mia visita a Milano, che la mamma lo chiamava “mon cadeau”, cioè “il mio regalo”, non ho potuto fare a meno di avvertire, a livello profondo, un certo disappunto. La mamma non ne faceva parola con gli altri figli; forse capiva che questa denominazione non ci avrebbe fatto piacere. D’altronde lei era troppo delicata ed attenta a ciascuno dei suoi sei figli. Quando penso a mia madre e all’ambiente rozzo e ignorante da cui proveniva, sento per lei una grande ammirazione e amore. Evidentemente il periodo passato tra le 9 dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 10 il dialogo Figlie della Carità di S.Vincenzo de’ Paoli, all’incirca dai sei ai diciassette anni, l’aveva profondamente segnata. Lei amava la cultura, non per farne vanto, assolutamente e ci dava degli insegnamenti di carattere religioso, molto vissuti. Un amico di Corrado l’ha definita, molto correttamente, come madre “premurosa e vigile” e tale era. Ma torniamo a Vitangelo, da lei tanto amato. Io mi accorgevo di queste preferenze, ecco perché i rapporti col fratello più vicino sono stati per me sempre ambivalenti. Lui mi attraeva e nello stesso tempo, mi infastidiva. Io ammiravo le sue imprese, che erano sempre un po’ arrischiate, ma intanto sentivo che tutte le sue “uscite” venivano tollerate con benevolenza, mentre le mie no. Non era ammesso che una bambina facesse le stesse cose che possono fare i maschi, ecc. ecc. Quando si è trattato di intraprendere gli studi, io ho dovuto conquistarmi con fatica il diritto di andare oltre la media inferiore, lui no. Il babbo era convinto che per le donne bastasse il diploma di terza Avviamento e così Chiara, Maria ed io abbiamo frequentato quella scuola, che era un vicolo cieco. Il suo amico, Celestino Panunzio, che viveva a Milano, gli diceva che una ragazza che avesse studiato contabilità, dattilografia e francese, poteva stare ottimamente in un negozio e il progetto paterno era quello: avere tutti i figli nel negozio. Il quale progetto non era molto accettato da noi ragazze. Chiara, per esempio, aveva avuto a scuola ottimi voti e voleva continuare a studiare; si vide invece impedita nelle sue aspirazioni, perché era la figlia grande e in casa serviva il suo aiuto. Maria fece la sua piccola guerra di indipendenza e dopo essere stata avviata, senza troppo successo, da una sarta, nostra vicina di casa, riuscì, con esami da privatista, ad entrare nell’istituto magistrale e fu meglio per lei. Io riuscii, sotto il suo esempio, ad entrare da privatista nella quarta ginnasiale e poi a continuare gli studi nel liceo classico, per fortuna. I miei fratelli non conobbero tutte queste difficoltà e ricordo che io consideravo il tutto con un certo risentimento. Mi dispiace di dover dire queste cose mentre Vitangelo non è più presente. Dei morti – si sa – bisogna dire solo bene. Ma purtroppo sto facendo ancora pulizia dentro di me di tante piccole sconfitte, di tanti ricordi non sempre positivi. Ci sono, certo, per fortuna, bellissimi episodi: per esempio, quando andavamo al Pulo, luogo che forse avrai conosciuto. Si tratta di una grande voragine, dovuta al carattere carsico della Puglia, sulle cui pareti si aprono grotte in cui abitavano, nel periodo neolitico, uomini preistorici. Vitangelo non aveva paura ad avventurarsi nei meandri di queste grotte; io lo seguivo con una certa perplessità: non mi sono mai piaciuti i luoghi oscuri, le cantine, i sotterranei e cose simili. Però ammiravo molto il suo coraggio e la sua intraprendenza. In seguito mi è piaciuto di più avventurarmi nei “meandri dell’animo umano”, ma per quanto abbia tentato di renderlo mio compagno di ricerca, non ci sono riuscita. Non aveva l’abitudine di parlare della propria interiorità, come quasi tutti gli uomini, del resto. Tutti e due avevamo in comune una grande curiosità, anzi una curiosità che direi “insaziabile” ed invincibile. 10 Certe volte mi viene in mente che sant’Agostino la chiamava “vana cupiditas”, cioè una inutile cupidigia, ma non riesco ancora a liberarmene. Eppure sarebbe tempo che anch’io facessi i conti con l’età che avanza e che mi richiama piuttosto ai doveri di “mettere ordine” tra le cose che in tanti anni ho accumulato. Ma torniamo a Vitangelo.. La mamma, dicevo, stravedeva per lui. Sognava di vederlo medico, gli ricordava l’esempio del dottor Giuseppe Moscati, che da poco è stato fatto santo. Quanto avrebbe gioito per quello che lui ha fatto nel Togo! Per quest’ultima vicenda della sua vita, sento di aver contribuito anch’io a certe scelte. Studiavo a Milano, grazie – devo ricordarlo con riconoscenza – all’aiuto economico di mia sorella Maria, che già lavorava come maestra. Mi capitò tra le mani un opuscolo di un Istituto padovano, il CUAMM, Centro universitario medici missionari. Sapevo che Vitangelo voleva fare medicina e che da piccolo sognava Capitan Matamoro e altri personaggi dei fumetti che andavano in Africa a uccidere i leoni. Il Cuamm ospitava con tariffe vantaggiose i giovani che volevano avventurarsi su questa strada. Ne parlai in famiglia e Vitangelo si iscrisse a Padova; in seguito, non ricordo per quali motivi, terminò i suoi studi a Ferrara. Nel frattempo io ero alle prese col matrimonio, figli, concorsi ecc..e ci siamo persi un po’ di vista. Le notizie mi venivano da Chiara, che stravedeva anche lei per il fratello e continuava l’abitudine materna di scusarlo e giustificarlo sempre, qualunque cosa facesse. Io avevo troppe gatte da pelare, tra concorsi, malattie di mia suocera, figlie da allevare e via di seguito. Tra le sorelle, ero probabilmente la più staccata da lui e penso che così lui mi percepisse. Perciò mi prendeva un po’ in giro, come gli altri, nelle riunioni familiari, nelle quali le mie uscite erano occasioni di grandi risate, ma sentivo che di me temeva un certo giudizio. Senza dire che accanto a me c’era Giovanni, che, come ricordi, era ipercritico nei confronti della mia famiglia e che notava tante cose su cui io cercavo di stendere un velo pietoso. Per tutto questo, quando tu mi riferisti la sua frase: “Se potessi incontrarmi con Liliana!”, decisi lì per lì di andare a Milano, benché non fossi molto in forma e ci fosse un caldo eccezionale per quella stagione. Cioè sentii che dovevo superare tutte le mie difficoltà interiori e mettermi in treno. Veramente era da tempo che il pensiero di mio fratello mi tormentava. Da quando Fiorenza mi aveva riferito del suo aspetto tanto deformato e lei ne era rimasta sconvolta. Le ricordava la nonna Marta degli ultimi tempi. Mi andavo dicendo che forse, in assenza delle mie sorelle che sapevano provvedere a tante cose, io dovevo prendermi qualche responsabilità. Ero ormai la figlia maggiore. Mi assillavano le frasi evangeliche: “Se non ami il fratello che vedi, come puoi amare Dio che non vedi?” e l’altra: “Chi dice ‘raca’ (sciocco) a suo fratello, andrà nel fuoco della geenna”. Veramente questa seconda frase già da quando ero piccola mi impressionava. Possibile che per un peccato così piccolo si doveva andare nel fuoco della geenna? E a chi non è capitato di dire ad un fratello o ad una sorella “Quanto sei scemo!”? dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 11 il dialogo In seguito ero rimasta impressionata dal discorso del dottor Andrea Penna, (quello che cura con le costellazioni familiari), a proposito dei contrasti tra fratelli e sorelle. Egli ricordava che, mentre coi genitori noi abbiamo un patrimonio genetico del 50 %, coi fratelli abbiamo dal 70 all’80 % di contributi genetici, perciò le liti tra i fratelli sono le più micidiali. Quindi chi non ama suo fratello non ama se stesso. Quando parlai al medico della faccenda della geenna, lui mi confermò che la Scrittura aveva ragione. Insomma dovevo riconciliarmi interiormente con mio fratello. Tornando a parlare di Vitangelo, una sua buona qualità è che sapeva stare con i bambini. Infatti i nipoti, comprese le mie figlie, si entusiasmavano molto quando potevano stargli vicino. Ricordo sempre la grande quantità di pietre che, assieme a Teresa e Gianluca, loro raccolsero, girando per la campagna, alla ricerca di “cocci” che avessero una parvenza di antichità. Insomma stare con lui era un continuo divertimento. Naturalmente “vivere la vita come gioco” non è stato molto comodo per chi gli stava accanto e doveva affrontare i piccoli e grandi fastidi di una famiglia abbastanza numerosa. E qui mi sento coinvolta anch’io, che – come dicevo – da questo punto di vista, mi sento molto vicina a mio fratello. Ancora ho nelle orecchie i rimproveri di Giovanni, il quale non ammetteva che una donna potesse far propria una simile regola di vita e successivamente, anche le figlie hanno fatto le loro rimostranze per le mie manchevolezze. (per la verità, quando anche loro hanno sperimentato le difficoltà dell’essere madri, hanno addolcito alcuni giudizi nei miei confronti). Che altro dirti, cara la mia Pia? Dovrei scriverti tante altre cose , ma mi fermo; questa è una lettera-fiume. Ho sempre sentito per te molta simpatia. Ho ammirato la tua capacità di lavoro quando affrontavi tutti i problemi casalinghi, compresi quelli degli animali che Vitangelo ti scaricava tranquillamente, come faceva con nostra madre. Forse ora non hai animali in casa, spero. A proposito dei quali, in famiglia, solamente mio padre ed io e forse, tra i nipoti, Silvio, figlio di Donatella, prendiamo le dovute distanze. In famiglia, tutti stravedono per gli animali. Non so se piacciono anche a te o se li hai semplicemente sopportati Mia madre se li sarebbe messi nel letto, se il marito glielo avesse permesso. Da questo punto di vista io apprezzavo la dedizione e la pazienza con cui ti facevi carico di tutti i problemi familiari e... zootecnici. Forse ora hai diritto ad un po’ di riposo e ad un po’ di tempo da dedicare a te e a Gian. Dopo tutto, ad una certa età, bisogna cominciare a tirare i remi in barca e vivere secondo le proprie antiche aspirazioni. Fare ciò che per mille motivi, non si è potuto fare da giovani. Per fortuna hai un buon compagno. Sono stata contenta di aver potuto parlare con lui (per la verità lo avrò subissato di parole, in quei pochi giorni in cui sono stata a Sirmione). Forse più in là riprenderò tutti questi ricordi che sono un po’ disordinati. Ora vorrei farti giungere il mio scritto quanto prima. Come ho già detto, parlare di Vitangelo mi tormenta non poco. Sono stata felice di avere trovato i tuoi figli tanto legati alla famiglia. Ho fatto proprio un “bagno” di affetto familiare. Sei veramente riuscita a “fare l’Unità d’Italia”. Che bellezza! Addio, cara, spero di vederti quanto prima. Abbraccia per me Gian ed i tuoi ragazzi. Un grosso bacio. Liliana Gadaleta Minervini ATTIVITÀ DI COMUNITÀ Dal mese di novembre, la Comunità di Minervino di Lecce, si riunisce ogni giovedì presso l’Oratorio di tutti i Santi per incontrarsi ed incontrare la Parola. CONDOGLIANZE … e nel cammino della vita, un altro compagno di viaggio si è ricongiunto al Divino. Giannetta Umberto, nostro caro confratello, membro da sempre della C.V.C.I., persona amata e stimata da tutti, si è spento Lunedì 5 Dicembre. A nome di tutta la Comunità Vetero-Cattolica Italiana, esprimiamo alla famiglia le nostre più vive condoglianze e fervide preghiere. BUON NATALE “…Amerai il prossimo tuo come te stesso”(Mt 22,39). Che ogni cuore possa riassaporare il gusto genuino di sentirsi in armonia con se stesso e con il prossimo. A voi tutti, fratelli: Buon Natale! Per l’occasione, ci è gradito segnalarvi una piccola, ma preziosa pubblicazione, ultima fatica di Giuseppe Giulino, autore di tante altre opere da noi apprezzate e divulgate: “Signore dacci sempre questo pane” (editrice: Ancilla). dialogo_DIC_2011_DEF_Layout 1 25/01/12 11:19 Pagina 12 il dialogo Direttore Resp. Dr.ssa Cristina Caroppo Reg. 233 Trib. RE Redaz. Missione Cristcattolica Direz. e Amm. Via Matteotti, 27 42019 Scandiano (RE) Sito internet: www.chiesaveterocattolica.it e-mail: [email protected] Stampato da: Lisanti srl
Scaricare