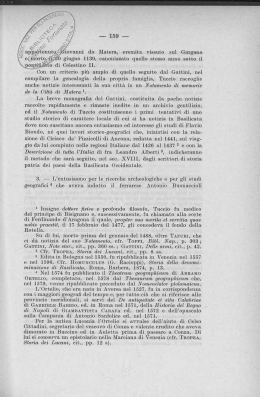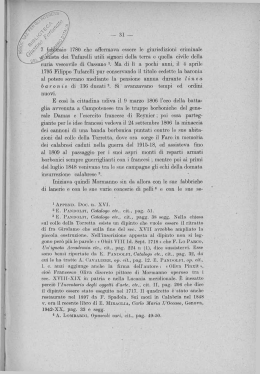L’Ellisse L’Ellisse Comitato scientifico: Guido Baldassarri (Padova), Francesco Bausi (Cosenza), Concetta Bianca (Firenze), Sebastiano Gentile (Cassino), James Hankins (Harvard), Yasmin Haskell (Western Australia), Giuseppe Langella (Milano Cattolica), Marc Laureys (Bonn), Frances Muecke (Sydney), Silvia Rizzo (Roma «La Sapienza»), Claudio Scarpati (Milano Cattolica), Maria Antonietta Terzoli (Basilea). Redazione: Stefano Benedetti, Giuseppina Brunetti, Maurizio Campanelli (dir.), Giuseppe Crimi (segr.), Silvia Finazzi, Maurizio Fiorilla (dir.), Carlo Alberto Girotto, Paola Italia, Gianfranca Lavezzi, Paolo Pellegrini, Maria Agata Pincelli, Emilio Russo (dir.), Valerio Sanzotta, Massimiliano Tortora (dir.). L’Ellisse Studi storici di letteratura italiana Anno VIII/1 2013 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER L’Ellisse, VIII/1 Studi storici di letteratura italiana Copyright 2014 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER Via Cassiodoro, 19 - Roma www.lerma.it - [email protected] Tutti i diritti riservati. è vietata la riproduzione di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore. L’Ellisse : studi storici di letteratura italiana. - 1(2006)- . Roma : «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2006 .- v. ; 24 cm Annuale ISSN 1826-0187 CDD 21. 850.5 1. Letteratura italiana - Periodici Sommario Saggi e note Monica Berté, Tracce della biblioteca ciceroniana di Petrarca? Due codici delle Philippicae… … pag. 9 Benedetta Fordred, “Errori” del Boccaccio o varietà della lingua trecentesca?… ………… »… 43 Maurizio Fiorilla, Ancora per il testo del Decameron… …………………………… »… 75 »… 91 »… 101 di Giacomo Leopardi tra erudizione, traduzione e moda letteraria… ………………… »… 109 Silvia Rizzo, Schede per Corno inglese di Montale…………………………………… »… 145 »… 159 »… 197 Tavole… ………………………………………………………………………… »… 225 Norme per gli autori e i collaboratori de «L’Ellisse» … ………………………………… »… 229 Silvia Finazzi, Una sententia di Petrarca attribuita a Boccaccio e possibili tracce delle Genea… logie nel Laurenziano 37, 3… ………………………………………………… Giuseppe Crimi, Niccolò Povero e la nuova edizione della seconda mattana… ……………………… Margherita Centenari, «Prendere persona di greco». Per una rilettura dell’Inno a Nettuno … Materiali e documenti Maurizio Campanelli, Settecento Latino III. L’inflazione dei poeti e il monte di Testaccio in … un’epistola di Contuccio Contucci…………………………………………………… Francesca Ori, Il ritorno di Colombo: contributo all’edizione critica di Odi e Inni … di Pascoli… ……………………………………………………………………… Il fascicolo VIII/2, 2013, curato da Emilio Russo e Franco Tomasi, sarà interamente dedicato a rime e lettere di Torquato Tasso. Saggi e note Monica Berté Tracce della biblioteca ciceroniana di Petrarca? Due codici delle Philippicae * Di recente ho pubblicato integralmente le postille di Petrarca al codice delle Philippicae, il Par. lat. 5802, che fu da lui annotato nei primi anni cinquanta e che, come la sua famiglia di provenienza (c), contiene solo le prime quattro1. Già Nolhac, tuttavia, aveva segnalato che Petrarca conosceva e citava anche le altre, naturalmente nella tradizione dei cosiddetti decurtati (D), dove a causa di un’ampia lacuna fra la fine della quinta e l’inizio della sesta orazione si verifica il salto di un’unità nel conteggio (risultano tredici anziché quattordici)2. I richiami alle Philippicae rintracciabili nella produzione * Per comodità del lettore elenco in ordine alfabetico le sigle dei manoscritti che compaiono nel corso dell’articolo: A = Avignon, Bibliothèque Municipale, 1215; C = Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. acq. lat. 3070; H = London, British Library, Harl. 4927; L = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1481; Matr = Madrid, Biblioteca Nacional, 9116; O = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 1453; P = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1820; Par = Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 6342; Q = Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 5802; R = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Rossi 957 [XI 107]; Rom = Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Vitt. Em. 1632; T = Troyes, Bibliothèque Municipale, 552; V = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9305; Vat = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2193. Per la lettura di queste pagine e per i preziosi suggerimenti ringrazio Michael D. Reeve e Silvia Rizzo. 1 M. Berté, Petrarca e le Philippicae: la lettura del Par. lat. 5802, «Studi medievali e umanistici», VII, 2009 [ma 2012], pp. 241-288, con la bibliografia qui data sul manoscritto. Allestito in Francia, forse a Chartres, verso la metà del XII secolo (prima del 1164), Q è scritto da un’unica mano in gotica francese e ha avuto più lettori che vi hanno lasciato varie postille e graffe; contiene, oltre alle prime quattro Philippicae, il De vita Caesarum di Svetonio, i Monosticha di Ausonio, qui attribuiti a Svetonio, l’Epitome di Floro, gli Strategemata di Frontino, il Breviarium di Eutropio e le Tusculanae di Cicerone. Di Q ho edito anche i pochi interventi petrarcheschi alle Tusculanae: Ead., Petrarca lettore di Svetonio, Messina, CISU, 2011, pp. XVII-XVIII. Sulla tradizione delle Philippicae vd. Cicerone, Le Filippiche, edizione critica a cura di G. Magnaldi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, cui rinvio qui e sempre per il testo critico. 2 P. de Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, 2 voll., Paris, Libraire Honoré Champion, 19072 (rist. anast. 1965), vol. I, pp. 103, 107, 113, 246-248, 252-253, e vol. II, pp. 34, 100. Come è noto, il ramo D era l’unico 10 monica berté petrarchesca si datano tutti dopo il 1350, con l’eccezione di uno: l’ultima orazione contro Antonio è echeggiata in una lettera del 23 maggio del 1333, la Fam. 3, 3, indirizzata a Stefano Colonna il giovane3. Dato che di questa Familiare non ci è pervenuta la missiva, non si può escludere che la frase con la menzione dell’orazione sia stata aggiunta dall’autore al momento dell’inserimento dell’epistola nella raccolta, ovvero negli anni cinquanta, tanto più che senza di essa il periodo funziona comunque. Se così fosse, verrebbero meno l’unica attestazione di una lettura dell’opera da parte di Petrarca anteriore a quella del Parigino e il conseguente problema di dover giustificare il fatto che egli, pur possedendo un manoscritto con l’intero corpus, appose su Q, con le sole prime quattro orazioni, un così alto numero di segni d’attenzione e di interventi critico-testuali, frutto peraltro d’ingegno e non di collazione. Successivamente alla consegna del mio articolo su Q sono venuti fuori interessanti indizi che potrebbero darci qualche lume sul codice o sui codici con tutte le Philippicae posseduti o letti da Petrarca. 1. L’Harleiano 4927 Il ruolo di Petrarca nella tradizione delle orazioni di Cicerone è ricostruibile tramite una serie di testimonianze, dagli scambi epistolari con i suoi contemporanei ai manoscritti da lui annotati, che ci sono giunti autografi o attraverso apografi. L’individuazione di questi ultimi è in primo luogo possibile grazie alle postille presenti nei margini, la cui paternità petrarchesca è comprovata da un insieme «di motivi che singolarmente presi possono anche non essere definitivi, ma nel loro complesso non lasciano dubbi»4: oltre al tono e al contenuto delle annotazioni, il ripetersi di alcune di esse identiche in più di un testimone dimostra la loro provenienza da un comune capostipite, ossia il manoscritto di Petrarca5. L’orizzonte non è facilmente circoscrivibile a causa dell’ampiezza e della varietà del panorama: a fronte di codici, come il Vat. lat. 9305, italiano della fine del XIV secolo, così fedeli al modello da riprodurne grafia e disposizione di note, varianti marginali e segni d’attenzione6, ve ne sono alcuni circolante fino al 1426, anno in cui il cardinale Giordano Orsini ritrovò in Germania l’attuale Vaticano, Arch. S. Pietro H. 25 del IX secolo, che è anch’esso mutilo, ma diversamente rispetto a D. 3 Al § 9 dell’epistola Petrarca menziona la «crudelissima Parmensium clades, cuius in Philippicis Cicero meminit», alludendo a Phil. 14, 8: vd. Berté, Petrarca e le Philippicae, cit., pp. 241-242. Qui e sempre per le Familiari rimando a F. Petrarca, Le Familiari, ed. critica per cura di V. Rossi, 4 voll., Firenze, Sansoni, 1933-1942 (il vol. IV per cura di U. Bosco). 4 S. Rizzo, La tradizione manoscritta della Pro Cluentio di Cicerone, Genova, Istituto di Filologia classica e medievale, 1979, p. 34. 5 Tale fenomeno è stato per la prima volta osservato da Nolhac, Pétrarque, cit., vol. II, pp. 36-37. 6 Su V vd. S. Rizzo, Apparati ciceroniani e congetture del Petrarca, «Rivista di filologia e di istruzione classica», CIII, 1975, pp. 5-15, a p. 7; Ead., Catalogo dei codici della Pro Cluentio ciceroniana, Genova, Istituto di Filologia classica e medievale, 1983, pp. 162-163 (scheda n. 150), e M. Tullii Ciceronis Oratio pro P. Quinctio, tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 11 che operano una selezione del materiale originale o ne alterano la formulazione e altri che a esso affiancano interventi posteriori, come il Vat. Pal. lat. 1481, dell’inizio del XV secolo di origine veneta, il quale conserva postille di una mano quattrocentesca che sovrappone considerazioni proprie a note di derivazione petrarchesca7; il Vat. Ross. 957, scritto, almeno in parte, a Costanza nel 1415, con marginali di provenienza petrarchesca uniti a quelli presumibilmente elaborati dallo stesso copista Federico Spezia8; l’Ottob. lat. 1453, copiato dopo il 1415, forse a Firenze, con postille apposte dalla medesima mano del testo, fra cui alcune risalenti a Petrarca9; il manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli, IV B 8, della fine del XIV secolo, fittamente postillato da più lettori, fra i quali Gasparino e Guiniforte Barzizza10. Ques’ultimo codice è andato solo di recente ad accrescere la lista degli apografi di note petrarchesche alle edidit M.D. Reeve, Stutgardiae et Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1992, pp. XII-XV; sui suoi segni d’attenzione e disegni vd. M. Fiorilla, Marginalia figurati nei codici di Petrarca, Firenze, Olschki, 2005, pp. 31-33. Contiene: Manil. (1r-9r), Mil. (9r-21r), Planc. (21r-35r), Sull. (35r-46r), Arch. (46r-50r), Marcell. (50r-53v), Lig. (53v-57v), Deiot. (57v-63r), Cluent. (63r-84v, fino a § 192 ne forte ma-), Quinct. (85r-95r, mutila per la caduta di una carta dall’inizio fino a § 7 defendere cu-), Flacc. (95r-107r), p. red. ad Quir. (107r-109r, fino a § 17 cum suo periculo pene sensit per la caduta degli ultimi fogli). 7 Su L vd. Rizzo, Catalogo, cit., pp. 144-145 (n. 133). Conserva: Manil. (1r-7v), Mil. (8r-18v), Planc. (19r31r), Sull. (31v-41r), Arch. (41v-44v), Cluent. (47r-60v), Quinct. (62v-73v), Marcell. (75r-78v), Lig. (78v-83r), p. red. ad Quir. (85r-89v), p. red. in sen. (91r-97r), Cael. (97r-109r, col testo fino a § 70 commissa vobis), Balb. (109v119v), Flacc. (120r-134v), Sest. (135r-147v), Q. Cic. pet. (147v-154r), Vatin. (155r-158r), har. resp. (158r-166v), exil. (167r-170r), prov. (170v-177v). 8 Su R vd. Rizzo, Catalogo, cit., pp. 152-153 e 187-196 (n. 140). Tramanda: Catil. (2r-16v), ps. Sall. in Cic. (16v-17v), ps. Cic. in Sall. (17v-20r), Phil. (21r-100r), Q. Cic. pet. (101r-106v), Philippus Aristoteli sa. d., inc. Filium mihi (107r), Cluent. (109r-140r), Marcell. (140r-144v), p. red. in sen. (144r-149v), Arch. (149v-154r), Tim. (155r-159r). Per la studiosa le postille di provenienza petrarchesca sarebbero solo quelle in margine alla post reditum in senatu e alla pro Archia, mentre quelle che si trovano accanto alle Catilinariae e alle Philippicae e che sono state da lei, in parte, pubblicate sarebbero opera del copista-annotatore quattrocentesco, il ferrarese Spezia, allievo di Pietro da Parma (vd. ivi, pp. 189-193). Per quel che riguarda la tradizione della pro Cluentio R è privo di annotazioni e appartiene non alla famiglia petrarchesca ma a quella fiorentina: vd. Rizzo, La tradizione manoscritta, cit., pp. 61-63. 9 Su O vd. Rizzo, Catalogo, cit., pp. 135-136 (n. 125): i suoi marginali, in inchiostro rosso, mostrano un particolare interesse per l’ambito giuridico e una buona conoscenza di autori classici da parte dell’annotatore. Contiene: Rhet. Her. (estratti: 1r-3v), L. Bruni, Cicero novus (4r-28r), Manil. (32r-45v), Marcell. (46r-51v), p. red. ad Quir. (52r-57v), p. red. in sen. (58r-66v), Mil. (67r-87v), Planc. (88r-110v), Deiot. (111r-119v), Arch. (120r-126v), Lig. (127r-133v), Sull. (134r-152r), Quinct. (152v-169v), exil. (170r-175v), Vatin. (176r-181v), prov., (182r-192r), Cluent. (192v-236r), S. Rosc. (237r-263v), har. resp. (264r-279r), Cael. (279v-296r), Balb. (296v309v), dom. (310r-340v), Mur. (341r-362v), Flacc. (363r-382r), Sest. (382v-400r). 10 Sul manoscritto napoletano, che fu in seguito acquistato a Milano da Aulo Giano Parrasio fra il 1499 e il 1506, vd., da ultimo, M. Berté, Petrarca, Salutati e le orazioni di Cicerone, in Manoscritti e lettori di Cicerone tra Medioevo ed Umanesimo. Atti del III Simposio Ciceroniano, Arpino, 7 maggio 2010, a cura di P. De Paolis, Cassino, Università degli Studi di Cassino - Dipartimento di Filologia e Storia, 2011, pp. 21-52, alle pp. 50-51, con la bibliografia ivi data. Conserva: p. red. ad Quir. (1ra-3rb, mutila fino a § 2 nichil est), dom. (3rb-22va), Cael. (22va-32ra, col testo fino a § 70 de vi), Balb. (32ra-40va), Vatin. (40va-45va, fino a § 41 esse videatur), har. resp. (45vb-55vb), prov. (55vb-62va), Catil. (62va-79rb), ps. Sall. in Cic. (79rb-80rb), ps. Cic. in Sall. (80rb-83rb). 12 monica berté orazioni di Cicerone finora individuati, ovvero il Vat. Pal. lat. 1820 scoperto da Giuseppe Billanovich11 e quelli emersi dalla recensio dei testimoni della pro Cluentio condotta da Silvia Rizzo12. Il Napoletano tramanda quasi tutte le orazioni del secondo gruppo (le tre mancanti, p. red. in sen., la spuria exil. e Sest., dovevano trovarsi nelle carte iniziali oggi perdute), confermando così la discendenza da Petrarca anche di questo corpus, che, come quello con le orazioni del primo gruppo, fu messo insieme da lui verosimilmente nel periodo milanese (1353-1361) e fu oggetto di analoghe cure filologico-esegetiche. Tale riprova è particolarmente preziosa alla luce dei ragionevoli dubbi avanzati da Maurizio Fiorilla sull’assegnazione al giovane Francesco di note, faccette e curiose graffe con motivo vegetale dell’Harl. 4927, che tramanda diverse opere di Cicerone, fra cui tutte le orazioni del secondo gruppo13. In un altro mio recente contributo, pur ribadendo le perplessità di Fiorilla e sostenendo l’impossibilità di dare per scontata una precoce conoscenza petrarchesca di questi testi, ho, però, segnalato una manciata di graffe a forma di fiorellino di H, che per grafia e inchiostro sono diverse da quelle edite da Billanovich e Pellegrin, ma simili a quelle vergate da Petrarca a partire dagli anni quaranta14. Ho, inoltre, potuto aggiungere, grazie a Michael Reeve, un nuovo tassello nella storia di H: in origine e almeno fino al 1411 esso conteneva tutte le Philippicae sulla base della sua identificazione con il codice n. 829 del catalogo della biblioteca di 11 G. Billanovich, Petrarca e Cicerone, in Miscellanea G. Mercati, 4 voll., Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1946, vol. IV, pp. 88-106, ora in Id., Petrarca e il primo umanesimo, Padova, Antenore, 1996, pp. 97-116. P tramanda: Off. (1r-36r), Lael. (36v-46r), Cato (47r-55v), parad. (57r-61v), Marcell. (62r-64v), Lig. (65r-68r), Deiot. (68r-70v), ps. Sall. in Cic. (70v-71v), ps. Cic. in Sall. (71v-73r), Catil. (73v-86v), Manil. (86v-93v), Mil. (93v-104v), Planc. (104v-116r), Sull. (116r-126r), Arch. (126r-129v). 12 Oltre ai quattro Vaticani, L O R V, già menzionati (vd. supra, note 6-9), per un elenco e una descrizione di altri apografi petrarcheschi della pro Cluentio vd. Rizzo, Catalogo, cit., pp. 24-25 (n. 3), pp. 30-31 (n. 8), 76-77 (n. 55), 78-79 (n. 57), pp. 89-90 (n. 69), 92-93 (n. 72), 100-101 (n. 81), 102-104 (ni 84 e 86), 108 (n. 91), 110-112 (ni 94-96), 119-121 (ni 104-106), 122-123 (n. 108), 132 (n. 121), 139-141 (n. 129: vd. infra, § 2, nota 48). 13 Fiorilla, Marginalia figurati, cit., pp. 28-31. Sono stati G. Billanovich-É. Pellegrin, Un manuscrit de Cicéron annoté par Pétrarque au British Museum, «Scriptorium», VIII, 1954, pp. 115-117, ad attribuire a Petrarca e, in parte, a pubblicare i marginalia di H, fondandosi sulla loro somiglianza grafica con le annotazioni e le preghiere da lui vergate, secondo i due studiosi, fra il 1335 e il 1338. H, copiato nel XII secolo su due colonne in gotica francese, conserva: Catil. (1ra-18rb), ps. Cic. in Sall. (18rb-20vb), ps. Sall. in Cic. (20vb21rb), exil. (21rb-24vb), p. red. in sen. (24vb-29va), p. red. ad Quir. (29va-31vb), dom. (32ra-50rb), parad. (50rb55va), Vatin. (55va-58va), Cael. (58va-67rb), Balb. (67va-74vb), har. resp. (75ra-83vb), prov. (83vb-89va), Sest. (89va-99vb), Marcell. (99vb-102vb), Lig. (102vb-106va), Deiot. (106va-110vb), Lael. (110vb-120vb). 14 Berté, Petrarca, Salutati, cit., pp. 24-27 con tav. II. Riporto le graffe forse riconducibili a Petrarca, già ivi date: a 11ra-b (in margine a Catil. 3, 5-6 quorum opera… inciperent e a Catil. 3, 7 in tantis… coegi), a 32rb (di fianco a dom. 4 Ita ne… commutatio, meno elegante delle due precedenti e collocata a destra di una preesistente graffa col motivo vegetale), a 84ra (accanto a prov. 4 Hannibal… effecerint), a 84va (in margine a prov. 6 morte… depulisse), a 88ra (di fianco a prov. 38 Nemo… ipsi sibi), a 110ra (accanto a Deiot. 35 nichil vulgare… preteritum); potrebbero, infine, essere suoi pure i tre punti che formano un triangolo in margine a Deiot. 35 vereor… Cesar, sempre a 110ra. tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 13 Peñiscola appartenuta all’antipapa Benedetto XIII (1411 o poco dopo), il quale non solo tramanda i medesimi testi di H nello stesso ordine (più, in coda, le Philippicae e il De oratore), ma ha anche le ultime parole di 1r b, Gayus Gracus (Catil. 1, 4), registrate nell’inventario papale di Peñiscola del 1423 edito da Pommerol e Monfrin, che si ritrovano in uguale posizione in H15. Accertato, quindi, che l’Harleiano proviene dalla biblioteca pontificia, Petrarca potrebbe averlo consultato quando si trovava lì e aver ricavato dalle carte perdute di questo la sua prima conoscenza delle Philippicae. 2. Il Par. lat. 6342 All’inizio del secolo scorso Pierre de Nolhac attribuì al frate francescano Tedaldo Della Casa la stesura del Par. lat. 6342, che era per lui copia di un codice petrarchesco16. Si tratta di una ricca miscellanea in pergamena di 194 carte, che tramanda le Fam. 24, 3-4 di Petrarca (2r-3r), off. (4r-39r), epitafi in lode di Cicerone (39r-v)17, parad. M.J. de Pommerol-J. Monfrin, La bibliothèque pontificale à Avignon et à Peñiscola pendant le grand schisme d’Occident et sa dispersion, 2 voll., Rome, Publications de l’École Française de Rome, 1991, vol. II, p. 676 (n. Pc 350): «incipit in littera rubea Incipit liber, et finit in secundo colondello Gayus Gracus». Si noti, però, che la grafia registrata nell’inventario papale del 1423 non corrisponde a quella di H, che ha Gaius Graccus. L’identificazione di H con il codice n. 829 della biblioteca di Benedetto XIII era stata già ipotizzata (vd. R.H. Rouse-M.D. Reeve, Cicero. Speeches, in Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics, ed. by L.D. Reynolds, Oxford, Clarendon Press, 19862, p. 93, nota 218), ma resa incerta dalla segnalazione di un altro manoscritto, Louvain, Bibliothèques Universitaires, 107, databile al primo quarto del XV secolo, di origine francese, distrutto nel 1940, che presentava lo stesso contenuto di quello di Peñiscola (vd. E. Ornato, Les humanistes français et la redécouverte des classiques, in Préludes à la Renaissance. Aspects de la vie intellectuelle en France au XV e siècle, études réunies par C. Bozzolo-E. Ornato, Paris, Editions du CNRS, 1992, pp. 25-30). Tuttavia, Reeve ha verificato sulla bobina del codice di Louvain conservata presso l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (I.R.H.T.) che qui la carta 1rb termina diversamente, con ad confirmandam audaciam (Catil. 1, 4). 16 Nolhac, Pétrarque, cit., vol. I, p. 253, nota 3, e vol. II, pp. 279-282. Lo studioso francese, ivi, vol. II, p. 280, adduceva come spia dell’origine petrarchesca del Parigino l’appartenenza di esso al ramo D; tale parentela, però, non è affatto probante, perché l’omissione e il salto di numerazione dei libri riguarda, come si è detto, tutta la famiglia dei decurtati, l’unica circolante prima del ritrovamento del Vat. Arch. S. Pietro H. 25. 17 Sono tredici in tutto con il primo epitafio ripetuto due volte, a dodici dei quali Alexander Riese assegnò il titolo di Hexasticha de Cicerone post mortem illius, e nell’Anthologia Latina, sive Poesis Latinae Supplementum, I/2, recensuit A. Riese, Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 19062, pp. 86-90 e 263, corrispondono ai seguenti numeri: I e Ibis = Anth. Lat. 784; II-XIII = Anth. Lat., 603-614. Gli Hexasticha fanno parte della raccolta di epigrammi noti come Carmina XII sapientum, composta da un unico autore e riedita da A. Friedrich, Das Symposium der XII Sapientes. Kommentar und Verfasserfrage, Berlin-New York, de Gruyter, 2002, pp. 62-66 (sap. 109-120), con un ampio commento alle pp. 201-227. Tali carmina hanno avuto una fortuna straordinaria in età medievale e umanistica e la serie di epitafi ciceroniani ha avuto una diffusione di gran lunga superiore ai restanti; la «troviamo già isolata in codici del s. X… Sono noti ottantadue manoscritti che contengono questo solo gruppo, associato in genere al De officiis o alle opere di retorica ciceroniane e anche pseudo-ciceroniane» (M. Rosellini, Sulla tradizione dei carmina duodecim sapientum, «Rivista di filologia e di istruzione classica», CXXII, 1994, pp. 436-463, alle pp. 443-444). 15 14 monica berté (40r-43v), Lael. (44r-51v), Cato (52r-59v), Tusc. (60r-114r), Catil. (114v-128v), Marcell. (129r-131v), p. red. in sen. (132r-133r, fino a § 12 malum gereretis [gemeretis ed.] nichil )18, p. red. ad Quir. (133v-136r, fino a § 23 verum etiam)19, Deiot. (136v-140r), Lig. (140v-143v), ps. Sall. in Cic. (143v-144r), ps. Cic. in Sall. (144v-146r), rep. 6 (146r-147v), Phil. 1-14 (148r-194r). Il volume è scritto in una corsiva di base con lievi tratti cancellereschi da un’unica mano, alla quale sono da assegnare anche le rubriche e i titoli correnti in rosso, nonché la maggioranza dei marginalia e degli interventi critico-testuali, tranne alcuni sporadici inseriti da un lettore più tardo, che inoltre colma parzialmente il testo mancante delle due post reditum (vd. supra, note 18-19). Il recto della prima carta, priva di numerazione, è guastato da macchie di umidità in modo così irreparabile da rendere illeggibile il testo, che però dovrebbe corrispondere all’inizio del De officiis dato che il verso del medesimo foglio contiene off. 1, 5 non nulle discipline - 1, 9 pugnare videtur. La carta successiva, numerata 1r-v e anch’essa rovinata, inizia con off. 1, 73 diligens e termina con 1, 84 in rebus urbanis; sunt. Entrambe fungono carte di guardia e, quindi, devono essersi danneggiate prima della legatura del manoscritto. A 2r si trova la Fam. 24, 3 a Cicerone; il verso di questa carta è bianco così come lo è il recto, non numerato, della seguente, che nel verso ospita l’altra Familiare a Cicerone, la 24, 4, la quale si estende fino a 3r. Queste due epistole petrarchesche hanno qui il testo nella forma precanonica e sono prive di segni d’attenzione20. Il foglio 3v è 18 Vd. Rouse-Reeve, Speeches, cit., p. 59, nota 26. Anche altri recentiores, fra cui il Laur. 23 sin. 3, assegnato alla mano di Salutati, hanno la post reditum in senatu mutila a partire dal medesimo punto, ma in Par, 193r, una mano diversa da quella del copista annota che la fine dell’orazione si trova in un altro volume: «finis huius orationis est in uno alio volumine, in ultimo illius libri» (la postilla è edita da Nolhac, Pétrarque, cit., vol. II, p. 279, nota 3). Chi verga tale annotazione trascrive, inoltre, una porzione del testo mancante (fino a § 13 et tumulenta quod), minima dato il poco spazio disponibile, e per la lettura del resto rimanda appunto ad altro volume. Sul Laur. 23 sin. 3, sul problema della sua attribuzione a Coluccio e sui testimoni mutili della p. red. in sen. vd. Berté, Petrarca, Salutati, cit., pp. 39-52, con la bibliografia qui data. Michael Reeve, il quale mi ha gentilmente fornito l’elenco dei codici con la p. red. in sen. incompleta allo stesso modo (Esc. V III 6, Laur. 23 sin. 3, Bodl. Rawl. G 138, Freiburg, Bibl. Univ. 159, Par. lat. 6342 e 7695, Ottob. lat. 1184 e 1478, Ross. 1034, Marc. lat. Z 432 [1656], Leiden, Voss. lat. F 91), mi fa osservare che Par ha nella p. red. in sen. una trasposizione (§ 3 teneremini nimis obsessi) che non si ritrova negli altri e che, quindi, lo esclude come fonte. 19 La p. red. ad Quir. si interrompe nel medesimo punto in T, ma in Par una mano più tarda, la stessa che inserisce l’aggiunta della p. red. in sen., trascrive la parte finale mancante, ovvero la conclusione di § 23 e tutto il paragrafo successivo; vd. Nolhac, Pétrarque, cit., vol. II, p. 279, nota 4. Su T, petrarchesco a partire dal 1342, vd., da ultimo, Berté, Petrarca, Salutati, cit., pp. 22-24, con la bibliografia ivi citata: esso conserva varie opere di Cicerone, fra cui tutte quelle tràdite dal Parigino, a eccezione delle Philippicae. 20 Della prima Familiare a Cicerone abbiamo sia la data della stesura precanonica, Verona, 16 giugno 1340, sia quella definitiva, 1345, mentre della Fam. 24, 4 solo quella della redazione finale, Avignone, 19 dicembre 1345: vd. E.H. Wilkins, Petrarch’s Correspondence, Padova, Antenore, 1960, pp. 88-89, cui si rimanda anche per la datazione delle altre epistole menzionate nelle pagine seguenti. Sul testo precanonico delle due Familiari a Cicerone vd. Petrarca, Le Familiari, cit., vol. I, pp. XCI e CIX, e vol. IV, pp. 225-231, dove Rossi dà in apparato le varianti redazionali di ambedue e registra il Par. lat. 6342 fra i testimoni da lui collazionati, senza darne la descrizione. tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 15 occupato dalla tavola del contenuto di ciò che segue. A partire da 4r riprende ex novo la trascrizione del De officiis, ornata da un’elegante iniziale aurea con al centro raffigurato un porporato su fondo ceruleo21. Alla fine del volume il copista aggiunge una lista di opere ciceroniane, «Tituli operum et librorum editorum a M. Tullio Cicerone» (194v), ripartita in quattro sezioni tematiche e comprendente sia gli scritti salvati sia quelli perduti, che Nolhac ha pubblicato ritenendola, a ragione, degna di rilievo22. Sempre di mano del copista sono le tre date presenti nel manoscritto, due delle quali nel margine destro e in corpo più piccolo rispetto a quello del testo: la prima «22 Maii 1375» al termine delle Tusculanae (114v) e la seconda «27 Aprilis 1376» in coda alle Philippicae (194r). L’altra, invece, si trova all’interno dello specchio di scrittura e nello stesso corpo del testo, di seguito all’explicit del Paradoxorum liber, «scriptus anno Domini M°CCC°LXXIIII» (43v)23. Dunque, per accettare che Par sia stato copiato, come voleva Nolhac, da Tedaldo, bisognerebbe concludere che questi l’abbia confezionato prima del suo soggiorno a Padova, dove andò nel 1378, ovvero prima di poter accedere alla biblioteca petrarchesca24. Ma già nel 1965 Giuseppe Billanovich escludeva che Par fosse stato scritto da Tedaldo e lo collocava nell’Italia transpadana25. Dopo di allora il codice è stato trascu- Più avanti ritornano i paragrafi presenti nelle due carte incipitarie danneggiate, regolarmente inseriti all’interno dell’opera, a 4v la prima sezione (off. 1, 5-9) e a 11r-v la seconda (off. 1, 73-84), anche se nel riscriverli il copista abbrevia in modo diverso alcune parole, così che i due doppioni non risultano del tutto coincidenti nella distribuzione del testo. Analogamente, nel trasferimento dei marginalia dai primi due fogli a 4v e 11r-v la loro collocazione subisce qualche lieve modifica. 22 Nolhac, Pétrarque, cit., vol. II, p. 281: «D’où qu’il vienne, le document est instructif sur les études cicéroniennes au XIVe siècle». In questa lista la sezione oratoria è suddivisa nei seguenti libri («Isti sunt pratici et omnes pertinent ad eloquentiam et ad rationalem philosophyam»): «Liber invectivarum. Liber Verrinarum vel de signis (= Verr. 2, 4). Liber Cesarianarum. Liber orationum variarum. Liber de lege agraria. Liber de lege frumentaria (= Verr. 2, 3). Liber Phylipicarum (sic)». Sull’equivoco, diffuso nella seconda metà del Trecento, relativo al De lege frumentaria, ovvero il titolo del terzo libro dell’actio seconda contro Verre, vd., da ultimo, Berté, Petrarca, Salutati, cit., p. 47, con la bibliografia ivi data. 23 Le tre date sono registrate da É. Pellegrin, Manuscrits de Pétrarque dans les Bibliothèque de France. I, «Italia medioevale e umanistica», IV, 1961, p. 381, ora Ead., Manuscrits de Pétrarque dans les Bibliothèque de France, Padova, Antenore, 1966, p. 41, dove si legge che Par fu copiato, secondo Nolhac, da Tedaldo Della Casa e posseduto dal cardinale Mazarin, morto nel 1661, e che origine e decorazione sono italiane. Karl Atzert, editore del De officiis, colloca la stesura del Parigino dal 1374 al 1376, senza motivarla, ma evidentemente sulla base delle date interne al codice: vd. M. Tullius Cicero, De officiis. De virtutibus, edidit C. Atzert, Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1963, pp. XXI-XXII, LI, dove Par, che qui è siglato π, è definito consanguineus Petrarcae. 24 Sulla spedizione padovana di Tedaldo vd. G. Billanovich-É. Pellegrin, Una nuova lettera di Lombardo della Seta e la prima fortuna delle opere del Petrarca, in Classical, Mediaeval and Renaissance Studies in honor of Berthold Louis Ullman, ed. by Ch. Henderson jr., 2 voll., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1964, vol. II, p. 220, ora in Billanovich, Petrarca, cit., p. 562. 25 G. Billanovich, Tra Dante e Petrarca, «Italia medioevale e umanistica», VIII, 1965, pp. 1-44, a p. 2: Par non fu «scritto da Tedaldo in una cella di Santa Croce…, come la sola ortografia basterebbe a dichiarare; fu allestito nell’Italia transpadana dell’ultimo periodo gotico, quanto più rigogliosa tanto più torbida». Ricordo che un paio di decenni prima lo stesso Billanovich aveva accolto senza muovere obiezioni 21 16 monica berté rato dagli studiosi, anche se la sua assegnazione all’Italia settentrionale ha rafforzato l’ipotesi di un suo collegamento con la biblioteca petrarchesca26. Trascurato è stato pure il suo corredo di postille, segni d’attenzione e interventi critico-testuali (cruces, integrazioni, varianti, introdotte da aliter o eccezionalmente da vel ), che presuppongono un lavoro di collazione da parte dello stesso copista esteso a tutti i testi, sia pure in proporzione diversa. Siamo, quindi, di fronte a un’imponente collezione di opere ciceroniane (delle quali sappiamo che erano tutte presenti nella biblioteca di Petrarca), redatta in area transpadana negli anni 1374-1376, ovvero a ridosso della morte di questo stesso. Il sospetto che l’ignoto allestitore del codice possa avere attinto alla biblioteca dell’umanista e possa magari essere stato persona a lui vicina rende necessario un attento esame dei marginalia (che, come si è detto, sono di mano del copista, che dunque potrebbe averli ripresi, almeno in parte, dal suo modello) alla ricerca di tracce che possano confermare la provenienza da materiali petrarcheschi27. Comincio col segnalare subito una corrispondenza molto interessante. Accanto a Cato 56 (57r) Curio ad focum sedenti magnum pondus auri (auri pondus P T ed.) Sannites cum attulissent, repudiati sunt; non enim aurum habere preclarum sibi videri dixit, sed hiis (eis T ed.) qui haberent (-bant P) aurum imperare il Parigino ha «nota eximiam laudem continencie M. Curii repudiantis aurum Sannitum» e in interlinea sopra Curio «scilicet Marco» (vd. tav. I). Il racconto del rifiuto da parte di Marco Curio dell’oro dei Sanniti viene rievocato più avanti in una postilla che lo stesso copista verga in margine a Tusc. 5, 91 (111v) Xenocrates cum legati ab Alexandro quinquaginta ei talenta attulissent, que erat pecunia temporibus illis, Athenis presertim, maxima, abduxit legatos ad cenam in Achademiam; hiis apposuit tantum quod satis esset nullo apparatu. Cum postridie rogarent eum, cui numerari iuberet, ‘quid? vos externa (hesterna Matr Rom ed.)’ inquit ‘cenula (cevala Matr) non intellexistis me pecunia non egere?’; quos cum tristiores vidisset, XXX minas accepit, ne aspernari regis liberalitatem videretur: «simile habetur de Marco Curio romano qui hoc modo repudiavit dona Sannitum». Proprio come l’autore di questa annotazione, anche Petrarca affianca l’attribuzione al frate francescano proposta da Nolhac (vd. G. Billanovich, Petrarca letterato. I. Lo scrittoio del Petrarca, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1947, p. 36, nota 1), come pure, prima ancora, R. Sabbadini, Le scoperte dei codici latini e greci ne’ secoli XIV e XV, II, Firenze, Le Lettere, 1996 (I ed. 1914, ed. anast. con nuove aggiunte e correzioni dell’autore 1967), p. 176, il quale soffermava la sua attenzione sul catalogo dei libri ciceroniani di Par, in particolare su tre titoli e sull’ordine in cui erano citati, Liber epistolarum ad Q. fratrem, Liber epistolarum ad Brutum, Liber epistolarum ad Atticum, che Della Casa non poteva aver desunto da un elenco tradizionale, ma neppure averli letti nel Laur. Plut. 49, 18, visto che in esso la raccolta ad Brutum precede e non segue quella ad Q. fratrem e che il Laurenziano con le epistole di Cicerone arrivò a Firenze dopo l’allestimento di Par. 26 Vd. Rouse-Reeve, Speeches, cit., p. 94, nota 223: «Paris lat. 6342 (a. 1376), which Nolhac ascribed to the Florentine Tedaldo Della Casa and regarded as a copy of a manuscript from Petrarch’s library, is assigned to northern Italy by Billanovich…; but the connection with Petrarch remains – if anything, stronger». 27 Il confronto della mano del copista di Par con quella di Lombardo Della Seta ha dato esito negativo. tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 17 l’episodio del greco Xenocrate a quello del latino Marco Curio in una sua epistola, priva di data (ma databile sulla base della collocazione nella raccolta al 1346-1347) e indirizzata a un amico anonimo, a cui invia un dono e soggiunge: Non quod ego sim nescius quosdam fortes, quosdam doctos ac simillimos tui viros, et utrosque magnanimos, frustra olim muneribus fuisse tentatos; in quibus ante alios est Fabritii clarum nomen et Curii, Romanorum ducum, quorum alter Pyrri regis, alter aurum contempsisse samniticum laudatur, clarus uterque contemptus, sed nobilitatus alter etiam claritate responsi. Quamvis enim scolastici quidam more suo confundant historias, responsum tamen illud nobile ac famosum ‘Romanos nolle aurum, sed aurum habentibus imperare’, non Fabritii, ut vulgus putat, ad regem, sed Curii est ad Samnitium legatos. Xenocrates legatos Alexandri Macedonis cum quinquaginta talentis ad eum ab ipso rege transmissos, invitatos ad cenam in villam Achademie ac mediocri et minime apparato cibo philosophice habitos cum dimisisset, postridie reversos querentesque cui numerari pecuniam regis vellet, sic increpuit: ‘Quid vos’ inquit ‘hesterna cena non intellexistis me pecunia non egere?’. Quo responso cum mestos factos cerneret, ne munus ac legationem regiam sprevisse diceretur, de magna pecunia exiguam particulam accepit, reliquum referri iussit ad regem (Fam. 6, 8, 4-5)28. La postilla di Par non trova riscontro nei quattro codici con le Tusculanae risalenti a Petrarca, ma potrebbe discendere da un ulteriore testimone da lui annotato29. Il collegamento fra i due personaggi, Xenocrate e Marco Curio, è tanto più significativo in quanto non è né immediato né ovvio, perché il modo di respingere dell’uno e dell’altro è simile, ma non esattamente uguale. D’altro canto, a rigore non si può escludere che le due postille di Par siano state scritte da qualcuno che aveva letto la Familiare di Petrarca. Si noti che in Tusc. 5, 91 Par ha l’erroneo externa per hesterna, che è invece lezione tràdita da Rom Matr e accolta in Fam. 6, 8, 5. Sulla morigeratezza di Marco Curio Petrarca costruisce il capitolo tredicesimo del De viris illustribus, nel quale viene ripetuto il racconto ciceroniano relativo al rifiuto dell’oro dei Sanniti: De Marco Curio Dentato 3-4; per il De viris, la cui composizione accompagnò quasi tutta la vita dell’autore, si rimanda qui e sempre a F. Petrarca, De viris illustribus, ed. critica per cura di G. Martellotti, Firenze, Sansoni, 1964. Un accenno alla temperanza di Xenocrate è, invece, in Sen. 13, 14, 13 (a Francesco Bruni, Arquà, 28 giugno 1372): vd. F. Petrarca, Le Senili. Libri XIII-XVIII e indici, traduzione e cura di U. Dotti, collaborazione di F. Audisio, Torino, Nino Aragno, 2010, cui si rinvia qui e sempre per questi libri. 29 Sui quattro codici petrarcheschi con le Tusculanae (Matr, Q, Rom, T ) vd. S. Rizzo, Un nuovo codice delle Tusculanae dalla biblioteca del Petrarca. Atti del IX Colloquium Tullianum, Courmayeur, 29 aprile-1° maggio 1995, «Ciceroniana», n. s., IX, 1996, pp. 75-104, alle pp. 77 e 85, nota 36. Il Romano, fatto allestire dallo stesso Petrarca non prima della metà degli anni cinquanta e da lui riccamente postillato, ha solo quest’opera e di fianco a Tusc. 5, 91 (57vb) il notabile «Xenocrates», là dove l’apografo Matritense conserva, invece, due annotazioni, vergate una sotto l’altra, «Valerius dicit hoc idem (= Val. Max. 4, 3 ext. 3)» e «frugalitas non eget pecunia» (171r). E ancora su Q e T vd. rispettivamente supra, note 1 e 19, e Berté, Petrarca, Salutati, cit., pp. 22-24, con la bibliografia qui data; su Matr, che, oltre alle Tusculanae, tramanda come Par i Paradoxa, L.D. Reynolds, The Transmission of the De finibus, «Italia medioevale e umanistica», XXXV, 1992, pp. 1-30, a pp. 22-26; Id., Petrarch and a Renaissance Corpus of Cicero’s philosophica, in Formative Stages of Classical Traditions: Latin Texts from Antiquity to the Renaissance. Proceedings of a Conference held at Erice, 16-22 October 1993, ed. by O. Pecere and M.D. Reeve, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1995, pp. 409-433, in particolare, p. 417, nota 25; L.D. Reynolds, Petrarch and Cicero’s philosophical Works, «Les Cahiers de l’Humanisme», I, 2000, pp. 37-52. 28 18 monica berté Sappiamo, infatti, che egli conosceva almeno un altro manoscritto con quest’opera, non ancora identificato, appartenuto al grammatico bergamasco Iacopo Domenico de Apibus (magister Crottus). Di questo esemplare Petrarca parla in una lettera a lui indirizzata, la Fam. 18, 14 (Milano, 1° settembre 1355), nella quale lo ringrazia dell’invio di un codice su cui gli aveva chiesto informazioni nella Fam. 18, 13 (Milano, 21 agosto 1355), avendo appreso che esso conteneva molti e rari testi ciceroniani30. Tornando al nostro Parigino, perfettamente corrispondente agli interessi petrarcheschi è anche la postilla da esso tràdita in margine a parad. 12 (40v) que (que vis Matr) patrem (matrem T) Decium, que filium devoravit et (denotavit T devota vita ed.) immisit armatas in (omnem misit in dormatas T immisit in armatas ed.) hostium copias?] «Decii duo: pater et filius». H, 51rb, omette l’intera frase, che in P, 57v, senza segni d’attenzione, è aggiunta nel margine con le seguenti divergenze rispetto a Par: vis prima di patrem e devovit immisitque. T, 249va, ha una crux nell’intercolumnio. Petrarca accenna più volte ai Decii, immolatisi per la patria, interrogandosi sul problema relativo al loro numero, perché leggeva di due negli storici antichi oltre che in Cicerone qui e nel De divinatione (1, 51), mentre ne trovava tre nello stesso Cicerone in Tusc. 1, 89 (vd. infra, p. 23) e in fin. 2, 61, rispettivamente postillati in Rom (12ra: «Tres Decii. Totidem .2. de finibus in medio») e in Matr (200r: «Tres Decii. Duos habent historie communes et Cicero idem, primo de divinatione ante medium. Tres vero itidem habet primo Tusculanarum»). Si osservi che fra le fonti registrate da Petrarca nella postilla del codice di Madrid non compare il rinvio a questo luogo dei Paradoxa, che pure egli certamente conosceva31. 30 Dalle parole di Petrarca non si ricava con certezza se si trattasse di un dono o di un prestito, ma la prima ipotesi sembra la più probabile: «Tu michi eum (sc. Tusculanarum librum) nunc ad unguem correctum et aliis tullianis monimentis insuper et amicissimis ac lepidissimis tuis litteris comitatum direxisti» (Fam. 18, 14, 11). Su magister Crottus vd. A. Foresti, Aneddoti della vita di Francesco Petrarca, Padova, Antenore, 1977, pp. 395-398 e sulle due Familiari a lui indirizzate Rizzo, Un nuovo codice, cit., p. 86. Il Cicero del grammatico bergamasco non può essere stato il modello del Romano fatto allestire da Petrarca, poiché quest’ultimo deriva certamente dal Matritense, ma forse, in un secondo momento, il Romano potrebbe essere stato collazionato con il codice di magister Crottus. Se così fosse, però, questo non potrebbe essere messo in rapporto con Par, perché da una prima verifica, condotta sul campione di interventi critico-testuali presenti in Rom (editi in Rizzo, Un nuovo codice, cit., pp. 88-89), risulta che nessuno di essi coincide con la lezione tràdita da Par. Del resto, dietro la definizione petrarchesca et alia tulliana monimenta non mi pare possa nascondersi una raccolta di scritti ciceroniani così ingente come quella del nostro Parigino. 31 Il passo dei Paradoxa, con la relativa annotazione di Par, va ad accrescere le già numerose testimonianze sul numero dei Decii (due e non tre) elencate e commentate da Rizzo, Un nuovo codice, cit., pp. 94-95, cui si rimanda per la bibliografia e i luoghi petrarcheschi qui raccolti. La studiosa, ivi, pubblica anche le due postille relative ai Decii di Matr e Rom, successivamente riedite da Reynolds, Petrarch and Cicero’s philosophical Works, cit., p. 46. Alla fine, con ogni probabilità, Petrarca dovette convincersi che i Decii erano solo due: vd. Petrarca, Res seniles. Libri I-IV, a cura di S. Rizzo, con la collaborazione di M. Berté, Firenze, Le Lettere, 2006, p. 279, con la nota di commento a Sen. 4, 1, 80, a Luchino Dal Verme, Padova, 1° aprile 1364 («… duo Decii – addit et tertium Cicero, sed ille historicis videtur ignotior –…»), che concorda con la redazione definitiva di TrF 1, 67-69. Qui e sempre per il libri I-IV delle Senili si rinvia all’ed. Rizzo e per i Triumphi a F. Petrarca, Trionfi, Rime extravagnati, Codice degli abbozzi, a cura di V. Pacca, in F. Petrarca, Opere italiane, ed. diretta da M. Santagata, 2 voll., Milano, Mondadori, 1996, vol. II. tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 19 Faccio seguire una breve analisi di altre annotazioni di Par segnalando, per consentire un confronto, eventuali note di Petrarca presenti accanto agli stessi passi nei suoi codici autografi o apografi. Avverto che da qui in avanti, qualora non venga specificato, il testo degli altri manoscritti e delle moderne edizioni coincide con quello di Par e che la presenza di segni d’attenzione o postille negli altri testimoni da me collazionati è sempre esplicitata. Lungo i margini di Par si incontrano solo di rado rimandi a luoghi di altri autori: off. 1, 146 (17v) quo in genere non est incomodum, quale quidque eorum (horum P) sit, ex aliis iudicare, ut si quid non dedeceat (deceat ed.) in illo (illis P T illos ed.), vitemus et (et om. P T ed.) ipsi] «facilius, ut vulgo dicitur, videmus alienam festucam quam nostram trabem»; si tratta del celebre detto evangelico (Matth. 7, 3-5 e Luc. 6, 41-42), citato sia da Petrarca in Inv. magn. 143 sia da Jean de Hesdin nell’invettiva contro di lui32. Est, il secondo -de- di dedeceat ed et sono aggiunti in interlinea, dove, inoltre, ci sono «scilicet in nobis» e «aliquo» rispettivamente sopra iudicare e illo. La correzione di deceat in dedeceat deve essere frutto di collazione: l’erroneo dedeceat è ampiamente attestato dalla tradizione ciceroniana; ce l’hanno anche T e P, che però ha disconveniat sopra dedeceat, oltre all’emendamento eorum in luogo di horum e all’inserzione interlineare di et prima di ipsi (14r). off. 3, 13 (29r) etenim quod summum bonum a Stoicis dicitur convenienter nature vivere…] «de hoc Horatius: ‘Vivere nature si convenienter oportet’ (= Hor. epist. 1, 10, 12)»; hoc è aggiunto sopra, il che forse è spia del fatto che il copista sta trascrivendo la nota da un antigrafo33. parad. 6 (40r) neque enim expletur umquam (umquam expletur Matr T) nec satiatur cupiditatis sitis (sinus P) neque solum ea qui (que Matr T) habent libidine augendi (augmentandi H) cruciantur sed etiam amittendi metu] «simile fere dictum invenies in Salustio (= Sall. Cat. 11, 3)»34. In H, 50vb, c’è una manicula; in P, 57r, e in Matr, 175r «nota» con una graffa35. parad. 50 (43v) habuit enim ediculas (-am T) in Carinis] «locus Rome de quo Horacius: ‘nimiumque Foro distare Carinas’ (= Hor. epist. 1, 7, 48)». Il verso dell’epistola oraziana è riportato in De rem. 1, 15, 18, e non è postillato nell’Orazio Laurenziano, 84v, che ha atque Foro nimium, come il testo critico, in luogo di nimiumque Foro della nostra nota36. In H, 55rb, ediculas è aggiunto nel margine. 32 Vd. rispettivamente F. Petrarca, Invective contra medicum. Invectiva contra quendam magni status hominem sed nullius scientie aut virtutis, a cura di F. Bausi, Firenze, Le Lettere, 2005, p. 196, cui si rimanda da qui in poi, e M. Berté, Jean de Hesdin e Francesco Petrarca, Messina, CISU, 2004, p. 140. 33 L’Orazio, Laur. 34, 1, acquistato da Petrarca a Genova il 28 novembre 1347 e postillato in due riprese (la prima a ridosso dell’acquisto e la seconda non molto oltre la fine del 1350), non ha segni d’attenzione in corrispondenza di questo verso (86r). 34 «Avaritia pecuniae studium habet, quam nemo sapiens concupivit: ea quasi venenis malis inbuta corpus animumque virilem effeminat, semper infinita <et> insatiabilis est, neque copia neque inopia minuitur». 35 Il marginale di P è registrato da Billanovich, Petrarca, p. 100. 36 Petrarca cominciò la stesura del De remediis a metà degli anni cinquanta; da qui in poi per quest’opera si rinvia all’ed. a cura di C. Carraud, 2 voll., Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 2002, che si fonda su un incunabolo e nella quale il testo del verso oraziano è «dum redit foro, nimium distare Carinas». La stessa lezione si trova nell’autorevole testimone trevigiano del De remediis, Marc. lat. 475 (= 1660), 11ra, che in corrispondenza ha una manicula e che ho collazionato per tutti i passi di quest’opera citati da qui in poi. 20 monica berté Tusc. 3, 54 (88v) sensim enim et pedetemtim progrediens dolor extenuatur (extenuatur [-tinguitur Matr] dolor Matr ed.), non quo ipsa res immutari soleat aut possit, sed id, quod ratio debuerat, usus docet, minora esse ea que sunt (sint Matr ed.) visa maiora] «Seneca in tragedia: ‘Quod ratio nequit sepe sanavit mora’ (= Sen. Ag. 130)», con una graffa fra testo e postilla37. Il passo è evidenziato da una graffa in Rom, 32vb. Phil. 2, 112 (160v) caritate et (te et ed.) benivolentia civium septum oportet esse, non armis] «nota similia verba in Iugurtino Salustii circa principium (= Sall. Iug. 10, 4)38», con una manicula nel margine opposto. In Q, 143rb, Petrarca evidenzia con una graffa questo stesso luogo, che poi riporta alla lettera in Sen. 14, 1, 61 (a Francesco da Carrara, Arquà, 27 novembre 1373). Colpisce, inoltre, l’attenzione dell’anonimo copista-annotatore per le opere perdute di Cicerone, come nel caso di off. 2, 31 (22r) nunc dicamus de gloria, quamquam ea quoque de re duo sunt nostri libri ] «nota II libros de gloria editos a Tullio qui non reperiuntur apud modernos» (in P, 18r, c’è la nota «gloria, de qua 2° libri Ciceronis»), o nel caso di Tusc. 4, 1 (92v) in hiis sex libris quos de re publica (republica scripsimus ed.)] «nota sex libros de re publica editos a Tullio qui non reperiuntur» (in Matr, 145r, si legge l’annotazione «sex libri de re publica»)39. Questa tipologia di annotazione è da mettere in rapporto con la lista delle opere ciceroniane che chiude il codice e non sembra proprio che possa risalire a Petrarca (l’espressione qui non reperiuntur non suona sua)40. Equamente distribuite, sia pure con una maggiore frequenza nella prima parte del volume, sono le postille esegetiche; ne riporto un campione. off. 2, 35 (22r) nequis sit admiratus cur, cum inter omnes philosophos constet a meque ipso sepe disputatum sit, qui unam haberet, omnes habere virtutes, nunc ita seiungam…] «cur omnis qui unam habet virtutem habeat omnes»; anche in margine a P, 18v, sono riportate le parole di Cicerone: «qui habet unam virtutem habet omnes». Le edizioni moderne di Seneca accolgono non quit in luogo di nequit, lezione attestata dalla tradizione. «Non exercitus neque thesauri praesidia regni sunt, verum amici, quos neque armis cogere neque auro parare queas: officio et fide pariuntur», in corrispondenza del quale il codice Laur. 64, 18, 5v, con note di Petrarca, non ha segni d’attenzione. L’omissione di te nel passo ciceroniano è comune al ramo D. Sulla postillatura delle Philippicae vd. infra, § 4 e su questo luogo in particolare pp. 30-31. 39 Vd. Fam. 24, 4, 13: «Tuorum sane, quia de his michi nunc sermo erat, quorum insignior iactura est, hec sunt nomina: reipublice, rei familiaris, rei militaris, de laude philosophie, de consolatione, de gloria, quamvis de his ultimis spes michi magis dubia, quam desperatio certa sit». 40 Una formulazione analoga è, invece, usata dal frate domenicano Giovanni Colonna, amico di Petrarca, nel suo Liber de viris illustribus, la cui stesura cominciò nel 1332; alla fine del breve profilo di Cicerone c’è un elenco delle sue opere: «Scripsit autem Tullius egregios libros quam plurimos: De re publica libros sex, qui nunc nusquam reperiuntur; De officiis libros 3; De amicitia librum 1; De senectute librum 1; De oratore libros 3; De paradoxis librum 1; Philippicarum librum 1; Rethoricorum libros 2; De tusculanis questionibus libros 5; Orationum libros 7; Invectivarum libros 6; De natura deorum libros 3; De divinatione libros 2; De creatione mundi librum 1; Dyalogorum ad Hortensium librum 1; De partitione orationis librum 1; De agricultura librum 1; De iustitia et iure naturali libros 2; De consiliis librum 1; De gloria humana; De consolatione; De laude Marci Catonis, De responsis aruspicum; De pronosticis. Item epistolas ad diversos multas»: vd. W. Braxton Ross, Giovanni Colonna, Historian at Avignon, «Speculum», XLV, 1970, p. 563. 37 38 tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 21 off. 2, 81 (27r) at vero Aratus Scitionius (Sitionis P Sicionius T ed.) iure laudatur, qui, cum eius civitas quinquaginta annos a tyrannis teneretur, profectus Argis Scitionem (Sit- P Sic- T ed.) clandestino introytu urbe est potitus, cumque tyrannum Nichodem (in eodem P mecodem T Nicoclem ed.) improviso pressisset (oppre- ed.), sexcentos exules… restituit remque publicam (-ce T ) adventu suo liberavit] «splendidum et egregium factum Arati Sicionii», che tacitamente corregge la lezione a testo; P, 23v, reca una nota simile: «Arati Sitionii factum», nonché due correzioni, queste ultime però vergate da una mano più tarda, Nicodem per in eodem e oppressisset per pressisset. Petrarca ricorda questo episodio in Fam. 20, 3, 4 (a Galeotto Spinola, Milano, probabilmente 1357): «non te etas teneat; senior Aratus Sicyonem…, senior Camillus urbem Romam servitio liberavit». off. 3, 32 (30v) nulla est enim societas (enim societas est T ) nobis cum tyrannis sed (et T ed.) potius summa distinctio (distractio est T ed.) neque est contra naturam spoliare eum, si possis, quem est honestum necare] «nota contra tyrannos»; P, 25r, similmente appunta «in tyrannos». off. 3, 45 (31v) Damonem et Pythiam (Phintiam ed.) pithagoreos ferunt hoc animo inter se fuisse…] «pulcrum exemplum constantis amicitie»; P, 28r, ha «Damon et Phytias» e analogamente T, 137rb, ha il doppio notabile, di mano non petrarchesca, «Damon» e «Pithias». Petrarca richiama il bell’esempio dell’amicizia fra Damone e Pitia in tre epistole: le Var. 44 e 49 (rispettivamente Disp. 23, a Francesco Nelli, Milano, settembre 1353, e Disp. 7, a Barbato da Sulmona, Avignone, 18 gennaio 1347) e la Fam. 12, 16 (a Niccolò Acciaiuoli e Giovanni Barrili, Valchiusa, 24 maggio 1352)41. Lo stesso episodio è raccontato da Cicerone anche in fin. 2, 79 (senza marginali in Matr, 166v) e in Tusc. 5, 63 (privo di segni d’attenzione in Par, 108v, e Rom, 54rb). off. 3, 86 (35v) cum (cum enim ed.) rex Pyrrus populo romano bellum ultro intulisset… perfuga ab eo venit in castra Fabricii… Hunc Fabricius reducendum curavit ad Pirrum idque eius factum laudatum a senatu est] «nota commendabile factum Fabricii Romanorum consulis»; P, 32r, ha il notabile «Fabricius» e la postilla «comparat Fabritium Aristidi». L’episodio di Fabrizio e Pirro è riportato alla lettera nel capitolo quattordicesimo del De viris illustribus dedicato proprio al console romano, elogiato per la sua morigeratezza come Marco Curio, protagonista del capitolo precedente: vd. De Fabritio Lucinio 4-642. Petrarca, inoltre, riprende l’accostamento ciceroniano di Fabrizio al greco Aristide in Sen. 6, 7, 13 (Milano, 19 settembre 1358, senza destinatario) e TrF 2, 32 («Aristidès, che fu un greco Fabritio»), qui ricordato, sempre accanto a Marco Curio, come esempio di frugalità43. In margine a parad. 12, dove c’è un accenno alla continenza di Fabrizio e alla sobrietà nel cibo di Marco Curio («quid continentia C. Fabricii, quid tenuitas [qui semitas T] victus M. Curii sequebatur?»), Par, 40v, ha due notabili, uno sotto l’altro, «Fabricius» e «M. Curius». parad. 8 (40r-v) necnon (neque non T ) sepe (sepe om. P) illum laudabo sapientem (illum sapientem laudabo Matr laudabo sapientem illum H P ed.), Biantem ut oppinor, qui numeratur in (inter H Matr P T) septem: cuius cum patriam plenam (plenam : om. H propriam propienniam T Prienam ed.) cepisset hostis ceterique In Fam. 12, 16, 26 i «pithagorei iuvenes Damon et Phitias» sono menzionati insieme ad altre celebri coppie di amici; di loro narra anche Val. Max. 4, 7 ext. 1: vd. F. Petrarca, Lettere disperse, a cura di A. Pancheri, Parma, Guanda, 1994, p. 158, con il commento a nota 5, a cui rimando qui e sempre per le Variae. 42 Su Marco Curio e Fabrizio vd. supra, pp. 16-17, con nota 28. 43 Per la Senile si rimanda a F. Petrarca, Res seniles. Libri V-VIII, a cura di S. Rizzo, con la collaborazione di M. Berté, Firenze, Le Lettere, 2009, p. 146 (cui si rinvia da qui in poi per i ll. V-VIII). Si noti che questa epistola nelle due redazioni precanoniche che ci sono pervenute non ha la menzione di Aristide, che viene inserita da Petrarca solo nella raccolta canonica: vd. ivi, pp. 137-146, anche per il problema della data e del destinatario. 41 22 monica berté ita fugerent ut multa de suis rebus asportarent, cum esset admonitus a quodam ut idem (idem ipse Matr T ed.) faceret, ‘ego vero’ inquit ‘facio; nam omnia mecum porto mea’ (mea mecum porto H P)] «comendabile dictum Biantis phylosophi», con una manicula che indica le parole di Biante; si noti l’insolita grafia comenper commen-, normalmente usata dal copista-annotatore di Par (vd. supra, p. 21). H, 51ra, ha la frase evidenziata da una graffa, annotata con «sapiens Byans (sic)» e cum in interlinea sopra cuius; T, 249rb, ha il notabile «Bias» e Matr, 175r, ha nel testo Hyantem corretto in interlinea in Byantem, con una graffa marginale. Il filosofo greco Biante compare più volte negli scritti petrarcheschi; di questo episodio specifico si trova menzione nella già citata Fam. 6, 8, 1 («animus enim proculdubio dives est, Bianteo more sua secum bona circumferens…»); in Rer. mem. 3, 66, 6 («Cicero quodam loco hoc narrans sic ait: ‘Sepe illum laudabo sapientem Biantem’»), dove la fonte è citata alla lettera secondo l’ordo verborum tràdito da Par e da T; in De rem. 2, 55, 4 («‘bona’ inquit ‘mea omnia mecum porto’»), dove, invece, l’ordo verborum non corrisponde a quello di nessuno dei manoscritti da me collazionati44. Si noti, inoltre, che nessuno di essi ha la lezione corretta Prienam, ovvero Priene, patria di Biante, che pure Petrarca mostra di conoscere: vd. De rem. 2, 4, 8 («nescis Biantem Prieneum fuisse») e Sen. 13, 3, 5 («nascendo… Prienem Bias… honestavit»; l’epistola è scritta a Giovanni Fei d’Arezzo, Arquà, 9 settembre 1370). Il nome della città natale di Biante era, comunque, per lui ricavabile da altre fonti (vd. Val. Max. 7, 2 ext. 3 e 3 ext. 3; Sol. 40, 6-8). parad. 9 (40v) ille hec (hec : autem H) ludibria fortune ne (nec H Matr T ) sua quidem (quidem : apellanda esse P) putavit, que nos appellamus etiam (appellamus esse H etiam apellamus P) bona. ‘Quid est igitur’ queret aliquis ‘bonum’ (Queret igitur aliquis ‘quid sit bonum’ H P Quid est igitur aliquis queret bonum si quid sit Matr Quid est igitur quereret aliquis quid sit bonum T )?] «quid sit bonum». H, 51ra, ha una postilla esattamente coincidente con quella di Par; Matr, 175r, ha invece una graffa. parad. 16 (41r) G. vero Marium vidimus, qui michi secundis (michi in secundis P T Matr michi secundis in ed.) rebus unus ex fortunatis (-natissimis T ) hominibus, in adversis unus ex summis viris videbatur, quo beatius esse mortali nichil (mortali nichil esse H esse mortalium nichil esse P) potest ] «G. Marius. Et nota de illo mirabilem virtutem». P, 58r, ha nel margine «nemo Gayo Mario beacior» con una graffa e la correzione testuale mortali nichil esse; H, 51vb, ha una manicula; Matr, 176r, «G. Marius» e in prima di secundis aggiunto in interlinea. Lael. 56 (48r) constituendi autem sunt (sunt autem T ) qui sint in amicitia fines (sunt autem qui fines sint in amicitia H) et quasi termini diligendi. De quibus tres video sententias ferri (fieri P), quarum nullam probo] «nota III sententias de finibus seu terminis amicitie»; in margine a H, 116rb, si trova una nota simile, che ripete quanto detto da Cicerone: «qui sint fines et termini amicitie». P, 42r, ha «aliter ‘ferri’» di fianco a fieri. Lael. 67 (49r) extitit autem hoc loco questio quedam (quaedam questio P T ed.) subdifficilis: num quando amici novi digni amicitia veteribus sint (sunt T) anteponendi, ut equis vetulis teneros anteponere solemus] «an novi amici anteponi debeant veteribus». In H, 117va, c’è una postilla quasi identica: «an amici novi preponi debeant antiquis»45. Lael. 71 (49v) odiosum sane (sane om. H) genus hominum officia exprobancium (exprobra- H P ed.); Per la Fam. 6, 8 vd. supra, p. 17. In attesa di una nuova edizione con traduzione che sta ultimando Marco Petoletti, per i Rerum memorandarum libri, composti fra il 1343 e il 1345, si rinvia qui e sempre a F. Petrarca, Rerum memorandarum libri, ed. critica per cura di G. Billanovich, Firenze, Sansoni, 1943. Le parole di Biante sono riportate anche da Val. Max. 7, 2 ext. 3 («‘ego vero’ inquit ‘bona mea mecum porto’») e da Sen. epist. 9, 18 e De cost. 5, 6, che però le attribuisce a Stilpone («‘omnia mea mecum sunt’»). 45 La nota di H è edita da Billanovich-Pellegrin, Un manuscrit de Cicéron, cit., p. 117. 44 tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 23 que meminisse debet is pocius (pocius om. H P T ed.) in quem collata sunt, non commemorare qui contulit ] «contra exprobantes officia collata amicis». La nota ripete l’erroneo exproba- del testo in luogo di exprobra-. Sia P, 43r-v, che H, 117vb, hanno una graffa. Lael. 98 (51r-v) ‘magnas vero gratias michi agere Thays (agere gratias Thais michi H P T ed.)?’ satis erat respondere: ‘magnas’; ‘ingentes’ inquit] «verba Terencii (= Ter. Eun. 391-392)»; P, 45v, ha nel margine «hec verba Terencii sunt in suis comediis». Cato 31 (54v) videtis ne ut apud Homerum sepissime Nestor de virtutibus suis predicet (virtutibus prediceret T)?] «Nestor senex facundissimus»46. Cato 54 (56v) nec consitiones modo delectant, sed etiam insitiones (insitiones etiam T ), quibus nil invenit agricultura solertius] «nota commendationem inserendi, quod vulgo dicitur ‘incalmare’»; in interlinea sopra consitiones c’è «idest seminationes vel plantationes» e sopra insitiones «idest ‘incalmi’». L’uso di ‘incalmare’ / ‘incalmo’ per ‘innestare’ / ‘innesto’ è largamente attestato nell’italiano antico in varie regioni. P, 52r, ha nell’interlinea sopra il primo termine la spiegazione «plantationem solum» e sopra il secondo «simul arbores facere diversos fructos». Questo passo ciceroniano è ripreso in Sen. 12, 1, 113 (a Giovanni Dondi Dell’Orologio, Arquà, 13 luglio 1370)47. Cato 78 (59r) Socrates… omnium sapientissimus oraculo Apollinis iudicatus] «Socrates sapientissimus omnium»; in T, 248ra, Petrarca annota «Apollineum oraculum de Socrate» e in De rem. 1, 12, 22 riporta questa definizione di Socrate data dall’oracolo di Apollo. Cato 78 (59r) sic sencio, cum tanta celeritas animorum sit (sit celeritas animorum P), tanta memoria preteritorum futurorumque (-um P) prudentia, tot artes, tante (tot T ) scientie, tot inventa (inventa constat P), non posse eam naturam que res (res ea P) contineat, esse mortalem] «elegans persuasio immortalitatis». Tusc. 1, 89 (70r) quotiens non modo ductores nostri, sed universi (universi etiam Matr ed.) exercitus ad non dubiam mortem concurrerunt! Que quidem si temeretur, non Lucius Brutus arcens eum reditu tyrannum, quem ipse expulerat, in prelio occidisset (conc- Matr ed.); non cum (quod Matr) Latinis decertans pater Decius, cum Etruscis filius, cum Pyrro nepos se (ne posse Matr) hostium telis obiecissent; non uno bello pro patria cedentes (cadentis Matr) Scipiones Yspania vidisset, Paulum et Geminum Canne, Venusia Marcellum, Litana (Latini Matr) Albinum, Lucani Grachum (Grecum Matr)] «nota gloriosas mortes aliquorum ducum et imperatorum romanorum». In Matr, 116r-117r, ci sono due notabili incolonnati, «Brutus» e «Decius». Tusc. 1, 97 (71r) ‘magna me’ inquit (michi quidem Matr) ‘spes tenet, iudices, bene michi evenire, quod mittar ad mortem’ ] «oratio Socratis quando ad mortem mittebatur» nel margine sinistro; in quello destro, in una grafia diversa e di modulo più grande, si legge: «Socratis pulcra verba in morte». In Matr, 118v, c’è una graffa e la nota «Socratis oratio». In Sen. 13, 9, 4 (a Pandolfo Malatesta, Arquà, 8 giugno 1371) Petrarca riporta una citazione esplicita tratta dal discorso pronunciato da Socrate in punto di morte. 46 Negli scritti petrarcheschi Nestore è sempre associato alla longevità e alla sapienza, mai, però, è definito eloquente o facondo: vd. Sen. 10, 4, 56 (a Donato Albanzani, Padova, estate-settembre 1368) «sapientissimus Grecorum Nestor…» (vd. Pétrarque, Lettres de la vieillesse III. Rerum senilium libri VIII-XI, éd. crit. d’E. Nota. Trad. de C. Laurens. Prés., notices et notes de U. Dotti, Paris, Les Belles Lettres, 2004, cui si rinvia da qui in poi per i libri IX-XI) e TrF 2, 19 «Nestor che tanto seppe e tanto visse». 47 «Quid denique Ciceroni, in eo presertim libro quo senectutem defendit ab his vitiis atque incommodis que insani iuvenes illi obiciunt etati, in quo quidem Cato ipse censorius inducitur, tantus vir, agriculturam, mechanicam licet, tamen hauddubie utilissimam mundo artem, miris laudibus efferens atque inter multa salubria ac iocunda consitionibus atque insitionibus arborum nichil illam asserens invenisse solertius?» (Sen. 12, 1, 113, ed. a cura di M. Berté-S. Rizzo, in Petrarca e la medicina. Atti del Convegno di Capo d’Orlando, 27-28 giugno 2003, a cura di M. Berté, V. Fera e T. Pesenti, Messina, CISU, 2006). 24 monica berté Tusc. 2, 19 (76r) ‘heu! qui salsis (qui falsis Matr) fluctibus mandet / me ex sublimi vertice saxi? / iam iam assumor; conficit animam / vis vulneris, ulceribus estus’ ] «versus Sophoclis de dolore Herculis cum induit tunicam nesseo sanguine tinctam» e in interlinea «aliter ‘en’» sopra heu. Si confronti con Ov. Met. 9, 151-153 («omnibus illis / praetulit inbutam nesseo sanguine vestem / mittere»), di cui forse l’autore della postilla conserva un’eco. Tusc. 3, 71 (90v) itaque Oileus ille apud Sophoclem, qui Telamonem antea de Aiacis morte consolatus esset, is cum audisset de filio (suo Matr ed.), fractus est] «nota omnes melius consolari alios in luctu rebusque adversis quam se ipsos», accompagnata da una graffa e sormontata da una manicula che indica il periodo immediamente precedente. In Rom, 35ra, si trovano nel margine il notabile «Sophocles» e in interlinea «Aiace» sopra suo; in Matr, 142v, «Sophocles», «Thelamon», «Aiax». Tusc. 4, 14 (94r) est ergo egritudo opinio recens mali presentis, in quo demitti (demitti animi ed.) contrahique animo rectum esse videatur, letitia opinio recens boni presentis, in quo (quo hec Matr) efferri rectum esse videatur, metus opinio impendentis mali, quod intollerabile esse videatur, libido opinio (opinio om. Matr) venturi boni, quod sit ex usu iam presens esse atque adesse] «quid sit egritudo, qui vulgo dicitur tristitia» e sotto, in colonna, «quid leticia», «quid metus», «quid libido». Analogamente in Matr, 147v, si legge «quid est egritudo», «quid est leticia», «quid est metus», «quid est libido», con una graffa davanti ciascuna nota e in Rom, 38rb, «egritudo quid», «letitia», «metus», «libido». Tusc. 5, 81 (110r-v) sapientis est enim proprium nichil quod penitere (penitere quod Matr) possit facere, nichil iniuste (invitum Matr Rom ed.), splendide constanter graviter honeste omnia, nichil ita expectare quasi certo futurum…] «nota vere proprium sapientis», con una graffa che abbraccia tutto il periodo; inoltre sopra iniuste c’è la variante «aliter ‘invite’» e fra nichil e ita viene inserito non nell’interlinea. Similmente Rom, 56va, ha «sapientis proprium» e Matr, 169v, «nota quid sapientis proprium», entrambi con una graffa che evidenzia il passo. Catil. 1, 24 (117r) qui tibi ad Forum Aurelium prestolarentur armati…] «nota de Foro Aurelio». Catil. 2, 24 (121r) o bellum magno opere pertimescendum, cum hanc habiturus sit (sit habiturus H P R ed.) Catilina (c. H) scortorum (-tatorum R T) cohortem pretoriam! ] «yronice»48. rep. 6, 14 (146v) … vestra vero que vita dicitur (dicitur vita T ) mors est ] *49. Questa sentenza è ripresa da Petrarca in più luoghi: in modo esplicito in De rem. 1, 47, 14; in Sen. 1, 5, 52 (a Giovanni 48 Tale avverbio, che ritorna in Par più di una volta, è ampiamente attestato negli scolii medievali e anche nei margini di alcuni codici della biblioteca di Petrarca o di suoi apografi con altre orazioni ciceroniane. Per esempio nel Virgilio Ambrosiano, 3v, si trova di fianco a egl. 1, 73 (n. 51 in F. Petrarca, Le postille del Virgilio Ambrosiano, a cura di M. Baglio, A. Nebuloni Testa e M. Petoletti, Roma-Padova, Antenore, 2006, p. 203); o ancora nel Vat. Pal. lat. 1476, 96ra, e nel già citato manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli, IV B 8, 9rb, si incontra in corrispondenza dello stesso passo, dom. 47. Sul Pal. lat. 1476, scritto presumibilmente a Venezia alla fine del XIV secolo o all’inizio del XV del secolo, vd. supra, § 1, nota 12: n. 129, e Berté, Petrarca, Salutati, cit., pp. 31-32. In De vita sol. 1, 7, p. 106 (ed. a cura di M. Noce, Milano, Mondadori, 200012, cui si rimanda da qui in avanti) Petrarca riporta un’affermazione di Cicerone sulla solitudine tratta da off. 1, 158 («si omnia nobis que ad victum cultumque pertinent, quasi virgula divina, ut aiunt, suppeditarentur, tum preditus [preditus om. ed.] optimo quisque ingenio negociis omnibus omissis totum se in cognitione et scientia collocaret. Non est ita; nam et solitudinem fugeret») e precisa che questi aveva parlato ironice; di fianco a questo luogo del De officiis, 18v Par, da cui cito, ha la nota «posita obiectione respondet». Per altre occorrenze di quest’avverbio negli scritti di Petrarca vd. De vita sol. 2, 12, p. 282, e De rem. 2, 13, 12 (riferito entrambe le volte a un verso oraziano). 49 La graffa abbraccia anche il periodo precedente, il § 13, che è evidenziato nel margine opposto da una di un altro lettore. Anche l’Harleiano 5204, 1v, che conserva postille autografe di Petrarca, ha una manicula di fianco a rep. 6, 14. Da qui in avanti indico la graffa con l’asterisco (*). tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 25 Boccaccio, Padova, 28 maggio 1362) e in 3, 7, 39 (a Neri Morando, Venezia, 25 aprile 1363); in modo allusivo in Sen. 10, 4, 24 e 13, 1, 6 (a Niccolò d’Este, Arquà, 5 agosto 1370). Nella Sen. 1, 5 l’autore accosta esplicitamente il passo del Somnium Scipionis a quello quasi identico di Tusc. 1, 75 nam hec quidem vita mors est (senza segni d’attenzione in Par, 68r)50. Il corredo delle postille di Par è indubbiamente variegato e potrebbe derivare da fonti diverse; forse qualcuna di esse potrebbe risalire a Petrarca, magari modificata nel dettato dal trascrittore, anche se va osservato che lettori vicini a lui potevano annotare in un modo molto simile al suo. Nel complesso, comunque, l’analisi dei marginalia fornisce qualche indizio che sembra corroborare quelli ricavabili dal contenuto, dalla data e dalla provenienza del codice, che già di per sé puntano in direzione della biblioteca petrarchesca quale possibile luogo di origine dei materiali, o di parte di essi, riuniti nel manoscritto. Dunque, abbiamo forse un testimone contenente l’intero corpus delle Philippicae che potrebbe darci un’idea del perduto codice di Francesco, ma prima di passare all’analisi delle annotazioni e del testo delle orazioni contro Antonio tràdite da Par è necessario introdurre un altro possibile testimone. 3. Avignon, Bibliothèque Municipale, 1215 Di recente Jeroen de Keyser ha identificato un apografo petrarchesco della pro Archia, di cui sta curando una nuova edizione critica: il manoscritto 1215 della Bibliothèque Municipale di Avignone (Anc. fonds 386)51. Si tratta di una silloge di orazioni ciceroniane, ordinate nel seguente modo: Marcell. (1r-4r), Lig. (4r-8r), Deiot. (8r-12v), Phil. 1-14 (12v-62v), Arch. (62v-66r), p. red. ad Quir. (66r-69r), p. red. in sen. (69r-74r), exil. (74r-77r), Mil. (77r-87v), Manil. (87v, fino a § 3 oblata est in qua e nel margine inferiore c’è il regolare richiamo all’incipit del fascicolo che doveva venire dopo «oratio deesse nemini potest [possit ed.]», ovvero il seguito di Manil. 3)52. È un codice in pergamena 50 «Sunt autem duo hec: unum, quod hec nostra que dicitur vita mors est. Hoc iuvenis Cicero VI Reipublice libro scripsit; idem senex Tusculanarum questionum prima luce repetiit» (Sen. 1, 5, 52). Sia in Rom, 9vb, che in Matr, 114r, il passo delle Tusculanae è annotato: entrambe le postille sono edite e commentate da Rizzo, Un nuovo codice, cit., p. 87; per quella di Matr vd. anche Reynolds, Petrarch and a Renaissance Corpus, cit., pp. 429-430. 51 Ringrazio Jeroen De Keyser per avermi gentilmente fornito la descrizione del codice avignonese fatta da Anna Bellettini per l’I.R.H.T. Secondo lo studioso, che ha collazionato oltre duecento manoscritti, A appartiene al medesimo ramo del Laur. 23 sin. 3 ma non deriva da questo, rispetto al quale presenta un testo migliore; inoltre, è l’unico testimone del suo gruppo ad avere marginalia e variae lectiones riconducibili a Petrarca, il quale deve avere spedito più copie della pro Archia corredate dalle sue varianti alternative, scomparse nei discendenti, avendo ciascuno di questi optato per l’una o l’altra delle doppie lezioni del modello: vd. J. De Keyser, The Descendants of Petrarch’s Pro Archia, «The Classical Quarterly», LXIII, 2013, pp. 292-328, alle pp. 304-307 e 312. Sul Laur. 23 sin. 3 vd. supra, § 2, nota 18. 52 Il fascicolo è completo; la caduta materiale, quindi, riguarda quello o quelli successivi, dove, oltre al resto di quest’orazione, è possibile che ci fossero anche le altre due del quartetto di Lapo da Castiglionchio 26 monica berté di 87 carte (+37bis), scritto a piena pagina in un’umanistica databile agli anni quaranta del Quattrocento e collocabile in area settentrionale, probabilmente lombarda, come mi suggerisce Marco Petoletti. Fu posseduto dal convento dei domenicani d’Avignone, come si ricava dall’ex libris nel margine inferiore di 1r («Ex bibliotheca fratrum praedicatorum conventus Avinionensis»). A 1r e 12v vi sono le uniche due iniziali ornate presenti nel manoscritto e a 16r, in coda alla prima Philippica, è inserito un estratto da Giovenale (10, 122-126), preceduto dal titolo «Iuvenalis» ed evidenziato da una graffa nel margine sinistro e dalla nota «Iuvenalis versus» nel margine destro, vergate entrambe dalla stessa mano, coeva a quella del copista, che inserisce i notabilia, le postille e i titoli correnti in rosso53. Vi sono annotazioni di almeno un altro lettore, che compaiono soprattutto di fianco alla pro Milone, l’orazione che complessivamente ne ha il maggior numero. Le Philippicae sono apparentemente tredici per la lacuna fra quinto e sesto libro comune al ramo D (vd. supra, p. 9); tale errore provoca nei libri successivi qualche confusione del copista nell’indicazione della loro numerazione54. Nel margine inferiore di 37v, che contiene Phil. 7, 11-16, egli scrive l’esametro «quicquid penna notat veri de flumine manat». Il riconoscimento di questo apografo della pro Archia è stato possibile grazie alle variae lectiones che esso conserva, riconducibili agli interventi filologici eseguiti da Petrarca, e grazie ai marginalia, parzialmente coincidenti con quelli di altri manoscritti di sicura discendenza petrarchesca (vd. supra, § 1, p. 10). Riporto i luoghi di quest’orazione postillati da A e da almeno uno dei codici da me collazionati (L O P R V ), tralasciando i notabili e le graffe anche se coincidenti con quelli di altri manoscritti, dando il testo tràdito da A e specificando i casi in cui questo diverge dagli altri testimoni e/o dall’edizione critica55. Arch. 2 (62v) etenim omnes artes, que ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinclum et quasi cognatione quadam inter se continentur ] * «omnes artes coniunctas simul esse nota» A * «omnes artes esse coniunctas» O «nota» P V (P ha anche una graffa). Arch. 9 (63v) Metellus, homo sanctissimus modestissimusque omnium, tanta diligentia fuit…] «Metelli laudem nota» A «Metellus» P V. (pro Plancio e pro Sulla). Non è finora emerso il pezzo mancante al codice di Avignone, ossia un esemplare con un testo acefalo della pro lege Manilia in posizione incipitaria. 53 Vd. L.-H. Labande, Catalogue sommaire des manuscrits de la Bibliothèque d’Avignon (Musée-Calvet), Avignon, Seguin Frères, 1892, p. 148, e Id., Avignon. Tome I, in Catalogue général des manuscripts des bibliothèques publiques de France. Départements, Paris, Librairie Plon, 1894, vol. XXVII, pp. 536-537 (in ambedue i cataloghi il codice è datato alla fine del XV secolo). Una riproduzione dell’iniziale miniata di 12v si può trovare in http://www.enluminures.culture.fr. 54 Vd. 36v: «Explicit V Philippicarum liber. Incipit sextus» (Incipit sextus è in una grafia diversa e successiva a quella del copista); 37vbis: «Explicit liber V. Incipit liber VI. Liber VI incipit Philippicarum M.T.C.» (anche qui la seconda parte è aggiunta in inchiostro rosso da una mano diversa); 46r: «Explicit liber VIII. Incipit liber VIIII Philippicarum»; 50v : «Explicit X. Incipit XI eiusdem». 55 Per l’elenco e la discussione delle variae lectiones vd. De Keyser, The Descendants, cit., pp. 305-307, che pubblica anche la terza delle annotazioni che seguono nel mio testo. Per l’elenco delle orazioni contenute in L O P R V vd. supra, § 1, note 6-9 e 11. Par, lo ripeto, non ha la pro Archia. tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 27 Arch. 18 (64v) atqui (atque ed.) sic a summis hominibus eruditissimisque accepimus ceterarum rerum studia et doctrina et preceptis et arte constare, poetam natura ipsa valere et mentis viribus excitari et quasi divino quodam spiritu inflamari (afflari O inflari L P R V ed.)] «ars ceteros studiosos, natura poetam facit» A L O P V «poeta ipsa natura valet» R56. La nota in A e O è accompagnata da una graffa, in V da una manicula (vd. tav. II). V, inoltre, ha nella postilla facerit in luogo di facit e A ha nel testo sopra atqui la correzione «vel ‘-que’». Un’ulteriore prova dell’origine petrarchesca di questa nota è la citazione esplicita del luogo ciceroniano cui essa si riferisce in Coll. laur. 2, 7 e in Contra med. 1, 12057. Arch. 26 (65v) … trahimur omnes studio laudis et optimus quisque maxime gloria ducitur. Ipsi illi philosophi etiam illis libellis, quos de contemnenda gloria scribunt, nomen suum inscribunt…] * «audi Nasonem» A * * «glorie appetitus» O V P (quest’ulimo senza graffa). L ha una graffa. P e V condividono anche un’altra nota: «‘quid? nostri philosophi nonne in hiis libris ipsis quos scribunt de contempnenda gloria sua nomina inscribunt?’ Idem primo Tusculanarum (I° Tusol. V )», che rimanda a Tusc. 1, 34 («quid? nostri philosophi nonne in iis libris ipsis quos scribunt de contemnenda gloria sua nomina inscribunt?»), luogo ripreso da Petrarca in Coll. laur. 7, 2, dove è significativamente accostato a Ov. Pont. 4, 2, 35-36 («excitat auditor studium laudataque virtus / crescit et immensum gloria calcar habet»), a cui con ogni probabilità allude l’annotazione di A58. I versi ovidiani, inoltre, sono citati in Sen. 5, 5, 78 (a Donato Albanzani, Padova, 22 aprile 1367). A eccezione delle note in margine ad Arch. 2, che si ritrova quasi identica in O, ad Arch. 18, che dimostra la comune genesi di tutti i manoscritti collazionati, e ad Arch. 26, che rinvia a Ovidio, fonte accostata a Cicerone pure da Petrarca nel suo discorso per la laurea in Campidoglio, non ci sono coincidenze significative fra A e gli altri codici. Tuttavia l’importante indizio dato dalla presenza di una postilla identica a quella testimoniata dagli apografi petrarcheschi e la collocazione stemmatica di A per il testo della pro Archia invitano a considerare con più attenzione il manoscritto nel suo complesso alla ricerca di altre possibili tracce. Ho, quindi, effettuato una ricognizione di tutti i marginalia mettendoli a confronto con quelli petrarcheschi agli stessi luoghi. Anticipo subito che non ho ricavato da quest’esame indizi decisivi per l’attribuzione a Petrarca di qualche annotazione. Mi limito, perciò, a riportare pochi esempi, secondo l’ordine e il testo in cui le orazioni sono tràdite da A, ricordando che agli esemplari già menzionati vanno aggiunti H Par e l’autografo Vat per le orazioni conservate anche da essi59. La postilla di P, che omette per sbaglio natura, è edita da Billanovich, Petrarca, cit., p. 103. La Collatio fu scritta nel 1341, poi rivista negli anni successivi, mentre l’Invectiva contra medicum a partire dal 1352 e anch’essa fu sottoposta a revisione da parte dell’autore. Vd. C. Godi, La «Collatio laureationis» del Petrarca nelle due redazioni, «Studi petrarcheschi», n. s., V, 1988, pp. 1-58 (cui si rinvia da qui in avanti), a p. 31, e Petrarca, Invective contra medicum, cit., p. 40. 58 In corrispondenza delle parole Tusc. 1, 34 Rom, 4vb, ha una graffa. Le due annotazioni relative alla gloria di P sono edite da Billanovich, Petrarca, cit., p. 100. 59 Il Vat. lat. 2193 è una miscellanea con solo due scritti di Cicerone, la pro Marcello (82va-83vb) e la pro Ligario (153ra-154va), i cui marginalia autografi sono pubblicati da C. Tristano, Le postille del Petrarca nel 56 57 28 monica berté Marcell. 26 (3r) siquidem gloria est illustris et (ac L Par) pervagata magnorum (multorum magnorum L) vel (vel om. Par) in suos (suos cives L R Vat ed.) vel in patriam vel in omne genus hominum fama meritorum] * «nota quid sit gloria» A «diffinicio glorie» P Vat * * «gloria» R «descriptio glorie» O. Inoltre, Par e R hanno una manicula e Vat una graffa. A ha la variante «vel ‘maiorum’» in luogo di magnorum e L, che non ha segni d’attenzione, espunge ac e sovrascrive et, aggiungendo un altro et prima di illustris. Questa definizione ciceroniana della gloria è ripresa da Petrarca in Secr. 3, p. 25860. Deiot. 26 (10v) ego tamen frugalitatem, idest modestiam (modestiam et ed.) temperantiam, virtutem maximam iudico] «frugalitas quid sit vide» A «frugalitas» V. H ha una graffa. p. red. ad Quir. 4 (66v) sicut (sed sic H sed sicut L sic Par sed ed.) tam (tanquam H L O Par ed.) bona valitudo iocundior est his (eis L O iis ed.) qui eg (eg : ex egritudine Par e gravi morbo H L O ed.) sunt recreati (recreati sunt H L O Par ed.) quam qui non (numquam H L O Par ed.) egro (egri O) corpore fuerunt, sic hec (ea L O Par) omnia desiderata magis quam assidue percepta delectant ] * «comparatio» A O * * «comparatio egregia» L. H ha una graffa. A ha uno spazio bianco in corrispondenza della porzione di testo mancante (-ravi morbo). p. red. in sen. 5 (69v) cum virtute, gloria, rebus gestis Gneius Pompeius omnium gentium, omnium seculorum, omnis memorie facile princeps tuto se venire in senatum (in senatum venire O R) arbitraretur…] * A «laus ingens Gnei Pompei Magni» Par «magna laus Pompei» H «immensa laus Pompeii» R «divina laus Pompeii» O «Pompeius» L. Tutti i codici collazionati, salvo Par, hanno anche una graffa61. Mil. 28 (79v) cum hic insidiator, qui iter illud ad cedem faciendam apparasset, cum uxore veheretur in (et in O) reda, penulatus (penulatus vulgus O V), magno et (et om. O) impedimento ac (-dito et ed.) muliebri et (ac ed.) delicato ancillarum puerorumque comitatu] «ironia» A «yronice» P V. A ha la parola ironia scritta per esteso, mentre P V hanno yro-, che sciolgo con l’avverbio per analogia con altre postille62. A, inoltre, ha una crux accanto alla nota, sotto la quale si legge «idest longam vestem habens», che spiega penulatus del testo. Mil. 73 (c. 84r) eum qui civem quem senatus, quem populus romanus, quem omnes gentes urbis ac vite civium conservatorem iudicabant (iudicarant ed.) servorum armis exterminavit…] «intelligit autem hic Cicero de se ipso» A «de se loquitur» P V. Queste occorrenze non sono sufficienti per concludere che pure le altre orazioni tràdite da A, oltre alla pro Archia, discendono da un esemplare petrarchesco. D’altro canto, però, anche rispetto a quest’ultima, A risulta avere solo una porzione minima del corredo marginale petrarchesco testimoniato dagli altri apografi. A rigore, quindi, non si può escludere che il suo copista si sia comportato in modo altrettanto selettivo nei riguardi della postillatura originaria delle restanti orazioni oppure che gran parte di questa sia andata dispersa nel passaggio da una copia all’altra, dato che A è un testimone tardo, databile, come si è detto, agli anni quaranta del Quattrocento. Vaticano Lat. 2193 (Apuleio, Frontino, Vegezio, Palladio), «Italia medioevale e umanistica», XVII, 1974, pp. 365-468. Ricordo che è di mano di Petrarca anche il testo delle due orazioni. 60 Per il Secretum si rinvia a F. Petrarca, Secretum, a cura di E. Fenzi, Milano, Mursia, 1992. 61 La postilla di H è pubblicata da Billanovich-Pellegrin, Un manuscrit de Cicéron, cit., p. 116. 62 Su questa nota vd. supra, § 2, p. 24, con nota 48. tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 29 4. I marginalia alle Philippiche in Par e A Un discorso a parte richiedono i marginalia alle Philippicae, perché il confronto si può fare solo fra A Par Q per le prime quattro e fra A e Par per le restanti, dal momento che nessun altro degli apografi petrarcheschi con opere di Cicerone finora rinvenuti conserva le orazioni contro Antonio, a parte R, che però in margine a esse ha postille ricondotte da Silvia Rizzo al suo copista, Federico Spezia, e non a Petrarca (vd. supra, § 1, nota 8). Ne ho, comunque, tenuto conto ma esclusivamente in rapporto ad A Par e Q, tralasciando in questa sede i numerosi casi in cui presenta annotazioni a luoghi non postillati da questi tre codici63. Gli interventi critico-testuali tràditi da Par o da A non corrispondono mai alle correzioni eseguite da Petrarca su Q e né l’uno né l’altro hanno gli errori singolari di Q64. Le varianti alternative di Par, apposte in margine o in interlinea da due mani differenti, correggono guasti banali salvo che nei seguenti casi (qualora non sia specificato, è sottinteso che il testo di base di Par coincide con quello di A Q R e delle moderne edizioni e che quest’ultime nulla registrano in apparato): Phil. 1, 8 letius] «aliter ‘levius’» (A ha letius sovrascritto nel testo a una parola non più leggibile perché erasa e nel margine il passo è evidenziato da una graffa a forma di fiorellino); Phil. 2, 26 navis] «aliter ‘navem’»; Phil. 2, 61 quisquis… quisquis (quis qui… quis qui R ed.)] «aliter ‘quisque’» per due volte: la variante del primo quisquis è nel margine, l’altra in interlinea (la lezione a testo di A Par Q è dei sottogruppi n s v); Phil. 7, 3 ante (an A R ed.)] «aliter ‘aut’»; Phil. 11, 26 Bellidem (Byllidem ed.)] «aliter ‘Helidem’»; Phil. 13, 48 illum dignum] «aliter ‘illam dignam’»65. Analogamente anche le lezioni alternative di A rimediano sempre a una corruttela del testo di base tranne le poche eccezioni che riporto (se non è indicato, è implicito che il testo di base di A coincide con quello di Par Q R e delle moderne edizioni): Phil. 1, 27 si ita] «vel ‘cuiuslibet’» (il segno di richiamo che accompagna la variante di A è ripetuto nel testo sopra sopra si); Phil. 2, 17 defendendam] «aliter ‘defendendum’»; Phil. 2, 51 hostem togatum (hostem rogatus Par)] «vel ‘iure rogatus’»; Phil. 2, 53 inferendi (refe- Par)] «vel ‘deferendi’»; Phil. 2, 113 quam] «vel ‘quivis’»; Phil. 5, 2 potestas] «vel ‘posteritas’»; Phil. 8, 6 e laterna (Claterna Par R ed.)] «aliter ‘e caterva’»; Phil. 8, 7 cedem (penam Par R necem ed.)] «aliter ‘penam’» (R ha in interlinea «vel ‘cedem’»); Phil. 8, 13 denique (idem Par quidem ed.)] «aliter ‘dein’, aliter ‘den[uo]’» (la 63 Ricordo che le postille più interessanti di R alle Philippicae sono state già edite da Rizzo, Catalogo, cit., pp. 191-193. Per un caso di coincidenza fra la postillatura di Q e quella di R vd. § 5, p. 38, con nota 91. 64 A Phil. 2, 7, per esempio, A e Par hanno loca come la restante tradizione (R compreso), a eccezione di n, che ha ioca, variante accolta dalle moderne edizioni e congetturata da Petrarca in margine a Q (vd. Appendice, nota 106); a Phil. 2, 117 A e Par hanno la variante ingesta in luogo di inusta, mentre Q ha uno spazio bianco corrispondente alla lunghezza della parola mancante (vd. Appendice, nota 104). A, inoltre, ha nel margine «aliter ‘inusta’», che è lezione a testo in R. 65 Sia A sia Par hanno un buon numero di errori singolari che non vengono emendati e non risultano registrati dai moderni apparati. 30 monica berté prima delle due varianti di A è dei sottogruppi n s v; tutta la frase nell’edizione critica è diversa); Phil. 8, 28 venditabant (vindicabant Par vendicabant R)] «aliter ‘vindicabant’»; Phil. 9, 4 Tolomius (-lominus Par -lonius R -lumnius ed.)] «aliter ‘Colconius’». Sulla base delle tabelle di errori o varianti di trasmissione dell’edizione Magnaldi è possibile ascrivere sia Par sia A al gruppo β dei decurtati, cui appartengono n s v (n, però, è mutilo a partire da Phil. 13, 29). Più specificatamente, Par ha quasi tutti gli errori congiuntivi del sottogruppo γ (= n s)66, compresi quelli ereditati dal codice autografo di Poggio Bracciolini (Laur. 48, 22), il cui stretto legame con n s è garantito dalla condivisione di numerosi guasti significativi67. Anche A ha tutti i guasti di n s e del manoscritto di Poggio, ma nessuno di quelli riconducibili al solo γ (= n s) registrati dalla Magnaldi68. Veniamo ora alle annotazioni tràdite da A e Par. Vi sono casi in cui entrambi i codici, o uno dei due, ne hanno una di fianco a un passo evidenziato in Q e/o in R e casi in cui i soli A e Par reagiscono in margine al medesimo luogo, anche se non nel medesimo modo. Cito secondo la lezione dei manoscritti segnalando le eventuali discordanze fra loro o con le moderne edizioni e omettendo i casi in cui tutti hanno solo una graffa o un notabile di fianco allo stesso passo: Phil. 1, 29 ea (om. ed.) autem est (est autem ed.) gloria et (et om. ed.) laus recte factorum magnorumque in rem publicam meritorum] * A, 15r; «nota quid sit vera gloria» Par, 150v, con una manicula nel margine opposto; * «nota» R, 25v 69. Phil. 2, 61 quam miserum est id negare non posse quod sit turpissimum confiteri! Si te municipiorum non pudebat, ne veterani quidem exercitus?] * «proverbium» A, 22r; anche Q, 139va, ha una graffa, mentre R, 36r, una manicula. Si osservi che l’esclamazione ciceroniana a cui la nota di A è affiancata non è però esattamente un proverbio. Phil 2, 97 … statuiturque ne post M. Brutum pro consule sit Creta provincia] «M. Brutus» A, 25v; «de insula Creta» Par, 159r; «Creta» R, 40v. Phil. 2, 104 studiorum enim suorum M. Varro voluit esse (esse om. ed.) illud, non libidinum diversorium] * Q, 142va, e R, 42r; «commendatio M. Varronis» Par, 160r. Phil. 2, 112 nonne (non ed.) igitur milies (miles A miliens ed.) perire est melius quam in sua civitate sine armatorum (armorum A) presisidio non posse vivere? Sed nullum est istuc, michi crede, presidium; caritate et 66 Fanno eccezione soltanto Phil. 2, 9 ad iudicem con v per ad vicem di n s1 (ad civem ed.) e Phil. 2, 66 suppellex, lezione giusta, per supplex di n s. 67 Vd. Magnaldi, Cicerone, cit., pp. XXIII-XXIX; la studiosa precisa, motivandolo, che il manoscritto di Bracciolini doveva essere più vicino non a n ma a s e che, oltre a vari errori, s e Laur. 48, 22 hanno quattro lacune comuni integrate da Poggio con la collazione di v e non di b t. 68 Fa eccezione solo Phil. 2, 100 Ianuariis per Iuniis. 69 In apparato all’edizione critica si legge: «ea est autem b c t ea autem est n v s»; quindi ea è in tutti i decurtati, ma l’ordo verborum di A Par R dei soli n v s. Per l’attenzione petrarchesca ai luoghi ciceroniani in cui si parla della fama vd. Billanovich, Petrarca, cit., p. 100, nota 9, dove l’autore ricorda che «nel Secretum Francesco confessava a s. Agostino di avere raccolto le definizioni che Cicerone aveva dato della gloria». Per una nota di tenore analogo di fianco a Marcell. 26 vd. supra, § 3, p. 28. tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 31 (et : te et ed.) benivolentia civium septum oportet esse, non armis] * * «quando sit melius mori» A, 27r. Q, 143rb, ha una graffa; R, 43r, ha una manicula, come pure Par, 160v, che inoltre aggiunge un rimando a Sallustio già riportato (vd. supra, § 2, p. 20). Le parole da caritate ad armis sono citate alla lettera in Sen. 14, 1, 27. Phil. 2, 113 et nomen pacis dulce est et ipsa res salutaris, sed inter pacem et servitutem plurimum interest. Pax est tranquilla libertas, servitus postremum malorum omnium (omnium malorum R), non modo bello sed morte etiam repellendum] * «quid sit libertas, quid servitus» A, 27r; «nota de pace» e «nota» Par, 160v (rispettivamente nel margine sinistro e destro, vergate una dal copista e l’altra da un lettore successivo); * «nota» R, 43r, con una manicula. Q, 143rb, ha due graffe petrarchesche, una a destra e una a sinistra del testo, quella di sinistra sovrapposta a una di una mano precedente e quella di destra affiancata dalla postilla di un altro lettore che ripete le parole di Cicerone «pax est tranquilla libertas». Phil. 2, 116 fuit in illo ingenium, ratio, memoria, litteratura (litterae, cura ed.), cogitatio, diligentia] * «laus Cesaris» A, 27r ; «laus ingens Iulii Cesaris» Par, 161r; * «laudes eximie Cesaris» R, 43v70. Phil. 4, 2-3 C. Cesar, qui rem publicam libertatemque vestram suo studio, consilio, patrimonio denique tutatus est et (ut Par) tutatur maximis senatus laudibus ornatus est…; nichil est (est om. Par ed.) ex omnium singulorum (seculorum Q R ed.) memoria tale cognovi] «ad C. Cesaris laudem nota» A, 32r; «magna laus Cesaris» R, 51r; Q, 146vb, ha una graffa. Sia A sia Par hanno in luogo di singulorum la variante «aliter ‘seculorum’», tràdita da Q R e dal ramo del Vat. Arch. S. Pietro H 25 e accolta da Poggio nel suo Laurenziano71. Sotto la lezione alternativa l’annotatore di A precisa «hic collatum», che non rimanda al lessico filologico petrarchesco e che compare altre due volte in margine alle Philippicae: accanto a 3, 35-36 (31r) e a 4, 13 (33r). Phil. 4, 13 quanquam mortem quidem omnibus natura (natura omnibus Q ed.) proposuit, crudelitatem mortis et dedecus virtus propulsare solet, que (que ve A) propria est romani generis (nominis R) et seminis. Hanc retinete, queso, Quirites (Quirites om. Q), quam vobis tanquam hereditatem maiores vestri reliquerunt. Quanquam ([quamquam] ed.) omnia alia (omnia alia falsa Q alia omnia falsa ed.) incerta sunt, caduca, mobilia; virtus est una altissimis defixa radicibus] * * «romana virtus» Q, 147va; doppia manicula Par, 166r-v (una sotto l’altra, scritte rispettivamente nel recto e nel verso del foglio); * * «nota» R, 52r (anche qui le due graffe sono una sotto l’altra ed entrambe a forma di fiorellino)72. Phil. 5, 31 omne malum nascens facile opprimitur; inveteratum fit plerumque robustius] «proverbium» A, 36r; «nota» Par, 169v, e R, 57v, che ha pure una manicula. Phil. 8, 2 belli nomen ponendum quidam in sententia non putabant, tumultum appellare malebant…: potest enim bellum esse (esse bellum A R ed.) sine tumultu (ut tumultus non sit ed.), tumultus esse sine bello non potest] * «tumultus et bellum» A, 38r; «quid sit tumultus» Par, 172r; «bellum, tumultus» R, 62r. La lezione dei nostri quattro codici è di n s t v. A differenza di quanto si legge nei moderni apparati, non tutti i manoscritti della famiglia c cui appartiene Q hanno seculorum; per esempio il Laur. S. Marco 268, 31r, ha singulorum (ma seculorum ha C, il codice di Salutati, 44vb, sul quale vd. Appendice). È questo l’unico intervento critico-testuale alle Philippicae che A e Par hanno in comune, a meno di non considerare anche i due riportati nella tabella data sopra (Phil. 8, 7 e 28: vd. pp. 29-30), se si suppone che Par abbia accolto direttamente nel testo la variante che A registra nel margine. Per quel che riguarda le restanti orazioni, ne hanno soltanto altri due uguali, entrambi in margine alla pro rege Deiotaro: 3 exorsus (exortus ed.)] «aliter ‘extortus’»; 8 affectum] «aliter ‘afflictum’», lezione registrata nei moderni apparati. 72 L’omissione di Quirites è di b c (quaeso quaesoque t) e del ramo del Vat. Arch. S. Pietro H. 25 contro quaeso Quirites di s v (queso populo romano n). Par ha nel testo queso queso Quirites con il primo verbo espunto, mentre A ha la variante «aliter ‘quidem’» per quam e -te di retinete aggiunto in interlinea. 70 71 32 monica berté Phil. 8, 19 excogitare que tua ratio sit, Calene, non possum. Antea deterrere te ne popularis esses non poteramus; ut nunc sis popularis exorare (exorare nunc ut sis popularis ed.) non possumus. Satis multa cum Fusio (Fufio ed.) ac sine odio omnia, nichil sine dolore] «popularis» A, 39v; «hucusque cum Fusio, qui et Calenus, contentionem fecit auctor» Par, 173v. La postilla di Par (con est sottinteso nella relativa) chiarisce che l’autore fino a lì ha polemizzato con Quinto Fufio Caleno, console nel 47 a.C., appartenente al partito democratico, prima cesariano e poi filo-antoniano, a cui Cicerone si rivolge chiamandolo talora Q. Fusius talora Calenus (vd. Phil. 8, 11-12 e 15-16; 10, 3 e 5-6; 11, 15; 12, 3-4 e 18). La precisazione che Fusio e Caleno sono la medesima persona ritorna in margine a Phil. 10, 2 (176v) sententia eius qui rogatus est ante me: «scilicet Fusii, qui et Calenus», preceduta da un segno di richiamo che si ripete sopra eius nel testo. Phil. 8, 23 C. Pompilius (Pop- R ed.) apud maiores nostros cum ad Antiochum regem legatus missus esset… circumscripsit ] «C. Pompilius» A, 40r; «nota de Antyoco in circulo incenso a C. Pompilio ut responderet legationi» Par, 174r; «Popilius constans legatus ad Anthiocum» R, 65r 73. Phil. 9, 3 ego autem, patres conscripti, sic interpretor sensisse maiores nostros ut causam mortis censuerint, non genus esse querendum. Etenim cui legatio ipsa mortis fuisset causa (ipsa mortis causa fuisset A R ipsa morti fuisset ed.), eius monumentum extare voluerunt, ut in bellis periculosis obirent (ab- A) homines legationis munus audacius] * «legatorum honorem nota» A, 41v; Par, 175r, ha una graffa. In R, 67r, la o di obirent è su rasura. Phil. 9, 10-11 omnes ex omni etate qui hac (hac om. ed.) in civitate intellegentiam iuris (iuris om. ed.) habuerunt si unum in locum conferantur, cum Ser. Sulpicio non sint (sunt R) comparandi; neque (nec ed.) enim ille magis iuris consultus quam iusticie fuit; itaque (ita ea ed.) que proficiscebantur a legibus et a iure civili semper ad facilitatem equitatemque referebat ] * «audi magnum verbum» A, 42r; «nota» Par, 175v; * «non sic moderni» R, 68v74. Le parole di Cicerone da neque a fuit sono riportate da Petrarca in Sen. 14, 1, 100, che in luogo di consultus della fonte ha consulti, variante introdotta per adattare la citazione al contesto. Phil. 10, 20 magna nos quidem spem (quidem nos spe A ed.) et prope exploratam (-ta ed.) libertatis causam suscepimus; sed ut concedam incertos exitus esse belli Martemque communem, tamen pro libertate vite periculo decertandum est ] «nota omnia substinenda aut acquibenda (sic) pro libertate» Par, 178r; «incerti exitus belli» R, 72v; A, 45v, ha una graffa che abbraccia anche il periodo sotto riportato. Acquibenda di Par sarà errore per accipienda. Phil. 10, 20 nos ita a maioribus instituti atque imbuti sumus ut omnia consilia atque facta ad virtutem et ad dignitatem referamus (ad dignitatem et ad virtutem referremus ed.)] «laus Romanorum» Par, 178r; * «nota» R, 72v. Phil. 11, 17 nam extraordinarium semper (semper om. ed.) imperium populare atque ventosum est, minime nostre gravitatis, minime nostri (huius A R ed.) ordinis. Bello Antiochi (antiochino ed.)… surrexit P. Africanus] «Antiochus. C. Lelius. P. Africanus. L. Scipio» A, 48r ; * «bellum Anthiochi» R, 76r, con una manicula, come pure Par, 180v. L’episodio relativo alla difesa che l’Africano maggiore fece del proprio fratello, Lucio Scipione, davanti al senato perché gli fosse assegnata la provincia dell’Asia durante la guerra contro Antioco è raccontato anche da Liv., 37, 1, 9, in margine al quale sul Par. lat. 5690, 324ra, Petrarca appunta un rimando alle Philippicae75. Pompilius è variante di b t v. La postilla di R è edita da Rizzo, Catalogo, cit., p. 193 (n. 31). 75 La postilla del Livio Parigino «Africanus fratri legatus. De hoc in parte aliter Cicero Philippicis 9°» è edita in Nolhac, Pétrarque, cit., vol. II, p. 30; Petrarca, De viris illustribus, cit., p. 290 (Martellotti ha per 73 74 tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 33 Phil. 11, 28 est enim lex nichil aliud nisi recta (rata A) etiam (et R et[iam] ed.) a numine (munere A) deorum tractatio (tracta ratio A R ed.), imperans honesta, prohibens contraria] * «quid lex» A, 49v; «nota quid sit lex» Par, 181v, accompagnata da una manicula; * «lex, numen» R, 78v. Phil. 13, 14 licet autem nemini contra patriam ducere exercitum, siquidem licere id dicimus quod legibus, quod more maiorum institutisque conceditur. Neque enim, quid (quod A R ed.) quisque potest, id ei licet, nec, si non obstatur, propterea etiam permitittur ] * * «contra patriam exercitum ducendum non esse nota» A, 55r; «nota quid sit licitum» Par, 187r; R, 88r, ha una manicula. Vd. De gest. Ces. 20, 1, là dove Petrarca racconta il momento in cui Cesare comincia ad abusare del suo potere: «… vere tamen nulla sufficiens causa est contra patriam arma moventibus»76. Phil. 14, 32 brevis a natura vita nobis data est (autem nobis [vobis] vita data est A R), at memoria bene reddite vite sempiterneque (sempiterna. Que A R ed.) si non esset longior quam hec (hec : est ed.) vita, quis (qui R) esset tam amens qui maximis laboribus et periculis ad summam laudem gloriamque contenderet? ] * «nota verba de spe vite eterne» A, 61v; «nota de premio bonorum et pena malorum post exitum e vita» Par, 193v ; * «consolatoria» R, 99r. Phil. 14, 34 optima est hec quidem consolatio: parentibus, quod tanta rei publice presidia genuerunt] «consolatio parentum de mortuis in bello pro re publica» Par, 193v; A, 62r, e R, 99v, hanno una graffa. Ognuno dei nostri due esemplari ha, poi, marginalia in corrispondenza di luoghi non evidenziati dall’altro. Trascrivo per prime le annotazioni di Par, omettendo i segni d’attenzione o i semplici notabili e registrando tutte le corrispondenze con R: Phil. 2, 18 (153r) homo disertus non intelligit eum quem contra dicit laudari a se, eos apud quos dicit vituperari] «yronice»77. Phil. 2, 21 (153r) at Miloni ne favere quidem potui] «Milo iste occidit Publium Clodium»; nel De gest. Ces. 16, 2 Petrarca ricorda Milone come l’uccisore di Clodio: «Hunc [sc. Clodium], amicum Cesaris, Milo, amicus Marci Ciceronis, occiderat». In margine a Phil. 2, 11 (29r) cuius [sc. Clodii] quidem tibi (te A R) factum (fatum A ed.)78, sicut C. Curionem (Centurionem A -ni ed.), manet, quoniam id domi (domui Q domus ed.) tue est quod fuit illorum utrique fatale R ha una postilla con un rimando interno proprio a Phil. 2, 21: «quia P. Clodius fuit a Milone interfectus, ut patet infra in presenti libro, et ita sperabat Tullius quod eveniret de Antonio quod similiter evenerat de Curione, quia ut illi fuerant homicide, legum neglectores et omni flagitio corrupti, sic et erat Antonius». Phil. 2, 25 (153v) sed hec vetera, illud vero recens, Cesarem meo consilio interfectum] «hic excusat se auctor de morte Cesaris». Phil. 3, 20 (163r) convenerunt conrogati (contogati R)] «nota de consilio conrogatorum» con un disegno sottostante in inchiostro rosso che raffigura un castello. R, 47r, ha la variante «vel ‘conrogati’». primo segnalato che la nota rimanda all’undicesima Philippica e non alla nona come scrive Petrarca); Berté, Petrarca e le Philippicae, cit., p. 246, nota 2. 76 Per il De gestis Cesaris si rinvia qui e sempre all’ed. a cura di G. Crevatin, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2003. 77 Su questa annotazione, che ricompare anche più avanti (Phil. 8, 18; 10, 21; 13, 4), vd. supra, § 2, nota 48. 78 Il copista di R espunge, come anche Q, 136ra, la c di factum, lezione di tutta la tradizione salvo il sottogruppo b e il ramo del Vat. Arch. S. Pietro H. 25. 34 monica berté Phil. 5, 24 (169r) circumsedit (-sedet ed.) Mutinam, firmissimam (fortissimam A) et splendidissimam populi romani coloniam] «laus Mutine». R, 56v, ha «Mutina». Phil. 7, 1 (170r) de Apiana (Apia via A Appia via R ed.) et de Moneta consul… refert] «Apiana et Moneta leges apud Romanos». Il testo tràdito da Par non è di immediata comprensione non solo per l’erroneo Apiana in luogo di Appia via, della quale il console Pansa voleva discutere forse dei lavori di manutenzione, ma anche per l’ellittico Moneta, epiteto di Giunone così chiamata per aver avvertito (moneo) i Romani di un terremoto imminente, che sottintende il tempio dedicato alla dea sul Campidoglio. Non stupisce, dunque, che l’annotatore abbia frainteso entrambi i termini ritenendoli nomi di leggi79. Phil. 8, 18 (173v) vide quanta caritas sit patrie: cum homini sit iratus, tamen rei publice causa defendit Antonium] «yronice». R, 64r, ha una postilla identica, affiancata da una graffa. Phil. 10, 21 (178r) quamquam habet secum Lucium fratrem… cuius desiderium civitas ferre diutius ( ferre diutius civitas ed.) non potest ] «yronice». Anche in questo caso R, 72v, ha la stessa annotazione di Par 80. Phil. 12, 7 (183v) quem ad modum vestrum (nostrum A ed.) consilium hoc (hoc consilium ed.) Capua probabit, que temporibus hiis Roma altera est? ] «nota amplitudinem et potentiam Capue». R, 81r, ha «Capua». Phil. 12, 10 (183v) Patavini alios excluserunt, alios eiecerunt missos ab Antonio] «nota de Patavo et Patavinis». R, 81v, ha «Patavini». Phil. 13, 4 (186r) o fidam dexteram Antonii (-ni ed.) qua ille plurimos cives trucidavit, ornatum (o ratum ed.) religiosumque fedus quod cum (quodcumque R quod cum Antoniis ed.) fecerimus! Hoc si M. Antonius (Antonius A R Marcus ed.) violare conabitur horeum (horeum : non eum A R Luci eum ed.) sanctitas a scelere revocabit ] «yronice», come pure R, 86r, che inoltre ha la variante marginale «aliter et melius ‘quod cum his fecerimus! Hoc si Antonius violare conabitur Lucii eum sanctitas a scelere revocabit’» in luogo di quodcumque… revocabit che viene sottolineato; è espunta anche la seconda i di Antonii. Par divide con un trattino verticale hor da eum (-or è in rasura) e fra cum e fecerimus aggiunge in interlinea forse -que, ma la lettura non è sicura81. Phil. 14, 8 (191v) declaravit in Parmensium calamitate, quos optimos viros honestissimosque homines, maxime cum auctoritate huius ordinis populique Romani dignitate coniunctos, crudelissimis (-me R ante corr. -mus R post corr.) exemplis (exemplis om. A R) interemit (interfecit R) proludium (prelu- R propu- ed.) illud et portentum, L. Antonius] «nota de Parmensibus commendationem». R, 95v, ha «Parmensium calamitas». Il passo è evocato da Petrarca ben due volte: al § 9 della già ricordata Fam. 3, 3 e in un’annotazione vergata sul suo Svetonio dell’Exeter College. Si osservi per inciso che questa e altre postille di Par evidenziano il valore di città e cittadini fedeli a Roma e ostili ad Antonio: oltre a Parma, Padova (Phil. 13, 4), entrambe care a Petrarca, nonché Capua (Phil. 12, 10), da lui definita «olim prepotens…, nunc regina urbium Parthenope» in Fam. 7, 1, 4 (a Barbato da Sulmona, Avignone, 11 settembre 1347), e Modena (Phil. 5, 24), il cui assedio a opera di Antonio è ricordato, insieme a quello di Parma, sia in Fam. 3, 3, 9 Una nota di Par che mostra la stessa attenzione per le leggi romane si trova in margine a post. red. in sen. 11, 133r ut lex Allia (Elia A R ed.) et Fusia non (Suffia ne A Sufia ne R Fufia ne ed.) valeret, que nostri maiores tutissima presidia (certissima subsidia R ed.) rei publice contra tribunitios furores esse voluerunt?] «Allia et Fusia leges fuerunt ab Allio et Fusio auctoribus edite». Qui A, 70v, ha una graffa. 80 L’ordo verborum dei nostri codici è attestato dai sottogruppi n s (ferre civitas diutius b t v). 81 L’omissione di Antoniis è di n s; non di A R è tràdito dal solo n (L[uci ] b t v). 79 tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 35 sia nella nota dello Svetonio di Oxford, ma anche in Rer. mem. 2, 63, 1 e in Fam. 18, 1, 43 (a Carlo, 23 novembre 1353)82. A sua volta, in margine a passi non toccati da Par, A conserva diversi notabili o graffe, che non elenco a meno che non siano accompagnati da un’annotazione vera e propria: Phil. 1, 3 (12v) dictaturam, que vim iam (nimium Par iam vim R ed.) regie potestatis obsederat (obtinebat R), funditus ex re publica sustulit ] «dictatura quid fuerit olim aspice». R, 21r, ha «dictatura» con una graffa. Phil. 1, 8 (13r) nec ita multo post edictum Bruti affertur et Cassii… plenum equitatis videbatur] «ad Brutum et Cassii laudem dicta esse nota». Phil. 1, 10 (13r) si quid michi humaniter (-tus Par Q R ed.) accidisset] «humaniter». Queste parole di Cicerone sono citate alla lettera in Fam. 23, 2, 33 (a Carlo IV, Milano, 21 marzo 1361), dove però si legge humanitus, lezione accolta dalle edizioni moderne e tramandata da Par Q R, che non hanno segni d’attenzione; il guasto di A si spiega come banale errore di scioglimento dell’abbreviazione di -us. Phil. 1, 33 (15v) carum esse civem, bene de re publica mereri, laudari, coli, diligi gloriosum est; metui vero et id odio (et in odio Q ed. et odio R) esse invidiosum, detestabile, imbecillum, caducum] * «quid sit gloriosum esse». R, 26r, ha «hac via itur ad gloriam, imo ‘sic itur ad astra’ (= Verg. Aen. 9, 641)» con una graffa83. Il passo ciceroniano è riferito alla lettera in Sen. 14, 1, 17, che però ha odio, come R, per id odio di A Par e in odio delle moderne edizioni e di Q, il quale ha una graffa non petrarchesca nel margine. Il verso virgiliano di cui la nota di R riporta la fine è citato da Petrarca per esteso nel Secr. 1, p. 106, e parzialmente in Fam. 7, 17, 13 (a Giberto Baiardi, Padova, 26 marzo 1351). Phil. 2, 5 (16v) quod est aliud, patres conscripti, beneficium latronum nisi ut commemorare possint his (iis ed.) se dedisse vitam quibus non ademerint?] * «latronum beneficium». Questa postilla è in una grafia diversa da quella che verga la maggior parte delle note e la graffa è a forma di fiorellino. R, 27v, ha una manicula. In De rem. 2, 61, 4 Petrarca afferma: «Non est enim aliud beneficium latronum, quam quod Cicero ait in Philippicis, ut commemorare possint his se vitam dedisse, quibus non ademerunt». Phil. 2, 103 (26r) ab hac perturbatione relligionum advolas in M. Varronis, sanctissimi atque integerrimi viri, fundum Cassinantem (-nacum Par Casinatem Q R ed.)] * «in M. Varronis laudem dici nota». R, 41v, ha «M. Varronis fundus Cassinas». Phil. 3, 15 (29r) ignobilitatem obiecit (obicit Par Q R ed.) G. Cesaris filio, cuius etiam naturalis (-ra ed.) pater, si vita suppeditasset, consul factus esset. ‘Aricina (Arigina Q Aritina R) mater’… Videte quam despiciamur (-am Par) omnes qui sumus e municipiis id est, omnes plane: notus (quotus ed.) enim quisque non (nostrum R nostrum non ed.) est? ] «nota Cesarem municipem natum». Integro nella nota la seconda m di municipem: l’annotatore rileva che, essendo originario di Ariccia, Cesare era di un 82 Per Fam. 3, 3, 9 vd. supra, nota 3; per la nota dello Svetonio di Oxford, Exeter College, 186, 212va, in margine ad Aug. 17, 2 vd. Berté, Petrarca lettore, cit., p. 72 (n. 283: «Bononienses Antonii amici, ut hic, Mutinenses contra, quos obsedit – patet supra –, et Parmenses, quos crudelissime interemit, ut in Philippicis»). Proludium è di s t v. 83 La postilla di R è edita da Rizzo, Catalogo, cit., p. 191 (n. 17). 36 monica berté municipio e, dunque, non cittadino romano a pieno titolo. In Q, 144vb, Petrarca corregge Arigina in Aricina e nel suo codice svetoniano già citato, Oxford, Exeter College, 186, ritrovando in Aug. 4, 2 (11rb) la notizia che la famiglia di Augusto da parte di madre, sorella di Cesare, era originaria di Ariccia (Aricie ha qui il testo), la collega a questo luogo delle Philippicae con la postilla «‘aricina mater’: Philippicarum 3, columna 5, in fine»)84. R, 46v, ha una graffa e la variante interlineare «vel ‘-iecit’», attestata anche da A, sopra a -icit di obicit. Phil. 4, 1 (31v) Frequentia vestrum incredibilis… tanta quantam meminisse non videor] «Lucanus: ‘Tullius eloquii romani maximus auctor’ (= Lucan. 7, 62-63)». I versi della Pharsalia hanno nelle moderne edizioni un diverso ordo verborum: «cunctorum voces romani maximus auctor / Tullius eloquii». Phil. 8, 12 (39r) sed, queso, Calene, quid tu? Servitutem pacem vocas? Maiores quidem nostri non modo ut liberi essent sed etiam ut imperarent arma capiebant; at (at om. ed.) tu arma abicienda censes ut serviamus? que causa iustior est belli gerendi quam servitutis depulsio?] * «Calenus» e «nota de servitute». R, 63r, ha lo stesso notabile. Va precisato che, oltre a questa, la coincidenza di notabili in margine alle Philippicae fra i due manoscritti è significativamente alta85. Phil. 9, 10 (42r) nec vero silebatur (-bitur Par R ed.) admirabilis quedam et incredibilis et (ac ed.) pene divina (-ne Par) eius (sc. Ser. Sulpicii) in legibus interpretandis, equitate explicandi (-da Par ed.) scientia] * «Servium Sulpicium iurisconsultum fuisse nota» (vd. supra, p. 32). R, 68v, ha «ingentissime laudes Ser. Sulpicii» con una graffa che evidenzia quasi tutta la pagina. Phil. 9, 12 (42r) est enim (om. Par autem ed.) ita affectus ut nemo unquam unici filii mortem magis doluerit quam ille meret patris. Equidem (Et quidem ed.) etiam ad famam Ser. Sulpici filii arbitror attinere (pertied.) ut videatur honorem debitum patri prestitisse] * «fili amorem erga patrem nota». Integro la sillaba -rem di amorem. R, 68v, ha «laus quam ingens filii de pietate in patrem» con una graffa86. Phil. 9, 14-15 (42v) sed statue intereunt tempestate, vi, vetustate ([vel vetustate] ed.), sepulchrorum autem sanctitas in ipso solo est, quod nulla vi moveri neque deleri potest, atque, ut cetera extinguntur, sic sepulchra sanctiora fiunt (fiunt sanctiora R) vetustate. Augeatur igitur isto etiam honore (honore etiam ed.) is vir cui nullus honos (honor R) tribui non debitus potest; gratissimus (grati simus R grati[s] simus ed.) in eius morte decoranda cui nullam (nullam iam Par ed.) aliam gratiam referre iam (iam om. Par ed.) possumus] * «sepulchra sancta dici nota». Vd. Sen. 10, 4, 12: «Quamvis autem ciceroniana sententia sit Philippicarum libro VIII gratiam aliam referri mortuo non posse quam statue vel sepulcri, apud nos tamen quedam maior est gratia, preces scilicet ad Deum fuse pro defuncti anima ac salute»87. Sulla correzione di Q, sulla nota dello Svetonio di Oxford e su un’ipotesi di identificazione del manoscritto cui Petrarca rimanda vd. Berté, Petrarca lettore, cit., p. 64 (n. 238) ed Ead., Petrarca e le Philippicae, cit., p. 280 (n. 130), con il mio commento. Arigina è lezione di c t (ancina v). Il quarto capitolo del secondo libro del De remediis reca il titolo De ignobili patria, nel quale Ratio afferma che l’origine umile di un uomo virtuoso non lo rende ignobile, ma che anzi è la sua patria a essere nobilitata da lui; per dar forza all’argomento, viene messa in campo una serie di esempi tratti dall’antichità, fra cui il filosofo Biante (sul quale vd. supra, § 2, pp. 21-22) e Augusto: «Summo hominum Augusto, etsi recens romana, quia ipse scilicet in palatio natus sit, origo tamen gentis antiquior veliterna est» (§ 10). Veliterna è aggettivo riferito al nome della città di Velletri, ma anche alla regione della quale essa faceva parte insieme ad Ariccia. Su Augusto nativo di Velletri vd. Suet., Aug. 94, 2, di fianco a cui nel suo codice oxoniense, 21va, Petrarca appone il notabile «Velitre» (n. 520 della mia edizione). 85 At è attestato in s t v. Su Caleno vd. supra, p. 32. 86 Attinere è tràdito da n s. 87 Questo e il paragrafo successivo dell’epistola mancano nel testo precanonico; Petrarca deve aver aggiunto il rinvio alla nona Philippica, che per lui era l’ottava (vd. supra, p. 9), solo nella redazione definitiva. 84 tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 37 Phil. 10, 10 (44r) erat ei spes una in Antonio (in C. Antonio ed.), qui duorum fratrum etatibus medius (etatibus mediis Par medius etatibus R) interiectus cum (cum : viti<i>s cum ed.) utroque certabat] «vide tres Antonios». Phil. 11, 8 (47r) ac Dolabella quidem tam fuit immemor humanitatis… ut suam insatiabilem crudelitatem exercuerit (exac- Par) non solum in vivo sed etiam in mortuo] «Dolabelle crudelitatem nota». Phil. 11, 24 (49r) … reddite prius nobis Brutum, lumen et decus civitatis] «Bruti honorem nota». R, 77v, ha «Brutus lumen et decus civitatis. Ergo non in centro inferni ponendus, ut eum describit Danthes»88. Phil. 13, 30 (57r) … M. Cato, idem (idemque Par R ed.) omnium gentium virtute princeps] «Marci Catonis laudem nota». R, 90v, appunta «Catonis summa laus» con una graffa. Phil. 14, 32 (61v) illi igitur impii quos cecidistis etiam ad inferos penas parricidi luent; vos vero qui extremum spiritum in victoria effudistis piorum estis sedem et locum consecuti] * «qui ad inferos penam luent». R, 99r, ha una manicula e una graffa. 5. Conclusioni Tirando le somme, abbiamo preso in esame tre manoscritti, l’Harl. 4927, il Par. lat. 6342 e il codice 1215 della Bibliothèque Municipale di Avignone, che per ragioni diverse potrebbero avere un legame, diretto o indiretto, con la biblioteca di Petrarca. Sebbene, infatti, in base alle argomentazioni di Fiorilla i marginalia dell’Harl. 4927 assegnati al giovane Francesco da Billanovich e Pellegrin non possano più con sicurezza ricondursi a lui, un nuovo controllo autoptico del codice mi ha portato, comunque, a non escludere un contatto fra di esso e Petrarca (la presenza di una manciata di graffe a forma di fiorellino simili nel tratto a quelle da lui tipizzate a cominciare dagli anni quaranta). Inoltre, dell’Harleiano sappiamo che almeno fino al 1411 conteneva tutte le Philippicae, grazie alla sua identificazione con il manoscritto n. 829 della biblioteca di Benedetto XIII; tale riconoscimento ha offerto un ulteriore spunto di riflessione: Petrarca potrebbe non averlo posseduto, ma averlo solo consultato nella libreria papale o avuto in prestito per un periodo limitato, così come è accaduto per altri volumi lì conservati89. Questa ipotesi si concilia con un’altra da me avanzata, ovvero che sia il Par. lat. 5802 (non l’Harleiano) il primo codice con le Philippicae di cui Petrarca fu proprietario, come si desume dalla ricca messe di correzioni e segni d’attenzione di sua mano, che difficilmente si giustifica se non con la mancanza di un esemplare con il corpus completo, e dal comparire di citazioni delle orazioni contro Antonio nella La postilla di R è edita da Rizzo, Catalogo, cit., 193 (n. 33). Basti pensare alla Naturalis historia di Plinio che egli poté leggere nella biblioteca avignonese, quando compose i Rerum memorandarum libri tra il 1343 e il 1345, prima di acquistare a Mantova il 6 luglio 1350 il suo Par. lat. 6802: vd., da ultimo, M. Petoletti, Francesco Petrarca e i margini dei suoi libri, in «Di mano propria». Gli autografi dei letterati italiani. Atti del Convegno internazionale, Forlì, 24-27 novembre 2008, a cura di G. Baldassarri, M. Motolese, P. Procaccioli, E. Russo, Roma, Salerno, 2010, pp. 93-121, a p. 101, con la bibliografia ivi citata. 88 89 38 monica berté produzione petrarchesca solo a partire dagli anni cinquanta (con un’unica eccezione, che però è dubbia: vd supra, p. 10). Oltre a questo generico termine post quem non si riesce ad andare: non è infatti possibile ricostruire con maggior esattezza quando il primo manoscritto con tutte le Philippicae sia giunto nella mani di Petrarca, né tanto meno per quale via e con quale facies 90. Le altre due sillogi ciceroniane, il Parigino e il codice di Avignone, conservano l’intero corpus delle orazioni contro Antonio, così come il Vat. Ross. 957, la cui postillatura è stata attribuita al suo copista Federico Spezia e datata dopo il 1415 (a 100r si legge: «Explicit liber Marci Tuliii Ciceronis Philippicarum anno domini M°CCCCXV°»). Non è, tuttavia, da escludere che, al pari di altre orazione da esso tràdite, anche le Philippicae conservino qualche nota di origine petrarchesca: in aggiunta ai casi riportati nelle tabelle di § 4 in cui R glossa lo stesso passo di Par e/o A, ce ne sono altri nei quali R reagisce a un luogo evidenziato da Q (e non da Par e A)91. Dopo aver partecipato al concilio di Costanza, nel 1417-1418 Spezia «si trovava in servizio a Firenze… e andava e veniva da Venezia, che era in rapporto con umanisti come il Traversari, il Barbaro, l’Aurispa e che compare, nel luglio 1426 e in seguito, al servizio dei Visconti di Milano»: è plausibile, quindi, che egli abbia avuto più di un’occasione per entrare in contatto con manoscritti provenienti dalla biblioteca di Petrarca92. Circa tre decenni dopo l’allestimento di R, ossia intorno agli anni quaranta del Quattrocento venne copiato, probabilmente in Lombardia, A; Par, invece, si colloca cronologicamente molto prima, a ridosso della morte di Petrarca (1374-1376), e geograficamente in area transpadana. Sul piano testuale, da un primo sondaggio limitato alle tabelle di errori e varianti delle Philippicae edite dalla Magnaldi, A e Par, risultano appartenere al sottogruppo γ del ramo D, anche se ciascuno con lezioni e guasti propri; quanto a R, è difficile stabilire a quale famiglia appartenga il suo testo di base, dal momento che in esso la contaminazione ha agito a più livelli93. 90 Relativamente a essa, però, abbiamo una preziosa indicazione, ovvero l’annotazione conservata dall’apografo Pal. lat. 1820, 17v («hec ipsa sententia et sequens est 1° Philippicarum, columna antepenultima, non procul a fine»), che rinvia a Phil. 1, 33-34 e che è in margine a off. 2, 23, dove Cicerone afferma che il timore e l’odio degli uomini sono fatali per chiunque voglia avere un potere duraturo. La postilla, che ho già pubblicato (vd. Berté, Petrarca e le Philippicae, cit., p. 247 nota 2), rimanda a un codice con le Philippicae diverso dal Par. lat. 5802, 134vb, dove il passo di Phil. 1, 33-34 si trova non alla fine, bensì all’inizio della penultima colonna del primo libro. 91 In margine a Phil. 3, 13 R e Q hanno una postilla quasi coincidente: in R, 46r, lo Spezia scrive «laudes Gallie Cisalpine», analogamente a quanto appunta Petrarca in Q, 144va, «laus Gallie Cisalpine», ambedue con un segno d’attenzione, ma tale coincidenza non è, a mio avviso, rilevante; una nota dello stesso tenore si trova anche nel codice di Salutati vd. Appendice, nota 103. 92 Rizzo, Catalogo, cit., p. 196. Per le altre sottoscrizioni datate Costanza 1415 vd. ivi, p. 153: di R entrò, poi, in possesso il cardinale Domenico Capranica (è registrato nell’inventario del 1480 conservato nel Vat. lat. 8184, 40r). 93 Interessante al riguardo è la postilla di R, 48v, a Phil. 3, 28 «secundum quedam volumina hic est principium libri quarti», collocata di fianco alla riga con Hodierno (-ne ed.) die etc., davanti alla quale nel testo viene inserito un segno di paragrafo: evidentemente l’annotatore conosceva più di un testimone in cui la quarta Philippica iniziava in questo punto. tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 39 La presenza nei nostri codici di annotazioni ad altre opere ciceroniane che sembrerebbero risalire a un antigrafo petrarchesco e la perdita dell’esemplare del poeta con tutte le Philippicae mi hanno indotto a un’analisi incrociata dei rispettivi marginalia, che però non ha dato conferma né di un rapporto fra di essi (non c’è alcun caso significativo di coincidenza nella postillatura)94, né di una loro sicura discendenza da Petrarca. È altresì indubbio che, oltre alle annotazioni di R, di cui già la Rizzo ha sottolineato l’interesse, anche quelle di Par, qualunque sia la loro paternità, meritano attenzione, così come la fisionomia stessa del codice che ospita un gran numero di testi di Cicerone, una lista di sue opere conservate e non, una raccolta di epitafi composti per lui, nonché le due Familiari di Petrarca a lui indirizzate. Del resto, una presenza diffusa di cultori e raccoglitori trecenteschi di testi di Cicerone nell’Italia settentrionale è documentata anche da altre testimonianze, come il manoscritto Gudiano lat. 2 di Wolfenbüttel, l’imponente silloge di scritti filosofici allestita e riccamente postillata dal giudice padovano Rolando da Piazzola95, o il già ricordato volume del grammatico bergamasco magister Crottus 96. 94 Ci sono solo tre eccezioni, ma per nulla dirimenti, fra Par e A: la lezione alternativa in margine a Phil. 4, 3 e le note in margine a Phil. 2, 116 e 11, 28. Tre volte Par e R hanno «yronice» in margine allo stesso passo (Phil. 8, 18; 10, 21; 13, 4); ci sono infine due note quasi identiche fra A e R di fianco a Phil. 8, 2 e 13, 30 (tutte registrate nelle tabelle di § 4: vd. supra, pp. 31, 33-34, 37). A e R hanno poi, come si è osservato, un numero abbastanza alto di notabili e di segni d’attenzione coincidenti, che fanno supporre un qualche legame fra di essi o, più probabilmente, un antigrafo comune. 95 Vd. G. Billanovich-P.L. Schimidt, Cicerone e i primi umanisti padovani. Il codice Gudiano lat. 2 di Wolfenbüttel, «Italia medioevale e umanistica», XXVIII, 1985, pp. 37-56. 96 Su di lui vd. supra, § 2, p. 18, con nota 30. 40 monica berté Appendice Il Par. lat. 5802 di Francesco Petrarca e il Par. nouv. acq. lat. 3070 di Coluccio Salutati È stato ipotizzato che il Par. nouv. acq. lat. 3070, appartenuto a Coluccio Salutati e risalente alla stessa famiglia del Par. lat. 5802, sia un apografo petrarchesco. Si tratta di un codice in pergamena, copiato nel XIV secolo, che contiene l’Epitome di Floro (1ra-27vb) e le prime quattro Philippicae (27vb-46ra), e ha l’indicazione dei fogli in numeri arabi e non, come nella maggior parte dei codici colucciani, romani: «102 Carte 99» (1r)97. Sul foglio di guardia iniziale si legge «Florus, qui raro occurrit manu exaratus, sec. XIII compegit C. Lewis. Henry Drury», mentre su quello finale «Vente de S. G. Hamilton, de Hertford College, Oxford Sotheby, juillet 1917, p. n. 184» (il numero di pagina non è indicato e, in corrispondenza, c’è uno spazio bianco)98. Ha subito la perdita di 53 fogli, che però, secondo Ullman, non dovevano contenere i restanti libri delle Philippicae, perché «there is a group of manuscripts containing only the first four of these orations»99. Per Rouse e Reeve il manoscritto potrebbe, appunto, essere una copia di Q o «at least a close relative». Tuttavia la celebre epistola di Coluccio a Lombardo Della Seta, scritta da Firenze il 13 luglio 1379, nella quale chiede copia di testi ciceroniani presenti nella biblioteca petrarchesca, documenta che egli possedeva già un codice con le prime quattro Philippicae e che da Padova desiderava ricevere le rimanenti100. Dalla testimonianza di Petrarca sappiamo, inoltre, che un manoscritto con le Philippicae, verosimilmente con le prime quattro, si trovava a Firenze già nel 1351 e che, dunque, almeno a partire da questa data Salutati avrebbe potuto procurarsene una copia in città, senza bisogno di cercarla altrove101. Non c’è modo di appurare se questa copia, ovvero l’esemplare menzionato nella lettera a Lombardo, fosse proprio Vd. Rouse-Reeve, Speeches, cit., p. 78, nota 146. Henry Drury fu nel primo Ottocento proprietario anche dello Svetonio petrarchesco ora conservato all’Exeter College di Oxford; vd. Berté, Petrarca lettore, cit., p. XIII, con la bibliografia ivi data. Si osservi che, come Q, anche C tramanda l’Epitome di Floro. 99 B.L. Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati, Padova, Antenore, 1963, pp. 196-197 (n. 102). A riprova di questa affermazione si aggiunga che la scrittura del codice si interrompe a metà della col. a del recto dell’ultimo foglio. Su C vd., da ultimo, Coluccio Salutati e l’invenzione dell’umanesimo, a cura di T. De Robertis-G. Tanturli-S. Zamponi, Firenze, Mandragora, 2008, pp. 345-346 e 359 (n. 133). 100 Vd. C. Salutati, Epistolario, a cura di F. Novati, 4 voll., Roma, Istituto Storico Italiano, 1891, vol. I, p. 332; si veda, inoltre, Nolhac, Pétrarque, cit., vol. II, pp. 280-281. Nella lettera Coluccio riporta l’incipit delle quattro orazioni; l’inizio della seconda nell’ed. Novati dell’epistolario ha quoniam per quonam dell’intero ramo dei decurtati (compresi Q e C) e delle moderne edizioni delle Philippicae: quoniam risulta essere tràdito solo dal ramo del Vat. Arch. S. Pietro e la curiosa coincidenza con la lezione attestata dalla missiva di Salutati non può che essere accidentale. 101 Vd. Var. 45 (= Disp. 12; a Lapo da Castiglionchio, Parma, 6 gennaio 1351), con la quale Petrarca accompagna l’invio della pro Archia a Lapo; al riguardo vd. Nolhac, Pétrarque, cit., vol. I, p. 90, nota 2, e p. 248; Foresti, Aneddoti, cit., p. 243. 97 98 tracce della biblioteca ciceroniana di petrarca? due codici delle philippicae 41 il Par. nouv. acq. lat. 3070, ma è assai probabile102. Esso reca in margine alle Philippicae un numero esiguo di postille e segni d’attenzione; pochi di più sono gli interventi critico-testuali, vergati da mani diverse fra cui quella di Coluccio, la quale compare in misura minore rispetto alle altre ed è databile all’incirca al 1375103. Dalla collazione di esso con i loci di Q postillati o corretti da Petrarca si riscontra che la gran parte degli errori singolari di questo non compaiono in C 104; che le pochissime varianti di collazione nel codice di Salutati non trovano riscontro in quello di Petrarca105 e che, viceversa, le proposte di emendamento petrarchesche non sono accolte da C 106, a eccezione delle seguenti quattro: A Phil. 2, 60 (139rb) Q ha sit veri affiancato dalla correzione petrarchesca «sic tueri», lezione dei moderni editori che nulla registrano in apparato; C, 36rb, ha identici sia l’errore che l’emendamento, che però è vergato nell’interlinea e accompagnato da altri interventi correttori al passo non presenti nel codice di Petrarca. A Phil. 2, 85 (141va) Q ha recipiebat, errore del ramo di D, affiancato nel margine dalla congettura petrarchesca reiciebat, che è pure lezione delle moderne edizioni recuperata dal ramo del Vat. Arch. S. Pietro H. 25 e n 2; il manoscritto colucciano, 38va, ha la medesima correzione nell’interlinea. 102 Vd. Berté, Petrarca, Salutati, cit., pp. 48-50, dove, fra l’altro, è parzialmente riportata la lettera di Salutati a Lombardo. 103 Ci sono solo tre casi di coincidenza da me riscontrati fra le note di Salutati e i marginalia petrarcheschi alle Philippicae: accanto a Phil. 3, 2 dies… solet Q, 143vb, ha una graffa di mano petrarchesca, accompagnata da una manicula apposta da un altro lettore, e C, 41rb, ha pure una graffa che affianca la postilla «nota», ambedue vergate da Salutati; in margine a Phil. 3, 13 nec vero… dignitatis Q, 144va, ha una graffa e la nota «laus Gallie Cisalpine» (vd. supra, § 5, nota 91), mentre C ha «laudes Gallie provincie» di mano, però, di chi copia il testo di base e non di Coluccio; in margine a Phil. 4, 13 quamquam mortem… redegerunt Q, 147va, ha due graffe, una sotto l’altra, e l’annotazione «romana virtus», mentre C, 45vb, ha una graffa autografa di Salutati che abbraccia tutto il periodo. 104 Registro qualche esempio. Di fianco a Phil. 2, 43 num etiam huius (hoc ed.), homo audacissime, ex Cesaris commentariis? Q, 138rb, reca una crux, inserita forse per segnalare la corruttela huius per hoc, non registrata nei moderni apparati e non tràdita da C, 34vb, che ha regolarmente hoc. A Phil. 2, 117 sed ex plurimis malis que ab illo rei publice sunt (sunt inusta ed.) hoc tamen boni est… Q, 143vb, ha uno spazio bianco in luogo di inusta e nulla in margine; inusta è invece normalmente presente in C, 41ra. In corrispondenza di Phil. 4, 1 quod si ante facere conatus essem, nunc facere (facere non possem. Hodierno enim die, Quirites, ne mediocrem rem actam arbitremini, fundamenta ed.) iacta sunt reliquarum actionum Q, 146vb, ha una crux in riferimento alla lacuna, non condivisa da C, 44vb, che tramanda il testo delle moderne edizioni (eccetto quo hanc ne per Quirites in accordo con la famiglia c, e auctam per actam, non registrato nei moderni apparati). 105 Cito un solo caso: a Phil. 3, 3 cumque eius a Brundisio erudito (erudito : crudisio Q om. ed.) crudelis et pestifer reditus timeretur C, 41rb, ha la variante «aliter ‘eruptio’», mentre Q, 143vb, ha una crux nel margine. 106 In Q, 135va, in margine a loca di Phil. 2, 7 Petrarca appone la variante «‘ioca’»; loca è lezione comune a tutta la tradizione, compreso C, 31vb, a eccezione del sottogruppo n dei decurtati, che ha ioca, messo a testo dai moderni editori (vd. supra, § 4, nota 64). In Q, 139rb, principibus di Phil. 2, 55, errore della famiglia c (principi ed.), viene corretto in principiis, mentre C, 35vb, conserva la corruttela di c. In Q, 144vb, come si è detto (vd. supra, § 4, pp. 35-36) compare tre volte la correzione dell’aggettivo arigin- in aricin- di Phil. 3, 15-16, non attestata da C, 42va, che ha sempre arigin-, errore di c. 42 monica berté A Phil. 2, 113 (143rb) Q ha l’errore, non registrato nei moderni apparati, statua emendato nel margine in ista tua, lezione che coincide con quella delle edizioni critiche; la stessa situazione si ritrova in C, 40va, ma qui, come nei casi precedenti, l’intervento è nell’interlinea. A Phil. 2, 115 (143rb) Q ha la lezione gustatum (accolta dalle moderne edizioni e tramandata da tutta la famiglia con le sole prime quattro orazioni e dal ramo del Vat. Arch. S. Pietro H. 25) che viene corretta in gustum tramite l’espunzione di -at; analogamente C, 40vb, depenna le medesime lettere della parola: gustum è nel resto del ramo D107. Questi comuni emendamenti non bastano a provare un rapporto di parentela fra i due manoscritti dal momento che gli elementi che portano a concludere il contrario sono molti e stringenti. Si potrebbe, semmai, pensare a una successiva collazione da parte di Coluccio del codice petrarchesco, dal quale però il cancelliere avrebbe prelevato soltanto quattro delle congetture presenti nei margini di Q. È, in ogni caso, plausibile che Salutati, sensibile e reattivo ai fenomeni di corruzione dei testi, abbia emendato il suo codice ricorrendo al suo ingegno e/o alla collazione di un altro testimone108. Si sa, infatti, che un manoscritto con l’intero corpus delle Philippicae giunse a Firenze sicuramente dopo il luglio 1379, data dell’epistola di Coluccio a Lombardo, e prima del 20 ottobre del 1425, data di una lettera di Poggio Bracciolini scritta da Roma a Niccolò Niccoli, nella quale il mittente riferisce di essersi fatto mandare da Firenze un esemplare con le Philippicae, che aveva chiesto nell’agosto del medesimo anno e che di lì a breve, nel 1428, avrebbe collazionato con il Vat. Arch. S. Pietro H. 25109. Non è, tuttavia, possibile né restringere i confini cronologici dell’arrivo di questo prezioso testimone né stabilire se esso sia approdato a Firenze, direttamente o indirettamente, dalla biblioteca petrarchesca. 107 Vd. Magnaldi, Cicerone, cit., pp. XXVIII-XXIX: la studiosa sospetta che gustatum fosse affiancato dal sinonimo gustum già nel capostipite di D, che doveva avere, secondo lei, una serie di duplices lectiones. 108 Si osservi che anche nel caso del De finibus la copia di Salutati è indipendente da quella di Petrarca: vd. Reynolds, Petrarch and Cicero’s philosophical Works, cit., pp. 49-50. 109 I rapporti fra Bracciolini e Salutati, come è noto, furono molto stretti: il 23 dicembre del 1403 Coluccio scrive a Poggio di inviargli al più presto un codice ciceroniano da lui trascritto da un antigrafo posseduto e ottenuto da Iacopo Angeli da Scarperia, che è stato erroneamente identificato da Novati proprio col Laur. 48, 22 con le Philippicae (vd. Salutati, Epistolario, cit., vol. III, p. 656, nota 1). Il manoscritto cui tale lettera allude non è stato finora riconosciuto, ma nessun indizio conduce a un esemplare con le Philippicae: vd. S. Rizzo, Il lessico filologico degli umanisti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1973, pp. 327-338, in particolare p. 328, nota 1. Benedetta Fordred “Errori” del Boccaccio o varietà della lingua trecentesca?* 1. Introduzione Saranno presi in esame alcuni luoghi particolarmente problematici e peculiari della sintassi del Decameron. Si tratta sia di fenomeni macroscopici, ovvero di periodi “irregolari” piuttosto articolati, sia di fenomeni di entità minore, ovvero probabili sviste d’autore o omissioni. Si tornerà dunque a parlare dei cosiddetti “errori” del Boccaccio, indagando quali tra le anomalie sintattiche considerate siano imputabili alla distrazione del Boccaccio-copista, quali, invece, a scelte stilistiche del Boccaccioautore, o quali, ancora, debbano considerarsi costrutti piuttosto diffusi nella lingua del Trecento (e solo in seguito percepiti come erronei), non ancora normalizzata e codificata. In particolare, si cercherà di verificare se la dimensione dell’oralità, implicita nella struttura dei racconti del Decameron, possa aver inciso sulla tipologia della lingua, fino al punto di autorizzarla ad alcune trascuratezze ed “errori”. L’attenzione sarà rivolta principalmente alle anomalie in questione, ma verranno analizzati anche alcuni passi dell’opera caratterizzati da esiti sintattici che da un punto di vista linguistico moderno possono definirsi regolari (cfr. in questo contributo il § 9). Un’analisi degli interventi degli editori sul testo del Decameron e soprattutto delle differenti lezioni recate dai tre principali codici della tradizione manoscritta dell’opera, e, ancora, un confronto con testi di autori precedenti, coevi, e posteriori al Boccaccio, aiuteranno a comprendere quanta parte di queste devianze possa essere attribuita allo stato della lingua del tempo, quanta alla libertà stilistica dell’autore, o, piuttosto, alla sua distrazione di copista di se stesso e quali elementi della lingua trecentesca fossero inammissibili per gli editori cinque-seicenteschi. * Questo contributo è tratto dalla tesi di laurea dell’autrice del saggio, Gli errori del Boccaccio (discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova, A.A. 2010-2011), vincitrice dell’edizione 2013 del Premio Nazionale Giovanni Boccaccio (sezione riservata alle tesi di laurea magistrali). Ndr 44 benedetta fordred 2. “Errori” di copista o costrutti “anomali”? «Amanuense trascurato e frettoloso»1 e «con una sua certa caratteristica patologia scrittoria»2, «autore-copista distratto»3 e «non certo scrupoloso»4: così è stato definito il Boccaccio dai filologi che studiarono l’Hamilton 90 (B), copia autografa del Decameron vergata dal Certaldese attorno al 1370. Ma già molti secoli prima, nell’Indice dei libri proibiti si leggeva: «Boccatii Decades seu novellae centum, quae hactenus cum intolerabilibus erroribus impressae sunt, et quae in posterum cum eisdem erroribus imprimentur»5, con riferimento tanto alla morale quanto alla lingua. Prima di entrare nel cuore della questione e di introdurre l’aspetto della prosa decameroniana di cui si tratterà in questa analisi, può essere possibile ripartire da una considerazione di Melania Marra: cifra distintiva della “prosa media”, ma non del tutto assente nella prosa d’arte medievale, è una certa “irregolarità” nell’organizzazione periodale, che risulta, perciò, priva del rigore e della logica della sintassi moderna, percorsa da incertezze, ripensamenti, cambi di progetto e costrutti sospesi assolutamente estranei alla razionalizzazione periodale odierna […]. Gli stessi grammatici, dalla tradizione classicistica in poi, non esitarono ad intervenire, regolarizzando o censurando queste forme, etichettate, di volta in volta, come […] ingenuità linguistiche, errori6. Si è parlato a più riprese, infatti, degli “errori” del Boccaccio, facendo riferimento ad alcune anomalie sintattiche della prosa decameroniana, su cui da sempre gli studiosi si sono interrogati e che anche oggi incuriosiscono e insospettiscono. Si tratta di passi in cui il testo non torna a norma di sintassi odierna e, a volte, anche di quella, presumibile, antica. Se ne era occupato, più di un secolo fa, Adolfo Mussafia7, postillando l’edizione Fanfani del Decameron. Sono tornati a considerare l’intera questione, prima Franca Brambilla Ageno8, e in tempi più recenti, altri studiosi (come Mario V. Branca-P.G. Ricci, Un autografo del Decameron, Padova, Cedam, 1962, p. 31. G. Boccaccio, Decameron. Facsimile dell’autografo conservato nel codice Hamilton 90 della Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz di Berlino, a cura di V. Branca, Firenze, Fratelli Alinari-Istituto di edizioni artistiche, 1975, p. 41. 3 Branca-Ricci, Un autografo del Decameron, cit., p. 33. 4 Branca in Boccaccio, Decameron. Facsimile, cit., p. 39. 5 G. Chiecchi-L. Troisio, Il Decameron sequestrato. Le tre edizioni censurate nel Cinquecento, Milano, Unicopli, 1984, p. 18. 6 M. Marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, «Studi di grammatica italiana», XXII, 2003, pp. 63-104, a p. 63. 7 A. Mussafia, Il Decameron di Giovanni Boccaccio riscontrato coi migliori testi e postillato da Pietro Fanfani, in Scritti di filologia e di linguistica, a cura di A. Daniele, L. Renzi, Padova, Antenore, 1983. 8 F. Ageno, Annotazioni sintattiche sul Decameron, «Studi sul Boccaccio», II, 1964, pp. 217-234; Ead., Errori d’autore nel Decameron?, «Studi sul Boccaccio», VIII, 1974, pp. 127-136; Ead., Ancora sugli errori d’autore nel Decameron, «Studi sul Boccaccio», XII, 1980, pp. 71-93. 1 2 “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 45 Marti, Giancarlo Breschi, Maurizio Fiorilla e Teresa Nocita) ma a partire soprattutto da considerazioni ecdotiche, legate alla restituzione del testo in corrispondenza di lezioni particolarmente problematiche dell’Hamilton 909. L’indagine di Mussafia del 1857, basata sulle notazioni dei commentatori dell’epoca (Colombo, Fanfani, Dal Rio), ha analizzato una serie di casi, ora riconoscendo un “errore” o una lacuna nel testo del Boccaccio, ora invece, spiegando i fenomeni ai sensi della lingua del tempo e del suo stato sintattico più liquido e poco normato10. Franca Brambilla Ageno ha dedicato alla questione degli “errori” tre lunghi saggi. La studiosa avverte sulla difficoltà di classificare per tipologia le irregolarità sintattiche dell’autografo e di indagarne le cause. Esisterebbero, a suo giudizio, due categorie di “errori”: quelli commessi dal Boccaccio come autore durante la composizione dell’opera, nati da una confusione che è «a monte del fatto materiale della scrittura»11 e «che derivano da una non completa chiarificazione dei motivi che 9 M. Marti, Sulle due redazioni del Decameron, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXX, 2003, pp. 55-65; G. Breschi, Il ms. Parigino It. 482 e le vicissitudini editoriali del Decameron. Postilla per Aldo Rossi, «Medioevo e Rinascimento», XVIII/n.s., XV, 2004, pp. 77-119. M. Fiorilla, Per il testo del Decameron, «L’Ellisse», V, 2010, pp. 9-38; Id., Ancora per il testo del Decameron, pubblicato in questo stesso numero de «L’Ellisse», pp. 75-90; T. Nocita, Loci critici della tradizione decameroniana, in «Dai pochi ai molti». Studi in onore di Roberto Antonelli, a cura di P. Canettieri e A. Punzi, Roma, Viella, i.c.s. 10 «Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenzia narrata nello appicicarsi da uno a altro, che non solamente l’uomo all’uomo, ma questo, che è molto più, assai volte visibilmente fece, cioè che la cosa dell’uomo infermo stato, o morto di tale infermità, tocca da un altro animale fuori della spezie dell’uomo, non solamente della infermità il contaminasse ma quello infra brevissimo spazio uccidesse» (Dec., I Intr. 17). Mussafia avverte l’irregolarità sintattica del passo («A che verbo s’appoggiano quelle parole l’uomo all’uomo? A nessuno»), supponendo che il Boccaccio «ebbe l’intenzione di finire il periodo con costruzione […] l’uomo ad altro animale fuori della sua spezie l’appiccasse […] Ma frattanto mutò costruzione, e non si ricordò di adattarvi anche quelle prime parole che ora stanno in aria» (Mussafia, Il Decameron di Giovanni Boccaccio riscontrato coi migliori testi, cit., p. 33). Nel corso della narrazione, infatti, l’autore cambia completamente costruzione (inserendo una coordinata avversativa «ma questo assai volte visibilmente fece», interrotta da un’incidentale relativa «che è molto di più», e che introduce una dichiarativa «non solamente della infermità il contaminasse», a cui è interposta una parentetica condizionale «tocca da un altro animale fuori della spezie dell’uomo») e finito il periodo, non modifica, adattandola al resto del testo, la prima parte. Giustifica, invece, il seguente caso di concordanza del participio col soggetto: «Il che quanto in poca cosa Cisti fornaio il dichiarasse, gli occhi dello ’ntelletto rimettendo a messer Geri Spina, il quale la novella di madonna Oretta contata, che sua moglie fu, m’ha tornata nella memoria, mi piace in una novelletta assai piccola dimostrarvi» (Dec., VI 2 7). Afferma, infatti, che «non è da dimenticare che i primi scrittori delle lingue, non avendo apprese regole grammaticali, non le seguono con quell’esattezza che gli addottrinati di età posteriori: nelle costruzioni il pensiero vale a loro piú che la forma; e l’orecchio, specialmente in lingua cosí armoniosa come la nostra, li seduce a costruzioni che all’attento grammatico si dimostrano erronee» (ivi, p. 6). Il suo lavoro, articolato in tre parti (il testo, la punteggiatura e le note), individua nello stile dell’autore delle costanti estranee alla regolarità grammaticale e specialmente a quella moderna. Le osservazioni di Mussafia funzionano spesso, ancora oggi, perfettamente e si ritrovano infatti nelle note a molti luoghi del Decameron dell’accreditata edizione Branca. 11 Ageno, Errori d’autore, cit., p. 131. 46 benedetta fordred lo scrittore ha in mente»12, e quelli del Boccaccio copista, «in cui egli incorse nel registrare materialmente il suo pensiero»13. In sostanza ci sono, secondo l’Ageno, errori che il Boccaccio avrebbe commesso nel copiare il testo e costrutti anomali che risalirebbero alla sua pratica di scrittore. Sarà da vedere se sempre autorizzata, o per lo meno prevista, dalla lingua del tempo, o no. La studiosa conclude che questi ultimi, che definisce “errori d’autore”, sono da rispettare in sede editoriale come autentici, dato che il compito dell’editore non deve essere quello di sostituirsi all’autore ed essendo, per di più, in alcuni casi, molto arduo proporre una lezione alternativa. Gli errori da copista, invece, sono emendabili, «come oggi si corregge- Ivi, p. 128. Ead., Ancora sugli errori d’autore nel Decameron, cit., p. 71. Il passo sotto riportato, la cui irregolarità sintattica è costituita dall’incidentale relativa composta dal rispettivo pronome seguito da un gerundio piuttosto che da un predicato di modo finito, è un esempio di “errore” risalente, per l’Ageno, all’atto di composizione dell’opera: «Avvenne che, avendol costoro nel pozzo collato, alcuni della famiglia della signoria, li quali e per lo caldo e perché corsi erano dietro a alcuno avendo sete, a quel pozzo venieno a bere: li quali come quegli due videro, incontanente cominciarono a fuggire, li famigliari che qui venivano a bere non avendogli veduti» (Dec., II 5 67). L’Ageno spiega che «essendo l’uso del gerundio altrettanto esteso e meccanico accade che relativo e gerundio compaiano in secondarie l’uno dopo l’altro, dove una sintassi corretta richiederebbe solo un gerundio, oppure il relativo seguito da un modo finito, indicativo o congiuntivo» (ivi, p. 82). «Difficile districare un caso simile», osserva Melania Marra, «in cui non si capisce se sia il relativo i quali a rimanere senza sèguito, oppure il soggetto di una principale lasciata in sospeso (alcuni della famiglia della signoria)» (Marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 90). «Gulfardo, udendo la ’ngordigia di costei, isdegnato per la viltà di lei la quale egli credeva che fosse una valente donna, quasi in odio transmutò il fervente amore e pensò di doverla beffare: e mandolle dicendo che molto volentieri e quello e ogni altra cosa, che egli potesse, che le piacesse» (Dec., VIII 1 8). In questo caso, nota l’Ageno, manca il condizionale «avrebbe fatto» nella frase: «e mandolle dicendo che molto volentieri e quello e ogni altra cosa, che egli potesse, che le piacesse». Non si tratterebbe di un’omissione del Boccaccio copista, ma di una confusione del Boccaccio autore: «è pensabile che lo scrittore non abbia introdotto il farebbe al principio della dichiarativa, perché aveva intenzione di introdurlo dopo potesse; e che, giunto a potesse, lo abbia dimenticato, pensando di averlo già scritto» (Ageno, Errori d’autore, cit., p. 132). È da notare, inoltre, «la successione di due relative senza alcun legame, di cui la prima equivale a un aggettivo («ogni altra cosa a lui possibile che…)»: G. Boccaccio, Il Decameron, a cura di V. Branca, Torino, Einaudi, 19993 (da qui in poi Branca 1999), p. 892. Un tipico “errore” risalente, invece, alla trascrizione dell’opera sarebbe, per l’Ageno, il seguente: «Laonde ella, vergognandosi d’apparire dove veduta fosse, assai volte miseramente pianse la sua ritrosia e il non volere, in quello che niente le costava, al vero sogno del marito voluta dar fede» (Dec., IX 7 14). Al posto del verbo servile «volere» dovremmo leggere l’ausiliare «avere» del «voluta» successivo, per ottenere la forma composta «aver voluta»: «rimpianse la sua scontrosità e il non aver voluta dar fiducia al veritiero sogno del marito, che non le sarebbe costata nulla». Si tratterebbe di un “errore” di anticipo identico a quello in cui incorrevano sovente i copisti: «qui il Boccaccio pensando al voluta che doveva usare alla fine del periodo, ha introdotto in distrazione volere in luogo del verbo servile che occorreva» (Ageno, Errori d’autore, cit., p. 132). Del resto, concordava anche Mussafia «io per me tengo essere errore di copiatore che ha scritto volere per avere, avendo la mente al voluta che veniva appresso» (G. Boccaccio, Il Decameron di messer Giovanni Boccaccio; riscontrato co’ migliori testi e postillato da Pietro Fanfani, con l’aggiunta delle osservazioni su questa edizione e sulla sintassi del Boccaccio di Adolfo Mussafia, Firenze, Le Monnier, 1924 [da qui in poi Fanfani], p. 322). 12 13 “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 47 rebbe liberamente un errore di stampa»14, in quanto dovuti a un trascorso di penna durante la trascrizione del testo. Inutile dire che, per noi, i casi più interessanti sono i costrutti anomali, sui quali infatti l’Ageno si sofferma ampiamente, riportando e commentando quelli più oscuri dal punto di vista sintattico, ai margini dell’edizione Branca. La studiosa sottolinea come alcuni di essi siano presenti in serie nell’autografo del Decameron e parla di «persistenza nell’errore»15, riferendosi alle difficoltà del Boccaccio anziano a gestire la prosa del proprio capolavoro. Se infatti un costrutto irregolare si presenta una sola volta o non è riconducibile a tipologie ricorrenti, la possibilità di spiegarlo con problemi “locali” del testo o dell’autore che lo scrive o dell’autore copista che lo trascrive è maggiore. Se invece queste anomalie si riaffacciano ripetutamente, è lecito avanzare perlomeno l’ipotesi che esse siano dovute alla lingua, al sistema linguistico del Trecento, e quindi che possano aiutarci a descrivere meglio la sintassi dell’epoca. 3. I costrutti anomali nella tradizione editoriale Le edizioni del Decameron sono state allestite nel corso dei secoli a partire da diversi manoscritti. I principali sono il Parigino Italiano 482 (P), che riflette uno stadio anteriore rispetto al Berlinese16, Il Laurenziano 42 1, noto anche come l’Ottimo o codice Mannelli (Mn), che fu testimone fondamentale già per le edizioni del XVI secolo17, fino alla definitiva acquisizione dell’autografia del Hamilton 90 (B)18, sul quale si sono basati, tra gli altri, Branca, e successivamente Rossi, per fissare il testo critico dell’opera19. In due recenti edizioni Fiorilla si è però discostato in diversi punti 14 M. Barbi, La nuova filologia e l’edizione dei nostri scrittori da Dante al Manzoni, Firenze, Sansoni, 1938, pp. 105-106. 15 Ageno, Ancora sugli errori d’autore nel Decameron, cit., p. 90. 16 Si veda almeno V. Branca-M. Vitale, Il capolavoro del Boccaccio e due diverse redazioni, 2 voll., Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002. 17 G. Boccaccio, Il Decameron di M. Giovan Boccaccio nuovamente alla sua intera perfettione, non meno nella scrittura, che nelle parole ridotto per Girolamo Ruscelli. Con le dichiarazioni, annotationi, et avvertimenti del medesimo sopra tutti i luoghi difficili, regole, modi, e ornamenti della lingua volgare, et con figure nuove e bellissime, che interamente dimostrano i luoghi ne’ quali si riducevano ogni giornata à novellare. Et con un Vocabolario generale nel fine del libro, Venezia, Valgrisi, 1552 (da qui in poi Ruscelli); Id., Il Decameron di messer Giouanni Boccaccio cittadin fiorentino, di nuouo ristampato, e riscontrato in Firenze con testi antichi, & alla sua vera lezione ridotto dal caualier Lionardo Saluiati, Firenze, Giunti, 1582. 18 Il codice Mannelli ha continuato comunque ad essere codice di partenza per ricostruire il testo del Decameron in corrispondenza delle lacune dell’Hamilton 90. 19 G. Boccaccio, Decameron. Edizione critica secondo l’autografo Hamiltoniano, a cura di V. Branca, Firenze, presso l’Accademia della Crusca, 1976 (da qui in poi Branca 1976a); Id., Il Decameron, a cura di A. Rossi, Bologna, Cappelli, 1977 (da qui in poi Rossi). Il testo curato da Branca nel 1976, ripreso in edizioni accompagnate dalle sue note di commento, è diventato punto di riferimento per studiosi e lettori del Decameron: Branca 1999. 48 benedetta fordred dal testo di Branca proponendo soluzioni alternative in alcuni loci critici (in cui l’autografo è portatore di lezioni problematiche)20. Ora, al di là dei testimoni scelti e della premesse ecdotiche di partenza, è possibile riscontare una certa tendenza generale degli editori a intervenire con maggiore o minore disinvoltura sul testo decameroniano per agevolare la lettura in punti problematici e per renderlo più conforme all’italiano ad essi coevo, emendandolo sintatticamente. Già lo stesso Francesco d’Amaretto Mannelli, amanuense scrupoloso e preciso, dichiarava di trascrivere il testo dall’autografo con rispetto «fino al punto di non intervenire su quelli che gli sembravano errori manifesti»21, ma limitandosi a commentare i passi con postille volte a segnalare i latinismi («nota pulcram parenthesin») o l’irregolarità del testo («latino imperfecto è qui»), a rimproverare lo stesso Boccaccio quando oscuro («costrutto in zoccoli, messer Giovanni»), quando troppo prolisso («alle consequentie, alle consequentie», «hora alle consequienzie!»), o quando troppo fantasioso («questo non cred’io»)22. Talvolta Mannelli, che dice di avere di fronte un «originale», prova a congetturare le irregolarità e le lacune presenti nel suo antigrafo, proponendo lezioni alternative e segnalando a margine l’integrazione con un deficiebat 23. Le modifiche dei curatori al testo sono state, a volte, oggetto di critica da parte degli studiosi loro contemporanei24. 20 G. Boccaccio, Decameron, a cura di M. Fiorilla, illustrazioni di M. Paladino, Roma, Istituto della Enciclopedia fondata da Giovanni Treccani, 2011; Id., Decameron, Introduzione, note e repertorio di Cose (e parole) del mondo di A. Quondam, Testo critico a Nota al testo a cura di M. Fiorilla, Schede introduttive e notizia biografica di G. Alfano, Milano, BUR-Rizzoli, 2013, pp. 109-123. 21 S. Carrai, La prima ricezione del Decameron nelle postille di Francesco Mannelli, in Autori e lettori di Boccaccio. Atti del Convegno internazionale, Certaldo, 20-22 settembre 2001, a cura di M. Picone, Firenze, Cesati, 2002, pp. 99-111, a p. 99. 22 Ivi, pp. 102 e 110. 23 Cfr. M. Cursi, Il Decameron: scritture, scriventi, lettori. Storia di un testo, Roma, Viella, 2007, p. 48; per alcuni esempi cfr. Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 27, 29-30; Id., Ancora per il testo del Decameron, pp. 81-83. 24 In particolare furono le varianti proposte da Ruscelli nella sua edizione decameroniana ad attirare l’attenzione dei grammatici, che si scagliarono contro «la pretesa ruscelliana di aver perfezionato l’ortografia e corretto tutti gli errori» (C. Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron: polemiche editoriali e linguistiche, «Studi sul Boccaccio», XXXI, 2003, pp. 327-348, a p. 332). Netto fu, anche, il disappunto del Borghini per l’edizione curata da Ruscelli, da lui stesso definita una «storpiatura» di Boccaccio: «gli anni passati fu stampato in Venezia un Boccaccio da un certo Ruscello, che è impossibile a dire quanto egli storpiasse quello autore con i suoi capricci, che piacendo a un Dio un dì si torneranno tutti a casa con mostrare al mondo quanto fu prosontuoso uno che parli di quel ch’ e’ non sa. Et per questo rispetto vi ho detto più volte, che nelle cose dubbie si vada adagio, perché è molto minore errore lasciare un luogo scorretto in un autore, che impiastrarlo che paia, che egli stia bene, perché quando si fa così, si passa via e non vi si pensa più, e però non si sana mai; dove apparendo il male, viene occasione di poterlo sanare» (V. Borghini, Lettera intorno ai manoscritti antichi, a cura di G. Belloni, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 77, citato in Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron, cit., p. 335). Ruscelli propone in margine alla sua edizione, uscita nel 1552 a Venezia, emendamenti che non esita a indicare come «varianti» e le osservazioni del Borghini dimostrano che spesso «le presunte anomalie linguistiche dipendono da idiosincrasie del curatore» (Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron, cit., p. 340). Borghini sottolinea l’inutilità e la presunzione degli interventi non solo di “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 49 Nel Cinquecento gli interventi dei Deputati fiorentini Vincenzio Maria Borghini, Pierfrancesco Cambi, Sebastiano Antinori, Agnolo Guicciardini e Antonio Benivieni sul testo del Decameron ebbero, come si sa, due caratteristiche diverse: in parte si trattava di censure finalizzate a modificare le parti più compromettenti per la morale dell’epoca, in parte, invece, di interventi più propriamente linguistici. Interessano qui ovviamente quelli linguistici. I Deputati propongono una dettagliata analisi delle anomalie sintattiche del Decameron: ora accettandole, in quanto proprie di un linguaggio d’uso e naturale, e mostrando insofferenza verso le correzioni proposte dai minuziosi e asfittici grammatici del loro tempo (colpevoli di falsificare l’opera e impoverire le capacità espressive della lingua antica); ora avanzando essi stessi correzioni; ora spiegando alcune manchevolezze con le modalità del processo di copia, durante il quale «tanta forza ha la natura et l’uso proprio, radicato et ben fermo, che e’ ti viene scritto al tuo ordinario, che quasi non te ne avvedi»25. Fortemente critici nei confronti di alcune correzioni proposte dai grammatici, che intervengono non solo nei luoghi più oscuri, ma anche quando non strettamente necessario, derubando l’autore di quelle voci «le quali non sol gli usciron di bocca, ma furon dalla sua mano fermate in su la carta et come suoi proprii beni ci havea lasciate»26, già i Deputati auspicavano un confronto con altri autori («antichi et sinceri»)27 di opere in prosa del Trecento che consentisse al capolavoro di Boccaccio di guarire dalla «malattia» per vie più autentiche. Del resto, come osserva giustamente Dardano, «per giudicare rettamente […] dobbiamo fondarci su esperienze di lettura di testi medievali, senza cedere alla tentazione di imporre consuetudini stilistiche moderne o prevenzioni ideologiche di varia natura»28. Neanche i curatori moderni hanno esitato a intervenire sul testo, ogni volta che il periodo è risultato oscuro o irregolare rispetto alla sintassi corrente. Ruscelli, ma anche di altri curatori, sui testi dei grandi scrittori dell’epoca: «di certi Ruscelli e simili mi pare opera perduta il ragionare […] ma per cavar d’errore certi più semplici, che tirati dalle molte scritture e postille e lisciamenti a molti libri, mentre come correttori si vanno guadagnando la vita, e abbagliati dalle varie malie e vane promesse e sicurità del parlar si vogliono mostrar padroni della lingua nostra non che intendenti, e scoprire al mondo quel che e’ sono, e quanto e’ sanno, non per cagione loro, ma per difesa della lingua, la quale per la ignoranza e audacia loro, è stata malmenata, e in molti suoi scrittori corrotta e imbastardita» (V. Borghini, Scritti inediti o rari sulla lingua, a cura di J.R. Woodhouse, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1971, p. 30, citato in Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron, cit., p. 338). Il celebre filologo difende la prosa boccacciana, affermando che «uno de’ begli capricci […] di questo Rusc.[elli] è quello che spesso egli vuole emendare il B.[occaccio]» (ivi, p. 343), e ironizza su alcuni suoi interventi. Dove Ruscelli annotava, a proposito di talune espressioni, che erano «poste freddamente», Borghini non esitava a commentare in toni canzonatori «accostale un poco al fuoco, o tu le metti al sole et si riscaldano» (Ruscelli, p. 134, citato in Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron, cit., p. 343). 25 G. Chiecchi, Le annotazioni e i discorsi sul Decameron del 1573 dei Deputati fiorentini, Roma-Padova, Antenore, 2001, p. LI. 26 Ivi, p. 13. 27 Ivi, p. 14. 28 M. Dardano, Collegamenti nel Decameron, in Omaggio a Gianfranco Folena, 3 voll., Padova, Programma, 1993, vol. I, pp. 593-612, a p. 597. 50 benedetta fordred Nel seguente passo, si noti l’uso, come si mostrerà più avanti molto frequente nel Decameron, del che seguito da una proposizione infinitiva: Dec., II 2 5: Costoro, veggendol mercatante e estimando lui dovere portar denari, seco diliberarono che, come prima tempo si vedessero, di rubarlo29. Massèra30 aveva proposto di emendare come segue: Costoro, veggendol mercatante ed estimando lui dovere portar denari, seco diliberarono, come prima tempo si vedessero, di rubarlo. Il periodo risulterebbe in questo modo meglio congegnato, in quanto, essendo omessa la congiunzione completiva «che» dopo il predicato «deliberarono», terminata la parentetica, il discorso riprende correttamente con una completiva implicita. Nel valutare questa e altre situazioni di questo tipo mi pare opportuno innanzitutto, ripartendo dalle riflessioni di Franca Ageno, tornare sul concetto stesso di “errore”, cercando di comprendere se tale etichetta sia da attribuire rigidamente, secondo identiche modalità, a tutti i luoghi oscuri del testo, o se invece debba essere colta in un’accezione più ampia ed “elastica”, inglobante diverse prospettive che consentano, eventualmente, di motivare le irregolarità in questione e di distinguere le sviste di mano del Boccaccio verificatesi involontariamente durante la trascrizione dell’opera dalle forme sintattiche da lui avallate con convinzione. Alcuni casi sembrano, effettivamente, essere semplicemente lapsus e distrazioni del Boccaccio. Ma i grammatici che li precedettero, scrivono i Deputati, «mai usciti dalle scuole dei fanciugli» e che «vogliono che il verbo habbia i suoi casi innanzi et dopo per ordine», hanno severamente condannato queste «libertà» come “errori”, non concedendo «per tutto l’oro del mondo una di queste gentilezze al Boccaccio»31. Oggi siamo certi che nell’Hamilton 90 sono presenti numerosi errori di copia, giustamente sanati da Branca anche dopo il riconoscimento dell’autografia del manoscritto32. Tuttavia in alcune situazioni in cui il codice Hamiltoniano presenta un testo problematico, ma in qualche modo “ricevibile”, Branca ha preferito conservare la lezione dell’autografo. Studi filologici recenti, alla luce di un confronto esteso ad altri codici della tradizione, hanno invece sottolineato la necessità di emendare il testo del Berlinese in casi in cui Branca non è intervenuto. Nelle pagine che seguono vorrei 29 1999. Il testo del Decameron viene citato in questo articolo, salvo diversa segnalazione, secondo Branca G. Boccaccio, Il Decameron, a cura. di A.F. Massèra, 2 voll., Bari, Laterza, 1927 (da qui in poi Massèra), vol. I, p. 79. 31 Chiecchi-Troisio, Le annotazioni e i discorsi sul Decameron, cit., p. 170. 32 Cfr. Branca 1976a, pp. LXII-LXXXVI. 30 “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 51 richiamare l’attenzione su altri casi di lezione sospette dell’Hamilton 90 (su cui non si sono soffermati finora altri contributi). Negli esempi riporto sempre il testo secondo Branca 1999, registrando in parentesi quadre, in corrispondenza dei luoghi problematici (evidenziati in corsivo), le lezioni del Parigino Italiano 482 (P), del Mannelli (Mn) e dell’Hamilton 90 (B). Comincio con il segnalare un caso in cui Mn e P sono in accordo contro la lezione di B: Dec., V 8 4: In Ravenna, antichissima città di Romagna, furon già assai nobili e gentili uomini, tra’ quali un giovane chiamato Nastagio degli Onesti, per la morte del padre di lui e d’un suo zio, senza stima rimase [rimaso P Mn rimase B] ricchissimo. La lezione recata dall’Hamiltoniano non è sintatticamente regolare: il periodo così congegnato sarebbe corretto, se dopo il nominativo leggessimo un pronome relativo (ad esempio il quale) necessario per introdurre il passato remoto «rimase». In mancanza di tale pronome, la sintassi richiede un predicato al participio («rimaso»), lezione portata da P e Mn. Stesso discorso vale per l’esempio che segue: Dec., X 6 13: Le giovinette, venute innanzi onestamente e vergognose, fecero reverenzia al re; e appresso, là andatasene onde nel vivaio s’entrava, quella che la padella aveva, postala giú e l’altre cose appresso, preso [prese Mn P preso B] il baston che l’altra portava, e amendune nel vivaio, l’acqua del quale loro infino al petto agiugnea, se n’entrarono. La lezione dell’Hamilton presuppone una costruzione con paraipotassi, in quanto la congiunzione «e» coordina la proposizione indipendente «amendune nel vivaio se n’entrarono» alla precedente circostanziale implicita «quella […] preso il baston». Gli altri due codici recano una lezione per noi oggi più corretta. Presentano l’indicativo «prese» al posto del participio «preso» di B, per cui si configura (in Mn e P) una proposizione indipendente «quella […] prese il baston», alla quale è coordinata, per mezzo della congiunzione «e», un’altra proposizione indipendente «e amendune nel vivaio […] se n’entrarono». Poiché P si colloca in un altro ramo di tradizione rispetto a B e Mn (che avevano uno stesso antigrafo)33, è chiaro che per promuovere a testo la lezione «preso» bisogna considerarla una variante d’autore inserita in extremis da Boccaccio durante la trascrizione dell’Hamilton 90, salvo non considerare «prese» un errore poligenetico di P e Mn. La presenza di «appresso» (che precede immediatamente) induce piuttosto a ritenere possa trattarsi di un errore di ripetizione (compiuto da Boccaccio in fase di copia), spingendo a ripristinare la lezione portata dagli altri due testimoni. Segnalerò ora tre diversi casi in cui P reca segmenti di testo non presenti in Mn e B: 33 Cfr. da ultimo Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 13-16. 52 benedetta fordred Dec., IV 1 7: Essa scrisse una lettera, e in quella ciò che a fare il dí seguente per esser con lei [per esser con lei avesse P per esser con lei Mn B] gli mostrò. In questo caso la lezione del Parigino con il congiuntivo «avesse» è forse più consona rispetto a quella recata dagli altri due codici: il predicato in questione è necessario al tessuto della frase per conferire un senso di compiutezza al periodo, e soprattutto per dotare il nesso relativo «ciò che» di un verbo («ciò che a fare avesse»). Dec., II 5 38: gli venne per ventura posto il piè sopra una tavola, la quale dalla contraposta parte sconfitta [era sconfitta P sconfitta Mn B] dal travicello sopra il quale era, per la qual cosa capolevando questa tavola con lui insieme se n’andò quindi giuso. Anche in questo passo la lezione del Parigino è regolare sintatticamente, in quanto la subordinata relativa introdotta da «la quale» è dotata di un predicato («la quale dalla contrapposta parte era sconfitta dal travicello»). Dec., III 4 7: Tornò in questi tempi da Parigi un monaco chiamato don Felice, conventuale di San Brancazio, il quale assai giovane e bello della persona [persona era P persona B Mn] e d’aguto ingegno e di profonda scienza: col quale frate Puccio prese una stretta dimestichezza. L’omissione del predicato «era», come mostra la lezione recata da Mn e da B, rende il periodo irregolare dal punto di vista sintattico: il relativo «il quale», con funzione di soggetto, ha bisogno di un predicato di accompagnamento. La lezione di P è preferibile, mentre quella degli altri due codici sarebbe accettabile, piuttosto, in mancanza di tale pronome. In tutti e tre i passi, dunque, il Parigino contiene elementi necessari alla sintassi e al senso («avesse» a IV 1 7 e «era» a II 5 38 e III 4 7) e andrebbe promosso a testo. Con ogni probabilità in questo caso Mn e B hanno ereditato errori già presenti nel loro comune antigrafo: difficilmente infatti le lezioni che caratterizzano i due codici rispetto a B possono configurarsi come errori poligenetici o come varianti d’autore34. Più delicata la situazione nei due casi che seguono: Dec., III 5 13: E sí come umilissimo servidor vi priego, caro mio bene e sola speranza dell’anima mia, che nell’amoroso fuoco sperando in voi si nutrica, che la vostra benignità sia tanta e sí ammollita la vostra passata durezza verso di me dimostrata, che vostro sono, che io dalla vostra pietà rinconfortato possa dire che [dire P dire che Mn B], come per la vostra bellezza innamorato sono, cosí per quella aver la vita. Dec., VII 7 13: Avvenne un giorno che, essendo andato Egano a uccellare e Anichino rimaso, madonna Beatrice, che dello amore di lui accorta non s’era ancora (e [om P e B Mn] quantun- 34 Per altri esempi simili cfr. Breschi, Il ms. Parigino It. 482, cit., pp. 87-94; Marti, Sulle due redazioni, cit., pp. 60-63; Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 25-33; Id., Ancora per il testo, cit., pp. 81-87; Nocita, Loci critici della tradizione, cit. “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 53 que seco, lui e’ suoi costumi guardando, piú volte molto commendato l’avesse e piacessele), con lui si mise a giucare a scacchi. Nel primo caso siamo di fronte ad una di quelle situazioni, frequenti nel Decameron, in cui la congiunzione completiva che, dopo un inciso, è seguita da un verbo all’infinito. Il testo di P reca una lezione forse preferibile: omette infatti la congiunzione completiva e, dopo l’inciso, il discorso può riprendere con un predicato all’infinito. Nel secondo passo in Mn e in B è presente una coordinazione tra una relativa e una concessiva doppia, assente in P. Il legame che si viene a delineare mediante la congiunzione coordinativa «e» tra le proposizioni in questione appare problematico semanticamente, essendo la subordinata concessiva concettualmente legata alla proposizione relativa che la precede («che dello amore di lui accorta non s’era») piuttosto che alla successiva («con lui si mise a giucare a scacchi»), a meno che non si attribuisca alla congiunzione coordinante «e» un valore avversativo: «Madonna Beatrice, che dello amore di lui accorta non s’era ancora (ma tuttavia seco, lui e’ suoi costumi guardando, piú volte molto commendato l’avesse e piacessele)». Se in questo paragrafo si è dato conto di situazioni sintattiche in cui l’autografo appare viziato da veri e propri errori da correggere, nelle pagine successive verranno esaminati passi dell’opera che presentano nel tessuto della frase anomalie da non emendare, perché giustificabili alla luce di un confronto con testi precedenti e coevi. 4. Paraipotassi La paraipotassi è da considerarsi un costrutto tipico dell’italiano antico, che attesta la differente percezione del rapporto tra ipotassi e paratassi, così come della strutturazione del discorso, rispetto a quella postcinquecentesca. Erano frequenti nella lingua dell’epoca costrutti «collegati agli elementi reggenti, e dunque al resto del periodo […], attraverso un rapporto non pienamente ascrivibile né al campo della subordinazione né a quello della coordinazione»35. Charles Bally, infatti, come ricorda Simona Valente nella sua analisi sulla sintassi del Filocolo, affianca alla subordinazione e alla coordinazione un’ulteriore categoria sintattica: la segmentation, individuando «trois types d’énonciation qui ont ce caractère 35 S. Valente, Note sulla sintassi del periodo nel Filocolo di Boccaccio, in Boccaccio angioino. Materiali per la storia culturale di Napoli nel Trecento, a cura di G. Alfano, T. D’Urso, A. Perriccioli Saggese, Bruxelles, Lang, 2012, pp. 31-46, a p. 33. Nella sua analisi sulla sintassi del Filocolo, la Valente si sofferma a considerare le costruzioni assolute gerundive e participiali, le proposizioni relative appositive e le costruzioni correlative, sottolineando l’incertezza dei grammatici cinquecenteschi di fronte a questi fenomeni, non ritenendoli classificabili né al campo della subordinazione, né a quello della coordinazione. «Le connessioni che tali costruzioni stabiliscono sono state infatti spesso ricondotte ad una categoria diversa […] e dotata di proprie peculiarità oppure a punti diversi di un ideale gradiente di dipendenza ai cui poli si collocano la subordinazione e la coordinazione» (ivi, p. 46). 54 benedetta fordred commun de lier deux termes par un rapport grammatical, et ce caractère différentiel de donner a ce rapport une rigidité croissante: coordination, segmentation et soudure»36. Si riporta di seguito un esempio di paraipotassi: Dec., III 7 87: E essendo stati magnificamente serviti nel convito gli uomini parimente e le donne, né avendo avuto in quello cosa alcuna altro che laudevole, se non una, la taciturnità stata per lo fresco dolore rappresentato ne’ vestimenti obscuri de’ parenti di Tedaldo (per la qual cosa da alquanti il diviso e lo ’nvito del pellegrino era stato biasimato e egli se n’era accorto), ma, come seco disposto avea, venuto il tempo da torla via, si levò in piè, mangiando ancora gli altri le frutte. Tuttavia già alcuni editori otto-novecenteschi sono intervenuti sul testo per emendare questo fenomeno. Fanfani, ad esempio, nell’edizione da lui curata, omette direttamente la congiunzione avversativa «ma» che precede la proposizione principale: Dec., III 7 87: Et essendo stati magnificamente serviti nel convito gli uomini parimente e le donne, nè avendo avuto in quello cosa alcuna altro che laudevole, se non una, la taciturnità stata per lo fresco dolore rappresentato ne’ vestimenti obscuri de’ parenti di Tedaldo (per la qual cosa da alquanti il diviso e lo ’nvito del pellegrino era stato biasimato et egli se n’era accorto), come seco disposto avea, venuto il tempo da torla via, si levò in piè, mangiando ancora gli altri le frutte37. Alcuni studiosi moderni hanno proposto una lettura testuale della paraipotassi, individuando nella coordinazione, tipica di questo fenomeno, tra la principale e l’elemento subordinato, una sorta di subordinazione intermedia finalizzata a conferire un senso di immediatezza al racconto (la congiunzione assumerebbe così il valore discorsivo di «ecco», «eccoti»), cosicché la congiunzione avrebbe «funzione di accompagnamento e di sottolineatura di rapporti correlativi»38. Come ricorda Ilde Consales, infatti, numerosi studiosi hanno spesso sottolineato e ribadito il ruolo di «correlazione di tipo testuale» che svolge la congiunzione paraipotattica all’interno del periodo. La studiosa richiama in primo luogo l’attenzione sulla funzione di cum inversum (che ricalcherebbe «il modulo et ecce dello stile biblico»), di «aggancio tra subordinata e sovraordinata» (che Durante ha attribuito alla congiunzione paraipotattica) e, successivamente, su quel «segnale […] di polemicità dialogica» (cui fa riferimento Mazzoleni)39. La Consales 36 C. Bally, Linguistique générale et linguistique française, Berne, Francke, 1965, p. 55, citato in Valente, Note sulla sintassi del periodo, cit., p. 33. 37 Fanfani, p. 270. 38 F. Brambilla Ageno, Paraipotassi, in Enciclopedia Dantesca, 6 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970-1978, vol. VI, pp. 441-442, a p. 441. 39 I. Consales, Coordinazione e subordinazione, in Sintassi dell’italiano antico. La prosa del Duecento e del Trecento, a cura di M. Dardano, Roma, Carocci, 2012, pp. 99-119, a p. 118. La studiosa, inoltre, precisa che «Quando agisce da anaforico sì può essere considerato una marca di asserzione, un elemento ricapitolativo, semanticamente impoverito, atto a garantire continuità tematica fra subordinata e reggente. Al pari di e, sì introduttore “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 55 spiega, inoltre, che «lo sbiadimento semantico che e presenta in tali combinazioni lo avvicina al sì operatore di correlazione presente in it. ant. Questo elemento tonico, che è un segno di focalizzazione, assume nel contesto diversi valori: temporale, causale, avversativo, rafforzativo del verbo»40. Tuttavia questa condizione è inaccettabile nell’italiano moderno, che non ammette questi casi di commistione sintattica: «oggi la paraipotassi non è più tollerata, almeno nello scritto e nel parlato non troppo informale; verrebbe anzi considerata un grave errore di grammatica»41. Come osserva Mazzoleni, infatti, «la paraipotassi è un fenomeno tipico dell’it. ant., perché la presenza di una congiunzione coordinante in una struttura ipotattica sarebbe agrammaticale in it. mod.»42. Dec., III 8 5: Ora avvenne che, essendosi molto con l’abate dimesticato un ricchissimo villano il quale avea nome Ferondo, uomo materiale e grosso senza modo (né per altro la sua dimestichezza piaceva all’abate, se non per alcune recreazioni le quali talvolta pigliava delle sue simplicità), e in questa dimestichezza s’accorse l’abate Ferondo avere una bellissima donna per moglie, della quale esso sí ferventemente s’innamorò, che a altro non pensava né dí né notte43. di sovraordinata […] accompagna la sequenza anaforica e ne diventa lo strumento […] Inoltre, è rilevante che sì, in qualità di operatore di correlazione, sia presente anche in contesti concessivi: […] “come io giunsi di là, sì fu uno il qual pareva che tutti i miei peccati sapesse a mente” (Dec VII, 10, 25, p. 880)». 40 Ibid. 41 L. Serianni, Grammatica Italiana. Italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET, 1988, p. 451. 42 L. Meszler-B. Samu-M. Mazzoleni, Le strutture subordinate, in Grammatica dell’italiano antico, a cura di L. Renzi e G. Salvi, Bologna, Il Mulino, 2010, vol. II, pp. 763-789, a p. 783. «Ess. simili [a Dante, Vita Nuova, cap. 23, par. 3] che si possono trovare nella lingua letteraria moderna sono dovuti a imitazioni consapevoli di quella antica: Se la tua Dea è morta, e tu tagliati il ventre… (A. Panzini, Il bacio di Lesbia, Milano, Mondadori, 1937, p. 183), Se non volete esser giudicati, e voi non giudicate… (R. Bacchelli, Lo sguardo di Gesù, Milano, Garzanti, 1948, p. 138)». 43 Il Massèra, il Singleton e il Marti (con l’unica differenza che quest’ultimo racchiude tra due punti e virgola le proposizioni che i due precedenti autori circoscrivono in parentesi) riportano il passo in questo modo: «Ora, avvenne che, essendosi molto con l’abate dimesticato un ricchissimo villano il quale avea nome Ferondo, uomo materiale e grosso senza modo (né per altro la sua dimestichezza piaceva all’abate, se non per alcune ricreazioni le quali talvolta pigliava delle sue simplicità), in questa dimestichezza s’accorse l’abate, Ferondo avere una bellissima donna per moglie, della quale esso, sì ferventemente s’innamorò, che ad altro non pensava né dí né notte» (Massèra, vol. I, p. 241; G. Boccaccio, Il Decameron, a cura di C.S. Singleton, 2 voll., Bari, Laterza, 1955, vol. I, p. 241; Id., Decameron, a cura di M. Marti, Milano, Bur-Rizzoli, 1974 [da qui in poi Marti], p. 239). Interessante notare che l’edizione del 1761 riporta così il passo: «Hora adenne che, essendosi molto collo abate dimesticato un ricchissimo villano il quale avea nome Ferondo, huomo materiale e grosso senza modo, ne per altro la sua dimestichezza piaceva allo abate, se non per alcune recreazioni le quali talvolta pigliava delle sue simplicità, che in questa dimestichezza s’accorse l’abate Ferondo avere una bellissima donna per moglie, della quale esso si ferventemente s’innamorò, che a altro non pensava ne dí ne notte» (G. Boccaccio, Il Decameron di Giovanni Boccaccio tratto dall’ottimo testo scritto da Francesco d’Amaretto Mannelli sull’originale dell’autore, a cura di P.A. Guadagni, A.M. Bandini, Lucca, Giunti, 1761, p. 123); per cui si verifica un caso di ripetizione di congiunzione completiva che, frequente, come vedremo, nel Decameron, laddove nelle altre edizioni abbiamo un caso di paraipotassi. «Il Mannelli 56 benedetta fordred Mario Marti, riferendosi proprio all’esempio appena riportato, osserva che «più che funzione copulativa regolare questo e tiene della natura del che ripetuto dopo lungo inciso (da “avvenne che”): o meglio dell’e in ripresa dopo un gerundio narrativo (“essendosi”) con il solito significato di “ecco che”»44. E in effetti nel Pecorone, il costrutto è frequente proprio con l’attualizzatore esplicitato; come osserva Durante, «talora l’istantaneità dell’evento che si aggancia all’enunciato temporale anteposto è messa in rilievo dalla congiunzione e con l’avverbio attualizzante ecco»45: Pec., IV 1 295: E andatosene in camera, e posti a sedere, e ecco venire due donzelle co vino e co confetti; e quivi bevvero e confettarono, e poi s’andarono a letto: e com’egli fu nel letto, cosí fu addormentato; Pec., I 2 245: Disse Bucciolo: Che iersera, poi ch’io fui in casa colei, ed eccotti il marito, e cercò tutta la casa, e non mi seppe trovare46. È possibile rinvenire anche nel latino medievale e nel volgare il suddetto collegamento tra una principale e una proposizione subordinata mediante congiunzione copulativa e dal valore attualizzante ecco che, tipico esempio di simbiosi tra oralità e scrittura. Ad esempio, nelle Vite dei Santi (S. Hugberti episcopi traiectensis, 15 e 17) si legge: legge che in questa ma avverte che nel Ms da cui esso copiava, era et in questa. Fu seguito dagli editori di Livorno e di Milano, ma il 27 i Deputati e tutti gli altri lasciarono e difesero et in questa. Ma nol fecero con tante buone ragioni che io non creda sempre la correzione del Mannelli essere eccellente, come quella che rende naturalissimo e chiaro il discorso, e dà esempio di una di quelle che ripetute dopo parentesi, e delle quali è così vago il Boccaccio. Alcune edizioni poi, come que’ del 27, dopo et in questa posero dimestichezza, ma erratamente; e forse per non aver compreso che in questa è qui modo avverbiale e sta per in questo tempo» (Fanfani, p. 273). Si veda anche F. Ageno, Il problema dei rapporti fra il codice berlinese e il codice Mannelli del Decameron, «Studi sul Boccaccio», XII, 1981, pp. 5-37, a p. 19: «Mn giustamente: che in questa, che riprende l’inizio: Ora avvenne che, secondo un atteggiamento didattico assai diffuso alle origini». 44 Marti, p. 380. 45 M. Durante, Dal latino all’italiano moderno. Saggio di storia linguistica e culturale, Bologna, Zanichelli, 1981, p. 117. 46 Riferendosi al passo seguente del Decameron: «E mentre in questa guisa stava senza alcun sospetto di lupo, e ecco vicino a lei uscir d’una macchia folta un lupo grande e terribile» (Dec., IX 7 12), Ruscelli annotava che «questa, et, doppo la parola mentre, ha molto per proprio di dire il Bocc[accio]. Come più volte s’è veduto per questo libro, ma per certo è fuor d’ordine, et della proprietà della lingua chi ben considera». Interessante è il passo che segue, in cui la congiunzione coordinativa e che determina il legame paraipotattico tra le proposizioni in questione, è seguita, per altro, da un verbo di modo infinito piuttosto che da un indicativo o congiuntivo: «E giunti a casa del padre della fanciulla e lei trovata che con acqua tornava dalla fonte in gran fretta per andar poi con altre femine a veder venire la sposa di Gualtieri» (Dec., X 10 16). Ruscelli commentava a riguardo che «chi intende la lingua, et sa i modi et gli ordini del parlare, conosce senza molte parole, come questo giunti, et trovata qui pendeno, et non hanno dove posarsi, et la sentenza non è ordinata, per istar bene, dove qui dice et lei trovata, vorrebbe non esservi la et, et dir lei trovarono. Ma così come qui si legge hanno tutti gli stampati» (Ruscelli, pp. 417 e 475-476, citato in Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron, cit., p. 343). “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 57 um adpropinquarent locum, et ecce multitudo populi; quando… audierunt et ipsi in timore et pavore conversi non audebant diutius persistere in basilica47. Dunque è da ritenere che si tratti di un tratto costitutivo della sintassi medievale non solo volgare, per cui in assenza «di un confine netto tra ipotassi e paratassi» si inserisce un ecco che «che unisce i due poli della subordinazione e della coordinazione, lungo il quale si collocano le diverse modalità d’espressione di questa particolare relazione della contemporaneità»48. La frequenza del fenomeno nella lingua del Medioevo è documentabile anche da testi francesi; si vedano ad esempio i due passi qui di seguito, tratti da Aucassin et Nicolette (XIV, 26) e La mort le roi Artu (25, 45)49: La u Aucassins et Nicolete parloient ensanble, et les escargaites de le vile venoient tote une rue; et quant la pucele entent ceste parole, si en a moult grant joie. Marra si sofferma sull’importanza delle fonti francesi o latine per la diffusione del costrutto in alcuni testi volgari della prosa delle origini, in particolare del Duecento. Considerando il Tristano Riccardiano, «testo simbolo della prosa media del Duecento, influenzato più degli altri dalla pratica della narrazione orale, e dal modello francese», e il Tesoro volgarizzato, osserva che «nei confronti dell’originale in francese mancava il senso di distanza tra le due lingue e si procedeva con maggiore scioltezza e disinvoltura, mantenendone la sintassi scorrevole e colloquiale e scivolando spesso in queste “irregolarità”, anche quando non erano presenti nell’originale»50, come dimostra l’esempio seguente tratto dal Trésor (CVII) e dal relativo volgarizzamento (II 37), in cui è il volgarizzatore a introdurre la congiunzione di ripresa: Mais quant il vient de grant ravine et o fortune, li marinier l’apelent lebech; ma quando egli viene di grande fortuna e di grande rapina, sì ’l chiamano li marinai libeccio. «Maggiore rispetto si riservava al modello latino, di cui ci si sforzava di imitare la sintassi complessa e sostenuta, anche a costo di rendere innaturale e forzata la tradu- M. Corti, Studi sulla latinità merovingia in testi agiografici minori, Messina-Milano, Principato, 1939, p. 137. I. Consales, Un tipo particolare di temporale nella prosa antica: il caso del cum inversum, in SintAnt: la sintassi dell’italiano antico. Atti del Convegno internazionale di studi, Roma, Università Roma Tre, 18-21 settembre 2002, a cura di M. Dardano e G. Frenguelli, Roma, Aracne, 2004, pp. 101-116, a p. 116. 49 Seguo rispettivamente: Aucassin et Nicolette, éd. par J. Dufournet, Paris, Flammarion, 1984; La mort le roi Artu, éd. par J. Frappier, Paris, Minard, 1964. 50 Marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 81. Rimando alla stessa indicazione bibliografica per i due esempi che seguono. 47 48 58 benedetta fordred zione, che risulta più controllata e priva di espressioni che si potrebbero ricondurre alla vivacità ed espressività del parlato»51: (De cons. philos., 14): Quod si natura quidem inest sed ratione diversum; (BOE, III 10 47): Che se per natura è iddio sommo bene, ma è diverso per ragione. Marra, a differenza di Stussi e Manni (che inseriscono il fenomeno nel complesso della sintassi mista di Boccaccio), stupendosi della diffusione della paraipotassi nel Decameron, «opera che per il suo stile latineggiante e sostenuto dovrebbe essere distante da un fenomeno così “irregolare”, ma che in realtà dimostra, ancora una volta, di essere irriducibile ad una schematizzazione troppo rigida, ed aperta a ogni possibile aspetto e coloritura della lingua», specifica che nel capolavoro del Boccaccio il costrutto «ricorre per lo più in ambito dialogico, o, se narrativo, solo in situazioni particolarmente vivaci e movimentate, quando si vuole evidenziare l’improvviso delinearsi di un evento o la comparsa di un personaggio»52. Anche la paraipotassi relativa «doveva ricorrere con una certa frequenza nell’italiano antico e costituire una forma di legame periodale abbastanza nota e consapevolmente accettata»53, anche se bisogna ammettere che «la serie più fitta e caratteristica si dispone attorno alla metà del Trecento o poco oltre, e prende particolare consistenza […] soprattutto nelle raccolte novellistiche del Boccaccio e del Sacchetti»54. La presenza della paraipotassi relativa in testi latini induce a ritenere che sia anch’essa un fenomeno dovuto a una ridotta distanza tra scritto e orale, comune alla cultura del tempo, prima ancora che a questa o a quella lingua: Mulomedicina Chironis, 50: Si aquatilia fuerint in articulis aut in cambis, quae minime ferro frigido tetigeris55; Orosio, Liber apologeticus, V 2: At ille cum saepe nos docendi simulatione… in aliquam professionis speciem temptaret inducere, dicens quia ad Abraham dictum esset a Domino: «ambula coram me et esto sine macula»… et Zachariam atque Elisabeth pronuntiatos esse iustos ambos ante Dominum, incedentes in iustificationibus Domini sine querela…, cui responsum per me est…56. «Si tratta, come si vede, di una costruzione strettamente analoga, anzi, verosimilmente, della stessa costruzione, che, come tanti altri fenomeni della tarda e meno Ibid. Ivi, pp. 82-83. 53 G. Ghinassi, Casi di «paraipotassi relativa» in italiano antico, «Studi di grammatica italiana», I, 1971, pp. 45-60, a p. 51. 54 Ivi, p. 58. 55 Ivi, p. 52. 56 Ibid. 51 52 “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 59 sorvegliata latinità, si è trasmessa alla sintassi volgare dalle origini»57. L’uso letterario della paraipotassi relativa è da ritenere estinto a metà del Cinquecento, quando diviene più chiaro e definito il confine tra paratassi e ipotassi: «a questa data […] è evidentemente considerata un puro e semplice errore e relegata tra le bizzarrie e le goffaggini degli antichi»58. Le diverse tipologie di paraipotassi possono certamente essere riconosciute, come alcuni dei fenomeni precedentemente osservati, procedure ammissibili in una situazione del sistema della lingua in cui le esigenze di espressività e di senso prevalgono sul rigore dei legami formali, che si allentano sia nella tenuta morfosintattica (come per le costruzioni ad sensum), sia puramente sintattica (come nei casi di paraipotassi). Non a caso, parecchi di questi fenomeni non sono confinati nella lingua letteraria antica, ma continuano nell’uso informale e popolare e prevalentemente, ma non solo, orale dell’italiano contemporaneo. 5. “Che” ripetuto Tra i costrutti anomali frequenti nel Decameron e assai diffusi nella lingua del Trecento va annoverata la ripetizione del che, introduttore di completive, dopo brevi o lunghi incisi: Dec., II 9 10: E da questo, dopo molte altre lode, pervenne a quello di che quivi si ragionava, affermando con saramento niuna altra piú onesta né piú casta potersene trovare di lei; per la qual cosa egli credeva certamente che, se egli dieci anni o sempre mai fuori di casa dimorasse, che ella mai a cosí fatte novelle non intenderebbe con altro uomo»59; Dec., IV 1 60: Ma pure, se niente di quello amore che già mi portasti ancora in te vive, per ultimo don mi concedi che, poi a grado non ti fu che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo vivessi, che ’l mio corpo col suo, dove che tu te l’abbi fatto gittare, morto palese stea60. Ibid. «Commentatori e grammatici, posti di fronte agli esempi boccaceschi riportati sopra, cominciano a mostrare segni di disagio e ad esprimere cauti dubbi e censure più o meno velate. Il Dolce corregge senz’altro, nell’edizione giolitina del ’52, l’avendo di Decameron IX VII 4 con aveva, e aggiunge in margine: “havendo hanno alcuni testi, ma scorrettamente, percioché l’ordine non segue”» (Ghinassi, Casi di «paraipotassi relativa», cit., p. 60 e si veda anche G. Boccaccio, Il Decamerone. Nuovamente alla sua vera lettione ridotto da Lodovico Dolce, Venezia, Giolito, 1552, p. 428). 59 In questo caso notiamo, nella seconda parte del periodo, la ripetizione della congiunzione subordinata che, dopo l’inciso («se egli dieci anni o sempre mai fuori di casa dimorasse»). 60 Il che subordinante è ripetuto dopo una proposizione causale («poi a grado non ti fu»), che regge a sua volta una soggettiva («che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo vivessi»). L’edizione cinquecentina riporta così il passo: «ma pur se niente di quello amore, che gia mi portasti anchora in te vive, per ultimo dono mi concedi, poi che a grado non ti fu, che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo vivessi, che ’l mi corpo col suo, dove che tu l’habbia fatto gittare morto, palese stea» (G. Boccaccio, Il Decameron di M. Giovanni Boccaccio nuovamente corretto et con diligentia stampato, Firenze, Giunta, 1527, p. 111). In questo caso non abbiamo la ripetizione del che, in quanto tale congiunzione, retta dal predicato della reggente «mi concedi», viene inserita 57 58 60 benedetta fordred Si tratta di «costrutti tipici ‘ad incastro’, nei quali la proposizione subordinata di grado superiore […] viene incapsulata tra due segnali deboli di dipendenza sintattica (un che dichiarativo ripetuto), che svolgono la funzione di raccordo e di richiamo, secondo un procedimento di sovrappiù di informazione grammaticale caratteristico della comunicazione orale»61. Questa tipologia di costrutto non è sfuggita alla Grammatica dell’italiano antico, che si sofferma sul fenomeno, descrivendolo in questi termini: in it. ant., quindi, diversamente dall’it. mod., il complementatore che può comparire due volte in una stessa frase subordinata (argomentale o avverbiale). Questo accade in particolare quando all’inizio della subordinata, in posizione periferica rispetto al centro della frase, si trova un’altra subordinata, di tipo avverbiale: in tal caso oltre al che che introduce l’intera struttura subordinata e che precede la subordinata avverbiale, può comparirne un secondo, immediatamente dopo la subordinata avverbiale e prima del corpo della frase62. La diffusione di questi costrutti nell’italiano dell’epoca è confermata dalla loro frequenza non solo in altre opere dello stesso Boccaccio, ad esempio nel Corbaccio (anche se meno diffusi), ma anche in quelle di altri novellieri del secolo, come nel Trecentonovelle del Sacchetti63. Meszler, Samu e Mazzoleni64 individuano una variante di questo fenomeno, precisando che talvolta «il confine tra periferia e corpo della frase poteva essere segnato, invece che da un secondo che, da un avverbio come sì con lo stesso valore di richiamo»: Lettera di Consiglio de’ Cerchi, II, p. 602, r. 33 – p. 603, r. 1: sì ragionammo co.llui che quando elgli avesse fatto di costà quello c’avesse a ffare, sì si ne partisse e venissesine in Fiandra; solo in seguito ai due incisi «poi che a grado non ti fu, che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo vivessi». Inoltre nelle altre edizioni, a differenza di quella del Branca, la virgola è posta dopo l’aggettivo «morto», che, pertanto, essendo integrato nell’incidentale, si riferisce al corpo di Guiscardo e non a quello di Ghismonda. 61 R. Tesi, Storia dell’italiano: la formazione della lingua comune dalle Origini al Rinascimento, Bari, Laterza, 2001, pp. 161-162. 62 Meszler-Samu-Mazzoleni, Le strutture subordinate, cit., p. 772. 63 «Messer Dante, voi mi date consiglio di due cose più forte che non è la principale; però che forte cosa serebbe che la donna ingravidasse, però che mai non ingravidò; e vie più forte serebbe che poi che la fosse ingravidata, consinderando di quante generazioni di cose ell’hanno voglia, ch’ella s’abattesse ad avere voglia di me» (Trecentonovelle, VIII 9; seguo l’ed. a cura di V. Marucci, Roma, Salerno Editrice, 1996); «E fecionli credere che, conoscendo eglino la condizione d’Alberto, che egli non era salito su quel letto per alcuno male, ma per molta dimestichezza, avendo voglia di dormire» (Trecentonovelle, XIV 11). E nel Pecorone: «Fa’ che la prima volta ch’e’ ti dice più niente, che tu gli dia intro ’l volto, e non mi ci venire piú con queste novelle, però che tu sai bene ch’egli è nimico del marito mio» (Pec., II 2 65; seguo l’ed. a cura di E. Esposito, Ravenna, Longo, 1974); «Disse la donna: Fa’ che la prima volta ch’egli ti dice più niente, che tu li dichi per mia parte ch’e’ mi mandi una roba di quel panno ch’avea indosso la sorella stamane in chiesa» (Pec., II 2 105). Già nel Convivio di Dante si può leggere: «Li quali priego tutti che se lo convivio non fosse tanto splendido quanto conviene a la sua grida, che non al mio valore ma a la mia facultade imputino ogni difetto» (Conv., I 1, 19). Esempio tratto da R. Tesi, Parametri sintattici per la definizione di “italiano antico”, in SintAnt, cit., pp. 426-444, a p. 436. 64 Meszler-Samu-Mazzoleni, Le strutture subordinate, cit., p. 773. Rimando alla stessa indicazione bibliografica per i due esempi che seguono. “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 61 Compagnia di S. M. del Carmine, p. 63, rr. 31-34: fue ordinato, (…) che, quando si fae la elettione de’ nuovi officiali, secondo la forma [norma] de’ capitoli nostri, sì si debbia eleggere. Si è visto che il costrutto di paraipotassi era attestato prima di tutto nel latino medievale, oltre che nel volgare. Il fenomeno di ripetizione della congiunzione completiva che, invece, come osservano Meszler, Samu e Mazzoleni, «è una creazione volgare e non fu un riflesso del latino: […] alle attestazioni del doppio che in it. ant. nelle versioni latine corrisponde regolarmente l’uso del complementatore quod, e non si ha una singola occorrenza di una costruzione del tipo statum est quod… si quod…»65. Il numero dei casi di ridondanza del che invita dunque a evitare l’etichetta di “errore”. Più che di “errore” si può parlare di un complesso di movimenti sintattici che ricalcano l’oralità: Le ultime tendenze della linguistica (pragmatica e funzionale, soprattutto) stanno rivalutando questi fenomeni ricollocandoli nella loro epoca e riconducendoli, oltre che alla maggiore libertà sintattica, anche alle diverse esigenze imposte dalle situazioni comunicative. I testi antichi, in particolare quelli della prosa media e divulgativa, erano legati alla pratica della lettura ad alta voce e questo ne spiega la ripetitività, la segmentazione, i frequenti processi di messa in rilievo66. Tale costrutto può rientrare dunque in quei fenomeni dell’oralità, o della simulazione dell’oralità, che sono costituiti dal rilancio dei nessi sintattici quando finiscono per trovarsi lontano dal punto di aggancio cui si riferiscono. Manni osserva: «assai diffusa nella prosa delle origini, la ripresa del che subordinante si integra nella sintassi decameroniana per la sua capacità di garantire coesione testuale in un periodare contrassegnato da continue interruzioni dell’ordine lineare»67, interruzioni che sono movenze tipiche di quel parlato che, in fondo, costituisce la grana di base del Decameron, libro che raccoglie racconti che si fingono narrati a voce. Pertanto la ripetizione del complementatore che potrebbe spiegarsi anche facendo appello alla «situazione comunicativa, la quale impone di riferirsi, con precisione, a precedenti intese verbali che devono essere richiamate e alle quali si deve dare seguito»68. Anche Meszler e Samu attribuiscono tale funzione di nesso di raccordo alla congiunzione quando affermano che «dal punto di vista discorsivo, la ripetizione del che funge da segnale di richiamo e facilita la comprensione del testo da parte dell’ascoltatore/lettore, in particolare in casi di strutturazione sintattica complessa della frase. Questa costruzione risponde perciò all’esigenza pragmatico-testuale di rendere più trasparente l’articolazione sintattica e concettuale di un periodo complesso»69. Il che Ivi, p. 775. Marra, «La sintassi mista» dei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 63. 67 P. Manni, Il Trecento toscano, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 307. 68 M. Dardano, La subordinazione completiva, in Sintassi dell’italiano antico, cit., pp. 120-195, a p. 188. 69 Meszler-Samu-Mazzoleni, Le strutture subordinate, cit., p. 772. 65 66 62 benedetta fordred ripetuto avrebbe, dunque, da una parte funzione di ricostruzione dei legami sintattici allentati dalla lontananza, dall’altra di una simulazione pragmatica tipica dell’oralità70. Il fenomeno della ripetizione del che dopo inciso non era sfuggito ai grammatici del Cinquecento, che si soffermarono sul costrutto, ora condannandolo come Ruscelli, ora accettandolo, come i Deputati. Ruscelli non esitò a definire «difettosa»71 tale costruzione; segno che la lingua del suo tempo non la trovava più del tutto ammissibile. Interessante quanto notato da Ruscelli sul passo di seguito riportato: Dec., VIII 10 12: Salabaetto, udendo questo, fu il piú lieto uomo che mai fosse; e preso l’anello e fregatoselo agli occhi e poi basciatolo, sel mise in dito e rispuose alla buona femina che, se madama Iancofiore l’amava, che ella n’era ben cambiata per ciò che egli amava piú lei che la sua propria vita e che egli era disposto d’andare dovunque a lei fosse a grado e a ogn’ora. Annotava a proposito che «queste che così soverchiamente et malamente replicate si truovano in tutti i Boc[caccio] così à penna, come stampati, et io non ho voluto in modo alcuno levarle. Ma bene avvertirne i lettori, perche così vengano a raffinare il giudicio, et la prefettion dell’intendimento»72. Questo costrutto, apparentemente il più sospettabile di distrazione scrittoria, è così diffuso nella lingua dell’epoca che non può essere facilmente catalogato come svista d’autore ed è più in generale riferibile anch’esso come la paraipotassi ad una situazione sintattica propria della lingua delle origini, tant’è vero che si trova frequentemente in condizioni analoghe anche in testi francesi: Si que se supprime ainsi volontiers là où nous ne saurions nous en passer, en revanche, on la répète dans des cas où nous n’en voyons pas la nécessité. Il s’agit de phrases reliées par que à un verbe declaratif (affirmer, dire, savoir, etc.) ou à un verbe de promesse ou de commandement 73. Non solo i versi, ma anche l’antica prosa francese attesta il fenomeno in questione, come l’Aucassin et Nicolette (rispettivamente VIII 35 e XIV 30): je prenderai les armes, s’irai a l’estor, par tex convens que, se Dix me ramaine sain et sauf, que vos me lairiés Nicolete me douce amie tant veir que j’aie deus paroles u trois a li parlees et que je l’aie une seule fois baisie; Già Fornaciari aveva attribuito questa funzione al che ripetuto, anche in casi in cui non vi è la presenza di un inciso interposto tra la congiunzione e la rispettiva subordinata, spiegando che «più proposizioni coordinate tra loro, ma subordinate alla medesima principale, ripetono la congiunzione subordinante, quando la chiarezza o la forza del discorso lo richiede» (G. Fornaciari, Sintassi italiana dell’uso moderno, Firenze, Sansoni, 1881, p. 420). 71 Tesi, Parametri sintattici per la definizione di “italiano antico”, cit., p. 440. 72 Ruscelli, p. 385, citato in Gizzi, Girolamo Ruscelli editore del Decameron, cit., p. 342. 73 L. Foulet, Petite syntaxe de l’ancien français, Paris, Champion, 1961, pp. 336-337. 70 “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 63 la u Aucassin et Nicolete parloient ensanble, et les escargaites de le ville venoient tote una rue, s’avoient les espees traites desos les capes, car li quens Garins lor avoit conmandé que, se il le pooient prendre, qu’ i l’ocesissent. Si noti che nell’ultimo passo citato il fenomeno della ripetizione si presenta due volte di seguito a distanza ravvicinata, dopo due diversi tipi di subordinate (X 50): Enne m’eustes vos en covent que, quant je pris les armes et j’alai a l’estor, que, se Dix me ramenoit sain et sauf, que vos me lairés Nicolete ma douce amie tant veir que j’aroie parlé a li deus paroles ou trois? Anche in La mort le roi Artu il fenomeno è piuttosto frequente. Foulet ha ben sintetizzato: le que de liaison une fois exprimé, la proposition complétive est brusquement interrompue pour y insérer une incident; puis, l’incidente achevée, on revient à la proposition laissé en suspens pour la reprendre et la terminer; seulement on ne se donne pas la peine d’aller voir si le que avait déjà été énoncé, ou on estime que la clarté ne perdra rien à ce qu’on le répète. Cet emploi est très fréquent74. Va osservato, inoltre, che in francese, nella maggior parte dei casi, l’incidentale che origina e favorisce il fenomeno della ridondanza della congiunzione completiva que è costituita da una condizionale. Come afferma Dardano, «la ripetizione del che complementatore, non è da considerare sempre un fatto di ridondanza, messo in atto quando il nesso tra sovraordinata e subordinata si allenta per l’inserimento di materiale lessicale; in molti casi è il segnale di un’intensificazione enunciativa, di una sottolineatura espressiva legata al contesto»75. Foulet, Petite syntaxe, cit., p. 337. Dardano, La subordinazione completiva, cit., p. 147. Si riportano di seguito altri esempi di ripetizione del complementatore “che”, tratti da Dardano: a) «I savi strologi providero che s’elli non stesse anni diece che non vedesse il sole, che perderebbe lo vedere (Nov XIV, 2, p. 33); b) E conviene, che chi ciò fae, ch’elli mangi il dì molte volte, e poco insieme, e diverse e varie vivande e buone (Z. Bencivenni, Santà, 26 v, p. 103); c) e nessuno dubita che s’elle comandassero a voce, che questo non fosse lo loro comandamento (Cv I, VII, ii, p. 29); d) ordinò che colui de’ suoi figliuoli appo il quale, si come lasciatogli da lui, fosse questo anello trovato, che colui s’intendesse essere il suo erede (Dec. I, 3, 11, p. 81); e) Eo te sconçuro per lo nome de Cristo salvaore, che se tu èi homo overo alcuna criatura rasonevole la qual habiti en quella spelonca, che tu me dobie parlare e dire veritae de tie (Vite Santi, p. 150). Dardano sottolinea che «nella maggioranza degli esempi si ha una ripresa pronominale, realizzata mediante che ciò, che colui, che ella, che questo, che ambo queste, ch’elli. Diversa è la situazione nella poesia: ad esempio, la ripetizione di che presente nella prosa del Convivio è assente nelle Rime di Dante, e in genere nei testi poetici del tempo» (ivi, p. 148). 74 75 64 benedetta fordred 6. “Che” seguito da infinito Altro e più vistoso scarto dalle norme sintattiche per noi correnti è certamente una completiva introdotta da che, il cui verbo si svolge, però, al modo infinito76: Dec., I 1 3: Manifesta cosa è che, sí come le cose temporali tutte sono transitorie e mortali, cosí in sé e fuor di sé esser piene di noia, d’angoscia e di fatica e a infiniti pericoli sogiacere77; Dec., III 5 13: E sí come umilissimo servidor vi priego, caro mio bene e sola speranza dell’anima mia, che nell’amoroso fuoco sperando in voi si nutrica, che la vostra benignità sia tanta e sí ammollita la vostra passata durezza verso di me dimostrata, che vostro sono, che io dalla vostra pietà rinconfortato possa dire che, come per la vostra bellezza innamorato sono, cosí per quella aver la vita; Dec., VII 5 3: Nobilissime donne, la precedente novella mi tira a dovere similmente ragionar d’un geloso, estimando che ciò che si fa loro dalla lor donna, e massimamente quando senza cagione ingelosiscono, esser ben fatto78. Si riporta di seguito un esempio tratto da Dardano (ivi, p. 165): «avendo udito che per li buoni consigli di Giannotto di Civignì Abraam aver l’anima salvata e Melchisedech per lo suo senno avere le sue ricchezze dagli aguati del Saladino difese, […] intendo di raccontar» (Dec., I 4 3). A proposito di questo passo, lo studioso osserva che «si ha il mutamento della subordinazione (che + infinito)» (ivi, p. 166); si veda quest’altro esempio tratto da Dardano «[alcuni] si lasciano andare in qualunque colpa, dicendo sé sapere quel c’hanno e non sapere quel ch avranno e che, se pure avviene che perdano i beni dell’altra vita, non voler perdere quegli di questa (Boccaccio, Esposizioni, ix, 5, p. 508)». Dardano osserva che «la decentralizzazione della configurazione complessa prova come essa tenda a espandersi grammaticalizzandosi» (ivi, pp. 185-186). 77 Parafrasando il passo in italiano moderno, si noterà chiaramente l’irregolarità in questione: «è noto che, così come le cose terrene sono tutte transitorie e mortali, così sono in se stesse e all’infuori di se stesse piene di noia, di angoscia e di fatica e sottoposte a infiniti pericoli». Notiamo la costruzione con il che e l’infinito, dopo la parentetica comparativa («sì come le cose temporali tutte sono transitorie e mortali»): in una costruzione regolare i predicati dell’oggettiva esplicita dovrebbero essere di modo finito, in quanto introdotti dalla congiunzione che. Colombo annota: «Il Boccaccio e altri scrittori del secolo quattordicesimo alcuna fiata eziandio con la particella che adoperarono l’infinito; ma ciò non fecero mai, che io mi sappia, senza mettere tra la detta particola e il verbo qualche proposizione incidente. Così in questo luogo vi si frappone siccome sono transitorie e mortali; e là dove il medesimo Boccaccio disse (nel finale della Giorn. 8): “assai manifestamente veggiamo che, poiché i buoi alcuna parte del giorno hanno faticato sotto il giogo ristretti, quegli esser dal giogo alleviati o disciolti” vi s’interpose poiché alcuna parte del giorno con quel che segue» (G. Boccaccio, Decameron, corretto ed illustrato con note [di M. Colombo], Parma, Blanchon, 1812, vol. I, p. 115). Marti commenta: «Il periodo è stato in un primo tempo concepito così: manifesta cosa è che… sono piene ecc. Poi si è passati alla costruzione: manifesta cosa è… esser piene, ecc.; il che è rimasto come un inutile residuo della prima costruzione. È questa una particolarità sintattica frequente nel Boccaccio» (Marti, p. 27). 78 Ruscelli, riferendosi a questo passo, afferma che «questo incomportabile vizio che ha il Boccaccio di dare la congiunzione che allo infinito come spesso in questo suo libro si vede, non fu avvertito dal Bembo, che oltre che è vizio senza scusa, l’avrebbe almen ricordato come proprio modo ò forma di dire» (Tesi, Parametri sintattici per la definizione di “italiano antico”, cit., p. 441). 76 “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 65 Il che seguito da un verbo di modo infinito79 si trova anche nel Trecentonovelle del Sacchetti, (rispettivamente ai passi XXVI 4 e XVIII 2): Voglio che ogni volta che tu avrai male, essere tenuto di medicarti in dono; Considerando che dopo desinare, lavate le mani, in su la sparecchiata tavola d’arcare loro, e cosí fece. Anche Rohlfs aveva notato il fenomeno, affermando che «nell’antica lingua letteraria non è raro che una proposizione dipendente retta da che, la quale venga interrotta da un altro pensiero, sia poi ripresa con un’ingiustificato infinito, in forma d’anacoluto: seco deliberarono che, come prima tempo si vedessero, di rubarlo (Decam. 2, 2), considerando che dopo desinare, levate le mani, in su la sparecchiata tavola d’arcare loro (Sacchetti, 18)»80. Il fenomeno va comunque visto insieme col seguente, di cui costituisce una variante. 7. Cambio di costruzione «Nello stesso periodo convivono talvolta diversi tipi di subordinazione, i quali tendono a combinarsi e a fondersi tra loro. Questa caratteristica, propria della sintassi della prosa medievale, deve essere osservata attentamente»81. Sono frequenti nel Decameron ravvicinati cambi di costruzione, coordinando ad esempio due dipendenti, una di modo finito e l’altra di modo infinito, all’interno del periodo. È un’altra caratteristica tipica dell’elasticità sintattica della lingua antica per cui «se è vero che nell’italiano moderno i costituenti di una struttura coordinata devono appartenere alla stessa categoria sintattica, e avere la stessa funzione semantica, il Decameron non sembra condividere rigidamente tale restrizione»82. Va per altro osservato che la distinzione tra i due modi verbali, nella lingua delle origini, in assenza di una norma regolarizzatrice, non era ben netta. Marra ricorda Una variante di questo costrutto ricostruisce parzialmente il rigore sintattico, riprendendo dopo l’inciso non con un che, ma con un di, più appropriato al modo infinito che segue, anche se sempre contradditorio rispetto alla congiunzione precedente: «Io intendo che, in merito del servigio che mi farete, di darle prestamente de’ miei denari quella dote che voi medesima a maritarla onorevolmente stimerete che sia convenevole» (Dec., III 9 44). 80 G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e i suoi dialetti (trad. it.), Torino, Einaudi, 1969, vol. III, p. 189. 81 Dardano, La subordinazione completiva, cit., p. 184. Riguardo alla coordinazione tra proposizioni implicite ed esplicite, Dardano distingue tre categorie di subordinazione: completiva di modo finito + infinitiva; infinitiva + completiva di modo finito; due infinitive + completiva di modo finito (ivi, p. 187). 82 A. Stussi, Lingua, in Lessico critico decameroniano, a cura di R. Bragantini e P.M. Forni, Torino, Bollati, Boringhieri, 1995, pp. 192-221, a p. 218. 79 66 benedetta fordred come talvolta «il gerundio svolge anche la funzione di infinito declinato con preposizione, tanto che si ebbe a volte un senso di identità tra i due modi che portò in qualche caso alla loro coordinazione»83. Significativi i casi che seguono84: Dec., I 1 23: Noi abbiamo de’ fatti suoi pessimo partito alle mani: per ciò che il mandarlo fuori di casa nostra cosí infermo ne sarebbe gran biasimo e segno manifesto di poco senno, veggendo la gente che noi l’avessimo ricevuto prima e poi fatto servire e medicare cosí sollecitamente, e ora, senza poter egli aver fatta cosa alcuna che dispiacer ci debbia, cosí subitamente di casa nostra e infermo a morte vederlo mandar fuori85; Dec., X 9 77: questo fatto, comandò che a messer Torello, il quale era già forte, fosse messa indosso una roba alla guisa saracinesca, la piú ricca e la piú bella cosa che mai fosse stata veduta per alcuno, e in testa alla loro guisa una delle sue lunghissime bende ravolgere86; Marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 90. Marra riporta altri due esempi tratti dal Decameron: «uomini li quali, le corti de’ signor visitando, di contraffarsi e di nuovi atti contraffacendo qualunque altro uomo li veditori sollazzavano» (Dec., I 1 23); «ma se vuogli la fedeltà del tuo famiglio cognoscere, tu puoi lieggermente, mettendoti indosso una delle guarnacche mie e in capo un velo, e andare laggiuso a aspettare se egli vi verrà» (Dec., VII 7 35). 84 Si riportano altri esempi di coordinazione tra proposizione esplicita e implicita tratti da Dardano (ivi, p. 160): «a) A cui la donna rispose sé non potergli né questo né altro negare, e che veramente ella si conforterebbe (Filocolo, IV, 67, 16, p. 451); b) [Panfilo] rispose sé padre mai non avere conosciuto, però che postumo era, e che le sue cose, dell’idii grazia, tutte prosperamente stavano, e che mai più qui non era dimorato, e ora intendeva di dimorarci poco (Fiammetta, VII, 8, 15, p. 169). Il contesto più ampio permette di mostrare la complessità di periodi che all’infinitiva fanno seguire la subordinazione di modo finito». 85 Analizziamo la seconda parte del periodo: «per ciò che il mandarlo fuori di casa nostra così infermo ne sarebbe gran biasimo e segno manifesto di poco senno» è la reggente a cui è coordinata una proposizione al gerundio («veggendo la gente che») che regge una serie di oggettive tutte coordinate tra loro («che noi l’avessimo ricevuto prima e poi fatto servire e medicare così sollecitamente»). Fino a questo punto il periodo scorre regolarmente, perché abbiamo una proposizione al gerundio che regge più infinitive di forma esplicita; ma è bene considerare l’ultima coordinata oggettiva, per altro interrotta da una parentetica («senza poter egli aver fatta cosa alcuna») che regge una relativa-consecutiva («che dispiacere ci debbia»), «così subitamente di casa nostra e infermo a morte vederlo mandar fuori»: «come si collega quel vederlo all’andamento del periodo?» (Mussafia, Il Decameron di Giovanni Boccaccio riscontrato coi migliori testi, cit., p. 33). In quest’ultima proposizione, l’autore cambia costruzione (veggendo la gente che… vederlo mandar fuori). L’espressione «vederlo mandar fuori», oltre che per la forma implicita, anche a livello semantico non si lega correttamente alla reggente, esprimendo lo stesso concetto di «vedere». Branca ipotizza un anacoluto: «era da aspettarsi lo mandiam fuori, dipendendo da veggendo la gente che noi; invece il B. torna col pensiero al costrutto il mandarlo fuori, oppure coordina col gerundio precedente veggendo» (Branca 1999, p. 56). 86 Si tratta dei soliti cambi di costruzione con l’oggettiva come quelli precedentemente analizzati, frequenti nel Boccaccio: l’autore, dopo aver introdotto un’oggettiva esplicita, continua il discorso con una coordinata (all’oggettiva) implicita. Consideriamo l’ultima proposizione coordinata «e in testa alla loro guisa una delle sue lunghissime bende ravolgere»: questa ha un predicato di modo infinito («ravolgere»), ma non è chiaro da cosa sia retto il verbo in questione; l’autore, infatti, cambia completamente costruzione e il predicato potrebbe esser retto da un «gli fece» che Boccaccio, preso dal discorso, si dimentica di scrivere (gli fece ravolgere), ottenendo una coordinata alla principale (comandò che… e gli fece avvolgere). Non è attestato, invece, dal Massèra e dal Marti: «e questo fatto, comandò che a messer Torello, il quale era già forte, fosse messa indosso una roba alla guisa saracinesca, la piú ricca e la piú bella cosa che mai fosse 83 “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 67 Dec., II 9 16: Se l’uomo adunque è di maggior fermezza e non si può tenere che non condiscenda, lasciamo stare a una che ’l prieghi, ma pure a non disiderare una che gli piaccia, e, oltre al disidero, di far ciò che può acciò che con quella esser possa, e questo non una volta il mese ma mille il giorno avvenirgli. Marra si sofferma ancora su II 9 16, osservando che «un primo fenomeno da segnalare è un cambio di costrutto: l’uso di di far ciò in dipendenza da non condiscenda e in correlazione con a non disiderare; l’“irregolarità” più evidente è, comunque, l’uso dell’infinito avvenirgli in luogo di un indicativo o congiuntivo»87. E specifica che non sono rari i casi in cui il gerundio88 è usato «con funzione di verbo finito, come nel seguente passo dove ha valore di imperfetto»89: Dec., VI 5 6: E per ciò, avendo egli quell’arte ritornata in luce, che molti secoli sotto gli error d’alcuni, che piú a dilettar gli occhi degl’ ignoranti che a compiacere allo ’ntelletto de’ savi dipignendo, era stata sepulta, meritamente una delle luci della fiorentina gloria dir si puote. «Deve trattarsi di una scarsa attitudine», tipica e consueta della lingua antica, «a ordinare logicamente il pensiero, per la quale non si arriva a precisare ed esprimere i nessi fra i diversi predicati e, restando tali nessi indistinti, ci si contenta di una forma verbale di senso più generico (appunto l’infinito)»90. La diffusione di questo costrutto in più testi trecenteschi e per periodi piuttosto complessi attesta che «il modulo esisteva non come un’alternativa stilistica ad altri più correnti, o una variatio formae a disposizione di qualunque scrittore, bensì come un risultato dell’impaccio costruttivo e dell’insufficiente attitudine al rigore del ragionamento»91. Entro la categoria di cambio di costruzione vanno inclusi anche i periodi in cui sembrano esserci più proposizioni lasciate in sospeso. Come afferma Marra, un aspetto indicativo della scarsa pianificazione sintattica medievale è la frequenza di strutture del periodo lasciate in sospeso in seguito ad un improvviso cambio di progetto, o ad una “dimenticanza” dell’autore. Il fenomeno è ben presente nella prosa media, ma tocca il stata veduta per alcuno, ed in testa alla lor guisa una delle sue lunghissime bende gli fe’ ravvolgere» (Massèra, p. 303; Marti, p. 719). 87 Marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 98. 88 Dardano nota che talvolta il gerundio «ha il fine di scorciare la struttura sintattica, sostituendo secondarie di struttura più complessa», come dimostra «la frequente apparizione del gerundio all’inizio del periodo» e riporta esempi dal Novellino: «Stando Alessandro alla città di Giadre con moltitudine di gente ad assedio, un nobile cavaliere era fuggito di pregione» (801, 25); «Amando messere Tristano di Cornovaglia Iaotta la Bionda, moglie del re Marco, si fecero tra loro un signale d’amore di tal guisa» (854, 16) (M. Dardano, Lingua e tecnica narrativa nella prosa del Duecento, Roma, Bulzoni, 1969, p. 215). Per i due passi citati cfr. ivi, p. 178, nota 248. 89 Marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 93. 90 F. Ageno, Il verbo nell’italiano antico. Ricerche di sintassi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1964, p. 399. 91 Ibid. 68 benedetta fordred suo picco massimo nella prosa decameroniana, dimostrando come non basti etichettare tali costrutti come ingenuità stilistiche92. Non mancano, infatti, nel Decameron, casi in cui Boccaccio sembra lasciare sospesa o addirittura omettere la principale: Dec., VIII 4 2: Venuta Elissa alla fine della sua novella non senza gran piacere di tutta la compagnia avendola raccontata, quando la reina a Emilia voltatasi le mostrò voler che ella appresso d’Elissa la sua raccontasse. Questi costrutti sintatticamente per noi piuttosto anomali si presentano, per la maggior parte, dopo inciso più o meno lungo; a dimostrazione del fatto che la sintassi antica tendeva a far prevalere l’esigenza della comunicazione (nei casi del che ripetuto) e seguiva decisamente la pista del senso (nei casi di coordinazione tra proposizioni esplicite o implicite o di che e infinito), anche a costo di forzare il rigore dei legami formali. 8. Problemi di stile o di sistema? I cosiddetti “errori” d’autore nella sintassi del Decameron sono fenomeni diversi, ora isolati, ora sistematici (ancorché in maniera non univoca come si è visto), come quelli qui esaminati. Alcuni di essi, come la paraipotassi, sono già stati riconosciuti come costanti della lingua delle origini, che li attesta anche in opere e autori non italiani, per cui sembra di dover sottoscrivere quanto afferma Tesi: «“esiste” una “lingua antica” che ha caratteristiche – soprattutto sintattiche e lessicali – sensibilmente, se non completamente, diverse dalla “lingua moderna”»93. Colpisce, infatti, non solo la frequenza di questi costrutti anomali ma anche il loro essenziale costituirsi in sistema, la cui regola di funzionamento è certamente quella descritta da Si veda, ad esempio: «il quale ampia materia a ciò che m’è stato proposto mi presta di favellare, e ancora a dimostrare quale e quanta sia la ipocrisia de’ religiosi, li quali con panni larghi e lunghi e co’ visi artificialmente palidi e con le voci umili e mansuete nel domandar l’altrui, e altissime e robuste in mordere negli altri li loro medesimi vizii e nel mostrar sé per torre e altri per lor donare venire a salvazione; e oltre a ciò non come uomini che il Paradiso abbiano a procacciare com noi ma quasi come possessori e signori di quello danti a ciaschedun che muore secondo la quantità de’ denari lasciata da lui, più e meno eccellente del luogo, con questo prima se medesimo, se così credono, e poscia coloro che in ciò alle loro parole dan fede sforzandosi d’ingannare» (Dec., IV 2 5-6). «Anche in questo caso il periodo è complesso, starei per dire che sfugga di mano allo stesso Boccaccio, maestro nel dominio ipotattico: qui a rimanere in sospeso è, anzitutto, il relativo li quali seguito da una serie di temporali implicite concluse con pausa forte […] Ma più interessante si rivela la seconda parte del periodo, in cui, dopo una serie di subordinate, rimane in sospeso il gerundio sforzandosi, probabilmente con valore di modo finito» (Marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., pp. 84-86). 93 Tesi, Parametri sintattici per la definizione di “italiano antico”, cit., p. 442. 92 “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 69 Dardano, quando afferma: «il prevalere dei significati e delle situazioni sull’organizzazione sintattica e testuale spiega il ‘disordine’ di taluni passi del Decameron […] e a una certa discontinuità della struttura sintattica corrispondono relazioni semantiche univoche e rapporti pragmatici ben delineati»94. Si tratta, dunque, di rimettere il giudizio filologico e linguistico su questi fenomeni ancor prima che all’autore, allo stato della lingua del suo tempo e a sottolineare, con Marra, «una tendenza alla mimesi del parlato»95. Già i Deputati, non a caso, suggerivano rispetto e cautela nell’avvicinarsi ai testi del Trecento, soprattutto a quelle costruzioni sintattiche considerate in parte già allora, come da noi oggi, anomale: non habbiamo subito, come hanno fatto alcuni, credutoli errori et molto meno siamo corsi a corregerli, che sarebbe veramente un corromperli […] cosí siamo iti ricercando per riconoscere in viso queste tali parole nelli scrittori et scritture di quel medesimo secolo, né sopportato che sia guasta l’antica forma et, come dire, habito, del quale allhora andavan vestite96. Per quanto neanche i Deputati ammettessero tutto, o avvertendo le irregolarità in questione, o intervenendo direttamente sul testo, la sensazione è che in questa mappa di anomalie sintattiche, lo stadio aurorale della lingua e la maggior vicinanza dello scritto al parlato costituiscano la ragione primaria della loro manifestazione: «ciò che vale la pena di mettere in rilievo è il fatto che non si può naturalmente parlare né di regresso né di progresso linguistico, si tratta soltanto di una posizione diversa della lingua»97. Questi costrutti sintatticamente fluidi non sono un’esclusiva dell’italiano antico. Intanto, alcuni sono riscontrabili già nel latino medievale e altri sono attestati, come dal nostro volgare, da quello francese antico; «aspetti sintattici ritenuti caratterizzanti del francese antico sono in gran parte gli stessi che si incontrano nei testi dei volgari medievali italoromanzi»98. Se è vero che determinati costrutti attestano la specificità della lingua antica nel gestire periodi piuttosto articolati, è doveroso ricordare anche, con Marra, che «il testo antico privilegiava l’espressività, la ripetitività, l’efficacia pragmatica rispetto alla moderna razionalizzazione e gerarchizzazione dei rapporti sintattici»99. È facile osservare che la maggior parte di questi fenomeni si presentano dentro edifici sintattici complessi, quegli stessi che, nel Decameron, sono in genere riferibili a un’ambizione periodale che risentirebbe del latino. La prevalenza del senso sulla coerenza formale introduce elementi di informalità e oralità in una sintassi, la cui complessità non sarebbe dovuta solo al calco elegante delle strutture latine, ma anche alla spigliata simulazione di un parlato continuo. Infatti, come osserva Dardano: Dardano, Collegamenti nel Decameron, cit., p. 604. Marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 64. 96 Chiecchi-Troisio, Le annotazioni e i discorsi sul Decameron, cit., p. 25. 97 Corti, Studi sulla latinità merovingia, cit., p. 153. 98 Tesi, Parametri sintattici per la definizione di “italiano antico”, cit., p. 431. 99 Marra, «La sintassi mista» nei testi del Due e Trecento toscano, cit., p. 63. 94 95 70 benedetta fordred Quelle che, nella prospettiva dell’it. mod., sono giudicate “irregolarità” o “incoerenze” hanno trovato, nel corso degli ultimi anni, una giustificazione “pragmatica”. La voce svolge un ruolo di primo piano nella testualità medievale romanza e questo è un fattore che condiziona a fondo alcuni aspetti della sintassi; anche il carattere collettivo della ricezione di alcuni tipi di testi è una circostanza da tenere ben presente nella prima fase di sviluppo del volgare. La testualità, l’assetto pragmatico e la sintassi sono aspetti tra loro connessi e sono soggetti a variare a seconda di generi e tipi testuali100. 9. Alternanza tra costrutti regolari e anomali da un punto di vista linguistico moderno Si tratteranno di seguito una serie di casi che, pur apparendo al limite della regolarità, presentano costrutti sintattici corretti da un punto di vista linguistico moderno. Va detto, a questo punto, che in parecchi casi il Decameron affianca alle sue “devianze”, in situazioni identiche, esiti che noi, dal punto di vista odierno, definiremmo “regolari”. «La prosa di Boccaccio si caratterizza per alcuni tratti specifici che sono rintracciabili in tutte le sue opere: diversa è però la loro proporzione e, di conseguenza, l’equilibrio che ne risulta»101. Come osservano giustamente Meszler, Samu e Mazzoleni «la ripetizione di che […] non era obbligatoria, per cui si potevano avere strutture come quelle dell’it. mod., che costituiscono anzi la norma»102. La ripetizione del che dopo proposizione incidentale, ad esempio, uno dei casi più diffusi e nel Decameron e nelle altre opere qui considerate, non è attestata costantemente ogniqualvolta tra la suddetta congiunzione e la rispettiva subordinata venga interposta un’incidentale: Dec., II 5 18: Ma tu udirai tosto la cosa la quale piú ti farà forse maravigliare, sí come è che io sia tua sorella; e dicoti che, poi che Idio m’ha fatta tanta grazia che io anzi la mia morte ho veduto alcuno de’ miei fratelli, come che io disideri di vedervi tutti, io non morrò a quella ora che io consolata non muoia. Ci saremmo aspettati, data l’estensione degli incisi, il ribadimento della congiunzione completiva, ma questo non avviene, a dimostrazione di una sostanziale equipollenza tra il che ripetuto e quello per noi, per così dire, normale, tanto che talvolta, a poca distan- Dardano, La subordinazione completiva, cit., p. 195. M. Biffi-N. Maraschio, La lingua del Boccaccio, pubblicazione Internet sul portale http://www.italicon.it, 2002, p. 21, cit in Valente, Note sulla sintassi del periodo, cit., p. 32. 102 Meszler-Samu-Mazzoleni, Le strutture subordinate, cit., p. 773. Ecco due esempi citati dagli studiosi, in cui, dopo inciso, non si verifica la ripetizione della congiunzione che: «pensando che se sarà compagno di Dio nelle passioni [sofferenze], sarà suo compagno nelle consolazioni» (Bono Giamboni, Libro, cap. 7, par. 12); «Noi crediamo che quando avrete questa lettera Chiaro sarà passato di costà per andare in Isscozia» (Lettera di Consiglio de’ Cerchi, I, p. 598, rr. 23-24). 100 101 “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 71 za, ci sono sia l’una che l’altra soluzione. Come precisano Meszler, Samu e Mazzoleni, infatti, «la ripetizione di che era possibile anche dopo un sintagma non pesante»103: Dec., X 3 36: e per ciò ancora ti dico e priego che, s’ella ti piace, che tu la prenda e te medesimo ne sodisfaccia: io non so come io la mi possa meglio spendere. Io l’ho adoperata già ottanta anni, e ne’ miei diletti e nelle mie consolazioni usata: e so che, seguendo il corso della natura, come gli altri uomini fanno e generalmente tutte le cose, ella mi può omai piccol tempo esser lasciata. Allo stesso modo accade che il che introduca correttamente un predicato regolare di modo finito, anche dopo incisi abbastanza estesi: Dec., VII 6 6: Ora avvenne che, essendo costei bella donna e avvenevole, di lei un cavalier chiamato messer Lambertuccio s’innamorò forte. Oppure abbiamo alternanza tra esiti irregolari e corretti a distanza ravvicinata, come in questo passo: Dec., VII 7 20: e quasi colle lagrime in su gli occhi le disse chi egli era, quel che di lei aveva udito e dove e come di lei s’era innamorato e perché per servidor del marito di lei postosi104. La presenza di costrutti rispondenti alla regolarità moderna nelle stesse condizioni in cui ci si potrebbe aspettare una costruzione per noi anomala potrebbe avallare quanto afferma Alessandra Corradino, che spiega l’alternanza delle forme grafiche negli autografi volgari del Boccaccio in nome della variabilità del contesto narrativo: Alcuni termini assumono anche solo dal punto di vista grafico la forma che meglio si addice al contesto nel quale compaiono, ‘adeguandosi’ al tono dell’occasione, al particolare significato che rivestono, al grado di cultura del personaggio cui sono posto in bocca, ecc.105. 10. Conclusioni Nella lingua del Trecento sembrano convivere spinte sintattiche diverse (verso il senso e l’espressività, verso la forma e la regolarità). Tale alternanza di costrutti può 103 Meszler-Samu-Mazzoleni, Le strutture subordinate, cit., p. 774. Interessante è il caso sotto riportato, dove notiamo come la ripetizione del che non si verifichi dopo l’inciso più lungo, che, in quanto tale, avrebbe potuto far perdere facilmente il filo della narrazione, ma dopo quello breve e il tutto nello stesso passo, a poche righe di distanza. 104 Particolarmente interessante quest’ultimo caso, dove notiamo che, a distanza ravvicinatissima, la costruzione con il predicato di modo finito viene mantenuta nelle prime tre coordinate, ma nell’ultima è, invece, sostituita da un participio. 105 A. Corradino, Rilievi grafici sui volgari autografi di Giovanni Boccaccio, «Studi di grammatica italiana», XVI, 1996, pp. 5-74, a p. 65. 72 benedetta fordred in parte spiegarsi con la compresenza nel sistema della lingua di forme e modalità in concorrenza tra loro, che si configurerebbero come opzioni libere disponibili per gli utenti, magari con valenze differenziate diastraticamente (e anche, per la morfologia, diatopicamente). Vale a dire che potrebbe trattarsi di fenomeni riconducibili a quella condizione fluida della lingua delle origini, quando l’assenza di una norma codificata consente di ammettere e conservare nell’uso molte più forme concorrenziali di quanto non succeda quando è definita una grammatica. Oltretutto, come si diceva, le diverse soluzioni sintattiche, con il loro differente grado di tenuta formale, possono essere riferibili anche a varietà sociolinguisticamente e situazionalmente connotate nella lingua antica, esattamente come accade oggi per molti “errori” (ad esempio la forma “gli/le dico” spesso alternata a “ci dico”). Che si tratti di anomalie non più ammesse in nessuna varietà della lingua o di costrutti irregolari ritenuti compatibili con i suoi livelli diastratici o diamesici più bassi, i cosiddetti “errori” del Boccaccio sono tutti, o quasi, ascrivibili anche a una sintassi del senso e dell’oralità, tipica del parlato. Sembra che Boccaccio abbia di volta in volta selezionato, nel repertorio delle opzioni sintattiche disponibili, quelle più convenienti a sottolineare ora la proprietà e l’eleganza scritta del costrutto, ora l’informalità e la negligenza colloquiale del discorso. Alla luce di quanto riscontrato fin qui, potremmo affermare che le oltranze sintattiche analizzate, alcune delle quali proprie del parlato, potrebbero essere spiegabili con un realismo non solo dei fatti e dei personaggi delle cento novelle, ma anche della lingua, cioè con una scelta stilistica dello scrittore che accoglie largamente procedure linguistiche al limite della regolarità, ma molto comuni nel parlato. Si consideri il seguente passo, assai significativo, tratto dalla novella di Andreuccio: Dec., II 5 67: Avvenne che, avendol costor nel pozzo collato, alcuni della famiglia della signoria, li quali e per lo caldo e perché corsi erano dietro a alcuno avendo sete, a quel pozzo venieno a bere. Si noti il pronome relativo “li quali” seguito da un verbo al gerundio “avendo sete”. La costruzione non regge sintatticamente: come avverte Fornaciari, «questo gerundio, quasi attratto dal precedente avendol costor, non si avverte molto, ma rompe l’ordine logico del periodo»106. Dovremmo leggere, infatti, o il pronome relativo seguito da un verbo finito (“accadde che, avendolo costor calato nel pozzo, alcuni membri della polizia, li quali avevano sete sete per il caldo e per aver rincorso qualcuno, a quel pozzo andarono a bere”), o un gerundio isolato: (“accadde che, avendolo costor calato nel pozzo, alcuni membri della polizia, a quel pozzo andarono a bere, avendo sete per il caldo e per aver rincorso qualcuno”). Questo caso, come alcuni degli altri considerati, sarebbe riconducibile al prevalere delle ragioni del senso, tipiche dell’oralità, su quelle della forma. 106 Branca 1999, p. 195. “errori” del boccaccio o varietà della lingua trecentesca? 73 Alcuni costrutti, infatti, riproducono i moduli tipici di una «conversazione diretta, faccia a faccia»107, così da poter quasi attribuire all’autore l’invenzione di un «dialogato “moderno”»108, non solo nel discorso riportato, ma anche in quello del narratore di turno e considerare le cento novelle «il prototipo della mimesi del linguaggio parlato»109. Boccaccio pare essere pienamente consapevole della valenza realistica di procedure sintattiche marcate sfruttando «appieno tale caratteristica morfosintattica per connotare l’oralità dei suoi personaggi»110. Del resto, nella Conclusione, dalle parole dello stesso autore, sembra trapelare una sorta di consapevolezza di un uso “irregolare”, ma “necessario”, della lingua, quando afferma che «la qualità delle novelle l’hanno richiesta, le quali se con ragionevole occhio da intendente persona fian riguardate, assai aperto sarà conosciuto, se io quelle della lor forma trar non avessi voluto, altramenti raccontar non poterlo»111. Boccaccio dà l’impressione di accettare, accentuare e sfruttare lo stato fluido e poco normato della lingua trecentesca anche a livello sintattico, oltre che morfologico112: probabilmente nel suo capolavoro sentiva l’esigenza di rendere realistica non solo la materia della narrazione, ma anche la sua forma, ricorrendo a costrutti meno rigidi. Senza dimenticare, va ripetuto, che anche in questi casi, Boccaccio non si inventa procedure, ma si limita ad autorizzarne alcune più informali e funzionali attestate ai suoi tempi non solo nel parlato, ma anche nello scritto. La regola grammaticale, non essendosi ancora affermata, sembra rispondere unicamente agli usi individuali dell’autore che «la vezzeggia da innamorato, diresti che ei vedesse in ogni parola una vita che gli fosse propria, né bisognosa altrimenti di essere animata dall’inteletto […] La loro eccellenza gli era indicata dall’orecchio ch’egli a disporli nella prosa aveva delicatissimo»113. Dunque, le ragioni stilistiche influenzano fortemente l’organizzazione strutturale della prosa decameroniana, «adeguandola a quelle movenze emotive che sono proprie dell’uso orale, in un sapiente equilibrio di artificio retorico e naturalità»114. Molti degli studi che si sono soffermati fin qui sui cosiddetti “errori d’autore” del Decameron, giustificandoli all’interno di una cifra stilistica caratteristica di certi momenti della scrittura del Boccaccio, hanno impostato correttamente il problema, ma senza forse ragionare fino in fondo sulle anomalie sintattiche riscontrate. In que- Tesi, Storia dell’italiano, cit., p. 105. Manni, Il Trecento toscano, cit., p. 319. 109 Tesi, Storia dell’italiano, cit., p. 102. 110 Manni, Il Trecento toscano, cit., p. 319. 111 Branca 1999, p. 1255. 112 G. Nencioni, Un caso di polimorfia della lingua letteraria dal sec. XIII al XVI (1954), in Id., Saggi di lingua antica e moderna, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989, pp. 11-188 e V. Coletti, I problemi dell’abbondanza. La polimorfia verbale in italiano, in Id., Eccessi di parole, Firenze, Cesati, 2012, pp. 61-88. 113 U. Foscolo, Discorso sul testo del Decameron, in Id., Saggi e discorsi critici, a cura di C. Foligno, Firenze, Le Monnier, 1953, p. 305. 114 Manni, Il Trecento toscano, cit., p. 319. 107 108 74 benedetta fordred sto modo hanno rischiato di etichettare come erronei costrutti115 che (come avevano intuito, a loro modo, gli antichi Deputati) più propriamente sembrano riflettere in gran parte libere opzioni tra varietà disponibili nella lingua trecentesca, cui Boccaccio attinse con la spregiudicatezza e la franchezza richieste dal realismo linguistico programmatico delle sue cento novelle. 115 Scriveva al riguardo Vittore Branca: «la fantasia creatrice del grande artista sa intuire e creare rapporti a un livello superiore più categorico: di un’espressività più potente che quella del linguaggio nostro, corrente e regolare» (V. Branca, Beckmesser legge il Decameron, in Stimmen der Romania Festschrift fur W. Theodor Elwert zum 70. Geburtstag, hrsg. von G. Schmidt und M. Tietz, Wiesbaden, Heymann, 1980, pp. 113-119). Maurizio Fiorilla Ancora per il testo del Decameron … per il filologo, e più specificatamente per l’editore di testi, l’autografia è questione di nessun rilievo, visto che non accetteremo lezioni non volute dall’autore neppure se testimoniate da un autografo. C’è di più. Ho già accennato di passaggio alla possibilità che dietro un autografo sia esistito un altro autografo perduto non più ricostruibile dal materiale superstite, cioè che siamo in contatto coll’autore in quanto copista anziché coll’autore in quanto autore. (Michael D. Reeve, Manuscripts and Methods, Roma, Storia e Letteratura, 2011, pp. 20-21). 1. Premessa Questo articolo prosegue le riflessioni filologiche sul testo del Decameron avviate in un contributo pubblicato in questa sede nel 20101, con discussione di altri casi di lezioni problematiche dell’autografo, il codice Hamilton 90 della Staatsbibliothek di Berlino, mantenute da Vittore Branca nella sua edizione critica uscita nel 1976 per l’Accademia della Crusca (e nelle successive sue edizioni commentate uscite per Mondadori e per Einaudi)2. Come nel mio saggio precedente, sulla base del confronto con gli altri due fondamentali manoscritti della tradizione, il Parigino Italiano 482 e il Laurenziano Pluteo 42, 1 (Mannelli), proporrò soluzioni testuali alternative M. Fiorilla, Per il testo del Decameron, «L’Ellisse», v, 2010, pp. 9-38. G. Boccaccio, Decameron. Edizione critica secondo l’autografo Hamiltoniano, a cura di V. Branca, Firenze, presso l’Accademia della Crusca, 1976 (d’ora in poi Branca 1976); G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, in Id., Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, vol. IV, Milano, Mondadori, 1976; G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Torino, Einaudi, 1980 [con successivi aggiornamenti ivi, 1983, 1987, 1992 e 1999]. 1 2 76 maurizio fiorilla a quelle dell’autografo; in questo secondo contributo ho tenuto conto in alcuni casi anche di altri due codici frammentari della proto-diffusione del Decameron, il ms. II II 8 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (frammento Magliabechiano) e il ms. Vitali 26 della Biblioteca Passerini-Landi di Piacenza (frammento Vitali). Saranno esaminate anche lezioni problematiche del codice Mannelli in luoghi in cui viene utilizzato dagli editori per ricostruire il testo boccacciano in corrispondenza delle lacune dell’Hamiltoniano. Per notizie sui tre manoscritti principali, per lo stemma e per gli studi pregressi sulla tradizione del testo del Decameron rinvio alle pagine del mio precedente articolo (indicherò nelle note solo i contributi usciti successivamente)3. Ricordo che l’Hamilton 90 (B), il Par. It. 482 (P) e il Laur. 42, 1 (Mn), tutti e tre collegati ad un precedente autografo o comunque ad un antigrafo d’autore, occupano i gradini più alti della tradizione. P, di mano Giovanni d’Agnolo Capponi, databile al settimo decennio del Trecento, contiene una prima versione dell’opera (dipendente probabilmente da un perduto autografo databile alla seconda metà degli anni ’50)4, mentre B (vergato da Boccaccio attorno al 1370)5 e Mn (copiato nel 1384 da Francesco d’Amaretto Mannelli)6 sono collaterali e riflettono uno stato redazionale più avanzato. La tradizione risulta dunque divisa in due rami, uno rappresentato da P e l’altro dal perduto antigrafo di Mn e B (α), che contiene varianti d’autore e contemporaneamente sicuri errori di trasmissione; il testo di B presenta poi rispetto a Mn ulteriori errori di copia, minime correzioni e rare varianti d’autore (inserite dal Boccaccio in extremis durante la trascrizione). Mi limito a ripercorrere in sintesi la prassi ecdotica proposta nel precedente articolo. Nella ricostruzione dell’ultima redazione dell’opera è opportuno sempre ripartire da B (e da Mn nei punti in cui l’autografo è lacunoso). B però va corretto nei casi in cui è portatore di un testo del tutto irricevibile (perché palesemente erroneo), ma anche quando presenta un testo problematico contro una buona lezione che trovi l’accordo di P e Mn. La concordanza di P e Mn, appartenenti a due rami diversi, ci restituisce l’originale, fatti salvi sempre i casi in cui attraverso l’esame delle varianti in gioco non sia possibile ipotizzare che nell’esecuzione della copia autografa Boccaccio sia tornato autore introducendo cambiamenti intenzionali. Quando B e Mn sono entrambi portatori di lezioni che appaiono erronee è possibile affidarsi a P 3 Cfr. Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 9-16; cfr. poi Id., Decameron, in Boccaccio autore e copista, a cura di T. De Robertis, C.M. Monti, M. Petoletti, G. Tanturli, S. Zamponi, Firenze, Mandragora, 2013, pp. 129-136, alle pp. 132-134. 4 Cfr. da ultimo: M. Cursi-M. Fiorilla, Giovanni Boccaccio, in Autografi dei letterati italiani, dir. da M. Motolese ed E. Russo, Le Origini e il Trecento. I, a cura di G. Brunetti, M. Fiorilla e M. Petoletti, Roma, Salerno Editrice, 2013, pp. 34-103, a p. 56 (n. 2); M. Cursi, Il Decameron illustrato di Giovanni d’Agnolo Capponi, in Boccaccio autore e copista, cit., pp. 142-144 (n. 25). 5 Cfr. da ultimo Cursi-Fiorilla, Giovanni Boccaccio, cit., p. 48 (n. 1); M. Cursi, L’autografo berlinese del Decameron, in Boccaccio autore e copista, cit., pp. 137-138 (n. 22). 6 Cfr. da ultimo M. Cursi, Il codice Ottimo del Decameron di Francesco d’Amaretto Mannelli, ivi, pp. 140142 (n. 24). ancora per il testo del decameron 77 (valutando sempre con attenzione che si tratti davvero di errori e non di rielaborazioni autoriali). In alcuni casi, per confermare le lezioni di P, può essere utile anche il confronto con due antichi testimoni (databili entrambi al settimo decennio del XIV secolo e collocabili in una tradizione testuale prossima a quella del codice Parigino): il frammento Vitali7 e il frammento Magliabechiano8. I brani del Decameron esaminati nelle pagine successive vengono riportati in corpo minore, preceduti da indicazione del passo (giornata, novella e paragrafo), secondo l’edizione a cura di Branca uscita per Einaudi nel 1999, che costituisce – a livello editoriale – il punto di riferimento più avanzato elaborato dallo studioso nel corso del tempo)9; le lezioni discusse, per le quali ho proposto (o riproposto) soluzioni alternative, sono evidenziate in corsivo, seguite in parentesi quadre da quelle offerte da P, Mn e B; nei casi in cui B e Mn sono concordi, i due testimoni vengono indicati con α. Le lezioni del frammento Magliabechiano e del frammento Vitali sono richiamate a sostegno di P all’interno della discussione. Nelle note a piè di pagina, mi sono questa volta limitato a dar conto solo delle scelte operate negli stessi luoghi nelle tre edizioni critiche, curate da Charles Singleton nel 1955, dallo stesso Branca nel 1976 e da Aldo Rossi nel 1977 10. 7 Cfr. M. Cursi, Il Decameron: scritture, scriventi, lettori. Storia di un testo, Roma, Viella, 2007, pp. 36-39 e 228-230 (n. 52); per un esame testuale dei frammenti cfr. A. Grippa, Le carte piacentine del Decameron, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena», xx, 1999, pp. 77-120. 8 Cfr. Cursi, Il Decameron: scritture, scriventi, lettori, cit., pp. 21-31 e 196-197 (n. 27); Id., Un’antichissima antologia decameroniana confezionata a Napoli, in Boccaccio autore e copista, cit., pp. 139-140 (n. 23). 9 G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Torino, Einaudi, 1999 (d’ora in poi Branca 1999); per notizie sull’edizione cfr. anche Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., p. 9, nota 1. 10 Cfr. Branca 1976; G. Boccaccio, Il Decameron, a cura di C.S. Singleton, 2 voll., Bari, Laterza, 1955 (d’ora in poi Singleton); Id., Decameron, a cura di A. Rossi, Bologna, Cappelli, 1977 (d’ora in poi Rossi). Occasionalmente sono state richiamate anche le edizioni curate da Aldo Francesco Massèra e Giuseppe Petronio: Id., Il Decameron, a cura di G. Petronio, 2 voll., Torino, Einaudi, 1950 (da qui in poi Petronio); Id., Decameron, a cura di A.F. Massèra, 2 voll., Bari, Laterza, 1927 (da qui in poi Massèra). I risultati sul piano della storia editoriale del testo boccacciano sono in linea con quelli emersi nel mio articolo del 2010 (cfr. Fiorilla, Per il testo del Decameron, pp. 11-12 e 36-38). Le edizioni elaborate da Branca, a partire da testo critico prodotto nel 1976, tendono a conservare le lezioni dell’autografo in un certo numero di situazioni problematiche, là dove invece lo stesso Branca era a mio avviso opportunamente intervenuto in quelle da lui curate nel 1951-52 e del 1960, costruite con una prassi ecdotica non condizionata dall’autografia del Berlinese (cfr. G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, 2 voll., Firenze, Le Monnier 1951-1952, e Firenze, Le Monnier, 19602). L’edizione curata da Singleton, elaborata prima della definitiva acquisizione dell’autografia del manoscritto, coincide in diversi dei casi discussi con la ricostruzione testuale da me proposta (ma a partire da una diversa organizzazione della tradizione manoscritta). Come ho avuto modo di rilevare nel contributo precedente, l’edizione di Singleton (insieme a tutte quelle uscite prima del definitivo riconoscimento dell’autografia dell’Hamilton 90), non è però più ricevibile in diversi luoghi, oltre che nella veste grafico-linguistica (cfr. Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 36-38). Le lezioni proposte da Singleton sono state adottate – ma solo in parte – anche da Rossi, meno conservativo nei confronti dell’Hamilton 90 rispetto a Branca. Non sempre tuttavia Rossi è intervenuto sulle lezioni problematiche dell’autografo (e manca completamente una discussione dei loci critici); in un buon numero di casi, inoltre, gli errori del codice Hamiltoniano sono stati sanati ricorrendo al Par. It. 482, là dove il Mannelli offriva una 78 maurizio fiorilla Le soluzioni alternative al testo Branca qui presentate sono state da me accolte nella nuova edizione del Decameron uscita nel 2013 per la Rizzoli-Bur (curata con Amedeo Quondam e Giancarlo Alfano)11, insieme a quelle discusse nel mio precedente articolo (già recepite nella mia edizione Treccani)12 e ad altri emendamenti proposti da Mario Marti, Giancarlo Breschi e, da ultimo, da Teresa Nocita e Benedetta Fordred13. Su altri luoghi problematici su cui per ora si è preferito non intervenire, occorrerà tornare a ragionare in futuro, a partire dal riesame dall’intera tradizione manoscritta, strada già indicata come necessaria da Michele Barbi14. 2. Casi in cui P e Mn si oppongono a B Inizierò con l’esame di casi in cui P e Mn sono in accordo contro lezioni di B che appaiono erronee o che comunque sembrano configurarsi come sviste paleografiche e banalizzazioni compiute dal Boccaccio copista (e non come varianti d’autore)15. Agli scambi di pronomi avvenuti in B già segnalati nel precedente contributo16, si dovrà aggiungere il caso che segue: buona lezione in uno stato redazionale più avanzato. Rossi, come anche Singleton, considerava il Mannelli un apografo dell’Hamilton 90 e per questo non lo ha sfruttato fino in fondo in situazioni problematiche (cfr. ad esempio Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 23-25, casi relativi a Dec., II 6 55 e X 10 19). Nelle ricostruzioni di Singleton (cfr. qui note 30, 35 52) e Rossi (cfr. qui nota 29) un ruolo di una certa importanza ha rivestito anche il Laurenziano 42, 3, codice che appare però contaminato e caratterizzato da sospette interpolazioni (cfr. qui nota 29). Per riflessioni più ampie sulla storia editoriale cfr., da ultimo, anche Id., Sul testo del Decameron: per una nuova edizione critica, in Boccaccio letterato, Atti del Convegno Internazionale, Firenze-Certaldo 10-12 ottobre 2013, a cura di M. Marchiaro e S. Zamponi, i.c.s. 11 M. Fiorilla, Nota al testo, in G. Boccaccio, Decameron, introduzione note e repertorio di Cose (e parole) del mondo di A. Quondam, testo critico e nota al testo a cura di M. Fiorilla, schede introduttive e notizia biografica di G. Alfano, Milano, Rizzoli-Bur, 2013, pp. 109-123. 12 Cfr. Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit.; Id., Nota al testo, in G. Boccaccio, Decameron, a cura di M. F., illustrazioni di M. Paladino, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, pp. XLV-XLVIII. 13 Cfr. M. Marti, Note e discussioni sulle due redazioni del Decameron, «Giornale storico della letteratura italiana», n.s., clxxx, 2003, pp. 251-259; G. Breschi, Il ms. Parigino It. 482 e le vicissitudini editoriali del Decameron. Postilla per Aldo Rossi, «Medioevo e Rinascimento», n.s., xv, 2004, pp. 77-119; B. Fordred, “Errori” del Boccaccio o varietà della lingua trecentesca?, in questo stesso numero de «L’Ellisse», pp. 43-74, alle pp. 50-53; T. Nocita, Loci critici della tradizione decameroniana, in Dai pochi ai molti. Studi in onore di Roberto Antonelli, a cura di P. Canettieri e A. Punzi, Roma, Viella, i.c.s. 14 Cfr. Fiorilla, Sul testo del Decameron: per una nuova edizione critica, cit. 15 Per altri esempi cfr. Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 16-23; Fordred, “Errori” del Boccaccio, cit., p. 51 (casi relativi a Dec., V 8 4 e X 6 13); Nocita, Loci critici, cit. (casi relativi a Dec., II 7 89, IV 8 8, V 6 25, V 10 23, VIII 7 125 e IX 2 7). 16 Cfr. Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 16-17 (casi relativi a Dec., IV 4 9 e X 9 110). ancora per il testo del decameron 79 IV 8 26: Alla fine prese consiglio di volere in altrui persone tentar quello che il marito dicesse da farne; e destatolo quello che presenzialmente a lui [lei P Mn lui B]17 avvenuto era disse essere a un’altra intervenuto, e poi il domandò se a lei avvenisse che consiglio ne prenderebbe. In questo punto della novella la Salvestra, dopo essere stata a lungo in dubbio se svegliare il marito per raccontargli quanto le era capitato (l’arrivo di Girolamo nel loro letto e la sua morte), decide alla fine, in prima istanza, di narrare quanto avvenuto come fosse capitato a un’altra. In questo quadro, la lezione a lui non può funzionare e sarà da interpretare nel quadro filologico come errore di copia di B; l’accordo tra P e Mn garantisce che lei doveva essere nell’originale e la lezione va pertanto accolta a testo. Mi soffermerò ora su alcune lezioni esclusive di B, mantenute da Branca, in cui il significato o i tempi del verbo fanno difficoltà, là dove P e Mn recano ancora un volta le lezioni attese, che sono paleograficamente molto simili a quelle della copia autografa; per questa ragione è possibile per diverse di queste situazioni richiamare il principio elaborato da Scevola Mariotti (cui ho fatto riferimento in altri casi esaminati nel primo articolo)18, secondo cui «se due varianti sono più vicine tra loro per la forma che per il senso, è più probabile che si tratti di varianti di tradizione che di varianti d’autore»19. IV Intr. 34: E se non fosse che uscir serebbe del modo usato del ragionare, io producerei le istorie in mezzo, e quelle tutte piene mostrerei d’antichi uomini e valorosi, ne’ loro più maturi anni sommamente avere studiato di compiacere alle donne: il che se essi non fanno [sanno P Mn fanno B]20, vadano e sì l’apparino. La lezione sanno presente nella protasi dell’ipotetica, che può vantare l’accordo di P e Mn, è richiesta dal sì l’apparino che chiude l’apodosi; si tenga conto che lo scambio di s e f è frequentissimo nei manoscritti (perché molto simili paleograficamente). Il passaggio da sanno a fanno è dunque a mio avviso valutabile come un errore compiuto dal Boccaccio nella trascrizione di B. VIII 2 22: Disse la Belcolore: «Deh! andante andate [andate andate P Mn andante andate B]21: o fanno i preti così fatte cose?». Edd. critiche: lei (Singleton), a lui (Branca 1976), a .l‹ei› (Rossi). Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 19-21 (casi relativi a Dec., II 5 9-11 e III 8 6), 26-32 (casi relativi a Dec., I Intr. 97, II 7 112, IV 3 23, V Concl. 1, X 9 80). 19 S. Mariotti, Note al testo dell’Hermaphroditus del Panormita, in Id., Scritti medievali e umanistici, a cura di S. Rizzo, Roma, Storia e Letteratura, 20103, pp. 381-394, a p. 388 (già in Filologia umanistica per Gianvito Resta, a cura di V. Fera e G. Ferraù, 2 voll., Padova, Antenore, 1997, vol. II, pp. 1233-1245, a p. 1240). 20 Edd. critiche: sanno (Singleton e Rossi), fanno (Branca 1976). 21 Edd. critiche: andate andate (Singleton e Rossi), andante andate (Branca 1976). 17 18 80 maurizio fiorilla Branca giustifica la scelta di mantenere la lezione di B (andante andate) ipotizzando che andante abbia valore avverbiale; anche in questo caso si tratta a mio avviso di una delle tante sviste di B. P e Mn recano infatti la lezione attesa: andate andate. II 1 20: La qual cosa veggendo Stecchi e Marchese cominciarono fra sé a dire che la cosa stava male, e di se medesimi dubitando non ardivano a aiutarlo, anzi con gli altri insieme gridando [gridavano P Mn gridando B]22 ch’el fosse morto, avendo nondimeno pensiero tuttavia come trarre il potessero delle mani del popolo. La sintassi richiede l’imperfetto gridavano di P e Mn (cioè lo stesso tempo di ardivano che precede), al posto del gerundio gridando (trasmesso da B), altrimenti dopo il connettivo avversativo anzi la frase rimane priva di verbo di modo finito (segue infatti una subordinata modale al gerundio). Difficile pensare dunque ad una variante d’autore introdotta in extremis da Boccaccio durante la trascrizione di B; più facile pensare ad un errore di anticipo o di ripetizione a partire dalla presenza dei due gerundi vicini (dubitando e avendo) che potrebbero aver contribuito alla involontaria alterazione di gridavano in gridando. Ritengo siano poi da aggiungere all’elenco delle sviste di B le due occorrenze di incotanente per incontanente: II 1 15 e V 2 29 (uniche due attestazioni in tutta l’opera di Boccaccio)23; in questi due luoghi P e Mn recano entrambi la lezione attesa, incontanente, che compare altre 58 volte nel Decameron (sempre incontanente in P, Mn e B) e ha numerose occorrenze in altre opere del Boccaccio24. A fronte dell’accordo di Mn e P e del quadro che emerge dai testi boccacciani, appare senz’altro più economico ipotizzare che il Certaldese abbia dimenticato il titulus per la nasale sulla o. II 10 42: Messer Riccardo, veggendosi a mal partito e pure allora conoscendo la sua follia d’aver moglie giovane tolta essendo spossato, dolente e tristo s’uscì della camera e disse parole assai a Paganino le quali non montavano [montarono P Mn montavano B?]25 un frullo. In questo caso la scrittura di B non è chiara. Il testo del codice è stato ripassato in questa sezione del manoscritto (a causa del solito distaccamento dell’inchiostro). Lo stesso Branca avverte che montavano in B forse è stato riscritto su un originario montarono e poi aggiunge «Certo la seconda a appare molto schiacciata o manca un’asta alla Edd. critiche: gridando (Singleton, Branca 1976 e Rossi). Edd. critiche: incontanente (Singleton e Rossi), incotanente (Branca 1976). 24 Incontanente ricorre una volta nel Teseida, 40 nel Filocolo, 2 nell’Amorosa visione, 2 nell’Elegia di madonna Fiammetta, 4 nel Corbaccio, 50 nelle Esposizioni. Ricordo che di queste opere solo il Teseida ci è giunto in versione autografa, trasmessa dal Laurenziano Acquisti e doni 325: cfr. da ultimo Cursi-Fiorilla, Giovanni Boccaccio, cit., p. 49 (n. 4); W.E. Coleman, L’autografo del Teseida, primo poema epico della letteratura italiana, corredato dal commento del Boccaccio, in Boccaccio autore e copista, cit., pp. 94-95 (n. 9). 25 Edd. critiche: montavano (Singleton e Branca 1976), monta‹ro›no (Rossi). 22 23 ancora per il testo del decameron 81 n seguente: si potrebbe anche leggere montarano»26. La scelta più opportuna mi pare quella di promuovere la lezione montarono, garantita da P e Mn. 3. Casi in cui P si oppone ad α Presenterò ora nuovi casi in cui P reca segmenti di testo mancanti in Mn e B. In diversi casi tali assenze sembrano compromettere in modo significativo il senso, la sintassi o la coerenza del testo boccacciano. Si tratta a mio avviso di errori che Mn e B hanno ereditato da α, e non di scorciature volute dall’autore27. Comincio con segnalare casi di omissioni di segmenti necessari al testo in cui Mn ha cercato di sanare la lacuna per congettura. Mannelli dichiara – come è noto – di copiare da un originale; le sue integrazioni non provengono da collazione con altri manoscritti della tradizione, ma sono suoi tentativi di restaurare il testo ope ingenii (e per questo non possono essere promosse a testo)28. IX 1 5: Dico adunque che nella città di Pistoia fu già una bellissima donna vedova, la qual due nostri fiorentini, che per aver bando di Firenze dimoravano [a Pistoia dimoravano P là dimoravano (in marg. deficiebat riferito a là) Mn dimoravano B]29, chiamati l’uno Rinuccio Palermini e l’altro 26 Branca 1976, p. 172. Singleton nella sua edizione diplomatico-interpretativa legge montavano, marcando che ci si trova in una porzione di testo che è stata ripassata (cfr. G. Boccaccio, Decameron. Edizione diplomatico-interpretativa dell’autografo Hamilton 90, a cura di C.S. Singleton, con la collaborazione di F. Petrucci Nardelli, A. Petrucci, G. Savinio e M. Mardesteig, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1974, p. 175). 27 Per altri esempi cfr. Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 27 e 29-30 (casi relativi a Dec., V 8 24 e III 7 96); Nocita, Loci critici, cit. (casi relativi a Dec., II 7 8 e 106, VIII 1 3). 28 Per altre integrazioni congetturali del Mannelli segnalate con deficiebat cfr. Singleton, vol. II, pp. 406-414 (tavv. VIII e IX); Branca 1976, pp. LXXVII-LXXVIII (tav. XVIII 4). Alcune delle congetture del Mannelli sono state accolte a testo da Massèra e Petronio (per un esempio cfr. infra la nota seguente). 29 Edd. critiche: a Pistoia dimoravano (Singleton), dimoravano (Branca 1976), ‹vi› dimoravano (Rossi). Segnalo che Massèra e Petronio hanno invece accolto la proposta del Mannelli, promuovendo a testo la lezione là dimoravano. La lezione proposta da Rossi è attestata nel Laurenziano 42, 3, manoscritto databile al terzo quarto del XV secolo, che lo studioso considerava appartenente ad un stato redazionale intermedio (cfr. Rossi, pp. 604-605) e che Singleton (codice FL3 del suo stemma) riteneva un collaterale dell’Hamilton 90 (cfr. Singleton, vol. II, p. 386; cfr. anche p. 410). La lezione del Laur. 42, 3 (peraltro non accolta da Singleton in questo caso) potrebbe apparire a prima vista di un certo interesse ma sospetto si tratti di una iniziativa del copista (o comunque di una revisione non autoriale forse già presente nel suo antigrafo); non mancano infatti altri casi in cui il codice è portatore di lezioni singolari, valutabili come interpolazioni, come ad esempio la lezione perduto amorotto per perduto Marato a Dec., II 7 41; se ne incontrano altre negli stessi luoghi problematici che verranno presentati nelle pagine successive (cfr. qui le note 30, 35, 52, 54). Il codice reca inoltre tracce di contaminazione: in alcuni dei casi esaminati in questo paragrafo e nel successivo il codice Laurenziano ha le stesse lezioni di P (precisamente a Dec., V 4 33, VII 1 3, VII 7 20, VII 9 19, VIII 10 8, IX 3 24, IX 10 8, X 1 8, X 9 84, X 9 102-103), mentre in altri coincide con il testo di B e Mn (a Dec., V 2 26, VI 2 1, IX 16). Mi pare interessante rilevare infine il comportamento eccentrico del Laur. 42, 3 a Dec., V 10 46, in cui il manoscritto reca la lezione a preghare e a 82 maurizio fiorilla Alessandro Chiarmontesi, senza sapere l’uno dell’altro, per caso di costei presi, sommamente amavano, operando cautamente ciascuno ciò che per lui si poteva a dovere l’amor di costei acquistare. I due fiorentini banditi da Firenze a Pistoia dimoravano, lezione correttamente portata da P che va accolta a testo. Senza a Pistoia, omesso da B, il verbo dimoravano rimane privo dell’indicazione del luogo in cui Rinuccio e Alessandro risiedevano una volta cacciati da Firenze; lo stesso Branca scrive nel suo commento che in questo caso «si sottintende là, a Pistoia, con facile costruzione a senso». Il Mannelli, che pure eredita la lacuna, inserisce per congettura a testo proprio là, assente nell’antigrafo da cui copiava. L’avverbio è accompagnato infatti da deficiebat. X 9 39: Partissi adunque il Saladino e’ compagni con grandissimo animo, se vita gli durasse e la guerra la quale aspettava nol disfacesse, di fare ancora non minore [minore onore P minore honore (in marg. deficiebat riferito ad honore) Mn minore B]30 a messer Torello che egli a lui fatto avesse. Il sostantivo onore, recato da P, è necessario al senso e va dunque reinserito a testo. Saltato con ogni probabilità per errore già all’altezza di α ed assente in B, è stato inserito per congettura dal Mannelli (che con il solito segno di richiamo collega la parola honore con il deficiebat). Leggermente diverso il caso che segue (che coinvolge peraltro la stessa parola onore), in cui Mannelli si è limitato a segnalare che qualcosa mancava nel testo: IX 10 8: Compar Pietro d’altra parte, essendo poverissimo e avendo una piccola casetta in Tresanti appena bastevole a lui e a una sua giovane e bella moglie e all’asino suo, quante volte donno Gianni in Tresanti capitava tante sel menava a casa, e come poteva, in riconoscimento [in riconoscimento dell’onor P in riconoscimento (in marg. hic deficit aliquid) Mn in riconoscimento B]31 che da lui in Barletta riceveva, l’onorava. .cchonfortare; si tenga conto che l’Hamilton 90 in quel punto ha a testo la lezione a pregar e a margine confortar, variante alternativa (di mano dello stesso Boccaccio) proveniente da un precedente stadio redazionale (P e Mn hanno infatti a testo confortar/confortare). Nel Laur. 42, 3 (o forse già nel suo antigrafo) per errore è entrata dunque una variante alternativa che in origine era a margine (per esempi simili in codici seriori contaminati cfr. A.M. Costantini, Correzioni autografe dell’Hamilton 90. Una proposta, in Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca. ii. Boccaccio e dintorni, Firenze, Olschki, 1983, 69-77, a p. 72 nota 10). In questa fase ritengo, alla luce anche di quanto appena rilevato, che appaia imprudente affidarsi alle lezioni del Laur. 42, 3. La posizione stemmatica del codice andrebbe comunque ridefinita con nuove indagini estese all’intera tradizione manoscritta (cfr. anche Fiorilla, Sul testo del Decameron: per una nuova edizione critica, cit.). Sul codice cfr. intanto almeno Cursi, Il Decameron: scritture, scriventi, lettori, cit., pp. 183-184 (n. 17). 30 Edd. critiche: non minore onore (Singleton), non minore (Branca 1976), non minore onore (Rossi). Segnalo che il Laur. 42, 3 ha qui la lezione non meno. 31 Edd. critiche: in riconoscimento dell’onore (Singleton), in riconoscimento (Branca 1976), in riconoscimento ‹dell’onor› (Rossi). ancora per il testo del decameron 83 In B e Mn manca dell’onor, necessario a sintassi e senso, presente regolarmente in P. Si tratta con ogni probabilità anche in questo caso di un errore già presente in α. Mannelli in margine ha scritto semplicemente Hic deficit aliquid (preceduto da una sua crux). Una mano posteriore scrisse poi a fianco della segnalazione marginale del Mannelli dello honor. Non deficit amplius32. La lezione del Parigino (confermata anche dal frammento Vitali e dal frammento Magliabechiano) è dunque anche in questo caso senz’altro da accogliere a testo. VI 2 15: Messer Geri, al quale o la qualità [la qualità del tempo P la qualità α]33 o affanno più che l’usato avuto o forse il saporito bere, che a Cisti vedeva fare, sete avea generata, volto agli ambasciadori sorridendo disse […] La specificazione del tempo, presente solo in P e riferita alla qualità, è a mio avviso necessaria alla comprensione e va rimessa a testo. Mannelli questa volta non corregge all’interno del testo ma a margine propone: Credo che voglia dire «o la qualità del tempo». Lo stesso Branca in nota commenta: «Si riferisce al vino o probabilmente al tempo e quindi alla calura della stagione». Si tenga conto anche che Boccaccio usa altre due volte nel Decameron questa stessa espressione (corsivi miei): «seco della qualità del tempo molte e varie cose cominciarono a ragionare» (I Intr. 52); «maladiceva la qualità del tempo» (VIII 7 39). Negli esempi che seguono, a differenza di quelli esaminati in precedenza, Mannelli non ha integrato nulla né segnalato problemi34. Inizierò da due salti contenuti nella penultima novella del libro. X 9 18: E appresso questo menati i gentili uomini nel giardino, cortesemente gli domandò chi e’ fossero [chi fossero e donde e dove andassero P chi e’ fossero α]35; al quale il Saladino rispose: «Noi siamo mercatanti cipriani e di Cipri vegniamo e per nostre bisogne andiamo a Parigi». Secondo la lezione di P, messer Torello, rivolgendosi al Saladino e ai suoi uomini, domanda loro chi fossero e donde e dove andassero. Effettivamente la risposta del Saladino, Noi siamo mercatanti cipriani e di Cipri vegniamo e per nostre bisogne andiamo a Parigi, sembra presupporre la lezione del codice Parigino. È possibile allora che anche qui sia avvenuto un salto dallo stesso allo stesso (fossero/andassero) in α, che reca chi e’ 32 Sugli interventi di mano posteriore nel codice Mannelli cfr. S. Carrai, Di chi sono le postille nel codice Mannelli?, «Studi sul Boccaccio», XXX, 2002, pp. 159-168. 33 Edd. critiche: la qualità del tempo (Singleton), la qualità (Branca 1976), la qualità ‹del tempo› (Rossi). 34 Per altri esempi cfr. Marti, Note e discussioni, cit., pp. 256-257 (casi relativi a Dec., I 7 28, II 6 76, III 4 18, III 6 34, VII 2 19, VIII 7 143); Breschi, Il Parigino It. 482, cit., pp. 88 e 91 (casi relativi a Dec., III 2 26 e V 7 27); Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., p. 29 (caso relativo a Dec., IV 1 5); Fordred, “Errori” del Boccaccio, cit., pp. 51-52 (casi relativi a Dec., II 5 38, III 4 7, IV 1 7). 35 Edd. critiche: chi e’ fossero e dove andassero (Singleton), chi e’ fossero (Branca 1976 e Rossi). La lezione promossa a testo da Singleton è attestata nel Laur. 42, 3. 84 maurizio fiorilla fossero (omettendo e donde e dove andassero). In P però manca il pronome e’ (che pure ci vorrebbe). Si dovrebbe a questo punto a mio avviso restituire chi e’ fossero e donde e dove andassero. Non si può escludere però in questo caso che Boccaccio abbia voluto semplificare e rendere meno scolastico il dettato, modificando la lezione del Parigino in chi e’ fossero (il Saladino poteva rispondere alla domanda aggiungendo da dove veniva e dove andava con i suoi compagni). Più significativo il caso che segue nella parte finale della stessa novella: X 9 102-103: Ella similmente alcuna volta guardava lui non già per riconoscenza alcuna che ella n’avesse, ché la barba grande e lo strano abito e la ferma credenza che aveva che egli fosse morto gliele toglievano [toglievano, ma per la novità dell’abito P toglievano α]36. Ma poi che tempo parve a messer Torello di volerla tentare se di lui si ricordasse […] B e Mn non recano ma per la novità dell’abito, presente in P e necessario al testo, altrimenti mancherebbe il secondo elemento della correlazione avviata da non già. La moglie di Messer Torello (tornato a Pavia ma in quel momento sotto travestimento) lo guardava non già perché lo avesse in qualche modo riconosciuto, perché la barba e lo strano abito e la sicurezza che fosse morto le impedivano di vedere in lui il marito, ma per la novità dell’abito. Qui è avvenuto sicuramente un salto dallo stesso allo stesso in α (salvo non ipotizzare un errore poligenetico in Mn e B). Si noti infatti come la frase successiva ricominci con Ma poi. V 4 33: «Sù tosto, donna, lievati e vieni a vedere che tua figliuola è stata sì vaga dell’usignuolo che ella l’ha preso [che ella è stata tanto alla posta che ella l’ha preso P che ella l’ha preso α]37 e tienlosi in mano». Proprio in relazione a questo caso specifico già Guido Martellotti, in una recensione al saggio in cui Branca e Ricci dimostrarono definitivamente l’autografia dell’Hamilton 90, scriveva che in situazioni simili non era possibile «prendere come buona la lezione di B e Mn, perché è chiaro che essa deriva dall’autentica per omissione, dovuta ad omoioteleuto» (che ella… che ella)38. Anche in questo Edd. critiche: toglievano, ma per la novità dell’abito (Singleton), toglievano (Branca 1976 e Rossi). Edd. critiche: che ella è stata tanto alla posta che ella l’ha preso (Singleton), che ella l’ha preso (Branca 1976), che ella ‹è stata tanto alla posta che ella› l’ha preso (Rossi). 38 G. Martellotti, rec. a V. Branca-P.G. Ricci, Un autografo del Decameron (codice Hamiltoniano 90), Padova, CEDAM, 1962, «Studi sul Boccaccio», I, 1963, pp. 547-553, a p. 552 (poi in Id., Dante e Boccaccio e altri scrittori dall’Umanesimo al Romanticismo, con una premessa di U. Bosco, Firenze, Olschki, 1983, pp. 197-205, a p. 203). Branca difende così la lezione dell’autografo: «Anche in questo caso nonostante tutte le apparenze di un salto du même au même (“ella”), il senso, la struttura boccacciana della frase, l’efficacia dell’ironia bonaria di Lizio rimangono intatte. Anzi anche qui può essere facile pensare a una scorciatura voluta: perché nulla, nessun precedente nella novella richiedeva quell’“è stata tanto alla posta”, anzi può sembrare troppo insistente per la leggera e bonaria ironia di Lizio. O può 36 37 ancora per il testo del decameron 85 passo dell’opera dunque andrà promossa a testo la lezione di P. Stesso discorso per il caso che segue: IX 3 24: «Ma per certo, se io scampo di questa, ella se ne potrà ben prima morir di voglia [ella non saprà sì bel giuoco fare che mai più l’advenga, ella se ne potrà ben prima morir di voglia P ella se ne potrà ben prima morir di voglia α]»39. La frase ella se ne potrà ben prima morir di voglia (pronunciata da Calandrino) non regge senza il segmento che precede in P (presente anche nel frammento Vitali ma assente in α), ella non saprà sì bel giuoco fare che mai più l’advenga (la moglie di Calandrino potrà morire dalla voglia prima che le ricapiti di fare un così bel gioco). Siamo di fronte al medesimo saut du même au même del caso precedente (ella… ella). Certamente più problematico il caso che segue: IX 1 16: E appresso questo, te n’andrai a Rinuccio Palermini e sì gli dirai: ‘Madonna Francesca dice che è presta di volere ogni tuo piacer fare, dove tu a lei facci un gran servigio, cioè che tu stanotte in su la mezzanotte te ne vadi all’avello dove fu stamane sotterrato Scannadio, e lui, senza dire alcuna parola di cosa che tu oda o senta [che tu oda o veggia o senta P che tu oda o senta α]40, tragghi di quello soavemente e rechigliele a casa. Il Parigino ha senza dire alcuna parola di cosa che tu oda o veggia o senta (lezione confermata anche dal frammento Vitali). La disgiuntiva o veggia (tra oda e senta) è assente in P e Mn; senta non sarà forse da intendere qui come ‘sentire con le orecchie’ ma nel senso di ‘sentire con il corpo’. Rinuccio non dovrà dunque dire una parola di quello che vedrà o ascolterà o percepirà, mentre tirerà fuori il cadavere di Scannadio dalla tomba41; o veggia allora pare necessario a completare il riferimento ai tre sensi (udito, vista, tatto) e potrebbe essere anche in questo caso stato omesso non per volontà dell’autore, ma per un salto dallo stesso allo stesso (o… o). Ci sono casi in cui le omissioni non si giustificano per omeoteleuto. Si tratta però sempre di dettagli necessari al funzionamento della coerenza narrativa o sintattica. V 2 6: Martuccio, sdegnato di vedersi per povertà rifiutare, con certi suoi amici e parenti giurò [con certi suoi amici e parenti armato un legnetto giurò P con certi suoi amici e parenti giurò α]42 di mai in Lipari non tornare se non ricco […] sembrare viceversa più divertitamente umoristico?» (V. Branca-M. Vitale, Il capolavoro del Boccaccio e due diverse redazioni, 2 voll., Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, vol. II, pp. 199-200). 39 Edd. critiche: ella non saprà sì bel giuoco fare che mai più l’avvenga fatto, ella se ne potrà ben prima morir di voglia (Singleton), ella se ne potrà ben prima morir di voglia (Branca 1976), ‹ella non saprà sì bel giuoco fare che mai più l’advenga›, ella se ne potrà ben prima morir di voglia (Rossi). 40 Edd. critiche: che tu oda o veggia o senta (Singleton), che tu oda o senta (Branca 1976 e Rossi). 41 La preoccupazione di Madonna Francesca è legata al fatto che Rinuccio troverà in realtà in quel sepolcro il corpo del vivo Alessandro (che dovrà fingersi morto). 42 Edd. critiche: con certi suoi amici e parenti armato un legnetto, giurò (Singleton), con certi suoi amici e parenti giurò (Branca 1976 e Rossi). 86 maurizio fiorilla Nel testo di B e Mn (quindi con ogni probabilità già in α) manca armato un legnetto, presente in P. Secondo la lezione del codice Parigino dunque, Martuccio, preparata con certi suoi amici una piccola barca per partire, giura di non tornare ma più a Lipari se non diventato ricco (per poter sposare la Gostanza). Si tenga conto che questo è il primo e unico luogo in cui il legnetto (cioè la barca) viene nominato. Poco più avanti, al § 8, si legge (corsivo mio): «In Lipari tornò, non per uno o per due ma per molte e diverse persone, la novella che tutti quegli che con Martuccio erano sopra il legnetto erano stati annegati». Boccaccio qui fa riferimento alla piccola imbarcazione, il legnetto (cioè ‘quel legnetto’), che deve aver per forza nominato in precedenza. Per queste ragioni il segmento recato dal solo P, armato un legnetto, che contiene un dettaglio che si presuppone già inserito nella narrazione, è necessario al testo che andrebbe restituito come segue (con cambio di interpunzione): «Martuccio, sdegnato di vedersi per povertà rifiutare, con certi suoi amici e parenti armato un legnetto, giurò di mai in Lipari non tornare se non ricco […]». X 9 84: Ma essendo già tardi e il nigromante aspettando lo spaccio e affrettandolo, venne un medico con un beveraggio [affrettandosi venne un medico con un beveraggio a messer Torello P affrettandolo venne un medico con un beveraggio α]43 e, fattogli vedere che per fortificamento di lui gliele dava, gliel fece bere. Il Parigino ha qui a messer Torello, assente in Mn e B, ma necessario perché i pronomi che seguono vanno riferiti proprio a messer Torello, e questo presuppone che sia stato appena nominato: «e fattogli vedere che per fortificamento di lui gliele dava, gliel fece bere» (corsivi miei). Mn e B hanno la lezione affrettandolo (in cui lo va riferito allo spaccio) al posto di affrettandosi di P. Ritengo che solo quest’ultima variante tramessa da B e Mn sia d’autore e dunque vada promossa a testo. Il testo dovrebbe alla fine essere restituito come segue: «Ma essendo già tardi e il nigromante aspettando lo spaccio e affrettandolo, venne un medico con un beveraggio a messer Torello e, fattogli vedere che per fortificamento di lui gliele dava, gliel fece bere». VIII 9 14: Il medico, udendo questo e senza saper che si fosse credendolo, si maravigliò molto e subitamente entrò in disidero caldissimo di sapere che cosa fosse l’andare in corso, affermandogli che per certo mai a niuna persona il direbbe [e con grande istanza il pregò che gliel dicesse, affermandogli che per certo mai a niuna persona il direbbe P; affermandogli che per certo mai a niuna persona il direbbe α]44. La frase «affermandogli che per certo mai a niuna persona il direbbe» presuppone prima la presenza della frase e con grande istanza il pregò che gliel dicesse, trasmessa solo da P, necessaria alla sintassi e al senso del passo. 43 Edd. critiche: affrettandolo venne un medico con un beveraggio a messer Torello (Singleton), affrettandolo venne un medico con un beveraggio (Branca 1976 e Rossi). 44 Edd. critiche: e con grande istanza il pregò che gliel dicesse, affermandogli che per certo mai a niuna persona il direbbe (Singleton), affermandogli che per certo mai a niuna persona il direbbe (Branca 1976), ‹e con grande istanza il pregò che gliel dicesse›, affermandogli che per certo mai a niuna persona il direbbe (Rossi). ancora per il testo del decameron 87 VIII 10 8: E essendo non a radere ma a scorticare uomini date del tutto, come un mercatante forestiere vi veggono, così da’ libro della dogana [da’ libro della dogana o da’ sensali P da’ libro della dogana α]45 s’informano di ciò che egli v’ha e di quanto può fare. Più delicato questo caso, in cui il testo non sembra presentare problemi specifici e potrebbe essere anche mantenuto nella versione fornita da Branca. La disgiuntiva o da’ sensali, trasmessa solo da P, non è strettamente necessaria, ma appare singolare che Boccaccio, rivedendo il testo, abbia deciso di eliminarla. Poco prima infatti, al § 6, aveva detto che sono proprio i sensali a prendere notizie sui mercanti e i loro carichi (corsivi miei): «E da questo libro della dogana assai volte s’informano i sensali e delle qualità e delle quantità delle mercatantie che vi son, e ancora chi sieno i mercatanti che l’hanno». La stessa protagonista della novella, Iancofiore, ricorre ad un certo punto della novella all’aiuto di un sensale (cfr. §§ 63 e 65). 4. Casi in cui P si oppone a Mn (in assenza di B) Gli stessi problemi evidenziati nella sezione precedente sono riscontrabili nel Mannelli in punti del testo in cui B è lacunoso (per la perdita di tre fascicoli) o illeggibile. X 1 8: Appresso questo, commise il re a un suo discreto famigliare che, per quella maniera che miglior gli paresse, s’ingegnasse di cavalcare [di cavalcare la prima giornata P di cavalcare Mn]46 con messer Ruggieri in guisa che egli non paresse dal re mandato e ogni cosa che egli dicesse di lui raccogliesse sì che ridire gliele sapesse; e l’altra mattina appresso gli comandasse che egli indietro al re tornasse. Il re chiede al suo famigliare di fiducia di cavalcare (senza rivelare la propria identità) con messer Ruggieri, per capire la sua reazione al dono di una mula. P reca di cavalcare la prima giornata, mentre Mn ha di cavalcare (omette dunque la prima giornata). Il segmento portato dal Parigino è necessario, anche perché è importante che il famigliare segua subito il cavaliere (per capire la sua reazione), ma soprattutto perché appena subito dopo nel testo Boccaccio scrive e l’altra mattina appresso. Per questo anche in questo caso la lezione di P è preferibile e difficilmente il testo di Mn può essere portatore di una variante d’autore. VII 9 19: Che gloria ti può egli essere che una così fatta donna, così bella, così gentile [così bella, così gentile, così ricca P così bella, così gentile Mn]47, te sopra ogn’altra cosa ami! 45 Edd. critiche: da’ libro della dogana o da’ sensali (Singleton), da’ libro della dogana (Branca 1976 e Rossi). 46 Edd. critiche: di cavalcare la prima giornata (Singleton), di cavalcare (Branca 1976), di cavalcare ‹la prima giornata› (Rossi). 47 Edd. critiche: così bella, così gentile, così ricca (Singleton), così bella, così gentile, (Branca 1976 e Rossi). 88 maurizio fiorilla P ha così bella, così gentile, così ricca. Anche in questo caso il testo di Mn, che omette così ricca, difficilmente può essere una scorciatura voluta dall’autore rispetto al Parigino. L’eliminazione del così ricca rompe la triplice anafora (così… così… così), che naturalmente potrebbe aver avuto un ruolo nel favorire l’involontario salto dell’ultimo segmento da parte del Mannelli (o del copista di α). Quel che più conta però è che Lusca, cameriera di Lidia, prospetta poco dopo a Pirro l’arricchimento che potrà avere se sarà compiacente verso l’amore della sua padrona (corsivi miei): «Qual tuo pari conosci tu che per via di diletto meglio stea che starai tu, se tu sarai savio? quale altro troverrai tu che in arme, in cavalli, in robe e in denari possa star come tu starai, volendo il tuo amor concedere a costei?» (§ 21). Lidia era effettivamente ricca perché ricco era l’uomo che aveva sposato (cfr. §§ 5 e 6). Queste ragioni spingono a promuovere a testo la lezione del Parigino. Anche nell’esempio che segue il quadro testuale è simile: VII 7 20: Allora disse Anichino: «Poi che voi mi promettete così, e io il vi dirò»; e quasi colle lagrime in su gli occhi le disse chi egli era, quel che di lei aveva udito e dove e come di lei s’era innamorato [e come di lei s’era innamorato e come venuto P e come di lei s’era innamorato Mn]48 e perché per servidor del marito di lei postosi. Il come venuto, trasmesso da P e omesso da Mn, recupera un filo narrativo di un certo rilievo per la storia e soprattutto per il racconto di Anichino, perché è importante che spieghi alla dama come era arrivato da lei a Bologna, per mettere in evidenza un’altra difficoltà che aveva dovuto superare per poterla incontrare: aveva infatti ottenuto a fatica dal padre il permesso di allontanarsi da Parigi, fingendo di volere andare in Terrasanta a visitare il Sepolcro (cfr. § 7). All’interno della stessa novella, in un passo che precede, Mn omette un altro piccolo segmento: VII 7 13: Avvenne un giorno che, essendo andato Egano a uccellare e Anichino rimaso [rimaso a casa P rimaso Mn]49, madonna Beatrice […] Il dettaglio a casa trasmesso da P non è strettamente necessario, ma la sequenza rim(aso) a c(asa) induce a sospettare che la sua assenza in Mn sia riconducibile ad una svista di copia (e non sia variante d’autore). Anichino rimane in effetti a casa con la moglie di Egano a giocare a scacchi e di lì a poco, approfittando dell’assenza del marito, le rivelerà il suo amore. Il testo di Mn sembra contenere altre lezioni che appaiono difettose: X 8 47-48: Era la camera di Tito a quella di Gisippo congiunta e dell’una si poteva nell’altra andare: per che, essendo Gisippo nella sua camera e ogni lume avendo spento, a Tito tacitamente 48 Edd. critiche: e come di lei s’era innamorato e come venuto (Singleton), e come di lei s’era innamorato (Branca 1976), e come di lei s’era innamorato ‹e come venuto› (Rossi). 49 Edd. critiche: rimaso a casa (Singleton), rimaso (Branca 1976 e Rossi). ancora per il testo del decameron 89 andatosene gli disse che con la sua donna s’andasse a coricare. Tito vedendo [udendo P vedendo Mn]50 questo, vinto da vergogna, si volle pentere e recusava l’andata. P ha la lezione attesa, udendo questo, mentre Mn ha vedendo questo, che appare erronea. I lumi infatti erano spenti e Tito non può veder nulla (e ogni lume avendo spento si legge poco prima). Siamo dunque con ogni probabilità nel frequente scambio paleografico tra u e v (già riscontrato in altri casi)51. IX 9 23: Quindi, dopo alquanti dì divenuti [pervenuti P divenuti Mn, illeg. B]52 a Antiocia, ritenne Giosefo Melisso seco a riposarsi alcun dì. La lezione di B qui è illeggibile (o meglio si intravede la fine della parola […]venuti ma non la prima parte). P ha dì pervenuti (come anche il frammento Vitali), lezione senz’altro da preferire, visto che non sappiamo cosa c’è in B e che la lezione del Mannelli (promossa a testo da Branca), oltre ad essere poco perspicua, potrebbe configurarsi come errore di ripetizione dì/divenuti. Si tenga conto che il termine dì compare di nuovo anche più avanti (alcun dì); l’iterazione di dì all’interno della frase ha probabilmente indotto Mannelli in errore, portandolo ad alterare pervenuti in divenuti. 5. Un altro possibile lapsus d’autore Nella sezione finale dell’articolo precedente avevo dato due esempi di possibili sviste del Boccaccio nate forse in fase compositiva e poi mai più sanate53. Anche nel caso che segue ci sono a mio avviso gli estremi per considerare la lezione comune a P e ad α come un lapsus d’autore: VIII 5 9: E con loro andatisene in palagio, mostrò loro questo giudice e le brache sue. Costoro dalla lungi cominciarono a ridere di questo fatto: e fattisi più vicini alle panche sopra le quali messer lo giudice stava, vider che sotto quelle panche molto leggiermente si poteva andare, e oltre a ciò videro rotta l’asse sopra la quale messer lo giudicio [messer lo giudicio P α]54 teneva i piedi, tanto che a grande agio vi si poteva mettere la mano e ’l braccio. Branca mantiene la lezione messer lo giudicio e pensa ad un «metaplasmo di declinazione di carattere popolare, con evidente senso beffardo». Lo stesso giudice marchigiano è Edd. critiche: udendo (Singleton), vedendo (Branca 1976 e Rossi). Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 19-20 (caso relativo Dec., II 6 9-11). 52 Edd. critiche: dì venuti (Singleton), dì divenuti (Branca 1976), dì pervenuti (Rossi). La lezione promossa a testo da Singleton è attestata nel Laur. 42, 3. 53 Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 34-35 (casi relativi a Dec., II 4 19 e II 8 99). 54 Edd. critiche: messer lo giudice (Singleton), messer lo giudicio (Branca 1976 e Rossi). La lezione messer lo giudice è attestata nel Laur. 42, 3 (che potrebbe però aver corretto per congettura). 50 51 90 maurizio fiorilla nominato però altre tre volte dallo stesso Filostrato nel racconto, sempre come messer lo giudice (ancora nel § 9 e anche ai §§ 12 e 19) e altre cinque volte semplicemente come giudice (cfr. rubrica, §§ 9, 11 e 14). L’unica occorrenza di messer lo giudicio, che compare in un momento diegetico del racconto e non all’interno di un dialogo tra i protagonisti della novella, potrebbe insomma configurarsi come una semplice svista (condizionata forse dal lo che precede), per questo a mio avviso messer lo giudicio si potrebbe emendare in messer lo giudice (come già proposto da Singleton)55. 55 Segnalo, a conclusione di questo secondo contributo, un piccolo errore di trascrizione nel testo Branca contenuto nel seguente brano (I Intr. 55): «non prendersi per voi [noi P α] a quello di che ciascuna di voi meritamente teme alcun compenso». Branca riteneva dubbia la lettura in B del per voi e del di voi che segue subito dopo: «può restare il dubbio che sia da leggere per noi…di noi oppure per noi…di voi: ma il confronto coi noi precedenti e seguenti inclina alla lezione adottata» (Branca 1976, p. 18). Nel codice Hamiltoniano, come ho avuto modo di riscontrare direttamente sull’originale, in realtà si legge sicuramente «non prendersi per noi a quello di che ciascuna di voi», testo tramesso anche da P e Mn (promosso già a testo da Singleton e Rossi; cfr. anche Boccaccio, Decameron. Edizione diplomatico-interpretativa, cit., p. 9). Per altri errori di trascrizione (da B e da Mn) nelle edizioni critiche cfr. Breschi, Il Parigino It. 482, cit., pp. 92-93 (casi relativi a Dec., I Intr. 37 e 41); Fiorilla, Per il testo del Decameron, cit., pp. 35-36 (casi relativi a Dec., VII 8 49, X 4 30 e X 5 26). Silvia Finazzi Una sententia di Petrarca attribuita a Boccaccio e possibili tracce delle Genealogie nel Laurenziano 37, 3 Nel f. 166v e nella carta di guardia finale del Laurenziano Pluteo 37, 3, codice membranaceo corredato di miniature che tramanda le tragedie di Seneca, esemplato nell’ultimo quarto del XIV secolo dal copista e maestro di grammatica toscano Nofri di Giovanni da Poggitazzi1, si trovano alcune citazioni tratte da auctoritates quali Cicerone, lo stesso Seneca e Agostino. Tra questi excerpta vergati in svariate tipologie di scrittura, all’apparenza mere prove calligrafiche di mani diverse, ma con ogni probabilità coeve al copista principale2, nel verso della carta di guardia finale si può notare una sentenza moraleggiante sul motivo della stultitia. L’anonimo copista 1 Questo il testo della sottoscrizione che si legge al f. 166v: «Expliciunt Annei Senece Cordubensis decem Tragedie scripte per Nofrium Johannis ad reverentiam et honorem Virginis gloriose». Oltre a A.M. Bandini, Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Medicae Laurentianae, 4 voll., Florentiae, vol. II, 1775, col. 248, e A.P. MacGregor, The Manuscripts of Seneca’s Tragedies: A Handlist, in Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, hrsg. von H. Temporini und W. Haase, Berlin-New York, De Gruyter, 1985, pp. 11341241, a p. 1189 (n. 144), per maggiori dettagli su questo manoscritto, quasi interamente palinsesto su testi notarili e documentari risalenti al XIII secolo, e che presenta un considerevole apparato di note marginali e interlineari (le quali riproducono in parte anche il commento alle tragedie senecane di Nicola Trevet), cfr. la relativa scheda in Seneca. Una vicenda testuale. Catalogo della mostra, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana 2 aprile-2 luglio 2004, a cura di G. Resta e T. De Robertis, Firenze, Mandragora, 2004, p. 152. Sulle varie ipotesi circa l’identità del copista Nofri di Giovanni, la sua contestualizzazione entro l’ambiente delle scuole toscane di fine Trecento e alcuni minimi accenni a questo codice, rinvio a V. de Angelis, Magna questio preposita coram Dante et domino Francisco Petrarca et Virgiliano, «Studi petrarcheschi», n.s. I, 1984, pp. 103-209, part. a p. 130, nota 50; R. Black, Humanism and Education in Medieval and Renaissance Italy. Tradition and Innovation in Latin Schools from the Twelfth to the Fifteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, alle pp. 200-203, 214-215; Id., Education and Society in Florentine Tuscany. Teachers, Pupils and schools, c. 1250-1500, Leiden, Brill, 2007, in part. alle pp. 81, 311-312, 319-320, 552-553 e 564; G. Pomaro, Scritture di scuola e per la scuola ad Arezzo, in 750 anni degli statuti universitari aretini. Atti del Convegno Internazionale, Arezzo 16-18 febbraio 2005, a cura di F. Stella, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 273-298, part. alle pp. 279-281. 2 Cfr. in merito Black, Humanism and Education, cit., p. 214. 92 silvia finazzi assegna tale massima, della quale fornisco trascrizione qui di seguito, a Giovanni Boccaccio: Credere se sapientem primus astultitiam gradus est profimus profiterj dominus Johannes Bocacius. Come ebbe modo di rilevare già Vittore Branca, che per primo si interessò alla citazione, al fine di rendere intelligibile il senso della frase (ossia ‘credersi sapiente è il primo passo verso la stoltezza’) è necessario correggere astultitiam in ad stultitiam, e un ancor più evidente monstrum quale profimus in proximus 3. Di questa sententia, tuttavia, non vi è alcuna traccia nelle opere boccacciane a oggi note, e a nessun risultato convincente hanno portato i sondaggi condotti a suo tempo dallo stesso Branca in moderni repertori di proverbia e sententiae 4, e in antiche raccolte (tra cui il Fiore dei filosofi o il Compendium moralium notabilium di Geremia da Montagnone). Lo studioso quindi, giudicando «scarsissime […] le probabilità […] che la sentenza socratica sia del Boccaccio», e ritenendo al contempo quell’attribuzione una «testimonianza minima, ma non senza interesse, della diffusione dell’immagine del Boccaccio maestro di probità intellettuale, quale si era divulgata certo soprattutto dagli ultimi libri del De Genologia »5, avanzò possibili collegamenti con la tradizione scritturale, in particolare con Prov. III 7, XXVI 12 e 16; Is. V 21; Jer. X 14 e Rom. I 22, XI 25 (recuperati anche attraverso gli Ammaestramenti di Bartolomeo da San Concordio). Da allora, a quanto mi risulti, soltanto Robert Black è tornato una decina di anni fa brevemente sul problema, occupandosi di alcuni maestri di grammatica e retorica attivi in Toscana tra XIV e XV secolo, nel suo studio Humanism and Education in Medieval and Renaissance Italy 6. Nella scheda dedicata al Laur. 37, 3, Black si è riagganciato alle considerazioni di Branca, facendo altresì presente di essere riuscito a rintracciare la sentenza nel repertorio curato da Walther e Schmidt7, laddove si rinvia direttamente al settecentesco Florilegium adagiorum et sententiarum Latino-Germanicum di Andreas Ritzius. Nemmeno una verifica su quest’ultimo contribuisce però a dirimere granché la questione, dal momento che la sententia, riportata oltretutto in forma incompleta («Credere se sapientem primus ad stultitiam gradus est»), appare priva di qualsiasi riferimento a fonti8. V. Branca, Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio. I. Un primo elenco dei codici e tre studi, Roma, Storia e Letteratura, 1958, p. 240. 4 Viene menzionato in particolare J. Werner, Lateinische Sprichwörter und Sinnspräche des Mittelalters, Heidelberg, Winter, 1912. In questo repertorio, Branca individuò comunque tangenze tra la massima attribuita a Boccaccio e l’adagio «Addiscit sapiens, quia se putat esse inscientem: Negligit insipiens, quia se putat esse scientem» (ivi, p. 2). 5 Branca, Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio. I, cit., p. 240. 6 Cfr. Black, Humanism and Education, cit., pp. 214-215. 7 Proverbia sententiaeque Latinitatis medii ac recentioris aevi. Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters und der frühen Neuzeit, n.s., aus dem Nachlass von H. Walther, hrsg. von P.G. Schmidt, 3 voll., Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, vol. I, 1982, p. 450 (n. 818a1). 8 Florilegium adagiorum et sententiarum Latino-Germanicum, in quo X chiliades proverbiorum et sententiarum 3 una sententia di petrarca attribuita a boccaccio 93 Sistematici spogli da me effettuati nel corso di ulteriori ricerche parallele, in ogni caso, mi hanno consentito di restituire questa massima sulla stultitia a Francesco Petrarca. Si tratta precisamente di un passo del capitolo De sapientia all’interno del primo libro del De remediis, in cui la Ratio risponde a un Gaudium appena definitosi sapiens: Gaudium: «Sum sapiens» Ratio: «Si vere sapiens esse vis, noli id quidem opinari. Credere se sapientem primus ad stultitiam gradus est, proximus profiteri»9. Alla luce di quanto rilevato pertanto, a maggior ragione se si tiene conto della verosimile altezza cronologica della testimonianza del codice Laurenziano, questo piccolo episodio tardo trecentesco di sovrapposizione tra il Petrarca morale e il Boccaccio morale carica senza dubbio di ulteriori significati l’erronea attribuzione della sententia. Anche sulla scorta di questo nuovo dato, ripercorrerò ora gli altri elementi di interesse boccacciano riscontrati da Branca e Black nel Laur. 37, 3. A tal proposito, vi è innanzitutto da chiarire un aspetto di primaria importanza, ossia l’attenzione richiamata da Branca specificamente su di un’opera boccacciana: le Genealogie deorum gentilium. Nel suo imponente lavoro di ricognizione di tutti i testimoni delle opere boccacciane, inclusi quelli oltremodo parziali, lo studioso ritenne inizialmente10 di comprendere in quest’ultima categoria anche il codice Laur. 37, 3, giacché ravvisò proprio in alcuni degli excerpta trascritti nelle carte finali, frammenti mitologici che deriverebbero dalle Genealogie11. Branca si riferiva in primo luogo al frammento, incentrato su Diana e strutturato come una sorta di elenco con varie caratteristiche ed epiteti divini, che si legge al f. 166v. Ne propongo una prima trascrizione completa, limitandomi a sciogliere le abbreviazioni (il cui uso, peraltro, è soggetto a diverse oscillazioni interne, anche a breve distanza), e inserire alcuni segni interpuntivi al fine di consentirne una maggiore leggibilità. Nelle rispettive note, discuto quindi brevemente alcuni dei punti più problematici: non sine delectu conquisitae reperiuntur in usum et gratiam studiosae juventutis, adornatum ab M. Andrea Ritzio Sangallensi, Basileae, Brandmüller, 1728, p. 662. 9 Petrarca, Rem., I 12, 8 (corsivi miei). Cito da Pétrarque, Les remèdes aux deux fortunes, texte établi et traduit par C. Carraud, 2 voll., Grenoble, Millon, 2002, vol. I, p. 60. 10 Al riguardo, specifico che il Laur., 37, 3 non compare direttamente nei due elenchi di testimoni delle Genealogie pubblicati in Branca, Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio. I, cit., pp. 109-115, e Id., Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio. II. Un secondo elenco di manoscritti e studi sul testo del Decameron con due appendici, Roma, Storia e Letteratura, 1991, pp. 64-69, ma era stato incluso dallo studioso nel suo primissimo elenco di codici, che si può leggere in V. Branca, Motivi preumanistici, in Id., Boccaccio medievale, introduzione di F. Cardini, Milano, Rizzoli, 2010 (Ia ed. Firenze, Sansoni, 1956), pp. 331-356, alle pp. 349-350, nota 43. Del resto poi, anche la cronologicamente successiva appendice sulla sententia di cui si è parlato sopra (Branca, Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio. I, cit., p. 240), si apre ricordando la presenza nello stesso manoscritto di «un passo su Diana derivato forse dal De Genologia», e, come si è avuto modo di vedere, il contenuto della massima veniva in parte ricondotto al Boccaccio prettamente morale degli ultimi libri delle Genealogie. 11 Cfr. Branca, Motivi preumanistici, cit., pp. 349-350, nota 43. 94 silvia finazzi Prosepina in inferno, Diana in silvis, Trivia in tribus viis, Delia a Delo monte vel insula, Echate ab Echa quod ceterum [sic ]12 Echoos deus, nam Menelaus precum Platonem13 Helene fecit ei contra hostias, Thitonia a Thitanis, Dictina a Dicti[ne] monte Dithina, Phebe quia soror Phebi, vel amphos14, quod est lux, Luna in celo a luce. Di certo, alcune delle espressioni impiegate in questo breve testo appaiono a tratti poco perspicue, e presentano notevoli scorrettezze (fin dal primo epiteto Proserpina, riportato, a seguito di un’omissione di titulus, nella forma Prosepina), erronee ripetizioni od omissioni, cui vanno ad aggiungersi cancellature e parziali ripensamenti (in particolare in corrispondenza dell’epiteto Trivia, nel segmento riguardante l’epiteto Dictina, dove appare cassata l’ultima sillaba di Dictine, e Phebe, con il nesso ph preceduto dal tratto iniziale di un’altra lettera). Una facies complessiva, di fronte alla quale non si può escludere il sovrapporsi di almeno due livelli di trasmissione: da un dettato orale a una forma scritta già viziata da errori, quindi un successivo passaggio di copia, a partire da quel testo, che ha determinato a sua volta il prodursi di ulteriori corruttele. A ben guardare poi, un puntuale confronto tra questo elenco e la specifica trattazione dedicata ai nomi di Diana nelle Genealogie boccacciane (IV 16) non fa emergere altro che rare e parziali tangenze nella serie di tradizionali epiteti: «Lunam, Hecatem […] Dianam, Proserpinam, Triviam […] Phebem […] Lunam a lucendo dictam volunt […] Hecates autem ideo dicta est, quia centum interpretatur, in quo numero, quasi finitum pro infinito positum sit, volunt multiplicitatem eius potentie denotari. Triviam nonnulli, esto Seneca poeta triformem dicat in tragedia Ypoliti, a triplici suo nomine principali dictam volunt; vocatur enim Luna, Diana et Proserpina» (da notare qui il rinvio a Seneca tragico per l’epiteto Trivia e la natura triplice della dea). Ma anche epiteti meno frequenti quali Dictinna/Dictima (ivi, IX 35: «et eam Dictimam appellarent, eo quod piscatorum retia, quibus in terram deductum est Brictone cadaver, dicthia nominentur»), apparirebbero di per sé giustificabili attraverso l’azione di molteplici fonti classiche e tardoantiche15. 12 Si potrebbe avanzare qui l’ipotesi del fraintendimento di un originario centum, il nome Ecate viene infatti tradizionalmente ricondotto anche ad ἑκατόν (cfr. poco oltre lo stesso Boccaccio). 13 In generale, il senso dell’intero periodo riguardante Menelao ed Elena, minato con ogni probabilità da diverse lacune, appare di difficile comprensione. In ogni caso, in luogo di precum (gen. plur. di prexprecis), si potrebbe anche supporre una lettura procum, ossia ‘pretendente’ della bella Elena. Al contempo, non ho avuto modo di trovare spiegazioni plausibili per il riferimento al nome Platone, salvo ipotizzare una lezione originaria Plutonem (Plutone notoriamente rapì Proserpina, che coincide appunto con uno degli epiteti-identità di Diana). 14 Si dovrà intendere a phos (φῶς), ossia ‘luce’. 15 Benché, alla luce delle note esaminate, risulti arduo ipotizzare che tali anonimi glossatori possano avere attinto a fonti particolarmente ricercate, si segnalano comunque qui di seguito punti di contatto con testi classici e tardoantichi. Per alcuni epiteti e definizioni formulari, basti rinviare ad esempio a Varro, Ling., V 67-75 (in particolare per Proserpina e l’identificazione con la luna) e VII 16: «Titanis Trivia Diana est […] vel quod luna dicitur esse, quae in caelo tribus viis movetur», con rinvii interni anche a Ennio e Plauto; tuttavia, una diretta conoscenza di quest’opera varroniana, a quell’altezza cronologica, è da considerarsi una sententia di petrarca attribuita a boccaccio 95 Al di là dell’effettivo contenuto del frammento, sul quale in realtà nessuno si è mai soffermato in modo preciso, va specificato che Vincenzo Romano, curatore nel 1951 di un’edizione delle Genealogie per la collana Scrittori d’Italia di Laterza, manifestò ben presto numerosi dubbi sull’opportunità di promuovere questo Seneca Laurenziano a testimone parziale del trattato boccacciano16. Da parte sua Robert Black, nella già ricordata scheda sul codice, dopo aver rimarcato la debolezza di un’ipotesi fondata su quello scarno elenco di epiteti17, ha introdotto un altro, notevole elemento che sembrerebbe corroborare l’affermazione dell’esistenza di un legame con le Genealogie. Al f. 31r infatti, a margine di Thy., 731, si legge la postilla: «Qui puer nominatus fuit Arpagines secundum dominum Johannem Bocacium alegantem Theodontium dicentem de hoc». Questa nota di lettura dunque, senza incorrere in errate attribuzioni, chiama nuovamente in causa il dominus Johannes Bocacius per specificare il nome dell’unico dei tre figli di Tieste non menzionato nel testo, con il puntuale intento di rinviare a Gen. deor. gent., XII 8, dove il Certaldese cita appunto Seneca tragico e dichiara di essersi attenuto all’auctoritas di Teodonzio18. Secondo Black questa postilla, non vergata da ipotesi assai remota (sulla relativa tradizione manoscritta, che discende come noto da un archetipo conservato quale il Laur. Plut. 51, 10, codice in beneventana risalente al sec. XI, recuperato a Montecassino e parcamente postillato dallo stesso Boccaccio, che ne trasse anche una copia per Petrarca, cfr. almeno L.D. Reynolds, Varro, in Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics, ed. by L.D. r., Oxford, Clarendon, 1983, pp. 430-431). Si pensi poi a Cic., Nat. deor., II 68-69 (identificazione con la luna); Aug., Civ. Dei., IV 11, VII 2 e 16 (l’espressione «Diana in silvis» e l’identificazione con la luna, sorella di Apollo-sole); Serv., In Aen., III 171 («Dictaea. Dictaeus mons Cretae est, dictus a Dicte nympha, quae illic colitur, in quo dicitur altus Iuppiter, ut “Dictaeo caeli regem pavere sub antro”»), IV 511 («Tergeminamque Hecaten. Quidam Hecaten dictam esse tradunt, quod eadem et Diana sit et Proserpina, ἀπὸ τῶν ἑκατέρων, vel quod Apollinis soror sit […] sed secundum Hesiodum Hecate Persi Titanis et Asteriae filia est, Diana Iovis et Latonae, Persephone Iovis et Cereris […] cum super terras est, creditur esse Luna; cum in terris, Diana; cum sub terris Proserpina […] et quidem nascendi Lucinam deam esse dicunt, valendi Dianam, moriendi Hecaten»; diversi gli accenni alla natura triplice, connessa anche ai templi «in triviis») e X 216 («Phoebe luna, sicut sol ‘Phoebus’, item ‘Titan’ sol, et ‘Titanis’ luna»); Lact., In Theb., IV 515 («Hecate») e IX 632 («Dictynna»); Isid., Orig., VIII 11, 57-75 (vari epiteti, soprattutto «Triviam […] Proserpinam»). 16 Cfr. V. Romano, Ancora della doppia redazione della Genealogia del Boccaccio e di altri problemi inerenti al testo, «Belfagor», VIII, 1953, fasc. 2, pp. 185-219, part. a p. 191; alle cui considerazioni peraltro, a tratti acerbamente polemiche, rispose lo stesso Branca nella nota sopra citata (Branca, Motivi preumanistici, cit., p. 350, nota 43). 17 Cfr. Black, Humanism and Education, cit., p. 214. 18 Boccaccio, Gen. deor. gent., XII 8: «Tantalus, Phystenes et Arpagiges filii fuerunt Thyestis ex coniuge Atrei suscepti, ut per verba Senece poete in tragedia Thyestis comprehenditur, esto duos tantum nominat, Tantalum scilicet, dum dicit: “Primus locus (ne deesse pietatem putes) Avo dicatur: ‘Tantalus prima hostia est’” etc. Deinde nominat Phystenem, dicens: “Tunc illi ad aras Phystenem sevus trahit, Adicitque fratri” etc. Tertium puerum vocat, dum dicit: “Ferrumque gemina cede perfusum tenens, Oblitus in quem rueret, infesta manu Exegit ultra corpus, ut pueri statim Pectore receptus ensis a tergo extitit; Cadit ille” etc. Tercium hunc puerum Theodontius dicit Arpagigem nuncupatum. Et sic ex eis preter patrui crimen, et patris escam nil legitur» (cito sempre dall’ed. a cura di V. Zaccaria, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, vol. VII-VIII, t. 2, Milano, Mondadori, 1998). Le citazioni interne da Seneca corrispondono esattamente a Thy., 717-718, 726-727 e 738-742. 96 silvia finazzi Nofri di Giovanni ma da una mano certamente coeva, potrebbe essere ricondotta a un allievo della sua stessa scuola di grammatica. In effetti, le patenti incertezze che caratterizzano in prima istanza il frammento su Diana, ma anche altre note conservate specialmente nelle carte di guardia, parrebbero in tal senso avvalorare l’ipotesi di Black riguardo all’intrecciarsi di glosse del maestro ed esercizi di alcuni allievi19. Per converso, si dovrà aggiungere che un precoce e diretto uso a fini didattici di un testo come le Genealogie, cui ora si potrà a buon diritto affiancare anche il De remediis, dimostrerebbe altresì la non comune apertura verso le più avanzate istanze preumanistiche da parte di un maestro come Nofri20. Al fianco del frammento su Diana, vi è però almeno un altro aspetto degno di approfondimento in ottica boccacciana, che non mi risulta essere stato finora individuato nel complesso delle probationes calami contenute nel codice21. Sulla sinistra si Cfr. in questa direzione anche la postilla al f. 41r, che riferisce una curiosa opinione dello stesso Nofri, introdotta dalla formula «dicit magister Nofrius», sulla presunta sonnolenza di Seneca, poi integrata da una mano tardo quattrocentesca con un giudizio ben più irriverente di tale Marsilius (cfr. Black, Humanism and Education, cit., pp. 202-203 e 214, che si è spinto a ipotizzare in merito: «could this be Ficino?»). 20 Merita ricordare al proposito quanto scritto da Claudia Villa circa il diffuso interesse nei confronti delle tragedie di Seneca nell’ambiente culturale fiorentino sul finire del XIV secolo (soprattutto negli anni Ottanta, cui risalgono notizie di letture senecane tenute da Domenico di Bandino, Lorenzo Ridolfi e forse Bartolomeo da San Concordio): «Finalmente bisognerà ragionare sui possibili ispiratori di questi cicli, anche ricordando che nei commenti letterari si intravedono figure di intellettuali assai aggiornati, capaci di citare nomi illustri: così maneggia Petrarca, richiamandone le Epistole, un postillatore la cui nota è riprodotta in Firenze Laurenziano 37, 5, f. 34r e poi anche nel Vaticano lat. 1645, f. 30v […] D’altra parte in tutto il Valdarno si avverte il forte interesse per Seneca. Il codice di Pistoia, Forteguerri A 46, appartenuto a Sozomeno, introduce frequentissimi richiami marginali al Boccaccio, Genealogiae, perché le questioni mitologiche sembrano particolarmente appassionanti […] Nella scuoletta di grammatica di Antonio da San Gimignano, maestro del più famoso Sozomeno, un Giovanni di Antonio completa la trascrizione delle Tragedie (Firenze, Laurenziano 91 sup. 30, f. 76v); e un Bartolomeo da San Gimignano copia nel 1387 il codice ora London, British Library Burn. 250; anche fra Tedaldo della Casa, animatore dei circoli fiorentini più legati al ricordo di Petrarca, si trascrive il suo Seneca nel Laurenziano Gaddi IV Plut. 34» (C. Villa, Le «Tragedie» di Seneca nel Trecento, in Ead., La protervia di Beatrice. Studi per la biblioteca di Dante, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2009, pp. 233-249, a p. 248). Un generale contesto in cui appare ora lecito riconoscere un pur modesto ruolo anche a Nofri di Giovanni e alla sua scuola di grammatica. 21 Con l’obiettivo di valutare il peso specifico di ogni singolo excerptum, ho tentato di ricondurre a una precisa fonte ciascuno dei frammenti. Fornisco pertanto qui di seguito il quadro complessivo. Carta di guardia iniziale: sotto una serie di brevi e incompleti argumenta delle tragedie (derivanti per lo più dal commento del Trevet), la stessa mano ha vergato sei sententiae morali senza alcun rinvio alle rispettive fonti, e che sono nell’ordine riconducibili a Ps.-Sen., Mor., 128 e cfr. Nicola da Chiaravalle, Ep., XI, in PL, vol. CXCVI, col. 1608; Sen., Benef., II 1, 3-4, nonché a tre passi pressoché consecutivi del libro VIII della Historia destructionis Troiae di Guido delle Colonne (cfr. l’ed. a cura di N.E. Griffin, Cambridge, The Medieval Academy of America, 1936, a p. 81). Al f. 166v, appena sopra i due frammenti mitologici qui analizzati, citazione da Val. Max., VI 9 ext. 7 (con inserimento nel testo della formula «quia Valerius»); al di sotto, serie di tre sententiae: Cic., Lael., 75 (preceduta da «Tulius de Amicitia ait»); Ps.-Sen., Mor., 12 (preceduta da «Ait Senecha»); Sirach, XI 9, con la seconda parte che parrebbe sovrapporsi a Ps., XXV 4 (seguita da generico rinvio all’Ecclesiastico). Carta di guardia finale: nella parte superiore del recto, serie di sententiae senza rinvio alle rispettive fonti, tratte 19 una sententia di petrarca attribuita a boccaccio 97 legge infatti un altro elenco, riferito segnatamente a nove categorie di ninfe, trascritte una per riga: «Nayades dee fontium / Nereydes dee maris / Potamides dee fluviorum / Ninphe dee stagnorum / Driades dee silvarum / Amadriades dee arborum / Horeades dee montium / Himudes dee platorum / Napee dee florum». Nonostante le consuete imprecisioni osservabili nel testo (segnalo qui Himudes per Humides e platorum per pratorum), farei notare come questo elenco si possa avvicinare, eccetto talune oscillazioni terminologiche o nell’ordine di citazione, a quello di sette categorie di ninfe copiato da Boccaccio nel f. 48r dello Zibaldone Laurenziano (Plut. 29, 8 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze), a chiosa del v. 136 dell’egloga di Giovanni del Virgilio ad Albertino Mussato («Pana tibi testor Driadas pulchrasque Napeas»): «Nayades dee fontium / Orcades dee montium / Driades dee nemorum / Nereides dee maris / Napee dee florum / Amadriades dee arborum / Nimphe dee fluviorum»22. Inoltre, allineandomi a quanto già rilevato da Giorgio Padoan in merito alla glossa dello Zibaldone Laurenziano23, aggiungerei che entrambi i suddetti elenchi si possono accostare a un terzo passo collegato a Boccaccio, ovvero il catalogo delle ninfe della Genealogia deorum secondo Franceschino degli Albizzi e Forese Donati, a tutt’oggi nota unicamente per le sezioni copiate dalla mano del Certaldese, conservate ai ff. 121r-123r dello Zibaldone Magliabechiano (Banco Rari 50 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze). Riporto pertanto anche una trascrizione di quest’ultimo testo (f. 121v), che reca a sua volta sette categorie di ninfe e presenta, esclusa la dispositio verticale a elenco, un’identica struttura che scandisce le categorie con formula tripartita, attraverso la successione nome-dee-elemento naturale: «Nereides dee maris, Nayades dee fontium, Nymphe dee fluviorum, Humides dee pratorum, Horeades24 dee camporum, Driades dee montium, Amadriades dee arborum». nell’ordine da Gregorio Magno, Moralia in Job, XX 2 e I 1; Pier Damiani, Serm., XXXVII, in PL, vol. CXLIV, col. 704; ancora Gregorio Magno, Moralia in Job, I 19, e Cic., Verr. 2, 39, citato anche in Aug., Civ. Dei, XVIII 5 (segue infatti l’indicazione: «Tulius ait, ut recitat Augustinus xviiij de civitate dej iiij»). Nel verso della medesima carta: Ps.-Sen., Mor., 1, 15 e 13 (con accanto due indicazioni «Seneca de moribus» e un «Seneca idem», probationes in differenti tipologie di scrittura); Verg., Aen., VI 620. Quest’ultimo verso virgiliano precede la citazione attribuita a Boccaccio e, mi sembra utile segnalarlo, viene menzionato sia dal Certaldese nelle stesse Genealogie (il verso intero a IX 25; oltre che nelle Esposizioni sopra la Comedia, a chiosa di Inf., VIII 22-24), che da Petrarca (solo il primo emistichio), proprio all’interno dell’opera appena coinvolta nell’identificazione della successiva sententia: Rem., II 81, 12. La sentenza sulla stultitia chiude di fatto le sequenze di citazioni, seguono infatti sparute glosse di diverse mani, anche seriori, tra cui una nota di possesso e una sorta di infantile filastrocca mnemonica sugli elementi del calendario romano (sulla quale cfr. Black, Humanism and Education, cit., pp. 214-215). 22 Le definizioni «deas nemorum» e «deas florum» compaiono anche in interlinea, sovrascritte alle due corrispondenti categorie citate direttamente a testo, ossia «Driadas […] Napeas». 23 Cfr. G. Padoan, Boccaccio, le Muse, il Parnaso e l’Arno, Firenze, Olschki, 1978, pp. 187-188. 24 Rispetto all’edizione fornita da A. Hortis, Studj sulle opere latine del Boccaccio, Trieste, Julius Dase, 1879, pp. 537-542, a p. 539, presa a riferimento da tutti gli studi successivi, propongo qui una nuova trascrizione, nella quale mi pare opportuno segnalare la necessità di leggere non Horcades bensì Horeades, poiché quest’ultima è la lezione che ho effettivamente riscontrato nello Zibaldone Magliabechiano. Sulla questione relativa alla denominazione delle Oreadi secondo Boccaccio, rinvio a Padoan, Boccaccio, le Muse, cit., pp. 187-188; cfr. inoltre Id., «Habent sua fata libelli». Dal Claricio al Mannelli al Boccaccio, «Studi sul Boccaccio», XXV, 1997, pp. 143-212, alle pp. 182-183 e 187-188. 98 silvia finazzi Quanto alle oscillazioni rilevabili nella nomenclatura e nel computo totale delle categorie, andrà ricordato come esse siano ben consuete nelle fonti classiche, tardoantiche e medievali sul tema25, tanto che non ne appare immune neppure il medesimo Boccaccio, che vi si sofferma in primo luogo nel libro VII delle Genealogie 26. Per concludere, mi limito a segnalare in merito la possibilità di istituire alcuni raffronti tra l’elenco del Laur. 37, 3 e le compilazioni mitologiche ricondotte, nella fattispecie da Teresa Hankey, a Paolo da Perugia27, delle cui Genealogie il testo copiato da Boccaccio, conservato ai ff. 110r-114v dello Zibaldone Magliabechiano, dà notoriamente conto in modo parziale (come si può evincere scorrendo le voci dell’indice al f. 110r). Nell’impossibilità di estendere i confronti al rispettivo elenco di ninfe, assente in quella porzione di testo, ho dunque effettuato uno spoglio dei manualetti editi dalla Hankey, servendomi al contempo dei riscontri in apparato con altre opere di un certo interesse da un punto di vista boccacciano (si pensi alla sezione De diis della Chronologia magna di Paolino Veneto). Tale operazione mi ha consentito di rilevare in tutto quattro elenchi, 25 Segnalo di aver concentrato le ricerche in primo luogo sulle compilazioni che si avvicinano, almeno in parte, alla struttura a elenco che qui più interessa. Tra gli esempi rintracciati, a principiare almeno da Serv., In Aen., I 500 (Oreades, Dryades, Amadriades, Napeae vel Naides, Nereides); ma cfr. anche In Ecl., X 62 (Hamadriades, Dryades, Oreades, Perimelides, Naides, Limonides, Curotrophae); Lact., In Theb., IV 254-255 (Dryades, Oreades, Potamides, Napeae), basti in questa sede rinviare a: Isid., Orig., VIII 11, 97; Rabano Mauro, De univ., XV 6; Ainardo, Glossario, a cura di P. Gatti, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2000, p. 54; Papiae Elementarium doctrinae rudimentum, Venetiis, Boninus Mombritius, 1496, c. 111r (cfr. inoltre singolarmente anche le corrispettive voci). 26 Boccaccio, Gen. deor. gent., VII 14: «Nynphe generale nomen est quarumcunque humiditatum, quod ideo dico, quia humiditates secundum diversitatem rerum, quibus deserviunt, nomina diversa accipiunt, ut in sequentibus apparebit […] Harum quidem alie sunt marine, et appellantur Nereides […] Sunt et alie que dicuntur fluminum, et he vocantur Naiades […] Nec obstat his immixtas esse, vel aliis aliquas ex nominatis inter Nereidas […] Sunt et alie que dicuntur fontium, et he appellantur Napee, quasi Naptee, id est aquarum fomites […] Sunt et alie quas nemorum dicunt, et he Dryades vocitantur, eo quod dryas arbor seu quercus sit […] Sunt et alie, quas arborum dixere, easque Amadriades vocavere, quasi in speciali arbores, non in generali nemora amantes. Alie vero sunt montium, quas dixere Orcades, quasi Oroncades; nam oron Grece Latine mons dicitur. Sic etiam et alie Hymnides appellantur, ut placet Theodontio, quas dixit pratorum atque florum nynphas existere». Le sette principali categorie di humiditates nominate in modo diretto (Nereides, Naiades, Napee, Dryades, Amadriades, Orcades, Hymnides), andranno peraltro confrontate con altre sedi, dove però il Certaldese si limita sempre ad alludere generalmente al termine ninfe, o a ricordare due, tre categorie a esempio: Filocolo, I 1, 6 e III 38, 7; Elegia di Madonna Fiammetta, V 30; Comedia delle Ninfe, III 4; oltre che Teseida, V 62, 3 e relativa chiosa interlineare al f. 57r dell’autografo dell’opera, il ms. Acquisti e Doni 325 della Biblioteca Medicea Laurenziana, con le definizioni «dij de boschi» e «dee de gli alberi» sovrascritte ai nomi «fauni» e «driade»; nel Buccolicum carmen inoltre compaiono in diversi luoghi le Napee. Su alcuni dei passi citati, cfr. almeno Padoan, Boccaccio, le Muse, cit., pp. 187-188, nota 117. 27 Cfr. T. Hankey, Un nuovo codice delle Genealogie deorum di Paolo da Perugia (e tre manualetti contemporanei), «Studi sul Boccaccio», XVIII, 1989, pp. 65-161; per altre considerazioni della studiosa sull’argomento, e ulteriore bibliografia aggiornata, cfr. anche Ead., La Genealogia deorum di Paolo da Perugia, in Gli Zibaldoni di Boccaccio. Memoria, scrittura, riscrittura. Atti del Seminario internazionale, Firenze-Certaldo, 26-28 aprile 1996, a cura di M. Picone e C. Cazalé Bérard, Firenze, Cesati, 1998, pp. 81-94. una sententia di petrarca attribuita a boccaccio 99 tre di sette categorie e uno di nove28. Soprattutto quest’ultimo, contenuto in una delle due Genalogie falsorum deorum testimoniate dai mss. Par. lat. 8699 della Bibliothèque Nationale de France, Marc. lat. X 70 (= 3328) e XIV 109 (= 4623) della Biblioteca Marciana di Venezia, presenta, al di là del differente ordine di citazione, una suddivisione interna pressoché sovrapponibile a quella osservata nella nota del Laur. 37, 3: «Potanides fluviorum. Heumenides pratorum. Oreades montium. Driades silvarum. Nereides maris. Naiades fontium. Napee florum. Amadriades arborum. Nimphe stagnorum»29. I nuovi elementi di valutazione presentati in questa sede dunque, dimostrata per prima cosa la paternità petrarchesca della sententia morale assegnata a Boccaccio al f. 166v, fanno altresì constatare come le notizie di carattere mitologico, contenute nelle carte finali del Laur. 37, 3, non siano in buona sostanza riconducibili direttamente alle sole Genealogie deorum gentilium, o comunque all’attività letteraria del Certaldese. Si tratta in ogni caso di dati, attestati come visto nella tradizione scoliastica, enciclopedica e mitografica, tardoantica e medievale, che circolavano in forme assai simili anche in ambienti prossimi al medesimo Boccaccio. Resta inoltre di particolare interesse il rimando alle Genealogie contenuto nella postilla al Thyestes in margine al f. 31r, la quale, contestualizzata ora entro il complesso delle citazioni vergate nelle carte iniziali e finali del codice, ivi compresa la sententia tratta dal De remediis, costituisce al tempo stesso una tessera utile ad approfondire il quadro culturale di riferimento della scuola del maestro Nofri di Giovanni. 28 Cfr. Hankey, Un nuovo codice, cit., alle pp. 100 (e nota 7 per i rinvii a Mythographi Vaticani e Paolino Minorita), 125, 143. 29 Ivi, p. 132. Si noti, tra l’altro, la perdurante incertezza circa la denominazione delle ninfe dei prati (ora Humides, così prossima al «generale nomen» humiditates, ora Hymnides), storpiate come visto in Himudes nel Laur. 37, 3, e addirittura in Heumenides in questa anonima Genealogia. Preciso che i tre testimoni manoscritti citati sono databili l’uno (il Parigino) all’ultimo quarto del XIV secolo, e gli altri due alla metà del XV. Riguardo alla datazione dei testi, la Hankey ha concluso che debbano risalire «al più tardi al primo Trecento, e probabilmente al Duecento», evidenziando come molti materiali si avvicinino soprattutto, pur con varie storpiature nei nomi progressivamente corrette ad opera della trattatistica successiva (incluso lo stesso Boccaccio), «ora a Conrado de Mure, ora a Franceschino degli Albizzi» (ivi, pp. 75-77, cui rinvio per maggiori dettagli sul testo). Giuseppe Crimi NICCOLÒ POVERO E LA NUOVA EDIZIONE DELLA SECONDA MATTANA «Tra tanto infuriare di studi sul comico, finiremo come Margutte: scoppieremo delle risa»: così il 10 dicembre 1906 scriveva il giovane Ezio Levi (classe 1884), da Firenze, al suo maestro, Vittorio Rossi, per commentare una ripresa filologica e saggistica allora tanto fervida intorno alla letteratura comica1. Affermazione che, tutto sommato, si potrebbe sottoscrivere anche ai giorni nostri. Le considerazioni che seguono si originano dalla nuova edizione della seconda mattana (incipit: Sì duramente un sonno mi percosse) del giullare fiorentino Niccolò Povero, fatto conoscere ufficialmente per la prima volta proprio dal benemerito Levi nel 19082. Per i frequentatori meno assidui della rimeria giullaresca del Trecento, ricordo in modo rapido che i due componimenti in terzine del Povero (mattane, secondo la più corretta interpretazione dell’ultimo editore, Vittorio Celotto) costituiscono preziosi esempi di letteratura “alla burchia”, non distanti dall’esperienza dell’Orcagna sonettista, che Fabio Carboni ha riconosciuto nel pittore trecentesco3, e comunque antecedenti all’esperienza poetica del Burchiello. La recente edizione della seconda mattana del giullare, dovuta, appunto, a Celotto, permette di leggere e di citare un testo offerto finalmente con criteri filologici più rigorosi rispetto a quelli, pur meritori, di Levi. L’editore ha presentato, in anteprima, un corposo assaggio dell’articolo pubblicato successivamente in rivista con l’incremento di un’ampia discussione filologica, della nota linguistica e del commento al testo4. 1 La lettera è conservata presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma (= BUA), Carteggio Rossi, cassetta 49, dalla quale provengono anche le citazioni delle altre missive. 2 E. Levi, Le paneruzzole di Niccolò Povero (contributo alla storia della poesia giullaresca nel medioevo italiano), «Studi medievali», III, 1908, 1, pp. 81-108, poi con il titolo Niccolò Povero, giullare fiorentino in Id., Poesia di popolo e poesia di corte nel Trecento, Livorno, Giusti, 1915, pp. 77-114 (da cui si cita). 3 F. Carboni, L’Orcagna e il Frusta, «Cultura neolatina», LXIX, 2009, 1-2, pp. 111-165. 4 V. Celotto, Tra nonsense e folklore. Niccolò Povero e la medicina alla rovescia, in Recipe… Pratiche mediche 102 giuseppe crimi Sarà opportuno precisare che le mattane hanno conosciuto una loro storia critica. Cominciamo col dire che alla scoperta di Levi, in Italia, fu assegnato il giusto rilievo nella Cronaca del «Giornale storico della letteratura italiana»5, mentre ancor più estesa si presentava la scheda apparsa sulla «Rassegna bibliografica della letteratura italiana»6. Una brevissima recensione, in un periodico tedesco, questa volta, fu scritta da Berthold Wiese7. Grazie a Levi il Povero guadagnò l’ingresso ufficiale nelle storie letterarie: Natalino Sapegno incluse il giullare con alcuni suoi versi nel prestigioso Trecento 8. Dopo un periodo di oblio, i testi furono riportati all’attenzione degli studiosi, negli anni Sessanta del Novecento, grazie a Giuseppe Cocchiara9. Quasi certamente dalla lettura di Cocchiara Piero Camporesi ha avuto accesso al Povero, citato a più riprese10. Un saggio di sicuro spessore è stato scritto da Rosanna Brusegan, la quale ha accostato le soluzioni del nostro giullare alla tradizione francese, con acquisizioni che restano ancora valide, se i riscontri vengono riproposti dallo stesso Celotto11. Tito Saffioti ha ripubblicato le due mattane nel suo volume dedicato ai giullari, che peraltro, da poco, ha visto una nuova edizione12. Contemporaneamente anche Antonio Lanza, negli stessi anni Novanta, ribadiva l’importanza del Povero per la ricostruzione della storia della poesia burchiellesca13. cosmetiche e culinarie attraverso i testi (secoli XIV-XVI), a cura di E. Treccani e M. Zaccarello, Verona, Cierre Grafica, 2012, pp. 115-154 e Id., Un precedente poco noto della ricetta medica burchiellesca. La «mattana» di Niccolò Povero «Sí duramente un sonno mi percosse», «Filologia e critica», XXXVII, 2012, pp. 64-113. 5 Cronaca, «Giornale storico della letteratura italiana», LIII, 1909, pp. 450-478, a p. 451. 6 Cronaca, «Rassegna bibliografica della letteratura italiana», XVII, 1909, 7-8-9, pp. 264-265. 7 B. Wiese, «Literatur für germanische und romanische Philologie», XXXI, 1910, coll. 30-31. 8 N. Sapegno, Il Trecento, Milano, Vallardi, 19814, p. 573. 9 G. Cocchiara, Il mondo alla rovescia, presentazione di P. Camporesi, Torino, Boringhieri, 1981 (I ed. 1963), pp. 141-145. Cfr. G.B. Bronzini, Poesia popolare e giullaresca come particolari forme minori della letteratura, in Il «Minore» nella storiografia letteraria, Atti del convegno internazionale, Roma, 10-12 marzo 1983, a cura di E. Esposito, Ravenna, Longo, 1984, pp. 365-382, a p. 374, che si può leggere in altra forma con il titolo Poesia popolare e poesia giullaresca, «Lares», LX, 1994, 4, pp. 467-481, a p. 475. 10 Cfr., ad esempio, P. Camporesi, Il paese della fame, Milano, Garzanti, 2000 (I ed., Bologna, Il Mulino, 1978), p. 89, Id., La maschera di Bertoldo. Nuova edizione rivista e aumentata, Milano, Garzanti, 1993, p. 117 e note 15-16, e Id., Introduzione a G.C. Croce, Le astuzie di Bertoldo e le semplicità di Bertoldino, a cura di P. Camporesi, Milano, Garzanti, 2004 (I ed. 1993), pp. 7-77, a p. 40. 11 R. Brusegan, La farmacia del giullare. Ricette, reliquie e discorsi da vendere, in Atti dell’XI Convegno di studio del Centro di studi sul teatro medioevale e rinascimentale di Viterbo sul tema “Il contributo dei giullari alla drammaturgia italiana delle Origini” (17-19 giugno 1977), Roma, Bulzoni, 1978, pp. 259-275, ed Ead., La medicina dell’impossibile, «Paragone. Letteratura», XXXII, 1981, 380, pp. 5-24. 12 T. Saffioti, I Giullari in Italia. Lo spettacolo, il pubblico, i testi, Milano, Xenia, 1990, pp. 445-457 (la seconda mattana alle pp. 451-457); la nuova ed. è uscita per i tipi della napoletana Liguori nel 2012 (il secondo componimento alle pp. 421-427). Si segnala anche il recente saggio di S. Pietrini, I giullari nell’immaginario medievale, Roma, Bulzoni, 2011; sulla poesia popolare da ultimo C. Giunta, Poesia popolare, poesia d’arte, «Studi mediolatini e volgari», LVI, 2010, pp. 217-243. 13 Cfr. A. Lanza, Il pungiglione della poesia aulica e la sua battaglia con monna Malinconia, in C. Angiolieri, Le rime, a cura di A. Lanza, Roma, Archivio Guido Izzi, 1990, pp. VII-LVI, a p. LV, A. Lanza, L’epopea niccolò povero e la nuova edizione della seconda mattana 103 Va reso il merito a Claudia Peirone, in uno studio capillare sulla terza rima, di aver evidenziato con chiarezza i rapporti con Burchiello e con la tradizione della medicina alla rovescia, integrando le osservazioni di Levi e Brusegan14. Di recente Niccolò Povero è stato riproposto al grande pubblico grazie alle pagine di Alessandro Bencistà15. Da parte sua l’editore del Pataffio, Federico Della Corte, in maniera condivisibile ha accostato il poemetto in terza rima, di probabile paternità sacchettiana, alle mattane 16. Nello stesso anno dell’edizione del Pataffio, chi scrive ha cercato di mettere in luce il valore pre-burchiellesco delle mattane, rapportandole con i precedenti mediolatini e volgari17. Appare tuttavia curiosa e meritevole di osservazione la strada percorsa da Levi prima di approdare alla pubblicazione definitiva del contributo. Una manciata di lettere inedite ci può fornire un primo assaggio. Di Rossi Levi era stato allievo e non è escluso che egli abbia ricevuto indicazioni preliminari sul giullare proprio dal maestro18: l’estratto del saggio in rivista sul Povero, conservato presso la Biblioteca Alessandrina (Fondo Vittorio Rossi, Misc. 127/11), reca la dedica «13. 2. ’09 | Al mio Maestro | Prof. Vittorio Rossi | con grande affetto | E[z]io Levi». Al 1° giugno 1908 risale la prima testimonianza che ho rinvenuto nella quale Levi parla del lavoro sul Povero. Il giovane filologo mantovano scrive da Berlino, città in cui risiedeva da qualche tempo: […] Vorrei comporre anche un articoletto su Le due panieruzzole di Niccolò Povero; tutto è pronto; mi manca solo questo libro, che non mi riesce di avere a Berlino: S. SalomoneMarino, La baronessa di Carini. Ne ho bisogno, perché il S.-M. deve parlare del Medicu Riversu un poemetto popolare, affine alla Panieruzzola IIa, poemetto che ho potuto studiare a Firenze al Museo Etnografico nella Raccolta D’Ancona, che il D’Ancona e il Loria mi degli omosessuali fiorentini e dei tradizionalisti citrulli, in S. F iniguerri detto il Z a , I poemetti, a cura di A. Lanza , Roma, Zauli Arti Grafiche, 1994, pp. 9-19, a p. 12, A. Lanza, La letteratura tardogotica. Arte e poesia a Firenze e Siena nell’autunno del Medioevo, Anzio, De Rubeis, 1994, p. 471, e ancora le integrazioni dello stesso studioso in V. Rossi, Storia della letteratura italiana, edizione rivista e ampliata sotto la direzione di A. Lanza e a cura di F. Casari, presentazione di A. Lanza, Padova, Piccin, 2009, pp. 250 e 301. 14 C. Peirone, Storia e tradizione della terza rima. Poesia e cultura nella Firenze del Quattrocento, Torino, Tirrenia Stampatori, 1990, pp. 19-21. 15 A. Bencistà, Le “paneruzzole” di Niccolò Povero, in Id., L’ambulante scuola. Poesia popolare ed estemporanea in Toscana, prefazione di M. Zoppi, Firenze, Semper, 2004, pp. 79-83. 16 F. Della Corte, Periplo del Pataffio. Per un quadro storico-critico, in F. Sacchetti, Il Pataffio, edizione critica a cura di F. Della Corte, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2005, pp. XI-L, a p. XIX. 17 G. Crimi, L’oscura lingua e il parlar sottile. Tradizione e fortuna del Burchiello, Manziana, Vecchiarelli, 2005, pp. 128-163. Da ultimo, sulla prima mattana, A. Parenti, Arzigogolo, «Lingua nostra», LXXII, 2011, 3-4, pp. 88-98, alle pp. 97-98. 18 Su Levi C. Segre-A. Varvaro, Ezio Levi D’Ancona, Napoli, Società nazionale di scienze lettere e arti, 1986, A. Motta, Levi, Bonucci e l’enigma Volpini, «Studi e problemi di critica testuale», 67, 2003, pp. 19-42, p. 23 nota 11, L. Levi, Ricordo di Ezio Levi, «Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti. Atti e Memorie», n. s., LXXV, 2007, pp. 229-255 e Id., Ezio Levi. Postille, ivi, LXXVI, 2008, pp. 199-217. 104 giuseppe crimi avevano messa a piena disposizione. Dove potrei trovarlo? A Firenze non c’è e a Palermo è in prestito […]19. Il 1° luglio, da Berlino, Levi si rivolge nuovamente a Rossi: […] per Niccolò Povero ho finito lo studio comparativo dei tre manoscritti di quelle panzane e tra poco potrò varare un opuscoletto. La ringrazio della premura con la quale Ella ha voluto cercarmi la baronessa di Carini; ora non si dia più pena, dacché dopo molto cercare ho scovato a Berlino anche quel libricciuolo. Ma non vi ho ritrovato quello che mi premeva, qualche notizia biografica di Antonio Zacco, poeta popolare catanese del ’500. Mi vorrebbe Ella indicare qualche lavoro speciale? […]20. Ancora Levi al maestro, da Berlino, il 4 agosto 1908: «[…] Al Giornale Storico darò un lavoro su Adriano de’ Rossi; al Libro e la Stampa quell’altro su Niccolò Povero. E così verrò sfollando la troppo stipata materia […]». Il 29 novembre 1908, da Milano, Levi comunica il cambio di destinazione: «[…] Ho dato agli Studi Medievali un primo Contributo alla Storia della poesia giullaresca nei primi secoli della nostra letteratura; nel prossimo fascicolo vorrei continuare con un secondo contributo col titolo Lettere di giullari del Trecento o a loro dirette. Ho tra mano un epistolario assai curioso […]»21. Quindi una storia editoriale non proprio lineare. Certo è che, per quanto Levi avesse lavorato ai testi, anche lo stesso Rossi – come vedremo – aveva raccolto informazioni sulle mattane. Il testo critico della seconda mattana stabilito da Celotto è preceduto da uno studio che rende conto del motivo della medicina alla rovescia e delle varie componenti che animano il testo22. Dopo aver rinvenuto un possibile personaggio storico menzionato nelle lettere di santa Caterina da Siena e sovrapponibile al nostro giullare (siamo nella seconda metà del Trecento)23, Celotto si sofferma sul lessico tecnico impiegato nella seconda mat- Cfr. Levi, Niccolò Povero, giullare fiorentino, cit., p. 100, note 1 e 2. Cfr. ivi, pp. 100-102. 21 Si ricordi che il titolo del saggio apparso in rivista era Le paneruzzole di Niccolò Povero (contributo alla storia della poesia giullaresca nel medioevo italiano). 22 Celotto, Tra nonsense e folklore, cit., pp. 115-146 e Id., Un precedente poco noto della ricetta medica burchiellesca, cit., pp. 64-73. Il motivo della medicina alla rovescia recentemente ha fatto registrare un altro significativo contributo, quello di M. Villoresi, L’allegra medicina. Ricette, terapie, consigli nella letteratura comica toscana, «Paragone. Letteratura», 96-97-98, 2011, pp. 93-111. Ricordo anche i versi pasquineschi: «Iacobaccio allor fece un serviziale, / el Ponzetta ordinò la medicina / di grasso di mosconi e di cicale / e raglio di somaro in gelarino, / suon di campane e succo di pitale / e stemperato ovolo di gal‹l›ina / e fumo di calcina / quando si spegne ed un grillo stillato, / che molto è cordïal a l’amalato», in Pasquinate romane del Cinquecento, a cura di V. Marucci, A. Marzo e A. Romano, presentazione di G. Aquilecchia, 2 tt., Roma, Salerno Editrice, 1983, t. I, p. 232 (243, vv. 9-17). 23 Appare necessario riproporre le riflessioni di Mario Chiesa, il quale ha accostato il nome di Niccolò Povero a quello di Limerno Pitocco, facendo osservare che «se, come suppose il Levi, “Povero” è nomignolo che i “contemporanei gli appiccicarono”, avremmo la prova che sinonimi di pitocco erano usati per designare cantori di piazza» (M. Chiesa, Introduzione a T. Folengo, Orlandino, a cura di M. Chiesa, Padova, Antenore, 1991, pp. VII-XLIV, a p. XXVII). 19 20 niccolò povero e la nuova edizione della seconda mattana 105 tana, debitore dei trattati medici coevi. Nel primo contributo citato, nello specifico, viene proposta una lettura della mattana alla luce dei riscontri con testi in versi affini. Ma veniamo all’aspetto ecdotico, che qui più interessa: lo studioso segnala tre manoscritti che tramandano l’opera, ossia Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II IV 344, cc. 94r-95r (= F); Firenze, Biblioteca Marucelliana, C 155, cc. 64r-v (= M) e Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberiniano Latino 3936, già XLV 30, cc. 34v-39r (= Vb3), e una stampa, la nota pseudo-londinese del Sonetti del Burchiello, del Bellincioni e d’altri poeti fiorentini alla burchiellesca, Londra, s.e. [ma Livorno, Masi], 1757, pp. 177-185 (= V)24. Nella recensio, rispetto all’edizione Levi, pertanto, Celotto aggiunge M25, Vb3, di cui Zaccarello aveva pubblicato alcuni versi26, e la suddetta stampa V. L’edizione moderna della mattana consta di duecentodieci versi27. Celotto, dopo aver discusso il rapporto tra i testimoni, opta per la scelta di F come il manoscritto più autorevole e utile per l’edizione: […] Lo studio della tradizione non consente di dimostrare l’esistenza di un archetipo per l’assenza di errori significativi comuni a tutti i testimoni. L’analisi degli errori comuni, affiancata allo spoglio di serie di varianti condivise, consente al più di dividere le testimonianze in due gruppi, dotati di un certo grado di stabilità e omogeneità della veste redazionale: α (rappresentato dai mss. F e M) e β (Vb3 e V suo descritto). Venendo a mancare qualsiasi criterio automatico di scelta della lezione, l’esame delle varianti caratteristiche dei due raggruppamenti ha permesso di individuare il carattere innovante di molte lezioni del gruppo β, e ha imposto dunque di fondare l’edizione sul ms. F (vista anche la grave lacuna di M), testimone più autorevole dal punto di vista della posizione nell’ordinamento, bisognoso di correzioni poco onerose e in numero non elevato […]28. Per tornare a Rossi, allo studioso veneto erano ben note le mattane: tra gli studi preparatori all’edizione del Burchiello29, da M, cc. 56r-v egli aveva trascritto inteDescrizioni analitiche in Celotto, Un precedente poco noto della ricetta medica burchiellesca, cit., pp. 73-76; preciso che l’esemplare dell’edizione settecentesca consultato da Celotto (BUA, AE s 65) è appartenuto a Vittorio Rossi e reca le sue annotazioni. 25 È singolare il fatto che Levi abbia utilizzato M, contenente entrambe le mattane, soltanto per l’edizione del primo testo (cfr. Levi, Niccolò Povero, giullare fiorentino, cit., pp. 80 nn. 4 e 8, e 85; il rilievo appartiene a Celotto, Un precedente poco noto della ricetta medica burchiellesca, cit., p. 76). 26 M. Zaccarello, Una forma istituzionale della poesia burchiellesca: la ricetta medica, cosmetica, culinaria tra parodia e nonsense, in «Nominativi fritti e mappamondi». Il nonsense nella letteratura italiana. Atti del convegno, Cassino, 9-10 ottobre 2007, a cura di G. Antonelli e C. Chiummo, Roma, Salerno Editrice, 2009, pp. 47-64, a p. 59. 27 Celotto, Tra nonsense e folklore, cit., pp. 148-154 e Id., Un precedente poco noto della ricetta medica burchiellesca, cit., pp. 96-112. 28 Celotto, Tra nonsense e folklore, cit., pp. 147-148; si veda anche Id., Un precedente poco noto della ricetta medica burchiellesca, cit., p. 81. 29 Al proposito G. Crimi, «L’augurio se lo portò il vento». L’edizione del Burchiello preparata da Vittorio Rossi, «Letteratura italiana antica», VII, 2006, pp. 355-403. 24 106 giuseppe crimi gralmente il primo capitolo (BUA, Misc. Rossi A, fasc. 4, cc. 17v-19v) e i primi e gli ultimi versi del secondo (ivi, c. 20r), ma, soprattutto, aveva individuato anche Vb3 (fasc. 35/4, c. 15r), testimone del capitolo incluso nella scheda dei componimenti burchielleschi dubbi (fasc. 10, c. 82r), nella quale aveva provveduto a indicare anche la collocazione nella stampa pseudo-londinese; inoltre, il capitolo tràdito da Vb3 era stato collazionato con il testo a stampa nell’ed. pseudo-londinese (fasc. 31/24, cc. 16-17r)30. Tuttavia, non so stabilire se questi appunti siano antecedenti o successivi agli studi di Levi. Va specificato che Levi – il quale pure menzionò il ms. Vaticano in un paio di occasioni31 – non se ne servì per lo studio sul Povero. Per rendere più ampia la recensio, va aggiunto che la seconda mattana è tràdita anche dal ms. Vat. Barberiniano Latino, 3989 (già XLV 83), cc. 75v-79r (= Vb4), che contiene Poesie diverse volgari raccolte da Leone Allacci, già stampate dall’istesso (come scritto al recto della seconda carta di guardia): pur essendo incluso tra vari sonetti burchielleschi, il capitolo presenta soltanto la rubrica «Medicine». Di fatto, non sembra scoperta eclatante, trattandosi di un descriptus dell’altro Vaticano32. Ad ogni modo l’assegnazione al Burchiello andrà riconosciuta a monsignor Allacci, il quale trascrisse l’incipit del capitolo con paternità al barbiere di Calimala nel ms. Vat. Barberiniano Latino 3088, c. 93r (Sì duramente un sompno mi percosse Burchiello). In più non sarà inutile ricordare che il capitolo era stato edito, già nel Seicento, appunto, da Allacci nei Poeti antichi (= Al)33: la pubblicazione non era sfuggita al Su questo manoscritto ivi, pp. 363, 370 e 377. E. Levi, Francesco di Vannozzo e la lirica nelle corti lombarde durante la seconda metà del secolo XIV, Firenze, Galletti e Cocci, 1908, p. XVII. Si veda anche Id., Un giullare del Trecento: Zaffarino (1909), in Id., Poesia di popolo e poesia di corte nel Trecento, cit., pp. 45-59, a p. 58 n. 5. 32 Descrizione in D. De Robertis, Censimento dei manoscritti di rime di Dante, «Studi danteschi», XLII, 1965, pp. 419-474, a pp. 427-428; F. Carboni, Inventario e indice bibliografico della lirica italiana due-trecentesca nei fondi manoscritti vaticani e nazionali (Saggio), «Cultura neolatina», XXXIV, 1974, 2, pp. 251-326, a p. 251 nota 1; M. Messina, Per l’edizione delle Rime del Burchiello. I. Censimento dei manoscritti e delle stampe, «Filologia e critica», III, 1978, pp. 196-296, a p. 253, dove naturalmente si specifica che il ms. corrisponde a un descriptus di Vb3. Si tratta molto con ogni probabilità di un autografo di Allacci: cfr. C. Giunta, La tenzone tra ser Luporo e Castruccio Castracani, «Studi di filologia italiana, LX, 2002, pp. 5-34, a p. 19 e nota 23. Di fatto, Zaccarello aveva lasciato intendere come anche Vb4 fosse latore del capitolo: si veda M. Zaccarello, Introduzione, a I sonetti del Burchiello, edizione critica della vulgata quattrocentesca a cura di M. Zaccarello, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2000, pp. XIII-CXXXII, a p. XLIV nota 3: «Che questa (i.e. la ricetta medica) fosse una maniera caratteristica del B., e come tale posta in risalto dai copisti, lo dimostra il fatto che in Vb3 e Vb4 i Sonetti sono seguiti senza soluzione di continuità dalle Medicine in terza rima, che passano (probabilmente dagli stessi Barberiniani) alla vulgata settecentesca (pp. 177-185)». 33 Poeti antichi raccolti dai codici m.ss. della Biblioteca Vaticana e Barberina, Napoli, per Sebastiano Allacci, 1661, alle pp. 143-152, dal suddetto ms. Vaticano (rubrica: Del Burchiello da Fiorenza. Medicine). L’indicazione si trova anche in BUA, Carte Vittorio Rossi, Cassa A, fasc. 10, c. 82v (rinvio bibliografico a inchiostro rosso). 30 31 niccolò povero e la nuova edizione della seconda mattana 107 Crescimbeni34, da cui ricavava le stesse informazioni il Mazzuchelli35; un’ulteriore segnalazione si deve a Pietro Bilancioni36. Una rapida collazione permette di osservare che Vb3 e Vb4 sono apparentati: ciò che posso affermare limitatamente al nostro testo è che la redazione del secondo manoscritto deriva molto probabilmente da quella del primo; Vb4, inoltre, non deriva dalla stampa, anzi sembrerebbe proprio il contrario. La stampa settecentesca V non attinge a Vb3, ma alla stampa Al, a sua volta esemplata su Vb4. Soltanto due casi che mi sembrano i più eloquenti per indicare la trafila. In corrispondenza dell’attuale v. 60, Vb3 reca Bollire al vento, e no(n) dire i mi scosto (c. 36r), Vb4 Bollire al vento e no(n) dir i mi scosto (c. 76v), che in Al diventa Bollire al vento, e non dir i scosto (p. 145), e che in V subisce un’ulteriore corruttela, Bollire al vento, e non andar discosto (p. 179); secondo caso: in corrispondenza del v. 137, Vb3 e Vb4 recano la lezione iscodielier (rispettivamente cc. 37v e 78r), che in Al diventa scudichier (p. 149) e in V scudiscier (p. 182)37. Quanto poi alla diffusione, Alessio Decaria ha segnalato che i vv. 13-15 della seconda mattana («Imprimamente, la sua vertù cresce, / ché uno partito dàne maccatelle, / e to’ la in tre, rizando a spinapesce») possono aver agito sul componimento di Francesco d’Altobianco Alberti, Quella habbundante grazia che procede, vv. 52-54: «Alle volte gl’incontra, a·cchi perde esce, / che, perché la faccenda il serve bene, / l’acoglie in tre rizzando a spinapesce»38. 34 G.M. Crescimbeni, L’istoria della volgar poesia, Roma, per il Chracas, 1698, p. 48: «E finalmente di stil burlesco, oltre il famoso Capitolo delle Medicine del Burchiello Barbier di Fiorenza, che fiorì circa il 1480 stampato nella Raccolta dell’Allacci, avvi Terze Rime d’Antonio Pucci Gentiluomo Fiorentino». 35 G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia […], vol. II, pa. IV, Brescia, Bossini, 1763, p. 2435 e nota 48. 36 Cfr. C. e L. Frati , Indice della carte di Pietro Bilancioni, «Il Propugnatore», vol. II, 1889, pa. II, pp. 271-355, a p. 345 n. 307; la precisazione anche in M essina, Per l’edizione delle Rime del Burchiello, cit., pp. 288-289, in part. p. 289. 37 Inoltre, in corrispondenza del v. 69, Vb3 e Vb4 recano du sbastoni rispettivamente cc. 36r e 76v) che in Al e V diventano dui bastoni (pp. 149 e 180). Cfr. Celotto, Un precedente poco noto della ricetta medica burchiellesca, cit., pp. 89-90: «Che la testimonianza di V relativa a Sí duramente dipenda da quella di Vb3 (per via diretta o per il tramite di quale interposito) è dimostrabile sulla base degli elementi che si sono già visti. La concordanza pressoché costante dei due testimoni si interrompe in pochi casi in cui errori peculiari di Vb3, non separativi perché tutti facilmente emendabili per congettura, non vengono ricevuti da V, i cui concieri però in più casi si dimostrano comunque rivelatori di una dipendenza […]. Se gli errori comuni che si sono visti e la concordanza in lezioni caratteristiche e interpolazioni rivelano una sicura derivazione di V dalla silloge tardo quattrocentesca, l’azione congiunta degli errori peculiari di Vb3 e delle lezioni singolari di V spinge a tenere in considerazione l’ipotesi di interferenze occasionali, derivanti, oltre che da probabili interventi congetturali, dalla consultazione di altre fonti, con ogni probabilità pur sempre prossime all’ambito di β». 38 F. d’Altobianco Alberti, Rime, edizione critica e commentata a cura di A. Decaria, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2008, p. 181 e nota ad locum a p. 187; si può aggiungere che «a spinapesce» in clausola si trova anche in Lorenzo de’ Medici, Simposio, IV, 50: «ad onde balenando a spinapesce» (in Id., Tutte le opere, a cura di P. Orvieto, Roma, Salerno Editrice, 1992, vol. II, p. 626; nell’ed. delle Poesie a cura di F. Sanguineti, Milano, Rizzoli, 20012, nella nota ad locum a p. 142 si rinvia al capitolo in terza rima attribuito, secondo la pseudo-londinese, a Burchiello). Per la spiegazione Celotto, Un precedente poco noto della ricetta medica burchiellesca, cit., p. 98 nota ad locum. 108 giuseppe crimi Le brevi considerazioni espresse, tuttavia, non spostano naturalmente di un millimetro la questione sostanziale relativa alla fissazione del testo, per la quale non possiamo che essere grati a Celotto. I testimoni qui segnalati risultano descripti, così se essi appaiono inutili per stabilire il testo critico, rivestono un loro interesse per prendere atto della fortuna dei versi, che hanno conosciuto una circolazione probabilmente più ampia rispetto a quella oggi nota e supposta. Margherita Centenari «PRENDERE PERSONA DI GRECO». PER UNA RILETTURA DELL’INNO A NETTUNO DI GIACOMO LEOPARDI TRA ERUDIZIONE, TRADUZIONE E MODA LETTERARIA* All’altezza della primavera del 1816, nonostante la giovane età, Giacomo Leopardi aveva già saggiato le proprie doti di poeta e scrittore affrontando molti e diversi generi letterari, ma mai fino ad allora si era cimentato nella composizione di un falso, un tipo di esperimento che in varie forme avrebbe più volte fatto ritorno nella sua produzione successiva1. L’Inno a Nettuno d’incerto autore, composto a soli diciotto anni, costituisce insieme alle Odae Adespotae – che ne rappresentarono fin dagli inizi una sorta di appendice2 – la prima contraffazione che egli sottopose ai propri lettori, celandone la vera natura. Il poemetto venne infatti diffuso come il volgarizzamento in versi di un presunto inno greco ritrovato in un codice di età medievale da un * Ringrazio Giovanni Antonio Benedetto, Christian Genetelli, Franco Longoni e Massimo Magnani per l’interesse che hanno dimostrato per il mio lavoro e per i loro preziosi consigli. 1 Dopo la stesura, tra il 1816 e il 1817, dell’Inno a Nettuno e delle Odae Adespotae, Leopardi produsse un altro falso che, a sua volta, non mancò di ingannare lettori assai esperti: il Martirio de’ santi padri del monte Sinai, il cui testo, redatto in volgare trecentesco nell’autunno del 1822, venne poi edito nel 1826, suscitando largo clamore in ambiente purista (cfr. S. Covino, Giacomo e Monaldo Leopardi falsari trecenteschi. Contraffazione dell’antico, cultura e storia linguistica nell’Ottocento italiano, 2 voll., Firenze, Olschki, 2009; più in generale, sui falsi leopardiani, cfr. R. Damiani, Leopardi falsificatore, in Contrafactum. Copia, imitazione, falso. Atti del XXXII convegno interuniversitario, Bressanone/Brixen 8-11 luglio 2004, a cura di A. Andreose e G. Peron, Padova, Esedra, 2008, pp. 221-228). Accanto a questi episodi di vera e propria contraffazione, vanno poi menzionati i più scoperti apocrifi, o “falsi d’autore”, rappresentati dal Cantico del gallo silvestre e dal Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco, risalenti al biennio 1824-1825, nei quali Leopardi volle intrattenere con il lettore un sottile e divertito gioco di travestimento, ricorrendo al diffuso espediente del ritrovamento di oscuri codici manoscritti contenenti antichissime opere perdute – lo stesso escamotage, tra l’altro, che egli aveva già utilizzato in gioventù proprio per Inno e Odae. 2 Nell’editio princeps dei componimenti («Lo Spettatore Italiano», 1° maggio 1817, t. VIII, quad. LXXV, pp. 142-165) le due Odae – Εἰς Ἔρωτα e Εἰς Σελήνην – seguivano direttamente il testo dell’Inno a Nettuno d’incerto autore nuovamente scoperto. Traduzione dal greco del conte Giacomo Leopardi da Recanati. Cfr. anche infra, nota 16. 110 Margherita Centenari anonimo Ciamberlano di S.[ua] M.[aestà] I.[imperiale] R.[eale] A.[postolica], Cavaliere dell’Ordine Gerosolimitano, amico di Leopardi e dedicatario dell’opera3. Stando alla messinscena, lo scopritore del manoscritto, impegnato nell’emendazione e nella stesura dell’edizione critica del testo antico, ma ugualmente intenzionato a renderne al più presto disponibile al pubblico una versione volgare, ne avrebbe commissionato al giovane sodale recanatese la realizzazione. Questi aveva corredato il proprio lavoro di un ampio e dottissimo apparato di note erudite, nonché di un Avvertimento ai lettori, nel quale si fornivano nientemeno che il titolo del componimento – Τοῦ αὐτοῦ Εἰς Ποσειδῶνα – e l’originale greco del primo e dell’ultimo verso4. Avvertimento e Note costituivano dunque il ricco corollario ideato da Leopardi per avvalorare l’autenticità di un testo poetico che si presentava ai lettori composto da ben 203 endecasillabi sciolti (traduzioni dei corrispondenti esametri immaginari), suddivisi in cinque sezioni di differente estensione, ognuna aperta da un distico, spesso combinato in forma di domanda retorica e recante in sintesi l’argomento dell’intera stanza o di una parte consistente di essa5. Così articolato, l’Inno sviluppava una lunga e variegata serie di Per la dedica, cfr. G. Leopardi, Canti e poesie disperse, edizione critica diretta da F. Gavazzeni, 3 voll., Firenze, Accademia della Crusca, 2009, vol. III: Poesie disperse, edizione critica diretta da F. Gavazzeni, coordinata da P. Italia, a cura di C. Catalano et alii, p. 233 (d’ora in poi solo Poesie disperse, edizione di riferimento per il testo dell’Inno). Maria Antonietta Terzoli ha giustamente individuato nella Notizia intorno a Didimo Chierico, associata alla traduzione foscoliana del Sentimental Journey, un suggestivo parallelo della dedica dell’Inno: «stampata alla fine della traduzione del Viaggio sentimentale nel 1813, la Notizia era stata riproposta con notevoli varianti nell’edizione dell’Ipercalisse uscita a Zurigo nei primi mesi del 1816. In questa seconda edizione tra l’altro – coincidenza davvero curiosa – l’editore Lorenzo Alderani, nell’intestazione di una lettera premessa da Didimo alla sua visione, è insignito proprio del titolo di Cavaliere Gerosolimitano: “Didymus Clericus / M. I. Rainero Eq. Hier. Sal.”» (M.A. Terzoli, Nell’atelier dello scrittore. Innovazione e norma in Giacomo Leopardi, Roma, Carocci, 2010, pp. 53-54). Accanto a questo possibile riferimento – sostenuto anche dalla presenza di una copia dell’opera foscoliana nella biblioteca di Palazzo Leopardi (cfr. ivi, pp. 53-54, nota 40) – non va tralasciato il fatto che Giacomo, fregiando l’anonimo dedicatario dell’Inno del titolo di Cavaliere di Gerusalemme, avrebbe anche potuto alludere a fatti o persone che ruotavano attorno alla sua stessa famiglia, con la probabile intenzione di dare maggior credito alla messinscena del ritrovamento: lo zio materno, Carlo Antici, era stato proclamato già nel 1782 Cavaliere dell’Ordine Gerosolimitano, congregazione che peraltro a Recanati aveva una della sue numerose sedi (cfr. C. De Rosa, Notizie di alcuni Cavalieri del Sacro Ordine Gerosolimitano illustri per lettere e per belle arti, Napoli, Fibreno, 18412, pp. 19-21). 4 Così nell’Avvertimento: «Un mio amico in Roma nel rimuginare i pochissimi manoscritti di una piccola biblioteca il 6 gennaio dell’anno corrente [curiosamente, il giorno dell’Epifania], trovò in un Codice tutto lacero, di cui non rimangono che poche pagine, quest’Inno greco; e poco appresso speditamene una copia, lietissimo per la scoperta, m’incitò ad imprenderne la traduzione poetica italiana, facendomi avvisato che egli era tutto atteso ad emendare il testo greco, a lavorarne due versioni latine, l’una letterale e l’altra metrica, e a compilare ampie note sopra l’antica poesia […]. Fu forza cedere; ed ecco che io do ad un’ora al Pubblico la nuova della scoperta, la traduzione dell’Inno in compagnia di alcune note, e la promessa di un’altra molto migliore edizione dello stesso greco componimento. L’Inno pare antichissimo, avvengachè il Codice non sembri scritto innanzi al trecento. Comincia nel greco così: Ἐννοσιγαῖον κυανοχαίτην ἄρχομ’ ἀείδειν. Termina con questo verso: Ἀμφ’ ἂρ’ ἀοιδοῖς βαῖν’, ὕμνων γὰρ τοῖσι μέμηλε» (Poesie disperse, p. 234). 5 Stanza I: vv. 1-73; II: vv. 74-102; III: vv. 103-152; IV: vv. 153-170; V: vv. 171-203. Data l’assenza di uno schema metrico che caratterizzi il poema, il riconoscimento di tali suddivisioni testuali dipende 3 «prendere persona di greco» 111 temi e motivi tradizionalmente attribuiti a Nettuno, che si susseguono e richiamano all’interno di uno schema compositivo rigidamente paratattico: dopo un breve prologo contenente l’evocazione della divinità (vv. 1-7), Leopardi giustappose ad una prima porzione testuale di natura narrativa (vv. 7-92) – dove si trovano rievocati la nascita del dio, l’acquisizione dei suoi poteri ed il racconto di alcuni suoi scontri con eroi e divinità – una seconda parte essenzialmente descrittiva (vv. 93-191), in cui vengono elencate le prerogative di Nettuno, i suoi amori e i figli, per lasciare infine spazio ad una preghiera per la salvezza dei naviganti e ad un saluto finale rivolto dalla voce narrante alla divinità (vv. 191-203). Molte delle notizie che riguardano la storia della composizione e della pubblicazione di questo audace scherzo letterario sono per lungo tempo rimaste confinate in varie carte autografe e in alcune pagine dell’epistolario leopardiano. Solo in anni assai recenti esse sono divenute l’oggetto di un’approfondita analisi condotta da Rossano Pestarino e confluita nella recente edizione critica delle Poesie disperse di Leopardi6, dalla quale si apprende che, dopo aver dato inizio alla stesura dell’Inno nel maggio del 1816, già nel novembre dello stesso anno, egli aveva deciso di registrarlo nell’indice delle proprie opere, al n. 8 dell’elenco, tra gli scritti di imminente pubblicazione7. Il testo era stato quindi da un dato puramente grafico, individuabile già nell’editio princeps dell’opera, dove il verso di apertura di ognuna delle cinque sezioni di testo risulta di poco indentato rispetto al margine della stampa. La stanza I è aperta dall’evocazione del dio («Lui che la terra scuote, azzurro il crine, / A cantare incomincio», vv. 1-2), a cui fa seguito il racconto della sua nascita e di una delle sue prime imprese. La seconda sezione, introdotta dai vv. 74-75 («Ma qual cagione a tenzonar ti mosse / Con Palla Diva occhi-cilestra?») narra la contesa tra Nettuno e Pallade; i vv. 103-104 («Qual però de le ninfe a te dilette, / Signor del mare, io canterò?») costituiscono l’esordio della terza stanza, che contiene un lungo catalogo di nomi di divinità minori associate al dio del mare; la quarta, aperta dall’apostrofe «Salve, o gran figlio di Saturno. Il tuo / Lucente cocchio è in Ega» (vv. 153-154) descrive Nettuno che solca il mare sul proprio carro divino; la quinta, infine, con i vv. 171-172 («Ma qual potrò chiamarti, o del tridente / Agitatore?») introduce un elenco di epiteti del dio seguito da una scena di tempesta e si chiude ancora con un distico, in cui la voce narrante prende congedo dalla divinità, pregandola di proteggere i poeti che hanno cura degli inni («O nume, salve, e con benigna mente / Proteggi i vati che de gl’inni han cura», vv. 202-203). 6 L’edizione dell’Inno è contenuta in Poesie disperse, pp. 159-262. In particolare la Storia del testo si trova alle pp. 165-173. 7 Il mese d’avvio della composizione si ricava dalla famosa lettera inviata da Leopardi a Giordani il 30 maggio del 1817, in cui il giovane dichiara: «È un anno e mezzo che io quasi senza avvedermene mi son dato alle lettere belle che prima non curava, e tutte le cose mie che Ella ha vedute ed altre che non ha vedute sono state fatte in questo tempo […]. E l’Inno però e le note col resto, l’ho scritto appunto un anno fa: in questi mesi non avrei potuto reggere a quella fatica» (G. Leopardi, Epistolario, a cura di F. Brioschi e P. Landi, 2 voll., Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 106; d’ora in poi solo Epist.), ma – si capisce – tale riferimento è troppo vago per essere assunto quale termine per una datazione rigidamente circoscrivibile, cfr. infra nota 96. Delle fasi di composizione precedenti la stampa rimangono solo due manoscritti conservati presso la Biblioteca di Casa Leopardi in Recanati e difficilmente databili: AR, autografo leopardiano, e P, vergato da Paolina; per una loro attenta descrizione, condizionata però dall’impossibilità di analizzarne autopticamente le carte, cfr. Poesie disperse, pp. 159-161. Per il testo completo dell’indice delle Opere di G. Leopardi del 16 Novembre 1816, cfr. G. Leopardi, Tutte le poesie, tutte le prose e lo Zibaldone, a cura di L. Felici e E. Trevi, Roma, Newton & Compton, 20105, pp. 1038-1039 (d’ora in 112 Margherita Centenari spedito al tipografo ed editore Anton Fortunato Stella il 21 febbraio del 1817 per essere stampato, insieme alle Odae, sulla rivista milanese «Lo Spettatore Italiano»8. La copia manoscritta del componimento, però, una volta inviata da Recanati alla tipografia, per un errore postale non giunse alla destinazione desiderata e fu invece recapitata a Giuseppe Acerbi, direttore della «Biblioteca Italiana», il quale si offrì subito di ospitare l’inedito sul proprio giornale9. L’equivoco venutosi così a creare venne risolto da Stella, che recuperò il manoscritto, pubblicandone il contenuto nell’aprile del 1817 e fornendone poi una seconda edizione, assai più corretta della prima e stampata su fascicoli autonomi, della quale egli promise di inviare al giovane autore 40 copie in omaggio10. Dopo l’uscita del testo, eccezion fatta per pochi riferimenti contenuti in alcune lettere risalenti al 181711, l’interesse leopardiano per il falso sembra progressivamente affievolirsi e addirittura scomparire almeno fino alla metà degli anni Venti: è proprio nel 1825 infatti che il poeta, soggiornando a Bologna, considerò la possibilità di ri- poi abbreviata TTP e utilizzata, salvo diverse indicazioni, come edizione di riferimento per tutte le opere leopardiane tranne Inno e Odae). 8 La missiva insieme alla quale Leopardi inviò a Stella il manoscritto contenente l’Inno e le Odae si trova di nuovo in Epist., pp. 55-57. 9 Cfr. la lettera inviata da Milano a Recanati il 12 marzo 1817 e quella di risposta spedita da Leopardi il 21 dello stesso mese (ivi, pp. 64-65, 67-68). Va detto che Acerbi, pur disponibile a concedere all’Inno uno spazio sulla rivista, aveva già intuito la natura della burla leopardiana, sostenuto in questo dal parere di un anonimo «Maestro» (forse Giordani, cfr. ivi, p. 2134) ed aveva riportato in una lettera al giovane autore alcune perplessità in merito al valore del presunto originale. 10 Leopardi ne richiederà alla fine «una decina e non più» (ivi, pp. 99-101). L’editio princeps dell’Inno sullo «Spettatore Italiano» e quella riedita poco dopo su fascicolo sono rispettivamente siglate SI17 e M17 in Poesie disperse, pp. 161-162, dove viene anche fornita per ciascuna una dettagliata scheda di presentazione. Sulle intricate ed enigmatiche vicende che riguardano la spedizione, il recupero e la pubblicazione del testo, vedi, oltre a quelle già menzionate, la lettera inviata da Leopardi al cugino Francesco Cassi il 17 ottobre del 1817 (Epist., p. 148) e, soprattutto, quelle che Stella, Acerbi e Leopardi si scambiarono tra il 21 marzo e il 19 aprile del 1817 (ivi, pp. 73-75, 79-81, 84-86 e 87-88). Un tentativo di spiegare l’errore postale è avanzato dagli editori dell’epistolario a p. 2134, dove si nota: «in realtà, almeno in un altro caso [scil. quello che riguarda l’invio da parte di Monaldo della Lettera ai Sigg. compilatori della Biblioteca Italiana in risposta a quella di Mad. la baronessa di Staël Holstein ai medesimi] era stato effettivamente spedito un manoscritto allo Stella perché lo trasmettesse all’Acerbi […]: l’errore può essere insorto per questo motivo». 11 Al 12 maggio del 1817 risale la missiva con la quale Giacomo, in vista della stampa dell’Inno su fascicolo – avvenuta probabilmente nel mese di giugno – comunica a Stella gli errata della prima edizione, raccomandandosi riguardo al greco (ivi, p. 100; per l’emendazione dei «54 spropositi» contenuti nella princeps, cfr. anche ivi, pp. 105-107, 112-113). Solo pochi giorni dopo, il 30 maggio, a distanza di circa un anno dall’inizio della stesura dell’opera, nella lettera inviata all’amico Giordani, egli ammette «che quanto […] spaccia della scoperta dell’Inno, è una novella», e si dichiara consapevole dello scarso valore del falso (ivi, pp. 106-107), che presto gli sarebbe parso «opera più tosto dell’ingegno che della fantasia e della facoltà poetica», Poesie disperse, p. 231, Per l’avvertimento da premettersi a un’altra edizione di quest’Inno (= AN3, cfr. infra, note 12 e 41). Una terza missiva, rivolta ancora a Giordani il 14 luglio 1817, nella quale Leopardi ironizza sulla fortuna che l’Inno aveva ottenuto a Roma, conserva pressoché l’ultimo riferimento al componimento rintracciabile nell’epistolario di questi mesi (Epist., p. 125). All’autunno, infatti, risalgono soltanto una lettera di ringraziamento allo Stella per la corretta riedizione dell’opera (ivi, p. 145) e la già ricordata epistola al Cassi, con la quale Leopardi omaggiava il cugino di una copia dell’Inno (ivi, p. 148). «prendere persona di greco» 113 pubblicare l’Inno prima nel volume dei Versi, e poi in quello delle Opere del Conte G. Leopardi. Com’è noto, l’edizione delle Opere non sarebbe mai stata realizzata, mentre è interessante considerare le vicende che riguardarono la tentata ristampa nei Versi (Bologna, Dalla Stamperia delle Muse, 1826), poiché esse testimoniano da parte di Leopardi una significativa ambiguità d’intenti. Secondo quanto rilevato da Pestarino, infatti, dopo essersi fatto spedire dal fratello Carlo parte del materiale utile all’allestimento dell’edizione12, egli sembrò dapprima voler pubblicare il testo privandolo del corposo apparato di note ad esso legato e rivelandone così la veste fittizia13, salvo poi smentirsi espungendo l’Inno dalla raccolta nell’edizione a stampa e presentandolo ancora come inedito antico nella notizia biobibliografica inviata poco dopo a Carlo Pepoli (ottobre 1826)14. Queste oscillazioni nel proporre l’opera ora come contraffatta ora come originale contribuiscono in maniera sostanziale a spiegare parte della tribolata vicenda editoriale del falso, che Leopardi non ripubblicò mai dopo il 1817: nelle incertezze nutrite dal poeta si rispecchia infatti il problematico statuto di un testo ritenuto dal suo stesso autore di difficile collocazione all’interno di un programma compositivo pur vario e multiforme come quello dei Versi, dove l’Inno non sembrava pienamente e coerentemente assimilabile né agli altri originali, né alle traduzioni presenti nella silloge. Diverse furono invece le ragioni che provocarono il fallimento degli ultimi tentativi di rieditare Inno e Odae prima della morte del poeta: innanzitutto non venne portata a termine la progettata edizione degli scritti filologici leopardiani a cura di De Sinner, nella quale i falsi avrebbero probabilmente trovato spazio come versioni di adespoti greci15; quindi, la censura borbonica interruppe la pubblicazione napoletana delle In merito all’invio dei materiali a Bologna si veda la lettera del 23 novembre 1825, con cui Leopardi richiede «il Virgilio e l’Inno postillati», cfr. Epist., pp. 1002-1005, spec. 1004 (ma si considerino anche le lettere di Carlo, 14 e 30 novembre 1825, ivi, pp. 994-995 e 1010-1013). L’esemplare dell’Inno mandato a Giacomo insieme ad un cartiglio recante una versione rivista dell’Avvertimento da premettere al falso (AN3), dovrebbe corrispondere all’autografo AN1, una copia di M17 contenente postille leopardiane al testo, forse già tutte presenti quando il manoscritto venne spedito al poeta, oppure almeno in parte frutto di un lavoro svolto successivamente. A questo stesso periodo bolognese pare risalire anche AN2, un foglietto autografo con una riscrittura, parte sul recto e parte sul verso, dei primi diciannove endecasillabi dell’Inno, traccia dell’inizio di un lavoro di ripubblicazione del testo ancora riconducibile ai Versi del 1826, cfr. Poesie disperse, pp. 170, 229-230 e R. Pestarino, Leopardi tra Canti e poesie «disperse», «Strumenti Critici», 125, 2011, n. 1, pp. 68-76. 13 Le intenzioni dell’autore sono testimoniate dalla stesura autografa della Prefazione alla raccolta dei Versi: «[…] si è tralasciato il lungo comento stampato in seguito dell’Inno a Nettuno quando questo fu pubblicato per ischerzo come tradotto dal greco», passo poi interamente cassato nella stampa (cfr. Poesie disperse, pp. 170-171). 14 Nella lettera al Pepoli Leopardi cita tra le sue pubblicazioni anche un «Inno a Nettuno (supposto) tradotto dal greco, nuovamente scoperto, con note e con appendice di due odi anacreontiche in greco, (supposte) nuovamente scoperte. Milano 1817» (Epist., pp. 1257-1258). 15 Compiacendosi dell’ambizioso progetto, il filologo svizzero suggeriva di includervi anche il falso, che significativamente mostrava di distinguere dagli altri scritti eruditi leopardiani, cfr. la lettera del 29 febbraio-8 marzo 1836, ivi, p. 2059. 12 114 Margherita Centenari Opere nel 1836. Dopo l’uscita della princeps, insomma, l’Inno sarebbe stato sottoposto a vari ripensamenti e riscritture da parte dell’autore, il quale, tuttavia, per ragioni tanto esterne quanto interne ad esso, non sarebbe più riuscito a dare una veste definitiva al proprio componimento16. La storia editoriale del falso successiva al 1817 spinge dunque, inevitabilmente, a riconoscere nella sua natura ibrida – non una traduzione, non una semplice compilazione erudita, né solo un originale poetico17 – la caratteristica di certo più significativa, ma anche più sfuggente dell’opera, che proprio a tale “inafferrabilità” – e, di conseguenza, alla difficile collocazione nella produzione dell’autore – deve almeno in parte la marginale posizione guadagnata in ambito critico. Tra le molteplici ragioni di questa scarsa fortuna, è comunque necessario considerare anche le parole con le quali Leopardi stesso – ad un solo anno di distanza dall’inizio della stesura del testo – confessava a Giordani il fallimento del proprio esperimento letterario, affermando con amarezza che la difficoltà di conciliare l’imitazione delle fonti classiche con la necessità di conferire ai propri versi l’aspetto di una traduzione, gli aveva «impastoiato e rallentato la mente» a tal punto da indurlo a fare «tutt’altro che poesia»18. Non è poi da escludere che, almeno per un certo periodo, il disinteresse per l’opera sia stato motivato dal giudizio tendenzialmente negativo che Francesco De Sanctis aveva espresso su gran parte della produzione giovanile dell’autore, alla quale anche l’Inno appartiene, considerandola di matrice prettamente erudita e di sostanziale intralcio alla scoperta e allo sviluppo della successiva vocazione poetica19. Date tali premesse, dunque, non stupisce rilevare che nella bibliografia leopardiana – tuttora priva di un contributo esauriente integralmente dedicato all’Inno – non sia possibile rintracciare che poche ed isolate osservazioni formulate attorno ad esso Esso verrà ripubblicato solo nel 1845, all’interno del vol. III dell’edizione delle Opere di Leopardi (Studi filologici, a cura di P. Pellegrini e P. Giordani, Firenze, Le Monnier, 1845); per le successive edizioni del testo rimando a Poesie disperse, p. 173. Si aggiunga a parte che le Odae non godettero di una sorte migliore: redatte contemporaneamente all’Inno e pure presentate come inediti antichi ricevuti dallo scopritore del manoscritto, queste due brevi anacreontee vennero composte direttamente in greco, accompagnate da una versione latina, corredate da un succinto apparato critico e stampate su «Lo Spettatore Italiano» consecutivamente al testo del falso, dovendone rappresentare una sorta di completamento (cfr. Poesie disperse, pp. 264-269). Anche se Leopardi vi rivolse la propria attenzione nel 1831, in vista dell’edizione fiorentina dei Canti (Firenze, Piatti), esse non vennero mai inserite nella raccolta (cfr. Poesie disperse, pp. 172 e 264-269 e Pestarino, Leopardi tra Canti e poesie «disperse», cit., pp. 66-68). Per un preliminare esame stilistico delle Odae, è ancora necessario rimandare agli ormai datati G. Pesenti, Le Odae Adespotae di G. Leopardi, «Atene e Roma», XVI, 1913, nn. 173-174, pp. 129-150 e M. Mazzocca, Per una interpretazione delle Odae Adespotae del Leopardi, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXXXIV, 1975-1976, pp. 525-541. 17 Dell’Inno a Nettuno come «testo “di crisi”, quasi cerniera tra i due momenti dell’erudizione e delle “lettere belle”» ha recentemente parlato lo stesso Pestarino, Leopardi tra Canti e poesie «disperse», cit., p. 75. 18 Cfr. la già citata lettera del 30 maggio 1817 (vd. supra nn. 7 e 11). 19 Cfr. F. De Sanctis, Leopardi, a cura di C. Muscetta e A. Perna, Torino, Einaudi, 1983, pp. 59-60, 80, 104, 489, 496-499. 16 «prendere persona di greco» 115 nel corso dell’ultimo cinquantennio20. Per quanto orientati nella direzione potenzialmente più produttiva per illuminare i caratteri fondamentali dell’opera, i decisivi studi di Sebastiano Timpanaro sul Leopardi filologo e quelli, di pur ampio respiro, dedicati da Hans Ludwig Scheel al rapporto tra il giovane poeta e l’antichità, hanno riservato all’Inno – tanto nell’esame del componimento, quanto in quello del suo apparato erudito – uno spazio assai limitato21. Maggior fortuna ha invece ottenuto la contraffazione nel settore d’indagine inaugurato dal saggio di Emilio Bigi, Il Leopardi traduttore dei classici (1814-1817), pubblicato nel 1964 e vòlto a considerare il valore eminentemente letterario delle versioni dal greco e dal latino redatte a ridosso della prima “conversione”. I numerosissimi contributi succedutisi fino ad oggi sulla strada segnata da Bigi hanno poi trovato un particolare motivo di interesse nei falsi del 1816, riconoscendo in essi uno degli esiti più radicali della ricerca stilistica intrapresa da Leopardi a mezzo delle traduzioni, ma, di nuovo, in merito all’Inno, non sono andati oltre qualche breve, sia pur talvolta illuminante, osservazione22. Lo stesso, infine, si potrà affermare anche 20 A mia conoscenza, il solo studio integralmente dedicato all’Inno leopardiano è F. Borio, Nota sull’Inno a Nettuno di Giacomo Leopardi, «Letteratura e società», 7, 2005, pp. 64-71, il quale, tuttavia, pure incentrato sull’influenza della fonte callimachea, dedica al testo poche e stringate riflessioni. 21 Rispettivamente, S. Timpanaro, La filologia di Giacomo Leopardi, Roma-Bari, Laterza, 19973, pp. 19-24 e H.L. Scheel, Leopardi und die Antike. Die Jahre der Vorbereitung (1809-1818) in ihrer Bedeutung für das Gesamtwerk, München, Max Hueber, 1959, pp. 139-143. Benché Timpanaro abbia dimostrato che l’ampio e dotto apparato dell’Inno contiene uno dei primi originali e significativi contributi leopardiani all’esegesi critica dei testi antichi (cfr. infra p. 109), non sembra che le sue brevi riflessioni sul falso abbiano finora suscitato tra gli studiosi un interesse bastevole a proseguirne ed approfondirne l’analisi. Quanto poi rilevato da Scheel in merito al trattamento delle fonti greche nell’Inno a Nettuno possiede tuttora valore, ma le sintetiche notazioni ad esso riservate rivelano il livello di suggestione a cui si era limitata la sua analisi e dimostrano contestualmente un interesse che, prescindendo dal valore del falso, era rivolto soprattutto ai riflessi delle contraffazioni del 1816 sulla produzione successiva (spec. p. 142). 22 Dopo quello di Bigi (E. Bigi, Il Leopardi traduttore dei classici (1814-1817), in Id., La genesi del Canto notturno e altri studi sul Leopardi, Palermo, Manfredi, 1967, pp. 11-80, già edito in «Giornale storico della letteratura italiana», CXLI, 1964, n. 434, pp. 186-234, da cui si cita), i contributi sulla traduttologia leopardiana che hanno riservato maggiore spazio all’Inno sono (in ordine di apparizione): S. Orlando, Il pessimismo antico nel Leopardi traduttore, in Studi in onore di Alberto Chiari, 2 voll., Brescia, Paideia, 1973, vol. II, pp. 911-973, spec. pp. 915-916, dove il movente della composizione è ricondotto alla volontà dell’autore di esibire la propria mens philologa; P. Fasano, L’entusiasmo della ragione. Il romantico e l’antico nell’esperienza leopardiana, Roma, Bulzoni, 1985, pp. 53-128, spec. 67-73, che presenta l’Inno come uno tra più interessanti sbocchi della ricerca linguistica e poetica testimoniata dalle traduzioni giovanili; E. Parrini Cantini, «M’inginocchio innanzi a tutti i letterati d’Italia»: Leopardi traduttore dell’Odissea, «Per Leggere», III, 2003, n. 4, pp. 75-117, spec. pp. 101-102, in cui si rilevano le connessioni teoriche e poetiche tra Saggio di traduzione dell’Odissea e Inno a Nettuno, mostrando – sulla scia di quanto suggerito da G. Panizza, Da greco a italiano: Leopardi e la funzione Giordani, in Giordani letterato. Seconda giornata piacentina di studi, Piacenza 20 maggio 1995, a cura di G. Panizza, Piacenza, Tip.Le.Co, 1996, pp. 74-75 – come questo rappresenti il momento più “foscoliano” del Leopardi-traduttore; F. Nasi, Le maschere di Leopardi e l’esperienza del tradurre, «Studi e problemi di critica testuale», 75, 2007, pp. 73-95, spec. pp. 89-92, in cui i falsi del 1816 testimoniano l’esperienza di “mascheramento” preliminare alla composizione poetica. Una menzione a parte spetta al fondamentale contributo di A. Prete, Finitudine e infinito. Su Leopardi, 116 Margherita Centenari per i saggi di Marco Santagata e Riccardo Bonavita, che – secondo una prospettiva più ampia e di lungo termine – hanno presentato il falso come una tappa decisiva nell’elaborazione di quella lingua poetica “naturale e ingenua” che avrebbe connotato la produzione successiva dell’autore23. Questi pochi, anche se illustri, riferimenti non possono che confermare la posizione radicalmente satellitare assunta dall’Inno a Nettuno nel panorama critico. Anche alla luce delle nuove prospettive d’indagine aperte dalla sua recente edizione24, credo che esso meriti, tuttavia, un’approfondita riconsiderazione: come si evince infatti dalla varietà degli studi citati e, soprattutto, dall’impressionante serie di traduzioni, prose e opere in versi portate a termine nel corso del 1816, l’esperienza del falso sembra riassumere in sé alcuni dei principali interessi che avevano animato un momento decisivo della vicenda letteraria leopardiana. Tra il gennaio e l’aprile di quell’anno il giovane recanatese aveva volgarizzato il Frontone scoperto da Angelo Mai in un palinsesto ambrosiano, premettendovi un Discorso sopra la vita e le opere di M. Cornelio Frontone; tra la primavera e l’estate aveva tradotto il I e parte del II libro dell’Odissea, le Inscrizioni greche Triopee di Marcello Sidete, il poemetto pseudo-virgiliano Moretum, il II canto dell’Eneide (insieme ad una sezione del III) e, sempre nello stesso periodo, aveva dato inizio alle compilazioni del Parere sopra il Salterio ebraico e del discorso Della fama di Orazio presso gli antichi; nel giugno avevano inoltre visto la luce di stampa le Notizie istoriche e geografiche sulla città e chiesa arcivescovile di Damiata (Loreto, per Ilario Rossi). Accanto a questi studi di carattere prevalentemente erudito, poi, datano all’estate del 1816 anche alcune opere originali, come l’idillio in versi sciolti Le rimembranze, la rielaborazione della «burletta Milano, Feltrinelli, 1998, che nel contesto di una più vasta e varia trattazione sulle questioni del tradurre e dell’imitare nella teoria e poetica leopardiane (cfr. ivi, Traduzione e imitazione, pp. 143-170) ha riservato alcune importanti pagine proprio all’Inno (pp. 152-156), ponendone in evidenza l’eccezionale natura, a metà tra l’imitazione dei modelli antichi e l’originalità della composizione (si veda anche il più recente Id., All’ombra dell’altra lingua. Per una poetica della traduzione, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, pp. 67-69). 23 Rispettivamente, M. Santagata, Quella celeste naturalezza. Le canzoni e gli idilli di Leopardi, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 89-102 e R. Bonavita, L’autenticità è apocrifa. Lingua e stile nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica di Giacomo Leopardi, «Strumenti Critici», 96, 2001, pp. 297-324, spec. pp. 320 sgg. Mentre Santagata, mirando ad identificare alcuni dei principali caratteri del codice idillico, ha illustrato i nessi tra la scrittura “antica” impiegata nell’Inno e quella utilizzata negli idilli del 1819, Bonavita ha cercato di proiettare le contraffazioni del 1816 sullo sfondo teorico e critico costituito dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (1818), ad esse per molti aspetti rapportabile. 24 Cfr. Poesie disperse e supra p. 95. È inoltre possibile ritrovare qualche riferimento al falso anche in altri studi, i quali, pur non occupandosi direttamente della prima conversione leopardiana ed innestando invece le proprie riflessioni su questioni di più ampio respiro, hanno offerto alcune utili indicazioni: L. Felici, L’Olimpo abbandonato. Leopardi tra «favole antiche» e «disperati affetti», Venezia, Marsilio, 2005, pp. 18-19, che ha dimostrato come in certe immagini liriche dell’Inno sia possibile ravvisare le prime tracce di un uso personale e non solo erudito della mitologia classica (cfr. infra nota 65) e G. Tellini, Rifare il verso. La parodia nella letteratura italiana, Milano, Mondadori, 2008, pp. 199-203, dedicate alla teoria, alla pratica parodica e all’ironia del Leopardi falsificatore, cfr. infra pp. 117-118. «prendere persona di greco» 117 anacreontica» La dimenticanza, iniziata già nel 1811, l’abbozzo di tragedia intitolato Maria Antonietta e – composti in pochi giorni tra novembre e dicembre – i cinque canti in terzine del poema Appressamento della morte. Non pago, Leopardi volle anche intervenire nel dibattito culturale promosso dall’austriacante e neonata «Biblioteca Italiana», alla quale – com’è noto – indirizzò due lettere, entrambe rimaste poi inedite: la prima, spedita da Recanati il 7 maggio del 1816, era dedicata alla teoria del tradurre (Lettera ai compilatori della Biblioteca Italiana); la seconda, inviata il 18 luglio, segnava invece il suo ingresso nella polemica tra classici e romantici (Lettera ai Sigg. compilatori della Biblioteca Italiana in risposta a quella di Mad. la Baronessa di Staël Holstein ai medesimi)25. Un vero e proprio furor compositivo, insomma, che portò ben presto Giacomo a rammaricarsi per l’inferma condizione fisica raggiunta26 e che era l’esito di almeno tre diversi ma complementari interessi della sua prima formazione: uno di matrice filologico-erudita, il secondo più specificamente legato all’esercizio di traduzione letteraria dal greco e dal latino ed il terzo che lo aveva condotto alle prime prove di natura essenzialmente poetica. L’Inno, componimento originale presentato sotto le mentite spoglie di una traduzione dal greco e corredato da una lunga serie di note colme di erudizione, appare quindi il sorprendente punto di incontro fra queste inclinazioni e, proprio in virtù di tale convergenza, nelle pagine seguenti verrà posto in relazione alla coeva produzione leopardiana, allo scopo di comprendere meglio le motivazioni sottese ad un testo finora sostanzialmente trascurato, ma che a buon diritto può rappresentare un terreno privilegiato per illustrare il profilo intellettuale del poeta recanatese, così come esso si era venuto configurando all’altezza del 1816. I. Tra erudizione e filologia Le radici dell’erudizione leopardiana affondano negli studi intrapresi dapprima seguendo le lezioni di latino impartite da don Sebastiano Sanchini – modesto precettore di formazione gesuitica – e poi coltivando da autodidatta la lingua ebraica e soprattutto quella greca, che il giovane apprese a partire dal 1813 ed approfondì con 25 Per una lista completa degli scritti risalenti al 1816, arricchita da utili informazioni editoriali e cronologiche rintracciabili anche nelle note ai singoli testi, cfr. TTP, ad locc.; più in particolare per ciò che riguarda le traduzioni, si rimanda a G. Leopardi, Poeti greci e latini, a cura di F. D’intino, Roma, Salerno Editrice, 1999. 26 Si ricordino le frequentatissime parole inviate da Leopardi a Giordani con la lettera del 2 marzo 1818: «perchè in somma io mi sono rovinato con sette anni di studio matto e disperatissimo in quel tempo che mi s’andava formando e mi si doveva assodare la complessione. E mi sono rovinato infelicemente e senza rimedio p[er] tutta la vita, e rendutomi l’aspetto miserabile, e dispregevolissima tutta quella gran parte dell’uomo, che è la sola a cui guardino i più» (Epist., pp. 183-184). 118 Margherita Centenari dedizione negli anni successivi27. Gli interessi per la cultura classica, maturati a seguito di questi studi, costituirono una cifra caratteristica della vicenda di quegli anni; essi infatti sostanziarono la gran parte delle opere risalenti al quadriennio 1813-1816 e offrirono a Leopardi la prima vera occasione per tentare di valicare gli stretti confini della provincia, entrare in contatto con le grandi personalità dell’epoca e ottenere così lustro e gloria personale nel campo dell’antichistica28. Eccezion fatta per il trattatello illuministico Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, di stampo esplicitamente divulgativo, la grandissima parte dei testi composti tra il 1813 ed il 1815 possedeva un’ispirazione propriamente erudita, come la precocissima Storia dell’astronomia (1813), gli studi su Esichio Milesio, su Porfirio, sui retori d’età imperiale e sui Padri della Chiesa. Un discorso a parte merita il Giulio Africano, ultimo scritto riconducibile a questa fase e già considerato da Timpanaro come l’opera più riuscita tra quelle redatte prima del 1816: impreziosita dall’introduzione di alcuni fondamentali concetti di critica testuale e dalla presenza di pregevoli emendazioni, congetture e selezioni di varianti manoscritte29, quest’edizione mostrava le prime avvisaglie di una preoccupazione filologica intesa in senso moderno, che faticava a trasparire dalle compilazioni precedenti, caratterizzate invece da un sovrabbondante accumulo di informazioni dotte che spesso conferiva loro un aspetto pedantemente enciclopedico30. Mentre dunque l’Africano può a buon diritto collocarsi al termine della prima fase degli studi leopardiani – tutti orien- 27 Per i primi saggi compilati in latino sotto la guida di don Sanchini, e in generale, per la formazione erudita giovanile, cfr. Timpanaro, La filologia, cit., pp. 3-18. Per una completa rassegna su Leopardi filologo “in erba” rimando al recente ed ampiamente documentato G. Leopardi, Rhetores, a cura di C.O. Tommasi Moreschini, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2009. 28 La missiva a Giordani del 30 aprile 1817 esprime il giudizio impietoso di Leopardi sulla desolazione culturale della provincia marchigiana nel primo decennio dell’Ottocento e, parimenti, mostra un disagio intellettuale e personale che non doveva essere troppo dissimile da quello che aveva stimolato la compilazione delle prime opere erudite, di pochi anni precedenti a queste amare affermazioni: «ma che crede Ella mai? Che la Marca e ’l mezzogiorno dello Stato Romano sia come la Romagna e ’l settentrione d’Italia? Costì il nome di letteratura si sente spessissimo: costì giornali accademie conversazioni libraj in grandissimo numero. […] Qui, amabilissimo Signore mio, tutto è morte, tutto è insensataggine e stupidità. Si meravigliano i forestieri di questo silenzio, di questo sonno universale. Letteratura è vocabolo inudito» (Epist., pp. 89-90). Sebbene la Marca non fosse del tutto “sonnolenta” (cfr. infra pp. 120 sgg.), Leopardi percepiva ormai distintamente i limiti culturali della provincia e guardava già al fervore che animava i grandi centri della penisola. D’altra parte la sua fama di filologo – al di là di una rapida citazione delle sue doti da enfant prodige nella Dissertazione intorno agli uomini dotati di gran memoria di Francesco Cancellieri (Roma, Bourlié, 1815, pp. 88-90) – avrebbe lentamente iniziato a diffondersi solo a seguito del viaggio a Roma compiuto nel 1822, cfr. Timpanaro, La filologia, cit., pp. 63 sgg. passim. 29 Cfr. ivi, pp. 12-18 e, per una ricca introduzione a questo scritto, G. Leopardi, Giulio Africano, a cura di C. Moreschini, Bologna, il Mulino, 1997. 30 Cfr. Timpanaro, La filologia, cit., pp. 8-12, dove i numerosi limiti di questa prima produzione, precedente la svolta verso la “filologia formale”, non vengono ricondotti solo all’immaturità del giovanissimo erudito, ma soprattutto all’impossibilità da parte di quest’ultimo di accedere alle novità editoriali dei maggiori poli culturali italiani, di stabilire contatti col mondo intellettuale esterno alla provincia e di procurarsi tutti i materiali bibliografici, specialmente i codici manoscritti, necessari a rendere più solido il proprio lavoro (ivi, pp. 12-15). «prendere persona di greco» 119 tati alla raccolta e all’organizzazione di dati tratti dalla dottrina antica – l’Inno a Nettuno è tradizionalmente associato alla produzione successiva, caratterizzata da una sensibilità diversa, ormai vicina ai nuovi interessi che animarono la cosiddetta “conversione letteraria” del 1816, anno in cui il giovane iniziò (gradatamente) a rivolgere una più profonda attenzione ai classici, dei quali dimostrerà presto di apprezzare non più o non solo il valore storico e documentario, ma anche e soprattutto quello artistico e poetico31. Nell’Inno, tuttavia, si riconosce ancora, per molti versi, l’influsso degli scritti filologico-eruditi precedenti32. In particolare una tale impressione si può ricavare scorrendo il densissimo apparato di 59 note che correda i 203 endecasillabi del testo: in esse «ogni volta che [il presunto] autore antico nomina un personaggio […] o una località, il Leopardi raccoglie tutte le altre testimonianze in proposito, ingolfandosi spesso in lunghe digressioni»33. Collocate per lo più nella seconda metà del componimento e spesso associate a nomi o ad epiteti di divinità, le note leopardiane contengono materiale erudito ed antiquario e si rivolgono tanto al lettore poco esperto di antichità, che vi poteva reperire informazioni utili alla comprensione del testo, quanto a quello colto che vi rintracciava numerosi riferimenti a questioni filologiche, mitografiche e lessicografiche, le quali, proprio grazie alla pubblicazione dell’inedito inno, trovavano nuove ed inaspettate risposte34. 31 È noto che fu Leopardi a voler ricondurre la propria conversione al 1816, tuttavia, come ricorda Timpanaro, essa era probabilmente già iniziata nell’anno precedente e si sarebbe prolungata almeno fino al 1819, cfr. ivi, p. 19. Un’eccellente ricostruzione del complesso periodo della prima conversione letteraria è offerta da C. Genetelli, Incursioni leopardiane. Nei dintorni della «conversione letteraria», Roma-Padova, Antenore, 2003. 32 Del resto anche Timpanaro – esprimendo un giudizio di valore forse eccessivamente duro sulle opere del 1816 – riconosce la stretta continuità tra i primi esercizi eruditi e la produzione letteraria degli anni della conversione, allorché nelle traduzioni, nelle opere filologiche e nei falsi del periodo «il dato erudito si riveste di un ornamento letterario, senza però diventare né critica né storia. I lavori di questo periodo sono un esercizio di bella letteratura, un’esperienza che al Leopardi servì per conquistare il proprio stile […], ma dal punto di vista storico-critico non superano gran che i precedenti commentarii de vita et scriptis» (Timpanaro, La filologia, cit., p. 21). 33 Ivi, p. 9, in cui lo studioso, pur non riferendosi direttamente all’Inno a Nettuno, tratteggia con chiarezza il metodo di lavoro che Leopardi avrà con ogni probabilità seguito anche per la compilazione dell’apparato del falso. Sull’«erudizione più pellegrina e recondita», in gran parte raccolta dalle medesime fonti impiegate per la stesura di alcune delle dotte compilazioni precedenti e di cui si nutrono anche le note all’Inno, cfr. Epist. p. 106 e Scheel, Leopardi und die Antike, cit., pp. 140-141. 34 Solo 8 sono le note che si rintracciano in corrispondenza della prima metà del componimento, mentre ben 51 commentano i vv. 103-203; la netta maggioranza di esse (il 66% circa) è appiccata a nomi o a epiteti divini. Nelle note si discutono problemi lessicografici, filologici, mitografici e antiquari; si elencano passi paralleli all’Inno e si accenna brevemente a questioni traduttive. Le fonti citate sono prevalentemente greche (44 a fronte delle sole 17 latine) ed eterogenee: vengono menzionate opere in prosa e in poesia, testi risalenti all’età arcaica, classica e cristiana e non mancano citazioni di lessici o glossari tardi e addirittura medievali. Per un utile e dettagliato elenco di tutti i loci richiamati nell’apparato, cfr. l’Indice degli autori e delle opere compilato da Pestarino (Poesie disperse, pp. 307-324), mentre per una suddivisione tipologica ed una descrizione più approfondita delle note, rinvio all’edizione commentata di Inno a Nettuno e Odae Adespotae che ho attualmente in preparazione. 120 Margherita Centenari Ma la volontà del giovane autore di sfoggiare un’ampia dottrina emerge anche in un’altra, nient’affatto secondaria sezione del paratesto, l’Avvertimento ai lettori. In esso – come era avvenuto qualche anno prima nell’ampio Discorso sopra la Batracomiomachia, dove si dilungava in annose questioni attributive in merito alla paternità del poemetto pseudo-omerico – Leopardi si cimenta, questa volta animato da una certa beffarda ironia, in un dotto excursus, nel quale, dopo avere formulato e scartato varie ipotesi, finge di voler ricondurre la composizione dell’inno ritrovato ad un ignoto poeta proveniente dall’Attica: Simonide e Mirone o Merone, poetessa di Bisanzio, scrissero Inni a Nettuno. Ma l’autore di questo mi par sì bene istrutto delle cose degli Ateniesi, che io lo credo d’Atene, o per lo meno dell’Attica. Panfo Ateniese scrisse altresì un Inno a Nettuno, come si raccoglie da Pausania, ma quello ora scoperto, benchè molto antico, non può essere di quel poeta che si dice vissuto avanti Omero; oltrechè quivi non ha ciò che Pausania lesse nel componimento di Panfo. Nulla dico dell’Inno a Nettuno, non più lungo di sette versi, che è fra gli attribuiti ad Omero […]35. Nell’Inno non mancano comunque notazioni di natura più squisitamente filologica: nel commento al falso, il giovane offre infatti uno dei suoi primi contributi – ancora oggi ritenuto valido36 – all’esegesi dei testi antichi. Fu Timpanaro a rilevare che alla nota 7, relativa ai vv. 84-92 («[…] onde a te diero i fati / I cavalli domar veloci al corso. / […] e primo / Tu de la terra scotitor possente / A’ chiomati destrieri il fren ponesti»), era possibile rintracciare un’osservazione critica di un certo pregio che illuminava un controverso passo virgiliano: discutendo la figura di Nettuno creatore del cavallo e protettore dei domatori, Leopardi affermava che in Aen. VII 691 l’eroe Messapo era definito Neptunia proles non perché, come malamente osservava Servio insieme ad altri antichi esegeti, egli fosse giunto in Italia dal mare, ma perché, come sintetizzato dallo stesso Virgilio mediante l’uso di un epiteto collocato nel primo emistichio del verso, egli era equum domitor, prerogativa attribuita proprio al dio del mare da una significativa parte della tradizione greco-latina37. Di nuovo sarà allora opportuno volgere l’attenzione all’Avvertimento, dove pure è possibile riconoscere la presenza di indicazioni che dimostrano una buona consapevolezza da parte di Leopardi in campo critico e soprattutto “paleografico”. È proprio nella prosa indirizzata ai lettori, infatti, che egli si sofferma sul contesto di ritrovamento e sull’aspetto del manoscritto che doveva conservare il testo dell’inno, 35 Ivi, p. 235. Nella citazione mancano tre note nelle quali Leopardi rimanda ad alcune fonti che testimoniano quanto segnalato a proposito degli inni a Nettuno composti rispettivamente da Simonide, Merone e Panfo (secondo le attuali edizioni di riferimento: schol. Eur. Med. 5 Schwartz; Eust. Il. II 711 Van der Valk; Paus. VII 21 9). 36 Cfr. Timpanaro, La filologia, cit., p. 24 nota 17 e p. 221 e più recentemente G. Drago, Timpanaro e gli studi filologici leopardiani, «Allegoria», XII, 2001, n. 39, pp. 105-121, a p. 121. 37 Cfr. Poesie disperse, p. 248. «prendere persona di greco» 121 giungendo a formulare alcune ipotesi sulla datazione del codice e sul suo originario contenuto: Un mio amico in Roma nel rimuginare i pochissimi manoscritti di una piccola biblioteca il 6 gennaio dell’anno corrente, trovò in un Codice tutto lacero, di cui non rimangon che poche pagine, quest’Inno greco […]. L’Inno pare antichissimo, avvengachè il Codice non sembri scritto innanzi al trecento. […] Il nome dell’autore non è nelle pagine che ci avanzano del Codice già molto più ampio, e non si può di leggeri indovinarlo. L’Inno porta per titolo: Τοῦ αὐτοῦ Εἰς Ποσειδῶνα = Del medesimo: a Nettuno =, da che apparisce che avea nel manoscritto altri componimenti dello stesso poeta, e di questi si leggono a gran fatica nel Codice qua e là alcuni frammenti […]38. L’accumulo di richiami e citazioni di fonti classiche di cui l’apparato al testo è letteralmente infarcito e la presenza nell’Avvertimento di puntigliose disquisizioni di natura ecdotica documentano dunque le connessioni tra il falso e la produzione precedente. Non va tuttavia dimenticato che queste esibizioni dottrinali venivano collocate da Leopardi nel contesto, fino ad allora inedito, di una contraffazione ed erano dunque finalizzate non più ad un’autentica indagine sul passato, ma – in quanto parte integrante della messinscena – orientate a conferire credibilità ad un testo antico inesistente. Proprio questa rifunzionalizzazione della pratica erudita costituisce una delle più interessanti caratteristiche dell’Inno, poiché essa testimonia il grado di disinvoltura raggiunto dal giovane poeta nel maneggiare gli strumenti e il lessico dell’antichista e rivela una maggiore spregiudicatezza e libertà d’approccio alla ricerca filologica, che veniva così allontanata dal suo primario obiettivo e subordinata alle nuove esigenze della composizione originale39. II. Una finta traduzione Tra il 1814 e il 1816, un’altra vocazione caratterizzò la biografia intellettuale del giovane Leopardi, ispirando, insieme a quella filologico-erudita, l’ideazione dell’Inno a Nettuno: la passione per il volgarizzamento dei testi classici40. Lo stretto legame che Ivi, pp. 234-235. Così viene commentato l’Avvertimento in Terzoli, Nell’atelier dello scrittore, cit., p. 56: «È questo, mi pare, un caso di straordinario interesse, dove il falso apparato paratestuale gioca un ruolo di primissimo piano per accreditare la presunta scoperta: e insieme contribuisce attivamente a costruire e rafforzare le molteplici e diffratte immagini di raffinatissimo e spregiudicato pasticheur, di un autore che ormai domina senza riserve ogni forma e ogni registro della scrittura letteraria». 40 Tra i numerosissimi studi sul primo vertere leopardiano, inaugurati dal già citato contributo di Bigi, si aggiungano a quelli nominati alla nota 22 i saggi elencati nella rassegna di M. Natale, Dagli Scherzi a Imitazione. Leopardi traduttore dei poeti: bibliografia 1955-2005, «Lettere italiane», LVIII, 2006, n. 2, pp. 304-335. Meritano inoltre di essere ricordati i più recenti B. Stasi, Idee di Leopardi sulla traduzione, in Traduzioni letterarie 38 39 122 Margherita Centenari unisce il falso alle coeve traduzioni di opere greche e latine è messo in luce da un appunto personale, con il quale l’autore stesso commentò l’Inno dopo la sua pubblicazione: Dovechè i traduttori si studiano di parer originali, io doveva essendo originale studiarmi di parer traduttore. e qui si possono mettere tutte le riflessioni sopra questo particolare ch’io scrissi al Giordani nella mia lettera dove si parla di quest’inno. ec.41. Nella già citata missiva inviata all’amico Giordani il 30 maggio del 1817, infatti, ricostruendo la genesi dell’opera, aveva scritto: la stretta necessità d’imitare, o meglio di copiare e di rimuovere dal componimento l’aria di robusto e originale, perché come un velo rado rado, anzi una rete soprapposta all’immaginario testo, ne lasciasse vedere tutti i muscoli e i lineamenti, e in somma lo lasciasse pressoché nudo a fine d’ingannare, m’impastoiò e rallentò p[er] modo la mente, che senza dubbio io ho fatto tutt’altro che poesia42. Lo sforzo imitativo al quale Leopardi imputa il proprio fallimento era dunque vòlto a conferire al testo dell’Inno l’aspetto di un volgarizzamento, camuffando sistematicamente ogni suo carattere di originalità. Questo intento emerge con tutta evidenza sul piano prettamente formale, laddove, come è stato giustamente rilevato da Bigi, spesso si riscontra nel falso la «presenza esplicita di quei moduli stilistici, con i quali nelle versioni […] il poeta cercava di attingere […] la divina “naturalezza” degli antichi»43, moduli che nel contesto di una contraffazione avrebbero fuorviato i lettori, spingendoli a riconoscere nel testo i tratti di una vera e propria traduzione. Se letta da un punto di vista più generale, però, questa osservazione rappresenta anche un primo, fondamen- e rinnovamento del gusto: dal Neoclassicismo al primo Romanticismo. Atti del convegno internazionale di studi, Lecce-Castro 15-18 giugno 2005, a cura di G. Coluccia e B. Stasi, 2 voll., Galatina, Congedo, 2006, vol. II, pp. 291-324; N. Primo, Leopardi lettore e traduttore, Leonforte, Insula, 2008; V. Camarotto, «La gemma perduta». Le traduzioni omeriche di Leopardi (1815-1818), «Rivista internazionale di Studi Leopardiani», 6, 2010, pp. 79-116 e Id., Note sulla traduzione del II canto dell’Odissea, ivi, 8, 2012, pp. 55-68. A parte va poi segnalato lo studio di G. Lonardi, L’oro di Omero. L’Iliade, Saffo: antichissimi di Leopardi, Venezia, Marsilio, 2005, che, in continuità con il precedente Id., Classicismo e utopia nella lirica leopardiana, Firenze, Olschki, 1969, ha riconosciuto nelle giovanili traduzioni dal greco tracce utili a comprendere il complesso rapporto che lega il Leopardi dei Canti al mondo antico. Due preziosi strumenti per lo studio delle versioni giovanili sono inoltre Leopardi, Poeti greci e latini, cit., edizione critica, commentata e riccamente introdotta da Franco D’Intino e G. Savoca-N. Primo, Concordanza delle traduzioni poetiche di Giacomo Leopardi. Concordanza, lista di frequenza, indici, Firenze, Olschki, 2003. 41 Si tratta dell’annotazione autografa di AN3 «foglietto di mm 135 x 100, scritto solo nel terzo superiore, e contenente la schedula intitolata Per l’avvertimento da premettersi a un’altra edizione di quest’Inno […]» (Poesie disperse, pp. 165 e 231). La grafia con cui Leopardi vergò il biglietto parrebbe riconducibile al 1817 o comunque ad una fase cronologica subito a ridosso delle due edizioni dell’Inno, cfr. ivi, p.165. 42 Epist., p. 106. 43 Bigi, Il Leopardi traduttore, cit., p. 223. «prendere persona di greco» 123 tale indizio del fatto che la pratica di traduttore di opere greche e latine, in quanto finalizzata all’assimilazione delle loro qualità espressive, costituisce il presupposto teorico e poetico dell’Inno in quanto composizione lirica originale. Come testimoniato da una celeberrima annotazione dello Zibaldone 44, fu proprio l’assiduo esercizio di traduzione dei classici ad aver deviato gli interessi del giovane Leopardi dalla filologia e ad aver posto le basi per la sua “conversione dall’erudizione al bello”. In particolare dal 1813, grazie all’apprendimento del greco, egli iniziò gradualmente a non intendere più il volgarizzamento come un mero esercizio stilistico45 e a percepirlo invece come una fonte di vitale arricchimento personale, che poteva assicurargli non solo una via di fuga dal controllo della pressante educazione razionalistica impostagli dai famigliari, ma anche un piacevole turbamento emotivo frutto dell’eccezionale incontro con espressioni e immagini poetiche «naturali» ed «ingenue», assimilabili a quelle proprie di una fanciullezza non ancora corrotta dalla ragione46. La funzione che la pratica del tradurre venne allora ad assumere agli occhi di Leopardi fu quella di consentire alla mente di assorbire e fare proprie le bellezze della parola antica, servendosi delle stesse armi della ragione e della scienza filologica di cui egli aveva fatto uso per dare corpo ai nutriti apparati che corredavano le opere di stampo erudito e che avrebbero accompagnato anche la maggior parte dei suoi volgarizzamenti47. 44 «Le circostanze mi avevan dato allo studio delle lingue, e della filologia antica. Ciò formava tutto il mio gusto: io disprezzava quindi la poesia. Certo non mancava d’immaginazione, ma non credetti d’esser poeta, se non dopo letti parecchi poeti greci» (G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, a cura di G. Pacella, 3 voll., Milano, Garzanti, 1991, vol. I, p. 1741 dell’autografo; d’ora in poi solo Zibaldone). E cfr. Bigi, Il Leopardi traduttore, cit., p. 192: «non sembra azzardato fissare l’inizio di quel passaggio “gradato” dall’erudizione al bello, di quella progressiva scoperta della propria vocazione poetica, appunto in rapporto con il gruppo di traduzioni dal greco che abbiamo ricordato [scil. quelle degli anni 1814-1815]». Sul periodo della conversione, cfr. supra p. 103. 45 Già al 1809-1812 risalgono ad esempio le puerili versioni da Orazio, tutte improntate ad un «gusto scolasticamente ed accademicamente arcadico», cfr. Bigi, Il Leopardi traduttore, cit., pp. 188-190. 46 Cfr. Leopardi, Poeti greci e latini, cit., pp. XII-XIII. Sui concetti poetici di «naturalezza» ed «ingenuità», da sempre associati per Leopardi alla poesia antica, si vedano i numerosi riferimenti presenti già nella prosa del Discorso sopra Mosco (1815), che troveranno in seguito maggiore compiutezza nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (1818), cfr. TTP, pp. 412 sgg. e 968-995, passim. 47 A proposito della funzione del tradurre, Leopardi, ormai al termine della sua prima esperienza di volgarizzatore, scriveva a Giordani: «Ella dice da Maestro che il tradurre è utilissimo nella età mia, cosa certa e che la pratica a me rende manifestissima. Perchè quando ho letto qualche Classico, la mia mente tumultua e si confonde. Allora prendo a tradurre il meglio, e quelle bellezze per necessità esaminate e rimenate a una a una, piglian posto nella mia mente e l’arricchiscono e mi lasciano in pace», (lettera del 21 marzo 1817 in Epist., p. 71). Le parole antiche, dunque, prima di “pigliare posto” nella mente del poeta, dovevano essere «esaminate e rimenate», ognuna andava ricercata e controllata su grammatiche e dizionari, in modo che tutti i tasselli della naturalezza primitiva fossero sottoposti al vaglio della moderna ragione. D’altronde, nella lettera a Giordani del 30 aprile 1817, è Leopardi stesso, ripensando al sorgere della propria passione per l’antichità, a riconosce il ruolo decisivo di uno studio “scolastico” delle lingue classiche: «Chi m’ha fatto strada a imparare le lingue che m’erano necessarie? la grazia di Dio. […] Io avea allora 15 anni, e stava dietro a studi grossi, Grammatiche Dizionari greci ebraici e cose simili tediose, ma necessarie» (ivi, pp. 91-93). A questo proposito utilissime osservazioni sono contenute in Leopardi, Poeti greci e latini, cit., Introduzione, spec. pp. XII-XVIII. 124 Margherita Centenari Le motivazioni che condussero Leopardi a dedicarsi alle versioni dal greco e dal latino rimasero sostanzialmente inalterate fino al 1817 – anno della Titanomachia di Esiodo e del concludersi della sua prima esperienza di traduttore –, ma gli approcci e gli esiti ai quali egli approdò variarono significativamente nel tempo e lo spinsero a dare corpo ad una teoria del vertere sperimentale e mutevole, che contribuì in maniera sostanziale ad animare l’audace esperimento di contraffazione dell’Inno a Nettuno. Sarà dunque ripercorrendo – sia pure in estrema sintesi e a costo di qualche semplificazione – le differenti e talvolta contraddittorie forme assunte dalla teoria e dalla pratica del tradurre, che si potranno cogliere con chiarezza le radici più profonde della scelta leopardiana di conferire al falso l’aspetto di un volgarizzamento in versi. Se nelle prime versioni dal greco (Scherzi epigrammatici e Poesie di Mosco, 1814-1815) – nonostante l’utilizzo di uno stile ancora intriso di gusto arcadico e neoclassico – Leopardi mirava a preservare nella resa italiana l’ingenuità dell’originale mediante una strenua conservazione della lettera ed «in consapevole polemica con […] i “travestitori” settecenteschi»48, già ne’ La guerra dei topi e delle rane (1815) la regola di fedeltà che lo aveva dapprincipio ispirato appare ben mutata49: il bersaglio della critica leopardiana passa allora dal Mosco travestito alla parigina di Poinsinet de Sivry alla versione della Batracomiomachia realizzata dall’abate Antonio Lavagnoli, accusato di avere dato alle stampe una traduzione «fredda e quasi letterale» del testo greco50. Oscillazioni dello stesso genere si possono facilmente rintracciare anche nelle traduzioni approntate durante la prima metà del 1816: mentre per quella del Moretum pseudo-virgiliano Leopardi dichiara «senza rossore» di aver condotto il suo lavoro liberamente, rivendicando come primarie le esigenze di una resa del tutto “sponta- Bigi, Il Leopardi traduttore, cit., p. 193. Sulle caratteristiche estetiche e formali della traduzione delle traduzioni, cfr. ivi, pp. 191-201, dove lo studioso mostra le affinità tra tali versioni e quelle curate da Giuseppe Maria Pagnini (Le poesie di Anacreonte, di Saffo, e di Erinna dal greco trasportate in rime toscane per opera di Eritisco Pilenejo P.A., Lucca, Marescandoli, 1794) e chiarisce come da queste prime prove traduttive discenda anche il componimento Le Rimembranze, cfr. ivi, p. 201. 49 Nel Discorso sopra la Batracomiomachia emerge la volontà di conferire al volgarizzamento del poemetto pseudo-omerico una certa spontaneità, giungendo addirittura ad adeguare l’opera antica a criteri estetici ad essa estranei, come il metro italiano: «Cercai d’investirmi dei pensieri del poeta greco, di rendermeli propri, e di dar così una traduzione che avesse qualche aspetto di opera originale, e non obbligasse il lettore a ricordarsi ad ogni tratto che il poema, che leggea, era stato scritto in greco molti secoli prima. Volli che le espressioni del mio autore, prima di passare dall’originale nelle mie carte, si fermassero alquanto nella mia mente, e conservando tutto il sapor greco, ricevessero l’andamento italiano, e fossero poste in versi non duri e in rime che potessero sembrare spontanee» (TTP, p. 399). 50 A Poinsinet de Sivry Leopardi rivolse pungenti accuse nel suo Discorso sopra Mosco (ivi, pp. 413-415). Contro l’opera del Lavagnoli aveva sentenziato: «Il Rubbi diede sopra tutte le traduzioni italiane della Batracomiomachia la preferenza a quella del Lavagnoli. Ma questa, a dir vero, non è che una fredda e quasi letterale interpretazione del testo greco, fatta coll’originale e col Rimario alla mano, in versi poco eleganti, e con rime stentate e spiacevoli. Leggendone il primo verso senza saper nulla del titolo, si conosce tosto che esso appartiene ad una traduzione, tanto questa è lontana dall’aver l’aria di un componimento originale» (ivi, p. 398). 48 «prendere persona di greco» 125 nea” dell’archetipo; nella premessa al volgarizzamento del I libro dell’Odissea, egli si rivolge orgogliosamente ai propri lettori perché verifichino la sua puntuale aderenza ad Omero, sfidandoli ad aprire a caso il poema e a confrontarlo con la versione51. Questa pendolarità nell’accordare la propria preferenza ora alla necessità di garantire una traduzione fedele al modello, ora a quella di dare corpo ad un testo caratterizzato da qualche libertà può spiegare almeno in parte l’insorgenza, durante lo stesso 1816, di alcune riflessioni sui metodi del tradurre, mediante le quali il giovane recanatese cercò a più riprese di razionalizzare lo sperimentalismo che aveva fino ad allora contraddistinto la sua produzione52. A fianco di alcune soluzioni teoriche rimaste poi prive di sviluppi53, almeno a partire dalla primavera del 1816 iniziò a farsi strada in Leopardi una nuova idea di fedeltà all’originale, che segnò il definitivo superamento dell’opzione letteralismo/traduzione libera passando attraverso la fondamentale «intuizione che fedeltà e originalità sono istanze interne a ciascun atto di traduzione poetica, e quindi in realtà inseparabili»54. Cosa aveva spinto il giovane traduttore a tali riflessioni? È probabile che egli si fosse orientato in Cfr. l’inedita Nota introduttiva alla bella copia di a, in L. Stefani, La Torta di Giacomo Leopardi, «Studi e problemi di critica testuale», 5, 1972, pp. 135-179, a p. 146 e TTP, p. 423, a cui si possono aggiungere le considerazioni raccolte nella coeva Prefazione alle Inscrizioni greche Triopee, dove Leopardi si rammaricava che il grande Visconti, traduttore letterale dei testi antichi, avesse purtroppo finito col sacrificarne lo spirito (cfr. ivi, p. 428). 52 Su questo ambiguo atteggiamento verso la pratica della traduzione, cfr. Fasano, L’entusiasmo, cit., pp. 59-67; Prete, Finitudine e infinito, cit., pp. 149-152 ed E. Sanguineti, Il chierico organico. Scritture e intellettuali, a cura di E. Risso, Milano, Feltrinelli, 2000, pp. 123-125, dove l’oscillazione tra rispetto della fonte e ricerca di originalità è definita nei termini di un vero e proprio «paradosso» leopardiano, che accompagnerà il poeta ben oltre il confine della giovanile conversione, riversandosi in molte delle riflessioni consegnate alle carte dello Zibaldone. In merito a Batracomiomachia e Moretum, è però necessario riflettere su un’importante considerazione che devo alla cortesia di Christian Genetelli, il quale giustamente nota come queste traduzioni, più libere, non contraddicono necessariamente il criterio dominante della fedeltà, ma si possono spiegare soprattutto alla luce del genere a cui appartengono i due testi: uno parodico e dunque già di partenza operazione di cultura e non di natura, l’altro umile; su quest’ultimo scritto in particolare, cfr. J.L. Bertolio, La torta ovvero il primo idillio: Leopardi traduttore del Moretum, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXXVIII, 2011, 623, pp. 396-423. Si veda inoltre V. Camarotto, «Antica lite io canto». La traduzione leopardiana della Batracomiomachia (1815) tra parodia e satira, «La Rassegna della letteratura italiana», CXI, 2007, 1, pp. 73-97. 53 Mi riferisco in particolare alla Lettera inviata alla «Biblioteca Italiana» il 7 maggio del 1816, che contiene i primi tentativi operati da Leopardi di giustificare la propria pratica traduttiva (cfr. TTP, pp. 939-941). In essa egli aveva cercato di risolvere l’alternanza tra aderenza all’originale e libertà del traduttore, individuando un possibile criterio guida nelle caratteristiche stilistiche dei componimenti antichi, alcuni dei quali necessitavano di traduzioni letterali (Omero e Anacreonte), al contrario di altri che potevano «soffrire maggior libertà» (ivi, p. 940). Qualcosa di simile veniva ribadito da Leopardi anche nel pressoché contemporaneo preambolo alle Odae Adespotae, dove si legge: «Colui che disse, rima e traduzione esser cose incompatibili, a miglior dritto avria potuto dirlo di una traduzione di Anacreonte, la quale se non è più che fedelissima, se non serba un suono, un ordine di parole esattissimamente rispondente a quello del testo, è piombo per oro forbito puro lucidissimo» (Poesie disperse, p. 281). 54 Fasano, L’entusiasmo, cit., p. 63. 51 126 Margherita Centenari questa nuova direzione, stimolato dalla lettura di due celebri articoli foscoliani pubblicati non molti anni prima sulla rivista «Annali di Scienze e Lettere»: Traduzione de’ due primi Canti dell’Odissea e Caro ed Alfieri traduttori di Virgilio 55. Essi – come Bigi ebbe il merito di notare per primo – incisero profondamente tanto sulla pratica traduttiva quanto sulle esposizioni teorico-critiche redatte da Leopardi, che poté in particolare trovare negli scritti foscoliani una reinterpretazione di quella norma di fedeltà, che tanta importanza aveva avuto nelle sue prime prove e che veniva declinata da Foscolo come principio di conservazione del “calore” sentimentale e fantastico dei testi antichi56. È tuttavia proprio sul terreno dell’interpretazione di questo principio di rigorosa e assoluta fedeltà che si registra anche il distacco di Leopardi dalle teorie del suo predecessore, ormai di stanza in Inghilterra, e al quale il giovane si era avvicinato mediante il filtro dei fogli letterari milanesi ed il confronto con gli autorevoli e ben più vicini Monti e Giordani. L’esigenza di strenua aderenza al greco, di cui Leopardi si sforzava di conservare ogni «gemma», tradiva infatti le reali intenzioni foscoliane, secondo le quali «la fedeltà del traduttore può e deve consentire una notevole elasticità e libertà rispetto alla lettera proprio allo scopo di una più profonda adeguazione alla concreta fisionomia storica dell’originale»57. Dunque, mentre di fatto il criterio perseguito da Foscolo portava, paradossalmente, ad una traduzione libera, Leopardi operava la scelta opposta, rispettando non solo il senso del testo-base, ma anche la sua forma; non solo lo spirito del modello, ma anche il suo corpo. Questa idea indirizzò le traduzioni del I libro dell’Odissea, del II dell’Eneide e delle Inscrizioni Triopee, tutte caratterizzate dall’estremo rigore con cui l’autore mantenne la più stretta osservanza del greco e Cfr. U. Foscolo, Traduzione de’ due primi Canti dell’Odissea, «Annali di Scienze e Lettere», II, 1810, n. 4, pp. 25-78 e Id., Caro ed Alfieri traduttori di Virgilio, ivi, VII, 1811, n. 21, pp. 358-397; entrambi i testi – il secondo in realtà arrangiato da Michele Leoni su materiali foscoliani – si leggono in U. Foscolo, Lezioni, articoli di critica e di polemica (1809-1811), a cura di E. Santini, Firenze, Le Monnier, 1933 («Edizione Nazionale delle Opere», vol. VII), pp. 197-230 e 437-456. La conoscenza leopardiana degli articoli è comprovata dalla presenza nella biblioteca recanatese delle due annate della rivista, che aveva costituito una delle letture di riferimento per Leopardi già durante la stesura della Storia dell’astronomia (cfr. Genetelli, Incursioni leopardiane, cit., pp. 3-97 e G. Panizza, Letture di un momento: un’indagine sui periodici, in Gli strumenti di Leopardi: repertori, dizionari, periodici. Pavia 17-18 dicembre 1998, a cura di M.M. Lombardi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2000, pp. 145-159). 56 Cfr. Bigi, Il Leopardi traduttore, cit., pp. 204-212. La lettura degli scritti foscoliani, inoltre, aveva favorito un cambiamento di rotta negli interessi di Leopardi, che si rivolse allo studio sistematico di «opere di grande respiro poetico e umano» (ivi, p. 205), come i poemi epici classici e la Bibbia, secondo un gusto che rispecchiava in parte anche quello testimoniato dalle nuove tendenze della filologia europea, per le quali cfr. Timpanaro, La filologia, cit., pp. 16-18. Un secondo punto di contatto con le teorie di Foscolo concerne l’importanza riservata alla conoscenza della lingua, della cultura e della storia antica, ritenuta il mezzo più sicuro per comprendere a fondo i classici e renderne al meglio il significato nelle traduzioni (cfr. Bigi, Il Leopardi traduttore, cit., pp. 206-207). Si aggiunga poi che più di recente Panizza e Genetelli hanno ribadito l’importanza del dialogo «serrato e vitale» intrattenutosi tra Foscolo e Leopardi in merito al vertere, approfondendone e precisandone molti aspetti salienti (cfr. Panizza, Da greco a italiano, cit., pp. 73 sgg. e Genetelli, Incursioni leopardiane, cit., pp. 9, 29-55, spec. 39-43). 57 Bigi, Il Leopardi traduttore, cit., p. 210. 55 «prendere persona di greco» 127 del latino, seguendo la precisa convinzione che il rigido conservatorismo rappresentasse la chiave per attingere alla tanto agognata «castissima santissima leggiadrissima natura»58. Tuttavia, passando dalla teoria alla pratica, e sempre più consapevole che il principio della fedeltà letterale talvolta rischiava di non rendere compiutamente le qualità estetiche del modello59, Leopardi non lesinava rese più libere che caricavano il testo di sfumature inattese – drammatizzandolo mediante l’impiego di intensificazioni patetiche, o impreziosendolo con arcaismi lessicali – e rispondevano all’esigenza di preservarne per intero il valore artistico ed emotivo, laddove una resa troppo fedele avrebbe rischiato di oscurarlo60. Una buona traduzione, dunque, non poteva limitarsi a riprodurre in un’altra lingua forma e contenuti dell’opera antica, ma richiedeva qualcosa di più audace: nel solco della lezione foscoliana61, il traduttore doveva immedesimarsi nel poeta che traduceva, cercando di ottenere con una versione vivida gli stessi effetti che il testo aveva prodotto sul suo pubblico originario. La pratica traduttiva finiva così per essere nobilitata e assimilata all’atto creativo, nella misura in cui essa si 58 Lettera ai Sigg. compilatori della Biblioteca Italiana in risposta a quella di Mad. la baronessa di Staël Holstein ai medesimi, TTP, p. 944. Com’è noto, Mario Fubini definì l’atteggiamento leopardiano testimoniato dalla Lettera «primitivismo classico» (M. Fubini, Giordani, Madame de Staël, Leopardi [1952], in Id., Romanticismo italiano. Saggi di storia della critica e della letteratura, Bari, Laterza, 19602, pp. 98-99), ma sullo stesso tema si veda anche il più recente Bonavita, L’autenticità è apocrifa, cit., p. 324, dove si parla di classicismo «sperimentale» soprattutto in merito alla produzione apocrifa degli anni 1816-1822. Sull’aderenza agli originali greci testimoniata dai volgarizzamenti di Odissea, Eneide ed Inscrizioni Triopee, cfr. di nuovo Bigi, Il Leopardi traduttore, cit., pp. 212-222. 59 Si ricordino le parole, dettate da un inedito senso di scoramento, che Leopardi consegnò alla premessa della Traduzione del libro secondo della Eneide: «E sì ho tenuto sempre dietro al testo a motto a motto (perché, quanto alla fedeltà di che posso giudicare co’ miei due occhi, non temo paragone); ma la scelta dei sinonimi, il collocamento delle parole, la forza del dire, l’armonia espressiva del verso, tutto mancava, o era cattivo, come, dileguatosi il poeta, restava solo il traduttore. Le immense difficoltà che ho scontrato per via, né puoi tu da per te stesso così bene penetrare come io che holle sperimentate, né posso io darti al tutto ad intendere con parole» (TTP, p. 434). 60 Tali caratteristiche si trovavano già nella traduzione del I libro dell’Odissea, ma, come osserva Bigi: «tutti questi aspetti – fedeltà letterale al testo antico, intensificazioni patetiche e indefinite ed aspri e solenni arcaismi – tornano più sistematicamente e intensamente accentuati, e legati da un rapporto più consapevole e non privo di una sua originalità letteraria, nella prima redazione, composta “sullo scorcio dell’estate” 1816, della versione del secondo libro dell’Eneide» (Il Leopardi traduttore, cit., p. 217). Sui patetismi del volgarizzamento dall’Odissea, cfr. inoltre A. Sole, La traduzione leopardiana del primo libro dell’Odissea, in Leopardi e il mondo antico. Atti del V convegno internazionale di studi leopardiani, Recanati 22-25 settembre 1980, a cura di U. Bosco, Firenze, Olschki, 1982, pp. 600-604 e I. Mazzini, Le traduzioni poetiche giovanili di Giacomo Leopardi (1809-17). Differenziazioni rispetto al modello, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata», XX, 1987, pp. 353-363, spec. pp. 358-359; su quelli, ben più numerosi, rintracciabili nella traduzione virgiliana, cfr. L. Blasucci, Una fonte linguistica per i Canti: la traduzione del secondo libro dell’Eneide [1981], in Id., Leopardi e i segnali dell’infinito, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 9-30. 61 Si vedano il famoso passo sull’indispensabile consonanza di spirito tra traduttore e autore antico nell’articolo Traduzione de’ due primi Canti dell’Odissea (Foscolo, Lezioni, cit., p. 210) e le puntuali osservazioni con cui Foscolo critica le versioni di Caro e Alfieri, inadeguate a riprodurre gli effetti poetici dell’originale virgiliano (cfr. ivi, pp. 437-456, passim). 128 Margherita Centenari faceva poesia e riproduceva in una nuova lingua il testo di partenza, mantenendovisi però strettamente e pienamente fedele. Questo stadio della riflessione leopardiana, già attivo all’altezza della primavera-estate 1816 e perseguito nelle versioni dell’Odissea e dell’Eneide 62, trova forse la sua più esplicita formalizzazione nell’elogio all’esemplare volgarizzamento omerico dell’Iliade montiana, contenuto nel discorso introduttivo alla Titanomachia di Esiodo (1817): «Abbiamo, non dirò una classica traduzione dell’Iliade, ma l’Iliade in nostra lingua, e già ogn’Italiano, letto il Monti, può francamente e veramente dire: ho letto Omero»63. Composto nel periodo in cui Leopardi elaborava ed approfondiva queste considerazioni, l’Inno a Nettuno finisce dunque per rappresentare l’esito più radicale – ma naturale – di una teoria traduttiva in continua evoluzione, che mirava al diretto recupero dell’antico attraverso la realizzazione di una versione moderna poeticamente ispirata. Proprio come quella dei volgarizzamenti, infatti, la lingua dell’Inno si proponeva di conservare l’eco della naturalezza greca, ma nel falso questa “risonanza” non veniva prodotta attraverso l’adesione ad un testo già esistente, bensì mediante una resa italiana che, camuffata da traduzione, fosse in grado di far trasparire al di sotto della sua superficie i tratti di un’opera autenticamente arcaica. Con la propria contraffazione, insomma, Leopardi dimostrava di riconsiderare su nuove basi lo stretto rapporto tra vertere ed inventio, ridisegnandolo secondo equilibri inediti, senza disconoscerne la fecondità. Se infatti, fino a quel momento, la traduzione aveva rappresentato l’unica chiave d’accesso all’ingenuità dei classici, con l’Inno egli sperimentava una strada nuova, quella dell’imitazione diretta dei modelli greci nell’ambito di una composizione lirica originale. La scelta di conferire alla propria contraffazione l’aspetto di un volgarizzamento, tuttavia, dimostrava allo stesso tempo l’impossibilità di svincolarsi definitivamente dalla prassi traduttiva, rivelando, al contrario, che per dare sostanza Lo dimostrano tanto le parole di ammonimento rivolte all’improvvida impresa di Bernardo Bellini – che aveva annunciato la preparazione di una «“traduzione in verso italiano di tutti i poeti classici greci”» nell’ovvia impossibilità di trovare una perfetta corrispondenza d’animo con ognuno di loro (Lettera ai compilatori della Biblioteca Italiana, TTP, p. 939) – quanto la prefazione alla Traduzione del libro secondo della Eneide: «so ben dirti avere io conosciuto per prova che senza esser poeta non si può tradurre un vero poeta» (ivi, p. 434). 63 Ivi, p. 444. Allo stesso ideale si rifanno anche le metafore di matrice alimentare ed erotica che Leopardi aveva impiegato qualche mese prima per descrivere il processo di assimilazione dei contenuti e dei valori artistici degli originali che ogni traduttore deve compiere: «Leggiamo e consideriamo e ruminiamo lungamente e maturamente gli scritti dei Greci maestri e dei Latini e degl’Italiani che han bellezze da bastare ad alimentarci per lo spazio di tre vite se ne avessimo» (Lettera ai Sigg. compilatori della Biblioteca Italiana in risposta a quella di Mad. la baronessa di Staël Holstein ai medesimi, ivi, p. 944) e «[…] Perciocché letta la Eneide (sì come sempre soglio, letta qual cosa è, o mi pare veramente bella), io andava del continuo spasimando, e cercando maniera di far mie, ove si potesse in alcuna guisa, quelle divine bellezze; né mai ebbi pace infinché non ebbi patteggiato con me medesimo, e non mi fui avventato al secondo Libro del sommo poema, il quale più degli altri mi avea tocco, sì che in leggerlo, senza avvedermene, lo recitava, cangiando tuono quando si convenia, e infocandomi e forse talvolta mandando fuori alcuna lagrima» (Traduzione del libro secondo della Eneide, ivi, p. 434). 62 «prendere persona di greco» 129 artistica alla propria opera era indispensabile riprodurre in essa i caratteri formali di una traduzione, la quale, proprio per la sua capacità di farsi eco dell’originale, rimaneva evidentemente il mezzo privilegiato per riproporre in lingua moderna la naturalezza primitiva. È allora in questa prospettiva che acquista ulteriore spessore lo stretto legame formale già notato da Bigi tra l’Inno a Nettuno e i volgarizzamenti del periodo; legame che si concreta tanto in una fitta trama di arcaismi, latinismi e grecismi propri anche delle versioni del 181664, quanto nella presenza di espressioni «grandiosamente patetiche e soprattutto indefinite» che richiamano direttamente quelle delle coeve traduzioni65. Ed è infine in questa stessa ottica che le parole con cui Leopardi, nell’Avvertimento, professa la propria fedeltà al presunto testo greco ritrovato non suonano affatto insincere, ma piuttosto dichiarano un reale sforzo di aderenza ai modelli, perseguito non solo e non principalmente allo scopo di beffare i lettori meno accorti, ma soprattutto con l’intento di rifare il verso antico: «Ho adoperato molto per tradurre fedelissimamente, e non ho trascurato pure una parola del testo, di che potrà agevolmente venire in chiaro chi vorrà ragguagliare la traduzione coll’originale, uscito che sarà questo alla luce»66. Come ha acutamente notato Pino Fasano, nell’Inno «per inseguire una poesia “senza modelli”, che si rispecchia direttamente nella natura, Leopardi non trova altro modo […] che una mimesi minuta e analitica, un doppio gioco di travestimento e finzione (“io dovea, essendo originale, studiarmi di parer traduttore”) che non tarderà molto ad apparirgli “opera più tosto dell’ingegno che della fantasia e della facoltà poetica”»67. III. Le ragioni di un falso 1. Tradurre e contraffare paiono dunque due differenti ma complementari aspetti di una stessa ricerca – estetica ed umana insieme – vòlta al recupero della purezza espressiva della poesia antica mediante l’imitazione. Proprio tale ricerca, sia pure implicitamente, viene indicata come scopo fondamentale dell’Inno nella più volte ricordata lettera a Giordani del 30 maggio 1817, dove l’impiego di una metafora derivata dal campo semantico erotico pone in evidenza il movente squisitamente poetico della Cfr. Bigi, Il Leopardi traduttore, cit., p. 224. Cfr. ivi, pp. 224-225. Sulla liricità propria di alcune immagini dell’Inno ha recentemente richiamato l’attenzione Lucio Felici (L’Olimpo abbandonato, cit., p. 19), che osserva come nel leopardiano racconto della nascita di Nettuno – vv. 13-48 – «il mito venga umanizzato e, ad un tempo, proiettato su uno scenario arcano e cosmogonico […]. Le divinità si identificano con le potenze e i fenomeni primordiali: il Cielo, la Terra, la Notte, i quali si alleano con un moto di pietà per proteggere una “nascita” dalla violenza edace di un altro dio, Saturno, che è Cronos ossia il Tempo che tutto consuma e divora. Contro il mito della crudeltà e della morte si afferma e si impone il mito della pietas e della vita»; nella stessa direzione andavano anche le brevi notazioni di D. De Robertis, Leopardi. La poesia, Bologna-Roma, Edizioni Cosmopoli, 1996, pp. 16-17. 66 Poesie disperse, p. 235. 67 Fasano, L’entusiasmo, cit. p. 73. 64 65 130 Margherita Centenari composizione: «Innamorato della poesia greca, volli fare come Michel Angelo che sotterrò il suo Cupido, e a chi dissotterrato lo credea d’antico, portò il braccio mancante. E mi scordava che se egli era Michel Angelo io sono Calandrino»68. Qualora insomma si volessero individuare le ragioni profonde che condussero il giovane autore alla stesura del falso, sarebbe in prima istanza necessario riconoscervi alla base una chiara intenzione letteraria. Ciò risulta tanto più vero se si pensa che la contraffazione – proprio in quanto finalizzata a riprodurre il verseggiare greco – potrebbe aver addirittura contribuito ad affrontare praticamente una delle questioni allora al centro del dibattito culturale, nonché di primaria importanza per lo stesso Leopardi, che di quel dibattito avrebbe voluto essere uno degli animatori: è ancora possibile fare vera poesia nei tempi moderni? A tale proposito, non sarà inutile notare che poco dopo l’inizio della composizione dell’Inno, egli volle discutere i termini di tale questione nella celebre Lettera alla «Biblioteca Italiana» spedita da Recanati il 18 luglio 1816: Ricordiamoci (e parmi dovessimo pensarvi sempre) che il più grande di tutti i poeti è il più antico, il quale non ha avuto modelli, che Dante sarà sempre imitato, agguagliato non mai, e che noi non abbiamo mai potuto pareggiare gli antichi […] perché essi quando voleano descrivere il cielo, il mare, le campagne, si metteano ad osservarle, e noi pigliamo in mano un poeta, e quando voleano ritrarre una passione s’immaginavano di sentirla, e noi ci facciamo a leggere una tragedia, e quando voleano parlare dell’universo vi pensavano sopra, e noi pensiamo sopra il modo in che essi ne hanno parlato; e questo perché essi e imprimamente i Greci non aveano modelli, o non ne faceano uso, e noi non pure ne abbiamo, e ce ne gioviamo, ma non sappiamo farne mai senza, onde quasi tutti gli scritti nostri sono copie di altre copie […]69. Replicando con decisione alle parole di Madame De Staël, che dalle pagine della rivista aveva suggerito ai letterati italiani di rivolgere le loro attenzioni «ad oltremonte e ad oltremare», Leopardi sosteneva la superiorità della tradizione greco-latina, di cui quella italiana era l’erede privilegiata, riconoscendo nella letteratura classica il solo modello degno di essere imitato in quanto depositario per eccellenza di quei fondamentali valori di naturalezza e semplicità ai quali egli, proprio negli stessi mesi, aveva cercato di attingere mediante la pratica traduttiva. Nondimeno – confessava – la modernità, pur operando nella massima fedeltà all’antico, non può illudersi di eguagliarne la bellezza, in quanto necessariamente vincolata ad esso dall’imitazione e quindi priva della semplicità propria della poesia primigenia, nata per definizione senza modelli70. Se, come è probabile, Leopardi iniziò a lavorare prima al falso che alla Lettera, non è escluso che proprio l’attività svolta intorno a quest’esperimento lo avesse spinto a tali riflessioni; con la sua contraffazione, egli mirava infatti a cogliere e a trasfondere nella lirica mo- Epist., p. 106, corsivo mio. TTP, p. 943. 70 Cfr. ivi, p. 944: «Nello stato in che il mondo si trova di presente, non si può scrivere senza aver letto, e quello che era possibile ai giorni d’Omero è impossibile ai nostri». Su questo concetto, forse derivato a Leopardi da Monti, cfr. Panizza, Da greco a italiano, cit., pp. 82-83. 68 69 «prendere persona di greco» 131 derna i medesimi valori poetici antichi che gli sarebbero poi parsi irrimediabilmente perduti. All’inizio della sua stesura, l’Inno costituiva ancora una via originale per fare vera poesia, un veicolo nuovo che avrebbe potuto rifunzionalizzare in senso creativo la pratica imitativa. Di qui dunque la volontà di mostrare «tutti i muscoli e i lineamenti» dell’ipotetico inno celato sotto la finta traduzione, con lo scopo innanzitutto «d’ingannare» i lettori – fatto che riguardava il falsario – ma insieme anche con quello, ben più nobile, di far sì che le bellezze antiche «pigliassero posto nella propria mente», secondo un processo assimilatorio che interessava esclusivamente il poeta e che gli avrebbe consentito in ultima istanza di «prendere persona di greco»71. Forse proprio questa volontà, soffocata dalle molte difficoltà incontrate durante l’elaborazione del testo – delle quali rimane traccia nella missiva a Giordani72 – spinse Leopardi a denunciare la condizione potenzialmente aporetica di una letteratura moderna che, pur ispirata a quella primitiva, faticava ad essere altrettanto “spontanea” perché costretta in ogni caso a farsi deteriore imitazione di quella. 2. Oltre al movente letterario, che, come si è cercato di dimostrare, rivestì un ruolo di assoluto rilievo nella realizzazione dell’Inno a Nettuno, anche altre ragioni di natura più personale stimolarono la composizione del poema: prima tra tutte la divorante ambizione del suo giovane autore. Proprio nel 1816 Leopardi iniziò ad affrancarsi dai ristretti orizzonti della provincia marchigiana, intrattenendo una serie di rapporti epistolari con alcuni dei più importanti uomini di cultura del tempo, come Angelo Mai e gli editori Giuseppe Acerbi e Anton Fortunato Stella, sulla cui rivista egli aveva pub- L’intenzione perseguita da Leopardi di immedesimarsi nella lirica antica a tal punto da farsi poeta greco era già stata ben individuata da Giordani, il quale affermava (cfr. Proemio a Leopardi, Studi filologici, cit., p. XVI e vd. pp. XVII-XVIII, XXII): «io vorrei dire ch’egli fosse una di quelle anime preparate da natura per incarnarsi in Grecia sotto i tempi di Pericle e di Anassàgora; e da non so qual errore tardata sino a questi miseri giorni ultimi d’Italia: per mezzo i quali, parlando con voce italiana pensieri greci, come straniera passò. Nè vi parrà assurdo il mio imaginare, se guardate ciò che scrisse qualora volle prendere persona di greco. Vedete l’inno a Nettuno stampato nel 1817 prima di avere 19 anni. Chi non si spaventa alla moltitudine di autori, anche de’ meno conosciuti alla massima parte de’ letterati; onde il giovinetto autorizza quasi ogni parola del suo non breve componimento? chè ben lo sapete inventore di quello che fingeva di avere tradotto. Ma questo è ancora poco; al che potevano bastare gran tempo e gran pazienza. Chi ha domestichezza cogli antichi greci ne dica se poteva farsi cosa più greca, più antica; veda se tra tutti gl’Inni che ci restano della greca antichità se ne legge uno di eguale bellezza. Tanto egli era dentro alla teologia di quel popolo!». Che Leopardi non coltivasse questa aspirazione ingenuamente, illudendosi cioè di poter annullare la distanza cronologica che lo separava dall’antichità, lo dimostrano da un lato – nell’approccio ai testi classici – il costante ricorso al filtro della filologia (cfr. G. Benedetto, Giordani, Leopardi «sommo filologo» e gli studi di greco nell’Italia della Restaurazione, in Giordani Leopardi 1998. Convegno nazionale di studi, Piacenza 2-4 aprile 1998, a cura di R. Tissoni, Piacenza, Tip.Le.Co, 2000, pp. 77-129) e, dall’altro, lo statuto stesso del falso che porta «dentro di sé la duplice figura di uno scrivere che cerca di avvicinarsi all’antica perfezione ed insieme, nel suo anelito “regressivo”, racchiude il germe della lacerazione, la consapevolezza della distanza: la traduzione è una scrittura che comunque rinvia all’originale, il falso è un travestimento precario ed artificioso» (Bonavita, L’autenticità è apocrifa, cit., p. 322 e vd. le pp. 321-323). 72 Cfr. supra p. 106. 71 132 Margherita Centenari blicato in quegli anni gran parte delle proprie opere73. Sempre nello stesso periodo, in un significativo ed accorato appello contenuto nel discorso introduttivo alla versione dell’Odissea, Giacomo aveva dimostrato una spiccata determinazione a proporsi sulla scena intellettuale italiana in veste di filologo e traduttore74; intento pienamente confermato dalla decisione stessa di impegnarsi a volgarizzare un poema che, come si legge nell’articolo foscoliano sulla Traduzione de’ due primi Canti dell’Odissea, non aveva ottenuto ancora in Italia una degna versione75. Non è certo casuale inoltre che proprio al 1816 risalgano anche gli scritti teorici contenuti nelle lettere inviate alla «Biblioteca Italiana», che rappresentarono i primi concreti tentativi di partecipare attivamente alle ferventi querelles promosse dalla rivista e divenirne uno stabile collaboratore76. La composizione dell’Inno, maturata in questa stessa temperie di aspirazioni ed aspettative, e sostanziata da un ampio sfoggio di dottrina, non poteva non essere animata dal medesimo desiderio di dimostrare alla società intellettuale contemporanea le proprie Per i primi rapporti tra Leopardi ed Angelo Mai, non sempre animato da buone intenzioni nei confronti del giovane collega, cfr. Timpanaro, La filologia, cit., pp. 25-41. Per ciò che concerne i legami della famiglia Leopardi con l’ambiente editoriale milanese e in particolare con Stella si vedano gli studi di P. Landi, L’editore milanese Anton Fortunato Stella e i primi rapporti con casa Leopardi, «Otto/Novecento», XI, 1987, nn. 3-4, pp. 5-32; Ead., Leopardi e Milano. Per una storia editoriale di Giacomo Leopardi, Milano, Electa, 1998, passim e Genetelli, Incursioni leopardiane, cit., pp. 164-198. Non si dimentichi poi che ai primissimi mesi del 1817 (anno della pubblicazione dell’Inno) risalgono anche i contatti del giovane con Monti e Giordani, noto al contino già dal 1816, quando egli leggeva con «avidità da affamato» gli articoli del futuro maestro che conferivano «stabilità e forza alla sua conversione» letteraria (Epist., lettera del 30 aprile 1817, p. 93). Sull’ancora troppo poco indagata relazione tra Leopardi e Monti, cfr. Panizza, Da greco a italiano, cit., pp. 75-85; A. Bruni, Giordani, Leopardi, Monti e la cultura milanese, in Giordani Leopardi 1998, cit., pp. 131-160; D. Vanden Berghe, Osservazioni sull’«omerismo leopardiano», «Italianistica», XXX, 2001, n. 2, pp. 341-361 e ancora Genetelli, Incursioni leopardiane, cit., pp. 37-41, i quali riconoscono numerose contiguità tra le riflessioni leopardiane e quelle montiane in merito al vertere e alle categorie di “originale” e “imitazione”. 74 Scriveva Leopardi: «M’inginocchio innanzi a tutti i letterati d’Italia per supplicarli a comunicarmi il loro parere sopra questo Saggio, pubblicamente o privatamente, come piacerà loro quando non mi credano affatto indegno delle loro ammonizioni. Deh! possano essi parlarmi schiettamente, e risparmiarmi una fatica inutile, se questo Saggio non può esser lodato con sincerità» (TTP, p. 423). Queste ingenue esternazioni, tra l’altro, costarono al giovane qualche canzonatura da parte degli intellettuali milanesi (cfr. Epist., pp. 86-87 e 114). 75 Cfr. Foscolo, Lezioni, cit., p. 198. Sulle ragioni che spinsero il recanatese a preferire la traduzione dell’Odissea a quella della ben più amata Iliade (prima fra tutte, il timore di misurarsi con Monti), cfr. Sole, La traduzione leopardiana del primo libro dell’ Odissea, cit., pp. 595-597 e Parrini Cantini, «M’inginocchio innanzi a tutti i letterati d’Italia», cit., pp. 89-94, dove si sostiene anche che il giovane poeta non conoscesse, se non di fama, la versione pindemontiana dei primi due canti dell’Odissea, approntata dal veronese ed edita già nel 1809 (I. Pindemonte, Traduzione de’ due primi canti dell’ Odissea e di alcune parti delle Georgiche. Con due epistole, una ad Omero, l’altra a Virgilio, Verona, Gambaretti, 1809). 76 Per i rapporti che legavano il giovane ad alcune delle maggiori riviste letterarie del tempo – in particolare ai rasoriani «Annali di Scienze e Lettere» e alla tanto apprezzata «Biblioteca Italiana» – cfr. Genetelli, Incursioni leopardiane, pp. 3-97; Panizza, Letture di un momento, passim ed E. Bigi, Il Leopardi e i romantici, in Id., Poesia e critica tra fine Settecento e primo Ottocento, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1986, pp. 149-173. 73 «prendere persona di greco» 133 straordinarie capacità, le quali peraltro avrebbero presto iniziato ad ottenere illustri estimatori, tra cui Monti e Mai, che – come affermava Giordani – «non deono maravigliarsi per poco», ma di fronte alle doti del precoce contino «sogliono al pari di me stupirsi»77. Al di là però delle alte ambizioni nutrite da Leopardi, la realizzazione dell’Inno a Nettuno si arricchisce di un altro movente del tutto congeniale all’indole del suo autore: il gusto per la beffa. La vocazione parodica e scherzosa aveva fatto parte dell’esperienza letteraria leopardiana fin dalla traduzione della Batracomiomachia 78 e, come è stato da più parti rilevato, non manca di far capolino anche nell’Avvertimento del falso, dove il tono fintamente pedante che ne caratterizza l’esposizione suggerisce un intento non certo emulativo, ma al contrario fortemente canzonatorio rivolto dall’autore alle ridicole pose spesso assunte da certi polverosi perlustratori d’archivio, dei quali egli prende di mira soprattutto la smaniosa impazienza di avere sottomano sempre nuovi testi antichi79: ed egli [scil. l’amico che nella finzione avrebbe scoperto il manoscritto dell’inno], tuttochè io ripugnassi moltissimo, non volendo annunziare il primo la sua scoperta e farmi bello di cosa non mia, imposemi che dessi incontanente al Pubblico la mia traduzione, dicendo essersi già tardato anche troppo a far tutti consapevoli dell’accaduto, e tornar meglio con una versione della cosa scoperta far conto ai letterati lo scoprimento, che darne loro la secca novella in una gazzetta, da che eglino per lo più sono mossi ad impazienza, e stretti quasi a mormorare d’ogn’indugio che trappon l’Editore, il quale non può spacciarsi così tosto80. Un gusto per l’ironia, che, a pochi mesi dalla pubblicazione dell’opera, si faceva più scoperto e prendeva le forme di un compiaciuto e divertito sarcasmo in una lettera indirizzata a Giordani e datata al 14 luglio 1817, dove Leopardi raccontava all’amico 77 La citazione è tratta da una lettera inviata da Giordani «il dì di Pasqua» del 1817 (in Epist., p. 76). In generale, l’epistolario del 1817 testimonia i giudizi, per lo più lusinghieri, che tali illustri personaggi diedero di alcune prove letterarie del giovane poeta ricevute in omaggio. Quanto all’Inno, chiunque si sarebbe stupito di fronte alla ricca dottrina esibita nel suo apparato di note; si rileggano in proposito le parole piene di ammirazione, mista ad una sincera preoccupazione per le cagionevoli condizioni di salute del contino, che Giordani rivolse a Leopardi nella missiva inviatagli da Milano «il dì dell’Ascensione» del 1817: «E in questo timore [scil. per la salute di Giacomo] mi premeva di più l’aver letto il suo inno a nettuno, accompagnato di tanto eruditissime note: parendomi impossibile che tanta erudizione, ch’io nè vidi nè lessi mai in alcuno della sua età, non possa aversi senza danno grave d’una salute anche più vigorosa e gagliarda della sua» (ivi, p. 101). 78 Nel Discorso introduttivo alla versione, Leopardi si appellava all’autorità di Alexander Pope per affermare che la vena mercuriale non è estranea nemmeno agli spiriti più elevati: «e Pope dice che un grande autore può qualche volta ricrearsi col comporre uno scritto giocoso, che generalmente gli spiriti più sublimi non sono nemici dello scherzo, e che il talento per la burla accompagna d’ordinario una bella immaginazione, ed è nei grandi ingegni, come sono spesso le vene di mercurio nelle miniere d’oro» (TTP, p. 395). 79 Cfr. le considerazioni contenute in Bonavita, L’autenticità è apocrifa, cit., p. 323 e Tellini, Rifare il verso, cit. pp. 200-203. 80 Poesie disperse, p. 234. 134 Margherita Centenari della fortuna che l’Inno aveva riscosso là dove meno avrebbe dovuto averne, a Roma, nella patria della filologia e dell’erudizione: L’Inno a Nettuno ha avuto fortuna a Roma dove meno dovea. S’arrabattano p[er] trovare quel Ciamberlano, il quale p[er] la paura è corso subito a intanarsi, e rannicchiarsi in me di maniera che siamo diventati tutt’uno. E sì come lassù il saper leggere non è da tutti, credono che la Vaticana m’abbia somministrato l’inno (quando io a bello studio ho detto ch’è stata una piccola libreria di pochissimi manoscritti) e il Custode di quella biblioteca giura che scoprirà chi ne l’abbia cavato senza saputa sua81. 3. Gli argomenti fin qui addotti cercano di individuare le ragioni più o meno profonde che spinsero Leopardi a comporre l’Inno a Nettuno e contribuiscono perciò a motivarne la genesi, ma lasciano inevasa un’importante questione che riguarda da vicino la sua stessa fisionomia: perché Leopardi scelse di contraffare proprio un antico inno greco82? Una prima ipotesi a questo riguardo potrebbe spiegare la scelta di genere con una scelta di stile. Insieme all’epos, l’innologia religiosa greca costituisce infatti una delle espressioni più arcaiche della letteratura classica e – proprio in ragione dell’aura di primitivo che la circonda – essa poteva costituire il genere più adatto per avvicinarsi alla naturalezza espressiva delle origini. D’altronde è Leopardi stesso, nell’Avvertimento, a fingere di sostenere la notevole antichità del testo greco ritrovato, assumendo come termine di paragone per la sua attribuzione le composizioni innodiche di Panfo Ateniese, poeta collocato dalla tradizione in un’epoca addirittura precedente a quella omerica83. Gli inni greci arcaici presentavano inoltre una stretta affinità stilistica e contenutistica con un genere letterario che in quel periodo suscitava il più fervido interesse da parte di Leopardi, l’epica. Non sarà infatti una semplice coincidenza che la stesura dell’Inno si collochi proprio a ridosso di quelle dei volgarizzamenti del canto I dell’Odissea e del II dell’Eneide, entrambe realizzate nel corso della primavera-estate del 1816 e stimolate, come già accennato, dalla lettura dei due articoli foscoliani sul tradurre. Epist., p. 125. In realtà l’Inno a Nettuno solleverebbe almeno un’ulteriore questione di sicuro interesse, alla quale, tuttavia, in mancanza di precisi e soddisfacenti riscontri, si può solo per il momento accennare e che riguarda i possibili rapporti tra la contraffazione leopardiana e la voga falsificatoria diffusasi nell’Italia di inizio Ottocento. Come recentemente dimostrato da Sandra Covino, nei primi decenni del XIX secolo si falsificava, oltre che per truffa e guadagno, anche per seguire la moda culturale e di costume, per entrare in maniera furbescamente coperta, e spesso polemica, nel dibattito linguistico sul purismo, oppure ancora per sostenere rivendicazioni patriottiche, o peggio, campanilistiche (cfr. Covino, Giacomo e Monaldo Leopardi falsari trecenteschi, cit., pp. 1-157). Nonostante ciò, non è facile ricostruire concreti rapporti tra questa moda e l’Inno: mancano ancora indizi significativi che portino a ritenere che Leopardi, al tempo della stesura del testo, fosse a conoscenza di contraffazioni di opere antiche che avrebbero potuto ispirare o in qualche modo influenzare il suo “scherzo”, come ad esempio i “frammenti fanoclei” inseriti nella Chioma foscoliana (cfr. infra nota 90). 83 Cfr. Poesie disperse, p. 235. Sugli effetti epicizzanti e sacralizzanti ottenuti da Leopardi nell’Inno mediante il modulo della ripetizione, cfr. Santagata, Quella celeste naturalezza, cit., pp. 91-93. 81 82 «prendere persona di greco» 135 La scelta di contraffare un antico inno può però esser giustificata anche alla luce di un’altra ben più documentabile motivazione di natura “contestuale”. L’interesse per l’innologia greca sembra infatti avere costituito, nelle varie forme in cui si espresse – produzione di edizioni, commenti, riscritture, ecc. – una sorta di moda letteraria attiva in Italia tra la seconda metà del Settecento e il primo Ottocento84. Stando ai dati che è possibile raccogliere dai maggiori repertori bibliografici del tempo, compilati da Jacopomaria Paitoni (1766-1767) e da Fortunato Federici (1828)85, assai numerosi furono a quell’epoca gli italiani che vollero cimentarsi in volgarizzamenti di testi classici86 e in particolare in quelli di inni omerici e callimachei: il solo catalogo federiciano, per il quarantennio 1780-1820, elenca dieci pubblicazioni recanti traduzioni di inni appartenenti al corpus omerico e ne riporta addirittura quattordici per quelli contenuti nella silloge callimachea, che, insieme ai primi, vennero volgarizzati da alcune tra le personalità più rilevanti nel panorama letterario italiano dell’epoca come Conti, Pagnini e Pindemonte87. Nello stesso periodo anche l’uscita di edizioni critiche e commenti fu assai abbondante88, ed è proprio guardando a questo continuo lavoro di esegesi e traduzione protrattosi per alcuni decenni che si può comprendere la decisione presa dal classicista Giuseppe Ignazio Montanari – professore di retorica presso Pesaro – di ampliare le sue Istituzioni di rettorica e belle lettere, tratte dalle lezioni dello scozzese Hugh Blair, con una sezione nuova ed integralmente dedicata all’innologia, dove ampio spazio veniva accordato alle composizioni greche e latine, in virtù del loro ruolo fondativo nei confronti della produzione moderna89. Ancora ai primi anni del XIX secolo 84 Tracce di un simile interesse sono presenti anche nel panorama europeo. Significativo è il numero delle edizioni e delle traduzioni di inni omerici e callimachei stampate in Europa tra la metà del XVIII e l’inizio del XIX secolo: si confrontino, solo a titolo esemplificativo, i cataloghi riportati nella Bibliotheca scriptorum classicorum, hrsg. von W. Engelmann, 2 voll., Hildesheim-Zurich-New York, Olms, 19928, vol. I, Scriptores graeci, pp. 393-411 e pp. 235-236. Non mancavano inoltre trattazioni teoriche specificamente dedicate all’innologia greca, come la De Hymnis Veterum maxime Graecorum Dissertatio Inauguralis di J.A. Kries (Göttingen, Vandenhoeck, 1742). 85 Rispettivamente, J. Paitoni, Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati, 5 tt., Venezia, Occhi, 17661767 e F. Federici, Degli scrittori greci e delle italiane versioni delle loro opere, Padova, «pei Tipi della Minerva» [senza indicazione dello stampatore, ma la licenza è di Simone Occhi], 1828. Un fondamentale contributo su Le «Biblioteche» dei volgarizzatori si trova nell’omonimo articolo di F. Longoni edito nel volume Biblioteche del mondo antico. Dalla tradizione orale alla cultura dell’impero, a cura di A.M. Andrisano, Roma, Carocci, 2007, pp. 163-173. 86 Sulla diffusione delle traduzioni dei classici greci e latini nella penisola all’alba del XIX secolo, cfr. almeno P. Treves, Lo studio dell’antichità classica nell’Ottocento, Milano-Napoli, Ricciardi, 1962 e M. Mari, Momenti della traduzione fra Settecento e Ottocento, Milano, Istituto di propaganda libraria, 1994, accanto ai quali si possono citare i più recenti volumi miscellanei Traduzioni letterarie e rinnovamento del gusto, cit.; Teorie e forme del tradurre in versi nell’Ottocento fino a Carducci. Atti del convegno internazionale, Lecce 2-4 ottobre 2008, a cura di A. Carrozzini, Galatina, Congedo, 2010 e Traduzioni e traduttori del Neoclassicismo, a cura di G. Cantarutti, S. Ferrari e P.M. Filippi, Milano, Franco Angeli, 2010. 87 Cfr. Federici, Degli scrittori greci, cit., pp. 32-33, s.v. «Omero» e pp. 187-188 s v. «Callimaco». 88 Cfr. ivi, pp. 17-19 per le edizioni omeriche e pp. 186-187 per quelle callimachee. 89 Cfr. G.I. Montanari, Istituzioni di rettorica e belle lettere tratte dalle lezioni di Ugo Blair dal padre Francesco Soave, 2 tt., Firenze, Ricordi, 18392, t. II, cap. IV: Dell’Inno, pp. 45-58. 136 Margherita Centenari risale la pubblicazione di uno dei più noti casi di “falsificazione” di inni antichi, quello operato da Foscolo nel commento alla Chioma di Berenice (Milano, 1803), in cui il poeta aveva presentato ai suoi lettori alcune porzioni di versi delle future Grazie, facendoli passare per frammenti innodici greci da lui ritrovati e tradotti90. Sebbene non sia possibile affermare che Leopardi avesse avuto notizia di tale esperimento letterario, né che ne avesse eventualmente percepita la reale natura91, è interessante notare che esso proveniva proprio da uno dei poeti-traduttori che senza dubbio aveva influenzato più profondamente l’esperienza letteraria del giovane recanatese nel corso del 1816. A fianco poi di edizioni, volgarizzamenti e contraffazioni, significativa fortuna ebbero anche certe produzioni liriche originali, direttamente ispirate all’innologia antica, che potremmo definire vere e proprie composizioni “alla greca”, redatte in volgare e dedicate alle divinità olimpiche, in cui i numerosissimi richiami alla tradizione ellenica venivano ricoperti da un’evidente patina neoclassica. Particolarmente rilevante a questo riguardo è la raccolta intitolata Inni A gli Dei Consenti, un elegante opuscolo per nozze pubblicato a Parma nel 1812 per i tipi bodoniani e probabilmente noto a Leopardi già prima del 1817, come parrebbero suggerire le parole piene di modestia contenute in una lettera inviata dal giovane il 17 ottobre di quell’anno al cugino Francesco Cassi che, all’interno di tale raccolta, aveva composto proprio un Inno a Nettuno 92: Carissimo Cugino | Avendo avuta occasione di pubblicare un inno [sic] a Nettuno, e ricordandomi di quello che voi scriveste sulla med.a divinità p[er] le nozze Perticari e Monti, ho voluto mandarvi una copia del mio opuscolo, non già perchè lo paragonaste col vr̃o, ma perchè aveste il diletto di vedervi vincitore senza combattere. La copia che vi mando è della seconda ediz.e molto più corretta della prima, che è stata fatta l’Aprile passato. Come vedete, la cosa non è di q.i giorni, ed io già ci vedo mille difetti; sì che a voi che p[er] l’amicizia me li perdonerete, volentieri la mando in segno di confidenza, ma non vorrei che la mostraste alle persone di buon giudizio. Più tosto avrò ben caro che me ne diciate sinceram.e e anche severam.e il vr̃o parere. Siate certissimo che mi farete sommo favore dicendomene t.o il male che meriterà93. 90 Nella nota di commento al v. 57 della Chioma catulliana, Foscolo cita la propria traduzione di un passo tratto da un presunto antico inno alle Grazie, nel quale vengono descritte una scena di banchetto e le Ore intente a risciacquare le briglie nelle acque del fiume Peneo: «Ne’ frammenti greci ch’io credo d’un antico inno alle Grazie, da me un tempo tradotti, veggonsi le Ninfe fluviali ancelle ad un convito dato in Tempe da Venere a tutti gli Dei, e le Ore ministre del carro e de’ cavalli del Sole […]» (U. Foscolo, Scritti letterari e politici: dal 1796 al 1808, a cura di G. Gambarin, Firenze, Le Monnier, 1972 [«Edizione Nazionale delle opere», vol. VI], p. 350). 91 Stando alle notizie riportate dal Catalogo della Biblioteca Leopardi in Recanati (1847-1899), a cura di A. Campana, prefazione di E. Pasquini, Firenze, Olschki, 2011, non sembra che Leopardi possedesse il testo della Chioma foscoliana, la quale, pubblicata in pochissime copie nel 1803, non risulta essere conservata presso la biblioteca paterna. 92 Il testo degli Inni viene anche riportato nel IV Elenco di letture leopardiane (settembre 1823): cfr. Zibaldone, vol. III, p. 1146. 93 Epist., p. 148. Sui rapporti tra Cassi e Leopardi, cfr. almeno S. Sconocchia, La cultura classica nelle Marche del primo Ottocento e la filologia di Giacomo Leopardi, in Quei monti azzurri. Le Marche di Leopardi, a cura «prendere persona di greco» 137 L’opuscolo, manifesto programmatico di una scuola letteraria di alto livello come fu quella classica romagnola e allestito sotto l’egida di Monti, venne stampato «per Decreto dei Dodecandri» dell’Accademia Simpemenia dei Filopatridi in occasione delle nozze tra Telesilla Meonia (Costanza Monti, figlia del poeta) e Alceo Compitano (Giulio Perticari). Esso contiene quindici inni, che già alla prima lettura mostrano per aspetto e contenuto innumerevoli difformità rispetto al falso leopardiano94; si tratta infatti di testi dall’impronta anti-romantica e purista, composti per lo più in terza rima e riguardanti temi prettamente erotici, dettati dall’occasione per la quale essi vennero redatti95. Tra i molti casi di moderni rifacimenti, uno in particolare che invece potrebbe più direttamente aver influito sull’esperimento leopardiano è costituito dall’inno A Nettuno che il giovane erudito maceratese Giuseppe Boccanera aveva pubblicato sul quaderno LVIII de’ «Lo Spettatore Italiano» del 15 agosto 1816, ben sei mesi prima del licenziamento definitivo dell’Inno da parte di Leopardi, e proprio sullo stesso fascicolo del giornale nel quale Giacomo aveva nel frattempo editato la prima parte delle Poesie di Mosco 96. Il testo di Boccanera si compone di nove strofe costruite sull’alternanza di quattro endecasillabi e quattro settenari (rima ababcded) ed è il frutto, come di E. Carini, P. Magnarelli e S. Sconocchia, Venezia, Marsilio, 2002, pp. 296-297 e P. Palmieri, «Non m’arrischio di scrivergli il primo»: Leopardi, Cassi, Perticari e la Scuola classica romagnola, ivi, cit., pp. 363-388, spec. pp. 377-382. 94 Gli autori dei quindici inni sono: Enrica Dionigi, Paolo Costa, Tommaso Poggi, Francesco Cassi, Luigi Biondi, Pellegrino Farini, Loreto Antonio Santucci, Giambattista Giusti, Eduardo Bignardi, Giovanni Gucci, Bartolomeo Borghesi, Camillo Bertoni, Girolamo Amati, Cesare Arici (l’Inno a Vulcano è anonimo). Sulla Scuola classica romagnola e i suoi rappresentanti (oltre a quelli già menzionati e al Perticari, si ricordino anche Vincenzo Monti, caposcuola del gruppo, Dionigi Strocchi, Terenzio Mamiani, Monaldo Leopardi e forse lo stesso Giacomo), cfr. Scuola classica romagnola. Atti del convegno di studi, Faenza 30 novembre-1-2 dicembre 1984, Modena, Mucchi, 1988 e la ricca rassegna bibliografica di C. Nonni, Interpres ut poeta. La Farsaglia di Francesco Cassi, Bologna, Pàtron, 2010. 95 A questo proposito illuminante è il giudizio che Timpanaro diede dell’Inno a Nettuno di Cassi nel Dizionario biografico degli Italiani, 78 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-, vol. XXI, 1978, s.v., p. 466: «L’inno del C. non è certo tra i migliori della raccolta: presenta, accentuati, quei caratteri di freddo neoclassicismo e sovrabbondante erudizione mitologica che, in varia misura, si notano anche negli altri». 96 Gli scritti leopardiani erano stati pubblicati da Stella nella Parte Italiana del LVIII quaderno della rivista (t. VI) e collocati prima di una lunga Ode redatta da Giuseppe Boccanera in onore di Sua Maestà Ferdinando IV Re delle due Sicilie, la quale a sua volta era seguita dall’inno A Nettuno del medesimo autore (pp. 214-215). A meno di non pensare ad un’eventuale conoscenza pregressa di questo testo da parte di Giacomo (fatto del resto possibile, data la diffusa prassi di far circolare localmente i propri inediti), se l’ipotesi esposta alle pagine seguenti fosse confermata, si porrebbe innanzitutto un problema di datazione per l’autografo recanatese dell’Inno (AR), testimone forse non delle primissime fasi di stesura del componimento, ma di quelle appena successive, e in particolare posteriori all’uscita dell’inno di Boccanera. Anche il lavoro compiuto da Leopardi sul falso verrebbe in questo caso ad estendersi ben oltre la primavera del 1816, suggerendo così come il poema fosse stato oggetto di molteplici interventi e ripensamenti da parte dell’autore; fatto che parrebbe anche indirettamente confermato dall’attento lavoro di postillatura immediatamente successivo alla stampa (aprile 1817) e documentato da AN1, cfr. supra nota 12. 138 Margherita Centenari quello leopardiano, di un’interessante e dotta esercitazione, nella quale trova spazio un abbondante accumulo di dati di genere mitologico relativi al dio Nettuno e cuciti insieme all’interno del tessuto narrativo ed espositivo dell’opera. Alcune significative convergenze contenutistiche e formali, rilevabili ad un rapido confronto tra i testi, spingono a nutrire il sospetto che questo scritto abbia potuto in qualche misura influenzare Leopardi durante la realizzazione dell’Inno. Facilmente si noterà infatti che in esso vengono replicati alcuni stilemi e moduli retorici già presenti nel poema di Boccanera. Si pensi ad esempio al reiterato ed anaforico uso che il giovane recanatese fece dell’allocutivo «a te» rivolto alla divinità, registrato anche presso Boccanera con così alta frequenza da divenire quasi una cifra distintiva di entrambi i componimenti: A te (in incipit di verso o di periodo) B vv. 1, 49, 53 ~ L vv. 3, 89, 133, 164, 181; a te (interno al verso) B vv. 8, 16, 38, 46 ~ L vv. 7, 84, 95, 103, 123, 152, 16897. Inoltre, la formula deprecatoria «stolto colui che» / «stolto che», di derivazione omerica98, è impiegata dai due autori con il medesimo scopo di introdurre nel tessuto lirico una digressione di natura narrativa e mitologica, il cui protagonista – Ippolito per Boccanera e Laomedonte per Leopardi – macchiato dalla pesante colpa di avere disconosciuto il potere divino, viene atrocemente punito da Nettuno99. Sempre sul piano formale, è poi assai frequente che nomi propri, sostantivi ed attributi già utilizzati dal maceratese e motivati da scelte lessicali non scontate – spesso legate al modulo epicizzante della ripetizione – ricorrano identici nel falso, pur assumendo talvolta funzioni logiche differenti: 97 Per le citazioni tratte dal componimento di Boccanera mi sono avvalsa della copia della rivista conservata presso la Bodleian Library di Oxford e disponibile on-line alla pagina web [http://books.google. it]. Qui e di seguito indico l’inno di Boccanera con la sigla “B” e l’inno di Leopardi con “L”; il simbolo ~ segnala invece il confronto tra i due testi. 98 «Stolto» rende il greco νήπιος, che nell’epos omerico sistematicamente si abbina ad un intervento della voce narrante che sottolinea la tragicità e la cieca stoltezza dei personaggi, i quali, a differenza degli dèi che li guidano, non conoscono il loro destino: cfr. e. g. Il. II 37-38 φῆ γὰρ ὅ γ’ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ | νήπιος, οὐδὲ τὰ ῇδη, ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα «Pensava di prendere la città di Priamo quel giorno, / stolto! che non sapeva quali opere meditava Zeus», cfr. Omero, Iliade, trad. R. Calzecchi Onesti, a cura di C. Pavese, Torino, Einaudi, 1950. Sull’impiego di tale formula nei poemi omerici, cfr. I.J.F. De Jong, Homer, in Narratas Narratees, and Narratives in Ancient Greek Literature, edd. by I.J.F. De Jong, R. Nünlist and A. Bowie, Leiden-Boston, Brill, 2004, pp. 14-18. 99 Sono i vv. 55-72 di B, dove si trovano narrate le tristi vicende di Ippolito, giovane figlio di Teseo, devoto alla vergine Diana ed indifferente al culto di Venere. Punito dalla dea dell’amore che volle condurlo alla rovina, Ippolito venne ucciso proprio dal dio Nettuno che fece imbizzarrire i cavalli che trainavano la sua biga, esaudendo così la maledizione scagliata contro di lui dal padre. In L, ai vv. 59-73, si legge invece del violento maremoto che travolse Troia, su cui regnava l’improvvido Laomedonte, il quale si era attirato le ire della divinità del mare venendo meno alla promessa di ricompensarla per la costruzione delle mura della città. «prendere persona di greco» 139 Nume (B vv. 1, 34, 56 ~ L vv. 12, 32, 121, 202); possente (B vv. 1, 60 ~ L vv. 91, 119, 191, ampiopossente v. 133); venti (B vv. 2, 31 ~ L vv. 163 sing., 169 sing., 187 sing., 199); fremente (B v. 3 ~ L gravi-fremente v. 142); vergini (B v. 7 ~ L v. 89 sing.); Eleo (B v. 10 ~ L Elate v. 175); onda (B vv. 11, 30 pl., 36 pl. ~ L vv. 67 pl.,169, 183 pl., 200 pl.); Trezenio (B v. 15 ~ L v. 176; Trezene v. 193); Ega (B v. 17 ~ L vv. 154, 194); fren (B v. 19 ~ L v. 92); indomito (B v. 27 ~ L v. 161); sonante (B v. 28 ~ L alti-sonante vv. 22, 141, 185); Trinacrie (B v. 32 ~ L Trinacria v. 125); arciero (B v. 33 ~ L v. 86 pl.); Anfitrite (B v. 34 ~ L v. 105); Dori (B v. 34 ~ L Doride v. 105); impero (B v. 35 ~ L vv. 7, 170); tempeste (B v. 39 ~ L v. 197 sing.; tempestose nubi v. 186); divino (B vv. 40, 68 sing.f. ~ L vv. 156 sing.f., 165 pl.f.); destrier (B v. 42 ~ L vv. 83, 92 pl., 99 pl.); corso (B v. 42 ~ L v. 85); toro candido (B v. 45 ~ L neri tori v. 135); voti (B v. 50 ~ L v. 181); nocchiero (B v. 50 ~ L nocchier vv. 4, 182); nomi (B v. 54 ~ L vv. 77 sing., 118 sing., 177 sing.; nomarle v. 115, noma v. 179); mano (B v. 68 ~ L v. 165 pl.f.). Sembra poi difficile derubricare a semplici coincidenze la presenza di alcuni motivi “speculari” nei due componimenti: se, per ciò che concerne le allusioni a località geografiche e a divinità minori frequentemente connesse a Nettuno – come le citazioni delle città di Elea, Trezene ed Ega o della ninfa e sposa del dio, Anfitrite – si potrebbe obiettare che le sovrapposizioni tra i due inni siano casuali e motivate non da una loro concreta interdipendenza ma dal riferimento ad una tradizione mitografica nota e diffusa, più difficile sarà affermare lo stesso per il ricorso ad immagini poetiche poco usuali e soprattutto raramente collegate al dio, come quella del nocchiero che, sorpreso in mezzo al mare dalla tempesta, volge le proprie accorate preghiere di salvezza a “Nettuno protettore dei naviganti”. Tale immagine si trova ai vv. 49-52 di B, ma costituisce il centro tematico di tutto il poemetto, dove il narratore si appella alla divinità per pregarla di sopire l’impeto dei venti devastatori e condurre sana e salva la bella Lesbia alle coste della Sicilia (vv. 25-32 e 47-48). Il medesimo topos apre e chiude l’Inno leopardiano, conferendogli una struttura “circolare” (Ringkomposition) tipicamente innodica: ai vv. 3-7 il nocchiero deve rivolgersi a Nettuno per scampare il pericolo di naufragio, mentre ai vv. 195-201, dopo la descrizione di una violenta tempesta che investe una nave (vv. 181-191), è la voce narrante a pregare Ποσειδῶν Ἀσφάλειος di rischiarare il cielo e far cessare i venti per la salvezza dei marinai100. Le corrispondenze fin qui sinteticamente riportate, che potrebbero essere accresciute da altre non meno significative101, indurrebbero insomma ad ipotizzare una certa Le fonti antiche che registrano la presenza di un Nettuno “salvatore dei naviganti” sono scarse, «tanto che qualche volta questo suo aspetto è stato sottovalutato» (Inni omerici, a cura di F. Càssola, RomaMilano, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, 1975, p. 384). Le poche testimonianze di tale tradizione si limitano sostanzialmente a Il. IX 362, h.Hom. XXII 5 e Pi. I. VII 52 (cfr. The Homeric Hymns, edd. by T.W. Allen, W.R. Halliday and E.E. Sikes, Oxford, Oxford University Press, 19362, p. 415). Altri motivi che si rintracciano speculari in entrambi gli inni, anche se notevolmente ampliati in quello leopardiano, sono legati ai riti in onore del dio, secondo i quali venivano offerti in dono ai suoi altari tori sacrificali – bianchi per Boccanera e neri per Leopardi – e alla varietà di nomi ed epiteti riferiti al suo diffusissimo culto (cfr., rispettivamente, B vv. 45-46 e vv. 53-54 e L vv. 135-140 e vv. 171-180). 101 Rilevante ad esempio il ricorso al modulo epico della domanda retorica documentato sia da B che da L, dove – come sempre accade – esso viene sottoposto ad una consistente amplificazione, cfr. B vv. 61-64 e L vv. 57-58, 74-75, 103-116, 171-172. 100 140 Margherita Centenari consapevolezza da parte di Leopardi nel voler richiamare, nel contesto di un inno spacciato per antico, le movenze di un poema del tutto moderno. Ma è possibile rintracciare sufficienti indizi che testimonino un reale contatto tra i due letterati? Giuseppe Boccanera, nato nel 1794 a Fabriano e figlio di Giovanni Battista, letterato e medico primario di Macerata, fu un erudito e filologo di belle speranze, morto troppo giovane (nel 1817, a soli 23 anni) per vederle compiutamente realizzate102. Fece parte di alcune importanti accademie dell’epoca, tra cui l’Arcadia romana, soggiornò a Napoli e, nonostante la morte precoce, lasciò molti scritti per buona parte legati al campo dell’antichistica. Tra questi in particolare si segnalano i contributi alla Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli – opera alla quale l’autore dovette molta della sua fama –, che iniziò ad essere pubblicata a partire dal 1813 e che sarebbe poi stata accompagnata dalla Biografia degli uomini illustri della Sicilia (1817), alla quale egli prese parte con l’elogio di Mosco103. All’altezza del 1816, dunque, il nome di Boccanera aveva già ottenuto ampia risonanza nell’ambiente culturale marchigiano per le indubbie doti di enfant prodige del giovane, che d’altra parte era riuscito ad ottenere numerosi apprezzamenti anche presso circoli intellettuali esterni allo Stato Pontificio, come quelli di Napoli, una delle città più attive nel campo degli studi classici104. Non mancavano inoltre al ragazzo legami con influenti personalità dell’epoca e in particolare della provincia maceratese, come il conte Saverio Broglio D’Ajano, che, com’è noto, manteneva stretti rapporti anche con la famiglia Leopardi. Quest’ultimo, al quale Giacomo avrebbe richiesto un passaporto progettando in segreto la fuga dal palazzo paterno nel 1819105, era membro, insieme a Boccanera, dell’Accademia dei Catenati di Macerata e fu addirittura l’autore dell’elogio funebre composto in occasione dell’improvvisa scomparsa del giovane106. 102 Per le notizie riguardanti la biografia di Boccanera, cfr. V. Brocco, Dizionario bio-bibliografico dei Maceratesi, in Storia di Macerata, vol. II, a cura di A. Adversi, D. Cecchi e L. Paci, Macerata, Tip. R. Compagnucci, 1972, s.v. e Dizionario storico-biografico dei marchigiani, a cura di G.M. Claudi e L. Catri, 3 voll., Ancona, Il Lavoro Editoriale, 1992-1994, vol. I, s.v. 103 Cfr. rispettivamente la Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli, ornata de’ loro rispettivi ritratti, 9 voll., Napoli, Gervasi, 1813-1822 e la Biografia degli uomini illustri della Sicilia, ornata de’ loro rispettivi ritratti, 4 voll., Napoli, Gervasi, 1817-1821. Tra le altre opere composte da Boccanera, una segnalazione a parte merita la fortunata traduzione Delle Istorie di Vellejo Patercolo libri due, Napoli, Nobile, 1815. Accanto poi a queste pubblicazioni, si ricordino la collaborazione al «Giornale del Musone» – sul quale Boccanera aveva editato nel 1812 varie note critiche e alcuni inni mitologici (cfr. «Giornale del Musone», nn. 40-44) – e le numerose compilazioni storicoerudite ancora oggi documentate dai manoscritti conservati presso la Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. 104 L’Elogio storico dedicato a Gian Vincenzo Gravina realizzato da Boccanera in occasione della stampa della Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli venne selezionato per introdurre l’edizione delle Opere scelte italiane del letterato (Milano, Silvestri, 1819), un’importante pubblicazione di cui si diede notizia anche sulle pagine della «Biblioteca Italiana», t. XIV, 1819, p. 261. Per un’ampia e ricca introduzione allo studio dei circuiti intellettuali della Napoli erudita tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo, cfr. La cultura classica a Napoli nell’Ottocento, a cura di M. Gigante et alii, 2 voll., Napoli, Dipartimento di Filologia Classica dell’Università degli Studi di Napoli, 1987. 105 La lettera del 29 luglio 1819, in cui Leopardi chiedeva al confidente «un passaporto per il regno Lombardo-Veneto» si legge in Epist., pp. 316-317. 106 Cfr. Brocco, Dizionario, cit., p. 48. «prendere persona di greco» 141 La comune collaborazione a «Lo Spettatore», rivista alla quale Leopardi e Boccanera inviavano i propri scritti nello stesso torno d’anni richiamando l’attenzione del pubblico milanese, si iscriveva dunque in un quadro storico e biografico ben ricco e complesso, che fa sospettare che i due – appartenenti a famiglie del notabilato marchigiano, legati da amicizie comuni, pressoché coetanei, e soprattutto celebri per le loro prodigiose e rare doti intellettuali107– fossero a conoscenza l’uno della fama dell’altro e che condividessero forse una certa rivalità reciproca. Non sarà perciò del tutto arbitrario ipotizzare che Leopardi – visto lo scritto di Boccanera sulle pagine della rivista milanese – avesse deciso di misurarsi con lui, riecheggiando nell’Inno alcuni tratti del testo del predecessore e producendo così col proprio falso un sottile ed ironico effetto di controcanto. Del resto un indizio dell’esistenza di un sottile antagonismo fra i due eruditi potrebbe anche venire dallo sferzante giudizio espresso da Boccanera sulla traduzione leopardiana di Mosco ed inserito nell’elogio all’antico poeta siciliano redatto dal maceratese proprio tra il 1816 e il 1817: Moltissimi in Italia tradussero i versi di Mosco fra’ quali contansi Luigi Alamanni, Girolamo Pompei, Giovan-Battista Vicini, Giuseppe Maria Pagnini, e il Pagani Cesa. Il Conte Giacomo Leopardi ne ha data ultimamente una versione che ricorda a noi la fedeltà, e la trivialità Salviniana108. Anche ammessa la reale consistenza di queste schermaglie, forse sorte nel contesto dell’ambiente provinciale marchigiano, ciò che più preme rilevare è che la varietà e la copiosità degli esperimenti sopra menzionati – compreso quello realizzato da Boccanera – fanno percepire non solo il diffuso e genuino interesse che gli intellettuali dell’epoca nutrivano per la produzione innodica antica, ma costituiscono anche l’espressione del clima di febbrile attesa con cui il mondo letterario sette-ottocentesco era pronto ad accogliere ogni “novità” che riguardasse la cultura classica. Dovettero dunque essere soprattutto queste attenzioni ed aspettative, proprie di un ampio e generalizzato pubblico di eruditi ed appassionati, ad aver contribuito a convincere Leopardi ad escogitare l’espediente dell’Inno, col quale egli si proponeva nelle vesti di traduttore di un inedito greco, tanto più interessante in quanto «antichissimo»109. Insieme alla scelta del genere, infatti, anche questa professione di antichità si iscriveva nel quadro dell’ambizioso progetto con il quale il giovane cercava di intercettare i gusti e gli interessi della società intellettuale coeva e di garantire così assoluta rilevanza alla millantata scoperta. A questo proposito, si rivela particolarmente istruttivo ricordare lo scalpore suscitato da un celeberrimo caso letterario, scoppiato nel giugno del 1778, quando dalle pa- 107 Novella Bellucci non ha mancato di notare la significativa somiglianza tra i curricula di Leopardi e Boccanera nel volume G. Leopardi e i contemporanei. Testimonianze dall’Italia e dall’Europa in vita e in morte del poeta, Firenze, Ponte alle Grazie, 1996, pp. 56-57, nota 5. 108 Biografia degli uomini illustri della Sicilia, cit., vol. I, Mosco, corsivo mio. 109 Poesie disperse, Avvertimento, p. 234. 142 Margherita Centenari gine della rivista tedesca «Bibliotheca Critica» venne data notizia del ritrovamento da parte di Christian Friedrich Matthaei di un codice moscovita che conservava, insieme a quelli già noti, due antichissimi inni rimasti fino ad allora sconosciuti ed attribuibili ad Omero: si trattava della parte finale di un componimento indirizzato a Dioniso (= h.Bacch. 10-21) e di uno, leggibile quasi per intero, dedicato a Demetra (= h.Cer.). Il fatto aveva destato da subito un grandissimo interesse presso i lettori del periodico che richiesero a Matthaei di fornire maggiori spiegazioni sulla sensazionale novità. Sollecitato in questa direzione, lo scopritore inviò una prima e incompleta trascrizione del codice al filologo tedesco David Ruhnkenius, il quale in tempi estremamente rapidi ne produsse l’edizione, che uscì nella primavera del 1780, presentandosi agli occhi di studiosi e curiosi dell’epoca assai scorretta a causa della fretta che aveva accompagnato il lavoro e soprattutto degli errori e delle lacune contenute nella trascrizione. Nel frattempo, però, spinto dal desiderio di far circolare il tesoro omerico appena ritrovato, Matthaei aveva spedito nel novembre del 1779 una seconda e corretta copia del manoscritto al conte Christian Stolberg in previsione dell’allestimento da parte di quest’ultimo di una traduzione tedesca che avrebbe dovuto seguire la princeps e che venne in effetti stampata nel novembre del 1780 sulle pagine del «Deutsches Museums», venendo così a costituire la prima, completa, “edizione” dei due inni antichi, i quali avrebbero dovuto invece attendere il 1781 per vedere integralmente pubblicato il loro testo greco sempre per le cure filologiche del Ruhnkenius110. Con ogni probabilità noto a Leopardi – sia pure, forse, non in tutte le sue peripezie111 – questo episodio presenta significative assonanze con la messinscena dell’Inno: in entrambi i casi ci troviamo di fronte a preziosissime scoperte di testi innodici arcaici (una vera, l’altra fittizia) fino ad allora ignoti, che, in attesa delle edizioni filologiche annotate, vengono immediatamente divulgati a mezzo di traduzioni. Si rileggano a questo proposito le parole che Leopardi aveva premesso al testo del suo falso: 110 Per una ricostruzione delle vicende che portarono alle prime edizioni e traduzioni degli inni omerici a Dioniso e Demetra, oltre a E. Hulshoff Pol, Studia Ruhnkeniana. Enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798), Diss. Leiden, 1953, pp. 176-186, cfr. T. Gelzer, Zum Codex Mosquensis und zur Sammlung der Homerischen Hymnen, «Hyperboreus», 1, 1994, pp. 113-137, spec. pp. 113-119. 111 Oltre che mediante la lettura delle riviste letterarie di maggior circolazione, Leopardi avrebbe potuto essere al corrente del celeberrimo ritrovamento dell’Inno a Cerere grazie alla presenza nella biblioteca paterna del tomo X del Parnaso de’ poeti classici d’ogni nazione (Venezia, Zatta, 1794), dove il Rubbi, introducendo la ristampa della traduzione pindemontiana dell’inno (editio princeps: Volgarizzamento dell’Inno a Cerere scoperto ultimamente e attribuito ad Omero, Bassano, Remondini, 1785), riassumeva sinteticamente la storia della sua scoperta e le vicende editoriali che l’avevano riguardato, cfr. il Catalogo della Biblioteca Leopardi, cit., s.v. «Rubbi Andrea». Da notare, inoltre, che anche sotto la voce «Pindemonte Ippolito» si registra un «Omero. Inno a Cerere. Venezia, 1794, in-8», ma, poiché nel Catalogo di regola non si trova segnalazione di opere già contenute in raccolte o in collane, non sarebbe inverosimile ipotizzare che tale indicazione vada riferita non al tomo del Parnaso, ma ad una non meglio precisata ristampa della princeps pindemontiana, dalla quale Leopardi avrebbe potuto trarre, forse, ulteriori informazioni sul “caso” moscovita, in gran parte contenute nella dedica All’ornatissima Signora Contessa Elisabetta Contarini Mosconi già posta ad apertura dell’edizione remondiniana. «prendere persona di greco» 143 Un mio amico in Roma nel rimuginare i pochissimi manoscritti di una piccola biblioteca il 6 gennaio dell’anno corrente, trovò in un Codice tutto lacero, di cui non rimangono che poche pagine, quest’Inno greco; e poco appresso speditamene una copia, lietissimo per la scoperta, m’incitò ad imprenderne la traduzione poetica italiana, facendomi avvisato che egli era tutto atteso ad emendare il testo greco, a lavorarne due versioni latine, l’una letterale e l’altra metrica, e a compilare ampie note sopra l’antica poesia112. A conferire maggiore rilievo all’associazione tra il progetto di contraffazione leopardiano e le vicende editoriali degli inni moscoviti interviene anche un ultimo, curioso particolare. Si tratta di un’informazione che è possibile ricavare da un autografo dell’Inno vergato da Paolina, contenente una versione del componimento successiva a quella riportata dal manoscritto recanatese, ma precedente alla stampa113: nella titolatura, proponendo un’attribuzione che non avrebbe trovato successivo riscontro nella princeps, si indicava temerariamente proprio in Omero l’autore del presunto inno tradotto. Per quanto sostenuta da una serie di sorprendenti coincidenze, l’idea che il giovane poeta abbia potuto organizzare la propria falsificazione ispirandosi direttamente al ritrovamento omerico di Mosca, resta – è bene dirlo – solo un’intrigante ipotesi, ma le affinità tra i due casi letterari paiono comunque rilevanti, specialmente nella misura in cui esse offrono un’ulteriore conferma all’impressione che la scelta leopardiana del genere letterario innodico risponda ad una precisa strategia “promozionale” ideata dall’autore per ottenere la propria definitiva consacrazione nel panorama intellettuale italiano, facendo leva su una passione per l’innologia antica consolidatasi a cavallo tra Settecento e Ottocento. Una strategia che, per quanto abilmente dissimulata, non mancò di insospettire l’occhio esperto dell’Acerbi, il quale – trovatosi tra le mani la copia dell’Inno destinata alla stampa – in una missiva spedita al giovane recanatese il 12 marzo 1817 si augurava che questi non avesse ceduto alla tentazione di imitare i sempre più numerosi eruditi che millantavano ritrovamenti di testi sepolti in ormai dimenticati codici antichi al solo scopo di «dar pregio alla poetica composizione»: Spero ancora che il ritrovamento del Codice non sia uno de’ soliti pretesti per dar pregio alla poetica composizione, ed Ella mi farebbe cosa gratissima col primo corso di posta a spedirmi almeno una dozzina di versi greci cominciando dal primo, qualora non fosse indiscreto il chiederglieli tutti; il primo e l’ultimo ch’Ella cita essendo tali da potersi fare anche da chi si fosse dilettato d’imporne114. Poesie disperse, p. 234. Cfr. ivi, p. 160, dove si trova la scheda di presentazione del manoscritto siglato P dall’editore, per cui cfr. supra nota 7. 114 Cfr. Epist., p. 65. 112 113 Silvia Rizzo SCHEDE PER CORNO INGLESE DI MONTALE Intendo qui presentare qualche osservazione su Corno inglese di Montale. Avverto che mi soffermerò solo sui punti sui quali ritengo di poter dire qualcosa di nuovo e presuppongo i commenti e la vasta bibliografia su questo componimento1. Corno inglese Il vento che stasera suona attento – ricorda un forte scotere di lame – gli strumenti dei fitti alberi e spazza l’orizzonte di rame dove strisce di luce si protendono come aquiloni al cielo che rimbomba (Nuvole in viaggio, chiari reami di lassù! D’alti Eldoradi malchiuse porte!) e il mare che scaglia a scaglia, Esaustive indicazioni bibliografiche si trovano nel più recente contributo: M. Tortora, «Ogni apparenza d’intorno vacilla s’umilia scompare». Lettura di Corno inglese, «Allegoria», LXV-LXVI, 2012, pp. 134-153, a p. 135 note 4 e 5. Ho potuto leggere in anteprima questa interpretazione nuova e suggestiva per cortesia dell’autore, che qui ringrazio anche per aver letto a sua volta il mio testo discutendo con me alcuni problemi e per avermi procurato fotocopie di alcune voci della bibliografia. Corno inglese fu pubblicato la prima volta, come sesto di una serie di sette componimenti intitolati ognuno a uno strumento e riuniti sotto il titolo complessivo di Accordi, in «Primo tempo» del 1922. Montale stesso dice: «con assoluta precisione non saprei dare una data a quelle poesie [di Accordi]: sono certamente posteriori al primo vero e proprio osso («Meriggiare» del ’16), ma assai anteriori a «Riviere» (marzo 1920)» (E. Montale, L’opera in versi, edizione critica a cura di R. Bettarini e G. Contini, Torino, Einaudi, 1980, p. 865). Secondo T. Arvigo, Guida alla lettura di Montale, Ossi di seppia, Roma, Carocci, 2001, p. 37, è probabile che l’intero gruppo degli Accordi risalga al 1917-1918. 1 146 silvia rizzo livido, muta colore, lancia a terra una tromba di schiume intorte; il vento che nasce e muore nell’ora che lenta s’annera suonasse te pure stasera scordato strumento, cuore2. Sulla difficile sintassi di questa poesia i commentatori sorvolano3, mentre ci si soffermano a lungo Gian Paolo Biasin in un saggio pubblicato per la prima volta nel 1982 e ripresentato in volume nel 19854, Romano Luperini nel 2005 e da ultimo Massimiliano Tortora5. Non sarà inutile tornarci sopra perché nessuno finora ha argomentato in favore di quella che è, a mio avviso, l’unica interpretazione possibile (presupposta, come diremo, da Alessandro Martini nel 19876). Biasin, dopo aver premesso che «siamo di fronte per la prima volta nell’opera di Montale a una poesia costruita su un unico periodo dall’ampio respiro, come avverrà più tardi nella più famosa L’anguilla», analizza la struttura sintattica del componimento sostenendo che i verbi principali sono due, entrambi con «il vento» come soggetto, cioè «lancia» di v. 12 e «suonasse» di v. 16; per lui la frase dichiarativa «Il vento lancia a terra una tromba di schiume intorte» diventa ottativa, «il vento suonasse te pure». «Meno persuasiva» gli pare la soluzione di far dipendere «lancia» dal soggetto «il mare» includendo quindi quest’enunciato nella relativa introdotta da «che muta colore», perché questa interpretazione Montale, L’opera in versi, cit., p. 11. Arvigo, Guida alla lettura di Montale, Ossi di seppia, cit., p. 37, si limita a notare che «l’esperimento musicale poggia su un’architettura sintattica, quella del periodo unico, che Montale sperimenterà poi più volte nelle raccolte della maturità (ma si veda anche l’«osso» breve Upupa, ilare uccello calunniato)». L’osservazione era già in un saggio di Pier Vincenzo Mengaldo del 1974, ora in P.V. Mengaldo, La tradizione del Novecento. Prima serie, Torino, Bollati Boringhieri, 1996 (prima ed. Milano, Feltrinelli, 1975), in cui si parla (p. 328) di «struttura sintattica uniperiodale e circolare, specie di giovanile cartone della tarda e suprema Anguilla». Cfr. anche Luigi Blasucci in un saggio del 1990, ora in L. Blasucci, Gli oggetti di Montale, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 24, che parla di «struttura sintattica serrata (un solo periodo saldamente tenuto sino in fondo), tutta gravitante verso la dichiarazione-augurio finale». 4 G.P. Biasin, Il vento di Debussy. La poesia di Montale nella cultura del Novecento, Bologna, Il Mulino 1985, pp. 9-41, a pp. 30-32 (il saggio uscì per la prima volta in «La Regione Liguria», X, 1982, n. 12). 5 R. Luperini, Commentando Corno inglese: dissonanze e «accordi» nel primo Montale, in Id., L’autocoscienza del moderno, Napoli, Liguori, 2005, pp. 149-160, e Tortora, «Ogni apparenza d’intorno vacilla s’umilia scompare», cit. 6 A. Martini, Occasioni musicali nella poesia del primo Montale, «Versants», XI, 1987, pp. 105-122. 2 3 schede per corno inglese di montale 147 toglie forza (e drammaticità) proprio al vento che è il soggetto grammaticale, l’occasione della poesia, l’antagonista del poeta; senza contare che a livello strettamente sintattico la costruzione di due verbi collegati paratatticamente da una virgola (per di più aggiunta solo nell’edizione critica: «il mare che […] muta colore, lancia a terra una tromba»») è certamente insolita in Montale. Biasin conclude, richiamandosi a Morton Boomfield, che questa possibilità di doppia interpretazione è un caso di «ambiguità sintattica» usata come mezzo poetico. La soluzione scartata da Biasin è invece presupposta da Alessandro Martini (che ricorda quella di Biasin in nota): L’indubbio fascino del testo sta anzitutto nell’essere costituito di un solo periodo ottativo: un unico vocativo sospeso lungo l’arco estremamente teso di 18 versi. Certo la sintassi è sempre complessa in Montale, ma qui lo è in modo eccezionale, tanto da arrischiare l’oscurità. La coordinazione di orizzonte 4 e mare 10 è interrotta da ben cinque versi, occupati dalla descrizione del cielo e dai vocativi alle nuvole, ai reami, agli Eldoradi, per quanto evidenziata dal fortissimo legame fonico dell’anagramma fra rame 4 e mare 107. Sul problema torna nel 2005 Luperini, che non cita Biasin. Egli individua due possibilità, di cui la prima coincide con quella preferita da Biasin: 1. «il mare» (v. 10) può essere complemento oggetto di «spazza» (v. 3), mentre il successivo «lancia» (v. 12) va riferito al «vento» del v. 1, da considerarsi soggetto di questa azione (così: il vento – che suona gli strumenti dei fitti alberi e spazza l’orizzonte e il mare – lancia a terra una tromba di schiume intorte); 2. il «mare» è soggetto di «lancia» e interno alla proposizione relativa aperta da «dove» (v. 5): il vento spazza l’orizzonte «dove» strisce di luce si protendono come aquiloni e il mare, che muta colore, lancia a terra una tromba di schiume intorte. Lo stesso Luperini esclude che «mare» sia soggetto di una proposizione autonoma, esterna alla relativa introdotta da «dove»: se infatti questa fosse sintatticamente conchiusa e autosufficiente – formata cioè da una relativa («che scaglia a scaglia, livido, muta colore») e da una principale («lancia a terra una tromba di schiume intorte») –, introdurrebbe una frase parallela a quella aperta da «vento» e quest’ultima, essendo priva di un verbo reggente, resterebbe sospesa tagliando in due il componimento e rendendo insostenibile la ripresa del v. 14 («il vento che nasce e che muore»); se invece fosse formata da due relative divise da una virgola (quella successiva a «colore») – come se fosse: «che scaglia a scaglia, livido, muta colore e lancia a terra una tromba di schiume intorte» – sarebbe essa stessa a rimanere sospesa non dandosi poi, nei versi successivi, alcuna sua ripresa8. 7 8 Ivi, p. 111. Luperini, Commentando Corno inglese, cit., pp. 151-152. 148 silvia rizzo La soluzione proposta da Biasin e come n. 1 da Luperini è accettata più recentemente anche da Tortora9 e si può quindi dire che sia oggi la vulgata. Eppure io sono fermamente convinta che l’unica possibile interpretazione della sintassi del componimento sia quella accolta da Martini, giudicata meno persuasiva da Biasin e Tortora e non presa in considerazione da Luperini. Il vento, con una ripresa anaforica al v. 14, è l’unico soggetto di tutta la poesia e c’è un solo verbo principale, quello dell’ottativa finale «suonasse». Dopo un’apertura sonora nella quale si evoca il rumore del vento fra alberi fitti paragonandolo esplicitamente a un «forte scotere» di lamiere e implicitamente, attraverso il titolo, allo strumento musicale a fiato detto corno inglese10, la poesia prosegue con la descrizione degli effetti del vento percepibili con la vista: il verbo «spazza» regge due oggetti, «l’orizzonte di rame» del v. 4 e «il mare» del v. 10, separati nettamente fra loro dalla parentesi. Ognuno di questi oggetti è seguito in modo perfettamente simmetrico da relative («dove» del v. 5 e «che» del v. 10), nelle quali vengono descritti gli effetti del vento rispettivamente sul cielo e sul mare, congiunti fra loro da un orizzonte color rame per il filtrare fra nuvole tempestose della luce del sole al tramonto. La relativa che descrive il mare contiene due azioni verbali in asindeto: «che scaglia a scaglia, livido, muta colore (e) lancia a terra una tromba di schiume intorte». Dobbiamo immaginare il poeta collocato sulla riva, in posizione abbastanza elevata nei pressi di un folto di alberi, con lo sguardo rivolto al mare sul quale sta tramontando il sole (che è esattamente la situazione di chi sta sulla costa delle Cinque Terre): il sole, ormai basso sull’orizzonte, è nascosto dalle nubi, ma poiché il forte vento le dirada e le squarcia qua e là, si fanno strada fra di esse i suoi raggi luminosi (le «strisce di luce»), che, protendendosi11 dall’orizzonte verso il cielo ancora rimbombante dei tuoni della tempesta che si allontana, guidano in alto lo sguardo verso un luminoso intermezzo di nubi chiare e trascorrenti che fa intravedere la possibilità di mondi diversi e migliori. Dopo questa parentesi col v. 10 lo sguardo torna verso il mare, che sotto l’azione del vento si corruga, cambia colore diventando livido e si abbatte sulla riva con una torsione schiumosa di onde. Il vento è l’agente che imprime a tutto – alberi, luci dell’orizzonte, nuvole, mare – un moto rapido e cangiante e che infine, con brusco stacco segnalato dal cambio di ritmo al v. 14, si placa mentre annotta. Dal punto di vista sintattico il componimento si apre con l’enunciazione del soggetto «il vento», cui segue una serie di relative e di incisi: poi, dopo una ripresa anaforica del Tortora, «Ogni apparenza d’intorno vacilla s’umilia scompare», cit., pp. 145-147. Rispondendo a una domanda sul perché, traducendo dalla Tempesta di Emily Dickinson «There came a wind like a bugle» con «Con un suono di corno / il vento arrivò», avesse sostituito «corno» a «bugle», Montale osservava: «Forse “suono di corno” mi suonava meglio di altri possibili sinonimi. E tra i tanti tipi di corno avrei potuto pensare al corno inglese: dà un certo lamento che andrebbe bene qui» (Biasin, Il vento di Debussy, cit., p. 39 nota 57). Sulla traduzione montaliana della poesia della Dickinson vd. V. Janner, La Tempesta di Emily Dickinson nella traduzione di Montale, «Rassegna europea di letteratura italiana», XXIX-XXX, 2007, pp. 169-184. 11 Sulla valenza ‘etica’ di questo verbo in Montale si veda la notazione di Arvigo, Guida alla lettura di Montale, Ossi di seppia, cit., p. 39 nota 10. 9 10 schede per corno inglese di montale 149 soggetto ormai lontano (v. 14), tutto precipita sull’unico verbo principale: «suonasse». Si tratta della movimentata, e al tempo stesso estremamente precisa, descrizione di un momento di cambiamenti atmosferici simile alla breve tempesta estiva descritta in Arsenio, componimento nel quale non a caso ritornano la «tromba» marina, il vento, le nubi, il tuono, il rumore di lamiera: Discendi all’orizzonte che sovrasta una tromba di piombo, alta sui gorghi, più d’essi vagabonda: salso nembo vorticante, soffiato dal ribelle elemento alle nubi (vv. 13-17)12. quando rotola il tuono con un fremer di lamiera percossa (vv. 25-27)13. Nonostante la distanza, anche ideologica oltre che cronologica (Arsenio è del 1927), che divide le due poesie, le accomuna la descrizione di uno di quegli improvvisi sconvolgimenti della natura in cui sembra quasi possibile lo schiudersi del miracolo che rompa la catena della necessità. Va sottolineato che, nonostante la ricchezza di riferimenti culturali, non solo letterari ma anche musicali, additati dagli studiosi per Corno inglese – e ne aggiungerò qualcuno anch’io –, all’origine di una descrizione così esatta e dettagliata non può esserci che un’esperienza reale. Tornando alla sintassi, mi sembra che l’interpretazione che oggi va per la maggiore, quella cioè che divide il componimento in due periodi, entrambi col «vento» come soggetto e aventi il primo come verbo principale «lancia», il secondo «suonasse», rompa la compattezza del componimento dividendolo in due valve e dia un indebito risalto all’azione di lanciare «a terra una tromba di schiume intorte», che invece fa parte dell’insieme della descrizione degli effetti del vento: molto più efficace che la tensione del componimento si sciolga nell’unico verbo finale, l’ottativo «suonasse». Una riprova che questa è l’unica interpretazione possibile si ha anche dal confronto con altri componimenti montaliani costituiti da un unico periodo: prendo come termini di raffronto i due che sono stati ricordati dagli interpreti, l’Osso sull’upupa e L’anguilla 14. In tutte e tre queste poesie c’è una struttura portante costituita da riprese anaforiche – del soggetto nel caso di Corno inglese, del vocativo nel caso dell’Upupa, dell’oggetto nel caso dell’Anguilla – con gli Cataldi-D’Amely interpretano «ruotante nembo salato, che il vento spinge (“soffiato”) dal mare, elemento selvaggio (“ribelle”), verso le nubi» (cfr. E. Montale, Ossi di seppia, a cura di P. Cataldi e F. d’Amely, Milano, Mondadori, 2003, collezione Oscar, ad locum). Io invece intenderei: «soffiato verso le nubi dall’elemento ribelle (il vento)». 13 Montale, L’opera in versi, cit., p. 81. 14 Ivi, pp. 47 e 254. 12 150 silvia rizzo elementi descrittivi inseriti in relative e in apposizioni, finché la tensione sintattica del componimento si scioglie nei versi finali che contengono l’enunciato verbale e rivelano la struttura: l’ottativa «suonasse» al v. 16 di Corno inglese, due esclamative in asindeto introdotte da «come», la prima delle quali composta a sua volta da due frasi asindetiche, ai vv. 9-10 dell’Upupa, l’interrogativa «puoi tu / non crederla sorella?» ai vv. 29-30 dell’Anguilla. Ebbene, in tutti e tre i casi Montale usa il punto e virgola esclusivamente prima delle riprese anaforiche: si vedano il v. 13 di Corno inglese, il v. 4 dell’Upupa, i vv. 14, 19, 25 dell’Anguilla 15. Questo rilievo consente di escludere che in Corno inglese ci sia più di una principale prima della fine e dentro una delle riprese anaforiche, come accadrebbe se «lancia» del v. 12 (che viene prima del punto e virgola) avesse per soggetto il vento. Quanto all’affermazione di Biasin citata sopra che «la costruzione di due verbi collegati paratatticamente da una virgola […] è certamente insolita in Montale», essa è smentita, mi sembra, dai vv. 5-7 dell’Upupa: come per te il tempo s’arresta, non muore più il Febbraio, È notevole che l’asindeto sia stato introdotto da Montale a partire dall’edizione Ribet: la Gobetti aveva infatti come per te s’arresta il tempo e non muore più il Febbraio; La virgola, che qui separa, a partire dalla riformulazione in unico periodo nella Ribet, i due membri dell’asindeto, in Corno inglese è stata aggiunta dall’autore solo in occasione della pubblicazione nell’Opera in versi ed è spia del fatto che egli avvertì la difficoltà per il lettore di orientarsi nella complessa sintassi del componimento e volle eliminare una possibile ambiguità, evitando che «lancia» potesse essere preso per verbo avente a soggetto «il vento» di v. 1; infatti la nuova virgola, che non ha rispondenza prima del «che» relativo, non può essere intesa come virgola che isoli una subordinata relativa ma solo come evidenziatore di un asindeto, 15 È da notare che nell’Osso sull’upupa la struttura a periodo unico compare solo a partire dalla Ribet. La Gobetti era formulata diversamente e si articolava in due distinti periodi con un punto fermo dopo «pollaio» (Montale, L’opera in versi, cit., p. 877). L’intenzionalità nell’uso del punto e virgola a sottolineare esclusivamente le riprese anaforiche nelle strutture a periodo unico è provata dal fatto che nella prima redazione in due periodi c’era un punto e virgola ‘normale’ dopo «Febbraio». Anche nell’Anguilla il punto e virgola prima dell’ultima ripresa del soggetto mediante apposizione («l’iride breve») è aggiunto a partire dall’inclusione della poesia nella Bufera, Venezia, Neri Pozza, 1956, mentre mancava ogni interpunzione nella prima edizione in «Botteghe Oscure» del 1948, a riprova anche qui dell’intenzionalità di quest’uso montaliano del punto e virgola. schede per corno inglese di montale 151 mentre con l’interpretazione Biasin-Luperini la virgola separerebbe il verbo dal suo soggetto16. Rispetto ai due componimenti a periodo unico chiamati a confronto, Corno inglese ha un andamento sintattico assai più complesso e spezzato, che inevitabilmente genera ambiguità: mi sembra per esempio che a una prima lettura si sia fatalmente portati a intendere «e il mare» di v. 10 come coordinato a «Il vento» di v. 1 e solo con la ripresa anaforica «il vento» al v. 14 si esce dall’inganno; e abbiamo già visto come l’asindeto dei vv. 11-12 abbia fuorviato gli interpreti. La difficoltà sintattica è ulteriormente accresciuta dall’inciso del v. 2, un paragone del rumore del vento con lamiere scosse inserito addirittura prima che il verbo «suona» riceva il suo oggetto, e dalla lunga parentesi dei vv. 7-9, che separa il verbo «spazza» con il complemento oggetto «l’orizzonte» dal secondo complemento oggetto «e il mare». Non credo affatto che queste durezze sintattiche siano volute e servano a generare ambiguità poetica: mi sembrano anzi la spia di qualcosa di non del tutto risolto in questa pur straordinaria poesia giovanile. Un indizio potrebbe essere il fatto che al momento di riproporla nell’Opera in versi Montale, oltre ad aggiungere, come abbiamo detto, una virgola prima di «lancia» per chiarire l’asindeto, mandò per lettera alla Bettarini una «possibile variante» che riscriveva i primi quattro versi allo scopo di eliminare il primo inciso, che gli «pareva insopportabile»17. Del tutto divergente la valutazione di Tortora, che assegna all’ambiguità sintattica una posizione centrale nella sua interpretazione del componimento e la ritiene un obiettivo perseguito volutamente dal poeta allo scopo di gettare il lettore in uno stato di confusione che, facendogli smarrire completamente con l’oscillazione fra diverse possibilità «le elementari coordinate spaziali», gli consente il ‘salto’ verso «una dimensione altra, superiore all’umana contingenza»18. 16 Luperini, Commentando Corno inglese, cit., p. 152, avverte la difficoltà e pensa di risolverla dando alla virgola un valore non sintattico ma retorico, di segnalazione di pausa: «Quella virgola, da sola [cioè senza la corrispondente prima del relativo “che” al v. 10], potrebbe invece indicare una cesura, una sospensione necessaria perché il lettore possa ricollegare al suo lontano soggetto (la parola “vento”) il verbo “lancia”». 17 Montale, L’opera in versi, cit., p. 865: «Il vento che stasera ha suonato / con un suo forte scuotere di lame / gli strumenti degli alberi e ha sconvolto / uno sfondo di rame». 18 Tortora, «Ogni apparenza d’intorno vacilla s’umilia scompare», cit., p. 148. Si può ancora aggiungere che l’immagine del mare che «lancia a terra una tromba / di schiume intorte», oltre alle reminiscenze dannunziane segnalate in Mengaldo, La tradizione, cit., p. 328 (Le Ore marine, 53-55 «e ascolta la romba / della voluta / e odevi la tromba / del Tritone…» e Anniversario orfico, 5-6 «Dalle schiume canute ai gorghi intorti / fremere udimmo tutto il mare nostro»), presenta sorprendenti consonanze con Virgilio, Georg., 4, 528-529 «Haec Proteus, et se iactu dedit aequor in altum, / quaque dedit, spumantem undam sub vertice torsit», ed Aen., 3, 207 = 4, 583 «adnixi torquent spumas», versi nei quali ritornano tutti insieme i concetti di torcere, lanciare e schiume: «lancia» in unione con l’aggettivo «intorte» è in un certo senso la resa dell’unico verbo latino «intorqueo» (o «torqueo»), che non di rado è unito con «procella» o «undae» ed è verbo che combina in sé l’idea di «torcere» («intorte») e «lanciare». Debbo questo suggerimento a Vincenzo Fera, che mi segnala inoltre che «spazza» del v. 3, collocato in fine di verso e con enjambement, è certamente memore – come dimostra il ricorrere nella stessa posizione metrica con enjambement nonché 152 silvia rizzo Desidero infine soffermarmi sull’intermezzo luminoso dei versi 7-9. Essi costituiscono una «parentesi sospensiva […] di ascendenza petrarchesco-leopardiana»19, per la quale è stato chiamato a confronto un luogo di Pascoli: Su tutte le lucide vette tremava un sospiro di vento; squassavano le cavallette finissimi sistri d’argento (tintinni a invisibili porte che forse non s’aprono più?…)20. Anche questi versi fanno parte di una lirica in cui c’è un turbamento tempestoso della natura (vv. 5-6: «Venivano soffi di lampi / da un nero di nubi laggiù») e vi compare un cenno a porte che forse non s’aprono. Ma torniamo alla parentesi che costituisce il cuore di Corno inglese 21. Dalle nuvole chiare che viaggiano in cielo si schiude una promessa di felicità, molto simile a quella dei gialli dei limoni intravisti, in una poesia di poco posteriore, «da un malchiuso portone»22. Questo valore simbolico delle nuvole negli Ossi è confermato dai numerosi riscontri interni che sono stati indicati23, fra i quali il più interessante, perché vi torna anche il concetto delle nuvole in viaggio, è Fine dell’infanzia, vv. 69-71: Eravamo nell’età verginale in cui le nubi non sono cifre o sigle ma le belle sorelle che si guardano viaggiare24. la particolarità della parola – di U. Foscolo, Sepolcri, vv. 231-232 «il tempo con sue fredde ale vi spazza / fin le rovine» e che alle reminiscenze pascoliane di Corno inglese segnalate finora è forse da aggiungere Canti di Castelvecchio, La canzone della granata, vv. 1-4: «Ricordi quand’eri saggina / coi penduli grani che il vento / scoteva, come una manina / di bimbo il sonaglio d’argento?» e 7-8 «tu gracile e roggia / tinnivi coi cento ramelli» (si noti il ricorrere delle parole «vento» e «scuotere» e il paragone del vento col rumore di qualcosa di metallico: «sonaglio d’argento» in Pascoli / «lame» in Montale). 19 Arvigo, Guida alla lettura di Montale, Ossi di seppia, cit., p. 39. 20 Myricae, L’assiuolo, 17-22, segnalato da E. Pasquini, Intertestualità e intratestualità nella Commedia dantesca, Bologna, CLUEB, 1993, p. 207. 21 Biasin, Il vento di Debussy, cit., p. 32, la giudica «il centro – sintattico, visivo, musicale, affettivo – di tutta la poesia, nella quale produce una dissonanza fondamentale, sottolineata e contenuta dalle parentesi che prolungano la sospensione già ampia tra il soggetto e l’oggetto, tra la natura e il poeta». 22 I limoni, vv. 43-45: vd. Biasin, Il vento di Debussy, cit., p. 32. I limoni sono datati al novembre del 1922 (Montale, L’opera in versi, cit., pp. 862-863). 23 E. Bonora, La poesia di Montale. Ossi di seppia, Padova, Liviana, 1982, p. 123; Blasucci, Gli oggetti di Montale, cit., pp. 120-121. Bonora rinvia anche a una prosa di Baudelaire, L’étranger: «J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages!». 24 Montale, L’opera in versi, cit., p. 66. E si ricordino anche «le carovane dell’aria» di una redazione di Vasca anteriore a quella definitiva, v. 16 (ivi, p. 882). schede per corno inglese di montale 153 Per gli «alti Eldoradi» – variazione raffinata del più banale «nuvole d’oro» di Pascoli, Myricae, Con gli angioli, v. 8 – è stato richiamato un passo dei Trucioli di Sbarbaro, che Montale ben conosceva25. Interessante è anche l’accostamento operato da Lonardi26 fra reami di lassù! D’alti Eldoradi malchiuse porte! e le parole di un recitativo di Alfonso XI nella Favorita di Donizetti (una parte, quella di Alfonso, che Montale stesso dichiara di aver imparato per intero quando studiava sotto la guida di Ernesto Sivori27): Giardini d’Alcazàr, de’ mauri regi care delizie28. Come osserva Lonardi, anche se nessuna delle parole dell’opera viene ripresa, «il recipiente sintattico-ritmico è proprio quello» e la somiglianza a livello metrico è accentuata dall’endecasillabo con forte cesura data dalla parola tronca in sesta sede; infine «anche la densità esoticheggiante e insieme sonora del recitativo di Alfonso è ricalcata da questo di Montale. E allora non solo si risponde con l’Eldorado all’Alcazàr, ma abbondano le toniche in -à-». Nonostante la ricchezza di riferimenti culturali proposti per la parentesi mi sembra si possa ancora aggiungerne uno non irrilevante: Calibano – Be not afeard; the isle is full of noises, sounds and sweet airs, that give delight, and hurt not. Sometimes a thousand twangling instruments will hum about mine ears; and sometimes voices, that, if I then had wak’d after long sleep, will make me sleep again: and then, in dreaming, the clouds methought would open, and show riches R. Luperini, Storia di Montale, Bari, Laterza 1986, p. 28 nota 28; C. Sbarbaro, L’opera in versi e in prosa, Milano, Garzanzi, 1999, p. 178: «Come d’un eldorado andavamo in cerca di una locanda». In altro senso è usato El Dorado in Costa San Giorgio, v. 13. Sul termine e su un possibile riferimento a Baudelaire vd. anche Tortora, «Ogni apparenza d’intorno vacilla s’umilia scompare», cit, p. 149 nota 43. Per una possibile eco dannunziana nella parola «reami» vd. Mengaldo, La tradizione del Novecento. Prima serie, cit., p. 323. 26 G. Lonardi, Montale, la poesia e il melodramma, «Chroniques italiennes», LVII, 1999, 1, pp. 65-75, a p. 71. 27 «Imparai poi tutta la parte di Alfonso XII [sic] nella Favorita» (Il profeta dell’Apocalisse, in E. Montale, Il secondo mestiere. Arte, musica, società, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1996, p. 1664). 28 Cito il testo da un’edizione di quegli anni: La Favorita. Dramma serio in quattro atti di Royer e Vaez, tradotto da F. Jannetti, musica di G. Donizetti, Milano, Attilio Barion, 1922, p. 10 . 25 154 silvia rizzo ready to drop upon me; that, when I wak’d, I cried to dream again. Shakespeare, The Tempest, Act III, Scene II Molti, mi sembra, i punti di contatto fra i due testi: un risuonare nella natura di strumenti («instruments» / «strumenti») dal suono metallico («twangling» / «scuotere di lame») e soprattutto nubi («clouds» / «nuvole») che si aprono («methought would open» / «malchiuse porte») mostrando ricchezze («riches» / «Eldoradi»). Shakespeare era molto presente a Montale negli anni in cui fu composto Corno inglese, come appare da un paio di notazioni in Quaderno genovese 29. Quanto alla Tempesta, se ne trova addirittura una citazione nel Mottetto 9 delle Occasioni: e poi? Luce di lampo invano può mutarvi in alcunché di ricco e strano. Altro era il tuo stampo. È Montale stesso a segnalare la citazione inviando la poesia alla Brandeis: Nella quale [scil. poesiola] è incluso un verso di Shakespeare: something of rich and strange, o qualcosa di simile che ho ricordato a memoria30. E non c’è bisogno di ricordare che lo Shakespeare dei sonetti e di Midsummer’s night apre il Quaderno di traduzioni e che da un sonetto di Shakespeare è tratta l’epigrafe per la IV sezione delle Occasioni. E visto che siamo nell’ambito della letteratura inglese, segnalo ancora il vagabondare delle nubi nell’incipit di una famosa poesia di William Wordsworth: «I wandered lonely as a cloud / that floats on high o’er vales and hills»31. Ed è già stato notato lo stretto legame di Corno inglese con l’Ode to the West Wind di Percy Bysshe Shelly32, alla quale, oltre che di spunti particolari, è debitrice dell’idea strutturante dell’invocazione al vento perché faccia del poeta il suo strumento. 29 E. Montale, Quaderno genovese, a cura di L. Barile, con uno scritto di S. Solmi, Milano, Mondadori, 1983, pp. 22-23 (notazione di lunedì 5 marzo 1917): «Qualche cosa di Shakespeare (Sogno, Macbeth, forse Amleto)» è inclusa fra i quaranta libri che porterebbe con sé dovendosi ritirare a vita cenobitica; p. 64 (2 agosto 1917): «Letto alquanto di una Antologia Shakespeariana molto utile», che la curatrice, p. 175 nota 249, pensa possa essere G. Shakespeare, Tragedie scelte (Otello, Macbeth, Il mercante di Venezia), con prefazione del prof. E. Levi, Milano, Sonzogno, 1911. 30 E. Montale, Lettere a Clizia, a cura di R. Bettarini, G. Manghetti e F. Zabagli, con un saggio introduttivo di R. Bettarini, Milano, Mondadori, 2006, lettera n. 143 del 20 novembre 1938, pp. 258-259. Si tratta di Tempesta, atto I, sc. 2 «but doth suffer a sea-change / into something rich and strange» (canzone di Ariele). Ringrazio Francesco Bausi per la segnalazione. 31 Per un possibile rapporto di Corno inglese con alcuni versi del Prelude dello stesso Wordsworth vd. Arvigo, Guida alla lettura di Montale, Ossi di seppia, cit., p. 40. 32 Biasin, Il vento di Debussy, cit., p. 30 e p. 40 nota 68. schede per corno inglese di montale 155 Infine la frase nominale della parentesi con la sua triplice elencazione e i suoi punti esclamativi (ridotti da tre a due nel passaggio dalla pubblicazione su «Primo Tempo» alle edizioni successive, così come è eliminato il punto esclamativo finale dopo «cuore») trova un perfetto parallelo in una poesia della maturità di Montale compresa nella Bufera, nella strofa conclusiva del Gallo cedrone: Zuffe di rostri, amori, nidi d’uova marmorate, divine!33 Anche in questo più tardo componimento la frase nominale esclamativa introduce nella cupezza del componimento sulla morte dell’animale abbattuto da un «breve sparo», col quale il poeta s’identifica, una sospensione momentanea di felicità, questa volta la felicità passata del piccolo animale-simbolo34. E che si tratti sia in Corno inglese sia nel Gallo cedrone di uno di quei momenti privilegiati in cui la vita «rompe dal suo insopportabile ordito» è dimostrato dal legame che unisce le «zuffe di rostri» del Gallo cedrone con un’altra zuffa di altri animali-simbolo, i falchi (si ricordi «il falco alto levato» di un Osso), in una poesia ancora più tarda, a riprova della sostanziale unitarietà del libro poetico di Montale: I falchi sempre troppo lontani dal tuo sguardo raramente li hai visti davvicino. Uno a Étretat che sorvegliava i goffi voli dei suoi bambini. Due altri in Grecia, sulla via di Delfi, una zuffa di piume soffici, due becchi giovani arditi e inoffensivi. Ti piaceva la vita fatta a pezzi, quella che rompe dal suo insopportabile ordito35. Xenia II, 12 La vita fatta a pezzi che rompe dall’ordito ha il suo corrispondente sintattico nella parentesi sospensiva di Corno inglese e nella sua enumerazione nominale, stilema, questo secondo, al quale non a caso Montale ricorre di nuovo con valenza in tutto simile nel Gallo cedrone. Montale, L’opera in versi, cit., p. 253. Mi pare che basti questo parallelo a escludere l’interpretazione dei sostantivi in parentesi come vocativi data da Martini, Occasioni, cit., p. 111 (vd. sopra, p. 131). 34 Pascoli aveva evocato i momenti di felicità della breve vita del torello condotto a morte con analoga frase esclamativa: «Passa: un uomo alla testa, uno alle spalle: / è impastoiato, ad or ad or trempella… / Passa… Oh! poggi solivi! ombrose stalle! / E quanto fieno! quanta lupinella!» (Primi poemetti, Il torello, V 7-10). 35 Montale, L’opera in versi, cit., p. 308. 33 Materiali e Documenti Maurizio Campanelli Settecento latino III. L’inflazione dei poeti e il monte di Testaccio in un’epistola di Contuccio Contucci Il nome di Contuccio Contucci, gesuita nato a Montepulciano nel 1688 e morto a Roma nel 1768, non è di quelli che possano suscitare una qualche commozione nello studioso di letteratura italiana1. La sua fama, altissima presso i contemporanei, episodica ai giorni nostri, è quella dell’antiquario, che fu prefetto del Museo Kircheriano dal 1751 al 1768, dopo esser stato prefetto della pinacoteca (dal 1741) e per quasi trent’anni professore di retorica presso il Collegio Romano (1720-1748)2. 1 Quasi inesistente la bibliografia specifica: cfr. F.R. De Angelis, Contucci, Contuccio, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-, vol. XXVIII, 1983, pp. 558-559, e la breve voce di M. Zanfredini in Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, I, a cura di Ch. E. O’Neill – J.M.a Dominguez, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2001, p. 937, vd. anche T. Griggs, Ancient Art and the Antiquarian. The Forgery of Giuseppe Guerra, 1755-1765, «Huntington Library Quarterly», LXXIV/3, 2011, pp. 485-486 e 495-500. Ringrazio Heather Hyde Minor per avermi fornito gli abbondanti materiali bibliografici delle sue ricerche su Contuccio e per tutte le ulteriori informazioni che ha avuto la generosità di comunicarmi nelle nostre reiterate discussioni. Ringrazio anche Lorenzo Geri, Massimiliano Malavasi, Pietro Petteruti, Emilio Russo e Valerio Sanzotta per i loro preziosi consigli. 2 Ma anche dopo il 1748 Contuccio continuò a lavorare per le scuole del Collegio. Il suo successore e biografo Mazzolari ricorda che, finiti trent’anni d’insegnamento, Contuccio fu nominato prefetto delle Scuole inferiori, un ufficio ben più ingrato dell’insegnamento, come precisa il Mazzolari con parole in cui chiunque abbia insegnato a scuola non mancherà di riconoscere situazioni vissute: «Multa enim secum incommoda atque molestias munus illud affert: invisendae scholae, invigilandum magistris, census discipulorum habendus, qui novi adveniunt examinandi, veteres ad superiores gradus promovendi, nunquam cessandum. Quod vero gravius est, contendendum saepe cum parentibus, qui vel ineptos promoveri omnino volunt et diutius in scholis detineri liberos queruntur suos, nec vero non audent de docendi ratione praescribere, de Magistrorum praestantia judicare, homines harum plerumque rerum ignorantissimi» (J. Mariani Parthenii S. J. Commentarii, Roma, G. Salomoni, 1772, p. 116). Nella collezione di autografi della Biblioteca Nazionale di Roma si conserva (segnata A.28.24) una Scrittura fatta dal P. Contuccio Contucci, Prefetto delle Scuole inferiori del Co Ro, e presentata a’ Superiori l’a. 1756 in occasione di una lettera mandata dal P. Provinciale al Rettore. Si tratta di una copia in bella parziale, ovvero di un bifolio copiato solo nella prima facciata, che ha per titolo Se la sceltezza degli scolari sia facile ad aversi nelle Scuole inferiori 160 maurizio campanelli Scarsissima la sua produzione ufficiale, che si restringe ad un minuscolo manipolo di orazioni d’occasione pronunciate nel Collegio Romano (un panegirico per Benedetto XIII nel 1725, un’orazione funebre per il cardinal Tolomei nel 1726, un nuovo panegirico, questa volta per Benedetto XIV, nel 1741), alla tragedia Jaddus, recitata dai convittori del Collegio Romano nel 1730 in omaggio al nuovo papa Clemente XII, ex convittore, e alla Vita della santa vergine e imperatrice Pulcheria, pubblicata nel 17543. Il suo nome non figura nell’opera che doveva sentire più vicina alle sue corde, e al suo ruolo istituzionale, ovvero i due tomi dei Musei kirkeriani in Romano Soc. Iesu collegio aerea notis illustrata, stampati nel 1763 e nel 1765; ma restare anonimo, e soprattutto prestare la propria penna ad altri, era quasi una vocazione, come scrive il suo biografo, rilevando che quella «efficiendi et perficiendi patientia et voluntas» che Contuccio non aveva nelle proprie cose la metteva tutta in quelle degli altri: «Itaque non pauca scripsit, et castigate scripsit, quae alieno nomine vulgata iis, quorum gratia scripta fuerant, summam eruditionis famam commendationemque pepererunt»4. Del suo prestarsi a risistemare le opere altrui rimane notizia certa nel catalogo delle antichità conservate nella villa e nel palazzo Mattei, opera dalla lunga gestazione, in cui a Ridolfino Venuti, scomparso nel 1763, era succeduto Giovanni Cristofano Amaduzzi, che stava allora lavorando alla quarta edizione dei Vestigia veteris Romae, ovvero della Forma Urbis curata dal Bellori, pubblicata nel 1764. All’Amaduzzi fu consegnato il testo manoscritto del Venuti, nel quale risaltavano gli interventi di Contuccio: «Quare ipsius apographum, quod et emendatum et aliqua etiam sui parte reformatum fuerat a Contuccio, olim Kircheriani Musei Praefecto et deletae Loyolitarum Societatis Alumno, mox vita functo, traditum nobis fuit»5. La prefazione anonima alla versione latina dell’opera del Ficoroni sulle maschere sceniche antiche è certamente opera di Contuccio, che ricorda come il Ficoroni del Collegio Romano. Contuccio doveva essersi trovato in una situazione scomoda: “A due si riducono le accuse portate nella Lettera del P. Provinciale; alla facilità di ammettere i nuovi scolari, ed a quella di far passare i vecchi da una all’altra scuola sul fine dell’anno”. Insomma l’accusa era quella di gestire i voti con manica larga, ma la cosa non sembra preoccupare più di tanto l’anziano prefetto: “I meloni che compra d’estate lo spenditore, non tutti si trovano di quella pasta, che si desidera; chi però potrà accusarlo di sbadataggine, quando in una tal compra usi di quella esperienza e sapere, che gli dà il suo impiego?”. 3 Segnalo che l’esemplare di questa edizione (Roma, G. Salomoni, 1754) conservato presso la Biblioteca Nazionale di Roma, con la segnatura 71.2.C.13, presenta notevoli aggiunte, correzioni e varianti manoscritte, ed anche note ad uso di tipografi, quali Da capo o corsivo. La mano che scrive tutto ciò non può che essere quella dell’autore, il quale evidentemente stava lavorando sul suo testo in funzione di una seconda edizione; il volume doveva essere l’esemplare destinato all’invio in tipografia. 4 Parthenii Commentarii, cit., p. 105. 5 Vetera Monumenta quae in Hortis Caelimontanis et in aedibus Matthaeiorum adservantur, nunc primum in unum collecta et adnotationibus illustrata a R. Venuti et a Ioh. Chr. Amadutio, 3 voll., Roma, V. Monaldini, 1776-1779, vol. I, p. LVI. A proposito della deleta Loyolitarum Societas, va ricordato che l’Amaduzzi fu un tenace antigesuita, e c’è una possibilità che sia stato l’estensore del breve con cui nel 1773 Clemente XIV soppresse la Compagnia di Gesù (vd. A. Fabi, Amaduzzi, Giovanni Cristofano, in Dizionario biografico degli Italiani, cit., vol. II, 1960, pp. 612-615). l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 161 avesse compilato le sue opere in uno stile rozzo e oscuro, «praeter postrema eius opera quae ope cuiusdam amici in elegantiorem elocutionem fuerunt redacta». È probabile che l’amico in questione fosse proprio Contuccio, che così prosegue: Itaque pretium operis me facturum existimavi, si interea hoc de Larvis opusculum in Latinum verterem atque publici juris facerem. In eo autem vertendo non servi pecoris, sed fidi interpretis munus implere studui; etenim quisquilias resecavi et nonnulla, quae addi poterant, currente rota adjeci6. Quod si lector eruditus hunc meum qualemcumque laborem aequi bonique faciat, alia etiam eiusdem Auctoris opera Latine vertam in amicitiae pignus, quae inter me ipsumque Ficoronium intercessit7. Winckelmann stesso dice che i suoi Monumenti antichi inediti sarebbero passati anche per le mani di Contuccio8; e rimane tutto da chiarire il contributo dato dal gesuita alle opere teoriche di Piranesi. Ma per tracciare un profilo del Contuccio antiquario occorrerebbe almeno un libro; quindi, piuttosto che tentare impossibili sintesi, mi affido al medaglione giocoso che Mazzolari inserì nel sesto libro dei suoi Electrica (1767) e mise poi in conclusione della biografia di Contuccio: Ille autem lente gradiens tardante senecta9 ecquis erit10, meritos cui cingit laurea canos, nescio quid manibus versans et totus in illo? Fallor, an11 admoto detrita numismata vitro callidus explorat? Non fallor; scilicet ille est egregius Vates12, summusque Orator, avitum florere eloquium stupuit quo Rhetore Roma; nare sagax13 idem longoque instructus ab usu 6 Superfluo sottolineare le memorie oraziane di queste due frasi: il fidus interpres e la currente rota rispettivamente di ars 133-134 e 22. 7 Premessa erudito lectori in F. Ficoroni, Dissertatio de larvis scenicis et figuris comicis antiquorum Romanorum ex Italica in Latinam linguam versa, Roma, A. de’ Rossi, 1750, senza numero di pagina. 8 «[…] la Spiegazione stesa in Italiano sarà terminata fra un mese, e passerà prima sotto gli occhi de’ più esperti antiquarj e de’ più tersi ed eleganti Scrittori in Volgare, principiando da Baldani, Contucci, poi l’ultimi raffinamenti li darà Bottari e Giacomelli»: lettera a Mengs del maggio 1762, in J.J. Winckelmann, Briefe, in Verbindung mit H. Diepolder hrsg. W. Rehm, Berlin, de Gruyter, 1952, p. 231. 9 Cfr. Verg., Aen., V 395: «sed enim gelidus tardante senecta». Non scorgerei invece nel lente gradiens una memoria, sia pur semanticamente e metricamente ricontestualizzata, di Ov., met., XI 179: «induiturque aures lente gradientis aselli». 10 «Ecquis erit» in posizione iniziale viene da Verg., ecl., X 28 ed Aen., IX 51. 11 Fallor an è inizio ovidiano: cfr. am., III 1, 34; met., XIII 641; fast., I 515 e V 549; trist., I 2, 107; Pont., II 8, 21; cfr. anche Val. Fl., VIII 351. 12 L’espressione vates egregius si ritrova solo in Giovenale: «sed vatem egregium, cui non sit publica vena» (VII 53). 13 Inizio che sembra derivare da Sil., III 296: «nare sagax e calle feras». 162 maurizio campanelli quidquid edax reliqui saeclis labentibus aetas fecit odorari14. Quell’«egregius Vates» rimanda ad una pratica del verso, ovviamente latino, la cui traccia sembra del tutto svanita dalla tenue memoria che oggi si conserva di Contuccio, ma il lettore della biografia contestualizzava perfettamente quell’epiteto, perché il Mazzolari aveva dedicato alcune pagine al poema scientifico-didascalico De plantis, che Contuccio, seguendo un ineludibile costume dei suoi colleghi e predecessori nel Collegio Romano, si era accinto a comporre: Mazzolari ne loda l’imitazione delle Georgiche, cita due passi della prefazione in prosa e un estratto di 18 versi, ricorda lo stato di incompiutezza in cui si trovava il testo, per colpa dell’autore («Verum Contuccio non facultas sed voluntas defuit»), cosa che giustificava il suo rifiuto di preparare il poema per la pubblicazione; non si trattava infatti di dare soltanto una, pur ardua, ripulitura finale: «ita multa multis partibus manca sunt et mutila ut restaurari, quod veteribus in statuis fieri nunc ab Artificibus solet, nonnisi difficillime possit»15. Ma prima ancora del De plantis Mazzolari aveva ricordato l’unica prova poetica di qualche respiro che avesse raggiunto la stampa: Jam, quod ad artem Poeticam attinet, in ea non excelluit minus quam in Oratoria. Documento sit carmen illud quod de Monte Testaceo scripsit, et in Collectione Latinorum Poematum, quae composita ab Arcadibus Romae edita sunt, legitur. Hujusmodi carmen satis ejus hoc in Poematium genere praestantiam declarat. Proxime enim ad Horatianam scribendi formam accedit et subtilissmo quodam, quo maxime Horatius praecellit, juncturarum et coagmentandorum verborum artificio commendatur16. Nel terzo volume degli Arcadum carmina, stampato nel 1768, anno della morte di Contuccio, figura in effetti una lunga Epistola de Monte Testaceo, indirizzata a Michele Giuseppe Morei, fatto arcade durante l’adolescenza, presto entrato nel Savio Collegio, attivissimo custode dell’Accademia dal 1743 alla morte, avvenuta nel 176617. La parte finale dell’epistola piange la prematura e recente scomparsa di Francesco Maria Gasparri, in Arcadia Eurindo Olimpiaco, ai suoi tempi non meno rinomato come poeta che come giurista18, il quale aveva sposato la sorella del Morei; la morte del Gasparri, avvenuta l’8 agosto 1735, rappresenta il termine post quem dell’epistola, che deve essere Parthenii Commentarii, cit., p. 122. Ivi, p. 103. Sulla poesia scientifica nel Collegio Romano vd. Y. Haskell, Loyola's Bees: Ideology and Industry in Jesuit Latin Didactic Poetry, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 178-244. 16 Ivi, pp. 98-99. 17 M. Catucci, Morei, Michele Giuseppe, in Dizionario biografico degli Italiani, cit., vol. LXXVI, 2012, pp. 571-573. 18 Per un prospetto dei versi che pubblicò in vari volumi delle Rime degli Arcadi si veda M.L. Doglio – M. Pastore Stocchi, Rime degli Arcadi 1-14. 1716-1781. Un repertorio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, ad indices; utile anche S. Baragetti, I poeti e l’accademia. Le Rime degli Arcadi (1716-1781), Milano, LED, 2012. 14 15 l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 163 stata composta a ridosso di quella data. Il soggetto dichiarato dell’epistola è uno fra i più oscuri dei tanti enigmi legati ai monumenti e ai luoghi di Roma tra Medioevo e prima età moderna. Se l’enorme quantità di cocci di anfore che aveva formato il monte di Testaccio richiedeva di necessità una spiegazione, nessuna fonte antica era lì pronta a fornirla. Giovanni Cavallini, romano relegato ad Avignone che negli anni ’40 del Trecento riversò la sua immedicabile nostalgia per la grandezza dei Romani antichi in una costipata enciclopedia, la Polistoria de virtutibus et dotibus Romanorum, ripeté ciò che meglio si confaceva all’idea imperiale di Roma: i tributi che arrivavano nell’urbe da regni e province dell’orbe, di cui Cavallini cita solo una favolosa Persida, risalivano lungo il Tevere, «et vasa terrea, in quibus tributa huiusmodi portabantur, frangebantur; ex quarum fragmentis factus fuit quidam acervus sive cumulus elevatus in altum, qui Romano dyomate dicitur hodie mons Testatie, id est testarum acervus, positus inter Tiberim et portam Trigeminam vel Capenam»19. Questa leggenda varcò la soglia dell’Umanesimo, figurando in una lettera di Pier Paolo Vergerio che descrive la Roma del 1398: «In eadem parte est mons manufactus, qui Testaceus appellatur, eo quod sit totus ex fragmentis vasorum fictilium, quibus tributa provinciarum et regum urbi inferebantur»20. Come molte altre storie di analogo tenore, anche questa trovò il capolinea nella Roma instaurata di Biondo Flavio, il quale, dopo aver ripetuto quello che narrava la fama «[…] multis ante saeculis continuata», ed averla subito dichiarata «falsissima», si appellava a quelli che avevano letto con lui le Romanorum gestas res e conoscevano la vicenda di Catone, che aveva fatto chiudere i tributi riscossi in Asia e a Cipro in sacchetti di tenacissimo cuoio, posti sulla poppa della nave e legati con lunghissime funi ad un sughero, in maniera tale che in caso di naufragio Roma avrebbe sì perso Catone, ma almeno recuperato i soldi. Biondo citava quindi un paio di brani di Plinio il Vecchio (nat., XXXV 157-160) per dimostrare che i maiores, fondatori del dominio di Roma, avevano fatto larghissimo uso della terracotta, al punto che in quel materiale erano stati realizzati i simulacri degli dei, gli ornamenti dei templi, molti altri elementi architettonici ed oggetti di vita quotidiana. D’altra parte, proseguiva Biondo, il lavoro del vasaio richiede la vicinanza all’acqua, e gli scarti della lavorazione non possono né esser dispersi nei campi, perché li renderebbero sterili, né esser gettati nel fiume, perché lo intaserebbero; fu quindi saggia decisione quella di concentrare i numerosi «figulorum collegia» là dove «Testaceum inter montem et Tyberim vineas videmus». Dopo una breve riflessione su quanto numerosi dovevano essere i collegi dei vasai nel periodo in cui Roma fu più popolata, Biondo concludeva con un’iperbole: «Haec omnia attente considerantes 19 I. Caballini de Cerronibus Polistoria de virtutibus et dotibus Romanorum, rec. M. Laureys, Stutgardiae et Lipsiae, Teubner, 1995, pp. 187-188 (VI 41, 4). 20 P.P. Vergerio, Epistolario, a cura di L. Smith, Roma, Tipografia del Senato, 1934, p. 218; l’epistola è ripubblicata in forma più corretta in Codice topografico della città di Roma, a cura di R. Valentini e G. Zucchetti, 4 voll., Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1940-1953, vol. IV, 1953, p. 98. 164 maurizio campanelli mirari solemus cur Testatius mons, supra fidem eorum qui non viderunt arduus, non in Alpem potius insurrexerit»21. Naturalmente la leggenda medievale rimase viva, anche se ai piani bassi della cultura, come testimonia Giovanni Rucellai, venuto a Roma per l’anno santo 1450, che, oltre alle chiese, si dilettava di visitare le antichità: Testaccio, che è uno monte pocho meno ch’el monte di Sancto Miniato di Firenze, fatto solo di vasi rotti di terra cocta, ne’ quali i suditi de’ Romani, quando signoreggiavano il mondo, recavano e’ tributi o vero e’ censi, et vòti che gli erano, i Romani gli facevano portare in su detto monte22. Bartolomeo Marliani nella sua Topographia non fece altro che ripetere Biondo, aggiungendo, senza ovviamente citar fonti, che il divieto di gettare gli scarti di terracotta nel Tevere e il luogo della discarica erano stati fissati da una disposizione del Senato: Cum autem Senatus cavisset ne in Tiberim eius artis purgamenta abjicerentur, quibus sensim repletus in urbem restagnaret, his locum assignavit, quo ea deferrent; quibus coacervatis ingens surrexit tumulus, qui Testaceus est nuncupatus23. Il gesuita Alessandro Donati tornò a porre il problema dell’origine del monte, lasciandone la spiegazione ad altri: «Nam de eo perpetuum apud antiquos silentium». Forse Donati è il primo a dire esplicitamente che non c’erano fonti antiche che parlassero del monte; questo lo autorizza a riferire una diceria circolante tra i romani: Quidam Romae opinantur factum e fragmentis urnarum, quae olim fiebant ad excipiendos cineres crematorum corporum, et magna copia diversaque figura quotidie non solum e vineis sed tota Romana planicie effodiuntur. Ma anche questa era, ovviamente, una voce destinata a rimanere tale: «Sed an vere in unum coacervatae locum, cur quandoque fuerint, dicere non possunt»24. Il lungo brano si trova nel terzo libro della Roma instaurata, per cui non si dispone di un’edizione moderna; cito quindi dall’editio princeps, che non reca note tipografiche, ma è stata stampata a Roma, dallo stampatore dello Stazio, prima del 26 luglio 1471 (ISTC ib00701000); il volume non ha numerazione di fascicoli o carte, ma il brano si trova ai ff. [52]r-[53]r. Su questa stampa vd. M. Reeve, An Annotator of “Roma instaurata”, in Studi latini in ricordo di Rita Cappelletto, a cura di C. Questa e R. Raffaelli, Urbino, Quattro Venti, 1996, 179-94. 22 G. Rucellai, Della bellezza e anticaglia di Roma, in Codice topografico, cit., p. 417. 23 B. Marliani Urbis Romae topographia, Roma, V. e L. Dorico, 1544, p. 63 (l. IV, cap. I). 24 Roma vetus ac recens utriusque aedificiis ad eruditam cognitionem expositis, auctore A. Donato […] Editio secunda correctior, Roma, F. De’ Rossi, 1648, p. 252 (l. III, cap. 13). 21 l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 165 L’ipotesi più gettonata rimase sempre quella promossa da Biondo, e rilanciata da Famiano Nardini nella sua Roma antica, pubblicata postuma nel 1666: La vera sua origine […] si consente da gli Scrittori essere, perché quivi anticamente furono i cretaij, trasportativi forse da Tarquinio Prisco, quando fè il Circo, per la commodità dell’acqua, e insieme dell’imbarco de’ loro lavori; da i cui frammenti gettativi il monte potè crescere per il gran numero de’ cretaij, ch’era in Roma, e per i molti vasi di creta, che s’adopravano per dogli da vino, da acqua, da altri liquori, da bagnarsi, da cenere de’ morti, e da altro, e fin per simulacri di Dij, e per incrostar le muraglie. La notazione sui vasi «da cenere de’ morti» in qualche modo finiva per inglobare anche l’altra ipotesi. Ma in conclusione del discorso Nardini faceva finalmente balenare l’ipotesi che si sarebbe rivelata giusta: «Oltre di che non è strano, che dalla frattura anche di molti dei vasi, ne’ quali venivano per fiume varie mercanzie, crescesse il monte»25. In pieno Settecento tuttavia la discussione era ancora aperta, e il monte continuava a rappresentare una crux per gli antiquari. Così Francesco Ficoroni poteva riproporre la tesi delle urne funerarie, ma la postdatava all’epoca delle invasioni e dell’affermarsi del Cristianesimo, invocando anch’egli un fantomatico editto del senato, sia pur col beneficio del dubbio: Io per me […] direi, secondo che porta la mia poca intelligenza, che dopo l’invasione de’ Barbari cambiata Roma di fede, il popolo per render fruttiferi gli spaziosi siti ripieni di rovine di sepolcri, ne’ quali si sa ritrovarsi urne di terra cotta e vasi cinerarj, come anche altri vasi lunghi e tondi della stessa materia usati per l’acqua da lavare le ossa bruciate, vennero tutti questi trasportati, e forse per editto del Senato, in questa pianura del Tevere26. Il Ficoroni sosteneva questa ipotesi col fatto che nelle grotte scavate nei fianchi del monte per conservarvi il vino fossero stati rinvenuti vasi integri, stretti e lunghi; inoltre sotto il monte era stato ritrovato un intero mausoleo, cosa che avrebbe dovuto escludere l’esistenza del monte in epoca antica. Nel frattempo il Testaccio, di cui fin dal Medioevo era stato fatto un uso strumentale, per non dire becero, come già aveva lamentato il Vergerio («omitto et id, quantum annuis Romanorum ludis, quos carniprialibus festis exercent, hactenus diminutum est»27) e ribadito il Nardini («avendo veduto io a’ miei giorni levarne infinite F. Nardini, Roma antica, Roma, per il Falco, 1666, p. 459 (l. VII, cap. 9). F. Ficoroni, Le vestigia e rarità di Roma antica, 2 voll., Roma, G. Mainardi, 1744, vol. I, p. 150. 27 Vergerio, Epistolario, cit., p. 218, e Codice topografico, cit., p. 99. Sulle feste di Testaccio vd. A. Sommerlechner, Die Ludi Agonis et Testatie. Das Fest der Kommune Rom im Mittelalter, «Römische historische Mitteilungen», XLI, 1999, pp. 339-370. La più vivace descrizione di quello che succedeva si legge in Adam de Usk, The Chronicle of Adam de Usk, 1377–1421, ed. and transl. C. Given-Wilson, Oxford, Clarendon, 1997, pp. 194-196. 25 26 166 maurizio campanelli carrettate, per rimediar con quelle coccie alla fangosità delle strade circonvicine»28), era divenuto un luogo di interesse archeologico, come dimostra un Editto sopra il Monte di Testaccio, emesso contro coloro che con licenza o meno, si facessero lecito scavare […] Terra e Cocci, di cui è formato detto Monte in molta quantità, e di poi trasportarli per le strade per riattamento delle medesime, o in altri usi, con gravissimo pregiudizio non solamente di dette Grotte, che in tal forma restano esposte al raggio del Sole ed alle pioggie delle acque, ma altresì in danno del Publico, venendosi in tal forma a distruggere un’antichità così celebre29. In realtà pare che dall’inizio del Seicento alla metà del Settecento il monte sia servito come bersaglio per le esercitazioni dei Bombardieri di Castel Sant’Angelo, notizia che però contrasta col fatto che nel 1674 le autorità cittadine concessero licenze di costruzione di celle o cantine da vino proprio sotto il luogo del bersaglio30. Posto sotto i riflettori degli studiosi di antichità, il monte iniziò ad acquisire un qualche interesse anche per quella letteratura che giocava con l’erudizione e l’antiquaria. In un’ecloga di Leone Strozzi, pubblicata nel primo volume degli Arcadum carmina31, il pastore Nitilo, nome arcadico dello Strozzi, riceve da un pastore morente un vecchio pezzo di corteccia, sul quale è inciso un breve testo che racchiude il segreto di un tesoro nascosto nel suo campicello. Naturalmente occorre qualcuno che sia in grado di interpretare quel testo: Alcimedonta peto Superis ereboque timendum, doctum fatidica arte Virum. Degebat in antro dolioli montis, qui nunc Testaceus Urbe dicitur, e vario testarum fragmine natus, qui nunc praegelidis factus notissimus umbris saepe calescentem Bromium frigescere cogit et certare aliis Romae cum collibus32 audet. Il monte si configura dunque quale un recente iscritto al novero dei loca amoena dell’Urbe. Mentre Nitilo esita sulla soglia della grotta di Alcimedonte, come i pastori che anticamente si recavano ad interpellare la Sibilla cumana o quella tiburtina, l’indovino appare: Nardini, Roma antica, cit., p. 459. È un editto dei Conservatori del settembre 1742, che fa riferimento a una Congregazione Capitolina tenutasi due anni prima, pubblicato in E. Rodríguez Almeida, Il Monte Testaccio. Ambiente, storia, materiali, Roma, Quasar, 1984, p. 125 (riproduzione dell’originale a p. 126). 30 Come precisa lo stesso Rodríguez Almeida (p. 123). 31 Nytilus Pastor in suburbana Villa thesaurum frustra quaerit, in Arcadum Carmina, Roma, A. De’ Rossi, 1721, pp. 202-204. 32 «aliis collibus» in questa giacitura metrica si trova in Manilio: «atque alias aliis fundentem collibus uvas» (IV 737). 28 29 l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 167 Praevenit mea vota senex egressus ab antro, primus in occursum verbis ita fatus amicis33: “Pelle metus vatemque audi tua fata canentem34. Sat notum cur nostra petis penetralia, Pastor: invenies quodcumque cupis tellure sepultum”. A tal fine Alcimedonte dona a Nitilo una bacchetta da rabdomante, ma lo Strozzi non indugia più di tanto su questo, piuttosto vuole descrivere la scena, con la grotta che trasuda vino da ogni poro del tufo, le tigri di marmo che lambiscono il mosto che stilla dal fornice, il vecchio claudicante, con gli occhi spiritati, che più beve e più profetizza: Quis sedem vultusque senis describet anheli?35 Stant hederae circum stillatque ex ubere tophi pendula gutta merum, cedit gelida unda Lyaeo, marmoreae lambunt Tigrides de fornice mustum36, dependens vitisque umbracula praebet Jacco. Ebrius hic vates oculis candentibus adstat, ambigua instabili figens vestigia gressu37, et bibit et loquitur, crescit facundia vino. In ambito strettamente romano, anzi romanesco, già alla fine del Seicento Giovanni Camillo Peresio aveva inserito il monte nel suo Jacaccio: Testaccio è un monte e ferma ’l su’ ginoccio dove a scerocco ha Roma ’l muro veccio, fu ben vestito e drento e for de coccio già già con antichissimo appareccio; de mentuccia, raponzoli e finoccio intorno ha un praticel che glie fa intreccio, ha nel su’ repostin più d’un grottaccio, che te fa ’l vin d’estate fresco giaccio38. Sdoganato il Testaccio per una letteratura che faceva il verso all’antiquaria, l’epistola di Contuccio è, a mia conoscenza, il primo testo poetico che sia interamente dedicato Il secondo emistichio è debitore di Verg., Aen., II 372: «verbis compellat amicis». «Pelle metus» viene da Sil., III 571; «fata canentem» da Ov., met., XIV 381. 35 Il secondo emistichio è debitore di Virgilio: «senibus medicantur anhelis» (georg., II 135). 36 Per l’immagine delle tigri (vere) che leccano oggetti intrisi di vino vd. Stat., Theb., IV 658: «et uda mero lambunt retinacula tigres». 37 Verso modellato su Iuv., XIV 272: «hic tamen ancipiti figens vestigia planta». 38 Cito da Gio. C. Peresio, Il Jacaccio overo Il palio conquistato, introduzione, testo e note con un lessico romanesco del seicento, a cura di F. A. Ugolini, II, Roma, Presso la Società, 1939, canto V, ottava 79 (p. 133). Devo questo passo al mio amico Massimiliano Malavasi. 33 34 168 maurizio campanelli al monte, sebbene questo sia solo un pretesto. Contuccio gioca su una tacita inversione di ruoli: mentre lui è a Frascati per l’ottobrata, il Morei non si schioda dalla città, lavora per una gloria postera che passa per un letale sfinimento presente, del quale prima o poi ci si pente, ma sempre quando è troppo tardi39. Nei pomeriggi di quell’inizio di autunno il Morei saliva da solo sull’Aventino, contemplava il Tevere, ma anche in quei frangenti si guardava bene dal divagarsi, la sua mente essendo tutta rapita dal culto dei monumenti in qualche modo sopravvissuti al tempus edax. Il problema del Morei è credere che anche gli altri siano come lui, e così un giorno, mentre passeggia con Contuccio nei pressi di Porta San Paolo, discettando su quale fosse il luogo originario della porta, rivolge all’amico un’inopinata domanda: come era nato il monte di Testaccio? Contuccio si avvolge in grandi ambagi, come s’usa quando non si sa qualcosa e non si vuole confessare di non saperla, e in definitiva si trincera dietro due ipotesi, quella già nota delle urne funerarie, e quella dei vasai che, risalendo il Tevere verso Roma, scaricavano la loro fragile merce nel porto che sarà poi di Ripa Grande, ammassando nella pianura vicina i frammenti delle anfore che inevitabilmente si rompevano; singolare ipotesi, quest’ultima, che si avvicina molto alla verità (già colta dal Nardini), anche se è singolare che Contuccio pensasse che a Roma si importassero in quantità vasi di terracotta vuoti da parte di vasai evidentemente forestieri. Ma forse non lo pensava, perché il testo non è altro che uno scherzo, come certifica anche la conclusione: inutile porsi queste domande, è roba troppo antica, che gli antichi stessi non hanno voluto far sapere ai loro seri nepotes. Contuccio però ha potuto contare sull’aiuto di Apollo, che, implorato, gli è apparso non in sogno, ma in una vera e propria visione la notte successiva, portandolo sul Palatino, nella biblioteca di Augusto, un luogo pensato per offrire un sicuro recesso alle opere dei poeti. Lì ogni cinque anni si svolge il sacrum lustrum: poiché la biblioteca si è ormai riempita di ogni sorta di poetastri, Apollo e le Muse si costituiscono in tribunale e chiamano a giudizio i poeti defunti nell’ultimo quinquennio. Quel tribunale poetico non promette nulla di buono per la maggior parte dei recenti inquilini della biblioteca: già prima che inizi il giudizio Contuccio vede Apollo vagare fra gli scaffali, spostando poeti da una parte all’altra, togliendo dai sacra pegmata e scagliando lontano, in mezzo al pavimento della biblioteca, quei libri che aveva guardato lumine torvo. L’atmosfera ricorda quella dei Ragguagli di Parnaso boccaliniani, certamente presenti a Contuccio40, sebbeme io non sia riuscito a ravvisare riprese puntuali di quei testi. Questo ritratto del Morei refrattario alle vacanze, o almeno all’ottobrata, andrà confrontato con quello che si legge all’inizio del suo Autunno Tiburtino: «Correa la stagione di Autunno, ed io, che da qualche anno sovra i Colli Albunei, e nella Città dell’antichissimo Tiburto edificata soleva in tal tempo portarmi, non tanto per dar sollievo alla mente colla salubrità di quell’aria, e coll’amenità di quei luoghi, quanto per godere della genial conversazione dell’ottimo Alfesibeo, General Custode d’Arcadia, e di altri Arcadi amici, che o fra quelle selve dimorano, o vi soglion concorrere, non aveva lasciato anco in quell’anno, non ostante la morte del mentovato Custode seguita la precedente Primavera, di colà trasferirmi» (Autunno Tiburtino di Mireo Pastore Arcade, Roma, A. de’ Rossi, 1743, p. 1). 40 Sulla fortuna dei Ragguagli vd. H. Hendrix, Traiano Boccalini fra erudizione e polemica. Ricerche sulla fortuna e bibliografia critica, Firenze, Olschki, 1995. 39 l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 169 Non vado oltre nel compendiare il testo, visto che lo pubblico qui di seguito fornito di una traduzione. Sogni e visioni erano di casa in Arcadia, e Morei stesso raccontò in forma di sogno il suo arruolamento arcadico: il Somnium dictum in Arcadum Parrhasio Nemore in Exquiliis Anno 1710 figura in apertura dei suoi Carmina41. In un panorama estivo di armenti, cani e bifolchi, il Morei inopinatamente si addormenta, ritrovandosi sbalzato in Arcadia, dove ninfe e pastori vivono tra canti, danze e bevute in un’atmosfera che ricorda quella delle scampagnate serali d’inizio estate a Testaccio, dove i clamori dei bagordi arrivano a turbare l’eterno sonno del Cestio chiuso nella piramide omonima: Non aliter Romae, dum Ver intercipit aestas, sepositis curis, qua se Testacea rupes attollit, gelidis rupes celeberrima cryptis, plebs confusa Remi mensis hinc inde paratis accubat42, in multam extendens convivia noctem; hic canit, hic cytharam dum pectine pulsat eburno43 indulget choreis44, hic frigida vina coronat: plausibus omne simul pratum, simul omne tumultu45 laetitiâque fremit; tum vero moenia Romae46, concava rupis et antra sonant47 sonitumque vicissim reddit Aventinus vicinaque Tibridis unda et dolet irrisam turbari Coestius Umbram48. In Arcadia Morei vede i poeti defunti, che grazie alla poesia hanno vinto i fata riservati ai mortali, vede un luogo in cui la gioventù si esercita a difendere con le armi i confini patrii, vede un teatro, che è poi quello del Bosco Parrasio, in cui alcuni M.J. Morei Carmina Roma, G. Zempel, 1740, pp. 2-5. Va notato che nella seconda edizione dei Carmina (Roma, G. Salomoni, 1757, pp. 1-4) il Somnium reca la data del 1711 e presenta notevoli varianti rispetto all’edizione del 1740; la terza edizione (Roma, G. e F. De’ Rossi, 1762, pp. 5-10) ripropone il testo della seconda. 42 Accubat in posizione iniziale si trova in Val. Fl., II 193: «accubat attonitum Phlegyan et Thesea iuxta». 43 Prestito da Verg., Aen., VI 647: «iamque eadem digitis, iam pectine pulsat eburno». Per «hic canit» in posizione iniziale vd. Verg., Aen., I 742 e III 155. 44 Inserto virgiliano, Aen., IX 615: «desidiae cordi, iuvat indulgere choreis», che Morei varia collocandolo al principio del verso. Virgiliana è anche la clausola: vd. Aen., I 724 e VII 147. 45 Altro inserto virgiliano, Aen., VIII 4: «extemplo turbati animi, simul omne tumultu». 46 Anche questo verso è tessuto su Virgilio, da cui vengono l’inizio: «laetitiaque fremunt animosque ad sidera tollunt» (Aen., IX 637), e la clausola: «Albanique patres atque altae moenia Romae» (Aen., I 7). Quest’ultima fu ripresa da Lucano (III 90; III 99; III 298), da Silio Italico una miriade di volte (I 389 e 608; III 182 e 509; V 124 e 634; VI 630 e 642; IX 44; X 64, 359 e 589; XII 47 e 564; XIII 79; XVI 152; XVII 353), e quindi da Stazio (silv., I 2, 191; IV 4, 14; V 2, 169). 47 Forse è una variatio metrica di Val. Fl., IV 92: «antra sonant, Sol auricomis cingentibus horis». 48 Questo brano non figura nel testo della prima edizione dei Carmina, ma è inserito in quella del 1757 (pp. 1-2) e riproposto in quella del 1762 (p. 6). 41 170 maurizio campanelli arcadi stanno tenendo le loro recitationes di versi. Sembra quest’ultimo un luogo in cui c’è posto per tutti, pur non essendo tutti sullo stesso piano49: Sunt bona qui recitent, sunt qui mediocria, sunt et50 qui mala; perfectus namque ut dicare Poeta, non satis Arcadicis tua scribere nomina Fastis; claros ingenium Vates, sudore parata virtus assiduo, studium multiplicis horae judiciumque facit: nectas nisi talia, nunquam, crede mihi, optata cinges tua tempora lauro51. Morei si addentra quindi in un sacrum nemus e attraverso una densissima sylva arriva all’agreste Templum in mezzo al quale sorge l’enorme simulacro marmoreo di Pan, circondato da fauni, silvani, satiri, a cui un gran numero di sacerdoti intona un inno. In una valletta appartata stanno gli arcadi, presieduti dai dodici colleghi e dal custode; mentre Morei li osserva con un parvum vitrum (un cannocchialetto da teatro?), il custode lo chiama e lo fa arcade, conferendogli le canoniche insegne e la relativa facoltà di poetare, e così, mentre Morei si prepara a recitare un commosso carme di ringraziamento, svanisce il sonno e con esso i somnia. La distinzione tra poeti e verseggiatori ritorna in una serie di ottave che pure narrano di un ritrovarsi del Morei nei boschi dell’Elicona e che potrebbero – ma è ipotesi spericolata – esser state anch’esse composte in occasione del suo ingresso in Arcadia: O quanti stan sull’onorato monte, che sen vivono in Terra ascosi, e queti! Quanti quaggiù fra noi alzan la fronte usurpandosi il nome di Poeti! E mai non bevver d’Ippocrene al fonte, nè vider d’Elicona i bei laureti; che non basta esser Arcade, e Quirino, per aver parte del furor Divino. Odono le cittadi, odon le Ville delle sampogne e delle trombe il suono; ma fra la schiera di ben mille, e mille, ch’osan cantar, pochi i Poeti sono. Hanno i Poeti in sen certe scintille, 49 Il brano che segue si legge alle pp. 3-4 dell’edizione del 1740, ed è riproposto senza varianti in quelle del ’57 (p. 3) e del ’62 (p. 8). 50 Cfr. Mart., I 16, 1-2: «Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura / quae legis hic». 51 Clausola virgiliana: «sic fatus cingit viridanti tempora lauro» (Aen., V 539), ripresa nella Consolatio ad Liviam pseudovidiana (459). l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 171 che suol dar Febo alle grand’Alme in dono; né fa propizio o liberale Apollo la Lupa al fianco, o la Siringa al collo52. Nello stesso 1735 in cui presumibilmente Contuccio scrisse la sua epistola, Morei recitò un carmen elegiaco in una pubblica adunanza degli Infecondi tenutasi sull’Aventino, nel medesimo luogo in cui venti anni prima si riunivano gli Arcadi. Il testo è tutto un rimpianto di una gioventù poetica rapidamente sfiorita, così come scomparsi erano i poeti che Morei aveva ammirato da giovane, fra i quali si ricordano Forteguerri, Gigli, Leers, Zappi, Guidi, Leoni, Crescimbeni e finalmente il cognato Gasparri. Quindi gli appare Apollo: «Jam me correptum turbine tali / excitat atque idem mihi quae monstravit Apollo53 / nunc eadem vulgare jubet». Il dio lo porta in una spelonca, dove gli si svelano «prospera rerum presagia»: ‘Aspice – dicebat Deus ille –, nigerrima Caci, si nescis54, domus ista fuit, mox ordine verso Roma vetus Geniusque loci quae colle sub isto acciderint variis sic expressere figuris’55. Gli appaiono così i dodici avvoltoi scolpiti in marmo scuro, Remo sconfitto dal fratello, le fatiche di Ercole e in particolare Caco che esala l’anima tra le fiamme e il fumo, ed altro ancora; Morei stesso guardandosi intorno scorge le acque del Tevere riprodotte in argento massiccio, la lupa con i gemelli, Romolo che con la spada in pugno descrive il perimetro delle mura di Roma. L’ennesimo sogno archeopoetico, dunque, che si conclude con la celebrazione del teatro degli Infecondi, che era stato anche quello degli Arcadi: Talia miranti56 ‘Viden hoc?’ mihi subdit Apollo, ac simul interea candenti in pariete sculptum innuit hoc ipsum, formosior ore, theatrum. Mox verbis fata involvens aperire futura57 incipit; at quis erit, qui Magno prodita Phoebo aut queat aut audax oracula pandere tentet? Cito dalla prima edizione delle Poesie del Morei, stampata a Roma, da A. de’ Rossi, nel 1745 (pp. 20-21). 53 Da notare che nella terza edizione dei Carmina il testo si conclude qui, con Apollo e le Muse a fare orecchi da mercante: «Jam me correptum turbine tali / destituunt Musae refugitque vocatus Apollo» (p. 43). 54 «Si nescis» in posizione iniziale si legge in Verg., ecl., III 23, Prop., II 15, 12, Ov., am., III 8, 13, her., X 150, Pont., III 6, 8, ma ricorre anche in Marziale e Giovenale. 55 Per «variis figuris» in questa giacitura metrica vd. Lucr., II 682: «haec igitur variis debent constare figuris». 56 «Talia miranti» in posizione iniziale si trova in Val. Fl., V 470. 57 Clausola memore di Ov., met., XV 559: «edocuit gentem casus aperire futuros». 52 172 maurizio campanelli Hoc tamen, hoc memini, quorundam nomina Vatum non semel ad Cytharae numeros memorasse canoros58. Questo Apollo fatidico, i cui oracoli non possono essere ripetuti, ma che in conclusione si fa lui stesso cantore dei poeti, poteva prestarsi ad ironie facili, ma anche a parodie sottili, e certamente l’Apollo accigliato di Contuccio, che non si perde in oracoli, non indugia in descrizioni di monumenti, ma si fa giudice severo dei poeti contemporanei, poteva rientrare in questa seconda categoria. D’altra parte tra Contucci e Morei doveva esserci una qualche consuetudine, come sembra testimoniare anche il breve componimento in faleci indirizzato a Lireno, nome arcadico di Contuccio, che Morei inserì nel quarto libro dei suoi Carmina, quello che raccoglie gli Epigrammata: Dum Tu carminibus canens Latinis, vires et Veneres originesque59 Hetruscae memoras, Lyrene, Linguae, Hetruscam celebres licet Poesim, nil cum carminibus tuis venustis, nil ipsi, mihi crede, Amice, prodes. Quin ne illi noceas cave Poesi; nam dum carminibus facis venustis ut Linguae pateat decus Latinae, Musis posthabitis nitentis Arni, omnes ut Latiam tuo sequantur exemplo tacitus mones Poesim60. Questi versicoli ci restituiscono una notizia che suscita una qualche sorpresa: Contuccio aveva scritto un componimento in latino, forse della misura di un poema didascalico, sulla storia e le qualità della lingua volgare. Potrebbe essere una delle tante cose che Contuccio scrisse a nome di altri, ma c’è un ulteriore dettaglio che sembrerebbe smentire questa ipotesi. La terza edizione dei Carmina ha una struttura più complessa delle prime due, essendo divisa in quattro libri, rispettivamente di Sylvae, Eclogae, Elegiae ed Epigrammata, con quattro dedicatari diversi, mentre le prime due edizioni non hanno alcuna divisione interna; la terza edizione è inoltre provvista di due appendici, la prima Il carme si legge alle pp. 113-116 dell’edizione del ’40, in cui si precisa anche che in quel tempo Morei era un assessor degli Infecondi; il passo qui citato si trova alle pp. 115-116. 59 Rifatto sul «Veneres Cupidinesque» di Catull., III 1 e XIII 12, che fu ripreso da Mart., IX 11, 9 e XI 13, 6. 60 Gli Hendechasyllabi ad Lyrenum P. A. si leggono, senza varianti, a p. 33 della prima edizione, a p. 28 della seconda edizione, alle pp. 221-222 della terza. Poiché nella prima e nella seconda edizione i carmi sembrano disposti secondo un ordine cronologico, e gli endecasillabi, che non recano data, si trovano tra un’Ecloga apologetica del 1717 (pp. 29-32) e un’elegia in morte dello Zappi, datata 1719, che fu recitata in un’adunanza degli Arcadi pochi giorni dopo la scomparsa dell’interessato (pp. 34-37; lo Zappi morì il 30 luglio), possiamo ipotizzare che siano stati composti fra il ’17 e il luglio del ’19. 58 l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 173 delle quali contiene i carmi latini scritti a Morei da altri, la seconda, ancor più smaccato omaggio alla propria vanagloria, elenca una serie di Illustria alia de authore et ejus carminibus testimonia, tra cui figura il seguente: Contuccius Contucci S.J. in Libris de praestantia Linguae et Poesis Italicae, quorum tertium librum versibus pluribus Authori inscripsit (p. 265). Questo ulteriore passo sembra confermare che di poema doveva trattarsi, dal momento che era diviso in almeno tre libri, e sembra anche escludere che andasse sotto il nome di altri. D’altra parte è curioso che il biografo Mazzolari non abbia fatto il minimo riferimento a quest’opera. Per ora queste due citazioni del Morei sono destinate a rimanere enigmatiche, anche se certamente aggiungono un nuovo capitolo alla biografia intellettuale del Contucci. Che Contuccio conoscesse il Somnium e le ottave del Morei, sebbene ancora non raccolte in volume, e che abbia voluto sottilmente rispondere con la sua visione ai sogni dell’amico è ipotesi meno ardita di quanto possa sembrare. Ammessi comunque rapporti cordiali fra i due, bisognerà riflettere brevemente sul sottile gioco del gesuita, che trasforma l’informe monte di Testaccio in una metafora del momento culturale che si stava vivendo a Roma e non solo: il poeta Morei che cerca una puntuale quanto chimerica verità antiquaria viene messo di fronte ad una meno tangibile ma ben più profonda verità letteraria dall’antiquario Contucci. Apollo e le Muse eretti in tribunale, che sfrondano a colpi d’ascia la selva dei poeti contemporanei, eliminando libri che non hanno altri pregi che quelli tipografici ed autori tanto vacui quanto pretenziosi, senza dimenticare i plagiari e i compratori di versi altrui da recitare in pubblico come propri, svolgono il ruolo che dovrebbe svolgere, per esserlo autoattribuito, l’Arcadia, un ruolo (ingrato, anzi impossibile) al quale l’accademia era andata di necessità abdicando nel corso dei decenni. Non so dire se l’epistola di Contuccio sia stata recitata o meno nel Bosco Parrasio o in qualche pubblica adunanza di arcadi, così come non ho idea di quale circolazione possa aver avuto prima di venir stampata nel terzo volume degli Arcadum carmina, ma la visione di Contuccio andrà comunque letta come un richiamo all’accademia perché tornasse a svolgere un ruolo vero nell’agone letterario italiano e non continuasse a percorrere la china della propria musealizzazione. Quel rischio, negli anni del custodiato di Francesco Lorenzini, doveva apparire quanto mai tangibile, e Morei nel 1735, se ancora non si considerava custode in pectore, era già uno dei personaggi più attivi sul fronte accademico, foriero di promesse che del resto avrebbe a suo modo mantenuto, dando all’Accademia un rinnovato impulso editoriale (ma forse non era questo quello che Contuccio avrebbe voluto). Nella parte finale dell’epistola Contuccio scinde Morei dai poetastri che causano l’inarginabile crescita del monte di Testaccio: lui è un poeta che possiede la vetus fandi copia e il mos Latius, cose che gli consentiranno di raccogliere il testimone poetico caduto troppo presto dalle mani del cognato Gasparri. Ma da questo primo profilo del Morei emergeva uno scoperto prestito oraziano: «mos etiam Latius, quo pectora fonte / cum semel imbueris» richiamava subito alla memoria un ritratto tutt’altro che lusinghiero: «An, haec animos aerugo et cura peculi / cum semel imbuerit, speremus carmina fingi / posse linenda cedro et levi servanda cupresso?» (ars, 330332). Una situazione analoga si ritrova alla fine dei versi dedicati al Morei: «non tibi cognatae desunt exempla poesis / quae proprius spectes» rinvia immediatamente a 174 maurizio campanelli «ut propius spectes lacrimosa poemata Pupi» (epist., I 1, 67). Il continuo gioco di ripresa e ricontestualizzazione di emistichi, clausole, iuncturae di poeti antichi che vena l’intera epistola di Contuccio seguiva qui i percorsi del capovolgimento. Non è detto che ciò dovesse necessariamente dispiacere al Morei; ancora non sappiamo nulla dei codici di questa poesia, su cui si articola tanta parte di quella tela di ragno che era la res publica arcadica, e può darsi che simili procedimenti facessero normalmente parte del gioco, e che fossero anzi apprezzati, ma sta di fatto che Morei non riportò il brano né fece menzione alcuna dell’epistola De monte Testaceo nelle citate appendici alla terza edizione dei suoi Carmina, in cui, apparentemente, cercò di mettere tutto ciò che poteva. I curatori, a tutt’oggi ignoti, del terzo volume degli Arcadum carmina non badarono a queste quisquilie, complice anche la scomparsa di dedicante e dedicatario; al contrario, la pubblicazione dell’inedita l’epistola veniva ad essere un omaggio ad entrambi, oltreché al Gasparri; l’epistola consentiva anzi di recuperare, ad oltre trent’anni di distanza, un significativo frammento di quella comunità letteraria, in special modo romana, di cui le raccolte degli Arcadum carmina, non diversamente dai volumi delle Rime, costituivano il grande, inclusivo atlante. Ma inserire l’epistola De monte Testaceo in una raccolta di poesia arcadica poteva presentare qualche vantaggio anche in termini di storia culturale. La questione del numero esponenzialmente crescente di poeti, quasi tutti presunti, e dei correttivi da porre in atto per ridurlo, o almeno impedirne l’ulteriore crescita, ritorna a più riprese nel dibattito letterario settecentesco, ed è parte del più grande problema, discusso fin dalle origini della stampa, del proliferare dei cattivi libri61. In prospettiva di storia letteraria, il capitolo più significativo, oltre che più dilettevole, di tale dibattito sono le Lettere Virgiliane del Bettinelli (1757), che non a caso chiamavano in causa direttamente l’Arcadia, anzi «i legislatori della nuova Arcadia». Il miglior inquadramento del problema è il brano d’esordio della prima lettera: Tutto l’Elisio, o Arcadi, è posto in tumulto dagl’italiani poeti, che, d’ogni età, d’ogni stato, qua scendono in folla ogni giorno a perturbare la pace eterna de’ nostri boschetti. Par che la febbre, per cui gli Abderiti correvan le strade recitando poemi, sia venuta sotterra co’ vostri cantori, 61 Sul quale basterà leggere questo passo della Bibliopea del Denina: «Peraltro non era cosa inaudita che prima di pubblicare un libro si proponesse al giudizio d’uomini gravi e intelligenti, per autorità pubblica a ciò deputati. Eusebio pretende che ci fosse questa legge o usanza appresso gli Ebrei e che Platone, il quale nella sua Repubblica la propone, l’abbia presa da loro. Qualche altro antico [in margine il rinvio: Galenus contra Julian. ap. Theoph. Raynaud., de bonis et malis libris, p. 278] parlò più chiaro sopra questo proposito; e infastidito e noiato degl’inutili e cattivi libri, che si publicavano, avrebbe voluto che vi fosse un collegio di savj, al cui giudizio si presentassero, per lasciarne uscir fuori i buoni e sopprimere gli altri. Le società regolari che in molte cose prevennero i buoni ordini del governo politico, avanti ogni legge ecclesiastica e civile aveano stabilito che gl’individui loro non pubblicassero scritti senza licenza de’ superiori». Cito dalla seconda edizione: C. Denina, Bibliopea o sia l’arte di compor libri, Milano, G. Silvestri, 1827, p. 354 (rist. anast. Modena, Mucchi, 1994), più corretta della prima (Torino, fratelli Reycends, 1776). l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 175 verseggiatori e poeti importuni, a profanare con barbare cantilene ogni selva, ogni fonte, ogni grotta, sacra al silenzio e alla pace dei morti. Ogn’italiano che scende tra noi, da alcun tempo in qua, parla di versi, recita poemetti, è furibondo amatore di rime, e recasi in mano a dispetto di tante leggi infernali o tometto, o raccolta, o canzoniere, o sol anche sonetto, e canzone, che vantasi d’aver messa in luce, benché a tutt’altro mestier fosse nato. Or pensate, arcadi magistrati, in qual confusione sia tutto il nostro pacifico regno poetico62. Brano da leggere insieme all’ironica chiusa dell’epistola: Voi sedete legislatori e giudici in un tribunale supremo di poesia; voi mandate colonie poetiche in ogni terra italiana; voi date poetica cittadinanza perfino ai re dell’Europa e alle nazioni straniere; e in ciò sembrate antichi romani; dee dunque piacervi il mio zelo. Che se alcuno se ne dorrà e leverà la voce contro di me, ricordisi almeno che parla a un morto63. Un tribunale per giudicare i poeti italiani, in particolare quelli nuovi, era quanto auspicava Luciano in conclusione del suo intervento, incluso nella settima lettera: Un tribunale dovrebbe istituirsi, a cui dovesse ognun presentarsi che venga solleticato da prurito poetico. Innanzi a giudici saggi gli si farebbe esame dell’indole e del talento, e certe pruove se ne farebbono ed esperimenti. Chi non reggesse a questi, all’aratro, e al fondaco, come natura il volesse, o alla spada e alla toga n’andasse; chi riuscisse, un privilegio otterrebbe autentico e sacro di far versi e pubblicarli, qual di chi batte moneta del suo64. Quando Virgilio torna a Roma per rendersi conto dal vivo di quale fosse lo stato della poesia italiana, dopo varie esperienze, tutte venate d’amarezza, approda finalmente in un luogo deputato alla conservazione del sapere letterario: Udii finalmente parlarsi di biblioteca da cotai due che, in una gran porta entrando di magnifico albergo, a salir si mettevano una marmorea scala ed amplissima. Dietro lor m’avviai senza più, né più bello spettacolo mi venne veduto mai. Il numero e l’ordine e lo splendor de’ volumi, e gli ornamenti medesimi di quelle sale, mi richiamarono a mente la palatina biblioteca Apollinea d’Augusto. Mi volsi tosto alla classe de’ poeti, ove trovai di che contentare la mia curiosità largamente. Ve n’erano le migliaia di soli italiani, rimpetto a’ quali greci e latini assai pochi sembravano65. Ovviamente Bettinelli non pensava che l’Arcadia potesse svolgere quel ruolo, ammesso e assolutamente non concesso che pensasse ad un soggetto istituzionale capace di tener a freno le smanie poetiche degli italiani. La settima legge del suo Codice nuovo di leggi del Parnaso italiano recita così: S. Bettinelli, Lettere virgiliane e inglesi e altri scritti critici, a cura di V.E. Alfieri, Bari, Laterza, 1930, p. 5. Ivi, p. 8. 64 Ivi, pp. 41-42. 65 Ivi, p. 51. 62 63 176 maurizio campanelli L’Arcadia stia chiusa ad ognuno per cinquant’anni, e non mandi colonie o diplomi per altri cinquanta. Colleghisi intanto colla Crusca in un riposo ad ambedue necessario per ripigliar fama e vigore. Potranno chiudersi per altri cinquant’anni dopo i primi, secondo il bisogno66. Forse non lo pensava neppure Contuccio, ma la sua epistola, letta in questa chiave, rimane a testimoniare che il problema era in qualche modo già avvertito all’interno dell’Arcadia, più di venti anni prima di Bettinelli. I curatori del terzo volume degli Arcadum carmina ebbero molte più gatte da pelare di quante oggi si possa credere. Il solito Mazzolari, parlando della familiarità che Contuccio aveva con Marziale, certamente in relazione alla raccoltina di epigrammi che negli Arcadum carmina segue l’epistola su Testaccio, fa riferimento all’apparizione di un testo che metteva alla berlina il volume: «Prodiit Satyra quaedam, egregie illa quidem conscripta, quae Arcadicam Collectionem illam, quam diximus, vehementer exagitavit». Mazzolari difende chi aveva curato la collezione, a cui non mancava certo la capacità di discernere la buona dalla cattiva poesia, ma che aveva dovuto piegarsi a pressioni che poco avevano da spartire con schiette valutazioni di valore poetico: «Nam quid facias, cum aut imperiosa nobilitas aut importuna inepti alicujus ambitio potentiorum sustentata opibus irrumpat et locum per vim in Collectione expugnet?». Per evitare «multorum offensiones» tanto valeva fare di tutta l’erba un fascio, mettere insieme i buoni e gli ottimi con i mediocri e talora anche coi cattivi, contando sulla capacità di distinguerli a valle, da parte di un lector sapiens, e disinteressandosi del giudizio degli indotti, i soli con i quali i cattivi poeti avrebbero potuto menar vanto di esser stati associati ai buoni67. Era la stessa situazione sublimata da Contuccio nella visione del sacrum lustrum: buoni e cattivi poeti gli uni a fianco agli altri, ed un giudizio da dare a posteriori, ma non da privati lettori, bensì da un supremo tribunale, giudizio che sarebbe durato per sempre. I motivi che indussero i curatori del terzo volume degli Arcadum carmina ad inserire l’epistola di Contuccio probabilmente non li sapremo mai, ma certo, al di là degli intrinseci pregi letterari, quel testo portava un piccolo balsamo, sia pur mettendoci dentro il dito (ma con discrezione di gesuita), a ferite reali che, evidenziate dalle ormai vecchie critiche, trasversali e di ampio respiro, del Bettinelli, così come dall’episodio puntuale dell’ancora ignota satira apparsa all’indomani della stampa del volume, rimanevano ancora aperte nella missione e nella prassi dell’Arcadia di metà Settecento. Per questi motivi credo che si possa recuperare e rileggere l’epistola del Contucci, che probabilmente, a causa anche del titolo, che nient’altro sembra promettere se non antiquaria in versi, non è più stata letta da quando quel volume del 1768 finì di circolare per le librerie. 66 67 Ivi, p. 61. Cfr. Parthenii Commentarii, cit., pp. 100-101. CONTUCCIUS CONTUCCI POLITIANUS SOC. JESU INTER ARCADES LYRENUS BOLEJUS DE MONTE TESTACEO EPISTOLA1 Optime Romulidum, quamvis, Miroee, paternum2 et genus Etruscis et mos te vindicet oris3, dum me rura tenent4 et silvis otior altis Thelegoni, dominâ cessas tu lentus in urbe5, 5 nec patrio haerentem nido te mollior aura dimovet, aeriae invitent seu Tiburis arces6, seu Latio dilecta Jovi vocet Alba. Camoenas si sapis, Octobres simul ac venère Kalendae, falle, nec, ut pictâ populo spectère tabellâ 10 laurifer, insanum quaeras urgere laborem7, Il testo è tratto da Arcadum carmina III, Roma, G. e F. De’ Rossi, 1768, pp. 107-114. Ho modificato l’interpunzione in alcuni passi; il testo presenta numerosi accenti, perlopiù sulle forme avverbiali, ma anche sui cum, ed in genere su tutte le parole che terminano in e (a partire dai ne); ho mantenuto soltanto quelli che avevano reale valore diacritico, ovvero che servivano ad evitare possibili equivoci. L’analisi delle fonti mostra come, nonostante la generale temperie oraziana messa in rilievo anche da Mazzolari (vd. supra, p. 162), Contuccio attinga soprattutto al repertorio dell’epica latina antica, con Virgilio a far la parte del leone, e all’Ovidio delle opere dall’esilio. Le riprese e le rielaborazioni si concentrano soprattutto nelle parti iniziali e nelle clausole; non mancano i casi in cui la ripresa testuale sottointende un gioco di echi con i contenuti del modello, e molte sono le evenienze nelle quali Contuccio somma e sovrappone fonti diverse, talora anche disparate. Naturalmente bisogna tenere sempre presente che decenni di lettura e di insegnamento di questi testi potevano rendere molte riprese frutto di una sorta di inconscio poetico, di memoria poetica profonda, capace di riaffiorare e di imporsi senza che nell’atto della composizione Contuccio fosse immediatamente consapevole di star riproponendo un modello preciso (ma sono certo che non avrebbe avuto difficoltà a ritrovare tutti i riferimenti, se ne avesse avuto bisogno). Più interessanti sono i versi in cui vengono riprese, o leggermente variate, particolari iuncturae o giaciture metriche e, a partire da queste, il verso assume una struttura metrica che corrisponde a quella del modello, con parole mutate. L’analisi al microscopio (ma ovviamente senza pretese di esaustività) delle fonti consente in definitiva di recuperare un piccolo frammento di ars poetica applicata del più maturo classicismo settecentesco. 2 L’epistola inizia col rifacimento di un verso oraziano: «O maior iuvenum, quamvis et voce paterna» (ars, 366). 3 Tra il quarto e il quinto piede sembra inserirsi una memoria ovidiana: «utque cupis credi, memori te vindicat ira» (her., XXI 11). 4 L’emistichio ha un andamento lucaneo: «nudus rura tenet» (Luc., IX 440). 5 Si noti l’intarsio da un verso ovidiano, significativamente dedicato a chi non riesce a staccarsi da Roma: «Si te causa potens domina retinebit in urbe» (rem., 291), contaminato col «lentus in umbra» di Virgilio (buc. I 4; il «nec patrio» del verso seguente echeggia i «nos patriae» e «nos patriam» del luogo virgiliano). 6 La clausola è prelevata da Marziale: «Itur ad Herculei gelidas qua Tiburis arces» (I 12, 1), ma va messo in conto anche Giovenale, che usa due volte «Tiburis arce» in clausola (III 192 e XIV 87); Contuccio vi inserisce inoltre una memoria virgiliana: «protinus aerias Phaeacum abscondimus arces» (Aen., III 291). 7 Una variazione sul testo virgiliano: «Tartara, et insano iuvat indulgere labori» (Aen., VI 135). 1 178 maurizio campanelli 15 20 25 30 ne, si te lecto macies affixerit8, et jam ultima per totas ierint contagia venas, Pieridas frustra damnes et Apollinis artes. Nec tamen ignoras quid opis sibi postulet usus9, et curanda cutis, licet intra tecta moreris abditus et, veteres prope dedignatus amicos, magnum aliquid tecum in seros meditere Nepotes10. Namque soles, ubi Sol medio decessit Olympo, solus Aventinum petere et spectare superne in mare currentem Tyberim remisque carinas nitentes contra, nec te quandoque sub imâ valle piget duras animi deponere curas11, mons ubi vicino Testaceus incubat amni12, quamquam non tibi mens, non doctis otia curis, tunc quoque cum viridi tecum spatiaris in umbrâ13, ipsa vacant, sed quae nobis monumenta reliquit tempus edax14, recolis prudens aevique prioris quaeris opes15 varias et amico pectore condis16. Nam memini17, cum dissereres qui pristinus aut quà Trigeminae fuerat portae locus, ilicet ex me scitari quoque, tam multas qui casus in unum conseruit testas plenoque coegit acervo18, Qui la variazione è su Orazio: «aut alius casus lecto te adflixit [var. lectiones afflixit, adfixit, affixit], habes, qui» (serm., I 1, 81). 9 Verso ricavato dalla combinazione dell’oraziano «nec tamen ignorat, quid distent aera lupinis» (epist., I 7, 23) e dell’ovidiano «armandique modo, mittor, quo postulat usus» (met., XIII 215). 10 Per l’immagine dei seri nepotes cfr. Verg., georg., II 58 «tarda venit seris factura nepotibus umbram»; Prop., III 1, 35 «meque inter seros laudabit Roma nepotes»; Ov., pont., III 2, 35 «vos etiam seri laudabunt saepe nepotes»; Luc., VII 207-208 «haec et apud seras gentes populosque nepotum, / sive sua tantum venient in saecula fama»; Stat., Theb. I 185 «augurium seros dimisit ad usque nepotes»; Sil., IV 399-400 «si modo ferre diem serosque videre nepotes / carmina nostra valent». 11 Il secondo emistichio è una citazione virgiliana: «nate, licet tristis animo deponere curas» (georg., IV 531); si noti come pure il primo emistichio sia non solo prosodicamente, ma anche fonicamente (nate – valle, licet – piget) modellato sul verso di Virgilio; virgiliane sono anche le «durae curae»: «ast aliis duras immittere curas» (Aen., IV 488). 12 «Vicino amni» tradisce forse una memoria lucanea: «spectat vicinos sitiens exercitus amnes» (IV 336). 13 «Viridi umbra» viene da Virgilio: «spargeret aut viridi fontes induceret umbra?» (ecl., IX 20). 14 «Tempus edax» all’inizio di un esametro è stilema ovidiano: «tempus edax rerum tuque, invidiosa vetustas» (met., XV 234) e «tempus edax igitur praeter nos omnia perdet» (Pont., IV 10, 7). 15 Memoria oraziana: «quaerit opes et amicitias, inservit honori» (ars, 167). 16 Memoria virgiliana, forse non priva di qualche ironia: «hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit» (Aen., XII 950). 17 Per «nam memini» ad inizio di esametro vd. «Nam memini Hesionae visentem regna sororis» (Verg., Aen., VIII 157) e «Nam memini, cum te saevum veniente minaxque» (Ov., her., XIX 85). 18 «Pleno acervo» sembra derivare da Giovenale, con mutamento della posizione dell’aggettivo: «nummus et e pleno tollatur semper acervo» (VI 364). 8 l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 35 40 45 50 55 179 unde loco nomen19 vetus est et montis origo. Tunc ego, fabor enim20, rebus deprensus in arctis, respondi quae fama foret, sed multa loquutus21, ut mos est22, cum nos pudet ignorata fateri, haerebam tamen; et meministi quaerere causas non re, sed veri quae proximitate placerent; nam tibi quid recti notique reponere possem? seu multus circa fossor, quas eruit urnas, dum sarrit vineta, locum congessit in unum manibus insessas et turpes ossibus albis, Romulidum cum plebs olim post fata23 jaceret condita fictilibus tumulis et paupere testâ, seu figulus procul hinc Tyberi subvectus in Urbem, argillâ dives fragili, dum litora complet24 fictilibus, statio fuerat quà proxima cymbis, in vacuam urceolos et fractas contulit ollas planitiem, longo res est obscurior aevo25, scire nec id prisci seros voluère nepotes26. Sed quoniam veram montis praedicere causam27 non valui, cum me cupido sermone rogares, accipe, quam precibus28 dudum exoratus Apollo me docuit, nec te pigeat29, si grande minaris carmen et Aonidum famâ Sacraria comples, inceptis operam magnis non amplius horae furari spatio: gaudent hac fraude Camoenae30, Intarsio ovidiano: «illa loco nomen fecit, locus ipse Lupercis» (fast., II 421). Inciso virgiliano: «Hic tibi, fabor enim, quando haec te cura remordet» (Aen., I 261). 21 Per «multa locutus» in clausola vd. «saepe ‘vale’ dicto rursus sum multa locutus» (Ov., trist., I 3, 57) e «mollius es solito mecum tum multa locutus» (eleg. in Maecen., I 67). 22 Prestito da Lucano: «ut mos est Phariis miscendi licia telis» (X 126). 23 Cfr. «miseri post fata Sychaei» (Verg., Aen., IV 20); «meum post fata levamen» (Prop., IV 11, 63); «post fata quiescit» (Ov., am., I 15, 39); «post fata reposco» (Ov., met., XIII 180). 24 Per questa clausola cfr. «deducunt socii navis et litora complent» (Verg., Aen., III 71); «exercitum ruit ad portus et litora complent» (Verg., Aen., III 676); «circumeunt, alii rupes ac litora complent» (Luc., IV 464). 25 Per «longo aevo» in quella giacitura metrica cfr. «sustinet – et longo facite ut narremur in aevo» (Ov., met., XIV 731); «aspicis ut longo teneat laudabilis aevo» (Ov., trist., V 14, 35); «Lucus erat longo numquam violatus ab aevo» (Luc., III 399); «iam piger et longo iacet exarmatus ab aevo» (Stat., Theb., XI 743); cfr. anche Sil., IV 474; V 187; VI 255; XVI 332. 26 Per i seri nepotes vd. supra, nota 10. 27 Verso debitore di Lucrezio: «naturam et veram verbis exponere causam» (III 951). 28 Il prestito da Marziale, «accipe quam primum; brevis est occasio lucri» (VIII 9, 3), può essere ammesso, anche in considerazione di quello che scrive Mazzolari circa le accuse di eccessiva familiarità con Marziale che furono rivolte a Contuccio, certamente per gli epigrammi inseriti nel terzo volume degli Arcadum carmina (vd. supra, p. 176). 29 Intarsio ovidiano: «nec faciem nec te pigeat laudare capillos» (ars, I 621). 30 Chiara la ripresa oraziana: «Vergilio annuerunt gaudentes rure Camenae» (serm., I 10, 45). 19 20 180 maurizio campanelli et quodcumque datur, dulce est cognoscere verum. Nam mihi per visum, serà cum nocte jacerem31 60 pervigil, Augusti patuere palatia clivi32, qualis erat33 Latiis olim cum Vatibus aulam explicuit sedemque dedit, quâ vivere longe a populi turba vigilata poemata possent et latera introrsum et totam praetexere frontem34. 65 Huc et tum Deus ipse, loco qui praesidet, unà Phoebus et Aonidum coetus convenerat omnis. Miranti, quid enim vellet concursus ad aulam quaerebam tacitus, “Mos est – ait una sororum35 – hic Vates censere et sacrum condere lustrum. 70 Nam postquam coepere legi quae scripta beatos implerent loculos, Vatumque accessit imago cedrina quae nomen scriptoris et ora notaret36, institit et favor immeritos et gratia vates tollere, jamque malos capiebant scrinia libros37, 31 Doppia ripresa virgiliana: «haec adeo tibi me, placida cum nocte iaceres» (Aen., VII 427) e «vincla recusantum et sera sub nocte rudentum» (Aen., VII 16). 32 Clausola debitrice di Marziale: «inde sacro veneranda petes palatia clivo» (I 70, 5) e «et sacro decies repetis palatia clivo» (IV 78, 17). 33 L’inizio sembra un’eco di Virgilio: «qualis eram, cum primam aciem Praeneste sub ipsa» (Aen., VIII 561). 34 Per avere un’idea delle conoscenze che si avevano sulla biblioteca palatina di Augusto ai tempi di Contuccio può esser utile leggere quanto ne scrive un archeologo che doveva essere molto vicino al gesuita, ovvero Ridolfino Venuti (riporto tra parentesi quadre le note al testo del Venuti stesso): «Era questo Tempio ornato di Statue, e marmi preziosi, avendo sul Frontespizio un carro dorato, e le porte d’Avorio istoriate de’ fatti d’Apollo [Ved. le Medaglie di quest’Imperatore app. il De Bia, e il Bellor. Num. XII Caes.]. Vi fu anche aggiunto dopo il portico di colonne d’Affricano, e la Libreria; sotto la base della Statua d’Apollo di bronzo colossale furono dal medesimo Augusto situati i Libri Sibillini [Svet. loc. cit. c. 31]. Si racconta essere stato in questo Tempio un Lampadario a somiglianza d’Albero di pomi [Plin. H. N. lib. 36 c. 5]. Vi fu ancora una Biblioteca; la Biblioteca era divisa in Greca, e Latina [Ved. Murat. Inscript. Dion. Ovid. lib. 3. Trist. Eleg. 1 lib. 2 Eleg. 31 Propert.], ed esisteva ancora al tempo di Numeriano, a cui fu inalzata una Statua nella medesima per la sua virtù [Hist. August. Horat. sat. lib. 1 sat. 10]. Sono divisi gli Autori se il celebre Colosso d’Apollo di bronzo di altezza di 62. piedi fosse nella Biblioteca, o nel Tempio, parendo a me più proprio in quest’ultimo [Ved. Nard. e Donat.]. Nella Biblioteca solevano i Poeti recitare pubblicamente le loro opere, ed Augusto già vecchio vi tenne il Senato [Svet. in Vit. c. 47]» (R. Venuti, Accurata e succinta descrizione topografica delle antichità di Roma, Roma, G. B. Bernabò e G. Lazzarini, 1763, parte I, pp. 15-16). 35 Il verso è un pezzo di bravura nella tarsia poetica. Il primo emistichio è variazione di uno ovidiano: «quaerebant taciti, noster ubi esset amor» (her., III 12); «mos est» dopo la cesura è ripresa virgiliana: «virginibus Tyriis mos est gestare pharetram» (Aen., I 336) e «tela, sed haec lento mos est aptare flagello» (Aen., VII 731); «una sororum» in clausola combina Virgilio: «Aonas in montis ut duxerit una sororum» (ecl., VI 65) e Ovidio: «Mnemonidas, quam sic adfata est una sororum» (met., V 268). 36 Clausola che varia Ovidio: «Nais ab his tacuit, pueri rubor ora notavit» (met., IV 329). 37 Ancora un prestito da Marziale: «Plena laboratis habeas cum scrinia libris» (IV 33, 1). l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 181 75 candida quos priùs Augusti rejecerat aetas, mixtaque rusticitas veteri sordebat in auro. Quae ne forte lues, ut vos pejoribus uti non piget exemplis38, reliquum manaret in aevum, providus Ausonios, quoties jam quinta rediret 80 bruma, Palatinas acciri Phoebus in aedes39 instituit Vates, sed quos jam funere mersit40 summa dies41, ne quid gravius tum forte notandis ambitio prodesse aut fallax gratia posset. Et jam quinta redit censendis bruma poetis. 85 Audis qui circa strepitus, quo tecta frequentes jam circumvolitent animae subeantque tumultu42? Forsitan et notos aliquos, dum vita maneret43, aspicies illic44: ita tu censeberis olim”. Sic ait et medio cupidum sermone reliquit45. 90 Ac dum conveniunt Vates atque aurea46 complent templa, Deum vidi forulos et scrinia circum errantem atque alios aliâ de sede moventem La giacitura di exemplis rivela che, in un brano di sapore satirico, Contuccio ha scelto di dialogare con Giovenale: «Quid si nunquam adeo foedis adeoque pudendis / utimur exemplis, ut non peiora supersint?» (VIII 183-184). 39 Rifacimento di un verso properziano: «Musa, Palatini referemus Apollinis aedem» (IV 6, 11). 40 Obbligato il rinvio al celebre «abstulit atra dies et funere mersit acerbo» (Verg., Aen., VI 429 e XI 28). Ancor più vicino è però Claudiano: «hunc quoque nunc Gildo, tanto quem funere mersit» (XV 410). 41 Per «summa dies» in posizione iniziale vd. «Summa dies e quinque tubas lustrare canoras» (Ov., fast., III 849) e «summa dies vetitumque dari mortalibus armis» (Stat., Theb., III 624). 42 Il secondo emistichio ormeggia il virgiliano «extemplo turbati animi simul omne tumultu» (Aen., VIII 4). 43 La prima parte del verso segue Ovidio: «forsitan exiguas, aliquas tamen, arcus et ignes» (Pont., III 3, 33), la seconda varia il «dum vita manebat» di Verg., Aen., V 724; VI 608; VI 661. In Claudiano si legge «volui si quid, dum vita maneret» (XV 306), a cui si può accostare Mario Vittore: «vae mihi labe mali! felix dum vita maneret» (aleth., II 43). Ma in questo caso, come in quello citato poc’anzi, a mio parere Contuccio non aveva presente Claudiano (ed ancor meno l’Alethia): il suo modo di riprendere i poeti antichi, e in particolare Virgilio, prevede ovviamente la variatio, che dissimula la citazione e mostra l’abilità del versificatore, per cui queste perfette coincidenze con Claudiano dovrebbero configurarsi quali parallelismi. 44 Aspicies in posizione iniziale è virgiliano: «aspicies. Dixit pressoque obmutuit ore» (Aen., VI 155); ma più vicino a Contuccio è Properzio: «illic aspicies scopulis haerere Sorores» (II 30, 27), e identico è Ovidio: «adspicies illic positos ex ordine fratres» (trist., I 1, 107). 45 Per «sic ait et» ad inizio di verso cfr. Verg., Aen., I 142; II 296; III 189; IV 705; V 365; IX 749; XI 520; ricorre poi infinite volte in Stazio. Ma il verso è complessivamente modellato su «mortalis medio adspectus sermone reliquit» (Aen., IX 656), mentre più lontano è «mortalis visus medio sermone reliquit» (Aen., IV 277). Registro un secondo parallelismo con Mario Vittore nell’imitazione virgiliana: «proderet in medio famulum sermone reliquit» (aleth., III 681). 46 Altro minuscolo intarsio virgiliano: «iam subeunt Triviae lucos atque aurea tecta» (Aen., VI 13), peraltro già ripreso nell’antichità da Valerio Flacco: «praecipites agit ille gradus atque aurea misit» (VIII 131). 38 182 maurizio campanelli 95 100 105 110 115 pegmatibus sacris libros, quos lumine torvo47 intuitus mediam procul abjiciebat in aedem. His minio titulus cedroque notata libellis48 frons erat49; at pretium splendens praestabat iisdem omne color; tantum ruris crassaeque Minervae50 intus erat. Quot tu censes, Miroee, libellos diriperet nido cultos auroque nitentes51, scrinia si censor nostratia Phoebus adiret! Vilior in tota conductae pensio cellae52 Urbe foret, nec tam fines laxaret ubique bibliotheca frequens, scriptor si rarior oris aut Italis foret aut tinearum copia major53. Sed ne te morer54, ut summa consedit in aede Phoebus et hunc juxta tenuere sedilia Musae, affusae coeunt animae stipantque tribunal, ceu solet55, ingenti cum jura Citorius aulà civica respondet Judex, crebrescere vulgus, utque reos illic consultoresque tabellas vidisti gestare manu, sic ora subibant Musarum libros Vates praetendere jussi quos olim scripsere; tamen mirabar inanes quid ferrent urnas animae gremioque tenerent complexae, quid et his facies non omnibus una56, non moles foret, at latum pars major in alvum desinerent ollis similes, pars cuspidis instar Clausola virgiliana: «cernimus adstantis nequiquam lumine torvo» (Aen., III 677), ripresa da Ovidio: «talia dicentem iamdudum lumine torvo» (met., IX 27). 48 Variazione di un verso e di una situazione ovidiani: «nec titulus minio nec cedro charta notetur» (trist., I 1, 7). 49 Ripresa ovidiana, con le fronti cornute che diventano i frontespizi dei libri deteriori: «atque illos, gemino quondam quibus aspera cornu / frons erat» (met., X 222-223). 50 Inserto oraziano: «Ofellus / rusticus abnormis sapiens crassaque Minerva» (serm., II 2, 2-3). 51 Clausola staziana: «victa fames, signis perfectam auroque nitentem» (Theb., I 540). 52 Fa di nuovo capolino Marziale: «Unde tibi togula est et fuscae pensio cellae?» (III 30, 3). C’è qualcosa che non mi è chiaro nel paragone (è ovvio che una stanzetta valga meno di una biblioteca, per quanto piccola), a meno che vilior non sia un errore polare per carior. 53 «Copia maior» ricorre in clausola in Lucrezio: «quo facilis magis est natura et copia maior» (V 1288), Orazio: «si recte frueris, non est ut copia maior» (epist., I 12, 2), Ovidio: «innumerasque faces cremat et, quo copia maior» (met., VIII 838). 54 Piccola memoria oraziana: «ne te morer, audi / quo rem deducam» (serm., I 1, 14-15). 55 Ripresa da Valerio Flacco: «ceu solet, et blanda poscit me pabula lingua» (VIII 63). 56 In questo caso il secondo emistichio è tratto di peso da Ovidio: «facies non omnibus una / non diversa tamen, qualem decet esse sororum» (met., II 13-14). 47 l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 183 oblongae sensim fundo gracilesceret57 imo58. Hoc quoque, quod59 docta didici Pimpleide, dicam. 120Urnam etenim, quicumque sacras Heliconis ad undas accedit vatisque sibi deposcit honores, qua valeat fontis latices haurire disertos, accipit a Musis, forma tamen impare, Vatum ut dispar etiam est genus et non una poesis. 125 Fictilis est quaevis – inopes namque esse Camoenas id nosti quoque – sed signis inscripta notisque, ut quondam Urceolos Latii magnasque Diotas signabant Figuli palmis aut nomine, quo se et certam populo possent monstrare Tabernam60. 130 Has Deus oblatas circumlustrabat Apollo, Pieriamne manum quaevis signata referret legitimasque notas, an falso tessera signo61 luderet et Vatis furtivam proderet urnam. Interea dum fervet opus, dum jura vocatis62 135 dant Musae censorque libros expendit Apollo, aspiceres63 varie – nam pendet calculus anceps – affectos vates: pars maesta fronte silebant attoniti trepidique metu; spes ore sereno64 virtutisque comes suffusa modestia vultu65 140 firmabat quosdam, placido quos lumine Musae cernebant digitoque aliis monstrare66 parabant. 57 È curioso notare come il verbo gracilesco nel latino antico sia attestato solo in un autore che Contuccio poteva anche aver letto, ma che certo non doveva tener presente quando scriveva la nostra epistola: Ammiano Marcellino (in particolare XVII 4, 7; XX 3, 10; XXII 8, 4; XXII 15, 29). 58 Altro intarsio virgiliano: «cum gemitu glomerat fundoque exaestuat imo» (Aen., III 577) e «fulmine deiecti fundo volvontur in imo» (Aen., VI 581). 59 «Hoc quoque quod» in posizione iniziale è stilema ovidiano (fast., III 336; her., XIII 125 e XX 93; trist., V 9, 20). 60 Clausola giovenaliana: «ne pudeat dominum monstrare tabernae» (II 42). 61 Il secondo emistichio ormeggia Virgilio: «classica iamque sonant; it bello tessera signo» (VII 637). 62 L’inizio del verso è debitore di Ovidio: «Interea, dum cuncta negant ventique fretumque» (her., XVIII 55), come potrebbe esserlo di Tibullo: «Interea, dum fata sinunt, iungamus amores» (I 1, 69), mentre la parte finale viene da Virgilio: «hoc Priami gestamen erat, cum iura vocatis» (Aen., VII 246) e «indicitque forum et patribus dat iura vocatis» (Aen., V 758). 63 Ripresa virgiliana: «aspiceres, pontem auderet quia vellere Cocles» (Aen., VIII 650). 64 Clausola contesa tra Stazio: «non habitu, quo nota prius, non ore sereno» (Theb., XI 459) e Marziale: «quod si deus ore sereno / adnuerit» (II 24, 7-8). 65 Clausola lucanea, con minima variazione: «hos pudor, hos probitas castique modestia vultus» (VIII 156). 66 Si può cogliere una memoria di Persio: «At pulchrum est digito monstrari et dicier ‘hic est’» (I 28), che forse interagisce con Marziale: «rumpitur invidia, quod turba semper in omni / monstramur digito» (IX 97, 3-4). 184 maurizio campanelli 145 150 155 160 At sibi pars fidens erat et jactantior aequo67. Hi reliquos prae se temere contemnere sueti68 mirificeque rati nec Vatum e more69 loquutos se solito; sed prae reliquis iratior illis Phoebus erat: vidi maesto discedere vultu70 increpitos; at scripta solo dejecta jacebant71. Proximus his erat, alterius qui scripta poetae compilare suisque ausus componere furto aut qui non sua blanditiis pretiove parata72 vaniloquus mediâ recitavit carmina turbâ73: horum fallaces deprensae protinus urnae74. Ergo alios Musae libros concerpere jussae, augustis alios forulis et sede locabant75 delectos paucosque. Et jam de sedibus altis76, quos dudum Vates Phoebi censura probarat77, ibant Elysium laeti Phoebumque canebant: hi meritas humeris referebant protinus urnas, tessera quae mox cuique forent et nobile Vatis indicium, qua donati post funera possent Elysiis et adesse choris et dicere carmen78. Il primo emistichio è una memoria di Ovidio: «altera pars fidens pedibus dat terga sequenti» (halieut., 63), mentre il secondo contiene un inserto virgiliano: «quem iuxta sequitur iactantior Ancus» (Aen., VI 815), già ripreso da Stazio: «laetus abi multumque aliis iactantior umbris» (Theb., IX 559). 68 Contuccio arricchisce col gioco «temere contemnere» una clausola lucreziana: «prima acie constant ictus contemnere sueta» (II 448), che riaffiora in Claudiano: «solliciti scenae; Romam contemnere sueti» (XX 339). 69 Inserto staziano: «non mihi iam solito vatum de more canendum» (Theb., X 829); si noti come il solito del modello venga dislocato al verso successivo. 70 Variazione su Valerio Flacco: «lumina nec potuit maestos non flectere vultus» (VII 105). 71 La seconda parte del verso è curiosamente, e forse casualmente, vicina a Giovenco: «Quod mox cuncta solo passim disiecta iacebant» (Evangeliorum libri, IV 90). 72 Clausola tratta da Silio Italico: «feminea fabricata manu pretiove parata» (I 445). 73 Il tema delle poesie ‘noleggiate’ è ricorrente negli epigrammi di Marziale; non sarà dunque un caso l’assonanza del secondo emistichio con «Carmina Paulus emit, recitat sua carmina Paulus» (II 20, 1). 74 Le fallaces urnae e l’architettura del verso vengono da Giovenale: «gratia fallaci praetoris vicerit urna» (XIII 4). 75 La clausola varia il virgiliano «ad sese et sacra longaevom in sede locavit» (Aen., II 525), ripreso da Valerio Flacco: «Tacita pavidum tunc sede locavit» (II 257). 76 Clausola ovidiana: «bis sex caelestes medio Iove sedibus altis» (met., VI 72). 77 Prelevando da Valerio Flacco la parte centrale del verso, Contuccio, come in altre occasioni analoghe, dà all’intero verso la stessa struttura del modello, mutando le parole: «tunc etiam vates Phoebo dilecta Polixo» (II 316). 78 La parte centrale del verso è tratta da Orazio: «adspirare et adesse choris erat utilis, atque» (ars, 204); per la clausola citerò «pascere oportet ovis, deductum dicere carmen» (Verg., ecl., VI 5), «quid tibi nunc misero prodest grave dicere carmen» (Prop., I 9, 9) e «quaerit Hymen thalamis intactum dicere carmen» (Stat., silv., I 2, 238). 67 l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 185 At quos rejecit Phoebus, quae pleraque Vatum turba fuit79, Pindique choro decedere jussit, stabant exanimes casu paenamque timentes. 165 Hi vacuum in campum Romae trans maenia, quà se80 collis Aventinus placide demittit ad amnem81, comportare soloque urnas deponere jussi82 quas male tractarant, monumenta perennia nequis mentis inops83 famam Claria sibi quaereret undâ. 170 Vidi ego, cum jam planitiem campumque tenerem84 monstratum85 – nondum hunc prolato maenia gyro ambierant86 – jussas urnas allidere terrae maerentes animas87; sed erat tum parvus acervus testarum poteratque minor vel colle videri88, 175 qui modo par monti superas excrevit in auras89. Sed quia paulatim testae crevere novumque mons toties auctum quinto quoque coepit in anno, hinc et Roma parum sensit concrescere molem, 79 È questo l’unico caso in cui si potrebbe scorgere un’eco di Claudiano che non abbia un precedente in un poeta classico: «turba fuit: qualem Stilicho deicerit hostem» (Claud., Bellum Geticum, XXVI 164). 80 Per «qua se» in clausola si veda «in somnis, multo manufesti lumine, qua se» (Verg., Aen., III 151; cfr. anche Luc., IV 587 e X 486). 81 La prima parte del verso è debitrice di Virgilio: «collis Aventini silva quem Rhea sacerdos» (Aen., VII 659); per la seconda si può citare ancora Virgilio: «Lethaeumque domos placidas qui praenatat amnem» (Aen., VI 705), anche se ancora più vicino è Ovidio: «donec harenosi placidum Ladonis ad amnem» (met., I 702). 82 Clausola lucanea: «quod non victrices aquilas deponere iussus» (I 339). 83 «Mentis inops» in posizione iniziale è stilema ovidiano (fast., IV 457; met., II 200 e VI 37); ma va messo nel conto anche Sil., V 631. 84 L’inizio del verso è debitore di Silio Italico «Vidi ego, cum geminas artis post terga catenis» (II 340); la clausola è virgiliana: «vix e conspectu exierat campumque tenebat» (Aen., XI 903). 85 Principio oraziano: «monstratum? Scaevae vivacem crede nepoti» (serm., II 1, 53). 86 Inizio ovidiano: «ambierantque torum: ‘quid nunc dubitatis inertes?» (met., VII 332) e «ambieratque Venus superos colloque parentis» (met., XIV 585). 87 Non si può escludere che nella memoria poetica di Contuccio riaffiorasse un verso di Paolino di Nola: «maerentes animos laetificate fide» (carm., XXXI 382). 88 «Poteratque videri» in questa dislocazione è ovidiano: «addiderat poteratque puer iuvenisque videri» (met., III 352); «nam modo quae poterat Diti quoque maesta videri» (met., V 569); «verba sono poteratque viri vox illa videri» (met., XII 204); si aggiunga anche «desectum poterat gramen versare videri» (met., XIV 646). 89 «Superas auras» è inserto virgiliano: «redditaque Eurydice superas veniebat ad auras» (georg., IV 486) e «sed revocare gradum superasque evadere ad auras» (Aen., VI 128); poteva contare anche una ripresa ovidiana: «ecce viri fautrix superas delapsa per auras» (met., III 101). Questi versi confermano che la visione si colloca nell’antichità, come già si poteva indovinare dall’inizio, quando Contuccio dice che il Palatino gli appare nella forma che aveva quando Augusto vi fondò la biblioteca; va notato che la musa dice a Contuccio che fra i poeti in attesa di giudizio avrebbe potuto scorgerne alcuni che gli erano stati noti dum vita maneret. Mi si perdoni la pedanteria di questo rilievo; è chiaro che Contuccio si sentiva libero di giocare con i diversi livelli temporali. 186 maurizio campanelli nec prior edixit, cur mons ita creverit, aetas. 180 Nec credas, si mole vides consurgere tanta factitium90 montem, certo jam fine supremum accepisse modum: super et Soracte superque, perpetuo dum posteritas erit Itala gyro, aerias Alpes tumidum caput inseret astris91 185 et Latiis superincumbens dominabitur oris92. Nam quamquam93 faedis jaceant disjecta ruinis tecta, Palatinus quae quondam insedit Apollo94, mos tamen antiquus95 manet et censere solutos corporibus Vates pergunt hac sede Camoenae. 190 Quod si tantus amor penitus rem nosse latentem96, contemplator: ubi reduci quinquennia lustro97 transierint, auctas illic mirabere testas. Tam multus Vatum numerus, tot ubique disertos Pieridum sitiunt latices, ceu nuper ad undas 195 guttatim fusas, reliquum si fecerat usquam Facticius non è parola del latino classico, e tantomeno del lessico poetico; compare in Plinio il Vecchio ed ha poi un’attestazione in Tertulliano e tre in Agostino: cfr. Thesaurus linguae Latinae, vol. VI/1, col. 133, rr. 63-74. 91 «Aerias Alpes» è iunctura virgiliana: «tum sciat, aerias Alpis et Norica si quis» (georg., III 474); ma in posizione iniziale si trova in Ovidio: «aeriaeque Alpes et nubifer Appenninus» (met., II 226), e in Silio Italico: «aerias Alpes. Occurrunt moenia Grais» (XV 168). La parte finale è ancora debitrice di Silio: «surge, age et emerito sacrum caput insere caelo» (VII 19), ma non senza una possibile interferenza dell’Hercules Oetaeus di Seneca, in cui da una parte l’immagine è riferita ad una catena montuosa: «qua trepidus astris inserit Pindus caput» (493), dall’altra si ritrova, in un diverso contesto metrico, l’espressione che Contuccio userà come clausola: «nemus aetheriis inseret astris» (1154). Vale la pena ricordare che Biondo Flavio, con un’immagine che fu ripresa da altri antiquari, e che quindi poteva ben essere nella memoria di Contuccio, aveva manifestato il suo stupore per il fatto che Testaccio, considerata la sua vera origine, non avesse raggiunto l’altezza delle Alpi (vd. supra, p. 164). 92 Clausola virgiliana: «Hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris» (Aen., III 97). 93 «Nam quamquam» in posizione iniziale è ovidiano (met., I 185; IX 247; trist., III 4a, 7; Pont., III 5, 17). 94 Come in altri casi, ripresa dal modello antico la iunctura costituita dalla parola che precede la cesura e da quella finale del verso, Contuccio riproduce l’intera struttura del modello, cambiandone le parole: «scripta, Palatinus quaecumque recepit Apollo» (Hor., epist., I 3, 17). 95 Debito ovidiano: «Mos erat antiquus niveis atrisque lapillis» (met., XV 41). 96 Il primo emistichio è tratto di peso da Virgilio: «quod si tantus amor menti, si tanta cupido» (Aen., VI 133), e virgiliana è anche la seconda parte: «insequor et causas penitus temptare latentis» (Aen., III 32). 97 Contemplator in posizione iniziale è lucreziano: «contemplator enim, cum solis lumina cumque» (II 114) e «contemplator enim, cum montibus adsimulata» (VI 189); per una volta Virgilio appare come colui che riprende anziché essere ripreso: «contemplator item, cum se nux plurima silvis» (georg., I 187) e «contemplator: aquas dulcis et frondea semper» (georg., IV 61). Di matrice virgiliana, o pseudovirgiliana, è la clausola: «tardaque confecto redeunt quinquennia lustro» (Ciris, 24), ma Contuccio avrà avuto presente anche Marziale: «Ut qui prima novo signat quinquennia lustro» (IV 45, 3); inoltre «quinquennia lustris» è clausola che ricorre nelle Silvae di Stazio (IV 2, 62; V 3, 253; «quinquennia lustri» in II 2, 6; cfr. anche III 5, 92 «et Capitolinis quinquennia proxima lustris»). 90 l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 200 205 210 215 220 187 sole gravis fontem et longis fervoribus aestas, vulgus acervatim situlas praebebat. At illi multa licent scribant et mira poemata pangant98, lecta parùm si vox fuerit, si vividus absit impetus et neque res neque rerum eluxerit ordo99, allident urnas monti nomenque poetae100. At non tu, Miroee: vetus tibi cognita fandi copia, mos etiam Latius, quo pectora fonte cum semel imbueris101, plectro seu facta Latino Abhramidum canere et sicco divisa secantem aequora salsa gradu Mosem atque exordia rerum102, sive paras Italo pastorum jurgia versu dicere, magna feres geminatae praemia laurus et tua per Latium loculis digesta superbis Pierides, quotquot doctis patuere libellis103, scripta volent numquam periturae tradere famae104, et, quamquam te Phoebejam formavit ad artem doctrina et studio natura potentior omni105, non tibi cognatae desunt exempla poesis quae propius spectes et quae, seu vincere certes106, sive sequi malis, Divum te caetibus addant Musarumque choris107. Nam quo Gasparrius oris eloquio, siquid caneret, quo percitus oestro insereret caelo caput108 Ausoniosque referret nuper Avos? Indum credo quaeque ultima solis trans iter est nostri, Thulen novisse, nec ullo, donec erunt terrae109, tacituram tempore famam. Scoperta memoria oraziana: «nunc satis est dixisse: ‘ego mira poemata pango’» (ars, 416). I due versi giocano con un celebre brano dell’Ars oraziana: «Cui lecta potenter erit res, / nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo» (ars, 40-41). 100 Clausola oraziana, «Nanciscetur enim pretium nomenque poeta» (ars, 299), con parziale rovesciamento della situazione: qui i poetastri rinunciano per sempre al titolo di poeta, lì tentano di procurarselo senza miglior titolo che un’affettazione di follia e stravaganza. 101 Prestito oraziano (vd. supra, p. 173): «cum semel imbuerit, speramus carmina fingi» (ars, 331). 102 «Exordia rerum» è ovviamente clausola lucreziana (II 333; III 31; IV 45; IV 114). 103 I «docti libelli» rinviano ad Ovidio: «nec me, quae doctis patuerunt prima libellis» (trist., III 1, 71) e a Marziale: «paulisper domini doctos sepone libellos» (VII 29, 5). 104 Clausola proveniente da Silio Italico: «quam deceat pretiumque operis sit tradere famae» (XVI 45). 105 Verso tutto rifatto su Giovenale: «quid enim puero conferre potest plus / custode et cura natura potentior omni?» (X 302-303). 106 Ripresa di Orazio (vd. supra, pp. 173-174): «ut propius spectes lacrimosa poemata Pupi» (epist., I 1, 67), mentre la clausola è virgiliana: «Non iam prima peto Mnestheus neque vincere certo» (Aen., V 194). 107 Ripresa properziana: «Musarumque choris implicuisse manus» (III 5, 20). 108 Inserto siliano: «obieci caelo caput atque in me omnia verti» (XVI 651). 109 Emistichio che ormeggia Ovidio: «donec erunt ignes arcusque Cupidinis arma» (am., I 15, 27), e Valerio Flacco: «donec erunt divum meritae mortalibus irae» (IV 526). 98 99 188 maurizio campanelli Atque utinam fato nobis non praecoce raptus ante diem foret! Haud sacrae facundia linguae110, 225 quae toties captas renuit dulcedine Musas, nos desiderio jam nunc torqueret inani. Ac latebras si Pierides atque otia quaerunt111, non illo quisquam tota distentior unquam, seu legum interpres sive author rebus agendis, 230Urbe fuit112; nec enim juris prudentior ullus, cui totam se jam puero praeque omnibus uni113 crediderat Themis. Hinc Italâ praestare poesi mirari Vatem solita est Urbs alta Quirini114, cum Musis tantum in strepitu turbaque forensi 235 praeriperet spatii quantum sanctumque tribunal juris et aequarum dederat custodia legum115. Ille quidem sibi post cineres et fata superstes116 vivit et excedens meritorum praemia117 caepit, quòd populo Patribusque118 et toti flebilis Urbi 240 occidit119. At tu, divini nunc pectoris haeres, jamdudum debes famae quod debuit ille, munere si vitae licuisset longius uti120. Ergo age, nec Phoebi timeas censoria jura, quae metuunt Vates quales ego121 multaque mecum 245 turba, sed ut reliquis parcam, secernere vatum me prius incipiam numero Pindumque bicornem122 110 Clausola ovidiana: «cuius in ingenio est patriae facundia linguae» (trist., IV 4, 5) e «me tuus ille pater, Latiae facundia linguae» (Pont., II 3, 75). 111 Clausola e situazione ovidiane: «carmina secessum scribentis et otia quaerunt» (trist., I 1, 41). 112 Per «urbe fuit» ad inizio di verso si poteva ricorrere a Virgilio: «urbe fuit summa, Laurentis regia Pici» (Aen., VII 171), Silio Italico: «Urbe fuit media sacrum genetricis Elissae» (I 81) e Stazio: «Urbe fuit media nulli concessa potentum» (Theb., XII 481). 113 Clausola virgiliana: «concurrunt Thyrrenae acies atque omnibus uni» (Aen., X 691). 114 Ripresa di Ovidio: «dique relinquendi, quos urbs habet alta Quirini» (trist., I 3, 33). 115 Verso interamente rifatto su Marziale: «Iuris et aequarum cultor sanctissime legum» (X 37, 1). 116 Il secondo emistichio combina Virgilio: «contra ego vivendo vici mea fata, superstes» (Aen., XI 160), e Lucano: «Non imis haeret imago / visceribus? Quaerat cineres victura superstes» (IX 71-72). 117 Intarsio staziano: «Quae tibi nunc meritorum praemia solvam?» (silv., III 1, 170). 118 Variazione su Virgilio: «cum patribus populoque, penatibus et magnis dis» (Aen., VIII 679). 119 L’inarcatura deriva da Valerio Flacco: «fors mihi gente satum magnusque et flebilis urbi / conciderit» (III 202-203). 120 Clausola siliana: «servata interea sedes; nec longius uti / his opibus Battoque fuit» (VIII 62). 121 Verso ricalcato su Giovenale, con una buona dose di autoironia: «qualemcunque potest, quales ego vel Cluvienus» (I 80). 122 «Bicornis» in clausola preceduto da un nome figura in Virgilio: «extremique hominum Morini Rhenusque bicornis» (Aen., VIII 727), Ovidio: «aut quas semideae Dryades Faunique bicornes» (her., IV 49) e Stazio: «firmasti, si stagna peti Cirrhaea bicorni» (Theb., I 62-63). l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 189 vocalesque Heliconis aquas nescire fatebor123. Hinc Musas Phoebumque et siquid forte minarum est, ut pelagus Nauta et tumidos e litore fluctus124 250 despiciam. Nam pro testa Pimpleidos urnae urceus est modicus mihi, Transtyberina supellex: si sit opus gelidâ, Triviae me fonte beatum Roma facit; tali, si quidquam scribere conor, arida proluimus potu labra125. Non ego Vates, 255 dulcis amice126, ultra noli tu tendere contra127, non ego sum, non128, si dicat, Miroee, Poetam Musarum quoque me chorus et juratus Apollo129. Clausola oraziana: «et, quod non didici, sane nescire fateri?» (ars, 418). La parte iniziale del verso è una variazione di Lucrezio: «In pelago nautis ex undis ortus in undis» (IV 432). Il secondo emistichio combina memorie di Valerio Flacco: «aut campo iacet aut tumido riget ardua fluctu» (IV 726) e «aequora et adversos statuunt a litore fluctus» (VIII 327), Silio Italico: «languentes tacito lucent in litore fluctus» (VII 259), Stazio: «inpedit, insanique tacent sine litore fluctus» (Theb., XII 729). 125 Memoria del celebre «Nec fonte labra prolui caballino» (Pers., chol., 1). 126 Contuccio ricolloca metricamente l’oraziano «te, dulcis amice, reviset / cum Zephyris» (epist., I 7, 12-13), ma aveva sicuramente presente anche Persio: «Pars tua sit, Cornute, animae, tibi, dulcis amice» (V 23). 127 «Tendere contra» si legge in clausola in Virgilio (Aen., V 27; IX 377 e 795) e Valerio Flacco (I 834; VI 362). 128 Gli esempi di «non ego sum» ad inizio di verso sono numerosi (Prop., II 13, 9; Tib., II 6, 42; Ov., her. III 68; VI 43; VII 45 e 165; X 130; met., I 513), ma la reiterazione del non figura solo in Properzio: «non ego sum laudi, non natus idoneus armis» (I 6, 29). 129 Contuccio termina con un verso che rifà Valerio Flacco: «Musarum chorus et citharae pulsator Apollo» (V 693). 123 124 EPISTOLA SUL MONTE DI TESTACCIO DI CONTUCCIO CONTUCCI POLIZIANO S. J. TRA GLI ARCADI LIRENO BOLEIO* 5 10 15 20 25 30 Mireo, dei figli di Romolo il meglio – sebbene la stirpe paterna e i costumi reclamino te alle terre d’Etruria –, mentre perso in campagna nelle selve profonde mi svago di Telegono, tu indolente indugi nell’urbe signora; al patrio nido attaccato, non c’è dolce brezza che possa smuoverti, sia che l’aeree di Tivoli rocche ti invitino o Alba, a Giove latino diletta, ti chiami. Se hai l’estro delle Camene, arrivate che son le calende d’ottobre, sparisci e, perché il volgo t’ammiri in tavola pinta redimito d’alloro, non t’ostinare in insane fatiche, affinché, se al letto fatale un mal ti inchiodasse e oramai per ogni vena letale contagio si fosse diffuso, tu non stia a condannare invano le Muse e le arti di Apollo. Né d’altronde tu ignori il tributo che l’uso richiede e alla pelle è d’uopo tenerci, sebbene tu te ne stia in casa celato e, i vecchi amici come sdegnando, qualcosa di grande elucubri che giunga a tardi nipoti. E così non appena il Sole dal centro d’Olimpo si scosta, salir l’Aventino suoli solengo e mirare dall’alto il Tevere che corre al mare, e barche che a forza di remi vanno controcorrente, e di tanto in tanto non sdegni lasciar le crude turbe dell’animo in fondo alla valle là dove il monte Testaccio s’allunga sul fiume vicino, sebbene la mente tua e gli ozi di dotte ansie nutriti, pure nell’ora che all’ombra del verde romito passeggi, mai trovino posa, ma i monumenti a noi risparmiati dal tempo edace tu saggio coltivi e indaghi le varie ricchezze dell’evo antico, e in un cuor le riponi che l’ama. Ben ti ricordo allorché dissertavi di quale e di dove fosse il pristino sito di porta Trigemina e a me chiedesti d’un tratto qual caso in un luogo solo raccolse, ammassati in un cumulo fitto, di cocci quantità tale, da cui l’antico nome del luogo e del monte la causa. Io allor – confessarlo mi tocca – sorpreso su roba spinosa * Ho scelto di tradurre in esametri ritmici non per dar adito a una vena poetica, che non ho mai avuto, e meno che mai per emulare l’originale, ma solo perché mi è sembrato l’unico modo per avere una traduzione che, pur con tutte le asperità (del resto già intrinseche alla musa pedestre dell’epistola), fosse veramente fedele al testo, l’unica via per far sentire il sapore autentico del testo originale a chi non fosse in grado di leggerlo. l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 35 risposi quel che si sa, ma pur dopo tante parole – come al solito quando confessar l’ignoranza ci pesa – m’impantanavo; e tu ricordi che cause chiedevi che non come vere ma come prossime al vero piacesser. Cosa davvero potrei replicarti di retto o di noto? 40 Se di zappatori una turba le urne, lì intorno scavate sarchiando i vigneti, ammassato abbia in un unico luogo, urne abitate da spettri, di bianche ossa discariche, dei tempi in cui la romulide feccia defunta giaceva riposta in sepolcri d’argilla e chiusa in poveri cocci, 45 o se il vasaio laggiù, verso Roma dal Tevere spinto con fragil tesoro d’argille, mentre ricolma le sponde col vasellame, ad un passo da dove approdavan le barche, anfore rotte e orcioli nella vuota pianura raccolti abbia, la cosa dal lungo tempo oscurata fu assai, 50 e gli antichi non vollero farla sapere ai lontani nipoti. Poiché tuttavia a divinare la causa vera del monte capace non fui allorché con fervore a me lo chiedesti, eccoti quello che Apollo or ora con preci implorato volle mostrarmi, e a te non dispiaccia, che un grosso minacci 55 poema e vai di gloria i sacrari colmando all’Aonidi, rubare a un lavoro che nutre magne ambizioni soltanto il tempo di un’ora: è un inganno che le Camene rallegra e, valga ciò che valga la storia, è dolce conoscere il vero. Un’apparizione, mentre a notte fonda giacevo 60 insonne, e s’aperse a me il clivo del Palatino di Augusto, qual era un tempo, quando ai poeti latini il palazzo fu aperto da lui e data una sede in cui viver lontano dalla masnada del volgo i carmi vegliati potessero, i margini dentro voltati e il titolo tutto celando. 65 Lassù allora sia Febo, il dio che al luogo presiede, sia dell’Aonidi il coro s’erano insieme riuniti. A me che stupito che cosa fosse al palazzo l’accorrere chiedevo silente “È d’uso – delle sorelle una disse – far qui il censimento dei vati e il sacro lustro avviare. 70 Da quando si cominciò a raccogliere scritti che empissero fortunati palchetti, e ad unirvi dei vati un ritratto su cedro, che insieme col volto il nome all’autore serbasse, ad innalzare gli indegni fra i vati il favore e la grazia pronti si diedero; ormai mali libri accoglievan gli armari, 75 che già rifiutati aveva d’Augusto il fulgido evo e all’oro antico mischiata stava fetente rozzezza. A scongiurar che tal peste – poiché degli esempi peggiori l’uso a voi non rincresce – di sé permeasse l’evo futuro, il provvido Febo, tutte le volte che già il quinto inverno 80 tornava, volle disporre che del Palatino nel tempio 191 192 maurizio campanelli 85 90 95 100 105 110 115 120 125 venir dovessero i vati, sol quelli che già il giorno estremo privò della vita, in modo che punto giovare potessero brighe o fallace favor putacaso a quelli peggiori. Ed ecco che il quinto inverno a censire i poeti ritorna. Senti che strepiti in giro e con quale tumulto la folla d’anime intorno svolazzi e ora faccia il suo ingresso a palazzo? Potrebbe darsi che alcuni, noti mentre erano in vita, tu scorga lì: ugualmente tu un giorno censito sarai”. Così disse e piantò il mio desiderio a metà del discorso. E mentre s’adunano i vati e vanno colmando l’aureo tempio, io vidi il dio che intorno ad armari e cassette vagava, e taluni da un posto, altri dall’altro spostava, e i libri sui quali con sguardo truce si era fermato dai sacri scaffali scagliava lontano in mezzo alla sala. Avevano titoli rossi e fronti segnate di cedro tali libelli, ma tutto restava il loro valore nel color rilucente: tanto di zolla e di crassa ignoranza v’era dentro celato. Quanti libelli tu credi, Mireo, che lindi e d’oro dipinti Febo censor scaglierebbe via dai lor posti, se mano ai nostri armari mettesse? A un minor prezzo starebbe nell’Urbe tutta l’affitto d’una stanzetta, né ovunque tanto s’allargherebbero biblioteche ricolme, se in terra d’Italia più rari fosser gli autori o maggiore vi fosse abbondanza di tarme. Per non fartela lunga, seduto che fu in fondo alla stanza Febo e ad egli d’intorno preso ebber posto le Muse, s’adunano l’anime sparse stipandosi nel tribunale come suole, quando nell’aule vaste di Montecitorio il giudice emana sentenze civili, il volgo addensarsi, e come in quel luogo i colpevoli e i consiglieri vedesti in mano portar documenti, così affrontavan l’aspetto delle Muse i vati richiesti di porre innanzi quei libri che un tempo avevano scritto; io però mi chiedevo stupito perché l’urne vuote portassero l’anime, strette tenendole in grembo, e perché ciascuna fosse d’aspetto diversa, diversa di mole: la parte maggiore larga di ventre finiva di pentola in guisa, una parte a modo di lancia oblunga via via verso il fondo sottil più e più si faceva. Pure questo dirò, di cui mi fe’ dotto la dotta Pimpleide. Invero di un’urna a chiunque alle sacre onde eliconie s’accosta, per rivendicare a sé gli onori di vate, fanno omaggio le Muse, con cui della fonte faconde l’acque attingere possa, ma diversa è la forma, dei vati com’è la schiatta difforme e non una è la poesia. Tutte son fatte di coccio – povere son le Camene, questo neppure ti sfugge – ma iscritte con segni e con note. l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio 130 135 140 145 150 155 160 165 170 Così un tempo i latini vasai le grandi brocche e gli orcioli coi palmi segnavano oppure col nome, col quale sé stessi e una precisa osteria render noti alla gente potessero. Girava il dio Apollo osservando le urne che gli erano offerte, se ognuna d’esse mano di Pieride impressa recasse e note conformi alle leggi o se il bollo con segno falsato celasse un inganno e dal vate l’urna rubata svelasse. Frattanto, mentre ferve il lavoro e giustizia ai chiamati rendon le Muse e Apollo censore i libri soppesa, potresti gli umori diversi – incerta pende la libra – dei vati vedere; parte taceva contrita in aspetto, stordita, di paura tremante; serena in viso speranza e, di virtude compagna, modestia soffusa nel volto, incoraggiavano alcuni, che le Muse con occhio benigno andavan guardando e agli altri col dito a indicar preparavansi. Alcuni sicuri andavan di sé, vanitosi oltremodo: soliti, a lor paragone, disprezzar senza scrupoli gli altri, persuasi di dir meraviglie, cose esulanti dall’uso comune dei vati. Ma più adirato con lor che con altri era Febo: con facce afflitte li ho visti che andavano via dileggiati, ma i loro scritti a terra buttati restavano. Subito dopo veniva chi d’altro poeta gli scritti osò saccheggiare e furtivamente nei suoi ricucire oppure chi carmi non suoi, con moine o denaro acquisiti, con vano ciarlare andò recitando in mezzo alla folla. Di questi le urne fallaci furon scoperte all’istante. Mandate dunque a far strame di certi libri, le Muse nella sede augustea e sugli scaffali ne ponevano altri pochi e selezionati. E già dalle alte dimore quei vati che avevan l’esame di Febo da poco passato andavano lieti agli Elisi di Febo le lodi cantando. Si posero subito in spalla l’urne di meriti colme, che fossero poi per ciascuno lasciapassare e attestato di nobile vate, dono con cui dopo morti potessero delle schiere elisie far parte e carmi andar recitando. Ma quelli che Febo respinse – e fu della turba dei vati la maggior parte – e fece sparir dalle schiere del Pindo, stavan lì esanimi per il colpo, temendo la pena. Oltre le mura di Roma, ad un campo vuoto, là dove il colle Aventino serenamente al fiume declina, dovettero in massa portare e a terra deporre le urne che avevan male trattato, moniti eterni, a evitare che un idiota cercasse la fama nell’acque d’Apollo. Io vidi, appena la pianura e il campo raggiunsero a loro mostrato (le mura ancor non l’avevano in giro più ampio incluso), le anime in pena, a cui era ordinato che l’urne 193 194 maurizio campanelli 175 180 185 190 195 200 205 210 215 fracassassero a terra, ma allora era piccolo il mucchio dei cocci, ed anche d’un colle poteva più basso sembrare quello che or pari a un monte attinge le altezze del cielo. Ma dato che lentamente crebbero i cocci ed il monte al compiersi d’ogni quint’anno la nuova giunta si prese, perfino Roma poco s’accorse che la mole cresceva né l’età prisca mai seppe di tanto crescer la causa. E se con mole sì grande svettare la vedi, non creder che l’artificiale montagna, ormai terminata, l’altezza massima abbia raggiunto: pur sopra al Soratte e, con strati perenni, finché vi saranno italici posteri, sopra l’aeree Alpi fra gli astri andrà a metter tronfia la cima e sovrastandole dominerà sulle terre latine. Infatti sebbene giaccia ridotta a sordidi avanzi la sede in cui il Palatino Apollo ebbe un tempo dimora, l’antica usanza rimane pur sempre, e a censire i poeti, dai loro corpi disciolti, arrivano qui le Camene. E se tanto brami di apprender cosa che sfugge del tutto, guarda bene: quando al ritorno del lustro un quinquennio sarà passato, stupito vedrai lì i cocci aumentati. Tanto dei vati è il numero, da tanti ai licori facondi delle Pieridi ovunque s’anela, quale ad acque cadenti goccia a goccia la plebe, se altra fonte lasciato non aveva l’estate opprimente di sole e lunghe arsure, or non è molto in massa allungava le secchie. Ma quelli, per quanto scrivano molto e compongan mirabili carmi, se bene scelta non sia la parola, se manchi vivace passione e non splendan concetti né dei concetti la trama, le urne e la fama poetica fracasseranno sul monte. Ma non tu, Mireo: nota è a te dell’eloquio antico la ricchezza, noto il costume latino; una volta colmato il petto a tal fonte, sia che con plettro latino le gesta tu canti dei figli d’Abramo e Mosè che fende con piede asciutto il mare spianato, o i primi di natura elementi, sia che in versi italiani dei pastori i diverbi ti poni a cantare, tu i gran premi otterrai del duplice alloro e gli scritti tuoi, quanti son pubblicati in dotti libelli, allineati in superbe latine librarie, le Pieridi vorranno affidare a una fama mai a perir destinata, e sebbene all’arte di Febo te già abbian formato la dottrina e l’indole, più d’ogni studio possente, di simili specie di versi a te non mancano esempi che tu possa da presso osservare e che, o tu a vincerli ambisca o preferisca imitarli, al consesso t’uniscan dei numi e delle Muse allo stuolo. Infatti il Gasparri con quale facondia, alcunché poetar se volesse, da che estro spronato l’inflazione dei poeti e il monte di testaccio giungerebbe il cielo a toccare e gli avi riviver farebbe 220 d’Ausonia? Credo che l’Indo e Tule, che ultima giace oltre l’andar del nostro giorno, lo conoscano, e mai, finché esisterà la terra, vorrà tacerne la Fama. E se solo un fato precoce a noi non lo avesse rapito prima del tempo! Ora noi invano non tormenterebbe 225 l’esser rimasti privi della sua divina facondia, che sovente si negò alle Muse, da dolcezza irretite. E se liberi studi e arcani recessi cercan le Pieridi, vuoi che leggi esponesse o patrocinio all’agire fornisse, in tutta Roma nessuno preso da brighe fu mai 230 più di lui; nessuno fu mai di lui nel giure più esperto, al qual solo, ancora fanciullo, più che ad ogni altro, già tutta Temide s’era concessa; eccellente nei versi italiani di Quirino la nobile urbe soleva ammirarlo poeta, quando fra il chiasso e le turbe del foro tanto alle Muse 235 riservava di spazio quanto il sacro conceder poteva tribunal del diritto e dell’eque leggi l’esser custode. Dopo la morte e l’urna, davvero a sé stesso superstite vive, e all’andarsene ottenne i premi dei meriti suoi, poiché dalla gente, dai nobili e Roma tutta compianto 240 scomparve. Ma tu, che erediti adesso quel petto divino, devi fin d’ora alla Fama ciò ch’era dovuto da lui, se avesse potuto più a lungo il dono goder della vita. Forza, dunque: non temere il diritto censorio di Febo qual lo paventano i vati come me e la turba nutrita 245 dei simili miei; ma gli altri salvando, a levarmi dei vati dal conto comincerò io per primo e il Pindo bicipite confesserò d’ignorare e l’acque d’Elicona canore. D’ora in poi le Muse, Febo e qualunque possibil minaccia, come fa il marinaio da riva col mare e l’onde rigonfie, 250 guarderò da lungi. Invece del vaso d’una Pimpleide io non ho che un piccolo orcio, roba che vien da Trastevere: se d’acqua fresca ho bisogno, Roma mi rende felice con la fontana di Trevi; se tento di scriver qualcosa, lì vado a bagnare le labbra secche. Vate non sono, 255 dolce amico, e tu non voler l’evidenza smentire; non lo sono, Mireo, neppure se me chiamasse poeta delle Muse lo stuolo e poeta Apollo giurasse ch’io sia. 195 Francesca Ori Il ritorno di Colombo: contributo all’edizione critica di Odi e Inni di Pascoli La guerra ispano-americana, scoppiata nel luglio 1898 tra Stati Uniti e Spagna in merito alla questione cubana, è un evento su cui la stampa americana e quella europea si soffermano per mesi, orientando nel primo caso l’opinione pubblica a favore della causa indipendentista cubana, e nel secondo a supporto dello stato spagnolo, sull’orlo del declino politico-economico. L’evento che fornisce il casus belli del conflitto, la tragedia del Maine1, è riportato dai media dei due continenti in maniera antitetica e tendenziosa: se da una parte si punta il dito contro gli spagnoli o gli insorti cubani allo scopo di sollevare l’opinione pubblica statunitense in favore di un intervento a Cuba, in Europa si parla invece di incidente o di sabotaggio degli stessi americani che nutrono interessi economici nell’entrare in guerra. Il conflitto che segue, denominato dal segretario di Stato americano John Hay “splendida piccola guerra” per la rapidità con cui si risolve, vede la disfatta degli spagnoli che vengono sopraffatti da americani e ribelli cubani. Il riconoscimento dell’indipendenza di Cuba che, con l’armistizio del 12 agosto 1898, diventa un protettorato americano e la cessione agli Stati Uniti di altre ex colonie spagnole vengono percepite da molti intellettuali europei come una pesante sconfitta per l’intero mondo neolatino, nonché come primo segno di sopraffazione del Nuovo Continente ai danni del Vecchio. Anche in Italia la guerra ispano-americana riempie le prime pagine dei giornali, e il suo esito drammatico allarma enormemente la classe politica e intellettuale, scatenando il dibattito sulle possibili ripercussioni sull’Europa del rapido affermarsi degli Stati Uniti come potenza mondiale. Una minaccia, questa, avvertita anche da Giovanni Pascoli, attento osservatore tanto delle dinamiche partitocratiche nazionali, quanto degli equilibri politici internazionali. Agli La corazzata americana di stanza a L’Avana che, scoppiando, provoca la morte di 260 marinai americani (15 febbraio 1898). 1 198 francesca ori occhi del poeta, l’onta della disfatta militare spagnola è ulteriormente esacerbata dalla notizia del rimpatrio a Siviglia delle ceneri di Cristoforo Colombo, “esiliate” dalle isole caraibiche dove giacevano, per volere dello stesso navigatore, dal XVI secolo2. Questi i principali fatti che ispirano a Pascoli l’inno Il ritorno di Colombo, pubblicato su «Minerva: rivista delle Riviste» il 12 febbraio 1899, inserito in Odi e Inni nel 1906, e che qui si presenta per la prima volta in edizione critica. L’inno, che consta di tre gruppi strofici, ha come protagonista non l’uomo Colombo nel 1492, ma il suo spirito che, risvegliatosi nel 1898 durante il funesto viaggio di ritorno in Europa, s’illude che quello sia invece il suo glorioso primo sbarco in America. La lirica si apre in medias res con il grido di un marinaio che, di notte, avvista «TERRA!» (v. 1). Già il giorno prima Colombo aveva notato indizi certi di prossimità alla costa: prima una canna che galleggiava alla deriva e poi, nella notte, un flebile fuoco che brillava in lontananza. Avuta la certezza della vicinanza alla meta, egli decide di aspettare fino all’alba per sbarcare su quelle rive ignote. La notte, resa «lunga» dalla trepidazione generale e «divina» (vv. 21-22) perché passata a pregare e perché gli indigeni credono che Colombo sia una divinità (vv. 15-16), finalmente si rischiara e cede il passo all’alba. Il terzo gruppo strofico dell’inno rappresenta il momento epifanico della vicenda: Colombo si risveglia, ma non, come crede, da un sonno reale, dopo la notte d’attesa, bensì da un’illusione, quella di essere ancora nel XV secolo: «TERRA!… – Sì, terra, sì. Tristo | risveglio! Dormivi: da secoli, | o portatore del Cristo» (vv. 41-43). Il poeta rivela all’esploratore, ridotto ora ad «esule cenere muta» (v. 48), che il suo viaggio procede con la poppa della nave illuminata dal tramonto (vv. 51-52), ovvero da Occidente verso Oriente, e non più seguendo l’orbita del sole (v. 15), per cui non sta arrivando in America, ma ritornando in Spagna. Questo «fatale ritorno», che decreta l’inesorabile «sera», anzi, «la notte del giorno / latino» (vv. 50-56), avviene non a bordo delle sue care tre caravelle, ma di comuni, moderne imbarcazioni d’acciaio (vv. 57-60). Da un attento confronto tra il testo apparso su rivista e quello pubblicato in Odi e Inni emergono chiare differenze di carattere stilistico ed ideologico. Se la composizione dell’inno avviene tra il 1898 e il 1899 (anni che Pascoli trascorre a Messina come docente di Letteratura latina), la sua rielaborazione per la princeps di Odi e Inni, uscita nel 1906 per i tipi Zanichelli, si colloca invece tra il 1905 e il 1906, l’inizio del cosiddetto “periodo bolognese”, nel quale il poeta, appena succeduto a Giosuè Carducci sulla cattedra di Lettere, si vede insignito anche del ruolo di vate d’Italia. Il conseguente innalzamento dei toni poetici, che si fanno aulici e magniloquenti, e il graduale passaggio dal sistema di pensiero socialista umanitario (che contraddistingue gli anni messinesi) ad un altro nazionalista di stampo patriottico (che identifica la permanenza bolognese) emergono con evidenza dalle due diverse stesure dell’inno. Nel 1541 le spoglie di Colombo, per volontà dello stesso navigatore, vengono portate dalla Cattedrale di Siviglia a quella di Santo Domingo. Nel 1795, quando Santo Domingo passa sotto il dominio francese, le ceneri sono traslate a Cuba, nella cattedrale de L’Avana, dove rimangono fino alla guerra ispano-americana. Nell’agosto 1898 i resti di Colombo tornano a Siviglia. 2 il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 199 Grazie al materiale inedito (autografi e bozze di stampa) riguardante la lirica, conservato all’Archivio di Casa Pascoli di Castelvecchio e alla Biblioteca Statale di Lucca, è inoltre possibile ricostruire i vari passaggi del processo creativo dell’autore e scandagliarne i riflessi politico-ideologici durante questo interessante momento di transizione. Descrizione dei testimoni Il materiale preparatorio riguardante Il ritorno di Colombo consta principalmente di cinque autografi incompleti: CP36, CP37, CP38, CP39, CP40 (la sigla indica la collocazione nell’Archivio di Casa Pascoli, il numero progressivo non coincide con l’ordine cronologico); due bozze di stampa relative alla princeps e una alla rivista. Per l’allestimento dell’apparato critico sono inoltre tenute in considerazione: la pubblicazione dell’inno su «Minerva» e le prime due edizioni di Odi e Inni 3. Autografi e bozze di stampa sono conservati presso l’Archivio di Casa Pascoli, e in particolare: gli autografi e B1 si trovano nella Cassetta LV4, plico 25, mentre B17 è collocato nella Cassetta LXXVI, plico 9. B49 proviene invece dal Fondo Pascoli della Biblioteca Statale di Lucca, alla collocazione S.P.I.e.7. CP36 – Foglio di mm 208 x 154, numerato 26 dall’archivista. Carta giallina ruvida e opaca, con orli sfrangiati e maculati dal tempo. Inchiostro bruno e marcato ovunque. Nell’angolo superiore sinistro presenta un forellino, lo stesso visibile in CP37CP40: questi autografi sono stati cuciti assieme, probabilmente da Maria Pascoli (fondatrice e prima curatrice dell’archivio), ma oggi si presentano sciolti. Sotto il titolo Il ritorno di Colombo, centrato, compare nei quadranti superiore sinistro e inferiore destro il testo poetico. Il quarto di foglio superiore destro riporta invece esperimenti metrici in piedi, che saranno abbandonati poco oltre6. Il restante quadrante rimane vuoto, Si tratta di G. Pascoli, Odi e Inni, Bologna, Zanichelli, 1906 e Id., Odi e Inni, Bologna, Zanichelli, 1907, d’ora in poi siglate rispettivamente OI1 e OI2. 4 Tra le 82 cassette di cui si compone l’Archivio, la 55 è quella adibita a Odi e Inni. In essa, divisi in 17 plichi, sono conservati 340 fogli relativi a tutti i componimenti della silloge tranne: La piccozza, Al Dio Termine e Il sogno di Rosetta. Altro materiale su OI è reperibile, in minore quantità, in altre cassette dell’Archivio. 5 Lo stesso plico include anche gli autografi di: L’antica madre, L’anima, Al Re Umberto e Al Duca degli Abruzzi e ai suoi compagni. 6 Si tratta di una strofa di sette versi così composta: i vv. 1, 3 e 5 sono doppi senari dattilici (con accenti sulla 1a, 4a, 7a e 10a); i vv. 2 e 4 sono endecasillabi formati da tre dattili e uno spondeo (con accenti sulla 1a, 4a, 7a, 10a e 11a); il v. 6 è un quinario formato da un dattilo e uno spondeo (con accenti sulla 1a, 4a, 5a); infine il v. 7 è un decasillabo composto da due dattili, un trocheo e un trocheo/spondeo, ovvero Pascoli traccia il segno di sillaba lunga su quello di sillaba breve (con accenti sulla 1a, 4a, 7a, 9a e, nel secondo caso, sulla 10a). Dopo una maggiore spaziatura e un trattino verticale, il poeta rielabora ulteriormente lo schema metrico di una strofa di otto versi così composta: i vv. 1, 3 e 7 sono doppi senari dattilici; i vv. 2, 4, 5 e 6 sono ottonari, composti da due dattili e uno spondeo (con accenti sulla 1a, 4a, 7a e 8a); infine il v. 8, 3 200 francesca ori eccetto che per un’annotazione illeggibile a matita rossa, seguita dalla parola «cacao» a lapis blu. Il ductus è tipico di un testo in fieri a un suo primo stadio compositivo: si presenta infatti mosso, veloce e irregolare. I versi si sviluppano su righe talvolta convergenti verso la fine. Il testo del quadrante inferiore destro, da «Scendi, purpureo nel manto» a «non sono le tue caravelle», è scritto con caratteri piccoli e molto inclinati verso destra ed è inframmezzato da frequenti spazi bianchi e schiere di puntini, indicanti lezione non risolta. CP36 appare costellato di ripensamenti e cassature di entità varia. Contiene la prima stesura incompleta dell’inno (strofe 1-3). Cp37 – Foglio di mm 210 x 155, numerato 27 dall’archivista. Carta identica alla precedente, ma scritta su due facciate. Inchiostro bruno per lo più marcato. È presente un forellino d’ago nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della e di «Terra!» del verso iniziale. Una piega trasversale divide idealmente a metà il foglio: tale ripiegatura si deve alla posizione in cui il testimone è stato conservato nell’archivio in anni passati. Il testo di CP37, composto interamente nel recto, appare disomogeneo: nel quadrante superiore sinistro i versi, in fase elaborativa, sono stilati con mano posata e sono già suddivisi nelle tre unità strofiche (in margine si legge «Str.a», «ant.a» ed «ep.o»), tuttavia si caratterizzano per le numerose cassature e rifacimenti marginali; nel quadrante inferiore destro il brano è invece in piena fase compositiva e lo si deduce, oltre che dalla lontananza dal testo definitivo, dal ductus sbrigativo e irregolare, dai caratteri grandi, dall’andamento obliquo del dettato e dall’intensità variabile dell’inchiostro. Quest’ultimo brano, aperto dal numerale «II», riporta, a tratti in prosa, in altri in versi, alcuni elementi cardine che verranno poi rielaborati a partire dal secondo gruppo strofico in poi. Nel quadrante superiore destro appare solo la scritta «Str.a» ripetuta due volte e posta sopra un intreccio di segni obliqui sovrapposti. CP37 è impreziosito da un disegno, situato in basso a sinistra: si tratta del primo piano di un giovane nativo americano dai capelli lunghi e con un copricapo di penne. Il recto contiene la terza stesura de Il ritorno di Colombo (strofe 1, 2, 3, A7), mentre il verso reca il titolo abbreviato «A Colombo». CP38 – Foglio di mm 310 x 106, numerato 28 dall’archivista, simile al precedente per le caratteristiche della carta, ma scritto solo sul recto. Testo poetico redatto ad inchiostro bruno con tratto sottile. Presenta un forellino d’ago in corrispondenza di quello dei precedenti autografi. Il testo poetico occupa solo il primo terzo della lunga striscia di carta. Il ductus si caratterizza nella prima strofa per l’impiego di caratteri ottonario anch’esso, è formato da due spondei separati da un dattilo (con accenti sulla 1a, 2a, 3°, 6a e 7a). A seguito di una linea orizzontale sono poi rappresentati un anapesto a sé stante seguito dallo stesso ottonario creato poco sopra, formato da due dattili e lo spondeo. A fianco di quest’ultima rappresentazione in piedi appare la scritta “enoplis.”. Per l’analisi della metrica dell’inno cfr. E. Turolla, La metrica di Odi e Inni, in Id., La tragedia del mondo nella poesia civile di Giovanni Pascoli, Bologna, Zanichelli, 1926, pp. 189-190 e Il ritorno di Colombo, in G. Pascoli, Odi e Inni, a cura di F. Latini, in Poesie, a cura di I. Ciani e F. Latini, 3 voll., Torino, UTET, 2008, vol. III, p. 261. 7 Con le lettere alfabetiche in maiuscolo si indicano quelle strofe che non saranno incluse nel testo definitivo (OI2). il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 201 piccoli, chiari e verticaleggianti, mentre altrove per una grafia mossa, obliqua e irregolare, interrotta più volte da ripensamenti e cassature. Il dettato si svolge su righe orizzontali, ma non equidistanti, infatti l’interlinea aumenta in prossimità degli ultimi versi. La fascia centrale dell’autografo è occupata da scritte programmatiche che non riguardano l’inno in questione ma che rivelano la ben nota capacità dell’autore di lavorare simultaneamente ad opere molto diverse tra loro. Come questo variegato elenco di fonti (che include esponenti della lirica provenzale, di drammaturgia spagnola e di critica letteraria) sembra indicare, al momento della stesura di questo abbozzo Pascoli ha intenzione di recensire o quantomeno di citare un passo di Lope de Vega commentato in un’opera di Antonio Restori8, di lavorare all’opera di esegesi dantesca Sotto il Velame, (dedicata, tra l’altro, al Restori) pubblicata l’anno successivo9, e di porre mano a un terzo lavoro non ben identificabile a causa dell’oscurità dell’ultima riga dell’annotazione autografa. Si legge dunque in CP38: «Passo di Lope | (Restori)», dopo un trattino «Sacri contesti | Malaspina e Raimbaut de Vaqueiras», dopo una lineetta «parola indecifr. Pietro parola indecifr.». L’ultimo terzo di foglio contiene invece il menù per una cena domenicale: «Domenica | 6. p.m. | Tagliatelle asciutte | Antipasto – | dentice? spigola? pauro? | Pesce (del.) lesso / Mayonnese – Vino bianco | ciccia di vitello | Arrosto (pollo) – vino rosso | Insalata | Dolce e frutta Vino (in marg.) | Caffè». L’autografo si chiude con una lista di ingredienti necessari, forse, per marinare il pesce: «Due uova | Olio | Sale | Limone | pepe bianco | capperi». CP38 contiene la seconda stesura incompleta dell’inno (strofe 1 e 2). CP39 – Foglio di mm 208 x 134, numerato 29 dall’archivista. Cartoncino giallino ruvido con una leggera cannettatura e bordi sfrangiati ma regolari. Inchiostro bruno nel complesso marcato. Presenta un foro circolare sovrapponibile a quello dei testimoni precedenti. Il testo si svolge principalmente su una lunga colonna che occupa per intero la metà sinistra del foglio. I quadranti di destra riportano invece un elenco di parole-rima delle strofe D e 810, lo stesso elenco in parte modificato poco più in basso, infine alcuni rifacimenti marginali di varia entità contraddistinti da una cassatura della lunghezza di tre versi. La stesura si apre come copia in pulito, caratterizzata da un ductus regolare e riposato, tuttavia nel quadrante inferiore sinistro la grafia diventa più incerta e mossa, i caratteri ingrandiscono e si infittiscono i depennamenti e i rifacimenti marginali. Contiene la quarta stesura incompleta de Il ritorno di Colombo (strofe A, B, 3/B, 8, C). CP40 – Foglio di mm 95 x 105, numerato 30 dall’archivista. Carta giallina ruvida e opaca, con orli sinistro e inferiore sfrangiati e maculati dal tempo. Presenta una lace- Antonio Restori (1859-1929), professore di lingue e letterature neolatine all’Università di Messina, collega di Pascoli negli anni che trascorse in Sicilia. Di Restori erano usciti in quegli anni su Lope de Vega: A. Restori, Una collezione di commedie di Lope de Vega Carpio: CC. 5. 28032 della Palatina parmense, Livorno, Vigo, 1891; Id., Obras de Lope de Vega, Halle, Niemeyer, 1898-1899, 10 voll. 9 G. Pascoli, Sotto il velame. Saggio di un’interpretazione generale del Poema Sacro, Messina, Muglia, 1900. 10 Cfr. infra, l’analisi del testo relativa a CP39. 8 202 francesca ori razione accanto al numero d’ordine e il forellino di rilegatura nell’angolo superiore sinistro. Inchiostro bruno, nel complesso marcato. Il ductus è mosso e sbrigativo, ma nel complesso uniforme; i caratteri sono inclinati verso destra e si sviluppano su righe orizzontali ed equidistanti. L’assenza di cassature e ripensamenti (unica eccezione è una variante interlineare al v. 57) e la vicinanza dei versi alla loro forma definitiva confermano che si tratta di una copia in pulito. Contiene la quinta stesura, incompleta, dell’inno (strofe B/C, 9). B1 – Foglio di mm 275 x 155 numerato 32a dall’archivista. Contiene la prima bozza pervenutaci dell’inno per OI1. In alto, a lapis blu, è presente l’annotazione autografa: «Odi e Inni | pag. 115 – 116 – 117 | 118 bianca». Sotto, in grande e a matita, è ripetuto 115. I numeri si riferiscono alle pagine in cui sarà collocato l’inno nella princeps11. Alla sinistra del componimento, in verticale, è scritta a matita blu, calcata e sottolineata, la parola «Corretta». La bozza è molto interessante in quanto contiene diversi interventi correttori nel testo a stampa e riporta anche la copia, in pulito, autografa del secondo gruppo strofico, e per intero e della prima strofa del terzo gruppo. Quest’ultima strofa è stata scritta di seguito alle altre, ma su un foglietto a parte, catalogato dall’archivista col numero d’ordine 32b, per distinguerlo e insieme collegarlo a B1. Il testimone, poi incollato sulla bozza, cela una precedente stesura della strofa appena leggibile in controluce12. La somiglianza tra il testo che emerge da B1 e quello di OI1, l’uso degli stessi tipi, nonché l’annotazione che l’inno avrebbe dovuto occupare lo spazio di tre pagine provano che la bozza è preparatoria alla princeps. Contiene le strofe: 1-3, 8, D (ricavata da A + C) e 9 a stampa; infine le strofe 4-7, manoscritte. Le varianti di B1 rispetto OI2 sono state registrate in apparato critico, mentre gli errori di stampa corretti dall’autore sono i seguenti: 2. una] corretto da nna 54. terra] corretto da teria 56. fatale] corretto da iatale 59. sono…] corretto da sono.. B17 – Foglio di mm 275 x 155 numerato 26 dall’archivista. Contiene una bozza dell’inno ricollegabile a Mi. Anche in questa sede la coincidenza dei tipi, dell’impaginazione e soprattutto la vicinanza delle redazioni tra bozza e rivista sono state utilizzate come parametri per ricongiungere i due testimoni. Nell’angolo superiore destro è presente la dedica autografa: «Alla mia povera buona mammina | figliolina Mariù | Giovanni». Come nella versione in rivista il testo a stampa si chiude con nome e Simili annotazioni, che si riferiscono ai numeri di pagina di OI1, sono presenti anche negli autografi e nelle bozze di: Prefazione, Note, Il dovere, La cutrettola, L’ederella, L’agrifoglio, Il sepolcro, Il vecchio, Il cane e Convito d’ombre. 12 La strofa 7 (32b) e la sua precedente stesura sono collazionate in apparato critico. 11 il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 203 cognome dell’autore. Contiene le strofe: 1-3, 8, D (ricavata da A + C) e 9. B17 riporta i seguenti refusi corretti dall’autore: 2. coffe] corretto da coppe 4. solleva] corretto da Solleva B49 – Tre fogli di mm 275 x 155 numerati 141-143 dall’archivista e 116-117 a stampa a partire dal secondo foglio. Contengono la seconda bozza dell’inno per OI1. Si tratta di un testimone certamente successivo a B1, in quanto figurano a testo tutte le correzioni e le varianti introdotte in B1, oltre ad altri rari rimaneggiamenti riguardanti per lo più segni interpuntivi. Riporta tutte le nove strofe deIl’inno. Il testimone non contiene refusi, ma solo rare varianti autografe interpuntive di cui si dà nota in apparato critico. Mi – «Minerva: Rivista delle Riviste», Roma-Torino, vol. XVII, 12 febbraio 1899, p. 205. Presenta, sotto il titolo definitivo, l’inno in sei strofe non ancora suddivise in gruppi. Sono già rispettate le rientranze grafiche. A conclusione del componimento sono stampati in maiuscolo nome e cognome dell’autore. Il testimone non presenta refusi. Contiene le strofe: 1-3, 8, D e 9. Le varianti sono state registrate in apparato critico. OI1 – Prima edizione Zanichelli datata 1906: contiene una Prefazione, 28 odi, 17 inni e le Note finali di corredo ai testi. Le odi La quercia d’Hawarden, Bismark, La favola del disarmo, Nel carcere di Ginevra e Andrèe erano già state tutte pubblicate nella seconda edizione dei Poemetti13. Tutti gli altri componimenti verranno raccolti in OI1 per la prima volta. Il ritorno di Colombo si trova, secondo la volontà dell’autore, a p. 115, tra Manlio e Andrèe. L’inno non contiene errori e si distanzia dal testo definitivo solo per rari segni interpuntivi, come indicato in apparato critico. OI2 – Seconda edizione Zanichelli, pubblicata nel 1907. Si tratta certamente dell’edizione più completa, e consta di: Prefazione, 27 odi, 17 inni, un’Appendice contenente Il ritorno e Il sogno di Rosetta (annoverate tra le odi nella princeps), e infine le Note. Mancano, rispetto a OI1 La sera (che muta il titolo ne L’imbrunire) e Il viatico che confluiscono nei Canti di Castelvecchio; l’ode L’anima viene ribattezzata A una morta14; inoltre sono aggiunte: A Giuseppe Giacosa, L’anima, La rosa delle siepi, che per la loro tarda composizione non riescono ad entrare in OI1. Cambia radicalmente, rispetto a OI1, anche l’ordine delle odi, a partire da Gli eroi del Sempione in poi, mentre rimane inalterata la sequenza degli inni, per cui Il ritorno di Colombo, sempre tra Manlio e Andrèe, si trova ora a p. 107. La stesura della lirica in questione è priva di refusi. OI2, in quanto ultima edizione approvata in vita dall’autore, è assurta a testo di riferimento per l’edizione critica15. G. Pascoli, Poemetti, Palermo, Sandron, 1900. Il poeta risolve così un problema di omonimia che si sarebbe verificato con l’introduzione di una nuova ode intitolata proprio L’anima. 15 Cfr. infra Nota al testo. 13 14 204 francesca ori Primo stadio compositivo: dai manoscritti alla pubblicazione in rivista Per un’adeguata ricostruzione delle vicende dell’inno è opportuno distinguere idealmente due momenti compositivi separati, ciascuno dei quali risulta in una pubblicazione a stampa. La prima fase è circoscritta tra l’armistizio tra Spagna e Stati Uniti nell’agosto 1898, e quella dell’uscita dell’inno su rivista il 12 febbraio 1899. La scelta dell’argomento, un fatto di attualità, non è nuova all’autore che, ancora prima di ideare la silloge OI116, prende volentieri spunto dalle notizie di cronaca per i suoi componimenti. Ad altri eventi eclatanti del 1898 Pascoli dedica infatti svariate liriche. Nello specifico si tratta di Pace!, ispirata ai moti di Milano di quel maggio, La quercia di Hawarden, epicedio dello statista inglese William Gladstone deceduto il 19 maggio, Bismark, scritta in morte del cancelliere prussiano (30 luglio), e infine Nel carcere di Ginevra, sull’assassinio dell’imperatrice Elisabetta d’Austria per mano dell’anarchico Luigi Luccheni (10 settembre). Si tratta sempre di eventi eccezionali, dunque, che servono al poeta non a puri fini celebrativi, ma come pretesto per potersi esprimere sui principali temi umanitari e ideologici del tempo, e, non da ultimo, per misurarsi direttamente con D’Annunzio su simili argomenti17. Non è da escludere poi che la trattazione di fatti di cronaca non si debba anche all’influenza che esercita sull’autore l’ambiente della rivista «Marzocco», su cui Pascoli pubblica regolarmente dal 1896 fino alla morte. Nel periodico, che proprio in quegli anni va cambiando orientamento in fatto di poetica (la poesia non deve essere più solo “pura” e fine a se stessa, ma farsi anche portavoce di istanze morali e sociali, divenendo “educativa”), si trovano frequenti lodi alle opere di Pascoli e di D’Annunzio attinenti ad avvenimenti contemporanei18. Tuttavia, ciò che porta l’autore a scegliere la sconfitta della Spagna come materia per l’inno è di certo il poter introdurre così la figura cardine di Colombo, che funge da capostipite per la celebrazione in OI1 di altri grandi eroi vissuti in epoca moderna, basti pensare agli inni Ad Antonio Fratti, Alle Kursistki, Al Duca degli Abruzzi e ai suoi compagni e ad Andrèe. Gli elementi chiave dell’inno, ovvero la disillusione dell’eroe per la constatazione dell’inesorabile declino del mondo neolatino e, al contempo, l’esaltazione del genio In OI2 27 liriche su 46 prendono le mosse da fatti storici. Cesare Garboli nota poi: «Le grandi illustrazioni dei fatti di cronaca, il ‘giornalismo’ commemorativo della produzione poi convogliata di OI, hanno un preciso correlativo nelle copertine di attualità, nel giornalismo figurativo di massa, agitato e drammatico, popolare e ‘pindarico’ del Beltrame sulla “Domenica del Corriere”» (C. Garboli, Trenta poesie famigliari di Giovanni Pascoli, Torino, Einaudi, 1990, pp. 111-112). Anche Guido Capovilla ha constatato come le illustrazioni abbiano avuto un ruolo chiave nel suggestionare il poeta, portandolo a conferire maggiore enfasi ai testi. Cfr. G. Capovilla, Pascoli, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 190. 18 Sulla reciproca influenza in atto tra Pascoli e l’ambiente della rivista fiorentina, cfr. G. Nava, La presenza di Pascoli e D’Annunzio nel «Marzocco», in Il Marzocco: carteggi e cronache fra Ottocento e avanguardie, 18871913. Atti del seminario di studi, 12-14 dicembre 1983, a cura di C. Del Vivo, Firenze, Olschki, 1985, pp. 5-95. 16 17 il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 205 italico sono per Pascoli talmente in sintonia con il resto della raccolta, che l’autore decide di includere il componimento in OI1 quando la silloge è ancora in fase di allestimento. A testimonianza di ciò si osservi che Il ritorno di Colombo figura nella maggior parte dei programmi di stampa di OI1, conservati in diversi quadernetti nell’Archivio di Casa Pascoli. Nella cassetta LXXIII, plico 3 dell’Archivio si hanno infatti numerose testimonianze19: al foglio 61 si legge, tra la lista degl’inni «Ritorno di Cristoforo», al foglio 79 è scritto, tra l’altro, «Colombo – Il vecchio | capo Azteco o altrimenti», al foglio 127 è trascritto, sempre come parte di una lista di liriche di OI1, «Il caino lez. inc. e Colombo». Alla cassetta LXXIX, plico 1 bis, foglio 255, si legge «Colombo e l’Indiano» in mezzo a una lunga lista intitolata «Poemi e Poemetti», e, di nuovo, «Colombo» in un elenco di odi e di inni, tra cui figurano anche «Al Re Umberto», «A Verdi», «Manlio», «Cagni», «Duca» e altri20. L’idea di verseggiare sul celebre genovese, tuttavia, precede di anni la data di composizione dell’inno, come provano i programmi di lavoro abbozzati nella cassetta LXXIV, plico 421, tra cui, nel foglio 52 si legge «Colombo giovinetto»22. Un altro abbozzo difficilmente databile, in cui compaiono accenni al personaggio Colombo è quello conservato nella cassetta LXXIX, plico 1 bis, foglio 145, in cui il nome del navigatore compare ben tre volte assieme ad altri personaggi illustri, quali Marsilio Ficino e Michelangelo23. Passando all’analisi degli autografi ascrivibili al periodo compreso tra l’agosto 1898 e il febbraio 1899 si può osservare come nella prima stesura dell’inno (CP36), sotto il titolo definitivo e a sinistra dello schema metrico in piedi, Pascoli abbozzi la prima strofa24 ed elementi che finiranno nella seconda (l’avvistamento della canna) e 19 Per la descrizione del quadernino e la datazione delle pagine si rimanda a G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, a cura di N. Ebani, Scandicci, La Nuova Italia, 2001, pp. 364-378. Ebani, attraverso prove interne risale alle possibili datazioni delle pagine: p. 61 è stata composta non oltre il 1900, p. 79 tra la fine del 1900 e l’inizio del 1901, mentre p. 127 è ascrivibile alla seconda metà del 1901. 20 Il testimone è ascrivibile al 1901, in quanto è a quest’anno che risale la composizione di molti dei componimenti citati. 21 Per la descrizione del quadernino contenuto nella cassetta LXXIV, plico 4, si veda G. Pascoli, Myricae, a cura di G. Nava, Firenze, Sansoni, 1974, pp. CCI-CCXIII. Le pagine in questione, (pp. 52 e 153) sono ascrivibili con probabilità al 1896. A riprova di tale datazione si noti la presenza, tra i titoli delle opere di p. 52, il poemetto Il conte Ugolino (Primi Poemetti), pubblicato nel 1896 (cfr. G. Pascoli, Primi Poemetti, a cura di N. Ebani, Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 1997, pp. 145-149), mentre a p. 153 fa da testimonianza l’annotazione «Primo Marzo – Adua – Odi» (la battaglia di Adua è avvenuta il 1 marzo 1896), primo accenno ad A Ciapin o a un’altra delle odi africane. 22 Un’altra ipotesi è che Pascoli si sia annotato di leggere sulla giovinezza di Colombo. Tra le varie opere a disposizione del poeta, la scelta più plausibile ricade su una biografia pubblicata l’anno prima, C. De Lollis, Vita di Cristoforo Colombo, narrata secondo gli ultimi documenti da Cesare De Lollis, Milano, Treves, 1895. 23 Un’annotazione dell’abbozzo relativa ai Poemi Conviviali aiuta a circoscrivere gli anni di composizione della carta, che non può essere successiva al 1904, né precedente al 1894. 24 La numerazione delle strofe o dei versi, come indicato tra parentesi quadra, si riferisce alla loro posizione nell’edizione definitiva (OI2). 206 francesca ori nella quinta (il fuoco che brillava sull’acqua). Seguono due rifacimenti dei vv. 19-20 «non è la tua Santa Maria / non sono le tre caravelle», che da B1 in poi costituiranno il ritorno con cui vengono chiusi tutti e tre i gruppi strofici (il primo dei due versi in parte modificato, il secondo ripetuto sempre uguale). Nel quarto destro inferiore del foglio, invece, si ha un primo abbozzo della terza strofa (vv. 15-20). Nel complesso questa prima stesura si caratterizza per la sua natura prosastica, tipica di molti primi abbozzi pascoliani, in cui abbondano i riferimenti ad eventi storici precisi, tra cui, oltre ai sopracitati segni di avvicinamento alla terraferma, il fatto che a gridare «terra», dall’albero, sia stato il gabbiere25, e infine l’uso dell’appellativo spagnolo «Almirante», ovvero ‘ammiraglio’, titolo che Colombo stesso si era guadagnato raggiungendo le Indie26. Tutti questi dettagli spariranno in Mi. Interessante notare in CP36 la presenza di «Destati», imperativo rivolto all’«almirante», che, forse perché troppo esplicito e ovvio, viene eliminato da CP38 in poi. In realtà si tratta della vera parola chiave dell’inno, che implica il doppio risveglio del protagonista dal sonno e dall’illusione. Per questo Pascoli, a partire dall’aggiunta autografa di B1, decide di reintrodurre il campo semantico a essa legato nella strofa 7, vv. 41-44: «[…] Tristo / risveglio. Dormivi: da secoli, / […] dormivi; e giungeva a te l’eco». La seconda stesura, parziale anch’essa, è conservata in CP38 e consta della prima strofa, dei vv. 8-11 della seconda, seguiti dal rifacimento dei vv. 5-7 e v. 12. Siamo qui ancora in piena fase compositiva, ma i riferimenti storici tendono a scomparire, lasciando spazio a una descrizione più vaga e indeterminata dell’accaduto. Il «grido del gabbiere» si trasforma nel «canto di una voce»; il gonfalone con lo stendardo, poi riformulato ne «il crociato stendardo» di CP36, si semplifica qui in «la serica croce» (v. 4); è introdotto il contrasto tra «ieri» (in cui «fu vista una canna») e «oggi» (in cui le navi «tremano in panna») della seconda strofa; si aggiungono i vv. 5-7 «alzala! e prima le incognite arene / sentano un’ombra nell’alba che viene: / Colombo, con te» diversamente reso poco dopo con «tu nel tramonto mettesti la prora / che ti spingeva anelando l’aurora / lontano da sé»; ma sopravvive l’epiteto «almirante». Prevale in questa stesura un certo stile nominale, come emerge dal v. 9: «verde (anziché nuotava di OI2) sul mare profondo», e un andamento ritmico spezzato, osservabile nei vari rifacimenti del v. 12. Tale cadenza, incalzante e “militaresca”, che caratterizzerà l’inno nella sua redazione definitiva, è quindi sperimentata già in questa seconda stesura. Il gabbiere era il marinaio addetto al compito di manovrare le vele di gabbia e godeva per questo di una posizione privilegiata. 26 Secondo il contratto (Capitolaciones), firmato il 17 aprile 1492 a Santa Fè (Granada) tra i Re di Spagna e Colombo, il navigatore avrebbe ottenuto, in caso di riuscita del viaggio, il titolo di Ammiraglio e la carica di Viceré e Governatore delle terre scoperte. Cfr. C. Colombo, Narrazione dei quattro viaggi intrapresi da Cristoforo Colombo per la scoperta del Nuovo continente dal 1492 al 1504, a cura di M.F. Navarrete, Prato, Giachetti, 1840-1841, ora in C. Colombo, Diario di bordo: libro della prima navigazione e scoperta delle Indie, a cura di G. Ferro, Milano, Mursia, 1895, a p. 20. 25 il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 207 CP37 contiene la terza e ultima stesura pervenutaci delle prime tre strofe dell’inno in versione quasi definitiva (i vv. 15-16 sono ritentati più volte), e un abbozzo in prosa delle strofe A e B, ovvero di due unità metriche elaborate in vari altri autografi da CP37 in poi ma tralasciate in OI2. La strofa iniziale è trascritta in pulito ed è esente da ripensamenti. Il «da riva» del v. 1 di CP38 lascia spazio a «solenne», molto più simile al finale «notturna» (da B1), mentre il verso successivo si apre con la stessa voce verbale di CP38, «cantare», coniugata però al passato remoto, tempo che persisterà nella lezione definitiva «bandì», introdotta da Mi in poi. Inoltre, sempre al v. 2 «nell’alba» è sostituito con il definitivo «dalle coffe». Si noti che l’indicazione spaziale («da riva») e quella temporale («nell’alba») contenute nei primi due versi di CP38 si trasformano in CP37 rispettivamente in connotazione qualificativa («solenne»)27 e spaziale («dalle coffe»), rimangono tali in Mi, e poi si evolvono di nuovo in elemento temporale («notturna») e spaziale («coffe») da B1 in poi. Quindi i vv. 1-2 di B1 risulteranno dalla fusione di CP38, di cui si mantengono le coordinate spazio-temporali (che compaiono però invertite), e di CP37, per l’uso dell’attributo anziché del sintagma. Al v. 3 «tuo manto» (monosillabo più bisillabo) di CP38 è sostituito da «mantello» (trisillabo) a partire da CP37: il verso rimane un ottonario dattilico con accenti sulla 1a, 4a e 7a sillaba, ma acquista maggiore fluidità grazie alla ridotta allitterazione in t. Al v. 4 «prendi» viene sostituito con «solleva», più specifico ed enfatico, mentre al sintagma «la serica croce» di CP38 viene preferita l’endiadi «il vessillo e la croce». Gli altri versi della prima strofa sono risolti qui definitivamente e coincidono con quelli di OI2, eccezion fatta per la punteggiatura che varierà ancora sensibilmente prima di giungere alla sua redazione definitiva. Anche l’antistrofe si presenta quasi risolta, nonostante i vv. 8 e 12 si caratterizzino per qualche ripensamento. In questo secondo verso Pascoli recupera da CP38 «primo almirante», che si pone in anticipazione della soluzione definitiva «Colombo» (da Mi in poi). Al v. 9 «verde» di CP38 si trasforma in «tremava» in CP37: a un connotato iniziale descrittivo, dunque, si sostituisce un’azione, quella di muoversi quasi traballando, del tutto casuale e involontaria, che verrà a sua volta sostituita da «nuotava», da B1 in poi. Nella bozza l’autore sembra infatti voler alludere alla volontà della canna, quasi personificata, di muoversi verso una meta e con un fine, ovvero di andare incontro a Colombo per segnalargli la terra. Il «tremava», riferito alla canna ricompare in CP39, quando Pascoli riprende i vv. 8-9, li inverte, e sembra volerli impiegare nella conclusione dell’inno. Sempre con l’intento di affinare il vocabolario verso esiti più suggestivi, al v. 10 il poeta sostituisce in CP37 a «tremavano» (CP38), detto delle navi in panna, «cullavano» che racconta meglio il movimento ondulatorio delle navi ferme ad aspettare l’alba. È solo in CP37, inoltre, che nascono i vv. 15-16, i quali però completano l’antistrofe in maniera ancora provvisoria. A sopravvivere in OI2 sarà soltanto l’elemento religioso del distico; infatti se in CP37 Colombo scende a terra col «crociato stendar- 27 «Solenne» è qui aggettivo qualificativo con valore avverbiale, in quanto connota il verbo “cantare”. 208 francesca ori do», in OI2 egli si farà portatore, una volta sbarcato, delle «le sacre parole» (da CP39). Dal v. 17, molto tormentato, Pascoli preleva l’attributo «incognita» (rielaborazione di «ignote»), per farlo slittate al v. 18, dove rimarrà stabilmente inserito dalla prima bozza della princeps. Il verbo “tremare” (v. 18), utilizzato per la seconda volta in questa stesura, passerà a Mi, ma viene poi sostituito con l’evocativo «brillavano» da B1 in avanti. Nel quadrante inferiore sinistro, infine, il testimone riporta in prosa alcuni concetti che svilupperà nelle strofe A e B. Sotto il numerale «II», indice dell’intenzione dell’autore di suddividere l’inno in gruppi strofici (che attuerà però solo da B1), si legge: «Il tramonto ti avvolge | non venivano quei tempi da | essa, quel giorno: | ma nell’azzurro del mare | verde ridea Guanahani. | Sono una (a seguito di la) soglia fiorita (a seguito di di chiesa a seguito di del tempio) | nel dì del perdono» (Strofa A). Segue: «Ne vennero plausi: od acclamazioni | ma cantavano uccelli bianchi: | empiendo di colore la riva e la foresta | parola indecifr. e gli indù |… dèi neri | … | tu grande, tu buono» (Strofa B). Di queste due strofe, nella versione definitiva di OI2, rimarrà solo il nome indigeno dell’isola di San Salvador: Guanahani. In margine al periodo, compare il lemma «gagra» di lettura incerta. CP39 contiene la copia in pulito delle seguenti strofe: A «Non si sentiva tornare, | quel dì (a seguito di giorno), da castelli (a seguito di merli) lontani: | ma nell’azzurro del mare | tranquilla ridea Guanahani; | verde siccome le soglie | d’un tempio, coperte di foglie | nel dì del Perdono»; strofa B: «Era la soglia soave | d’un tempio aspettante il suo Dio; | Dio che veniva per mare | più celere (corr. da sollecito) dopo un oblio. | Dio che portava agli ignoti, | sentendo alla fine i loro voti, | più grande il suo dono»; strofa 3/B, ovvero: vv. 15-16, un distico della B «Scendi, tu forte tu buono | cui portarono l’erme procelle», infine i vv. 17-19. CP39 contiene poi una sbozzatura molto tormentata delle strofe 8 e C. Quest’ultima, particolarmente lacunosa, è così composta: i suoi primi due versi riportano «Non è la tua! Non il mondo | tuo! … corr. da Oh! non è quella ch’a un tratto | Questa è la solita terra corr. da L’altra ti caccia, o Colombo: | quel tempio ha cacciato il suo Dio!»; il terzo verso riporta: «ieri sul mare profondo corr. da dal mare s’alzò con l’aurora! corr. da Donde, Oh! …»; il quarto: «tremava una canna… Oh! non ieri»; il quinto: «Scendi: con te: con l’urna a seguito di Scendi… oh! corr. da Scendi»; il sesto: «chi scarica (a seguito di Scarica…) all’ombra notturna (a. ~ n. riscritto su parola indecifr.)»; il settimo «catene di schiavi?». Infine CP39 contiene, nella metà sinistra del foglio, due liste di parole-rima. La prima, situata nel quadrante superiore, è così composta: «tornare | lontani | mare | Guanahani» (dalla strofa A), dopo un trattino di stacco «giorno | ritorno | … | del (del.) giorno latino» (strofa 8). Nel quadrante inferiore si legge la rielaborazione del primo elenco: «tornare | lontani | mare | Guanahani. | Oggi nell’ombra notturna | … | catene di schiavi». Questa seconda lista è di maggior interesse in quanto fissa per la prima volta le parole-rima di quella che da Mi in poi costituirà la strofa D, ottenuta dalla fusione di A e C. Ultimo dei cinque autografi pervenutici, CP40, contiene un abbozzo di C e la stesura quasi definitiva della strofa 9. C è così composta: «Non è la (a seguito di nella) il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 209 tua, non il (a seguito di nel)28 mondo | tuo: Dio, t’hanno escluso dal tempio. | Oh! sul sepolcro infecondo | che pianto, che sangue, che scempio! | Sento che insieme con l’urna | tua sbarcano, all’ombra notturna, | catene di schiavi!». Si tratta senza dubbio di una rielaborazione successiva all’abbozzo di CP39, ma, al contempo, di un passo indietro. Perché Pascoli, che già in CP39 aveva deciso quali versi inserire nella strofa D (tramite l’elenco delle parole-rima), ora in CP40 non fonde i primi tre versi di A e gli ultimi tre di C (come farà in Mi) ma si accinge invece a crearne di nuovi, di tono molto più elevato e dall’evidente stampo carducciano (vedi le espressioni «sepolcro infecondo» e la giustapposizione di «pianto», «sangue» e «scempio»)? Potrebbe l’autore aver scritto gli elenchi dopo aver composto CP40? La risposta è negativa perché in quegli elenchi la rima urna : notturna non è ancora stata maturata. Semplicemente Pascoli in CP39 contempla l’idea di riunire tutti i versi di A e C in una strofa unica, ma poi, in CP40 cambia idea e allunga C, servendosi anche del rifacimento marginale abbozzato nel quadrante inferiore destro di CP39. Il poeta tornerà però sulle sue decisioni in occasione della pubblicazione in rivista. Questa prima fase dell’inno si conclude con la pubblicazione su Mi. Il ritorno di Colombo appare composto da sei strofe: 1, 229, 330, 831, D (ottenuta da A + C)32 e 933. A parte alcuni interventi circoscritti al contenuto e alla punteggiatura, la novità più significativa che emerge in Mi riguarda la strofa D, in cui i due versi iniziali non trovano riscontro negli autografi: «vecchia!… Oh! quel dì!… limitare | di tempio aspettante i lontani» in cui Pascoli sostituisce la prima parola-rima, «tornare», con «limitare», ma non la seconda, «lontani». I due versi successivi vengono invece tratti da A: «sopra l’azzurro del mare | tranquilla ridea Guanahani», infine gli ultimi tre sono rielaborati da C: «Oggi… perché, con quell’urna, | si sbarcano, all’ombra notturna, | catene di schiavi?». Nel complesso l’inno, così come emerge da Mi, è compatto, essenziale ed efficace in quanto mantiene la simmetria metrica del 3 + 3 in cui metà inno è dedicato all’illusione del viaggio e l’altra metà alla rivelazione della realtà. La forma sintetica enfatizza il messaggio conclusivo, la “sera del mondo latino”, senza perdersi nei dettagli descrittivi del viaggio; al contempo fa risaltare la grandiosità di quella spedizione “voluta da Dio”, senza dimenticare i crimini di cui i colonizzatori si macchiarono, ovvero la tratta degli schiavi. Nelle strofe A, B e C, Pascoli descrive Guanahani (San Salvador) come «un tempio» verde e rigoglioso che aspettava il suo Dio, un Dio che veniva per nave e che portava agli sconosciuti il suo dono più grande, ossia la fede cattolica e la civiltà Le varianti «è la» e «nel» sono redatte a lapis blu. Queste prime due emergono da CP37. 30 Restituita da CP37 e CP39. 31 Tratta da CP39. 32 Risultante dall’unione di versi di CP39 e CP40. 33 Proveniente da CP40. 28 29 210 francesca ori spagnola34. Non una dominazione coatta, dunque, attuata con le armi, ma un’opera di educazione e acculturamento a cui quelle “genti selvagge” si lasciarono assoggettare volentieri. Questa interpretazione degli eventi, in linea con la versione ufficiale di Colombo descritta nel suo Diario di bordo35, costituisce una tappa fondamentale del pensiero politico pascoliano in quanto preannuncia la sua particolare visione del colonialismo. In una lettera del 30 ottobre 1899, Pascoli scrive a Luigi Mercatelli36: «Io mi sento socialista, profondamente socialista, ma socialista dell’umanità, non d’una classe. E col mio socialismo, per quanto abbracci tutti i popoli, sento che non contrasta il desiderio e l’aspirazione dell’espansione coloniale. Oh! Io avrei voluto che della colonizzazione italiana si fosse messo alla testa il baldo e giovane partito sociale; ma aimè esso fu reso decrepito dai suoi teorici»37. Se al tempo della stesura dell’inno Pascoli si limita ad approvare i principi fondamentali del colonialismo in quanto strumento difensivo necessario all’Italia per contrastare le mire imperialiste di altre nazioni, in seguito arriverà ad indicarlo come principale soluzione per arginare la piaga dell’emigrazione: un colonialismo non di sfruttamento, quindi, ma di lavoro e di civilizzazione38. Sul contrasto vissuto da Pascoli negli anni a cavallo del secolo tra l’appartenenza al credo socialista e l’adesione al nazionalismo colonialista, già ampliamente scanda- 34 Un riscontro di questo particolare si trova in Cfr. Navarrete, Narrazione dei quattro viaggi, cit., ora in Colombo, Diario di bordo, cit., p. 49: «Gli uni ci portavano acqua, gli altri altre cose da mangiare; altri, quando vedevano che io non mi curavo di andare a terra, si gettavano in mare nuotando e venivano e capivamo che ci domandavano se eravamo venuti dal cielo. E un vecchio venne dentro al battello e altri, a gran voce, chiamavano tutti, uomini e donne: “Venite a vedere gli uomini che vengono dal cielo, portate loro da mangiare e bere”». 35 Cfr. Navarrete, Narrazione dei quattro viaggi, cit., ora in Colombo, Diario di bordo, cit., p. 47: «E credo che facilmente si farebbero cristiani, perché mi parve non abbiano alcuna setta». Cfr. anche la lettera di Colombo al sopraintendente dei re cattolici in Navarrete, Narrazione dei quattro viaggi, cit., ora in G. Pascoli, Fior da Fiore, a cura di C. Marinucci, Bologna, Pàtron, 2009, p. 306: «Credo che indipendentemente da questi doni essi abbracceranno la religione di Cristo, poiché sono inclinati ad amare ed a servire le Loro Altezze e tutta la Nazione Castigliana. […] Non hanno alcun culto ed ignorano affatto l’idolatria». La missiva figura sotto il titolo Il primo viaggio di Colombo. 36 Luigi Mercatelli (1853-1922) è giornalista, uomo politico e studioso di questioni africane. Nel 1899 viene nominato condirettore de «La Tribuna», dopo essere stato l’inviato speciale durante la guerra in Eritrea. È anche console generale a Zanzibar, governatore del Benadir e poi dalla Tripolitania. Pascoli nutre per lui profonda ammirazione e usa i suoi articoli sulla guerra in Abissinia come fonte d’ispirazione per OI. 37 Cfr. G. Pascoli, Lettere inedite di Giovanni Pascoli a Luigi Mercatelli, «Nuova Antologia», a. LXII, 133, 16 ottobre 1927, a cura di G. Zuppone Strani, pp. 427-441, a p. 428. 38 Cfr. M. Pazzaglia, Pascoli e il socialismo nazionalistico, in Pascoli Socialista, a cura di G. Miro Gori, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 145-160, a p. 146: «Il colonialismo verrà a far parte della cultura pascoliana, non tanto sulla scia della “nazione eletta” cui D’Annunzio dedicava un applaudito e imperialistico Canto Augurale (Elettra, questo è il canto conclusivo della raccolta), ma come rimedio allo strazio dell’emigrazione endemica che coinvolgeva ogni anno centinaia di migliaia di Italiani». il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 211 gliato dalla critica, fanno fede i discorsi politici messinesi, in particolare L’eroe Italico39 e Una sagra 40 (entrambi del 1901), e le numerose lettere indirizzate ad amici e collaboratori41. Importa inoltre far notare che il tentativo di conciliare l’umanesimo socialista e la guerra imperialista, per quanto ambiguo possa apparire, non sia una peculiarità esclusiva solo dell’ideologia pascoliana, come sottolinea Gianfranco Miro Gori: «All’epoca anche molti progressisti erano colonialisti; e ben pochi contestavano la prevalenza dello Stato-nazione sui diritti dell’uomo; non obiettavano al principio della colonizzazione come missione civilizzatrice: semmai venivano discussi i metodi violenti ma non i principi»42. Cfr. G. Pascoli, L’eroe italico in Id., Pensieri e discorsi, Bologna, Zanichelli, 1907, p. 214: «Or dunque poiché il nazionalismo conserva il carattere e l’essenza dei singoli popoli, e l’internazionalismo è per impedire le guerre che cancellerebbero quel carattere e distruggerebbero quell’essenza dei singoli popoli; ebbene, bisogna voler essere nazionalisti e internazionalisti nel tempo stesso, o, come dissi già con frase molto combattuta, socialisti e patrioti!». 40 Cfr. anche Id., Una sagra, ibid., alle pp. 176-177: «L’un problema è evitare che le ricchezze si accentrino in pochi sin che vadano a finire in un solo Moloch. L’altro è evitare che i singoli popoli siano assorbiti dai più forti sin che vadano a finire in un solo impero […] logicamente quelli che repugnano a che la ricchezza sia di pochi, devono repugnare a che i popoli più piccoli e più deboli siano preda dei più grandi e forti; e perciò, come nella lotta economica sostengono gli operai contro i padroni, e i meno ricchi de’ padroni contro i più ricchi, così nella lotta politica devono sostenere le nazioni contro gl’imperi, e le idealità e tradizioni singole e particolari contro le assorbenti ambizioni che già si mostrano come le prime nuvole di un uragano, che livella, perché distrugge […]. In due parole semplici, dico che io auguro come uomo all’umanità, e come italiano […] all’Italia, l’avvento del ‘socialismo patriottico’». 41 Cfr. Id., Lettere inedite di Giovanni Pascoli a Luigi Mercatelli, cit., p. 430: l’8 giugno 1900 il poeta dichiara all’amico giornalista di avere la missione di «introdurre il pensiero della patria e della nazione e della razza nel cieco e gelido socialismo di Marx»; ibid., p. 432 (2 luglio 1900) Pascoli rivela poi a Mercatelli l’intenzione di rivolgersi in particolare ai giovani, in quanto «I giovani, quelli almeno che sono veramente giovani, hanno in sé qualcosa di eroico. Quelli, di qualche tempo fa, si sentivano spinti dall’eroismo patriottico, quelli d’ora all’eroismo, diciamo, socialistico. Però in fondo al loro cuore è un dissidio profondo. Sentendo la difesa di Amba Alagi, anche quelli, che avevano fatto dedizione dei loro sentimenti eroici all’idea umanitaria, provarono una scossa ebbene bisogna conciliare questo dissidio che travaglia (io lo so, io lo sento) il cuore della gioventù». All’amico e collaboratore lucchese Alfredo Caselli scrive inoltre il 14 gennaio 1901: «Io non sono né socialista, né antisocialista, perché sono libero e modesto predicatore d’una nuova dottrina [Il “partito degli uomini liberi”, ideato da Pascoli, ndr]. Spero d’essere sostanzialmente d’accordo, se non col da me odiato sempre […] credo Marxistico; col sentimento almeno, che li anima, i socialisti veramente sinceri. Il fatto è che del socialismo io […] voglio fare, come praticamente faccio, una religione, la quale […] è un fondamento molto più scientifico che il plus-valore dell’economista ebreo-tedesco. Qua a Messina mi hanno scomunicato, perché io predico che l’Italia essendo la nazione proletaria ed essendo insidiata dalle nazioni borghesi (oltre Francia, Inghilterra e Deutschland), i socialisti resterebbero socialisti anche diventando […] patrioti…». Cfr. G. Pascoli, Carteggio Pascoli-Caselli (1898-1912), a cura di F. Florimbii, Bologna, Patron, 2010, p. 95. 42 G. Miro Gori, Pascoli socialista: un prologo, in Pascoli socialista, cit., pp. 16-23, a p. 18. Sulla stessa tematica si è espresso M. Ridolfi, Il socialismo al tempo di Pascoli, ibid., pp. 25-42, a p. 26: «Diversi furono coloro i quali, tra Otto e Novecento, dapprima incontrarono il socialismo in ragione dei suoi principi di riscatto sociale e di rigenerazione morale, quindi lo abbracciarono e ne divennero “compagni di strada”, 39 212 francesca ori L’auspicabilità dell’unione delle nazioni neolatine in un “Rinascimento latino” (idea comune allora in Italia e Francia) per arginare l’incombente egemonia anglosassone è una tematica che si affaccia per la prima volta sulla produzione poetica pascoliana proprio con l’inno Il ritorno di Colombo43. Questo concetto, unito alla contingenza del componimento legato a un fatto d’attualità (lo scacco della Spagna) che richiama un evento storico (la conquista dell’America) e, non da ultimo, alla celebrazione del genio italico attraverso la figura di Colombo portano Pascoli a voler includere la lirica in OI1. La raccolta è infatti l’opera pascoliana più politicizzata, più attinente alla vita reale, quella, insomma, in cui più che altrove, l’autore attribuisce al suo canto44 una funzione propagandistica, educatrice e moralizzante. Tuttavia, prima di inserire Il ritorno di Colombo nella silloge, l’autore decide di rimetterci mano per approfondire con toni più retorici alcuni concetti chiave già emersi in Mi. Da questa volontà del poeta prende il via la seconda fase elaborativa dell’inno, che segue la pubblicazione in rivista. Secondo stadio compositivo: dalla rivista a Odi e Inni Gli anni che intercorrono tra Mi (1899) e OI1 (1906) sono ricchi di attività per il poeta, come dimostrano i suoi programmi di lavoro e gli elenchi di opere conservati all’Archivio di Casa Pascoli nelle cassette da LXXIII a LXXIX. Posteriore a tali testimonianze è una pagina dei Repertori (ovvero gli autografi contenuti nella cassetta LXXIX contenenti per lo più elenchi di opere) trascritta dal critico Augusto Vicinelli nella biografia Lungo la vita di Giovanni Pascoli 45, ma irreperibile in archivio. Si tratta di un manoscritto redatto tra la fine del 1904 e l’inizio del 190546 che riporta il piano per la composizione o la stampa di OI1 in cui sono elencate una serie di poesie “da fare” per poi passare oltre, secondo una direttrice che vide le spinte di natura etica e umanitaria lasciare il posto a inclinazioni individualistiche e idealistiche, con sempre più marcate pulsioni patriottiche di segno nazionalistico». 43 Tra le fonti dell’inno si può annoverare il canto leopardiano Ad Angelo Mai, come fa notare Francesca Latini: «Se Colombo con la sua scoperta determinò, secondo il Recanatense, la caduta delle illusioni e l’avvento del vero, per Pascoli l’Europa riesce a mantenere la sua supremazia politico-intellettiva fino a questi giorni, allorchè si assiste alla fine del più antico impero coloniale e alla prima grande affermazione degli Stati Uniti in campo mondiale» (Latini, in Pascoli, Odi e Inni, cit., p. 260). 44 Non a caso è il virgiliano Canamus, il motto della silloge. 45 Cfr. M. Pascoli, Lungo la vita di Giovanni Pascoli, a cura di A. Vicinelli, Milano, Mondadori, 1961, p. 760. 46 La datazione proposta da Vicinelli (maggio 1905) va anticipata alla fine del 1904-inizio del 1905, in quanto essendo l’elenco di liriche riportato nell’autografo alquanto provvisorio, esso non può considerarsi un piano quasi definitivo per una raccolta che sarebbe andata in stampa di lì a pochi mesi. La lista include infatti titoli quali: L’elettricità boia, Il vireless, Il ciliegio, L’uomo rosso, Ad A. C., Inni Agricoltura, a (Virgilio e Dante)?… Inoltre, in testa alla lista di opere “da fare” c’è, unica estranea ad OI, il discorso Messa d’oro, letto nel maggio del 1905, e quindi composto in precedenza. il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 213 e altre compiute da tempo ma “da ricercare”. Quest’ultima categoria si apre con: «Il ritorno di Colombo. 4. | al Navarco. 2. | a Fratti. 4.». Le cifre indicano le suddivisioni in gruppi strofici delle rispettive liriche, ripartizioni che rispecchiano le redazioni definitive nel caso di A Giorgio Navarco ellenico e Ad Antonio Fratti, ma non in quello de Il ritorno di Colombo, che avrà tre gruppi strofici soltanto. Da questo particolare si deduce che Pascoli tra la fine del 1904 e l’inizio del 1905 ha in programma di rimettere mano all’inno, ma che tale progetto non è ancora stato attuato. Dalle tante lettere scambiate tra Pascoli e l’amico Alfredo Caselli47 emerge poi chiaramente che dal 1899 in poi il poeta continua a lavorare incessantemente alle liriche di OI1 e che dal 1903 inizia a pensare alla loro pubblicazione in volume. Il 30 settembre di quell’anno48, Pascoli spiega infatti all’amico che la silloge sarà formata sia da delle odi che da degli inni, che le odi andranno collocate prima, ma che al momento gli inni sono ad uno stadio più avanzato di preparazione. Aggiunge poi: «Io vorrei, per liberare i caratteri, che si impaginassero e poi tirassero gl’Inni. Come fare? Facilmente. Io so il fatto mio. Si fa così: si stampano e tirano gl’Inni, cominciando dal foglio (di 8) 13, ossia dalla pagina 97 e si continua. Sarà mia cura che le Odi termineranno appunto con la pag. 96». Da varie lettere successive si capisce che il poeta inizia a mandare a Caselli alcuni ritagli di giornale o copie in pulito di liriche di OI1 per approntare le bozze di stampa, tuttavia nell’epistolario non è detto di quali componimenti si tratti. La tiratura dell’opera completa è ritardata di anni, a causa dell’acquisto di una grande partita di carta giudicata dal poeta inadatta ai suoi volumi, di incomprensioni varie con lo stampatore Marchi49 e soprattutto della ricerca affannosa di un editore. Solo nell’aprile 1905 il poeta annuncia a Caselli50 che darà a Odi e Inni gli ultimi ritocchi entro Pasqua. Le bozze corrette de Il Ritorno e Il sogno di Rosetta, ultime delle odi in OI1, sono rimandate corrette al tipografo nel gennaio del 190651, quelle delle Note pochi giorni dopo52. Infine, dopo gli ultimi frenetici passaggi di mano tra autore, tipografo e correttore (Caselli), le seconde bozze dell’opera com- 47 Alfredo Caselli (1865-1921), intimo amico del Pascoli, lavora come droghiere nell’attività ereditata dal padre, il Caffè Carluccio (oggi Antico Caffè di Simo), a Lucca. Il suo locale è frequentato da nobili, intellettuali ed artisti locali e da figure di spicco di passaggio per Lucca. Oltre che con Pascoli, Caselli intrattiene rapporti d’amicizia con Puccini, Verdi, Mascagni, Carducci, Verga, D’Annunzio, Collodi, Kipling e Shaw. È Caselli che presenta all’autore Alberto Marchi, il tipografo che stamperà OI1 per Zanichelli. Le lettere scambiate tra Pascoli e il droghiere (1898-1910) costituiscono un’indispensabile testimonianza per ricostruire e datare la genesi e l’evoluzione compositiva della maggior parte delle liriche di OI. Le lettere sono pubblicate in Pascoli, Carteggio Pascoli-Caselli (1898-1912), cit. 48 Ibid., a p. 483. 49 Alberto Marchi, di Lucca, stampa OI1 ma non OI2, impressa invece nello stabilimento Poligrafico Emiliano di Bologna. Entrambe le pubblicazioni sono edite e distribuite da Zanichelli, che cura anche le copertine disegnate da Adolfo De Carolis. 50 Cfr. lettera a Caselli dell’ 8 aprile 1905 in Pascoli, Carteggio Pascoli-Caselli (1898-1912), cit., p. 610. 51 Lettera del 3 gennaio 1906 (ibid., p. 659). 52 Lettera del 24 febbraio 1906 (ibid., p. 662). 214 francesca ori pleta vengono rispedite a Marchi per essere mandate urgentemente “in macchina”53. Finalmente quello stesso mese esce la princeps di Odi e Inni. De Il ritorno di Colombo, oltre a B17, ci sono pervenute altre due bozze di stampa: B1 e B49. Quest’ultima è una seconda bozza ed è ascrivibile ai primi mesi del 1906: anticipa cioè di poco l’uscita dell’inno in volume. B1 invece potrebbe essere stata redatta tra il 1903 e il 1904, come si apprende dalla lettera sopracitata al Caselli del 30 settembre 190354, e poi corretta dall’autore in un secondo momento, forse nel 1905, successivamente alla pagina dei Repertori menzionata sopra; oppure può essere stata approntata a stampa e poi corretta in tempi relativamente brevi, sempre, però, in seguito alla stesura della pagina dei Repertori. B1 costituisce dunque il più antico testimone rimastoci di questa seconda fase compositiva dell’inno. La sua rilevanza è data non tanto dal testo a stampa, che coincide con la redazione di Mi, ma dalle consistenti aggiunte autografe. B1, che può considerarsi un ideale punto di congiunzione tra Mi e OI1, documenta infatti l’inserimento di quattro nuove strofe (4, 5, 6, 7). Il testimone presenta al centro il testo a stampa con correzioni e varianti autografe, e alla sinistra il brano manoscritto. L’abbozzo della strofa 7 si trova occultata da un foglietto quadrato incollato su B1 (e numerato 32b dall’archivista) che riporta un rifacimento degli stessi versi. La redazione che emerge da B1 segue questa successione strofica: 1, 2 e 3 a stampa; 4, 5, 6 e 7 (e suo rifacimento) manoscritte a margine; poi, di nuovo a stampa, D depennata e quindi 9 nella sua versione definitiva. È probabile che Pascoli abbia cancellato D per poi creare 7, che riprende il tema della schiavitù. Della strofa D il poeta decide di salvare anche: l’aggettivo «notturna» che riutilizzerà al v. 1 per rimpiazzare «solenne»; l’esordio strofico, «vecchia!…», che viene ora adibito ad aprire la strofa 9, v. 55, al posto di «Scendi:»; infine il toponimo «Guanahani», che inserisce al v. 39. Se il poeta agisce allungando e suddividendo il componimento in tre gruppi, non interviene però sulle sue unità metriche fondamentali di strofe, antistrofe ed epodo, che considera in linea con la struttura generale degli inni55. Nel complesso il testo che emerge da B1 risulta più particolareggiato, retorico e verboso rispetto a Mi, a causa della tendenza generale del Pascoli di OI1 di voler rappresentare il fatto in ogni sua sfaccettatura56. Dilatando così l’inno, il cui senso di poetica indeterminatezza giunge ora ai minimi termini, il poeta non fa altro che indebolirne la carica espressiva e frammentarne la musicalità. Lettera del 9 marzo 1906 (ivi, p. 670). Il ritorno di Colombo, quinto tra gli inni, è una delle prime liriche ad essere stampata. 55 Cfr. Capovilla, Pascoli, cit., pp. 180-181: «Il recupero anche formale di questi generi, avviene in tacita emulazione con D’Annunzio e soprattutto mira ad inserirsi in una prospettiva retorico formale additata da Carducci nell’ultima sua raccolta, Rime e Ritmi, del ’99, con la presenza di strutture polimetriche il cui impianto triadico (strofe, antistrofe, epodo) alludeva ad un principio strutturale della lirica corale greca, riconducibile soprattutto a Pindaro». 56 Sono noti gli attacchi della critica a OI (e in particolare all’Inno secolare a Mazzini e ad A Verdi), tacciati di oscurità e prolissità. 53 54 il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 215 Le strofe 3-6 aggiungono ulteriori dettagli sulla notte di attesa, restituendo una rappresentazione teatralizzata dell’evento57, mentre la strofa 7 ha la funzione di rendere ancora più drammatica ed esplicita la caduta dell’illusione e il risveglio di Colombo. Inoltre, senza più D, le strofe 8 e 9 risultano vicine, e ciò comporta un avvicinamento delle espressioni «sera di un giorno latino» (v. 51), «del giorno latino» (v. 53) e «la notte del giorno | latino» (vv. 55-56) che creano un effetto sforzato e ridondante. L’aggiunta, nella strofa 4, di «Salve Regina» e «figli dell’Eva» ai vv. 24-25, e, nella strofa 7, dell’appellativo «portatore del Cristo», traduzione del nome «Cristoforo», sono volti a sottolineare, ancor più che in precedenza, l’elemento religioso della missione di Colombo, esaltando così gli altri due richiami già presenti in Mi: «le sacre parole», che il Genovese deve portare a terra (v. 16) e la «divina» (v. 22) notte d’attesa. è solo in questa seconda versione, infine, che l’inno si tinge di colori più pacifisti e umanitari. Si noti infatti l’aggiunta di concetti quali «pace» (v. 32) e «pianto degli schiavi» (vv. 46-7): i versi piuttosto neutrali di Mi «Oggi… perchè, con quell’urna, | si sbarcano, all’ombra notturna, | catene di schiavi?» si caricano di umana compassione da B1: «[…] a te, presso | la tomba, il lor pianto sommesso | piangean gli schiavi». La strofe del terzo gruppo strofico sottolinea inoltre la contrapposizione tra il sogno di pace e la “Storia”, fatta invece “d’armi e di sferze”, vero topos della visione pessimistica della storia di Pascoli, che non crede in alcuna idea di progresso. Solo nella seconda versione dell’inno emerge quindi nettamente la contrapposizione tra il Cristoforo, letteralmente “portatore di Cristo”, e guerra e schiavitù che invece hanno trionfato. Se di nazionalismo pascoliano si tratta, è dunque un’ideologia sui generis, ben distante dal credo guerrafondaio di Gabriele D’Annunzio o di Enrico Corradini, basti pensare che proprio tra il ’99 e i primissimi anni del ’900 il poeta scrive, proprio in OI, i suoi componimenti più pacifisti: Pace!, Alle Kursitski e Nel carcere di Ginevra. Una volta corretta, la bozza viene inviata dal poeta al tipografo, il quale ne stampa una seconda (B49). Ad essa l’autore appone le ultime correzioni, prima di dare l’approvazione definitiva a procedere con la stampa in volume. Le varianti in questione sono rare e riguardano principalmente segni interpuntivi. Fa eccezione il v. 28, in cui il poeta sostituisce a «Tu, non la stella Polare» un nuovo verso dalla stessa rima «Sotto le stelle già rare». Una volta sistemati tutti i componimenti di OI1, l’autore scrive la Prefazione (datata 27 febbraio 1906) e, in seguito, le Note 58. Queste ultime vengono composte pochi giorni prima dell’uscita di OI1. Il 24 febbraio 1906, a proposito della nota a Il La marcata teatralità della lirica, ottenuta anche attraverso l’uso di interrogative ed esclamative e di una punteggiatura fortemente espressiva è stata notata da Capovilla come tratto distintivo degli Inni e sarebbe dovuta, a suo parere, al tentativo di Pascoli di misurarsi con D’Annunzio sul terreno della retorica per la celebrazione di eventi contemporanei. Cfr. G. Capovilla, Pascoli, cit., pp. 190-191. 58 In OI2, rispetto alla princeps, le Note subiscono notevoli interventi autoriali, tuttavia la nota riguardante Il ritorno di Colombo rimane invariata. 57 216 francesca ori ritorno di Colombo, Pascoli scrive all’amico bibliotecario Gabriele Briganti59: «Mio buon Gabriele, ho bisogno che ella mi trovi subito le date dei seguenti fatti: […] quando finì la guerra di Cuba, e furono riportate le ceneri di Colombo? […] Se qualche data non può essere completata, la mandi come può, ma subito»60. Il bigliettino è accluso a una lettera ad Alfredo Caselli61. E sarà lo stesso Caselli che annoterà sul retro del foglio, a lapis, le risposte, dettategli probabilmente dal bibliotecario. Quella dell’inno in questione è: «Protocollo preliminare di pace fra la Spagna e gli S. U. firmato a Washington. La Spagna rinuncia alla sovranità di Cuba, cede agli S. U. Portorico, le altre Antille Spagnole e qualche isola del gruppo dei Ladroni». È da queste informazioni che Pascoli ricava dunque la nota a Il ritorno di Colombo: «Finita, col danno dei nostri fratelli spagnoli, la guerra di Cuba, le ceneri di Colombo furono riportate in Europa. Lo scopritore latino era espulso dalla sua grande isola». La presenza di una nota, di cui non tutti i componimenti sono corredati, si giustifica per due ragioni: innanzitutto l’inno viene pubblicato in OI1 sette anni dopo il fatto storico in questione, quindi al poeta sarà sembrato opportuno “rinfrescare” la memoria dei lettori62 su eventi non deducibili dalla sola lettura dell’inno; inoltre la nota fornisce l’occasione al poeta, ora vate ufficiale d’Italia, di reinterpretare l’accaduto alla luce della vicinanza al nazionalismo. Mentre infatti in Mi il poeta si limitava a constatare amaramente e passivamente la venuta a «sera del giorno latino», riecheggiando tra l’altro un concetto già espresso nella dannunziana Vergine delle Rocce, nell’inno e nella nota di OI1 Pascoli assume un atteggiamento più reattivo. A questo fine sono accostate da B1 in poi le strofe 8 e 9, per condensare le espressioni che indicano la fine della supremazia neolatina. Sempre con lo stesso scopo, poi, nella nota sono adottate parole di indignazione come “danno” per indicare la campagna militare ed “espulsione” per il rimpatrio di Colombo63. Lo sdegno del poeta però non è fine a se stesso, ma è teso piuttosto a rafforzare un sentimento di fratellanza (gli spagnoli, in un sintagma tutt’altro che retorico, sono detti “i nostri fratelli”) tra tutti i popoli neolatini, uniti nella gloria come nel disonore. Oltrepassando le barriere nazionali, Colombo diventa lo “scopritore 59 Gabriele Briganti (1874-1945), insegnante superiore di Inglese a Lucca, lavora prima come impiegato e poi come direttore alla Biblioteca Statale della città. Conosce Pascoli tramite Caselli e collabora col poeta a più riprese quando questi necessitava di libri per scopi didattici o letterari. 60 Cfr. G. Pascoli, Lettere a Gabriele Briganti, in Id., Lettere agli amici lucchesi, a cura di F. del Beccaro, Firenze, Le Monnier, 1960, pp. 356-358. 61 Cfr. G. Pascoli, Carteggio Pascoli-Caselli (1898-1912), cit., p. 662: «Mio caro, mando le note del libro al Marchi. Non ho voglia di aggiungere altre poesie […], e così abbondo nelle note per far volume. Passa l’acclusa nota a Gabrielino, e fa che risponda subito subito. Io qua [a Bologna, ndr.] non ho carte né giornali per riscontro». 62 Si noti che la pubblicazione in rivista, avvenuta a pochi mesi dalla sconfitta spagnola a Cuba, è sprovvista di nota. 63 Va precisato che in realtà non sono gli Stati Uniti a espellere le ceneri di Colombo, ma la Spagna a rivolerle indietro. il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 217 latino”: lui e le sue imprese non sono più un’esclusiva dell’Italia, che gli diede i natali, o della Spagna, che gli rese possibile il viaggio, ma diventano patrimonio di tutti i paesi di cultura romanza. L’espulsione delle sue spoglie, così come la perdita di Cuba, devono perciò scuotere l’intera “latinità”, così come l’acquisizione di nuovi territori coloniali da parte di una delle “nazioni-sorelle” deve portare al giubilo generale. L’idea di riunire i popoli latini in una federazione che lotta per difendere i propri territori e la propria cultura, unione denominata “panlatinismo”, viene espressa da Pascoli nel 1904 sulla rivista «Il Regno» di Enrico Corradini, quando, in risposta all’inchiesta sui Rapporti tra l’Italia e L’Austria, spiega: «è cominciato per l’umanità il periodo dei grandi agglomerati di razza. L’Italia deve cercare di fare di tutte le nazioni latine un tutto, una federazione e un impero che, mercè la Spagna e la Francia, si estenderebbe nell’America, nell’Africa e nell’Asia…, pronto sin d’ora a dare la mano a tutte le altre razze e formare con esse la pacifica e lavoratrice umanità. Un impero, caro Corradini, antimperialista!»64. Ancora sulla guerra ispano-americana e sul concetto di panlatinismo, il poeta si esprime in un’altra nota di OI1, relativa ad Aurora Boreale: «Fu nel 1870. Parve, quella meteora, il riflesso che si spargeva sui campi della Francia invasa. Quale scossa ebbe allora la gente latina, sebbene per le disfatte francesi noi riavessimo Roma! Ricordiamocene in questo momento in cui il cielo sembra un’altra volta rosseggiare! Si fa ogni giorno più manifesto che bisogna allargare il concetto di nazione a quello di razza. Pensiamo che Tunisi, per esempio, fu conservata alla latinità, come Cuba alla latinità fu tolta». Se così rimaneggiato e fornito della nota Il ritorno di Colombo può entrare a pieno diritto in OI1, è solo con il suo accostamento ad Al Duca degli Abruzzi, Ad Umberto Cagni 65, e ad Andrèe 66 che l’inno viene completamente legittimato: soltanto così la sconfitta del genovese può fare da contraltare all’eroismo di altri grandi prodi moderni67. La prossimità di queste quattro liriche è tale che la critica, per contraddistinguerle, ha coniato la definizione “ciclo dei novissimi Colombo latini”68. La fascinazione del poeta per la figura di Colombo, come abbiamo visto, è incondizionata e duratura, al punto che Pascoli, oltre a lavorare all’inno tra il 1898 e il 1906 per OI1 (in OI2 la lirica viene ristampata con pochissimi aggiustamenti interpuntivi), sceglie anche di inserire una missiva del Genovese al sovrintendente dei reali di Spagna nella sua antologia scolastica Fior da Fiore (1901)69. Appare dunque immotiva- La replica è riportata da Vicinelli in Pascoli, Lungo la vita, cit., p. 757. Gli inni sono incentrati sulla spedizione al Polo Nord di Luigi Amedeo di Savoia e il suo capitano Cagni partiti il 12 giugno 1899. 66 Inno sul tragico ultimo viaggio dell’intrepido aviatore scomparso nell’arcipelago danese delle Svallbard l’11 luglio 1897. 67 Per questa interpretazioni si vedano in particolare R. Barilli, L’inverno (Odi e Inni) in Id., Pascoli simbolista. Il poeta dell’“avanguardia debole”, Milano, Sansoni, 2000, pp. 143-166 e Pascoli, Odi e Inni, cit., pp. 267 e 296. 68 Cfr. M. Biagini, Il poeta solitario. Vita di G. Pascoli, Milano, Mursia, 1963, p. 422. 69 Cfr. G. Pascoli, Fior da Fiore, cit., pp. 304-309. 64 65 218 francesca ori to il rifiuto del poeta a tenere un discorso su Colombo all’Esposizione di Milano in occasione dei 400 anni dalla morte dello scopritore. In una lettera all’amico e giornalista Augusto Guido Bianchi70 del 3 agosto 190671 Pascoli confessa: «di Colombo e di navigazione sono un po’ digiuno. Bisognerebbe che tu mi facessi aiutare validamente, mandandomi un po’ di letteratura Colombina (ci sono pubblicazioni recentissime del De Lollis72, mi pare e di tanti altri) […]». In realtà Pascoli è esperto di fonti colombine: ha di certo letto il Diario di bordo di Colombo nell’edizione curata da Martin Fernandez de Navarrete (lo si deduce dalla dovizia di particolari con cui si descrivono nell’inno i segni di avvicinamento a terra o l’iniziale soggezione degli indigeni verso di loro), e le opere di Cesare De Lollis Vita di Cristoforo Colombo73 e Cristoforo Colombo nella leggenda e nella storia74. È possibile che tra le fonti colombine di Pascoli vada anche annoverata l’operetta morale leopardiana Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez, a cui il poeta si ispira per descrivere la notte d’attesa prima dello sbarco75. A queste opere va infine aggiunta la Narrazione dei quattro viaggi intrapresi da Cristoforo Colombo, sempre a cura del Navarrete, da cui l’autore trae la lettera di Colombo per Fior da Fiore. Dopo molto tergiversare Pascoli declina l’invito di Bianchi, ma per motivi ben diversi dalla sua inadeguata conoscenza di Colombo76. La figura di Colombo sarà infine ripresa da Pascoli nell’Inno degli emigrati italiani a Dante, composto nel 1911 ed inserito da Maria Pascoli in OI3 (1913). Attraverso vari richiami a passi de Il ritorno di Colombo, Pascoli affermerà ivi l’idea dolente degli emigrati come “esiliati”, con l’asse nobile degli esuli-eroi Dante, Ulisse e Colombo. Nota al testo Come testo definitivo per questa edizione critica è stato assunto quello di OI2, l’ultima pubblicata in vita dall’autore, che testimonia l’ultimo stadio di elaborazione dell’opera anche sotto l’aspetto grafico e interpuntivo. Del testo edito da Zanichelli a Bologna nel 1907 sono 70 Augusto Guido Bianchi (1868-1951), torinese, è redattore del «Corriere della Sera» dal 1887. Conosce Pascoli a Lucca nel 1902 in occasione del processo al brigante Musolino a cui Bianchi assiste in veste di cronista. L’amicizia con il poeta è lunga e duratura, eccetto rari momenti di diffidenza e di incomprensione. 71 Cfr. G. Pascoli, Carteggio Pascoli-A.G. Bianchi, a cura di C. Cevolani, Bologna, Pàtron, 2007, p. 267. 72 Cesare De Lollis (1863-1928), filologo e critico letterario, è direttore de «La Cultura» e insegna alle università di Genova e Roma. L’opera a cui Pascoli si riferisce è C. De Lollis, Cristoforo Colombo nella leggenda e nella storia, Milano, Treves, 1892. 73 Id., Vita di Cristoforo Colombo, cit. 74 Id., Cristoforo Colombo nella leggenda e nella storia, cit. 75 Pascoli, Odi e Inni, cit., pp. 260-261. 76 Come si legge nelle lettere a Caselli e poi a Bianchi a trattenere il poeta sono in realtà un attacco satirico a La cavalla storna, apparso nel giornale milanese «Guerin Meschino» e la modifica della proposta dell’orazione. Sul fatto cfr. anche G. Pascoli, Carteggio Pascoli-A. G. Bianchi, cit., pp. 269-273 e Id., Carteggio Pascoli-Caselli (1898-1912), cit., p. 703. il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 219 stati riprodotti inoltre segni di interpunzione, accenti e dieresi, segni particolari (parentesi tonde, punti di sospensione e lineette), così come l’impiego del corsivo e del maiuscolo. Il componimento in questione, Il ritorno di Colombo, non mostra refusi in OI2, ma ne contiene in B1 e B17. Le edizioni a stampa sono siglate OI1 (prima edizione Zanichelli del 1906) e OI2 (seconda edizione Zanichelli del 1907); i manoscritti sono stati siglati CP, in richiamo alle iniziali di Casa Pascoli, nel cui archivio sono conservati; B è usato per le bozza di stampa; infine Mi indica la testata giornalistica «Minerva: rivista delle riviste». L’edizione critica de Il ritorno di Colombo, e più in generale di Odi e Inni, prevede un apparato critico genetico di tipo verticale, ovvero comprensivo sia delle varianti a stampa che di quelle manoscritte. La trascrizione, in separata sede, è prevista soltanto nei casi di materiale manoscritto irriducibile ad apparato (ad esempio le parti in prosa). Degli errori, corretti o meno dall’autore, si dà testimonianza non in apparato, ma all’interno della descrizione dei testimoni. L’apparato registra analiticamente anche i segni d’interpunzione e uso del maiuscolo, minuscolo e corsivo. Il ritorno di Colombo offre numerosi abbozzi di intere strofe che non trovano riscontro nella redazione definitiva. Per non confondere tali strofe con le altre, queste sono state siglate con lettere maiuscole anziché numeri. I testimoni sono collazionati al testo di riferimento seguendo l’ordine dal più recente al più antico. Questa edizione critica non tenta di riprodurre né di rappresentare la posizione delle singole lezioni sul foglio, ma vuole ricostruire per via congetturale la sequenza con cui le varianti, delete o meno, sono state apportate. Per stabilire tale gerarchia diacronica sono stati utilizzati i seguenti criteri: caratteristiche dell’inchiostro e del ductus; concordanza o meno col testo definitivo o con altri abbozzi immediatamente successivi, corrispondenza di parole-rima, posizionamento delle varianti all’interno dell’autografo rispetto alla lezione originaria. Sigle e abbreviazioni corr. = corretto del. = deleto (la sigla compendia i casi di depennamento, cassatura, biffatura) indecifr.= indecifrabile interl. = in interlinea marg. = in margine lez. inc.= lezione incerta om. = omesso Il segno | indica il passaggio a nuovo rigo. Le indicazioni tra parentesi tonde, ad esempio (del.), si riferiscono alla parola che immediatamente precede. Qualora l’intervento riguardasse due parole, queste saranno trascritte in forma abbreviata tra parentesi, in tutti gli altri casi si riportano la prima e l’ultima parola separate da una tilde. Indico con corr. la correzione di una o più parole depennate nel testo e aventi una variante interlineare o marginale, mentre con a seguito di la lezione a testo non depennata e avente anch’essa una variante. Indico con interl. le annotazioni interlineari che per ragioni metriche o semantiche non si possono considerare varianti alternative o sostitutive della lezione a testo. Con riscritto su, infine, indico una parola ricalcata su un’altra. 220 francesca ori Elenco dei testimoni inclusi in apparato in ordine cronologico Sigle dei testimoni utilizzate in apparato A Segnature dei testimoni Elenco dei versi riducibili in apparato B C D E Casa Pascoli, cassetta LV, plico 2 (CP36; vv. 1- 4, 8, vv. 15-20, v. 31) Casa Pascoli, cassetta LV, plico 2 (CP38; vv. 1-12) Casa Pascoli, cassetta LV, plico 2 (CP37; vv. 1-14, vv. 17-20) Casa Pascoli, cassetta LV, plico 2 (CP39; vv. 15-20, vv. 48-54) Casa Pascoli, cassetta LV, plico 2 (CP40; vv. 55-60) Bmi Casa Pascoli, cassetta LXXVI, plico 9, foglio 26 (B17) Mi «Minerva: Rivista delle Riviste», Roma-Torino, vol. XVII, 12 febbraio 1899, p. 205 (Mi) Boi Casa Pascoli, cassetta LV, plico 2, fogli 32a, 32b (B1) B2oi Biblioteca Statale di Lucca, Fondo Pascoli, S.P.I.e.7, fogli 141143 (B49) OI1 G. Pascoli, Odi e Inni, Bologna, Zanichelli, 1906, pp. 115-117 OI2 G. Pascoli, Odi e Inni, Bologna, Zanichelli, 1907, pp. 107-109 il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 221 Testo critico Il ritorno di Colombo TERRA!… notturna, d’un tratto, bandì dalle coffe una voce. Vesti il mantello scarlatto, solleva il vessillo e la croce, tu che mettesti la prora nel pallido occaso, e l’aurora seguì la tua scìa!77 Guarda: fu ieri: una canna nuotava sul mare profondo: oggi si cullano in panna le navi su l’orlo d’un mondo. Sorgi, Colombo: l’aurora nel grande vestibolo indora la Santa Maria. 1 TERRA! …] Terra! … C B Terra a seguito di TERRA! A notturna, d’un tratto, corr. da solenne ad un tratto, Boi solenne ad un tratto Mi solenne, ad un tratto, C da riva ad un tratto B grida il gabbiere a seguito di il gabbiere gridava dall’albero corr. da al cielo (a. c. corr. da dall’albero) grida il gabbiere. A 2 bandì ~ voce] Destati, almirante A bandì] cantò C canta B dalle coffe] nell’alba B 3 Vesti] indossa A mantello] tuo manto B tuo mantello A 4 solleva ~ croce] prendi la serica croce, B prendi il crociato stendardo (i. ~ s. a seguito di il gonfalone col crocifisso) A 5-7 tu ~ scìa!] tu nel tramonto mettesti la prora | che’ ti spingeva anelando l’aurora | lontano da la tua scia. (l. ~ s. a seguito di se’) a seguito di alzala! e prima le incognite arene | sentano un’ombra nell’alba che viene: | Colombo, (corr. da che viene) con te. B occaso,] occaso; C scìa!] scia! OI1 Boi Mi scia: C 8 Guarda ~ ieri:] Fermati! fu ieri: a seguito di Guarda: (del.) fu ieri: a seguito di Fermati! Oh! ieri (del.) C Ieri fu vista (f. v. corr. da il gabbiere) una canna B Guarda ~ canna] ieri si vide il giunco e lo spino e | la canna. A Guarda: corr. da Guarda, Boi Guarda, Mi 9 nuotava] riscritto su tremava Bmi tremava C verde riscritto su vide B 10-11oggi ~ mondo] oggi le navi (l. n. a seguito di rimangono) in panna | pendono, (riscritto su le navi) in vetta d’un mondo a seguito di presso ad un vergine (del.) mondo B le navi, sull’orlo d’un mondo: C su l’orlo corr. da sull’orlo Boi sull’orlo Mi 12 Sorgi, Colombo:] primo almirante a seguito di sorgi: sei giunto: C Guarda, almirante c’è (in interl.) il a seguito di Sorgi, almirante: sei giunto. (s. g. corr. da giungesti corr. da sei) corr. da ecco, e sei giunto alle terre B Destati, almirante. A 77 In Boi Pascoli annota alla fine dei vv. 7, 14 e 54: “In linea col precedente”. Nelle successive edizioni a stampa, infatti, tutti i senari (vv. 7, 14, 27, 34, 47 e 54) non sono rientranti, ma allineati coi novenari che li precedono. 222 francesca ori Scendi, o venuto col sole, recando le sacre parole; lascia la tolda cui lungo la via brillarono incognite stelle; vieni… – Oh! non è la tua Santa Maria! non sono le tre caravelle!… – II TERRA!… Fu lunga la notte78, la notte fu scura e divina; quando, tirate le scotte, cantarono SALVE REGINA gli esuli figli dell’Eva, cui tutto all’intorno diceva: Domani! Domani! 15-16Scendi ~ parole;] Prendi da sotto il tuo grande stendardo | tu prendi il (t. ~ i. riscritto su conquista il tuo) mondo col guardo (riscritto su parola indecifr.) a seguito di leva il crociato stendardo: (i. ~ s. del.) | tu prendi (riscritto su parola indecifr.) il tuo mondo e il tuo guardo: a seguito di Sotto il crociato stendardo | Presidi (del.) il tuo mondo col guardo: (m. ~ g. del.) C Scendi, purpureo nel manto (p. ~ m. corr. da almirante vestito) | di re, con fiorente stendardo corr. da di porpora ed alza il A Scendi] «Scendi D parole;] parole D 17 lascia ~ via] lascia la tolda su (riscritto su in) cui per la via Bmi Scendi, tu forte (a seguito di grande, tu), tu buono D poi dalla tolda, ove ignote (o. i. a seguito di su cui per via) a seguito di lascia la tolda su cui per la incognita (t. ~ i. corr. da il castello sul quale per) via C lascia la nave, in via (i.v. corr. da da cui per a seguito di da per) a seguito di da cui per la vergine (l. v. a seguito di l’incognita) via a seguito di il castello (i. c. corr. da la nave), sul quale per via a seguito di Lascia la nave, (segue spazio bianco) sua via (lez. inc.) A 18 brillarono ~ stelle;] cui portarono l’erme procelle: D tremarono incognite (favolose lez. inc., numerose lez. inc. in interl.) stelle: C tremarono (a seguito di mirasti) le incognite (corr. da vergini) stelle: a seguito di mirasti (a seguito di stupisti ) le incognite stelle: A brillarono corr. da tremarono Boi tremarono Mi 19-20vieni ~ Maria!] non è la tua santa Maria | non sono le tre caravelle: a seguito di … la santa Maria. | non sono le tre caravelle. a seguito di scendi: oh! non è la tua santa Maria, | non sono le tue caravelle a seguito di è terra, ma non è quella. |Oh! qual terra? qual nave? A 19 vieni ~ Maria!] lascia i tuoi carri che volano Oh no! No (v. ~ N. a seguito di volanti…» Oh! non sono) D vieni… – Oh! corr. da vieni… Oh! Boi scendi, Colombo (a seguito di … Oh!) C Maria! corr. da Maria, Boi Maria, Mi C 20 tre caravelle!… – corr. da tre caravelle!… 2Boi tre caravelle! – corr. da tre caravelle! Boi tre caravelle! Mi D C 27 Domani! Domani!] domani! domani! Boi In Mi mancano i vv. 21-47; in Boi invece tali versi sono scritti dall’autore lungo il margine sinistro della bozza e sono preceduti da un segno di richiamo per indicare al tipografo dove inserirli. 78 il ritorno di colombo: contributo all’edizione critica di odi e inni di pascoli 223 Sotto le stelle, già rare, fissavi la tenebra, o Loco! Su l’anelare del mare vedevi tu il guizzo d’un fuoco… Era il tuo mondo che pace chiedeva agitando una face con l’onde, sue mani. Ora, non anche s’è stinta la tenebra, e di su la Pinta s’alza la voce… I due generi umani s’incontrano sotto le stelle… TERRA…! – Oh! non è, non è più Guanahani! non sono le tre caravelle! – III TERRA!… – Sì, terra, sì. Tristo risveglio! Dormivi: da secoli, o portatore del Cristo, dormivi; e giungeva a te l’eco d’armi e di sferze; a te, presso la tomba, il lor pianto sommesso piangeano gli schiavi. 28 29 31 41 42 43 44 45 47 48 Sotto le stelle, già rare] Tu, non la stella polare Bo Loco] Loco Boi vedevi ~ fuoco…] tu questa notte hai veduto il fuoco, A fuoco…] fuoco. B2oi Boi i TERRA! ~ Tristo] corr. da O portatori di Cristo Boi risveglio ~ secoli,] corr. da Non odi? Tu dormi? oh da secoli Boi o ~ Cristo] corr. da dormi? E tu sonno ben tristo Boi dormivi; e corr. da dormivi, e B2oi dormivi, e corr. da contrista lez. inc. Boi o sferze; a] sferze, a corr. da stragi, Boi schiavi.] corr. da schiavi… Boi muta] muta, a seguito di mesta: (riscritto su parola indecifr.) D 224 francesca ori Esule cenere muta, non questo è l’arrivo: è il ritorno! Dietro la poppa battuta dall’onde, è la sera d’un giorno… esule cenere mesta, del giorno latino! Ed è questa la terra degli avi,79 vecchia! È la notte del giorno latino; è il fatale ritorno. Quelle che stanche affaticano i cavi là, sotto le solite stelle, sono… d’acciaio?… le solite navi; non sono le tre caravelle! 8 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 0 non ~ ritorno] non questo è l’arrivo: è il ritorno. corr. da chè il tempio respinge il suo Dio. D ritorno] ritorno: Boi Mi Dietro] dietro Boi Mi la sera d’un giorno…] il tramonto (a seguito di la fine) del giorno: (fine del [f. d. del.] giorno latino. | gio in interl.)80 D giorno…] giorno, Boi giorno: Mi esule] Esule D Ed] ed Boi Mi avi,] avi: D vecchia! è corr. da Scendi: è Boi Scendi: è Mi Questa è E latino;] riscritto su latino! Bmi latino: E stanche ~ cavi] fischiano (lez. inc.) all’urto dei cavi a seguito di tendono immobili i cavi E … d’acciaio?…] –d’acciaio! – E caravelle!] caravelle! – B2oi caravelle. E 79 Dopo “la terra degli avi”, il testo continua in Mi con: “Vecchia!… Oh! quel dì!… limitare | di tempo aspettante i lontani, | sopra l’azzurro del mare | tranquilla ridea Guanahani. | Oggi… perchè, con quell’urna, | si sbarcano, all’ombra notturna, | catene di schiavi?” L’antistrofe è poi depennata in Boi. 80 Il fragmento interlineare “fine ~ gio” non può considerarsi una variante del v. 51, ma piuttosto una semplice annotazione, che si situa a metà tra il v. 51 (ormai risolto e quindi da non ritoccare) e il v. 53. TaVOLE 226 tavole Tav. I: Paris, Bibl. Nationale de France, Lat. 6342, f. 57r tavole Tav. II: Avignon, Bibl. Mun., 1215, f. 64v 227 Norme per gli autori e i collaboratori de «L’Ellisse» 1. Norme di carattere generale I contributi vanno inviati per posta elettronica all’indirizzo [email protected]. La pagina del documento deve essere scritta in carattere Times New Roman, corpo 12 per il testo, corpo 10 per le note; la pagina stessa deve essere impostata con margini 3 cm da tutti i lati e interlinea 1,5. I capoversi devono essere chiaramente indicati, facendo rientrare l’inizio del rigo di circa un centimetro. Le bozze devono essere corrette e rispedite in tempi brevi, evitando soprattutto aggiunte cospicue. 2. Norme redazionali 2.1. Note Le note devono essere collocate a piè di pagina. Nel testo, il numero di richiamo in esponente deve precedere l’eventuale punteggiatura [es.: sostiene Guglielmi6.; «romanzo»1.]. All’interno della nota non è ammesso l’inserimento di capoversi. 2.2. Citazioni Quando superano le tre righe le citazioni vanno fuori testo, separate prima e dopo da una riga bianca, senza virgolette e in corpo infratesto (11 Times New Roman); le citazioni inoltre non devono presentare rientri di capoverso. Citazioni inferiori alle tre righe devono essere riportate nel testo, racchiuse tra virgolette basse («…»); eventuali citazioni interne alla citazioni saranno indicate dai doppi apici inglesi o virgolette alte (“…”). 230 norme per gli autori e i collaboratori de «l’ellisse» La lettera iniziale di una citazione dev’essere maiuscola o minuscola a seconda delle esigenze del luogo in cui la citazione è inserita, e indipendentemente dalla forma originale (può essere lasciata l’iniziale maiuscola dopo i due punti). Le omissioni vanno sempre segnalate (eventualmente, se necessario, anche all’inizio o alla fine della citazione) con tre puntini tra parentesi quadre ([…]). 2.3. Indicazioni bibliografiche – Autore: iniziale del nome e cognome in maiuscoletto, con iniziali maiuscole (lo stesso criterio deve essere adottato anche nei casi dei curatori, traduttori, ecc.) [es. P.V. Mengaldo, Prima lezione di stilistica, Roma-Bari, Laterza, 2001]. – Titoli dei saggi e dei volumi: sempre in corsivo; lo stesso vale anche per eventuali sottotitoli. La citazione di opere (di qualsiasi genere) all’interno del titolo va indicata in tondo [es.: P. Gibellini, Le sinopie di Alcione, Milano-Napoli, Ricciardi, 1980]. – «Titoli delle riviste»: sempre tra virgolette basse [es. S. Carrai, Come nacque La coscienza di Zeno, «Studi novecenteschi», XXV, 1998, n. 56, pp. 345-358]. – Nel caso dei volumi si indicherà Autore, Titolo, luogo, editore (tipografo per le edizioni antiche), anno di stampa, volume (vol.), pagina/pagine (p./pp.) [es.: F. De Sanctis, Manzoni, Torino, Einaudi, 1955, p. 21; G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, 2 voll., Torino, Einaudi, 19923, vol. I, p. 120]. – Per i saggi su rivista si indicherà Autore, Titolo, (senza indicare “in”) «Rivista», numero di serie se necessario o eventuale indicazione n.s. (nuova serie), annata in numeri romani, anno solare, pagina/pagine (p./pp.) [es.: H. Grosser, Osservazioni sulla tecnica narrativa e sullo stile nei Promessi Sposi, «Giornale storico della letteratura italiana», LXXXIX, 1981, pp. 409-440]. – Per le miscellanee si indicherà Titolo, Curatore (in maiuscoletto preceduto dalla sigla “a cura di”), luogo, editore, anno di stampa [es.: Leggere i Promessi Sposi, a cura di G. Manetti, Milano, Bompiani, 1989]. – Per gli atti dei convegni si indicherà Titolo. Luogo e data del convegno, Curatore (in maiuscoletto preceduto dalla sigla “a cura di”), luogo, editore, anno di stampa [es.: Italo Svevo scrittore europeo. Atti del convegno internazionale, Perugia 18-21 marzo 1992, a cura di N. Cacciaglia e L. Fava Guzzetta, Firenze, Olschki, 1994]. – Per i saggi, gli articoli e gli interventi contenuti in miscellanee e in atti di convegni si seguirà il criterio adottato per le riviste: Autore, Titolo, dati del convegno o del volume miscellaneo, pagina/pagine [es.: G. Baldi, Da Senilità alla Coscienza: inattendibilità del personaggio focale e inattendibilità dell’io-narratore, in Italo Svevo scrittore europeo. Atti del convegno internazionale, Perugia 18-21 marzo 1992, a cura di N. Cacciaglia e L. Fava Guzzetta, Firenze, Olschki, 1994, pp. 325-352; S. Agosti, Enunciazione e punto di vista nei Promessi Sposi, in Leggere i Promessi Sposi, a cura di G. Manetti, Milano, Bompiani, 1989, pp. 133-144]. – Nel caso in cui un volume o un saggio siano stati già citati, è sufficiente indicare Autore (in maiuscoletto, segnalando solo il cognome), Titolo, seguito da cit., sempre preceduto da virgola; è possibile anche citare il titolo in forma abbreviata; [es.: Agosti, Enunciazione e punto di vista nei Promessi Sposi, cit., p. 139; Baldi, Da Senilità alla norme per gli autori e i collaboratori de «l’ellisse» 231 Coscienza, cit., pp. 329-332; Grosser, Osservazioni sulla tecnica narrativa e sullo stile nei Promessi Sposi, cit., p. 432]. – Per la citazione di saggi in raccolte d’autore, operare come segue: G. Baldi, Renzo e la sommossa: voce e prospettiva del racconto, in Id., Narratologia e critica. Teoria ed esperimenti di lettura da Manzoni a Gadda, Napoli, Liguori, 2003, pp. 37-74. – Per la citazione dei classici, quando questi non siano oggetto di analisi specifica, è sufficiente il luogo [es.: Leopardi, Il risorgimento, vv. 105-106; Novellino, LXII; Ariosto, Orlando furioso, XLII 23]. – Quando si cita la stessa opera già citata nella nota immediatamente precedente, indicare Ivi; solo per indicare il medesimo luogo dell’ultima citazione, indicare Ibid. 2.4. Altre indicazioni – Uso delle virgolette: basse («…») soltanto per le citazioni; alte (“…”) per sottolineature enfatiche o attenuazioni prudenziali; alte singole, o apici (‘…’), per spiegazioni di significati. – All’interno del testo non è consentito l’uso del neretto e delle sottolineature (eccezioni che risultassero necessarie andranno concordate con la redazione). – Il corsivo oltre che per il titolo dei saggi e dei volumi è usato anche per le parole straniere e nell’indicazione di recto e verso (anche se in forma abbreviata; e quindi r e v). – Le parentesi quadre vanno usate anche per eventuali osservazioni dell’autore all’interno di una citazione. – Nel rinviare alle pagine e ai versi si ripete l’intera cifra, senza abbreviare centinaia e migliaia [es.: pp. 495-496 e non 495-96; vv. 1423-1433 e non 1423-33 né 1423-433]. – Si prega di prestare particolare attenzione, soprattutto nella fase di correzione delle bozze, agli accenti distinguendo poiché da cioè, È da E’, ecc. 2.5. Immagini Eventuali immagini da pubblicare insieme ai contributi vanno preliminarmente digitalizzate e consegnate per posta elettronica o su un CD-Rom. In ogni caso gli autori sono pregati di prendere contatto con la redazione per concordare il formato del file. 3. Abbreviazioni app. art., artt. c., cc. cap., capp. cfr. cit., citt. doc., docc. ed. cit. appendice/i articolo/i carta/e capitolo/i confronta citato/i documento/i edizione citata ed., edd. es., ess. f., ff. f.t. fasc. fig., figg. ibid. edizione/i esempio/i foglio/i (nel rinviare alle car- te utilizzare sempre c., cc.) fuori testo fascicolo figura/e ibidem 232 ill. ms., mss. n., nn. n.s. p., pp. par., parr. r rist. anast. s.d. s.v. norme per gli autori e i collaboratori de «l’ellisse» illustrazione manoscritto/i numero/i (nota e note sem- pre per esteso) nuova serie pagina/e paragrafo/i recto di una carta (in corsivo, di seguito al numero senza spazi intermedi: es. c. 35r) ristampa anastatica senza data sub vocem sec., secc. sez. sg., sgg. t., tt. tab., tabb. tav., tavv. trad. v vd. vol., voll. secolo/i sezione/i seguente/i tomo/i tabella/e tavola/e traduzione verso di una carta (in corsivo, di seguito al numero senza spazi intermedi: es. c. 35v) vedi volume/i Finito di stampare in Roma nel mese di febbraio 2014 per conto de «L’ERMA» di bretschneider dalle Arti Grafiche Editoriali S.r.l. - Urbino
Scarica