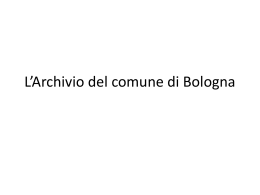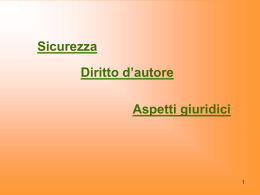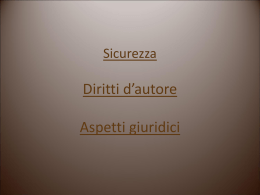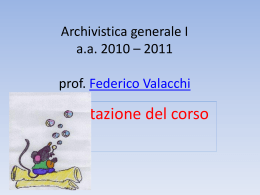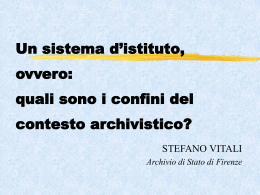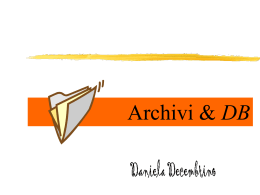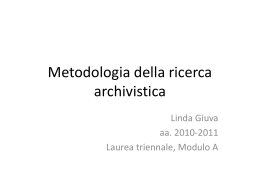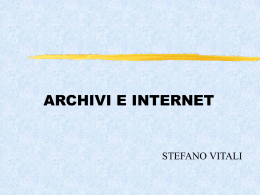RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO anno LXI - n. 1-2-3 roma, gen./dic. 2001 Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Servizio documentazione e pubblicazioni archivistiche, Roma. Direttore generale per gli archivi: Salvatore Italia, direttore responsabile. Direttore del Servizio documentazione e pubblicazioni archivistiche: Antonio DentoniLitta. Comitato di redazione: il direttore generale per gli archivi, presidente, Paola Carucci, Antonio Dentoni-Litta, Ferruccio Ferruzzi, Cosimo Damiano Fonseca, Guido Melis, Claudio Pavone, Leopoldo Puncuh, Isabella Ricci, Antonio Romiti, Isidoro Soffietti, Giuseppe Talamo. Segretaria di redazione: Ludovica de Courten. Redazione: Antonella Mulè De Luigi, Mauro Tosti-Croce. La corrispondenza va indirizzata a Rassegna degli Archivi di Stato, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Servizio documentazione e pubblicazioni archivistiche, via Gaeta, 8/a, 00185 Roma, tel. 06/492251-4746404 fax 4742177. Sito Internet: http://www.archivi.beniculturali.it/Divisione _V Posta elettronica: [email protected] I manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono. È vietata la riproduzione, totale o parziale, degli articoli pubblicati, senza citarne la fonte. Gli articoli firmati rispecchiano le opinioni degli autori: la pubblicazione non implica adesione, da parte della rivista, alle tesi sostenute. Vendite e abbonamenti: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Funzione editoria, Libreria dello Stato, piazza G. Verdi 10, 00198 Roma, tel. 85081 - fax 85084117 (versamenti in c/c postale 387001, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato o richiesta contrassegno). Un fascicolo L. 55.000 (€ 28,41), abbonamento annuo L. 125.000 (€ 64,56); estero: L. 80.000 (€ 41,32) e L. 180.000 (€ 92,96). Fascicolo doppio o arretrato, prezzo doppio. Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 ORIETTA CEINER - SILVIA MISCELLANEO, I protocolli notarili d’Ampezzo (15981808) 7 CARLA BENOCCI, La magnificenza di due casati uniti: l’inventario del 1687 dei quadri di Federico Sforza e di Livia Cesarini 101 ERMANNO ORLANDO, La documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani fra Tre e Quattrocento 129 JUANITA SCHIAVINI TREZZI, Censimenti e mezzi di corredo archivistici. Riflessioni in margine al censimento degli archivi parrocchiali della Diocesi di Bergamo 166 GUIDO MELIS, Il deposito della memoria. L’evoluzione degli archivi amministrativi nella storia italiana 208 ANTONIO FIORI, La stampa nel Casellario politico centrale 226 GIORNATA DI STUDIO: « COSTANZO CASUCCI ARCHIVISTA E STORICO » (Roma, Archivio centrale dello Stato, 15 gennaio 1999) 244 (P. Carucci, p. 246; C. Pavone, p. 252; G. Sabbatucci, p. 257; G. Talamo, p. 263; G. Carocci, p. 266) PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI FILIPPO VALENTI: Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale (Archivio di Stato di Firenze, 16 ottobre 2000) 271 (R. Manno Tolu, p. 272; C. Pavone, p. 273; S. P.P. Scalfati, p. 276; A. Spaggiari, p. 280; D. Toccafondi, p. 283; S. Vitali, p. 289; I. Zanni Rosiello, p. 294) CRONACHE Giornata di studi: « Progetti di tutela e fruizione di archivi ecclesiastici » (Bari, Soprintendenza archivistica per la Puglia, 23 marzo 2001) (F. Cavazzana Romanelli) 299 NOTE E COMMENTI I precedenti della spedizione dei Mille: lettere di Francesco Crispi e Rosolino Pilo nell’Archivio di Piero Sraffa (R.L. Romano) 306 « Un’altra Italia nell’Italia del fascismo ». Una mostra sui Rosselli all’Ar- chivio centrale dello Stato (M. Giannetto) 309 Eduardo De Filippo: un attore impresario e il suo archivio (M. Procino) 319 ORDINAMENTI E INVENTARI Archivio di Stato di Milano 333 NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO Archivi nobiliari e domestici. Conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica, a cura di L. Casella e R. Navarrini (p. 339); G. Incarnato, La maledizione della terra (1500-1848). Per una storia, non solo agraria, dell’Italia meridionale (p. 345); V. Lazzarini - L. Lazzarini, Maestri scolari amici. Commemorazioni e profili di storici e letterati a Padova e nel Veneto alla fine dell’Ottocento e nel Novecento, a cura di G. Ronconi P. Sambin, (p. 346); A.A. Mola, Corda fratres. Storia di un’associazione internazionale studentesca nell’età dei grandi conflitti (1898-1948) (p. 347); Riformagioni della Repubblica di Lucca (1369-1400), IV, febbraio 1373dicembre 1374, a cura di G. Tori (p. 348); J.D. Spence, Il figlio cinese di Dio. Storia di un profeta guerriero e della sanguinosa rivolta dei Taiping (p. 353); M. Vaquero Piñeiro, La renta y las casas. El patrimonio inmobiliario de Santiago de los Españoles de Roma entre los siglos XV y XVII (p. 361). LIBRI RICEVUTI 364 NOTIZIARIO LEGISLATIVO 367 INDICI DELL’ANNATA 370 Notiziario bibliografico Opere segnalate Collaboratori 373 374 I PROTOCOLLI NOTARILI D’AMPEZZO (1598-1808) * Il presente studio è il risultato di una convenzione tra l’« Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore » e l’Ufficio centrale per i beni archivistici, finalizzata all’ordinamento, all’analisi e all’indicizzazione dei 56 protocolli dei notai dell’Ampezzano (1598-1808), conservati presso l’Archivio di Stato di Belluno. Nato nel 1929, l’« Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore » vanta la maggiore anzianità fra i periodici culturali della provincia di Belluno: attualmente diretto da Paolo Conte, diffonde la conoscenza dell’archeologia, la storia, la letteratura, la storia dell’arte, gli usi, i costumi, i dialetti bellunesi. In particolare, sulle pagine del trimestrale l’edizione di fonti archivistiche inedite ha sempre avuto larghissimo spazio, ed è stata riservata speciale attenzione alla pubblicazione dei laudi (statuti rurali) delle Regole del Cadore. Conosciuto per la serietà delle ricerche anche presso l’Archivio di Stato di Belluno, con il quale sono state realizzate in passato altre proficue collaborazioni, nel 1994 il periodico è stato parte della convenzione in questione, tesa a promuovere la valorizzazione di un fondo archivistico dell’Archivio di Stato poco conosciuto, quale appunto quello dei protocolli notarili d’Ampezzo: va sottolineato che esso non è conservato all’interno dell’Archivio notarile, che contiene tutti gli atti e testamenti dei notai bellunesi, bensì nel fondo Livinallongo-Ampezzo, giunto nel 1994 all’Archivio di Stato di Belluno sulla base della competenza territoriale. Il progetto, realizzato da Orietta Ceiner e Silvia Miscellaneo sotto il coordinamento scientifico dell’allora direttore dell’Archivio di Stato, Giustiniana Migliardi O’ Riordan, ha avuto come oggetto una prima fase di riordino ed inventariazione dei protocolli; una seconda d’indicizzazione informatizzata delle parti contraenti ed una terza di analisi della documentazione, al fine di * Tutte le citazioni bibliografiche in nota sono date in forma abbreviata (cfr. Bibliografia, pp. 78-92). Nella trascrizione dei documenti si è ritenuto opportuno proporre in apparato critico, oltre alle note testuali, indicate da esponente in carattere alfabetico, anche delle note illustrative, contrassegnate da esponente numerico. Quest’ultime sono state tuttavia ridotte al minimo limitandone generalmente l’utilizzo alla spiegazione di termini del dialetto ampezzano di non immediata comprensione. Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 8 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo calarla in un contesto storico istituzionale suo proprio, in modo da rendere il fondo più facilmente accessibile anche a chi ha poca dimestichezza con la storia dell’Ampezzano e con le peculiarità istituzionali che il territorio tuttora in parte conserva. L’ordinamento dei protocolli ha comportato in primo luogo l’esigenza di stabilirne la paternità, problema non sempre d’immediata soluzione, e successivamente di studiare le particolari tipologie negoziali legate al diritto di proprietà collettiva ivi presenti. Il lavoro ha comportato anche la redazione degli indici delle parti contraenti per quei protocolli che ne erano privi, a cominciare da quelli del secolo XVIII, attualmente completati (6 registri per un totale di circa 1.700 atti). L’interesse della documentazione sta nella particolare realtà giuridica nella quale si trovarono ad operare i notai ampezzani di nomina imperiale o eventualmente apostolica. È interessante constatare come, a differenza di altri territori di confine sottoposti a giurisdizione imperiale, quali il Livinallongo, altro « giudizio » del Tirolo, la conca d’Ampezzo mantenne la propria autonomia istituzionale, con le sue Regole, conservando l’uso dell’istituto del notariato italiano. Per tale motivo qui gli atti dei privati, al fine di acquisire certezza, non vengono trascritti nei registri di cancelleria, com’è uso nei territori imperiali, ma vengono rogati da notai. Tra questi atti inoltre, proprio per la specifica realtà montana nella quale si negozia, e per la presenza delle Regole, possono individuarsi particolari tipologie negoziali come la consortìa, la vizza, l’albergo. Tali atti non sono ancora stati analiticamente e sistematicamente studiati da un punto di vista diplomatistico e giuridico-istituzionale: non vi è peraltro la presunzione di farlo in questo studio, nel quale si tenta però di proporne qualche esempio significativo con il relativo inquadramento storico e la trascrizione. Anche se, come è noto, il concetto di proprietà collettiva è comune a tutte le società alpine sin dai tempi antichi, tale situazione nel territorio d’Ampezzo è perdurata fino ai giorni nostri. PAOLO CONTE GIUSTINIANA MIGLIARDI O’RIORDAN « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore » Soprintendenza archivistica per il Veneto I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 9 SOMMARIO: 1. Lineamenti storici. 2. Il notariato in Ampezzo: 2.1. La professione e le istituzioni; 2.2. La formazione professionale; 2.3. Le tipologie contrattuali; 2.4. Le formule del documento; 2.5. La lingua; 2.6. Le modalità di compilazione; 2.7. I caratteri estrinseci. 3. Alcune tipologie documentarie: 3.1. Le regole; 3.2. La consortia; 3.3. La vizza; 3.4. L’albergo. 4. L’intervento archivistico: 4.1. L’ordinamento; 4.2. L’inventario; 4.3. Gli indici delle parti contraenti. BIBLIOGRAFIA. 1. LINEAMENTI STORICI Al fine di offrire un utile strumento di approccio alla documentazione, si propone qui un sintetico inquadramento storico alla produzione notarile ampezzana, ripercorrendo solo a grandi linee l’evoluzione del territorio attraverso i secoli e richiamando le principali figure istituzionali tipiche degli ordinamenti statutari locali più frequentemente ricorrenti negli atti 1. Forse non è superfluo precisare che d’ora in poi si parlerà sempre di Ampezzo 2, indicando — come d’uso — tutta la vallata che solo attualmente corrisponde al territorio comunale di Cortina d’Ampezzo: una volta infatti il toponimo Cortina (= recinzione, cimitero) corrispondeva soltanto alla « frazione centrale della vallata, sede del municipio e della chiesa parrocchiale » 3. La documentazione esaminata si riferisce invece all’intera conca ampezzana, corrispondente al bacino superiore della valle del torrente Boite — affluente del Piave — comprensiva sia dell’insediamento centrale, che delle frazioni limitrofe. Non si hanno dati certi sui primi stanziamenti abitativi nella valle, sebbene numerosi indizi facciano supporre la presenza d’insediamenti stabili di popolazioni paleovenete durante il periodo preromano. Con la romanizzazione Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle molteplici opere di Giuseppe Richebuono, che si è occupato specificamente della storia del territorio ampezzano soprattutto in Ampezzo di Cadore e Storia d’Ampezzo, con ampio corredo di documentazione e pubblicazione di fonti per lo più inedite. 1 La prima attestazione del toponimo è teram in Ampicio, presente in un documento del 1156, ma la critica suppone che il nome sia stato assegnato alla conca già in età romana, all’epoca dell’aggregazione del Cadore al municipium di Julium Carnicum. Le varie ipotesi sull’etimologia risultano invece tuttora non del tutto convincenti: Ampicium potrebbe infatti collegarsi tanto ad amplum, « ampio, spazioso » , quanto alla base –amp, presente in lampone, ma potrebbe pure essere un prediale, o ancora un fitotoponimo derivato dalla denominazione di piante indigene del sottobosco. In merito in particolare BATTISTI, I toponimi, pp. 73-74; PALLABAZZER, Terra, pp. 311-314; RICHEBUONO, Storia, p. 51. 2 3 La definizione è di RICHEBUONO, Ampezzo, p. 1. Il termine, diminutivo di corte, risulta attestato per la prima volta in composizione (Curtina Ampitii) nel 1317 e trovò la sua ampia diffusione solo in epoca recente, attraverso lo sviluppo del turismo; cfr. anche PALLABAZZER, Terra, p. 311. 10 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo del territorio cadorino, anche Ampezzo venne inclusa nella Venetia et Histria, con dipendenza dal municipium di Julium Carnicum; l’opinione della critica storica maggiormente accreditata tende ad attribuire Ampezzo al Friuli senza soluzione di continuità 4 fino al 1077, anno in cui, assieme al comitatus friulano, venne annessa al Patriarcato di Aquileia. Dal 1138 al 1335 i conti da Camino, feudatari del Patriarca, furono signori del Cadore, di cui Ampezzo costituiva una centena 5: essi stilarono nel 1235 gli Statuta et banna, che, pur non essendo un vero e proprio statuto, rappresentano un’importante raccolta di disposizioni sussidiarie e integrative del diritto comune allora vigente 6. Alla morte dell’ultimo erede maschio della famiglia da Camino, il Cadore fu per breve tempo sotto la protezione della dinastia di Lussemburgo (1337-1342) e successivamente di quella bavarese (1342-1347): proprio in questi anni, e precisamente nel 1338, il Cadore, costituitosi in libera comunità, si diede un proprio statuto di autonomia, che restò poi in vigore per quasi cinque secoli. Si tratta in questo caso di un vero e proprio codice, completo e sistematico, ripartito per argomenti in tre libri che coprono organicamente i campi del diritto amministrativo, civile e penale, con relative procedure 7. Nonostante il documento originale non sia pervenuto, è noto che il testo venne riconosciuto dal Patriarca nel 1347; a partire da tale data infatti, il Cadore fu nuovamente incluso sotto la giurisdizione del Patriarcato, restandone alle dirette dipendenze senza più rispondere ad alcun feudatario o ad altra forma di mediazione istituzionale per oltre un settantennio (1347-1420). Questa situazione mutò solo con l’esaurirsi del potere temporale del Patriarcato, quando la Repubblica di Venezia, ereditandone le prerogative, assunse la protezione di tutto il territorio cadorino, che rimase sotto la Serenissima fino alla caduta della Repubblica (1797). 4 FABBIANI, Breve storia, pp. 24-29; RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 1-2; ID., Storia, pp. 47-49; per una puntuale disamina dello stretto legame tra il Cadore ed il Friuli come fenomeno di lunga durata ZANDERIGO ROSOLO, Il Cadore, passim, in particolare I, pp. 95-99, con discussione critica della bibliografia precedente. 5 Il Cadore risulta sin dall’epoca franca o longobarda diviso in dieci decanìe, successivamente dette centenari, ovverosia circoscrizioni territoriali ed amministrative costituite dall’unione di nuclei abitativi limitrofi (Regole), che tutte insieme formavano la Comunità di Cadore, nell’ambito della quale erano rappresentate ciascuna da propri delegati; anche Ampezzo costituì sino al 1511 una centena del Cadore. Per un rapido inquadramento di questi temi bastino FABBIANI, Breve storia, pp. 35-36; RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 51-52; ID., Cenni, passim e Storia, pp. 57-58. Sui centenari si sofferma a lungo ANDRICH, Appunti, pp. 31-33. 6 Trattazione specifica in RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 19-29 e ID., Storia, p. 55. Cfr. anche ANDRICH, Appunti, pp. 26-31 e ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, pp. 191-193. Si noti che tra i dieci rappresentanti del Cadore presenti alla stesura del documento, vi è un Azzo notaio d’Ampezzo, che costituisce una delle prime citazioni esplicite dell’esistenza del notariato ampezzano; cfr. Il notariato, p. 39. FABBIANI, Gli Statuti; Il primo, passim; ZANGRANDO, Note, pp. 8-14; RICHEBUONO, Storia, pp. 75-76 e ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, pp. 200-215, in particolare per la disciplina statutaria in rapporto alle Regole. Per il testo, con le integrazioni successive, cfr. Statuti. 7 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 11 Il territorio d’Ampezzo, invece, fu nel 1511 occupato dalle truppe dell’imperatore Massimiliano I nel corso della guerra cambraica contro Venezia e venne effettivamente sottoposto alla sovranità dell’Impero austriaco nel 1516, senza che i Veneziani riuscissero più a riconquistarlo 8: con la ratifica del trattato di Worms nel 1523, questo stato di fatto divenne pacifico e definitivo, ponendo le basi per la secolare separazione politica del territorio ampezzano da quello cadorino 9. Sebbene Ampezzo fosse stata aggregata alla contea del Tirolo, allora retta dagli arciduchi d’Austria, le fu tuttavia riconosciuto il diritto di continuare a reggersi secondo gli antichi ordinamenti 10, ovverosia in base allo Statuto cadorino e secondo i laudi delle Regole locali 11 fino al 1792, anno in cui Giuseppe II ne abolì l’autonomia ed i privilegi, assimilandola definitivamente al Tirolo tedesco. In virtù di tale riconoscimento la Magnifica Comunità d’Ampezzo, formata dall’insieme delle Regole ampezzane, continuò a svolgere in proprio tutte le funzioni prima espletate dal Consiglio Generale di Cadore: ogni anno l’assemblea dei capifamiglia eleggeva al suo interno un rappresentante, detto marigo, due consiglieri, detti sindici, un officiale, con competenza giurisdizionale di prima istanza, ed un cancelliere. Col tempo si andò affermando il Consiglio generale d’Ampezzo, detto anche arengo o consiglio, che affiancò le riunioni plenarie dei capifamiglia ed è attestato per la prima volta nel 1548: consisteva in una sorta di consiglio comunale ristretto, formato da due consiglieri per ognuno dei sei sestieri, dal marigo del Comune, dall’officiale e dai due sindici; oltre a questi 16 membri — che rappresentavano la popolazione del paese — partecipavano alle adunanze il capitano del castello di Botestagno (al contempo vicario e giudice d’Ampezzo) come rappresentante del sovrano, quattro consoli ed infine un cancelliere per la verbalizzazione delle sedute. Il Consiglio era autonomo e dotato di sovranità 8 A seguito dei trattati di Noyon e Bruxelles (1516) e della ratifica delle cessioni da parte di Venezia sottoscritta il 7 e il 21 gennaio 1517, come precisa RICHEBUONO, Storia, p. 160. Su questo aspetto in particolare STOLZ, p. 718. Si tenga presente però che fino al 1751 Ampezzo continuò dal punto di vista ecclesiastico a far parte del Patriarcato d’Aquileia e dell’Arcidiaconato del Cadore, il che comportava una serie di conseguenze di tipo giurisdizionale, come ad esempio il fatto che le cause matrimoniali ampezzane venissero trattate a Pieve di Cadore, come sottolinea ZANDERIGO ROSOLO, Il Cadore, I, p. 94. Per i successivi mutamenti di giurisdizione ecclesiastica cfr. RICHEBUONO, Storia, pp. 280-281. 9 10 Presso l’ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CORTINA [d’ora in poi ASCC] sono conservati i documenti di conferma dei privilegi che i vari sovrani del Tirolo rilasciarono successivamente alla Comunità d’Ampezzo: da quello dell’arciduca Ferdinando I (1523) a quello dell’imperatore Francesco II (1792); questi sono elencati da RICHEBUONO, Storia, pp. 174. 11 Sul riconoscimento degli Statuti cfr. STOLZ, p. 717. Sul concetto di Regola ci si soffermerà più oltre, nella sezione dedicata alle tipologie documentarie; per ora basti ricordare che non si tratta di un ente territoriale, bensì di un’associazione di tipo gentilizio, ovverosia di un consorzio privato di coeredi, che derivano il loro diritto di compartecipazione dallo jus sanguinis e adottano particolari codici comportamentali detti laudi; cfr. RICHEBUONO, Storia, pp. 82-83. Per i laudi delle Regole ampezzane cfr. FABBIANI, I laudi di Ampezzo e RICHEBUONO, Antichi. 12 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo per qualsiasi questione interna alla Comunità, ma doveva comunque rispondere alla Dieta di Innsbruck in materia di tasse, confini, difesa militare 12. Se dal punto di vista istituzionale tale situazione si mantenne sostanzialmente inalterata fin quasi allo spirare del secolo XVIII, in seguito alla terza guerra di coalizione contro Napoleone, per effetto della pace di Presburgo (26 dicembre 1805), l’Austria dovette cedere tutto il Tirolo al Regno di Baviera, cosicché Ampezzo, insieme ai limitrofi territori di Livinallongo e Colle Santa Lucia 13, visse la dominazione bavarese fino al 1809. Con la ripresa delle guerre napoleoniche e la successiva pace di Schönbrunn (14 ottobre 1809), il Tirolo venne ceduto dall’Austria ai Francesi ed il territorio ampezzano fu aggregato al Dipartimento della Piave del Regno d’Italia 14, di cui fece parte dal 1810 al 1813. Dopo la disfatta di Napoleone in Russia, alla ripresa delle ostilità franco-austriache, il Tirolo venne riconquistato dall’Austria, che ne prese ufficialmente possesso il 28 novembre 1813. Il ritorno della dominazione austriaca fu felicemente accolto dagli Ampezzani, che speravano di poter recuperare la loro secolare forma di autonomia: ma gli Austriaci riportarono sostanzialmente in vita i vecchi ordinamenti, precedenti alle fasi bavarese e napoleonica, cosicché Ampezzo venne di nuovo unita amministrativamente al Circolo di Pusteria con sede a Brunico e non riacquistò mai più i suoi privilegi. Da questo momento in poi Ampezzo rimase soggetta alla dominazione asburgica, fino alla fine della prima Guerra mondiale. Al termine di essa, insieme al Trentino e all’Alto Adige, passò all’Italia e venne inclusa nella Provincia di Trento: solo nel 1923 fu definitivamente aggregata a quella di Belluno, insieme ai due Comuni di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia 15. 2. IL NOTARIATO IN AMPEZZO 2.1. La professione di notaio e le istituzioni. — A testimonianza dell’attività svolta dai notai ampezzani 16 nel periodo medievale e moderno, sino 12 RICHEBUONO, Storia, pp. 184-185 e 226-228. Sulla posizione giuridica di Ampezzo rispetto al governo centrale di Innsbruck, cfr. anche STOLZ, p. 717. 13 Già sottoposti sin dal 1077 al Principato vescovile di Bressanone, secolarizzato nel 1803. La denominazione completa per il Comune di Ampezzo di quegli anni fu per la precisione Dipartimento della Piave, Distretto di Cadore, Cantone di Pieve, Comune d’Ampezzo; RICHEBUONO, Storia, pp. 311-313. 14 Dal punto di vista ecclesiastico, invece, i due Decanati di Cortina d’Ampezzo e di Livinallongo vennero aggregati alla Diocesi di Belluno solo nel 1964. 15 16 Le considerazioni che seguono muovono dall’esigenza di tentare un primo ritratto istituzionale della figura del notaio in Ampezzo per i secoli XVII e XVIII. Le fonti archivistiche analizzate, quali risultano dalla premessa, arricchiscono decisamente le scarse notizie bibliografiche finora disponibili, poiché a parte le brevi note del RICHEBUONO (Due Soldi, Segni, pp. 10-11; Atti, pp. 6-7; Ampezzo, pp. 69-70; Storia, pp. 250-251), nessuno studio specifico risulta essere I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 13 allo spirare del secolo XVI, non consta siano pervenuti né protocolli, né minutari derivanti dall’attività notarile, fatta eccezione per un protocollo risalente appunto agli ultimi anni del ’500, già conservato presso l’Archivio storico del Comune di Cortina d’Ampezzo 17. Per il periodo antecedente a tale data sono pervenuti invece solo numerosi atti sciolti 18, ovverosia instrumenta, dai quali risulta che i notai ivi operanti durante il Medioevo erano per lo più notarii sacri palacii, nominati dall’imperatore, dal papa, o da loro rappresentanti 19. Ma già a partire dal XIV secolo, e successivamente per tutta l’età moderna, in corrispondenza coll’affermarsi in tale funzione di delegati delle due autorità — e principalmente dei conti palatini 20 — i notai ampezzani si sottoscrivono qualificandosi alternativamente imperiali auctoritate, apostolica auctoritate, o apostolica ac imperiali auctoritate 21. È ben nota la varietà che caratterizza l’attestazione e distribuzione dell’istituto latino del notariato nelle valli alpine dell’attuale Trentino Alto Adige soggette ad autorità laiche ed ecclesiastiche di legge germanica 22. Tale difstato finora condotto sui documenti del fondo in parola, né tantomeno sul notariato ampezzano. Inoltre, ad eccezione del contributo di FABBIANI (Notizie) sul notariato cadorino e del più recente catalogo della mostra sul documento di diritto privato bellunese edito dall’ARCHIVIO DI STATO DI BELLUNO [d’ora in poi AS BL] (Il notariato) non esistono studi specifici neppure sul notariato della provincia di Belluno. Si precisa comunque che quanto segue deriva in via principale, per non dire pressoché esclusiva, dallo studio strettamente archivistico e diplomatistico dei protocolli notarili d’Ampezzo, senza alcuna pretesa di approfondimento in ambito più propriamente giuridico. 17 Al momento delle ricerche risultava questo l’unico esemplare esistente non compreso tra quelli esaminati. Il registro è stato di recente trasferito all’Archivio di Stato di Belluno ed ora incluso nel fondo con il numero 29 bis. 18 Ci si riferisce in via principale alle raccolte di pergamene conservate presso l’ASCC e l’ARCHIVIO DELLE REGOLE D’AMPEZZO [d’ora in poi ARAMP]. 19 Su questo aspetto in generale BRESSLAU, pp. 569-573; cfr. anche ROLANDINO, p. 101; FALCONI, Lineamenti, pp. 104 e 141-143. Per Ampezzo in particolare cfr. Due Soldi, Segni, pp. 10-11; RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 60-70 e 210-213; FABBIANI, Notizie (1964), p. 12. Ad essi poteva essere conferita la prerogativa della comitiva maior o della comitiva minor, « la prima era quasi sempre ereditaria, la seconda ad personam; la prima, a differenza della seconda, assieme ad altre ampie facoltà, comprendeva anche il diritto alla nomina di altri a conti palatini. A entrambe era però congiunto il diritto alla nomina di notai »; così BRESSLAU, pp. 575576; cfr. anche BUSSI, pp. 66-67. In merito all’autorità di creare notai anche REDLICH, pp. 55-56; GRZIWOTZ, pp. 180 e 186; REICH, pp. 236-237; CAMMAROSANO, p. 269; BEZZI, p. 142; BRAVI, pp. 6-7; SOMEDA, p. 28. 20 21 Ad es. ASCC, Pergamene III, n. 2 (a. 1367), n. 26 (a. 1472), n. 45 (a. 1603), n. 47 (a.1610), n. 49 (a. 1623), n. 60 (a. 1671), n. 62 (a. 1691) e AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 9 (1690-1702), c. 2; prot. 54 (1773-1807), c. 1. Tale uso non si discosta peraltro da quello diffuso nel resto dell’attuale provincia di Belluno ove, fino alle disposizioni del Senato Veneto del 1612-1613 con le quali fu imposta la veneta auctoritas, i notai si sottoscrivevano generalmente in forma analoga; al contrario ad es. i notai delle famiglie Fabris e Nardei, che già nel corso del ’400 e del ’500 rogavano in Cadore per autorità veneta; cfr. Archivio, p. 275. 22 Si pensi, solo a titolo di esempio, che per i secoli considerati il notariato è attestato nel territorio del principato vescovile di Trento, ma non in quello del contiguo principato vescovile di 14 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo formità è condivisa anche dal territorio odiernamente incluso nella provincia di Belluno, comprendente anche zone che non furono interessate — almeno per i secoli in questione — dall’istituto del notariato: ci si riferisce in particolare ai territori degli attuali Comuni di Livinallongo del Col di Lana e Colle S. Lucia, dipendenti dal principato vescovile di Bressanone fino alla sua secolarizzazione del 1803 e successivamente annessi alla Provincia di Tirolo. Qui, i contratti di diritto privato non venivano rogati dal notaio, bensì compiuti secondo l’uso germanico davanti al vicario (o giudice) ed insinuati presso la cancelleria del Giudizio, mediante la registrazione di essi in appositi libri d’archiviazione detti anche protocolli e libri da copie 23. Per quanto riguarda i territori di giurisdizione imperiale, nel 1512 entrò in vigore un vero e proprio codice comportamentale relativo all’attività del notaio: si tratta dell’Ordinamento della Maestà Imperiale per istruire i notai pubblici su come esercitare i loro uffici, emanato dall’imperatore Massimiliano I d’Asburgo l’8 ottobre 1512 ed avente validità in « tutto il sacro Romano Impero, i paesi ereditari e i regni della sua Maestà Imperiale e in tutti gli altri luoghi » 24. Il territorio ampezzano invece, anche in seguito all’avvento della dominazione tirolese, non recepì tali disposizioni, ma conservò l’uso del notariato secondo modalità proprie: ciò in virtù del riconoscimento degli antichi Statuti di Cadore 25, che dal 1523 in poi furono sempre riconfermati dai vari regnanti della casa d’Austria, fino al 1792. Nel Codice cadorino l’istituto del notariato di tradizione giuridica tipicamente latina risulta regolamentato nei suoi aspetti fondamentali 26 e in Ampezzo si mantenne vivo, anche dopo gli eventi del 1511, secondo modalità che non risultano vistosamente difformi da quelle in essere nei limitrofi territori di giurisdizione veneziana. Per quanto riguarda invece la provenienza dell’autorità notarile, a partire dal 1613 si evidenzia una sostanziale differenza tra il territorio cadorino e quello ampezzano, in quanto, da allora in poi, i notai di Bressanone, né nella vicina città di Bolzano; l’area atesina risulta peraltro ricca di zone in cui la sovrapposizione dell’uso tipicamente italiano del notariato a quello tedesco della notizia sigillata e del successivo libro di archiviazione, dà talora esito a forme ibride di documentazione, come evidenziato da BRAVI, pp. 7; 10-11; cfr. anche REICH, pp. 236-237; BEZZI, pp. 142-144 e, per il periodo medievale, HÄRTEL, L’atto privato, pp. 19-22 e ID., Il notariato, pp. 10 ss. 23 Si noti che a Livinallongo i Libri del Giudizio non assunsero mai la denominazione tedesca, generalmente diffusa nel resto del Tirolo, di Verfachbucher: ciò va ascritto alla particolare posizione di confine del territorio, che pur adottando i modelli giuridici in uso nel mondo germanico, non è indenne da punti di contatto tipici della sfera istituzionale italiana, come precisano GASSER, p. 99 e Il notariato, pp. 40 e 44; MISCELLANEO, pp. 107-108. Collectio, pp. 430-434. Il testo integrale dell’Ordinamento, corredato da un approfondito saggio illustrativo, è riportato in lingua italiana da GRZIWOTZ, pp. 159-202. Sull’applicazione dello stesso in area germanica REDLICH, p. 61 24 25 Segni, p. 11; MISCELLANEO, pp. 103-106, Il notariato, pp. 39-44. Sullo Statuto cadorino FABBIANI, Il primo; ID., Breve storia, pp. 64-66. Statuti, in particolare capp. XII-XIV, pp. 9-10; cap. XXI, p. 102; cap. XVI, p. 117; cap. CXIX, p. 141; sull’attività dei notai come pubblici ufficiali e cancellieri della Comunità cap. LV, p. 21; cap. LXII, p. 22; capp. IX-X, pp. 114-115. 26 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 15 area bellunese 27 dovevano necessariamente ricevere la loro investitura « veneta auctoritate » 28 da Rettori della Serenissima, mentre quelli della conca ampezzana, trattandosi di un territorio al di fuori dello Stato veneto, continuavano a rogare per autorità imperiale ed apostolica. Non è dato sapere con precisione da chi i notai ampezzani derivassero tale titolo, ossia da quali autorità principesche od ecclesiastiche fossero beneficiati 29, mentre è noto che in Cadore tale prerogativa sovrana fu esercitata nel secolo XVI da personalità quali il pittore Tiziano Vecellio 30, Luigi Lollino (1557-1625) vescovo di Belluno, o l’umanista Pierio Valeriano (1477-1558), canonico e arciprete a Belluno, nonché conte palatino 31. È logico pertanto supporre che i notai d’Ampezzo anche per il periodo successivo all’instaurarsi della giurisdizione tirolese continuassero ad ottenere la loro investitura per lo più da conti palatini di territori circonvicini, sebbene al momento non si sia a conoscenza di diplomi di notariato che testimonino in tal senso. Sappiamo solo che durante il corso del secolo XVIII la facultas rogandi derivava loro anche da membri della Casa dei conti di Collalto e di San Salvatore 32, come dimostra la citazione di un documento contenuta in un repertorio conservato presso l’Archivio di Stato 27 Salvo diverse precisazioni d’ora in poi col termine di Bellunese s’intenderà indicare tutto il territorio dell’attuale provincia di Belluno soggetto fino al 1797 alla dominazione veneziana, escludendo pertanto, oltre all’Ampezzo, gli attuali Comuni di Livinallongo del Col di Lana e di Colle S. Lucia, che, secondo gli usi colà vigenti, non conobbero (almeno per i secoli in questione) l’uso del notariato pubblico. 28 PEDANI FABRIS, pp. 6-7; 180; 197-199. Su ciò in generale, CAMMAROSANO, p. 269. Va precisato che nemmeno negli Statuti cadorini esiste alcuna precisa disposizione in ordine alla creazione dei notai, né al tipo di autorità delegata alla nomina di essi. 29 Creato conte palatino dall’imperatore Carlo V con diploma del 10 maggio 1533, che gli conferiva appunto, tra gli altri privilegi, anche la facoltà di investire notai e giudici ordinari, FABBIANI, Notizie (1964), pp. 14-15; ID., Notizie (1965), pp. 10-12. 30 31 FABBIANI, Notizie (1964), pp. 10-15. Notizie biografiche sui personaggi citati in MIARI, pp. 89; 119-121. 32 Fin dal secolo IX tra i protagonisti della storia della Marca trevigiana e del Cadore e quindi del Bellunese, furono feudatari imperiali e conservarono importanti prerogative connesse al potere feudale molto a lungo, anche dopo la fine del Medioevo, precipuamente nei territori divenuti parte della Terraferma della Repubblica di Venezia, cfr.: PASSOLUNGHI, Da Conti di Treviso, p. 11; BATTISTELLA, passim; RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 41, 145, 147, 151 e COLLODO, pp. 28-33, che sottolinea i rapporti di natura politica che legarono il territorio ampezzano ai Collalto in epoca medievale. Nel novero di questi attributi sovrani i conti palatini Collalto poterono mantenere anche quello di creare giudici ordinari, dottori in legge e notai, anche dopo l’esclusiva assunzione di tale regalia da parte della Serenissima nel 1613. Emblematico, a tal proposito, il fatto che nel piccolo feudo di San Salvatore, ove già esisteva la sede di un collegio notarile proprio, ancora il 7 aprile 1784 tale istituto sia stato ristrutturato per regolamentare meglio l’attività dei notai Veneta et Collalti ac Sancti Salvatoris auctoritate, cfr. PASSOLUNGHI, I Collalto, p. 173. In area trevigiana erano proprio i Collalto a concedere la licentiam exercendi artem notariae in via pressoché esclusiva, cfr. CAGNIN, p. 4. 16 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo di Belluno 33: si tratta della registrazione di una richiesta del 15 dicembre 1787 pervenuta da parte dell’Ufficio circolare di Pusteria all’Ufficio vicariale d’Ampezzo, volta ad appurare « da quanto tempo la Casa Collalta abbia il diritto di creare notarii e fino dove si estenda tale diritto ». In data di poco precedente era stato inoltre richiesto l’invio di un esemplare di diploma notarile concesso dai Conti suddetti, nonché una relazione sul numero ed il tipo di autorità dei notai all’epoca ammessi a rogare sul territorio 34. La conferma di quanto ipotizzato è peraltro confortata proprio da un privilegio notarile che si è conservato fino a noi, inserto in uno dei protocolli: si tratta di una copia semplice, cartacea, priva di qualsiasi forma di convalida o mezzo di autenticazione, del diploma notarile concesso da Scipione di Collalto a Pietro Antonio Clemente De Zanna, che rappresenta molto probabilmente soltanto un exemplum di quella che doveva essere l’autorizzazione all’esercizio della professione 35. L’iter d’investitura non si discosta nella sostanza da quello attestato in altri diplomi notarili rilasciati da analoga autorità in territori circonvicini 36, come è rilevabile dalla trascrizione del documento che segue: Noi Scipione conte di Colalto et cetera. A tuti et ad ogni uno, che vederano et parimente legerano le presenti nostræ, anunciamo salute et sincero affeto di a amore. La sagace invencione degli huomini, considerata la memoria et stabilità delle cose, acciò che le cose, che vengeno notate, per la lungezza del tempo non vadano b in oblivione, inventò l’officio del c nodariato, aciò che venise scrita la volontà dei contrenti, et indi si conservasero le scriture longo tempo. Sì che dunque il prudente giovine Pietro Antonio Clemente De Zanna, figioulo di domino Gioan Maria, di stato imperial, dioce d’Aquilea, avanti di noi genufleso, humilmente suplice che si degnasimo di concedergli l’officio del nodariato et di giutice ordinario. Noi dunque, inclinati all’humile suplica del predeto Pietro Antonio, il quale d habiamo trovato abile et suficiente a ricever questo honore et oficio, fatogli fare prima un diligente esame sopra gli punti legali del arte notariale, riceputo prima da esso il 33 AS BL, Livinallongo - Ampezzo, Giudizio distrettuale Ampezzo, b. 342, Repertorio degli ordini sovrani 1787-1794, sub littera N, n. 355. Il relativo atteggio non è stato invece reperito. 34 Ibid., sub littera N, n. 338 e 303. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 33: notaio Ghedini Simone (1673-1684), c. 216v, c. inserta. Al verso: « 1718. Privileggio notariale del signor Pietro Antonio Clemente di Zanna, ut intus ». Dell’attività di tale notaio non risultano essere pervenuti protocolli; se ne conserva invece uno del padre Pietr’Antonio. Per un confronto con analoghi diplomi di notariato rilasciati dai conti di Collalto si veda ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO, Archivio storico del Comune, b. 196; cfr. CAGNIN, pp. 13-14 e BETTO, p. 94. 35 36 In generale BRESSLAU, p. 572. Per il Bellunese cfr. ad es. ALPAGO NOVELLO, pp. 938939, per il Cadore, FABBIANI, Notizie (1964), p. 16, per il Trevigiano BETTO, pp. 93-94, per l’area trentina CASETTI, Il notariato, pp. 244-247, per quella friulana SOMEDA DE MARCO, pp. 42-43. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 17 gioramento in nome del Sacro Romano Imperio, et per noi, et per tuti della nostra casa Colalta, che non sarà, nemeno darà consilgo, che sia e contra l’agustissimo Imperatore, né mai noi, né altre della nostra casa predeta, membro, honore, iurisdicione et autorità, et le scriture da ridursi da esso in publica forma non le farà in carta papiria et abrasa; nelle cause delle chiese, hospidale, luogi pii, vedove, horfani et finalmente || per tute le persone miserabeli gli facia il suo potere giusticia, ragione, et al posibele gli sarà begnino f ; et il deto oficio notariale con somma fete et legalmente esercitarà, non agiungento, né sminuento cosa alcuna, che ad uno, o ad altro de contrente potese esere faureule, o vero danoso; et le deposicione dei testimoni g exseminati et le sentenze ad alcuno non palesarà, sino che, ricercantolo la iusticia, sarano publicati; habiamo per ciò giudicato ben fato di concetere al h deto Pietro Antonio lo oficio del tabelionato, con la audorità che deniamo di crear nodari et iudice ordinario i col consenargli la pena, il calamaro et la carta, che sono gli insegni dela deta arte, et le investimo del deto oficio, concedento, et danto al j deto Pietro Antonio la audorità a noi adribuita piena li carca et haudorità di formar instrumenti, ati, contrati, testamenti, codicili, donacione, et ultime volontà, tener prodocoli, scriver letere, copiare, ricever et exeminar testimoni, et formar qualsivolga scritura, interponer decreti sopra allienacioni k, decerer l et decretar gli alamenti ai popili et orfani, et finalmente a fare et exercitare tute quele altre cose, che ochorerano, et serano necesarie m per il deto oficio || et che ad esso Pietro Antonio come nodaro publico et giudice ordinario et persona auttentica n, si debe haver il ricorso e nel resto ad esso et alle sue scriture, si doverà dare piena et indubitata fete. In fete dele quale cose habiamo ordinato che sino fate le presente nostre per il soto scrito nodaro, et con li imposicione del nostro segilo habiamo comandato sino coroborate et munitte. Fato et dato nel Castelo di San Salvatore, nel oficio di corte et cancelaria nostra, l’anno del Signor 1718, indicione 11, giorno di venertì 18 di marzo. b Con i corretta su a. Da notate... a… vadano, al margine sinistro e richiamato nel testo con c d doppio segno d’inserzione. Nel testo dell con la seconda l depennata. Quale con u e f soprascritta. Corretto su sii. Nel testo bgnino con lettera soprascritta non identificata. g Corretto su testamonti. h All nel testo. i Con o finale apparentemente depennata. j All nel testo. k Con i finale corretta su e. l Da intendersi presumibilmente deceder. m Con e finale soprascritta su lettera depennata illeggibile. n Con l’ultima t corretta su d non depennata. a Una volta in possesso del privilegio notarile, per poter svolgere la professione era indispensabile conseguire il placet della Magnifica Comunità di Cadore. Mentre infatti nel resto del territorio bellunese soggetto alla Serenissima si affermò l’istituzione dei Collegi notarili (attestati a Belluno, Feltre, Mel), in Cadore non si ebbe mai un vero e proprio Collegio professionale, in quanto fu sempre il Consiglio generale di Cadore a esercitarne in tutto e per tutto le funzioni: stabiliva i compensi da corrispondersi per le varie tipologie negoziali, provvedeva alla conservazione e revisione degli atti e — ciò che forse è più peculiare — regolava l’ammissione degli aspiranti al notariato 37. Il riconoscimento veniva conferito dal consesso in pubblica seduta, come sanciva 37 FABBIANI, Notizie, II, pp. 13-14. 18 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo una precisa norma statutaria 38; in assenza di esso, si prescriveva nullità per qualsiasi forma di attività notarile, tanto ad instrumenta quanto ad acta, esercitata da un notaio non riconosciuto dalla Comunità 39. Dopo il passaggio dell’Ampezzo alla Casa d’Austria, grazie alla riconferma degli antichi privilegi, il notariato ampezzano continuò a regolarsi secondo quanto stabilito dagli Statuti cadorini, ma naturalmente senza più sottostare all’autorità del Consiglio generale di Cadore, né alle numerose disposizioni impartite in materia dalle magistrature veneziane 40: pertanto da quel momento in poi le funzioni in materia di regolamentazione del notariato vennero svolte — per evidente analogia con quello di Cadore — dal Consiglio della Comunità d’Ampezzo 41. L’abilitazione all’esercizio della professione notarile veniva di norma concessa dal Consiglio in seguito ad esame del candidato condotto in presenza del vicario d’Ampezzo. Tale prassi è rilevabile, a titolo di esempio, dalla deliberazione del 16 agosto 1615: (…) fatta prima la debita esamina a questo conveniente del molto nobile et molto magnifico signor Giovanni Cristoforo Bindelofer, degnissimo capitanio della rocca di Bottestagno et honorando vicario d’Ampezzo, per tenore anco dal mandato arciducale, il signor Tomaso figliolo del quondam domino Ioseffo Gidini è stato accettato et confirmato per publico nodaro, di modo che possia essercitare et administrare l’officio di tabellionato in questo nostro luogo et territorio 42. L’istituzione di un vero e proprio collegio notarile in Ampezzo non va ipotizzata nemmeno sulla base di alcuni elementi che potrebbero indurre ad 38 Statuti, p. 141, cap. CXIX. Che li nodari siano approvati per il conseglio. « Essendo, che l’officio di Nodaro sia di gran peso, & che in esso ricercasi somma bontà, & sofficienza, & però statuimo, che se alcuno vorrà esercitar detto officio in Cadore, sia tenuto presentarsi prima al Conseglio generale, nel quale fatto diligente esamine della sua sofficienza, dottrina, & bontà, se sarà ammesso, & approvato per detto Conseglio, ò per la maggior parte di esso, all’hora possi, & vaglia esercitar l’officio del Nodaro; altramente non si dia, né dar si debba fede alcuna alle sue scritture, come publiche ». Statuti, p. 117, cap. XVI. Che Nodaro foresto non possi in Cadore rogare instromenti, né altre scritture pubbliche. « Non possi, né debba alcun Nodaro foresto rogare instromenti, overo altri atti civili, ò criminali nella contrada di Cadore, & tutto quello, ch’egli haverà scritto, & notato, & rogato, sia di niun valore, & efficacia, & quello, che haverà ricercato à far tal cosa, sia condannato ». 39 40 Ad es. l’obbligo circa la conservazione dei rogiti dei notai defunti; il controllo e la revisione annuale dei protocolli da parte del Consiglio generale di Cadore; in merito FABBIANI, Notizie (1965), p. 40, doc. VI; cfr. PEDRINELLI, II/2, pp. 19-21. Sulla composizione del Consiglio generale d’Ampezzo si veda quanto esposto nell’introduzione storica, pp. 11-12. 41 42 ASCC, reg. 19: Protocollo delle delibere del Consiglio Comunale di Ampezzo, c. non num., 16 agosto 1615. Ulteriore prova che tale era la prassi in uso per l’accesso alla professione è data dalla deliberazione con la quale « (…) fu confirmato et approbatto per nodaro pubblico Alessio Gidini, havvendo mostratto il suo privilegio, et havvendo ritrovato idoneo et suficiente a tal offizio », Ibidem, c. non num., 2 gennaio 1661. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 19 immaginarne l’esistenza: indizi di ciò sarebbero costituiti dalla particolare sottoscrizione di alcuni notai, che si definiscono collegiati d’Ampezzo 43, nonché dall’annotazione presente in calce ad un protocollo, che riporta la data in cui fu « collegiato » il notaio Benedetto Costantini 44. La presenza di casi analoghi attestati nell’ambito del territorio cadorino consente di affermare che in Ampezzo, come in Cadore, la definizione di « collegiato » risulta impiegata in senso improprio o più semplicemente generico, cioè, per indicare semplicemente il possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione in loco, rilasciata dal Consiglio generale delle rispettive Comunità 45. La mancanza di un organismo corporativo, ossia di un collegio professionale 46, appare del resto chiara laddove si esaminino le norme statutarie: non solo se ne ricava che la Comunità stessa fungeva da organo di controllo, regolando l’accesso alla libera professione e agli officia publica 47, ma, stante il ruolo primario allora come oggi rivestito dai notai nella società 48, erano previste anche disposizioni specifiche circa l’esercizio del notaio ad instrumenta 49, la cui attività risulta regolata dal punto di vista economico insieme a quella propria di cancelleria, da un apposito tariffario 50. Come si vedrà in altro capitolo, tra i soggetti degli atti protocollati compaiono spesso società private, confraternite, Regole o addirittura la stessa Communità, non solo come parti contraenti di contratti usuali (compravendita, locazione, ecc.), ma anche di tipologie negoziali peculiari del territorio ampezzano e cadorino (consortie, vizze, alberghi), per le quali lo Statuto detta norme specifiche, regolanti anche l’attività del notaio 51. Ulteriori disposizioni in merito sono rintracciabili anche sotto forma 43 Ad es., AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prott. 42 e 43, c.1; prot. 32, c.1. 44 AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 18, c. 290. 45 FABBIANI, Notizie (1965), p. 40, doc. VI. Sull’organizzazione corporativa notarile, in assenza di uno studio specifico per i collegi del territorio bellunese, si vedano ad es. per l’area trevigiana BETTO, pp. 19-129, per quella trentina CASETTI, Il notariato, pp. 254-258, per quella friulana SOMEDA, nell’Appendice di CARLO PASQUALINI, pp. 99-132, in particolare pp. 110-115. 46 47 Statuti, p. 9, cap. XI.I. Dell’officio delli Nodari, e del loro Salario. Sulla partecipazione del ceto notarile alle élites sociali e alle cariche istituzionali di prestigio si veda, per il Cadore, la tesi di laurea della EICHER CLERE, passim. 48 Statuti, p. 9, Cap XII. Dell’officio delli nodari, e del loro salario; cap. XIV. Che non si debbano pagar gl’instromenti, se non doppò fatti & dati; p. 21, cap. LV. Del Nodaro & massaro, & suo Giuramento; p. 25, cap. LXXII. Dell’officio del Cancelliere, & suo salario; p. 34, cap. XXVII. Del scriver, & dire le coherentie del podere; p. 34, cap. XXIX. Del farsi la data, & la vendita del podere; p. 36, cap. XXXV. Che si cancelli l’instromento, per il quale si fa la data, & che si scriva esso Instromento della data; p. 114, cap. X. Dell’officio del Cancelliere del commune di Cadore; p. 134, cap. XC. Che li Sacerdoti non possano scrivere l’instromenti, né altri atti civili, ò criminali. 49 Statuti, p. 9, cap XII. Dell’officio delli nodari, e del loro salario. Questa versione del tariffario viene in seguito ulteriormente definita ed aggiornata: cfr. Statuti, pp. 150-152. 50 51 Statuti, p. 135, cap. XCI. Delli consorti, & della successione in essi. « (…) alla qual pena ancora siano tenuti tutti li nodari, che facessero instromenti di tal vendite [consortie, n.d.a.], & 20 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo di deliberazioni della Magnifica Comunità d’Ampezzo, come ad esempio quella del 1616, con la quale si stabilì che la carica di cancelliere dovesse essere ricoperta dai notai, con avvicendamento annuale: « (…) che la Cancellaria vada un anno per nodaro tale al presente si ritrova et così successivamente d’anno in anno, facendo quel tanto che appartiene al suo officio (...) » 52; oppure quella del 1662, che regolamentava la redazione definitiva delle scritture pubbliche: « ...fu determinato che per l’avvenire mentre per li nodari et cancellisti non farano fuori le scritture publice d’anno in anno non possino pretender mercede alcuna, ma senza premio, passato l’anno, siino obligati farle fuori in ottima redazione » 53. Poiché le cariche di cancelliere e di ufficiale dovevano essere ricoperte da notai di professione, alcuni di essi si sottoscrivono a volte nella duplice veste di professionista notaio e di officiale o cancelliere della Communità 54: non solo, ma nei protocolli, frammisti agli atti regolati dal diritto privato, accade di leggere anche atti che rientrerebbero più propriamente tra quelli di diritto pubblico 55. Un caso singolare, che non sembra trovare paragone in area bellunese, risulta infine rappresentato dagli atti in cui il notaio agisce al contempo sia in qualità di rogatario che di parte contraente: si tratta di una prassi piuttosto diffusa 56, che non pare ascrivibile alla difficoltà di reperire in loco un altro notaio, in quanto i casi rilevati si riferiscono a periodi in cui sulla piazza d’Ampezzo rogavano contemporaneamente almeno due professionisti. All’interno degli Statuti trova disciplina anche un aspetto di non trascurabile rilevanza per il processo di affermazione della certezza del diritto, che si sostanzia nella questione del « cavar copia dalle abbreviature » dei alienationi, & simil vendite, etiam alienationi ipso iure siano nulle, & di niun valore, & momento, come se non fossero fatte. »; p. 139, cap. CIX Delli boschi vizzati. « (…) Né alcun Nodaro possi far instromento alcuno di alcuna vizza, se non sarà deliberato, & determinato dal Conseglio. & se si trovarà qualche instromento fatto contra la forma del presente ordine sia, & habbiasi per nullo ». 52 ASCC, reg. 19: Protocollo delle delibere del Consiglio Comunale di Ampezzo, c. non num., 8 marzo 1616. 53 Ibid., c. non num., 11 ottobre 1662 e 22 ottobre 1662. Per la subscriptio cancellarii cfr. ad es. AS BL, prot. 5, cc. 200v-201r; prot. 14, c.174r; a partire dal 1752, con l’esautorazione del capitano di Botestagno, la carica di vicario e giudice d’Ampezzo fu ricoperta sempre da notai ampezzani fino al 1788 e pertanto nei protocolli si trovano talora anche atti da loro redatti nell’esercizio di tale funzione: es. ibid., prot. 52, c.2v; prot. 46, c. 20r; 41r; 74r. 54 55 Un chiaro esempio di ciò sono i cosiddetti pagamenti e stime di giustizia, atti rogati dal notaio nella sua veste di ufficiale della Comunità sulla base di decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal vicario (ossia giudice in prima istanza) d’Ampezzo; es. ibid., prot. 50, c. 33v; prot. 51, cc. 168v-169v. 56 Ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 5, c. 207v; prot. 12, cc. 129r-v, 137r, 152v; prot. 13, c. 62r; prot. 36, cc. 43r e 162r. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 21 notai morti e nella conseguente pubblicazione dei relativi rogiti 57. Tale aspetto si connette alla pratica, evidentemente diffusa nell’Ampezzano, di vendere i protocolli dei notai defunti ad altro notaio, qualora nell’ambito della famiglia non vi fossero eredi esercitanti la professione 58. Si spiega così, probabilmente, non solo la presenza di scritture di più mani all’interno di un registro, ma anche l’utilizzo dello stesso protocollo da parte di notai appartenenti a famiglie diverse 59. La pratica della conservazione dei rogiti notarili non trova peraltro alcuna forma di regolamentazione all’interno degli Statuti e, stante la perdita dei registri delle deliberazioni della Comunità successive al 1704, non è stato possibile verificare se in seguito a tale data siano state introdotte in merito precise disposizioni 60. È probabile che in Ampezzo gli antichi ordinamenti in materia notarile si siano mantenuti in vigore senza l’adozione di precisi provvedimenti ad hoc sino alla risoluzione sovrana del 3 gennaio 1788, con la quale il Governo di Innsbruck avocava esclusivamente a sé il diritto di nomina dei notai pubblici, prescrivendo che gli stessi Statuti, p. 102, cap. XXI. Se gl’instromenti delle abbreviature d’altri si debbano publicare, ò nò. « Item, fù ottenuto, & riformato, che niun Nodaro debba cavare dalle abreviature d’alcun Nodaro morto alcuna presa, ò precetto, ò instromento di debito, ò sentenza di debito, la quale, & il quale sia stato fatto già anni quindeci passati: né alcun testamento, né instromento di vendita, overo altro instromento, qual fù fatto già quarant’anni passati: se non sarà di commissione del Signor Vicario, ò se non sarà ricercato da quello, a chi si aspetta detto instromento, ò testamento ». Sull’argomento in generale REDLICH, p. 55. 57 58 Chiara testimonianza di ciò in atti del notaio Ghidini Giacomo Filippo di Simone (16061613), AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 30, c. 2r, ove si legge: « 3 settembre 1773. Da me Giovanni Antonio Constantini fu il presente protocolo comprato dal nobile signor Pietro Zanna, col esborso della summa (…) » L’uso di vendere i protocolli ad altri notai risulta invalso anche in altre zone limitrofe: si cfr. ad es. per il Trentino CASETTI, Guida, p. 856; ID., Il notariato, p. 251 ed in generale CAMMAROSANO, p. 270. Diversamente a Venezia, PEDANI FABRIS, pp. 83 e 112 ed in Friuli, SOMEDA DE MARCO, pp. 29; 41-42; 69, ove la precoce istituzione di un archivio dei notai defunti garantiva la conservazione dei rogiti. In Cadore, la terminazione dei Conservatori ed esecutori delle Leggi del 2 aprile 1754, prescriveva che i protocolli dei notai defunti, privi di figli in grado di esercitare la professione, dovessero essere consegnati all’archivista deputato del Centenaro in cui il notaio era morto; FABBIANI, Notizie (1965), p. 40 e PEDRINELLI, II/2, pp. 19-21. Così ad es. per AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 42, in cui a Gaspari Tomaso di Antonio subentra Verocai Giovanni di Giovanni Paolo, come pure Ibidem, prot. 49, ove agli atti di Ghedini Simone fanno seguito quelli di Verocai Giulio di Giovanni. In entrambi i casi risulta evidente come il protocollo del notaio defunto, evidentemente privo di successori nell’ambito della famiglia, sia stato rilevato e successivamente utilizzato da altro rogante per la registrazione dei propri atti. 59 Non sono stati infatti consultati nell’ambito di questa ricerca gli archivi austriaci di Vienna e di Innsbruck (in particolare Tiroler Landesarchiv), che conservano, oltre alle disposizioni governative di carattere generale, documentazione relativa all’Ampezzo dal 1511 in poi; cfr. RICHEBUONO, Storia, pp. 24-25. 60 22 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo dovranno (…) da qui in poi deporre il loro giuramento [presso il Governo], dove anche nel protocollo particolare si terrà nota del notaio, del sigillo e segno del notariato, che ciascuno s’avrà elletto, come pure del diploma e dove finalmente la ratificazione del giuramento verrà parimente protocollata e sottoscritta dal notaro di propria mano. All’istesso tempo si ordina che i notari apostolici debbano dimostrar al Governo se abbiano ottenuto il placeto regio per esercitar un tal diritto, mentre senza tal licenza, in qual si sia caso, resta affatto interdetto l’esercizio del notariato non meno a quelli che ai notari nominati dai conti palatini, quando non sono in stato di legitimarsi con qualche diploma principesco o governiale 61. Il 15 aprile dello stesso anno perveniva tramite l’Ufficio circolare di Pusteria una disposizione che ordinava « a’ notari di tenere e conservare gl’esemplari degl’atti da essi scritti » , mentre una richiesta volta ad accertare se gli atti dei notai venissero conservati in archivio era già stata avanzata il 25 novembre 1787 62. Se dunque per l’epoca precedente non risultano essere state adottate particolari misure in merito alla tenuta, al controllo e alla conservazione dei rogiti notarili, che venivano evidentemente trattenuti dai familiari del rogante o rilevati da altro notaio, sul finire del Settecento 63 il Governo cominciò a far sentire la propria autorità anche nella regolamentazione di tale attività, imponendo la conservazione dei protocolli presso l’archivio dell’Ufficio vicariale. Probabilmente è proprio grazie a tale disposizione che i registri, insieme alla restante documentazione del Giudizio distrettuale d’Ampezzo, sono in seguito stati trasferiti ad Innsbruck ed infine pervenuti fino a noi. 2.2. La formazione professionale. — Dalle disposizioni statutarie e dai protocolli a noi pervenuti non è possibile ricavare dati precisi sulla formazione dei notai d’Ampezzo. Neppure esistono testimonianze di un loro capitolare locale, nel quale leggere le norme in materia di preparazione e corso di studi. Tuttavia pare verosimile ipotizzare che per accedere alla professione non fosse in quest’epoca necessariamente richiesta alcuna conoscenza specifica della materia giuridica 64. 61 AS BL, Giudizio distrettuale Ampezzo, Atti politici-amministrativi diversi, b. 241, fasc. 1788. Cfr. anche Ibidem, b. 372, reg. 2: Repertorio degli ordini sovrani 1787-1794, sub littera N, n. 16. Sull’argomento NESCHWARA, pp. 515-519. AS BL, Giudizio distrettuale Ampezzo, Atti politici-amministrativi diversi, b. 372, reg. 2: Repertorio degli ordini sovrani 1787-1794, sub littera N, n. 338. 62 63 Ciò evidentemente in seguito alle prime riforme costituzionali di Maria Teresa d’Austria, ma soprattutto di Giuseppe II, che nel 1787 introdusse un nuovo ordinamento di procedura civile, cui l’anno dopo seguì quello penale. Tra le riforme imposte, fu previsto anche che la carica di giudice fosse ricoperta da giuristi di professione e funzionari approvati dallo Stato: pertanto dal 1789 in poi i vicari d’Ampezzo furono sempre forestieri, e i notai locali, generalmente non laureati, poterono rivestire soltanto la carica di vicevicari, come sostituti del titolare in sua assenza, RICHEBUONO, Storia, pp. 257-258. 64 Sulla scarsa preparazione dei notai per i secoli in questione si vedano in generale FALCONI, Lineamenti, p. 141; per il Bellunese ALPAGO NOVELLO, p. 938; per i territori di veneta I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 23 Si può solo presumere che gli aspiranti notai seguissero in Ampezzo la scuola d’istruzione elementare 65 ed in seguito potessero frequentare dei corsi di studio nella vicina Pieve di Cadore, ove esisteva una scuola superiore di latino 66; per quanto riguarda invece eventuali studi di specializzazione, si esclude che fosse richiesta la frequenza di corsi giuridici a livello universitario 67. La primaria, fondamentale istruzione, che — a giudicare dal tenore degli atti — in molti casi non andava forse oltre l’apprendimento della grammatica, doveva poi essere corredata da un periodo di tirocinio presso un notaio: la formazione notarile si sostanziava dunque nell’imprescindibile ed essenziale funzione svolta dall’apprendistato pratico 68, con il quale si acquisivano probabilmente anche quegli elementi di cultura generale e quei rudimenti del diritto privato, che stanno alla base dell’ars notariae. Molto spesso la pratica veniva svolta nell’ambito familiare, poiché la professione risulta evidentemente trasmettersi di padre in figlio, o comunque attraverso la parentela, dando luogo a vere e proprie dinastie di notai, dai cognomi di famiglia e nomi di battesimo ricorrenti 69. A riprova di ciò si segnala che nel medesimo protocollo notarile si trovano spesso atti registrati da diversi membri della famiglia, talora numerati senza soluzione di continuità 70. 2.3. Le tipologie contrattuali. — Come si può rilevare anche dalla nota di possesso di seguito trascritta, le tipologie contrattuali maggiormente testigiurisdizione GRANDI VARSORI, p. 19 e, limitatamente ai secc. XIII-XVI, BETTO, pp. 82-83; per l’area imperiale GRZIWOTZ, pp. 179-183. Per l’area atesina il BEZZI, pp. 9-10 afferma addirittura che « (…) nel Seicento, quando alla vacuità del secolo si accompagna l’uso del volgare in luogo del latino notarile (…) l’ignoranza del notaio era proverbiale. ». 65 La cui esistenza è ipotizzata in Ampezzo in maniera stabile a partire dal 1356, allorquando il Comune cominciò a mantenere il cappellano di Santa Caterina, cfr. L’istruzione, p. 3. 66 FABBIANI, Notizie (1964), p. 14; ID., L’istruzione, p. 3. In particolare, un primo esame condotto sulle matricole dei laureati in utroque jure presso l’Università di Padova, ha dato esito negativo; si è invece propensi a pensare come più probabile l’eventuale iscrizione a corsi specifici di ars notariae attestati in area friulana, non solo ad Udine e a Cividale, ma anche a San Daniele del Friuli, ove una scuola di grammatica e ars notariae fu attiva fino al 1770, secondo SOMEDA DE MARCO, pp. 32-33; cfr. FABBIANI, Notizie (1964), p. 14; SCALON, pp. 99-101. Rispetto a tali sedi, pare più probabile un eventuale completamento degli studi ad Innsbruck, ove, stando a RICHEBUONO, Storia, p. 253, le matricole dei laureati presentano un discreto numero di studenti ampezzani. La mancanza di una formazione culturale a livello universitario era comunque usuale nella classe notarile e tale titolo non fu mai richiesto per l’esercizio della professione nemmeno a Venezia, ove su settecento notai appartenenti al Collegio, soltanto tre risultano laureati, come evidenziato da PEDANI FABRIS, p. 169. 67 68 Così FALCONI, Lineamenti, p. 141; sull’argomento anche GRZIWOTZ, p. 181; PEDANI FABRIS, pp. 64-65; BERENGO, p. 386. 69 Su tale aspetto ad es. BERENGO, pp. 388-389. Si vedano ad esempio AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 45, contenente atti dei notai Giovanni, Giulio, Gaetano e Giovanni Paolo Verocai, oppure prot. 41, che raccoglie indistintamente gli atti di Giovanni Verocai e del figlio Giovanni Paolo, o ancora il prot. 23, dei fratelli Giovanni Antonio e Benedetto Constantini di Nicolò. 70 24 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo moniate nei protocolli notarili d’Ampezzo sono, così come per l’area giuridica italiana 71, i contratti di disposizione di beni immobili, specialmente fondiarii, e tra questi in particolare l’emptio-venditio denominata negli Statuti anche vendita o alienatione, ma nella prassi notarile locale esclusivamente compera o compreda 72. Prottocollo segnato letera O di me Giovanni Verocai, publico nodaro d’imperiale autorità et collegiato d’Ampezzo imperiale… nel quale si contengono instromenti di vendita, compreda, permute, dattioni in pagamento, stime, dotti, compromessi, sentenze arbitrarie, patti, concordii, quietationi, divisioni, testamenti, codicilli, donationi et d’ogni altro genere e nattura, che vi accaderanno a scrivere di scritture publiche non sol in avvenire, ma etiamdio rogate per l’adietro per me nodaro e qui reggistrate ad perpetuam rei memoriam, per ordine d’alfabetto e in questo ordine continuerò sino a piacere di sua divina Maestà, a maggior gloria sua, a beneficio de persone publiche et private et anco di me stesso, che Dio m’aiuti, come di dentro si contiene. Signum mei [signum tabellionis] tabellionatus. Ad laudem Dei 73. La forma dell’atto, pur ricalcando di massima quella prevista dai più comuni manuali notarili 74, assume nei formulari connotati che differiscono da quelli usuali nei territori circonvicini 75 e le cui caratteristiche sono informate al modello che segue, risultante dalla collazione di numerosi atti dei primi decenni del ’600: n. per se et suos heredes, iure proprio, in perpetuum, liberam quidem francham nullique servituti obnoxiam, dedit, vendidit et tradidit n. ementi et recipienti ... salvis verioribus confinibus. Ad semper habendum, tenendum et posidendum et cetera, cum omnibus et singulis et cetera, cum accesionibus et egresionibus suis et cetera, omnique iure et cetera, et hoc nominatim pretio foro et definitivo per ante dictos testes, delato prius debito iuramento ... quam extimationem ambes partes laudaverunt et probaverunt. Quod pretium dictus venditor contentus et confessus fuit se ab eodem emptore habuisse et recepisse et cetera. Constituens nullam inferre litem neque inferenti consentire sub obligatione dupleri extimationis; promitens et cetera, pro ut in forma. Tale formulario si mantiene sostanzialmente costante per il resto del secolo e per tutto il successivo, anche attraverso la progressiva volgarizzazione, non sempre omogeneamente adottata: 71 Sulla preponderanza di tale tipologia contrattuale nei protocolli notarili della penisola italiana molteplice è la letteratura: cfr. ad es. CAMMAROSANO, p. 271 ed, in particolare RICHEBUONO, Atti, pp. 6-7 e Storia, pp. 250-251. 72 Statuti p. 32, cap. XIX. Della compreda fatta da Alcuno. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 45, notaio Verocai Giovanni di Giovanni Paolo (1737-1741), c.1. 73 74 Per i formulari impiegati in area veneta nel periodo in questione in particolare FACIO, pp. 124-128; PEDRINELLI, I/1, pp. 74-76. In generale per l’area italiana FALCONI, Lineamenti, pp. 158-190 e MORELLO-FERRARI-SORGATO, pp. 111-125. 75 Per un confronto con i formulari del Bellunese cfr. ad es. Il notariato, pp. 66-67. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 25 n. come persona di sua ragione, di ragion propria et in perpetuo, libera, franca et senza alcuna gabella 76, per sé et heredi suoi, ha datto, venduto et trato a n. per sé et suoi heredi stipulante, comprante et recipiente ... salvi li più veri confini, se ne fussero. Ad haver, tener et posseder et far quanto al detto comprator parerà et piacerà con tutte quelle ragioni ... et questo per pretio … confessò et manifestò esso venditor haver hauto et riceuto et di quello si chiamò interamente pagato et sodisfatto, renuntiando ad ogni ecetione. Ponendolo in possesso di detto ... et che di quello disponer possa come patron absoluto. Promettendo il venditor per sé et heredi suoi al comprator per sé et heredi stipulante la presente venditione et tutte le cose nel presente instrumento contenute perpetuamente da qualunque molestia, persona, in giuditio et fuori, a sue spese et pericoli legitimamente defender et mantener, soto obligatione di altri suoi beni presenti et venturi et cetera. Il contratto di compravendita appare qui tanto più diffuso per il fatto che sotto la denominazione di compera o compreda vengono incluse nei protocolli ampezzani anche tutte le forme contrattuali di livello, nomen iuris che non risulta quasi mai impiegato né nel formulario dell’atto, né nei repertori notarili coevi e che invece ricorre negli Statuti 77. Nell’ambito di tale fattispecie, la tipologia più attestata appare quella che nell’area d’influenza veneziana viene identificata come livello francabile veneto 78. Questa forma di contratto, 76 Al volgere del secolo XVIII tale formulario si arricchisce dell’ulteriore specifica: « (…) libera e senza servitù fuorché la steura provinciale (…) », come ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 54, c. 24v. Statuti, p. 144-145, cap. XXXIII. Delli livelli. « Commandiamo, & ordiniamo, acciò che li poveri non siano oppressi, che il Signor Vicario debba amministrar Giustitia sommariamente, & senza strepito di giudicio à ciascuno, che si dolerà, che li livelli siano scossi troppo eccessivamente; & se vederà alcuno defraudato nell’esattione di simili Livelli à tempo, ò perpetuo, il qual eccedi la summa di lire sei per cento, cosi da pagarsi in biada, come in denari; & questo sotto pena di lire venticinque de piccoli da pigliarsi ad esse parti, che contrafaranno, & di perdere il capitale, & che il contratto Ipso Iure sia nullo, & di niun valore, & momento. Et nell’istessa pena incorrano li Nodari, che scriveranno tali contratti, alli quali non si presti fede alcuna, & sotto pena anco del pergiuro. Dichiarando, che delli Livelli passati, gli obligati à dar quattro calvie per centenario non possino essere astretti, & obligati à più di soldi trenta per ciascuna calvia di segala. Et li obligati à tre calvie, non s’astringhino, né sforcino, se non à soldi quaranta per ciascuna calvia, & l’istessa s’intende delli Livelli, nelli quali si debba pagare frumento talmente, che il pagamento non ecceda la somma di lire sei per cento, & sia in libertà de gli obligati à pagar detti Livelli in pagarli in dinari, ò in biada per la somma, ò quantità, come si è detto, & di più, che gli Avvocati, & Procuratori, che saranno ricercati d’avvocare sopra qualche patto, ò di procurare sopra il negocio d’essi Livelli, havendo competente mercede, siano tenuti, & debbano avvocare, & procurare sotto pena di lire vinticinque de piccoli d’applicarsi alla corte. ». 77 Per il livello come forma di contratto agrario agrario cfr. in generale BENEDETTO; per il livello veneto in particolare FERRO e più specificatamente PEDRINELLI, I/1, pp. 50-52; si segnala che il formulario ivi riportato non corrisponde però a quello impiegato in area ampezzana. Ampia trattazione di tale fattispecie contrattuale per l’area veneta in VENDRAMINI, La mezzadria, pp. 2628; CORAZZOL, Fitti, pp. 15-16; ID., Livelli, part. pp. 13-14; BRUNORO, pp. 208-213; KNAPTON, pp. 426-428. 78 26 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo meglio nota nella storia del diritto italiano 79 come vendita livellare, non equivaleva nella sostanza al contratto di locazione agraria (la locatio-conductio del diritto romano), bensì ad un negozio avente per oggetto la concessione di un prestito con relativa garanzia su un bene immobile, redatto però secondo il formulario proprio della compravendita. L’atto di livello risultava pertanto costituito da due contestuali momenti negoziali: alla formulazione propria del contratto di compravendita si aggiungeva quella di concessione del medesimo bene a titolo di affitto su pagamento del relativo canone annuo, che corrispondeva di fatto all’interesse del prezzo di vendita. Generalmente vi era poi inserita una clausola (promissio francandi) con la quale l’acquirente-prestatore si obbligava a restituire al venditore-beneficiario la piena proprietà del bene, una volta avvenuta la restituzione del capitale e nel caso non vi fossero interessi decorsi in sospeso 80. Il negozio potrebbe sostanzialmente assimilarsi a quello dell’attuale ipoteca, con la principale differenza che il livello francabile si configura come un atto di vendita fittizia, per sottrarsi a possibili accuse di usura 81. Per l’Ampezzano, la fattispecie in parola si presenta diplomatisticamente come un unico atto di compera, seguito da una contestuale disposizione con la quale il bene venduto viene concesso in affitto su corresponsione di un canone annuo, generalmente pari al 5% del prezzo di vendita 82. Ciò che appare significativo nell’ambito di questa tipologia negoziale è l’elevata frequenza con la quale una delle parti contraenti è costituita da personalità pubblica: più precisamente si tratta spesso della Comunità d’Ampezzo, che agisce nella veste di prestatore verso un privato. In questo specifico caso il termine entro il quale la somma dovrà essere restituita per rientrare in possesso del bene non viene indicato, poiché si fa semplicemente riferimento a invalse consuetudini, come evidenziato dal relativo formulario che nel corso 79 LEICHT, Il diritto privato, III, pp. 122-125 ed in particolare Il diritto privato, II, p. 140: « [Tale contratto] è da distinguersi dall’uno [livello comune] e dall’altro [livello di tipo locatizio] di questi due tipi di livello la così detta vendita livellare, molto comune nei tempi andati. Per essa un proprietario di beni immobili verso il pagamento di una certa somma datagli da una persona che dicevasi compratore, si assoggettava al pagamento d’una annua prestazione gravante sul fondo a titolo di livello. Nei formularii notarili dei secoli XVI-XVIII, un tale contratto era definito come vendita di livello. Era uno dei mezzi escogitati per sfuggire alle censure lanciate dalla Chiesa (...) ». 80 CORAZZOL, Livelli, p. 13; per il formulario cfr. PEDRINELLI, I, pp. 50-52. Statuti, p. 42, cap. LXIII. Che non s’impresti danari ad usura; cap. LXIV. Di quello, che comprarà Possessioni, ò case, & prometterà restituirle frà un certo tempo. A tal proposito si segnala che i notai ampezzani non adottano mai nei loro protocolli la denominazione di livello, altrove comunemente in uso; viceversa, presso l’ASCC e l’ARAMP esistono vari registri di riscossione dei canoni derivanti da tali contratti stipulati dai medesimi notai ampezzani tra la Comunità e/o la Regola ed il singolo, denominati Libri dei livelli. 81 Nel resto del Bellunese il contratto risulta spesso costituito da due atti veri e propri, l’uno di compravendita e l’altro di contestuale locazione, con l’esplicita indicazione delle modalità e del termine dell’affrancazione ed un canone d’affitto più elevato (generalmente il 6%). 82 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 27 del secolo XVII risulta particolarmente sintetico (es. « la Comunità li affitta detta terra pagando l’affitto conforme è affittato alli altri ») 83. La frequenza dei prestiti concessi dalla Magnifica Comunità d’Ampezzo ai privati mediante tale forma di transazione va verosimilmente ascritta al fatto che questo sistema permetteva agli abitanti della vallata di acquisire denaro in prestito, senza ricorrere al finanziamento da parte di speculatori esterni, ovverosia senza il rischio di cedere le proprie terre a forestieri 84. Dopo le compere e i testamenti nuncupativi, le tipologie più frequentemente ricorrenti sono quelle riconducibili alle varie forme di disposizioni dei beni dotali: diversamente dall’usus affermato nel resto del Bellunese, risultano rarissime le carte di dote stipulate all’atto del matrimonio, mentre sono assai più numerose le quietanze di dote, per lo più rogate molti anni dopo le nozze. Ben testimoniate sono poi le divisioni ereditarie, e, a seguire, le permute, le donazioni, le quietanze, le cessioni, le emancipazioni, i legati, le cauzioni, le procure, i patti e gli arbitrati, noti quest’ultimi con il nomen iuris proprio e tipico di concordi. Tipologie più sporadicamente attestate sono invece il fedecommesso, la confessione di debito, la cosiddetta recupera (retrodazione di un bene) ed il patrimonio clericale (costituzione di una rendita per il futuro sacerdote) 85. La forma testamentaria adottata è nella quasi totalità dei casi quella nuncupativa: in misura assai minore sono attestate le cedole sacerdotali, per la redazione delle quali l’uso della lingua latina persiste nel formulario ancora per tutto il secolo XVIII. Pressoché assenti risultano invece i testamenti olografi, peraltro non esplicitamente previsti dagli Statuti 86. Va ricordato che nell’Ampezzano i testamenti e gli atti ad essi assimilati non risultano dar vita ad una serie documentaria particolare e distinta, ma venivano registrati frammisti agli altri contratti, a differenza di quanto avveniva nello stesso periodo in Cadore ed in generale nelle zone circonvicine di legislazione veneziana 87. Un 83 Così AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 36, c. 253r, (anno 1629). Significativo anche il formulario Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 9, c. 141v-142r (anno 1697): « Li sopradetti signori cappi (…) danno, locano ed affittano a (…) per il tempo che parerà alla Magnifica Communità con obligazione di pagar in questo mentre il solito affitto in ragione di lire 5 per ogni cento, iusta l’uso del paese ». Sull’argomento cfr. Due Soldi, Toponimi ampezzani, p. 4. 84 Su tale aspetto si soffermano brevemente ALVERÀ, p. 111 e RICHEBUONO, Atti, pp. 6-7. Cfr. FACIO, p. 172; PEDRINELLI, I/1, p. 5. Sulla particolarità linguistica di tale atto, che sino alla fine del secolo XVIII viene redatto interamente in latino, ci si soffermerà più oltre. 85 86 Ne è un raro esempio la carta inserta in AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 49, c. 62v. Cfr. Statuti, p. 56, cap. CIX. Delli testamenti. Una particolare norma statutaria adottata in Ampezzo dopo il 1615 stabiliva che i testamenti dovessero essere pubblicati entro un mese dalla morte del testatore, pena la nullità dell’atto: Statuti, p. 160, Circa li Testamenti. 87 Così ad esempio nei restanti territori dell’attuale provincia di Belluno, dove tale uso si riscontra in maniera sporadica già durante il sec. XVII e si fa sempre più frequente durante il corso del XVIII, fino a divenire costante nella seconda metà del secolo; ciò probabilmente già per effetto del richiamo all’applicazione delle leggi vigenti in materia, rivolto dal Senato ai Rettori di Terraferma l’8 agosto 1744 e successivamente in esecuzione della terminazione dei Conservatori alle Leggi del 17 febbraio 1755; PEDRINELLI, II/2, pp. 42-44; 173. 28 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo approfondimento a parte meriterebbero poi le cosiddette stime ed i pagamenti di giustizia, che si configurano come atti registrati in sede impropria, in quanto redatti dal notaio nella sua veste istituzionale di ufficiale della Comunità, cioè nell’esercizio dell’attività di funzionario ad acta e non di libero professionista ad instrumenta. 2.4. Le formule del documento. — Una certa essenzialità nei formulari, che si evidenzia per tutti i protocolli e per quasi tutte le tipologie di atti, appare come caratteristica peculiare costante dell’attività notarile ampezzana, con qualche eccezione, soprattutto nell’ambito delle disposizioni di ultima volontà, che presentano spesso un’ampia e colorita varietà nell’esposizione delle arenghe. Circa i modi di espressione dell’invocatio, nella generalità dei casi appare maggiore l’impiego della forma « In Christi nomine », talora alternata alla variante « In nomine Christi ». Altre modalità espressive ricorrenti sono « Nel nome di Christo... », « Nel nome del Signore », oppure « Nel nome di Christo salvator nostro », o ancora « Nel nome della santissima et individua Trinità. Padre, Figliolo et Spirito Santo ». L’alternanza nell’impiego dell’una e dell’altra espressione, come pure del latino o del volgare, non sembrano dipendere dall’epoca di redazione dell’atto, bensì unicamente dalla discrezionalità del notaio. È tuttavia rilevabile come nel corso del secolo XVIII si faccia via via sempre più raro il ricorso alla lingua latina nell’invocatio ed in generale in tutto il protocollo del documento, ove si era conservata a lungo, quasi cristallizzata, quale forma di solennità sacralizzante l’intero atto notarile. Per quanto riguarda le date di tempo e di luogo, poste sempre nel protocollo del documento e mai nell’escatocollo 88, l’anno viene indicato sulla base dello stile moderno, corredato dall’indicazione del ciclo indizionale secondo l’uso detto romano (o pontificio): solo raramente l’indizione viene espressamente qualificata come romana 89. La formula usata nell’enunciazione della data (« Anno ab eiusdem Nativitatis… »; « L’anno della sua Natività… »; « Anno Domini… »; « L’anno dell’Incarnazione del nostro Signore… ») non sempre rispetta lo stile adottato e non va dunque intesa in senso proprio 90. All’indicazione dell’anno segue quella consueta del giorno del mese e, assai di rado, della settimana. La data topica oscilla tra le forme « In Cortinam Ampitii, iurisdictionis arcis Bottestagni »; « In Cortina d’Ampezzo, iurisdition arciducale della fortezza di Bottestagno »; « In Cortina d’Ampezzo arciducale »; « In Cortina d’Ampezzo »; « In Ampezzo arciducale »; « In Cortina d’Ampezzo, iurisdizione imperialle della fortezza di Bottestagno »; « In Am88 Tranne nel caso dei testamenti, che solo talora riportano la datatio al termine dell’atto, come del resto usuale per la tipologia. 89 Ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 48, c. 280r. « Non ha in genere una precisa rilevanza ai fini della determinazione dello stile effettivamente usato », come precisa VALENTI, p. 86. 90 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 29 pezzo imperiale », etc. La forma più frequentemente attestata è senz’altro quella che definisce il territorio d’Ampezzo come dipendente dalla giurisdizione del castello di Bottestagno: l’alternanza della qualifica di Ampezzo come imperiale o arciducale deriva invece dal riferimento al rappresentante della Casa d’Austria che deteneva in quel momento la titolarità del governo del Tirolo e, di conseguenza, la sovranità d’Ampezzo. Piuttosto rara risulta la forma espressiva che collega il territorio ampezzano direttamente all’Austria 91, mentre va decisamente sottolineata la resistenza da parte di alcuni notai nel definire Cortina d’Ampezzo come facente parte del Cadore 92, anche a molti anni di distanza dalla sua annessione all’Impero. La localizzazione geografica viene poi normalmente completata dall’ulteriore puntualizzazione relativa al preciso sito di rogazione, sia che si tratti di una frazione del territorio ampezzano, sia che si voglia indicare la sede fisica in cui il notaio si trova a rogare, ad es.: « in domo, in stupha o stuffa mei notarii » oppure, in volgare, « in casa di mia solita abitazione »; « in casa di mio padre », o ancora « in casa di me infrascritto notaro », espressione quest’ultima ricorrente nella maggior parte dei casi, da cui si ricava che i notai ampezzani rogavano tendenzialmente presso la propria abitazione e non erano soliti spostarsi presso quella del cliente. Un breve accenno meritano gli atti dell’ultimo decennio del ’700, ed i pochi documenti redatti durante il periodo del dominio bavarese (1805-1809), che presentano una forma di datazione assai più stringata, di stampo prettamente cancelleresco, non preceduta da invocatio e priva d’indicazione indizionale (es. « Actum Ampezzo, li 22 marzo 1792 ») 93. Il protocollo del documento si chiude infine con l’indicazione dei testimoni, presenti generalmente in numero di due, tranne nel caso di disposizioni testamentarie, che ne richiedevano almeno cinque, o di altri particolari atti d’interesse pubblico. Anche in questo contesto il formulario risulta espresso alternativamente in latino (es. « presentibus… testimonis habitis et rogatis ») o in volgare (es. « alla presenza di… testimonii hauti »), indipendentemente dall’epoca. 91 Cfr. ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 4, notaio Constantini Pietro di Francesco (1620-1634), passim: « In Ampitii iuresdictionis arciducalis Austriae, regnante feliciter serenissimo domino Leopoldo arciduca ». 92 Così ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 30, notaio Ghidini Giacomo Filippo di Simone (1606-1613), passim: « Ad Cortinam Ampicii Cadubri, iurisdicionis imperiali arcis Bottestagni ». 93 In AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 25, tale uso si trova attestato con continuità già a partire dall’anno 1792, cc. 63 ss; diversamente ibid., prott. 54 e 55, ove questa forma di datazione ricorre sistematicamente solo nei rari documenti del periodo bavarese, successivi cioè al 1806. Oltre all’assenza pressoché totale di protocollo ed escatocollo, questi atti presentano una progressiva ed estrema sintesi del formulario, e talora anche la mancanza della notitia testium, sostituita dalla sottoscrizione del rogante, che non si qualifica più come notaio, ma come semplice rogatario, es. « Giovanni Antonio Verocai scrisse e testimoniò » (prot. 54, c. 92r). Altrove manca invece la sottoscrizione del rogatario e compaiono quelle dei testimoni, in forma sia allografa che autografa (prot. 54, c.80v; prot. 55, c.2r e c. 94v). 30 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Nell’ambito del mesocollo, di cui si sono già visti i formulari dispositivi più ricorrenti, va segnalata la particolare forma di corroborazione attestata nel caso in cui la parte contraente sia persona di sesso femminile: in tale circostanza infatti, a conferma della veridicità dell’atto, la donna doveva toccare con la propria mano l’instrumentum. In tal caso la formula conclusiva del documento, posta appunto in sede di corroboratio, risulta essere la seguente: « et per segno della verità la sudetta donna … ha toccato il presente instromento con la mano propria ». Tale uso va ricondotto alla non piena capacità giuridica riconosciuta alla donna: qualora infatti agisca come auctor di un negozio, appare sempre rappresentata o assistita da persona di sesso maschile, ad eccezione che negli atti di ultima volontà. La sua ridotta capacità giuridica è rilevabile anche dallo specifico formulario adottato nel caso in cui sia protagonista di atti non testamentari: al consueto dettato dispositivo si aggiunge in tal caso la clausola cautelativa « non per forza, né paura, ma di sua propria et vera volontà » 94. Passando alla parte finale del documento, si può affermare che l’escatocollo in senso proprio, ove presente, si riduce alla sola espressione dell’adprecatio, generalmente nelle forme di « Laus Deo », « Ad laudem Dei », « Laus Deo semper » o « Laus Deo optimo maximo ». In alcuni casi si riscontra la presenza di adprecatio impropria in sede di protocollo dell’atto, sia a completamento dell’invocatio (« amen », o « così sia »), che in forma autonoma, in luogo di essa (« Laus Deo semper »). Manca invece l’elemento che generalmente in area bellunese caratterizza questa sezione dell’instrumentum, ovverossia la sottoscrizione del notaio, nonostante essa venga quasi sempre annunciata nel protocollo dell’atto 95; negli sporadici casi in cui sia presente, non si accompagna mai al signum tabellionis, che compare solo sulla prima carta del registro 96, ad autenticazione dell’identità del notaio. I rari esempi di segni tabellionali in calce agli atti sono stati rilevati solo negli instrumenta in mundum, oppure nel caso in cui il documento sia redatto dal notaio nella sua veste di vicario d’Ampezzo 97. 94 Ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 31, cc.53v-54r; Ibidem, prot. 37, c. 42r: cfr., seppur con qualche lieve lapsus di trascrizione, Il notariato, p. 67. Si veda l’instrumentum riprodotto alla tavola n. 7. 95 Ove appunto, la datatio topica viene frequentemente specificata dalla formula « in casa di me infrascritto nodaro ». 96 La sottoscrizione ed il segno del notaio espressi in questa sede, costituivano probabilmente sufficiente elemento di convalida per tutti gli atti registrati nel protocollo, come attestato anche per i notai trentini, CASETTI, Il notariato, p. 253; nei protocolli del Bellunese, ove spesso i notai apponevano in calce all’atto la propria sottoscrizione, l’uso di tracciare in tale sede anche il proprio segno d’autenticazione va estinguendosi già nel corso del sec. XVI, e pertanto risulta pressoché assente per i secoli qui considerati. 97 Ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 44, c. 100v. Alcuni segni tabellionali dei notai ampezzani sono stati riprodotti e pubblicati da RICHEBUONO, in Due Soldi, Segni; per un confronto con segni notarili di area cadorina vd. FABBIANI, Notizie, passim; per alcuni esempi di area bellunese Il notariato, pp. 50-51. Sull’evoluzione, il significato e l’iconografia del sigillo notarile in generale BRESSLAU, p. 606; cfr. DE LORENZI, II, passim. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 31 I signa attestati sono per lo più tracciati manualmente ad inchiostro nel corso del ’600, ma già a partire dalla fine del secolo XVII, similmente a quanto avviene in area veneta 98, compaiono i primi sigilli ad impressione, che venivano apposti con matrici in legno o in metallo: è questo ad esempio il caso del notaio Giacom’Antonio Alverà, che nella prima carta del suo protocollo del 1753 imprime il proprio signum notarii, timbrato presumibilmente a fumo 99. Altrettanto rare risultano le sottoscrizioni dei testimoni, per lo più presenti in forma allografa 100 e, ancor più sporadicamente, in forma autografa 101. Una particolarità tipicamente locale — comune anche ad altri territori montani — risulta quella dell’impiego a tale fine dei segni di casa 102, simboli convenzionali distintivi di ogni nucleo familiare appartenente ad una Regola, generalmente incisi o impressi a fuoco sugli strumenti da lavoro, sul legname e, spesso, sul colmo del tetto dell’abitazione. In calce al documento i segni di casa compaiono sia in luogo della sottoscrizione, che in aggiunta ad essa, probabilmente con il duplice scopo di elemento distintivo e di corroborazione 103. Talora invece il segno di casa, autografo, veniva tracciato dal testimone per sua incapacità di scrivere, affiancando la sottoscrizione allografa, estesa per mano del notaio 104. 2.5. La lingua. — La lingua impiegata è prevalentemente quella volgare, come del resto appare consentaneo agli usi notarili attestati per tutta quanta l’area bellunese e cadorina, durante il periodo qui considerato. Si tratta più precisamente di un volgare d’ambito veneto 105, che non differisce nella 98 A Venezia tale uso si fece comune a partire dal 1650, e fu successivamente imposto dai Conservatori ed esecutori delle leggi il 26 agosto 1779: PEDANI FABRIS, p. 86; cfr. DE LORENZI, vol. II, p. 6. Si noti che in Cadore i primi ad adottare il segno tabellionale ad impressione furono i notai Vecellio, già a aprtire dal 1540, cfr. FABBIANI, Notizie (1964), p. 20. In Ampezzo il primo sigillo timbrato risulta essere quello del notaio Verocai Giovanni Paolo di Giovanni, presente sulla coperta dell’indice delle parti coevo al prot. 39 (1674-1678), AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, b. 59. 99 Riprodotto alla tavola n. 2. 100 Ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 3, c. 218; prot. 5, c. 110v; prot. 21, c. 183v; prot. 22, c. 71v; prot. 54, c. 75v. 101 Così AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 1, cc. 111v e 115v; prot. 5, c. 62r-v; prot. 54, c. 75v. 102 In generale, sui segni di casa dell’area cadorina e comelicense, MARCUZZI e, più recentemente, PAIS BECHER-MARTELLA, mentre un dettagliato repertorio dei segni di casa ampezzani è in Vocabolario ampezzano, pp. 335-337. 103 Ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 4, cc.19v-23r (segni privi di sottoscrizione); prot. 25, cc. 36r-39v (segni con sottoscrizione, allografi,); prot. 28, cc. 66v, 96r e prot. 54, c.4v (segni con sottoscrizione, autografi). 104 Ne è esplicito esempio l’ultima sottoscrizione dell’atto, prot. 54, c. 4v. 105 RICHEBUONO, Storia, p. 114, la definisce « veneto con inflessioni locali ». È del resto naturale, stanti la lunga appartenenza del territorio ampezzano al Cadore e gli stretti rapporti commerciali, oltre che politici, intrattenuti con Venezia: solo a titolo di esempio si ricorda che gli Ampezzani vi detenevano il monopolio nel commercio delle perle false, come si rileva anche da numerosi atti registrati nei protocolli notarili. Su questo aspetto in particolare TRIVELLATO, p. 249. 32 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo sostanza da quello in uso nei protocolli notarili degli altri territori del Bellunese; potrebbe definirsi di tipo « documentario », poiché, discostandosi palesemente dalle parlate dialettali d’uso quotidiano delle zone considerate — spesso profondamente differenti tra loro — risulta ovunque adottata come lingua scritta nella stesura degli atti ufficiali. Presenta le usuali persistenze del latino, consuete nel glossario tecnico notarile (item, in presentia, rogatus, in fidem, in quorum, et cetera) come pure l’impiego di latinismi (infrascritto, hauti, laudato, onoranda, astretti), d’ipercorrettismi (havvendo, frattello, ritto, elletto, cappi, capittaneo, ittem) e secondariamente di prestiti immediati dal dialetto (dapoi, varda, in suso, zoso, cau, dasa). Per quanto attiene alla sintassi, al di là dei consueti formulari, si rileva una prevalenza del costrutto ipotattico in particolar modo in quegli atti che richiedono una definizione dell’oggetto particolarmente complessa 106. La peculiarità linguistica della valle d’Ampezzo è costituita da un dialetto appartenente al ladino dolomitico e più propriamente cadorino, ben poco contaminato da parlate tedesche o comunque appartenenti al ceppo germanico, malgrado quattro secoli di dominazione austriaca 107. Ma la lingua d’uso quotidiano — come poc’anzi enunciato — affiora solo in minima parte negli atti notarili 108, emergendo evidentemente solo nelle tipologie in cui maggiore è lo spazio riservato alla descrizione dell’oggetto. Ne sono frequenti esempi tutti quei termini indicanti utensili ed arnesi d’uso quotidiano (bràndol, stramàz, stùa) ricorrenti soprattutto negli atti di stima, nelle divisioni, negli inventari di dote; così pure i vocaboli d’immediato riferimento al territorio e all’ambiente naturale (spona, lasta, vara, trozo, tizòn, luda, rù, pezzo, avedino, zirmolo) e più specificamente i toponomini, frequenti soprattutto negli atti di vizza e di albergo, che nell’ambito degli atti costituiscono gli indicatori principali della lingua parlata e della sua specificità (es. Picia de Parù, Parù de ra Fava, Pian del Lova, Rufredo, Antruilles, Padevon, Travenanzes, Proguoito) 109. Molti di questi vocaboli appaiono in qualche misura nobilitati e 106 Si confronti a tal proposito la trascrizione degli atti di vizza e di albergo, riportata nella sezione successiva. 107 Su ciò in particolare KRAMER, Voci (1984), p. 8 e passim. Sulla posizione dialettale di Cortina d’Ampezzo ci si limita qui a ricordare lo studio sul ladino dolomitico di ALTON, seguito dal vocabolario del MAJONI e soprattutto dagli studi di BATTISTI, Storia; La Posizione; Prefazione; inoltre MENEGUS TAMBURIN, Il Dialetto e Dizionario. Più recentemente RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 132-133; ID., Storia di Cortina, pp. 20-30 ed in particolare PELLEGRINI, Prefazione, pp. VII-XIV e CROATTO, in Premessa al Vocabolario ampezzano, pp. XV-XIX; per un confronto con il dialetto ladino del restante territorio cadorino, PELLEGRINI, I dialetti, pp. 249-265. Per una sintesi aggiornata sulle attuali problematiche connesse al significato e all’identità del ladino ID., La genesi, corredato da ricca bibliografia. Sul lessico PELLEGRINI-BARBIERATO, ad vv. Alcuni esempi di termini dialettali impiegati negli atti sono rilevabili dalle trascrizioni dei documenti che seguono nella sezione apposita. 108 109 Per il significato delle voci di uso quotidiano si rinvia a Vocabolario Ampezzano, Vocabolario Italiano-Ampezzano, e MAJONI, ad vv., mentre, per un confronto con analoghi termini del I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 33 « italianizzati » rispetto alle forme dialettali vere e proprie 110, per cui si ha, ad esempio, Rufredo anziché Rufiedo; Padevòn anziché Padeòn; trozzo in luogo di trozo per sentiero; pezzo in luogo di pezuò per abete rosso; cessa per zèsa, tratto di terreno che circonda la casa; stupa in luogo di stùa, per designare la stanza d’abitazione della casa ampezzana. La lingua latina, che risulta prevalente soltanto nel più antico dei protocolli 111, permane in uso a lungo solo limitatamente alle parti invocative ed ai formulari; continua invece ad essere impiegata per l’intera stesura del documento sino a tutto il secolo XVIII nel caso di alcuni particolari atti, di più immediata influenza colta o d’ambiente ecclesiastico, quali i patrimoni clericali e le cedole testamentarie. Un’ulteriore precisazione merita la particolarità della lingua impiegata nel privilegio notarile trascritto, per l’evidente influsso germanico, che rappresenta un caso unico nell’ambito dei registri esaminati. Si tratta pur sempre di lingua volgare, caratterizzata però soprattutto dal frequente scambio nell’impiego della dentale sorda t con la corrispondente sonora d (giutice, fete, agiungento, sminuento, concedento, danto, ma anche nodariato, audorità) e dalla significativa assenza della lettera h tra gutturale e vocale successiva (vengeno, lungezza, luogi): tale usus linguistico parrebbe proprio di una persona di lingua tedesca che parli stentatamente l’italiano. 2.6. Le modalità di compilazione dei protocolli. — Se il registro veniva predisposto e rilegato prima della compilazione, come si evince anche dall’esplicita nota presente sulla coperta di uno di essi 112, resta invero incerta la definizione dei tempi e delle modalità di redazione, visto che nessuna prescrizione in merito è prevista dagli Statuti o da apposite delibere del Consiglio della Comunità 113. Una precisa normativa venne stabilita, limitatamente al dialetto veneziano, cfr. BOERIO, ad vv. Per i toponimi in particolare BATTISTI, I toponimi; La posizione e I nomi; DE ZANNA-BERTI, ad vv.; Due Soldi, Toponimi ampezzani, ad vv.; Oronimi, ad vv.; GHEDINA DE TOMAS, ad vv.; PELLEGRINI, Commento, passim; RUSSO, Pallidi, pp. 45-73. 110 Poiché in Ampezzo la lingua ufficiale rimase sempre quella italiana, tale uso si riscontra anche nei registri della Comunità ed in particolare nei libri livellari conservati presso l’ASCC; cfr. Due Soldi, Toponimi ampezzani, p. 4. 111 AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 29 bis del notaio Ghidini Nicolò di Pietro (1598-1600) e prot. 30 del notaio Ghidini Giacomo Filippo di Simone (1606-1613). Si tenga presente che anche per i secoli XII-XIV « (...) il latino dei notai locali diventa talora un “latinus grossus” pieno di dialettismi latinizzati alla meglio, o persino lasciati qualche volta tali e quali (...) », RICHEBUONO, Ampezzo, p. 132. 112 AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 29 bis, già ASCC, Registro 5, Protocollo del notaio Nicolò fu Pietro Ghidini (1598-1600): Protacol da instromenti ligado per mi Joseph Gidin ogidì che è li 14 marzzo del 1598. 113 L’unica disposizione rintracciata a tal riguardo è una delibera del Consiglio generale d’Ampezzo in ASCC, reg. 19: Protocollo delle delibere del Consiglio Comunale di Ampezzo, c. 34 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Cadore, solo con una disposizione del 1754 114 emessa dalla competente magistratura veneziana: tale norma, decisamente applicata dai notai cadorini, non risulta aver trovato successiva ricezione in ambito statutario, né tantomeno adozione da parte dei notai ampezzani. Da un attento esame dei protocolli risulta tuttavia evidente che essi non venivano compilati in sequenza rigidamente progressiva, e si è portati a credere che nella più parte dei casi la loro redazione avvenisse solo in un secondo momento, anche a distanza di molto tempo dal compimento del fatto giuridico. Ciò perché spesso i rogiti presentano delle aggiunte successive, talora anche piuttosto consistenti, che non solo risultano compilate con la medesima tonalità d’inchiostro usato per l’atto cui si riferiscono, ma soprattutto s’inscrivono in spazi che difficilmente sarebbe stato possibile prevedere e lasciare in bianco in calce all’atto, al momento della sua stesura. Questa supposizione pare inoltre suffragata dal fatto che in molteplici casi l’ordine cronologico nella sequenza dei rogiti non appare assolutamente rispettato 115. Ulteriore indizio di ciò può essere forse colto dalla dichiarazione del notaio Giovanni Verocai, che dopo aver elencato le diverse tipologie contenute nel suo protocollo Lettera O aggiunge: (...) et ogni altro genere e nattura che vi accaderanno a scrivere di scritture pubbliche, non solo in avvenire ma etiamdio rogate per l’addietro per me nodaro e qui registrate ad perpetuam rei memoriam 116. L’analisi della grafia impiegata ha rivelato la presenza di molteplici mani di scrittura anche per uno stesso registro, fatto che induce ad ipotizzare come probabile il ricorso a scrivani 117, talora verosimilmente componenti della stessa famiglia aspiranti alla professione. Potrebbe essere questo il caso testimoniato dal protocollo più antico, già conservato presso l’Archivio storico non num., 11 ottobre 1662 e 22 ottobre 1662, « In pieno et general Consiglio fu determinato che per l’avvenire, mentre per li nodari et cancellisti non farano fuori le scritture publice d’anno in anno, non possino pretender mercede alcuna, ma senza premio passato l’anno siino obligati farle fuori in ottima forma ». Tale provvedimento, stando al disordine cronologico dei rogiti di alcuni protocolli, non pare aver trovato comunque rigorosa applicazione. 114 Terminazione dei Conservatori ed esecutori delle leggi, 2 aprile 1754, relativa alla provincia del Cadore, in PEDRINELLI, II/2, pp. 19-21: « (…) Quarto. Sarà obbligo preciso, e sacro d’ogni Nodaro estender le minute de’ loro Atti di qual si sia sorte in Quinternetti cuciti, e registrare quelle di mese in mese ne’ Protocolli, che doverano questi per evitare le frodi esser numerati, alfabettati, e bollati con il Bollo di detto Maggior Consiglio di Cadore, di quali sia tenuto in oltre un Indice, o Alfabetto … doverà ciscun Nodaro nel mese di maggio di cadaun anno …presentare …nella Cancelleria li loro Protocolli bollati… ». 115 Per vistosi esempi bastino AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 3; prot. 12; prot. 17; prot. 33; prot. 37; prot. 44. 116 AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 45, c.1r. Di tale opinione sembra anche FABBIANI, Notizie (1964), p. 18, per quanto riguarda i notai cadorini in generale. 117 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 35 del Comune di Cortina, del notaio Nicolò fu Pietro Ghidini 118: esteriormente il registro è contrassegnato come « Protacol da instromenti ligado per mi Ioseph Gidin ogidì che è li .14. marzzo del .1598. », ma gli atti in esso contenuti sono — come d’uso per lo più negli altri protocolli — del tutto privi di sottoscrizioni del rogatario. L’ultima carta presenta invece la dichiarazione « con miglior via et forma, per non esser nodaro che posa scriver, dalle parte pregato io Iosepho Gidini fidelmente scrissi », che certo non agevola l’identificazione dell’effettivo autore degli altri atti, in questo caso probabilmente il padre. Del resto, anche l’ordinanza di Massimiliano I d’Asburgo in materia di notariato prevedeva che, in casi di particolare necessità, gli atti potessero essere redatti da persona di fiducia del notaio, pur non autorizzata alla professione 119. Nella generalità dei registri notarili, in margine al testo ricorrono le annotazioni relative all’avvenuta redazione dell’atto nella sua forma perfetta e definitiva, o all’estrazione di eventuali copie: alle più frequenti voci di « extractum », « exactum », « extrafactum », « estratto », « mundo », « extractum fuit ab originali, fatto fuora per ambo le parti », si alternano più sporadicamente gli appunti indicanti l’avvenuta esazione del relativo compenso 120, espressi dalle formule: « pagato », « pagate le mercedi del notaio », « annullato e pagate le mercedi ». Le carte dei protocolli non sono originariamente numerate e gli atti si presentano nella quasi totalità repertoriati mediante l’attribuzione di un numero proprio, posto a margine del testo 121. Solo nel caso del protocollo n. 34 il 118 Il registro cartaceo presenta una coperta in pergamena, esito di riutilizzo di un testo ecclesiastico dai capilettera rubricati; il generale stato di conservazione può definirsi cattivo, soprattutto per il notevole grado di annerimento delle pagine e la scrittura piuttosto deleta. Le carte, numerate in originale, contengono atti non repertoriati rogati dal 1598 al 1600, per natura tipologicamente affini a quelli dei protocolli notarili conservati in AS BL, la cui forma risulta però assai più sintetica e compendiata. L’ordine nel quale si susseguono è grosso modo cronologico e la lingua prevalente è quella latina, con frequente ricorso all’impiego di abbreviazioni e forme ceterate. Nelle espressioni di invocatio ricorre generalmente Anno Domini e, più raramente In Christi nomine, cui fa immediato seguito la datatio cronica espressa con il numerale dell’anno, l’indicazione dell’indizione e quella del giorno del mese. Per la datatio topica ricorre « in Cortina Ampicii Cadubri, iurisdictionis imperialis arcis de Buttestagno, diocesis Aquilegiensis, in stuba domus mei subnotati notarii ». I formulari, similari a quelli conosciuti, risultano anche in questo caso alquanto scarni ed essenziali, come pure molto brevi sono generalmente le formule conclusive del documento, mai completo di sottoscrizione del rogatario. Frequentissime sono le annotazione a margine degli atti protocollati, nella forma di extractum, item o it. ripetuta a lato del testo per ogni clausola del medesimo atto. Limitatamente all’esame dei contenuti cfr. RICHEBUONO, Storia, p. 187. 119 Collectio, p. 432. A tal proposito si richiama l’esistenza del tariffario e del relativo aggiornamento previsto dallo Statuto di Cadore: cfr. Statuti, p. 9, cap. XII, e Nota delle mercedi del nodaro, pp. 150-152. 120 121 Diversamente dai protocolli del Bellunese, che non presentano in genere la numerazione degli atti, ma solo quella originale delle carte. Mette conto segnalare — e ciò depone per una 36 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo notaio non aveva eseguito tale operazione, ma aveva invece numerato le carte, e sulla base di tale sistema indicizzato gli atti nella relativa rubrica. In genere è infatti presente un repertorio (o alfabetto) contenente l’indice delle parti contraenti, in registro di formato minore di quello del relativo protocollo, solitamente slegato ed inserto per il secolo XVII, più frequentemente rilegato e ricavato dalle pagine del registro stesso, per i protocolli del XVIII. Consentaneamente, l’indicizzazione si basa sull’iniziale del nome di battesimo, cui fanno seguito il cognome di famiglia e l’indicazione della tipologia negoziale; in altri casi il nome del primo contraente è abbinato a quello del secondo, entrambi seguiti dal tipo di negozio e dall’indispensabile indicazione del numero di repertorio dell’atto. Anche questi piccoli registri dimostrano di aver subito manomissioni in seguito ad interventi di ordinamento non proprio condivisibili, che avevano comportato per alcuni di essi erronee attribuzioni e collocazioni. Talora i protocolli presentano, in aggiunta od in alternativa al loro repertorio coevo 122, un indice delle parti compilato presumibilmente durante il secolo XIX 123 e redatto secondo criteri moderni, ossia sulla base del cognome di entrambi i contraenti: laddove presente, questo strumento agevola decisamente i percorsi di ricerca. 2.7. I caratteri estrinseci. — I protocolli (generalmente del formato di mm 220 x mm 310) hanno forma di registro costituito dall’unione di più fascicoli cartacei, come riscontrabile per l’epoca sia nelle zone vicine del territorio bellunese, che più in generale in area italiana 124. Le legature presentano, rispetto a quelle adottate dai notai del Bellunese, una ridotta varietà e risultano per lo più rappresentate dalla tipologia a busta, costituita da piatti di cartone rivestiti in pergamena chiara, con squadratura dei bordi tracciata a secco, ribalta di chiusura e lacci in membrana; spesso sono presenti sul dorso tasselli di rinforzo in cuoio, in corrispondenza degli ancoraggi 125. Questo tipo di legatura, tipicamente archivistica, risulta raramente impiegata nei protocolli notarili di area bellunese, ove è invece ben più diffusa nei registri di produzione cancelleresca. Tra le coperte che si discostano da questo modello si segnalano quella del protocollo n. 7, caratterizzata dal reimpiego di una pergamena indicizzazione degli atti non contestuale alla registrazione degli stessi, bensì successiva — che gli atti annullati (ovviamente cassati in un momento successivo), appaiono solo sporadicamente repertoriati. Ne sono corredati 41 protocolli, mentre il repertorio di mano successiva è presente per 15 registri. 122 123 Il ductus scrittorio, che appare tipico dell’area austriaca o tedesca suggerisce che tali strumenti di corredo siano stati redatti durante la permanenza del materiale ad Innsbruck. 124 CAMMAROSANO, p. 269; PETRUCCI-NARDELLI, pp. 28-29; PETRUCCI, pp. 107-112. Sulle legature archivistiche cfr. PETRUCCI-NARDELLI, pp. 25-29 ed in particolare PROSPERI, p. 81. 125 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 37 con testo liturgico, con capolettera rubricati e turchini; quella del protocollo n. 55, con piatti in cuoio decorati ad impressione e dorso rinforzato da due pergamene dipinte, di riutilizzo 126; infine quella del protocollo n. 10, che conserva la confezione originale in pergamena, completa di cinghia di chiusura in cuoio, fermata da fibbia in ferro 127. Alcuni registri (in particolare quelli più antichi) sono stati sottoposti ad intervento di sostituzione della coperta originale, probabilmente durante il secolo XIX, ed in questo caso presentano legature più vicine a quelle librarie, con l’impiego di svariate carte marmorizzate. La scrittura utilizzata è una minuscola umanistica di tipo notarile, dal ductus generalmente molto corsivo, che assume talora l’aspetto irregolare e poco curato tipico dei minutari; ma se la grafia dei più antichi registri si avvicina a quella di un brogliaccio, man mano che si procede verso il secolo XIX, si assiste ad un deciso aumentare del grado di calligraficità, che si spinge sino a raggiungere livelli di accuratezza formale ed eleganza dei tratti, degni di caratteri a stampa 128. L’uso delle abbreviazioni, decisamente più consistente nei protocolli del ’600, risulta nel complesso piuttosto contenuto e comunque non difforme da quello dei territori circonvicini del Bellunese 129. Molto frequente è invece l’impiego di forme ceterate in luogo dei completi formularii, usus che si mantiene anche nella redazione dei relativi instrumenta in mundum 130. L’ornamentazione interessa in particolare i capolettera, che presentano un’ampia gamma di metamorfosi della I dell’invocatio verbale, dai tratti e dalle forme davvero fantasiose 131. Nell’iniziale dell’espressione « In Christi nomine » infatti, vediamo le I trasformarsi in spicchi di luna 132, modificarsi in motivi ornamentali involuti ed orientalizzanti 133, o addirittura assumere forme antropomorfe, inneggianti alla Veritas, all’Impero, o a Maria Teresa d’Austria 134. L’aspetto decorativo presenta però anche alcuni esempi notevoli dal punto di vista artistico: è questo il caso del notaio Pietro Antonio Constantini, che sfoggia l’immagine di un Cristo crocifisso disegnato a piena pagina sulla 126 Per le immagini e le descrizioni delle quali si rinvia a Il Notariato, pp. 42-43. 127 Riprodotta alla tavola n. 8. Ci si riferisce in particolare ai prott. 1-3, del notaio Alverà Giacom’Antonio di Bartolomeo (1753-1778), AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, b. 45, e ai prott. 24-25 di Constantini Benedetto di Nicolò (1789-1792). 128 129 Per il sec. XVII basti ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 35, passim. Ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 10, c. 73r, ins. e c.191r, ins.; prot. 14, c.78r, ins. Cfr. riproduzione alla tavola n. 7. 130 131 Ad es. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, prot. 23, passim, part. c. 80v. 132 Ibid., prot. 7, cc. 91r-92v. 133 Ibid., prot. 23, passim, part. cc. 18r-82r. Ibid., prot. 14, c. 224r; prot. 23, c. 94r; Ibid., c.27r. Per le immagini, cfr. Il notariato, pp. 47-49. 134 38 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo prima carta di uno dei suoi protocolli 135. Un ulteriore esempio delle capacità artistiche dei notai di questa famiglia è offerto dal frontespizio dei protocolli nn. 15 e 16 di Nicolò Constantini figlio di Pietro Antonio, recanti immagini della personificazione della Giustizia, con i classici attributi della bilancia e della spada, accompagnata dal motto « Iustitiam diligite » 136. L’effige probabilmente ricalca quella presente sul frontespizio dell’editio princeps dello Statuto di Cadore, stampata a Venezia nel 1545: il fatto risulta del resto tanto più comprensibile, qualora si consideri la familiarità che il notaio autore del disegno doveva avere con le fonti del diritto locale, avendo ricoperto dal 1760 al 1769 la carica di vicario e giudice d’Ampezzo 137. 3. ALCUNE CARATTERISTICHE TIPOLOGIE DOCUMENTARIE 3.1. Le Regole. — Gli atti di diritto privato redatti dai notai ampezzani di cui si riporta trascrizione integrale in questa sezione sono accomunati dal fatto di avere come auctores entità collettive, assimilabili ai comuni rurali sorti in particolare al termine del XIII secolo nell’Italia settentrionale e centrale, che ebbero vigore, con alterne e varie vicende a seconda dei luoghi, sino all’età napoleonica 138. Caratteristica peculiare di tali associazioni, nel Bellunese dette più precisamente Regole 139, fu quella di corrispondere all’insieme dei capifa135 Ibid., prot. 10, c. 1, immagine riprodotta alla tavola n. 3. Ibid., prott. 15-16, c.1. Il motto è tratto dalla più completa citazione « Diligite iustitiam, qui iudicatis terram » (Sapienza I, 1; ripreso in DANTE, Paradiso, XVIII, 91-93), incisa anche sull’archivolto di una delle porte di accesso alla sala del Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore. L’immagine riportata nel protocollo è poi sormontata da un festone che racchiude l’ulteriore citazione biblica « In manu Dei prosperitas hominis est, et super faciem scribae imponet honorem suum » (Ecclesiaste, X, 5). Si noti che quest’ultima compare anche sulla prima carta del protocollo di un notaio di Longarone di pochi anni successivo, il che dimostra una certa diffusione del versetto, emblematico della professione notarile: AS BL, Archivio notarile, notaio Domenico Tezza fu Giacomo, reg. 6825 (1737-1742), già segnalato in Il notariato, p. 56. Cfr. riproduzione alla tavola n. 4. 136 137 ALVERÀ, p. 378. 138 LEICHT, Il diritto pubblico, p. 269. 139 Per l’etimo ed il significato del termine cfr. DU CANGE, Regula; DE FELICE, passim; PERTILE, Storia, IV, p. 334; ID., I laudi p. 461; BOLLA, p. 66; KRAMER, Regula, pp. 497-498; RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 79-80; ID., Storia, p. 82. Poiché non è questa la sede per tentare una sintesi in merito, ci si limita a ricordare che per quanto riguarda il Cadore, abbondante è la bibliografia tematica sulle Regole: in particolare risultano fondamentali le varie edizioni dei relativi ordinamenti, ovverosia laudi, dovute a diversi storici — non solo locali — del diritto italiano quali Antonio Pertile e Gian Luigi Andrich, che tra la fine dell’800 e i primi anni del ’900, dedicarono proprio all’argomento svariati saggi, per i quali si rinvia alla Bibliografia generale. In tempi più recenti Ferruccio Vendramini in Le comunità rurali bellunesi ha dedicato ampio spazio allo studio istituzionale delle Regole del distretto di Belluno in epoca veneziana, corredando il suo studio di una ricca bibliografia estesa a tutte le Comunità montane dell’arco I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 39 miglia originari di un determinato agglomerato abitativo, al fine di regolare tra gli associati precipuamente l’uso di boschi e pascoli, detenuti a pieno titolo di proprietà o, più spesso, in semplice godimento. Tali comunità rurali o montane erano dotate di una discreta autonomia, eleggendo con regolarità al loro interno il capo-regola (marigo), i consiglieri che lo assistevano (laudadori o sindici), tra i quali il tesoriere (massaro, in Ampezzo coglietro o cuietro), le guardie campestri (saltari), le guardie giurate (zuradi di giustitia) ed altre figure istituzionali con specifiche competenze, variabili a seconda della zona 140. Le Regole ampezzane, facenti capo fino al 1511 alla Magnifica Comunità di Cadore e poi a quella d’Ampezzo, godevano della facoltà di dotarsi di un proprio codice comportamentale, ovverosia il laudo, raccolta di norme approvate dall’assemblea dei regolieri, prevalentemente in materia di selvicoltura e pastorizia 141. La regola ampezzana 142 si configura infatti come un consorzio agro-silvo-pastorale di natura privata 143, che consocia i capifamiglia originari di una o più frazioni, allo scopo di sfruttare al meglio il patrimonio boschivo e alpino italiano. Sempre con ottica rivolta a tutti i comuni montani delle Alpi è condotto lo specifico e corposo studio, abbracciante anche le istituzioni dell’età contemporanea, Comunioni familiari montane, a cura di Emilio Romagnoli e Cesare Trebeschi, che ripropone inoltre una raccolta d’importanti contributi specifici già editi, spesso di difficile reperimento. In particolare allo studio delle Regole cadorine si è dedicato Giovanni Fabbiani, cui si deve l’edizione a stampa di numerosi laudi; sulla stessa linea si colloca il saggio Note di storia giuridica del Cadore di Fiorello Zangrando, che analizza l’argomento dal poco praticato punto di vista istituzionale. In anni più recenti, un’esaustiva sintesi in materia è stata operata da Giandomenico Zanderigo Rosolo nei suoi Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII-XIV. Per quanto riguarda invece più strettamente l’Ampezzano, Giuseppe Richebuono, autore di numerosi saggi, in particolare con Ampezzo di Cadore, Antichi laudi delle Regole fino alla fine del 1400, e Storia d’Ampezzo, dedica ampio spazio alla storia istituzionale propria delle Regole d’Ampezzo. Per le cariche tipiche delle Regole bellunesi VENDRAMINI, Le comunità, p. 16, n. 2; per le Regole cadorine PERTILE, I laudi, pp. 462-468 e ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, pp. 160-167; per quelle ampezzane in particolare RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 82-83 e Antichi, p. 6; DE ZANNA, Regole, pp. 437-438. 140 141 ANDRICH, Appunti, pp. 34-50; PERTILE, I laudi, 471-475; ID., Le fonti, p. 212; FABBIANI, I laudi di Ampezzo; RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 81-82; ID., Antichi, passim; ID, Storia, pp. 82-83; ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, pp. 136 ss. Si tenga tuttavia presente che i laudi, a partire dal 1456, dovevano essere confermati dal vicario di Cadore. Si ricorda che le Regole ampezzane, insieme a quelle cadorine (per la maggior parte site in Comelico), sono le uniche rimaste in vita ancor oggi: a seguito di una annosa vertenza il Comune di Cortina riconobbe loro, già nel 1959, la totalità dei pascoli ed il 90% dei boschi. Le Regole d’Ampezzo, cui con una legge del 1971 è stata riconosciuta la personalità giuridica di natura privata, gestiscono attualmente anche il Parco delle Dolomiti d’Ampezzo, che si estende per circa 11.000 ettari nella zona nord della valle. 142 Sulla natura della personalità giuridica delle Regole, pubblica o privata, è in corso da anni un acceso dibattito, per il quale si rinvia principalmente a Comunioni I e II, passim e più in particolare a RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 92-99. 143 40 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo pascolivo 144. Tra gli atti rogati dai notai ampezzani e registrati nei protocolli si trovano con frequenza anche fattispecie giuridiche proprie di tali consorzi locali: oltre naturalmente ai frequenti atti di compravendita e di livello stipulati dalla Comunità d’Ampezzo o dalle Regole, i protocolli contengono infatti tipologie negoziali più peculiarmente rappresentative di questi istituti, quali le consortìe, cioè atti di ammissione; le vizze, cioè bandite di boschi; gli alberghe, ovverosia bandite di radure con alberi atti a fungere da ricovero notturno per gli animali al pascolo. L’interesse di questi atti, dal punto di vista strettamente archivistico, si sostanzia soprattutto nel fatto che essi risultano in alcuni casi reperibili in unica copia in questi protocolli: da un primo esame della documentazione conservata presso l’Archivio delle Regole di Cortina, infatti, risulta che queste tipologie documentarie, stese in forma notarile dopo essere state deliberate dall’assemblea della Regola (o dal Consiglio della Comunità, nel caso della vizza), non erano poi registrate integralmente in un instrumentario che le raccogliesse, ma ne veniva conservato soltanto l’atto sciolto, ovverosia l’instrumentum in mundum esteso dal notaio, oggi talvolta irreperibile. Nei documenti della Regola o nei libri della Comunità è possibile invece rintracciare la fase precedente, ossia la deliberazione mediante la quale l’assemblea determinava di procedere al compimento dell’atto giuridico ed alla sua documentazione. 3.2. La consortìa. — Questa tipologia, di cui si trascrivono due esempi, rispettivamente per i secoli XVII e XVIII, presenta il nomen iuris di consortìa (dal latino cum + sors, -tis, ad indicare genericamente la comunanza di condizione, o addirittura lo sfruttamento di lotti di terreno contermini) 145: si tratta dell’ammissione alla Regola di un nuovo membro, consorte appunto, status che consentiva di godere di determinati privilegi, specie nell’utilizzo di boschi e pascoli siti prevalentemente nella conca di Cortina d’Ampezzo. Da una prima ricognizione a campione condotta su protocolli notarili dei vicini territori del Cadore e del Comelico, nei quali ebbe vigore medesimo ordinamento statutario, risulterebbe che al nomen iuris di consortìa corrisponda indifferentemente tanto l’atto di ammissione alla Regola, quanto l’atto di 144 In origine esistevano soltanto la Regola di Lareto, il cui territorio si estendeva lungo la sinistra orografica del torrente Boite e quella d’Ambrizzola, cui spettavano invece i pascoli posti sulla sponda destra; ma essendo il territorio delle due Regole troppo vasto per essere opportunamente sfruttato ed amministrato, si vennero man mano a creare delle suddivisioni interne, cosicché dalle due regole matrici di Lareto ed Ambrizzola, chiamate poi Regole Alte, si formarono successivamente altre nove Regole, denominate Basse. Alla fine del secolo XV si avevano dunque la Regola Alta di Lareto e quelle di Màndres, Zuèl, Fraìna, Lareto Basso, Chiave; la Regola Alta di Ambrìzzola, e quelle di Campo, Pocòl, Rumèrlo, Cadìn: così FABBIANI, I laudi, p. 1; diversamente RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 76-80; ID., Storia, pp. 63-64; 82 e 128-129. 145 Per l’etimo ed il significato del termine cfr. DU CANGE, Consortes e Consortia; DE FELICE, passim; PERTILE, Storia, IV, p. 334; BOLLA, p. 66; per una più completa trattazione dal punto di vista storico-istituzionale ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, pp. 99-102 e 121-127, part. 122. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 41 vendita della quota di consorte, vietata a terzi estranei dagli Statuti, ma frequentemente praticata in seno alle Regole cadorine soprattutto nel corso dei secoli XV-XVI 146. Questa seconda fattispecie non risulta invece attestata nei protocolli notarili d’Ampezzo, in quanto la documentazione conservata si riferisce ad epoca successiva al divieto di alienazione, ribadito solennemente da parte della Regola ampezzana di Lareto nell’anno 1505 147. Precisa regolamentazione in materia è contenuta negli Statuti di Cadore, che in Ampezzo, come si è visto, rimasero sempre vigenti: in tali norme si prescrive che l’aspirante non possa essere accettato come regoliere senza il preventivo assenso da parte della Magnifica Comunità, che rilasciava il diritto di cittadinanza solo a chi dimorasse stabilmente in loco 148. Il riconoscimento di consorte richiedeva il requisito della discendenza legittima da altro comprovato membro, in coesistenza con la condizione di residente originario 149. La procedura di ammissione comportava la presentazione di precisi documenti e testimonianze in appoggio alla richiesta, sulla scorta dei quali lo status di regoliere veniva o meno accordato all’aspirante. Evidente prova di ciò può essere rappresentata dall’escatocollo dell’atto di consortìa del 1649, ove si afferma che l’instromento notarile viene rogato affinché la parte richiedente — come pure i suoi discendenti — possa in qualsiasi momento provare la legittimità della sua appartenenza alla Regola. Tale condizione comportava, oltre ai benefici connessi al godimento collettivo del patrimonio, anche delle prestazioni obbligatorie, come pure delle spese derivanti dall’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali 150, alle quali tutti i membri concorrevano in solidum. Sempre negli Statuti è contenuta prescrizione in materia di disponibilità dei diritti connessi alle consortìe: in particolare se ne limitava il moltiplicarsi e frammentarsi per successione; il gravare le stesse di oneri; se ne vieStatuti, p. 135, cap. XCI. Delli consorti & della successione in essi. Sull’argomento ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, pp. 125-127; cfr. anche Le pergamene, pp. 31-32 ed in particolare i numerosi testi trascritti o regestati alle pp. 93-105. 146 147 Il documento, conservato all’ARAMP, Lareto, perg. n. 101, è stato parzialmente pubblicato da ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, p. 125, n. 106 e successivamente da RICHEBUONO, Storia, pp. 577-578. Secondo RICHEBUONO, Storia, pp. 127-128, anche la Regola di Ambrizzola dovette comportarsi analogamente, e singole vendite di consortìe si troverebbero attestate ancora solo fino al 1537. Statuti, pp. 128-129, cap. LXIX. Che non s’accettino li vicini per le Regole, se prima non sono assonti in cittadini del Conseglio; cap. LXX. Che li vicini non s’accettino, ne s’amettino, se non veniranno ad habitar in Cadore; cap. LXXI. Di quelli, che vanno con la famiglia fuori di Cadore, & vi stanno per sei mesi, & non torneranno. 148 ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, p. 99 e RICHEBUONO, Storia di Cortina, p. 302. Sulla possibilità di partecipazione alla Regola da parte di forestieri non Cadorini, cfr. DE SANDRE, Le proprietà, pp. 115-116. 149 150 PERTILE, I laudi, pp. 465 ss; Sugli officia delle Regole cadorine in particolare ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, pp. 157 e 160 e sulle prestazioni d’opera d’interesse collettivo pp. 175-177. Per un confronto con le Regole del Bellunese VENDRAMINI, Le Comunità, pp. 28 e 51 ss. e per quelle della vicina Carnia BIANCO, pp. 32-54. 42 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo tava l’alienazione a forestieri, specialmente todeschi; si richiedeva la preventiva autorizzazione alla vendita da parte del Consiglio della Comunità 151. Periodicamente si procedeva al censimento degli « aventi diritto » tramite la redazione di un libro di regola, contenente l’elenco dei consorti: per il periodo di cui ci si occupa, ne esiste un significativo esempio presso l’archivio della Regola di Ambrizzola, con i nomi dei regolieri suddivisi in base alla località di residenza 152. A margine del nome è talora riportata la data di accettazione all’interno della Regola, con l’indicazione della quota di denaro corrisposta e dell’obbligo di far celebrare un certo numero di messe. La somma pagata per entrare in consortìa si attesta generalmente, per la seconda metà del secolo XVIII, tra le 12 e i 15 lire venete 153: dagli atti dei protocolli notarili infatti la moneta comunemente in uso in Ampezzo risulta essere quella veneta 154. In rari casi, viene parimenti registrata a margine del nome la rinuncia ai diritti di regoliere, con relativa data: si noti però che tutte queste annotazioni non contemplano mai il riferimento al relativo atto notarile, che risulta evidentemente non richiesto dalla prassi 155. Se per la consortìa gli Statuti non prescrivono una forma di redazione particolare, è tuttavia quasi naturale aspettarsi quella notarile, trattandosi di un atto di diritto privato 156: il relativo documento si presenta simile nella sostanza a quello d’ammissione a fraglie o corporazioni, in cui si entri a godere dei benefici previsti da una societas previo versamento di una determinata quota. Diplomatisticamente, i formulari impiegati, che — come di consueto per l’area ampezzana — appaiono alquanto scarni, per il secolo XVII sembrano rifarsi a terminologie tipiche di medievali investiture: nel primo documento trascritto, infatti, il verbo della dispositio viene contestualmente espresso da due termini che richiamano, contraddittoriamente, ora la sfera regolata dal diritto pubblico (investire), ora quella del diritto privato (accettare) 157. Per quanto riguarda 151 Statuti, p. 43, cap. LXVIII, Che non s’alienino le Possessioni d’un Commune senza il consenso d’altri; p. 97, cap. I, Di quelli che vendono, obligano, ò alienano le possessioni alli foresti; p. 135, cap. XCI. Delli consorti & della successione in essi. 152 ARAMP, Ambrizzola, doc. n. 198: 1784. Catastro de membri e consorti dell’onoranda Regola di Ambrizzola ut intus et cetera. Caso analogo, anche se più tardo, si ha per Lareto, doc. n. 162: Urbario della magnifica Regola Grande di Laretto. In fine del presente si contiene il catastro, distinto de consorti di Regola fatto li 14 settembre 1806. Sui libri di Regola del Cadore cfr. in generale ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, pp. 105-106. 153 ARAMP, Ambrizzola, doc. n. 198, passim. Sul valore delle quote d’ingresso ad una Regola nel periodo in questione cfr. per il vicino territorio della Carnia BIANCO, pp. 51-52. 154 Cfr. Due Soldi, Vecchie misure, p. 9 e RICHEBUONO, Storia, pp. 166-167; sul tipo di moneta in uso nel territorio trentino-tirolese, cfr. STELLA, pp. 26-27. 155 Caso contrario e particolare è quello rappresentato dall’iter di non ammissione alla Regola, la cui documentazione viene riportata poco oltre in trascrizione. 156 Non pare che atti simili siano conservati presso l’ARAMP, a parte i già menzionati catasti di regola, su cui RICHEBUONO, Ampezzo, p. 84 e ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, p. 105. 157 LEICHT, Il diritto pubblico, pp. 149 e 240; ID., Il diritto privato, I, pp. 129-130. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 43 l’atto di consortìa del secolo XVIII, la volontà dispositiva viene invece espressa dai verbi creare, accettare e nominare, che meglio definiscono il rapporto paritetico tra i membri e che risultano più comunemente ricorrenti in atti di aggregazione corporativa o religiosa della medesima epoca. In entrambi i documenti il nuovo compartecipe viene definito con una sequenza di sinonimi, che denotano la volontà di specificarne inequivocabilmente il ruolo, comprendendone il significato in tutte le possibili accezioni e sfaccettature: nel primo caso consorte, collega e regoliere, poi membro, regoliere e consorte. Il formulario, a parte la già menzionata diversità del verbum iuris, risulta sostanzialmente costante, non presentando significative difformità nel passaggio dal secolo XVII al secolo XVIII 158. Documenti: 1. La Regola d’Ambrizzola, tramite i suoi rappresentanti istituzionali, accetta Simone Gaspari di Giovanni Maria come consorte della Regola, previo versamento della quota di lire venete trentacinque di denari piccoli. Nel nome di Christo, amen. L’anno della Sua natività .1649., inditione seconda, li .26. del mese di luglio, in Cortina d’Ampezzo giurisditione arciducale della fortezza di Botestagno, in casa di mastro Iacomo da Dié da Campo, alla presentia di mastro Toffol de Michiel et di mastro Iacomo Filipo quondam Zuanne de Maii, testimonii havuti, et cetera. Dove che si notifica con il presente instromento publico come a mastro Andrea Appolonio marigo, mastro Zannetto de Zanna et mastro Dorigo figliolo di Gasparo Verocai sindici et capi della spetabil Regolla d’Ambrizolla del presente anno, di consenso et deliberatione fatta in piena et general Regolla al suo luogo solito, hanno investito et accettato et cola presente scrittura investiscono et accettano (havvendo la gratia ricercato) mastro Simon quondam Zamaria de Caspar et suoi sucessori et heredi in perpetuo per consorte, collega et regoliere, dandoli piena et ampla autorità di potter per l’avenire monteare sopra essa Regolla ogni sorte d’animali, et fare come può et deve fare ogn’altro buon regolliere et consorte, et stare al bene et al male come fanno et sono sottoposti li altri, et secondo parla il laudo della prenominata Regola; ma essendo che in pien Regola è statto determinato che per la gratia et concessione che se li ha fatto et si fa, che in ricompensa di quella debba esser fatta una tansa, et da alquanti huomini della Regolla elletti dalli capi b una dichiaratione di quanto ha da contribuire alla Regolla, per tanto c a far simil tansa furono dalli prefatti capi elletti li sotonotadi huomini, tutti consorti della Regolla, cioè mastro Gasparo Verocai, mastro Mathio Soravia, mastro Zuanne de Michiel, mastro Zuanne de Menardo, mastro Piero de Val, mastro Andrea dal Vera, Piero quondam Hieronimo de Val, Zanpierio de Menardo, Zuanne de Val, Andrea de Zorzo ditto de Dorigo, mastro Iacomo Appollonio, mastro Pietroantonio Appollonio et mastro Iacomo da Dié da Campo; li quali huomini tutti uniti insieme hanno (consideratis considerandis) fatto, deliberato et tansato che Simon de Caspar sudetto debba per la medesima gratia ricevuta dare et 158 AS BL, ibid., notaio Giulio Verocai di Giovanni, prot. 51, cc. 37v-38r, rep. 54. 44 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo esborsare alla Regolla lire trentacinque, videlicet lire .35. di buona et corente valuta, || et così esso Simon si contentò et di subito esborsò et contò fuori li dinari alli capi antedetti in nome della Regolla, et cetera. Siché per l’avenire mastro Simon predetto d, suoi heredi et sucessori seranno come è detto di sopra proprii et veri Regolieri como sono li altri consorti. Promettendo di mantenirli quanto li hanno promesso sotto obligatione de loro beni presenti et venturi in forma; dando commissione a me nodaro che a cautione di Simon et suoi posteri debba farli il presente instromento, acciò ch’in breve come longo tempo possia mostrare in ogni evento le sue cautioni, et cetera. Et così fu fatto et da me nodaro e a perpetua memoria registrato in forma consuetta, et cetera. Laus Deo semper. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, notaio Giovanni Verocai di Giovanni Paolo, prot. 38, cc. 76v-77r, rep. 186. b c Come in soprallinea, senza segno di inserzione. Segue la depennato. Segue a tal da d e Segue serà depennato. Nodaro in soprallinea, senza segno di inserzione. depennato. a 2. La Regola di Zuel, tramite i suoi rappresentanti istituzionali, accetta Giovanni Maria Dibona di Giovanni Maria, Giovanni Battista Lorenzi fu Giovanni Battista e Pietr’Antonio Dibona di Girolamo, come consorti della Regola, previo rispettivo versamento della quota di lire venete settantacinque di denari piccoli. In Christi nomine, amen. L’anno di nostra salute .1751., inditione romana .14a., adì .9. maggio, in Ampezzo arciducale et in casa del signor Silvestro Manaigo; presenti il signor Antonio Manaigo, il signor Lorenzo Alverà et il signor Biasio Zangrandi quondam Andrea, et altri testimonii havuti, et cetera. Convocata pien e general Regola di Zuel de more et al luogo solito, sotto la marighezza del signor Nicolò Zambelli, nel giorno d’hoggidì, per instanza e requisitione di mastro Zamaria figlio di mastro Zamaria Di Bona, di mastro Giovanni Battista quondam Giovanni Battista Lorenzi et di mastro Pietr’Antonio figlio di Girolamo Di Bona, richiedendo questi, stante ad umilissima supplica in scriptis esposta, d’essere fatti membri et essere agregati nel numero et ruollo e membri e regolieri della medema, ut in ea et cetera. Dove che udita la richiesta a, dalla sudetta onoranda Regola fu in pieni votti, niuno in contrario, determinato e risolto d’accetarli e riceverli per membri e consorti della prefata Regola, mediante una contributione da essere conrisposta dalli medemi supplicanti, quale venirà dechiarata da numero .10. huomini dell’istessa elletti e nominati et cetera. Esecutivamente a detta determinatione, et accetata da detti b supplicanti il signor Nicolò Zambelli, marigo dell’antedetta onoranda Regola dell’anno presente, in nome della medema e consorti di quella, per sé et heredi, hora et in perpetuo crea, acceta e nomina per membri regolieri e consorti li sopradetti Zamaria Di Bona, Giovanni Battista Lorenzi e Pietr’Antonio Di Bona accetanti, et cetera; ita, che essi e loro descendenti in perpetuo restino, s’intendano e debbano essere membri, consorti e regolieri della più mentovata onoranda Regola, e godere possano et liberamente usufrutuare monti, pascoli et altri benefitii dell’istessa, così anco partecipare tutti li benefitii, gratie, honori e prerogative, quali godono e goderano tutti gl’altri consorti e membri, senza alcuna contraditione, né I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 45 oppositione della medema, né d’altri consorti, tamquam se ab origine fossero di quella stati consorti, dovendo hora e per sempre essere c conosciuti tali, e per membri legitimi et idonei, et cetera. All’incontro debbano e siano tenuti corrispondere per tal benefitio et utile all’istessa onoranda Regola la summa di lire .75. per cadauno, in pronti et effettivi contanti, da essere numerati et esborsati al prefato signor Nicolò Zambelli, marigo, così tansato dalli numero .10. huomini elletti || e nominati et approvato dalli supplicanti, et cetera. Che così, omni excceptione remota de iure, vel de facto, generali ac speciali, un e l’altra parte promete le cose infrascritte di fermamente mantenere, attendere et osservare per ferme, ratte, grate, et inrevocabili, né alle predette cose mai, né in breve né in lungo tempo, tregivevare et retrocedere, sotto nessun pretesto, colore over raggione, obligando perciò sotto manutentione tutti e cadauni suoi beni et effetti, presenti et venturi, in ogni miglior e più valida forma, et cetera. Actum, publicatum, laudatumque fuit anno, mense ac die dicta et alla presentia delli sudetti testimonii, et cetera. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, notaio Giulio Verocai di Giovanni, prot. 51, cc.37v-38r, rep. 54. a Segue e depennata. d’inserzione sottostante. b Segue e più mentovati depennato. c Essere in soprallinea con segno Analogamente all’atto di consortìa, si riporta qui di seguito la trascrizione di un documento che può forse definirsi come l’opposto, cioè la negata ammissione ad una Regola. La fattispecie si articola in due fasi: nella prima la Regola nomina una sorta di collegio arbitrale, costituito dall’autorità giudiziaria locale — il vicario d’Ampezzo — affiancata da due regolieri in qualità di assessori, per sottoporre a vaglio i titoli presentati da una famiglia del luogo richiedente la compartecipazione. La seconda consiste nella pronuncia della relativa sentenza da parte del collegio arbitrale, sulla base delle testimonianze esaminate 159. Rilevante, anche nel formulario di quest’atto, la definizione della societas data da una sequenza di più termini consimili: vicinia, consortia, università, regola e regolato; si noti inoltre che in quest’ultimo caso il notaio agisce nella pubblica veste di cancelliere 160. 3a. La Regola di Zuel, rappresentata dal marigo e da alcuni consorti, avvia nei confronti della famiglia Ghidini procedura di verifica dei requisiti necessari per l’appartenenza alla Regola. Anche su questo argomento esistono molteplici controversie: cfr. ad es. ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, in particolare pp. 99-102. 159 Come si è già visto, la carica di cancelliere doveva essere sempre ricoperta da un notaio della Comunità, che talora registrava nel medesimo protocollo sia gli atti rogati nella sua veste di privato professionista, che in quella di pubblico ufficiale. 160 46 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Laus Deo semper, et cetera. Adì .4. zugnio .1705., in Ampezzo imperiale, et cetera. Vertendo litte et differentia tra signor Pietro Ghidini, menego, insieme con signor Francesco Ghidini, signor Iacomo Ghidini et altri pretendenti, non solo per sè medessimi, ma ancora per nome di tutta la casada Ghidini et heredi della medessima da una parte, et tra mastro Zambattista quondam Gasparo Pompanin, attual marigo della magnifica et honoranda Regolla di Zuel, insieme anco con signor Tomaso Gaspari, astretto con giuramento et per via di giustitia per addure le sue ragioni et il signor Simon Aquabona, signor Dorigo di Zorzo, signor Antonio Manaigo detto Da Lago et altri diversi consorti dell’istessa Regolla, per loro proprii et per nomine de tutta la Regolla sudetta, dall’altra parte, et cetera. In ciò, di ciò et sopra il punto che li signori Ghidini intendono esser consorti et Regollieri della medessima Regolla di Zuel, come a sonno gl’altri, con ragioni così et honori, tanto quanto sono gl’altri consorti et Regolieri. Et all’incontro li signori della Regolla sudetta opponendosi et intendendo che non siano consorti et Regolieri et esclusi senza minima attione, né ragione, et cetera; et come meglio sì per l’una come per l’altra parte più diffusamente serrano addotte le loro ragioni, et cetera. || Sicché dall’illustrissimo signor Chistoforo de Bincheloffen, capitano di Bottestagnio et vicario d’Ampezzo, a richiesta delle parti, è statto hoggi concesso una giornata per diffinire detta loro differentia, et per assessori sono stati elletti il signor Iacomo Caldara et signor Pietro Valle, huomini idonei et soficienti, alle parti non sospetti, ma lodatti et confirmati, et cetera. Che perciò chi delle parti vorà addure et produre le sue ragioni, le producheno, che qui in processo serrano registratte, et indi da sua signoria illustrissima et dalli spetabili signori assessori (udita, ascoltata et intesse le ragioni) serà datta la sentenza diffinitiva, et cetera. Segue la sentenza. Laus Deo semper. a Segue come depennato. 3b. Christoph von Winkelhofer 161, capitano del castello di Botestagno e vicario d’Ampezzo, unitamente agli assessori appositamente designati, sentenzia che la famiglia Ghidini non sia accettata come consorte della Regola di Zuel e sia condannata al pagamento delle spese processuali. Adì .26. ottobrio .1705. in Ampezzo imperiale, nella casa della magnifica Communità, luogo idoneo et deputato, et cetera. Pertanto dall’illustrissimo signor Christoforo de Bincheloffen, et cetera, per la sacra cesarea Maestà benemerito capitano della fortezza di Bottestagnio, vicario et giudice d’Ampezzo, insieme con signori Iacomo Caldara et signor Pietro Valle, spetabili et honorandi signori assesori (sedendo et cetera, vedutto il processo, vedutte le dimande e risposte, vedutte le scritture hic inde presentate, vedutti gl’essami per l’una et l’altra parte introdotti, et refletite || le cose tutte degnie di consideratione, viste l’allegationi et udite le ragioni dell’una et dell’altra 161 Si tratta del capitano e vicario d’Ampezzo Johannes Joachim Christoph von Winkelhofer, in carica dal 1661 al 1714, il cui cognome appare attestato in forme diverse: solo a titolo di esempio Michlofer in Statuti, p. 153 e Minchlafer, ibid., p. 157, oppure Winchelhofen, prot. 45, c.171r. La carica di capitano di Botestagno fu ricoperta con continuità da membri di questo casato dal 1659 al 1752, anno in cui fu abolita tale figura istituzionale. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 47 parte dette vocalmente, et finalmente considerate merito considerandis (invocato prima il nome dell’altissimo Iddio, a quo et cetera) venendo alla diffinitiva sentenza, sententiando hanno iuridicamente sententiato, terminato et diffinito che non havendo la casa Ghidini suficientemente provato il giusto titolo, né meno fatto constare, né provato il real posseso, che essi signori Ghidini et casada Ghidini siano effetivamente esclusi dalla vicinia, consortia, università, Regolla, et Regolato di Zuel et che debbano et siano tenuti essi signori Ghidini a pagar tutte le spese sucesse nella presente contraversia, che sono lire .246.10. Et quella parte ha speso fuora via, habbia speso et debba separatamente pagare. Datta et pronunciata fu la sudetta sentenza dal prefatto illustrissimo signor capitano et vicario et dalli spetabili signori assesori, scritta et publicata di suo ordine, da me infrascritto nodaro et cancellier elletto in questa causa, l’anno, loco et giorno soprascritto et alla presenza di mastro Liberal di Menardo et di mastro Sebastian di Zaniacomo testibus et cetera. Ad laudem Dei. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, notaio Giovanni Verocai di Giovanni Paolo, prot. 41, cc. 104v-105r, rep. 104. 3.3. La vizza. — Altro atto significativo che si riporta in trascrizione integrale, in quanto vi appare quale auctor la Comunità, è quello che risponde al nome di vizza, viça, vicia, wiza, altrove wifa o guizza, equivalente all’azione di bandita di un bosco 162. Il termine è di controversa etimologia, oscillante tra un rimando al diritto longobardo, per il quale wizan significherebbe « pena, multa » e quindi, estensivamente, « bosco protetto dal taglio con una multa », oppure riconducibile al germanico wifan, significante invece « mannello di paglia » simbolo proprio della presa di possesso germanica (gewere) 163. Il fatto documentato assume la forma di una solenne cerimonia, con la quale vengono poste delimitazioni confinarie ad un territorio boschivo, al fine di regolarne l’uso 164 tramite l’apposizione di particolari segnali, per lo più croci, tracciati sui tronchi degli alberi o più generalmente su massi e pietre. Per una puntuale disamina sul significato e l’etimologia del termine ANDRICH, Appunti, pp. 71-85; ID., La wifa, pp. 2-12; LATTES, pp. 944-979; PELLEGRINI, Postille, pp. 1-5; per il valore dell’istituto in rapporto al Cadore SCHUPFER, pp. 119-125; ZANGRANDO, Note, pp. 54-55; ID., Profilo, pp. 15-16; RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 85-86 e ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, pp. 81-85. Generalizzato fu sin dal medioevo -ed in Italia particolarmente- l’uso di porre sotto speciale tutela determinati luoghi, contraddistinguendoli con l’apposizione di speciali segnali, in particolare con croci, che in seguito rappresentarono il confine ed in generale il limite dei terreni posti sotto la protezione del Commune. 162 La prima etimologia risulta quella più generalmente accettata e diffusa (cfr. RICHEAmpezzo, p. 120), mentre la seconda interpretazione è sostenuta principalmente da ANDRICH, Appunti, pp. 73-74 e PELLEGRINI, Postille, pp. 1-5, ripresa in Oronimi, p. 260. Entrambe le posizioni sono ben sintetizzate dalla RUSSO, Toponimi, pp. 23-24 e 481-484 e da ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, pp. 81-95, part. 81-83; per l’attuale significato cfr. Vocabolario Ampezzano, ad vocem.. 163 BUONO, 164 Si confronti in proposito la descrizione del CIANI, I, pp. 46-47, che attribuisce alla cerimonia il significato di presa di possesso. 48 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo All’interno del confine, così delimitato, non era consentito il pascolo e le piante non si potevano liberamente tagliare o utilizzare, ma erano vigilate e protette. La vizza cadorina dunque è un istituto che regola il diritto d’uso della proprietà boschiva, in certi casi inibendolo a tutti, in altri consentendolo ai soli aventi diritto, nel rispetto di ben determinate modalità 165 e sotto pena di apposita sanzione. In Cadore sono documentati infatti, a seconda delle finalità, diversi tipi di vizza: la vizza da lavina, stabilita a protezione degli abitati su terreni particolarmente soggetti a frane e valanghe; la vizza da dassa o da zema 166, utilizzata per la salvaguardia di legname utile al rifabbrico; la vizza da fogolar per la legna da ardere; la vizza per le chiese, destinata a garantire la manutenzione degli edifici di culto; un caso particolare è poi costituito dalla vizza da riserva, bosco interdetto a tutti, da utilizzarsi per calamità pubbliche o eventi imprevedibili 167. In base allo Statuto cadorino 168, l’atto di vizza non poteva essere regolarmente steso se non previa deliberazione e licentia Consilli Generalis, analogamente a quanto previsto per gli atti di vendita o di alienazione a qualsiasi titolo di beni comuni o regolieri; da quando Ampezzo fu separata dal Cadore, tale provvedimento di autorizzazione veniva evidentemente adottato dal Consiglio generale d’Ampezzo, che ricopriva gran parte delle funzioni istituzionali prima svolte dal Consiglio generale di Cadore. La necessaria autorizzazione appare richiamata, in sede di narratio, anche nell’atto di seguito trascritto, risalente alla metà del secolo XVII: in base ad esso è stato possibile rintracciare e ricostruire il completo iter procedurale della vizza, che risulta costituito da tre fasi 169: 165 Generalmente, sottrarre il bosco all’uso comune per regolarne e disciplinarne l’utilizzo significa permettere ai regolieri il taglio del legname necessario al fabbisogno familiare, ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, p. 87. 166 Termini del dialetto locale indicanti ramoscelli verdi di conifere e cimoli di resinose, cfr. Vocabolario Ampezzano, ad vocem e MENEGUS TAMBURIN, Il dialetto, ad vocem. 167 Tale classificazione in ZANGRANDO, Note, pp. 54-55; ID., Profilo, pp. 15-16. Statuti, p. 139, cap. CIX. Delli boschi vizzati. « Vogliamo, & commandiamo, che niuna Regola, o commune di Cadore possi, né vaglia farsi, ò terminarsi alcuna vizza senza espressa licenza del conseglio; & se si sarà fatta, & terminata altramente, non vaglia, né tenga, ma sia di niun valore & momento. Né alcun Nodaro possi far instromento alcuno di alcuna vizza, se non sarà deliberato, & determinato dal Conseglio. Et se si trovarà qualche instromento fatto contra la forma del presente ordine sia, & habbiasi per nullo. In oltre niuna persona di ciascuna conditione, commune, ò regola, ò consorti ardisca, ò presumma con alcun inzegno, causa, ò colore tagliare, ò far tagliare in alcuni boschi vizzati legni, ò legno alcuno, se non per li ponti, case, strade ò cisure: & per le chiusure li legni non eccedano la revolutione, & grossezza di un piede commune sotto pena di lire ducento, & di perder li legni, la metà della qual pena sia applicata al Dominio, & l’altra metà al commune con li legni tagliati ». Cfr. anche p. 140, cap. CXIV. Di quelli, che cavano li legnami dalli monti. 168 169 Si veda, come utile esempio, la documentazione relativa alle disposizioni adottate nell’arco di oltre due secoli per proteggere la vizza di Naulù, in Due Soldi, La vizza, passim. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 49 — la preventiva deliberazione da parte dell’assemblea della Comunità, in questo caso espressa nella forma « (…) item fu determinato che sii fato vizza nel luoco detto Parù della Fava et cetera » 170; — il successivo compimento del fatto giuridico in loco e la documentazione di esso in forma notarile, come di seguito trascritto; — l’approvazione finale del documento da parte del Consiglio della Comunità, come ad es. « in pieno et general Consiglio (…) fu lodato in tutto e per tutto l’instromento della soprascritta vizza fata nel luocho detto Palù della Fava et sue pertinenze » 171. Si ricorda che il legname delle vizze ampezzane era a pieno titolo di proprietà esclusiva della Comunità, ad eccezione di quello del bosco circostante il castello di Botestagno, che venne indemaniato a partire dalla metà del secolo XVI 172. Gli atti di vizza boschiva nell’Ampezzano sono attestati solo a partire dal secolo XV 173; ve ne sono sporadici esempi per il secolo XVI, mentre dall’esame dei protocolli notarili e dei numerosi atti sciolti conservati, la fattispecie risulta assai più ampiamente documentata nel corso del ’600 e del ’700 174. Si riporta di seguito la trascrizione di un atto di vizza del secolo XVII, con cui si vieta il taglio di ogni tipo di legname, sotto pena di 5 lire per ogni fusto abbattuto: di questo documento non è stato rinvenuto presso l’Archivio del Comune di Cortina il rispettivo instrumentum, forse perduto. La testimonianza del secolo successivo, che pur si trascrive, documenta invece il rinnovo di una vizza da dassa (ramoscelli verdi di conifere), con la quale s’intende preservare dal taglio e dalla raccolta il legname generalmente impiegato per usi di rifabbrico. In entrambi i casi si attuava una sorta di tutela forestale, impedendo ai regolieri di utilizzare le piante prima che fossero mature: una volta caduto il divieto, si permetteva il taglio del bosco e con ciò la vizza si estingueva. Risulta pertanto evidente come si riproponesse, a distanza di anni, la necessità di rinnovarne le delimitazioni confinarie, e ciò spiega l’elevato numero di atti che risultano attestati. 170 ASCC, reg. 19: Protocollo delle delibere del Consiglio Comunale di Ampezzo, c. non num., 23 luglio 1665. 171 Ibid., c. non num., 24 agosto 1665. RICHEBUONO, Storia, pp. 188-189. Per le differenze tra l’istituto della vizza cadorina e quella più propriamente ampezzana ZANDERIGO ROSOLO, Appunti, p. 83; l’importanza del patrimonio boschivo era sancita in modo particolare dagli Statuti, p. 61, cap. CXXV. Delli boschi di Cadore e capitoli successivi. 172 173 Per il periodo precedente, oltre alle cosiddette vizze di laudo, esistono solo vizze di pascolo, il cui documento più antico, del 1228, è trascritto da RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 200-210; cfr. RICHEBUONO, Storia, p. 121. Il testo del più antico instrumentum vizae conservato, del 1464, è trascritto in MENEGUS TAMBURIN, Atti, pp. 270-273. 174 Gli atti di vizza di questo periodo sono conservati presso l’ASCC ed in gran parte elencati da RICHEBUONO, Storia di Cortina, pp. 301-302. 50 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Dal punto di vista diplomatistico i due documenti presentano un dettato alquanto omogeneo, che lascia assai poco spazio al formulario fisso ed ampia parte alla descrizione fisica dell’oggetto, comprensiva di numerosi riferimenti topografici ed elementi toponomastici; in entrambi nell’ambito delle formule di dispositio viene sottolineata l’utilità comune dell’atto (…a benefitio d’ogni uno; … a benefitio publico). Documenti: 1. La Magnifica Comunità d’Ampezzo delimita il territorio di una vizza che si estende dal lago di Parù de ra Faa di sotto fino al ponte della segheria di Pezié de Parù. Nel nome del Signore, così sia. L’anno della Sua natività .1665., inditione .3a., li .31. luglio in Cortina d’Ampezzo, in casa di me infrascritto nodaro; presenti mastro Zuanne Zangrandi et mastro Domenego quondam Zuanne de Menardo, testimonii hauti, et cetera. Stante ala parte in pieno et generale Conseglio passata soto li .23. luglio del anno corente, di dover far vizza cominciando dal lago di Palù dalla Fava di soto et arivar sino al ponte della siega di Picia di Parù et andar verso la montagna, conforme al parere delli || cappi della magnifica Comunità, essendo offitialle il signor Francesco Constantini nodaro, marigo mastro Zuanne figliollo di Pietro Alverà deto da Grava, tuti sindici, mastro Tomaso quondam Andrea Alverà, mastro Nicolò quondam Zuanne di Maion et huomini eleti, mastro Zuanne quondam Biasio Zangrandi et mastro Domenego quondam Zuanne di Menardo, laudadori, mastro Ieronimo quondam Iacomo di Vall, mastro Antonio quondam Domenego di Minighell detto d’Ardoara, et così d’ordine del predetto spettabile Conseglio sono andati a far et determinare fuori la presente vizza, a benefitio d’ogni uno. Et prima hanno posto il primo termine: et comincia ad un sasso mediocre posto lontano dal fiume Costeana passa numero .6. in circa, nel qualle vi è scolpita una croce, qual guarda verso matina et è apresso il trozzo che si passa esso fiume andando di Volpere fuori, et da quello tendendo in fuori et in suso va ad arivare ad un sasso grande, nel qualle vi sono scolpite dui croci, guardano verso mezzogiorno; et da quello andando in suso va a referire ad un sasso grande appresso il lago, nel quale vi è scolpita una croce, guarda verso sera, et da quello andando in suso a drita linea va a referire ad un altro sasso grande sopra la strada lontano da essa circa un tiro d’arcabuggio, nel qualle vi è stato fato una croce, qual guarda verso la strada; et da quello voltando in suso andando per la costa a man sinistra va a referire ad un sasso non molto grande sopra del qualle vi è un zirmolo, sopra del qual sasso vi è stata scolpita una croce, qual guarda pur verso la strada; et da quello voltando in su per la costa va ad arivare ad un sasso non grande nel qualle vi è scolpita una croce, qual guarda verso sera, || lontano dal rù passa numero .5. in circa, et da quello tendendo in su a man sinistra va a ad arivare ad un sasseto picolo negro apresso la strada, sopra del qual vi è scolpita una croce, et da quello andando in su per la strada va ad un sasseto picolo di fuori della strada et appresso la strada, nel qual vi è scolpita una croce, che guarda verso nullhora, et da quello andando in su sino in cima la costa va ad un sasso non grande nel qual vi è scolpita una croce, guarda verso null’hora; et da quello andando per cima la costa va a referire andando a man sinistra ad un sasso mediocre, nel qualle vi è scolpita una croce, qual guarda verso sera, et da I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 51 quello andando a man sinistra va a referire ad un sasso grande di fuori della strada, nel qualle vi è scolpita una croce, guarda verso nullhora, et da quello tendendo in su a man sinistra ariva ad un sasso in cima la costa, nel qualle vi è scolpita una croce di sopra, et da quello tendendo in su a drita linea verso la crepa, va a referire ad un sasso non molto grande di dentro della strada, nel qualle vi è scolpita una croce, qual guarda verso mezogiorno, et da quello andando a drita linea per strada va a referire ad un sasso non grande, sopra del qualle vi è scolpita una croce, guarda verso matina, et da quello andando pur in suso a drita linea va a riferire ad un sasso non grande apresso la strada, nel qualle vi è scolpita una croce, qual guarda verso sera, partendosi da quello va a referire andando in su alla crepa deta Crepa Cianù, cioè alla cima di quella et da quella crepa voltando in || dentro per soto le creppe va a referire ad un sasso attacato alla crepa, nel qualle vi è scolpita una croce, guarda verso matina, et da quello andando pur dentro più dentro per soto le crepe va a referire ad un sasso b grande sopra del quale vi è scolpita una croce, che guarda verso sera, et da quello andando a dreta linea tendendo a man destra va a referir ad un sasso non grande, nel qualle vi è scolpita una croce che guarda verso null’hora; et da quello andando in dentro et in zoso a man drita va a referire ad un sasso al piedi della luda [vallone scosceso], sopra il qualle vi è scolpita una croce, et da quello andando in dentro et in zoso va ad un sasso non molto grande appresso il tizzo [sentiero], sopra del qualle vi è scolpita una croce; et da quello tendendo in zoso per il tizon c va a referire ad una lasta al piedi de esso tizon in mezo d’esso tizzon, o strada, sopra della qualle vi sono scolpite dui croci et da quella andando in zoso va a referire al ponte di sopra della siega, apresso il qual ponte vi è una lasta, sopra della qualle vi è scolpita una croce, et da questa lasta andando per apresso il fiume Costeana zoso va a referire al primo termine et tra questi confini s’intenda il tuto vizza, et perciò ogni sorte di legname proibito, soto pena di lire .5. per legno, et cetera. Laus Deo semper, et cetera. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, notaio Alessio Ghidini di Simone, prot. 31, cc.69v-71r, rep. 129 a Vad nel testo. b Segue non molto depennato. c Segue a depennato. 2. La Magnifica Comunità d’Ampezzo rinnova la delimitazione della vizza della Cejura Granda sopra Campo, definendone i confini. *Laus Deo semper*. Adì .27. novembre .1733., inditione .11a., in Ampezzo imperiale, in casa di me nodaro, et cetera. In viggor et essecutione di parte passata in pien e general Conseglio sotto li .9. ottobre decorso, essendo officiale il signor Nicolò Costantini nodaro et officiale, marigo il nobile signor Ignatio de Zanna, suoi sindici signori Daniel de Maion et Zamaria Zambelli et capi della magnifica Communità nostra del presente anno, assieme con mastro Giacomo quondam Giacomo da Dié Sartor, laudador, et mastro Bortolo Soravia huomo delle pertinenze a deputato dal spetabile Conseglio, con me cancelliere, a benefitio publico, furono aggionti e rinovati li termini e confini della vizza detta della Cesura grande sopra Campo, pertanto transferiti sopra luogo: et il primo termine incomincia alla lasta grande posta in luogo detto in Cima il salto sopra della strada, la quale è segnata con una croce che varda 52 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo mattina e da quella callona et b descendendo in zò per strada si vien a refferire ad un sassoto quasi al piede della costa un pocchetto di fuori della strada del salto, circa passa .10. di dentro della Cesura grande e di sopra, nel quale vi è scolpita una croce, che mira verso mattina e da detto sasso c venendo in zò per strada di dentro della Cesura s’arriva ad un sasso non grande, circa passa .4. di dentro della strada, marcato con una croce che varda mezodì (salvi li termini e confini de particolari della Cesura grande) et da detto sasso callando in zò per la strada di fuora, si viene ad un sasso grande appresso la strada a man sinistra nel venir in zoso, nel quale vi è improntata una croce, che varda verso mezzodì, e da quello callando in zò per strada, si arriva ad un sasso mediocre, posto circa passa .25. sopra il palù detto delle Cesurette, a man sinistra d di dentro d’essa strada, segnato con e due croci, l’una che mira a mattina e l’altra a mezzodì, et da questo traversando et andando in fuora per la strada sopra Col Tondo, et ascendendo alquanto di dentro della costa, arrivasi ad un sasso || grando due passa in circa sopra la strada a man dritta nell’andar in fuora, marcato con croce riguardante mattina, et da questo callando e traversando zò per la costa si vien a rifferire ad un sasso honestamente grande posto in mezzo del Pian o Pallude delle Fontane sopra val dall’aqua, nel quale vi sono scolpite due croce, l’una che varda mezzodì e l’altra verso il cielo e verso sera; e da questo andando in fuora et ascendendo per la strada si viene ad un sasso mediocre di fuori et appresso detta strada, marcato con croce riguardante verso settentrione, e da questo andando su per la strada s’arriva ad un sasso grande sopra la costa di fuori della detta strada, lontano circa passa .6., segnato con croce riguardante mezzodì; e da quello tendendo fuora per la strada a man sinistra, s’arriva alla cima della Crepa di Pol dal Porin di dentro, et appresso il rù di Comin; e da quella tendendo su per il rù di Comin si va a refferire alle aquarolle che descendono in zoso per una vallesella, et ascendendo in su et in dentro per essa vallesella, arrivasi ad un sasso grando posto in luogo detto Pol dal Purin, appresso e di fuora della strada, segnato con due croci, una guarda verso sera et l’altra verso null’hora, et ascendendo a dritta linea in su et in dentro, s’arriva ad un sassetto in cima una costa, segnato con croce che mira mezzodì, et da questo andando dentro per la cima dela costa s’arriva ad un sasso grandotto, marcato con croce riguardante mezzodì; e da quello tendendo a dritta linea f dentro per la cima della costa si viene ad un sasso mediocre, nel quale vi è scolpita una croce che rivarda mezzodì; e da quello tendendo in dentro per la costa si va ad arrivare ad un lasta situata appresso; e di fuori della strada che si va in cima il salto g, segnata con croce, mira a mezzodì; e da quella si va refferire alla lasta grande in cima il salto sopra la strada, primo termine. Che però dentro li sudetti termini e confini s’intende vizza e || proihibito il tagliare alcuna sorte di legname da dassa, grande e piccolo, sotto penna, oltre la perdita del legniame, d’un fiorino per piede. Che così a gloria di Dio et a benefitio publico, si publica, acciò ogn’uno sappi da contenersi. Publicata sotto la loggia, coram pupulo, li .28. febrario .1734. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, notaio Giovanni Verocai di Giovanni Paolo, prot. 44, cc.250r-251r, rep. 242. b delle pertinenze in soprallinea con segno d’inserzione sottostante. et su cancellatura. e segue vend depennato. d sinistra in soprallinea scritto in luogo di dritta depennato. segue f g croce depennato. segue per depennato. segue e da que depennato. a c I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 53 3.4. L’albergo. — I due documenti dei quali segue trascrizione si riferiscono alla delimitazione di alberghe, ovverosia di spiazzi intorno alle malghe, riservati al ricovero serale delle mandrie in alpeggio e delimitati con croci incise su pietre o alberi 175. L’albergo, probabilmente dotato in origine soltanto di alberi frondosi atti ad accogliere gli armenti durante le ore notturne 176, fu poi attrezzato anche con appositi ricoveri in legno; le piante scelte a delimitarne l’area erano per la loro importante funzione particolarmente protette e non potevano perciò essere abbattute o danneggiate 177. Come nel caso della vizza, anche per la delimitazione d’albergo era prassi che alla preventiva deliberazione emanata dall’assemblea della Regola e alla relativa autorizzazione da parte del Consiglio della Comunità, facesse seguito il vero e proprio compimento dell’atto giuridico, redatto in forma notarile. Purtroppo, stante l’assenza dei libri delle delibere della Regola grande di Lareto 178, auctor di entrambi gli atti, non è stato possibile in questo caso rintracciare la determinazione da cui derivano i testi di seguito trascritti. Di entrambi i documenti è stato però rinvenuto 179 il relativo instrumentum in mundum, completo di sottoscrizione e signum tabellionis del notaio rogante. Si riporta integrale trascrizione di questi atti non solo per la peculiarità documentaria di cui sono testimoni, ma anche per la loro relativa rarità, giacché risultano essere gli unici rintracciati nei protocolli notarili ampezzani 180: si è infatti portati ad ipotizzare che tale tipologia documentale si affermi solo a partire dall’inizio del secolo XVII, vista l’assenza di riferimenti ad essa sia nei laudi delle Regole cadorine che nei più accreditati testi di storia delle Regole dei secoli XII-XV 181. Similmente a quanto già visto per i docuIl termine si riconduce probabilmente al gotico haribaírg, come evidenziato da BATStoria, p. 222 e ID., I toponimi, p. 71, ripreso da RUSSO, Toponimi, pp. 496-498. 175 TISTI, 176 Si trattava in particolare del bestiame non da latte, che poteva trascorrere la notte all’addiaccio, come precisa PALLABAZZER, Su alcuni, pp. 218-221. 177 Per la definizione di albergo si vedano Vocabolario ampezzano, ad v.; DE SANDRE, Notizie, p. 74; Oronimi, pp. 79, 117; MENEGUS, pp. 107-108; più diffusamente RUSSO, Toponimi, pp. 496-497; ID., Pallidi, pp. 59-60. 178 Dalla documentazione conservata presso l’ARAMP non risultano pervenuti veri e propri registri con i verbali delle deliberazioni prese dalla Regola durante le assemblee anteriori al sec. XIX. Si noti che la Regola grande di Lareto era, tra le Regole ampezzane, quella che gestiva la parte più estesa di territorio; RICHEBUONO, Ampezzo, pp. 77-78. 179 ARAMP, Lareto, docc. nn. 142 e 143 (entrambi cartacei). Viceversa, atti sciolti a documentazione di tale tipologia sono conservati, come già visto, presso l’ARAMP. 180 181 L’argomento non risulta infatti trattato da RICHEBUONO, Ampezzo, passim; ID., Storia, passim; ZANDERIGO, Appunti, p. 169, part. n. 157. Ad un atto di albergo del 1612 accenna RICHEBUONO, Storia di Cortina, p. 303, ma stante l’assenza di protocolli notarili per gli anni antecedenti al 1598, risulta difficile dire se in precedenza atti di questo genere venissero analogamente rogati. A tal proposito si noti peraltro che la menzione di Alberghi dei Buò si rintraccia in un’aggiunta al laudo di Lozzo di Cadore del 1751, pubblicato da FABBIANI, I laudi di Lozzo, p. 30. 54 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo menti di vizza, l’importanza e la singolarità di questi atti si evidenzia soprattutto in rapporto al patrimonio toponomastico che conservano, nonché alla particolare descrizione di un territorio — oggi talora mutato — di cui sono fedeli testimoni 182. Documenti: 1. La Regola Grande di Lareto delimita il territorio degli alberghe ampezzani di Valbòna, Padeón, Rufiedo, Ospitale, Antrúiles, Piàn de Lóa e Progóito, definendone i confini. Nel nome della santissima et individua Trinità, Padre, Figliolo Spirito Santo, amen. L’anno della gloriosissima natività Sua .1732., inditione decima, li .26. maggio, in Cortina d’Ampezzo imperiale, in casa di me nodaro; presenti il signor Zamaria Costantini et signor Silvestro Apollonio, testimonii a. In l’esecutione di parte passata in pien e general Regola grande di Laretto sotto li .4. maggio .1732. dal signor Antonio de Ghirardo marico, signor Andrea Ghedini coglietro, mastro Mattia quondam Battista Soravia et mastro Bortolo Apollonio sindici e tutti capi attuali dell’onoranda Regola grande di Laretto dell’anno presente, con autorità e permissione publica passata in pien e general Consiglio il dì de .6. e .11. maggio, anno corrente, stante ad humilissima supplica fatta all’assistenza del signor Antonio quondam Giacomo b Bellodis, marico attuale della Magnifica Comunità nostra del presente anno, del signor Pietro quondam Bastian Apollonio consule, del signor Battista de Zan consigliere et di me nodaro e cancelliere elleti, destinati e deputati a tall’effetto dal spetabile Consiglio; portatisi tutti sopra locho a benefitio universale de membri e regolieri, per ricovero dell’animali furno terminati li seguenti alberghi, di ragione della prefatta Regola, dove che furno distintamente a chiara inteligenza e per regola d’ogni uno scolpiti li termini e confini nel modo, forma e come hora segue. Il primo termine dell’albergo di Valbona principia dentro in cau l’albergo ove appresso il tizzon che va in Sopìs lontano dall’aqua circa .5. passi è un sasso nel quale sono scolpite due croci, una granda verso c mezogiorno et l’altra a settentrione e .3. passi distante dal sasso è un pezzo signato con una croce, che varda a sera, et andando in fuori e in giù a dritta linea sopra 3 passi || ove è un sasso con una croce scolpita, che guarda mezogiorno, et appresso è un pezzo signato con una croce che mira ad oriente, dal qual termine andando in fuori a dritta linea .30. passi in circa evvi un sasso piciolo con una croce scolpita che mira il cielo, e mezodì et un pocho distante è un pezzo con croce signata che mira a sera da dove andando in giù et in fuori circa .35. passi, ove è un sasso con una croce scolpita che mira verso il cielo e .3. passi distante è un pezzo con croce signato che varda a sera, andando in fuora poi a dritta linea .13. passi distante, ove è un sasso con croce scolpita che varda mezogiorno et appresso è un pezzo signato con una croce che mira l’oriente e questo termine è appresso la strada che va al pallude del boscho; et andando .30. passi in fuora a dritta linea evvi un pezzo signato con una croce che guarda mattina e da quello andando in Alcuni degli alberghe citati in questi documenti sono tuttora vitali ed utilizzati dalle Regole al medesimo scopo: così ad es. Ra Stùa, Antrúiles, Progóito, cfr. RUSSO, Toponimi, pp. 497498 e DE ZANNA-BERTI, ad vv. 182 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 55 su .40. passi verso mattina è un sasso con croce scolpita mira verso sera, et un pocho distante è un pezzo signato con croce, che mira l’oriente, dal qual termine andando in su .48. passi in circa ove appresso il tizzon che va alla motta è un sasso piciolo con una croce scolpita, che mira il cielo, et appresso è un pezzo signato con una croce, che varda a sera; et da quello andando in su .19. passi riferisce ad un sasso, che ha una croce scolpita, che varda verso mezodì andando in dentro per la sponna.40. passi in circa lontano, ove è un sasso con una croce scolpita che guarda a mattina et appresso un avedino con croce signato, che varda mezodì, dal qual termine andando su per la spona .32. passi lontano, ove è un sasso grande, che ha su due pezzi || et un avedino signato con una croce, che guarda l’oriente, similmente un pezzo signato con una croce che mira a mattina, et andando circa .30. passi lontano è un sasso con una croce d scolpita che guarda mattina, parimente un pezzo con una croce signato, che guarda mezogiorno; continuando poi il viaggio in dentro .40. passi lontano ove in mezo la valle è un sasso piciolo con una croce scolpita, che varda verso mezogiorno et un pezzo con croce signato che varda sera e da questo andando in dentro cima la costa, ove è un sasso con una croce scolpita che guarda verso il cielo, appresso del quale è un pezzo signato con una croce che mira l’oriente, et andando .25. passi lontano in mezo il tizzon è un sasso distante dalla fontana dell’albergo .50. passi, su di cui è scolpita una croce che varda a sera, et appresso evvi un pezzo con una croce signato, che varda a sera, da dove tendendo in dentro a dritta linea un pocho su per la costa .34. passi distante è un sasso piciolo con una croce scolpita, che varda verso sera; ittem un pezzo appresso con croce signata guarda il mezodì il qual termine è distante dall’albergo idest dalla sommità .70. passi in circa, così tirando in dentro per sopra l’albergo .34. passi lontano ove è un sasso con croce scolpita, che mira l’oriente e .3. passi distante è un pezzo con croce signato, guarda mezogiorno, et andando .19. passi in dentro e in su è un sasso con una croce scolpita, che guarda il cielo et appresso un pezzo sopra un sasso con croce signata, che mira l’oriente e da quello tirando in dentro .19. passi ove è un sasso con una croce scolpita che guarda il cielo et appresso un pezzo con croce e signata che guarda a mattina e così tirando f sino all’aqua, la qual aqua da parte di dentro termina da un capo all’altro, sino g a riferire al primo termine. || Il primo termine dell’albergo di Padevon principia dalla parte di cima Forcha al piede della spona, ove appresso il rio sono due pezzi, ambi segnati con due croci, che mirano a settentrione, indi andando in su a dritta linea .40. passi in circa evi un cirmolo segnato con una croce che guarda a null’ora et .4. passi più in su evvi un sasso con una croce scolpita, che guarda settentrione, indi tendendo su a drita linea .20. passi in circa va a riferire ad un sasso con una croce scolpita, che guarda a sera, andando poi in dentro per sopra l’albergo .24. passi distante è un pezzo segnato con una croce, che mira il mezogiorno, indi andando in su a man dritta .40. passi in sopra ove, di là dell’aqua, è un pezzo signato con croce, che mira settentrione, indi andando in dentro .40. passi a dritta linea evvi un pezzo appresso il tizzon, su di cui è segnata una croce, che guarda a null’ora, andando poi .16. passi in dentro è un pezzo segnato con croce, che guarda a mattina et da quello .25. passi in dentro riferisce ad un pezzo segnato con una croce, che guarda mezogiorno, indi .25. passi in dentro è un pezzo signato con una croce, che guarda a null’ora, andando poi in dentro e in giù è un pezzo signato con una croce, che mira il mezogiorno e .36. passi più in dentro è un pezzo segnato con una croce, che mira a mattina, indi venendo in giù .13. passi, ove è un pezzo con due croci che guardano l’una a mezogiorno et l’altra a settentrione, indi caminando .45. passi in giù, ove è un 56 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo pezzo grande segnato con una croce, che guarda settentrione, poi .20. passi giù a basso appresso la strada è un sasso con croce scolpita, che mira a sera et da questo termine all’aqua, qual aqua confina dalla parte di sotto sino a riferire al primo termine. Il primo termine dell’albergo di Rufredo principia all’aqua da || parte di sotto e dall’aqua tirando in su a drita linea sino al ponte di Rufredo e da quello andando .12. passi in su è un pezzo signato con una croce che guarda mezodì e da quello andando passi .27. in circa a man manca riferisce ad un sasso con una croce scolpita che mira oriente, et un pezzo signato con croce che guarda a mattina, .25. passi lontano dali circuito dell’albergo e da quello andando passi .30. in circa verso null’ora evvi un sasso signato con croce, che guarda l’oriente, dal qual termine tirando in dentro per sopra l’albergo .40. passi distante è un pezzo signato con due croci, l’una mira a mattina et l’altra mezogiorno, andando poi in giù .27. passi si ritrova un sasso basso con croce scolpita, che mira il cielo et appresso un pezzo signato con una croce, che guarda a mattina, andando poi in giù .25. passi è un sasso basso con croce scolpita, che mira il mezogiorno et appresso un pezzo con croce, che guarda sera, andando a drita linea .35. passi, ove sopra la strada è un sasso basso con croce scolpita, che mira mezodì et un pezzo signato con croce, che guarda verso mattina e da quello tirando a dritta linea va a riferire all’aqua, l’aqua poi confina sino al primo termine. Il primo termine dell’albergo dell’Ospedale principia passi .15. circa sotto la strada regia dalla parte dell’Ospedale, ove è un sasso con una croce scolpita, che guarda mezodì e da quello andando giù a drita linea sino alla chiesura, ove è un sasso con croce scolpita, che guarda a mattina, e da quello va secondo la chiesura e poi all’aqua, la qual confina sino a riferire ad un sasso circa .40. passi lontano dall’albergo sopra l’aqua, nel quale è scolpita una croce, che mira il cielo, et un pezzo signato con croce, che guarda settentrione e da quello|| tirando in su a dritta linea, ove .3. passi sotto la strada regia è una lasta con una croce scolpita, che mira il cielo e poi confina per sopra via la strada regia, sino a riferire al primo termine. Il primo termine dell’albergho d’Antruilles principia dalla parte verso null’ora idest all’aqua, qual aqua confina da parte di dentro sino ad un sasso situato di qua della sponna circa .4. passi, nel quale è scolpita una croce che mira il cielo et un pezzo signato con croce, che guarda a mattina e da quello andando via per sopra l’albergo .34. passi è un sasso grande con una croce scolpita che mira l’oriente et appresso un pezzo gemello signato con croce, che guarda mezodì, andando poi in giù sotto la strada .30. passi in circa, ove è un sasso con una croce scolpita, che mira il cielo et un pezzo con croce signata che guarda a null’ora, andando in giù .47. passi, ove in cima la costa è un sasso con croce scolpita, che guarda il cielo, et appresso un pezzo con croce, che guarda a settentrione continuando poi giù a dritta linea .35. passi, ove è un sasso rotondo con una croce scolpita, che mira il cielo, venendo poi .36. passi in giù in cima la sponna dell’aqua, ove è una piciola lasta, su di cui è scolpita una croce, che guarda il cielo, et appresso un pezzo signato con croce, che mira a null’ora et da quello all’aqua, l’aqua poi confina sino all’altra aqua, primo termine. Il primo termine dell’albergo di Pian del Lova principia da parte di fuori sopra la strada .5. passi in h circa ove è un sasso con una croce scolpita, che mira il cielo e da quello tirando su a dritta linea .16. passi ad un sasso grande nel quale è scolpita una croce, che guarda a mezodì, andando poi .26. passi in su è un i altro sasso in cui trovasi scolpita una croce, che mira il mezogiorno, e da quello distante .40. passi va a inferire ad un sasso nel quale è scolpita una croce, che guarda il mezodì, item un pezzo signato con una croce, che guarda l’oriente, andando .16. passi in su è un sasso con croce I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 57 scolpita, che guarda mezodì, et un pezzo signato || con croce, che mira il mezogiorno, indi .25. passi in dentro un pocho a man drita è un sasso piccolo con una croce scolpita, mira il cielo et un pezzo signato con croce, che guarda sera, andando .26. passi in dentro è un sasso con croce scolpita, che guarda il cielo et un pezzo signato con croce che guarda mezogiorno, andando poi in giù a man sinistra è un sasso con croce scolpita, che mira il cielo, et un pezzo appresso signato con croce, che guarda mattina, andando poi in giù a man dritta .30. passi sono due pezzi, ambi signati con croci, che guardano mattina, e mezogiorno, e da quelli .48. passi distante è una piciola lasta con una croce scolpita, che guarda sera et un pezzo con croce signato che mira l’oriente, venendo poi in giù .30. passi è un pezzo signato con una croce che mira null’ora; ittem su la radice d’esso legno una croce, che mira il cielo, andando .18. passi a drita linea è un sasso signato con una croce, che mira il cielo, sopra la strada e sotto la strada è un pezzo signato con croce, che guarda settentrione, da questo poi va all’aqua. L’aqua poi confina per sotto via sino a riferire al primo termine. Il primo termine dell’albergo di Proguoito incomincia sotto la strada, che va in Travenanzes ove è un sasso con croce scolpita, che mira il cielo et da quello andando per sotto l’albergo via .16. passi in cima una costa è un sasso piciolo che ha una croce scolpita, che guarda a sera, et da quello per la sponna via .50. passi lontano ad un sasso con croce scolpita, che mira il cielo e da quello .27. passi lontano è un sasso con croce scolpita che mira il cielo e poi .34. passi distante evi un sasso piciolo con croce scolpita, che guarda il cielo, andando poi in su .40. passi in circa ove è un sasso con croce scolpita, che mira a sera, et da quello ad un sasso con croce scolpita, che guarda mezogiorno .20. passi poi distante voltando in dentro a drita linea, ove è un sasso con una croce scolpita che mira il cielo .30. passi lontano, andando .30. passi indentro || va a riferire ad un sasso ove è scolpita una croce, che guarda setentrione e da quello tirando giù ad una valesella e questa servirà per ultimo confine sino alla strada ove all’orlo di quella è il primo termine. Dentro de quali termini e confini non sia lecito ad alcuna persona di che qualità essere si voglia, recidere o tagliare niuni legni di sorte alcuna né grandi né picioli, né verdi né sechi, senza la permissione del spettabile Consiglio et dell’onoranda Regola, ma nunc pro tunc et tunc pro nunc restano proibiti, banditi et interdeti deti legni, sol debbano servire per ospitio e ricovero degl’animali, sotto pena a trasgressori e violatori di deti termini e confini, col recidere arbori in deto centro di lire .6. per cadauno e per cadauna volta che saranno ritrovati deliquenti, da essere formato il proccesso vel praticato da signori capi dell’onoranda Regola, che pro tempore sarano e postea da medemi da essere eseguita et applicata in questa forma: quando è accusatore, una parte al medemo, una alla Communità et l’altra alla Regola; non esendo poi accusatore, due parti alla Communità et una alla sudetta Regola, et il legname resti a dispositione della Communità. Similmente, che niuno non ardisca incendiare, abbruciare o in qualsivoglia modo falssare a fine si sechino, overamente in altro modo dannegiare detti arbori continenti nelli sudetti termini et il marigo, che pro tempore serà, debba eseguire le sopra dette cose, sotto vincolo del suo giuramento et sotto pena di pagare col proprio, et alli contrafacienti (oltre la pena sudetta) quello parerà alla spettabile Communità, quando per tal raggione potesse ridondare qualche grave danno. Che tanto in virtù della determinatione del predetto Consiglio et acconsentimento e ratificatione dell’onoranda Regola a benefitio maggiore della medema, laude et honore del signor Iddio (che ci liberi da infortunii), è stato determinato, deliberato e statuito, il che serva ad perpetuam rei memoriam e per regola d’ogni uno, amen.|| Laus Deo semper, adì .15. giugno 58 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo .1732. Convocata pręconia voce al locho solito l’onoranda Regola grande di Laretto sotto la marighezza del signor Antonio de Girardo, del signor Andrea Ghedini cuglietro l, mastro Bortolo Apollonio, et mastro Domenego figlio di mastro Antonio d’Andrea elletto in vece del sudetto Mattia Soravia, passato fra questo tempo (come speriamo), a miglior vita, sindici e tutti capi attuali della medema onoranda Regola, dove che conferita la terminatione presente fu in detta Regola a chiara inteligenza d’ogn’uno publicata da me sottoscrito nodaro more solito e nell’istesso tempo fu omninamente laudata, approvata e confirmata ita che habbia in avenire il suo valore, effetto e che da signori capi il tutto sarà quod sii eseguito sotto vinculo del loro giuramento. Giulio Verochai nodaro et cancelliere. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, notaio Giulio Verocai di Giovanni, prot. 48, cc.165v-169v, rep. 279. b Segue havuti depennato. Quondam Giacomo in soprallinea con segno d’inserzione sottoc e f stante. Segue sera depennato. Segue scolpita depennato. Segue andando depennato. g h i Segue al depennato. In soprallinea in senza segno d’inserzione. altro in soprallinea l senza segno d’inserzione. coglietro in soprallinea senza segno d’inserzione, in luogo di marigo espunto. a 2. La Regola Grande di Lareto delimita il territorio del nuovo albergo di Ra Stua, definendone i confini. *In Christi* nomine, amen. L’anno di Sua santissima natività .1757., inditione romana .5a., adì .23. del mese di ottobre, in Cortina di Ampezzo arciducale, in casa di me nodaro, alla presenza delli signori Antonio quondam Bortolo Colle e di Pietro quondam Giacomo de Ghedina, testii avuti, et cetera. Et ivi in adempimento di parte passata in pien e general a Regola grande di Laretto, essendo merico attuale di quella il signor Andrea quondam Santo Lacedelli, queglietro il signor Giovanni Ghilardoni, sindici li signori Donato da Lus e Raimondo Gaspari, sotto il giorno .26. del passato mese di luglio, esecutivamente a parte permissiva del spettabile Conseglio nostro, in ordine a loro humilissima supplica, et cetera, sotto li *** del mese di agosto, a quall’effetto furno destinati e deputati ad assistere ed intervenire per l’assegno qui sotto, li spettabili signori Francesco quondam Valentin Appollonio e Giacomo Apollonio, consoli, per assegnare per benefitio di essa Regola, per ricovero de loro animali, un nuovo albergo nelle pertinenze e così detto della Stua, attinenze di Campo di Croce, delle estensione, come qui sotto e fra li infrascritti termini. Principia dunque il primo termine sopra la stradda di fuori del rio, dove giace un sasso rotondo, scolpito di croce, che guarda il cielo, e da questo andando reta linea verso Lerosa per passa numero .33. circa, dove s’attrova un sasso poco alto da terra bislungo, munito di croce che mira a null’ora, e da questo seguitando ed ascendendo per passa numero .27., ove è un pezzo gemello, in zima la sponna di fuori del rio, segnato con tre croci, due b nelle radice e l’altra nel legno, indi seguitando in su ed in dentro || e di dentro del rio passa numero .32., ove s’attrova un sasso picolo rotondo e basso, marcato con una croce, che guarda a sera e da questo seguitando al in dentro ed in su passa numero .35., dove in zima una costesella giace un sasso alquanto alto rotondo, scolpito de due croci, una che mira a null’ora e l’altra al cielo, e da questo termine precedendo in dentro passa numero .30. 59 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) circa in zima ad altra costesella di rimpetto e dritto al casone dell’albergo stesso, dove s’attrova un sasso basso, munito di croce, che guarda a mezzo giorno, indi seguitando e continuando in dentro passa numero .40. circa, dove giace un sasso rotondo munito di croce, che mira al mezzo giorno, e da questo continuando in dentro passa circa .62. dove in un sasso basso, in punta di una costesella che giace, fu con croce scolpito, che guarda a null’ora, e seguitando al in dentro passa .33. circa, dove in un sasso mediocre rotondo fu scolpita una croce, che guarda il mezzo giorno, e seguitando e continuando pur in dentro passa numero .53., passati li tizzoni della Risena Vechia, s’attrova un sasso rotondo basso, inciso con croce, che mira il mezzodì, e da questo termine voltando a man manca, a cantone per passa numero .37. circa, vi è un sasso rotondo sopra la stradda, scolpito con croce, che mira a sera e da questo discendendo passa circa .30. sino al rio di Val di Salata, sin’all’acqua che da quello scorre, dove|| è un sasso mezzano marcato con croce, che tende a sera e da questo continuando il rio passa numero .34. ad un sasso ivi vicino, scolpito con croce, che mira il cielo, e continuando passa numero .126. per il rio stesso, ove in una valesella s’attrova un sasso piccolo sotto la stradda monito con croce, che guarda a mattina, e da questo continuando in fuori passa numero .50. circa s’arriva al primo termine, dichiarando che non essendo il corso del rio a reta linea, li legni che sono sopra il rio se intendano compresi nel presente instrumento, et cetera. In quanto poi alla proprietà e dominio di esso albergo per gli albori sopraposti, così pure rispetto alla pena a chi entro li predetti confini ardirà tagliare, se si riporta in tutto e per tutto all’instrumento di assegnatione fatta di altri alberghi l’anno .1732., come in quello senza eccettione alcuna. Che così, et cetera. AS BL, Protocolli notarili d’Ampezzo, notaio Nicolò Constantini di Pietro Antonio, prot. 21, cc. 36r-37r, rep 58 Segue grande depennato, in soprallinea, con segno d’inserzione sottostante. con la seconda delle u in soprallinea. a b Nel testo duue, 4. L’INTERVENTO ARCHIVISTICO 4.1. L’ordinamento. — I protocolli notarili d’Ampezzo sono compresi nell’ambito del complesso documentario denominato Livinallongo-Ampezzo, che fu ceduto dall’Austria all’Italia nel corso dei primi anni Venti del Novecento, passando dall’Archivio di Stato di Innsbruck all’Archivio di Stato di Bolzano, ove rimase fino al 1970. La documentazione fu in quell’anno trasferita all’Archivio di Stato di Treviso in attesa che si costituisse quello di Belluno — sede attuale e definitiva per competenza territoriale — ove pervenne nel 1994. All’inizio delle operazioni di studio e riordino del fondo, i protocolli notarili risultavano corredati di un semplice elenco di consistenza indicante i registri in ordine cronologico, non essendo stato attuato fino ad allora un vero e proprio ordinamento archivistico. La sistemazione assegnata risaliva comunque ad un momento antecedente al trasferimento presso l’Archivio di Stato di Treviso: all’epoca risultavano infatti già apposte sulle coperte dei protocolli delle vistose segnature archivistiche ad inchiostro acrilico rosso, in sostituzio- 60 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo ne delle precedenti tracciate a pennarello nero. Entrambe le segnature sono peraltro già indicate nello strumento di corredo redatto a Bolzano dall’archivista Albino Casetti prima del 1970 e pervenuto quale elenco di versamento del fondo. Il criterio adottato nel corso della precedente sistemazione era stato comunque quello meramente cronologico e pertanto i vari registri di uno stesso notaio non risultavano accorpati tra loro. Inoltre l’identificazione dei roganti non sempre era corretta: le fuorvianti segnature non coeve presenti sulle coperte dei protocolli, foriere di errate attribuzioni, erano state infatti recepite e riproposte anche dall’ultimo ordinatore. La fase di ordinamento 183 dei registri ha avuto come obiettivo primario quello di riunire i vari protocolli del medesimo notaio, procedendo preventivamente all’individuazione della corretta paternità di ogni singolo pezzo. Le operazioni di attribuzione dei registri si sono tuttavia immediatamente rivelate piuttosto complesse, in quanto la mancata sottoscrizione degli atti costituisce usus comune a quasi tutti i notai ampezzani documentati. Inoltre, i frequenti cambi di mano riscontrabili nella scrittura dei documenti all’interno di uno stesso protocollo, inducevano ad ipotizzarne l’utilizzo anche da parte di più notai. Non potendosi dunque desumere il nome del rogante dalla sottoscrizione del singolo atto, è stato necessario basarsi in primo luogo sulla dichiarazione d’identità del notaio, spesso presente sulla prima carta del registro 184, talora anche accompagnata dal relativo signum tabellionis. La validità di tale dato per tutta l’estensione del protocollo è stata poi verificata o corretta attraverso la lettura dei singoli instrumenti, dai quali è possibile ricavare sporadiche sottoscrizioni, o impliciti indizi relativi al soggetto rogante. In mancanza della prima carta quindi, per individuare il nome del rogatario si è fatto ricorso alla lettura dei singoli atti del registro, nonché ad operazioni di controlli incrociati condotti su più protocolli 185. In tal modo è stato possibile non solo ricondurre a paternità tutti i protocolli pervenuti 186, ma anche individuare l’esistenza di 183 Solo a titolo di essenziale e non certo esaustiva citazione, si ricordano quali opere di costante riferimento nel corso del lavoro CASANOVA; PRATESI, Una questione; SELMI; CARUCCI, Le fonti; I protocolli; ROMITI, nonché il continuo scambio con la responsabile scientifica del progetto, dr.ssa Giustiniana Migliardi O’Riordan. 184 A causa della cattiva conservazione o della legatura non originale dei registri, tale carta risulta purtroppo mancante in numerosi casi. 185 A tal fine si è fatto ricorso anche alla consultazione di altre fonti documentarie utili ed attinenti, come nel caso del protocollo n. 31, in cui l’identità del notaio, mai esplicitamente dichiarata, è stata desunta tramite la collazione con i registri delle deliberazioni della Comunità d’Ampezzo. 186 La mancanza di sottoscrizione e quindi di autenticazione degli atti non garantisce in assoluto la corretta paternità di tutti i protocolli: un margine d’incertezza si verifica ad es. per i registri nn. 32 e 33, in quanto l’attribuzione — anche se suffragata da altri elementi — si è basata in questo caso soprattutto sull’unica sottoscrizione presente, che si trova in calce non ad un atto, bensì ad un fac-simile di formulario. Non si può infatti escludere che, trattandosi di un semplice modello di atto, peraltro mai utilizzato nell’ambito di quel protocollo, esso sia stato fedelmente riprodotto, copiando dall’originale anche la sottoscrizione. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 61 atti rogati da notai finora ignoti o precedentemente non individuati. Nel corso del riordino è stato inoltre rinvenuto un indice delle parti contraenti a sé stante, privo di sottoscrizioni od altri elementi identificativi: poiché l’esame dei caratteri estrinseci ha consentito di attribuirlo ad un protocollo non pervenuto del notaio Verocai Giovanni Paolo di Giovanni, l’indice è stato inserto in uno dei registri di quel notaio 187. 4.2. L’inventario. — I protocolli, una volta attribuiti, sono stati accorpati e disposti in successione cronologica nell’ambito dell’attività di ogni singolo rogante. All’interno dell’inventario i nomi dei notai si susseguono generalmente in ordine alfabetico, tranne quando l’appartenenza di essi ad una medesima famiglia costituisca vincolo logico preponderante rispetto al convenzionale andamento alfabetico. In tal caso infatti la numerazione coeva dei registri dimostra che vi era una stretta continuità nel passaggio dell’attività tra padre e figlio, che è stata archivisticamente rispettata 188. Nello strumento di corredo che rende conto dell’ordinamento attuato, ogni registro è stato descritto indicandone i seguenti elementi: — Il numero della busta, poiché i protocolli non costituiscono attualmente fondo autonomo, ma risultano compresi all’interno del complesso archivistico denominato Livinallongo-Ampezzo. — L’attuale numero di corda, seguito dalle precedenti segnature archivistiche (numeri rossi e numeri neri), che compaiono tra parentesi tonde. — Il nome del notaio con relativa paternità, ove rilevabile. Nel caso in cui esso sia risultato discordante da quello indicato sulla coperta del registro, o nel precedente strumento di corredo, è stata segnalata l’errata attribuzione, altrimenti fuorviante ai fini della consultazione. Sono stati altresì evidenziati quei notai che, non avendo protocollo proprio, bensì in comune con altri, non erano stati precedentemente individuati (protocolli nn. 23, 41, 42, 45, 49). — Gli estremi cronologici, con eventuale citazione di date sporadiche che esulino dall’arco cronologico prevalente. — Il numero degli atti, che generalmente risultavano già originariamente repertoriati, salvo nel caso dei protocolli nn. 29 bis, 34 e 54, per i quali si è proceduto a numerazione critica, cercando di uniformarsi il più possibile alle modalità ed ai criteri rilevabili dal confronto con gli altri registri. Tale intervento è stato segnalato in inventario inserendo il numero tra parentesi quadre. — Il totale delle carte, che sono state numerate nel corso dell’ordinamento, salvo nel caso del protocollo n. 29, che risultava già corredato di coevi numeri di pagina. — L’eventuale presenza di carte staccate o fascicoli slegati e di carte inserte. 187 Si tratta del prot. n. 39. 188 Si veda a tal proposito nell’inventario la successione dei protocolli 44-45-46. 62 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo — L’eventuale presenza dell’indice delle parti contraenti coevo, del sec. XIX, o ricostruzione attuale, con relative segnature. — Il tipo di legatura e di coperta, con relative segnature coeve. Di queste ultime sono state rilevate solo quelle funzionali all’ordinamento archivistico, tralasciando dunque eventuali segnature doppie o posteriori, spesso foriere di errate attribuzioni. — Lo stato di conservazione, nel complesso piuttosto buono. Nella trascrizione delle segnature gli scioglimenti di eventuali abbreviazioni sono stati espressi tra parentesi tonde, mentre le diciture che costituiscono esito di deduzione elaborata in base ad elementi esterni al documento e pertanto priva di oggettivo riscontro, sono indicate tra parentesi quadre. Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero 45 1 (39) (37) 2 (43) 3 4 46 Nome del notaio e descrizione del registro Estremi Con atti cronologici dal / fino al ALVERÀ GIACOMO ANTONIO DI BARTOLOMEO Atti repertoriati 1-202, cc.1-140 Indice delle parti coevo, cc. 134-137 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-6, Contrassegnato erroneamente Giacomo Alverà Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1753; Protocollo segnato Lettera A Conservazione buona 1753-1757 1766 (40) ALVERÀ GIACOMO ANTONIO DI BARTOLOMEO Atti repertoriati 1-295, cc.1-187, inserte cc. 2 Indice delle parti coevo, cc. 176-186 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1757; Protocollo segnato Lettera B Conservazione buona 1757-1762 1766 (44) (41) ALVERÀ GIACOMO ANTONIO DI BARTOLOMEO Atti repertoriati 1-327, cc.1-159, inserta c.1 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-18 Legatura originale Coperta membranacea Consevazione buona 1762-1778 (3) (3) CONSTANTINI PIETRO DI FRANCESCO Atti repertoriati 1-559, cc.1-147 Mancanti atti 375-379 e 526-547 Indice delle parti (2000) Legatura non originale (sec. XIX), non rilegato fasc. degli atti 379-559, inserto Coperta cartacea Conservazione discreta 1620-1634 63 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero 5 (5) (5) Nome del notaio e descrizione del registro Estremi Con atti cronologici dal / fino al 1634-1667 CONSTANTINI PIETRO DI FRANCESCO Atti repertoriati 88-669, cc.1-237, inserte cc. 2, slegato fasc. degli atti 1-9 Mancanti atti 1-9 e 58-87 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-20 Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente deperita Conservazione cattiva 6 (8) (-) 1655-1664 CONSTANTINI FRANCESCO DI PIETRO con anche atti di VEROCAI GIOVANNI 1653 DI GIOVANNI PAOLO (già attribuito a VEROCAI GIOVANNI) Atti repertoriati 1-615, cc.1-227, inserte cc. 4 Mutilo Indice delle parti (2000) Legatura non originale (sec. XIX) Coperta mancante Conservazione buona 47 7 (11) (10) CONSTANTINI ANDREA DI PIETRO 1669-1682 Atti repertoriati 1-159, cc. 1-92, inserta c.1, Staccate cc. 90-91 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-18, Contrassegnato G Legatura originale Coperta membranacea di riutilizzo, parzialmente mancante Segnatura coeva: G Conservazione buona 8 (15) (14) CONSTANTINI ANDREA DI PIETRO 1682-1720 1679 1690-1702 1722 Atti repertoriati 1-372, cc. 1-148, inserte cc. 12, di cui una membranacea Mutilo Indice delle parti coevo, non completo, cc.1-10 Legatura non originale (sec. XIX): c. 56 erroneamente rilegata come c. 148 Coperta mancante Conservazione discreta 9 (17) (16) CONSTANTINI PIETRO ANTONIO DI ANDREA Atti repertoriati 1-430, cc.1-273, inserte cc. 4 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-24 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1690; P(rotocollo) n(umero) 1 Conservazione discreta 64 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero 48 10 (19) (18) 11 (22) 12 49 50 Nome del notaio e descrizione del registro Estremi Con atti cronologici dal / fino al CONSTANTINI PIETRO ANTONIO DI ANDREA Atti repertoriati 1-394, cc.1-232, inserte cc.11 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-19, Contrassegnato 1702 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1702 Conservazione buona 1702-1707 1709 (21) CONSTANTINI PIETRO ANTONIO DI ANDREA Atti repertoriati 1-297, cc.1-182, inserte cc. 3 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-18 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1707 Conservazione buona 1707-1712 (23) (22) CONSTANTINI PIETRO ANTONIO DI ANDREA Atti repertoriati 1-234, cc.1-156 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-17 Legatura originale Coperta mancante Conservazione discreta 1712-1716 13 (24) (23) CONSTANTINI PIETRO ANTONIO DI ANDREA Atti repertoriati 1-288, cc.1-163, inserte cc. 2, slegato fasc. degli atti 255-288 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-16, con probabile S.T. (ad impressione) Legatura originale Coperta cartacea, parzialmente mancante Conservazione cattiva 1716-1720 14 (26) (25) CONSTANTINI PIETRO ANTONIO DI ANDREA Atti repertoriati 1-366, cc.1-239, inserte cc. 4, slegato fasc. degli atti 340-344 e 351-366 Indice delle parti (1996) Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1721 Conservazione discreta 1721-1730 15 (29) (28) CONSTANTINI NICOLÒ DI PIETRO ANTONIO Atti repertoriati 1-242, cc.1-255, inserte cc.11 Indice delle parti coevo, cc. 241-255 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-22 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1731; Num(e)ro p(ri)mo Conservazione buona 1731-1737 1730 65 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero 16 (30) (30) Nome del notaio e descrizione del registro CONSTANTINI NICOLÒ DI PIETRO ANTONIO Estremi Con atti cronologici dal / fino al 1736-1741 Atti repertoriati 1-177, cc.1-170, inserte cc. 4 Indice delle parti coevo, cc.163-170 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc. 1-22 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: Num(ero) Conservazione buona 17 (33) (32) CONSTANTINI NICOLÒ DI PIETRO ANTONIO 1739-1741 Atti repertoriati 1-176, cc.1-149, inserte cc. 3 Indice delle parti coevo, cc. 142-149 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-14 Legatura originale Coperta membranacea, tagliata Segnatura coeva: 1739; Protocolo Conservazione buona 51 18 (34) (33) CONSTANTINI NICOLÒ DI PIETRO ANTONIO 1741-1749 1754 Atti repertoriati 1-331, cc.1-290, inserte 3, staccata c.10 Indice delle parti coevo, cc. 2-18 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-28 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1741; Protocolo Conservazione buona 19 (36) (35) CONSTANTINI NICOLÒ DI PIETRO ANTONIO 1746-1749 Atti repertoriati 1-202, cc.1-200, inserte cc. 3 Indice delle parti coevo, cc.187-200 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-21 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1746; Protocolo Conservazione buona 52 20 (38) (36) CONSTANTINI NICOLÒ DI PIETRO ANTONIO Atti repertoriati 1-242, cc.1-205 Indice delle parti coevo, cc.191-205 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-30 Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente deperita Segnatura coeva: Anno 1749; N(umero) 6 Conservazione buona 1749-1755 1759 66 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero 21 (41) (39) Nome del notaio e descrizione del registro CONSTANTINI NICOLÒ DI PIETRO ANTONIO Estremi Con atti cronologici dal / fino al 1755-1767 Atti repertoriati 1-240, cc.1-208, inserte cc. 3 Indice delle parti coevo, cc.193-208 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-24 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1755 Conservazione buona 22 (46) (43) CONSTANTINI GIOVANNI ANTONIO DI NICOLÒ 1767-1772 Atti repertoriati 1-133, cc.1-151, inserta c.1 Indice delle parti coevo, cc.136-151 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1767 Conservazione buona 53 23 (49) (46) CONSTANTINI GIOVANNI ANTONIO DI NICOLÒ 1773-1776 Atti repertoriati 1-80, cc. 1-90, inserta c.1 CONSTANTINI BENEDETTO DI NICOLÒ 1776-1779 Atti repertoriati 81-159, cc. 91-147 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-24, Contrassegnato Alfabetto 1773 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1773 Conservazione buona 24 (51) (48) CONSTANTINI BENEDETTO DI NICOLÒ 1779-1788 Atti repertoriati 1-233, cc.1-153, inserte cc. 2 Indice delle parti coevo, cc.144-153 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1779; Protocollo num(e)ro p(ri)mo Conservazione buona 25 (54) (51) CONSTANTINI BENEDETTO DI NICOLÒ Atti repertoriati 1-127, cc. 1-83 Indice delle parti coevo, cc.73-83 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1789; Protocollo II Conservazione buona 1789-1792 67 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero 54 26 (42) (-) Nome del notaio e descrizione del registro DA DIÉ GIACOMO ANTONIO Estremi Con atti cronologici dal / fino al 1756-1770 (già attribuito a ALVERÀ GIACOMO) Atti repertoriati 1-377, cc.1-278, inserte cc. 26 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-18, Contrassegnato 1756 Legatura originale Coperta cartacea (già rivestita in pergamena), parzialmente staccata Conservazione cattiva 27 (48) (45) DA DIÉ GIACOMO ANTONIO 1770-1782 (già attribuito a PADRÈ GIOVANNI ANTONIO) Atti repertoriati 1-258, cc.1-162, inserte cc.23 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-16, Contrassegnato Alfabetto Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1770 Conservazione discreta 55 28 (52) (49) DA DIÉ GIACOMO ANTONIO 1781-1792 (già attribuito a PADRÈ GIOVANNI ANTONIO) Atti repertoriati 1-228, cc.1-159, inserte cc.15 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-14, Contrassegnato Alfabetto 1781 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1781 Conservazione cattiva 29 (12) (11) DE ZANNA GIOVANNI MARIA 1672-1703 Atti repertoriati 1-687, pp. 1-585 Indice delle parti coevo, cc.1-17 Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente deperita Segnatura coeva: 1672; 1 Conservazione buona 29 bis GHIDINI NICOLÒ FU PIETRO 1598-1600 Atti non repertoriati in originale [270], cc. 1-72, inserte cc. 4 Legatura originale Coperta membranacea di riutilizzo Conservazione discreta: c. 1 tagliata 56 30 (1) (1) GHIDINI GIACOMO FILIPPO DI SIMONE Atti repertoriati 69-954, cc.1-243, inserta c.1 Non completo (mancanti atti 1-68) 1606-1613 1710 68 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero Nome del notaio e descrizione del registro Estremi Con atti cronologici dal / fino al Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-36 Legatura non originale (sec. XIX) Coperta cartacea Conservazione discreta 31 (9) (8) 1661-1667 GHIDINI ALESSIO (già attribuito a VEROCAI GIOVANNI DI PAOLO) Atti repertoriati 1-183, cc.1-105 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-12, Contrassegnato erroneamente Giovanni Paulo Verocai Legatura non originale (sec. XIX) Coperta cartacea Conservazione buona 32 (10) (9) [GHEDINI SIMONE DI NICOLÒ] (già GIOVANNI DI 1664-1673 PAOLO VEROCAI nel prec. inv.) Atti repertoriati 1-283, cc. 1-196, inserte cc.13, slegati fascc. atti 1-27 e 28-58 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-20 Legatura originale Coperta membranacea parzialmente mancante Conservazione discreta 57 33 (13) (12) [GHEDINI SIMONE DI NICOLÒ] 1673-1684 Atti repertoriati 1-437, cc.1-256, inserte cc. 5, slegati fascc. atti 301-348, 349-389, 390-437 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-19 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-24 Legatura originale Coperta membranacea Conservazione discreta GHEDINI SIMONE 1730-1735 vd. Protocollo n. 49, con VEROCAI GIULIO 34 (18) (17) GHIDINI FRANCESCO Atti non repertoriati in originale [494], cc.1-319, inserte cc.14 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-19, Contrassegnato Alfabeto Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: Portacolli di Ghidini Nodaro Ampezzo Imperiale; S.T. (ad impressione) Conservazione buona 1698-1729 1679 69 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero 58 35 (2) (2) Nome del notaio e descrizione del registro VEROCAI GIOVANNI PAOLO DI GIOVANNI Estremi Con atti cronologici dal / fino al 1611-1621 (già attribuito a CONSTANTINI FRANCESCO) Atti repertoriati 1-660, cc.1-203 Indice delle parti (2001) Legatura non originale (sec. XIX) Coperta cartacea Conservazione buona 36 (4) (4) VEROCAI GIOVANNI PAOLO DI GIOVANNI 1621-1631 (già attribuito a COSTANTINI FRANCESCO) Atti repertoriati 1-1227, cc.1-290, inserte cc. 5, slegato fasc. degli atti 803-1001 Indice delle parti del sec. XIX, cc.1-26, erroneamante contrassegnato Francesco Costantini Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente deperita Segnatura coeva: 1621; Protocollo Conservazione discreta 59 37 (6) (6) VEROCAI GIOVANNI DI GIOVANNI PAOLO 1645-1656 1633 (già attribuito a VEROCAI PAOLO) Atti repertoriati 188-839, cc.1-240, slegato fasc. degli atti 787-839 Mancanti atti 1-187 Indice delle parti (2001) Legatura originale Coperta membranacea, tagliata Segnatura coeva: 1637-1656; Protocollo di me Giovanni Verocai Conservazione discreta 38 (7) (7) VEROCAI GIOVANNI DI GIOVANNI PAOLO 1654-1658 (già attribuito a VEROCAI GIOVANNI DI PAOLO) Atti repertoriati 1-306, cc.1-118, c. inserta 1 Indice delle parti del sec. XIX, inserto, (solo coperta) Legatura originale Coperta membranacea, tagliata Segnatura coeva: 1654-1658; Protocollo di me Giovanni Verocai Nodaro d’Ampezzo; N(umero) 2 Conservazione buona 39 (14) (13) VEROCAI GIOVANNI PAOLO DI GIOVANNI (già attribuito a VEROCAI GIOVANNI DI PAOLO) Atti repertoriati 1-359, cc.1-244 Probabilmente mutilo 1674-1678 1673 70 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero Nome del notaio e descrizione del registro Estremi Con atti cronologici dal / fino al Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-20, Contrassegnato L(ettera) C, con S.T. (ad impressione) Legatura non originale (sec. XIX) Coperta mancante Conservazione discreta Contiene anche: [VEROCAI GIOVANNI PAOLO DI GIOVANNI] (ex b. 56) Indice delle parti coevo, privo del rispettivo protocollo, cc.1-18, atti 1-477 Legatura originale Coperta cartacea Conservazione discreta Segnatura coeva: L(ettera) E 60 40 (16) (15) 1690-1699 VEROCAI GIOVANNI PAOLO DI GIOVANNI (già attribuito a VEROCAI GIOVANNI DI PAOLO) Atti repertoriati 1-624, cc.1-300, inserte cc. 4 Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-24, Contrassegnato L(ettera) F Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-18 Legatura non originale (sec. XIX) Coperta cartacea Conservazione buona 61 41 (20) (19) 1704-1708 VEROCAI GIOVANNI DI GIOVANNI PAOLO (già attribuito a VEROCAI GIOVANNI DI PAOLO) con frammisti atti di VEROCAI GIOVANNI PAOLO DI GIOVANNI (in precedenza non individuato) Atti repertoriati 3-221, cc.1-227, inserte cc. 2 Non completo (mancanti atti 1-2) Indice delle parti coevo, cc.1-18, contrassegnato Alfabetto del Protocollo segnato Libro H Indice delle parti del sec. XIX, inserto, cc.1-32 Legatura non originale (sec. XIX) Coperta cartacea Conservazione buona 42 (21) (20) 1715-1720 VEROCAI GIOVANNI DI GIOVANNI PAOLO (già attribuito a VEROCAI GIOVANNI DI GIO- VANNI) Atti repertoriati 1-241, cc.14-182, inserte cc. 3 GASPARI TOMASO DI ANTONIO Atti non repertoriati in originale [25], cc.1-13 Mutilo Indice delle parti coevo, inserto, cc. 1-5 (non completo), contrassegnato 1706-1720; Lettera L 1706-1708 71 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero Nome del notaio e descrizione del registro Estremi Con atti cronologici dal / fino al 1720-1730 1717 1727-1737 1739 1737-1741 1706 Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente mancante Segnatura coeva: 1706-1715; Protocolo Lettera L Conservazione cattiva 43 (25) (24) VEROCAI GIOVANNI DI GIOVANNI PAOLO (già attribuito a VEROCAI GIOVANNI DI GIO- VANNI) Atti repertoriati 1-297, cc.1-158, inserte cc. 7 Indice delle parti coevo, cc. 1-20, Contrassegnato Lettera M Legatura non originale (sec. XIX), non rispettosa dell’originaria repertoriazione Coperta cartacea Segnatura coeva: Protocollo M Conservazione buona 62 44 (28) (27) VEROCAI GIOVANNI DI GIOVANNI PAOLO (già attribuito a VEROCAI GIOVANNI DI GIOVANNI) Atti repertoriati 1-310, cc.1-299, inserte cc. 4 Indice delle parti (1996) Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente deperita Segnatura coeva: 1728; Protocollo segnato Lettera N; con S.T. Conservazione buona 45 (32) (31) VEROCAI GIOVANNI DI GIOVANNI PAOLO (già attribuito a VEROCAI GIOVANNI DI GIOVANNI) Atti repertoriati 1-75 cc. 1-78r 1742 VEROCAI GIULIO DI GIOVANNI Atto rep. 76, cc. 78v-79 VEROCAI GAETANO DI GIACOMO FILIPPO 1741-1750 Atti repertoriati 77-161, cc. 80r-169v VEROCAI GIOVANNI PAOLO DI GIACOMO FILIPPO Atti repertoriati 162-305, cc.169v-285, staccate cc. 284-285 e 270-273 Indice delle parti (1996) Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente mancante Segnatura coeva: 1737; Protocollo segnato Lettera O Conservazione discreta 1750-1770 72 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero 63 46 (47) (44) Nome del notaio e descrizione del registro VEROCAI GIOVANNI ANTONIO JUNIORE, DI Estremi Con atti cronologici dal / fino al 1768-1784 GIOVANNI PAOLO Atti repertoriati 1-356, cc.1-202, inserte cc. 3, slegati fasc. degli atti 355-356 e indice, cc. 184-202 Indice delle parti coevo, cc.184-202 Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente mancante Segnatura coeva: 1768; Protocollo segnato Lettera P Conservazione discreta 47 (53) (50) VEROCAI GIOVANNI ANTONIO JUNIORE, DI 1785-1788 GIOVANNI PAOLO Atti repertoriati1-133, cc.1-102, staccate cc. 81-82 Indice delle parti coevo, cc. 83-102 Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1785 Conservazione buona 48 (27) (-) VEROCAI GIULIO DI GIOVANNI 1724-1736 Atti repertoriati1-432, cc.1-290 Indice delle parti (1996) Legatura originale Coperta membranacea Segnatura coeva: 1724; Lettera A Conservazione buona 64 49 (31) (29) VEROCAI GIULIO DI GIOVANNI 1736-1745 Atti repertoriati1-413, cc.17-282, inserte cc.11 Indice delle parti coevo, cc. 264-282 GHEDINI SIMONE 1730-1735 Atti repertoriati 43-77, cc.1-15, inserta c.1 Non completo (mancanti atti 1-42) Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-4 Legatura originale Coperta membranacea, tagliata Segnatura coeva: B Conservazione discreta 50 (35) (34) VEROCAI GIULIO DI GIOVANNI Atti repertoriati 1-287, cc.1-196, inserta c.1 Indice delle parti coevo, cc.182-196 Legatura originale Coperta membranacea slegata (già contrassegnata da num. rosso 56) Conservazione buona Segnatura coeva: L(ettera) C 1744-1749 1740 73 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) Num. Num. Num. Num. busta nuovo rosso nero 51 (37) (-) Nome del notaio e descrizione del registro Estremi Con atti cronologici dal / fino al 1749-1753 VEROCAI GIULIO DI GIOVANNI Atti repertoriati 1-145, cc.1-97, inserte cc. 3 Indice delle parti (1996) Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente mancante Conservazione buona 65 52 (40) (38) 1754-1760 VEROCAI GIULIO DI GIOVANNI Atti repertoriati 43-208, cc.1-99, slegati fascc. degli atti 167-208 Non completo (mancanti atti 1-42) Indice delle parti coevo, inserto, cc.1-16 Legatura originale Coperta membranacea Conservazione discreta 53 (45) (42) VEROCAI DE COLLE GIOVANNI ANTONIO DI 1763-1777 GIULIO Atti repertoriati 1-249, cc.1-182, inserte cc. 3, staccata c. 176 Indice delle parti coevo, cc.167-182 Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente deperita Conservazione buona 54 (50) (47) VEROCAI DE COLLE GIOVANNI ANTONIO DI 1777-1793 1807 1791-1804 1808 GIULIO Atti non repertoriati in originale [139], cc.1-95 Indice delle parti (1996) Legatura originale Coperta membranacea Conservazione buona 55 (55) (52) VEROCAI DE COLLE GIOVANNI ANTONIO DI GIULIO Atti repertoriati 1-207, cc.1-105, inserte cc. 11 Indice delle parti coevo, cc. 97-105 Legatura originale Coperta membranacea, parzialmente di riutilizzo Conservazione buona 4.3. Gli indici delle parti contraenti. — Alla fase di ordinamento ed inventariazione del fondo ha fatto seguito uno specifico progetto di valorizzazione dello stesso, per facilitarne il più possibile l’accesso e la fruizione. In 74 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo considerazione del fatto che alcuni protocolli risultavano privi del relativo repertorio dei contraenti, evidentemente disperso, ci si è proposti di ricostruire quelli mancanti, prendendo avvio dai protocolli del secolo XVIII 189. Nel corso del lavoro si è operato attenendosi il più possibile ai criteri scientificamente e criticamente individuati quali regolanti la redazione coeva, per non creare degli strumenti che si discostassero totalmente da quelli a noi pervenuti, rischiando di presentarsi arbitrari e antistorici. Ci si è proposti infatti di creare non tanto degli indici critici 190, quanto dei repertori che venissero ad integrare la serie di quelli già esistenti, parzialmente perduti. A tal fine si è adottato come criterio di base il massimo rispetto della fonte, studiando i modi di redazione e repertoriazione propri di ciascun notaio, attraverso gli indici delle parti di mano dello stesso o redatti da suoi contemporanei. In quest’ottica si è tuttavia ritenuto opportuno offrire alcuni elementi in più rispetto a quelli presenti negli indici coevi: oltre al nome delle parti, al nomen iuris e al numero di repertorio dell’atto, sono state infatti rilevate le date topica e cronica, dati questi oltremodo utili ai fini della ricerca, soprattutto in considerazione del fatto che in un ambito territoriale ristretto, quale la conca ampezzana, la ridotta varietà cognominale crea frequentissime omonimie, anche all’interno di un medesimo arco cronologico. Per quanto riguarda la tipologia contrattuale, si tenga presente che il nomen iuris vuol essere soltanto un’indicazione di massima, non già un tentativo di sintesi dell’atto stesso, per il cui contenuto negoziale si rimanda sempre e comunque alla lettura ed all’interpretazione del testo. Si offre di seguito una breve sintesi esplicativa di ogni voce rilevata nella compilazione degli indici, cui corrisponde relativa finca. — Nome del notaio: trattandosi per lo più di registri redatti da un unico notaio, esso figura di norma nell’intestazione, preceduto dal numero di protocollo: soltanto nel caso del protocollo n. 45, che comprende atti di quattro notai diversi, con numeri di repertorio più volte ripetuti, esso compare in apposita finca. Gli indici sono stati elaborati tramite programma informatico Excel in vista di eventuali conversioni in formato data-base, che permettano il collegamento dei dati con analoghi repertori informatizzati in corso di realizzazione presso l’Archivio di Stato di Belluno. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha nel frattempo finanziato una nuova tranche del progetto per l’indicizzazione dei protocolli del secolo XVII. 189 190 Il dibattito in tema di indicizzazione si è fatto in questi ultimi anni particolarmente vivace, anche in virtù della sempre maggiore disponibilità di strumenti informatici: per quanto riguarda in particolare l’indicizzazione di antroponimi ci si limita a ricordare in questa sede i contributi di ALTIERI MAGLIOZZI; SALMINI; SAMBITO; FERRARI, citati nella Bibliografia in appendice. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 75 — Nomen iuris: nell’individuazione di esso si è proceduto prima allo studio generale delle varie fattispecie giuridiche locali, sulla scorta della lettura incrociata dei protocolli e dei relativi alfabeti, per cercare di comprendere appieno la tipologia contrattuale e la denominazione con cui veniva repertoriata negli indici coevi. Il nomen iuris è stato quindi indicato utilizzando i termini originali del luogo, per evitare l’artificiosa creazione di erronee ed antistoriche categorie giuridiche, non corrispondenti a quelle allora vigenti. Ci si limita pertanto a fornire di seguito definizione o spiegazione dei termini adottati — ora non più usuali — e delle tipologie contrattuali prettamente locali, ricordando che nel definire il nomen iuris di un atto, si è assunto come rilevante solo il fatto giuridico che nell’ambito di esso appariva primario e prevalente. Calcolazione: stima. Compera: compravendita (anche qualora comprenda contestuale locazione del bene oggetto della transazione). Dote: con tale denominazione si è inteso indicare non solo l’istituto proprio, ma anche tutte le possibilità giuridiche inerenti ad esso, a volte non chiaramente distinguibili (es. recupera, restituzione, pagamento, stima, quietanza di dote). Patrimonio clericale: costituzione di una rendita a favore di un membro della famiglia impegnatosi nel sacerdozio, al fine di garantirne il mantenimento economico. Patto: qualsiasi forma di accordo bilaterale che non rientri strettamente in nessuna delle altre tipologie contrattuali citate. Recupera: atto con cui si rientra in possesso di un bene precedentemente alienato, impegnato, od altrimenti detenuto da altri. Stima o pagamento di giustizia: stima o pagamento effettuati a seguito di decreto ingiuntivo di pagamento di un debito. Vizza: atto di delimitazione di un territorio boschivo o pascolivo, al fine d’impedirne o regolarne l’uso. Albergo: atto di delimitazione di un territorio di pertinenza collettiva adibito al ricovero di animali. Consortìa: atto con cui si concede l’ammissione ad una determinata Regola. — Parte contraente: i nomi delle parti sono stati mantenuti nella loro forma originaria, sciolta da eventuali abbreviazioni, comprensiva di eventuali soprannomi o specificazioni di provenienza. Si è ritenuto tuttavia opportuno indicizzarli per cognome, anziché per nome di battesimo, come compaiono invece nei repertori coevi. Tale uso si sarebbe presentato infatti non solo 76 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo evidentemente svantaggioso ai fini della successiva consultazione, ma anche estremamente problematico, contemplando la possibilità di numerose varianti di un medesimo nome, a seconda della sua citazione nella forma italiana o dialettale (basti il comunissimo esempio di Giovanni / Zuanne / Zan, che compare indifferentemente negli indici coevi sotto due iniziali diverse, implicando dunque una non sistematicità di repertoriazione). L’intervento di normalizzazione dei cognomi si è limitato alla posposizione della preposizione « De » solo nel caso di cognomi attestati per la medesima area che attualmente ne risultino privi 191. Sono state introdotte inoltre voci di rinvio laddove la variante attestata si discosti sensibilmente dalla forma attuale del cognome, comportandone l’indicizzazione sotto diversa iniziale (es. Appollonio: cfr. anche Polloni (de); Alverà: cfr. anche Dal Vera). Le persone di sesso femminile sono state indicizzate sotto il nome della famiglia di provenienza, seguito da eventuale cognome del marito, qualora coniugate o vedove; in assenza del cognome di nascita, la donna compare direttamente sotto il suo cognome da coniugata. Nel caso di eredi o pupilli privi di capacità giuridica e non nominati personalmente, la ricerca andrà invece effettuata sotto il nome del padre o di chi ne esercita la patria potestà (es. Ghedina fu Zuanne, eredi). — Data topica e cronica: pur essendo elementi non presenti nei coevi repertori, sono state rilevate per maggior completezza e comodità di consultazione. L’indicazione della località, quando assente, ma desumibile da elementi non esplicitamente espressi nel documento, è stata integrata ed espressa tra parentesi quadre. — Numero di repertorio: nel caso di numeri di repertorio doppi o assenti è stato specificato anche il numero della carta o pagina corrispondente. — Procuratori e assistenti: sono stati rilevati, ove presenti, nel caso in cui la parte contraente risulti assistita da un garante o rappresentata da un procuratore. — Note: sotto tale dicitura hanno trovato spazio indicazioni supplementari di varia natura che apparivano funzionali al percorso di ricerca. Sono risultati in tal caso strumenti utili LORENZI, part. pp. 51-66; MENEGUS-TAMBURIN, Il cognome; Dizionario, pp. 335-42; infine la serie dei merici, sindaci e capocomuni di Ampezzo giusta l’anno della loro elezione redatta da ALVERÀ, pp. 369-386. 191 77 I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) Esempio di indicizzazione Prot. 37 notaio Verocai Giovanni di Giovanni Paolo Nomen iuris Dote Dote Compera Compera Stima di giustizia Stima di giustizia Compera parte contraente Menardo (de) Maddallena cgt. Iacomo Menardo (de) Iacomo Maion (de) Zamaria fu Iacomo De Betto Andrea e figlio Compera Lorenzo (de) Tomaso fu Andrea Da Lago Dorothea cgt. Antonio Verocai Cattarina ved. Bortolamio Piruzzo (de) Zamaria Compera Peruzzo (de) Zamaria Compera Compera Soravia (de) Bortolomio fu Stefen Da Lago Antonio fu Stefen Compera Da Lago Antonio fu Paullo Stima di giustizia Stima di giustizia Divisione Barbaria (de) Lucia cgt. Giorgio Barbaria (de) Giorgio Verocai Nicolò Divisione Verocai Simon Testamento Lorenzo (de) Lucia ved. Zuanne Zambelli Zanna cgt. Bortolo Zambelli Bortolo Stima di giustizia Stima di giustizia Arbitrato Arbitrato Arbitrato Maion (de) Danel di Andrea Maion (de) Iacomo di Andrea Padovan fu Iacomo, eredi data topica Cortina Ampitii Cortina Ampitii Cortina Ampitii Cortina Ampitii Cortina Ampitii Cortina Ampitii Cortina Ampitii Cortina Ampitii Cortina Ampitii Cortina Ampitii Cortina d’Ampezzo Cortina d’Ampezzo Cortina Ampitii Cortina Ampitii Cortina d’Ampezzo Cortina d’Ampezzo Cortina d’Ampezzo Cortina d’Ampezzo Cortina d’Ampezzo Cortina d’Ampezzo Cortina d’Ampezzo Cortina d’Ampezzo data cronica n. rep. 1645.09.07 188 1645.09.07 188 1645.11.02 189 1645.11.02 189 1645.11.06 190 1645.11.06 190 1645.11.13 191 1645.11.13 191 1645.11.13 192 1645.11.13 192 1642.10.29 192 1642.10.29 193 1643.12.15 194 1643.12.15 194 1645.06.18 195 1645.06.18 195 1645.09.22 196 1645.10.13 197 1645.10.13 197 1633.10.04 198 1633.10.04 198 1633.10.04 198 procuratori e assistenti Manaigo Silvestro De Betto Dorigo ORIETTA CEINER - SILVIA MISCELLANEO note 78 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo BIBLIOGRAFIA ALPAGO NOVELLO = LUIGI ALPAGO NOVELLO, Un’infornata di notai a Belluno nei primi anni del ’500, in « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 55 (1938), pp. 937939. ALTIERI MAGLIOZZI = EZELINDA ALTIERI MAGLIOZZI, L’elaborazione degli indici delle pubblicazioni archivistiche: prima indagine sui criteri di indicizzazione nei nomi medievali, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLIX (1989), 3, pp. 558-579. ALTON = JOHANN ALTON, Die ladinischen Idiomen in Ladinien, Gröden, Fassa, Buchenstein, Ampezzo, Innsbruck, Wagner, 1879. ALVERÀ = PIETRO ALVERÀ, Cronaca di Ampezzo nel Tirolo dagli antichi tempi fino al XX secolo, manoscritto, s.d., [1924] (rist. anast., Cortina d’Ampezzo, La Cooperativa di Cortina, 1985). AMELOTTI-COSTAMAGNA = MARIO AMELOTTI - GIORGIO COSTAMAGNA, Alle origini del notariato italiano, Milano, Giuffrè, 1975. ANDRICH, Di un’antica = GIANLUIGI ANDRICH, Di un’antica forma di proprietà collettiva nel Bellunese (nozze Tamassia-Centazzo), Belluno, Tip. Cavessago, 1896. ANDRICH, Fabula = GIANLUIGI ANDRICH, Fabula nel Cadore ed a Belluno. Note, estratto da Studi giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer nella ricorrenza del XXXV anno del suo insegnamento, II, Torino, Fr.lli Bocca, 1898. ANDRICH, La wifa = GIANLUIGI ANDRICH, La wifa in un documento bellunese, in Al prof. Giulio Cesare Buzzati nel giorno in cui dà la mano di sposo alla signorina Alba Mantovani, Belluno, Tip. Cavessago, 1902, pp. 2-12. ANDRICH, Appunti = GIANLUIGI ANDRICH, Appunti di diritto pubblico e privato cadorino, Belluno, Tip. Fracchia, 1909. Archivio = Archivio comunale di Lozzo di Cadore. Inventario della sezione separata (1295-1950), a cura di A. DE MARTIN PINTER, Venezia, Giunta regionale del Veneto, 1997. BATTISTELLA = ORESTE BATTISTELLA, Res Collaltinae. Dagli spogli e regesti archivistici…, Venezia, Officine Grafiche Ferrari, 1929. BATTISTI, Prefazione = CARLO BATTISTI, Prefazione a ANGELO MAJONI, Cortina d’Ampezzo nella sua parlata, Forlì, Tip. Valbonesi, 1929 (rist. anast., Cortina d’Ampezzo, La Cooperativa di Cortina, 1981), pp. III-XXXVI. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 79 BATTISTI, Storia = CARLO BATTISTI, Storia linguistica e nazionale delle valli dolomitiche atesine, Firenze, Rinascimento del libro, 1941. BATTISTI, I toponimi = CARLO BATTISTI, I toponimi ampezzani, in Dizionario toponomastico atesino…, diretto da C. BATTISTI, III, parte III, Roma-Bolzano, Istituto di studi per l’Alto Adige, 1947, pp. 67-211. BATTISTI, La posizione = CARLO BATTISTI, La posizione dialettale di Cortina d’Ampezzo, in Dizionario toponomastico atesino…, III, parte III, Roma-Bolzano, Istituto di studi per l’Alto Adige, 1947, pp. 1-45. BATTISTI, « Fabula » = CARLO BATTISTI, « Fabula ». Bosco in bando, in « Archivio per l’Alto Adige » XLIII (1949), pp. 347351, rist. in Comunioni familiari montane, a cura di E. ROMAGNOLI - C. TREBESCHI, Brescia, Paideia, 1975, pp. 421-424. BATTISTI, I nomi = CARLO BATTISTI, I nomi locali dell’Ampezzano, in « Archivio per l’Alto Adige », L (1956), pp. 1-162. BELLI = MARIO FERRUCCIO BELLI, Storia di Cortina d’Ampezzo, Cortina D’Ampezzo, Edizioni Dolomiti, 1982. BENEDETTO = MARIA ADA BENEDETTO, Livello, in Novissimo Digesto Italiano, IX, Torino, UTET, 1965, pp. 987-990. BERENGO = MARINO BERENGO, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, Torino, Einaudi, 1999, pp. 369-392. BETTO = BIANCA BETTO, I collegi dei notai, dei giudici, dei medici e dei nobili in Treviso (secc. XIII-XVI). Storia e documenti, Venezia, Deputazione editrice, 1981. BEZZI = QUIRINO BEZZI, Le patenti notarili in val di Sole dal 1500 al 1800, in « Studi trentini di scienze storiche », XLIX (1970), 2, pp. 142-156. BIANCO = FURIO BIANCO, Carnia XVII-XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino, Pordenone, Ed. Biblioteca dell’Immagine, 2000. BOERIO = GIUSEPPE BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Andrea Serafini, 1829, voll. 2. BOLLA = GIAN GASTONE BOLLA, Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal laudo, in « Archivio per l’Alto Adige », XLIV (1951), pp. 4988. BOURGAIN = PASCALE BOURGAIN, Sur l’édition des textes littéraires latins médiévaux, in « Bibliothèque de l’Ecole des Chartes », 150 (1992), 1, pp. 5-49. BRAVI = FERRUCCIO BRAVI, Il notariato atesino, Bolzano, Tip. Presel, 1968. 80 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo BRESSLAU = HARRY BRESSLAU, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia, traduzione di A.M. VOCI-ROTH, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, in particolare pp. 564-579 (Sussidi, 10). BRUNORO = BRUNO BRUNORO, La pratica del livello a Vas nel ’600, in Vas. Una comunità tra il Piave e la montagna, a cura di G. FOLLADOR, Vas, Amministrazione comunale di Vas, 1990, pp. 207-225. BUSSI = EMILIO BUSSI, Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo, Milano, Giuffrè, 1959, II, pp. 66-67. CACCIAVILLANI, La proprietà = IVONE CACCIAVILLANI, La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima, LimenaPadova, Signum, 1988. CACCIAVILLANI, La sentenza = IVONE CACCIAVILLANI, La sentenza Fletzer sulle Regole, Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, 1989. CAGNIN = GIAMPAOLO CAGNIN, Le carte dei notai medievali, Venezia, Grafiche Veneziane, 1993. CAMMAROSANO = PAOLO CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991. CARUCCI, Le fonti = PAOLA CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1983. CARUCCI, Ancora = PAOLA CARUCCI, Ancora sul tema della normalizzazione, in « Archivi per la storia », VII (1994), 1, pp. 299-307. CASANOVA = EUGENIO CASANOVA, Archivistica, Siena, Arti grafiche Lazzeri, 1928 2 (rist. anast., Torino, Bottega d’Erasmo, 1966). CASANOVA DE MARCO = MICHELE CASANOVA DE MARCO, La Dominante nel Cadore ladino. Il capitano di Venezia a Pieve nel 1500, Costalta (San Pietro di Cadore), Gruppo Musicale di Costalta, 2000. CASETTI, Guida = ALBINO CASETTI, Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961. CASETTI, Il notariato = ALBINO CASETTI, Il notariato trentino e l’istituzione dei più antichi archivi notarili in Trento: L’« archivio (vecchio) dei morti » e l’« archivio (nuovo) dei vivi » (a. 1595-1607), in « Studi trentini di scienze storiche », XXXI (1952), 3-4, pp. 242-285. CIANI = GIUSEPPE CIANI, Storia del popolo cadorino, Padova, Stabilimento tipografico Sicca, 1856 - Ceneda, Gaetano Longo, 1862 (rist. anast., Bologna, Forni, 1969), voll. 3. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 81 Collectio = Collectio constitutionum imperialium; hoc est DD. NN. imperatorum, caesarum, ac regum augustorum Sacri Romani Imperii Germano-Romani recessus, ordinationes… Tomus primus… industria atque studio Melchioris Goldasti Haiminsfeldii, Francofurti ad Moenum, ex officina Zunneriana, sumptibus Johannis Adami Jungii, typis Antonii Heinscheidtii, 1713. COLLODO = SILVANA COLLODO, Il Cadore medievale verso la formazione di un’identità di regione, in Il dominio caminese tra Piave e Livenza. Atti del convegno di studio nel 650° anniversario della morte di Rizzardo VI da Camino (Vittorio Veneto, 23 novembre 1985), Vittorio Veneto, Tipse, 1988, pp. 23-50. = Comunioni familiari montane, a cura di E. ROMAGNOLI e C. TREBESCHI, Brescia, Paideia, 1975-1992, voll. 2. = GIGI CORAZZOL, Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del ’500, Milano, Angeli, 1979. = GIGI CORAZZOL, Livelli stipulati a Venezia nel 1591. Studio storico, Pisa, Giardini, 1986. = EMANUELE D’ANDREA, Gli statuti cadorini del 1338 con le aggiunte sino al 1478, Pieve di Cadore, Magnifica Comunità di Cadore, 2001. = EMILIO DE FELICE, Valore, diffusione ed etimo del toponimo « regola », in « Archivio per l’Alto Adige » XLII (1949), pp. 339-347, rist. col titolo Vecchie voci amministrative delle comunità rurali alpine. I. Valore, diffusione ed etimo del toponimo regola in Comunioni familiari montane, a cura di E. ROMAGNOLI - C. TREBESCHI, Brescia, Paideia, 1975, pp. 425-431. = PAOLO DE LORENZI, Storia del notariato ravennate, Ravenna, Arti grafiche, 1961-1962, voll. 2. = GABRIELE DE SANDRE, Le proprietà collettive di S. Vito di Cadore, in « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore » 121 (1952), pp. 105-116; 122 (1954), pp. 19-21. = GABRIELE DE SANDRE, Notizie storiche raccolte intorno ai nomi locali del Comune di S. Vito di Cadore, in « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 124 (1953), pp. 74-84. = ILLUMINATO DE ZANNA, Regole d’Ampezzo, in Comunioni familiari montane, a cura di E. ROMAGNOLI C. TREBESCHI, Brescia, Paideia, 1975, pp. 433-450. = ILLUMINATO DE ZANNA, Confini del territorio comunale di Cortina d’Ampezzo, Cortina d’Ampezzo, Cassa rurale e artigiana di Cortina, 1977. Comunioni CORAZZOL, Fitti CORAZZOL, Livelli D’ANDREA DE FELICE DE LORENZI DE SANDRE, Le proprietà DE SANDRE, Notizie DE ZANNA, Regole DE ZANNA, Confini 82 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo DE ZANNA-BERTI = ILLUMINATO DE ZANNA - CAMILLO BERTI, Monti e pascoli ampezzani nei nomi originali, Cortina, La Cooperativa di Cortina, 1983. DI BÉRENGER = ADOLFO DI BÉRENGER, Dell’antica storia e giurisprudenza forestale in Italia Treviso - Venezia, Tip. Longo, 1859-1863 (rist. anast., col titolo di Studii di Archeologia forestale, Firenze, Tip. Coppini, 1965). DU CANGE, Consortes Consortia e = CHARLES DU FRESNE DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, II, Niort, Léopold Favre, 1883 (rist. anast., Bologna, Forni, 1971), pp. 520-521. DU CANGE, Livellus = CHARLES DU FRESNE DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, V, Niort, Léopold Favre, 1885 (rist. anast., Bologna, Forni, 1972), p. 130. DU CANGE, Regula = CHARLES DU FRESNE DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, VII, Niort, Léopold Favre, 1886 (rist. anast., Bologna, Forni, 1972), p. 99. Due Soldi, Vecchie misure = Vecchie misure usate in Ampezzo, in « Due soldi », periodico edito dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo, III (1967), 5, pp. 8-9. Due Soldi, Segni = Segni di tabellionato di alcuni notai ampezzani, in « Due soldi », III (1967), 10, pp. 10-11. Due Soldi, Toponimi ampezzani = Toponimi ampezzani, in « Due soldi », III (1967), 12, pp. 4-7. Due Soldi, Toponimi dei boschi = Toponimi dei boschi e pascoli ampezzani, in « Due soldi », IV (1968), 12, pp. 5-9. Due Soldi, La Vizza = La « Vizza di Naulù », in « Due soldi », VI (1971), 4, pp. 9-10; VI (1971), 5, pp. 7-8. EICHER CLERE = PATRIZIA EICHER CLERE, La Comunità sregolata: notai-notabili e potere locale nel Cadore del secondo ’500, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Venezia, a. a. 1987-88, relatore G. Politi. FABBIANI, Saggio = GIOVANNI FABBIANI, Saggio di bibliografia cadorina, Feltre, Tip. Castaldi, 1939. FABBIANI, Il primo = GIOVANNI FABBIANI, Il primo statuto cadorino è del 1338, (Nozze Fabbiani-Da Pra), Feltre, Tip. Castaldi, 1952, già in « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 118 (1952), pp. 1-11; 119 (1952), pp. 4851. FABBIANI, Gli Statuti = GIOVANNI FABBIANI, Gli Statuti della Magnifica Comunità di Cadore dell’anno 1338 integralmente fotografati, Feltre, Tipografia Castaldi, 1954. FABBIANI, La posizione = GIOVANNI FABBIANI, La posizione storica di Ampezzo, in « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 132 (1955), pp. 84-93. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) FABBIANI, I laudi di Lozzo 83 = GIOVANNI FABBIANI, I laudi di Lozzo di Cadore (1444-1821) annotati ed illustrati, Belluno, Tip. Benetta, 1957. FABBIANI, I laudi di Ampezzo = GIOVANNI FABBIANI, I laudi di Ampezzo di Cadore, in « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 144 (1958), pp. 80-87; 145 (1958), pp. 120-132; 146 (1959), pp. 27-39; 147-148 (1959), pp. 69-83. FABBIANI, Prime giunte = GIOVANNI FABBIANI, Prime giunte al saggio di bibliografia cadorina, dall’anno 1532 all’anno 1960, dal n. 6067 al n. 10.351, Feltre, Tip. Castaldi, 1962. FABBIANI, Notizie = GIOVANNI FABBIANI, Notizie sul notariato cadorino, in « Rassegna economica », 6, XI-XII, (1964), pp. 12-24; 1, I-II, (1965), pp. 34-52; 2, II-IV, (1965), pp. 7-21. FABBIANI, Breve storia = GIOVANNI FABBIANI, Breve storia del Cadore, Pieve di Cadore, Magnifica Comunità di Cadore, 1992 5. FACIO = ATTILIO FACIO, Prattica d’instrumentare ad uso universale con le solennità che ricercano gl’instrumenti e testamenti del signor Attilio Facio… Venetia, per Domenico Lovisa, 1700. FALCONI, Lineamenti = ETTORE FALCONI, Lineamenti di diplomatica notarile e tabellionale, Parma, CUSL, 1983. FALCONI, L’edizione = ETTORE FALCONI, L’edizione diplomatica del documento e del manoscritto, Parma, Casanova, 1984 2. FERRARI = DANIELA FERRARI, Problemi di indicizzazione negli inventari d’archivio, in Standard, vocabolari controllati, liste d’autorità. Atti del seminario svoltosi a Milano il 25 maggio 1994, a cura della REGIONE LOMBARDIA, Milano, Regione Lombardia, 1995. FERRO = MARCO FERRO, Livello, in Dizionario del diritto comune e veneto dell’avvocato Marco Ferro, II, Venezia, Santini, 1847 2, pp. 202-204. FILIPPI = FIORENZO FILIPPI, Atlante del territorio silvo-pastorale delle Regole e del Comune di Cortina d’Ampezzo, Cortina d’Ampezzo, Cassa rurale e artigiana di Cortina, 1985. FORCELLINI = ÆGIDIUS FORCELLINI, Totius latinitatis lexicon…, Patavii, typis Seminarii, 1831. GASSER = HUBERT GASSER, Livinallongo e il vescovo principe di Bressanone. Dalle istituzioni al documento, in Recenti acquisizioni documentarie: nuove proposte per la ricerca storica (Belluno, Archivio di Stato, 5 dicembre 1994), estratto da « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 291 (1995), pp. 175-108, in particolare 97-103. 84 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo GHEDINA DE TOMÀŠ = FRANCESCA GHEDINA DE TOMÀŠ, Contributo allo studio della toponomastica di Cortina d’Ampezzo, Cortina d’Ampezzo, Regole d’Ampezzo - Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo - Union de i Ladis de Anpezo U.L.d’A., 1998. GRANDI VARSORI = MARIA SILVIA GRANDI VARSORI, Note di una ricerca sul notariato nella Terraferma veneta del XVIII secolo, in Venezia e la Terraferma attraverso le Relazioni dei Rettori. Atti del Convegno. Trieste, 2324 ottobre 1980, a cura dell’ISTITUTO DI STORIA ECONOMICA DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE - CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICO-ECONOMICA REGIONALE, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 191201. GRZIWOTZ = HERBERT GRZIWOTZ, Kaiserliche Notariatsordnung von 1512. Spiegel der Entwicklung des europäischen Notariats, München, Beck, 1995 (in italiano, pp. 159-202). HÄRTEL, L’atto privato = REINHARD HÄRTEL, L’atto privato in area germanica, in Il notariato e il documento di diritto privato. Bellunese, Ampezzo, Livinallongo (secoli XV-XIX), Catalogo della mostra documentaria a cura di G. MIGLIARDI O’RIORDAN, Belluno, Archivio di Stato di Belluno, 1998. HÄRTEL, Il notariato = REINHARD HÄRTEL, Il notariato fra Alpi e Adriatico, « Rassegna degli Archivi di Stato », LX (2000), 1, pp. 9-26. KANN = ROBERT A. KANN, Storia dell’Impero asburgico, Roma, Salerno editrice, 1998. KNAPTON = MICHAEL KNAPTON, Tra Dominante e Dominio (1517-1630), in G. COZZI - M. KNAPTON - G. SCARABELLO, La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, Torino, UTET, 1992, pp. 203-549. KRAMER, Voci = JOHANNES KRAMER, Voci tedesche nel dialetto di Cortina d’Ampezzo, in « Archivio per l’Alto Adige », LXXVIII (1984), pp. 7-28; LXXIX (1985), pp. 185205; LXXXII (1988), pp. 255-265. KRAMER, Regula = JOHANNES KRAMER, Regula, in Etymologisches Wörterbuch des Dolomitenladinischen, zusammengestellt von Johannes Kramer, V, Hamburg, Buske, 1993, pp. 497-498. LATTES = ALESSANDRO LATTES, Parole e simboli. Wifa, brandon, wiza, in « Rendiconti dell’Istituto lombardo di scienze lettere ed arti », 1900, 33, pp. 1-22. LEICHT, Formulari = PIER SILVERIO LEICHT, Formulari notarili nell’Italia settentrionale, in Scritti vari di storia del diritto italiano, II, tomo I, Milano, Giuffrè, 1948. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 85 LEICHT, Il diritto privato = PIER SILVERIO LEICHT, Storia del diritto italiano. Il diritto privato. Parte prima. Diritto delle persone e di famiglia. Lezioni, Milano, Giuffrè, 1960; Parte seconda. Diritti reali e di successione. Lezioni, Milano, Giuffrè, 1960; Parte terza. Le obbligazioni, Milano, 1948 2. LEICHT, Le fonti = PIER SILVERIO LEICHT, Storia del diritto italiano. Le fonti. Lezioni con appendice di documenti…, Milano, Giuffrè, 1966 4. LEICHT, Il diritto pubblico = PIER SILVERIO LEICHT, Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1972 3. LORENZI = ERNESTO LORENZI, Osservazioni etimologiche sui cognomi ladini, Trento, Zippel, 1908 (rist. anast., Firenze, Istituto di studi per l’Alto Adige, 1992). MAJONI = ANGELO MAJONI, Cortina d’Ampezzo nella sua parlata, Forlì, Tip. Valbonesi, 1929 (rist. anast., Cortina d’Ampezzo, La Cooperativa di Cortina, 1981). MARCUZZI = GIORGIO MARCUZZI, « Segni di casa » del Basso Veneto e del Cadore, in « Dolomiti », XV (1992), 2, pp. 47-64. MENEGUS = GIUSEPPINA MENEGUS, Annotazioni su figure regoliere e organizzazione del pascolo nel Cadore, in Malgari e pascoli. L’alpeggio nella provincia di Belluno, a cura di D. PERCO, Feltre, Libreria Pilotto, 1991, pp. 107-112. MENEGUS TAMBURIN, Il dialetto = VINCENZO MENEGUS TAMBURIN, Il dialetto dei paesi cadorini d’Oltrechiusa (San Vito, Borca, Vodo, Ampezzo), Belluno, Tip. Vescovile, 1959. MENEGUS TAMBURIN, Dizionario = VINCENZO MENEGUS TAMBURIN, Dizionario del dialetto di Cortina d’Ampezzo, Vicenza, Neri-Pozza, 1973. MENEGUS TAMBURIN, Il cognome = VINCENZO MENEGUS TAMBURIN, Il cognome nelle pievi cadorine di San Vito e Ampezzo, in « Archivio per l’Alto Adige », LXVII (1973), pp. 211-374. MENEGUS TAMBURIN, Atti = VINCENZO MENEGUS TAMBURIN, Atti pubblici e privati della centuria cadorina in Ampezzo ora Cortina d’Ampezzo, in « Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti », Classe di scienze morali, lettere ed arti, CXXXVI (1977/1978), pp. 263-286. MIARI = FLORIO MIARI, Dizionario storico-artistico-letterario bellunese… Belluno, Tip. Deliberali, s.d. (ma 1843; rist. anast. Bologna, Forni, 1968). MIGLIARDI O’RIORDAN = GIUSTINIANA MIGLIARDI O’RIORDAN, Progetto per l’inventariazione dei protocolli notarili d’Ampezzo: convenzione tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e l’« Archivio storico di Belluno, Feltre e 86 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Cadore » (febbraio 1995 - agosto 1996), in « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 297 (1996), pp. 256-257. MISCELLANEO = SILVIA MISCELLANEO, L’ordinamento del fondo archivistico Livinallongo-Ampezzo, in Recenti acquisizioni documentarie: nuove proposte per la ricerca storica (Belluno, Archivio di Stato, 5 dicembre 1994), estratto da « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 291 (1995), pp. 175-108, in particolare 103-108. MORELLO-FERRARISORGATO = ARISTOTELE MORELLO - EMANUELE FERRARI - ANTONIO SORGATO, L’atto notarile, Milano, Giuffrè, 1977. NEQUIRITO = MAURO NEQUIRITO, Le Carte di Regola delle Comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico, Mantova, Arcari, 1988. NESCHWARA = CHRISTIAN NESCHWARA, Geschichte des österreichischen Notariats, I, Vom Spätmittelalter bis zum Erlaβ der Notariatsordnung 1850, Wien, Manz, 1996. NORBERG = DAG NORBERG, Manuale di latino medievale, Firenze, La Nuova Italia, 1974. Il notariato = Il notariato e il documento di diritto privato. Bellunese, Ampezzo, Livinallongo (secoli XV-XIX), Catalogo della mostra documentaria a cura di G. MIGLIARDI O’RIORDAN, Belluno, Archivio di Stato di Belluno, 1998. OESTERLEY = F. OESTERLEY, Das deutsche Notariat…, Hannover, Hahnschen Hofbuchhandlung, 1842, voll. 2. Oronimi = Oronimi Bellunesi. Ricerca in itinere sotto la guida del professor G.B. Pellegrini. Ampezzo-Auronzo-Comelico, a cura di A. ANGELINI - E. CASON, Belluno, Fondazione Angelini, 1993. PAIS BECHER-MARTELLA = GIANNI PAIS BECHER - ADA MARTELLA, I segni nelle Dolomiti Orientali, Vittorio Veneto, Poligrafico Bianca e Volta, 1998. PALLABAZZER, Su alcuni = VITO PALLABAZZER, Su alcuni termini e usanze pastorali della regione dolomitica, in Malgari e pascoli. L’alpeggio nella provincia di Belluno… cit., pp. 215-224. PALLABAZZER, Terra = VITO PALLABAZZER, Terra d’Ampezzo, in « Rivista bellunese », VI (1975), 3, pp. 311-316. PASSOLUNGHI, Da conti = PIER ANGELO PASSOLUNGHI, Da conti di Treviso a conti di Collalto e San Salvatore: presenza politica ed impegno religioso della più antica famiglia nobile del Trevigiano, in « Atti e memorie dell’Ateneo di Treviso », 1983/1984, 1, pp. 7-38. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 87 PASSOLUNGHI, I Collalto = PIER ANGELO PASSOLUNGHI, I Collalto. Linee, documenti, genealogie per una storia del casato, Treviso, B&M, 1987. PASSOLUNGHI, Note = PIER ANGELO PASSOLUNGHI, Note sulla perdita dell’archivio Collalto, in « Atti e memorie dell’Ateneo di Treviso », 1987/1988, 5, pp. 7-19. PEDANI FABRIS = MARIA PIA PEDANI FABRIS, « Veneta auctoritate notarius ». Storia del notariato veneziano (15141797), Milano, Giuffrè, 1996. PEDRINELLI = GIOVANNI PEDRINELLI, Il notajo istruito nel suo ministero secondo le leggi e la pratica della Serenissima Repubblica di Venezia, Venezia, per Carlo Todero, 1768, voll. 2. PELLEGRINI, Nomi = FRANCESCO PELLEGRINI, Nomi locali di città, terre, castelli, borghi, villaggi e casali ordinati secondo le desinenze, nella provincia di Belluno e nei vicini paesi di Primiero, Livinallongo e Ampezzo, Venezia, Deputazione Veneta sopra gli Studi di Storia Patria, 1885. PELLEGRINI, Commento = GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI, Commento al Foglio XII « Cortina d’Ampezzo », in « Archivio per l’Alto Adige », XLVII (1953), pp. 37-50. PELLEGRINI, Postille = GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI, Postille etimologiche a voci giuridiche alto-medievali, in « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 173 (1965), pp. 121-132. PELLEGRINI, I dialetti = GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI, I dialetti ladinocadorini, in « Archivio per l’Alto Adige », LXXII (1978), pp. 245-265. PELLEGRINI, Prefazione = GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI, Prefazione al Vocabolario Ampezzano, a cura di E. CROATTO, Cortina d’Ampezzo, Cassa rurale ed artigiana di Cortina d’Ampezzo, 1986, pp. VII-XIV. PELLEGRINI, La genesi = GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI, La genesi del retoromanzo (o ladino), Tübingen, Niemeyer, 1991. PELLEGRINI-BARBIERATO = GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI - PAOLA BARBIERATO, Comparazioni lessicali « retoromanze ». Completamento ai « Saggi ladini » di G. I. Ascoli, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1999. Le pergamene = Le pergamene del Comune di Valle di Cadore (secoli XIV-XVIII), a cura di ORIETTA CEINER - SILVIA MISCELLANEO, Valle di Cadore, Comune di Valle di Cadore, 1999. PERTILE, Storia = ANTONIO PERTILE, Storia del diritto italiano…, s.n.t., 1871-1887 2, voll. 8 (rist. anast., Bologna, Forni, 1965-1966). 88 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo PERTILE, I laudi = ANTONIO PERTILE, I laudi del Cadore, in « Atti dell’Istituto veneto di scienze lettere ed arti », XLI (1889), pp. 127-146, rist. in Comunioni familiari montane, a cura di E. ROMAGNOLI - C. TREBESCHI, Brescia, Paideia, 1975, pp. 461-475. PETRUCCI = ARMANDO PETRUCCI, La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1984. PETRUCCI NARDELLI = FRANCA PETRUCCI NARDELLI, La legatura italiana, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1989. POMPANIN = UGO POMPANIN, Comunioni familiari montane, ra regoles d’Anpezo, in « Mes Alpes à moi ». Civiltà storiche e comunità culturali delle Alpi, a cura di E. CASON ANGELINI, Belluno, Fondazione Angelini Regione del Veneto, 1998, pp. 353-355. PRATESI, Una questione = ALESSANDRO PRATESI, Una questione di metodo: l’edizione delle fonti documentarie, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XVII (1957), pp. 312-333. PRATESI, Elementi = ALESSANDRO PRATESI, Elementi di diplomatica generale, Bari, Adriatica, 1964. PRATESI, Genesi = ALESSANDRO PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Roma, Jouvence, 1979. PRATESI, Appunti = ALESSANDRO PRATESI, Appunti per una storia dell’evoluzione del notariato, in Studi in onore di Leopoldo Sandri, tomo III, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1983, pp. 759-772 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVIII). Progetto = Progetto di norme per l’edizione di fonti documentarie, a cura dell’Istituto Storico Italiano, in « Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano », 1984, 91, pp. 491-503. PROSPERI = CECILIA PROSPERI, Il restauro dei documenti di archivio. Dizionarietto dei termini, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 89). I protocolli = I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca. Atti del Convegno. Brindisi, Archivio di Stato, 12-13 novembre 1992, a cura di F. MAGISTRALE, in « Archivi per la storia », VI (1993), 1-2. REDLICH = OSWALD REDLICH, Die Privaturkunden des Mittelalters, München-Berlin, 1911, Estratti in trad. it. con il titolo Il documento privato italiano, a cura dell’Archivio di Stato di Bologna - Università di Bologna, Bologna, 1951. Le regole = Le regole d’Ampezzo in Tirolo. Dissertazione stampata nel « Tiroler Volkshlatt » di Bolzano anno 1884, I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 89 nr. 51 e 52, indi tradotta e ricorretta, Bolzano, Tip. e libreria G. Wohlgemuth, 1884. REICH = DESIDERIO REICH, Patenti di notariato, e notizie sugli archivi notarili trentini, in « Tridentum », XIII (1911), 5, pp. 236-245. Relazioni, I = Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma. I. Patria del Friuli (Luogotenenza di Udine), a cura dell’ISTITUTO DI STORIA ECONOMICA DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE, Milano, Giuffrè, 1973. Relazioni, II = Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma. II. Podestaria e Capitanato di Belluno. Podestaria e Capitanato di Feltre, a cura dell’ISTITUTO DI STORIA ECONOMICA DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE, Milano, Giuffrè, 1974. RICHEBUONO, Ampezzo = GIUSEPPE RICHEBUONO, Ampezzo di Cadore dal 1156 al 1335, Belluno, Tipografia vescovile, 1962. RICHEBUONO, Antichi = GIUSEPPE RICHEBUONO, Antichi laudi delle Regole fino alla fine del 1400, Cortina d’Ampezzo, Cassa rurale ed artigiana di Cortina d’Ampezzo, 1962. RICHEBUONO, Atti = GIUSEPPE RICHEBUONO, Atti del notaio Giacomo Filippo Ghedini, in « Due Soldi », IV (1967), 7, pp. 6-14. RICHEBUONO, Storia di Cortina = GIUSEPPE RICHEBUONO, Storia di Cortina d’Ampezzo. Studi e documenti dalle origini al 1915, Milano, Mursia, 1974. RICHEBUONO, Le antiche = GIUSEPPE RICHEBUONO, Le antiche pergamene di San Vito di Cadore, Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, 1980. RICHEBUONO, La storia = GIUSEPPE RICHEBUONO, La storia dei Ladini delle cinque valli dolomitiche, in « Provincia autonoma », 1985, 40, pp. 15-21. RICHEBUONO, Cenni = GIUSEPPE RICHEBUONO, Cenni storici sulle Regole d’Ampezzo, Belluno, Tipografia Piave, 1986. RICHEBUONO, Notizie = GIUSEPPE RICHEBUONO, Notizie sui comuni delle valli ladine dolomitiche, in Il comune rurale. Convegno storico di Bad Ragaz (16-18 ottobre 1985), Bolzano, Athesia, 1988, pp. 177-188. RICHEBUONO, Storia = GIUSEPPE RICHEBUONO, Storia d’Ampezzo, Cortina d’Ampezzo, La Cooperativa di Cortina, 1993 2. RICHEBUONO, Il castello = GIUSEPPE RICHEBUONO, Il castello di Botestagno in Ampezzo, Cortina d’Ampezzo, Regole d’Ampezzo, 1994. ROBERTI = MELCHIORRE ROBERTI, Svolgimento storico del diritto privato in Italia. II, parte terza, Proprietà, possesso e diritti sui beni altrui, Padova, CEDAM, 1935. 90 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo ROLANDINO = ROLANDINO DE’ PASSEGGERI, Summa totius artis notarie, Venetiis, apud Iuntas, 1546 (rist. anast. a cura del Consiglio nazionale del notariato, Bologna, Forni, 1977). ROMITI = ANTONIO ROMITI, I mezzi archivistici per la gestione del documento singolo, in Gli strumenti archivistici. Metodologia e dottrina. Atti del Convegno, Rocca di Papa, 21-23 maggio 1992, in « Archivi per la Storia », VII (1994), 1, pp. 145-164. RUSSO, Toponimi = LORENZA RUSSO, Toponimi della valle d’Ampezzo, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1989-1990, rel. prof. Arena, in particolare Vizza, pp. 482-484 e Albergo, pp. 496-499. RUSSO, Pallidi = LORENZA RUSSO, Pallidi nomi di monti, Cortina d’Ampezzo, Regole d’Ampezzo - La Cooperativa di Cortina - Cassa rurale ed artigiana di Cortina d’Ampezzo, 1994. SALMINI = CLAUDIA SALMINI, Tra norme e forme. Considerazioni e proposte sugli indici di fonti d’archivio in banche dati, in Gli strumenti archivistici. Metodologia e dottrina. Atti del Convegno, Rocca di Papa, 21-23 maggio 1992… cit., pp. 231-277. SAMBITO = SANTINA SAMBITO, L’elaborazione degli indici negli strumenti di ricerca: questioni e criteri metodologici, in Gli strumenti archivistici. Metodologia e dottrina. Atti del Convegno Rocca di Papa, 21-23 maggio 1992… cit., pp. 279-288. SCALON = CESARE SCALON, Produzione e fruizione del libro nel Basso Medioevo. Il caso Friuli, Padova, Antenore, 1995, in particolare pp. 96-108. SCALFATI = SILIO PIER PAOLO SCALFATI, Trascrizioni, edizioni, regesti. Considerazioni su problemi e metodi di pubblicazione delle fonti documentarie, in Gli strumenti archivistici. Metodologia e dottrina. Atti del Convegno Rocca di Papa, 21-23 maggio 1992… cit., pp. 165-182. SCHUPFER, Manuale = FRANCESCO SCHUPFER, Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e scienza, Città di Castello, Lapi Loescher, 1892. SCHUPFER, Il diritto = FRANCESCO SCHUPFER, Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all’Italia, Città di Castello, Lapi Loescher, 1907, voll. 2. SCHUPFER, Il Cadore = FRANCESCO SCHUPFER, Il Cadore, i suoi monti e i suoi boschi. Contributo alla storia della proprietà territoriale a proposito di una sentenza della Corte di Appello di Firenze, Roma, Tip. Del Senato, 1912. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 91 SELMI = PAOLO SELMI, Cenni di Archivistica pura-pratica, dispensa dattiloscritta per la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Venezia, [Venezia] 1967. SOMEDA DE MARCO = PIETRO SOMEDA DE MARCO, Notariato friulano, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1958. Statuti Statuti della Communità di Cadore, in Venetia, appresso Andrea Poletti, 1693 (rist. anast., s.l., Tip. Mura, 1983). STOLZ = OTTO STOLZ, Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol, Innsbruck, Wagner, 1937-1939, in particolare pp. 715-722. TAMBA = GIORGIO TAMBA, Instrumenti e imbreviature negli Archivi di Stato italiani, in ID., Documentazione notarile e notai in Bologna, Bologna, Archivio di Stato di Bologna, 1996, pp. 6-25 (già in Gentium memoria archiva. Il tesoro degli archivi, Roma, De Luca, 1996, pp. 73-80). TOGNETTI = GIAMPAOLO TOGNETTI, Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani, Roma 1982 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 51). TOMASIN = LORENZO TOMASIN, Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XIII-XVIII), Padova, Esedra editrice, 2001. TORELLI = PIETRO TORELLI, Studi e ricerche di diplomatica comunale, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980. TRIVELLATO = FRANCESCA TRIVELLATO, Fondamenta dei vetrai. Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento, Roma, Donzelli, 2000. VALENTI = FILIPPO VALENTI, Il documento medievale. Nozioni di diplomatica generale e di cronologia, Modena, STEM- Mucchi, 1961. VENDRAMINI, La mezzadria = FERRUCCIO VENDRAMINI, La mezzadria bellunese nel secondo Cinquecento. Note e documenti, Belluno, Tarantola, 1977. VENDRAMINI, Le comunità = FERRUCCIO VENDRAMINI, Le comunità rurali bellunesi. Secoli XV e XVI, Belluno, Tarantola libraio, 1979. Vocabolario Ampezzano = Vocabolario Ampezzano, a cura di E. CROATTO, Cortina d’Ampezzo, Cassa rurale ed artigiana di Cortina d’Ampezzo, 1986. Vocabolario Italiano-Ampez- = Vocabolario Italiano-Ampezzano, Taliàn-Anpezàn, a zano cura del Comitato del Vocabolario delle Regole d’Ampezzo, Cortina d’Ampezzo, Cassa rurale ed artigiana di Cortina d’Ampezzo, 1997. ZANDERIGO ROSOLO, Appunti = GIANDOMENICO ZANDERIGO ROSOLO, Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII-XIV, 92 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, 1982. ZANDERIGO ROSOLO, Il Cadore = GIANDOMENICO ZANDERIGO ROSOLO, Il Cadore nella patria friulana, in « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 284 (1993), pp. 93-107; 285 (1993), pp. 133-155. ZANDERIGO ROSOLO, Postilla = GIANDOMENICO ZANDERIGO ROSOLO, Postilla ampezzana, in « Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », 286 (1994), pp. 35-45. ZANGRANDO, Note = FIORELLO ZANGRANDO, Note sulla storia giuridica del Cadore, estratto da « Archivio per l’Alto Adige », LIV (1960), pp. 1-62. ZANGRANDO, Profilo = FIORELLO ZANGRANDO, Profilo della storia giuridica ed economica dei boschi del Cadore, in « Rassegna economica », VIII (1960), 4, pp. 15-18. I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) Tav. 1. Nota di possesso del notaio Alverà Giacom’Antonio di Bartolomeo (1753-1757) con elenco delle possibili tipologie negoziali contemplate e signum tabellionatus impresso a fumo (AS BL, Livinallongo-Ampezzo, Protocolli notarili d’Ampezzo, b. 45, prot. 1, c. 1). 93 94 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Tav. 2. Nota di possesso del notaio Verocai Giovanni Antonio “juniore” di Giovanni Paolo (1768-1784) con elenco delle possibili tipologie negoziali contemplate e signum tabellionatus tracciato ad inchiostro (AS BL, Livinallongo-Ampezzo, Protocolli notarili d’Ampezzo, b. 63, prot. 46). I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 95 Tav. 3. Carta iniziale del primo protocollo del notaio Constantini Pietro Antonio di Andrea (1702-1707), con disegno a penna della Crocifissione. In basso compaiono le iniziali del nome del notaio, che si dichiara anche cancelliere della Comunità per l’anno 1702 (AS BL, Livinallongo-Ampezzo, Protocolli notarili d’Ampezzo, b. 48, prot. 10, c. 1). 96 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Tav. 4. Carta iniziale del primo protocollo del notaio Constantini Nicolò di Pietro Antonio (1731-1737) con disegno a penna della personificazione della Giustizia e doppia citazione biblica (Ecclesiaste, X, 5 e Sapienza, I, 1). In basso, la sua sottoscrizione (AS BL, Livinallongo-Ampezzo, Protocolli notarili d’Ampezzo, b. 50, prot. 15). I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) 97 Tav. 5. Atto di compravendita, 1779, ago. 22, Cortina d’Ampezzo, notaio Constantini Benedetto di Nicolò (1779-1788) (AS BL, Livinallongo-Ampezzo, Protocolli notarili d’Ampezzo, b. 53, prot. 24, c. 1). 98 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Tav. 6. Privilegio notarile concesso da Scipione di Collalto a Pietr’Antonio Clemente De Zanna, 1718, mar. 3, San Salvatore di Susegana (AS BL, Livinallongo-Ampezzo, Protocolli notarili d’Ampezzo, b. 57, prot. 33, c. 216v inserta). I protocolli notarili d’Ampezzo (1598-1808) Tav. 7. Instrumentum di compravendita del notaio Constantini Pietro Antonio di Andrea (1702-1707) in copia conforme redatta dal figlio Constantini Nicolò, con signum tabellionatus tracciato ad inchiostro, 1707, mag. 22, Cortina d’Ampezzo (AS BL, Livinallongo-Ampezzo, Protocolli notarili d’Ampezzo, b. 48, prot. 10, c. 73r inserta). 99 100 Orietta Ceiner - Silvia Miscellaneo Tav. 8. Due esempi di protocolli chiusi che presentano la legatura archivistica più ricorrente. Notai Constantini Pietro Antonio di Andrea (1702-1707) e Alverà Giacom’Antonio di Bartolomeo (1762-1778) (AS BL, Livinallongo-Ampezzo, Protocolli notarili d’Ampezzo, b. 48, prot. 10 e b. 45, prot. 3). LA MAGNIFICENZA DI DUE CASATI UNITI: L’INVENTARIO DEL 1687 DEI QUADRI DI FEDERICO SFORZA E DI LIVIA CESARINI « Molto si dilettò nella sua gioventù dello studio delle belle lettere, che compose molto in versi volgari, nel che avea una particolar facilità, e ne’ suoi componimenti si riconosceva sempre una limpida e natural chiarezza accompagnata da vivacità di spirito (…) fu di buona indole e di sollevato ingegno, di candidi costumi, sincero nel tratto, di singolar gentilezza d’animo ed affabile e manieroso con tutti »: così il Ratti 1 sintetizza l’elogio funebre che tratteggia la personalità di Federico Sforza (1651-1712), « degno nipote del gran Federico Cesi suo avo materno », legato alla regina di Svezia, membro dell’Accademia degli Umoristi, di cui diviene principe, e, dal 1691, dell’Accademia degli Arcadi, con il nome di Miseno Ladoneceo. Personalità di spicco nella società del tempo ma non di grande spessore, il che giustificherebbe l’oblio di cui è stata fatta oggetto per diversi secoli, se si esclude l’episodio del suo matrimonio nel 1673 con Livia Cesarini (1646-1711), già oblata nel convento romano della Madonna dei Sette Dolori, anch’essa dotata, secondo i giudizi dei contemporanei — riportati dal Ratti 2 — di un « carattere piuttosto inclinato alla riservatezza, e dedito alla pietà (…) il cui pregio singolare (…) fu la di lei religione, che (…) le fece conservare in mezzo al mondo un tenor di vita, che potrebbe dirsi monastico ». Questo giudizio non esaltante era frutto di una « denigrazione », sempre secondo il Ratti, messa in atto dai Colonna per la lunga causa con la quale Livia si era contrapposta al connestabile Lorenzo Onofrio, principe di Sonnino; essa era paragonata alla sorella Cleria, data in sposa nel 1671 a Filippo Colonna, fratello dello stesso connestabile, donna « singolare per talento e vivacità di spirito ». Con il loro matrimonio Federico e Livia conseguirono l’eccellente risultato di riunire le due grandi casate, gli Sforza e i Cesarini, mettendo a frutto le potenti alleanze internazionali della prima e le cospicue risorse economiche della seconda, nonostante la strenua opposizione esercitata contro di loro da Lorenzo Onofrio Colonna, uno degli uomini più potenti e colti del suo tempo, protagonista sulla scena romana anche grazie alla sua vocazione per le feste e 1 N. RATTI, Della famiglia Sforza, Roma 1794-1795, voll. 2, in particolare I, 1794, p. 347. 2 Ibid., II, 1795, pp. 202-215. Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 102 Carla Benocci per le relazioni sociali, splendido collezionista, soggetto di innumerevoli racconti e relazioni per le sue vicende matrimoniali con Maria Mancini, tale quindi da eclissare per fama ed importanza i due rampolli delle casate illustri già ricordati. Occorre considerare come Livia Cesarini dimostri una forte determinazione nel conseguimento dei propri obiettivi matrimoniali e di rivendicazione dell’eredità Cesarini 3: seguendo il proprio intento di sposarsi anziché proseguire la via del convento, rifiuta i partiti inadeguati che le erano stati proposti, individuando come soggetto idoneo Federico Sforza, così da accogliere la proposta del cardinale Paluzzo Altieri, avanzata più che altro per contrastare il connestabile Colonna; ella si oppone con tutte le risorse disponibili — familiari ma soprattutto giudiziarie — alle costrizioni dello zio Filippo, divenuto capo della casata Cesarini, che prediligeva la sorella Cleria. Anche Federico dimostra capacità diplomatiche non comuni, riuscendo a farsi appoggiare dallo zio cardinale Federico Sforza, che celebra il suo matrimonio opponendosi alla fazione legata ai Colonna; mantiene ottimi rapporti sia con la corona di Spagna (cui era « attaccatissimo », come lo zio cardinale, secondo quanto attesta lo stesso Ratti) che con quella di Francia, con la quale gli Sforza erano imparentati tramite Maria de’ Medici, proseguendo così il tradizionale orientamento filofrancese dei matrimoni delle donne Cesarini. I due sposi riescono a vincere la causa sulla legittimità del matrimonio intentata il 4 aprile 1673 dal connestabile Colonna presso il Tribunale della Rota e quella per i diritti sulla primogenitura Cesarini, anch’essa promossa dal Colonna e conclusasi con sentenza rotale del 7 febbraio 1681. Le due sorelle Livia e Cleria si accorderanno infine con una transazione del 10 settembre 1709, che conferma il passaggio dei beni Cesarini a Livia. Un momento critico in questa vicenda si colloca alla fine degli anni Ottanta del Seicento: il 20 aprile 1686 muore Filippo Cesarini e diviene urgente la definizione dell’eredità; nel 1687, fra l’altro, a seguito della morte di Gaspero Luigi de Haro, marchese del Carpio, viceré di Napoli, Lorenzo Onofrio Colonna, in virtù dei privilegi connessi con la carica di Gran Connestabile, assume il governo del Regno di Napoli, fino all’arrivo di Filippo Benavides conte di S. Stefano, nominato viceré; nello stesso anno anche Federico Sforza viene nominato dal re di Spagna, Carlo II, ambasciatore straordinario del Regno di Napoli presso il pontefice. Nel quadro di questi avvenimenti si inserisce l’inventario del 1687, che registra i quadri commissionati, acquistati o comunque posseduti da Federico e da Livia (tra cui quelli ereditati dalla casa Sforza), mirando così ad afferma3 Si veda, oltre al Ratti, anche A. ADEMOLLO, Il matrimonio di Suor Maria Pulcheria al secolo Livia Cesarini, Roma 1883; A. GALIETI, La fine romanzesca della nobile famiglia Cesarini, in « Rassegna Nazionale », ottobre 1939, p. 660; F. DIONISI, Livia Cesarini, vita travagliata della Signora di Genzano, in « Lunario Romano », 1978, pp. 219-241; L. BERTONI, Cesarini Livia, in Dizionario biografico degli italiani, 24, Roma 1980, pp. 197-198. L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 103 re l’esclusione di questi beni dall’eredità Cesarini, sulla quale il principe Colonna mantiene le sue mire, ora più forti in relazione alla carica acquisita. Si tratta di un documento raro ma non unico nel grande Archivio Sforza Cesarini, depositato presso l’Archivio di Stato di Roma, un patrimonio documentario straordinario, indagabile sia attraverso l’elenco di deposito sia attraverso il confronto tra i diversi inventari archivistici redatti nel corso degli ultimi due secoli; tra questi ultimi di grande importanza è l’« indice » del 1876 dell’archivista di famiglia, P. Presutti, attendibile per i documenti ancora conservati e prezioso per la menzione di documenti ora non più rintracciabili. È un archivio familiare particolarmente ricco per le notizie relative alle numerose committenze artistiche legate al mecenatismo dei vari membri delle case Sforza e Cesarini, ricostruibili sia grazie agli inventari dei beni conservati che ai diversi capitolati, giustificazioni e conti di artisti, che offrono un quadro molto interessante della cultura romana ed italiana almeno a partire dal XVI secolo. Nell’archivio sono confluiti spezzoni di altri archivi familiari, in conseguenza delle complesse vicende matrimoniali ed ereditarie dei membri delle casate Sforza e Cesarini: sono presenti infatti atti dei Savelli, dei Peretti, dei Conti e dei Mattei di Paganica. La pubblicazione dell’inventario del 1687, che segue quella di altri inventari dei beni 4, non è che la prima anticipazione di un lavoro più complesso — in corso di elaborazione — finalizzato all’edizione critica degli elenchi patrimoniali contenuti in questo archivio familiare, nel quadro più ampio di una identificazione delle fonti per la committenza artistica romana tra Sei e Settecento; fonti utili alla ricostruzione dei più diversi campi dell’attività artistica: architettura, pittura, scultura, realizzazione di gioielli, stoffe ed oggetti d’arredo. L’inventario del 1687 presenta inoltre una particolarità che spesso non si ritrova in altri documenti analoghi: le opere elencate sono infatti non tanto la summa di due eredità quanto l’espressione del gusto artistico dei due sposi individuato in un momento preciso, così da fissare il clima culturale in una delicata fase di transizione tra l’età del barocco, ancora vitale, e la successiva età dei lumi. Il confronto con i quadri ricordati dal testamento del connestabile Colonna del 1689 5, oltre che con quelli citati negli altri inventari dei quadri 4 C. BENOCCI, Santa Fiora (Grosseto), Firenze, Giunta regionale toscana - Roma, Bonsignori, 1999 (Atlante Storico delle città italiane. Atlante Storico delle città della Toscana. 7); ID., Sfarzo e quotidiano nella Roma del Settecento: gli “abiti d’inverno” e gli “abiti d’estate” del duca Gaetano Sforza Cesarini Savelli, in « Bollettino dei Musei Comunali di Roma », XL (1997), pp. 53-62; ID., Una festa barocca a Roma all’ombra del Re Sole ed una relazione sulla corte francese del Seicento, in « Strenna dei Romanisti », LIX (1998), pp. 25-38; ID., L’inventario del 1808 del Palazzo Poli a Fontana di Trevi ed un ritratto di Pompeo Batoni, ibid., LXIII (2002), pp. 31-45; ID., Gli ultimi splendori di una grande famiglia: l’inventario dei quadri del cardinale Innocenzo Conti, in « Ricerche di storia dell’arte », in corso di pubblicazione. 5 Sui Colonna cfr. P. LITTA, Colonna di Roma, s.l., 1838, tav. XV; N. GOZZANO, Il testamento di Lorenzo Onofrio Colonna (1689). Documenti inediti per la storia del collezionismo a Roma nel secondo Seicento, in « Storia dell’arte », 1998, 93-94, pp. 374-395; cfr. anche N. Carla Benocci 104 dei Colonna 6, sottolinea affinità e divergenze, riservando a Federico e Livia un ruolo originale, partecipe delle diffuse istanze classicistiche ma anche aperto a diverse correnti artistiche, sicuramente innovatrici. Si tratta di 311 quadri, il cui valore è stimato in doppie ed in scudi, in conseguenza della prevalente circolazione di moneta spagnola. Non si può escludere che tale elenco sia stato predisposto anche con intenti commerciali, osservando che il quadro raffigurante « una testa di un vecchio che sta pensoso, di bellissima maniera, l’Ambasciatore di Spagna la volse pagare doppie sei sc. 36 ». L’inventario offre notizie tanto più attendibili in quanto elenca opere di artisti scomparsi da pochi anni ma ancora molto amati o di pittori contemporanei di grande successo o comunque di moda, si dimostra accurato nelle attribuzioni e nella descrizione delle opere, anche se non sempre vengono riportate le misure; vi si distingue con cura la mano dei maestri da quella dei copiatori e si descrivono i soggetti con competenza; in alcuni casi si ricordano anche i committenti prevalenti di alcuni artisti (Claude Lorrain e Jacques Courtois sono definiti pittori dei Sacchetti). Ciò che il documento rispecchia è comunque ben chiaro: Federico e Livia intendono affermare la magnificenza della nuova casata, erede di due grandi famiglie, attraverso uno straordinaria quadreria, attenta alle correnti più alla moda ma con scelte originali ed in grado di apprezzare le personalità di maggiore rilievo della cultura barocca, oltre a preannunciare lo sviluppo che avrà la pittura nel nuovo secolo. L’interesse per la pittura si inserisce in un panorama più ampio di commissioni artistiche attuato dai due sposi: essi rinnovano secondo il gusto « alla moda » le residenze Cesarini e Sforza, come il Palazzo Sforza Cesarini alle Botteghe Oscure, il casino della vigna fuori di Porta del Popolo (« all’arco oscuro ») ed il palazzo in Borgo 7. In particolare, il 26 agosto 1687, viene pagato il pittore Benedetto Guidetti « per aver dipinto al Palazzo posto alli Cesarini numero quattro fregi in tela di chiaro oscuro bianco con putti e fiori coloriti », « per aver dipinto numero quattro finestre nelle istesse stanze delli fregi con aver ragiustato un soffitto dipinto »; il 5 agosto del 1688 lo stesso pittore viene pagato per « lavori fatti alla vigna all’arco schuro », tra cui « li GOZZANO, Nature morte e paesaggi nella collezione di Lorenzo Onofrio Colonna (1689), in S. DANESI SQUARZINA, Natura morta, pittura di paesaggio e il collezionismo a Roma nella prima metà del Seicento, Roma 1996, pp. 139-156; E. TAMBURINI, Due teatri per il principe. Studi sulla committenza teatrale di Lorenzo Onofrio Colonna (1659-1689), Roma 1997. 6 Collezione dei dipinti Colonna. Inventari 1611-1795, a cura di E. A. SAFARIK, Münich 1996. 7 Cfr. i pagamenti agli artisti in ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d’ora in poi ASR), Archivio Sforza Cesarini, I parte, b. 465: tra gli altri, compaiono Domenico Rosati, Carlo Guerrini e Gioseppe Giardino, chiavari, Pietro Cappelli, indoratore, Daniele Duiter, Gio. Aliosci, imbiancatore; Francesco De Grandis, vetraro, Bartolomeo Vasino e Domenico Cardellini, falegnami; cfr. anche la b. 464, dove tra gli artisti risultano inoltre Gio. Battista Maffei, tornitore, Benedetto Guidetti, pittore, Gio. Arioli, imbiancatore. L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 105 ornamenti alla stanza de paesi dipinti dal signor Nicola cioè fatte le cornice di chiaroscuro giallo a quattro paesi grandi e quattro sopra finestre con quattro parapetti ornati con fogliami e cornice di chiaroscuro bianco et avere ornato con cornice e cartocci et altro le dette finestre sì come le due porte e poi fatto sotto li detti paesi intorno la stanza un basamento con piedistalli e requatri e dentro li detti requatri fattoci pietre mischie (…) per haver fatti li detti ornamenti alla stanza dipinta da Monsù Monper cioè fatto le cornice di chiaro schuro giallo a n° 17 paesi e l’ornamento a una porta e poi fatto il basamento sotto li paesi atorno la stanza con cornice e pilastrelli e requatri e dentro detti requatri finti di pietra (…) e più per haver dipinto la stanza dove sta la renghiera tutta di prospettiva con colonne e piedistalli e archi di chiaro schuro bianco e pietre finte (…) e più per haver dipinto la stanza che segue fatta di chiaroscuro cioè finta di travertino con pilastri et archi basamento piedestalli balaustrate e vasi et ornamenti di porte »; il 27 febbraio 1689 viene pagato per « lavori fatti al palazzo posto alli Cursori » in Borgo, dove il pittore ha dipinto « n° tre soffitte con rose di chiaroscuro bianco con il fondo paonazzo e torchino et aver dipinto sotto li travicelli e fianchetti similmente atorno li travi maestri e ricorso atorno le stanze il fregio quanto è grosso il detto trave con la menzola che li sta sotto et anco avendoci messe le borchiette indorate alle rose (…) e più per haver dipinto quattro finestre della stanza più grande cioè parapetti archetti e fianchi con requatri scorniciati cartelloni fogliami e fiori coloriti (…) e più per haver dipinto altre quattro finestre dell’altre dui stanze cioè parapetti archetti e fianchi con requatri di cornice cartelloni e fogliami con festoni di campanelle colorite (…) e più per haver dipinto attorno le dette tre stanze il basamento da basso con cornice et il zoccholo di bianco e nero »; il 15 maggio 1689 ancora Guidetti viene pagato per « haver dipinto al palazzo della Ecc.ma Sig.ra Duchessa Cesarini un tramezzo della stanza grande tutta dipinta et averlo dipinto dalle due parte accompagnato il vecchio con prospettiva architettura e colonne figure ornamenti e paesi », lavori tarati (valutati) dal perito Domenico Paradisi in scudi 218. Si tratta di partiti decorativi che inquadrano pitture riconducibili agli stessi artisti i cui quadri sono ricordati nell’inventario del 1687, Nicola Nasone e Momper, quest’ultimo probabilmente identificabile con un membro della dinastia di artisti di Anversa autori di quadri di paesaggio e di genere (tra cui Joos II de Momper, 1564-1635, e Frans de Momper, 1603-1660). Ne emerge una scelta omogenea e coerente tra le diverse correnti pittoriche in quel momento in auge. Una somma più consistente, di scudi 259,70, viene impegnata nel 1688 dal duca Cesarini per il pagamento di una serie di gioielli eseguiti per la duchessa Livia dal gioielliere Antonio Cavalieri, gioielli di grande pregio 8. Il 8 ASR, Archivio Sforza Cesarini, I parte, b. 464: « L’eccellentissimo signor duca Cesarini deve all’eredi del q. Antonio Cavalieri le seguenti somme, cioè a dì 23 giugno 1688 scudi settanta moneta per prezzo d’una croce di lapislazzaro; a dì 2 luglio detto anno per una corona di lapislazzaro scudi cinquanta d’accordo; per una medaglia di oro di filagrano scudi dodici; per Carla Benocci 106 17 ottobre 1689 viene ingaggiato l’indoratore Pietro Cappelli per « tiratura di una tela e per farla impremire di lunghezza palmi seddici et alta palmi treddici (…) e più per haver fatto dipingere a olio nella sudetta tela tre arme, cioè una del papa e una di Spagna e l’altra del popolo romano di grandissima fattura, con cinque puttini grandi più assai del naturale, con un festone di cotogni e frondi intorno, e con altri adornamenti », per un importo di scudi 45, valutato in scudi 25 dal « maestro di casa » Raffaello Fioresi, poi rivisto in scudi 28 9. Nel 1690 viene pagato il pittore Antonio Fagnani per le pitture « al palchetto del teatro di Tor di Nona », con lavori stimati e tarati da Tommaso Mattei, mentre nel 1704 viene pagato il chiavaro Gioseppe Giordano per lavori fatti « al Palazzo alli Cesarini, dove è andato ad abitare monsignor Aldovrandi » 10. Il lusso si estende anche ad altri oggetti, come le splendide stoffe pagate tra il 1691 ed il 1701 a Nicolò Sebastiano e Gio. Pietro Casanova per portiere, baldacchini, « camiciole » e abiti vari, per un importo di scudi 733,75 11, cui si sommano scudi 191,60 dati nel 1691 a Francesco Trincia setarolo dalla duchessa Livia per pregiati damaschi, « taffettani » e velluti di diversi colori e lavorazioni, utilizzati sia per gli arredi dei palazzi che per gli abiti 12. Interessanti sono anche i volumi acquistati dal 18 aprile 1690 all’8 maggio 1691 dal libraro Giovanni Andreoli, con relative legature, tra i quali compaiono, accanto alle immancabili grammatiche e dizionari, anche testi classici, come le opere di Marziale, di Virgilio, di Orazio, di Ovidio, di Cicerone, le favole di Esopo, le vite dei pontefici — in particolare quelle scritte dal Platina — ma anche l’Ucelliera dell’Ulina, l’Historia del Concilio di Trento del Maciletti, la vita di santa Francesca Romana, la Corte Santa del Causino 13. A questi libri si sommano quelli acquistati dagli stessi duchi dal libraro Antonio Manaro, testi destinati in parte ai figli Gaetano e Giorgio, con la precisazione per ambedue « dal primo anno che principiò andare al Collegio sino al presente giorno di dicembre 1690 »: si tratta per i due fanciulli di dizionari di latino e « galesino » (francese), di epistole latine di vari autori, tra cui Cicerone, delle favole di Esopo, dell’opera di Virgilio e di Ovidio, di « due rudimenti lingua greca », della « scientia d’huomini illustri », di grammadue medaglie di filagrano doppie d’argento scudi tre e baiocchi 60; per un’altra detta piccola sc. 1.10; a dì 28 agosto scudi trentadue moneta per prezzo di due anelli con pietre fine uno a rosetta di diamanti e l’altro con smeraldo e sei diamanti; per quattro anelli, uno con tre diamanti e tre con smeraldi e diamanti a scudi dodici l’uno, sc. 48; per oncie sei e mezza di lapislazzaro sc. 4; per una rosetta di diamanti a faccette d’accordo scudi dicidotto; a dì 6 settembre scudi ventuno per libre tre di lapislazzaro; somma in tutto sc. 259.70 ». 9 Ibid., I parte, b. 465. 10 Ibidem. 11 Ibid., I parte, b. 464. 12 Ibidem. 13 Ibidem. L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 107 tiche varie tra cui quella francese, di vite dei santi e di diversi « offitij ». I libri di donna Livia sono costituiti anch’essi da vari « offitij », tra cui uno « della Madonna in tre tomi di stampa di Colonia in 24 ligato in zegrino », da vari breviari e da una bibbia, testi religiosi legati alla vocazione della gentildonna, che le aveva fatto scegliere in un primo tempo la via del convento e che ancora la caratterizzava per l’intensa devozione 14. Anche negli anni successivi si mantiene questa magnificenza, in particolare per notevoli oggetti di arredo, quali orologi, mobili, tra cui specchiere, studioli e cassette preziose, medaglie, carrozze e finimenti per i cavalli, oggetti pagati, il 22 gennaio 1702, a Gio. Andrea Lorenzani « alli Coronari »15. Non erano da meno i piaceri della gola, alimentati dalle lussuriose vivande preparate ad esempio dal « coco » Antonio Nicoletti il 9 aprile 1691, dove abbondano tartufi, spezie e carni pregiate, alcune delle quali inviate insieme ad un « pasticcio di pesce » ad « una monaca » legata a « Sua Eccellenza » donna Livia 16. Anche il duca Cesarini nel 1711 deve dare scudi 47,50 al confettiere Andrea Migliorini solo per i sorbetti già gustati. Indubbiamente questo amore per le arti e per i piaceri della vita era derivato al duca Federico dal padre Paolo, soldato ma anche committente di opere artistiche di rilievo, come la Villa Sforza ai Quattro Cantoni 17, dotata di un magnifico ciclo di affreschi, e dalla madre Olimpia Cesi, che già aveva portato in dote al marito 18, oltre a 31.000 scudi, una cospicua collezione artistica e soprattutto la grande eredità letteraria e scientifica di Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei. Più da lontano veniva il gusto collezionistico di Caterina Nobili Sforza, rimasto celebre 19. Anche lo zio Federico Sforza, nominato cardinale da Innocenzo X, si era distinto per commissioni artistiche: aveva riedificato dai fondamenti la cattedrale di Rimini nel 1668 e di nuovo nel 1673, a seguito del terremoto del 1672; aveva ricostruito in gran parte a sue spese la cattedrale di Segni ed aveva fatto erigere una cappella dedicata alla Ss. Croce, dotandola di una rendita; aveva fatto costruire monumenti nella chiesa vescovile di Tivoli, con cospicui doni di arredi preziosi, ed aveva lasciato in eredità alla chiesa non solo la sua cappella ma anche tutta la ricchissima dotazione di argenti e suppellettili sacre. Noto per la « liberalitas assidua » e per l’amicizia con il celebre committente artistico Camillo Pam14 Ibid., I parte, b. 465. 15 Ibidem. 16 Ibid., I parte, b. 464. C. BENOCCI, Villa Sforza ai Quattro Cantoni, in « Strenna dei Romanisti », LXI (2000), pp. 23-56. 17 18 Sui beni di Olimpia Cesi cfr. C. BENOCCI, Le opere d’arte e i libri di Olimpia Cesi, nobildonna romana del Seicento, in « Studi Romani », XLIX (2001), 1-2, pp. 101-110. 19 Cfr. L. CORSINI SFORZA, La collezione artistica di Caterina Nobili Sforza contessa di Santa Fiora, in « L’Arte », I (1898), p. 275. Carla Benocci 108 philj, era molto legato alla Spagna, anche in qualità di protettore dei Regni di Spagna e di Napoli, e non di meno era apprezzato dalla Francia per la magnificenza con cui aveva assolto ai compiti diplomatici assegnatigli a Parigi. Ricchissimi erano gli arredi del suo palazzo romano, descritti nell’« Inventario [di] tutta la roba del guardaroba consegniata dall’eredi del signore Domenico d. Santi già guardaroba a Francesco Beltrari nuovo guardaroba questo dì 10 de febbraro 1672 », contenente anche la « dichiaratione come le robbe cioè apparati, quadri et altro, che stanno notate in questo inventario stanza per stanza sono state permutate in altre stanze d’ordine di sua eccellenza et affinché se ne trovi nota si è fatta la presente dichiarazione essendosi tutta la robba dentro il palazzo questo dì 10 febraro 1673 » 20. Sono ricordati nelle carte oggetti raffinati di uso quotidiano ed arredi sacri, abiti e stoffe, parati di corame, lavorato in oro ed argento, di velluto e di damasco, un baldacchino « di panno rosso ricamato di raso », parati di arazzi « dell’istoria di Diana », a « boscaglie » ed « a figura », orologi, studioli di ebano, mappamondi, un cembalo « coperto di corame rosso », e numerosi quadri, di cui però non vengono ricordati in gran parte i soggetti e gli autori, ma tra i quali figurano diversi ritratti, tra cui quelli dello stesso cardinale, di sua madre, del cardinale Pamphilj, del pontefice regnante, della regina e dell’infante di Spagna, alcuni soggetti religiosi, come la Madonna in rame, san Francesco Saverio in rame, san Giovanni, ed alcuni « paesi ». Anche il giovane Federico abita nello stesso palazzo, in un appartamento vicino a quello del cardinale, costituito da una sala decorata con un « parato di corami d’oro e argento con colonne simile e rosce, con una coperta compagna, di pelle, 750 in circa », da una « prima anticamera » con un « parato di dammascho cremisi a opera di terra con corona con trina » e con un « quadro sopraporta di figure », dalla « camera della credenza » e dalla camera dove dorme, decorata con lo stesso parato descritto precedentemente. L’amore per le arti ed il culto dell’immagine erano stati due elementi peculiari di casa Sforza fin dal XV secolo 21, legati all’ascesa del casato fondato dal celebre Muzio Attendolo e coltivati da numerosi membri, sia dei conti di Santa Fiora, sia dei duchi di Milano, sia del ramo di Pesaro, sia delle altre linee minori. La famiglia si era distinta anche per alcune figure femminili, come Caterina Sforza, particolarmente consapevoli dell’importanza dell’arte in tutte le sue manifestazioni per l’affermazione di una recente e discussa nobiltà. Queste capacità erano unite ad una sapiente gestione dei possessi territoriali: esemplare è, in questo senso, l’acquisizione per via matrimoniale e la gestione dello Stato di Santa Fiora, importante snodo territoriale al confine con il Granducato di Toscana e lo Stato pontificio. Venduta al Granduca nel 20 ASR, Archivio Sforza Cesarini, I parte, b. 127; sul cardinale cfr. anche N. RATTI, Della famiglia Sforza… cit., I, 1794, pp. 337-342. 21 L. GIORDANO, L’autolegittimazione di una dinastia: gli Sforza e la politica dell’immagine, in « Artes », 1993, 1, pp. 7-33. L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 109 1633 e riacquisita come bene feudale, la contea di Santa Fiora manterrà fino al 1860 la sua autonomia fiscale e normativa rispetto al Granducato. Agli inizi del Cinquecento, per opera di Guido Sforza, prosperava con i proventi di fruttuose attività agricole e artigianali e grazie al contrabbando, essendo portofranco per passaggio d’armi e merci, e realizzava un notevole riassetto urbanistico che prevedeva anche la creazione di splendidi cicli decorativi 22. L’antica e celebre famiglia Cesarini, oltre che dotata di un cospicuo patrimonio, non era certo da meno sul piano culturale: ben note sono alcune personalità di spicco vissute nel Seicento, come il celebre poeta, astronomo, filosofo, geografo e medico Virginio Cesarini (1595-1624), morto prematuramente 23. Il padre di Livia, Giuliano, aveva realizzato un piano di sistemazione territoriale di Genzano, creando alle porte di Roma una proprietà moderna e raffinata, oltre che razionalmente organizzata. I Cesarini avevano anche proprietà a Civita Lavinia ed Ardea, oltre a diversi casali. Livia segue a Genzano le orme del padre, sistemando ed aprendo nuove strade (la Via Livia e la Via Sforza), che si inseriscono all’interno del tridente alberato realizzato da Giuliano, e creando un nuovo tridente, delimitato da diversi edifici con facciate realizzate secondo le indicazioni fornite dagli architetti della casata e su terreni concessi da donna Livia a titolo gratuito. Gli artefici di queste innovazioni sono gli architetti di famiglia, Innocenzo Mattei, nel 1684-1689, Tommaso Zannoli, nel 1701-1705, e Ludovico Gregorini, dal 1706 24. Da tale contesto emergono le personalità dei due sposi, veramente di notevole rilievo. L’inventario dei quadri di Federico, redatto nel 1713, dopo la sua morte, dal pittore Antonio Amorosi 25, comprende 149 dipinti, tra cui opere rinascimentali di Livio Agresti, del Vasari, del Bronzino, del Salviati e della scuola del Perugino, di caravaggeschi, di vedutisti come il Brill e il Tassi, un nucleo di opere dei maestri della prima metà del Seicento ed una parte più moderna — legata all’ambito di Pier Francesco Mola ed alla scuola emiliana, con numerosi fiamminghi e bamboccianti e pittori di battaglie — che apre la strada alla pittura settecentesca romana. 22 C. BENOCCI,. Santa Fiora… citata. 23 Cfr. A. GOTTIFREDI, In funere Virginij Caesarini oratio, Romae 1624; I. RIQUIUS, De vita viri praestantissimi Virginii Caesarini Lyncei, Juliani, Civitatis Novae Ducis, Baronis Romani F. Liber, Patavii Antenoris 1629. 24 V. MELARANCI, Il Palazzo Sforza Cesarini a Genzano, in « Castelli Romani », XXXV (1995), n. mon.: Echi del Barocco, a cura di F. PETRUCCI, pp. 44-88; cfr. anche A. ATTANASIO, Note sull’Archivio Sforza Cesarini, in « Roma moderna e contemporanea », I (1993), 3, pp. 23249; F. PACE, Le trasformazioni del palazzo Sforza Cesarini in Roma, in « Architettura Storia e Documenti », 1991-1996, pp. 180-202. 25 Per questo inventario dei quadri di Federico Sforza e per quello di Gaetano, suo figlio, redatti entrambi nel 1713 da Antonio Amorosi e conservati nell’Archivio Sforza Cesarini, si veda F. PETRUCCI, Committenti nei Castelli Romani, in Il Baciccio: Giovan Battista Gaulli 1639-1709, catalogo della mostra, a cura di M. FAGIOLO DELL’ARCO, D. GRAF, F. PETRUCCI, Milano 1999, pp. 223-232. Carla Benocci 110 Si tratta, come è stato già rilevato, di una quadreria importante, che somma i quadri provenienti dalle eredità Sforza e Cesarini e quindi non esclusivamente frutto delle commissioni di Federico e Livia: si ritrovano alcuni autori ricordati nell’inventario del 1687, come il Troppa, il Morandi, lo Scilla, il Lauri e il Trevisani ma con opere diverse, probabilmente legate a commissioni affidate dopo il 1687. Possono essere identificate anche alcune tele presenti sia nel 1687 che nel 1713, ma nel primo inventario sono indicati con maggiore esattezza — come si dirà — autori e soggetti. Nei due inventari appaiono stimate molto diversamente opere tra di loro paragonabili se non addirittura identiche; nel secondo inventario il valore delle opere risulta drasticamente diminuito, forse in collegamento con il cambiamento del gusto e del mercato. Minori sono le analogie con l’altro inventario del 1713 relativo ai quadri posseduti dal figlio di Federico e Livia, il duca Gaetano Sforza Cesarini 26. Elemento comune a gran parte degli artisti le cui opere sono ricordate nell’inventario del 1687 è l’appartenenza all’Accademia di San Luca, che svolge effettivamente un ruolo centrale nell’evoluzione del gusto e che in questo caso assicura una scelta di artisti alla moda, prescelti da Federico, nominato accademico d’onore. Egli è ricordato nel 1707 tra i collezionisti d’arte che possono esporre quadri presso S. Salvatore in Lauro. Nel 1713, l’anno successivo alla morte di Federico, tra i quadri che espone suo figlio Gaetano sono ricordate alcune opere che possono essere identificate nell’inventario del 1687 e quindi evidentemente provenienti dall’eredità del padre 27. La scelta di Federico e Livia si orienta verso diverse correnti artistiche della cultura tardobarocca, tutte di grande rilievo, con alcune aperture verso l’arte settecentesca. È presente la scuola di Pietro da Cortona, maestro di cui vengono copiate opere celebri, secondo la moda affermatasi in tutto il Seicento e seguita ad esempio dai Pallavicini, in base alla quale le famiglie si dotavano, almeno in copia, dei quadri ritenuti maggiormente significativi nella cultura del momento. L’inventario del 1687 riporta con precisione il nome del copiatore, Bartolomeo Palombo: « tre quadri in tela d’otto e dieci, uno il ratto delle Sabine, l’altro l’idolatria di Salomone, e l’altro l’historia de Romani, di Bartolomeo 26 27 Ibidem. Si sottolinea la grande importanza delle esposizioni di quadri organizzate, dal 1682 al 1725, per la festa della Traslazione della Santa Casa di Loreto, il 10 dicembre, nella chiesa di S. Salvatore in Lauro ad opera dell’Arciconfraternita dei Marchigiani, esposizioni curate da Giuseppe Ghezzi e negli ultimi anni anche dal figlio Pier Leone Ghezzi. La documentazione relativa, pubblicata da Giulia De Marchi nel volume Mostre di quadri a S. Salvatore in Lauro (1682-1725). Stime di collezioni romane. Note e appunti di Giuseppe Ghezzi, Roma 1987, offre un panorama esauriente dello sviluppo della cultura romana e del ruolo svolto dalle famiglie più in vista, seguendo l’evolversi del gusto e del prestigio di cui godevano i diversi personaggi chiamati ad esporre le proprie opere. L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 111 Palombo, della scuola di Pietro da Cortona, doppie 50 sc. 150 » (n° 76); quadri ricordati anche nell’inventario dei beni di Gaetano Sforza Cesarini (n° 4), con piccole modifiche nelle misure, senza l’esatta indicazione dell’autore (« opere del Cortonese ») e con una stima ridotta (100 scudi); due di essi, di proprietà dello stesso Gaetano, sono ricordati nel volume di Giulia De Marchi come esposti nel 1713 a S. Salvatore in Lauro, ma attribuiti esplicitamente al Cortona (« il Ratto delle Sabine, grande, del Cortona, col compagno », p. 277). Alla scuola del Cortona rimandano la « Madonna in tela d’imperatore scarsa, della maniera del Romanelli, doppie cinque sc. 15 » (n° 65) e soprattutto le opere di Guglielmo Cortese (ad esempio « un S. Gioseppe », n° 128) e del fratello Giacomo (« doi quadretti, uno di Monsù Jacomo, pittore di Sacchetti, e l’altro di Guglielmo Bavaro dell’istessa misura, con cornici di pero e con intaglio indorate, doppie quattro sc. 12 », n° 23; « tre paesi in tela d’imperatore di Monsù Jacomo olandese, doppie ventiquattro sc. 12 », n° 69; « doi battaglie picciole ovate del Borgognone, con cornice nere et oro, doppie 20 sc. 60 », n° 115; « Doi paesini, uno del Borgognone e l’altro di Perino, con cornici indorate, doppie dodici sc. 36 », n° 127) 28, pittore il primo di cui viene ricordata una collaborazione col Baciccio (« un ponte con paesino del p. Jacomo Borgognone, colle figure di Baciccio, con cornice d’intaglio indorata, doppie 12 sc. 36 », n° 106), nonché le diverse opere di Carlo Cesi (« doi teste, una di S. Caterina e l’altra d’un vecchio, in tela di mezza testa, con cornici d’intaglio indorate », n° 6, « una testa di un Ecce Homo copiata da Carlo Cesi e Guido », n° 47, « un vecchio », n° 49, « una Madonna, in tela di mezza testa, con cornice indorata », n° 56), artista di grande interesse per lo sviluppo secentesco del cortonismo e del gusto barocco 29. È presente anche un altro protagonista della cultura barocca, Guido Reni, con « quattro mezze figure, cioè una di Guido Reni, e l’altre tre della Sirani, con cornici tutte d’intaglio indorate, doppie 100 sc. 300 » (n° 92), opere di cui vengono ricordati i soggetti nell’inventario dei quadri del 1713 di Federico Sforza (la Madonna, santa Caterina della Rota, san Pietro ed una Sibilla, n° 66) ed attribuite nel loro insieme al Reni, mentre nell’esposizione dei quadri a S. Salvatore in Lauro del 1713 tra i quadri di Gaetano Sforza compaiono un san Pietro di Guido Reni e « la Sibilla, compagno del medesimo ». (G. De Marchi, p. 278). 28 Cfr. G. SESTIERI, I pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo, Roma 1999. 29 Aedium Farnesiarum tabulae ab Annibale Caraccio depictae a Carlo Caesio aeri insculptae atque Lucio Philarchaeo explicationibus illustratae, Romae 1753; G. TAMANTI, Cesi Carlo, in Dizionario biografico degli italiani, XXIV, Roma 1980, pp. 250-253; V. DI FLAVIO, Carlo Cesi. Pittore e incisore del Seicento tra ambiente cortonesco e classicismo marattiano, 16221682, catalogo della mostra, Rieti 1987; U. V. FISCHER PACE, Carlo Cesi als Zeichner, in « Bulletin du Musée Hongrois des Beaux Arts », 1995, 82, pp. 93-168; A. VANNUGLI, Carlo Cesi, in Pietro da Cortona 1597-1669, catalogo della mostra, Milano 1997, pp. 257-264. Carla Benocci 112 Anche il Domenichino è richiamato da « un san Francesco in rame nella maniera del Domenichino, con cornici di pero in intaglio d’oro, doppie otto sc. 24 » (n° 19). Non manca anche l’ambiente caravaggesco, con una « tela di sette cinque con Christo battuto del Manfredi, con cornice tutta d’intaglio indorata, doppie 30 sc. 90 » (n° 93), opera che può essere identificata con il quadro « rappresentante Nostro Signore alla colonna opera della scuola di Michelangelo di Caravaggio sc. 60 » dell’inventario del 1713 dei quadri di Federico (n° 64) e che richiama pur con un soggetto in parte diverso l’incoronazione di spine già in collezione Rengers van Pallandt (fig. 1) 30. È presente anche un altro pittore caravaggesco non tra i più comuni, Antiveduto Grammatica, con « le quattro staggioni in tela d’imperatore per alto, di Antiveduto Gramatica, con cornice d’intaglio indorata, doppie 20 sc. 60 » (n° 78) 31. Un caravaggismo di diversa maniera è quello rappresentato da « una testa bislunga del Borgiani, con una lattuga al collo, doppie 2 sc. 6 » (n° 145). È ben rappresentata comunque la corrente classicistica del Sacchi e del Maratta: del primo maestro sono presenti « una testina di pastello d’un vecchio, con cornice indorata (…) » (n° 26) e soprattutto « Caino et Abel in tela d’imperatore di Andrea Sacchi, cornice d’intaglio indorata, doppie 50 sc. 150 » (n° 85), coincidente con il quadro esposto a S. Salvatore in Lauro nel 1713 (G. De Marchi, p. 278) e probabilmente con quello ricordato nell’inventario dello stesso anno dei quadri di Federico « un quadro di palmi 6 e 3 e ½ rappresentante Adamo ed Abelle opera d’Andrea Sacchi sc. 100 » (n° 68), quadro che può essere identificato con il « quadro tela d’imperatore con Caino che ha occiso Abelle con cornice gialla », citato insieme ad altre due versioni nell’inventario del giugno 1661 di casa Sacchi (n° 165) 32. Si tratta di un tema importante nella produzione del pittore, tema di cui sono ricordate queste tre versioni, presenti nel 1661 nella casa del Sacchi, mentre una quarta versione, dipinta nel 1644 per il cardinale Antonio Barberini come sopraporta, era passata poi alla regina Cristina di Svezia. Per quanto riguarda le tre versioni del 1661 è nota solo la storia di quella venduta nel 1662 dagli eredi Sacchi ai Barberini per 80 scudi: questo quadro è citato nell’inventario del 1671 del cardinale Antonio Barberini, valutato 350 scudi, ed è identificabile con quello conservato presso l’Institut of Arts di Minneapolis (fig. 2). La versione presente in casa Sforza almeno fino al 1713 introduce un’altra pista di ricerca, per seguire le tracce della dispersione subita dal patrimonio Sforza nel XIX secolo. 30 Michelangelo Merisi da Caravaggio e i suoi primi seguaci, a cura di M. GREGORI, s.l., 1997, p. 358, n° 10. 31 32 Cfr. H. P. RIEDL, Antiveduto della Grammatica: Leben und Werk, München 1998. A. SUTHERLAND HARRIS, Andrea Sacchi, Oxford 1977, pp. 75-76, fig. 69; cfr. anche ID., Andrea Sacchi, in L’Idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, catalogo della mostra, a cura di E. BOREA e C. GASPARRI, Roma 2000, II, pp. 442-444. L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 113 Carlo Maratta, protagonista assoluto sulla scena romana soprattutto dopo la morte del Bernini nel 1680, ricercato da una élite culturale ed economica (« per i prezzi egli era divenuto quasi inabbordabile e comunque bisognava fare la fila ed aspettare a lungo per aver un parto del suo pennello, tanto che molti signori si accontentavano delle ottime repliche di bottega » 33), è presente nell’inventario del 1687 con « doi ovati bislonghi, uno che rappresenta un angelo, di Carlo Maratta, l’altro che rappresenta la Madonna, di Carlin Dolce, con cornice d’intaglio indorata, doppie 60 sc. 180 » (n° 86) e « doi quadretti che formano una Annuntiata, di Carlo Maratta, colle ghirlandine di fiori di Girolamo Solari, ritoccati da Filippo Lauri, con le cornici tutte d’intaglio indorate, doppie 30 sc. 90 » (n° 102), descrizione attendibile anche per la precisa menzione delle collaborazioni di altri artisti ben noti, come il Lauri, e comunque molto più puntuale rispetto alle citazioni delle ultime due opere nell’elenco di quadri esposti a S. Salvatore in Lauro nel 1713 ricordati nel volume della De Marchi (« Madonna et Angelo, da testa, Annunziata del cav. Maratti », p. 277) e nell’inventario dello stesso anno di Federico Sforza (n° 43, « due quadri di palmi 2 e ½ rappresentante uno la SS. Nunziata e l’altro l’Angelo della scuola di Carlo Maratta », opere stimate in sc. 20). In misura minore è presente anche l’esponente dell’altro filone del tardo barocco, il Baciccio, sia nel quadro già citato in collaborazione con Giacomo Cortese sia in « doi testine, una di Baciccio e l’altra di Agostino Scilla, con cornici indorate, doppie 4 sc. 12 » (n° 132), a testimoniare la vasta cultura artistica di Federico e Livia, anche se con un orientamento più indirizzato verso il filone classicistico 34. Questa complessità di gusto è documentata dalle diverse opere di Giacinto Brandi, seguace del Lanfranco ed attento al caravaggismo di Mattia Preti, di cui è da segnalare una « Madalena », soggetto più volte ripetuto dal pittore 35 ma in questo caso « con il paese ritoccato da Filippo Lauri, con cornice d’intaglio indorata » (n° 38). Anche il Lauri è ampiamente presente, anticipando le raffinatezze del barocchetto romano settecentesco 36. D’altra parte è ben rappresentato anche Fabrizio Chiari, quest’ultimo sempre allineato verso un’ispirazione classicistica 37, principe dell’Accademia di San Luca nel 16851686, presente anche nell’inventario dei quadri di Federico del 1713 con « due favole sc. 6 » (n° 49), forse riferibili ad una delle due coppie di quadri di soggetto favolistico e mitologico (nn° 126 e 136 dell’inventario del 1687). 33 S. RUDOLPH, Carlo Maratti, in L’Idea del Bello… cit., II, p. 457. 34 Cfr. Il Baciccio… citato e Il Baciccio un anno dopo. La Collezione Chigi, restauri e nuove scoperte, catalogo della mostra, Milano 2001. 35 G. SESTIERI, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, I, Torino 1994, p. 37. 36 Ibid., pp. 104-106. 37 Ibid., p. 51. 114 Carla Benocci L’interesse per il paesaggio è testimoniato dalla presenza di opere di artisti dell’ambiente carraccesco, come Giovanni Francesco Grimaldi e suo figlio Alessandro, Claude Lorrain, ma anche di esponenti di altri ambiti, come i già ricordati fratelli Courtois, il Guercino, di cui viene ricordato un « campo Vaccino in tela di sette cinque, doppie 50 sc. 150 » (n° 87), Viviano Codazzi, Simone Felice Delino, Nicola Nasone, e soprattutto i fiamminghi, sia paesisti che bamboccianti, come Hermann van Swanevelt (Monsù Armanno), Pieter van Laer, detto il Bamboccio (Monsù Laiè), Mathieu van Plattenberg (Monsù Montagna), Momper, Adrian van der Kabel (Vandercable), « Monsù Schinch », Dirk Theodor Helmbrecker (Monsù Teodoro), di cui nell’inventario del 1713 sono citate quattro bambocciate. Il vedutismo di genere è rappresentato anche da autori che avranno notevole successo a fine secolo XVII, come l’arguto Pasqualino Rossi. Anche la natura morta è presente con le opere di Mario Nuzzi, detto Mario de’ Fiori, dello Stanchi, dello Spadino, e non mancano le battaglie, dei Borgognone e di Ciccio Napoletano (Francesco Graziani) (nn° 8, 9). Tra gli esponenti più significativi della cultura tardobarocca ed ampiamente presenti con varie opere sono Agostino Scilla (presente nell’inventario del 1713 con « un quadruccio di palmi 2 e ½ rappresentante la Pittura opera di Agostino Scilla scudi 3 », forse riferibile al n° 120 del 1687), Girolamo Troppa e Giovanni Maria Morandi. Quest’ultimo, molto amato in quegli anni 38, soprattutto come ritrattista 39, venne chiamato anche da Federico e Livia per ritrarre vari membri delle famiglie Sforza e Cesarini ed il pontefice Clemente IX, quadri che si accompagnano al ritratto del papa Innocenzo X di Giusto Sustermans, a quello di « Monsù Vuet » (Fernand Jacob Voet) ed ai « dieci ritratti imperatori turchi, quattro bellissimi di Federico Zuccari » (n° 88) 40, nonché al « ritratto di Filippo Quarto in tela d’imperatore, di Diego Velázquez, cornice indorata con intaglio, doppie 50 sc. 150 » (n° 80), interessante presenza romana di uno dei numerosi ritratti del re di Spagna 41. Il Morandi è inoltre rappresentato da un « bozzetto dello sposalitio della Madonna fatto nella sacrestia dell’Anima, con cornice di pero et intaglio d’oro » (n° 35), che rimanda al foglio di Berlino proveniente dalla collezione Pacetti, a sanguigna, acquerello rosso rialzato di bianco su carta 38 Ibid., pp. 131-132; E. WATERHOUSE, A note on Giovanni Maria Morandi, in « Studies in Renaissance and Baroque Art presented to A. Blunt », 1967, pp. 117-121. 39 F. PETRUCCI, Sull’attività ritrattistica di Giovanni Maria Morandi, in « Labyrinthos », 1998, 17, pp. 131-174, n° 33-34. 40 M. WINNER - D. HEIKAMP, Der Maler Federico Zuccari. Ein römischer Virtuoso von europäischem Ruhm, München 1999. 41 Cfr. J. LOPEZ REY, Velázquez. A catalogue raisonné of his oeuvre, London 1963, pp. 206-226, nn° 231-301; ID., Velázquez Maler der Maler, Wildenstein Institute 1996; Velázquez: pintor y criado del rey, Hondarruba 1999; Velázquez, aposentador real, Madrid 1999; Velázquez a Roma, Velázquez e Roma, a cura di A. COLIVA, Ginevra 1999; Velázquez, catalogo della mostra, Roma, Fondazione Memmo, 30 marzo-30 giugno 2001, a cura di F. V. GARIN LLOMBARTE e S. SALORT PONS, Roma 2001. L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 115 avorio (fig. 3) 42, rappresentante appunto il modello della pittura dello stesso soggetto nella sagrestia della chiesa di S. Maria dell’Anima a Roma, eseguita nel 1680-1683 (fig. 4) e forse identificabile con un quadro dello stesso soggetto dell’inventario del 1713 di Federico Sforza (n° 45). Sempre del Morandi è elencato un « bozzetto di un S. Filippo ch’è nel Domo di Siena » (n° 104), corrispondente alla visione di S. Filippo Neri eseguita nel 1680 nel duomo di Siena (fig. 5) 43, che rinvia ad un quadro sempre con lo stesso soggetto ricordato nell’inventario di Federico del 1713 (n° 46). La tela di Nicolò Tornioli raffigurante « Cleopatra con i serpi al seno (…) cornice antica, doppie 20 sc. 60 » (n° 81) rimanda con una singolare affinità al quadro d’identico soggetto in collezione privata milanese (fig. 6), che costituisce una « tipica produzione dell’artista del quinto decennio del secolo » 44, corrispondente forse al quadro citato nell’inventario del 1713 riferito a « Monsù Daniele » (n° 56). Sono anche identificabili due opere di Francesco Trevisani, l’artista che risulta già orientato verso lo sviluppo rococò della cultura barocca: « un rametto con la favola di Latona (…) cornice indorata et intagliata, doppie 4 sc. 12 » (n° 124) presenta sostanziali analogie rispetto al quadro in rame raffigurante Latona che trasforma i pastori in rane, già in collezione Briganti a Roma (fig. 7) 45; « un rame con Olindo e Sofronia, con cornici di pero intagliate, doppie otto sc. 24 » (n° 39) è riferibile probabilmente al quadro battuto all’asta di Sotheby’s a New York il 20 maggio 1993 (n° 111) (fig. 8), citato nell’inventario del 1738 del cardinale Melchior de Polignac e probabilmente in quello del 1783 del cardinale Carlo Colonna (n° 578); si tratta comunque del quadro ricordato nell’inventario dei quadri di Federico Sforza del 1713 (n° 96). La cultura barocca si conclude così degnamente, ma è preceduta da alcune opere risalenti al periodo rinascimentale: significativi, in questo senso, sono « un convito, bozzetto del Tintoretto o pure di Luca Giordano bellissimi, con cornice di pero e riporto d’oro » (n° 60), la « Madonna in tavola col Bambino in braccio e S. Gioseppe di dietro, cornice nera col riporto d’oro, di Perino del Vaga, doppie cento sc. 300 » (n° 90), valutazione molto rilevante a sostegno della rarità del pezzo e della sua importanza, mentre la « Madonnina di Raffaele che era un voto antico, con cornici d’oro, doppie quattro sc. 12 » 42 E. SCHLEIER, Disegni di Giovanni Maria Morandi nelle collezioni pubbliche tedesche, in « Antichità viva », XXXI (1992), 3, pp. 15-25, Kupferstichkabinett, KK 321-1988, Staatliche Museen, Berlino. 43 E. SCHLEIER - A. STALZENBURG, Disegni di Giovani Maria Morandi nelle collezioni pubbliche tedesche: l’album del Museo di Lipsia, con alcune note sulla sua provenienza, in « Studi di storia dell’arte », 1998, 9, pp. 247-276. M. CIAMPOLINI, Integrazioni al catalogo di Nicolò Tornioli, in « Antichità viva », 34 (1995), 4, p. 28. 44 45 G. SESTIERI, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento… cit., I, pp. 173-176; III, fig. 1088. Carla Benocci 116 (n° 15) e la « copia di un Moisè di Raffaele, doppie 10 sc. 30 » (n° 75) sono citazioni del grande maestro necessarie in una collezione raffinata, priva però di opere celebri del periodo 46. Il confronto con la quadreria del connestabile Colonna, come già rilevato, sottolinea la raffinatezza delle scelte artistiche ma un numero indubbiamente minore di opere, mentre maggiori affinità si ritrovano nelle collezioni di Nicolò Maria Pallavicini 47, del banchiere Francesco Montioni 48 e del marchese Paolo Girolamo Torre 49, trovando poi adeguati sviluppi nella quadreria di Maria Camilla Rospigliosi Pallavicini 50, a testimoniare la vivacità e la ricchezza del collezionismo romano di fine Seicento. CARLA BENOCCI Comune di Roma Sovraintendenza ai beni culturali 46 Sul raffaellismo in età barocca cfr. G. PERINI, Una certa idea di Raffaello nel Seicento, in L’Idea del Bello… cit., I, pp. 153-161. 47 S. RUDOLPH, Niccolò Maria Pallavicini. L’ascesa al Tempio della Virtù attraverso il mecenatismo, Roma 1995. 48 S. RUDOLPH, Francesco Montioni di Spoleto, banchiere e mecenate in Roma: schedula per una identità, in Scritti di archeologia e storia dell’arte in onore di Carlo Pietrangeli, a cura di V. CASALE, Roma 1996, pp. 265-270. 49 50 C. BENOCCI, Villa Abamelek, Milano 2001. A. NEGRO, La collezione Rospigliosi. La quadreria e la committenza artistica di una famiglia patrizia a Roma nel Sei e Settecento, Roma 1999. L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 117 APPENDICE * « Inventario delli quadri delli signori don Federico Sforza e donna Livia Cesarini sua moglie, fatto nell’anno 1687 » (ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, Archivio Sforza Cesarini, I parte, b. 465) 1. Quadri numero quattro di ritratti di don Paolo Sforza, duca Giuliano Cesarini, don Federico Sforza e donna Livia fatti dal signor Morandi, con cornice d’intaglio indorate, doppie cinquanta scudi 150 2. Una Sammaritana in rame di Filippo Lauri, cornice di pero con intaglio d’oro, doppie quindici sc. 45 3. Due paesi di Tempestino, con cornici indorate, in tela di quattro palmi, doppie tre sc. 9 4. Doi paesi di Monsù Mumper in tela, di quattro palmi, con cornici indorate, doppie tre sc. 9 5. Nove quadri di paesi in tela, di quattro palmi, di Nasone, con figure di diversi, di cornici indorate, doppie dodici sc. 36 6. Doi teste, una di S. Catarina e l’altra d’un vecchio, di Carlo Cesi, in tela di mezza testa, con cornici d’intaglio indorate, doppie quattro sc. 12 7. Doi marine bislonghe di Monsù Schinch, con cornici indorate, doppie quattro sc. 12 8. Doi rami con doi battaglie copiate da Ciccio Napoletano, dal Borgognone, con cornici intagliate assai indorate, doppie dodici sc. 36 9. Una copia simile un poco più bislonga in tela dell’istesso autore, con cornice et intaglio indorate, doppie cinque sc. 15 10. Un quadretto picciolo di Luigi Gentile, esprimente la regina di Svezia e papa Alessandro, con cornice di pero et oro intagliate, doppie quattro sc. 12 11. Doi paesini con figurine di Filippo Lauri, con cornici nero et oro intagliate, doppie dodici sc. 36 12. Testina della Madonna di miniatura con cornice di pero et oro intagliata, doppie due sc. 6 13. Doi miniature in penna d’inchiostro ovate, con cornici di pero et oro intagliate, doppie tre sc. 9 14. Quattro santini a oglio di Luigi Gentile dell’istessa misura, con cornici di pero et intaglio di oro, doppie sei sc. 18 15. Una Madonnina di Raffaele che era un voto antico, con cornici d’oro, doppie quattro sc. 12 16. Una Madonna di miniatura di penna, con cornice d’intaglio d’oro, doppie 4 sc. 12 * La numerazione è stata aggiunta nella trascrizione per facilità di consultazione. 118 Carla Benocci 17. Doi bassi rilievi d’avorio, con cornici di pero negro, doppie una sc. 3 18. Un ramettino picciolo di Filippo Lauri, con cornicetta tutta d’intaglio indorata, doppie sei sc. 18 19. Un San Francesco in rame nella maniera di Domenichino, con cornici di pero in intaglio d’oro, doppie otto sc. 24 20. Una miniatura, con cornicette di pietra et accattaglio d’argento, doppie una sc. 3 21. Tre miniaturine ovate, dentro una sola cornice d’intaglio d’oro, doppie due sc. 6 22. Tre prospettive di Simon Felice in carta pecora, con cornici di pero e battente d’oro, doppie sei sc. 18 23. Doi quadretti, uno di Monsù Jacomo, pittore di Sacchetti, e l’altro di Guglielmo Bavaro dell’istessa misura, con cornici di pero e con intaglio indorate, doppie quattro sc. 12 24. Sei quadretti in rame di Monsù Mumper, cinque con cornici indorate et intaglio et una di pero negro, doppie otto sc. 24 25. Un disegno in penna d’una Madalena di Giacinto Siciliano, con cornice di pero negra, doppie una sc. 3 26. Una testina di pastello d’un vecchio, con cornice indorata, d’Andrea Sacchi, doppie doi sc. 6 27. Un paese con doi figure, con cornice indorata, del Troppa, in piccolo, doppie doi sc. 6 28. Doi paesini in tela di mezza testa di Vandercable, doppie sei, con cornice d’intaglio indorate sc. 18 29. Un ritrattino in rame di Monsù Teodoro di sua mano, con cornice d’intagli indorate, doppie due sc, 6 30. L’istesso di Agostino Scilla, doppie due sc. 6 31. L’istesso di Francesco Trevisano, doppie 2 sc. 6 32. Vecchia di teluccia picciola di Monsù Teodoro, con cornice indorata, doppie una sc. 3 33. Ritrattino di Gubau di sua mano, con cornice intagliata et indorata, doppie 2 sc. 6 34. Due quadretti in tela di mezza testa di Monsù Mumper, con cornici indorate, doppie doi sc. 6 35. Bozzetto dello sposalitio della Madonna, quadro del Morandi fatto nella sacrestia dell’Anima, con cornice di pero et intaglio d’oro, dodici doppie sc. 36 36. Rametto con Erminia et il pastore, di Pasqualino, doppie quattro sc. 12 37. Villano con la piva di Scurienz, con cornice d’intaglio indorata, doppie doi sc. 6 38. Madalena di Giacinto Brandi, con il paese ritoccato da Filippo Lauri, con cornice d’intaglio indorata, doppie dieci sc. 30 39. Un rame di Francesco Trevisani con Olindo e Sofronia, con cornici di pero intagliate, doppie otto sc. 24 40. Doi marinette d’Arrigo lo Spagnoletto, in tela di mezza testa, con cornici indorate et intagliate, doppie quattro sc. 12 L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 119 41. Un rame di frutti piccioli et animali diversi, di maniera tedesca bellissimo, con cornice indorata et intaglio, doppie otto sc. 24 42. Doi quadretti di Filippo Lauri, uno Christo all’orto e l’altro de tre Marie, con cornice d’intaglio indorate, doppie 12 sc. 36 43. Doi testine di vecchi, con cornici di pero et riporto di oro, doppie tre sc. 9 44. Un rametto picciolo con l’istoria di Circe, maniera di Francesco Trevisani, con cornice d’intaglio indorate, doppie tre sc. 9 45. Doi quadri che formano una Annuntiata, con cornice indorata di buona maniera, doppie sei sc. 18 46. Doi ovati in marmo di maniera incognita, doppie due sc. 6 47. Una testa di un Ecce Homo copiata da Carlo Cesi e Guido, doppie una sc. 3 48. Doi testine, una d’Anton Gherardi e l’altra di Monsù Teodoro, con cornici d’intaglio indorate, doppie tre sc. 9 49. Un vecchio di Carlo Cesi, doppie una sc. 3 50. Quattro paesi di Nicola Nasone, con le figure di Monsù Egidio, con cornice indorata, doppie tre sc. 9 51. Ritratto di Monsù Vuet in tela di mezza testa, con cornice indorata antica, doppie tre sc. 9 52. Disegno a chiaro oscuro d’un Christo con un mondo in mano, di Monsù Laiè, doppie una sc. 3 53. Quattro paesi piccioli di Monsù Nasone, con cornici indorate, doppie quattro sc. 12 54. Doi marine di Girolamo Troppa bislunghe, con cornici nere e filettate d’oro, doppie tre sc. 9 55. Un quadro di fiori, copia di tela, di cornice indorata, di quattro palmi, doppie 1 sc. 3 56. Una Madonna di Carlo Cesi, in tela di mezza testa, con cornice indorata, doppie doi sc. 6 57. Doi rametti, uno d’Omero e l’altro d’un putto con una colomba in mano, uno dello Scilla e l’altro del Pasqualini, con cornici indorate, doppie doi sc. 6 58. Un quadretto di Monsù Mumper ovato, doppie una sc. 3 59. Doi vedute, una della Marmorata e l’altra della Trinità de Monti, di Monsù Claudio di Sacchetti, doppie 30 sc. 90 60. Un convito, bozzetto del Tintoretto o pure di Luca Giordano bellissimi, con cornice di pero e riporto d’oro, doppie quindici sc. 45 61. Un quadro più grande di mezza testa, rappresentante il ricco Epulone, di Monsù Teodoro, doppie cinque sc. 45 62. Doi paesi in tela di sette cinque, di Nicola Nasone, con cornici indorate, doppie dieci sc. 30 63. Doi tele d’imperatore, in una Arianna e Bacco con molte figure, e l’altra una donna che bagia un pastore, con cornici indorate, doppie dieci sc. 30 64. Una tela di sette cinque, Adone e Venere, di Girolamo Troppa, con cornice indorata, doppie dieci sc. 30 65. Una Madonna di tela d’imperatore scarsa, della maniera del Romanelli, doppie cinque sc. 15 120 Carla Benocci 66. Una tela d’imperatore con S. Sebastiano per alto, di Girolamo Troppa, cinque doppie sc. 15 67. Ritratto d’un nano di casa Sforza, fatto da Rodomonte castrato, doppie cinque sc. 15 68. Quattro paesi in tela d’imperatore di Gioseppe Montani, con figure di Monsù Teodoro, doppie quaranta sc. 120 69. Tre paesi in tela d’imperatore di Monsù Jacomo olandese, doppie ventiquattro sc. 12 70. Dieci tele d’imperatore di Nicola Nasone scudi quaranta sc. 40 71. Sette paesi in tela di quattro palmi del medesimo, doppie sette sc. 21 72. Quattro tele dell’istesso di dodici et otto, doppie 20 sc. 60 73. Doi tele di mezza testa, uno Polifemo, dicono accademia di Lanfranco, e l’altro studio di teste d’Agostino Scilla, doppie due sc. 6 74. Quattro ritratti in piedi della casa Sforza, di buona maniera, doppie 16 sc. 54 75. Copia di un Moisé di Raffaele, doppie 10 sc. 30 76. Tre quadri in tela d’otto e dieci, uno il ratto delle Sabine, l’altro l’idolatria di Salomone, e l’altro un historia de Romani, di Bartolomeo Palombo, della scuola di Pietro da Cortona, doppie 50 sc. 150 77. Un Moisé nella culla, in tela di otto e dodici, di ottima maniera, doppie 100 sc. 300 78. Le quattro staggioni in tela d’imperatore per alto, di Antiveduto Gramatica, con cornice d’intaglio indorata, doppie 20 sc. 60 79. Assunta d’Alessandro Bronzino con molte figure, cornice d’intaglio indorata, doppie 50 sc. 150 80. Ritratto di Filippo Quarto in tela d’imperatore, di Diego Velasquez, cornice indorata con intaglio, doppie 50 sc. 150 81. Cleopatra con i serpi al seno di Nicolò Tornioli, cornice antica, doppie 20 sc. 60 82. Susanna al bagno, ritocco del Domenichino, cornice antica, doppie 20 sc. 60 83. Arianna e Bacco di Girolamo Trotti, con cornice di cotogne indorata, doppie 15 sc. 45 84. Quattro tele d’imperatore, di Brugolo, bellissime, cornice d’intaglio indorate, doppie 200 sc. 600 85. Caino et Abel in tela d’imperatore di Andrea Sacchi, cornice d’intaglio indorata, doppie 50 sc. 150 86. Doi ovati bislonghi, uno che rappresenta un angelo, di Carlo Maratta, l’altro che rappresenta la Madonna, di Carlin Dolce, con cornice d’intaglio indorata, doppie 60 sc. 180 87. Campo Vaccino del Quercino, in tela di sette cinque, doppie 50 sc. 150 88. Dieci ritratti imperatori turchi, quattro bellissimi di Federico Zuccaro, doppie cento sc. 300 89. Sei quadri di tela di quattro palmi, di Monsù Teodoro, doppie 60 sc. 180 90. Madonna in tavola col Bambino in braccio e S. Gioseppe di dietro, cornice nera col riporto d’oro, di Perino del Vaga, doppie cento sc. 300 L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 121 91. Tela d’imperatore di una donna con un puttino et un vecchio, di Gio. Maria Morandi, cornice d’intaglio d’oro, doppie 40 sc. 120 92. Quattro mezze figure, cioè una di Guido Reni, e l’altre tre della Sirani, con cornici tutte d’intaglio indorate, doppie 100 sc. 300 93. Tela di sette cinque con Christo battuto del Manfredi, con cornice tutta d’intaglio indorata, doppie 30 sc. 90 94. Un S. Girolamo dello Spagnoletto, con cornice liscia indorata, doppie 8 sc. 24 95. Una Madalena del Troppi, in tela di quattro palmi, con cornice indorata, quattro doppie sc. 12 96. Una Madonna del medesimo dell’istessa misura, doppie 4 sc. 12 97. Doi marine in tela di quattro palmi, di Monsù Montagna, con cornice d’intaglio indorata, doppie 20, sc. 60 98. Quattro tele di quattro palmi, prospettive di Viviano colle figure di Anton de Valle, cornice liscia indorata, doppie quaranta sc. 120 99. Doi bagni, uno di Diana e l’altro di Calisto, di Filippo Lauri, in rame, con cornice nera a oro, doppie 60 sc. 180 100. Doi prospettivette in tela di mezza testa, una di don Vincenzo e l’altra di Monsù Ghi, ritoccate, e colle figure di Filippo Lauri, cornice nera e oro, doppie 20 sc. 60 101. Madonnina col putto in braccio e S. Gioseppe in rame, di Giacomo Sementa, colla cornice tutta d’intaglio di oro, doppie settanta sc. 210 102. Doi quadretti che formano una Annuntiata, di Carlo Maratta, colle ghirlandine di fiori di Girolamo Solari, ritoccati da Filippo Lauri, con le cornici tutte d’intaglio indorate, doppie 30 sc. 90 103. Madonnina col putto in braccio di Gio. Maria Morandi, con cornice nera et oro, doppie quindici sc. 45 104. Bozzetto di Gio. Maria Morandi di un S. Filippo ch’è nel Domo di Siena, doppie 12 sc. 36 105. Prospettiva di Viviano per alto, ritoccata da Filippo Lauri, con figure del medesimo, con cornice indorata, doppie 12 sc. 36 106. Un ponte con paesino del p. Jacomo Borgognone, colle figure di Baciccio, con cornice d’intaglio indorata, doppie 12 sc. 36 107. Doi prospettive in tela di mezza testa di Costanzo Valle, con le figure di Filippo Lauri, con cornici d’intaglio indorate, doppie 20 sc. 60 108. Doi vasi di fiori di bellissima maniera, colle cornici indorate, doppie dieci sc. 30 109. Una Madonna con un putto in braccio, con un S. Giovannino con un melo in mano, di Monsù Teodoro, con cornice di pero, con certi riporti d’oro, doppie sei sc. 18 110. Un paese, copia d’un tedesco, con cornice d’oro liscia, doppie 2 sc. 6 111. Doi vasi di fiori dello Stanchi, con cornice d’oro, doppie 3 sc. 9 112. Doi ovati coll’historie del figliol prodigo, della maniera di Francesco Giovine, con cornice indorata, doppie otto sc. 24 113. Un rivolto santo in rame di Gio. Maria Morandi, doppie dieci sc. 30 122 Carla Benocci 114. Doi ritratti di lapis di don Paolo Sforza e cavaliere Sforza, con cornicette d’oro, del Morandi, doppie 4 sc. 12 115. Doi battaglie picciole ovate del Borgognone, con cornice nere et oro, doppie 20 sc. 60 116. Doi quadretti di frutti di Spadino, con cornici d’oro, tre doppie sc. 9 117. Doi vasi di maiolica con fiori dello Stacchi, con cornice d’intaglio indorata, doppie dieci sc. 30 118. Ritratto del cardinale Sforza, dicono del Guercino o di Mattia Bolognini, doppie quattro sc. 12 119. Un paesetto di Girolamo Troppi, del gusto del Mola, doppie una sc. 3 120. Una scuola di pittori d’Agostino Scilla, con certi modelli di gesso, doppie quattro sc. 12 121. Una pietà in marmo nel gusto del Guercino, doppie dodici sc. 36 122. Una tela di mezza testa, di Monsù Teodoro, con uno a cavallo nel somaro, con cornice d’intaglio indorata, doppie cinque sc. 15 123. Un pastore con certe pecorelle dell’istesso, un poco più picciolo, doppie 4 sc. 12 124. Un rametto con la favola di Latona, del Trevisani, cornice indorata et intagliata, doppie 4 sc. 12 125. Altro rametto di Agostino Scilla, con un pittore che accommoda il modello all’Accademia, doppie tre sc. 9 126. Doi quadretti di Fabritio Chiari, uno di istoria di Arianna et Teseo e l’altro di Polifemo, con cornici indorate, con un poco d’intaglio, doppie 20 sc. 60 127. Doi paesini, uno del Borgognone e l’altro di Perino, con cornici indorate, doppie dodici sc. 36 128. Doi S. Gioseppe, uno di Monsù Guglielmo e l’altro di Girolamo Troppi, con cornici indorate liscie, doppie dodici sc. 36 129. Una testa di un vecchio che sta pensoso, di bellissima maniera, l’Ambasciatore di Spagna la volse pagare doppie sei sc. 36 130. Una tela di 4 palmi con Catone che si straccia le budelle di Girolamo Troppi, doppie 4 sc. 12 131. Doi paesi ovati di Monsù Armanno, con cornici nere et oro, doppie 12 sc. 36 132. Doi testine, una di Baciccio e l’altra di Agostino Scilla, con cornici indorate, doppie 4 sc. 12 133. Doi scole, una di putti e l’altra di zitelle, di Pasqualino, con cornici indorate, doppie sei sc. 18 134. Doi altri rametti di frutti dell’istesso, doppie 4 sc. 12 135. Due paesini di Gio. Francesco bolognese, in rame, con cornici indorate, quattro doppie sc. 12 136. Doi historie di Fabritio Chiari, in uno Rinaldo et Armida e nell’altro Aretusa che fugge, con cornice liscia indorata, doppie 6 sc. 18 137. Un historia del figliol prodigo, con cornice indorata, di Monsù Teodoro, doppie 6 sc. 18 138. Una primavera con molti putti che figurano i venti, in tela piccola, con cornice d’intaglio indorata, del Morandi, doppie sette sc. 21 L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini 123 139. Un paesino con cornice indorata a bolino, di Bartolomeo, doppie 2 sc. 6 140. Doi vasi di fiori, uno di tulipani, di Mario, e l’altro della signora Laura, con cornici d’intaglio indorate, doppie 4 sc. 12 141. Un S. Rocco dipinto in raso, di Giacinto Brandi, con cornice indorata, doppie 4 sc. 12 142. Doi mazzi di rose in tela di mezza testa, con cornici indorate liscie, di Girolamo Solari, doppie 4 sc. 12 143. Sei paesini ovati di Mumper, doppie quattro sc. 12 144. Doi canestrini di fiori, una di Bodesson e l’altra di Girolamo Solari, doppie 2 sc. 6 145. Una testa bislunga del Borgiani, con una lattuga al collo, doppie 2 sc. 6 146. Una battaglia del Tor di Valle, con cornice dorata liscia, doppie sei sc. 18 147. Un altro del P. Jacomo, colle figure di Giacinto Brandi, con cornice d’intaglio indorata, doppie otto sc. 24 148. Due teste di papi, uno di papa Innocenzo X, di Monsù Giusto, e l’altro di Clemente IX del Morandi, con cornice d’oro d’intaglio, doppie 12 sc. 36 149. Due teste del pastello del Morandi, col vetro davanti, e l’altra a oglio dicono di Caracci, doppie sei sc. 18 150. Doi quadretti di Spadino, d’uva e persiche, con cornici indorate liscie, doppie tre sc. 9 151. Un ritratto di bellissima maniera di un giovane con collarino di merletto, con cornice d’intaglio indorata, doppie tre sc. 9 152. Un altro pastello d’una testa col vetro davanti d’ottima maniera, con cornice liscia indorata, doppie 2 sc. 6 153. Due paesini del figlio di Gio. Francesco Bolognese, in rame con cornice nera e battente indorato, doppie tre sc. 9 154. Due altri paesini quasi simili di Anton de Valle, doppie tre sc. 9 155. Un Bambino che dorme nella croce, con cornice verde indorata, di Agostino Scilla, doppie 4 sc. 12 156. Tre teste di putti dello Spadarino, con cornici d’intaglio indorata, doppie 6 sc. 18 157. Un rametto picciolo con incantesimo, tutta la cornice indorata et intagliata del Trevisani, doppie tre sc. 9 158. Doi ritratti, uno di Ranuccio Farnese e l’altro della moglie, del Padovano vecchio, con cornice indorata liscia, doppie 4 sc. 12 159. Un Christo all’orto in tavola, di maniera antica, tutto rifatto da Filippo Lauri, con cornice indorata liscia, doppie dieci sc. 30 160. Un S. Domenico con un angelo che lo presenta all’altare, d’autore incognito, doppie 2 sc. 6 161. Doi paesi in tela di sette cinque, di Nicola Nasone, doppie dieci sc. 30 162. Un paese grande bislungo dell’istesso, doppie sette sc. 21 163. Dui paesi del Genovese, doppie 2 sc. 6 164. Due copie del Montani, una del Carro del Sole di Guido, e l’altro della Notte di Giovanni da S. Giovanni, doppie dieci sc. 30 124 Carla Benocci 165. Una copia di S. Teresa di Guido che sta a Caprarola dell’istesso, doppie 2 sc. 6 166. Una tela di quattro palmi con Medoro che scrive il suo nome ad un albero et un cane alli piedi, della maniera di Francesco Giovane, doppie 4 sc. 12 167. Doi paesi del cavalier de Maio, con certe figurine sue del medesimo, con cornici nere et argento che pare oro, doppie 3 sc. 9 168. Altro rame con paesino di Monsù Mumper scudi 2 sc. 2 L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini Fig. 1. BARTOLOMEO MANFREDI, Cristo battuto e coronato di spine (già in collezione Rengers van Pallandt) Fig. 2. ANDREA SACCHI, Abele ucciso da Caino contemplato da Adamo (Institute of Arts, Minneapolis) 125 Fig. 3. GIOVANNI MARIA MORANDI, Lo sposalizio della Vergine, disegno preparatorio per la pittura della chiesa di S. Maria dell’Anima a Roma (Kupferstichkabinett, KK 321-1988, Staatliche Museen, Berlino) Fig. 4. GIOVANNI MARIA MORANDI, Lo sposalizio della Vergine (sagrestia della chiesa di S. Maria dell’Anima, Roma) 126 Carla Benocci L’inventario dei quadri di Federico Sforza e Livia Cesarini Fig. 5. GIOVANNI MARIA MORANDI, La visione di S. Filippo Neri (Duomo di Siena) Fig. 6. NICOLÒ TORNIOLI, Cleopatra con i serpi al seno (Milano, collezione privata) 127 128 Carla Benocci Fig. 7. FRANCESCO TREVISANI, Latona che trasforma i pastori in rane (già in collezione Briganti, Roma) Fig. 8. FRANCESCO TREVISANI, Olindo e Sofronia (rame, asta di Sotheby’s, New York, 20 maggio 1993, n. 111) LA DOCUMENTAZIONE A REGISTRO DEI MONASTERI E CONVENTI TREVIGIANI FRA TRE E QUATTROCENTO ∗ SOMMARIO: 1. All’origine della documentazione a registro: gli archivi dei monasteri e conventi trevigiani nel Trecento; 2. Pratiche archivistiche: smembramenti e dispersioni; 3. Storia delle istituzioni e prassi documentaria; 4. Autonomia comunale e gestione dei patrimoni documentari: i registri notarili di S. Maria di Mogliano; 5. Il sostegno della congregazione: la contabilità delle camaldolesi di S. Cristina e S. Parisio di Treviso; 6. Vivacità spirituale e consapevolezza documentaria: la certosa di S. Maria e S. Girolamo del Montello; 7. Strategie documentarie degli ordini mendicanti: S. Nicolò e S. Francesco di Treviso; 8. La Terraferma trevigiana e i suoi monasteri nel XV secolo: l’esplosione documentaria differita; 9. Politiche patrimoniali e specializzazione delle scritture d’archivio. 1. All’origine della documentazione a registro: gli archivi dei monasteri e conventi trevigiani nel Trecento. — I più recenti contributi di storia della documentazione hanno posto l’accento sulla ricca fioritura documentaria dei secoli XIII e XIV, contrassegnati dall’emersione e dalla progressiva consolidazione, accanto e in aggiunta alle scritture singole, su pergamena, di una vasta gamma di scritture su quaderno e registro, e dalla contestuale diversificazione del panorama delle tipologie documentarie, ciascuna delle quali elaborata per formalizzare precisi ambiti di intervento amministrativo, giuridico od economico 1. Si è allora parlato di un ampio distendersi di nuove prassi ∗ Si pubblica in questa sede il testo, annotato ed ampliato, di un intervento tenuto a San Miniato in occasione del XIII seminario di studio « Fonti per la storia della civiltà italiana tardomedievale: i fondi monastici », organizzato dalla Fondazione Centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo (San Miniato, 6-11 settembre 1999). Desidero ringraziare il prof. Gherardo Ortalli, la dott. Alessandra Schiavon, direttrice dell’Archivio di Stato di Treviso e le dott.sse Manuela Barausse, Paola Benussi e Gilda P. Mantovani per le utili indicazioni e per il tempo dedicato alla lettura del testo; ringrazio pure il prof. Leopoldo Puncuch, membro del comitato di redazione della « Rassegna degli Archivi di Stato », per le indicazioni suggeritemi al momento di licenziare il testo per la rivista. Sono particolarmente grato, infine, alla dott. Francesca Cavazzana Romanelli, già direttrice dell’Archivio di Stato di Treviso, per i commenti e il proficuo confronto che hanno sostenuto l’elaborazione della presente ricerca. 1 Mi riferisco, in particolare, a P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma 1991; A. BARTOLI LANGELI, La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV. Forme, organizzazione, personale, in Culture et idéologie dans la genèse de l’état Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 Ermanno Orlando 130 di produzione e conservazione di scritture politiche e amministrative, sia in ambito civile che ecclesiastico; di « esplosione documentaria » 2 con esiti irrefragabili sia nelle dimensioni quantitative della documentazione prodotta, sia nella elaborazione di nuovi strumenti di registrazione; di affermazione della « documentazione amministrativa in registro » 3, diretta manifestazione di processi incipienti di crescita economica, demografica, di definizione delle strutture organizzative e di governo; di « passaggio dalla semplicità alla complessità, dalla uniformità alla varietà » 4 con l’affermazione di un sistema di registri originali e continuativi per accogliere, con regolarità e serialità, scritture contabili, finanziarie, processuali, atti e delibere di magistrature cittadine come pure di capitoli monastici o conventuali e così via. Insomma, « una considerazione orientata sull’insieme delle scritture, sulla opaca ordinarietà della vita economica, amministrativa e istituzionale » 5 evidenzia, a partire dalla metà del Duecento, un panorama diffuso di crescita e differenziazione dei processi di scrittura, di disponibilità ad elaborare nuove forme di registrazione, come pure di esplicitarle o semplificarle in un quadro di intensa sperimentazione e di sistemazione delle prassi consolidate dall’uso. Ebbene, muovendo da un siffatto angolo di osservazione, da un quadro generale che vede emergere e consolidarsi esperienze vieppiù mature di produzione e diversificazione delle scritture su registro, è parso interessante verificare l’aderenza o meno a tali orizzonti di una realtà locale quale quella trevigiana, fissare i termini e i tempi di radicamento dei nuovi modelli documentari nei monasteri e nei conventi della Marca trevigiana del XIV secolo. Si è trattato allora — per una esperienza che, come vedremo, solo gradualmente e con fatica sembra aderire a tali modelli — di cogliere il senso e i tratti costitutivi più peculiari della civiltà monastica e conventuale trevigiana in fatto di produzione documentaria, di valutare la sua capacità di esprimersi, stare nella società e manifestarsi attraverso la scrittura; per giungere, infine, a proporre scansioni cronologiche più rispondenti alle dinamiche locali di assimilazione di tali forme più complesse e maggiormente diversificate di moderne. Actes de la table ronde organisée par la Centre national de la recherche scientifique et l’École française de Rome, Roma 15-17 ottobre 1984, Roma 1985, pp. 35-55; ID., Le fonti per la storia di un comune, in Società e istituzioni dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV). Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, I, pp. 521; A. BARTOLI LANGELI - E. IRACE, Gli archivi, in Le città e la parola scritta, a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano 1997, pp. 401-428; per la documentazione prodotta da strutture monastiche e conventuali della Marca trevigiana si vedano D. RANDO, Archivi di monasteri e conventi. L’età medioevale, Treviso 1994 (Itinerari tra le fonti. Quaderni, 6); F. CAVAZZANA ROMANELLI, Archivi di monasteri e conventi. L’età moderna, Treviso 1994 (Itinerari tra le fonti. Quaderni, 7). 2 D. RANDO, Archivi di monasteri e conventi. L’età medioevale… cit., p. 8. 3 A. BARTOLI LANGELI, La documentazione degli stati italiani… cit., p. 47. 4 ID., Le fonti per la storia di un comune… cit., p. 8. 5 P. CAMMAROSANO, Italia medievale… cit., p. 239. Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 131 documentazione. Uscendo da linee di interpretazione consolidate e da confinazioni cronologiche troppo strette, si è voluto, in sostanza, leggere comparativamente l’esperienza documentaria monastica trevigiana, una esperienza che è sembrata dispiegarsi, per tutto il XIV secolo, all’insegna della discontinuità se non addirittura della rarità delle scritture su quaderno e registro. Iniziamo a proporre qualche dato, anticipando almeno, in questa sede, il censimento della situazione documentaria trecentesca che verrà ripresa più oltre. Il fondo Corporazioni religiose soppresse. Monasteri e conventi, conservato nell’Archivio di Stato di Treviso 6 — a fronte di un complesso di 45 fondi minori relativi ad enti conventuali e monastici ubicati nei territori delle antiche diocesi di Treviso e Ceneda, per un totale complessivo di 11.923 unità archivistiche tra fascicoli, filze, volumi e registri 7 — comprende, relativamen6 Il fondo è stato oggetto di una recente operazione di censimento nell’ambito del progetto « Anagrafe informatizzata degli Archivi di Stato italiani », avviato a partire dal 1997. Si è trattato di una operazione guidata sino al febbraio del 1998 da Francesca Cavazzana Romanelli, quindi da Alessandra Schiavon con la collaborazione della stessa Francesca Cavazzana Romanelli, che ha permesso a chi scrive di sottoporre l’intero complesso archivistico ad una lettura globale e contestuale, di navigare tra le diverse tipologie documentarie e riconoscerle nel loro costituirsi, moltiplicarsi, razionalizzarsi o decadere, come anche confrontarle e metterle in fila, declinandone caratteristiche comuni e momenti di sostanziale differenziazione. Una lettura tridimensionale peraltro facilitata dal fatto che si erano già elaborati — in precedenti progetti di inventariazione degli archivi dei monasteri e dei conventi della Marca avviati da alcuni anni presso l’Archivio di Stato di Treviso — ipotesi di scansione e di individuazione di tipologie documentarie, griglie di riferimento su cui si sono potute innestare le nuove acquisizioni emerse dal suddetto censimento. Cfr., presso l’Archivio di Stato di Treviso, Corporazioni Religiose Soppresse. Monasteri e conventi della Marca trevigiana. Guida ai fondi, a cura di E. ORLANDO, direzione scientifica di F. CAVAZZANA ROMANELLI e A. SCHIAVON, 1999. 7 Quanto alla documentazione pergamenacea dei monasteri e conventi trevigiani, essa risulta per la gran parte conservata nel fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Treviso, costituito da 7.679 pergamene (6 del sec. XI, 21 del sec. XII, 530 del sec. XII e 7.122 relative ai secc. XIV-XVIII) estratte dagli archivi delle corporazioni religiose agli inizi del XIX secolo. Con i decreti di soppressione emanati tra il 1806 e il 1810 dal napoleonico Regno d’Italia, infatti, i fondi delle corporazioni religiose, o manomorte, furono indemaniati e concentrati negli edifici dell’ex convento degli eremitani di S. Margherita, ove ebbero a subire un processo di intenzionale smembramento riguardante appunto il settore più antico e pregiato dei fondi, quello pergamenaceo, destinato ad essere trasferito a Milano, nel costituendo diplomatico dell’Archivio generale di S. Fedele. « Alla violenta operazione di cernita delle antiche pergamene, dettata più dal gusto dominante del collezionismo che dal rispetto della natura e della fisionomia dei fondi, risulta essere stato addetto, almeno fino al 1812, il conte Agostino Carli Rubbi, incaricato di analoga operazione anche negli archivi demaniali di Venezia e Padova, e sostituito dopo tale data dal canonico Battista Rossi. (…) Separate dunque dai rispettivi archivi monastici, solo in parte trasferite a Venezia sulla via per Milano, ove non sarebbero mai giunte per il crollo dell’impero napoleonico nell’ottobre 1813, le pergamene trevigiane oramai costituite in Diplomatico furono nel 1882 ufficialmente consegnate, assieme ai fondi delle corporazioni religiose del territorio trevigiano, al Municipio di Treviso » (F. CAVAZZANA ROMANELLI, Archivi di monasteri e conventi… cit., pp. 9-10). L’intero fondo delle Corporazioni religiose soppresse fu quindi consegnato all’Archivio di Stato di Treviso nel 1970, all’indomani dell’apertura dell’istituto di conservazione trevigiano. Nell’occasione, le stesse pergamene che in precedenza avevano preso la via per Venezia, successivamente confluite nell’Archivio dei Frari, sono anch’esse tornate a Treviso, ad affiancare, negli attuali ordinamenti, gli originari fondi monastici di provenienza. Ermanno Orlando 132 te al periodo che qui interessa, solamente un piccolo nucleo di scritture su registro. Si tratta, nella fattispecie, di cinque registri di imbreviature notarili provenienti dall’archivio delle benedettine di S. Maria di Mogliano e S. Teonisto di Treviso (1313-1401) 8; di alcuni registri di cassa, un registro del granaio e due degli affittuari appartenenti alle camaldolesi di S. Cristina e S. Parisio di Treviso (con alcuni frammenti di registri di difficile attribuzione a più organiche unità archivistiche, tutti della seconda metà del XIV secolo) 9; di due catastici (1351-1437), un registro del procuratore e uno della sacrestia (con annotazioni rispettivamente a partire dal 1361 e dal 1336) per il convento domenicano di S. Nicolò di Treviso 10; di un registro di natura contabile che riporta dati dal 1363, contenuto — ma l’attribuzione rimane dubbia — tra le carte dei minori di S. Francesco di Treviso 11; infine, di un catastico delle 8 Nella serie Locazioni si conservano cinque registri trecenteschi, che raccolgono atti non solo relativi a contratti di locazione, ma anche a « compromessi, accordi, sententie, stime, pagamenti, procure, renovationi di quelle et altre diverse scritture e contratti »; ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO (d’ora in poi ASTV), Corporazioni Religiose Soppresse. Monasteri e conventi. S. Maria di Mogliano e S. Teonisto di Treviso (d’ora in poi CRS.MC, S. Teonisto), Locazioni, b. 29, reg. « Affitacioni, instrumenti et altre cose », fasc. inserto « Repertorio »). L’archivio è oggi analiticamente descritto in L’archivio di Santa Maria di Mogliano e San Teonisto di Treviso, 1. Introduzione all’inventario. 2. Inventario, a cura di F. CAVAZZANA ROMANELLI e E. ORLANDO, Venezia 2001 (Itinerari tra le fonti. Inventari e cataloghi), frutto della collaborazione instauratasi, giusto in occasione delle celebrazioni del millennio di fondazione dell’abbazia moglianese, fra l’Archivio di Stato di Treviso e il Comitato per il Millennio di Fondazione dell’Abbazia di Mogliano. Cfr. pure, a cura degli stessi autori, L’archivio di Santa Maria di Mogliano e di San Teonisto di Treviso, in Mogliano e il suo monastero: 1000 anni di storia. Atti del Convegno, Abbazia di Santa Maria di Mogliano Veneto (Treviso), 6-7 giugno 1997, a cura di F.G.B. TROLESE, Cesena 2000, pp. 173-193 (Pubblicazioni Centro Storico Benedettino Italiano. Italia Benedettina, 19). 9 ASTV, Corporazioni Religiose Soppresse. Monasteri e conventi, S. Cristina e S. Parisio di Treviso (d’ora in poi CRS.MC, S. Cristina e S. Parisio), Registri d’amministrazione, b. 27; cfr. la guida ai fondi Corporazioni Religiose Soppresse… cit., S. Cristina e S. Parisio di Treviso, camaldolesi, serie Registri d’amministrazione. Il registro di cassa del 1395 è invece conservato, sempre presso l’ASTV, nella busta n. 1 dei Fondi vari di Treviso. Città. 10 ASTV, Corporazioni Religiose Soppresse. Monasteri e conventi, S. Nicolò di Treviso (d’ora in poi CRS.MC, S. Nicolò), Catastici dei beni, b. 47; Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Venezia (1970), b. 2; Giornali del procuratore, b. 32; ASTV, Comune di Treviso, sec. XIV1797 (d’ora in poi Comunale), b. 792. Cfr. S. Nicolò di Treviso. Inventario del fondo cartaceo a cura di M. BARAUSSE - G.P. BUSTREO - A. POZZAN, direzione scientifica di F. CAVAZZANA ROMANELLI, 1995, presso l’Archivio di Stato di Treviso; G.P. BUSTREO, L’archivio di San Nicolò: note in margine, in I frati predicatori del Duecento, Verona 1996, pp. 137-139, 142 (Biblioteca dei quaderni di storia religiosa); ID., Le terre e le case dei frati. Ricerca sui patrimoni dei conventi mendicanti trevigiani fra medioevo e prima età moderna, Tesi di dottorato di ricerca in Storia sociale europea discussa presso l’Università degli Studi di Venezia, ciclo IX 1993/1996, pp. 7-8, 10 (si ringrazia l’autore per aver consentito la lettura dell’elaborato). 11 ASTV, Corporazioni Religiose Soppresse. Monasteri e conventi, S. Francesco di Treviso (d’ora in poi CRS.MC, S. Francesco), Registri di entrata e uscita, b. 29. Cfr. S. Francesco di Treviso. Inventario del fondo cartaceo, a cura di P. MINIUTTI - E. ORLANDO - A. POZZAN, direzione scientifica A. SCHIAVON (in corso di completamento presso l’Archivio di Stato di Treviso). Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 133 scritture del 1390 (pervenuto in copia del XVI secolo) e tre inventari dei beni della seconda metà del secolo conservati nel fondo della certosa di S. Maria e S. Girolamo del Montello 12. Nel complesso, dunque, nemmeno 20 registri per il periodo che va dal secondo decennio del Trecento sino alla fine del secolo: una povertà che sollecita approfondimenti di analisi, una difficoltà che attende di essere valutata e inquadrata nel contesto della produzione di scrittura del tardo medioevo trevigiano e delle successive vicende di dispersione e frammentazione delle carte d’archivio prodotte dai monasteri e dai conventi della Marca. 2. Pratiche archivistiche: smembramenti e dispersioni. — Le motivazioni e le circostanze di un simile paesaggio discontinuo e rarefatto possono essere molteplici. Innanzitutto bisognerà mettere in conto i traumi, le dispersioni, le diminuzioni delle carte d’archivio « talora casuali », più spesso « intenzionali, frutto di vere e proprie strategie di gestione dei patrimoni documentari » 13 elaborati dalle stesse comunità religiose; politiche di conservazione dei fondi archivistici in gran parte fondate su criteri di gestione utilitaristici, funzionali ora alla sopravvivenza, ora alla difesa, talvolta al consolidamento del patrimonio comunitario, spesso pensati e messi in atto in momenti di debolezza istituzionale, di marginalità politica o di precaria incidenza economica e pertanto non in grado di innescare processi di legittimazione e confronto con la quotidianità e l’ordinarietà delle proprie scritture amministrative e contabili. A tale proposito, già Attilio Bartoli Langeli, in un noto contributo sulle fonti per la storia del comune medioevale 14, aveva segnalato — nel confronto con gli archivi (in quel caso gli archivi pubblici dell’Italia comunale), con le loro strutture, con la storia della loro sedimentazione, con le complicazioni e le fratture della « traditio » documentaria —, numerosi casi di assenza completa di registri in serie fino a tutto il Trecento e oltre in contesti dove tali registri era lecito aspettarsi di trovare. Si trattava di scarti sostanziali tra il momento della produzione e quello della conservazione, che l’autore aveva per l’appunto imputato alla natura delle pratiche archivistiche del tempo, strumen12 ASTV, Corporazioni Religiose Soppresse. Monasteri e conventi, S. Maria e S. Girolamo del Montello (d’ora in poi CRS.MC, S. Maria e S. Girolamo), Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Venezia (1970), Catastici delle scritture, b. 1[ter]; Inventari dei beni, b. 66; Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Venezia (1970), Inventari dei beni, b. 1[ter]. Cfr. la guida ai fondi Corporazioni Religiose Soppresse… cit., S. Maria e S. Girolamo del Montello, certosini, Inventari dei beni; Atti trasferiti dall’Archivio di Stato di Venezia (1970), Catastici delle scritture e Inventari dei beni. 13 F. CAVAZZANA ROMANELLI, Fondi monastici negli archivi veneti. I viaggi delle carte, in Il monachesimo nel Veneto medioevale. Atti del Convegno di studi in occasione del Millenario di fondazione dell’Abbazia di S. Maria di Mogliano Veneto (Treviso), a cura di F.G.B. TROLESE, Cesena 1998, p. 203 (Italia benedettina, XVII). 14 A. BARTOLI LANGELI, Le fonti per la storia di un comune… cit., pp. 10-12. Ermanno Orlando 134 tali ad operazioni di salvaguardia della documentazione avente diretta funzionalità giuridica, patrimoniale o politica quanto non interessate ad organizzare convenientemente le scritture contabili e di amministrazione, vale a dire il complesso delle carte prodotte dalle singole magistrature o dagli uffici giudiziari del Comune. Che tale disinteresse, tale sostanziale dicotomia fra disponibilità a ricapitolare e valorizzare i « monumenta » — i titoli di proprietà e giurisdizionali conservati in pergamene sciolte — e impaccio nel regolare il complesso della documentazione « ordinaria » sia espressione dei tempi, di pratiche di fissazione e salvaguardia dei patrimoni documentari ancora troppo sbilanciate verso la regolazione dei soli « munimina » o documenti « pesanti » 15, sembra dimostrato dall’unica operazione di sistemazione delle carte prodotte o acquisite da un cenobio nel panorama degli istituti monastici e conventuali trevigiani del Trecento, ossia l’inventario delle scritture « vetera et nova » della certosa del Montello risalente al 1390 16. Approntato da un istituto florido, vivace, spiritualmente in salute — come si illustrerà più ampiamente nelle prossime pagine — tale elenco ricognitivo della documentazione della comunità monastica 17 risulta infatti del tutto privo di qualsivoglia accenno alle scritture ordinarie in registro che sappiamo invece prodotte e conservate dall’ente nella seconda metà del secolo. Incertezze da ricondursi dunque alla prassi archivistica del periodo, piuttosto che all’incompiutezza delle strategie di conservazione elaborate dall’istituto. Se è dunque ragionevole accostarsi al problema facendo riferimento, in via preliminare, alle strategie interne di gestione e conservazione del materiale documentario, una lettura complessiva dei vuoti della documentazione monastica e conventuale trevigiana, delle sue lacerazioni e dispersioni deve tuttavia considerare altri, e certamente più traumatici, fattori di discontinuità, altri alteratori delle originarie consistenze archivistiche. Mi riferisco in particolare agli smembramenti causati dalla fluidità istituzionale di parecchi degli istituti qui considerati — cambiamenti di sede, variazioni di intitolazione, riduzioni in commenda, associazioni a congregazioni —, ma soprattutto agli sconvolgimenti e ai traumi arrecati ai complessi archivistici dalle soppressioni e indemaniazioni promosse dalla Repubblica veneta nella seconda metà del Settecento e dal napoleonico Regno d’Italia negli anni dal 1806 al 1810, percorsi esaustivamente ricostruiti dagli studi di Francesca Cavazzana Roma15 Così definisce Paolo Cammarosano i documenti « relativi a trasferimenti di proprietà e possesso, trattati con particolare cura dai loro custodi »; cfr. P. CAMMAROSANO, Italia medievale… cit., p. 65. 16 ASTV, CRS.MC, S. Maria e S. Girolamo, Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Venezia (1970), Catastici delle scritture, b. 1[ter]. 17 Si tratta di un censimento della documentazione attestante gli « iura » del monastero, ripartiti per località di ubicazione dei beni cui i documenti si riferiscono — « iura possessiones de Glaura », « iura possessiones Cusignane » e così via — o per tipologia di atti, soprattutto testamenti. Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 135 nelli 18 e ai quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti. In questa sede sarà sufficiente procedere a qualche spicciola esemplificazione, per comprendere le modalità e l’entità di questi depauperamenti e frammentazioni provocati « dal di fuori o addirittura contro la volontà » 19 delle comunità monastiche, soffermandoci particolarmente sui pochi fondi che ancora conservano documentazione trecentesca a registro. Più di altri, quanto a smembramenti, dispersioni e ricomposizioni delle carte d’amministrazione, sembra emblematico proprio il caso dei registri trecenteschi del fondo di S. Maria e S. Teonisto. Originariamente composto da almeno sei unità archivistiche, come si evince dallo spoglio degli indici antichi delle carte dell’archivio monastico, il fondo trecentesco, in seguito a vicende complesse di trasmigrazione e movimentazione dei registri (delle quali si dà conto più distesamente in nota), risulta ora ridotto a cinque unità; va rilevata infatti, per il complesso moglianese, la perdita del registro « 1328, XI zugno. Libro de intromissioni de fogli n. 24 in bergamina », distolto dall’archivio successivamente alla soppressione del cenobio nell’aprile del 1810 e non più recuperato 20. 18 F. CAVAZZANA ROMANELLI, Archivi di monasteri e conventi. L’età moderna… cit.; ID., Fondi monastici negli archivi veneti… cit., pp. 201-215. 19 20 Ibid., p. 203. Riusciamo a seguire le vicende del fondo trecentesco partendo dai dati d’insieme forniti da un inventario antico del cenobio, il « Repertorio de protocolli de nodari diversi » (ASTV, CRS.MC, S. Teonisto, Catastici delle scritture, Catastico Scoverti, b. 1, fasc. « Repertorio de protocolli de nodari diversi »), stilato dal « sindaco » Francesco Scoverti alla fine del XVI secolo: una lista di consistenza in successione cronologica dei protocolli notarili, comprensiva di intitolazione sintetica ma chiaramente espressiva del contenuto, della cartulazione e del tipo di legatura, che conta in tutto sei registri relativamente agli anni 1313-1401. Di questi, i registri « 1313 », « 1359 » e « 1360 », sappiamo essere stati sottratti dal fondo archivistico a ridosso delle indemaniazioni napoleoniche, ed essere migrati, per il loro valore eminentemente patrimoniale o piuttosto per motivi di pregio e di rarità, presso i depositi del Demanio di Venezia. Confluiti successivamente tra le carte delle manomorte dell’Archivio di Stato di Venezia, solo nel 1970, in occasione dell’apertura dell’Archivio trevigiano, sono ritornati a Treviso a saldare la sequenza di una serie certamente eccezionale nel panorama locale della documentazione monastica medievale. Ancora, il registro « 1392 et 1397 fino 1401 » risulta tuttora separato dal fondo e conservato nella Biblioteca Civica di Treviso: scorporato nel 1882 dai fondi delle Corporazioni religiose soppresse allora depositati presso la biblioteca e posto, per ragioni di tutela e di facilità di consultazione, « nella camera riservata presso le pergamene » (BIBLIOTECA CIVICA DI TREVISO, Catalogo dei codici di maggior rilievo dell’archivio delle soppresse corporazioni religiose estratti dalle posizioni relative e posti nella camera riservata presso le pergamene, a cura di L. BAILO, ms., 1882), è sfuggito ai percorsi che hanno condotto, nel 1970, alla consegna del materiale delle manomorte al neonato Archivio di Stato trevigiano, rimanendo, con pochi altri brandelli in quell’istituto, a formare un parallelo ma alquanto ridotto fondo « ombra » delle corporazioni soppresse. In questo quadro di sussulti e assestamenti così mosso e magmatico, non sorprende dover registrare l’assenza importante di cui si è detto: la perdita del registro « 1328, XI zugno. Libro de intromissioni de fogli n. 24 in bergamina », distolto dall’archivio probabilmente in occasione di una delle evenienze qui sopra ricordate e non più recuperato. Il caso è rilevato e approfondito in F. CAVAZZANA ROMANELLI - E. ORLANDO, L’archivio di Santa Maria di Mogliano… citato. 136 Ermanno Orlando Certamente meno significativo quanto a possibilità offerte di leggere e fissare il « deperditum », ma interessante dal punto di vista delle complicazioni della sedimentazione, il caso dell’archivio di S. Cristina e S. Parisio di Treviso. A parte un unico registro, il libro di cassa del 1395 avulso dal fondo sempre probabilmente all’indomani della soppressione napoleonica (dell’aprile del 1810) e ora conservato tra le carte dei Fondi vari di Treviso. Città, i rimanenti registri e frammenti di registri trecenteschi che si conservano delle monache camaldolesi sono oggi contenuti nella eterogenea serie dei Registri d’amministrazione dell’archivio monastico. Tale serie accorpa in 7 buste segnate A-G, secondo un criterio meramente estrinseco di raccolta di fascicoli e registri di ridotta consistenza, la variegata produzione di scritture relative al governo economico e alla gestione contabile del cenobio — « dar et aver », « catastici dei beni », « entrata ed uscita de possessioni », « scodaroli », ecc. —: un insieme collettaneo, dunque, e talvolta difficilmente districabile, in cui sono tuttora costrette le stesse scritture contabili e inventariali prodotte dal monastero nel XIV secolo 21. 21 Tale configurazione è il risultato di un complesso sforzo ordinatore operato dal « cancelliere » del cenobio Fortunato Mandelli nella seconda metà del XVIII secolo: in tale occasione il complesso documentario, preventivamente sezionato e riscontrato per « titoli » (gli atti certificanti e fondanti il possesso e i diritti della comunità), per « serie » o materie e per « famiglie » afferenti al governo economico del monastero, veniva accuratamente descritto secondo la collocazione fisica delle carte nelle « caselle » e nei « mazzi » dell’archivio, ciascuno individuanti una precisa categoria di titoli — « Visite », « Decreti dei superiori », « Atti capitolari », « Licenze », « Beni di Volpago » etc. — sino alla composita categoria dei « Libri di entrata e uscita ». Al censimento faceva seguito una altrettanto sistematica operazione di condizionamento delle scritture, con la raccolta in buste dei fascicoli e dei registri di ridotta consistenza relativi alla succitata tipologia dei libri contabili. Su tale piattaforma, così saldamente strutturata, si inseriva infine il tentativo di Luigi Bailo — direttore della Biblioteca civica dove i fondi delle manomorte, come detto, si trovavano e compilatore nel 1882 dell’Inventario libri e carte dell’archivio delle soppresse corporazioni religiose in Treviso (cfr. F. CAVAZZANA ROMANELLI, Archivi di monasteri e conventi. L’età moderna… cit., p. 11) — di recuperare almeno in parte il mosaico delle tipologie documentarie generate dai diversi uffici che avevano scandito e regolato la vita interna del cenobio, e così anche i meccanismi di produzione e conservazione delle carte, di riconsiderare l’edificio settecentesco dove molti dei contesti documentari si trovavano ormai quasi fossilizzati e privi di profondità: tentativo condotto, con forte senso pragmatico, riconducendo tutto il materiale riconfezionato nel Settecento in tre grosse partizioni, la serie « Estimi, perticazioni, proclami, atti, contenziosi, locazioni, testamenti », la serie « Raccolta di lettere, processi, suppliche, decreti » e, per l’appunto, la serie dei « Registri d’amministrazione », e ricostruendo per il materiale sfuggito — per ragioni di voluminosità — all’operazione di confezionamento settecentesca, il rampollare delle serie quale plausibile rilettura dell’ampio spettro di attività e di funzioni proprie della comunità camaldolese (cfr. l’introduzione di chi scrive al fondo S. Cristina e S. Parisio di Treviso, camaldolesi, in Corporazioni Religiose Soppresse… cit.). Il Mandelli comprendeva nella categoria dei « Libri d’entrata ed uscita » cinque registri relativi al secolo XIV, contrassegnati con numerazione romana progressiva da I a V: « I. 1358–1363. Dar ed aver; II. 1362-1366. Dar ed aver; III. 1378–1388. Dar ed aver; IV. 1378. Catastico de beni; V. 1395. Catastico de beni ». Descriveva quindi ulteriormente i cinque registri nell’« Indice cronologico », un tentativo di rileggere diacronicamente il complesso delle scritture prodotte o acquisite nei secoli dal monaste- Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 137 Qualche altra indicazione, ancora sbilanciata piuttosto verso le trasmigrazioni che non le dispersioni delle carte, può essere raccolta scorrendo l’inventario del convento domenicano di S. Nicolò di Treviso. Balza agli occhi la collocazione del quaderno della sacrestia relativo agli anni 13361352 22: il registro, avulso dal fondo, si trova a tutt’oggi contenuto in una busta dell’archivio storico del Comune di Treviso 23. L’origine di tale errata dislocazione va probabilmente ricercata in quella che è stata realisticamente descritta come « la lacerazione più violenta e cieca fra tutte quelle che in passato avevano attentato all’integrità dei fondi » 24, ossia il bombardamento che nell’aprile del 1944 distruggeva l’ala del Museo civico ove gli archivi delle manomorte erano conservati assieme ai fondi del Comune e dell’Ospedale dei Battuti. Nelle successive campagne di recupero del materiale disperso e di attribuzione delle carte ai rispettivi fondi di provenienza, non è improbabile si siano allora verificati delle cadute di lucidità e consapevolezza archivistica — dovuti ai tempi, all’emergenza, alla fretta —, con la conseguente riduzione di alcuni pezzi, e tra questi il quaderno domenicano, in complessi documentari non pertinenti. Solo dei campioni. Nessuno dei quali avvicinabile, quanto a traumaticità di conseguenze per l’integrità dei fondi, alle vicende di dispersione e diminuzione in cui incorsero taluni archivi in occasione delle soppressioni, in particolar modo di quelle venete (1767-1773) 25. Basti un esempio, tratto da uno studio recente di Francesca Cavazzana Romanelli e riferibile all’archivio di S. Caterina dei Servi di Maria di Treviso 26. Un « Inventario de libri economici » del convento stilato nel 1773, giusto in occasione della sua soppressione, ro camaldolese: « 1358, 18 novembre. Entrate ed uscite del monastero. Libro I; 1362, 28 ottobre. Entrata ed uscita del monastero. Libro II; 1378. Entrata del monastero. Libro III; 1378. Beni del monastero. Libro IV; 1395. Entrata ed uscita per la fabrica della chiesa e monastero. Beni del monastero. Libro V » (cfr. ASTV, CRS.MC, S. Cristina e S. Parisio, Catastici delle scritture, b. 2, reg. « Indice cronologico »). Per quanto riguarda infine la figura del catasticatore, Fortunato Mandelli fu un esponente illustre dell’erudizione ecclesiastica settecentesca, continuatore, dal 1756 al 1787, della celebre « Raccolta di opuscoli scientifici e filologici » fondata nel 1728 dal camaldolese Angelo Calogerà, del monastero di S. Michele di Murano, una « summa della erudizione ecclesiastica e laica del secolo » sorta con l’obiettivo di riunire « piccole dissertazioni degli eruditi viventi o del passato, su argomenti diversi, dalla teologia alla morale, alla storia, all’erudizione, alle scienze fisiche e matematiche, alla filologia, all’archeologia, alla storia dell’arte, non esclusa la poesia »; cfr. A. NIERO, L’erudizione storico-ecclesiatica, in Storia della cultura veneta, 5/II: Il Settecento, Vicenza 1986, p. 121. 22 ASTV, Comunale, b. 792; cfr. S. Nicolò di Treviso… citato. 23 G.P. BUSTREO, L’archivio di San Nicolò… cit., pp. 145, 156, n. 38; ID., Le terre e le case dei frati… cit., p. 11. 24 F. CAVAZZANA ROMANELLI, Archivi di monasteri e conventi. L’età moderna… cit., 25 Ibid., pp. 8-9; ID., Fondi monastici negli archivi veneti… cit., pp. 204-209. p. 11. 26 ID., Santa Caterina dei Servi. I documenti d’archivio, in Il ritorno di Orsola. Affreschi restaurati nella chiesa di Santa Caterina in Treviso, Treviso 1992, pp. 5-9. Ermanno Orlando 138 segnala un patrimonio documentario ricco di 250 fascicoli processuali, organiche serie di libri contabili, filze di ricevute, un catastico delle scritture, un cabreo, un libro di fabbriche e un registro di istrumenti. Ebbene, di tale complesso di scritture, terminate le pratiche di soppressione, l’alienazione dei beni indemaniati e la cessione, con i beni, delle carte relative alle proprietà, rimangono oggi solamente 91 fascicoli processuali contenuti in 4 buste. Un caso davvero notevole di impoverimento archivistico. Questa carrellata sulle complesse vicende della sedimentazione archivistica, seppur veloce e limitata ad alcuni casi maggiormente significativi, è sembrata opportuna per cogliere la fisionomia, il volto del paesaggio documentario monastico e conventuale trevigiano. Un paesaggio spesso frammentato, discontinuo, dove i passaggi di titolarità degli archivi e in particolar modo le soppressioni delle case religiose hanno comportato perdite e smembramenti talora importanti. In un panorama siffatto sarebbe quanto mai rischioso sottovalutare la cifra di quanto è stato prodotto e per varie ragioni non si è conservato: pur non disponendo sempre di strumentazione idonea per computare le mancanze, soprattutto relativamente al materiale più antico, non mancano, e lo si è visto, le testimonianze di dispersioni, lacerazioni, spostamenti, ricongiunzioni delle carte di cui, inizialmente, si è dovuto tener conto. 3. Storia delle istituzioni e prassi documentaria. — Purtuttavia, al di là dei sussulti della tradizione, al di là di strategie di conservazione dei patrimoni documentari deboli e poco avvertite verso le carte dell’amministrazione corrente, al di là degli sconquassi provocati dalle soppressioni, rimane l’impressione che la povertà e la carenza di scritture « ordinarie » proprie della civiltà monastica e conventuale trevigiana del XIV secolo, i ritardi a mettere radici e consolidare una consuetudine di scritture a registro, le esitazioni a superare forme più collaudate di documentazione notarile, possano essere in aggiunta additate ad aspetti che trascendono il dato archivistico, a fenomeni che chiamano in gioco altri ed altrettanto decisivi fattori di rarefazione e impoverimento. A tale proposito sembra opportuno ricapitolare alcune caratteristiche e alcuni tra gli orientamenti e i contenuti più peculiari della tradizione monastica veneta e quindi anche trevigiana 27, consapevoli del rapporto diretto 27 Tradizione lucidamente riassunta dai lavori sulle istituzioni ecclesiastiche trevigiane di Daniela Rando e, più recentemente, dal quadro d’insieme del monachesimo della Marca trevigiana e veronese in età comunale proposto da Sante Bortolami: cfr. D. RANDO, Archivi di monasteri e conventi. L’età medioevale… cit.; ID., Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV, I, Religionum diversitas, Verona 1996 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa); S. BORTOLAMI, Il monachesimo della Marca trevigiana e veronese in età comunale: un modello in cerca di omologhi, in Il monachesimo italiano nell’età comunale. Atti del IV Convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Abbazia di S. Giorgio maggiore, Pontida (Bergamo), 3-6 settembre 1995, a cura di F.G.B. TROLESE, Cesena 1998, pp. 367-401 (Italia Benedettina, XVI); ID., Monasteri e comuni nel Veneto dei secoli XII-XIII: un bilancio e nuove prospettive di ricerca, in Il monachesimo nel veneto medioevale… citato. Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 139 intercorrente tra gli assetti, le circostanze e i momenti della storia istituzionale e le pratiche correnti della prassi documentaria. Innanzitutto va detto che nel Veneto nessun monastero poté « vantare una storia e delle potenzialità equiparabili a veri astri della galassia cenobitica padani quali la Novalesa, Bobbio, Nonantola, S. Giulia di Brescia, Leno o Pomposa », con l’eccezione in parte di « pochi enti veronesi della stazza di S. Zeno o S. Giorgio in Braida, ricchi di corti, cappelle rurali e celle urbane » 28. In secondo luogo, va segnalata la tiepida accoglienza riservata ai movimenti di riforma del monachesimo benedettino, con esiti parzialmente favorevoli, proprio nel Trevigiano, per la congregazione cistercense, e timide e ritardate aperture alle esperienze camaldolese — la fondazione del monastero di S. Cristina e S. Parisio a Treviso risale al 1186 — e certosina, con l’impianto della Certosa del Montello giusto a metà del XIV secolo 29. Due snodi, questi della mancanza di centri monastici di rilevante peso specifico e dell’isolamento del monachesimo locale dalle correnti di riforma più vivaci e innovative del medioevo monastico padano, in grado — almeno così ci sembra — di incidere profondamente sulla capacità delle case religiose di confrontarsi con la realtà circostante e di aderire e dialogare con le strutture economiche della società basso medioevale, con immediate ripercussioni in termini di produzione di scrittura e di strategie di conservazione dei propri patrimoni documentari. Su tale prospettiva d’insieme vanno poi innestati i caratteri transitori, i ritardi, lo stato di declino e sofferenza del monachesimo trevigiano del Trecento, secolo comunemente e universalmente descritto come periodo di decadenza e di crisi, di emarginazione e di disagio, seppur in un contesto di sfumature ed evidenti chiaroscuri quale quello prospettato dagli ultimi lavori sulle istituzioni ecclesiastiche e sugli ordini religiosi veneti di Antonio Rigon 30 e di Sante Bortolami 31. Come nemmeno si può dimenticare, proprio per l’incidenza della prassi documentaria pubblica sui sistemi di scrittura monastici e conventuali, il ruolo di emarginazione politica cui Treviso sembra costretta in concomitanza con la lunga dominazione veneziana, con il conseguente e progressivo 28 ID., Il monachesimo della Marca trevigiana e veronese… cit., p. 373; stesse considerazioni in D. RANDO, Archivi di monasteri e conventi. L’età medioevale… cit., p. 4. 29 S. BORTOLAMI, Monasteri e comuni… cit., pp. 44, 47-48; ID., Il monachesimo della Marca trevigiana e veronese… cit., pp. 371-372. 30 A. RIGON, Vescovi e monachesimo, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV secolo alla metà del XVI secolo. Atti del VII convegno di storia della chiesa in Italia (Brescia, settembre 1987), a cura di G. DE SANDRE GASPARINI - A. RIGON - F.G.B. TROLESE - G.M. VARANINI, Roma 1990, pp. 149-181 (Italia sacra, 43); ID., Decadenza e tensioni di rinnovamento nei monasteri veneti sino al primo Quattrocento, in Il Veneto nel Medioevo. Le signorie trecentesche, a cura di A. CASTAGNETTI - G.M. VARANINI, Verona 1995, pp. 359-378. 31 S. BORTOLAMI, Monasteri e comuni… cit., pp. 39-74. 140 Ermanno Orlando esautoramento degli organi di governo cittadini e il fallimento dei suoi progetti di disciplinamento e organizzazione centralizzati 32. Crisi dunque degli ordini religiosi — crisi patrimoniale e religiosa al tempo stesso — che smorza le capacità dialettiche delle comunità di interagire con il mondo circostante, rende anchilosati i rapporti con i processi produttivi e condanna la proprietà ecclesiastica a politiche di sussistenza segnate dalla rigidità se non addirittura da atteggiamenti di resistenza ai mutamenti strutturali dell’economia 33. Una incapacità di essere e dialogare con le forze vive della società e dell’economia colta dalla stessa Dominante veneta che tra il 1376 e il 1377, a fronte delle « male gubernationes » degli amministratori ecclesiastici e dei poderi che « vadunt in desolationem », proibisce alle comunità religiose l’acquisto di nuovi terreni senza previa autorizzazione dei consigli veneziani e vieta ai testatori di alienare beni in loro favore per più di cinque anni 34. Tale mediocrità di presenza delle case religiose nel tessuto socioeconomico trevigiano non può non essersi ripercossa sulla capacità degli enti di produrre documentazione, tanto più se si tratta, come nel nostro caso, della documentazione ordinaria, delle carte di amministrazione, delle scritture di relazione con il mondo della terra, con le sue strutture produttive, con la città, il suo mercato e il suo orizzonte di relazioni economiche. Crisi anche e in aggiunta — si diceva — delle strutture pubbliche di governo, con conseguenze certificate sulle sorti della documentazione comunale tra basso medioevo e prima età moderna 35. Il Comune, in passato e in circostanze più favorevoli propulsore di una intensa circolarità di esperienze amministrative, è anch’esso in difficoltà; la marginalità politica cui è obbligato sotto la dominazione veneziana ne mette in discussione il ruolo di propagatore di modelli documentari, isterilisce quella capacità di stimolo che aveva in alcuni casi favorito — a 32 Per approfondimenti sulla crisi istituzionale della compagine politica trevigiana in età veneziana si veda soprattutto G.M. VARANINI, Istituzioni e società a Treviso tra Comune, Signoria e poteri regionali (1259-1339), in Storia di Treviso, II, L’età medioevale, a cura di D. RANDO - G.M. VARANINI, Venezia 1992, pp. 196-197, 211-213. 33 Un quadro più esaustivo circa il controllo esercitato dalla Signoria veneta sulla proprietà ecclesiastica in ID., Proprietà fondiaria e agricoltura, in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, V, Il Rinascimento. Società ed economia, a cura di A. TENENTI - V. TUCCI, Roma 1996, pp. 825-828, 864-865; approfondimenti puntuali sullo stato di salute e le prospettive della proprietà monastica pure in S. COLLODO, L’evoluzione delle strutture economiche nel Trecento: l’economia delle campagne, in Il Veneto nel Medioevo… cit., pp. 295-298. 34 G.M. VARANINI, Proprietà fondiaria e agricoltura… cit., pp. 824-827; provvedimenti editi in Gli statuti del comune di Treviso secondo il codice di Asolo (1316-1390), a cura di G. FARRONATO - G. NETTO, Asolo 1988, pp. 572, 618-619, 621, 622. 35 Le vicende della documentazione prodotta dagli organismi di governo trevigiani sono state recentemente ripercorse alla luce dei travagli della storia politica ed istituzionale del Comune dallo stesso Gian Maria Varanini nella sua Nota introduttiva, in Gli acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, a cura di A. MICHIELIN, Roma 1988, p. XIX (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 12). Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 141 Treviso come altrove — il passaggio, nella documentazione, « alla “forma” a registro, tipica della concezione documentaria comunale » 36. Un insieme di ragioni che sembrano dunque poter far parlare, per il monachesimo trevigiano trecentesco, di una ricezione incerta della scrittura su registro, che si verifica in stretta connessione con una contemporanea crisi dei modelli e delle forme di documentazione amministrativa, giudiziaria e contabile proposti dagli organismi di governo cittadini. Una testimonianza preziosa, seppur nella sua episodicità, della sterilità e atonia dei monasteri e dei conventi trevigiani in fatto di produzione di scritture ordinarie su registro, ci viene dal monastero cistercense di S. Maria di Follina, pesantemente in difficoltà sin dalla metà del secolo XIV e con l’aprirsi del Quattrocento affidato in commenda ad amministratori provenienti dalle più illustri casate veneziane 37. Tra le carte dei cistercensi si conservano infatti alcuni dettagliati inventari quattrocenteschi dello stato patrimoniale della comunità, voluti dai commendatari per monitorare il possesso e poter impostare la gestione e i criteri di amministrazione dei beni; orbene, tali censimenti contengono pure utili indicazioni sui titoli di proprietà del cenobio, sullo stato del materiale d’archivio e sulle carte d’amministrazione in genere, rivelandosi in tal modo una fonte qualificata per comprendere i processi di adozione e diffusione della documentazione in registro in ambito monastico. Un primo inventario, stilato nel 1450 dal protonotario apostolico Venceslao Porcia su disposizione del commendatario Pietro Barbo (futuro papa con il nome di Paolo II), fa emergere innanzitutto la situazione di estremo degrado e abbandono in cui versa l’archivio a metà Quattrocento. La decadenza del monastero si trasfonde nella perdita di identità delle sue carte, depotenziate della loro funzionalità giuridica e politica e costrette ad una separazione innaturale dalle strutture che le avevano prodotte: 42 « sacceti », contenenti molto genericamente le scritture del cenobio, « que reperte fuerunt ex una capsa domini Bartolomei, quae erat (…) in domo Boni de Cisono » 38. Più disteso in termini di descrizione delle carte d’archivio, ora nuovamente recuperate al monastero e più opportunamente conservate « in studio », l’inventario redatto nel 1460 dal canonico Cristoforo da Feletto assieme a Marco Barbo vescovo di Treviso, sempre su sollecitazione del commendatario Pietro Barbo. Il bisogno di fornire un supporto di validità ai beni da gestire e ai diritti da 36 ID., Monasteri e città nel duecento: Verona e S. Zeno, in Il liber feudorum di S. Zeno di Verona (sec. XIII), a cura di F. SCARTOZZINI, Padova 1996, pp. XLI-XLII (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 10). 37 Sul monastero cistercense ha dedicato ampi studi Pier Angelo Passolunghi; cfr. P.A. PASSOLUNGHI, Santa Maria di Follina monastero cistercense, Treviso 1984; ID., Nella decadenza del Trecento follinate: vicende e stato patrimoniale di un monastero cistercense veneto, in « Benedictina », 31 (1984), pp. 47-78; ID., Il monastero di S. Maria di Follina e la sua biblioteca nel sec. XV, in « Benedictina », 34 (1987), pp. 451-472. 38 ID., Il monastero di S. Maria di Follina… cit., p. 460. Ermanno Orlando 142 rivendicare spinge i nuovi amministratori ad un primo confronto con la documentazione d’archivio, nell’occasione censita, approssimativamente identificata e in qualche modo ordinata. Le scritture generiche sono ora riconosciute come istrumenti notarili, conservati in parte nei 42 « sacculi » sopra menzionati, in parte in « una capsa de talpono magna »; soprattutto vengono elencati e precisati nella loro valenza giuridica i titoli di fondazione, i privilegi e le concessioni: « duo privilegia domini Ottonis imperatoris »; « unum privilegium domini Innocentii pape tertii » e così via 39. Ma il documento più interessante è rappresentato certamente dall’inventario steso nel 1484 dal notaio milanese Andrea, su incarico del patriarca Marco Barbo, commendatario in Follina sin dal 1481. Per la prima volta vi si trovano indicati, oltre al materiale sciolto su pergamena, il complesso delle scritture a registro prodotte dalla comunità: un « inventarium possessionum abbatiae Folinae in carta bona paginata et copertum rubeo corio »; « inventarium unum parvum in bonis cartis de possessionibus existentibus in Cadubrio »; « aliud inventarium etiam in bonis cartis magis antiquum de possessionibus Cadubrii »; « plures libri de introitibus cum pluribus aliis diversis scripturis ad ipsam abbatiam de la Folina spectantibus » 40. Ora, non sapremmo dire con certezza se si tratti di diversa sensibilità archivistica del compilatore di quest’ultimo inventario, più matura e quindi più disponibile a vedere quelle scritture ordinarie su registro che i catasticatori precedenti non avevano scorto, o se effettivamente siano stati registrati nel 1484 registri e fascicoli che sino alla metà del secolo non erano in archivio semplicemente perché non erano stati prodotti. Sappiamo tuttavia che un inventario dello stato patrimoniale di un ente è uno strumento statistico, notarile; uno strumento che per sua natura implica necessariamente l’esercizio di capacità magari elementari di analisi e spoglio del patrimonio archivistico. Se non si è visto, riscontrato, registrato, insomma, forse la ragione va ricercata nel fatto, banale e scontato quanto si vuole, che non vi era nulla da registrare. Stando così le cose, potremmo allora datare l’adozione della documentazione su registro per l’abbazia di Follina solo a partire dai decenni centrali del XV secolo: un dato solo apparentemente tardo che, come avremo modo di vedere, riflette abbastanza fedelmente le dinamiche produttive della documentazione ordinaria espresse dagli enti monastici del territorio trevigiano. Tradotti in questo universo costellato di ritardi, di isolamenti, di strategie archivistiche poco consapevoli, gli sparuti relitti documentari che si conservano del Trecento monastico trevigiano, descritti in apertura, acquistano una luce diversa, potendosi in sostanza leggere come indicatori di tenuta degli ordini religiosi, come espressione di vivacità dialettica, di resistenza agli urti e agli scossoni del tempo, di ininterrotto impegno amministrativo. Strumenti 39 Ibid., p. 461. 40 Ibid., pp. 462-463. Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 143 dunque per illuminare certe zone di penombra altrimenti difficilmente scrutabili, per vivificare taluni barlumi di espressività; vettori preziosi infine, come già sottolineava Daniela Rando 41, per dare spessore a quei pochi tentativi di riforma monastica che hanno segnato, seppur con difficoltà, anche la decadenza del Trecento trevigiano. 4. Autonomia comunale e gestione dei patrimoni documentari: i registri notarili di S. Maria di Mogliano. — Nella debolezza generale dell’ordine benedettino alcuni dati in controtendenza si possono ricavare dalle carte del monastero femminile di S. Maria di Mogliano e S. Teonisto di Treviso 42. Si tratta di un cenobio di antica fondazione che — dopo alcuni secoli di crescita patrimoniale, di impegno nell’organizzazione del territorio e nella coordinazione economica della campagna trevigiana tra la città e i bordi lagunari e di indiscusso prestigio politico — conosce difficoltà crescenti durante la dominazione ezzeliniana su Treviso (1236-1257), con ripetute espropriazioni di beni e danneggiamenti del patrimonio 43; è l’inizio di una fase di declino, di margina41 D. RANDO, Archivi di monasteri e conventi. L’età medioevale… cit., p. 8. 42 Per una panoramica degli studi sul monastero benedettino si vedano: C. AGNOLETTI, Treviso e le sue pievi, Treviso 1897-98 (Bologna 1968), I, pp. 142-143, 22; II, pp. 200-213; A. MARCHESAN, Treviso medioevale. Istituzioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità, II, Treviso 1923, pp. 377-384; P.F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum. Italia Pontificia, VII, Venetiae et Histria, parte I: Provincia Aquileiensis, Berolini 1923, pp. 116-117; E. PERINOTTO, Abbazia di S. Maria di Mogliano e S. Teonisto di Treviso (sec. X-XIX), Roma 1952; A.A. MICHIELI, Il cenobio benedettino di Mogliano e una bolla di papa Eugenio IV, in « Archivio Veneto », XLVIII-XLIX (1951), pp. 75-86; ID., Casi e vicende di Mogliano Veneto. Storia d’un piccolo paese in quella d’un grande, Treviso 1957; ID., Luci e ombre di una grande storia, in Miscellanea in onore di Roberto Cessi, Roma 1958, pp. 81-108; G. LIBERALI, La diocesi delle visite pastorali, I, Treviso 1976, pp. 148-155 (Documentari sulla riforma cattolica e post-tridentina a Treviso, VII); P.A. PASSOLUNGHI, Un documento del 1043 relativo a S. Maria di Mogliano, in « Benedectina », 26 (1979), pp. 22-24; ID., Il monachesimo benedettino della Marca trevigiana, Treviso 1980, pp. 123-127; L. PESCE, La chiesa di Treviso nel primo quattrocento, I, Roma 1987, pp. 594-599; A. CONTO’, Le pergamene del monastero di Santa Maria di Mogliano nel fondo “Stefani” della Biblioteca Comunale di Treviso, in Sulle tracce di G.B. Verci. Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Atti del convegno. Treviso 25-27 settembre 1986, a cura di G. ORTALLI e M. KNAPTON, Roma 1988, pp. 113-123; L. PUTTIN, La giurisdizione degli enti ecclesiastici: il caso di Santa Maria di Mogliano, ibid., pp. 99-106; A. GASPARI, Il monastero di Santa Maria Assunta di Mogliano 997-1307, Tesi di laurea discussa presso l’Università degli studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1988-89; R. FORNASIER, L’abbazia di S. Maria di Mogliano dal 1189 al 1319 (con appendice di 104 documenti inediti), Tesi di laurea discussa presso l’Università degli studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1993-94; Regesti delle pergamene di Santa Maria di Mogliano. 997-1313, a cura di M. POZZA, Mogliano Veneto 2000. La più recente produzione storiografica sul monastero, nel contesto più generale del monachesimo in area veneta, andrà ricercata nei volumi di atti dei convegni su Il monachesimo nel Veneto medioevale… cit. e su Mogliano e il suo monastero: 1000 anni di storia… cit. 43 LAMI, R. FORNASIER, L’abbazia di S. Maria di Mogliano… cit., II, p. 75, doc. 28; S. BORTOMonasteri e comuni… cit., p. 65. Ermanno Orlando 144 lità politica e di scollamento amministrativo su cui si innesta l’azione di recupero e tutela del governo cittadino, nel solco di una tradizione precoce e collaudata di salvaguardia dei patrimoni monastici « anche in vista di un più sicuro controllo del territorio » 44. La connotazione pubblica del cenobio, lo stretto legame delle monache con l’ambiente d’origine, i vincoli e le solidarietà di ordine economico e sociale con i vertici della gerarchia cittadina richiamano la città a funzioni di mediazione, di vigilanza e disciplina sia in ambito religioso che amministrativo-patrimoniale, che si esplicitano in una serie di interventi legislativi a favore dell’istituto e dei suoi beni 45 considerati un patrimonio indispensabile per le esigenze demografiche, economiche e sociali della collettività. Contestualmente all’attività di tutela svolta dal Comune trevigiano si sviluppa il tentativo di restaurazione religiosa condotto dalla gerarchia ecclesiastica: nel 1340, nello spirito di riorganizzazione e riforma della vita religiosa dell’ordine benedettino voluti da papa Benedetto XI con la bolla « Summi magistri » del 1336, fatto proprio e rilanciato dai capitoli della provincia aquileiese dello stesso anno e del 1340 e dal concilio provinciale di Aquileia del 1339 46, Pierpaolo dalla Costa, vescovo di Treviso, interviene disciplinarmente presso la comunità femminile per destarla dal torpore spirituale e dal dissesto economico in cui era caduta e recuperarla all’ordine e ad una corretta gestione del patrimonio 47. I segnali di una ritrovata capacità di raccordarsi con l’esterno, di adeguarsi alle mutate condizioni ambientali e di rinnovare gli strumenti di coordinazione economica sembra si possano scorgere nell’adozione, da parte delle monache, dei più elastici e vantaggiosi contratti di conduzione a breve termine e a canone fisso, che diventano la norma — rimanendo ai dati forniti dagli studi di Giampaolo Cagnin 48 — proprio a partire dai primi decenni del Trecento. È dunque in questa situazione di rinnovata presenza politica e patrimoniale del cenobio che si collocano i cinque registri trecenteschi — di cui li primo potremmo definire almeno in parte un copiario 49 — del monastero 44 S. BORTOLAMI, Monasteri e comuni… cit., pp. 65-67. 45 R. FORNASIER, L’abbazia di S. Maria di Mogliano… cit., pp. 141-154; S. BORTOLAMI, Monasteri e comuni… cit., p. 67; sulla tutela pubblica esercitata dalla città sui monasteri femminili si veda soprattutto G. ZARRI, Monasteri femminili e città (secoli XV-XVIII), in Storia d’Italia. Annali, La chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di G. CHITTOLINI - G. MICCOLI, Torino 1986, pp. 359-429. 46 A. RIGON, Vescovi e monachesimo… cit., pp. 157-162; ID., Decadenza e tensioni di rinnovamento… cit., pp. 363-364; F.G.B. TROLESE, Decadenza e rinascita dei monasteri veneti nel basso medioevo, in Il monachesimo nel veneto medioevale… cit., pp. 177-180. 47 Notizie sulla visita canonica di Pierpaolo dalla Costa in L. PESCE, La chiesa di Treviso… cit., I, p. 595. 48 G. CAGNIN, I patti agrari in territorio trevigiano dalla metà del secolo XII agli inizi del secolo XIV: tradizione e innovazione, in Storia di Treviso… cit., II, p. 343. 49 Sui cartulari di produzione monastica e sui paralleli libri « iurium » delle strutture pubbliche si vedano, tra gli altri, A. ROVERE, Libri « iurium-privilegiorum, contractuum-instrumen- Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 145 benedettino: la volontà espressa dai vertici della gerarchia pubblica ed ecclesiastica di controllare, riorganizzare e fissare il patrimonio monastico determina, a livello documentario, una operazione forte di ricapitolazione e sistemazione dei titoli di proprietà, ora raccolti e condizionati in singoli « contenitori », più accessibili e più facilmente consultabili 50. Tali registri raccolgono, grosso modo in sequenza cronologica e in parte topografica, atti riguardanti il patrimonio immobiliare quali locazioni, compravendite, permute, donazioni, « compromessi, accordi, sententie, stime, pagamenti, procure, renovationi di quelle et altre diverse scritture e contratti » 51, redatti pure da notai vicini all’apparato amministrativo del Comune a testimonianza ulteriore dello stretto contesto di interazione tra Comune e monastero che si instaura giusto in occasione della presente operazione di recupero documentario. Strumenti allo stesso tempo amministrativi e conoscitivi, dunque, i cinque registri dell’archivio benedettino, approntati sia per supportare giuridicamente eventuali rivendicazioni, sia per impostare una gestione più proficua e dinamica del patrimonio fondiario della comunità. Delineato il contesto di produzione e i legami fra tali scritture su registro e l’ambiente economico-istituzionale, vale la pena soffermarsi, per una serie di motivazioni che ora andremo ad esporre, sul pezzo iniziale della serie, un registro contenente in apertura documentazione in copia autentica a partire dal 1313. Si tratta nella fattispecie di un registro costruito attraverso diverse e successive fasi di implementazione, il cui fascicolo iniziale — un copiario appunto — contiene, grosso modo per aree territoriali, contratti di locazione di terre concesse ad affitto da Bono « faber » da Pozzan di Campagna, gastaldo e sindaco del cenobio, nel breve periodo che va dal settembre del 1313 al novembre del 1316. I diversi documenti, rogati da Manfredino « Aslini de Fossis », notaio di sacro palazzo, sono trascritti e autenticati nel copiario in torum » e livelli della chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica, in « Atti della Società ligure di storia patria », n.s., XXIV (1984), 1, pp. 105-171; ID., I « libri iurium » dell’Italia comunale, in Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989, pp. 157-199; ID., I « libri iurium » delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione, « Archivi per la storia », VI (1993), 1-2, pp. 7994; A. ROVERE - D. PUNCUCH, I « libri iurium » dell’Italia comunale: una iniziativa editoriale degli Archivi di Stato, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLIX (1989), 3, pp. 580-585; D. PUNCUCH, Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento, in Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del convegno (Fermo, 17-19 settembre 1997), Fermo 1999, pp. 341-380; G.G. FISSORE, Un « liber iurium » ecclesiastico tutto particolare, in Il « liber » di S. Agata di Padova (1304), a cura di G. CARRARO, Padova 1997, pp. V-XXVIII (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 11). 50 Sulle ricadute documentarie della tutela esercitata dal comune bassomedievale sugli istituti monastici si vedano, ad esempio, G.M. VARANINI, Monasteri e Città… cit., pp. VII-LXXIX; G.G. FISSORE, Un « liber iurium »… citato. 51 ASTV, CRS.MC, S. Teonisto, Locazioni, b. 29, reg. « Affitacioni, instrumenti et altre cose », fasc. inserto « Repertorio ». Ermanno Orlando 146 questione dal notaio Nicolò q. Antonio « de Romario » da Treviso, in una data imprecisata che sembra potersi collocare a ridosso del 1316 — anno di rogazione dell’ultimo documento esemplato —, e comunque non oltre il 1352, anno con cui si apre il successivo « Quaternus abreviationum diversorum instrumentorum scriptorum per me Iohannem de magistro Liberio notario » 52. Perché insistere su questo nucleo di documenti in copia probabilmente degli anni Dieci del Trecento, di scarsa rilevanza quantitativa — 24 documenti in tutto, contenuti nelle carte 2-31 —, relativi pressoché tutti ad un’unica tipologia documentaria, interessanti un arco cronologico circoscritto e aventi per oggetto esclusivamente beni situati in due sole località della campagna trevigiana? Perché dare risonanza ad una operazione che in altri frangenti si sarebbe potuto facilmente ricondurre nel solco di analoghe esperienze di « travaso » 53 di documenti contenuti in protocolli notarili, di cui il monastero non possiede gli originali probabilmente perché non ancora redatti « in mundum »? Perché, e la circostanza non sembra affatto casuale, la redazione e probabilmente la trascrizione di tale nucleo documentario, coincidono con la conclusione della dominazione caminese su Treviso e il recupero delle libertà comunali 54, e dunque con un periodo di rifondazione istituzionale favorevole ad iniziative di revisione e ristrutturazione dei patrimoni documentari degli istituti in qualche modo controllati e tutelati dal potere pubblico. Sono anni di straordinario attivismo sul piano della produzione documentaria e dell’elaborazione di strategie di conservazione dei complessi archivistici (giusto precedenti il rilassamento che invece contraddistingue il periodo della dominazione veneziana su Treviso), che si risolvono, sotto la spinta dell’iniziativa del Comune, in una « radicale trasformazione del panorama delle fonti » 55 trevigiane. È infatti di questi anni, precisamente del biennio 1317-1318, la redazione del « liber iurium » del Comune, meglio conosciuto come « Codex Tarvisinus », contenente le copie autenticate dei documenti attestanti « l’autorità politica ed economica del Comune e i suoi diritti sul territorio dipendente » 56. Risale 52 Tale collocazione cronologica risulta suffragata dall’essere lo stesso notaio Giovanni di maestro Liberio, oltre che il redattore dei documenti contenuti nel quaderno, anche l’autore delle molte note marginali presenti nei documenti della sezione iniziale, annotazioni volutamente ricapitolative del quadro delle successive modifiche patrimoniali o contrattuali relative ai beni locati in quegli anni dal monastero. 53 Espressione tratta da A. ROVERE, I « libri iurium » dell’Italia comunale… cit., p. 169. 54 Su tale « “restaurazione” istituzionale », sulla temperie, gli avvenimenti e i protagonisti della riorganizzazione del governo comunale si è recentemente soffermato Giampaolo Cagnin nella sua Introduzione storica, in Il processo Avogari (Treviso, 1314-1315), a cura di G. CAGNIN, con un saggio introduttivo di D. QUAGLIONI, Roma 1999, pp. XXXIII-XXXVIII (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 14). 55 56 G.M. VARANINI, Nota introduttiva… cit., p. XLIV. Il « Codex Tarvisinus » è stato oggetto di studio e descrizione da parte di S. ROSSO, Il « Codex Tarvisinus ». Struttura e contenuto del liber iurium del Comune di Treviso, in « Archivio Veneto », s. V, CXXXIX (1992), pp. 23-46; la citazione a p. 23. Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 147 sempre a questo periodo, e più precisamente al 1316, e all’intervento della pubblica autorità, l’operazione di ricapitolazione e sistemazione del complesso documentario della Mensa vescovile in un unico volume, il « Libro delle renovationi de feudi del vescovato di Treviso con moltissimi privilegi, raccolti in quattro libri e distribuiti in buon ordine dalla vigilanza di monsignor vescovo Tolberto » 57, comprendente la trascrizione e l’autenticazione della documentazione già conservata sciolta su pergamena, nell’occasione raccolta e ordinata per « titula » topografici e per tipologie documentarie (un’intera sezione centrale è dedicata alla riproduzione in copie imitative dei più antichi privilegi papali, delle concessioni vescovili e dei diplomi imperiali a favore dell’episcopio). Sembra dunque indubitabile, nel quadro che si è appena delineato, la diretta interconnessione tra tali esperienze e lo sforzo di rifondazione documentaria messo in atto dalle monache benedettine. Un simile tentativo di costruzione di uno strumento ricognitivo dei diritti patrimoniali del monastero, pur assolutamente povero nell’impostazione e nei risultati, sembra insomma anch’esso rientrare nel clima e nei processi di stabilizzazione istituzionale, di legittimazione della propria ritrovata autonomia e di formazione di una nuova coscienza politica sollecitati e in qualche modo diretti dal Comune trevigiano. 5. Il sostegno della congregazione: la contabilità delle camaldolesi di S. Cristina e S. Parisio di Treviso. — Per il monachesimo camaldolese veneto del Trecento si sono messi in evidenza alcuni casi significativi di recupero di vitalità e di buona capacità di tenuta — un esempio paradigmatico è in tal senso rappresentato dall’abbazia polesana di S. Maria della Vangadizza 58 — pur in un panorama non del tutto immune da crisi di identità, da processi di svuotamento e devitalizzazione, a cui non sembra sfuggire, per esempio, la comunità femminile di S. Cristina e S. Parisio di Treviso 59. Il cenobio, anzi, 57 ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE DI TREVISO, Mensa vescovile, Libri dei feudi. L’intervento pubblico risulta chiaramente dalle sottoscrizioni dei notai; un esempio a c. 2r, in cui il notaio, nel formulario di autenticazione, fa diretto riferimento al mandato del podestà: « et hoc de mandato et auctoritate nobilis viri domini Francisci de Mezonilanis de Bononia honorabilis potestatis Tarvisii »; cfr. G.M. VARANINI, Istituzioni e società a Treviso… cit., p. 179. 58 59 A. RIGON, Decadenza e tensioni di rinnovamento… cit., pp. 372-373. Per una sintesi della storia del cenobio si deve ricorrere ancora a G.B. MITTARELLI, Memorie della vita di San Parisio monaco camaldolese e del monastero de SS. Cristina e Parisio di Treviso, Venezia 1748. Di particolare interesse la contestualizzazione di alcuni aspetti della storia istituzionale, religiosa ed economica del monastero femminile trevigiano nel più ampio panorama dell’esperienza camaldolese in Italia proposta da C. CABY, De l’érémitisme rural au monachisme urbain. Les camaldules en Italie à la fin du moyen âge, Roma 1999, in particolare alle pp. 21, 47, 101, 108-109, 241, 253, 296-298, 302-307, 319-322, 346, 376-377, 403-404, 442-443, 451, 471, 495, 511-513, 540, 731. Altre notizie sulla comunità camaldolese in C. AGNOLETTI, Treviso e le sue pievi… cit., I, pp. 228-229, 232, 240, 243, 249, 251; A. MARCHESAN, Treviso… cit., I, p. XV; II, pp. 194, 358, 368; P.F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum… cit., VII, parte I, pp. 112-113; P.A. PASSOLUNGHI, Il monachesimo benedettino… cit., pp. 56-61; L. PESCE, La chiesa di Treviso… cit., I, pp. 607-611; G. VEDOVATO, L’inizio della presenza camaldolese nel Veneto (1186-1250), in Il monachesimo nel veneto medioevale… cit., pp. 177-180. Ermanno Orlando 148 per tutto il secolo si vede costretto su posizioni di retroguardia e di affannata difesa della propria esistenza, risultando più volte funestato da guerre e calamità naturali e costretto a ripetuti interventi di riedificazione del proprio complesso edilizio 60. Un istituto, dunque che, pur in mancanza di più approfonditi studi sul periodo in esame 61, mostra evidenti segni di decadenza, di condizionamento politico e di disgregazione patrimoniale, ma che rimane purtuttavia in grado di produrre forme di documentazione su registro seppur elementari e in larga parte arretrate. I pochi registri conservati della comunità camaldolese 62 si caratterizzano infatti — oltre che per il fatto rilevante di essere in gran parte redatti di propria mano dalle monache investite della guida del cenobio — per la sostanziale elementarità dei criteri di compilazione, evidenti sin dai libri di cassa o della « cameraria » 63, che contengono il 60 I registri contabili superstiti dell’archivio monastico abbondano di riferimenti a spese sostenute per il rifacimento del complesso cenobitico all’interno delle mura cittadine. Il registro individuato dal Mandelli come « 1358-1363. Dar ed aver » (cfr. supra, nota 21) interrompe i conteggi relativi alle entrate e alle uscite del cenobio con una lapidaria nota di cronaca: « In nomine Domini Ihesu Christi amen. Anno Domini nostri Ihesu Christi Millesimo trecentesimo LXII redifichatum fuit monasterium istud tam per magistros lapidum quam per magistros lignaminum ». Lo stesso Mandelli, nell’identificare il registro delle entrate e delle uscite del 1395, lo intitola come « Entrata ed uscita per la fabrica della chiesa e monastero »; cfr. « Indice cronologico », c. 11r. Tra le notizie riportate dal Mittarelli, che dedica un intero capitolo alla « distruzione del monastero di S. Cristina fuori delle mura di Treviso ed erezione del nuovo dentro la stessa città » (G.B. MITTARELLI, Memorie… cit., pp. 91-104), si ha notizia di un permesso concesso nel 1369 da Giovanni, generale della congregazione camaldolese, al vicario generale del monastero, Paolo Lazzari abate di S. Michele di Murano, per l’alienazione di un manso con il cui ricavato sostenere le spese di edificazione del cenobio, interamente distrutto per ragioni difensive dal Comune di Treviso nel 1355. Poco oltre, il subentrante generale della congregazione, il fiorentino Girolamo di Lapo di Uzzano, dà licenza di vendere alcuni immobili « conoscendo (…) la necessità che avevano di estendere la loro abitazione e di comprare case, giacché il disegno di riedificare il monastero dove era prima situato, riusciva, dirò così, impossibile a cagione delle guerre continue » (ibid., p. 98). Ancora nel 1400 le precarie condizioni economiche delle monache e i continui lavori per la riedificazione del complesso monastico inducono la Serenissima a concedere al cenobio importanti sgravi fiscali: « sono loro differite le restituzioni degli imprestiti che erano stati loro fatti da Camirlinghi di Treviso, ad oggetto che riparare potessero i monasteri loro dalle guerre distrutti » (ibid., pp. 101-102). Sulle controverse tappe della ricostruzione del complesso monastico, funestato durante tutto il Trecento da eventi bellici di particolare gravità, rilette pure sulla scorta di dinamiche comuni all’intera esperienza camaldolese di inurbamento progressivo delle comunità femminili, si sofferma diffusamente C. CABY, De l’érémitisme rural… cit., pp. 298-307, 319-322. 61 Mancano soprattutto letture approfondite della storia patrimoniale del cenobio, della sua rete di relazioni con le istituzioni politiche e sociali cittadini, del ruolo giocato dalla Dominante nello sviluppo del cenobio, solo in parte deducibili dal prezioso lavoro di sintesi tentato da C. CABY, De l’érémitisme rural… cit., in particolare pp. 365-366, 376-377, 400-404, 490-492, 494496, 507, 511-513. 62 ASTV, CRS.MC, S. Cristina e S. Parisio, Registri d’amministrazione, b. 27; ibid., Fondi vari di Treviso. Città, b. 1. 63 Il Mandelli riconosce almeno tre registri di cassa: « I. 1358-1363. Dar ed aver; II. 13621366. Dar ed aver; III. 1378-1388. Dar ed aver » (cfr. supra, nota 21). Di difficile attribuzione alla serie altri frammenti di registri conservati pure nella b. 27 di cui alla nota precedente. Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 149 movimento del denaro conteggiato in sezioni distinte per le entrate e per le uscite. Gli accrediti e gli addebiti, disposti su partite sovrapposte, riportano la causale del pagamento o il nome della persona solvente con la causa dell’entrata, seguiti dall’enunciazione dell’importo sempre privo di datazione. Tutti i dati sono compresi nel corpo della partita, con evidenti difficoltà di incolonnamento delle somme e di determinazione dei totali in entrata e in uscita. Per facilitare i bilanci di fine esercizio, di regola i registri riportano in calce alle partite il totale delle somme comprese nella carta, senza tuttavia presentare visti o altri segni di verifica che testimonino un iter, seppur elementare, di revisione e controllo dei dati parziali e generali dell’annata contabile. I conteggi dell’anno si aprono sempre con il nome della monaca preposta all’ufficio — alla cameraria si sostituisce talvolta nella tenuta della contabilità la stessa badessa —; manca tuttavia, all’inizio dell’incarico, la formalizzazione dell’avvenuto passaggio di consegna dell’ufficio o forme di presentazione del bilancio di chiusura dell’esercizio finanziario precedente alla cameraria subentrante. Si tratta dunque, nell’insieme, di scritture poco strutturate, talvolta anzi disomogenee e disordinate, certo non mature per sostenere forme consapevoli di controllo e revisione contabile, ma in grado di offrire un quadro sufficientemente preciso del movimento finanziario del cenobio. Il registro degli affittuari del 1378 64, annota in partite intestate alle ditte la corresponsione dei fitti e dei censi pattuiti con i propri locatari, secondo uno schema di redazione molto semplificato che prevede la descrizione veloce del bene, la sua ubicazione, il nome dell’affittuario, l’ammontare della rendita annua e i flussi delle riscossioni. Il disordine e l’approssimazione delle forme di conduzione del patrimonio monastico che si presuppone contraddistinguere la vita del cenobio a questa data, sembrano anzi quasi prendere forma nelle pagine dello strumento di registrazione delle rendite fondiarie, nel suo linguaggio asciutto, nei vuoti di compilazione, nella interruzione precoce della rendicontazione che si riscontra in molti dei conteggi in esso contenuti. Quanto al registro del 1395, contrassegnato dal numero romano V 65, esso si compone di due sezioni distinte, l’una dedicata alla contabilità delle spese sostenute per la riedificazione del complesso monastico, la seconda relativa alle rendite livellarie del cenobio. Se la sezione contabile presenta caratteristiche formali e criteri di compilazioni non dissimili da quelli illustrati per i rimanenti registri di cassa delle monache, la sezione predisposta per accogliere i dati relativi agli affitti degli immobili del cenobio — « Infrascriti eno li glabitaduri del monasterio de Sancta Cristina » — si configura più come un 64 Registro « 1378. Beni del monastero. Libro IV », in ASTV, CRS.MC, S. Cristina e S. Parisio, Registri d’amministrazione, b. 27; ibid.,Catastici delle scritture, b. 2, reg. « Indice cronologico », c. 8r. 65 Registro « 1395. Entrata ed uscita per la fabrica della chiesa e monastero. Beni del monastero. Libro V », ibid., Fondi vari di Treviso. Città, b. 1 e Catastici delle scritture, b. 2, reg. « Indice cronologico ». Ermanno Orlando 150 censimento ricapitolativo dei beni e delle rendite annuali spettanti al monastero, che come un registro contabile delle rendite livellarie; un « catastico » insomma, piuttosto che un registro delle riscossioni come nel caso del libro descritto in precedenza. Strutture semplificate, infine, ma anche una certa confusione compilativa, si possono riscontrare pure nel registro del granaio delle monache, che raccoglie tutti i dati relativi alle entrate delle granaglie (con registrazioni dal 1363) 66; una successione molto corsiva delle rendite della comunità, incapace di approdare a momenti di valutazione e riscontro contabile dei generi pervenuti o quantomeno di fissare la situazione di magazzino dell’annata, esemplificativa di una gestione sincopata di tali proventi, tutta giocata sull’autoconsumo e del tutto inavvertita delle dinamiche del mercato. In mancanza di dati più sicuri cui ancorare le nostre riflessioni, in attesa di ulteriori approfondimenti storiografici che diano maggiormente conto delle dinamiche di sviluppo patrimoniale del cenobio, della sua capacità — o impossibilità — di mantenere una posizione propositiva nei confronti del mercato cittadino, risulta difficile cogliere il senso di una produzione documentaria di natura contabile comunque eccezionale nel panorama del monachesimo trevigiano. Come interpretare infatti tale sensibilità delle monache nell’approntare strumenti contabili, seppur sommari e poco coordinati, nell’elaborare una prassi documentaria attenta ai risvolti organizzativi e gestionali dell’azienda monastica? Soprattutto, come spiegarlo per una comunità che appare profondamente in crisi 67, come intontita dai continui attacchi sferrati dai nemici esterni e per tutto il periodo minata nella sua saldezza e stabilità originarie? La risposta non può che rinviare al complesso di relazioni e all’intreccio di connessioni favoriti dalla struttura congregazionale cui le monache di S. Cristina e S. Parisio appartengono. Un movimento monastico, quello camaldolese, capace, anche in pieno Trecento, di alimentare forme di inquadramento e organizzazione istituzionale centralizzate 68, di promuovere, attraverso la ricorrenza delle visite 69, il controllo delle comunità dipendenti, di 66 ASTV, CRS.MC, S. Cristina e S. Parisio di Treviso, Registri d’amministrazione, b. 27; il registro non è descritto nell’inventario del Mandelli. 67 La stessa Cécile Caby descrive la comunità monastica come « en crise profonde depuis son installation dans le centre de Trévise »; cfr. C. CABY, De l’érémitisme rural… cit., p. 731. 68 Un quadro puntuale degli assetti legislativi, dell’organizzazione territoriale e dell’inquadramento fiscale della congregazione, nonché degli organismi e degli strumenti di centralizzazione dell’ordine, ibid., pp. 121-147. 69 La congregazione camaldolese adotta sin dagli inizi del Duecento l’istituto della « visitatio » dei monasteri dipendenti; nel 1231 fanno la loro comparsa ufficiale due visitatori e correttori con specifiche mansioni di supervisione, controllo e intervento sia negli affari spirituali che temporali: cfr. ibid., pp. 132-134; G. VEDOVATO, Camaldoli nell’età comunale (1088-1250), in Il monachesimo italiano nell’età comunale… cit., pp. 542-543 (Cécile Caby avanza a tal proposito l’ipotesi che le visite fossero anzi più numerose ai monasteri femminili che a quelli maschili. C. CABY, De l’érémitisme rural… cit., p. 145). Canale diretto di diffusione di pratiche di ammini- Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 151 scongiurare alle case affiliate gli inconvenienti e i danni provocati dall’isolamento, di recuperarle dai pericoli della cattiva amministrazione e di favorire, infine, la circolazione di esperienze più agili e funzionali di gestione patrimoniale, contabile e non ultimo documentaria 70. Non sfugge in aggiunta il fatto che si tratti ancora di un monastero femminile, oggetto anch’esso di tutela da parte del potere politico cittadino 71, con una sua funzione pubblica riconosciuta 72, al centro delle interessate strategie familiari dell’aristocrazia cittadina 73 così come delle mire dell’apparato di governo volte al controllo e alla salvaguardia del patrimonio ecclesiastico. Dinamiche di vigilanza dei beni e di elaborazione di strategie documentarie più consapevoli che abbiamo già descritto per il monastero benedettino di S. Maria di Mogliano, e che non sembra inopportuno riproporre anche per le monache di S. Cristina e S. Parisio. 6. Vivacità spirituale e consapevolezza documentaria: la certosa di S. Maria e S. Girolamo del Montello. — Ha scritto recentemente Antonio Rigon che « se la storia del monachesimo si esaurisse in quella dei certosini, il Trecento e il Quattrocento potrebbero essere considerati a buon diritto i secoli d’oro dell’espansione e dell’influenza monastica in Italia » 74: ciò vale in particolar modo per la Certosa di S. Maria e S. Girolamo del Montello, la prima fondazione certosina del Veneto. Originatasi dal recupero in un quadro di cenobitismo di primitive spinte eremitiche — una comunità di eremiti era stanziata sul Montello dagli anni Venti del Trecento, sotto la guida di Giovanni di S. Giuliana di Fassa —, ed approdata all’ordine certosino nel 1349, la certosa fu oggetto dell’attenzione benevola e del sostentamento di Pierpaolo dalla Costa, già ricordato vescovo di Treviso (ma pure di Pietro da Baone e strazione e — almeno così si presuppone — anche di tenuta di scritture ordinarie, lo stesso registro di cassa del 1358-1363 contiene una testimonianza diretta di una visita effettuata al monastero. Una nota di spesa del 1362 infatti così dichiara: « Item dedi al vichario libbre X li quali danari egli spese in carne al nostro generale e alli visitatori e nella festa di San Parigi in carne e in altre chose », ASTV, CRS.MC, S. Cristina e S. Parisio di Treviso, Registri d’amministrazione, b. 27. 70 La stessa studiosa francese mette in risalto l’intensa circolazione di scrittura intercorrente fra il centro e la periferia della congregazione, in particolare la « circulation des lettres adressées par le général à ses sujets », C. CABY, De l’érémitisme rural… cit., pp. 139-141. In altro luogo la studiosa rileva come la tipologia dei documenti prodotti dai monasteri dell’ordine sia riconducibile alle scritture più tradizionali della pratica giuridica e amministrativa dell’ordine benedettino, ibid., pp. 172-174. 71 Ibid., pp. 490-503. 72 Centro di un culto civico riconosciuto dalla stessa statutaria comunale, in quanto sede delle reliquie di S. Parisio, santo venerato come protettore della città, ibid., pp. 511-513. 73 Cécile Caby a tale proposito avanza l’immagine del monastero come di un « hospice de la noblesse », luogo « de sélection aristocratique des familles de recrutement », ibid., pp. 400-404. 74 A. RIGON, Vescovi e monachesimo… cit., p. 162. Ermanno Orlando 152 del presule padovano Ildebrandino Conti), dell’appoggio e della protezione dei conti di Collalto, nonché della generosità e predilezione di molti devoti, tra cui personaggi di spicco della gerarchia ecclesiastica e dell’aristocrazia trevigiane e veneziane e del mondo della cultura 75. I lasciti e le donazioni da subito estremamente copiosi permisero ai monaci di intraprendere ed ultimare entro il secolo le opere di edificazione del complesso monastico e della chiesa, consacrati nel 1396 dal patriarca di Costantinopoli Angelo Correr, futuro papa con il nome di Gregorio XII. Favorirono pure repentini processi di implementazione e accorpamento del patrimonio fondiario, tanto consistenti da sollecitare la redazione — assai anticipata nel panorama monastico trevigiano — del censimento ricognitivo delle scritture e degli istrumenti fondanti i diritti di possesso e i privilegi del cenobio, di cui si è detto in apertura 76. A riprova della robustezza e della vivacità spirituale ma anche patrimoniale della certosa, di una consapevolezza e stabilità di presenza capace di innescare precocemente processi di confronto con le proprie origini, di proposizione anche encomiastica e autocelebrativa della propria identità, va ricordata la dettagliata « Cronaca domus » 77 redatta dal priore Antonio de Macis tra il 1415 e il 1419. Aldilà degli eventi di storia monastica della certosa, che si dipanano in un raggio d’anni che va dal 1320 al 1419, ci interessa lo spirito « di crescente dettaglio e riscontro documentario » 78 che pervade tutta l’opera, 75 Per alcuni approfondimenti sulla Certosa del Montello si vedano C. AGNOLETTI, Treviso e le sue pievi… cit., I, pp. 151-152, 236-237; II, pp. 656-660; P. SAMBIN, Una donazione di Filippo de Mézières ai Certosini (1378), in Ricerche di storia monastica, Padova 1959, pp. 5355; P.A. PASSOLUNGHI, Il monachesimo benedettino... cit., pp. 129-133; L. PESCE, Ludovico Barbo vescovo di Treviso (1437-1443), Padova 1969, I, pp. 12, 14, 81, 96, 99, 201-201, 239-242, 254, 263, 308; ID., La chiesa di Treviso… cit., I, pp. 573-581; ID., Filippo de Mézières e la Certosa del Montello, in « Archivio Veneto », CXXXIV (1990), pp. 5-44; La cronaca della Certosa del Montello, a cura di L. CROVATO, prefazione di G. CRACCO, con una Nota archivistica di D. RANDO, Padova 1987 (Miscellanea erudita XLVI); G. CRACCO, Realismo e tensioni ideali nella cultura trevigiana del tardo medioevo, in Tommaso da Modena e il suo tempo. Atti del convegno internazionale di studi per il 6° centenario della morte (Treviso 31 agosto - 3 settembre 1979), Venezia 1980, pp. 119-131; L. SBRIZIOLO, Un inedito dell’Agnoletti e alcuni nodi da sciogliere per la storiografia della certosa del Montello, ibid., pp. 133-142; A. RIGON, Vescovi e monachesimo… cit., pp. 163-166; ID., Decadenza e tensioni di rinnovamento… cit., pp. 373-374; D. RANDO, Religione e politica nella Marca… cit., I, pp. 373-374. Un quadro d’assieme sul « sistema » delle certose venete tra Tre e Quattrocento in D. GALLO, Dalla certosa del Montello alla certosa di Vedana: la fortuna dei certosini nell’ambiente veneto del Tre-Quattrocento, in La Certosa di Vedana. Storia, cultura e arte in un ambiente delle prealpi bellunesi. Atti del colloquio. Sospirolo (Belluno), 21 ottobre 1995, a cura di L.S. MAGOGA e F. MARIN, Firenze 1998, pp. 7-21 (in particolare sulla certosa del Montello pp. 12-15). Più attento alle strutture archivistiche e alla storia della documentazione del cenobio il saggio di F. CAVAZZANA ROMANELLI, La certosa del Montello, in Narvesa all’alba del secondo millennio, a cura di G. CANIATO, Nervesa della Battaglia (TV) 1994, pp. 63-66. 76 Cfr. supra, p. 134. 77 BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER, ms. Cicogna 2001. 78 F. CAVAZZANA ROMANELLI, La certosa del Montello… cit., p. 64. Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 153 lo scrupolo del cronista di rivelare sempre le fonti cui attinge, anche quando si tratti di fonti documentarie. In tal modo la « Cronaca » si propone tout court come mappa della produzione documentaria del cenobio, come palinsesto delle scritture correnti in dotazione all’archivio; scorre pertanto davanti ai nostri occhi la ricca documentazione sciolta, su pergamena, del monastero — i rogiti notarili, gli istrumenti, gli atti pubblici —, assieme e in aggiunta alle scritture su registro. Chiedendosi quali fossero state le fonti principali utilizzate dal de Macis per inquadrare la storia del cenobio dal punto di vista della sua crescita patrimoniale ed economica 79, Maria Luisa Crovato, curatrice della « Cronaca domus », sottolineava l’importanza primaria in tal senso assunta dai rogiti notarili. Tra le altre fonti compulsate non dimenticava però di annoverare alcuni registri e quaderni inerenti la gestione amministrativa e contabile del monastero, sicuramente visionati dall’autore: tra questi, i « registri delle elemosine, scritti dagli stessi priori della “domus” trevigiana, che annotavano le entrate e le uscite del convento » 80, allo stato attuale purtroppo dispersi, ma soprattutto alcuni inventari dei beni fondiari e mobiliari del monastero, riconosciuti dallo stesso de Macis come imprescindibili per la conoscenza delle donazioni entrate a far parte della certosa dal tempo della sua fondazione 81 (come rileva in un passaggio dell’opera che recita: « si quis nosce<re> cupit melius benefactorum gesta, inventarium et instrumenta legat, ubi plenius continentur » 82). Scendendo nel dettaglio, ricordava la curatrice le tre compilazioni inventariali trecentesche tuttora conservate tra le carte dell’archivio: l’« inventarium possessionum », contenente in apertura la teoria dei « fundatores et hedificatores domus Montelli necnon et a quibus provenerunt possessiones et redditus ipsius » 83, base di redazione della successiva lista dei benefattori ed elenco delle donazioni fatte alla comunità dal 1349 fino al 1376 circa 84, entrambi utilizzati dalla « Cronaca » per ricostruire la processione dei primi sostenitori del cenobio; e, infine, un inventario di tutti gli oggetti lasciati in eredità da Elena « de Hengenolfis », compilato probabilmente tra la fine del secolo e i primi anni del successivo 85. 7. Strategie documentarie degli ordini mendicanti: S. Nicolò e S. Francesco di Treviso. — In questo tentativo di leggere la civiltà monastico/con79 M.L. CROVATO, Introduzione, in La Cronaca della Certosa… cit., pp. 19-23. 80 Ibid., p. 21. 81 Ibid., p. 22; D. RANDO, Nota archivistica… cit., p. XIV. 82 M.L. CROVATO, Introduzione… cit., p. 75. 83 ASTV, CRS.MC, S. Maria e S. Girolamo, Inventari dei beni, b. 66, reg. « Inventarium possessionum », in apertura. 84 Ibid., Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Venezia (1970), Inventari dei beni, b. 1 85 Ibid., Inventari dei beni, b. 66. [ter]. Ermanno Orlando 154 ventuale trevigiana del Trecento attraverso lo spoglio dei dati archivistici, di dare spessore al complesso dei fattori di debolezza e immobilismo, ma anche alle manifestazioni di rinnovata vitalità, alla capacità delle case religiose del Trevigiano di dialogare con la società civile e di interagire con i processi economici, tentativo fatto a partire dalle carte d’archivio, un capitolo a parte merita la documentazione corrente prodotta dagli ordini mendicanti. Senza voler tracciare linee di demarcazione troppo rigide, è innegabile che l’esperienza documentaria mendicante del XIV secolo abbisogni di spazi di approfondimento differenti, di schemi interpretativi maggiormente calibrati sulle peculiarità genetiche del fenomeno della mendicanza. Una più attenta riflessione sugli archivi conventuali — seppur in un quadro storiografico ancora deficitario 86 — ha cercato, negli ultimi anni, di delineare i processi di definizione del rapporto — incerto, conflittuale, faticoso — degli ordini mendicanti con la prassi documentaria, il divenire di una tradizione che con difficoltà mette radici, si afferma e si consolida 87. Si è anzi insistito su una diffidenza originaria verso il documento scritto del tutto strutturale agli ideali dei mendicanti, e forte a tal punto da soffocare atteggiamenti chiari e decisi di implementazione documentaria e da condizionare, in taluni casi, la sopravvivenza delle carte d’amministrazione negli archivi conventuali. « Insomma » — per dirla con Attilio Bartoli Langeli — « i mendicanti in quanto tali non potevano sviluppare una organica strategia documentaria. Lo fanno intravedere quelle fondazioni che, essendo proprietarie, “usarono” la documentazione in funzione della salvaguardia e dello sviluppo delle proprie risorse patrimoniali. Lo fa intravedere solo quell’ordine, tra i mendicanti, la cui autocoscienza si tradusse in una solida struttura istituzionale e ideologica, ossia l’ordine dei Predicatori » 88. È questo il caso del convento domenicano di S. Nicolò di Treviso, studiato diffusamente, quanto a strategie di produzione e conservazione delle carte d’archivio da Giampaolo Bustreo, e inquadrato in taluni risvolti di eccezionalità documentaria da Attilio Bartoli Langeli 89. Si tratta di un convento 86 Così almeno secondo A. BARTOLI LANGELI - N. D’ACUNTO, I documenti degli ordini mendicanti, in Libro, scrittura, documento… cit., pp. 382-384. 87 Tematiche soprattutto sviluppate ibid., pp. 389-390 e in A. PRATESI, Nolo aliud instrumentum, in Francesco d’Assisi. Documenti e archivi. Codici e biblioteche. Miniature, Milano 1982, pp. 11-12; A. RIGON, Frati minori e società laicali, in Francesco d’Assisi e il primo secolo di storia francescana, Torino 1997, p. 261; G.P. BUSTREO, Le terre e le case dei frati… cit., pp. XVIII-XIX. 88 89 A. BARTOLI LANGELI - N. D’ACUNTO, I documenti degli ordini mendicanti… cit., p. 390. G.P. BUSTREO, L’archivio di San Nicolò… cit., pp. 135-158; ID., Le terre e le case dei frati… cit., pp. 3-8, 10-13, 16-19, 124-129, 137-139; A. BARTOLI LANGELI - N. D’ACUNTO, I documenti degli ordini mendicanti… cit., pp. 388-390. La presenza mendicante a Treviso e nel suo territorio è stata ampiamente studiata da Daniela Rando, ai cui saggi si rimanda per una introduzione storica al fenomeno: cfr. soprattutto D. RANDO, Religione e politica nella Marca… cit., I; ID., Minori e vita religiosa nella Treviso del Duecento, in Minoritismo e centri veneti nel Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 155 pienamente inserito sulla scena cittadina, con un ruolo riconosciuto tanto in termini religiosi quanto sociali e politici, che fa registrare una marcata accelerazione dei processi di implementazione del patrimonio in particolare nei decenni a cavallo della metà del secolo. Una comunità protesa a canalizzare la propria crescita soprattutto in direzione di un irrobustirsi della presenza immobiliare in città e attenta al patrimonio fondiario, seppur in un quadro di staticità rivolto più alla tenuta delle rendite che alla conservazione e razionalizzazione dei propri beni 90. È in tale orizzonte di fiduciosa presenza nel tessuto urbano, di adeguamento delle strategie patrimoniali e di attenzione alla stabilità delle rendite del convento che vanno inquadrati i registri trecenteschi della comunità domenicana. In qualche modo, dunque, è la ricchezza dell’istituto a « giustificare » la presenza dei due catastici delle proprietà e delle rendite, il « Liber (…) locorum (…) in quibus sunt possessiones de quibus percipimus aliquid annuatim » del 1351-1391 91, e il « Quaternus responssionum afictuum tam manssorum quam eciam domorum et pecuniarum annualiter reccipiendarum de omnibus infrascriptis et legatis dimissis in testamentis » del 1391-1437 92. Frutto di una operazione organica di repertoriazione e ricapitolazione delle fonti d’entrata del convento, ciascuno dei due registri annota, grosso modo per località di ubicazione dei beni, la descrizione dell’immobile, il nome dell’affittuario, l’entità del canone, il regesto del titolo giustificativo della proprietà — testamento, compravendita, permuta 93 —, il flusso dei pagamenti e l’eventuale situazione debitoria del colono 94. La stessa disponibilità di dialogo con il mondo circostante e di incidenza sull’ambiente urbano sembrano inoltre stare alla base dei rimanenti due registri trecenteschi prodotti dalla comunità: il « Liber primus procuratie ab anno 1360 ad 1406 » 95, che documenta l’attività del procuratore, ossia di colui che aveva quale suo compito precipuo quello di soddisfare le necessità materiali del convento, di registrare tutti i movimenti in Duecento, a cura di G. CRACCO, in « Civis », VII (1983), 19-20, pp. 63-91. Altre notizie sui conventi mendicanti cittadini in R. CITERONI, Il convento di S. Nicolò e la città (1270 circa 1305), in I frati predicatori nel Duecento, Verona 1996, pp. 105-133 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa); L. PESCE, La chiesa di Treviso… cit., I, pp. 461-479 (minori conventuali di S. Francesco) e pp. 479-496 (domenicani di S. Nicolò). 90 È questo il quadro emergente dallo studio di G.P. BUSTREO, Le terre e le case dei frati… cit., soprattutto pp. 31-33, 51-56, 66, 79. 91 ASTV, CRS.MC, S. Nicolò, Catastici dei beni, b. 47. 92 Ibid., Atti provenienti dall’Archivio di Stato di Venezia (1970), b. 2. 93 Lo stesso che compare, della stessa mano, in attergato alle pergamene del diplomatico del convento, a testimonianza di una operazione archivistica lucida e pienamente consapevole. 94 G.P. BUSTREO, L’archivio di San Nicolò… cit., pp. 137-139; ID., Le terre e le case dei frati… cit., pp. 7-8; A. BARTOLI LANGELI - N. D’ACUNTO, I documenti degli ordini mendicanti… cit., p. 389. 95 ASTV, CRS.MC, S. Nicolò, Giornali del procuratore, b. 32. Ermanno Orlando 156 entrata e in uscita e di riscontrarli settimanalmente mediante « rationes », o consuntivi, delle differenze di cassa; e il registro della sacrestia (con annotazioni dal 1336) o « quaternum » ove « scribatur tota pecunia recepta pro missis et testamentis supra XL soldos » 96, che si propone allo stesso tempo quale strumento di conoscenza e segnale ineccepibile del successo ottenuto dagli ordini mendicanti nell’amministrazione dei sacramenti, nell’ascolto delle ultime volontà dei morenti e, più in generale, nelle strutture della « cura animarum » 97. Rimane da dire dell’unico registro contabile trecentesco conservato nell’archivio dei minori di S. Francesco di Treviso e relativo agli anni 13631393 98. Un registro di dubbia attribuzione al fondo, in pessimo stato di conservazione, che tuttavia non sembra alterare granché — fosse anche stato prodotto dai minori — il quadro di scarsa « visibilità » della documentazione francescana, quegli elementi di debolezza e di diffidenza verso il documento scritto, di cui si è detto più in generale per tutti gli ordini mendicanti 99, e che sembrano davvero specifici dell’esperienza dei seguaci di san Francesco, « poveri per definizione » 100. Se per i domenicani di S. Nicolò, infatti, si è potuto parlare di una strategia documentaria sicura e coerente, per i francescani rimane l’impressione forte, confermata dal vuoto di documentazione ordinaria su registro almeno sino alla metà del Quattrocento, di un rapporto con la scrittura corrente contraddittorio, incerto, e in qualche modo di un « inseguimento » del modello domenicano che per tutto il secolo non verrà « mai coronato » 101. 8. La Terraferma trevigiana e i suoi monasteri nel XV secolo: l’esplosione documentaria differita. — La vera esplosione documentaria e la parallela diversificazione delle tipologie di registrazione vanno allora differite, stando alle indicazioni delle carte e ai dati forniti dal censimento delle Corporazioni religiose soppresse di Treviso, ai decenni centrali del Quattrocento. È solo da allora che cominciano ad apparire, in modo sistematico e diffuso, tipologie documentarie peculiari della produzione di scrittura delle case religiose: libri capitolari, inventari dei beni, registri di entrata e spesa, libri degli affittuari, libri dei resti, « vacchette » di ricevute, libri del granaio oltre ai primi fascicoli 96 ASTV, Comunale, b. 792. 97 G.P. BUSTREO, L’archivio di San Nicolò… cit., pp. 142-143; ID., Le terre e le case dei frati… cit., pp. 10-11, 127-128. 98 ASTV, CRS.MC, S. Francesco, Registri di entrate e uscita, b. 29. 99 Cfr. supra, nota 79. 100 A. BARTOLI LANGELI - N. D’ACUNTO, I documenti degli ordini mendicanti… cit., p. 389. 101 Espressione tratta da A. BARTOLI LANGELI, I libri dei frati. La cultura scritta dell’Ordine dei minori, in Francesco d’Assisi… cit., p. 295, nella fattispecie usata in riferimento alla cultura libraria dei francescani. Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 157 di natura processuale 102. La tabella che segue riporta i dati relativi alla produzione di scrittura su registro e alla diversificazione delle tipologie documentarie tra il secolo XIV e i primi decenni del Cinquecento. Sulla prima colonna compare la denominazione dell’ente produttore — quasi tutti gli enti sono di antica fondazione, fatta eccezione per le cassinesi di S. Maria delle Grazie di Mestre (1490) e i minori conventuali di S. Maria delle Grazie di Motta (1484) e di S. Giovanni Battista di Serravalle (sec. XV) — sulla seconda l’elenco delle serie che vedono la luce durante il periodo, nella terza la data iniziale della tipologia documentaria: Ognissanti di Treviso, benedettine S. Cristina e S. Parisio, camaldolesi S. Francesco di Treviso, minori conventuali S. Margherita di Treviso, eremitani Registri degli affittuari Libri dei resti Libri dei debitori Libri di cassa Giornali di entrata e spesa Registri degli affittuari Catastici delle rendite Libri del granaio “Vacchette” di amministrazione Registri di entrata e uscita Quaderni del procuratore Registri delle esazioni “Vacchette” di spese Locazioni Registri “campione” Locazioni Libri di affitti e spese Locazioni Libri “campione” 1432 1435 1472 1358 1489 1378 1395 1363 1478 1363(?) 1478 1485 sec. XV 1483 1495 1313 1474 sec. XV 1445 S. Maria e S. Teonisto di Treviso, benedettine S. Maria Maggiore di Treviso, benedettini poi canonici regolari di S. Salvatore S. Maria Nova di Treviso, cistercensi Quaderni di amministrazione delle rendite livellarie 1480 S. Nicolò di Treviso, domenicani Libri dei religiosi avviati alla professione, morti ed elenchi dei priori 1458 Locazioni 1471 Catastici dei beni 1351 Registri di cassa della sacrestia. Prima serie 1449 Libri del “sindico” 1506 Libri del granaio 1422 Giornali del procuratore 1463 Registri “riceveri” 1361 Registri dei debitori verso il convento 1512 “Vacchette” di spese diverse 1491 (?) Libri di fabbriche 1506 Registri della sacrestia 1336 102 Questo il quadro emergente dal censimento del fondo Corporazioni religiose soppresse. Monasteri e conventi presso l’Archivio di Stato di Treviso. 158 Ermanno Orlando S. Paolo di Treviso, domenicane SS. Quaranta di Treviso, canonici regolari lateranensi S. Francesco di Conegliano, minori conventuali Istrumenti Locazioni Catastici dei beni Registri di cassa Libri del granaio Giornali del “procuratore” Giornali del “bursario” Registri “riceveri” Locazioni Libri degli affittuari Istrumenti Libri di affittanze Inventari dei beni Libri delle entrate Registri di amministrazione Locazioni Catastici dei beni 1430 1501 1410 1498 1498 1476 1467 1474 1485 1517 1435 1474 1451 1468 1506 1510 1493 S. Maria Mater Domini di Conegliano, clarisse di S. Damiano poi benedettine 1447 SS. Martino e Rosa di Conegliano, Istrumenti e locazioni 1424 crociferi Obblighi di messe 1518 Libri e catastici delle rendite 1513 Libri “maestri” S. Maria delle Grazie di Mestre, Libri di ricevute 1492 cistercensi 1390 S. Maria e S. Girolamo del Montel- Catastici delle scritture sec. XV lo, certosini Istrumenti 1501 Locazioni sec. XIV Inventari dei beni 1489 Libri di cassa 1487 Libri degli affittuari 1481 Libri dei resti S. Maria delle Grazie di Motta, mi- Libri di entrata e spesa 1503 nori conventuali Libri “maestri” 1506 S. Maria di Follina, cistercensi Libri degli affittuari 1451 S. Giovanni Battista di Serravalle, Istrumenti 1491 minori conventuali S. Giustina di Serravalle, agostiniane Catastici dei beni 1431 “Vacchette” dei versamenti degli af1497 fittuari 1507 Libri “maestri” di amministrazione 1475 Libri di ricevute Come appare dalla tabella, si tratterebbe dunque, per le scritture ordinarie prodotte dagli istituti religiosi, di un ritardo di maturazione, di una situazione che fatica a decollare e che si sblocca definitivamente in stretta dialettica con l’inserimento delle comunità in un paesaggio istituzionale, politico ed economico profondamente mutato dalla presenza — a tale data articolata e Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 159 capillare — della Dominante veneta. È lo stato regionale che ora, con forte senso pragmatico, indirizza, organizza, garantisce, media, seppur tra inevitabili incertezze e ambiguità. Interviene sul patrimonio ecclesiastico, considerato una « riserva importante per le esigenze finanziarie » dello Stato « così come per gli appetiti e le aspirazioni delle aristocrazie di governo » 103, ora disciplinando i processi di erosione delle proprietà fondiarie, ora favorendone i meccanismi di spoliazione, talvolta al contrario difendendo le istituzione ecclesiastiche in ragione di esigenze superiori di sicurezza e ordine interno 104. Ne discende tutta una teoria di leggi talora contraddittorie, ma nell’insieme rivolte — come è stato detto 105 — a semplificare i diritti di possesso, ad equilibrare la configurazione patrimoniale delle campagne della Terraferma e in qualche modo a sancire le situazioni già esistenti. Così nel 1412, per tutelare i beni degli enti ecclesiastici, il Senato veneziano proibiva le affittanze a « gran tempo », fatte « con danno et iactura delle chiese », prescrivendo che tali affittanze non dovessero superare i tre anni con l’eccezione « si affictentur personis villarum que acciperent pro laborando personaliter ipsas possessiones aut terrena et hoc possint fieri solum per tempus ab annis quinque ». Un modo per evitare le conseguenze dei contratti d’affitto a lunga e lunghissima scadenza che in sostanza comportavano, per le comunità religiose, la perdita dei diritti reali sul fondo 106. Di contro, una legge del Senato del 1451 consentiva a coloro che avessero lavorato terreni ecclesiastici per oltre 40 anni, dietro certificabile pagamento di una « uniforme pensione », di essere riconosciuti come enfiteuti, con il diritto di mantenere inalterato il canone per il futuro e il 103 G. CHITTOLINI, Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell’Italia centrosettentrionale del Quattrocento, in Storia d’Italia. Annali, La chiesa e il potere… cit., p. 170; G. CHITTOLINI, Note sulla politica ecclesiastica degli stati italiani nel sec. XV (Milano, Firenze, Venezia), in État et Église dans la genèse de l’État moderne, a cura di J.P. GENET - B. VINCENT, Madrid 1986, pp. 195 sgg. Sulla politica religiosa della Dominante veneta nella prima età moderna si vedano pure G. COZZI, La politica religiosa, in La repubblica di Venezia nell’età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517, Storia d’Italia, XII/1, Torino 1986, pp. 233-252; P. PRODI, The structure and organisation of the Church in the Renaissance Venice: suggestions for research, in Renaissance Venice, ed. by R. HALE, London 1974, pp. 409-430. 104 G. CHITTOLINI, Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche… cit., pp. 171-173. 105 G.M. VARANINI, Proprietà fondiaria e agricoltura… cit., p. 828; A. PIZZATI, Commende e politica ecclesiastica nella Repubblica di Venezia tra ’500 e ’600, Venezia 1997, p. 96 (Istituto veneto di scienze, lettere e arti. Memorie. Classe di scienze morali, lettere ed arti, LXX). 106 M. FASSINA, « Astrenzer i contadini a lasciar stare il monastero ». Le disavventure delle proprietà di un ente ecclesiastico in una comunità contadina nel XVI secolo, in « Annali Veneti. Società cultura istituzioni », I (1984), 1, pp. 148-149; G.M. VARANINI, Proprietà fondiaria e agricoltura… cit., p. 829; C.M. CIPOLLA, Une crise ignorée. Comment s’est perdue la proprieté ecclesiastique dans l’Italie du nord entre le XI et le XVI siécle, in « Annales. Economie, Societé, Civilisation », II (1947), pp. 321-322; cfr. pure G. CHITTOLINI, Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattrocento e Cinquecento, in « Rivista storica italiana », LXXXV (1973), 2, pp. 353-393, ma soprattutto pp. 353-355, 362-363, 369-370; ID., Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche… cit., p. 172; ID., Note sulla politica ecclesiastica… cit., pp. 204-205. Ermanno Orlando 160 privilegio di non poter essere escomiati dal fondo 107. Un intervento normativo, dunque, che all’opposto traduceva e favoriva le dinamiche di spossessamento della proprietà ecclesiastica, garantendo al colono una sorta di investitura perpetua sul fondo a canone irrisorio e in rapida svalutazione. Meccanismi sui quali si inseriva prontamente l’inframmettenza laica, e in primo luogo gli investitori fondiari veneziani, comportando in breve tempo l’allontanamento dell’ente dai diritti di proprietà 108. Ancora, l’attenzione della Dominante si rivolge al controllo dei benefici ecclesiastici 109 e alle ricche commende abbaziali. D’altronde — come è stato da più parti rilevato — la commenda rappresenta uno strumento di forte incidenza sul patrimonio monastico, di subordinazione delle case religiose agli interessi della nobiltà lagunare, e un canale privilegiato di trasferimento di rendite — sia in natura che in denaro — verso i mercati e i magazzini della capitale 110. Non sembra davvero un caso, in tal senso, che quegli stessi assi fluviali che avevano marcato la penetrazione fondiaria nell’entroterra trevigiano accompagnino pure, a partire dalla seconda metà del Trecento, la pressione esercitata dall’aristocrazia veneziana per l’accaparramento delle ricche commende abbaziali: S. Bona di Vidor, S. Andrea di Busco, S. Pietro di Colle 111, S. Maria di Follina, S. Maria del Monte e S. Polo di Conegliano 112, sono infatti tutti monasteri situati in prossimità o nelle vicinanze del corso sinuoso del Piave. La presenza vigile della Repubblica indirizza e ordina pure la straripante vivacità, la forza di espansione e la capacità di presa sulla devozionalità popolare propri del movimento delle « osservanze », imprimendole connotazioni fortemente regionali; si pensi alla congregazione di S. Giustina, nell’estendersi del cui movimento la Serenissima vide « la possibilità di allargare l’influenza veneziana a monasteri di tutta Italia » 113; alla associazione dei 107 M. FASSINA, Astrenzer i contadini… cit., p. 151; A. PIZZATI, Commende e politica… cit., p. 97; BUSTREO, Le terre e le case dei frati cit., p. 100. 108 G. CHITTOLINI, Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche… cit., p. 172; M. FASSINA, Astrenzer i contadini… cit., pp. 151-153; G.P. BUSTREO, Le terre e le case dei frati… cit., pp. 111-113. 109 G. CHITTOLINI, Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche… cit., p. 174; ID., Note sulla politica ecclesiastica… cit., pp. 197-202. La politica di controllo esercitata dal governo e dal patriziato veneziano sulla provvista dei benefici ecclesiastici secolari in G. DEL TORRE, Stato regionale e benefici ecclesiastici: vescovadi e canonicadi nella terraferma veneziana all’inizio dell’età moderna, in « Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti », CLI (1992-93), pp. 1171-1236. 110 G.M. VARANINI, Proprietà fondiaria e agricoltura… cit., pp. 829, 836-839. 111 Sulle vicende di splendore e decadenza di tali monasteri si veda P.A. PASSOLUNGHI, Abbazie soggette a Pomposa in diocesi di Ceneda (S. Andrea di Busco, S. Maria e S. Bona di Vidor, S. Pietro di Colle), in « Benedictina », 14 (1977), pp. 225-250. 112 Sui monasteri di S. Maria del Monte e S. Polo di Conegliano vedi ID., Il monachesimo benedettino… cit., pp. 133-136, 172-175. 113 G. CHITTOLINI, Note sulla politica ecclesiastica… cit., p. 203. Sulla congregazione di S. Giustina, nel contesto più ampio dei movimenti di riforma del monachesimo veneto, si rimanda al Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 161 monasteri camaldolesi della Terraferma veneta alla congregazione di S. Michele di Murano (1474) 114; agli agostiniani osservanti che nel 1436 danno vita alla congregazione di Monte Ortona; ai serviti associati in S. Maria di Monte Berico di Vicenza; alla provincia veneziana dei carmelitani eretta per scongiurare pericolose invadenze da parte della congregazione mantovana (1473) 115. Favorire l’affermazione di congregazioni regolari su base regionale significava ampliare e rendere più solido il controllo sulle case monastiche riformate della Terraferma; significava certo comprimere gli spazi di condizionamento esercitati dalla nobiltà veneziana sulle risorse del clero regolare, ma altresì assicurarsi sostegni e solidarietà per una più efficace politica di intervento sulla vita sociale, per il mantenimento dell’ordine pubblico e per sostenere l’azione caritativa e pastorale promossa dalla stessa compagine statale. Una strada tuttavia, questa del patrocinio dell’osservanza, niente affatto praticata per il Trevigiano, dove Venezia sembra piuttosto incoraggiare l’affermazione della struttura commendataria e gli spazi di controllo più stretto e sistematico ad essa collegati. Un interesse al mantenimento del regime commendatizio che — come è stato rilevato per altre situazioni simili — pare ovvio, quasi scontato, trattandosi di un sistema pienamente funzionale, per motivi clientelari, economici e politici, agli interessi della Dominante: ci si poteva rinunciare solo in presenza « di interessi politici superiori » 116, non certamente nel caso di una città, quale per l’appunto Treviso, precocemente costretta ad un ruolo di subalternità politica, in difficoltà istituzionale, soffocata dalla vicinanza prevaricante della capitale. Nel paesaggio profondamente modificato dalla presenza sollecitante del neonato Stato regionale non intervengono, ovviamente, solo modificazioni di natura politico-istituzionale; vistose sono parimenti le alterazioni apportate al sistema dalla pressione economica e commerciale, dalla penetrazione fondiaria e dalle strategie di presenza patrimoniale della vicina città lagunare 117. Con volume Riforma della chiesa, cultura e spiritualità nel Quattrocento veneto. Atti del convegno per il VI centenario della nascita di Ludovico Barbo (1382-1443), Padova, Venezia, Treviso, 19-24 settembre 1982, a cura di G.B.F. TROLESE, Cesena 1984 (Italia Benedettina, 6), in particolare i saggi di Gregorio Penco, Giovanni Battista Francesco Trolese, Luigi Pesce, Willibrord Witters, Mario Fois, Giorgio Picasso, Cosimo Damiano Fonseca, Valerio Cattana, Venturino Alce, Emanuele Boaga e Silvana Collodo). 114 Cfr. C. CABY, De l’érémitisme rural… cit., pp. 762-771. 115 G. CHITTOLINI, Note sulla politica ecclesiastica… cit., pp. 202-204; ID., Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche… cit., pp. 174-175; G. ZARRI, Aspetti dello sviluppo degli ordini religiosi in Italia tra Quattro e Cinquecento. Studi e problemi, in Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, a cura di P. PRODI, P. JOHANEK, Bologna 1984, pp. 250-252. 116 117 G. ZARRI, Aspetti dello sviluppo degli ordini religiosi… cit., p. 241. Per un primo approfondimento si vedano almeno D. BELTRAMI, La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961; M. KNAPTON, Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso, in Tomaso da Ermanno Orlando 162 tale vivacità di presenza economica, anzi, Treviso impara ben presto a convivere e a fare i conti, giungendo in breve tempo a ritagliarsi spazi di intervento del tutto integrati con le esigenze della Dominante. Si prefigura in tal senso quella « profonda, intima compenetrazione fra società ed economia veneziana, ed istituzioni società economia della più vicina città di Terraferma » 118, che hanno indotto a parlare, per Treviso, di uno sviluppo precocemente integrato e non concorrenziale tra economie complementari, l’economia veneziana e quella appunto trevigiana, e della creazione di un mercato « subregionale », funzionale alle richieste della Dominante e da questa apertamente controllato 119. Un bacino di rifornimento vicino e sicuro dunque, su cui Venezia afferma tutta una serie di solidarietà economico-commerciali indirizzate soprattutto ad assicurarle i fabbisogni alimentari di frumento e vino, e che determina l’immissione della produzione locale, compresa quella rilevante delle case religiose trevigiane, nei circuiti economici e nei mercati commerciali controllati dalla Serenissima 120. Un’ultima annotazione: se il baricentro del sistema politico, istituzionale, economico sembra tutto sbilanciato a favore della presenza strutturata e diffusa dello Stato regionale, sul reticolato di rapporti approntato e regolato dalla Dominante, non sfugge tuttavia il ruolo, seppur meno appariscente, più contenuto, svolto dalla comunità cittadina in ordine alla regolazione e al controllo del clero regolare e delle sue proprietà. In particolare, non si dimentica l’azione di patronato e tutela, di cui si sono già esemplificati casi significativi relativamente al XIV secolo, esercitata dal governo cittadino sui monasteri femminili, con azioni ripetute di stimolo, di riforma e di risanamento anche patrimoniale 121; o ancora la creazione, sull’esempio della vicina Padova, di una magistratura di « Provisores Ecclesiarum » con il compito di provvedere al buono stato di chiese e monasteri, dato « quod ecclesie, monasteria, domus etcetera, possessiones eorumdem male gubernantur et tendunt in ruinam » 122. Pur in un quadro di soggezione politica e ridimensionamento istituzionale la città sente dunque di dover garantire e regolamentare le istituzioni monastiche, in particolar modo quelle comunità femminili il cui ordinato Modena e il suo tempo… cit., pp. 43-46; G. DEL TORRE, Il Trevigiano nei secoli XV e XVI. L’assetto amministrativo e il sistema fiscale, Venezia 1990, pp. 7-9. 118 G.M. VARANINI, Proprietà fondiaria e agricoltura… cit., p. 829. 119 Utili indicazioni in materia ibid., p. 809; ID., Società ed economia a Legnago, in B. CHIAPPA - S. DALLA RIVA - G.M. VARANINI, L’anagrafe e le denunce fiscali di Legnago (143032). Società ed economia di un centro minore della pianura veneta nel Quattrocento, Verona 1997, pp. 11-12; M. KNAPTON, Venezia e Treviso nel Trecento… cit., pp. 51-52. 120 G.M. VARANINI, Proprietà fondiaria e agricoltura… cit., p. 809. 121 G. ZARRI, Aspetti dello sviluppo degli ordini religiosi… cit., p. 256; G. CHITTOLINI, Note sulla politica ecclesiastica… cit., p. 207. 122 ASTV, Comunale, b. 4825, fasc. A; sulla costituzione di tale magistratura a Padova si veda A. RIGON, Vescovi e monachesimo… cit., p. 175. Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 163 o disordinato governo « chiama in causa l’onore o il disonore delle casate e dell’intera città » 123. 9. Politiche patrimoniali e specializzazione delle scritture d’archivio. — È un mondo, in definitiva, quello della Terraferma veneta del XV secolo, che appare profondamente mutato, contrassegnato da una intensa circolazione di uomini, merci e scritture, da un accentuato dinamismo delle relazioni e dalla presenza diffusa dello Stato regionale. Il problema che ci si pone è allora quello di verificare le reazioni delle case religiose trevigiane di fronte a tali modificazioni strutturali, è considerare la qualità delle risposte date dai monasteri e dai conventi investiti dall’onda di piena delle nuove realtà politiche, economiche ed istituzionali. Diciamolo subito: si tratta generalmente di risposte contratte, talora affannate, tese al mantenimento di una propria configurazione giuridica, patrimoniale ed economica piuttosto che a trarre nuova linfa dalla pluralità di mutamenti in atto. Per quanto riguarda le strategie patrimoniali — quelle che più ci interessano, perché è proprio dall’amministrazione del patrimonio e delle sue rendite che discendono in gran parte le scritture correnti e di relazione di cui ci stiamo occupando — prevale una concezione fortemente conservativa: si tratta in sostanza, di fronte all’aggressività dell’elemento laico e all’ingerenza dello Stato, di difendere e conservare i beni dell’ente e di garantirsi un gettito stabile dalle rendite patrimoniali. L’obiettivo primario sembra essere generalmente quello del mantenimento del possesso fondiario in funzione di una rendita sicura e conveniente, capace di preservare la comunità dalle difficoltà di tutti i giorni. Relativamente alla produzione, si punta soprattutto sulla coltivazione del frumento, più spendibile sul mercato cittadino e maggiormente richiesto dai flussi commerciali controllati e sollecitati dalla città lagunare. Il frumento risulta essere infatti un bene massicciamente consumato e facilmente monetizzabile, quindi in grado di assicurare alla comunità quella disponibilità di liquido così necessario in una economia monetaria quale quella collegata a Venezia 124. Solo a partire dal più maturo Quattrocento, dunque, in corrispondenza di un panorama così mosso e condizionante, in ragione dell’apporto di forze plurime e diversificate quali quelle descritte, e in presenza di trasformazioni profonde del paesaggio istituzionale, sociale ed economico sembra plausibile parlare di implementazione delle scritture correnti e di specializzazione delle tipologie documentarie dei monasteri e dei conventi trevigiani. Una tendenza alla diversificazione delle carte e ad una maggiore articolazione dei criteri di 123 124 G. ZARRI, Monasteri femminili e città… cit., p. 379. Per queste riflessioni ci si è ampiamente ispirati a G.P. BUSTREO, Le terre e le case dei frati… cit., soprattutto pp. 53-71 e 102-103; cfr. inoltre F. LANDI, Il paradiso dei monaci. Accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna, Roma 1996, pp. 98-99, 104-105. Ermanno Orlando 164 redazione suggestivamente esemplificata dalle annotazioni introduttive di alcuni registri contabili della Certosa del Montello, compilati a cavallo dei secoli XV e XVI, e che ora si vorrebbe — in conclusione — rapidamente far scorrere. A cominciare dal libro « del monasterio del Montello de debitori et creditori (…) per io don Illarion procurador tenuto » 125, ove il redattore, con un linguaggio diffuso e ricco di particolari, propone una sorta di guida alla documentazione corrente del cenobio, alle strutture formulari dei registri d’amministrazione e ai loro contenuti. Da tale vademecum approntato per orientare gli amministratori del monastero e in qualche modo per dominare una ricchezza di scritture allora sì debordante e difficile da controllare, siamo informati della varietà di tipologie documentarie prodotte dalla certosa e sulle loro caratteristiche intrinseche. Eccone alcuni passaggi. Un « libro dela cassa » in cui si annotano « tutti li danari intrà in cassa sì de fiti come de robe se vendesse over se schodesse da debitori over per elamosina », indicante l’ammontare dei « danari scossi et da chi et perché »; un libro del « procurator » contenente « tuti li danari se spende per chaxa sì in viver come vestir e calzar, opere et altre persone »; un registro « zornal (…) nel qual è notado tuti li bestiami, formazi, butiri, puine, formenti, vini et altre biave se schuode de fiti over tuolse in pagamento »; un « libro de fiti (…) de tuti li nostri afituali », comprensivo di « quel li paganno ogni anno de fito » con l’avvertenza che « poi scodando biave se porta in zornal »; un libro « de resti de debitori, sì boni chome tristi, sì vivi chome morti », ordinati « per alphabeto dove stanciano al presente vel circa »; infine, un « libro chiamato memorial », in cui viene registrato « quel achade per zornata, per non atenir su polize, poi spazato da nota et depenà ». Ma si badi bene, non una cronaca delle vicende della certosa, ma solo una regolazione delle opere dovute al cenobio dai propri coloni: « opere a segar, restelar, cerpir, serar i prà, serar le piantade et altri bisogni del monasterio ». È ancora da una nota introduttiva ad un registro contabile, questa volta il libro « chassa 1500-1506 » 126 di mano del priore della certosa Stefano Trevisan, che veniamo a conoscenza delle poche ma chiare avvertenze che si debbono tenere nella compilazione del registro, affinché « fato questo ordene non temer che le tue scriture non siano laudate »: « meni el numero di danari distintamente intro ala partide e chavà fuori per l’abacho; item dà la persona che tu rezevi li danari; item per che cossa el te dà li diti danari; item el tempo te numera diti danari », precisando che « el tempo vuol sopratuto el zorno, mese et anno ». Per finire con l’introduzione esplicativa del libro dei « resti » relativo agli anni 1474-1480 127, ove il compilatore si premura di precisare che « presens 125 ASTV, CRS.MC, S. Maria e S. Girolamo, Libri dei resti, b. 2. 126 Ibid., Libri cassa, b. 2. 127 Ibid., Libri dei resti, b. 23. Documentazione a registro dei monasteri e conventi trevigiani 165 (…) liber tenebitur secundum more venetiarum, et deinceps conscribentur in eo omnes introitus et exitus domus tam in pequniis quam in omnibus aliis, sub forma (ut dictum est) librorum mercatorum venetorum »: un incipit particolarmente interessante, che ci prospetta e conferma un quadro di adozione e diffusione delle tecniche di contabilità su partita contrapposta, in dare e in avere, in anticipo di alcuni decenni rispetto alla pubblicazione a Venezia del Tractatus particularis de computis et scripturis di Luca Paciolo, avvenuta nel 1494 128. ERMANNO ORLANDO Progetto “Anagrafe” Archivio di Stato di Treviso 128 TERIO, L. PACIOLI, Trattato di partita doppia. Venezia 1494, edizione critica a cura di A. CONintroduzione e commento di B. YAMEY, nota filologica di G. BELLONI, Venezia 1994. CENSIMENTI E MEZZI DI CORREDO ARCHIVISTICI RIFLESSIONI IN MARGINE AL CENSIMENTO DEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI DELLA DIOCESI DI BERGAMO * Quasi sospesi tra giurisdizione ecclesiastica e intervento statale, normativa canonica e legislazione civile, gli archivi ecclesiastici hanno vissuto in Italia, tra Otto e Novecento, tutte le difficoltà e le contraddizioni del confronto tra le due istituzioni, a partire dalle pesanti ingerenze statali nell’amministrazione del patrimonio ecclesiastico e nello svolgimento delle attività pastorali del periodo napoleonico e della Restaurazione (di cui troviamo immediati riflessi nelle carte diocesane e parrocchiali). Anche nel campo specifico della tenuta degli archivi, l’intervento statale andò sempre più sovrapponendosi a quello della Chiesa con l’aprirsi ed il cronicizzarsi della « questione romana ». Infatti, se la Chiesa, nel solco di una tradizione che riporta alla celebre costituzione Maxima vigilantia emanata da Benedetto XIII nel 1727 1, diramava * Ringrazio vivamente per le informazioni fornitemi con generosità: Antonio Pesenti, archivista e cancelliere della diocesi di Bergamo, Livio Sparapani e Giancarlo Manzoli, rispettivamente archivisti delle diocesi di Trento e di Mantova e Anna Picchi e Lucia Cecchi degli archivi diocesani di Como e Pistoia; Renata Da Nova e Anna Gonnella della Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia, Andreina Bazzi e Marina Messina della Soprintendenza archivistica per la Lombardia, Domenica Porcaro Massafra della Soprintendenza archivistica per la Puglia; Paola Benigni della Soprintendenza archivistica per la Toscana; Giorgetta Bonfiglio Dosio dell’Università degli studi di Padova e Roberto Grassi dell’Assessorato alla cultura della Regione Lombardia. Devo un sincero grazie a Pasquale Galata della biblioteca del Seminario vescovile di Bergamo e a Maria Pacella dell’Archivio di Stato di Bergamo per la grande disponibilità dimostrata durante le mie ricerche nei loro istituti ed a Roberto Navarrini, dell’Università degli studi di Udine, per i preziosi consigli. Ultimo, ma non certo perché meno sentito, un grazie con affetto filiale all’indimenticabile mons. Mario Benigni, già direttore del Centro studi « Giovanni XXIII », che mi ha chiamato a seguire da vicino la grande e bella avventura del censimento e dei corsi per archivisti parrocchiali, unendo all’esempio di intelligente e colta operosità anche un alto insegnamento morale quando la vita gli ha proposto la dura prova della sofferenza fino a toglierlo prematuramente alla Chiesa ed agli amici. 1 Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum. Documenta potiora Sanctae Sedis de archivis ecclesiasticis a Concilio Tridentino usque ad nostros dies, a cura di S. DUCA e P. SIMEON, Città del Vaticano 1966, pp. 104-116 (il testo della costituzione); pp. 331-336 (« Istruzione per le scritture da riporsi negli archivi »). Cfr. G. BADINI, Archivi e chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna 1984, pp. 81-82. Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 167 nel 1902, il Regolamento per la custodia e l’uso degli archivi e biblioteche ecclesiastiche di qualsiasi natura 2, e nel 1907 ordinava l’istituzione, in ciascuna diocesi, di un Commissariato diocesano pei documenti e monumenti custoditi dal clero (incaricato, tra l’altro, di redigere « cataloghi » di tali beni) 3, lo Stato italiano, da parte sua, non perdeva occasione per affermare il proprio controllo sugli archivi ecclesiastici. Oltre a quelli delle corporazioni religiose soppresse, di cui si prevedeva il trasferimento presso pubbliche biblioteche e musei e negli Archivi di Stato 4, furono sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione statale quelli « delle curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione » 5 e quelli degli enti morali ecclesiastici, accomunati a Province, Comuni e agli altri enti morali nelle norme sulla tenuta degli archivi contenute nei già citati regolamenti del 1902 e del 1911 che giungevano fino a prevedere forme di intervento sostitutivo da parte dello Stato in caso di inosservanza (ordinamento ed inventariazione a spese del possessore). Le prescrizioni in materia di archivi contenute nel Codex Juris Canonici del 1917 6 e le sollecitazioni per un’intensificazione dell’attività dei Commissariati diocesani rivolte ai vescovi dalla Segreteria di Stato con la circolare del 15 aprile 1923 7, ridiedero vigore all’iniziativa ecclesiastica, mentre il quadro normativo statale era destinato a mutare radicalmente in seguito al Concordato dell’11 febbraio 1929 che, pur senza fare esplicita menzione degli archivi, all’art. 30 escludeva ogni intervento da parte dello Stato italiano nella « gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa », riservando vigilanza e controllo alle competenti autorità della Chiesa 8. Coerentemente, la rinuncia dello Stato all’esercizio della vigilanza sugli archivi ecclesiastici si tradusse nel silenzio, al riguardo, delle due successive e fondamentali leggi archivistiche: la n. 2006 del 22 dicembre 1939 e il d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409 che hanno lasciato alla sfera dei rapporti personali e comunque all’adesione spontanea della 2 Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum... cit., pp. 163-186. 3 Ibid., pp. 186-188. 4 R.d. per la soppressione delle Corporazioni religiose 7 lug. 1866, n. 3036, art. 24; r.d. 9 set. 1902, n. 445, che approva il regolamento generale per gli Archivi di Stato, art. 69; r.d. 2 ott. 1911, n. 1163, Regolamento per gli Archivi di Stato, art. 73. All’obbligo del versamento erano però sottratti gli archivi fatti oggetto di disposizioni speciali in deroga e « quelli della cui buona conservazione si avessero sufficienti garanzie ». 5 Art. 22 del r.d. 27 mag. 1875, n. 2552, Regolamento per l’ordinamento generale degli Archivi di Stato. 6 Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum... cit., pp. 189-193. 7 Ibid., pp. 194-203. 8 L. 27 mag. 1929, n. 810, Esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del concordato sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia l’11 febbraio 1929, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (d’ora in poi G.U.), n. 130 del 5 giu. 1929. Il testo del concordato è alle pp. 2527-2532; l’art. 30 a p. 2531. 168 Juanita Schiavini Trezzi parte ecclesiastica, eventuali accordi per iniziative congiunte a favore degli archivi ecclesiastici. In questo quadro hanno operato, da allora, sia gli organismi pubblici e privati che hanno realizzato convegni, corsi di archivistica ecclesiastica, riordinamenti, mostre, edizioni di guide ed inventari 9, sia la l. 23 maggio 1952, n. 630 (ripetutamente prorogata fino al 1975) che ha finanziato soprattutto l’acquisto di scaffalature metalliche nell’ambito della lotta antitermitica, sia le leggi speciali emanate dagli anni ’70 in occasione di calamità naturali per il recupero e la salvaguardia dei beni culturali, ai cui finanziamenti sono stati ammessi anche gli archivi ecclesiastici 10. È degno di nota il fatto che le dichiarazioni di notevole interesse storico emesse da alcune Soprintendenze archivistiche ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 1409/63 nei confronti di archivi ecclesiastici, considerati, con una notevole forzatura, alla stregua di archivi privati, sono scaturite (e non poteva essere diversamente) da accordi bilaterali o su richiesta delle autorità ecclesiastiche, spesso al fine di consentire l’erogazione di contributi statali per il restauro della documentazione d’archivio. Per disporre di una cornice normativa più adeguata a sviluppare l’« alleanza » così avviata tra Stato e Chiesa, si sarebbe dovuto attendere il nuovo Concordato del 1984 il cui art.12, in logica correlazione con la nuova impostazione generale data ai rapporti tra le due istituzioni, ne sanciva la collaborazione in materia di tutela del patrimonio storico e artistico, rinviando la definizione delle modalità di conservazione e consultazione degli archivi ecclesiastici a più specifiche intese tra i competenti organi delle due parti 11. Primo frutto del nuovo contesto è stata la l. 5 giugno 1986 n. 253 che prevede la concessione di contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi privati sottoposti a vincolo nonché degli archivi ecclesiastici che, a giudizio del soprintendente archivistico competente per territorio, rivestano interesse storico e i cui titolari si impegnino al rispetto 9 Se ne vedano i puntuali resoconti nella « Rassegna degli Archivi di Stato », in « Archiva Ecclesiae » ed in « Archivi per la storia », rivista dell’Associazione nazionale archivistica italiana. 10 E. TERENZONI, Ordinamenti e restauri di archivi ecclesiastici in base alle leggi di finanziamenti speciali. Alcune questioni di metodo, in « Archiva Ecclesiae », 38-39 (1995-1996), pp. 147-162. 11 L. 25 mar. 1985 n. 121 di ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, pubblicata nel supplemento ordinario n. 28 alla G.U. n. 85 del 10 apr. 1985. Il testo di una prima Intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche è stato firmato il 13 set. 1996 e pubblicato nella G.U., n. 262 dell’8 nov. 1996. Cfr. anche, più oltre, la nota 15. Ulteriori progressi nella determinazione delle modalità di collaborazione sono stati compiuti con l’intesa, riguardante in maniera specifica i beni archivistici, firmata il 18 aprile 2000, divenuta esecutiva per l’Italia con d.p.r. 16 mag. 2000, n. 189 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 lug. 2000. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 169 degli obblighi imposti ai privati dall’art. 38 della legge archivistica del 1963 12. Nel frattempo, una serie di iniziative di parte ecclesiastica ne aveva accentuato l’impegno in campo archivistico: istituzione nel 1955 della Commissione permanente per gli archivi ecclesiastici d’Italia 13, nascita nel 1956 dell’Associazione archivistica ecclesiastica, la cui opera assidua e di alto profilo scientifico trovava ben presto voce e testimonianza nella rivista « Archiva Ecclesiae » (edita dal 1958), direttive dei sinodi e dei vescovi delle singole diocesi 14, per culminare con la promulgazione nel 1983 del nuovo Codex Iuris Canonici che, impartendo precise disposizioni, in parte confermava, in parte innovava ma anche esplicitava quanto adombrato nel testo del 1917 dove la conservazione delle scritture era assorbita nella disciplina generale di tutela del patrimonio artistico e storico della Chiesa. « Tutti i documenti che riguardano la diocesi o le parrocchie devono essere custoditi con la massima cura (...) » (can. 486). « Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari di cui uno sia conservato nell’archivio della rispettiva chiesa e l’altro nell’archivio diocesano (...) » (can. 491). « In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità e utilità; tutti questi libri e documenti devono essere ispezionati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita pastorale o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che essi non vadano in mano di 12 G DE LONGIS CRISTALDI, Interventi e contributi dello Stato a favore degli archivi ecclesiastici, in « Archiva Ecclesiae », 34-35 (1991-1992), pp. 85-92. Come ben rimarca l’autrice, ancora una volta si deve alla particolare posizione giuridica degli enti ecclesiastici e all’impossibilità, da parte dell’Amministrazione archivistica, di intervenire unilateralmente, il diverso trattamento riservato dalla legge agli archivi ecclesiastici rispetto a quelli privati che si manifesta laddove per i primi non è previsto il provvedimento amministrativo della dichiarazione di notevole interesse storico nelle forme fissate dall’art. 36 del d.p.r.1409/63. 13 Lettera della Segreteria di Stato al card. Mercati 5 apr. 1955 in Enchiridion ... cit., pp. 246-247. Nel 1988 è stata invece creata la Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico (tra cui sono annoverati anche i documenti conservati negli archivi e nelle biblioteche). GIOVANNI PAOLO II, Pastor bonus. Costituzione apostolica sulla curia romana 28 giu. 1988, art. 101, riportata in: Archivi ecclesiastici e legislazione concordataria dopo il nuovo accordo tra Stato e Chiesa. Atti del seminario di studio. Bari 23-24 marzo 1988, a cura di G. DAMMACCO, in « Archivi per la storia », II (1989), 1, p. 197. 14 Sugli interventi della Santa Sede a favore degli archivi ecclesiastici italiani da Leone XIII a Giovanni XXIII (in particolare durante la seconda guerra mondiale), sull’attività della Associazione Archivistica Ecclesiastica e per una carrellata su iniziative realizzate da istituzioni diverse negli anni ’70 v. G. BATTELLI, Gli archivi ecclesiastici in Archivi biblioteche ed editoria libraria per la formazione culturale della società italiana. Atti del convegno nazionale di Grottaferrata 22-25 giugno1978, Roma, s.d., pp. 81-100. 170 Juanita Schiavini Trezzi estranei. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente secondo le disposizioni del diritto particolare » (can. 535) 15. 15 Codex Juris Canonici (promulgato nel 1983). Edizione bilingue commentata a cura di P. LOMBARDIA e J.I. ARRIETA, I-III, Roma 1986-1987. Per una più agevole ricerca è possibile utilizzare L. CHIAPPETTA, Dizionario del nuovo codice di diritto canonico. Prontuario teoricopratico, Napoli 1986 2. Le voci « archivio diocesano » e « archivio parrocchiale » alle pp. 44-45, con edizione integrale dei canoni dal testo più breve e sintetizzata di quelli più articolati. Disposizioni sulla tenuta degli archivi ecclesiastici si trovano anche nei canoni 482, 487-490, 1283-1284 e 1306, mentre molto più numerosi sono i cenni occasionali, dati in canoni sparsi nel testo, in cui si parla di materiale archivistico e della registrazione di atti. Estratti delle principali fonti della vigente normativa canonica, ma anche pattizia, statuale e regionale, sono stati pubblicati in: Archivi ecclesiastici e legislazione concordataria ... cit., pp. 177-203. Ivi numerosi altri contributi dedicati ad analisi della norma concordataria nonché delle prospettive aperte dalla cooperazione tra la Chiesa e lo Stato italiano per la tutela e valorizzazione degli archivi ecclesiastici. Allo stesso tema è stato dedicato ampio spazio, sotto il titolo Chiesa e Stato per la tutela dei beni ecclesiastici, nel « Notiziario » del Ministero per i beni culturali e ambientali, XII (1997), 53, pp. 5-18. Vi sono pubblicati, tra l’altro, il testo dell’intesa fra il Ministero e la Conferenza episcopale italiana (CEI) firmata il 13 set. 1996 in applicazione del concordato del 1984 e le norme per la concessione di contributi finanziari della CEI a favore dei beni culturali ecclesiastici (con il relativo Regolamento esecutivo). Cenni sull’intesa, resa esecutiva nei due ambiti, civile ed ecclesiastico, rispettivamente con d.p.r. 26 set. 1996, n. 571 e con decreto del presidente della CEI 29-9-1996, nonché sulle più recenti leggi italiane a favore degli enti ecclesiastici (ad es. la n. 253 del 5 giu. 1986 sulla concessione di contributi e il d.l. 117 del 6 mag. 1997 sugli impianti di prevenzione e sicurezza) in G. GIORDANO, La tutela degli archivi ecclesiastici nella normativa della Chiesa e dello Stato italiano, in ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Quaderni della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, Palermo 1996, pp. 151-161 (Studi e Strumenti, 1). Per un ampio panorama della legislazione statale sugli archivi ecclesiastici dall’Unità ai nostri giorni cfr. O. BUCCI, Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle leggi eversive alle modificazioni del concordato, in « Archiva Ecclesiae », XXVIII-XXIX (1985-1986), pp. 73-100 ed anche E. LODOLINI, Organizzazione e legislazione archivistica italiana. Storia, normativa, prassi, Bologna 1998 5, cap. XXIX: Gli archivi ecclesiastici, pp. 499-520. Tra i molti commenti alle norme canoniche e concordatarie emanate nel 1983-1984 segnaliamo anche A. LAURO, Gli archivi ecclesiastici nel nuovo Codice di Diritto Canonico, in « Archiva Ecclesiae », XXVIII-XXIX (1985-1986), pp. 23-35; L. OSBAT, Gli archivi ecclesiastici ed il nuovo codice di diritto canonico, in Il patrimonio documentario ecclesiastico: aspetti giuridici e realtà locali. Atti della giornata di studi 17 giugno 1985, Napoli, Soprintendenza archivistica per la Campania, 1986, pp. 23-37; C. D. FONSECA, Prima, durante e dopo l’art. 12 del concordato del 18 febbraio 1984, ibid., pp. 39-48; O. BUCCI, Tre livelli di disciplina degli archivi ecclesiastici d’interesse storico, in La « conta delle anime ». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di G. COPPOLA e C. GRANDI, Bologna 1989, pp. 69-83 (Annali dell’Istituto italo-germanico di Trento, Quaderno 27); R. MACERATINI, La legislazione canonica e gli archivi ecclesiastici, in Fonti per la storia del principato e della Chiesa tridentina. Atti del convegno. Trento 17-18 maggio 1991, Trento, Provincia Autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 1995, pp. 41-62; E. BOAGA, Archivi ecclesiastici e nuovo codice di diritto canonico, in Archivi ecclesiastici e mondo moderno. Atti del convegno, Padova - Basilica di S. Giustina 5 ottobre 1991, Padova, CEDAM Giunta Regionale del Veneto, 1993, pp. 27-44. Dello stesso Boaga, un quadro delle norme ecclesiastiche per gli archivi dall’antichità al Vaticano II, Gli archivi ecclesiastici nel diritto canonico, in Archivi e chiesa locale. Studi e contributi. Atti del corso di archivistica ecclesiastica, Venezia dicembre 1989-marzo 1990, a cura di F. CAVAZZANA ROMANELLI - I. RUOL, Venezia 1993, pp. 51-66. Per una sintesi particolarmente attenta alla realtà bergamasca: E. ZANETTI, La legislazione canonica riguardo agli archivi parrocchiali, in Gli archivi parrocchiali Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 171 E tuttavia, nonostante le esplicite norme canoniche e statali, le intese concordatarie, l’indubbio fervore di attività di sostegno, recupero, valorizzazione, l’intensificarsi delle segnalazioni da parte degli storici circa l’eccezionale importanza delle fonti ecclesiastiche confermata « sul campo » da studi di demografia storica, storia dell’arte, storia economica e sociale oltre che religiosa, esse rimangono nell’indefinita vaghezza di un continente poco esplorato tanto che è difficile persino dire « quante siano state le iniziative di censimento degli archivi parrocchiali e quante siano in corso. Per quanto si abbiano pubblicazioni relative a qualche regione, come l’Emilia Romagna e la Puglia, si è ben lontani dalla conoscenza dell’intero patrimonio documentario conservato in questi piccoli e preziosissimi archivi. I dati che li riguardano sfuggono anche alle autorità vescovili » 16. Per quanto ci risulta, ad oltre dodici anni dalla constatazione di Salvatore Palese, non si può dire che la situazione sia mutata in misura significativa, dal momento che non solo si è lontanissimi da una mappatura completa degli archivi parrocchiali, sull’esempio di quanto si è riusciti invece a fare per gli archivi diocesani 17, ma anche le iniziative locali, molto frammentarie nella della Diocesi di Bergamo. Censimento 1997, a cura di M. BENIGNI, Bergamo, Diocesi di Bergamo - Centro culturale « N. Rezzara », 1998, pp. 493-500. Da sottolineare il fatto che, se la diocesi di Bergamo fa ancora riferimento alla normativa sugli archivi parrocchiali prodotta nel XXXI Sinodo diocesano del 1952 ed alle indicazioni pratiche approntate da don Antonio Pesenti e approvate dal vescovo Giuseppe Piazzi nel 1958-1959, ancora nel 1991 risultavano essere pochissimi i sinodi postconciliari che si fossero occupati di archivi. La ragione principale è stata individuata nel fatto che alla tradizionale accentuazione dei profili giuridici si è sostituita, secondo echi e direttive del Vaticano II, la centralità della problematica pastorale. Cfr. S. TRAMONTIN, Gli archivi ecclesiastici in alcuni sinodi postconciliari, in Fonti per la storia del principato... cit., pp. 63-71. 16 S. PALESE, Tipologia e geografia degli archivi ecclesiastici, in « Archivi per la storia », II (1989), 1, p. 64. Circa la situazione organizzativa degli archivi parrocchiali e la scarsa consapevolezza della relativa problematica da parte dei parroci, possono risultare ancora illuminanti (nonostante il lungo lasso di tempo trascorso) i risultati dell’inchiesta svolta nel 1965-66 da don Giuseppe Raspini per conto dell’Associazione archivistica ecclesiastica. G. RASPINI, Proposte concrete in base alle inchieste fatte sui titolari relativamente agli archivi delle parrocchie, delle confraternite e delle associazioni, in « Archiva Ecclesiae », VIII-IX (1965-1966), pp. 80-84. 17 Un primo censimento degli archivi ecclesiastici italiani, in vista della loro protezione dai pericoli bellici, fu indetto dal card. Giovanni Mercati, già prefetto della Biblioteca Vaticana e poi archivista di Santa Romana Chiesa, con una lettera indirizzata a tutti i vescovi in data 1° nov. 1942 in cui si sottolineava l’importanza di accogliere le nuove esigenze della ricerca scientifica. Nonostante le difficoltà dovute allo stato di guerra, numerose diocesi risposero all’appello restituendo le schede debitamente compilate che, nelle intenzioni del cardinale promotore, avrebbero dovuto essere poste a disposizione degli studiosi presso l’Archivio Vaticano. Purtroppo il censimento, interrotto e poi ripreso nel 1947, non potè essere completato anche perché, nel frattempo, le vicende belliche avevano causato ulteriore disordine e perdite talvolta ingenti. G. BATTELLI, Il censimento degli archivi ecclesiastici d’Italia e la loro tutela durante la guerra, in « Rivista di storia della Chiesa in Italia », I (1947), pp. 113-116 e Gli archivi ecclesiastici d’Italia danneggiati dalla guerra, ibid., pp. 306-308 riediti in G. BATTELLI, Scritti scelti. Codicidocumenti-archivi, Roma, Scuola Vaticana di paleografia e diplomatica, 1975, pp. 85-90 e 91-95; ID., Il censimento degli archivi ecclesiastici d’Italia, in « Archiva Ecclesiae », I (1958), pp. 81- Juanita Schiavini Trezzi 172 loro distribuzione geografica, appaiono soprattutto prive di coordinamento negli obiettivi e nelle metodologie di lavoro e pertanto disomogenee nei risultati. Come osservava Isabella Zanni Rosiello, in questi ultimi anni numerosi sono stati, con riferimento a specifiche aree geografiche o a singole città, le indagini conoscitive o i progetti di censimento, di riordinamento, di inventariazione. Sono registrabili un po’ in tutte le regioni italiane; tra i protagonisti principali vanno ricordati le Soprintendenze Archivistiche, gli enti locali, le università e, ovviamente, le autorità ecclesiastiche. Alcuni sono stati portati a termine; di altri, segnalati come in corso alcuni anni fa, non si hanno più notizie; forse sono stati ultimati, forse hanno subìto brusche battute d’arresto. Si tratta in genere di interventi che, al di là della loro variegata impostazione, cercano di migliorare o perlomeno di non far ulteriormente peggiorare le condizioni conservative in cui si trovano; raramente però portano a un miglioramento delle possibilità d’accesso della documentazione, data l’impossibilità di attrezzare locali idonei 18. Ci pare che il brano citato costituisca un buon punto di partenza per qualche riflessione su almeno tre nodi della problematica che investe gli archivi parrocchiali: — la già accennata frammentarietà delle iniziative per la loro stessa identificazione prima ancora che per la valorizzazione 19; 85. Lo stesso autore è tornato sul tema vent’anni dopo al convegno di Grottaferrata con Gli archivi ecclesiastici… cit., pp. 90-91. Attualmente le schede prodotte sono consultabili presso l’Archivio Vaticano ma dovrebbe esisterne copia presso ciascun archivio vescovile in quanto le disposizioni impartite all’epoca ne prescrissero la compilazione in duplice esemplare di cui uno da conservare in Curia. Fatta salva la necessità di valutare con prudenza l’attendibilità dei dati, le schede costituiscono un prezioso punto di riferimento per un riscontro delle sussistenze attuali. Circa l’incompletezza della rilevazione del 1942 ed il fatto che in taluni archivi vescovili non ne è rimasta traccia cfr. G. RASPINI, Gli archivi parrocchiali della regione ecclesiastica toscana, in « Archiva Ecclesiae », XVIII-XXI (1975-1978), p. 169 ed anche S. TRAMONTIN, Indicazioni delle visite pastorali per la «conta delle anime»: il caso veneziano, in « La conta delle anime »... cit., pp. 184-185. L’appello lanciato da Antonio Panella nel 1952 (cogliendo un’idea di Luigi Schiaparelli): Per una « Guida storica degli archivi ecclesiastici » che, nelle intenzioni del promotore, avrebbe dovuto in primo luogo render nota l’ubicazione dei diversi tronconi di archivi smembrati e dispersi, cadde inascoltato, cfr. A. PANELLA, Scritti archivistici, Roma 1955, pp. 269-278 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XIX). L’iniziativa di un censimento, ripresa in tempi assai più favorevoli, ma anche con obiettivi più circoscritti e realisticamente affrontabili, dall’Associazione archivistica ecclesiastica nel Congresso di Loreto del 1984, è giunta felicemente in porto con la pubblicazione, a cura di V. MONACHINO - E. BOAGA - L. OSBAT - S. PALESE, dei tre volumi della Guida degli archivi diocesani d’Italia, edita sia in « Archiva Ecclesiae », XXXII-XXXIII (1989-1990); XXXVI-XXXVII (1993-1994); L-LI (1997-1998), sia nella collana « Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato » ai numeri 61 (Roma 1990); 74 (Roma 1994); 85 (Roma 1998). 18 19 I. ZANNI ROSIELLO, Andare in archivio, Bologna 1996, p. 100. I dati forniti nelle pagine seguenti sono stati raccolti nel 1999: è pertanto possibile che nelle more della pubblicazione talune iniziative allora in corso siano giunte a buon fine o che Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 173 — il contributo alla tutela che può essere fornito da censimenti, guide ed altri mezzi di corredo archivistici; — le modalità di conservazione in rapporto alla fruibilità da parte degli studiosi. Le esperienze maturate in varie regioni confermano le difficoltà incontrate ad ottenere la convinta adesione dei parroci, a individuare le metodologie di lavoro più efficaci e a coagulare per il tempo necessario forze adeguate all’impresa. In Abruzzo un censimento avviato nel 1977 e che presupponeva la collaborazione dei parroci ai quali veniva chiesto di compilare un questionario tipo, risultava « oltremodo lacunoso » ancora alla fine del 1993 20. Non a caso (e forse proprio facendo tesoro della precedente esperienza) una nuova indagine conoscitiva avviata nella diocesi di Termoli-Larino ma rivolta, nelle intenzioni, a tutti gli archivi ecclesiastici della regione Molise ed in primo luogo agli archivi parrocchiali, veniva impostata osservando che « per una esatta rilevazione dei dati, non si può prescindere dalla verifica autoptica dei documenti. Spesso, nella nostra esperienza personale, non si è trovato riscontro tra i dati rilevati e quelli inviati per corrispondenza, in risposta a questionari anche piuttosto recenti. In questi casi, la mancanza di riscontro non è scaturita da una oggettiva modificazione della situazione reale, ma da una inesatta individuazione dell’esistente » 21. Anche un’inchiesta sugli archivi parrocchiali della regione ecclesiastica Toscana, svolta a titolo personale nel 1975-1976 da don Giuseppe Raspini (in vista della relazione che era stato invitato a svolgere nell’XI convegno degli archivisti ecclesiastici) mediante l’invio agli archivisti di tutte le diocesi toscane di un modulo appositamente studiato, ebbe un esito assai incerto. Come ebbe a dichiarare lo stesso Raspini, su venticinque diocesi, sei non risposero neppure all’appello e delle restanti diciannove, poche restituirono il modulo compilato in tutte le sue parti e fornendo risposte adeguate. Ne derivavano l’assoluta impossibilità di dire quale fosse, all’epoca, la consistenaltre abbiano preso avvio senza tuttavia che la situazione generale possa considerarsi mutata in maniera significativa. Molteplicità dei protagonisti scesi in campo nel recupero e valorizzazione delle fonti, assenza di un’efficace opera di coordinamento (spesso sfuggita di mano alle Soprintendenze), ambiguità dovute al sovrapporsi di interlocutori diversi ed assenza di soluzioni concrete ispirate a criteri uniformi circa la destinazione ultima del materiale documentario (concentrazione o mantenimento in loco), sono state segnalate anche in altri campi. Si veda ad esempio il lucido benché sintetico quadro tracciato da Maria Guercio riguardo agli archivi d’impresa, Gli archivi degli operatori economici: la ricerca di nuove fonti per la storia, in Saggi archivistici, Didattica nelle Marche 2, a cura di M. V. BIONDI, Ancona 1989, pp. 97-100. 20 A. E. CIATTONI - A. SILVESTRE, L’ufficio archivi ecclesiastici e paleografico, in Gli archivi come fonte di ricerca storica, Pescara, Soprintendenza archivistica per l’Abruzzo, 1994, p. 263. 21 L. DI SANTO, Riflessioni su alcuni problemi di censimento degli archivi ecclesiastici, in « Archivi per la storia », VII (1994), 1, pp. 77-81 (il brano citato è a p. 78). Juanita Schiavini Trezzi 174 za degli archivi delle 3093 parrocchie toscane e la constatazione che non solo gli archivisti vescovili non avevano il quadro della situazione ma anche molti parroci non conoscevano neppure la consistenza del proprio archivio 22. Non minori le difficoltà incontrate dallo stesso don Raspini nell’avvio del suo progetto di censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Fiesole: « Mi posi al lavoro ma ben presto dovetti rinunziare perché non tutti i parroci erano disposti ad accogliere questa mia intromissione nelle loro cose » 23. L’impresa ebbe successo, sfociando in quello che, per quanto ci risulta, fu la prima pubblicazione di questo genere 24, solo quando Raspini, assunto l’incarico di convisitatore, potè affiancare il vescovo Antonio Bagnoli nella sua terza visita pastorale. Della stessa opportunità si avvalse don Eugenio Cazzani, che tra il 1965 ed il 1976, in qualità di convisitatore accanto al card. Giovanni Colombo, ispezionò 853 parrocchie dell’arcidiocesi di Milano rilevando i dati relativi agli archivi storici e di deposito 25. Altrove, l’iniziativa individuale di un sacerdote ha fatto registrare qualche successo, benché parziale. È il caso della diocesi di Mantova, dove l’archivista vescovile mons. Giancarlo Manzoli, tra il 1970 ed il 1981, è riuscito a visitare 129 archivi parrocchiali su 170 redigendo per ciascuno un elenco sommario e annotando quelle notizie che l’esperienza gli suggeriva più importanti per la ricerca storica 26. Che la difficoltà di accedere agli archivi parrocchiali sia un ostacolo in grado di far abortire anche le iniziative animate dalle migliori intenzioni e che l’invio di questionari costituisca tutt’altro che una valida alternativa, è dimostrato dal caso campano. In questa regione, la collaborazione tra la Soprintendenza archivistica e le autorità ecclesiastiche, favorita (e quasi imposta) dalle drammatiche conseguenze del sisma del 1980, ma al tempo stesso intralciata da tradizionali resistenze e diffidenze da parte dei parroci, ha portato a visitare a tutto il 1985, 166 archivi di cui 131 parrocchiali. Gli sforzi della stessa Soprintendenza per completare il programma di censimento non sono stati tuttavia premiati da risultati apprezzabili sia per le difficoltà di accesso agli archivi, sia per il mancato riscontro da parte dei custodi delle carte alle 22 G. RASPINI, Gli archivi parrocchiali della regione ecclesiastica Toscana... cit., pp. 153154 e 168. 23 Ibid., pp. 170-171. 24 ID., Gli archivi parrocchiali della Diocesi di Fiesole. Inventario, Roma, Il centro di ricerca, 1974 (Studi di storia legislazione e tecnica degli archivi moderni, IX). Il termine inventario è usato impropriamente in quanto si tratta, in realtà, di un censimento. 25 A. PALESTRA, Il recente riordinamento degli archivi parrocchiali della Diocesi di Milano, in « Archiva Ecclesiae », XVIII-XXI (1975-1978), p. 129. Le enormi difficoltà di un censimento completo derivarono in questo caso dalla vastità della diocesi che nel 1976 contava 1.100 parrocchie sparse nel territorio di cinque province. 26 G. MANZOLI, L’archivio parrocchiale e i beni culturali locali, in « Archiva Ecclesiae », XXIV-XXV (1981-1982), p. 57. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 175 circolari ed ai questionari per il rilevamento dei dati, benché inviati di concerto con le autorità diocesane 27. Parzialmente diversa la via seguita dalla Soprintendenza archivistica pugliese che, avviando nell’autunno del 1981 il censimento della documentazione conservata presso le parrocchie dell’arcidiocesi di Bari (poi esteso alle diocesi di Brindisi, Ostuni, Oria, Lecce e Castellaneta), scartata l’idea di far uso dei questionari, sceglieva di affidare la rilevazione al personale della Soprintendenza stessa, chiamando a collaborare al programma anche i funzionari degli altri istituti archivistici della regione. Tuttavia, rispetto alle previsioni iniziali, i tempi di realizzazione del censimento si dilatavano notevolmente « per il presentarsi di non poche difficoltà anche pratiche; tra queste, non ultime, la necessità di raggiungere località notevolmente distanti dalla sede dell’Istituto, di lavorare in ambienti non sempre idonei, di operare su archivi che (…) si trovavano per la maggior parte dei casi in uno stato di estremo disordine ». Ridimensionato il progetto alla rilevazione degli archivi delle sole trenta parrocchie erette prima del 1900 (sulle 94 di cui si compone l’arcidiocesi barese) e constatato che, per il disordine in cui versavano le carte, sarebbe stato possibile fornire dati sicuri solo sulle serie dei libri canonici, si preferì infine effettuare l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi più rilevanti « piuttosto che fornire una fotografia tutto sommato poco confortante » 28. Un’altra Soprintendenza archivistica, quella per la Toscana, sperimentava una propria « ricetta » originale. Facendo leva su un programma per l’occupazione giovanile e d’intesa con la Curia vescovile, inseriva il censimento degli archivi parrocchiali della diocesi d’Arezzo nell’ambito del progetto per la costituzione di un sistema informativo regionale sui beni culturali affidato ad una società specializzata. L’inedita collaborazione col privato, che ha messo a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e tecnologiche, ha dato risultati positivi, portando alla schedatura dei 333 archivi parrocchiali esistenti in diocesi per un totale di 398 fondi individuati. Purtroppo sono rimasti 27 M. G. RIENZO, L’attività di censimento degli archivi ecclesiastici della Campania, in Il patrimonio documentario ecclesiastico: aspetti giuridici e realtà locali... cit., pp. 89-97. 28 P. BOZZANI, Un’esperienza di lavoro nel campo degli archivi ecclesiastici: l’attività della Soprintendenza archivistica per la Puglia, in Il patrimonio documentario ecclesiastico: aspetti giuridici e realtà locali... cit., pp. 117-127. Sullo stesso tema cfr. D. PORCARO MASSAFRA, L’ordinamento degli archivi parrocchiali dell’arcidiocesi di Bari nell’ambito del censimento degli archivi ecclesiastici pugliesi, in Prime indagini e archivi parrocchiali, a cura di S. PALESE, Bari 1986, pp. 125-130. Per l’esperienza leccese v. M. SPEDICATO, La « conta delle anime » nella diocesi di Lecce in epoca moderna. Orientamenti pastorali e problemi demografici, in La « conta delle anime ». Popolazioni e registri parrocchiali... cit., p.148; Gli archivi delle parrocchie della diocesi di Lecce. Censimento ed inventari, in Nuove fonti e nuovi strumenti di ricerca per la storia di Terra d’Otranto. Problematiche metodologiche e prospettive di utilizzazione, Atti del seminario di studi, Lecce 3 novembre 1992, a cura di C. PICCOLO GIANNUZZI, Lecce, Archivio di Stato di Lecce, 1993, pp. 137-148; ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Le parrocchie della diocesi di Lecce in età moderna. Guida alle fonti documentarie, Lecce 1997. 176 Juanita Schiavini Trezzi estranei al censimento gli archivi parrocchiali delle diocesi soppresse di Sansepolcro e Cortona e il prodotto finale non è giunto alla pubblicazione 29. Altrove le sollecitazioni degli ambienti scientifici che si occupano di demografia storica hanno favorito la realizzazione di censimenti su base diocesana o vicariale che, se da un lato hanno raggiunto l’obiettivo prefissato, dall’altro non hanno preso in esame l’intera consistenza degli archivi parrocchiali, ma solo le serie dei libri canonici: così a Reggio Emilia, Guastalla, Cesena e Sarsina, Faenza, Perugia, Roma, peraltro potendo talvolta lavorare, come nel caso della Sardegna centro-meridionale, su fondi concentrati negli archivi diocesani (nel caso di Roma presso l’archivio storico del vicariato) e non disseminati nelle parrocchie d’origine 30. Di questa concentrazione, avviata fin dal 1984, si sono certamente giovati anche i censimenti degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche delle diocesi di Pistoia e Pescia, esplicitamente considerati il primo passo verso un progetto più ampio di riordinamento del patrimonio archivistico ecclesiastico esistente. Per quanto riguarda la diocesi di Pistoia, alla fine del 1997 solo nove parrocchie avevano mantenuto in sede la documentazione, rendendo quindi necessario il rilevamento in loco, mentre a Pescia erano stati concen29 F. VALACCHI, Il censimento degli archivi parrocchiali della diocesi storica di Arezzo nell’ambito del sistema informativo regionale dei beni culturali, in La Chiesa e le sue istituzioni negli archivi ecclesiastici della Toscana, Pistoia 1999, pp. 111-115. Cenni anche da parte di R. DE GRAMATICA, Lavori in corso negli archivi ecclesiastici toscani, ibid., p. 91, nota 6. 30 I libri parrocchiali della diocesi di Reggio Emilia, a cura di G. BADINI - F. MILANI, Bologna 1973; I libri parrocchiali della diocesi di Guastalla, a cura di G. BADINI, Bologna 1976; I libri parrocchiali delle diocesi di Cesena e Sarsina, a cura di G. ARMUZZI - B. BARDUCCI - O. BONAVITA - C. RIVA - G. SAVINI, Bologna 1979; I libri parrocchiali della diocesi di Faenza, a cura di E. BONZI, Bologna 1983. Per cenni sulla rilevazione dei libri canonici della diocesi di Piacenza-Bobbio (indagate 408 parrocchie su 436) v. G.P. BULLA - A. RIVA, Anagrafe e biografia. Registrazione dei dati personali tra Stato e Chiesa in territorio piacentino, in Libri canonici e stato civile: segretazione o consultabilità? Orientamenti legislativi e storiografici. Atti del convegno di Spezzano (4 settembre 1998), a cura di E. ANGIOLINI, Bologna, Sez. ANAI Emilia Romagna - Comune di Fiorano Modenese, 1999, p. 24. Per la metodologia adottata nella rilevazione, svolta in tutte le diocesi della regione anche se nella maggior parte dei casi rimasta inedita, cfr. G. PLESSI, Censimento dei libri canonici conservati nelle parrocchie dell’Emilia Romagna, in La « conta delle anime ». Popolazioni e registri parrocchiali... cit., pp. 161-170 che pubblica anche le « Norme per la compilazione delle schede » cui i rilevatori sono stati chiamati ad attenersi; G. LETI - L. TITTARELLI, Le fonti per lo studio della popolazione della diocesi di Perugia dalla metà del XVI secolo al 1860, I, Guida alle fonti, Gubbio 1976, pp. 106-115; Fonti per la storia della popolazione, I, Le scritture parrocchiali di Roma e del territorio vicariale, Roma 1990 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 59) (a p. 15 nota 1, segnalazioni bibliografiche su libri canonici e stati d’anime di altre città); B. ANATRA - A. M. GATTI - G. PUGGIONI, I cinque libri nella Sardegna centro-meridionale, in La « conta delle anime »: popolazioni e registri parrocchiali... cit., pp. 113-133; Fonti ecclesiastiche per lo studio della popolazione. Inventario dei registri parrocchiali di sette diocesi della Sardegna centromeridionale, a cura di B. ANATRA - G. PUGGIONI, Roma, Comitato italiano per lo studio della popolazione (CISP), 1983. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 177 trati presso l’archivio storico diocesano 29 archivi storici parrocchiali, nove erano rimasti presso le sedi naturali e, per le restanti dieci parrocchie della diocesi, di recente istituzione, non se ne era giudicato opportuno il versamento trattandosi di archivi non comprendenti documentazione antica 31. Un’indagine conoscitiva sul patrimonio documentario custodito negli archivi delle 456 parrocchie dell’arcidiocesi di Trento, concepita quale strumento tecnico di valutazione della situazione e punto di riferimento per l’elaborazione di un appropriato programma di interventi, è stata svolta nel 1987-1988 per iniziativa e col finanziamento della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con l’Archivio diocesano rimanendo inedita 32. Sono stati invece pubblicati i risultati della schedatura di oltre 5.000 libri canonici microfilmati tra il 1985 e il 1987 di concerto con la Genealogical Society dello Utah 33. In Piemonte un progetto organico, predisposto nel 1986 e concluso dieci anni dopo, ha portato non solo al censimento ma anche al riordino e inventariazione di tutti gli archivi parrocchiali della Comunità Montana Valli Curone, Grue e Ossona, caratterizzandosi dunque per la scelta di un ambito geografico-istituzionale diverso da quello diocesano 34. La particolare morfologia delle zone montuose, che da sempre ha determinato il definirsi di ambiti territoriali « separati », marcati da significative peculiarità sia sul piano socio-economico sia su quello politicoistituzionale, ha fatto sì che anche nella diocesi di Como un censimento degli archivi parrocchiali abbia riguardato solo quelli situati in provincia di Sondrio, potendo contare sui finanziamenti statali erogati in seguito all’alluvione che 31 M. BONANNO, Gli archivi parrocchiali delle diocesi di Pistoia e Pescia, in Gli archivi parrocchiali: organizzazione, gestione, fruizione e ricerca storica. Atti dei convegni di Fiorano Modenese (4 settembre 1996) e di Ravenna (5 ottobre 1996), a cura di E. ANGIOLINI, Fiorano Modenese 1997, pp. 1-33. Dopo la conclusione dei lavori, sintetiche relazioni sono state presentate da R. L. AIAZZI - L. CECCHI, Il censimento degli archivi storici ecclesiastici della diocesi di Pistoia, in La Chiesa e le sue istituzioni negli archivi ecclesiastici della Toscana…cit., pp. 95-96; N. PARDINI, Il censimento degli archivi ecclesiastici della Valdinievole, ibid., pp. 97-98; A. M. ONORI, Gli archivi storici parrocchiali della diocesi di Pescia. Dal riordino alla gestione, ibid., pp. 99-110. 32 Sintetici resoconti dell’indagine sono stati presentati da P. CHISTÉ, Interventi della Provincia Autonoma di Trento nel settore degli archivi ecclesiastici, in Fonti per la storia del principato e della Chiesa tridentina... cit., pp. 73-75 e da L. SPARAPANI, Personale dell’archivio diocesano. Reclutamento, qualificazione e volontariato, in « Archiva Ecclesiae », XXXVIIIXXXIX (1995-1996), p. 102. 33 L. SPARAPANI, I libri parrocchiali della diocesi di Trento, in La « conta delle anime ». Popolazioni e registri parrocchiali... cit., pp. 277-319; Fonti per la storia della popolazione, II, Scritture parrocchiali della diocesi di Trento, Roma 1992 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 70). 34 D. BRUNETTI, Gli archivi parrocchiali della diocesi di Tortona in Piemonte, in Gli archivi parrocchiali: organizzazione, gestione... cit., pp. 23-31. Si ha notizia di un’analoga rilevazione in corso per le parrocchie lombarde della stessa diocesi. Juanita Schiavini Trezzi 178 colpì la Valtellina nel 1987 e sull’inserimento nel piano di interventi della Regione Lombardia 35. Esperienza del tutto singolare e tuttora in corso, il progetto ARCA relativo al vasto complesso degli archivi storici della Chiesa veneziana (suddivisi in tre gruppi: archivi di curia e altri fondi centrali, archivi di parrocchie, archivi di confraternite, associazioni e privati), impostato su un rigoroso lavoro di riordino e inventariazione informatizzata, non ha potuto a sua volta prescindere, nella sua fase iniziale, da una prima operazione di censimento degli archivi parrocchiali che ha suggerito l’articolazione del programma in due applicazioni fisicamente distinte (CENS ed ARCA) benché unite da un punto di vista logico 36. La realizzazione di un ambizioso piano nazionale su base informatica, varato dall’allora Ministero per i beni culturali e ambientali, denominato progetto Anagrafe 37, ha costituito lo spunto per l’avvio, da parte della Soprin35 Censimento degli archivi storici e dei fondi librari antichi delle parrocchie della provincia di Sondrio, a cura di S. XERES - G. ANTONIOLI, Milano, Provincia di SondrioConsorzioArchidata, 1996. 36 Il progetto ARCA è stato ripetutamente presentato, sia nella sua fase progettuale (qualificato come censimento ed inventariazione), sia nei successivi stati di avanzamento: F. CAVAZZANA ROMANELLI, Per un censimento degli archivi storici della Chiesa veneziana, in « Archiva Ecclesiae », XXX-XXXI (1987-1988), pp. 249-253; C. SALMINI, Regione Veneto: il progetto ARCA, in « Archivi & Computer », I (1991), 1, pp. 83-84; A. SCHIAVON, ARCA, in « Archivi & Computer », II (1992), 2, pp. 166-172; F. CAVAZZANA ROMANELLI - C. SALMINI, Inventariazione archivistica e standard descrittivi; il progetto « ARCA », in « Archivi per la storia », V (1992), 1, pp. 119-147; F. CAVAZZANA ROMANELLI, Il progetto ARCA per gli archivi storici della Chiesa veneziana, in Archivi e Chiesa locale: studi e contributi... cit., pp. 23-28 (in particolare, sul censimento preliminare, p. 25). Per la descrizione del programma informatico e delle relazioni tra CENS ed ARCA, cfr. C. SALMINI, Informatica e archivi. Vent’anni di esperienze italiane e il programma ARCA, ibid., pp. 223-226; ID., ARCA: un’applicazione di CDS/ISIS per l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi storici della Chiesa veneziana, in « Archiva Ecclesiae », XXXIV-XXXV (1991-1992), pp. 209-218. Il bilancio più recente, ma ancora provvisorio, trattandosi di un’esperienza non solo in corso ma anche in perenne evoluzione, è stato tracciato ancora una volta da F. CAVAZZANA ROMANELLI, Gli archivi parrocchiali veneziani, in « Notiziario bibliografico. Periodico della Giunta regionale del Veneto », 32, settembre 1999, pp. 16-27, dove l’autrice riprende e sviluppa un precedente intervento dal titolo Gli archivi parrocchiali veneziani. Strategie di tutela, descrizione dei fondi, prospettive storiografiche, in Libri canonici e stato civile: segretazione o consultabilità?… cit., pp. 85-117. 37 Censimento degli archivi vigilati concepito con l’obiettivo di creare un sistema informativo funzionale all’attività di controllo, sorveglianza, vigilanza svolta dall’Amministrazione archivistica in vista della loro conservazione e fruizione. Tra le tante occasioni di presentazioni e commenti cfr. E. ORMANNI, Il progetto Anagrafe degli archivi italiani, in Strumenti di gestione e di ricerca degli archivi italiani. Atti delle giornate di studio Molfetta 9-10 dicembre 1994, a cura di D. PORCARO MASSAFRA, Bari 1996, pp. 21-29 (Quaderni della Soprintendenza archivistica per la Puglia, 1); ID., Relazioni tra « Censimento » e « Anagrafe », in Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall’Archivio centrale dello Stato, Roma 20 aprile 1995, Roma 1998, pp. 6369 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 46). Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 179 tendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia, del censimento di tutti gli archivi parrocchiali presenti sul territorio regionale che appartengono alle quattro diocesi di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, oltre alle quindici parrocchie dipendenti dalla diocesi di Vittorio Veneto. Il lavoro, svolto in coordinamento con centri di documentazione ed istituti culturali privati nell’intento di evitare dispersione di energie, sovrapposizioni ed imbarazzanti intralci, è stato completato per la diocesi di Trieste e per quella di Vittorio Veneto ma ha poi subìto un rallentamento legato alle vicende del progetto Anagrafe 38. Nei casi di cui abbiamo tentato una panoramica che li raggruppasse secondo obiettivi e modalità di attuazione, i pochi giunti in porto hanno dunque riguardato ambiti territoriali coincidenti con la circoscrizione ecclesiastica diocesana o definiti al suo interno (ad es. le parrocchie della provincia di Sondrio nell’ambito della diocesi di Como, o quelle piemontesi della diocesi di Tortona). Il primo e unico progetto su base territoriale più vasta approdato alle stampe ci risulta essere quello relativo alle parrocchie della provincia di Modena, comprendente per intero il territorio delle diocesi di Modena-Nonantola e di Carpi e parzialmente, quello delle diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e di Bologna 39. Privilegiando la produzione di un mezzo di primo livello e di carattere generale finalizzato al reperimento delle fonti, piuttosto che di strumenti ad alto grado di analiticità, e rinunciando all’accattivante richiamo (questo sì poco archivistico) di costituire una bella banca dati col trattamento delle informazioni contenute nelle fonti, lo staff modenese ha avuto il grande merito di dimostrare la fattibilità e l’utilità di un’impresa ricca di insidie superate grazie al solido e realistico impianto del progetto, al coagularsi di forze adeguate, alla ferma determinazione nel perseguire l’obiettivo che ci si era prefissi: descrivere sinteticamente la documentazione rispecchiando le effettive condizioni degli archivi senza la pretesa di attingere un’improbabile esattezza ma anche senza scadere nella genericità o nella sciatta approssimazione. Meno condivisibile è però la scelta di escludere dal censimento 36 parrocchie di recente istituzione oltre alle undici rimaste « impraticabili » 40 per motivi che sarebbe stato forse meglio chiarire (inagibilità di locali a 38 A. GONNELLA, Gli archivi parrocchiali e il progetto « Anagrafe », in Gli archivi parrocchiali: organizzazione, gestione, fruizione e ricerca storica. Atti dei convegni di Fiorano Modenese (4 settembre 1996) e di Ravenna (5 ottobre 1996)… cit., pp. 91-106. ID., Gli interventi della Sovrintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia sugli archivi ecclesiastici della Regione, in Libri canonici e stato civile: segretazione o consultabilità?… cit., pp. 73-84. 39 Gli archivi parrocchiali della provincia di Modena. Censimento, a cura di F. BALDELLI, Modena, Centro di documentazione per la storia contemporanea, 1994 (Fonti e documenti, I) Della distrettuazione ecclesiastica si è tenuto conto raggruppando le schede dei 264 archivi censiti per diocesi e vicariati di appartenenza. 40 La circostanza è segnalata dalla stessa curatrice, Franca Baldelli, ibid., p. XXX. Juanita Schiavini Trezzi 180 rischio di crollo? Opposizione radicale di qualche parroco? Materiale imballato per trasloco in atto?) per convincere il lettore che si trattasse di ostacoli davvero insormontabili nonostante ragionevoli dilazioni e comunque entro i termini della consegna alle stampe. Da più parti sono state segnalate le molteplici cause di tanta difficoltà nella gestione degli archivi parrocchiali e nell’organizzazione di efficaci interventi a loro favore, derivanti in parte da un generalizzato atteggiamento di scarsa percezione del valore culturale degli archivi e di « strabiliante noncuranza (…) verso i documenti e verso il mondo giuridico-amministrativo in genere », testimoniata in modo inequivocabile dalla scarsa attenzione con cui viene organizzato l’archivio corrente 41, tanto da essere spesso sprovvisti di un comunissimo registro di protocollo 42. Altre ragioni sono invece indubbiamente specifiche della realtà parrocchiale: mancanza di mezzi (resa con espressione felicemente icastica dal responsabile dell’archivio vescovile di Prato: « un archivio ecclesiastico è un terreno in cui non c’è da spartire che un’endemica povertà » 43), problemi di dialogo con interlocutori laici (in senso proprio ed in senso politico) ed istituzioni pubbliche, timore di sottrazione di documenti o di divulgazione di notizie riservate, diminuzione del clero secolare e soppressione delle parrocchie meno popolose in conseguenza della crisi delle vocazioni e così via. Ci pare tuttavia che le ragioni fondamentali vadano ricercate ad un livello più profondo: in primo luogo nella polverizzazione delle realtà ecclesiali e nel totale decentramento delle responsabilità. Se infatti ci si può rallegrare che manchino le rigidità centraliste che si riscontrano là dove esiste una figura solitaria e cruciale d’archivista della Chiesa nazionale [il riferimento è alla Francia], non è certo positiva una situazione di atomizzazione quasi completa » 44. L’osservazione, fatta nell’ambito di un’analisi critica sulle applicazioni dell’informatica in cui non manca un’acuta sottolineatura dei fallimenti cui possono portare parcellizzazione dei percorsi ed ingenuità degli investimenti, è riproposta (non a caso) in un altro intervento sul rapporto tra archivi ecclesiastici ed informatica. « Si deve tener conto, inoltre, del fatto che gli archivi ecclesiastici non possiedono un’amministrazione centralizzata e articolata (…). La capillare frammentazione che essi rivelano è strettamente congiunta con la peculiarità delle istituzioni ecclesiastiche e con la composita natura delle comunità ecclesiali. Non è facile, quindi, raggiungere 41 L’osservazione, svolta riguardo agli archivi degli istituti culturali ma che ci pare valida anche nel caso di quelli ecclesiastici, è di G. BONFIGLIO DOSIO, I mille volti della cultura: gli archivi degli istituti culturali della provincia di Padova, Padova 1998, p. 17. 42 L. M. DI PALMA, Archivi ecclesiastici ed informatica: problemi e suggerimenti, in Strumenti di gestione e ricerca degli archivi italiani... cit., p. 100 43 NALE R. FANTAPPIÉ, Lavorare in un archivio ecclesiastico toscano, in ANAI SEZIONE REGIOTOSCANA, Il lavoro negli archivi. Giornata di studio, 9 dicembre 1988, Lucca 1989, p. 70. 44 A. MELLONI, Archivi storico-religiosi e strumenti di lavoro. Problemi ed esperienze di coniugazione di tecnologia e ricerca in Italia, in Le carte della memoria. Archivi e nuove tecnologie, a cura di M. MORELLI - M. RICCIARDI, Bari 1997, p. 134. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 181 una certa uniformità nella gestione (…) ed ottenere un’adeguata modernità nei servizi che ad essi si richiedono 45. La delega agli ordinari diocesani per la regolamentazione della tenuta di archivi correnti e storici e dei servizi archivistici e l’ulteriore chiamata in causa dei singoli parroci, previste dal diritto canonico, se da un lato potevano porre le premesse per una flessibilità rispettosa delle realtà locali e valorizzatrice delle consuetudini e delle esperienze maturate in contesti diversi, dall’altra non hanno permesso di imprimere un vigoroso impulso alla conoscenza del valore culturale degli archivi (a partire da quelli correnti) 46 né di tradurre questo interesse in attività costante e coerente in luogo di quella sporadicità di iniziative, troppo legate al ruolo di singole personalità più attente e motivate o al verificarsi di felici coincidenze che tutti possiamo constatare. Non è poi un mistero che il clero secolare, sia di curia che preposto alla guida delle singole comunità ecclesiali, è spesso caratterizzato da uno spiccato individualismo anche nell’interpretazione e nelle forme di attuazione delle stesse direttive episcopali. Ben sintetizzava Gino Badini nel suo notissimo manuale: « La guida sostanzialmente e più diffusamente monocratica dell’istituzione parrocchiale rendeva e rende abbastanza instabile l’uniformità evolutiva dell’archivio a causa del succedersi, a volte assai frequente, dei parroci, quasi sempre sprovvisti, com’è comprensibile, di un ufficio debitamente organizzato per la tenuta delle carte. L’archivio parrocchiale quindi, pare avvicinarsi moltissimo all’archivio familiare o addirittura personale. A volte le sue carte sono considerate, erroneamente e in buona fede, come cose disponibili da parte del parroco o dei suoi eredi, con esclusione dei registri canonici, riconosciuti pubblici dal diritto ma anche dal senso comune, in questo caso senza incertezze » 47. Se di questi meccanismi possiamo trovare segni evidenti anche nel passato, ben riflessi dallo stato degli archivi storici parrocchiali, un secondo ordine di ragioni è venuto ad accentuare la « crisi archivistica » nel periodo post-conciliare. La collocazione dell’archivio nella vita delle chiese locali e nell’impegno quotidiano del clero è cambiata parallelamente alla profonda trasformazione 45 L. M. DE PALMA, Archivi ecclesiastici ed informatica... cit., p. 101. 46 La conferma di quanto sia radicato ed esteso (persino tra gli archivisti!) il pregiudizio verso la documentazione contemporanea e latitante la considerazione che le premesse per un archivio ricco e ordinato si pongono al momento stesso della sua formazione, viene dalla constatazione che persino alcune delle pur meritorie rilevazioni, di cui si è tracciato più sopra un sintetico panorama, hanno deliberatamente escluso gli archivi delle parrocchie di più recente istituzione, lasciandosi tra l’altro sfuggire l’opportunità di approfittare del censimento per svolgere un’importante opera di sensibilizzazione. 47 G. BADINI, Archivi e Chiesa. Lineamenti ... cit., pp. 87-88. 182 Juanita Schiavini Trezzi della fisionomia istituzionale della parrocchia. Recependo la lezione del Vaticano II, il codice del 1983 non la considera più come territorio (così come la presentava il codice del 1917) ma come comunità di fedeli, di cui il parroco è pastore chiamato a riconoscere e promuovere il ruolo dei laici e ad approfondire l’impegno pastorale con interventi diretti al di fuori dei tradizionali « recinti » del sacro e proiettati nel presente e nel futuro tanto da dimenticare, talvolta, la dimensione del passato come risorsa (almeno a livello di confronto e di esperienza). Preoccupazione pastorale, ricerca di prospettive nuove, venir meno del modello organizzativo fondato sull’accentuazione dei profili giuridici ereditato dai secoli precedenti, hanno inciso profondamente sulla percezione dell’importanza di certi adempimenti formali e del ruolo del sacerdote quale custode delle carte attestanti i diritti della Chiesa, le sue funzioni sociali, i suoi rapporti con l’autorità civile, ecc. L’archivio aveva una consolidata funzione nella conservazione della memoria dei privilegi e diritti della propria istituzione (…) [la quale] utilizzava per la sua organizzazione e per la sua attività un quadro di riferimento, espressioni e procedure di tipo giuridico (…). La stessa cura pastorale aveva costanti registrazioni formali (…); l’amministrazione di un sistema beneficiario delle masse comuni, dei giuspatronati, richiedeva non solo la produzione di una circostanziata documentazione, ma pure la conservazione di essa, per dimostrare la fondatezza di diritti e di usi. I documenti dell’archivio (...) ricordavano imprescrittibili privilegi, precedenze nelle processioni, aspetti rilevanti nell’organizzazione sociale di un ambiente. Erano un materiale molto utile nei contenziosi così frequenti nel mondo ecclesiastico (...). Allora l’archivio costituiva, quasi come la custodia delle reliquie esposte in feste particolari alla venerazione dei fedeli (e anch’esse richiedevano documenti e attestazioni), un recesso nobile della chiesa o del santuario (...) 48. Il mutamento di prospettiva introdotto dal Concilio è stato profondamente assorbito dai sacerdoti, soprattutto delle nuove generazioni, che non solo non hanno più il tempo di dedicarsi all’archivio, alla stesura del chronicon, agli studi storici nella quiete della canonica, ma sono ormai intimamente e sinceramente convinti che la loro missione vada vissuta per le strade, tra la gente, in un caleidoscopio di attività, rifiutando ab imis come un tradimento della propria vocazione la prospettiva di farsi amministratore di beni e di carte, custode di saperi legati al passato, memoria non solo di realtà tramontate e non più condivise (dalle processioni confraternali alle pie usanze come la benedizione delle case o delle uova, ecc.) ma anche di iniziative portate avanti con impegno e convinzione, percepite però in chiave puramente pastorale e non come testimonianza meritevole di conservazione di un certo vissuto 48 A. RICCARDI, L’archivio ecclesiastico come memoria storica della comunità ecclesiale e della società civile, in « Archivi per la storia », II (1989), 1, pp. 13-27. In particolare, si vedano alle pp. 16-20 le acute riflessioni sul mutamento nel ruolo dell’archivio posto in relazione con le riforme conciliari. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 183 ecclesiale e locale (ad es. i grest, i campi scuola, i cineforum, l’accoglienza degli emarginati, ecc.) 49. In una realtà così variegata e in costante evoluzione, a proposito della quale il provocatorio interrogativo se l’istituzione dell’archivio ecclesiastico non si stia avviando ad una morte lenta non si colloca certo, a nostro avviso, sul piano delle esercitazioni retoriche ma prospetta un rischio assolutamente reale e da non sottovalutare 50, la necessità di adottare adeguate misure di sostegno appare ineludibile ed urgente. Su alcune possibili linee d’intervento ritorneremo più avanti ma, poiché non è dato predisporre progetti operativi per soluzioni adeguate alle diverse e concrete circostanze, senza una conoscenza di base di quest’ultime, riteniamo che debba essere considerata prioritaria l’identificazione e la quantificazione dei giacimenti archivistici, da realizzare con lo strumento più efficace (anche in una logica di ottimizzazione del rapporto costi/benefici): il censimento. Il quadro delle ricognizioni svolte in varie parti d’Italia tracciato nelle pagine precedenti, certamente non esaustivo (per la notevole difficoltà nel reperire informazioni su iniziative locali non segnalate in pubblicazioni a diffusione nazionale), ci pare tuttavia sufficientemente ampio per consentire qualche riflessione sulle ragioni del successo o del fallimento o del mutamento d’indirizzo in itinere delle singole esperienze e per trarne conclusioni di cui si è tenuto conto nello svolgimento del progetto bergamasco e che potrebbero essere utili anche ad altri. In primo luogo, il progetto non dovrà essere unilaterale, ossia concepito, messo a punto ed attuato da una singola istituzione, non importa se civile o ecclesiastica per quanto di alto profilo (dalle diocesi alle Soprintendenze) perché, « evaporati » gli entusiasmi iniziali, difficilmente essa troverà al proprio interno tutte le risorse necessarie al buon esito dei lavori: professionalità competenti (in archivistica, diritto canonico, storia della Chiesa, informatica ecc.), autorevolezza unita a conoscenza delle persone e delle sensibilità locali, risorse finanziarie. Naturalmente le sinergie verranno poste in essere di volta in volta tenendo conto delle circostanze e approfittando delle disponibilità esistenti che, nella condizione di frammentarietà favorita dall’attuale quadro normativo canonico e civile, non possono manifestarsi se non attraverso la personale attenzione di coloro che si trovano a svolgere il ruolo di referenti istituzionali ai vari livelli 51. 49 Alcune dense osservazioni sugli esiti del Vaticano II nella trasformazione della fisionomia istituzionale della parrocchia o del modello sinodale in relazione alla tematica archivistica in S. TRAMONTIN, Gli archivi ecclesiastici in alcuni sinodi postconciliari... cit., pp. 63-64 ed anche in B. BERTOLI, Le parrocchie veneziane dal Medioevo al secolo XX. Un profilo storicoistituzionale, in Archivi e Chiesa locale... cit., pp. 144-146. 50 51 A. RICCARDI, L’archivio ecclesiastico come memoria storica... cit., p. 20. Una difficoltà, segnalata per la Toscana ma che certamente può emergere anche in altre regioni, che ostacola il decollo di convenzioni specifiche tra autorità ecclesiastiche ed enti locali 184 Juanita Schiavini Trezzi Se la convinta adesione del vescovo è ovunque imprescindibile, il progetto potrà vedere in campo Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Soprintendenze archivistiche, Università, altre istituzioni pubbliche e private, di matrice ecclesiale (come, nel caso bergamasco, il Centro culturale « Nicolò Rezzara ») o civile, banche e perfino privati cittadini in veste di moderni mecenati 52. In secondo luogo, i promotori dovranno definire con estrema chiarezza gli obiettivi del progetto (dimensione geografica e livello di analiticità dei dati che si intendono rilevare), i tempi di realizzazione ed i mezzi con cui si potranno conseguire i risultati programmati. Questi tre elementi sono strettamente intrecciati ed ogni errore di valutazione, avendo pesanti ripercussioni sull’architettura del progetto, può creare pericolosi scompensi e finanche il fallimento. Se le risorse umane messe in campo sono sottodimensionate rispetto all’ampiezza dell’area d’intervento, diventerà difficile concludere il lavoro nei tempi previsti e se gli operatori non dispongono di una formazione adeguata, le schede si trasformeranno in un insieme di dati acriticamente affastellati e poco significativi. Il venir meno dei finanziamenti interromperà il lavoro, un programma informatico non funzionale (oppure operatori impreparati) ne renderà macchinosa l’applicazione e insufficienti le prestazioni e così via. In particolare, sembra importante sottolineare alcune indicazioni emerse dalle esperienze sopracitate. Vi è maggior garanzia di successo: — se le circostanze sono vagliate con la massima attenzione in modo da non lasciare nulla al caso: se un terremoto è imprevedibile, in condizioni normali le difficoltà derivanti da situazioni logistiche o dal disordine degli archivi possono e devono essere ampiamente preventivate; — se il progetto non supera la dimensione diocesana, d’altronde preferibile in quanto quadro istituzionale di riferimento in cui si collocano le vicende delle parrocchie prese in esame 53; in caso contrario, è bene che sia almeno nel campo dei beni archivistici, deriva dal fatto che la « geografia istituzionale ecclesiastica » non coincide con i confini provinciali. R. DE GRAMATICA, Lavori in corso... cit., p. 93. 52 Pur non trattandosi di un censimento, ci piace segnalare l’esempio della prof. Maria Verga Bandirali che, a titolo puramente personale e mossa dal desiderio di contribuire alla salvaguardia delle fonti della storia locale, ha sostenuto le spese di riordino ed inventariazione dell’archivio parrocchiale di Offanengo (Cremona). L’inventario, a cura di Mauro Livraga, è stato poi pubblicato, con il finanziamento congiunto della Parrocchia, del Comune e della locale Banca di Credito cooperativo, in S. Maria Purificata di Offanengo. Dalla pieve collegiata alla parrocchiale 1898-1998, Crema 1998, pp. 91-142. 53 Per limitarci ad un esempio relativo al territorio bergamasco, si pensi alle profonde differenze che hanno marcato nei secoli le parrocchie appartenenti all’arcidiocesi di Milano rispetto a quelle, limitrofe, in diocesi di Bergamo e di rito romano. Retaggio di antiche, complesse vicende politico-ecclesiastiche, seguono tuttora il rito ambrosiano non solo le parrocchie rimaste nell’arcidiocesi milanese, ma anche altre in diocesi e provincia di Bergamo come Caprino, Cassiglio, Cisano, o in diocesi di Bergamo e provincia di Lecco (v. anche nota 97). Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 185 suddiviso in moduli aventi compiutezza in sé per assicurare risultati validi anche se parziali; — se l’obiettivo è conseguibile in tempi brevi e a costi ragionevolmente limitati; — se l’avvio è preceduto da un accurato lavoro preparatorio nei confronti dei parroci volto ad informarli delle finalità, delle modalità di attuazione (compresa la presentazione diretta dei responsabili e degli esecutori), ma anche a farne coprotagonisti coscienti e attivi e non semplici soggetti passivi 54; — se la direzione scientifica è affiancata da un responsabile attivamente impegnato sul piano organizzativo, del coordinamento e del sostegno al lavoro dei rilevatori in una costante opera di « tessitura » di rapporti 55; — se il compito della rilevazione viene assegnato a persone di cultura universitaria con un contratto di collaborazione vincolato in maniera esplicita alla realizzazione del progetto e al rispetto della tempistica prestabilita. Al contrario, le probabilità che il progetto si areni saranno elevate (o addirittura si potrà prevedere con certezza il suo fallimento): — se calato dall’alto senza ottenere la sincera adesione dei parroci; — se diretto ad un ambito geografico molto vasto (ciò infatti richiede ingenti risorse umane e materiali e pone maggiori problemi metodologici, ma soprattutto ostacola fino ad annullarlo il rapporto personale e diretto tra i diversi protagonisti dell’impresa); — se effettuato contando sulla compilazione di questionari inviati ai parroci o ai custodi degli archivi 56; — se affidato a personale, anche il più preparato sul piano culturale e tecnico, che possa però esserne distolto dall’insorgere di altri e prioritari compiti istituzionali; — se la scheda di rilevazione sarà troppo articolata e il livello di informatizzazione troppo spinto, ciò infatti renderà problematica la compilazione nel caso di archivi gravemente disordinati, inciderà sulle difficoltà ed i tempi di attuazione accrescendo notevolmente i costi del progetto e dilazionandone 54 La stessa convinzione, maturata anche nell’ambito dell’esperienza aretina, è manifestata da F. VALACCHI, Il censimento degli archivi parrocchiali... cit., p. 113. 55 L’esigenza che le diverse fasi del lavoro siano seguite e coordinate costantemente da un responsabile è stata espressa anche da R. DE BENEDITTIS, I censimenti, in « Archivi per la storia », VII (1994), 1, pp. 14 e 18. 56 Rispetto alla casistica illustrata nelle pagine precedenti, ne è ulteriore e recente conferma il fallimento della raccolta di dati relativi ai servizi archivistici in funzione presso gli archivi diocesani toscani tentata nel 1996 in vista di un convegno sulle esperienze e sui progetti relativi agli archivi ecclesiastici di quella Regione svoltosi a Pistoia l’11 gennaio 1997. R. DE GRAMATICA, Lavori in corso... cit., p. 94 nota 14. 186 Juanita Schiavini Trezzi la conclusione 57. Quanto ai tempi eccessivamente dilatati, oltre ad affievolire (come di solito avviene) la tensione positiva di tutte o alcune delle parti in causa verso il conseguimento del risultato, hanno il grave svantaggio di rendere impossibile la sincronicità dei dati che, come vedremo, è invece una delle caratteristiche essenziali di un censimento; — infine, è essenziale che i responsabili del progetto ne reggano saldamente il timone senza cedere alla tentazione di mutamenti in itinere anche se motivati dall’intento di perfezionare l’opera e che però rischiano di confermare l’antico adagio secondo cui « il meglio è nemico del bene ». Ad esempio, nel corso di un censimento volto a fotografare una situazione reale, non ci si dovrà sorprendere né preoccupare eccessivamente se lo stato di disordine di alcuni archivi renderà impossibile un’esatta e completa identificazione della tipologia dei documenti, della consistenza e degli estremi cronologici delle serie e non si dovranno aprire parentesi di riordinamento ed inventariazione all’interno del lavoro in corso. Lo slittamento dei tempi, l’esplosione dei costi, la persistente incoerenza dei dati forniti (a meno che non si riordinino con la stessa metodologia tutti gli archivi interessati, permarranno infatti livelli diversi di precisione delle schede) peseranno negativamente sull’esito dell’impresa fino a comprometterne non solo i risultati ma anche il senso. Sarà dunque bene, a questo punto, tentare qualche riflessione sul concetto di censimento, visto in relazione ad un altro mezzo di corredo archivistico, la guida. Nella prassi, i due termini sembrano essere considerati del tutto fungibili: è possibile infatti constatare che pubblicazioni simili, se non identiche, per impostazione metodologica, schema organizzativo, tipologia dei dati forniti, vengono indifferentemente presentate come censimenti o come guide 58. 57 Come è stato lucidamente (e forse anche coraggiosamente) osservato, « l’esperienza negativa accumulata in sede di pubblica amministrazione nella realizzazione dei primi progetti FIO (i cosiddetti “giacimenti culturali”) ha mostrato il punto debole d’una applicazione inconsulta di strumenti tecnologici a beni museali, archivistici o paesistici. Il tallone d’Achille di quei progetti infatti, stava nel disequilibrio fra ammortamento e obsolescenza (...) ». E ci pare del tutto condivisibile l’ulteriore giudizio che « questa esperienza, ritenuta da tutti un modello negativo non solo per ragioni etiche legate alle assegnazioni, ha però prodotto poca analisi critica per il futuro ». A. MELLONI, Archivi storico-religiosi e strumenti di lavoro... cit., p. 135. Siamo convinti che anche i lavori fondati sull’applicazione di metodologie e strumenti informatici debbano prevedere in ogni caso la tradizionale stampa dei loro prodotti. Saranno gli utenti a decidere (in base ai propri obiettivi di studio e alla propria dimestichezza col mezzo informatico) se utilizzare le maggiori risorse della ricerca on line o limitarsi alla consultazione di guide, inventari, indici a stampa. 58 Ampie rassegne bibliografiche in materia (parzialmente coincidenti) sono state pubblicate da R. DE BENEDITTIS, I censimenti… cit., p. 15 note 6 e 8; G. BONFIGLIO DOSIO, L’amministrazione del territorio durante la Repubblica Veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori, Padova 1996, p. 1, note 1 e 2; Gli archivi comunali della provincia di Oristano. Risultati di un censimento, a cura di C. PALOMBA - G. USAI, Oristano, Provincia di Oristano - Soprinten- Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 187 Talora vengono introdotti aggettivi con funzione limitativa (guida « sommaria »), o caratterizzante l’ambito cronologico o il livello di chiarezza espositiva (censimento « storico», censimento « descrittivo ») 59, ma anche per suggerire l’idea dell’attenzione prestata alle vicende storiche degli archivi presi in esame (è il caso della « guida storica » proposta da Antonio Panella) 60 o addirittura quella di completezza (guida o anche censimento « generale ») 61 unita a precisione e rigore metodologico (censimento « sistematico ») 62. In altre occasioni si è preferito invece evitare prudentemente sia l’uno sia l’altro termine optando per quello di « rilevazione » 63. Quanto alla dottrina, se ampia è stata la disamina del concetto di guida, non altrettanto può dirsi per quello di censimento, al quale quasi nessun autore ha dedicato la propria attenzione. Il Brenneke nel suo famoso manuale non fa uso di nessuno dei due vocaboli 64. Per Eugenio Casanova, la guida è un « vademecum » in quanto « scritdenza archivistica per la Sardegna, 1999, p. 43, nota 1. Numerose guide e censimenti compaiono inoltre nella ricca bibliografia presentata da I. ZANNI ROSIELLO, Andare in archivio... cit., pp. 105-138. Tra le molte pubblicazioni con cui potrebbero essere integrati tali elenchi, segnaliamo: ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA, Guida sommaria agli archivi degli Istituti di storia della Resistenza, Milano 1974; ISTITUTO PER LA STORIA DI BOLOGNA, Gli archivi delle istituzioni di carità e assistenza attive in Bologna nel Medioevo e nell’età moderna, Bologna 1984; B. GERA - D. ROBOTTI, Cent’anni di solidarietà. Le società di mutuo soccorso piemontesi dalle origini. Censimento storico e rilevazione delle associazioni esistenti, Torino 1989; G. BONFIGLIO DOSIO, I mille volti della cultura… cit.; PROVINCIA DI LODI - REGIONE LOMBARDIA, Censimento degli archivi dei Comuni e degli ex E.C.A. della Provincia di Lodi, a cura di D. FUSARI, Lodi 1999. 59 Guida sommaria agli archivi degli Istituti di storia della Resistenza... cit., p. XI; B. GERA - D. ROBOTTI, Cent’anni di solidarietà... cit.; REGIONE LOMBARDIA, Gli archivi storici degli ospedali lombardi. Censimento descrittivo, Milano 1982 (Quaderni di documentazione regionale n.s. 10). 60 A. PANELLA, Per una « Guida storica degli archivi ecclesiastici », in Scritti archivistici... cit., pp. 268-278. 61 Guida generale degli Archivi di Stato italiani, I-IV, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981-1994; P. BENIGNI - O. CAMPANILE - I. COTTA - F. KLEIN - S. VITALI, Riflessioni sul censimento generale dei fondi dell’Archivio di Stato di Firenze, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLVII (1987), p. 406. 62 Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri.... cit., p. 15. Per le più recenti puntualizzazioni su natura e struttura dei due lavori (Guida e Censimento) e sui rapporti reciproci e con Anagrafe cfr. A. DENTONI-LITTA, Il censimento e l’aggiornamento della Guida generale degli Archivi di Stato italiani, ibid., pp. 70-76. 63 Gli archivi delle istituzioni di carità e assistenza attive in Bologna... cit., pp. 5-7. 64 Il concetto di guida potrebbe forse celarsi in quelli che egli chiama « inventari sommari » (vedute d’insieme ad uso di «chiunque deve ambientarsi nell’archivio e soprattutto i nuovi impiegati», grazie al fatto che abitualmente « comprendono anche l’indicazione della collocazione del materiale archivistico nel deposito ») e « inventari sommari stampati », redatti in maniera meno concisa dei precedenti perché destinati a descrivere al pubblico esterno i fondi conservati in un determinato istituto. A. BRENNEKE, Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea, traduzione italiana di R. PERRELLA, Milano 1968, pp. 31-32. Juanita Schiavini Trezzi 188 tura che succintamente descrive parte per parte tutto l’insieme di un archivio generale, seguendone quasi la collocazione » 65. Commentava severamente il Pratesi che in tal modo « ne fa una specie di manuale turistico per il visitatore dell’archivio » 66. Giudicando riduttiva anche la definizione data dall’Elsevier’s Lexicon of Archive Terminology, in quanto la guida, là indicata come « strumento di lavoro per orientare i lettori nella conoscenza e l’utilizzazione dei fondi d’archivio », « vi viene considerata unicamente sotto il profilo dell’utilizzazione da parte dello studioso », il Pratesi ne sottolineava la validità anche per l’archivista, specie nei grandi archivi dove è praticamente impossibile conoscere tutti i fondi. Proponendone una redazione non puramente descrittiva ma anche e soprattutto storica, ne identificava le caratteristiche essenziali nel fornire informazioni d’indole generale sull’archivio o sul fondo, sulla distribuzione del materiale e sui sussidi di cui dispone 67. Benché non siano mancate, anche in tempi abbastanza recenti, interpretazioni tanto riduttive da considerare la guida dell’archivio come una « rilevazione puramente topografica delle serie conservate in un singolo archivio » 68, Elio Lodolini, sulla scia del Cencetti e del Pratesi, ne rivendicava la dignità scientifica accostandola all’inventario da cui si differenzia in quanto descrive, in maniera sommaria, tutti i fondi di un istituto archivistico sulla base della storia delle istituzioni produttrici, mentre l’inventario descrive in forma più o meno analitica un singolo fondo secondo l’ordine che gli è stato dato dal riordinatore 69. Nel manuale di archivistica edito dalla Direction des Archives de France nel 1970 troviamo le definizioni, supportate da un’ampia esemplificazione, di « état sommaire » o « état par fonds » e di « guide ». Quest’ultima può riguardare « l’ensemble d’un dépôt », « une série ou un fond particulier » o anche « une catégorie de recherches particulières ». L’iniziativa di una guida generale degli Archivi dipartimentali viene collocata a metà strada tra l’« état général » e la guida mentre quest’ultima pare distinguersi dall’« état sommaire » 65 E. CASANOVA, Archivistica, Siena 1928, ristampa anastatica Torino 1966, p. 252. L’autore utilizza il termine di censimento una sola volta, nel manuale (p. 119), a proposito delle vicende degli archivi durante la prima guerra mondiale, riferendo della circolare 27 dicembre 1916 con cui il Comando supremo delle forze armate italiane ordinò « il censimento degli archivi trovati nelle terre nuovamente occupate e la denunzia delle eventuali sottrazioni fattene dai nemici ». 66 A. PRATESI, I mezzi ausiliari della scienza archivistica, in « Archiva Ecclesiae », XIIXVII (1969-1974), p. 60. 67 Ibid., pp. 60-61. Il testo di riferimento è il dizionario pubblicato per iniziativa dell’International Council on Archives, Amsterdam-London-New York, Elsevier Publishing Company, 1964, p. 41. In seguito la definizione di guida ivi fornita fu fatta propria da A. D’ADDARIO, Lezioni di archivistica, I, Bari 1972, p. 99. 68 V. GIORDANO, Archivistica e beni culturali, Caltanissetta-Roma 1978, p. 156. 69 E. LODOLINI, Archivistica. Princìpi e problemi, Milano 1995 7, p. 225. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 189 solo per una maggior ampiezza e ricchezza di dettagli 70. Nella nuova edizione del 1993 gli archivisti francesi, ribadite la stretta derivazione della guida dall’« état sommaire » e la sua triplice tipologia (« par services d’archives », « par types de fonds » e « par catégories de recherches »), affermano che, come indica il suo stesso nome, la guida è lo strumento che deve orientare il lettore nel dedalo degli archivi. Mentre la prima tipologia ha l’obiettivo di presentare una veduta d’insieme dei fondi presenti in un determinato istituto di conservazione e la terza può essere identificata con quella che in italiano si definisce « guida tematica », la seconda si propone di facilitare l’accesso a fondi conservati in uno o più istituti. La sua caratteristica è quella di descrivere l’istituzione di cui si occupa, la varietà dei diversi documenti prodotti, gli strumenti di ricerca da utilizzare, la metodologia da seguire. Il riferimento bibliografico fornito per illustrare il caso di una guida ad archivi conservati in sedi diverse, Le guide des archives judiciaires et pénitentiaires en France, edita nel 1992, ne suggerisce l’affinità con le nostre « guide settoriali » 71. Da parte loro, i dizionari pubblicati sotto l’egida del Consiglio internazionale degli Archivi per avviare a soluzione i problemi legati alle forti differenze linguistiche con cui operano gli archivisti di paesi diversi, propongono soltanto le « guide/guide par dépots » (reso con « guida generale » nella traduzione italiana) e il « summary of records / guide spécialisé » (tradotto in italiano con « guida tematica ») 72, non trovandovi dunque cittadinanza la fattispecie delle guide settoriali che « descrivono tutti gli archivi di un determinato tipo, presenti ad esempio in una Regione » 73. 70 MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES, DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Manuel d’archivistique. Théorie et pratique des Archives publiques en France, Paris 1970, pp. 251260. La formula della guida « par dépots » (ossia dedicata ai fondi conservati in un singolo istituto), giudicata un eccellente strumento di ricerca, è stata codificata in Francia con circolare della Direction des Archives dell’8 aprile 1969. Tuttavia la perfezione richiesta e che presuppone approfonditi studi storico-istituzionali, un perfetto ordinamento dei fondi ed una grande esperienza di archivista e storico da parte di chi vi si accinga, costituisce, ad avviso degli stessi autori del manuale, uno svantaggio, per cui essi ritengono preferibile, nella maggior parte dei casi, limitarsi ad una realizzazione più modesta, ma che possa essere messa a disposizione degli studiosi in tempi brevi. 71 La pratique archivistique française, éd. par J. FAVIER e D. NEIRINCK, Paris 1993, pp. 156-158. Sulle guide cfr. anche E. TAILLEMITE, Les instruments de recherches dans les archives, in appendice a H. A. TAYLOR, The arrangement and descriptions of archival materials, München - New York- London- Paris, International Council on Archives, 1980, p. 140. Il glossario ivi pubblicato dal Taylor, studioso di matrice anglosassone, prevede peraltro la sola tipologia della guida tematica (p. 158). La duplice accezione francese del termine di « guide par fonds » viene lasciata cadere anche dagli archivisti canadesi francofoni che la considerano solo come strumento descrittivo di fondi o serie all’interno di uno stesso archivio. Cfr. C. COUTURE - J.Y. ROUSSEAU, Les archives au XX siècle, Montreal, Université de Montréal, 1982, pp. 246-250. 72 INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, Dictionary of Archival Terminology, a cura di P. WALNE, München - New York - London - Paris 1988, ad vocem 209 (ICA Handbooks Series, 3). 73 P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma 1983, p. 211. Juanita Schiavini Trezzi 190 Dopo che Paola Carucci ha messo a punto una chiara elencazione delle tipologie di guide che è possibile realizzare (generali, particolari, settoriali, tematiche, topografiche), ponendole sotto la definizione comune di « strumento per la ricerca che descrive sistematicamente in maniera più o meno dettagliata i fondi conservati in uno o più istituti archivistici » 74, non è mancata la puntualizzazione di Antonio Romiti che al tema dei mezzi di corredo ha dedicato un denso intervento riassumendo attentamente anche le posizioni dei più noti archivisti italiani. Giudicate le distinzioni fissate nel glossario in appendice al manuale della Carucci « oggettivamente indiscutibili », egli richiama la lezione di Lodolini e Pratesi individuando la parte qualificante di una guida « sia nell’introduzione generale, nella quale compaiono le notizie relative all’origine, alle vicende e allo sviluppo dei singoli istituti, sia nelle presentazioni alle sezioni o serie archivistiche, redatte in dimensioni giustificate dalle necessità illustrative e corredate da uno specialistico apparato critico, sia nelle sintetiche fasi descrittive dei ’fondi’, pure esse rese significative da brevi indicazioni e completate, ove richiesto, da notazioni bibliografiche e archivistiche » 75. Alle guide settoriali ha dedicato in seguito un interessante approfondimento Domenica Porcaro Massafra che, raccogliendo ed elaborando il messaggio di Romiti e Carucci, ne formula una più completa definizione: « La guida settoriale è lo strumento per la ricerca che descrive sistematicamente, in maniera più o meno dettagliata, gli archivi di un determinato tipo » 76. Se abbiamo insistito in questo excursus attraverso le interpretazioni del concetto di guida, è perché il confine tra guide settoriali e censimenti appare molto labile e forse non ancora interamente esplorato. La questione potrebbe essere liquidata rapidamente se ci si risolvesse ad affermare che la dottrina archivistica non ha preso in considerazione il censimento per la semplice ragione che esso non è, di per sé, un mezzo di corredo, ma solo un mezzo « preparatorio agli strumenti di ricerca » 77, un’indagine su determinati archivi finalizzata alla pubblicazione della relativa guida 78, visto che le guide (settoriali) desumono i loro dati dagli inventari e dai censimenti 79. 74 Ibidem. 75 A. ROMITI, I mezzi di corredo archivistici, in Temi di archivistica, Lucca 1996, pp. 67102, il passo citato è alle pp. 94-95 (saggio già apparso in « Archivi per la storia », III, 1990, 2, pp. 218-246). 76 D. PORCARO MASSAFRA, Le guide archivistiche settoriali, in « Archivi per la storia », VII (1994), 1, pp. 23-40. Nella stessa sede (alle pp. 59-62), C. VIGGIANI ha proposto invece: Appunti sulle guide tematiche e R. DE BENEDITTIS il già citato intervento sui censimenti. 77 D. PORCARO MASSAFRA, Le guide archivistiche settoriali... cit., p. 38. 78 P. BENIGNI, Caratteri e finalità degli strumenti di corredo: un tema da riprendere, in Strumenti di gestione e ricerca degli archivi italiani... cit., pp. 81-82, nota 4. 79 Gli archivi comunali della Provincia di Oristano... cit., p. 43. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 191 Paola Carucci sembra a sua volta sottendere il medesimo concetto quando afferma che « le guide generali e particolari si propongono di massima di descrivere secondo criteri sistematici un insieme di fondi individuati per istituto di conservazione o per tipologia di archivi (censimenti) su base territoriale o nazionale » 80. Il censimento viene rapidamente additato quale rilevazione che si pone in un momento ben distinto e preliminare rispetto alla redazione di « idonei e scientifici strumenti archivistici » anche da Giorgetta Bonfiglio Dosio 81 che tuttavia, poco oltre, colloca censimenti e guide nello stesso ambito degli strumenti archivistici, che si differenziano solo per una maggior ricchezza di notizie e di chiavi d’accesso delle seconde rispetto ai primi. Il riferimento è esplicitamente alla De Benedittis che infatti scriveva: « Diversamente da altri strumenti di ricerca, il censimento non presuppone un preventivo riordinamento degli archivi presi in considerazione (...). In una fase successiva, con la elaborazione di strumenti di ricerca più elaborati (guide, inventari, repertori ecc.) si potrà compiere un’analisi comparata delle schede di rilevamento del censimento, individuando i fondi e le serie che sono stati segnalati senza rigore metodologico e inquadrandoli in una esposizione logica archivisticamente accettabile » 82. Entrambi dunque strumenti di ricerca, laddove il confine archivistico e metodologico tra i censimenti e le guide sta nella « fase di transizione da dati scarni, essenziali e non uniformi ad informazioni più logiche e ragionate » 83. A nostro avviso invece, il censimento (inteso come quadro in cui vengono presentati in forma organizzata i dati risultanti dall’omonimo lavoro di rilevazione) non solo è uno strumento di ricerca (ciò che non sembra necessiti di dimostrazione), ma deve essere accolto tra i mezzi di corredo archivistici primari 84. Il suo obiettivo infatti non è unicamente quello di corrispondere a questa o quella istanza proveniente dal mondo della ricerca (come nel caso delle guide tematiche, in cui non riusciamo a scorgere alcuna oggettività), ma di fornire un quadro descrittivo di ciascuno degli elementi dell’insieme costituito da tutti gli archivi prodotti da un gruppo omogeneo di soggetti. 80 P. CARUCCI, I vari livelli dell’inventariazione, in Gli archivi e la memoria del presente, Roma 1992, pp. 51-62 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 23); il passo citato è a p. 57. 81 « L’ente Provincia (...) è il soggetto giuridico maggiormente qualificato ed abilitato per collaborare con le Soprintendenze archivistiche, al fine prima di tutto di censire l’esistente per tutelarlo nel miglior modo possibile e poi di rendere disponibile agli studiosi e ai cittadini, attraverso idonei e scientifici strumenti archivistici, il patrimonio documentario conservato nel territorio provinciale », cfr. G. BONFIGLIO DOSIO, L’amministrazione del territorio durante la Repubblica Veneta… cit., p. 1. 82 R. DE BENEDITTIS, I censimenti... cit., p. 17. 83 Ibid., p. 20. 84 L’impostazione del problema terminologico è mutuata da A. ROMITI, I mezzi di corredo archivistici... cit., pp. 78-79 dell’edizione Lucca 1996. Juanita Schiavini Trezzi 192 Sembra opportuno ricordare che il censimento non è il solo mezzo di corredo a non presupporre il riordino preventivo degli archivi: così è anche per la guida e per l’elenco e tuttavia nessuno avanza l’ipotesi che la sommarietà o provvisorietà di un elenco (il quale si propone di offrire un’immagine fotografica dell’archivio ed è quindi frutto di un’operazione semplicemente descrittiva) ne infici il carattere di mezzo di corredo primario o « strettamente archivistico ». D’altro canto non si vede perché l’operazione del censimento debba per sua stessa natura prescindere dal rigore metodologico e dar necessariamente luogo ad un quadro descrittivo grezzo ed archivisticamente irrazionale. Se l’elenco è mezzo di corredo predisposto per un singolo fondo, il censimento può essere definito come mezzo di corredo che abbraccia una pluralità di archivi, prodotti (come s’è detto) da un gruppo omogeneo di soggetti: non però come semplice sommatoria di elenchi singolarmente presi, ma come prodotto di una metodologia di lavoro che ne evidenzi gli elementi comuni; ad esempio attraverso una sistematizzazione dei dati meno rigorosa di quella richiesta da una guida, ma sufficiente a fornire un quadro tendenzialmente organico e non un affastellamento di informazioni in ordine puramente casuale. Che ciò sia cosa consueta nella prassi, risulta evidente dalla lettura di qualsiasi pubblicazione qualificantesi come censimento. A nostro avviso, l’elemento davvero caratterizzante la natura del censimento nei confronti della guida settoriale va tuttavia cercato altrove, attingendo al significato corrente del termine ed alle analisi cui è stato sottoposto dal punto di vista giuridico: « operazione statistica di rilevazione diretta e totale intesa ad accertare lo stato di un fatto collettivo in un determinato momento e caratterizzata dall’istantaneità, dalla generalità e dalla periodicità » 85; « operazione statistica, basata sul rilevamento diretto, che permette di conoscere sistematicamente il maggior numero di dati concernenti lo stato di una popolazione o di un fatto a carattere collettivo o sociale » 86; « operazione statistica di rilevazione universale simultanea intesa ad accertare in un dato momento lo stato di un fatto collettivo » 87, « il censimento considera il fenomeno da rilevare con metodo uniforme e continuato, nel suo aspetto statico » 88. Dai princìpi della istantaneità (implicita anche nell’affermazione che il fenomeno non deve essere colto nella sua evoluzione dinamica ma « fermato » come in un fotogramma), generalità (o universalità), sistematicità, immediatezza (nel senso che l’approccio deve essere diretto e non mediato), è possibile trarre una conclusione fondamentale nel contesto in cui ci muoviamo: il censimento (nella duplice accezione di rilevazione dei dati e quadro descritti85 Vocabolario della lingua italiana, I, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1986. 86 Dizionario enciclopedico universale Sansoni, I, Milano 1995, p. 309. 87 N. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 1999. 88 Enciclopedia del diritto, VI, Milano, Giuffrè, 1960, p. 710. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 193 vo delle sue risultanze), deve necessariamente abbracciare la totalità degli elementi che compongono l’insieme preso in esame. Non altrettanto si può dire della guida, sostantivo nel quale non rientra necessariamente il concetto di totalità tanto che, non a caso, quando ciò accade, viene corredato da un aggettivo qualificativo atto a precisarne la natura e l’estensione. Difatti nella prassi, accanto a guide generali che descrivono la totalità dei fondi presenti in un certo istituto di conservazione o in tutti gli Istituti di pari natura (ad es. gli Archivi di Stato o gli Istituti di storia del movimento di liberazione), e a guide settoriali che prendono in considerazione gli archivi prodotti da tutti gli enti di un certo tipo presenti in un certo territorio (ad es. le Camere di commercio italiane o i Comuni dell’Emilia Romagna), troviamo numerosi esempi di guide settoriali che non accampano certamente pretese di esaustività. Il caso più frequente è quello in cui ci si occupi di categorie di soggetti produttori d’archivio dai contorni non ben definibili (ad es. le istituzioni culturali o quelle assistenziali) o che per varie ragioni (non esclusa la normativa vigente) non possano essere né identificati né raggiunti nella loro totalità (ad es. gli archivi privati) 89. In tutti i casi in cui l’obiettivo dell’universalità (nell’ambito, lo ribadiamo, dell’insieme predeterminato in base a tipologia di enti e dimensione geografica) non sia raggiungibile, sarà doveroso rinunciare a qualificare il lavoro come un censimento. Quanto all’espressione « censimento tematico » 90, ci appare contraddittoria e improponibile in quanto la proposizione di un tema, spostando l’indagine da un insieme omogeneo di istituzioni produttrici d’archivio al piano degli argomenti trattati nelle fonti prodotte da una pluralità di soggetti diversi, non può che approdare all’indefinita vaghezza della soggettività in cui si muovono, peraltro, anche le guide tematiche. Esse sono infatti intrinsecamente soggettive in quanto la definizione dell’aderenza o meno di un fondo, di una serie, finanche di un singolo documento, al tema proposto, è operazione intimamente legata alla cultura e alla sensibilità del redattore, oltre a sottostare apertamente alle esigenze della ricerca così come si manifestano in un determinato momento storico. 89 Tutti i curatori di pubblicazioni in merito, hanno sentito la necessità di premettere avvertenze circa la definizione del campo d’indagine. A titolo esemplificativo cfr., per gli archivi di enti culturali, G. BONFIGLIO DOSIO, I mille volti della cultura: gli archivi degli istituti culturali della provincia di Padova... cit., pp. 9-13 e V. CAVALCOLI, Per una prima ricognizione sugli archivi degli enti culturali nelle Marche, in Saggi archivistici. Didattica nelle Marche 2... cit., p. 107. Per gli archivi degli enti assistenziali cfr. Gli archivi delle istituzioni di carità e assistenza in Bologna... cit., p. 6. Per gli archivi privati: Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida, I, Roma 1991, pp. XIII-XV (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CXII). Si vedano, inoltre, gli esiti dei tentati censimenti degli archivi d’impresa. Per le difficoltà dell’operazione cfr. per tutti quanto riferisce M. Guercio nell’introduzione alla Guida degli archivi economici a Roma e nel Lazio, Roma 1987, pp. 11-18 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 54). 90 Utilizzata da R. DE BENEDITTIS, I censimenti… cit., p. 21. Juanita Schiavini Trezzi 194 A tutto ciò non pone alcun rimedio, a nostro avviso, l’eventuale esposizione in « corretta adesione a canoni archivistici consolidati » 91. In tal modo infatti si produrrà un elenco più ordinato e razionale, ma non meno soggettivo. Al contrario, il censimento, oltre ad essere necessariamente generale, è anche per sua natura oggettivo, poiché viene prodotto con metodi ed obiettivi archivistici e l’eventuale approssimazione dei dati, in quanto derivante dallo stato di disordine dei fondi, è un elemento puramente estrinseco. La componente della professionalità dell’estensore entra certamente in gioco anche nella realizzazione di un censimento in maniera analoga a quanto accade nella redazione di un inventario e non secondo le modalità che caratterizzano il lavoro dello storico, il quale seleziona le fonti in funzione della sua ricerca. Così, se la scheda di rilevazione del censimento dovrà essere quanto più aderente possibile alla tipologia dell’archivio preso in esame e delle scritture che lo compongono, il curatore dello strumento in cui confluiranno le schede dovrà astenersi dall’applicare criteri selettivi o dall’inserire valutazioni di merito sulla maggior o minore importanza di questa o di quella serie, o dall’avanzare interpretazioni sui contenuti. Riemerge dunque, nell’ambito del censimento, quell’esigenza di avalutatività messa a fuoco da Leopoldo Cassese nel tracciare i caratteri dell’archivistica quale disciplina autonoma rispetto alla storia 92. Si dovrà invece fare in modo che attraverso il censimento affiorino quegli elementi comuni che, al di là delle peculiarità di ciascun archivio, contraddistinguono la produzione documentaria e le sue forme di organizzazione all’interno di un insieme omogeneo di enti produttori. Il censimento potrebbe così rivelarsi uno strumento prezioso per inoltrarsi sulla via additata da Filippo Valenti: « individuare, per entro l’infinita varietà delle singole fattispecie, se non proprio delle “leggi generali”, quanto meno dei parametri che ci permettano di intessere gradualmente una tipologia delle strutture dei fondi d’archivio ». In altre parole, enucleare, mediante un’analisi comparata delle modalità di organizzazione della memoria da parte degli istituti produttori, dei parametri generali 93. Non insisteremo sull’utilità dei censimenti quale strumento conoscitivo per la pianificazione degli interventi di salvaguardia, riordinamento, inventariazione, valorizzazione sia da parte degli enti produttori sia da parte dell’Amministrazione archivistica. Merita forse qualche cenno, invece, il tema 91 C. VIGGIANI, Appunti sulle guide tematiche, in « Archivi per la storia », VII (1994), 1, pp. 59-62. L’intervento è centrato principalmente sulle esigenze redazionali di questi strumenti legate alle difficoltà di sistematizzazione e di normalizzazione 92 Sintetizzando, l’avalutatività « è un’assenza di intervento ideologicamente turbativo che o nella organizzazione delle fonti, o nella loro predisposizione all’uso, le potrebbe rendere diverse da quello che sono state e che rappresentano », cfr. D. TAMBLE’, La teoria archivistica italiana contemporanea. Profilo storico critico (1950-1990), Roma 1993, p. 37. 93 F. VALENTI, Parliamo ancora di archivistica, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XXXV (1975), pp. 191-192. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 195 della funzione di freno alle dispersioni e distruzioni di carte riconosciuta da molti ai mezzi di corredo archivistici. Occorre tuttavia ammettere che tale affermazione è a dir poco ottimistica: se può avere qualche conferma nel breve periodo, troppi esempi dimostrano che su tempi medio-lunghi non è stata certo la presenza di un accurato inventario (né tanto meno di elenchi sommari) a proteggere archivi più o meno ricchi e importanti dal disordine, dalla vendita come carta straccia, dall’utilizzo quale combustibile e così via. La sensibilizzazione indotta nei titolari dell’archivio o nelle persone preposte alla sua custodia si affievolisce tanto più rapidamente quanto più l’archivio resta un corpo sostanzialmente estraneo al vissuto quotidiano del soggetto produttore e certamente la concentrazione in un istituto specializzato costituisce la contromisura più rapida ed efficace. La crescita culturale necessaria per assicurare una buona gestione in loco ha infatti tempi ben più lunghi ed esiti assai più incerti. E tuttavia ci pare che la sfida vada raccolta almeno nel caso specifico degli archivi parrocchiali, troppo intimamente legati alla vita delle comunità locali perché debbano esserne allontanati, risorse troppo preziose per l’autocoscienza delle popolazioni (e non solo dei fedeli), sussidio alla pratica pastorale per i parroci, perché vengano loro sottratti in nome dell’interesse di qualche studioso a svolgere più agevolmente le proprie ricerche in confortevoli sale studio ecclesiastiche o statali. A nostro avviso il censimento, molto più degli interventi sui singoli archivi scollegati tra loro, è ricco di potenzialità quale ausilio nell’opera educativa indubbiamente difficile che ha come obiettivo il coniugare la permanenza degli archivi nelle sedi originarie e la loro corretta custodia (ma anche riscoperta, utilizzazione, ecc.). In primo luogo le sue stesse modalità di realizzazione (così come brevemente illustrate e concretamente tradotte nell’esperienza bergamasca di cui si dirà tra breve) creano un collegamento tra i responsabili dei diversi archivi e li chiamano a farsi parti attive di un progetto comune, stimolando la condivisione degli obiettivi, la conoscenza reciproca, il dialogo con scambio di esperienze, informazioni, consigli. Inoltre l’edizione dei risultati dell’indagine in forma necessariamente collettiva, consente confronti che attivano meccanismi di apprezzamento e di emulazione. Infine, se la realizzazione di un censimento è impresa complessa e irta di difficoltà, la verifica dello stato degli archivi, sulla scorta della prima redazione, è lavoro certamente assai più agevole. Non sembra perciò utopistico ipotizzare una periodicità quanto meno coincidente con quella delle visite pastorali. L’ispezione, prescritta dallo stesso codice di diritto canonico, verrebbe notevolmente semplificata proprio perché sarebbe sufficiente annotare, attenendosi alla stessa griglia predisposta a suo tempo, le sole discrepanze riscontrate rispetto alla situazione fotografata nel censimento. L’esperienza bergamasca è nata da un’idea di don Mario Benigni, direttore del Centro studi « Giovanni XXIII - Fondazione L. F. Capovilla », istituito presso il Seminario di Bergamo, docente di storia della Chiesa nello Studio Juanita Schiavini Trezzi 196 teologico del Pontificio istituto missioni estere di Milano, già presidente della Commissione storica nella causa di canonizzazione di papa Giovanni XXIII 94. L’intento iniziale di verificare sommariamente lo stato delle fonti per la storia religiosa di Bergamo, specialmente per il periodo tra Ottocento e Novecento in quanto indispensabili per l’attività del Centro studi, si trasformò ben presto, nei colloqui con il delegato vescovile Maurizio Gervasoni, nel desiderio di mettere a punto un progetto di più ampio respiro, che desse risultati più sistematici e duraturi: il censimento degli archivi parrocchiali. La calorosa approvazione del vescovo mons. Roberto Amadei, dettata non solo dalla sollecitudine pastorale ma anche dalla particolare sensibilità del presule, per anni docente di storia della Chiesa ed autore egli stesso di apprezzati saggi storici, consentì a don Benigni di mettersi al lavoro con intelligenza, entusiasmo, alacrità. Sua prima preoccupazione fu di attivare la collaborazione con la Soprintendenza archivistica per la Lombardia, l’Archivio di Stato di Bergamo, il Centro culturale « Nicolò Rezzara », l’Assessorato alla cultura della Regione Lombardia, in modo che il progetto potesse avvalersi di solidi apporti professionali e finanziari. Ad integrazione dei fondi già messi a disposizione dalla diocesi nella persona del delegato vescovile per le attività economiche e i beni culturali mons. Arrigo Arrigoni, la Regione accettò infatti di erogare un significativo contributo, mentre le altre componenti del pool, impostata la scheda di rilevazione, si impegnavano a fornire la consulenza per i problemi che eventualmente fossero emersi in itinere. Nel frattempo, don Benigni effettuava alcune scelte che si sarebbero rivelate determinanti per il successo dell’iniziativa. La prima fu quella di affidare la raccolta dei dati a un gruppo di giovani laureate che per curriculum e qualità personali offrissero garanzie di serietà, preparazione culturale, capacità tecniche, determinazione, rispettosa però delle prerogative e delle sensibilità personali dei parroci e non disgiunta dalla cordialità del tratto. In seguito si sarebbe potuto constatare come l’obiettivo di censire ben 426 archivi parrocchiali, chiesto a questa piccola équipe composta da Emanuela Antozzi, Barbara Curtarelli, Marilisa Rota e Valentina Zappa, non sarebbe stato raggiunto senza la loro disponibilità incondizionata, pronta anche ad affrontare i disagi di peregrinazioni condotte nella stagione climaticamente meno favorevole (tra l’autunno del 1996 e la primavera del 1997) e sostenuta da compensi tutt’altro che lauti. Non meno determinante fu però l’impegno profuso personalmente da don Benigni nel preparare il terreno presso i parroci ricorrendo a tutti i possibili canali di informazione e con un’organizzazione tanto capillare quanto attenta a contemperare le esigenze locali con quelle di un rapido e soddisfacente esito 94 Tra le numerose pubblicazioni di don Benigni si segnala il corposo e documentatissimo Papa Giovanni XXIII chierico e sacerdote a Bergamo, 1892-1921, Milano 1998 (Studi e memorie del Seminario di Bergamo, 5). Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 197 dei lavori. All’invio di una prima lettera di segnalazione dell’iniziativa, a firma di mons. Gervasoni e contenente in allegato lo schema della scheda di rilevazione perché i destinatari potessero rendersi subito conto della natura dei dati che si intendevano rilevare, seguì la presentazione del progetto condotta a viva voce dallo stesso Benigni in occasione degli incontri vicariali (talvolta avvalorata dall’incoraggiante parola del vescovo) e aperta ad ogni richiesta di chiarimenti, proposta o franco scambio di idee. Ottenuta così la consapevole disponibilità di tutti i parroci, la stesura del calendario delle visite fu improntata al massimo rispetto per gli impegni dei singoli sacerdoti. Si tenne conto, ad esempio, di feste patronali, programmi di catechesi, missioni, riunioni di organi ecclesiali, impegni legati all’insegnamento scolastico o ad altri incarichi civili o ecclesiali; al tempo stesso però, la programmazione fu assai rigorosa in modo da non consentire (né tanto meno, suggerire) dilazioni o rinvii a tempo indeterminato. L’intervento personale dell’infaticabile Benigni, amichevole e convincente, poté aver ragione anche di qualche ostinata resistenza o inguaribile distrazione. Le visite si svolsero per vicariati: in questo modo era possibile razionalizzare gli spostamenti delle rilevatrici, ridurre i tempi di « lavorazione », facilitando eventuali ritorni di controllo nei giorni successivi trovandosi ancora impegnate nella stessa zona, mantenere alta l’attenzione dei parroci per il tempo necessario a completare il percorso nel raggio relativamente ristretto della circoscrizione vicariale e, dal punto di vista strettamente archivistico, notare eventuali linee comuni nella formazione e conservazione degli archivi di parrocchie distribuite su aree omogenee dal punto di vista geografico, storico, socio-economico. Il vicariato di Ardesio-Gromo costituì il banco di prova per sperimentare l’adeguatezza della scheda preparata a tavolino e per la messa a punto di una comune metodologia di lavoro da parte delle rilevatrici che, per questo, operarono in gruppo e sotto la guida di don Benigni in tutti gli archivi della zona per poi invece suddividersi l’impegno della visita ai restanti 27 vicariati della diocesi. Per tutta la durata della rilevazione non mancarono comunque momenti di confronto per dare soluzione coerente ai molti dubbi provocati soprattutto dal diverso stato di ordinamento degli archivi. Dalla rielaborazione informatizzata delle schede, affidata a Ornella Genua del Centro culturale « Nicolò Rezzara » scaturì infine il volume Gli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo. Censimento 1997 a cura di don Mario Benigni, cui si devono anche la nota introduttiva su « metodologia e risultati » e le sintetiche notizie sull’origine della parrocchia premesse alla descrizione di ciascun archivio. Per facilitare la consultazione, le schede sono state inserite in ordine alfabetico generale per località con le parrocchie del capoluogo (cattedrale in testa) che precedono quelle del territorio e appaiono così strutturate: intitolazione della parrocchia, comune di appartenenza (informazione indispensabile perché molte hanno sede in frazioni), distanza dal capoluogo, altitudine, c.a.p. e numero telefonico, cenni sulla sua storia (con particolare riguardo a Juanita Schiavini Trezzi 198 origine, incorporazioni, smembramenti, soppressioni, tutte vicende strettamente intrecciate con quelle dell’archivio), descrizione dell’archivio, sigla della rilevatrice. Come avverte il curatore, « il titolario che indicizza il materiale è convenzionale e non vuol suggerire alcuna norma di riordino » 95. L’obiettivo di conferire omogeneità ai dati è stato infatti raggiunto (anche se qua e là si percepiscono incertezze dovute allo stato di disordine nelle carte e forse anche alla diversa « mano » delle rilevatrici) individuando una griglia adatta a raccogliere il materiale documentario di tutti gli archivi, indipendentemente dal tipo di ordinamento, dal fatto che fosse stato adottato o meno un titolario e dalla diversità dei titolari stessi. Le voci, di cui ciascuna scheda riporta solo quelle effettivamente riscontrate in archivio, sono le seguenti: carteggio con autorità ecclesiastiche; privilegi e concessioni; visite pastorali; autenticazione reliquie; chronicon; omelie; clero parrocchiale; corrispondenza vicariale; rapporti con autorità civili; libri dei battesimi; libri delle prime comunioni; libri delle cresime; libri dei matrimoni; processi e atti matrimoniali; pubblicazioni di matrimonio; libri dei morti; atti di morte; stati delle anime; attività pastorali; cappellanie; legati; benefici; atti notarili; vicinìe; patrimonio parrocchiale; fabbriceria; amministrazione e bilanci; controversie e liti; libri messe; oratorio; società di mutuo soccorso; asilo; ospizio; confraternite e associazioni; carteggio. Di ciascuna « serie » (ma evidentemente in alcuni casi si tratta di veri e propri archivi aggregati), sono forniti consistenza, estremi cronologici ed eventuali note esplicative. La presenza di una biblioteca di particolare interesse è stata invece segnalata (con corretta scelta metodologica) nei cenni introduttivi. Benché attualmente le parrocchie della diocesi siano 389, gli archivi censiti sono complessivamente 426, in seguito alla decisione di dedicare una scheda autonoma agli archivi storici di ciascuna delle parrocchie accorpate con i decreti vescovili del 18 luglio 1986 96. In ogni caso, la circostanza è richiamata, con gli opportuni rimandi, nei cenni introduttivi ad ogni scheda. Chi si accingerà ad utilizzare il volume non dovrà però dimenticare che i confini della diocesi non coincidono con quelli della provincia e dunque non vi si troveranno le numerose parrocchie della provincia di Bergamo appartenenti alle diocesi di Brescia, Cremona e Milano. Viceversa, sono presenti le parrocchie della diocesi di Bergamo ubicate in altre province: una (Paratico) in quella di Brescia e 14 (l’Alta Val San Martino) in quella di Lecco, peraltro di recente istituzione 97. 95 Gli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo... cit., p. 7. 96 Ibid., elenco alle pp. 7-8. 97 Si trovano in diocesi di Brescia: Bossico, Lovere, Palosco, tre parrocchie nel Comune di Rogno e sei corrispondenti ad altrettante frazioni del Comune di Costa Volpino. Alla diocesi di Cremona appartengono le parrocchie ubicate nei comuni che, dal punto di vista civile, costituiro- Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 199 Per motivi di riservatezza e per le frequenti variazioni cui sono soggetti, si è invece deliberatamente evitato di pubblicare l’esatta ubicazione degli archivi nonché lo stato dei locali e delle attrezzature rinviando, per le condizioni di accessibilità, agli accordi che gli interessati potranno prendere con i singoli parroci. Per rimarcare l’intento di fornire, alle parrocchie stesse oltre che agli studiosi, un agile strumento di lavoro e non un volume da dimenticare su uno scaffale, la veste tipografica è stata ricalcata su quella ormai tradizionale e ben collaudata dell’annuario diocesano, con il caratteristico formato (15x21 cm.) ed i margini azzurri a rubrica a scandire l’ordine alfabetico delle iniziali delle varie località. Un ulteriore elemento introdotto per caratterizzare l’opera come strumento di lavoro è l’appendice, che comprende tre contributi volti a fornire un primo corredo di informazioni essenziali ai parroci, ai loro collaboratori nella tenuta degli archivi e a chi volesse accostarsi agli archivi parrocchiali bergamaschi per svolgervi ricerche storiche. Eugenio Zanetti, con La legislazione canonica riguardo agli archivi parrocchiali, oltre ad una chiara sintesi del quadro normativo, offre anche un pratico vademecum sulle tipologie di documenti da custodire in archivio, sulle modalità di conservazione più opportune, sull’organizzazione dell’archivio nelle diverse fasi della sua vita (corrente, di deposito, storico), uso e consultazione e sui rapporti con altri archivi e con le autorità civili, anche alla luce delle direttive della CEI e del XXXVI Sinodo diocesano, dei suggerimenti che vengono da disposizioni di diocesi vicine oltre che dalla legislazione civile in materia di privacy. L’opportunità del contributo di Vincenzo Marchetti Fonti edite e bibliografia per la storia delle parrocchie della diocesi di Bergamo è stata suggerita dalla constatazione che nel fiorire di opere di storia locale che ha caratterizzato gli ultimi due decenni, accanto a lavori di ottimo o buon livello, ve ne sono stati numerosi nei quali la buona volontà degli estensori non è stata supportata da un adeguato livello di preparazione, neppure sulle fonti e sulla bibliografia fondamentali da cui sarebbe indispensabile prendere le mosse (ivi no l’Alto Cremonese e parte della Gera d’Adda nel Ducato di Milano: Antegnate, Arzago d’Adda, Barbata, Brignano Gera d’Adda, Calcio, Calvenzano, Caravaggio (con il Santuario della B. Vergine avente gestione autonoma e le frazioni di Masano e Vidalengo), Casirate d’Adda, Covo, Fontanella al Piano, Fornovo San Giovanni, Misano Gera d’Adda, Mozzanica, Pumenengo, Torre Pallavicina. Per ragioni storiche altrettanto evidenti, dipendono dall’arcidiocesi di Milano le cinque parrocchie in cui è suddiviso il territorio comunale di Treviglio (più la cappellania ospedaliera) e quelle di Brumano, Canonica d’Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d’Adda, Pontirolo Nuovo. L’appartenenza di 14 parrocchie alla provincia di Lecco è dovuta alla recente istituzione di tale provincia mediante scorporo di alcuni comuni da quelle contermini: tra di essi, appunto, i comuni bergamaschi di Calolziocorte (con le frazioni di Foppenico, Lorentino, Pascolo, Rossino, Sala di Calolzio, tutte sedi parrocchiali), Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de’ Busi (con le frazioni di San Gottardo e di San Marco), Vercurago (con la frazione di Somasca). La Diocesi di Bergamo. Guida ufficiale 2000, a cura dell’UFFICIO DIOCESANO DI STATISTICA, Bergamo 1999, pp. 357-364. Juanita Schiavini Trezzi 200 compresa, pare incredibile, la storia della diocesi) 98. In relazione poi all’auspicata possibilità che il censimento condotto stimoli nuove iniziative di riordino ed inventariazione, l’autore sottolinea, a ragione, che essendo inconcepibile il riordino di un archivio senza la conoscenza dell’ente che lo ha prodotto, « scopo di questo scritto è appunto quello di segnalare alcuni strumenti utili per lo studio dell’istituzione parrocchiale bergamasca » 99. Particolarmente apprezzabile, visti gli obiettivi dichiarati, il fatto che il testo non si limiti a fornire un arido elenco bibliografico ma lo introduca con descrizioni esplicative e commenti critici rivelandosi un valido aiuto per orientare anche il ricercatore meno esperto. Il volume si chiude con un invito a prendere in considerazione la possibilità di integrare le notizie tratte dagli archivi ecclesiastici facendo ricorso alle Fonti per la storia delle parrocchie negli archivi degli uffici statali (sec. XIX) di Juanita Schiavini Trezzi. Gli archivi di riferimento sono quello prefettizio (nel periodo napoleonico e nel Regno d’Italia postunitario), dell’I. R. Delegazione provinciale (durante il Regno lombardo-veneto) e dell’Economato generale per i benefici vacanti istituito nel 1860; tutti organismi attraverso i quali si esplicò il controllo politico-amministrativo statale non solo sulla gestione dei patrimoni ecclesiastici ma anche sulla pratica religiosa delle popolazioni e sull’attività prettamente pastorale del clero. Per questo tali fonti, sottoutilizzate se non addirittura sconosciute a molti, si rivelano particolarmente ricche anche rispetto a quelle conservate negli archivi diocesani. Ora è già possibile tracciare un primo bilancio dell’iniziativa, tenendo conto di quanto annotava nell’introduzione il principale protagonista del progetto: « arrivati alla fine del lavoro e nell’atto di licenziarlo alle stampe, si vorrebbe ricordare che questo è il primo tentativo nel suo genere che si compie nella diocesi di Bergamo (...). Sembrava comunque che il rischio di fare un’opera in qualche sua parte lacunosa e forse errata doveva essere corso, sia per colmare una lacuna, questa sì vera, in diocesi, sia per incoraggiare una sempre maggior cura nella gestione degli archivi parrocchiali. Saranno perciò gradite le segnalazioni di errori, dimenticanze, lacune, imprecisioni che si dovessero ancora trovare nonostante i numerosi controlli sui dati e sul testo finale, in vista di una seconda più aggiornata e corretta edizione » 100. Al di là, appunto, di ogni possibile critica, ci pare che il censimento abbia colto ampiamente nel segno in almeno tre direzioni fondamentali: — evidenziare la ricchezza degli archivi parrocchiali; — generare consapevolezza del significato culturale di un bene spesso trascurato e stimolare iniziative di riordino, inventariazione, valorizzazione; 98 Diocesi di Bergamo, a cura di A. CAPRIOLO - A. RIMOLDI - L. VACCARO, Brescia 1988 (Storia religiosa della Lombardia, 2). 99 100 Gli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo... cit., p. 501. Ibid., p. 10. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 201 — portare alla luce una realtà sommersa ossia la silenziosa presenza, in molte parrocchie, di laici impegnati nel ruolo di custodi dell’archivio. È sufficiente una rapida scorsa alla tipologia e consistenza delle carte presenti nei 426 archivi censiti per coglierne appieno le straordinarie potenzialità ai fini dei più svariati filoni della ricerca storica. Ben 39 archivi custodiscono libri canonici (battesimi, matrimoni, morti) anteriori alla fine del Concilio di Trento che ne dispose l’introduzione nel 1563 101 e altri 82 ne risultano provvisti entro la fine del ’500. Numerosissime le parrocchie dotate di chronicon la cui compilazione è di norma discontinua (evidentemente perché troppo legata agli umori del parroco pro tempore) ma che costituiscono impareggiabili testimonianze di vita quotidiana sia nei casi di eccezionale antichità 102 sia in quelli, più frequenti, datati al XIX secolo, sia nei numerosissimi « diari » del Novecento, in cui ci sembra di poter cogliere che una maggior propensione a fissare la memoria degli eventi emerga in concomitanza con le due guerre mondiali e nel periodo che le collega. Eccezionalità degli avvenimenti, formazione culturale del clero, modelli e ritmi di vita sacerdotale, e fors’anche direttive più puntuali da parte di vescovi e sinodi potrebbero essere alcune delle ragioni di un fenomeno certamente non casuale. Così come non è stato certamente casuale l’abbandono generalizzato della prassi cronachistica tra la fine degli anni Sessanta e la metà del decennio successivo. L’ipotesi di lavoro già suggerita da chi, occupandosi del fenomeno storico del mutualismo e constatando l’estrema dispersione degli archivi delle società di mutuo soccorso, ne ha individuato significative tracce anche negli archivi parrocchiali 103, è confermata appieno dal caso bergamasco. 101 I più antichi si trovano ad Albano S. Alessandro (1518), Carenno (1525), Nasolino (1534), Rosciano (1538), Osio Sopra (1539), Gandino (1541). Benché sia noto che i decreti tridentini furono anticipati in molte diocesi dall’avvio di forme di registrazione dei battesimi e dei matrimoni, per autonoma iniziativa dei parroci o su sollecitazione delle autorità sia ecclesiastiche che civili, si ha l’impressione che nelle parrocchie bergamasche il fenomeno sia stato particolarmente diffuso. Per Venezia ad esempio, viene segnalato che le date di origine delle serie decorrono dagli anni ’50 del XVI secolo, precedute solo da pochi casi risalenti agli anni ’30 e ’40, limitati alle registrazioni di battesimi, matrimoni e morti di persone del ceto nobiliare effettuate dai parroci per ordine dell’Avogaria di Comun. F. CAVAZZANA ROMANELLI, Gli archivi parrocchiali... cit., p. 19. Per riscontri su altre aree geografiche cfr. i numerosi contributi editi in La « conta delle anime ». Popolazioni e registri parrocchiali... cit., in particolare la bibliografia elencata alla nota 18. 102 Si conservano cronache risalenti al XV secolo in cinque località: Alzano Maggiore, Novazza, Somendenna, Trescore Balneario, oltre a Gandino in cui però il riferimento ad un precocissimo XII secolo fa pensare che si tratti di un elaborato posteriore. In altre undici parrocchie si trovano cronache risalenti al XVI secolo, in 17 al XVII secolo e infine in 13 al XVIII. 103 L. TREZZI, Fonti per la storia del movimento cattolico negli archivi parrocchiali delle diocesi lombarde, in « Archiva Ecclesiae », XVIII-XXI (1975-1978), pp. 277-297; F. DELLA PERUTA, Fonti archivistiche per la storia della Lombardia, in Gli archivi per la storia contemporanea, Roma 1986, p. 92 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 7). Per le testimonianze sul mutualismo cattolico negli archivi ecclesiastici veneti cfr. i contributi di M. Barausse, F. Juanita Schiavini Trezzi 202 Il censimento ha evidenziato carte di tali società, datate all’incirca tra il 1880 ed il 1940, negli archivi di 51 parrocchie e di Casse rurali in dieci di esse: ulteriore stimolo ai parroci perché, consapevoli della presenza nei loro archivi anche di questi materiali così preziosi e purtroppo disseminati, vigilino attentamente sulla loro conservazione 104. Ma negli archivi parrocchiali si trovano anche carte di altri circoli e associazioni a carattere non strettamente religioso: dei combattenti e reduci a Chignolo d’Isola, del circolo « Uniti e Forti » a Ponte Giurino di Berbenno, della filodrammatica a Ghiaie di Bonate Sopra, delle associazioni degli emigranti a Carona, Moio de’ Calvi, S. Gallo, delle bande musicali a Boltiere, Ghisalba, Palazzago e inoltre, molto spesso, documentazione di istituzioni di assistenza e beneficenza, congregazioni di carità, ospizi, asili infantili. Alla storia della religiosità popolare riconduce in particolar modo la fitta documentazione di una vera e propria galassia di confraternite ed associazioni laicali. Nelle pagine del censimento ne abbiamo contate 150 105, dalle più antiche (come i Disciplini, con documenti dal 1343 a Gandino, dal 1531 a Clusone, dal 1639 a Cividate al Piano, dal 1706 a Sorisole), alle moderne Azione Cattolica, FAC (Fraterno Aiuto Cristiano), UNITALSI, Movimento apostolico ciechi, passando attraverso congregazioni capillarmente diffuse e di lunga vita come quelle del SS. Sacramento, del Suffragio, del S. Rosario, di S. Vincenzo de’ Paoli, il Terz’ordine francescano, altre legate, con ogni evidenza, a particolari devozioni locali (Confraternita della Beata Vergine della cintura, di S. Tarcisio, di S. Anna, dei SS. Valentino e Bonifacio, fino ad un’inedita Pia associazione Domneone Domna ed Eusebia), altre ancora portatrici di intitolazioni di per se stesse emblematiche di un certo clima culturale all’interno di un preciso momento storico: Angiolette e Luigini, Anime vittime del S. Cuore di Gesù, Lampade viventi, Lega di perseveranza, Segretariato per la moralità, eccetera. Una segnalazione a parte meritano le Scuole della dottrina cristiana, documentate in almeno 199 parrocchie 106 con carte datate dal sec. XVII in Cavazzana Romanelli e R. Camurri in Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del seminario di studio. Spoleto 8-10 novembre 1995, Roma 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 49). 104 Punto di riferimento fondamentale per un più preciso riscontro delle fonti superstiti nella provincia di Bergamo potranno essere le statistiche delle Società di mutuo soccorso esistenti nel territorio nazionale edite dal Ministero di agricoltura, industria e commercio tra il 1864 ed il 1912. Una rilevazione dedicata in maniera specifica alle società operaie cattoliche fu pubblicata dallo stesso Ministero nel 1908. Cfr. M. LAZZERI, Gli archivi delle società di mutuo soccorso in Umbria, in Le società di mutuo soccorso italiane… cit., p. 62, nota 3; E. ARIOTI, Un sondaggio sugli archivi delle società di mutuo soccorso dell’Emilia Romagna, ibid., p. 110, nota 2. 105 Il loro numero effettivo è certamente superiore perché lo stato di disordine degli archivi ha spesso impedito di identificarle con precisione e di elencarle analiticamente nella scheda. 106 Vale qui la stessa avvertenza della nota precedente. Inoltre è doveroso ricordare che gli estremi cronologici indicati qui e altrove nel testo, pur ampiamente attendibili e comunque di per sé significativi, potranno essere modificati in seguito al riordinamento degli archivi. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 203 trenta casi (le più antiche a Paladina, Nembro e Treviolo dal 1609, Romano di Lombardia e Grumello de’ Zanchi dal 1610, Vertova dal 1611, Cerete Alto dal 1617, Clusone dal 1618) e dal sec. XVIII in ben 74 parrocchie 107. Non devono però essere ritenute di minor importanza le testimonianze di un passato meno remoto. Le carte delle fabbricerie tra ’800 e ’900 ci permettono di scrutare la quotidiana gestione degli affari parrocchiali tra cui le pratiche concernenti la costruzione e manutenzione degli edifici di culto, l’acquisto di arredi, suppellettili e paramenti sacri, l’installazione e riparazione di organi e campane 108. Tra le attività pastorali troviamo anche l’assistenza agli emigranti (come a Desenzano al Serio) o quella ai militari in guerra, col parroco impegnato a raccogliere notizie e a far da tramite con le famiglie nei difficili scambi epistolari (come a Pontida e alle Ghiaie di Bonate Sopra), il funzionamento dell’oratorio e del cinema parrocchiale o delle scuole serali. Il censimento non ha comunque trascurato le parrocchie di più recente istituzione, sia per coerenza con la propria stessa natura (come s’è detto un censimento deve abbracciare la totalità dei soggetti appartenenti all’insieme individuato) sia per cogliere l’occasione di sensibilizzare i parroci sul tema dell’archivio in fieri. Il risultato è stato però superiore alle aspettative e abbastanza sorprendente rispetto all’opinione comunemente diffusa in quanto, oltre ai libri canonici ed al primo, esiguo, sedimento della breve attività parrocchiale, si è rivelata la presenza di significativi nuclei di carte anteriori all’anno dell’acquisita autonomia parrocchiale. Si tratta sia di documenti stralciati dall’archivio della parrocchia da cui è avvenuto il distacco, sia prodotti dalla comunità esistente da tempo (in qualche caso da secoli) attorno a quella chiesa. Così a Cirano di Gandino, la chiesa di S. Giacomo apostolo, eretta a parrocchiale nel 1969 ma attestata fin dal XV secolo, conserva autenticazioni di reliquie dal 1675, stati d’anime, legati e atti notarili, carte riguardanti la fabbriceria e l’amministrazione del patrimonio risalenti al XIX secolo. 107 Al tempo della visita pastorale di san Gregorio Barbarigo, le parrocchie del territorio diocesano erano 262, nell’84% delle quali era attivata la Scuola. D. MONTANARI, Gregorio Barbarigo a Bergamo (1657-1664). Prassi di governo e missione pastorale, Milano 1997, in particolare il cap. III.1 dedicato alle Scuole della dottrina cristiana, pp. 59-68 (Studi e memorie del Seminario di Bergamo, 2). 108 È superfluo ricordare che non vi è ricerca di storia dell’arte o intervento di tutela e restauro concernente architetture sacre, opere pittoriche, sculture, oreficerie ecc. che non possa o debba attingere agli archivi ecclesiastici. Proprio per questo il già citato progetto ARCA ha potuto usufruire del contributo del Save Venice Inc. di New York il cui coinvolgimento concretizza felicemente un approccio integrato ai diversi beni culturali. F. CAVAZZANA ROMANELLI, Gli archivi parrocchiali veneziani... cit., p. 17. Per una significativa esemplificazione riferita ad insigni opere cui gli archivi parrocchiali della diocesi di Mantova hanno consentito di assegnare la corretta attribuzione, datazione o provenienza cfr. G. MANZOLI, L’archivio parrocchiale e i beni culturali locali, in « Archiva Ecclesiae », XXIV-XXV (1981-1982), pp. 57-79. Juanita Schiavini Trezzi 204 A Cicola (Carobbio degli Angeli), parrocchiale dal 1956, troviamo carteggio dal 1909, libri dei morti dal 1919, libri messe dal 1935, bilanci dal 1948. La comunità di Camorone (in Comune di Brembilla), autonoma dalla chiesa matrice di S. Giacomo in Sedrina per decreto del vescovo Bernareggi nel 1937, è stata poi accorpata con la parrocchia di Brembilla nel 1986. Tuttavia quasi tutte le serie del suo archivio iniziano dai primi anni del secolo, i libri messe addirittura dal 1796. L’esemplificazione potrebbe continuare a lungo poiché la presenza di carte anche molto antiche nelle parrocchie di recente istituzione pare essere più una norma che un’eccezione, messa in luce proprio dal censimento, alla quale sfuggono solo le pochissime parrocchie al servizio di quartieri periferici di recentissima espansione non sviluppatisi attorno ad una chiesa preesistente. Tra i frutti del censimento non è mancata neppure la spinta al riordino ed inventariazione di singoli archivi. Per decisione dei rispettivi parroci, si sono così svolti (o sono stati avviati) i lavori nelle parrocchie di Alzano Lombardo, Bonate Sopra, Rota Imagna e Suisio. Ma di un’altra importante realtà sommersa ci si è resi conto grazie ad esso. Si tratta del fatto che in diocesi gli archivi non sono poi così abbandonati come si potrebbe credere (anche sulla scorta di negativi resoconti che giungono da altre aree geografiche). « La consolante maggior sensibilità storica da parte dei parroci e da parte della stessa popolazione che della propria parrocchia ama conoscere le origini e le vicende, ha portato ad una maggior confidenza con gli archivi. Quasi tutti sono stati ordinati 109, molte parrocchie ne hanno fatto studiare il materiale per la pubblicazione della loro storia e molte hanno affidato a incaricati scelti la custodia e la consultazione dei documenti (...) » 110. Proprio la presenza dei laici nel ruolo di archivisti parrocchiali, operanti in sintonia con il parroco che ne resta ovviamente il responsabile, ci sembra una ricchezza da estendere e consolidare, la sola in grado di offrire incoraggianti prospettive per il futuro. L’inserimento dell’archivistica nel piano di studi sviluppato nei Seminari, invocato da più parti, ci pare francamente anacronistico per quanto già si è detto sulle irreversibili innovazioni post conciliari e per le urgenze di nuovi e « altri » saperi richiesti al chierico destinato a calarsi come pastore tra gli uomini del terzo millennio. Poiché però, come è stato osservato, « se non si provvederà tempestivamente e non vi saranno nel prossimo futuro titolari di archivio coscienti dell’importanza anche pastorale della documentazione che in essi è conservata, non si potrà nemmeno pensare ad una responsabile e seria ricerca di personale ausiliario, 109 Si fa qui riferimento ad un ordinamento non scientifico ma ad una sistemazione sufficiente a sottrarre gli archivi all’abbandono dando invece loro una dignitosa collocazione su scaffali in locali idonei che ne consenta anche la consultabilità. Non mancano però archivi effettivamente riordinati e inventariati con rigore metodologico. 110 Introduzione di Benigni a Gli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo… cit., p. 8. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 205 capace di valorizzarla nel suo pieno significato storico ed ecclesiale » 111, ci chiediamo se non sia opportuno impostare un programma formativo su brevissimi cicli di lezioni (comprendenti almeno una visita all’archivio diocesano ed una ad un archivio parrocchiale) destinati ai giovani diaconi, da svolgere in concomitanza con l’inizio del loro ministero nelle comunità locali o anche a tutti i sacerdoti, programmabili (in questo caso) nell’ambito dei consueti incontri per la formazione permanente del clero. Si tratterebbe, in un certo senso, di una ripresa delle indicazioni fornite ai vescovi d’Italia dalla Segreteria di Stato nel 1923 e dal cardinale Mercati nel 1942. In entrambi i casi, tenendo ben presente l’opportunità di non appesantire i programmi dei Seminari, si suggeriva il ricorso a conferenze svolte da « persone autorevoli e competenti » 112. La conoscenza delle basilari norme canoniche e pattizie concernenti l’archivio parrocchiale, la percezione del suo valore sul triplice piano amministrativo, storico-culturale e di prezioso strumento per l’azione pastorale metterebbero in grado i sacerdoti di apprezzare e valorizzare la collaborazione dei laici se preesistente e spontanea, di ricercarla e stimolarla là dove mancasse. La diocesi verrebbe così a dotarsi di una fitta schiera di persone cui indirizzare specifiche attività formative ed occasioni d’incontro, che potrebbero essere favorite anche dalla costituzione di un’associazione specifica sull’esempio di quella che riunisce da decenni i sacrestani 113. L’associazione, ponendosi in rapporto diretto con altre anche di livello nazionale (pensiamo a quella degli archivisti ecclesiastici e all’ANAI), potrebbe inoltre essere luogo privilegiato per veicolare informazioni circa corsi, convegni, mostre, riordinamenti e tutte quelle iniziative extradiocesane che possano costituire occasione di aggiornamento per chi abbia scelto di porsi al servizio della comunità ecclesiale occupandosi dell’archivio parrocchiale. Al consistente nucleo di laici già impegnati in tal senso, individuati in occasione del censimento, si è rivolto il primo « Corso per archivisti parrocchiali », di carattere generale ed introduttivo, organizzato dalla diocesi di Bergamo tramite il Centro culturale « Nicolò Rezzara », svoltosi nella primavera del 1998. Inizialmente programmato a numero chiuso per un massimo di 111 L. SPARAPANI, Personale dell’archivio diocesano. Reclutamento, qualificazione e volontariato... cit., p. 103. 112 113 Ibid., p. 104. Non è forse inutile ricordare che l’ausilio di altre persone al lavoro del parroco nella tenuta dell’archivio è consentito dal codice di diritto canonico e dallo schema-tipo di regolamento degli archivi ecclesiastici italiani approvato dalla CEI nel 1995 che così recita: « L’archivio diocesano e quelli dei principali enti ecclesiastici siano affidati a persone qualificate, che si serviranno di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a livello esecutivo. Là dove si ritiene opportuno e se ne riconosce una qualificata preparazione, è possibile usufruire della collaborazione di personale volontario ». Cfr. E. ZANETTI, La legislazione canonica riguardo agli archivi parrocchiali... cit., p. 497. 206 Juanita Schiavini Trezzi 50 partecipanti, sotto la pressione delle richieste pervenute (chiaro indice dell’interesse suscitato dalla proposta), ha invece finito con l’accogliere ben 80 iscritti. Pur essendo a conoscenza di analoghe iniziative realizzate altrove (basti citare Trento, Piacenza, Venezia, Loreto), gli organizzatori (in prima linea ancora una volta don Mario Benigni) hanno scelto una linea autonoma, originale ed eminentemente pragmatica, tracciando un programma articolato in sette lezioni nell’arco di due mesi e che tenesse conto delle esigenze di formazione di un gruppo di corsisti tutt’altro che omogeneo per età e preparazione culturale e comunque, di norma, privi di specifici studi archivistici. Affiancando lezioni teoriche ad esercitazioni pratiche e lasciando il maggior spazio possibile agli interventi dei corsisti, che si sono rivelati ansiosi di presentare i propri dubbi, confrontare le soluzioni adottate, sollecitare chiarimenti non solo in relazione alla tecnica archivistica ma anche in materia di accesso alle fonti, regolamenti d’archivio, rapporti con i parroci ecc., si è avuto il conforto di un risultato lusinghiero anche per il secondo corso, dedicato ai libri canonici, svolto nell’autunno del 1999, il sabato pomeriggio, per un totale di sette incontri. Il terzo si è svolto tra ottobre e novembre del 2000 ponendo al centro dell’attenzione gli istituti giuridici e gli enti che affollano il linguaggio dei documenti conservati negli archivi parrocchiali: dal beneficio al giuspatronato, dal subeconomato alla fabbriceria. Se i docenti non hanno la pretesa di esaurire la materia di studio in poche ore, gli allievi non hanno la presunzione di improvvisarsi tecnici di ineccepibile professionalità. Molto più modestamente c’è, da parte di tutti, la convinzione che la buona volontà, sorretta da una preparazione di base continuamente arricchita, non potrà che giovare alla soluzione di un problema che è prima di tutto di salvaguardia e corretta gestione. La spolveratura ed il buon condizionamento, l’individuazione delle serie principali e dei loro estremi cronologici, la redazione di semplici elenchi, la sorveglianza durante la consultazione da parte di appassionati di storia locale, studenti, ricercatori, l’organizzazione delle operazioni di trasloco, la regolare pubblicazione sul bollettino parrocchiale (o in altri spazi disponibili in loco come il bollettino della biblioteca comunale) di « Notizie dall’archivio » e la segnalazione di qualche documento di particolare interesse, sono di per sé grandissimi risultati che non richiedono una laurea in archivistica ma, oltre a salvare l’archivio, permettono di mantenere viva l’attenzione su di esso, di educare tutta la popolazione (e non solo i fedeli) ad apprezzare la ricchezza dell’archivio così come ha imparato a fare per le opere d’arte custodite nella sua chiesa. L’opinione negativa espressa da taluni sul contributo del volontariato 114 ci pare debba essere relativizzata rapportandola alla specificità delle situazioni 114 Riferendosi (se ben interpretiamo le sue parole) non solo agli archivi diocesani ma anche a quelli parrocchiali, l’archivista diocesano di Trento insiste sulla necessità di disporre di personale qualificato e retribuito, dicendosi convinto che non si possa realisticamente pensare al futuro facendo leva sul volontariato. L. SPARAPANI, Personale dell’archivio diocesano... cit., pp. 110-111. Censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo 207 locali. Per quanto riguarda la diocesi di Bergamo, crediamo che il volontariato stia dando invece prova di sapersi dedicare con la necessaria continuità e pazienza all’impegno richiesto dagli archivi. Alle istituzioni ecclesiastiche e civili (in primo luogo gli archivi diocesani), ai professionisti della scienza archivistica e della ricerca storica, il compito di coltivarlo e sostenerlo rendendosi disponibili a porsi come stabili punti di riferimento 115, ai parroci l’impegno a non far mancare quelle gratificazioni che, se talora (o quasi sempre) non potranno essere in denaro, valgano però ad incoraggiare i loro preziosi collaboratori laici sulla via intrapresa. JUANITA SCHIAVINI TREZZI Università degli studi di Udine 115 Oltre allo svolgimento con periodicità costante, di corsi di formazione, si potrebbe ad es. ipotizzare l’istituzione, presso l’archivio diocesano, di un « punto di ascolto e d’intervento » a disposizione degli archivisti parrocchiali, gestito personalmente dall’archivista diocesano o tramite uno o più esperti da lui delegati, che fornisca non solo consulenza ai propri uffici ma anche, a richiesta o per iniziativa propria, ma sempre concordata, effettui sopralluoghi presso gli archivi delle singole parrocchie onde poter indirizzare al meglio il lavoro degli incaricati locali. IL DEPOSITO DELLA MEMORIA. L’EVOLUZIONE DEGLI ARCHIVI AMMINISTRATIVI NELLA STORIA ITALIANA* Nel Regolamento del 1853, che diede corpo alla riforma Cavour dell’amministrazione centrale del Regno di Sardegna 1 la parola « archivio » compariva per la prima volta all’articolo 78, dove si stabiliva che l’archivio dei ministeri sarebbe stato diviso in due parti, « corrente e generale »: « L’Archivio corrente — proseguiva il comma 2° di quell’articolo — sarà distribuito nei vari Uffici, e comprenderà tutte le carte dell’anno che corre. L’Archivio generale sarà tenuto dal Segretario generale, ed avrà la stessa classificazione dell’Archivio corrente » 2. Seguivano varie disposizioni: sui tempi del passaggio delle carte dall’Archivio corrente a quello generale, sui modi di conservazione e classificazione delle pratiche (« un repertorio che serva ad assicurare la ricerca »), sull’accesso agli archivi da parte degli uffici, sulla vigilanza circa la buona tenuta degli archivi 3. Erano così poste, sia pure ancora in modo embrionale, alcune delle regole chiave che avrebbero presieduto a lungo al funzionamento degli archivi governativi. Nel modello gerarchico-piramidale che la riforma del 1853 aveva imposto nei ministeri del Regno di Sardegna (e che per altro sarebbe stato presto interamente recepito nell’organizzazione degli uffici nel Regno d’Italia) gli archivi ebbero inizialmente una posizione cruciale, indirettamente testimoniata dallo stesso spazio ad essi dedicato dal Regolamento. Concepita come una macchina (e di « ruotismi amministrativi » si parlò infatti più volte sin nel dibattito parlamentare del 1852-1853), l’amministrazione per ministeri avrebbe dovuto assicurare secondo i suoi ideatori l’esecuzione appunto « meccanica » (cioè « pronta » ed esattamente corrispondente * Il testo dell’articolo, in traduzione inglese, è già apparso in « Archivum », XLV (2000): The Profile of the Archivist: Promotion of Awareness, pp. 81-96. 1 Il Regolamento fu approvato con r.d. 23 ottobre 1853, n. 1611. Faceva seguito alla l. 23 marzo 1853, n. 1483. 2 R.d. 23 ottobre 1853, n. 1611, art. 78. 3 Ibid., artt. 79-84. Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 L’evoluzione degli archivi amministrativi 209 all’input iniziale impressole dall’alto, dall’azione del ministro) di ogni direttiva politica. Rispondeva a questo fine l’organizzazione ideata per il lavoro amministrativo: la porta d’entrata e d’uscita della pratica (o dossier, come — con terminologia francese — si esprimeva il legislatore piemontese) sarebbe stato il protocollo generale, sistema di annotazioni dettagliate in appositi registri, che avrebbe dovuto indicare il numero d’ordine di arrivo di ogni lettera o carta, la data dell’arrivo, la data del documento protocollato, il nome e la qualità dello scrivente, il soggetto della lettera, la direzione generale o ufficio cui sarebbe stata smistata. Ciascuna direzione generale avrebbe poi dovuto tenere aggiornato il proprio protocollo speciale (sempre in costante rapporto con quello generale), e così pure avrebbero fatto le divisioni o gli uffici esterni nei quali l’amministrazione fosse eventualmente articolata. Ne sarebbe derivata una fitta rete di note, rimandi, verifiche incrociate, tale da garantire il controllo degli atti in ogni momento del complesso metabolismo interno rappresentato dal lavoro amministrativo. In quest’ottica l’archivio era concepito come l’esatto pendant del protocollo, un punto-chiave e d’arrivo della catena burocratica così delineata. L’archivio generale del Ministero era infatti nient’altro che il luogo della memoria storica dell’amministrazione, ma una memoria attiva, immanente nella vita quotidiana degli uffici: negli scaffali dell’archivio l’accumulazione degli atti (le lettere o le domande di poco rilievo conservate in cartelle, gli altri affari in « fascicoli a stampa sui quali sarà annotato regolarmente il corso della pratica ») avrebbe riflesso puntualmente la sedimentazione stessa dell’esperienza amministrativa, dando ragione dei « precedenti » e consentendo in ultima analisi all’amministrazione di ripercorrere in qualsiasi momento — grazie alla bussola rappresentata dalle pratiche già archiviate, talvolta anche da quelle esaurite da molto tempo — il solco dei suoi stessi comportamenti, di rifondare il presente sulla reiterazione del passato. Sotto questo specifico profilo — vale la pena di notare incidentalmente — l’archivio costituiva, in tempi di sistema amministrativo allo statu nascenti, la garanzia della ripetitività e della continuità dell’azione amministrativa (elementi entrambi necessari a trasmettere all’esterno il senso rassicurante della certezza e della prevedibilità). Anche se, allo stesso tempo, proprio il ricorso sistematico e quasi obbligato all’archivio (cioè alle decisioni già assunte, alle procedure già applicate, allo stile e al linguaggio già sperimentati ed entrati stabilmente nell’uso) avrebbe rappresentato la tentazione dominante alla ripetitività e alla sclerotizzazione dei comportamenti, e sarebbe stata all’origine di quella tendenza a « ragionare per atti », a non discostarsi dal « precedente », che già alla fine dell’Ottocento qualche polemista rimproverava come un vizio congenito alla burocrazia della nuova Italia. Classificare e conservare carte, così come riordinare depositi di atti pubblici, allineare numeri di protocollo, compilare registri, redigere inventari e matricole non fu però per l’amministrazione italiana soltanto un volgersi all’indietro. Fu anzi, nei decenni immediatamente postunitari, un altro modo, Guido Melis 210 forse meno eroico e visibile, certo efficace e persino — chissà — decisivo, per « fare l’Italia ». Ciò spiega la meticolosa cura che l’amministrazione di quella lunga fase costituente mise nel regolamentare i suoi archivi. La vicenda è nota nei suoi aspetti generali 4. Sin dagli anni Sessanta fu posto — in Parlamento e altrove — il quesito se gli archivi dovessero restare divisi fra vari ministeri (come di fatto era avvenuto dopo l’unificazione) o se non si dovessero unificare sotto l’egida di un solo dicastero; e se non si dovesse — anche — introdurre la distinzione tra « archivi amministrativi » e « archivi storici » (qualcuno preferiva dire tra « archivi moderni » e « archivi antichi »). Come ha scritto ormai quasi quarant’anni fa Leopoldo Sandri, tra le amministrazioni che si contendevano la competenza sulla materia il Ministero dell’interno fu il più pronto a porre le premesse del proprio controllo sugli archivi: « unificazione nel proprio bilancio delle voci relative agli archivi, quale che fosse il Ministero di appartenenza; assoluta indifferenza alla distinzione tra archivi storici ed amministrativi; specifica possibilità di intervenire meglio di qualsiasi altro su gli archivi dei Comuni, degli enti di assistenza e di beneficenza » 5. Tra il 1870 (data di insediamento della Commissione Cibrario incaricata di fare chiarezza sul problema) e il 1874-1875 (biennio che racchiuse il primo provvedimento che concretamente attuava la riunione degli archivi ponendoli alle dipendenze dell’Interno e il regolamento che stabiliva le regole per l’ordinamento generale degli Archivi di Stato) 6 si verificò una prova di forza tra amministrazioni — specialmente tra l’Interno e la Pubblica istruzione —, conclusasi infine con l’assetto che sarebbe durato per almeno un secolo: gli Archivi di Stato, come istituti di conservazione storica, sotto l’egida del Ministero dell’interno. Diversa fu la sorte degli archivi correnti dei ministeri 7, dopo che — come ha scritto Isabella Zanni Rosiello — si consumò definitivamente « la 4 Da ultima P. FERRARA, I tecnici della memoria nella pubblica amministrazione: archivi e biblioteche, in Burocrazie non burocratiche. Il lavoro dei tecnici nelle amministrazioni tra Otto e Novecento, a cura di A. VARNI e G. MELIS, Torino, Rosenberg & Sellier, 1999, pp. 109 e sgg. Fondamentali A. D’ADDARIO, La collocazione degli Archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario (1860-1874), in « Rassegna degli Archivi di Stato », XXXV (1975), pp. 11-115, e, più di recente, I. ZANNI ROSIELLO, Archivi e memoria storica, Bologna, Il Mulino, 1987, specialmente pp. 80 e seguenti. 5 L. SANDRI, Gli archivi dello Stato (genesi e formazione), in « Amministrazione civile », numero speciale su Cento anni di amministrazione pubblica, V (1961), n. 47-51, p. 423. 6 Rispettivamente r.d. 5 marzo 1874, n. 1852; e r.d. 27 maggio 1875, n. 2552. Da tenere presenti anche i rr.dd. 26 marzo 1874, n. 1861, relativo al riordinamento degli Archivi di Stato e all’istituzione di un Consiglio per gli archivi, e 31 maggio 1874, n. 1949, sull’istituzione di dieci soprintendenze archivistiche. 7 Non offre più di un quadro di sintesi, in proposito, E. CALIFANO, Gli archivi correnti dei Ministeri, in « Amministrazione civile », numero speciale su Cento anni di amministrazione pubblica… cit., pp. 433 e seguenti. L’evoluzione degli archivi amministrativi 211 rottura del nesso produzione-conservazione-uso di documentazione » e si radicalizzò « la distinzione fra modi di conservazione-trasmissione esercitati da istituti archivistici e modi di conservazione-trasmissione praticati da ufficiorgani produttori di carte » 8. Le vicende organizzative di questi archivi testimoniano di una situazione di incertezza che si sarebbe protratta sino alla fine del secolo XIX ed oltre. Così nel Ministero dell’interno, dove una autonoma Direzione degli archivi generali del Regno ed Archivio centrale aveva figurato nella pianta organica tra il 1860 e il 1863, per assumere quindi la denominazione di Direzione generale centrale dal 1863 al 1870, e dove comunque la Divisione 1a aveva mantenuto negli stessi anni il controllo dell’ufficio di rubrica generale e della registrazione degli « affari di competenza di altri ministeri » (nonché la materia degli archivi del Regno, quanto a personale e spesa), nel 1887-1888 archivio, copia generale e spedizione furono attribuiti insieme alla Segreteria generale: e questa collocazione unitaria di funzioni tanto diverse non sarebbe più mutata, se non nominalmente, con il passare degli anni 9. Negli altri ministeri avvenne qualcosa di molto simile: l’archivio andò in genere stabilizzandosi nell’ambito di piccole strutture di vertice (segretariati generali, direzioni degli affari generali e del personale), quasi sempre assieme al protocollo del ministero e — spesso — alla biblioteca. Nel Ministero degli esteri fu posto sin dagli anni Sessanta in una Divisione amministrativa Sezione archivi (appunto con biblioteca, protocollo, personale); altrettanto avvenne all’Agricoltura, industria e commercio, ai Lavori pubblici (sotto la Divisione 2a del Segretariato generale), alla Pubblica istruzione (nella Divisione 1a, che era anche quella del personale), alle Finanze (nella Divisione 1a del Segretariato) 10. Confuso con le funzioni di gestione del ministero, spesso affidato a impiegati privi di una specifica competenza, l’archivio tendeva insomma a retrocedere, già negli anni Settanta dell’Ottocento, a deposito morto di carte. Fu con Crispi, e comunque nella seconda metà degli anni Ottanta, che il problema della circolazione delle informazioni nell’amministrazione, e quindi quello dell’organizzazione delle carte (e degli archivi), ritornò insistentemente all’ordine del giorno. 8 I. ZANNI ROSIELLO, Archivi e memoria storica… cit., p. 82. 9 I dati sono tratti da L’amministrazione centrale dall’Unità alla Repubblica. Le strutture e i dirigenti, a cura di G. MELIS, II. Il Ministero dell’Interno, a cura di G. TOSATTI, Bologna, Il Mulino, 1992, passim. 10 Sul nesso archivio-biblioteca cfr. G. MELIS, Organizzazione del sapere e cultura dell’amministrazione: le biblioteche dei ministeri, in Le biblioteche dell’amministrazione centrale dello Stato italiano, a cura di M. CRASTA - S. BULGARELLI - P. VALENTINI, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 1990, pp. 23 e sgg. Le verifiche sulla collocazione dell’archivio nelle varie amministrazioni sono state condotte nella collezione dei « Calendari generali del Regno » editi a cura del Ministero dell’interno. Guido Melis 212 Gli anni Ottanta segnarono per lo Stato italiano un’epoca di svolta, caratterizzata dall’ampliamento delle funzioni pubbliche, da una più consapevole ingerenza in ambiti sociali sino ad allora lasciati alla sola iniziativa dei privati, dall’urgenza di prevedere, conoscere, controllare e se possibile razionalizzare fenomeni nuovi connessi alla prima crescita dei centri urbani e alla nuova domanda di servizi pubblici che ne derivava 11. Da un punto di vista anche solamente quantitativo, la crescita della documentazione amministrativa fu ingentissima. Vi concorse, oltre allo sviluppo inedito del numero degli affari trattati (puntualmente registrati nelle tabelle dei carichi di lavoro redatti con scrupolo dalle varie amministrazioni), la nuova complessità assunta dalle pratiche amministrative. Una legislazione ormai distante dal modello ideale della norma universale e astratta, sempre più prossima a quella che sarebbe poi stata la tipologia della legge-provvedimento, introdusse, e spesso a carico dell’amministrazione, una quantità di compiti di controllo, certificazione, ispezione, vigilanza; nel settore dei lavori pubblici, ad esempio, le lineari norme del 1865 si complicarono nelle minute prescrizioni degli anni Ottanta e Novanta, talvolta in veri e propri procedimenti, tesi a regolare i contraddittori rapporti tra l’autorità pubblica ed il gioco degli interessi privati in settori economici spesso di strategica rilevanza per lo sviluppo del capitalismo italiano. Ne venne una maggiore complessità degli atti, una più frequente interconnessione tra amministrazioni e tra livelli amministrativi (enti locali-Stato, ad esempio) ed anche il primo impianto di banche-dati destinate a costituire l’ossatura dell’apparato informativo pubblico, con il potenziamento delle rilevazioni statistiche al centro e delle anagrafi in periferia, da una parte, e l’inizio delle schedature di massa a scopo di pubblica sicurezza, di tutela della salute, di controllo demografico e sociale, dall’altra 12. E ne derivò — anche — l’esigenza di dominare, con risorse di personale tutto sommato limitate, una « mole di affari » via via più ingombrante. Sotto questo profilo la direttiva che la classe dirigente crispina (o forse soprattutto Crispi personalmente) dette a partire dal 1887 fu quella della semplificazione: meno passaggi burocratici, più rapidità esecutiva, una modulistica uniforme ed essenziale, l’adozione ove possibile di bollettini a stampa, l’uso di schedari, uno stile ed un vocabolario amministrativi più asciutti e concreti 13. 11 Ho affrontato questi temi più distesamente in Storia dell’amministrazione italiana, 18611993, Bologna, Il Mulino, 1996, specialmente pp. 115 e seguenti. 12 G. TOSATTI, La repressione del dissenso politico tra l’età liberale e il fascismo. L’organizzazione della polizia, in « Studi storici », XXXVIII (1997), 1, pp. 217 e seguenti. 13 Cfr. in proposito G. MELIS - G. TOSATTI, Il linguaggio della burocrazia italiana tra Otto e Novecento, in « Le Carte e la Storia », V (1999), 1, pp. 34-45. Emblematica la circolare di Crispi ai prefetti del 16 settembre 1887, relativa al protocollo ed archivio degli uffici di pubblica sicurezza (ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, d’ora in poi ACS, Ministero dell’interno, Circolari, 1887): dopo aver lamentato l’inapplicazione delle norme impartite nel 1866, la L’evoluzione degli archivi amministrativi 213 Furono, quelli di Crispi e più in generale quelli di fine secolo, anni di silenziose ma tuttavia importanti operazioni di riordinamento archivistico 14. Per fare un solo esempio, ma significativo, tra il 1883 e il 1890, con soli 25 dipendenti, la Divisione dell’istruzione superiore, diretta da Giovanni Ferrando, impiantò su basi più moderne l’archivio dell’ufficio 15. Tempi e modalità di quell’operazione-modello sono ora desumibili dalle carte conservate nell’Archivio centrale dello Stato: tra agosto e dicembre 1883 completata la schedatura delle fondazioni di studio; tra il 1887 e il 1890 compilata la raccolta dei documenti sulle università, compiute le ricerche necessarie a completarli, richieste a prefetti, Archivi di Stato e archivi notarili le informazioni mancanti, acquisiti i pareri del Consiglio di Stato. Nel maggio 1882 un solo impiegato intraprese il lavoro di « mettere in pari i registri del Personale addetto alle Università e agli Istituti superiori », lavoro trasformato l’anno successivo nell’impianto della matricola del personale insegnante, amministrativo e inserviente delle università italiane. L’operazione — « lunga e faticosa » — sarebbe proseguita per mesi (al giugno 1884 risultavano a matricola 984 nomi, ma ne restavano ancora 1.216 da trascrivere). Alla fine del 1882, intanto, era stato terminato il nuovo registro dei concorsi, e redatto l’indice del vecchio, mentre si lavorava alacremente ai tre registri del personale delle biblioteche e, nel marzo 1885, alla revisione degli elenchi del personale addetto agli stabilimenti scientifici. Anche l’archivio della divisione risentì in quegli anni dei nuovi ritmi imposti all’attività. Nel marzo 1884 l’archivista dovette, di fronte allo straripare delle carte, eliminare le ingombranti scatole delle pratiche dell’anno precedente per sostituirle con le nuove buste a filza, riesaminando nell’occasione uno per uno tutti i fascicoli « per accertarsi che ogni documento [fosse] al suo posto »: 55.556 atti, ai quali si aggiungevano le 331 relazioni dei concorsi universitari dal 1865 al 1882, coi relativi processi verbali delle commissioni esaminatrici ed allegati i pareri del Consiglio superiore 16. Quello dell’Istruzione superiore non è che un esempio, per quanto forse meglio documentabile di altri. Tutta l’amministrazione di fine secolo, specie quella centrale, fu attraversata dalla medesima operosità: crebbero infatti le circolare riordina le categorie, vieta perentoriamente di adottare miscellanee, impone la collocazione degli affari a scaffale in ordine alfabetico, ribadisce l’adozione di colori differenti per le copertine a seconda della categoria dell’affare. 14 Cfr. L. MONTEVECCHI, Il Ministero degli interni: gli archivi e le informazioni, in Le riforme crispine, 1, Amministrazione statale, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 415 sgg. (Archivio Isap, n.s., 6); qualche spunto anche in G. MELIS, « Visione feudale » degli archivi e storia delle istituzioni contemporanee, in « Le Carte e la Storia », IV (1998), 1, pp. 57-61. 15 Mi servo qui dei risultati di un mio precedente studio: Alle origini della Direzione generale per l’istruzione superiore, in L’Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano, a cura di I. PORCIANI, Napoli, Jovene, 1994, pp. 185 e seguenti. 16 Ibidem. 214 Guido Melis ore di straordinario, fu impiegata più massicciamente la risorsa degli avventizi, si aumentarono i ritmi di lavoro. Un esercito alacre di copisti e una modulistica finalmente razionalizzata contribuirono all’impresa. Su questa situazione di generale revisione dei criteri organizzativi e dei metodi di lavoro intervenne il provvedimento più significativo di questa fase, il r.d. 25 gennaio 1900, n. 35, che approvò il nuovo Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle Amministrazioni centrali. Le nuove disposizioni, frutto in verità di un lungo periodo di gestazione e messe a punto da una commissione interministeriale ma con la determinante regìa del direttore dell’Archivio di Stato di Roma, Enrico De Paoli 17 (al cui « savio e competente consiglio » — si precisava in una circolare — i singoli ministeri in difficoltà avrebbero potuto rivolgersi), miravano essenzialmente a realizzare l’uniformità archivistica: « poiché — si sosteneva — non differiscono sostanzialmente gli atti per la nomina di un prefetto o di un giudice, di un professore o di un colonnello, per l’amministrazione di un istituto civile o di uno militare; sono eguali i procedimenti delle leggi amministrative, qualunque ne sia l’oggetto, ed è una la legge di contabilità per tutte le amministrazioni, che non vi è ostacolo a rendere eguali le regole della registrazione e conservazione degli atti nei dicasteri » 18. In particolare il regolamento stabiliva un « Ufficio di registratura e di archivio » in tutte le direzioni generali e nelle « altre grandi ripartizioni che a queste corrispondono » 19, nelle ragionerie centrali, nelle segreterie di gabinetto; sopprimeva i protocolli generali; fissava con chiarezza le regole da seguirsi per il ricevimento degli atti, per la loro classificazione (in titoli, classi e sottoclassi), per la tenuta dei registri di protocollo, per la registrazione delle carte in arrivo, per la formazione dei fascicoli, la trascrizione (con puntuali prescrizioni sulla carta da usare, sull’inchiostro, sulla redazione delle minu17 Cfr. E. CALIFANO, Gli Archivi correnti dei Ministeri… cit., p. 439. Una prima commissione era stata nominata dal ministro dell’interno il 3 ottobre 1894 (dopo che il Consiglio per gli archivi ne aveva approvato nel 1882 l’idea, avanzata da De Paoli). Rimasta senza esito la proposta messa a punto in quella occasione, dal 1895 lavorò una sottocommissione che elaborò una « Proposta di Regolamento per gli Uffici di Registratura e di Archivio delle Amministrazioni Centrali ». Nel 1899, tenuto conto delle critiche dei ministeri, si ebbe un terzo testo, pressoché definitivo, approvato poi il 4 maggio di quell’anno dal Consiglio per gli archivi e sottoposto quindi al parere del Consiglio di Stato il 9 novembre. Nel frattempo, con circolare del Ministero dell’interno, Direzione generale dell’amministrazione civile, n. 17100 del 1° marzo 1897 (firmata dal direttore generale Astengo) erano state anticipate per la tenuta degli archivi comunali quelle norme che sarebbero state poi ripetute nel regolamento approvato nel 1900 (cfr. il testo della circolare in « Rivista amministrativa del Regno », gennaio 1897, p. 274; debbo questa citazione alla cortesia di Enrico Gustapane). 18 Cfr. ACS, Ministero della pubblica istruzione, Miscellanea di divisioni diverse I, II, III (1929-1945), b. 13, nota del ministro al direttore generale per l’istruzione superiore e le biblioteche, datata Roma, 22 marzo 1900; la nota accompagnava l’invio del regolamento. 19 Regolamento per gli Uffici di registratura e di archivio nelle Amministrazioni centrali… cit., I, art. 2. L’evoluzione degli archivi amministrativi 215 te) 20, per la spedizione, la registrazione, l’invio e infine per la circolazione delle carte tra gli archivi (distinti adesso in « corrente » e « di deposito ») sino all’Archivio del Regno 21. Sarebbe stato compito delle amministrazioni far precedere all’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento l’approvazione del titolario degli atti 22. Allo sforzo uniformatore del 1900 non corrispose tuttavia, o per lo meno non da subito, un tempestivo adeguamento degli archivi ministeriali. Secondo i dati raccolti nel 1906 nel « manuale teorico pratico » messo insieme e pubblicato in quell’anno da Pietro Taddei, archivista presso il Ministero della pubblica istruzione 23, pressoché tutti i ministeri presentavano, agli inizi del secolo, situazioni anomale: spesso gli archivi generali convivevano con gli « archivi speciali » (cioè non solo con quelli delle singole direzioni generali ma anche con quelli di divisioni o di uffici particolarmente rilevanti). L’Interno, ad esempio, annoverava « archivi speciali » del Gabinetto del ministro, della Divisione del personale, della Direzione generale delle carceri e di quella di sanità 24; nel Ministero di grazia e giustizia ogni divisione manteneva il proprio archivio ma con peculiari modalità di classificazione e con qualche vistosa differenza persino tra le divisioni dello stesso Ministero (così, notava Taddei, nell’archivio della Divisione culti gli atti non erano custoditi né per materie né per circoscrizioni ma per località) 25; ugualmente 20 Ibid., VII, artt. 43-53. È interessante il cenno alle « macchine scriventi », il cui uso è limitato alla trascrizione del carteggio. 21 Ibid., XI, artt. 79-96. Da segnalare la disposizione secondo la quale « gli archivi corrente, di deposito e del Regno sono ordinati egualmente; cioè la collocazione degli atti vi corrisponde alle classi nelle quali essi furono, sin dall’origine, ripartiti ». 22 ACS, Ministero della pubblica istruzione, Miscellanea di divisioni diverse I, II, III (19291945), b. 13, nota del ministro al direttore generale per l’istruzione superiore e le biblioteche, Roma, 22 marzo 1900 citata. 23 P. TADDEI, L’Archivista. Manuale teorico-pratico, Milano, Ulrico Hoepli, 1906; da vedere, anche se meno pertinente, P. PECCHIAI, Manuale pratico per gli archivisti delle pubbliche amministrazioni e degli archivi notarili, Milano, Ulrico Hoepli, 1928 2. 24 P. TADDEI, L’Archivista… cit., p. 237: « L’esattezza — continuava Taddei — è stata raggiunta mercé la razionale e ben delineata ripartizione delle classi e delle categorie; la ricerca è facilitata dalle molteplici rubriche, le quali indicano, sotto i suoi più svariati aspetti, l’esistenza del documento ricercato; infatti oltre una rubrica generale vi sono, in quest’archivio, rubriche speciali per ragione di luogo, di materia, di persone; rubriche numeriche (l’archivio è tenuto col sistema sintetico, cioè a numero fisso, ed i fascicoli del personale sono numerati) e varie altre, a seconda del personale, degli uffici e delle materie speciali ». 25 Ibid., p. 239: « vi si trovano in attuazione i due sistemi di protocollazione, l’analitico e il sintetico, nonché diversi metodi di classificazione e custodia. Base generale della ripartizione dei fascicoli è la circoscrizione delle Corti d’Appello. Il personale è tenuto per ordine di numero: al momento della formazione del fascicolo, il nome della persona assunta in servizio viene registrato sopra una grande rubrica, assegnandogli un numero; quel numero viene conservato dal fascicolo per tutto il tempo che il funzionario presta servizio. I numeri lasciati vuoti da coloro Guido Melis 216 nel Ministero delle finanze gli archivi corrispondevano alle varie direzioni generali, tradizionalmente dotate di una certa autonomia, e adottavano metodi di ordinamento parzialmente diversi da quelli stabiliti dal regolamento generale 26; ugualmente al Tesoro, dove ogni divisione aveva il suo archivio, con differenze vistose nella classificazione delle carte da parte della Ragioneria generale e della Direzione generale del debito pubblico 27; il Ministero della guerra, pur avendo formalmente adottato un ordinamento unitario, in linea con le norme stabilite nel 1900, continuava in realtà ad articolarsi in archivi distinti per divisione o ufficio tra loro non comunicanti, mentre il Segretariato generale da solo manteneva in funzione ben tre archivi distinti 28; un po’ meglio si presentava la situazione alla Marina, che tuttavia manteneva in parte ancora in vigore l’ordinamento archivistico del 1865 29; nel Ministero della pubblica istruzione esisteva ugualmente una pluralità di archivi per divisione, ad eccezione della direzione generale delle belle arti che funzionava con un suo archivio centralizzato 30; ai Lavori pubblici gli archivi erano stati riordinati secondo le disposizioni del 1900 31, ma esisteva poi l’Ufficio dell’ispettorato alle strade ferrate con « tanti archivi quanto sono le divisioni o uffici che li che, per qualsiasi motivo, cessano dal far parte dei ruoli, vengono, anno per anno, assegnati ai nuovi nominati ». 26 Ibid., pp. 245 e seguenti. 27 Ibid., p. 257: « ogni archivio ha le sue rubriche di persone e di uffici, ad eccezione dell’archivio della ragioneria nel quale è stato possibile sopprimere la rubricazione. La classifica principale delle carte di questo archivio è rappresentata dai capitoli del bilancio: è sotto il numero del capitolo sul quale fu emesso il decreto che si custodiscono le richieste dell’ammissione a pagamento dei mandati: in questo archivio vengono custoditi i registri copia-mandati, per ordine numerico di capitolo di bilancio e separati per esercizi finanziari; da questi registri si possono trarre tutte le indicazioni necessarie quando si presentino casi di contestazione (...). La Direzione Generale del Debito Pubblico ha un archivio speciale. Esso è ripartito in due distinte sezioni: quella degli Atti, e quella delle Matrici ». 28 Ibid., p. 259: « al Ministero della Guerra ogni archivio ha le sue rubriche e registri propri, differenti, di poco se si vuole, ma quanto basta per cambiare i criteri della registrazione ». 29 Ibid., pp. 261-252. 30 Ibid., p. 289: « la registrazione e la protocollazione della corrispondenza si fa col metodo analitico; la rubricazione delle carte è affidata al criterio degli archivisti, i quali seguono, generalmente, il sistema soggettivo; la ripartizione degli affari in categorie, classi e sottoclassi è varia, con prevalenza della ripartizione geografica. Il personale viene custodito, in quasi tutti gli archivi, per ordine alfabetico: al beneplacito degli archivisti è affidato l’impianto delle rubriche e registri ausiliari, nonché le formalità meccaniche del movimento delle pratiche ». 31 Ibid., p. 291: « per la custodia degli atti vi è adottato di preferenza l’ordine geografico, raggruppando per province le opere idrauliche, le bonifiche e gli affari relativi ai ponti e strade; tutto ciò che si riferisce ai lavori dei porti viene riunito sotto il nome della località; le derivazioni d’acqua invece vengono classificate e distinte dal nome dell’individuo che ne domanda la concessione; i corsi d’acqua più importanti hanno classifica propria; il protocollo è analitico; le rubriche, veri e propri repertori di fascicoli, indicano la classifica e la collocazione di essi, generalmente riassunta nella formula composta di numeri e lettere alfabetiche ». L’evoluzione degli archivi amministrativi 217 compongono » 32; nel Ministero dell’agricoltura, industria e commercio vigeva il sistema degli archivi per direzione generale 33; in quello delle Poste e Telegrafi, dove le disposizioni del 1900 erano state subito tradotte nel nuovo titolario, funzionavano quattro archivi (nel Segretariato generale, nella Direzione generale dei risparmi, in quella delle Poste e in quella dei Telegrafi) 34; agli Esteri, infine, conviveva con gli archivi delle divisioni un Archivio storico 35. Se l’intento del regolamento generale era quello di far parlare agli archivi ministeriali lo stesso linguaggio, la rassegna compiuta da Taddei rivelava una vera babele di lingue contrastanti. Che le norme del 1900 (destinate ad andare in vigore dal 1° gennaio 1901) non avessero trovato uniforme e stabile applicazione negli uffici e che, di conseguenza, lo stato degli archivi correnti dell’amministrazione centrale non fosse brillante sarebbe stato del resto più volte confermato nel corso del quindicennio successivo. Per restare alla già ricordata amministrazione dell’Istruzione superiore, si dovette registrare intanto il ritardo nella redazione del titolario (fissata per il mese di luglio del 1900, la scadenza slittò più volte, nonostante le sollecitazioni dell’ufficio del personale del Ministero) 36; poi vi fu, da parte del rappresentante della Pubblica istruzione nella commissione interministeriale di coordinamento, una sia pur rispettosa contestazione dei criteri cui il regolamento generale si ispirava (perché — si obiettò polemicamente già nell’estate 1900 — « gli atti per la nomina di un prefetto sono d’ordine politico-amministrativo; quelli per la nomina di un giudice sono d’ordine giudiziario; quelli per la nomina di un professore sono d’ordine scolastico; quelli per la nomina di un colonnello sono d’ordine militare ») 37. 32 Ibid., p. 292: « in questi archivi è in uso il protocollo a sistema analitico, che viene rinnovato di anno in anno; la corrispondenza dell’ufficio viene scrupolosamente registrata, ma tale registrazione non serve che a dare un numero ordinale alle carte in arrivo ed a constatare la quantità della corrispondenza nel periodo di un anno (...). Le rubriche non sono rubriche nel vero senso della parola, ma prontuari dei fascicoli ripartiti alfabeticamente ». 33 Ibid., p. 297: « il loro ordinamento è semplice e bello, ma presenta il medesimo difetto che abbiamo avuto occasione di riscontrare in altri archivi, cioè quello di non fornire il modo di riscontrare quali e quanti atti abbiano concorso alla formazione di un fascicolo ». 34 Ibid., pp. 298-299. 35 Ibid., p. 231: « quello che nelle altre amministrazioni è un semplice archivio di deposito, qui assurge all’onore di archivio storico. Infatti, oltre alle carte contabili ed alla corrispondenza relativa ad affari privati e di ordine generale, come in tutti gli altri Ministeri, vengono in esso custoditi trattati originali, le convenzioni internazionali, la corrispondenza con l’estero della Real Casa ed i carteggi politici riservati ». 36 ACS, Ministero della pubblica istruzione, Miscellanea di divisioni diverse I, II, III (19291945), b. 13, cfr. ad es. lettera del direttore dell’Ufficio del personale e affari generali al direttore generale per l’istruzione superiore e le biblioteche, Roma, 18 luglio 1900. Cfr. anche la lettera del Ministero al direttore generale per l’istruzione superiore, Roma, 24 novembre 1900, ove si fa esplicito cenno all’opportunità di « rimandare » la riforma, anche per le « difficoltà di varia indole » che vi si oppongono. 37 Ibid., lettera dal capo degli Uffici d’ordine Barnabò al direttore generale per l’istruzione superiore, Roma, 23 luglio 1900. La controproposta accompagnava uno schema di titolario nel Guido Melis 218 Non era difficile — a voler leggere in trasparenza la corrispondenza ufficiale — riconoscere i segni del fastidio delle burocrazie ministeriali di fronte a quella che, per lo meno nel delicato campo della conservazione delle carte d’ufficio, dovette apparire come un’invadenza esterna da subire, sì, ma nei fatti da non condividere: « Checché si affermi — scriveva il responsabile dell’archivio della Pubblica istruzione, l’anziano cavalier Barnabò — (...) come non ogni abito s’addice alla persona, non ogni disposizione conviene all’Archivio. E poi — aggiungeva non senza malizia — non va dimenticato che il regolamento 25 gennaio è stato fatto più che altro in vantaggio dell’Archivio di Stato. Ciò si deduca all’evidenza dalle cortesi quanto perseveranti esibizioni del suo illustre Direttore, al cui “savio e competente consiglio” sento con meraviglia che si può ricorrere, senza guardare se l’atto e l’effetto non producano vera mancanza di riguardo verso chi rappresentava degnamente il Ministero dell’Istruzione nella commissione che discusse e propose la vastissima riforma. Insomma, questa è stata fatta soprattutto per impedire che nell’Archivio di Stato entrino monti farraginosi di carte inutili, “che non basterebbe l’aumento annuo di tre chilometri di palchetti, se vi si raccogliessero tutte”, e le utili ci vadano ordinate uniformemente. Credo pertanto che il detto regolamento non si possa convenientemente attuare, se non con uniformità relativa, rispettando le buone tradizioni e tenendo conto dei bisogni veri di ogni servizio » 38. Non si trattava di resistenze isolate. La scadenza del 1° gennaio 1901, prevista per l’applicazione del regolamento in tutti i ministeri, dovette essere procrastinata nel tempo, per « difficoltà di varia indole e soprattutto [per] la mancanza di locali e la deficienza del personale » 39. Seguì, in molte amministrazioni centrali, un periodo di difficoltà, connesso con la crescita del lavoro amministrativo (specialmente nella prima parte del decennio giolittiano) e con la novità delle materie adesso divenute oggetto quale « la classificazione delle materie principali, o per maggiore esattezza, degli ordini di studi e di persone e di provvedimenti, è fatta per classi, come era più naturale, non già per titoli, come voleva l’art. 14 del regolamento 25 gennaio »; poi, « con opportuni aggruppamenti di classi, si sono formati i titoli, riducendoli alla più semplice espressione ». Lo schema correggeva il titolario De Paoli anche nell’abolizione delle lettere maiuscole (A, B, C) da riportarsi in ogni classe quale indicazione di affari generali e di massima, di affari collettivi e di miscellanea. 38 ACS, Ministero della pubblica istruzione, Miscellanea di divisioni diverse I, II, III (19291945), b. 13, dal capo degli Uffici d’ordine Barnabò al direttore generale per l’istruzione superiore, Roma, 23 luglio 1900. « Infine — concludeva il funzionario — le carte che veramente meritano d’essere conservate nell’Archivio di Stato per l’amministrazione, gli studiosi e la posterità, si riducono meno che al quinto; gli altri quattro quinti circa non richiederebbero che temporanea considerazione. E sotto questo aspetti riesce incerto il vantaggio di tante norme e di tante registrazioni ». 39 Ibid., dal Ministero della pubblica istruzione, Ufficio del personale e degli affari generali al direttore generale per l’istruzione superiore, Roma, 24 novembre 1900. Una testimonianza della inapplicazione delle norme del 1900 anche nel giudizio di Cesare Salvarezza (autorevole dirigente del Ministero dell’interno) richiamato da E. CALIFANO, Gli Archivi correnti dei Ministeri… cit., p. 444, nota. L’evoluzione degli archivi amministrativi 219 dell’intervento pubblico: una legislazione in continua evoluzione, quantitativamente in crescita e spesso qualitativamente inedita per materia e soluzioni tecnico-normative, ebbe per riflesso la più intensa circolazione delle carte e una produzione di atti via via più corposa. Se — come è stato scritto — il modello di gestione della cosa pubblica di Giovanni Giolitti si risolse specialmente in « progetto burocratico di governo », l’amministrazione dovette necessariamente assumere in esso una sua specifica centralità. La situazione dell’Istruzione superiore non differiva, sotto questo profilo, da quella di altre amministrazioni. Nel 1909, un’ispezione condotta con scrupolo in quell’archivio corrente dall’ispettore Ernesto Ovidi confermò largamente lo stato di crisi: l’archivio della divisione apparve all’ispettore « eccezionalmente sovraccarico di carte d’ogni specie », con parecchia documentazione collocata fuori posto, e non già per mancanza di spazio quanto piuttosto per gli scarti non effettuati puntualmente 40. Gli affari correnti « archiviati senz’ordine predisposto » assieme a quelli « compiuti », numerosissimi « i fascicoli complessivi, contenenti cioè più affari i quali avrebbero dovuto in origine ripartirsi più opportunamente per le distinte materie dei vari servizi », molti fascicoli privi della « copertina forte prescritta dal regolamento generale », il titolario di fatto assente: l’analisi di Ovidi toccò uno dopo l’altro tutti i punti critici di una situazione che dovette essere, in quei primi anni del secolo, piuttosto diffusa nelle amministrazioni centrali 41. I rimedi suggeriti, ispirati all’attuazione fedele delle prescrizioni del regolamento generale, si sarebbero egualmente potuti estendere a molti altri uffici: «1. Sfollare l’Archivio stesso di tutto il materiale di affari compiuti, venutosi accumulando nel periodo di un settennio; sfollamento questo della massima necessità ed urgenza, saggiamente previsto dal regolamento suddetto (...). Si rende indispensabile una attenta ed accurata cernita da eseguirsi con piena conoscenza dei servizi, intesa a separare tutte le carte riflettenti affari compiuti, dalle altre riguardanti affari vivi, indi versare ordinatamente le prime nell’archivio di deposito mercé una sistematica formazione di pacchi con indicazioni sommarie del contenuto dei medesimi e della rispettiva propria posizione in Archivio; coordinare di poi fra loro le seconde. riunendo quelle attinenti alla stessa materia e racchiudendone i fascicoli con coperta su cui, per risparmio di tempo, di lavoro e di spesa, potrebbe, in via eccezionale, bastare che venissero riprodotte semplici sommarie indicazioni (...). 2. Condurre a termine l’iniziata abolizione delle posizioni complessive, ripartendo le carte fra le diverse materie alle quali hanno speciale attinenza. 3. Nella formazione dei nuovi fascicoli fare uso costante della accennata coperta forte, che rivesta ciascun fascicolo, corredandola 40 La relazione Ovidi (Roma, 8 giugno 1909) è ora in ACS, Ministero della pubblica istruzione, Miscellanea di divisioni diverse I, II, III (1929-1945), b. 13. 41 Ibid.: « presentemente il titolario — scriveva l’ispettore Ovidi — consiste soltanto in una specie di elenco che sotto il nome generico di posizioni contiene con numerazione progressiva (dal 1 al 30) una serie di voci di carattere generale, taluna delle quali non rispecchiante precisamente la natura degli affari ». Guido Melis 220 delle indicazioni contemplate nel citato regolamento (...). 4. Rispetto alla registratura, impiantare l’indice rubrica delle registrazioni in protocollo » 42. Seguivano altre proposte, più minute. Ma soprattutto l’ispettore insisteva sulla riforma del titolario: « un nuovo titolario — come lo descriveva — che rispecchiasse (...) un’organica, omogenea classifica della materia e venisse coordinato in pari tempo da una rispondente formazione dei fascicoli, a base di numero stabile per ciascun fascicolo, allo scopo di rendere fissa la sua posizione in Archivio » 43. Nei ministeri del primo quindicennio del secolo, in effetti, il problema della funzionalità degli archivi amministrativi e della loro reciproca connessione — ma anche il più generale tema della comunicazione amministrativa — cominciavano a porsi come punti cruciali di quella che sempre più frequentemente era denunciata come « la questione burocratica » 44. La prima guerra mondiale e gli anni difficili del dopoguerra ebbero sull’amministrazione italiana effetti rilevanti. Da un lato la rottura (per la prima volta) della lineare struttura organizzativa adottata sin dall’unificazione, con la proliferazione delle « amministrazioni di guerra » (apparati — fossero denominati ministeri o commissariati o uffici speciali — caratterizzati dalla specifica missione loro affidata e da una certa libertà di azione); dall’altro l’imporsi della inedita forma organizzativa dell’ente pubblico, specialmente economico-finanziario, e quindi il delinearsi di quella che è stata definita giustamente come un’« amministrazione parallela » 45. La scissione dei grandi ministeri dell’età giolittiana — come avvenne ad esempio per quello economico, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — e la distribuzione delle funzioni prima accentrate in una pluralità di soggetti, ministeriali e non, non potè non riverberarsi negativamente sull’unità dei grandi archivi amministrativi; tanto più che, accanto agli archivi governativi, nascevano adesso, spesso al di fuori di ogni regola e di qualunque controllo statale, gli archivi degli enti pubblici (consorzi di bonifica, opere di guerra, enti assistenziali, enti di finanziamento, più gli enti di gestione sorti dopo la crisi degli anni Trenta). L’INA (per citare il più importante degli istituti finanziari dotati di personalità giuridica pubblica, ed il primo ad essere istituito su 42 Ibidem. 43 Ibidem. Ovidi lodava quindi l’azione del nuovo archivista, Pio De Angelis, cui riconosceva di avere iniziato alcune delle riforme proposte (in effetti una precedente relazione De Angelis, ispirata a principi simili, figura nel fascicolo). Era implicitamente severo il giudizio sul predecessore di De Angelis, Barnabò. 44 È da tenere presente che con il r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163 fu emanato un nuovo regolamento per gli Archivi di Stato. 45 Sul punto mi permetto di rinviare a G. MELIS, Due modelli di amministrazione fra liberalismo e fascismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1988 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 10). L’evoluzione degli archivi amministrativi 221 basi nazionali sin dall’anteguerra) organizzò ad esempio il suo archivio generale nell’ambito del Servizio affari generali, come « archivio generale dei contratti di assicurazione e delle quietanze »: 2.100 metri quadri di estensione, « 16 grandi reparti », « 405 scaffali di lamiera divisi in 8450 scomparti » ognuno dei quali contenente 350 polizze. Organizzato come il centro documenti di una grande impresa industriale, l’archivio INA conservava al 1932 2.103.127 « posizioni » ed aveva un movimento di quasi 2 milioni di « incarti » all’anno 46. Il dibattito apertosi già dopo la guerra sulla « semplificazione amministrativa » — che per una parte della classe dirigente coincise essenzialmente con la velleità di ridurre il personale e di ripristinare la struttura più elementare dei ministeri dell’età giolittiana — investì solo marginalmente il problema degli archivi e del loro riordino. Il tema ebbe spazio, però, nell’elaborazione del cosiddetto « taylorismo della scrivania », una corrente di riforma che prendeva le mosse dal modello organizzativo della grande fabbrica moderna per proporre analoghi moduli di lavoro negli uffici pubblici: calcolo e taglio dei tempi, ristrutturazione degli ambienti (abolizione delle strutture cellulari a favore dei luminosi open spaces all’americana), ricorso massiccio ai mezzi meccanici (macchina da scrivere, ma anche apparecchi scriventi dictograph o di apparati per la registrazione, telefoni, poligrafi per la riproduzione dei documenti, duplicatrici per gli indirizzi ecc.), rinnovo degli arredi d’ufficio secondo criteri di efficienza (schedari, scaffali a scansie mobili). La comunicazione amministrativa — secondo i sostenitori di questa linea di riforma — avrebbe dovuto ridursi all’essenziale, sopprimendo il « viaggio della pratica sulle scrivanie ». Alla comunicazione scritta si sarebbe dovuto sostituire, ove possibile, quella orale (meglio se telefonica o a mezzo di apparecchi fonici interni). Alla conservazione delle carte, le registrazioni di sintesi dei dati essenziali su fogli o moduli prestampati 47. Gli archivi, in quest’ottica razionalizzatrice, avrebbero trovato posto come uno degli elementi della catena produttiva: riorganizzati secondo criteri di centralizzazione, ammodernati nei metodi di lavoro, avrebbero dovuto funzionare agli stessi ritmi dell’intera « macchina » burocratica, uscendo da quel torpore un po’ polveroso che era ormai entrato a far parte della loro immagine nella pamphlettistica antiburocratica 48. 46 L’Istituto Nazionale delle Assicurazioni 1913-1933, Roma, 1933-XI, pp. 30-31. 47 Cfr. F. SODDU, Tayloristi della scrivania: dalla « Rivista delle Comunicazioni » all’« Organizzazione scientifica del lavoro », in Le fatiche di Monsù Travet. Per una storia del lavoro pubblico in Italia, a cura di A. VARNI e G. MELIS, Torino, Rosenberg & Sellier, 1997, pp. 155 e seguenti. 48 Cfr., per tutti (ma la letteratura è copiosissima), F. MARINO, Il burocrate sorridente, Milano, Gastaldi, 1956, p. 93: « un altro tipo, direi meglio macchietta era rappresentato dall’archivista ». 222 Guido Melis Contro quel cliché, del resto spesso giustificato dalla destinazione all’archivio di impiegati di livello basso, esiliati in quella responsabilità perché emarginati dalla carriera, il taylorismo amministrativo degli anni Venti condusse una particolare battaglia. Occupandosi nel 1928 di « razionalizzazione dell’amministrazione statale », Remo Malinverni, proponeva dalle colonne de « L’Organizzazione scientifica del lavoro », « la riforma dei vari servizi di archiviazione, in modo [che] vengano introdotti sistemi perfetti di classificazione adattabili ai singoli casi e si arrivi gradatamente all’accentramento dei servizi stessi » 49. Molti degli spunti emersi nel dibattito del dopoguerra sarebbero stati ripresi qualche anno più tardi dal Comitato per il perfezionamento dei metodi di lavoro e di controllo nelle amministrazioni dello Stato istituito dal capo del Governo nell’ottobre del 1928. L’esperienza di questo organismo è nota: creato per dar seguito al programma razionalizzatore del primo fascismo e presieduto dall’ex ministro delle finanze di Mussolini, Alberto De’ Stefani, il Comitato produsse, in un anno circa di attività, una densa relazione, contenente una serie di proposte di riforma. Inviate ai ministeri e poi al Consiglio di Stato perché esprimessero il proprio parere, le proposte furono in sostanza rigettate dall’amministrazione (il supremo organo consultivo compì su di esse un’abile operazione di revisione e ritaglio, sostanzialmente riducendole a ordinari interventi sui servizi). Mussolini, probabilmente preoccupato dell’impatto che esse avrebbero potuto produrre, preferì rinviare sine die la loro applicazione 50. Il Comitato, comunque, concluse i suoi lavori proponendo tra l’altro l’adozione della comunicazione telefonica tra amministrazioni, l’uso di mezzi meccanici per la scrittura, l’adozione di moduli « razionali ». Nessun cenno esplicito era fatto alla situazione degli archivi ministeriali. In generale il periodo fascista non segnò, né sotto questo specifico profilo né altrimenti, un sensibile mutamento della situazione precedente, se non nel senso che agli archivi dei ministeri vennero ad affiancarsi quelli del partito fascista e delle grandi organizzazioni del regime, generalmente equiparate ad 49 R. MALINVERNI, La razionalizzazione dell’amministrazione statale, in « L’organizzazione scientifica del lavoro », III (1928), p. 709: « Il problema della classificazione — continuava Malinverni — è fondamentale di tutti i servizi, di tutti gli uffici statali. È il problema generalmente più trascurato. Si ritiene che la funzione di classificare sia una funzione trascurabile: la si affida ad un archivista che è talvolta anche fattorino. Oppure ogni ufficio crea per conto proprio una classificazione. Mancano gli uffici centralizzati di classificazione. Quanto tempo si perde nella ricerca di documenti? Se dovessimo fare un calcolo vedremmo che si tratta di milioni e milioni che si perdono annualmente ». 50 Ho ricostruito l’intera vicenda in Storia dell’amministrazione… cit., pp. 322 sgg., dove sono anche richiamate le fonti. Il testo apparve in COMITATO PER IL PERFEZIONAMENTO DEI METODI DI LAVORO E DI CONTROLLO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, Proposte per una riforma generale dei metodi di lavoro e di controllo, Roma, Provveditorato Generale dello Stato. Libreria, 1929-VIII. Da tenere presente anche la rievocazione di De’ Stefani (con qualche imprecisione) in Una riforma al rogo, Roma, Il Quadrato, 1963. L’evoluzione degli archivi amministrativi 223 enti pubblici e dotate di propria personalità giuridica. Si ebbe, cioè, anche in ragione dell’affermarsi della società di massa, una crescita delle banche-dati e dei luoghi deputati a conservarle. Il pluralismo istituzionale degli anni Trenta, con il proliferare di nuovi soggetti pubblici esterni allo Stato (tali furono gli enti sorti in quel periodo), agì da fattore di moltiplicazione degli archivi pubblici. Ha ricordato Elio Califano, in quella che resta una delle rare ricostruzioni storiche del problema, che sarebbe stato necessario attendere la l. 22 dicembre 1939, n. 2006 perché l’amministrazione potesse faticosamente avviare — per altro non senza incontrare difficoltà pratiche talvolta immobilizzanti — una politica di vigilanza sugli archivi ministeriali 51. La prima indagine nell’amministrazione del secondo dopoguerra sulla semplificazione dei servizi e dei metodi di lavoro risale al 1949 52. Interrogati preventivamente su quali misure sarebbe stato opportuno adottare, i ministeri affrontarono il tema in una serie di risposte assai prudenti nel tono e nei contenuti, limitandosi per lo più ad indicare specifici miglioramenti da introdurre nelle procedure ma evitando comunque di affrontare globalmente la questione. Sugli archivi, oggetto anch’essi della sollecitazione, le risposte furono — se possibile — ancora più laconiche. Emblematica, tra le altre, quella del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Per quanto concerne la disciplina della registrazione e della archiviazione degli atti, non sembra che essa possa essere oggetto di disposizioni di carattere generale, se non nei limiti in cui la disciplina stessa risponde ad esigenze tecniche fondamentali, comuni a tutte le Amministrazioni, mentre, al di fuori di tali norme generali, vi sono esigenze peculiari, in rapporto alle specifiche attribuzioni di ciascuna Amministrazione. In conformità di tale criterio si ravviserebbe opportuno che sia lasciato un largo margine di discrezionalità, in base al quale ogni singola Amministrazione possa organizzare nella maniera più adeguata i propri servizi di archivio, come di fatto è già avvenuto, discostandosi notevolmente dalle disposizioni del R.D. 25 gennaio 1900, n. 35, le quali, nella maggior parte, sono da considerare del tutto superate dallo sviluppo e dalla sempre maggiore complessità dell’azione amministrativa 53. L’insofferenza delle varie burocrazie verso le norme del 1900, e la rivendicazione a « far da sé », ritornavano dunque nel dopoguerra più o meno negli stessi termini nei quali si erano presentate all’indomani del provvedimento e poi, ripetutamente, nel corso dei decenni successivi. Nel gennaio 1950 fu costituito intanto, presso la Presidenza del Consiglio, il primo nucleo di quello che sarebbe divenuto l’anno successivo l’Uf51 E. CALIFANO, Gli Archivi correnti dei Ministeri… cit., p. 444. 52 ACS, Presidenza del Consiglio dei ministri, Gabinetto, 1955-1958, Circolare n. 30603.1207.4.1.1.2 avente per oggetto « semplificazione dei servizi e metodi di lavoro ». 53 ACS, Presidenza del Consiglio dei ministri, Gabinetto, 1955-1958, fasc. 1.1.2.9207. Guido Melis 224 ficio per la riforma dell’amministrazione. Guidato, sino alla metà del 1955, dal sottosegretario Roberto Lucifredi (« vero deus ex machina dell’appena costituita struttura ministeriale ») 54, l’Ufficio cercò di acclimatare nell’amministrazione le tecniche organizzative ed i metodi di lavoro propugnati dalla moderna scienza dell’organizzazione, soprattutto da quella di matrice anglosassone: uffici studi e di propulsione presso i ministeri, corsi di formazione del personale, razionalizzazione delle tecniche di lavoro, controllo dei costi e misurazione dei prodotti dell’attività amministrativa. Una serie di indagini, promosse con l’avallo della Presidenza del Consiglio, mirò inizialmente a chiarire lo stato reale dell’amministrazione uscita dal fascismo e dalla guerra. Quindi l’Ufficio affrontò i principali problemi attraverso una sequenza di circolari: sulle condizioni di lavoro e attrezzature negli uffici, sulla preparazione e aggiornamento del personale, sulla tecnica organizzativa. Una delle circolari del 1954 (esattamente la n.7070/27 del 7 febbraio 1954) fu dedicata alla classificazione, archiviazione e documentazione 55. Una serie di studi — cui parteciparono tra l’altro prestigiosi esponenti degli Archivi di Stato — diede luogo a proposte di modernizzazione notevoli, sebbene destinate a restare sulla carta 56. Non sembra che le pur numerose commissioni di studi sulla riforma amministrativa succedutesi nel dopoguerra abbiano tenuto in particolare conto il problema degli archivi correnti 57. Per un fenomeno non raro nella nostra storia amministrativa, il tema degli archivi scomparve per alcuni decenni dall’agenda delle riforme. Emblematica è del resto la lunga vigenza (sebbene in regime di sostanziale inapplicazione) del vecchio regolamento del 1900, protrattasi sino al recentissimo DPR 20 ottobre 1998, n. 428, che, nell’introdurre la gestione informatica dei protocolli, abroga, all’art. 23, il quasi centenario regolamento di Pelloux. Nell’annunciare il provvedimento alla prima Conferenza nazionale degli archivi, il ministro Franco Bassanini ne ha rese esplicite le motivazioni, enfatizzando il senso di una svolta che — ove si traducesse in future coerenti politiche di riforma — modificherebbe radicalmente la collocazione e la funzione degli archivi correnti dell’amministrazione. Quello degli archivi pubblici tornerebbe ad essere, come accadeva alle origini, « un tema chiave 54 G. CAPANO, L’improbabile riforma. Le politiche di riforma amministrativa nell’Italia repubblicana, introduzione di G. FREDDI, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 96. 55 G. MELIS, L’Ufficio per la riforma: l’illusione della razionalità, in « Lavoro e diritto », X (1996), 2, pp. 217 e seguenti. 56 Sull’elaborazione di quegli anni in materia di archivi cfr. specialmente Lo stato dei lavori per la riforma della pubblica amministrazione (1948-1953), Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1953, 3, all. 67. 57 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA, La riforma amministrativa 1918-1992. Gli studi e le proposte, Roma, Istituto Poligrafico e Libreria dello Stato, 1994 (Quaderni del Dipartimento per la Funzione pubblica, 27). L’evoluzione degli archivi amministrativi 225 anche per l’opera di riforma e di modernizzazione dell’amministrazione », nell’ottica di una « stretta connessione tra l’innovazione nella gestione dei documenti e la reingegnerizzazione dei processi amministrativi » 58: da deposito separato di carte a parte integrante dell’attività amministrativa corrente; da « morta gora » di pratiche burocratiche a snodo vitale della moderna comunicazione amministrativa. GUIDO MELIS Scuola speciale per archivisti e bibliotecari Università degli studi di Roma « La Sapienza » 58 F. BASSANINI, Archivi, formazione e informazione nel processo di riforma delle pubbliche amministrazioni, in Conferenza nazionale degli archivi. Roma. Archivio Centrale dello Stato. 1-3 luglio 1998, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999, pp. 23 e 24 per le citazioni (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 56). LA STAMPA NEL CASELLARIO POLITICO CENTRALE Lo Stato italiano unitario recepì il regime di libertà di stampa del Regno di Sardegna, previsto dallo Statuto albertino e basato sull’editto sulla stampa promulgato da Carlo Alberto il 26 marzo 1848. Ma giornali e periodici, il cui ruolo nella vita politica era stato importante durante il Risorgimento e andò sviluppandosi sempre di più negli ultimi decenni dell’Ottocento anche per il continuo aumento delle tirature, vennero sottoposti — come le associazioni e i movimenti politici e gli individui considerati sovversivi — a controllo da parte del Ministero dell’interno 1. Questo controllo, la cui base era costituita dalla schedatura sistematica della stampa, venne esercitato con varie forme di favore per i giornali e i giornalisti « amici » — dai sussidi con i fondi segreti del Ministero dell’interno, all’abbonamento ad alcune testate per le prefetture e altri uffici, al privilegio dell’inserzione a pagamento degli annunci legali — e con l’applicazione, spesso non corretta, dell’istituto del sequestro per i fogli giudicati politicamente pericolosi 2. In Francia, viceversa, a partire dal 1881 vi fu una forte liberalizzazione del regime della stampa. Infatti la legge del 29 luglio 1881, voluta dalle forze liberali della Terza Repubblica e celebrata come « une loi d’affranchissement et de liberté », si tradusse, sul piano delle regole e dei controlli di polizia amministrativa, nella soppressione delle misure preventive e nella riduzione al minimo delle formalità amministrative e sul piano delle responsabilità giudiziarie in un sistema privilegiato che impedì ogni incriminazione delle opinioni e derogò al diritto comune in favore della stampa. La conseguenza diretta fu che nel Ministère de l’intérieur la Direction de la presse, che contava nel 1876 1 Per un orientamento sulle competenze del Ministero dell’interno e in particolare della Direzione generale della pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico vedi Guida generale degli Archivi di Stato italiani, I, A-E, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981, pp. 145-157; sull’organizzazione della polizia vedi P. CARUCCI, L’organizzazione dei servizi di polizia dopo l’approvazione del testo unico della legge di P. S. del 1926, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XXXVI (1976), 1, pp. 82-114; ID., Il Ministero dell’interno: prefetti, questori e ispettori generali, in Sulla crisi del regime fascista 1938-43, a cura dell’ISTITUTO VENETO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA, Venezia 1996, pp. 21-73; G. TOSATTI, La repressione del dissenso politico tra l’età liberale e il fascismo. L’organizzazione della polizia, in « Studi storici », XXXVIII (1997), 1, pp. 217-255. 2 Vedi A. FIORI, Per la storia del controllo governativo sulla stampa: le circolari del Ministero dell’interno dall’Unità alla prima guerra mondiale, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLVII (1987), 1, pp. 9-102. Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 La stampa nel Casellario politico centrale 227 una sessantina di impiegati e quattro uffici, decadde e diventò un semplice bureau con pochi dipendenti 3. In Italia invece gli apparati di controllo sulla stampa vennero rinforzati proprio alla fine dell’Ottocento dal Crispi e dal Pelloux e furono mantenuti in vita per tutto il periodo giolittiano. Durante la prima guerra mondiale la stampa venne sottoposta ad una rigida censura preventiva e con la conquista del potere da parte di Mussolini vennero emanate le norme del 1923-1925 che in nome degli interessi della nazione sovvertivano i principi liberali in materia di stampa introdotti nel 1848. Furono gradualmente sospesi o soppressi tutti i giornali che svolgevano una politica ostile al regime e venne adottata una censura più forte e più raffinata rispetto a quella del periodo bellico 4. A testimonianza di questo assiduo controllo sulla stampa, tra la documentazione della Direzione generale della pubblica sicurezza pervenuta all’Archivio centrale dello Stato sono conservate tre serie: la F.1 - Stampa italiana (1894-1926), che contiene soprattutto fascicoli intestati a periodici sovversivi 5; la F.1 - Stampa sovversiva e clandestina (1926-1943), relativa a giornali e a pubblicazioni, spesso stampate « alla macchia », del periodo fascista, e la F.4 - Stampa estera (1923-1943), con materiale relativo ai periodici stranieri giudicati pericolosi e ai giornali italiani antifascisti pubblicati all’estero. Ma copie di stampati in tutte le loro forme (quotidiani, periodici, numeri unici, opuscoli, manifesti, volantini e così via) sono conservate nelle numerose serie dell’archivio della Direzione generale della pubblica sicurezza, dalle cosiddette « categorie permanenti » (come la A5G - Prima guerra mondiale, 19141918, la G.1 - Associazioni, la K.1 - Propaganda massimalista) alle categorie annuali 6; non fanno eccezione i fascicoli del Casellario politico centrale (CPC) 7. 3 F. TERROU, L’évolution du droit de la presse de 1881 à 1940, in Histoire générale de la presse française, publiée sous la direction de C. BELLANGER, J. GODECHOT, P. GUIRAL e F. TERROU, III, De 1871 à 1940, Paris, Presses universitaires de France, 1972, pp. 7-22; P. ALBERT, La presse française de 1871 à 1940, ibid., pp. 146, 241-243. 4 Mancano studi generali approfonditi sulla censura nel periodo fascista; può essere utile come punto di partenza M. CESARI, La censura nel periodo fascista, Napoli, Liguori, 1978 e la bibliografia sugli ordini di servizio, le così dette « veline », in G. OTTAVIANI, Le note di servizio. Ipotesi per una ricerca, Poggibonsi, Lalli, 1993; tra i più recenti contributi specifici v’è l’ampio G. FABRE, L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, Zamorani, 1998. 5 Questa serie è fornita di inventario a stampa: ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Direzione generale della pubblica sicurezza. La stampa italiana nella serie F.1 (1894-1926), inventario a cura di A. FIORI, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995 (Pubblicazione degli Archivi di Stato. Strumenti CXXV). 6 Del resto materiale a stampa si trova anche negli archivi di altre istituzioni che avevano il compito del controllo o della repressione dei movimenti politici giudicati pericolosi. Particolarmente abbondante (spesso costituiva il « corpo di reato ») è quello contenuto negli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1927-1943). Questo materiale è stato schedato da Maria Pia Bumbaca e Simonetta Carolini su incarico dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, d’intesa con l’Archivio centrale dello Stato. 7 Sul Casellario politico centrale vedi G. TOSATTI, Il Ministero degli interni: le origini del Casellario politico centrale, in Le riforme crispine, I, Amministrazione statale, Milano, Giuffrè, 228 Antonio Fiori Paola Cagiano de Azevedo ha schedato sistematicamente la stampa contenuta in questi fascicoli, utilizzando la seguente scheda: collocazione / classificatore / autore: personale - collettivo / intestazione / titolo / sottotitolo / destinatario / incipit / firma / direttore - gerente / prefazione e introduzione / data / annata e numeri / luogo di edizione / editore e tipografo / data di stampa / pagine / copie / dimensioni / periodicità / illustrato - b. e n. - colori carta riso - ciclostilato - mutilo - microfilm - reprint / prezzo / regesto / varie 8. Le 700 schede che sono frutto di questo censimento non sono numerose rispetto ai circa 160.000 fascicoli del CPC; ma esse sono relative a materiale significativo, in alcuni casi raro, che merita attenzione 9. Cronologicamente gli stampati partono dagli anni immediatamente precedenti il 1894 quando venne attivato presso la Direzione generale della pubblica sicurezza il « Servizio dello schedario biografico degli affiliati ai partiti sovversivi »; si è anzi rinvenuta una copia dell’anarchico « La Questione sociale » (Firenze) del 1888 10. V’è comunque una forte prevalenza della stampa pubblicata nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, conformemente all’altra documentazione del CPC. Non manca qualche periodico degli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale 11. Gli stampati sono generalmente antigovernativi e anzi spesso considerati sovversivi dalla polizia. Naturalmente il concetto di stampa sovversiva, come d’altronde quello di individuo o di movimento sovversivo, variò notevolmente nel corso della storia italiana unitaria. Se nel periodo della Destra fu tenuta sotto un particolare controllo la stampa antiunitaria e federalista e quella mazziniana e garibaldina, in seguito il potere politico giudicò più pericolosa, per la sicurezza dello Stato, la stampa anarchica. Negli anni Novanta, con la nascita del Partito dei lavoratori (il futuro Partito socialista italiano), fu giudicata sovversiva anche la stampa socialista. Fu soprattutto Pelloux che precisò, 1990, pp. 447-485 (Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica, Archivio, nuova serie, 6); ID., L’anagrafe dei sovversivi italiani: origini e storia del Casellario politico centrale, in « Le Carte e la storia », III (1997), 2, pp. 133-150; sulla banca dati del fondo archivistico vedi i contributi nel volume CENTRE D’ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION SUR L’ÉMIGRATION ITALIENNE, L’immigration italienne en France dans les années 20, Actes du Colloque organisé par le CEDEI les 15-16-17 octobre 1987 à Paris, Paris 1988. 8 In questa scheda manca una voce sul colore politico degli stampati, che però non è un elemento oggettivo e che in alcuni casi è difficile da determinare. 9 Le schede, conservate nell’Archivio centrale dello Stato dove sono a disposizione degli studiosi, non comprendono i ritagli di giornale. 10 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d’ora in poi ACS), Ministero dell’interno (d’ora in poi MI), Direzione generale della pubblica sicurezza (d’ora in poi DGPS), Divisione affari generali e riservati (d’ora in poi DAGR), Casellario politico centrale (d’ora in poi CPC), b. 5330, fasc. 15737 « Vassi Pietro ». 11 Ad esempio « Democrazia popolare, Giornale dei lavoratori italiani in Cecoslovacchia », organo comunista pubblicato a Praga. Un numero speciale per le feste natalizie (1° gennaio 1949, anno II, 7), si trova come allegato in ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 5246, fasc. 65694 « Turco Calogero ». La stampa nel Casellario politico centrale 229 nella fondamentale circolare del 1° settembre 1898 12, quale stampa dovesse ritenersi sovversiva: la repubblicana, la socialista, l’anarchica, la clericale. Tra i giornali cattolici egli distinse quelli che si occupavano « solo di cose religiose e di ordinamenti e di interessi puramente ecclesiastici », che giudicò non sovversivi, e quelli che « più che occuparsi di cose attinenti alla Religione » avevano fatto e facevano « della politica e della propaganda ostile alle Istituzioni dello Stato ». Ma, con la graduale partecipazione di gruppi politici socialisti e cattolici alla vita politica costituzionale, la classificazione di « stampa sovversiva » adottata dal Pelloux si rivelò piuttosto rigida. Gli stessi prefetti notarono a volte, nei loro rapporti al ministro dell’interno, la funzione positiva, ai fini della stabilità del governo, di alcuni periodici cattolici che si occupavano di politica. E quando, subito dopo la dichiarazione della guerra all’Austria-Ungheria, l’ispettore generale del Ministero dell’interno Agostino D’Adamo 13 chiese da Udine che venisse inviato un elenco dei giornali sovversivi, poiché il Comando supremo intendeva vietarne l’introduzione in zona di guerra, il direttore generale della pubblica sicurezza, Giacomo Vigliani, prontamente ne inviò uno comprendente 29 testate. Di queste ultime 10 erano socialiste, 9 repubblicane, 6 anarchiche, 3 sindacaliste, una rivoluzionaria, quasi tutte dell’Italia centrosettentrionale, e, significativamente, nessuna cattolica 14. D’altro canto nella classificazione si dovette tenere conto della nascita dei periodici che erano l’espressione di nuovi movimenti e partiti estremisti come quello nazionalista e, nel dopoguerra, quello fascista e quello comunista. Con l’avvento del regime vi fu una graduale fascistizzazione della stampa più « addomesticabile » 15, mentre venne considerata sovversiva tutta quella avversa al fascismo 16. Vennero anzi guardate con sospetto e in vari casi sequestrate 12 Circolare n. 10607, rimasta in vigore fino al 1919, pubblicata in A. FIORI, Per la storia del controllo governativo… cit., pp. 96-102. Anche le altre circolari del Ministero dell’interno alle quali faremo riferimento in questo lavoro (tranne i casi nei quali diamo la collocazione archivistica) sono state pubblicate o riassunte nel saggio citato. 13 D’Adamo era stato inviato da Salandra ad Udine con il compito di costituire e di dirigere il Segretariato generale per gli affari civili presso il Comando supremo dell’esercito mobilitato. Cfr. A. FAVA, D’Adamo Agostino, in Dizionario biografico degli italiani, 31, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1985, p. 591. 14 Telegramma del 25 maggio 1915, n. 4398, di D’Adamo e telegramma del 26 maggio, n. 17439, di Vigliani, in ACS, MI, DGPS, DAGR, A5G - Prima guerra mondiale, b. 77, fasc. 158, s. fasc. 20, ins. 24. 15 Per un quadro d’insieme della stampa italiana nel periodo fascista vedi i saggi di N. TRANFAGLIA, La stampa quotidiana e l’avvento del regime, 1922-1925 e di P. MURIALDI, La stampa quotidiana del regime fascista, in N. TRANFAGLIA - P. MURIALDI - M. LEGNANI, La stampa italiana nell’età fascista, Roma-Bari, Laterza, 1980. Sull’inizio del processo di fascistizzazione della stampa vedi G. PADULO, Appunti sulla fascistizzazione della stampa, in « Archivio storico italiano », CXL (1982), fasc. 511, disp. I, pp. 83-115. 16 Sulla stampa sovversiva nel periodo fascista vedi M. LEGNANI, La stampa antifascista, 1926-1943, in N. TRANFAGLIA - P. MURIALDI - M. LEGNANI, La stampa italiana… cit., che comprende alle pp. 360-363 una bibliografia divisa per tendenza politica dei giornali e alle pp. 364-366 un elenco delle principali testate. Vedi pure A. DAL PONT - A. LEONETTI - M. 230 Antonio Fiori quelle pubblicazioni non strettamente politiche che erano espressione di una filosofia diversa da quella del fascismo: per esempio riviste teosofiche e antroposofiche dedicate alla scienza dello spirito 17. Riguardo la tendenza politica, la stampa quantitativamente più rappresentata tra i fascicoli del CPC è quella anarchica. Accanto a copie di alcuni periodici italiani del periodo precedente la prima guerra mondiale, come « Il Libertario » di La Spezia 18, « Rompete le file! » (pubblicato a Milano, poi a Bologna, poi a Genova), o del periodo successivo alla guerra, come « Il Vespro anarchico » di Palermo 19, sono presenti copie di giornali pubblicati dagli importanti gruppi di anarchici italiani negli Stati Uniti d’America: « L’Adunata dei refrattari », fondato nel 1922 per iniziativa di un circolo che era riuscito a sopravvivere alla dura repressione operata da Wilson; « Il Grido della folla »; il battagliero organo ad indirizzo anarco-sindacalista « Il Martello », tutti pubblicati a New York 20; « La Questione sociale » e « L’Era nuova » di Paterson e « Germinal » di Chicago. Rappresentata è anche la stampa anarchica italiana pubblicata a Buenos Aires, come « L’Avvenire »; a Ginevra, come « Il Risveglio »; a Parigi, come « La Diana », « Il Monito » e il supplemento al « Risveglio ». Fra i giornali comunisti 21 sono presenti oltre a « L’Unità » 22 (numerose copie in vari fascicoli) ad esempio « Falce e martello » di Zurigo, « Il Riscatto » di Bruxelles, « Il Lavoratore » di New York. MASSARA, La stampa clandestina antifascista, 1922-1943, Roma, ANPPIA, 1964; R. ROSENGARTEN, The italian antifascist press (1919-1945), Cleveland 1968. 17 Vedi per esempio le pubblicazioni e i dattiloscritti, sequestrati dalla Questura di Udine e inviati alla Direzione generale di pubblica sicurezza, riguardanti l’Associazione eclettica di Aldo Lavagnini (1920-1929), in ACS, MI, DGPS, DAGR, Atti speciali (1898-1940), b. 6, fasc. 44, s. fascc. 1-6. Su Lavagnini vedi l’ampio fascicolo ibid., CPC, b. 2737. D’altronde alcuni degli oppositori politici del fascismo avevano fatto esperienze di teosofia o di antroposofia, cfr. R. PERTICI, Giovanni Amendola: l’esperienza socialista e teosofica (1898-1905), in « Belfagor », XXXV (1980), 2, pp. 185-197; M. PANZANELLI, L’attività politica di Eugenio Curiel (19321943), in « Storia contemporanea », X (1979), 2, pp. 253-296. 18 Su questo giornale vedi C. BIANCO - C. COSTANTINI, Il « Libertario » dalla fondazione alla guerra mondiale, in « Movimento operaio e socialista in Liguria », VI (1960), 5, pp. 131-154. 19 Su questi periodici vedi le schede in L. BETTINI, Bibliografia dell’anarchismo, I, t. 1, Periodici e numeri unici in lingua italiana pubblicati in Italia (1872-1971), Firenze, Crescita politica, 1972. 20 Sui periodici anarchici in lingua italiana pubblicati all’estero vedi le schede in L. BETTINI, Bibliografia dell’anarchismo, I, t. 2, Periodici e numeri unici anarchici in lingua italiana pubblicati all’estero (1872-1971), Firenze, Crescita politica, 1976. Nella scheda relativa al « Martello » si fa presente che documenti importanti relativi a questo periodico, come copie di numeri sequestrati, sono stati reperiti nell’Archivio centrale dello Stato, tra i fascicoli della Direzione generale della pubblica sicurezza, compresi quelli del CPC. 21 Sulla stampa comunista vedi P. SALVETTI, La stampa comunista da Gramsci a Togliatti, Torino, Guanda, 1975. 22 Sull’« Unità » vedi l’abbondante documentazione in ACS, MI, DGPS, DAGR, F.1 Stampa sovversiva e clandestina (1926-1943), bb. 53-63. Tra gli studi più recenti sul giornale F. La stampa nel Casellario politico centrale 231 La stampa socialista è rappresentata naturalmente dall’« Avanti! », considerato dalla polizia italiana nel periodo giolittiano e nel corso della Grande guerra come il più importante giornale sovversivo 23, dal « Nuovo avanti! » di Parigi, da vari periodici editi in Italia, come « Il Semplicista » di Scicli (Siracusa), « La Scintilla » di Napoli, « Germinal » di Messina e « Il Giornale del popolo » 24, definito dalla polizia « socialista rivoluzionario », nonché dal sindacalista « Il Proletario », pubblicato a New York 25. Sono presenti anche i principali giornali editi dal 1927 al 1934 dalla Concentrazione antifascista, che si proponeva di formare un fronte degli antifascisti non comunisti e di far conoscere all’opinione pubblica internazionale la pericolosità del fascismo 26. Troviamo infatti varie copie del settimanale « La Libertà » 27, diretto dal socialista riformista Claudio Treves, del quindicinale « Italia », redatto dall’altro leader riformista Filippo Turati, dell’edizione francese del « Becco giallo » 28, soppresso in Italia nel 1926. Tra gli altri giornali antifascisti possiamo ricordare « La Voce degli italiani », nato nel 1937 a Parigi come portavoce dell’Unione popolare italiana, e « Il Nuovo mondo », quotidiano di New York dalle tormentate vicende 29; non mancano poi copie di periodici di varia tendenza come il massonico « L’Aurora » di Philadelphia 30. LUSSANA, Ideale rivoluzionario e propaganda politica negli anni clandestini dell’« Unità », in « Studi storici », XXXVII (1996), 4, pp. 1257-1299. 23 Su questo giornale vedi G. ARFE’, Storia dell’« Avanti! », 1896-1940, voll. 2, MilanoRoma 1956; 1958. 24 La Direzione generale della pubblica sicurezza aveva aperto fascicoli intestati a questi giornali; cfr. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Direzione generale della pubblica sicurezza. La stampa italiana nella serie F.1 (1894-1926)… cit., ad indicem. 25 Un importante strumento per lo studio della stampa socialista è Bibliografia del socialismo e del movimento operaio italiano, I, Periodici, Roma-Torino, Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano (ESMOI), 1956, tt. 2; II, Libri, opuscoli, articoli, almanacchi, numeri unici, Roma-Torino, ESMOI, 1962-1966, tt. 3. Una bibliografia sulla stampa socialista nel periodo fascista in M. LEGNANI, La stampa antifascista cit., pp. 361-362. 26 Vedi B. TOBIA, Il problema del finanziamento della Concentrazione d’Azione antifascista negli anni 1928-1932, in « Storia contemporanea », IX (1978), 3, pp. 425-474; ID., La stampa della Concentrazione d’azione antifascista (1927-1934): struttura, diffusione e tematiche, in « Italia contemporanea », XXXIII (1981), fasc. 144, pp. 47-77. I due saggi sono stati ripubblicati, assieme ad altri due contributi relativi alla stampa antifascista, in ID., Scrivere contro. Ortodossi ed eretici nella stampa antifascista dell’esilio, 1926-1934, Roma, Bulzoni, 1993. 27 Su questo settimanale pubblicato a Parigi vedi i fascicoli in ACS, MI, DGPS, DAGR, F.4 - Stampa estera (1923-1943), bb. 52, 53, 54. 28 Ibid., bb. 9-12 contengono ampia documentazione, compresa tra il maggio 1927 e il giugno 1931; su questo giornale satirico vedi pure l’antologia « Il Becco giallo », 1924-1931, a cura di O. DEL BUONO - L. TORNABUONI, Milano, Feltrinelli, 1972. 29 30 Su questi due giornali vedi M. LEGNANI, La stampa antifascista… cit., ad indicem. ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 1781, fasc. A49794 « Di Domenico Angelo ». Altro materiale di interesse massonico, per esempio, nel fascicolo intestato a Giuseppe Leti (ibid., b. 2775, s. fasc. n. 25883), il quale in seguito all’azione repressiva del regime fascista nei confronti 232 Antonio Fiori Riguardo il luogo di stampa v’è una netta prevalenza dei giornali pubblicati all’estero 31 rispetto a quelli pubblicati in Italia, fatto che non sorprende considerato che la maggior parte degli antifascisti fu costretta a rifugiarsi all’estero. In primo luogo periodici pubblicati in Francia e in particolare a Parigi 32; sono comunque presenti giornali antifascisti pubblicati in Belgio, in Lussemburgo, in Svizzera (Zurigo, Ginevra, Lugano), in Germania, in Spagna, in Inghilterra. Tra gli Stati dell’emigrazione politica extraeuropea sono rappresentati la Tunisia, l’Argentina e soprattutto gli Stati Uniti d’America, con giornali provenienti da molte delle località in cui gli anarchici italiani avevano formato importanti gruppi: Paterson, Pittsburgh, New York, Chicago, Pueblo (Colorado) e Tampa (Florida) 33. Il quadro della stampa nel CPC non sarebbe completo se non accennassimo alla presenza di periodici e altri stampati in lingua straniera e soprattutto di copie di giornali non sovversivi, generalmente contenenti notizie riguardanti individui giudicati politicamente pericolosi 34. della massoneria si era rifugiato in Polonia. In particolare si veda il testo di una conferenza da lui tenuta a Varsavia il 19 maggio 1927 su invito della Società italo-polacca « Dante Alighieri » (G. LETI, Italia e Polonia, Velletri, Stab. Tip. Pio Stracca, 1927) e una copia del quotidiano « Messager polonais » (n. 228, 5 ottobre 1927) che riporta il testo di una conferenza dello stesso Leti intitolata Ugo Foscolo à l’occasion du centenaire de sa mort. Sulla figura di Leti vedi A. A. MOLA, Storia della massoneria italiana. Dalle origini ai nostri giorni, Milano, Bompiani, 1992, ad indicem. 31 Sulle dimensioni e sulle caratteristiche della stampa italiana all’estero, che riflettono naturalmente i caratteri del fenomeno migratorio, cfr. V. BRIANI, La stampa italiana all’estero dalle origini ai nostri giorni, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1977. 32 Sulla stampa italiana in Francia nel periodo 1920-1930 vedi F. FERRATINI TOSI, La stampa italiana in Francia, in CENTRE D’ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION SUR L’ÉMIGRATION ITALIENNE, L’immigration italienne en France dans les années 20… cit., pp. 69-75. Le considerazioni contenute in questo contributo sono basate sullo studio del catalogo della stampa periodica dell’emigrazione italiana all’estero conservato nell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Questo catalogo documenta la presenza di 230 periodici italiani in Francia, compresi anche quelli di breve durata, altri « istituzionali », altri ancora fascisti. Vedi pure ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Roma - CENTRE D’ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION SUR L’ÉMIGRATION ITALIENNE, Paris - CENTRO STUDI PIERO GOBETTI, Torino, ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA, Paris, L’Italia in esilio. L’emigrazione italiana in Francia tra le due guerre. L’Italie en exil. L’émigration italienne en France entre les deux guerres, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1993, che comprende alle pp. 586-593 una bibliografia essenziale dell’antifascismo italiano in Francia. 33 Vedi Appunti per una storia dell’anarchismo italiano negli Stati Uniti d’America, in L. BETTINI, Bibliografia dell’anarchismo, I, t. 2, cit., pp. 289-297. Sulla stampa italiana negli Stati Uniti, sia filofascista sia antifascista, vedi G. FACONDO, Socialismo italiano esule negli USA (1930-1942), con presentazione di F. MALGERI, Roma, Bastogi, 1993. 34 Per fare un esempio in ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 5249, fasc. 32069 « Turina Pietro », v’è una copia di un numero de « La Tribuna » del 1895 che riporta la notizia dell’espulsione dalla Francia di Turina. Non mancano poi copie di giornali direttamente collegati alle organizzazioni fasciste, come « Il Grido della stirpe » diretto dall’ex anarchico Domenico Trombetta. Vi sono poi copie della « Gazzetta ufficiale » che pubblicava i decreti di perdita della cittadinanza La stampa nel Casellario politico centrale 233 In effetti presso la Direzione generale della pubblica sicurezza veniva fatta una lettura, presumibilmente sistematica, di tutta la stampa alla ricerca di notizie, anche minute, riguardanti le persone, le associazioni, i congressi, i periodici (e così via) dei movimenti sovversivi. Nel 1890, mentre Crispi era presidente del consiglio e ministro dell’interno, venne data ai prefetti una disposizione significativa, che va inquadrata nel tentativo di rendere più efficiente il controllo di polizia. Il direttore generale della pubblica sicurezza, Luigi Berti, chiese 35 infatti che, a partire dal 1° agosto di quell’anno, venissero spediti al Gabinetto del Ministero dell’interno tutti i giornali politici, eccettuati quelli ai quali il Ministero si era abbonato per mezzo della Prefettura. Fino a quel momento ai prefetti era stato chiesto solamente di inviare i prospetti contenenti informazioni sulla stampa politica. L’intento della nuova disposizione era quello di avere, a livello centrale, ulteriori strumenti per delineare un quadro della realtà nazionale e locale e per poter intervenire. E anche se tale disposizione dopo qualche tempo venne probabilmente disattesa, Pelloux ritornò ancora sulla questione il 1° settembre 1898 chiedendo ai prefetti di inviare una copia di ogni numero od esemplare dei periodici e degli opuscoli sovversivi il lunedì di ogni settimana. Durante il periodo giolittiano non tutte le Prefetture inviavano regolarmente le copie dei giornali e degli stampati; ma il Ministero interveniva in vari casi per segnalare questa inadempienza e anzi nel 1913 il direttore generale della pubblica sicurezza, Giacomo Vigliani, dopo aver notato che la spedizione da parte delle Prefetture era stata trascurata soprattutto per quel che riguardava le pubblicazioni di relazioni di congressi, programmi, statuti, numeri unici, opuscoli di propaganda e altre pubblicazioni occasionali per ricorrenze di anniversari, dispose 36 che i prefetti inviassero tutti i periodici anarchici, sindacalisti e antimilitaristi 37 apparsi nel territorio delle relative giurisdizioni, man mano che venivano pubblicati e possibilmente nello stesso giorno. Nel dopoguerra il direttore generale della pubblica sicurezza, Vincenzo Quaranta, revocò le disposizioni che prescrivevano la trasmissione di ogni numero dei periodici sovversivi 38, ma con l’avvento del fascismo il nuovo direttore generale, Emilio De Bono, ordinò che venissero inviati i giornali sovversivi il giorno stesso della loro pubblicazione 39. Durante il periodo giolittiano e durante il periodo fascista la Direzione generale della pubblica sicurezza, proprio in base all’attenta lettura dei giornaitaliana (come pure di revoca di questi decreti) da parte di alcuni sovversivi, come ad esempio Vincenzo Vacirca e Tommaso Luigi Tonello. 35 Con la circolare del 22 luglio 1890, n. 737. 36 Con la circolare del 4 maggio 1913, n. 8972. 37 Queste disposizioni sono naturalmente da mettere in relazione con il rafforzamento dei movimenti anarchici e antimilitaristi durante e dopo la guerra di Libia. 38 Col dispaccio telegrafico del 30 agosto 1919, n. 2458. 39 Con i dispacci telegrafici del 22 novembre 1923, n. 26569 e del 6 dicembre, n. 27614. Antonio Fiori 234 li e degli stampati sovversivi inviati dai prefetti, così come della stampa non sovversiva alla quale essa era abbonata, fu in grado di intervenire varie volte per chiedere ai prefetti se certe iniziative, come una conferenza, un congresso, la pubblicazione di un numero unico — preannunciate magari in qualche trafiletto nella quarta pagina di giornali a diffusione locale — fossero state effettivamente realizzate, se fossero vere certe notizie riguardanti individui politicamente pericolosi come la loro partenza o la presenza in una determinata città, la morte e così via 40. Naturalmente la polizia svolgeva indagini anche tramite i confidenti, per sapere quali persone lavoravano alla preparazione dei periodici. Il direttore infatti poteva rimanere occulto in quanto il suo nome non figurava nella testata: la responsabilità ricadeva sul gerente, il così detto « uomo di paglia », spesso una persona ignorante che non svolgeva un ruolo effettivo nel giornale. Solo con la l. 31 dicembre 1925, n. 2307, venne stabilito che ogni pubblicazione periodica dovesse avere un direttore responsabile. Redattori e collaboratori a volte non firmavano i loro articoli o li firmavano con pseudonimi; ma le autorità di pubblica sicurezza riuscivano in vari casi ad identificarli anche attraverso controlli incrociati nelle carte dell’archivio della Direzione generale. Altre ricerche venivano svolte per identificare i sottoscrittori della stampa sovversiva: spesso erano gli stessi giornali a fornire elementi utili, pubblicando alcune liste anche se in esse figuravano sigle e pseudonimi. In vari casi la polizia riuscì a sequestrare gli elenchi di abbonati a giornali giudicati pericolosi e ad avere così una conoscenza dettagliata degli appartenenti e dei simpatizzanti di gruppi sovversivi. Nel 1911 nel CPC venne attivato uno « schedario oblatori » per identificare in particolare gli anarchici individualisti, riluttanti ad esporsi, ma disposti a sostenere la stampa libertaria 41. Nel 1924 e nel 1925 vennero sottoposti a controllo e spesso anche a perquisizioni gli abbonati e i sottoscrittori dei più importanti giornali antifascisti, dall’« Unità » all’« Avanti! » e a « La Voce repubblicana », da « La Giustizia » al cattolico « Il Cittadino » di Brescia 42. Le misure di controllo sugli 40 Alcuni articoli di giornale contenenti informazioni giudicate interessanti sono stati evidenziati col lapis dalla polizia: per esempio in ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 4335, fasc. 104855 « Rinaldi Luigi », un trafiletto del « Libertario » (1912) che riporta la notizia della fondazione di un circolo di studi sociali ad opera di Rinaldi; in b. 2776, fasc. 25883 « Leti Giuseppe », s.fasc. 1, un articolo del « Messager polonais » (n. 229, 6 ottobre 1927) che informa della partenza di Leti dalla Polonia. 41 Vedi M. R. OSTUNI, « Innocenti o leggermente colpevoli ». Gli emigrati biellesi tra lavoro e politica: appunti su una fonte, in BANCA SELLA - FONDAZIONE SELLA - BIELLESI NEL MONDO, Studi sull’emigrazione. Un’analisi comparata, Atti del Convegno storico internazionale sull’emigrazione, Biella, 25-27 settembre 1989, a cura di M. R. OSTUNI, Milano, Electa, 1991, pp. 201-210, in particolare p. 205. 42 p. 312. V. CASTRONOVO, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1984, La stampa nel Casellario politico centrale 235 abbonati alla stampa giudicata potenzialmente pericolosa vennero rafforzate durante il regime 43. Rispetto ai periodici può risultare più difficile a volte la determinazione del colore politico degli altri stampati contenuti nel CPC, come gli opuscoli. Qualche esempio può dare un’idea del tipo di materiale che si può trovare e che in qualche caso può sembrare peregrino. Nel fascicolo del pubblicista socialista Aldo Salerno 44 v’è abbondante materiale a stampa: due opuscoli di propaganda antitedesca pubblicati nel corso della Grande guerra dal prof. Luigi Maria Bossi, direttore dell’Istituto ostetrico ginecologico dell’Università di Genova, I pericoli e le vittime della cultura tedesca nel campo ginecologico (Genova, Stab. Tip. G. B. Marsano, 1915) 45, e Il criminoso mercantilismo della cultura tedesca in campo psichiatrico (Genova, Stab. Tip. G. B. Marsano, 1917) 46; il testo della commemorazione di Mazzini fatta da Ugo Della Seta 47; i volumi Mario Mariani, I colloqui con la morte. Impressioni di guerra e novelle di trincea (Milano, Sonzogno, s. d.³) 48; L. Trotzky, L’avènement du bolscevisme (Paris, Editions et Librairie, [1919]); Exposition de la presse antifasciste italienne. Cologne, 10 juin 1928 (Paris, Union des journalistes antifascistes italiens « G. Amendola », s. d.) 49; infine copie di quotidiani e di periodici di differente natura politica 50. 43 Vedi per esempio in ACS, MI, DGPS, DAGR, F.4 - Stampa estera (1923-1943), sottocategoria F.4/A (bb. dalla 109 alla 116), dove è conservata la documentazione relativa ai destinatari della stampa estera per gli anni 1935-1937. 44 ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 4533, fasc. 73458 « Salerno Aldo », s.fasc. 1. 45 Si tratta della conferenza di chiusura dell’anno accademico, tenuta il 15 maggio 1915. Su Bossi, fondatore e presidente della Lega di azione antitedesca, vedi la « voce » non firmata in Dizionario biografico degli italiani, 13, Roma, Istituto Enciclopedia Treccani, 1971, pp. 327-329; B. P. F. WANROOIJ, Storia del pudore. La questione sessuale in Italia (1860-1940), Venezia, Marsilio, 1990, p. 86; A. STADERINI, Combattenti senza divisa. Roma nella Grande guerra, Bologna, il Mulino, 1995, ad indicem. 46 Si tratta di un estratto dalla « Ginecologia moderna »; contiene come prefazione l’articolo Il bacillo patogeno, apparso sul « Corriere della sera », 13 gen. 1917. 47 V. DELLA SETA, Mazzini. Commemorazione tenuta al Teatro Argentina in Roma il 10 marzo 1918, Roma, Tip. editrice La Speranza, 1918. 48 Su Mario Mariani, « sovversivo » nel senso più ampio della parola (era anche autore di romanzi erotici e libertari), cfr. L. BARILE, Il Secolo 1865-1923: storia di due generazioni della democrazia lombarda, Milano 1980, pp. 332-333. 49 Dello stesso è conservata nel fascicolo anche l’edizione in tedesco: Ausstellung der italienischen antifascistischen Presse, Köln a/Rh., 10 Juni 1928, Paris, Vereinigung der italienischen antifascistischen Journalisten « G. Amendola », s. d. 50 Per esempio il « Corriere degli italiani », Parigi 5 ott. 1926, dove veniva segnalato il nome di Salerno tra un gruppo di quindici persone alle quali era stata tolta la cittadinanza italiana; un numero di « Critica sociale » del giugno 1929 in onore di Matteotti; « Il Giornale di Roma » del 22 dic. 1922; « Il Giornale d’Italia » del 22 dic. 1922; « Il Messaggero » del 21, del 22 e del 24 dic. 1922; infine « Die Welt am Abend », Berlino 27 ott. 1928, dove viene segnalato l’articolo di Salerno Es steht nicht gut im Mussolinis Paradies (Non si sta bene nel paradiso di Mussolini). Antonio Fiori 236 Uno dei numerosi opuscoli che vennero ritenuti pericolosi fu Programma massimo della repubblica internazionale del socialismo cristiano di Francesco Porru 51. In esso si accennava ad iniquità commesse dalle autorità costituite di varie nazioni, specialmente durante la prima guerra mondiale. Porru il 20 agosto 1928 venne fermato, proveniente dagli Stati Uniti, allo scalo marittimo di Terranova (la denominazione attuale è Olbia) e venne trovato in possesso di una quarantina fra opuscoli — come alcune operette antimilitariste di Leone Tolstoj, Il contratto sociale di Rousseau, Il regicidio di Amilcare Cipriani e così via — e copie di giornali sovversivi. Interrogato dalla polizia, Porru dichiarò di aver sempre professato idee antimilitariste, delle quali aveva fatto attiva propaganda, esortando gli italiani a disertare durante la guerra; ammise inoltre di essere stato abbonato e assiduo lettore del giornale antifascista « Il Martello ». Ma nel giugno 1927 era rimasto favorevolmente impressionato dalla lettura della Carta del lavoro e aveva modificato le sue idee politiche; aveva anzi scritto una lettera al capo del governo, Mussolini, senza riuscire a farla recapitare. Nei rapporti di polizia degli anni successivi Porru viene presentato, con riferimento anche al suo Programma massimo, come un individuo « affetto da grafomania a sfondo religioso ». Anche se non aveva dato motivo a particolari rilievi in linea politica, ancora alla fine del 1940 non venne radiato dal novero dei sovversivi in quanto non aveva dato « concrete prove di ravvedimento ». Nel fascicolo di Giuseppe Scarrone 52, definito nella copertina « socialista », anche se in un rapporto del Comando generale dell’arma dei carabinieri del 1926 veniva considerato anarchico, vi sono numerosi stampati, tutti pubblicati dallo stesso Scarrone. Questi dopo l’avvento del fascismo era emigrato in Brasile e aveva aperto una fabbrica di vetri a Rio de Janeiro. La polizia italiana cominciò ad interessarsi di lui nel 1924, quando pervennero all’Ufficio postale di Savona 87 copie, prontamente sequestrate, di un suo opuscoletto intitolato Commemorando il 2° anno di governo fascista in Italia (Rio de Janeiro 1925); l’attenzione della Pubblica sicurezza si accentuò nel 1925, in seguito alla spedizione in Italia di alcune copie dei suoi successivi scritti: Onorevole Giacomo Matteotti nel 1° anniversario del suo assassinio. 10 giugno 1925 (Rio de Janeiro, s. n. t., 1925) e Il terzo anno di governo fascista in Italia mentre hanno paura di un morto. 29 ottobre 1925 (Rio de Janeiro, Officina Industrial Graphica, 1925); Note, memorie e commenti sul governo fascista in Italia (Rio de Janeiro, s. n. t., 1925) 53. L’anno successivo 51 Una copia dell’opuscolo, s. n. t., in ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 4091, fasc. 18785 « Porru Francesco ». Nella copertina del fascicolo Porru viene schedato come socialista. 52 53 Ibid., b. 4675, fasc. 27661. Alla fine dello stesso anno venne diffuso in Brasile un volantino intitolato « Saggio di educazione politica di chi oggi parla in nome dell’Italia », contenente il testo di una lettera del 27 novembre 1925 del segretario generale del Partito nazionale fascista, Roberto Farinacci, a Scarrone e la rispettiva risposta del 25 dicembre 1925 (ibid., fasc. 27661). La stampa nel Casellario politico centrale 237 Scarrone pubblicò altri due opuscoli: La mia difesa avanti al tribunale speciale che in Italia proibisce di parlare, all’estero impedisce la critica, privando dei beni e della cittadinanza italiana a chi ha il coraggio di criticare (Rio de Janeiro, s. n. t., 1926); Inventario dei quattro anni di governo fascista in Italia (Rio de Janeiro, s. n. t., 1926) 54. Negli anni seguenti Scarrone continuò a pubblicare opuscoli come: Aprite le porte al lavoro! 1° maggio 1929 (Rio de Janeiro, s. n. t., 1929); Decimo anniversario della fondazione dei Fasci di combattimento in Italia (Rio de Janeiro, s. n. t., 1929); Il Brasile. La sua grandezza, la sua produzione e l’industria del vetro (Rio de Janeiro, s. n. t., 1932) 55; Prendendo congedo dalla politica attiva (Rio de Janeiro, s. n. t., 1935) 56. L’ambasciatore in Brasile il 20 giugno 1930 inviò le seguenti informazioni riservate fornite dal Consolato italiano in Rio de Janeiro: Scarrone era un « vecchio esaltato e rammollito, irresponsabile per quanto innocuo, il cui antifascismo manifestato attraverso sgrammaticati opuscoli nessuno piglia[va] sul serio ». Eppure Scarrone era considerato dalla polizia italiano un individuo abbastanza pericoloso e da arrestare; venne condannato anche per offese al re; nel 1938 il suo nome risultava in un elenco degli abbonati « al noto libello g. e l. » che la Divisione polizia politica aveva avuto in via riservata. Un’opera di carattere strettamente scientifico, Motivi spirituali platonici 57, è conservata nel fascicolo del filosofo Giuseppe Rensi 58. Questi, docente di filosofia nell’Università di Genova, venne denunciato dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per aver diffuso, col concorso della moglie Lauretta Perrucchi, il libello antifascista Alleanza nazionale di libertà. Venne arrestato il 2 ottobre 1930 a Genova e venne poi tradotto nel carcere di Verona. Guglielmo Ferrero spedì da Ginevra a Lauretta Perrucchi una copia del giornale « L’Européen » 59 contenente l’articolo Scepticisme, firmato da Léo Ferrero e dedicato al valore intellettuale e morale di Rensi, e una copia de 54 In copertina compare questa scritta: « Distribuzione gratuita a qualsiasi signore o fascista che ne faccia richiesta ». Una copia venne spedita da Rio de Janeiro a Gaetano Salvemini e venne recapitata per mancanza di indirizzo al Regio consolato a Londra. 55 Una copia venne inviata da Scarrone a Mussolini con la richiesta che venisse permessa l’introduzione dell’opuscolo in Italia. 56 Nel fascicolo sono conservate anche alcune copie di cataloghi della Fábrica nacional de vidrios di Scarrone, rispettivamente del 1925, del 1926, del 1929. 57 G. RENSI, Motivi spirituali platonici, Milano, Gilardi e Noto, 1933; il volume è dedicato « alla memoria dell’amico Cesare Battisti ». 58 ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 4278, fasc. 2628; Rensi viene schedato come socialista. Un profilo biografico di Rensi in F. ANDREUCCI - T. DETTI, Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico, 1853-1943, IV, Roma, Editori riuniti, 1978, pp. 327-332; per una bibliografia aggiornata vedi N. EMERY, Lo sguardo di Sisifo. Giuseppe Rensi e la via italiana alla filosofia della crisi, Milano, Marzorati, 1997; F. MANCUSO, L’itinerario intellettuale di Giuseppe Rensi nelle lettere inedite a Guglielmo Ferrero (1902-1928), in « Nuova antologia », 133° (1998), fasc. 2208, pp. 218-283. 59 Parigi, 3 dic. 1930. Antonio Fiori 238 « La Prensa » 60, contenente una corrispondenza da Genova nella quale si dava la notizia, che venne poi smentita, della morte di Rensi. Nel 1934 Rensi venne esonerato dall’insegnamento universitario per « idee non conformi al regime fascista » e il suo volumetto Scolii. Pagine di diario 61 venne sottoposto a sequestro. Nei fascicoli del CPC sono presenti anche manifesti e volantini e altri stampati, come lettere di invito a congressi e a conferenze, cartoline e così via. Una buona parte di questo materiale è di provenienza estera e veniva considerato sovversivo dalla polizia, a cominciare naturalmente dalle effigi e dalle commemorazioni di Giacomo Matteotti 62. Non mancano comunque stampati rivolti contro esponenti del sovversivismo, come alcune pasquinate dedicate nel corso della Grande guerra a Filippo Turati e al « disfattista cattolico » Guido Miglioli 63. Sulla diffusione delle idee tramite i manifesti e i volantini (un sistema ampio, veloce ed economico) aveva richiamato l’attenzione dei prefetti Luigi Pelloux, assai allarmato, nella circolare del 1° settembre 1898. L’art. 65 della legge sulla pubblica sicurezza 64 prevedeva che nei luoghi pubblici non si potessero affiggere stampati o manoscritti senza il permesso dell’autorità politica. Tale permesso era sottoposto alla tassa di bollo; non era necessaria la preventiva licenza per l’affissione degli stampati o manoscritti relativi a materie commerciali o annunzi di vendite o di locazioni 65. Nel 1912, mentre era in corso la guerra di Libia, molti giornali per aumentare le proprie tirature usavano varie forme di pubblicità, come l’utilizzo degli strilloni o l’affissione di manifesti contenenti i sommari degli articoli. Venne posto il quesito se l’affissione di simili stampati fosse sottoposta 60 Buenos Aires, 9 dic.1930. 61 G. RENSI, Scolii. Pagine di diario, Torino, Edizioni Montes, 1934. 62 Sui volantini antifascisti vedi ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Volantini antifascisti nelle carte della Pubblica sicurezza (1926-1943). Repertorio, a cura di P. CARUCCI - F. DOLCI M. MISSORI, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CXXIV). 63 ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 5241, fasc. 89052 « Turati Filippo », s. fasc. 1. Sulla figura di Miglioli vedi L. BRUTI LIBERATI, Miglioli « disfattista », in « Rivista di storia contemporanea », VII (1978), pp. 251-264; altra bibliografia in A. FAPPANI, Miglioli Guido, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, 1860-1980, II, I protagonisti, Casale Monferrato, Marietti, 1982, pp. 379-384. Tra la documentazione dell’ACS vedi MI, DGPS, DAGR, 1919, A.1, b. 12, fasc. « Miglioli (On.le) », contenente carte del periodo agosto 1917 - febbraio 1919 e inoltre alcuni volantini e una copia dell’« Azione » del 1° dicembre 1917; i quattro fascicoli del CPC, b. 3274, contengono documentazione solo dal 1926 al 1941. 64 Il Testo unico della legge di pubblica sicurezza coordinato col codice penale venne approvato col r. d. 30 giugno 1889, n. 6144. 65 Le principali disposizioni sull’affissione degli stampati fino al 1914 sono in MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, Raccolta di disposizioni legislative e regolamentari e di circolari e lettere di massima per uso degli uffici di P. S., VI, Tipografie - Stampa - Affissione di manifesti - Pornografia - Agenzie pubbliche, 1° ottobre 1914, Roma 1914, pp. 71-84. DELL’INTERNO, La stampa nel Casellario politico centrale 239 all’obbligo della licenza di cui all’art. 65 della legge di pubblica sicurezza. Il Ministero dell’interno promosse al riguardo il parere del Consiglio di Stato, il quale nell’adunanza del 3 maggio 1912 si pronunciò in senso affermativo. Ritenne infatti che la straordinaria diffusione inerente a questo mezzo di pubblicità, la forma stessa nella quale agiva più sulle masse che su lettori isolati, il suo carattere locale, per cui si rendeva facilmente « strumento di passioni », imponessero maggiori riserve, una vigilanza più diligente e tempestiva che per la stampa in generale 66. Durante la Grande guerra e durante il regime fascista l’attenzione delle forze dell’ordine verso questa forma di stampa diventò ancora più assidua 67. Vi sono state differenti « modalità di accesso » (per così dire) degli stampati nei fascicoli del CPC. Alcuni giornali antifascisti pubblicati in Argentina vennero spediti dall’ambasciata italiana a Buenos Aires al Ministero degli affari esteri e in alcuni casi direttamente al Ministero dell’interno. Un volantino antifascista stampato a Parigi nel 1931 — contenente l’articolo di Arturo Labriola Viva l’Italia, evviva! tratto da un numero della « Libertà » del 1930 — venne spedito alla Prefettura di Potenza da Rio de Janeiro dall’antifascista Domenico Ferraro 68. Una copia del 1930 di « Le Réveil anarchiste », uno dei maggiori organi dell’anarchismo internazionale, venne consegnata dall’antifascista Pietro Turina al capo della Divisione polizia politica, che lo aveva incontrato a Ginevra 69. A volte vengono messi in evidenza con il lapis articoli scritti dai sovversivi in giornali che erano stati spediti dalle prefetture in base alle disposizioni che abbiamo ricordato prima. Ma una grande parte del materiale è pervenuto in questi fascicoli in seguito ad un sequestro. L’istituto del sequestro dei giornali è stato utilizzato con differenti modalità e intensità dai governi che si sono succeduti in Italia. Minuziose norme erano state stabilite subito dopo l’Unità, in particolare dal segretario generale del Ministero dell’interno, Silvio Spaventa, durante il ministero Farini, poi Minghetti, norme che erano state perfezionate durante i successivi governi della Destra e della Sinistra. Perché i provvedimenti di sequestro risultassero efficaci vennero coinvolte non solo le autorità giudiziarie ma anche quelle postali. La Direzione generale delle poste rivendicò in vari casi la natura tecnica del servizio postale, non compatibile con interventi di carattere politico; ma in altre occasioni si mostrò meno ferma e inviò 66 Vedi la circolare del Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Div. 4, Sez. 2, n. 12971-5, 22 magg. 1912, firmata per il ministro da Vigliani, ibid., pp. 78-80. 67 Vedi la documentazione in ACS, MI, DGPS, DAGR, A5G - Prima guerra mondiale; l’indice posto alla fine dell’inventario facilita la ricerca degli stampati. Per il periodo fascista vedi ibid., F.1 - Stampa sovversiva e clandestina (1926-1943). 68 ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 2029, fasc. 2029 « Ferraro Domenico ». 69 Ibid., b. 5249, fasc. 32069 « Turina Pietro ». Antonio Fiori 240 circolari agli uffici dipendenti con la richiesta di aprire i pacchi provenienti da certe località per verificare se contenessero giornali sovversivi. In ogni caso a livello locale poteva risultare difficile a semplici impiegati postali fare resistenza alle richieste delle autorità di pubblica sicurezza 70. In molti casi l’istituto del sequestro si dimostrava inefficace, ma i giornali colpiti dovevano a volte sopportare conseguenze pesanti come per esempio il sequestro degli elenchi degli abbonati. Come venne denunciato da molti giornali dell’epoca liberale, ciò poteva riuscire addirittura letale alla vita del periodico in quanto la direzione non poteva più comunicare o ricevere le quote di abbonamento. Anche l’uso invalso tra la magistratura di ordinare sequestri senza poi procedere nella maggior parte dei casi ai relativi giudizi, danneggiava gravemente i periodici. Sul problema intervenne il ministro di grazia e giustizia, Pasquale Stanislao Mancini, con la circolare del 16 maggio 1876 71, nella quale tra l’altro affermava: « Siffatta usanza trascendendo i termini della legge, prende sembianza di arbitrio e provoca sdegni e doglianze, come di una offesa alla libera manifestazione del pensiero, e ai diritti di proprietà, senza possibilità di difesa innanzi ai magistrati competenti ». Le successive circolari dei ministri guardasigilli Raffaele Conforti e Giuseppe Zanardelli costituiscono una conferma del perdurare di questo abuso. Finalmente la l. 28 giugno 1906, n. 278, abolì il sequestro preventivo, statuendo, con quella semplicità tipica di molte leggi dell’Ottocento alla quale siamo ormai disabituati: « Non si può procedere al sequestro dell’edizione degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero, contemplate nell’Editto sulla stampa 26 marzo 1848, se non per sentenza definitiva del magistrato ». Ma nel momento della guerra contro la Turchia Giolitti ritornò al sistema del « sequestro dei giornali nelle stazioni prima della loro distribuzione », giustificando questo e gli altri provvedimenti eccezionali, presi sotto la sua « sola responsabilità e senza esitazioni (…) con il grande interesse pubblico che si trattava di tutelare ». Così le autorità di polizia, andando al di là della legge del 1906 che ammetteva una sola eccezione, quella per gli stampati offensivi del buon costume o del pudore, fecero sequestrare ingenti quantità di periodici e di volantini antimilitaristi 72. Alla vigilia della dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria venne istituita la censura preventiva sulla stampa con r.d. 23 maggio 1915, n. 675; il prefetto, il sottoprefetto o chi ne faceva le veci nel comune nel quale aveva sede l’officina tipografica, aveva la facoltà di procedere immediatamente, con provvedimento non soggetto a reclamo, al sequestro quando ravvisava nello 70 Vedi A. FIORI, Per la storia del controllo governativo... cit., pp. 21-27, 33-40, 47-55. 71 Circolare n. 654 ai procuratori generali del re presso le corti di appello del Regno, pubblicata in « Cronaca legislativa », supplemento al « Monitore dei tribunali », vol. 18, 1876, pp. 106-107. 72 A. FIORI, La censura durante la guerra di Libia, in « Clio », XXVI (1990), 3, pp. 483511, in particolare pp. 507-508. La stampa nel Casellario politico centrale 241 stampato elementi di reato perseguibile d’ufficio e quando riteneva che la sua pubblicazione potesse, « deprimendo lo spirito pubblico, scuotendo la fiducia nell’autorità dello Stato, eccitando gli urti tra i partiti politici, o altrimenti, essere gravemente pregiudizievole ai supremi interessi nazionali connessi con la guerra o con la situazione interna e internazionale dello Stato » 73. Il governo fascista introdusse un principio che sovvertiva le norme sulla stampa del periodo liberale con l’art. 4 del r.d.l.15 luglio 1923, n. 3288 74: « Il sequestro è eseguito dall’autorità di pubblica sicurezza senza che occorra speciale autorizzazione ». Ciò venne precisato meglio nel r.d.l. 10 luglio 1924, n. 1081 75, e soprattutto nelle dettagliate disposizioni date il 12 luglio 1924 ai prefetti dal ministro dell’interno, Federzoni 76. Sotto una particolare vigilanza dovevano essere tenute le « intollerabili intolleranze di quella più accesa stampa interventista » che soleva « trarre argomento da tutti i più tristi avvenimenti di cronaca per eccitare l’odio tra le classi e la ribellione contro lo Stato e l’ordine sociale »; ma le sanzioni dovevano essere applicate anche contro i giornali « più o meno costituzionali » che tenevano lo spirito pubblico « in una preoccupante eccitazione » e contro gli stessi giornali fascisti che davano « esca a pericolose accensioni di animi atte a perturbare l’ordine pubblico ». Come direttiva pratica Federzoni ricordava che il sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche poteva essere ordinato dal prefetto o da un funzionario da esso delegato, indipendentemente dalla diffida, per il solo fatto che il giornale avesse pubblicato uno scritto che presentasse i caratteri di pericolosità e di dannosità — recando intralcio all’azione diplomatica del governo nei rapporti con l’estero, screditando la nazione all’interno e all’estero, destando ingiustificato allarme nella popolazione, eccitando all’odio di classe o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità — o si rendesse colpevole di vilipendio verso la patria, il re, la famiglia reale, il sommo pontefice, la religione dello Stato, le istituzioni e i poteri dello Stato e le potenze amiche. In definitiva il ministro dell’interno consigliava un’ampia applicazione dell’istituto del sequestro, ritenendo che potesse bastare per compiere « quell’opera di persuasione e di pressione (...) 73 Sulle disposizioni riguardanti la censura, vedi A. FIORI, Il filtro deformante. La censura sulla stampa durante la Prima Guerra Mondiale, prefazione di L. LOTTI, Roma, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, 2001. 74 Il decreto, intitolato « Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche », venne pubblicato solamente dopo un anno, nella « Gazzetta ufficiale » dell’8 luglio 1924, n. 159. Le disposizioni legislative del 1923-1925 sulla stampa sono in MINISTERO DELL’INTERNO, Raccolta di disposizioni sulla stampa periodica, Roma 1926. Un commento su di esse in G. LAZZARO, La libertà di stampa in Italia dall’Editto albertino alle norme vigenti, Milano, Mursia, 1969, pp. 101-110. 75 Questo decreto-legge, contenente norme di attuazione del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 3288, diveenne poi l. 31 dicembre 1925, n. 2308. 76 Le disposizioni vennero impartite con circolare telegrafica n. 15026, in ACS, MI, DGPS, DAGR, Massime, S.4, b. 102, fasc. « Vigilanza sulla stampa. Affari generali », s.fasc. « Circolari e disposizioni generali ». Antonio Fiori 242 indispensabile per frenare gli abusi della libertà di stampa », e ricordava che dovevano essere proibite nel modo più assoluto le caricature del re, del papa, dei membri della famiglia reale e tutte quelle che gettassero discredito sulla religione e sui poteri dello Stato. Una serie di disposizioni successive ordinava di provvedere al sequestro dei giornali prontamente e in modo efficace, di coordinare l’azione nelle varie province per i giornali che avessero una diffusione non solo locale 77, di telegrafare il numero delle copie sequestrate di ciascun giornale e di inviare una copia del giornale stesso al Gabinetto del Ministero dell’interno, all’Ufficio stampa e alla Direzione generale della pubblica sicurezza 78. Un’altra circolare di Federzoni del 25 gennaio 1926 79, considerato il notevole miglioramento della situazione politica e dell’ordine pubblico, dava ulteriori suggerimenti ai prefetti: come quello di far intendere ai direttori dei giornali, « usando l’opportuna prudenza di linguaggio », che per assicurare una normale e continuativa pubblicazione dei giornali stessi essi avrebbero dovuto « evitare di ricadere negli eccessi di ingiuriosa diffamazione del governo e del fascismo »; come quello di ostacolare la pubblicazione « dei giornalucoli sedicenti umoristici o satirici » 80; come quello di non consentire una « elencazione di sequestri, perquisizioni e altre misure di polizia » che mirassero a dare un quadro allarmistico della vita pubblica italiana. Nel 1928 intervenne personalmente Mussolini con la richiesta ai prefetti 81 di applicare « con la necessaria ampiezza » l’art. 112 della legge di pubblica sicurezza — che vietava la vendita o la distribuzione di stampati contrari all’ordine nazionale dello Stato o lesivi della dignità e del prestigio nazionale — anche alle pubblicazioni lesive della dignità e del prestigio del fascismo. Il Codice penale Rocco dedicava due articoli, il 57 e il 58, a disciplinare in maniera organica la « responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa »; in esso non sussistevano più dubbi sulla responsabilità degli autori dei singoli articoli, firmati o no, sempre che naturalmente fossero identificabili. Nel Codice vi era un certo numero di casi nei quali veniva considerato elemento essenziale del reato la pubblicità data ad un certo comportamento o ad una certa manifestazione di pensiero; e tra le forme di pubblicità vi era naturalmente la stampa. Tra questi casi spiccavano i reati di vilipendio alle 77 Ibidem. 78 Ibid., Circolare telegrafica 1° genn. 1926, n. 6. 79 Ibid., Circolare telegrafica n. 1852. 80 Nell’Italia unitaria aveva avuto un notevole sviluppo la stampa satirica; vedi per esempio V. TEDESCO, La stampa satirica in Italia, 1860-1914, Milano, Angeli, 1991. 81 Vedi telespresso del 1° dicembre 1928, n. 19073, in ACS, MI, DGPS, DAGR, Massime, S.4/A, busta attualmente non numerata, fasc. 7 « Pubblicazioni lesive della dignità e del prestigio del fascismo ». La stampa nel Casellario politico centrale 243 istituzioni costituzionali, alla nazione italiana, alla religione di Stato e così via, tutti puniti ben più severamente rispetto al Codice Zanardelli 82. Col Testo unico di polizia del 1931 (articoli 112, 113 e 114) e col regolamento del 6 maggio 1940, n. 635 (articolo 200), venne autorizzato il sequestro in via amministrativa di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti politici, sociali, economici, costitutivi dello Stato o lesivi del prestigio delle autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore e della pubblica sicurezza. Molto del materiale a stampa conservato nel CPC era stato sequestrato, con differenti modalità, dalla polizia. Il libello Infamia delle autorità fasciste italiane in Argentina, pubblicato a Buenos Aires nel 1934, fu sequestrato in Italia dove era stato introdotto nascosto tra pagine di giornali non colpiti da ordine di sequestro 83. In vari casi il materiale venne sequestrato direttamente alla frontiere, nel bagaglio di individui sospetti che uscivano dall’Italia oppure rientravano dall’estero. In alcuni casi il sequestro venne effettuato all’estero: per esempio varie copie di differenti volantini nel domicilio di Ruggero Grieco a Parigi 84. Soprattutto durante il periodo fascista il materiale a stampa venne sequestrato anche dalle autorità postali: per esempio nel 1930 varie copie di giornali spedite da Pittsburgh ad Emilio Stella 85. Riguardo il motivo del sequestro v’è una notevole varietà, compreso il caso di offese alla famiglia reale 86. In conclusione gli stampati presenti nel CPC, oltre ad essere ovviamente in stretta relazione con gli atti conservati, in vari casi costituiscono l’elemento qualificante, la ragione stessa dell’apertura dei fascicoli. ANTONIO FIORI Archivio centrale dello Stato 82 Sul codice penale del 1931, noto come codice Rocco, vedi C. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 223-227; sull’assorbimento in questo codice dei reati commessi tramite la stampa vedi G. LAZZARO, La libertà di stampa in Italia… cit., pp. 125-135. 83 ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 1561, fasc. A43700 « Curino Giuseppe ». 84 Ibid., b. 2528, fasc. 22465 « Grieco Ruggero », s. fasc. 1. 85 Ibid., b. 4949, fasc. 85999 « Stella Emilio »; i giornali furono sequestrati dall’Ufficio di revisione di Verona. 86 Il numero unico « Aurora vermiglia », Chiasso, 27 ott. 1906, fu sequestrato per le offese alla regina madre contenute nell’articolo Angherie alla dogana di Ponte Chiasso, ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, b. 5022, fasc. 63799 « Tangorra Francesco ». GIORNATA DI STUDIO: « COSTANZO CASUCCI ARCHIVISTA E STORICO » (Roma, Archivio centrale dello Stato, 15 gennaio 1999) Si pubblicano, di seguito, gli interventi con cui l’Archivio centrale dello Stato ha ricordato Costanzo Casucci, scomparso il 27 novembre 1996. La giornata ha visto il contributo, oltre che di Paola Carucci, di Claudio Pavone, Giovanni Sabbatucci, Giuseppe Talamo e infine di Giampiero Carocci, che pur non avendo partecipato alla manifestazione ha fatto pervenire in seguito il suo scritto. Nato a Tuoro sul Trasimeno (PG) l’11 agosto 1921, laureatosi in filosofia, Casucci rimase, durante la guerra, prigioniero degli inglesi per oltre due anni. Dopo aver vinto nel 1951 il concorso per archivista di Stato, fu destinato nel gennaio 1952 all’Archivio di Stato di Roma, quindi trasferito nel luglio dello stesso anno a Firenze, alla fine del 1953 al Centro microfotografico di Roma e, subito dopo, all’Archivio centrale dello Stato, che era stato formalmente istituito in quell’anno, anche se di fatto rimase ancora unito all’Archivio di Stato di Roma fino al 1960. Destinato alla Sezione del S. Michele, ove si trovavano in gran parte i fondi destinati all’ACS, Casucci, in collaborazione con Claudio Pavone, iniziò subito a censire i materiali e a studiare sistematicamente le istituzioni centrali dello Stato unitario dal 1861. Quando, nel 1960, iniziò l’attività dell’ACS presso la nuova sede dell’EUR, Casucci ebbe la direzione della Sezione che si occupava del Ministero dell’interno, degli archivi fascisti, del Comitato di liberazione nazionale, delle Raccolte varie, e, successivamente, anche del Ministero della cultura popolare. Lasciò l’amministrazione archivistica il 30 giugno 1973. Seppe conciliare con intelligenza e passione i suoi personali interessi di ricerca sul fascismo e l’antifascismo, fortemente connotati in una dimensione etico-politica, con l’impegno istituzionale di riordinamento e inventariazione dei fondi, con l’assistenza agli studiosi e con il delicatissimo compito di gestione dei documenti riservati. Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 245 Tra i suoi lavori più rilevanti si segnalano l’inventario degli Archivi di « Giustizia e Libertà », 1915-1945 (Roma 1969, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LXVIII), l’Antologia di scritti critici sul fascismo (Bologna, Il Mulino, 1961); la seconda, più ampia raccolta antologica, Interpretazioni del fascismo (Bologna, Il Mulino, 1982) e l’edizione critica in due volumi degli Scritti dall’esilio di Carlo Rosselli (1929-1937), pubblicati da Einaudi rispettivamente nel 1988 e nel 1992. Proprio in occasione dell’allestimento da parte dell’Archivio centrale dello Stato di una mostra sui fratelli Rosselli (26 giugno 2002 - 31 maggio 2003) a conclusione delle manifestazioni organizzate dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario delle nascite di Carlo e Nello, sembra doveroso ricordare l’archivista che per primo si è occupato delle fonti documentarie relative ai Rosselli e al movimento di « Giustizia e Libertà », studiando poi a fondo il pensiero di Carlo. 246 Paola Carucci PAOLA CARUCCI (sovrintendente all’Archivio centrale dello Stato) Delineare i tratti essenziali di Casucci archivista significa per me riandare con il pensiero ai primi anni trascorsi presso questo Istituto, quelli che contribuiscono a dare un’impronta determinante alla propria formazione, a chiarire l’identità professionale. Vi è dunque in me un debito di riconoscenza, oltre a un sentimento di stima e di affetto. Ho diviso la stanza per quasi dieci anni con Casucci, in un sodalizio caratterizzato dall’assonanza dei cognomi e da una radicale diversità di carattere. Non abbiamo mai litigato, anche se per molti non era facile andare d’accordo con lui per il tono perentorio con cui talora apostrofava le persone, per l’inopportunità di certe sue domande e le terribili gaffes, per certi eccessi di moralismo che lo portavano a valutazioni troppo rigide e un po’ manichee delle persone, per qualche improvviso e brevissimo accesso d’ira, per il dubbio che ti cercasse solo quando aveva bisogno di qualcosa. Invece era forte in lui il senso dell’amicizia. Determinante quella con Claudio Pavone, sempre permeata da una connotazione di deferenza, per cui spesso qualche collega lo prendeva benevolmente in giro, ma anche il legame con poche altre persone che costituivano per lui saldi e duraturi punti di riferimento. Di natura estroversa e conviviale, aveva in realtà una personalità semplice e complessa insieme, in cui lo slancio vitale che lo proiettava verso gli altri coesisteva con una attitudine alla vita solitaria, con il pudore della propria sensibilità, con un senso di malinconia crepuscolare. Era importante per lui la dimensione politica e intellettuale che trasfondeva nel suo impegno professionale. Di intelligenza acuta, aveva intuizioni illuminanti anche se non sempre sostenute da una lunga tenuta nella coerenza delle argomentazioni e una forte aspirazione a sistematizzare, che trovava qualche impedimento nel rischio della semplificazione o nell’impeto passionale con cui aderiva alle sue convinzioni. Casucci prende servizio nell’Amministrazione archivistica nel gennaio 1952 e dopo una breve parentesi a Firenze passa all’Archivio di Stato di Roma, ove con Piero D’Angiolini, Luciano Gulli, Vittorio Stella e Giovanni Zarrilli viene incaricato della noiosissima schedatura delle Giustificazioni di Tesoreria sotto la guida vessatoria di Gaetano Ramacciotti, evocato spesso negli anni — soprattutto da D’Angiolini — come un incubo, come la persona che avrebbe potuto fare odiare per sempre il lavoro di archivista. Nell’Istituto, all’epoca diretto da Armando Lodolini, si trovano anche Giampiero Carocci, Leopoldo Sandri, Elio Lodolini, Edvige Aleandri Barletta, Maria Cristofari, Michele Pardo, Elio Califano, Claudio Pavone, Fausto Fonzi, poi Gilmo Arnaldi e Renato Grispo e, più tardi, Salvatore Carbone. Un nucleo di personalità forti, intelligenti, di alto livello culturale, con motivazioni politiche e interessi determinati che segneranno sviluppi di carriera diversi, ma che Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 247 portano in quel momento una vivacità intellettuale, una serie di stimoli e di sollecitazioni ideologiche, un contrasto generazionale con i colleghi più anziani che gioverà molto a una nuova configurazione del lavoro dell’archivista, anche se per alcuni di questi l’appartenenza all’Amministrazione archivistica è stata solo una fase, per quanto lunga in certi casi, seguita da scelte universitarie in settori diversi della storia o della filosofia. Tra costoro, molti hanno dato un contributo fondamentale all’evoluzione del lavoro dell’archivista e alla storia dell’Archivio centrale dello Stato. Elio Lodolini, con la sua vasta produzione di teoria e legislazione, ha contribuito a conferire statuto di disciplina scientifica all’archivistica. D’Angiolini e Pavone, con il progetto e la realizzazione della Guida generale degli Archivi di Stato italiani, hanno dato corpo alla più imponente sperimentazione del metodo storico, incentrando sul rapporto tra fonti documentarie e istituzioni produttrici il momento identificativo del fondo, secondo una prospettiva che solo vent’anni più tardi troveremo al centro del dibattito teorico internazionale sui criteri di descrizione archivistica. Carbone, con la realizzazione in tempi brevissimi del trasferimento delle carte dai vari depositi dell’Archivio di Stato di Roma alla nuova sede dell’EUR, contribuì in maniera determinante all’organizzazione e all’avvio dell’attività dell’Archivio centrale dello Stato. Fondamentale per il trasferimento era stata la compilazione degli schedoni, introdotti, credo, da Emilio Re, che resero possibile, come ha scritto Pavone, la « riunificazione degli sparsi brandelli di uno stesso fondo e perfino di una stessa serie » (L’Archivio centrale dello Stato 1953-1993, a cura di M. Serio, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993, p. 540, Saggi, 27). Alla schedatura parteciparono con entusiasmo Casucci, D’Angiolini, Fonzi, Stella, Pardo e Pavone, che aveva prefigurato la sistemazione del materiale secondo un preciso progetto di ricostruzione delle istituzioni; alla sistemazione delle carte, nella sede di arrivo, operava instancabile Mario Missori, che entrava così in contatto con l’Istituto, costituendo poi per lunghissimi anni un particolare punto di riferimento per i giovani archivisti e per i ricercatori. Sandri, che aveva coordinato i lavori degli archivisti, tra cui anche Casucci, per l’inchiesta Abbate volta a verificare agli inizi degli anni Cinquanta quanta documentazione giacente nei depositi dei ministeri dovesse confluire nella nuova sede dell’Archivio centrale dello Stato, gestì come sovrintendente la « fase pionieristica » dell’attività dell’Istituto e lo diresse per oltre un decennio con grande equilibrio. Grispo, infine, come sovrintendente all’Archivio centrale dello Stato prima e in seguito come direttore generale dell’Amministrazione archivistica, ha poi contribuito molto a dare una fisionomia specifica alla biblioteca dell’Istituto e un ulteriore impulso all’intervento sugli archivi correnti dell’Amministrazione dello Stato, allo sviluppo delle pubblicazioni, al ruolo del nostro paese nella comunità internazionale degli archivi. Casucci non ha scritto di archivistica, ha diretto a scavalco, dal 1963 al 1965, un piccolo Archivio di Stato come quello di Terni, ha redatto quasi esclusivamente inventari sommari salvo l’ottimo inventario del Carteggio 248 Paola Carucci riservato della Segreteria particolare del duce, ha pubblicato soltanto l’inventario di « Giustizia e libertà ». Quale è stato dunque il suo contributo specifico? Casucci lavorava in maniera intelligente e con grande modestia, con alto senso dello Stato e con una istintiva capacità di mediazione culturale. Se si tiene conto che gestiva da solo una Sezione comprendente gli archivi del Ministero dell’interno, gli archivi fascisti e le carte del Ministero della cultura popolare, i fondi cioè su cui fin dai primi anni Sessanta si concentra l’interesse dei ricercatori e che erano tutti più o meno privi di strumenti di ricerca salvo parziali elenchi di versamento, si può ben comprendere come fosse essenziale possedere una razionale visione degli interventi necessari per rendere consultabile la documentazione. Questo infatti era per lui un obiettivo fondamentale, in sostanziale controtendenza rispetto ai canonici principi dell’archivistica, che subordinavano l’accesso all’inventariazione dei fondi: Casucci si proponeva invece di mettere i fondi in consultazione il prima possibile, prescindendo dal riordinamento e dalla presenza di strumenti di ricerca analitici, ma avendone colto le caratteristiche principali e le connessioni tra i vari versamenti, procedendo a elenchi e inventari sommari, ma essenziali e corretti nell’informazione. Del resto la possibilità di procedere a una efficace sintesi è condizionata dalla profonda conoscenza della situazione storica cui le carte si riferiscono, dalla capacità di decodificare gli indici di classificazione, dall’attitudine a cogliere dalla massa dell’informazione gli elementi più rilevanti. Determinanti, inoltre, per l’acquisizione del metodo erano state le esperienze del censimento per l’inchiesta Abbate e degli schedoni per il trasferimento. Il lavoro prioritario pertanto era l’analisi attenta degli elenchi di versamento, la compilazione e revisione di elenchi, la schedatura sommaria o parzialmente analitica di nuclei particolarmente significativi per il riordinamento, il rimbustamento, che coinvolgeva gli addetti all’archivio, Di Genova e l’inafferrabile Franz, che solo amava scrivere in bella calligrafia i cartellini. Ma forte era anche il richiamo al rigore filologico quando procedeva alla sia pur sintetica descrizione o all’edizione di documenti come nel caso di alcune lettere di Gramsci o, successivamente, con l’impegnativo lavoro sugli Scritti dall’esilio di Carlo Rosselli. Così Casucci riusciva ad avere il controllo intellettuale di masse enormi di documenti, così — teorizzando il suo sistema — ho insegnato per anni la tecnica dell’ordinamento ai miei studenti, trasmettendo ad altri quanto avevo appreso dalla pratica quotidiana del lavoro con lui. Aveva il gusto di comunicare agli studiosi quanto veniva a conoscere attraverso questo approccio diffuso ai vari nuclei di documentazione, che sembrava procedere senza collegamenti e rispondeva invece a una metodica e progressiva identificazione delle connessioni. Convocava gli studiosi e, con toni un po’ teatrali, poneva domande sulla ricerca in corso, forniva preziose informazioni, a seconda della persona allargava il discorso su temi politici, Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 249 storiografici, filosofici. De Felice, Aquarone, Spriano, Lyttelton, Schieder, Petersen, Rossini, Melograni, Procacci, Cannistraro, Corner, Castronovo, Scherrer, Kacin-Wohinz, Talamo, Sabbatucci, Tranfaglia, Aga Rossi, Cordova, Riosa, Colarizi sono solo alcuni dei nomi che mi vengono alla mente. Forse qualche volta lo studioso avrebbe preferito non essere interrotto nelle sue ricerche, ma nell’insieme credo che tutti apprezzassero la dimensione umana e intellettuale che veniva a stabilirsi con lui, archivista orgoglioso della sua professione. Per me ascoltare quei colloqui, cui all’inizio per timidezza e incertezza delle mie cognizioni non osavo partecipare, ha costituito una fonte ricchissima e insostituibile di stimoli e di riflessioni; seguire in certi casi, grazie all’abile provocazione di Casucci, la dinamica della formulazione del giudizio critico in storici di rilievo mi ha dato momenti di grande felicità. Ascoltando il percorso di ricerca degli studiosi, Casucci arricchiva le sue conoscenze circa le potenzialità dei significati delle carte, allargava la sua esperienza che poi trasmetteva ad altri studiosi. Contro la tendenza diffusa tra molti archivisti a tenere gelosamente nascoste le scoperte che inevitabilmente si fanno lavorando quotidianamente sulle carte, Casucci godeva nel far circolare l’informazione e nel mettere in contatto tra loro studiosi che affrontavano temi affini. Sempre in questa ottica di diffondere l’informazione e di razionalizzare il sistema della comunicazione, Casucci imposta e realizza il primo saggio di bibliografia dell’Archivio centrale dello Stato, la prima indagine cioè sui saggi e le monografie che hanno utilizzato i fondi dell’Istituto, proseguita poi da altri archivisti e concretizzatasi nella pubblicazione di due volumi. Con Mario Missori cura l’aggiornamento della guida di sala studio. Impianta artigianalmente lo schedario degli archivi personali conservati in sedi diverse dall’Archivio centrale dello Stato, individuati facendo lo spoglio delle citazioni nei testi storiografici. Era un’iniziativa validissima che non si è riusciti in seguito a portare avanti e che ancora oggi fatica a decollare benché siano stati avviati da altri archivisti il repertorio degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, di cui sono usciti due volumi (Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991; 1998, Strumenti, CXII; CXXXIII) su tre; il catalogo delle guide e inventari editi (Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995, Sussidi, 8) di cui è in corso il primo aggiornamento; repertori di archivi privati per il Lazio, la Lombardia e la Toscana realizzati in ambito regionale (Soprintendenza archivistica per il Lazio, Guida degli archivi economici a Roma e nel Lazio, a cura di M. Guercio, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1987; Gli archivi d’impresa nell’area milanese. Censimento descrittivo, a cura di D. Bigazzi, per conto dell’Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia, Milano 1999; Archivi di imprese industriali in Toscana: risultato di una prima rilevazione condotta dalla Sovrintendenza archivistica, Firenze 1982; Guida agli archivi delle personalità della cultura in Toscana tra ’800 e ’900. L’area fiorentina e L’area pisana, a cura di E. Capannelli e E. Insabato, Firenze 1996 e 2000). 250 Paola Carucci Ad un altro settore, fondamentale per la ricerca nell’ambito della storia contemporanea, Casucci ha dedicato gran parte del suo tempo: la gestione dei documenti riservati. A un quindicennio dalla fine della guerra si apre la ricerca sul fascismo. La quantità dei documenti riservati per la presenza di notizie private di persone è ingentissima e concentrata soprattutto nella sua Sezione. Era noto che in parte la documentazione — trasferita dopo l’8 settembre del 1943 al Nord e restituita al governo italiano dopo la firma del trattato di pace — era stata microfilmata dagli alleati e i microfilm, in due distinte serie, erano stati portati in Inghilterra e negli Stati Uniti, ove la consultazione veniva sottratta al controllo italiano. Va ricondotta a Sandri la decisione di avviare l’accesso alle più rilevanti serie di natura politica relative al fascismo, ma la documentazione acquisita dall’Istituto è molto più consistente di quella microfilmata e l’impegno per metterla in consultazione — in tempi così vicini agli eventi rappresentati nei documenti — richiede onerose cautele: la lettura dei fascicoli e l’esclusione dalla consultazione di eventuali documenti che contengono notizie riservate su persone, quella che nel nostro gergo si chiama « scrematura ». Una parte autorevole degli archivisti si dichiara contraria alla « scrematura » dei fascicoli, con argomentazioni teoriche incentrate sulla non scientificità di una indagine condotta su fonti depauperate di alcuni documenti. L’Archivio centrale assume una posizione netta: non procedere alla scrematura, infatti, equivale a bloccare per decenni la ricerca storica sul fascismo. Sarà proprio Casucci a sobbarcarsi il peso maggiore derivante da questa politica di cui è un sostenitore convinto, gestendo questo delicatissimo servizio con equilibrio e assoluta imparzialità. La sua consuetudine con gli studiosi infatti non lo ha mai indotto a favoritismi, sentendosi investito di una responsabilità che coinvolgeva l’immagine dell’Istituto e la figura professionale dell’archivista. Questa esperienza italiana ha suscitato l’interesse di altri paesi che, a seguito di radicali rivolgimenti politici, si sono trovati a gestire documenti riservati sui quali pressante era la domanda degli storici: la prassi della « scrematura » è ormai un concetto diffusamente acquisito ed è considerata una delle varie misure di cautela rivendicate dagli archivisti e rese oggi necessarie in tutti i paesi dalle norme sulla tutela dei dati personali. Casucci operava all’Archivio centrale dello Stato in una fase in cui l’acquisizione di fondi recenti di grandissima rilevanza storico-politica e la nuova legge archivistica, approvata nel 1963, che introduceva termini mobili per la libera consultabilità dei documenti e disciplinava la possibilità di autorizzare l’accesso ai documenti riservati per motivi di studio, applicata peraltro con grande liberalità dall’Amministrazione archivistica, favorivano — come egli stesso scrive — una « autentica politica culturale (...) intesa al progresso degli studi e al loro più libero e aperto confronto » (Saggio di bibliografia dell’Archivio centrale dello Stato, 1953-1968, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XXXI, 1971, p. 338). Sarebbe difficile per lui capire come sia diventata più complessa oggi la normativa per l’accesso ai documenti contemporanei. L’involuzione del Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 251 processo di liberalizzazione, iniziata con il passaggio dell’Amministrazione archivistica al Ministero per i beni culturali e determinata da un insieme di norme incongrue e da una più difficile temperie culturale, ha portato nel biennio 1997-1998 a una situazione inaccettabile per la ricerca storica e particolarmente umiliante per gli archivisti. Spettava all’Archivio centrale dello Stato assumere un’iniziativa forte per rivendicare un ruolo agli archivisti, assicurando tuttavia al ministro dell’interno che l’Istituto poteva garantire una rigorosa gestione dei documenti riservati, aperta alla ricerca e nello stesso tempo rispettosa della tutela della riservatezza e dei dati personali. Nella spinta a ricostituire un nesso di continuità con quel clima di liberalità che aveva caratterizzato il periodo della mia collaborazione con Casucci, ho trovato la determinazione per perseguire l’obiettivo della ricostituzione di un organismo consultivo, in cui fossero di nuovo rappresentati archivisti e storici, a supporto delle decisioni del prefetto circa le autorizzazioni alla consultazione dei documenti riservati. Nell’introduzione alla Bibliografia dell’Archivio centrale dello Stato (Roma 1986, Sussidi, 1), Casucci rileva che « il collegamento con il mondo degli studi, la sensibilità alle esigenze nuove del paese, la consapevolezza della rilevanza anche politica che hanno gli archivi, lo scrupolo e la duttilità a un tempo con cui viene svolto il lavoro specifico di Istituto, hanno fatto dell’Archivio centrale dello Stato uno dei centri di ricerca più fervidi e avanzati tra quanti operano nel campo storico ». Si può rilevare che queste parole riflettono il suo modo di operare in Archivio, ma non rendono l’idea di quanto fosse, in realtà, determinante il suo specifico apporto. RELAZIONE PRESENTATA DAL DOTT. CASUCCI AL DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI STATO ROMA, ARMANDO LODOLINI, UNA SETTIMANA DOPO AVER PRESO SERVIZIO, ROMA 17 GENNAIO 1952 (ACS, Fascicoli del personale, Casucci Costanzo) DI Oggetto: prime impressioni della vita di archivio. Rispondere alla domanda rivoltami dal Direttore dell’archivio, presso cui presto servizio, implica rispondere ad una domanda necessariamente pregiudiziale: « Per quali ragioni ho fatto il concorso di archivista di Stato? ». Soltanto quando avrò chiarito tali ragioni e un po’ lo spirito e le aspirazioni su cui ho affrontato la nuova vita sarà possibile capire il perché di certe mie reazioni alle prime esperienze dell’archivio. È stata una esigenza di studio che mi ha portato a questo concorso e mi spiego più chiaramente: ho cercato con esso un lavoro e un ambiente di lavoro consoni alle mie aspirazioni di svolgere un’attività scientifica. L’archivista non è un impiego come un altro, ma un impiego che comporta un’attività scientifica, che consiste, direi meglio, in un’attività scientifica. E qui posso subito dire quale è stata, su questa base, la mia prima reazione. Nella promessa solenne mi sono impegnato moralmente alla scrupolosa osservanza del segreto di ufficio: il compito dell’archivista non è esclusivamente scientifico come può essere quello del docente universitario; esso svolge un’attività scientifica, mentre il restante 252 Paola Carucci Claudio Pavone personale statale svolge un’attività prevalentemente pratica, ma come tutto il personale statale esso ha dei precisi compiti pubblici. Se pure svolge un’attività scientifica l’archivista è anzitutto un funzionario: il custode dei documenti dello Stato. Nell’archivista dunque sono necessarii questi due elementi: una esigenza scientifica e una salda coscienza della sua qualità di funzionario: ciò spiega perché si è creato un corpo specializzato nell’ambito dell’apparato statale e lo si è vincolato con il giuramento. Ma mentre l’esigenza scientifica non può sorgere che individualmente, dall’intimo della propria personale vocazione, la coscienza della posizione di funzionario non può sorgere che come risultato di una educazione che solo la concreta vita nell’archivio può dare: donde l’importanza della tradizione, del tramandarsi di una profonda consapevolezza delle proprie funzioni e della loro peculiarità dai vecchi ai giovani. Detto questo ci sarà più facile affrontare un delicato problema che subito i vecchi hanno, in un certo senso, posto a noi giovani: l’esodo di molti giovani dalla carriera dell’archivio che rischia appunto di spezzare o, quanto meno, di indebolire la tradizione. Questo, per quel che credo di capire, è avvenuto per due motivi: i giovani o hanno intrapreso carriere più redditizie e brillanti oppure una carriera puramente scientifica. Nel primo caso si tratta semplicemente della mancanza di quella esigenza scientifica che abbiamo detto essere premessa indispensabile dell’archivista; nel secondo invece si tratta di cosa più semplice. In genere a me pare si tratti di una deficiente comprensione della funzione dell’archivista, del carattere pregiudiziale per tutta una serie di attività che ha l’ordinamento degli Archivi sia nei settori di interesse storico-culturale sia in quelli di interesse giuridico e amministrativo. La funzione dell’archivista riveste un’importanza scientifica e pratica niente affatto secondaria rispetto ad attività presunte più nobili: l’ordinamento dei documenti è per la scienza storica così importante come l’utilizzazione che di essi faranno i singoli storiografi, la custodia di documenti aventi valore giuridico in atto è per la società così importante come la tutela concreta dei diritti che essi comprovano. Ad un ultimo problema desidero accennare: visitando le sezioni di archivio di S. Michele e di Campo Marzio ho potuto constatare come i fondi più importanti dei singoli Ministeri non fossero versati all’Archivio centrale dello Stato. Mi sembra che tale prassi non sia lodevole: tranne i più recenti, aventi ancora una immediata importanza politica, i documenti dello Stato debbono essere tutti affidati al personale all’uopo specializzato, che accanto alla garanzia della più scrupolosa segretezza offre la specifica preparazione che sola permette un ordinamento organico completo di essi. CLAUDIO PAVONE Ho scelto di parlare dei contributi che negli ultimi anni della sua vita Casucci ha dato ai temi del fascismo, dell’antifascismo, della Resistenza, del revisionismo, i quali costituiscono il punto di arrivo di un percorso che illustrano Sabbatucci e Talamo. Ma anche io, come ha particolarmente sottolineato Carucci, non riesco a sottrarmi alla emozione del ricordo personale. Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 253 Fra tutti i presenti sono sicuramente il primo che conobbe Costanzo. Lo incontrai nel Seminario di studi storici « Giaime Pintor » che, nell’immediato dopoguerra, raccoglieva giovani più o meno avviati a tali studi, nel senso che non tutti provenivano da regolari corsi di storia e non tutti si accingevano a seguire la carriera universitaria, ma tutti erano attratti dalla storia in virtù della schietta passione etico-politica che li animava. Il Seminario aveva come padre spirituale Gastone Manacorda e si riuniva in una sala di via Santo Stefano del Cacco dove oggi ha sede il teatro Flaiano. Ci ritrovammo poi nell’Archivio di Stato di Roma che allora conviveva nel palazzo della Sapienza con l’Archivio centrale, come da poco era stato ribattezzato l’Archivio del Regno. Costanzo archivista è stato ricordato da Paola Carucci. Io vorrei sottolineare che egli diede subito una forte impronta morale al suo lavoro in Archivio, nel quale sapeva far convivere il rigore scientifico con la serietà del funzionario dello Stato. Il lavoro archivistico, sia quello dedicato a ordinamenti e inventariazioni, sia quello volto al servizio degli studiosi, lo attraeva più che lo scrivere saggi di dottrina. La larga presenza qui di colleghi, di amici, di studiosi, di estimatori è indice del rispetto e della stima che egli faceva nascere anche in chi lo avvicinava per motivi professionali. Eppure, accademicamente e politicamente Costanzo era un isolato. « Democratico coraggioso e anticonformista » lo ha chiamato Tranfaglia nel bel necrologio dedicatogli su « l’Unità » del 14 gennaio 1997, cui ha dato l’appropriato titolo di Quella dedizione a Rosselli. Sia da destra che da sinistra Costanzo fu guardato spesso con qualche sospetto teorico-politico, ma della assoluta integrità della sua persona e della sua ferma volontà di verità nessuno ha potuto mai dubitare. Certo, Costanzo poteva nel parlare, non nello scrivere, essere enfatico fino a sfiorare talvolta la retorica. Ma in lui l’enfasi era un’arma per sfuggire all’isolamento e alla timidezza. Probabilmente pensava che quanto più la sua enfasi fosse stata sopra le righe, tanto più sarebbe stato evidente l’intento autoironico. Ma non tutti lo capivano. Costanzo appariva un estroverso, perfino rumoroso. Ma era incrollabile nel difendere l’assioma che il privato è sacro. Le sue confidenze personali erano perciò rare e contenute, come se egli avesse paura che potessero condurre fuori dalla strada delle grandi dispute di principio che erano la sua passione dominante. Soltanto nella intervista concessa negli ultimi tempi a Ermanno Taviani per il CD-rom sulla Resistenza, curato da un gruppo di giovani studiosi facenti capo all’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza ed edito da Laterza, si lasciò andare a parlare della prigionia anche in termini soggettivi. Asciutto e sobrio è comunque il suo racconto della marcia attraverso la Turchia, dove era fortunosamente riuscito a fuggire da Rodi, della consegna agli inglesi, della prigionia in Egitto. Un altro carattere personale di Costanzo, sotteso anche al suo lavoro di archivista e di studioso, era la sua religiosità, che lo spingeva a cercare 254 Paola Carucci Claudio Pavone sempre coerenza fra convinzioni e comportamenti. Vorrei fare un paragone un po’ azzardato. In una pagina dei suoi diari Ciano racconta che Mussolini avrebbe dato di se stesso la definizione di cattolico non cristiano. Per Casucci la indovinata formula può ribaltarsi: Costanzo era un cristiano non cattolico, e laico. Prendere posizione in nome della verità era per lui un dovere. Per questo riteneva indispensabile compromettersi con i suoi giudizi, una volta compiuti con il dovuto scrupolo gli accertamenti filologici. Egli citava volentieri il saggio di Croce che chiamava quella del dottissimo Ranke una « storiografia senza problemi ». Ma vengo al tema specifico del mio intervento. Partirei dal saggio Il trauma dell’8 settembre e il problema dell’identità nazionale pubblicato nel 1994 su « il Mulino », che va ricollegato a due scritti precedenti: Una cultura sconfitta (in Il fascismo e gli storici oggi, a cura di J. Jacobelli, Roma-Bari, Laterza, 1988) e Il significato dell’antifascismo oggi, comparso anch’esso su « il Mulino » nel 1989. La versione originale del saggio del 1994 cominciava nel modo seguente: « Da tempo si sta affermando nel nostro paese una storiografia che ben può definirsi disfattista, nel senso proprio del termine in quanto disfa, vanifica il patrimonio ideale della nazione: vengono così espulsi dalla nostra storia l’antifascismo prima, la Resistenza dopo, infine la stessa identità nazionale. Di tale atteggiamento De Felice può essere considerato l’esponente più significativo; il percorso logico del suo pensiero parte dalla svalutazione dell’antifascismo, trascorre alla interpretazione riduttiva del movimento resistenziale, per concludere con l’affermazione della disintegrazione della identità nazionale ». La redazione della rivista non accettò questo testo e propose alcune modifiche. Costanzo tenne il punto, accettando solo quelle di forma. Su « il Mulino » fu tuttavia pubblicato un testo dal quale erano scomparse le parole che vanno da « che ben può definirsi disfattista » a « in quanto disfa ». Nella lettera di protesta inviata alla rivista il 27 luglio Costanzo aveva posto una distinzione che riteneva fondamentale: « la storiografia revisionista è un fatto positivo, quella disfattista invece un fatto negativo ». E proseguiva rivendicando che la storiografia revisionista era stata « in realtà iniziata da Casucci sulle pagine del “Mulino” » con il saggio del 1960 Fascismo e storia dove veniva formulata la parola d’ordine davvero innovativa « “farsi fascisti coi fascisti”, capire il fascismo dall’interno ». Questa affermazione, che gli costò molte critiche da parte antifascista, era in quella lettera sostenuta da una chiara e netta presa di posizione: « Si deve combattere, come Casucci ha fatto, ogni degenerazione settaria dell’antifascismo, ma non si può deflettere da una posizione di intransigenza di principi come ho bene espresso nel titolo dell’introduzione alla seconda edizione dell’antologia, Il fascismo caso di coscienza della nazione ». Quanto gli fosse costata la mutilazione imposta al suo testo dalla rivista è confermato dal fatto che nella nota introduttiva ai documenti pubblicati da « Il Ponte » (aprile 1997), Italia prigioniera, dove è riprodotta con alcuni Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 255 tagli anche la intervista a Ermanno Taviani, egli riproponesse le parole sul disfattismo che erano state censurate. L’uso della parola « disfattista » è la spia linguistica di un tema per Costanzo essenziale, quello dell’interventismo democratico. Egli lo trattava sempre con grande passione: ricordo le accanite dispute nelle quali non eravamo su questo punto d’accordo, pur consentendo entrambi nella disgustata repulsa dell’apologia dell’arditismo fatta, ad esempio, da Bottai che ne aveva parlato come di qualcosa che aveva rotto « il grigiore della guerra umanitaria ». In una pubblica discussione Jens Petersen disse una volta: « voi italiani quando parlate dell’intervento del 1915 sembra che dobbiate decidere se intervenire o no il giorno successivo ». Il fascismo, questo era il pensiero di Costanzo, aveva malamente dissipato la possibilità che l’Italia avrebbe avuto di svolgere un ruolo autonomo di pace e di democrazia nella politica internazionale postbellica, che era appunto l’obiettivo finale dell’interventismo democratico. Costanzo prendeva le mosse da lontano. Il Risorgimento aveva a suo avviso dimostrato la possibilità della sintesi fra nazionalità e libertà. Egli si poneva in questo modo sulla linea della grande storiografia liberale e non mancava di appellarsi all’autorità di Rosario Romeo che, nella Enciclopedia del Novecento edita dall’Istituto della Enciclopedia italiana, alla voce Nazione aveva scritto avere la Resistenza consentito in qualche misura all’Italia di ricollegarsi al passato risorgimentale. L’interpretazione che Costanzo dava di questa tradizione era nettamente democratica. Di qui nasceva la natura del suo antifascismo, la sua dedizione a Rosselli, il suo rispetto per Parri: insomma per tutto ciò che, sfociato nell’azionismo, era ed è particolarmente inviso ai « disfattisti ». Sinceramente sconsolata era la conclusione di Costanzo: « Ci duole che la storiografia revisionista, con cui abbiamo percorso un non breve tratto in comune e a cui tanto debbono gli studi sul fascismo, per la sollecitazione di contingenti preoccupazioni politiche lo stia invece disattendendo », disattendendo cioè 1’unione di analisi critica e intransigenza nei principi (è il finale di Il significato dell’antifascismo oggi). È chiaro dunque perché Costanzo fosse nemico della formula « morte della patria » messa in circolazione da Galli della Loggia. Si trattava per lui, molto più che di una operazione storiografica di una operazione politica, lecita naturalmente sul proprio terreno. Il vero obiettivo politico — egli chiariva — era in realtà il comunismo; ma la trasposizione in campo storiografico della polemica anticomunista inquinava l’intero antifascismo, identificato arbitrariamente con il comunismo. La paradossale conseguenza era che la intera eredità dell’antifascismo veniva lasciata così ai comunisti; e in tal modo la tradizionale accusa mossa loro di voler monopolizzare l’antifascismo e la Resistenza veniva capovolta riconoscendone ad essi l’esclusiva rappresentanza. Costanzo risale a monte dell’8 settembre e ricorda senza infingimenti il suo desiderio che l’Italia fascista venisse sconfitta nella guerra condotta 256 Paola Carucci Claudio Pavone a fianco della Germania nazionalsocialista. « Io — dice nell’intervista a Taviani — ero contro il fascismo, non contro la guerra; ma per la vittoria degli Alleati ». Nel saggio sull’8 settembre spiega che la guerra « avrebbe comportato, anche se vittoriosa, la perdita dell’identità nazionale perchè l’Italia sarebbe stata ridotta comunque a satellite della Germania ». L’8 settembre perciò « il senso della patria non è definitivamente perduto, ma comincia a essere ritrovato nel dolore » (« Il Ponte », Italia prigioniera): mi sembrano queste fra le parole più alte scritte su quel drammatico nodo della storia del nostro paese. Costanzo anticipa l’attenzione che solo ora comincia ad essere prestata con la dovuta ampiezza ai prigionieri italiani disseminati in quattro continenti e trattenuti da mani tanto diverse. Egli qualifica come resistenti in senso forte la grande maggioranza degli internati militari in Germania che si rifiutarono di aderire alla Repubblica sociale. Originale fu la sua posizione di prigioniero degli inglesi in Egitto. Egli, che nel 1940 aveva fatto parte della cellula comunista studentesca romana, non aderì al governo Badoglio, rinunciando così a tutti i benefici che ne sarebbero per lui derivati. Preferì rimanere prigioniero insieme ai fascisti che, in quanto tali, non avevano aderito. Fu spinto a questa decisione perché voleva capire davvero i fascisti, precorrendo con questa scelta esistenziale quello che sarà il movente di fondo del suo invito di studioso a farsi fascisti con i fascisti. Gli inglesi resero questo suo proposito meglio attuabile perché, non senza perfidia, rinchiusero nello stesso campo fascisti e comunisti. Costanzo faceva in quel campo pubblica lettura della Divina Commedia e di altri testi classici, cercava di mettere pace quando scoppiavano risse, una volta disarmò due calabresi che con armi di legno si esercitavano alla lotta al coltello (si trattava di due criminali comuni che, con supplemento di perfidia, gli inglesi avevano unito ai fascisti e ai comunisti). Costanzo era addolorato, più ancora che irritato, quando sentiva dire, con il tono che si usa quando coraggiosamente si enunciano sconvolgenti novità, che la seconda guerra mondiale era stata vinta non dai partigiani ma dagli eserciti alleati (compreso, anche se egli lamentava che raramente venisse nominato, quello sovietico). Vedeva, in questa proposizione applicata all’Italia, il risorgere della vecchia rovinosa formula italiana di fronte ai grandi bivi: chi ve lo ha fatto (chi ve lo fa) fare? Non avrebbe mai ammesso che coloro che avevano compiuto la difficile scelta resistenziale, intesa nel senso più ampio, fossero degli sprovveduti che non si erano resi conto che la patria era ormai morta. Anche in questo caso Rosselli gli veniva in aiuto. Citava un passo del 1936 degli Scritti dell’esilio da lui stesso curati (vol. II, p. 231): « Un popolo italiano che venga liberato dal fascismo e dalla guerra non per iniziativa propria ma per iniziativa esclusivamente altrui, o che sulla iniziativa altrui non innesti un grande atto, un grande fatto proprio, di storico riscatto ed emancipazione, è un popolo destinato a rimanere stremato, vassallo ». Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 257 Il passo è citato anche in Il trauma dell’8 settembre. Nello stesso saggio Costanzo chiariva: « Non tutto l’antifascismo accettava il principio di libertà, come ha giustamente rilevato la storiografia revisionista. Che però ha ignorato un dato essenziale: se l’antifascismo non era condizione sufficiente, era però condizione necessaria per la creazione di un regime liberaldemocratico ». Che la riconquista della libertà fosse legata alla sconfitta era per Costanzo un dato incontrovertibile; e si poteva forse scorgere in lui il timore che, dopo il mito nazionalista della vittoria mutilata, nascesse per la seconda guerra un opposto mito antifascista della sconfitta mutilata, se quella non avesse avuti i suoi positivi esiti resistenziali. La Resistenza aveva per di più permesso all’Italia postbellica — e anche questo era un tema a lui caro — di non essere affetta dalla sindrome di Weimar, contribuendo così ad evitare la nascita di qualsiasi forma di revanscismo. La « serietà della storia d’Italia » è una espressione cara a Costanzo, da lui ripetuta in molteplici occasioni. Essa ci permette di cogliere l’ispirazione etico-politica di fondo che guida la intera sua ricerca. Costanzo, sempre in Il trauma dell’8 settembre, la ribadisce a proposito della esecuzione di Mussolini, che rientrava nelle direttive del CLNAI, ma sulla quale ancora si discute: « La conclusione della vita di Mussolini — scrive, nobilitandone così il significato — è una conferma della serietà della storia d’Italia, del suo carattere tragico che sta al di sotto degli opportunismi e dei compromessi di superficie ». GIOVANNI SABBATUCCI (Università degli studi di Roma « La Sapienza ») Chiunque abbia conosciuto Costanzo Casucci sa bene che per lui il fascismo era innanzitutto un « problema di coscienza ». Un problema di coscienza degli italiani, ma anche suo personale: e non perché lui, cresciuto nel Ventennio, avesse avuto col fascismo frequentazioni particolarmente intense (al contrario il suo approdo all’antifascismo fu piuttosto precoce), ma perché aveva la tendenza a farsi personalmente carico dei problemi collettivi. E il fascismo — su questo insisté sempre — era un problema di tutti gli italiani. Nell’introduzione alla seconda edizione della sua antologia (Il fascismo. Antologia di scritti critici, Bologna, Il Mulino, 1982), Casucci ricorda le due esperienze che lo hanno in qualche modo costretto a occuparsi del problema: la giovanile militanza in un gruppo antifascista e, soprattutto (e quasi simmetricamente), la prigionia, vissuta a contatto con la « gente comune » che dal fascismo non era uscita come ne era uscito lui. Si può osservare che altri avevano vissuto esperienze analoghe alle sue, con esiti completamente diversi (spesso nel senso della rimozione). Ma per lui la tensione etica si traduceva da un lato in un’ansia di sincerità che gli impediva di accettare le verità di 258 Paola Carucci Giovanni Sabbatucci comodo, dall’altro (a volte contraddittoriamente) nella continua ricerca di una sintesi coerente che facesse comunque tornare i conti a un livello superiore di conoscenza e di consapevolezza del problema. Al problema del fascismo Casucci dedicò, oltre a interventi minori, due saggi, nel ’54 e nel ’60, entrambi accolti nella prima versione della sua antologia (Bologna, Il Mulino, 1961). Il primo — scritto in occasione di un dibattito su « Terza generazione » — parla in realtà più dell’antifascismo che del fascismo (si intitolava Valori umani dell’antifascismo). Ci sono argomenti discutibili (la retrodatazione dell’antifascismo di massa) e spunti interessanti (una definizione della Resistenza che allarga il concetto fino a comprendervi i contadini, le « povere vittime anonime » e persino il papa, anticipando per molti aspetti certe tesi dell’ultimo Scoppola). Ma c’è soprattutto, nel collegamento dell’antifascismo alla tradizione della nazione democratica, l’indicazione di quella linea di continuità fra Risorgimento e Resistenza attraverso l’interventismo democratico che rappresenta un motivo ricorrente di tutti gli scritti di Casucci. L’idea della continuità fra tradizione risorgimentale e Italia repubblicana potrebbe, quasi automaticamente, portare a un’interpretazione parentetica del fascismo. Ma è proprio questa interpretazione che Casucci non può e non vuole accettare, perché sa, per esperienza, che non è vera. Questo è il nodo che affronta nel saggio del ’60 (Fascismo e storia), pubblicato su « Il Mulino »: il più organico e argomentato dei suoi interventi in tema di fascismo. Il saggio parte proprio da una confutazione sia della teoria della parentesi, sia di quella, opposta e simmetrica, della « rivelazione » (per inciso, Casucci fu, credo, il primo a chiamarla così, riprendendo un’espressione di Fortunato). Dove, fra l’altro, si osserva intelligentemente che l’una e l’altra conducono a una sorta di vanificazione dell’oggetto della ricerca: se il fascismo è parentesi, è un punto oscuro da rimuovere, se è rivelazione di quanto già c’era, allora semplicemente non esiste come realtà autonoma; e parlare di fascismo o di nazismo significa in realtà parlare dell’Italia liberale o della Germania guglielmina. È questa, fra l’altro, la ragione per cui la tesi della « rivelazione » non è esemplificata nell’antologia di De Felice, Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici (se ne veda l’ultima edizione, Roma-Bari, Laterza, 1999). Invece Casucci insiste proprio sull’autonomia e sulla reale consistenza del fenomeno. E lo fa con accenti che potevano suonare addirittura scandalosi ed erano certamente coraggiosi, in un momento in cui la riscoperta dell’antifascismo avveniva in forme spesso propagandistiche e ritualistiche e, di converso, la rappresentazione del fascismo tendeva a fissarsi in immagini stereotipe, sempre in bilico tra il demoniaco e il caricaturale. È notevole che, nel 1960, un antifascista invitasse gli storici del fascismo a recuperare quel tanto di identificazione con l’oggetto della propria indagine che è « condizione prima per fare storia » (e dunque a « farsi fascisti con i fascisti »). E ancor più che polemizzasse energicamente contro il Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 259 tentativo di espellere il fascismo dalla storia nazionale, con parole che mi sentirei di sottoscrivere in toto: Per una sorta di metafisica negazione, noi antifascisti vorremmo quasi che i fascisti siano fascisti e nient’altro, come gli « uomini e no » di Vittorini, che gli italiani divenuti fascisti quasi cessino di essere italiani, per cui l’Italia del ventennio si riduce ad un pugno di eroi che seppero testimoniare. Invece no! Fu l’Italia, furono gli italiani che divennero ad un certo momento fascisti senza mai cessare di essere italiani, per poi diventare o tornare a diventare democratici: compito della storiografia è l’analisi di questo processo in tutta la sua interezza, senza hiatus, senza « parentesi », non separando mai le componenti di esso, ma distinguendole e riportandole costantemente all’unità della storia (p. 430 dell’Antologia del 1961). Restava a questo punto aperto il problema di come inserire un fenomeno negativo come il fascismo all’interno della storia d’Italia: una storia, che per Casucci era seria, spesso tragica, come quella di un paese « costretto a vivere al limite delle sue possibilità » (così nell’introduzione alla seconda edizione dell’Antologia), ma anche una storia piena di momenti alti e da leggersi complessivamente in positivo (in questo si differenziava profondamente dall’« anti-italianismo » di matrice radical-gobettiana). Per uscire dalla contraddizione, Casucci riprende — e arricchisce di notazioni personali — un tema tipico dell’autocritica democratico-socialista sull’avvento del fascismo. Il fascismo vince perché si appropria di valori e di sentimenti collettivi che la classe dirigente ha colpevolmente trascurato e che il movimento operaio ha addirittura rinnegato: il patriottismo in primo luogo, ma anche l’aspirazione all’eroismo, l’etica del sacrificio e anche, ove necessario, dell’obbedienza (significativa, in proposito, la citazione di un articolo di Bottai del ’24 — inserito nella seconda Antologia alle pp. 239-250 — dove si parla di « ansia di obbedire » ), dell’annullamento di sé. Nella Resistenza Casucci vede il recupero di questi valori da parte di minoranze « eroiche » (in questo si colloca appieno entro una tradizione gobettiana e « azionista », da cui invece si distacca, come si è visto, nel giudizio generale sulla storia d’Italia). E questi valori, in senso lato « patriottici », non devono essere trascurati dall’Italia repubblicana (come lo furono dall’Italia liberale), pena nientemeno che il ritorno del pericolo fascista. « Il paese ha bisogno di eroismo »: questa la formula coraggiosamente inattuale con cui Casucci conclude la sua introduzione all’Antologia del 1982. Su queste conclusioni non sono mai stato d’accordo con Costanzo. Penso infatti che il destino di un paese non può affidarsi alle minoranze eroiche se non in momenti eccezionali e che il vero problema per l’Italia è quello di vivere una vita dignitosa in tempi normali e grazie all’opera di normali maggioranze regolarmente elette. Credo inoltre che il tentativo di ricostruire e valorizzare un filo « positivo » della storia nazionale comporti eccessive forzature in una realtà dove bene e male si intrecciano troppo strettamente 260 Paola Carucci Giovanni Sabbatucci per essere separati a posteriori. Ne abbiamo discusso tante volte con Costanzo: anche pubblicamente, in particolare a proposito dell’interventismo democratico, tema a lui molto caro (per lui era uno dei momenti alti della storia nazionale, per me un episodio di grave confusione e di delegittimazione del Parlamento). Il mio dissenso dalla sua linea interpretativa e anche da certi suoi valori di riferimento non mi ha mai impedito però di riconoscere la nobiltà di quei valori e la coerenza di quella linea: e soprattutto di ammirare l’onestà intellettuale di chi la sosteneva in un continuo confronto con le opinioni diverse dalle sue. La testimonianza di questa disponibilità al confronto, ma anche il contributo più importante di Casucci al dibattito sul fascismo, è la più volte citata Antologia di scritti critici del ’61, poi riedita con sostanziosi accrescimenti nell’82 (ma forse sarebbe più corretto parlare di due antologie, visto che la seconda ha uno sviluppo quasi doppio rispetto alla prima). Sull’importanza e sul significato innovativo di quell’antologia, che in pratica apriva una nuova stagione di studi e di dibattito sul fascismo in Italia, nel panorama della letteratura quale si presentava attorno al 1960, credo sia superfluo insistere. Basti ricordare che, essendo l’Antologia divisa in due parti — Le interpretazioni tradizionali e La ricerca del periodo post-fascista —, la seconda parte sviluppava circa la metà della prima, e non certo per colpa del curatore. Il quale, per parte sua, faceva una scelta molto soggettiva, seguendo soprattutto il filo della sua personale ricerca: non troviamo in questa seconda parte le poche opere storiche disponibili (Chabod, Salvatorelli-Mira, Alatri, Valeri), ma troviamo soprattutto interventi tratti da riviste non di primissima fila (« Il dibattito politico », « Terza generazione », « Ordine civile » …) dove il problema veniva affrontato nei termini che più stavano a cuore al curatore. Da notare la presenza (con due articoli) di Augusto Del Noce, che, in quanto studioso del fascismo (e critico dell’antifascismo), fu un po’ una scoperta di Casucci. Della prima parte c’è da dire che sia la partizione (fascisti, cattolici oppositori, cattolici fiancheggiatori, liberali, radicali, socialisti, comunisti), sia la scelta dei testi (con una sola lacuna per me imperdonabile: Tasca) sono frutto di una ricerca molto intelligente e approfondita e anticipano in parte la sistemazione che De Felice darà una decina di anni dopo nelle Interpretazioni del fascismo: in particolare per quanto riguarda le « interpretazioni classiche », in qualche misura già esemplificate nell’Antologia e discusse nel già citato saggio del ’60. Nei vent’anni che passano fra la prima e la seconda edizione dell’Antologia, la storiografia sul fascismo fa un salto gigantesco, legato soprattutto all’opera di De Felice. E non credo sia esagerato affermare che una parte del merito di questo salto spetti anche a Casucci, sia in quanto archivista (in questo senso rinvio a quanto detto da Paola Carucci), sia in quanto autore dell’Antologia. Comunque, quando decide di rimettere le mani sul suo lavoro, Casucci ha un doppio problema. Tenere conto di tutto il materiale Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 261 critico uscito nel frattempo, e anche di quello — soprattutto fascista — riportato in luce dalle ricerche recenti. E prendere posizione nel dibattito sviluppatosi negli anni Sessanta e Settanta. Per quanto riguarda il primo punto, c’è da notare che lo sviluppo dell’Antologia avviene non solo per aggiunte, ma anche attraverso una struttura assai più articolata: per esempio, i fascisti vengono divisi in ben undici sottocategorie (segno di un’attenzione sempre vigile e di una capacità analitica molto affinata, grazie, come Casucci riconosce, soprattutto agli studi di De Felice), i comunisti in tre, i liberali in fiancheggiatori e oppositori. C’è l’interpretazione degli anarchici (rappresentati da uno scritto di Luigi Fabbri) che prima mancava; e c’è una sezione sulle interpretazioni « al di fuori dal sistema politico », che comprende un brano di Prezzolini e uno di Gustavo Vinay, scelti rispettivamente come rappresentanti dei « cinici » e degli « uomini di scrupolo » (categoria quest’ultima tipicamente casucciana, nella quale penso lui stesso si annoverasse). La seconda parte (quella dedicata al « periodo post-fascista ») resta pressoché inalterata, con due esclusioni di cui il curatore dà conto nell’introduzione: i brani di Giuliano Scolastici (Franco Rodano) e di Lucio Magri, entrambi considerati troppo datati, il primo per l’eccessiva rigidezza delle sue categorie classiste e per il giudizio troppo liquidatorio sul ceto medio, il secondo perché assimila tout-court il franchismo al fascismo (assimilazione errata secondo Casucci). Del tutto nuova è la terza parte, dove Casucci accoglie le novità dell’ultimo ventennio, introducendo una serie di nuove categorie (a volte discutibili: stupisce, per esempio trovare i « neo-fascisti » accanto agli « storici » e ai « sociologi », o gli « ideologi » intesi come studiosi delle ideologie, o i « contestatori » rappresentati da Guido Quazza, che probabilmente non gradì questa etichetta). Categorie a parte, Casucci inserisce in questa sezione alcune scelte, per così dire, obbligate, a cominciare da De Felice; alcune « scoperte » di De Felice (per esempio Gino Germani), anche su suggerimento di De Felice stesso (i rapporti fra i due erano ancora piuttosto stretti, si sarebbero allentati negli ultimi anni); e alcuni autori da lui particolarmente apprezzati già presenti in altre sezioni: per esempio Ludovico Incisa e ancora Del Noce. Da notare l’inclusione (un’altra prova di coraggioso anticonformismo), in rappresentanza dell’interpretazione « neo-fascista », di un paio di articoli di Adriano Romualdi, che era un giovane di notevole intelligenza, ma era anche un fascista duro, un personaggio dalle frequentazioni imbarazzanti. Ma, come dicevo, l’esigenza più sentita in questo momento è per Casucci quella di prendere posizione (un dovere a cui mai si sottrasse). Cosa che fa nell’Introduzione: un’altra novità rispetto all’edizione precedente, dove c’era solo una breve premessa. È questo il più lungo dei suoi scritti sul fascismo (e probabilmente di tutti i suoi scritti), anche se non il più organico perché in buona parte occupato dalla presentazione dei testi antologizzati (ma anche dalla discussione di autori non inclusi nell’antologia, da Fromm a 262 Paola Carucci Giovanni Sabbatucci Monnerot a Mosse). In quest’introduzione ci sono comunque molte cose interessanti. Alcune le ho già citate. Per quanto riguarda il dibattito sulle tesi di De Felice, la posizione è chiara, anche se articolata. Di De Felice Casucci accetta nella sostanza il discorso sul consenso. E accetta anche la distinzione tra « fascismo regime » e « fascismo movimento », anche se ritiene il primo più importante del secondo (proprio ai fini della raccolta del consenso). Ma rifiuta alcune implicazioni della ricerca defeliciana, come si evince bene da una frase: La polemica è stata progressivamente alimentata dal duplice errore della storiografia revisionista non sufficientemente consapevole della contraddittorietà della tesi che sosteneva ad un tempo la profondità del consenso al fascismo e l’inattualità di ogni residuo atteggiamento antifascista e della storiografia a quella aprioristicamente avversa che, pur di opporsi ad ogni ripensamento dei termini del problema del fascismo, si è arroccata su di una seconda linea di difesa dove l’esistenza del consenso non veniva negata, ma se ne trasvalutava il significato (p. 68 dell’Antologia del 1982). Insomma, gli ortodossi cercano di negare il problema, o di minimizzarlo (qui Casucci dice parole definitive circa la vanità della tesi che fa riferimento alla non autenticità del consenso ai regimi fascisti: « Il vero problema storico — afferma — comincia proprio a partire dal consenso autentico »). I revisionisti (per inciso: li chiamava già così nel 1981) individuano il problema ma non ne traggono le giuste conseguenze. In altri termini, ciò che Casucci rimproverava ai revisionisti non erano tanto i singoli giudizi e le singole diagnosi (sulle quali spesso concordava), quanto la caduta di tensione etico-politica che per lui quell’approccio comportava e che per giunta, a suo parere, era in contraddizione con i risultati della loro ricerca. Insomma, se De Felice dimostrava con i suoi studi che il fascismo era stato un fenomeno serio e profondamente radicato nella storia italiana, come poteva poi sostenere che quel fenomeno si era concluso irrevocabilmente col 1945 e che dunque l’antifascismo tradizionalmente inteso non serviva più? Anche su questa argomentazione non ero e non sono d’accordo: il fascismo poteva essere un pericolo mortale negli anni Venti e Trenta e non esserlo più cinquant’anni dopo. Più in generale credo che il compito dello storico sia più modesto di quello che Casucci gli assegnava, che sia in sostanza quello di raccontare e di spiegare « come le cose sono effettivamente andate ». Ma so bene che questo a Costanzo non bastava. Per lui il problema era un altro: recuperare innanzitutto il filo di una tradizione patriottica e democratica in cui il paese potesse riconoscersi senza aver vergogna di sé. Il problema era, come ho detto, far tornare i conti a un livello più alto di quello di una corretta ricostruzione del passato. Ciò che va detto, a suo onore, è che, per far tornare i suoi conti, non cercò mai di confondere le carte né di nascondersi la realtà. Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 263 GIUSEPPE TALAMO (Istituto per la storia del Risorgimento italiano) Devo dire che sono particolarmente grato a Paola Carucci e agli organizzatori di questa giornata dedicata a Costanzo Casucci, per avermi dato la possibilità di ricordarlo, insieme ai suoi amici e colleghi, e quindi anche di riandare ad anni lontani, che ci sembrano a volte ancora più distanti, proprio per la progressiva scomparsa di amici con i quali si è fatto un lungo percorso. Prima di parlare dello studioso di Carlo Rosselli, in particolare dei due volumi di Scritti dall’esilio, curati da Casucci, nel 1988 il primo (19291934), e quattro anni dopo il secondo (1934-1937), mi consentirete di indulgere ad un momento rievocativo dei nostri incontri e delle nostre frequentazioni. D’altronde sappiamo bene che a una certa età, quando il ricordo tende a prevalere sulla fase progettuale, non è facile resistere alla tentazione autobiografica. Gli studiosi della mia generazione, che per le loro ricerche frequentavano l’Archivio di Stato di Roma alla « Sapienza », e a partire dal 1960 l’Archivio centrale dello Stato, nella nuova sede dell’Eur, venivano a contatto con l’Istituto assai spesso proprio tramite Costanzo Casucci, sempre disponibile e informato, cortese ed estroverso. Paola Carucci e Claudio Pavone hanno certamente avuto con Casucci rapporti molto stretti di colleganza e di consuetudine di lavoro e sono quindi in grado di offrirci un efficace e vivo ricordo dell’archivista. Io vorrei invece ricordare quello che lo studioso coglieva quasi subito in quel funzionario con il quale si stabiliva un rapporto di intenso scambio intellettuale, spesso di confronto, più spesso, forse, di polemica. Ciò che mi colpì subito, e che ricordo bene a distanza di vari decenni, fu l’impegno, la convinzione, direi anzi l’orgoglio, usando lo stesso termine che ha usato Paola Carucci, che aveva Casucci di essere archivista, e che era reso possibile dalla sua grande capacità di cogliere, di enfatizzare a volte, la valenza culturale del mestiere che faceva. In modo simile Casucci ricordava il breve ma significativo periodo del suo insegnamento al Liceo « Visconti ». Docente ed archivista, queste a mio giudizio rimasero le sue professioni ideali, le più lontane dalla routine burocratica, le più capaci di contatti umani, le più formative, nel senso più ampio del termine. Quando Casucci ricordava un archivista principe, un archivista eccellente, ne sceglieva uno che era anche un docente. Nello studioso, nello storico, nell’archivista come nel docente, Casucci cercava, anche se spesso la ricerca risultava infruttuosa, una carica morale ed un forte impegno etico. Era questa carica che Casucci sapeva riconoscere anche in persone di formazione del tutto diversa dalla sua, e che rendeva possibile il dialogo prima e l’amicizia poi. Questa esigenza era presente a mio giudizio alla base della personalità del Casucci studioso, nel quale trovavano spazio, anzitutto, quei momenti storici che Omodeo e, dopo di lui, Alessandro Garrone, avevano chiamato « primavere del genere 264 Paola Carucci Giuseppe Talamo umano », i momenti creativi di nuovi valori e quindi il Cristianesimo, il Comunismo, il Risorgimento, l’Antifascismo, la Resistenza. Proprio tra i partiti che avevano cercato di resistere al fascismo, anche sul piano internazionale, vi era il movimento di « Giustizia e Libertà », la cui stessa denominazione si riallacciava al Risorgimento, riprendendo un noto verso carducciano che usava appunto i termini giustizia e libertà nelle due liriche Dopo Aspromonte e Ode a Victor Hugo. Quando Casucci cominciò ad occuparsi in maniera sistematica di Rosselli, ed in genere di « Giustizia e Libertà », la prima osservazione che faceva era che nel dibattito culturale e politico svolto negli ultimi decenni sulla classe dirigente pre-fascista, l’attenzione degli studiosi e della diffusa e più autorevole editoria era stata soprattutto rivolta a Gramsci, a Sturzo e a Turati, che erano espressione delle maggiori forze politiche emerse nel secondo dopoguerra, e in parte a Piero Gobetti, teorico di una rivoluzione liberale capace di integrare nello Stato la classe operaia. Di altri, come di Carlo Rosselli, fondatore del movimento di « Giustizia e Libertà », ispirato ad una forma di socialismo liberale, titolo da lui scelto per la sua unica opera teorica, ci si era occupati di meno e più tardi. Soltanto nel 1968 era stata pubblicata dalla casa editrice Laterza una sua biografia, scritta da Nicola Tranfaglia, che dall’esperienza della guerra giungeva al processo di Savona del 1927, in una documentata analisi della sua formazione e delle sue prime esperienze politiche. Questa scarsa fortuna editoriale del maggior rappresentante di quel movimento, che diede poi vita al Partito d’azione, corrisponde alla scarsa fortuna di questa formazione politica, bersaglio costante e privilegiato di polemiche particolarmente accanite, di elevato livello culturale con Benedetto Croce, o di becere contumelie nella campagna scatenata nell’immediato dopoguerra da Guglielmo Giannini e dal Fronte dell’Uomo Qualunque. Cercare di capire le ragioni, non di quelle polemiche, perfettamente comprensibili nella loro genesi e nei loro obiettivi, ma di quella sorta di fastidio e di insofferenza nei confronti delle tesi azioniste, largamente diffusi allora, e vivi anche dopo la scomparsa dell’oggetto della polemica, può aiutarci a comprendere le caratteristiche del movimento politico e della sua ideologia, e le ragioni della mancata penetrazione nel nostro paese, come della perdurante ostilità nei suoi riguardi. Da questo punto di vista, riteneva Casucci, una migliore conoscenza di Carlo Rosselli, che era stato certamente l’esponente più rappresentativo di quel movimento, basata sui suoi scritti e sulle testimonianze della sua azione politica, era la condizione essenziale per parlare con cognizione di causa di lui e del movimento che a lui si richiamava. Acquistò veramente un grande rilievo la pubblicazione del secondo volume degli scritti dall’esilio di Carlo Rosselli, Dallo scioglimento della concentrazione antifascista alla guerra di Spagna (19341937), curato appunto da Casucci, come il precedente, Giustizia e Libertà e la concentrazione antifascista (1929-1934). Ad un rigore filologico impeccabile, cui si deve anche il ritrovamento di significativi documenti inediti, Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 265 Casucci aggiunse una densa introduzione che analizzava accuratamente il pensiero e l’azione politica di Carlo Rosselli nell’ambito della storia d’Italia dalla prima guerra mondiale all’affermarsi del regime fascista. Valutava anche contemporaneamente la presenza di Rosselli nel dibattito politico dell’epoca, da cui scaturiva una convincente interpretazione, alla quale, a mio giudizio, non nuoceva l’innegabile consonanza con il leader antifascista ucciso in Normandia nel 1937, insieme al fratello Nello, su ordine del governo di Roma, dall’organizzazione terroristica francese La Cagoule. Che cosa c’è dunque all’origine della diffusa ostilità che colpì in ugual misura il movimento di « Giustizia e Libertà », Carlo Rosselli e il Partito d’azione, un’ostilità, bisogna aggiungere, qualitativamente diversa da quella ovviamente rintracciabile in tutte le polemiche politiche? Forse la stessa principale caratteristica del movimento, la sua linea metapolitica, il costante richiamo a principi che trascendevano la consueta sfera politica. Tale richiamo ad una rigorosa coerenza e ad una ferma intransigenza, finiva per produrre negli avversari e nei movimenti concorrenti quel senso di fastidio che provoca spesso chi, al di là delle sue stesse intenzioni, si pone come severo giudice e assume quindi una posizione distaccata e sostanzialmente elitaria. Condanna dei compromessi ed intransigenza morale, in quanto divengono essi stessi programma politico, portano necessariamente ad una sorta di isolamento ed attirano gli strali polemici degli avversari più diversi. In questo senso, il richiamo a Mazzini, fatte naturalmente le debite proporzioni e tenuto conto di un contesto del tutto diverso, può essere accolto soprattutto come la costante presenza di un dover essere, che era parte integrante di ogni azione politica. E non meraviglia certo che proprio Augusto Del Noce, filosofo particolarmente attento all’incremento e al regresso del senso religioso nella società, abbia sottolineato la presenza della religiosità mazziniana nella cultura politica del Partito d’azione. Era proprio questo carattere di « Giustizia e Libertà » che era colto con particolare sensibilità da Casucci. Negli scritti politici di Carlo Rosselli, soprattutto quelli apparsi tra il 1934 ed il 1937, emergono due valori decisivi per una sua corretta collocazione politica: la libertà e la nazione. La prima non poteva essere abbassata ad un mezzo tattico o ad un obiettivo provvisorio per preparare la dittatura del proletariato, e neppure poteva coincidere con la libertà realizzata in Russia dalla Rivoluzione di ottobre. « Chi oserebbe oggi sostenere che il popolo russo è un popolo libero? » scriveva Carlo Rosselli il 14 dicembre 1934. L’altro tema, su cui Rosselli condusse una polemica assai significativa, riguardava il giudizio sul Risorgimento. Consapevole che non si trattava di un problema storiografico, ma di sapere se, ed entro quali limiti, il movimento rivoluzionario italiano potesse collegarsi al Risorgimento, o a talune correnti di esso o se si dovesse farne tabula rasa lasciandone il monopolio al fascismo, Carlo Rosselli polemizzò fermamente contro quanti rigettavano 266 Paola Carucci Giampiero Carocci insieme al Risorgimento scolastico, ufficiale, retorico, l’intero moto delle nazionalità del secolo XIX, considerato una costruzione artificiosa del pensiero. « Contro l’internazionalismo astratto dei socialisti vecchio stile » — sottolineava Casucci — « Rosselli intese e difese sempre il sentimento nazionale come realtà viva e operante, e si rese conto anche della necessità della priorità data da Mazzini e dallo stesso Cattaneo alla cacciata dell’Austria e quindi all’indipendenza nazionale, condizione per qualsiasi trasformazione sociale ». GIAMPIERO CAROCCI Chi è stato amico di Costanzo Casucci non dimentica il prorompente entusiasmo con cui era solito accompagnare tutto ciò che riguardava la sua attività intellettuale. L’entusiasmo era in parte una manifestazione di candido autocompiacimento ma era anche una forma quasi di autoironia sotto la quale egli celava una psicologia complessa, i cui irrisolti problemi teneva gelosamente nascosti a tutti e forse anche a se stesso. In realtà, sotto il rumoroso autocompiacimento, Costanzo era profondamente modesto. Amava dire di se stesso che era « di serie B » e ricordava, quasi compiaciuto, un giudizio che Garin aveva dato su di lui in anni lontani: giovane vivace e intelligente ma dall’orizzonte « un po’ provinciale ». A furia di sentirgli ripetere che era « di serie B » avevo quasi finito per crederci anch’io, pur stimandolo. Solo tardi, troppo tardi, mi sono reso conto di quanto la sua modestia fosse ingiusta, e mi resta il rimpianto di non aver fatto in tempo a dirglielo. Gli ha reso giustizia, fra gli altri, Nicola Tranfaglia, in un breve articolo apparso sull’« Unità » dopo la sua morte, ricordando « la sua libertà intellettuale, l’apertura alle interpretazioni nuove e insieme il rifiuto del revisionismo distruttore che è stato di moda negli ultimi anni ». Fin dai primi anni Cinquanta Costanzo avvertiva con pari forza una doppia esigenza: quella di un antifascismo rigoroso e quella di considerare e studiare il fascismo dal di dentro, sforzandosi di coglierne le intime ragioni. È stata questa la sua originalità, una originalità che ne fa una personalità, credo, unica nel panorama intellettuale italiano di quegli anni, quando ancora dovevano apparire le innovative ricerche sul fascismo di De Felice e di Lyttelton e quando ancora Ragionieri non aveva pubblicato le bellissime Lezioni sul fascismo di Togliatti (che però si concentravano prevalentemente su un solo aspetto del regime, quello delle organizzazioni di massa). Il rapporto fra Costanzo e De Felice merita una ulteriore osservazione. De Felice apprezzò le idee di Costanzo, di cui vide l’originalità, e Costanzo apprezzò il Mussolini di De Felice. Ma mentre in Costanzo l’esigenza di studiare il fascismo dal di dentro fu sempre unita ad un antifascismo rigoroso, quella stessa esigenza indusse De Felice ad attenuare l’antifascismo fino quasi ad annullarlo. Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 267 Certo, anche Costanzo aveva i suoi difetti. Il culto della coerenza morale, cosa in se stessa encomiabile, era però spinto in lui a un livello tale da vedere incarnata la virtù nell’uomo tutto d’un pezzo, sottovalutando quelle sfumature discordanti che, senza indebolire la coerenza di fondo, arricchiscono spesso la vita morale e che, pur presenti nel suo carattere, erano però assenti dalla sua consapevolezza e dalla sua intelligenza. C’era qualcosa di « un po’ provinciale » nel mazzinianesimo di maniera in forza del quale affermava apoditticamente che « compito di ogni nazione è di essere se stessa, di sviluppare il suo genio » nella libertà. Lo stesso si dica dell’entusiasmo con cui Costanzo esaltava oltre misura lo storicismo idealistico di ascendenza crociana; anche se gli va dato il merito che esaltare Croce negli anni Cinquanta significava andare coraggiosamente controcorrente. Scriveva nel 1954: « Nessuna cultura, in nessun paese del mondo, ha detto della nazione in generale e della propria nazione in particolare con tanta nobiltà e tanto rigore scientifico » come quella crociana. Eccessiva, infine, era la sopravvalutazione dell’importanza dell’interventismo democratico del 1914-1915. Eppure proprio l’interventismo democratico, un grande amore della sua vita intellettuale, fu anche la conclusione ideale di convinzioni maturate nel corso della sua gioventù e dalle quali doveva scaturire l’originalità cui ho sopra accennato. È probabile che anche Costanzo abbia fatto, a suo modo, il « lungo viaggio attraverso il fascismo ». Da adolescente aveva desiderato ardentemente partecipare alla guerra, che il regime al potere gli aveva insegnato a considerare l’esperienza « suprema ». Ma alla fine del Ventennio partecipava ad un gruppo clandestino di ispirazione dapprima crociana e poi cattolicocomunista. Costanzo era cattolico di formazione e tale, che io sappia, rimase a lungo anche in seguito. Qualche anno dopo l’esperienza cattolico-comunista, un’altra esperienza, di segno diverso e per vari aspetti opposto, doveva segnarlo profondamente. Nel 1944, prigioniero di guerra in mano degli inglesi avvertì in modo prepotente il senso della patria, necessario per affratellare i compagni di prigionia, divisi fra fascisti e antifascisti. Mentre gli internati militari in Germania, che non avevano aderito alla Repubblica sociale erano affratellati fra loro dall’antifascismo che aveva implicito in sé il patriottismo, per Costanzo, prigioniero degli inglesi che combattevano contro il fascismo e lo odiavano in modo particolare, la situazione era più complessa. Il patriottismo acquistava un valore autonomo rispetto all’antifascismo. Egli realizzò la sua maturazione etico-politica non attraverso il solo antifascismo ma attraverso l’antifascismo intrecciato col senso della patria che abbracciava anche i fascisti. A mio avviso sta qui la radice della sua originalità, dell’intreccio tra antifascismo rigoroso e comprensione dal di dentro del fascismo che di lì a poco lo avrebbe caratterizzato. Il suo era un antifascismo che, materiato da una forte carica umana (forse di derivazione cattolica), avvertiva l’esigenza di considerare anche i fascisti figli della stessa patria. 268 Paola Carucci Giampiero Carocci Nei primi anni Cinquanta fu molto vicino a « Terza generazione », una rivista di giovani cattolici che, allo stesso modo di Costanzo, sentivano il fascismo come l’evento centrale della nostra storia recente e che erano insoddisfatti dell’antifascismo perché lo ritenevano irretito in una faziosità preconcetta e, in quanto tale, incapace di superare completamente il fascismo. Essi chiedevano « un giudizio finalmente storico sul fascismo ». In un articolo del febbraio 1954 (Valori umani dell’antifascismo) Costanzo condivideva questo punto di vista, formulato in un articolo del dicembre precedente da Bartolo Ciccardini (Il fascismo, esame di coscienza delle generazioni); ma, contro il giudizio riduttivo di quest’ultimo, difendeva appassionatamente le ragioni dell’antifascismo, considerato la premessa indispensabile per andare oltre il fascismo. Tuttavia dissentiva dall’antifascismo ufficiale. « In effetti — scriveva nel 1960 (Fascismo e storia) — la storiografia [antifascista] sul fascismo patisce un difetto di fondo: un atteggiamento di invincibile, pregiudiziale opposizione che la porta ad una negazione tanto più assoluta quanto più frettolosa. Quasi una fuga da se stessi, una evasione angosciosa dal proprio vergognoso passato ». E ancora in quell’anno Costanzo precisava come il totalitarismo « costringa e corrompa l’uomo mediante un’azione che non muove, come comunemente si pretende, dal di fuori, bensì dal di dentro della coscienza ». Di qui, a maggior ragione, l’esigenza di studiare il fascismo dal di dentro. Nei decenni successivi agli anni Cinquanta-Sessanta (la data è imprecisata), Costanzo andò dissolvendo il cattolicesimo in una visione compiutamente laica della sua concezione etico-politica e andò radicalizzando verso sinistra il suo antifascismo. Ma già negli scritti del 1954 e del 1960 c’erano tutti gli aspetti più originali e interessanti della sua posizione intellettuale. Quasi si direbbe che il fascismo doveva essere una cosa seria per giustificare la serietà dell’antifascismo. « Il fascismo è il problema fondamentale della storia dell’Italia contemporanea, è il caso di coscienza della nazione ». Il fascismo « parte da un generoso ideale nazionale, (…) riscopre la missione dell’Italia nel mondo, (…) riesce a mobilitare la nazione come nessun altro regime è riuscito a fare ». Il fascismo aveva deformato questi ideali in un grossolana e fallimentare parodia nazionalistica. Ma era figlio, sia pur degenere, della Grande guerra, che Costanzo amava considerare la quarta guerra d’indipendenza, sottovalutandone gli aspetti imperialistici. Dunque, occorreva comprendere il fascismo e, per comprenderlo, farne la storia. Ma fare storia significa « identificarsi con l’oggetto della propria indagine, riviverne dall’interno l’intiero processo di sviluppo: nella fattispecie farsi fascisti con i fascisti ». Ciò andava fatto anche se « costa dolore ripercorrere i tempi bui, oscuri della propria storia ». Ripercorrere quei tempi mantenendo intatta l’ottica antifascista era possibile solo « restaurando il senso della patria », quel senso che aveva avuto la sua più alta espressione nell’interventismo democratico del ’14-’15 e a cui Costanzo doveva aver pensato durante la prigionia di guerra. Giornata di studio: « Costanzo Casucci archivista e storico » 269 Costanzo ha mantenuto fede a questo programma con la sua antologia di scritti sul fascismo apparsa nel 1961 e poi ripubblicata nel 1982 in una seconda edizione molto accresciuta (da questa edizione abbiamo tratto quasi tutte le nostre citazioni). L’antologia dimostra quanto vario e contraddittorio fosse il mondo ideale degli intellettuali fascisti, un mondo di cui Costanzo si sforza di mettere in evidenza le ragioni, ma senza mai dimenticarne il carattere reazionario e molto spesso mistificante. A causa della sua concezione totalmente negativa del fascismo, identificato con la dittatura e la repressione, l’antifascismo, nel giudizio di Costanzo, aveva per reazione un aspetto di « permissivismo » che dopo il ’68 andò ulteriormente accentuandosi nell’estremismo extraparlamentare. Contro il « permissivismo », dal quale dissentiva totalmente, Costanzo auspicava un antifascismo « caratterizzato da un intransigente moralismo », fatto di senso del dovere e di eroismo. È un atteggiamento che aiuta a comprendere la sua ammirazione per Del Noce, per il filosofo cattolico che aveva individuato il male della civiltà moderna nell’ateismo, i cui figli sarebbero il permissivismo e il nichilismo. La presa di posizione del PCI dopo il ’68 contro ogni estremismo settario, dal « permissivismo » al terrorismo, contribuì, credo, a indurre Costanzo ad abbracciare senza più remore quell’antifascismo ufficiale dal quale aveva dissentito per i motivi che abbiamo detto. La causa prima, ben anteriore al ’68, la causa che stava a monte delle altre, del settarismo antifascista consisteva nel fatto che, per negare il fascismo, l’antifascismo negava ogni valore alla Grande guerra e allo stesso interventismo democratico, coinvolti nella responsabilità di aver dato vita al fascismo (la guerra) o di essere stato da questo sconfitto (l’interventismo democratico). Perfino una personalità dell’interventismo democratico come Parri aveva finito nel 1974, con dolore di Costanzo, per darne un giudizio riduttivo, considerandolo valido come fermento morale ma non come direttiva politica. Ci imbattiamo ancora una volta nella sopravvalutazione dell’interventismo democratico. Questa sopravvalutazione indusse Costanzo ad attribuire all’antifascismo così inteso, figlio cioè dell’interventismo democratico, un valore attivamente politico e non di solo fermento morale, come invece molti già negli anni Cinquanta cominciavano a capire, dai collaboratori del « Mondo » a Del Noce. Anche il PCI attribuiva all’antifascismo un valore attivamente politico. Ma diversa era per Costanzo la causa: era l’interventismo democratico considerato, grazie alla sua altezza morale, la matrice principale, e addirittura unica, dell’antifascismo. Era una deformazione moralistica che, identificando la morale con la storia, la identificava anche con l’azione politica, sopprimendo le mediazioni crociane fra la morale e la politica. Anche questo, come quelli ricordati sopra, era un difetto di Costanzo, ma un nobile difetto. 270 Paola Carucci PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI FILIPPO VALENTI: SCRITTI E LEZIONI DI ARCHIVISTICA, DIPLOMATICA E STORIA ISTITUZIONALE (Archivio di Stato di Firenze, 16 ottobre 2000) ∗ ∗ Il volume (Roma 2000), curato da Daniela Grana, è apparso nelle collane Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 57. Nelle note che seguono per gli articoli di Valenti riproposti nel citato volume ci si è limitati a riportare il titolo e il numero di pagina, con l’anno della prima pubblicazione. Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 Rosalia Manno Tolu 272 ROSALIA MANNO TOLU (direttore dell’Archivio di Stato di Firenze) I motivi che ci hanno indotti a proporre l’Archivio di Stato di Firenze quale sede della presentazione del volume Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, di Filippo Valenti, edito dall’Ufficio centrale per i beni archivistici e curato da Daniela Grana, sono molteplici. Ragioni legate alla forte considerazione, alla centralità, direi, che il magistero di Valenti incontra nell’esperienza contemporanea dell’Archivio di Stato di Firenze, ma anche motivi riconducibili alla volontà di riflettere sulla tradizione archivistica toscana, da Bonaini ai giorni nostri. Le prime sono testimoniate, tra l’altro, dalla partecipazione attiva di Valenti alla presentazione del volume Tra Toscana e Boemia. Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell’Archivio centrale di Stato di Praga, di Stefano Vitali e Carlo Vivoli (Roma, UCBA, 1999, Strumenti, CXXXVII), tenutasi in questa stessa sala il 2 marzo scorso 1. E significativi riferimenti agli scritti e al pensiero del nostro autore erano emersi già nel 1994, negli interventi presentati al convegno su Gli strumenti della ricerca, i cui atti sono stati curati da Diana Toccafondi, per la collana dei Quaderni della Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica 2. D’altra parte, retrocedendo ancora di qualche anno, e rileggendo le « riflessioni di natura teorica scaturite dai lavori di preparazione del materiale documentario per il trasferimento dell’Archivio di Stato di Firenze dagli Uffizi alla nuova sede di piazza Beccaria » 3, pubblicate nel 1987 sulla « Rassegna degli Archivi di Stato », troviamo che, nei poderosi lavori preparatori del trasferimento, gli archivisti impegnati in quell’impresa si rifacevano esplicitamente all’insegnamento di Valenti, perseguendo una preliminare conoscenza della « complessiva realtà dell’Archivio, considerato come un fenomeno “storicamente ed intrinsecamente condizionato” 4 con un’identità propria non riconducibile alla semplice somma delle sue singole parti » 5. Per quanto attiene alla tradizione archivistica nata in Toscana con la fondazione dell’Archivio centrale di Stato, nel 1852, e ai criteri con cui furono ordinati gli archivi a Firenze e negli altri Archivi di Stato istituiti nella regione, in altre parole al « metodo storico » tenacemente voluto e applicato da Bonaini e dai suoi illustri collaboratori, ci sembra fondamentale, per una com1 Il testo dell’intervento tenuto da Filippo Valenti in quell’occasione è stato pubblicato come recensione al volume in « Bullettino senese di storia patria », CVI (1999), pp. 617-621. 2 Gli strumenti della ricerca, a cura di D. TOCCAFONDI, Firenze, Edifir, 1997 (Archivio di Stato di Firenze, Scuola di archivistica paleografia e diplomatica, 6). 3 Dagli Uffizi a piazza Beccaria, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLVII (1987), p. 398. 4 5 F. VALENTI, Parliamo ancora di archivistica (1975), p. 76. P. BENIGNI - O. CAMPANILE - I. COTTA - F. KLEIN - S. VITALI, Riflessioni sul censimento generale dei fondi dell’Archivio di Stato di Firenze, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLVII (1987), p. 406. Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 273 comprensione critica di questo metodo e del suo sviluppo teorico-pratico — come si è manifestato da allora ad oggi in Europa — un confronto con le innovative considerazioni che Filippo Valenti è venuto facendo nei suoi scritti. E il riferimento all’Europa non è una concessione allo spirito dei tempi e non ha un valore retorico, perché anche solo scorrendo le pagine di questo volume vediamo che europea è la dimensione culturale in cui spazia il pensiero del nostro autore. Se queste sono state le motivazioni che ci hanno spinto a proporre l’Archivio di Stato di Firenze quale sede della presentazione odierna, devo dire che ad esse molte altre se ne aggiungono in relazione all’importanza della riedizione congiunta di scritti fondamentali per l’insegnamento dell’archivistica, della diplomatica e della storia delle istituzioni, nelle Scuole d’archivio e in ambito universitario. E ciò è tanto più vero se consideriamo le grandi trasformazioni in atto anche nell’universo degli archivi, quale portato dei cambiamenti epocali indotti dalle innovazioni tecnologiche nella formazione e nella trasmissione dei documenti e, più in generale, nella comunicazione e, quindi, nei processi di formazione e di conservazione della memoria contemporanea. Anche in riferimento agli interrogativi e ai problemi che da ciò derivano, gli scritti di Valenti si rivelano di grande attualità, come opportunamente sottolinea Angelo Spaggiari nella sua presentazione e come, credo, emergerà dagli interventi che seguiranno. Sono certa di interpretare un sentimento unanime, esprimendo a Daniela Grana il più vivo apprezzamento e anche una sincera gratitudine per il lavoro compiuto a vantaggio degli archivi, con la cura certamente impegnativa di questo volume. Gratitudine desidero esprimere anche a tutti i relatori, che hanno accolto l’invito di presentare oggi il cinquantasettesimo titolo dei Saggi delle Pubblicazioni degli Archivi di Stato; ad essi non voglio rubare altro tempo e passo quindi la parola ai relatori. CLAUDIO PAVONE Questo denso volume di Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale sollecita da parte mia una doppia lettura: una ispirata alla professione, l’altra all’amicizia. La prima ha per me, che da molti anni non lavoro più negli archivi, il valore di un ripasso e di un aggiornamento ad alto livello. Scopro così tante mie lacune nei tre campi disciplinari indicati nel titolo e, nello stesso tempo, sono sollecitato a ricordare i molti debiti che ho contratto con Valenti e che ho talmente assimilato da offuscare talvolta in me stesso il ricordo della loro provenienza. La seconda lettura è quella che mi fa ripercorrere il cammino lungo il quale è nata una profonda amicizia con un collega coetaneo, e sottolineo quest’ultimo dato. Da questo punto di vista il mio rapporto con Filippo è di- 274 Claudio Pavone verso da quello degli altri partecipanti a questa presentazione dei suoi scritti, tutti più giovani. Cercherò di stare in bilico tra queste due letture, ricche di reciproci rinvii, forse utili a sollecitare anche un confronto generazionale con i colleghi più freschi. Valenti archivista, senza dubbio: ma io preferirei dire « Valenti in Archivio ». Queste parole mi sembrano più stimolanti perché richiamano l’attenzione sul modo in cui un uomo dalla complessa struttura come Valenti è stato in Archivio ed ha ragionato sugli archivi, sulla archivistica e sulle discipline sorelle, la diplomatica, appunto, e la storia delle istituzioni. Della personalità ricca e sfaccettata di Filippo vorrei allora ricordare almeno due tratti, a prima vista piuttosto lontani dal mestiere di archivista: l’intenso suo rapporto con la filosofia e quello altrettanto essenziale con la musica. Sono due campi coltivati con un impegno che va oltre le preferenze extraprofessionali che da dilettanti ed in varie direzioni tutti manifestiamo nella vita, perché divenute in lui parte integrante della sua personalità. Se dovessi collocare le posizioni di Valenti in una delle grandi correnti che caratterizzano la filosofia contemporanea indicherei quella della filosofia analitica e del neopositivismo logico. Chiedo scusa a Filippo se egli non vi si riconosce appieno. Ma è dalla confidenza con questo modo di filosofare che egli ha tratto, mi sembra, l’amore per le distinzioni precise e chiarificatrici che sole danno senso e rigore all’insieme del discorso. Di qui la sua schietta ripugnanza per le essenze metafisiche, e più che mai per quelle archivistiche. Qui sta la radice teoretica della sua diffidenza, espressa ad esempio con calma sicurezza in apertura del saggio sull’Archivistica di Brenneke, contro ogni « “filosofismo” fuori luogo », contro ogni « esasperata e un po’ peregrina preoccupazione di ricercar essenze e di formular definizioni », contro la preoccupazione « di assicurare a tutti i costi all’archivistica una propria autonomia di fronte ad altre discipline, e alla storiografia in particolare, pur restando fedeli ad una concezione della medesima nella quale, se rigidamente intesa, per una simile autonomia non c’è e non può esserci posto » 6. Nella pagina successiva Valenti non esita a parlare di « funambolismi »; e poi rincara la dose criticando chi fa « dell’entità “archivio” una sorta di categoria dello spirito » 7. La conclusione, suffragata da precedenti osservazioni di Sandri e di Moscati, è che « l’approfondimento del concetto di “archivio”, pur avendo avuto punte assai vivaci, si è esaurito ben presto nella sua fondamentale vanità, ripiegandosi su sé medesimo e ben poco aggiungendo a quanto già acquisito e fin troppo dogmaticamente consacrato » 8. Del linguaggio musicale Valenti ama tra l’altro il rigore formale, dai fiamminghi a Schoenberg. È stato sempre orgoglioso di avere nel suo archivio 6 F. VALENTI, A proposito della traduzione dell’« Archivistica » di Adolf Brenneke (1969), 7 ID., Parliamo ancora di archivistica (1975), p. 65. Ibid., p. 69. p. 4. 8 Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 275 modenese il testo di Orlando di Lasso, Hercules dux Ferrariae. Acquistò un casello ferroviario dismesso e lo trasformò, suonando egli stesso ed ascoltando, in un suo privato tempio della musica. Valenti è stato allievo, come molti altri della sua generazione, me compreso seppure più da lontano, del gentiliano più che crociano Giorgio Cencetti, il quale sembrava talvolta andare quasi alla ricerca dell’atto puro archivistico. Si deve alla formazione filosofica cui ho accennato se Filippo ha interpretato in modo originale il metodo storico e la connessa dottrina della conversione della archivistica speciale in storia delle istituzioni. Non sembri un paradosso affermare che anche per queste sue componenti culturali Valenti è il maggior teorico di archivistica della sua generazione. In lui il bisogno di chiarificazione e sistemazioni teoriche nasce dall’amore per gli archivi come cose concrete, empiricamente constatabili, con le quali ci si misura giorno per giorno. C’era un sofista che diceva: « oh Socrate! Io vedo il cavallo ma non la cavallinità! ». Filippo ha visto innanzitutto i cavalli, vari e variopinti, talvolta riottosi, che si aggirano negli Archivi in cerca dell’eterno riposo, e si è posto il problema del se e del come da quelli si possa risalire a qualche sorta di cavallinità. Lo stile di Valenti, sorvegliatissimo, ricco di subordinate in un’epoca in cui le coordinate sembrano avere il sopravvento, analitico e chiaro, mai gergale, quasi aulico, riflette bene questo suo modo di essere e di pensare. Valenti rifugge da precettistiche spicciole. Egli va in cerca di una fenomenologia archivistica comparata, di tipologie, di una euristica delle fonti documentarie. Si misura in tono rispettoso con teorici quali Brenneke, del quale accoglie il termine « tettonica » come diverso da « struttura », ma critica il « principio di provenienza liberamente applicato ». Valenti compie una analisi attenta e piena di riconoscimenti del Manuel francese, ma nello stesso tempo mette in chiaro le contraddizioni che vi sono fra il respect des fonds (logica storicistica) e i cadres de classement (logica classificatoria). Dall’opera di Valenti si può trarre un ricco e ragionato elenco dei massimi problemi archivistici. Ne nomino alcuni alla rinfusa, rinviando per un discorso più preciso e completo agli altri partecipanti a questa presentazione. Penso innanzitutto al rapporto tra la provenienza ed il contenuto specifico o, in termini che implicano già un notevole grado di astrazione, la materia del singolo documento, della serie, del fondo. Certo, contenuto e materia discendono molto dalla provenienza, ma non in modo lineare e totale. È un problema strettamente congiunto all’altro della non sicura corrispondenza tra la funzione esercitata dall’organo produttore e la fisionomia istituzionale di questo nell’ambito dell’ordinamento in cui è inserito. Ed è un problema che rinvia ancora all’altro delle non automatiche coincidenze fra le periodizzazioni storiche generali, le periodizzazioni istituzionali, le periodizzazioni strettamente archivistiche. Questi nessi, contiguità, sovrapposizioni nell’opera di Valenti non sono risolti dogmaticamente ma criticamente problematizzati. Si dica altrettanto del « mito » dell’« ordinamento originario », quando la sua restaurazione viene posta come obiettivo principe del lavoro di riordinamento. Esiste Silio P.P. Scalfati 276 davvero quel momento aurorale, limpido e felice? Esso, si chiede Valenti, costituisce la regola o l’eccezione? La storiografia moderna ha sottoposto a serrata critica il canone, o « idolo » (come lo chiamava Marc Bloch), della ricerca delle origini, preferendo sostituirvi i più duttili criteri di genesi, eredità, lasciti, percorsi di lunga durata, eccetera. Ritengo auspicabile che anche in archivistica si cominci a ragionare con questi scrupoli critici. Credo che ognuno di noi si troverebbe in gravi difficoltà se dovesse definire quale sia l’« ordinamento originario » dell’archivio che durante la propria vita egli va costruendo. La domanda, certo meno drasticamente, può porsi altresì per gli archivi delle istituzioni. Valenti ha al riguardo una osservazione che dovrebbe far riflettere: « anche il disordine, non dimentichiamolo, non è mai soltanto ed esclusivamente disordine » 9. È singolare l’assonanza di queste parole con il principio, oggi generalmente professato dagli storici, che tutto è fonte, anche gli errori, anche i falsi. La distinzione tra archivio-sedimento e archiviothesaurus mi sembra possa a sua volta essere ricondotta a questo ordine di problemi, che è poi quello della distinzione dell’uso degli archivi da parte dei loro produttori e dell’uso invece da parte di chi, professionista o no della storiografia, è mosso da diversi interessi. Mi si consenta infine di concludere tornando al nodo tra il legame della professione e quello della amicizia che mi uniscono a Filippo. Il primo rapporto di lavoro che ebbi con lui fu quello relativo agli archivi dei Governi provvisori e straordinari che ressero l’Italia tra il 1859 e il 1861, svolto in occasione del centenario dell’Unità d’Italia. Valenti redasse le parti relative a Modena e alle « Regie Provincie dell’Emilia » 10. Cominciò allora tra noi la confidenza archivistica ed extra archivistica. Dopo, egli è stato uno dei pochi che, al centro come alla periferia, hanno fin dal primo momento « creduto » nella Guida generale. Le discussioni con lui furono di grandissima utilità, a Piero D’Angiolini e a me, nella impostazione dell’opera e nel superamento delle difficoltà che venivano via via presentandosi nello svolgimento del lavoro. Valenti ha anche collaborato nella revisione di alcune voci ed ha scritto quella di Modena, rifondendovi tutta la sapienza accumulata nel lavoro giornaliero e negli scritti sulle carte di quell’Archivio, qui ripubblicati. Nella raccolta, come è ovvio, la voce « Modena » non figura; ma per tratteggiare a pieno tondo la figura di Valenti archivista non è possibile prescinderne. SILIO P.P. SCALFATI (Università degli studi di Pisa) Poco fa l’amico e collega Claudio Pavone ha giustamente osservato che nella giornata odierna noi ci troviamo qui riuniti per parlare non tanto di Filippo Valenti archivista bensì di Filippo Valenti « in archivio », per esprimere 9 10 Ibid., p. 75. F. VALENTI, Gli archivi dei governi provvisori modenesi, 1859 (1961), pp. 417-465 e Gli archivi del governo delle Province dell’Emilia, 1859-1860, (1961), pp. 467-509. Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 277 cioè la nostra stima e il nostro affetto ad uno studioso di alto livello al quale dobbiamo molti importanti studi nel campo delle scienze del documento. D’altronde, nella introduzione al suo ben noto manuale di archivistica come euristica delle fonti documentarie, lo stesso illustre festeggiato, occupandosi del problema delle cosiddette discipline ausiliarie o sussidiarie della storia e dei rapporti fra archivistica e diplomatica (su cui sono intervenuti anche altri studiosi, p. es. Alessandro Pratesi), scriveva che Theodor von Sickel, « un grande diplomatista e quindi un assiduo frequentatore di archivi » fu tra i primi a precisare che per historische Hilfsdisziplinen (o Hilfswissenschaften) si intendono quelle « specializzate nella conoscenza formale e nella critica testuale delle fonti della storia in senso proprio ». E a questo proposito mi paiono di grande interesse le dichiarazioni di Valenti contenute nella lettera citata da Diana Toccafondi. A me esse ricordano le parole di un compianto filologo romanzo che mi fu maestro ed amico, Silvio Pellegrini, il quale osservava che « mutila e vuota è una filologia che non sia in funzione dell’intendimento storico » e poco dopo: « in questo presente spezzettarsi delle grandi discipline in minori segmenti è bene che rimanga qualcuno ad attestare l’unità dell’occidente europeo nel medioevo e dopo, che rimanga qualcuno a proclamare che se l’esigenza dei tempi moderni è la specializzazione, si è tuttavia tanto migliori specialisti quanto più si è in grado di guardare fuori della siepe del proprio orto » 11. Non vi è dubbio al riguardo che Filippo Valenti ha voluto e saputo sempre andare al di là delle certezze e dei dogmi, delle « verità » e dei limiti statutari e disciplinari, per affrontare i tanti e complessi problemi delle fonti storiche con la sensibilità, la padronanza degli strumenti e il coraggio di un esploratore insofferente della routine e dei luoghi comuni. Molto spesso, diceva Luigi Schiaparelli, è impossibile « dire con sicurezza dove debba arrestarsi il diplomatista e principiare il lavoro dello storico o viceversa » 12. L’esempio più cospicuo ed evidente che possiamo citare in proposito, per limitarci ai contributi di diplomatica accolti nel recente volume pubblicato dall’Ufficio centrale per i beni archivistici, è rappresentato da uno studio su alcuni documenti falsi che finora dagli studiosi erano stati considerati genuini; ne parleremo fra poco. Ma già prima di questo importante saggio il Valenti si era occupato di diplomatica, a partire da un manuale che ha rappresentato fra l’altro la prosecuzione di una illustre tradizione inaugurata da Cesare Paoli sul finire dell’Ottocento, ripresa poi da Giovanni Vittani, da Armando Lodolini e in seguito da altri benemeriti archivisti ai quali dobbiamo utili testi di questa disciplina destinati alle Scuole di archivistica e agli studenti universitari. Un valido esempio di questo ultimo tipo di manuali è quello che il decano dei diplomatisti italiani, Alessandro Pratesi, pubblicò « per uso degli allievi del corso di Paleografia e Diplomatica dell’Università di Bari » nello stesso 11 12 S. PELLEGRINI, Ringraziamento e congedo, Padova, Liviana, 1972, pp. 7 e 10-11. L. SCHIAPARELLI, Diplomatica e storia, in « Annuario del R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento », Firenze 1906, p. 29. 278 Silio P.P. Scalfati anno (1961) in cui uscì a Modena il volumetto dedicato al documento medioevale da Valenti, il quale nella Avvertenza (purtroppo eliminata nella raccolta dei suoi scritti) si richiama bensì alla fondamentale opera del Paoli, ma non manca tuttavia di osservare che dopo quasi un secolo l’intera disciplina avrebbe bisogno « di una buona revisione o quanto meno di un radicale processo di articolazione e di approfondimento in chiave storicistica ». A distanza di quarant’anni dalla pubblicazione dei due manualetti, che adottano sostanzialmente la medesima impostazione ed esposizione della materia, questa osservazione conserva ancora tutta la sua attualità, anche per il fatto che nel frattempo il panorama dei nostri testi di carattere didattico è rimasto sostanzialmente immutato. Così, mentre il Paoli non si occupava delle norme di edizione dei documenti né della storia della diplomatica (argomenti sui quali, con riferimento all’Italia, non avrebbe avuto peraltro granché da dire, in epoca pre-Schiaparelli), il Vittani apriva la sua trattazione con un capitolo dedicato agli studiosi e alle opere di maggiore rilievo nel campo della scienza del documento e la concludeva con alcune note di « metodologia della lettura e trascrizione ». Il Valenti tratta invece di questi temi in due rapide appendici, lasciando dunque immutata la struttura dell’opera del Paoli e seguendo al tempo stesso l’esempio del Vittani, che nel suo corso svolto nel 1914 dedicava uno spazio relativamente ampio alla storia della disciplina e alle norme di edizione. Che d’altronde i testi di Paoli e di Vittani non rappresentino soltanto due autorevoli classici in materia è provato dal fatto che il primo, dopo essere stato riedito nel 1942 con note di aggiornamento e tavole di facsimili a cura di Giacomo C. Bascapè, è stato poi ristampato fino ai giorni nostri ed è tuttora adottato come testo base in diversi atenei italiani; mentre degli Appunti delle lezioni del prof. G. Vittani esiste una ristampa anastatica del 1972. Ai criteri di edizione e a cenni di storia della diplomatica dedica infine due capitoli specifici il manualetto del Pratesi, che non soltanto nel titolo ma anche nell’impostazione di alcune parti (p. es. sul documento privato) mette bene in risalto l’aspetto della « genesi » e dello sviluppo oltre a quello delle « forme » del documento medioevale, quasi rispondendo in tal modo alla richiesta di « approfondimento in chiave storicistica » che esprimeva il Valenti nella premessa del suo volume. A proposito del quale si deve infine osservare che, trattandosi di un testo scritto per gli allievi delle Scuole di archivio alla fine degli anni Cinquanta e che in un centinaio di pagine riesce a condensare con apprezzabile chiarezza espositiva le principali nozioni di diplomatica generale, sarebbe eccessivo pretendere la trattazione di questioni e problemi che la scienza del documento nei Paesi di cultura tedesca sapeva affrontare da oltre un secolo con rigore metodologico e capacità analitiche esemplari. Possiamo ora dedicare la nostra attenzione all’ampio saggio storicodiplomatistico (più di un centinaio di pagine) con cui il libro presentato si conclude, quello al quale alludevo all’inizio di queste note, cioè allo studio sui più antichi documenti del monastero modenese di S. Pietro. Esso fu pubblicato nel 1985 dalla Deputazione di storia patria per le antiche province Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 279 modenesi nella collana dedicata al millenario di questo ente religioso. Nella nuova edizione — destinata ad una più vasta cerchia di lettori — una delle due « divagazioni di storia urbanistica » in cui si esaminano in dettaglio vari e intricati problemi di topografia cittadina, è stata coraggiosamente soppressa, consentendoci così di poter meglio apprezzare il metodo e seguire senza intralci il percorso piuttosto complesso nell’esame delle fonti scritte utilizzate. All’origine di questo lavoro stanno due conferenze dedicate dall’autore al monastero di S. Pietro e alla sua documentazione più antica, sulla cui genuinità egli nutriva forti sospetti fin dall’epoca in cui il suo « indimenticabile Maestro », Giorgio Cencetti, lo aveva incaricato di seguire la redazione della tesi di laurea di una sua allieva, dedicata appunto all’edizione delle pergamene del fondo monastico custodito nell’Archivio di Stato di Modena, di cui in quegli anni Valenti era direttore. Pur trattandosi di documenti di capitale importanza per la storia cittadina, ben noti e molto spesso citati dagli studiosi, non ne esisteva ancora una edizione critica ma soltanto semplici trascrizioni a stampa. Nella breve premessa Valenti dichiara che col suo studio intende mostrare che la diplomatica è « una metodologia intesa alla corretta lettura e interpretazione » delle fonti documentarie, « in poche parole, dunque, un modo particolare essa stessa di fare della storia ». I documenti su cui si fonda la ricerca, una dozzina in tutto, tra la fine del sec. X e la metà del sec. XI, sono perlopiù privilegi con cui i vescovi di Modena concedono o confermano proprietà fondiarie e diritti di varia natura al cenobio dedicato a S. Pietro. Una delle principali ragioni della loro importanza sta nel fatto che si tratta delle uniche fonti scritte relative alle origini e ai primi passi del più antico monastero cittadino. Utilizzati da tutti gli storici fin dai primi del Seicento e poi nei secoli successivi fino ai giorni nostri, questi diplomi rappresentano fra l’altro i più antichi testimoni dell’esistenza e dell’attività di una cancelleria vescovile in Modena. Nel presentarli e poi nel condurre un accurato esame critico dei singoli pezzi, il Valenti svolge una vera e propria lezione di diplomatica speciale o territoriale, dopo avere affrontato alcuni problemi preliminari ed aver criticato le edizioni disponibili, antiche e moderne, per via della « scarsa o nulla differenza che esse fanno tra originali (o sedicenti tali) e copie », pur in presenza di copie semplici redatte ben due o tre secoli dopo gli originali. Che la questione della tradizione sia in effetti di capitale importanza ai fini dell’accertamento della genuinità o falsità dei documenti in questione, è provato dall’analisi delle copie autentiche pervenuteci, a proposito delle quali lo studioso ha cura di osservare preliminarmente che nel medioevo si faceva ricorso non di rado all’opera di notai « per dar vita ed effetto giuridico a documenti mai esistiti o esistiti con contenuti parzialmente diversi ». Grave è purtroppo che non soltanto gli eruditi dei secoli scorsi ma anche medievisti del pieno sec. XX siano incautamente caduti nei « veri e propri tranelli » tesi dagli abili falsari, osserva il Valenti nel fare « da diplomatista un discorso soprattutto di forme », che comunque finisce ovviamente per investire la fides e 280 Angelo Spaggiari il contenuto stesso dei documenti. L’ampio e minuzioso studio critico degli originali e delle copie, della loro tipologia e cronologia, della scrittura, formulario, sottoscrizioni e quant’altro, si conclude con l’accertamento dei modi, tempi, luoghi e ragioni dell’opera dei falsari. Nell’epilogo l’autore dichiara di rammaricarsi per essere stato « più un distruttore che un costruttore », ma in realtà l’avvincente esame delle diverse fonti disponibili (sono infatti prese in considerazione anche quelle narrative, cronistiche e agiografiche) ha il merito indiscutibile non soltanto di distruggere « l’armamentario di leggende e ipotesi contraddittorie » relative alle origini e alla storia più antica del monastero di S. Pietro, ma anche — e direi soprattutto — di offrirci una lezione di metodo in un campo in cui non di rado gli studiosi continuano a dar credito « nel modo più acritico » a quella storiografia che il Valenti definisce agiografica « nel senso analogico e non soltanto specialistico del termine », la cui fortuna non si concluse col secolo dei lumi e del trionfo della ragione ma prosegue ininterrotta fino ai giorni nostri, pur se in vesti rinnovate e su posizioni di retroguardia. ANGELO SPAGGIARI (Archivio di Stato di Modena) Prima di leggere le mie considerazioni in merito al volume che stiamo presentando, mi sia consentito di ringraziare la collega Rosalia Manno che ha voluto invitarmi a partecipare a questa presentazione che, a mio modo di vedere, ha per l’archivistica italiana il significato di un grande evento, tra l’altro reso solenne dalla presenza del Direttore generale per i beni archivistici, prof. Salvatore Italia. Il volume curato da Daniela Grana, edito dall’Ufficio centrale per i beni archivistici, per il fatto stesso di raccogliere gli scritti archivistici e diplomatistici di Filippo Valenti rappresenta certo un atto di fiducia nell’archivistica e, più in generale, nella figura dell’archivista. E ciò in un momento particolarmente difficile per la disciplina, per la professione e per lo stesso bene culturale archivistico. Siamo tutti « addetti ai lavori » e pertanto non starò a dilungarmi su questo argomento, che deve necessariamente tenere conto dell’impatto dell’informatica sul nostro già impoverito orticello. Mi basterà riferire una frase di Isabella Zanni Rosiello: « non so quanti studiosi di storia, che affermano in dibattiti, in convegni, in incontri, in riviste specializzate e sulla stampa quotidiana (…) di voler salvare la memoria storica dell’immediato passato, si sono chiesti che cosa accadrà, o sta già accadendo, a un tipo particolare di memoria, quella archivistica » 13. Ebbene, in questo momento critico per la « memoria archivistica » giunge a proposito 13 I. ZANNI ROSIELLO, La tutela e il policentrismo della conservazione, in Conferenza nazionale degli archivi, Roma, Archivio centrale dello Stato, 1-3 luglio 1998, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 50), p. 63. Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 281 — nell’interesse della difesa della nostra identità di archivisti — questo libro, che ripropone, in primo luogo, l’opera archivistica di Filippo Valenti. L’opera archivistica del Valenti, « cui molte generazioni di archivisti devono la loro formazione » per dirla con Daniela Grana, è infatti un’opera di base per l’archivistica italiana, nel senso che ha contribuito a rinforzare, con vigore scientifico e con logica stringente, il « fondamento teorico » della nostra disciplina. Al pensiero archivistico di Valenti hanno fatto ricorso, in effetti, quasi tutti gli autori che si sono occupati di problemi archivistici in quest’ultimo quarto di secolo e — vale la pena di notare — non per fare sfoggio di una qualche dotta citazione in più, ma per superare i numerosi « sesti gradi » che si incontrano in ogni lavoro di teoria archivistica. Si cita Valenti, insomma, non perché sia di moda citare Valenti, ma perché è invitabile e per certi versi indispensabile citare Valenti, proprio perché il lavoro archivistico di questi ultimi anni ha dovuto percorrere il sentiero da Valenti indicato 14. Ed io penso, o mi auguro, che anche l’archivistica odierna e quella del futuro (futuro che è già incominciato e che deve tener conto dell’informatica e delle tecnologie ad essa collegate) seguiteranno a citarlo, se vorranno mantenere una linea di continuità nel divenire della nostra disciplina. Non è mio compito sviluppare questo tema, quanto piuttosto illustrare il terzo capitolo del volume, che va sotto il titolo di Inventari, storia delle istituzioni, edizione di fonti. Siamo di fronte, come si può vedere, a lavori di argomento prevalentemente modenese ed estense (e ciò giustifica la mia presenza), lavori nondimeno collegabili all’archivistica teorica di cui ho finora parlato. Fra questi lavori — come ci fa giustamente osservare la curatrice — non è stata inserita la voce Archivio di Stato di Modena della Guida generale degli Archivi di Stato per ragioni di economia editoriale, il che non toglie che tale voce rappresenti comunque l’applicazione (se non addirittura la verifica) di alcuni concetti teorici fondamentali elaborati dal nostro autore. La scelta (obbligata) di omissione della voce Archivio di Stato di Modena ha quasi automaticamente provocato l’esclusione di un altro importante lavoro di Valenti e cioè la guida generale dell’Archivio storico comunale di Modena, del 1988 15. Certamente non avrebbe avuto senso pubblicare la guida dell’Archivio storico comunale senza offrire — in sinossi — la ristampa della guida dell’Archivio di Stato. 14 Per non parlare dei numerosi riferimenti a Valenti da parte della nuova — ci sia consentita l’espressione — « scuola archivistica toscana » (Antoniella, Toccafondi, Vitali, Vivoli, ecc.); si menziona, tanto per fare un esempio, un recente articolo — di argomento molto tecnico e quindi a prima vista lontano dalle tematiche trattate dal Valenti — che, nondimeno, a quel pensiero fa esplicito richiamo, L. GIUVA, Gli strumenti archivistici per la gestione dei documenti: la registrazione di protocollo, la classificazione, i piani di conservazione, in « Rassegna degli Archivi di Stato », LIX (1999), pp. 128-139. 15 F. VALENTI, Comune di Modena. Archivio storico comunale, in Archivi storici in Emilia Romagna. Guida generale degli archivi storici comunali, a cura di G. RABOTTI, Bologna, Analisi, 1991, pp. 437-448. Angelo Spaggiari 282 D’altro canto la curatrice ha ben precisato che qui « non si tratta (…) dell’opera omnia di Filippo Valenti », ma bensì di una raccolta « volta a testimoniare della professionalità a tutto tondo di un archivista che (fra l’altro) non ha disdegnato di cimentarsi con il quotidiano mestiere di riordinare e descrivere complessi archivistici di diversa specie ». Così, il lettore del capitolo III si troverà di fronte la descrizione dell’archivio privato Albergati conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna, e subito dopo, il celebre Profilo storico dell’Archivio segreto estense che funge anche da introduzione all’inventario della « sezione » Casa e Stato dell’Archivio segreto estense, dallo stesso Valenti curato 16. Il Profilo segue di circa novant’anni i Cenni storici intorno l’Archivio secreto estense del Campi 17, e mostra sia il cammino fatto dalla nascente archivistica italiana nella illustrazione dei grandi archivi dell’antico regime sia le prime intuizioni di Valenti in merito alla struttura dei complessi documentari. È qui solo il caso di riportare una riflessione anticipatrice di tante considerazioni archivistiche degli anni successivi. Dice dunque il Valenti a proposito della « struttura originaria » dell’Archivio segreto estense: « per l’archivio di una corte principesca, questa struttura originaria è già di per sé qualcosa di meno logico, meno spontaneo e meno significativo di quello alla cui conservazione tanto tengono le moderne concezioni archivistiche [l’inventario è degli anni Cinquanta n.d.r.] quando si riferiscono all’archivio di una particolare magistratura » 18. Dopo il Profilo storico, la curatrice ha poi felicemente proposto quelli che essa stessa ha definito « oramai classici saggi di storia delle istituzioni estensi » e cioè le Note storiche sulla Cancelleria degli estensi a Ferrara e I consigli di governo presso gli Estensi dalle origini alla devoluzione di Ferrara. Ai due noti articoli vorremmo accostare altri saggi contenuti in questo terzo capitolo, e cioè l’introduzione ad una edizione di fonti, fatta per l’« Archivio storico italiano » nel 1966, Il carteggio di padre Girolamo Papino informatore estense dal Concilio di Trento durante il periodo bolognese, nonché le introduzioni a tre inventari, intitolate, rispettivamente, Gli archivi dei governi provvisori modenesi (1859), Gli archivi del governo delle Provincie dell’Emilia (1859-1860) e Il fondo pomposiano nell’Archivio di Stato di Modena. L’insieme di questi saggi, la cui alta qualità è provata dall’abbondanza delle citazioni nei lavori storiografici successivi 19, ci induce ad alcune consi16 ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, Archivio segreto estense, Sezione « Casa e Stato ». Inventario, Roma 1953 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XIII). 17 G. CAMPI, Cenni storici intorno l’Archivio secreto estense, ora diplomatico, in « Atti e memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le Provincie modenesi e parmensi », II (1864), pp. 335-362. 18 19 F. VALENTI, Profilo storico dell’Archivio segreto estense (1953), p. 378. Non è certamente possibile menzionare i numerosissimi lavori storiografici nei quali sono citati questi classici saggi del Valenti. Qui ci limiteremo a citare — anche per segnalarne l’attualità — il recente lavoro di A. PROSPERI, Girolamo Papino e Bernardino Ochino: documen- Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 283 derazioni sul rapporto tra archivistica e storia. Intendiamoci, qui non vogliamo parlare di quel rapporto nella sua interezza, visto che allo stesso ha dedicato profonde e documentate pagine Isabella Zanni Rosiello 20, ma vorremmo ribadire quel concetto che la citata autrice dà per scontato, e cioè che « l’archivista nello svolgere il proprio mestiere sia anche e soprattutto storico ». Questi lavori del Valenti sono infatti esempi della storiografia propria dell’archivista: una storiografia, per tanti versi, simile a quella dello storico delle istituzioni, ma per tanti altri aspetti diversa e comunque inevitabile per l’archivista stesso. L’archivista, in sostanza, quando si accinge a riordinare e a descrivere archivi non può esimersi dal fare storia istituzionale, né può demandare ad altri questo compito. Deve, inevitabilmente, produrre la sua storia istituzionale, perché è attraverso la sua interpretazione dei fatti (e più ancora degli istituti) che passerà gran parte della sua interpretazione dell’archivio. Ciò è quanto si ricava dalla lezione storico-istituzionale del Valenti; lezione confluita del resto nella grande impresa della Guida generale 21 alla quale egli contribuirà, oltre che con la voce Archivio di Stato di Modena — di cui sopra detto — anche con preziosi interventi nelle discussioni relative alla sua redazione. In conclusione, dopo aver rinviato all’indice per quanto riguarda i restanti lavori compresi nella terza sezione, dei quali, per ragioni di tempo, non ho potuto parlare, tengo a sottolineare che la parte del volume che a prima vista può apparire una rassegna di argomenti spiccatamente modenesi o estensi, e quindi di interesse unicamente locale, si rivela in effetti come una campionatura di lavori che — illustrando dal punto di vista dell’archivista complesse vicende istituzionali — possono essere considerati momenti preparatori per il pensiero archivistico del Valenti, espresso nei vigorosi saggi del primo capitolo di questo libro, e destinati a restare un punto fermo dell’ormai lungo cammino dell’archivistica italiana. DIANA TOCCAFONDI (Archivio di Stato di Prato) Si realizza oggi un desiderio, o meglio un concorso di desideri. Come è già stato sottolineato, il significato di questa manifestazione va senza dubbio molto al di là dell’occasione che ne è all’origine: la presentazione di un volume peraltro molto atteso e di cui si avvertiva fortemente — e non da ora — la mancanza. ti per la biografia di un inquisitore, in L’aquila bianca. Studi di storia estense per Luciano Chiappini, a cura di A. SAMARITANI e R. VARESE, Ferrara, Corbo, 2000, pp. 287-306. 20 Se ne veda un’ampia rassegna nell’apposita sezione del volume L’archivista sul confine. Scritti di Isabella Zanni Rosiello, a cura di C. BINCHI e di T. DI ZIO, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 60). 21 Sulla Guida generale, opera al tempo stesso archivistica e storico-istituzionale, si veda C. PAVONE, La Guida generale degli Archivi di Stato, riflessioni su un’esperienza, in « Le carte e la storia », I (1995), 1, pp. 10-12. 284 Diana Toccafondi Questa presentazione è in realtà l’occasione che ci consente una restituzione dovuta, il pagamento di un debito, che soprattutto ci consente di esprimere — ognuno a suo modo e alla luce della sua personale esperienza — qualcosa che ha profondamente a che fare, direi, con l’azione del « riconoscere », in tutte le sue accezioni. Prima di tutto, nell’accezione che indica il ri-trovare, dopo molti anni, una persona conosciuta che sembrava scomparsa; secondariamente, in quella di « distinguere, identificare nei suoi tratti caratterizzanti » e quindi ri-conoscere ciò che questa persona ci ha trasmesso; infine, in quella di « ammettere, confessare pubblicamente », di avere nei suoi confronti un debito di gratitudine, di ri-conoscenza, appunto. Credo che questo compito spetti soprattutto a noi, che qui rappresentiamo la generazione degli « ex-giovani ». Noi che, sicuramente, in questa sede più che il ruolo di presentatori (per il quale, almeno personalmente, mi sento sicuramente lusingata ma anche inadeguata) credo dobbiamo assolvere a quello di testimoni, testimoni in questo caso di una continuità, così come alcuni dei relatori precedenti — con ben altro titolo ed esperienza — erano invece testimoni di una contiguità (e, per certi versi, anche di una complementarietà) non solo e non tanto generazionale, ma di temi, sensibilità e metodi. Quando, nell’aprile del 1998, ho avuto la ventura e la fortuna di iniziare un carteggio con Filippo Valenti (l’occasione fu quella di inviargli due volumi della collana della nostra Scuola di Archivistica, nella convinzione che nessuno fosse miglior destinatario di lui, dal momento che in molti dei saggi ivi contenuti agiva in modo profondo la lezione dei suoi scritti, e mi sembrava doveroso quanto meno farglielo sapere), espressi il desiderio di vedere raccolti i suoi scritti in un volume, senza sapere che già, per le sollecitazioni di molti e grazie soprattutto all’impegno generoso e intelligente di Daniela Grana, il volume era in via di realizzazione. È un fatto innegabile, e ampiamente condiviso, che quegli scritti, soprattutto quelli di archivistica teorica e di didattica, hanno costituito, per la generazione cui appartengo e non solo per quella, un riferimento essenziale e una sostanziale occasione di maturazione, sono stati fecondi di sviluppi anche imprevisti nel dibattito successivo fino a quello recente e continuano a rappresentare una lettura irrinunciabile nell’attività professionale, così come nella didattica (parlo a ragion veduta, proprio alla luce delle mie esperienze anche in questo campo). E questo volume ne è una conferma, un volume voluto in prima istanza non tanto dal suo autore, che dal suo lungo ritiro extra moenia con un po’ di stupore e solo abbastanza recentemente, se non sbaglio, ha « scoperto » di avere un così vasto seguito, ma soprattutto dai tanti che ne hanno apprezzato e sviluppato la lezione. In molti casi, come nel mio, l’incontro con i saggi cui sopra facevo riferimento non è avvenuto tanto negli anni formativi (quelli della Scuola d’Archivio, per intendersi) ma, almeno in gran parte, poco dopo l’ingresso in Archivio. Ed è stato un incontro che ha lasciato subito un segno profondo, condizionando gli indirizzi successivi e, in primo luogo, producendo la benefica e liberatoria sensazione di un’apertura, di una possibilità di approfondimento Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 285 teorico di cui francamente sentivo la mancanza, a fronte di un’archivistica chiusa, adagiata su se stessa e senza più prospettive, se non quella di ripetere all’infinito il refrain di un metodo storico acriticamente inteso e proposto come la fine di ogni possibile ulteriore problematizzazione. Oggi posso dire che non avrei vissuto la professione con la passione che mi ha sempre accompagnato se allora non avessi trovato, nelle riflessioni di Valenti così come in quelle di Claudio Pavone e di Isabella Zanni Rosiello, questo stimolo a congiungere la sensibilità storica e l’intelligenza critica alla capacità di osservazione per fare del « documento-archivio » un oggetto di interesse, un medium interpretativo, e non solo uno strumento di ricerca. Strano destino quella della generazione cui appartengo, nata professionalmente tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta: una generazione che non ha vissuto, nemmeno indirettamente, il travaglio della Guida generale, e che — almeno inizialmente — non è sembrata neppure interessata a raccoglierne il testimone (da qui lo iato che si crea in quegli anni, e che forse provoca quella scarsa utilizzazione della Guida da parte degli stessi archivisti, osservata e lamentata sia da Pavone che da Valenti). Una generazione incerta e combattuta nelle scelte e nella coscienza professionale (sono gli anni della ridefinizione della figura professionale all’interno del nuovo Ministero per i beni culturali, ma anche gli anni della crisi della storia delle istituzioni, nonché quelli della crisi occupazionale…). Una generazione almeno inizialmente non eroica (che, a Firenze per esempio, non ha conosciuto l’Archivio dei tempi romantici e cenobitici « alla maniera antica » e neppure ha vissuto eventi epocali come l’alluvione del ’66) che sembra quindi non aver nulla da raccontare, che pensa di dover ricominciare da capo, ognuno nella solitudine della propria particolare ricerca. Eppure — parlo sempre dal punto di vista archivistico — anche una generazione insofferente alle ripetizioni scolastiche o alle vuote elucubrazioni, allevata ad una scuola — come è sempre stata quella fiorentina — impregnata di forte realismo e senso critico. È un terreno in cui per fortuna certi semi mettono radici e fruttificano facilmente. Prova ne sia lo stile non dogmatico che caratterizza in quei primi anni Ottanta (così come, d’altro canto, ancor oggi) la Scuola di archivistica dell’Archivio fiorentino, che è sempre stata un’importante cinghia di trasmissione. Una Scuola dove allora insegnavano Vittorio Biotti, Carlo Vivoli, Paola Benigni, Augusto Antoniella. Dai testi a corredo delle lezioni di archivistica, così come dai saggi storico-archivistici editi da questi colleghi in quegli anni emerge chiaramente come la lezione di Valenti — soprattutto per quanto riguarda la critica ad una certa interpretazione del metodo storico o della teoria cencettiana del rispecchiamento tra archivio ed ente produttore — venga ampiamente e proficuamente meditata. L’anno di preparazione al trasferimento (1988) costituirà infine l’occasione per affrontare il problema degli archivi e della loro sedimentazione storica, per interrogarsi sulla natura e struttura dei fondi, la loro articolazione interna, il rapporto tra i singoli fondi e le concentrazioni archivistiche e ripro- 286 Diana Toccafondi porsi il problema dell’ordinamento generale, scontrandosi una volta di più con le aporie del metodo bonainiano. Il confronto con la Guida e con le discussioni a corredo, in primo luogo gli articoli di Valenti e Pavone, apparirà subito inevitabile. Perdonatemi la digressione che, mi rendo conto, da generale è finita per diventare eccessivamente « fiorentinocentrica ». Ma mi premeva giustificare storicamente, e non solo sul piano personale, il perché di un richiamo, di una sintonia che in qualche misura rende ragione e fa da sfondo a questa giornata. D’altro canto, a ulteriore conferma di questo radicamento fiorentino e della sua perdurante continuità, ricordo che nel 1994, nel corso della giornata di studio dedicata in questa sede a Gli strumenti della ricerca, in occasione dell’uscita del quarto volume della Guida generale, Claudio Pavone si dichiarò piacevolmente stupito di trovare a Firenze così viva, soprattutto nei giovani (diciamo pure ancora gli « ex giovani ») la lezione di Valenti — citatissimo in quell’occasione — e così sentita la continuità con il dibattito animato negli anni Settanta dal gruppo della Guida. Sarebbe arduo condensare in poche battute senza banalizzarlo l’apporto di Filippo Valenti al rinnovamento della disciplina archivistica maturato intorno agli anni Settanta: i temi principali, che ritroviamo negli articoli pubblicati sulla « Rassegna » come nelle Lezioni di Archivistica che finalmente vedono qui la luce sotto il titolo Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie vanno, come sappiamo, dalla critica alle ambiguità del termine ordinamento, al concetto idealistico di archivio, alla problematizzazione del rapporto tra archivistica e storia delle istituzioni, al tentativo di identificare « modelli tipologici generali » individuati attraverso la « comparabilità delle strutture », all’attenzione quindi agli elementi costitutivi, di struttura appunto, degli archivi fino alla messa in crisi di termini e concetti dati per scontati (il fondo, la serie…) e la loro riproposizione (di cui vale la pena segnalare l’attualità) come moduli di identificazione e descrizione. Come giustamente fa notare Daniela Grana nell’Introduzione, ritroveremo gran parte di questi temi all’interno del dibattito sugli standard della descrizione archivistica provocato, dalla fine degli anni Ottanta in poi, dall’introduzione della tecnologia informatica. Pensiamo, solo per fare un esempio, alla « normalizzazione » come necessità di rintracciare ed esprimere in linguaggio adeguato elementi comuni e, più in generale, ai problemi inerenti la ricerca di un linguaggio descrittivo « unico » e compatibile che metta in comunicazione i sistemi informativi che si vanno creando negli archivi: tutti aspetti che ripropongono, sebbene con codici e linguaggi nuovi, il problema di cosa si intenda per « fondo », « soggetto produttore », ecc. e delle loro relazioni. Aggiungerei, a questo proposito, che soprattutto l’articolo del 1981 (Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi), inaugurando solidamente l’analisi di struttura degli archivi e introducendo un nuovo linguaggio e un atteggiamento particolarmente attento agli aspetti descrittivi e stratigrafici piuttosto che a quelli precettistico-ordinativi, prepara il terreno alla successiva Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 287 traduzione informatica, nella cui logica la nozione di struttura e di descrizione secondo modelli multilivellari si trova, come sappiamo, fortemente accentuata. La ragione di questo passaggio non è casuale ma riposa, a mio avviso, in una sorta di condivisione culturale originaria che — grazie alla vastità e molteplicità degli interessi del Valenti (che spaziano dalla filosofia, alla linguistica, alla semiologia, alla logica, all’ermeneutica, all’estetica) — gli fa consapevolmente presentire e in qualche misura condividere, in una sorta di « consonanza epocale », la sensibilità agli aspetti linguistici e i presupposti logicoculturali che segneranno le scienze della comunicazione e la tecnologia informatica. La pregnante attualità dell’insegnamento di Filippo Valenti non solo dunque giustifica questa pubblicazione ma, a mio modesto avviso, ne raccomanda vivamente la rilettura proprio per evitare, a noi che ci dibattiamo nei temi sopra ricordati, quei tecnicismi e quelle secche nominalistiche in cui l’attuale discussione rischia talvolta di arenarsi, abbassando il livello, sterilizzando la problematica storica in un appiattimento senza problemi e alla fine, forse, perdendo di vista il suo vero oggetto. Questa piena, concreta e reale aderenza all’oggetto è ancora, credo, uno dei tratti essenziali che troviamo ribaditi in queste pagine, anche in quelle di più recente elaborazione, e ne costituisce forse il senso profondo. Nelle pagine finali delle Nozioni, prima di proporre una tipologia dei fondi (non una classificazione esterna sulla base di categorie mutuate da altre discipline, ma il prodotto di un’osservazione interna che si concreta in categorie conoscitive proposte come paradigmi, sorta di idealtipi weberiani), Valenti annota: « Il problema infatti, o quanto meno il primo problema, non è quello di classificare i fondi non ancora adeguatamente noti e inventariati (…), ma bensì quello di capirli, di esplorarne e penetrarne dal di dentro l’intima struttura, individuandone all’occorrenza le articolazioni. Dopo di che si potrà parlare di riordinamento, di inventariazione ed eventualmente, per determinati scopi, di classificazione ed informatizzazione dei dati » 22. Ma c’è anche un altro aspetto, forse meno evidente ma senz’altro non meno rilevante, a mio giudizio, che merita di essere sottolineato: la bella, musicale, prosa del Valenti veicola un rinnovato modo di parlare, di scrivere, e quindi di pensare intorno agli archivi. Sue le metafore geologiche che ormai sono entrate nel nostro linguaggio corrente (sedimento/sedimentazione; concrezione), sua la citatissima espressione « sulla carta e non sulle carte », sue l’espressione « modalità archivistiche » per definire il modo e le ragioni di formazione degli archivi, e sono solo alcuni esempi. Detto questo, e dopo aver messo in risalto la felice trasmissione generazionale di tanti contenuti, ho tuttavia la sensazione di aver lasciato fuori qualcosa, qualcosa che non costituisce una parte accessoria ma piuttosto il tratto distintivo dell’insegnamento del Valenti, e che invece rischia di rimanere in 22 F. VALENTI, Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie (anno accademico 1975-1976), p. 217. 288 Diana Toccafondi ombra se non viene chiaramente detto. Mi spiego meglio. Proprio la lettura del libro, unitario nella sua tessitura e insieme vario e poliedrico nei suoi contenuti (esattamente come l’autore), mi ha fatto riflettere su quanto ancora dobbiamo imparare sotto un profilo che vorrei chiamare di stile (o ancor meglio, di valori). In primo luogo, l’attenzione al linguaggio, alla sua pulizia, al suo rigore, alla sua comprensibilità, direi quasi al suo valore didattico se non addirittura maieutico. Poi (ma le due cose sono strettamente collegate) l’onestà intellettuale, e, accanto ad una vastità di interessi coltivati in modo profondo e consapevole che suona, per noi, come un invito a non impoverirsi in uno specialismo monotematico, il senso della misura e quello della divisione degli ambiti, la ritrosia a porre sullo stesso piano la competenza professionale di archivista e problematiche ben più generali, contro le tentazioni oracolari, i gerghi, le mode, la confusione dei linguaggi. E tuttavia, insieme a questo, la superba capacità di incrociare linguaggi e competenze diverse. Bellissimo il saggio su S. Pietro, appassionante come un romanzo giallo, una pagina magistrale di diplomatica, storia, agiografia, urbanistica, definita semplicemente (ma anche con l’orgoglio di chi sa fare il proprio mestiere) « diplomatica applicata ». Infine, il mestiere appunto. A questo punto, con il permesso dell’autore, vorrei proseguire con le parole stesse del Valenti, tratte da una recente lettera, da cui traspare una biografia intellettuale lucida e pregnante, che ha, credo, molto da dirci: « Pervenuto alla professione di archivista di Stato non tanto per una singolare vocazione quanto per tutta una serie di contingenze postbelliche, ho continuato per più di mezzo secolo — e tutto sommato continuo ancora — a tenere ben distinto quello che per me non era che un mestiere da quelli che erano stati fin dai banchi del ginnasio i miei veri interessi. (…) Naturalmente, a questo che ho chiamato mestiere mi ci sono però ben presto affezionato ed anche (mio malgrado? mi chiedo talora) appassionato; al punto di sceglierlo ad un certo punto come il settore in cui avrei forse lasciato qualche tangibile orma del mio…passaggio. Tutto ciò trasferendovi, dell’altro me stesso, tanto per intenderci, lo strumentario metodologico, ma non tuttavia i contenuti (il che è ovvio) e nemmeno (che è già meno ovvio) la valenza speculativa e neanche (che ovvio certamente non è) quanto di essa poteva esservi convertito. (…) Ma mi permetta di chiarirle a cosa intendevo alludere accennando allo « strumentario metodologico » che avrei trasferito dai miei hobbies alla professione: intendevo alludere ad un’inguaribile, pedantesca esigenza di rigore logico e di responsabilità epistemologica nell’esprimersi, derivatami dal curriculum della mia formazione attorno agli anni Cinquanta. Non si tratta, mi creda, di un fatto soltanto positivo, si tratta anche di una sorta di palla al piede che tarpa le ali a molte valide intuizioni (…) Si tratta però — e su questo non ci possono essere dubbi — di una garanzia. Ed era comunque un’opzione inevitabile per chi, con i miei interessi dominanti e con una testa a compartimenti stagni come la mia, si sia formato in quella stagione: quando da poco Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 289 aveva fatto irruzione in Italia, assieme all’esistenzialismo (la cui vocazione metaletteraria non faceva certo al mio caso) un tipo di filosofia che, sia pure in diverse chiavi, poneva al centro della speculazione l’analisi del linguaggio; o meglio il riconoscimento della fondamentale importanza del medium linguistico e, paradossalmente, la conseguente diffidenza nei confronti del medesimo e delle sue lusinghe (alle quali la cultura francese in particolare, a differenza di quella anglosassone, non sapeva e non sa ancora resistere) ». Rigoroso controllo del linguaggio, responsabilità, aderenza al reale, « ossessione per la concretezza »: questa in sintesi la vera e più profonda lezione che ancora dobbiamo meditare e fare nostra, noi, così esposti ad altre tentazioni « virtuali », alle lusinghe di nuovi e sempre più raffinati simboli linguistici che, secondo una felice espressione del politologo Eric Voegelin, « pretendono di essere concetti pur essendo soltanto topoi non analizzati » 23 e così tendono a perdere il contatto con la realtà. Ha scritto ancora Eric Voegelin: « Uno dei fenomeni tipici del ventesimo secolo è l’avvenimento determinato da gente spiritualmente energica che rompe con il gruppo intellettualmente dominante per ritrovare la realtà che era stata smarrita » 24: nel nostro piccolo ambito professionale ed umano, e con tutto il senso del limite e del rigore che egli ci ha insegnato, di questo soprattutto dobbiamo ringraziare Filippo Valenti. STEFANO VITALI (Archivio di Stato di Firenze) Rileggendo i saggi di Valenti, pubblicati finalmente tutti insieme nel bel volume Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, non ho potuto fare a meno di riconoscervi parole, espressioni, giri di frase, metafore che mi capita, parlando e scrivendo di archivi, di usare in continuazione. Non avevo mai riflettuto sulle fonti del mio linguaggio archivistico e, come spesso accade, ho fino ad oggi creduto, in buona fede, mio, ciò che invece avevo soltanto preso a prestito. Evidentemente ho talmente introiettato il suo linguaggio, da non essere più grado, se non compiendo uno sforzo di autoriflessione, di riconoscere il mio debito. E non credo di essere il solo, fra gli archivisti della mia generazione. Per il tema che vorrei affrontare qui — quello della perdurante fecondità degli scritti di Valenti nella riflessione teorica e nella pratica archivistica — già la diffusa penetrazione del linguaggio all’interno dei nostro modo di esprimerci, del nostro — per dir così — immaginario « archivistico », costituisce, di questa fecondità, una prima notevole conferma, proprio perché il linguaggio, come lo stesso Valenti ci potrebbe ben insegnare, non veicola soltanto comunicazione verbale, ma concetti, strutture del pensiero. Darò più oltre qualche dimostrazione, che credo molto 23 E. VOEGELIN, La politica: dai simboli alle esperienze, Milano, Giuffrè, 1993, p. 158. 24 Ibid., p. 159. Stefano Vitali 290 pertinente, di quello che voglio dire. Ma la lingua non è che il primo indizio di una influenza che si estende su ben altri piani. Valenti, in conversazioni private, tiene vigorosamente a precisare che i suoi scritti sono profondamente radicati negli anni Settanta. Lo ha anche scritto nella nota a piè di pagina che dà conto dei criteri di pubblicazioni delle sue Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie, laddove afferma che « deve essere ben chiaro che il presente testo rimane, nel suo complesso, un testo datato e come tale vuol essere considerato » 25. Che l’origine delle problematiche da cui hanno preso avvio i suoi più importanti saggi di archivistica, comprese le Nozioni, siano i dibattiti svoltisi negli anni Settanta all’interno della comunità archivistica italiana, è ovviamente innegabile, così come è indubbio che di quei dibattiti i saggi di Valenti portino fortemente impressi i caratteri. Che questo sia un limite è invece un elemento su cui si può discutere. Per quel che mi riguarda, una tale origine piuttosto che un difetto costituisce un pregio, un grande pregio, in effetti, perché in quei dibattiti sono germogliate idee ed ipotesi, che hanno aperto indirizzi e prospettive di riflessione di forte portata innovativa. E soprattutto hanno fornito una strumentazione teorica, che, pur in una situazione così radicalmente mutata come quella attuale, conserva, per più di un aspetto, una persistente vitalità ed una innegabile utilità. C’è in particolare, nelle riflessioni che Valenti ha sviluppato all’interno di quelle discussioni, un nocciolo teorico che, a mio avviso, ha avuto il grande merito « storico » — di una piccola storia, certamente, ma importante per chi l’ha vissuta — di aver forgiato alcuni strumenti analitici che hanno reso possibile agli archivisti della mia generazione — almeno a quelli interessati — di confrontarsi in modo creativo con i problemi posti dall’applicazione dell’informatica agli archivi. Di affrontarli non come questioni che imperativamente comportavano un puro e semplice e, tutto sommato, passivo adattamento delle pratiche di lavoro alle nuove tecnologie. Ma, piuttosto, di considerarli dei problemi di cui si trattava di cogliere e, al tempo stesso, di sapere dominare, lo spessore teorico, o almeno di cercare di farlo. Il primo « attrezzo », per così dire, di questa strumentazione teorica è certamente costituito dal concetto di « struttura ». È indubbio che la rimessa in discussione da parte di Valenti del valore paradigmatico del concetto di « ordinamento » — e a maggior ragione anche di quello di « riordinamento » — così centrale nella dottrina tradizionale e nella precettistica pratica dell’archivistica italiana, a favore di quello meno normativo di « struttura » (« mentre un ordinamento è qualcosa che deliberatamente si dà a un determinato insieme, una struttura è qualcosa che vi si scopre, cioè si cerca, si individua e si studia, indipendentemente dal fatto che sia stata “data” a suo tempo o si sia invece spontaneamente costituita » 26) , ha continuato a dimostrare anche in 25 F. VALENTI, Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie (anno accademico 1975-1976), p. 137. 26 F. VALENTI, Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi (1981), p. 103. Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 291 anni recenti la sua generale portata e fecondità. Per averne conferma è sufficiente pensare alle conoscenze scaturite da un approccio critico ai fondi archivistici che non si propone di misurarne la maggiore o minore adeguatezza rispetto ad un supposto ordinamento originario che dovrebbe rispecchiare lo « spirito » del soggetto produttore — o quanto meno la sua storia e la sua organizzazione —, ma che studia i fondi per quello che sono veramente, per ricostruire e comprendere i concreti processi di sedimentazione e di trasmissione che ne hanno determinato gli assetti reali. Ma per chi ha cercato di inventarsi un modo creativo di risolvere i problemi posti dall’applicazione dell’informatica agli archivi, a quelli storici in particolare, il concetto di struttura ha contato molto di più. Essersi infatti addestrati, sulla scia di Valenti, a ragionare in termini di strutture che nei fondi andavano individuate, interpretate e comprese, per essere ovviamente spiegate e descritte, si è rivelato un tirocinio formidabile quando si è trattato di cominciare ad esaminare la realtà archivistica per cogliervi le « entità » e le « relazioni », delineare modelli di rappresentazione e proporre tracciati descrittivi; quando si è trattato, cioè, di compiere tutte quelle operazioni, analitiche e logiche, che sono alla base della costruzione di programmi e sistemi archivistici informatizzati. Per chi era, appunto, abituato a cercare nei fondi le strutture, quindi a comprendere i nessi che legano fra loro le varie articolazioni dei fondi stessi e i modi migliori per rappresentare tali nessi all’interno degli strumenti di ricerca, le operazioni analitiche richieste dall’applicazione dell’informatica, sono rimaste, pur all’interno di un quadro del tutto nuovo, operazioni fondamentalmente archivistiche e di un’archivistica, tutto sommato, molto familiare. Così, anche la cosiddetta descrizione multilivello, rappresentata graficamente attraverso l’albero rovesciato che procede dal generale al particolare, cioè dal fondo all’unità archivistica e al documento, suggerita da Michael Cook e ripresa in ISAD (G), non è apparsa che la formalizzazione di un visione della realtà archivistica che era ben conosciuta. Una parte credo cospicua del lavoro e delle discussioni in cui siamo immersi attualmente quando esaminiamo i fondi, cerchiamo appunto di capirne la struttura per rappresentarla all’interno di programmi informatici di descrizione o gestione degli archivi, trova la propria radice teorica e metodologica nelle riflessioni di Valenti: basti pensare alle considerazioni su fondo e serie contenute in Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi. Anche se, a dire il vero, il lavoro che noi facciamo e i nostri dibattiti rischiano talvolta di essere aridamente classificatori a paragone della ricchezza problematica contenuta nello scritto di Valenti. Ma oltre al concetto di struttura, il taglio con il quale in Italia è stata affrontata la questione dell’applicazione dell’informatica agli archivi e sono stati recepiti gli standard internazionali di descrizione credo sia debitore alle discussioni degli anni Settanta e alle idee di Valenti, di altri, significativi contributi. È noto che lo standard internazionale per la descrizione dei soggetti produttori di archivi prevede una sorta di doppia struttura informativa per ge- 292 Stefano Vitali stire le descrizioni archivistiche: una per la descrizione della documentazione archivistica ed una per la gestione delle informazioni sui soggetti produttori d’archivio, cioè sul contesto di produzione della documentazione. Le due strutture entrano in relazione, cioè sono collegate tra loro, al livello di descrizione pertinente, cosicché un fondo può essere messo in relazione con il proprio soggetto produttore, una serie con un soggetto produttore diverso ecc. Molti programmi informatici di descrizione degli archivi, all’estero come in Italia, hanno cercato negli ultimi anni di incorporare questa metodologia di rappresentazione degli archivi e delle entità connesse. Il modello di riferimento è certamente quello delle liste di autorità degli autori nell’ambito della catalogazione bibliotecaria, che mira fondamentalmente a razionalizzare ed ottimizzare le pratiche di gestione e di recupero dell’informazione. Ma la particolare accentuazione che ha avuto in Italia il dibattito e la ricezione dello standard internazionale relativo ai soggetti produttori e al modello di descrizione separata da esso previsto, ne ha invece immediatamente messo in evidenza una portata teorica che si ricollegava direttamente e strettamente ai dibattiti degli anni Settanta e soprattutto al contributo di Valenti. Il nodo centrale qui è quello del rapporto complesso, multidimensionale e dinamico fra fondo e soggetto produttore messo in evidenza da Valenti, a correzione del modello ideal-tipico dell’archivio totalmente identificato con un soggetto produttore, modello come è ben noto di ascendenza cencettiana. Non solo perfetta sovrapposizione — ha notato Valenti — ma anche discrasia può e deve leggersi spesso fra fondi e soggetti produttori; una discrasia che deriva dal fatto che « ogni fondo riflette non soltanto (...) la storia dell’ente produttore, ma quella altresì della sua particolare vicenda archivistica », una vicenda che vede gli archivi « soggetti — per una sorta di spontanea meccanica strutturale dovuta a fatti ed eventi estrinseci ed intrinseci, oltreché per cosciente volontà degli uomini (archivisti o legislatori che siano) — a venir manipolati, concentrati, smembrati e fusi tra di loro; o comunque ad agganciarsi gli uni agli altri, o viceversa a scindersi, sotto la spinta di una storia delle istituzioni che non è sempre storia di istituzioni singole ed isolate, ma di istituzioni che si susseguono, bensì e si compenetrano sovente a vicenda » 27. Un modello di rappresentazione entità-relazioni, come quello adottato nei nostri sistemi archivistici informatizzati, che vede il rapporto fra fondi e soggetti produttori non come una relazione uno ad uno (ad un fondo può corrispondere uno ed un solo soggetto produttore) ma come una relazione molti a molti (ad uno stesso fondo possono corrispondere più soggetti produttori e viceversa), che cos’è se non una traduzione in linguaggio formale di queste riflessioni? A molti di noi almeno è parso così, e questa lettura appunto abbiamo dato della proposta di descrizione separata e connessa contenuta nello standard internazionale relativo ai soggetti produttori, tentando di superarne una visione angustamente tecnicistica. 27 F. VALENTI, A proposito della traduzione italiana dell’Archivistica di Adolf Brenneke (1969), pp. 6-7. Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 293 Ma c’è un ulteriore punto che vale la pena di ricordare. Una parte consistente delle riflessioni svolte nel nostro paese a proposito dei problemi teorici che gli standard internazionali di descrizione hanno messo in luce sono state sintetizzate in un documento redatto nel 1997 per presentare le proposte italiane nell’ambito del processo di revisione di ISAD (G) (General International Standard Archival Description). Uno dei punti qualificanti di tale documento è costituito dalla proposta di integrazione della definizione di fondo contenuta nel glossario di ISAD (G). Essa chiedeva di aggiungere alla definizione di fondo (« L’insieme della documentazione, senza distinzione di tipologia o di supporto, organicamente prodotta e/o accumulata e usata da una determinata persona, famiglia o ente nello svolgimento delle proprie attività e competenze ») questa frase: « Il fondo presenta una propria fisionomia e struttura che usualmente è il risultato: 1) delle attività e competenze del soggetto produttore; 2) delle modalità di gestione e archiviazione dei documenti da parte del soggetto produttore e/o di altri soggetti subentratigli nelle attività e competenze; 3) di eventuali interventi effettuati nel corso di processi di trasmissione documentaria da altri soggetti con finalità di utilizzazione, ordinamento, conservazione » 28. All’epoca in cui tale documento è stato preparato, io non avevo letto le Nozioni di archivistica come euristica, che è stata per me certamente la sorpresa più interessante del libro di Valenti. Non so se qualcuno degli archivisti che a Bologna hanno partecipato alla stesura di questo documento nel 1997 conoscesse quel testo, ma certamente non lo avevano sotto mano e probabilmente non lo avevano nemmeno presente. Figurarsi allora la mia meraviglia, quando ho letto una definizione di fondo che mi è sembrata non dissimile a quella da noi proposta: « Ogni archivio ha un ordinamento particolare che è il risultato e del modo di organizzare la propria memoria (Pavone) che l’ente o gli enti produttori di tempo in tempo hanno adottato, e delle vicende storicoistituzionali, nonché di carattere specificamente archivistico, alle quali di tempo in tempo è andato soggetto » 29. Insomma, se pur in ordine diverso, anche Valenti individua gli stessi elementi che secondo il documento « bolognese », convergono a determinare la struttura dei fondi (1. le specifiche tecniche di archiviazione che variano col variare delle epoche e talvolta delle aree geografiche; 2. l’articolazione, l’organizzazione e la storia del soggetto produttore, la prassi burocratica, o la sua attività quotidiana; 3. la storia della trasmissione o tradizione documentaria). Non so cosa ne possa pensare Valenti, che forse poco si riconosce nell’uso che delle sue idee è stato fatto dagli archivisti (almeno da alcuni) che sono venuti dopo di lui, ma a me in questa ulteriore convergenza su un tema 28 F. VALENTI, Proposte di integrazione e modifica dell’ISAD (G) formulate dall’Amministrazione archivistica italiana e dall’ANAI in occasione della revisione quinquennale, in « Rassegna degli archivi di Stato » LVIII (1998), p. 117. 29 F. VALENTI, Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie (anno accademico 1975-1976), p. 168. 294 Isabella Zanni Rosiello così cruciale come la definizione di fondo è sembrato di vedere ancora una prova, seppure ve ne era bisogno, di quanto le sue riflessioni teoriche siano state importanti e feconde per gli archivisti che, come noi, si sono dovuti confrontare con le nuove tematiche dell’informatica e degli standard. E mi piace pensare che l’attenzione che le posizioni italiane, tanto debitrici al pensiero di Valenti, hanno avuto a livello internazionale negli ultimi tempi, siano un ulteriore riconoscimento dell’importanza e del posto di primo piano che tale pensiero ha avuto nell’archivistica del Novecento. ISABELLA ZANNI ROSIELLO Parlare di e su Filippo Valenti non è facile. Non è facile soprattutto in un’occasione come questa e avendo tra le mani un volume tanto rilevante per la sua mole quanto denso di contenuti, di osservazioni, di riflessioni. Buona parte degli scritti di questo volume mi erano noti. Dirò di più: di alcuni di essi ho in un certo senso seguito la rispettiva gestazione da parte dell’autore. Gli incontri, i confronti e scambi di idee tra Filippo Valenti e me, soprattutto quando entrambi eravamo più giovani, sono stati infatti frequenti. Ancora oggi ricordo non senza rammarico e nostalgia i tanti colloqui avuti con lui. Nel confronto discorsivo riusciva spesso a dare il meglio di sé, se non altro per la lucida intelligenza e il grande rigore logico con cui argomentava problematiche e osservazioni. Ma rileggere i suoi scritti raccolti nel volume che oggi viene presentato — e si tratta di un opera voluta con appassionato impegno da Daniela Grana che l’ha curata e meritatamente accolta dall’Ufficio centrale per i beni archivistici e dalla Divisione studi e pubblicazioni in una prestigiosa collana — rileggerli ora, dicevo, è operazione tutt’altro che ovvia e tanto meno un modo come un altro per richiamare alla memoria problemi e tematiche eventualmente accantonati o dimenticati. Ciò che Valenti ha scritto in anni recenti e meno recenti non poteva del resto essere accantonato o dimenticato dagli archivisti suoi coetanei e da quelli più giovani. Non poteva esserlo, data l’importanza e la novità delle sue riflessioni, soprattutto, anche se non solo, quelle di natura archivistica. Nessun dubbio, mi pare, si possa avere circa l’importanza di ciò che Valenti è andato via via scrivendo a partire dagli anni Settanta (e mi riferisco ai saggi che ora possiamo rileggere nella parte del volume intitolata Archivistica teorica). Ne sono prova i dibattiti e le discussioni che all’interno del mondo archivistico immancabilmente seguivano alla pubblicazione di questo o quel suo scritto. Ma è anche vero che le sue riflessioni erano, e non di rado, tanto innovative e le connesse argomentazioni tanto acute e sottili che c’è voluto un po’ di tempo prima che fossero adeguatamente assorbite all’interno della cultura storicoarchivistica ed entrassero a far parte del sapere teorico-pratico di gran parte degli archivisti. E così non pochi — e forse perfino lo stesso Valenti — si sono sorpresi della perdurante validità delle intuizioni e delle riflessioni che è andato comunicandoci nel corso degli anni. Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 295 Ritengo che confrontarsi con quanto Valenti ha messo per iscritto continui a essere una sfida. Una sfida intellettuale che affascina e sgomenta nello stesso tempo, tante e tali sono le suggestioni, ma anche i rischi, che si incontrano se, nel prendere in mano i suoi scritti, si voglia eventualmente discutere questo o quel punto. I rischi sono tanti perché le possibili critiche potrebbero essere da lui puntualmente e sapientemente smontate (o rinviate al mittente). Valenti del resto, da quel che so, non scrive di getto. Prima di mettere per iscritto idee, riflessioni, osservazioni, ipotesi, ci pensa e ripensa ripetutamente e usa, nell’esprimerle, uno stile molto sorvegliato e un linguaggio che aspira a eliminare, o perlomeno a ridurre, ambiguità e polisemie. Allora Valenti è una sorta di « monumento » da ammirare incondizionatamente senza che ci siano margini per sia pur lievi critiche? Credo che faremmo torto alla fecondità e vivacità della sua profonda intelligenza e alla passione con cui ha svolto il suo magistero, se proprio oggi che siamo qui riuniti per festeggiarlo ci limitassimo a rendergli ossequioso omaggio senza tentare di rilanciargli qualche strale, qualche provocazione. Proverò pertanto ad abbozzare in proposito un tentativo anche se temo che probabilmente si rivelerà assai maldestro; lo farò prendendo spunto da uno soltanto degli scritti — tutti peraltro di notevolissimo spessore — contenuti nel volume che ho sotto gli occhi. Un volume molto importante per le osservazioni e riflessioni che contiene e per i settori disciplinari e interdisciplinari in cui esse affondano o ai quali rinviano. Mi limiterò peraltro a prendere in considerazione soltanto uno scritto. E precisamente quello intitolato Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie, Corso di archivistica tenuto presso l’Università di Bologna, Facoltà di lettere e filosofia (corso di laurea in Storia, indirizzo medievale) Anno accademico 1975/1976 [con rifacimenti e aggiunte negli ultimi due capitoli ]. Il titolo, come si vede, è molto lungo, segno e prova a un tempo di onestà intellettuale e di meditata acribia. Ma l’autore lo ha per così dire ulteriormente articolato e precisato nonché ulteriormente chiosato nella circostanziata nota iniziale. In breve, si tratta di un testo che ha conosciuto una storia singolare. Gli Appunti delle lezioni universitarie tenute nell’a.a. 1975-1976 non erano sinora mai stati editi. Eppure erano ben noti; in versione dattiloscritta hanno infatti avuto ampia circolazione e sono stati ripetutamente utilizzati, a seconda dei casi in modo proprio o improprio, da docenti di Scuole d’archivio e più in generale da archivisti. A circa venticinque anni di distanza dalla sua iniziale elaborazione, il testo è stato ora pubblicato, ma con non poche e rilevanti modificazioni, tagli, correzioni, aggiunte. A detta di Valenti (p. 135), il « testo rimane, nel suo complesso, un testo datato, e come tale vuol essere considerato ». Difficile accettare tout court questa affermazione, dato che, a mio parere, si tratta di un saggio che ha perso per strada molti pezzi relativi a « nozioni di base » in senso strettamente didattico e si è per contro arricchito di altre parti in cui vengono approfonditi problemi specificamente dottrinari e teorici. Il testo di cui sto parlando è, come del resto lo sono in generale gli scritti di Valenti, molto articolato, circostanziato, meditato. Non è ovviamente mia 296 Isabella Zanni Rosiello intenzione riassumere, commentare o discutere l’intero testo. L’amico Valenti mi scuserà se prenderò in considerazione — e per di più di sfuggita — soltanto pochi aspetti del suo invero ampio e denso discorso complessivo (il che significa aumentare i rischi, cui poco fa accennavo, di esporsi a inesorabili confutazioni). Contenga o meno il saggio che ho ricordato semplici nozioni di base, o qualcosa di più e di diverso, come io credo, mi sembra che in esso venga soprattutto posta al centro dell’attenzione — fin dallo stesso titolo — « un’archivistica come euristica delle fonti documentarie ». Ma cosa si intende per « euristica »? Scrivere di archivistica significa — come si legge a p. 137 — farlo « con lo scopo precipuo di orientar[e] sul dove e come mettere le mani se e quando [ci] si impegnerà in una ricerca storica ». Occuparsi di archivistica in quanto « euristica » significa dunque occuparsi della ricerca di fonti documentarie, senza trascurare peraltro — e cito testualmente da p. 137 — « la precettistica (che a sua volta è “come dicono i dizionari un complesso di norme relative alla tenuta degli archivi”, p. 142) ma solo nella misura in cui il lavoro di conservazione e ordinamento ha condizionato e condiziona, come è ovvio, quello della ricerca (...): misura peraltro assai rilevante, dal momento che non è facile stabilire tra i due termini una precisa linea di demarcazione ». Tra « precettistica » ed « euristica » non sembrano esserci dunque nette distinzioni; la grandezza di un Bonaini — osserva ad esempio Valenti a p. 160 — sta fra l’altro proprio nell’aver segnato « un nuovo decisivo passo, per non dire un punto d’arrivo, nel cammino verso l’incontro tra archivistica e storia, e quindi tra precettistica ed euristica ». Ma, osserva ancora Valenti ben consapevole delle ambiguità che continuano a connotarla in quanto disciplina ’ausiliaria’ o meno, l’archivistica non solo tende « ad approfondire la natura e la storia del fenomeno ’archivio’ come diretta memoria e materiale residuo dell’umano governare e amministrare rapportata alle istituzioni di tempo in tempo operanti », ma anche a « porre i tesori documentari e le competenze in proposito acquisite a disposizione degli storici » (p. 142). A Valenti comunque, sia che l’archivistica sia da intendere come precettistica, come euristica, come entrambe le cose (o altro ancora) interessa — mi pare — soprattutto fissare o meglio nuovamente precisare alcuni aspetti di carattere teorico, anche se in fin dei conti si tratterà « di un primo abbozzo, di un tentativo affatto parziale e certamente discutibile, se non di una semplice proposta » (p. 216). È ciò che fa in particolare nelle pagine finali del testo, riprendendo la lezione di Brenneke a proposito della rilevanza che può avere, per la disciplina archivistica, una tipologia degli archivi e dei fenomeni ad essa connessi e su cui già in anni precedenti si era soffermato (mi riferisco al saggio A proposito della traduzione italiana dell’“archivistica” di Adolf Brenneke del 1969 ora ripubblicato nel volume degli Scritti). Valenti ritiene del resto che « proprio nella varietà e complessità della fenomenologia che ci troviamo di fronte sia possibile individuare dei modelli ricorrenti di comportamento, o magari di spontanea strutturazione (…), diversi bensì a seconda dei tempi e dei contesti, ma riconducibili nondimeno nelle grandi linee a una Presentazione degli scritti di Filippo Valenti 297 sorta di tipologia in base alla quale orientarci » (p. 199). Pensare di costruire una « morfologia generale degli archivi » sembra dunque a Valenti « oltre che un programma di precettistica (…) anche, e addirittura soprattutto, un programma di euristica » (p. 169). E così Valenti si sofferma a parlare di « modelli », di « tipi ideali », di « paradigmi ». Non ovviamente di « classi » o di tassonomie di stampo setteottocentesco, anche perché, come si legge a p. 148, l’archivistica, non è, come invece sembra essere la diplomatica né « classificatoria », né « nomologica », ma « essenzialmente euristica ». I modelli, le tipologie, i paradigmi di cui parla Valenti dovrebbero servire a dare basi più solide non solo all’archivistica teorica, ma anche, se non ho frainteso, all’archivistica tout court. Scrive infatti Valenti che essi possono servire a « classificare i fondi » nonché a « capirli, [a] esplorarne e penetrarne dal di dentro l’intima struttura, individuandone all’occorrenza le articolazioni » (p. 217). E articolazioni, categorie, partizioni, classificazioni con relative suddivisioni sono termini-concetti che ricorrono più volte nel corso del testo a sostegno di questa o quella osservazione. Ciò si verifica sia che si parli della struttura degli archivi « in senso proprio » o « in senso lato » o delle loro possibili e variegate contaminazioni (per il significato dato da Valenti ad « archivi in senso proprio », « archivi in senso lato » e a « struttura » degli archivi è ovviamente necessario rifarsi al suo importante saggio Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi del 1981, anch’esso ripubblicato nel volume degli Scritti). Che la modellistica (o la tipologia) che sta a cuore a Valenti possa dare spessore e consistenza all’archivistica teorica non ho dubbi; così pure non ho dubbi che da esse possano derivare rilevanti conseguenze per più puntuali e precise descrizioni di complessi documentari e di singole unità archivistiche. E non penso solo a descrizioni di tipo diciamo così tradizionali, ma anche, anzi soprattutto, di tipo informatico (per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è da sottolineare ancora una volta la perdurante validità e modernità delle sue sempre profonde e straordinarie idee). Non sono invece del tutto convinta che la modellistica delineata da Valenti possa aprire nuovi approcci all’euristica (termine-concetto non dimentichiamolo evidenziato ripetutamente nel testo a partire dallo stesso titolo e dalla collocazione didattica cui lo scritto era almeno in un primo tempo destinato), e, più in generale, se contribuirà a porre rapporti più stretti e fecondi tra il lavoro euristico e il lavoro storico. Mi chiedo cioè se la tipologia dei fondi che Valenti propone e di cui fornisce uno schema-esempio (p. 218 sgg.) serva a orientare meglio chi vuole fare ricerca sulle e nelle fonti archivistiche, fornendogli una sorta di « bussola » sul « dove » e « come » cercarle (Valenti, qualcuno lo ricorderà, ha usato in un’altra occasione — Un libro nuovo su archivi e archivisti, p. 125 — il termine « bussola » contrapposto ad « amo »). Una volta acquistata dimestichezza con un « archivio-tipo » o con un « archivio-archetipo », cosa farà chi, nel cercare fonti documentarie, si troverà tra le mani « un archivio reale » (p. 298 Isabella Zanni Rosiello 204)? Non lo so. Ma potrebbe anche accadere che la tipologia che Valenti ci propone venga criticata con la stessa foga, anche se certamente non con la stessa finesse, con cui in alcune pagine iniziali del suo saggio sono state criticate le classificazioni di fonti che accreditati manuali di metodologia storica hanno in passato proposto e in parte continuano a proporre. Tanto per tentare di rimandare qualche sfida a Valenti userò le sue stesse parole e cioè che le proposte tipologiche che vengono avanzate potrebbero incorrere in qualche rischio, ad esempio in quello — dall’autore probabilmente calcolato — di esser ritenute « troppo concettuali e nient’affatto empiriche » (p. 146). Come Valenti ben sa e come mi ha più volte fatto notare con affettuosa amicizia, io sono pragmatica, fattuale, riottosa ai richiami della teoria archivistica, soprattutto quando quest’ultima si avviluppa in bizantinismi o indulge in nominalismi. E così mi è più congeniale continuare a riflettere, e invitare i più giovani che non l’avessero ancora fatto a farlo, su un passo che si legge all’interno del saggio cui ho fatto più volte riferimento. Lo rileggo: « Resta comunque confermato nei fatti che, anche per un archivio in senso proprio, il dogma della spontaneità genetica di formazione dell’archivio, tanto esaltato dai sostenitori ad oltranza del metodo organico, comunemente detto metodo storico, è più uno schema ideale che una realtà. Tra ente produttore e archivio non c’è di massima corrispondenza assoluta, ma corrispondenza mediata tramite il diaframma dei sistemi di memorizzazione (come ha icasticamente messo in luce Claudio Pavone), nonché degli eventuali successivi interventi; non soltanto sistemi di archiviazione, ma anche ulteriori vicende di ordinamenti e di eventuali riordinamenti applicati e sovrapposti gli uni agli altri dagli archivisti del tempo, a seconda delle esigenze dell’ente e dei suoi successori, se non addirittura a seconda delle mode archivistiche o del capriccio del singolo riordinatore » (p. 206). Chi nel fare ricerca nelle e sulle fonti archivistiche desidera essere orientato non solo su dove e come trovarle ma anche su quali deve cercare (appartenga o meno quest’ultimo aspetto all’euristica) non potrà fare a meno — a mio parere — di meditare, e ripetutamente, sulle annotazioni che vi ho appena letto; non potrà fare a meno di essere grato a Valenti per la lucida intelligenza con cui le ha esposte. Più in generale non si finirà mai di ringraziarlo per quanto, ed è tanto, anzi tantissimo in quanto frutto della sua prolungata e pensosa esperienza di lavoro e delle sue originali riflessioni, è contenuto nel volume degli Scritti. Gli archivisti di oggi e di domani continueranno a leggerlo e rileggerlo senza stancarsi. Cronache GIORNATA DI STUDI: « PROGETTI DI TUTELA E FRUIZIONE DI ARCHIVI ECCLESIASTICI » (Bari, Soprintendenza archivistica per la Puglia, 23 marzo 2001) Fra le caratteristiche dell’attività di una Soprintendenza fra le più dinamiche ed impegnate nel settore degli archivi ecclesiastici — è questo il caso della Soprintendenza archivistica per la Puglia — va certamente segnalata la tempestività con la quale sono stati colti e proposti alla comune riflessione temi e problematiche emergenti dal lavoro sui fondi ecclesiastici, non solo dal punto di vista delle peculiarità descrittive o degli sviluppi storiografici, ma pure per taluni non secondari risvolti di consultabilità e di diffusione degli strumenti di ricerca, specie quando essi si configurino in forma di banche dati elettroniche o di riproduzione digitalizzata dei documenti stessi. Si consideri ad esempio, come concreta applicazione di tale interesse, la realizzazione presso la medesima Soprintendenza e lo sviluppo oramai triennale del progetto « Pergamo », che ha visto la schedatura analitica e l’acquisizione su supporto ottico digitale di una consistente mole di documentazione pergamenacea appartenente sia a due prestigiosi archivi gentilizi quali quelli dei Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni e dei Caracciolo de’ Sangro di Martina Franca, sia ad una decina di archivi diocesani pugliesi, all’archivio della Basilica di San Nicola e a quello del Capitolo metropolitano di Bari. La tavola rotonda sul tema « Accesso, consultazione e commercializzazione di documenti elettronici e di banche dati di archivi storici della Chiesa e dello Stato », che ha impegnato in un serrato dibattito a più voci pressoché l’intera mattinata della giornata di studi, ha costituito infatti una preziosa occasione di confronto su quanto al proposito va emergendo — esperienze di lavoro e dispiegamento di professionalità, orientamenti culturali e tecnologie informatiche, figure di collaborazione e modelli di investimenti, riferimenti giuridici e disposizioni normative — sia entro l’Amministrazione archivistica, sia nell’ambito dei beni culturali ecclesiastici, sia ancora nel mondo dell’editoria e in genere dell’imprenditorialità multimediale e telematica. Non va dimenticato a questo proposito, come ha rievocato pure nel suo intervento di apertura e di inquadramento dei lavori il sovrintendente archivistico per la Puglia, Domenica Porcaro Massafra, che l’Istituto è anche coinvolto — assieme ad altre Soprintendenze della Regione, alla Provincia di Bari e ad alcuni Istituti dell’Università e del Politecnico di Bari — nella sperimen- Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 300 Francesca Cavazzana Romanelli tazione preliminare all’attuazione del progetto « Parnaso », promosso da alcune società operanti nel settore informatico ed editoriale (Tecnopolis, Laterza, Grifo) e mirante alla realizzazione di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo di servizi telematici nel campo della valorizzazione scientifica e didattica dei beni culturali e ambientali pugliesi. Sullo sfondo dei lavori, ancora, la collaborazione fra lo Stato e la Chiesa nella valorizzazione e nella fruizione dei beni culturali ecclesiastici, riproposta e ulteriormente regolamentata dall’intesa per la conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche, sottoscritta fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana il 18 aprile 2000 e approvata con d.p.r. 11 maggio 2000, n. 189. Una collaborazione le cui tracce si possono cogliere — ed ecco sempre nell’introduzione di Domenica Massafra il filo unificante le relazioni della mattinata con quelle del pomeriggio — sia nella realizzazione pugliese del progetto « Pergamo », sia, in altro ambito, nella pubblicazione, sempre nel 2000, del primo volume della Guida degli archivi capitolari d’Italia, uscita in edizione congiunta fra l’Ufficio centrale per i beni archivistici e l’Associazione archivistica ecclesiastica. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti CXLVI / « Quaderni di Archiva Ecclesiae », 6). Quale lungo cammino di effettiva e operante collaborazione fosse comunque, nei fatti, già alle spalle del recente strumento dell’intesa, è emerso con chiarezza dall’intervento di Maria Grazia Pastura, che dall’osservatorio privilegiato della direzione della Divisione archivi non statali presso l’Ufficio centrale per i beni archivistici ha avuto modo di seguire e in molti casi di promuovere direttamente, tramite specifici finanziamenti, non pochi progetti di censimento e inventariazione di fondi ecclesiastici. Ma gli strumenti normativi più recenti anche in ambito statale, in particolare la legge 112 /98 che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali e il nuovo Testo unico sui beni culturali (l. 490/1999), ispirati ad un concetto di tutela che si coniuga con il principio parimenti condiviso del policentrismo della conservazione, consentono e anzi suggeriscono — ricordava sempre Maria Grazia Pastura — forme di cooperazione ben più ampie, organiche e programmate che per il passato, quando gli interventi erano affidati in prevalenza, come per il progetto pugliese « Pergamo » o per quello veneto « Ecclesiae Venetae », allo strumento estemporaneo dei finanziamenti speciali. Ulteriori precisazioni sono infine giunte, sempre da parte di Maria Grazia Pastura, sia riguardo all’ampliamento delle norme sull’accesso alla documentazione previste dalle leggi 675 e 676 del 1996 e dal già ricordato Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, sia riguardo al principio della gratuità della ricerca. A proposito di quest’ultima sono state richiamate pure le suggestive espressioni della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 13 luglio 2000, che individuano nella libertà e nella gratuità di accesso agli archivi un vero e proprio profilo di civiltà, nonché l’esercizio di un diritto democratico da parte di ogni cittadino. Progetti di tutela e fruizione di archivi ecclesiastici 301 I temi dell’accesso e della comunicazione dell’informazione sono stati anche al centro dell’intervento di Gigliola Fioravanti, che ne ha illustrato le connessioni con la più generale attività culturale degli istituti archivistici, di cui costituiscono la struttura portante e non solo una variabile più o meno occasionale o facoltativa. L’attività degli archivi deve tendere ancora — secondo la responsabile della Divisione documentazione archivistica dell’Ufficio centrale — non solo a favorire la consultazione delle fonti, ma anche ad illustrare le attività istituzionali dell’Amministrazione, in una prospettiva, sottolineata pure dalla l. 150/2000, di effettivo avvicinamento del cittadino alle istituzioni. Un impegno di tal genere comporta necessariamente di ripensare, sotto il profilo della comunicazione e delle attività di reference archivistico, la formazione specifica degli addetti al servizio al pubblico, anche promuovendo apposite iniziative e investimenti. Comporta in aggiunta un’analisi accurata della fisionomia del pubblico degli archivi, oramai molto diversificato; pubblico che, secondo i dati di sintesi a livello nazionale offerti da Gigliola Fioravanti per la realtà degli Archivi di Stato, confrontata pure con analoghi dati di situazioni estere, è composto per un buon 70% da utenti che non sono ricercatori di professione. Non più luoghi elitari e rarefatti, gli istituti archivistici sono da tempo alle prese con un pubblico composto in grande prevalenza di semplici studenti, di appassionati di storia locale, di cittadini desiderosi di conoscere la propria genealogia, forse meno attrezzati scientificamente ma alla ricerca di un’informazione comunque qualificata. Gli archivisti sono dunque oggi impegnati nell’individuazione di nuove forme di accoglienza, così come di nuovi modi di compilazione degli strumenti di ricerca, sostenuti in tal senso dall’utilizzo inventivo e pertinente delle tecnologie informatiche e telematiche. Accesso significa ancora — ha continuato Gigliola Fioravanti con riferimento alla grande massa di documentazione tuttora priva di inventari o ancora presso gli uffici che l’hanno prodotta — immettere nelle reti del sapere un patrimonio che è ancora del tutto sconosciuto, o nel migliore dei casi affidato solamente alla mediazione personale dell’archivista. I nuovi settori di attività: la valorizzazione dei fondi, la didattica, la ricerca, lo stesso obiettivo del prolungamento degli orari di apertura degli istituti con il conseguente maggior carico di assistenza al pubblico, un generale invecchiamento medio degli archivisti in servizio nell’Amministrazione, sempre meno affiancati da nuove leve di più giovani colleghi (e la compilazione di un inventario, ricordava Gigliola Fioravanti, richiede sovente disponibilità continuativa di energie e di concentrazione intellettuale, di cui è più facile disporre nelle fasi iniziali della vita professionale), hanno di fatto provocato un pericoloso rallentamento delle attività di inventariazione. Né a tali difficoltà sono estranei problemi, quali la carenza di spazio nei depositi degli istituti archivistici, resi ancor più drammatici dal fenomeno, oramai in pieno svolgimento, di dismissione progressiva di competenze e funzioni da parte dello Stato e dalla relativa necessità di ricoverare e selezionare le carte oramai storicizzate di uffici la cui natura giuridica viene radicalmente mutata: una delicata fase di passaggio, non solo istituzionale e 302 Francesca Cavazzana Romanelli amministrativa ma pure archivistica, che sollecita l’indispensabile progettazione di nuove, forse inedite forme di aggregazione archivistica nelle quali misurare in concreto prassi di sinergie organizzative con le Regioni e gli Enti locali. Garantire l’accesso significa infine, ha concluso Gigliola Fioravanti, saper conservare nei modi opportuni la documentazione originale — non solo quella cartacea, ma pure quella costituita da film, fotografie, CD, nonché i documenti che nascono già su supporto elettronico —, e fare un uso appropriato delle diverse tecnologie sostitutive, quali le riproduzioni in digitale o in microfilm. Quanto ai problemi connessi ad ipotesi di commercializzazione dei servizi d’archivio, l’intervento ricordava come, una volta individuati e garantiti precisi standard di qualità per le attività pubbliche essenziali e gratuite, quali la consultazione per motivi di studio o amministrativi, sia possibile, anche sulla scorta di recenti indicazioni normative, individuare una larga fascia di servizi non essenziali che dovrebbero poter essere sottoposti a contributo tramite un’equa determinazione degli introiti, da ridestinare, se del caso, quali retribuzioni di risultato al personale stesso degli istituti: fra tali servizi, ad esempio, il prestito di documenti per mostre commerciali, l’effettuazione di ricerche monotematiche, il rilascio con urgenza di copie per motivi non di studio, l’iscrizione alle Scuole di archivistica e il rilascio dei relativi diplomi. Due concisi ma efficaci interventi hanno successivamente illustrato, a proposito dei problemi aperti nella tavola rotonda, la situazione degli archivi ecclesiastici. Il carmelitano padre Emanuele Boaga, segretario dell’Associazione archivistica ecclesiastica, ha segnalato come, mentre sui problemi dell’accesso si può notare un positivo e generalizzato cambio di mentalità fra gli archivisti ecclesiastici, sollecitato pure dalla ricezione da parte delle diverse diocesi del Regolamento degli archivi ecclesiastici elaborato dalla stessa Associazione, più incertezze si riscontrino in tema di riproduzione dei documenti, come confermano pure le norme applicate da alcune diocesi e regioni pastorali. Assimilando infatti le problematiche della riproduzione della documentazione d’archivio a quelle degli altri beni culturali, permane la preoccupazione che l’immagine, il cui valore non è solo informativo o estetico ma teologico, biblico o liturgico, venga utilizzata in modo non corretto. Ogni diffusione di immagini di beni culturali, sicuramente da favorire quando serva a raggiungere l’utenza più remota e a produrre divulgazione, dovrebbe in ogni caso — secondo padre Boaga — poter garantire una lettura contestualizzata della documentazione e prevedere eventuali danni provocati dall’usura della riproduzione. Analoghe preoccupazioni di contestualizzazione sono state espresse da padre Boaga anche a proposito della consultazione di archivi in rete, specie da parte di utenti non specializzati nella ricerca archivistica. Il profilarsi di una nuova era, densa di continue sfide e sollecitazioni anche per gli archivi ecclesiastici, è ritornato nelle parole di mons. Salvatore Palese, presidente dell’Associazione archivistica ecclesiastica, che ne ha ricavato la sollecitazione per una nuova capacità progettuale a medio e a lungo termine da parte delle istituzioni ecclesiastiche coinvolte. Su temi quali la Progetti di tutela e fruizione di archivi ecclesiastici 303 riproduzione di documenti e la loro commercializzazione si riscontra infatti, sulla scorta di quanto già va facendo la Conferenza episcopale italiana, l’esigenza di un reale coordinamento di indirizzi e decisioni, specie su aree territoriali o istituzionali omogenee, affinché la pluralità degli archivi ecclesiastici — diocesani, parrocchiali, di ordini e associazioni, di singoli — non divenga un limite o dia motivo a una disorientante molteplicità di soluzioni. Una delicata fase di transizione, ricca di innovatività ma pure di problematicità e di rischi si apre dunque oggi a proposito della circolazione di descrizioni e immagini archivistiche sulla rete. Sul filo di questa acuta consapevolezza, suffragata da raffinate citazioni dalla letteratura del settore, si è sviluppato anche l’intervento di Stefano Vitali dell’Archivio di Stato di Firenze, presidente del Comitato per gli standard descrittivi del Consiglio internazionale degli archivi. Il passaggio verso il digitale, che potrà rendere visibile in rete lo sterminato patrimonio dei nostri archivi, non si svolgerà infatti, secondo le previsioni di Vitali, in modo meccanico o neutro ma sarà indubbiamente pretesto e occasione per scelte di vario tenore, sulle quali si misureranno la qualità scientifica dei progetti così come il conseguimento di specifici obiettivi di politica culturale. Una panoramica di alcune realizzazioni internazionali, fra le quali quelle della National Archives Record Administration statunitense o degli Archivi australiani, presentate da Vitali con la consueta, accattivante lucidità, ha testimoniato in modo evidente alcuni possibili differenti esiti di tali operazioni. Più che di fonti in rete si tratta infatti, in casi come quelli illustrati, di materiali scelti e composti per suggerire intenzionali letture del passato, a scopo prevalentemente didattico e sovente con forti contenuti di identificazione civile. Anche a proposito di talune iniziative di commercializzazione di immagini tratte da documentazione archivistica, messe in atto dagli stessi istituti di conservazione o da privati — si pensi ad esempio alla digitalizzazione di importanti fonti demografiche contemporanee quale il censimento della popolazione del 1901 ora curato dal Public Record Office, previo pagamento per la visione della documentazione — si prospettano secondo Vitali pressanti interrogativi circa i criteri che hanno portato a scegliere per la riproduzione e per la conseguente commercializzazione alcune piuttosto che altre possibili fonti. Determinante per la selezione può forse essere in alcuni casi una logica di mercato, attenta soprattutto se non esclusivamente alla domanda prevalente del pubblico o alla gradevolezza estetica dei documenti. I caratteri di una più attenta progettualità culturale, mirante a restituire tutta la complessità del contesto archivistico e della tradizione storiografica dei fondi, sono per converso quelli che hanno guidato, nell’illustrazione che ne ha fatto Stefano Vitali, il progetto di digitalizzazione del Mediceo avanti il Principato portato a termine all’Archivio di Stato di Firenze, ove si è in aggiunta sperimentata la possibilità di inserire i visitatori del sito in una sorta di sala di studio virtuale, tenendo distinta la libera lettura delle fonti dalla possibilità di scaricare e stampare i testi. 304 Francesca Cavazzana Romanelli Certamente oggi anche la Chiesa cattolica italiana pare fortemente orientata a riappropriarsi della sua diretta responsabilità nei confronti della gestione dei beni culturali ecclesiastici: una responsabilità troppo a lungo trascurata, che ha visto talora andare di pari passo disattenzioni nella tutela e posizioni di serpeggiante subalternità allo Stato. Da notazioni di tal genere ha preso le mosse l’incisivo intervento di mons. Giancarlo Santi, direttore dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana, che nel descrivere i criteri di impostazione del sito web ove, grazie alla collaborazione con l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), sarà possibile via via consultare in rete l’intero inventario dei beni artistici e storici delle diocesi, ne sottolineava la possibilità di un quadruplice percorso — liturgico, catechistico, teologico e biblico — secondo molteplici itinerari di ricerca e contemporaneamente di ermeneutica dei beni culturali ecclesiastici. Un invito alla fiducia nella collaborazione, e contemporaneamente alla circospezione e alla prudenza, formulato rievocando l’invito evangelico ad essere « prudenti come i serpenti e semplici come le colombe », è giunto dunque da mons. Santi, che ha sollecitato a non perdere di vista, specie in situazioni di particolare e rapida evoluzione, la connessione con gli strumenti giuridici che devono regolamentare i rapporti fra le istituzioni ecclesiastiche e quelle statali. Il quadro delle recenti intese dovrebbe così poter mettere in atto, caso per caso, apposite convenzioni, ove sia specificato il permanere dei diritti dei proprietari dei singoli beni, ed ove l’uso, la consultabilità, la diffusione e l’eventuale commercializzazione degli stessi venga esplicitamente autorizzata dall’ordinario diocesano interessato, senza trascurare per quest’ultima evenienza l’eventuale divisione dei proventi e l’indicazione dei soggetti che li dovranno gestire. Senza idealizzare né demonizzare il mercato — che tuttavia, come ha ricordato mons. Santi si è prestato pure, specie in presenza di interlocutori deboli, a prevaricazioni o strumentalizzazioni — va tuttavia riaffermata la necessità di definire in modo chiaro e concreto i termini di una collaborazione che va comunque perseguita. Inventari e immagini di archivi diocesani in rete, dunque? Certamente, ma non solo nei siti delle Soprintendenze e non prima di aver stipulato espliciti accordi. Una disponibilità all’accordo comunque, che è stata ribadita a chiare lettere, per la situazione locale, dal presidente della Conferenza episcopale pugliese, mons. Cosmo Francesco Ruppi, il quale ha sottolineato, se pure ve ne fosse stato ulteriore bisogno, il grande contributo offerto dalla locale Soprintendenza per la valorizzazione degli archivi delle Chiese della regione, così come il sostegno offerto agli stessi archivisti ecclesiastici. Fra gli interventi che hanno animato il dibattito, prima della presentazione del progetto « Pergamo » nella sua nuova versione aggiornata informaticamente ed ampliata nell’impostazione della descrizione strutturale dei fondi, merita ricordare almeno quelli di Claudio Lodoli, direttore dei servizi editoriali e responsabile delle edizioni on line della casa editrice Laterza e di Carlo Dell’Aquila, docente di informatica presso l’Università di Bari. All’insegna di Progetti di tutela e fruizione di archivi ecclesiastici 305 una buona sinergia fra privato e pubblico, che si realizzi in una collaborazione a garanzia della qualità di ciò che viene immesso nella rete, il primo ha riferito di talune interessanti iniziative di editoria elettronica di cultura, molte delle quali indirizzate al mondo della scuola, quali l’archivio interattivo di educazione letteraria o per alcuni aspetti lo stesso progetto « Parnaso », suggerendo in aggiunta la possibilità di gestire concordemente fra editore ed ente detentore dei beni i percorsi di consultazione secondo chiavi e livelli predeterminati. Un pressante invito alla necessità della manutenzione dei materiali e dei sistemi informatici, unito all’esortazione alla chiarezza nel distinguere fra ciò che deve essere gratuito e restare estraneo ad iniziative d’impresa — come l’accesso alla documentazione archivistica — e quanto possa rientrare nei cosiddetti servizi aggiuntivi, è giunto infine da Carlo Dell’Aquila, che ha suggerito pure, per quanto riguarda le immagini, la possibilità far uso nel primo caso di diffusioni a bassa risoluzione, da commutare se del caso in alta dietro pagamento. Sempre all’insegna della collaborazione fra Stato e Chiesa, come si è anticipato, è stata la manifestazione pomeridiana, che ha visto la presentazione del primo volume della Guida degli archivi capitolari d’Italia, curata da Salvatore Palese, Emanuele Boaga, Francesco De Luca e Luisella Ingrosso. Agli interventi di De Luca, che ha delineato un profilo delle istituzioni capitolari e dei loro archivi, ha fatto seguito quello di Antonio Dentoni-Litta, che ha fra l’altro ricordato l’impegno della Divisione studi e pubblicazioni da lui diretta nell’edizione di censimenti, inventari e repertori di fondi diocesani, parrocchiali e monastici: attività scientifica fondamentale, a fianco di coedizioni quali quelle della Guida agli archivi diocesani d’Italia e della Guida agli archivi capitolari, e a convenzioni con istituzioni scientifiche finalizzate all’ordinamento e alla stesura di inventari, per una politica culturale di valorizzazione e sostegno della realtà degli archivi ecclesiastici. Da ultimo, la relazione di Cosimo Damiano Fonseca ha magistralmente inserito la Guida nella temperie storiografica dell’ultimo quarantennio, rievocandone il collegamento con il superamento dell’ecclesiologia giuridica sollecitato dal Vaticano II, il conseguente spostamento dell’asse delle ricerche di storia della Chiesa verso i contesti diocesani o subdiocesani e il rinnovato interesse per le indagini sulla vita quotidiana del clero. Ha infine concluso la giornata la festosa inaugurazione della nuova sede della Soprintendenza nel neorestaurato complesso del palazzo Sagges, frutto del lungimirante impegno del locale Provveditorato alle opere pubbliche nel risanamento di una consistente porzione del vecchio centro storico di Bari, cui la Soprintendenza archivistica ha offerto felice occasione di restituzione all’utilizzo civile e culturale. FRANCESCA CAVAZZANA ROMANELLI Direzione progetto « Ecclesiae Venetae » Note e commenti I PRECEDENTI DELLA SPEDIZIONE DEI MILLE: LETTERE DI FRANCESCO CRISPI E ROSOLINO PILO NELL’ARCHIVIO DI PIERO SRAFFA Salvatore Candido ha descritto analiticamente i carteggi di Francesco Crispi, conservati nell’Archivio centrale dello Stato e nel Museo centrale del Risorgimento di Roma 1, e non ha escluso la presenza di altre carte dello statista in archivi stranieri. Infatti le vicende legali intercorse tra lo Stato e gli eredi sulla destinazione dei carteggi in base alle disposizioni testamentarie del defunto, non impedirono la commercializzazione di alcune lettere. In questa breve comunicazione si segnala l’esistenza di alcune lettere di Rosolino Pilo e di Francesco Crispi nell’Archivio di Piero Sraffa, che sembrano non essere state oggetto di studi specifici da parte degli storici del Risorgimento. La Wren Library del Trinity College di Cambridge in Inghilterra conserva l’archivio dell’economista Piero Straffa (1898-1983) 2. Professore di economia politica nelle Università di Perugia e di Cagliari, Sraffa ha insegnato alla Cambridge University nel 1927 ma già dal 1930 abbandonò l’insegnamento (a parte un breve periodo durante la guerra) e prestò servizio come bibliotecario alla Marshall Library. Fu fellow prima del King’s College e poi del Trinity College, vivendo prevalentemente a Cambridge fino alla morte. Visse a stretto contatto con personalità come Keynes e Wittgenstein ma seguì con interesse gli sviluppi della vita politica e culturale italiana; fu particolarmente vicino ad Antonio Gramsci negli anni del carcere e partecipò attivamente alle scelte editoriali della Einaudi e della Feltrinelli. Non rinunciò mai alla cittadinanza italiana e all’inizio della guerra fu internato, seppur brevemente, fra il maggio e l’estate del 1940, in un campo di prigionia 1 S. CANDIDO, Sui Carteggi di Crispi epistolari editi ed inediti, in « Archivio Storico Siciliano », 11 (1985), pp. 327-361. 2 I più recenti volumi apparsi in Italia che contengono notize sull’Archivio Sraffa sono: Omaggio a Piero Sraffa (1898-1983). Storia Teoria Documenti, a cura di N. SALVADORI, Pisa, Gruppo editoriale internazionale, 1998 (Il pensiero economico italiano, VI/I), e Piero Sraffa: contributi per una biografia intellettuale, a cura di M. PIVETTI, Roma, Carocci, 2000. Una biografia dell’economista è stata tracciata da J.P. POTIER, Piero Sraffa: biografia, Roma, Editori riuniti, 1990. Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 Lettere inedite di F. Crispi e R. Pilo 307 nell’isola di Man 3. Autore di Produzione di merci a mezzo di merci (1960) 4 e di pochi articoli su riviste scientifiche, curatore dell’edizione critica dell’opera di David Ricardo, è stato al centro di diversi dibattiti e quasi ognuna delle sue poche pubblicazioni ha avuto una notevole influenza sullo sviluppo del pensiero economico. L’archivio prodotto nel corso della sua vita è stato recentemente ordinato ed inventariato da Jonathan Smith 5. La meticolosità di Sraffa nel conservare qualsiasi « pezzo di carta » sul quale avesse annotato qualcosa 6, ha contribuito alla formazione di un archivio particolarmente consistente. Straordinaria è la collezione dei Diaries (1927-1981), piccole agende per appuntamenti che consentono agli studiosi di poter ricostruire, con estrema precisione, i viaggi di Sraffa, le persone incontrate, i suoi corrispondenti, qualche breve giudizio su fatti contingenti. Sraffa fu anche un esperto bibliofilo e si avvicinò al mondo degli antiquari, diventando collezionista di libri antichi e di documenti 7. La Collection of manuscripts of economic historians (17 th-20 th) comprende per lo più lettere scritte o ricevute da personalità italiane e straniere di indubbia fama. La Collected correspondence è suddivisa per autore ed è ordinata cronologicamente. Tra gli autori delle lettere vi sono Giovanni Battista Vico, Giuseppe Mazzini, Antonio Labriola 8, Maffeo Pantaleoni 9, Vilfredo Pareto. Le lettere più significative, per consistenza e per contenuto, sono quelle di Rosolino Pilo e di Francesco Crispi. 3 Cfr. J.P. POTIER, Piero Sraffa… cit., p. 79. 4 Una completa letteratura relativa all’opera Produzione di merci a mezzo di merci di Piero Sraffa, è in A. RONCAGLIA, Sraffa e la teoria dei prezzi, Bari, Laterza, 1981, in particolare pp. 189-229. 5 Il catalogo è consultabile su http://www-lib.trin.cam.ac.uk 6 Cfr. J. SMITH, Le carte di Sraffa presso la Biblioteca del Trinity, in Piero Sraffa: contributi… cit. Cfr. p. 21: « ma conservava persino appunti da lui rifiutati. Marcandoli con la dicitura “fesserie”, egli sceglieva di conservarli, presumibilmente, per non imboccare di nuovo la stessa strada ». 7 Cfr. J. SMITH, The papers of Pietro Sraffa at Trinity College, Cambridge, in Omaggio a Piero Sraffa… cit., cfr. nota 7: « Sraffa’s bibliographical interest were not confined to the purchase of books. He was active in the a manuscript market and built up a small collection representing many major figures in the History of economic thought. These manuscripts were for the most part, separated from the library and the working papers in the years after Sraffa’s death and catalogued as a discrete collection ». 8 Come scrive G. VACCA, Sraffa come fonte di notizie per la bibliografia di Gramsci, in Piero Straffa: contributi… cit., p. 43, n. 13: « Copia delle lettere di Labriola ad Angelo Camillo De Meis sono depositate presso l’Istituto Gramsci. Probabilmente queste copie furono chiesta da Giuseppe Berti a Sraffa per la preparazione delle celebrazioni, da parte dell’Istituto Gramsci per il cinquantesimo della morte di Labriola ». 9 Alcune lettere di Pantaleoni sono state pubblicate da MASSIMO M. AUGELLO, Dalla collezione di autografi di Piero Sraffa: tre lettere inedite di Maffeo Pantaleoni, in Omaggio a Piero Sraffa… cit., p. 265. L’autore fa cenno anche alle lettere di Rosolino Pilo e di Francesco Crispi. 308 Rosa Lucia Romano Le lettere di Rosolino Pilo, in particolare, sono contrassegnate dal codice B36/1-42. Le prime 28, datate tra il 1850 e il 1855, sono indirizzate a Francesco Crispi e contengono riferimenti sul processo Cassola, su articoli comparsi su il « Progresso » e sul « Risorgimento », sulla composizione del Comitato siciliano a Parigi, su una « presunta sollevazione in Palermo che (…) altro non produsse che 290 arrestati e 5 appiccati ». Il rapporto tra i due appare intenso e Pilo si interessa per far arrivare a Crispi giornali, libri e informazioni su comuni conoscenti. Nel documento contrassegnato dal codice B 36/22 Pilo informa Crispi di non aver trasmesso la lettera per mettere in contatto Kossuth con i patrioti siciliani perché non era convinto che questi ultimi fossero affidabili. I giudizi espressi su Garibaldi e Mazzini, oltre che su Luigi Orlando, Luigi Pellegrino e Pasquale Calvi potrebbero consentire agli studiosi di capire i motivi dei tentennamenti e dei ritardi nella spedizione in Sicilia: « se tenteranno un qualche movimento guidato da persone che non godono generalmente opinione d’uomini onesti non saranno seguiti dalla maggioranza, e quindi falliranno nell’intento ». Le altre 14 lettere datate tra il 1855 e il 1857, sono indirizzate al patriota modenese Nicola Fabrizi. Qui Pilo diventa meno prudente, forse anche per l’intensificarsi degli eventi, e parla di rivolte, di finanziamento delle imprese, di fucili spediti e addirittura « all’occorrenza [di] una rivoluzione ». Le lettere di Francesco Crispi a Rosolino Pilo contrassegnate con il codice B37, sono soltanto 7 e sono tutte del 1853, quando, dall’esilio di Malta, Crispi espone a Pilo le sue preoccupazioni e la necessità di coordinare gli sforzi: « bisogna parlare francamente con Mazzini e Kossuth, esporre la vera posizione delle cose, quello che bisogna fare, metterci tutti d’accordo ». Qualche giorno dopo però la speranza scema e prevale il pessimismo: Crispi esprime duri giudizi su Mazzini dal quale « non si possono avere che chiacchiere e dispiaceri », e sugli uomini da lui scelti; di Calvi dirà « vedi quindi di quali elementi si è serviti il Sig. Mazzini! Senza piano preventivo, senza idea preconcetta sul modo di organizzare il Paese (…) Calvi già si crede alla vigilia dalla presidenza, e che come sempre, all’odor del potere si ubriaca, mi rispose in modi così inconcludenti e strani, che ci volle la mia freddezza per non rompere decisamente (...) ». Evidentemente Crispi non si sbagliava su Calvi e, commentando la sommossa che sarebbe dovuta avvenire, dice: « la bomba calvinista avrebbe dovuto scoppiare ieri », ma sembra invece che gli autori dell’impresa, « invece di lanciarsi in un dubbio cimento, se ne fossero iti a Tunisi per mangiare comodamente il raccolto denaro ». ROSA LUCIA ROMANO Archivi dell’Università degli studi di Pisa « UN’ALTRA ITALIA NELL’ITALIA DEL FASCISMO ». UNA MOSTRA SUI ROSSELLI ALL’ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO * Vorrei soffermarmi brevemente su alcuni punti, utili alla conoscenza e alla comprensione delle scelte sottese al percorso espositivo e all’organizzazione del volume che accompagna la mostra. « Un’altra Italia nell’Italia del fascismo » è il titolo, ed anche il logo simbolico, che si è scelto per illustrare eventi, realtà e culture che corrono parallelamente, spesso intrecciandosi dialetticamente. Vicende, ideologie e culture relative ad una porzione rilevante dell’antifascismo, quella ruotante attorno ai Rosselli e al loro composito entourage socio-politico e culturale in Italia e all’estero. Un entourage costituito in massima parte dagli esponenti di una « grande borghesia », grande per il rigore morale, l’intransigenza antifascista, la solidità della formazione culturale, la forza di una tradizione consolidatasi in età liberale, spesso ancorata a radici risorgimentali. Quei valori di cui lo stesso Carlo Rosselli scriveva, riconoscendoli in molti di coloro che ne condividevano le idee: « disciplina spirituale, rigoroso abito morale, stoica indifferenza verso gli aspetti pratici e volgari della vita » 1. La scelta di questo titolo ha voluto anche fare riferimento all’intenzione di guardare alle vicende e ai valori di questo gruppo senza dimenticare eventi, ideologie e culture proprie dei loro antagonisti naturali: il governo e la classe * È questo il testo dell’intervento presentato dalla curatrice in occasione dell’inaugurazione della mostra. Cfr. anche il catalogo delle mostre organizzate dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze (14 maggio - 14 giugno 2002) e dall’Archivio centrale dello Stato (26 giugno 2002 - 31 maggio 2003) nell’ambito delle manifestazione promosse dal Comitato per le celebrazioni del centenario delle nascite di Carlo e Nello Rosselli: Carlo e Nello Rosselli. Catalogo delle mostre ed edizione di fonti, I, BIBLIOTECA NAZIONALE DI FIRENZE, Lessico familiare. Vita, cultura e politica della famiglia Rosselli all’insegna della libertà. Catalogo a cura di Z. CIUFFOLETTI e G. L. CORRADI. Mostra a cura di A. CALCAGNI ABRAMI, L. CHIMIRRI, G. L. CORRADI; II, ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Un’altra Italia nell’Italia del fascismo. Carlo e Nello Rosselli nella documentazione dell’Archivio centrale dello Stato. Mostra, catalogo ed edizione delle fonti a cura di M. GIANNETTO, Città di Castello (PG), Edimond; Roma, Direzione generale per gli archivi, 2002. 1 DELLO Lettera di Carlo Rosselli a Ferruccio Parri, Lipari, 23 feb. 1928, in ARCHIVIO CENTRALE STATO (d’ora in poi ACS), Carte Ferruccio Parri, sc. 221, fasc. « Rosselli Carlo ». Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 310 Marina Giannetto dirigente fascista. Una scelta, va sottolineato, scaturita naturalmente — se non addirittura imposta — da un ordine logico legato alla tipologia del patrimonio documentario conservato dall’Archivio centrale dello Stato, costituito da archivi istituzionali e da archivi privati di personalità di particolare rilievo nella storia del nostro paese. La ricerca dunque — ed è questo un altro punto fondamentale per comprendere le logiche che sono alla base dell’andamento della narrazione espositiva — ha presto trasceso l’oggetto specifico dell’indagine: Carlo e Nello Rosselli e la rete complessa di relazioni che li accompagnava all’interno di una porzione assai significativa del movimento antifascista. La ricerca ha finito ineluttabilmente per estendersi e per dare conto della organizzazione e dello sviluppo degli organismi deputati ad osservare, controllare, normalizzare, indirizzare, fino a reprimerle, le diverse forme di opposizione, se non di dissociazione, o anche solo di estraneità o diversità rispetto alle convenzioni e al conformismo delle culture, del linguaggio, degli stili di vita e delle prassi indotte dal regime fascista. Ne è scaturita l’esigenza di un quadro mosso da una dialettica in base alla quale la storia di Carlo e Nello Rosselli e di quanti li affiancarono è diventata, anche, in certo modo la storia dello sviluppo delle strutture repressive del dissenso o del non consenso: la storia di quegli organismi di informazione politica che attraverso i propri archivi hanno contribuito a sedimentare il ricordo, o meglio le tracce di vita — fino a consegnarcele in una loro artificiosa freschezza —, di quanti il regime intendeva neutralizzare, mettendoli in condizione di tacere, condannandoli, cooptandoli, sollecitandone talvolta le vanità o ricattandoli, corrompendone insomma la coscienza politica nell’intento di cancellarli fino ad eraderli dalla coscienza collettiva. Il lavoro di scavo documentario e la lettura di questa specifica categoria di documenti ha comportato e comporta perciò un problema metodologico fondamentale, quello dell’analisi critica delle fonti documentarie, della loro contestualizzazione, del loro confronto con altre fonti archivistiche e non, metodo imposto proprio dalla natura istituzionale dei soggetti produttori di gran parte della documentazione utilizzata. Tali organismi, seppure con modalità e prassi assolutamente differenti, utilizzavano fiduciarie provenienti da una imponente rete di informatori. E ci si riferisce al Ministero dell’interno, alle strutture create a supporto dell’azione di governo e a quelle deputate a gestire le politiche di controllo e orientamento dell’opinione pubblica e di organizzazione del consenso, quali la Segreteria particolare del duce e il Ministero della cultura popolare. L’utilizzo di queste specifiche fonti ha anche condizionato la scelta degli estremi cronologici delle vicende narrate. L’attività antifascista di Carlo e Nello Rosselli balzò, infatti, compiutamente all’attenzione degli uffici preposti ai servizi di informazione politica nel 1925-1926, e, dunque, è questa la data assunta come inizio del percorso espositivo. E qui occorre ricordare che il Carlo e Nello Rosselli nella documentazione dell’ACS 311 1926 fu l’anno in cui, per naturale contiguità e reazione, si perfezionò quel quadro normativo che costituì la base per la costruzione progressiva di un sistema capillare di controllo, prevenzione e repressione del dissenso politico sempre più evidentemente focalizzato contro due schieramenti: il Partito comunista e il movimento giellista. Proprio la tipologia documentaria utilizzata, frutto dell’attività di questa polizia — responsabile delle operazioni dirette a controllare l’attività dell’entourage ruotante attorno ai Rosselli e a sventare sin dal loro primo apparire i nuclei giellisti in Italia e all’estero — ci consente di rilevare quale fosse il livello di comprensione del complesso fenomeno delle opposizioni politiche da parte dei vertici politico-burocratici dell’Interno; questo è stato infatti uno degli obiettivi cui si è puntato, specie nella selezione dei documenti pubblicati: esaminare quale fosse la « cultura politica » che ne guidava le scelte e le strategie tanto da condizionare pesantemente l’attività delle opposizioni. È nota, almeno nei suoi aspetti formali e nei suoi snodi fondamentali — e a questo ha fatto riferimento Paola Carucci nel suo intervento per l’apertura della mostra — la storia legislativa e l’evoluzione degli uffici preposti ai « servizi di informazione e di sicurezza » repentinamente segnati dalla trasformazione della cultura giuridico-istituzionale avviata dal governo fascista. Il convincimento che nell’attività della polizia prevalessero « mansioni di carattere politico », e che questa fosse il « presidio dell’ordinamento sociale dalle insidie e dagli attacchi delle organizzazioni sovversive », fu alla base dei provvedimenti eccezionali adottati dal governo nel novembre 1926, culminati nell’introduzione della pena di morte, nell’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e nell’articolarsi di un imponente servizio informativo. E questi provvedimenti, insieme al nuovo Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — nelle parole del ministro dell’interno Luigi Federzoni — segnavano « una profonda e radicale trasformazione del diritto di polizia, secondo i principi etici, che informano la dottrina dello Stato Fascista » 2. In questo quadro, come ha rilevato Nicola Tranfaglia, « chi come Rosselli e alcuni amici de “Il Quarto Stato” credeva ancora alla possibilità e all’efficacia di un’opposizione clandestina in Italia ebbe nel novembre del 1926 il problema di dimostrare in qualche modo all’opinione pubblica che l’opposizione al regime non aveva cessato di esistere » 3, e ciò in un momento in cui l’organizzazione degli strumenti e degli organismi repressivi fascisti, seppure ben delineata, era agli inizi e non completamente operativa. 2 Circolare del ministro dell’interno, Luigi Federzoni, 5 set. 1925, n. 12982, in ACS, Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati (d’ora in poi MI, DGPS, AAGGRR), Atti diversi, b. 3, fasc. 28. 3 N. TRANFAGLIA, Carlo Rosselli dall’interventismo a Giustizia e Libertà, Bari, Laterza, 1968, p. 344. 312 Marina Giannetto Entro le coordinate legislative, politiche e istituzionali appena accennate, l’attività dei Rosselli in Italia e all’estero e quella del movimento di Giustizia e Libertà si sarebbe svolta parallelamente allo sviluppo dei servizi di informazione politica, contribuendo in maniera determinante — così come accadeva nel caso del Partito comunista — a stimolare l’ampliamento e ad affinare le tecniche di organismi come quello della Polizia politica, che avrebbe visto un salto di qualità nell’organizzazione e nelle strategie di intelligence dei servizi e dei fiduciari affermatosi compiutamente sotto la direzione del capo della polizia Arturo Bocchini tra il 1929 e il 1930, con l’avvio di un imponente servizio fiduciario in Italia e soprattutto all’estero. Gli archivi degli organismi della Direzione generale di pubblica sicurezza (degli Affari generali e riservati, della Polizia politica, dell’OVRA) hanno consentito di leggere e contestualizzare su di un piano politico-istituzionale gli scritti di Rosselli dell’esilio — gran parte dei quali rifluiti nell’edizione critica curata per l’Einaudi da Costanzo Casucci —, e anche le numerose corrispondenze scambiate con Pietro Nenni, Ferruccio Parri e Giuseppe Emanuele Modigliani, i cui archivi sono pure conservati dall’Archivio centrale. Oggi, la ricerca confluita nel percorso documentario inteso a ricostruire « un’altra Italia », oltre che sugli archivi appena accennati, poggia anche su un nuovo filone di indagine avviato dall’Istituto sulla attività della Polizia politica e sui suoi informatori. Il quadro che ne è emerso — da cui deriva una maggiore conoscenza dell’organizzazione e dei protagonisti dei sistemi informativi — ha consentito di riorientare l’analisi, mettendo in luce l’organizzazione interna del sistema e l’attività degli stessi fiduciari, informatori o spie, e quella del gruppo di funzionari della Polizia politica o dell’OVRA — i cui nomi ricorrono nei documenti esposti o pubblicati — che ne organizzarono la formazione e ne indirizzarono l’attività sulla base di precise politiche di intelligence finalizzate non solo alla conoscenza, al controllo e alla repressione del movimento cospirativo ma all’« orientamento » delle opposizioni attraverso un uso massiccio di agenti provocatori abilmente addestrati su specifiche strategie di infiltrazione e manipolazione. L’organizzazione di questo sistema informativo nasceva dalla consapevolezza che sull’organicità della sedimentazione documentaria e della circolazione dell’informazione poggiava l’efficienza degli organismi di PS, i cui archivi — con la stratificazione ininterrotta di carte di lavoro e di carte e corrispondenze capillarmente sequestrate o intercettate, accentuatasi con l’entrata in vigore nel 1927 del Testo unico che imponeva, per l’impennata dei servizi di polizia, una massiccia raccolta di dati — hanno appunto permesso di ricostruire, non solo dal lato eminentemente operativo, ma anche nei suoi contenuti culturali e ideologici, il ruolo fondamentale svolto da Carlo Rosselli nella lotta antifascista e il ruolo altrettanto significativo che svolsero il fratello Nello e molti di coloro che li affiancarono negli anni delle prime esperienze politiche, del confino e dell’esilio. Carlo e Nello Rosselli nella documentazione dell’ACS 313 Gli archivi creatisi nell’attività di osservazione e controllo svolta dal Ministero dell’interno hanno dunque conservato una pluralità di tracce di vita dei Rosselli. Tracce inerenti alla loro vita privata, alla formazione intellettuale, ideologica e politica, tracce, ancora, relative alla concreta attività politica e alla produzione scientifica ed editoriale. Venivano, infatti, puntualmente registrate dalla polizia talune tappe biografiche di Carlo, la militanza socialista, l’amicizia con Salvemini, la docenza universitaria a Milano nel 1923-1924, nell’Istituto di politica economica di Luigi Einaudi, e poi a Genova a fianco di Attilio Cabiati, l’aggressione subita da parte di un gruppo di giovani fascisti genovesi, il consolidarsi della rete amplissima di relazioni che lo avrebbe accompagnato nel 1926 nell’avviare l’esperienza e il gruppo de « Il Quarto Stato » e successivamente negli anni del confino e dell’esilio. Di Nello si segnalava l’adesione all’associazione repubblicana antifascista « Italia Libera », la collaborazione al « Non Mollare », gli stretti rapporti con esponenti di « partiti avanzati », Amendola e Bencivenga, le relazioni con Salvemini, Guglielmo Ferrero e Arturo Labriola, la svolta radicale imposta dal delitto Matteotti che lo rese « oppositore maggiormente accanito e violento » 4. E questo era anche il contesto più generale in cui maturava la clamorosa fuga di Sandro Pertini e Filippo Turati nel dicembre 1926, da cui prese le mosse la sequenza di eventi che, dall’arresto di Parri e Carlo Rosselli, avrebbe condotto al confino di Ustica nel 1927, al processo di Savona, all’esperienza importante del confino di Lipari nel 1928, sino alla fuga dall’isola dello stesso Rosselli, Lussu e Nitti in Francia nel luglio 1929, a compimento di quella maturazione intellettuale ed ideologica sfociata nel manoscritto di Socialismo liberale e nel progetto di costituzione di quello che sarebbe stato il movimento giellista. Nei casi appena accennati ci si è riferiti alle innumerevoli informative dei fiduciari, alle note, relazioni e corrispondenze dei funzionari di PS e all’epistolario relativo ai rapporti politici, culturali, scientifici e familiari dei Rosselli esposti in mostra e soprattutto pubblicati, che costituiscono solo una porzione limitatissima rispetto alla abbondanza di « tracce » raccolte dalla polizia nello svolgersi della loro esistenza. E qui occorre sottolineare come l’organizzazione dei servizi di informazione all’estero si misurasse con l’imponente e nuovo fenomeno del fuoruscitismo pronto a varare inedite forme di cospirazione politica, delle quali Bocchini intuiva la pericolosità, legate com’erano al diffondersi dell’« azione individuale », scarsamente controllabile, agile, spesso condotta indipendentemente dall’attività dei partiti, tale da richiedere l’uso massiccio di una ramificata rete confidenziale. « Quanto alla tattica da seguire — scriveva il capo 4 Relazione del prefetto di Firenze Giuseppe Regard, 7 giu. 1927, in ACS, MI, DGPS, AAGGRR, Casellario politico centrale, b. 4422, fasc. « Rosselli Sabatino ». 314 Marina Giannetto della polizia, delineando il tono generale dell’attività svolta in quella fase dal movimento antifascista all’estero — è agevole rilevare che le ambizioni, le gelosie reciproche, le differenti visioni programmatiche, i contrasti di interessi e, diciamo pure, il basso livello morale di molti, rendono questa massa antifascista divisa, rissosa, condizioni che possono essere abilmente sfruttate da un’azione oculata e prudente di incuneamento e di disgregazione, servendosi di accorti fiduciari ed emissari, nonché della stampa amica. Del resto, l’ostilità e la incompatibilità reciproca fra i comunisti da una parte e gli anarchici, repubblicani, socialisti e democratici-massoni dall’altra, sia in Francia, sia in Svizzera, è un fatto ormai assodato, vani sono riusciti finora gli appelli alla concordia per il fronte unico antifascista » 5. Si è detto che con il consolidarsi del sistema informativo — e ci riferiamo al biennio 1929-1930 — si perfezionavano le maglie della rete di controllo. Basti pensare alle fiduciarie minuziose sulle politiche del movimento giellista, sui rapporti dei suoi dirigenti con i partiti della Concentrazione e con i componenti dei nuclei via via sorgenti in Italia e in altri paesi, alle informative sul momentaneo disorientamento seguito allo scioglimento del cartello concentrazionista, e a quelle sulle idee, gli scritti, le prese di posizione, le iniziative, le relazioni, gli incontri, le curiosità intellettuali, le passioni e anche i momentanei avvilimenti di Carlo Rosselli. Basti pensare, ancora, ai rapporti epistolari di Nello — minutamente intercettati e trascritti dalla polizia — che raccontano le aspirazioni, le passioni e l’impegno intellettuale, il cammino delle ricerche storiche a Firenze, a Torino, in Germania e in Inghilterra, il farsi della sua produzione scientifica, dall’esperienza presso la Scuola di storia moderna e contemporanea di Gioacchino Volpe, al Bakunin, alle collaborazioni editoriali (e qui occorre ricordare Alessandro Luzio, la Massoneria e l’obiettività degli storici pubblicato sulle pagine de « Il Quarto Stato » nel maggio del 1926), al successo del Pisacane. Un epistolario che racconta, ancora, la gioia di vivere, la ricchezza di innumerevoli rapporti sociali e la vastità delle relazioni intellettuali, le collaborazioni con la « Nuova Rivista Storica » di Corrado Barbagallo, con Luigi Einaudi, il rapporto fecondo con Ferruccio Parri, Alessandro Levi e Guglielmo Ferrero, l’amicizia con Gina Ferrero Lombroso e con il figlio Leo, il prestigioso progetto per una « Rivista di storia europea del XIX secolo », attorno al quale Nello aveva finito per aggregare un’amplissima rappresentanza di studiosi e storici italiani e anche stranieri. Basti pensare, infine, alle corrispondenze intercettate che illustrano il mondo pubblico e privato di Amelia Rosselli, di Marion Cave, la moglie di Carlo, e di Maria Todesco, la moglie di Nello, i loro interessi, le letture, i viaggi, il rapporto con figli e nipoti, sino al dolore straziante del 9 giugno 1937 e alle prime esperienze maturate dopo l’approdo negli Stati Uniti, 5 Ibid., Segreteria del Capo della polizia, b.22, fasc. « Relazioni sul servizio della Direzione generale di pubblica sicurezza per l’anno 1928-1929 ». Carlo e Nello Rosselli nella documentazione dell’ACS 315 corrispondenze che illustrano, insomma, il loro stile di vita e tramite le loro parole la « vita » di Carlo e Nello. Come si è accennato, con il 1927 il percorso verso l’enucleazione e l’affermazione di autonomi istituti di polizia politica poteva dirsi concluso. Il TU di PS, l’istituzione del Servizio di investigazione politica, il pacchetto varato con le leggi eccezionali del novembre 1926 sanzionavano l’articolarsi del servizio di informazione politica attraverso una molteplicità di poli: la Divisione AAGGRR, gli ispettorati generali di PS (OVRA), la Divisione polizia politica, le prefetture e le questure, gli uffici politici del Partito nazionale fascista, delle Federazioni provinciali, dei Fasci comunali e rionali, gli Uffici politici del Comando generale della Milizia, dei Comandi di legione della milizia ordinaria e delle milizie speciali, il SIM, i Fasci all’estero, i Consolati italiani all’estero, la Segreteria particolare e l’Ufficio stampa del capo del Governo, il Servizio speciale riservato presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Tra il 1927 e il 1941 sarebbero state, inoltre, attivate 11 zone OVRA affidate a ispettori generali di « lunga durata », basti pensare a Francesco Nudi, preposto alla I Zona dal 1927 al 1937, e dunque tra i principali responsabili delle operazioni condotte contro i nuclei giellisti di Genova, Milano e Torino — città nella quale Nello Rosselli risiedette nel 1928 consolidando un’ampia rete di relazioni col mondo accademico torinese —, operazioni nel corso delle quali svolgevano un ruolo di primo piano informatori assai noti: Alberto Fistermacher, Carlo Del Re, Dino Segre e René Odin che, con Mario Fille, avrebbe operato lungamente a Firenze e soprattutto a Roma, entrando in relazione con Nicola Chiaromonte, stretto collaboratore di « GL » e interlocutore di Carlo Rosselli. Si pensi ancora a Giuseppe D’Andrea, a capo della II Zona dal 1930 al 1940, collaboratore importante delle operazioni appena accennate e responsabile delle indagini svolte contro il nucleo giellista sardo nei primi anni Trenta; ad Innocenzo Aloisio, preposto sino al 1939 al Nucleo di Firenze, afferente alla II Zona, e pertanto responsabile del controllo sulla famiglia Rosselli e sul vasto entourage familiare, culturale e professionale che la circondava (proprio a Firenze veniva intercettata la totalità della corrispondenza inviata ad Amelia e Nello ampiamente pubblicata nel catalogo ed esposta parzialmente in mostra); ad Edoardo Mormino, in Sicilia dai primi anni Venti, responsabile delle operazioni condotte sui più esigui nuclei giellisti operanti a Palermo, ove si distingueva Ugo Lombroso, collaboratore di « Giustizia e Libertà », la cui famiglia vantava legami fraterni con i Rosselli; a Dino Fabris, continuativamente in Sardegna dal 1937 al 1944. A questa rete occorre aggiungere Napoli, sottoposta al solo controllo della Questura, ove operava l’avvocato giellista Generoso Jodice e si svolgeva larga parte delle relazioni culturali di Nello Rosselli, in parte ruotanti attorno alla « Rassegna storica napoletana »: Ruggero Moscati, Adolfo Omodeo, Benedetto Croce, sino ad Aldo Romano, accurato informatore su Nello e sulla famiglia Rosselli. Marina Giannetto 316 La sedimentazione documentaria raggiungeva un picco nel corso degli anni Trenta. Allora i gruppi di cospirazione legati al movimento giellista si erano definitivamente imposti all’attenzione dei servizi di informazione politica. « Si è potuta sventare in pieno — scriveva nel 1930 il capo della polizia politica Michelangelo Di Stefano — prevenire e reprimere un’organizzazione delittuosa abilmente preordinata da taluni pericolosi esponenti del fuoroscitismo e precisamente dal Cianca, dal Berneri, dal Tarchiani, dal Chiodini, dal Sardelli ed altri minori. Costoro avevano organizzato attentati terroristici da compiere simultaneamente sulle strade ferrate, nella capitale in occasione del matrimonio del principe ereditario con la folle speranza di poter colpire anche il duce (…). La scoperta portò all’arresto del Cianca, del Berneri, del Tarchiani, del Sardelli, ed alla condanna dei primi due e portò per lungo tempo lo scompiglio nella organizzazione dei fuorusciti con conseguenze di cui tuttora si risentono gli effetti » 6. « Attraverso nostri abilissimi fiduciari — proseguiva la relazione — si è potuto addivenire alla scissione del Partito socialista ed alla creazione di un partito indipendente che osteggia e combatte la Concentrazione con effetti utilissimi. Moltissima parte del materiale di propaganda che i vari gruppi di fuorusciti, compreso il comitato GL inviano nel Regno (libelli, giornali, manifesti) sono stati sottratti alla circolazione, essendosi potuto costituire dei centri fiduciari riceventi che i fuorusciti ritenevano e ritengono loro affiliati ». Basti ancora ricordare, tra gli episodi più noti: gli arresti del nucleo milanese, « gli intellettuali » facenti capo a Riccardo Bauer, Ernesto Rossi e Umberto Ceva, in cui incappava anche Ferruccio Parri, interlocutore privilegiato di Carlo e Nello Rosselli; le indagini sulla attività di individui, gruppi o nuclei comunque legati al movimento, alla quale si contrapponeva l’attività febbrile di agenti provocatori infiltrati tra le fila dell’antifascismo; gli arresti a Torino di Mario Andreis e del gruppo ruotante attorno a Mario Levi e, ancora, le operazioni contro il gruppo della rivista « La Cultura » di Giulio Einaudi, cui facevano capo, tra gli altri, Cesare Pavese, Augusto Monti, Barbara Allason, Leone Ginzburg e Carlo Levi. « Attraverso l’azione di nostri fiduciari all’estero — proseguivano le relazioni della Polizia politica — sono stati alimentati e acuiti i dissidi già provocati fra i vari gruppi di fuorusciti e la campagna di taluni di questi gruppi contro la Concentrazione antifascista, sottratti alla circolazione moltissimi materiali di propaganda, fra cui quelli di Giustizia e Libertà » 7. Nel settembre 1925, nella fase in cui si elaborava il TU delle leggi di pubblica sicurezza, il ministro dell’interno Luigi Federzoni, delineando gli orientamenti e i caratteri della cultura giuridica cui si ispirava il « nuovo 6 Ibid., per gli anni 1929-1930. 7 Ibid., per gli anni 1930-1931. Carlo e Nello Rosselli nella documentazione dell’ACS 317 diritto di polizia », annunciava il radicale cambiamento istituzionale avviato dal governo. « La conquista del potere politico da parte della nuova generazione della guerra e della Vittoria non poteva limitarsi alla semplice formazione di un Ministero nuovo, sia pure forte e duraturo — scriveva Federzoni — ma doveva esprimere, nella creazione di un nuovo diritto, la nuova coscienza di potenza e di disciplina che la Nazione si era formata, appunto, attraverso il duro sacrifizio della guerra e lo sforzo eroico della Vittoria ». « Ora il vigore politico del Governo nazionale — proseguiva il ministro — si esprime nella creazione di un nuovo diritto pubblico e privato, che porta, pur nella diversità delle sue varie norme, l’impronta unitaria che gli deriva dalla rinnovata coscienza della forza e della dignità dello Stato, non più inteso come la creazione contingente dell’arbitrio individuale o di gruppi, ma come l’espressione e la creazione più alta della volontà di vita e di potenza della Nazione. Il nuovo diritto di polizia deve esprimere, appunto, questa rinnovata coscienza etica e giuridica del Paese. Per far ciò occorre liberarsi dagli ultimi residui di vecchi abiti mentali e da pregiudizi troppo a lungo conservati. La polizia della Nazione rinnovata non deve essere guardata col vecchio occhio miope dell’individualismo atomistico e liberaloide e agli organi di sicurezza occorre riconoscere capacità organiche di potere e autonomia di azione e di esecuzione, nell’ambito del diritto obbiettivo » 8. Sul fronte delle opposizioni — ove si moltiplicavano i fiduciari addetti al controllo dei Rosselli e di « Giustizia e Libertà » rigidamente manovrati dai vertici dei servizi politici e ai quali si deve una produzione massiccia di informative (Romolo Gabrieli, magistrato dell’Ufficio indagini dell’Alto commissariato aggiunto per la punizione dei delitti, ne avrebbe contati 42, ignorandone una gran quantità) — si aveva piena consapevolezza dei cambiamenti istituzionali appena accennati e della cultura che vi era sottesa, entrambi lucidamente inquadrati da Carlo Rosselli nelle martellanti analisi complessive delle politiche del fascismo instancabilmente pubblicate su « Giustizia e Libertà » e sui « Quaderni di Giustizia e Libertà ». In realtà, di questo imponente apparato informativo, reiteratamente denunciato dalle opposizioni nei propri organi di stampa, Rosselli ne faceva anche un successo politico e strategico, secondo le linee di un processo dialettico per il quale ciascuno degli attori finiva per cogliere il senso della propria forza e in certo qual modo per riorientare il proprio ruolo e la propria attività grazie anche alla presenza, alle azioni e reazioni dell’altro. E, anzi, se l’anarchico Camillo Berneri, guardando al fenomeno degli informatori e degli agenti provocatori del fascismo, coglieva gli aspetti di « un dramma tragicamente rappresentativo dei tormenti e delle insidie dell’esilio » 9, 8 9 ACS, MI, DGPS, AAGGRR, Atti diversi, circolare di Federzoni del 5 set. 1925 citata. C. BERNERI, Lo spionaggio fascista all’estero, Marsiglia, ESIL (Pagine dell’Italia libera, 3), s.d. [ma 1933]. 318 Marina Giannetto Rosselli, nell’editoriale intitolato Il movimento di « Giustizia e Libertà » comparso sulle pagine de « La Libertà » del 27 ottobre 1932, tracciando il bilancio di un triennio di attività, ne scriveva come nel Diario di un combattente, quasi a delineare il compimento di un ciclo apertosi proprio con la fuga da Lipari: « Lo scompiglio è stato portato nel campo nemico — denunciava Rosselli — La tirannide non spende oggi meno di un miliardo e mezzo per la sua polizia, interna ed estera (…). Il regime si proclama sicuro, ma paventa tradimenti, sorprese, audacie, colpi di mano, sommosse improvvise (…). Contribuire a creare nel campo fascista allarmi falsi o veri, a creare fra i detentori della tirannide la psicologia di una banda di briganti che si senta costantemente minacciata di perdere il frutto delle rapine compiute, esasperare la situazione e impedire ogni ritorno a una normalità vile e miserabile, foriera di compromessi e bassezze, è fare cammino verso la rivoluzione ». MARINA GIANNETTO Archivio centrale dello Stato EDUARDO DE FILIPPO: UN ATTORE IMPRESARIO E IL SUO ARCHIVIO ∗ 1. Eduardo: un artista capocomico. — « Diciamo di solito che per l’uomo la nascita è il punto di partenza e la maturità il punto d’arrivo. Io l’ho sempre visto rovesciato questo concetto e cioè la nascita per l’uomo è il punto di arrivo su questa terra. Quello che egli realizza nel corso della sua vita, da adulto e la immancabile morte è il punto di partenza per quelli che vengono dopo di lui, i giovani (...). La vita che continua è tradizione (...). Certo se ci si ferma al passato diventa un fatto negativo, ma se ce ne serviamo come trampolino di lancio, salteremo più in alto che se partissimo da terra ». Ecco in poche parole la concezione della vita di Eduardo De Filippo, uno dei più grandi autori di teatro, uno dei più straordinari attori che il secolo appena trascorso ci abbia regalato 1. Eduardo de Filippo nasce a Napoli il 24 maggio 1900. La madre, Luisa De Filippo, è figlia di Luca, un modesto commerciante di carbone, il padre è uno degli autori ed attori più famosi in quel periodo, Eduardo Scarpetta. I due non sono sposati 2: dal loro rapporto nascono nel 1898 Annunziata (Titina), due anni dopo Eduardo e nel 1903 Giuseppe (Peppino), tre fratelli destinati ad essere attori tra i più grandi del teatro italiano. Eduardo debutta a soli sei anni: è un giapponesino nella parodia di un’operetta di Sidney Jones, La geisha. Inizia presto la sua gavetta teatrale, nella compagnia del fratellastro Vincenzo ma non si ferma: il teatro lo attira in tutte le sue sfaccettature. « Oggi nascono degli attori che potrebbero essere grandissimi, ma la maggior parte diventano svogliati, perché spesso non amano il lavoro che fanno, lo fanno così per routine, per un fatto abitudinario, ∗ Il presente lavoro costituisce una sintesi della tesi di diploma discussa presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università degli studi di Roma « La Sapienza », relatore il prof. Giovanni Paoloni. 1 Seminario all’Istituto del Teatro dell’Università di Roma, Teatro Ateneo, 4 aprile 1981, in « Biblioteca Teatrale », 1981, n. 27, p. 11. 2 Luisa ha venticinque anni in meno di Scarpetta ed è nipote della moglie di questi Rosa. Eduardo e Rosa hanno tre figli: Domenico (in realtà riconosciuto da Scarpetta ma frutto di un incontro di Rosa con il re Vittorio Emanuele II), Vincenzo, Maria (anche lei nata da una relazione di Scarpetta e riconosciuta da Rosa). Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 Maria Procino 320 come al servizio di certi registi. Noi sì che eravamo contenti quando battevamo la montagna, la campagna, quando recitavamo per le strade » 3. Nel settembre 1915 Eduardo è nella « Comica Compagnia Napoletana del Comm. Eduardo Scarpetta » diretta da Vincenzo Scarpetta. Fa la parte di una guardia nella parodia dell’opera La Bohème; nella compagnia recitano Vincenzo, Maria Scarpetta, Titina ed attori come Agostino Salvietti e Giuseppe Maiuri, che verranno scritturati più tardi nella ditta dei tre De Filippo. La gavetta teatrale del giovane De Filippo continuerà anche in altre formazioni: quella di Enrico Altieri, che porta in scena drammi popolari e farse, quella di Peppino Villani, attore di café-chantant, e nella compagnia italiana di Luigi Carini. Nel 1917 Titina, Eduardo e Peppino si ritroveranno insieme proprio nella compagnia di Vincenzo Scarpetta. Nel 1920 il servizio militare a Roma, nella 2 ª Compagnia bersaglieri di Trastevere. Eduardo è già un attore affermato a tal punto che in caserma dirige una piccola compagnia con grande successo. L’idea però è quella di creare una compagnia propria insieme ai fratelli: nel 1929 i tre De Filippo formano la prima impresa indipendente « Ribalta Gaia »; seguirà « Il Teatro umoristico di prosa », « La Compagnia di sketch umoristici di Eduardo De Filippo con Titina e Peppino », e infine nel 1931 « Il Teatro Umoristico », divenuta poi « Il Teatro Umoristico. I De Filippo ». Non sono soli, accanto a loro due amici, due professionisti del mondo teatrale, Guido e Carlo Nobile, in arte Argeri. I fratelli Nobile erano esperti di teatro: figli di un tipografo-editore napoletano, uno dei primi che insieme ai Fratelli Razzi 4 si era occupato di teatro ai tempi del café-chantant. Guido e Carlo erano praticamente cresciuti all’ombra del futurismo ed interessandosi di canzoni ma anche delle nuove tendenze e dei nuovi movimenti del mondo artistico dell’epoca. Guido fu giornalista, direttore della rivista « Eldorado » e dal 1924 del « Café-Chantant »; scopritore di talenti, conobbe Elvira Donnarumma e lavorò con lo stesso Petrolini. Scrittore di novelle e autore di canzoni, fu rappresentante di quell’agenzia teatrale Campanile-Chimenti-Argeri che si occupò dei tre De Filippo all’inizio degli anni Trenta. Quasi logico fu dunque il suo seguire i De Filippo insieme al giovane fratello Carlo, che restò un fedelissimo ed intelligentissimo amministratore anche dopo la morte di Guido avvenuta nel 1962. Carlo fu accanto ad Eduardo fino agli anni Ottanta, morì nel 1994. 3 4 Seminario all’Istituto del Teatro…, p. 11. I fratelli Razzi, Francesco ed Enrico, erano stati, a Napoli, editori della rivista « NapoliEden », pubblicata dal 1897 al 1899. Dal 10 febbraio 1900 si occuparono di una nuova rivista « Il Café-Chantant », fino al 1924, quando furono sostituiti nella direzione da Guido Argeri, Alfredo Chimenti, Arturo Campanile. Eduardo De Filippo e il suo archivio 321 Il 1° giugno 1931 il debutto della nuova ditta al cinema-teatro Kursaal Principe (oggi Filangieri): si va in scena con ’O chiavino, un atto di Carlo Mauro. Insieme ai De Filippo, Pietro Carloni, Alfredo Crispo, Carlo Pisacane. Arriveranno poi Dolores Palumbo, Tina Pica, Agostino Salvietti. Nel 1932 il debutto a Torino al Politema Chiarella: il « Teatro Umoristico » conquista l’Italia 5. Di quest’anno è anche il debutto cinematografico di Eduardo e Peppino in Tre uomini in frac, regia di Mario Bonnard, protagonisti Tito Schipa e Assia Noris. Nel 1936 i due De Filippo costituiscono un’impresa capocomicale che elegge come sede Napoli, la direzione ed il capocomicato sono affidati ad Eduardo mentre Peppino ha la responsabilità amministrativa. I tre De Filippo sono seguiti ed amati: i borderò del « Teatro Umoristico » parlano del grande successo ma evidenziano anche tournée lunghe e senza giorno di riposo. « Non si riposano sugli allori. La sera recitano, il pomeriggio provano e la mattina, rubando le ore al sonno, scrivono commedie » 6. La corrispondenza di questi anni segnala la quantità e la varietà dei rapporti: per esempio scrittori e attori che chiedono di veder recitate le loro opere dai tre fratelli. Ma lavorare vuol dire anche per tre grandi nomi come sono ormai i De Filippo, dialogare e confrontarsi con le istituzioni deputate a regolamentare e controllare il teatro ed in genere il mondo dello spettacolo. La corrispondenza testimonia i rapporti con l’UNAD 7, per esempio, con l’Ispettorato del teatro poi Direzione generale 8, direttore Nicola De Pirro, con l’Ufficio censura teatrale, a capo del quale era Leopoldo Zurlo 9, con la potente Federazione nazionale degli industriali dello spettacolo. 5 Il repertorio comprende tra le numerose commedie anche: Natale in casa Cupiello, L’ultimo bottone, La voce del padrone, Gennareniello, Quei figuri di trent’anni fa di Eduardo De Filippo; Quale onore, Caccia grossa, Cupido scherza e spazza, Aria paesana, Spacca il centesimo, Una persona fidatissima, di Peppino, ed atti unici di Maria Scarpetta. 6 L. RÈPACI, Umorismo tragico dei De Filippo, in « Scenario », 8 agosto 1940. 7 L’UNAD, Unione nazionale dell’arte drammatica (poi UNAT, Unione nazionale dell’arte teatrale) era l’unica agenzia di mediazione riconosciuta dallo Stato e voluta dagli industriali dello spettacolo, il mediatorato privato infatti verrà proibito. 8 Nel 1934 con r.d. 6 sett. n. 1434, viene istituito il Sottosegretariato per la stampa e propaganda; il successivo r.d.l. 1° apr. 1935, n. 327, crea l’Ispettorato del teatro alle dipendenze del Sottosegretariato. Con r.d. 24 giu. 1935, n. 1009 il Sottosegretariato viene poi trasformato in Ministero e l’Ispettorato assorbito dalla Direzione generale del teatro. In seguito con r.d. 27 mag. 1937 n. 752 il ministero assumerà la denominazione di Ministero della cultura popolare. 9 Per quanto riguarda la censura preventiva, negli anni del fascismo vige il Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con r.d. 18 giu. 1931, n. 773. Con l’istituzione dell’Ispettorato del teatro, la competenza in materia di censura sugli spettacoli, fino ad allora gestita dal Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, e affidata in quegli anni al prefetto del Regno, Leopoldo Zurlo, passa all’Ufficio censura teatrale, gestito sempre da Zurlo. Due copioni vengono presentati all’ufficio, uno di questi è rilasciato alla compagnia munito di nulla osta ministeriale. 322 Maria Procino Nel 1945 la separazione: Eduardo organizza la sua compagnia, Peppino è scritturato dalla compagnia Villi-Brazzi-Sordi e recita, durante la stagione romana, nella rivista Imputati... alziamoci! di Michele Galdieri. Dopo questa esperienza organizzerà la sua compagnia: la « Compagnia Peppino De Filippo », che diverrà poi « La compagnia del Teatro Italiano Peppino De Filippo ». Mette in scena Non sei mai stato così bello, di Nelli e Mangini 10. Recita all’Olimpia di Milano il 24 agosto 1945 con I casi sono due. Eduardo dal canto suo creerà la « Compagnia Teatro Napoletano di Eduardo » 11. Il 25 marzo 1945 al Teatro San Carlo di Napoli va in scena Napoli Milionaria! con Titina; dietro le quinte l’insostituibile Guido Argeri. Nel 1947 la ditta sarà « Il teatro di Eduardo con Titina de Filippo », infine « Il teatro di Eduardo », impresa con la quale l’artista percorrerà altri trent’anni. Nel 1977 poi il capocomicato passerà al figlio Luca. Ma torniamo agli anni Quaranta: il successo continua e dopo Napoli Milionaria! Eduardo mette in scena Questi fantasmi! e Filumena Marturano, che debutta a Napoli il 7 novembre 1947 12. Nel dopoguerra si continua a parlare di crisi del teatro: le speranze di un totale rinnovamento sono ormai già lontane. Sono cambiati i referenti 13 ma i dirigenti non cambiano, le leggi restano sostanzialmente le stesse ed il teatro sarà regolato da sovvenzioni e censura 14. 10 Nell’Archivio Eduardo De Filippo di Napoli, nella serie Teatro San Ferdinando è conservato un fascicolo riguardante le spese (marzo-aprile 1945) della « Compagnia Peppino de Filippo » - gestione Cogliati-Dezza-Paone, per l’allestimento scenico della rivista Non sei mai stato così bello!, amministratore: Carlo Argeri. Tra gli attori: Clelia Matania, Amedeo Girard, Mario Riva, Mario Maresca. (AEDF, TSF, b. Peppino de Filippo, fasc. Non sei mai stato così bello, 1945). 11 La censura modificherà il titolo in Non sei mai stata così bella!. La compagnia sarà formata da Dolores Palumbo, Tina Pica, Giovanni Amato, Pietro Carloni, Vittoria e Clara Crispo, Enzo Donzelli e Rosita Pisano. 12 « Non è detto che il riconoscimento sia stato subito unanime (…) non a tutti i nostri letterati garbava riconoscere un posto d’onore a uno che veniva dalla gavetta, dall’artigianato, dal mestiere. Furono costoro a ripetere l’ammonimento che si trattava di un artista geniale ma le cui opere rimanevano (…) legate indissolubilmente alla persona di chi l’aveva concepite sulla propria misura (…) quelle commedie (…) varate da Eduardo e da Titina, in un secondo momento si staccarono dalle loro persone, dalla loro mimica, dal loro dialetto: furono ascoltate e ammirate alla radio, e in lingua italiana, e nella lingua d’altri paesi ». S. D’AMICO, Cantata dei giorni dispari. Eduardo De Filippo autore drammatico, in « Scenario », 1°-15 giugno 1951. 13 Il Ministero della cultura popolare viene soppresso con d. lgt. 3 lug. 1944, n. 163 con il quale è istituito il Sottosegretariato per la stampa e le informazioni alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel 1948 i servizi stampa, spettacolo e turismo sono definitivamente affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri: il d.lg. 8 apr. 1948, n. 274 definisce la sistemazione dei servizi e del neonato Commissariato per il turismo. Nascono la Direzione generale dello spettacolo, il Servizio delle informazioni e l’Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica. Nel 1959 con la l. 31 lug., n. 617 verrà istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo soppresso dopo un referendum popolare con d. lg. 4 ago. 1993, n. 273. 14 Nel dopoguerra resta in vigore il T.U. del 1931 ma la situazione diventa ancora più difficile per tutto il settore dello spettacolo: due esemplari dattiloscritti del copione devono essere Eduardo De Filippo e il suo archivio 323 Nel 1948 Eduardo inizia il rapporto con la casa editrice Einaudi, che porterà alla pubblicazione di Napoli Milionaria per la « Piccola biblioteca scientifico-letteraria » e poi alla pubblicazione della sua opera con il titolo: La Cantata dei giorni pari e la Cantata dei giorni dispari 15. Nel 1949 Eduardo aderisce alla SIAD (Società italiana autori drammatici); si intensificano i suoi contatti con l’estero e numerosissime sono le richieste per tradurre o portare in scena sue commedie. Si occuperà anche di cinema non solo come attore e regista ma anche tentando coproduzioni: così dopo l’avventura della DeFilm 16, dopo l’Arco Film, sarà la volta della San Ferdinando Film che produrrà sei telefilm insieme alla RAI e Questi fantasmi! in associazione con la Titanus di Goffredo Lombardo. Il 1948 è un anno importante soprattutto per l’acquisto dell’antico Teatro San Ferdinando di Napoli o per meglio dire per l’acquisto delle macerie 17. Sei milioni il prezzo, 350 milioni il costo della ricostruzione. Il progetto San Ferdinando è nella mente di Eduardo un punto di partenza per creare in quegli anni difficili un’azienda attiva che servisse da elemento propulsore per una delle zone più povere della città. Invece le forze politiche lo lasceranno solo e leggi e burocrazia si trasformeranno in ostacoli insormontabili 18. Dovrà presentati alla Presidenza del Consiglio, Direzione generale dello spettacolo, Ufficio censura teatrale (dal 1960 Ministero del turismo e dello spettacolo, Direzione generale dello spettacolo) per avere il visto della censura, sentito il parere di una commissione di prima istanza. Ottenuto il nullaosta, il prefetto o l’autorità di pubblica sicurezza possono comunque sospendere lo spettacolo. La censura preventiva sul teatro viene abolita nel 1962 con l. 21 apr., n. 161 e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 11 nov. 1963, n. 2029; resta, come intervento preventivo, quello relativo all’ammissione dei minori di 18 anni agli spettacoli. Rivista, commedie musicali, avanspettacolo e opere cinematografiche restano soggette al nullaosta. Rimane invariato per l’intero settore il permesso di agibilità rilasciato dal Ministero ai sensi del d.c.g. 14 feb. 1938, n. 153. Sull’argomento cfr. V. BRANCATI, Ritorno alla censura, Bari, Laterza, 1952; C. DI STEFANO, La censura teatrale in Italia, Bologna, Cappelli, 1964; A. CIAMPI, Verso l’abolizione della censura teatrale, in « Il Corriere della sera », 2 gennaio 1962; M. CESARI, La censura nel periodo fascista, Napoli, Liguori, 1978; M. QUARGNOLO, La censura ieri e oggi nel cinema e nel teatro, Milano, Pan, 1982; N. FANO, Tessere o non tessere, Firenze, Liberal libri, 1999. 15 « I giorni pari erano quelli che credevamo sereni. Li credevamo, bada, era un’illusione », chiarisce Eduardo nell’intervista rilasciata a Roberto de Monticelli, Eduardo imprendibile scappa sempre via dal suo gran monumento, in « Corriere della sera », 24 maggio 1980. 16 Casa di produzione cinematografica creata nel 1938 in società con Peppino. 17 « Fu un atto che non esito a definire coraggioso, audace, perché, per costruire su quelle rovine uno dei più moderni e razionali teatri italiani, dovetti affrontare allora e sostengo tutt’oggi gravi sacrifici ». Così Eduardo nell’intervista rilasciata a Riccardo Longone, La parola ad Eduardo De Filippo, in « L’Unità », 27 settembre 1959. 18 « Naturalmente per l’inaugurazione invitai il ministro, il sottosegretario, il direttore generale De Pirro e i più alti funzionari della Direzione Generale dello Spettacolo. Mi aspettavo che, attraverso la loro presenza essi avrebbero avuto piacere di congratularsi con un attore che aveva dimostrato il suo grande amore per il teatro, impiegando i suoi sudati risparmi non nell’acquisto di ville e di automobili, ma nella ricostruzione di un locale distrutto dalla guerra. Può sembrare Maria Procino 324 chiedere finanziamenti alle banche alle quali andranno per molti anni tutti i suoi guadagni compresi i diritti d’autore. Per occuparsi della ricostruzione del teatro Eduardo non forma compagnia né per la stagione 1951-1952, né per la successiva 19. Il San Ferdinando conserva all’esterno l’architettura dell’antico stabile settecentesco ma all’interno la struttura, il palcoscenico, ne fanno uno dei teatri più moderni degli anni Cinquanta. I camerini del teatro sono spaziosi, su ogni piano telefono, bagni, docce, altoparlanti per ascoltare la recita dal camerino; particolare attenzione Eduardo ha rivolto alla realizzazione del palcoscenico. Se il boccascena con il suo sipario di velluto rosso si allunga per dieci metri, il palcoscenico, oltre i dieci metri della scena misura ancora dieci metri dietro le quinte ed è profondo sei metri e mezzo. « Il palcoscenico, ampio in lunghezza, profondità ed altezza, sarà dotato di tutti gli accorgimenti antichi e moderni dei vecchi e provati macchinisti, i Mercurio » 20. Cinquecentocinquanta i posti in platea, 150 posti nei palchetti ed in alto il loggione con 300 posti. « Il palcoscenico del teatro San Ferdinando è ampio e bianco di calce fresca — racconta Paolo Ricci — a un lato del palcoscenico vi è una grossa ruota dentata, con ingranaggi di legno ed altri complicati congegni: si tratta probabilmente di un argano che suggerisce a Georges Sadoul, che è con noi, il ricordo di Piranesi. Eduardo parlava del suo teatro come di una cosa viva, reale. Diceva: farò il palcoscenico così e così. Impianterò la scenografia (...). Oggi che lo visitiamo a lavori compiuti insieme a Valentine Tessier e a Georges Sadoul e sua moglie Ruta il sogno di Eduardo è divenuto realtà » 21. Il 20 gennaio 1954: prova generale di Palummella zompa e vola di Antonio Petito, opera con la quale si aprirà il 22 gennaio la prima stagione teatrale del San Ferdinando. Oltre alla compagnia « Il Teatro di Eduardo », De Filippo formerà « La Scarpettiana » 22, che durerà fino al 1961 per poi essere riorganizzata nel 1966-1967. incredibile ma quella sera non si fecero vedere » (R. LONGONE, La parola ad Eduardo De Filippo… cit.). 19 « Lascia credere volentieri che da un momento all’altro la maggior parte delle sue giornate potrebbero essere assorbite dal cinema e che tra un anno il tempo libero da impegni cinematografici gli servirà per mandare avanti il teatro in corso di costruzione a Napoli » (R. RADICE, La cantata di Eduardo, in « L’Europeo », 8 aprile 1951). 20 E. DE FILIPPO, Confidenze, in « Gazzetta del Lunedì » (Genova), 12 marzo 1951. 21 P. RICCI, Un De Filippo inedito per il teatro di Eduardo, in « Vie Nuove », 11 ottobre 1953. 22 La compagnia « La Scarpettiana » metterà in scena il repertorio di Scarpetta: debutterà il 30 settembre 1955 con ’A nanassa. Vi recitano attori come Pupella Maggio, Pietro De Vico, Ugo D’Alessio e Franco Sportelli. Eduardo De Filippo e il suo archivio 325 Nel 1961 registra il primo ciclo di commedie per la Tv, nel 1963 un secondo ciclo, seguito poi, nel 1974, dall’ultima collaborazione con la Rai per due cicli di commedie, di cui il primo comprenderà opere scarpettiane e l’altro opere del suo teatro dal Sindaco del Rione Sanità a Natale in casa Cupiello. Nel 1955 rappresenterà l’Italia a Parigi al 2° Festival d’art dramatique, nel 1960 sarà ancora a Parigi con il Pulcinella di Pasquale Altavilla; nel 1962 una tournée in Russia, Germania occidentale, Ungheria, Polonia, e nel 1972 in Gran Bretagna. Nel 1958 Eduardo viene interpellato per dirigere il Teatro Stabile della Città di Napoli: si apre così una querelle destinata a durare per anni; perderà la battaglia contro politici e burocrati che lui stesso definirà « sprovveduti a decidere le sorti di una iniziativa tanto importante per la cittadinanza napoletana » 23. Nel 1961 il San Ferdinando chiude i battenti, riapre nel 1964 con una nuova società, la « Teatrale Napoletana », frutto della collaborazione con Paolo Grassi, direttore del Piccolo Teatro di Milano. Ancora crisi negli anni Sessanta e non trova soluzioni radicali. Il teatro è destinato a morire? « Dicono in molti che il teatro è morto. È un coro di rane. Il teatro è sopravvissuto per secoli ad ogni crisi, ad ogni involuzione, ad ogni aberrazione. Perché dovrebbe morire proprio oggi? Secondo me, dovrebbe tornare ad essere umile, onesto e libero; esattamente il contrario, cioè, di quello che è adesso » 24. Eduardo è autore, attore, regista ma anche capocomico ed impresario, esplora il teatro in tutte le sue sfaccettature ma si occupa anche di cinema, lirica, televisione, poesia. Continua però ad essere un personaggio scomodo, amato dal pubblico ma meno da molti dei suoi interlocutori 25. 1980: un nuovo progetto si realizza, una Scuola di drammaturgia a Firenze. Il 24 maggio Eduardo festeggia gli ottant’anni a Milano, in palcoscenico, con tre atti unici: Gennareniello, Dolore sotto chiave, Sik-Sik, l’artefice 23 E. DE FILIPPO, Introduzione a Pulcinella che ba’ truvanno ’a furtuna soia pe’ Napule, Napoli, Edizioni Teatro San Ferdinando, 1958, p. 8 24 25 S. LORI, Teatro o moneta falsa. Intervista a Eduardo, in « Il Dramma », dicembre 1972. « Forse il peccato che, inconsciamente, la cultura italiana gli ha fatto scontare è quello di aver rotto schemi di comportamento, scavalcato barriere professionali e di categoria, superato confini culturali, procedendo in modo del tutto personale e libero, senza però assumere quel piglio rivoluzionario o quegli atteggiamenti da veri o falsi maîtres à penser (…). Il grande successo di pubblico, che in qualunque altro paese sarebbe stato considerato un titolo di merito per un uomo di teatro, in Italia è stato guardato dai settori più snobistici della cultura con diffidenza » P. QUARENGHI, Vicoli stretti e libertà dell’arte, introduzione a Eduardo De Filippo. Teatro. 1. Cantata dei giorni pari, a cura di P. QUARENGHI e N. DE BLASI, Milano, Mondadori, 2000, pp. XII-XIII. Maria Procino 326 magico. Decide di smettere di recitare. All’inizio di ottobre incomincerà a curare la regia di La donna è mobile, lo spettacolo di Vincenzo Scarpetta con il quale debutterà a Firenze « La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo », il 17 gennaio 1981. Dopo il terremoto nell’Irpinia del 23 novembre, Eduardo promuove una conferenza stampa al Teatro Quirino di Roma per la raccolta di fondi in favore delle zone colpite. Inizierà un periodo di recital, alcuni con Carmelo Bene. Inaugura un corso di drammaturgia all’Università di Roma, che proseguirà fino al 1983. Sempre nel 1981 riceve dal presidente della repubblica Pertini la nomina a senatore a vita: non perde tempo, e nel suo primo intervento al Senato introduce il problema dei minori « deviati » e rinchiusi nelle carceri e si batte con successo affinché vengano considerati non come normali delinquenti ma per quello che sono: « le vere vittime di una società carente come la nostra nei riguardi della gioventù » 26. E dei ragazzi si occuperà fino alla fine, progettando un villaggio dove possano studiare ed imparare un mestiere, incoraggiandoli nelle sue visite al carcere minorile Filangieri di Napoli ed al carcere minorile dell’isola di Nisida, dove nascerà un laboratorio di scenografia. All’inizio del marzo 1983 comincia a registrare La tempesta di Shakespeare da lui tradotta in napoletano seicentesco: Eduardo dà la voce a tutti i personaggi maschili, l’attrice Imma Piro sarà la voce di Miranda. Il 26 ottobre 1984 viene ricoverato, muore il 31 ottobre. « Riassumere una vita artistica tanto lunga e piena di avvenimenti (…) non è una cosa facile: tutto sembra importante eppure niente pare indispensabile, nel proprio passato, tanto che a un certo punto non si riesce a capire se si è detto troppo o troppo poco. Forse è perché l’unica cosa che conta veramente nella vita di un artista è il futuro, e il passato, a insistervi a lungo, limita la creatività e la voglia di essere creativi » 27. Scriverà di lui Federico Fellini: « Questo è oggi Eduardo, per me: una di quelle presenze che hanno raggiunto una dimensione miracolosa, fatata, una statura ed una leggerezza che lo pongono fuori dal contingente. Eduardo crea, al suo apparire in palcoscenico, una sorta di lieve vertigine magica: non si sa neanche se è veramente in scena oppure siamo noi che lo portiamo dentro » 28. 26 Atti parlamentari, Senato della Repubblica, legislatura VIII, tornata del 23 marzo 1982, 389 ª seduta, interpellanza presentata da Eduardo De Filippo Sul funzionamento dell’Istituto Filangieri per la rieducazione dei minori, pp. 20885-20891. 27 E. DE FILIPPO, Scritto autografo, in Eduardo De Filippo. Vita e opere 1900-1984, a cura di I. Q. DE FILIPPO e S. MARTIN, Milano, Mondadori, 1986, p. 59. 28 F. FELLINI, Eduardo, in Dossier in occasione dell’ottantesimo compleanno di Eduardo De Filippo, a cura di U. SERRA, in « Il Mattino », 24 maggio 1980. Eduardo De Filippo e il suo archivio 327 2. L’archivio Eduardo De Filippo. — Autore, attore, ma anche capocomico, impresario, Eduardo conosceva il teatro a 360 gradi: conosceva profondamente i meccanismi perfetti del palcoscenico come conosceva il meccanismo complesso dell’amministrazione teatrale; chiedeva ai suoi attori e ai suoi tecnici rispetto per il loro lavoro come chiedeva a chi aveva nella mani le redini dell’organizzazione e della politica del teatro rispetto per i teatranti e per il pubblico. Grazie alla sua straordinaria e complessa attività è andato stratificandosi un considerevole archivio oggi conservato a Firenze e a Napoli: carte divise quindi, ma necessariamente complementari e di grande interesse storico e culturale. La ricchezza della documentazione rispecchia la complessità del lavoro nel settore teatrale. 2.1 Il fondo De Filippo al Gabinetto Vieusseux. — Nel 1994 la moglie di Eduardo, Isabella ed il figlio, Luca De Filippo affidano in comodato all’Archivio contemporaneo « A. Bonsanti » del Gabinetto Vieusseux 29 di Firenze una parte cospicua delle carte dell’archivio di Eduardo: i manoscritti delle commedie e quelli delle poesie, ed un ricco carteggio. Carte sedimentatesi nel tempo e che avevano avuto la loro sede naturale nelle abitazioni di Eduardo: dalla casa napoletana di Parco Grifeo alla successiva di Posillipo, dall’isola d’Isca allo studio romano. Eduardo ed i suoi collaboratori lavoravano spesso proprio in casa e la stessa abitazione romana dei fratelli Argeri in via Valadier fu per anni la sede amministrativa ufficiale dei De Filippo. Ecco perché, insieme ai manoscritti e alle lettere, si ritrova oggi tra le carte del Vieusseux una documentazione di tipologia differente, una corrispondenza più tecnica, i cui destinatari o mittenti erano gli interlocutori soliti di un’amministrazione teatrale: i ministeri, la SIAE, AGIS, le agenzie o i teatri. Carlo Argeri aveva poi l’abitudine di scrivere spesso dei piccoli rapporti che inviava al suo capocomico e che conservava con grande cura. Un primo lavoro paziente di ricerca e di riflessione fu realizzato da Isabella De Filippo che recuperò le centinaia e centinaia di carte, le riordinò in fascicoli in ordine cronologico, corredandole di un elenco. Oggi dunque l’Archivio contemporaneo « A. Bonsanti » conserva, nelle bellissime stanze del Palazzo Corsini Suarez di Firenze, un patrimonio di grande rilevanza, la cui schedatura e il riordinamento hanno coinvolto negli anni vari esperti, da Cristina Giannini che per prima ha ordinato il fondo a 29 L’Archivio contemporaneo a tutt’oggi conserva più di 130 fondi, oltre 500.000 documenti, 50.000 volumi e raccolte di quadri, disegni, oggetti personali di intellettuali ed artisti. C’è nei progetti futuri del Vieusseux la realizzazione di un catalogo informatizzato dei fondi già schedati, lavoro che ci si augura venga prodotto con la collaborazione della Regione Toscana. Il catalogo potrà essere utilizzato dagli utenti collegandosi con il sito Internet del Vieusseux: www.vieusseux.fi.it/archivio.html 328 Maria Procino Ilaria Spadolini che ha sistemato la corrispondenza a Attilio Vergni che ha schedato le commedie; infine, nel giugno 2000, Antonella Giordano con la consulenza di Ilaria Spadolini, ha curato l’elaborazione informatica dell’inventario, utilizzando il software ISIS. Le carte possono essere consultate previo consenso della famiglia tenendo presente il rispetto ed i limiti delle norme di legge relative alla tutela del diritto d’autore e della privacy. Nucleo principale è la corrispondenza: oltre 12.500 pezzi, più di 5.300 mittenti, per un arco cronologico che va dal 1910 (anno della morte della madre di Eduardo) al 1984, anno della morte di Eduardo. Il fondo De Filippo è stato strutturato in serie: CORRISPONDENZA (1910-1984). Organizzata in fascicoli nominativi; quella anonima e senza data e le condoglianze per la morte di Eduardo De Filippo sono state poste in appendice. Si tratta di lettere, messaggi, telegrammi di ammiratori e di personaggi della politica e della cultura non solo italiana: da Andreotti a Nilde Iotti, da Pirandello a Calvino, a Pasolini, da Marta Abba a Ingrid Bergman ad Anna Magnani, da Tennessee Williams a Laurence Olivier a Orson Welles; inoltre un considerevole numero di lettere testimoniano il rapporto tra Eduardo e produttori cinematografici e teatrali e traduttori delle sue opere in tutto il mondo. Sono presenti anche lettere e minute di risposta di Eduardo, di Argeri e dei vari amministratori del San Ferdinando. MANOSCRITTI. La serie è articolata in: commedie e frammenti 1920-1984 (52 fascicoli); prose (19 fascicoli); appunti (raccolti in 4 quaderni e in 6 fascicoli). I manoscritti rappresentano una parte preziosa del fondo visto che vi sono gli autografi di Eduardo con gli appunti preparatori e le successive revisioni. POESIE. 141 poesie in italiano e in dialetto napoletano edite ed inedite, in ordine cronologico. DISEGNI, SPARTITI, FOTOGRAFIE. 11 fascicoli. OGGETTI DI SCENA. Due ventagli e tre paia di baffi finti. CARTE VARIE. Documentazione, non quantificata, relativa alla gestione amministrativa delle compagnie, oltre a documenti privati come atti, dichiarazioni, certificati. Probabilmente tale documentazione ha una relazione indissolubile con la documentazione conservata a Napoli. DIARI DI ISABELLA QUARANTOTTI DE FILIPPO 1956-1984. Diari autografi, per ora non consultabili (carte sciolte in 3 buste). 2.2 Il fondo De Filippo dal San Ferdinando alle stanze della Società napoletana di storia patria. — Alla fine degli anni Sessanta, due stanze all’ul- Eduardo De Filippo e il suo archivio 329 timo piano del Teatro San Ferdinando, furono adibite a spazio adatto a conservare una parte dell’archivio De Filippo. Il materiale proveniva da un deposito in via S. Efrano a Napoli e dalla direzione del teatro stesso, liberata dalle carte alla vigilia della nuova gestione, quella ETI. Furono organizzate scaffalature metalliche ed anche per queste carte, l’opera di riordinamento di Isabella De Filippo si sarebbe rivelata in seguito decisiva. Copioni, manifesti, locandine, fotografie e, oltre al materiale iconografico, anche lettere, contratti, fogli paga, libri Enpals, atti di compravendita ecc., fonti documentarie estremamente preziose per lo studio dei meccanismi che regolano la vita di una compagnia teatrale e di un teatro del Novecento, e per ripercorrere la storia, le scelte dell’autore-attore, dell’impresario-imprenditore ma anche dell’uomo Eduardo De Filippo. Una buona parte, dunque, di questo materiale nasce sia dall’attività amministrativa del « Teatro Umoristico » prima e del « Teatro di Eduardo » poi, con la collaborazione dei fratelli Argeri, e sia dall’attività gestionale del Teatro San Ferdinando. I copioni ed i documenti relativi erano ordinati in fascicoli e « viaggiavano » nel baule dell’amministratore che se ne serviva all’occorrenza ovunque si trovasse. Col tempo, quelli non utilizzati venivano riposti nei depositi, infine nella direzione del San Ferdinando. Quando la gestione del teatro venne affidata all’ETI, che dagli anni Settanta produsse altra documentazione, le carte inerenti all’attività passata della compagnia di Eduardo e alla sua attività come capocomico ed autore, finirono nelle stanze suddette, all’ultimo piano del teatro. Nel 1976 chi scrive compilò insieme a Evole Gargano 30 e su richiesta dello stesso Eduardo, un elenco della documentazione e delle fotografie conservate negli scaffali. Il materiale comprende i copioni di autori ottocenteschi e del Novecento, quelli delle commedie rappresentate, del suggeritore o degli attori, i copioni utilizzati durante le prove dallo stesso Eduardo e infine quelli vistati dall’Ufficio Censura 31. Vi sono inoltre manifesti e locandine e programmi teatrali e cinematografici; una ricca e interessante documentazione fotografica: da rare e preziose foto di Eduardo e Vincenzo Scarpetta alle foto riguardanti la messa in scena delle opere di Eduardo nelle varie stagioni teatrali, le sue 30 Evole Gargano fu la sarta di Eduardo per molti anni ma non solo: nata nel 1910 a Castel di Sangro, sposatasi a 14 anni con un attore di avanspettacolo, Antonio Ercolano, fu ballerina e attrice già prima di essere scritturata nella compagnia De Filippo insieme al marito. Evole fu poi responsabile della sartoria del Teatro San Ferdinando. 31 Per la documentazione ed i copioni relativi alle commedie messe in scena da Eduardo De Filippo, cfr. anche ACS, Ministero della cultura popolare, Ufficio censura teatrale (19401944); Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo, Censura teatrale (1946-1962); Ministero del turismo e spettacolo, Revisione teatrale (1962-1998). Maria Procino 330 regie, le registrazioni televisive. Infine il materiale a stampa, ovvero gli articoli di giornali dai primi anni del Novecento, le interviste, scritti vari e le recensioni delle opere allestite fino al 1984. Negli anni Novanta, tornando a lavorare con Luca De Filippo, ripresi ad occuparmi anche dell’archivio: l’obiettivo temporaneo era la conservazione e la sistemazione del materiale che nel frattempo era aumentato, trasformando lo stesso teatro in un grande deposito 32. Nel 1997, consegnato il teatro al Comune, la famiglia De Filippo affida il materiale d’archivio all’Associazione napoletana Voluptaria, nata nel 1989 come associazione di amanti del teatro, presieduta da Ernesto Cilento. Nel 2001 la Voluptaria ha creato un Centro di documentazione teatrale destinato a divenire un punto di raccolta del patrimonio teatrale napoletano, come spiega lo stesso Cilento: « Già quando nel ’92 demmo vita ad un Comitato promotore per un museo-centro di documentazione teatrale a Napoli, cui aderirono, oltre agli eredi De Filippo e Viviani, intellettuali, operatori ed esponenti politici, ritenevamo che la realizzazione di un centro di testimonianza del patrimonio teatrale e luogo di documentazione attivo, attrezzato con biblioteca specializzata, videoteca ed un museo in progress doveva costituire una delle priorità per il rilancio civile oltre che turistico della città » 33. L’ordinamento del materiale De Filippo si sta svolgendo ad opera di Claudio Novelli, membro della Voluptaria, nella sede della Società napoletana di storia patria, a Castelnuovo (Maschio Angioino). Grazie all’intervento di Giuseppe Galasso, presidente della Società, è stato possibile disporre della Torre San Giorgio e sistemarvi l’archivio. Il primo risultato è costituito dalla pubblicazione: Archivio Eduardo De Filippo. Copioni, realizzata da Claudio Novelli nel 1998. Il catalogo raccoglie 1.500 copioni manoscritti e dattiloscritti, dalla metà del sec. XIX fino ai nostri giorni, schedati osservando i criteri delle biblioteche specializzate e tenendo presenti le norme dell’ICCU. I testi sono ordinati alfabeticamente per autore, quelli anonimi seguono l’ordine alfabetico per titolo; infine, in appendice compaiono brevi note sugli autori stessi. Nel 2000 è stato pubblicato il catalogo degli articoli di quotidiani, riviste etc. 34, raggruppati in otto sezioni ordinate cronologicamente (ad eccezione di Spettacoli e Cinema che seguono un ordine alfabetico): Spettacoli, San Ferdi32 Non bisogna dimenticare la presenza di oggetti di scena; scenografie (per esempio i fondali e le quinte realizzate su disegni di Maccari e Guttuso); il baule personale di Eduardo, i costumi di scena, materiale oggi conservato, temporaneamente, in un deposito romano. 33 Archivio Eduardo De Filippo, Copioni, Napoli, Legma, 1998, p. 8 (Quaderni di catalogazione dell’Associazione Voluptaria). 34 Archivio Eduardo De Filippo, Ritagli di stampa, Napoli, Legma, 2000 (Quaderni di catalogazione dell’Associazione Voluptaria). Eduardo De Filippo e il suo archivio 331 nando, La Scarpettiana, Regie liriche, Cinema, Scritti di Eduardo, Interviste, Scritti vari. È in programma l’informatizzazione del catalogo delle foto e di quello di locandine, programmi e manifesti. Chi scrive, svolgendo una collaborazione volontaria, si sta occupando invece del riordinamento dei documenti riguardanti sia l’attività culturale del Teatro San Ferdinando, che la gestione amministrativa, i rapporti con istituzioni, la gestione della compagnia, e infine la vita privata di Eduardo: ci si accorge infatti ogni giorno di più di essere davanti ad un archivio teatrale che è per alcuni aspetti anche archivio di famiglia. Nella prima fase di ricognizione si è cercato di ricostruire prima di tutto l’iter della sedimentazione delle carte, degli interventi sull’archivio e delle perdite subite. Si è quindi cercato di impostare uno schema di ordinamento che rispettasse non solo gli interventi originari ancora leggibili ma anche l’esigenza di rendere consultabile la documentazione: COMPAGNIA TEATRO UMORISTICO I DE FILIPPO (1930-1945). Contratti con imprese teatrali e con gli attori, UNAD-UNAT; corrispondenza ordinata alfabeticamente; borderò ordinati cronologicamente; EIDA-SIAE, estratti conto ed iscrizione alla SIAD (1935-1949); COMPAGNIA IL TEATRO DI EDUARDO (1945-1980). Contratti, corrispondenza con i ministeri competenti e contabilità, ordini del giorno (1954-1976) (in corso di ordinamento). TEATRO SAN FERDINANDO (1948-1984). Dalla gestione SIT (1948-1955) alla gestione ETI (1971-1984). AMMINISTRAZIONE (1948-1980). Fogli paga, prime note, libri Enpals; il materiale, laddove possibile, viene suddiviso per stagione e comunque ordinato cronologicamente (in corso di ordinamento). CARTE EDUARDO DE FILIPPO (1948-1984). Rapporti con gli editori, rapporti con traduttori e registi stranieri per l’utilizzo delle opere, carteggi (da Lilla Brignone alla stessa Titina, da Macario a Taranto), rapporti con Tv e cinema, carte private contabili. Il lavoro è lungo e complesso ma affascinante: l’obiettivo è la realizzazione di un inventario che permetta, insieme agli altri strumenti di corredo e con il permesso della famiglia, la consultazione e dunque la fruibilità dell’archivio stesso. Una documentazione eterogenea che offrirà approcci e letture trasversali, un fondo che si delinea già come uno dei più completi nel panorama teatrale italiano. Un passo ambizioso quanto importante potrà essere il recupero virtuale dell’unità dell’archivio De Filippo, di grande interesse per chi voglia appro- 332 Maria Procino fondire la struttura e l’attività di una compagnia e di un teatro ed il rapporto stesso delle istituzioni con il mondo teatrale. Tali memorie documentali costituiscono un’importante testimonianza di un settore come quello teatrale, ancora poco esplorato dalla ricerca storico-archivistica. L’informatizzazione potrebbe creare un collegamento tra le due sedi « fisiche » dell’archivio De Filippo ed eventualmente anche con altri istituti che per varie ragioni storico-culturali posseggono materiale di o su Eduardo e sui fratelli De Filippo, quali l’archivio e la cineteca del Centro Ateneo dell’Università « La Sapienza » di Roma diretto da Ferruccio Marotti, la Biblioteca e Raccolta teatrale del Burcardo, l’archivio storico della Giulio Einaudi editore ora depositato presso l’Archivio di Stato di Torino e in fase di riordinamento, il Museo dell’attore di Genova, l’archivio del Piccolo di Milano e l’Archivio centrale dello Stato che, oltre a conservare le carte relative alla censura del Ministero della cultura popolare e del Ministero del turismo e spettacolo, custodisce archivi privati di notevole rilevanza storico-teatrale come i fondi Torraca e Peppino De Filippo. MARIA PROCINO Ordinamenti e inventari ARCHIVIO DI STATO DI MILANO Autografi <Donne celebri>, fascc. 341 (secc. X-XIX). Inventario analitico a cura di Daniela Bernini (collaboratore esterno); coordinamento Maria Pia Bortolotti e Maurizio Savoja (2000). Base dati MS Access appositamente configurata con migrazione di dati raccolti nell’ambito del progetto Anagrafe. Finanze parte antica <Eredità vacanti>, bb. 248 (secc. XVI-XVIII). Elenco alfabetico dei fascicoli per cognome a cura di Carmela Santoro e Ivana Corsetto (in corso). Si trattava di una delle voci di entrata della finanza statale, in quanto le eredità vacanti si sarebbero dovute devolvere al fisco. La serie è costituita da pratiche individuali in ordine alfabetico. <Provvidenze generali: tariffe daziarie, appalti>, bb. 15 (1340-1801). Inventario analitico a cura di Carmela Santoro e Simona Tarozzi (2001). La serie comprende le Provvidenze generali in materia di appalti e tariffe daziarie applicate alle diverse tipologie di merci. Senato <Deroghe giudiziarie per comunità e corpi>, bb. 98 (secc. XV-XIX). Inventario analitico a cura di Maurizio Savoja (2000), con migrazione dei dati da Anagrafe in Access. La serie Deroghe giudiziarie per comunità e corpi comprende documentazione relativa alle deroghe richieste da comunità (cittadine e comitatine) e corpi (specialmente le corporazioni di arti e mestieri) rispetto alla legislazione vigente, soprattutto statutaria. Cancelleria del viceré <Geheime Section>, bb. 39 (1818-1848). Inventario analitico a cura di Simona Tarozzi (2001) Il fondo fa parte degli archivi riservati restituiti dall’Austria dopo la prima guerra mondiale. La serie comprende documentazione classificata come « segreta ». Senato lombardo-veneto del Supremo Tribunale di giustiz i a , bb. e regg. 273 (1815-1851). Inventario a cura di collaboratori esterni nell’ambito del progetto Anagrafe, coordinamento Maria Pia Bortolotti, Bernadette Cereghini, Maurizio Savoja (2000). È in corso l’attività di migrazione dei dati in altro sistema di gestione basi dati. Il fondo si articola in: Atti presidenziali; Affari criminali; Appendice; Protocolli di Consiglio; Protocollo di Consiglio del Tribunale di Appello di Zara; Rapporto Mazzetti. Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 334 Ordinamenti e inventari Prefettura di Milano <Archivio generale>, bb. 6.000 (1861-1924). Inventario sommario curato da collaboratori esterni nell’ambito del progetto Anagrafe, coordinamento Maria Pia Bortolotti, Bernadette Cereghini, Maurizio Savoja (2000). È in corso l’attività di migrazione dei dati in altro sistema di gestione basi dati. <Cementi armati>, bb. 1.000 (1950-1972). Inventariazione analitica in corso a cura della Cooperativa Archimedia (su incarico della Prefettura di Milano); supervisione Fiammetta Auciello La serie conserva gli atti della Divisione 4 ª, Ufficio controllo opere in cemento armato, relativi all’attività di vigilanza esercitata dalla Prefettura sulle opere in cemento armato, ai sensi del r.d. 16 nov. 1939, n. 2229, recante « Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od ornato ». E c o n o m a t o b e n e f i c i v a c a n t i , fascc. 388 (1838-1958). Inventario analitico a cura di Daniela Bernini, Antonella Cassetti, Raimonda Cuomo (collaboratori esterni); coordinamento Maurizio Savoja (2000). Sono presenti atti relativi a fabbricerie (decreti prefettizi di nomina di presidente e membri). La documentazione è ulteriormente divisa nei seguenti subeconomati: Abbiategrasso, Cuggiono, Codogno, Gorgonzola, Lodi, Milano. G e n i o c i v i l e , b b., voll. e regg. 4.000 (secc. XVIII-XIX). Inventariazione in corso a cura di Michele Dean. Il fondo conserva la documentazione prodotta dai seguenti enti dalla fine del sec. XVIII al 1885: Direzione generale di acque e strade; Direzione generale delle pubbliche costruzioni; Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni di Milano; Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni di Lodi e Crema. Si segnala che nel 1859 la Provincia di Lodi e Crema venne soppressa e unita a quella di Milano. La Provincia di Crema era stata invece annessa a quella di Lodi già nel 1815. C a r c e r e d i S . V i t t o r e , regg. 28 (1940-1945). Elenco a cura di Fiammetta Auciello (2000). Si tratta dei registri delle matricole dei detenuti. È in corso, in assenza di rubriche alfabetiche originali, la indicizzazione dei nomi e delle matricole dei detenuti su supporto digitale Access. Tribunale civile e penale di Milano <Sentenze civili e penali>, bb., voll. e regg. 4.962 (1866-1948) Inventario sommario a cura di collaboratori esterni nell’ambito del progetto Anagrafe, coordinamento di Maria Pia Bortolotti, Bernadette Cereghini, Maurizio Savoja (2000). È in corso l’attività di migrazione dei dati in altro sistema di gestione basi dati. <Sentenze di fallimento, di commercio, di deliberamento e vendita, di stato civile>, voll. e regg. 492 (1866-1912). Schedatura in corso a cura di Antonella Cassetti (collaboratore esterno); coordinamento Maurizio Savoja in collaborazione con Bernadette Cereghini. Base dati Access opportunamente configurata da Maurizio Savoja C o r t e d ’ a s s i s e d i p r i m a i s t a n z a . Circolo di Milano <Fascicoli processuali a campione>, fascc. 11 (1921-1924). Inventario analitico a cura di Antonella Cassetti (collaboratrice esterna), coordinamento Bernadette Cereghini e Ordinamenti e inventari 335 Maurizio Savoja (2000). Applicazione informatica base dati Access configurata da Maurizio Savoja <Sentenze>, voll. e regg. 111 (1862-1951). Inventario a cura di Daniela Bernini (collaboratrice esterna), coordinamento Maurizio Savoja (2000). Applicazione informatica base dati Access configurata da Maurizio Savoja. Corte d’assise di prima istanza. Circoli di Como, Pavia e Sondrio <Sentenze>, voll. e regg. 58 (1931-1951). Inventario a cura di Daniela Bernini (collaboratrice esterna) coordinamento di Maurizio Savoja (2000). Applicazione informatica base dati Access configurata da Maurizio Savoja. C o r t e d ’ a s s i s e s t r a o r d i n a r i a d i M o n z a , fascc. 84, voll. e regg. 3 (1945-1946). Inventario analitico e indice a cura di Antonella Cassetti e Raimonda Cuomo (collaboratori esterni); coordinamento Bernadette Cereghini e Maurizio Savoja (2000). Applicazione informatica base dati Access configurata da Maurizio Savoja. Corte di appello di Milano <Magistratura del lavoro>, bb., voll. e regg. 308 (1928-1956). Inventario sommario a cura di collaboratori esterni nell’ambito del progetto Anagrafe, coordinamento di Maria Pia Bortolotti, Bernadette Cereghini, Maurizio Savoja (2000). È in corso l’attività di migrazione dei dati in altro sistema di gestione di basi dati. <Penale>, bb., voll. e regg. 1.258 (1862-1950 con docc. fino al 1965). Inventario sommario a cura di collaboratori esterni nell’ambito del progetto Anagrafe, coordinamento di Maria Pia Bortolotti, Bernadette Cereghini, Maurizio Savoja (2000). È in corso l’attività di migrazione dei dati in altro sistema di gestione di basi dati. Ministero dell’assistenza postbellica. Uffici milanesi <Ricevute di ingaggio>, bb. 11 (1941-1945). Ordinamento alfabetico dei fascicoli in corso a cura di Fiammetta Auciello <Schede di partenza dei lavoratori in Germania>, bb. 30 (1940 - 1947). Inventariazione analitica di 4 cartelle e indice alfabetico delle restanti a cura di Rocco Marzulli (collaboratore esterno); coordinamento di Fiammetta Auciello (2001). Applicazione informatica base dati Access configurata da Maurizio Savoja. La schedatura analitica delle cartelle è disponibile nelle pagine dell’AS Milano sul sito Internet della Direzione generale per gli archivi. Il Ministero dell’assistenza postbellica venne istituito con d. lgt. 21 giu. 1945 n. 380, e organizzato con d.lg. lgt. 31 lug. 1945 n. 425 che gli attribuiva le funzioni dell’Alto commissariato per i prigionieri di guerra, dell’Alto commissariato per l’assistenza morale e materiale dei profughi di guerra e dell’Alto commissariato per i reduci, enti soppressi con il medesimo decreto. Disponeva sul territorio nazionale di uffici regionali e provinciali. A Milano fu creato un Ufficio distaccato dell’Alta Italia con d.m. 19 set. 1945, che agisse nella giurisdizione dell’Allied Military Government (AMG) al Nord. Il Ministero dell’assistenza postbellica fu soppresso con d. lg. del Capo provvisorio dello Stato 14 feb. 1947 n. 27 e gran parte delle sue competenze furono assorbite dal Ministero dell’interno, presso il quale fu istituita, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 lug. 1947 n. 808, la Direzione generale dell’assistenza postbellica che a sua volta, con d.m. 1° giu. 1949, ha assunto la denominazione Direzione generale dell’assistenza pubblica assorbendo le attribuzioni della Direzione generale dell’am- 336 Ordinamenti e inventari ministrazione civile in materia di assistenza. Il fondo è stato versato all’Archivio di Stato di Milano da parte della Prefettura di Milano. Esso concentra tre archivi ereditati da due uffici periferici del Ministero dell’assistenza postbellica (l’Ufficio provinciale di Milano e l’Ufficio regionale per la Lombardia) e da uno centrale (l’Ufficio distaccato dell’Alta Italia). Questi archivi non sono completi di tutte le serie; è probabile che dei materiali siano pervenuti ad altri ministeri che hanno assorbito alcuni compiti di questi uffici. È compresa, inoltre, documentazione prodotta, nell’ambito della Prefettura di Milano, dall’Ufficio provinciale dell’assistenza postbellica (poi Ufficio provinciale dell’assistenza pubblica) nello svolgimento delle competenze ereditate dal Ministero dell’assistenza postbellica. La serie Schede di partenza dei lavoratori in Germania contiene documentazione prodotta dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria (CFLI) e dalla Confederazione dei lavoratori dell’industria (CLI). U f f i c i o p r o v i n c i a l e d e l l a m o t o r i z z a z i o n e c i v i l e , bb., voll. e regg. 384 (sec. XX). Inventariazione analitica in corso a cura di Maurizio Savoja, con la collaborazione di Davide Sacco, Maria Pia Valentini, Laura Tagliabue, Alessandra Borgese (collaboratori esterni). U f f i c i o s p e c i a l e t r a s p o r t i a i m p i a n t i f i s s i , scatole 28 (19401970). Inventariazione analitica in corso a cura di Valeria Chiappa (collaboratore esterno) con la supervisione e il coordinamento di Maurizio Savoja. Gli USTIF sono istituiti con l. 1° dic. 1986, n. 870, che ne prevede la competenza sul risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione e sulla vigilanza sulla sicurezza di esercizio dei trasporti a impianti fissi (ferrovie, tramvie, metropolitane, funicolari, sciovie). Organi periferici del Ministero dei trasporti, Direzione generale motorizzazione civile e trasporti in concessione, le loro competenze sono precisate con successivo decreto ministeriale n. 102 del 24 mar. 1987, nel contesto in particolare delle norme « in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle Ferrovie » di cui al d.p.r. 11 lug. 1980, n. 753. L’USTIF di Milano estende le sue competenze sul territorio della Regione Lombardia. Con la sua nascita l’USTIF di Milano acquisisce documentazione relativa ai propri ambiti di competenza dai preesistenti uffici periferici del Ministero dei trasporti (Uffici provinciali della motorizzazione civile e trasporti in concessione). La documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Milano risale a un versamento del 1995, del quale si prevedono ulteriori integrazioni nei prossimi anni. Notarile; Rubriche dei notai; Notarile ultimi versamenti; A p p e n d i c e n o t a i (secc. XIII-XIX) Riorganizzazione in un unico indice informatizzato dei nomi dei notai i cui atti sono conservati nei fondi notarili suindicati. Per ogni notaio è realizzato il collegamento all’elenco, dove disponibile, dei pezzi; la schedatura dei pezzi è presente per la parte del fondo Notarile relativa al sec. XVI, anche grazie al reimpiego di una schedatura realizzata per un progetto dell’Università degli studi di Milano, Istituto di storia medievale e moderna, a cura di F. Cocucci con la collaborazione di L. Arcangeli, P. Ceriani, A. Dattero, C. Donati, 1995. Complessivamente sono presenti ca. 9.700 schede notaio e 30.500 schede pezzo. Si procederà ad integrare la base dati con schede notaio dagli altri fondi (Rogiti camerali; Atti notarili della Cancelleria arcivescovile) e con schede pezzo dove non presenti. Ordinamenti e inventari 337 La base dati Access a cura di Maurizio Savoja è già disponibile. È tuttora in corso la realizzazione dell’interfaccia web a cura di Lorenzo Cibrario (collaboratore esterno). Ufficio tecnico erariale di Milano <Mappe Piane> e <Registri catastali>, pezzi 1.650 e 4.356 (secc. XVIII-XIX) Integrazione e revisione dei corredi e degli inventari già esistenti per le serie delle mappe e dei registri catastali di attivazione e conservazione dei comuni della provincia di Milano riferibili ai catasti teresiano, lombardo veneto e nuovo terreni, in vista della redazione di strumenti per la consultazione su supporti sostitutivi analogici (microfilm) o digitali. L’intervento, in corso a cura di Mario Signori, prevede la verifica sui toponimi coevi, l’inserimento di altri dati integrativi (circoscrizioni coeve, toponimi attuali etc.), l’integrazione di dati riguardanti le riproduzioni già esistenti o in corso di realizzazione (unità e sottounità di riproduzione). È prevista la realizzazione di un unico indice informatizzato per toponimi attuali e coevi per le unità documentarie di varie tipologie presenti nelle diverse serie dei fondi, con collegamento all’elenco delle singole unità (o sottounità) documentarie e di fotoriproduzione. C a v a z z i d e l l a S o m a g l i a , bb. 377 (comprendenti atti sciolti e registri), 12 mappe di grande formato, due scudi in metallo con lo stemma familiare (secc. XIVXX). Inventariazione analitica in corso a cura di Marina Valori, Anna Lucia Brunetti, Carmela Santoro. I nuclei documentari individuati sono: Banzi; Cavazzi della Somaglia; Mellerio; Orio Litta; Somaglia. Clerici di Cavenago <Stampe>, pezzi 239 (XVIII-XIX). Inventario analitico e indice a cura di Marina Valori (2001). L’archivio familiare Clerici di Cavenago è costituito da due sezioni Ramo marchionale antico e Ramo marchionale moderno e una serie Stampe. Queste ultime si riferiscono tutte, direttamente o indirettamente, alla vita e alle imprese di Napoleone Bonaparte. Crivelli Giulini <Grampa-Palanchina>, cartelle 7 (secc. XVI-XX). Inventario analitico a cura di Anna Lucia Brunetti (2001). Le carte Crivelli Giulini, consistenti di oltre 1.000 pezzi, sono state donate all’Archivio di Stato nel 1973 dalla Amministrazione Binelli-Crivelli. Il fondo comprende gli archivi delle famiglie Crivelli di Agliate e della famiglia Giulini Della Porta, imparentatesi per nozze a seguito del matrimonio di Beatrice Giulini con Ariberto Crivelli nel 1875; in tali archivi erano già confluite, in seguito alle diverse vicende familiari, carte di altre casate quali Biglia, Gallina, Giussani, Medici di Marignano, Moriggia, Gera, Caimi, Parravicini, Sadarini, Dal Verme. Il fondo, in gran parte riordinato e inventariato, consiste, secondo un’articolazione che risale alla confluenza nel 1875 delle due famiglie, di due grandi insiemi documentari principali: Crivelli, con le serie Araldica, Archivio vecchio, e le serie riferite ai possedimenti familiari; Giulini, con le serie Araldica, Eredità e divisioni, Benefici, cappellanie e messe, e le serie riferite ai possedimenti familiari. A questi si aggiungono una sezione Registri e una Mappe e Ritratti. 338 Ordinamenti e inventari La documentazione della serie Grampa-Palanchina è riferita all’omonima possessione, di proprietà Giulini, sita nel Novarese nei comuni di S. Pietro Mosezzo, frazione Mosezzo, Zottico e Vicolungo, frazione Visconta. I documenti, di carattere patrimoniale e relativi alla gestione dei terreni, degli immobili e delle acque, sono ordinati in base a un sistema di classificazione analogo a quello delle altre serie riferite al patrimonio familiare. Notiziario bibliografico Archivi nobiliari e domestici. Conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica, a cura di LAURA CASELLA e ROBERTO NAVARRINI, Udine, Forum, 2000, pp. 348. Il volume in questione, a cura di Laura Casella e Roberto Navarrini, racchiude gli atti del Convegno nazionale omonimo, svoltosi a Udine il 14-15 maggio 1998 e dedicato agli archivi privati, in particolare a quelli nobiliari. La pubblicazione rispetta la suddivisione del Convegno in due giornate di studio: la prima in cui sono intervenuti per lo più archivisti che hanno argomentato attorno alla conservazione, alla legislazione e alle metodologie di riordino degli archivi privati; la seconda che ha visto invece gli storici proporre casi di studio e prospettive di ricerca considerando questi medesimi archivi come una fonte in gran parte inedita per la storia politica ed economica dell’età moderna. Certo il tema del Convegno è circoscritto ma la tipologia archivistica presa in esame è « assimilabile per la metodologia della gestione e per la conservazione dal punto di vista giuridico a quella prodotta e conservata da organi del potere pubblico » ed offre — sulla scorta dell’esperienza veneziana tra XVI e XVIII secolo — una ricca potenzialità d’indagine e di comparazione in tutti i territori degli antichi stati italiani. D’altro canto, « negli archivi pubblici è sempre stata forte la tendenza a selezionare le forme di memoria, in rapporto alle esigenze di governo e di amministrazione; nelle fonti private, al contrario, la mancanza, molte volte, di tale selezione ha consentito lo stratificarsi di testimonianze Rassegna degli Archivi di Stato, LXI (2001), 1-2-3 molto più esplicite della cultura locale nei suoi diversi caratteri », peccato però che gli archivi privati siano più soggetti di quelli pubblici a dispersione/distruzione volontaria o involontaria. Dunque, tutela e valorizzazione delle fonti archivistiche private sono le parole d’ordine prioritarie che scaturiscono da questo volume storico-archivistico, quanto mai utile, visto che nell’odierno dibattito politico è sempre più viva la discussione sulle identità e culture locali. Ad aprire la prima sezione del libro è la relazione di Antonio Romiti (Gli archivi domestici e personali tra passato e presente, pp. 13-32), che si sofferma sugli aspetti teorici ed operativi degli archivi privati, in particolar modo su quelli personali. Attraverso le definizioni del termine archivio usate dall’antichità romana fino ad oggi, Romiti cerca di capire quale considerazione abbia avuto la documentazione prodotta dai privati: tranne alcune eccezioni italiane e tedesche del Seicento e del Settecento, bisogna attendere la seconda metà dell’Ottocento per vedere indebolita l’incertezza dottrinaria nei confronti degli archivi privati e aspettare gli anni Venti del Novecento per avere piena maturità di pensiero. Ma il problema giustamente evidenziato da Romiti non è ancora risolto, perché in Italia se pur è stata riconosciuta alla documentazione privata la possibile qualificazione di « archivio », è altrettanto vero che « il momento caratterizzante della individuazione dell’archivio non dovrebbe dipendere quindi dalla natura del soggetto produttore, quanto dalle modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione », cioè 340 Notiziario bibliografico « l’attenzione dovrebbe essere rivolta ai criteri costitutivi » dell’archivio e perciò « riconoscere il vincolo naturale (tra le singole unità archivistiche) quale momento qualificante per distinguere l’archivio da altre entità anche similari » come le raccolte. E, considerando proprio la casualità e la confusione che spesso contraddistinguono la formazione di un archivio privato, non è sempre possibile applicare per il riordino il cosiddetto metodo storico; pertanto Romiti — rifacendosi all’esperienza tedesca — indica la soluzione più opportuna nel principio di « provenienza liberamente applicato » di Adolf Brenneke, ma solo per questi casi! Oddo Bucci (Il profilo storico della legislazione italiana in materia di archivi privati, pp. 33-48) ci offre un profilo storico della legislazione italiana, soffermandosi soprattutto su quella normativa che ha trattato esplicitamente tale materia: pietre miliari restano ancora la leggi archivistiche del 1939 e del 1963, mentre semplificazione burocratica e incentivi per la cessione di archivi privati allo Stato hanno caratterizzato i provvedimenti del 1982, 1986 e del 1997. In questo iter legislativo s’inserisce ad hoc l’ampio intervento di Valeria Piergigli (L’amministrazione archivistica e la tutela degli archivi privati, pp. 49-80) sul regime giuridico degli archivi privati, con riferimento però alle leggi più recenti: dal d.p.r. 1409/1963 al d.p.r. 112/1998. In ben nove paragrafi vengono analizzati i punti fondamentali: gli archivi storici pubblici o privati come beni culturali, gli articoli 9 e 112 della Costituzione per spiegare il fondamento costituzionale della politica dei beni culturali, i profili organizzativi per l’amministrazione dei beni culturali tra Stato e Regioni, gli effetti della notifica di « notevole interesse storico » di archivi e documenti privati, alcuni cenni sul regime delle agevolazioni fiscali, gli archivi nelle legislazioni regionali. In riferimento a questo ultimo punto la Piergigli rileva come gli interventi regionali « assumono per lo più portata residuale rispetto al più ampio spazio accordato alla normativa sui musei e le biblioteche. Generalmente, inoltre, la disciplina dei beni archivistici non presenta carattere autonomo, ma accede a quella dettata per le biblioteche degli enti locali ». Tra l’altro, lo stesso d.p.r. 112/1198, pur promovendo la collaborazione tra Stato e Regioni, lascia ulteriori punti interrogativi proprio sulle modalità di cooperazione. Nonostante tutto, comunque, alcuni consigli regionali si sono contraddistinti per un’efficace tutela degli archivi privati: è il caso del Friuli Venezia Giulia, efficacemente esposto da Renata Da Nova Erne (L’amministrazione archivistica e la conservazione degli archivi privati in Friuli Venezia Giulia, pp. 8186). Questa regione infatti, all’indomani del tragico terremoto del 1976, iniziò a finanziare interventi di restauro, riordino e inventariazione anche di archivi privati con la consulenza e il coordinamento tecnico della Sovrintendenza archivistica. Segue poi la relazione di Roberto Navarrini (La conservazione della memoria nell’azienda di famiglia, pp. 87-98) che si sofferma sulla conservazione della memoria nell’« azienda famiglia »: azienda perché pilastro principale della famiglia era ed è tuttora il patrimonio. Pertanto la preoccupazione di conservare e gestire questo patrimonio origina la produzione di documentazione posta in essere per certificare e tramandare un determinato « possesso ». La tipologia di categorie in cui ricondurre tale documentazione è di difficile strutturazione, vista la varia e complicata natura della stessa, ma Navarrini ci fornisce lo stesso, in modo snello ed esaustivo, ben otto ripartizioni: una categoria di documenti che trovasi in tutti Notiziario bibliografico gli archivi familiari sono le prove giuridiche di un determinato possesso, cioè i titoli (compravendite, privilegi, concessioni, legati, ecc.); la gestione di quel possesso da vita quasi ovunque a quelle serie documentarie genericamente dette economiche che si strutturano in maniera più o meno complicata a seconda dello status e degli scopi che la famiglia si prefigge; vi è poi il rilevante nucleo documentario delle strategie patrimoniali (alleanze politiche o economiche) consistente in strumenti dotali, inventari, contratti matrimoniali ed affini; una quarta categoria Navarrini la individua nelle disposizioni di ultima volontà, le cui clausole sono redatte in modo tale da assicurare ai posteri l’ereditarietà del patrimonio familiare (si veda a tal proposito la costituzione del fedecommesso); conseguente a questa è un’altra categoria, quella di processi, atti di causa e di liti tra parenti in seguito a passaggi di eredità ed alleanze matrimoniali; vi è la documentazione riguardante la partecipazione al potere (i mezzi per acquisire ciò sono tra i più disparati e la relativa documentazione, essendo molto variabile, è difficile da individuare e lo stesso Navarrini deve ricorrere ad esempi concreti); più evidente, invece, la documentazione riferentesi ai cosiddetti modelli di consumo, ovvero quei documenti testimonianti l’economia domestica (libri di spesa per la cucina, per la servitù, per le medicine e per tutto quello che riguardava la gestione della casa); un’ultima categoria, ma non per importanza, Navarrini la individua in quei documenti riconducibili a investimenti e speculazioni nel campo dei censi e più tardi in borsa, attraverso i quali le famiglie gestivano i loro patrimoni. Dunque, la necessità di avere delle testimonianze scritte era sentita per lo più da nobili e mercanti. Ma a differenza di quella nobiliare, come osserva Navarrini, la classe mercantile attribuiva minore 341 peso alla conservazione delle proprie scritture, per il motivo che i documenti mercantili perdevano utilità dopo esser venuto meno lo scopo per cui erano stati redatti, finendo pertanto distrutti al termine delle operazioni contabili. Prosegue questo percorso Giorgetta Bonfiglio Dosio (Dall’archivio di famiglia all’archivio dell’impresa, pp. 99114), la quale descrive sia gli aspetti comuni che le differenze esistenti fra archivi familiari e archivi imprenditoriali, cercando di comprendere quali tipologie documentarie siano state usate per fissare e tramandare una determinata notizia La differenza più evidente è che dall’epoca comunale in poi tra i mercanti, cioè inter pares, è possibile « porre in essere documenti muniti di capacità probatoria » senza dover così ricorrere — come fanno altre categorie — all’instrumentum notarile: è questa produzione documentaria autonoma che, fortemente tecnica e specialistica ma allo stesso tempo sovranazionale, comporta « conseguenze archivistiche molteplici », positive e negative allo stesso tempo. Infatti a fronte di un sistema autonomo per fissare e trasmettere la memoria, vi è l’altrettanta realtà strumentale di tale documentazione, ovvero venuto meno l’interesse gestionale del mercante o imprenditore per quella documentazione, lo stesso può liberamente sbarazzarsene. E non è un caso — come giustamente osserva la Bonfiglio — che i registri contabili (comuni a tutte le categorie) si siano conservati per lo più in archivi familiari ed ecclesiastici che in quelli d’impresa. Ciò che invece accomuna macroscopicamente le categorie imprenditoriali e familiari è la politica gestionale e di sviluppo del proprio patrimonio (come sopra evidenziato anche da Navarrini): per esempio si adottano le medesime alleanze e strategie matrimoniali usate tra individui o tra aziende. D’altra parte l’or- 342 Notiziario bibliografico ganizzazione, cioè la struttura per gestire quel patrimonio è similare: a seconda delle dimensioni, una o più agenzie e una fitta rete di fattori o di rappresentanti, come nel caso della famiglia udinese dei Papafava Antonini o della ditta mercantile Datini di Prato. Invece, « la differenza di finalità istituzionali tra le due categorie di produttori si riflette sui rispettivi archivi. In quello familiare acquistano spazio ed evidenza documenti relativi alle situazioni biologiche e giuridiche delle singole persone » soprattutto dal sec. XVIII, quando i documenti prodotti dal singolo « si configurano come archivi personali aggregati all’archivio familiare ». Poi c’è la serie delle lettere: negli archivi familiari si chiamano epistolari, si ordinano per destinatari e solitamente non vengono fatte copie; negli archivi d’impresa, invece, si indicano col termine di carteggio, hanno rilevanza giuridica e ne viene fatta copia. Questa « diversità sostanziale tra gli epistolari familiari o personali e il carteggio aziendale influisce sia sulla stratificazione delle lettere nel momento formativo dell’archivio sia sui criteri da adottare in fase di riordino ». Un’ultima differenza viene evidenziata dalla Bonfiglio: l’archivio di famiglia, specie se di estrazione aristocratica, ha subito nel tempo vari scarti e riordini per mano dei catasticatori affinché salvaguardassero gli affari gestionali, mentre l’archivio d’impresa — anche se nella maggior parte dei casi non è integro — ha conservato il più delle volte la struttura e l’ordine originari. Con Stefania Ricci (Sigilli privati, sigilli ad uso privato, pp. 115-122) si entra nel campo d’indagine della sfragistica: i sigilli privati, troppo spesso trascurati — come lei sostiene — dagli stessi archivisti e studiosi, costituiscono la parte più cospicua del patrimonio sigillografico mondiale, ma studiarli è a tutt’oggi molto difficile per motivi diversi che la Ricci spiega con chiarezza e brevità nel suo intervento. Rifacendosi a Cencetti, esorta la sigillografia italiana a seguire gli orientamenti di quella europea, « volta a creare dei corpora sigillografici di carattere locale, che comprendano l’intera produzione sfragistica di una determinata regione », studiando in tal modo non solo i sigilli più belli e importanti. La successiva relazione di Laura Giambastiani (Le vicende di un archivio gentilizio: il caso Spada, pp. 116-122) ci riporta all’archivio privato nella sua complessità. Prendendo ad esempio l’archivio gentilizio Spada (tra i più significativi della Toscana, visti i prestigiosi incarichi diplomatici assunti da alcuni suoi esponenti), la Giambastiani ripercorre l’iter di alcuni importanti archivi familiari confluiti a vario titolo — per donazione, deposito, acquisto — nell’Archivio di Stato di Lucca, città che da tempi lontani mostra un particolare interesse nei confronti di questa tipologia archivistica. Roberta Corbellini (Gli archivi privati dell’Archivio di Stato di Udine, con una riflessione sul metodo storico, pp. 135150) si sofferma sugli archivi privati dell’Archivio di Stato di Udine, con una riflessione sul metodo storico. Qui vengono elaborate due utili digressioni: nella prima viene analizzato il modo col quale vengono considerati gli archivi privati dalle due generazioni di archivisti avvicendatesi dopo l’Unità d’Italia fino agli anni seguenti alla seconda guerra mondiale; in parallelo la Corbellini traccia un’utile panoramica sulle iniziative pubbliche prese direttamente o indirettamente a favore degli archivi privati in Friuli. A quest’ultimo aspetto si riallaccia la seconda digressione che indaga significativamente sul metodo storico applicato agli archivi familiari friulani, e dalla quale emergono numerosi spunti di ricerca e un’ulteriore conferma del fattore necessi- Notiziario bibliografico tante: il rispetto del vincolo archivistico. Lucia Pillon (L’archivio Coronini Cronberg di Gorizia. La schedatura preliminare all’ordinamento, pp. 151-164) ci porta nel vivo del lavoro archivistico con la schedatura preliminare all’ordinamento dell’Archivio Coronini Cronberg di Gorizia. Un archivio importantissimo per la copertura cronologica (1257-1990) e per la diversità di materiale documentario, ivi raccolto anche per motivi di collezionismo dall’ultimo discendente della famiglia, il conte Guglielmo. Sul piano più propriamente teorico-dottrinario si concentra l’attenzione di Juanita Schiavini Trezzi (I piccoli archivi domestici, pp. 151-164): dapprima fornisce un breve excursus sul dibattito degli archivi privati sviluppatosi in Italia in età contemporanea, evidenziando le tre principali direttive sulle quali si è articolato. Poi rileva come poca attenzione si sia posta all’ordinamento e all’inventariazione degli archivi privati « in rapporto ai problemi metodologici posti dalle loro peculiarità » e come si siano per lo più trascurati gli archivi domestici prodotti dalla piccola borghesia: la loro caratteristica principale è la frammentarietà, derivante soprattutto dalla preselezione di carte operata dalla persona produttrice di quello stesso archivio; e una volta entrate quelle carte saranno soggette ad aggiuntive operazioni di scarto in senso proprio, in quanto non ritenute utili alla conservazione. Urge, pertanto, la salvaguardia di queste piccole fonti documentarie, attuabile — secondo la Schiavini — con tre percorsi complementari, già conosciuti ma riproponibili alla luce della nuova normativa: un maggior approccio psicologico nei confronti dei possessori d’archivio, un recupero della figura degli ispettori onorari (ma con ruolo e denominazione riformulati), una semplificazione amministrativa per la tutela degli archivi stessi; un ultimo consiglio: dotare questi archivi di un inventario analitico. 343 La seconda sezione del libro si apre con la relazione di Dorit Raines (L’arte di ben informarsi. Carriera politica e pratiche documentarie nell’archivio familiare di patrizi veneziani: I Molin di San Pantalon, pp. 187-210): si analizza la composizione di un archivio familiare veneziano — quello dei Molin di San Pantalon — attraverso la carriera politica di uno dei suoi più illustri esponenti, Vettor Benedetto II. Ne risulta che per i patrizi veneziani in questione il modo più efficace per poter svolgere nel ’600 e nel ’700 le funzioni di dirigente era quello di apprendere una « informazione di tipo generale, e in particolar modo, la storia veneziana »; solo in un secondo momento, quando si era delineata la carica da assumere, confluivano nell’archivio documenti relativi ad una specifica magistratura. Questo stato di cose è ben rappresentato dall’analisi tipologica che Raines fa dell’intero archivio. Significativo per la storia dell’arte veneta è il saggio di Martina Frank (Lettura di alcuni episodi di storia dell’arte attraverso l’archivio dei Loschi, famiglia vicentina, pp. 225-240) che, ripercorrendo le vicende dell’archivio familiare dei Loschi, ricostruisce la vera committenza del complesso architettonico di Villa Motterle in Monteviale di Vicenza. Un proficuo contributo per una maggior comprensione della storia istituzionale del Friuli Venezia Giulia viene dato da Liliana Cargnelutti (Gli archivi familiari come fonte per una storia delle giurisdizioni e della nobiltà friulana in età veneta, pp. 225-239) vengono presi in considerazione gli archivi familiari dei Pancera e dei Tartagna, rappresentanti rispettivamente della vecchia e nuova nobiltà, attraverso i quali è possibile ricostruire le varie strategie politiche ed economico-sociali messe in atto dal Parlamento e dalla cittadinanza udinese nel corso dei secoli. XVII-XVIII. 344 Notiziario bibliografico Con Roberto Bizzocchi (Un archivio primogeniturale: Bracci Cambini, Pisa, secoli XVII-XIX, pp. 241-254) si ritorna in terra toscana: analizzando l’archivio dei Bracci Cambini nei secoli XVIIXVIII, l’autore propone il tema della strategia patrimoniale attraverso la primogenitura maschile, ben documentata, per l’appunto, dalle carte familiari in cui è possibile rilevare, leggendo soprattutto le lettere, la « interazione — non contrapposizione! — fra logica del cognome e affettività ». Irene Fosi (Archivi di famiglie e persone toscane nella Roma del Cinque e Seicento: problemi e prospettive di ricerca, pp. 255-276) pone l’attenzione sugli archivi di alcune famiglie toscane di origine mercantile che si inseriscono nel variegato e complicato mondo della nobiltà romana. Analizzando il caso di tre famiglie fiorentine — i Salviati, i Ruspoli e i Sacchetti — la Fosi tende a dare i possibili campi di ricerca che questi fondi archivistici offrono: « il peso della proprietà feudale, la formazione di una cultura nobiliare ed i suoi mutamenti, il ruolo delle carriere ecclesiastiche ». Purtroppo a causa di mezzi di corredo insufficienti, la consultazione di questi archivi non è agevole ma si è comunque in grado di comprendere come le rispettive famiglie abbiano conservato od occultato deliberatamente la propria memoria mercantile. Fondamentale per un primo approccio alla realtà geografica del Sud-Italia è il contributo di Elena Papagna (Archivi di famiglia nel Mezzogiorno d’Italia. Il caso dei Caracciolo di Brienza-Martina, pp. 277-298): ripercorrendo le vicende di un’antica famiglia nobile napoletana, i Caracciolo di Brienza-Martina, la Papagna individua le diverse finalità che hanno portato i componenti di quella famiglia a costituire i propri archivi dal tardo medioevo fino all’Ottocento: studiando i loro documenti è così possibile ricostruire l’evoluzione dell’ideologia nobiliare e quali siano state le motivazioni a conservare una determinata documentazione archivistica piuttosto di un’altra. L’analisi di questo archivio ci permette di riformulare parzialmente il ruolo statico della donna e soprattutto ci permette di constatare come dalla fine del Settecento vengano chiamati dei veri e propri archivisti alla conduzione di quel complesso documentario, pur adottando per il riordino e l’inventario il metodo per materia, all’epoca consuetudinario. Con Elena Riva (Tra Como e Milano. Storie e memorie familiari nella seconda metà del Settecento, pp. 299-330) si ritorna al Nord-Italia: anche in questo caso vengono presi in considerazione due archivi nobiliari nella seconda metà del Settecento, quello dei Giovio di Como e dei Greppi di Milano (di origine bergamasca). I due archivi sono utili non solo per la storia delle due importanti famiglie ma per rapporti inediti con la società economica, civile, culturale e politica dell’epoca, l’archivio Greppi in tal senso è di notevole rilevanza internazionale. Chiudono il volume le note conclusive di Maria Antonietta Visceglia (Archivistici e storici di fronte agli archivi di famiglia. Note conclusive, pp. 331-347), la quale — oltre a riassumere i tratti più significativi del Convegno — propone ulteriori indirizzi di ricerca per far incontrare e confrontare su un terreno comune archivisti e storici: la valorizzazione degli epistolari e delle autobiografie; una rigorosa ricostruzione delle genealogie familiari; inoltre « sarebbe interessante comprendere come struttura e composizione degli archivi mercantili evolvano nel corso dell’età moderna » e capire quanto la consultazione degli archivi familiari abbia influito sulla formazione della classe dirigente italiana nell’Ottocento; infine la Visceglia auspica che il metodo di evidenziare « il nesso tra bisogno di cultura politica e Notiziario bibliografico formazione dell’archivio » venga applicato anche alle famiglie cardinalizie romane o alle famiglie principesche, la qual cosa rivelerebbe senz’altro aspetti ancora sconosciuti. Ugo Falcone GENNARO INCARNATO, La maledizione della terra (1500-1848). Per una storia, non solo agraria, dell’Italia meridionale, Napoli, Loffredo Editore, 2000, pp. 153 (Zelig, 12). Dopo Le « Illusioni del Progresso » nella società napoletana di fine Settecento, raccolta di saggi in due volumi per l’editore Loffredo (1991 e 1993), ancora una volta, l’autore propone una riflessione sulla storia economica e sociale del Mezzogiorno: lo studio della lenta trasformazione dei rapporti affermatisi nel feudo, il passaggio dalla gestione feudale alla gestione borghese, la crisi del riformismo, il ruolo patriarcale degli istituti in antico regime, il trauma della rivoluzione, la Restaurazione. Sono passaggi lenti o repentini, seconda l’ottica con la quale si guardano. Le aspirazioni e i programmi dei riformisti, — il Regno ai loro occhi appare ricco di risorse endogene non sfruttate — prendono forma nei diversi tentativi di razionalizzazione in materia di gestione della terra. Parallelamente la precoce e lunga crisi della aristocrazia incoraggia le speranze dei nuovi ceti emergenti, che contrastano però con gli interessi della Corte. Condotta su un vasto repertorio di fonti archivistiche, arricchita da apporti bibliografici di largo respiro, l’indagine sulla gestione patrimoniale dello Stato d’Atri, nel Ternano, consente all’autore di ridimensionare la portata della « rivoluzione economica » e il conseguente « precoce sviluppo di borghesie » già individuato e 345 discusso da numerosi storici. Incarnato è attento nel ricondurre le fonti letterarie al loro valore di documento: le lettere di Giovanni Antonio Campano, vescovo di Teramo, disegnano il quadro ambientale e agrario, i ritmi di vita degli uomini del tempo. Da Teramo alla Campagna romana è poi il Trattato della caccia del Boccamazza (1548), a delineare uno spaccato della mentalità e della realtà del XVI secolo. A saperlo leggere questo trattato diventa una miniera di informazioni: dov’è, per esempio, il paesaggio agrario che una certa storiografia vuole mal sfruttato da parte di una aristocrazia in fase di rifeudalizzazione? Emerge piuttosto una natura molteplice e varia. La Campagna romana, gli Abruzzi, la Puglia, ovunque « macchia, bosco e coltivo si alternano e si integrano. (...) All’interno di vaste superfici alborate o macchiose vivono numerosi nuclei familiari ». Ma è un equilibrio destinato a durare poco. Ceti dominanti e in ascesa devono fare i conti con questa intensa presenza umana in crescita. Quella in cui si trovano ad operare i duchi, gli Acquaviva d’Atri, è una realtà complessa, lontana dagli indirizzi agrari monocolturali, lontana anche da una retorica che vede la caccia privilegio esclusivo dell’aristocrazia. Già nella Teramo di fine ’400 la caccia degli animali da penna veniva praticata dalla intera collettività. « Con questa democrazia antica dovettero sempre misurarsi i signori feudali, che ebbero successo duraturo solo quando si limitarono ad assolvere la funzione di arbitri e principes ». Un quadro complesso, dicevamo, e dinamico. Sembra di vederli nel bosco di Castellana, « un affannarsi di uomini e animali, un contrasto inestricabile di piccoli e grandi interessi ». Presenza umana diffusa con annessi usi civici, polverizzazione delle forze produttive, progressivo degrado del manto boschivo, « cerque affiancate a terre lavoratorie » riporta il 346 Notiziario bibliografico Liber Singularis Releviorum Ducis Hatriae (1529). Di fronte ad una pluralità di soggetti è difficile individuare con un taglio netto « lì il borghese in ascesa, qui il feudatario monopolista, e infine un proletariato agricolo oppresso ». Belli i brani trascritti dai Processi Civili della Regia Camera della Sommaria (ASNapoli). L’autore rivolge l’attenzione ai quadri intermedi dell’amministrazione signorile, all’analisi dei diversi ceti, ai loro contrasti interni. Una accorta politica matrimoniale solleva gli Acquaviva in piena crisi seicentesca. Viene sottolineato il loro ruolo nella vita di corte a Napoli, le doti di buongoverno e abilità anche di fronte ad uno stato di continuo indebitamento e alla crisi della giustizia ordinaria. Non si hanno però rivolte: dal « viaggio fiscale » del 1529, sappiamo che i vassalli del duca sono soddisfatti del governo degli Acquaviva, le imposizioni feudali nel complesso appaiono limitate. L’anelito dei duchi d’Atri ad una grande politica deve infatti fare necessariamente i conti con le scarse entrate baronali. Purtroppo non c’è credito, le risorse limitate, condizionate dalle rendite fondiarie, decreteranno infine il fallimento dei lungimiranti tentativi di sviluppo civile. Dopo due secoli di viceregno, ecco le riforme, improvvise, a volte contraddittorie, certo destabilizzanti. Incarnato analizza la tensione dell’adattamento alle sfide poste dai tempi nuovi. Il sogno di uno sviluppo armonioso è infranto dal trauma violento dell’invasione francese. Malgrado l’entusiasmo per le riforme, alla prova dei fatti, emerge una arretratezza del Mezzogiorno dovuta più a motivi tecnici e contingenti che ai temuti feudatari monopolisti. Risulta difficile smantellare strutture arcaiche che assolvevano a compiti di « garantismo », strutture di un’organizzazione sociale apparsa « gotica » agli occhi dei riformisti. Le famiglie emerse dal crollo delle speranze dei riformisti: Savini, Cerulli, Ciafardoni, non sono legate ai circoli illuministi. Le vicende, ad esempio, del doganiere Pasquale Cerio, lungo la incontrollabile linea di confine del Tronto, sono indicative di come in una società segnata da guerriglia e anarchia, si è ancora lontani dal vero progresso borghese. La lettura si snoda attraverso il suggestivo paesaggio abruzzese, sfondo dei tentativi di modernizzazione, condizionati però nella pratica quotidiana, e fino a tempi a noi vicinissimi, da questioni di difficile soluzione: impossibile portare avanti la desiderata privatizzazione della terra, presupposto imprescindibile, per lo sviluppo economico e culturale borghese. Non mancano nel volume riferimenti alla coeva Inghilterra e all’Europa. Ampio spazio è dedicato anche al ruolo di mediazione svolto dalla figura dell’intendente, sostituito poi dal prefetto, il tutto nell’ambito di una rigorosa ricerca scientifica. Carmen Sferruzzi VITTORIO LAZZARINI - LINO LAZZARINI, Maestri scolari amici. Commemorazioni e profili di storici e letterati a Padova e nel Veneto alla fine dell’Ottocento e nel Novecento, a cura di GIORGIO RONCONI-PAOLO SAMBIN, Trieste, LINT, 1999, pp. XIV-469. Vittorio Lazzarini (1866-1957) fu insigne studioso di storia padovana, veneziana e veneta in età medioevale, vicedirettore del Museo civico di Padova e poi docente nel locale Ateneo. Suo figlio Lino (nato nel 1906) si dedicò a studi di letteratura italiana, che insegnò, a partire dal 1942, all’Istituto universitario di architettura di Venezia prima e all’Università di Padova poi. L’intensa attività di entrambi entro le istituzioni culturali favorì il loro incontro con personalità di rilievo della cultura internazionale, interessate alla storia politica e letteraria del Veneto. Notiziario bibliografico Giorgio Ronconi e Paolo Sambin hanno avuto la felice idea di raccogliere in un unico volume 48 commemorazioni di studiosi veneti, 24 scritte da Vittorio e 24 da Lino Lazzarini, ognuna corredata dalla bibliografia del singolo studioso, segnalata, curata o aggiornata da Elisabetta Barile. Ne è derivato un repertorio biobibliografico estremamente ricco per chi si occupa di storiografia veneta, contributo che abbina al valore scientifico la capacità di ricostruire anche attraverso le vicende umane un clima e un ambiente ricco di fermenti e di entusiasmi. Gli studiosi presenti nel volume sono: Giovanni Monticolo, Andrea Gloria, Enrico Simonsfeld, Carlo Cipolla, Giulio Bistort, Giuseppe Pellegrini, Giuseppe Occioni Bonaffons, Arnaldo Segarizzi, Horatio Forbes Brown, Pompeo Molmenti, Eugenio Musatti, Antonio Medin, Gaetano Cogo, Giovanni Marchesini, Nino Tamassia, Pietro Bertini, Vincenzo Crescini, Antonio Battistella, Giuseppe Albertotti, Lando Landucci, Nicola Jorga, Guido Mazzoni, Luigi Rizzoli, Luigi Alpago Novello, Emilio Lovarini, Giovanni Bertacchi, Oliviero Ronchi, Natale Busetto, Paolo Maria Tua, Gasparo Zonta, Sebastiano Serena, Arnaldo Ferraguto, Manlio T. Dazzi, Pier Luigi Chelotti, Luigi Gaudenzio, Michele Benetazzo, Mario Todesco, Venanzio Todesco, Attilio Dal Zotto, Giuseppe Biasuz, Giorgio Oreffice, Giuseppe Aliprandi, Novello Papafava dei Carraresi, Umberto Campagnolo, Ezio Franceschini, Marino Gentile, Emilio Menegazzo, Fabio Metelli. I curatori forniscono inoltre il profilo biografico e la bibliografia di Vittorio e di Lino Lazzarini e corredano il volume di un indice dei nomi di persona e dei luoghi. Giorgetta Bonfiglio-Dosio 347 ALDO A. MOLA, Corda fratres. Storia di un’associazione internazionale studentesca nell’età dei grandi conflitti (1898-1948), Bologna, CLUEB, 1999, pp. 202 (Università degli studi di Bologna, Collana di studi). L’autore di questo studio, dedicato a una associazione che svolse un ruolo fondamentale negli anni compresi tra la crisi di fine secolo e lo scoppio del primo conflitto mondiale, è ben consapevole della sua natura pionieristica, sia per la mancanza di studi precedenti, sia per la dispersione delle fonti relative e ne enuncia con giusta soddisfazione tale caratteristica fin dalle premesse. D’altra parte il suo curriculum scientifico non è nuovo a questi percorsi, basti pensare alla sua fortunata Storia della massoneria italiana dalle origini ai giorni nostri, che molti anni fa, quando gli studi sull’ordine erano ancora limitati e settoriali, avviò una ricerca sistematica utilizzando gli archivi dell’organizzazione. La Federazione internazionale studentesca Corda fratres (Cuori fratelli) nacque nel 1898 dall’intuizione del torinese Efisio GiglioTos, allora ventottenne, convinto della validità di rinnovare i legami di solidarietà e fratellanza delle antiche confraternite universitarie, nel mondo diviso dagli incipienti nazionalismi della fine del XIX secolo. L’iniziativa si rivelò rapidamente il frutto di un felice intuizione di cui furono prova le iscrizioni sempre più numerose che nel corso di una quindicina d’anni, alla vigilia del primo conflitto mondiale, portarono gli universitari italiani iscritti a circa settemila. Ma l’organizzazione studentesca mossa dalla fede nel ruolo che una nuova « internazionale » delle menti avrebbe potuto svolgere una dimensione più vasta, non si fermò entro i confini nazionali, e sezioni affratellate nacquero nelle principali sedi universitarie: in Belgio, Francia, Ungheria, Polonia, Romania, Svizzera. In Italia, 348 Notiziario bibliografico le adesioni crescenti e le intense attività pubbliche e congressuali furono accompagnate dal plauso di personaggi eminenti, a cominciare dai maggiori leaders politici e di governo, e da intellettuali di prestigio. Basti ricordare che tra i soci e presidenti dell’associazione ci furono Angelo Fortunato Formiggini, Guglielmo Marconi e Giovanni Pascoli. A quest’ultimo si deve anche la composizione dell’inno in latino della Corda fratres, che rivendicava la fratellanza studentesca come base su cui costruire in futuro la fratellanza universale, in nome della pace e della solidarietà tra i popoli: pax in iure gentium, come suonava la formula di Efisio Giglio-Tos. Questi ideali, la base di massa dell’organizzazione e la sua proiezione internazionale ne facevano un interlocutore quasi naturale della Massoneria, che si preoccupò quasi subito di « infiltrarla », cercando con alterne fortune di pilotarne in qualche modo il cammino. Di qui un ulteriore elemento di interesse di questa storia pressoché sconosciuta che ci offre indirettamente anche un capitolo inedito delle vicende dell’Ordine massonico. Come altre, e ben più potenti internazionali, anche la Corda fratres venne sostanzialmente travolta dallo scoppio della prima guerra mondiale e i cordafratrini si trovarono, durante il conflitto, costretti in opposte trincee. Ma il seme era penetrato in profondità e tentò di ridare frutti dopo la guerra, finché il fascismo non ne decretò la fine. Inutili furono quindi i tentativi dopo la seconda guerra mondiale di riprenderne le fila, perché l’età dell’innocenza e dei sogni metapolitici era ormai tramontata. Questo, per sommi capi, è il cuore della ricerca condotta da Aldo A. Mola su fonti di prima mano: dall’archivio Formiggini, conservato presso la Biblioteca Estense di Modena, all’Archivio storico dell’Università di Bologna ad una lunga serie di collezioni e archivi privati che hanno consentito all’autore di mettere a fuoco i primi tasselli di un percorso di studio di cui questo volume è necessariamente soltanto il primo capitolo. Aldo G. Ricci Riformagioni della Repubblica di Lucca (1369-1400), IV, Febbraio 1373Dicembre 1374, per cura di GIORGIO TORI, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1998, pp. I-LXXXVIII; 1-720 (Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831. Serie III, Parlamenti e Consigli maggiori dei Comuni italiani). Tra gli « Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831 », ordinati dalla Commissione costituita presso l’Accademia dei Lincei, hanno grande rilievo sul piano della storia delle istituzioni le Riformagioni della Repubblica di Lucca, provvedimenti approvati dagli organi istituzionali di cui i lucchesi erano dotati fra 1369 e 1400, anni per la Repubblica di una ritrovata libertà. La collana accademica era, infatti, ferma, salve rare eccezioni, alla fine del secolo XIX. Va quindi ascritto a Giorgio Tori, direttore dell’Archivio di Stato di Lucca, e a Antonio Romiti, ordinario di archivistica presso l’Università di Firenze, il merito di avere dato novello impulso alla serie dell’Accademia dei Lincei che annovera opere riguardanti Parlamenti e Consigli maggiori dei Comuni italiani, avvicendandosi nella pubblicazione, a partire dal 1980, dei primi quattro volumi delle Riformagioni lucchesi, dei quali tre attengono al periodo marzo 1360 - gennaio 1373 e il quarto riguarda l’arco temporale compreso fra il febbraio 1373 e il dicembre 1374. I due studiosi hanno trascritto i testi dei principali provvedimenti giuridici che si presentano raccordati tra loro da Notiziario bibliografico puntuali note e da un approfondito commento — uno per ogni libro — che traccia le linee salienti del quadro storico e politico in cui vanno collocati i documenti, senza trascurare gli aspetti sociali e finanziari e anche la tecnica di registrazione da parte di chi ha operato come cancelliere dello Stato, imprimendo un suggello formale agli atti normativi della Repubblica. L’opera, omogenea nella struttura e dotata di preziosi indici e elenchi dei nomi dei membri che hanno partecipato alle assemblee degli organi deliberanti e esecutivi, facilita un approccio graduale con la difficile materia istituzionale, la cui complessità discende principalmente dall’interferenza di poteri di natura diversa sui diritti fon
Scarica