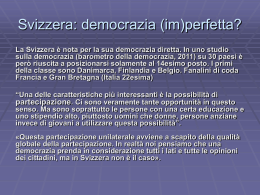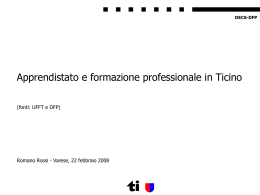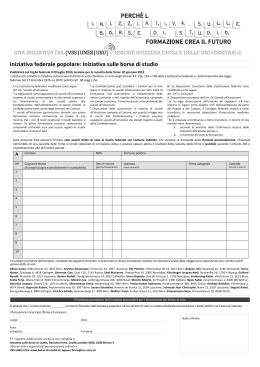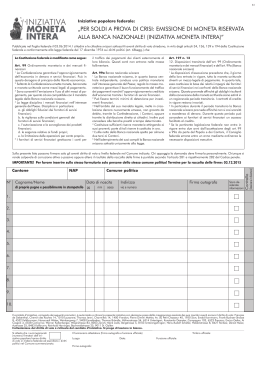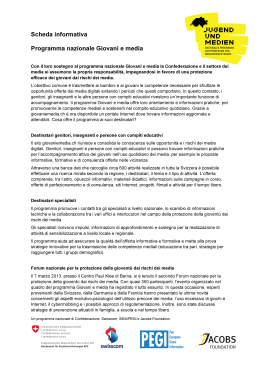Direttore: Francesco Gui (dir. resp.). Comitato scientifico: Antonello Biagini, Luigi Cajani, Francesco Dante, Anna Maria Giraldi, Francesco Gui, Giovanna Motta, Pèter Sarkozy. Comitato di redazione: Andrea Carteny, Stefano Lariccia, Daniel Pommier Vincelli, Vittoria Saulle, Luca Topi, Giulia Vassallo. Proprietà: “Sapienza” - Università di Roma. Sede e luogo di trasmissione: Dipartimento di Storia moderna e contemporanea, P. le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma tel. 0649913407 – e - mail: [email protected] Decreto di approvazione e numero di iscrizione: Tribunale di Roma 388/2006 del 17 ottobre 2006 Codice rivista: E195977 Codice ISSN 1973-9443 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Indice della rivista luglio – settembre, 2014, n. 32 STUDI E RICERCHE Riflettendo sull’identità storica degli stati dell’Unione europea di Francesco Gui p. 3 La Costituzione del 1848 e la nascita dello Stato federale svizzero di Vera Nava p. 34 Eugenio Colorni e la riflessione europeista nel Partito socialista italiano dagli anni Trenta alla Resistenza di Giulia Vassallo p. 121 *** RECENSIONI Maria Antonietta Visceglia (a cura), Papato e politica internazionale nella prima età moderna, Viella, Roma 2013 di Giovanni Contel p. 144 2 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Riflettendo sull’identità storica degli stati dell’Unione europea di Francesco Gui Il recente caso del referendum scozzese, dall’imponente rilevanza potenziale per l’Inghilterra, ma anche per l’intero continente, induce a riflessioni e ad approfondimenti che vale la pena si estendano ben al di là delle dinamiche politiche contingenti, nonché della singolarità dell’esperienza scozzese, per abbracciare l’intera Europa. Al di là del risultato della consultazione, il riemergere di un regno di età medievale, seppure mai del tutto estinto all’interno del Regno Unito, aspirante a rivendicare la propria indipendenza con il fine di inserirsi nel più vasto contesto dell’Unione europea, sollecita considerazioni in cui la consapevolezza storica può intervenire con non trascurabili apporti. In prima battuta torna alla mente, provocando un minimo di vertigine, l’ammirazione con cui Luigi Einaudi, nei suoi celebri articoli scritti a conclusione della prima guerra mondiale per auspicare la federazione europea, giudicava l’unione settecentesca fra i regni d’Inghilterra e Scozia quale esempio eccellente di associazione volontaria fra stati1. Evidentemente anche in quel lodevole connubio, tutto da imitare, avrebbero potuto intervenire nel tempo ripensamenti e regressi. A tale proposito, l’impressione di chi scrive è che sia stato proprio l’odierno assetto politico ed istituzionale dell’Unione europea a contribuire all’attualizzazione e al rilancio delle problematiche di cui la Scozia è risultata protagonista, con la Catalogna beninteso al seguito. Basti pensare alle conseguenze dell’allargamento ai Balcani, condotto aprendo le porte alle singole statualità sortite dalla frammentazione della ex Jugoslavia, Ma non si dimentichi nemmeno la secessione della Slovacchia dalla Repubblica Ceca, attuata nella prospettiva dell’adesione all’Unione. Ad oggi, insomma, venir 1 Cfr. per esempio l’articolo uscito sul Corriere della Sera del 5 gennaio 1918, consultabile on line. F. Gui, Riflettendo 3 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 riconosciuti come stati sovrani, ma al tempo stesso membri della Ue, può risultare traguardo davvero incoraggiante per leader e popolazioni che ambiscano a veder valorizzata la propria identità, con sicuro accrescimento in termini di prestigio ed influenza. A riprova, una volta eventualmente raggiunta l’indipendenza, la Scozia, o la Catalogna, o l’antico ducato di Milano? potranno schierare propri membri nel Consiglio europeo, nella Commissione, nel Consiglio dei ministri (con diritto a presidenze semestrali tanto sbandierate dai titolari, Italia compresa), nella Corte di Giustizia e nella Corte dei Conti; inoltre saranno dotati di diritto di veto (con conseguenti potenzialità, diciamo, di contrattazione) su tematiche essenziali per l’Unione; infine godranno di una sovrarappresentazione nel Parlamento europeo e potranno tutelare più direttamente i propri interessi. Non che si tratti certo di processi scontati e inarrestabili. Per fronteggiare i possibili divorzi, e la Scozia se ne è dimostrata consapevole, gli stati minacciati dispongono inter alia del diritto di veto al successivo ingresso nell’Unione dei fedifraghi. Tuttavia resta indiscutibile che dall’attuale configurazione istituzionale della Ue sia derivato un potente incoraggiamento alla riscoperta di antiche identità, nazionali o statuali che fossero. Anche perché, appunto, tale recupero è in gran parte già avvenuto - si pensi agli stati baltici - specie dopo il tracollo del sistema sovietico e l’ingresso dei nuovi membri nell’Unione. Con in più, da non sottovalutare, la prospettiva di ulteriori allargamenti. Pertanto, anche qualora nessuna delle attuali rivendicazioni indipendentistiche andasse a buon fine, il problema della composizione e della identità degli attuali stati dell’Unione resterebbe ampiamente all’ordine del giorno, insieme all’opportunità di compiere su di essi un’approfondita indagine storica. Tale indagine potrà presumibilmente fornire un contributo in vista della messa a punto di un sistema istituzionale più confacente alle realtà “effettuale” dell’Unione a 28 membri, nonché candidata ad aprirsi a nuovi ingressi negli anni a venire. Ingressi ed anni a venire, d’accordo, non immediati, dopo le recenti dichiarazioni del neopresidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, che ha escluso inclusioni di neofiti nel prossimo quinquennio, e pur tuttavia dati per scontati nel medio termine, oltre che apertamente auspicati anche da governi come quello italiano. Allo stato dei fatti, a fronte del paritario riconoscimento della dignitas di stato nazionale sovrano ai suddetti 28 (e venturi), non si può non constatare una profonda diversità, non solo demografica, fra lo stato sloveno o lussemburghese (o montenegrino), tanto per dire, e lo stato federale tedesco. Una diversità che supera di gran lunga le disparità riscontrabili negli Usa fra la California e il Delaware, o il Maine. Di conseguenza, è possibile rilevare lo sconcertante paradosso per il quale, in tutte le istituzioni della Ue, la maggioranza delle F. Gui, Riflettendo 4 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 poltrone viene occupata – lo ha notato anche la deputata francese Sylvie Goulard – da esponenti di stati europei che la rappresentano piuttosto marginalmente. Scrive infatti l’europarlamentare: Ces dernières années, la physionomie de l’Union européenne s’est profondément modifiée. Les six Etats membres les plus peuplés qui comptent chacun entre 40 et 80 millions d’habitants (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et Pologne) représentent plus des deux tiers de la population européenne (360 millions au total sur 500 environ) et les trois quartes de son PIB. Les dix suivants comptent entre 7 et 19 millions de resortissants et pèsent 22% de la population européenne et 13% de son PIB; quant aux douze Etats restants, les moins peuplés, il comptent 7% de la population, 14% de sa richesse. 22 commissaires sur 28 viennent des pays représentants moins d’un tiers de la population européenne. Est-ce raisonnable?2 Ma lo stesso dicasi, come accennato, della Corte di Giustizia o della Corte dei Conti, oltre che sotto tanti altri profili. Il risultato è la sensazione di un notevole squilibrio complessivo, solo in parte fronteggiato dalle disposizioni dei trattati riguardanti il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri, che esigono un “retroterra” del 65 per cento di popolazione dell’Unione, oltre al 55 per cento degli stati, affinché si possa legittimamente adottare una decisione a maggioranza3. Il quale paradosso, notato en passant, autorizzerebbe a riconoscere le sedi eminentemente intergovernative come le più rispettose dei principi democratici all’interno dell’Ue. Ciò detto, sia come sia, di fatto in tutte le altre istituzioni dell’Unione – e a differenza degli Usa, dove la Corte federale, per esempio, conta solo nove membri, nominati a vita dal Presidente, d’intesa con il Senato – continua a vigere imperterrito il principio che si direbbe “one state, one chair”. Con il risultato, per un verso, di incoraggiare i ricordati tentativi di secessione alla scozzese, per l’altro di rendere poco credibili le istituzioni dell’Unione. Il che, stante anche la crisi economica e politica corrente, si propone oggettivamente come problema centrale, sia pure sorprendentemente, o scientemente, tralasciato. Eppure, persino un commissario lituano ha di recente lamentato la difficoltà di risultare rapidi e concreti con 28 diritti di veto incombenti sui processi decisionali, mentre la Corte tedesca di Karlsruhe ha sentenziato da tempo che il Parlamento europeo non può essere considerato espressione realmente democratica della volontà del popolo europeo in quanto la iperrappresentazione dei paesi piccoli inficia pesantemente il principio “one man, one vote”. Paradossalmente si potrebbe affermare che la nascita di uno stato scozzese o catalano, per non parlare del già menzionato ducato di Milano Cfr. Sylvie Goulard, Europe: amour ou chambre à part?, Flammarion 2013, pp. 31-32. Sistema ufficialmente in vigore dal 1 novembre 2014; se il Consiglio non delibera su proposta della Commissione, la maggioranza qualificata deve raggiungere invece almeno il 72% degli Stati membri rappresentanti almeno il 65% della popolazione. 2 3 F. Gui, Riflettendo 5 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 o della repubblica veneta, avrebbe il merito di contribuire al riequilibrio dei rapporti istituzionali e di potere, almeno formale, all’interno dell’Unione. Appare pertanto indispensabile, anche allo stato attuale, riflettere su come ovviare agli inconvenienti suddetti, se non altro in vista delle annunciate riforme, per quanto in lontananza, delle comuni istituzioni. A titolo di esempio: la futura Camera degli Stati o Senato della Ue, volendo rifarsi ancora al modello americano, prevedrà immancabilmente la presenza di due senatori per ogni stato membro, grande e piccolo che sia? o magari invece, pensando alla Germania, si riconoscerà la titolarità della Baviera, della Sassonia e di altri Land ad esprimere due senatori per ciascuno, come concesso alla Croazia o alla Lettonia? o sarà ancor meglio prendere qualcosa a prestito dal federalismo svizzero, su cui più avanti? Sicuramente ne uscirebbe un assetto più equilibrato, senza necessariamente attentare all’unità di quelli che chiamiamo gli stati grandi. E ancora, ma perché mai dotarsi perennemente, con tutto il rispetto, di giudici della Curia estoni e maltesi (e poi albanesi) e invece never, se non per caso, di togati scozzesi (salvo futuri successi indipendentistici per ora scongiurati), ovvero partenopei, che pure di cultura giuridica masticano qualcosa? Si tenga in conto infine, ricorrendo a comparazioni e proporzioni, che a 315 milioni circa di cittadini statunitensi fanno riscontro ben 50 stati membri della Federazione, mentre gli 8 milioni di svizzeri si dividono in 26 cantoni: solo due in meno, cioè, rispetto alle entità entro cui si raccolgono più di 500 milioni di europei. Ma al di là di questo - per quanto si tratti di materia, quella istituzionale, decisamente cruciale non meno che strategica – dedicarsi ad un puro esercizio di spassionata riflessione sulla natura e l’identità storica dei presunti 28 stati nazionali sovrani può comunque risultare giovevole. Nell’attesa di estendere la ricognizione, in una successiva occasione, ai protagonisti dei futuri, per quanto non immeditati allargamenti. Analizzare con una certa meticolosità la contrastata policromia degli attuali componenti dell’Unione – la quale raccoglie in sé, accantonando la Russia, i candidati balcanici e pochi altri, la maggior parte del continente - si presume susciti in ogni osservatore scintille di puro interesse conoscitivo, stimolazioni all’assemblaggio e ordinamento di nozioni già acquisite, incoraggiamenti a piccole e grandi scoperte soggettive, o magari momenti di autocoscienza collettiva. Il piacere, insomma, di riflettere su un puzzle decisamente suggestivo, anche perché ad ognuno di noi, cittadini dell’Unione, assai intensamente connesso. Con la doverosa premessa, sia ben chiaro, che l’esercizio proposto in questa sede rappresenta soltanto un primo tentativo, sicuramente elementare, F. Gui, Riflettendo 6 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 incompleto ed emendabile, di una investigazione che questa pubblicazione si ripropone però di allargare e proseguire anche nei numeri successivi. Taglia media ovvero regolare, radicata nel tempo. Con parecchie originalità Volendo trovare un punto di partenza, che rimanda peraltro alle irrequietezze scozzesi, si può notare come, malgrado le tante traversie, una quota consistente degli attuali stati membri della Ue, in genere di media dimensione demografica e territoriale, rappresenti una sorta di modello base. In pratica, sia rimasta sostanzialmente invariata nella configurazione di erede di antico regno (magari non sempre ab origine e più tardi sovente trasformato in repubblica) risalente in linea di massima all’età medievale, ovvero all’epoca dell’adesione alla Christianitas mediante riconoscimento imperiale e/o papale. Seppur spesso sottomessi o subordinati a potenze maggiori, tali stati hanno conservato fino ad oggi – pur con traumi eccezionali come la spartizione polacca – dei caratteri di specifica identità e nazionalità. Laddove il riferimento alla Christianitas – detto di sfuggita, ma non troppo - rimanda al fattore religioso-culturale di origine semitica, fatto proprio anche da Roma imperiale, che nel corso del primo millennio ha costituito il maggior fattore di unificazione fra le diverse entità del continente Europa. Per citarli complessivamente, i soggetti modello base sarebbero: i regni di Svezia, di Danimarca, di Olanda (quest’ultima risultato di una nota scissione rispetto al Belgio asburgico, alias Paesi Bassi cattolici, su cui più sotto), nonché le repubbliche del Portogallo, d’Irlanda (con note appropriazioni britanniche), di Croazia, di Bulgaria, Ceca (alias Boemia, più Moravia con ricordi di antica grandezza) e di Ungheria. Fra tali entità, quelle mantenutesi sempre o quasi sempre indipendenti sono: la Svezia (9,2 milioni di cittadini, 445 mila kmq di superficie, 20 Mep, cioè Members of European Parliament), la Danimarca (5,5m, 43,1m.kmq, 13Mep), l’Olanda (16.4m, 41,5m.kmq, 26Mep), il Portogallo (10,6m, 92m.kmq, 21Mep). Quanto alle restanti, rimaste a lungo subordinate a potenze superiori nell’età moderna ed emancipatesi con la prima guerra mondiale, salvo ulteriori strascichi, ecco l’elenco: Croazia (4,4m, 56,6m.kmq, 11Mep), Repubblica Ceca (10,5m, 78,8m.kmq, 21Mep), Ungheria (10m, 93m.kmq, 21Mep), Bulgaria4 (7,6m, 112m.kmq,17Mep), cui va aggiunta l’Irlanda (4.5m, 70m.kmq, 11Mep). Le popolazioni dei suddetti stati membri della Ue oscillano dai 4.4 della Croazia o dai 4,5 dell’Irlanda (per quanto monca) ai 16.4 milioni di abitanti dell’Olanda, per un’estensione che varia dai 41.500 kmq, sempre dell’Olanda, ai Il principato di Bulgaria venne riconosciuto, seppur in dimensioni ridotte, alla conferenza di Berlino del 1878, ma solo nel 1908, a seguito di notevoli travagli, peraltro destinati a proseguire, si ritrovò indipendente sotto uno “zar” di Sassonia Coburgo-Gotha. 4 F. Gui, Riflettendo 7 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 112 mila dell’antropicamente rarefatta Bulgaria. Alcuni di essi contengono al proprio interno delle minoranze, ma non tali, si direbbe, da costituire potenziali soggetti autonomi. Ma perché poi escludere da questa tipologia le repubbliche della Grecia (11,2m, 132m.kmq, 21Mep) o dell’Austria (8,3m, 83,8m.kmq, 18Mep)? In effetti la loro vicenda, alquanto paradossale, oltre che imperiale, le pone in una posizione sostanzialmente analoga, seppur anche parecchio ellittica rispetto alla classificazione finora proposta. Dell’identità nazionale della Grecia difficile dubitare, salvo l’emigrare dal suo baricentro ateniese-peloponnesiaco classico verso la temperie ellenistica e successivamente alla Costantinopoli romanobizantino-ortodossa, per poi sgombrare dallo Stretto sotto il dominio turco, fino a ritrovarsi con se stessa, nuovamente ricollocata attorno ad Atene in età risorgimentale, anno 1829, in qualità di regno affidato a dinastie germaniche. Dopodiché il tormentoso seguito, che avrebbe portato da ultimo all’abolizione della dittatura dei colonnelli, o regime di destra post seconda guerra mondiale, e all’ingresso nelle Comunità nel 1981, aprendo così la strada al secondo allargamento, quello mediterraneo, riguardante anche le altre due dittature parafasciste prolungatesi nel dopoguerra occidentale, salazariana e franchista. Anche la Grecia, entità di taglia media dal punto di vista demografico e territoriale, può annoverarsi pertanto, sia pure con dei distinguo, nella schiera degli stati a radicamento nazionale già presenti con propria sovranità nel Medioevo e ancor prima. Peccato però per le tensioni, anche territoriali, non minimali con il vicino portatore di religiosità non cristiana, responsabile della caduta dall’apice bizantino e della prolungata cancellazione dell’identità politica del popolo greco. Alla medesima tensione con il vicino può presumibilmente ricondursi il mantenimento di una confessione religiosa “predominante” nella costituzione greca, che potrebbe teoricamente interferire con la giurisprudenza e la concezione dei diritti emananti dalle fonti europee competenti. Un tema ad oggi tutto sommato marginale, seppure non isolato (che dire di Elisabetta, capo della Chiesa anglicana?), ma destinato a fermentare parecchio qualora il vicino scomodo, un tempo drasticamente laico, oggi di meno, si vedesse accolto nel novero dei componenti l’Unione brussellese5. Itinerante, eccezionale, discontinuo, travagliato, di tardiva modernizzazione ordunque l’assetto greco, laddove, detto di sfuggita, anche sulla radicata ovvero recente saldezza ed efficienza degli assetti amministrativo-istituzionali dei singoli paesi varrebbe la pena, quando possibile, di azzardare una classificazione. Ma tant’è. Passando a questo punto In senso proprio una religione di Stato, cattolica, vige a Malta, mentre sussiste una chiesa di stato nazionale luterana in Danimarca (come in Norvegia o Islanda), accanto all’anglicana inglese e all’ortodossa greca. 5 F. Gui, Riflettendo 8 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 ad uno dei modelli di eccellenza in fatto di amministrazione, vale a dire alla felicemente nuziale statualità austriaca, risulterà difficile negarne la natura di soggetto portatore di ininterrotta sovranità dal Medioevo ad oggi (salvo scivolone in età hitleriana). E che sovranità, se l’Austria asburgica ha interpretato per secoli il potere imperiale innalzato ai vertici dell’Europa, nonché il soggetto assiso su parecchi popoli circonvicini, con ramificazioni a dir poco tentacolari6. Eppure, in quanto Austria, a sua volta divisa in superiore e inferiore, la signora della cosiddetta Mitteleuropa non è stata mai un regno e nemmeno un elettorato del Reich (salvo passare allo status imperiale in età napoleonica), bensì un pur prestigiosissimo ed unico arciducato. Peraltro quello asburgico si configurava come un assetto plurinazionale, con note insofferenze ungheresi e non solo, mentre l’Austria in quanto tale avrebbe mantenuto le dimensioni che conosciamo, insieme alla coscienza nazionale immersa nella più grande identità germanica. Sicché, durante la ricordata età hitleriana - ma già alla Dieta di Francoforte - non sarebbe parsa così improponibile l’aggregazione viennese al resto della nazione tedesca unificata. In definitiva, l’Austria come Austria, malgrado il fantasmagorico passato, non risulterebbe poi tanto incomparabile rispetto a Baviera (12,4m) o Prussia, ambedue già regni e neanche di poco conto. Eppure Vienna resta l’unica ad esser dotata di piena sovranità, tanto da far invidia ai lontani e insofferenti scozzesi, per parte loro tuttora dotati di uno status regale, seppur a suo tempo votatosi all’abbraccio britannico. Dal singolare curriculum dell’Austria possiamo peraltro attenderci a tutt’oggi una certa capacità di influenza sulle regioni circonvicine, a conferma di un’altra sfumatura dei rapporti di convivenza fra europei, ovvero della sussistenza di aree transfrontaliere dotate di una relativa omogeneità, dall’Alpen-Adria alle solidarietà baltiche, a non poche altre. Sempre in riferimento all’Austria vale ancora la pena di sottolinearne – con qualche complicazione per un’ipotesi di Unione sovranazionale - la politica di neutralità, che la associa a Svezia, Finlandia, Irlanda, Cipro, Malta, paesi almeno per ora non aderenti alla Nato, seppur nel contesto della Pesc e della Pesd della UE, da cui soltanto alla Danimarca è stato concesso l’opting-out in materia di difesa. Al novero fin qui citato vanno infine aggiunte le singolari specificità del regno belga, ereditate dalla Gallia omonima in singolare intreccio lotaringico con Olanda e Lussemburgo, nonché quelle che associano due ulteriori, recenti stati membri, collocati l’uno alle estremità nordiche, l’altro sud-orientali Sulla storia austriaca si vedano le istruttive considerazioni di Giuseppe Galasso in Nell'Europa dei secoli d'oro: aspetti, momenti e problemi dalle guerre d'Italia alla Grande Guerra, ed. Guida, Napoli 2012, p. 129 e ss. 6 F. Gui, Riflettendo 9 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 dell’Unione: vale a dire la Finlandia, entrata nel 1995, e la Romania, accolta nel 2007. Per parte sua, il Belgio (10,7m, 30,5m.kmq, 21Mep), schiera una città che è stata una capitale d’Europa già all’epoca di Carlo V, ma al tempo stesso porta notoriamente in seno tutta la complicata storia delle Fiandre, o Paesi Bassi, caratterizzata dalla compresenza di popolazioni gallo-romane e germaniche, dall’appartenenza all’Impero e al ducato di Borgogna, non meno che dalle divisioni a carattere religioso, a seguito delle travagliatissime guerre confessionali della prima età moderna. Pertanto il Belgio, separatosi dalle Province Unite olandesi e rimasto sotto controllo asburgico austro-ispanico per poi cadere sotto quello francese, avrebbe finito per costituitosi in regno autonomo e sovrano nel 1830, ospitando in sé fiamminghi e valloni cattolici (affiancati dalla minoranza germanofona a conclusione della prima guerra mondiale). Il quale assetto indipendente evidentemente non contrasta con il radicato legame fra i pur litigiosi stati nordico-lotaringici, testimoniato dalla sussistenza del Benelux, il trio cofondatore delle Comunità, né può far dimenticare che talune città dell’area – anche l’olandese Utrecht - sono state fin da epoche remote indicate dai filosofi e politici visionari dell’unità europea come sedi ideali delle comuni istituzioni trans o sovranazionali. Con l’odierna aggiunta, altrettanto lotaringica, della Strasburgo euro-parlamentare ed euro-giudicante (quest’ultima operante per il Consiglio d’Europa, ovviamente, collocandosi notoriamente a Lussemburgo la Curia della Ue). Non un’unità statuale con dignità di regno fin dal Medioevo, in ogni caso, il Belgio; non una solida entità spiccatamente nazionale giunta alla sovranità autonoma, o tanto meno ricongiuntasi in età risorgimentale. Caso mai uno stato di tipo federale con la vocazione a non far dimenticare del tutto la conformazione aggregativa delle Fiandre gallo-romano-fiammingo-germaniche sussistita fin agli esordi dell’età moderna. Tant’è che esso non risulta affatto immune al suo interno – ulteriore complicazione del quadro - da tensioni imitative delle pulsioni scozzesi o catalane. Eppure un asse portante degli equilibri europei, ancora il Belgio, che per le sue dimensioni e il certamente non breve radicamento storico-istituzionale può essere aggregato, scongiurando lacerazioni, agli stati “modello base” su cui in esordio. Quanto alla Finlandia (5,3m, 338m.kmq, 13Mep), essa non ha mai costituito, benché caratterizzata etnicamente, un’entità sovrana, bensì un ducato interno alla monarchia svedese, per poi diventare, inizi dell’Ottocento, granducato dell’impero russo, sia pure con caratteri di autonomia e con una propria costituzione, che metteva le basi per il traguardo dello stato nazionale sovrano. Quest’ultimo veniva raggiunto alla fine del primo dopoguerra novecentesco, con tutte le tensioni successive fra tendenza filotedesca e F. Gui, Riflettendo 10 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 condizionamento sovietico, perdurato fino alla caduta del Muro. Ed anche oggi, si sa, le folate da Est non mancano. Ciononostante, la Finlandia, alla fin dei conti, potrà vedersi inserita nel modello basic come il Belgio. Lo stesso dicasi, seppure con consistenza demografica assai più corposa e con vicende storiche nettamente diverse, per la Romania (21,5m, 237,5mkmq, 32Mep). Frutto dell’unificazione ottocentesca di Valacchia, Voivodina e Transilvania, unite da un’affinità secolare pur nella distinzione fra voivodati e malgrado la secolare soggezione alle potenze circonvicine, l’erede del popolo daco-romano, di obbedienza cristiano-ortodossa, si presenta con una forte identità nazionale. Il che non può tuttavia far dimenticare sia la sussistenza all’interno dello stato di consistenti minoranze ungheresi, tedesche e turche, sia le ingenti ramificazioni della comunità romena (ben 9 milioni) insediate soprattutto in Moldavia, a seguito delle ingerenze sovietiche, ma anche altrove nei Balcani. Una riprova, su cui si tornerà sopra, delle complicazioni etniche assai diffuse, e aggrovigliate ancora un po’ di più quelle belghe, riscontrabili nell’area orientale dell’Unione. Nel complesso, per chiudere sul punto, dodici paesi membri, più la complessa Romania, oltretutto albergatrice di fitte entità zigane, rispondono alla tipologia “ottimale” sovraindicata, cui potrebbe aggiungersi anche la Polonia, se non fosse per le dimensioni, che la inseriscono fra i pezzi grossi dell’insieme, e per i noti scombussolamenti territoriali, di evenienza novecentesca, su cui si richiede un minimo di approfondimento. Piccolo è bello? Non necessariamente, salvo ritocchi elvetici Se le entità fin qui citate rispondono in maniera, esageriamo, “ottimale” alle caratteristiche dell’assetto di tipo federale tortuosamente perseguito dalla Ue - e lasciando stare per ora che i tre più importanti, almeno per dimensioni, stati “fondatori”, dicesi Francia, Germania, Italia, non rientrano nel novero - si venga ora ai primi casi di maggiore criticità. Il Lussemburgo, di minime dimensioni (0,5m, 2,5m.kmq, 6Mep), ha il merito o la fortuna di essere l’unico ducato di origine imperiale conservatosi tale fino ai nostri giorni, pur essendo passato da una subordinazione all’altra, l’ultima all’Olanda ottocentesca, tanto da giungere alla dignità di stato nazionale sovrano fondatore delle Comunità europee. Ma non solo, giacché gli esponenti del Lussemburgo hanno ripetutamente svolto incarichi importanti (cuscinetto fra i grandi?) nel contesto comunitario e dell’Unione, come capita sovente ai cosiddetti “paesi piccoli”, specie se aderenti al Benelux. Eppure, sarà possibile definire stato sovrano, e magari nazionale, il Lussemburgo? Certo, non va dimenticato che la nativa dinastia, si pensi a Carlo IV, quello della Bolla d’oro, quello che lo eresse a ducato, sedeva sul trono imperiale già in pieno F. Gui, Riflettendo 11 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Medioevo, più o meno come Jean-Claude Juncker a Palazzo Berlaymont di questi tempi. Però, obiettivamente, come entità statale a tutti gli effetti, il granducato (divenne tale al congresso di Vienna) può sollevare qualche quesito, insieme alle altre qui di seguito in elenco. La Slovenia (2m, 20,2m.kmq, 8Mep), per esempio, corrispondente in buona parte al ducato di Carniola, ha sempre costituito un Land slavofono dell’Austria (mentre la parte litoranea apparteneva a Venezia), mai rettosi come stato autonomo, per poi accorparsi alla neonata Jugoslavia nel 1918. Indubbiamente la repubblica con a capo Lubiana è da considerarsi uno stato sovrano, riconosciuto a livello internazionale dopo la fine dei regimi comunisti, ma altrettanto indubbiamente rappresenta un serio problema, in compagnia degli stati riemersi dalla dissoluzione della federazione jugoslava. Come accennato, qualora tutti costoro, in una con l’Albania, dovessero entrare nell’Unione alle condizioni istituzionali attuali, si troverebbero a disporre di un’enorme presenza numerica nelle sedi strategiche e di tali possibilità di contrattazione (a esser buoni) da far temere l’importazione della balcanizzazione nel cuore dell’Unione. Tanto per fare un esempio, e pur calcolando per approssimazione: qualora la Jugoslavia fosse entrata unitariamente dalle parti di Bruxelles, con 23,7 milioni di abitanti avrebbe avuto diritto a 30 deputati e poco più, laddove, ad oggi, Croazia e Slovenia, da sole, con 6 milioni e qualche cosa, ne contano 8 più 11, vale a dire 19. Per non parlare ancora una volta dei giudici della Suprema Corte, quella che decide sulle sorti di tutti noi in decisive materie, e a cui ci si inchina con venerazione, i quali giudici della Curia di provenienza transadriatica diverrebbero circa un quinto di tutto il consesso. Sempreché, naturalmente, una Bosnia Erzegovina, per dire, si mantenga unita o non prevalgano al suo interno gli imitatori degli indipendentisti scozzesi. A ciò si aggiunga la debolezza, salvo eccezioni, delle tradizioni politico-amministrative di tipo democratico dell’area balcanica. Peccato tuttavia che le classi dirigenti europee, specie talune a noi prossime, continuino a perorare senza “ni” e senza “ma” la causa dell’allargamento. Peccato anche che illuminate figure insistano nel considerare il Parlamento europeo della proporzionalità degressiva come il vero interprete della volontà generale dei cittadini europei “uti singuli”. La corte federale tedesca, come già detto, non è d’accordo. Sarà anche perché, fatte le debite proporzioni con la Slovenia, la Germania dovrebbe disporre di ben 320 deputati europei, non degli attuali 99 (e l’Italia di 240, non 72). Se poi dalla costa adriatica ci trasferiamo a Malta (0,4m, 316kmq, 6Mep), lo smarrimento può farsi ancora più intenso, ancor più che con il Lussemburgo. Ma sul punto istituzional-quantitativo ci si è ormai soffermati abbastanza. Difficile negare che sotto il profilo storico, Malta disponga di una sicura F. Gui, Riflettendo 12 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 identità, per lo meno geografica, di fatto anche politica, seppure riconosciuta come sovrana soltanto nel 1962, a conclusione della multisecolare soggezione alle più diverse potenze del sud e del nord, dell’est e dell’ovest (ordine cavalleresco compreso) dai credi alquanto distanti fra loro. Ad oggi, sul piano formale delle prerogative di potere, non sussiste differenza fra Malta e la Germania all’interno della Ue. Giusto nel Consiglio, per ripetersi, il principio di proporzionalità rispetto alla popolazione mantiene una certa, consistente importanza. Il che tuttavia non impedisce che anche in quella sede l’oscillare della Valletta da una parte o dall’altra possa talvolta fare la differenza per la sorte di 500 milioni e passa di europei. Per non accennare poi ai 6 europarlamentari isolani, espressione di 400 mila cittadini in tutto (per eleggerne uno solo in Italia o in Germania ce ne vogliono più di 800 mila), i quali cittadini potrebbero risultare influenzabili senza troppo sforzo, magari sotto l’incantamento di un paese “pezzo grosso”, orientando così il non minimale pacchetto dei propri rappresentanti verso una direzione o verso l’altra. Sempre che poi il “pezzo grosso” non provi a fare lo stesso anche con altri minipartner, fortunati portatori di tesoretti dai 6 agli 8, agli 11 euromembri, perché la cosa potrebbe risultare decisamente avvincente. Si vorrà allora, con questo, mettere in dubbio il diritto di Cipro (0,8m, 9,2kmq, 6Mep) a costituire un altro stato nazionale sovrano? In effetti qui la complicazione è massiccia. Per un verso, va riconosciuta l’esistenza di un regno cipriota fin dal 1195, nell’età delle crociate, per poi passare sotto Venezia a fine Quattrocento e sotto il turco circa un secolo dopo. D’altro canto, come è noto, l’indipendentismo isolano avrebbe aspirato all’unificazione con la Grecia, evento frustrato dalle potenze maggiori. Inoltre, ed è altrettanto risaputo, anche il tentativo di creare uno stato unitario, in grado di garantire la minoranza turca, è fallito definitivamente nel 1975 con la creazione di uno stato turcocipriota insediato in metà dell’isola della beltà ciprigna, previa occupazione ad opera della Turchia. A farla breve: aggiungendovi anche le note cointeressenze bancarie russe nell’isola, anzi, nella mezza isola greco-cipriota, è proprio sicuro, oltre che saggio, assicurare alla minima, divisa, condizionata Cipro tutte le prerogative di stato nazionale sovrano dell’Unione? Da questo punto di vista, il mantenimento dello schema intergovernativo, in cui ogni membro risulta dotato di evidenti poteri di veto e di condizionamento, a dispetto di un legame a crescente vocazione sovranazionale (si pensi alla moneta), appare presumibilmente pericoloso, in primis per gli interessi legittimi dei cittadini europei e dei paesi membri. Non a caso, sempre dalla Goulard, parlamentare francese, eppure abbastanza coraggiosa da parlare a nuora perché suocera parigina intenda, è giunto in proposito un irriverente commento: “Sacraliser la souveraineté F. Gui, Riflettendo 13 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 nationale revient à émietter le pouvoir de décision” (p. 32). Sicché, obiettivamente, il punto andrebbe di sicuro passato al vaglio, con la dovuta circospezione ed auspicata volontà di riforma. E si venga ora alla intriguing realtà delle repubbliche baltiche. Per la verità, difficile negare alla pur piccola Lituania (3,3m, 65m.kmq, 11Mep), uno status consolidato nel tempo che la avvicina in parte ai paesi di taglia media, cioè quelli aventi le caratteristiche che diremmo giuste per un assetto equilibrato dell’Unione. Ma sarà poi conveniente, detto per incidens, riconoscere all’Olanda solo 26 eurodeputati, ovvero poco più del doppio di quelli di Vilnius e dintorni, a fronte di una popolazione 6 volte superiore? Sia come sia, proseguendo nella ricognizione storico-politica, l’identità nazionale lituana, con relativa statualità, benché scombussolata fra Polonia e Russia in età moderna e contemporanea, e benché poco nettamente delineata nei suoi confini territoriali, risulta riconosciuta fin dall’età medievale, con momenti di notevole fortuna, seppure in stretta unione con il regno polacco. Sicché una presenza nel futuro Senato dell’Unione - con qualche considerazione aggiuntiva, da lasciare in fondo a questa esposizione – le spetta decisamente, senza obiezioni. Viceversa, risalendo lungo le coste orientali del Baltico per giungere a Riga, che con 717 mila abitanti conta da sola per un terzo dei cittadini della Lettonia (2,3m, 65m.kmq, 8Mep), oltre ad incappare in un altro diritto di veto e via discorrendo, si stenta non poco a trovare un’identità istituzionale (per non dire della sovranità) radicata e perpetuatasi nel tempo, con l’eccezione del piuttosto ristretto ducato di Curlandia, al solito conteso per secoli fra PoloniaLituania, Svezia e Russia, insieme al resto di quella che si chiamava Confoederatio Livoniana, medievale opera di aggregazione dell’Ordine teutonico. Detto con tutto il rispetto, beninteso, per Riga città anseatica e sede di un arcivescovado di notevole autorevolezza. Quanto all’identità linguistica, sicuramente caratterizzata, emergono forti affinità – lasciando stare il circa 30%, non poco, di minoranza russa - con quella dei cugini lituani, giunti anch’essi al riconoscimento dell’identità nazionale e statale alla fine della Grande Guerra. Peccato che nel 1940, dopo coraggiose renitenze e subendo tanto incursioni tedesche che crudeli repressioni, le due cugine finissero sotto il dominio russo sino alla caduta del Muro, di conserva con i baltici estoni. E precisamente a questo punto, proprio in riferimento all’Estonia (1,3m, 45m.kmq, 6Mep), sopravviene un ulteriore conforto alla colpevolizzazione goulardiana della sovranità nazionale, additata come responsabile dell’émiettement dei processi decisionali dell’Unione. Ad oggi popolato da poco più di un milione di persone, disteso attorno a Tallin anseatica, un tempo soggetto all’obbedienza danese prima di venire affidato all’ordine teutonico, per poi cadere, in compenetrazione con la Livonia (a sua volta parte della F. Gui, Riflettendo 14 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Lettonia), sotto la dominazione svedese e russa, il paese delle 1500 isole e isolette, pur identificandosi con un’etnia, gli Esti, già segnalata da Tacito, e pur avendo lingua propria, non baltica, bensì ugro-finnica (con 25% di minoranza russa), non ha mai rappresentato un soggetto politico sovrano sulla scena europea. Salvo fra le due guerre. E salvo divenire tale all’interno dell’Unione. Ciononostante, malgrado l’aggiungersi di montanti turbolenze rivendicative russe sugli antichi soggetti, un dibattito in argomento resta a tutt’oggi davvero sommesso. Senza voler procedere oltre, e guardandosi bene dal disconoscere la legittimazione delle identità statuali di ognuno dei 28 (passibili di accrescersi), si può tuttavia presumere che una ricognizione della realtà cantonale svizzera, con le sue differenziazioni fra cantoni e semicantoni7, possa contribuire ad aiutare la riflessione sulla complessità dell’aggregato di stati costituito dall’Unione, incentivando al tempo stesso il flusso di proposte miranti a renderne più coerenti le istituzioni. Giacché, in effetti, ove non si ritenga la complessità non equilibrata essere addirittura una risorsa dell’Unione, basterà soffermarsi sull’ultimo, o pressappoco, degli stati alquanto eccentrici dell’insieme, vale a dire la repubblica di Slovacchia (5,4m, 48,8m.kmq, 13Mep). Di per sé, in effetti, ovvero per le sue dimensioni, la nazione guidata da Bratislava (alias Presburgo o Possonia, cioè Poszony, a un passo da Vienna, capitale del regno di Ungheria per più di 300 anni, causa l’occupazione turca di Buda) potrebbe anche annoverarsi fra le entità statali medie inserite nella prima categorizzazione. Tuttavia l’asburgica compagine, sempre la Slovacchia ovviamente, molto appetita dai germanici e tuttora con un 14% circa di minoranza ungherese, non soltanto non ha mai costituito uno stato che possa dirsi sovrano, bensì, come già accennato, si è trovata a far parte della Cecoslovacchia dal 1918 fino al gennaio 1993 (salvo parentesi indipendentistica, con benedizione hitleriana). Ciò significa che, una volta caduto il muro, e prima di entrare nell’Unione, essa ha concordato la secessione con la d’allora in poi repubblica Ceca per essere a quel punto cortesemente accettata nel novero degli stati nazionali sovrani, tanto in sede internazionale che a Bruxelles. Praticamente quello che avrebbero voluto fare – non temiamo la ripetitività - gli indipendentisti del ben più caratterizzato regno di Scozia, eppure flagellati per questo da avversari e critici come pericolosi sovvertitori del Regno Unito e dell’intero ordine europeo. Il che produce, vale la pena di riconoscerlo, un qualche sintomo di smarrimento. Va da sé che non sarebbe A parte l’inesistenza del diritto di veto, i sei semicantoni (anche se tale dizione è stata abolita, ma non il fatto) svizzeri hanno diritto ad un solo posto ciascuno nel Consiglio dei cantoni, mentre agli altri 20 ne spettano due. 7 F. Gui, Riflettendo 15 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 stato facile impedire allora il disfacimento della pur amabile Cecoslovacchia, quasi come accettare oggi con gioia l’indipendenza scozzese. Tuttavia la vicenda ha contribuito a émietter ancora di più l’Unione, in quanto sede di sovranità nazionali decisamente poco disponibili, sia antiche che parvenu, a mantener fede all’impegno federale della pur capitale dichiarazione Schuman, da cui prese il via il processo di unificazione. A ben vedere, la prospettiva dell’ingresso nella Ue ha fatto sì che uno stato mai esistito come tale, la Slovacchia, diventasse preventivamente stato nazionale sovrano, per quanto modesto, con tutte le prerogative e privilegi annessi. Curioso: un progetto federale che incentiva la nascita di stati sovrani. Come minimo, il precedente ha costituito un incoraggiamento difficilmente contestabile per altri soggetti che intendessero, o intendano nutrire analoghe ambizioni indipendentistiche. I pezzi grossi. Previa divagazione piuttosto lunga Prima di procedere nella rassegna, varrà la pena di inserire qualche considerazione preliminare e complessiva ad un tempo. La vicenda storica dell’Europa odierna risulta notoriamente mostrare ai suoi esordi, ovvero nella sua origine alto-medievale, un assetto da Respublica Christiana sottoposta ad un vertice imperiale, a sua volta legittimato dal papato, oltre che affiancato dalla struttura ecclesiastica romano-cattolica ad ogni livello della nota piramide subsidiaria. All’interno di tale configurazione “repubblicana”, seppur non priva di contraddizioni e smentite interne, l’Europa dell’unità religiosa, della lingua franca latina e degli intrecci socio-nobiliari sovranazionali vide costituirsi una serie di potentati intermedi, fra cui spiccavano quei regni o potentati ad essi paragonabili che abbiamo visto rappresentare, qualora perpetuatisi fino ad oggi, il modello di statualità “ottimale” per lo sviluppo federale dell’Unione nata a Maastricht. In un certo senso, ma senza esagerare di molto, si può asserire che l’Europa medievale fosse più idonea, appunto, alla vocazione federale di quanto lo sia stata successivamente, ovvero, ed è un paradosso, nella fase della modernizzazione, del progresso culturale, scientifico ed economico, che ne avrebbe fatto un luogo privilegiato dello sviluppo di quella che chiameremmo attuale civilizzazione. Una fase caratterizzata, come è noto, dalla costituzione dei grandi stati “nazionali” sovrani, avversi all’assetto sacro-temporale universale e in grado di soggiogare in modo tendenzialmente assolutistico gruppi di regni e potentati autonomi preesistenti. Quasi come se la negazione del fattore unitario continentale, sia politico che religioso, magari con esperienze di Konfessionalisierung più o meno marcata, si sia rivelata promotrice di crescita sotto ogni profilo. Di qui una significante contraddizione, che diremmo costitutiva, dell’intera vicenda europea, passata e presente. F. Gui, Riflettendo 16 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Allo stato dei dati disponibili, per ricostruire almeno in parte le ragioni del disgregarsi della Respublica e dell’aggregarsi di blocchi più ristretti, ma più coesi ed omogenei, e dunque assai dinamici e innovatori, sia lecito osservare quanto segue, premettendo che si tratta di una sommaria ricostruzione, per la quale restano gradite osservazioni, contestazioni e integrazioni, al fine di renderla sempre più precisa ed attendibile. E pertanto le ragioni sarebbero: a) la sussistenza di aree “nazionali” assai più ampie di quelle corrispondenti ai regni medievali, già note in età romana e riconosciute anche nei concordati e concili della Chiesa papale, quali la Gallia, l’Iberia, l’Italia, ovviamente la Germania, ma anche l’Inghilterra seppur con le sue complicanze, o magari la Grecia, cui si è accennato, per non dire delle novità relativamente più recenti, quali l’insediamento ungaro o l’enorme distesa della realtà slava. In tale contesto non va peraltro dimenticata, a conferma delle non poche ambivalenze interne all’anima europea, la profonda contaminatio indotta dalle popolazioni germaniche, protagoniste delle “grandi migrazioni”, sulle “nazioni” state soggette all’impero romano e pertanto latinizzate, pur restando diverse fra loro. Basti pensare, detto di sfuggita, al Portogallo visigoto, o a denominazioni assai significanti come “Lombardia” o “Inghilterra”, ovvero al termine “Francia”, la cui mutuazione dal tedesco non sembra risultare occasionale o ininfluente. Di fatto, “la France” suona indizio di intrecci persino disorientanti fra identità gallica, latina e germanica, portando presumibilmente in sé la proiezione universalistica di una cultura “nazionale” che non disdegna di essere identificata con un nome e un popolo “altro”, ovvero germanico, il quale ha avuto il merito di renderla sede e detentrice originaria della dignità imperiale nell’Occidente cristiano. Al tempo stesso non si può negare che il limes Romanus, sussistente spesso oltre il confine linguistico fra latinizzati e germanici (si pensi all’area renana o alla Baviera, lasciando stare, ma fino ad un certo punto, il vallo scozzese), abbia continuato a rappresentare un crinale non trascurabile fino ai nostri giorni. Tra l’altro, esso coincide, in linea di massima, con lo spartiacque delle divisioni confessionali consolidatesi nel continente dall’epoca dei conflitti di religione, a conferma del superiore radicamento di antiche strutture ecclesiastiche e politiche rispetto a quelle delle aree la cui più o meno forzata cristianizzazione (ed ingresso nella Respublica con riconoscimento dell’identità politica) avvenne nella prospettiva dell’anno mille, ovvero a secoli di distanza rispetto alle aree di cristianizzazione risalenti all’impero di Roma. Tanto da far risultare il mondo germanico come il più significativamente diviso sul piano confessionale, a dispetto della sua forte coesione etnico-identitaria. b) l’esclusività di fatto – proseguendo nell’elencazione delle cause disgregatrici della Respublica - dell’attribuzione della carica imperiale alla natio F. Gui, Riflettendo 17 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 germanica propriamente detta, così come precocemente avvenuto dopo la divisione dell’eredità di Carlo Magno e l’insediarsi sul trono degli Ottoni. La guida della repubblica comune non costituiva dunque patrimonio di tutti, bensì appannaggio di una singola realtà di tipo etnico, sebbene non del tutto estranea, e pur tenendo conto che in astratto restava sempre possibile per un sovrano, presumibilmente francese, si pensi ai tentativi di Francesco I di Valois, riuscire ad aggiudicarsela. Sotto questo profilo, il rapporto fra potentati della Respublica e vertice imperiale - quand’anche di natura elettiva, come del resto era quello papale, e non formalmente “nazionale” – si poneva anche come antagonismo fra nazionalità, indebolendo la legittimazione del soggetto superiore. Si pensi alla retorica della Lega Lombarda e della battaglia di Legnano, tuttora parecchio in auge, benché l’opposizione al Barbarossa non comportasse il rifiuto dell’ordine imperiale, come sarebbe avvenuto nell’epoca del “risorgimento” delle nazionalità. In ogni caso, non si può negare che, per quanto l’imperatore restasse formalmente al vertice della piramide perpetuatasi ben addentro nell’età moderna (non si dimentichi la rinascita imperiale dell’età di Carlo V), e pur nel contesto di un intreccio che manteneva comunque forti elementi di pluralismo e di coesione interna, l’antica divisione fra i carolingi avesse tarlato fin dalle origini la Respublica8. Un diffuso antigermanesimo si sarebbe peraltro rivolto anche verso l’Austria, rimasta al sommo di un impero multinazionale fino ai nostri giorni. Quanto al regno di Francia, l’antagonismo nei confronti del vertice imperiale teutonico, pur provenendo da una dinastia “franca” ma sempre più identificata con Lutetia, ne avrebbe costituito un fattore motivante ed identitario decisivo. A rafforzarlo sarebbe spesso intervenuto l’appoggio, divide et impera, della Chiesa romana, impegnata a fronteggiare il potere imperiale utilizzando ove opportuno la fille ainée, al punto da passar sopra persino allo spiacevole episodio della detenzione avignonese. Di fatto, la formula “rex imperator in regno suo” risulta di emanazione parigina, non meno della tensione per il ristabilimento della frontiera sul Reno (ove non nascondesse ambizioni alla Luigi XIV o addirittura alla Napoleone) come compito persino Non si può dimenticare a tale riguardo, e a titolo di esempio, che l’elemento determinante nella dieta elettorale imperiale restava il re di Boemia, ovvero il sovrano di un regno slavo, come conseguenza di complessi equilibri raggiunti fra le varie componenti della Respublica. Ciò non impediva che l’imperatore restasse tedesco, purché appartenente ad un potentato non membro della dieta elettorale, oltre che, si direbbe, geograficamente marginale, come i Lussemburgo e gli Asburgo. La definizione del Sacro Romano Impero quale appannaggio “della nazione tedesca” venne in ogni caso ufficializzata tardi, nel 1512, benché la rivendicazione della sua germanicità durasse ormai da secoli (cfr. ad esempio H. Schulze, Storia della Germania, Donzelli, Roma 2000, p. 34. 8 F. Gui, Riflettendo 18 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 etico della monarchia francese, impegnata a recuperare alla latinitas i territori occupati dall’invasore teutonico. Non solo, giacché il mito dello nation elaborato in Francia avrebbe finito per imporsi sulla cultura europea, insieme alla rivendicazione dei diritti individuali e politici che costituiscono la base delle attuali democrazie, in un intreccio di principi potenzialmente omologante l’intera umanità (su null’altro si fonda infatti lo stesso progetto di federazione europea), ma al tempo stesso atto a separare nettamente fra loro le singole comunità nazionali, in ossequio ad una sovranità assolutizzante, in quanto fondata sulla volontà generale spettante esclusivamente alla nation, appunto. Una complicazione protrattasi notoriamente fino ai nostri giorni, con la Francia particolarmente affetta dal fenomeno. c) un terzo fattore tenacemente disgregatore della monarchia dantesca medievale può essere identificato nel progressivo ridimensionamento, anche culturale, subito dall’Europa continentale-imperiale, non meno che papale, rispetto a quella affacciata sull’Oceano Atlantico, per effetto di due eventi epocali, fra loro non privi di interconnessione: i) la pressione islamica da est e da sud, tale da paralizzare sia l’area mediterranea, sia i rapporti con l’Oriente. Un dato oggettivo, che inserisce l’avanzata ottomana, più tardi anche russa, tra gli agenti prioritari dell’evoluzione europea in senso che diremmo latamente occidentale; ii) lo sviluppo coloniale/commerciale verso nuovi mondi, con l’effetto congiunto di moltiplicare le risorse, le innovazioni tecnologicoproduttive e il potenziale militare delle monarchie affacciate sull’Atlantico, non a caso le prime ad accelerare il processo di accentramento e riduzione di potentati minori, di etnicità affine, sotto le dinastie insediate nelle “capitali”. Peraltro, l’effetto della caduta di Costantinopoli rendeva ancora più aggressive ed invadenti rispetto alle altre le monarchie sud-occidentali, le quali, adducendo la necessità della crociata, si scontravano per il dominio sull’Italia (interagendovi i diritti imperiali e papali) con notevole sconvolgimento degli equilibri precedenti. Ad un siffatto sconfinamento concorreva il sistema stesso gerarchico imperial-feudale vigente nella Respublica, seppure in via di frantumazione, il quale autorizzava dinastie di rango superiore, qualunque ne fosse la nazionalità, ad assidersi su altri potentati ovunque si trovassero, vuoi per effetto di strategie matrimoniali, vuoi di autorizzazioni dall’alto (si pensi alle politiche papali verso il Mezzogiorno), vuoi di conflitti abilmente condotti. Anche il rafforzamento della casa d’Austria, per quanto geograficamente collocata a difesa della pressione turca, ma per ragioni non fortuite legatasi alla Spagna e alle Fiandre, può essere inserito in un simile contesto, oggi inquadrato dalla storiografia nella tipologia delle “monarchie composite”. F. Gui, Riflettendo 19 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 d) la perdita dell’unità religiosa, la quale unità, al di là degli aspetti spirituali e dogmatici, agiva come fattore legittimante di un primo stato, quello ecclesiastico, diffusamente presente in tutta la Respublica e gerarchicamente subordinato al papato. Ne sarebbe derivato un processo di lungo periodo dagli effetti laceranti e destrutturanti soprattutto sul mondo tedesco e sulla tenuta dell’autorità imperiale. A ciò si aggiunga il progressivo, seppur lento decadere del secondo stato, o almeno dell’alta nobiltà – anch’esso espressione di una struttura sociale piramidale - come fattore di intreccio interetnico fra i ceti privilegiati della medesima repubblica, tale da attenuare sensibilmente le chiusure politico-nazionali. e) il ruolo decrescente del latino come lingua franca, per effetto dell’estendersi dell’accesso alla cultura anche al di fuori del primo stato e il consolidarsi delle lingue nazionali come veicolo di messaggi letterari e successivamente anche scientifici. Paradossalmente, ancora nell’età di Carlo V, signore dell’impero della nazione tedesca eppur sempre sacro e romano, era proprio l’uomo di Gand a voler difendere l’uso del latino, imponendolo agli altri popoli progressivamente riluttanti ad accettarlo, italiani compresi, fra cui non ultimo il Bembo. Sempre a proposito di lingua franca, vale la pena di ricordare che assai recentemente proprio il presidente tedesco ha riproposto il tema della lingua franca dell’Unione, in particolare dell’inglese. Un idioma, si può aggiungere, esemplarmente commisto di radice germanica e terminologie latine. Non solo, ma anche idioma emblematico di quel processo che ha portato l’Europa a trasferire le proprie esperienze e le proprie aspirazioni tanto democratiche che sovranazionali, o per lo meno unioniste, al di là dell’Atlantico. Al punto che il nuovo mondo di cultura anglosassone, a sua volta emancipato dalla casa madre, sarebbe divenuto il baricentro di una seconda Europa, in grado di ridondare sul vecchio continente e sui suoi dissidi insanabili per ricondurlo sulla strada sovranazionale, pena il tracollo verso forme imperiali di tipo autocratico tali da far impallidire gli Ottoni e i Barbarossa. Ciò detto, per concludere sul punto, il ricorso ad una lingua franca, a questo punto a vocazione mondiale (non si dimentichi al riguardo il ruolo dell’impero britannico), si direbbe fondamentale per recuperare la dimensione di una res publica senza per questo rinunciare ad un diffuso multilinguismo. La qual cosa richiede tuttavia un creativo impegno di studiosi, oltre che di garanti incaricati del rispetto dei non madrelingua, in un contesto di consapevole costruzione collettiva di tale patrimonio, cui fa invece attualmente riscontro, almeno nel nostro paese, un atteggiamento di indifferenza o di prona subordinazione per senso di inferiorità. F. Gui, Riflettendo 20 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Di conseguenza: a occidente, al centro, a oriente Per effetto dei processi qui sommariamente accennati, si può constatare come la storia europea centro-occidentale abbia registrato il precoce emergere del regno “nazionale” di Francia, di conserva con quello spagnolo e inglese, da considerarsi al tempo stesso come le maggiori potenze coloniali dell’età moderna e successiva. A tale proposito varrà la pena di sottolineare che di regni, appunto, si trattava, e di natura ereditaria: un’altra caratteristica che li distingue rispetto all’intreccio italo-germanico, su cui più oltre, ed anche alle monarchie elettive dell’Europa centro orientale. Quasi che lo status inferiore, di regni, a paragone con quello imperiale, abbia ancora una volta paradossalmente agito come fattore di precoce modernizzazione rispetto al vertice della Respublica. Fra i potentati occidentali, quello gallico risultava assai influente già in età duecentesca, tanto da far sì – perdono per l’abbozzo di sorriso - che l’attuale santo nazionale italiano, allora elevato agli altari, portasse propriamente il nome di “San Francese”, in un concorso di soddisfazioni commerciali paterne e presumibili ammiccamenti pontifici verso tanta potenza d’Oltralpe (nell’attesa del trasferimento ad Avignone). In breve, con la fine dell’età medievale il regno di Francia, sarebbe stato il primo a completare sostanzialmente, dopo alterni conflitti tanto interni che paneuropei, l’opera di assorbimento sotto di sé di altri regni e potentati, quali la Borgogna, l’Aquitania, la Provenza, la Normandia, la Bretagna, imponendo ben presto il comune idioma d’oil a tutto il territorio. Di conseguenza, a farla breve, e pur tenendo conto delle ambizioni lionesi, pur non dimenticando la distinzione fra paesi d’état e paesi d’éléction, pur constatando anche al giorno d’oggi i dilemmi interiori di una nation che non ha totalmente digerito la laicità rivoluzionaria, si deve comunque prendere atto della superiore compattezza dello stato sovrano francese, frutto di un precoce processo di unificazione ed accentramento che ha fortemente soffocato le precedenti realtà autonome sul territorio dell’antica Gallia. Tanto più che esse, a differenza del Regno Unito e in parte della stessa Spagna, non esprimevano una nazionalità nettamente diversa; benché, certo, la Romanie non mancasse di personalità e di idioma, come nemmeno la Navarra. A ciò si aggiungano per rincaro, oltre al travolgente ed epocale Ottantanove, gli effetti delle vicende novecentesche, che hanno fatto della Francia una potenza vincitrice del secondo conflitto mondiale, assicurandole un posto privilegiato nel Consiglio di sicurezza dell’Onu e il possesso dell’arma nucleare. In pratica, cosa che non può mai essere dimenticata, e di sicuro non è trascurata a Berlino, all’interno di una Ue per quanto solidale esistono membri che possono potenzialmente distruggere gli altri, ma non viceversa. Anche recentemente è capitato sentire esponenti francesi ricordare il superiore status F. Gui, Riflettendo 21 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 “politico” della Francia rispetto alla pur economicamente egemone Germania. Di qui un’entità fortemente incardinata sul principio della sovranità nazionale, dell’eccezionalità della propria identità nel bene e nel male, nonché la più restia a riconoscere articolazioni sussidiarie al suo interno9. A riprova, la vicenda dell’unificazione europea appare rivelatrice dell’atteggiamento francese, dalle contraddizioni addirittura vistose. Per un verso, infatti, a guerra finita, il senso di responsabilità verso l’intera Europa, sia pure promanante da un leader di estrazione lotaringica e ancora in assenza del potere nucleare, pareva confermare in positivo qualche rimembranza dell’antica proiezione paneuropea del regno franco, ovvero la coscienza dalla primauté della Francia erede della rivoluzione che aveva messo fine all’ancien régime nazionale ed europeo. Tant’è che la dichiarazione Schuman, decisamente più avanzata dei coevi disegni churchilliani promotori del Consiglio d’Europa, annunciava la federazione europea come caposaldo per una pace durevole, foss’anche da raggiungere con il notorio sperimentalismo funzionalistico (indizio di qualche reticenza ab origine) di marca monnettiana. D’altro canto, è di dominio pubblico la vicenda della caduta della Comunità europea di difesa del ’54, al pari del colpo mortale inferto al trattato costituzionale del 2004 ad opera del relativo referendum francese, per non dire d’altro. Di qui, appunto, la pregnanza delle considerazioni autocritiche di una eurodeputata illuminata come la Goulard, ben consapevole che per non intaccare minimamente l’integrità dello stato nazionale sovrano si è preferito conferirla anche a mezza Cipro o alla minima Estonia (e il 25% di minoranza russa?) con le curiose conseguenze dalla medesima signora denunciate. Di fatto, la Francia, per non parlare dell’Inghilterra (che viene qui di seguito, ma per certi aspetti risulta meno indispensabile), costituisce il maggior ostacolo oggettivo ad un’integrazione sovranazionale, non meno che ad una riorganizzazione delle istituzioni dell’Unione che si dimostri più attenta alle realtà subnazionali degli stati più grandi. In breve, uno scoglio difficilmente superabile per la costruzione federale dell’Europa, benché la Francia stessa, in primis sul terreno economico, avverta una certa dipendenza dal coté orientale dell’antico regno franco. Peraltro si possono comprendere le perplessità di Parigi, già percepibili dai comportamenti del presidente Mitterrand in occasione della caduta del Muro, di fronte ad una riunificazione della Germania che l’avrebbe nuovamente posta in una posizione di superiorità demografica ed economica sul continente, aprendole al tempo stesso grandi spazi di influenza sul versante Significative a tale proposito le pagine introduttive, ma anche il testo nel suo insieme, di Pierre Chaunu, La France, Laffont, Parigi 1982. 9 F. Gui, Riflettendo 22 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 orientale, con immaginabili tentazioni di egoismo e primazia nazionale. Lo stesso trasferimento della capitale a Berlino, deciso nel ’91 e preferito rispetto al mantenerla a Bonn, confermava la temuta tendenza, da taluni considerata mirante ad instaurare l’Europa tedesca, non a completare il processo verso una Germania europea. Un dilemma, in effetti, non ancora pienamente chiarito, pur nelle assicurazioni del governo, in verità tentennanti, di voler completare il processo di unione politica europea. Proseguendo ora al di là della Manica, quanto ai dati dei tre “paesi grandi” di antica unificazione, mettendoli uno vicino all’altro, si annota: Francia (64,3m, 550m.kmq, 74Mep); Gran Bretagna (61,7m, 244,8m.kmq, 73Mep); Spagna (45,8m, 504,7m.kmq, 54Mep). Della vicenda del reame inglese, caratterizzata da una maggiore continuità non solo formale rispetto all’Europa di ancien régime, sono risaputi la gradualità e il relativo rispetto per i regni di età medievale dalle marcate identità etniconazionali con cui è sorto, lo dice il nome stesso, il Regno Unito 10. Peraltro va constatata una sostanziale diversità numerica fra la popolazione inglese e quella di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, in un rapporto fra più di 50 milioni da una parte e circa 10, se non meno, complessivi dall’altra. Di fatto, la componente propriamente inglese è molto consistente e al momento gestita alquanto unitariamente, se è vero come è vero che una regionalizzazione del territorio anglosassone è iniziata soltanto per effetto della spinta del trattato di Maastricht a valorizzare le regioni europee. Anche in questo caso, dunque, sia pure con modalità diverse rispetto a quelle francesi, malgrado le piccole entità di contorno, si deve registrare all’interno dell’Unione la presenza di un soggetto etnico-politico, un regnum, diremmo esorbitante rispetto agli altri soggetti “ottimali” ereditati dal Medioevo11. A tale ridondanza si accompagnano lo status internazionale paragonabile a quello francese, con in più il legame con il Commonwealth (in varie parti del quale la regina è ancora formalmente sovrana), per non dire della relazione speciale con gli Usa, a far sì che la Britannia resti difficilmente comprimibile nelle dimensioni di un membro fra gli altri all’interno dell’Unione. Non a caso la tentazione di uscirne resta assai forte, se è vero, come è vero, che un referendum è già stato annunciato in proposito. D’altro canto, l’Inghilterra non risulta così essenziale quanto la Francia ad un’Unione maggiormente integrata, I termini Stati Uniti, Regno Unito, Province Unite, come anche precedentemente confoederatio bohemica, la stessa confederazione svizzera rivelano una concezione dello stato non centralizzato e garante delle sue diversità substatuali. 11 L’unitarietà del territorio del Regno d’Inghilterra è stata rivendicata esplicitamente dalle componenti della società inglese che si riconoscono nella specificità del suo assetto istituzionale tradizionale, incentrato sul “King in Parliament”. 10 F. Gui, Riflettendo 23 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 secondo quanto confermano i suoi vari opting-out, anche se per la sua notoria affidabilità istituzionale e i meriti acquisiti nel secondo conflitto mondiale è sempre bene, opinione personale ma non solipsistica, che Londra resti associata alla casa comune. Venendo ora al terzo regno occidentale, la Spagna, nato da accorpamento di regni precedenti, un’ulteriore particolarità nasce dal suo esser stata a lungo occupata dai “mori”. Sicché, nell’area centro settentrionale troviamo Galizia (2,7m), Catalogna (7,5m), storicamente legata all’Aragona (oggi comunità autonoma), Paese Basco (3,0m), stato a suo tempo regno di Pamplona, poi Navarra, in parte assorbito dalla Francia all’epoca di un sovrano navarrino disposto a scambiare una messa per Parigi, e ovviamente Castiglia (suddivisa in due comunità). Viceversa, nella zona meridionale, è più arduo individuare delle entità politiche subnazionali del tipo che si è definito “ottimale”. Peraltro, come è di conoscenza comune, la Catalogna si è associata alla Scozia per le aspirazioni all’indipendenza e al riconoscimento come stato nazionale sovrano all’interno dell’Unione. Una divisione della Spagna con il distacco della Catalogna (che si tratti davvero di una nazionalità autonoma?) finirebbe per sminuire uno “stato grande” senza assicurare un riequilibrio complessivo incentrato su stati “ottimali”, ma al tempo stesso incentivando altre parti d’Europa alla prospettiva separatista. Difficile negare tra l’altro che lo stesso Paese Basco non esprima una nazionalità ben definita. Nello spostarsi ora nell’Europa centrale, si lascino a margine gli eredi della Lotaringia, di cui, pur nei limiti, si è detto (ma parecchio resterebbe ancora da dire su Alsazia, Lorena e perché no? Franca Contea). Nell’area, la nuova tipologia di stato nazionale “grande” è quella ereditata dall’esaurimento del complexum Romano-Germanicum, che ha a lungo tenuto intrecciate sia Italia che Germania, portandole all’unificazione soltanto in età risorgimentale. Un’unificazione basata in ambedue i casi, sia pure con importanti diversità regionali, su una sostanziale unità etnico-psico-culturale, forse ancora più forte in Germania (82m, 356,8m.kmq, 96Mep) che in Italia (60m, 301,2m.kmq, 73Mep). Da notare in proposito, pur con eccezioni e temperamenti non trascurabili, la tradizione praticamente ininterrotta di indipendenza e di condizione diremmo di superiorità del mondo tedesco nei confronti del resto dell’Europa, peraltro sempre memore del lascito identitario di Teutoburgo, rispetto alla vicenda di sottomissione e “contaminazione” dell’Italia, malgrado la risorsa della presenza del papato, oltre alla creatività artistico culturale 12. Naturalmente non si deve dimenticare l’epoca di forte influenza francese sulla Renania dopo la pace di Westfalia, né il ricordato condizionamento della Boemia sugli equilibri imperiali e nemmeno, ovviamente, l’umiliazione napoleonica, da cui uscì tuttavia rinnovato il sentimento di unità nazionale, con forti tinte nazionalistiche ed identitarie. 12 F. Gui, Riflettendo 24 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Quanto alla debordante presenza costituita dall’impero asburgico, imperniato sull’Austria già ricordata, questa sarebbe giunta all’esaurimento con la prima guerra mondiale, che segnò il realizzarsi completo (ben oltre Trento e Trieste) del processo di liberazione delle nazionalità nell’Europa centro-orientale. In effetti, a dispetto delle evidenti disparità, o forse anche in forza di esse, un reale viluppo ha tenuto per secoli intersecata l’Italia con l’Impero, stanti le sovranità del secondo sulla prima, insieme alle prerogative del romano pontefice, peraltro signore territoriale, insistenti sulla realtà istituzionale tedesca. Sicché, per quanto riguarda l’Italia, la reciproca intersezione, nel consentire alla penisola il progressivo costituirsi di importanti principati nello schema che potremmo definire della pace di Lodi, non ammise né un’unificazione nazionale vera e propria - pur in presenza di forti fattori di coesione già evidenti a personalità come Dante e Petrarca - e nemmeno la consacrazione di regni, lasciando stare ovviamente il regno d’Italia longobardo, o anche quello carolingio, ben presto appassito. Ovvero, volendo aggiustare il tiro: la constatazione è valida per il nord e il centro dell’Italia. Nel Mezzogiorno sussistettero invece due regni, dovuti all’antica appartenenza bizantina, con il concorso della perenne rivalità papatoimperatore. Di fatto, come accennato, il pontefice romano, per quanto portatore di universalità spirituale e fautore di unità politica a vocazione imperiale, contrastava l’egemonia tedesca, penetrata sino in Sicilia, anche con dosi di sentimento nazionale e ricorrendo ad aiuti esterni alla penisola. Di qui, dunque la spartizione fra regno di Sicilia e regno di Napoli, ambedue infeudati alla Chiesa ed affidati a dinastie francesi o iberiche, con in più il regno di Sardegna di marca aragonese, dal non piccolo merito di aver conferito stato regale al Piemonte, ma soltanto nel diciottesimo secolo. Ciò detto, concorrendovi il compimento relativamente recente dell’unificazione italiana - avvenuta con criteri accentratori alla francese, per non dire del fascismo, ma successivamente corretta con una decisa regionalizzazione, seppure attualmente in fase di contenimento sul piano dell’autonomia finanziaria - è possibile ancora identificare nella penisola parecchie delle entità autonomistico-dialettali già presenti nel Medioevo e perpetuatesi in notevole continuità sino alla creazione del regno ottocentesco. Sia per dimensione che per consistenza numerica molte corrispondono, specialmente al centro-nord, ai criteri “ottimali” più volte citati: si pensi al Piemonte, alla Lombardia, al Veneto (in concorrenza con una Padania decisamente più generica), alla Toscana, ma anche alla Sicilia o alla Sardegna, peraltro contraddistinte, come tutto il Sud, da una diversità marcata rispetto all’Italia della prolungata subordinazione (spagnoli interferendo) all’impero romano-germanico, poi voltosi in austriaco. Maggiori difficoltà, in tema di F. Gui, Riflettendo 25 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 continuità autonomistico-istituzionali, si incontrano a proposito dell’antico stato della Chiesa, disteso fra l’Emilia e la Ciociaria, ed anche della Puglia o della Calabria, nei loro rapporti con Napoli. Trasferendosi invece al di là delle Alpi, ovvero in Germania – uno stato di nascita ottocentesca con aspirazioni neoimperiali, ma funditus ricostruito, con evidente concorso anglosassone, dopo il disastro della guerra mondiale, nonché decisamente ridimensionato rispetto alle epoche di massima espansione - la costituzione federale manifesta evidenti rimembranze rispetto ai pluralismi del passato sacro-imperiale. Vale a dire per un assetto composto da potentati di consistenza europeisticamente “ottimale”, nessuno con dignità di regno ma pur tali da costituire solidi principati, elettorali e non, quali la Baviera (diventata regno nel 1806), la Sassonia, il Brandeburgo-Prussia (non a caso il primo a diventare regno nel 1701, peraltro in subordinazione feudale all’imperatore), il Palatinato e via dicendo, cui si aggiungeva la presenza di città-stato. Qualcosa di non dissimile, a ben vedere, dai Land attuali, seppure con comprensibili mutamenti. Qualcosa inoltre, che fa venire in mente certe affermazioni dell’Abbé de Saint-Pierre13 solo apparentemente sorprendenti: a suo avviso il bello dell’impero tedesco era quello di far vivere in pace tanti potentati autonomi, tenuti insieme da regole e istituzioni comuni. In definitiva, Deutschland e Italia, pur avendo inseguito le monarchie occidentali nel processo di unificazione nazionale, mantengono in linea di massima un assetto non incompatibile con i pluralismi subnazionali della repubblica cristiana, ovvero una potenzialità di affinità di natura istituzionale fra le proprie componenti regionali e quei membri dell’Unione in questa sede definiti “ottimali”. Sui due paesi, del resto, magari anche con un minimo di amarezza, non grava nemmeno la responsabilità privilegiata di possedere uno status internazionale e militare di serie A, essendo usciti ambedue sconfitti dall’ultimo conflitto mondiale. In aggiunta, nelle loro costituzioni, salve fatte le garanzie di democraticità, è accolta positivamente la possibilità di passaggio verso assetti di sovranazionalità europea. Traslando ora verso oriente, il quadro presenta ulteriori particolarità per quanto attiene alla complessa interazione fra nazionalità e statualità. Ebbene, nell’Europa centrale e occidentale, come si è detto, le grandi quanto antiche affinità etnico-linguistiche (gallici, italici, germanici, iberici, salvo il renitente Portogallo, e Benelux o scandinavi eccependo) hanno spinto prima o poi verso il superamento del pluralismo medievale e il progressivo coincidere dei due fattori. Altrimenti deve constatarsi invece a proposito della sterminata realtà Cfr. “Prefazione” del “Progetto per rendere la pace perpetua in Europa”, in Daniele Archibugi, Franco Voltaggio (a cura di), Filosofi per la pace, Ed. Riuniti, Roma 1991, p. 50. 13 F. Gui, Riflettendo 26 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 slava. Anche a voler escludere Russia, Bielorussia ed Ucraina, e pur tenendo conto dei ripetuti intrecci dinastici o reciproche sottomissioni egemoniche, il processo unitario in linea di massima non è avvenuto. Senza dubbio, il fascino della “Slavia” ha vissuto una sua stagione di avvincente suggestione soprattutto nel corso dell’Ottocento, ma non solo. Né si può negare che la stagione dell’impero sovietico si sia nutrita anche di questo. E tuttavia le particolarità nazionali sub-slave, concorrendovi l’attrazione verso l’Occidente e i riconoscimenti di status regale ottenuti dalla Respublica in piena età medievale, hanno nettamente prevalso. Per di più, come già ripetutamente accennato, anche recentemente non solo la Cecoslovacchia si è scissa in due al cadere della cosiddetta cortina di ferro, ma il tentativo novecentesco di dar vita almeno alla Yugoslavia ha fatto fallimento, in un mare di sangue oltretutto, con i pericoli di esportazione della balcanizzazione verso il cuore dell’Unione di cui si è parimenti detto. Da questo angolo visuale, ovvero della ritardata “modernizzazione” del mondo centro-orientale, che ha impedito gli accentramenti nazionali pan-slavi, salvando invece dei “regni” di dimensioni “ottimali”, possono trarsi due deduzioni. Primo, l’Europa centro-orientale è più idonea, almeno in astratto, ad accettare un’Unione federale, in quanto non presenta blocchi nazionalsovranisti di dimensioni vistose. Secondo, mantenendosi l’approccio confederale (in verità non poco apprezzato nell’area, stanti i ricordi del regime sovietico) e per di più applicandolo anche ai paesi microscopici, l’Unione europea rischia non già di diventare un solido aggregato sovranazionale, quanto piuttosto di bloccarsi nell’impotenza14. Un discorso a parte, ovviamente, meriterebbe l’Ungheria, “ottimale” sicuramente, eppure carica di pericolose insofferenze, se non altro per la questione delle minoranze magiare distribuite nei paesi circonvicini, conseguenza di penalizzazioni postbelliche che incoraggiano, non da sole, atteggiamenti pesantemente nazionalistici dalle parti di Budapest. Ciò detto, un occhio di riguardo va ora rivolto, come premesso, alla repubblica di Polonia (38,1m, 312,6m.kmq, 51Mep), che si direbbe parimenti “ottimale”, anche per l’origine riconducibile alla Christianitas medievale, ma con una consistenza demografica che ne fa uno stato “grande” pur in assenza di accorpamenti di “regni” preesistenti. Non pare che in essa sussistano infatti le Scozie, o le Baviere, o le Sicilie rilevabili altrove. La sua storia, caso mai, al di là di una radicata coscienza identitaria, rivela esperienze di confederazione con stati circonvicini, anche di lingua diversa, come la Lituania, ossia con quei Algirdas Šemeta, commissario europeo uscente, benché appartenente ad un paese come la Lituania, che della situazione potrebbe avvantaggiarsi, ha recentemente notato come l’esercizio del diritto di veto ostacoli grandemente i processi decisionali dell’Unione. 14 F. Gui, Riflettendo 27 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 popoli che la separano dalla minacciosa Moscovia. Semmai, verso la Polonia risultano essersi rivolte le mire soggiogatrici e spartitorie dei potentati più importanti dell’area centro-orientale, ovvero, appunto, la Moscovia medesima, il Brandeburgo-Prussia e l’Austria asburgica. Alla fin fine, come già osservato, a prevalere sulle aggregazioni/subordinazioni di tipo imperiale sono intervenute le aspirazioni indipendentistiche ed autoreferenziali delle nazionalità in buona parte sub-slave, Polonia compresa, collocate nell’area. Con alcune particolarità, tuttavia, passibili di ingrigire non minimalmente le prospettive di una coesistenza indisturbata. Tali incongruenze sono il risultato dell’intersecazione della wilsoniana primavera delle “nazioni”, rigogliosamente fiorita a conclusione del primo conflitto mondiale, con i drastici adattamenti introdotti a conclusione del secondo. E con in più le “code” seguite alla caduta del Muro. Vale a dire: a) confini polacchi e ucraini spostati verso ovest a danno della Germania e a vantaggio della Russia, sia pure con il paradossale temperamento comportato da ingenti trasferimenti di popolazioni, altrimenti destinate a trasformarsi in insofferenti minoranze etnico-linguistiche desiderose di ricongiungersi con la madrepatria. La qualcosa non impedisce notevoli tensioni e miraggi di ritorni alle proprie origini, forse anche più intensi rispetto a quanto si percepisca qua e là a proposito dei Sudeti, ovvero dell’Alto Adige; due) sussistenza in ogni caso di minoranza etnico-linguistiche consistenti all’interno di quasi tutti i membri orientali della Ue (con l’Ungheria, lo si è detto, indispettita a contrario); c) persistenti appetiti dell’odierna Russia nei confronti di stati, soprattutto baltici, ma anche slavi, quali l’Ucraina, desiderosa in maggioranza di aderire all’Unione, o la Moldavia, divisa fra romeni e presenze ucraine e russe, nonché, soprattutto, tornando di nuovo sul Baltico, verso quella parte della antica Prussia orientale che ha per capitale Kaliningrad (la Koenigsberg di Immanuel Kant) e che resta ancora come una sorta di cuneo soggetto a Mosca all’interno del territorio della Ue. Volendo esprimersi con una certa franchezza, nella componente orientale dell’Unione si presentano tuttora fattori di instabilità che come minimo ne sconsigliano una sovrarappresentazione all’interno della struttura istituzionale comune. Riassumendo L’estrema disparità di dimensioni fra gli stati dell’Unione, accompagnata dallo squilibrio esistente fra il numero di membri, con relativa popolazione, dell’Europa centro-occidentale rispetto a quelli della zona orientale-insulare di recente acquisizione, per non parlare del “pericolo” di ulteriori allargamenti, consiglia l’approfondimento della riflessione sul futuro assetto istituzionale di un’Unione che possa riuscire credibile e funzionale. F. Gui, Riflettendo 28 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 In primo luogo, l’esercizio dei diritti di veto, per quanto raramente esercitato, eppure sempre incombente nelle trattative, non potrà essere mantenuto (la storia polacca peraltro insegna), anche perché difficilmente potrebbe affermarsi che i 28 costituiscano tutti stati nazionali sovrani, tali da giustificare il riconoscimento di un diritto di tutela di prerogative nazionali inviolabili. E sempre che tale tutela sia ammissibile in un contesto a vocazione federale. Un netto veto pertanto, inevitabile, al diritto di veto, salvo eccezionali casi di eccezione. Inoltre: non solo lo stato attuale, ma anche l’eventuale “dimagrimento” delle istituzioni di governo e di amministrazione della giustizia attraverso la riduzione delle poltrone e la rotazione delle medesime fra i 28 – come previsto, ma poi disatteso, per i posti in Commissione – non risulta credibile. E questo sia per l’evidente squilibrio delle proporzioni (nel corso di una turnazione, a titolo di esempio, lo stesso posto toccherebbe per tre volte ad uno stato baltico e una volta sola alla Germani) e sia per il declassamento provocato a certe regioni “ottimali” dell’Unione (Sicilia, Baviera, Catalogna, Scozia, Normandia), mai autorizzate in quanto tali a occupare, sempre a titolo di esempio, un seggio di giudice di Curia, laddove Slovenia, Slovacchia, o Lussemburgo (ma poi Montenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Macedonia, Kosovo?) ne deterrebbero perennemente uno di diritto. A tale proposito, la soluzione ottimale non potrà che essere la riduzione di posti, accompagnata da criteri di attribuzione di natura politica e non nazional-statale, ovvero nascenti da un esecutivo ed un legislativo determinati con criteri garantisti per tutti. Auspicabilmente, come sollecitato dalla Corte di Karlsruhe, se è vero, ed è vero, che la Camera dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione non può che rappresentarli “uti singuli”, le disposizioni che attribuiscono una iperrappresentazione a taluni stati, come già altre volte rilevato su EuroStudium3w15, negandole invece a regioni “ottimali” decisamente più significanti, non potranno che essere disapplicate. In caso contrario si perpetuerà la negazione del principio della “volontà generale”, così caro alla cultura dell’89, di sicura provenienza franco-gallica. Pertanto, volendo evitare di polverizzare le presenze dei “piccoli”, sarà come minimo necessario introdurre a Strasburgo dei criteri di tutela del principio di maggioranza, ovvero soluzioni di voto qualificato analoghe a quelle vigenti nel Consiglio. Il quale Consiglio finirebbe altrimenti per confermarsi, si fa per dire, nel ruolo dell’istituzione più garantista delle altre. Cfr. F. Gui, G. Vassallo, Verso le elezioni del Parlamento europeo. Voce dei cittadini o ultimo inganno degli stati nazionali?, in «EuroStudium3w», ottobre-dicembre 2008, n. 9, pp. 1-23. 15 F. Gui, Riflettendo 29 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Cosicché proprio a questo proposito cade la quaestio: stante la composizione tanto diversa e squilibrata degli stati dell’Unione, non meno che fra le diverse aree, ci si dovrà dunque rassegnare una volta per tutte alle logiche intergovernativa e alla netta prevalenza del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri, se non addirittura ad un perenne esercizio di “direttorio” da parte degli stati più grandi, alias Germania e Francia, con il contorno più o meno influente dei restanti? Presumibilmente la prospettiva resta realistica, seppur con le evidenti carenze riscontrabili in tempi di malessere e depressione economica come quelli attuali. Tuttavia non si può passare sotto silenzio che sempre da parte tedesca, la Cdu di qualche tempo fa in particolare, ma anche sulle pagine di recenti commentatori, è tornata di moda la proposta radicale: ovvero l’elezione a suffragio universale diretto del presidente della Commissione europea, per effetto della quale la scelta dell’uno alla guida del governo di tutti permetterà di superare l’aggrovigliato molteplice dell’assetto intergovernativo e sovranistico attuale. Qualcosa che fa tornare in mente, sia consentito il balzo indietro cronologico, e mutatis ovviamente mutandis, le argomentazioni dantesche del Monarchia a favore dell’uno al comando e della sua insostituibilità al fine di interpretare visibilmente, identificandolo con la propria persona, il bene comune. Una soluzione peraltro già adottata, come stranoto, al di là dell’Atlantico, allorché, resisi evidenti i limiti dell’assetto confederale, si procedette con l’approvazione della costituzione democratica ad oggi vigente più antica del mondo, benché prodotta dallo stato nazionale (federale) più recente e innovativo della storia occidentale. Una soluzione, quella presidenziale Usa, di sicuro assai effective, presumibilmente ottimale, alla luce delle note vicende di età contemporanea, pur con i limiti che non possono essere nascosti nemmeno ai nostri giorni. Tuttavia non risulta sicuro che la ricetta sia idonea, o facilmente impartibile al groviglio europeo. La storia dei cantoni svizzeri, come sottolinea assai utilmente il saggio di Vera Nava, che appare in questo numero della rivista, ci mette al corrente di un deciso rifiuto del presidenzialismo statunitense ad opera dei costituenti elvetici del 1848, benché ispiratisi proprio al modello federale d’Oltreatlantico. Forse temevano la prevalenza senza alternative di una componente etnica, presumibilmente la germanica, o magari invece religiosa, in presenza di un forte conservatorismo cattolico a fronte di radicati, radicali e all’epoca vincenti confessionalismi protestanti. La scelta di fatto adottata fu quella di un governo in cui le diverse componenti si trovassero tutte insieme all’interno dell’esecutivo e tutte insieme procedessero a quella contrattazione decisionale che appare consustanziale ai regimi federali, tanto svizzero che F. Gui, Riflettendo 30 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 americano, per parte sua rimasto legato al modello di interazione sovranoordini (ovvero stati) proprio della storia britannica. Ebbene, se l’esperienza dei cantoni svizzeri, in quanto europei, multilingue e multiconfessionali al pari degli stati dell’Unione, potrà risultare altrettanto se non ancor più istruttiva di quella avviata a Filadelfia per i progressi dell’Europa dei nostri giorni, allora un supplemento di investigazioni storiche sarà di certo utile e consigliato. Tanto più, a riprova, che proprio in questi mesi le procedure e le soluzioni adottate nel corso dell’innovativo, se non addirittura capitale rinnovamento della Commissione europea, in sintonia con gli esiti delle elezioni del Parlamento europeo, sembrano effettivamente avvalorare la maggiore praticabilità di una soluzione alla svizzera, ossia di “tutti insieme” nell’esecutivo, piuttosto che quella del presidenzialismo washingtoniano. Il punto essenziale appare pertanto vertere sulle potenzialità “cantonali” della compagine europea con sede a Bruxelles, sempre che la combinazione fra sovranismi francesi e renitenze dei nuovi arrivati orientali (Inghilterra ovviamente a parte) non renda velleitario l’esercizio speculativo. Come immaginare insomma, al di là delle riforme riequilibranti di cui si è già detto, una trasformazione della rappresentanza degli stati all’interno dell’Unione al fine di avvicinarsi al modello federale canonico, impostato sul bicameralismo, mediante l’istituzione di una camera degli stati, appunto, accanto a quella del popolo, già insediata a Strasburgo? Gli attuali Consiglio europeo (se non trasformato in presidente collettivo, tutto da calibrare) e soprattutto il Consiglio dell’Unione restano a caratura sostanzialmente intergovernativa, malgrado le modalità del voto, quando esercitato a maggioranza. Servirebbe ricorrere invece, stando così le cose, ad una sorta di camera dei cantoni, in cui alcuni membri dell’Ue, i più piccoli, facessero la parte dei sei semicantoni svizzeri (nati per divisione interna di tre precedenti cantoni) ovvero ottenessero un solo senatore, rispetto ai due spettanti agli “ottimali”. E per i “grandi” della Ue, a quel punto, cosa si potrebbe invece immaginare? Dovrebbero accontentarsi di due anch’essi, come del resto si verifica per tutti gli stati della federazione statunitense? In tutta evidenza non pare auspicabile che la regola del due per tutti possa valere anche per i big dell’Unione. Negli Usa, che si è già notato essere molto più plurali quanto a numero di stati in rapporto alla popolazione, il membro più gremito, la California, schiera meno della metà degli abitanti della Germania, mentre il più piccolo, il Wyoming, con 560 mila cittadini all’incirca, supera più di dieci volte Malta o Lussemburgo. Tra l’altro, detto di passata, al di là dell’Atlantico la rappresentanza degli eletti all’interno della Camera (appunto) dei rappresentanti è sufficientemente proporzionale rispetto alla F. Gui, Riflettendo 31 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 popolazione dei singoli stati. Ebbene, per stringere, se ai 16 milioni dell’Olanda o ai 21 della Romania sarà consentito schierare due senatori, potrà immaginarsi che i 60 milioni di italiani ne eleggano 6 e i tedeschi 8? Insomma, non si potranno meglio valorizzare in questo modo le realtà “ottimali”, cioè i regni o principati che esistevano già nel Medioevo in Italia, o in Germania o nella stessa Francia, e che portano con sé tradizioni consolidate, tali da distinguerli piuttosto nettamente all’interno dello stesso stato-nazione “grande”? Per certo, la soluzione servirebbe a fronteggiare gli squilibri attualmente esistenti, seppure ponendo dei problemi non proprio secondari. Per esempio, i senatori dei singoli stati potrebbero votare in modo differente, secondo appartenenze partitiche, minacciando l’unità del proprio stato e sconvolgendo totalmente l’ottica confederale. Qualcosa di impensabile per un approccio, diciamo, gaullista. Tuttavia, anche in Usa o in Svizzera, il fatto che uno stato elegga due senatori fa sì che essi possano dividersi su tematiche strategiche. E tuttavia la cosa non risulta come attentato nei confronti dell’identità “nazionale” del cantone, o dello stato a stelle e strisce di provenienza. Tutti aspetti, insomma, su cui riflettere. Magari, in una fase intermedia, si potrebbe ipotizzare l’obbligo per i senatori di uno stato di trovare un accordo precedentemente al voto, per tutelare la posizione unitaria nazionale. Inoltre è assai probabile che l’evoluzione di tipo federale dell’Unione investa dapprima il settore socio-economico, lasciando ancora a lungo intatta la gestione confederale della politica estera e di sicurezza, mantenendo in vita, quindi, le differenze non facilmente superabili fra potenze di serie A e paesi, per quanto grandi ed economicamente forti, ma di categoria B. Sicché il pluralismo delle presenze senatoriali non risulterebbe così lesivo per i risvolti più gelosi della sovranità. Un momento, ma non sarà forse mera ingenuità cominciare a pensare a qualcosa che in un futuro ragionevole si avvicini alla camera degli stati o dei cantoni? Non si direbbe; in realtà sono ormai in molti a perorare un’evoluzione dell’Unione in senso “democratico”, per lo meno per quel che riguarda i paesi della zona euro. Assai recentemente, in un convegno romano presso il Cnr, è stata autorevolmente prospettata come inevitabile l’istituzione di una seconda camera, seppure non eletta direttamente dai cittadini dei singoli stati, come negli Usa attuali (o in Svizzera), bensì secondo le norme antecedenti il 1913, in cui erano le assemblee degli stati ad inviare i propri rappresentanti nel Senato di Washington. Si tratta ovviamente di un’ipotesi, di un auspicio da realizzare possibilmente nel prossimo decennio, eppure avanzato con notevole convinzione e concretezza. Tra l’altro, come sottolineato nel medesimo convegno, anche le regioni, almeno in Italia, potrebbero essere chiamate a condividere la scelta dei senatori europei provenienti dalla penisola, tenendo F. Gui, Riflettendo 32 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 conto del già avviato coinvolgimento di parlamenti nazionali e regioni nelle fasi ascendenti e discendenti della legislazione europea. Per non dire della pur flebile sussistenza dell’alquanto pletorico Comitato delle regioni dell’Unione. Concludendo: tutto resta ancora da valutare attentamente. Ma la premessa indispensabile per avviare il già ufficialmente preannunciato progresso istituzionale dell’Unione16, salvo incappare in crisi crescenti, è sicuramente una circostanziata valutazione delle identità storico-nazionali dei 28 membri e dei candidati all’adesione, nonché delle differenze esistenti fra le diverse statualità maturate in Europa fra area occidentale, centrale e orientale, oltre che da mezzogiorno a settentrione e viceversa. La cancelliera tedesca ha affermato più volte di considerare come avviato il processo di unione politica della Ue, sia pure moderandosi alquanto in successive occasioni, mentre il cosiddetto documento dei quattro presidenti, della Commissione, della Bce, del Consiglio europeo e dell’Eurogruppo, perora dal 2012 un accrescimento della legittimità democratica dell’Unione. Annunciato inoltre, salvo ripensamenti, l’avvio di una nuova Convenzione per la riforma dei trattati Ue, ai fini de “l’approfondimento” ulteriore dell’integrazione. 16 F. Gui, Riflettendo 33 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 La Costituzione del 1848 e la nascita dello Stato federale svizzero di Vera Nava La forma di governo federativa svizzera, una delle più consolidate che la storia europea conosca, è stata e continua ad essere materia di confronto e di ispirazione per l’elaborazione di modelli istituzionali consimili. Viviamo infatti in un Europa che tenta di trovare il proprio ruolo, all’interno di equilibri mondiali segnati dalle dinamiche della globalizzazione, attraverso un sistema federativo che si prefigga l’obiettivo di coniugare il desiderio di creare un’identità europea unitaria in nome di necessità, anche economiche, condivise, con la volontà di render ragione della pluralità di realtà etniche, culture e idiomi, che caratterizzano i suoi Stati membri. Il fatto che l’obiettivo fosse stato efficacemente raggiunto, fin dall’ormai lontano 1848, dalla piccola confederazione di Stati elvetici sita nel cuore dell’Europa non è sfuggito ai promotori della federazione europea. Così, già nel 1951, il Consiglio d’Europa, sotto la presidenza del Conte Coudenhove-Kalergi, aveva presentato il “Progetto di una costituzione federale europea”, ispirato proprio alla struttura organizzativa della costituzione svizzera. Vi figuravano difatti un parlamento bicamerale, la cui camera dei deputati avrebbe dovuto rappresentare i popoli della federazione in proporzione alla densità demografica dei territori, e un Consiglio federale come esecutivo1. Ciò nondimeno va ricordato che, guardando al modello svizzero come assetto istituzionale in grado di garantire l’unità delle diversità che lo compongono, è stato spesso ribadito da altri autori il fatto che esso, pur essendo un esempio dal quale non si può prescindere parlando di sistema federale, non Cfr. il “Progetto di una costituzione federale europea” in Mayer-Tasch/Contiades, Die Verfassungen Europas: mit einem Essay, verfassungsrechtlichen Abrissen und einem vergleichenden Sachregister, Stuttgard 1966, p. 631 e segg., che è stato citato come ottimale dalla sentenza della Corte tedesca di Karlsruhe del 30 giugno 2009, in merito al trattato di Lisbona. 1 V. Nava, La Costituzione 34 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 è “realisticamente applicabile in altri Paesi che non abbiano avuto una storia analoga”. Questo è, per esempio, il pensiero di Franco Masoni, presidente dell’Associazione Carlo Cattaneo di Lugano, espresso in occasione di un’intervista rilasciata alla rivista on-line “Progetto Italia Federale2”. Le medesime considerazioni sono riscontrabili anche nelle pagine dedicate da A. Barbera e C. Fusaro alla forma di governo direttoriale elvetica in Il governo delle democrazie3. Più precisamente, gli autori del testo citato affermano che “non deve sorprendere la virtuale impossibilità […] di riprodurre in altri contesti un modello così peculiare.4” La specificità del sistema federale elvetico – la quale viene individuata da Barbera e Fusaro nell’istituzionalizzazione di un modello consociativo in grado di rappresentare e connettere a livello nazionale le differenti realtà cantonali – affonda le sue radici nella storia di quel Paese e nella capacità del suo popolo, più volte dimostrata attraverso i secoli, “di dividersi senza drammi sui problemi concreti5”, di cooperare rendendo possibile la convivenza fra lingue, religioni e culture differenti. Per certo, e al di là della diversità delle opinioni, come suggeriscono le riflessioni dello storico del diritto Luigi Lacché, il federalismo svizzero resta comunque fenomeno intimamente storico, ovvero il processo peculiare attraverso il quale si sono potuti consentire “la tensione creatrice tra l’uno e il diverso, l’unità e il pluralismo”. La qual cosa, a ben vedere, costituisce “il paradigma della storia costituzionale europea” 6. Pertanto risulterà sempre meritevole di interesse, qualunque deduzioni se ne vogliano trarre, ricostruire in quale periodo e in che contesto politico si sia affermato il sistema istituzionale che tutt’ora regge l’impalcatura del federalismo elvetico. La genesi del sistema di governo svizzero è da ricercare nelle vicende storico-politiche del 1848, che ebbero come risultato l’entrata in vigore della prima Costituzione federale che gli elvetici si poterono dare autonomamente e la storica transizione da Confederazione di Stati a Stato federale. Inoltre, avremo modo di vederlo, la capacità degli svizzeri di ricomporre i dissidi in nome di un peculiare senso civico, è ben rappresentata dai tumultuosi avvenimenti di quel periodo. Attraverso l’esame della storiografia esistente sull’argomento, si cercherà pertanto di indagare la vicenda storica che portò alla nascita dello Stato federale svizzero, tentando di cogliere in particolare le dinamiche culturali, politiche e http://www.progettoitaliafederale.it/approfondimento10.html. A. Barbera, C. Fusaro, Il governo delle democrazie, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 101-105. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ivi, p. XII. 2 3 V. Nava, La Costituzione 35 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 sociali che possono rendere ragione delle peculiarità dell’ordinamento elvetico. Si avrà modo altresì di capire e illustrare, attraverso l’analisi delle relative disposizioni della quarantottesca Costituzione, in cosa consistette, alle sue origini, il sistema istituzionale che continua ad essere preso a esempio per modelli federativi consimili. 1. Le premesse storico-politiche della Costituzione del 1848: dal 1798 alla convocazione della Commissione costituente L’origine dello Stato federale svizzero affonda le proprie radici in quei tumultuosi avvenimenti che segnarono la storia elvetica a partire dalla grande rivoluzione istituzionale operata dagli “invasori” francesi nel 1798. La vicenda elvetica proseguì poi fino all’emanazione del testo costituzionale del 1848, che sancì la transizione definitiva da Confederazione di Stati a Stato federale, attraverso gli svariati rivolgimenti che di seguito ci proponiamo di ricostruire sinteticamente, tentando di porre in risalto gli snodi più decisivi. Al principio di questo percorso, ovvero alla fine del Settecento, la Svizzera si presentava come un mosaico di 13 Stati indipendenti e sovrani7, i cui rapporti non erano definiti da una costituzione scritta, bensì regolati da particolari e diversi trattati di alleanza, sia pure nel contesto di un comune senso di appartenenza alla Confederazione, di un “elvetismo” le cui radici iniziavano a rafforzarsi proprio a partire da quel secolo8. In breve, unico organo di governo comune era la Dieta, ovvero un’assemblea di plenipotenziari entro cui venivano discussi gli affari collettivi, spesso in modo talmente inconcludente da procurare ai confederati l’appellativo di “lega degli elementi discordi” 9. Quanto ai Cantoni, nel corso del tempo avevano conquistato taluni territori definiti i loro “baliaggi comuni” – i cui abitanti non erano considerati confederati ma sudditi dei signori svizzeri – e godevano dell’alleanza di altri con cui avevano stretto trattati a scopo difensivo. I baliaggi comuni erano costituiti da gran parte dell’Argovia, dalla Turgovia, da quasi tutto l’attuale Canton San Gallo, e dal Ticino (salvo la Leventina). Le entità territoriali legate alla Confederazione da particolari e diversi trattati di alleanza corrispondono invece agli attuali Cantoni Vallese, Grigioni, parte di San Gallo, Ginevra, Neuchâtel, Giura e alle città di Bienne, Mulhouse e Strasburgo. Ossia Uri, Svitto, Untervaldo, Lucerna, Zurigo, Berna, Zugo, Glarona, Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa e Appenzello. 8 F. Chabod, L’idea di nazione, Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 26-37. 9 AA.VV., Costituzione svizzera in edizione integrale: commenti alla Costituzione e cenni di storia svizzera nell’ambito dell’Europa contemporanea, Lugano, J. Juilland Editrice l’elicottero, 1975. 7 V. Nava, La Costituzione 36 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 1.1.Una e indivisibile: la Repubblica elvetica La sua prima costituzione la Svizzera dovette riceverla dai francesi, e come si disse, “sulla punta delle baionette”10. Quella francese si rivelò un’invasione sì, ma almeno inconsapevolmente preparata, se non proprio desiderata, da molti confederati. Dal fascino delle idee di libertà ed uguaglianza promosse dalla grande Rivoluzione francese infatti non restarono immuni nemmeno gli elvetici: sì brindò alla libertà dapprima nella Svizzera romanda, geograficamente portata ad essere più sensibile all’influenza francese; dopodiché dal Vodese al Vallese le celebrazioni inneggianti alla “rivoluzione elvetica” si propagarono in tutto il territorio confederato, giungendo fino alla proclamazione di tante piccole Repubbliche autonome, come la “Repubblica Lemanica”, che consacrò la liberazione del Vodese dal giogo di Berna. Quello incline ad accogliere il vento rivoluzionario era un popolo stanco dell’arbitrio tiranneggiante dei governi aristocratici che si erano saldamente collocati al potere in molti Cantoni, ma i più sofferenti erano i sudditi dei territori dei baliaggi, costretti nelle mani dei balivi. La situazione era ben nota a Parigi, dove si era costituito quel Club Elvetico che in nome della liberazione della Svizzera giunse, il 21 dicembre 1797, a richiedere l’intervento francese. Parte di quella cerchia furono personalità come Peter Ochs, uomo politico basileese e personalità di punta tra le file del patriottismo radical-democratico. Ochs, convocato a Parigi da Napoleone, di fronte alle rivendicazioni del Direttorio francese di riorganizzare l’intera compagine svizzera, ritenne suo compito avviare una rivoluzione pacifica in territorio confederato. Egli infatti, non intuendo le reali intenzioni dei francesi, non sollecitò un’invasione, ma solo la mobilitazione delle truppe sul confine11. Ciò a differenza di quanto fece il suo connazionale Frédéric-César Laharpe, avvocato, che tentò invano di far insorgere il Vodese, procurandosi l’ostracismo dal governo di Berna. Costretto a rifugiarsi a Parigi dal 1796, egli vide nell’intervento francese l’unico modo per liberare il territorio di Vaud dal giogo di Berna. È di uomini come questi che si servì una Francia desiderosa di circondarsi di repubbliche ad essa devote e affini: come afferma lo storico E. R. Papa, “Erano patrioti, e tuttavia non si avvidero, o se ne avvidero troppo tardi, che non erano loro a servirsi della Francia, ma che era la Francia a servirsi di loro” 12. Il 28 febbraio 1798 la Repubblica francese giunse così a dichiarare guerra ai tredici Cantoni: di fronte ad una Dieta incapace di agire, solo Berna si apprestò a combattere strenuamente, con una milizia improvvisata, l’esercito straniero Ibidem. P.F. Kopp, “Peter Ochs” in AA.VV., Dizionario storico della Svizzera, edizione online. 12 E.R. Papa, Storia della Svizzera. Dall’antichità ad oggi. Il mito del federalismo, Milano, Bompiani, 1993. 10 11 V. Nava, La Costituzione 37 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 capitanato dal generale Brune, il quale si era precedentemente premurato di precisare che non in qualità di conquistatore, ma come amico, giungeva a capo delle sue truppe. La Svizzera quindi, almeno stando a Brune, non aveva nulla da temere per la propria indipendenza politica: occupazione militare e saccheggi convinsero in breve tempo del contrario, finendo per scontentare anche molti di quei patrioti che l’intervento francese lo avevano desiderato. La capitolazione dell’antica repubblica aristocratica di Berna, il 5 marzo 1798, segnò la fine dell’antica Confederazione e la proclamazione di quella Repubblica elvetica, una ed indivisibile, creata ad immagine e somiglianza della “sorella” Repubblica francese. Stato satellite, in realtà, ove le antiche sovranità e autonomie cantonali dovettero lasciare il posto a circoscrizioni amministrative, parti di un unico Stato unitario, sottoposte all’autorità dei prefetti13. Ciò comportò altresì l’emancipazione delle popolazioni degli antichi baliaggi, che ora si andavano ad affiancare agli altri Cantoni, per un totale, inizialmente, di 21. È ciò che troviamo sancito all’interno della nuova Costituzione elvetica, la prima legge fondamentale scritta che ebbe la Svizzera, altrimenti chiamata “Libretto di Ochs” dal nome dell’autore che ne predispose il progetto sulla falsariga della costituzione direttoriale francese del 1795. Peraltro, l’originario progetto di Ochs, commissionatogli dal Direttorio francese, fu da quest’ultimo fortemente rimaneggiato, al punto da guadagnare al basileese l’accusa di arrendevolezza verso lo straniero e la sua destituzione persino dal Direttorio elvetico. Va sottolineato infatti che, malgrado le attese di molti, la carta costituzionale, insieme al nuovo assetto imposto dalla Francia, venne fin da subito avversata in modo deciso da componenti determinanti della società svizzera, in particolare dai piccoli Cantoni “primitivi”, difensori impavidi della propria autonomia. Pertanto il nome di Ochs, poiché irrimediabilmente legato alla pur innovativa prima Costituzione svizzera, sarebbe caduto in un disonore irrecuperabile, nonostante gli sforzi da lui compiuti per mettersi diligentemente al servizio del nuovo Stato14. La novella Costituzione sostituiva l’antica Dieta con l’istituzione di un potere legislativo bicamerale, rappresentato dal Senato – composto da quattro deputati per Cantone e dagli “ex-direttori” elvetici – e dal Gran Consiglio, “La Repubblica elvetica è una e indivisibile. Non vi sono più confini tra Cantoni e paesi sudditi, né tra Cantoni e Cantoni. L’unità di patria e d’interessi succede al debole vincolo che teneva insieme e guidava a caso parti eterogenee, ineguali, sproporzionate e sottoposte a piccole località e domestici pregiudizi. Si era deboli di tutta la debolezza individuale; si sarà forti della forza di tutti.” Articolo Primo, Costituzione della Repubblica elvetica; AA.VV., Costituzione svizzera…, cit., p. 11. 14 P.F. Kopp, “Peter Ochs”…, cit. 13 V. Nava, La Costituzione 38 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 incarnante l’elemento democratico della nazione, animato da un numero di “gran consiglieri” proporzionale agli abitanti dei singoli Cantoni. Il potere esecutivo invece, esercitato dal Direttorio, era composto da cinque membri eletti dal parlamento e dotato di amplissimi poteri, tra cui la gestione della politica estera, l’esecuzione delle leggi e la nomina dei membri del Tribunale supremo – potere giudiziario – e degli altri ministri e funzionari. Inoltre, figlia delle vicende rivoluzionarie francesi, la Costituzione non poteva che prevedere l’abolizione dei privilegi della nobiltà, delle città e delle corporazioni e introdurre quei diritti individuali – come la libertà di coscienza e di credo15, o la libertà di stampa – che tuttavia vi appaiono incompleti se confrontati con la Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino del 178916. La sorte di questa Costituzione è nota, come la breve e poco gloriosa vicenda della unitaria Repubblica elvetica: subito odiata dagli antichi governanti, giunse a scontentare anche il popolo, finendo per divenire nella memoria storica sinonimo di accentramento tirannico, di dominazione straniera. Il mutamento di regime troppo brusco e lo spirito di autonomia cantonale fortemente radicato fecero sì che alla fine di questo periodo si configurassero due schieramenti opposti: i “federalisti”, univocamente controrivoluzionari, cui si contrapponevano gli “unitari”. Termini, questi, in uso all’epoca e poi confluiti nel lessico storiografico elvetico per indicare due opposte tendenze politiche che – come si avrà modo di vedere ulteriormente – con qualche variazione continuarono a caratterizzare la vicenda storica svizzera. A ciò si sommò il disagio di vedere il suolo patrio divenire un campo di battaglia durante la guerra francese contro la coalizione europea, per non dire dei disordini causati dagli elementi controrivoluzionari, fra cui il primo colpo di Stato, dell’anno 1800, cui sarebbe seguito il ritiro delle truppe francesi nel 1802: tutti elementi che contribuirono a far cadere il Paese in uno stato di caos che, rasentando la guerra civile, vide susseguirsi altri colpi di Stato e altrettante nuove costituzioni. 1.2 L’Atto di mediazione napoleonico del 1803 Poiché dire Francia voleva dire Napoleone, già dal 30 settembre del 1802 egli egli decise di intervenire direttamente. Il Primo console futuro imperatore non poteva tollerare che gli svizzeri, guardiani di passi alpini di strategica importanza, si dilaniassero a vicenda divenendo facile preda degli avversari. Di La configurazione di questa disposizione impronta l’intera Costituzione al principio di laicità dello Stato, che vide il clero escluso dal diritto elettorale e dalla possibilità di rivestire cariche politiche, e le chiese – definite “sette” – trattate alla stregua di associazioni private. 16 A. Kölz, Le origini della costituzione svizzera, Locarno, Armando Dadò Editore, 1999, pp. 68-98. 15 V. Nava, La Costituzione 39 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 conseguenza inviò un proclama che, tacciando di cattivi scolari gli abitanti elvetici che offrivano “da due anni uno spettacolo pietoso”, annunciava un intervento per così dire provvidenziale di mediazione che avrebbe salvato la Svizzera. A conferma di ciò, il 19 febbraio 1803, Napoleone poneva fine alla Repubblica elvetica emanando il celebre Atto di mediazione, con il quale si instaurava un sistema di governo destinato a protrarsi per un intero decennio. Il provvedimento a carattere costituzionale, predisposto con la collaborazione dei consiglieri e notabili elvetici di fedeltà napoleonica, venne presentato ai Cantoni attraverso una lettera che, rivelando la profonda conoscenza della natura e della storia del territorio elvetico, annunciava il ritorno al principio federativo: La Svizzera non rassomiglia a verun altro Stato, sia per la sua situazione geografica, sia per i diversi linguaggi, per le diverse religioni e per quella straordinaria diversità di costumi che esiste nelle diverse sue parti. La natura ha fatto del vostro Stato uno Stato federativo; non è da uomo saggio il volerla correggere. 17 Allo scopo di adattarsi all’imperativo della natura, che voleva la Svizzera una Confederazione di Stati, il “grande Mediatore18” restituì allora ai Cantoni – riconosciuti nuovamente liberi e indipendenti, ma non sovrani – buona parte delle competenze che avevano detenuto sotto l’ancien régime. A ciascuno dei Cantoni – per un totale di 19, comprendenti quindi gli antichi baliaggi, a cui venne riconfermata quell’emancipazione giuridica già affermata durante la Repubblica elvetica – venne consacrato un capitolo dell’Atto di mediazione, nel quale si trovava esposta la rispettiva costituzione cantonale. Al tempo stesso, a riprova del carattere confederativo che si volle rinnovare alla Svizzera, solo alla fine del testo costituzionale – dunque al ventesimo capitolo – venne collocato quell’Atto federale che doveva sia ripristinare l’antica Dieta, quanto istituire la nuovissima carica di “Landamano”. Per quel che concerne la Dieta, istituzione elvetica di origine medievale, essa veniva investita di competenze legislative, esecutive e giudiziarie ora definite in modo preciso. Punto per punto, la Dieta: ordina il contingente di truppe previsto per ogni Cantone e nomina il generale; risolve le contestazioni fra i Cantoni qualora queste non possono esser regolate da arbitri designati dal Landamano; inoltre essa non si riunirà più sotto la presidenza del solo Canton Zurigo, ma le sue sessioni si terranno alternativamente nei 10 dicembre 1802; W.E. Rappard, La Costituzione federale della Svizzera, Locarno, Carminati, 1948, p. 22. 18 Ibidem. 17 V. Nava, La Costituzione 40 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 capoluoghi dei sei nuovi “Cantoni direttori” (Vorort)19. Quanto ai Cantoni più popolosi, vi saranno rappresentati con due voti anziché con l’uno di cui dispongono gli altri, secondo quell’embrionale principio di rappresentanza popolare che verrà ripreso, e ulteriormente sviluppato, nella composizione dell’Assemblea federale istituita nel 184820. Nella figura del Landamano invece – carica ricoperta a rotazione dal borgomastro di un Cantone direttore – è lecito vedere un riflesso del gusto per il potere personale di Napoleone. Ad un tempo Capo di governo e Capo di Stato, il Landamano presiede la Dieta e funge, nei limiti del possibile, da valvola di sicurezza nei confronti delle eventuali eccessive pretese del padrone di Francia, a cui doveva comunque rendere conto e a cui, in definitiva, continuava a spettare la direzione della politica estera dello Stato confederato21. Preciso intento del “grande Mediatore” era quindi – almeno stando all’opinione del ministro plenipotenziario elvetico a Parigi, Philipp Albert Stapfer – quello di “annullare politicamente la Svizzera, e di procurare agli svizzeri la maggior felicità domestica possibile22” attraverso il congiunto ritorno alle tradizioni del passato ed il mantenimento di quelle innovazioni – come il principio di uguaglianza giuridica dei cittadini e dei territori23 – già proclamate dalla Costituzione del 1798, con l’obiettivo di assicurare la perpetuità del germoglio rivoluzionario. In quest’ottica si deve anche vedere l’impegno profuso per la difficile realizzazione dell’unità monetaria, della libertà di domicilio e di commercio che, già avviate dalla legislazione della Repubblica elvetica, non riusciranno a sopravvivere al tempestoso vento reazionario che inizierà a manifestarsi in Svizzera ancor prima della caduta di Napoleone e investirà definitivamente il territorio confederato all’attuazione del Patto federale del 1815. 1.3 Il Patto federale del 1815: la Restaurazione La battaglia di Lipsia (16-19 ottobre 1813) vide cadere il “grande Mediatore” e fece orbitare il destino della Confederazione dalle influenze francesi a quelle delle potenze del centro e dell’est d’Europa: la coalizione vittoriosa si preoccupò da subito delle sorti svizzere, allo scopo di assicurarsi che la sua neutralità non ostacolasse l’inseguimento delle truppe francesi e al fine di I quali sono, secondo l’art. XIII dell’Atto di mediazione, Friburgo, Berna, Soletta, Basilea, Zurigo e Lucerna. 20 Infra, p. 44; art. 23. 21 G.A. Chevallaz, Le Gouvernement des Suisses ou l’histoire en contrepoint, Lausanne, Éditions de L’Aire, 1989. 22 Parole scritte dal ministro Stapfer il 18 gennaio 1803. 23 Costituzionalizzato nell’art. 3 dell’Atto di mediazione attraverso le parole “In Svizzera non esistono più né regioni soggette, né privilegi di luogo, di nascita, di persone o di famiglie”. 19 V. Nava, La Costituzione 41 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 riportare anche il territorio confederato nell’alveo dell’ancien régime. A questo proposito non dovettero sforzarsi troppo: la Svizzera proclamò la sua neutralità e infranse la condizione di Stato alleato alla Francia. Non solo, il 28 dicembre 1813, a Zurigo, un’assemblea promossa da dieci tra i più antichi Cantoni decretò revocato l’Atto di mediazione dando il via a spinte reazionarie che in molti Cantoni si tradussero in colpi di Stato, ritorno al potere degli antichi patriziati e rivendicazioni di dominio territoriale sugli ex baliaggi. Il Paese nuovamente rasentò la guerra civile e nuovamente lo straniero intervenne: consigliato dal vecchio amico vodese Laharpe, lo zar di Russia Alessandro I convinse gli altri monarchi alleati della bontà del proposito di indurre gli antichi Cantoni a rinunciare alle rivendicazioni territoriali. Pertanto le potenze unite intimarono ai confederati, sotto minaccia di intervento armato, di darsi un nuovo ordinamento. I 19 Cantoni detti “della Mediazione” iniziarono così i lavori che si protrassero fino al 31 agosto 1815: era l’inizio di quella che venne chiamata la “lunga Dieta.” Intensi mesi di trattative in cui venne rinnovata la proposta dei conservatori di ricostituire l’antica Confederazione dei tredici Cantoni e persino, su proposta del Canton Svitto, quella di ritornare all’originario “Patto dei tre Cantoni” del 1291, ma che condussero, infine, a quel Patto federale che, consegnato nelle mani dei protagonisti del Congresso di Vienna, diede loro l’ultima parola sui confini territoriali della Svizzera. Il nuovo assetto vedeva tre nuovi Cantoni, Vallese, Ginevra e Neuchâtel – quest’ultimo rimaneva paradossalmente al contempo un principato prussiano – aggiungersi ai precedenti 19, per un totale di 22. Furono queste le condizioni imposte dalle potenze del Congresso quale contropartita alla garanzia di neutralità della Svizzera, internazionalmente riconosciuta il 20 novembre 181524. La fuga di Napoleone dall’isola d’Elba nella primavera del 1815 e il suo governo dei “cento giorni” generarono anche in Svizzera quell’inquietudine che spinse le redivive classi dirigenti aristocratiche ancor più verso le potenze restauratrici di Austria, Prussia e Russia. Il Patto, che entrò ufficialmente in vigore il 7 agosto 1815, fece la sua comparsa in scena sotto il più marcato degli spiriti della Restaurazione. Un Patto, dicevamo, vale a dire un contratto fra Stati tornati sovrani, il quale, in soli 15 articoli, oltre a cancellare la figura del Landamano, registrava un rilassamento dei vincoli associativi fra i Cantoni e un sensibile indebolimento dell’autorità centrale. C. Hilty, Le costituzioni federali della Svizzera. Opera pubblicata in occasione del sesto centenario della prima alleanza perpetua del primo agosto 1291, per incarico del Consiglio federale svizzero, Berna, Tipografia S. Collin, 1891, p. 342. 24 V. Nava, La Costituzione 42 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 La Dieta, dalle competenze ancor più limitate e convocata sempre all’interno dei Cantoni direttori, ora però ridotti a tre25, ritorna ad essere un’assemblea di plenipotenziari, nella quale tutti i Cantoni vi sono rappresentati in modo eguale. La ripristinata sovranità dei Cantoni si esplica anche nella rinnovata possibilità data loro di concludere capitolazioni militari e accordi economici con i governi stranieri, mentre il perentorio divieto di stipulare alleanze fra Cantoni espresso nell’Atto di mediazione viene sostituito dal blando invito a non “formare tra essi legami pregiudizievoli al Patto federale”26. Non solo vengono meno la libertà di domicilio e la legislazione volta all’unificazione monetaria, ma la stessa politica commerciale unitaria – agevolata dall’Atto di mediazione nella misura in cui aveva garantito su tutto il territorio nazionale la libera circolazione e proscritto i dazi e le dogane interne, pur senza proibire ai Cantoni la percezione di pedaggi utili alla manutenzione delle vie di comunicazione – viene abbandonata. Anche i principi di eguaglianza giuridica, affermati con decisione durante la Repubblica elvetica prima, e nell’Atto di mediazione poi, vengono meno: le potenze alleate avevano strappato ai Cantoni il consenso all’abolizione dei privilegi civici e territoriali, da cui il vago articolo 7 del Patto federale27, ma la legislazione cantonale relativa al diritto di voto seppe eludere anche su questo punto quanto restava di una delle più importanti conquiste del diritto rivoluzionario francese, riportando al potere il patriziato reazionario28. D’altronde, il primo articolo della nuova carta costituzionale rende chiaro che lo scopo della rinnovata Confederazione era quello di garantire la libertà dei Cantoni, non dei cittadini29. Il Patto del 1815 non arretrò invece per quel che concerne la riforma dell’esercito e le disposizioni relative alla difesa nazionale: nella misura in cui la caduta dell’ancien régime veniva ascritta alla debolezza delle istituzioni militari, la nuova Costituzione oltrepassò l’Atto di mediazione nel precisare il carattere obbligatorio dei contingenti cantonali, facilitato peraltro dall’istituzione di una Ossia Zurigo, Berna, Lucerna. W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 89. 27 “La Confederazione consacra il principio per il quale, dopo il riconoscimento dei ventidue Cantoni, non esistono più in Svizzera dei Paesi sudditi, così pure il godimento dei diritti politici non può, in nessun Cantone, essere privilegio esclusivo di una classe di cittadini”. 28 Cfr. A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., pp. 135-147. 29 “I XXII Cantoni Sovrani della Svizzera […] si riuniscono con il presente Patto federale pel mantenimento della loro libertà e della loro indipendenza contro ogni attacco per parte dell’estero, egualmente che per la conservazione dell’ordine e della tranquillità all’interno. Essi si garantiscono reciprocamente le loro costituzioni, tali quali saranno state adottate dall’Autorità Suprema di ciascun Cantone, in conformità dei principi del Patto federale. Essi si garantiscono pure reciprocamente il loro territorio”. 25 26 V. Nava, La Costituzione 43 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 cassa militare federale. L’altra innovazione di cui si fece portatore il Patto del 1815 è di ordine religioso e di estrema importanza per comprendere gli avvenimenti che si verificarono in seguito: l’articolo 12 infatti poneva ora la tutela dei conventi sotto l’autorità centrale, sottraendola pertanto alle prerogative cantonali. Promotori di questa disposizione furono i piccoli Cantoni cattolici, altrimenti notoriamente ostili a qualsiasi accentramento, anche relativo alle istituzioni militari. Ciò avveniva in un’Europa che vedeva il costituirsi, il 26 settembre 1815, di quella Santa alleanza fra i tre monarchi di Russia, Prussia e Austria che fece del cristianesimo il proprio bastione a sostegno dei governi monarchici, cui il 27 gennaio 1817 aderì anche l’elvetica confederazione di Stati pur sempre repubblicani. 1.4 La Rigenerazione: 1830-1848 L’eco delle giornate parigine del luglio 1830, che videro il crollo dell’assolutismo di Carlo X, giunse anche in Svizzera a portare quella scossa che, attraverso grandi adunate popolari e l’insurrezione delle forze liberali, portò ad un profondo rinnovamento in senso democratico e liberale di molti ordinamenti cantonali. È la fase della “Rigenerazione”, termine della periodizzazione storica con cui gli studiosi della Svizzera indicano il periodo che va dalle revisioni delle costituzioni cantonali, che segnarono la fine della Restaurazione, alla formazione del nuovo Stato federale nel 1848. Il termine, utilizzato per la prima volta da Ignaz Paul Vital Troxler, evoca altresì la forza con cui il popolo cercò di creare un ordinamento statale fondato su principi di libertà e di eguaglianza sociale, di cui già si presumeva l’esistenza in un lontano passato30. Una “rigenerazione”, appunto, di cui i fatti rivoluzionari di Francia costituirono, in realtà, solo la scintilla necessaria ad accendere una miccia preparata da tempo in territorio elvetico. Ne sono prova quegli avvenimenti che il 4 luglio, quindi prima delle incandescenti giornate francesi, portarono all’approvazione di una nuova costituzione di stampo liberale nell’italiano Canton Ticino. Anche nel resto della Svizzera, verso la fine degli anni Venti, la legittimità della classe tradizionale detenente il potere politico stava venendo meno: le rimembranze degli ideali e avvenimenti politici che avevano caratterizzato la Rivoluzione francese e la Repubblica elvetica fecero capolino nelle coscienze di coloro che quei fatti li avevano vissuti – Peter Ochs e Frédéric César Laharpe tra gli altri – ai quali si unirono gli intrepidi teorici liberali più giovani, espressione intellettuale dei piccoli gruppi liberali cittadini. Si trattò di un movimento 30 C. Koller, “Rigenerazione” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. V. Nava, La Costituzione 44 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 inizialmente sotterraneo, che si mosse tra le file del nascente associazionismo elvetico, manifestazione più importante del quale furono la Società elvetica e l’associazione studentesca di Zofingia31. Attinse al patrimonio ideale francese rivoluzionario, portato a rivivere nei contemporanei fatti parigini, anche l’altra forza promotrice della Rigenerazione, se non forse la sua vera protagonista: la borghesia. Nei primi trent’anni dell’Ottocento infatti, seconda solo all’Inghilterra, la Svizzera aveva avviato la sua rivoluzione industriale, procurando nuovi mezzi finanziari e prestigio a commercianti, artigiani, grandi allevatori e agricoltori, i quali si andarono ad affiancare nel desiderio di autodeterminazione politica a coloro che praticavano le ormai moltiplicate professioni redditizie, come i medici, gli imprenditori, gli avvocati e i docenti. Le forze borghesi consolidatesi verso la fine della Restaurazione accostavano rivendicazioni economiche – innanzitutto la soppressione dei dazi e l’attuazione della libertà di commercio ed industria – a istanze di carattere civilistico e politico, come la libertà di stampa e di credo, l’eguaglianza giuridica di tutti i cittadini ed un’equa rappresentanza in parlamento. Questi nuovi protagonisti dell’Ottocento elvetico seppero mobilitare, per giungere ai propri fini, anche la popolazione rurale contadina e quella maggiormente industrializzata che viveva nelle campagne vicine alle città, sensibili entrambe a rivendicazioni che potessero venire immediatamente finalizzate al perseguimento di pratici obiettivi economici, come una maggior rappresentanza delle regioni di campagna in seno al parlamento, l’abolizione del voto censuario e l’introduzione del diritto di petizione. Queste le istanze e le forze motrici di quel movimento che, dicevamo, attraverso imponenti assemblee popolari e talvolta scontri armati, giunse a costringere governi e Gran consigli – ossia i parlamenti cantonali – a concedere nuove costituzioni. Una storia complessa quella della Rigenerazione svizzera, nella misura in cui vide protagoniste le singole vicende cantonali, le quali si articolarono secondo percorsi particolari non sempre lineari e dagli esiti differenziati. Capofila degli altri dieci Cantoni “rigenerati” – Zurigo, Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa, San Gallo, Argovia, e Vaud – fu il Cantone Turgovia; i cattolici Friburgo e Lucerna sarebbero passati, nel volgere di breve tempo, al campo conservatore; Basilea, dopo alcune concessioni giudicate insufficienti dai suoi antichi sudditi della campagna, dovette rassegnarsi a quella secessione che nel 1833 diede vita al Cantone autonomo di Basilea Campagna. 31 E.R. Papa, Storia della Svizzera. Dall’antichità ad oggi…, cit., pp. 166-173. V. Nava, La Costituzione 45 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 In generale è possibile affermare che la Rigenerazione, mirante a stabilire la sovranità popolare rovesciando i regimi aristocratici, lasciò intatte tutte le antiche “democrazie” (Landsgemeinde32) e nei suoi ultimi rivolgimenti venne sostenuta soprattutto dall’ardore della Svizzera protestante, i cui ideali liberali si tinsero talvolta di sfumature radicali, urtando invece nell’opposizione sempre più ostinata della Svizzera cattolica, conservatrice e clericale. Di questa opposizione si fece portavoce il non ancora “rigenerato” Canton Berna quando, il 23 dicembre 1830, convocò la Dieta chiedendo ai delegati di pronunciarsi sull’opportunità di un intervento federale per il mantenimento dell’ordine e della difesa delle costituzioni cantonali, di cui il Patto del 1815 si era eretto difensore in base al principio di reciproca garanzia. La Dieta, deliberando a tredici voti contro nove che ogni Stato era libero di apportare i cambiamenti reputati necessari alla propria costituzione, non solo inflisse un colpo decisivo all’autorità del Patto federale che, se interpretato nello spirito della sua concezione, avrebbe senz’altro giustificato l’intervento dell’autorità centrale, ma rinunciando ad un’opposizione ufficiale al movimento di “rigenerazione” eliminò l’ultimo ostacolo al compimento delle riforme costituzionali cantonali33. Queste si innestarono – soprattutto negli ordinamenti del territorio elvetico occidentale e nei nuovi Cantoni come il Ticino – su quei resti di strutture istituzionali del periodo riformista francese sopravvissuti alla scure restauratrice abbattutasi sulla Svizzera dopo il 1815. Vale a dire: il sistema francese dell’organizzazione amministrativa gerarchica e razionale; quello giudiziario, anch’esso gerarchico, con la figura del giudice di pace; i frammenti di codificazione giuridiche parzialmente portati avanti durante il periodo della Restaurazione; un programma di istruzione pubblica ispirata ai principi di laicità; qualche sbiadito diritto individuale. Dopo le innovazioni introdotte con la Repubblica elvetica, questo secondo periodo riformista poté così venir ricollegato a molti aspetti della situazione esistente. In un quadro dalle molteplici sfumature è dunque possibile constatare che la Rigenerazione ambì, anzitutto, alla decisa proclamazione della sovranità popolare, che si tradusse nell’affermazione del principio rappresentativo attraverso l’elezione dei Istituzione ufficiale dei Cantoni rurali, di origine tardo medievale, la Landsgemeinde rappresentava la suprema autorità cantonale, consistente in un’assemblea in cui i cittadini aventi diritto di voto eleggevano le proprie autorità e deliberavano circa le questioni del Cantone. Quale organo di democrazia diretta, era in funzione nei Cantoni di Uri, Svitto, Untervaldo, Appenzello interno ed esterno, Glarona, Grigioni e Zugo; H. Stadler, “Landsgemeinde” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 33 W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., pp. 66-71. 32 V. Nava, La Costituzione 46 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 membri del Gran consiglio, e conseguentemente nella supremazia del parlamento sugli altri poteri. L’espressione “sovranità popolare” portava con sé anche la nuova legittimazione conferita alle costituzioni cantonali grazie all’introduzione del referendum costituzionale obbligatorio, ossia il diritto accordato ai cittadini di approvare o respingere la propria legge cantonale fondamentale, diritto precluso nelle precedenti costituzioni, compresa quella federale del Patto del 1815. A questo proposito, in due Cantoni in particolare, San Gallo e Basilea Campagna, le tendenze democratiche si spinsero al punto da sottoporre ogni legge all’approvazione del popolo attraverso il diritto di veto. Oltre a ciò, con esiti diversi, ora in forme più estese ora meno, si tentò di costituzionalizzare i principi di eguaglianza giuridica dei cittadini, sia politica – vale a dire la distribuzione equa dei seggi “gran consigliari” fra le diverse regioni del Cantone, cittadine e di campagna, e la configurazione del diritto di voto attivo e passivo – e sia civile, secondo la formulazione che vedeva tutti i cittadini eguali dinnanzi alla legge. Vennero inoltre riaffermati alcuni diritti individuali, i quali completamente assenti nel periodo dell’ancien régime fondato su principi corporativi, erano stati occultati nuovamente durante il periodo della Restaurazione dopo essere stati affermati durante la Repubblica elvetica e da lì – oltre che dalla “Charte constitutionnelle” francese dell’agosto del 1830 – nuovamente ripresi. Risorse così in molti Cantoni la libertà di stampa, di petizione e, con maggior prudenza, di associazione, poiché temuta dai liberali moderati e dai conservatori che paventavano la formazione di gruppi radicali. In campo religioso invece solo sei costituzioni “rigenerate” garantirono la libertà di culto o di coscienza, o entrambe. Inoltre, in ottemperanza ai principi del liberalismo economico, tutte le costituzioni dei Cantoni “rigenerati” contemplarono la garanzia della proprietà privata e molte la libertà di domicilio, necessaria a incrementare e tutelare la libertà di commercio e industria. Quest’ultima conobbe tuttavia un’affermazione più timida, soprattutto in quei Cantoni che fino ad allora si erano organizzati intorno a principi corporativi. Ciononostante le successive legislazioni cantonali risultarono impegnate nel tentativo di liberare l’economia del Paese da dazi, pedaggi e altri oneri gravosi34. Riassumendo, principi di libertà ed uguaglianza, sovranità popolare e separazione dei poteri accomunarono i movimenti di “rigenerazione”, creando fra i Cantoni che ne furono promotori quella solidarietà e comunione di intenti che finì per rompere le barriere cantonali nella misura in cui era desiderosa di 34 Cfr. A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., pp. 225-237. V. Nava, La Costituzione 47 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 trascinare al proprio seguito tutta la Confederazione. In altre parole, i Cantoni “rigenerati” fecero irruzione sul terreno federale, chiedendo la revisione di quel Patto che, solo se riformato, avrebbe potuto portare a compimento la diffusione dell’ideale liberal-democratico attraverso la creazione di una sola volontà nazionale, mediante la centralizzazione del regime federale. Contro di essi si elevò tuttavia lo sbarramento di quella opposizione, fatta di attaccamento sincero alle tradizioni federalistiche, di fedeltà incrollabile alla sovranità cantonale, esercitata dai piccoli Cantoni, più numerosi ma meno popolati e per lo più cattolici, che vedevano nel Patto del 1815 il guardiano dei valori tradizionali della patria. Una polarizzazione di due schieramenti la cui interazione contrassegnò le vicende storiche elvetiche fino al 1848, permeando infine l’intero spirito attraverso cui venne concepita la nuova Costituzione federale. 1.5 Il tentativo di riforma federale del 1832-33 Il percorso per giungere alla Costituzione del 1848 si sarebbe rivelato, però, ancora lungo e impervio e dovette passare, anzitutto, attraverso il tentativo di riforma federale del 1832-33. Fu l’intraprendente Canton Turgovia, che abbiamo visto alla testa del movimento di “rigenerazione” delle costituzioni cantonali, a prendere l’iniziativa e a proporre alla Dieta, il 25 marzo 1831, la revisione del Patto del 1815. Lo fece invitando tutti i Cantoni a dare istruzioni per eseguire la riforma della Costituzione federale, al fine di operare “una maggiore centralizzazione, conformemente agli interessi superiori della Svizzera intera” 35. Proseguendo nei dibattiti relativi alla possibilità di riformare il testo costituzionale, il rappresentante di Turgovia ebbe modo di essere ancora più preciso circa le motivazioni che rendevano necessario l’atto di rinnovamento: L’epoca presente, così feconda di conquiste diverse, è stata propizia anche alla nostra patria. In quasi tutti i Cantoni l’ordine costituito si è trasformato […] affinché questa evoluzione verso fini migliori e maggiormente consoni alle necessità attuali non rimanga incompiuta è necessario che lo Stato federale […] si elevi e divenga forza potente. Solo così potranno svilupparsi un vero spirito nazionale, un patriottismo che animi tutti i cittadini e una prosperità della quale beneficeranno le generazioni presenti e future. In tutte le parti della Confederazione, l’opinione pubblica si pronuncia energicamente in favore di un simile progetto […] e del resto, tale augurio è espresso nella nuova costituzione del Canton Turgovia. 36 Infatti non solo la costituzione riformata di quel Cantone sanciva con decisione tutti i più importanti principi del movimento di “rigenerazione”, ma stabiliva al suo interno – caso unico nella storia delle costituzioni cantonali 35 36 W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 72. Ivi, pp. 74-75. V. Nava, La Costituzione 48 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 elvetiche – la possibilità di cedere competenze in materia estera ed economica alle autorità federali in caso di una revisione del Patto del 1815. Quanto all’opinione pubblica che si era pronunciata “energicamente in favore” della riforma federale, è verosimile dedurre che il delegato turgoviese si riferisse alle popolazione dei Cantoni che poi si espressero effettivamente a favore al momento di deliberare una decisione in merito alla questione. Si schierarono con la volontà rinnovatrice di Turgovia i Cantoni di Friburgo, Lucerna, Zurigo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, e Argovia. Tutti di lingua tedesca – a parte il bilingue Friburgo – ma soprattutto tutti Cantoni che avevano già riformato le proprie costituzioni. La volontà di cambiare la legge fondamentale della Confederazione è dunque intimamente connessa ai movimenti di “rigenerazione” stessa e venne sostenuta da quei Cantoni che vi avevano preso parte. Più precisamente accadeva che quando uno di questi Cantoni subiva la reazione conservatrice – come avvenne per Lucerna nel 1839 o San Gallo nel 1843 – il nuovo governo si poneva in posizione ostile alla riforma federale promossa dai predecessori liberali. Quando invece un’autorità cantonale refrattaria all’istanza di revisione del Patto subiva una rivoluzione radicale – come accadde a San Gallo e Ginevra nel 1846 e 1847 – il nuovo governo non tardava ad abbracciare la causa riformatrice sul piano nazionale37. Tornando alle discussioni alla Dieta, fra i Cantoni che non espressero lo stesso parere manifestamente favorevole, solo i tre Cantoni primitivi di Uri, Svitto e Untervaldo, oltre che il Vallese, furono dichiaratamente ostili alla riforma. Nella deliberazione finale, poi, avvenuta il 16 luglio 1832, agli otto che si erano mostrati favorevoli fin dall’inizio delle discussioni alla Dieta si aggiunsero Berna – che nel frattempo aveva compiuto la sua “rigenerazione” – Appenzello esterno, Grigioni, Basilea, Vaud e Ginevra. Con ciò era stata raggiunta la maggioranza di tredici Cantoni e un semi-cantone. Allo scopo di portare a termine il nuovo obiettivo, la Dieta nominò una speciale commissione incaricata di redigere il progetto di riforma. Furono scelti a tale scopo i delegati di Lucerna, Zurigo, Berna, Uri, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, San Gallo, Grigioni, Sciaffusa, Argovia, Ginevra, Neuchâtel e Vaud. Il rappresentante di Uri, avverso al principio stesso di revisione, rifiutò il mandato, e venne sostituito dal delegato turgoviese. Questi fatti mostrano la volontà della Dieta di dar voce ai Cantoni considerati politicamente più importanti e influenti, nominandone i rappresentanti come membri di commissione. Mostrano altresì, attraverso il rifiuto di Uri, le difficoltà che caratterizzarono fin dall’inizio i tentativi di riforma. Ma le divergenze di vedute non tardarono a farsi strada anche in seno 37 Ibidem. V. Nava, La Costituzione 49 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 alla commissione stessa, a lavori avviati, generando opinioni opposte le une alle altre che videro lo scontro fra chi invocava un cambiamento consistente e una decisa opera di centralizzazione, e chi si dimostrava più ossequioso delle tradizioni difendendo il principio di assoluta sovranità cantonale38. Nonostante le difficoltà, il progetto, cui si diede il nome di Atto federale, venne portato a termine entro il mese di dicembre del 1832. Esso si rivela interessante per una duplice motivazione: per le disposizioni che vi ritroviamo, talvolta talmente affini a quelle che poi contraddistinsero il testo del 1848 da rendere il progetto del 1832-33 il canovaccio della futura Costituzione federale; e per le motivazioni che invece da questa lo distinsero, precisamente le stesse che ne decretarono il fallimento. I due progetti costituzionali sono accomunati innanzitutto dalle considerazioni che indussero a redigerli, e che vanno ricercate nelle critiche rivolte a quel Patto federale del 1815 che buona parte del popolo elvetico percepiva ormai come invecchiato, non conforme allo spirito del secolo e alla mutata condizione del Paese. Il Patto in vigore si era rivelato inadatto al suo scopo nella misura in cui non era stato in grado di creare quel regime di libera circolazione e unità doganale necessario all’incrementato sviluppo economico della Confederazione. Inoltre, le sue blande disposizioni relative all’ordine interno avevano finito per configurarlo come un semplice trattato di alleanza fra Cantoni, deludente nella sua incapacità di subordinare i capricci di questi ad una volontà comune, rendendo infine l’intera Confederazione un organismo minuto e fragile in un’Europa di giganti. A queste motivazioni si affianca poi quella di ordine identitario e ideale, che anzi abbraccia tutte le altre e che vede un popolo sempre più cosciente ed orgoglioso della propria unità nazionale reclamare qualcosa di più di un Patto che in definitiva si configurava come una mera alleanza fra Cantoni sovrani: Svizzero. Questa parola domina sopra la diversità dei nostri idiomi, de’ costumi, delle religioni, dell’industrie; questa parola, con tutto il seguito delle idee che l’accompagnano, primeggia al di sopra delle tradizioni locali, o meglio direbbesi, in sé tutte le assorbe. […] è dessa che c’imprime un carattere indelebile di comune nazionalità. 39 Le parole di Pellegrino Rossi – delegato di Ginevra alla Dieta su cui si tornerà in modo più approfondito fra poco – sono indicative di quello spirito che, caratterizzando i membri più audaci della commissione, mirava a dotare la Confederazione di una struttura istituzionale completamente nuova. La volontà di rinnovamento era quindi animata anche dal desiderio di dare una veste istituzionale a quella “forza segreta”, a quel “cemento morale” – per utilizzare 38 39 Ibidem. Ivi, p. 83. V. Nava, La Costituzione 50 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 le parole dello storico del diritto L. Lacché – che da secoli univa i Cantoni elvetici in un sol corpo statale: il principio nazionale40. Tuttavia non era possibile operare alcun cambiamento senza tenere conto dell’essenza stessa della Confederazione: “la sovranità dei Cantoni è in Svizzera il principio storico e fondamentale, l’espressione del passato e del presente 41”, affermava Rossi. Queste opposte tendenze, la volontà di assicurare il principio unitario e l’inclinazione a difendere la sovranità cantonale, precorsero i grandi temi che si sarebbero riproposti con forza nel 1848 elvetico, e indicano la soluzione che i costituenti del 1832-33 credettero di poter trovare. Si ritenne che la via era da ricercare nel compromesso; la Svizzera doveva continuare ad essere una Confederazione, avvicinandosi alla repubblica federale “quanto si può senza cambiar natura”42. Maggior centralizzazione pur senza ledere le autonomie cantonali, quindi. L’opera di mediazione fra istanze radicali tendenti all’unitarismo e volontà rispettose delle tradizioni e dello status quo è ben rappresentata dalla figura del già citato P. Rossi. Nato a Carrara, giunse in Svizzera nel 1815 come rifugiato politico dopo aver militato fra le file dell’improvvisato Regno di Gioacchino Murat e averne condiviso la rotta politica e militare. Rossi approdò così a Ginevra, dove il suo talento e la brillante eloquenza gli permisero un’ascesa sociale rapida e irresistibile: primo cattolico ad insegnare nell’Accademia della città calvinista, ricevette la cittadinanza nel 1820 e venne eletto nel consiglio rappresentativo ginevrino, riuscendo a far divenire la sua voce sempre più influente. Rossi, poi, fu scelto nel 1832 come rappresentante di Ginevra alla Dieta per affrontare la questione della riforma. Venne designato come relatore dei lavori di commissione, riuscendo a distinguersi come uno dei principali redattori di quel progetto che infatti porta anche il suo nome43. In quest’occasione egli si fece ambasciatore della via di mezzo - del juste milieu, citando nuovamente Lacché44- nel tentativo di avvicinare le due ali estreme del movimento attraverso un progetto di riforma le cui parole chiave furono progresso e moderazione. Moderato è definibile anche l’orientamento politico di Rossi, il quale, nonostante i suoi trascorsi italiani da rivoluzionario, additava i radicali e “unitari” elvetici come gli elementi più pericolosi per l’esistenza della Svizzera, P. Rossi, Per la Patria comune. Rapporto della Commissione della Dieta ai ventidue Cantoni sul progetto d’Atto federale da essa deliberato a Lucerna il 15 dicembre 1832, edizione a cura di L. Lacché, Manduria, Piero Licata Editore, 1997, p. XLIII. 41 Ibidem. 42 Ibidem. 43 L’Atto federale viene talvolta indicato anche con il nome di Patto Rossi; A. Dufour, “Patto Rossi” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 44 P. Rossi, Per la Patria comune. Rapporto della Commissione della Dieta…, cit. p. XLIII. 40 V. Nava, La Costituzione 51 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 coloro che “intendevano applicare alla Confederazione una teoria sovversiva”45. Allo stesso tempo però, in virtù del suo pensiero intrinsecamente liberale, Rossi manifestò di volere fortemente il progresso e la riforma. Egli, oltre che moderato, è definibile anche come “moderatore”, per il ruolo di mediazione che svolse durante i lavori costituenti, in quanto, riflettendo perfettamente gli orientamenti ginevrini, si fece portavoce di quello spirito di conciliazione fra istanze estreme che permeò infine tutto il progetto dell’Atto federale. Le vicende politiche della vita del carrarese, che fecero seguito al fallimento della riforma, sono poi indicative non solo della personalità di questo protagonista, ma anche del clima che allora vigeva in territorio Confederato. Deluso dalle sorti della riforma elvetica del 1832-33, Rossi si trasferì nella Francia degli Orléans, dove, naturalizzato francese, ottenne la cattedra presso l’Institut parigino e poco dopo assurse alla dignità di Pari di Francia. Quindi gli venne conferito l’incarico di mediare la questione dei gesuiti, di cui i francesi volevano liberarsi, senza provocare l’ira della Santa sede. Giunse pertanto a Roma come incaricato straordinario, e vi rimase poi come ambasciatore francese presso lo Stato pontificio. In quest’occasione ebbe modo di guadagnarsi le simpatie di Pio IX, il quale – in seguito agli sconvolgimenti rivoluzionari del 1848 che fecero cadere la monarchia francese e costrinsero Rossi a dimettersi dal ruolo di ambasciatore di Francia – conferì al carrarese l’incarico di formare il nuovo governo pontificio. Il timore che riuscisse a portare a termine l’arduo compito indusse i suoi nemici ad assassinarlo, il 15 novembre del 1848. Gli avversari di Rossi vengono individuati dalla ricerca storica svolta da G. Andreotti nei liberali “preoccupati per l’efficacia del suo riformismo” e nella “camarilla curiale” la quale “non accettava che si volesse far politica democratica sul serio”46. Si è ritenuto opportuno approfondire ulteriormente la figura e la storia di P. Rossi, non solo perché essa è denotativa del fatto che egli continuò a svolgere il ruolo di mediatore fra opposte istanze, finendo per procurarsi la morte, ma anche poiché – come si è potuto vedere – le sue vicende narrano di un cattolico che prima di svolgere il ruolo di portavoce del dissenso francese circa l’ordine dei gesuiti e di entrare poi alla “corte” del Papa, si era posto al servizio di una causa riformatrice, quella elvetica, che era espressione soprattutto della parte protestante della popolazione confederata. Fatti, questi, che da un lato infittiscono la trama delle dinamiche politiche svizzere e dall’altro sono indicativi del clima elvetico del 1832-33, il quale non era ancora stato esasperato dalla guerra che precedette immediatamente il nuovo tentativo di riforma 45 46 Ibidem. G. Andreotti, Ore 13: il Ministro deve morire, Milano, Rizzoli Editore, 1974, p. 8. V. Nava, La Costituzione 52 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 operato nel 1848 e che – avremo modo di vederlo – sorse anche dallo scontro delle due confessioni prevalenti in territorio confederato. La penna vivace ed eloquente di Rossi, inoltre, realizzò un “Rapport de la Commission de la Diète”, che, unito ai 120 articoli dell’Atto federale, completa il progetto di revisione costituzionale e ci informa sull’influenza che i lavori del 1832 esercitarono su quelli più arditi della Dieta costituente del 1848 47. Affinità, quelle fra i due movimenti di riforma, di cui si è già accennato e che è possibile ravvisare anche nella struttura dei due testi costituzionali, ambedue costituiti da tre capitoli, suddivisi come segue. Nel primo, intitolato “Disposizioni generali”, compaiono gli articoli volti a stabilire i limiti entro cui potevano ancora esplicarsi i diritti di sovranità dei Cantoni, le cui singole costituzioni sarebbero state garantite dall’autorità federale solo a patto che avessero soddisfatto importanti criteri, il più innovativo dei quali era il diritto concesso ai cittadini di modificare le proprie leggi fondamentali cantonali. Sempre fra le “disposizioni generali” figurano norme atte a regolare l’organizzazione militare e assicurare l’unità nazionale dal punto di vista economico48. Il secondo capitolo, “Autorità federali”, provvede invece a dotare la Confederazione di veri organi istituzionali – legislativi, esecutivi e giudiziari – mentre il terzo contiene le disposizioni necessarie a regolare la questione delle future revisioni costituzionali. Alle somiglianze riscontrabili nella struttura dei testi costituzionali del 1832 e del 1848 vanno aggiunte poi quelle relative alle specifiche disposizioni: l’istituzione di quel potere esecutivo, per esempio, concepito già nel 1832 come strettamente collegiale poiché composto di soli 5 membri, e di cui il futuro quarantottesco Consiglio federale sarà l’erede, pur modificando il carattere di eguaglianza fra i consiglieri che lo compongono, in ossequio alle tradizioni elvetiche, attraverso la sostituzione del Landamano con la figura di un presidente primus inter pares49. L’altro organo istituzionale previsto dall’Atto federale del 1832 è invece massimamente indicativo della differenza che intercorre fra i due testi. Il potere legislativo rappresentato dalla Dieta prevista dal progetto del 1832 è infatti cosa ben diversa da quell’Assemblea federale che verrà istituita nel 1848: nel primo “Rapport de la Commission de la Diète aux vingt deux cantons suisses sur le projet d’acte fédéral par elle délibéré à Lucerne, le 15 décembre 1832, Genève 1832”. 48 Anche nel testo del 1832, come in quello del 1848, attraverso clausole tendenti a favorire la libertà di commercio, quella di domicilio e l’unificazione di moneta, pesi, misure e servizi postali. 49 Il Patto Rossi ripristinava, infatti, la carica di Landamano – in qualità di presidente del Consiglio federale – riprendendola dall’assetto costituzionale deciso da Napoleone, mentre – come avremo modo di vedere – la Costituzione del 1848 caratterizzò il presidente come un semplice primus inter pares rispetto ai suoi colleghi. 47 V. Nava, La Costituzione 53 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 caso, si trattava di un parlamento monocamerale, la Dieta, composta da due rappresentanti per ogni Cantone o semi Cantone, come già previsto nel Patto federale del 1815. Un assetto, questo, che, rivelandosi più desueto persino di quello stabilito dal precedente Atto di mediazione napoleonico - il quale, si ricorderà, aveva concesso ai Cantoni più popolosi una rappresentanza doppia rispetto agli altri – non era in grado di soddisfare le sopraggiunte ambizioni di sovranità popolare, le quali sarebbero state assecondate soltanto nel 1848, attraverso l’istituzione di un meccanismo bicamerale di rappresentanza in parlamento. Quest’ultimo teneva conto della densità di popolazione nel Consiglio nazionale, rappresentando in modo differenziato i Cantoni nel Consiglio degli Stati, cioè assegnando un solo consigliere ai semi Cantoni e due ai Cantoni. Viceversa, nel progetto di riforma del 1832-33 non era prevista una rappresentanza differenziata dei Cantoni in seno al parlamento, ma essi erano definiti “uguali, indipendenti e sovrani, indipendentemente dal loro territorio, dalla loro popolazione e dalla loro ricchezza”. Ecco in cosa i due progetti differiscono, e soprattutto ecco le ragioni che decretarono il fallimento di quello del 1832: i membri della commissione, per quanto convinti che il principio di sovranità nazionale dovesse trionfare su quello dei singoli Cantoni, decisero di prendere atto delle radici profonde del sentimento cantonale, e lasciarono che esso continuasse a prevalere, ponendo in essere una centralizzazione estremamente moderata. Fatto che risulta chiaro dalle parole pronunciate, il 2 giugno 1832, dall’allora presidente della Dieta, il lucernese Edoardo Pfyffer, liberale, ma convinto della necessità di una riforma moderata che potesse non urtare le sensibilità cantonali: […] è indispensabile aumentare l’autorità e le competenze dei poteri federali. Ma non si tratterà mai di unità assoluta. Siffatta unità sarebbe incompatibile con la nostra situazione, con le nostre abitudini […]. Il Principio dominante dovrà sempre essere la sovranità dei Cantoni. 50 Desiderosi di guadagnarsi l’approvazione dei piccoli Cantoni conservatori gelosi delle proprie autonomie – anche poiché molto numerosi e quindi in grado di condizionare l’approvazione dell’Atto federale al momento della votazione finale alla Dieta – i costituenti del 1832 giunsero così a stilare un progetto di riforma costituzionale dalla natura fortemente compromissoria, che finì per rinnegare sotto profili essenziali – fra cui l’espressione della volontà generale e l’esercizio di un governo comune – i principi liberal-democratici che i Cantoni riformati volevano estesi a livello federale. Nel fare ciò, non seppero tenere presente la verità fondamentale, e cioè che i piccoli Cantoni conservatori erano decisi a rifiutare in ogni caso il progetto, poiché convinti 50 W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 75. V. Nava, La Costituzione 54 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 dell’inopportunità, a prescindere dalle buone intenzioni dei costituenti, di modificare quel Patto che rappresentava per loro il baluardo delle tradizioni della patria. Per questo motivo il Patto Rossi, ulteriormente emendato in senso conservatore e federalista dalla Dieta cui la commissione lo sottopose, finì al tempo stesso sia per scontentare quelle stesse forze unitarie e nazionali che lo avevano promosso, sia per incontrare la generale opposizione di quei Cantoni da sempre dichiaratisi ostili. Di conseguenza, nella votazione finale del 1833 venne approvato da nove Cantoni soltanto, cosa che ne decretò il definitivo fallimento sotto lo sguardo compiaciuto delle potenze estere. 1.6 Verso la riforma costituzionale del 1848: la guerra del Sonderbund Il fallimento del progetto di riforma federale non fece altro che polarizzare ulteriormente i due schieramenti caratterizzanti la Confederazione. Su di un fronte, il Concordato dei Sette, stipulato già nel marzo 1832, sancì formalmente l’alleanza dei Cantoni “rigenerati” 51, che intendevano garantirsi reciprocamente i nuovi ordinamenti liberali, in attesa di poterne affidare la tutela alla Confederazione riformata. Per tutta risposta, i Cantoni conservatori Uri, Svitto, Untervaldo, Neuchâtel e Basilea città, dopo aver inutilmente richiesto alla Dieta di sciogliere quella che aveva tutto l’aspetto di una confederazione dentro la Confederazione, decisero di stipulare a loro volta un concordato, il Patto di Sarnern (Sarnerbund), al fine di difendere la libertà tradizionale e promuovere la resistenza contro la riforma federale52. Si trattava di alleanze di carattere essenzialmente politico, ma a modificare gli equilibri e imprimere una svolta all’impasse si aggiunse ben presto il fattore confessionale. La guerra civile che ne derivò, però, la celebre guerra del Sonderbund, fu solo apparentemente una guerra di religione, quanto piuttosto un conflitto che ad un certo punto vide sommarsi il problema confessionale ai più antichi antagonismi di natura politica e costituzionale. Ciò avvenne quando, il 20 gennaio 1834, i delegati di sette Cantoni, parzialmente o interamente cattolici, ma tutti “rigenerati”53, adottarono a Baden un programma di riforma ecclesiastica che proponeva innanzitutto l’istituzione di una sede arcivescovile in Svizzera, al fine di promuovere l’unità nazionale a livello ecclesiastico, emancipandosi così dalla gerarchia imposta da Roma. Il programma mirava inoltre, mediante le altre 14 risoluzioni – che costituiscono gli articoli di Baden Fra i Cantoni Zurigo, Berna, Lucerna, Soletta, San Gallo, Argovia e Turgovia. Stipulato nel novembre del 1832. 53 Gli autori dei cosiddetti “articoli di Baden” furono: Lucerna, Berna, Soletta, Basilea Campagna, San Gallo, Argovia e Turgovia; F Genoud, “Articoli di Baden” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 51 52 V. Nava, La Costituzione 55 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 propriamente detti – a regolamentare i rapporti fra Stato e Chiesa nel senso di una subordinazione di quest’ultima alla volontà del primo54. È in questi articoli che è lecito scorgere l’origine della guerra del Sonderbund, nella misura in cui essi ebbero l’effetto di allargare il baricentro del confronto al campo della politica ecclesiastica – che i liberali riformisti della prima ora avevano invece affrontato con moderazione – dando avvio a disordini a partire da quei Cantoni, come Argovia e San Gallo, che quegli articoli li applicarono in modo spregiudicato. Alla rivolta che vide il popolo delle campagne schierarsi al fianco dei parroci, Argovia rispose con la soppressione di otto conventi, il 20 gennaio 1841, e con la richiesta alla Dieta di espulsione dell’ordine dei gesuiti dal territorio confederato. La chiusura dei conventi – contraria alle norme del Patto del 1815, il cui articolo 12, lo ricordiamo, ne garantiva espressamente l’esistenza – e la mozione sui gesuiti, rifiutata però dalla Dieta, suscitarono l’indignazione dei conservatori elvetici, la quale si tradusse nell’atto compiuto dal governo di Lucerna, tornato nel frattempo nell’alveo conservatore, di convocare i gesuiti e affidare loro la direzione dei principali istituti d’insegnamento del Cantone. Azione che venne sentita come una provocazione, prontamente colta dai liberal-radicali, i quali costituitisi in veri e propri corpi franchi, invasero due volte, nel dicembre del 1844 e nel marzo del 1845, il territorio di Lucerna. Fu proprio sotto l’impressione suscitata da questi eventi che l’11 dicembre 1845 venne concluso il Sonderbund – la lega da cui l’intero conflitto prese il nome – tra i Cantoni Lucerna, Svitto, Uri, Untervaldo, Friburgo, Vallese e Zugo. Una lega separata che si rese ancor più suscettibile di condanna nel momento in cui, benché ai Cantoni fosse proibito stipulare legami pregiudizievoli al Patto federale (art. 6), si rivolse alle potenze straniere di Austria e Prussia 55. Gli avvenimenti successivi sono noti: il 20 luglio 1847 la Dieta varò la proposta di sciogliere il Sonderbund grazie al voto determinante di San Gallo; il 16 agosto decretò la revisione del Patto federale ed elesse a tal scopo una speciale Commissione; il 3 settembre ordinò a tutti i Cantoni di espellere i gesuiti; infine il 4 novembre decise di sciogliere il Sonderbund con le armi. La guerra vide alla testa dell’esercito protestante e riformatore il generale Guillaume Henri Dufour, il quale seppe concluderla da vincitore causando pochissime vittime e in poche settimane, senza dare il tempo ad Austria, Prussia e Francia di giungere in soccorso dei separatisti. Il nome del celebre generale Dufour ricorre nella storiografia elvetica accanto a quello del comandante delle forze militari del Sonderbund, Salis Johann Ulrich von Soglio, Per un approfondimento relativo alla complicata situazione episcopale nella Svizzera di quegli anni si veda A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., pp. 278-282. 55 W. Martin, Storia della Svizzera..., cit., pp. 224-229. 54 V. Nava, La Costituzione 56 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 a riprova della natura complessa di una guerra che difficilmente può essere definita semplicemente “di religione”. Infatti il capo delle forze militari conservatrici e cattoliche, Salis-Soglio, era un protestante, mentre il generale dello schieramento protestante e riformatore, Dufour, era di orientamento politico conservator-moderato56. Questi ultimi intensi avvenimenti influirono sull’evoluzione costituzionale – e dunque aprirono la via alla transizione da Confederazione di Stati a Stato federale – in quanto crearono l’atmosfera propizia alle soluzioni innovatrici imposte anche con la forza. Dinamica felicemente riassunta da W. E. Rappard attraverso una suggestiva metafora: Questi avvenimenti, per le pressioni che generarono e che, a loro volta, esercitarono, agirono come un aratro che scavasse nel suolo elvetico solchi abbastanza profondi perché le ideesementi che vi erano state gettate durante gli anni precedenti potessero infine lievitare. La messe del 1848, infatti, era composta della filosofia liberale del 1830, delle reiterate iniziative di riformatori animati da quella filosofia, dal fanatismo confessionale e dell’anticlericalismo che si esasperarono l’un l’altro e, infine, del sangue dei soldati avversari e difensori del Sonderbund. 57 La guerra del Sonderbund ebbe dunque il merito di rompere la resistenza dei fautori intransigenti delle prerogative cantonali e far tacere gli scrupoli dei giuristi che contestavano la possibilità di una revisione legale del Patto del 1815, senza l’accordo unanime dei suoi firmatari. La Commissione designata dalla Dieta però non poté iniziare i suoi lavori prima del febbraio dell’anno seguente: la guerra in atto indusse ad attendere che i propri connazionali, ora nemici, potessero collaborare una volta esaurito il conflitto; ma la prudenza li fece temporeggiare anche nel timore che l’intervento delle potenze estere potesse stroncare il progetto di revisione sul nascere. Il pericolo era reale poiché, il 18 gennaio 1848, l’ambasciatore austriaco aveva inoltrato, anche a nome di Prussia, Francia e Russia, ma non d’Inghilterra, una nota gravida di minacce: l’occupazione militare nei Cantoni del Sonderbund doveva avere fine; gli elvetici non avevano il diritto di modificare il Patto federale senza l’approvazione unanime di tutti i Cantoni 58. La Dieta rispose con una fermezza che viene valutata da Kölz un capolavoro di diplomazia politico-giuridica: le potenze del Congresso, il cui sguardo aveva vigilato sulla redazione del Patto del 1815, avevano garantito solo il territorio della Confederazione; non avevano vincolato la carta costituzionale alla neutralità della Svizzera. Se poi eventuali modifiche al Patto federale dovessero Fra gli altri, E.R. Papa, Storia della…, cit., p. 186. E.W. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 104. 58 G.A. Chevallaz, Le Gouvernement des Suisses ou l’histoire…cit. 56 57 V. Nava, La Costituzione 57 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 essere possibili solo mediante un consenso unanime di tutti i Cantoni o attraverso la sua maggioranza, era affare che competeva unicamente agli Stati membri della Confederazione, non poteva essere deciso nella maniera più assoluta da Stati esteri59. D’altronde, lo stesso Patto del 1815 non era forse stato adottato da una semplice maggioranza di Cantoni, ben prima che la minoranza desse la sua adesione, sotto la pressione delle Potenze del Congresso di Vienna? Queste stesse considerazioni vennero fatte presenti a quei confederati che indugiavano sull’opportunità di una revisione costituzionale poiché intimoriti dal pericolo d’invasione. Se la Svizzera scampò ad un pericolo che probabilmente l’avrebbe vista soccombere fu per due ragioni: dapprima l’opposizione dell’Inghilterra rallentò l’intervento militare di Austria e Francia durante la guerra del Sonderbund, una guerra che si rivelò rapida al punto da cogliere di sorpresa lo straniero che si accingeva a giungere in soccorso dei separatisti, i loro avversari seppero quindi batterli sul tempo60; poi, a conflitto terminato, i lavori della Commissione poterono essere portati a termine poiché le rivoluzioni avviate nel febbraio 1848 giunsero con tempismo quasi provvidenziale a paralizzare la politica reazionaria dell’Europa di Metternich, riducendo a nulla le velleità interventistiche che avevano minacciato l’indipendenza della Svizzera61. 1.7 Orientamenti politici degli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento È possibile constatare che la Costituzione del 1848 e la nascita dello Stato federale sono il risultato dei movimenti di idee e dei dibattiti che si fecero strada durante gli intensi anni di mutamenti di cui abbiamo parlato. In particolare il periodo della Rigenerazione svizzera e la creazione dello Stato federale risultano legati da un’evidente rapporto di causalità. Il lavoro dei costituenti del 1848 necessita dunque di essere compreso alla luce di quegli orientamenti politici che iniziarono a delinearsi proprio a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento: liberalismo, radicalismo e conservatorismo sono le grandi correnti di pensiero che, in una Svizzera ancora essenzialmente pre-partitica, determinarono il progetto di riforma federale. A questo proposito, prima di analizzare la composizione e il modus operandi della Commissione nominata dalla Dieta, si rende necessario fare qualche considerazione. È innanzitutto opportuno tenere presente che liberali e radicali furono uniti fin dal principio dalla volontà di riformare il Patto del 1815, e per questo si contrapposero “in blocco” allo schieramento conservatore, difensore dello status quo. Infatti, , il “ceppo originario” delle due “fazioni” fautrici del cambiamento, A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 382. E.R. Papa, Storia della Svizzera…, cit., p. 187. 61 W. Martin, Storia della Svizzera…, cit., p. 227. 59 60 V. Nava, La Costituzione 58 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 per citare le parole di Lacché, era “quello liberale” da cui, all’inizio del 1830 iniziò a dipartire il ramo “radicale”, che solo negli anni Quaranta acquistò una caratterizzazione più definita62. In questo senso è possibile parlare di orientamento liberal-radicale, senza operare un’ulteriore distinzione fra le due correnti di pensiero, pur differenziandosi circa la configurazione specifica che si voleva assunta da alcuni aspetti della riforma. Per quel che concerne il profilo economico, ad esempio, i liberali puri, ispirandosi alle dottrine degli economisti e fisiocrati francesi, oltre che alla teoria classica di Adam Smith63, postulavano uno Stato che non ostacolasse in alcun modo l’esercizio dell’attività economica, e che si limitasse a sopprimere i dazi doganali protezionistici di qualsiasi natura. Anche i radicali caldeggiavano l’eliminazione di ogni ostacolo al libero commercio, teorizzando però un potere statale forte e interventista, che avrebbe dovuto programmare una politica economica la quale privilegiasse il benessere della collettività64. Inoltre, mentre i radicali si battevano per la creazione di uno Stato sociale ed egualitario e per l’introduzione di mezzi di intervento politico a favore del popolo – come l’iniziativa popolare per le leggi e il diritto di revoca da parte dei cittadini rispetto al parlamento – per i liberali la parola d’ordine permaneva “libertà e proprietà”, non “eguaglianza e libertà”. In questo modo i liberali interpretavano il concetto di sovranità popolare unicamente come eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, non prevedendo l’abolizione delle disparità economiche e sociali dei singoli e accantonando istanze maggiormente ispirate alle forme di democrazia diretta. Infine, i radicali si distinsero dai liberali per quel che concerne i mezzi e i tempi che giudicarono necessari per giungere ai propri scopi: postularono il capovolgimento dell’ordinamento tradizionale optando spesso per soluzioni audaci e violente. Ma, come dicevamo, i due orientamenti politici rimanevano accomunati dal medesimo obiettivo generale: cambiare l’ordine costituito riformando il Patto del 1815, creando uno Stato forte che muovendosi in senso unitario e accentratore – attraverso una ridefinizione in senso limitativo delle prerogative cantonali – potesse essere dotato degli strumenti necessari al perseguimento di specifici obiettivi: sicurezza interna e dall’esterno, prosperità economica e benessere dei cittadini. I fautori del cambiamento trovarono però un freno ai loro propositi nell’opposizione dei conservatori. Essi, elevando la sovranità cantonale a teoria politica nazionale e a sinonimo di libertà, si opposero al concetto di Stato centralistico, unitario e L. Lacché, “Un italiano a Ginevra, alla ricerca della patria comune” in P. Rossi, Per la Patria comune…, cit. p. XXIV. 63 Ibidem. 64 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 198. 62 V. Nava, La Costituzione 59 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 individualistico promosso da radicali e liberali. Fedeli alle istituzioni concrete esistenti, quali la Chiesa e l’organizzazione cantonale dello Stato, si proclamarono difensori di quelle libertà corporative in base alle quali concepivano la società – Chiesa, Cantoni, corporazioni – rifiutando al contempo di percepirla come una somma di individui avente il diritto di reclamare eguali diritti politici. Dei progetti di riforma federale avversarono anche le iniziative per la libertà di commercio e di industria, temuti soprattutto dai conservatori cattolici, i quali paventavano la contaminazione dell’unità confessionale qualora la libertà di domicilio avesse agevolato la mobilità intercantonale del ceto imprenditoriale a maggioranza protestante65. Come abbiamo avuto modo di vedere, poi, il processo di confessionalizzazione della politica che prese avvio con i fatti della guerra del Sonderbund, ben rappresentato dall’atteggiamento clericale e filo-gesuita assunto dai conservatori cattolici, contribuì a definire la configurazione degli orientamenti politici svizzeri. Aspetto sul quale è importante soffermarsi, poiché la storiografia elvetica non è sempre prodiga di informazioni precise circa le istanze di cui si fecero portatori i singoli Cantoni e la configurazione geo-politico-religiosa della Svizzera del 1848. Infatti, citando nuovamente Lacché, le “ripartizioni politiche si codificano riferendosi ai Cantoni, più che hai singoli ‘partiti’ 66”, con il risultato che furono le diverse unità territoriali del Paese a farsi portavoce delle differenti istanze politiche. A questo proposito, in un quadro ricco di sfumature che rende ragione della complessità socio-culturale della Svizzera e della sua natura federale, è anzitutto possibile affermare che si formò una contrapposizione nazionale che ricalcava in grandi linee i due schieramenti della guerra del Sonderbund. I Cantoni definibili “conservatori” sono quelli che avevano costituito la lega separata: Uri, Svitto, Untervaldo, Lucerna, Friburgo, Vallese e Zugo. Anche Basilea città è annoverabile fra i territori tradizionalmente conservatori, quanto meno per quel che concerne la fazione politica al potere. Si deve inoltre menzionare Appenzello interno, il quale decise inizialmente di rimanere neutrale rispetto al conflitto “sonderbundista” e alla questione della riforma, ma che – avremo modo di vederlo meglio – manifestò chiaramente la propria indole conservatrice al momento della votazione popolare cantonale sul progetto elaborato dalla Commissione. Questi territori erano tutti accomunati dalla confessione cattolica della propria popolazione e, se paragonati soprattutto ad alcuni Cantoni dell’opposto schieramento, anche da un grado di industrializzazione relativamente basso o da una economia prettamente agraria. 65 66 Ivi, pp. 204-206. L. Lacché, “Un italiano a Ginevra, alla ricerca della patria comune”, cit., p. XXIV. V. Nava, La Costituzione 60 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Specialmente i Cantoni originari di Uri, Svitto e Untervaldo, poi, i quali rappresentavano il cuore dell’antica Confederazione, erano contraddistinti da entità geografiche e densità di popolazione che se confrontate con il vasto e popoloso territorio di Berna si distinguevano per le loro modeste estensioni territoriali e demografiche. Dunque, in buona parte piccoli e più antichi, agrari, cattolici e conservatori; queste erano le caratteristiche dei Cantoni che rappresentarono l’opposizione al progetto di riforma e che si fecero difensori del mantenimento del principio di sovranità cantonale e di un assetto di tipo confederativo e non federativo. La storiografia relativa alle vicende svizzere definisce questi Cantoni e le istanze di cui si fecero portavoce con il termine “federalisti” – anche se, alla luce della transizione da Confederazioni di Stati a Stato federale che venne operata nel 1848, sarebbe forse più preciso definirli attraverso il termine “confederalisti” – in quanto essi si contrapposero a quei territori cantonali che si fecero promotori dell’accentramento delle competenze federali, cui invece si diede il nome di “unitari”. Quest’altro schieramento, corrispondente agli avversari del Sonderbund, è appunto rappresentato da quei Cantoni definibili “liberal-radicali”, favorevoli alla riforma del Patto del 1815 e ad un’affermazione del principio unitario, inteso però dalle diverse componenti territoriali in modo differente. All’interno dei promotori del processo di accentramento è infatti possibile distinguere fra quei Cantoni, identificabili propriamente come “radicali”, che teorizzavano un cambiamento tendente all’affermazione del principio unitario inteso come eliminazione quasi totale dei confini e delle sovranità cantonali, e quelle unità geografiche che invece propendevano per un processo di accentramento che fosse in grado di tenere conto almeno in parte delle antiche prerogative cantonali. Fra i primi sono annoverabili soprattutto i Cantoni della Svizzera germanofona, maggiormente industrializzati e – massimamente nel caso di Berna – caratterizzati da estensioni territoriali più vaste, le cui popolazioni, inoltre, erano interamente protestanti. Questa è la descrizione dei Cantoni radicali di Zurigo e Berna, cui si deve aggiungere il francofono Cantone di Vaud e i territori che avevano registrato recentemente l’emancipazione dalla condizione di baliaggio, e che anche per questo si dimostrarono più inclini a riconfermare i principi democratici e unitari che dalla Francia erano stati introdotti al momento della transizione da territorio asservito a Cantone: ad esempio Tugovia ed Argovia. Fra i Cantoni pur sempre favorevoli alla riforma, ma secondo orientamenti più moderati rispetto ai radicali, e per questo definibili semplicemente come “liberali”, sono annoverabili i restanti territori elvetici, con sfumature varie che V. Nava, La Costituzione 61 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 contemplarono sia il moderato ma largamente protestante Canton Ginevra che il territorio di Soletta, la cui popolazione era in maggioranza, ma non interamente cattolica. A quanto detto è possibile aggiungere la constatazione secondo cui le vicende del ’48 elvetico svelarono anche la contrapposizione fra aree di città e aree di campagna di territori attigui: è il caso dell’area geografica di Basilea, la quale – come si è visto – scissa in due semi-cantoni, vide la componente di campagna sostenere a gran voce la riforma costituzionale e la classe politica cittadina al potere nell’altra metà cantonale, Basilea città appunto, avversarla fortemente; o di Appenzello esterno, annoverabile fra i Cantoni liberal-radicali, e Appenzello interno, invece, decisamente definibile come Cantone conservatore. 2. La vicenda costituente: dal progetto della Commissione di revisione alle modifiche apportate dalla Dieta Gli orientamenti politici dei diversi Cantoni si manifestarono chiaramente al momento di votare il progetto di riforma costituzionale elaborato dalla Commissione costituente; la composizione della stessa invece, riflette solo in parte le tendenze politiche appena illustrate. Infatti, anche se a conflitto terminato presero parte ai lavori tutti i rappresentanti dei Cantoni, dunque anche quelli delle regioni ostili alla riforma – ad eccezione di Appenzello Interno e del Cantone protestante di Neuchâtel, che all’inizio dei lavori era ancora regolato da una costituzione monarchica67 – la Commissione annoverava fra i suoi membri per lo più personalità di orientamento liberal-radicale. Fatto naturale per i deputati dei Cantoni della Rigenerazione ma non scontato per i rappresentanti dei Cantoni conservatori che si erano associati in seguito. Fu la Dieta stessa – riunita sotto la presidenza di Ulrich Ochsenbein nel Cantone radicale di Berna, su cui si tornerà fra poco – a favorire fra i membri di ogni delegazione cantonale, quindi anche in quelle dei Cantoni conservatori, la nomina di rappresentanti di orientamento liberal-radicale o tuttalpiù liberalconservatore. Inoltre, al termine della guerra civile, la pressione militare e politica dei Cantoni vincitori aveva imposto agli sconfitti l’“elezione” di governi liberali. 2.1 La Commissione costituente: composizione e orientamenti politici Quale rappresentante del Canton Lucerna, che aveva diretto il Sonderbund, venne quindi nominato il medico radicale Jakob Robert Steiger, mentre 67 W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., pp. 126-128. V. Nava, La Costituzione 62 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Friburgo delegò il radicale professore di liceo Jean-François Bussard68. Protagonisti indiscussi dei lavori di commissione furono però i rappresentanti dei Cantoni liberal-radicali: per citare i più importanti, Ulrich Ochsenbein, oltre ad essere presidente della Dieta nel Cantone Vorort di Berna, lo divenne anche della Commissione costituente; il vodese radicale Henri Druey venne designato quale redattore di lingua francese del progetto costituzionale; Johann Konrad Kern, delegato del Canton Turgovia, fu invece scelto per l’elaborazione dei testi in lingua tedesca69. Il primo, giovane presidente trentaseienne, dopo aver terminato gli studi di diritto aveva capeggiato il movimento radicale del suo Cantone durante il periodo della Rigenerazione, per poi svolgere un ruolo attivo anche nella guerra del Sonderbund. Anzi, ne fu protagonista nella misura in cui prima presiedette la Dieta che decise lo scioglimento della Lega separata e poi comandò una divisione militare dell’esercitò di Dufour che ne decretò la sconfitta70. Anche Henri Druey aveva compiuto un percorso di studi in ambito giuridico e nel 1845 fu il promotore della rivoluzione che nel Canton di Vaud destituì la maggioranza liberale contraria all’uso della violenza verso il gesuitico Canton Lucerna. Collocatosi al potere con gli altri esponenti radicali, riformò la costituzione cantonale. Ma già precedentemente, in seguito alla rivoluzione liberale vodese del 1830, Druey aveva iniziato a sostenere la battaglia per la revisione del Patto del 1815 con una determinazione che, in seguito, si rivelò tutta radicale: fu infatti ostile alla moderazione del generale Dufour durante la guerra civile71. Di orientamento liberale era invece Johann Konrad Kern, come ebbe modo di dimostrare attuando la revisione costituzionale nel suo Cantone, Turgovia. Ma anch’egli, nel momento in cui si trovò ad operare sul piano federale, si rivelò radicale quanto Druey: in qualità di membro della “commissione dei Sette” incaricata di risolvere le ostilità del Sonderbund, nel novembre 1847 si fece promotore della soluzione del conflitto con la forza delle armi72. I grandi protagonisti del ’48 elvetico erano dunque tutti animati dall’audacia radicale con cui si prefissero l’obbiettivo di riformare il Patto del 1815. Ciò nondimeno, ci si permetta di anticiparlo, diedero per primi prova di grande realismo politico e capacità di compromesso al momento di attuare la riforma, dimostrando di conoscere le radici profonde del tradizionale sentimento cantonale elvetico e assecondando le istanze federaliste quando A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 383. Ibidem. 70 Beat Junker, “Ochsenbein Ulrich”, in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 71 A. Lasserre, “Druey Henri”, in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 72 V. Rothenbühler, “Kern Johann Konrad” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 68 69 V. Nava, La Costituzione 63 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 ritenuto opportuno, elaborando di conseguenza un progetto costituzionale che venne giudicato dai posteri un capolavoro di moderazione e saggezza73. Le brevi informazioni relative a questi protagonisti del ’48 elvetico sono indicative di alcune peculiarità che accomunarono anche gli altri membri della Commissione. La maggioranza di essa infatti era composta da giuristi, per lo più membri degli esecutivi cantonali, giudici e avvocati74. Accanto ai giuristi, un numero importante era rappresentato dagli ufficiali superiori che avevano appena combattuto nella guerra del Sonderbund75. Molti, e fra essi i più influenti, avevano partecipato alle riforme costituzionali che si svolsero nei Cantoni durante il periodo della Rigenerazione76, e alcuni avevano avuto l’occasione di prendere parte ai dibattiti concernenti la revisione del Patto che avevano avuto luogo alla Dieta negli anni precedenti. Infine, è possibile constatare che tra i membri della Commissione non si trovano quei pubblicisti e docenti universitari radicali che, dopo il 1830, avevano contribuito con i loro scritti a diffondere nell’opinione pubblica elvetica idee ardite sulla riforma federale77. È dunque l’esperienza a contraddistinguere i costituenti del 1848: uomini politici, animati da un pragmatismo lontano dalle speculazioni teoriche della pura filosofia liberale e radicale; oltretutto per lo più capi dei governi cantonali, abituati alla responsabilità e al potere. Poiché i loro primi passi politici erano stati mossi nei ranghi dell’opposizione liberale e radicale che sostituì poi i magistrati dei propri Cantoni, essi trasfusero l’ardire della loro opera riformatrice al superiore livello federale. Allo stesso tempo, proprio perché avevano rovesciato i regimi conservatori dei loro Cantoni issandosi al potere, ebbero modo di maturare quell’esperienza che permise loro di dar prova di grande realismo politico. Le stesse dinamiche sono all’origine di quella prudenza che li avrebbe indotti a non elaborare una riforma federale che Opinione comune di giuristi e storici, sostenuta tra gli altri da W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 122; W. Martin, Storia della Svizzera…, cit., p. 229 e E.R. Papa, Storia della Svizzera…, cit. p.194. 74 Anche il delegato dell’industrializzato e influente Canton Zurigo, Jonas Furrer, aveva compiuto studi di diritto nel suo Cantone; R.F. Widmer, “Furrer Jonas”, in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 75 Per esempio Rilliet-Constant, delegato del Cantone Ginevra, che aveva comandato la prima divisione dell’esercito del generale Dufour; P. Coet, “Rilliet-Constant Louis”, in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 76 Oltre ai già citati Ochsenbein, Druey e Luvini, anche Frey-Herosé d’Argovia e Munzinger di Soletta. 77 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 384. 73 V. Nava, La Costituzione 64 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 sarebbe potuta risultare eccessivamente progressista agli occhi di una popolazione in parte conservatrice e legata alle antiche tradizioni78. Infine, è possibile constatare che la Commissione annoverava personalità non discendenti da famiglie dell’antico patriziato: i membri rappresentavano i “nuovi” esponenti della classe emergente borghese, che avevano avuto modo di ricevere un’istruzione universitaria e talvolta di maturare un’esperienza all’estero. Ci si meraviglia, inoltre, della loro relativa giovinezza: la maggior parte dei delegati aveva più o meno quarant’anni, quattro di essi ne avevano anche di meno, e tra questi il presidente Ochsenbein, lo ricordiamo, aveva solo trentasei anni79. 2.2 La Commissione costituente: metodo di lavoro e obiettivi La Commissione così composta tenne la sua prima seduta il 17 febbraio 1848. Venne stabilito di riunirsi cinque volte la settimana e furono nominati i due redattori cui doveva spettare il compito di elaborare un programma di lavoro e predisporre i testi che sarebbero stati adottati. Il lavoro venne quindi organizzato dividendo la Commissione in gruppi, più precisamente in quattro sezioni. La procedura consistette nel far precedere da un dibattito generale l’attribuzione a una determinata sezione dei singoli ambiti da riformare. Le sezioni elaboravano poi gli avanprogetti dei testi che venivano successivamente adottati, respinti o emendati dalla Commissione al completo. In questo modo i gruppi di lavoro venivano incaricati del compito di tradurre in testi costituzionali le opinioni della maggioranza della Commissione. Il progetto doveva essere poi sottoposto al vaglio della Dieta, la quale lo avrebbe ulteriormente discusso ed emendato, e infine al voto dei Cantoni80. L’importanza e l’assiduità dei membri delle quattro sezioni fu molto ineguale. Tra le sezioni la prima dovette essere la più importante, a giudicare dalla sua composizione: fra i suoi partecipanti annoverava infatti Ochsenbein e Furrer di Zurigo e beneficiò della collaborazione dei due redattori, Kern e Druey. Questo gruppo di lavoro si distinse anche per gli importanti oggetti che dovette trattare: il “problema cardine”, ossia la configurazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario del nuovo Stato federale, ed in particolare la spinosa questione della configurazione del parlamento. Più in generale, la prima sezione dovette occuparsi della struttura della nuova Confederazione; la seconda di talune materie enumerate nel programma sotto il titolo di “Oggetti W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., pp. 128-131. Ibidem. 80 Ivi, pp. 135-138. 78 79 V. Nava, La Costituzione 65 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 diversi”, tra cui le questioni attinenti alle capitolazioni militari e ai compiti di polizia; la terza dei dazi e la quarta dei diritti di consumo81. Questo è quel poco che è dato sapere – anzi intuire – a coloro che cerchino di comprendere il ruolo svolto dai gruppi di lavoro e dai singoli membri della Commissione. Ciò poiché la principale fonte cui è possibile attingere informazioni sicure sulle delibere della Commissione è il Protocollo ufficiale redatto dal cancelliere Johann Schiess, all’interno del quale si decise di mantenere l’anonimato dei membri che presero la parola durante i dibattiti. Questa accortezza venne decisa in base alla considerazione secondo cui altrimenti alcuni membri della Commissione non si sarebbero sentiti liberi di manifestare la propria opinione se contraria a quella prevalente nel proprio Cantone. Il cancelliere lasciò volutamente in ombra anche lo scopo preciso delle quattro sezioni e la ripartizione fra esse delle materie da discutere82. Considerazioni simili a quelle che indussero i costituenti a non citare nel Protocollo ufficiale i nomi dei delegati motivarono anche la decisione di tenere le sedute della Commissione a porte chiuse, misura che avrebbe agevolato anche la celerità dei lavori. La rapidità nel redigere la nuova Costituzione era tanto più necessaria in quanto i vincitori del Sonderbund intendevano sfruttare il potere conquistato, almeno temporaneamente, ai Cantoni cattolicoconservatori. Ma, soprattutto, risultava indispensabile mettere quanto prima di fronte al fatto compiuto le potenze europee conservatrici che avevano contestato alla Svizzera il diritto di darsi una nuova legge fondamentale. E in effetti si rimane stupiti di fronte alla velocità con cui venne elaborata la nuova Costituzione federale: dalla prima seduta della Commissione, tenutasi il 17 febbraio 1848, al progetto conclusivo dell’8 aprile, trascorsero infatti solo otto settimane, durante le quali si tennero 31 sedute plenarie83. Durante questo arco di tempo la Commissione scrisse i 114 articoli che diedero modo al nuovo Stato federale di prendere vita e assumere quella configurazione che nelle sue linee essenziali mantiene tutt’ora. Alcune disposizioni riflettono articoli già presenti nelle Costituzioni del 1803 e del 1815, ma la maggior parte di esse vennero elaborate riformulando quelle predisposte in occasione della redazione del Patto Rossi del 1832-33. Tuttavia, se molte disposizioni poterono essere riprese da questo documento, esso non forniva nessuna soluzione d’avanguardia circa il problema più controverso, vale a dire l’equilibrio di poteri e competenze fra Confederazione e Cantoni e, conseguentemente, la questione della sovranità e della configurazione del legislativo. È proprio nelle soluzioni cercate in quest’ambito che i lavori della Ivi 133-134. Ibidem. 83 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., pp. 385-386. 81 82 V. Nava, La Costituzione 66 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Commissione rivelarono tutta la loro originalità: appurato il debito nei confronti dei precedenti testi costituzionali, risulta quindi evidente che le innovazioni di maggior portata furono il risultato delle idee dei membri della Commissione84. Sicurezza interna e dall’esterno, prosperità economica e benessere dei cittadini costituiscono la chiave di lettura per comprendere la volontà che mosse i costituenti. Questa volontà intendeva tradursi nell’istituzione di uno Stato forte, il quale, muovendosi in senso unitario e accentratore attraverso una ridefinizione in senso limitativo delle prerogative cantonali, potesse essere dotato degli strumenti necessari al perseguimento di tali obiettivi. Gli strumenti vennero individuati in un rinnovamento degli organi istituzionali, in un autorità centrale rafforzata attraverso una nuova configurazione del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. La via percorsa per il raggiungimento degli scopi dello Stato federale venne altresì perseguita codificando in legge nazionale le principali disposizioni atte a favorire lo sviluppo economico – principalmente eliminando gli ostacoli interni e permettendo la libertà di circolazione – e il benessere dei cittadini, fissandone i diritti imprescindibili. In altre parole si trattava di trasformare una Confederazione di Stati in Stato federale, tenendo sempre presente però le istanze dei Cantoni conservatori, le quali limitarono talvolta la volontà riformatrice dei membri della Commissione. Per usare le stesse parole di Papa: “l’elemento conservatore-illuminato riuscì a contenere il nuovo verbo liberal-democratico, in un evoluzione e in un progresso pur sempre radicati nelle ragioni profonde della realtà del Paese”, e quindi “l’esplosione radicale, che aveva condotto alla guerra contro il Sonderbund, andò costringendo il suo discorso d’estremismo democratico nell’originario suo alveo liberale”85. 2.3 Il progetto costituzionale sottoposto al vaglio della Dieta Il progetto elaborato dalla Commissione era destinato alla Dieta. Poiché da essa era stata costituita, era appunto ai delegati cantonali della Dieta che doveva anzitutto rendere conto. Ma visto che i rappresentanti dei Cantoni, secondo la prassi, avrebbero dovuto pronunciarsi in merito al progetto in base alle istruzioni ricevute dalle proprie autorità regionali, il testo costituzionale elaborato dalla Commissione venne rivolto direttamente ai parlamenti cantonali. Questo provvedimento venne preso per guadagnare tempo: così Basti pensare alla soluzione del parlamento bicamerale, come avremo modo di vedere novità quasi inedita in territorio confederato. 85 E.R. Papa, Storia della Svizzera…, cit., p. 192. 84 V. Nava, La Costituzione 67 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 facendo, i delegati poterono essere muniti rapidamente delle istruzioni necessarie86. Dunque, durante quattordici sedute, dal 16 maggio al 10 giugno 1848, la Dieta sottopose innanzitutto il progetto ad una prima lettura. Il 21 maggio, su istanza di Berna, rinviò gli articoli concernenti la centralizzazione amministrativa all’esame di una commissione di nove membri, la quale propose alcuni emendamenti che furono approvati dalla Dieta nelle sedute che si svolsero il 13 e il 23 giugno. Infine il 24, 25 e 26 giugno, il progetto venne sottoposto ad una seconda lettura, prima di pronunciarsi definitivamente sul testo costituzionale emendato87. Sui risultati finali della votazione alla Dieta avremo modo di ritornare; intanto è opportuno precisare che le iniziali reazioni delle autorità cantonali furono, come si può immaginare, molto diversificate. In generale è possibile riscontrarvi la polarizzazione di schieramenti che aveva già caratterizzato gli antagonismi della guerra del Sonderbund. I Cantoni che avevano preso parte alla Lega separata si mostrarono generalmente ostili al progetto poiché convinti dell’inopportunità di modificare il Patto del 1815. Ma per quel che concerne le istruzioni che queste autorità cantonali diedero ai propri delegati, bisogna operare una distinzione: la volontà manifestata dai rappresentanti dei Cantoni conservatori e cattolici di Uri, Svitto, Untervaldo e Appenzello interno fu rappresentativa della reale ostilità al progetto propria degli abitanti di quei territori, poiché lì il popolo, grazie anche ai meccanismi di democrazia diretta propri dei governi a Landsgemeinde, poté manifestare la sua volontà liberamente. Invece nei Cantoni di Lucerna, Zugo, Friburgo e Vallese – anch’essi cattolici ed ex-membri della Lega separata – a causa della vittoria degli avversari nella guerra del Sonderbund, le minoranze radicali e liberali erano riuscite ad issarsi al potere approfittando dell’occupazione militare, e quindi fu soprattutto la loro volontà a venire espressa dai delegati alla Dieta, e non quella realmente rappresentativa dei sentimenti del popolo88. Per quanto riguarda i Cantoni che avevano trionfato nella guerra del Sonderbund, come sappiamo, essi erano unanimi nel voler riformare il Patto del 1815. Però, quando le autorità cantonali dovettero esprimersi per istruire i propri rappresentanti alla Dieta, furono molto severi in merito al progetto elaborato dalla Commissione. Più precisamente, i Gran consigli a larga maggioranza liberal-radicale criticarono il testo della Commissione poiché avrebbero voluto vedervi affermati con maggior decisione i principi W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., pp. 140-141. Ibidem. 88 Ivi, pp. 138-139. 86 87 V. Nava, La Costituzione 68 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 rappresentativi del proprio orientamento politico 89. Questa dinamica caratterizzò soprattutto le proposte dei Cantoni Berna, Zurigo e in parte Vaud, più radicali ed industrializzati, i cui politici si erano già distinti per audacia nei lavori di Commissione. Nonostante ciò, il testo, nella sua configurazione finale e dunque sottoposto alle modifiche apportate dalla Dieta, si discosta in misura lieve dall’avanprogetto elaborato dalla Commissione90. A questo proposito, Ruffieux rileva che la Dieta riuscì ad aggregare le maggioranze necessarie per procedere con il lavoro soltanto a prezzo di importanti rinunce e che il testo ne uscì emendato in senso maggiormente “federalista”91. La difficoltà riscontrata alla Dieta nell’aggregare i voti necessari al raggiungimento della maggioranza è forse spiegabile considerando che le riserve espresse dai delegati delle autorità cantonali si configurarono come più denotative degli orientamenti politici dominanti in quei territori, nel senso che istanze unitarie di matrice liberal-radicale, ma anche federaliste di stampo conservatore vennero ripresentate, almeno in un primo momento, con forza. In definitiva, anche i delegati alla Dieta si dovettero piegare al compromesso, al fine di superare l’impasse, accettando di emendare di poco, come abbiamo detto, il progetto iniziale. Se il testo subì modifiche che denotano un influenza più “federalista” che volontà unitarie rispetto al testo elaborato dalla Commissione, è altresì verosimile supporre che la capacità di conciliazione venne messa in campo soprattutto dai rappresentanti dei Cantoni a maggioranza liberal-radicale. Ciò considerando che questi, numerosi – e ancor più accresciuti nel loro numero dal fatto che le delegazioni di Lucerna, Friburgo, Zugo e Vallese, come si è detto, espressero orientamenti più liberali rispetto a quanto avrebbe fatto la maggioranza popolare conservatrice dei Cantoni che rappresentavano – nelle votazioni alla Dieta non avrebbero avuto, in linea teorica, eccessivi problemi nell’affermare la propria posizione, emendando il progetto in senso maggiormente unitario e liberal-radicale. Se ciò non avvenne, probabilmente, fu per due ragioni. Innanzitutto, poiché anche i rappresentanti dei Cantoni erano consapevoli che il progetto per entrare in vigore, oltre ad ottenere il voto di maggioranza della Dieta, il progetto avrebbe dovuto essere approvato anche dalla volontà popolare espressa dai cittadini di ogni Cantone. La tradizione “federalista” – in definitiva Ibidem. A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., pp. 426-427; W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 137. 91 R. Ruffieux, “La Svizzera dei Radicali (1848–1914)”, in R. Broggini (a cura di), Nuova storia della Svizzera e degli svizzeri, Bellinzona, Casagrande, 1983, pp. 9 e 10. 89 90 V. Nava, La Costituzione 69 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 forse non completamente estranea nemmeno ai fautori della “unità” nazionale, o comunque non facilmente rinnegabile alla luce della storia del Paese – era certamente radicata in una parte non poco rilevante della popolazione elvetica, e pertanto doveva essere tenuta nella giusta considerazione. Ma soprattutto questo atteggiamento è indicativo del fatto che anche le autorità cantonali, come già prima di loro i membri della Commissione che avevano elaborato il progetto, furono mosse da un sentimento di solidarietà nazionale e di responsabilità civica che le spronò innanzitutto a trovare una soluzione di compromesso tale da conciliare le diverse istanze, gettando le basi di un assetto istituzionale che avrebbe potuto garantire la pace in territorio confederato e scongiurare altre guerre civili. È giunto il momento di comprendere in quale modo e in che misura ciò avvenne, quali furono le istanze liberal-radicali che trovarono applicazione pratica nel testo costituzionale e in quale modo si scelse, invece, di rispettare le tradizioni antiunioniste. Insomma, si rende necessario capire come questa transizione da Confederazione di Stati a Stato federale venne operata dai costituenti, analizzando più approfonditamente le principali disposizioni di quel testo che ne permise l’attuazione: la Costituzione del 1848, la prima che gli svizzeri si poterono dare senza l’influenza dello straniero. 3. Da Confederazione di Stati a Stato federale: la Costituzione del 1848. Il testo elaborato dalla Commissione e sottoposto al vaglio della Dieta si compone di un breve preambolo, tre capitoli comprendenti 114 articoli e alcune disposizioni transitorie92. In forza dei nuovi principi enunciati dalla quarantottesca legge fondamentale, la Svizzera cessa di essere una Confederazione e diviene uno Stato federale. Citando J. Aubert: Tel est donc le principal effet de la Constitution […] bien que le terme soit conservé pour des raisons d’histoire et de politique, cesse d’être une Confédération de plusieurs Etats pour devenir un seul Etat, divisé en cantons. 93 Ciò significa anzitutto che i rapporti fra i Cantoni e tra essi e lo Stato non sono più di natura contrattuale, fra interlocutori con eguali diritti, ma costituzionalmente unilaterali94. Inoltre, allo scopo “di rassodare la lega dei Confederati, di mantenere ed accrescere l’Unità, la Forza e l’Onore della Nazione Svizzera”, come recita il preambolo, la Costituzione stabilisce i termini entro cui potrà continuare a dispiegarsi la sovranità cantonale e definisce le R. Ruffieux, “La Svizzera dei Radicali (1848 – 1914)”, cit., p. 11. J.F. Aubert, Petite histoire constitutionnelle de la Suisse, Berna, Ed. Francke, 1979, p.30. 94 G.A. Chevallaz, Le Gouvernement des Suisses ou l’histoire…, cit. 92 93 V. Nava, La Costituzione 70 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 competenze ora accresciute della Confederazione, enumerandone diritti e doveri. È ciò che viene stabilito attraverso le “Disposizioni generali”, titolo sotto il quale i costituenti del ’48 raccolsero le norme del primo capitolo, volte a definire la natura, lo scopo e la struttura dello Stato federale, i cui provvedimenti più importanti ci proponiamo di riassumere sinteticamente in quanto segue. 3.1 Competenze della Confederazione e sovranità cantonale Massimamente significativo per la comprensione delle incombenze generali della Confederazione e per la ridefinizione degli ambiti di competenza dei Cantoni è l’articolo 2, il quale definisce in modo preciso gli obiettivi del nuovo Stato federale: La lega ha per iscopo: di sostenere l’indipendenza della Patria contro lo straniero, di mantenere la tranquillità e l’ordine nell’interno, di proteggere la libertà e i diritti dei Confederati, e di promuovere la loro comune prosperità. 95 Sicurezza dall’esterno e all’interno, libertà e prosperità dei cittadini sono quindi gli obiettivi che i costituenti si prefissarono di raggiungere attraverso le disposizioni della Costituzione. Per garantire “l’indipendenza della Patria contro lo straniero” venne deciso anzitutto che tutti i Cantoni dovessero essere rappresentati all’estero esclusivamente dalla Confederazione Svizzera96. Ponendo nelle mani della sola autorità federale le relazioni con altri Stati, l’articolo 8 stabilisce quindi che unicamente la Confederazione ha il diritto di dichiarare guerra e di concludere la pace, ma anche di stipulare con gli Stati esteri alleanze o trattati. Al medesimo scopo i costituenti cercarono di riformare l’organizzazione dell’esercito avocandone la gestione all’autorità federale attraverso gli articoli 18, 19 e 20, il primo dei quali stabilisce la leva obbligatoria, anche allo scopo di rafforzare la “nazionalità svizzera”. Nonostante queste premesse, le spinte centralistiche poterono essere assecondate solo entro certi limiti, poiché i Cantoni avevano fino ad allora curato i propri affari militari e intendevano continuare a farlo con una certa gelosia. Pertanto la Commissione – richiamandosi ai progetti del 1832 e 1833 – prospettò la creazione di un esercito federale formato da contingenti di truppe cantonali, ma alla Confederazione finì per spettare solamente la supervisione dell’istruzione militare e la gestione della formazione superiore, mentre l’addestramento delle truppe rimase Articolo 2. Obiettivo, questo, caro soprattutto alla fazione radicale della Commissione che predispose il progetto: fu Druey a insistere sull’importanza di rappresentare la Svizzera come una totalità, in modo che nessuno Stato potesse rivolgersi ad un singolo Cantone inteso come sovrano; A. Kölz, Le origini…, cit., p. 402. 95 96 V. Nava, La Costituzione 71 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 prerogativa dei Cantoni97. Si ripresenta qui, a monito costante di una dinamica che come un filo rosso percorre e percorrerà la storia del Paese, la tensione che vede contrapposte volontà tese all’accentramento politico e sovranità cantonali. Al Paese era indispensabile un’efficiente organizzazione militare anche per scongiurare ulteriori conflitti interni, che il recentissimo ricordo del Sonderbund evocava con timore costante. Si cercò di provvedere all’ordine e la sicurezza interni – secondo obiettivo enunciato nel sopra citato articolo 2 – oltre che riorganizzando l’esercito, vietando ogni lega e ogni trattato speciale di natura politica tra Cantoni98 e, mediante gli articoli 14, 15 e 16, definendo le modalità di azione in caso di contese fra essi, di aggressione esterna o disordini interni. Diritti e doveri che si configurano innanzitutto come azioni di mutua assistenza fra i Cantoni, secondo quel principio che fu causa e origine della stessa nascita della Svizzera99. Riconfermando l’antico, ma non sempre osservato precetto secondo cui le diverse unità territoriali devono astenersi dal farsi giustizia autonomamente100, veniva ora precisato l’obbligo di chiedere soccorso alle autorità federali e agli altri Cantoni in caso di attacco esterno, e il dovere della Confederazione di intervenire spontaneamente se, a causa di disordini interni, “la sicurezza della Svizzera è periclitante” 101. Tuttavia va ricordato che all’autorità federale non venne conferita quasi nessuna competenza di polizia – a parte la possibilità, anch’essa osteggiata dai “federalisti”, di emanare provvedimenti di polizia sanitaria in casi di gravi epidemie102 – ancora una volta per rassicurare l’animo cantonale. Anche le garanzie offerte dalla Confederazione ai Cantoni rientrano fra le disposizioni atte ad assicurare l’ordine interno: attraverso l’articolo 5, le cui condizioni vengono chiarite mediante il successivo articolo 6103, la Confederazione si impegna a garantire il territorio, la sovranità, le costituzioni, la libertà e i diritti del popolo di ogni Cantone. Ciò solo a patto, però, che le costituzioni cantonali nulla contengano di contrario alla Costituzione federale, assicurino l’esercizio dei diritti politici nelle sole forme repubblicane – rappresentative o democratiche – e a condizione che le costituzioni siano state accettate dal popolo e possano essere riformate qualora la maggioranza assoluta H. Senn, “Costituzione federale del 1848 e organizzazione militare” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 98 Articolo 7. 99 R. Ruffieux, “La Svizzera dei Radicali (1848 – 1914)”, cit., p. 11. 100 A questo proposito la procedura di arbitrato prevista dalla Dieta, secondo l’articolo 5 del Patto federale del 1815, venne sostituita dall’azione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario del nuovo Stato federale. 101 Articolo 16 102 Articolo 59. 103 J.F. Aubert, Petite histoire constitutionnelle…, cit., p.33. 97 V. Nava, La Costituzione 72 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 dei cittadini lo richieda104. In questo modo, ergendosi a garante dell’incolumità dei Cantoni, la Confederazione veniva investita al contempo del ruolo di giudicante delle costituzioni cantonali. Per questo motivo il numero 6 è stato definito “l’articolo della omogeneità”: imponendo ai singoli Cantoni le stesse condizioni necessarie per poter essere garantiti dalla Confederazione, aveva lo scopo di indurre gli stessi ad adattarsi alla medesime forme istituzionali, obiettivo fondamentale per poter dare alla Confederazione quel carattere di omogeneità, appunto, caro soprattutto ai radicali105. Le garanzie offerte ai Cantoni rappresentano anche la contropartita necessaria al ridimensionamento della sovranità cantonale: l’articolo 3 della Costituzione precisa infatti che, secondo il principio di sussidiarietà106, “i Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale, e come tali, esercitano tutti i diritti, che non sono devoluti all’Autorità federale”. Lungi dal divenire semplici circoscrizioni amministrative107, rimasero certamente padroni in ambiti importanti, quali la pubblica educazione e ampie branche dell’amministrazione della giustizia 108; eppure – a confronto con le competenze cantonali mantenute fino al 1848 – quella che appare è una sovranità mutilata in nome di un movimento accentratore votato a creare un potere centrale forte, in grado di far fronte alle esigenze del tempo. Ma Kölz fa giustamente notare che la formulazione dell’articolo 3 è al contempo un altro esempio di compromesso, nel quale è il soggetto-Cantone ad essere indicato quale sovrano e non il popolo, ma solo nella misura in cui è limitato dal potere e dalle competenze dell’autorità federale; un esempio in cui teorie e dottrine sviluppate faticosamente nel corso del tempo lasciano spazio al pragmatismo dell’uomo politico svizzero, pronto all’accordo per trovare il giusto equilibrio tra le parti109. Per quel che concerne il terzo obiettivo del nuovo Stato federale, ossia “proteggere la libertà e i diritti dei Confederati”, i costituenti del 1848, ispirandosi alle costituzioni cantonali “rigenerate” e al progetto di riforma del 1832-33, sancirono all’interno della Costituzione i principali diritti di libertà dei cittadini. Si giunse così al riconoscimento nazionale della libertà di stampa, del Quest’ultima disposizione è precisamente la formulazione dell’iniziativa popolare per la riforma costituzionale, principio ispirato alle teorie rousseauiane e già adottato da alcuni Cantoni della Rigenerazione. 105 W. Martin, Storia della Svizzera..., cit. p. 231. 106 A. Kley, “Confederazione e Cantoni”, in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 107 J.F. Aubert, Petite histoire constitutionnelle…, cit., p. 34. 108 Infra, p. 61. 109 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 404. 104 V. Nava, La Costituzione 73 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 diritto di associazione e di petizione110. Venne garantita anche la libertà di religione, attraverso l’articolo 44, ma non senza riserve, soprattutto da parte dei Cantoni cattolici-conservatori. Per questo motivo venne elaborata una formula vaga e poco articolata, consistente nell’affermazione secondo cui “è garantito il libero esercizio di culto delle Confessioni cristiane riconosciute su tutto il territorio della Confederazione”. Gli ebrei rimasero dunque esclusi da tale diritto, e l’articolo 48 rende chiaro che l’obbligo per i Cantoni dell’eguale trattamento in ambito giudiziario e legislativo riguarda i soli cittadini di confessione cristiana111. Anche la fortemente discussa libertà di domicilio rientra fra le libertà dei cittadini che la nuova Costituzione intendeva garantire, ma poiché le motivazioni teoriche e le ripercussioni pratiche che sottintendono questa disposizione sono direttamente ricollegabili ai provvedimenti presi in ambito economico, ci riserviamo di parlarne in modo più approfondito fra poco. Prima di analizzare le importantissime disposizioni riguardanti l’economia del Paese è opportuno ricordare l’altra fondamentale innovazione apportata mediante il testo costituzionale del 1848. Si tratta del diritto accordato ai cittadini confederati di modificare la propria legge fondamentale in qualsiasi momento. L’articolo 113 prescrive che, qualora cinquantamila cittadini o una delle due Camere del Parlamento propongano la revisione della Costituzione e, in questo secondo caso, l’altra Camera si manifesti contraria, la decisione deve essere sottoposta alla votazione del popolo svizzero. Se quest’ultimo si dichiara favorevole alla riforma si procede alla rielezione di entrambe le Camere e all’elaborazione di una nuova costituzione. Infine, il nuovo progetto costituzionale entra in vigore solo se approvato sia dalla maggioranza dei cittadini votanti, sia da quella dei Cantoni112. A questo proposito Ruffieux fa notare che se è vero che l’opera di centralizzazione non venne portata a compimento in modo sistematico nel 1848, i radicali riuscirono comunque a lasciare aperta la via a cambiamenti più profondi mediante la possibilità di una revisione delle disposizioni costituzionali113. La transizione da Confederazione di Stati a Stato federale comportò dunque, volendo riassumere, la ridefinizione in senso limitativo delle prerogative cantonali e, conseguentemente, l’accrescimento delle competenze dell’autorità centrale. Questa spinta accentratrice, promossa dai membri liberalradicali della Commissione, pose nelle mani dell’autorità federale le relazioni con l’estero di qualsiasi natura e l’amministrazione dell’esercito, ma con i limiti In ordine si tratta degli articoli 45, 46 e 47. J.F. Aubert, Petite histoire constitutionnelle…, cit., p. 32. 112 Articolo 114. 113 R. Ruffieux, “La Svizzera dei Radicali (1848 – 1914)”, cit. p. 11. 110 111 V. Nava, La Costituzione 74 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 a cui abbiamo accennato. Ostacoli ad un processo di accentramento visibili anche per quel che concerne gli articoli riguardanti l’istituzione di un’università ed un politecnico federali114: il tiro alla fune tra Cantoni e Confederazione si ripresentò in questo caso nella preoccupazione che un istituto universitario federale potesse svalutare le università cantonali già esistenti ma poco consolidate. E infatti, per quanto la disposizione riuscì a confluire nel testo costituzionale, è possibile affermare che i voti contrari ebbero la meglio sulla effettiva realizzazione del progetto, poiché la Svizzera risulta tutt’ora sprovvista di un istituto universitario federale. 3.2 Disposizioni economiche Si è visto che la Costituzione del 1848 dichiara che la Confederazione deve promuovere la comune prosperità. Secondo Kölz quest’ultimo obiettivo è da ricondurre ai propositi propri della fazione radicale della Commissione, volti ad incentivare il progresso attraverso lo sviluppo dell’istruzione, della scienza e delle tecnica, al fine di porre le fondamenta di quell’edificio che un giorno avrebbe acquisito le sembianze di un vero e proprio Stato sociale 115. Quest’ultimo obiettivo, però, è forse interpretabile anche come dichiarazione avente lo scopo di legittimare l’intervento dell’autorità federale in ambito economico: si tratterebbe dunque di promuovere la comune prosperità economica attraverso misure quali l’abolizione dei dazi interni e l’attuazione della libertà di domicilio116. L’intervento in quest’ambito realizzato mediante l’entrata in vigore del nuovo testo costituzionale risulta infatti di ampia portata, come avremo modo di vedere illustrando i provvedimenti predisposti dai costituenti del 1848. I promotori della centralizzazione agirono sull’economia del Paese innanzitutto attraverso le disposizioni relative alla politica daziaria e doganale. Agli occhi di buona parte dello stesso popolo svizzero infatti il più urgente di tutti i provvedimenti da attuare attraverso la nuova Costituzione era quello di sopprimere gli ostacoli che paralizzavano il commercio interno compromettendo l’unità del Paese. Si trattava, però, anche del più difficile dei compiti, poiché, se tutti lamentavano gli ostacoli al libero commercio, fino ad allora dazi e imposte doganali erano stati gestiti dai Cantoni, costituendo per quest’ultimi una delle più importanti risorse per i rispettivi bilanci117. Articolo 22. Ibidem. 116 Sono di questo parere molti studiosi, fra cui – lo vedremo fra breve – W. Martin e W.E. Rappard. 117 M. Polli-Schönborn, “Dogane. Epoca Moderna” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 114 115 V. Nava, La Costituzione 75 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 La Commissione che predispose i numerosi e lunghi articoli destinati a risolvere l’impasse da lungo tempo constatata si adoperò seguendo tre linee direttrici principali, secondo le quali: 1) l’amministrazione dei dazi doveva passare dalle mani cantonali a quelle federali; 2) ciò sarebbe potuto avvenire solo corrispondendo un’indennità ai Cantoni; 3) ma cercando di salvaguardare pur sempre, nei limite del possibile, i principi generali del libero mercato 118. Il primo di questi articoli, il numero 23, proclama pertanto che “i dazi sono di competenza federale”. Sancendo contemporaneamente l’abolizione dei dazi e dei pedaggi di terra e acqua fra i Cantoni, e arrogando alla Confederazione la gestione delle imposte doganali relative all’estero, non solo veniva compiuto il passo determinante per la liberalizzazione del commercio intercantonale, ma l’autorità federale stabiliva quella che d’ora in poi sarebbe stata la maggior risorsa per il finanziamento del neonato Stato federale, al punto che negli anni successivi gli introiti avrebbero di gran lunga superato le aspettative della Dieta119. I Cantoni, consapevoli della perdita che sarebbe stata loro arrecata, rivendicarono immediatamente un risarcimento da parte della Confederazione e a questo proposito i reclami più sentiti giunsero soprattutto dai territori interessati dal transito alpino. Avremo modo di vedere che l’abolizione dei dazi interni in alcuni casi giocò un ruolo fondamentale nel decidere l’approvazione da parte dei Cantoni della nuova Costituzione federale. La Dieta, per quanto conscia di questo pericolo, ne sancì comunque l’abolizione 120, ma i Cantoni ottennero che gli introiti venissero trasferiti all’autorità federale gradualmente e i costituenti predisposero un risarcimento proporzionale alle entrate effettive 121. Inoltre, poiché i Cantoni a prevalente economia agricola – al contrario di quelli maggiormente industrializzati – registravano introiti molto ingenti dalle imposte di consumo, essi si batterono molto duramente per il mantenimento di queste prerogative, ottenendo infine di poter conservare i diritti di riscossione sulle imposte delle bevande alcoliche, per quanto fortemente limitate da restrizioni122. Abbiamo già accennato al fatto che la centralizzazione della politica doganale venne attuata ispirandosi a principi il più possibile liberali: risultò Per un approfondimento dei lunghi dibattiti che condussero alle complicate procedure per la centralizzazione della politica daziaria e doganale si veda W.E. Rappard, La Costituzione…, cit., pp. 264-281. 119 M. Polli-Schönborn, “Dogane. Dall’Elvetica alla costituzione dello Stato Federale”, in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 120 Articolo 24. 121 Una disposizione peraltro in seguito abbandonata viste le difficoltà di stabilire precisamente l’ammontare dei dazi Cantone per Cantone e le evidenti diseguaglianze tra questi. 122 Articolo 32. 118 V. Nava, La Costituzione 76 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 chiaro infatti che i Cantoni avrebbero rinunciato ai propri diritti solo se il nuovo Stato si fosse premurato di non costringerli fra le mura di una prigione protezionista123. Per questo motivo, oltre alla libertà di acquisto e vendita, d’importazione, d’esportazione e transito delle merci di ogni genere fra un Cantone e l’altro – eccetto le bevande alcoliche, il sale e la polvere da sparo – l’importantissimo articolo 25 stabilisce la tassazione minima sulle materie prime necessarie all’industria svizzera e sui beni di consumo considerati di prima necessità, e la tassazione massima per gli oggetti considerati di lusso 124. Ciò in linea con il pensiero secondo cui i dazi di transito, come anche le tasse d’esportazione, dovessero essere il meno possibile gravosi per agevolare il libero commercio internazionale. È in questa disposizione che si concretizzò la riflessione volta ad enfatizzare i vantaggi derivanti dal libero scambio e che determinò la rinuncia al varo di una politica protezionista. Una disposizione peraltro giudicata da Kölz generica e riduttiva: Il postulato di un ordinamento commerciale europeo, che gli economisti del XVIII secolo avevano già auspicato, si rivelò troppo idealistico anche per la Svizzera e troppo inadeguato al crescente nazionalismo che caratterizzava l’Europa di quegli anni. 125 Più in generale, l’autore, constatando che l’idea di uno Stato “economicamente dinamico” sfuggiva ancora alla classe dirigente svizzera, sostiene che le forze economiche tese all’unificazione non abbiano svolto un ruolo centrale nell’edificazione dello Stato federale del 1848. È vero che nel periodo della Rigenerazione i Cantoni liberali avevano in gran parte attuato i principi del libero commercio all’interno dei propri territori, ma la libera produzione non era stata ancora del tutto garantita e le prestazioni lavorative erano sovente sottoposte – ancora nel 1848 – a limitazioni dalle organizzazioni corporative che avevano operato nel passato. Secondo lo studioso, la classe liberale, sempre più irrigidita e concentrata sul concetto di proprietà privata, intendeva unicamente centralizzare dazi e imposte che fino a quel momento avevano paralizzato il commercio, e non unificare gli ordinamenti economici cantonali. L’importanza degli articoli inerenti al commercio e all’industria non sono quindi, a parere di Kölz, da sopravvalutare: l’ “economicizzazione” della politica aveva conquistato solo pochi Cantoni di orientamento radicale e non era ancora preponderante nella restante maggioranza. A. Kölz, Le origini…, cit., p. 414. Principio, quest’ultimo, già presente nella costituzione della Repubblica Elvetica. 125 A. Kölz, Le origini…, cit., p. 415. 123 124 V. Nava, La Costituzione 77 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Dell’avviso opposto è Martin: egli infatti tende a ricondurre il lavoro svolto dai costituenti del 1848 all’intento principale di rinsaldare e liberare l’economia del Paese. A questo proposito afferma chiaramente: Lo scopo principale della rivoluzione del 1847 fu di dare alla Svizzera l’unità economica, fondamento dello Stato moderno. La costituzione federativa non è sorta da un’idea, ma da una necessità. […] L’unità economica è apparsa, alla metà del secolo XIX, come una condizione dell’esistenza della Confederazione. Da questa necessità è sorta l’unità politica che ha avuto il compito di creare l’unità economica. 126 Fra i fattori esplicativi del nuovo assetto federale, anche Rappard assegna una parte importante alle esigenze di natura economica127. Elemento rilevante ma certamente non l’unico, come abbiamo cercato di chiarire individuando nel desiderio di sicurezza della nazione, nella volontà di accrescere la prosperità del Paese – appunto, attraverso disposizioni agevolanti il libero commercio – e nella volontà di garantire la libertà e i diritti dei Confederati i principali fini che motivarono il lavoro dei costituenti. La stessa Costituzione del 1848, attraverso gli obiettivi dichiarati all’inizio del testo, induce a trarre queste considerazioni. Sempre la struttura del testo costituzionale persuade anche a dare non poca rilevanza al fattore economico, se si considera che le disposizioni concernenti il commercio vi occupano una parte molto cospicua, più precisamente ben 14 articoli, dal numero 23 al 37. A questi è possibile aggiungere la disposizione relativa alla libertà di domicilio. Abbiamo infatti già avuto modo di constatare che la richiesta della libera circolazione delle persone è ricollegabile alle rivendicazioni relative allo sviluppo economico del Paese, alla libertà di commercio e d’industria128. Il dibattito che precedette la redazione di questo articolo, il numero 41, fu lungo e controverso, poiché incontrò l’opposizione dei conservatori cattolici, i quali temevano che la libera circolazione di persone protestanti potesse ledere l’unità cantonale della loro fede cattolica. Ma dietro a questa preoccupazione è possibile scorgerne anche una di natura economica, relativa al timore, non espresso ma intuibile, per il potere economico dei protestanti, rappresentanti in Svizzera il pilastro non solo della democrazia individualistica occidentale ma anche dell’industrializzazione moderna129. Nonostante queste opposizioni di carattere federalistico-conservatore, si riuscì ad introdurre il principio di libertà di domicilio. Più precisamente, venne W. Martin, Storia della Svizzera..., cit., p. 232. W.E. Rappard, Comment et pourquoi la Confédération Suisse est-elle devenue Etat fédératif en 1848. Conférence faite à la reprise des cours universitaires le 29 octobre 1947, Genève, Libraire de l’Université Georg, 1947, p. 14; W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., pp. 118-120. 128 S. Guzzi-Heeb, “Libertà di domicilio” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 129 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 409. 126 127 V. Nava, La Costituzione 78 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 stabilita la possibilità per i cittadini svizzeri provenienti da altri territori cantonali di acquisire e vendere terreni nel nuovo comune di residenza, ma si concesse altresì la prerogativa ai Cantoni di esigere da coloro che formulavano richiesta di domicilio la documentazione comprovante l’idoneità al lavoro e sufficienti mezzi di sussistenza. Il richiedente poteva ottenere inoltre il diritto di domicilio nel nuovo Cantone solo dopo un termine di aspettativa di cinque anni. E anche se la proposta, sempre di parte conservatrice, di estromettere totalmente i cittadini di altri Cantoni dal godimento dei diritti politici cantonali venne rigettata, si decise per l’esclusione del diritto di voto negli affari comunali, lasciando inoltre alle autorità cantonali la possibilità di espulsione nel caso di condanna per reato130. Come si può vedere, la libertà di domicilio fu tanto dibattuta poiché determinante effetti pratici diretti: a monte delle disposizioni confluite nell’articolo vi erano il timore per una concorrenza economica maggiorata, probabili aumenti dell’onere legato all’assistenza ai poveri e l’incrinarsi dell’omogeneità confessionale nei Cantoni cattolici. Questa disposizione era altresì fondamentale per incrementare il dinamismo dell’economia del Paese e per incentivare una coscienza nazionale possibile solo attraverso il superamento dei rigidi confini cantonali. L’articolo 41 risulta quindi essere uno degli esempi più tipici del carattere compromissorio della nuova costituzione, in un settore nel quale si intrecciarono e scontrarono controversie religiose, oltre a fattori economici e sociali. Infine, fra le disposizioni inerenti l’economia del Paese si possono annoverare anche quelle che assecondarono la spinta accentratrice costituzionalizzando l’unificazione del sistema postale, quello monetario, pesi e misure. Provvedimenti necessari per poter gettare le basi di un ordinamento economico liberalizzato ed efficiente. Nonostante i tentativi effettuati durante la Repubblica elvetica infatti, il sistema postale non si presentava meno disorganizzato di quello doganale. I legislatori decisero di porre rimedio alla situazione dopo aver constatato che un sistema postale efficiente e quindi centralizzato, attuabile attraverso le intricate disposizioni dell’articolo 34, fosse una premessa necessaria per ovviare a situazioni deplorevoli per il commercio – causate da costi eccessivamente elevati delle spese di spedizione e dal fatto che alcuni Cantoni avessero delegato la gestione del sistema postale a privati131. Considerazioni della medesima natura portarono anche alla decisione che la coniatura monetale da parte dei Cantoni avrebbe dovuto cessare: constatando che in Svizzera erano tre 130 131 Articolo 41. A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 415. V. Nava, La Costituzione 79 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 i sistemi monetari che tendevano ad affermarsi – quello tedesco, quello francese e quello indigeno – e che i sostenitori dei rispettivi sistemi non sarebbero riusciti ad accordarsi autonomamente, attraverso l’articolo 36, si decise di sancire il monopolio federale della “regalia monetaria”, delegando alla futura legislazione federale il sistema monetario e le modalità di attuazione132. Più complesse furono le vicende che condussero all’unificazione di pesi e misure, poiché, per quanto l’articolo 37 stabilisse l’estensione su tutto il territorio confederato del sistema concordato nell’agosto del 1835 fra dodici Cantoni – basato sull’unità di misura del “piede svizzero”133 – i Cantoni romandi, che non avevano aderito al precedente concordato, si opposero sostenendo il sistema metrico francese da loro già adottato. Una soluzione definitiva al problema verrà trovata solo con la riforma costituzionale del 1874. Infine, anche la disposizione relativa ai lavori pubblici, costituzionalizzata attraverso il precedente articolo 21, si rendeva indispensabile al fine di agevolare la fluida circolazione delle merci. L’audace opera di centralizzazione posta in essere dagli uomini del ’48 spinse ad affermare che nell’interesse del Paese la Confederazione aveva il diritto di erigere opere pubbliche a sue proprie spese, riservandosi il diritto di espropriazione mediante indennizzo. La gestione del sistema ferroviario rimase però nelle mani dei Cantoni. Queste le disposizioni volte ad incrementare la prosperità economica del Paese, ritenute necessarie al fine di agevolare la creazione di un mercato nazionale unico e liberalizzato, a beneficio dei cittadini confederati. Allo stesso tempo però queste stesse misure servirono a pianificare le risorse finanziarie che avrebbero dovuto mettere in moto e alimentare la macchina del neonato Stato federale: il rafforzamento dell’autorità federale, il processo di accentramento politico-economico, avrebbe comportato una dilatazione dell’apparato amministrativo e burocratico, necessitante di risorse finanziarie per poter operare. Era indispensabile fare i conti con il bilancio statale dunque, ed è proprio ciò che i costituenti si predisposero a fare redigendo le disposizioni dell’articolo 39. Esso chiarisce che la cassa federale viene alimentata attraverso gli interessi dei fondi federali di guerra, i prodotti dei dazi di frontiera, quelli dell’amministrazione postale e della polvere da sparo. Inoltre è prevista una contribuzione da parte dei Cantoni, da imporsi però solo previa emanazione di un decreto federale e pertanto da demandare alla legislazione futura. Ciononostante venne preventivamente precisato che le contribuzioni cantonali avrebbero dovuto essere proporzionali alla densità demografica e al prodotto derivante dall’industria di ogni unità territoriale, parametri attraverso i quali si 132 133 W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., pp. 300-303. Corrispondente a tre decimi del metro campione francese. V. Nava, La Costituzione 80 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 sarebbe posto a revisione a cadenza ventennale il contributo in denaro fornito da ogni Cantone. La centralizzazione del sistema doganale e postale aveva dunque il duplice scopo di garantire il libero commercio e alimentare le casse federali. A proposito di ciò, si è già accennato al fatto che nel tempo la disposizione relativa all’unificazione doganale si sarebbe rivelata la maggior risorsa per il finanziamento del neonato Stato federale, al punto che negli anni successivi gli introiti avrebbero di gran lunga superato le aspettative della Dieta134. Ciò non di meno, durante le discussioni che si svolsero nella stessa, e in quelle della Commissione che per prima abbozzò l’articolo 35, per quel che concerne la risorsa fiscale derivante da dazi e dogane emerse più volte il proposito di evitare l’eccessivo aggravio delle tariffe doganali, al fine di non compromettere il principio liberoscambista135. 3.3 Organi istituzionali La Costituzione innovò soprattutto attraverso l’istituzione di nuovi organi di governo: veri strumenti propulsori del neonato assetto federativo, ingranaggi attraverso cui dare avvio alle innovazioni di cui si è appena parlato, risultarono inoltre indispensabili a soddisfare il desiderio di rappresentanza nazionale, oltre che cantonale, che nel 1848 veniva reclamato a gran voce da molti confederati. Le autorità federali – ossia gli organi istituzionali – predisposte a sostituire l’ormai inefficiente e desueta Dieta furono tre: l’Assemblea federale, suddivisa nelle due sezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (potere legislativo), il Consiglio federale (potere esecutivo) e il Tribunale federale (potere giudiziario). Analizzando in particolar modo l’Assemblea e il Consiglio federale, ne chiariremo struttura e funzioni seguendo gli articoli costituzionali che ne predisposero l’attuazione. Si cercherà poi di comprendere le dinamiche storiche e gli orientamenti politici che portarono alla configurazione di quegli specifici organi istituzionali, esaminando sia le idee che vennero presentate durante i lavori di Commissione, sia i dibattiti che ne completarono la redazione alla Dieta. L’Assemblea federale L’Assemblea federale è definita dal sessantesimo articolo della Costituzione la suprema autorità della Confederazione. Gli articoli 60-82 illustrano quindi la disposizione costituzionale più innovativa e carica di conseguenze: siamo di fronte alla nascita del bicameralismo svizzero. La Dieta unica in qualità di 134 135 M. Polli-Schönborn, “Dogane. Dall’Elvetica alla costituzione dello Stato Federale”, cit. W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., pp. 313-318. V. Nava, La Costituzione 81 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 organo legislativo viene sostituita da un sistema senza precedenti storici nel Paese, a parte l’effimera esperienza del 1798, all’epoca della breve avventura della Repubblica unitaria. L’Assemblea federale si compone, come accennato, di due camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. La prima esprime la rappresentanza nazionale, la volontà della popolazione in senso unitario, scevra dai particolarismi risultanti dalla suddivisione cantonale. Questa camera si compone pertanto di deputati eletti in ragione di uno per ogni 20.000 anime 136, direttamente dal popolo, attraverso circoli elettorali federali, i quali non possono però essere formati da parti di Cantoni diversi137. Il Consiglio nazionale è eletto per la durata di tre anni e viene rinnovato al termine della legislatura attraverso rielezioni integrali138. Sono eleggibili tutti i cittadini svizzeri aventi diritto di voto139, ma i membri delle altre autorità federali non possono essere contemporaneamente deputati di questa Camera140. La medesima elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice-presidente per ogni sessione, i quali non sono rieleggibili in quella successiva. I membri del Consiglio nazionale vengono indennizzati dalla Confederazione. La seconda Camera, il Consiglio degli Stati, rappresenta l’autorità cantonale, la volontà particolarista degli antichi Stati sovrani necessaria a far da contrappeso alla unitaria volontà nazionale espressa dalla prima Camera 141. Per tale motivo essa è composta da 44 deputati, due per Cantone e uno per semiCantone, eletti nella gran parte di questi – secondo il sistema vigente all’epoca142– con votazione del parlamento cantonale143. Come i membri del Consiglio nazionale, anche i deputati del Consiglio degli Stati vengono indennizzati, ma dai Cantoni, e non possono contemporaneamente al proprio mandato prendere parte al Consiglio federale o alla prima Camera144. Articolo 61. Articolo 62. 138 Articolo 65. 139 Si ricorda inoltre che ha diritto di voto ogni svizzero che abbia compiuto il ventesimo anno di età, non escluso dal diritto di cittadinanza attiva, secondo quanto prescritto dalla legislazione cantonale del proprio domicilio. 140 Articolo 66. 141 La funzione “moderatrice” della Camera alta è tale anche per l’ordinamento degli Stati Uniti. C. Hilty, Le costituzioni federali della Svizzera…, cit., p. 366; L. Lacché, Una “mobile complessità”…, cit., p. 11. 142 E.R. Papa, Storia della Svizzera…, cit., p. 199. 143 Articolo 69. 144 Anche il Consiglio degli Stati elegge un proprio Presidente ed un Vice-presidente, ma un Cantone non può far ricoprire queste cariche ad uno dei suoi deputati eletti per due sessioni consecutive; Articolo 71. 136 137 V. Nava, La Costituzione 82 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 L’Assemblea federale così composta gode di attributi che le vengono conferiti attraverso gli articoli 73-82 della Costituzione. Dopo aver affermato che i due Consigli devono trattare tutti gli “oggetti”, ossia gli ambiti, di pertinenza federale che non sono attribuiti ad altra autorità145, il lungo articolo 74 specifica la natura di tali competenze. Tra gli ampi poteri dell’Assemblea rientra la legislazione per l’attuazione della stessa Costituzione; la nomina del Consiglio federale, del Tribunale federale, del Cancelliere e del Capo di Stato maggiore; la facoltà di stipulare trattati, dichiarare guerra e concludere la pace con l’estero; la possibilità di prendere i dovuti provvedimenti per assicurare la pace interna e mantenere la neutralità della Svizzera; la legislazione concernente l’organizzazione militare federale; la costruzione di opere pubbliche e la gestione delle relative espropriazioni; l’emanazione di leggi e decreti in materia di dazi, poste, monete, pesi e misure; le competenze in merito alle garanzie delle costituzioni e dei territori dei Cantoni e il potere di regolare le contese tra gli stessi. Infine, fortemente indicativo della suddivisione dei poteri prevista dalla Costituzione, all’Assemblea compete la suprema sorveglianza sull’amministrazione federale e sulla giustizia. I restanti articoli riguardanti l’Assemblea federale stabiliscono che entrambi i Consigli si radunano una volta all’anno in sessione ordinaria, ma – a determinate condizioni – possono essere convocati straordinariamente146. Per quel che concerne le modalità di deliberazione, l’articolo 79 prescrive che i membri di ciascun Consiglio votino senza ricevere istruzioni da parte dei propri Cantoni di appartenenza. Inoltre, a parte alcuni oggetti specifici, le due sezioni dell’Assemblea federale devono deliberare separatamente147: a questo proposito l’articolo 76 specifica che è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei deputati del rispettivo Consiglio, mentre l’articolo successivo prescrive che nel Consiglio nazionale e in quello degli Stati decide la maggioranza dei votanti. Infine, la Costituzione sancisce che ognuno dei due Consigli ed ogni deputato di essi ha il diritto di iniziativa, il quale può essere esercitato, per corrispondenza, anche dai Cantoni148. Questi gli articoli costituzionali che definiscono e illustrano la struttura ed il funzionamento del parlamento elvetico. Tuttavia, per cogliere in modo più compiuto la natura del bicameralismo svizzero, comprendere le dinamiche storiche e gli orientamenti politici che portarono alla scelta di questa specifica rappresentanza parlamentare, è opportuno analizzare più approfonditamente quali furono le idee che vennero presentate dalla Commissione e alla Dieta, Articolo 73. Si veda l’articolo 75. 147 Articolo 80. 148 Articolo 81. 145 146 V. Nava, La Costituzione 83 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 mettendo in evidenza gli snodi che determinarono le caratteristiche peculiari del sistema bicamerale elvetico. Ciò che non è possibile desumere dalla sola lettura del testo costituzionale è che il bicameralismo federale fu il frutto di una lunga e travagliata gestazione, prima in seno alla Commissione che ne elaborò il progetto e poi alla Dieta che lo dovette varare149. Del sistema delle due camere si era già discusso, a partire dal 1830, grazie agli studi dei pubblicisti che lo raccomandarono150. Ma all’inizio non vi fu nessun convinto sostenitore all’interno della Commissione che poi ne predispose il progetto: il solo a formulare la proposta di un assetto bicamerale fu il colonnello Rilliet-Constant di Ginevra, a quanto pare più perché il Gran Consiglio del suo Cantone glielo aveva raccomandato che per convinzione propria. Anzi, nei tre progetti relativi all’organizzazione del potere legislativo che la Commissione si trovò a dover analizzare alla dodicesima seduta del 3 marzo, l’istituzione delle due camere non era proprio contemplata151. Infatti, il primo dei tre progetti manteneva invariata la disposizione di una sola Dieta, con gli stessi rapporti di rappresentanza che regolamentavano il Patto federale. L’unica modifica rispetto al regime in vigore risultava dal fatto che i deputati sarebbero stati vincolati dalle istruzioni dei rispettivi Cantoni solo per la discussione delle questioni di maggiore importanza. La seconda proposta invece prevedeva una versione rivisitata del sistema costituzionale della Mediazione. Ad una sola Dieta infatti sarebbe spettato il compito di gestire gli affari federali, divisi però in due gruppi: il primo, relativo agli argomenti di pertinenza cantonale, necessitava della delibera attraverso l’istruzione dei delegati dai rispettivi Cantoni. Gli affari rimanenti, appartenenti al secondo gruppo, sarebbero anch’essi stati decisi dalla Dieta, ma autonomamente, senza istruzioni cantonali, e attraverso un rapporto di rappresentanza modificato: il numero dei delegati risultava variabile; una ripartizione che doveva tenere conto della diversa entità demografica dei Cantoni. Il terzo ed ultimo progetto invece venne proposto da uno dei maggiori protagonisti del 1848 svizzero, il più volte ricordato Druey, del Cantone di Vaud. Egli prospettò l’istituzione di un solo parlamento nazionale, composto di deputati scelti mediante elettori, a loro volta designati dalla popolazione svizzera suddivisa in circoli elettorali che non tenessero conto delle suddivisioni cantonali. Sempre allo scopo di attutire i particolarismi suscitati dalle istanze cantonali, i membri del parlamento avrebbero dovuto deliberare senza istruzioni. Pur prevedendo un evidente preponderanza dell’elemento M. Graf, “Assemblea federale” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. Tra gli altri Fazy, Bornhauser, Roger, Troxler e Kasthofer; Cfr. A. Kölz, Le origini…, cit., p. 389. 151 Ivi, pp. 387-389. 149 150 V. Nava, La Costituzione 84 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 nazionale, il progetto di Druey teneva comunque in considerazione la salvaguardia degli interessi dei Cantoni, predisponendo che le decisioni relative agli ambiti di loro pertinenza avrebbero potuto essere sottoposte al veto della maggioranza degli Stati152. Tutte e tre le proposte erano il frutto del tentativo di conciliare le due principali istanze che caratterizzavano il Paese: quelle dei Cantoni animati perlopiù da orientamenti politici conservatori – generalmente cattolici, in gran parte agrari e di montagna – e quelle dei Cantoni a maggioranza liberali – in prevalenza protestanti, industrializzati, delle regioni pianeggianti del territorio confederato. Una dicotomia che vedeva contrapposte la piccola unità territoriale e il grande Cantone popoloso e che riproduceva, almeno in grandi linee, la polarizzazione tra i vinti e i vincitori della guerra del Sonderbund 153. Ai vincitori infatti premeva ottenere una rappresentanza parlamentare che tenesse nella giusta considerazione il maggior peso demografico della propria unità territoriale e il più oneroso contributo che i grandi Cantoni sarebbero stati chiamati ad apportare in conseguenza del processo di accentramento del potere federale che la nuova Costituzione stava predisponendo. In altre parole, come recita il rendiconto ufficiale delle sedute del 6 e 7 marzo: Se il Canton Untervaldo cede la propria sovranità riguardo al servizio postale, è l’identica sovranità che deve pure cedere il Cantone Berna. Bisogna però convenire che, in realtà, c’è una grandissima differenza poiché il servizio postale di Untervaldo rende annualmente 10 luigi d’oro mentre quello di Berna 200.000 franchi. 154 Era giusto, allora, secondo loro, che ai Cantoni più grandi, chiamati a dare il maggiore contributo, venisse attribuito più potere decisionale, attraverso – ad esempio – l’istituzione di un parlamento nazionale sul modello unicamerale presentato da Druey. Mediante un siffatto sistema infatti sarebbe stata infatti la legge del numero a decidere la linea politica del Paese, e non l’unità territoriale, rappresentata dai Cantoni. Per i vincitori della guerra del Sonderbund non era pensabile lasciare immodificato l’attuale rapporto di rappresentanza, che vedeva il piccolo e poco popoloso Cantone di montagna avere la medesima influenza dei grandi155. Al contrario, i Cantoni più piccoli, perlopiù conservatori, combattevano per il mantenimento del medesimo rapporto di rappresentanza vigente grazie al Patto federale. Già ostili alla centralizzazione prevista dalla nuova Costituzione, temevano che questa recasse loro perdita di influenza, a fronte dei W.E. Rappard, La Costituzione…, cit., pp. 158-159; A. Kölz, Le origini…, cit., pp. 388-389. Ibidem. 154 W.E. Rappard, La Costituzione…, cit., p. 160. 155 M. Graf, “Assemblea federale” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 152 153 V. Nava, La Costituzione 85 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 vantaggi conquistati dai grandi, e che quest’ultimi stavano appunto reclamando. Per tale motivo, si sarebbero rassegnati solo qualora la loro posizione costituzionale non fosse stata indebolita. A sostegno della propria causa invocarono la storicità della loro sovranità e uguaglianza giuridica: una regola consacrata da secoli di storia non poteva essere revocata tanto facilmente; i Cantoni si erano associati in una Confederazione quali Stati sovrani e giuridicamente equiparati, e tali dovevano rimanere. Solo in questo modo, attraverso il mantenimento di un organo simile all’antica Dieta – in cui il principio dell’eguale rappresentanza cantonale e non quello pro capite avrebbe deciso degli affari del Paese – sarebbe stato possibile sopravvivere alla pressione dei Cantoni più popolosi e portare avanti la propria concezione di Stato vincolata alla chiesa e alla famiglia, alle antiche tradizioni corporativistiche156. L’antinomia assoluta delle due concezioni, per ripetersi usando la terminologia in auge all’epoca e confluita poi nella storiografia elvetica, è rappresentata dalla dicotomia fra “unitari” – rappresentati perlopiù dai Cantoni più popolosi, industrializzati, protestanti e caratterizzati da governi liberal-radicali – e “federalisti”, espressione dei piccoli Cantoni, generalmente agrari, conservatori e cattolici: un puzzle di due soli pezzi dalla difficile composizione. Le personalità politiche impegnate nel progetto di revisione del Patto federale – i membri della Commissione – erano consapevoli della necessità di trovare un compromesso che potesse assecondare entrambe le parti. Questo l’intento dei tre progetti sopra illustrati, falliti – in definitiva – proprio poiché non ritenuti in grado di poter soddisfare le opposte esigenze. Fu allora che si comprese che la soluzione poteva venire solo da un sistema bicamerale 157. Quest’ultimo non giunse, però, alle menti dei membri della Commissione come una rivelazione dall’alto, un’illuminazione estemporanea capace di risolvere senza impedimenti l’impasse. Come già affermato, il sistema bicamerale non era infatti nuovo ai fautori della revisione del Patto federale. Tra gli altri, il pubblicista professore di filosofia Ignaz Paul Vital Troxler ne aveva preconizzato l’istituzione nell’opuscolo elaborato in occasione della revisione costituzionale tentata nel 1832-33158. Individuando nel sistema bicamerale americano il modello a cui ispirarsi, egli prospettò che questo fosse l’unico in grado di garantire e Ibidem. Ibidem. 158 Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Centralherrschaft und Kantonsthümelei sowie zum neuen Zwitterbunde beider; nebst einem Verfassungsentwurf. (L’unica vera Confederazione in antitesi al centralismo e al “cantonalismo” e alla loro nuova, ambigua alleanza; unitamente a un progetto di Costituzione). 156 157 V. Nava, La Costituzione 86 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 rappresentare le diversità cantonali e l’unità nazionale 159. Dopo Troxler, anche il radicale ginevrino James Fazy ne raccomandò l’attuazione. Proprio dalla sua riflessione, esposta nel “Projet de Constitution Fédérale” del 1837, venne la proposta del sistema bicamerale formulata alla Dieta dal colonnello RillietCostant, rappresentante di Ginevra nella Commissione. D’altronde, Kölz fa notare che guardare al sistema statunitense, e dunque al modello bicamerale, era abbastanza scontato, dal momento che anche la Confederazione era nata da un’associazione di Stati e l’Unione americana era, in quel periodo, l’unica democrazia rappresentativa al mondo160. Tuttavia, pare che l’idea di istituire due Camere risultasse all’inizio impopolare tanto nei grandi Cantoni quanto in quelli piccoli. Entrambi rimproveravano ad un siffatto sistema i costi maggiori che avrebbe comportato, oltre l’andamento decelerato che la duplice deliberazione avrebbe inflitto agli affari dello Stato, rendendo particolarmente problematica la situazione del Paese soprattutto qualora si fossero verificate condizioni di emergenza161. Dell’ordinamento bicamerale non veniva apprezzato nemmeno l’origine straniera: non solo non aveva precedenti di una qualche importanza in territorio confederato, ma soprattutto si ritenne che non potesse essere adeguato alla Svizzera un sistema ispirato al modello dell’America del Nord, la cui costituzione traeva i tratti fondamentali da quella inglese. Secondo molti infatti, un legislativo bicamerale, intrinsecamente portato a causare gravi collisioni in caso di disaccordo delle due sezioni del parlamento, non avrebbe potuto trovare in Svizzera nessuna unità superiore in grado di conciliare le due Camere, come accadrebbe invece in una monarchia costituzionale attraverso la figura del principe, o in un sistema repubblicano nella persona del presidente. E per parte sua il popolo elvetico era assolutamente e tradizionalmente ostile all’idea di concentrare un potere così determinante nella figura di una sola persona. Infine si fece notare che altri possibili svantaggi si sarebbero verificati qualora si fosse deciso di attribuire ad una Camera il solo diritto di discussione preliminare e all’altra la facoltà di deliberare. Si temeva che la prima Camera, solo consultiva – incarnante l’elemento nazionale – con il tempo sarebbe stata sovrastata dal “cantonalismo” espresso dalla seconda162. Ciononostante, l’ordinamento bicamerale finì per risultare l’unica soluzione praticabile. Solo attraverso l’istituzione di due Camere sarebbe stato possibile, da un lato, attraverso l’equivalente di una Camera dei A. Kölz, Le origini…, cit., p. 269. Ibidem. 161 C. Hilty, Le costituzioni federali della Svizzera…, cit., p. 366. 162 Ibidem. 159 160 V. Nava, La Costituzione 87 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Rappresentanti, soddisfare le esigenze dei grandi Cantoni promotori di una rappresentanza nazionale che rendesse ragione della maggior ricchezza ed entità demografica delle proprie unità territoriali. Dall’altro, mediante una seconda Camera degli Stati, sarebbe stato possibile salvaguardare i diritti particolaristici dei singoli Cantoni, anche dei più piccoli, custodendo le antiche tradizioni suggellate da anni di storia confederale basata sul principio dell’eguale rappresentanza cantonale163. Inoltre, l’istituzione di una seconda Camera – quella dei Cantoni – avrebbe agevolato l’accettazione del nuovo ordinamento ai Cantoni più piccoli, permettendo al contempo di soddisfare il principio di rappresentanza nazionale ispirata ai principi della democrazia individualistica di derivazione francese. E se era vero che un parlamento diviso in due sezioni poteva risultare problematico, qualcuno fece notare che “uno scambio di idee fra le due Camere sarebbe da preferire, per la nazione, a un conflitto disordinato fra il popolo”164. In definitiva, per dirla con le parole dei costituenti: Se si considera, da un lato, il bene al quale si aspira e, dall’altro, che non deve essere leso nessun diritto, il solo metodo di intendersi reciprocamente sul sistema proposto sarebbe quello di allontanarsi tanto da un federalismo puramente tradizionale, quanto da un principio unitario che non riconoscerebbe nulla di quello che esiste. 165 Quando la Commissione passò ai voti, rilevando una seppur risicata maggioranza favorevole ad un cambiamento che denotava una qualche simpatia per il sistema bicamerale, decise di assegnare alla prima sezione – la più importante – il compito di redigere un progetto per dotare la Confederazione di poteri legislativi, esecutivi e giudiziari. La composizione della sezione è indicativa dell’importanza data alla questione: oltre ad annoverare fra i suoi membri Ochsenbein di Berna e Furrer di Zurigo, fruì anche della collaborazione dei due redattori della Commissione166, Kern di Turgovia e Druey del Canton Vaud. I lunghi dibattiti in seno alla Commissione e all’interno della prima sezione non dovettero essere facili se alcuni membri arrivarono persino a proporre di abbandonare la revisione del Patto federale, viste le criticità relative all’accordo sul “problema cardine”, l’organizzazione – appunto – del potere legislativo. Questa proposta non fu tuttavia tenuta in considerazione, poiché proprio i piccoli e ostili Cantoni diedero prova di disposizioni concilianti, spiegando che l’opposizione ad una rappresentanza ineguale sarebbe stata superata qualora la Confederazione avesse saputo M. Graf, “Assemblea federale”, cit. Discussione delle sedute del 6 e 7 marzo; W.E. Rappard, La Costituzione…, cit., p. 161. 165 Ibidem. 166 I quali furono aggiunti formalmente alla sezione nella seduta del 2 marzo 1848. 163 164 V. Nava, La Costituzione 88 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 rassicurarli riguardo al timore che i grandi Cantoni imponessero loro oneri materiali insostenibili167. La sezione incaricata, quindi, giunse a presentare il progetto raccomandando unanimemente il bicameralismo, pur essendo ancora divisa su punti importanti relativamente alle questioni di competenza e alle modalità di deliberazione delle due Camere dell’Assemblea federale. La discussione del progetto all’interno della Commissione incontrò nuovamente oppositori nei rappresentanti dei piccoli Cantoni ma, infine, nella seconda votazione del 20 marzo 1848, con una seppur scarsa maggioranza di undici voti, venne sancito il principio bicamerale168. Quest’ultimo non si sarebbe esplicato, però, nell’azione di due Camere caratterizzate dalle medesime competenze e deliberanti in reciproca autonomia169. Secondo il progetto così strutturato, gli affari federali, ed una serie di ambiti importanti, sarebbero stati discussi in seduta comune, garantendo di conseguenza alla corrente unitaria gran parte della sua forza, poiché il futuro Consiglio nazionale – in base al rapporto di rappresentanza che designava un delegato ogni 20.000 anime – sarebbe stato composto da 110 o 120 membri, i quali avrebbero potuto facilmente sopraffare durante le votazioni i 25 deputati della Camera dei Cantoni. Questo squilibrio tra elemento nazionale e cantonale non dovette passare inosservato se, pochi giorni dopo, la Commissione adottò un emendamento che, modificando il progetto della sezione, introduceva un bicameralismo puro, anche in questo simile a quello nordamericano, in base al quale, in linea generale, le due sezioni del parlamento erano chiamate a discutere e deliberare separatamente. Si fece una deroga solo per alcune importanti questioni: le due Camere avrebbero deliberato in seduta comune in occasione dell’elezione del Consiglio federale, del Tribunale federale, del Cancelliere, del Capo di Stato-maggiore e dei rappresentanti federali, per la concessioni del diritto di grazia e per la soluzione dei conflitti di competenza 170. Il dibattito che precedette la votazione dell’emendamento ne illustra i motivi: venne spiegato che l’istituzione di due Camere indipendenti ed investite entrambe del diritto di iniziativa era il solo modo per tutelare la sovranità cantonale, confermando in particolare le rassicurazioni precedentemente elargite ai piccoli Cantoni. È altresì possibile dedurre che il progetto originario prevedesse sedute comuni per ovviare al timore di continui attriti che si sarebbero invece verificati se le due Camere avessero deliberato separatamente, W.E. Rappard, La Costituzione…, cit., pp. 162-163. Ibidem. 169 Condizioni giuridicamente indispensabili, peraltro, per definire un tale sistema “bicameralismo” in senso pieno. Cfr. J.F. Aubert, Traité de droit constitutionnel…, cit., p. 459. 170 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., pp. 391-393. 167 168 V. Nava, La Costituzione 89 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 e che la Commissione, dopo aver optato per la conduzione separata dei lavori camerali, abbia pensato di limitare questa specifica eventualità sancendo il divieto di istruzione cantonale ai deputati degli Stati. Per dirla con le stesse parole di uno dei più illustri membri della Commissione – il redattore Kern di Turgovia : […] se i Cantoni dovranno cercare le proprie garanzie nel buon senso dei delegati designati non ne deriverà che gli interessi territoriali vengano difesi con rigore inflessibile, ma i deputati, affrancati dalla costrizione delle istruzioni, voteranno per convinzione personale nell’interesse generale della nazione. 171 A ben vedere, accettando che le due sezioni del legislativo deliberassero separatamente, la posizione dei Cantoni più popolati veniva indebolita d’un colpo, mentre le piccole unità territoriali sarebbero rimaste forti del voto da loro espresso nella Camera rappresentante i Cantoni. Ecco che allora si rendeva necessario riequilibrare i rapporti di forza eliminando almeno il diritto degli Stati di istruire i propri deputati. Per le stesse ragioni si decise di modificare l’antica consuetudine per la quale ogni unità cantonale aveva diritto ad esprimere un voto: venne invece introdotta la disposizione secondo la quale ogni Cantone elegge due deputati mentre i semi-Cantoni ne eleggono solo uno. In altre parole, la rappresentanza tanto difesa dalle piccole unità territoriali – ed infine ottenuta attraverso il mantenimento di una Camera degli Stati avente il diritto di deliberare autonomamente – venne così ulteriormente indebolita. In sintesi, il liberale e progressista Canton Zurigo avrebbe potuto godere di due voti, mentre il piccolo e conservatore semi-Cantone Nidvaldo avrebbe disposto solo di un voto. Rilliet-Constant, giustificò l’equilibrio così sancito affermando: […] i reciproci rapporti esistenti fra le due Camere avranno un influsso salutare, poiché, mentre la nazione potrà pronunciarsi attraverso il Consiglio nazionale – nel quale il principio del movimento e del progresso sarà, con tutta probabilità, debitamente rappresentato – la Camera degli Stati farebbe da contrappeso ai movimenti interni, cioè sarebbe una garanzia dei diritti cantonali. 172 Sempre per tutelare quest’ultimi, e nel tentativo di accostare i piccoli Cantoni al principio bicamerale, la Commissione adottò un ulteriore emendamento relativo alla composizione del Consiglio dei rappresentanti, con il quale decise che tutti i Cantoni dovevano essere rappresentati nella Camera popolare. Un altro punto di attrito riguardò, poi, le modalità di elezione del Consiglio nazionale: i radicali proposero di creare un’unica circoscrizione 171 172 Ibidem. W.E. Rappard, La Costituzione…, cit., p. 169. V. Nava, La Costituzione 90 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 elettorale estesa a tutta la confederazione. L’intento era quello di dare un ulteriore impulso al sentimento nazionale, agevolando il superamento dello spirito “cantonalistico”. I “federalisti” si opposero fermamente, sostenendo la necessità di piccole circoscrizioni nazionali su base cantonale, e anche in questo – come mostra l’articolo 62 – ebbero la meglio173. La fazione liberal-radicale la spuntò invece ottenendo l’esclusione del clero dalla Camera nazionale, adducendo la motivazione secondo la quale la chiesa cattolica partiva dal principio che essa avrebbe dovuto “dominare sullo Stato”, e che il ceto ecclesiastico era essenzialmente vincolato a Roma. Anche il clero protestante, stando a Kölz, non si era ancora potuto ‘liberare pienamente’ dalle tendenze gerarchiche174. Infine, la Commissione decise i nomi che tutt’ora designano il potere legislativo della Confederazione: “le due sezioni della rappresentanza nazionale riunite si chiamerebbero ‘Assemblea federale’, la sezione eletta dalla nazione ‘Consiglio nazionale’ e quella formata dagli Stati ‘Consiglio degli Stati’175”. Il nome “Dieta” non godeva più della necessaria popolarità, mentre “Camera”, eccessivamente aristocratico, evocava qualcosa di estraneo alle tradizioni elvetiche. Ecco tracciate dunque le linee generali del progetto relativo alla struttura dell’Assemblea federale, il cui testo venne adottato dalla Commissione l’8 aprile 1848, pronto ad essere sottoposto al vaglio della Dieta. Ruffieux ci informa che, stretti tra le proposte radicali più ardite e le resistenze federalistiche più caparbie, alla Dieta i protagonisti del ’48 elvetico riuscirono a trovare gli appoggi indispensabili presso i radicali moderati e i liberali conservatori, desiderosi di trovare una soluzione in tempi brevi176. A differenza delle deliberazioni della Commissione, quelle della Dieta furono brevi. Allo scrutinio di preconsultazione la maggior parte dei delegati, istruiti dai governi dei rispettivi Cantoni, si pronunciarono contro il sistema bicamerale. A parte i tre Cantoni primitivi e Appenzello – che, come era naturale che fosse, caldeggiarono il mantenimento della Dieta e dell’eguale rapporto di rappresentanza cantonale – Zurigo, Berna e Argovia si pronunciarono a favore di un legislativo unicamerale. Altre delegazioni invece, ossia quelle di Sciaffusa, del Vallese, dei Grigioni e di Glarona, sostennero una rappresentanza diseguale in un parlamento in ogni caso unico177. Kölz ci induce a ragionare sul fatto che l’ostilità manifestata nei confronti del principio bicamerale non è da ricercarsi unicamente nelle medesime Ibidem. A. Kölz, Le origini…, cit., p. 397. 175 Seduta del 5 aprile; W.E. Rappard, La Costituzione…, cit., p. 172. 176 R. Ruffieux, “La Svizzera dei Radicali (1848 – 1914)”, cit., p. 9. 177 W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., pp. 177-179. 173 174 V. Nava, La Costituzione 91 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 argomentazioni proposte durante i lavori della Commissione – che comunque non mancarono di essere ribadite – ma anche negli eventi che contemporaneamente stavano scuotendo l’Europa e che non lasciarono indifferente il clima politico elvetico. Da quando erano iniziati i dibattiti della Dieta federale – l’11 maggio 1848 – la situazione era mutata infatti sotto un aspetto importante: in Francia era stata proclamata le repubblica ed eletta una nuova assemblea costituente, che lasciava prevedere il varo di una nuova costituzione improntata ai principi di uno Stato unitario con legislativo unicamerale178. I delegati dei Cantoni alla Dieta osteggiarono quindi la proposta di un parlamento a due sezioni non solo perché i governi cantonali che rappresentavano non si erano ancora rassegnati al compromesso, come invece erano stati portati a fare i membri della Commissione, ma anche perché molti di loro esprimevano una rinnovata simpatia per il principio unitario e democratico, sotto l’impulso dell’esempio francese. I Cantoni Berna e Ginevra giunsero a chiedere l’insediamento di un Consiglio costituente federale; la delegazione di Zurigo si professò per un sistema unicamerale, affermando che l’istituzione di un Consiglio degli Stati avrebbe ostacolato il progresso. Ed era parere comune nei Cantoni liberal-radicali che il sistema bicamerale, se instaurato, avrebbe rappresentato soltanto un periodo di transizione che prima o poi avrebbe dovuto lasciare il posto “all’unitarismo” rappresentato da una sola Camera nazionale179. Queste asserzioni erano destinate a rimanere, tuttavia, null’altro che dichiarazioni di principio dei parlamenti cantonali, volti a mettere in evidenza la necessità di reciproche concessioni. Molti delegati infatti lasciarono intravedere che in caso di insuccesso delle proposte di cui erano mandatari, avevano già ricevuto istruzione di accettare il principio bicamerale, seppur a titolo transitorio. La votazione che si sarebbe svolta il 17 maggio, per quanto all’interno di uno schieramento fortemente frammentario, era destinata nuovamente a premiare la via del compromesso che solo un parlamento a due Camere poteva realizzare: la nascita del sistema bicamerale elvetico venne sancita con il voto di 16 Cantoni180. La storia della nascita del bicameralismo svizzero dunque è definibile come un compromesso che ha la parvenza di un matrimonio di ragione tra A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., pp. 393-395. Ibidem. 180 Votarono per il sistema bicamerale proposto dalla Commissione i Cantoni Berna, Zurigo, Lucerna, Friburgo, Soletta, San Gallo, Grigioni, Turgovia, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Basilea Campagna, Sciaffusa e con una “riserva” ritirata pochi giorni dopo il Cantone Glarona; Basilea Città si espresse a favore nella seconda votazione. 178 179 V. Nava, La Costituzione 92 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 diverse e spesso opposte istanze. È il risultato del ricercato equilibrio tra tradizione storica e innovazione politica, tra elemento cantonale – nerbo dell’antica Confederazione – e impulso unitario nazionale, obiettivo anelato da liberali e radicali progressisti. In questo senso, il Consiglio nazionale, rappresentante il popolo nel suo insieme, si presupponeva avrebbe svolto una funzione “accentratrice”, mentre al Consiglio degli Stati sarebbe spettato un ruolo di contrappeso, di freno posto ad una evoluzione troppo rapida verso l’unità181. È possibile affermare, quindi, che le dinamiche che condussero all’accordo furono più di natura politica che di diritto costituzionale. Abbiamo visto che i rappresentanti dei meno popolosi Cantoni conservatori erano i più ostili al progetto: le loro popolazioni giunsero persino a biasimare i loro magistrati per essersi prestati alle discussioni della Commissione 182. Dovendosi rassegnare alla scomparsa di una Dieta unica, nella quale fino a quel momento le piccole unità cantonali avevano goduto dell’arma fondamentale del loro stesso numero, erano chiamati a fare un sacrificio più tangibile ed evidente rispetto ai loro rivali. Ma a quanto pare, anche i fautori risoluti della preponderanza della nazione sul Cantone, in particolare i membri della Commissione di Zurigo e Berna, vissero la soluzione del bicameralismo senza alcun entusiasmo. Ammettere la rappresentanza cantonale – attraverso l’istituzione di una seconda Camera degli Stati – a fianco di quella nazionale e successivamente sancire il principio dell’uguaglianza dei due Consigli significava limitare sensibilmente la predominanza che avrebbero voluto dare ai Cantoni più popolosi. Per personalità come Furrer, Ochsenbein, Kern e Druey, le concessioni federaliste erano eccessive ed in particolare Furrer e Druey si ritrovarono a doversi giustificare di fronte ai concittadini del proprio Cantone, che guardarono alla natura di quel bicameralismo come ad una sconfitta dell’elemento nazionale183. Come mai, allora, dirigenti radicali e liberali decisero di sostenere il principio fondamentale dello Stato americano, quando per loro concezione razionale e individualistica erano più vincolati all’ideale dello stato maggiormente unitario rappresentato da un parlamento unicamerale di derivazione francese? Le motivazioni che spinsero costoro, principali membri della Commissione, ad optare per il sistema bicamerale sono ravvisabili nelle parole del già citato pubblicista James Fazy: “…è possibile, di fronte all’egoismo cantonale attuale, fare una riforma se non si rilascia ai Cantoni una garanzia W. Martin, Storia della Svizzera..., cit., p. 234. W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 175. 183 Ibidem. 181 182 V. Nava, La Costituzione 93 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 diretta per la conservazione della loro sovranità? Questo è un compromesso necessario184”. Non si trattava dunque di adempiere a convinzioni teoriche ma di comprendere l’importanza di assecondare esigenze politiche pratiche. Le concessioni elargite all’elemento cantonale e conservatore erano lo scotto da pagare per raggiungere l’obiettivo tanto anelato di creare uno Stato federativo forte. Se i radicali finirono per accettare un sistema che inizialmente avevano scartato, era perché si sentivano particolarmente responsabili verso tutto il Paese185, ma anche perché erano convinti che il tempo avrebbe lavorato a loro favore: il dinamismo caratterizzante l’elemento popolare espresso attraverso il Consiglio nazionale avrebbe finito per vincere la staticità insita nel volere cantonale rappresentato nel Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale La Costituzione del 1848 illustra anche la natura e la struttura del Consiglio federale, potere esecutivo dello Stato elvetico. Il governo della Svizzera viene definito attraverso l’articolo 83 “la suprema Autorità esecutiva e direttoriale della Confederazione”, i cui sette consiglieri vengono nominati per tre anni dall’Assemblea federale fra tutti i cittadini svizzeri che sono eleggibili come membri del Consiglio nazionale186. L’articolo 84 precisa anche che i consiglieri federali devono provenire da Cantoni diversi, e per tutta la durata del mandato non possono svolgere contemporaneamente nessun’altra occupazione, tantomeno al servizio della Confederazione187. L’articolo 86 conferisce al Presidente del Consiglio federale anche il titolo di “Presidente della Confederazione”; egli e il Vice-presidente vengono scelti dall’Assemblea federale fra i membri dello stesso, e svolgono la propria carica per un anno, al termine del quale non sono immediatamente rieleggibili188. Per quel che concerne le modalità di deliberazione, l’articolo 88 prescrive che devono essere presenti in Consiglio almeno quattro membri. Gli affari di governo vengono gestiti mediante dipartimenti suddivisi fra i singoli consiglieri, sulla base del presupposto sottolineato dall’articolo 91: “questa distribuzione ha unicamente per iscopo di agevolare l’esame e lo spaccio degli affari; la decisione emana sempre dal Consiglio federale come Autorità189”. A. Kölz, Le origini…,cit., p. 272. C. Hilty, Le costituzioni federali della Svizzera…, cit. p. 367. 186Articolo 84. 187 Articolo 85. 188 Inoltre, sia le due cariche di Presidente e Vice-presidente, sia i membri del Consiglio ricevono un onorario annuo dalla cassa federale; Articolo 87. 189 Articolo 91. 184 185 V. Nava, La Costituzione 94 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Il lungo articolo 90 specifica le competenze spettanti all’organo esecutivo della Confederazione. Fra queste rientrano anzitutto funzioni di supervisione e controllo: vegliare sulla precisa osservanza della Costituzione, sulle leggi e i decreti della Confederazione, oltre che sulla garanzia data alle singole costituzioni cantonali; assicurare la conservazione degli interessi della Svizzera all’estero, il mantenimento della sua indipendenza e neutralità, e garantire la sicurezza esterna ed interna del Paese; sorvegliare l’operato di tutti i funzionari ed impiegati dell’amministrazione federale. Il Consiglio federale ha anche funzioni esecutive, che lo incaricano di dirigere gli affari della Confederazione e attuare sia le sue leggi e risoluzioni, sia le sentenze del Tribunale federale e quelle relative alle questioni di arbitrato fra i Cantoni. Inoltre, al governo elvetico spetta, in generale, la conduzione degli affari esteri, quelli militari e relativi all’amministrazione. Deve altresì gestire le finanze della Confederazione, di cui risponde attraverso la presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto delle entrate e delle uscite dello Stato. La Costituzione stabilisce che il Consiglio è responsabile di fronte all’assemblea federale nella misura in cui deve renderle conto in ogni sessione ordinaria – o quando la stessa lo richieda – facendo rapporto relativamente alla propria gestione e alla situazione interna ed esterna al Paese, e raccomandando quelle misure che ritiene vantaggiose per la comune prosperità. Più precisamente ha la facoltà di proporre leggi e risoluzioni al parlamento della Confederazione, ma i membri del Consiglio federale hanno diritto al solo voto consultivo in entrambe le Camere dell’Assemblea190. La configurazione dell’esecutivo, così illustrata attraverso gli articoli costituzionali, seguì un iter molto più breve e semplice in seno ai lavori della Commissione. La proposta di creare un Consiglio federale in qualità di organo esecutivo della Confederazione venne approvata il 24 marzo 1848 da una maggioranza di 22 voti. Con la stessa unanimità la Commissione decise inizialmente che fosse composto di soli cinque membri e scartò la proposta di affidare l’elezione del Presidente al voto popolare191. In occasione del primo dibattito, le uniche questioni che diedero luogo a serie divergenze fra i membri della Commissione furono quelle relative al tema dell’incompatibilità delle cariche e del carattere collegiale del governo della Confederazione. In particolare, per quel che concerne il carattere collettivo dell’esecutivo elvetico, si discusse in merito al ruolo individuale del singolo consigliere qualora questi avesse maturato opinioni divergenti dalla maggioranza dei suoi colleghi. Con soli dieci voti favorevoli, contro nove 190 191 Articolo 89. C. Hilty, Le costituzioni federali della Svizzera…, cit., p. 366. V. Nava, La Costituzione 95 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 contrari, venne riconfermata la natura strettamente collegiale dell’organo di governo, attribuendo al solo Consiglio federale nella sua totalità la facoltà di presentare progetti di legge alle Camere. La seconda lettura del progetto, iniziata il 5 aprile, fu scenario di una lunga discussione che vide al centro la proposta di emendamento volta ad attribuire al popolo la facoltà di eleggere i membri del Consiglio federale192. Protagonista della scena fu l’intraprendente bernese Ochseinbein, il quale fece presente che, poiché era stato deciso di respingere la proposta di un’unica circoscrizione elettorale per l’elezione del Consiglio nazionale, la nomina dei consiglieri federali da parte del parlamento sarebbe stata suscettibile delle influenze particolaristiche delle realtà cantonali. L’intrepido sostenitore della preponderanza della nazione sul Cantone propose allora di porre rimedio a questa eventualità conferendo al popolo la facoltà di eleggere direttamente i propri membri di governo193. Fra le svariate argomentazioni che vennero addotte contro la proposta di emendamento, spicca il ragionamento di Druey, il quale, pur avallando la mozione di Ochsenbein, si trovò a constatare che l’elezione dei consiglieri da parte del parlamento avrebbe giocato a favore dell’unità delle autorità federali ed era necessaria ai fini della subordinazione del potere esecutivo al “massimo potere legislativo194”. Alla Dieta, le discussioni relative al Consiglio federale furono altrettanto concise e condussero a soli due mutamenti importanti rispetto al progetto iniziale. Il primo riguardava l’aumento del numero di consiglieri federali da cinque a sette. L’innovazione è interessante più per le originali argomentazioni messe in campo che per l’importanza dell’emendamento in sé. Infatti, coloro che si espressero per il mantenimento del numero dei consiglieri federali a cinque, oltre a far valere le ragioni dei vantaggi economici, della maggiore autonomia e omogeneità di un piccolo Consiglio, avvertirono del pericolo di ozio in un governo troppo numeroso, il cui spettacolo di poltroneria avrebbe screditato il Consiglio federale di fronte al laborioso cittadino elvetico. Ma si fece notare che “lo svizzero non vedrebbe di buon occhio che un simile potere riposasse nella mani di così pochi magistrati195”. La riforma avrebbe certamente comportato un aumento dei costi ma avrebbe altresì permesso una gestione più oculata degli affari importanti, creando inoltre l’opportunità di una rappresentanza maggiormente equa delle diverse parti del Paese; l’incremento Ibidem. Ibidem. 194 Riflessione esposta nel suo “Rapporto illustrativo sul progetto di Costituzione federale” (Beleuchtender Bericht über den Entwurf einer Bundesverfassung.); A. Kölz, Le origini…, cit., p. 399. 195 Nei dibatti alla Dieta, che si svolsero dal 3 al 6 giugno, questa opinione venne sostenuta dal delegato del Cantone Svitto, W.E. Rappard, La Costituzione…, cit., p. 186. 192 193 V. Nava, La Costituzione 96 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 del numero dei consiglieri federali si rendeva tanto più necessario quanto più era stata aumentata la centralizzazione rispetto al progetto costituzionale del 1832-33. Il secondo emendamento invece ripropose con forza la dinamica che abbiamo visto caratterizzare anche la nascita del bicameralismo svizzero e che si è configurata in più occasioni come un braccio di ferro tra piccoli Cantoni, conservatori e cattolici, e i popolosi Cantoni di orientamento liberal-radicale. Durante le discussioni alla Dieta infatti venne stabilito che tra i membri del Consiglio federale non poteva essere eletto più di un rappresentante di uno stesso Cantone. Evidentemente questa proposta era l’espressione di una preoccupazione sentita nei piccoli Cantoni, ma del resto – una volta tanto – non trovò nessuna opposizione nei grandi: […] se si vuole che il Consiglio federale acquisti il favore del popolo e ne ottenga la fiducia, è necessario che i Cantoni rappresentati siano parecchi: in secondo luogo, che quei posti onorifici non diventino esclusività o privilegio di un numero limitato di Stati. 196 La saggezza di quest’ultima considerazione non impedì, tuttavia, di respingere l’ulteriore proposta che vedeva la carica non rinnovabile oltre due periodi elettorali, affinché i consiglieri non si trasformassero gradualmente in consoli a vita. Ma ciò che lascia effettivamente sorpresi è la constatazione del fatto che l’emendamento venne seriamente discusso e accolto unicamente durante le discussioni conclusive della Dieta: infatti la proposta secondo la quale il Consiglio federale non poteva contare più di un membro dello stesso Cantone aveva già trovato espressione attraverso la voce di Kern agli albori dei lavori di Commissione, incontrando una tale opposizione in svariati suoi colleghi da indurlo ad una sollecita rinuncia. Alla Dieta invece non solo il provvedimento – questa volta suggerito, per la verità, dall’affatto poco esteso Canton Grigioni – venne accolto da una risoluta maggioranza di quindici Cantoni, ma fu affiancato da mozioni che proponevano di rappresentare equamente anche le differenti confessioni della Confederazione. Espressione delle istanze cattoliche del Paese, quest’ultima proposta non poteva che incontrare il favore dei soli tre Cantoni primitivi e di Appenzello interno, e quindi venire respinta. La relativa facilità con cui si giunse a determinare l’organizzazione del potere esecutivo della nazione può lasciare tanto più sorpreso l’osservatore straniero, in quanto posto a confronto con l’unico esempio di forma di governo direttoriale esistente al mondo197. Il Consiglio federale infatti non si configura come una magistratura di ministri subordinati al presidente in carica, bensì 196 197 Ivi, p. 187. A. Barbera, C. Fusaro, Il governo delle democrazie, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 101-105. V. Nava, La Costituzione 97 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 come un collegio di Capi di Stato il cui presidente, generalmente scelto a rotazione fra i sette membri designati, è nella pratica unicamente un primus inter pares, dotato esclusivamente di poteri di rappresentanza, e dunque esente da funzioni di coordinamento e direzione198. I sette consiglieri gestiscono collegialmente tutti gli affari previsti dalla Costituzione, benché ognuno di loro presieda un dipartimento: ciò significa che le decisioni del Consiglio vengono deliberate da tutti e sette tramite voto di maggioranza e illustrate al parlamento dal consigliere preposto al singolo dipartimento competente, anche qualora quest’ultimo abbia espresso voto contrario199. L’adozione di un siffatto sistema di governo venne decisa scartando il sistema presidenziale suggerito dal medesimo Paese che aveva ispirato il bicameralismo elvetico, gli Stati Uniti d’America: Senza misconoscere i vantaggi che offrirebbe una presidenza per l’unità, per il seguito degli affari, per l’espressione della volontà nazionale e per la responsabilità dei funzionari, la commissione non poteva nemmeno pensare di proporre la creazione di una carica così contraria alle idee e alle abitudini della Svizzera, la quale avrebbe potuto scorgervi un avviamento verso la monarchia o la dittatura. In Svizzera, si preferiscono i Consigli. E il sentimento democratico nostro rifiuta qualsiasi preminenza troppo esclusiva. 200 Queste le parole di Druey riportate nel rapporto del 26 aprile 1848. La medesima riflessione può indurre a chiedersi perché, allora, non venne approvato l’emendamento volto ad impedire la reiterazione della carica di consigliere federale oltre due periodi elettorali, ma soprattutto a domandarsi il motivo per cui lo spirito democratico e avverso alle dittature non inducesse gli uomini del ’48 elvetico a porre un limite ulteriore al potere esecutivo attraverso l’introduzione del voto di sfiducia. A differenza delle forme di governo parlamentari infatti, l’esecutivo – che è anche collegialmente vertice dello Stato – non può essere fatto cadere dall’Assemblea federale, benché questa lo elegga, e un consigliere non può essere destituito durante la legislatura201. Ebbene, le spiegazioni relative alla peculiarità del governo elvetico vanno ricercate nei trascorsi e nelle tradizioni della Confederazione stessa: se il bicameralismo appariva quasi un esotismo agli occhi dei costituenti del 1848, affidare il potere esecutivo del Paese ad un collegio di magistrati eletti dal parlamento, ma al tempo stesso non soggetto a revoca, risultava invece la trasposizione naturale di quanto già avveniva a livello cantonale. Infatti, i Cantoni della Rigenerazione, a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento, U. Altermatt, “Consiglio federale” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. Ibidem. 200 W.E. Rappard, La Costituzione…, cit., p. 180. 201 A. Barbera, C. Fusaro, Il governo…, cit., pp. 101-105. 198 199 V. Nava, La Costituzione 98 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 avevano già provveduto a consacrare un simile modello di governo alla tradizione elvetica. Introdotto per la prima volta a San Gallo nel 1831 – Cantone composto non a caso da regioni tanto eterogenee – esso venne poi adottato da altri Cantoni su impulso di un radicalismo centralista e statalistico. Gli storici del diritto istituzionale svizzero, e in particolare Kölz, affermano che l’ispirazione al modello direttoriale venne loro dal diritto rivoluzionario francese202: il progetto costituzionale girondino e la successiva costituzione montagnarda del 1793 avevano sperimentato infatti, per la prima volta in Europa, un governo strettamente collegiale, il quale trovò ulteriore declinazione nel direttorio previsto dalla cosiddetta costituzione dell’anno terzo, promulgata nell’agosto del 1795203. I Cantoni della Rigenerazione, facendo proprio il sistema francese del 1795, non discussero nemmeno l’introduzione di un esecutivo di tipo parlamentare, che avrebbe consentito la destituzione del governo da parte del Gran consiglio204. Secondo Kölz, le ragioni vanno ricercate nel fatto che il sistema di governo parlamentare – non ancora pienamente sviluppato e consolidato in Europa – se assunto dai Cantoni della Rigenerazione, sulla base degli esempi storici contemporanei di Francia e Inghilterra205, avrebbe previsto la nomina di un primo ministro, di un Capo di governo responsabile, ed era appunto ciò che si voleva evitare: landamani e borgomastri avevano conquistato un potere personale troppo forte nel periodo della Restaurazione 206. Il modello direttoriale quindi, per la sua natura atto ad evitare eccessive concentrazioni di potere, si era già rivelato il più adatto ai governi di tipo liberale che avevano iniziato ad affermarsi a livello cantonale a partire dal 1830. L’elezione dei membri di governo da parte dei parlamenti cantonali, fra l’altro da sempre praticata nelle democrazie dei Cantoni primitivi, avrebbe inoltre ulteriormente vincolato il potere esecutivo subordinandolo al legislativo, A. Kölz, Le origini…, cit., pp. 248-249. Allo scopo di porre fine al governo delle commissioni parlamentari, che aveva portato al Terrore di Robespierre, la carta costituzionale francese del 1795 previde più specificatamente un sensibile indebolimento del parlamento a fronte di un rafforzamento del potere esecutivo, il quale trovava comunque un limite nella sua configurazione collegiale, prevedente la nomina di cinque membri dal mandato limitato nel tempo, i quali avevano alle proprie dipendenze da sei ad otto ministri. 204 Ossia, ricordiamolo, l’istituzione parlamentare cantonale. 205 L’esempio estero infatti poteva fornire solo due modelli di questo tipo: il parlamentarismo orleanista, di Francia, prevedeva un governo che doveva reggersi sulla fiducia della Camera dei deputati ma anche del re, e l’esempio inglese, il cui sistema parlamentare, seppur formalmente indipendente dalla volontà del sovrano, si sarebbe consolidato solo successivamente; A. Kölz, Le origini…,cit., pp. 248-249. 206 Ibidem. 202 203 V. Nava, La Costituzione 99 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 secondo un principio di separazione dei poteri limitato che aveva anch’esso la propria matrice nei fatti rivoluzionari di Francia, in particolare nel modello costituzionale montagnardo del 1793207. Alla luce di queste informazioni, che cos’è allora il Consiglio federale se non la trasposizione sul piano nazionale di un istituto da tempo familiare ai Cantoni? I costituenti del ’48 decisero di appellarsi alle proprie tradizioni, configurando un esecutivo forte, dotato di stabilità nella misura in cui era sganciato dal voto di fiducia dell’Assemblea federale ma pur sempre da questa eletto, e non incline all’abuso di potere che un sistema presidenziale avrebbe potuto prefigurare208. Il tempo avrebbe dato loro ragione in occasione degli sviluppi verificatisi di lì a poco in Francia: i moti rivoluzionari del 1848 avrebbero lasciato in eredità una costituzione che prevedeva un potere esecutivo delegato ad un presidente eletto dal popolo ogni quattro anni. È noto che la carica venne assegnata al principe Luigi Napoleone, il quale, quattro anni dopo, pose fine alla Seconda repubblica francese con un plebiscito che gli conferì poteri dittatoriali. Il Tribunale federale Per ragioni di completezza è opportuno accennare anche al terzo ed ultimo degli organi di governo sanciti dalla Costituzione del 1848: il Tribunale federale. Gli articoli che ne prescrivono il funzionamento209, stabiliscono anzitutto che “Vi è un Tribunale federale per l’amministrazione della giustizia in quanto essa cade nella competenza della Confederazione. Per giudicare e sentenziare dei delitti sono istituiti dei Tribunali di giurati (Jury).” Ciò non significa altro che, come le disposizioni costituzionali rendono chiaro, che il Tribunale federale ha competenze solo in materia di diritto privato e penale. Più precisamente, in ambito civilistico esso giudica sia le controversie fra i Cantoni, sia quelle che insorgono tra gli stessi e la Confederazione che non vengono definite di diritto pubblico, ma solo qualora il Consiglio federale lo ritenga opportuno. Nel momento in cui quest’ultimo ritenga che la questione non sia di spettanza dell’organo giudiziario della Confederazione o sia indeciso in merito, l’oggetto della contesa viene risolto dall’Assemblea federale. Nella misura in cui la questione è di importanza tale da rientrare nelle competenze della legislazione federale, il Tribunale si occupa altresì delle controversie insorte tra la Confederazione, da una parte, e le corporazioni o i soggetti privati dall’altra210. Ibidem. O. Sigg, Die politischen Institutionen der Schweiz, Zürich, Ed. Pro Helvetia, 1983, p. 39. 209 Dal numero 94 al numero 107. 210 Articolo 101. 207 208 V. Nava, La Costituzione 100 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 In ambito penale invece, la Corte è incaricata di giudicare, con il concorso di una giuria, i casi di alto tradimento contro le autorità federali e i reati politici, oltre che i funzionari statali accusati di infrazioni di natura penale 211. Sulle sentenze l’Assemblea federale ha comunque la facoltà di praticare il diritto di grazia212. La stessa decide se rimettere al giudizio del Tribunale le controversie concernenti la violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione federale 213. Di più: si pose nelle mani del Consiglio e dell’Assemblea federale la realizzazione effettiva dei diritti di libertà e di eguaglianza giuridica nei Cantoni 214. Più precisamente, venne stabilito che solo il parlamento della Confederazione ha la facoltà di decidere se è stata commessa un’eventuale infrazione del diritto costituzionale e di stabilire se un simile caso debba ricadere tra le competenze del Tribunale, consacrando in questo modo l’Assemblea al ruolo di una sorta di Jury215. La preminenza che si volle conferire al potere legislativo è riscontrabile altresì nella nomina da parte del parlamento dei giudici del Tribunale216, i quali possono essere scelti anche fra i non giuristi e tra le stesse fila dell’Assemblea federale, ma non tra quelle del potere esecutivo. Per i giudici inoltre non è previsto un onorario fisso dalla Cassa federale ma solo un indennizzo a giornata217. Come nelle costituzioni cantonali del periodo della Rigenerazione vigeva quindi la convinzione che l’indipendenza della giustizia potesse essere minacciata unicamente da un collegamento personale con l’esecutivo. Perciò si volle limitare il potere dei giudici subordinando il potere giudiziario – oltre a quello esecutivo – al potere legislativo, configurando così uno squilibrio fra i poteri che, mettendo in pratica le teorie di Rousseau, rifiutava al contempo quelle di Montesquieu218. Rappard è del parere che un confronto fra l’assetto giudiziario elvetico del 1848 e le corti supreme di molti Paesi esteri, in particolar modo del mondo anglosassone, lasci poco spazio a valutazioni positive. Lungi dal configurarsi come un tribunale supremo guardiano delle libertà costituzionali dei cittadini e Articolo 104. Articolo 104. 213 Articolo 105. 214 W. Brüschweiler, “Tribunale federale” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 215 Si veda anche l’articolo 74 che definisce le competenze dell’Assemblea federale. 216 Il numero di membri dell’autorità giudiziaria è fissato a sette – a cui si aggiungono i supplenti – eletti dall’Assemblea federale per la durata di tre anni; Articoli 95 e 96. Spetta altresì all’Assemblea la designazione del Presidente e del Vice-presidente del Tribunale, scelti tra i membri dello stesso; Articolo 98. 217 Articolo 99. 218 Si veda, ad esempio, la costituzione montagnarda del 1793. Cfr. A. Kölz, Le origini…, cit., pp. 60-71. 211 212 V. Nava, La Costituzione 101 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 istanza di ricorso contro le decisioni degli enti giudiziari cantonali, il Tribunale federale finì per essere concepito come organo subordinato219. In effetti, è possibile evincere dallo stesso testo costituzionale che il potere giudiziario, nello spirito della Commissione che ne elaborò il progetto, non si doveva configurare come una corte permanente di giustizia composta da magistrati di carriera, e tantomeno come una corte suprema votata a tutelare i cittadini dagli abusi di potere commessi dalle autorità; non venne predisposta nemmeno per vegliare sul rispetto della Costituzione. L’amministrazione della giustizia restava per lo più ai Cantoni, “sotto riserva delle competenze del Tribunale federale220”; tutte le controversie relative al diritto pubblico rimasero di competenza delle autorità politiche. Ciò poiché nei propositi di coloro che elaborarono gli articoli costituzionali vi era in primo luogo la preoccupazione di gettare le fondamenta di un edificio giudiziario che il legislatore avrebbe dovuto erigere successivamente 221. Se non altro, le discussioni relative all’istituzione del Tribunale federale diedero occasione a parecchie delegazioni alla Dieta di formulare proposte molto ambiziose concernenti l’unificazione del diritto: specialmente i rappresentanti dei Cantoni Berna e Soletta ne preconizzarono l’attuazione in ambito commerciale e penale222. I tempi, però, non dovevano essere ancora maturi, se tutte le proposte in merito vennero scartate a fortissima maggioranza, naturalmente in nome della sovranità cantonale. L’istituzione del Tribunale federale non si configurò dunque come il più efficiente fra gli organi di governo, ma rivestì un’importanza capitale nella misura in cui portò alla creazione di un’autorità giudiziaria di cui la Confederazione era stata fino a quel momento praticamente sprovvista 223. Ponendo rimedio alla più evidente lacuna del Patto federale, il testo costituzionale del 1848 gettò inoltre le basi per la giurisdizione federale che avrebbe conosciuto nuovi sviluppi negli anni a venire. Prima di approfondire i risultati delle votazioni cantonali alla Costituzione del 1848, vorremmo formulare alcune osservazioni di carattere generale circa la genesi del testo costituzionale appena esaminato. Alla luce della dinamica di interazione e scontro fra tendenze unitarie e istanze federaliste emersa più volte nella redazione dei singoli articoli costituzionali, è lecito domandarsi come e in quale misura questi orientamenti W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., pp. 187-188. E.R. Papa, Storia della Svizzera…, cit., p. 200. 221 W. Brüschweiler, “Tribunale federale” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 222 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 401. 223 J.F. Aubert, Petite histoire constitutionnelle…, cit., p. 34; W. Brüschweiler, “Tribunale federale”, cit. 219 220 V. Nava, La Costituzione 102 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 politici finirono per caratterizzare l’opera nel suo complesso. In altre parole, la vittoria fu della componente liberal-radicale votata all’“unitarismo” – inteso sempre come affermazione del principio unitario all’interno di un assetto federale – a maggioranza protestante, rappresentata per lo più nei grandi Cantoni industrializzati, o dei “federalisti” – difensori dell’assetto confederale – espressione di quell’orientamento conservatore che trovava la propria sede soprattutto nei piccoli Cantoni cattolici, agrari e di montagna? In primo luogo, è possibile constatare che la critica storiografica è unanime nell’affermare che la Costituzione del 1848 è opera di un compromesso fra le due parti224. Il carattere compromissorio del testo del 1848 risulta evidente anche da quanto scritto nelle precedenti pagine, dalle quali risulta che la redazione degli articoli vide i costituenti liberal-radicali frenati nei propri propositi accentratori da istanze federaliste e cantonali. La storiografia, però, sembra altrettanto generalmente concorde nel constatare che i protagonisti del 1848 elvetico furono, in definitiva, i liberalradicali, i promotori di uno Stato forte e centralizzato. Solo per citare alcuni esempi, Rappard, pur tenendo presente gli elementi federalistico-conservatori che inevitabilmente confluirono nel testo costituzionale, afferma chiaramente che la Costituzione del 1848 è opera del liberalismo politico ed economico e del radicalismo ugualitario e statalista. Kölz sostiene che l’aspirazione all’unità politica e costituzionale era espressione soprattutto della fazione radicale dei costituenti, che nei loro intenti riuscì a coinvolgere anche i liberali, in misura sufficiente da arginare le forze conservatrici e particolaristiche del Paese225. Papa, pur considerando che l’elemento conservatore-illuminato riuscì a contenere il nuovo verbo liberal-democratico, definisce la Costituzione del 1848 un’opera di carattere liberale226. Lacché afferma addirittura che “la Costituzione del 1848 resta la costituzione dei radicali vincitori227”. La disamina del testo costituzionale e dei dibattiti che si svolsero per redigerlo, svolta nelle precedenti pagine, sembra consolidare – ma lo vedremo, solo in parte – il giudizio degli studiosi. Il mutamento costituzionale dal Patto del 1815 alla carta del 1848 è certamente grande. È un dato di fatto che la Costituzione del 1848 riuscì nell’istituzione di uno Stato più forte e centralizzato nella misura in cui limitò la sovranità cantonale subordinandola all’unitario potere federale. L’autorità centrale ne uscì rafforzata non solo grazie all’ampliamento delle sue competenze in ambito militare, economico e di A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 429; W. Martin, Storia della Svizzera..., cit., p. 230; E.R. Papa, Storia della Svizzera…, cit., p. 192; L. Lacché, Una “mobile complessità”…, cit., p. 11. 225 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 429. 226 E.R. Papa, Storia della Svizzera…, cit., pp. 192 e 194. 227 L. Lacché, Una “mobile complessità”…, cit., p. 12. 224 V. Nava, La Costituzione 103 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 politica estera, ma anche mediante l’istituzione e la definizione dell’Assemblea e del Consiglio federale, che andarono a sostituire l’antica e debole Dieta. Questi mutamenti assecondarono, almeno in parte, i propositi liberal-radicali tendenti all’unitarismo e al rafforzamento dell’autorità federale. Le aspirazioni di quell’orientamento politico vennero soddisfatte anche nella misura in cui il 1848 vide la costituzionalizzazione di alcuni importanti diritti e libertà dei cittadini e l’istituzione del principio di sovranità popolare attraverso l’elezione dei deputati al Consiglio nazionale. In definitiva, senza l’apporto degli esponenti liberal-radicali, non vi sarebbe stata alcuna transizione da Confederazione di Stati a Stato federale. Ma la prospettiva potrebbe mutare se assunta dal medesimo punto di vista dei “vincitori”. Infatti, Rappard ci informa che il risultato delle riforma federale non suscitò nella stessa parte di popolazione liberal-radicale che l’aveva sostenuta il medesimo entusiasmo che ispira oggi allo storico imparziale228. Agli occhi dei fautori della revisione del Patto del 1815, definiti audacemente dall’autore “estremisti dell’epoca”229, il distacco dalle tradizioni del passato non parve abbastanza netto e coraggioso. Per loro il bicameralismo federale, che sanciva anche la rappresentanza cantonale accanto a quella nazionale, decretava la sconfitta della sola affermazione della sovranità popolare; la centralizzazione compiuta attraverso l’opera costituzionale fu troppo limitata; la costituzionalizzazione dei principi liberali, troppo timida 230. Costituenti come Ochsenbein, Furrer, Kern e Druey, i quali, lo abbiamo visto, pur appartenendo decisamente all’orientamento liberal-radicale, dovettero dar prova di moderazione nell’elaborazione del progetto, si trovarono quindi a dover difendere la propria opera davanti allo scontento dei propri concittadini e dei colleghi dei parlamenti cantonali. Lo fecero presentando la nuova Costituzione come un compromesso, quasi un ripiego, necessario però al compimento futuro delle proprie ambizioni centralisticoprogressiste231; individuando il proprio merito soprattutto nell’opportunità ora ottenuta di nuovi mutamenti e ulteriori revisioni costituzionali. W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 139. Ibidem. 230 Le riserve verso una riforma federale giudicata eccessivamente moderata e federalista vennero espresse soprattutto dalla componente liberal-radicale della Svizzera germanofona, e specialmente nel preminente Cantone Vorort di Berna, ma anche, e in particolare, nel francese Canton di Vaud. 231 Ibidem. A questo proposito, si ricorderà infatti che se i costituenti più progressisti finirono per accettare il compromesso nella redazione del progetto costituzionale, fu anche per la convinzione che il tempo avrebbe lavorato a loro favore: il dinamismo caratterizzante l’elemento popolare, che si sarebbe espresso attraverso il Consiglio nazionale, avrebbe finito a 228 229 V. Nava, La Costituzione 104 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Ciò poiché, per i liberal-radicali, se la meta da raggiungere non era l’istituzione di un vero e proprio Stato unitario sul modello francese, che eliminasse completamente i Cantoni, rimaneva comunque un accentramento molto più deciso di quello attuato, in grado per esempio di eliminare la rappresentanza cantonale nelle istituzioni di governo232. A questo proposito, le parole pronunciate da Druey il 26 aprile 1848 appaiono emblematiche: […] se la Svizzera non si trova più nella situazione di quando venne redatto il Patto del 1815, non è però ancora in quella che presupporrebbe il regime unitario, una nuova Repubblica elvetica. Infatti, per adempiere al proprio scopo e per non essere un federalismo bastardo, una repubblica una e indivisibile dovrebbe eliminare i Cantoni per far posto ad un unico governo […] Giungerà la Svizzera, più tardi, al regime unitario? […] è possibile. 233 L’approfondimento che abbiamo svolto sul testo del 1848 e relativamente ai dibattiti che intercorsero per scriverlo può essere d’aiuto per comprendere il punto di vista dei liberal-radicali. Può essere utile, altresì, per non sottovalutare la misura in cui le istanze federaliste e conservatrici finirono per caratterizzare la nuova Costituzione. Nel fare ciò prendiamo anche atto dei pareri espressi da Hilty e Roca, i quali – uniche voci fuori dal coro fra gli storici della Costituzione del 1848 – nei loro studi mostrano di tenere maggiormente in considerazione gli elementi “federalisti” del testo costituzionale. Più precisamente, Hilty li rileva constatando che la via verso la centralizzazione sarebbe stata perseguita con maggior decisione nelle riforme costituzionali successive, in particolare in quella del 1874. Secondo Hilty, paragonata a questa, la divisione della sovranità fra la Confederazione e i Cantoni attuata con la revisione del 1848 “sgraziatamente, taglia per metà certe istituzioni” lasciando troppe competenze ai Cantoni, “difetti” che “parvero allora di poco conto”234. Roca invece avvisa della necessità di completare la visione unilaterale che tende ad attribuire a liberali e radicali i meriti di ogni conquista costituzionale 235. Lo fa constatando che le istanze conservatrici contribuirono “a ostacolare una soluzione centralista e altri sconvolgimenti rivoluzionari, auspicati dai radicali”236. Dunque, individuare tutti gli ambiti entro cui la volontà federalista e conservatrice riuscì ad affermarsi o, quantomeno, seppe compromettere quella più unitaria di matrice liberal-radicale, può confermare questa ipotesi. A partire dal titolo e dal preambolo del testo costituzionale, si è visto che le istanze loro avviso per vincere la staticità insita nel volere cantonale rappresentato dal Consiglio degli Stati. 232 W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 139. 233 Ivi, p. 176. 234 C. Hilty, Le costituzioni federali della Svizzera…, cit., p. 367. 235 R. Roca, “Sonderbund” in AA.VV., Dizionario storico…, cit. 236 Ibidem. V. Nava, La Costituzione 105 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 federaliste ebbero ragione delle proprie convinzioni ottenendo di designare il territorio elvetico con la dicitura ufficiale di “Confederazione svizzera”, non “Stato federale” e tantomeno “nazione”237. In omaggio alle tradizioni storiche, la Svizzera dovette quindi continuare a presentarsi al mondo come una Confederazione, una Lega – altro termine citato nel preambolo – di Cantoni. E proprio i Cantoni vennero presentati dall’articolo 3 come principale soggetto di interazione con l’autorità centrale. È la loro sovranità – seppur ora molto limitata rispetto al Patto del 1815 – che viene precisata all’interno della Costituzione, e non quella del popolo, come avrebbero voluto i liberal-radicali. Per quel che concerne gli articoli destinati ad organizzare l’esercito della Confederazione, si è potuto constatare che la riforma finì per configurarsi molto moderata rispetto alle aspettative: l’autonomia cantonale si impose nel decidere che alla Confederazione doveva spettare solo l’istruzione dei quadri superiori dell’esercito e la supervisione dell’addestramento delle truppe, la cui gestione diretta rimaneva, quindi, tra le competenze dei Cantoni. Inoltre, aspetto assai importante, alla Confederazione non venne conferita quasi nessuna competenza di polizia. La centralizzazione di dazi e dogane riuscì invece in modo molto più compiuto, ma solo in seguito a lunghi dibattiti e assicurando ai Cantoni il dovuto indennizzo. I provvedimenti relativi all’istruzione sono poi ancora più indicativi delle vittorie talvolta effimere conseguite dai politici liberal-radicali: l’istituzione di una università federale venne approvata solo con una debole maggioranza e, come sappiamo, mai in seguito attuata. In definitiva, ai Cantoni continuò a spettare la gestione dell’intero ordinamento scolastico elementare e superiore. Per quel che attiene alle infrastrutture invece, nonostante i progressi relativi ad un ampliamento delle competenze federali, ai Cantoni rimase comunque l’importante gestione del sistema ferroviario. Anche la libertà di domicilio, uno dei principali cavalli di battaglia degli unitari, poté essere assicurata solo a prezzo di grandi compromessi. A questo proposito, l’articolo 42, concernente la dichiarazione di nazionalità svizzera per tutti gli abitanti dei Cantoni, scatenò la resistenza dei federalisti conservatori, i quali ottennero che il cittadino svizzero potesse esercitare i diritti politici nel nuovo Cantone di residenza solo dopo una dimora prolungata non inferiore a due anni. La libertà di religione venne promulgata solo attraverso una locuzione vaga e poco articolata, poiché soprattutto la parte di popolazione cattolica e di orientamento conservatore non sarebbe stata pronta a riconoscere una libertà di culto generalizzata, come avevano invece fatto molti Cantoni Seppur quest’ultimo termine riuscì a farvi la sua comparsa nel preambolo della Costituzione, ma in modo giuridicamente non vincolante; A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 401. 237 V. Nava, La Costituzione 106 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 liberal-radicali della Rigenerazione sancendo questo principio all’interno dei propri ordinamenti. In generale, tutto ciò che attiene all’ambito ecclesiastico, come la gestione dei conventi, rimase di competenza cantonale. Inoltre, per quel che concerne il sistema bicamerale del parlamento elvetico, non solo i federalisti ottennero il mantenimento della rappresentanza cantonale accanto all’istituzione della nuova rappresentanza nazionale, ma si ricorderà che il principio secondo cui le due camere deliberano separatamente – per lo meno sulla maggior parte degli oggetti – era volto a tutelare la volontà dei Cantoni, la quale, in caso di delibera in seduta comune, sarebbe stata schiacciata da quella della rappresentanza nazionale, più forte grazie al maggior numero dei componenti del Consiglio nazionale. I sostenitori della preminenza del Cantone sulla componente nazionale, per di più, ebbero la meglio ottenendo che le elezioni del Consiglio nazionale avessero luogo basandosi su circoscrizioni cantonali, e non mediante un’unica circoscrizione elettorale estesa a tutta la Confederazione, come avrebbero voluto i radicali. Infine, all’autorità cantonale rimaneva buona parte dell’amministrazione della giustizia. Le proposte progressiste relative all’unificazione del diritto in ambito commerciale e penale vennero respinte; quelle relative alla tutela del cittadino da abusi commessi dall’autorità cantonale furono scartate, risolvendo che la giurisdizione interna restava riservata ai Cantoni quale attributo della loro sovranità. Ebbene, lo scotto che i promotori della riforma del Patto del 1815 dovettero pagare per poterla attuare, quindi, non fu lieve. Le considerazioni svolte fin qui inducono a non sottovalutare il grande ruolo giocato dalle istanze federaliste e conservatrici, e a usare maggior cautela nel proclamare vincitori gli esponenti di orientamento liberal-radicale. Vittoriosi essi lo rimangono senz’altro alla luce del fatto che loro fu la volontà di riformare il Patto del 1815, e riuscirono a portarla a compimento. I protagonisti della scena fin dagli Trenta dell’Ottocento, con le riforme costituzionali dei Cantoni nel periodo della Rigenerazione rimangono loro. Fosse stato per i conservatori federalisti l’esistenza della Confederazione avrebbe dovuto continuare ad essere regolata dal Patto federale del 1815. Liberali e radicali riuscirono a compiere l’impresa di creare uno Stato più forte e centralizzato attuando una Costituzione che può essere senza dubbio definita di stampo liberale. Ma anche fortemente federale. La Costituzione del 1848 regola pur sempre l’esistenza di un Stato di tipo federativo che lascia ampie autonomie ai Cantoni. Grazie alla voce degli esponenti maggiormente votati al rispetto delle tradizioni, al mantenimento dell’antica sovranità dei Cantoni, la rottura definitiva con il passato non venne operata. V. Nava, La Costituzione 107 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 4. Votazione ed entrata in vigore della nuova Costituzione Per entrare in vigore, il progetto costituzionale destinato ad attuare la transizione da Confederazione di Stati a Stato federale doveva essere approvato. Si ritenne che una decisione di tale importanza, implicante un mutamento storico di così vasta portata, necessitasse di una legittimità salda, che le si volle conferire sottoponendo il progetto prima al voto dei rappresentanti cantonali alla Dieta, poi al vaglio della doppia volontà della popolazione e dei Cantoni. Il conteggio a consultazione avvenuta fu dunque duplice: popolo e Cantoni. Di questi dati dovette poi prendere atto la Dieta, cui nuovamente, e in ultima istanza, spettò la parola per decretare la riuscita o il fallimento della missione che un anno prima si era prefissata di portare a termine. Alla Dieta, dopo aver emendato il progetto della Commissione, la votazione finale del testo costituzionale si svolse il 27 giugno 1848. Approvarono la Costituzione, con la sola riserva della ratifica popolare, tredici Cantoni: Zurigo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Glarona Grigioni, Argovia, Turgovia, Ginevra, Lucerna, Zugo, Friburgo e Vallese. I delegati di Vaud, Neuchâtel e Appenzello Esterno, pur non manifestando deliberatamente un voto contrario, tergiversarono dichiarando che preferivano pronunciarsi dopo aver sottoposto ulteriormente “i progetti ai loro governi” e, in definitiva, al giudizio popolare. Il delegato ticinese non approvò il testo costituzionale 238, e il voto favorevole del semi-Cantone Basilea campagna non poté essere conteggiato, poiché l’altra sua metà, Basilea città, aveva espresso un parere contrario. Anche l’importantissimo Cantone Vorort di Berna non approvò, poiché ritenne che la nuova Costituzione fosse troppo poco improntata all’unità, e perché non era stata elaborata da un vero consiglio costituente. Ma i Cantoni che opposero un netto rifiuto al testo costituzionale furono i notoriamente “federalisti” e conservatori Uri, Svitto, Untervaldo e Appenzello Interno. I loro delegati dichiararono che “non approvavano il progetto e che i rispettivi Cantoni si riservavano tutti i diritti religiosi, politici e materiali” 239. Però si impegnarono, anch’essi, a sottoporlo al giudizio dei loro cittadini 240. Dunque, ricapitolando, nell’agosto del 1847 la Dieta aveva risolto di riformare il Patto del 1815 attraverso il voto di tredici Cantoni – ossia tutti, tranne Basilea Città e Neuchâtel (che avevano deciso di rimanere neutrali rispetto alle vicende della guerra del Sonderbund) e naturalmente i sette Infra. W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 141. 240 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 426; W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 141. 238 239 V. Nava, La Costituzione 108 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Cantoni della Lega separata – ed ora, a quasi un anno di distanza, nuovamente tredici voti approvavano il risultato di quella riforma. I numeri sono i medesimi, eppure qualcosa, negli equilibri all’interno della Dieta, era mutato. Fra i Cantoni Zurigo, Berna e Vaud, i cui esponenti durante i lavori costituenti si erano rivelati i più progressisti e arditi fautori della riforma, solo Zurigo approvò il progetto finale con convinzione. Il rifiuto del fondamentale Canton Berna rivela una disapprovazione pressoché totale. Inoltre, fra i tredici votanti che approvarono il nuovo testo costituzionale figurano anche Lucerna, Zugo, Friburgo e Vallese: notoriamente conservatori, storicamente schierati con gli altri Cantoni agrari e cattolici della lega separatista. Il voto affermativo di questi territori è spiegabile alla luce della rinnovata composizione della classe politica ora al potere, tendenzialmente progressista, che si era collocata al governo dopo la sconfitta del Sonderbund. In ogni caso, la maggioranza alla Dieta era stata raggiunta, si trattava ora di verificare se il voto delle autorità cantonali, appena pronunciato dai delegati alla Dieta, avrebbe trovato conferma in quello espresso dal popolo dei Cantoni. In vista delle votazioni popolari cantonali si svolsero nuovi dibattiti all’interno dei Cantoni. È in questa occasione che si verificò un colpo di scena: il bernese Ochsenbein ebbe la soddisfazione, il 19 luglio 1848, di veder mutare la precedente posizione del Gran consiglio e il parlamento cantonale raccomandare al popolo l’adozione del testo costituzionale con 146 voti contro 40241. La Dieta si riunì il 4 settembre 1848: era la sua ultima sessione. Nel rapporto del Cantone direttore, i suoi membri trovarono le indicazioni relative alle consultazioni popolari che avevano appena avuto luogo, fra il 5 agosto e il 3 settembre242. I risultati si rivelavano molto positivi per la maggioranza liberalradicale della Dieta243. Infatti, ben quindici Cantoni avevano annunciato l’approvazione del testo costituzionale mediante consultazione popolare, attraverso voto segreto o voto in Landsgemeinde244. Questi Cantoni erano: Zurigo, Berna, Lucerna, Glarona, Soletta, Basilea città e campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, San Gallo, Argovia, Turgovia, Vaud, Neuchâtel, e Ginevra. Il rapporto riportava le cifre – relative al numero di voti a favore e contro la riforma – per ogni Cantone che si era espresso positivamente sul progetto costituzionale: Ivi, p. 145. R. Ruffieux, “La Svizzera dei Radicali (1848 – 1914)”, cit., p. 10. 243 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 426. 244 Dunque per alzata di mano. 241 242 V. Nava, La Costituzione 109 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Voti favorevoli contrari Zurigo 25.119 2.517 Berna 10.972 3.357 Lucerna 15.890 11.121 Soletta 4.599 2.834 Basilea Campagna 3.699 431 Basilea Città 1.364 186 Sciaffusa 4.273 1.107 San Gallo 16.893 8.072 Grigioni - - Argovia 20.699 8.744 Turgovia 13.384 2.054 - - 15.535 3.535 Neuchâtel 5.481 304 Ginevra 2.984 653 Ticino Vaud Tuttavia, a Friburgo fu il Gran consiglio ad approvare la costituzione “in nome del popolo”. Ironia della sorte, proprio il governo progressista instaurato a Friburgo decise di rubare la parola ai suoi concittadini. Se questi avessero potuto esprimersi, con ogni probabilità non avrebbero manifestato il medesimo parere. Le forzature nelle consultazioni popolari non si limitarono al caso friburghese. Infatti, l’approvazione di Lucerna, che alla lettura dei numeri lascia stupiti, non poté essere tenuta in considerazione che con riserva245, in quanto il governo liberale di quella città-Cantone aveva conteggiato i non votanti alla stregua di votanti a favore. In realtà, Lucerna avrebbe respinto il progetto costituzionale, poiché i 15.000 voti a favore comprendevano circa 10.000 voti di cittadini che non avevano in realtà espresso il proprio parere, mentre i voti esplicitamente contrari ammontavano a 11.121246. Dunque per due di quei quattro Cantoni (Friburgo, Lucerna, Vallese e Zugo) che alla Dieta avevano manifestato un parere che era più espressione della volontà delle autorità 245 246 Infra. A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 428. V. Nava, La Costituzione 110 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Cantonali – rinnovate, lo abbiamo detto, in seguito alle sorti della guerra della Sonderbund – che delle reali istanze del popolo la forzatura venne reiterata. Per quel che concerne gli altri voti positivi riportati in tabella, è anzitutto possibile affermare che il popolo dai governi maggiormente radicali, soprattutto quello di Berna, si dimostrò più soddisfatto e convinto dell’operato dei costituenti di quanto avessero invece manifestato le autorità che avevano appena espresso il parere alla Dieta: Zurigo premiò il lavoro di Furrer con ben 25.119 voti favorevoli e solo 2.517 contrari. Il Canton Vaud con 15.535 contro 3.535. Numeri rivelatori non solo della fiducia riposta nei propri uomini di Stato, ma anche indicativi dell’effettivo orientamento politico delle popolazioni di quei Cantoni. La stessa cosa dicasi per i risultati conseguiti nel Canton Berna: i voti affermativi superavano di circa tre volte quelli negativi. Evidentemente, se Ochsenbein faticò tanto per persuadere i colleghi del parlamento cantonale della bontà del suo operato, riuscendo a volgere in positivo solo in un secondo momento la loro opinione, i suoi concittadini non furono altrettanto severi. Andrebbe forse tenuto in considerazione, però, un dato a cui la storiografia consultata non pare dare troppa importanza. Berna, Cantone agli occhi della stessa Dieta determinante nella consultazione popolare per l’alto numero dei suoi cittadini – pari a circa il doppio della popolazione di Zurigo – aveva espresso un totale di soli 14.329 voti, ben 13.304 in meno di quelli, appunto, di Zurigo: un’affluenza alle urne pari a solo il 19% degli aventi diritto al voto247. Gli altri Cantoni – Soletta, Basilea campagna, Sciaffusa, San Gallo, Argovia, Turgovia, Ginevra e Grigioni – che avevano deciso per la revisione del Patto del 1815 nell’agosto del 1847, esprimendosi poi altrettanto favorevolmente mediante i propri delegati alla Dieta qualche mese prima della consultazione popolare, riconfermarono tutti le medesime posizioni. A questi si aggiungeva l’approvazione del popolo di Basilea Città, in palese contrasto con l’atteggiamento del Gran consiglio di quel Cantone, la cui delegazione era stata istruita, ancora nel mese di giugno, a contrastare l’approvazione della nuova Costituzione. La contraddizione fra i due pareri è comprensibile alla luce del fatto che il voto espresso alla Dieta dal suo governo era espressione del patriziato che deteneva il potere politico, e non del resto della popolazione248. Anche Neuchâtel, che si era astenuto in occasione della votazione per decidere la riforma del Patto del 1815 nell’agosto del 1847, ma che aveva già espresso un parere positivo in relazione al progetto costituzionale alla Dieta, 247 248 R. Ruffieux, “La Svizzera dei Radicali (1848 – 1914)”, cit., p. 10. A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 428. V. Nava, La Costituzione 111 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 diede la sua approvazione e con la percentuale di “sì” in assoluto più alta, pari al 95% del totale dei voti espressi. Il largo consenso al progetto di riforma è spiegabile considerando i risvolti politici che avevano nel frattempo interessato quel Cantone: caratterizzato dalla complessa condizione giuridica che lo vedeva essere ad un tempo Cantone e principato prussiano, tra la fine di febbraio e i primi di marzo, Neuchâtel aveva compiuto una rivoluzione che portando al potere la fazione schiettamente repubblicana del Cantone aveva permesso, nonostante le proteste del monarca, di prender parte ai lavori di Commissione, anche se solo nella sua fase finale249. Il rapporto ufficiale fornisce informazioni ancora più dettagliate riguardo ai voti contrari degli altri Cantoni, riportando, oltre alle cifre delle unità territoriali che si espressero con votazione popolare, le motivazioni avanzate dai Cantoni a Landsgemeinde. Nelle parole riprodotte dal rapporto ufficiale, Nidvaldo (Sottoselva) appellandosi all’autorevolezza conferitagli dal suo status di Cantone primigenio e originario, ribadì con forza l’essenza della natura svizzera, individuata nella libera associazione di Cantoni sovrani e nella partecipazione autentica agli antichi valori della patria, radicati nella devozione alla confessione cattolica. L’abdicazione imposta della totale sovranità cantonale, baluardo della quale era il principio dell’eguale rappresentanza cantonale alla Dieta, mal celava, secondo questo Cantone, una pericolosa tendenza al potere unitario, negazione in termini del principio fondamentale elvetico, e un attentato alla Chiesa cattolica 250. La nuova Costituzione riformata non poteva che essere rifiutata in modo deciso. I restanti Cantoni a Landsgemeinde - Uri, Appenzello Interno e Untervaldo (Sopraselva) - caratterizzati dal medesimo orientamento politico e confessionale, espressero la stessa posizione, ma in modo meno eloquente e M. Agliati, “Quadro europeo e svizzero del 1848” in Id. et al (a cura di), Il Cantone Ticino nel nuovo Stato Federale. 1848-1859, Dipartimento della pubblica educazione, Bellinzona, Edizioni di “Scuola Ticinese”, 1981, p. 5. 250Dal rapporto della Dieta: “La Landsgemeinde di Sottoselva, considerato che dai tempi più antichi a tutt’oggi le comunità svizzere sono state unite fra loro dai vincoli di una libera convenzione fra Cantoni sovrani, con uguali diritti di rappresentanza, e che per la sua stessa natura, una libera convenzione ha forza obbligatoria solo nel caso in cui le parti hanno aderito volontariamente, e che di diritto potrebbe venir modificata soltanto dal libero consentimento delle parti contraenti; considerato che il nuovo patto viola l’antico principio fondamentale della Confederazione svizzera, che sopprime quasi completamente la sovranità dei Cantoni e che non offre una garanzia sufficiente né alla Chiesa Cattolica[…], e che è di natura tale da non celare una tendenza al potere unitario; Considerato che lo Stato cattolico di Sottoselva è uno dei più antichi Cantoni sovrani della Confederazione […]decide conseguentemente di attenersi al Patto del 1815 e di rifiutare la Costituzione federale riformata così come è stata elaborata dalla Dieta dal 15 maggio al 27 giugno 1848; Dal rapporto della Dieta; W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 144. 249 V. Nava, La Costituzione 112 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 categorico, e in qualche caso lasciando prevedere la capacità di questi territori di adattarsi alla situazione e al volere espresso dalla maggioranza del popolo svizzero251. Infine, fra i voti negativi sono annoverabili anche quelli della popolazione del Canton Ticino, seppur in modo particolare. Infatti, nel suo rapporto ufficiale la Dieta dovette prendere atto che non solo i voti favorevoli erano pochi, ma che per di più erano subordinati alle condizioni enunciate dal Gran consiglio del Cantone italiano, il quale auspicò l’entrata in vigore della Costituzione solo a patto però che venissero modificate le disposizioni attinenti alla centralizzazione del sistema doganale, fondamentale risorsa di quel territorio. Pertanto la Dieta decretò che “poiché un’accettazione condizionata non è un’accettazione bensì l’equivalente di un rifiuto, i 1582 voti summenzionati non possono venire aggiunti dalla commissione a quelli dei veri aderenti252”. È anche possibile constatare che nei Cantoni che mediante i delegati alla Dieta non avevano espresso un parere realmente conforme alla volontà popolare, ma, come si è visto, a differenza di Friburgo e in parte di Lucerna, poterono far sentire la voce del popolo in quella seconda occasione, il verdetto dei cittadini smentì puntualmente il voto affermativo espresso dai propri rappresentanti a giugno. Le popolazioni di Zugo e Vallese infatti, seppur con una percentuale di voti negativi non elevatissima, rifiutarono infatti il progetto costituzionale. Riconfermando le medesime dinamiche che sono state rilevate anche precedentemente, e constando che le votazioni cantonali aiutano a far luce sulla variegata configurazione politico-culturale della Svizzera, è in generale possibile affermare che le combinazioni di variabili in grado di condurre ad un certo tipo di voto furono principalmente tre: la confessione prevalente nel dato Cantone, l’urbanizzazione e il grado della sua industrializzazione, ciò in accordo con Kölz253. Più precisamente, è possibile constatare che la percentuale di voti affermativi aumenta quanto più i singoli Cantoni risultavano industrializzati, quanto maggiore era la quota di popolazione di confessione protestante, e alta quella di urbanizzazione. Criteri di valutazione non assoluti e da considerare tenendo presenti le relative eccezioni e le peculiari sfumature di Ibidem; “La Landsgemeinde di Appenzello Interno si sarebbe pronunciata per il rifiuto dei progetti in discussione. Però, il governo di quel Cantone attende il comunicato ufficiale del risultato della votazione in tutti i Cantoni […] per poter sottoporre di nuovo i progetti alla Landsgemeinde. […]. La Landgemeinde [di Sopraselva], considerando che la nuova Costituzione federale arrecherebbe pregiudizio agli antichi diritti e alle libertà politiche e religiose, si era pronunciato per il rifiuto. Però, cedendo alla pressione implacabile (“unausweislichen Drang”) degli avvenimenti, si sottoporrebbero alla sua applicazione. 252 W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 146. 253 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 428. 251 V. Nava, La Costituzione 113 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 ogni Cantone, ma generalmente indicativi delle caratterizzazioni delle diverse aree del Paese. Nel Cantone Zurigo, per esempio, protestante e con un grado di industrializzazione elevatissima rispetto agli altri territori, la quota di voti favorevoli all’entrata in vigore del testo costituzionale ammonta a circa il 91% dei votanti. Nel Canton di Vaud, pure protestante ma meno industrializzato, la percentuale si abbassa all’82 %. Nonostante la presenza anche cattolica nel Canton Ginevra, i voti di approvazione alla costituzione rappresentarono ben l’82% del totale, ma il Cantone risultava fra i più urbanizzati della Confederazione254. Le variabili individuate per la determinazione del voto in merito alla nuova Costituzione federale possono valere anche per i Cantoni che respinsero il progetto. Quindi, più l’unità territoriale era caratterizzata da un economia essenzialmente agraria, da un basso grado di urbanizzazione e un’elevata componente cattolica, più l’ostilità alla revisione della Costituzione vi trovò conferma. Infatti, le percentuali di rifiuto risultano importanti per quel che concerne i montani Cantoni originari di Uri, Nidvaldo e Obvaldo, a cui si deve aggiungere Appenzello interno. Le Landsgemeinde di quei territori espressero un rifiuto massiccio che toccò maggioranze stimabili nel 96% dei votanti, praticamente un’opposizione totale255. Inoltre, fra i fattori che influirono sulla consultazione popolare vanno annoverati anche quelli economici e doganali: nei Cantoni dove, per la loro stessa collocazione geografica, predominavano gli interessi di frontiera, la tendenza al rifiuto del progetto costituzionale – in alcune zone rafforzata dalla componente ideologica del federalismo alpino – aveva avuto la meglio, tranne che a Basilea città e nei Grigioni. Questo è il caso, per esempio, del Cantone Ticino. Nell’accettazione della Costituzione, invece, non sembra aver influito in modo determinate il fattore linguistico: se il bilingue Friburgo vi trovò una popolazione essenzialmente ostile al progetto, Neuchâtel e Vaud vi espressero la percentuale più alta di voti favorevoli, e il Vallese registrò consensi quasi solo nella parte di territorio francofona. La predisposizione ad un assetto di tipo federativo e non confederativo espresso dalle aree francesi è indicativo del fatto che esse non esibirono il timore generalizzato di venir sopraffatte, in quanto minoranza linguistica, dalla maggioranza germanofona, una volta attuata quella costituzione pur votata all’accentramento. La medesima considerazione però non sembra però essere valida per la vera minoranza linguistica della Svizzera, quella rappresentata dall’italiano Canton Ticino. I dibattiti che si 254 255 Ibidem. Ibidem. V. Nava, La Costituzione 114 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 svolsero al Gran Consiglio e che verosimilmente influirono sul voto popolare rivelano l’inquietudine di essere soffocati da una maggioranza linguisticamente e culturalmente diversa256. Alle suddette considerazioni è possibile affiancare quella più generale secondo cui i Cantoni dell’Altopiano affermarono una tendenza progressista, la quale – oltre agli elevati gradi di industrializzazione, urbanizzazione e alla confessione prevalentemente protestante – può essere compresa anche alla luce dell’importanza assunta in quei territori dal regime rappresentativo già durante il periodo della Rigenerazione257. In un’opposizione che vide soventemente contrapposti piccoli e grandi Cantoni, come si è detto, l’isolamento della minoranza cattolica registrò talvolta delle eccezioni nei Cantoni contraddistinti da qualche frangia più liberale, come è possibile constatare, ad esempio, nel caso del Canton Soletta. Le popolazioni cantonali avevano dunque espresso la loro volontà, ma l’ultima parola in merito all’entrata in vigore del nuovo testo costituzionale era stata conferita alla Dieta258. La quale, attraverso una speciale commissione istituita per adempiere al delicato compito, si espresse con le seguenti parole: Se ci si accontenta delle indicazioni approssimative concernenti i cittadini che, il 13 e il 27 agosto hanno votato […] ne deriva, tenendo conto delle astensioni – che a Lucerna vennero assimilate ai voti affermativi – che dei 437.103 cittadini svizzeri circa aventi diritto di voto (cioè un quinto della popolazione totale), 241.642 – quindi più della metà – hanno preso parte alla votazione per la Costituzione federale. Circa 169.743 di questi, compresi Friburgo, si pronunciarono per la Costituzione e 71.899, compreso il Ticino, contro259. […] I risultati dello scrutinio straordinariamente favorevoli alla nuova Costituzione – la maggioranza preponderante della popolazione svizzera (quasi i sette ottavi) e oltre i due terzi dei Cantoni si sono pronunciati per essa – sono di natura tale da facilitare in modo particolare il compito della Dieta. Essa infatti non può far altro che dichiarare solennemente che la nuova Costituzione federale è stata adottata e che, d’ora in poi, essa è la legge fondamentale della Confederazione. 260 Risulta abbastanza evidente che la Dieta era propensa a far apparire il corpo elettorale leggermente più favorevole di quanto fosse in realtà. Nel Constatazione deducibile per esempio dalle parole pronunciate in Gran consiglio dal curato Calgari, il quale, sconsigliando l’approvazione del progetto costituzionale dichiarò che “per farsi intendere dai tedeschi sarebbe stato necessario saper tre lingue” e che “Noi siamo italiani, e gli altri Cantoni sono Tedeschi; e noi saremo quindi sacrificati”; Atti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, sessione straordinaria dell’agosto 1848; M. Agliati, “Il Gran consiglio ticinese di fronte alla costituzione federale del 1848” in Id. et al (a cura di), Il Cantone Ticino…, cit., pp. 8 e 10. 257 R. Ruffieux, “La Svizzera dei Radicali (1848 – 1914)”, cit., p. 10. 258 Supra, capitolo III. 259 W.E. Rappard, La Costituzione federale…,cit., pp. 147 e 149. 260 Ibidem. 256 V. Nava, La Costituzione 115 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 valutare la portata legale dei voti, infatti, aveva deciso di conteggiare fra quelli favorevoli i cittadini di Friburgo, il cui parere era stato in realtà deciso dal suo Gran consiglio. Inoltre, come rileva anche Kölz, il calcolo della Dieta era un po’singolare, oltre che audace: gli aventi diritto che avevano approvato erano soltanto 169.743, detratti i non votanti lucernesi, contro i 71.899 voti a sfavore. A tale cifra, la commissione era pervenuta attraverso il semplice conteggio della popolazione complessiva dei quindici Cantoni e mezzo nei quali la Costituzione era stata approvata, senza dedurre da essa, fra l’altro, i non aventi diritto, i voti contrari e i non partecipanti261. Secondo i calcoli presentati da Ruffieux, l’ottimistica proporzione presentata dalla Dieta di sette ottavi di popolazione accettante la costituzione si riduce, in una prospettiva più realistica, ad un rapporto di sette abitanti favorevoli su tre contrari. Con una partecipazione solo del 56% del corpo elettorale, a sua volta rappresentante il 19% della popolazione totale, la proporzione dei voti favorevoli risulta essere di circa il 40% e quella dei “no” di quasi il 15%; gli astensionisti formano il partito più significativo, circa il 45%262. Inoltre, in base ai dati – per quanto opinabili – riassunti nel rapporto della commissione, è legittimo chiedersi se fosse sufficiente la duplice maggioranza appena espressa dal voto del popolo e dei Cantoni per dichiarare l’abrogazione del Patto del 1815 e l’entrata in vigore della nuova Costituzione. Se nel rispondere a questa domanda si tiene conto delle disposizioni costituzionali sulle quali la Svizzera si reggeva ancora nel 1848, ossia quelle del Patto federale del 1815, probabilmente no. Il Patto infatti non conteneva alcuna norma di prescrizione per la sua revisione, e soprattutto era entrato in vigore grazie all’approvazione unanime di tutti i Cantoni. Queste furono precisamente le considerazione a cui si erano appellati i Cantoni conservatori fautori dell’assetto confederale fin dalla votazione, svoltasi nell’agosto dell’anno precedente, in relazione alla decisione di riformare il Patto. Esso era il frutto della concorde volontà di tutti i firmatari e quindi poteva essere emendato solo dalla loro unanime volontà. La tesi dell’unanimità, giuridicamente difficilmente contestabile, si ricorderà, era stata sostenuta anche dalle potenze estere, attraverso la nota inviata alla Dieta da Austria, Prussia e Francia. Ma, rinnegando ancora, un’ultima determinante volta, il principio di unanimità per la revisione della Costituzione, la Dieta e la sua commissione decisero di porre fine ad una controversia che si trascinava da anni, constatando che i risultati avevano comunque oltrepassato ogni previsione positiva, comprese quelle dei fautori più ottimisti della nuova Costituzione. Infatti, se 261 262 A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., p. 428. R. Ruffieux, “La Svizzera dei Radicali (1848 – 1914)”, cit., p. 10. V. Nava, La Costituzione 116 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 alla Dieta i rappresentanti di tredici Cantoni avevano accettato il progetto, il popolo lo aveva premiato alle urne con il voto affermativo di quindici cantoni e mezzo263. Fra questi, inoltre, vi erano quelli determinanti di Zurigo, Berna, Vaud, San Gallo e Argovia, che dal nuovo assetto costituzionale sarebbero stati chiamati a dare il maggior contributo economico-finanziario264. Forti di questi risultati, i membri della commissione proseguirono nel loro compito sottoponendo un progetto di decreto alla Dieta. Attraverso le seguenti parole la transizione da Confederazione di Stati a Stato federale veniva sancita definitivamente: LA DIETA FEDERALE […] decreta: Art. 1. LA COSTITUZIONE FEDERALE della Confederazione svizzera, adottata dalla Dieta nelle sedute dal 15 maggio al 27 giugno 1848, e sottoposta alla votazione in tutti i Cantoni, conformemente all’art. 1 delle disposizioni transitorie, è dichiarata solennemente accettata e riconosciuta come legge fondamentale della Confederazione svizzera. 265 Il decreto, recante la data del 12 settembre 1848, giorno a partire dal quale venne considerata in vigore la nuova Costituzione, fu approvato alla Dieta da una maggioranza di sedici Cantoni e due semi-Cantoni. Nella deliberazione che precedette il voto, i deputati di Uri, Svitto, Untervaldo, Zugo e Appenzello interno rinnovarono le loro riserve, ma si esonerarono dal votare contro il progetto. I delegati del Ticino e del Vallese, nonostante il rifiuto della Costituzione espresso dalla maggioranza popolare, unirono i loro voti a quelli dei colleghi favorevoli al decreto. Si giustificarono dichiarando che i loro Cantoni erano bendisposti ai principi fondamentali della nuova legge fondamentale, e che soltanto le disposizioni finanziarie di essa ne avevano determinato il rifiuto266. Anche i Cantoni più antichi, cattolici e tradizionalmente federalisti, seppero dimostrare dunque, seppur solo alla resa dei conti, una qualche capacità di compromesso in nome del sentimento di solidarietà verso la patria. La Costituzione del 1848, e la transizione da Confederazione di Stati a Stato federale, risultò dunque essere l’espressione della duplice volontà della maggioranza cantonale e popolare. La sua storia e l’assetto che essa configurò, a metà strada tra la Confederazione di Stati e lo Stato nazionale, furono il risultato dell’intrecciarsi di molteplici interessi ed istanze, di natura liberalMa si tengano sempre presenti i due casi speciali di Friburgo e Lucerna. Durante l’elaborazione delle disposizioni transitorie la Dieta aveva manifestato l’intenzione di decretare l’entrata in vigore della nuova Costituzione solo se quei Cantoni l’avessero approvata; A. Kölz, Le origini della costituzione…, cit., pp. 424-425. 265 W.E. Rappard, La Costituzione federale…, cit., p. 150. 266 Ibidem. 263 264 V. Nava, La Costituzione 117 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 radicale e conservatrice, di volontà federaliste e tendenti all’unità, di tradizioni cattoliche e riformate, di opposizioni che videro schierati su diversi fronti piccoli e grandi Cantoni, vecchia e nuova Confederazione. Dinamiche che videro, in definitiva, il mosaico dei differenti popoli abitanti i Cantoni ricomporsi, e trovare la propria strada in nome dei supremi valori di fedeltà alla patria e solidarietà nazionale. V. Nava, La Costituzione 118 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 BIBLIOGRAFIA AA.VV., Costituzione svizzera in edizione integrale: commenti alla Costituzione e cenni di storia svizzera nell’ambito dell’Europa contemporanea, Lugano, J. Juilland Editrice l’elicottero, 1975. AA.VV., Dizionario storico della Svizzera, Locarno, Armando Dadò Editore, 2002. Consultabile in edizione on-line all’indirizzo: http://www.hls-dhsdss.ch/?lg=i. Agliati M., “Quadro europeo e svizzero del 1848” in Agliati M. et al (a cura di), Il Cantone Ticino nel nuovo Stato Federale. 1848-1859, Bellinzona, Dipartimento della pubblica educazione, Edizioni di “Scuola Ticinese”, 1981, pp. 4-7. Agliati M., “Il Gran Consiglio ticinese di fronte alla costituzione federale del 1848” in Agliati M. et al (a cura di), Il Cantone Ticino nel nuovo Stato Federale. 1848-1859, Bellinzona, Dipartimento della pubblica educazione, Edizioni di “Scuola Ticinese”, 1981, pp. 8-14. Andreotti G., Ore 13: il Ministro deve morire, Milano, Rizzoli Editore, 1974. Aubert J.F., Traité de droit constitutionnel Suisse, Neuchâtel, Ed. Ides et Calendes, Voll. 1 e 2, 1967. Aubert J.F., Petite histoire constitutionnelle de la Suisse, Berna, Ed. Francke, 1979. Barbera A., Fusaro C., Il governo delle democrazie, Bologna, Il Mulino, 1997. Chabod F., L’idea di nazione, Roma-Bari, Laterza, 1974. Chevallaz G.A., Le Gouvernement des Suisses ou l’histoire en contrepoint, Lausanne, Éditions de L’Aire, 1989. Ducrest M., Dorand J.P., Stevan D., Vial J.C., Walter F., Histoire de la Suisse, Friburg, Editions Fragnière, 1984. Ghiringhelli A., Il cittadino e il voto: materiali sull’evoluzione dei sistemi elettorali nel Cantone Ticino. 1803-1990, Locarno, Armando Dadò Editore, 1995. Hilty C., Le costituzioni federali della Svizzera. Opera pubblicata in occasione del sesto centenario della prima alleanza perpetua del primo agosto 1291per incarico del Consiglio federale svizzero, Berna, Tipografia S. Collin, 1891. Knapp B., L’ordinamento federale svizzero, Torino, G. Giappichelli Editore, 1994. Kölz, A., Le origini della costituzione svizzera, Locarno, Armando Dadò Editore, 1999. Lacché L., “Costituzioni e federalismo nella Svizzera del XIX secolo”, in "I Viaggi di Erodoto", fasc. 25, vol. 9, 1995, pp. 130-143. V. Nava, La Costituzione 119 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Lacché L., Una “mobile complessità”: Costituzionalismo e democrazia nella Svizzera del XIX secolo, Barcellona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1999. Martin W., Storia della Svizzera. Con un’appendice di Pierre Béguin: la storia recente (1928-1977), Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1980. Papa E.R., Storia della Svizzera. Dall’antichità ad oggi. Il mito del federalismo, Milano, Bompiani, 1993. Rappard W.E., La Costituzione federale della Svizzera, Locarno, Carminati, 1948. Rappard W.E., Comment et pourquoi la Confédération Suisse est-elle devenue Etat fédératif en 1848. Conférence faite à la reprise des cours universitaires le 29 octobre 1947, Genève, Libraire de l’Université Georg, 1947. Rossi P., Per la Patria comune. Rapporto della Commissione della Dieta ai ventidue Cantoni sul progetto d’Atto federale da essa deliberato a Lucerna il 15 dicembre 1832, edizione a cura di L. Lacché, Manduria, Piero Licata Editore, 1997. Ruffieux R, “La Svizzera dei Radicali (1848 – 1914)”, in Broggini R. (a cura di), Nuova storia della Svizzera e degli svizzeri, Bellinzona, Casagrande, 1983, pp. 8-18. Sigg O., Die politischen Institutionen der Schweiz, Zürich, Ed. Pro Helvetia, 1983. Viviani Schlein M.P., “La Svizzera” in Bardusco A., et al (a cura di) Costituzioni comparate, Torino, G. Giappichelli Editore, 2009, pp. 67-108. V. Nava, La Costituzione 120 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Eugenio Colorni e la riflessione europeista nel Partito socialista italiano dagli anni Trenta alla Resistenza. di Giulia Vassallo Commentava Altiero Spinelli nella sua autobiografia, a proposito del suo primo incontro con Pietro Nenni: Eugenio [Colorni, ndr.] mi presentò a Nenni, che così vidi per la prima volta con la sua testa piccola, la bocca simile a quella di Paperino, gli occhi vivaci e penetranti, la voce dalle calde inflessioni romagnole. Gli parlai a lungo della necessità di prepararsi sin da ora a pensare in termini non solo di restaurazione democratica nazionale, ma anche di costruzione di un potere democratico europeo. Nenni ascoltava, annuiva e dichiarò infine di essere completamente d’accordo con noi. Uscendo dalla visita, Eugenio esultava: «Hai visto? Lo abbiamo pienamente convinto. Il partito socialista sarà federalista». Scrollai il capo incredulo. Se l’impostazione federalista, gli risposi, avesse fatto parte della tradizione culturale socialista, avrei compreso l’assenso facile e quasi automatico di Nenni. Ma non ne faceva parte, e mi sarei perciò atteso da lui un minimo di resistenza intellettuale, di riflessione critica, di discussione, prima di accettare. 1 Nell’ottica di chi scrive, tali affermazioni da un lato chiariscono la ragione al fondo del disimpegno socialista nei confronti dell’azione federalista, almeno per quanto riguarda i primi due decenni di storia comunitaria. Dall’altro riassumono le divergenze politiche che inquinarono – pur senza comprometterlo – il rapporto tra Colorni e Spinelli negli anni immediatamente successivi alla liberazione dal confino di quest’ultimo. Entrambi gli aspetti, per la centralità che rivestono nel precisare i contorni di una vicenda ancora sfumata, come quella degli apporti del socialismo al dibattito sull’Europa federale, meriterebbero ciascuno un approfondimento sistematico. Senza alcuna pretesa di esaustività, le pagine che seguono intendono offrire qualche spunto di riflessione, alla luce dei principali 1 Cfr. A. Spinelli, Come ho tentato di diventare saggio, Il Mulino, Bologna 1988, pp. 359-360. G. Vassallo, Eugenio Colorni 121 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 contributi storiografici in argomento e sulla base di alcuni documenti originali, reperiti sia tra i fondi dell’Archivio Centrale dello Stato, sia tra le carte dell’archivio della Fondazione Pietro Nenni. Gli Stati Uniti d’Europa nella riflessione socialista degli anni Trenta: un’attenzione più che incidentale Quanto alle connessioni tra socialismo italiano negli anni dell’esilio e federalismo europeo, occorre osservare che l’allusione di Altiero all’assenza di contenuti europeisti nella “tradizione culturale socialista” sembrerebbe scaturire dalla delusione del militante federalista per la mancata accoglienza delle proprie idee da parte di un determinato gruppo politico, piuttosto che essere fondata su inconfutabili dati di fatto. Non soltanto infatti, come ha recentemente osservato Francesco Gui2, l’espressione “Stati Uniti d’Europa” riecheggia già esplicitamente nell’ambito della prima Internazionale e, più precisamente, a Ginevra, nel 1867, al congresso per la pace presieduto dal socialista Giuseppe Garibaldi3. Ma soprattutto negli anni Trenta, quando il Psi vive una delle sue stagioni più drammatiche - lacerato da spaccature interne e incapace di trovare un modus vivendi con i comunisti che non soltanto sia praticabile, ma che più che altro metta d’accordo tutti all’interno del partito torna ad imporsi accanto all’imperativo della lotta antifascista. E certo non a caso. Gli anni dell’esilio e della cosiddetta Concentrazione, durante i quali il Psi “had to operate outside Italy and in the context of both international politics and European-wide ideological struggles over how to deal with the fascist danger”4, mettono drammaticamente in luce le insufficienze di una prospettiva Cfr. F. Gui, “Rivisitando il Manifesto dei federalisti europei”, in U. Morelli (a cura di), Altiero Spinelli: il pensiero e l’azione per la Federazione europea. Atti del convegno Aspetti fondamentali del pensiero e dell’azione federalista di Altiero Spinelli (Torino, 6-7 dicembre 2010), Giuffrè editore, Milano 2010, pp. 11-22, qui pp. 18-19. 3 Sul socialismo di Garibaldi si veda la scheda di approfondimento pubblicata sul n. 1 della rivista «Ragionamenti», febbraio 1991. La copia digitalizzata è riprodotta in www.archivionline.senato.it, Istituto per la storia della democrazia repubblicana, Presidenti del Senato, Ivanoe Bonomi (1948-1949). Per un ulteriore approfondimento sulla partecipazione di Garibaldi al Congresso di Ginevra si veda A.M. Isastia, “Giuseppe Garibaldi, Pace, Stati Uniti d’Europa”, in F. Gui [et al.], Momenti di storia europea: saggi e ricerche, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006. 4 A. De Grand, ‘To Learn Nothing and To Forget Nothing’: Italian Socialism and the Experience of Exile Politics, 1935-1945, in «Contemporary European History», Vol. 14, No. 4, pp. 539-558, qui p. 540. Lo stesso autore riassume in maniera efficace composizione e attività della Concentrazione: “The Italian exile community began to gather in Paris after the Fascist regime moved to a full dictatorship in 1925 and in 1926. In 1927, the various political parties – the renamed PSU, now Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI), the PSI ,the Italian Republican Party (PRI), the 2 G. Vassallo, Eugenio Colorni 122 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 parziale, la stessa che aveva portato i socialisti a sottovalutare la portata della propaganda fascista sulle masse, come pure a soccombere di fronte all’urto politico degli uomini in camicia nera. E la consapevolezza di dover mettere in atto, e rapidamente, una rigenerazione del partito, ovverossia una riformulazione degli obiettivi da perseguire e della metodologia da utilizzare nel perseguirli, genera una frattura molto più profonda di quella, pur insanabile, che, anni prima, aveva spinto i massimalisti di Bordiga e Gramsci a fondare il PcdI5. È pur vero, come ha acutamente osservato Alexander De Grand, che “The struggle within the Italian Socialist Party in exile was an important chapter in the long battle for the soul of socialism in Italy”6. Come a dire che il dibattito interno al Psi, anche quando incentrato su questioni meramente programmatiche, nella maggior parte dei casi ha finito per destrutturare l’impianto ideale e mettere in discussione le stesse fondamenta dottrinali del partito, vale a dire “l’anima” del socialismo italiano. Ma, pure sotto questo profilo, l’eccezionalità degli anni dell’esilio, e in particolare del quinquennio 1934-1939, è di quelle che lasciano il segno, anche nel lungo periodo. Siamo infatti in una fase in cui gli equilibri interni ed esterni alle rispettive formazioni politiche si vanno sfilacciando e ricomponendo in un gioco di alternanze tanto serrato quanto destabilizzante, e in cui, allo stesso modo, si consuma il contrasto forse più stridente tra le resistenze ad abbandonare antichi riferimenti concettuali e connesse metodologie politiche da un lato, e la spinta al nuovo che da più parti va premendo su militanti più e meno giovani dall’altro. Certo è che, nel 1934 - come fa osservare Giuseppe Saragat a Nenni, in una lettera del 25 novembre - sostanzialmente “il movimento langue”7. E, di fronte a tale immobilismo, non consola neanche il fatto che “i comunisti sono più morti di noi” e che “G[iustizia e] L[ibertà] è semplicemente puerile”8. Eppure, exiled General Confederation of Labor (CGL) and the Italian League for the Rights of Man (LIDU) – formed a loose inter-class alliance, the Anti-fascist Concentration, in 1927. The secretary general of the Concentration was Nenni, the Socialist leader. Its programme tended to be reformist, aiming at the restoration of democracy, the creation of a republic based on the working class, and the socialisation of certain essential industries. Absent from the Concentration was the PCdI, whose situation in exile was quite different from the other parties”. Ivi, p. 542. 5 Per una sintetica ricostruzione della vicenda, si veda Ivi, pp. 540-541. 6 Cfr. A. De Grand, cit., p. 540. 7Cfr. http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=468688l, Giuseppe Saragat a Pietro Nenni, La Leyne, 25 novembre 1934. 8Cfr. http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=468688, Saragat a Nenni, Le Luc, 14 dicembre 1934. G. Vassallo, Eugenio Colorni 123 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 giustamente rileva Gaetano Arfè, l’emigrazione socialista italiana, soprattutto quella espatriata in terra francese, nella quale si raccoglie tutto il gruppo dirigente, è tutt’altro che paralizzata, tanto da trovare il modo di: darsi… una base consistente e relativamente stabile, al punto di rendere possibile la ricostituzione di due partiti socialisti… con propri organi di stampa e proprie attività editoriali e finanche una propria rete di cooperative… promuovere revisioni dottrinali e operazioni politiche e organizzative rivolte a superare i vecchi contrasti e a sanare le vecchie scissioni… stabilire rapporti con gruppi di socialisti italiani emigrati in altri paesi e in altri continenti… 9 E, sempre in accordo con la ricostruzione di Arfè, tale capacità organizzativa e di propulsione, che il Psi riesce a mantenere inalterata e anzi ad accrescere, pur in una temperie eccezionalmente complessa, costituisce un polo d’attrazione efficacissimo sia per attirare nel partito i dissidenti di altri gruppi politici (tra cui Ignazio Silone10 e Angelo Tasca11), sia per tener vivo il confronto e la collaborazione con altre formazioni, tra cui GL e i repubblicani12. Cosa che, di rimando, conferendo eterogeneità, rende il movimento senz’altro più permeabile a nuove suggestioni politiche e culturali. Ora, stando alle considerazioni sopra esposte, verrebbe da chiedersi su quali basi poggino tanto le rimostranze di Saragat sulla scarsità di iniziative, quanto le dichiarazioni dello stesso Arfè, il quale, poco più avanti nel suo saggio sul socialismo dell’esilio, allude agli anni tra il 1930 e il 1934 come ad una fase “buia” del socialismo italiano13. G. Arfè, “La politica del gruppo dirigente socialista nell’esilio”, in AA.VV., L’emigrazione socialista nella lotta contro il fascismo (1926-1939), Sansoni editore, Firenze 1982, pp. 13-33, qui p. 14. 10 Come è noto, Ignazio Silone (pseudonimo di Secondino Tranquilli) partecipa alla fondazione del Partito comunista d’Italia, nel 1921 e nello stesso partito rimane attivo fino al 1931 e si avvicina al socialismo riformista. Torna alla militanza nel 1940, all’interno del Psi, allorché è chiamato a dirigere il Centro estero di Zurigo e il giornale socialista L’Avvenire dei Lavoratori. Cfr. “Ignazio Silone: The European mission of socialism”, in W. Lipgens, W. Loth, Documents on the History of European Integration: The struggle for European Union by Political Parties and Pressure Groups in Western European Countries 1945-1950, Vol. 3, De Gruyter, Berlin-New York 1988, p. 179. 11 Angelo Tasca, come Silone, partecipa alla fondazione del PCdI, nel 1921 ed è altresì tra i fondatori della rivista «Ordine nuovo», insieme a Gramsci, Togliatti e Terracini. Nel 1926 viene addirittura chiamato nell’esecutivo della III Internazionale. Espulso dal partito nel 1929, causa l’opposizione alla collettivizzazione forzata, diviene membro della segreteria del Psi proprio a Parigi, nel 1936. Cfr. R. Melchiorre, Storiografi italiani del Novecento, Aletti editore, Roma 2010. 12 Cfr. G. Arfè, “La politica del gruppo dirigente...”, cit., p. 14. 13 Cfr. ivi, p. 20. Alla lettera: “Gli anni che vanno dal ’30 al ’34 dal congresso dell’unità dei socialisti italiani alla firma del loro primo patto di unità d’azione coi comunisti, sono per il socialismo anni bui…”. 9 G. Vassallo, Eugenio Colorni 124 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Tornando alle parole di Spinelli riportate in apertura, si potrebbe sciogliere la questione spostando l’attenzione sulle resistenze di una determinata parte del socialismo italiano – quella parte che, peraltro, finisce per assumere la guida morale del partito all’indomani della liberazione – non soltanto ad accogliere idee ed esperienze non perfettamente conformi all’ortodossia marxista, ma addirittura a rielaborare, in misura più consona alle sollecitazioni esterne in tale direzione, una parte importante del proprio patrimonio culturale. Tale ipotesi, peraltro, troverebbe conferma nelle conclusioni sia di Leonardo Rapone, sia di De Grand, i quali concordano nel porre l’accento sul mancato rinnovamento tanto della composizione, quanto del bagaglio politico del Psi, durante come pure a seguito dell’esperienza dell’esilio14. Cionondimeno, che un cambiamento nel modo di concepire l’Europa e il tema dell’unità continentale si sia prodotto, e che ad innescarlo sia stato il contatto con una realtà più dinamica di quella italiana – com’è in particolare il contesto francese degli anni tra le due guerre – è testimoniato dalla riflessione e dal conseguente atteggiamento politico di alcuni elementi eterodossi. Ma non solo. A ben guardare, perfino parte degli uomini che rimangono ben saldi alla guida del partito, anche a Italia liberata, lasciano trapelare, soprattutto in alcuni De Grand, mutuando la propria posizione da Giuseppe Tamburrano, sostiene quanto segue: “Nenni’s biographer, Giuseppe Tamburrano, recalled that exiles leave their country defeated but with all their intellectual and political baggage in tow and return from exile with all of this legacy plus the polemics and rancour of the exile years. The Socialist experience in exile revealed how resistant the party was to new ideas and experiences that deviated from orthodox Marxism, but how, nonetheless, those external forces pressed on the party… By the end of the 1930s, one could argue that except for a few maverick Socialist, the Italian Socialist Party (PSI) emerged from the crisis of the 1930s even more entrenched in the framework of the past than ever. Indeed, one could go further. The bitter debates in the 1930s over planning, over strategies to compete with Fascism for the support of the lower middle classes, and, above all, over the degree of support for the Soviet Union and relations between socialists and communists left a deep legacy of resentment in the men who were to lead Italian socialism after 1943”. Cfr. A De Grand, cit., p. 540. Quanto a Rapone, l’allusione alla continuità col passato è contenuta nelle righe conclusive di un confronto tra il lavoro svolto da Silone in Svizzera e l’azione di Nenni in Francia: “Senonché sul lavoro svolto da in questa direzione [diffondere in Italia i lineamenti di una nuova politica socialista, ndr.], con la proposta di un socialismo «purificato dagli errori e dalle debolezze del passato», prevalsero gli orientamenti convergenti della vecchia generazione socialista, rimasta in Italia durante il ventennio, e dei giovani quadri formatisi nel Centro interno di Morandi. Fu dall’unione di questi due ceppi che risorse in Italia un partito socialista di cui Nenni avrebbe nuovamente potuto assumere la guida, il 25 agosto 1943, e che, nelle urgenze del momento, avrebbero assunto una collocazione unitaria e di classe inequivocabile”. Cfr. L. Rapone, Pietro Nenni, la seconda guerra mondiale e le prospettive del socialismo italiano. Il "Nuovo Avanti" clandestino del 1942, in «Storia contemporanea: rivista bimestrale di studi storici», a. XI, 1980, n. 4/5, pp. 859-887, qui p. 887. 14 G. Vassallo, Eugenio Colorni 125 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 articoli scritti sulle pagine de l’Avanti!, convincimenti che mostrano più di qualche punto di contatto col pensiero europeista15. In sintesi, benché tra il 1930 e il 1934 il socialismo italiano si trovi stretto nella morsa dell’immobilismo e immerso in uno scenario europeo alquanto disorientante16, per non dire dell’aggressione comunista, che in quel periodo si scaglia con tutta la propria veemenza contro il subdolo socialfascismo, riescono a porre “un nesso indissolubile tra antifascismo, europeismo, politica di piano”17 e cercano di trapiantare questo programma nelle progettualità politiche delle sinistre europee. Guardando ora agli estensori e ai sostenitori di tale piattaforma (che comunque rimane minoritaria, giacché al Congresso finisce col prevalere la linea del patto di unità d’azione con i comunisti18), il riferimento va a Giuseppe Faravelli19, Giuseppe Emanuele Modigliani20 e al già menzionato Tasca, i quali certo non erano rimasti indifferenti alla lezione rosselliana “for the creation of a Sugli articoli dell’Avanti! dai dichiarati accenti europeisti si veda G. Arfè, Storia dell’Avanti!: 1926-1940, Edizioni Avanti!, Milano-Roma 1958. 16 Stando al pregevole resoconto di Gaetano Arfè “i laburisti subiscono… una secca sconfitta che… li lascerà per lungo tempo senza idee e senza fiato. I socialisti francesi sono divisi da dissensi profondi e inquinati da revisionismi ambigui… La socialdemocrazia tedesca… dalla lezione del fascismo italiano ha tratto la convinzione che a favorirne l’avvento siano state le intransigenze di un proletariato non tutto e non del tutto maturo, e batte la via inversa… e i suoi deputati si presenteranno al Reichstag ad approvare patriotticamente la politica estera di Hitler… I militanti migliori, già da tempo bersagli di aggressioni, vengono massacrati o avviati nei campi di concentramento. I socialdemocratici di Austria… al momento dell’urto… sono già da tempo soli”. Cfr. G. Arfè, “La politica…”, cit., pp. 20-21. 17 Ivi, p. 21. 18 Ivi, p. 22. 19 Per quanto attiene alla riflessione socialista sull’unità europea, Faravelli rappresenta una figura che, seppure con contributi non sempre nitidi, partecipa attivamente al dibattito in argomento all’interno del Psi, sia negli anni dell’esilio – quando la questione è senz’altro di second’ordine rispetto a tematiche più cogenti, come la lotta al fascismo e l’unità d’azione coi comunisti – sia dopo il 1943, quando si ritrova in Svizzera, al fianco dello stesso Ernesto Rossi, a partecipare alle attività di propaganda del Centro estero di Zurigo, guidato dall’europeista Ignazio Silone. Su quest’ultimo aspetto si tornerà a parlare più avanti. Sulla figura di Faravelli, merita di essere segnalato il recente volume a cura di P.C. Masini e S. Merli, Il socialismo al bivio: l’archivio di Giuseppe Faravelli, 1945-1950, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 1990. 20 Ricorda Gaetano Arfè a proposito di Modigliani: “Superstite della vecchia guardia riformista, Modigliani ha alle proprie spalle una lunga esperienza, che ha come punti di riferimento ideali il pacifismo levato a dogma e il culto della libertà. Pace e libertà restano per lui valori assoluti… Il comunismo, anche nella sua veste frontista e antifascista, resta per lui dottrina e pratica inquinata di totalitarismo. L’alleanza militare tra l’URSS e l’Occidente quand’anche si saldasse per aggredire il nazismo esploderebbe in una nuova guerra imperialistica, estranea e avversa ala causa del socialismo”. Ivi, p. 28. 15 G. Vassallo, Eugenio Colorni 126 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 post-fascist United States of Europe”21. Tra i secondi, invece, figurano Giuseppe Saragat – per alcuni versi - e lo stesso Eugenio Colorni, la cui palese apertura alle tematiche del federalismo europeo sortisce, tra tutte, gli effetti più profondi e duraturi nel mutare la percezione dell’unità continentale da parte dei socialisti italiani. E tutto ciò senza che venga compromessa in alcun modo la posizione di preminenza del co-ispiratore del Manifesto di Ventotene nell’ambito del Psi. Anzi, al contrario, è proprio in virtù delle entrature nell’intellighenzia socialista che Colorni riesce a portare avanti con discreto successo la propria opera di propaganda federalista nel partito. Ma di questo si parlerà diffusamente più appresso. Si torni ora al primo gruppo di “dissidenti”, cioè a coloro che, già dagli anni Trenta - riflettendo sulle motivazioni che avevano portato il socialismo a soccombere tanto di fronte al nazifascismo, quanto alla deriva staliniana del comunismo – avvertono l’esigenza di “andare oltre Marx”22 per dirigersi verso una “via di democrazia e libertà”, così come descritta da Ignazio Silone nel suo Memoriale dal carcere svizzero23. In accordo con la ricostruzione di Ariane Landuyt, in questa pattuglia di esuli si raccoglie chi riconosce che “il socialismo tradizionale – di matrice secondinternazionalista – non ha… una risposta ai problemi che la storia gli aveva posti” ed è pertanto alla ricerca di “prospettive nuove tenendo conto di un quadro di riferimento più vasto” 24. E in tale mutamento di prospettiva e direzione, nel quale, agli occhi di chi lo propugna con forza, si inscriverà la rinascita del socialismo, il tema dell’Europa si impone giocoforza come parte integrante e imprescindibile del nuovo patrimonio concettuale, come pure del futuro programma politico. Detto altrimenti, il cosmopolitismo viene rielaborato sulla base delle mutate condizioni della società e riadattato agli obiettivi di breve periodo che i socialisti hanno l’obbligo di conseguire. E tutto ciò si attua passando attraverso A. De Grand, To Learn…, cit., p. 543. La letteratura sul socialismo liberale di Carlo Rosselli è particolarmente nutrita. In questa sede, ci si limiterà ad elencare le monografie più espressamente dedicate alle allusioni di Rosselli al tema degli Stati Uniti d’Europa: Z. Ciufoletti, Contro lo stalinismo: il socialismo federalista liberale di Carlo Rosselli, Lacaita, Manduria 1999; E.R. Papa, Rileggendo Carlo Rosselli: dal socialismo liberale al federalismo europeo, Guerini e associati, Milano 1999; S.G. Pugliese, Carlo Rosselli: socialist heretic and antfascist exile, Harvard University Press, Cambridge MA 1999; Id., Carlo Rosselli: Socialista eretico ed esule antifascista, Bollati Boringhieri, Torino 2001; N. Tranfaglia, Carlo Rosselli e il sogno di una democrazia sociale moderna, B. C. Dalai, Milano 2010. 22 L’espressione è ripresa da S. Soave, Angelo Tasca e Ignazio Silone. Da una parte all’altra della stessa frontiera, in «Laboratoire Italien. Politique et Societé», 12/2012, pp. 139-152, qui p. 143. 23 Ibidem. 24 Cfr. A. Landuyt, “Un tentativo di rinnovamento del socialismo italiano: Silone e il Centro Estero di Zurigo”, in AA.VV., L’emigrazione socialista…, cit., pp. 71-104, qui pp. 71-72. 21 G. Vassallo, Eugenio Colorni 127 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 una nuova idea di rivoluzione socialista, non più incentrata sul mito della classe operaia, ma organizzata attorno agli individui che agiscono uti singuli. Siamo di fronte alla svolta “personalista” del socialismo, la stessa che sembra trasparire in alcune pagine del Manifesto di Ventotene, e più in particolare in quella criptica definizione dell’uomo come “autonomo centro di vita”25. E certo tale constatazione apre uno spiraglio importante intorno all’influenza esercitata da Colorni sugli autori dello scritto pontino del ’41. La quale pare estendersi ben oltre il contributo marginale e la pur celebre “Prefazione” al testo che di consueto si accredita al professore milanese. Ma, anche per questo aspetto, si rimanda al paragrafo successivo. Rimanendo invece in tema di outsiders, un’attenzione particolare merita la figura di Angelo Tasca. Non soltanto perché, tra gli altri, egli rappresenta l’elemento più estremo e, al contempo, il caso più interessante per gli studiosi 26. Un uomo di eccezionale caratura politica, il quale, oltre ad essere un ex comunista, espulso dal partito nel 1929 per volontà dello stesso Stalin, ha mantenuto una sostanziale ambiguità per tutto il periodo dell’esilio e fino alla fine della guerra (tanto da decidere, nel giugno del 1940, di collaborare col governo di Vichy). Ma soprattutto per la sua strenua e inconciliabile divergenza di vedute con Nenni, la quale, come rileva De Grand, “foreshadowed the PSI’s rejection of proposals for European union that were developed during the war and the liberation of Italy by a number of unorthodox Socialists” 27. Quest’ultima affermazione è sicuramente di quelle che pesano. Perché, a detta dello storico in forza alla NC State University, senza i contrasti tra Nenni e Tasca il socialismo italiano avrebbe probabilmente giocato un ruolo diverso e più incisivo nel dibattito sull’Europa federale e nell’azione politica ad esso connessa. Cosa che, d’altro canto, lascerebbe presumere anche un riscontro Cfr. A.S., E.R., Il Manifesto di Ventotene, Mondadori, Milano 2006, p. 11. Sull’interpretazione dell’espressione “autonomo centro di vita” si veda G. Vassallo, Il Manifesto di Ventotene: premesse per un’edizione critica. Parte II. Un confronto a tutto campo con la cultura della propria epoca. Il percorso intellettuale di Rossi e Spinelli negli anni ’20-’30, in «Eurostudium3w», aprile-giugno 2011, n. 21, pp. 14-52. 26 Così anche De Grand: “Tasca’s case is even more interesting, caught as he was between two states (France and Italy) and between two parties (the French SFIO and the Italian PSI)”. A. De Grand, To Learn…, cit., p. 541. A tal proposito, David Bidussa ha sottolineato quanto il caso di Tasca non possa essere inquadrato in un contesto di partito, ma vada al contrario analizzato nella sua peculiarità, la quale coincide con l’originalità indiscussa del personaggio. Cfr. D. Bidussa, Angelo Tasca e la crisi della cultura politica socialista, in «Studi Storici», 1/1992, pp. 81-114, qui p. 81. Allo stesso modo si è espresso Nicola Tranfaglia in “Il caso Tasca”, pubblicato su La Repubblica del 24 marzo 1988 27 Ivi, pp. 541-542. 25 G. Vassallo, Eugenio Colorni 128 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 differente, da parte di Nenni, al colloquio con Spinelli e alle proposte di Colorni ricordati in apertura. Non che i rapporti tra i due dirigenti del Psi siano sempre stati tesi. Anzi, intorno alla metà degli anni Trenta si verifica una convergenza di posizioni che ha ricadute importanti sul partito, nella sua fisionomia, come pure negli equilibri interni. È vero che – occorre puntualizzare - già dal 1934, Nenni imprime un cambiamento sostanziale alla propria riflessione politica, riformulando in pratica tutta la strategia di alleanze e di azione dell’antifascismo socialista di cui è alla guida. Cioè, più precisamente, pur individuando nell’alleanza coi comunisti l’arma vincente per ricompattare il fronte antifascista – il che, come conseguenza, conduce alla rottura definitiva con GL e con i repubblicani – egli porta avanti una critica velata nei confronti dell’Urss e dell’idea di “Stato forte” che essa rappresenta. Giacché, come scriverà ne Il Nuovo Avanti del settembre 1935, “la via della rivoluzione… tende all’eliminazione progressiva dello Stato. E si può dire che il grado più o meno alto di socialismo si misura a seconda della soppressione della struttura coercitiva dello Stato”28. Si tratta di una presa di distanza abbastanza recisa da un’ottica comunista notoriamente acritica nei confronti delle manchevolezze – almeno a livello di coercizione politica – caratterizzanti la realtà sovietica. E, al contempo, di un recupero della tradizione socialista, la quale si fonda sul nesso inscindibile tra socialismo e libertà. E certo tale impostazione - che peraltro sembrerebbe essere foriera di un’apertura più che occasionale verso i temi dell’europeismo federalista - è alla base di un avvicinamento tra le diverse correnti ideali all’interno del Psi29, oltre che tra Nenni e Tasca. Tant’è che quest’ultimo, nel 1937, si unisce al primo in un compromesso che porta all’isolamento degli oppositori più accaniti dell’unità di azione e che al contempo tende a riequilibrare la posizione di Nenni nel gruppo dirigente30. Cfr. L. Rapone, “Il Partito socialista italiano fra Pietro Nenni e Angelo Tasca, in E. Collotti (a cura di), L’Internazionale operaia e socialista tra le due guerre, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 1985, pp. 661-710, qui p. 681. 29 Spiega in proposito Rapone: “…proprio grazie all’ispirazione pragmatica della politica di Nenni, tesa a sperimentare tutte le possibili convergenze tra PSI e PCI sul piano della lotta al fascismo assai più che ad approfondire un confronto “sulla definizione della democrazia e della dittatura”, le diverse ispirazioni ideali presenti nel gruppo dirigente socialista possono a lungo ritrovarsi in un indirizzo operativo comune e le posizioni più rigorosamente anticomuniste… vengono facilmente isolate”. Ivi, pp. 681-682. 30 Cfr. G. Vassallo, I documenti su Eugenio Colorni conservati nell’Archivio centrale dello Stato, in «Eurostudium3w», aprile-giugno 2009, n. 11, pp. 10-158, qui p. 70. Una sintesi sui risultati del congresso viene stilata da Faravelli in una lettera a Eugenio Colorni. Recita il documento: “Accennando ai lavori del congresso socialista, tenutosi a Parigi negli ultimi del giugno, si diceva: ‘È riuscito bene come prova di vitalità e maturità del partito. Si sono affrontate due tendenze: l’una (Nenni), che considera l’unità di azione come un fatto irrevocabile e quindi un 28 G. Vassallo, Eugenio Colorni 129 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 In sintesi, tra il 1934 e il 1938, Tasca infonde del suo “spirito” la linea ideologico-programmatica dei socialisti in esilio, la quale, a livello pratico, resta saldamente ancorata nelle mani di a Nenni31. Alla luce di tali considerazioni non stupisce che lo stesso capofila del fronte unico dichiari apertamente, in occasione del Consiglio nazionale del 1938, che la crisi europea si sarebbe risolta “col superamento dell’imperialismo, nella lotta per un’Europa unita e fondata sulla cooperazione tra gli stati e per la creazione degli Stati Uniti socialisti d’Europa”32. Sulla base di tali premesse, verrebbe da chiedersi quale sia il crinale decisivo, quello, cioè, intorno al quale le strade dell’agitatore (Nenni) e del professore (Tasca)33 finiscono per divergere irreparabilmente, determinando così anche il disancoraggio definitivo di Nenni dalle, pur labili, aperture europeiste. La frattura, osserva De Grand, si produce nell’ambito del dibattito sulla crisi di Monaco, allorché Tasca esce, per così dire, allo scoperto, mettendo cioè a nudo le proprie simpatie nei confronti degli Usa 34 e soprattutto richiamando l’attenzione sulla necessità degli Stati Uniti d’Europa. Questi ultimi, in particolare, si sarebbero dovuti costituire con la partecipazione dell’Urss e con lo scopo dichiarato di contrastare le potenze dell’Asse35. Rispolverando la lezione rosselliana – che l’ex comunista ha introiettato pur senza accoglierla ufficialmente – Tasca propone al Psi un “piano di ricostruzione europea” prefigurando un’organizzazione di tipo federale, strutturata sulla base del principio di sussidiarietà, cioè con forte partecipazione dei livelli di potere po’ come fine a se stessa. Questa tendenza è perciò incline a transigere alle peggiori posizioni comuniste: riconciliazione nazionale, lotta contro i com. dissidenti, ecc. con pericolo per l’autonomia del partito e della sua politica. L’altra tendenza (Tasca), che mi pare sia anche la vostra, se non di Anselmi, sostiene bensì l’unità di azione, ma la ritiene efficace solo in funzione di una politica schiettamente socialista. Le due tendenze, per ragioni tattiche di congresso, han finito per riconciliarsi’”. 31 Ivi, p. 696. 32 Cfr. A De Grand, To Learn…, cit., p. 544. 33 Così Nenni a Tasca in una lettera del 5 marzo 1939. Cfr. L. Rapone, “Il Partito socialista…”, cit., p. 696. 34 De Grand offre una ricostruzione abbastanza preciso del processo che porta Tasca a guardare con ammirazione alla realtà statunitense, soprattutto di quella plasmata dall’amministrazione Roosevelt: “Tasca was one of the rare socialists who paid some attention to the United States. He drew a parallel between Franklin Roosevelt’s re-election in 1936 and the struggle of Léon Blum’s government against the French plutocracy: ‘Roosevelt understands that he represents before the world a grandiose experience, and, more than an experience, a democratic regime capable of renewing itself and of responding to the needs and hopes of the vast popular masses’”. Cfr. A. De Grand, To Learn…, cit., pp. 549-550. 35 Ivi, p. 550. G. Vassallo, Eugenio Colorni 130 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 nazionali, regionali e locali. Quanto agli aspetti economici, esclude il controllo statale dell’economia e, al contrario, propone un libero scambio tra paesi democratici, in una sorta di “terza via” tra economia pianificata e capitalismo tradizionale36. E su quest’ultimo aspetto, che appare a molti, Nenni e Saragat nella pattuglia di testa, come un tradimento dei principi fondanti del socialismo, perpetrato nella speranza di un accordo meschino con le classi borghesi, si interrompe qualsiasi possibilità di dialogo tra “il professore” (ormai sempre più vicino alla Sfio e prossimo alla collaborazione con Pétain 37) e la dirigenza socialista, con buona pace delle virtualità del progetto taschiano per l’Europa. L’episodio, tuttavia, costituisce nient’altro che un incidente di poco conto su una via che conduce al baratro, ove il socialismo dell’emigrazione giungerà, di fatto, all’indomani dell’agosto 1939. Fuor di metafora, nel momento in cui si apre il dibattito su Monaco, la consapevolezza è ormai diffusa che i termini della lotta antifascista vanno reimpostati e che il nodo della riformulazione della strategia sarà dirimente per verificare la credibilità della coeva leadership socialista. Sul filo di questo delicatissimo tornante, venendo meno il compromesso tra Nenni e Tasca, il quale, come si è visto, aveva momentaneamente appianato le tensioni innescate dalla scelta frontista, le spaccature interne riemergono sotto forma di strali polemici che dall’una e dall’altra parte infuocano il dibattito politico. I toni più accesi, neanche a dirlo, sono quelli dei sostenitori della solidarietà coi comunisti, che poi costituiscono il nocciolo duro del partito. Nenni e Saragat, in particolare, liquidano la questione sostenendo che non è più tempo di soffermarsi su scaramucce ideologiche e diatribe dottrinali, perché, come appare chiaro, è in atto una convergenza di interessi tra gli imperialismi che richiede ai socialisti la massima compattezza nel rifiutare qualsiasi compromesso e nell’affrontare una guerra, che appare sempre più imminente, offrendo tutto il sostegno all’Urss contro le democrazie borghesi. Quanto a Tasca, le righe che seguono, tratte da una lettera di Saragat a Nenni, sono più che eloquenti nell’illustrare che il “professore” è ormai considerato un elemento di disturbo e prossimo a uscire fuori dal proscenio: Tasca è prigioniero della contraddizione che ho denunciato nel mio ultimo articolo. È da quella contraddizione che bisogna metterlo con le spalle al muro. Tasca dice che bisogna separarci dai governi e difende una potenza che ci renderebbe prigionieri dei governi. La verità è che per Ivi, pp. 550-551. Sul piano di ricostruzione europea si veda anche L. Rapone, L’Internazionale operaia…, cit., p. 700 e ss. 37 Sulle dinamiche che portano Angelo Tasca ad una collaborazione sempre più serrata con la Sfio e, successivamente, ad una collaborazione aperta con il governo di Vichy si veda D. Bidussa, Angelo Tasca…, cit. 36 G. Vassallo, Eugenio Colorni 131 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 “governo” Tasca intende la Russia. In altri termini bisogna bucare l’equivoco in cui si trincera e rovesciare contro di lui i suoi stessi argomenti. Avendo fama di difendere la nostra autonomia difende in realtà le posizioni imperialistiche del neoriformismo francese. La sua è una posizione nettamente anti russa e concretamente filo francese. Si tratta di inchiodarlo alla sua posizione. Penso che non ti sarà difficile dimostrando che è proprio lui che vuole riportarci alla politica del come prima anzi del peggio di prima che rimprovera ai comunisti. Noi dobbiamo veramente essere indipendenti dai governi ma soprattutto dai governi francese e inglese. C’è poi anche l’imbroglio del pacifismo che bisogna smascherare. Bisogna dire e ridire che il pacifismo neo riformista non è altro che carenza nei confronti del fascismo, e nazionalismo che farebbe mille guerre per difendere le posizioni imperialiste. Insomma Tasca è veramente preso nel mio articolo con le mani nel sacco. Bisogna insistere in modo che tutti i compagni si rendano conto di quali contraddizioni si rende portavoce. Parallelamente a questa azione di chiarimento ideologico bisogna che tu esamini a fondo il problema organizzativo dell’Unione Popolare. Questo è indiscutibilmente il nostro punto debole ed è questo che rende possibili le manovre anti unitarie… L’attacco di cui Tasca è il corifeo è preparato da Faravelli che introduce nel Partito i metodi della sezione riformista di Milano. Ed è chiaro che la scarlattina “fronte interno” da cui Menè [Modigliani, ndr.] è afflitto è una macchina da guerra montata contro l’attuale maggioranza alla Direzione e in modo particolare contro di te… Oggi scrivo a Tasca per ringraziarlo di un articolo che mi ha mandato e per esprimergli il mio disappunto per il suo dilettantismo professoresco in un tema delicato com’è la politica. 38 Sono questi i toni che accompagneranno la vita del Psi fino al crocevia decisivo dell’agosto ’39. Ed è quella descritta da Saragat la linea di divisione interna, con Faravelli, Modigliani e Tasca da una parte e Saragat e Nenni dall’altra. Ma “like a bolt out of the blue”, per dirla con De Grand39, il patto Ribbentrop-Molotov, ovverossia il “tradimento sovietico” 40 nei confronti delle forze dell’antifascismo, subentra a sconvolgere ancora una volta la fisionomia del partito e la bilancia dei poteri, rivalutando ex abrupto la riflessione taschiana sull’Urss e, con essa, la linea politica abbracciata e sostenuta da tutto il gruppo dei dissidenti. Nenni, per parte sua, si ritrova del tutto isolato nel suo tentativo di difendere un indifendibile mantenimento dell’alleanza coi comunisti e costretto ad abbandonare tanto la direzione de Il Nuovo Avanti, quanto la guida del partito, lasciando entrambe nelle mani di un triumvirato composto da Tasca, neanche a dirlo, Saragat e Oddino Morgari. Tale ricambio ai vertici del partito riporta repentinamente in primo piano la riflessione sugli Stati Uniti d’Europa, stavolta in stretta connessione con la Fondazione Pietro Nenni, Fondo Pietro Nenni, Carteggio Esilio, b. 13, Lettera di Saragat a Nenni, La Seyne sur mer, 19.11.1938. 39 Cfr. A. De Grand, To Learn…, cit., p. 552. 40 Così Saragat in una lettera a Nenni. Cfr. F. Fornaro, La passione per la libertà. A proposito di socialismo, totalitarismo e Giuseppe Saragat, in «Italianieuropei», 3/2002, http://www.italianieuropei.it/it/la-rivista/archivio-della-rivista/item/478-la-passione-per-lalibert%C3%A0-a-proposito-di-socialismo-totalitarismo-e-giuseppe-saragat.html 38 G. Vassallo, Eugenio Colorni 132 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 raggiunta consapevolezza che anche l’Urss è stata drammaticamente contagiata dal morbo del totalitarismo. È Il Nuovo Avanti a farsi portavoce della svolta che il nuovo direttore tenta di imprimere nell’orizzonte politico dei socialisti in esilio: “La Russia” - afferma il professore torinese in un articolo intitolato “Il Partito Socialista Italiano e la situazione internazionale” - “è uno stato totalitario in cui il potere è effettivamente nelle mani di un ristretto gruppo politico che si è costituito attorno alla dittatura personale di Stalin”. In tale contesto – prosegue l’articolo ancor più essenziale è il compito che l’antifascismo socialista si trova a dover svolgere, essendo chiamato a combattere su due fronti, da un lato contro il nazifascismo dell’Asse e dall’altro in opposizione al modello sovietico. E il solo modo per vincere la battaglia, conclude Tasca, sarebbe la costruzione degli Stati Uniti socialisti d’Europa, col supporto delle democrazie occidentali41. Stalinismo e nennismo, pertanto, diventano i due principali antagonisti del partito che Tasca ha l’obiettivo di rifondare attorno alla propria guida politica e morale. E certo qualche successo, in questa direzione, il dirigente torinese lo consegue pure, visto che le sue proposte vengono accolte con entusiasmo da quella parte del fuoriuscitismo socialista che aveva sempre mostrato una palese ostilità alla linea dell’unità d’azione intrapresa da Nenni, Faravelli su tutti. Orbene, è proprio in tale cornice che si colloca il documento approvato dalla direzione del Psi il 15 dicembre ’39, quello che Francesco Gui ha considerato “particolarmente illuminante”42 per chiarire quanto il patto del 23 agosto abbia inciso sulla propensione federalista di buona parte dell’antifascismo italiano, nonché sulla politicizzazione dell’idea ad opera di Spinelli, Ernesto Rossi e Colorni. Tale documento, osserva Gui nel suo saggio, denuncia il voltafaccia sovietico e addita l’Urss come “stato totalitario di tipo fascista”. Allo stesso tempo indica nella “costruzione di una nuova Europa”, e più precisamente negli “Stati Uniti d’Europa” l’unico strumento atto a “far circolare nelle masse, al fronte come nel paese, il soffio potente di una grande idea e di una grande speranza… non solo per “far crollare la dittatura staliniana”, ma anche per realizzare finalmente il socialismo, in Russia come altrove, attuando le speranze suscitate dalla Rivoluzione d’Ottobre. 43 Sicché, in sintesi, ricollegando il documento del 15 dicembre all’articolo di Tasca su Il Nuovo Avanti, si può affermare con qualche ulteriore certezza che in Cfr. A. Tasca, “Il Partito Socialista Italiano e la situazione internazionale”, Il Nuovo Avanti, 23 dicembre 1939. 42 Cfr. F. Gui, “Spinelli, Colorni e il Manifesto di Ventotene”, in F. Zucca (a cura di), Eugenio Colorni federalista, Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma 2011, pp. 25-37, qui pp. 28-30. 43 Ivi, p. 30. 41 G. Vassallo, Eugenio Colorni 133 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 entrambi traspare la medesima percezione della realtà, nonché l’evidenza di un approdo condiviso al tema degli Stati Uniti d’Europa. Approdo che passa attraverso un itinerario ideale e politico – quello taschiano, per l’appunto nutrito di distacco dal mito sovietico e dalla dottrina marxista e, d’altra parte, del recupero di valori e spiritualità se non proprio “cristiani”, almeno umani44. Tuttavia, come osserva Rapone, il “modo di sentire” del professore torinese è già troppo distante da quello “più diffuso nell’emigrazione politica italiana”45. Egli ha ormai sviluppato una sensibilità e un pensiero politico che coincidono quasi perfettamente con quelli del socialismo francese. E, non a caso, Soave parla di un “Tasca perduto nel 1939”46, poiché è proprio nel momento del suo accreditarsi al vertice del Partito socialista italiano che si perfeziona quel distacco che, allo sguardo retrospettivo, appare soltanto questione di tempo. A raccogliere la sua eredità di uomo fuori dagli schemi e convinto assertore degli Stati Uniti d’Europa, peraltro con una veste meno punteggiata di eterodossia e con un programma politico più coerente e ben impiantato sulla realtà coeva, sarà Eugenio Colorni, alla cui densissima vicenda degli anni a cavallo tra la direzione del Centro interno socialista e la morte, in una Roma prossima alla liberazione, è dedicato il paragrafo che segue. Eugenio Colorni tra dirigenza socialista e federalismo europeo Quanto detto fin qui aiuta a comprendere il clima in cui avviene la maturazione politica di Eugenio Colorni, nonché il bagaglio culturale e ideale con cui il filosofo milanese giunge a Ventotene e intraprende il proprio percorso di federalista europeo militante. Senza soffermarsi sulla vicenda autobiografica di un uomo di eccezionale spessore culturale e politico, come pure di straordinaria vivacità intellettuale47, Sulla riflessione di Angelo Tasca riguardo alla coincidenza tra civiltà cristiana e civiltà europea si veda, tra gli altri, S. Soave, Angelo Tasca e Ignazio Silone…, cit., pp. 147-148. 45 Cfr. L. Rapone, “L’internazionale operaia…”, cit., p. 709. 46 Cfr. S. Soave, Angelo Tasca e Ignazio Silone…, cit., p. 145. 47 L’interesse per la figura di Eugenio Colorni si è solo negli ultimi anni affacciato nel panorama storiografico nostrano. Tra le principali pubblicazioni dedicate alla sua biografia meritano di essere ricordate: M. Degl’Innocenti (a cura di), Eugenio Colorni dall’antifascismo all’europeismo socialista e federalista, Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma 2010; il già citato Eugenio Colorni federalista a cura di Fabio Zucca; i più datati volumi rispettivamente di Leo Solari, Eugenio Colorni: ieri e oggi, Marsilio, Venezia 1980 e di A. Forbice (a cura di), Matteotti, Buozzi, Colorni: perché vissero, perché vivono, Franco Angeli, Milano 1996; Sandro Gerbi, Tempi di malafede, Guido Piovene ed Eugenio Colorni: una storia italiana tra fascismo e dopoguerra, Hoepli, Milano 2012; G. Cerchiai, G. Rota (a cura di), Eugenio Colorni e la cultura italiana fra le due guerre, Lacaita, Manduria 2011 e il recentissimo saggio di A. Tedesco, Il partigiano Colorni e il grande sogno europeo, Editori Riuniti University Press, Roma 2014. 44 G. Vassallo, Eugenio Colorni 134 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 vale la pena di focalizzare l’attenzione sul brevissimo periodo in cui Colorni è alla direzione del Centro interno socialista di Milano, dall’aprile del 1937 all’8 settembre del 1938, il giorno del suo arresto a Trieste48. È in questi anni che Eugenio approfondisce i contatti con il fuoriuscitismo italiano e partecipa più direttamente e da vicino alle discussioni sull’indirizzo politico del partito. E ha il compito delicatissimo e centrale di tradurre in Italia le direttive provenienti da Parigi: rappresenta cioè un anello di congiunzione essenziale tra i due versanti delle Alpi, con funzioni di carattere eminentemente politico49. In tale qualità, il professore israelita è continuamente in contatto con Giuseppe Faravelli, oltre che con altri fuoriusciti antifascisti che però non militano nel Psi, in particolare Giorgio Diaz de Santillana, con cui condivide anche interessi di tipo culturale50. Si muove a tutto campo ed è fortemente critico dei metodi adottati sia dalla direzione di Parigi, sia dal Centro estero di Lugano nel condurre la lotta clandestina51. Il ruolo di Colorni, peraltro, è determinante per mantenere viva la presenza socialista in Italia, ove particolarmente forte è il pericolo che l’influenza del Psi venga offuscata dalla ben più organizzata e capillare rete comunista52. E, in tale prospettiva, la direzione del partito vede assolutamente di buon occhio che alla guida del Centro interno sia preposto il più maturo tra i giovani militanti, il quale parafrasando un intervento di Riccardo Lombardi al Congresso del Psi del 1937 – è giunto al socialismo “da sé”, passando attraverso l’esperienza giellista. “In Cfr. G. Vassallo, I documenti su Eugenio Colorni conservati nell’Archivio centrale dello Stato, in «Eurostudium3w», aprile-giugno 2009, n. 11, pp. 10-158, qui pp. 12-14. 49 Volendo precisare, in accordo con Leonardo Rapone, “Il nuovo Centro interno che attorno a lui [Colorni, ndr.] si costituì assolse prevalentemente compiti di elaborazione politica, mentre l’attività pratica di propaganda veniva svolta da gruppi ramificati, a diretto contatto con le realtà sociali e collegati al partito all’estero”. Cfr. L. Rapone, L'età dei fronti popolari e la guerra (1934-1943)”, in G. Sabbatucci (dir.), Storia del socialismo Italiano, vol. IV, Il Poligono, Roma 1981, pp. 179-411, qui p. 326. Restando in argomento, Maurizio Degl’Innocenti fornisce qualche ulteriore elemento, sostenendo che: “In quanto a Colorni, si evidenzia come avesse acquisito non solo un ruolo da dirigente sul piano strettamente politico, ma anche comprovate attitudini e esperienze sul piano strettamente organizzativo, due aspetti non sempre coesistenti nella medesima persona, e che, nella loro simbiosi, risultavano messi alla prova o, se si preferisce, temprati nella lotta clandestina”. Cfr. M. Degl’Innocenti, “Introduzione a Eugenio Colorni”, in Id. (a cura di), Eugenio Colorni…, cit., pp. 5-114, qui p. 103. 50 Cfr. Ivi. 51 Su questo tema si veda A. Tedesco, Il partigiano Colorni…, cit., p. 78 e ss. 52 A tale proposito, Rapone ha osservato che “Colorni divenne presto il principale punto di riferimento in Italia della Direzione del PSI”. Cfr. L. Rapone, “L'età dei fronti popolari…”, cit., p. 324. 48 G. Vassallo, Eugenio Colorni 135 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 tal modo – prosegue Lombardi – il movimento interno viene a ricollegarsi idealmente con la tradizione socialista e marxista italiana”53. Proprio in questa veste, in cui si sente personalmente a perfetto agio e che in parte gli ha cucito addosso il partito, Eugenio ha l’occasione di consolidare alcuni dei capisaldi del proprio pensiero politico. Si concentra in particolare sui metodi dell’azione cospirativa e sulla riqualificazione del ruolo delle masse. Più precisamente matura la convinzione che sia necessario mettere in moto fin da subito un’agitazione di massa, partendo dall’assunto che esista una “dinamica spontanea delle energie collettive”54. E arriva a prevedere, come puntualizza Rapone, “la possibilità di volgere a fini di lotta antifascista l’azione di propaganda all’interno delle strutture del regime”55. Tale riflessione condizionerà anche la sua posizione rispetto al tema caldo del frontismo. Riferisce infatti Faravelli in una lettera a un compagno, poi finita nelle mani della polizia politica: Accennando ai lavori del congresso socialista, tenutosi a Parigi negli ultimi del giugno, si diceva: “È riuscito bene come prova di vitalità e maturità del partito. Si sono affrontate due tendenze: l’una (Nenni), che considera l’unità di azione come un fatto irrevocabile e quindi un po’ come fine a se stessa. Questa tendenza è perciò incline a transigere alle peggiori posizioni comuniste: riconciliazione nazionale, lotta contro i com. dissidenti, ecc. con pericolo per l’autonomia del partito e della sua politica. L’altra tendenza (Tasca), che pare sia anche la vostra, se non di Anselmi, sostiene bensì l’unità di azione, ma la ritiene efficace solo in funzione di una politica schiettamente socialista. Le due tendenze, per ragioni tattiche di congresso, han finito per riconciliarsi”. 56 Sul congresso socialista si è già detto nel paragrafo precedente. Quanto a Colorni (Anselmi), il fatto che Faravelli alluda alla sintonia di orientamenti tra il direttore del Centro interno e Tasca non è elemento che può essere trascurato. Con una maturazione politica già quasi completata, il direttore del Csi finisce per convergere sulle posizioni del professore torinese e, in particolare, sull’idea che l’unità d’azione sia, alla fine dei conti, un’esperienza positiva, purché ad essa non venga sacrificata l’autonomia del partito. È la diffidenza sostanziale che tanto Tasca quanto il filosofo di Milano nutrono nei confronti dell’asservimento del Pcd’I a Mosca, nonché la repulsione che soprattutto Colorni nutre nei confronti del dogmatismo, a rafforzare in entrambi la convinzione che soltanto una politica autonoma del Psi possa scongiurare un allineamento di quest’ultimo sulle posizioni dei comunisti. A. Tedesco, Il partigiano Colorni…, cit., p. 90. Ivi, p. 325. 55 Ivi, pp. 324-325. 56 Cfr. G. Vassallo, I documenti..., cit., p. 70. 53 54 G. Vassallo, Eugenio Colorni 136 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Vale ora la pena di chiedersi se, considerata la somiglianza di convincimenti, non sia da ascrivere anche all’influenza taschiana, insieme alle suggestioni europeiste che si sviluppano nel Continente intorno agli anni Trenta57, il fatto che nell’estate del ’39, a Ventotene, Colorni condivida con Spinelli le proprie idee sul problema dello stato federale europeo58. Con ciò presupponendo che il filosofo milanese abbia avviato già in precedenza una riflessione sistematica intorno a tale questione. Sappiamo, dal paragrafo precedente, che i ragionamenti di Tasca sugli Stati Uniti d’Europa prendono corpo attorno alla vicenda di Monaco e che si sviluppano in un crescendo che porterà il dissidente ex comunista a trasporre la propria elaborazione teorica nell’indirizzo politico del Psi, non appena, all’indomani dell’accordo russo-sovietico, insieme a Saragat, ne assumerà la guida. Un orientamento che parte essenzialmente dalla considerazione che il Partito comunista è “una milizia al servizio dello Stato russo”, con cui “non è più possibile stringere alcun patto… poiché esso può tradire da un momento all’altro gli impegni presi o addirittura passare nel campo nemico, qualora ne riceva l’ordine da Mosca”59. Sono senz’altro affermazioni forti, che lasciano trasparire tutta l’amarezza per il patto del 23 agosto, nonché la sensazione di totale isolamento in cui quella scabrosa firma ha gettato il Psi. Ma l’aspetto più interessante del programma politico delineato da Saragat e Tasca, almeno nell’economia del presente lavoro, riguarda la rivalutazione dell’impegno antifascista delle democrazie occidentali, unita alla riscoperta del concetto di libertà come base imprescindibile del pensiero e della politica socialista. Il che conduce a ribaltare le alleanze, sostenendo che la guerra in corso va interpretata come “uno scontro tra i «popoli liberi» e gli «Stati totalitari»” 60, laddove i primi sono rappresentati dagli anglo-francesi e i secondi non soltanto dagli stati dell’Asse, ma anche dalla Russia. E implica altresì un cambiamento di prospettiva, nonché di obiettivi da conseguire al termine del conflitto, i quali coincidono ora con la costruzione di un “nuovo assetto internazionale, conforme ai valori di libertà e di solidarietà tra i popoli”, cioè con una “associazione europea” da cui prenderanno forma gli Stati Uniti d’Europa61. Sul punto si veda quanto riferito da Daniele Pasquinucci in “La Prefazione al Manifesto di Ventotene”, in M. Degl’Innocenti (a cura di), Eugenio Colorni…, cit., pp. 275-288. 58 Stando al Diario di Ventotene di Giuseppe Aventi, infatti, già nell’agosto 1939 Spinelli e Colorni sarebbero stati “affaccendati” su un “progetto di federazione europea”. Cfr. G. Aventi (Paganelli), Diario di Ventotene, Galata, Genova 1975, p. 58. 59 La citazione è tratta da un documento elaborato da Saragat e Tasca e approvato dalla Direzione del Psi nel dicembre 1939. Cfr. L. Rapone, “L'età dei fronti popolari…”, cit., p. 376. 60 Ibidem. 61 Ivi, 376-377. 57 G. Vassallo, Eugenio Colorni 137 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Ciò detto, rileggendo la “Prefazione” al Manifesto di Ventotene, è evidente che, di là dagli aspetti spiccatamente programmatici, il filo del ragionamento che conduce Colorni e Tasca all’opzione europeista e federalista appare pressoché coincidente. Più concretamente: Il nostro Movimento, che vive oramai da circa due anni nella difficile vita clandestina sotto l’oppressione fascista e nazista; i cui aderenti provengono dalle file dei militanti dell’antifascismo e sono tutti in linea nella lotta armata per la libertà… non è e non vuol essere un partito politico… vuole operare nei vari partiti politici e nell’interno di essi non solo affinché l’istanza internazionalista venga accentuata, ma anche e principalmente affinché tutti i problemi della sua vita politica vengano impostati partendo da questo nuovo angolo visuale, a cui finora sono stati così poco avvezzi. 62 Il che vorrebbe dire che Colorni, di fatto, trapianta nel dibattito federalista di Ventotene - alimentato, come è noto, dalle istanze dell’einaudiano Ernesto Rossi e dell’ex comunista Spinelli - tematiche che erano già state elaborate, dibattute ed accolte nell’ambito del Psi? In verità si potrebbe rispondere, con Daniele Pasquinucci, che l’autore della “Prefazione” al Manifesto sia essenzialmente un “autorevole rappresentante” del “socialismo federalista”, cioè di un movimento ben più ampio che si sviluppa nel fuoriuscitismo e nella Resistenza e che consiste nell’affermazione della prospettiva europeista e federalista come soluzione per l’assetto politico-istituzionale dell’Europa liberata dal giogo nazi-fascista. 63 La qual cosa, in altre parole, significherebbe che l’esperienza dell’intellettuale israelita al fianco di Rossi e Spinelli rientra in una più generale tendenza dell’antifascismo coevo, soprattutto di marca socialista, a ripensare la politica internazionale in chiave europeista. Tendenza che, a sua volta, si sviluppa nei primi anni Trenta, come reazione alla palese insufficienza della Società delle Nazioni a garantire la pace nel Vecchio continente64. Nulla di originale, pertanto, nella partecipazione di Colorni alla formulazione del programma federalista contenuto nel Manifesto di Ventotene. Eppure, guardando con più attenzione (pur nella carenza di fonti relative alla fase di stesura dello scritto pontino65) alla cornice in cui dapprima matura e Cfr. la “Prefazione” di Eugenio Colorni in A.S., E.R., Il Manifesto…, cit., p. 8. Cfr. D. Pasquinucci, “La Prefazione al Manifesto di Ventotene”, cit., p. 275. 64 Ivi, p. 276. 65 Allo stato attuale, non ci è pervenuto alcuno scritto di Colorni che spieghi in quale misura il professore socialista abbia partecipato all’elaborazione dello scritto ventotenese. A far fede sono soltanto le dichiarazioni di Altiero Spinelli, sia quelle contenute nella sua autobiografia, sia quelle rilasciate in occasione di alcune interviste, tra cui la più nota è quella a Sonia Schmidt, e il già citato diario di Paganelli. Cfr. A. Spinelli, Come ho tentato…, cit., p. 301; S. Schmidt, 62 63 G. Vassallo, Eugenio Colorni 138 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 poi si diffonde e guadagna consensi il progetto ventotenese, emerge che un personale contributo l’ex direttore del Csi lo abbia effettivamente offerto e che esso si sia articolato almeno in due apporti principali. In primo luogo, nella fase di elaborazione del documento, laddove, come osserva Piero Graglia66, Colorni agisce da “spirito santo della situazione”, nel senso che infonde del suo pervicace accento critico, come pure della sua attitudine a destrutturare qualsiasi certezza basata su dogmi preconfezionati, tutte le discussioni preparatorie67. In secondo luogo, allorché si tratta di diffondere le idee contenute nel Manifesto, si impegna a mettere a disposizione del gruppo federalista tutta la sua esperienza organizzativa, maturata nel contesto del Centro interno. Con quest’ultima caratteristica che diventa l’elemento chiave della partecipazione dell’intellettuale socialista alla Resistenza, periodo in cui Colorni si colloca effettivamente alla confluenza tra la lotta clandestina per il conseguimento degli obiettivi materiali delle forze di classe e la propaganda federalista messa in moto dal Movimento federalista europeo (Mfe)68. Lo testimonia, del resto, il suo duplice impegno – instancabilmente profuso durante la latitanza a Roma, dall’estate del 1943 alla morte, nel maggio del 1944 - sia nella redazione dell’Avanti! clandestino, sia nell’elaborazione del foglio L’Unità europea, che diventa la voce ufficiale del Mfe. Un lavorio intensissimo “Intervista con Altiero Spinelli”, in A. Spinelli e E. Rossi, Il Manifesto di Ventotene, Guida, Napoli 1982, pp. 171‐174 e G. Aventi (G. Paganelli), Diario…, cit. 66 Cfr. P.S. Graglia, “Colorni, Spinelli e il federalismo europeo”, in M. Degl’Innocenti (a cura di), Eugenio Colorni…, cit., pp. 249, qui p. 215. 67 A tale proposito, meritano di essere citate le osservazioni di Daniele Pasquinucci: “La storiografia… ha a lungo considerato il Manifesto di Ventotene come frutto esclusivo dell’elaborazione di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi (soprattutto del primo). Questa interpretazione non è in realtà del tutto esatta, come dimostrano ricerche molto recenti... Se nessuno può negare il ruolo di Spinelli e Rossi nella elaborazione di quel testo, occorre riconoscere anche quello svolto da Colorni. E questo non per un omaggio rituale o dovuto… ma perché anche Colorni animò i dibattiti federalisti, dette un contributo di stimolo critico dal punto di vista del socialismo autonomista – punto d vista che deve essere sempre tenuto presente per inquadrarne il federalismo -, e perché infine fu lo stesso Spinelli… a riconoscere il suo debito intellettuale non solo di Rossi, ma anche di Colorni”. Cfr. D. Pasquinucci, “La Prefazione…”, cit., p. 278. 68 Come sottolinea Daniele Pasquinucci (“La Prefazione…”, cit., pp. 283-284), peraltro, Colorni “ebbe un ruolo rilevante” anche nella riunione per la fondazione del Movimento federalista europeo, tenutasi a Milano alla fine di agosto 1943, soprattutto per quanto riguarda la “definizione della strategia e dell’organizzazione interna del sodalizio”, come pure nel sostenere che “i federalisti dovessero strutturarsi non come un partito… ma appunto come un movimento”. E in quest’ultima proposta è da leggere, almeno nell’opinione di chi scrive, la volontà di non dare origine ad una formazione politica che potesse risultare antagonista del Psi, tanto da impedire a Colorni di operare una sorta di fusione tra i due gruppi. G. Vassallo, Eugenio Colorni 139 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 che Eugenio svolge con l’obiettivo di individuare quel nesso politico che assicuri l’ancoraggio solido e permanente del Psi alla causa ventotenese. La “Prefazione” al Manifesto, del resto, andrebbe letta anche in questa chiave, ovverossia come stimolo per i socialisti, soprattutto per le nuove generazioni di aderenti al partito, a riesaminare i problemi politici del presente nella consapevolezza che “preconcetti dottrinari” e “miti di partito”69 hanno esaurito la propria funzione storica. E che è pertanto necessario, venendo ad uno tra gli elementi cardine del Manifesto, comprendere innanzitutto che “la linea di divisione fra partiti progressisti e partiti reazionari”70 è ora tracciata sulla base della maggiore o minore adesione al progetto di Europa federale. Il che, soprattutto nei confronti dei socialisti, rappresenta sia un invito ad abbandonare la prospettiva classica - quella cioè secondo cui la politica interna riveste un ruolo prioritario rispetto alla politica estera -, sia una sollecitazione a riconfrontarsi con la propria tradizione internazionalista e cosmopolita, identificando nel problema europeo il nodo centrale nella dinamica politica del dopoguerra. Tale atteggiamento, ritiene infatti Colorni, impedirà ai “vari partiti politici” di diventare “null’altro che pedine” nell’ “immenso gioco” tra potenze di cui sarà teatro l’Europa all’indomani del conflitto. Una lotta che – afferma con lungimiranza il filosofo israelita - si combatterà “manovrando e influenzando le varie correnti politiche… creando blocchi e controblocchi”71. Tutto questo, d’altro canto, senza che Eugenio tradisca quello che è stato, come si è visto, uno dei capisaldi della sua riflessione politica e che, d’altra parte, almeno ai suoi occhi, potrebbe agire come potente catalizzatore dell’interesse della dirigenza socialista verso l’azione politica del Mfe. Il riferimento è alla capacità di sollecitare un movimento dal basso, il quale, nel puntare all’obiettivo della federazione europea, porti avanti contestualmente le rivendicazioni per l’emancipazione delle classi lavoratrici. Tuttavia, in questa funzione di cerniera che Colorni sceglie di svolgere tra socialismo e federalismo europeo, il filosofo milanese si trova a scontrarsi tanto con Altiero Spinelli – come ricordato in apertura – tanto con una frazione non di secondo piano del socialismo europeo. Quanto al primo aspetto, fanno fede alcuni scambi epistolari tra i due ex confinati, tutti datati 1943 e puntualmente raccolti da Piero Graglia nel volume Machiavelli nel XX secolo72. I contrasti, per quanto attiene a Spinelli, ruotano Cfr. E. Colorni, “Prefazione”, in A.S., E.R., Il Manifesto…, cit., p. 4. Cfr. A.S., E.R., Il Manifesto…, cit., p. 28. 71 Cfr. la lettera di Colorni a Spinelli, datata maggio 1943, riprodotta in A. Spinelli, Machiavelli nel XX secolo. Scritti del confino e della clandestinità. 1941-1944, a cura di Piero Graglia, Il Mulino, Bologna1993, p. 197. 72 Cfr. Ivi, pp. 189-218. 69 70 G. Vassallo, Eugenio Colorni 140 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 essenzialmente attorno a due elementi della riflessione colorniana: il mito di una rivoluzione europea attuata per mezzo dell’azione spontanea delle masse, a partire da un nucleo russo-tedesco e con un ruolo strategico dell’Urss nel dare l’abbrivio a tale rivoluzione. Per parte sua, Colorni critica a Ulisse un atteggiamento che definisce “pantagruelico”, incapace di far presa sulle masse e di offrire loro un orientamento; nonché un “peccato di ideologia”, che preclude la possibilità di agire efficacemente sui “fatti che si vanno svolgendo”73. Tra le maglie di un dialogo politico estremamente serrato e interessante, per cui si rimanda al sopra citato volume a cura di Piero Graglia, ciò che rileva in questa sede è il fatto che i due federalisti europei si scontrino, oltre che sotto il profilo delle valutazioni politiche, anche sul terreno della strategia. Spinelli, infatti, che ha preso nettamente le distanze dall’idea del “partito rivoluzionario”, pur contenuta nel Manifesto74, e, più in generale, dai temi classici del dibattito politico progressista75, promuove un’opera di infiltrazione nei partiti tradizionali, soprattutto nel Partito d’Azione in quello socialista76. Colorni, viceversa, soprattutto in onore al suo ruolo di referente per le giovani generazioni di socialisti, è impegnato a conciliare il raggiungimento degli obiettivi strategici del Mfe con il richiamo costante al “pericolo di una guerra imperialista” e al rinnovamento sociale delle classi lavoratrici. Certo è che, di là dalla difficoltà del compito che si era assunto – con l’incoraggiamento e l’assenso dei federalisti – l’ex direttore del Csi riesce a conseguire qualche successo nella sua attività di propaganda della lezione ventotenese nell’ambito del Psiup. Tant’è che, come si legge sulla prima pagina sia dell’edizione milanese che di quella romana dell’Avanti! clandestino77, e più precisamente al punto n. 7 della “Dichiarazione politica” del partito ricostituitosi in Italia dopo la caduta di Mussolini, La lotta del proletariato è internazionale non solo perché i proletari di tutto il mondo combattono contro lo stesso nemico di classe e per lo stesso fine, ma perché non è possibile distruggere l’assetto capitalista della società borghese, se non se ne distrugge la struttura Cfr. Ivi, pp. 191-194. “Il partito rivoluzionario non può essere dilettantescamente improvvisato nel momento decisivo, ma deve sin da ora cominciare a formarsi almeno nel suo atteggiamento politico centrale, nei suoi quadri generali e nelle prime direttive d’azione”. Cfr. A.S., E.R., Il Manifesto…, cit., p. 35. 75 Tale distacco è ben descritto nelle Tesi federaliste, che Spinelli metterà a punto negli ultimi mesi di confino. Si veda, in proposito, P.S. Graglia, Altiero Spinelli, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 167174. 76 Cfr. Ivi, p. 171. 77 Cfr. “Dichiarazione politica del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria”, in Avanti!, numero straordinario, Roma, 26 agosto 1943, p. 1. E anche “Unità Proletaria”, in Avanti!, a. XLVII, n. 1, Milano, 1 agosto 1943, p. 1. 73 74 G. Vassallo, Eugenio Colorni 141 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 nazionalista, base di ogni imperialismo. Il P.S.I. appunto in quanto esprime i reali interessi del popolo lavoratore d’Italia, ripudia ogni politica di così detto ripiegamento nazionale, di isolamento politico di autarchia economica; esso considera la solidarietà internazionale dei partiti proletari come elemento essenziale della sua azione, come lo strumento per promuovere e concretare una politica di pace che armonizzi gli interessi di tutti i popoli e avvii l’Europa verso una libera federazione di stati. La fine della guerra attuale porrà sul tappeto in termini decisivi il programma del coordinamento unitario dei diversi paesi europei e questa deve essere intesa come una esigenza della ricostruzione socialista, come lo sbocco naturale a cui conduce l’evoluzione economica e politica dell’Europa, che liberata dai particolarismi capitalistici, dovrà raggiungere un’organizzazione federativa, avviamento all’Unione delle Repubbliche Socialiste d’Europa e del mondo. 78 Che altro non è se non la sintesi della strategia colorniana volta ad aprire nel Psiup un varco per la penetrazione delle idee federaliste. La morte prematura del professore milanese non consente di verificare quale sarebbe stata l’incidenza della sua azione nel lungo periodo. Di sicuro, come mostrano anche i toni ironici di Spinelli sulla reazione di Nenni più sopra riportati, nei socialisti di lungo corso – soprattutto Nenni e Rodolfo Morandi – prevale lo scetticismo nei confronti di un pensiero e di un movimento politico che tenta di demolire uno dei riferimenti concettuali cardine per i partiti del Novecento, vale a dire lo stato nazionale, come pure di criticare l’impostazione classista. Di particolare efficacia, a tale proposito, le considerazioni di Nenni sulla “assillante” propaganda federalista colorniana, riportate da Pasquinucci nel suo saggio: … io, nella piena coscienza della nobiltà dei suoi sentimenti e delle sue idee, ero costretto a trattarlo come avrei trattato chi nel ventennio della lotta contro il fascismo mi avesse detto: il fascismo cadrà quando il socialismo trionferà in tutto il mondo. 79 In effetti, in linea con quanto scrive Morandi a Spinelli, nell’ottobre del 1943, “le distanze” che separano socialisti e federalisti, soprattutto nel tornante fluido degli anni 1943-1944, non sono solo di linguaggio – di un particolare modo cioè di espressione -, ma sostanziali. È, ad essere sinceri verso noi stessi, una popolare opposizione che non c’è buona volontà di intendersi che possa ridurre. Anzi, meglio ci intendiamo, e più distanti ci sentiamo… poiché il vostro socialismo è in verità la diretta negazione del nostro. 80 Ibidem. Occorre precisare che la “Dichiarazione politica…” è riportata anche nel supplemento al secondo numero dell’Avanti! milanese, del 26 agosto 1943. 79 Cfr. D. Pasquinucci, “La Prefazione…”, cit., p. 287. 80 Cfr. la lettera di Morandi a Spinelli, datata ottobre 1943, in A. Spinelli, Machiavelli…, cit., pp. 221-222. 78 G. Vassallo, Eugenio Colorni 142 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Tali accenti inducono a credere che, se anche Colorni fosse scampato al fuoco della banda Koch, difficilmente il suo socialismo federalista sarebbe riuscito a sostituirsi alla linea politica tradizionale, sia a livello ideologico che strategico. Tuttavia, in estrema sintesi, di là dai successi e dalle sconfitte registrati dal socialismo federalista di Eugenio Colorni, la forza della sua voce critica e del carattere innovativo della sua elaborazione teorica hanno lasciato un’impronta profonda e sicuramente trasversale, tanto nel Mfe quanto nel socialismo italiano. G. Vassallo, Eugenio Colorni 143 Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Maria Antonietta Visceglia (a cura), Papato e politica internazionale nella prima età moderna, Viella, Roma 2013 di Giovanni Contel Il presente contributo intende prendere in considerazione una raccolta di atti di convegno edita nel corso dell’anno 2013 e dedicata alle dinamiche politiche, in senso lato, dell’azione internazionale del papato in una “prima” età moderna che di fatto, e non senza fondamento, si estende ampiamente verso il corpo centrale ed oltre di tale epoca. Nella sua mole politematica il volume si riferisce infatti ad un lungo arco temporale, compreso più o meno tra il Concilio di Costanza e la seconda metà inoltrata del XVIII secolo. Papato e politica internazionale nella prima età moderna offre insomma un corposo e variopinto spaccato dell’azione diplomatica della Santa Sede a cavallo fra quattro secoli, andando ad approfondire molti aspetti particolari, senza però rinunciare a tracciare un quadro organico nel suo complesso. Esso racchiude, con un'unica eccezione, gli interventi dei relatori al convegno internazionale svoltosi a Roma tra il 10 e il 12 giugno 2012, presso gli atenei di Roma “La Sapienza” e Roma Tre, nell’ambito del progetto nazionale di ricerca PRIN 2008, coordinato dalla professoressa Maria Antonietta Visceglia. Un progetto intitolato “Universalismo e italianità nella politica internazionale del papato in età moderna”, che ha visto la partecipazione di numerosi studiosi italiani e stranieri. Al fine di evidenziare la varietà e la ricchezza di questa ricerca, ottenute attraverso la collaborazione di eminenti scholars stranieri, il volume presenta contributi tanto in lingua italiana che nella lingua propria del relatore, o in quella più consona al campo di studi dello stesso studioso. Pertanto il lettore potrà trovare testi in inglese, francese, spagnolo, sebbene nell’occasione del convegno molti interventi di docenti non italiani siano stati pronunciati nella nostra lingua. Data la vastità del tema affrontato, la presente trattazione, intendendo cercare di restituire in modo omogeneo, comprensibile, nonché almeno parzialmente plausibile il quadro della ricca ricostruzione in analisi documentali e sintesi storiografiche riscontrabile nel volume, ha dovuto in parte tralasciare gli elementi più centrifughi rispetto al mainstream dell’intero percorso scientifico proposto dagli studiosi partecipanti. Al ricco indice della raccolta posto all'inizio segue dapprima una premessa della curatrice, che presenta il risultato del progetto di ricerca, per poi 144 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 proseguire, dopo le abbreviazioni bibliografiche, con le tre sezioni tematiche in cui sono stati inseriti gli interventi. La prima di esse si intitola “Strutture, risorse e limiti dell’universalismo papale” e comprende i contributi senza i quali non si potrebbe cogliere lo spirito unitario del lavoro scientifico compiuto. La seconda, “Lo spazio pontificio in Europa e nel Mediterraneo tra frontiere religiose, culturali e politiche”, racchiude i saggi dedicati alle diverse particolari vicende e ai vari contesti in cui si esercitò l’azione del papato in politica internazionale nell'epoca suddetta. La terza,“Il papato come centro di negoziazioni transoceaniche”, risulta essere meno pregna di luce propria, anche perché più ridotta, dato che consta di soli cinque scritti, relativamente omogenei nell'oggetto. Infatti i testi in essa presenti risultano per così dire coerenti a due a due, con i primi incentrati sulle relazioni con le Americhe, i secondi su quelle con il Celeste Impero, a cui si aggiunge l’interessante contributo di Christian Windler sui tentativi di alleanza politica tra la Curia papale e la corte safavide di Persia. Una politica “internazionale” del papato? Prima di proseguire, appare opportuno riflettere in breve, ma anche in modo “critico”, sul significato dell’espressione “politica internazionale” (o più genericamente interstatuale) connessa al soggetto “papato”. La politica internazionale intrapresa da uno Stato particolare come quello del papa, per quanto precocemente strutturatosi con caratteristiche da Stato “moderno”, è da intendersi diversamente dalla mera politica di potenza attuata dalle grandi monarchie europee in età moderna, o da semplici rapporti interstatali fra soggetti sovrani. E questo non soltanto perché il confronto puramente politicodiplomatico fra un pur rafforzato Stato della Chiesa e le maggiori monarchie sarebbe stato comunque impari, come dimostrato da note esperienze, ma soprattutto perché la forza del papato risiedeva sostanzialmente nell’esclusiva delle “armi spirituali”. Un’espressione di per se stessa non del tutto esauriente a causa dei molteplici poteri che essa comporta, ma che concentra nell’esercizio dell’autorità religiosa universale del papa, in quanto capo della Chiesa universale, un enorme potenziale di influenza e di condizionamento non certo soltanto politico, e comunque non di natura temporale. Nei fondamenti dell’autorità del papa restava infatti un fattore legittimante di per sé estraneo e, per così dire, superiore alle ragioni della politica internazionale in quanto tale. Non solo, ma tale fattore restava comunque spontaneamente riconosciuto, per una complesso di ragioni, religiose, ecclesiali ed ecclesiastiche, psicologiche, culturali, all’interno di una communitas più ampia rispetto ai confini dei singoli 145 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 stati, che comunque si perpetuava anche nel rafforzarsi dei processi di concentrazione del potere monarchico di tipo nazionale. Sicuramente, per concludere sul punto, non sono stati soltanto gli interessi e le forze temporali dei sovrani pontefici ad accreditarne l’autorevolezza internazionale o a determinarne la politica sulla scena europea e mondiale. Ciò non esclude che la pratica diplomatica e della relazione di tipo internazionale si sia diffusa con il progredire dell’età moderna, per un complesso di fattori riconducibili alle epocali trasformazioni verificatesi a partire dalla fine del Quattrocento, tanto di natura politico-istituzionale che culturale e religiosa, che scientifico-geografica, tali da privilegiare i rapporti da potere a potere all’interno della Christianitas, di fatto non più Respublica, ma sistema di potenze. Il paradosso della prima età moderna consiste nell’osservare come proprio nel momento in cui la crisi religiosa divideva l’Europa con la Riforma protestante iniziasse un ulteriore processo di universalizzazione della Chiesa cattolica, con a capo il papa romano che risultava al contempo sovrano di una media entità statale della penisola italica. La scoperta del Nuovo Mondo e delle nuove rotte per l’Estremo Oriente contribuivano a sconvolgere l’assetto religioso e culturale dell’Europa cristiana che veniva dal Medioevo, con l’esito di alimentare al tempo stesso una rinnovata idea universale di cristianesimo, da mettere in pratica con zelo, incoraggiando una nuova religiosità cattolica cresciuta di pari passo alla sfida pur traumatica della Riforma. Il che non escludeva che il papato venisse al contempo investito da problematiche che possono correttamente definirsi di politica internazionale, ovvero comportanti un insieme di strategie politiche e militari – di cui solo alcune connesse alla dimensione confessionale della guerra in età moderna – dettate dalla mera essenza temporale dello stato pontificale all’interno dello scacchiere italiano ed europeo. Pontefici e nationes: la politica concordataria Entrando in argomento, come riconosciuto dalla generalità dei contributi, alle soglie dell’età moderna il sistema delle relazioni internazionali conobbe anche ulteriori cambiamenti rispetto alle antiche consuetudini dell’Europa medievale. Mentre la percezione delle dimensioni e della conformazione del globo terrestre aumentava sempre più attraverso le scoperte geografiche, le distanze del vecchio continente, un tempo considerate troppo lunghe e pericolose, si riducevano grazie alle innovazioni tecnologiche, che consentirono innanzitutto una migliore navigazione. Inoltre, con lo sviluppo dei traffici commerciali, anche le strade si fecero più sicure per la circolazione delle persone, delle merci, 146 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 delle idee. La Christianitas, per lo meno quella occidentale, dato l’insorgere del Turco all’Est, non aveva mai avuto prima d’ora un contatto così relativamente stabile al suo interno. Tutto ciò dovette influire non poco sulla decisione di “inventare”un nuovo sistema diplomatico che si poggiasse su ambasciatori residenti nei singoli paesi e non più su precari inviati occasionali. Tra i primi fu Venezia, con il suo spirito mercantile, a coniare queste nuove figure, peraltro non del tutto nuove se paragonate ad agenti di compagnie commerciali o finanziarie, abbondantemente presenti già in epoche precedenti al tardo Medioevo. Ma trattare relazioni diplomatiche fra gli Stati moderni era comunque un’altra cosa. Questi ultimi stavano a loro volta mutando in nuove forme di statualità, chiudendo così la lunga gravidanza dell’Europa medioevale che stava partorendo l’Europa della modernità. In proposito, se i pionieristici studi di Paolo Prodi hanno fornito un contributo fondante per la comprensione dei meccanismi che portarono alla genesi dello stato moderno, in modo particolare dello stato ecclesiastico pontificio, oggi la storiografia continua nella medesima scia per scoprire quanto queste tematiche abbiano influito nelle relazioni politiche tra XV e XVIII secolo. Con riferimento specifico alla Chiesa romana, vale la pena di osservare che ancora oggi essa utilizza come strumento diplomatico primario, nel rapporto biunivoco con uno stato sovrano, il concordato, antica forma di trattato “internazionale”, inaugurato in verità a Worms (anno 1122) e tuttavia utilizzato in forma che si potrebbe definire sistematica proprio a partire dalla fase quattrocentesca di definizione dello Stato della Chiesa come monarchia all’avanguardia rispetto alle potenze europee. Nel suo contributo Marco Pellegrini delinea molto bene la storia del concordato come strumento politico della Santa Sede nei confronti dei singoli regni, soffermandosi sul periodo che va dal Concilio di Costanza fino al primo Cinquecento, mentre il saggio di Mario Rosa si concentra sull’evoluzione della natura, o significato, del concordato nel contesto politico italiano ed europeo del XVIII secolo. Per parte sua Pellegrini chiarisce bene la genesi dell’utilizzo del concordato come patto inizialmente stipulato soltanto con alcune potenze cristiane, non con tutte. In particolare ad essere interlocutrici di Martino V furono inizialmente le nationes, rappresentate dal clero e riunite nell’assise di Costanza che lo aveva appena eletto. Vale a dire: Gallica, Germanica (nel testo originale Alamanica), Hispanica, che includeva tutti i regni della penisola iberica, ed Anglica, recentemente distintasi a Costanza dalla grande famiglia di quelli che venivano indicati anche come Saxones, in quanto preminente espressione della nazione tedesca. 147 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Le quattro nationes, di fatto rappresentate dai rispettivi sovrani, ricevettero il privilegio di stabilire i loro legami con la Chiesa di Roma attraverso il documento concordatario, mentre gli altri paesi, tra cui gli stati italiani, restarono “paesi d’obbedienza”, nei quali nessun codice regolava e/o tutelava i diritti ed i doveri nel loro rapporto con il papato. I primissimi concordati, come sottolinea sempre l'autore, furono soprattutto atti di ampio respiro politicoecumenico, in quanto sancirono la rinata comunione con Roma delle quattro maggiori potenze cristiane dopo il concilio che concluse il Grande Scisma d’Occidente, assicurando così all’obbedienza romana la loro lealtà ed ottenendo che venissero sanate a proprio favore certe ambigue situazioni maturate nel quarantennio scismatico. Con particolare riferimento al concordato francese – il primo in ordine di redazione, che fece pertanto da modello agli altri, pur essendo seguito nel giorno stesso da quello con l’Alamanica – il documento costituiva principalmente in un contratto amministrativo e finanziario tra il sovrano ed il pontefice riguardo le collazioni di numerosi benefici ecclesiastici, il diritto sulle nomine episcopali e abbaziali, le distinte giurisdizioni civile ed ecclesiastica, etc. La storia delle relazioni con Parigi sarebbe proseguita nel XVI secolo, oltretutto non senza contrasti tra le spinte autonomiste del clero di Francia e il "gallicanesimo regio" proprio degli ambienti di corte, con il risultato di approdare al nuovo concordato di Bologna del 1516, stilato da Leone X e Francesco I. Un atto che se, da un lato, favorì le pretese della corona indossata dal Valois non fu per il papa una vera sconfitta, poiché permise di tenere buoni rapporti con il possente vicino d’oltralpe in un’ottica di spartizione di influenze che lasciava Milano nell’orbita della Francia, Napoli in quella della Spagna e l’ampio e indefinito centro Italia alla tutela della mano visibile della Santa Sede. Nella ricostruzione di Pellegrini, Leone X era spaventato dalle armi di Francesco I, recentemente vittoriose sul campo di Marignano, quasi quanto Alessandro VI temette quelle di Carlo VIII sobillato dal cardinale Giuliano Della Rovere. Di fatto, in cambio delle amplissime concessioni riconosciute alla monarchia, il papa Medici ottenne di evitare lo scisma con la Francia, un'ipotesi rimasta ad aleggiare sospesa sin dai tempi del Concilio di Basilea, e di tenere la Chiesa gallicana dipendente da Roma, almeno in materia spirituale, per quanto concerneva l’alta sovranità giurisdizionale per le causae maiores. Inoltre Francesco I per parte sua abolì la Prammatica Sanzione di Carlo VII, il documento più pericoloso per il primato romano e vera bandiera del gallicanesimo da più di mezzo secolo. Per il re il nuovo concordato stipulato insieme al papa costituiva infatti un successo più vantaggioso sul piano politico ed economico. Da un lato in quanto la sua prerogativa sul clero veniva così legittimata da entrambe le parti, dall’altro poiché appoggiarsi alla Prammatica 148 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Sanzione, che come atto unilaterale del sovrano era accusato di tendenze scismatiche e mal tollerato da una parte della stessa Chiesa francese, era ormai politicamente una pietra d’inciampo per le mire della stessa monarchia. Fin qui la Francia e il suo ruolo di primo sperimentatore della prassi concordataria, a proposito della quale vale la pena di sottolineare come all’origine dei concordati susseguenti al Concilio di Costanza stesse la forza politica della temperie conciliarista allora incombente sul papato unitario neoricostituito. Sotto questo profilo il pontefice veniva costretto ad un rapporto quasi bilaterale fra sé e la natio; d'altro canto Martino V concepì invece il concordato – come Pellegrini ricorda, fulmen in clausula, alla fine del suo contributo – precisamente come strumento per ricomporre il Grande Scisma. Pertanto l’obiettivo minimo perseguito era e rimase di tenere la Francia (primo paese concordatario e principale sostenitore politico del conciliarismo fino al XVI secolo inoltrato) imbrigliata nell’orbita romana precisamente attraverso l’intesa con il sovrano, pur riconoscendo un’autonomia della natio stessa. Per converso, la corona francese, nel farsi in qualche modo mediatrice fra la natio e il papato, otteneva in cambio il tacito assenso romano alla costruzione assolutistica dello Stato, sostenuta dal gallicanesimo regio, prevalente negli ambienti di corte e nel Parlamento di Parigi, ma non condiviso da tutto il regno. Ovvero si potrebbe sostenere che il concordato avrebbe finito per rivelarsi come un codice di regolamentazione (sia pure inizialmente sottoposto all’autorità del concilio) mirante a tutelare gli obblighi reciproci fra Chiesa papale e vertice monarchico dello Stato, con la Chiesa nazionale di fatto posta in condizione subordinata. Il sovrano si considerava difatti advocatus della propria Chiesa al di là di chi sedesse sul soglio di Pietro, proprio per evitare di ricadere nell’era dei pontefici scelti per convenienza: quello cioè che era accaduto all’epoca dello scisma delle due obbedienze contrapposte, romana ed avignonese. Per riassumere, riprendendo le fila dall’inizio, fu proprio durante il Grande Scisma che le monarchie dovettero, non senza un solido vantaggio, prendersi una maggior cura delle chiese nazionali, laddove lo scontro tra le varie sedi papali provocava un certo disordine nel governo della Chiesa. Alla fine di questo periodo – sebbene a fronte di una forte corrente conciliarista, ma al tempo stesso in presenza di un papato, certo non più prigioniero ad Avignone, ma pur sempre in stato di persistente debolezza – i sovrani non intesero comunque rinunciare al peso politico acquisito de facto. Pertanto si presentava loro l’occasione favorevole di un mandato papale fortemente condizionato dal concilio – organizzato per nationes proprio a Costanza – e dunque assai condizionabile anche da parte dei sovrani, peraltro rafforzati dalla sanzione papale stessa. Fecero tuttavia male i loro conti, se così si può dire, i padri conciliari eleggendo Martino V, il quale fu pronto a 149 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 dissimulare obbedienza ai decreti di Costanza, finendo poi con eluderli nel corso del suo pontificato. Il risultato complessivo sarebbe stato dunque un parallelo rafforzamento delle figure monarchiche del papa e del re, cui risultò conveniente l’instaurazione di un rapporto di tipo diplomatico a carattere bilaterale, con conseguente declassamento degli ordini e delle realtà subordinate. Quanto a Martino, papa romano di famiglia imperiale, da un lato, egli – secondo quella che potremmo definire, in analogia con l’elezione imperiale tedesca, la sua “capitolazione papale” innanzi all’assise di Costanza – avrebbe mostrato di attenersi alle promesse conciliariste convocando un sinodo a Pavia, poi trasferito a Siena per l’anno 1423, cui però non si recò nessuno; dall’altro, una volta tornato nell’Urbe, riprese l’azione politica di guida di tutta la Christianitas avvalendosi precisamente dei patti concordatari stipulati con le quattro principali nationes europee, e relativi sovrani, proprio nel 1418. In seguito, tra il secondo decennio e la fine del XV secolo, altre entità politiche sarebbero entrate nel club dei paesi concordatari, per primi, nel 1441, i due ducati francofoni di Bretagna e Borgogna, sobillati dall’astuto Eugenio IV contro il regno di Francia, poi il regno di Napoli, nel 1442, nonché, negli anni Cinquanta, il ducato di Milano, le repubbliche di Genova e di Venezia, il ducato di Savoia nel 1471, etc. A questo riguardo è clamoroso il dato che vede esclusa l’area degli stati della Toscana dalla prassi concordataria, cosa che Marco Pellegrini addebita agli ottimi e consolidati rapporti tra la Curia e i Medici, suoi principali prestatori e creditori, che avrebbe reso superflua la stipula di un concordato. Alcuni degli stessi paesi si ritrovano chiamati in causa nella narrazione di Mario Rosa, il quale insiste nel definire il Settecento come una particolarissima stagione concordataria, poiché a suo avviso – ed è questo il motivo del consistente salto temporale fra il suo intervento e quello di Marco Pellegrini – soltanto nel secolo dei Lumi vennero ricontrattati alcuni concordati tra la Santa Sede e gli Stati europei, tra cui molti italiani. L’autore analizza minuziosamente, dall’inizio del secolo, i vari passaggi di questo fenomeno, talvolta ingarbugliati nel rapporto tra Curia e pontefice regnante, come al tempo di Benedetto XIII Orsini, oppure travagliati ed interrotti a causa della successione pontificale. La particolarità della fase storica in questione è data, nella prima metà del secolo, dalle guerre di successione, le quali, andando a ridisegnare la carta geopolitica e dinastica dell’Europa e dell’Italia, portarono anche Roma a dover rivedere i legami con i nuovi venuti. Ne è esempio il caso del regno di Napoli, prima passato all’Austria per una trentina d’anni e poi nuovamente ricaduto in orbita spagnola sotto il ramo collaterale dei Borbone. 150 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Dalla metà del secolo entrò inoltre in gioco un fenomeno meno contingente di altri, in quanto riguardò tutta l’Europa occidentale, ossia l’Illuminismo di alcune corti sovrane, che presero a funzionare come grandi laboratori di riforme ispirate in parte al nuovo corso politico-filosofico. Tra i concordati stipulati alla luce di questi riflessi, il più importante e significativo è senza dubbio quello elaborato con la Lombardia austriaca fra 1757 e 1765, quando Maria Teresa associò al governo il figlio Giuseppe. Benché si tratti di casi tra loro diversi, alla base delle istanze dei governi civili vi era la comune necessità di recuperare terreno nella zona grigia tra potere civile e potere ecclesiastico, sia per motivi fiscali che per motivi di efficienza amministrativa. Le cosiddette “guerre dell’equilibrio” avevano dato fondo alle casse degli stati ed il modo più rapido di trovare risorse era cercare di tassare una parte dell’immensa mole di proprietà nobiliari ed ecclesiastiche. Benché obiettivo storico di lungo corso dei governi, il traguardo risultò raggiungibile con successo soltanto in questa fase di tramonto del prestigio universalistico di Roma e dell’unitarietà culturale interna all’orbita dell’Europa cattolica. Vale a dire dopo che la Francia di Luigi XIV aveva già praticamente tagliato il cordone ombelicale con il papato tramite i Quattro articoli della Chiesa gallicana, mentre la Spagna, guardiana della cattolicità, era precipitata nella sua inarrestabile, seppur lenta decadenza. La secolarizzazione dei rapporti internazionali risultava insomma quasi completata, dopo un’evoluzione a fasi alterne che aveva attraversato tutta la prima metà del XVII secolo, per poi protendersi, con il contributo fondamentale della Pace di Westfalia, nell’epoca in cui lo Stato della Chiesa e il suo pontefice si trovarono progressivamente sempre più isolati, tanto da uscire dal novero dei grandi protagonisti della politica internazionale. Si sottolinea però nell'introduzione di Maria Antonietta Visceglia che un certo giudizio, sentenzioso in negativo, sull'importanza ed il peso internazionale di Roma "oltre Westfalia", come scrive la curatrice del volume, vada riconsiderato alla luce di alcuni periodi di maggiore sprone politico fornito da parte del papato ad attività internazionali a largo raggio. Si pensi innanzitutto all'età innocenziana – oggetto di un recente convegno di studi, nel marzo del 2012 a Roma, in occasione del centenario della nascita del papa Odescalchi – durante la quale la spinta antiottomana della Chiesa contribuì ad innescare un processo politico-militare di lungo periodo, attraverso la sua virtuosa intesa diplomatica faticosamente tessuta fra le potenze cristiane alleate. In seguito, la catena degli eventi, dal fallito assedio di Vienna fino alle vittoriose campagne del principe Eugenio di Savoia ed oltre, aprì di fatto l'epoca della penetrazione asburgica nei Balcani, a discapito della Sublime Porta, ormai avviata alla sua inarrestabile contrazione politica e geografica nel Levante. 151 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Da qui in avanti, recuperando il filone principale del discorso, dopo aver delineato con Marco Pellegrini e Mario Rosa questo grande panorama della problematica concordataria dagli esordi tardomedioevali alla piena età moderna, è necessario tornare, sempre all’interno della prima sezione del volume, ai contributi dedicati alle questioni del papato come precursore dello Stato moderno e innovatore della politica internazionale a partire dai primi decenni del secolo sedicesimo. Le sfide dello stato ecclesiastico: politica estera, ruolo culturale e nodo dell’italianità Il modo di condurre da parte del papato la propria politica internazionale – concordano in linea di massima gli autori del volume – riflesse in modo dinamico ed innovativo le particolari condizioni ed esigenze politiche, istituzionali, giurisdizionali ed ecclesiologiche dello Stato della Chiesa, che ne fecero una sorte di precursore fra gli Stati dell’Europa del primo Rinascimento. In primo luogo, il papato si dedicò a dotarsi di strumenti efficienti, centralmente organizzati e diffusi sul territorio europeo (e non solo) al fine di perseguire la propria politica estera ed ecclesiastica, attraverso l’istituzione di un vero e proprio apparato diplomatico. Come a dire che a linee di condotta salvo eccezioni estranee a quelle presenti nelle cancellerie dei sovrani, ovvero a logiche particolari proprie della Chiesa romana, dovettero corrispondere strumenti particolari, affidati a funzionari ancor più fuori dell’ordinario. Roma fu insomma la vera innovatrice in questo campo attraverso l’istituzione del corpo dei nunzi apostolici, ovvero propri ambasciatori presso gli stati sovrani cristiani. In verità non si trattò di un’operazione facile, dato che la figura di questo nuovo legato impiegò parecchio tempo a consolidarsi in modo chiaro e preciso, e così i suoi compiti e le sue prerogative vennero a definirsi soprattutto a partire dalla fine del XV secolo e lungo il corso del XVI, con il sorgere di tutte le note innovazioni e conflittualità di età moderna. Se in questa lunga fase preparatoria i primi protagonisti a costituire un’innovazione furono i nunzi, seguirono poi i missionari, i gesuiti, gli inquisitori, ed infine all’inizio del XVII secolo la vasta galassia degli agenti della Congregazione De Propaganda Fide. Una lunga catena di apparati nati in epoche susseguenti e sotto la spinta di pontefici diversi, mossi loro volta da esigenze contingenti, verso quali però non venne talvolta usata adeguata previdenza e visione di lungo periodo, tali per cui alcune soluzioni adottate, non sempre risultarono utili alla vita della Chiesa. Questo vasto arco temporale che corrispose al processo di parziale risistemazione dei gangli vitali istituzionali del papato risulta suddivisibile, stando ai suggerimenti di Alain Tallon, in fasi caratterizzate o dall’attività 152 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 protagonista del pontefice regnante, oppure dalla particolare innovazione che in una singola fase cominciò a prendere piede. Inoltre, come tema fondante del percorso di ricerca, dal team di studiosi viene posta l’attenzione sul contrasto tra l’universalismo, reclamato come primo motore dell’azione internazionale del papato, e l’ineludibile presa d’atto del fatto che uomini e interessi eminentemente italiani esercitassero un ruolo chiave nel determinare le scelte di governo della Chiesa per tutta la durata dell’età moderna. Ad avviso di chi scrive, ciò in parte è un falso problema, in primis perché le personalità italiche (di Italia politica è anacronistico parlare, meglio adottare l’espressione “italica” al posto di “italiana”) provenivano da stati molto diversi fra di loro, spesso culturalmente e linguisticamente lontanissimi. Perciò non sussistendo un panorama socio-politico unitario ne consegue che difficilmente si possa in sede di studio affermare, al di là di casi specifici e documentati, che gli “italiani” costituissero un blocco così omogeneo dal punto di vista degli interessi e quindi che detenessero una vera egemonia dentro la Curia, chiudendosi a riccio nei riguardi di personaggi appartenenti ad altri popoli europei e chiamati a Roma per servire gli interessi della Chiesa. In quanto a forte coesione e potere gestito da un’oligarchia palese, forse erano state più omogenee la corte e la Curia avignonesi del XIV e XV secolo, senza dubbio condotte da una evidente prevalenza di elementi francesi. Al tempo stesso, non si può negare che la Chiesa abbia svolto un’intensa azione di comune acculturazione degli italici, o italiani che si vogliano chiamare. Come in un suo celebre saggio ricordava Carlo Dionisotti, la disputa linguistica sulla possibilità dell’uso autonomo del volgare rispetto al primato del latino fu per lo più interna agli ambienti intellettuali ecclesiastici, nell’ambito dei quali l’innovazione del pensiero di Pietro Bembo venne assai osteggiata dal suo amico e strenuo difensore del latino classico Jacopo Sadoleto; da notare che entrambi i personaggi furono segretari personali di Leone X. Il che risulta ancor più vero se il punto di vista viene rovesciato, nel senso che gli ambienti romani da sempre proliferavano di stranieri che raggiungevano influenze e posti ragguardevoli. Per certo si riscontra nell’età moderna rispetto al Medioevo una maggiore concentrazione di italiani, dettata e spiegata dal progressivo radicamento del papato come stato regionale italiano nel corso dei secoli XV e XVI. Tuttavia, accadeva di sicuro più facilmente che uno straniero riuscisse a fare carriera, in senso lato “politica”, a Roma piuttosto che nelle istituzioni imperiali, in cui l’elemento tedesco era preponderante rispetto alle pretese universalistiche del monarca della Christianitas latina. Solo con l’ascesa di Carlo V ed il suo utopico progetto imperiale si poté assistere all’attività di uomini dalle più varie provenienze a servizio del giovane imperatore. 153 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Sugli interessi italiani degli uomini del papa sarebbe più consono ricordare che i veri beneficiari di alcune politiche amministrative e fiscali direttamente connesse alle proprietà fondiarie ecclesiastiche – e quindi legate ai territori della penisola su cui Roma vantava vari tipi di giurisdizione – siano stati i casati nobiliari. Questi ultimi, tramite i propri congiunti e le alleanze di fazione in Curia, riuscivano ad indirizzare la condotta della Reverenda Camera Apostolica e a mettere nei posti chiave personalità che rappresentassero determinate istanze dinastiche, sia a livello minore, nella politica interna romana, che in politica estera italiana ed europea. Una rete di relazioni sociopolitiche che andavano anche al di là di mere motivazioni economiche ma che, pur partendo da esse, raggiungevano un grado di complessità politica difficilmente comprensibile se riferita soltanto a logiche di potere regionali italiche. A questo proposito rimangono molto importanti gli studi di Renata Ago sulle carriere prelatizie e le clientele della nobiltà nella Roma barocca. Dovendo fare i conti con il governo temporale di Roma, che era per forza di cose subordinato alle esigenze del magistero spirituale e quindi politico del papa, anche i protagonisti della politica internazionale del papato, espressione degli ambienti aristocratici romani e italici, dovettero assecondare il proprio interesse personale al disegno più grande, a rischio di delegittimare ciò che rappresentavano nella loro funzione. Per ultimo, si dovrebbe riconoscere con metodo obiettivo che molte figure italiche dimostrarono con i fatti una grande dedizione e preparazione, e che la vasta gamma delle famiglie religiose presenti a Roma fornì intellettuali e uomini d’azione di diverse esperienze e prospettive. Pertanto, nei vari contributi si sottolinea da più punti di vista quanto la rilevanza del tema storiografico dell’italianità del papato in età moderna andrebbe rimodulata, nel senso di superare la “condanna”, in verità assai diffusa, verso un papato e una Curia romana troppo italiani, a causa di un regime del governo della Chiesa chiuso e pilotato esclusivamente dalle consorterie dei principi italiani. In questa linea di ragionamento, l’esperienza traumatica delle guerre d’Italia causata dalla lotta per la supremazia francospagnola e dai disordini civili degli stati peninsulari può aver non poco contribuito a fare sì che anche negli ambienti romani, seppur più ecumenici per definizione, la presenza di religiosi stranieri – con l’importante eccezione del Sacro Collegio, entro il quale dovevano essere sempre rappresentate le nationes cristiane – sia stata vissuta con sempre maggiore sospetto, se non aperta ostilità. Del resto, anche da parte delle stesse potenze europee era vissuto come un pericolo il fatto che presso il papa vi fosse una fitta presenza stabile di prelati e consiglieri nazionali mandati dai propri nemici, potenzialmente nocivi per le proprie mire. Questo stato di cose non impedì peraltro che l’influenza dei grandi monarchi nei palazzi romani, non potendo essere esercitata per tramite 154 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 di propri sudditi, finisse per essere delegata per procura ad attori locali esponenti di ordini religiosi o dell’aristocrazia romana. Le guerre d’Italia e il papato costretto alle armi: da Carlo VIII al Sacco di Roma Più in generale, il Cinquecento, come è noto, si aprì con le questioni rimaste irrisolte dal decennio del pontificato borgiano: sin dall’invasione francese di Carlo VIII, il vecchio equilibrio quattrocentesco della penisola risultava sottoposto ad un intenso e perdurante terremoto che imponeva allo Stato della Chiesa di riorganizzarsi profondamente. Esso lo fece inizialmente attraverso le spinte belliciste del papato militante di Giulio II, il quale unì alla ripresa del controllo di tutti i territori da tempo sfuggiti alla giurisdizione di Roma – inclusi i ducati adriatici, teatro delle mire politiche del duca Valentino – il disegno di soggiogare addirittura tutta l’Italia centrale al potere temporale delle chiavi (o in questo caso delle spade) del successore di San Pietro. Questo pontefice in armatura, come è noto, giocò un ruolo diretto nella politica interna al sistema degli stati italici. Prima di lui nessuno l’aveva fatto così intensamente e neanche dopo di lui una tale spregiudicatezza politica poté prodursi di nuovo, vuoi per l’ondata di sdegno nei confronti di un sacerdoteguerriero da parte di intellettuali come il Guicciardini – il quale nei suoi Ricordi scrisse che Giulio II di strettamente "religioso" aveva solamente l'abito – vuoi per l'annoso ritardo nella riforma della Chiesa che spalancò i battenti al messaggio di Lutero. Sotto i pontificati medicei, almeno a parole ed anche tramite iniziative pubbliche che hanno lasciato traccia nelle vestigia artistiche da loro promosse, come riporta Heinz Schilling, i successori di Pietro si proposero invece come promotori di pace. La ricerca di una posizione di primato nell’interlocuzione politica con il nuovo giovane imperatore, ma anche, nei primi anni sul soglio di Leone X, l’apparentamento con Francesco I, come si è già in parte trattato, rivela come gli echi delle vittorie del papa Della Rovere si fossero spenti. Si stava delineando come del tutto relativa la forma di egemonia romana sulle sorti delle iniziative militari che potenze come Francia e Spagna intraprendevano sul suolo italico dopo aver constatato l’intrinseca debolezza dei principati e delle repubbliche peninsulari. Nonostante questa intermittenza nell’esercizio del potere, fu una fase, quella del primo trentennio del XVI secolo, in cui il papato sia nei momenti di prorompente affermazione sotto Giulio II, sia dopo la sua morte con Leone X e successivamente con Clemente VII, in genere adottò un profilo di continuità strategica. I pontefici in questione, eccezion fatta per la nobile parentesi moralizzatrice di Adriano di Utrecht, si risolsero sempre ad appoggiare 155 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 l’iniziativa della potenza più debole per contrastare, attraverso la costituzione delle leghe di alleanza tra gli stati minori, quella che era egemone in quel momento. Fu questo un ragionamento di politica più dell'interesse proprio dei Medici che dello stato ecclesiastico che non durò a lungo, in quanto questo gioco a rimpiattino prevedeva dei rapidissimi rovesciamenti di fronte e, alla fine, la lotta tra spagnoli e francesi vide la sconfitta dei secondi, alleatisi con Clemente VII, il cui disegno politico si rivelò fallimentare. Da Paolo III a Clemente VIII: una scelta di mediazione La svolta della diplomazia pontificia si ebbe sotto il pontificato farnesiano, come riporta l’interessante trattazione di Alain Tallon, il quale nota che dopo le guerre d’Italia e il Sacco di Roma, nonché l’avvenuta riconciliazione fra Carlo V e Clemente VII con l’incoronazione imperiale a Bologna nel 1530, il nuovo papato incarnato da Paolo III volle assicurare la “pace d’Italia” al fine di preservare la “libertà d’Italia”, oltre all’autonomia degli stati della Chiesa. Il papa Farnese quindi per impedire l’ingerenza politica degli stranieri, se non prevenire persino una nuova calata in armi, tolse la Chiesa di Roma dall’imbarazzo di schierarsi apertamente con quanti si contendessero il predominio italo-europeo nella prima metà del XVI secolo; ovvero proprio perché da una parte la Francia e dall’altra gli Asburgo miravano ad un solo scopo, inaugurando la politica della mediazione papale. Essa si incentrava sulla visione del pontefice come “padre comune” di tutti i principi cristiani, almeno quelli che ancora lo riconoscessero come tale dato che la Riforma aveva già generato la frattura della cristianità occidentale. Così il potere ecclesiastico si faceva terzo negli scontri che flagellavano l’Europa e si proponeva come arbitro delle contese fra sovrani cattolici. Sennonché, per salvare le apparenze e poiché le consuete polarizzazioni politiche all’interno degli stessi religiosi, in particolare nel Sacro Collegio, non erano venute meno, venne approntata dalla Curia la pratica della doppia legazione. Questa misura entrata in uso consisteva nell’invio di una missione diplomatica per ciascuna delle parti in causa, ponendo attenzione nell’assegnare ai porporati l'incarico di cardinali capidelegazione a seconda del loro manifesto schieramento geopolitico. A questo proposito Alain Tallon fa l’esempio della missione di pace del 1542, nella quale occasione si decise di inviare presso Carlo V il cardinal Contarini, affiliato al gruppo degli spirituali e di parte filo-imperiale, mentre il filo-francese cardinal Sadoleto fu mandato alla corte di Francesco I. I diplomatici di Santa Romana Chiesa affinarono le loro doti, pronti ai compiti difficili che li attendevano. Era di estrema importanza portare con sé tutti i frutti 156 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 della propria formazione, a proposito della quale da un certo momento in poi fra i ranghi degli inviati all’estero comparivano sempre di più allievi di scuola borromaica, fra i quali il rappresentante più eminente fu senza dubbio il vescovo di Padova Niccolò Ormanetto. Nel corso degli anni, i diplomatici romani svilupparono un consistente armamentario retorico, nel caso anche controversistico, composto di eloquenza e retorica di cui si servivano nei colloqui delle loro ambascerie, sia per sostenere opportunamente le loro tesi che per controbattere efficacemente alla parte avversa. A questo scopo essi seguivano un prontuario di motivi formulari che ricalcavano più o meno sempre gli stessi elementi, tratti dalla nutrita produzione di libellistica oratoria sviluppatasi lungo tutto l’arco del sedicesimo secolo. Ne furono autori studiosi vari che sostennero su base canonistica la primazia politica e giurisdizionale dei pontefici, fornendo nei loro scritti valide argomentazioni, le cui figure retoriche, talvolta stereotipiche nella ripetizione inveterata, erano riprese ad uso pratico dai diplomatici romani e non solo, quand’anche non fossero essi stessi tra gli autori dei suddetti trattatelli. Ma il vento stava per cambiare e, se arduo fu lo sforzo per la mediazione compiuto negli anni del suo pontificato, con la morte di Paolo III e la “parentesi” di Giulio III, gli eventi presero una piega assai differente, ripercuotendosi sulla politica della “terzietà” del papato. La presa di posizione neutrale durò dagli anni Trenta fino a metà anni Cinquanta, allorché fu eletto papa Giovanni Pietro Carafa, ex supremo inquisitore e di feroci vedute antispagnole. Come assai noto, egli aprì il suo pontificato con una frattura rispetto alla politica estera dei suoi immediati predecessori, convinto di dover perseguire la cacciata degli spagnoli dalla penisola italica, ma le armi gli diedero torto sul campo, dopo i fallimentari risultati della breve guerra contro la Spagna, in alleanza con la Francia. Paolo IV dovette quindi ricredersi e tornare sulla linea della mediazione, ma con una credibilità politica compromessa; toccò dunque ai suoi successori ricostruire il discorso riguardo la perduta posizione di neutralità. Alain Tallon sottolinea come la scelta della “neutralità attiva” consentì al papa di mantenere un ruolo internazionale di primo piano che il potere militare datogli dalla sua condizione di medio sovrano di area italiana non avrebbe potuto più garantirgli. Insomma, dalla metà del secolo in avanti si fece oltremodo lampante la convinzione che i fortunati tempi di Giulio II che voleva scacciare i barbari al di là delle Alpi, e che per breve tempo con fatica vi riuscì, non sarebbero più ritornati. Inoltre, a questa altezza temporale, un disegno più ambizioso aleggiava sullo sfondo della politica di mediazione papale: la visione di una “pace cattolica” ottenuta tra i sovrani d’Europa per estirpare, innanzitutto, l’eresia dai 157 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 propri confini interni e, in seguito, lanciare un’inedita crociata contro il Sultano di tutte le nazioni e le corone cristiane, alleate sotto l’egida del romano pontefice. Tuttavia i sovrani, guardinghi nei confronti di quelle che sembravano loro millantate promesse di gloria cristiana e di conquista di terre oltremare, ogni qual volta la prospettiva della spedizione armata adversus Turcos venne tirata fuori – prosegue Tallon – non se ne fecero incantare. Da un lato, ai loro occhi la crociata costituiva un motivo simbolico di affermazione del prestigio, nonché di deroga alle consuetudini dei rapporti economici con il clero nazionale, a tutto vantaggio della corona. Dall’altro, le stesse monarchie restavano politicamente convinte del fatto che il papato avrebbe sempre privilegiato i suoi interessi anche nei tentativi di conciliazione universale. Di conseguenza si guardarono bene, con comportamento inveterato nei decenni, dal concedere troppo ascolto agli appelli pontificali alla guerra santa, che finivano per restare più o meno larvatamente boicottati. Sempre a parere di Tallon, in seguito alla scomparsa politica del gruppo degli spirituali, che aveva giocato da protagonista la stagione della mediazione in un’ottica di alleanza tra l’Impero e la Chiesa, ma anche di compromessi con la corte francese, destinata a produrre risultati soddisfacenti in occasione del concilio ed oltre, nel secondo Cinquecento, pur superata la fase critica di papa Carafa, la diplomazia pontificia, ritornata, come accennato, ad un ruolo di mediazione ed alle aspirazioni all’esercizio di un ruolo di guida della cattolicità conobbe comunque resistenze diffuse e fasi sicuramente alterne. Altri leader sorsero in ogni caso a brandire la spada della Christianitas unita. Da ricordare su tutti i tentativi al contempo irenici ed egemonici dei sovrani francesi – a partire, sia prendendo il tutto con molte riserve, da Enrico IV di Borbone – i quali si appropriarono anche della causa della crociata contro gli ottomani, qualora fosse stata previamente concordata la pace fra le devote potenze cristiane. Presumibilmente, ove il disegno fosse andato in porto, la societas dei principi cristiani, conformemente a questo scenario, avrebbe riconosciuto come proprio apice il Re Cristianissimo di Francia, piuttosto che il papa di Roma. Ad ogni buon conto, sottolinea Tallon, la politica della mediazione romana produsse comunque dei seppur piccoli risultati, tra cui alcune significative tregue di contenimento dell’egemonia spagnola, quando per esempio si impedì un inutile bagno di sangue nel caso della missione genovese del cardinal Morone nel 1575, inviato ad scongiurare sia un intervento diretto di Filippo II, sia uno scoppio di violenza fratricida all’interno della Superba. Ciononostante è un fatto che la mediazione papale non ebbe effetti macroscopici sul lungo periodo, ad eccezione della Pace di Vervins, tramite cui il papato assurse alle glorie della scena politica come pacificatore delle guerre di religione in Francia. 158 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Essa ebbe come prezzo l’assoluzione di Enrico IV, concessagli da Clemente VIII in cambio della conversione, mentre la Spagna si trattenne dall’intromettersi più negli affari interni francesi. Fu questo un vero successo della mediazione pontificia? In verità non mancarono ripercussioni nei rapporti privilegiati tra Roma e la Spagna, mai stati del resto del tutto rosei nel secondo Cinquecento. Fu comunque con il protrarsi del XVII secolo che il papato si sarebbe ritrovato alla lunga, seppur fra alti e bassi, decisamente isolato nella politica internazionale. Pur vivendo anni floridi, e in certi momenti addirittura entusiasmanti, sotto i pontificati Borghese, Ludovisi e Barberini, Roma perse terreno in Europa – basti pensare alle delusioni della pace di Westfalia – riuscendo a riguadagnare prestigio solo alla fine del Seicento, con il ruolo di primo attore giocato da Innocenzo XI all’epoca dell’assedio di Vienna del 1683 e della conseguente stagione favorevole alle armi cristiane che si aprì di lì a pochi anni. Resta peraltro alquanto curioso riscontrare gli scarsi accenni dedicati nei saggi all’epoca della Montagna Bianca e dell’Editto di restituzione, che parvero annunciare una rivincita cattolica su tutto il continente. Si trattava di un grandioso successo, seppure relativamente effimero, eppur preparato accuratamente nel corso dell’epoca post-conciliare. La svolta romana degli anni Settanta e Ottanta. O l’impegno su più fronti Di fatto, retrocedendo un poco, tutta la seconda metà del XVI secolo straripa di un’attività frenetica e di sperimentazioni molto interessanti, sebbene spesso non gestite al meglio o tali da condurre sempre a risultati incisivi. Basti pensare al colossale riordino del sistema delle nunziature e in particolare, ricorda Visceglia, alla delegazione inviata da Pio IV in Danimarca e Svezia del 15601561, una parentesi conciliatoria con il mondo luterano, in vista oltretutto della chiusura del tridentino, drasticamente smentita dalla cesura teologica e dogmatica avvenuta con il suo successore. Pio V infatti fu artefice di una scelta di chiusura totale a tutto ciò che non fosse parte di una linea di netta contrapposizione all’eresia, considerando le aree grigie dal punto di vista culturale e confessionale, anche potenzialmente vaste, soltanto come pregne del nero colore dei nemici della fede. Seppur su molte cose affine al pontefice domenicano, in seguito fu proprio Gregorio XIII ad interessarsi a come sviluppare da Roma un legame con gli attori più defilati rispetto all’aperta lotta tra cattolici e protestanti. Con la svolta degli anni Settanta e Ottanta, come la definisce Maria Antonietta Visceglia nell’introduzione al volume, iniziata proprio con Gregorio XIII, il papato acquisì nuovi strumenti e nuovi linguaggi per la sua affermazione, per un verso 159 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 negativa verso eretici ed infedeli, per altro positiva verso l’evangelizzazione dei nuovi popoli, con il ruolo del pontefice proposto al vertice della società umana garantita dall’essere nel seno della Chiesa. Dapprima fu implementato dal papato il rapporto con le chiese orientali, continuando gli sforzi iniziati da Paolo III e da Giulio III. Le comunità patriarcali della sponda asiatica del Mediterraneo furono avvicinate, sentite, coinvolte, in nome di una condivisa partecipazione devozionale alla fede comune, all’interno del microcosmo romano, animato dai fervori culturali dei collegia delle nationes cristiane. Per la verità, non per tutti avveniva in quest’epoca il primo ingresso nel “gran teatro del mondo; ad esempio l’antichissimo filo delle relazioni con i cristiani dell’Etiopia e con i sovrani abissini non si era mai spezzato, tant’è che la Chiesa della loro comunità a Roma, Santo Stefano degli Abissini, ricevette molta attenzione dai cardinali protettori incaricati. Per parte loro, Melchiti, Maroniti, Copti riannodarono i rapporti con il papato, mentre ne furono intessuti di nuovi con i patriarchi delle chiese Armena e Nestoriana. Spedizioni vennero inviate in Etiopia e in Persia, quest’ultima terra di antiche speranze di alleanza in funzione antiturca, qualora l’Europa si fosse riunita pacificando i suoi principi sempre in lotta, per liberare con una nuova e definitiva crociata i luoghi santi e i loro fratelli cristiani orientali, come testimoniano i contributi di Aurélien Girard e Christian Windler. In molte corti della penisola italica presero piede posizioni che guardavano a oriente con interessi molteplici, anche culturali, dacché ad esempio lo studio dell’arabo, ma di anche altre lingue semitiche e non, fu incoraggiato per poter comunicare con questo mondo in parte dimenticato, se non addirittura del tutto sconosciuto. Tra la fine del XVI e i primi del XVII secolo, si approntarono inoltre traduzioni, grammatiche, dizionari, resoconti di viaggio, etc. in istituti nuovi come la Tipografia Poliglotta Vaticana, voluta e realizzata come organo proprio della Curia romana da Sisto V nel 1587. Ancora più a oriente, vi era lo scenario asiatico che fu la frontiera dei diversi interessi tra Spagna e Portogallo e tra questi ultimi e la Santa Sede. In questa direzione l’attenzione rivolta dai papi Boncompagni, Peretti e Aldobrandini, improntata anche alla curiosità e alla conoscenza del nuovo e dello stravagante, come nota Elisabetta Corsi nel suo saggio, fu costante sin dai primissimi contatti con quelle terre lontanissime da Roma. Si pensi alla pronta fondazione, nel giro di un solo decennio nel corso della seconda metà del XVI secolo, delle due diocesi di Macao e di Manila, erette rispettivamente da Pio V e da Gregorio XIII con l’intento esplicito di evidenziare le due differenti giurisdizioni coloniali, ciascuna con il suo pastore. La prima, quella portoghese, dal porto cinese – il cui vescovo era suffraganeo 160 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 del metropolitano di Goa – aveva interesse ad allungare le sue mire mercantili su Cina e Giappone, assicurandosi in tale modo il monopolio esclusivo di alcuni traffici. Da quella spagnola, il governo di Madrid riteneva invece di poter ampliare i suoi domini asiatici usando l’arcipelago delle Filippine – a loro volta dipendenti dall’arcidiocesi di Città del Messico – come testa di ponte per un’ipotetica invasione delle isole del Sol Levante. La quale, se fosse riuscita, avrebbe dato esecuzione al progetto, in seguito abortito, di fare dell’intero Pacifico un oceano spagnolo, raccordando così anche le rotte commerciali con le Americhe. Sempre a proposito della medesima zona, considerata a lungo una periferia esotica dagli europei, la coppia dei contributi di Elisabetta Corsi, sull’orientalismo e l’antiquaria a Roma nel secondo Cinquecento, e di Eugenio Menegon, a proposito delle vicissitudini della penetrazione politica e religiosa della Santa Sede nella Cina del Settecento, mostrano un suggestivo panorama dei rapporti papali diplomatici e culturali con l’Estremo Oriente. Difficile definirli sia come fuori dell’ordinario, sia come rientranti nei normali costumi delle relazioni internazionali in età moderna. Di fatto, il papato si servì della Compagnia di Gesù non solo come contingente missionario, ma anche politico e diplomatico. Sin dall’arrivo di Matteo Ricci nel Celeste Impero, i patres allacciarono infatti proficui rapporti con l’élite culturale e burocratica cinese. Tali intrecci politici e culturali avrebbero dato luogo persino ad alleanze di corte animate da comuni intenti tra i gesuiti e i mandarini, i quali condividevano entrambi l’accesso privilegiato alla Città Proibita come fidati consiglieri dell’imperatore. Conseguentemente, la ricostruzione di Menegon ci propone un papato risoltosi ad affidare alla Compagnia il compito di stabilire un legame diretto con i potenti di quelle terre remote, anche per evitare l’altrimenti obbligatorio filtro del potere coloniale delle monarchie iberiche, unici interlocutori europei, oltretutto cattolici, presenti in quell’area. Questo enorme slancio politico-ecumenico si esercitava su fronti troppo vari, complessi e discontinui fra loro per poter essere gestiti da Roma attraverso i metodi del passato. Da questo punto di vista il Cinquecento costituisce lo sfondo del lungo e travagliato processo di revisione del proprio modus operandi politico e culturale da parte della Chiesa. In questo senso sia i saggi di Paolo Broggio che di Francesca Cantù offrono degli spunti di notevole interesse. Personalità individuali, gruppi di pensiero, risorse ed istituzioni dovettero adattarsi ad un nuovo palcoscenico mondiale da cui trarre le idee, anziché semplicemente sovrapporvi elaborazioni preconcetti escogitate dai canonisti e dai teologi all’ombra della grande tradizione aristotelico-tomista, invero in fase calante. 161 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 A tale ultimo riguardo si potrebbe ancora aggiungere in via generale che il pensiero prodotto dalle università della cattolicità, se non proprio in crisi, restava almeno indeciso e confuso sui percorsi da seguire rispetto alle nuove sfide del dibattito culturale che faceva epoca in quel momento. Come a dire, l'élite dei filosofi della Chiesa, dai suoi refugia scolastici restava in parte pietrificata nella difesa dello status quo delle sue dottrine e si appoggiava saldamente al principio di auctoritas delle Scritture e dei Padri, anche perché troppo timorosa di barcollare al di fuori dell’ortodossia sancita dal Concilio di Trento. Figure ed istituzioni romane della Controriforma: Propaganda Fide protagonista Una delle chiavi di lettura che viene diffusamente adottata dagli autori del volume per valutare l’azione della Chiesa romana si avvale dei risultati degli approfondimenti delle ricerche su “Uomini e apparati”, come titola l’interessante saggio di Silvano Giordano. Lo studioso rivolge l’attenzione alla struttura del potere curiale, rilevando la ridotta consistenza numerica delle personalità ecclesiali incaricate di gestire l’amministrazione centrale e di condurre la politica diplomatica della Santa Sede nei primi decenni del Seicento, ponendo l’accento sul fatto che non fossero poi moltissime rispetto al numero delle cariche e dei compiti a cui attendere. Questo fatto è presto spiegato da due fattori, uno più virtuoso e l’altro meno: da un lato va tenuto in conto il numero relativamente esiguo – peraltro fissato da Sisto V– dei membri del Sacro Collegio, i quali, oltre a presiedere ciascuna congregazione principale, erano spesso anche cardinali protettori degli ordini religiosi, delle chiese nazionali e commendatari delle abbazie e dei monasteri dello Stato pontificio. In breve, delle istituzioni curiali maggiori erano esclusivi componenti soltanto i porporati, mentre ai livelli inferiori sedevano come segretari, anche di un certo peso, dei prelati minori. Sul versante meno virtuoso, risulta dalla documentazione che vi era un interesse molto evidente a mantenere scarso tale numero, per poter così fare parte di più commissioni di cui ogni componente riceveva una corrispondente indennità di funzione. Questo fece sì che, oltre alle dieci congregazioni riconosciute come permanenti nell’organigramma della Curia, come è ben riportato nell’ intervento di Giovanni Pizzorusso (da affrontare in tandem con quello di Giordano per una disamina organica della questione) nascessero quasi spontaneamente numerosi comitati ad hoc o congregazioni temporanee per cause contingenti più o meno necessitanti. Il che, in ogni caso, non risultava sufficiente. 162 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Tutto ciò finì per condizionare infatti l’efficienza dell’apparato curiale, rallentando anche l’istituzione di un’unica amministrazione centrale incaricata del complesso progetto missionario nelle terre d’oltreoceano. Con il risultato di favorire il patronato regio ispano-portoghese e di non garantire un’adeguata gestione della partita missionaria, in Europa e al di là dei suoi confini. Era una partita dai risvolti sia di natura strettamente ecclesiastica che di potere, legati alla dipendenza delle chiese territoriali dalle corone iberiche e alle vertenze amministrative tra Roma, le diocesi del patronato e i sovrani cattolici. Le cose sarebbero cambiate soltanto con la tardiva fondazione di Propaganda Fide nel 1622 per illuminato coraggio di Gregorio XV. Un’innovazione che, al di là della tematica missionaria in sé, avrebbe, da una parte, accresciuto i conflitti di competenze tra gli organi pontifici e, dall’altra, creato nuovi problemi dovuti alla complessità del gigante Propaganda Fide. Giovanni Pizzorusso cita nel suo contributo l’opinione critica dello storico Josef Metzler in merito al fatto che Propaganda riuniva in se stessa troppe direttrici d’iniziativa politica tra loro divergenti, cosa che l’avrebbe resa un calderone veramente complicato da amministrare tutto in una volta. Ad avviso di Metzler sarebbe forse stato meglio disgiungere in più istituzioni i suoi molteplici campi d’interesse, nel modo seguente. Ovvero prevedere: un solo organismo deputato alle missioni d’oltremare in America ed in Asia; un altro preposto alla lotta all’eresia protestante in Europa; infine un terzo destinato alla ricomposizione dello scisma d’Oriente e ai rapporti con i cristiani di rito orientale, nelle loro diverse obbedienze. Questi ultimi erano pensati soprattutto alla luce della riproposizione in sede internazionale europea della crociata contro il Turco ottomano per liberare i luoghi santi. A tale proposito il saggio di Laura Ronchi De Michelis traccia approfonditamente gli eventi, gli uomini ed il contesto in merito ai tentativi romani di attrarre nella propria orbita la Moscovia, un desiderio che vide scontrarsi nella Curia due linee politiche. Una, più realistica e al tempo stesso più speranzosa di poter ricongiungere l’intera cristianità, puntava alla promessa di riconoscimento del granduca come re, e successivamente anche come imperatore con diritto di discendenza sul trono bizantino, dopo che questo venisse, per così dire, restaurato con una spedizione militare congiunta di cattolici e ortodossi contro la Sublime Porta. L’altra linea direttrice, più rischiosa, ambiva alla conquista militare della Russia per convertirla al cattolicesimo con la forza delle armi di Sigismondo III Vasa, una scelta che con tutta evidenza incontrava maggiormente il favore della Polonia. Per parte sua, il regno confederato polacco-lituano non avrebbe di certo gradito che, secondo l’altra opzione politica, nella propria area d’influenza il papa riconoscesse una nuova potenza con aspirazioni di leadership su tutti i popoli slavi, per di più 163 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 consacrandola addirittura “imperiale”. Di qui la tentazione dell’atto di forza all’interno della Slavia. Tornando all’intervento di Giovanni Pizzorusso, vi si fa anche riferimento al duraturo dibattito storiografico su quali siano state le prime cause della nascita della congregazione presieduta da Francesco Ingoli, e quali le sue prime sfere d’interesse. Per un verso, Josef Metzler sostiene che essa sia stata fondata con il preciso fine di una riorganizzazione globale, ossia per ricucire una trama unitaria dell’intervento missionario in tutto il mondo. Conseguentemente, vi era anche lo scopo ultimo di separare lo sforzo evangelizzatore romano dalle politiche delle potenze cristiane, troppo frequentemente indirizzate a forme di dominio protocoloniale. Pertanto si auspicava negli ambienti papali di poter un giorno riscattare la Chiesa di Roma dai gravami del patronato che era stato concesso alla Spagna e al Portogallo con il Trattato di Tordesillas. Tali privilegi erano stati ulteriormente sanciti dalle bolle papali, come la borgiana Inter coetera, del 1493, e le due medicee Dum fidei constantiam ed Emmanueli regi Portugalliae illustri, entrambe del giugno 1514. Per parte sua, lo storico e giurista Eutimio Sastre Santos ritiene invece che Propaganda Fide nascesse con un marchio spiccatamente controriformistico nella contingenza della Guerra dei Trent’anni, con lo specifico fine di sradicare l’eresia protestante dalla Mitteleuropa. Egli suffraga la sua tesi con un’analisi documentaria frutto di molti anni di lavoro. I relativi riscontri vedono prevalere nell’archivio della congregazione una mole maggioritaria di carte riguardanti le attività perseguite nel vecchio continente piuttosto che quelle esercitate negli scenari extraeuropei. Risulta in effetti di indubbia rilevanza il ruolo interpretato dagli agenti di Propaganda negli anni in questione nelle terre dell’Impero, talvolta anche in aperto dissidio con altri attori della Controriforma come i gesuiti, i cappuccini, il clero secolare, gli ordini monastici, il Sant’Uffizio, la Segreteria di Stato. Soprattutto i gesuiti che agivano nella veste di insegnanti e confessori esercitavano un magistero spirituale negli ambienti nobiliari e cittadini, operando in una prospettiva e con metodi che si potrebbero dire di lungo periodo. I vescovi delle diocesi locali subivano invece la quotidianità delle influenze imperiali, insieme a quelle dei maggiorenti locali, altalenando così sulla bilancia del pragmatismo la lealtà a Roma con l’acquiescenza verso i principi territoriali e gli Asburgo. Infine, altre figure missionarie, talvolta isolate e in molti casi poste a stretto contatto con le comunità delle minoranze eretiche in Europa centroorientale – se non addirittura al confine con il mondo ortodosso e/o la giurisdizione ottomana e i nuclei di popolazione musulmana nei Balcani – si trovavano spesso lontanissime dalle città, oltre che prive di risorse di base e di 164 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 mezzi di comunicazione con il nunzio deputato a sovrintendere le singole aree geografica. In tale quadro, Propaganda assolse ad un ruolo di raccordo e di riconduzione all’osservanza romana di una realtà ecclesiastica che tendeva alla frammentazione. In generale, come nel resto d’Europa, anche nei domini ereditari asburgici, e soprattutto nelle terre della corona di San Venceslao, l’azione degli agenti romani di varia appartenenza spesso non incontrava il completo favore imperiale. Questa eventualità poteva accadere in quanto soprattutto in Austria, in Boemia e in Moravia si andava a toccare situazioni delicatissime a tutti i livelli, che si reggevano su precari equilibri tra ceti sociali diversi, città e territori spesso disomogenei, confessioni religiose varie e numerose. Di qui, appunto, il ruolo di Propaganda, soprattutto nell’epoca successiva alla fase boema della Guerra dei Trent’anni. Come ultima propaggine della cintura antiprotestante al nord-est, le terre del regno di Boemia risultavano necessarie per garantire la successione imperiale agli Asburgo. Infatti, come sottolinea il contributo di Francesco Gui, solo tramite il titolo di Rex Bohemiae il ramo austriaco del casato poteva entrare nel collegio elettorale ristretto: un equilibrio complesso che la Riforma aveva minacciato modificando i rapporti confessionali tra i principati elettorali. Infatti, la maggioranza per consentire l’elezione imperiale poteva essere espressa solo dal fronte cattolico, che teneva saldi i tre principati arcivescovili di Treviri, Magonza e Colonia insieme al regno di Boemia, almeno finché là regnassero dei sovrani cattolici. Pertanto, la perdita della Boemia avrebbe comportato non solo quella dell’Impero a vantaggio dei protestanti, ma anche della “massa critica” sufficiente per contrastare il pericolo ottomano. Oltre ad essere un bacino di legittimazione politica ed economica irrinunciabile, il regno sulle sponde della Moldava costituiva precisamente – insieme con l’Ungheria Reale, porzione residuale del regno di Santo Stefano a cui era stato risparmiato il giogo turco – il vero Antemurale Christianitatis contro gli Ottomani. Non solo, ma agli occhi di Roma, doveva proporsi come presidio della cattolicità verso il confuso panorama confessionale concresciuto nell’area di frontiera fra mondo slavo, presenze germaniche ed ungheresi, nonché dominio della Porta. Tale mondo, in preponderanza slavo-ortodosso, era però attraversato da fasce di tolleranza nei confronti dei gruppi riformati minori invisi anche alle confessioni protestanti canoniche (cioè il luteranesimo e l’insieme delle varie sette aderenti o riconosciute dal calvinismo). Fra questi citiamo ad esempio i Fratelli Boemi, i sociniani e quanti ricadevano nella dizione di “antitrinitari”, questi ultimi da un certo momento in poi solamente tollerati nel principato di Transilvania. 165 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Ciò detto, la variopinta situazione storica in cui si muoveva la prima dinastia della Mitteleuropa non permetteva che si potesse lasciare a questo composito reame, di fatto fulcro dell’Impero germanico, benché slavo, il libero arbitrio di potersi schierare al di là della coalizione asburgico-papale. Dunque i Boemi dovevano essere severamente controllati in materia di ortodossia, per non destabilizzare l’equilibrio della cristianità, con degli effetti sociali che generarono ricadute nella quotidianità dei sudditi non solo cechi ma anche di tutto il resto dell’Impero. E va da questo punto di vista riconosciuto, se così si può dire, che il successo “romano” della Montagna Bianca avrebbe definitivamente mantenuto l’Impero sotto l’egida della pur sempre fedele, seppur tutt’altro che remissiva, casa d’Austria. Geografia delle nunziature e diversità di vedute nella lotta antieretica Per riallacciarsi ora alla più ampia questione del mondo germanico, va prima sottolineato che, entro le sue viscere, più o meno ripercorrendo gli antichi confini orientali e settentrionali dell’Impero Romano d’Occidente, scorreva il limes geo-confessionale che dilaniava l’Europa dopo lo scisma protestante. La Dorsale Cattolica – che, ricorda Maria Antonietta Visceglia nella sua introduzione, fu un’espressione coniata da Renè Tavernaux nel 1972 – risultava composta dall’Austria, dalla Baviera, dai cantoni cattolici della Svizzera, dai principati vescovili alpini e, a latere, dalla stessa Spagna. La Monarquìa era presente nella fascia renana dell’Impero con i suoi possedimenti ex borgognoni (Fiandre, Lussemburgo e Franca Contea, per citare i più estesi) oppure attraverso territori acquisiti più avanti nei decenni, come accadde con il Basso Palatinato durante la Guerra dei Trent’anni. Con alle spalle Roma e gli stati italiani, questa linea si ergeva come una muraglia lungo questa frontiera religiosa, parallelamente sorvegliata anche dalle cosiddette “nunziature della riforma” che vennero istituite a guisa di capisaldi cattolici lungo i suoi avamposti: Bruxelles in Fiandra, Colonia in Renania, Lucerna in Svizzera, Monaco in Baviera e Graz in Stiria, oltre a quella presso l’imperatore a Vienna o a Praga. Come anelli di una catena segnavano la frontiera confessionale, la cui “percezione” – interessante espressione presente nel titolo del saggio di Gianvittorio Signorotto – ebbe una vera ricaduta politica, costituendo il motore di alcuni degli eventi principali della prima metà del Seicento in Europa. A tale proposito, e rimandando infra talune considerazioni sul ruolo della Francia, fra tali eventi si distinguono innanzitutto quei molteplici tentativi, talvolta poco preparati e spesso nient’affatto determinanti, che la parte cattolica metteva in atto per recuperare le popolazioni al vero credo. Queste azioni erano 166 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 concentrate proprio nei territori di confine con l’eresia e la loro buona riuscita dipendeva, oltre che dallo scorrere del tempo necessario e dalla quantità e dalla qualità degli uomini e delle risorse messi in campo, anche da un’idea di Controriforma decisamente combattiva. Come è infatti risaputo, all’interno della Chiesa un filone di pensiero, non tutti peraltro condiviso, sosteneva la linea della netta contrapposizione teologica e militare, che significava l’adozione di dure forme di repressione della vita civile. Questa fu di fatto la linea che si attestò anche visibilmente sulla frontiera e sulla quale si batté il fronte cattolico intransigente nel corso del conflitto trentennale. Va in ogni caso riconosciuto, come si deduce anche da taluni interventi, che un altro filone cattolico propugnava invece un sistema di riconquista delle anime “traviate” dei fedeli tramite il dialogo, l’educazione, la formazione culturale delle élite. Infine, come è noto, la Chiesa si servì anche della fascinazione, uno degli strumenti principi dell’epoca barocca che agiva sul sentimento e sulla psicologia delle masse. Ad un’attenta analisi di quanto è stato raccolto e delineato nei contributi dei medesimi studiosi, in realtà, nessuna delle due diverse linee e prassi riuscì definitivamente a prevalere sull’altra, se non per brevi intervalli di tempo. Se ne potrebbe forse dedurre che non si trattò mai di un confronto senza quartiere, poiché ambedue le tendenze erano consapevoli che la Chiesa aveva bisogno e degli uni e degli altri, la mano sinistra come contraltare della mano destra. Fra coloro i quali, al contrario, ritengono che complessivamente la Controriforma sia stata condotta soprattutto all’insegna della repressione delle coscienze, come per esempio testimoniano i noti studi di Paolo Prosperi o quelli di Massimo Firpo, circola la convinzione che la natura coercitiva della Chiesa abbia innescato anche il progressivo declino del papato sulla scena internazionale. Di fatto, la chiusura della porte alla conciliazione, avvenuta, secondo quanti aderiscono a questa visione, dopo il Concilio di Trento ed anche per responsabilità di alcuni particolari pontefici come Paolo IV, Pio V ed anche Gregorio XIII, avrebbe portato al potere romano una sorta di pensiero unico. A questo sarebbero imputabili le maggiori responsabilità dell’isolamento progressivo del papato nel novero delle grandi potenze. La riduzione della propria aura morale, grazie alla quale, come si è già detto, pontefici come Paolo III Farnese si erano arrogati il ruolo di pacificatori dirimendo le questioni diplomatiche, distolse sempre di più le altre monarchie dal coinvolgere Roma nelle grandi decisioni. Quindi colpevolmente la Chiesa non avrebbe saputo interpretare un indirizzo, o una visione, che potesse servire a ricomprendere tutte le sfumature del cristianesimo europeo nella cattolicità, costruendo quella civiltà cristiana, disegnata dai grandi umanisti come Erasmo, che risorgesse 167 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 priva delle storture che l’avevano condotta al fratricidio per odio religioso ed etnico. Cionondimeno, gli esiti di un processo non dovrebbero esercitare un’influenza sul giudizio delle singole decisioni adottate lungo un arco temporale considerevole e attraverso un’evoluzione complessivamente multiforme. L’Italia e il confine confessionale con l’eresia: le ansie papali su Milano, la Valtellina, la Svizzera e l’Impero A questo proposito, sia l’introduzione di Maria Antonietta Visceglia che i contributi di Giovanni Pizzorusso, Gianvittorio Signorotto e Irene Fosi fanno riferimento al fatto che, durante l'età moderna, uno degli ambiti cruciali della sfida confessionale sarebbe stato quello della cultura e ancor più della formazione. Quest’ambito influiva in profondità sia sui religiosi che sui laici, configurando un nuovo tipo di società che stava lasciando la sua condizione premoderna per approdare a nuovi lidi di consapevolezza ed autocoscienza. In campo cattolico si verificò una feroce disputa riguardo alla deroga alle norme tridentine, strenuamente difese dalla Congregazione per il Concilio, seppur a scapito della loro stessa applicabilità sul terreno. Tale proibizione poteva infatti risultare controproducente per almeno due motivi. In primo luogo, per quanto riguardava il divieto, rivolto ai religiosi, della lettura nelle lingue vernacolari, perché ai missionari risultava più difficile la predicazione al popolo di testi consultati in latino, ovvero in lingua diversa da quella compresa dagli ascoltatori. Difatti, come osserva Irene Fosi a proposito del divieto dell’uso delle lingue vernacolari per la lettura, rivolto non solo alle popolazioni ma anche al clero, la Congregazione specificò dopo alcuni negoziati che la proibizione sarebbe stata circoscritta limitatamente ad alcuni precisi testi, ad esempio i Salmi e non i Vangeli. Ancora più decisiva era poi la questione del divieto, rigorosamente imposto anche agli ecclesiastici, di leggere sia in latino che in altre lingue le opere dei grandi riformatori; una misura risalente alla prima ora della disputa luterana per evitare che nei ranghi protestanti passassero ulteriori transfughi. A tale riguardo si deve effettivamente riconoscere che la libertà dell’apprendimento della Parola di Dio e delle sue diverse interpretazioni risultava essere uno dei cavalli di battaglia dei protestanti, secondo i quali la dottrina del sacerdozio universale, come nota Heinz Schilling nel suo saggio, autorizzava tutti ad una vita spirituale autonoma, rendendo superfluo il ruolo sociale e rituale dei preti. Per cui risultava indispensabile proibire anche al clero la frequentazione di tali fuorvianti letture. Un argomento quest’ultimo 168 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 notoriamente trattato con competenza ed ampiezza di visione da Gigliola Fragnito, unitamente alla questione della temperie editoriale di Bibbie e scritti teologici poco ortodossi che proliferavano a dispetto dell’Indice. Al tempo stesso, si dovevano concedere alcune deroghe, per quanto rischiose. Conoscere cosa e come pensa il proprio nemico era un‘arma non trascurabile per i missionari. Pertanto a questo scopo almeno una parte dei religiosi doveva poter studiare gli scritti eretici e conoscere la lingua del luogo dove sarebbero stati mandati come agnelli in mezzo ai lupi. Soprattutto coloro che erano per un’apertura in questo senso avevano ben chiaro che il cattolicesimo non avrebbe mai riconquistato gli eretici se non si fossero formati dei predicatori abilissimi che fossero in grado di duellare a parole con gli intellettuali riformati. Erano infatti costoro i nemici più pericolosi, poiché nei primissimi anni della contestazione luterana era stato il loro magistero ad avere sospinto la gente ad abbracciare la nuova fede. La galassia teutonica in senso ampio era stata la fucina della Riforma; ora doveva essere il campo di sperimentazione dove la Controriforma potesse sommergere i nemici della fede e riportare tutti i popoli ed i regni cristiani sotto l’ala protettiva del Santo Padre. Nel suo intervento Irene Fosi sottolinea in modo particolare i riflessi che ebbe in Germania l’attività del Sant’Uffizio, sede di ultima istanza per molte delle questioni che passavano prima per il tavolo di Propaganda Fide. Questo insieme di problematiche comuni riguardava le conversioni, i matrimoni misti, il controllo dei riti e delle celebrazioni, il costume e la formazione del clero, locale o missionario che fosse. Difatti gli uomini che agivano sul luogo si trovavano a dover gestire dei quadri intricati, soprattutto laddove non esisteva una precisa regola a cui attenersi. A questo riguardo non si deve tuttavia commettere l’errore di pensare che fosse soltanto Roma a produrre documentazione con un fine di controllo totale. Anzi erano più spesso le periferie della cattolicità – nella persona dei legati de latere, dei nunzi, dei vescovi, dei membri degli ordini e degli uomini di Propaganda – a prendere l’iniziativa e a richiedere al Sant’Uffizio un consulto sul da farsi. Questo scambio stimolava le menti apicali dei sacri palazzi a stilare ex novo in maniera più precisa, o a ripensare del tutto in qualche caso, le direttive per i nuovi manuali di estirpazione dell’eresia inviati ai vescovi o anche le istruzioni papali ai nunzi. Un discorso a parte riguarda le interpretazioni della propaganda controriformistica elaborate dalle diverse famiglie religiose, pur all’interno dei medesimi contesti socio-politici. Ne è testimone il fatto che nella Milano spagnola della prima metà del XVII secolo – come riporta Gianvittorio Signorotto – la Chiesa ambrosiana del cardinal Federigo Borromeo, spinta 169 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 anche da motivi di orgoglio giurisdizionale e dalla difesa di prerogative fiscali, rimase ferma su posizioni realistiche e prudenti. I suoi atteggiamenti risultavano sostanzialmente insofferenti rispetto ai dettami politici e religiosi ispirati ad uno strettissimo connubio tra autorità ecclesiali, civili e militari affermati dal governo del re di Spagna. È nota in proposito l’opposizione dell’establishment meneghino all’introduzione nel ducato dell’Inquisizione iberica sin dall’epoca di San Carlo Borromeo, lo zio del sunnominato. Per contro, proprio nel ducato di Milano, ordini come i gesuiti e i carmelitani scalzi, entrambi molto legati alla corte di Madrid, sostenevano in modo ferreo la linea dura dei delegati della Monarquìa nei confronti del paventato rischio che l’eresia dilagasse in Italia attraverso i valichi alpini. La Milano spagnola doveva risultare una fortezza impenetrabile all’eterodossia, benché al suo stesso interno non tutta la Chiesa, come accennato, la pensasse allo stesso modo. Una crisi di questo delicato equilibrio giunse quando il fermento repressivo dei governanti spagnoli, non privo di appetiti territoriali a carattere strategico, ebbe come esito l’occupazione armata della Valtellina, avvenuta nel 1620 in seguito al massacro noto come Sacro Macello degli eretici riformati da parte dei valligiani cattolici. Rimanendo sempre a cavallo dello spartiacque alpino, zona di confine naturale e conseguentemente soggetta a radicate chiusure e al tempo stesso a scambi di vario tipo, la condivisione-frammentazione culturale derivante da questa condizione liminare portava anche a riflessi politici e religiosi. Nella trattazione di Bertrand Forclaz si evince come alcune questioni locali di intrecci giurisdizionali tra cantoni riformati, quelli cattolici e quelli misti nel contesto della Confederazione Elvetica nel suo complesso, compresi i territori alleati ma non federati – con in più le molteplici influenze delle grandi potenze confinanti – coinvolgessero Roma quanto e forse più di tanti altri luoghi. Ciò accadeva in quanto per la Curia la Svizzera era un territorio importante per un duplice motivo. Ovvero, sia per fare da argine all’eresia, che al di là delle Alpi metteva salde radici appena fuori dai confini naturali d’Italia; sia perché a Roma si era sempre sperato di poter recuperare alla vera fede tutta la Mitteleuropa iniziando proprio dalle valli elvetiche, per poi travalicare nelle vaste pianure tedesche. Una chimera, in effetti, ma che si risolse tale agli occhi del fronte cattolico soltanto alla fine della Guerra dei Trent’anni. A differenza di altre situazioni, Forclaz nota curiosamente un rapporto inverso nei ruoli di Propaganda Fide e del Sant’Uffizio. Quest’ultimo infatti era visto molto più disposto al buonsenso nella trattazione di certe vertenze rispetto all’attività locale degli agenti di Propaganda, la quale aveva subito il primo martirio per la fede tra i suoi ranghi proprio in terra svizzera. 170 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Su tutti i fronti: dalla questione inglese alla prosecuzione della Reconquista in Africa del Nord Ulteriori divergenze sulla teoria e sulla prassi di come venisse interpretata la lotta controriformistica sono riscontrabili perfino a proposito dell’agognato recupero dell’isola al di là della Manica. Sebbene l’Inghilterra, alla luce delle precise circostanze che furono a causa della riforma anglicana, venisse considerata come una sorta di pecorella smarrita che non obbediva più al suo pastore romano, a Roma – evidenzia Stefano Villani nel suo intervento – una strategia per il riacquisto della Gran Bretagna al cattolicesimo non venne mai impostata chiaramente. Vi furono infatti forti incomprensioni a cavallo fra il XVI e il XVII secolo fra la Curia e gli elementi cattolici presenti in Inghilterra. Da una parte c’erano i gesuiti, fautori di un’azione orgogliosa che rendesse i cattolici consapevoli di una propria identità di minoranza contrapposta ai soprusi della corona, che li riteneva in pratica dei fuorilegge. Dall’altra parte, i pochi fedeli inglesi, taluni nobili, altri borghesi, esponenti insieme a un clero residuale di una componente cattolica radicata nel sociale, non intendevano mostrarsi come dei traditori agli occhi del sovrano e dello stato. Anzi, tale querelle si acuì proprio nel momento in cui Giacomo I pretese l’Oath of Allegiance, chiaramente concepito come strumento del quale la corona si voleva servire per snidare le cellule di resistenza (tra cui la minoranza cattolica) ostili al suo disegno politico. Quest’ultimo, ricordiamo, condusse nei primi decenni del Seicento il trono di San Giacomo a scegliere l’isolazionismo in politica estera, che, pur deludendo le aspettative del fronte protestante, preservò le isole britanniche dal contrarre il contagio delle nefandezze e delle miserie della Guerra dei Trent’anni. A tale proposito, forse non si sbaglierebbe troppo nell’affermare che l’Inghilterra, seppure più o meno intensamente a seconda dei periodi, si sia mantenuta defilata dalle vicende che imperversavano sul continente. Se si escludono gli storici interessi di monopolio commerciale verso le Fiandre, dopo la perdita totale – ad eccezione della sola Calais – dei possedimenti sul suolo francese, e prima di rimettere piede sulla terraferma attraverso i legami dinastici con l’Hannover ai primi del secolo XVIII, essa abbia vissuto di vita propria, al di là di un pur altalenante legame con Roma, non completamente reciso da Enrico VIII e discendenti. Lasciamo adesso le rive atlantiche per approdare nel Mediterraneo e cercare di comprendere la percezione che in età moderna contribuì ad orientare la politica internazionale della Santa Sede, esiti compresi, in quell’area. Manuel Rivero Rodrìguez introduce brevemente il lettore a quale sia stata la genesi del concetto di frontiera elaborato nel corso del dibattito storiografico interno al mondo culturale ispanico e iberoamericano. Egli all’inizio tratta sotto una luce 171 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 diversa i concetti di spazio, giurisdizione statuale e linea di confine. Inoltre dal punto di vista del metodo risulta quanto mai interessante il fatto che, per descrivere come fosse vissuta la frontiera in Europa tra Medioevo e prima età moderna, l’autore si serva della prospettiva americana di un autore di fine Ottocento come F. J. Turner, il quale individuava come “frontiera” non tanto una linea retta quanto una fascia indefinita più o meno ampia in cui le differenze si attenuano, i tratti si confondono, le alterità si confrontano. Pertanto la frontiera da considerare non dipenderebbe solo dall’attribuzione politica di un dato territorio conteso tra due stati, ma soprattutto dal vissuto storico plasmato dagli uomini, le cui premesse sono un oggetto d’indagine della storiografia. Manuel Rivero Rodrìguez pone dunque l’accento sulla storia iberica, riportando tutto il ragionamento al lungo periodo della Reconquista, durante il quale il concetto e la prassi della frontiera contribuirono a costruire l’identità spagnola. Sebbene dopo aver convissuto sotto il dominio islamico anche in modo pacifico, la cosiddetta “Spagna delle tre culture” era nei fatti un’esperienza conclusa quando verso la fine del Medioevo il confine nella penisola iberica non separava tanto due o più stati sovrani quanto due mondi contrapposti, “noi cristiani e loro musulmani”come recitava un modo di dire. Ancora oggi le direttrici delle vittorie cristiane verso sud sono riconoscibili nella toponomastica in Andalusia, dove l’aggiunta de la frontera è presente in molti nomi di centri abitati, anche a varia distanza tra loro. Questo fenomeno è motivato proprio dal fatto che nella ripresa del possesso della penisola iberica la fase della Reconquista fu una vicenda assai mobile e diversificata, che non può certo essere liquidata secondo la nozione odierna di frontiera. L’autore propone allora di considerare in quest’ottica come spazio di frontiera il Mediterraneo occidentale, un’area spesso trascurata rispetto agli studi sulla politica estera del papato. In realtà essa fu invece molto partecipe degli scambi e degli scontri con il mondo islamico nelle sue varie sfaccettature. Fu una frontiera nel senso spiegato sopra, dove le parti politiche e militari non sempre corrisposero a quelle religiose. Le monarchie cattoliche iberiche si appoggiavano infatti sui potentati maghrebini come il Marocco e Tunisi, che mal digerivano l’alta sovranità di Istanbul, mentre dall’altra parte stavano il Sultano, la Francia sua convinta alleata, e alcuni regni mori lealisti come Algeri, la principale base logistica per le scorrerie dei pirati barbareschi. Rendere sicure le coste iberiche e lo Stretto di Gibilterra era un requisito fondamentale per la Spagna al fine di precludere al nemico infedele la rotta verso il Nuovo Mondo, riservando a se stessa la porta del Mediterraneo. Anche le Americhe costituirono un distaccato protagonista di queste vicende, poiché in fin dei conti, sostiene Manuel Rivero Rodriguez, l’impresa di Colombo così 172 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 come quella di Vasco De Gama vanno comprese come episodi di un fenomeno più grande. Ovvero, da un lato il Nordafrica consistette nel nuovo fronte militare contro i musulmani, a proseguimento della Reconquista, dall’altro la ricerca di nuove vie per le Indie si spiega anche come risposta alla pressione islamica sulle rotte mediterranee, dall’altro ancora la conversione delle colonie al cattolicesimo sarebbe stata complementare allo sforzo bellico. Nella visione millenaristica propria della Spagna dei re cattolici queste due imprese erano la pars destruens e la pars costruens di una nuova cristianità, che si preparava alla seconda venuta del Salvatore e alla sconfitta dell’Anticristo. Per alcuni insomma si avvicinava la battaglia finale descritta nell’Apocalisse e le scaramucce con il Turco ne erano solo un banale preambolo. Il papato ebbe un ruolo in queste vicende già alla fine del XV secolo sancendo la cruzada norteafricana sotto Alessandro VI nel 1494. In seguito, l’attenzione dei pontefici si sarebbe concentrata maggiormente sui fronti del Levante, balcanico e mediterraneo, in parziale dissenso con la Spagna. Per esempio, osserva l’autore, durante i negoziati per la Lega Santa, Filippo II tentò di includere il Nordafrica tra i campi di battaglia prioritari, sostenendo che la sicurezza del Mediterraneo occidentale fosse la chiave per ottenere dei risultati anche ad Oriente. Roma però non si fece persuasa di queste parole, in quanto la serie storica dei tentativi militari spagnoli sulla sponda meridionale del mare nostrum non portò mai la crociata più ad est di Tunisi. Allo stato dei fatti, eccettuato il caso di Lepanto che non venne sfruttato a dovere dalla coalizione cristiana, causa tale diversità di vedute, una politica mirante alla riconquista dei luoghi santi non trovò più una strategia né unitaria, né condivisa. Dalla crociata nel Levante alle questioni adriatiche È ora opportuno dare uno sguardo al campo d’azione privilegiato dal papato per la crociata, l’Europa ed il Mediterraneo orientali, laddove si confinava con i turchi infedeli sia per mare che, soprattutto, per terra. Venezia, la potenza egemone sulle acque, aveva incassato bene gli affondi inflitti dagli ottomani al suo Stato da Mar tra il XV e il XVI secolo. Ma dalla seconda metà del Cinquecento – ovvero dalla caduta di Cipro negli anni Settanta in avanti – anche la Serenissima si avviava inesorabilmente al suo declino come signora del Mediterraneo. Come è universalmente riconosciuto, autori del volume compresi, per la Serenissima la battaglia di Lepanto fu soltanto un palliativo ed ottenne di rimandare la vera decadenza di solo qualche decennio, quantunque in tutto l’Occidente l’esaltazione dell’evento glorioso desse adito a notevoli esercizi retorici e propagandistici. 173 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Come in parte accennato, la Lega Santa non fu in grado, per i dissidi strategici fra Spagna, papato, Venezia e Impero, di portare la coalizione ad un amalgama politico tale che le consentisse risultati maggiori nonché duraturi. Sulla terraferma le cose andarono diversamente, come ricorda fra gli altri Maria Antonietta Visceglia. Il nemico turco tentò da lì di colpire l’Europa cercandone il ventre molle già con l’invasione dell’Ungheria nel 1526 e il tentato assedio a Vienna nel 1529. Ma soltanto alla fine del XVII si decisero gli esiti di questa contrapposizione militare. Dal punto di vista dell’azione del papato, uno dei punti fermi fu mantenere unito il fronte delle nazioni che erano proiettate a sud-est, da un lato verso i Carpazi e i Balcani, dall’altro verso l’Egeo e l’Adriatico. A tale fine a Roma ci si proponeva di mettere ordine nelle controversie diplomatiche soprattutto tra Polonia, principati balcanici, Monarchia Asburgica, Venezia, Ordine di Malta e Spagna. Queste potenze trovarono un delicato punto comune soltanto quando ad essere seriamente minacciata fu Vienna nel 1683. Solo allora, e non riuscendo neanche a superare le diffidenze nel rapporto con Luigi XIV, il papato di Innocenzo XI riuscì ad unire i sovrani cristiani contro le armate ottomane di Kara Mustafà in quella che forse fu l’ultima crociata della storia europea. In generale, affidandosi anche alle considerazioni di Aurélien Girard, ad Oriente i problemi si facevano sempre più concreti, aumentando la pressione diplomatica sul papato. Se per l’Europa centrale si è detto che vivesse una frattura culturale e religiosa a cavallo delle frontiere confessionali, all’Est le frontiere erano marcatamente militari. E al di là di queste gli uomini belligeranti si consideravano vicendevolmente infedeli e pagani, altra cosa, insomma, rispetto alle divisioni interne del mondo cristiano. Quanto alla civiltà europea cattolica, essa aveva due avamposti nel cuore del mondo ortodosso, situati nella penisola balcanica. La prima, la Repubblica di Ragusa era una figlia fedelissima di Roma e del papa, sebbene fosse parzialmente compromessa con il Sultano, del quale riconosceva l’alta sovranità a beneficio dei suoi traffici. Poi c’era la città veneziana di Cattaro, snodo obbligato in ambito postale e commerciale per le relazioni tra la Serenissima e il governo della Sublime Porta. Antal Molnàr nel suo saggio attribuisce in particolare a questi due centri un ruolo di appoggio alle attività patrocinate dal papato in terra balcanica. Un compito svolto in due maniere diverse. Ragusa fece infatti del cattolicesimo la sua corazza identitaria per mettere in secondo piano la sua accettazione della supremazia turca, ponendosi pertanto in totale lealtà verso il papato. Questo atteggiamento ebbe degli evidenti riscontri nelle angherie subite dalle comunità ortodosse presenti nelle sue colonie commerciali all’interno e sulla costa. Dal canto suo Cattaro costituì lo strumento principale di Venezia per ottenere dei 174 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 riflessi positivi nei suoi rapporti con Roma, vantando la difesa esercitata dai veneziani nei confronti dei cattolici nei Balcani meridionali. Questo avveniva soprattutto riguardo alla Serbia, dove vigeva la giurisdizione della diocesi di Cattaro, mentre l’arcivescovo di Ragusa emanava la sua autorità verso l’entroterra, ma non sui possedimenti veneti. Sorgevano però delle discrepanze ogniqualvolta nelle città dell’Adriatico si iniziasse a parlare di crociata. Quando si trattava di schierarsi apertamente contro il Turco, a Cattaro – una terra di immediato confine con gli infedeli e più volte cinta d’assedio dagli ottomani, dove quindi il rischio di invasione era più sentito – si verificava grande partecipazione, motivata anche dagli interessi politici di Venezia. A Ragusa, invece, dove la sudditanza alla lontana Istanbul rendeva molto bene in caso di tranquillità e stabilità, con tutto vantaggio per la floridezza dei commerci, tali istanze belliciste erano poco considerate, lasciando il posto ad un atteggiamento molto ambiguo. In più, in quest’area vigeva una forma di dovere evangelico, che spingeva uomini ed istituzioni a lavorare per permettere ai padri missionari di stanziarsi in un simile spazio, aperto a tre differenti credi confessionali. Sempre considerando che in tutta l’area adriatica le due nunziature preposte, a Vienna e a Venezia, erano lontane dai luoghi di missione, le comunicazioni risultavano saltuarie e precarie. In particolare Propaganda Fide tendeva a servirsi di agenti ed informatori dalle fisionomie a dir poco curiose, tra cui stampatori e mercanti. Questi potevano spostarsi frequentemente, oppure essere residenti nei porti principali della costa orientale italiana, quali Venezia, ma anche a Ancona e Loreto, i due centri dello stato pontificio, nonché nelle colonie veneziane della riva illirica. L’Adriatico fu “un mare amaro”, come recita il titolo del saggio di Angelantonio Spagnoletti che riprende a sua volta un verso di Gabriele D’Annunzio. Un mare testimone di antichissimi e prolungati contatti tra le sue sponde, per esempio, nel caso in questione, fra la Puglia e l’Albania, o terra del Pirro d’altri tempi, nella cui memoria campeggiava l’eroe nazionale ante litteram, Giorgio Castriota Scanderbeg, il quale aveva strenuamente lottato per resistere alle invasioni ottomane nel XV secolo. Malgrado il successo di queste ultime, il regno delle aquile continuava a godere di particolari condizioni politiche e geografiche. Si trattava infatti di un territorio religiosamente assai composito. Secondo alcune stime risalenti all’epoca del dominio turco, a nord era rimasto pressoché cattolico, grazie alle antiche relazioni con l’Italia strette dai tempi dei Normanni e degli Angioini, che vi avevano posto delle teste di ponte, come ad esempio Durazzo. Il centro si era invece molto islamizzato, con influssi soprattutto sulle città maggiori, mentre il cristianesimo sopravviveva ancora nelle campagne e 175 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 tra i monti. A sud, invece, dove le popolazioni di lingua greca prevalevano ed avevano contatti con i vicini meridionali, l’ortodossia aveva mantenuto le proprie posizioni, insieme ad alcune comunità cattoliche di rito greco orientale. In quell’area, osserva ancora Spagnoletti, la contrapposizione fra cattolici di rito orientale ed ortodossi era divenuta di conseguenza naturale, poiché la conquista infedele le aveva entrambe ridotte a due minoranze costrette a contendersi gli spazi di libertà e rivaleggiare fra loro per ottenere un miglior trattamento dall’invasore. I cattolici rinfacciavano agli ortodossi di essersi asserviti per carpirne favori e per gettare discredito sui fedeli in comunione con Roma, mentre gli altri li accusavano di tradimento della fede comune. Quanto ai rapporti con il papa e l’Italia, molti missionari e vescovi incaricati per l’Albania risultavano originari della Puglia, nella quale, alla fine del XV secolo, erano fuggiti moltissimi cattolici di rito greco, riparando in Terra d’Otranto. Per questo ad essere inviati nei Balcani erano soprattutto i monaci basiliani, cioè cattolici di rito greco, che si confondevano meglio in Chimara tra i loro omologhi ortodossi. Da Bari, Lecce ed Otranto, i vescovi le cui diocesi risiedevano, temporaneamente o per sempre, in partibus infidelium tenevano sotto osservazione la situazione dell’altra sponda adriatica, soprattutto nei momenti di maggior crisi. Per esempio quando, in caso di assalti turchi, intere comunità monastiche o missionarie dovettero scappare per evitare le persecuzioni. Dagli stessi porti pugliesi partivano gli uomini e le merci per le missioni, mentre vi transitava la corrispondenza da e per Napoli e Roma, o anche Venezia qualora la via di Corfù fosse stata bloccata. Nell’area l’incrocio istituzionale politicoreligioso risultava davvero notevole. Cattaro infatti apparteneva sin dal Medioevo alla “provincia” del metropolita di Bari, anche, come annota Molnàr, per dispetto all’arcivescovo raguseo. Al tempo stesso, dipendeva territorialmente da Venezia, il cui nunzio aveva voce in capitolo sulle missioni albanesi e sulle nomine diocesane in Puglia, così come l’aveva, per affinità geopolitiche, anche quello di stanza a Napoli. In tutto questo, Ragusa – pur nella distinzione della propria area di influenza rivolta all’entroterra, mentre Cattaro badava più alle fasce costiere dell’Albania e del Montenegro – era tenuta, seppur di malavoglia, a mettersi a disposizione dei poteri ecclesiastici veneziani, quando non riusciva a superarli attraverso i suoi contatti privilegiati con Roma. In breve, un vero network di relazioni adriatiche che meriterebbero, come auspicano Molnàr e Spagnoletti, di diventare oggetto di studi approfonditi attraverso l’incrocio di più competenze e di studi specialistici. Per la verità i vuoti di conoscenza non parrebbero poi così estesi, considerando che la storia locale e quella che diremmo nazionalistica hanno prodotto dei contributi o degli 176 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 stimoli importanti negli anni passati. Tuttavia la messa in evidenza di figure chiave, tra le quali molti laici ed “informatori insospettabili” cui si è fatto cenno più sopra, potrebbe portare ad una migliore conoscenza degli eventi in sé, ove si sia in grado di trovare un giusto compromesso tra microstoria, storia propriamente locale e studi comparati di storia istituzionale, politica e religiosa. Una macchia della diplomazia papale? L’impium foedus con il Sultano all’epoca della calata di Carlo VIII L’Adriatico e le sue isole furono per tutta l’età moderna un vero spazio di frontiera, avvertito come un confine sensibilissimo per la sicurezza d’Italia già dal XV secolo anche nel regno di Napoli, il quale si sentiva minacciato poiché si protendeva con i litorali pugliesi verso le sponde albanesi e greche. Proprio da Otranto il dominio aragonese aveva rischiato l’invasione tra il 1480 e il 1481, a seguito dello sbarco turco, tristemente segnato dal celebre massacro da cui sarebbe sorto di lì a pochi anni, come elemento della generale propaganda antiturca della crociata, il culto degli 800 martiri, poi canonizzati dalla Chiesa nel 2013. Date tali premesse, non ci si aspetterebbe secondo logica quello che Giovanni Ricci narra nella sua relazione, ossia la vicenda del dialogo diplomatico intrattenuto da Alessandro VI con il Sultano Bayezid II nella seconda metà dell’anno 1494, sotto la spinta dell’invasione francese del Regno. Un episodio davvero avvincente ed emblematico, la cui ricostruzione costituisce una delle pagine più originali dell’intero volume, su cui vale la pena di soffermarsi con una certa estensione e ricchezza di particolari. La presa di contatto fra i due soggetti che si crederebbero inconciliabilmente rivali andò ben oltre rispetto alle consuete aperture diplomatiche che tutte le potenze mediterranee avevano già da tempo intessuto con la corte stambuliota. Al riguardo, la storia di Venezia ne è un caso lampante. Nonostante avesse dei contenziosi aperti riguardo il controllo insulare nell’Egeo – cosa che di lì a poco avrebbe inaugurato la corsa militare per Cipro – la Serenissima manteneva in vita i propri traffici accordandosi regolarmente con i turchi, veri signori del Levante. La Repubblica di Genova, dal canto suo, era accusata di aperta connivenza con la Porta, sin da quando, nel 1453, aveva assistito inerte dalla sua colonia di Pera alle manovre accerchianti Costantinopoli di Mehmet II – in seguito soprannominato Fatih, ovvero il Conquistatore – senza poi darsi troppo da fare per soccorrere il vacillante trono di Costantino XI Paleologo. Per addentrarsi infine negli eventi del 1494, la calata di Carlo VIII spaventò papa Borgia a tal punto che, per proteggere dalle pretese 177 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 "neoangioine" la Napoli aragonese, e contemporaneamente il suo soglio apostolico, sembra che scrivesse direttamente al Sultano Bayezid II. Neanche un mese dopo Alessandro VI avrebbe inviato ad Istanbul una legazione ad hoc capitanata da Giorgio Bucciardo, proprio per stabilire un’alleanza antifrancese. Anche il re Alfonso II d’Aragona, colui che tredici anni prima, da duca di Calabria, aveva scacciato i turchi dal Salento con l’aiuto dei veneziani, preso dal terrore per l’irruenza del moderno esercito francese, si sarebbe arrischiato a richiedere rinforzi da Istanbul. In realtà, alla fin fine pare non se ne facesse nulla, e tuttavia l’azione del papa non può che lasciare alquanto sconcertati, a causa di taluni particolari a dir poco sorprendenti. Per parte sua, il re Alfonso II fu infatti costretto a desistere a causa delle esorbitanti richieste della parte turca. A dispetto della disponibilità del Sultano, il quale era pronto ad inviare soltanto denaro, armi e cavalli senza che alcun piede ottomano toccasse i restanti lidi partenopei, il prezzo da lui stabilito, ossia il completo controllo turco di Otranto, Brindisi e Taranto – le “porte d’Italia” come ricorda Giovanni Ricci – risultava evidentemente inaccettabile per il re di Napoli. Fu Alessandro VI che andò invece oltre nelle trattative. E a questo punto risulta interessante notare come egli si rivolgesse a Bayezid II nei dispacci scambiati con quest’ultimo, purtroppo soltanto in parte pervenutici. Al di là della consueta deferenza fra i sovrani “d’antico regime”, dalla corrispondenza diplomatica (o, meglio, dai resoconti sopravvissuti in proposito) sarebbe emersa la proposta di affidare alla protezione del Sultano il regno di Napoli, sovrani aragonesi compresi, e persino lo stesso stato della Chiesa, a fronte di un giuramento, peraltro assai incerto nei particolari, prestato da Bayezid “sui nostri veri evangelii” in presenza del Bucciardo. O si trattava forse del Corano? Un particolare anche questo rimasto avvolto da dubbi e interrogativi tutt’altro che chiariti. Il papa esigeva comunque che la Porta si impegnasse a non attaccare i cristiani d’Ungheria e di Croazia. Per comprendere meglio la paradossale situazione riemersa dalle nebbie del passato grazie al contributo di Ricci (e alle fonti antiborgiane rivisitate), va precisato che il signore ottomano era interessato a partecipare alla campagna antifrancese purché la controparte romana si mostrasse accondiscendente su un altro punto ancora, che stava molto a cuore al Sultano: far sparire suo fratello, il principe Djem, sconfitto nella corsa al trono del 1482 e da allora latitante come semiostaggio per le corti d’Europa. Questi in quel momento si trovava proprio a Roma e per il suo “mantenimento in salute”, trattamento che non doveva favorirne in nessun modo il ritorno in patria, il Sultano pagava al bilancio pontificio 40.000 ducati veneziani annui. Nel gioco politico di sponda che vedeva i “due poteri ricattarsi”, come nota nel testo sempre l’autore, il papa 178 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 cedette alla proposta che pare fosse stata ideata a Costantinopoli e poi riferita a Roma dallo stesso Bucciardo, ovvero la soluzione più drastica e definitiva. Per la serenità del suo sultanato, il fratricida per procura Bayezid II avrebbe versato in un'unica soluzione alle casse pontificie 300.000 ducati veneziani d’oro, con i quali Alessandro VI avrebbe egregiamente predisposto le difese contro l’imminente arrivo del re di Francia. Se questa transazione fosse andata in porto, oltre alla gratitudine eterna dei Borgia per il Sultano, alle coste del regno aragonese sarebbe stata concessa una fase di tregua dalle consuete scorrerie turche. Anche Venezia nel caso si sarebbe ritenuta soddisfatta. Eppure, malgrado la disponibilità del papa, il disegno non sarebbe andato in porto. Inaspettatamente si profilò sulla scena la figura di Giovanni della Rovere, signore di Senigallia, il quale in teoria era militante sotto le ali del leone di San Marco, ma al contempo anche leale fratello del cardinale Giuliano, il quale a sua volta era passato con Carlo VIII per rovesciare il regime di Alessandro VI e della sua famiglia. Da lui giunse infatti l’attentato, peraltro anch’esso parecchio avvolto dalle nebbie, che venne perpetrato a danno del Bucciardo e dell’ambasciatore ottomano Kasim, consigliere militare di Bayezid, non appena i due, di ritorno dall’Oriente, furono sbarcati ad Ancona. Il primo fu catturato e poi torturato, mentre il denaro della presunta ricompensa venne involato insieme alle missive del papa e del Sultano. All’ospite turco riuscì invece di salvarsi. Non solo, perché prima di fare ritorno ad Istanbul fu in grado di passare in rassegna tutte le corti signorili d’Italia che vedevano di buon occhio un intervento, o per lo meno un interessamento, della Sublime Porta nelle questioni peninsulari. La temperie scatenata dall’invasione francese aveva infatti preoccupato molti medi e piccoli principati, tra cui la stessa Ancona, Mantova e Venezia, che più temevano di dover subire un ridimensionamento a favore degli alleati italiani di Carlo VIII divenuti ora potenti, come ad esempio Ludovico il Moro o gli Este di Ferrara. A complemento, qualche tempo dopo, nella Firenze occupata dai francesi iniziò a circolare una leggenda nera che voleva inserire tra le tante nefandezze del papa Borgia anche il tradimento della Christianitas, proprio poiché avrebbe voluto consegnare Roma e l’Italia ai turchi pur di salvare i suoi interessi dinastici. Pare che venissero approntate varie traduzioni dal greco e dal turco delle missive rubate dal Della Rovere, il cui contenuto è testimoniato da quanto scrivono vari autori, tra cui anche Marin Sanudo. Anche le notizie riportate da un anonimo cronista napoletano, che ricostruiscono la storia del ricatto perpetrato ad Alfonso II da Bayezid a proposito delle mire turche sulla Puglia, confermerebbero parte del contenuto delle lettere, di cui anche negli archivi turchi esiste ben più che una traccia lacunosa. 179 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 Insomma, tentando di guardare al significato più generale di queste vicende, non fu allora e forse non sarebbe oggi tanto sconvolgente lo scandalo in quanto tale, secondo cui il capo spirituale del cristianesimo avrebbe trattato ai danni di un sovrano europeo un’alleanza con il potente sovrano ottomano, capo spirituale dell’Islam sunnita. Ad opinione di chi scrive è da notare soprattutto la grande considerazione politica di cui godeva il Sultano nelle varie corti italiane della fine del XV secolo. Questi era visto infatti come un interlocutore quasi naturale e venne trattato come tale, tanto da farlo entrare nel gioco politico interno all’Italia e all’Europa, quasi non fosse un potente nemico orientale profondamente addentratosi nel Mediterraneo. Questi eventi dello scorcio del Quattrocento – per quanto poco noti al grande pubblico, benché abbastanza studiati negli anni più recenti – fungono da notevole precedente che, almeno in parte, contribuirebbe a ridimensionare un certo vituperato giudizio su Francesco I, il quale solo pochi anni dopo sarebbe sceso a patti con Solimano il Magnifico in una coalizione antiasburgica. Conclusioni La “prima” età moderna, specie se vista da Roma, costituì in definitiva, come si è cercato di ricostruire attraverso questa riflessione, lo sfondo variegato in cui interagirono molti agenti politici differenti tra loro e in costante evoluzione, seppure con tempi e modalità condivisi, ma al tempo stesso posti a confronto con tutte le capitali innovazioni, ivi comprese le scientifico-geografiche, avvenute in tale stagione. A ciò si aggiungevano, neanche a dirlo, gli sconvolgimenti avvenuti sulla frontiera orientale e mediterranea del continente, di conserva che le violente conflittualità confessionali. Una simile dinamica era ulteriormente sollecitata dall’azione e dalla reazione delle parti politiche, impegnate in una politica di potenza decisamente in ascesa sulla scena internazionale. Nel contesto della società dei principi in progressivo rafforzamento, in cui erano le dinastie se non la persona stessa del sovrano, salvo eccezioni, ad incarnare la politica estera dello stato, il papato si comportò come entità che se da un lato ne era partecipe dall’altro ne risultava un’eccezione, come del resto nessuno ignorava, né tantomeno contestava come realtà di fatto. Sia che il papa si presentasse come padre comune dei sovrani, sia come capo spirituale della Christianitas che promuoveva la crociata contro il Turco infedele, sia come contraltare politico rispetto alla supremazia nominale dell’imperatore, sia ancora come sovrano “interessato” nonché difensore di un’Italia minacciata di subordinazione a poteri stranieri, sia infine come promotore del cristianesimo romano nel globo intero, da tutta Europa si guardava a Roma come un centro 180 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 nevralgico sullo scacchiere politico-diplomatico. Grazie al concorso, indubbiamente, del fattore religioso-ecclesiale: come semplici fedeli o sudditi, se non eretici e nemici della fede, oppure nuove anime alle quali andava rivelata la vera religione, l’umanità che faceva parte o si relazionava con il mondo europeo e cristiano trovava prima o poi la politica del papato sulla sua strada. Un ruolo, in definitiva, sempre e comunque “internazionale”, prolungatosi, come accennato, ben più avanti rispetto alla “prima” modernità. A tale proposito viene spontaneo fare riferimento alla presentazione del volume Papato e politica internazionale nella prima età moderna, avvenuta giovedì 12 dicembre 2013, durante la Giornata di Studi interdisciplinari svoltasi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. A tale evento chi scrive ha potuto essere presente ed è quindi in condizione di restituire delle impressioni percepite al momento della discussione. Come Maria Antonietta Visceglia ha ribadito rispetto a quanto già scritto nella sua introduzione, uno dei punti focali del percorso di ricerca è consistito nell’individuazione precisa di una periodizzazione dai caratteri parzialmente originali. In breve, il papato protagonista politico della prima età moderna si estenderebbe dal pontificato del primo Papa Re, alias Sisto IV Della Rovere (1471-1484), fino ad almeno Clemente XI Albani (1700-1721). Senza voler delegittimare le classiche periodizzazioni della storia del potere romano in età moderna, il volume rivela infatti un intento decisamente innovativo. Ad esempio, non avrebbe un significato dal punto di vista politico considerare come spartiacque gli anni del Concilio di Trento, per quanto di per sé si tratti di un evento non meno periodizzante. Di rimando, risulterebbe più sfumata anche l’importanza della Pace di Westfalia, di solito considerata come punto di non ritorno della capacità di influenza e di azione politica del papato sulla scena internazionale. Non a caso Maria Antonietta Visceglia ha scelto di intitolare “Oltre Westfalia” un paragrafo della sua introduzione al volume. La curatrice spiega come il suo punto di vista non ridimensioni l’importanza dello scacco subito dalla parte cattolica alla fine della Guerra dei Trent’anni. Precisa che, anzi, proprio alla luce di esso, il papato cercò per quanto faticosamente di sperimentare nuove vie di mediazione politica. Si cita a questo proposito il pontificato di Innocenzo XI, sotto il quale grazie all’impegno diplomatico di personaggi come il nunzio Francesco Buonvisi ed altri, si aprì una fase senza dubbio vittoriosa per la diplomazia papale, per quanto non durevole. L’avanzata turca nei Balcani fin sotto le mura di Vienna costrinse un papato in ombra da qualche decennio ad assumere nuovamente un ruolo da protagonista, 181 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 come primo fautore di una proposta politica e militare di una nuova coalizione cristiana. Un altro elemento – utile per inquadrare questa peculiare periodizzazione – che andrebbe maggiormente sottolineato riguardo l’iniziativa romana nella seconda metà del XVII secolo, e fino all’inizio del XVIII, fu il perpetuarsi di quello che potrebbe definirsi un “laboratorio” di comunicazione e di interscambio politico, culturale e religioso attivato dai gesuiti con il ceto mandarino cinese. Soltanto negli anni Venti del Settecento la complicata questione dei riti cinesi, dopo essere stata a lungo discussa, fu risolta nella chiusura di questa esperienza originale proprio sotto il pontefice Albani. Questo evento rappresentò una cesura fra un prima e un dopo assai dirimente nelle strategie di evangelizzazione cattolica, mettendo fine ad uno degli ultimi bagliori del complesso fenomeno della proiezione su scala globale del papato e delle sue articolazioni in età moderna. Proprio da quegli anni verrebbe un’ulteriore conferma del prolungarsi ed al tempo stesso dell’esaurirsi del ruolo internazionale della Santa Sede. Sia pure auspicando esplicitamente approfondimenti e nuove ricerche in materia, la revisione operata da Maria Antonietta Visceglia mette in evidenza quanto accaduto agli esordi del Settecento durante la crisi delle guerre di successione, a partire quella spagnola. Fu in quell’occasione che il papato finì per vacillare definitivamente, mancando di assolvere alla propria, autorevole funzione mediatrice precisamente nella propria area di maggiore radicamento di potere, ovvero in quella che si potrebbe chiamare una sorta di “ritorno delle guerre d’Italia”. In quel frangente il papato venne invaso nel proprio territorio nel 1708 e subì una chiara sconfitta, fatto che suscitò in papa Clemente XI un pianto di cordoglio per le colpe della Chiesa a causa delle quali l’invasione dell’esercito imperiale venne interpretata come castigo divino. Aleggiando lo spettro di Carlo VIII e quello del Sacco di Roma – temuto così tanto dai tempi di papa Farnese ed in seguito soprattutto da Urbano VIII Barberini – un’invasione armata colpiva nuovamente al cuore l’autorità politica della Chiesa, innescando da quel momento in poi un incontrovertibile declassamento del papato come attore della politica internazionale anche all’interno delle potenze cattoliche. Con l’aggiunta del verificarsi di espropriazioni unilaterali dei benefici ecclesiastici da parte dei governi in contesa con Roma. Ineluttabilmente iniziò a perdere peso politico la persona stessa del papa e di conseguenza per tutto il XVIII secolo l’istituzione stessa venne condannata ad un lento declino nella sua influenza politica, morale, ed anche prettamente religiosa se si constatano i colpi subiti a seguito degli attacchi dell’anticlericalismo e del laicismo. Per non dire dell’influenza crescente del 182 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 pensiero illuministico e dei suoi grandi intellettuali, alcuni dei quali divenuti consiglieri di quei sovrani, i cosiddetti “despoti illuminati”, posti a capo delle monarchie per definizione più conservatrici. Di fatto in quest’epoca Roma perdeva l’appoggio politico dei suoi storici alleati nei vari settori, non solo nella politica internazionale ma anche in quella ecclesiastica. Da un lato la Spagna, ora sotto la dinastia borbonica, e ancora di più dall’altro l’Austria di Carlo VI e poi di Maria Teresa fino al radicalismo posteriore di Giuseppe II, secolarizzarono quasi del tutto la propria azione politica. Se già con Westfalia il papa aveva definitivamente perduto la possibilità di contare qualcosa nei confronti del mondo riformato, ormai anche riguardo le monarchie cattoliche il processo di costruzione statale era teso a ricomprendere in se stesso, se non in qualche caso a soffocare la dimensione ecclesiale. La riduzione dell’organizzazione della religione quasi ad una funzione dello stato moderno – stato pur sempre confessionale nella sua architettura istituzionale, il cui fulcro era e rimaneva ancora costituito dal sovrano e dalla sua dinastia nella loro dimensione sacrale e simbolica – contribuì inevitabilmente ad affievolire la portata non solo dell’azione, ma anche della parola del papa. In sintesi, una seconda Westfalia settecentesca, seppur meno eclatante ma non meno carica di effetti delegittimanti all’interno dell’Europa cattolica. A tali acquisizioni innovative riscontrabili nel volume vale la pena in conclusione di aggiungerne almeno altre due, che contribuiscono ad arricchire il portato del cospicuo progetto scientifico, i cui frutti sono disseminati nei molti interessanti contributi presenti nella raccolta. Uno dei criteri e degli oggetti di studio che più risaltano dai saggi proposti al lettore è certamente il ruolo di personaggi spesso minori e poco noti alle cronache, che tuttavia risultano come figure chiave nel contesto di una fittissima rete di relazioni stese tra Roma, l’Italia, l’Europa ed il Mediterraneo, piccolo mare tra gli oceani, eppure destinato a congiungere i suoi naviganti con i popoli e le regioni posti ai confini del mondo allora recentemente raggiunto, tra le Americhe e l’Asia. La concentrazione degli studi sulla politica internazionale del papato nell’epoca in questione ha favorito la convergenza di più voci di studiosi diversi su problematiche comuni, senza che gli argomenti specifici si sovrapponessero inutilmente, o che al contrario venissero isolati senza un’adeguata connessione. Va pertanto riconosciuto e stimato l’attento e perspicuo lavoro di coordinamento del team di ricerca, sia per quanto concerne la prima sezione del volume, ossia quella a carattere introduttivo e che conduce il lettore al centro del dibattito di studio, e sia per le altre due sezioni, che riflettono sulle peculiarità di situazioni fra loro stesse interconnesse, dal ruolo politico- 183 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 diplomatico di Roma e dei suoi emissari alle altre parti in causa, politiche, religiose, sociali, etc. tanto in ambito europeo che globale. L’oggetto della ricerca risulta essere stato messo a fuoco proficuamente ed interpretato efficacemente soprattutto in merito alle macroquestioni, le quali sono state utilmente sviscerate grazie alla partecipazione di molti specialisti. Quanto ai corpi politici sovrani le uniche grandi assenti, su cui non si potuto indagare in modo un po’ più approfondito come protagonisti, sono le due repubbliche marinare, Genova e Venezia, peraltro più volte ricordate nella narrazione come attori non di poco conto. Esse però, tranne la Serenissima per alcuni piccoli aspetti, non vengono analizzate compiutamente nella loro evoluzione storica dei rapporti internazionali con il papato. Queste piccole lacune però non intaccano il valore dell’apporto di questo imponente lavoro, soprattutto se si considerano gli stimoli in esso contenuti in merito alla riflessione sui nuovi approcci storiografici. Davvero infine, trattando più in generale della fisionomia della storiografia contemporanea, vale la pena raccogliere talune considerazioni sull’approccio in parte fornito a questa ricerca dalla cosiddetta World History. Maria Antonietta Visceglia delinea approfonditamente al principio della sua introduzione quanto questo nuovo punto di vista influisca sugli studi di politica internazionale del papato moderno, ma anche quanto possa essere la storia del papato stesso un ambito particolarmente adatto alla sua applicazione. È bene però dire qualcosa sul metodo in sé, e su che cosa potrebbe succedere se esso divenisse preminente nel panorama degli studi storici. Se questo conformarsi a tale filone di studi consistesse nell’accompagnare lo studio della storia occidentale, apportando talvolta un contributo fondante per la comprensione di taluni fenomeni e/o comportamenti nella relazione tra la vecchia Europa ed il resto del mondo, risulterebbe inderogabilmente un prezioso ed irrinunciabile punto di vista. Altro sarebbe se l’influenza della World History operasse delle innovazioni, più di nome che di contenuti, basate soltanto su tentativi di imitazione di un qualcosa che, solamente in quanto “globale”, risulti come finto nuovo o più veritiero. In tal modo – prescindendo dai contenuti della ricerca e ragionando intorno alle premesse del lavoro degli storici – i criteri di metodo dell’intera tradizione storiografica europea degli ultimi duecento anni non verrebbero neanche tecnicamente superati, ma per lo più nascosti o aggirati, a beneficio di un nuovo metodo la cui applicazione in alcune occasioni si è già rivelata superficiale. Proprio adesso, dopo una faticosa disamina durata per buona parte del XX secolo degli errori e dei vizi degli storici ottocenteschi, dopo aver lasciato indietro negli ultimi trenta anni alcune delle più radicate ideologie storicopolitiche, per quanto importanti, la prospettiva di rescindere i legami con il 184 G. Contel, Recensione Eurostudium3w luglio-settembre 2014 metodo “tradizionale” dal punto di vista europeo non sarebbe che una correzione meramente sul piano delle origini geografiche e culturali del metodo, eppure sufficientemente devastante. Significherebbe prescindere dall’identità culturale della storiografia che uno storico inteso come persona vivente nella storia conserverebbe lo stesso, pur etichettando la propria ricerca sotto l’egida di questo tipo di World History. È opportuno precisare che chi scrive non è un detrattore a priori di queste istanze, anzi, pensa che riguardo gli studi per l’età moderna del Nuovo Mondo, dell’Estremo Oriente e dell’Africa un’analisi incrociata di punti di vista e/o discipline varie possa solo giovare alla ricerca. Inoltre i vari filoni interni della storia globalizzante potrebbero comunque – se conosciuti a dovere e applicati tramite buonsenso – avere il compito di pungolare gli studiosi a delineare un profilo storico innovativo. Risulterebbe pertanto un metodo per il quale la sostanza della ricerca storica non possa cambiare radicalmente a seconda dei vari approcci. Un simile strumento consentirebbe di arricchire il quadro della storia dell’umanità da un punto di vista razionale, illuminando quegli angoli della conoscenza storica che potrebbero restare oscuri agli occhi, per certi versi e per certe questioni molto ingenui, di uno storico occidentale tout court. 185 G. Contel, Recensione
Scaricare