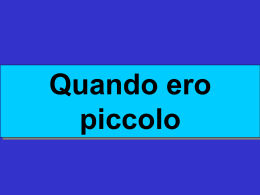chrissie foster con Paul Kennedy così in terra Una madre, due bambine, una lunga lotta per la giustizia Traduzione di Edy Tassi Titolo originale: Hell on the Way to Heaven © Chrissie Foster and Paul Kennedy 2010-09-27. A Bantam book first published by Random House Australia Pty Ltd 2010. This edition published by arrangement with pnlA/Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency Realizzazione editoriale: Conedit Libri Srl - Cormano (MI) I Edizione 2011 © 2011 - Edizioni Piemme Spa 20145 Milano - Via Tiziano, 32 [email protected] - www.edizpiemme.it «Il parroco della mia infanzia veniva accusato di essere un pedofilo. Io non lo avevo mai sospettato: lo sapevo per certo.» Emma Foster, 13 anni la gerarchia della chiesa cattolica romana deve biasimare solo se stessa se ho scritto questo libro. sono loro che mi hanno costretta a farlo. Prologo Sabato 19 ottobre 1996 Melbourne, Australia Partecipazione al forum organizzato dall’arcivescovo di Melbourne George Pell in risposta alla crisi degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica. La mia voce mi imbarazzava. Si incrinava sempre ogni volta che ero stressata o nervosa. Le parole mi si formavano perfettamente in testa. Erano parole forti e invincibili, che componevano frasi energiche e piene di una verità inconfutabile. Ma quando arrivava il momento di parlare, si spezzavano e mi uscivano incespicando dalla bocca, come sbeccate, stridule e tremanti. E la cosa mi faceva infuriare, ma non tanto quanto le altre ingiustizie della mia vita. A metà degli anni Novanta, quando stavo iniziando la mia terribile battaglia contro la Chiesa cattolica, registrai un messaggio che esprimeva tutta la mia angoscia. Rovesciai i miei sentimenti nel microfono di una sala di registrazione affinché venissero fatti ascoltare durante lo storico forum delle vittime degli abusi sessuali commessi dal clero, davanti alle loro famiglie, ai loro amici e ai capi della Chiesa. Chissà che effetto avrebbe fatto la mia voce grac- 9 chiante che rimbombava attraverso gli altoparlanti di quella sala gremita e piena di quieta tensione. Scelsi con grande cura ciò che volevo dire. «In passato leggevo la Bibbia tutti i giorni...» I rappresentanti della Chiesa mi avrebbero presa seriamente dopo tanti anni di devozione cristiana? «La gente muore...» Mi avrebbero creduta? «Siamo stati profondamente traditi.» La mia voce mi avrebbe umiliata? O peggio, si sarebbe rivelata così debole che la Chiesa non mi avrebbe nemmeno sentita? Ero sul punto di scoprirlo. La Chiesa insisteva che non si trattava di una crisi. Ma fra il 1992 e il 1996 in Australia erano stati arrestati e accusati di aggressione sessuale trentadue preti e religiosi pedofili, che in seguito si erano dichiarati spontaneamente colpevoli o erano stati dichiarati tali da un tribunale. Ventidue di essi erano già in carcere. E già questo costituiva uno scandalo. Ma non era che l’inizio. Ce n’erano molti altri che meritavano di venire scoperti e processati. La gerarchia si era fatta un’idea ragionevole delle potenziali dimensioni del problema perché aveva sottoscritto una polizza assicurativa multimilionaria per fare fronte alle richieste di risarcimento delle vittime. Doveva essersi sentita vulnerabile. Le azioni della Chiesa, che spostava i responsabili da una parrocchia all’altra, che cercava di nascondere i loro crimini, negando l’esistenza stessa della pedofilia e rifiutando ogni responsabilità, venivano tenute sotto pesante osservazione dai media. E il forum a cui stavamo partecipando poteva solo venire descritto come un comitato di crisi, anche se i padroni di casa si rifiutavano di usare questa espressione. Avevamo preso posto nella sede della Chiesa cattolica, a est degli edifici più imponenti della città, a due passi da una delle sue più maestose cattedrali, che dominava perfi- 10 no il parlamento. Mia madre e Anthony, mio marito, sedevano accanto a me. Vicino e intorno a noi c’erano mia zia, mio zio e alcuni amici di Oakleigh. Le vittime delle aggressioni sessuali, le loro famiglie e i loro amici stavano occupando rapidamente il resto dei posti e tutti guardavano con trepidazione verso il palco. L’atmosfera era tranquilla e solenne e le persone rimanevano sedute in silenzio da sole o parlavano a bassa voce riunite in piccoli gruppi. Ognuno di noi aveva la sua esperienza e il suo dolore, ma tutti nutrivamo la stessa segreta speranza che la giustizia e la comprensione fossero vicine. Sapevo che tutti noi avremmo preferito non essere lì, avremmo preferito che i nostri cari stessero dove avrebbero dovuto stare, lontani da ogni sofferenza. L’empia mano della pedofilia e delle aggressioni sessuali all’interno della Chiesa aveva toccato tutti i trecentocinquanta membri del pubblico. L’uomo che presiedeva il forum, George Pell, il nuovo arcivescovo di Melbourne, entrò nella sala. I nostri occhi lo seguirono in un silenzio carico di presentimenti. Lui si sedette e abbassò lo sguardo su di noi. Eravamo pieni di domande. Ci avrebbero finalmente prestato ascolto? Gli importava di noi? Ci credevano? Avrebbero aperto le loro menti e i loro cuori a tutte le vittime? 11 CApitolo 1 Le mie origini religiose Al largo della costa occidentale della Scozia, oltre le Ebridi Interne, oltre le Ebridi Esterne, proprio in mezzo all’Oceano Atlantico, c’è Santa Kilda, un’isola minuscola circondata da spuntoni rocciosi che sono stati modellati dalle onde dei secoli. Questo piccolo arcipelago, spazzato da un violento vento salmastro, deve essere il luogo non ricoperto di ghiaccio più ventoso e isolato della terra. Oggi, gli unici amici di queste scogliere sono le nubi basse e dense e migliaia di maestosi uccelli marini. Ma una volta era abitato dagli uomini. I miei antenati. Da parte di mio padre sono l’ultima di una lunga discendenza di scozzesi. Erano presbiteriani, ma questo dettaglio non veniva mai menzionato. Nella nostra vita esistevano solo i Cattolici e i Non-Cattolici. Santa Kilda non era il nome di una santa, ma deriva dalla parola skildir, cioè “scudo”, perché così era apparsa l’isola ai Vichinghi che l’avevano avvistata per la prima volta dalle loro navi. La gente di Santa Kilda viveva in modo semplice ma affascinante in un ambiente che imponeva molti sacrifici. Purtroppo, solo un bambino su dieci sopravviveva. La tradizione voleva che una donna anziana facesse visita a tutti i neonati con una sacca di pelle di pecora piena di olio da spalmare sui cordoni ombelicali dei bambini. Si trattava di 13 un rituale primitivo. La sacca e il suo olio trasmettevano il tetano e la maggior parte dei neonati moriva nel giro di pochi giorni. Era un evento così comune che quando andavano a partorire le madri portavano con sé anche delle piccole bare. Il nome di quel ramo della mia famiglia era MacQueen. Nelle vecchie foto cercavo sempre di identificare i miei parenti fino a quando non mi rendevo conto che erano tutti parenti, non solo quelli che si chiamavano MacQueen. Gli uomini dell’isola avevano i capelli rossi e le donne neri, proprio come i miei. Nel 1852, trentasei dei centodieci isolani accettarono l’offerta della Highlands and Islands Emigration Society, un ente benefico che promuoveva l’emigrazione della popolazione scozzese più povera, di imbarcarsi per l’Australia. Ma la cosa si rivelò un disastro per più di un motivo. Le otto famiglie che avevano deciso di affrontare il viaggio erano le più forti dell’isola. Erano l’avanguardia. Le altre le salutarono sperando un giorno di poterle ritrovare. Ma la loro partenza lacerò e gettò nello sconforto la piccola comunità. A volte, poi, essere coraggiosi non significa essere immuni alle malattie. Più della metà della mia gente, adulti e bambini, morì sulla nave. I sopravvissuti vennero trattenuti in un lazzaretto vicino alla punta meridionale di Port Phillip Bay, prima di venire trasportati a Brighton, a sud di Melbourne, poco lontano da un altro insediamento chiamato St Kilda. Nessuno scozzese li seguì più. Io sono una discendente di John MacQueen, che arrivò in Australia a tredici anni, e vivo a pochi chilometri di distanza da dove si stabilì lui. Sono nata centodue anni dopo il loro arrivo con la nave, al Brighton Hospital, che domina il cimitero dei pionieri dove fu seppellito Finlay, il padre di John MacQueen. Ho sempre voluto credere che il giovane John e i suoi antenati isolani abbiano tramandato fino a me qualcosa della loro forza e della loro capacità di adattamento. 14 Da parte di mia madre sono sempre stati tutti irlandesi cattolici, probabilmente sin dai tempi di san Patrizio stesso. La prima dei nostri antenati ad aver messo piede in terra australiana fu Mary Lee, una giovane di diciassette anni, che arrivò a Melbourne il 26 maggio 1849 a bordo di una nave che trasportava orfane. Lei e altre duecento adolescenti erano state inviate qui per svolgere una serie di mansioni predefinite, ma anche, e soprattutto, per porre rimedio alla penuria di donne nella colonia in cui stava per scoppiare la corsa all’oro. Un funzionario governativo ordinò a Mary di lavorare come cameriera a ovest di Melbourne per dieci sterline all’anno, con la libertà come indennità di licenziamento. Nel maggio del 1851, Mary sposò James Knight nella chiesa cattolica di St Francis a Melbourne, che allora faceva ancora parte del Nuovo Galles del Sud. La prima pietra della St Francis era stata posata solo dieci anni prima e la chiesa, come la maggior parte della città, era giovane e imponente. Dopo parecchie ricerche ho scoperto che Mary Lee, la mia bis-bis-bisnonna era stata sepolta in una tomba anonima nell’argilla rossa essiccata di una città mineraria chiamata Clunes. Chissà se aveva mai provato nostalgia per il fresco e il verde della sua nativa Limerick. Quando morì, a quarantasette anni, Mary Lee era rimarchevolmente sopravvissuta a due mariti e a cinque dei suoi undici figli. Quando i miei genitori si incontrarono, anche queste due storie si unirono. Io faccio parte della terza generazione di donne cattoliche che ha sposato un uomo non cattolico. Quando mia nonna era ancora una futura sposa, il suo fidanzato fu costretto a convertirsi così che si potesse celebrare il matrimonio. Mio padre non fu costretto a farsi il segno della croce, ma i miei genitori non poterono sposarsi davanti all’altare. Quasi vergognandosene, dovettero pronunciare la loro promessa nuziale nella sacrestia, una piccola stanza 15 all’interno della chiesa dove il prete e i chierichetti si vestono e si preparano per la messa, lontano dagli amici e dalla famiglia, dall’altare e dal crocifisso. Qualcuno aveva deciso che Dio non voleva assistere all’unione di mio padre e mia madre, proprio come qualcuno aveva deciso che mia madre, una volta adulta, non potesse partecipare ai matrimoni dei suoi amici non cattolici. Non poteva mettere piede nelle “altre” chiese. Questo era il controllo che la Chiesa cattolica esercitava sui suoi fedeli. Quando nel 1980 mi sposai io, nella chiesa di St Patrick, lungo la costa nella periferia di Mentone, i miei voti vennero pronunciati davanti all’altare, alla presenza della mia famiglia e di tutti i miei amici. Anthony non fu costretto a convertirsi, rimase ateo. Attraverso la firma di un accordo da parte degli sposi non cattolici, tutti i figli nati da questi matrimoni sono cresciuti da cattolici. Generazione dopo generazione, siamo stati tutti costretti a esserlo. Non c’erano alternative... a meno che non si preferisse andare all’inferno o, peggio, condannare all’inferno i propri figli. Ecco cosa ci veniva insegnato. Questo era il potere della Chiesa cattolica. La prima volta che inarcai un sopracciglio davanti alle regole cattoliche avevo circa otto o nove anni. Si stava svolgendo il Concilio Vaticano II, un periodo controverso durante gli anni Sessanta, in cui alcuni membri della gerarchia decisero di “rilassare” alcune delle loro regole ferree. Misteriosamente e improvvisamente, alcuni peccati non erano più peccati: le donne non erano più obbligate a portare il velo in chiesa, non bisognava più digiunare per otto ore prima di fare la comunione, si poteva mangiare carne di venerdì (a eccezione dei venerdì di Quaresima e del Venerdì Santo) e la messa del sabato pomeriggio divenne un’accettabile sostituta della celebrazione domenicale. Quest’ultimo cambiamento fu troppo per me. Com’era possibile che il giorno prima si finisse all’inferno per aver fatto qualcosa di sbagliato e il giorno dopo quella stessa 16 cosa andasse bene? Durante il secondo anno di scuola una suora ci aveva insegnato che potevamo andare a messa sei giorni alla settimana, ma se saltavamo la messa della domenica e morivamo prima di confessare questo peccato a un prete, saremmo finiti all’inferno: era una regola ferrea. Non si poteva evitare la messa della domenica. Adesso, invece, all’improvviso potevamo andare a messa il sabato. Chi lo diceva? Dio aveva detto sì o no, che saremmo andati all’inferno se avessimo saltato la messa della domenica? Se non lo aveva detto, allora come potevano degli uomini condannarci all’inferno quando la cosa non importava a Dio stesso per primo? I bambini sono piuttosto bravi a spaccare il capello in quattro e io applicai lo stesso ragionamento a tutti i cambiamenti introdotti dal Concilio Vaticano II, pensando che se Dio aveva stabilito le regole che noi seguivamo, allora dei semplici uomini non potevano cambiarle così. Prendevo seriamente il rischio di finire all’inferno per tutta l’eternità, perciò volevo davvero sapere com’era possibile che gli uomini decidessero chi ci andava... gli uomini non erano Dio. Ma tenevo per me i miei dubbi. Sentivo che non era il caso di discutere la cosa con il mondo degli adulti. I paletti morali mobili che ci avevano conficcato attorno non erano la sola cosa che mi preoccupava della religione. Sin dall’inizio la confessione era stata un’esperienza spaventosa. Dovevamo snocciolare i nostri peccati tutte le settimane, anche se non avevamo peccato. Io il più delle volte ero terrorizzata perché non avevo fatto niente di male ed ero costretta a inventarmi qualcosa. La mia confessione fasulla abituale era: «Ho disobbedito alla mamma e ho raccontato qualche bugia». E quella era la bugia vera, perché non avevo affatto disobbedito alla mamma. Amavo mia madre e volevo sempre comportarmi bene con lei. Un giorno, in un momento di debolezza, rubai sei centesimi alla mamma e mi sentii sollevata perché quello era davvero un peccato. Avevo davvero qualcosa da confessa- 17 re e mi sentivo tranquilla di non dover raccontare una bugia al prete. «Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.» ...non offenderti mai più? Ops, un’altra bugia? Il nostro prete era un altro motivo di paura e disagio durante il tanto temuto momento della confessione. La suora ci aveva detto che l’uomo che ascoltava i nostri peccati non era interessato a vederci o a scoprire chi si stava confessando. La confessione avrebbe dovuto essere anonima, ma ogni volta che entravo nel confessionale dovevo parlare attraverso l’apertura di un piccolo pannello scorrevole. Il prete dall’altra parte del divisorio si chinava e mi guadava dritto in faccia allo scopo di identificarmi. Ne dedussi che doveva fare lo stesso con tutti gli altri bambini che entravano nel confessionale, ma anche se odiavo la cosa non potevo fare niente per evitarla. Immagino che il prete fosse curioso di scoprire chi faceva cosa all’interno della parrocchia. Per me però era un affronto, visto che sapevo che non avrebbe dovuto invadere la mia privacy. Secondo la suora, almeno, non avrebbe dovuto farlo. Una volta ero così decisa a evitare la mia poco etica identificazione che mi scostai completamente dalla finestrella, in modo che il prete non potesse vedere il mio viso attraverso la griglia di metallo. Ma con mia grande preoccupazione mi accorsi che questo non lo fermava. Il prete si chinò sempre più giù, cercando di capire chi fosse entrato. Io mi contorsi e nonostante lo spazio ristretto riuscii a stare lontana dallo spioncino. Da quello che potevo vedere, lui era praticamente piegato in due e allungava il collo per cercare di cogliere uno scorcio della piccola peccatrice che stava bisbigliando nel confessionale. Per evitare il suo 18 sguardo, a quel punto avevo la faccia schiacciata contro la parete e mi ero praticamente alzata in piedi. Ogni volta che intravedevo un angolo della sua faccia, mi allontanavo un po’ di più. Il mio cuore martellava dalla paura, sapendo che se fossi stata riconosciuta sarei finita nei guai. Lui non mi ascoltava ed emetteva strani rumori. Percepivo la sua frustrazione. Ma continuava a borbottare: «Per penitenza... uhm... tre Ave Marie... un atto di contrizione...». «Mio Dio mi pento e mi dolgo...» Finita la confessione, mi alzai del tutto e con la faccia ancora rivolta verso la parete passai davanti alla finestrella in modo che lui potesse vedere solo il mio tronco. Quel giorno mi intrufolai fra le panche furtiva come un gatto e mi nascosi fra i miei compagni di scuola. Se il prete curioso fosse uscito dal confessionale, avrebbe visto solo un mare di volti. E per me la cosa aveva il sapore di una vittoria, perché per una volta lo avevo obbligato a comportarsi correttamente: la confessione si era svolta come avrebbe dovuto, senza che lui mi identificasse. Anche se non ne conosco il motivo, quando avevo circa dodici anni mio padre, che era agnostico, mi chiese: «Sei contenta di essere cattolica?». «No» gli risposi con una forza che mi sorprese. «Tutto quello che dico e faccio è peccato.» Ecco come ci si sentiva a vivere sotto il regime cattolico sia a scuola che a casa. A quindici anni ottenni un lavoro estivo come impiegata pubblica. Un’amica, che durante le vacanze scolastiche aveva trovato lavoro come me, mi incoraggiò a continuare a lavorare anche dopo l’inizio delle lezioni. Io volevo tornare a scuola, ma non volevo perdere la mia amica, così finii con il rimanere al lavoro. La mia educazione scolastica terminò al primo anno di liceo, cosa di cui mi sono sempre pentita. Allora, tuttavia, il lavoro mi piaceva moltissimo e continuai a lavorare come dipendente pubblica in due di- 19 versi dipartimenti per un totale di nove anni, con un intervallo di due anni durante i quali mi dedicai ad alcuni viaggi oltremare. Il mio primo lavoro fu presso il dipartimento dell’Agricoltura, situato in uno splendido edificio vittoriano bianco in cima alla scarpata verde che guardava verso i Melbourne Treasury Gardens. Durante il primo anno lavorai nella Sezione Informatica, inviando materiale informativo agli agricoltori e aiutando a stampare gli opuscoli che il dipartimento distribuiva. L’anno seguente, con mio grande piacere, mi fu assegnato un posto di dattilografa nella biblioteca del dipartimento, dove potei rispolverare la mia abilità nello scrivere a macchina. Aiutai il bibliotecario a compilare le schede bibliografiche e mi immersi ancora di più nelle scienze terrene dell’allevamento degli animali, dei biscotti al latte superproteici (in grado di sfamare tutto il mondo), del sessaggio dei polli, dell’orticultura, dell’apicoltura e della coltivazione della frutta. Dopo un paio di anni mi iscrissi a un corso per tecnici di biblioteca, vincendo una borsa di studio ministeriale che pagò la mia istruzione. A vent’anni completai due dei tre anni di corso e poi decisi di viaggiare. Trascorsi nove mesi in Europa e poi arrivai a Londra, dove vissi e lavorai per un anno. Nel 1977 ero impiegata in un ufficio di servizi dattilografici che da poco era passato dall’utilizzo di macchine da scrivere elettriche a una nuova tecnologia chiamata “computer word processing”. Era roba all’avanguardia, il secondo sistema del genere in tutta l’Inghilterra. La società che mi aveva assunta produceva e installava questi sistemi computerizzati e noi fornivamo i manuali d’uso specifici. Nell’ufficio in cui lavoravo io c’erano circa otto dattilografe e solo due erano inglesi. Il resto di noi proveniva da tutto il mondo. Una delle mie colleghe era Pinky, una ragazza indiana un po’ più giovane di me. Il giorno in cui l’avevo conosciuta, mentre stavamo uscendo dall’ufficio, mi aveva chiesto 20 dove stessi andando. Io dovevo andare alla stazione della metropolitana, e lei anche, così ci eravamo incamminate assieme. All’improvviso lei mi aveva presa a braccetto, cosa che mi aveva allarmata. Non sapevo cosa fare. L’ultima volta che avevo camminato così, o mano nella mano con un’altra femmina, era stato a scuola. Temevo che la gente cominciasse a guardarci pensando che eravamo una coppia gay. Ma mentre camminavamo mi ero accorta che altre donne facevano la stessa cosa. Era un’abitudine inglese. E pian piano mi affezionai a queste nostre passeggiate a braccetto fino alla metropolitana e quando i freddi mesi invernali arrivarono, avevo l’impressione di proteggere la mia piccola e ossuta amica Pinky, che si faceva più vicina mentre camminavamo e ridevamo. Raggiungevo ogni giorno il cuore di Londra in treno. I treni erano diversi da quelli che conoscevo a casa. Ogni carrozza era divisa in scompartimenti, con una fila di posti su entrambi i lati, un corridoio centrale e una porta alla fine di ciascuno. Il più delle volte i posti erano occupati da uomini che leggevano il giornale. Una mattina, mentre mi recavo al lavoro, decisi di fare uno strappo al budget e mi comprai un quotidiano. Una grossa notizia aveva catturato l’attenzione di tutti. Il governo inglese aveva inavvertitamente concesso un finanziamento di migliaia di sterline a un’organizzazione di pedofili. L’indignazione pubblica arrivava da tutte le direzioni. Il settantenne portavoce del gruppo (che aveva una “fidanzata” di soli tredici anni) era contento sia dei soldi che di tutta quell’attenzione. Il dibattito infuriava sui giornali e alla televisione da giorni. «Maledetti pedofili» imprecò un pendolare, con il naso infilato nel quotidiano che stava leggendo. Altri passeggeri annuirono a se stessi e gli uni con gli altri. Alcuni borbottarono il loro assenso. Io osservai quelle persone dal mio posto nell’angolo. Eravamo tutti estranei, ma per un istante ci ritrovammo uniti nella stessa opinione. 21 Era la prima volta che leggevo o sentivo la parola “pedofilo”. (Nel 1981 il Macquarie Dictionary, il dizionario dell’inglese australiano, non conteneva ancora questo vocabolo. Vi fu inserito per la prima volta nella seconda edizione, nel 1991). Fino a quel momento avevo sentito solo le raccomandazioni a proposito dell’“uomo nero”, dell’“uomo cattivo”, o dell’ “uomo che mi avrebbe portata via”. Tutti appellativi che in seguito erano ricaduti sotto l’etichetta “estraneo uguale pericolo”. Qui però c’era qualcosa di nuovo, di mai sentito prima. Un’organizzazione di pedofili stava sostanzialmente facendo la stessa cosa dell’uomo nero. Ma siccome ostentavano il loro comportamento, le loro vittime non scappavano. Dopo che lo scandalo si spense, non ne sentii più parlare e la mia cultura sui pedofili rimase quella che era. Lasciai il lavoro che amavo in Inghilterra per viaggiare tre mesi attraverso il Nord America e il Messico prima di ritornare a casa. Ero stata via due anni. Il settore pubblico mi accolse di nuovo e mi venne offerto un posto sia nella biblioteca parlamentare sia in un dipartimento di polizia chiamato D24. Il lavoro negli uffici della polizia di Melbourne mi sembrò un’occasione da non rifiutare. Ci rimasi per due anni, fino a quando la sveglia alle cinque della mattina non logorò il mio entusiasmo. Venni trasferita su un’auto di pattuglia appostata a solo un chilometro di distanza dalla casa dei miei genitori. Mentre svolgevo questo lavoro, incontrai Anthony. Uscivo già con un altro, un istruttore di volo. Anthony era una sua conoscenza e di recente aveva preso la licenza di pilota commerciale. Una sera passai a trovare il mio ragazzo e a casa sua trovai Anthony. L’uomo che volevo vedere non c’era, ma l’uomo con il quale avrei trascorso il resto della mia vita era in piedi dietro la zanzariera. «Non c’è» mi disse lo sconosciuto alto e magro. «Ma entra pure.» 22 «No, non è il caso» risposi. «Certo che sì, non c’è nessun problema» insistette Anthony. «Se ti va.» Era molto gentile. Capii di piacergli e immediatamente mi piacque anche lui. Ma pensavo che sarebbe stato sbagliato entrare in casa. Così me ne andai, senza sapere niente di quell’uomo misterioso dal sorriso caldo. Anthony e io ci incontrammo di nuovo dopo diversi mesi a una festa organizzata per festeggiare il 29 febbraio 1980. Io in quel momento ero di nuovo single. Eravamo in pochi e noi due parlammo tutta la sera. A un certo punto Anthony ebbe un’illuminazione. «Ma tu sei la ragazza che ho visto sulla porta quella sera» rise. «Sì. E tu sei quello con cui ho parlato?» Scoppiammo entrambi a ridere perché stavamo parlando da ore senza renderci conto che ci eravamo già incontrati. Prima di allora, sia Anthony che io eravamo stati sfortunati in amore e avevamo sviluppato entrambi un’idea molto precisa sul tipo di persona con la quale volevamo trascorrere il nostro tempo. Durante il nostro primo appuntamento, la settimana seguente, chiacchierammo di matrimonio e figli (quando si dice bruciare le tappe!). Ma io mi sentii sollevata quando questi argomenti vennero fuori perché ero stanca di essere sempre garbata e discreta nelle relazioni, solo per scoprire molto più avanti che stavo perdendo il mio tempo. Così misi subito tutte le carte in tavola. Per fortuna lui voleva le stesse cose. Parlammo dei nostri sentimenti e io fui contenta che Anthony si dimostrasse tanto affabile. Più lo ascoltavo e più mi sentivo attratta da lui. Era abile (scoprii in fretta che non c’era quasi niente che non sapesse fare o aggiustare), gentile e paziente. Non fumava, non beveva troppo, non giocava d’azzardo né leggeva «Playboy», tutte crocette sulla colonna dei “sì”. Ed era attraente. Mi sentivo come se fino a quel momento 23 fossi uscita solo con dei ragazzi. Adesso avevo incontrato un uomo e quell’uomo era tutto quello che volevo. Sei settimane dopo andammo a fare un picnic in campagna, scegliendo un angolino in cima a una collina. Il panorama era meraviglioso, la brezza gentile, noi eravamo innamorati e io non mi ero mai sentita meglio. Eravamo così felici, così grati di esserci trovati. Anthony non si inginocchiò quando mi chiese semplicemente: «Vuoi sposarmi?». La nostra vita insieme era appena cominciata, ma entrambi riuscivamo a vedere il futuro luminoso che si stendeva davanti a noi. E nel quale ci tuffammo di testa. Ricordo il pranzo di nozze a casa dei genitori di Anthony come un momento di grande euforia. La cosa più evidente fu la gioia con cui gli sposini consumarono la loro cena in una piccola stanza separata dal resto degli ospiti. Chiacchierammo e ridemmo come fanno i giovani quando hanno raggiunto quel punto della loro vita in cui possono godere appieno del dono della libertà senza il carico delle responsabilità. Lo champagne non aveva mai avuto un sapore più dolce. Adesso riguardo quelle vecchie foto del matrimonio in cui Anthony sfoggia impertinente il suo cravattino rosso e una rosa in tinta all’occhiello e io il mio abito attillato color magnolia (che mi aveva passato mia madre) con una coroncina di fiori d’arancio in cera che tratteneva il lungo velo, e avverto il calore di quei ricordi che non mi abbandoneranno mai. In meno di cinque mesi ci eravamo incontrati e sposati. Poco dopo rimasi incinta. La vita nella squadra anticrimine era un po’ turbolenta per le mie condizioni, così venni trasferita di nuovo, questa volta in un’altra sezione, dove raccoglievo le richieste di rilascio dei certificati penali e prendevo le impronte digitali dei richiedenti con il vecchio metodo dell’inchiostro. Anche se ero ancora giovane la mia carriera stava rallentando. Ma davanti a me si profilavano giornate molto più intense in veste di genitore. 24 Il 6 novembre 1981 arrivò Emma. Fu un travaglio veloce. Una notte, dopo che mi ero addormentata solo da mezz’ora, mi svegliai con la sensazione, ma non la certezza, che stesse per accadere qualcosa. Mancavano ancora dieci giorni al termine. «Dovremmo chiamare l’ospedale» suggerì Anthony, ma io avevo già il telefono in mano. L’infermiera che rispose alla mia chiamata e ascoltò i miei sintomi non era sicura che fossi già entrata in travaglio, perciò tornai a letto. Ma poi si ruppero le acque e io non ebbi più alcun dubbio. Andammo di corsa in ospedale. Avevamo frequentato dei corsi e avevamo imparato tutto sul parto, sulle sue fasi e su tutte le varie procedure, perciò pensavo di sapere cosa aspettarmi. «Questa fase di solito dura un paio d’ore» ci aveva avvertiti l’infermiera al telefono. «E lo stesso quella successiva.» Ma il mio corpo sembrava voler saltare da una fase all’altra. Il dolore aumentò in fretta, io storcevo la faccia e lottavo. A un certo punto sentii la voce di un’infermiera che mi disse qualcosa che non dimenticherò mai: «Su tesoro, non sprecare il tuo dolore!». Emma nacque alle due e ventidue del mattino. Il due era da sempre il mio numero fortunato e interpretai l’ora della nascita di Emma come un buon segno. Il medico non la sculacciò sul sederino, come avevo visto fare alla televisione e io ne fui sollevata. Secondo me era crudele far venire al mondo un bambino con un atto di violenza e non volevo che capitasse alla mia bellissima e pacifica bambina. Quando me la porsero, la prima cosa che guardai, dopo aver visto che era sana, furono le sue orecchie. Non mi piacciono le mie orecchie, perciò speravo che i miei figli nascessero con quelle di Anthony. Quelle della piccola Emma erano perfette. 25 Come tutti i neo genitori, ci sentimmo molto orgogliosi e onorati. Avevamo soggezione di lei. Emma aprì gli occhi e si guardò attorno: una piccola bimba avventurosa sin dall’inizio. Ricordo ancora quando Emma aveva solo poche settimane. La tenevo fra le braccia osservando quella personcina preziosa e delicata e all’improvviso mi resi conto della sua totale dipendenza verso chi doveva fare tutto per lei, nutrirla, scaldarla, darle riparo e proteggerla. Avevo pensato alla sua vulnerabilità immaginando che chiunque avrebbe potuto prenderla e portarla via, perfino farle del male, e lei non avrebbe potuto impedirlo. “Nessuno farà del male alla mia bambina” avevo dichiarato silenziosamente. La forza di questo amore che avvertivo dentro di me, la purezza di questo istinto di protezione nei confronti dell’innocenza più completa risvegliò in me un enorme senso di umiltà. Sarebbe stato un onore svolgere il compito con cui ero stata benedetta. Sono convinta che tutte le madri e tutti i padri provino questo senso d’integrità nei confronti dei loro figli e che ogni bambino, senza eccezioni, si meriti questo livello di protezione. Io proteggerei le mie figlie fino alla morte. Venti mesi dopo, nacque la nostra secondogenita, Katie. Durante tutta la gravidanza avevo avuto in mente la nascita velocissima di Emma e volevo essere pronta per un nuovo parto “accelerato”. All’approssimarsi del termine, feci visita al mio medico. Mancava ancora una settimana, ma avevo avvertito una contrazione di Braxton Hicks più forte del normale (sono finte contrazioni che avvengono prima dell’inizio del travaglio vero e proprio); ormai erano cominciate da mesi, proprio come con Emma. E non ero sicura se quella contrazione significasse che ero pronta per entrare in travaglio o no. Mentre mi visitava, il ginecologo si fece all’improvviso molto serio. 26 «Voglio che vada subito in ospedale» mi ordinò con un’urgenza che avrebbe dovuto allarmarmi. «Ci vediamo là.» Per fortuna l’ospedale si trovava proprio accanto all’ambulatorio. Anthony mi portò fin lì in macchina e io entrai barcollando nel reparto di ginecologia, mentre le contrazioni si facevano sempre più intense. «Mi sa che sta succedendo qualcosa» borbottai. «Dov’è il medico?» chiese il mio servizievole maritino. «L’hanno visto correre come un matto attraverso il prato fino a qui. Deve essere da qualche parte. Sembrava davvero di fretta» rispose un’infermiera con una smorfia birichina. Il ginecologo arrivò pochi minuti dopo, e anche Katie. Erano passati solo trentasei minuti da quando lo avevo visto nel suo studio. E più tardi mi raccontò che il suo contegno serio era dovuto al fatto che aveva capito che Katie stava per nascere e un movimento sbagliato da parte sua avrebbe potuto farmi partorire lì. Di nuovo, io e Anthony gioimmo dell’arrivo di un’altra bimba sana (e con le orecchie perfette). Un paio di mesi prima della nascita di Katie avevamo rilevato l’attività dei genitori di Anthony, che gestivamo da casa. La società vendeva, installava e provvedeva alla manutenzione di impianti di riscaldamento idraulici progettati da Anthony, e prima di lui da suo padre Ken. Lavorare da casa significava che io potevo occuparmi delle bambine senza doverle affidare alla cura di qualcun altro. Nel marzo del 1985, venti mesi dopo, nacque la nostra terza figlia. Visto che il mio medico era convinto che non sarei mai riuscita a raggiungere l’ospedale in tempo, Anthony si era preparato all’idea di un parto domestico. E per me fu stressante tenere sotto controllo ogni fitta, per cercare di identificare qualsiasi dolore insolito che avrebbe potuto indicare l’inizio del travaglio. Ma volevo essere il più pronta possibile perché continuavo a immaginarmi di partorire all’improvviso mentre ero per strada. 27 Una settimana prima del termine avvertii un piccolissimo sintomo, diverso da quello delle gravidanze precedenti, e così, per non rischiare, ci avviammo verso l’ospedale. Venni ricoverata. Una volta lì, pensai che forse eravamo stati precipitosi. Non stava succedendo niente. Così decidemmo che saremmo rimasti lì per un po’ e se il travaglio non fosse cominciato saremmo tornati a casa. Telefonai a mia madre dal letto e l’aggiornai. «Penso che sia un falso allarme» le spiegai. «Aspettiamo ancora un po’ e se non succede qualcosa torneremo a casa...» Mentre stavo parlando, la mia pancia sembrò farsi di cemento. Poi la sensazione passò. Io continuai a chiacchierare, riflettendo sulla strana sensazione che avevo appena provato. Poi avvertii di nuovo la pancia di cemento e guardai l’orologio. La volta dopo controllai di nuovo l’ora e quello che mi era sembrato un intervallo di cinque, dieci minuti, si rivelò invece una pausa di un solo minuto o due. Comprendendone il significato, dissi: «Adesso devo andare, mamma». «Okay, tesoro» mi rispose lei, senza sospettare nulla. «Fammi sapere cosa decidete.» «Okay, mamma. Ciao.» Dopo aver riappeso, cominciai a scendere dal letto. «Meglio che chiami un’infermiera» suggerii e mio marito corse lungo il corridoio in cerca di aiuto. Sedici minuti dopo tenevo fra le braccia la nostra nuova bambina. Ancora una volta condividemmo la felicità per la nascita di una figlia sana, anche lei con le orecchie di Anthony: tre su tre! 28
Scarica