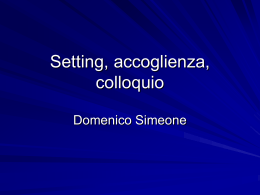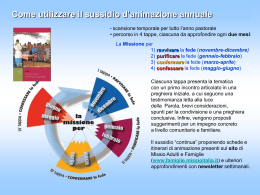Questa volta il professor Pelizzoni, nel suo ormai tradizionale opuscolo, si rivolge direttamente ai maturandi aiutandoli a porsi qualche utile domanda sul momento (direi, sul crinale) della vita che stanno per affrontare. In seconda istanza il testo vale per gli adolescenti in genere, perché tutti si sentano chiamati in causa: ciascuno, se si esamina onestamente, può trovare il discorso rivolto a sé. E i piccoli? Non loro personalmente, ma i genitori leggeranno queste pagine con frutto. Ne son sicuro. IL E LA SALE LUCE Quindi, buona lettura estiva a tutti! Il Rettore Collegio Ballerini, giugno 2009 Via Verdi, 77 - 20038 Seregno (MI) - Tel. 0362 235501 www.collegioballerini.it - [email protected] Lettera a ragazzi che diventano uomini in vacanza Stefano Pelizzoni in vacanza PENSIERI PENSIERI Stefano Pelizzoni Lettera a ragazzi che diventano uomini PRO MANUSCRIPTO giugno 2009 Ai maturandi dell’anno 2008-2009 Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. (Mt 5,13-16) Carissimi, quest’anno per voi non termina solo l’anno scolastico, ma un intero periodo della vostra vita. Tra poco vi troverete alle prese con un’esistenza completamente diversa da quella che avete vissuto finora, nella quale dovrete mettere a frutto tutto ciò che avete appreso sui banchi e nei laboratori. Se tale esistenza sarà più bella, più felice e più libera, ormai dipenderà solo da voi. È l’augurio sincero che noi educatori vi rivolgiamo, nella speranza che nel vostro futuro ci sia anche un po’ (o magari molto) di quello che vi abbiamo trasmesso in questi anni, non solo in termini di cultura e professionalità. Se una scuola cattolica si limitasse a quello, verrebbe meno alla propria missione educativa, che è quella di formare, 3 prima di ogni altra cosa, degli uomini. Ciò che sarete domani, quindi, dipende anche un poco da noi, da quello che abbiamo (o non abbiamo) saputo darvi in questo senso. E per questo che vorrei rubarvi ancora qualche minuto – che coraggio, dopo cinque anni di lagne! – per riprendere con voi il discorso iniziato con le vostre famiglie nei miei precedenti libretti. Ciò che segue non vuole essere una predica fuori dal pulpito o un monologo edificante. Immaginiamoci seduti in un bar a bere qualcosa, a fare quattro chiacchiere. Di che cosa parliamo? Non facciamo un discorso molto articolato… Diciamo che buttiamo lì qualche idea, qualche spunto di riflessione su alcuni concetti – ma se li possedeste davvero preferirei chiamarli doni – legati a ciò che mi auguro porterete fuori da qui. Sono input che abbiamo cercato di darvi – magari senza che ve accorgeste, e magari senza esserci neppure riusciti – durante il cammino che abbiamo percorso insieme e che penso sia importante riprendere per un’ultima volta. Magari con l’ambizione di poterci davvero ritrovare a parlarne, per sentire come la pensate anche voi. Perché è il vostro turno di essere trattati come adulti e non più come ragazzi. Perché ora sta a voi decidere cosa volete diventare; e perché la vostra scelta sia davvero quella di provare ad essere, anche nella quotidianità, sale della terra e luce del mondo. 4 La Ricerca Knockin’ on Heaven’s door Cominciamo con una prova di coraggio: alzi la mano chi se ne va da qui con la certezza di una Fede acquisita o rafforzata dalla permanenza in una scuola cattolica. Va bene, do il buon esempio: non la alzo neppure io. Non credo di essere stato un ragazzo molto diverso da voi, anche se certo ho vissuto in un mondo di soddisfazioni meno immediate. Dopo otto anni di scuola cattolica mi sentivo impregnato dal puzzo di sacrestia in una misura tale che, pur non allontanandomi dalla fede, di sicuro non ne ero uno dei suoi fan più accesi. Ma sarebbe disonesto attribuire solo ad altri questa freddezza. Di vero c’è che chi si sente attratto da pastori, pecorelle, pescatori e samaritani in un mondo di Iphone, Wii, divertimenti e piaceri a portata di mano finisce col sentirsi un po’ sfigato, e si accoda al resto della massa, spesso e volentieri facendo professione di ateismo, pur non sapendo neppure bene cosa voglia dire. O semplicemente non capisce perché dovrebbe perdere tempo a farsi venire emicranie sul mistero della sofferenza, del dolore, della morte quando è giovane, gode di ottima salute e ha una gran voglia di gustarsi la vita. O ancora non crede che sia il caso di faticare a farsi domande quando intorno ha già tante belle risposte che qualcun altro ha preparato per lui. O, infine, nell’errata convinzione che la fede sia una cosa da predestinati, e se uno nasce quadrato non può diventare rotondo. Il recupero della fede non è passato – come quasi mai avviene – da una folgorazione sulla via di Damasco, ma 5 piuttosto attraverso una ricerca, che del resto non considero assolutamente conclusa. Sono dell’idea che l’acquisizione della consapevolezza – quasi mai della pienezza, che è appannaggio dei santi – della propria fede sia una sorta di work in progress, un cammino in continuo divenire che deve contraddistinguere un cristiano per tutta la vita. Tre sono stati i punti fermi di questo percorso. Anzitutto, nonostante la crisi di rigetto iniziale, quel patrimonio di spiritualità vissuto negli anni della scuola, che solo apparentemente sembrava essere stato rimosso mentre era ancora lì, in un angolo della coscienza, pronto a risbucare. Una cosa di cui mi sono accorto solo anni più tardi, alla luce della mia esperienza di docente, è che quando cerchi di lavorare per tutti anziché semplicemente con tutti, il tuo operato finirà per dare frutto; magari non avrai neppure la soddisfazione di saperlo, ma se hai saputo seminare bene, anche la terra apparentemente più arida non riuscirà ad impedire ai germogli di spuntare. Il secondo punto è rappresentato dagli incontri occorsi durante il cammino. Avremo modo di riparlarne più avanti: nessuno giunge alla maturità della fede da solo, ma occorre avere la vicinanza di chi sappia guidarti nel percorso e di chi accetti anche di farsi guidare da te. O semplicemente di qualcuno che, mano nella mano, voglia percorrere un tratto di strada insieme, per la gioia di poterlo fare in tua compagnia. A tutti questi compagni di viaggio, ancora presenti o lasciati lungo il cammino, tutto il mio affetto e la mia gratitudine. E poi c’è un terzo elemento importante, che paradossalmente, non è un atto di umiltà, ma di superbia intellettuale. Viviamo in un’epoca che considera la religione il 6 residuo di un passato rimpianto solo da persone di basso profilo umano e culturale, patrimonio di nonnine che si consolano della vedovanza o di paolotti ingenui capaci di credere agli asini che volano. Il razionalismo, la scienza, l’intellighenzia dominante pretendono di trovare tutte le possibili risposte in se stesse, senza bisogno di aprirsi al mistero, all’Assoluto, a ciò che va oltre il sensibile perché, non potendo dare prove certe della sua esistenza, semplicemente non esiste. O, all’opposto, l’irrazionalismo, il consumismo, una visione distorta di certo spiritualismo portano alla convinzione che non esistano altre alternative che il ripiegamento su se stessi, la fuga nella superficialità, nello stordimento, nei paradisi artificiali. Alla fede mi ha riportato invece proprio la mia ragione, la mia cultura, quel complicato insieme di elementi che nel linguaggio comune va sotto il nome di intelligenza. Mi ha guidato a credere che contro la precarietà dell’esistenza, la mancanza di un significato apparente delle dinamiche della vita umana, la paura per l’avvenire, le domande non possono essere soddisfatte nell’orizzonte limitato di ciò che l’uomo moderno può offrire come responsi parziali o come surrogati di speranza. Che le soddisfazioni professionali, un pomeriggio di shopping al centro commerciale, una notte di follie o una vittoria del Milan sono spezzoni di felicità troppo immediati ed evanescenti per poter riempire da soli di senso il nostro percorso terreno. Oso anche sentirmi, in questa ritrovata certezza, più stupidamente ragionevole dei ragionevoli stupidi che usano la loro intelligenza per affermare che non esistono risposte alle nostre domande più profonde – e allora a che serve una ragione che non sa fornire ra7 gioni? –. E questo non per staccarsi dal mondo anzitempo, ma per starci ben ancorati, per sentire ogni giorno la certezza – a differenza di quanto canta Vasco Rossi – che questa vita un senso ce l’ha, e non dobbiamo neppure guardarci troppo lontano per trovarlo. Dopo di che ci saranno sempre i dubbi, le incertezze, i tentativi di leggere nella mente di Dio, per interrogarlo e chiedergli la ragione delle brutture che vediamo intorno a noi. Ma non vivremo prigionieri dell’angoscia, o non avremo bisogno di stordirci per non avvertirla. La consapevolezza che l’uomo non contiene all’interno di sé tutto ciò che il Creato ha da offrire è la via migliore per gustare quello che di meglio esso ci mette a disposizione. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. (Gv 8,32) 8 Il Cambiamento Quello che il bruco chiama la fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla Chissà da quanto tempo vi sentite continuamente ripetere che certe cose non dovreste più farle perché siete diventati grandi, che dovreste mostrare un po’ più di maturità, serietà, impegno e altre menate di questo tipo. Tali richiami, uniti alla consapevolezza che il tempo sta passando, possono far nascere un atteggiamento di diffidenza non tanto nei confronti della crescita – che è un fenomeno biologico assolutamente spontaneo –, ma del cambiamento, che è invece il prodotto consapevole di uno sforzo di adattamento a circostanze mutate e continuamente mutevoli. Soprattutto alla vostra età si può tradurre nella spasmodica ricerca di rimanere attaccati alla propria giovinezza, di rallentare il processo di crescita, nell’illusione di poter restare ragazzi il più a lungo possibile. Questo desiderio è oggi più che mai cavalcato dai media e dalla pubblicità, che propongono modelli – artificiali – di eterna giovinezza o filosofie ispirate alla sindrome di Peter Pan, che alimentano il mito della permanenza a tempo indeterminato nel limbo di un’infanzia innaturale e innaturalmente vissuta, senza impegni e responsabilità. In realtà, sarebbe bene che partissimo dal presupposto che non esistono età ideali, e men che meno lo è la giovinezza, che è il periodo degli squilibri, delle incertezze e della progressiva presa di coscienza di sé, delle proprie possibilità e soprattutto dei propri limiti. Voler restare ancorati ad un’ipotetica età dell’oro non ha niente 9 di eroico ma, specie come è vissuta oggi, porta non alla giovinezza eterna, ma a un giovanilismo spesso ridicolo, se non addirittura perverso, perché mira a ingabbiarci in una personalità artificiosamente definita una volta per tutte, senza o quasi lasciare spazio al suo sviluppo. Per un verso, questo atteggiamento si manifesta esteriormente col rifiuto di prendere atto che il tempo passa per tutti e si esprime nell’ansia per l’aspetto fisico o nella pedissequa osservanza della moda, anche in quelle forme che finiscono per arrecare danno a quello stesso corpo che si vorrebbe mantenere sempre perfetto. Ma ancor peggio del tentativo di restare ancorati alla gioventù fisica è quello di rimanere ostinatamente legati a comportamenti, atteggiamenti, abitudini e stili di vita che non appartengono più alla nostra età. La massima “bisogna essere giovani dentro” non corrisponde all’invito a fare i ventenni vita natural durante, ma a vivere serenamente e al massimo quanto ciascuna età può offrire. Esistono persone mature – e addirittura anziane – che sono vitalissime anche se da anni non sfrecciano più impennati sulla moto, non portano i jeans attillati e non hanno piercing o orecchini da esibire. Sono vitali appunto perché vivono al massimo le loro possibilità, che non sono per nulla impoverite dal trascorrere del tempo, ma al contrario sono arricchite dall’esperienza, dalla conoscenza e, perché no, dalle responsabilità che si sono succedute negli anni. Intendiamoci: cambiare non è per niente facile, ma non significa assolutamente dover ripartire da zero o rinunciare a tutto ciò che è stato. La paura che crescendo si finisca col perdere qualcosa di essenziale porta al ri10 schio di attraversare il naturale – ed inevitabile – ciclo biologico perdendosi tutto il meglio che ci può dare: il bruco deve morire per diventare farfalla e credo che nessuno possa negare che nel cambio ci guadagni non solo lui, ma noi tutti. La nostalgia, specie se immotivata, al contrario ci fa vedere il passato come qualcosa di luminoso, gettando invece l’avvenire nell’oscurità e rendendoci titubanti e pavidi non solo nell’affrontarlo, ma anche nel viverlo. Pensare che il futuro sarà per forza positivo è da fessi, ma restare ancorati al passato è da disperati. Ogni giorno ci presenta un nuovo fiore da cogliere; se teniamo in mano sempre lo stesso, non farà altro che morire più in fretta. Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. (Qo 3,1) 11 L’Impegno È facile avere le mani pulite se ce le teniamo in tasca L’ossessione dell’eterna giovinezza spesso porta con sé la tendenza al disimpegno. Alimentata da certa cultura e letteratura di inizio Novecento, che vedeva l’inutilità di assumere un ruolo definito in una società che schiacciava l’individualità umana, oggi tale inclinazione è diventata invece una comoda via di fuga dal valore puramente estetico. Impegnarsi è avvertito come qualcosa di insensato, inutile, limitativo. Certo, si prova ammirazione verso coloro che ancora sono capaci di dare tutto di sé nell’impegno in uno o più campi dell’attività umana – siano essi la politica, il volontariato, l’assistenza sociale o altro – ma tendiamo più a vederli come oggetto di contemplazione che non come esempio da imitare. Cediamo ancora alla tentazione di pensare che non prendere impegni significhi rimanere disponibili a tutto, dimenticandoci che in realtà significa non avere stimoli per portare a termine nulla. O, peggio ancora, a considerare che l’impegno vada indirizzato solo verso ciò che ci piace fare, e non verso ciò che dobbiamo fare, cosa che nei prossimi anni scoprirete in tutta la sua durezza. Non ho nessuna intenzione di unirmi al coro di quelli che si lamentano che i giovani d’oggi sono bamboccioni con la pappa sempre pronta, senza voglia di far nulla; ma non bisogna dimenticare che l’impegno vero porta con sé due altri disposizioni dell’animo: la responsabilità e la perseveranza. Cose per le quali non basta solo farsi un mazzo così – come docente dell’alberghiero vedo quotidianamente 12 quanto sono disponibili in tal senso ragazzi anche più piccoli di voi – ma occorrono attributi fumanti e zero peli sullo stomaco. L’obiezione classica “ma io l’ho fatto” non ha senso se non si tiene conto anche del come le cose vengono fatte. Non basta un “fare” generico per poter dire di essersi impegnati, se il lavoro è stato svolto con superficialità e con l’obiettivo primario di toglierselo dai piedi il prima possibile per dedicarsi ad altro. L’altra obiezione, che è quella di non poter pretendere più di tanto da giovani di questa età, si smonta da sé quando si consideri che oggi ragazzi di 14 o 15 anni hanno già provato di tutto – e per “tutto” intendo proprio tutto, dal fumo, alle droghe, al sesso come piacere fine a se stesso – rincorrendo gli atteggiamenti esteriori dell’adulto ma senza quel senso di responsabilità che dovrebbe caratterizzare tali scelte. E allora forse non è inutile cominciare dal rispetto nei confronti degli impegni, anche scolastici, e delle loro corrette modalità di attuazione per provare a trasmettere un minimo di scrupolo di coscienza. La perseveranza è spesso un altro atteggiamento sottovalutato, da non confondere con la pazienza – sapete bene che chi scrive ne ha scorte molto limitate – . Non è una inclinazione del carattere, ma un atteggiamento che si può esprimere in diversi modi, che si crea con l’esercizio assiduo. Alla vostra età, è soprattutto saper attendere il risultato di ciò che si fa. Ma in un mondo che apre migliaia di strade di fronte a noi, diventa difficile decidere di arrivare in fondo ad una sola di esse, col rischio di non poter vedere dove portano le altre. Così arriviamo a inseguire non le mete, ma il fascino di ipotetici traguardi sempre diversi; una volta sfumata la seduzione della no13 vità, abbandoniamo tutto per dedicarci a rincorrere altre chimere. Abbiamo l’ansia di concludere nel più breve tempo possibile ciò che c’è da fare, e talvolta non vedere i risultati nell’immediato non ci scoraggia nemmeno più, ma ci lascia addirittura indifferenti. Davanti ad una insufficienza in Storia maturata dopo un’ora di studio (ma siamo sicuri che basti comunque?), l’atteggiamento tipico non è quello di raddoppiare il tempo da dedicare alla preparazione, ma di lasciare perdere, “perché tanto”. Perché tanto cosa? Riuscire al primo colpo non è sempre indice di abilità, ma talvolta è legato all’azione del fattore C. È solo insistendo a perseguire un obiettivo che sembra non giungere mai che riusciamo meglio a capire le nostre possibilità e i nostri limiti: in una parola, a conoscerci. E in questo senso la perseveranza ci conduce anche all’umiltà di capire che non possiamo pretendere che tutto vada sempre come vorremmo, ma che dobbiamo insistere per ricavare le nostre piccole (o grandi) vittorie. Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. (Lc 9,62) 14 L’Errore Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior Diamo atto che talvolta l’apparente mancanza di impegno è data dalla paura di sbagliare. Una paura della quale noi insegnanti abbiamo le nostre responsabilità, anche se legate non alla necessità di esprimere un giudizio – cosa che fa parte del nostro mestiere – ma a taluni atteggiamenti nel farlo. Ma la demonizzazione dell’errore è parte integrante della nostra società, che propone solo modelli vincenti. Sbagliare è severamente proibito nel mondo che vende – non propone – tutto ciò che serve per apparire – non essere – perfetti. E l’ansia di stare dalla parte di chi vince spinge ad accantonare tutto il resto. Se i vincenti sono quelli che fanno soldi, ecco che ogni mezzo per averne diventa accettabile, compreso edificare in zone sismiche nella totale inosservanza delle leggi. Se i vincenti sono coloro che detengono il potere, qualunque strada è lecita per ottenerlo, dimenticando che chi occupa cariche pubbliche dovrebbe mettersi al servizio della collettività e non viceversa. Se i vincenti sono coloro che imperversano in televisione, va bene qualunque modo per arrivarci, compresa la messa all’asta del proprio corpo. Per noi esseri imperfetti, invece, l’errore non solo è inevitabile, ma addirittura necessario, perché fa parte delle dinamiche della crescita. È sbagliando che si impara, come dice il vecchio detto, se attraverso la correzione dell’errore possiamo apprendere le modalità da seguire per non sbagliare più la volta successiva. In questo 15 senso, l’errore è il perno per eccellenza della didattica. Sbagliare mi consente di conoscere quali sono i miei limiti, le mie carenze, i miei margini di miglioramento. Bisogna cercare di non commettere errori, ovvio, ma una volta fatti non bisogna nasconderli, perché il cammino si inizia solo accettandoli – e accettandoci come esseri fallibili – nella prospettiva di liberarsene un po’ alla volta. La differenza tra il saggio e lo stolto è infatti questa: il saggio non è colui che non commette mai errori, ma chi non vi rimane prigioniero. E la corretta prospettiva per valutare positivamente l’esperienza dell’errore è quella di non confonderlo con chi sbaglia. In questo noi cristiani, più di ogni altro, dovremmo dare il buon esempio. I Vangeli ci dicono che Gesù veniva rimproverato per le sue frequentazioni; i suoi amici erano peccatori, prostitute, ladri e via dicendo, coi quali si mescolava senza la paura di restarne insozzato. Un Dio che non cerca la compagnia dei bravi ragazzi ma dei figli di buona donna è la vera lieta novella. Se l’errore ci infastidisce, non dobbiamo esimerci dallo sporcarci le mani con chi lo compie, anziché limitarci ad affettare giudizi col coltello grosso. La saggezza con va confusa con il perbenismo, che ci spinge solo ad una sostenuta indifferenza nei confronti dell’altro, a chiuderci nelle nostre certezze, che non è per nulla detto che non siano a loro volta frutto di errori. Anzi, molto spesso è proprio confrontandoci con gli sbagli altrui che ci rendiamo conto che forse stiamo camminando sulla stessa strada, anche se ci sembrava di seguire la retta via. In quest’ottica è essenziale il ruolo che riveste il perdono, uno dei doni più difficili da concedere a chi ci sta vi16 cino, perché spesso ci sentiamo incapaci di dimenticare un’offesa, un torto subito, o semplicemente un atteggiamento che abbiamo considerato poco corretto, anche non nei nostri confronti. Perdonare, tuttavia, non significa dimenticare, ma fare un’azione pedagogica, perché non è solo l’atto gratuito di uno, ma implica corresponsione. Non perdono perché è cambiato qualcosa, ma perché può cambiare qualcosa proprio grazie al mio gesto, che deve spingere l’altro, se persona dotata di coscienza, ad una riflessione. Molti di voi hanno sicuramente fatto l’esperienza di un legame uscito rafforzato da un perdono; il letame che sembrava aver sepolto un rapporto lo ha fatto rifiorire più bello che mai. Non è certo una cosa facile – in materia di perdono non me la sento di pormi ad esempio –, ma questo non toglie nulla allo sforzo da fare per perseguire l’obiettivo. Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. (Rm 14,12) 17 La Relazione La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione Resistendo anche qui alle tentazioni dei modelli proposti dalla società, non dobbiamo mai scordare che l’ambito nel quale ci proponiamo con tutto ciò che siamo deve essere quello di una comunità. L’uomo è fatto per vivere in relazione; la solitudine porta allo squilibrio e alla follia. L’impostazione individualista è alimentata dall’impressione che conciliare le proprie esigenze – ma più spesso le proprie frenesie – con quelle degli altri sia un’insopportabile limitazione alla propria libertà. Stiamo sempre a fare i conti con quello che rischiamo di perdere e non vediamo ciò che stiamo rinunciando a guadagnare. In realtà l’individualismo ha un limite invalicabile: noi stessi. Ciò che va oltre le nostre possibilità non sarà mai raggiunto facendo affidamento solo sulle stesse. Ricordate cosa ci diceva Dante? Alla Salvezza non si arriva mai da soli, ma grazie ad una relazione. Virgilio, Beatrice, le anime incontrate durante il viaggio – anche quelle dannate – sono fondamentali per poter arrivare a Dio, che è il centro di tutte le relazioni e il punto dal quale è possibile entrare in relazione con chiunque. Imparare a vivere in comunione con gli altri non è solo una necessità: è l’occasione più importante che ci viene offerta per crescere e per arricchirci, specie quando ci spingiamo a uscire dal guscio delle conoscenze spontanee, di persone molto simili a noi, e arriviamo a confrontarci con chi invece non ci somiglia. Una comunità di persone che condividono lo stesso pensiero, la stessa sensibilità e le stesse credenze, 18 infatti, alla lunga presenterà gli stessi limiti tipici del singolo. Per uscire da essi è indispensabile il confronto con chi è “diverso”, ovvero colui – meglio coloro – che è in grado di stimolare un dialogo attraverso l’apporto di nuove esigenze. Per andare in profondità alle cose, occorrono più punti di vista; è dal confronto delle differenze, e non delle uguaglianze, che nasce un processo di scoperta di ciò che ci manca e l’individuazione di chi potrebbe aiutarci ad ottenerlo. Anche da questo punto di vista, la società odierna non ci è maestra. Di fronte al massiccio arrivo di persone provenienti da ogni angolo del mondo, le reazioni sono estreme: o la passiva accettazione – e il conseguente rischio di cedere alla tentazione di patteggiare i nostri valori – o il rifiuto totale – e il rimanere prigionieri di un orizzonte limitato –. Molto spesso, invece, si dimentica che il naturale atteggiamento dovrebbe essere quello del dialogo. Dialogando confronto ciò che sono io con ciò che è l’altro, non necessariamente per stabilire chi ha ragione, ma per testare la bontà di ciò che sappiamo o pensiamo di sapere. Dialogando non tradisco i miei principi, ma spesso verifico la mia convinzione nel sostenerli. Dialogando scopro spesso che mi manca qualcosa che mi può essere dato da qualcun altro, specie quando c’è in partenza la disponibilità ad offrirlo; in questo senso il dialogo è una forma di scambio, una dinamica determinate per lo sviluppo di una comunità. La paura di sentirsi ignoranti è spesso l’ostacolo principale al dialogo, specie quando siamo consapevoli che chi abbiamo di fronte ne sa più di noi. La chiusura non è data in realtà dal desiderio di difendere ciò che siamo, ma dal timore di metterci in gioco su ciò che non sappiamo e sentirci deboli. 19 L’identico ragionamento può essere applicato anche sulle piccole relazioni quotidiane: quante persone respingiamo perché abbiamo in realtà paura di non essere all’altezza del confronto? O perché, sostenendo posizioni diverse dalle nostre, li liquidiamo sbrigativamente come noiosi rompiballe? Solo la disponibilità e la voglia di arricchire possono aiutarci a infrangere la barriera che noi stessi erigiamo intorno ai nostri timori. Perciò confortatevi a vicenda edificandovi gli uni gli altri, come già fate. (1 Ts 5,11) 20 Il Silenzio Il rumore non fa bene e il bene non fa rumore Sembra paradossale, ma la società della comunicazione sta portando all’incapacità di comunicare. Che è cosa ben diversa dal parlare. Comunicare significa scambiarsi pensieri, informazioni, sentimenti, all’interno di una relazione nella quale si è di volta in volta emittenti e destinatari di un messaggio che richiede attenzione sia nel formularlo, sia nel recepirlo. Cosa ci comunicano, invece, le telerisse di cui siamo quotidiani spettatori? O, per rimanere nel nostro ambito, perché non si riesce a celebrare una Santa Messa – ma anche a proporre una banale proiezione cinematografica – senza che si venga continuamente infastiditi da un irritante brusio di sottofondo? Siamo pervasi dall’ansia di parlare, di dire la nostra, di commentare, anche se spesso nessuno ci ascolta, a propria volta preda della stessa frenesia. Il silenzio è evitato come la peste, perché viene interpretato come un segno di solitudine, e questa molto spesso spaventa. Ma siamo sicuri che la vera solitudine non stia altrove? Apparentemente, le principali innovazioni tecniche del recente passato sono nate proprio con l’obiettivo di sconfiggere definitivamente la solitudine; ma l’uso che ne facciamo risponde realmente a questo obiettivo? Nessuno rimpiange il tempo in cui tali strumenti non facevano parte della nostra vita quotidiana; ma utilizzarli non vuol dire per forza comunicare. Anzi, il tempo di utilizzo è inversamente proporzionale alla possibilità che ci offrono di stabilire comunicazioni vere. I ragazzi che trascorrono i 21 dieci minuti dell’intervallo per inviare freneticamente messaggini anziché ricrearsi o parlare coi loro compagni – anche per dire peste e corna dell’insegnante appena uscito – non comunicano, si isolano. Vedere un gruppo di persone al tavolo del ristorante ciascuno intento a telefonare con chi non è lì in quel momento fa malignamente pensare cosa si siano ritrovati a fare. Lo spettacolo di ragazzi che camminano per strada a sguardo basso con le cuffie infilate nelle orecchie e la musica perfettamente udibile anche dall’altra parte del marciapiede è sconfortante. Passare ore davanti ad un monitor a parlare col mondo ci priva in realtà dell’indispensabile apporto del contatto umano vero e autentico, spesso sostituendolo con una dimensione virtuale che diventa sempre più difficile distinguere dalla realtà. I moderni mezzi di comunicazione non hanno risolto il problema dell’alienazione: l’hanno ingigantito in modo subdolo. Un insieme di solitudini non fa una compagnia. Il silenzio non è dunque sinonimo di solitudine, che anzi oggi più che mai passa attraverso il rumore, il suono privo di significato. Si avvicina invece alla riflessione, una dimensione che sarebbe necessario recuperare. Fermarsi a pensare anche solo prima di parlare – e a maggior ragione di agire – appare oggi l’unico antidoto possibile ad un sistema che si nutre sempre più di istinto travestito da spontaneità. Non è assolutamente vero che la riflessione è una cosa “da grandi” e che i giovani devono per forza reagire con immediatezza agli stimoli. La riflessione è un esercizio che va coltivato nel tempo, ma iniziando prima che il cervello sia atrofizzato dalla mancanza di allenamento. E serve, garantisco, a vivere me22 glio, ad assumere il controllo delle situazioni anziché farsi trascinare da esse, a ricondurre le cose nella loro giusta dimensione, a non credersi al centro di una tragedia quando non sta accadendo nulla di anomalo, a capirsi meglio con chi sta intorno a noi. Basta un attimo di silenzio, che può anche tradursi nel semplice saper tacere, non lasciarsi andare alla tentazione di aprire sempre e comunque la bocca. Spesso il silenzio è più eloquente di centinaia di parole. Nella forma più sofisticata, invece, esso richiede un momento di isolamento in perfetta tranquillità. Ed è qui che spesso si misura cosa c’è davvero dietro la paura della solitudine: la mancanza d’abitudine a rimanere con se stessi, a leggersi dentro per quello che si è, nel timore di trovare centinaia di pagine bianche. Per questo lo stare soli diventa motivo di disagio; ma la risposta non può consistere nell’essere soli in mezzo agli altri con l’illusione di sentirsi in gruppo: quella è la vera solitudine. Lo stolto alza la voce mentre ride; ma l’uomo saggio sorride appena in silenzio. (Sir 21,20) 23 La Fragilità Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane Ci sono due diversi atteggiamenti che caratterizzano il nostro rapporto con la fragilità. Uno è quello dettato dalla società, che la considera quasi un peccato capitale, una cosa di cui vergognarsi e da nascondere a tutti i costi. Mostrare le proprie debolezze significa mostrarsi vulnerabile, e correre il rischio di essere messo sotto. Il forte è vincente, il fragile è perdente; di per sé non è un’equazione sbagliata, se non che non tiene presente che la fragilità è parte integrante del nostro essere, e rinunciarvi totalmente significa disumanizzarsi. Sappiamo fin troppo bene che le ideologie “forti” finiscono – o nascono – con l’essere discriminanti nei confronti di coloro che sono identificati come i deboli. Ciò conduce ad una società inumana e implacabile, che non tollera e non perdona l’errore. Ma rinnegare la nostra fragilità ci porta a chiudere la porta di fronte alla presa di coscienza della nostra incompletezza, e ci impedisce in realtà di affrontarla. Pretendere di essere forti da soli ci porta, presto o tardi, a scontrarci con i nostri limiti; farlo in determinate situazioni può significare precipitare rovinosamente. Riconoscersi fragili e incompleti significa prima di tutto lasciare ad altri uno spazio nella nostra vita, non per far loro assumere il ruolo di tappabuchi, ma per accogliere positivamente quanto possono insegnarci per evolvere la nostra personalità. In questa prospettiva, è proprio il riconoscermi fragile che mi permette di lasciare uno spazio anche a Dio, che spesso respingo nell’illusione che 24 non abbia nulla a che fare con la mia esistenza di essere pienamente autosufficiente. Per questo è importante sapersi leggere dentro con onestà e consapevolezza, per riscoprire – o scoprire – la spontaneità di un legame con la Fede che nessun altro può costruire al posto mio. Ma esiste anche una seconda dimensione della fragilità, tipica dei giovani ma oggi estremamente diffusa, che è quella di una debolezza orgogliosamente ostentata. Ci sono ragazzi che, per un motivo o per l’altro, si compiacciono quasi pubblicamente dei propri mali e malesseri; se non ne hanno di veri, se ne creano di finti. Tale tendenza autocommiserativa è purtroppo alimentata da un certo tipo di pedagogia, che va a riflettersi anche sull’atteggiamento eccessivamente comprensivo della famiglia, che finisce, anche se inconsapevolmente, per alimentare tale inclinazione. Chi gode del proprio dolore difficilmente troverà la strada per uscirne, perché non la cerca neppure; e costruirà intorno a sé una rete di relazioni sbagliate, equivocando l’atteggiamento di chi lo circonda, ricercando la compagnia di chi tende ad assecondare – anche con secondi fini – e fuggendo chi invece cerca di spronare ad una maggiore chiarezza interiore. Fino a che le loro menate non li renderanno insopportabili a tutti. Non c’è niente di nobile in tale fragilità, ma al contrario è un alibi per nascondere l’incapacità, o la mancanza di impegno, a evolvere la propria personalità, delegando ad altri – quasi mai quelli giusti – il compito di farlo. Quando non è addirittura frutto della convinzione che per stabilire un solido legame affettivo bisogna per forza interpretare il ruolo della vittima predestinata, cercando nella compassione il cemento di una rela25 zione. Si finisce così per fare comunella con chi non ha reale interesse al nostro bene, complicando ancora di più il cammino per emergere da tale atteggiamento. È una fragilità che non ha nulla di naturale perché non porta ad una evoluzione, ma all’involuzione nelle proprie paure e nelle proprie fobie. Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. (2 Cor 11,30) 26 Il Corpo Ma quale bellezza salverà il mondo? Si ha spesso l’impressione errata che il cristiano debba avere una visione negativa della materialità, ma non c’è nulla di più lontano dal vero. Le Scritture sono lì a testimoniarcelo. I Salmi sono pieni di lodi al Creatore per la bellezza del creato – e anche delle creature –; Gesù viene spesso rappresentato a godere dei piaceri della tavola – il cristianesimo è l’unica delle grandi religioni che non ha tabù alimentari –; il cardine stesso della nostra fede è la resurrezione corporale di Cristo – motivo di scandalo per la filosofia platonica dell’epoca, che considerava il corpo come la prigione dell’anima –. Nessun’altra religione celebra la nobiltà della corporeità come quella cristiana; tuttavia l’opinione comune è quella di credere all’esatto contrario. Se da un lato questo pregiudizio è legato all’immagine di talune pratiche di devozione mortificanti per il corpo – che francamente anche a me sono sempre sembrate un po’ poco evangeliche –, dall’altro pesa in misura determinate il fatto che la visone cristiana di esso è diametralmente opposta a quella che ci fornisce la società. È san Paolo che ci aiuta a capirne meglio il motivo, introducendo la distinzione tra corpo e carne, insegnandoci che il primo non è costituito solo dalla seconda, ma è tutto ciò che ci rende individui unici e irripetibili. Noi non abbiamo un corpo, siamo un corpo; ben l’aveva capito Dante, che infatti rappresenta nel suo viaggio ultraterreno delle realtà corporee ben riconoscibili, che corrispondono a individui privi solo della propria materialità. Al 27 contrario, non è al corpo che la società occidentale moderna consacra attenzione, bensì alla sua essenza esteriore, ovvero unicamente alla sua materialità. Questo è ben visibile non solo nel campo della moda, che in molte delle sue manifestazioni sottopone il corpo a vere proprie forme di martirio, senza che neppure vi sia l’attenuante della ricerca della santità. Ma è soprattutto visibile nell’atteggiamento di mortificazione a cui spingono gli eccessi, legati non solo all’alcol, alle droghe, al sesso come puro divertimento, ma anche all’ansia di piacere e piacersi esteriormente. Che tracima in ogni dove: ricordate l’esempio che porto spesso a lezione? Quello di un TG nazionale che, durante l’ora di pranzo, conclude i suoi servizi con uno spazio di almeno cinque minuti tutto a base di tette e culi. Se anche l’informazione scivola sulla buccia di banana della provocazione sessuale… Ma il piacere e la felicità sono anch’essi doni di Dio, fanno parte integrante della vita umana e vanno vissute nella pienezza e nella gioia. Anche i sensi collaborano a provocare emozioni interiori che ci fanno gustare meglio e la vita, e in definitiva ci avvicinano di più al suo Creatore. Quindi ricerchiamo il piacere, ma quello che si nutre anche di misura, cioè di controllo. Senza di esso l’uomo rimane prigioniero dell’istinto; dare libero sfogo ai propri desideri significa asservirsi ad essi. Il desiderio cristiano non si basa sulle proibizioni, ma sulla ragione, che permette di gustarlo senza venirne oppressi. Il piacere onesto è godere delle cose buone della vita senza diventarne schiavo. Avere cura del proprio corpo non significa stravolgerlo; ricercare il divertimento è cosa diversa dall’inseguire lo sballo; desiderare la persona amata 28 non è praticare sesso come unica forma di manifestazione affettiva, se non addirittura vederlo come normale modello di relazione tra un uomo e una donna. Profumiamoci e vestiamoci bene, andiamo a ballare, gustiamo il piacere della tavola, ricerchiamo le cose belle, divertiamoci. L’uomo è fatto anche per questo. Immagine e somiglianza di Dio, vive in un mondo bello; è quindi naturale che insegua la bellezza e, a sua volta, la produca. Lo stesso linguaggio biblico ed evangelico è ricco di riferimenti a questo termine e la sua accezione greca, kalòs, viene spesso tradotta con l’aggettivo buono. Bellezza e bontà sono due facce della stessa medaglia e per questo fa ancora più impressione vedere come molti giovani coltivino il gusto del brutto a livello estetico e inseguano un abbrutimento morale, con un atteggiamento slegato da qualunque misura e qualunque limite. L’idolatria del desiderio come sfrenata soddisfazione di bisogni indotti è la gabbia che il consumismo costruisce intorno alla nostra anima. La bellezza che salverà il mondo passa da una ricerca equilibrata del piacere e della gioia. Non privarti di un giorno felice; non ti sfugga alcuna parte di un buon desiderio. (Sir 14,14) 29 L’Umorismo Felici quelli che sanno ridere di se stessi, perché non finiscono mai di divertirsi Un’altra opinione comune vede la religione come qualcosa che impone seriosità negli atteggiamenti e nei comportamenti. Anche questa opinione richiede una secca smentita, che parte dalla distinzione tra il comico e l’umoristico. Il comico è ciò che ci porta ad una risata spesso fine a se stessa; l’umoristico è ciò che ci permette di sorridere in ogni situazione. Non è il generico buon umore, che è piuttosto legato a cause esterne e che può svanire alla prima contrarietà; l’umorismo è uno sguardo cosciente nei confronti della realtà, che nasce da un atteggiamento interiore. Anche le Scritture hanno parti umoristiche. Abramo ride quando, a novantanove anni, Dio gli promette una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Non è escluso che Gesù ridesse – o per lo meno si divertisse in modo molto british – nel vedere i sapienti del suo tempo andare in crisi nel tentativo di capire le parabole ispirate alla vita concreta di tutti i giorni. L’umorismo ci aiuta a combattere una grande malattia moderna: la depressione, spesso alimentata dal modo becero con cui i mezzi di distrazione di massa ci presentano il mondo in cui viviamo: guerre, catastrofi, carestie, violenze senza fine. Nessuno si illude che il mondo d’oggi sia il posto migliore in cui vivere, ma dietro tale visione si nasconde la serpeggiante idea che, siccome non si può far nulla per cambiare le cose, bisogna tenersele così come sono. Al massimo fuggirle, rifugiandoci nel tranquillo cantuc30 cio che ci viene offerto come consumatori di consolazioni illusorie. L’umorismo ci spinge ad assumere nei confronti della realtà un atteggiamento di sereno distacco, a non prendere troppo sul serio determinate situazioni. È ovvio che non è applicabile sempre e comunque: ci sono momenti la cui serietà deve essere vissuta sempre come tale; in altre occasioni, è un modo per sdrammatizzare, per riportare le cose alla loro giusta dimensione, a non creare drammi quando non ve n’è alcun bisogno. E soprattutto è utile quando viene esercitato nei propri confronti, perché aiuta a non prendersi troppo sul serio. Sorridere di se stessi non è solo una dote da grandi umoristi, ma è ciò che ci permette di affrontare con spirito il paragone tra la vita e la limitatezza dei nostri mezzi nell’affrontarla, senza cedere alla disperazione quando questi ultimi ci sembrano insufficienti. Oppure ci permette di ridimensionarci quando, al contrario, pretendiamo di ridurre il mondo alla nostra limitata dimensione. Ci fa sorridere delle nostre certezze non interiori ma esteriori, delle nostre prese di posizione assolute, dalla presunzione di avere sempre in tasca una verità preconfezionata da elargire agli altri per salvarli da loro stessi e malgrado loro. Libera le nostre azioni, qualunque esse siano, dallo spettro dell’integralismo, che non a caso considera il riso e il divertimento il suo peggiore nemico. Ci permette anche di vedere con distacco non solo ciò che siamo, ma anche ciò che abbiamo. In questo senso, l’umorismo è una grande virtù cristiana perché è anti-idolatrica: ci aiuta a non essere troppo attaccati alle cose, a goderne senza farcene divenire schiavi. Un famoso slogan del passato sosteneva 31 che una risata avrebbe seppellito qualcuno – salvo poi che l’attuazione del proposto è passata non attraverso l’ilarità ma le spranghe e i proiettili –; l’umorismo non seppellisce nulla e nessuno, ma rimette tutto in una prospettiva più umana. Del resto, per un cristiano, la certezza che attraverso Gesù Cristo giungerà alla salvezza non può che portare il sorriso sulle labbra. L’umorismo è la manifestazione più immediata e coinvolgente della speranza. Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà sorriderà di me!» (Gen 21,6) 32 Questa volta il professor Pelizzoni, nel suo ormai tradizionale opuscolo, si rivolge direttamente ai maturandi aiutandoli a porsi qualche utile domanda sul momento (direi, sul crinale) della vita che stanno per affrontare. In seconda istanza il testo vale per gli adolescenti in genere, perché tutti si sentano chiamati in causa: ciascuno, se si esamina onestamente, può trovare il discorso rivolto a sé. E i piccoli? Non loro personalmente, ma i genitori leggeranno queste pagine con frutto. Ne son sicuro. IL E LA SALE LUCE Quindi, buona lettura estiva a tutti! Il Rettore Collegio Ballerini, giugno 2009 Via Verdi, 77 - 20038 Seregno (MI) - Tel. 0362 235501 www.collegioballerini.it - [email protected] Lettera a ragazzi che diventano uomini in vacanza Stefano Pelizzoni in vacanza PENSIERI PENSIERI
Scaricare