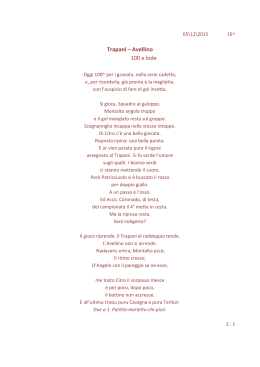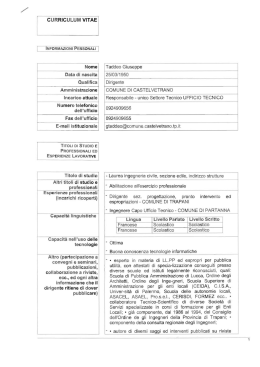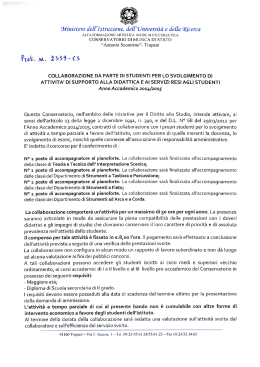Paceco diciassette Paceco diciassette Gennaio 2013 Edizioni 1 Paceco diciassette SOMMARIO G. Ingrassia La Redazione Presentazione Pag. Le copertine precedenti: storia silenziosa della nostra rivista » B. Palermo Antroponimi popolari: dai Malavoglia di Aci Trezza ai Ciùci di Paceco » F. Caronia Piazza Ammiraglio Umberto Cagni » A. Barbata Commemorazione di Serafino Culcasi » G. Barraco Ricordi di Paceco » F. Liggiato Satira-politica-cultura nel nostro paese » M. Russo Giovan Francesco Fardella, Secondo Principe di Paceco » A. Barbata La mostra permanente di antropologia e preistoria di Paceco » M. Vento Butrinto e Trapani: sulle antiche orme di Enea » M.E. Napoli Echi del passato » C. Fodale L’onorevole... Bianca » N. Piacentino Pastarelle di crema al “bon ton” » G.G. Gargano L’ultima battaglia » R. Lo Schiavo Paleontologia trapanese » G. Cottone Omaggio a F. De Sanctis » R. Fodale Asterischi » C. Fodale Segnalazioni librarie » Don S. Morghese Mostra di capezzali » V. Via Teatro... che passione! » A. Barbata Ricordo di Michele Barraco » Mons. G. Raineri Ricordo di Girolamo Avaro » G. Ingrassia Ricordo di Nicola Di Natale » COMITATO DI REDAZIONE Giovanni Ingrassia coordinatore Alberto Barbata Michele Russo Guido Abbate 3 5 6 18 29 41 45 69 86 90 93 104 108 111 116 124 128 133 141 143 145 147 149 Tutti i diritti letterari riservati. è vietata ogni riproduzione dei testi e delle foto © Copyright 2013 Ed. “La Koinè della Collina” Associazione Culturale - Paceco con il patrocinio della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO «SEN. P. GRAMMATICO» PACECO Quando l’imprevedibilità del caso e la bontà dei Soci hanno voluto che accogliessi nelle mie mani “La Koinè della Collina” e questa rivista rimaste orfane di Nino Basiricò, sapevo a quale onere andavo incontro, ciononostante l’ho assunto serenamente e senza esitazione: mi veniva chiesto un servizio e per me era semplicemente doveroso mettermi a disposizione. Perché poi avrei dovuto esitare? Mi avrebbe sorretto l’amore che ho sempre messo nelle cose in cui credo, il più efficace stimolante dell’attività e lenitivo della fatica che io conosca; avrei potuto contare sulla guida sicura di Rocco Fodale che, oltre alla sua preziosissima esperienza, mi avrebbe trasmesso tutto l’amore paterno col quale ha sempre curato questa rivista da lui messa al mondo; avrebbero continuato a segnarmi la via le impronte indelebili lasciate da Nino Basiricò; non mi sarebbe infine mancata la preziosa collaborazione di quanti, pacecoti e non, hanno nel tempo collaborato, con la penna e con l’opera, alla realizzazione di questo nostro fiore all’occhiello. Ed eccomi qua con l’unica ambizione di non deludere. “Paceco diciassette” si apre con la riproduzione di tutte le copertine dei numeri già pubblicati. Attraverso tale rassegna che, ripercorrendo il cammino fatto, racconta, sia pure silenziosamente, la storia della rivista, la Redazione ha voluto rendere omaggio ai “timonieri” precedenti prima di riprendere il viaggio che prosegue sulla rotta già tracciata e con lo stesso obiettivo fondamentale: il recupero della memoria collettiva della nostra comunità. Tale recupero, mai fine a se stesso, intende consegnare alle nuove generazioni testimonianze che le aiutino a scoprire le loro radici e a confrontarsi con il passato. Non a caso in questo numero è stata inaugurata una nuova rubrica affidata a un’adolescente (Che bello! Era ora che entrassero i giovani!) 3 che, dal punto di vista dei giovani, scopre il passato interrogandosi sul presente. Per il resto, a parte qualche cambio di guardia al suo interno (la rubrica Segnalazioni librarie passa da Rocco Fodale a suo fratello Carmelo, Rocco rottama il suo vecchio Specchietto retrovisivo sostituendolo con Asterischi), la rivista rimane aperta ai contributi culturali, sempre ben accetti, che provengono dall’esterno. Per finire, a nome di tutta la comunità pacecota (penso anche ai nostri compaesani sparsi per il mondo a cui rivolgo un affettuosissimo saluto e l’augurio di una buona lettura) si ringrazia la Banca di Credito Cooperativo “Sen. Pietro Grammatico” che con la sua generosità da quasi quindici anni ci consente questo sempre più atteso appuntamento annuale. GIOVANNI INGRASSIA 4 Le COPeRTINe PReCeDeNTI Storia silenziosa della nostra rivista 5 ANTROPONImI POPOLARI Dai Malavoglia di Aci Trezza ai Ciùci di Paceco “Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Aci Trezza […]. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio[…]”. Con queste parole si apre il capolavoro di Giovanni Verga che ha per titolo non il cognome della famiglia protagonista, ma il suo soprannome. E l’autore, fin dalle prime righe del suo romanzo, ci pone dinanzi a quell’elemento distintivo davvero efficace che può essere il soprannome e alla grande fortuna ed utilizzazione di cui esso ha sempre goduto nella nostra Sicilia. A conferma di questo, all’interno del romanzo davvero tanti sono i vari personaggi via via presentati con i loro soprannomi: da Piedipapara alla Zuppidda, da Bastianazzo alla Mangiacarrubbe. Inoltre, quasi a voler fare, per così dire, da “eco scientifico” a questa testimonianza letteraria, un altro illustre siciliano, contemporaneo del Verga, Giuseppe Pitrè, che dedicò la sua attenzione anche al soprannome, scriveva: “Andate in un paesello dell’isola, penetrate nei vicoli più modesti dell’Albergheria o della Kalsa in Palermo, della Civita di Catania, nella Giudecca di Trapani, e non troverete una donna che non abbia il suo bravo nomignolo, dal quale il nome sia stato scalzato. Provatevi a chiedere del tale o della tale, e le donne vi resteranno a bocca aperta, chiedete, invece, discorrete, per esempio di Pietro Lu Dannatu, di Rosa Funcidda, due ingiùrie belle e buone e sarete subito inteso”(1). Insomma, anche il Pitrè ci testimonia chiaramente l’ampia diffusione del soprannome in Sicilia e la sua capacità di scalzare nell’uso quotidiano addirittura il nome personale. è chiaro che, se Giovanni Verga fosse stato pacecoto, pur ambientandolo in luoghi e contesti differenti (magari tra salini e agghi di Nubia o vigni e miluna da Zafarana, nella città grande di Trapani o a Cìtta), avrebbe potuto scrivere lo stesso il suo romanzo, solo che i suoi protagonisti e personaggi si sarebbero chiamati Ciùci, Allìcca-Càntari, 6 Sanguittàra, Bbàcchiari, Bbùmmuli e Pìscia Rrasòliu, solo per citarne alcuni. Tanto tempo è però ormai passato da quando I Malavoglia consacravano la fama dello scrittore siciliano e Giuseppe Pitrè affidava alla futura memoria le sue considerazioni sul soprannome; a distanza di più di un secolo, in una società moderna come la nostra che, in tutti i suoi ambiti, è stata investita da un costante flusso di innovazioni, il soprannome sicuramente non conserva più lo stato e la vitalità che aveva fino a cinquant’anni o trent’anni fa, ma le interviste effettuate da me nell’anno 2000 a Paceco, per la mia tesi di ricerca Antroponimi popolari a Paceco (presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, sotto la guida dell’allora Preside Giovanni Ruffino), fanno emergere una realtà non molto lontana da quella descritta dal Verga o dal Pitrè: “Ccà pari u paisi d’i ngiùrie(2)…”; “Cci nn’è ngiùrie un ssaccu. Ma cci nni fùssiru ancora di ìnchiri giornali! Chi un nna finissi cchiù di ccà a ddumani!”; “Chi ccà a Ppaceca ngiùrie cci nn’è sapidd(r)u quantu!”; “Paceca è natu ri ngiùrie, nno ri cognomi, perché nna pissuna a Ppaceca è canusciuta chiossài comu ngiùria, nno comu cugnomi”; “E cci arrivàu il punto a Ppaceca chi vinìanu ggenti di fuori, a qquistari certi materiali, bbestiami e ccosi, rivolgendosi mpiazza, di trovare il cognome, cci ricìanu: “Ma jò a cchissu un nnu canùsciu!” E ss’è ppossibbile èranu vicini ri casa! È nna cosa incredibile! Da non credere! Ma era la rrealtà! Signìfica però, stu fattu rrisale, cent’anni fa, ottant’anni fa… cinquant’anni fa che esisteva questo”; “Ora, ripeto, con l’esperienza, cu a ggioventù di oggi, attraverso la scuola… già stanno scomparendo, già stannu finennu”. è chiaro come tali affermazioni, in riferimento al nostro paese, sembrano provare le osservazioni del Pitrè in maniera davvero eccellente. Addirittura è capitato che alcuni miei informatori, durante la spiegazione di qualche soprannome di cui mi stavano parlando, hanno fatto riferimento a qualche persona, citandola non per nome e cognome, ma esclusivamente per mezzo del soprannome e ciò senza che se ne rendessero conto; la cosa è ancora più sorprendente se pensiamo che essi in quel momento erano stati invitati a riferire i soprannomi di loro conoscenza ed è segno evidente di quanto il soprannome sia inscindibilmente legato alla vita quotidiana della gente e alla cultura popolare. 7 Per fare riferimento alla mia esperienza personale, come dimenticare quando da piccolo, andando in giro con il nonno, ero per tutti u niputi du zzu Vanni Ciùciu? e a zza Pia Putiara o a zza Caimmela Vaiana, presso le cui piccole e rifornite botteghe mi recavo a comprare il panino, la mattina, prima di andare a scuola? o u zzu Màriu Vanni che di sera suonava la fisarmonica? o ancora oggi, a zza Nnita Attaredd(r)a che curiosamente sta a due passi dai Succitedd(r)i? o u Bamminu che, andando a lavorare in campagna, passava con la sua coffa? Addirittura da piccolo, ricordo che mia madre, mandandomi a fare una commissione da una signora che gestiva una nota merceria, mi avvertì preoccupata: “Mi raccumannu, non è chi l’ha chiamari signura Ggioia-Mia, chi chissa è ngiùria!”; si rivolse a me con la stessa apprensione dell’Agnese manzoniana che, inviando Renzo a Lecco a cercare il dottore Azzecca-garbugli, dice al promesso sposo: “Ma non lo chiamate così, per amor del cielo: è un soprannome”. Da quanto detto risulta chiaramente come la ngiùria, nel nostro paese, ha avuto una forte presenza e in molti casi, nell’uso quotidiano, come elemento di denominazione ha sostituito il cognome. Nell’evoluzione dell’onomastica del nostro Paese, nel corso dei secoli, e volendo sintetizzare sommariamente, nel periodo che va dal IX al XVI secolo, si è passati dai tria nomina latini (praenomen - nomen - cognomen, del tipo Caius Iulius Caesar, sottolineando che già i cognomina avevano origine dai soprannomi e spesso facevano riferimento alle caratteristiche fisiche: P. Ovidius Naso, dal naso grosso, P. Licinius Calvus, il calvo), attraverso l’onomastica cristiana e quella germanica, all’attuale sistema onomastico nome - cognome, con l’affermazione del concetto di ereditarietà del nome di famiglia e la fissazione del cognome. Già allora, tra le varie origini del cognome moderno, così come era accaduto per i cognomina latini, la fonte più inesauribile e incomparabilmente più ricca fu proprio quella del soprannome, nella cui abile e spesso improvvisa creazione lo spirito popolare ha sempre continuato a prodigarsi. L’uso di tale sistema nome - cognome ha sicuramente ristretto l’utilizzazione del soprannome o, per meglio dire, come elemento distintivo lo ha eliminato dagli usi burocratici e giuridici, ma esso ha continuato a rimanere molto vivo nella vita quotidiana della gente. La sua origine e il suo uso affondano le loro radici davvero nella notte 8 dei tempi e, come afferma il Gentile, nei soprannomi “si esprime come una fonte inesauribile di creazioni lo spirito popolare, fissando, con intendimenti di varia natura e significato, qualità e difetti fisici e morali, circostanze e situazioni, atteggiamenti e tratti caratteristici con nomi trasparenti scaturiti da metafore affettive o caricaturali, o da storpiature di nomi propri”(3). Nella nostra cultura, il soprannome è una forma di denominazione che viene usata accanto alla formula onomastica ufficiale nome - cognome, ma che fino a pochi decenni fa, sia nelle piccole realtà rurali come la nostra sia all’interno di centri cittadini più grandi, godeva di una tale forza da ridurre l’uso del cognome o addirittura da scalzarlo definitivamente. In tal modo il soprannome, che integrava o addirittura sostituiva il cognome, finiva per diventare una sorta di sub-cognome per l’identificazione di un individuo o di un intero gruppo familiare. Bisogna però precisare che, mentre il nome e il cognome sono degli appellativi diretti, il soprannome invece veniva usato come uno strumento di identificazione riferito ad una terza persona e, laddove esso ancora sopravvive, tale continua ad essere la sua forma di utilizzazione. Esso infatti, nella maggior parte dei casi, per il suo carattere scherzoso e a volte anche graffiante ed ingiurioso, viene adoperato alle spalle della persona direttamente interessata che, non identificandosi quasi mai apertamente con esso, lo percepisce come una sorta di marchio offensivo e irrispettoso (non dimentichiamo che ngiùria deriva dal latino iniuria che significa offesa). Infatti, per la mia ricerca sui soprannomi di Paceco, in un primo momento ho tentato di intervistare delle persone scelte a caso, ma dopo una dozzina di tentativi ho dovuto constatare come la ngiùria venga vissuta dalle persone che devono parlarne come una sorta di marchio negativo, un elemento distintivo sicuramente giocoso, ma che può essere anche graffiante ed umiliante per sé e per altri; per questo si ha pudore e ritegno a parlarne con uno sconosciuto, come apparivo io, che per di più, nonostante i tentativi per far apparire tutto come una semplice chiacchierata, ad un certo punto (solo in alcuni casi la momentanea e apparente disponibilità delle persone mi ha spinto a questa richiesta) chiedeva il permesso di usare un piccolo registratore e diceva che queste informazioni sarebbero servite pâ scola. 9 Di fronte ai sorrisi, ora divertiti ora imbarazzati, delle persone cui mi sono rivolto e alle loro espressioni del tipo “A Ppaceca quasi ogni famìgghia avi a so ngiùria, ma jò un nni sàcciu, un mi li ricòiddu”, sono stato costretto a scegliere un altro sistema per raccogliere informazioni sui soprannomi di Paceco: ho cercato di contattare parenti, amici, conoscenti o di farmi presentare da questi ad altre persone che, secondo loro, avrebbero potuto darmi delle informazioni utili. In questo modo ho trovato una maggiore disponibilità nei miei confronti, minore diffidenza ed imbarazzo e, soprattutto, una grande e importante quantità di informazioni che, oltre alla registrazione di 393 soprannomi, mi ha permesso di tuffarmi nel passato e, in un certo senso, di ricostruire un mondo fatto di mestieri, attrezzi, aneddoti, situazioni, personaggi ormai scomparsi e immersi in ritmi di vita differenti dai nostri, in giornate cadenzate dal sorgere e dal tramontare del sole, tra botteghe e lavori agricoli, stalle, muggiti di buoi e il vestito nuovo della festa, tra suprastanti e iurnatara, tra la fatica del quotidiano e il giorno della festa religiosa, insomma un mondo identico a quello rappresentato da Verga nel suo romanzo. In riferimento alla fortuna di cui il soprannome ha goduto, come veniva sottolineato prima, essa va sicuramente fatta risalire alla sua efficacia identificativa che, a volte, finisce per essere maggiore di quella del nome, senza distogliere però la nostra attenzione dall’importanza del suo carattere ingiurioso o laudativo, scherzoso o irridente, insomma, della sua dimensione ludica, indissolubilmente legata alle vicende quotidiane della vita popolare e alla inesauribile capacità d’inventiva propria dell’uomo. Il soprannome, all’interno di una comunità, come quella di Paceca, può essere imposto all’individuo dal suo gruppo di appartenenza o addirittura dalla sua stessa famiglia. Davvero infinite sono le possibilità della sua genesi: esso può trarre origine o dalle caratteristiche fisiche (Bbàcchiaru, Ca-Zzimma, Cori-Malatu, Crozza, Cudd(r)uzzu, Cùitta, Longhi, Mustazzusa, Nasca, Nascaredd(r)a, Nasuni, Nasurrussu, Occhi-Nichi, Òivvi, Pagnuccuni, Panza-Sicca, Peri-Curti, Pilusu, Rentiroru, Rrussi, Sgammarra, Sùidda, Zzoppu) o da caratteristiche comportamentali dell’individuo in questione, come nel caso di Àffiu-chi10 Cani, Checcu, Ciàta (per il respiro affannoso), Ciùci (“Zza Catarina, cci emu a gghiri all’acqua?”. “Ora, quantu ciùciu stu focu, ora...”. Sta chistiana, quannu cci ricìanu amunìnni all’acqua, avìa sempri u focu a cciuciari! E cciuciava sempri u focu e cci mìsiru a Ciùcia! E arristàu Ciùcia!”), Cuppuluni, Gnagnaredd(r)u, Mancia-Gnòcculi (“Mamma, fammi i gnòcculi! Mamma, fammi i gnòcculi!”. So matri cci ricìa: “Ma chi, fìgghiu meu, fai sempri a mmanciari gnòcculi?”), Mìsticu, NaschiLòiddi, Occhialinu, u dutturi Pòitta-Pòitta, Sanguittara, Santa, Scassati (“Quannu pallava, pallava tantu migni magni”); o dalla sua associazione, per svariati motivi, con elementi del mondo minerale, animale e vegetale (Acedd(r)u, Add(r)rinedd(r)a, Add(r)uzzu, Attaredd(r)i, Attuppatedd(r)u, Bbiòcculi, Caiccarazza, Caiddidd(r)u, Cani-Bbuiddof, Cani-Campagna, Cavadd(r)uzzu, Cicaledd(r)a, Cicirri, Cucchi, Fanusu, Fava, Funcia, Lupi, Mazzu-ri-Ciùri, Miluni, Mulu, Murina, Patati, Picciuna, Picuridd(r)u, Pòiccu, Puci-di-Quasittuni, Scòiffani, Succitedd(r)i, Tracchi, Vaccaredd(r)i). Interessanti sono i soprannomi fonosimbolici del tipo Chilli-Calli, Gnìcchiti, Lollò, Mpàppiti, Ngo-Ngo, Tic-Tic, Trilli-Tri, Ntrìcchiu (“Fai ntri e a luci elettrica add(r)uma”) e quelli idiomatici, che traggono origine dal modo particolare di parlare: Ahiài (“Idd(r)a rissi “Ahiài” e jò mi l’arritirai”), Ciaccu (perché da ragazzo, giocando con i soldi, sapeva ciaccari, cioè colpire una pila di monete inserendo quella lanciata; diceva: “Ciaccu!” e ciaccava), Cicoria-del-mio-Giardino (perché vendeva cicoria), Còcula (“Arrutulai comu nna còcula!”), EjaEja (fascista fanatico della fine degli anni ’20 che andava male a scuola, e il maestro voleva bocciarlo; scoperto che il maestro era ostile al fascismo, un giorno si mette a gridare in classe: “Per Mussolini: èja èja!”. E tutti a ripetere alzando la mano nel saluto romano come allora si usava: “Alàla!”, anche il maestro per non avere guai. Il fatto si ripeté sino a quando il maestro chiamò in disparte il ragazzo e gli promise che l’avrebbe promosso. E l’èja èja in classe cessò), Èramo-in-Pochi, Ggiòia-Mia, I, Mammina, Mischini, Ngìmmi, Nicola-Miu. Tra i soprannomi legati ai mestieri meritano di essere citati quelli che fanno riferimento ad attività lavorative quasi scomparse: Acqualoru, Allicca-Càntari, Bboia-Cani, Caivvunaru, Campestri, Campu11 santaru, Curàtulu, Funnacara, Pagghialoru, Sana-Porci, Sapunaru, Scaipparu, Vuttaru; a questo proposito molti di noi ricordano Càimminu u Siminzaru che, fino a pochi anni fa, al centro della piazza vendeva cìciri, caccavetta e simenza caliata. Nutrita è poi la lista dei soprannomi triviali: Bbacaratunna, CacaMantu (“Me nonnu era acchisiàsticu, purtàvanu il mantellu, cû capùcciu, cu tuttu u mantellu granni, ed era nna comodità… u rragazzinu era sempri cu sso patri, cci vinni ri fari quàicchi ccosa e cci u fici supra u mantellu”), Caca-nno-Piattu, Caca-Rinari (perché, in qualsiasi attività si mettevano, facevano sempre affari), Cìcia-Nìura, Ciciazza, Ciolla-d’Oro (“Sta matri, quannu lu lavava stu picciridd(r)u, era tanta cuntenti d’aviri stu fìgghiu, chi cci ricìa sempri: “Talìa che bbedd(r)u stu fìgghiu meu! Ma chi ll’avi dd’oro sta ciolla?”), Minni-Lordi, Natichi-Modd(r)i, Pacchiuna, Pinnuluna (“Niatri semu ngiuriati Pinnuluna picchì me nonnu, ogni volta chi so moglie aspittava quàicchi picciridd(r)u, cci ddumannàvanu: “Com’è? Stavota chi ffa? Masculidd(r)u o …” “No stavota màsculu… fu siminatu pi màsculu e mmàsculu avi a bbèniri”. E… u risuittatu era màsculu. Siccomu tannu figghi nni facìanu nna caittedd(r)a, giustamenti, successi arrè. “Chi è stavota?”. “Mma… avi a pinnuliari arrè”. Pp’abbreviari u fattu ruràu quattru voti e pinnuliava sempi. Doppu chi passàu quattru voti, giustamenti canciàu a sunata e cci ddumannàvanu arrè… Rici: “Stavota com’è a stessa cosa?” “No, no, stavota no! Stavota un pinnulìa…”. Pecciò poi, doppu chi giustamenti appi n’atri ddu fìmmini e tutti ddu fìmmini era ggiustu comu ricìa idd(r)u, ci misiru a diri: “Allura chistu Pinnuluni sceltu è! Quannu rici chi avi a pinnuliari pinnulìa, quannu rici chi unn’avi a pinnuliari un pinnulia”. E comunqui cci arristàu Pinnuluni… per tutti li figghi chi appi e tutti i fìmmini e mmàsculi, tutti li sèntinu i Pinnuluna”), Piscia-Rrasòliu (una ragazza così bella e così brava nel suo lavoro che la madre diceva: “Ri me fìgghia puru a pisciazza addiventa rrasòliu!”. E allura cci mìsiru, cci attribbueru…Pìscia-Rrasòliu”), Strunzu-Nìuru, Titta-Pisciasti. La maggior parte dei soprannomi censiti ha però un carattere scherzoso, irridente o addirittura ingiurioso; qui ne cito solo alcuni: Bbeccu-a-Cùiddia, Bbummuli, Cappidd(r)uzzu, Càusi-cùitti, Corna 12 (“Mio nonno, libberàu u cornu di tutto quello che c’era dentro e n’ha fatto un porta… tabbacco, e quando prendeva tabbacco naso, lo offriva nna ssu corno), Cosci-Lordi, Cura-Lòidda (prete trasandato), Fimminella, Mala-Carni, Macaruri, Mancia-Mòivvu, Mezzu-Munnedd(r)u, Musulinu (per le fattezze fisiche simili a quelle del duce), Nfrinzusi, Omu-Zzitu (eternamente fidanzato), Paparuna (per l’andatura), Pisciati, Pupunàu (cattivo come un Lupu Mannaru), Prantalazza, Rre-di-Dinari (per il suo atteggiarsi), Sciloccu (perché era troppu muvimintatu), Scrivi-e-mmanna (perché sempre pronta a fare qualche esposto), Scucchia-Palati, Senza-Liggi, Spacca-Cirina (tirchio), Squagghia-Omini, Stuppàgghiu (per la bassa statura), Trenta-I, Vucca-ri-Zzuccaru (“Avìanu a vucca ruci e u culu amaru”). Pochi invece i soprannomi affettivi e laudativi tra cui: Bbamminu (“Me figghiu pari u Bbamminu”), Machinetta (per la velocità nel lavoro) e Maravigghia. Molto presenti i soprannomi etnici (del tipo Calabbisa, Capaciotu, Cittara, Massalisa, Mazzarisa, Muntisi, Napulitanu, Nubbioti, Paparidd(r)iota, Trapanisi), i patronimici e matronimici (come Bbinnàiddu, Calidd(r)a, Ciruculletta, Nzinufilici, Piu-Sciavèriu, Rrusanu) e una serie di soprannomi, percepiti come tali ma che in realtà derivano da cognomi o da nomi propri storpiati (Alacolla, Alarrosa, Bbattàgghia, Cirinisi, Cuiccasedd(r)u, Cuttuna, Ddi-Maiu, Nalli, Nazzarenu, Nuvaredd(r)a, Sulivestru, Vaiana, Vaittulazzu). Molti sono poi i soprannomi che ho rilevato il cui significato e movente restano oscuri (almeno per ora). Dagli esempi riportati emerge che ogni motivo può essere valido per sancire la creazione di un soprannome e che quest’ultimo, quasi sempre animato da una visione umoristica o ironica dell’individuo, con la sua capacità di tratteggiare efficacemente, per mezzo di una sola parola o di una breve locuzione, caratteristiche o circostanze a lui collegate, con il suo passare di bocca in bocca e con l’affermarsi nell’uso, finisce per risultare più espressivo del nome e del cognome anagrafico; dapprima attribuito ad un singolo individuo, molto spesso poi si estende a tutta la sua famiglia e viene trasmesso di generazione in generazione; quindi, data la loro origine lontana, molti soprannomi diventano inintellegibili, oscuri, a causa anche della corruzione o della deforma13 zione a cui frequentemente sono soggetti, ma soprattutto perché spesso non siamo più in grado di ricostruire la circostanza o la motivazione che ad essi ha dato origine. Riguardo all’importanza che nell’interpretazione di un soprannome non ci si leghi solamente al suo significato letterale, Antonino Marrale afferma che “non v’ha dubbio che di molti soprannomi l’etimo è trasparente, ma questa trasparenza riguarda la relazione significantesignificato-referente e non potrà mai dire con sicurezza quale sia la relazione di un soprannome con la persona cui è attribuito”(4). Per una più corretta interpretazione dei soprannomi è quindi molto importante la conoscenza della motivazione, altrimenti si può cadere in veri e propri abbagli e deviare dalla circostanza ricercata, perché il significato letterale non sempre coincide con il motivo per il quale è stato affibbiato il soprannome, ma addirittura spesso, per antitesi, esprime un concetto opposto. In effetti, durante la mia ricerca, a volte avevo l’impressione che i miei informatori, ingenuamente e tacitamente, ricostruissero l’origine del soprannome a partire dal suo significato. In ogni caso il soprannome, per la sua stretta aderenza con la vita, le circostanze e la cultura di una data comunità, in un suo ben determinato periodo storico, finisce naturalmente per assumere il ruolo di chiave e di strumento interpretativo di quella cultura e, nel caso in cui si tratti di soprannomi nati in tempi remoti ed in un contesto ormai lontano dal nostro, essi sono in un certo senso “testimonianza e documento” per la ricostruzione o la maggiore comprensione di una realtà storica, sociale, economica e culturale perduta; proprio in quanto “documenti” esigono, quindi, uno studio, un’interpretazione ed un’analisi rigorosa e quasi filologica. Per questo motivo, a partire dalla fine del XIX secolo, ci sono stati molti linguisti e filologi, studiosi di tradizioni popolari, storici ed eruditi locali che hanno sempre più rivolto la loro attenzione allo studio, alla raccolta dei soprannomi e alla loro classificazione che può essere di tipo semantico (come quelle proposte da Zanardelli e Rohlfs) o basata invece sul movente (come quella, oggi più convincente, anche se più complessa, proposta da Ruffino). Come è stato già detto, profondo è infatti il valore linguistico e storico culturale di questo elemento di denominazione che “in quanto prodotto verbale, non è soltanto porta14 tore di modi di dire, di voci gergali, di espressioni proverbiali, di allitterazioni e di altre forme del dialetto locale, ma conserva anche termini dialettali antiquati e in disuso”(5). A questo proposito, tra i soprannomi raccolti, basti ricordare alcuni termini ed espressioni che ho rilevato e che sono lontani dal nostro lessico quotidiano: Caella (una sorta di giubbone), Còcula (palla di legno), Cicirri e Cucchi (uccelli), Frascatuli (una pietanza fatta cu sìmmula ncucciàta rossa), Tracchi (branchie di pesce), Navetta (attrezzo del telaio), Coffa (borsa da lavoro), Sacchina (sacca in tessuto), Munnedd(r)u (recipiente e unità di misura), Rastedd(r)u (pertica ricurva), Mamma-Ddrau (personaggio mostruoso presente nei cuntura che spaventava i bambini); addirittura ho potuto registrare anche dei versi: “Un ggniti nna li Còivvi a ttravagghiari/ Vi mèttinu lu còriu a lu suli/ Mìnicu scòccia, Nirìa metti sali,/ Àsparu va mmezzu la chiazza a ddumannari:/ Cu voli carni di lu me azzuni?”. è chiaro quindi che, “data la sua natura, il soprannome è, molto spesso, depositario di usi, credenze, opinioni, atteggiamenti ideologici che sebbene, oggi, siano ormai, in gran parte, superati e non più condivisi da tutti, tuttavia possono informarci sulla concezione del mondo e della vita che, fino ad un recente passato, ha guidato il comportamento dei componenti di una data comunità”(6). In effetti la mia ricerca sui soprannomi di Paceco, sulla loro possibile origine e classificazione, nonostante tutti i limiti e la problematicità di un’operazione così complessa e, per così dire, aperta, ha confermato quanto detto finora e, durante le interviste, davvero affascinante è stato “perdermi” nelle spiegazioni delle possibili motivazioni dei soprannomi che, anche quando si capiva essere in qualche modo ricostruite dagli intervistati a partire dal significato letterale, avevano il merito di offrirmi squarci di un mondo che ormai non esiste quasi più. Come si diceva fin dall’inizio, il soprannome, che Leonardo Sciascia definiva come una specie di genere letterario(7), è ormai da decenni un genere in crisi. Molte sono le cause del suo declino sulle quali qui non mi voglio soffermare, in ultima analisi però sono tutte legate al passaggio da una comunità chiusa e agricola ad una moderna e in continuo cambiamento. Penso però che il declino del soprannome e della sua utilizzazione siano altresì da collegare con un altro fattore molto importante che, a mio avviso, caratterizza la società contemporanea: la crisi 15 della dimensione orizzontale ed interpersonale, lo “svuotamento” dei rapporti umani nella loro sostanza. Credo infatti che il nome personale e, soprattutto, il cognome stiano idealmente in una sorta di dimensione verticale, quella, cioè, che pone l’io di riferimento in relazione con i propri genitori, gli antenati, l’albero genealogico, con le proprie origini, la propria identità, dimensione dalla quale coloro che stanno al di fuori della propria famiglia sono necessariamente esclusi. Il soprannome, invece, trae la sua origine e deve la sua esistenza ad una dimensione orizzontale: quella del rapporto tra l’io e il suo prossimo, i suoi conoscenti, le persone dalle quali è quotidianamente circondato e con cui condivide la sua esistenza. Infatti laddove i rapporti umani sono intensi e costanti, dove c’è un coinvolgimento ed un “cointeresse”, ad un dato punto può accadere che, proprio in virtù di tale familiarità, ci si permetta il lusso di voler in qualche modo entrare nella dimensione verticale altrui, farla propria, volerla quasi alterare e “dire una parola” sulla identità dell’altro: tutto questo affibbiando un “semplice” soprannome. Anche se il soprannome individuale, dove questo tratto è sicuramente più evidente e più vivo, può poi estendersi ad un’intera famiglia e, divenendo una sorta di subcognome, essere associato alla dimensione verticale, penso che esso mantenga il marchio che lo identifica manifestamente come frutto di una relazione. A riprova di quanto il soprannome sia collegato a questa crisi della dimensione relazionale, basta osservare come, dove le relazioni si mantengono salde e profonde (all’interno di una classe scolastica, in una comitiva di amici, in un quartiere, in qualsiasi gruppo saldo e compatto), la produzione e l’utilizzo del soprannome si mantengono ancora costanti. Oggi, più che di soprannome, si parla invece sempre più di nickname, che altro non è che il corrispondente inglese del termine soprannome; lo si fa in relazione al mondo virtuale di internet, dove persone che non si conoscono affatto (diverse per cultura, età, provenienza, ecc…), lontane dal punto di vista fisico, in luoghi spesso posti a centinaia di chilometri di distanza, “si incontrano” all’interno di una chat (una sorta di stanza virtuale per le chiacchiere) e comunicano in tempo reale. Per accedere a questa “stanza” è necessario digitare nella tastiera del computer un nickname con il quale ci si presenta agli altri, una sorta di cartellino identificativo. Ancora una volta quindi si tratta di un so16 prannome che, a mio parere, ha però delle caratteristiche diametralmente opposte a quelle della ngiùria, proprio nella sua sostanza. Il soprannome, infatti, in quanto nato dalla vita reale e in quanto frutto della dimensione interpersonale, veicola un significato collegato alla personalità, alla vita, al carattere, all’identità di un individuo così come viene percepita dalle persone che lo circondano. Il nickname invece viene di volta in volta creato, scelto ed auto-attribuito, in modo da diventare il manifesto di una identità che può naturalmente corrispondere a quella dell’individuo, come può corrispondere invece ad una identità fittizia, artificiosa, costruita per dare di sé l’immagine che si vuole, in ogni caso non si tratta del frutto di una dimensione relazionale orizzontale, ma della percezione che l’individuo, nella solitudine della sua individualità, ha, vuole o finge di avere della sua identità. Se quindi il nickname ha in sé l’eco di una solitudine che cerca la relazione, la ngiùria invece, in quanto frutto di relazione, porta l’eco della piazza e della strada, della campagna e del paese, dei giorni di festa e del sudore quotidiano, delle risate dei momenti felici e delle lagrime di quelli tristi, in poche parole la ngiùria sembra quasi un inebriante distillato dell’esistenza sgorgato in un luogo e in un momento storico ben precisi; si tratta quindi di un prezioso prodotto che, se ben “conosciuto e usato”, è capace di proiettarci in quel luogo e in quel momento storico che hanno visto il suo nascere e di gustarne quindi i sapori, di ammirarne le sfumature, di percepirne le fragranze, di sentirne le voci camminando supra sti quattru rocchi, tra casi vasci di cantuna cummigghiati di ciaramìri, all’ùmmira di pèrvuli, ravanz’a porta. BALDO PALERMO Bibliografia e note 1. G. Pitrè, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, vol. II, G. Barbera Edi- tore, Firenze, in “Edizione Nazionale delle opere di Giuseppe Pitrè”, p. 381. 2. Il termine ngiùria è il corrispondente dialettale di “soprannome” utilizzato a Paceco. 3. A. Gentile, Il soprannome nei documenti medievali dell’Italia meridionale, Napoli, 1963, p. 5. 4. A. Marrale, L’infamia del nome. I modi e le forme della soprannominazione a Licata, Gelka ed., Palermo, 1990, p. 40. 5. M. Raciti Maugeri, Sui soprannomi in Sicilia e in Italia, in “Archivio storico per la Sicilia orientale”, LXXX, 1984, pp. 193-194. 6. M. Raciti Maugeri, op. cit. 7. L. Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, Torino, 1975, p. 40. 17 PIAZZA AmmIRAGLIO UmBeRTO CAGNI Il 5 agosto 2011 il quotidiano “La Stampa” riportava la notizia che il fotografo inglese Tim Hethergton, inviato in Libia durante la recente guerra civile, e Peter Bouckaert, capo di un’organizzazione internazionale, si trovavano a Bengasi dopo la liberazione della città ad opera dei ribelli e avevano avuto la possibilità di consultare alcuni documenti riservati, custoditi presso gli uffici della municipalità cittadina. La maggior parte del materiale riguardava la documentazione delle atrocità commesse dal regime di Gheddafi nei confronti degli oppositori, con foto e filmati di migliaia di arresti e spietate esecuzioni. Fra gli altri documenti veniva rinvenuto un fascicolo relativo a fatti accaduti nel 1941, durante il periodo di occupazione italiana della Libia. Detto fascicolo conteneva una segnalazione dell’Ufficio Speciale della Polizia di Bengasi alla Regia Prefettura e al Tribunale Speciale in cui i fratelli Nikoforais, di origine greca (cittadini di una nazione amica dell’Inghilterra), venivano sospettati di tradimento. I fratelli Nicola, Leonida e Stati Nikoforais, fotografi, gestivano un negozio in piazza Ammiraglio Umberto Cagni, la piazza principale della città di Bengasi, e gli affari andavano abbastanza bene anche perché da 18 poco era stato introdotto l’obbligo della carta d’identità, con fotografia, per tutti i cittadini del Regno. Inoltre, a poca distanza da piazza Cagni, erano ubicati il Circolo Ufficiali e la via Torino, la più elegante della città, con i suoi moderni negozi, soprattutto di abbigliamento. Le accuse di tradimento nei confronti dei Nikoforais non erano tuttavia suffragate da sufficienti elementi di prova per cui gli inquirenti italiani non procedevano all’arresto ma continuavano a tenerli sotto controllo. Intanto gli eventi bellici precipitavano e gli Inglesi, superando le linee difensive delle forze militari italiane, occupavano la città di Bengasi e ne mantenevano il controllo per 56 giorni, dal 6/2/1941 al 3/4/1941. Durante questo periodo di occupazione, il negozio dei fratelli greci era assiduamente frequentato da militari inglesi per le foto tessere delle carte d’identità. Il Comando inglese aveva concesso ai Nikoforais l’esclusiva per i servizi fotografici alle loro truppe, alimentando così i sospetti di collaborazionismo. Dopo 56 giorni, i soldati inglesi, a seguito dell’avanzata delle forze italo-tedesche, erano costretti a ritirarsi verso l’Egitto, liberando così la città di Bengasi e l’intera Cirenaica. Nel fascicolo a carico dei fratelli greci compariva un altro documento, datato 23 settembre 1941, a firma del capitano dei Carabinieri Giovanni Agrigento il quale, tenendo conto degli ultimi sviluppi della vicenda, proponeva l’internamento dei Nikoforais in un campo di concentramento. Nicola, Leonida e Stati Nikoforais venivano rinchiusi nel campo di concentramento italiano di Soluch, lo stesso campo di concentramento in cui, nel 1931, era stato internato e successivamente impiccato Omar el Mukhar, capo degli oppositori libici. Non si conosce che fine abbiano fatto i fratelli Nikoforais ma sappiamo che la foto portata sul petto da Muammar Gheddafi, durante la sua visita in Italia nel 2010, era proprio quella dell’eroe nazionale libico Omar el Mukhar. In questo quadro di avvenimenti storici, spesso drammatici, s’inseriscono e s’intersecano le vicende umane di diverse migliaia di cittadini italiani, soprattutto meridionali e veneti, emigrati in Libia in cerca di lavoro e di fortuna. 19 Le loro testimonianze e la memoria di quanti hanno ereditato i loro racconti costituiscono un patrimonio di verità e di valori che non devono essere dispersi. I documenti che seguono riguardano un cittadino italiano, uno dei tanti, che ha vissuto a Bengasi la drammatica esperienza della guerra e, dopo aver sperato invano nella vittoria, ha dovuto abbandonare la propria casa, ogni avere e affrontare tanti pericoli per riuscire a raggiungere con la propria famiglia il paese d’origine, a qualche migliaio di chilometri di distanza, in piena seconda guerra mondiale. Il suo nome è Salvatore Caronia, detto familiarmente Turiddu, ed era nato a Paceco, in provincia di Trapani, l’11 novembre 1906. Si era sposato il 20 novembre 1937 con Maria Stella Tartamella, anche lei di Paceco, nata il 18 marzo 1911, lo stesso anno in cui il governo presieduto da Giovanni Giolitti aveva dichiarato la guerra contro la Turchia per la conquista della Tripolitania e della Cirenaica. Il 5 ottobre 1911 era avvenuto il primo sbarco a Tripoli di un contingente militare italiano, con una nave scuola comandata dall’allora capitano di vascello Umberto Cagni. Come risulta dal timbro riportato sul lasciapassare per le Colonie, il 10 gennaio 1938 Salvatore era sbarcato a Bengasi e dopo qualche giorno aveva trovato lavoro presso un’impresa di costruzioni italiana, impegnata nella realizzazione di case coloniche sulla fascia costiera della Cirenaica. A distanza di un mese, il tempo necessario per sistemare casa, veniva raggiunto dalla moglie, anche lei imbarcatasi dal porto di Siracusa, e iniziavano così una nuova vita, piena di speranze, in terra d’Africa. 20 Abitavano a circa cinque km da Bengasi, in frazione Berca (o Berka), via Ben Schetuan n. 86. Berca era ben collegata alla città per mezzo di una tranvia a cavallo che percorreva via Vittorio Veneto, via Stazione, passando davanti alla Caserma Moccagatta e alla Caserma degli allievi Zaptiè, i famosi carabinieri libici. La tranvia a cavallo impiegava circa mezz’ora per coprire l’int e r o tragitto e quasi tutti prendevano quel mezzo per raggiungere piazza Cagni, nelle cui vicinanze erano ubicati diversi negozi di vario genere. Altro mezzo di locomozione era la bicicletta, in genere usata da Salvatore per recarsi in cantiere al mattino e ritornare a casa la sera o per raggiungere BenLasciapassare per le Colonie gasi, quando era necessario. Il lavoro non mancava e si guadagnava bene: con la qualifica di muratore di prima categoria il contratto prevedeva, per la zona di Bengasi, una retribuzione oraria di lire 3 e 95 centesimi, ovviamente in regola con le assicurazioni sociali. 21 Gli Arabi svolgevano lavori di manovalanza (in genere lavori che non comportavano particolari sforzi fisici) e la convivenza con gli Italiani poteva ritenersi, in linea di massima, pacifica. A Bengasi Salvatore aveva ritrovato i genitori, le sorelle Antonietta, Giuseppa e Caterina e tanti altri parenti, emigrati alcuni mesi prima; lavoravano quasi tutti e vivevano sereni, in quel mondo nuovo, aiutandosi l’un l’altro. Intanto era stato introdotto l’obbligo per i cittadini del Regno della carta d’identità con fototessera per cui Salvatore si recava con la moglie a piazza Cagni, presso lo studio fotografico dei fratelli Nikoforais. Il 20 gennaio 1939 (XVII dell’era fascista) il Comune di Bengasi rilasciava la nuova carta d’identità. Carta d’identità di Salvatore del 20 gennaio 1939 Il 10 giugno, sempre del 1939, Salvatore apriva un conto di deposito a piccolo risparmio, presso la Cassa di Risparmio della Libia ed effettuava il versamento di una modesta somma: sessanta lire. Questa è rimasta la prima e l’ultima operazione registrata sul libretto, come si può notare sulla pagina dei movimenti. Assieme al libretto la banca gli consegnava una cassettina salvadanaio dotata di serratura (la chiave la custodiva la banca) e di una feritoia per introdurre le monete o banconote di piccolo taglio. Quando la cassettina era piena occorreva riportarla in banca per lo svuotamento e l’accredito della somma risparmiata sul libretto di deposito. Il 28 ottobre 1939 nasceva la primogenita Giuseppa e fu festa grande quella domenica in cui fu celebrato il suo battesimo. 22 Per la sua tenera età, Giuseppa non verrà inclusa fra i dodicimila bambini a cui il regime fascista aveva regalato una vacanza di un mese da trascorrere in Italia, per vedere la madrepatria. I bambini erano partiti da Tripoli il 6 giugno 1940 e dopo pochi giorni, esattamente il 10 giugno, Mussolini dichiarava guerra alla Francia e all’Inghilterra e si schierava a fianco della Germania. Lontani dai loro genitori, quei 12.000 bambini, invece di un mese, rimasero in Italia fino alla fine della guerra e non tutti riuscirono, nel 194647, a ricongiungersi con i propri genitori. Giuseppa Caronia a Bengasi anno 1940 Libretto Cassa di Risparmio della Libia giugno 1939 Il 28 giugno 1940 il Governatore della Libia Italo Balbo era stato abbattuto col suo aereo mentre sorvolava la rada antistante la città di Tobruk, a circa 400 km ad est di Bengasi, perdendo la vita nell’incidente. Si disse dopo che a colpire l’aereo di Balbo fosse stata, per errore, la contraerea dell’incrociatore italiano San Giorgio che pattugliava il tratto di mare tra le città di Derna e Tobruk. Nonostante la dichiarazione di guerra, la popolazione civile non avvertiva ancora eccessivi disagi e 23 Salvatore, il 29 novembre, apriva un conto corrente cointestato con la moglie, presso l’ufficio postale di Berca (sicuramente più comodo da raggiungere perché a poca distanza da casa), sul quale effettuava un primo versamento di lire 1.000. Libretto postale - novembre 1940 Con due versamenti successivi, a poca distanza di tempo (11 e 28 dicembre), di 500 lire ciascuno, si ritrovava con 2000 lire sul libretto, il che voleva dire che si respirava un clima in cui prevaleva la fiducia nell’immediato futuro. Contrariamente alle aspettative, col nuovo anno (1941) si avvertiva un peggioramento della situazione e, a causa della guerra, aumentavano le difficoltà per il lavoro e per procurarsi i generi alimentari di prima necessità. Verso la fine di gennaio del 1941, l’esercito inglese sferrava un attacco per la conquista della Cirenaica e il 6 febbraio la città di Bengasi era stata occupata. La popolazione civile, in massima parte italiana, passava sotto il controllo del Comando militare inglese ed era costretta a vivere rinchiusa nelle proprie case o nei ricoveri, affrontando sempre maggiori difficoltà per rifornirsi degli alimenti strettamente necessari alla sopravvivenza. 24 Soltanto i più anziani, quando era possibile, uscivano allo scoperto per procurare del latte per i bambini, pane o altri generi che si potevano trovare nei pochi negozi rimasti aperti. Le forze militari italiane, con l’appoggio di alcuni reparti meccanizzati tedeschi, comandati dal generale Rommel, lanciavano una controffensiva e riuscivano a ricacciare gli Inglesi verso l’Egitto, liberando così, il 3 aprile 1941, la città di Bengasi e successivamente l’intera Cirenaica. L’intervento tedesco, in appoggio alle truppe italiane, determinò un eccesso di ottimismo sulla possibile vittoria finale della guerra, spingendo addirittura Benito Mussolini a recarsi in Cirenaica il 29 giugno 1941, per tenersi pronto ad entrare vittorioso a Il Cairo, in Egitto, col suo cavallo bianco. Mussolini attese invano una ventina di giorni durante i quali i suoi sogni, invece di realizzarsi, svanivano sempre più e così decideva, il 19 luglio, di ritornarsene repentinamente in patria. Intanto riprendevano i bombardamenti su Bengasi e Salvatore si rendeva conto che era necessario costruire un rifugio antiaereo dove poter ricoverare, soprattutto durante le ore notturne, i propri familiari (la moglie aspettava il secondo figlio per la fine dell’anno). Nel giro di poche settimane di duro lavoro, il rifugio veniva realizzato non molto distante dall’abitazione, ad una profondità di circa otto metri ed era composto da una rampa d’accesso e un corridoio sulle cui pareti erano state scavate quattro stanzette. Tutte le notti si dormiva nel rifugio che era utilizzato anche di giorno, quando il suono della sirena d’allarme preannunciava un bombardamento aereo. Bisognava anche tenere i documenti in ordine, nel caso di una improvvisa evacuazione della città e così Maria Stella richiedeva la nuova carta d’identità ed il lasciapassare per le Colonie, documento sostitutivo del passaporto, rilasciati rispettivamente il 12 e il 13 agosto 1941. Il 12 dicembre 1941 nasceva Francesco, secondogenito di Salvatore, dentro quel rifugio, a otto metri di profondità. A questo punto non vi erano più ostacoli che impedivano di programmare la partenza dalla Cirenaica e quindi il rientro in Italia. La Prefettura di Bengasi aveva organizzato dei convogli di automezzi militari per trasferire tutti gli sfollati a Tripoli, distante circa 1200 km. 25 Donne e bambini avevano la precedenza, poi gli anziani e quindi tutti gli altri. Per tutti valeva la raccomandazione di portarsi dietro un solo bagaglio a mano. Maria Stella, accompagnata dalla cognata Caterina e con i figli Giuseppa e Francesco, nato da pochi giorni, partivano con un autobus per Tripoli. Anche gli anziani suoceri erano partiti nello stesso periodo, ma con altri mezzi di fortuna. Il 15 dicembre Salvatore si recava presso l’ufficio postale di Berca, Lasciapassare per le Colonie e carta d’identità prelevava 1800 lire e ne laagosto 1941 sciava soltanto 200 sul libretto, chissà, con la speranza, forse, di poter ritornare un giorno. Non chiudeva neanche il conto alla Cassa di Risparmio della Libia dove erano rimasti le 60 lire iniziali. Il giorno dopo, caricata sulla bici una borsa contenente il minimo necessario, abbandonava la casa di Berca e andava a Bengasi dove, a piazza Cagni, era prevista la partenza dell’autocolonna per Tripoli. 26 Gli avevano assegnato un posto su un camion militare e iniziava anche lui il viaggio alla volta di Tripoli, per ricongiungersi con moglie e figli. Il viaggio non poteva che essere molto avventuroso, si viaggiava quasi sempre di notte, a fari spenti e lungo il percorso solo raramente si incontrava un centro abitato o un punto di ristoro. L’automezzo sul quale viaggiavano i genitori di Salvatore, giunto nei pressi di Misurata, fu bombardato da un aereo inglese. L’anziana madre riportò delle ferite ad una gamba e venne ricoverata in un ospedale da campo, assistita dal marito. Salvatore arrivava a Tripoli fra Natale e Capodanno e ritrovava moglie e figli, su indicazioni della Prefettura, presso una scuola che ospitava tutti gli sfollati provenienti da Bengasi. Alle prime ore del mattino del 6 gennaio 1942, gli sfollati, fra cui Salvatore e famiglia, si trasferivano con automezzi militari all’aero- Automezzi militari italiani in partenza da Bengasi dicembre 1941 porto di Tripoli per essere rimpatriati in Italia utilizzando gli aerei militari. Il primo aereo decollava con una dozzina di sfollati a bordo, ma dopo pochi minuti esplodeva in volo, diffondendo il panico fra tutti coloro che si trovavano in attesa in aeroporto. Ma non c’erano alternative, bisognava proseguire nelle operazioni di rimpatrio dei civili con i velivoli disponibili, anche se carenti di manutenzione e non perfettamente in efficienza. Il gruppo comprendente Salvatore con i suoi familiari e gli altri compagni di sventura, nello stato d’animo che si può soltanto immaginare, si imbarcava su un bombardiere tedesco alla volta dell’Italia, con destinazione l’aeroporto di Martina Franca, in Puglia. 27 Durante il volo, per motivi di sicurezza, il pilota cambiava la rotta e decideva di atterrare all’aeroporto militare di Milo, in provincia di Trapani. Nel giro di circa tre ore Salvatore, dopo aver abbandonato l’inferno libico, si ritrovava sano e salvo, con l’intera famiglia, a solo qualche chilometro dal paese natio, dal quale era partito quattro anni prima. Bisognava ricominciare daccapo ma, considerato tutto, era andata bene così. FRANCO CARONIA Bengasi Palazzo Cassa Risparmio Bengasi Teatro Municipale 28 SeRAFINO CULCASI Ultimo grande poeta popolare di Paceco Una solenne cerimonia di commemorazione in onore del poeta Serafino Culcasi si è svolta nel pomeriggio di sabato 12 maggio 2012 presso la Biblioteca comunale di Paceco, sotto gli auspici del Comune e del nuovo assessore alla Cultura, dott.ssa Filippa Anna Valenti Bongiorno. La cerimonia è stata aperta dal sindaco dott. Biagio Martorana che ha sottolineato l’importanza della memoria, quale mezzo di comunicazione, all’interno della comunità, dei valori ideali su cui si deve fondare una società moderna e democratica. Nel suo discorso inaugurale l’assessore Valenti ha evidenziato che la cerimonia di commemorazione da lei promossa, al di là dell’affetto personale che la lega al poeta, è un atto dovuto da parte dell’Amministrazione nei confronti di un cittadino che ha lasciato il segno, pertanto contribuisce al recupero e alla conservazione della memoria storica della comunità. Alla cerimonia in onore dell’ultimo grande poeta popolare di Paceco, scomparso pochi mesi fa, sono accorsi in numerosa schiera amici, poeti e compaesani da cui non è stato dimenticato. Durante la cerimonia, Alberto Barbata, direttore emerito della Biblioteca comunale, ha “riportato in vita” l’indimenticabile zzu Sarafinu dedicandogli il commosso ricordo e i versi di seguito riportati. ndr Che Serafino Culcasi fosse un uomo libero è certo ed infatti chi lo ha conosciuto saprà certamente quanto fosse sanguigno, possessivo ed appassionato nella sua misura d’uomo. Era vissuto on the road, possiamo dire, sulle strade che lui cilindrava ed asfaltava per il suo mestiere di impresario edile in un settore che lo poneva a contatto quotidiano non solo con gli operai, ma con la gente del suo paese e del circondario. Era nato in una famiglia di maestri murari della piccola borghesia, una famiglia particolare di appassionati verseggiatori nel dialetto nostro siciliano. Tutti in casa Culcasi erano poeti, dal padre Michele fino ad arrivare allo zio Giuseppe, celebre poeta anche nella lingua nazionale, e ai suoi cugini, non ultimo l’avvocato Peppino Catalano, per lunghi anni sindaco della nostra città. Serafino certamente aveva sempre poetato fin dalla prima giovinezza, ma ancora non aveva avuto l’occasione di stampare qualche composizione. La sua prima apparizione ufficiale in pubblico si ha nel 29 1965 con la partecipazione al primo concorso di poesia, indetto dall’Endas ed intitolato al fondatore di Paceco Placido Fardella, dove presenta una poesia intitolata Attualità che riscuote consensi, viene segnalata, ma non ottiene premi in quanto la giuria si era barricata dietro la scelta di opere più “inquadrate”, più classicheggianti, non certamente libere da schemi e preconcetti metrici. Attualità è una satira feroce della società e della politica italiana degli anni Sessanta, delle crisi e delle congiunture di quegli anni. “N’avemu picca di st’epuca fitenti” canta il poeta quasi ad auspicare la fine di un triste periodo di corruzioni e di sprechi. Il poeta è legato ancora alle tradizioni socio-linguistiche del suo paese contadino, parla “du tempu di lu riugghiutu”, tempo di pantani, dove la buona raccolta è riservata ai furbi soltanto. Attualità sempre attuale, si potrebbe dire oggi. Ma è giusto fare una premessa a questo punto. Il Culcasi è legato alla tradizione dei poeti precedenti, di quei poeti popolari che ogni anno, durante la festa del Carnevale, si scatenavano nelle pubbliche piazze, in Trapani ed in Paceco in particolare, con la forza della loro satira, esercitando l’antico diritto al mugugno. La libertà loro concessa in quei giorni viene esercitata contro tutto e tutti, soprattutto contro coloro che esercitavano il potere nelle istituzioni. Serafino è legato a questa tradizione, se ne libererà dopo alcuni anni di esercizio letterario. La sua scrittura per ora è legata agli antenati, a quelli che erano stati per secoli i padri fondatori della poesia in “lingua pacecota”, come direbbe il prof. Salvatore Di Marco. è legata a poeti come Matteo Barbera, mitico presidente della Società di mutuo soccorso fra gli onesti agricoltori di Paceco, autore del celebre poemetto L’anuri persu alla fera, conosciuto in tutta l’isola e continuamente plagiato in tutti i luoghi, esportato perfino in America dagli emigranti. Mio nonno, che esercitava la lettura con passione, se lo portò a Brooklyn dove lo leggeva nelle botteghe e nelle osterie. La sua poesia è legata a quella di Nino Amoroso detto Nuvaredd(r)a, mitico poeta dei Fasci Siciliani di Paceco. è legata infine al poetare di Nitto Basiricò detto Malacarne e a quello dello zio Peppe Culcasi, il daziere, che era stato in America, gli unici ad essere allittrati come si era soliti dire delle persone che avevano conseguito qualche grado scolastico. 30 Alla delusione avuta in seguito alla partecipazione al premio “Fardella”, dovuta anche alle rivalità che i poeti popolari esercitavano l’uno contro l’altro e da cui nascevano invidie e rancori, seguì la pubblicazione di un poemetto in ottave rime siciliane intitolato L’acidd(r)azzi di lu vintannali. La cronologia dei versi culcasiani non è certa, spesso il poeta ripubblicava composizioni che aveva reso note precedentemente, quindi mi è doveroso precisare le date non sicure di alcune poesie. Tuttavia per L’acidd(r)azzi si è sicuri che è successiva al premio. Ma occorre evidenziare che il legame con la tradizione dei “poeti partisti” non si ruppe facilmente, rimaneva nel suo cuore e nella sua mente, come ancestrale ricordo del passato, come memoria di tante vite della sua famiglia e di tante altre del suo paese. In Munnu di festa, infatti, inserita nell’antologia Lu tirrimotu, pubblicata nel novembre del 1968, sotto il logo “Edizioni Il Disco” (ma in realtà trattavasi dell’editore Celebes), sono presenti gli antenati pionieri che recitano la loro parte: “Iò sugnu lu dutturi ammintuatu,/ o cari amici si vi ricurdati,/ chidd(r)u chi vinni l’annu passatu/ a visitari tutti li malati:/ c’è qualchi malatedd(r)u chiù gravatu/ di chidd(r)i scarsulidd(r)i abbannunnati,/ chi fa la cura di vitamini strani,/ di cucuzzi, cipudd(r)i e milinciani”. è un ritorno al passato, rivisitato dalle contaminazioni linguistiche dell’italiano corrente, dove sono presenti le difficoltà del tempo e dell’economia, allorquando il boom non riuscì ad essere cosa di tutti gli Italiani e soprattutto in Sicilia, dalla cui terra ancora scappavano i poveri lavoratori per le terre del nord Italia e dell’Europa. Ma ritornando a L’acidd(r)azzi di lu vintannali, dopo un inizio direi metafisico dove s’invocano le porte del cielo, il poeta segnala le difficoltà del vivere dei poveri contadini, nella cui vita regna ancora la malatia di lu pitittu o, meglio, l’epuca di cu mancia e cu talia. Narra le vicende dei disoccupati che lavorano una settimana l’anno e poi le malefatte dei bottegai, ladri ed infingardi. Non dimentica l’artigianato morente ed invita il fabbro a cambiar mestiere, a far il nuovo mestiere di benzinaio sottolineando che “è tempu di cu strazza strazza,/ risorvi nenti cu lu travagghiari”. E poi alla fine de L’acidd(r)azzi ritorna a pubblicare Attualità che aveva presentato al premio e che la gente gradiva molto nelle piazze. 31 Menestrello e cantastorie, il poeta è consapevole che occorre diffondere nelle masse il messaggio della poesia per risvegliare dal basso i desideri sopiti della verità e della giustizia. Culcasi uomo è rimasto scottato dalla vicinanza con l’istituzione Regione, conosce bene gli ingranaggi della politica e della burocrazia, per la sua professione di titolare d’impresa e per la sua capacità di conoscenza della storia della sua terra. Serafino Culcasi nasce poeta e si risveglia alla poesia nel quinquennio dal 1965 al 1970, periodo nel quale scende nelle piazze e stampa una diecina di libretti di poesia che diffonde a piene mani nell’isola aiutato in questo da volenterosi amici che girano per le strade e i paesi diffondendo la satira mordace del poeta che cerca luce tra le tenebre che attanagliano i poveri contadini, artigiani, diseredati siciliani travolti di continuo dalle sventure che possono assumere ora il volto del terremoto ora di un’alluvione improvvisa che travolge strade e case. Il poeta scava ed apre miniere di ansia, le voci della fame lui sente davvero, perché l’ha vissuta nei giorni tristi della sua esistenza grama, quando il suo lavoro è stato distrutto dalla burocrazia e dai politici. In Poesie siciliane stampato dalla tipografia “La Combattente” nel 1966-67, seconda fatica nella quale qualcosa si ripete e si riscrive in maniera più corretta, è il dramma dell’alluvione a Trapani che il poeta mette in risalto con una immediatezza velocissima che non lascia respiro; Lu trapanisi scuncirtatu mette in evidenza i danni dell’alluvione dal Borgo Annunziata alle saline, prosegue il suo canto corale ed accorato ne La vigilia di lu voto dove invita alla rivolta: “quannu vennu li grossi a cuntrattari/ nun c’iti nudd(r)u, lassatili vuciari”. Le rime baciate, ottave, terzine, quartine si innalzano al di fuori di ogni prosodia, svelano una inquietudine tremenda, i cittadini dal basso vengono innalzati a protagonisti, come il villanello che aspetta sempre dietro lo sportello il suo benedetto certificato; anche ne Lu sciopiru di l’impiati comunali vi è una continua rincorsa verso tutte le verità, ma prevale una pietas antica verso le classi subalterne, i poveri della città. Ma Serafino, che ha un lungo passato nella società ed ha vissuto l’esperienza del Ventennio, racconta ne Lu vintinnali passato le vicende amarissime della guerra e della fame degli Italiani e le storture del regime: “e lu populu italianu/ si emancipava pianu pianu/ ‘nmezzu fru32 menti e la farina/ ci ammiscavano la rina”; “pirchì a Roma ‘a capitali/ un si mangiaru lu stivali,/ si lu mangiaru e lu digireru/ tuttu è tranquillu un pari veru!”. Penetra il poeta nelle stanze della storia, degli accadimenti più terribili della nazione dal fascismo alla democrazia, conosce bene il mondo e gli uomini e la sua voce si innalza come un grande coro di una umanità dolente, la sua voce è una denuncia continua, sia che parta dal passato più remoto degli antenati, sia che arrivi alla stazione della società odierna, attuale sempre, specialmente oggi nel tempo delle vacche magre e della grande crisi. Serafino canta la sua Paceco e la sua Trapani, le due realtà dove ha vissuto la sua esistenza intellettuale e morale, dove ha visto, osservato le strade, le case, gli uomini e le istituzioni. Ma a questo punto mi si affollano nella mente i ricordi, i tanti ricordi della giovinezza. Conobbi Serafino in quegli anni inquieti ed ansiosi della mia vita universitaria e così a poco a poco iniziai ad apprezzare i suoi versi; in quel tempo lavoravo al giornale “Il Faro” e alla casa editrice “Celebes” come correttore di bozze, cercavo di guadagnare qualche cosa per sopravvivere e così incontrai il poeta che desiderava stampare in maniera più adeguata le sue opere, ne corressi le bozze, tradussi qualche componimento come Lu Tirrimotu (scritto sull’onda dell’emozione dell’evento) e scrissi qualche introduzione. Niente di trascendentale. Mi legava a Serafino la sua amicizia per mio zio Gasperino che era morto giovinetto dopo una violenta partita di pallone. E poi Serafino aveva un millecento nero targato Tp 8692. Ed io non sapevo guidare e lui mi insegnò a guidare: che giorni tremendi e bellissimi! Il primo dei volumetti che riesce a stampare presso la tipografia “Celebes” del prof. Costantino Petralia con il logo “Edizioni il Disco” è Li Partiti e li Prumissi. Il poeta nel descrivere Li Partiti non ha limiti alla sua satira: “Fannu sulu fudd(r)a ppi acchianari/ genti d’ogni cetu e d’ogni razza/ chistu è lu tempu di cui strazza strazza/ miatu cu sapi mugghi rutuliari/ navota li cchiu grossi e li chiù dotti/ tinianu la distanza e lu puduri/ ma ora parlamu cu crianza/ nun c’è cchiù né dicoru e né distanza ” . Nessuno riesce a sfuggire al poeta che, sotto la metafora di un fantastico zoo, accusa tutti trasformandoli in animali rapaci che s’ingozzano in un grande banchetto; attacca i partiti e la corruzione: 33 “corruzioni prumissi vani/ democrazia cristiana/ dd(r)a c’è tutta e pappa sana/ l’antipastu li banani/ la sosizza, capuliatu/ vinu bonu a damigiani/ burru friscu e la fillata/ c’è na gran tavula cunzata”; “democrazia si un granni pilastrini/ l’avvirsariu vulcanu senza rotta/ chi travagghia cu la forza e l’ammuttuni/ di lu crateri la so vucca scotta/ damuci a su pilastru un trantuliuni/ viremu dopu comu si diporta/ s’un si metti a signu di ragiuni/ ittamulu ‘nterra ca secunna lotta”. Incita addirittura alla rivolta, alla rivoluzione, il poeta è consapevole del destino dei poveri cristi, li commisera con la sua voce piena di grande umanità, il dolore è dentro il suo cuore, lui conosce la società amara che non dà scampo ed in Munnu scilliratu alta è la sua elegia: “poviru nicu misiru ed afflittu/’nta stu munnu chi nasci a fari,/ manci picca, tintu, malirittu/ nudd(r)u chi ti veni a cunzulari/ t’affanni la to vita, ti cunzumi/ comu lu pappagghiuni ‘nta lu lumi”. Tutti i lamenti trovano posto nella sua poesia, dalle pensioni alla ricerca del posto, racconta tutti i sotterfugi di una società malata, vive la maledizione del tempo. Ancora sento la sua voce, in piazza Saturno, a Trapani, dove una folla immensa si raduna per ascoltarlo come quando arrivavano le celebrità nazionali. Nel giugno del 1969, dopo aver fondato un piccolo Centro Studi intitolato a Cesare Pavese, avevo concordato con l’amico americano Nat Scammacca, che si era ormai stabilito a Trapani, di realizzare un recital poetico, una festa, una kermesse in piazza a Paceco per radunare tutti i poeti dell’“Antigruppo”, una Associazione ideale e senza sede di poeti e scrittori, di rivolta contro l’establishement letterario ed editoriale del nord. Sarebbero venuti Santo Calì, professore di Linguaglossa, che presto sarebbe diventato poi una celebrità nazionale, il più grande poeta in lingua siciliana, Antonino Cremona, l’avvocato agrigentino, il poeta Crescenzio Cane, maestro vigile urbano di Palermo, Rolando Certa di Mazara, il professore Gianni Diecidue da Castelvetrano, Scammacca l’americano, Franco Di Marco, il medico trapanese, ed io che ero il più giovane. Che speranza c’era di radunare gente? Nessuna! Allora pregai lo zio Serafino di introdurre il raduno, recitando lui stesso, in piazza, le sue poesie in onore degli amici che sarebbero arrivati da ogni parte dell’isola. Serafino, uomo generoso, accettò l’invito e la sera del recital la piazza, la nostra piazza era strapiena: oltre un migliaio di persone erano venute ad ascoltare i poeti, ma soprattutto Serafino 34 Culcasi che con la sua voce stuzzicante e alata attirava la gente, la ammaliava e l’affascinava. Potenza della poesia popolare, in “lingua pacecota” certamente contaminata da quella nazionale, ma che era il risultato eccezionale della coniugazione di tre microcosmi che avevano costituito l’essenza vera della società pacecota: la drepanense, l’ericina e la lilibetana. La miscela bastarda era la voce della mia Paceco, era la sua voce, di Serafino Culcasi, da secoli cristallizzata nelle sue vene. E segue Munnu di festa, pubblicato nel 1967, dove è rilevante un piccolo poemetto intitolato Lu contadinu sicilianu, elegia per il piccolo villanello pacecoto, affittuario o piccolo proprietario, ma soprattutto per il bracciante, con la sua zappa, disprezzato da tutti o, meglio, non tenuto in conto nella società del borgo, al quale fa dire: “s’un fora ppi mia, saria tuttu desertu/ chista è la prima arti principali/ s’un siminassi frumentu a celu apertu/ mangissimu erba ‘nsiemi cu l’armali/ passu la notti, lu jornu affaticatu,/ zappu la terra, nudd(r)icu l’armali,/ mortu di lu friddu e aggragnatu,/ infini fazzu ‘na vita bistiali,/ tuttu pi manteniri lu Statu!”. Ed alla fine un evviva ed una speranza per i prodotti siciliani da esportare all’estero ed un risanamento all’insegna di una Regione Siciliana rinnovata con il suo Presidente. Il poeta si era illuso, certamente, ma non si vive forse di speranze dure a morire? E le poesie di Culcasi si leggevano giornalmente negli uffici degli assessorati regionali dove era molto conosciuto ed apprezzato. Potenza della poesia, in una Palermo ormai scomparsa e che presto sarebbe stata assaltata dal cemento e dalla nuova mafia. Non pensate che Culcasi fosse un poeta incolto, assolutamente: era un uomo che leggeva ed era aggiornato sulle dinamiche della società civile del suo tempo. Nell’antologia poetica intitolata Carusellu il poeta Culcasi si fa cronista della sua gente, scende nella piazza grande del suo borgo natio e parla ai vecchi che si stendono al sole sui sedili; dialoga e denuncia i mali che affliggono i poveracci, li fa parlare e racconta tutto quello che vede, fa sentire l’afflizione dei vecchi combattenti della prima guerra mondiale che non hanno ricevuto niente dallo Stato, nessuna ricompensa (per inciso, qualche anno dopo il 1970, i vecchi avrebbero ricevuto il cavalierato di Vittorio Veneto e una simbolica pensione, ma ben presto sarebbero tutti scomparsi per l’estrema età). Cerca l’egalitè 35 che non viene, dice, neanche durante la notte nei sogni e declama la sorte di tutti i martiri dal Cristo che morì in croce fino alle morti illustri più recenti, per quel tempo, come la triste sorte dei Kennedy, di Martin Luther King, concludendo che “cu lotta pri lu beni di li populi,/ mori come ammazzaru lu Signuri!”. Ma quando descrive e dipinge il suo paesello, la sua voce s’innalza alta nel cielo azzurro e tira sospiri d’amore: “guardu stu me paisi ch’è n’amuri/ tagghiatu cu lenza, chiummu e squadru/ comu lu stissu di guardari un quadru,/ fattu d’un gran celibri pitturi./ Strati dritti,larghi e squadrati,/ anguli perfetti e ripuliti/ fatti di tipa ‘ntagghiati e rifiniti/ hanno sfidatu la so’ antichitati./ Spissu lu cuntemplu e mi riflettu:/ è un paisi simmetricu e pirfettu!/ a centru di lu cori du paisi/ c’è na chiazza suspisa e ben squadrata,/ cu tri scaluneri e na firrata/ cu corduli di marmu ben suspisi,/ sembra na gran villa sta pineta/ criata cu tantu sintimentu/ a centru c’esti lu gran munumentu/ cu l’aquila tristi e scuntrubata / e la bedd(r)a chiesa in arancione fina/ di la prutittrici, Santa Caterina”. Non è soltanto una cartolina per i turisti, vi è la consapevolezza architettonica ed urbanistica del paese, nato ai primi del Seicento come tanti altri paesi nuovi di Sicilia, voluti dalla pura ragione come le città ideali del Rinascimento. Non a caso Serafino Culcasi, uomo intelligente, era un ottimo costruttore di case e di strade con tutto quello che ne seguiva. Ma in altre composizioni per il suo paese, ne faceva rilevare anche i difetti con dolcezza e delicato furore, mali come la mancanza d’acqua oppure le intemperanze dell’energia elettrica che per lunghi decenni appariva e scompariva in alternanza per la magra condizione degli impianti. Viene spontaneo domandarsi quanta capacità avesse l’uomo poeta e l’uomo della società di approfondire con il linguaggio vernacolare, di scavare nei profondi pozzi della verità il senso logico della sua vita e dei suoi simili, per ritrovare sprazzi di luce, alla ricerca di una condizione umana che non fosse quella dei dannati della terra per dirla alla Frantz Fanon. Quello che più colpisce nell’esame dell’opera di Serafino Culcasi è la consapevolezza delle dinamiche storiche attraversate dagli Italiani nell’arco di un secolo, dall’arrivo di Garibaldi fino alla seconda guerra mondiale, alla liberazione dell’Italia dalla tirannia nazifascista. Una ricerca che l’autore compie minutamente nella sua analisi. Entra il poeta 36 nelle stanze della storia italiana con un poemetto eccezionale di grande umanità, Sicilia marturiata, composto da 58 ottave. Rime baciate dove si snoda, come in un lento rosario, la storia italiana da Garibaldi alle guerre d’Africa, dall’Italia giolittiana alla prima guerra mondiale, con il sacrificio di tantissimi Siciliani. Il poema prosegue con il ventennio fascista e poi con la guerra e l’avvento della Repubblica fino alla nascita dell’autonomia siciliana: “Parla lu Duci, populu ascultati/… l’Italia conquistau l’imperu./ Musica festa strati strati/ mi truvava nmezzu puru eu/ di sira cu li ciacculi addumati”; “giovinotti, liggiamu certi voti/ nte mura scritturi allapazzati/ si li culli sunnu vuoti/ la patria nvecchia e nni dicati”; “l’Italia nudd(r)icava li surdati/ all’età di vint’anni, nto cchiù bellu/ nvagunati e mannati a lu macellu”. Un esame critico che esulava dalle ideologie, dalle quali il poeta voleva rifuggire non per un certo qualunquismo o per populismo, ma per una paura innata, atavica, tipica dei Siciliani che si portavano sulle spalle retaggi di dominazioni ed un innato desiderio di autonomia. Culcasi racconta la vita dura del trapanese durante la guerra: “mentri niautri, nta lu trapanisi/ quantu bombardamenti, quantu morti!/ nmezzu li maceri, tisi tisi/ li casi svintrati e senza porti/ curriamu versu fora, li sfullati/ durmennu terra terra e strati strati/…ci fu cu capitau qualchi pagghiaru/ cu mezzi mura,vecchi, senza tettu”. Il poeta prosegue il suo racconto con l’arrivo degli Americani sulle famose camionette e relativa distribuzione di cioccolato e caramelle, con i falsi film sulla liberazione delle città e dei porti e l’arrivo degli aiuti da parte dei parenti americani. Tutto viene esaminato con cura, il ricordo non può essere cancellato: “gli auguri a chidd(r)i chi turnaru/ pi cu morsi n’arristau lu turmentu/ li nostri capi li cummimuraru,/ stannu ncisi nta lu Munumentu”, (“caddero per risorgere in una luce vermiglia di gloria”, cantava la retorica fascista); l’analisi della storia conduce ad amare constatazioni, a conclusioni tristi e sconsolate: “la Sicilia pi cent’anni abbannunata/ abbannunatu ogni sicilianu/ fu di Garibaldi libirata/ e cunsignata a lu nostru suvranu/ nun riciviu mai na cazzulata!/ li navi salutava di luntanu/ pagannu forti tassi e mpidimenti/ a binificiu di lu continenti”. Culcasi osserva perfino le deformazioni urbanistiche e poi dialoga sulla emigrazione e sulla ricerca del posto e sulla condizione disperata dei poveri e degli afflitti Siciliani. E nel paragone finale, la Sicilia è ormai una donna ma37 tura, granni, ha vent’anni e la invita a ripulirsi la veste dalle lordure della corruzione e della mafia. Però non tralascia di elogiare la Sicilia come una ragazza tutta bruna e piena di calore, bella e dolce: “E tu sicilianedd(r)a tanta bruna,/ picciridd(r)uzza china di caluri/ nfucata di lu vulcanu tradituri/ l’occhi castagni, la facci di luna/ la to vuccuzza, lu pettu, li mascidd(r)i/ biatu cu ti vasa e ti cunnuci/ chi di peri finu a li capidd(r)i/ siciliana, si bedd(r)a e tutta duci!”. Nell’arco di quasi un decennio Culcasi, negli anni cruciali Sessanta, denuda la sua anima, fa uscire fuori dalle sue viscere tutte le cose accumulate per lunghi anni, fa rivivere la sua giovinezza e spezza una lancia per le classi subalterne, cerca luce dove c’è tenebra, entra nelle miniere dell’anima siciliana per non morire e non far morire quelli che come lui hanno sofferto e continuano a soffrire in una società malata che gronda sangue e miseria. Ecco chi era il poeta Serafino Culcasi, il siciliano disincantato ed enragé, ribelle, primitivo e colto, di una cultura antichissima, fatta di antropologia e di civiltà materiale, ma anche di una cultura delle dominazioni che avevano fatto della Sicilia una mistura di dolcezze e di veleno. Non accetta mezze verità, è solo contro tutti, pure quando subisce ingiustizie piccole, stupide, pure quando combatte contro i suoi stessi colleghi, siano essi il celebre Buttitta oppure il piccolo poeta paesano che era stato per ideologia vicino al potere e da questo era stato onorato anche meritevolmente. Culcasi tace poi per lunghi anni, parla soltanto ai suoi vecchi nella piazza attorno ai tavolini o ai sedili, parla in maniera semiseria dell’evoluzione dei costumi, di tutte quelle cose che osserva quotidianamente e su cui sente di dire la sua, o in allegria o in tristezza. Paragona la genealogia dei poeti popolari pacecoti ad un grande albero, “un’arvulazzu chi ogni anno duna granni contributu, riccu d’arti e di fantasia”, cita i suoi antenati poeti e racconta, novello Foscolo, i suoi viaggi al cimitero comunale dove va a visitare la tomba “di lu pueta forti, chiù sinceru, Peppi Culcasi lu silinziusu” mai commemorato dal Comune (“Pi na ricurdanza nudd(r)u chi ci pensa”). Sì, è vero, anche quando il poeta si arrabbiava ingiustamente contro chi non aveva potere e soldi per celebrare. Uomo libero il nostro poeta, piegato infine da una senescenza crudele. Culcasi aveva dato sempre fede al suo spirito, non aveva cercato 38 onori e prebende, ma la libertà. Ma una sera di inizio di questa primavera si è addormentato e non si è svegliato più, aveva trovato una soluzione inaspettata per la sua uscita di scena: silenziosamente è scivolato fuori dalle quinte del gran teatro del mondo, abbandonando la scena terrestre, entrando a far parte della storia dell’umanità di questa città come uno dei suoi testimoni più alti e più liberi. ALBERTO BARBATA Avevi iniziato per gioco Come gli antichi poeti omerici Cantori di gesta esaltanti Poi la vita ti condusse altrove Non è possibile Non credere alle storie della tua gente Storie antiche di miseria Gente indomita resistente La tua missione Cantare i poveri cristi Del tuo paese della tua Sicilia Suona un organino E tu sali dal vico finale Dove finiva o iniziava il paese Dalla tua vecchia casa La più antica, la più vera La casa che ti dette il principe Per coprirti Laggiù la pila E la piana una visione Di un mondo antico In fondo il sale e gli arabi L’antica città E tu sali Serafino In un velo bianco Tra gli angeli poveri Nudi che cantano le tue parole. U zzu Sarafinu A.B. 39 Oltre che da Alberto Barbata, Serafino Culcasi è stato anche ricordato dal giornalista e poeta Pino Ingardia. La commemorazione si è conclusa con un intenso e plaudito recital di poesie di Serafino Culcasi lette da Vita Finocchio, Peppe Catalano e Giovanni Ingrassia che, accompagnati dal maestro Franco Foderà, si sono così alternati: Acidd(r)azzi di lu vintannali (P. Catalano); Attualità (G. Ingrassia); Lu Tirrimotu (V. Finocchio - P. Catalano); Tempi passati (V. Finocchio - P. Catalano - G. Ingrassia); A Paceco (V. Finocchio); Sicilia marturiata (P. Catalano); Rusariu all’italiana (P. Catalano V. Finocchio); Sciopiru (G. Ingrassia); C’è na famigghia cchiù dd(r)a di Catanzaru (G. Ingrassia); La vigilia di lu votu (G. Ingrassia); Cercu pani (V. Finocchio); A lu defuntu pueta Giuseppe Culcasi da Paceca (P. Catalano). ndr Recital di Serafino Culcasi nella piazza di Paceco (foto C. Di Bella) Un momento della commemorazione di Serafino Culcasi (foto C. Di Bella) 40 RICORDI DI PACeCO Quando un uomo, ormai avanti negli anni, ha raggiunto i principali obiettivi della vita, la sua mente, sgravata da impegni professionali, può abbandonarsi piacevolmente a rivedere il passato e i ricordi che preferisce sono quelli più lontani, quelli dei periodi infantile e adolescenziale, fatti di episodi stranamente ancora molto vivi e forse tali perché sono stati per lui i più significativi. Sono nato nel dicembre del 1944 a Torniella di Roccastrada, un paese della provincia di Grosseto, dove mio padre era carabiniere. I miei genitori, Alberto Barraco e Vita Quartana entrambi di Paceco, si erano sposati da poco più di tre anni e avevano già avuto una bambina, Francesca come la nonna paterna, nata nel loro paese di origine. Io ero nato in Toscana, ma le tradizioni venivano rigorosamente rispettate e il mio nome non poteva non essere quello del nonno. Le abitudini della giovane coppia siciliana richiedevano necessariamente la ricerca di un’integrazione con quelle locali ma, in famiglia, il dialetto parlato era quello siciliano e i figli apprendevano con gioia, curiosità e orgoglio tale conoscenza. Non solo: la mamma non tradiva mai le sue origini ed ecco che sulla tavola, durante le festività, non mancavano mai i cannoli con la ricotta e gli agnidd(r)uzzi pasquali ricchi di zucchero. La cuccia poi, cereali lessati e conditi con il vino cotto, costituiva il piatto principale del 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, protettrice degli occhi. A cavallo degli ultimi anni 1940 e ’50, mamma, molto affezionata agli anziani genitori, peraltro non più in ottima salute, appena terminati gli impegni scolastici dei figli, si trasferiva in Paceco per l’intero periodo estivo. Qui e in particolare in contrada Porticalazzo ove il nonno aveva una casa di campagna con oliveto, vigneto e giardino di agrumi, iniziava la vera vacanza. Era per me il periodo più bello dell’anno e i ricordi di quei giorni sono sempre presenti nella mia mente e nel mio cuore con forza e nostalgia. Le giornate più belle erano quelle che trascorrevo in campagna insieme a nonno Nino. Lui stesso, al mio arrivo, mi consegnava una piccola zappa, u lasciunedd(r)u, che significava per me il riconoscimento di quel senso di fiducia e stima che si ha nei confronti di un collaboratore e io, con quell’attrezzo, mi sentivo grande e capace, in grado di aiutare il nonno. L’uso di quella zappa, che anno dopo anno appariva ai miei occhi sempre più piccola, interessava varie attività, ma la più gradita era sicuramente la ricerca di attuppatedd(r)i, chioccioline marroni chiuse da un naturale tappo bianco, che 41 si trovavano nelle vicinanze della base degli olivi, a pochi centimetri di profondità. Tali prelibatezze venivano accolte con gioia dalle donne di casa che poi, a richiesta del nonno, le cucinavano. Talvolta avevo l’incarico di portarmi vicino alla rara, il cancello di ingresso della proprietà, per segnalare a mia madre il passaggio del venditore di pesce sullo stratuni di Salemi. Anche questo, per me, era un incarico importante. Mi recavo sul posto un po’ prima del presunto transito e ciò mi consentiva di annacarimi con piacere sul cancello metallico, aprendolo e chiudendolo più volte. La vista del pescivendolo, un uomo con cappello di paglia e in canottiera che arrancava su una vecchia bicicletta corredata di una cassetta in legno contenente il pesce, interrompeva il mio dondolio e mi portava a farmi notare dall’uomo agitando le braccia nonché a correre da mia madre per informarla dell’evento. Quelli erano i giorni della pasta con le sarde o degli scurmi arrustuti ed erano giorni di festa. Non molto distante dalla casa si trovava un pozzo che forniva buona acqua e in quantità sufficiente alle esigenze della campagna. Annessa al pozzo, la senia assicurava il sollevamento dell’acqua alla gebbia da dove, per gravità, il nonno procedeva ad annaffiare il giardino di agrumi. Era un rudimentale meccanismo che comunque suscitava in me notevole interesse, se non altro per la presenza delle due ruote dentate che trasformavano il movimento circolare di un asse verticale in quello orizzontale di altro asse. Il primo movimento era ottenuto dalla fatica del povero sciccaredd(r)u che assicurato a una barra si muoveva in tondo lasciando sul terreno la traccia perfettamente circolare di un viottolo; il secondo, facendo scorrere una catena di cadd(r)i metallici, consentiva a tali recipienti di raccogliere l’acqua del pozzo, sollevarla e poi svuotarla su un piano inclinato da dove veniva convogliata nella gebbia. Ricordo, inoltre, che spesso il povero sciccaredd(r)u si arrestava, forse perché stanco o forse anche perché, pur asinello, aveva capito che camminando non stava andando da nessuna parte ma girava soltanto intorno a un asse. Un altro passatempo piacevole, dedicato alla tecnica, era la realizzazione di carretti in miniatura, utilizzando le pale delle piante di fichidindia: dalle pale, facendo attenzione alle spine, ricavavo le ruote, il pianale e le sponde che assemblavo poi con i frammenti di una canna. Due segmenti più grandi, sempre di canna, applicati sul pianale quali stanghe, definivano la parte anteriore del carretto. Il vivere in campagna mi consentiva di osservare e considerare alcune cose nuove rispetto a ciò che ero solito vedere in Toscana. Ricordo, ad esem- 42 pio, la coltivazione della vite a cespuglio e quell’uva dagli acini dorati, succulenti e molto più saporiti. Mi meravigliava la pianta di cotone e quel bocciolo che, schiudendosi, produceva un batuffolo bianco di un prodotto la cui origine io credevo fosse totalmente diversa. Mi stupiva la strana forma a clava della cucuzza longa e apprezzavo molto il gusto dei suoi tinnarumi che mi venivano serviti lessati o quale condimento per la pasta. Gli spostamenti dalla campagna a Paceco, dove il nonno aveva casa in via Lonero, avvenivano per lo più con il carretto. Talvolta, per brevi tratti, mi veniva permesso di tenere le briglie dell’asinello e sentirmi così provetto conduttore. Prima di entrare in Paceco, però, la guida tornava sempre al nonno anche perché la povera bestiola, giunti all’altezza delle prime case del paese ove si trovava un abbeveratoio pubblico, lo raggiungeva decisamente di sua iniziativa noncurante di eventuali diversi comandi. Le strade, percorse quasi esclusivamente da carretti, erano permeate di odori acri ma anche di profumi derivanti dalla cottura del pane che sono rimasti in me sempre vivi e indelebili. Notavo con tristezza che molte porte d’ingresso delle abitazioni mostravano una striscia di stoffa di colore nero, applicata in diagonale in segno di lutto per un familiare defunto. Nessuno toglieva quelle strisce, solo il tempo ne determinava il degrado e la successiva scomparsa. Le vie offrivano molti negozietti a conduzione familiare ed erano numerosi i venditori ambulanti, specie quelli di frutta e verdura, che spingendo a mano un carrettino abbanniavanu a gran voce, pubblicizzando la loro merce. Il lattaio, poi, suscitava in me molto interesse in quanto diverso da quello toscano che forniva bottiglie preconfezionate. Armato di un bastone e alla guida di alcune capre, egli transitava lungo la via e mungeva all’istante il latte che di volta in volta gli veniva richiesto dalle massaie. Non mancavano le passeggiate e il gioco con altri bambini nella piazza del paese. Nella circostanza era doverosa la visita alla chiesa della Matrice dove la mamma, ogni anno, ripeteva a mia sorella e a me che in quella chiesa si era sposata con papà. Poi, sempre in piazza, era rituale la degustazione di un delizioso cono gelato al gelsomino. Talvolta i trasferimenti dalla campagna a Paceco avvenivano a piedi, seguendo la scorciatoia delle Rocche Malummeri. Queste passeggiate venivano intraprese al tramonto, ma prima di mettersi in cammino era necessario dedicarsi alla confezione delle sponze da donare alle zie, vale a dire applicare numerosi boccioli di gelsomino ai rametti secchi di un’erba a forma di ombrellino che al mattino successivo, nello schiudersi, avrebbero formato un insieme bianco di fiori dal profumo indimenticabile. 43 Alcune sere, dopo cena, in compagnia della mamma facevamo visita ai parenti. Notavo, transitando in una Paceco poco illuminata, che molte famiglie si sedevano davanti alle loro case, alcune abbellite da pergolati, alla ricerca di un po’ di fresco e riposo. Anche i carretti, dopo una giornata di lavoro venivano parcheggiati davanti alla casa e davano mostra della loro bellezza, sfoggiando i loro numerosi intarsi e la vivacità dei colori. L’estate trascorreva velocemente e in settembre papà scendeva a Paceco per trascorrere la sua licenza e riportare poi la famiglia in Toscana. Prima di ripartire, però, era consuetudine recarsi nella bottega del barbiere che, ricordo, accoglieva me e mio padre con gioia e affettuosità. La circostanza, oltre ad assicurare il taglio dei capelli ad entrambi, consentiva a mio padre di essere aggiornato sugli eventi di maggior rilievo verificatisi in Paceco nell’anno trascorso e a me di ricevere in dono dal barbiere un meraviglioso temperino che custodivo con cura. Il ritorno in Toscana coincideva con l’inizio di un nuovo anno scolastico nonché con la quotidianità in una regione, sì, bella e ospitale, ma pur sempre priva del calore che Paceco mi offriva. Il grande mio desiderio era quello che l’estate successiva tornasse al più presto. Poi, con la perdita dei nonni e il mio ingresso in Accademia Militare al fine di seguire le orme di mio padre nell’Arma dei Carabinieri, le visite in Sicilia si sono drasticamente interrotte per ben quarant’anni. Da ufficiale inferiore e superiore avrei tanto gradito una destinazione in Sicilia, ma non è stato così. L’Arma mi ha impiegato per lungo tempo in varie sedi esclusivamente al centro - nord, ma il ricordo di quelle calde estati pacicote è stato sempre vivo, attuale, bello e profondo. Quello stesso profumo di gelsomino, la cui pianta ho imparato a coltivare e a riprodurre, per farne dono agli amici siciliani, non mi ha mai abbandonato, rafforzando sempre i miei ricordi. Intorno agli anni 2007 - 2008, con il grado di Generale di Corpo d’Armata, ho avuto l’onore di reggere il comando dell’Interregionale Carabinieri “Ogaden” con sede in Messina e competenza sulla Sicilia e sulla Calabria. Mi sentivo un po’ a casa anche perché, finalmente e piacevolmente, sentivo pronunciare il mio cognome in modo corretto, senza errori di accento. L’amore per le proprie origini è grande e nessuna distanza e nessun arco di tempo può affievolirlo ed io, pur anagraficamente toscano, amo la Sicilia profondamente e con il cuore. GIUSEPPE BARRACO 44 SATIRA - POLITICA - CULTURA Flash sulla vita sociale nei centri di aggregazione del nostro paese Scavare al buio nel passato è sempre aleatorio. Scoprire all’improvviso tracce di qualcosa che non stai cercando è assolutamente emozionante. L’idea di riportare alla luce, per quanto possibile, imprese satiricoculturali di baldi giovani intellettuali di casa nostra mi è venuta per caso riordinando fascicoli di vecchie carte lasciatemi in eredità da mio marito, cultore indefesso del passato e pertanto grande spigolatore di documenti d’epoca che scovava casualmente presso amici che ne erano in possesso per il medesimo fascino della memoria. Particolarmente emozionanti i reperti cartacei di quasi settant’anni fa, ancora religiosamente custoditi, di un periodo di storia (che a molti di noi sicuramente non appartiene) dove la capacità intellettiva e l’ingenuità giovanile si legavano ancora in un tutt’uno nell’esprimere la genuinità del pensiero, l’ironia sottile, la competizione, il piacere della condivisione della vita di gruppo a fior di scritti. Il progetto è ambizioso e intrigante. Ma io sono tosta: mi ci proverò. * * * Il tempo delle celie è acclarato che i primi fermenti culturali, politici, sociali nascono e si sviluppano all’interno di gruppi giovanili, quasi sempre di studenti universitari o comunque provenienti da ambienti più o meno colti. è acclarato altresì che all’interno di queste aggregazioni giovanili nascono, e si formano, spiriti eletti che nel corso della vita rivestiranno panni di poeta, scrittore, attore, politico, avvocato, medico, docente, musicista o altro ancora, epperò tutti insieme, da giovani intellettuali aggregati in circoli culturali, hanno dato vita a manifestazioni di atteggiamenti comportamentali all’impronta di atti burleschi, di raggiramenti, di umorismo anche inconsciamente crudele, a danno l’uno dell’altro, in una gara di “ botta e risposta”. La Storia si ripeterà all’infinito. E così è stato anche nel nostro paese. è l’anno 1946, la data più lontana riscontrata da cui inizierò, con documenti certi, l’excursus nei meandri dell’intellighènzia dell’epoca. Siamo ai prodromi di una lunga serie di scritti nati qua e là, non sempre ne45 cessariamente all’interno di organizzazioni ascrivibili a veri e propri circoli culturali, ma spesso scaturiti da gruppi giovanili sciolti da etichette specifiche, o semplicemente da occasionali aggregazioni di vogliosi ragazzi con l’unico scopo di raccontare, di poetare, di esserci. Dunque il 1946. Nasce “ NUOvA CRITICA”, Rivista Settimanale di Varietà, datata 11 agosto. è contrassegnata dal numero uno, ma probabilmente resterà un numero unico nato con le migliori intenzioni di continuare e poi abbandonato. Infatti non ci sono tracce di altre edizioni. La “NUOVA CRITICA”, ben formulata nella stesura e nell’effetto visivo di copertina, è formata da quattro fogli spillati in alto di cui il primo (che, appunto, vuole assomigliare ad una copertina) è manoscritto: probabilmente per via del titolone, elaborato in trasversale a caratteri cubitali e disegnini di abbellimento all’epoca non componibili altrimenti se non a penna. I tre fogli successivi sono dattiloscritti con sbiadito inchiostro blu e appena appena leggibili. La rivista apre con alcune battute spiritose e stuzzicanti l’amor proprio del gruppo di amici e compagni di avventure (soprattutto notturne. Citati, tra le righe degli scritti: Turi Bologna, Peppino De Luca, Pietro Basiricò e altri), raggruppate sotto il titolo abbastanza significativo di Alofari della mia Serra. La firma è siglata M.B. ossia Mino Blunda. E ancora di Mino Blunda sono le due pagine successive occupate brillantemente da un racconto, Incontri, dal quale spicca già il gusto letterario dell’autore non ancora ventenne: descrittivo, ironico, scenografico(1). Un accenno tratto da Incontri, che suppongo essere “opera prima” (probabilmente sconosciuta da tutti noi in assoluto) di Mino Blunda: “Notte di gennaio, le undici e mezzo, vento fortissimo, freddo; gli alberi si abbassano per sfuggire alla furia del vento; alcune foglie si rincorrono, mulinando, dopo si disperdono. Dal cortile a fianco la Matrice, folate di vento portano l’olezzo dell’urina depositata, durante la giornata, dai cafoni. Le lampade stradali, scosse dal vento, lanciano sprazzi di luce, ora qua ora là, lasciando ora quest’angolo ora quell’altro, immersi in una sinistra oscurità. I pini agitati dal vento, somigliano a strani esseri preistorici, a ombre dannate; un cane passa correndo e rientra nell’oscurità, da dove era uscito, una pioggerella minuta, fitta, persistente cade! Notte di lupi e di ladri, dice un cafone che si era attardato […]. Il racconto trasuda di humour nero, di falsi rumori e di silenzi sospetti, di paure, di parole smorzate, di fantasiose presenze mafiose nel buio agghiacciante del vicolo della Matrice nella tarda ora dell’incontro: in46 somma strabocca di tutto ciò che può terrificare gli increduli amici, mentre l’autore, nascosto dietro l’angolo, deliziosamente se la ride. In calce al racconto, però, è lo stesso M.B., probabilmente consapevole di aver calcato un po’ troppo la mano, che si scuserà con Turi Bologna (gli avrà tirato per primo, il caro amico, qualche colpo basso? Ahinoi, non lo sapremo mai!) chiamato suo malgrado ad interpretare la parte del credulone raggirato. Di certo il ruolo assegnatogli non sarà stato di suo gradimento. Un breve salto nel tempo e ci troviamo negli anni Cinquanta che, al pari del decennio successivo, saranno fra i più prolifici di produzione giornalistico-burlesca: assai spesso dal linguaggio metaforico, sempre in anonimato, scarabocchiata a mano o appena passata al tocco di una scarsa Olivetti d’epoca remota. “L’OSSeRvATORe”, rivista quindicinale d’informazione, sottotitolo: Passatempo del Circolo “Giosuè Borsi”, nasce, manoscritto, il 24 novembre 1951. è un largo foglio di carta quadrettata, con titolo dai caratteri cubitali tirati a matita rossa e una serie di grandi occhi ammiccanti disegnati qua e là, lungo la fascia in alto, fra gli spazi del titolo. Gli autori della testata giornalistica sono ovviamente anonimi (ma oggi sappiamo trattarsi di due baldi giovanissimi intellettuali: Rocco Fodale e Franco Vacatello e un non identificato M.P.). La sostanza degli articoli, a partire dal fondo, pretende di riuscire a camuffare il sottile umorismo, di cui erano maestri, assumendo negli scritti un’aria nuova, e sospetta, di serietà: ma il tono ammiccante e ridanciano dell’informazione è già chiaro nei disegni che connotano l’intestazione. Il quindicinale apre con l’appello del giovane cronista M.P. ai lettori perché collaborino attivamente alla redazione della testata con appunti e notizie di varia natura. La prima edizione è infatti molto scarna, ma sarà solo l’approccio con i suoi lettori perché già il secondo numero della rivista, datata 8 dicembre 1951, due fogli dattiloscritti, è fecondo di informazioni: gli articoli infatti sfiorano argomenti di attualità politica, di cronaca nera, annunci pubblicitari e, in seconda e ultima pagina, spera anche di riuscire a far sorridere il lettore con spiritose battute abbozzate nella forma di barzellette (pulite ma metaforiche) e con Ritrattini poetici e al tempo stesso pungenti su amici da prendere in giro. Ma il Circolo “G. Borsi”, nato dall’aggregazione di giovani studenti all’insegna del libero pensiero avulso da indirizzo politico, produrrà il meglio di sé con “LO jURNAL De LOS LOmBReS Che Se SIeNTON TALeS”, sempre del 1951. 47 La rivista, satirica come si evince già dal titolo, uscirà in tre edizioni ma il numero d’esordio, purtroppo, non ci è pervenuto. Il motivo lo chiarirà l’editoriale, abbastanza significativo, del successivo numero due: “[…] è stato strappato dai lettori per due motivi:1°- per puritanesimo testardo che non ha fatto capire le intenzioni del nostro foglio e le ha fatto scambiare per superficiali e vastasigne; 2°- per scoprire gli autori che, secondo le intenzioni del povero fesso, sarebbero dovuti saltare fuori”. Cosa che naturalmente non è avvenuta essendo gli autori felicemente coperti dall’anonimato: l’articolo di fondo è infatti firmato Don Justu Salati. La Direzione, tuttavia, con eleganza di stile, manderà, a piè di pagina, il seguente messaggio all’ignoto puritano: “Diamo il benvenuto al nostro caro M.I., che abbiamo visto ieri sera di sfuggita. Ci auguriamo ch’egli stia bene e che si sia aggiornato un po’. Se non ancora, cercheremo di erudirlo noi prossimamente e creare in lui una nuova mentalità sociale che più si adatti alle basse sfere in cui noi si vive. Bacetti […]”. L’antifona è chiarissima. E ancora nel più stretto anonimato è la brillante, e sicuramente allusiva, Ballata di Carmen. Ne riporterò alcuni versi, attribuendola (con audacia ed eccessiva libertà di pensiero?) a Rocco Fodale: giovanissimo e spiritoso(2). Spulcio tra i versi umoristici della Ballata di Carmen: Olè songo la Carmen, la donna timorata/ ritorno tosto tosto sulla ritta strada. Chi me vidìo un giorno muchacha spinta assai,/ sappi ch’el corpo mio non sfiorirà giammai. Andar por siempre in chiesa sarà lo scopos mios/ porchè son toda presa de l’amor gran de Dios. Porchè son la Carmen cambiata un pueco/ nel core mio innosiente ès purità de fueco. Porchè son la Carmen onesta a tutta prova/ sul conto mio de sierto nessun de ridìr trova. Olè. Tutto iò devo a Pedro, la vita e l’onestà/ ma l’arte mia d’un tiempo giammai ritornerà. Olè. (Carmen) La ballata è chiaramente metaforica. Il bersaglio ovviamente sconosciuto. Il Circolo “Giosuè Borsi” non avrà lunga vita, molto probabilmente si spopolerà dei suoi fondatori, cresciuti nel tempo, che ora, transfughi dal paesello, frequenteranno Università del territorio, ciascuno secondo il proprio percorso di studi. 48 Ma da adulti, laureati e non, li ritroviamo nel 1957 al Circolo ENAL comunale, più agguerriti di prima e rinforzati da un folto gruppo di giovanissimi studenti. Cambierà radicalmente lo stile della loro produzione giornalistica. E cambieranno gli obiettivi. L’età degli eroi La definizione figurativa è presa in prestito da un appunto di Rocco Fodale, eroe, insieme con il gruppo di giovani che ne condividevano principi e cultura, di un periodo storico in cui l’inventiva del pensiero raggiungerà alti picchi creativi all’interno del Circolo ENAL comunale. Non più burle e sollazzi a danno degli amici ma Quadretti di avvenimenti collettivi e Profili, certamente anche un po’ caricaturali, di particolari soci ritenuti emancipati (però, dalla lettura delle rime, li chiamerei semplicemente aspiranti dirigenti). Qui la prosa sarà bandita dagli scritti di bottega, e con il titolo di “U CATTUBBULU” inizierà, con fluida e raffinata vena poetica, una serie di manoscritti in quartine e, come rigorosamente d’uso, di autori anonimi ma come sempre individuabili dai contemporanei. “U CATTUBBULU”, metafora del calabrone che gira gira scruta punge e scappa, uscirà con il primo numero il 18 maggio del 1957. Si proporrà di essere Periodico Settimanale e l’articolo di presentazione ai soci lettori sarà di buon auspicio per il futuro: “Abbiamo constatato che da qualche tempo il nostro circolo ha raggiunto le vette più alte e più superbe dell’allegria e della sciccheria. Data la simpatica atmosfera che si è venuta a creare nel circolo abbiamo ritenuto opportuno inserirci in questa aria di belle èpoque con questo nostro settimanale facendo dei Profili di amici più emancipati e Quadretti di avvenimenti più caratteristici del tanto ospitale e nobile circolo […]”. Seguono le prime quartine, eleganti e rispettose di un ambiente culturale. Qualcuna a caso: “Viva il caro Serafino/ bello e biondo Granatiere/ che con fare birichino/ quasi a tutti la fa bere./ Ei gesticola imponente/ vuole tutto trasformar/ rosso in viso, sorridente/ torna sempre ad esclamar./ È il Circolo dei nobili/ io vi porto civiltà/ occorron ancora dei mobili/ non è forse verità?/ E le donne, grida felice/ vengano tutte, tutte qua/“Presto signora, signora Alice/ s’accomodi pure c’è il sofà”./ Che gran pacchia, che delizia/ questa è vera civiltà/ non c’è nota di mestizia/ qui non c’è povertà”. Al pari delle riviste èdite in tempi precedenti, pure questo elegante periodico sarà anonimo, anche se gli appunti ritrovati segnalano (scritti 49 sveltamente su un angolino d’ultima pagina) i nomi di Gaspare Culcasi, del giovane Rocco Fodale e di Peppe Catalano. L’edizione settimanale di “U CATTUBBULU”, che a salterelli si protrarrà sino alle soglie del sessanta, uscirà regolarmente con alcuni numeri, ma già nelle poche righe dell’editoriale del secondo numero si lamenterà, sempre attraverso quartine educatamente ammiccanti, la sparizione dalla bacheca del Circolo del precedente numero uno: probabilmente strappato, diranno gli editori, al fine di sottrarlo alla lettura dei soci. E senza colpo ferire, perseverando nel buon uso dello stile intrapreso, la direzione del settimanale risponderà all’immeritato strappo ancora con pacifiche quartine nell’edizione del 25 maggio: “Sia pure un po’ stonati/ in onor di Serafino/ dei versi abbiam cantati/ con rispetto fino fino./ Ma certo non possiamo/ il capitano trascurar/ ed ecco a mano a mano/ iniziamo a speronar”. E ancora nell’edizione del 2 giugno: “È sbarcato in questo baglio/ della grande nobiltà/ investito fu del maglio/ che detiene con fedeltà./ Per effetto di quel maglio/ ei comanda notte e dì/ e la gente del gran baglio/ è costretta ad obbedir./ Se si osa reclamare/ per qualcosa che non va/ non riesce a sopportare/ il reclamo che si fa”. Ma allorquando scenderanno nell’arena, a colpi di penna e di quartine, “ LA SPONZA” e “IL GRIFONe” (firme anonime ma ben individuate tra gli anziani del Circolo) con tutta una serie di scritti, sempre in quartine, dai titoli variopinti e allusivi e dalla forma linguistica purtroppo involgarita, i temi trattati non avranno più lo spirito goliardico cantato dai Cattubbuli all’inizio della loro avventura poetica, anche perché i giovani eroi si lasceranno coinvolgere dai vari Sponza, Grifone, Spazzola ed altri, tutti molto meno giovani di loro, in un gioco di botta e risposta scadendo così da quel promettente inizio di divulgazione poetica sottilmente sorniona che avrebbe, se mantenuta inalterata, fatto rifulgere di nuova luce creativa i loro passatempi rimati. Tra il cinquantasette e il sessanta spuntano, come funghi nell’umidità del sottobosco, numerosissimi manoscritti, spesso infecondi, sempre in quartine, ma sempre più sterili nei contenuti e nella costruzione delle rime. Tuttavia alcuni segneranno punti a loro favore perché ci parleranno di costume di vita, di feste paesane, di celebrazioni che oggi non esistono più. Ad esempio, da “ I SmANGIUSI”, Giornale di Critica Attuale in occasione dei festeggiamenti della Città di Paceco, spigolando fra le quaran50 tadue quartine, apprenderemo che: “Ogni anno ad ogni costo/ si sa già che a Ferragosto/ è un uso assai palese/ di festeggiar il paese./ Con l’avvocato in testa/ si preparò la festa/ fra gente ignara e colta/ inizia la raccolta./ Un fondo solidale/ che mai vi fu l’uguale/ poi nasce una contesa/ per fare buona spesa./ Il sabato è arrivato/ il primo dì è iniziato/ son l’otto del mattino/ ed esce il tamburino./ Domenica mattina/ la banda s’incammina/ rullando giunger vuole/ stavolta in Via del Sole./ Di dir m’ero scordato/ sàppian che abbiam scherzato/ la nostra fu allegria/ ch’è nota d’armonia”. La ben descritta scena chiassosa dei gruppi di ragazzini che saltellando seguono il tamburino per le vie del paese è un commovente, quanto fotografico flash sul candore dell’infanzia. Dall’anonima ressa di scritti che vanno dal cinquantasette al cinquantanove se ne distingueranno, tuttavia, un paio per metodo espositivo che li differenzierà dagli altri: “L’ANTI-CATTUBBULU”, in ottave manoscritte nel più stretto dialetto nostrano, e “U-CANTA-TUTTO” sottotitolo (abbastanza esplicativo del suo contenuto): Periodico di Cultura e Attualità, Edito per Invitare gli Amministratori ad una più Perfetta e più Seria Funzionalità, in quartine per la prima volta chiaramente dattiloscritte. Componimenti, entrambi, dall’aria ironica, lievemente satirica e pungente, dal linguaggio pulito e specificamente distensivo (soprattutto “UCANTA-TUTTO”) con buona pace di soci, amministratori e lettori esterni al club. Dal marzo del cinquantanove al settembre del sessanta, esce “eNAL CITy”, rivista semestrale di letteratura ermetico-satirica, sottotitolo: Licet insalsare pastam squaratam. Il tenore della rivista è già palese nel titolo e nel sottotitolo, nei toni e nell’ironia del latinismo maccheronico sfoggiato: quasi un ritorno al vecchio “U CATTUBBULU” di prima stesura, omettendone le superate quartine. Gli autori sono quei giovani liceali che, facendo corona agli eroi degli anni Cinquanta, ne ricalcheranno il gusto della cultura (soprattutto filosofica), della facezia e… dell’anonimato mai sopito. Dall’edizione numero tre di “ENAL CITy”, ecco come un giovane eroe descriverà con chiarezza una giornata imbarazzante di un normale socio ENAL nel pezzo intitolato I giorni difficili di un socio: “Apprendiamo che il prof Rock and Fodal si trova in una situazione molto Critica: egli da qualche tempo si trova sulle Spinoza perché s’è cacciato in un Vico oscuro e non può Voltaire indietro. Per questo Marxsticherà amaro e a quanto sembra questa Campanella suonerà a lungo. 51 Intanto ha delle Fichte di testa e non si può Radetzky più senza notare che lui, Bruno, ora diventa spesso molto Rousseau e non Kant più. L’abbiamo intervistato ed è stato molto Cartesio con noi: ci ha detto che non si Spaventa, che la sua Croce è stata l’Estetica che ha cozzato contro la Logica e l’Economia, che non ha fatto bene i Comte, che s’è ingannato del Tacito sebbene Livio consenso delle masse. Poi è rimasto a guardarci come un Locke ”. Il pezzo non è firmato, ma sappiamo che appartiene al giovanissimo liceale Nino Basiricò(3), appassionato di Filosofia, e che è scherzosamente quanto inconfutabilmente dedicato al maestro e amico filosofo Rocco Fodale. “ENAL CITy” sarà l’ultima pubblicazione curata dai giovani guasconi del periodo e chiuderà il cerchio produttivo di una magnifica stagione generazionale. Il buco che si aprirà nel settore è enorme e incolmabile. Quel gruppo di eroici autori si assottiglierà sino a disperdersi per vie diverse: chi nel mondo del lavoro, chi in Università per studi. Ora le motivazioni e gli interessi culturali non saranno più conciliabili con gli amati passatempi. I periodici dell’informazione: dai notiziari alla saggistica alla politica In anticipo sui “passatempi da circolo”, nascerà “IL CORRIeRe DI PACeCO”, periodico d’informazione a cadenza quindicinale, il cui battesimo avverrà il 4 luglio del 1955. Il giornale, diretto dal prorompente e inesauribile Rocco Fodale (mente vibrante ad ogni squillo di novità), collaborato dal giovane Franco Vacatello e via via da occasionali articolisti, dichiara da subito che “[...] mira al miglioramento del livello economico, culturale, ecc. del nostro paese ”. L’obiettivo è preciso ed encomiabile, e più avanti ancora dirà “[...] tutti i concittadini devono contribuire affinché esso viva e migliori ”. Le notizie su fatti e avvenimenti, talora anche di accadimenti esterni al nostro paese, saranno variegate: interviste con notabili (politici e non), incontri-scontri sportivi, pubblicità commerciale, politica, attualità. Ed emergono ripetutamente gli inviti ai giovani a collaborare con i loro interventi: “[...] e dateci molto molto lavoro, senza pietà” finirà un loro appello alla comunità. Ma la cittadinanza risponderà all’appello? Collaboreranno, i giovani, “senza pietà ”? La storia insegna, purtroppo, che non basta la buona vo52 lontà dei pochi capiscuola a colmare i profondi buchi dell’abulia dei tanti! E così, nel cinquantasei, dopo una breve pausa nella redazione del periodico dovuta presumibilmente a motivi economici, anche “i pochi” si arrenderanno. “IL CORRIERE DI PACECO” chiuderà la redazione definitivamente al secondo anno di vita. Nel corso degli anni Sessanta fioriranno nuove iniziative. Saranno i giovanissimi studenti che, lungi dall’ammainare le vele, riprenderanno le fila dei notiziari. Lo faranno a modo loro, lontano da tipografie e da circoli (culturali e non). Lo faranno aggregati all’interno del gruppo di Azione Cattolica o semplicemente uniti in nome dell’amicizia di piazza o ancora nel segno dell’interesse culturale che li avvicina. Spunteranno così alcuni giornalini ciclostilati, veicoli di notizie paesane, di annunci pubblicitari, di notiziole sportive e, talora, di qualche poesia in cui l’autore tenterà di lanciare all’ancora inconsapevole fanciulla meravigliosi messaggi ora d’amore ora di profonda tristezza ora di poetica solitudine. Alcuni dei quali, in verità, hanno tracciato in me particolare emozione. Come la lirica (scoperta per caso a tergo di uno spillato di sei pagine dedicato al racconto Al finire di luglio) di un giovanissimo Pino Ingardia, tra le cui rime manoscritte è palpabile, fra l’altro, una emergente insofferenza politica. Ne stralcerò alcuni versi: “Ti ho disegnata nuda/ fra le foglie verdi della rivoluzione/ fra le mie rassegnate lacrime/ di meridionale stanco./ Il gallo che canta per la mia gente onesta/ sui lenti campi di ristuccia/ muore giorno per giorno, e io/ che racconto da sempre la favola del mondonuovo/ crepo goccia a goccia fra mille erotici sogni/ fra mille frustrati sguardi di schiavi della terra ![...]”. E più oltre “Non venire quaggiù, ti cercherò io, quando/ scapperò braccato dai cani lupi di don/ Michele sui sentieri assolati delle sciare./ Verrò a cercarti/ quando dai canneti in fiamme la rabbia/ dei vitalori armati riempirà le bocche di schiuma/ e canteranno i colpi sui cieli dei campi arsi di ristuccia./ C’incontreremo, c’incontreremo, vivi o morti, amore mio”. Aprirà la pista dei ciclostilati, nel 1961, “IL NOSTRO TACCUINO”, bimestrale a cura dei ragazzi di A.C. diretti dal giovane insegnante William Alestra. I servizi giornalistici saranno attinenti ad avvenimenti sportivi, commemorazioni, interviste, notiziario parrocchiale, relax (barzellette), cucina, novelle, poesie, quiz. 53 Apprenderemo, da “IL NOSTRO TACCUINO”, delle prime esperienze di ricerca del giovane liceale Alberto Barbata: lo troveremo ai suoi primi approcci con lo studio del nostro territorio e dell’habitat in cui ci muoviamo. Ne diventerà nel prosieguo degli anni storico e divulgatore anche grazie all’ambiente di lavoro dove lieviterà, insieme con la passione per i ritrovamenti di reperti archeologici, anche un profondo interesse per le origini del nostro paese e la genealogia dei suoi fondatori (4). A “IL NOSTRO TACCUINO”, che a saltelli si protrarrà sino al 1964, seguiranno altri ciclostilati, notiziari più o meno curati nell’immagine editoriale e nella qualità redazionale. Ma intanto lentamente, in sincronia con il cambiamento del tessuto socio-culturale, matureranno nei giovani altri obiettivi e altre motivazioni che faranno perno al rinnovamento dell’informazione: non più novelle, non più ricette di cucina, né elenchi di nati di morti e di matrimoni. Ora comincerà a serpeggiare negli scritti la politica e con questa i malumori, le insofferenze, le denunce di disservizi, le diatribe ideologiche. Sul quindicinale “I GIOvANI”, anno primo, numero due, direttore Ignazio Spanò, si denuncerà, in una lettera aperta al Sindaco, la luce a singhiozzo che quasi tutte le notti lascia al buio le strade del paese. La risposta del sindaco Peppino Catalano, con lettera altrettanto aperta, non si farà attendere ed è diretta al segretario del Movimento Giovanile Socialista di Paceco: “In riferimento alla nota del 14 dicembre 1963 [...] mi premuro di informarLa che questa Amministrazione comunale ha più volte lamentato tale increscioso inconveniente con chi di competenza. Purtroppo alle assicurazioni non sono seguiti i fatti [...]”. La pubblicazione non sfiorerà l’anno secondo: il quindicinale esaurirà la sua redazione all’interno del sessantaquattro, anno in cui vedrà la luce un nuovo ciclostilato a cadenza mensile: “L’AmICO”, giornale indipendente che si fregerà, per tutto il tempo della sua redazione, di una accattivante copertina disegnata di volta in volta a tema: opera del giovane collaboratore Michele Russo(5). Dall’edizione del mese di agosto del sessantaquattro rileviamo, da una lettera di denuncia dell’ex assessore comunale Donato Forte e dalla risposta a fronte del (presumo) consigliere comunale Giovanni Leo, la discrepanza di opinione tra i concittadini già chiamati democraticamente ad una risposta (cui non è stato dato politicamente esito) e il sindaco Giuseppe Catalano, a proposito della dislocazione in altro sito del Monumento ai Caduti(6). 54 La polemica si protrarrà a lungo e la spunterà, con buona pace di tutti, la scelta salomonica di lasciare il Monumento ai Caduti dove era stato collocato a suo tempo dal podestà del Comune: cioè nella piazza Vittorio Emanuele dove ancora si trova. “L’AMICO” diffonderà ancora per qualche mese le sue informazioni su attualità e miscellanea varia, mantenendosi, come nelle dichiarate prerogative, spiccatamente lontano dall’approfondimento ideologico sul tale o talaltro partito politico. Ciò che invece farà “ L’UNITà SOCIALISTA”, edizione in numero unico. Redatta a cura della sezione PSI-PSDI di Paceco, già dall’editoriale stampato in bella vista proprio in copertina (perché non sfuggisse al lettore disattento!), è reso chiaro lo spirito dell’intervento: “[...] vogliamo avere un colloquio il più ampio possibile con tutti i lavoratori, allo scopo di stabilire con essi rapporti non solo politici ma umani perché siamo convinti che oggi ogni uomo, se vuole essere un vero cittadino, deve accostarsi alla politica per determinare all’interno del proprio partito un orientamento più aderente alle proprie esigenze e convinzioni [...]”. Gli articoli verteranno, com’è ovvio, su temi squisitamente politici come: Crisi al Comune di Girolamo Alestra; Il Partito Socialista unificato: Programma, Finalità e Funzioni in seno alla Società Italiana di Pietro Paesano; L’Unificazione Socialista di Giovanni Samannà; Politica e Cultura anonimo; Vera Democrazia con il P.S.U. di Giuseppe Paesano. Interessanti, all’interno del ciclostilato, le informazioni raccolte da un anonimo observer (ahimè, l’anonimato!) sulla storia della Biblioteca comunale: dalla sua nascita nel cinquantasette (ovviamente parliamo di progetto di nascita) al suo battesimo ufficiale avvenuto il 13 maggio del sessantadue, dopo un percorso difficile dovuto essenzialmente a motivi economici, ma anche (probabilmente) a disattenzione politica. Malgrado il mezzo secolo di storia, la Biblioteca comunale di Paceco, fiore all’occhiello del nostro paese, non ha ancora una intitolazione. Continuando a sfogliare i ciclostilati d’epoca, m’imbatto in una poesia intitolata Lenta terra del sud. è del versatile Alberto Barbata: la trovo simbolica nella mia analisi del periodo, attraversato da lampi di luce ma anche da brume, da lunghi silenzi e da risvegli. L’ermetismo distingue lo stile dell’autore: “Piangono i sogni delle nebbie/ mentre muore lentamente il pallido/ raggio di un vetro./ Filtri d’estasi scendono freddi/ attraverso nudi d’albero./ Lacrime non rigano più già le guance/ di maschera./ Il muto sangue chiuso ribolle/ al mesto 55 corteo di albe avvizzite./ Sinfonia di voci lontane in aria/ arcano di streghe di tempi più remoti./ Richiamo di baci sconosciuti/ di silenzi al crepuscolo/ mentre eterna luna parla in terre/ dove gente si ama e vive perenne/ la quercia della vita”. Dall’ermetismo dialettico della poesia, spostando la visuale troveremo i saggi filosofici di Rocco Fodale: L’Estetica di Gioberti, nel 1962; La filosofia politica di Dante, nel 1965; La Sofistica e la critica antica e contemporanea, nel 1972. Ma già la fine degli anni Sessanta vedrà spuntare una miriade di Numeri Unici. La politica terrà banco ma non sarà ancora esasperata. Sfogliando, troverò del sessantasette l’opuscolo “ChI TACe...”, sempre di informazione politica, a cura del Gruppo “J. Kennedy” di Paceco. Lo leggo accuratamente in cerca di dati e di notizie particolarmente pregnanti al fine di entrare nello spirito dei nostri giovani Kennediani. Già l’editoriale Basta con la falsa prudenza mi colpisce per la cruda disamina del momento politico della D.C. nel nostro comprensorio: “[...] in una intervista al Giornale di Sicilia abbiamo ripetuto a tutte lettere che non intendiamo affatto condurre battaglie personalistiche, ma combattere contro un andazzo, fuori e dentro il partito, che non è più tollerabile ”. Seguono le motivazioni di un palpabile rammarico dell’intervistato. Scoprirò, alla fine del lungo articolo, che la levata di scudi è di Rocco Fodale così come dello stesso acuto autore è il successivo articolo, sulla medesima rivista, dal quale emerge senza veli la palese amarezza personale per “lo sfacelo delle sezioni democristiane in provincia”. In quel periodo Rocco Fodale sarà punto di forza nella cerchia politica locale della balena bianca. Qualche pagina successiva dello stesso opuscolo “CHI TACE...”. Qui mi intriga l’analisi sociologica, ovviamente abbozzata, ovviamente incompleta ma coraggiosamente affrontata da Salvatore Ingrassia che nell’articolo Chi resta denuncerà la “fuga dai paesi verso la città” da parte dei nostri cervelli, dal sud al nord d’Italia, e segnatamente sottolineerà l’emigrazione da tutti i settori di lavoro dal professionista al bracciante al contadino come “causa prima oggi, del sottosviluppo del meridione e delle aree depresse”. E continua, a chiarimento: “Il fatto che nazioni povere di risorse del suolo e del sottosuolo come la Svizzera riescano ad avere una invidiabile situazione economica dimostra chiaramente che la causa principale del progresso economico è nell’uomo, nel suo cervello, nelle sue capacità tecniche”. L’analisi sulla valenza delle capacità del cervello umano mi trova assolutamente d’accordo. Ma nella fattispecie 56 del momento storico, non sarà stata al contrario la povertà atavica del paese, e del meridione tutto, a determinare la fuga dal sud al nord in cerca di lavoro, secondo l’equazione fuga = spinta vitale per la sopravvivenza? Ricordo ancora mio nonno quando raccontava, con la pipa piena di trinciato tra le labbra, della fuga di manovali e artigiani verso la ricca Torino, dove peraltro metteranno radici, e ancora prima verso l’America con le valigie di cartone e la speranza di trovare, almeno là, il lavoro. All’interno del medesimo arco di tempo ascriviamo l’opuscoletto “ NUOvA FRONTIeRA”, sempre a cura del Gruppo “Kennedy”, dove si evidenzierà l’articolo di Enzo Guidotto, studioso di antropologia ed esperto ricercatore di reperti archeologici. I ritrovamenti di materiale archeologico risalente al paleolitico superiore, raccolto da Enzo Guidotto nella zona nord di Paceco, nel tratto tra Malummeri e Sciarotta, di cui discetterà nelle pagine della “NUOVA FRONTIERA”, indurranno gli esperti paletnologici che li hanno esaminati a ipotizzare la retrodatazione dei primi insediamenti umani nella zona circoscritta al nord del paese. Da un articolo del 20 dicembre 1982 sul “Giornale di Sicilia”, che approfonditamente tratterà l’argomento, estrapoliamo qua e là “[...] Attraverso anni di paziente ricerca il professore Guidotto ebbe la fortuna di trovare altri oggetti e altre tracce [...]. I reperti degli insediamenti ora scoperti a Malummeri consentono una retrodatazione di 500.000 anni: la conferma è stata fornita dal professore Gerlando Bianchini, docente aggregato alla Sorbona di Parigi, direttore del Centro Siciliano di studi preistorici”. Tanto, a sostegno dell’importanza del lavoro di scavo effettuato dal Guidotto. Che peraltro non ha mai smesso di ricercare! Del mese di febbraio del sessantotto è il numero unico “NOI Che LOTTIAmO”. Gli editori sono giovani già impegnati attivamente nella politica, che sentiranno il bisogno di far sentire la loro voce di protesta. Della stessa fascia temporale è la rivista “PACeCO OGGI”, periodico di cui non ho trovato altra traccia se non note di convocazione del corpo direttivo (sic!) con tanto di carta intestata e timbro ufficiale, ma nessuna copia del giornale. Purtroppo. Il filo che legherà gli anni Settanta non ci porterà a testimonianze documentali significative ad eccezione di un paio di quaderni ciclostilati e ben rilegati del Centro Studi “Cesare Pavese” di cui il primo, a cura del ventenne (ma già ben attrezzato quanto ad ideologia politica di sinistra) Pino Ingardia, è dedicato interamente ad una Ricerca (chiamata testual57 mente Rapporto) su Paceco: piccola città agricola al bivio, dove la disamina sociologica si intreccerà (senza scontrarsi) con l’analisi economica e politica del territorio; mentre il secondo quaderno, a cura di Alberto Barbata, è dedicato ad uno studio antropologico ancora sul nostro habitat “[...] sulle tracce evidenti di un insediamento umano nell’età del Paleolitico e del Neolitico nella nostra zona”. Contestualmente l’autore affronterà anche la genesi del nostro paese, dal radicamento “sulla collina dei mandorli ”al lento sviluppo umano e sociale nei suoi quattro secoli di vita. Ma a partire dagli anni Ottanta si svilupperà nel paese un fiorente filone di attività culturale letteraria, di pari passo con le contestazioni dapprima sottotono, poi a megafono, di stampo politico (e sociale) per la salvaguardia di quello scorcio di patrimonio culturale paesaggistico storico, e in parte archeologico, che si chiama Castellaccio, Invaso Baiata, CineTeatro Roma, che prima ancora di essere realtà fisiche erano, e resteranno, un insieme di sentimenti, di ricordi, di sogni fugaci, di incontri, che nella disattenzione politica rischierebbero di andare perduti. L’età della maturità E siamo così entrati nell’età della maturità degli ex giovani. Cosa mai meglio degli scritti autobiografici, delle sillogi poetiche e narrative, delle storie di vita vissuta, dei vibranti ritratti di sé stessi nel periodo dell’adolescenza della giovinezza del primo scorcio della maturità, potrà mai esprimere i sentimenti più forti più intimi e più sinceri di noi stessi perché denudano la nostra anima? Ed ecco che esplode la corsa alla narrativa. Si tratta quasi sempre di squarci di vita rivista all’indietro, in una sorta di specchio concavo dove al centro ci sono solo i ricordi. Ora velati di nostalgia. Ora induriti da aspre esperienze. Ora disegnati con tratti di morbida matita dai colori pastello. E cito, ad esempio, la silloge di racconti dal vero, del 1979, Solamente un giorno d’estate, del giovane Pino Ingardia, nella cui narrazione degli episodi, da quelli iniziali ambientati nel gramo periodo della guerra (con l’incubo degli scarponi tedeschi prima e di quelli americani dopo) agli ultimi racconti della silloge, c’è sempre il venticello della politica, l’odore di prepotenza e, alla lontana, di mafia. Il campionario di personaggi che l’autore ci propone, sia del più lontano periodo doloroso della povertà in cui rotolavano braccianti e contadini della nostra terra, sia del meno lontano periodo dei suoi vent’anni, è di struggente umanità. Lo sti58 le è acre, asciutto. Le descrizioni di alcuni fatti, visti appena come riflessi di luce in una galleria di specchi , essenziali nello spirito dell’insieme dei racconti, toccano in profondità la realtà della dura battaglia per il pane(7). Ma non solo. Ci sono anche le vite romanzate di personaggi della porta accanto: La bottega di don Mimì, ad esempio, del 1975, autore Rocco Fodale, sarà specchio di autentici avvenimenti paesani raccontati con grande rispetto della veridicità dei fatti appresi. Come dirà lo stesso autore, si tratta di “[...] un romanzo che attraverso la narrazione della vita autentica di una bottega di barbiere, mette in luce il valore culturale e di aggregazione sociale di essa negli anni Trenta e nella prima metà degli anni Quaranta”. La bottega di don Mimì, rivisitata dallo stesso autore nel 1988 per la sua posposizione teatrale, chiuderà battenti (sul palcoscenico ovviamente) con l’eccidio di Cefalonia dove perderà la vita Paolino, il ragazzo di bottega figlioccio di don Mimì. E ci sono i libri di storia del nostro paese: della sua nascita, della popolazione, della sua struttura produttiva (causa prima della trasformazione sociale); rientra tra questi Una casa, una terra di Francesco Benigno, le cui ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento, coprono appunto i due primi secoli di vita, partendo dall’insediamento del paese descritto attraverso un racconto leggendario di migrazione e di migranti fermatisi infine “[...] su quella piccola collina rocciosa che domina da vicino Trapani, le bianche saline e, al largo della costa, le isole Egadi. Un posto magnifico[...]” e finalmente accogliente dopo il freddissimo monte San Giuliano, subito abbandonato, e le ricorrenti esondazioni che castigavano Xitta. Ma già a cavallo del Sei e Settecento cambierà la struttura sociale del nostro paese. Dirà il Benigno “[...] le vicende demografiche trasformarono in più sensi il volto di Paceco: se le ripetute crisi di mortalità colpirono violentemente la popolazione e la struttura produttiva del paese, le nuove ondate migratorie ne modificarono l’assetto sociale”. La provenienza dei migranti? Il Benigno opta per le zone viciniori, Trapani in testa. Segue una lunga discettazione, motivata da documenti attendibili, sulla qualità e quantità dei beni di proprietà delle famiglie residenti. Non entreremo nei particolari: a noi interessa in questa sede solo la conoscenza del fatto che già allora la proprietà di beni e di once distingueva il casato. La popolazione era suddivisa in due fasce: benestanti e poveri. 59 E ci sono ancora gli opuscoletti di approfondimento come L’Autonomia perduta e ritrovata, ad esempio, di Alberto Barbata che traccia un profilo ben stagliato della situazione politico-amministrativa del nostro paese nel difficile periodo storico che va dagli anni Venti alla fine degli anni Trenta (ventennio attraversato dal fascio e dalle sue nuove figure amministrative e politiche). In questo squarcio di tempo, il nostro paese perderà, come in una rocambolesca drammatica avventura, la sua autonomia amministrativa con l’annessione al Comune della vicina Trapani, diventandone una frazione. Paceco verrà restituita alla sua autonomia cinque anni dopo. E cito ancora i racconti, protagonisti i nipotini con le loro tenerezze e il loro amore ricambiato per il nonno, raccolti e rilegati in libri come: Racconti dal vero e tre fiabe semplici semplici, e ancora Viaggio nel firmamento con fata Meraviglia e altre fiabe dello scrittore di lungo corso Rocco Fodale (coadiuvato in quest’ultimo dal nipotino Davide) e Fammi tornar bambino, sottotitolo Vi racconto la mia storia di Vincenzo Ficara. C’è il libro di protesta alquanto duro nei riguardi di autorità politiche locali, intitolato Rarica di Gaspare Petralia (la cui pubblicazione non passerà inosservata). E ci sono pile di raccolte di poesie in vernacolo siciliano di Vincenzo Castiglia, di Vincenzo Adamo, di Michele D’Aleo, di Turi Sucamele, di Guglielmo Castiglia: suoni e colori di vita lontani che oggi non esistono più. Ma la loro passione per le rime in dialetto, percepibile a pelle, e i sentimenti che sprigionano da quel linguaggio poetico sono messaggi forti, e spesso commoventi, d’amore per la nostra terra. E ancora una miriade di suggestiva letteratura da cui emergono “aspetti e momenti di vita del territorio e della Comunità di Paceco”. Cito, ad esempio, Fiori di pietra sulla collina, autori vari, a cura del Comitato Pubblicazioni patrocinato dal Comune di Paceco: un insieme di articoli diversificati che parlano di storia e di leggende; che parlano di antiche arti e di mestieri ormai impraticabili ma da rispolverare per non dimenticare; che ci accompagnano nella cripta della baroccheggiante chiesa del Rosario chiusa al culto da decenni e ora, minata dal tempo e dalla disattenzione, abbandonata e svuotata dei suoi simboli. E infine, a volo di uccello, uno sguardo sul pezzo Fiori di pietra sulla collina (che dà appunto il titolo alla silloge), breve e significativo collage di poeti che hanno saputo tradurre in versi l’amore per quei centenari fiori di pietra che formano “[...] quel pugno di case aggrappate al colle che si affaccia sul60 la piana e sulle saline di Trapani e che porta il nome spagnoleggiante di Paceco”. Ma a cavallo degli anni Ottanta-Novanta, contemporaneamente alla narrativa, la carta stampata sarà invasa dalla politica militante: diatribe di parte, attacchi per la sopravvivenza partitica, ironia spicciola contro avversari di lista. E cito: Scopriamo le carte, corposo ciclostilato, èdito dal Circolo “Simone Gatto”, che partendo dalla premessa constatazione che “[...] il nostro paese, pur avendo raggiunto un notevole grado di articolazione sociale e culturale, non si è dato strumenti di memoria e di verifica della propria identità [...]” perviene alla assoluta necessità di dover correre immediatamente ai ripari dando “[...] un contributo di interpretazione di alcuni fenomeni e personaggi paesani [...]”. I fenomeni saranno i precorsi avvenimenti elettorali; i personaggi paesani saranno ovviamente gli eletti (da mettere subito sotto torchio!), i partiti nel mirino saranno i soliti noti: P.S.I. (titolo dell’articolo: Che cos’è?), P.C.I. (titolo: Proletariato a Paceco). Gli autori non firmeranno singolarmente gli articoli, ma poiché a fondo pagina troveremo i nomi di Salvatore Ingrassia e Gaspare Maltese, segnalati come collaboratori del giornale, è lecito attribuire loro la paternità del servizio. L’anno è il 1980. E cito “ORIZZONTI 2000”, foglio di partito, interamente dedicato alla imminente campagna elettorale. Anno 1985. E “PRemONITOR”, due o tre numeri unici (del mese di giugno del novantasei), apartitico, suggestivo e fortemente ironico come si evince dagli articoli e dai nomi dei suoi autori: I trombati di Metà Stasio, L’intervista di Hiro Niko, Abbiamo toccato il fondo di Sar Castico. Ma la pagina più esilarante è il racconto, tratto dal Decamelone (sic!), Come Messer Bartolo Lo Pellegrino ebbe ad uccellare sette beoti in cerca di una poltrona sicula. L’ambientazione scenografica virtuale era ovviamente il Parlamento regionale. E quanta carta stampata, libri, giornali, volantini in difesa del nostro mitico Castellaccio! L’ondata inizierà allorchè il sindaco pro tempore Totò Pellegrino, intervenendo tempestivamente, riuscirà a salvare (purtroppo solo temporaneamente) il sito bloccandone lo sterramento sulla sommità del timpone che ne avrebbe distrutto, in un colpo solo, il secolare mito della truvatura tanto cara a giovani e anziani, e la selvaggia macchia mediterranea oggetto di studi botanici e naturalistici. Per la cronaca, si era nel novantasette. Sull’imbarbarimento ambientale si spenderanno con motivati articoli, coinvolgendo politici e cittadini, numerose testate giornalistiche fra 61 cui “IL FARO” di Trapani con un lungo e angosciato articolo (Paceco e la sua Collina: Mitico Castellaccio, addio! ) di Nino Basiricò che partendo dalle ferite inflitte già anni prima sui versanti laterali del timpone, per colpevole incuria, continua “[...]ma non è solo il mito né il rudere dell’antico castello medioevale a rendere magico il sito. Ci sono (o c’erano?) i carrubi, le palme nane, gli azeruoli, i pini d’Aleppo, le mandorle, gli olivastri, le acacie, le ginestre [...]”. La prima quindicina di maggio del novantasette resterà un pezzo di storia sia per il battage pubblicitario sollevato dal “Giornale di Sicilia” (Paceco, il sito archeologico danneggiato dai trattori, di Giuseppe Lo Castro), dal quotidiano “La Sicilia” (Paceco, devastato un sito archeologico e, qualche giorno dopo, Paceco, i proprietari cancellano con una ruspa il Castellazzo, di Fabio Pace), sia perché, per la prima volta, l’Amministrazione comunale affronterà a muso duro il problema della salvaguardia del sito archeologico reiterandone la richiesta, già avanzata nel novantaquattro alla Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani, di “ vincolare il Timpone Castellazzo quale zona di interesse artistico, storico e archeologico”. Con la stessa nota il sindaco Pellegrino chiederà l’apposizione del vincolo antropologico anche per lo storico Cine-Teatro Roma che ha visto passare, dai primi anni Venti sin quasi alla fine degli anni Ottanta (l’ultima stagione cinematografica all’arena di Mario sarà nell’ottantadue, l’ultimo film al chiuso sarà nell’ottantasei), diverse generazioni, di padre in figlio, tra le sue file di poltroncine di fragile legno corroso dal tempo. Ne parleranno approfonditamente, con articoli sulle riviste “Paceco undici” del 2006 (Paceco e il Teatro, di Salvatore Ingrassia, La Vicenda del Cinema Mario, dell’ex sindaco Pellegrino, Il Cine-Teatro Roma di Paceco di Antonella Altese); “Paceco quattordici” del 2010 (Cinema Roma: Il progetto, a firma dell’informatissimo Pellegrino) e “Paceco quindici ” del 2011 (Il Cinema Roma, ancora firmato Pellegrino che parlerà di finanziamento regionale). Le vicissitudini che coinvolgeranno nel tempo il Timpone Castellazzo e il Cine-Teatro Roma avranno esiti, per la loro stessa natura, diversi: il timpone non otterrà il vincolo archeologico, malgrado lo strenuo impegno messo sul tappeto dal Sindaco, e malgrado le battaglie cartacee con la Sovrintendenza di riferimento, ma otterrà il solo vincolo paesistico. “Sull’area di Timpone Castellazzo” dirà Totò Pellegrino in un articolo sul “Giornale di Sicilia” del 3 maggio 1997 “esiste anche un progetto di massima per l’istituzione di un parco archeologico che è già stato inol62 trato alla Regione per il finanziamento” (progetto probabilmente poi evaporato); il Cine-Teatro Roma non otterrà dalla Sovrintendenza il richiesto vincolo per valenza culturale e antropologica che avrebbe accelerato, peraltro, le operazioni di richiesta e di ottenimento di un mutuo per l’acquisto dell’immobile, e tuttavia continuerà faticosamente il suo percorso malgrado le opposizioni politiche. Infatti non sarà la decisione negativa della Sovrintendenza a turbare le operazioni d’acquisto dell’ex Cine-Teatro Roma, ma saranno gli scontri interni al Consiglio comunale stesso tra i favorevoli a stipulare il mutuo per l’acquisizione dello stabile e i consiglieri decisamente contrari perché non interessati alla rinascita del vecchio cinema né evidentemente al suo utilizzo come spazio culturale polivalente. Dopo il rituale tiramolla, e le lunghe sedute, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’ex cinema alla fine avverrà: “Il Giornale di Sicilia” ne informerà la cittadinanza con un bell’articolo del 4 novembre novantotto, nella cronaca di Trapani. L’Associazione Culturale “La Koiné della Collina” pubblicherà gli ultimi avvenimenti del lungo cammino del Cinema Mario sulla sua rivista “Paceco quattordici” del 2010 (Il progetto, relativo alla ristrutturazione) e “Paceco quindici” del 2011 (sul finanziamento regionale dei lavori), con articoli dell’ex sindaco Totò Pellegrino. Abbiamo mantenuto viva per oltre un decennio la speranza che tutto alla fine venisse inquadrato in dirittura d’arrivo. Siamo stati fortunatamente fiduciosi: apprendiamo in questo momento (luglio 2012) che l’auspicato finanziamento regionale per la ristrutturazione del nostro Cinema Paradiso, testimone di fantastici ricordi d’infanzia e di fanciullezza, di atmosfere magiche, di lunghi sguardi d’amore che traducevamo in messaggi, è già realtà. Il vecchio cinema tornerà a vivere anche se sarà “altro” da noi. Il finanziamento ammonta a 1.420.000 euro: adesso sarà la Giunta comunale, guidata dal sindaco Biagio Martorana, ad avviare le operazioni di rito per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione. “Si sta provvedendo al bando di gara ” dirà lo stesso sindaco Martorana nell’incontro avuto il 15 ottobre corrente. E aggiunge il dettaglio che “i lavori inizieranno, presumibilmente, entro i primi mesi del 2013. La loro conclusione dovrebbe avvenire entro il 2015”. Il Cine-Teatro Roma riaccenderà, alla fine della lunga corsa, i suoi riflettori. 63 Altre controverse vie burocratiche, che ne appesantiranno enormemente l’iter, saranno percorse dal progetto infinito relativo ad un Parco suburbano sul torrente Baiata. L’invaso è una enorme distesa d’acqua di raccolta, simile in alcuni punti ad un esteso lago attorno al quale, già dal novantatrè, nascerà (all’interno di un laboratorio politico informale di giovani di sinistra, e altri) l’idea di creare un Parco suburbano che potesse non solo migliorare l’immagine paesaggistica di Paceco, ma movimentare il sonnolento paese con programmi sportivi di natura varia (dagli acquatici ai boschivi) per il nostro tempo libero e soprattutto, usufruendo della sua favorevole posizione di aggancio a Trapani e alla relativa vicinanza a Erice, lanciarlo ai fini turistici. L’iniziativa sarà recepita ben presto dall’Amministrazione comunale che avvierà l’iter per un “bando di concorso di idee mirato a definire sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e architettonico una parte marginale del territorio suburbano di Paceco, attualmente in condizioni assimilabili tra quelle di una periferia e quelle di un’area demaniale lacustre”, affidandone l’esecuzione al Centro Studi “G. B.Amico” (G.M. del 16.11.2004). Il “concorso di idee” avrà esito strepitoso per qualità e quantità di architetti partecipanti: ma il progetto del parco, dopo la lettura delle proposte circostanziate (e forse anche la premiazione del migliore lavoro sul tema!), non troverà sbocchi realizzativi. E questo, malgrado la formale volontà della G.M. reiterata con delibera n.633 del 10 dicembre 2004, di realizzare un parco intorno all’invaso Baiata. Inizierà comunque un lento susseguirsi di delibere e di progetti, di incontri su incontri con dirigenti di altri Enti (come il Consorzio Birgi e il Demanio Trapanese) coinvolti nel progetto, trattandosi di un’area appunto demaniale di cui il nostro Comune non aveva la disponibilità. Sull’interessante progetto del Parco sul Baiata, attraversato nel suo lungo iter da numerosi Sindaci e Commissario regionale che si sono succeduti alla guida del paese, così conclude Totò Pellegrino in una brillante relazione, Il da farsi, sulla rivista “Paceco dieci ” del 2005: “[...] la disponibilità del progetto esecutivo ci consentirà di partecipare ai diversi bandi di finanziamento regionali e di accedere ai finanziamenti europei [...] se riuscissimo ad essere veloci forse potremmo ancora rientrare nel Por 2000/2006. Contemporaneamente bisogna concludere in fretta, con il Demanio, la questione della gestione dell’area”. Stiamo per entrare anche in questo caso in dirittura d’arrivo? 64 Apprendiamo infatti che nel bilancio comunale del 2011, al TITOLO II, sarebbe già stata prevista la somma di 100 mila euro, proveniente dall’avanzo dell’esercizio dell’anno precedente, necessaria per l’ultimo atto: bandire la gara per l’assegnazione dell’incarico della progettazione definitiva. Dopo diciotto anni d’attesa, credo che sia l’ora giusta per l’Amministrazione comunale di deliberare con la massima sollecitudine. E il nostro sindaco Biagio Martorana, con la sua Giunta, ho motivo di sperare che opererà in tal senso prima possibile. Le calende greche, cui si rimandava di anno in anno sia per il Cinema Roma che per il Parco sull’invaso Baiata, entrambi progetti rimasti in itinere per lunghissimi anni, spero stiano per scadere. Paceco e la sua rivista Rivista apartitica e di “ memorie” per eccellenza, la pubblicazione “PACeCO” (già diverse volte citata nel corso di questo articolo) si attesterà come periodico di informazione culturale a cadenza annuale ininterrottamente dal mese di marzo del 1998, colmando quel periodo di vuoto nella carta stampata che in un paese di cultura avanzata, come il nostro, non avrebbe dovuto neppure crearsi. La rivista, che come elemento indicativo dell’annata di edizione porta la numerazione progressiva di uno, due, tre... ieri “Paceco sedici” oggi “Paceco diciassette”, partita probabilmente con trepidazione e con le insicurezze del futuro, susciterà vivo interesse già all’esordio, con la presentazione del numero uno avvenuta nella Biblioteca comunale del nostro paese. Ecco cosa ne scriverà l’esperto collaboratore del quotidiano “La Sicilia” Peppe Occhipinti il 4 aprile 1998, nella pagina delle attività culturali, titolando Strumento per la memoria. La rivista semestrale fa rivivere il paese: “[...] la prima rivista letteraria che indaga sulla cultura della cittadina alle porte del capoluogo. Si chiama “PACECO” e vede riunito nel comitato di redazione un gruppo di intellettuali progressisti locali che perseguono l’obiettivo di offrire ai loro concittadini uno strumento per consolidarne la carente memoria storica e ravvivare il senso di appartenenza ad una realtà sociale dopo aver rinunciato, per forza di cose, alla vecchia cultura contadina e paesana [...]”. Il redattore coglierà appieno l’essenza viva della pubblicazione e la sua valenza culturale di largo respiro. 65 La rivista, nata per essere semestrale, già alla terza edizione diventerà annuale. Di certo non ne conosco il motivo ma posso supporre che, escludendo i costi di pubblicazione da sempre sostenuti dalla locale Banca di Credito Cooperativo “Sen. Pietro Grammatico”, particolarmente sensibile alle divulgazioni culturali che riguardano la storia del paese, rimane come plausibile motivazione la rimodulazione del lavoro interno al fine di rendere più razionale e meno pesante la necessaria lettura degli articoli proposti dai concittadini - diventati sempre più partecipativi -, la correzione delle bozze di stampa, l’impaginazione e altro ancora. Coordinatore, responsabile e autore dell’editoriale sarà Rocco Fodale sino all’edizione di “Paceco sei ” del dicembre 2001, allorquando deciderà di lasciare l’impegnativo ruolo. Gli subentrerà nelle medesime funzioni Nino Basiricò, presidente dell’Associazione Culturale “La Koiné della Collina” che, contestualmente, assumerà la carica di editrice della rivista. Accettandone il ruolo di coordinatore e responsabile editoriale, nell’articolo di fondo Continuità nella svolta così Nino Basiricò scriverà su “Paceco sette” del dicembre 2002: “Al di là del cambiamento puramente formale del coordinatore, il Comitato di Redazione continua all’unisono nel fermo proposito di contribuire, per quanto possibile, alla crescita umana, sociale e culturale della nostra comunità. Forse l’unica vera novità è quella che vede, da questo numero, la nostra Rivista èdita dall’Associazione Culturale “ La Koinè della Collina” di Paceco. Resta fermo il nostro ringraziamento nei confronti della Banca di Credito Cooperativo “Sen. Pietro Grammatico” di Paceco che rende possibile, col suo finanziamento, la presente pubblicazione”. Dall’anno sociale 2012, a Nino Basiricò subentrerà Giovanni Ingrassia il quale, accettando la carica di presidente dell’Associazione Culturale “La Koinè della Collina”, assumerà contestualmente il coordinamento di questa rivista giunta alla sua diciassettesima edizione. Dall’editoriale del nuovo presidente, in prima pagina di questa pubblicazione, sottolineeremo la sensibilità emotiva e intellettuale che traspare dalle sue stesse parole: “Ed eccomi qua con l’unica ambizione di non deludere ” e, contestualmente dalla scelta, operata con l’intero gruppo di redazione, di ripercorrere visivamente la storia ultradecennale della rivista (la prima edizione risale al mese di marzo 1998) attraverso la “[...] riproduzione di tutte le copertine dei numeri già pubblicati ” al fine di “rendere omaggio ai ‘timonieri’ precedenti prima di riprendere il viag66 gio[...]” con il medesimo obiettivo del “recupero della memoria collettiva della nostra comunità ”. Al nuovo presidente, cui non faremo mancare la nostra collaborazione, auguriamo un proficuo lavoro all’interno della rivista e della nostra Associazione perché l’una e l’altra continuino ad essere, nei rapporti con l’esterno e nei progetti culturali, una vera koinè al servizio del paese. La rivista “Paceco”, sparsa ormai per il mondo in tutte le case dei nostri compaesani emigrati in terre lontane, apprezzata per i ricordi che suscita in loro, continuerà a mantenere vivo il cordone ombelicale che lega questi lontani amici al nostro e loro paese. L’informazione corre in rete Quanto tempo è occorso per passare dalla scrittura manuale con artigianali strumenti d’epoca ai primi ticchettii della tecnologia e alla carta stampata? Secoli di storia, se solo provassimo ad addentrarci nella conoscenza del percorso. Quanto tempo è occorso per passare dalla macchina per scrivere al computer alla videoscrittura all’internet al giornalismo in rete? Un salto del fosso! Che i nostri giovani non hanno trascurato di cogliere al volo con perspicacia. Nasce così “PACeCO weB”, giornale in rete di quotidiana informazione a trecentosessanta gradi: cultura, politica, sport, meteo e persino programmi TV. In breve: notizie di accadimenti giornalieri che attraverso il costante impegno di un ben assortito gruppo di appassionati navigatori entrano di soppiatto nelle nostre case. Ma chi sono questi giovani di ultima generazione? Non ne conosco nessuno, malgrado l’ostinata ricerca di informazioni in tal senso. è stato come rincorrere l’araba fenice. Epperò, nonostante non sia riuscita a conoscere i nomi dell’équipe, debbo riconoscere l’impegno del gruppo nella gestione del web, che testimonia la presenza attenta e costante sul territorio. Ma soprattutto la pazienza certosina nel correre dietro agli avvenimenti di vita quotidiana. Ed è attraverso l’editoriale Chi siamo, pagina di collaudo (suppongo) del giornale in rete, che il gruppo di lavoro presenta il suo biglietto da visita dettando il programma: “All’interno di questa rete di intenti nasce “PACECO wEB”, il primo portale-community della città che raccoglie informazioni, curiosità e notizie su tutto quello che riguarda la politica, la cultura, la storia, lo sport, gli eventi, i luoghi e la bellezza del nostro paese [...]”. 67 E, più in là, nel medesimo articolo, ci presenta le sue credenziali: “[...] cercheremo di essere un punto d’appoggio per tutti quei pacecoti legati profondamente al loro paese ma che si trovano fuori dal nostro territorio per svariati motivi”. Infine, ponendosi come “Faro della Città che illumina i meandri bui ”, il lusinghiero articolo conclude: “Sperando che le nostre parole abbiano risvegliato in molti la voglia di cambiare, diamo inizio a questa nuova avventura.“ PACECO wEB ” è al vostro fianco”. Prosit! Auguro che il link raggiunga in rete tutti i nostri emigrati, in qualunque paese si trovino. Il lato positivo del web è proprio l’immediatezza con la quale le notizie volano da un capo all’altro del mondo. Ma che non annebbi, contestualmente, il piacere di una distensiva lettura sulla vecchia carta stampata! Ringrazio calorosamente Rocco Fodale per avermi messo a disposizione gran parte del materiale di cui mi sono servita per la ricerca di notizie utili per la stesura di questo lavoro. Ringrazio altresì quanti si riconosceranno fornitori, nel tempo, di vecchio materiale qui citato, raccolto e conservato per il gusto della memoria storica. FRANCESCA LIGGIATO Note 1. Mino Blunda, commediografo e sceneggiatore, saggista, giornalista, poeta. Premio Pirandello 1973. 2. Rocco Fodale, fine e illustre narratore a largo raggio, commediografo, pedagogista, saggista. Premio Trinacria 1997 per la narrativa. 3. Nino Basiricò, sindaco del Comune di Paceco all’interno di due legislature: 1981/84 e successivamente 1992/1993. Presidente dell’Associazione Culturale “ La Koinè della Collina”dal maggio 2002 al dicembre 2011, per la quale impegnò senza remore tutte le sue capacità creative e intellettuali. 4. Alberto Barbata, direttore di lungo corso della Biblioteca comunale di Paceco alla quale ha dedicato tempo e passione nell’intero arco degli anni di servizio. 5. Michele Russo, da anni collaboratore di redazione della rivista “Paceco”. 6. Giuseppe Catalano (detto Peppino), sindaco storico del nostro paese. Presidente della Camera di Commercio di Trapani, carica che mantenne per lungo periodo. 7. Pino Ingardia, narratore dalle idee chiare e forti, dallo stile scorrevole e dal linguaggio sicilianizzante, del tutto scevro da tentazioni di leziosità. Nella sua abbondante attività di scrittore non è mai sceso a compromessi letterari. 68 GIOvAN FRANCeSCO FARDeLLA Secondo Principe di Paceco Un uomo solo, un marito umiliato Se, in un ipotetico sondaggio, si chiedesse ai pacecoti: “Conosci la storia dei Principi di Paceco?”, senza paura di sbagliare il 70%, meravigliato, risponderebbe di non sapere che Paceco è stata governata da un Principe; il 20% dichiarerebbe che un Principe di nome Placido Fardella ha fondato il paese quando si è sposato e l’ha chiamato col nome della moglie: Paceco; il 10% risponderebbe che Placido Fardella è stato un nobile che, con l’influenza politica di uno zio della futura moglie, ha avuto l’autorizzazione ad edificare un borgo che avrebbe chiamato Paceco in onore della futura sposa e per questo impegno avrebbe ricevuto il titolo di Principe. Esaminando le supposte e possibili risposte di questo ipotetico sondaggio risulta che, ogni qual volta il nostro ricordo va ai Fardella, Principi di Paceco, il primo ed unico nome che affiora alla mente è quello di Placido, fondatore del piccolo borgo seicentesco sulla collinetta accanto al torrente Baiata. Al nome del fondatore è legato indissolubilmente quello della moglie, Maria Pacheco y Mendoza, figlia di Juan Francisco, fratello del Viceré siciliano Juan Fernandez Pacheco, Marchese di Villena e Grande di Spagna, e di Maria Mendoza y Figuerosa. Per cui, volendo dare a ciascuno dei Fardella il dovuto contributo, senza andare molto lontano - come a Giacomo Seniore (detto Magno), Stemma Casato Fardella morto nel 1527, o a Giovanni Gaspare (detto Gaspano), morto nel 1563, o a Giacomo (Antonio) Juniore, morto nel 1575 - bisogna dire che il borgo fondato da Placido nacque grazie alla lungimiranza strategica di suo padre Giovanni Gaspare, il 69 quale ricoprì importanti cariche pubbliche come Capitano Giustiziere a Trapani, Ispettore delle imbarcazioni che arrivavano al porto di Trapani, Rettore del Monte di Pietà, Vicario Generale a Mazara. Egli, inoltre, si fece notare per la grande energia imprenditoriale. Ampliò il borgo S. Lorenzo - Xitta, con la costruzione di nuove case, amministrò le tonnare di Trapani e Marsala, commerciò con Genova e Firenze, comprò grande quantità di bestiame per sfruttare i “maggi”, le zone pantanose delle sue terre, ma soprattutto riuscì ad accumulare le maggiori superfici possibili di terra attorno al feudo di S. Lorenzo - Xitta, comprandola o controllandola con contratti enfiteutici a lunghissima scadenza. Ma il vero artefice della fortuna di Placido fu la tenacia di sua madre Caterina Torongì e Beccadelli di Bologna, seconda sposa del Barone di S. Lorenzo. La Baronessa Caterina, discendente per il lato paterno da una antica famiglia di Palma di Majorca, era una donna tenace e intraprendente. Rimasta vedova nel 1595, quando Placido Antica porta del Borgo S. Lorenzo - Xitta aveva 3 anni, continuò la strategia di ampliamento territoriale progettata dal marito, ma non solo. Era anche una donna dotata di una grande disinvoltura nel muoversi nei salotti della Corte palermitana e riuscì abilmente a tessere la tela per pianificare accuratamente la fortuna del figlio. Infatti, con l’aiuto di un nobile di origine trapanese, ben introdotto nei palazzi nobiliari palermitani, Don Antonio del Bosco, padrino di Placido, divenuto poi suo marito, riuscì, in crescendo, a disegnare per Placido una fulminea carriera che doveva sfociare in un titolo nobiliare di rango superiore e in un aumento del potere materiale, da guadagnarsi con la possibilità di costruire un nuovo borgo. Tutto ciò si avverò quando il 70 25 marzo 1607 avvenne il fidanzamento tra il quindicenne Marchese Placido(1) e la nipote del Viceré Maria Pacheco Mendoza, a cui fece immediatamente seguito, il 9 aprile 1607, la licenza “aedificandi et populandi ” e, il 12 settembre 1609, il coronamento della tela tessuta dalla madre: il titolo di Principe di Paceco. Forse era nel destino di Paceco di essere coinvolto in complesse e faticose questioni fin dalla sua nascita. Infatti la città di Trapani considerò pericolosa la costruzione del nuovo borgo e, soprattutto, la concessione del titolo di Principe al Marchese Placido che gli avrebbe consentito una ulteriore ascesa sociale e politica che, a detta dell’aristocrazia trapanese, avrebbe insidiato seriamente gli equilibri del potere. Anche la crescente borghesia trapanese avversò la nascita del nuovo borgo e, di conseguenza, la presenza di un mercato alternativo alla propria città, considerandola possibile causa di destabilizzazione dell’ordine pubblico. Tale lotta senza quartiere con alterne vicende coinvolse tutta la vita di Placido che, degno figlio di sua madre, reclamò sempre la posizione che riteneva gli spettasse tra la nobiltà siciliana sia nella vita politica, sia nella carriera militare. Infatti nel 1610, a soli diciotto anni, fu nominato Vicario Generale a Trapani e nei terreni confinanti(2); nello stesso anno, il 27 ottobre, venne nominato Presidente del Regno(3); otto anni dopo venne eletto Deputato del Regno, uno dei dodici membri che sostituiscono il Parlamento vacante; ed ancora l’aristocrazia palermitana lo scelse per la prestigiosa carica di Governatore della Compagnia dei Bianchi nel biennio 1620-21. La prestigiosa carriera di Placido, però, si interruppe bruscamente con la morte a trentuno anni, dopo una rapida malattia, a causa di una epidemia di peste che aveva colpito Trapani, mentre risiedeva lì con la sua famiglia. Era il 19 settembre del 1623. Venne sepolto a Palermo nella chiesa di Santa Teresa, a destra dell’altare. Sia a Palermo che a Paceco il rimpianto fu universale. A Paceco le esequie furono celebrate in tutte le chiese e fu un vero dolore del popolo che aveva imparato ad amare il fondatore del paese come se fosse suo padre. Il primo Principe di Paceco lasciava nove figli in tenera età e una inconsolabile moglie che spesso si recava a pregare sulla tomba che conteneva le spo71 glie di colui che era stato il suo sogno giovanile, colui che aveva amato teneramente e per il quale aveva lasciato la sua famiglia, i suoi parenti, la Spagna, terra natale, per restare fedele al giuramento pronunciato sull’altare: “Dove tu vorrai, io anderò e sarò felice al tuo fianco”. Subito dopo la morte del marito, quando lasciava Palermo, preferiva fare lunghi soggiorni a Paceco, piuttosto che risiedere nella sontuosa casa a Trapani. A Paceco “ritrovava il governatore don Tomaso de Fagendis, l’antico affezionato intendente di don Placido, e col vecchio e fedele servitore parlava di lui, rammentando i giorni belli del viaggio di Spagna, del ritorno colla corona principesca, degli splendori del tempo del cugino duca di Ossuna, delle feste e delle gale, di tutti gli avvenimenti che le ricordavano il marito perduto”(4). L’altera Principessa di una volta, ora vestita perennemente di nero, dopo qualche anno, si ritirò prima nel convento di clausura delle Carmelitane Scalze di Palermo da lei fondato e successivamente, recatasi a Madrid con le figlie più piccole, entrò nel convento delle Descalzas Reales, dove morì serenamente attorniata dai figli ai quali ripeteva che “dispiaceva a lei di lasciarli, ma che pensava con gioia che sarebbe andata a ritrovare l’adorato marito”. A questo punto, se agli ipotetici intervistati, che conoscevano il nome del fondatore del borgo di Paceco, si fossero chiesti in aggiunta i nomi dei successori di quel Placido Fardella, la risposta sarebbe stata: “Boh! Non lo so”. I Principi di Paceco di casa Fardella, successori di Don Placido, furono quattro: Giovan Francesco, suo figlio Placido II, i fratelli di Don Giovan Francesco: Giovan Gaspare ed Emanuele, e la figlia Maria, che chiude la linea dei discendenti dei Baroni di San Lorenzo, trasmettendo il titolo al figlio Giuseppe Leopoldo Sanseverino, nato dal suo matrimonio con Carlo Sanseverino, Conte di Saponara e futuro Principe di Bisignano. Mi soffermerò poco sugli ultimi tre maschi di casa Fardella - Maria non venne mai a Paceco neanche, nel luglio 1658, in occasione dell’inaugurazione della nuova Chiesa Madre dedicata a S. Caterina d’Alessandria, e il suo ruolo fu quello di transizione del titolo - perché più che Principi nel significato pieno del ruolo furono degli ammini72 stratori di eredità non sempre dotati di lungimiranza, impegnati talvolta in lunghe controversie ereditarie fra parenti a causa della mancanza nei testamenti della menzione dell’istituto del fedecommesso(5). Il primo successore di Placido Fardella e secondo Principe di Paceco fu, quindi, Giovan Francesco che portava i nomi dei due nonni, il paterno e il materno. Le cronache del tempo non ci hanno tramandato numerosi documenti né affidabili notizie biografiche su di lui e le informazioni che abbiamo, soprattutto quelle riportate dal Monroy(6), sono aneddotiche e da considerare con le dovute cautele. Notizie più attendibili si trovano nell’opera di Mugnos(7) e nella biografia di Donna Cecilia Fardella, sorella del Principe, scritta da Fra Biagio della Purificazione(8). Le più recenti pubblicazioni quali quella di Antonio Buscaino(9), il volume, pubblicato dalla “Koinè” nel 2009, Donec in Cineres - Una famiglia nella storia siciliana(10) e le numerose ricerche sulla famiglia Fardella e su Paceco pubblicate da Alberto Barbata hanno dato un quadro più ampio e veritiero della vita di questo giovanissimo Principe che, purtroppo, non fu mai coinvolto in grandi imprese. Nacque a Palermo il 21 febbraio 1610. Alla morte del padre, nel 1623, ereditò i titoli di II Principe di Paceco ( anche se non prese mai investitura); II Marchese di S. Lorenzo; VI Signore della Salina della Grazia; IV Signore della Tonnara di S. Giuliano; III Signore della Tonnara di Palazzo. La morte improvvisa del Principe Placido fece rallentare l’entusiasmo al processo di completamento del piano urbanistico e monumentale di Paceco anche se, come ci riporta il Monroy(11), “i lavori di costruzione … andavano avanti con un ritmo inaspettato …” soprattutto “… della costruzione di una nuova chiesa che doveva essere la matrice …”. Il Principe Giovan Francesco, che aveva passato buona parte della sua gioventù a Paceco, che prediligeva agli altri possedimenti, continuò la costruzione del nuovo borgo per onorare la memoria del padre. Inoltre, volendo fare cosa gradita alla madre la quale, dopo la morte del marito, preferiva Paceco alla sontuosa casa di Trapani e vi faceva lunghi soggiorni, iniziò la costruzione di un palazzo alla fine della IV 73 strada ad angolo con un ampio spiazzale dove già esisteva una cappelletta dedicata al SS. Crocifisso sulla quale si erano iniziati i lavori di ampliamento per trasformarla in una nuova chiesa che sarebbe dovuta essere la nuova Matrice in sostituzione di quella di Maria SS.ma di Portosalvo(12). In considerazione dei lunghi soggiorni a Paceco della Principessa Maria durante i giovanili primi anni del principato del figlio, non è improbabile che sia stata lei stessa, o chi per lei, ad occuparsi delle proprietà di Casa Fardella e dell’amministrazione dei beni. La Matrice all’inizio del 1900 Infatti Giovan Francesco, a differenza dei suoi predecessori, soppresse il sistema di conduzione a coltivazione diretta dei fondi agricoli, ceduti fin a quel periodo solo in piccole parcelle, una delle ragioni del successo economico della famiglia, e preferì cedere terreni, saline e tonnare in contratti enfiteutici a lungo termine, svincolandosi dai problemi della loro amministrazione e dalla produzione ma soprattutto dal loro controllo, con conseguenza economica negativa. Durante il principato di Giovan Francesco le frizioni e i conflitti con la città di Trapani, ereditati dal padre, Le saline di Nubia 74 cominciarono ad attenuarsi, forse perché ben consigliato dallo zio Gaspare, ma anche per l’esistenza di problemi più urgenti e perentori fra i quali la crisi demografica, conseguenza della peste degli anni Venti. A questa erano seguiti anni di carestia, come nel 1636 e nel 1637, che finirono con l’impoverire anche l’artigianato locale, che si trovò unito alle continue proteste promosse dalle classi più povere. In queste condizioni, le dispute fra il patriziato trapanese e la famiglia Fardella non avevano senso: entrambi potevano applicare prezzi più vantaggiosi che avrebbero favorito i consumatori dei prodotti derivati dalla trasformazione del grano. Comunque, durante i suoi litigi con la municipalità trapanese, un punto importante Giovan Francesco riuscì a metterlo a segno. Si oppose, infatti, con successo all’applicazione di una gabella decretata dai giurati su tutti i contratti d’affitto del trapanese. Il Principe, come cittadino della città di Palermo, ottenne, il 4 giugno 1631, con decreto del Viceré, il Duca di Alburquerque, l’esenzione da tale gabella(13). L’unico successo personale che si conosce, Giovan Francesco lo ottenne nel biennio 1638-1639, quando fu nominato Governatore della Compagnia dei Bianchi. I primi anni del suo principato, anche se non abbiamo notizie certe, vengono ricordati in modo negativo e sono addirittura disastrosi per la sua immagine. Secondo un aneddoto riportato dallo storico carmelitano Fra Biagio della Purificazione(14), alcuni vassalli del Principe, fuori dalla zona di giurisdizione del feudo, avevano frustato, per vendetta, un nevaro(15), che si era rifiutato di vendere agli emissari del Principe delle balle di neve da donare al Marchese del Viso che si trovava a Trapani. Il Principe Giovan Francesco venne accusato del delitto di lesa maestà, avendo con la sua azione usurpato una prerogativa reale, esercitata dallo stesso Viceré. Per questa accusa, nel 1635, venne recluso a Palermo, nel Castello a Mare, che fungeva da carcere della nobiltà, dal quale, dopo alcuni mesi, in occasione del cambiamento del Viceré, venne liberato. L’anno successivo, a 26 anni, Giovan Francesco si sposò(16) con Teopazia Caetani e Saccano, discendente di una delle famiglie più pre75 stigiose d’Italia(17). Da quel matrimonio nacquero tre figli: Maria, Antonia e Placido. Malgrado si trattasse di un eccellente partito, questa non era stata la prima scelta della famiglia. Il Marchese di Villena, zio di sua madre, sempre attento nell’occuparsi della famiglia, aveva cercato di concludere un vantaggiosissimo matrimonio con una giovane spagnola di Valencia, unica ereditiera di una gran fortuna. Gli accordi per il matrimonio con questa fanciulla, di cui non conosciamo né il nome né altri particolari, fallirono perché la famiglia non volle accettare la clausola che le proibiva di risposarsi nel caso restasse vedova. Il connubio con la famiglia Caetani aumentò la visibilità sociale del Principe di Paceco, anche perché sua moglie era la cognata del Principe di Paternò, in quel periodo Presidente del Regno, il quale facilitò la presenza del cognato Giovan Francesco Fardella in varie cerimonie ufficiali come quella avvenuta a Messina al Parlamento straordinario dell’anno 1636. Dopo quella data, come scrive nella sua opera lo storico generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, Fra Biagio della Purificazione(18), il Principe abbandonò l’isola per iniziare un lungo viaggio, “per le più cospicue città d’Italia, giovando somigliandi viaggi all’erudizione de’ nobili personaggi”, e proseguendo poi verso Madrid, per visitare la madre e per persuaderla ad abbandonare il convento dove si era reclusa, per tornare a Palermo. Non ci riuscì. Non abbiamo più notizie degne di menzione fino al 6 gennaio 1645 quando, alla giovane età di trentacinque anni, coinvolto in un oscuro episodio a Trapani, fu pugnalato, riportando gravi ferite che, tre giorni dopo, assistito amorevolmente dai fratelli e dallo zio Gaspare, lo condussero alla tomba. Che fu pugnalato mentre era a Trapani lo confermano il suo testamento, in cui si trova scritto “giacente a letto, gravemente ferito”, e lo scritto di Fra Biagio il quale riporta che, per non turbare troppo sua sorella Cecilia, annunciandole la fine del Principe le dissero “ch’era morto di mal di punta, ne havevano mentito, havendolo ucciso le punte del ferro”(19). In alcuni manoscritti(20) l’accaduto viene così descritto: “[…] trovandosi il Principe di Paceco con comitiva di diversi nobili al convento dell’Annunziata soprag76 giunse in quel luogo il clerico Marcello Caraffa con comitiva di diverse persone di riguardo […] tra la servitù di sudetto Principe e del Caraffa vi furono delle risse per il luogo dove far sostare le carrozze; ne successe un bisbiglio tale, che il Caraffa sentendosi giuriato dal Principe portossi con le carrozze alla Marina disfidò il sudetto Principe e perché il Caraffa era clerico si pigliò la spada di un suo servitore seguì il combattimento alla presenza di molti cavalieri dei quali molti sfoderarono le spade ogniuno per il suo partito finalmente un servidore del Caraffa senza consenso del Padrone uccise di dietro il Principe […]”. Al momento della morte Giovan Francesco si trovò accanto solo i due fratelli e lo zio Gaspare, che l’amava come un figlio. La Principessa Donna Teopazia era a Palermo. Chiamata al letto di morte del marito, non credette o non volle credere alla gravità della malattia di lui e giunse a Trapani quando la salma di Giovan Francesco era stata depositata nel sotterraneo della chiesa di San Giovanni, anche se il Principe nel suo testamento(21) aveva dettato la seguente volontà: “[...] in quanto al mio corpo doppo la mia morte voglio che s’intabuti e che di questa Città si porti nella Madre Chiesa del mio Principato di Paceco e questo senza nessun funerale con una carrozza con sei torci perché cossì voglio e non altrimenti”. Ma i lavori della nuova Chiesa Madre non erano ancora ultimati e, quando questi finirono, nessuno si incaricò successivamente di rimuovere la salma. Indicava il luogo della sua sepoltura una lapide apposta dal fratello e ora scomparsa dopo le infinite trasformazioni della chiesa. Il Principe Giovan Francesco nominò il figlio Placido “d’età d’anni setti in circa” erede universale. Anche il suo testamento, come quello del padre, non conteneva la clausola del fedecommesso, e ciò permise a sua figlia Maria di rivendicare i diritti di legittima erede. Nel testamento diseredò completamente la moglie, anche se la designava tutore di suo figlio assieme al fratello Don Emanuele e a Don Pietro Marino e Amato “coniunctim et non divisim”; ordinò per i suoi Stati un Consiglio di governo composto dai suoi fratelli, deliberando che almeno uno di essi doveva abitare a Trapani e a Paceco un minimo di sei mesi ogni anno; decise che il suo palazzo servisse per abitazione 77 ai suoi, ma che si chiudessero i grandi appartamenti di Trapani, fino alla maggiore età del figlio. Sembra che nel diseredare la moglie e nel lasciarle solo la funzione di tutore sotto la sorveglianza ed approvazione degli altri due nominati, il Principe dovesse avere le sue buone ragioni determinate da sospetti che si insinuavano nella sua mente per i lunghi periodi in cui Donna Teopazia restava tanto tempo lontana da lui, sospetti alimentati dalle male lingue che, non sappiamo con quanta ragione, si eraTrapani - Via Libertà Palazzo dei Principi di Paceco no messe naturalmente in moto. (opera di G.B. Amico) Infatti in quel momento, ospite dei suoi parenti in Sicilia, c’era a Palermo Don Francesco Caetani , Duca di Sermoneta, Principe di Caserta e Conestabile del Regno di Napoli, primogenito del ramo napoletano. Don Francesco era un uomo intelligente e spiritoso, aitante nella persona, animoso e superbo. Queste doti erano fatte per piacere a Donna Teopazia, e sembra che, profittando della parentela e della possibilità di potersi vedere spesso, i due non fossero diventati troppo indifferenti l’uno all’altra. Gli avvenimenti giustificarono le voci tendenziose. Infatti Donna Teopazia non aveva la vocazione di vedova inconsolabile della suocera e, undici mesi appena dopo la morte del marito, sposò Francesco Caetani che, dopo diversi prestigiosi incarichi, nel 1663, fu scelto come Viceré di Sicilia, carica che coprì fino al 1667. Fin qui le scarne notizie su questo giovane, e direi sfortunato, Principe. Come, purtroppo, sempre accade quando si succede ad una persona straordinaria, l’immagine del secondo Principe viene sempre confrontata con la brillante figura del padre, per cui appare molto sbiadita. Alcuni lo descrivono come un uomo privo dei carismi dimostrati dai suoi antenati e poco attento a migliorare e far crescere il potere della famiglia. Viene tramandato che non fu attento nella diplomazia, nel 78 campo militare e nella burocrazia di corte, non ebbe un disegno strategico combinando alleanze politiche e matrimoniali. Secondo altri cronisti, poco benevoli nei suoi confronti, fu accusato di superbia ed alterigia, non riuscendo a godere della simpatia e del successo del padre, mentre, secondo il Monroy, le sue relazioni sociali erano condizionate dalla sua timidezza che lo spingeva a non parlare mai. Forse hanno ragione entrambi, ma probabilmente hanno torto entrambi perché si limitano a riferire quello che vedevano, incuranti di riflettere sui motivi del suo comportamento. Certo la storia non si scrive con i “forse”, ma forse, se esaminassimo di più i “forse”, la storia sarebbe forse meno obiettiva ma sicuramente più umana. Io, che storico non sono né aspiro a diventarlo, preferisco seguire il filone dei “forse”, vedendo nel personaggio un individuo, con una sua sensibilità, con i suoi sentimenti, con le sue aspettative, con i suoi sogni, con le sue frustrazioni, con la sua storia. Divenuto Principe a soli 13 anni, egli “forse” avvertì eccessivamente il peso del cognome e dell’eredità cospicua sia in termini materiali che come responsabilità verso i familiari. Era ancora un bambino, tutto preso dai fantasiosi sogni della prima giovinezza e non pensava minimamente al futuro ruolo, ma, improvvisamente, dovette pensare ed agire da grande, anche se accanto a lui c’erano la madre e lo zio Gaspare. Era lui che doveva rappresentare la famiglia e il principato. Questo lo fece smarrire, gli fece perdere il sorriso dalle labbra, lo rese introverso. “Forse” col tempo avrebbe potuto emanare una luce diversa, “forse”….tuttavia, come scrisse Mugnos(22), “Il Principe Don Giovan Francesco visse virtuosamente…”. Due avvenimenti credo abbiano Stemma dei Fardella Principi agito in negativo sul suo comporta79 mento, oltre alla morte improvvisa del padre che, “forse”, cercava insistentemente nell’illusione di ritrovarlo vivo. Il primo colpo gli fu inflitto, “forse” involontariamente, dalla stessa madre quando Giovan Francesco si recò a Madrid per convincerla a lasciare il convento e ritornare con lui a Palermo. Il suo desiderio non fu esaudito. La madre restava chiusa nel suo dolore, tutta presa dal ricordo e dall’amore del defunto marito, non pensando che, amando più intensamente i figli ma soprattutto restando più vicina a loro, ascoltandoli, anche stando in silenzio, e regalando qualche carezza o soltanto un amorevole sguardo, avrebbe potuto fare cosa più gradita al “primo sogno” della sua vita: avrebbe potuto continuare ad amare il suo Placido, amando di più i figli, nati dall’amore e nell’amore del suo matrimonio. Ma era una donna d’altri tempi, di altra educazione e il giovane Principe ripartì col capo chino, con lo sguardo sempre più spento e con l’animo smarrito, convinto di essere rimasto sempre più solo. Il secondo colpo, “forse” il più atroce, lo ebbe col suo matrimonio. La nuova Principessa era altera, orgogliosa e si vantava di essere palermitana, di frequentare i più lussuosi salotti della capitale e le più potenti famiglie della nobiltà che gravitavano attorno al Viceré. Fece poi del suo meglio per rendere più evidente il contrasto col ricordo della suocera e per conciliargli il maggior numero di antipatie. Disprezzava apertamente i parenti di Trapani e chiamava, in modo offensivo, “quel pezzente” lo zio Don Gaspare, Barone di San Lorenzo. Inoltre era prepotente e gettava alte grida tutte le volte che il marito parlava di andare nei suoi possedimenti e “siccome i bravi abitanti di Paceco, come tutti quelli degli altri paesetti vicini, e con questi spesso, avendo le loro liti, le loro lotte ed i loro conflitti armati dichiarava che quello era un covo di sbannuti”(23). Così dopo i primi anni, la Principessa non mise più piede a Paceco e venne a Trapani il meno possibile. Il silenzioso, frustrato e quasi depresso marito non osava contrastare con lei, ma, dall’altro canto i fratelli Don Giovan Gaspare e Don Emanuele, che portavano rispettivamente il titolo di Marchese di S. 80 Lorenzo e di Barone di San Giuliano, erano di vedute opposte a quelle della cognata e rammentavano al primogenito che la famiglia era diventata grande a Trapani, che aveva a Trapani degli obblighi sociali ed una supremazia da esercitare e che perciò egli doveva venirci spesso, se non abitarci tutto l’anno. Il rassegnato Principe trovò un compromesso tra le opposte tendenze. Per compiacere ai giusti desideri dei fratelli, che gli ricordavano i doveri del suo titolo, e non sentire le ripetute affermazioni della moglie nei confronti dei suoi sudditi e del suo borgo, ci veniva da solo. Si aggirava per le vie per vedere l’avanzamento dei lavori, ma era taciturno e malinconico. “Forse” percepiva la presenza del padre e si vedeva giovanissimo sgambettante cercare di stare al passo col padre che gli illustrava lo sviluppo futuro del paese. Questo ricordo aumentava maggiormente la sua sensazione di solitudine e quando i suoi sudditi lo salutavano, rispondeva con ritardo e di ciò si scusava dicendo di essere stato distratto. Non sapevano i pacecoti quello che lui pensava e tacciavano di superbia questo suo atteggiamento, facendo dei confronti che andavano tutti a vantaggio del predecessore. “Forse” lo impressionavano di più le donne vestite di nero, scarne, spesse volte scalze, ma buone mogli e buone mamme, che, nei primi anni del suo principato, si rivolgevano a sua madre per un aiuto, un conforto. E rivedeva sua madre, donna di profonda vocazione religiosa ma ormai lontana dalla vita mondana, vestita di nero, entraUna casa della Paceco antica re in quelle piccole, misere e spesso sporche case, conversare con i suoi sudditi, rivolgere loro un sorriso, una parola di conforto, far recapitare qualche aiuto anche materiale. Ora, lui, il Principe si aggirava per le vie del suo borgo ed aveva “forse” vergogna di se stesso. Pensava “forse” a quella ragazza di Valencia che non aveva potuto sposare a causa di una ridicola clausola? Si chiedeva “forse”, guardandosi attorno, dov’era suo figlio e 81 dov’era sua moglie? Se lo chiese “forse” anche sul letto di morte. Cosciente della sua imminente e certa fine terrena, si vide confuso ed immerso in una immensa solitudine e, alzando la testa, mostrò l’autorevolezza di Principe e l’orgoglio di uomo ma soprattutto di marito e reagì finalmente con il solo atto energico di tutta la sua vita, sicuro di non subirne le conseguenze perché sarebbe stato conosciuto dopo la sua morte. “Io Don Giovan Francesco Fardella e Paceco Principe di Paceco e Marchese di Santo Lorenzo della Città di Palermo al presente trovandomi in questa Città di Trapane, essendo giacente a letto gravemente ferito, sano però per la Grazia di Dio Nostro Signore di mente senno et intelletto, e nella mia bona e perfetta memoria persistendo considerando l’humana fragilità e timendo il divino giuditio alle volte repentino poiché non c’è cosa più certa della morte né cosa più incerta dell’hora d’essa morte volendo a questo cautamente provedere et imitare li vestigij d’alcune persone savie le quali nella loro perfecta salute costumavano testare e disporre dell’ultima loro facultà, ho resoluto perciò fare il mio presente testamento chiuso e sigillato con tutte quelle solennità de Iure requisite […] et annullando tutti qualsivoglia altri testamenti codicilli donationi causa mortis et altre qualsivoglia ultime volontà per me forse fate etiam con clausole derogatorie vulendo e comandando che solamente lo presente mio testamento habbi d’havere ogni vigore e forza e non altrimente[...]. Quel testamento compiuto in silenzio dal timidissimo Don Giovan Francesco fu “la vera vendetta di un ‘buono’ e succube marito”. Infatti, fra le altre sue volontà, fece scrivere: “Item lego e lasso e comando che sia pagato lo dotario e che si restituiscano le dote all’illustre Donna Teopatia Principessa di Paceco mia moglie iusta la forma del suo contratto matrimoniale una con lo suo vestito anello e cammera di letto alla quale mia moglie oltre li detti doti e dodario ed altri sopra legati ci lego e lasso onze quattrocento l’anno durante la sua vita naturale tantum quale se ci pagano ogn’anno sopra li mei beni tertiatim antecipatim more alimentorum et hoc ratione boni coniugij et pro omni et quocumque iure che a detta mia moglie ci competisse oltre le sopradette dote etiam per salario come tutrice e pro tempore curatrice”. 82 Sicuramente dalla serenità del Paradiso, ove si trovava per intercessione della sorella Cecilia, ora Suor Maria Maddalena(24), il defunto si godette la scena dell’apertura del testamento. Vedeva sua moglie impettita e attenta seguire e ripetere quanto letto dal notaio, agitandosi ogni qual volta si passasse nella lettura ad ogni nuovo volere, pensando che in esso si parlasse di lei. Ma dovette aspettare quasi la fine della lettura, quando il notaio Cuculla la guardò “forse” negli occhi ed ella capì che era finalmente giunto il suo momento. Strinse con grande tensione i braccioli della sedia e “spalancò le orecchie” quando si lesse: “ Item lego e lasso e comando che sia pagato lo dotario e che si restituiscano le dote all’illustre Donna Teopatia Principessa di Paceco mia moglie […] e lasso onze quattrocento l’anno durante la sua vita naturale […] more alimentorum […] etiam per salario come tutrice e pro tempore curatrice”. Si agitò nella sedia “forse” furente Donna Teopazia, diventando di mille colori e con la mano tremolante, additando il capoverso del testamento, chiedeva balbettando di rileggerlo. Quel “volere” non solo l’aveva umiliata, diseredandola, ma l’aveva quasi ripudiata come sposa, riconoscendola solo come la madre dei suoi figli. E guardando quella scena, per la prima volta da quando era diventato Principe di Paceco, egli sicuramente rise... rise tanto, ...così tanto che, se non fosse già morto, sarebbe sicuramente morto dalle risate. MICHELE RUSSO Bibliografia e note 1. Placido Fardella ricevette il titolo di Marchese di S. Lorenzo il 19 novembre 1606 da un privilegio di Filippo III (Archivio di Stato di Palermo Protonotaro del Regno - Processi di investitura - Busto 1660, fasc. 8432) in cui si ricordano i servizi alla Corona prestati per generazioni dai Fardella e soprattutto dal padre Giovanni Gaspare. 2. Il Vicario Generale era un inviato speciale del Viceré, dotato di pieni poteri che sostituiva le autorità locali in zone colpite da casi di straordinaria emergenza. 3. Così era chiamato in Sicilia il sostituto nelle funzioni di Viceré quando il posto era vacante. 83 4. G. Monroy, Storia di un Borgo Feudale del Seicento - Paceco, Ed. “Radio”, Trapani 1929, p. 178. 5. La mancanza nel testamento della menzione del fedecommesso significava che l’erede al titolo poteva disporre liberamente dei beni apportati dal padre al patrimonio familiare, tranne di quelli ereditati dal genitore e vincolati da un fedecommesso precedente; inoltre i nuovi beni potevano essere ereditati anche da discendenti femminili non solo in linea diretta, ma anche dalle cognate che, oltre ai beni, ereditavano i titoli nobiliari. Il fedecommesso è un istituto giuridico già presente nel diritto romano, trasmesso poi al Medioevo durante il quale assunse caratteristiche proprie. Esso permetteva al testatore di indicare l’ordine di successione dei beneficiari, non solo per i più immediati, ma anche per quelli delle future generazioni in infinitum. Il successore in un fedecommesso entrava in possesso dell’asse ereditario per un diritto che gli era stato attribuito al momento della disposizione testamentaria, dal primo fondatore dell’istituzione, e questi beni in forma assolutamente vincolante dovevano essere trasmessi alle future generazioni senza alterazioni. L’istituto, adottato in varie parti d’Europa, nella forma giuridica integrale detta “maggiorasco” consentiva di tramandare alle generazioni successive il patrimonio integro. Normalmente ai figli nati dopo il primogenito si riservavano i beni non vincolati dalla clausola, ed in ogni caso l’erede universale doveva provvedere al mantenimento di tutta la famiglia. Cfr. P. Nocella, Donec in Cineres - Una famiglia nella storia siciliana, Ed. “La Koinè della Collina” 2009, p. VIII, nota 3. 6. G. Monroy, op. cit., pp. 179-182. 7. F. Mugnos, Teatro Genealogico delle Famiglie illustri, nobili titolate e feudatarie del fedelissimo Regno di Sicilia, Palermo 1647, ristampa 1988. 8. Vita dell’insigne serva di Dio, la madre Suor Maria Maddalena di S. Agostino, Carmelitana Scalza nel Monastero di Sant’Anna e Santa Teresa in Palermo, nel secolo Donna Cecilia Fardella e Pacheco, scritta dal padre Fra Biagio della Purificazione Carmelitano Scalzo della Provincia Romana, & Historico Generale del suo Ordine, dedicata all’illustrissima ed eccellentissima Donna Maria Fardella e Caetani, Principessa di Bisignano, e sua Nipote Paterna. In Roma MDCCIII. 9. A. Buscaino, Della fondazione, dei primi habitatores e della costruzione della Chiesa Madre di Paceco, Biblioteca comunale, Paceco 1990. 10. P. Nocella, op. cit. 11. G. Monroy, op. cit., p. 165. 12. Vedi il mio articolo La prima Chiesa Madre di Paceco. Un’ipotesi fantasiosa ma suggestiva, in “Paceco tredici”, Ed. “La Koinè della Collina”, gennaio 2009, pp. 11-24. 13. Atti del Senato di Trapani. Copia Lettere, Reg. 72 (vol. 1630-1631); 21.2; 21.5; 4,6. 1631. Citazione in P. Nocella, op. cit., p. 65, nota 123. 14. Fra Biagio della Purificazione, op. cit., p. 79 e sgg. 84 15. Il nevaro era il gestore delle fosse della neve dell’Etna. Dai tempi degli Arabi in tutta l’isola si usava conservare con ingegnosi sistemi la neve dell’Etna, che veniva in estate utilizzata per preparare i sorbetti, che erano considerati una specialità siciliana. 16. Per quell’occasione la madre intervenne alla cerimonia e fu la sola volta che smise il lutto. Citazione in G. Monroy, op. cit., p.179, nota 407. 17. Suo padre era Don Pietro, figlio primogenito di Don Cesare Caetani, Principe del Cassero, sua madre era Donna Maria Saccano dei Conti di San Pietro. Citazione in G. Monroy, op. cit., p.179. 18. Fra Biagio della Purificazione, op. cit., p.113. 19. Fra Biagio della Purificazione, op. cit., p.113. 20. G. Fardella, Annali della invictissima e fedelissima città di Trapani, p. 426 dalla versione trascritta. Secondo alcuni studiosi più fantasiosi, fra i quali il Monroy, l’uccisione era avvenuta sette anni dopo e il morto pugnalato non sarebbe stato Giovan Francesco, ma il fratello Giovan Gaspare, erede per breve termine del titolo che passò, dopo questo episodio, al fratello Emanuele. 21. La trascrizione integrale del testamento, dettato al Notaio Giovan Stefano Cuculla in data 4 gennaio 1645, 13° Indizione, è riportata in A. Barbata, I principi di Paceco - Biografie - Giovan Francesco Fardella e Pacheco, in “Paceco dieci”, pp. 31-33, Ed. “La Koinè della Collina”, dicembre 2005. 22. F. Mugnos, op. cit., pp. LXXIII. Citazione in P. Nocella, op. cit., p. 65. 23. G. Monroy, op. cit., pp. 179-180. 24. Fra Biagio della Purificazione, op. cit., nel Libro II, Capitolo VIII, pp. 141-146, titolato “Grazie fatte dal Signore alla sua serva e suo acerbissimo travaglio per la morte del Fratello”, narra: “L’avviso di questa morte […] apportò inesplicabile amarezza alla Madre Maria Maddalena […] Tenendola per tanto, questo acutissimo dolore trafitta, non puoteva nel suo interno raccogliersi, ed in questa aridità, ricevette la Santissima Eucarestia. Fermatasi doppo la Santissima Communione nel Choro à render le grazie, d’improvviso le fu rapita l’anima in Dio, e nel più intimo le fù detto, che già l’anima del Fratello, era in luogo di salute, e soggionto à modo di esclamazione, “O se tu sapessi Figlia la grazia, che ti ho fatta, non staresti di questo modo, ma non lo puoi conoscere”. Trascorsi parimenti pochi giorni, e mentr’era nell’orazione, intese nel suo interno. “Ti ricordi di quello mi pregasti, quando ti separasti dal tuo Fratello per andare al Monastero, già te l’ho concesso”. La sua domanda era stata, che lasciandolo ella per suo amore, si degnasse ricompensarla con fargli eternamente godere in Cielo della sua compagnia, onde intese essere stata esaudita quella sua domanda, e con ciò le fu comunicata nuova certezza della salute eterna del Principe”. 85 INTeRveNTO AL CONveGNO INAUGURALe PeR LA mOSTRA PeRmANeNTe DI ANTROPOLOGIA e PReISTORIA DI PACeCO Il 15 aprile 2012 è stata inaugurata la mostra permanente di antropologia e preistoria del Comune di Paceco. La mostra è ospitata nei locali del Municipio che danno sulla piazza. Al convegno che ha preceduto l’inaugurazione non poteva mancare il nostro Alberto Barbata che con l’intervento qui di seguito riportato ha ricordato il contributo di quanti, lui compreso, si sono spesi prima di arrivare alla realizzazione della mostra. ndr Nel rivolgere un sentito grazie al Sindaco e all’archeologo Francesco Torre per il simpatico invito rivoltomi al fine di essere testimonial in questo convegno per l’inaugurazione di questa nuova Mostra permanente di antropologia e preistoria che riassume oggi tutte le attività precedenti, sia spontanee che progettuali del nostro Comune, ritengo giusto e doveroso non dimenticare quanti nel tempo hanno contribuito materialmente e scientificamente alla crescita di questo originale Museo, di cui una parte risiedeva nella Biblioteca che io diressi per circa quaranta lunghi anni. Alcuni anni or sono venne a trovarmi, in Biblioteca, una gentile signora nata in questo nostro paese e da decenni residente (ma lei diceva in esilio) in un comune della Romagna, dove molti cittadini provenivano per origine dalla nostra Paceco. Cercava qualche libro, qualche opuscolo, qualsiasi cosa potesse portarsi nella sua nuova patria e che le ricordasse le sue radici. “Signora”, le dissi, “eccole alcune pubblicazioni, le porti come viatico nel suo viaggio di ritorno in Romagna”. Le consegnai anche una copia del libro Fiori di pietra sulla collina. Subito dopo la signora mi raccontò che era andata al fiume, nella valle del Baiata, ed aveva raccolto alcune pietre per portarsele come souvenir nella cara Romagna. Rimasi turbato e, direi, commosso del gesto, la guardai e poi rivolsi gli occhi al piccolo sacchetto che portava con sé. C’erano dei choppers, alcune schegge di selce, c’erano tracce di quella stazione preistorica che tanto avevamo miticizzato nella nostra prima giovinezza. Invero, prima della conoscenza capillare del territorio, dovuta in parte all’opera instancabile di ricercatori dilettanti e appassionati ed oggi, 86 negli ultimi anni, all’azione promotrice del Comune, andando a ritroso nel tempo, desidero ricordare con simpatia, in primo luogo, la nobile figura di un archeologo dilettante, Rosario Gervasi, che negli anni Trenta e Quaranta, dedicò la sua instancabile opera alla scoperta e conoscenza della stazione preistorica di Paceco, situata lungo le sponde del rio Baiata, tra Sciarotta e Malummeri, toponimi L’inaugurazione della mostra permanente (foto C. Di Bella) antichi del nostro centro urbano. Le ricerche di Gervasi aprirono la strada alle visite e agli studi di Jole Bovio Marconi, che poi studiò scientificamente i siti pacecoti nel suo lavoro sulle prime tracce della civiltà di tipo Sentinello nella Sicilia occidentale, pubblicato nel 1941 nell’“Archivio storico siciliano”. Questo studio dette la possibilità, nel 1953, ad un’allieva della Bovio Marconi, la professoressa Elsa Petralia, di avviare un esame più analitico e rigorosamente scientifico di tutta la stazione preistorica di Paceco, i cui reperti andarono ad arricchire le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Palermo e del Museo Pepoli di Trapani. Nello stesso periodo dette impulso a queste ricerche anche la nobile figura dello storico siciliano Carmelo Trasselli, che dirigeva in quegli anni l’Archivio di Stato di Trapani. Più volte intervenne su giornali e riviste trapanesi con articoli e saggi, oggi preziosi contributi ad una maggiore conoscenza del territorio dell’agro trapanese ed ericino. Le sue osservazioni sulle ricerche archeologiche, condotte nel trapanese, sono servite ad una riflessione necessaria ed utile alla comprensione della formazione della pianura e delle colline dell’entroterra trapanese e soprattutto di Paceco, di cui evidenziò, tramite l’analisi dei reperti rinvenuti, i rapporti commerciali esistenti nella preistoria con le isole e, in particolar modo, con Pantelleria. Risultò evidente uno scambio commerciale della creta trapanese con l’ossidiana pantesca, emblema dell’isola nera. Ma un esame effettivo e radicale del territorio comunale e del trapanese, alla ricerca di nuovi siti archeologici, dalla civiltà fenicia alla me87 dievale, è solamente frutto delle rinnovate conoscenze odierne, tramite l’impulso in primo luogo del progetto “Kalat”, che ha avuto il merito almeno di aver sollevato la polvere della sonnolente apatia che avvolge ogni possibilità di ricerca culturale dei luoghi nei quali abbiamo vissuto e viviamo, dei percorsi e delle strade che spesso abbiamo dimenticato, ed oggi dal nuovo gruppo archeologico diretto dal professore Torre. In effetti la ricerca scientifica archeologica è stata appannaggio esclusivo per lunghi decenni della iniziativa isolata di pochi aristocratici studiosi, pieni del sacro fuoco dell’amore per l’antico. Infatti la prima scoperta in Paceco di un manufatto antico, di civiltà fenicia, il Dio Bes, oggi conservato al Museo Pepoli, si deve ad un letterato famoso della città, il filologo Alberto Buscaino Campo. Le ricerche non conobbero sosta, ma continuarono a lungo, silenziosamente, ad opera di alcuni giovani intraprendenti ed appassionati, fra i quali mi è gradito menzionare Enzo Guidotto, che oggi vive a Castelfranco Veneto, dove ha insegnato per lunghi anni, e al quale dobbiamo dare atto delle donazioni consistenti di reperti per il nostro Antiquarium. Ma è soltanto nel 1979 che nasce l’idea di creare un piccolo museo preistorico presso la Biblioteca, al fine di conservare quanto veniva scoperto nel tempo ad opera dei dilettanti locali. La scoperta dell’officina litica delle Rocche Draele, lungo le sponde del Marcanzotta, terzo tratto dell’antico Pyrgoi, dette la possibilità a chi vi parla di potere raccogliere con gioia centinaia di lame di selce, primo nucleo dell’odierno Museo. La presenza nella Biblioteca di un gruppo di giovani assunti tramite la legge 285, per un progetto sui beni culturali del Comune, contribuì notevolmente alla ricerca, allo studio e alla schedatura delle centinaia di reperti preistorici rinvenuti sia alle Rocche Draele, come anche nel sito di Sciarotta e dintorni. Ma non posso dimenticare con rinnovata simpatia e stima l’azione confortante e nello stesso tempo propositiva dell’assessore capitàno Nino Plaja, nonché poi, successivamente, dell’assessore dottor Franco D’Agate. Oggi le ricerche sono continuate e gli studi recenti sulla valle del Baiata sono opera di due giovani studiosi seri ed appassionati, Antonino Filippi e Maria Tedesco Zammarano. Credo fermamente che una città o una comunità possa crescere e migliorare il proprio equilibrio naturale, la sua ansia di rinnovamento, la 88 protezione della propria identità, soltanto se riesce nel tempo a creare attorno a sé uno zoccolo duro e forte, tenace e duttile, composto di amore, di passione e di desiderio di conoscenza dei suoi beni culturali, di salvaguardia del proprio ambiente, dei suoi paesaggi, delle sue case, delle sue strade, dei suoi oggetti o manufatti che ha saputo creare per la propria vita attraverso lo scorrere del tempo. Diceva Marguerite yourcenar, nelle Memorie di Adriano, che “fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”. Credo che i musei siano fratelli delle biblioteche: insieme non solo conservano il pensiero umano, ma anche e soprattutto la memoria collettiva, necessaria, oggi come non mai, alle future generazioni, per continuare a credere, a sperare, a costruire l’avvenire. Il nostro è un piccolo museo, fatto di frammenti. Sono essi tracce della vita dell’uomo in questo territorio. Sono memorie spezzate e ricomposte. Il Museo oggi è una realtà più viva, più fruibile, didatticamente pronto per i fanciulli delle scuole, per tutti i cittadini che amano il proprio paese. Sono convinto che molto si potrà aggiungere, soltanto se la buona volontà dei cittadini e delle istituzioni preposte lo vorranno. Per questo rivolgo un sentito ringraziamento all’archeologo Sebastiano Tusa, insigne studioso della preistoria siciliana, per tutto quello che potrà e vorrà fare per Paceco. ALBERTO BARBATA Convegno inaugurale della mostra permanente (foto C. Di Bella) 89 BUTRINTO e TRAPANI SULLe ANTIChe ORme DI eNeA Luoghi distanti uniti dal mito e dalla storia e collegati a due tappe decisive del viaggio di Enea da Troia verso il Lazio Butroto (Bouthroton/Buthrotum, odierna Butrinto) in Albania e Drepano (Drepanon/Drepanum, attuale Trapani) in Italia: due luoghi affratellati da due tappe decisive del viaggio di Enea da Troia verso il Lazio, un percorso segnato dal fato che precorre di trecentotrentatré anni, secondo la cronologia virgiliana, la data della fondazione di Roma (753 a.C.). Ma già alla vigilia dell’arrivo dei Troiani i due siti erano stati accomunati per il duplice approdo degli Elimi, un popolo, come sostiene Tucidide, proveniente anch’esso dall’Anatolia e confluito in Epiro prima della migrazione in Sicilia. Parecchi studiosi apparentano gli Elimi ai Pelasgi: se ne è fatto assertore anche Muzafer Xhaxhiu, professore all’Università di Tirana, nel corso di un convegno promosso a Trapani dall’Associazione nazionale “Ludi di Enea”. Autorevole anticipatore di questo assunto era stato peraltro, nella seconda metà del XIX secolo, Giosuè Carducci in Rime nuove, LXIII - Primavere elleniche, II Dorica: “De l’ombroso pelasgo Erice in Erice - Sito del santuario della dea madre (foto C. Di Bella) 90 vetta / eterna ride ivi Afrodite e impera, / e freme tutta amor la benedetta / da lei costiera”. Carducci chiama dunque “pelasgo”, cioè “pelasgico”, il monte Erice abitato dagli Elimi, di cui l’omonimo sito sulla vetta era il principale centro religioso. Nel suo tempio le ierodule, sacerdotesse della dea madre, praticavano la prostituzione sacra, accogliendo i marinai in sosta nel porto di Drepano, da cui agevolmente raggiungevano il santuario della vicina Erice. vicende di profughi troiani Ma torniamo a Butroto, che rappresenta un momento cruciale dell’itinerario di Enea, in quanto qui l’eroe incontra la vedova di Ettore, Andromaca, già costretta dalle impietose leggi di guerra a unirsi con Neottolemo, figlio di Achille. Dopo la morte di lui essa aveva sposato il cognato troiano Eleno, gemello di Cassandra e anch’egli indovino. Da Eleno Enea apprende che sarebbe stata l’Italia la meta finale della lunghissima peregrinazione. Tappa intermedia successiva è Trapani, dove il condottiero giunge due volte, con parentesi cartaginese, prima della conclusiva partenza verso il Lazio. E Drepano ospita con manifesta simpatia i Troiani, le cui donne però rifiutano di proseguire nella perigliosa navigazione, protrattasi per oltre sette anni, e decidono di fermarsi definitivamente, con il consenso di mariti e figli, nella pianura collinare di Segesta, fondata dal re degli Elimi Aceste. Reminiscenze e suggestioni classiche Da tali precedenti ebbe origine la leggendaria crociera organizzata nel 1930, bimillenario della nascita di Virgilio, dall’Accademia d’Italia con la Lega Navale. A bordo erano illustri studiosi, guidati dal grecista e accademico d’Italia Ettore Romagnoli. Da Brindisi attraccarono a Butrinto e da qui mossero alla volta di Trapani, dove presenziarono all’inaugurazione della stele di Anchise, eretta in località di Pizzolungo, frazione del comune di Erice. A Butrinto fu realizzato un recital di passi virgiliani in metrica latina, affidato alla applaudita interpretazione a memoria di un gruppo di ragazze liceali e universitarie trapanesi. Nella circostanza la comitiva siciliana ebbe modo di visitare nell’antico Epiro il ricchissimo bacino archeologico, riesumato dalla missione italiana avviata con successo in Albania nel 1924 e diretta da Luigi Maria Ugolini. Fu proprio Ugolini a individuare il luogo dove sorgeva Butroto, a restituire alla luce e a riproporre all’ammirazione del mondo in quella acropoli il teatro greco, il ninfeo, la basilica romana, il battistero bizantino, le possenti mura, le numerose statue greche 91 e romane, come la famosa Dea di Butrinto e i ritratti Agrippa e di Augusto. Il sito è stato dichiarato patrimonio dell’umanità. Luoghi della memoria Due meravigliose zone archeologiche restano perciò a confronto, quella di Butrinto e quella di Trapani, comprese alcune aree della provincia di Palermo (San Cipirello, San Giuseppe Jato, Piana degli Albanesi, Contessa Entellina). Un itinerario abbinato da proporre ai ricercatori italiani e albanesi e un’occasione in più per la promozione culturale e sociale di due territori e di due popoli. MAURIZIO VENTO Butroto (Epiro), oggi Butrinto (Albania) - Ragazze trapanesi dell’Associazione “Ludi di Enea” posano per la foto ricordo dopo un recital nella città cantata da Virgilio. Da sinistra: Teresa Sammartano, Marcella Mazzeo, Mariella Tallarita, Anna Maria La Cava - 1989 92 eChI DeL PASSATO Vorrei poter dire di stupirmi ogni giorno di più nel constatare che sul mio stesso materasso hanno dormito quattro generazioni di donne della mia famiglia, o che quello strofinaccio con cui mia madre spolvera i mobili è quanto rimasto della vestaglia della mia bisnonna; invece mi rendo tristemente conto di quanto io, nel costringere e limitare gli oggetti alla loro attuale funzione, sia cieca dinnanzi a tutto ciò. è strano come l’uomo riesca, nel giro di cinquant’anni o poco più, a tramutare in semplici cose oggetti che hanno una storia e per la cui realizzazione sono stati necessari tempo, fatica, passione. L’uomo è tanto eccellente nel finger d’imparare qualcosa dal passato quanto svelto nel dimenticarsene; e così si ostina nell’eterna reiterazione dei propri errori poiché, nella correzione di alcuni di essi, non fa altro che generarne di nuovi, pertanto accade assai spesso che, nella foga di riparare ai propri sbagli esclusivamente attraverso lo studio di grandi autori o l’attuazione di celebri aforismi, perda l’occasione di apprendere da fonti tanto più concrete e vicine quanto, paradossalmente, distanti dalla sua attenzione. Un pomeriggio non molto lontano di una delle tipiche giornate torride della nostra terra mi ritrovai a pelare patate assieme ad una prozia che, poco convinta delle mie capacità, mi osservava di sottecchi con sguardo torvo. La sentii borbottare, nel cercare d’imitare certi movimenti fulminei del suo coltello, qualcosa come “Ah,i picciotti d’ora... nna vota unn’era accussì!”. Allora mi fermai e posi la domanda che mai avevo posto ma che in quel momento fremeva di esser pronunciata: “Perché? Com’era, una volta?”. Così ebbe inizio il mio viaggio a ritroso nel tempo. U cufuni di terracotta che fumava al centro della stanza costituiva la più grande aspirazione di tutti quegli uomini i quali, di ritorno da un’estenuante giornata di lavoro, dopo cena solevano sederglisi attorno a raccontare ed ascoltare i cunti antichi che costituivano il repertorio di leggende popolari tramandato di generazione in generazione. Un uomo canuto con la faccia ed il naso rossi di fuoco e vino giunse all’apice della sua descrizione del famigerato “Mostro del macello”. I bambini urlarono all’idea di essere mangiati da un momento all’altro; l’uomo scoppiò a ridere. 93 Una donna, stretta nel suo scialle, teneva sulle ginocchia un cerchio da ricamo, cercando invano di infilare un filo nella cruna dell’ago. La più grande delle sue due bambine accorse in suo aiuto: due momenti, e il filo pendeva dall’ago. “La bambina che mai ha filato tutto il giorno il filo ha infilato!” esclamò qualcuno in risposta. La seconda bambina pelava patate in un canto e lasciava cadere le bucce in un secchio ai suoi piedi, cercando d’imitare i movimenti di sua nonna, accanto a lei. La sera portò via i racconti e i ricami, il lume a petrolio fu spento, cessarono le urla dei bambini spettatori, i materassi di lana grezza accolsero tutti. Solo il fuoco rimase a crepitare, osservatore attento di una vita che non gli apparteneva. Tre volte cantò il gallo e svegliò le due sorelle nei loro letti di lana, ma non il sole, ch’era ancor lungi dal far capolino sulla montagna. Il mattino gelido e buio bruciava sulla pelle e penetrava nella stoffa pesante ricavata dalla casacca di qualche occasionale soldato che l’aveva barattata in cambio di pane o uova. Si diressero verso una pila di pietra all’aperto, piena d’acqua fredda; si lavarono in fretta e in silenzio. La sorella maggiore si ritirò in casa, con la scopa di ggiummarri avrebbe presto adempito al suo compito; la minore entrò nel malasenu adiacente alla casa e ne tirò fuori una mula scalpitante che legò poi al carretto di suo padre. La madre e la sorella giunsero poco dopo cariche di quaittari d’acqua ed issarono sul carretto un enorme quararu con il pranzo degli uomini. Nella piccola veranda sterrata davanti alla porta di casa, mentre il padre delle bambine intrecciava una corda di curina, s’era andata formando una piccola processione di uomini del vicinato che, sfilando uno dietro l’altro col cappello in mano, chiedevano, titubanti: “Zzu Cicciu, mu fa fari un iornu?”. L’uomo valutò quanti braccianti poteva permettersi e ne scelse alcuni; s’incamminarono piano verso il carretto, s’issarono su e partirono. Le bambine e la madre restarono a guardare finché la mula non trascinò, con fatica, il carretto al di là dell’angolo; poi, piano, rientrarono. La madre tirò fuori da un baule i grembiuli scolastici, li infilò in fretta sulle teste delle figlie e sistemò gli enormi fiocchi bianchi sul davanti. Dopo aver lanciato loro un ultimo sguardo per valutarne l’aspetto, si girò soddisfatta verso il tavolo della cucina, prese due pezzi di pane duro, li 94 porse alle bambine e disse: “Chissu è pani” – e mise loro in mano il primo pezzo – “E chissu è tumazzu” e, con uno sguardo d’intesa, lasciò cadere il secondo nelle loro manine, tese ad afferrarlo. U strummulu girava solitario sul banco di legno, solo il piccolo ronzio della sua punta di metallo rompeva il silenzio ammirato dei bambini, che lo guardavano bramosi da dietro i loro enormi fiocchi bianchi. Continuò a girare per un po’, poi, man mano, s’inclinò e cadde, inerte, con un piccolo tonfo. Un moto di delusione, unito ad una moltitudine di richieste di un bis, inondò l’aula. “Che succede lì?”. Silenzio. I bambini corsero al riparo dietro i loro banchi, pietrificandosi al cospetto del cipiglio severo di una donnetta bassa coi capelli raccolti in una stretta crocchia sulla nuca. Il proprietario dello strummulu allungò la mano sul banco per recuperare il suo prezioso avere, ma un’altra mano, più grande e rigida, lo batté in sveltezza. La maestra prese il malcapitato per il braccio e lo trascinò dietro la lavagna, dove sembrava esser improvvisamente spuntata una coltura di ceci. “In ginocchio!”. Assicuratasi dell’attuazione del castigo appena impartito, salì sulla piattaforma della cattedra e fece l’appello. Ad ogni nome, una testa svettava verso l’alto e gridava: “Presente!”. Quando si sentì strillare l’ultimo “Presente!”, la maestra estrasse una flessibile bacchetta scura, sorrise alla classe con dolcezza e cominciò: “Un per uno?”. “Uno” risposero tutti in coro. E continuarono così fino alla tabellina del dodici. Le sorelle si levarono le scarpe e le infilarono dentro le cartelle rigide. La strada di ritorno era sommersa da fango e terriccio, e le scarpe, contrariamente alla pioggia che scrosciava imperterrita sulle loro teste, non cadevano certo dal cielo. Giunsero a casa zuppe di pioggia, misero a scolare i vestiti su una sedia e si rannicchiarono davanti al forno dal quale venivano sfornate, una dopo l’altra, vastedd(r)i, lunicedd(r)i e sciavati. Uno sguardo di disapprovazione della madre e si riebbero dal loro beato torpore. Presero due spicchi d’aglio, qualche pomodoro ed un mortaio, pestarono il tutto e lo posero in una ciotola; aggiunsero acqua, olio, basilico, sale e pane, ed avevano preparato il pranzo di quella giornata: agghia pistata. Le bambine e la madre mangiarono in silenzio e lavarono i piatti nella pila. Dopo pranzo, quando sembrò che il cielo avesse placato i suoi malumori, la madre e le vicine si riunirono in cerchio a recitare il rosario, 95 anche se talvolta, accostando l’orecchio tra un’Ave Maria e l’altra, si aveva la possibilità di carpire gli ultimi aggiornamenti sulla vita privata di quella povera disgraziata ch’era oggetto dei più svariati pettegolezzi. Le sorelle presero, un manico ciascuna, una cartedd(r)a e la trasportarono sotto un albero di loti, la riempirono – facendone accidentalmente scivolare due o tre nelle loro tasche – e la riportarono indietro. Poi si sedettero per un po’ nell’aia e, mentre impastavano della crusca con l’acqua, a canigghia, osservavano una chioccia agitata che si trascinava dietro una lunga scia di pulcini pigolanti. Sentite le donne pronunciare sbrigativamente l’ultimo “amen”, la più grande si affrettò a rientrare in casa, cambiarsi le scarpe e dirigersi verso un’abitazione non molto distante dalla loro. Si girò solo un attimo per salutare la sorella, ma vedendola intenta in un accanito inseguimento della starnazzante e contrariata chioccia, le voltò le spalle e s’incamminò per la sua strada. “Ahi!” Si mise il dito in bocca. Laddove l’ago l’aveva punta si andava espandendo un lieve e bruciante rossore, ma lei continuò instancabile a ncimari l’orlo. A mastra sarta, vicina a lei, le passò un ditale e le mostrò un punto sulla stoffa, poi la fece sedere accanto ad una cigolante macchina da cucito ed esibì la sua maestria nel confezionare la manica di un lungo cappotto. La bambina stette lì a guardare attentamente ogni sua mossa ed un’ora dopo, coi piedi che a stento arrivavano a far oscillare il pedale, aveva accorciato la prima manica della sua vita. Non appena tornò a casa trovò la sorella minore sporca di fango e paglia dalla punta dei capelli alla pianta dei piedi. Evidentemente, pensò, doveva aver pulito la stalla della mula e il pollaio nello stesso pomeriggio. Al limitare del vigneto le parve di scorgere sua madre che estirpava erbacce con la zappa che calava senza pietà sulla ramigna nascente. Si udirono, dall’altro lato del baglio, grida di giubilo. La sorella maggiore osservò nuovamente la madre e, quando la vide scomparire dietro un filaru di viti, agguantò la sorella per il braccio e corsero insieme verso gli altri bambini. Quel loro compagno di scuola ch’era stato punito per il suo strummulu aveva le ginocchia scorticate e doloranti, tuttavia il suo preziosissimo gioiello destava ancora euforici schiamazzi nella piccola cerchia che contava i giri della trottola e ad ogni nuovo lancio faceva scommesse su quanto avrebbe girato. Si unirono al gruppetto, ma ben 96 presto, come accade sempre tra i bambini di tutte le epoche, si stancarono di quel gioco e si cimentarono insieme in un altro. Uno di loro si staccò dal gruppetto, raccolse una pietra bianca da un cumulo di calcinacci, s’inginocchiò per terra e si mise a disegnare tanti quadrati numerati. I suoi compagni d’avventura parvero gradire la trovata e si disposero in fila ridendo, vantandosi delle proprie vittorie passate e narrando le eroiche imprese compiute per la presa del sasso, alla fine del gioco. Tuttavia, alla vista di un veterano della cricca che s’era appena aggiunto alla competizione, tutti tacquero. Quel bambino era infatti il re del Triritricchiti poiché, dopo quel fortunato pomeriggio in cui, in una corsa sfrenata per i campi, si era lasciato alla spalle uno scoppio esplosivo e la sua gamba sinistra, riusciva a completare l’intero triritricchiti saltando su una sola gamba. Nessuno tra i bambini ne era capace e tutti l’osservavano con l’ammirata riverenza di chi teme e stima qualcuno al tempo stesso. Tutti gli fecero largo, e in un batter d’occhio il sasso venne portato indietro più e più volte. Si levò un coro di applausi e complimenti, che quasi sovrastò il rombo di un aereo che sorvolava le campagne, in rotta verso le città. Un bimbetto minuto esclamò orgoglioso ch’era suo fratello a pilotarlo e che un giorno l’avrebbe regalato a lui. L’affermazione venne liquidata dagli sguardi scettici di molti di loro. Le due sorelle videro il sole percorrere la sua lenta discesa per poi tuffarsi nel mare e, salutando gli amici, si avviarono sulla strada di ritorno verso casa dove la madre, furente per non essere stata informata della loro assenza, le aspettava contrariata con le mani sui fianchi. La sera costituiva sempre il momento più frenetico della giornata. Ognuno aveva la sua postazione: la sorella minore era appollaiata sul coperchio del pozzo per avvertire del ritorno degli uomini; la sorella maggiore era seduta davanti al fucularu a mescolare fagioli e ad osservare l’acqua che bolliva; la madre coordinava le varie operazioni apparecchiando la tavola e preparando la stalla per il ritorno della mula. E fu proprio alla vista del muso affannato di questa che la minore balzò in piedi e gridò: “Eccoli! eccoli!”. Fu l’inizio dell’agitazione: la maggiore buttò la pasta nell’acqua, la minore si preparò a sbrigliare la povera bestia e a scaricare il carretto assieme alla madre. La cucina, vuota fino a pochi minuti prima, si riempì di cartedd(r)i traboccanti di zzubbibbu e catarrattu, mentre il padre pagava ai braccianti il lavoro della giornata. 97 Questi ultimi si congedarono con un cenno del capo, e, quando l’ultimo andò via, i piatti a tavola vennero riempiti. La madre era seduta rigida accanto al marito, affamato ed esausto. La maggiore delle sue figlie le porse gentilmente un piatto, ma la donna, in risposta, la guardò sdegnata ed esclamò: “Prima all’ómini!” e passò il piatto al marito, che con una cucchiaiata ne vuotò mezzo. Distribuite le porzioni, la ragazza sedette, attendendo con ansia il parere del padre che la guardò torvo, poi sorrise e trangugiò un altro boccone. Dopo di ciò, anche loro presero a divorare le loro porzioni ed il padre, nell’osservare le facce delle due bambine quasi immerse nei piatti, disse loro: “Mangiate, mangiate! I me figghi pani nunn’annu addisiari mai!”. La fine della cena riportò le due bambine davanti alla pila. Impiegarono molto tempo per lavare tutte le stoviglie sporche. Quand’ebbero finalmente finito, raggiunsero i genitori nel malasenu adiacente, dove il padre saltellava dentro un tino appiccicoso da cui schizzavano gocce di mosto. Le bambine, eccitate, saltarono con un balzo dentro il tino, ed iniziarono a pestare l’uva affondando le gambette fino ai polpacci. Continuarono a spremere i grossi acini finché non uscirono tutti e tre doloranti dal tino ed andarono a gettarsi addosso dell’acqua per lavar via il mosto dalle gambe, sotto insistente richiesta della madre, che aveva più volte promesso che li avrebbe lasciati dormire all’addiaccio semmai si fossero azzardati ad entrare in casa in quello stato pietoso. Infine entrarono in casa. Quel cufuni di terracotta che fumava al centro della stanza costituiva il punto di ritrovo di tutti gli abitanti di quel baglio illuminato dalla fioca luce dei lumi a petrolio. La sciagurata vicenda dell’ennesima vittima del Mostro del macello si era conclusa tra le grida spaventate dei bambini, ed una donna, seduta alla luce del lume, liberò dal cerchio di legno la stoffa rimasta a lungo tesa e si fermò ad ammirare soddisfatta la sua nuova vestaglia da camera. S’alzò per salutare il vicinato, che stava raggiungendo le rispettive abitazioni, poi, voltandosi, girò la manopola del lume e mandò a letto le bambine, che smisero immediatamente quanto stavano facendo e si fiondarono sui materassi di lana che la madre aveva battuto quella mattina. Vi crollarono su senza neanche spogliarsi; la maggiore rimase per qualche minuto sveglia, ad osservare la sorella già assopita. 98 I suoi occhi seguirono i movimenti repentini delle ultime scintille di fuoco che s’attardavano a scemare, poi, troppo stanca per fare alcunché, si lasciò cullare lentamente dalla voce crepitante di una fiamma ormai divenuta cenere. Si svegliò alla fastidiosa sensazione dei raggi di un sole già alto che premevano sulle sue palpebre. La sveglia, sul comodino accanto al suo letto, si ostinava a suonare la sua canzoncina ripetitiva senza tuttavia ottenere risultati. Il deciso rumore di un paio di tacchi sul parquet spinse la bambina ad alzarsi dal letto. S’infilò le pantofole e barcollò verso il bagno, dove aprì l’acqua calda della doccia che lasciò scorrere finché non si decise a togliersi il pigiama di flanella e a fiondarsi sotto il getto bollente. Si crogiolò sotto quel calore, riluttante a privarsene, ma un forte bussare alla porta la convinse ad uscire. S’avvolse in un soffice accappatoio e andò in cucina a fare colazione. Una signora in tailleur si sbracciava tra un ferro da stiro ed una tazza piena di latte che infilò in un microonde. Prese dei cereali dalla credenza, diede una stirata veloce al grembiule di sua figlia; il microonde strillò e la donna prese la tazza, la riempì di cereali e la porse alla bambina. “Non lo voglio: non c’è il Nesquik”, disse quest’ultima. La donna sbuffò e provvide alla richiesta della figlia che mangiò lentamente, incurante delle continue esortazioni della madre a sbrigarsi. La donna corse in un’altra stanza, prese lo zaino della bambina e lo gettò su un divano; la piccola andò a vestirsi, riluttante. Dall’altro lato della casa una voce maschile annunciò che non sarebbe ritornato dal lavoro prima delle sette; poi scomparve dietro il tonfo del portoncino blindato che si chiudeva alla sue spalle. La donna mise i soldi per la domestica in una busta e la lasciò sul tavolo, poi si precipitò dalla figlia per aiutarla ad abbottonare il cappotto. La prese svelta per mano, attivò l’allarme schiacciando alcuni tasti e si sbatté la porta alle spalle. Il piede della signora tamburellava senza sosta sul tappetino dell’auto; il traffico poteva pur bloccare le vie, ma non le lancette dell’orologio. Fuori dalla macchina esplodeva un concerto di clacson, e la madre ripeteva fuor di sé: “è tardi, è tardi!”. Infine, percorrendo il tragitto metro per metro, giunsero davanti alla Scuola elementare. L’auto sostò nel bel mezzo della strada. La donna spalancò lo sportello e fece scendere la bambina 99 con uno sbrigativo “Passo a prenderti io, oggi”, poi chiuse lo sportello in faccia alla figlia e si reinserì nel traffico. La maestra sbraitava disperata al cospetto di una classe di bambini poco disposti ad imparare alcunché. Menzionare la famigerata nota non sortiva più lo stesso effetto, e nessuno degli insegnanti riusciva a domare quell’orda scalmanata seppellita sotto zaini dai colori sgargianti. Quando il clamore si placò gradatamente, la maestra prese tre gessetti di colore diverso e scrisse alla lavagna “unità” in blu, “decine” in rosso e “centinaia” in verde. Si sentì un mormorio di cerniere che s’aprivano e i bambini estrassero dall’astuccio il loro arsenale di penne colorate; poi lentamente copiarono, cambiando penna di volta in volta e ripetendo: “Che c’è scritto lì?!”. Il vento spirava gelido sull’asfalto davanti alla Scuola elementare, fuori dalla quale s’era precipitata ormai da molto tempo un’orda scalmanata e variopinta di studenti in miniatura. La bambina aspettava fuori dai cancelli, osservando ogni sporadica automobile che le sfrecciava davanti, pur non riconoscendone nessuna. Infine un suv grigio si fermò sul ciglio della strada, la piccola aprì lo sportello e vi si arrampicò. “Sei arrivata tardi!”, esclamò poi. “Hai ragione, scusami” - rispose - “Guarda che ti ho preso!” e le porse un ovetto Kinder. La bambina s’illuminò e iniziò a scartarlo, abbassò il finestrino elettrico e buttò l’involucro al vento. “E allora che avete fatto oggi a scuola?”, domandò la madre. La piccola ci pensò un po’: “Le unità, le decine...”. Suonò il telefonino. La madre rispose, parlò fitto fitto, infine se lo mise in tasca. “Quindi a che tabellina siete arrivati?”. “Noi non abbiamo ancora fatto...”. E nuovamente squillò il telefonino. Il crepitìo dei bastoncini di pesce che friggevano nella padella quasi sovrastava le battute del cartone animato. La bambina, seduta sul divano, alzò il volume. Il rumore delle stoviglie annunciò l’inizio del pranzo. La madre posò i piatti sul tavolo, ma la bambina non accennava a muoversi. “Vieni a tavola!”, ordinò. “No”, rispose la figlia. La madre ve la trascinò a forza, a patto di tenere il televisore acceso. La bambina guardò torva il piatto che le si presentava sotto il naso. “Non mi piace”, disse subito. “Almeno assaggiali”, ribatté la donna. Ma la figlia non accennò neanche a prender in mano la forchetta. La madre le cucinò un’altra cosa; finirono il pranzo sulle note di una sigla televisiva e poco dopo la lavastoviglie iniziò a tremare vorticosamente. 100 La baby-sitter ripose i piatti dalla lavastoviglie nella credenza mentre la bambina faceva i compiti. Questa non impiegò molto a finirli e sgattaiolò nella sua stanza cercando qualcosa da fare per il resto del pomeriggio. Il suo esercito di bambole la guardò con sguardo vacuo e fisso, la bambina ne prese una bionda e si mise a giocare con essa, tuttavia quella non rispondeva alle sue domande, né le faceva nuove proposte: si limitava a guardarla con quei suoi occhi vacui e quel suo sorriso fermo, con quel viso innaturalmente rosa che non sarebbe mai invecchiato. La bambina la rimise al suo posto, mentre la voce della baby-sitter annunciava dalla cucina di aver trovato nella credenza delle merendine con cui fare uno spuntino. Il suo riflesso continuava a fissarla dallo specchio della sala di danza dov’era stata accompagnata un’ora prima. Costretta in quel tutù rosa, imitava i movimenti di una sorridente insegnante che parlava in termini francesi poco comprensibili. Qualche volta guardava il repertorio di smorfie delle sue compagne ad ogni piegamento, e ridacchiavano insieme. Ad un cenno della maestra tolsero tutte la gamba dalla sbarra, si fecero un breve applauso e si precipitarono fuori. La bambina trovò la madre all’ingresso, col suo cappotto aperto in attesa che lei lo indossasse. Uscirono e s’infilarono in auto, la madre mise in moto e furono sotto casa in pochi minuti. Al tavolo della cucina era seduto anche il terzo componente della famiglia, che in quel momento aspettava la cena conversando animatamente con la bambina vogliosa di riversare le sue gesta quotidiane sul primo ascoltatore che le fosse malauguratamente capitato sotto tiro. La donna portò in tavola due piatti di verdure per lei ed il marito, e mise davanti alla bambina una cotoletta con delle patatine fritte, conscia che la figlia non avrebbe mai mangiato altro. L’edizione serale del telegiornale annunciava le ultime notizie, mentre marito e moglie parlavano della loro giornata di lavoro, dei loro fastidiosi dirimpettai, di mutui bancari e di altre questioni delle quali la figlia, che posava lo sguardo talvolta su uno e talvolta sull’altra, non riusciva a capire il senso. Il salone fu poi occupato dai tre, ed iniziò la lotta per il monopolio televisivo. La bambina voleva guardare un cartone animato, i genitori tutt’altra cosa. La figlia, contrariata dalla democratica vittoria dei due, andò a posizionarsi davanti al computer, accese il monitor e aspettò che si fossero attuati tutti gli aggiornamenti per poter giocare su internet. I genitori, dal canto loro, restarono davanti al televisore a sentir discutere un insi101 stente conduttore ed un alquanto caustico ospite, con lo sguardo acido della bambina puntato addosso. Il monitor fu oscurato dall’ombra di un uomo alle sue spalle. “E’ tardi” - le disse dolcemente - “Andiamo, t’accompagno a letto”. “Non voglio andarci”. “Devi invece. Dai! Io e la mamma ti raccontiamo una storia”. La bambina, vinta dalla propria curiosità, si alzò e s’andò a mettere sotto le coperte. Poco dopo i due genitori entrarono e si sedettero accanto a lei, raccontandole la storia antica di un famigerato mostro chiamato “Mostro del macello” che usava mangiare i bambini che rubavano dal suo frutteto. La bambina ne rimase terrorizzata e, quando i genitori uscirono dalla stanza lasciandola con la sola compagnia di un piccolo lumino in un angolo, restò a lungo a guardare le ombre che quella fioca luce proiettava sulle pareti imbiancate; poi, in un ultimo regolare respiro, chiuse gli occhi e s’addormentò. Trovo che si presenti sempre una strana ed insistente sensazione alla fine di ogni viaggio, come un’insensata insoddisfazione, una voglia sfrenata di saper cosa viene dopo, come continuerà la vita di quelle persone che ci appaiono così tremendamente distanti, distaccate dalla realtà. Adesso, questa sensazione non m’appartiene. Molto probabilmente perché non ritengo finito questo viaggio, o ancora perché i personaggi descritti non nascono dai miei polpastrelli, ma dal suono di un tempo lontano che s’interseca con uno più prossimo. Suono che spesso non ascoltiamo, sordi alle parole di un mondo che grida, che cambia. è strano osservare il suo ciclo, in apparenza così ripetitivo, eppure ogni volta così nuovo, stravolto. Il tempo è il brutale assassino di fugaci istanti che scorrono, che lasciano al mondo altri istanti destinati ad una morte senza la quale nulla esisterebbe. Così in ogni epoca, pur rivoluzionaria, pur innovativa, si ritrovano caratteristiche di quella precedente, madre di essa: come un figlio ribelle ai genitori che, guardandosi allo specchio, vede il riflesso degli occhi di suo padre, della bocca di sua madre. Tuttavia ci beffiamo del passato, lo esaminiamo per poi accantonarlo, lo definiamo irrimediabilmente sbagliato e l’additiamo in quanto passato, guardando ad un presente che riteniamo certamente migliore e ad un futuro sempre più bello del presente stesso. Ed allora crediamo di progredire circondandoci del superfluo, e 102 non capiamo di star sotterrando l’essenziale sotto un cumulo di apparenze; poiché quando non si ha nulla si tiene a quel poco che si ha, ma quando si ha tutto si viene inebriati da esso e si perde il senso di ciò che perdura. Sembriamo dimentichi del passato, incuranti degli echi dei suoi insegnamenti, indifferenti ai suoi fragili resti, seppur così evidenti ai nostri occhi; come certe stelle nella notte, che noi osserviamo in silenzio ignari del fatto che l’oggetto della nostra osservazione potrebbe essere l’ultima luce di una stella ormai spenta. Abbiamo il passato sotto i nostri occhi, nelle rughe del volto dei nostri cari, in un capello bianco, in uno strofinaccio malriposto. Ma quel ch’è ancor più bruciante è la tanto ignorata possibilità di rimediare adesso agli errori d’allora, piuttosto che sommarne altri ai precedenti. Pensando a questo nostro atteggiamento, mi viene in mente quell’antica favola esopica che narra di un astronomo il quale, caduto in un pozzo nell’osservazione del firmamento notturno, viene soccorso da un fortuito viandante. Voglio concludere questo mio viaggio proprio col medesimo interrogativo posto all’astronomo dal viandante: “Come credi di poter ammirare l’immensità del cielo se non ti accorgi di ciò che hai davanti ai tuoi occhi?”. MARIA ELENA NAPOLI Vita nel baglio antico (archivio C. Di Bella) 103 L’ONORevOLe… BIANCA Nel dicembre1964, l’anno in cui accaddero i fatti che narrerò, avevo 19 anni e mi ero appena iscritto al primo anno della facoltà di Filosofia dell’Università di Palermo. Quando non frequentavo le lezioni, ritornavo a Paceco dove trascorrevo la maggior parte del mio tempo libero giocando a carte o ascoltando i discorsi dei più grandi al Circolo ENAL di via Amendola, del quale ero uno dei più giovani soci. Proprio in quell’anno, esattamente il 6 dicembre, Antonio Segni, già colpito il 7 agosto da trombosi cerebrale e sostituito provvisoriamente, come previsto dalla nostra Costituzione, dal Presidente del Senato Cesare Merzagora, presentò le sue dimissioni volontarie e dal Presidente della Camera dei Deputati fu avviato l’iter procedurale per una nuova elezione del Presidente della Repubblica. Furono convocate le Camere in seduta comune con la partecipazione anche dei delegati eletti dai Consigli regionali e le votazioni, che ebbero inizio il 16 dicembre 1964, si svolsero nell’Aula di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. Il voto avveniva a scrutinio segreto e nei primi tre scrutini era prevista la maggioranza dei due terzi degli elettori (950 membri del Parlamento e 13 delegati regionali), mentre dal quarto in poi era sufficiente raggiungere la maggioranza assoluta. Presiedeva le sedute il Presidente della Camera l’on. Brunetto Bucciarello Bucci, coadiuvato dal sen. Ennio Zelioli Lanzini che sostituiva, temporaneamente, Cesare Merzagora nella carica di Presidente del Senato. Per eleggere, il 28 dicembre, Giuseppe Saragat nuovo Presidente della Repubblica, ci vollero 21 estenuanti sedute, che si rivelarono particolarmente difficili perché la situazione politica generale nel Paese era molto arroventata in quanto i due anni della Presidenza Segni (che del resto era stato eletto con i voti decisivi del MSI e dei monarchici) erano stati contrassegnati da fortissime tensioni tra il blocco della destra conservatrice e quello, che spingeva per le riforme sociali e strutturali, formato dalla sinistra democristiana di Aldo Moro, dal PSDI di Giuseppe Saragat, dal PSI di Pietro Nenni e dal PRI di Ugo La Malfa. Inoltre, a rendere ancora più incandescente l’atmosfera avevano contribuito la caduta del primo Governo Moro(1), la proposta del Presidente Segni di conferire a Moro l’incarico di formare un governo di tecnici sostenuto anche da militari e, 104 infine, il diffuso sospetto che il Presidente della Repubblica avesse avuto un certo ruolo nelle vicende del progettato Piano Solo(2). Mentre a Montecitorio le Camere in seduta congiunta continuavano a riunirsi per le votazioni, anche a Paceco, come del resto, suppongo, nei paesi e nelle città di tutt’Italia, gli animi si scaldavano e non di rado si assisteva a violentissimi scontri ideologici che, a volte, si concludevano con qualche naso rotto o con qualche pugno in più. Fortunatamente nel nostro Circolo gli scontri politici si mantenevano entro i limiti verbali e mai nessuno osò alzare le mani per far prevalere le proprie idee. Ogni giorno, in quel periodo fortemente tormentato sul piano politico, i soci si riunivano numerosi nella grande sala d’ingresso del pianoterra, in attesa di assistere allo scrutinio nella stanza della televisione al primo piano. A volte pacatamente, qualche volta anche in modo agitato, gli interventi riguardavano l’esito dello scrutinio del mattino oppure di quello della sera precedente. Ognuno cercava di difendere il proprio “carro” politico e si facevano pronostici sul possibile eletto: i democristiani di sinistra quasi arrivavano ai ferri corti con i loro amici delle correnti di centro e di destra; i socialisti, i repubblicani e i socialdemocratici avevano il dente avvelenato per la caduta del primo Governo Moro; i comunisti lottavano contro tutti. Spesso, quindi, i dibattiti si rivelavano, a chi ascoltava, incomprensibili e assordanti. Fortunatamente, puntuale, arrivava l’ora dello scrutinio e tutti si avviavano al piano di sopra per assistere alla diretta televisiva delle votazioni e del conseguente spoglio dei voti. Poiché nei primi tre scrutini, per essere eletto, il candidato doveva ottenere la maggioranza speciale dei due terzi dei componenti l’Assemblea e ciò era impossibile, i partiti si sondavano tra di loro proponendo inizialmente candidature strettamente di partito e non di coalizione, mentre, nel frattempo, fuori dall’Aula di Montecitorio, si svolgevano le riunioni segrete per raggiungere i necessari accordi su una candidatura condivisa almeno dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Al Circolo ENAL tutte le fasi delle votazioni erano seguite attentamente dai soci più politicizzati e capitava anche che durante lo scrutinio a volte la discussione si animava più del necessario, soprattutto quando si cominciarono a delineare meglio le possibili alleanze che avrebbero potuto imporre il risultato finale: Popoff, il socio iscritto al Partito Comunista, del quale i maligni dicevano che ogni domenica andasse a mes105 sa al Santuario della Madonna di Trapani per non essere visto a Paceco, sosteneva già dai primi scrutini con tutte le sue forze e con la potenza delle sue poderose corde vocali la candidatura di Alberto Malagugini, deputato del Partito Comunista; lo zio Ciccio, il sensale di fede monarchica che leggeva sempre gli articoli sulla famiglia reale, con modi molto pacati ed educati ma anche con un certo imbarazzo, in assenza di una proposta espressa dal Partito Monarchico, sosteneva la candidatura di Augusto De Marsanich, deputato del Movimento Sociale Italiano; il geometra Crispino, notorio anarchico, faceva una caciarosa propaganda elettorale per Umberto Terracini, notissimo antifascista e uno dei padri fondatori della Repubblica; i democristiani, che costituivano la maggioranza dei soci, capeggiati dall’avvocato Giuseppe, il quale con l’eterna sigaretta accesa in bocca contribuiva a rendere notevolmente più inquinata l’aria della stanza, all’inizio sostenevano, secondo le loro correnti di appartenenza, Fanfani, Taviani, Scelba, Leone e Pastore; Peppe, l’infermiere, consigliere comunale del Partito Liberale Italiano, sosteneva naturalmente la candidatura di Gaetano Martino, deputato del PLI ed europeista convinto. Mano a mano che gli scrutini si susseguivano, al Circolo diventava sempre più difficile discutere e spesso la voce di Popoff raggiungeva tonalità che misteriosamente, ma sicuramente, superavano anche i limiti delle possibilità umane. Nel grande clima di incertezze in cui si svolgevano le votazioni, rimaneva impresso nella mente degli elettori, anche per il sacro silenzio con cui veniva ascoltato, lo spoglio delle singole schede, una dopo l’altra, scandito dal Presidente della Camera dei Deputati: “Leone Giovanni…, De Marsanich …, Pastore…, bianca ..., Saragat…, Terracini…, bianca …, Leone Giovanni, bianca …, Martino Gaetano…, bianca…, Saragat … nulla…, Malagugini…, bianca…, Fanfani…, bianca…”. Dall’undicesimo scrutinio del 22 dicembre fino all’ultimo tutti notarono che sempre più spesso il Presidente, leggendo le schede, pronunciava la parola “bianca”, che arrivò a raggiungere anche 152 voti, piazzandosi, negli ultimi scrutini, quasi sempre al secondo o al terzo posto delle preferenze espresse dai grandi elettori. Alla fine, nel pomeriggio del 28 dicembre 1964, al 21° scrutinio, il secondo della stessa giornata, Giuseppe Saragat, ottenuti 646 voti su 937 presenti, fu eletto Presidente della Repubblica Italiana con l’appoggio 106 dell’intera sinistra, compresa quella del PCI di Luigi Longo, e della corrente democristiana di Aldo Moro. Proprio nel momento in cui il Presidente della Camera stava dichiarando che proclamava eletto Capo dello Stato l’on. Saragat, lo zio Peppe, persona amabile e scarsamente loquace che in verità aveva seguito le votazioni quasi sempre dormendo, si svegliò e, rivolgendosi a tutti, disse con un’ insolita voce chiara e squillante: “Talìa! Talìa! Cu l’aia a diri chi l’onorevoli Bianca, chi unn u canuscia nuddu, a momentu addivintava Prisirenti da Repubblica?”. CARMELO FODALE Note 1. Il 1° Governo Moro durò dal 4-12-1963 al 22-7-1964 e la sua coalizione politica era composta da DC, PSI, PSDI, PRI. 2. “La vicenda legata al cosiddetto Piano Solo del 1964 apre uno squarcio tutt’altro che rassicurante su una fase nodale della nostra storia repubblicana, contraddistinta da lotte intestine e poco commendevoli tra politici, generali, uomini dei servizi segreti italiani e stranieri e poteri forti”. Giovanni Grasso in “Avvenire” del 23 novembre 2010. Paceco - Via Amendola negli anni Cinquanta (archivio C. Di Bella) 107 PASTAReLLe DI CRemA AL “BON TON” L’ampia piazza Vittorio Emanuele II, tra gli anni 1970 - 75, pulsava di vita sociale essendo quello il luogo urbano solcato dai passi di persone senza tempo, quei veraci cittadini ammantati della dignità del loro onesto lavoro che vi respiravano l'aria di collina del mio piccolo paese. In prossimità della scalinata di accesso posta a nord-ovest della piazza, c’era il bar Pizzolato che prendeva il nome dal cognome del proprietario, orchestrale della banda musicale, dinamico gestore. Nella bella stagione un juke-box sul marciapiede a ridosso della porta suonava musica festivaliera (ricordo 100 lire per tre canzoni) intrattenendo gli usuali clienti seduti ai tavolini schierati sotto l’ombra degli alberi. Dalla sommità di quella scalinata si intravede la città di Trapani con il blu del Mediterraneo ed il bianco sporco della sua Colombaia; oggi chi si affaccia vede nella sottostante piana pure una distesa di pannelli fotovoltaici al silicio che coprono le serre installate, e nella calura estiva alla luce dei raggi del sole può assistere al riverbero dell’aria calda che tremolante vi galleggia sopra. Discesa quella scalinata ed attraversata la strada, ci si trova innanzi ad una scala in pietra, la cui prima rampa, più corta, è addossata al muro perimetrale mentre la seconda, lunga e ripida, è interna alla costruzione, un edificio a due piani. L’edificio ospitava allora, al primo piano, la sede del Circolo di Cultura “Luigi Pirandello” ed i soci erano soliti, nell’accedervi dalla piazza, percorrere quel saliscendi e varcare il vano della porta che rimaneva costantemente aperta. Di peculiare interesse culturale, a pensarci bene, non rammento che cosa ci potesse essere in quel ritrovo tanto da aver scomodato, per il nome così altisonante, lo straordinario scrittore agrigentino del Novecento. Mi è comunque rimasto il ricordo di numerosi amici e conoscenti con i quali ci si riuniva per chiacchierare, leggere i giornali, giocare a biliardo, vedere la televisione e, di tanto in tanto, fare qualche partitina a carte. Inutile dire che nella mia cerchia eravamo sempre gli 108 stessi: un gruppo di squattrinati coetanei per lo più studenti universitari. Nei locali affacciati sulla piazza, dove di recente è stata allestita una esposizione permanente di reperti preistorici in due sale ammodernate, alla bisogna, dall’Amministrazione comunale, quindi a toccare l’ex bar Pizzolato, c’era la sede della locale esattoria dove lavorava, come dipendente della società che riscuoteva le tasse comunali, Giovanni Gualberti, uomo sulla quarantina di carattere estroverso e gioviale, nativo di Mazara del Vallo, che per motivi di lavoro si era trasferito con la famiglia a Paceco. Egli aveva sicuramente notato quel via vai di giovani e meno giovani che scendevano la scalinata, si inerpicavano sulla prima rampa e subito scomparivano alla vista, quindi si era incuriosito e, un primissimo pomeriggio, nell’attesa che giungesse l’ora di recarsi in ufficio, decise di salire al primo piano per sincerarsi del motivo di tale andirivieni. Quando, varcato l’uscio, entrò, qualcuno dei cortesi soci di sicuro interruppe la lettura del “Giornale di Sicilia” e, alzando gli occhi dalla pagina, mosso da senso di ospitalità, sollevò l’intruso dallo stato di evidente imbarazzo pregandolo, con modi affettati e gentili, di accomodarsi nel locale. Giovanni notò che nella sala retrostante l’ingresso-sala di lettura c’erano alcune persone intente a giocare a carte e, stante la buona accoglienza ricevuta, si avvicinò con discrezione al tavolo per osservare meglio, quindi, dopo avere silenziosamente assistito per un po’ al susseguirsi delle mani della partita di ramino, chiese o fu invitato a prendere il posto di qualcuno che doveva alzarsi per andare via. Ricordo che da subito precisò che egli, di norma, era aduso a giocare con una posta in palio che prevedeva per il vincitore non dei soldi ma, soltanto, delle pastarelle, ciononostante per quella volta avrebbe fatto un’eccezione, infatti era consapevole che la posta di quel tavolo era costituita da pochi spiccioli e quindi l’alea della perdita equivaleva alla spesa necessaria per affrontare il domenicale acquisto dei dolci di cui era ghiotto. Quel giorno la dea fortuna ebbe a sostenere l’innegabile abilità al gioco di Giovanni che dopo un’ora aveva vinto una discreta sommetta 109 e, poiché doveva tornare al lavoro frettolosamente, ci lasciò un po’ imbarazzato quasi scusandosi e portando con sé un piccolo gruzzolo. Riposte le carte, sprofondammo nelle poltroncine della sala di lettura, a dire il vero, un po’ contrariati dal fatto che quel signore “straniero” ci aveva spennati, non riuscendo ad accettare l’ordinaria idea che probabilmente era giocatore più abile ed esperto di noi nel ramino. Dopo una decina di minuti che il “fortunello” era uscito, entrò nella sala il ragazzo del bar Pizzolato che reggeva tra le mani un vassoio colmo di pastarelle e ai nostri interrogativi muti, pronto, rispose dicendo: “Comodi, tutto pagato: sono un omaggio per i soci”. Il buon Giovanni aveva investito i soldi della sua fortunosa vincita in quel vassoio e conquistato, dunque, la nostra duratura simpatia. Dopo circa quarant’anni racconto il gesto di signorilità di un uomo senza tempo, per l’appunto il caro signor Giovanni, perché altri possano assaporare la fragrante delizia di quelle pastarelle di crema al bon ton. NINO PIACENTINO Clienti seduti ai tavolini del bar Pizzolato (archivio C. Di Bella) 110 L’ULTImA BATTAGLIA Alla fine di settembre Favignana era ritornata alla serenità e alla pace dell’antico. I turisti avevano lasciato da due settimane gli alberghi e i residence per tornare nelle loro città frenetiche; le imbarcazioni da diporto avevano ceduto il posto alle piccole e rare barche dei pescatori locali. Il professor De Angeli, quella mattina del 28 settembre, era uscito di buonora dalla sua villetta a Punta Lunga e, in bicicletta, si era recato a Calarossa. Lo faceva ogni giorno quando la stagione turistica era terminata e la cala rimaneva deserta e silenziosa, illuminata da un sole caldo e splendente che rendeva lo specchio d’acqua marina a tratti dorato, a tratti blu intenso e, in certi punti, violaceo come l’Egeo. Poggiata la bicicletta, il professore sedette sull’altura a contemplare la darsena azzurra. Il silenzio era profondo, scandito di tanto in tanto dal lieve rumore di qualche onda che si infrangeva sugli scogli. De Angeli era anziano, ma la passione per il mondo antico in lui non era mai finita: tante volte agli alunni del Liceo di Trapani aveva narrato di quella battaglia cruenta che si era combattuta presso le Egadi, proprio lì, a Calarossa, nel 241 avanti Cristo, quando i Romani, con a capo il pretore Publio Valerio Faltone, avevano sconfitto i Cartaginesi dalle navi più lente, mentre, come vuole la leggenda, attoniti e impotenti gli abitanti dell’isola, allora chiamata Egusa, assistevano alla battaglia. Gli sovvenivano spesso i ricordi delle pagine lette e rilette di storici latini e greci che accompagnavano le sue giornate di studio solitario. Quella mattina rimase a guardare il mare per molto tempo; improvvisamente udì il fragore delle armi, le grida concitate dei soldati, i colpi di remi sul pelo dell’acqua: la darsena era piena di navi romane che incalzavano le più ampie ma meno maneggevoli imbarcazioni fenicie; i rostri di due navi dei Romani avevano già speronato due legni cartaginesi: parecchi soldati romani, con le corazze scintillanti, si precipitarono sulle navi nemiche, aggredendo i Cartaginesi in un combattimento corpo a corpo senza sosta; al centro del ponte di legno De Angeli vide un ufficiale che impartiva ordini gridando: non poteva essere che il comandante di cui tanto aveva letto; per un attimo, sbigottito, percepì le scintille provocate dal ferro delle spade che si incrociavano con colpi tremendi. Mol111 ti Cartaginesi, feriti a morte, cadevano in mare e il loro sangue tingeva di rosso le acque. Anche alcuni Romani perivano nello scontro: taluni rimanevano prostrati sul ponte della nave nemica, altri rovinavano in mare. Il professore avrebbe voluto alzarsi e gridare, ma si scoprì immobile e incapace di proferire una sola parola. Di colpo, com’era venuta, la visione scomparve. De Angeli, spossato, si rialzò a fatica, inforcò la bicicletta e si avviò lentamente verso casa. Dopo il consueto pranzo frugale trascorse il pomeriggio a leggere pagine di Polibio, Tito Livio ed altri storici minori: non vi trovò nuovi riferimenti alla battaglia delle Egadi e tanto meno notizie che potessero suffragare la visione della battaglia. Concluse che si trattava di un sogno e di nient’altro. Uscì sul tardi e si recò presso un ristorante dell’isola dove incontrò alcuni vecchi amici con i quali chiacchierò di alcune cose futili e di vecchi ricordi. Tornato alla villetta ricevette, a tarda sera, la telefonata del suo unico figlio, ingegnere, che viveva a Milano con la famiglia. “Papà, come stai?”, fu la domanda non di prammatica del figlio, preoccupato per la salute e la solitudine in cui il padre era immerso. “Ah, benissimo! Ho trascorso una stupenda giornata in riva al mare”, rispose De Angeli, mentendo a stento. “Già, come se non sapessi che non passa giorno in cui non stai a studiare le tue vecchie carte!”, incalzò il figlio. “Ho tanti amici qui e il mare mi aspetta ogni giorno, non voglio perdere neppure un appuntamento!”; con queste parole e con un tono della voce più persuasivo il professore riuscì a rassicurare il figlio. Si salutarono affettuosamente e De Angeli andò a riposare. Si addormentò con un testo di Polibio tra le mani, mentre leggeva ancora della battaglia delle Egadi. Il giorno dopo tornò di buonora a Calarossa. Poggiata la bicicletta sul dorso dell’altura, discese lentamente lungo il sentiero tracciato, giungendo in fondo alla cala. Si sdraiò in riva al mare e, quasi assopito, chiuse gli occhi, gustando il profondo silenzio che ben conosceva. Dopo una mezz’ora, all’improvviso, fu destato dal fragore delle armi e dalle grida dei soldati; rivide il piccolo golfo pieno di navi antiche: la battaglia continuava ed era sempre più cruenta: il comandante, inter112 venendo personalmente, partecipava al combattimento ed impartiva gli ordini a gran voce; i Romani incalzavano con forza incredibile: i loro elmi crestati brillavano al sole, mentre i gladi infliggevano ferite mortali ai nemici e i loro scudi fregiati paravano colpi violentissimi. Il combattimento continuava, fino allo stremo delle forze, sul ponte delle navi nemiche speronate ancora una volta dai rostri. Ormai le imbarcazioni cartaginesi, sovraccariche, si muovevano a fatica e rimanevano incastrate tra gli scogli. Quando di colpo la visione scomparve, il professore rivide lo specchio d’acqua azzurrato con riflessi violacei, quasi immobile e solo leggermente increspato dall’onda per niente agitata. Era calato un silenzio profondo e intanto si avvicinava una barca. Il pescatore che la governava attraccò rapidamente e, con un balzo, scese a riva. Era Salvatore, suo ex alunno alla Scuola media dell’isola. “Prufissuri, ma chi ci fa ccà? sempri a taliari u mari!”. “Il mare ha tanto da dire e tu dovresti saperlo”, disse De Angeli. “Veru è, comu ni ricia Vossia a scola: dal mare viene tutto, la vita, la civiltà e anche la morte”. “Te ne ricordi ancora, bravo!”, disse De Angeli, ma il suo tono tradì una certa commozione per avere sentito la parola morte pronunciata da Salvatore a voce più bassa. “Prufissuri, taliassi chi bedd(r)u purpu chi piscai, ci lu regalu, sacciu chi ci piaci”. “Grazie, Salvatore, sei sempre gentile”. Si salutarono cordialmente, il professore salì sull’altura a fatica, riprese la bicicletta e tornò a casa. Mentre pedalava ripensava a quanto aveva visto. Non si trattava di un sogno, ormai ne era certo: la percezione della battaglia era nitida, realistica, perfino nel fragore delle armi; ma allora doveva esserci qualcosa che non andava. Dopo pranzo si imbarcò sull’aliscafo e giunse a Trapani. Vicino al porto c’era lo studio di un geriatra che era stato suo allievo al Liceo. Fu subito ricevuto dal medico che lo salutò calorosamente. “Quali problemi ci sono professore? Qualche disturbo?”, esordì il medico. “Se alludi alla circolazione o alla prostata perché sono vecchio, ti dico subito che sei fuori strada!”, disse De Angeli impettito. “E va bene, 113 non faccio allusioni, mi dica tutto lei”, disse arrendevole il geriatra. De Angeli era un po’ imbarazzato, ma si fece forza e proseguì: “Il fatto è che… mi càpita di vedere qualcosa, qualcuno.. che non è proprio reale… come se sognassi, ma in realtà non sogno, ne sono sicuro… insomma ieri ed oggi sono andato a Calarossa, come faccio spesso, a guardare quel meraviglioso braccio di mare e… ho visto soldati romani e cartaginesi in combattimento, ho sentito il fragore delle loro armi, ho visto le navi da guerra antiche nella darsena, ho sentito perfino le loro voci…”. Il medico lo interruppe: “Ho capito, professore, niente di grave. Quando non si è più giovani capita che il cervello faccia qualche scherzo e che le immagini che abbiamo sempre avuto in mente si concretizzino, ma poi, come per incanto, scompaiono di colpo. Non è avvenuto così per lei?”. De Angeli annuì. “Noi però possiamo farle sparire per sempre”, continuò il geriatra. Si alzò, trasse da un armadietto una boccettina di vetro scuro e la porse al professore: “Ne prenda dieci gocce la sera dopo cena per due settimane e i soldati con le loro navi andranno via”. De Angeli riprese: “Tu risolvi tutto con una prescrizione; è davvero così facile cancellare una parte della storia?”. Il medico sorrise: “Professore, la storia non si può cancellare, noi medici eliminiamo solo qualche difetto di… comunicazione”. De Angeli salutò in fretta e tornò ad imbarcarsi sull’aliscafo per Favignana. Quando giunse alla sua villetta di Punta Lunga era tarda sera. Si preparò una cena frugale e mangiò lentamente davanti al televisore senza prestare troppa attenzione alle notizie del telegiornale: aveva altro per la mente. Terminata la cena, prese la boccettina che il medico gli aveva dato, versò lentamente dieci gocce di medicina in un bicchiere d’acqua e rimase a riflettere. “Dunque – pensò tra sé – li ho solo immaginati: eppure ho trepidato con loro, ho sentito le loro grida, il fragore di spade e scudi, il loro comandante che impartiva ordini, ho quasi sofferto la paura della battaglia e il dolore delle loro ferite”. Si alzò da tavola con il bicchiere in mano e ne vuotò rapidamente il contenuto nel lavandino del bagno. Tornò a sedersi sulla poltrona del soggiorno e riprese tra le mani il testo di Polibio. Riprese a leggere della battaglia delle Egadi. Dopo una buona mezz’ora richiuse il libro e disse a bassa voce: “Ma io li ho visti e sentiti!”. La mattina dopo Salvatore, con un sacchetto di pesce fresco in mano, bussò alla porta della villetta. De Angeli non rispose. Il pescatore tor114 nò a bussare. Nessuna risposta. Andò quindi a guardare attraverso i vetri della finestra e vide il professore accasciato sulla poltrona con il capo riverso ed un libro in mano. Capì subito. Corse gridando alla guardia medica per chiamare un dottore che venisse a vedere. Il medico di guardia con il maresciallo dei Carabinieri si recarono alla villetta di Punta Lunga; sfondata la porta, il medico constatò la morte di De Angeli per infarto. Il maresciallo redasse un verbale e avvertì il figlio per telefono. Salvatore piangeva disperatamente e presto tutti gli amici e i conoscenti vennero alla villetta dove fu composta la salma. Il giovane ingegnere giunse a tarda sera da Trapani, dove era arrivato in aereo. Non riusciva a darsi pace e continuava a ripetere a tutti che aveva detto tante volte al padre di andare a Milano a vivere con lui e la sua famiglia, ma l’anziano genitore rifiutava sempre e preferiva restare a Favignana con i suoi libri, la sua storia, le sue battaglie. De Angeli era andato finalmente a combattere l’ultima battaglia con i soldati che aveva visto, per dividere con loro le paure e forse la gloria, ma suo figlio non l’avrebbe mai saputo. GIUSEPPE GUIDO GARGANO Favignana - Calarossa con Erice sullo sfondo (foto C. Di Bella) 115 PALeONTOLOGIA TRAPANeSe Il seguente è il testo della relazione che l’autore doveva tenere nel corso di un convegno sull’Antigruppo Siciliano, in progetto a Palermo circa una decina di anni fa. Il convegno non si è più effettuato e la relazione è rimasta caparbiamente a presidiare i cassetti del (mancato) relatore. Giunta notizia della resa degli ultimi giapponesi rimasti nascosti nella giungla a tener alto l’onore della bandiera contro gli yankees e avuto sentore del piano di ristrutturazione di una nota casa automobilistica, l’autore ritiene arrivato il momento di licenziare il testo nella sua illibatezza. (R.L.S.) Buonasera. Ringrazio gli organizzatori per avermi concesso questo spazio, mettendomi in imbarazzo, dato che non sono un protagonista né un testimone e non posso parlare sul tema dell’Antigruppo a Trapani neppure nella qualità di persona a conoscenza dei fatti. Non avrebbe d’altronde molto senso parlare dell’Antigruppo a chi lo conosce ben meglio di me, e se ho colto bene lo spirito che lo ha animato, dovrei dire che adesso non avrebbe senso neppure il semplice parlarne. Suppongo però che tacendo così farei un piacere postumo a molti che dell’Antigruppo patirono il morso polemico ed allora, in applicazione della par condicio, preferisco fare un torto ad entrambe le categorie: a dispetto dei detrattori dell’Antigruppo trapanese ne parlerò, ma lo farò adottando una prospettiva da archeologo di formazione anglosassone. Sono dunque lieto di annunciare ai presenti il rinvenimento di un giacimento di fossile letterario in quel di Trapani, all’estremità nordoccidentale della Sicilia. Si tratta di un giacimento in buone condizioni, mantenutosi praticamente intatto in virtù dell’impenetrabile coltre di silenzio che lo ha avvolto. Io stesso non ne avrei saputo niente – pur avendo interrogato numerosi nativi del luogo, appartenenti ad un ampio arco generazionale – se una serie di circostanze favorevoli non mi avesse condotto a questa scoperta. Un insano virus da cui purtroppo sono affetto mi spinge ad aggirarmi per le biblioteche e le librerie della cittadina che ho eletto a campo di indagine archeologica, nessun altro tipo di indagine è infatti attualmente possibile in quella zona, data l’assoluta inesistenza di forme di vita culturale che oltrepassino lo stadio protoplasmatico. Ebbene, dicevo, facendo qualche sondaggio di scavo mi sono imbattuto in tracce sparse di un 116 fossile che pareva differenziarsi dalle altre forme presenti in situ. Si tratta di un gruppo di pubblicazioni recanti i titoli “Una Possibile Poetica per un Antigruppo”, “Antigruppo 73”, “Antigruppo 75”, “Un Tulipano Rosso”, cui vanno collegate le terze pagine del periodico locale “Trapani Nuova”, che per alcuni anni pare avere sofferto di una infezione opportunistica (l’aggettivo è usato nell’accezione corrente fra i patologi) da virus dei ceppi ‘Antigruppo’ ed ‘Intergruppo’. Di un secondo gruppo di pubblicazioni, legate al primo da un rapporto di parentela, parlerò in seguito. Il primo volume è una raccolta di saggi di vari esemplari appartenenti alla specie, e si apre con la rivendicazione della centralità della libertà d’espressione, conculcata principalmente dagli scrittori ‘conosciuti e stabilizzati’, che con il peso dei loro successi impedirebbero agli altri di trovare spazio nelle riviste e nelle librerie. L’arma principale adoperata in quest’opera di rivendicazione – direi pressoché l’unica – è la polemica, definita anzi “scopo principale dell’antigruppo” e volta anche all’interno, contro gli altri esemplari del branco. La polemica crogiolo di creatività, pare essere questo il nucleo centrale del sistema nervoso del nostro fossile. Un esame paleontologico comparato – di solito me ne occupo la domenica – mi aveva inizialmente fatto pensare ad una sia pur lontana parentela con un fossile vissuto in epoca più antica, denominato dai miei colleghi Futurismo, ma credo che le somiglianze siano limitate solo ad alcuni elementi. Se comune alle due specie paiono il piacere della polemica, l’attacco alle autorità, l’antitradizionalismo, l’uso di qualche onomatopea o di stramberie simili, non così è per il rapporto tra contenuto e forma, la quale ultima l’Antigruppo decisamente subordina al primo, e per l’enfasi attribuita alla non meglio precisata ‘spontaneità’ dello scrittore, basata sul desiderio di essere compresi dal popolo, stupidaggine da cui saggiamente il Futurismo si asteneva. Ad un certo punto vengono esposti 21 punti che costituiscono la poetica di fondo dell’Antigruppo: il kerygma della nascita di una nuova religione, quella della lotta al benpensante, l’infingardo che accettando lo status quo lascia gli uomini nello stato peggiore. Conciossiacosaché l’uomo scopre ‘la propria eternità in questo mondo’, per immanentismo esso diventa il paradiso in terra, dove l’ homo polemicus vive come un Dio. 117 La comunicabilità tra gli uomini in realtà non esiste – continua il nostro quaternulus drepanensis – perché altrimenti l’io e il tu si annullerebbero; vige invece l’eterogeneità della monade, temperata dalla affermazione che l’esame interiore consente di cogliere differenze e somiglianze e soprattutto di scoprire dentro di sé cose prima sconosciute. Il confronto con altri giacimenti ampiamente studiati dai colleghi ci consente di affermare che il problema della comunicabilità era un tema di ampia discussione artistica e culturale negli anni ’60 del ‘900, al pari di quello della sublimazione del sesso, esplicitamente richiamato nello stesso quaternulus. L’invito a non farsi condizionare dai timori, di epicurea assonanza, si trova consociato ad una anarchica meritoclastia, che ritiene ‘immorale’ l’azione di premiare i migliori, perché essa avrebbe la grave conseguenza di avvilire gli altri, confinandoli alla periferia, ‘senza contatti rinnovatori cogli ambienti più progrediti ed agguerriti’. Coerentemente con quanto sappiamo delle ricerche sul moto degli elettroni a cavallo tra gli anni ’60 ed i ’70, questa posizione viene definita ‘di sinistra’, antagonistica a quella destrogira, accusata anzi di soffocare del tutto il movimento. Che questo fossile avesse uno spiccato senso di cura della prole si evince dall’auspicio che tutte le scuole, a partire da quelle elementari, si dotassero di un giornalino d’istituto per la libera espressione delle idee. L’interesse per la catena generazionale andava però anche verso l’alto, dato che a poca distanza si rinviene anche l’aborrimento dalla distruzione della lingua (tentativo operato allora da altre specie coeve) con la chiara coscienza che ciò avrebbe comportato ‘l’annullamento delle esperienze accumulate attraverso le generazioni’. Il nostro fossile doveva anche avere uno spiccato senso estetico, se giungeva ad affermare l’istintività del riconoscimento della bellezza nel mondo e ad aggiungere vichianamente che l’essenza della poesia sarebbe il disvelamento dell’uomo sul foglio. Insigni etologi hanno riconosciuto chiare tracce di gestaltismo ed anche un incredibile spirito profetico, visto che la distruzione del Liceo classico, invocata a pag. 36 dell’opuscolo, si è puntualmente avverata tre decenni dopo. Non è però da scartare la teoria, avanzata da acuti entomologi, che tale sindrome distruttiva sia provocata da un batterio a sviluppo tardivo che, passato attraverso le deiezioni pseudoculturali allora alluvionalmente copiose, si sia impiantato nelle larve di minister studiorum, che come si sa sogliono patire di dementia novandi. 118 Sappiamo che in quegli anni c’era stata una rivalutazione letteraria del concetto fisico di entropia; il nostro fossile ce ne mostra traccia laddove leggiamo che “il caos incoraggia la situazione locale, il governo locale e, in ultimo, la libertà individuale”. Il concetto è ulteriormente sviluppato e legato alla funzione di sentinella che lo scrittore dovrebbe rivestire, svelando i tentativi del potere di mettere a tacere il dissenso, ma è temperato dall’invito wittgensteiniano a tacere se non si ha niente da dire. La poesia deve creare “scopi valevoli per continuare l’esistenza”, e visto che in ogni individuo viene dal nostro quaternulus riconosciuta una capacità artistica, ma negata l’eccezionalità della persona dello scrittore, sorge il sospetto che il carattere masturbatorio dell’attività scrittoria, esplicitamente affermato per gli altri e negato per sé, fosse invece il tratto distintivo della sessualità del nostro fossile. Sorge anche il sospetto che questa specie patisse di dislessia, che cercava ingenuamente di curare con numerosi esercizi di riconoscimento della lateralità (soprattutto sulla contrapposizione destra/sinistra) e con un maniacale attenzione per gli spazi. Il nostro prediligeva quelli locali, mostrando (apparente?) noncuranza per quelli nazionali: all’interno di quegli spazi poi il nostro agiva con implacabile ferocia, contestando e distruggendo tutto quanto gli desse impressione di compromissione con i potentati letterari nazionali. Nella sua ferinità non badava a precisi accordi, bastandogli che i suoi occasionali compagni condividessero semplicemente l’istinto contestatorio antiistituzionale. Sono attestate incursioni di branchi di Antigruppo in vari territori della Sicilia, anche in pascoli di cuccioli indifesi custoditi nelle scuole: pare che in tali circostanze si verificasse un terribile accanimento contro le chiocce, di cui si trova eloquente testimonianza nel fossile “Un tulipano rosso”. Tra le prede preferite ci doveva essere sicuramente il gattopardo, ma non sono riuscito a capire se la nostra specie fosse anche vegetariana e se in tal caso preferisse il bosco o il sottobosco. Ho perfino l’impressione che i vari esemplari si sbranassero tra di loro, soprattutto per questioni di dominanza del gruppo, all’interno del quale agivano poi spinte disgregative esplicite in nome della libertà e dell’antimosaismo, qualunque fosse la legge cui ribellarsi, compresa quella dei 21 punti. Che la nostra specie soffrisse di una sorta di masochismo esistenziale, pare adombrato da una poesia emblematicamente titolata “L’arte è arte se insuccesso”: forse si trattava però di istinto di sopravvivenza, perché 119 nel testo della lirica leggiamo che “il successo porta alla morte, è morte” e che l’intransigenza è cecità irrazionale, fideismo che porta alle tenebre. Non masochismo, quindi, ma realismo dissociato in pessimismo masocheggiante e incazzosismo ottimeggiante. In un certo senso anche questa dissociazione attesta il non trascurabile stadio di vita mentale della specie che qui stiamo esaminando. Che fosse dotata di spirito religioso è inoppugnabilmente attestato dalla testimonianza di uno struggente culto di Calì, per quanto dobbiamo presumere che non di influsso indiano si trattasse, ma di puro evemerismo. Tale culto non di meno aveva un suo valore di rottura, perché sappiamo altrettanto inoppugnabilmente che nel pascolo trapanese vigeva e vige ancora un ferreo monoteismo d’origine fenicia, che vede come protagonista assoluto il dio Baal, cui sono dedicati in città numerosissimi templi, tanto da farla paragonare nel suo piccolo al celeberrimo santuario d’Elvezia. Da attente analisi sui resti pervenutici, il paleontologo ha potuto ricostruire abbastanza definitamente alcuni esemplari della specie. Tralasciando quelli che pertengono ad altri territori e di cui hanno già parlato o parleranno adesso gli illustri colleghi, pare che caratteristici del giacimento propriamente trapanese fossero tutto sommato pochi esemplari. Il primo è il Franco Di Marco, che alcuni numismatici ipotizzano frutto di un incrocio gallogermanico, ma che testimonianze di prima mano mi inducono a ritenere assolutamente indigeno. Questi era l’uomo della medicina, anzi oserei dire che le sue funzioni oscillassero tra quelle del phàrmakon e quelle del pharmakòs, perché mi pare che non rade volte finisse per farsi terapeuticamente scaricare addosso gli umori negativi degli altri esemplari del branco, in particolare dello Scammaccus Natalis, il vero esemplare dominante, le cui scorribande sono attestate ben al di là dei pascoli nordoccidentali siculi. L’attività del Di Marco pare fosse soprattutto di carattere verbale compartecipativo, anche se ci sono non sparute testimonianze di suoi scritti (soprattutto traduzioni e prose varie), dalle quali si può ricostruire un quadro psicologico che rivela inaspettati segni di gentilezza e di compitezza, riconosciutigli anche dallo Scammaccus, profondo ammiratore del suo sorrisetto ironico. Il merito principale ascritto al Di Marco è il profondo legame affettivo verso la sua città natale, nonché il sostegno da lui elargito alla causa della libertà letteraria, tale da farlo tramutare, agli occhi dello Scammaccus, da vero liberale buono ad anarchico responsabile. 120 Tra gli altri esemplari minori locali, spesso semplicemente di passaggio nei pascoli dell’Antigruppo, ricordiamo il Petrus Billecius, radicatamente acquatico, attivo come poeta e critico. Non conosciamo tra l’altro l’esistenza in loco di esemplari femmina, ma in compenso sappiamo di femmine esemplari per fedeltà e capacità di sopportazione nell’accudire i loro compagni. Il re dei sauri locali è sicuramente lo Scammaccus Natalis, che però pone seri problemi di paleontologia. Innanzitutto, la sua origine: nativo del Nuovo Mondo, sarebbe in realtà frutto epigonale di una spedizione transoceanica dei suoi antenati, originari della Sicilia Orientale; la sua nidificazione all’estremo occidentale dell’isola sarebbe legata alla stanzialità della femmina da lui prescelta, uno di quegli esempi di cui parlavo sopra. In questi territori di cova egli si sarebbe anche riprodotto, ma della sua prole non troviamo traccia nella carta stampata locale e non, segno di un deciso innalzamento della qualità della specie. Lo Scammaccus riassume in sé tutti i principali tratti distintivi della razza, ragion per cui ritengo inutile riproporli nel dettaglio; mi piace però sottolinearne l’animo poetico, singolarmente contrastante con la sua etologia da tirannosauro. Autore molto prolifico (i suoi parti letterari sono numerosi e non disprezzabili), stupisce la sua capacità di resistenza (come avrà pagato tutte quelle spese di stampa?), che lo vede operoso anche in tarda età. Questo esemplare offre infatti un interessante campo di studio agli studiosi di gerontologia: pare che l’ultimo quindicennio sia stato da lui trascorso nell’insana pretesa di dimostrare che l’Odissea sia stata scritta in Sicilia Occidentale e forse da una donna, rielaborando le avventure di un marinaio locale: teoria pubblicata cent’anni fa dall’inglese Samuel Butler e ripresa da altri eccentrici studiosi di vari continenti, a proposito della quale lo Scammaccus ha avuto il coraggio di organizzare ben due convegni internazionali a distanza di un decennio l’uno dall’altro. Il profano che considerasse innocua questa demenza senile, dovrebbe ricredersi: non si sa come e perché, alcuni dei protoplasmi localmente sopravviventi gli hanno dato retta, mostrando una vitalità dello spirito Antigruppo francamente inaspettata in una specie estinta o ritenuta in via di estinzione. Allo Scammaccus appartiene un folto gruppo di fossili letterari, tra i quali mi preme evidenziare quello dal titolo “Estetica filosofica populista dell’Antigruppo siciliano”, che riprende e sviluppa quanto enunciato 121 nella “Possibile poetica”. Il fossile è un inno alla forza centrifuga, salutata come liberatrice dai controlli soffocanti di ogni centro (ma bilanciata da una forza centripeta che consenta di fare gruppo), ed una rivendicazione della positività del concetto di populismo, ritenuto valido in quanto espressione locale del povero e non del borghese benestante. Quelli che Althusser definiva ‘Apparati ideologici di stato’ (scuola, Tv, Radio, ecc.) vengono attaccati per via del loro spirito antidemocratico ed antilocalista, ma ad essi viene contrapposto un supposto ‘autentico’ spirito popolare (ed una altrettanto supposta ‘autentica’ lingua popolare) che francamente lascia sospettare l’uso di letture allucinogene. La lotta contro la selezione è condotta nel nome della democrazia e dello sviluppo deweyano della personalità, in coerenza con lo spirito antiautoritario tipico degli anni ’60 e ’70; forti sono anche i temi più propriamente politici (la propensione per il sistema proporzionale piuttosto che per quello maggioritario, il decentramento, la semplificazione del numero delle leggi per via referendaria, ecc.). Un precedente di questi concetti si può trovare nella prolusione di Mario Pilo ad un corso di estetica da lui tenuto nell’Università di Bologna nel 1901 e pubblicata col titolo “Per una estetica naturalistica e democratica”: in essa l’autore se la prendeva con l’estetica tradizionale, incapace di guardare ai prodotti di bimbi, selvaggi, criminali, pazzi, del popolo incolto. Pilo non risparmiava critiche all’artista militante, per il quale l’arte diventa una specie di fede religiosa, ed allo studioso di estetica troppo pronto a formulare leggi generali; egli inoltre auspicava l’introduzione dello studio dell’arte e del bello fin dalle scuole elementari proprio per la loro struttura decentrata e localistica, per favorire una fruizione consapevole e veramente democratica dell’arte. Il rinascimento estetico doveva venire, per lui, ‘dall’alto e dal basso ad un tempo’; l’operaio che si privava del bicchiere di vino per comprare anche il più banale oggetto d’arte era per il nostro Pilo motivo di commozione ben maggiore del ricco che acquistava l’opera d’arte dei più famosi maestri contemporanei. Viene infine esplicitamente teorizzata la lotta all’accademismo e al dogmatismo. Coerentemente con lo spirito del tempo, l’autore professava un ‘determinismo totale’, diverso però dal ‘fatalismo’, che certamente lo differenzia dallo Scammaccus, ma a noi interessava mettere in risalto l’esistenza di un filone estetico e democratico anche in epoca ben anteriore a quella dell’Antigruppo. 122 Un’ultima precisazione: il vuoto assoluto in cui si sono conservati i fossili letterari di cui vi parlavo all’inizio è relativo alla menzione in fonti locali coeve o posteriori, e non riguarda l’esistenza di altre forme di vita letteraria nello stesso strato archeologico da me esplorato, che presenta anzi una certa ricchezza quantitativa. Si tratta però perlopiù di materiale di risulta, opera – come felicemente puntualizza Salvatore Mugno nel suo studio su quella autentica Cripta dei Cappuccini che è il Novecento Letterario Trapanese – di “isole e narcisi”, incapaci di scorgere altri che sé medesimi: giudizio duro ma forse non errato. Le capacità inventive dell’Antigruppo trapanese sono attestate dal tentativo di creare in città un simulacro di vita culturale, animata dai furiosi morsi polemici distribuiti a dritta e a manca; ciò che al benemerito Vittorio Frankenstein fu concesso, non toccò invece ai nostri dacnosauri che per un breve periodo. Oggi la cura delle acque trapanesi è affidata all’ammiraglio Persano, l’eroe di Lissa, le scuderie sono affidate a Giovanni Senza Terra, le onoranze funebri sono di spettanza di Francesco Ferrucci e Fabrizio Maramaldo: e se non se n’è accorto nessuno è solo perché – alla facciazza dell’Antigruppo – la cultura del popolo non ha voluto o saputo mantenere il contatto con la tradizione dotta e neppure con quella popolare, ma s’è irrimediabilmente e totalmente televisivizzata. Ecco perché sono spiacente di annunziare che gli Antigruppo ancora circolanti in loco non sono neppure dei cloni, bensì delle realtà virtuali, da cui la popolazione saprofita trapanese non riuscirebbe a trarre alcun nutrimento. A questo punto l’archeologo ha sufficientemente rotto le scatole e può anche salutare, ma il sottoscritto vuole sciogliere un cantico a quanti, simpatici o antipatici, in buona fede e con autentico spirito democratico, hanno tentato di vivificare un ambiente, quale quello trapanese, altamente refrattario alla vita culturale (paludata e non). Sarà perché li conosco, ma io a Franco Di Marco (che purtroppo oggi ci sorride da altro palco) e a Nat Scammacca voglio bene, forse perché ne ho saggiamente e parcamente dosato la posologia. Non sarà una dichiarazione interessante e neanche sensata, ma… RENATO LO SCHIAVO 123 OmAGGIO A F. De SANCTIS Al di sopra del clamore rissoso delle voci dei sostenitori del Romanticismo da una parte e del classicismo dall’altra si leva alta e limpida la voce di F. De Sanctis (1817-1883), il quale, pur se vivamente partecipa al movimento accettandone le posizioni essenziali, ne supera le contraddizioni e formula non una poetica, ma una vera dottrina estetica, originale e salda, fondata sulle teorie romantiche, ma costruita su fondamenti dottrinali rigorosissimi, quali fino a quel momento, pur tra intuizioni talora felici, nessuno era ancora riuscito a offrire. Nasceva così la critica estetica, che è gloria tutta nostra, su cui si fonderanno, si svolgeranno e si svilupperanno tutte quelle teorie critiche che, fino ai nostri giorni, hanno aperto nuove vie alla interpretazione e all’intendimento dell’opera d’arte. Alla scuola del purista B. Puoti, il De Sanctis aveva appreso il gusto della diligente e minuziosa lettura dei testi; ma l’arido studio della parola non poteva da sola soddisfare il giovane studioso che, nelle opere che andava leggendo, scopriva la ricca spiritualità dell’autore, che vi profondeva tutta la ricchezza della sua vitalità creativa. E lo stesso B. Puoti, che percepì il valore di questa particolare attitudine, gli affidò persino un gruppo di discepoli più giovani, che certo avrebbero beneficiato della sensibilità estetica della loro guida. A questa prima esperienza didattica si aggiunse, successivamente, il breve periodo di insegnamento a “La Nunziatella” di Napoli. Ma il momento più significativo di questa esperienza fu quello che si realizzò nella nuova scuola, che egli stesso fondò e diresse, in cui introdusse un metodo ben diverso da quello del Puoti. Le lezioni, in questa scuola, non erano dogmatiche o cattedratiche, ma si sviluppavano in una individuale ricerca e in una libera discussione tra il giovane discepolo e l’entusiasta maestro, cui facevano seguito poi discussioni, che coinvolgevano anche gli altri discepoli. In questo esercizio e nelle ricerche, in queste letture analitiche dei classici, venne formandosi la problematica e la dottrina del giovane maestro; mentre il suo senso critico e il suo innato gusto del bello si andavano affinando ogni giorno di più. Con lo studio della filosofia di Hegel, gli si dischiuse il campo delle dottrine filosofiche del Romanticismo germanico e si accorse che non è possibile fare critica d’arte senza fondarla su una concezione filosofica dell’arte. La sua 124 teoria dunque andava prendendo forma scientifica: e bisogna notare che se in un primo tempo egli si accostò alla dottrina di Hegel, che vede l’arte come un momento particolare della conoscenza (cioè un momento empirico, intuitivo, quasi un gradino più basso del vero momento conoscitivo e come contrapposto alla vera conoscenza, che è, invece, momento intellettualistico, universale, filosofico), in un secondo tempo però egli se ne allontanò poiché comprese che l’arte è una funzione autonoma dello spirito, che essa è puro frutto non della facoltà conoscitiva, ma della fantasia, perché facoltà creativa dello spirito umano. L’arte, per il De Sanctis, è forma, vale a dire bellezza, perfetta espressione di un mondo di pura fantasia. In virtù di questa concezione desanctisiana cade la ormai vieta distinzione tra contenuto e forma, per la quale l’arte era vista come elaborazione di un contenuto, materia scelta dalla volontà dell’artista e poi adornata da una bella veste formale. Ogni contenuto - dice invece De Sanctis - nasce con la sua forma ed è da essa inscindibile; per cui la sua forma non può essere che quella, perché nasce come unità indissolubile di quel contenuto con quella forma: il contenuto, un organismo vivo, che non può essere scisso nelle sue parti senza morire. Come i romantici tedeschi, F. De Sanctis proclama ancora la libertà dell’arte, dichiarando che la valutazione dell’opera d’arte è indipendente da ogni finalità pedagogica, morale, religiosa, politica ... : il valore dell’opera d’arte, infatti, per lui, sta nella sua bellezza, indipendentemente da ogni altro elemento di valore pratico o conoscitivo; proprio per questo il contenuto licenzioso, la dottrina politica non accettata, l’argomento scabroso non sono di per sé parametri negativi nella valutazione dell’opera d’arte perché sono estranei all’oggetto estetico: il solo elemento in cui si concreta l’opera d’arte è la bellezza. Quanto sin qui siamo andati dicendo sulla teoria estetica desanctisiana non ci viene da un’opera sistematica, ma si ricava dalla lettura della sua vasta produzione: le sue idee sono sparse nel contesto di tutta l’opera sempre in forma chiara, ben determinata, senza contraddizioni o incertezze, con una coerenza assoluta, che è frutto di una mente lucida e rigorosamente razionale. Il valore della sua teoria estetica del resto si può misurare anche dagli sviluppi ulteriori, che essa ha avuto nel ricco articolarsi delle posizioni dei molti critici successivi che da lui prendono le mosse. 125 L’opera del De Sanctis è testimonianza monumentale del suo temperamento vivo, ardente e comunicativo di maestro, che aveva vivissimo il senso estetico dell’arte, e rapida e sicura la capacità di cogliere, dall’opera che esaminava, il nucleo ispiratore, il centro da cui prendeva vita tutta la composizione. Con questi criteri, egli riprese in esame, con gusto vivido ed animo e occhi nuovi, tutta la nostra letteratura: da Dante a Leopardi e ci diede interpretazioni penetranti e acute, commosse ed equilibrate insieme, che nascono da una vibrazione intensissima di sentimento e si esprimono nel calore concitato dell’esposizione, che dà, ancor oggi, nel leggerle, l’impressione di udire la parola vivace e vibrata con cui egli parlava ai suoi discepoli. Però la sua non fu solo opera di critico, ma anche di storico, poiché, da quel romantico che era, egli considerò la letteratura come un aspetto dello spirito nel suo svolgersi, mai scisso dalle vicende della storia civile della patria, legando, talora forse troppo intimamente, alle alterne vicende civili e alle varie fortune del Paese, il valore estetico di talune opere della nostra storia letteraria. E quasi a sua discolpa, il Fubini(1), nel noto studio sul Romanticismo italiano, per spiegarne l’origine, chiarisce che la tendenza di dare un taglio nazionalistico alla storia delle lettere non è caratteristica esclusiva del De Sanctis o dell’Italia, ma è propria di tutto il Romanticismo europeo. Infatti alcuni giudizi della storia letteraria del De Sanctis ed alcuni periodi della nostra letteratura, da lui troppo frettolosamente o troppo severamente giudicati, perché legati a tempi di decadenza politica, sono stati rivisti in seguito da critici romantici posteriori. Da buon romantico, invece, F. De Sanctis fu grande ammiratore di Dante, di cui sentì però più potentemente la poesia dell’Inferno che quella del Purgatorio e del Paradiso, come quella più ricca di impeti e di passioni, così come fu anche più entusiasta del Medioevo primitivo, spontaneo e violento, e ricco di sentimenti, che del Rinascimento. Il cui equilibrio tra ritmo espressivo e immagini creative e la serena armonia che ne derivava, glielo fecero sembrare freddo e quasi privo di vita perché contenuti nella passionalità; a ciò si aggiungeva anche il suo rigetto delle teorie aristoteliche: del principio di imitazione e delle tre famose unità di luogo, di tempo e di azione. La sua opera ebbe, nel periodo in cui fu scritta, poca fortuna, imperando, in quel tempo la critica storica, sostenuta dall’autorità del Carducci ed egli stesso fu giudicato scrittore piuttosto sciatto incòndito. 126 In tempi più vicini a noi, non si scoprì soltanto l’alto valore della sua opera dal punto di vista critico, ma si mise in luce la vivezza, l’efficacia espressiva e il calore della sua prosa, che entusiasma e convince poiché dettata dalla foga della passione di ciò che pensa e ama con tanta convinzione: infatti in lui, grande fu la fede in un ideale non vago ed estratto, ma attuato, giorno per giorno, nella vita dell’individuo e della nazione. Ma per dare risalto alla ricchissima umanità di F. De Sanctis, mi piace concludere questo “ricordo” con una sua citazione, essa mostra non solo la statura morale del nostro personaggio, ma quanto egli avesse a cuore la formazione delle giovani generazioni, cui le parole sono indirizzate: “Libertà senza limite è una semplice e sterile fermentazione senza scopo e senza mezzi, è il Caos. Libertà come limite è la creazione, è l’organismo. Perciò Libertà e Legge sono termini correlativi, l’uno implica l’altro, l’uno non può stare senza l’altro. Libertà senza Legge è la dissoluzione della vita, Legge senza Libertà è la compressione della vita”. GASPARE COTTONE Note 1. Ma, dice il Fubini, “Non al De Sanctis, infatti, né all’Italia, impegnata nella lotta per l’indipendenza, e per l’unità è peculiare la concezione di una storia nazionale della letteratura, ché essa è propria di tutto il Romanticismo europeo e le contraddizioni cui dà luogo, la loro origine e anche forse la loro soluzione meglio si possono cogliere se ci si rifà alle idee e ai motivi del Romanticismo, che fu, come è noto, non soltanto un fenomeno europeo e contribuì a rimuovere barriere fra letterature e letterature e a fare intendere con uno spirito di simpatia, fino a quel tempo ignoto, opere poetiche di tutti i tempi e di tutte le nazioni ma per se stesso, per la giustificazione storica, a cui si richiamava, e direi, per il suo nome era un’affermazione vigorosa e nuova nella coscienza di una unità europea, della comune origine e di un comune carattere della moderna Europa; e tale fu sentito dai romantici nostri, i quali così vivamente si opposero all’angusto e retrivo nazionalismo dei classicisti, e si compiacquero di riconoscere nella letteratura nostra una delle letterature romantiche alle altre intimamente congiunta” (M. Fubini, Il Romanticismo italiano, Bari, Laterza, 1953). 127 ASTeRISChI Tra i ricordi scaldati, come dire? dalla tenerezza: il mio nipotino Davide, verso i quattro anni (2005), vuole veder dalla finestra del mio studio “Trapani”, “Pacheco”, “la Sicilia”… e mi chiede di venire in braccio. E spesso mi fa: “Nonno, sei pesante”. Su per giù in quel periodo, Davide mi domanda: “è vero che i nonni, quando sono vecchi vecchi, vanno in Cielo?”. “Così sembra”. “Ma io ti acchiapperò forte forte per la giacca e non ti farò andare”. E mi rimprovera: “Perché tu non hai acchiappato forte per la giacca tuo padre e i tuoi nonni?”. * Lo scopritore del DNA è convinto di possedere la prova scientifica che la coscienza ha origine fisica. Se siamo nati con la ragione, certo facciamo bene ad usarla, non ignorando tuttavia che simili opinioni di per sé non costituiscono scienza. D’altra parte non ci dice la scienza che la parte materiale dell’uomo si rinnova del tutto ogni sette anni, e perciò... come si spiega l’identità costante dell’io, sia pure con il cerchio delle esperienze e della crescita spirituali che si va allargando? * Non poche persone prima sgomitano per ottenere in premio un cavalierato o delle recensioni, o per essere assunte e di traùscu in posti di prestigio, o per occupare poltrone di sottogoverno... e poi si vantano del successo ottenuto come fosse frutto di merito. Spesso ben coperte dalla maschera del viso. * Mi torna alla memoria che per i festeggiamenti - piuttosto pretenziosi, qualche anno fa - organizzati nella nostra Chiesa Madre in onore di S. Caterina d’Alessandria, venne messo in rilievo, nel pieghevole distribuito, la presenza dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro (vistoso mantello speciale, e, sopra, facce intronate e soddisfatte). Per l’occasione fu organizzata anche una “conviviale di gala”, alla quale fui invitato (ma non andai), da un giovane sacerdote aristocrateggiante. Che ha a che fare il cristianesimo con simili messe in scena? * Ospedale civico di Palermo, diversi anni fa: spuntano dall’entrata e vanno leste per il corridoio tre monache - supposi - di clausura: basse, massicce, il viso vecchio e fosco, abiti e copricapo neri ed enormi; vanno come in fila, e l’ultima incede piegata in avanti, e questa e almeno un’altra hanno un’andatura e tratti che le fanno assomigliare al Quasimodo di Nôtre Dame o al personaggio più tipico - quanto meno nel film - del romanzo In nome della rosa. Questa è comunque l’immagine che immediatamente appare a me; e mi sento sbalestrato nel Medio Evo, in quel Medio Evo tetro della cui idea era rimasta traccia in me dai tempi della Scuola media e del Liceo. Quando, più tardi, le monache tornano indietro, il mio stato d’animo è cambiato: un po’ perché quell’idea di M. E. è stata soppiantata da quella - senz’altro diffe- 128 rente, ed ora riemersa - che mi son fatta insegnando Filosofia e Storia al Liceo classico, un po’ perché guardando meglio il viso delle monache, ora apparsomi non proprio vecchio, ho intravisto un candore illuminato, direi, da letizia. * Affermazione televisiva recente della nota astronoma Hack: “Milioni - o miliardi, non ricordo bene - di universi materiali si allontanano gli uni dagli altri… e che senso vi ha il piccolo Dio?”. è scientifico confondere metafisica e fisica? E Dio sarebbe “piccolo” per il fatto che è concepito senza materia, cioè (e a torto, per la Hack) come spirito? La Hack ha il diritto di avere le proprie certezze, come, sia pure in senso opposto (il mondo svela una Intelligenza superiore), Einstein; tuttavia non può scambiarle per verità sacrosante, non vivificate o rese almeno problematiche dal sale del dubbio. * A guardarlo in certe situazioni, il mondo sembra una giungla irredimibile: migliaia di bambini che ogni giorno muoiono di fame, assassinii di massa compiuti da bestiali dittatori, stupri “etnici”, ingiustizie e insensatezze... il cui buio tragico spinge non poche persone verso l’ateismo. Altre situazioni rivelano, direi, una straordinaria rivelazione di Dio: ad esempio, quel meraviglioso gioiello che è il cervello (materia e caso?) e a maggior ragione la crescita di un bambino con miliardi di cellule che in genere procedono in armonia, l’io consapevole di sé, taluni segni che fanno pensare ad una realtà diversa da quella fisica e su cui trascuriamo spesso di soffermarci... La giungla mi turba non poco. Ma pur’essa, in fondo, a pensarci bene potrebbe in qualche modo essere rivelazione. * C’è in ciascun uomo un dr Jekyll e un mister Hide? In me, francamente, non l’ho mai avvertito, anche se non sono immune da reazioni talvolta mal controllate. Ma l’ha visto, diciamo così, il compianto pittore compaesano Enzo Castiglione, in un ritratto da lui dipinto nella seconda metà degli anni Sessanta, al Circolo ENAL comunale del nostro paese, sotto i fumi dell’alcool: era convinto che il responsabile dell’ubriacatura fossi io (ne facevamo tanti, allora, scherzi da prete), e fattosi accompagnare a casa a prendere cavalletto, tela, pennello e colori, mi colorì con dei verdi che mi fecero inorridire. Quel quadro deve conservarlo la moglie. Penso che per farsi perdonare mi fece posare poi per il ritratto, che mi regalò e ho a casa mia e mi raffigura assai meglio, sia pure scamiciato e giacobino. * Mi tornano ogni tanto nella memoria fatti e sentimenti vissuti o provati in passato. Gradevoli, a volte, a volte uniti a un qualche rimorso (sofferenza inflitta a qualcuno, a cominciare dai miei genitori; incomprensione di alunni o colleghi docenti, mancata assistenza a persone bisognose...). In tal caso, comportano una afflizione tuttavia non priva di utilità, perché costituisce una sorta di esame di coscienza che per lo più spinge, credo, al riscatto. Naturalmente, gli errori e le colpe possono poi ripetersi, giacché un po’ tutti siamo come i personaggi del Gozzi, che commettono di solito gli stessi errori. 129 * Un ricordo, fra gli altri, mi torna ogni tanto in mente: il meraviglioso sapore del pane -poco prima o, più probabilmente, durante i primi anni di guerra (’40-41) -, dopo una malattia che, ragazzino, mi aveva privato per qualche tempo di esso. La mia vita, specialmente ora che sono avanti negli anni, è zeppa di ricordi di questo tipo, che fra l’altro riportano a straordinari sapori antichi. Infantili, direbbe il Croce; ma chissà che sarebbe, la vita, senza sapori o momenti infantili? * In moltissime persone c’è, seppure non sempre evidente, un bisogno profondo di Chiesa. Tant’è che spesso la “chiesa” viene identificata con la classe sociale, il partito, la Massoneria, l’Arma, l’associazione, e così via. Segno del bisogno di Assoluto? * Rileggendo miei vecchi scritti (articoli, lettere, ecc.), noto lacune, imprecisioni, stupidaggini. La vita spirituale di ciascuno è come il cerchio che si allarga nell’acqua dopo che vi hai lanciato un sasso: le idee, insomma, via via si precisano, si arricchiscono ed ampliano, con riflessi sull’evoluzione o sullo sviluppo dell’io. M’infastidisce (ma può anche destare in me un sentimento di tenerezza) ritrovarmi, talvolta, in un cerchio superato da tempo; ma in fondo è anche per quello che son potuto passare oltre ed essere pervenuto a quel personaggio, magari, a sproposito, sopravalutato, in crescita culturale e spirituale che sono oggi. * Guardando il cielo di notte - d’estate, in campagna - da più di un decennio riesco a vedere solo qualche stella e i pianeti più luminosi. Non più, dunque, la miriade di stelle che una volta occhieggiavano. Ricordo, negli anni della fanciullezza, la splendida Via lattea, le costellazioni, le nebulose che lassù tingevano, diciamo così, il firmamento. Le forti e a volte colorate luci dei paesi e anche delle strade isolate impediscono di distinguerle. Col cannocchiale, l’unico astro davvero godibile in campagna è ormai la luna. Da ragazzo, il firmamento m’incantava e rimanevo a lungo ad osservarlo. Non solo, in verità, da ragazzo. E sino a pochi anni fa, a Sant’Andrea di Valderice, dove la famiglia trascorre l’estate, erano facilmente osservabili Giove e numerosi suoi satelliti e altri pianeti, compreso lo spettacolare Saturno, che (con il cannocchiale, s’intende) osservavo senza particolare interesse scientifico ma con stupore poetico o, se vogliamo, fanciullesco. Mi manca la possibilità di alimentare questo stupore. Da casa mia, in paese, non riesco più a vedere nemmeno la stella polare. * Assistendo a un dibattito televisivo su “essere” e “avere”, noto - almeno così mi pare - gran confusione su termini e concetti: in genere, significato positivo ad “essere” e negativo ad “avere”. Ma si può essere Abele e più o meno anche Caino; santi e diavoli. Si può “avere” ed esserne schiavi ed “avere” per realizzare il nostro bisogno di amore, di solidarietà, di giustizia, ecc. 130 Quel che veramente conta è la sintesi tra “essere” e “avere”, insomma “essere”, via via sempre più, quel che di meglio c’è nella coscienza, e “avere” per aiutare gli altri, oltre che noi stessi, ad “essere”. * Le recensioni letterarie talvolta mi impressionano per la loro profondità, ma più spesso per la saccenza e la presunzione. Nell’uno e nell’altro caso penso siano, molto più di quanto non sembri, proiezioni della sensibilità, del tipo d’intelligenza, delle inclinazioni, dei limiti dei recensori più che analisi adeguate della produzione e/o della realtà dei recensiti. Ma possono anche essere, s’intende, espressioni di amicizia, di adulazione, di ipocrisia. Alcuni critici non sanno distinguere l’uomo, diciamo così, dallo scrittore (o dal pittore o dallo scultore, dal musicista, ecc.) e ritengono un grande scrittore anche un grande uomo, e ne apprezzano o giustificano persino comportamenti non degni d’essere apprezzati. E invece possono esserci grandi scrittori nel contempo piccoli uomini. La storia non ne fa difetto. * Non di rado gl’intellettuali sono incapaci, come dice il Metastasio, di un “bel tacere”: come se avessero sempre la missione di illuminarci. Quando Feltrinelli, per fare, penso, una spacconata terroristica cadde da un traliccio procurandosi la morte, non mancarono gl’intellettuali, a cominciare da Camilla Cederna, che gridarono al complotto. E, per fare un altro esempio: senza la base di elementi precisi furono trovate subito macchinazioni più o meno assatanate allorché Pasolini, che, come tutti sapevano, viveva una vita particolare, fu travolto, pare, sotto un’automobile da un giovane (che forse non operò da solo) adescato, prima, dallo scrittore. La politica ci ha abituati a sentir parlare di complotti ad ogni piè sospinto. Sarebbe frequente, insomma, da noi, esser presi di pìzzula, come dicevano una volta certe famiglie di studenti svogliati e di rampolli bocciati o rimandati. * Mi fanno impressione i festeggiamenti solenni che spesso vengono organizzati, se non autoorganizzati per festeggiare ricorrenze di prelati, con doni in genere preziosi. So di un giovane prete che, per una ricorrenza, chiese un calice d’oro per la messa e che, dovendo cambiar sede, chiese ad una nota persona di cultura un discorso “importante”. Esempi di grande umiltà, se paragonati a quelli offerti da Cristo, che, per compleanni e solennità che lo riguardavano, chiedeva, come si sa, oggetti di platino e celebrazioni solenni! * Ho assistito per la prima volta, lo scorso febbraio, alla sfilata dei nuovi carri di Carnevale, che sostituiscono le “carruzzate” di una volta, con carretti su uno dei quali un poeta popolare declamava versi satirici, in genere contro amministratori comunali o figure di spicco, e /o, il martedì pomeriggio, manifestava sofferenza per la morte del “nonno”, e ho apprezzato la buona volontà e il buon gusto degli organizzatori, che fra l’altro avevano coinvolto decine e decine di ragazzi (ma non solo ra- 131 gazzi), maschi e femmine, che in maschera precedevano i carri danzando con movimenti sobri e armonici. La mia memoria è andata, appunto, alle “carruzzate”, e agli “associamenti”, in cui gruppi di cittadini si organizzavano per ballare la sera e almeno in parte della notte dei giorni di Carnevale e del sabato successivo (il “sabatino”), ospitando nel macararu, sotto la guida del mastru-sala, le maschere che via via si presentavano. Mi ha fatto piacere vedere impegnati con tale armonia e sobrietà tanti giovani. Che prima o dopo, non ho potuto fare a meno di pensare, per ovvi motivi dovranno lasciare il paese, continuando a impoverirlo. * Le Scuole elementare e media del nostro paese hanno vissuto, sotto vari profili, momenti di grande prestigio: didattico-sperimentali, culturali, organizzativi… e con educatori di notevole valore. Succede, da qualche tempo, che gli alunni, naturalmente spinti dalle famiglie, si trasferiscano altrove, soprattutto a Trapani, che non mi pare, scolasticamente parlando, il meglio che ci sia. Quando, tempo fa, feci parte della commissione nominata per risolvere in provincia la piaga dei numerosi docenti non ancora abilitati, notai che molti di essi, non certo particolarmente brillanti, finirono nelle scuole trapanesi. Una mia conversazione con il Sindaco, allorché le carenze si fecero sempre più evidenti, mi parve vederlo non molto interessato. Sarebbe opportuno che ci pensasse un po’ di più, per qualche intervento in difesa del nostro passato e del nostro futuro. * In opuscoli curati anche da gente allittrata, che illustrano fra l’altro aspetti culturali ecc. del nostro paese, leggo frasi come queste: “di fronte le isole Egadi”, piuttosto che “di fronte alle isole Egadi”; “davanti la casa”, invece che “davanti alla casa” (oppure ”davanti casa”, e, per fare un altro esempio, “Davanti San Guido”); “la Torre del settecento di Nubia”, piuttosto che “la Torre del Settecento di Nubia”; “i Cannoli di ricotta”, piuttosto che “i cannoli di ricotta”. Nella scrittura dell’Italiano rispetto la libertà stilistica e l’uso di una lingua non fossilizzata, ma m’infastidisce l’anarchia ortografica e grammaticale, nonché la mancanza di uniformità della grammatica e dell’ortografia (cioè, ad esempio, ora Scuola media ora Scuola Media, che costituiscono cattivi esempi per i meno informati e soprattutto per i giovani (so che giornalisti anche noti scrivono talvolta allo stesso modo, ma non si tratta certo di modelli da imitare). E, ad esempio, m’infastidisce fra l’altro - e chiudo qui - il francesismo cous-cous, adottato dagli amministratori di San Vito Lo Capo per una loro sagra: forse - ma sono, diciamo così, in buona compagnia - lo ritengono una finezza letteraria: ma perché, nel dubbio, non usare i termini dialettali (e per qualcuno anche italiani) cùscusu o cùscus (derivati dall’arabo kuskus)? Vorrei invitare certe persone istruite del nostro paese... non dico a consultare occorrendo il Grande dizionario della lingua italiana dell’UTET, ma quanto meno un qualsiasi dizionario italiano (non mi riferisco, naturalmente, ai refusi). ROCCO FODALE 132 SeGNALAZIONI LIBRARIe Peccando sicuramente di eccessiva immodestia, ho accolto, come si suole dire ...senza fiatare, l’invito rivoltomi, con chiaro tono affettuosamente perentorio che non consentiva risposte diverse, da mio fratello Rocco il quale a partire da questo numero di “Paceco diciassette” non curerà più la “sua creatura” Segnalazioni Librarie. Alla ricerca ora di disperate attenuanti a mio favore, ci tengo a farvi sapere che nella decisione hanno giocato un ruolo molto importante il desiderio di non deludere le aspettative du frati ranni, una colpevole presunzione di riuscire a scrivere qualcosa di accettabile e, soprattutto, la voglia di continuare a fare conoscere ai più alcuni prodotti delle “Intelligenze” di questo estremo lembo, e non solo, della amata terra siciliana. VALDERICE 2012, ANNUARIO DeLLA SCUOLA meDIA “mAZZINI” L’annuario si presenta, come sempre, in piacevole forma tipografica, con articoli pregevoli e con bellissime fotografie. Interessante e ricco di particolari lo scritto dello storico Vincenzo Perugini, Vennero nella tonnara di Bonagia 13 galere di turchi; toccanti le pagine dedicate dagli amici al compianto dott. Giuseppe Basiricò, “già Comandante del Corpo di polizia di Valderice, storico e scrittore”; ricco di umanità l’articolo di Rocco Fodale che ricorda due alunni in difficoltà di apprendimento; belle le interviste proposte da Giovanni A. Barraco, Incontro con Stefania La Via - Giusi Todaro, scultrice e scenografa; piacevoli e apprezzabili gli articoli scritti dagli alunni; commoventi le pagine, Ritrovarsi..., che riportano i ricordi delle alunne diplomatesi nel 1970. STRòCCHIULI, STRùMMULI E CACALAZZùMMULI, di PAOLO mARCIANTe Dopo Lu pressepiu di Cataviddotta, già segnalato su “Paceco sedici”, Paolo Marciante offre ai suoi lettori un nuovo lavoro, Stròcchiuli, strùmmuli e cacalazzùmmuli, ricordi in versi e poesie. Edita da Salvatore Coppola, l’opera, scritta in lingua caltabellottese, mira essenzialmente a tutelare e recuperare il dialetto e a ricordare il vecchio mondo contadino nella sua dimensione paesana ed affettiva. Marciante ha la rara capacità di descrivere in versi eventi, ricordi, ambienti, sentimenti e di saperne trasmettere l’immagine al lettore, facendo anche superare facilmente la difficoltà di comprendere qualche vocabolo tipico del suo paese. Il poeta con le sue liriche supera i confini di Caltabellotta e diventa cantore della sicilianità; nei suoi versi si legge anche la storia del popolo siciliano, i suoi valori, le sue tradizioni, la sua vita fatta di sacrifici, di povertà, di mortificazioni, spesso di soprusi e, qualche volta, anche di stragi come quella dell’1 maggio 1947 a Portella della Ginestra. 133 Il libro, che comprende cinque sezioni in versi (Muntagnoli, Kataviddotta, Com’è lu tempu, Signala, Iuculani) e un brano in prosa (La memoria degli anni), è introdotto dalla bellissima poesia, Li pusa di la storia, nella quale l’autore indica i confini e i contenuti dell’intera sua opera, chiarendo anche qual è la sua Musa ispiratrice. Li pusa di la storia Nun mosi purtari nni stu fogliu/ pinni e pinnacchi o stucchi argintati/ né la pompa di famigli altulocati/ o la funcia di baruna ncappiddati./ Ma du cusuzzi, di sichinienza,/ cu la vuci, macari, accarcasciata,/ senza sivu, però, senza pumata./ Di stròcchiuli ti parlu e di bacareddi,/ di scarpeddi, di pica, di zzappuddi,/ di trusci e stracciali, di lisineddi./ Di mani cu li caddi, di pusa, di gammala,/ di fodetti, ncirati, di fodala./ E di cu smurca, e a li quattru è già pi li viola/ a sdari armali o a bbinniri scalora./ Chissu latti munci la me pinna/ chi tinci li ascidi du russetti,/ luntani di la storia, di li botti,/ chi mancu bboni su, a jucari a li mazzetti! Né ’N CELU Né ’N TERRA, di vINCeNZO ADAmO In questo suo nuovo libro di poesie, prezioso contenitore del patrimonio lessicale siciliano, così Vincenzo Adamo spiega il significato del titolo e presenta la sua opera: “Nel momento in cui l’uomo mette i piedi sulla terra inizia il suo viaggio verso il cielo, meta che si raggiunge attraverso ostacoli e difficili prove. Mi viene in mente un gioco di quando ero bambino, il ‘tricchiti’... Il gioco si svolgeva né ’n celu né ’n terra e assomiglia al ‘gioco della vita’, dalla nascita alla morte. I versi di queste poesie sono stati scritti in vari momenti di questo gioco”. La povertà diffusa, la mancanza di lavoro per tantissimi giovani, la prepotenza dei forti rendono spesso amare le riflessioni del poeta e lo inducono ad inveire contro un certo modo spregevole di fare politica e a denunciare la miseria morale di non rari personaggi pubblici. E tuttavia è forte nel suo animo la speranza che “un giorno il vento possa cambiare e il bene possa sopraffare lu tintu mali”, come annota nella Presentazione Paolo Marciante. Nelle poesie dedicate ai suoi cari, alla natura e ai suoi bellissimi paesaggi, il poeta trascina il lettore in un mondo nel quale tutto diventa un bene degno di essere ricordato e aspettativa di un futuro migliore; i suoi genitori, la suggestione delle stradine di Erice e del profilo della Colombaia, i tramonti di Trapani, il lavoro onesto, i sani sentimenti delle persone semplici rappresentano il riscatto dei tanti mali del mondo e la speranza che tutto possa cambiare. Senza timuri Senza timuri scopru lu disaggiu/ di viviri ‘na vita cu tristizza/ di viviri ‘na vita cu curaggiu/ di pruvari ogni ghiornu sulu stizza./’Sta suffirenza chi portu pi mantu/ fa perdiri la vogghia di campari/ fa crisciri cu forza lu rimpiantu/ e la spiranza fa disiddirari./ Aspettu ‘u tempu chi lu ventu gira/ chi lu mulinu rota li so’ pali/ chi lu disaggiu di ssa rutta vira/ chi ‘u beni supraffà lu tintu mali./ Aspettu d’attruvari a cu sa fira/ di dari a la mè vita ‘u giustu sali. 134 SARVA C’ATTROVI, di LUIGI BARRACO Il titolo, molto originale, l’autore, come egli stesso racconta, lo ha ricavato da una frase che spesso gli rivolge la madre: “Sarva c’attrovi” (conserva e troverai). Partendo dalla considerazione, ampiamente condivisibile e scritta nella sua Introduzione, che “l’impoverimento lessicale della nostra lingua, il siciliano, è un fenomeno rilevante che ... in pochi decenni ha fatto sì che una lingua ricchissima ha perso diverse centinaia di termini, caduti definitivamente nell’oblio e numerosi altri sono ormai patrimonio di una porzione sempre più ridotta di popolazione”, Luigi Barraco, memore anche della famosa frase di Ignazio Buttitta “ La chitarra del dialetto perde una corda al giorno”, vuole, con questa sua opera, recuperare, attraverso la testimonianza di molti anziani, le parole del nostro vocabolario ormai completamente dimenticate o poco utilizzate nell’attuale comune parlare. L’autore, in tale modo, offre alle nuove generazioni l’opportunità di potere cogliere, apprezzare e riutilizzare il vasto patrimonio di vocaboli offerto dal nostro dialetto. L’iniziativa letteraria assume maggiore importanza in questa nostra epoca multimediale nella quale non è difficile imbattersi, come nota chi naviga su internet e specificatamente su facebook, in un uso a volte blasfemo del lessico, della grammatica e della sintassi del nostro tanto bistrattato dialetto. Il libro in una sezione raccoglie vocaboli ormai scomparsi o desueti e nell’altra presenta antichi detti e modi di dire. RECONDITE ARMONIE, di GIUSePPe INGARDIA Edita, nella collana “Araba Fenice”, dalla Libreria Editrice Urso di Avola nell’ambito del concorso letterario internazionale “Libri di-versi in diversi libri”, l’opera di Giuseppe Ingardia, noto giornalista di origine pacecota, “contiene”, come sostiene nella Prefazione Rosa Maria Ancona, “versi che hanno robustezza di parola, caratteristica vera di un sentire mediterraneo”. L’autore, non dimentico del suo impegno nel giornalismo, racconta la sua storia personale e le grandi e piccole vicende, a volte anche tragiche, del passato e del presente secolo. Nelle sue poesie, come afferma ancora l’Ancona, il poeta “unisce socialità e bonarietà, umanesimo e fervore, amarezza e turbamento per i tanti pericoli che incombono”. La silloge poetica è stata presentata nel salone delle conferenze della Biblioteca comunale di Paceco il 9 giugno 2012 ed ha avuto come straordinari lettori di alcune poesie l’attore Giuseppe Catalano e il professore Giovanni Ingrassia. Trasparenze Le trasparenze sai, mettono a nudo/ anime e corpi se nell’acqua pura,/ quando riesci a leggere tra i cerchi/ sicuro ch’essi mai ti tradiranno./ In trasparenza oggi più che mai,/ ci sbattono sul viso mappamondi,/ seni arredati a balconi fioriti,/ spinti tanga tra montagne maestose./ Le trasparenze a volte non sono mai/ di questa nostra 135 terra calpestata,/ ridotta colabrodo,avvelenata/ senza rispetto alcuno,violentata./ Di trasparenze non mi puoi parlare,/ se pensi a svelate caste d’altura/ che legiferano sì con trasparenza,/ ma tenendoci in eterna…penitenza!/ Magari - amico mio - noi si potesse/ guardarci fissi gli occhi tutti i giorni/e senza dubbi né tentennamenti/ poterci legger sempre in trasparenza...! ALESSIO DI GIOVANNI, SAGGI E NOTE CRITICHE DAL 1988 AL 2010, di SALvATORe DI mARCO In questo volume, edito nel novembre 2011 dalla Biblioteca “Paolo Borsellino” del Comune di Cianciana, il professore Salvatore Di Marco, già noto ai nostri assidui lettori per precedenti segnalazioni di altre sue opere, presenta, come scrive nella Prefazione Salvatore Sanzeri “un’ampia raccolta di saggi critici, di relazioni e interventi a convegni di studio, articoli e varie note letterarie, che l’autore dal 1986 al 2010 ha scritto e pubblicato su periodici e volumi collettanei intorno alla figura e all’opera” del poeta ciancianese Alessio Di Giovanni, grande cantore del latifondo e delle voci del feudo, scomparso nella sua casa di Palermo il 6 dicembre 1946. GLI OCCHI DEL MONDO, SAGGI SU IGNAZIO BUTTITTA, di SALvATORe DI mARCO Edito nel novembre 2011 da Coppola Editore, questo libro,“voluto e progettato da alcuni anni dall’Editore stesso”, per usare le parole scritte dall’autore, viene presentato dopo dodici anni dalla pubblicazione del suo precedente volume di scritti su Ignazio Buttitta, Il filo dell’aquilone. E, si legge ancora nella Premessa: “[...] ci accomunano (autore ed editore) l’amore per la letteratura siciliana e [...] il riconoscimento dell’importanza che assume [...] l’opera poetica di Ignazio Buttitta e perciò l’opportunità di contribuire insieme a riproporre all’attenzione di tutti e degli studiosi più sensibili un discorso sulla poesia del grande poeta di Bagheria [...] per trarre fuori dall’ombra, che lo sta avvolgendo, un poeta la cui parola ci pare ancora ricca di fertilissimi insegnamenti, anche rispetto ai tempi che stiamo vivendo con preoccupazione per le sorti della Sicilia, della sua gente e della sua cultura”. Per l’autore, Ignazio Buttitta può dare ancora risposte e “si può pensare che la poesia del poeta bagherese, che condannò la mafia e l’ignoranza, e tenne alta la bandiera della dignità e del riscatto, [...] possa rivelarsi ancora attuale, adatta ai nuovi tempi, capace di dare un lume di speranza e di fiducia agli uomini”. Il libro è diviso in tre parti: la prima parte, intitolata Il poeta e le sue stagioni, presenta, rimaneggiati ed aggiornati, due saggi che erano stati già pubblicati nel volume Il filo dell’aquilone; la seconda parte, intitolata Il pensiero, i sentimenti e le idee, comprende tre nuovi saggi; la terza parte, intitolata Due recenti ritorni, mette insieme un lavoro inedito e l’intero saggio La vicenda del bandito Giuliano:tutta un’altra storia. 136 VENT’ANNI, a cura di DANIeLA GAmBINO eD eTTORe ZANCA Daniela Gambino, scrittrice e giornalista, ed Ettore Zanca, scrittore, blogger e giornalista online, a distanza di venti anni dalle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, hanno voluto ricordare, “nel modo più dolce possibile”, Paolo, Giovanni, Francesca, Emanuela, Walter, Rocco, Antonio, Agostino, Vincenzo e Claudio, chiedendo a tanti amici di scrivere cosa stessero facendo nei momenti in cui innocenti venivano colpiti in Sicilia dalla ferocia mafiosa. Moltissimi hanno risposto all’appello e così, scrive Zanca nel presentare il volume edito nel maggio 2012 da Coppola Editore, “sono venuti fuori ricordi con la sete di giustizia, la voglia di consegnare un mondo più onesto, o ancora scriverci sopra una canzone, riflettere che non c’è ancora un colpevole certo e che non ha pagato del tutto chi dovrebbe pagare”. Ecco, Vent’anni è l’antologia delle risposte delle tante ed “eterogenee” persone - editori, parenti delle vittime, magistrati, studiosi, sacerdoti - accomunate dai ricordi e dalla rabbia per una giustizia ancora non pienamente compiuta. LA TONNARA DI BONAGIA, di vINCeNZO PeRUGINI Nel volumetto, pubblicato nel luglio 2012 per conto del Comune di Valderice, Vincenzo Perugini, docente e storico valdericino, racconta la storia della Tonnara di Bonagia, “un feudo di mare”. Così l’autore stesso, nella Prefazione, introduce la sua opera: “In un mondo in cui le tonnare vanno progressivamente scomparendo, la Tonnara di Bonagia può vantare la capacità di riuscire non soltanto a mantenere in vita la memoria di una storia antica, ma di saperlo fare rendendo attuale una storia che deve ancora finire di essere scritta”. I SAPORI DEL COUSCOUS, di CLARA SALvO Clara Salvo, studiosa delle tradizioni popolari siciliane e cantante folk, con questa opera, edita nel settembre 2011 da Coppola Editore, ci parla del couscous, della sua origine e della sua diffusione nella cultura e nella gastronomia del mondo ebraico (cuscussù), del mondo arabo (kuskus), del mondo spagnolo con particolare riferimento all’Andalusia (cuscùs) e della tradizione della sola fascia costiera della Sicilia occidentale che va da San Vito Lo Capo a Mazara del Vallo (cuscusu), con la variante che nel Maghreb il couscous è l’alimento base quotidiano mentre in Sicilia è un piatto della festa. Corredano la simpatica pubblicazione ventisei ricette internazionali sui vari modi di cucinare la gustosa pietanza. MEDIOEVO E DINTORNI, a cura di mANUeLA GIRGeNTI e GIULIANA mUSOTTO Edita dall’Officina di Studi Medievali di Palermo, con il patrocinio della Banca di Credito Cooperativo “Sen. Pietro Grammatico” di Paceco, la pubblicazione rac- 137 coglie, come scrive Salvatore Girgenti nella Introduzione, tredici saggi “frutto di alcuni seminari, svoltisi presso la sede dell’Officina di Studi Medievali di Trapani, su argomenti e tematiche prettamente medievali e concernenti, in particolare, la storia delle idee filosofiche, politiche e sociali”. Nell’indicare di seguito l’elenco delle lezioni svolte e dei relativi docenti pensiamo di fare cosa gradita a chi volesse approfondire i temi trattati: Manuela Girgenti, Filone d’Alessandria e il giudaismo rabbinico; Antonio Bica, I vangeli gnostici e il Cristianesimo delle origini; Giuseppina Mammana, La ricerca di sé come ricerca di Dio e dell’anima nel pensiero di Sant’Agostino; Fabio Cusimano, Il monachesimo benedettino. Origini, tradizioni e cultura; Manuela Girgenti, Il concetto di giustizia nell’età antica medievale; Giuseppe Allegro, Medioevo e teologia. Scienza e ricerca di Dio; Luciana Pepi, Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia nel Medioevo; Salvatore D’Agostino, La Sicilia di Federico III d’Aragona; Vincenzo M. Corseri, Religione e politica in Europa nella prima metà del Quattrocento. Cusano e Piccolini a Basilea; Flavia Buzzetta, Aspetti della magia in epoca tardo-medievale; Salvatore Girgenti, Le radici politiche e religiose dei templari: una ipotesi di ricerca; Filippo Grammauta, La pergamena di Chinon. La prova dell’assoluzione dei dignitari templari dall’accusa di eresia; Salvatore D’Angelo, La medicina nel Medioevo. PAROLE PER PENSIERI, di GIOACChINO ALDO RUGGIeRI L’autore stesso, nelle sue due pagine, Due parole ai lettori, che introducono la silloge poetica, edita da Sigma Edizioni, ci spiega il significato da dare al titolo della sua opera: “Parole per pensieri. Perché? Per chi? Certamente per me stesso perché frutto di riflessioni che mi sembrano non peregrine. E, altrettanto certamente, per i miei cari lettori che da tempo mi seguono e mi chiedono di raccogliere in un volume quanto ho altrove pubblicato di questi pensieri nel corso del tempo e cioè dal 2002 ad oggi”. Gioacchino Aldo Ruggieri, personaggio notissimo non solo nella provincia di Trapani per i suoi molteplici impegni nei vari campi della vita sociale e professionale, nel corso degli anni “ si è guardato intorno”, si è lasciato coinvolgere emotivamente dagli eventi che la cronaca quotidiana sottoponeva alla sua attenzione, ha scritto tanto ed ha anche poetato sulle grandi e piccole vicende della vita. Scrive ancora il Ruggieri: “L’unica cosa certa di questi miei scritti, che nessuna velleità hanno, è che mi sono serviti per tentare di dimostrare che ancora oggi è necessario che le parole siano figlie del pensiero e non suoni vuoti, vagolanti, testimoni spesso di una disarticolazione concettuale che caratterizza molta parte della dialettica attuale. Se questo mio lavoro potrà servire a qualcosa, anche a non fare dimenticare la necessità umana della grande poesia, antica e moderna, a far apprezzare un’armonia spontanea tra parola e pensiero, tra contenuto e forma, questo lavoro non sarà stata vana fatica né velleitario inutile dispendio di energie”. 138 Che cosa canti Che cosa canti poesia dell’amore/ in questo mondo che muore ogni giorno/ nell’odio delle genti/ d’ogni plaga/ mediterranea/ africana o coreana o americana/ terrorista e senza pane/ dentro un fuoco che divora la speranza/ con la morte dentro il cuore/ con le bombe nelle tasche/ con le carni martoriate/ coi bambini per le strade/ col denaro che divora/ dignità e speranza/ mentre Dio prega pace/ nel silenzio indifferente/ Povera poesia dell’amore/ che cantasti l’anima immortale/ che vivesti di miti e di leggende/ che corresti le vie del cielo/ interrogando la luna silenziosa/ volando coi cavalli immaginari/ accompagnando le gesta degli eroi/ esaltanti nobiltà e fantasia/ cowboy cavalieri e donne nuove/ nel rinascimento senza fine/ lievito e sostanza della civiltà crescente/ Povera poesia dell’amore/ costretta dentro il muro di Berlino/ umiliata nei forni crematori/ dissacrata dalle mode strumentali/ sorgi orgogliosa nel domani/ diventa forza di nuovo umanesimo/ che gridi pace contro guerre inutili/ che imprigioni la malvagità umana/ ammantata di religiosi pregiudizi/ nel sole dell’avvenire nuovo/ perché tacciano cannoni e minacce/ in un grande tavolo mondiale/ d’una trattativa definitiva/ che risvegli gli orizzonti della vita/ nei colori molteplici degli uomini/ nelle latitudini modeste della terra/ pulviscolo del tutto universale/ stupido egoistico congegno/ di una rovina che sarà globale/ se non decideremo con urgenza/ di uccidere la fame e la miseria/ con l’unica arma della vita/ la pace universale dell’amore/ la dignità del vivere e morire/ sotto un cielo vivido di stelle/ capaci di illuminare ancora/ la solidarietà umana. LUMIE DI SICILIA, dell’ASSOCIAZIONe CULTURALe SICILIA-FIReNZe “Rivista quadrimestrale pubblicata a Firenze dall’Associazione culturale Sicilia-Firenze, e diretta dal trapanese Mario Gallo, un generale in pensione dalle rilevanti doti di intelligenza, cultura, satira amabile, capacità di scrivere in ottimo italiano, e non aggiungo altro per non offendere la sua modestia” (Rocco Fodale, Segnalazioni Librarie,“Paceco sedici”, gennaio 2012, p. 112). Come sempre, anche il n. 76 della rivista (ottobre 2012) offre all’attenzione dei suoi lettori articoli interessanti, ricerche approfondite, spazi lirici, simpatici ricordi, in sintesi momenti di “rivisitazione” affettiva e culturale della propria terra di origine da parte di molti Siciliani sparsi per il mondo e di tanti altri ancora residenti nella bellissima isola. Il fascicolo si apre con l’articolo L’oro di Selinunte di Giuseppe Cardillo che ci racconta delle vicende archeologiche e storiche che riguardano il grande complesso “siceliota” - 409 a.C. - rappresentato dal “cumulo stupefacente delle colonne del Tempio G” di Selinunte; simpaticissimo ed anche molto colto l’articolo del prof. Salvatore C. Trovato Un’indagine sul campo, quasi un racconto nel quale l’autore racconta, attraverso un aneddoto, come, a distanza di tanti anni e per caso, sia riuscito, “durante un’inchiesta dialettologica”, a trovare la “soluzione” di un dubbio linguistico che non riusciva a chiarire da moltissimi anni; Il viaggio dell’agente di viaggio 139 di Giorgio Montanti è la cronaca di un curioso sogno in un caldissimo pomeriggio estivo a Paceco; interessante lo scritto Baglio e Masseria di Rocco Fodale che ci parla dell’origine dei bagli siciliani, della particolarità della loro struttura architettonica e del complesso sistema di organizzazione laboratoriale e sociale che vi ruotava attorno; Gita a Pianto Romano di Renato Cesarò è il racconto di una insolita giornata di escursione a Pianto Romano, nei pressi di Calatafimi, di “un’allegra brigata di ex compagni di Liceo”; Senzio Mazza, Pizzini d’amuri/Love Notes di Marco Scalabrino è la presentazione del libro del Mazza, poeta di Linguaglossa; Lona e buccetta di Mario Gallo è un affettuoso e puntuale ricordo del poeta Nat Scammacca, cofondatore dell’“Antigruppo”, nato a Brooklyn nel 1924, nipote di emigranti siciliani e ritornato in Sicilia, dove è rimasto per il resto della sua vita, “col bagaglio di una conoscenza dell’italiano e del siciliano che spaziava tra buccetta (forchetta) e lona (luna)”; U frischittulu dalle mille vite di Maria Nivea Zagarella è ricca dissertazione sullo Zufolo parlante, fiaba raccolta dal Pitrè, ripresa prima dal Calvino e poi dal Bonaviri; La radice mediterranea del senso religioso di Vittorio Morello ci presenta riflessioni sull’opera Dio o il mondo? di Claudio Lamparelli; Il cartoccìo della foglia riarsa è una bellissima poesia dell’amico scrittore, poeta e storico pacecoto, Alberto Barbata; La promessa di Eugenio Giannone è un avvincente e commovente racconto di un viaggio in treno da Roma a Palermo di un emigrato in America di ritorno al suo paese natio, in Sicilia, dopo venticinque anni di assenza. P.S. Poiché non pervenuti in tempo utile per essere segnalati in questo numero, si parlerà dei volumi appresso indicati su “Paceco diciotto”: Raccontami, di Danilo Fodale, Edizioni ANAM; Pirandello. La pena di vivere così, di Gaspare Cottone, Edizione Accademia di Studi “Cielo D’Alcamo”. CARMELO FODALE Un momento della presentazione dell’ultima opera di V. Adamo (foto C. Di Bella) 140 mOSTRA DI CAPeZZALI Chi di noi, giovani e meno giovani, non ricorda quei capezzali, aventi per soggetto la Sacra Famiglia, posti nelle case dei nostri nonni o dei nostri genitori? Negli anni ’50 era molto diffuso il costume di arredare la parete della camera da letto con questi quadri e in ogni casa ce n’era uno. Erano tutti simili; con piccole varianti raffiguravano la Sacra Famiglia: S. Giuseppe, raramente da solo o col Bambinello, Maria, il Bambino Gesù (quest’ultimo in fasce, nella culla, appena cresciuto che accenna i primi passi, sotto lo sguardo amorevole dei genitori), a volte persino si trovavano raffigurati gli arnesi di falegname. Poi, con l’avvento del benessere, quadri di arte moderna, stampe o altri soggetti hanno sostituito questa tipologia di arredamento, confinando, se non nella spazzatura per un certo timore religioso, nelle soffitte, nei posti più nascosti dei ripostigli, e di conseguenza nel dimenticatoio, queste immagini ritenute demodé e di scarso pregio artistico. Se è vero che queste raffigurazioni non hanno alcun valore, riteniamo, tuttavia, che fanno parte di una tradizione, non solo religiosa, che si ricollega direttamente ad un’altra tradizione, quella della festa di S. Giuseppe, protettore della famiglia, e dell’ancor più tradizionale ammitu di S. Giuseppe, sul cui altare non manca mai una riproduzione di questo genere. Ci siamo allora chiesti: “Perché non recuperare e raccogliere questi capezzali, metterli in mostra, a ricordo per i meno giovani e a testimonianza delle nostre abitudini di un tempo per i giovani?”. Detto fatto: viene lanciata l’iniziativa fra le famiglie del paese! Alcune la accolgono con piacere e, fra mille raccomandazioni, specialmente da parte delle persone anziane (“State attenti; vi raccomando, il quadro mi è stato regalato quando mi sono sposata e da allora sta sempre sopra il mio letto; ha il vetro rotto; i colori sono sbiaditi; la cornice è rovinata...”) ci consegnano i loro “tesori”; altre non vogliono privarsi del loro capezzale e lasciare la parete sguarnita. Nonostante alcune reticenze, abbiamo recuperato circa 90 capezzali, pur se con qualche doppione. 141 Finalmente la mostra è pronta, allestita nel saloncino della Chiesa Madre: i capezzali fanno da corona all’altare di S. Giuseppe, integrati da pannelli riportanti brani tratti da dichiarazioni di Papi e di Padri della Chiesa che invitano a riflettere sull’importanza e il valore della famiglia. Il 17 marzo il dr. Maurizio Vitella, professore all’Università di Palermo, alla presenza del sindaco, dr. Martorana Biagio, in una chiesa strapiena di persone, inaugura la mostra con una interessante conferenza sulla iconografia della Sacra Famiglia nei capezzali e sulla sua evoluzione artistica nel corso del tempo. Numerosissimi sono stati i visitatori: dai bambini della Scuola materna, elementare e media, agli adulti, provenienti anche dai paesi limitrofi, a tutti quelli che, compiaciuti, vedevano appesi i loro capezzali, a quelli che non se ne sono voluti privare e, con un pizzico di rammarico, commentavano: “Ah, ma io ne avevo uno!”; “Ah, se sapevo, lo portavo!”. DON SALVO MORGHESE Capezzali raffiguranti la Sacra Famiglia (foto C. Di Bella) 142 TeATRO... Che PASSIONe! La passione per il teatro, nata a Marsala e condivisa con alcuni cari amici presso l’Oratorio dei preti Salesiani, mi ha sempre spronato a cercare testi teatrali nuovi, in particolare di autori siciliani, per una loro eventuale rappresentazione. Quando mi trasferii a Paceco, nei primi anni non avevo ancora consolidato rapporti di amicizia ed ero solito trascorrere parte del mio tempo libero nella Biblioteca comunale. Circa trenta anni fa, su suggerimento dell’allora direttore Alberto Barbata, che ringrazio di cuore, lessi Il Vendicatore di Francesco Lanza, farsa poco nota del teatro siciliano scritta negli anni 1921-23. Fu amore a prima vista. Il testo mi piacque subito. Pur vecchio di quasi un secolo, tratta con intelligente umorismo e senza volgarità un tema senza tempo: la commistione fra il pubblico e il privato nella lotta politica. Donna Ninì, giovane e attraente, chiede al suo amante don Vittorino di vendicare l’insulto che il paese rivolge al marito, “cornuto” sindaco in carriera, don Antonio Alicò. L’appellativo proviene dall’invidiosa, brutta e grassa donna Paolina detta “Tabarè”, moglie di Calogero Ciaramella suo rivale politico, anch’egli “cornuto” predestinato. Donna Ninì, che da anni intrattiene una relazione clandestina con suo cugino Vittorino, lo costringe, dunque, negandogli i suoi piaceri, a corteggiare e adescare donna Paolina per sorprenderla in flagrante e ricambiare così la moneta dell’insulto. Don Vittorino è però recalcitrante, perché donna Paolina è veramente brutta, e non sa se il suo “fisico” sia all’altezza di questa vendetta; ma da don Giovanni ormai in scadenza si perde vertiginosamente tra le pieghe burrose del corpo di donna Paolina, brutta, certo, ma capace di amare veramente. Lessi il testo più volte e, via via, pur consapevole delle molteplici difficoltà che avrei dovuto affrontare, cresceva forte il desiderio di portarlo in scena. 143 Le difficoltà iniziali sono state principalmente due: la necessità di rivedere il testo originale, scritto in dialetto siciliano disusato della provincia di Enna, per adeguarlo ai nostri giorni, compito molto oneroso, di cui mi sono fatto carico ben volentieri; la ricerca degli attori principali, condivisa con l’amico Peppe Catalano che conosceva l’opera e nutriva da tempo il desiderio di interpretare il ruolo di protagonista, e degli altri interpreti che sono stati individuati nella cerchia dei rispettivi amici e conoscenti. Le difficoltà di natura organizzativa sono state superate grazie al generoso intervento della nostra Associazione Culturale “La Koinè della Collina” che ha dato la disponibilità della sede per le prove, per la realizzazione delle scene e ha finanziato le spese necessarie alle rappresentazioni. L’impegno profuso da tutti durante le prove è stato determinante per la buona riuscita della rappresentazione. A tutti gli attori va la mia gratitudine per l’infinita pazienza che hanno avuto accettando i miei suggerimenti finalizzati ad ottimizzare la caratterizzazione dei vari personaggi. Sulla base della mia personale esperienza auspico che nel nostro paese, con la collaborazione di quanti amano il teatro, scuola di vita, si attui un laboratorio teatrale che, insieme alla Scuola, alla Chiesa, alle varie Associazioni ecc., contribuisca alla formazione umana e culturale delle nuove generazioni di Paceco. VITO VIA 144 RICORDO DI mICheLe BARRACO Il 22 ottobre di quest’anno è scomparso l’avvocato Michele Barraco, figlio dell’agricoltore Giuseppe e di Francesca Rizzo. Era nato a Paceco il 13 febbraio del 1924, da una antica ed importante famiglia di borgesi-possidenti del paese e si era laureato in Giurisprudenza ben presto presso l’Università degli studi di Palermo. Nelle elezioni comunali del 25 maggio 1952, spinto da un gruppo di amici, si era presentato candidato alle elezioni comunali nella lista civica “Emblema Paceco”, una lista di proprietari e borgesi capitanata dall’avv. Giuseppe Catalano e comprendente uno schieramento moderato. Aveva ottenuto il seggio comunale con 145 suffragi. Nel 1960, nelle elezioni comunali dell’8 novembre, Michele aveva compreso l’affidabilità della lista socialista nell’interesse di un avvento di una democrazia riformista che si aprisse a più larghi strati popolari e con 197 suffragi divenne consigliere comunale in un periodo storico interessante, quello del milazzismo, e poi del primo centrosinistra. Nella composizione della Giunta comunale del primo centrosinistra (28 settembre 1963) al quale parteciparono i socialisti, venne eletto assessore titolare ai Lavori Pubblici insieme a Pietro Paesano che sarà vicesindaco, per breve tempo, dell’Amministrazione capeggiata allora dall’avv. Catalano. Era entrato nel Partito Socialista, dove l’accomunava una intensa amicizia con Pietro Paesano, ormai divenuto protagonista delle battaglie politiche comunali. Nelle elezioni comunali del 22 dicembre 1966 ottenne maggiori consensi, raggiungendo ben 249 suffragi, sempre 145 nella lista del Partito Socialista, che lo avrebbe ancora una volta riconfermato consigliere nelle elezioni del 7 giugno 1970 con 264 suffragi. Dopo alcuni anni e precisamente nella primavera del 1978 l’assemblea dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana l’avrebbero eletto presidente dell’Istituto di credito, carica che avrebbe mantenuto per 14 anni, fino al 25 aprile del 1992. Ritiratosi dalle attività sociali e politiche, non aveva trascurato di dedicarsi alla sua passione di sempre, l’agricoltura, nel segno della tradizione familiare. Era stato viticoltore e cerealicoltore. Abitò a Paceco, ma soprattutto aveva una predilezione per la sua Dattilo (Formosa) dove erano le radici di una parte della sua famiglia, gli avi Lungari. L’avevo conosciuto molti anni or sono, sia nelle adunanze del Partito Socialista, sia nell’aula del Consiglio comunale, ed infine nelle assemblee della Cassa Rurale. Dopo ci siamo ritrovati, all’appuntamento domenicale, presso la Basilica della Madonna di Trapani, centro spirituale della città, dove sono stati celebrati i solenni funerali alla presenza di un folto gruppo di amici. Lo “zio Michele”, così come ormai ero abituato a chiamarlo, tra un’attesa e l’altra, mi raccontava brandelli di memoria, antiche storie del mio paese perduto, e l’avevo convinto a farmi fare copia di un gruppo di fotografie della sua giovinezza, in vista di un libro fotografico sui pacecoti. Erano foto di amici simpatici che anche io, più giovane, avevo conosciuto nell’indimenticabile sezione del Partito Socialista Italiano dove ci eravamo incontrati la prima volta. Vale. ALBERTO BARBATA 146 RICORDO DI GIROLAmO AvARO Girolamo Avaro nasce a Paceco nel giugno del 1923. Già da ragazzo è visibile la sua passione e inclinazione verso gli studi classici e umanistici tant’è che studia tra mille difficoltà, dato che il papà, mastru Peppe, era un semplice, ma abilissimo ciabattino. Si diploma all’Istituto magistrale e subito dopo la fine della guerra ottiene la cattedra di maestro nel Veneto dove insegna per qualche anno e, comunque, fino a quando gli arriva il trasferimento proprio a Paceco, dove incontra la sua collega e futura moglie Enza Merlino. In seguito accetta il passaggio al Provveditorato agli studi di Trapani, arrivando alla pensione con il massimo grado per un diplomato, segretario capo. Oltre al lavoro, Mommu coltiva diverse passioni. La prima sicuramente è quella sportiva, non agonistica, si può dire di supporto, visto che ottiene l’abilitazione di cronometrista ufficiale di diverse federazioni, dalla boxe all’automobilismo, all’atletica leggera etc. Questa sua passione lo porta, negli anni ’70, a diventare socio del Panathlon Club International e, più tardi, presidente provinciale per la durata del mandato istituzionale (anni 94/95). Tra gli altri impegni Mommu si avvicina pure alla politica, diventando, negli anni ’60, consigliere comunale a Paceco, ma dato che il suo carattere è troppo deciso, retto e non incline a compromessi, ben presto lascia l’incarico e si allontana definitivamente dalla politica per poi, in futuro, rientrare nell’attività del Comune facendo parte, con molto spirito critico, della Commissione toponomastica comunale. Sua grande passione è la musica, specialmente quella classica, e proprio in questa veste di grande intenditore aiuta con consigli, sicuramente efficaci, l’attività di una banda musicale locale. 147 Si interessa anche dell’Aeronautica militare, tanto che intrattiene e coltiva amicizie negli alti gradi dell’Arma. In ultimo, ma già avanti negli anni, collabora in prima persona con l’Associazione combattenti, sez. di Paceco, e ne diventa dirigente e tesoriere. Per le sue attività lavorative e non, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini il 2 giugno 1981 lo nomina Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Lascia questo mondo l’1 gennaio 2012, chiamato all’eternità. MONS. GIUSEPPE RAINERI Mommo Avaro (il primo a destra) nelle vesti di cronometrista (foto C. Di Bella) 148 RICORDO DI NICOLA DI NATALe Quando, ancora adolescente, gli feci leggere i miei primi versi, zio Nicola mi abbracciò commosso, mi ringraziò e, confidandomi che anche lui amava poetare, mi lasciò scolpito questo consiglio: “Giovanni mio, se puoi esprimere ciò che senti con una sola parola, non usarne due”. Più tardi scoprii che in quelle parole, al di là della ricerca poetica, si riassumeva la sua stessa vita priva di fronzoli, sfrondata di ogni vanità, vera. Ho avuto la fortuna di conoscerlo molto da vicino Nicola Di Natale: come persona, come poeta, come insegnante, lasciava il segno sempre in silenzio, senza mai apparire; difficile trovare un uomo più mite, più buono, più sensibile di lui, ma dietro quel suo aspetto dimesso c’erano una ricchezza interiore, una profondità di pensiero, una forza incommensurabili. Rocco Fodale (che ringrazio per avermi fornito un tassello d’amore in più) mi ha raccontato che fu lui, Nicola, a placare gli animi degli studenti pacecoti dell’epoca intenzionati a manifestare la loro ostilità contro i liberatori americani giunti a Paceco; lo fece con queste semplici ma convincenti parole: “Picciotti, a verra finìu”. Cristiano profondamente convinto, anche se amareggiato dal comportamento della Chiesa non sempre coerente con la povertà evangelica, non rinunciò mai alla sua professione di fede né smise di mettere al centro della sua vita quell’amore per gli altri, specialmente gli ultimi, che testimoniò con la fondazione, a Trapani, dell'Associazione “Amici dei lebbrosi” a cui si dedicò con tutto se stesso. Negli ultimi tempi, quasi novantenne, inchiodato su una sedia a rotelle, accettava serenamente la sua condizione senza mai un lamen149 to, un’imprecazione, anzi ringraziando di essere ancora vigile e in grado di parlare. Qualche mese prima di andartene mi hai chiesto di aiutarti a ordinare la tue poesie in vista di una pubblicazione. M’è mancato il tempo. Mi dispiace. Per ora accontentati di questo fiore raccolto dalla tua serra che poso qui in tua memoria. Pasticceria Cannoli, “pesche”, amaretti, torte, “baci”, pasticcini... è festa: c’è ressa d’avventori, tutti in ghingheri, eleganti. Intanto i bimbi dell’Africa muoiono di fame laceri e nudi; i lebbrosi marciscono nelle ignorate capanne; milioni di uomini periscono senza Cristo. Odio queste feste, questa società sazia ottusa, che si crede civile, che si dice cristiana. Signore, salvaci dalla sazietà, salvaci dalle nostre povertà. Ciao, mio indimenticabile zio Nicola. GIOVANNI INGRASSIA 150 BCC CREDITO COOPERATIVO Banca di Credito Cooperativo «Sen. Pietro Grammatico» di Paceco Società Cooperativa Litotipografia Michele Abate di Vincenzo Abate Via Calatafimi, 15 - Tel. 0923.881780 Fax 0923.526314 E-mail: [email protected] Paceco, gennaio 2013 153
Scaricare