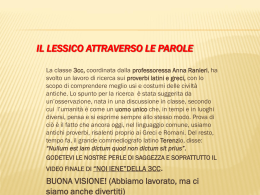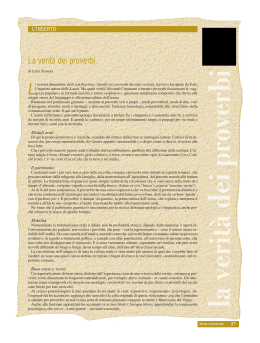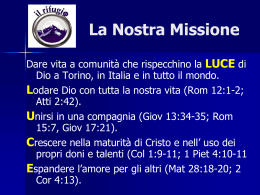L’enciclopedia dei poveri I proverbi marchigiani L’encicLopedia dei poveri i proverbi marchigiani A cura di Ugo Bellesi e Tommaso Lucchetti il lavoro editoriale Volume edito con il contributo dell’Assessorato Cultura della Regione Marche © Copyright 2014 by il lavoro editoriale (Progetti Editoriali srl) casella postale 297 - 60100 Ancona Italy www.illavoroeditoriale.com Isbn 9788876637650 Se addri maestri non ci ài segui li provérbi e bene farrai Se altri maestri non hai segui i proverbi e bene farai Questo volume ha avuto una gestazione redazionale piuttosto lunga. Nel 2010-11 fu avviata una ricerca, presso le principali Biblioteche civiche delle Marche, circa la disponibilità di raccolte di proverbi di carattere locale, edite spesso in edizioni a bassa circolazione, che erano state pubblicate negli anni Ottanta e Novanta del Novecento, in una nuova fase di interesse per le tradizioni locali, favorita dal regionalismo, ispirate dal diffuso municipalismo marchigiano, che aveva fatto seguito alla grande stagione positivistica e romantica di fine Ottocento. Questo lavoro, iniziato da Linda Pergolini, è stato completato nel 2013 da Fania Bronzini, con la raccolta di un ampio repertorio suddiviso per aree territoriali, anche considerando i dialetti, sul quale hanno esercitato la loro selezione e il relativo lavoro critico i due curatori del volume. L’editore sente il dovere di ringraziare, oltre alla Regione Marche per il contributo concesso alla pubblicazione, le Biblioteche che hanno collaborato nella prima indagine, le due collaboratrici e i curatori per il lavoro svolto, che, a distanza di molti anni dalle prime raccolte di proverbi marchigiani, cerca di dare un panorama complessivo di questo genere letterario. L’Editore A pag. 2 e in questa pagina, La caratteristica “pupa”, decorazione del biroccio marchigiano, dalla collezione del Museo del biroccio marchigiano di Glauco Luchetti, Filottrano (foto di Giovanni Rinaldi). Sul frontespizio il biroccio marchigiano dalla Etnografia illustrata di Luigi Mannocchi, sec. XX, Fermo, Biblioteca comunale “Romolo Spezioli”. L’enciclopedia dei poveri Introduzione* di Ugo Bellesi e Tommaso Lucchetti 1. Il sapere delle nazioni Scriveva Niccolò Tommaseo (1802-1874), letterato e linguista, e soprattutto autore, nei primissimi anni del Regno d’Italia, di un poderoso Dizionario della lingua italiana: “se tutti si potessero raccogliere e sotto certi capi ordinare i proverbi italiani, i proverbi d’ogni popolo, d’ogni età, colle varianti di voci, d’immagini, di concetti, questo, dopo la Bibbia, sarebbe il libro più gravido di pensieri”1. Tommaseo si era dedicato, per esempio, tra il 1841 ed il 1842, alla raccolta e pubblicazione dei proverbi della Corsica e della Toscana nell’opera Canti popolari, toscani, corsi, illirici, greci. La ricerca contemporanea ha seguìto il suo esempio. Da qualche decennio, presso l’Università di Firenze, ha sede il Centro Interuniversitario di Geoparemiologia (la disciplina con l’obiettivo di tracciare una geografia dei proverbi) che ha codificato e messo assieme la raccolta, in continuo divenire, dell’Atlante paremiologico italiano, mappatura dei proverbi del territorio nazionale registrabili nelle tradizioni orali delle varie regioni, oltre che nelle trascrizioni pubblicate in studi e testi. Con la pubblicazione da parte di questo istituto di un monumentale Dizionario dei proverbi, si potrebbe pensare che il sogno chimerico espresso più di un secolo e mezzo fa da Tommaseo abbia avuto una tangibile realizzazione editoriale, ma, come si può ben immaginare, l’impresa è molto più ardua, ed a conti fatti utopistica, vista la natura stessa di questo patrimonio vissuto, sopravvissuto e perpetuato per via principalmente orale. Ma pesa anche la difficoltà di indagare e catalogare quello che è una sorta di metasapere, di sapere dei saperi, dedicandosi i proverbi a tutto lo scibile umano, e riguardando inevitabilmente molti campi e discipline di studio. Come si legge nell’introduzione di quest’opera: “la paremiologia appare, dunque, nella nostra visione, un campo di studio tra i più complessi, interessante numerose discipline, e degno d’una considerazione ben superiore a quella sin qui attribuitale dai manuali, e nell’atteggiamento dei ricercatori”2. Decenni dopo Tommaseo, un altro nume tutelare della cultura italiana, Benedetto Croce (1866-1952), definirà i proverbi “il monumento parlato del buon senso”. Non tutti sanno che tutta la storia della letteratura ufficiale, quella più “alta” e dotta che troneggia nelle antologie scolastiche, è intrisa di proverbi, al punto che talvolta è “arduo distinguere il proverbio dalla massima di origine letteraria”3. Potrebbe essere citato per primo l’autore romantico ottocentesco annoverato tra i pro- * Il testo della presente Introduzione è stato elaborato su approfondimenti concordati tra i due autori. La stesura dei paragrafi da 1 a 5 si deve a Tommaso Lucchetti, quella dei paragrafi 6 e 7 a Ugo Bellesi. 1 Riportata da P. Toschi, Presentazione, in R. Bellabarba, Proverbi marchigiani illustrati, Firenze, Olschki, 1971. T. Franceschi, La formula proverbiale, in V. Boggione, L. Massobrio, Dizionario dei proverbi: i proverbi italiani organizzati per temi: 30.000 detti raccolti nelle regioni italiane e tramandati dalle fonti letterarie, Torino, Utet, 2004, p. XVI. 2 3 Ivi, p. XXIV. 8 L’enciclopedia dei poveri tagonisti del Romanticismo e del Risorgimento e tra i padri fondatori della nazione: Alessandro Manzoni (1785-1873), nel Fermo e Lucia, prima edizione del nostro romanzo nazionale (I promessi sposi), scrive: “dimmi con chi tratti e ti dirò chi sei, è un proverbio; e come tutti i proverbi non solo è infallibile, ma ha anche la facoltà di rendere infallibile l’applicazione che ne fa chi lo cita”. Sebbene abbiano difficoltà ad essere riconosciuti come espressione letteraria4, i proverbi sono presenti, infatti, nelle opere e negli autori di tutte le epoche; a cominciare dalla Bibbia, dove si ricorda nell’Antico Testamento il Libro dei proverbi (composto, secondo la maggior parte degli studiosi, in Giudea, nel V secolo a.C., con l’apporto di autori risalenti fino a cinque o sei secoli prima). Limitandosi a una antologia del contesto italiano, anche autori due, trecenteschi riportano proverbi attestandone l’antichità. Dante ne ingloba parecchi nelle terzine della Divina Commedia, ma anche Petrarca fa altrettanto (Proverbio ama chi t’ama è fatto antico)5. Il medioevo vide anche la redazione di repertori, raccolte e reinterpretazioni in chiave cristiana di antichi testi di carattere proverbiale, come ad esempio le varie versioni dei cosiddetti Disticha Catonis, florilegi di sentenze latine di celebri autori classici, con precetti di morale pratica. Con il tempo iniziarono a diffondersi anche in lingua volgare raccolte di proverbi o detti attribuiti al mondo contadino, con l’intento di evidenziare spunti di sapienza e saggezza popolare delle campagne, ma con l’ambiguo esito di sottolinearne anche la sprovveduta rozzezza e l’elementare ignoranza: le prime tipologie in questo senso sono i proverbi del villano apparsi per la prima volta in Francia nel XII secolo, e, a seguire, nelle altre letterature come quella italiana, nella quale erano conosciuti con il titolo di alfabeto dei villani. In età moderna il nome più importante è quello di Giulio Cesare Croce (1550-1609). Di questo autore, cantastorie di umili origini (in origine fabbro, poi anomalo letterato autodidatta), stampatore in proprio delle sue opere, si può leggere la vocazione paremiologica nell’opera più importante: Le sottilissime astutie di Bertoldo (1606). Qui si legge la costante comunicazione, improbabile ed impossibile, tra il povero ed il re, un dialogo fatto di proverbi, nella cronica incapacità di intendersi. Come nota lo storico della letteratura italiana (nonché antropologo) Piero Camporesi, nella saga di Bertoldo e nelle conversazioni con re Alboino, dalle bocche dei protagonisti “escono le stesse fiumane di proverbi”; solo che il contadino ed il re li usano in modo diverso e con un’infinità di equivoci, in un cronico, apparente dialogo tra sordi o finti sordi. “Dunque la “saggezza” dei proverbi è, in certi casi almeno, fortemente connotata sul piano sociale e culturale. Non è solo il contesto di produzione, ma soprattutto quello d’uso a determinarne il significato”6. Nei proverbi si affrontano ed al tempo stesso si confrontano due polarità sociali eternamente contrapposte, i poveri e i signori: “le due culture si incrociano e rappresentano interessi contrapposti, ma entrambe usano lo strumento del proverbio per affermare il proprio punto di vista”7. “L’attitudine moderna è quella di associare il proverbio al popolare, ma ritendendo nel contempo la letteratura, compresa quella che il popolare celebra e al popolare tende, come un qualcosa di completamente diverso e in fondo estraneo e dunque a considerare il proverbio stesso quasi esclusivamente come un fatto extraletterario, che certo può essere introdotto nella letteratura, ma soltanto nella dimensione dei contenuti, non in quanto forma e possibilità dell’espressione”. (V. Boggione, Logos, dialogo, letteratura, in V. Boggione, L. Massobrio, Dizionario dei proverbi, cit., p. XXII). 4 5 Ivi, p. XXIV. 6 M. Montanari, Il formaggio con le pere, Bari, Laterza, 2008, p. 121. 7 Ivi. Introduzione 9 Disseminata di proverbi è tutta la ricca produzione letteraria di Giulio Cesare Croce, del quale si deve citare anche la Selva di esperienza nella quale si sentono mille e tanti proverbi, provati et sperimentati da’ nostri antichi. Tirati per via d’alfabeto da G. C., stampata postuma nel 1618. Ai suoi tempi in tutta Europa vi sono significativi esempi di letteratura comico-realistica, di orgogliosa e spiccata coloritura popolare, nello stile, nei contenuti, e nell’ambientazione: i casi più eclatanti, dalla Francia e dalla Spagna, sono rappresentati da Gargantua e Pantagruele di Rabelais e dal Don Chisciotte della Mancia di Cervantes. Entrambe le opere sono una continua, funambolica, sequenza di citazioni di proverbi, motti e sentenze, formule dialettiche oltre che condensati di saperi e concetti che evidentemente incontrano sempre più riscontro nella quotidianità del popolo minuto, come anche di alcune categorie professionali sempre alla ricerca di artifici retorici di sicuro effetto, come aveva dimostrato la raccolta degli Adagia (1500) di Erasmo, che inaugura l’umanesimo del Nord Europa. Un’importante testimonianza in questo senso si ha anche in ambito iconografico, sopratutto nordeuropeo, e si riscontra nei dipinti dei Proverbi di Pieter Bruegel il vecchio. In Italia questo filone iconografico compare nelle opere seicentesche dell’incisore Giuseppe Maria Mitelli (bolognese come Giulio Cesare Croce), che ha raffigurato nelle sue stampe, oltre ai proverbi, i mestieri documentati per le vie di Bologna, e il Gioco di Cuccagna con i prodotti alimentari tradizionali delle varie città, e soprattutto le allegorie dei dodici mesi dell’anno, conosciute nell’immaginario collettivo contemporaneo perché hanno costituito, fino ai primissini anni Novanta del secolo scorso, le icone di una nota trasmissione televisiva: L’almanacco del giorno dopo. Nel Settecento, con l’illuminismo, si assisterà ad una fase critica dei proverbi, considerati portatori di un sapere vetusto, imbalsamato e lontano dalla verità scientifica. Sarà il secolo successivo, con la temperie romantica, a dare loro nuova dignità, con la nascita della ricerca folklorica, che li interpretò come il patrimonio dell’identità popolare profonda delle nazioni. 2. I pionieri del folklore marchigiano Nelle Marche, un personaggio fondamentale da ricordare per il suo basilare contributo nell’indagine non solo dei proverbi, ma di tutta l’identità culturale regionale, è stato certamente Giovanni Crocioni (1870-1954). Marchigiano di Arcevia (al dialetto della quale dedicò una monografia), dopo la laurea in lettere ed una in filosofia frequentando la scuola filologica romana, Crocioni orientò i suoi interessi verso la filologia romanza e la ricerca dei dialetti. Come storico della letteratura italiana si occupò di studi danteschi, mentre, come folklorista, codificò un proprio metodo per la disciplina (per esempio nel volume Problemi fondamentali dei folklore, con due lezioni sul folklore e D’Annunzio8) (Bologna 1928), il Crocioni intendeva contribuire a uno studio critico del folklore, oltre ad offrire un ulteriore strumento didattico per gli insegnanti. Egli procedeva, nello studio del patrimonio folklorico, secondo un metodo rigoroso di raccolta, selezione e classificazione del materiale che gli consentiva di svolgere un puntuale confronto tra elementi folklorici, generi letterari e formazione culturale dei principali autori italiani (segnaliamo a questo proposito le monografie su Leopardi, D’Annunzio, Giusti, Muratori). Una prima distinzione divideva il folklore in due grandi sezioni: una oggettiva o pratica, l’altra spirituale od orale; la prima comprendeva tutte le norme riguardanti le tecniche ed i mestieri che si tramandavano di generazione in generazione, la seconda concerneva tutto il patrimonio di canti, proverbi, motti, giochi, usanze. Un’ulteriore ripartizione distingueva quattro sezioni: arte, letteratura, scienza e morale dei popolo. 8 10 L’enciclopedia dei poveri dedicandosi sopratutto alle Marche. L’ambizione di Crocioni era cercare il terreno d’incontro tra la letteratura “alta” e quella popolare, come emerge nel suo Folklore e letteratura del 1954, e soprattutto Le tradizioni popolari nella letteratura italiana del 1970 (pubblicato postumo), nel quale egli “porta a termine il progetto di un’indagine complessiva sugli elementi folklorici presenti nella letteratura italiana da Dante ai veristi, con particolare attenzione per alcuni periodi in cui è maggiormente visibile questo legame”9. Come intellettuale, Crocioni fu anche particolarmente sensibile ed attento alla formazione delle scuole secondarie (tra le sue opere, Criteri fondamentali per il rinnovamento della scuola media, del 1918, ed Il professore di scuola media, la cui prima edizione è del 1919). Anche in qualità di attivista e sindacalista del corpo docente egli promosse la diffusione delle biblioteche scolastiche e l’inserimento della storia dell’arte tra le discipline insegnate, sostenendo soprattutto l’importanza della cultura popolare come base per lo studio delle materie tradizionali e la necessità di sviluppare una sensibilità particolare al contesto regionale nell’insegnamento (fondamentale l’opera del 1914 Le Regioni e la cultura nazionale, dedicata a Croce). Nel 1913 ottenne la libera docenza in letteratura italiana presso l’università di Bologna; fu presidente, dal 1922 al 1935, della Regia Deputazione di storia patria per le Marche, e diresse la rivista “Rendiconti dell’Istituto Marchigiano di scienze lettere ed arti”, da lui fondata nel 1925. Tra le imprescindibili opere dedicate all'amata regione d’origine, il volume Le Marche, letteratura, arte e storia (1914, nelle intenzioni il primo di una collana per la scuola secondaria, intitolata “Regioni”), i due tomi de La poesia dialettale marchigiana (1934-1936), Superstizioni e pregiudizi nelle Marche nel secolo XVII (1947), Il Leopardi e le tradizioni popolari (1948), La gente marchigiana nelle sue tradizioni (1952), Bibliografia delle tradizioni popolari marchigiane ( 1953). In quest’ultimo testo Crocioni tenta una mappatura delle fonti più antiche per i proverbi marchigiani rintracciandone di “ancora vivi, talvolta nella stessa forma latina, altre volte passati alla forma italiana sostanzialmente immutati” nel Proverbiorum libellus Plydori Vergili Urbinatis Presbyteri di Virgilio Polidori, stampato a Venezia nel 1498. Trova poi molti proverbi nelle opere di Baldassare Olimpo degli Alessandri da Sassoferrato (poeta burlesco cinquecentesco), ossia nella Pegasea, “una “frottola di motti bellissima et succosa de sententie assai”, e nella Nova Phenice, “Frottola de proverbi e motti volgari”, ma anche nell’Ardelia, che è strutturata in varie mattinate nelle quali ogni ottava si chiude con un detto o un proverbio10. Crocioni riferisce anche che un folklorista autorevole e celebre come il palermitano Giuseppe Pitrè (1841-1916) definiva l’opera di Belisario da Cingoli11 “un’incatenatura di proverbi”. Nella bibliografia marchigiana di Crocioni non manca un classico imprescindibile: l’opera del mondolfese Ivo Ciavarini Doni (1844-1908), filologo e studioso di antropologia, autore della raccolta Proverbi marchigiani raccolti ed ordinati, stampata ad Ancona nel 1883. Si tratta di un lavoro sicuramente prezioso, ricco di un repertorio unico12 di più “Da questa analisi risulta una ricostruzione metastorica della letteratura italiana ritenuta una filiazione del patrimonio culturale di cui il popolo è il depositario”, ivi. 9 10 G. Crocioni, Bibliografia delle tradizioni popolari marchigiane, Firenze, Olschki, 1953, pp. 140-150. L’opera a cui si fa riferimento è Il contrasto della Bianca e della Brunetta, di cui un’edizione a Firenze nel 1595. 11 12 D. Tiberi, Cultura e dialetto, in www.prourbino.it: “Alcuni di questi proverbi, riferiti alle stagioni, davvero originali e di tutto significato, non li troviamo in nessun’altra ricerca”. Introduzione 11 Sopra, San Nicola ferma un cavallo imbizzarrito, 1834, ex voto del Museo di San Nicola, Tolentino; sotto, San Nicola salva una donna incastrata nella ruota di un carro, sec. XIX, ex voto del Museo di San Nicola, Tolentino. 12 L’enciclopedia dei poveri di duemilacinquecento proverbi, catalogato con cura, seguendo l’ordine alfabetico, e soprattutto con una meticolosa classificazione secondo i temi più disparati degli aspetti della vita del tempo, dalle esperienze emotive ai saperi intellettuali e spirituali (sia di fede e devozione che di superstizione e credenza pagana), fino alla cultura materiale. Il limite oggettivo, e notevole, è la rimozione del tratto più forte e connotante della cultura e dell’identità territoriale, ossia la parlata dialettale, che solo raramente viene evocata o citata. Questa scelta fu condizionata da un preciso orientamento culturale che, in pieno clima postunitario, scoraggiava i regionalismi e le differenze locali, favorendo la rimozione del dialetto e l’affermazione di una lingua italiana colta e ufficiale13. Del resto anche i costanti rimandi e confronti dell’autore di proverbi analoghi o riconducibili del repertorio dialettale toscano (indagati anche da un cultore della lingua italiana come Tommaseo, pur non citato) non fanno che sottolineare la sua adesione ad un modello di lingua nazionale ed unificata. L’autore giustifica questo criterio infatti come “il più ragionevole per dare agio a tutti i lettori italiani e stranieri d’intendere i proverbi marchigiani”14. I successivi lavori di paremiologia hanno d’altra parte ben messo a fuoco le oggettive difficoltà di afferrare e circoscrivere la materia fluida e fluttuante del dialetto nelle sue infinite varianti e declinazioni15. Tra gli autori che Ciavarini Doni cita tra i suoi modelli, si incontra il nome di Antonio Gianandrea (1842-1898), considerato tra i pionieri del folklore marchigiano. Originario di Osimo, fu insegnante di lettere, storia e geografia a Jesi, ed è stato anche il primo segretario della Deputazione di Storia Patria delle Marche. Autore anche di saggi di storia e biografie, annovera tra i suoi lavori molte opere sulle tradizioni popolari marchigiane: Canti popolari marchigiani nella raccolta Canti e racconti del popolo italiano (1875), le monografie Biblioteca delle tradizioni popolari marchigiane (1878), Novelline e fiabe popolari marchigiane (1878), Saggio di giuochi e canti fanciulleschi delle Marche (1878), Fiabe e novelle popolari marchigiane (1881), Mazzolini di fiori campestri raccolti nell’amena valle dell’Esino (1886), Novelline e canti popolari delle Marche (1892). Innumerevoli sono stati poi i suoi articoli in riviste scientifiche e periodici di studi locali, che dimostrano sensibilità diverse per le varie espressioni della cultura e della devozione popolare. Un’altra illustre folklorista, Caterina Pigorini Beri (1845-1924), perlustrando le case e le 13 Ibidem: “Ma l'avversione del Ciavarini Doni agli idiomi locali non deve sorprendere più di tanto. Egli metteva a punto i suoi proverbi nel lontanissimo 1883 e non c'era, allora, famiglia di città o possidente di campagna che non sgridasse severamente i propri figli per una parola in dialetto, anche se pronunciata per gioco. È da dire invece che il testo del mondolfese è pregevole, se non altro per l'ampiezza e il senso dati alla ricerca e per i ricorrenti paralleli con la lingua toscana”. 14 I. Ciavarini Doni, Proverbi marchigiani, Ancona, Stab. Tip. Del Commercio, 1883 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1993), p. XXIII. “Ma a proposito di vernacolo è bene sottolineare quanto sia arduo, per non dire impossibile, mettere a punto una raccolta del genere interpretando ogni proverbio nella sua articolazione linguistica e conseguente pronuncia. E ciò, nonostante l'attenzione della quale mi sono fatto carico consultando ricerche locali, antologie preziose come quella di Leandro Castellani. E soprattutto raccogliendo testimonianze dirette tra la gente e gli anziani in primo luogo. Perché se identico è il precetto, vario e mutabile è il modo di esprimerlo, da vallata a vallata e da città a campagna. Quando non addirittura da paese a paese della stessa vallata con diversificazioni lessicali le più strane […]Un accenno e niente di più, per non sorprendersi del fatto che un proverbio, censito come maceratese o fermano, sia ricorrente e più conosciuto nella vicina Camerino o ad Ascoli. E viceversa. […] Per non dire, poi, dell'area del Montefeltro, con Urbino tra i più estesi comuni d'Italia, ricco di parlate che trovano modo di distinguersi tra cinta muraria e frazioni. E con un entroterra, solcato per valli che, specie nella parte montana, risente tantissimo dell'influsso linguistico delle regioni limitrofe” (Tiberi, Cultura e dialetto, cit.). 15 Introduzione 13 culture rurali apparentemente minime del borgo dove abitava e lavorava, scrisse diversi “bozzetti” sulla gente marchigiana, le sue tradizioni, ed anche i suoi proverbi. Sorella dell’illustre paletnologo Luigi Pigorini, a cui è intitolato il celebre Museo etnografico e delle tradizioni popolari di Roma, è stata a sua volta un’illustre studiosa della civiltà contadina. Era autodidatta e, dopo aver insegnato a Parma nelle scuole femminili di San Paolo, poi a Macerata, nel 1870 fu nominata direttrice della Regia Scuola normale e del Convitto Femminile di Camerino, dove sposò il sindaco, l’avvocato Antonio Beri. Le sue indagini folkloriche riguardarono anche la Calabria, dove si recò in viaggio (da cui il volume In Calabria, 1892), e naturalmente le Marche del territorio camerte, sulle quali scrisse descrizioni d’ambiente pubblicate prima sulla rivista “Nuova Antologia” e poi nel volume Costumi e superstizioni dell’Appennino Marchigiano (1889); studi che le valsero nel 1899 il premio al concorso per una monografia sulle superstizioni popolari in Italia della Società italiana di antropologia e di etnologia di Firenze16. Così scrive in proposito al suo contributo sui proverbi marchigiani: “per mostrare la vivezza del linguaggio marchigiano, ho voluto porre in dialoghi un saggio sui proverbi, che a migliaia escon di bocca al contado nel conversare. Non ho seguito l’uso comune di stamparli in raccolta divisi per materia, sapendo per prova che in siffatta materia sono difficilmente letti e studiati perché non parmi si possa ritrarre alcun utile da una frase secca e nuda, senza la debita illustrazione pratica”17. È uno schizzo di fine inverno con già sentori di primavera (“era un mattino di marzo”) che coincideva con la fine del Carnevale, come attesta a fine racconto l’offerta di una “ciambella guarnita di fulignata (confettini)”. Da Camerino, importante e blasonato centro del Maceratese, a Fermo, altra cittadina dalla ricchissima storia e dall’importante contributo alla cultura marchigiana, della quale sicuramente un esponente importante è stato Luigi Mannocchi (1855-1936), originario di Petritoli. Storico e studioso di folklore (con formazione prevalentemente da autodidatta), poeta dialettale e giornalista (con lo pseudonimo di “Lilliputo”), è stato autore di saggi tra i quali Il Piceno nelle tradizioni e nella prima letteratura (1906), Alcune feste e costumanze caratteristiche del Circondario di Fermo (1911), Feste, costumanze superstizioni popolari nel Circondario di Fermo (1920), Lunario fermano polare contadinesco perpetuo, e di molti altri studi rimasti inediti per molto tempo e pubblicati dopo la sua morte18. Di Petriolo (Macerata) era invece originario un altro folklorista della metà del Novecento, che ha indagato e raccolto tradizioni e proverbi delle Marche di un importante spicchio di territorio tra Maceratese e Fermano. Giovanni Ginobili (1892-1973) è stato anche etnomusicologo e compositore (di musica e testi), poeta e drammaturgo, e autore di una settantina di pubblicazioni sul dialetto, gli usi ed i costumi, le leggende della gente marchigiana. Dai suoi scritti emerge “la grande lezione dei nostri antenati”. Come scrive Enzo Calcaterra, “ripercorrendo con lui il sentiero delle parole fino al cuore delle radici riascoltiamo le voci cantare, i corpi raccontare un mondo sospeso tra la fantasia, il gioco, la sofferenza, la gioia genuina, la meditazione in semplicità sui grandi perché dell’esistenza”19. 16 R. Corso, Caterina Pigorini Beri, in Enciclopedia italiana (Roma, 1935), s.v. 17 C. Pigorini Beri, Costumi e superstizioni dell’Appennino Marchigiano, Città di Castello, S. Lapi, 1889, p. 69. 18 Cfr. A. Gianandrea, L. Mannocchi, Tradizioni marchigiane, Fermo, Andrea Livi, 2006. E. Calcaterra, Presentazione, in G. Ginobili, Se fa…, ma no’nze dice! Indovinelli, proverbi, scioglilingua, canti, stornelli licenziosi della tradizione marchigiana, a cura di E. Calcaterra, Tolentino, Biblioteca Filelfica, 2004, p. 8. 19 14 L’enciclopedia dei poveri La sua passione per il recupero di gesti e consuetudini vissute in prima persona fin dalla primissima infanzia nasce sul solco della memoria, come emerge anche da un ritratto di Ginobili tracciato da Guido Piovene nel suo Viaggio in Italia: “uno studioso locale, Giovanni Ginobili, vide nella sua infanzia liti furiose di comari che si denudavano in piazza perché le loro membra, non si sa come, dimostrassero a tutti, con il loro semplice aspetto, la fedeltà al marito, forse credendo che il peccato le avrebbe fatte dimagrire o annerire; oppure s’insultavano senza parole, mostrandosi in successione oggetti d’uso casalingo, che nel linguaggio muto della convenzione significavano oltraggio, sino a comporre tutto un lungo discorso”20. Tra i suoi scritti si possono ricordare Proverbi marchigiani (1951), Blasoni popolari: facezie, motti, frasi proverbiali, ecc. interessanti i comuni della provincia di Macerata (1953), varie raccolte per le quali si rinvia alla bibliografia in calce al volume. Venendo a contributi più recenti si debbono ricordare due importanti monografie uscite negli ultimi decenni del secolo scorso. Il regista televisivo Leandro casteLLani è anche studioso di storia e folklore locale, ed è stato autore, nel 1973, della raccolta Proverbi marchigiani, nella quale egli intende “cogliere e fissare i singoli proverbi nella forma caratteristica che essi hanno assunto in questa o quella zona, indicandone l’origine”. Vi si circoscrivono i tre grandi gruppi di dialetti della regione (il Montefeltro, il Pesarese, il Nord della provincia di Ancona, cioè l’area gallo-italica, con somiglianze con il Romagnolo; la parte centrale dell’Anconetano-Maceratese riconducibile al dialetto umbro; l’Ascolano con la tradizione umbro-latina influenzata dal dialetto abruzzese)21. Un altro importante contributo alla paremiologia marchigiana degli anni Settanta del Novecento, è il volume Proverbi marchigiani illustrati di renato beLLabarba, il quale così inquadra il repertorio da lui raccolto, selezionato e commentato: “certo i proverbi marchigiani non hanno né l’arguzia né l’audacia di quelli, per esempio, toscani o napoletani, ma nei temi peculiari reggono il paragone e bene esprimono – poco indulgendo all’a- L’aia della casa colonica del Fermano, dai disegni e studi della Etnografia illustrata di Luigi Mannocchi, sec. XX, Fermo, Biblioteca comunale “Romolo Spezioli”. 20 Questi altri passaggi della pagina di Piovene: “Giovanni Ginobili, maestro elementare, e studioso superstite del folclore marchigiano, abita a Macerata; è piccolo, con i capelli bianchi ritti a fiamma, che quasi ne raddoppiano la statura; ha raccolto canti, proverbi, musiche, costumanze, in una dozzina di libri e d’opuscoli” […] “Una volta si portò a casa una mendicante decrepita di 92 anni per un accenno a una leggenda che gli era parso di cogliere nei suoi balbettii”. 21 L. Castellani, Proverbi marchigiani, Firenze, Giunti, 1973, p. (IV). Introduzione 15 Una donna travolta da un uomo a cavallo invoca l’aiuto di San Nicola, sec. XIX, ex voto del Museo di San Nicola, Tolentino. dulazione e all’inganno – i caratteri tradizionali delle popolazioni picene, quali l’amore per la natura e il rispetto delle sue leggi, l’attitudine alla semplicità e alla chiarezza, il senso del dovere e della misura, la riservatezza del carattere”22. Tra gli studiosi contemporanei compare anche un politico, già presidente della Regione, dino tiberi che, in uno dei suoi saggi, si rifa ad una descrizione fotografica d’insieme di Gilberto Lisotti comparsa in Muse all’aperto (“la poesia dialettale marchigiana offre un panorama che assomiglia un po’ a quello fisico della nostra regione: ameno, dolcemente ondulato, riposante con una serie di colline e vallate aperte al vento del mare; con cime che poco si elevano sulle altre, mai nascondendo il volto tra le nubi”), per poter inquadrare con una similitudine efficace il repertorio paremiologico marchigiano: “altrettanto pare di poter dire dei proverbi, veri componimenti poetici, discreti, freschi di sentimenti, sempre disposti a sorprendere, mai avvolti nelle nebbie dell’incertezza”23. Nella presentazione che un illustre marchigiano d’adozione, Carlo Bo (com’è noto per mezzo secolo rettore dell’Università di Urbino) premette al libro di Tiberi si legge: “tutte le voci degli uomini che hanno faticato su quella terra e, nei momenti di meditazione poetica, hanno riscoperto la sapienza, la verità e la condizione dell’uomo soggetto a pagare quotidianamente il suo riscatto a quella parte minima che gli è concessa di sottrazione alla miseria (…) di strappare nel dolore, nella pena, e a volte nel sangue, il pane quotidiano”24. 22 R. Bellabarba, Proverbi marchigiani illustrati, Presentazione di P. Toschi, Firenze, Olschki, 1971, p. VIII. 23 D. Tiberi, Storie da proverbi marchigiani, Presentazione di Carlo Bo, p. 8. 24 C. Bo. Presentazione, in D. Tiberi, Storie da proverbi marchigiani, cit., p. 5. 16 L’enciclopedia dei poveri Ed è proprio questa ambascia giornaliera nello strappare volta dopo volta il necessario per il sostentamento e la sopravvivenza a connotare la sapienza dei proverbi ed i loro principali contenuti. L’obiettivo principale è pertanto dominare la terra, per poterla governare al meglio e ricavarne il massimo possibile. Se la terra è tangibile, concreta e controllabile, è invece inafferrabile il cielo con le sue decisioni insindacabili; esso, dell’alto, può decidere il buono ed il cattivo esito dell’operare umano. Dino Tiberi, nel commentare il proverbio (riportato nella sua raccolta anche da Ivo Ciavarini Doni) Ogni vento che tira una disgrazia, scrive: “per lo più il vento lo si chiamava di mezzo per i danni che arrecava alle colture, alle strutture abitative e alle cose in genere. Qui la disgrazia va riferita a credenze maturate nei tempi bui, quando l’intensità del soffiare la si legava non soltanto alla morte di qualcuno, ma anche al censo che lo distingueva: violento se altolocato o malvagio, più contenuto se persona comune. Negli anni Trenta-Quaranta c’era ancora, nelle campagne marchigiane, chi riteneva che i periodi ventosi fossero preceduti da grande siccità e che fossero annunciati da raffiche improvvise, calde all’inizio, poi gelide da caverna. Credenze antichissime, secondo le quali la terra era spezzata da antri immensi nei quali si susseguivano esplosioni, crolli, boati accompagnati da folate. Premonizioni che troviamo anche nella Meteorologia di Aristotile”. Dietro la stringatezza di un proverbio si aprono così memorie e principi di vita vissuta, ma anche informazioni scientifiche passate. Leandro Castellani osserva come certi proverbi siano “vere e proprie regole, quasi formule di sapere prescientifico, voci di un enciclopedia popolare da consultarsi in ogni evenienza: per conoscere il tempo come per sapere a quali lavori agricoli attendere, per vagliare presagi come per rispettare le consuetudini”25. Il cielo dalle decisioni insindacabili e purtroppo difficilmente prevedibili, va interpretato sulla scorta dell’esperienza, dell’osservazione dei suoi comportamenti e quindi dalla formulazione su base statistica di cosa potrà succedere in campo atmosferico. I proverbi cercano così di codificare e formulare una basilare ed essenziale meteorologia. Luigi Mannocchi scriveva nel suo Lunario fermano popolare contadinesco perpetuo: “tenendo l’occhio fisso a queste stelle i contadini vi sanno dire, quasi con precisione cronometrica, quanto manchi a farsi giorno e qualunque ora prima e dopo la mezzanotte. (…) I nostri contadini, vecchi Piceni, vecchia stirpe di razza sabina e pelasgica, vecchi agricoltori, uomini di lunga esperienza, non hanno inoltre bisogno dell’autorità di astronomi per predire il tempo che farà”26. 3. Un’arte della memoria popolare I proverbi registravano pertanto avvertimenti a proposito dei fenomeni atmosferici, pronunciando come condanna ferale la parola che tutti, nelle antiche società rurali, più temevano: Sóta la név el pèn, sóta l’aqua la fèm (sotto la neve il pane, sotto l’acqua la fame). Questa formula insegnava infatti ai contadini come la neve avesse un ruolo positivo nella crescita del frumento, mentre le piogge eccessive fossero invece pericolose27. 25 L. Castellani, Proverbi marchigiani, Firenze, Giunti, 1993, p. (IV). L. Mannocchi (Liiliputto), Lunario fermano popolare contadinesco perpetuo, Fermo, Tipografia Economica, 1924, p. 6. 26 27 T. Franceschi, La formula proverbiale, cit., p. XXXVII. “I proverbi non sono – come troppo spesso si sente dire – un repertorio di sapienza popolare (…) Eppure è innegabile come la maggior parte dei Introduzione 17 Il repertorio proverbiale fu utilizzato anche nei tentativi didattici di miglioramento della cultura contadina promossi nell’Ottocento. Massimo Montanari osserva come, già nel corso del Cinquecento, “il dibattito sull’istruzione contadina sia all’ordine del giorno”, e citava il caso di Camillo Tarello, agiato possidente del contado bresciano, autore di un Ricordo d’agricoltura pubblicato nel 1567, nel quale, riprendendo Aristotele, sentenziava che “tutti gli uomini naturalmente desiderano il sapere”, affermando l’esigenza di avvicinare i contadini alla conoscenza. Egli auspicava “ch’esso si faccia leggere e dichiarare dai preti d’ogni villa, castello e terra pubblicamente ogni mese una volta, per beneficio et intelligenza degli agricoltori”, e redigeva un libro in forma di proverbi per insegnare alcune questioni di pratica agraria ai contadini28. Per questo motivo i proverbi hanno spesso il carattere di precetti, di formule impiegate per memorizzare la scansione del tempo ed i lavori dei campi. Ancora oggi si ricorre ai proverbi per ricordare il numero dei giorni dei vari mesi dell’anno; anticamente si tenevano a mente i periodi dell’anno in base a ciò che, di volta in volta, la natura metteva ciclicamente a disposizione. Tanti, infatti, i proverbi che associano non solo i mesi, ma anche i santi, ossia i giorni precisi dell’anno, ad alcune mansioni della sussistenza. Ad esempio, a fine anno, con i primi freddi, giungeva la fine comandata del maiale, la cui carne era l’unico fondamento proteico dei poveri e la sola carne a disposizione (El porciello, è del povero il maciello, si sentenzia nell’Anconetano). Questo proverbio si lega ad una sentenza del Fermano che invita genericamente alla previdenza: Chi de Natà no’ ‘mmazza lu porcu / tuttu l’annu va co’ lu musu stortu (chi non ammazza il maiale per Natale, va tutto l’anno col muso storto). Per quanto riguarda invece il vino, è attraverso i santi titolari delle giornate del martirologio, che si ricordano alcune date, termini di paragone e virtuali promemoria per le pratiche da eseguire in cantina: un esempio è il consueto e conosciuto San Martino, quell’11 di novembre ricordato dall’omonima poesia di Carducci, che, nei proverbi di tutta Italia, fa rima baciata con le “botti piene di vino” (o di ogni mosto che è vino”). Nel Pesarese si ricorda che, al 6 di ottobre, El giorno d’San Brunòn s’sent el vin dal suchiòn (il giorno di San Bruno si assaggia il vino con il sifone), e che, invece, alle soglie dell’estate, al primo di giugno, San Giustin bev l’aqua e butta via el vin (San Giustino, bevi l’acqua e butta via il vino), avvertendo così di come la qualità di quanto resta nelle botti sia ormai svanita. Un generico ammonimento di dispensa, che si estende simbolicamente a tutto il vitto, concentrandosi però sull’endiadi anche eucaristica del cibo e della bevanda per antonomasia, recita nel Pesarese: A Natèl metà pèn, a Pasqua metà vén (fino a Natale metà pane, fino a Pasqua metà vino)29. detti paremiaci aspiri alla misura dell’esemplarità, indipendentemente dal fatto che il tono sia di seria gravità o di scanzonata o ribaldesca provocazione.” Perché nei proverbi le parole sono “già combinate secondo criteri di memorizzabilità, forza espressiva, efficacia relazionale, in ciò dunque sono estremamente simili alla “lingua della letteratura” e della poesia in particolare con cui condividono “la concisione, la pregnanza dell’immagine, l’importanza del ritmo e delle figure di suono all’uso della rima)”. M. Montanari, Il formaggio con le pere, cit., p. 103. C. Tarello, Ricordo d’agricoltura, a cura di M. Berengo, Torino, Einaudi, 1975, p. 122; l’edizione di riferimento dell’opera è quella settecentesca Ricordo d’agricoltura di M. Camillo Tarello, corretto, illustrato, aumentato con note, aggiunte, e tavole dal padre Gian Francesco Scottoni min. conventuale, Venezia, Bassaglia, 1772, pp. 245-246. 28 D. Tiberi 1997, p. 49: preciso punto di riferimento nell’economia domestica della famiglia rurale. Per essere certi che le provviste di un anno non facciano difetto, le si divide a metà: la prima tranche di grano fino a Natale, quella di vino fino a Pasqua. 29 18 L’enciclopedia dei poveri Riguardo al pane, tra i molti proverbi che si riferiscono all’assoluta valenza emblematica di questo alimento, metafora inequivocabile del sostentamento e della sopravvivenza quotidiana, si può citare una sentenza del Pesarese che raccomanda la giudiziosa capacità di essere autosufficienti e la virtuosa preparazione in proprio delle pagnotte di casa (Chi ha giudizi compra el grèn, chi n’ha poch compra la farina, chi en l’ha per gnent compra el pèn, chi ha giudizio compra il grano, chi ne ha poco compra la farina, chi non ne ha per niente compra il pane). Come osserva giustamente Leandro Castellani, “il proverbio, documento di cultura popolare, materiale di riflessione, è anche la patetica testimonianza di un’utopia perenne, l’illusione di poter vivere per tutti, di poter evitare agli altri gli sbagli che abbiamo commesso, di poter proteggere il capo indifeso di quelli che ci seguiranno”30. I proverbi non sono solo enunciati didattici, ma sempre, didascalicamente, riportano anche il bagaglio dell’esperienza di vita vissuta sulla propria pelle perché rappresentano e costituiscono “un aiuto che l’uomo offre ad un altro uomo, una guida per evitare l’errore o porvi rimedio”31, il conforto che l’esperienza può dare a chi deve ancora affrontarla. Un proverbio pesarese sentenzia in termini di scansione calendariale le porzioni dell’anno (secondo un ben preciso e dichiarato spartiacque), tra maledette e benedette (fas/ nefas); riguardo alla tranquillità della dispensa e delle scorte alimentari: Prima de Natèl né fred né fèm, da Natèl in là fréd e fèm in quantità (prima di Natale né freddo né fame, da Natale in là freddo e fame in quantità). Si torna inevitabilmente all’emergenza più totalizzante della sussistenza quotidiana del nutrirsi, preoccupazione primaria quando non ossessione nei secoli preindustriali, costantemente tormentati da ricorrenti carestie e calamità. Sulla fame si trovano prevedibilmente parecchi proverbi, tra cui insospettabili citazioni d’autore, perché, anche nel contesto marchigiano, alcuni di questi enunciati della tradizione cosiddetta popolare affondano le loro radici nel repertorio dotto della cultura ufficiale e della letteratura universalmente considerata “alta”. La sentenza il migliore condimento è la fame (nella variante pesarese El mei cundit è la fem), è in realtà una massima di Socrate, poi fatta propria da Cicerone32, e quindi ripresa nel medioevo da un grande mistico e padre fondatore del cristianesimo e del monachesimo, San Benedetto da Norcia, e dai molti suoi seguaci, i quali furono notoriamente anche cultori, tutori ed impagabili perpetuatori del patrimonio della cultura classica. Per quanto si possa affermare che il proverbio, rispetto agli aforismi o alle massime d’autore, si differenzi per essere “un enunciato senza enunciatore”33 (ed in effetti questo suo carattere di anonimato è la sua forza specifica, che accentua la sua portata universale34), esiste in molti proverbi anche una notevole, per quanto indeterminata e cora- 30 L. Castellani, Proverbi marchigiani, cit., p. (III). G. Pontiggia, Prefazione a Scrittori italiani di aforismi, a cura di G. Ruozzi, Milano, Mondadori, 1994, vol. I, p. 27. 31 32 Cicerone, De finibus bonorum et malorum, II.: “Cibi condimentum esse famem, potionis sitim: La fame rende gustoso ogni cibo, la sete ogni bevanda”. 33 M. Camille, Image on the Edge: The Margins of Medieval Art, Cambridge, Harvard University Press, 1992, p. 36. 34 M. Montanari, Il formaggio con le pere, cit., p. 122: questo conferisce ai proverbi “un senso di perentoria ed indiscussa autorevolezza che nel carattere impersonale assume quasi la forza di una totale assolutezza”. Introduzione 19 le, compiaciuta presenza di ascendenze e rimandi letterari (come sintetizza l’italianista ed antropologo Piero Camporesi, “il proverbio condensa il sapere non firmato del gruppo”)35. Ad esempio, nell’Anconetano (che ribadisce il concetto con Quando c’è la fame tuto è bono) due proverbi alludono al requisito irrinunciabile di rispetto della propria dignità e dell’inviolabile serenità familiare. Si diceva Pane, porro e pace oppure Pane cipolla e casa sua, o ancora più eloquentemente Pà e cipolla tutti li jorni ma in pace tuttu l’anno36. Il misero companatico degli umili bulbi, da abbinare però alla “pace” ed alla “casa sua (propria)” si riferisce al privilegio del mangiare con indisturbata tranquillità, e soprattutto con fierezza del proprio, senza dover essere sempre debitori dell’ospitalità e degli aiuti altrui, con obblighi di riconoscenza, quando non di debitoria sudditanza. Pur non essendo citazioni dirette, queste sentenze rimandano a luoghi comuni letterari che esaltano l’oasi della propria mensa, seppur frugale, come orgoglioso traguardo del proprio lavoro e della propria autosufficienza, quando non integrità. Si ritrovano riflessioni simili in Orazio, nella letteratura latina, ed in Ariosto (“Meglio una rapa in casa mia…”)37 nella letteratura italiana cinquecentesca, o persino nelle fiabe con intento morale di Fedro ed Esopo (il celebre apologo del topo di campagna, che preferisce i suoi tranquilli e rustici avanzi di dispensa in santa pace rispetto ai rocamboleschi furti di leccornie del topo di città). Proverbi come questi, dedicati alla stringatezza di pane e companatico, sono anche un fenomenale e sintetico ritratto di una realtà sociale o di un territorio: il detto anconetano Na feta de pa’ e do’acini d’uliva (una fetta di pane e due olive) può essere considerato, come sempre accade nei proverbi, dove tutto cambia a seconda del punto di vista e della prospettiva di chi li enuncia, un elogio della modestia e della frugalità o, al contrario, una certificazione di povertà, ma di certo è anche una fotografia d’epoca della risicatissima merenda dei braccianti di campagna. Il valore documentario dei proverbi per ricostruire la storia della cultura materiale è innegabile e, nel Pesarese, la constatazione Tèmp de carestia, pèn de ghiènda (tempo di carestia, pane di ghianda) rivela l’antica consuetudine in molti territori di impiegare la farina del frutto coriaceo delle querce per la panificazione, ottenendo pagnotte tutt’altro che appetibili, e che magari la letteratura scientifica suggeriva come succedanee ottimali, ma che, ovviamente, per quanto familiari, erano universalmente percepite come un malinconico emblema della miseria e della fame nera. Nella continua ricerca del “giusto mezzo”, che è una costante dei proverbi, una formula maceratese ricorda Bbonnanza stufa, caristia fa fame (l’abbondanza stanca, ma la carestia porta la fame). “Il proverbio è un testo aperto, la cui forma e il cui significato si definiscono di volta in volta secondo il punto di vista e gli interessi di chi lo pronuncia”; questo tipo di enunciato è poi un grande demarcatore sociale, perché “i saperi che esso esprime non sono universali, bensì legati a una precisa connotazione di classe”38. P. Camporesi, La formazione e la trasmissione del sapere nelle società pastorali e contadine, “Estudis d’història agrària”, V, 1985, pp. 77-89. 35 F.M. Serpilli, Cose da ride. Proverbi - Modi di dire - battute nei vari dialetti marchigiani, Varano, Comitato Organizzatore Manifestazioni Varanesi, 2009, p. 32. 36 37 L. Ariosto, Satire, III. 38 M. Montanari, Il formaggio con le pere, cit., p. 117. 20 L’enciclopedia dei poveri 4. L’alto e il basso In genere, le massime e gli aforismi enunciati dalle classi “alte” non riconoscevano al popolo, cronicamente affamato e presumibilmente non consapevole dei requisiti del buon cibo, una particolare competenza sulle qualità del mangiare: risulta emblematico il proverbio maceratese Vì, cascio e pere pasto de cavaliere (vino, cacio e pere pasto da cavaliere), versione marchigiana dell’universale Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere (che ha ispirato allo storico Massimo Montanari una riflessione così articolata da diventare un intero saggio). Nonostante però la presunta scarsa attitudine da gourmet attribuita ai ceti più umili, esistono anche, nella tradizione rurale marchigiana, proverbi che codificano una seppur elementare sapienza gastronomica. Inequivocabilmente è la centralità, nella cultura popolare marchigiana (ed in tutte le altre), delle pratiche di cucina, ad essere non solo veicolo di identità, ma anche specchio della società con le sue differenze e barriere di classe. Innanzitutto la cucina è il cuore della casa, e, in senso traslato, il luogo della padrona e delle sue virtù: una visione arcaica e maschilista scoraggia, infatti, tra i requisiti femminili, l’istruzione. Un proverbio pesarese censura la scelta di una consorte troppo dotta, perché Con la moje laureata, cena fredda apparecchiata; la variante finale cena fredda oppur salata fa riferimento agli insaccati e ai formaggi, e rimanda ad un altro proverbio, dove, con ulteriore forza, si ribadisce la condanna delle cattive massaie che ricorrono ai salumi invece di impegnarsi ai fornelli: Presciut e salèm, past da putèn (prosciutto e salame, pasto da donne poco raccomandabili). In altri casi i proverbi suggeriscono trovate che possono diventare vere e proprie ricette, mettendo in guardia le cuoche dai rischi in cucina, ma anche suggerendo soluzioni pratiche. Ad esempio La vaccina svergogna chi la cucina (forse per la difficoltà di preparazione, o perché trattasi di una carne che tende a ridimensionarsi in cottura), o La chèrne più bòna è quela tachèta a l’òs (la carne più buona è quella attaccata all’osso); il Pesc còtt e carne cruda (il pesce è buono cotto e la carne cruda). La funzione di proverbi di questo tipo è anche codificare valori sociali rispetto al cibo ed una gerarchia del vitto, considerato uno status symbol: Noce e pane pasto da sovrane è ad esempio la declinazione, nel repertorio marchigiano, di un classico nazionale, mentre nell’Anconetano, Le pere moscatelle non è fatte pe’ li pórci (equivalente del più idiomatico ed universalmente conosciuto Dare le perle ai porci) si coglie un significato più ampio che si riferisce a cure ed attenzioni rivolte a chi non le merita. Memore poi dell’antico criterio gerarchico, di ascendenza medioevale, che ripartiva i tagli della preda secondo il censo ed il merito venatorio, La coradella del lepr’ va a ’l cacciator che l’ha mazet (la corata della lepre spetta al cacciatore che l’ha uccisa). Alcune di queste formule a scopo mnemonico impartiscono consigli sulle qualità ottimali degli alimenti e sulla loro conservabilità: Pane con gli occhi, cacio senz’occhi si diceva per ricordare come la mollica bucherellata fosse più morbida e gustosa, e come invece il formaggio dalla pasta compatta ed uniforme risultasse più sostanzioso. Il principio era chiaramente non sprecare nulla e praticare l’arte del reimpiego di tutto ciò che fosse commestibile, a partire dagli avanzi da riciclare all’infinito (nel Pesarese si dice In tle chès en tocca buttè via gnanca j’oss dla pulenta, ossia nelle case non bisogna buttare via nemmeno gli ossi della polenta, cioè una cosa inesistente, niente). In questa ricerca ossessiva di risorse commestibili erano considerate strategiche e provvidenziali per tutto l’anno le erbe spontanee. In tutte le case contadine le “foglie” crude o cotte rappresentavano il vitto giornaliero principale, ed è inevitabile che i proverbi si dedicassero a questa provvista preziosa e comune, per sottolinearne il carattere vir- Introduzione 21 tuoso di cibo saziante e conveniente (nell’Urbinate, L’érba de campagna se chèpa quant se magna, l’erba di campagna si monda quando si mangia), o come promemoria della loro stagionalità o commestibilità (sempre nel Pesarese, Fin ch’en canta ’l cucch, l’erb enn bon tutt, finché canta il cuculo, le erbe sono tutte buone39). Ma questo piatto ordinario diventava emblema della più povera e stancante ripetitività dei pasti, Festa rmista è comme le foje rescallate (la festa rinviata è come un piatto di foglie riscaldato). Nel Fermano un proverbio identico usa l’analogia della pietanza ordinaria per eccellenza, quasi sempre vegetale e poco appetitosa (Fiera rbannita, minestra rescallata, fiera rimandata minestra riscaldata) per ribadire questo concetto. Del resto, i Marchigiani sono sempre stati celebri per le loro mesticanze (mescolanze) d’erbe, e, fin dal Cinquecento, la letteratura specialistica registra una Lettera sulle insalate, opera manoscritta del medico e botanico Costanzo Felici da Piobbico il quale afferma già, “insalata ben oliata, poco aceto ben salata”, archetipo di tutti i proverbi in materia che costellano il territorio regionale; a partire dalla medesima sentenza in dialetto pesarese ed urbinate, L’insalèta, pòc acét e bèn ulièta (l’insalata, poco aceto e ben oliata40), di cui esistono la variante anconetana (La insalata, ben lavata, poco aceto, bene oliata ed il sale a pizzicò) e maceratese (La ‘nzalàta: póco aceto, ben oliata e de sale ‘na pizzicàta). Si tratta spesso di enunciati che sono autentiche ricette da mandare a memoria, e che ribadiscono l’irrinunciabilità di certe erbe (La ‘nzalata non è bbona se non c’è la grispignola, la ‘nzalata non è bbella, se non c’è la pimpinella)41, oppure suggerimenti per la mescolata decisiva: Per cundì l’inzalata ce vole tre perzone: un giusto (pel sale), ‘n avaro (per l’aceto), e un spregó (per l’ojo). Talvolta queste formule diventano riflessioni filosofiche sul genere umano, come L’insalata vuole sette “p”: un povero per coglierla, un polito per lavarla, un perito per il sale, un parco per l’aceto, un prodigo per l’olio, un pazzo per mescolarla, un porco per mangiarla. Nel Fermano si ricorda, in rima baciata, ed in accezione negativa, come questa preparazione sia un demarcatore sociale degli affamati cronici: L’insalata bocca unta e panza tribolata. Verdure ed ortaggi erano infatti la dieta obbligata della gente umile (di campagna e non), un suo tratto identificativo, a volte spregiativo, come dimostra una letteratura “alta”, seppur di ispirazione ed ambientazione popolare e comico-realistica, che associa ai contadini l’olezzo di certe radici dai sapori acri e pungenti, di cui i proverbi danno testimonianza: La cpóla e l’aj còt pùsen sèt giórn e sèt nòt (la cipolla e l’aglio cotti puzzano sette giorni e sette notti). La presenza ricorrente di vegetali nelle tavole dei più portava ad una loro inflazione: I cavi riscaldèt j’è bon mo inn’è lodèt (i cavoli riscaldati sono buoni ma non sono lodati); ma, al tempo stesso, con tono consolatorio, dei medesimi cavoli si elogiava la conservabilità e la lunga appetibilità, perché Cavle e minestronse s’mantengne benon (cavoli e minestrone si mantengono benone). Di altri ortaggi poco saporiti si ammoniva di come andassero riccamente cucinati, nel senso gergale di “maritati” con altri ingredienti o procedure (La suca vòl la dòta d’una dòna bruta, la zucca vuole la dote di una donna brutta; Disse lu cavulo a lo cocu: mètteme a largo e famme foco, disse il cavolfiore al cuoco: mettimi in un recipiente largo e fammi un fuoco forte; La fava é come l’ovu, più se lessa e più doventa dura, la fava è come l’uovo: più si lessa e più 39 Spiegazione: fino ad Aprile le erbe campestri sono tutte buone da mangiare. Silvi Simoncelli, cit., p. 279: raccomandazione culinaria oggi ovvia e scontata, che non era tale in tempi di scarsità di cibo, quando si preferiva abbondare in aceto risparmiando il prezioso olio. 40 G. Ginobili sentenzia “questa sarebbe l’insalata campagnola” (Indovinelli, Scioglilingua e Proverbi Marchigiani, Macerata, Tipografia San Guseppe, 1960, p. 43). 41 22 L’enciclopedia dei poveri diventa dura). In altri casi sono occasione per consigliare accorgimenti di preparazione come la pulizia preventiva di certe provviste prima che vengano cotte: La lenta minchiona la giovane e la vecchia (la lenticchia inganna tanto la giovane quanto la vecchia, perché è difficile scorgere tutte le piccolissime impurità di cui mondare le lenticchie appena tolte dal sacco). Tra tutti i legumi, importantissimi surrogati proteici per le mense più povere, le fave erano assai ricorrenti e consumate con grande voracità. In un proverbio anconetano esse rappresentano il paradigma delle situazioni metereologiche cangianti: Tiempo arfatto de notte vale ‘n piatto de fae cotte (il tempo rimesso durante la notte dura quanto un piatto di fave cotte). Nel Maceratese si arriva allo scioglilingua: Le fae come le fae, le fae le fae bone (le fave, come le fai le fave le fai buone). Nel Pesarese ci si autorassicura che La mnèstra sai fagiòi cuntènta tut’i fiòi (la minestra coi fagioli contenta tutti i figlioli). Episodicamente, in barba alle refezioni ordinarie che devono saziare con poca spesa e poco dispendio di ingredienti, c’è la cucina sontuosa delle grandi occasioni, quella che era chiamata “di grasso” anche per la massiccia profusione di unto e condimenti. A queste occasioni si riferisce una massima universalmente conosciuta, che Frita è bòna anca la ciavata dla sòcera (fritta è buona anche la ciabatta della suocera), espressa da un proverbio pesarese, ma tradizionalmente ben familiare anche agli Anconetani (Diceva la bonanima de nona che frite è bone puro le ciavate) e agli Ascolani. Agli stessi Ascolani si riferisce una massima che ha una tradizione letteraria nobile risalente al latino: per la conclusione ottimale di un pasto si raccomanda che Lu doggë sta jó ‘nfunnë (il dolce sta giù in fondo), traduzione del celebre dulcis in fundo, diventato idiomatico. In merito al post-pasto, un proverbio pesarese ricorda un alimento sul quale hanno disquisito i gastronomi fin dal Rinascimento, ossia che Da la tèvla en t’alsè mèi si la bóca en sa d’furmèi (dalla tavola non alzarti mai se la bocca non sa di formaggio), mentre un detto anconetano prende posizione sulle confetture: Marmellata de pera, la cominci la mattina, la finisci la sera. Maceratese, invece, è un consiglio che si allarga alla metafora morale: Dell’ironia e de lo sale lo troppo è sèmbre male (dell’ironia e del sale il troppo è sempre male). Infine è ascolana una suggestiva riflessione sul caffè: Lu caffè pé èsse bbune, dev’èsse nére còme la nòtte, calle còme l’enfèrne e dóce còme l’amóre (il caffè, per essere buono, deve essere nero come la notte, caldo come l’inferno e dolce come l’amore). Quest’ultima massima sul caffè, preparato fino a non molto tempo fa di esclusivo ambiente signorile (gli Ascolani si esprimono anche sulla bevanda, all’opposto, più semplice e plebea, ossia l’acquaticcio, affermando che Tre dì è bonu e dopo è tristo), conferma che le disquisizioni sul gusto attraverso i proverbi non hanno una paternità esclusivamente popolare. Spesso infatti rivelano una matrice dotta: il pesarese Chi pèrla quant magna pérd el bucón (chi parla quando mangia perde il boccone) riecheggia per esempio la favola di Esopo del cervo e della volpe sull’espediente usato per rubare un boccone puntando sull’adulazione. Nell’Ascolano si rinvengono molti proverbi che, seppur nella loro prosaica ruvidezza, affondano le loro radici su antichi motti che elogiavano lo spirito di condivisione della convivialità: Cchié magne da sóle se stròzze (chi mangia da solo si strozza), Do’ magna due, magna tre (dove si mangia in due, si mangia in tre), che incoraggia ad ospitare ed accogliere alla mensa. Anche in questi casi ogni constatazione afferma e smentisce se stessa, perché “molti proverbi sono in contraddizione tra loro, né ciò significa che l’uno sia vero e l’altro sia falso; come sempre dipende dall’ambito di applicazione e dal punto di vista”42. Così, dopo l’esaltazione alla condivisione, il proverbio può anche capovolgersi 42 T. Franceschi, La forma proverbaile, cit., p. XXIV. Introduzione 23 e manifestarsi in maniera maliziosa su chi si approfitta della generosità altrui: Quant è ’l temp dl’uva e i fich s’arconosch tutti i amich (quando è il tempo dell’uva e dei fichi si riconoscono tutti gli amici). Tut’i frut vòlne ’l vin, sól i fichi en vòlne l’aqua (tutti i frutti vogliono il vino, solo i fichi non vogliono l’acqua) introduce un altro grande tema, quello del vino, emblema della condivisione conviviale e contesto rituale fin dalle più antiche civiltà che rappresentano le nostre fondamenta culturali. Memorie di questa eredità sopravvivono in certe credenze e superstizioni legate all’eco delle antiche libagioni, come quando si versa per terra del vino. Un proverbio anconetano ricorda: Casca il vino è buon destino, l’olio e il sale aspetta il male. Sul valore e l’importanza di mescite e di brindisi gli Ascolani sentenziano Magnà’ senzë bbeva è commä murà’ a ssecca (mangiare senza bere è come costruire un muro a secco). Esistono anche proverbi con valutazioni di natura enologica degne di simposiarchi e sommeliers d’altri tempi, come l’anconetano Vino amaro, tiello a caro, perché come un amico è raro. Alcuni proverbi ribadiscono anche per il vino la loro natura didascalico-didattica, impegnati a ricordare regole basilari della sua conservazione, trattandosi di una provvista fondamentale per le culture tradizionali. Si ricorda come El bòn vin fa el bòn acét (il buon vino fa il buon aceto), che è un avvertimento metaforico estendibile anche alle persone che maturano ed a tutte le situazioni in evoluzione, o, più tecnicamente, che El sur fa ’l vin, el vin fa ’l sur (il tappo di sughero fa il vino, il vino fa il tappo di sughero). L’esaltazione del vino, con la sua lunghissima tradizione, risalente fino ai poeti lirici greci, scivola via verso legittimazioni importanti, come il fermano Disse Cristo agli apostoli sui: l’erba e l’acqua so’ fatte pei bùi (disse Cristo ai suoi apostoli: l’acqua e l’erba sono per i buoi), apologia dei piaceri della carne e del vino che condanna gli astemi ed i vegetariani; ovvero come l’arguta e apotropaica massima maceratese Mejo puzzà de vì che d’ojo sando (meglio puzzare di vino che d’olio santo). 5. La medicina e la morale della dispensa Si può aprire anche un piccolo sotto-filone di proverbi sulle teorie medico-dietetiche popolari: sulle lenticchie esiste, ad esempio, un ammonimento di carattere medico-dietetico, cioè La lenticchia, tristu ‘llu corpu che se la ficca (infelice il corpo che mangia troppa lenticchia). Esistono in proposito analoghe osservazioni sul reale nutrimento e sulle caratteristiche digestive dei cibi: un proverbio maceratese sintetizza così le proprietà di tre cibi che rappresentano altrettanti fondamenti simbolici nella nostra cultura, ossia Vino fa sangue, carne fa carne, pane mandène (il vino fa sangue, la carne fa carne, il pane mantiene). Un proverbio fermano sancisce che Lo vi’ ci ha du’ virtù: prima va jó eppo’ rva su (il vino ha due virtù: prima va giù e poi ritorna su). Alcuni proverbi a tema medicodietetico del repertorio italiano risalgono al medioevo e non sono altro che precetti della scuola medica salernitana. Nel repertorio tradizionale marchigiano di questo ambito sanitario, dedicato agli effetti corroboranti sull’organismo ed alle caratteristiche digestive, è abbastanza noto il proverbio che si pronuncia su una tipica preparazione cotta della regione: La polènta, presto tira e presto lenta. Per quanto un proverbio pesarese la benedica (La pulenta è la mann di’ purett , la polenta è la manna dei poveretti), è con una certa malinconia che un detto rivolto all’identità locale (in genere chiamato “blasone”) arriva a sentenziare da tempo Marchigià magnapà magnapolenta. Il carattere identitario, caratterizzante e distintivo di certi cibi o piatti ricorre in altri proverbi che si appropriano dell’aspetto gastronomico solo come metafora: si afferma ancora, per esempio, che 24 L’enciclopedia dei poveri Mej la minestra a casa propria che i vincisgrassi a casa d’altri (meglio la minestra a casa propria che i vincisgrassi a casa d’altri)43, in un lembo della provincia di Pesaro prossimo all’Anconetano registrando la presenza di questo antico e sontuoso timballo di pasta. Un invito moraleggiante ad accontentarsi ricorda che En s’pòl fè i gnòc e la créscia (non si possono fare gli gnocchi e la crescia), mentre nell’Anconetano si mette in guardia dallo scialacquare e si invita alla moderazione ricordando che Chi vol mandà la casa a turlutù, mangi la crescia e li maccarù (chi vuol mandare la casa all’aria, mangi sempre la crescia e i maccheroni), evocando due pietanze ricche e laboriose, tradizionali dei grandi pranzi. Per quanto sia necessaria la parsimonia, ci sono i momenti canonici della festa, anche liturgica per le solennità religiose, da celebrare con autentiche leccornie devozionali, che anche i proverbi registrano. Nell’Urbinate, con l’approssimarsi dell’inverno e quindi delle festività natalizie, si recita Piov e neng, tutt l’ vecchie fann el bustrengh (piove e nevica tutte le vecchie preparano il bustrengo, dolce tradizionale); nell’Anconetano con i primi mesi dell’anno, Carnevale, bocca tenta, quant’è bona la castrenga (altro dolce tradizionale). L’attenzione all’uso dietetico si accompagna anche, necessariamente, al calendario e ai suoi riti. Molti proverbi mettono in relazione i mesi e le date legate ai Santi ed alle solennità religiose con le intemperie o i solleoni, e con l’urgenza delle varie pratiche agrarie nel perpetuo ciclo che va dal dissodamento al raccolto; oltre alle cure degli animali codificate nelle formule del sapere orale da pastori, norcini, pescatori e apicoltori. Un piccolo gruppo di proverbi però mette in relazione i mesi ed i giorni con alcuni cibi e pietanze tradizionali, e con le ricorrenze e le festività, non solo per la disponibilità stagionale delle provviste, ma anche per il portato evocativo e simbolico di certi alimenti. Ciò avviene attraverso rimandi a citazioni bibliche o al repertorio delle immagini sacre e devozionali. Ad esempio l’uovo, emblema di rinascita, ha la sua collocazione quando ci si ricorda, nel Maceratese, che Pasqua de resurrezio’ se magna l’ovu per devozio’ (Pasqua di Resurrezione, si mangia l’uovo per devozione), o che L’ovo pinto è bòno ancora dopo Pasqua (l’uovo decorato è buono anche dopo Pasqua), che fa riferimento alla tradizione pasquale di colorare ed ornare le uova sode per farle poi benedire e donare anche nei giorni seguenti, fino ad arrivare ai quaranta giorni dopo la Domenica di Resurrezione (fissata di anno in anno dopo la prima luna piena di primavera), ossia all’Ascensione. A questa data un altro proverbio maceratese-anconetano, specularmente identico a quello pasquale, ricorda che El giorno dell’Ascenziò / se magna le vitàlbe per divozione (il giorno dell’Ascensione si mangiano le vitalbe per devozione). Se per l’Ascensione è considerata rituale un’erba spontanea caratteristica (la vitalba appunto, spesso ingrediente protagonista di frittate), di certo la grande festa è vista come celebrazione conviviale importante, caratterizzata dalla golosità succulenta della carne, una volta davvero episodica, presenza rituale e anche eredità dei culti sacrificali della memoria pagana. Un proverbio anconetano mette in fila la sequenza ottimale: Gallina a Carnevale, pollastra a Ferragosto, cappone a Natale; un altro enunciato pesarese documenta anche l’istituto della mezzadria e dei contratti agrari, ricordando certi obblighi dei contadini verso i proprietari per le feste di fine anno: A Natèl al sòr padrón i purtan i bèi capón (a Natale al signor padrone gli Il proverbio elogia, secondo massime celebri nella storia della letteratura, la serena dignità della propria mensa frugale rispetto agli inevitabili compromessi ed all’inquetudine di ospitalità sontuose ma insincere; la quotidiana ed umile minestra è contrapposta ai celebri vincisgrassi, timballo di pasta raffinato, pietanza identitaria delle Marche, che come si vede era conosciuto anche nel Pesarese seppur in zone di confine (questo proverbio è stato raccolto a San Lorenzo in Campo, da P. Damiani, San Lorenzo Antico, San Lorenzo in Campo, Centro Culturale Polivalente G.B Pergolesi e R. Piccinini, 1991, p. 288). 43 Introduzione 25 portiamo i bei capponi). Riguardo alla assai sentita festività natalizia si ricorda come le episodiche abbuffate di carne venissero compensate dall’astinenza e dal digiuno. Del resto, tutto l’anno liturgico aveva le sue lunghe pause “di magro” in Quaresima ed in Avvento. Si teneva anche a mente un’altra pietanza tradizionale immancabile, perché En c’è vgilia d Natèl senza stucfìss (non c’è vigilia di Natale senza stoccafisso). L’apoteosi era naturalmente il Carnevale: un proverbio ascolano sentenziava: Quanne ‘rréve giuveddé grasse, pégne e fressóre fà fracasse (quando arriva giovedì grasso, pentole e padelle fanno fracasso), ed il gran lavoro in cucina era espresso da due proverbi speculari del Pesarese, che alludono, attraverso il riferimento ad un numero considerato magico, al reiterato impiego di forno e padella: El Giovdé grass ‘s rustisc sett volt (il giovedì grasso si arrostisce sette volte), oppure El giuvdì gras tòca frìgia sèt vòlt (il giovedì grasso bisogna friggere sette volte). Anche i suggerimenti di dispensa rassicurano e tranquillizzano che nella settimana “grassa” carnascialesca si può derogare dalla parsimonia; anzi si deve scoraggiare ogni forma di avara cautela ammonendo che La galina d’Carnevèl s’en s’masa va a mèl (la gallina di Carnevale se non si ammazza va a male), minimizzando anche sui rischi del dispendio di uova, tanto A Carnevèl la galina arvà al nidèr (a Carnevale la gallina ritorna nella cova per fare le uova); mentre le frittelle, assieme alla dolcezza delle feste, accennano alla loro brevità e inevitabile conclusione: Finito Carnevà, finito Amore, finito de staccià farina e fiore, finito de magnà le castagnole; descrizione di un attimo che, nella sua malinconia, assembla perfettamente la materialità del setaccio e del fritto con la spensieratezza ed i capricci d’amore. Questa attitudine a generalizzare, a trarre considerazioni morali dalla dispensa, o dal “melaro” (luogo in cui si custodivano i pomi), è diffusa, come attesta l’ascolano Nu frutte guaste, ne guasta tanti étre (un frutto guasto, ne guasta tanti altri). Altrove è pretesto per stigmatizzare la voracità frettolosa ed incosciente: Chi magna l’ua d’agosto, non arria a bee il mosto (chi mangia l’uva d’agosto non arriva a bere il mosto); oppure Chi vòl avé tut uliv en pòl avé tut òli (chi vuole avere tutte olive non può avere tutto olio) per mettere in guardia dall’invidia, o, ancora, La galina de la vicina fa j ovi più grosi (la gallina della vicina fa le uova più grosse). Come scrive Massimo Montanari, “i motti, le sentenze, gli aforismi nascono da riflessioni sul senso della vita, sul comportamento da tenere in questa o quella occasione, sulle soluzioni da dare ai problemi pratici e della convivenza”44. Negli innumerevoli casi in cui i proverbi vertono su questioni affettive o morali, inevitabilmente gli ammonimenti e le esortazioni scappano in tutte le direzioni, dal corretto allo scorretto, dal virtuoso al vizioso, dall’amore per la famiglia ed i figli ai veleni dei parenti serpenti, dalla devozione prostrata all’eresia più smaliziata. Nel lontano 1883, Ciavarini Doni scriveva: “non deve farsi meraviglia, se insieme con molti proverbi che insegnano moralità, virtù, prudenza, lavoro, industria, riflessione e simili ottime cose, vi siano altri che talvolta si abbiano ancora contraddizioni di idee e di opinioni; le quali chi volesse conciliare (e più di un autore e parziale lodatore di sapienza popolare ha avuto quest’animo) farebbe invero opera vana. La ragione dell’essere nei proverbi siffatte contraddizioni, dipende dall’essere queste in effetto del mondo reale, né potersi per ciò mai conciliare”45. La sorprendente forza di questa formula espressiva è che davvero sa coprire ogni diverso pensiero come un vestito su misura, che di volta in volta si adatta ad ogni momento, 44 M. Montanari, Il formaggio con le pere, cit., p. 5. 45 I. Ciavarini Doni, cit., p. XII. 26 L’enciclopedia dei poveri ad ogni potenziale richiesta di delucidazione o conforto. “Dove l’uomo pensa, e quando mai non pensa?, nasce un proverbio”46 […], scriveva ancora Ciavarini Doni. “Esso è una vera sapienza delle moltitudini, un intero corpo di dottrine, che basta ad ogni bisogno della vita. E tante più saranno, e tanto più ampie le pagine di questo gran libro del popolo, quanto più saranno larghi i confini della vita percettiva ed affettiva di lui”47. Quando, alla fine del Cinquecento, Cesare Ripa descrive l’allegoria dell’Esercizio nel repertorio di illustrazioni simboliche della sua Iconologia, lo immagina come un giovane che a terra ha “la diversità degli strumenti di Agricoltura che li mettiamo dalla parte sinistra che sono lustri, et non rugginosi, dimostrano l’esercitio, et la faticha che con essi si fa il lavoratore, et coltivare la terra, et le piante. Onde mediante detto esercitio si raccoglie il vivere per il genere humano”, ed in mano tiene il cartiglio con la parola Enciclopedia, che “significa il giro di tutte le scientie, dove che l’esercitio, si delle lettere, come dell’armi […] fa l’uomo illustre ed immortale”, in testa una clessidra come orologio, ed alla cintola un rosario. L’esercizio del vissuto, con le sue pratiche quotidiane e l’impiego dei saperi, ha codificato, nel tempo, l’insieme dei proverbi che hanno progressivamente composto i molti tomi dell’enciclopedia dei poveri. 6. Filosofia popolare dei Marchigiani Di questa enciclopedia era consapevole Benedetto Croce, che riteneva, con sensibilità romantica, che i proverbi fossero la saggezza del popolo. Anche se l’idea che i proverbi siano l’espressione dell’identità di un popolo, oggi, mostra un po’ la corda, alla luce delle analisi sulle culture popolari che ne hanno rivelato la complessità e lo scambio profondo con l’intertestualità e le culture “alte”, possiamo tentare di enucleare alcuni ingredienti di una filosofia popolare marchigiana, con alcuni suoi caratteri e spunti di riflessione. Darsi da fare. Il detto Chi de gajina nasce, sempre ruspa (chi nasce gallina è destinato a razzolare per sempre) è giustissimo, ma sapendo che, nel mondo contadino, la gallina è considerata un animale stupido, il proverbio cambia significato in quanto vuol dire: “Chi nasce con poco cervello, rimarrà sempre tale”. Da qui la necessità di cercare di migliorare le proprie condizioni (intellettuali ma anche economiche) per non rimanere sempre nelle modeste condizioni in cui si è nati. Anche il proverbio Dopo li troni, rvè sempre lu tempu vonu ha un doppio significato: uno letterale e cioè: “dopo il temporale arriva sempre il bel tempo”; l’altro più introspettivo, “non affliggerti mai troppo per le sventure che possono capitare perché sicuramente verranno sempre tempi migliori”. Ancora più significativo è un altro proverbio molto diffuso: Chi cià lo pà non cià li denti. Chi cià li denti non cià lo pà (chi ha il pane non ha i denti per mangiarlo e chi ha i denti non ha il pane). L’invito può essere, a chi è povero, a darsi da fare per ottenere il pane che potrà gustare meglio di chi non ha i denti. Un ulteriore stimolo a darsi da fare per avere risultati viene anche da un altro proverbio: I quadrin en s’troven fra la pula; se vuoi far fortuna abbandona l’attività che stai svolgendo e vatti a cercare un altro mestiere perché 46 Ivi, p. IX. 47 Ivi, p. VIII. Introduzione L’Esercitio, dalla Nuova Iconologia di Cesare Ripa, Padova, 1618. 27 28 L’enciclopedia dei poveri evidentemente insistere in un lavoro che non ti dà soddisfazione è fatica inutile, che è un argomento per molti aspetti dinamico dei rapporti fra le classi sociali, introdotto nelle Marche soprattutto dalla cultura “laborista” (il self help anglosassone) importata dai Piemontesi a fine Ottocento, dopo l’unificazione, per contrastare il rigido pessimismo e fissismo sociale delle classi subalterne marchigiane ereditati dallo Stato pontificio. Il proverbio è, infatti, un invito a muoversi, a cambiare la propria condizione, confermato da altri due proverbi risalenti al tempo in cui i pastori dei Sibillini portavano le pecore a svernare nel Lazio o nella Maremma toscana: Domannànno, domannànno se va a Roma e Chi cià le zampe e cià la léngua, ‘rria fino a Maremma. L’insegnamento è quindi quello di non essere timidi nell’affrontare nuove realtà, perché chi ha buone gambe e spigliatezza nel chiedere informazioni può arrivare molto lontano. La prudenza. Ci sono, al contrario, anche proverbi che suggeriscono di fare le cose con prudenza, senza azzardare troppo e senza buttarsi allo sbaraglio perché Chi troppo vuole nulla stringe. Su questa lunghezza d’onda sono i proverbi: Mejo l’ou ogghi, che la gajina domà e È mèi qualcosa ch’en gnent. Ma non è prudente neppure rischiare troppo affrontando un percorso di vita senza sufficienti informazioni: Chi va de notte, rlea le bbotte. Partendo dai concetti che Presto e bbène de rado avvène e che Per chi sa ‘spettà lo tèmbo sua ha da ‘rrià si fa presente che, in attesa di tempi migliori (e quindi che i nostri progetti si realizzino), è opportuno sapersi sacrificare, per cui Chi de tande cose sa fa’ a meno, viv’a longo e sereno, oppure Pija lo monno comme vvèene, dappertutto starrai vène. Ma anche Passa oggi che viè’ domà’. L’amicizia. Da questi pericoli nasce la necessità di avere amicizie. Tuttavia bisogna tener sempre presente che l’amicizia bisogna sapersela conservare, per cui Chi vò che l’amicizia se mantenga, ‘na mà va’ e ‘na ma venga. Infatti l’amicizia e lo scambio di aiuto non debbono essere a senso unico; bisogna che ci sia reciprocità in tutto. Mejo pesce donatu che pesce magnatu, perché nelle amicizie è meglio essere in credito che in debito. Religiosità. Della grande religiosità dei Marchigiani è superfluo parlare, ma c’è un proverbio che la sottolinea in modo particolare. Esso dice Pe’ Pasqua e pe’ Natà nisciù lascia la casa, nelle feste più religiose dell’anno è meglio rinunciare a gite e viaggi per rimanere a celebrare la ricorrenza con la propria famiglia. Argomento confermato da altri numerosi proverbi: Parlà de fede, non z’à da capì ma da crede; Joca co li fandi ma lascia stà li santi; La messa adè per chi la ‘scorda, no’ per chi la dice; Bisogna fare come lo prete dice e non come lo prete fa; Lavarsene le mà non è da cristià. La natura. Un proverbio che dimostra l’attenzione del Marchigiano nei confronti della natura dice espressamente: Marzu tégne, aprile depégne. Infatti (e questo è il suo significato intrinseco) la primavera è come un quadro nel quale il mese di marzo colora i campi con la tonalità del verde, mentre aprile apporta altri colori e completa un panorama incantevole. Sullo stesso slancio poetico un altro proverbio, per la verità un po’ sibillino, così si esprime: Aprì fa lu fiore, magghiu fa l’onore, le piante, in aprile, fioriscono, mentre il mese di maggio ha l’onore di produrre il frutto. Un altro riferimento alla natura emerge con il proverbio che dice: Tutti li jòrni se fa sera, maggio e giugno a malapena, le giornate, a fine primavera, si allungano mentre le nottate Introduzione 29 si accorciano. In altri proverbi si manifesta la piena fiducia nel fatto che tutte le stagioni, e quindi i rispettivi mesi, portino a maturazione i frutti migliori della terra. E infatti si dice: Se piòe d’agosto, piòe olio, mèle e mosto; Settembre, l’ùa è fatta e li fichi pènne; A San Martì ogni mosto è vì. Un accenno al cibo e ai condimenti da usare a tavola, come quando si dice La ‘nzalata: poco aceto, ben oliata e de sale ‘na pizzicata; Dell’ironia e de lo sale lo troppo è sèmbre male; Vì, cascio e pere pasto de cavaliere. C’è invece un proverbio che è un inno ai prodotti della terra: Robba de campagna, è cojò chi no’ la magna. Sulla stessa lunghezza d’onda: Terra vona, terra corda, non sfalla mai la raccorda, o ancora Aria, silenzio e sole ricchezze campagnole. Che tempo farà? Numerosi sono i proverbi sulle previsioni del tempo, che non hanno bisogno di spiegazione. Così Ruscin de matina, temborale se ‘vvicina; ruscio de sera, bon tembo se spera, come anche Se San Vicì se mette lu cappellu, tutta la Marca pija l’ombrellu. Il monte San Vicino viene preso come punto di riferimento per prevedere se pioverà o sarà sereno. Analogamente Quanno lamba verzo Sinigaja se non piòe ogghi, domà no sbaja. Altro punto di riferimento meteorologico è Pedaso: Quanne allamba a Pedase lu piove è in casa. In previsione dei mesi piovosi c’è una raccomandazione da fare: A settembre chi ‘dè esperto non viagghia mae scoperto. Ciò vuol dire che, avvicinandosi l’autunno, è meglio affrontare i lunghi tragitti avendo a disposizione ombrello e indumenti più pesanti. L’amore per la casa. Un proverbio sottolinea l’amore del Marchigiano per la propria casa; Per ogni uccello lo nido sua ‘dè bello. Altrettanto significativo il proverbio che dice che la propria casa può essere anche piccola ma il terreno da coltivare il più grande possibile per avere maggior reddito. E infatti Casa quanto copri, terra quanto scopri, cioè cerca tanta terra quanta ne puoi scoprire con lo sguardo. La salute. Non mancano i proverbi riferiti alla salute. E infatti di dice: Testa fresca, piedi calli: cambi cend’anni; Prevenì ‘de la cura più ‘fficace e sicura; Lo mèdeco pietoso fa la piaga puzzolente; Li più forti dolori non ze vede de fòri; Ogni risata vale du’ jorni d’ospedale; Quanno lu corpu sta ve’, l’anema canta; La pignatta rattoppata dura de più perch’è curata; Lo vecchio che se cura fino cend’anni dura. E invece Joendù disordinata fa la vecchiaja tribbulata. Il lavoro è sempre un buon rimedio per tutto: Aécce sembre da fa ‘dè ‘n segreto pe non ‘nvecchià. Gioie e dolori. Partendo dal dato di fatto che Lo tèmbo è sempre galandòmo e che, alla fine, si ottengono i risultati sperati, e la verità viene sempre a galla, si fa presente che la vita riserva momenti sereni alternati a sventure: Gioja e sciagura sembre non dura” mentre l’iniquità po’ prosperà ma non po’ durà. Concetto che vale in natura, e, infatti, Na ‘orda core lu ca’, ‘na orda lu lepre. Si cita anche la volpe quando disse ai figli che una volta si mangia da re e una volta si fa la fame, per cui Quanno a picciò e pollastri, quanno a grilli. Per concludere che A stu munnu chi piagne e chi ride. L’onestà. La nobiltà d’animo e la profonda onestà del Marchigiano emergono da numerosi proverbi che possono essere considerati delle raccomandazioni specifiche per i giovani ai quali si dice che Onestà co’ gindilezza supera ‘gni vellezza, ma anche Jènde disciplinata jènde sembre rispettata e Tre cose supera tutte l’addre: pazienza ‘nnocenza e bbona 30 L’enciclopedia dei poveri credenza. Sullo stesso tono, Un’anema innocende dè sembre trasparende; Chi fa la carità ‘dè ricco e no lo sa; La nobilità che vène dall’opere ‘dè mijore de quella che vèene da lo nome. Ma attenzione perché Onore e giovendù perzi ‘na òrda non ce l’hai più. La modestia. I proverbi forniscono al Marchigiano anche alcune norme di comportamento quando condannano la vanità (Chi se vantò se sbrodò), oppure invitano all’autoironia (Se non zai rride de te, non poli rride dell’addri), ma anche alla modestia (La modestia ‘dè l’abbeto ‘dè lo talendo). Non meno da vituperarsi è l’avarizia (A lo poretto manga tande cose, all’avaro tutte). Come è da condannare la superbia: La superbia è un difetto che ‘nnulla ‘gni virtù. Categorico l’invito a non essere pedanti nei rapporti con gli altri: Rimbrotti e conforti singeri e corti. Infine un comandamento preciso: Quanno non vo fa sapè ‘na cosa, no la fa (se devi fare una cosa poco corretta, tanto è vero che non vuoi che si sappia in giro, è meglio che rinunci a farla). Il buon senso. Il buon senso è ciò che domina in tutti i proverbi come quando si dice: Jeci virtù non fa lo rrumò d’un vizio; Dè mèjo un “tò” che cendo “te darrò”; Co’ stizza e bizza poco se realizza; Se po’ ordinà l’ubbidienza ma no lo judizio e la prudénza; Cà’ che bbàia nun moccica; Quanno la volpe predeca guardateve gajine. Altri proverbi costituiscono veri e propri ammaestramenti pratici: Chi va derète a du’ lebbre no ne ‘cchiappa mango una; Chi vòle va, chi non vòle manna; Commànna e fai da te e sarai sirvitu come ‘n re; Chi va co lu zoppu ‘mpara a zoppicà; Adè mèjo ‘ddormendasse co ‘na preoccupazio’ che svejasse cò un rimorso; Non te fidà de chi più parte fa; Omu ‘vvisato menzu sarvatu; Scànza lu sassu davanti a lu màttu; Na piccola scindilla po’ bbruscià ‘na villa; Tra l’osso e li dendi de lo cà no mmette mae le mà; Non dacete a li prepoténdi le manzioni dirigendi; Lo solo modo de vegne ‘na cagnàra ‘è quello d’evitalla; No spènne tutto quello che ci hai non dì tutto quello che sai; Solo chi non za pèrde è perzo; Chi riconosce la propria debolezza dà un zegno de saggezza; Le perzo’ più soscettibbili ‘dè quelle che sa d’avé torto; Fortunato chi ne lo piando ci ha un affetto accando; Anche cent’anni se dovrai campà, recordete, c’è sempre da ‘mparà; Lo libbro ‘dè lo solo amico che poli portatte sottobraccio do’ voli; Sinza fatiga non se fa cosa. La caparbietà. Uno dei difetti conclamati dei Marchigiani, trattato da una vasta letteratura, è la sua eccessiva modestia, l’abitudine ad accontentarsi della propria situazione. Ci sono però almeno due proverbi dai quali traspare il contrario: A mala sorte, reagisci da forte! e Chi vuole, puole. E ce n’è anche un altro che invita a fare squadra, a mettersi insieme: Gregge unito mette paura pure a lo lupo. Non manca il proverbio che raccomanda di non rimanere legati sempre ai vecchi schemi come alle idee più antiquate. E infatti Solo chi ci ha lo cervello po’ cambià idea. Sulla stessa lunghezza d’onda il proverbio Dàje e dàje, la cipolla dovenda àju, che ha lo stesso significato di A goccia, a goccia se sbùscia la roccia. Ma ancora Vesogna vatte lo ferro quanno è callo. E per concludere: Co’ l’acqua tiepida non ze coce gniè. L’attualità. Una serie di proverbi sembra calzare a pennello in un momento di crisi e soprattutto di trascuratezza dei valori come quello attuale. Infatti si dice: Lo péscio comenza a ‘ppuzzasse de la testa; Chi commànna se fa la legge; Lo ladro furbo tosa lo gregge co’ lo rispetto de la legge; Su ‘sto monno dissestato lo ladro po’ fa’ ccausa a lo derubato; Tanti galli a cantà, ‘n se fa mai jornu; La farzità rripetuta su la stamba po’ divendà vera. Introduzione 31 7. I blasoni popolari, ovvero i difetti dei vicini Giovanni Ginobili ha spiegato che i cosiddetti “blasoni popolari” erano “facezie, motti e frasi proverbiali”, usati nelle polemiche campanilistiche tra paesi confinanti o meno. Un tempo erano molto popolari perché, pur avendo spesso un carattere ingiurioso, tanto da sconfinare nel dileggio e nello scherno, partendo da maldicenze paesane, quasi sempre colpivano nel segno o avevano dei motivi fondati sulla realtà. Capitava che, nella foga di dir male l’uno dell’altro tra i vari paesi, non si andasse tanto per il sottile: ladri, cojon, matt, canaglia, suona a mort, guerci, zoppi, cagatora, in mezzo allo sterco, canaja, asini, cornuti, senza fede, pedocchjò, puttanelle ecc. Oggi non sono più di moda e molti lettori non sapranno neppure di che si tratta. C’è però uno di questi blasoni che è ancora abbastanza diffuso ed è riferito proprio ai Marchigiani e recita così: Mejo lu mortu dendro casa che lu marchiscià fori de la porta. Il detto era soprattutto diffuso a Roma al tempo del potere temporale della Chiesa. Infatti tutti temevano i gabellieri del papa che si presentavano in casa dei contribuenti per indurli a pagare le gabelle. Con l’avvento al soglio pontificio del marchigiano papa Sisto V la Sante Sede aveva deciso di affidare questo servizio ai Marchigiani, suoi compatrioti, ma anche agli Umbri (e infatti ne esiste una variante che li riguarda). Altri blasoni riguardanti i Marchigiani non sono maligni nei loro confronti. Uno dice: I marchigiani non saprebbero far male a una lucertola per indicare la loro bontà d’animo. Un altro invece riguarda il cibo: Marchigiano magnapà e magna polenta. Il detto si riferisce al tempo in cui c’era la mezzadria e gli agricoltori preferivano mangiare la polenta con farina di granturco per poter destinare invece alla vendita gran parte del grano prodotto, in quanto questo spuntava prezzi più remunerativi. Anche il termine magnapà non è dispregiativo perché un tempo il pane serviva per accompagnare qualsiasi cibo, dai salumi alla frutta. C’è poi il blasone che dice Più Marca si gira e più Marchigiani si trova nel senso che si incontrano marchigiani “di tutti i tipi” con abitudini, tradizioni, dialetto, costumi completamente diversi, a dimostrazione di una certa varietà anche oggi sopravvissuta. Gastronomia. Scegliendo “fior da fiore” tra i tanti blasoni è possibile individuare le tendenze gastronomiche di alcune località come anche le zone di produzione di certi prodotti. Significativo in proposito è il detto Magnapipicchiotto di Fabriano che è simile all’altro blasone A Fabrià se magna ‘l pipicchiotto, mezzo crudo e mezzo cotto. Si tratta di un piatto di origine pastorale (come ricordano Giovanni Ginobili e Nicla Mazzara Morresi) a base di carne di pecora che veniva cotta in una padella di ferro in cui si erano fatti rosolare nell’olio spicchi d’aglio interi, rosmarino, sale e pepe con aggiunta di mezzo bicchiere di vino. Come è evidente siamo di fronte ad un piatto che viene preparato ancora oggi ma che quasi più nessuno chiama pipicchiotto. Ma gli abitanti di Fabriano, in altro blasone, vengono anche chiamati Magnasardelle. Secondo Ginobili questa denominazione venne loro affibbiata da un viandante che, soggiornando a Fabriano, aveva notato l’uso locale di mangiare le sardelle a pranzo come secondo o a cena come piatto unico. Evidentemente era Quaresima. Cerreto d’Esi. Agli abitanti di Cerreto d’Esi era stato affibbiato il blasone Porcinai di Cerreto perché, un tempo, si erano specializzati nell’allevamento dei maiali che tenevano al piano terra delle loro abitazioni (come ricorda Giovanni Ginobili). Nei loro confronti c’era anche un altro blasone che dice: Li somari de Cereto porta ‘l vino e bee l’acqua!, 32 L’enciclopedia dei poveri significando che la popolazione di Cerreto è gente che lavora molto (fatica a trasportare il vino) ma guadagna poco (infatti beve l’acqua). Ma può avere anche un significato positivo nel senso che i “Cerretani” per guadagnare di più preferiscono vendere tutto il vino che hanno e bere acqua. Un altro blasone di Cerreto dice ‘Cciaccafave de Cerreto, facendo riferimento al fatto che, in quella località, c’era l’abitudine di sgranocchiare le fave secche fatte abbrustolire nella padella di ferro e condite con olio e sale. Jesi. Forse per il fatto che un tempo a Jesi vi era una grossa produzione di fagioli, il blasone dice Jesi, si seminan fagiuoli e nascon ladri (perché poi li vendevano a caro prezzo). Un altro blasone parla invece della produzione di zucche: A Jesi ce fa le zucche come le chiese, e si ce pioa, le fa grosse come Santa Maria Noa. La cosa viene sottolineata da un altro blasone, Le zucche di Jesi, i sellari di Cingoli, i gobbi di Macerata; infatti a Cingoli, un tempo, c’era un'eccezionale produzione di sedani molto pregiati. Altrettanto accadeva a Macerata, nella frazione di Trodica di Morrovalle, che aveva ed ha ancora un'eccellente produzione di cardi bianchissimi e molto teneri, rinomati anche fuori delle Marche. Un tempo a Jesi era molto attiva anche la macellazione di carne equina e asinina che ha generato il detto Jesi magnasomari e Magnacavalli de Jesi. Penna San Giovanni. Penna San Giovanni, nel Maceratese, aveva il seguente blasone: La Pènna ponte di salsicce. Sembra che ci fosse una tale produzione di insaccati di maiale che con le sole salsicce sarebbe stato possibile, per iperbole, costruirci un ponte. Chiaravalle. Agli abitanti di questo paese era stato dato il soprannome di Ranocchiari di Chiaravalle, perché la città era attraversata dal torrente Triponzio ricco di rane. Corinaldo. Il blasone di questa località fa riferimento alla leggenda popolare della polenta dentro il pozzo; Quelli de Corinaldo fa la pulè’ dendo ‘l pozzo. La leggenda narra che alcuni abitanti di Corinaldo, di ritorno dal molino dove avevano macinato del granturco, trasportavano dei sacchi di farina di mais lungo la salita che porta al centro, quando arrivò la notizia che il paese era stato occupato da truppe straniere. Allora, per decidere il da farsi, si fermarono appoggiando i sacchi sulle sponde di un pozzo. Alcuni passanti riferirono loro che in città si stava compiendo una strage ed essi indietreggiarono per lo spavento facendo cadere inavvertitamente i sacchi nel pozzo. Per non far sprecare la farina decisero di utilizzarla egualmente cominciando a rimescolare il fondo del pozzo con una lunga pertica. Poi qualcuno (aggiunge Giovanni Ginobili) andò a prendere alcuni maiali gettandoli nel pozzo per poterla condire. Cupramontana. Questa località vanta diversi blasoni, alcuni dei quali fanno riferimento al fatto che un tempo si chiamava Massaciu. Il più singolare è questo: Barlozzari de Cupra, il cui significato risulta un po’ complesso da capire. Ginobili spiega che il termine barlozzari deriva da barilotto (ma anche barlotto o barlozzo) che era usato come recipiente del vino. Gli abitanti di Cupramontana sono infatti famosi come produttori di Verdicchio, ma si vantano anche di essere dei buoni bevitori. Fermo. Uno dei blasoni affibbiati a Fermo dice: Li magnabbìti de li Fermà; e si riferisce ad un’antica usanza dei contadini fermani i quali, il primo maggio, erano soliti raccogliere le bietole che portavano poi in cattedrale per avvicinarle alle urne dei santi. Una parte Introduzione 33 delle bietole veniva lessata, condita con olio e sale, e quindi consumata; una parte era invece conservata per preparare decotti da utilizzare per influenze, raffreddori, febbri o altri lievi inconvenienti di salute. Fiastra. Il blasone di questa località si riferisce ad una sua frazione: Fiegni: Lo pa’ de Fiegni dove ‘rrivi, dove regni. Un tempo il pane prodotto a Fiegni era molto apprezzato a Roma, per cui ovunque si riusciva a portare questo pane si potevano fare dei buoni guadagni. Molti Marchigiani si trasferivano infatti a Roma dove spesso operavano come alimentaristi o ristoratori. Montefiore dell’Aso. Elegante questo blasone di Montefiore, famoso come dice il nome per la produzione di pesche di frutta e fiori. Esso fa riferimento a questa produzione: Mondefiore coperto de fiori, dendro e fòri tutti signori esalta la bontà d’animo e la grazia (indotti della floricoltura) degli abitanti, che se ne avvantaggiano anche economicamente. Montegiorgio. Gli abitanti di Montegiorgio vengono chiamati Caciunitti de Mondejòrghjo. Vi è qui il riferimento al fatto che in questo paese, soprattutto a Pasqua (ma anche in altre ricorrenze), si è soliti preparare i tipici dolci chiamati caciunitti. Ecco la ricetta come l’ha descritta Nicla Mazzara Morresi nel suo classico manuale della cucina marchigiana: “si prepara una pasta con farina, acqua ed un pizzico di sale e si lavora al punto giusto; quindi se ne tira una sfoglia di regolare spessore, che si taglia a piccoli dischi. Questi vanno poi riempiti con un composto a base di purea di ceci lessati con foglie di alloro, zucchero, cacao, liquore (a scelta), una presina di sale. I caciunitti, premuti bene ai bordi, si friggono in abbondante olio o strutto. Volendo, appena cotti, si possono cospargere di zucchero”. Sopra, Foggia del vestire invernale del contadino fermano, dai disegni e studi della Etnografia illustrata di Luigi Mannocchi, sec. XX, Fermo, Biblioteca comunale “Romolo Spezioli”; a destra, Il giogo, dallo stesso documento.
Scarica