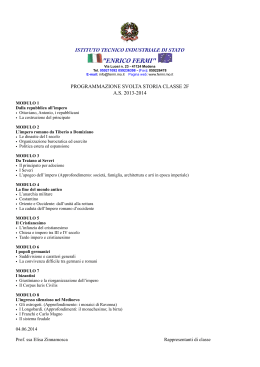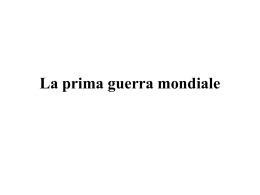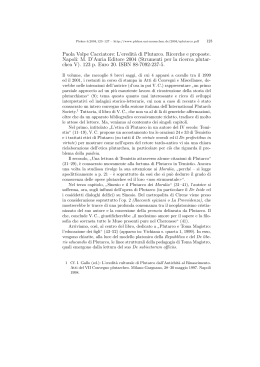Rassegna Stampa FONTE: http://www.criticaliberale.it/news/217927 DEL: 7 aprile 2014 Le menzogne della politica ovvero la politica come menzogna paolo fai Plutarco, in un opuscolo “morale” sulla curiosità, intesa nel senso deteriore di faccenderia, ficcanasaggine e simili, tra gli altri consigli rivolti al ficcanaso, aggiunge quello di tenersi lontano soprattutto dai potenti, dai re: «Quello che i re hanno di più piacevole e bello è esposto all’esterno, e sono i banchetti, le ricchezze, le feste, i favori, ma se hanno qualche segreto, non accostartici, non smuoverlo! Quello che tiene nascosto, invece, è terribile, cupo, senza sorriso, inavvicinabile». Questo passo mi pare individui con grande precisione la specificità caratteriale del politico: la doppiezza o l’ipocrisia. Quasi negli stessi anni in cui il dotto biografo-conferenziere-moralista greco tracciava il rapido ritratto del politico, attraverso poche considerazioni gettate lì come monito per quella figura umana del ficcanaso, giudicata tra le più biasimevoli, più vicino al Palazzo imperiale, da dove si diffondevano i pestilenziali miasmi d’una politica di intrighi e di corruzioni, lo storico Tacito, che, con realismo, giudicava inevitabile ed ineluttabile l’impero, dopo che, morto Augusto, i senatori erano prontamente corsi a inchinarsi, come dei servi, al nuovo princeps Tiberio, schizzava di lui un ritratto destinato a diventare la sinistra incarnazione, il turpe prototipo della doppiezza, della menzogna. Già nel discorso di insediamento a capo dell’Impero, dopo la morte di Augusto, quando Tiberio «dissertava in vario modo sulla vastità dell’impero e sulla propria modestia», lo storico ravvisa «più affettazione che sincerità e Tiberio, per natura sua o per abitudine, anche in quelle cose che non c’era bisogno di tenere nascoste usava sempre parole a mezz’aria e accenti velati; in questa circostanza, poi, ove si sforzava di nascondere del tutto i suoi pensieri, ancor più si avvolgeva nell’indeterminatezza e nell’ambiguità». Qualcuno potrebbe indicare in queste parole di Tacito l’atto di nascita del politichese, cioè di quel linguaggio settoriale la cui caratteristica precipua è lo sciorinare frasi, generalmente collegate a formare periodi lunghi e contorti, privi di consistenza logica. Andando a ritroso nel tempo, però, stando a Platone, la colpa dei fumosi discorsi dei politici sarebbe da imputare ai sofisti, abili a rendere “migliore il discorso peggiore”. Ma forse neppure il suggerimento del filosofo delle Idee riuscirà a soddisfarci, perché si ha l’impressione che, più sfondiamo il muro del tempo, più apparirà inconfutabilmente vera la nozione che la politica è costruita sulla menzogna. Si pensi al mito greco, che – così dicono gli studiosi – ha valore fondante e riassume, con pregnante valenza simbolica, verità non suscettibili di dimostrazione e confutazione. Agamennone, re di Micene, conduce la figlia Ifigenia in Aulide, falsamente promettendole che l’avrebbe fidanzata con Achille, ma di fatto per immolarla ad Artemide ad espiazione di una sua colpa commessa contro la dea. Così, placata l’ira della dea, gli Achei potranno salpare per Troia, a vendicare il ratto di Elena da parte di Paride. Altro che amore di padre! Dunque, già nella sfera del mito appare sinistramente manifesta quella che, in termini di pura teoria politica, si considera la più durevole conquista del pensiero politico moderno, cioè la natura demoniaca del potere, che Machiavelli fisserà, con rigore assiomatico, nel “terribile” capitolo XVIII del Principe: «Quanto sia Rassegna Stampa laudabile in uno principe mantenere la fede e vivere con integrità e non con astuzia, ciascuno lo intende; nondimanco si vede per esperienza ne’ nostri tempi quelli principi avere fatto gran cose che della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con l’astuzia aggirare e cervelli delli homini». Insomma, bene etico e bene politico non coincidono. Infatti, se all’idea di bene, in senso etico, è connesso il concetto di azione disinteressata, cioè fare il bene per il bene, questo concetto non può applicarsi al bene in senso politico. Non si è mai visto, infatti, un uomo politico compiere una buona azione «anche con eventuale sacrificio del suo interesse particolare» (Kant), e quelli che lo hanno fatto “ruinorno”, per usare una parola machiavelliana. Come sperimentò, sulla sua pelle, il marchese Domenico Caracciolo, viceré di Sicilia dal 1781 al 1786, uomo di formazione illuministica, fieramente avversato dalla nobiltà e dalla plebe per le riforme attuate, compresa la riduzione del Festino di Santa Rosalia da cinque a tre giorni. Caracciolo, dopo aver vissuto per vent’anni a Parigi e avere «sperato di restarci per gli anni che ancora aveva da vivere, […] già vecchio, a sessantasette anni», era stato «invece mandato a Palermo come viceré: dal luogo della ragione all’hic sunt leones, al deserto in cui la sabbia della più irrazionale tradizione subito copriva l’orma di ogni ardimento» (Leonardo Sciascia, Il Consiglio d’Egitto). In questo senso, tutti i politici sono in fondo dei narcisisti, sono cioè innamorati di sé stessi e dell’ebbrezza che provoca il sentirsi ammirati o odiati, poco importa, ma comunque oggetto di attenzione e di discussione da parte di una moltitudine. E ancora, non fa granché differenza che si tratti di uno stato totalitario o democratico: i meccanismi mentali e comportamentali che si mettono in moto sono gli stessi, anche se in uno stato di diritto, fondato cioè sul governo delle leggi, i governanti agiscono (dovrebbero agire) in conformità di leggi stabilite, sono controllati (dovrebbero essere controllati) dal consenso popolare e sono (dovrebbero essere) responsabili delle decisioni che prendono. E allora? Allora dovremo ammettere, anche se con riluttanza, che i politici sono uomini «con la mente aperta al come più che al perché, […] abili a mascherare, a contemperare volevo dire, il loro preciso particolare con le vaghe idealità pubbliche», come, nel romanzo Il Gattopardo, don Fabrizio Corbera dice all’emissario sabaudo Chevalley. Ma, per chiudere il circolo delle argomentazioni, è bene tornate a Plutarco e alla sua biografia di Lisandro, il generale spartano che trionfò su Atene nel 404, nella ventisettennale guerra che aveva opposto le due città della Grecia in quel torno di tempo più fiorenti, Atene e Sparta. Dal racconto di Plutarco emerge «la convinzione, radicata in Lisandro (ma anche in tanti altri aspiranti al potere monocratico), della piena coincidenza tra il proprio potere personale e l’interesse generale. […]. Naturalmente in questo meccanismo mentale interferisce, ad un certo momento, un fattore di accecamento: interviene l’adulazione, che spinge verso una ambizione incontrollata, e questa, a sua volta, costituisce elemento di crisi, se non anche di caduta, del politico. La traiettoria di Lisandro è esemplare. Egli ha raggiunto il massimo potere, anche perché graniticamente persuaso dell’effetto positivo generale del suo successo individuale, ma, a quel punto, l’eccesso di potere personale incontrollato lo ha portato a compiere errori via via più dannosi proprio al suo potere (cap. 19)». Così scriveva Luciano Canfora nel 2001 nell’Introduzione alla vita di Lisandro (Plutarco, Lisandro – Silla, BUR Rizzoli, Milano 2001), prefigurando una cornice idealtipica nella quale si può opportunamente mettere il quadro politico attuale con al centro il suo principale e più inquietante personaggio.
Scaricare

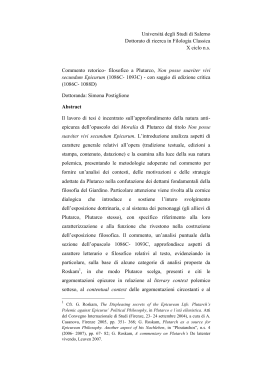

![L`impero romano nei secoli del massimo splendore [b].](http://s2.diazilla.com/store/data/000099212_1-8913594b6420dbae9d7f348b64db2063-260x520.png)