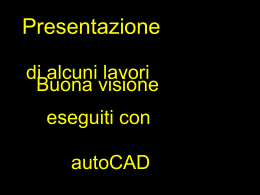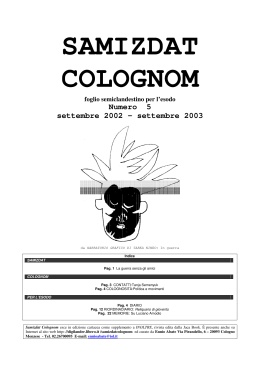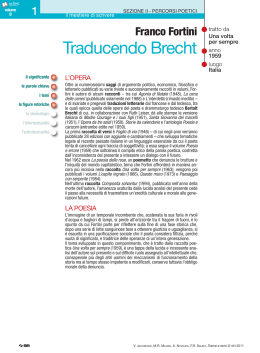SAMIZDAT COLOGNOM foglio semiclandestino per l’esodo Numero 6 settembre 2003 Indice LUOGHI / NON LUOGHI Pag. RIORDINADIARIO: Pag. CONTATTI: IZDAT/CONTATTI FRA SCRIVENTI : Leonardo Conti Pag. La Repubblica della Cartalettera Giallo è il sindacato Mio fratello sampdoriano Fucecchio: un non luogo? 11 Settembre 1973 Franco, Vittorio e il postino ER L’ESODO Pag. MEMORIE: L’immaginazione proletaria di Danilo Montaldi Da questo numero Samizdat Colognom esce in edizione cartacea come supplemento a L’OSPITE INGRATO del Centro Studi Franco Fortini. È presente anche su Internet al sito web http: //digilander.libero.it /samizdatcolognom . È curato da Ennio Abate, ma in collaborazione con Leonardo Conti. Per contatti: Ennio Abate, Via Pirandello, 6 – 20093 Cologno Monzese Tel. 02.26700095 E-mail: [email protected] SAMIZDAT? È termine russo. Indicava gli opuscoli della comunicazione dissidente nei paesi dell’Est e della ex Urss. Letteralmente significa autoedizione. Qui è assunto in entrambi i significati : foglio di pensiero critico e forma di pubblicazione non cortigiana. COLOGNOM? Abbreviazione straniante di Cologno Monzese. Allude al luogo/non luogo nel quale il foglio viene scritto, alla sua problematica perifericità, ai mutamenti decostruttivi e costruttivi possibili in questo spazio ibrido. ESODO? La parola rimanda alle migrazioni passate e presenti, al rifiuto di chiudersi o lasciarsi chiudere nell’intrasformabile mondo esistente dei padroni. PER L’ESODO: RIORDINADIARIOeadiario Progetto Patchwork sulla poesia delle donne 5 ottobre 2003 Cara Loredana [Magazzeni], che tu fossi stata una femminista anni '70 l'ho capito. Ma siamo nel 2003. Il femminismo, estratto dalla costola dell'Adamo comunista (ma senti un po' questo!), un po' -credo - sia rimasto vedovo (essendo un movimento va il neutro?) del contestato e infine tramortito sposo, assalito come padre-padrone, ma l'unico che -malgrado il suo maschilismo patriarcale - un po' della mela offertagli aveva assaggiato e preso sul serio. Gli altri maschi patriarcali doc sono rimasti inalterati. Dico qui, nell' Occidente che passa per democratico. Che se guardiamo altrove, c'è da rabbrividire. Il cambiamento in peggio della società (sotto molti aspetti) significa come minimo cancellazione del comunismo dal piano simbolico (chi ne parla più? Al massimo Toni Negri...), ma anche edulcorazione e accademizzazione del femminismo. Tu stessa sei costretta ad "abbassare il tiro" affermando che non siete un gruppo prettamente femminista ma di donne. Che è un modo per dire, secondo me, che non c'è più continuità fra gli anni d'oro del femminismo (anni '70 all'incirca) e l'oggi delle donne (io direi: della moltitudine). O che la continuità è tutta ideale. Non voglio fare il gufo, auguro una riuscita e delle scoperte sorprendenti alla vostra inchiesta che vuole accertare il pensiero delle donne sulla propria poesia. Ma facciamo una piccola scommessa: io prevedo che in poesia la differenza biologica o la differente autobiografia o la percezione della vita fra poeti e poetesse sarà in molti casi poco rilevante. Non ho tempo, ma mi piacerebbe fare un'antologia di poesie celando il nome dei poeti o delle poetesse che le hanno scirtte e sottoporle al giudizio di lettori e lettrici che dovranno indovinare il sesso di chi l'ha scritte. Non pensare che voglia irridere la vostra ricerca. Voglio solo riportare la tua attenzione agli aspetti meno consumati del rapporto uomini-donne. E almeno in poesia a me pare - come ti scrivevo - che le cose non stanno come ad un certo femminismo separatista piace pensare. La mia posizione verso femminismo, femministe e post-femminismo è davvero insolita. No, non auspico affatto che la poesia si maschilizzi, diventi aggressiva o conquisti un qualunque potere.( Semmai diverse femministe o donne che passano per femministe hanno introiettato lo stile maschilista rimproverato agli uomini di potere). Ma non credo che sia la mancanza di potere a muovere la poesia e la letteratura in genere (come tu scrivi), né che la poesia si muova sempre e automaticamente contro il potere e verso il suo ridimensionamento. In poesia e in letteratura si svolge un conflitto per far emergere o frenare bisogni legati ai corpi e e alle esperienze di vita di uominidonne , cioè di esseri in trasformazione alle prese col linguaggio storico. Il quale linguaggio storico (costruito da dotti e ignoranti, da uomini e donne) li agevola in parte e li condiziona pure nella loro trasformazione. Il grado di democraticità o un nuovo equilibrio fra maschile e femminile (che non sia quello patriarcale, ma neppure quello matriarcale) non è affatto garantito dal fatto di muoversi sul piano poetico e letterario. Ci sono fior di reazionari in poesia e letteratura. Guai a pensare che sempre i poeti siano democratici o d'animo gentile, ecc. 25 OTTOBRE 2003 Luciano Della Mea, INOLTRE e l’intellettuale massa Ho fra le mani le poche lettere che io e Luciano Della Mea ci siamo scritti. Vanno dal ‘96 al ‘99. Portano le tracce del nostro tardivo rapporto: guardingo e presto conflittuale da parte di entrambi sulle questioni legate alla rivista Inoltre (la ragione per cui ci siamo conosciuti); di solidarietà affettuosa, quando ci siamo confidati qualcosa sulle nostre famiglie, le fatiche quotidiane, le mie e sue poesie. La vicenda della rivista è stata per me fonte di pena, per lui di irritazione, credo. In quel 16 dicembre ’95, alla Biblioteca Serantini di Pisa, dove avviammo i lavori per farla nascere, eravamo in tanti: gli editori della Jaca Book, molti potenziali redattori e collaboratori di Pisa, di Milano e uno, Giuseppe Muraca, di Catanzaro. Luciano, 2 grazie alla sua amicizia con il presidente della Jaca Book, Sante Bagnoli, aveva concordato con lui e Giuseppe Muraca il progetto della nuova rivista, dopo che un altro editore, Pullano, aveva interrotto al terzo numero la pubblicazione di Utopia concreta, diretta dallo stesso Muraca e a cui alcuni di noi collaboravano. C’era un certo entusiasmo in quel primo incontro. Decidemmo che la nuova rivista sarebbe stata semestrale, con un tema centrale a numero, svolto non solo in forma saggistica ma anche in testi di vario genere (poesie, racconti, inchieste), un inserto d’immagini in bianco e nero; e che avrebbe avuto una direzione collegiale (Muraca per il Sud, io per il Nord, e per il Centro Luciano Della Mea e Marco Cini, quest’ultimo come coordinatore). Il patatrac avvenne di lì a poco: alla terza riunione, sempre alla Biblioteca Serantini, il 27 luglio ’96. Luciano propose e ribadì poi in una lettera “ai compagni della nuova rivista innominata” “un nuovo e diverso assetto direttivo della rivista” (direttore: Ivan, suo fratello, più Marco Cini). Ribaltò, cioè, senza preavviso, il percorso collegiale appena iniziato. Di fronte alle giuste (lo penso ancora oggi) rimostranze mie e di Muraca, si mostrò insofferente, testardo, sferzante nei giudizi personali e poco propenso a giustificare quel repentino cambiamento (poteva essere considerata “pletorica” una direzione a quattro, come lui affermò?). Ne venne una crisi, che bloccò a lungo l’uscita del secondo numero e portò all’abbandono mio e di Muraca. Con la mediazione di Sante Bagnoli e di Marco Cini, io accettai poi di continuare la collaborazione; ma Muraca, il più amareggiato, si ritirò. Inoltre ha continuato ad uscire, ma è altra cosa da come l’avevamo immaginata allora. Il progetto iniziale (si pensava di creare varie redazioni locali in Italia e magari anche fuori, guadagnare collaboratori e un certo numero di lettori, farsi sentire nel dibattito culturale, ecc.) ha marciato più lento e zoppicante. E non solo a causa del clima politico pesante del nostro paese, ma forse anche perché quell’esperimento di un lavoro collegiale che in pochi difendemmo contro Luciano (magari un po’ mitizzandolo) andava tentato e non affossato sul nascere, tasnto più che se tutti concordavamo su una “visione plurale del progetto-rivista” per coerenza la direzione della rivista doveva essere altrettanto plurale. Non farò perciò nemmeno ora, in ossequio alla retorica che sempre s’insinua in ogni commemorazione, le lodi del Luciano Della Mea organizzatore culturale aperto e sensibile. L’esperienza di Inoltre contraddice o offusca, magari di poco, questa sua immagine. In quel momento - per diffidenza d’antica data verso gli “intellettuali”, per quel suo pessimismo leopardiano-timpanariano, per legami affettivi che lo accecavano – fu miope e ostile verso di noi, bistrattati intellettuali massa, che volevamo cooperare alla pari. È un obiettivo che, a partire dal ’68, serpeggia in ogni movimento forse con più insistenza che in passato e che non era certo inconciliabile col “socialismo libertario” di Luciano. Egli ci contrappose, invece, un criterio verticistico di professionalità, lo stesso che vale nelle università e nelle aziende e che vige in modi a volte caricaturali e immiseriti anche nella tradizione partitica del movimento operaio (comunista e socialista). Rileggo ancora quelle nostre lettere; e sorrido ora di fronte alle scintille del nostro dissenso. Luciano giudicò un’inchiesta che proponevo ai redattori e collaboratori troppo macchinosa (meglio un curriculum!); rabbrividì a sentirmi parlare di “esodo dalla Sinistra”; contrappose alla mia ipotesi di una “rivista di studio” per gli intellettuali di massa la sua di una rivista “strumento di lotta”; desiderava che Inoltre riprendesse e ampliasse il lavoro che Il Grandevetro faceva da 20 anni, mentre io pensavo che dovevamo metterci “alle spalle” non solo la breve esperienza di Utopia concreta (la rivista di Muraca, la “preistoria” di Inoltre), ma anche il toscanocentrismo de Il Grandevetro; e dubitavo anche del “terzomondismo” della prima felice tradizione sessantottina della Jaca Book. Gli scrissi: “Vorrei un INOLTRE che davvero sia in (dove ci troviamo e spesso siamo costretti a stare), ma vada decisamente e coraggiosamente oltre (in senso non solo geografico-politico, ma culturale) le tradizioni in cui siamo cresciuti come “italiani”: cattolica, socialista, comunista, liberale).Dobbiamo tutti entrare in un flusso di idee più ampio e sconvolgente, in gran parte da decifrare”. E lui mi rispose, pungente, che in queste ultime mie parole leggeva “un verso di una a me incomprensibile poesia ermetica”. Mi chiedo oggi perché ho continuato a cercare il dialogo con lui (e poi 3 con suo fratello Ivan), malgrado questi dissensi di superficie e di profondità, e a collaborare in Inoltre “normalizzata”. Mi rispondo: - perché fare rivista oggi è impresa da dannati, ma necessaria nel deserto barbarico che ci assedia; - per riconoscenza verso la Jaca Book (“Ma non sono quelli di Comunione e Liberazione?”, mi chiedevano sospettosi gli amici, appena raccontavo della nuova rivista in cantiere. Non più di tanto, gli rispondevo, e a sinistra oggi c’è di peggio…); - perché, nel tempo dell’esodo (questo d’oggi…), ho imparato a marciare come singolo e non più intruppato, a non considerare casuale ma a verificare a fondo ogni incontro che mi capita. Inoltre è stato ed è uno di questi incontri. E può ridursi - lo scrissi nell’editoriale del primo numero (estate 1997) – ad un cenacolo rissoso e lamentoso di epigoni o di pensionati della sinistra sotto l’egida di una casa editrice cattolica “aperta”, ma non è escluso che possa ancora costruire un gruppo di intellettuali massa “altri da quello che incertamente siamo adesso”. Ma c’è un’altra ragione. Ho continuato per una sorta di onesta “complicità proletaria” con il Luciano dall’esistenza inquieta, quello che ho sentito a me più vicino. Questo lato della sua persona (mi scrisse: “La pratica è stata prevalente nella mia vita e per lo più ha reso la cultura, il sapere, funzionale alla pratica”) non compensava i limiti del militante di vecchio stampo (ma ogni militanza, anche la mia, esodante, ha addosso altri limiti storici!). Nel suo puntare all’utopia, non coglieva spesso come inavvertitamente il suo pensiero utopico diventava in lui una corazza ideologica, un surrogato della precedente divisa militare di cui si era spogliato. E, per strapparsi più tardi al progressismo del movimento operaio che ormai sentiva falso, scivolava facilmente in un materialismo nichilista (“Ho combattuto sodo pur ritenendo, dal 1945 in poi, che la vita in qualsiasi forma non abbia senso”). Tutto questo lo so. Tuttavia nelle lettere ci sono squarci di tenerezza senile per certe analogie delle situazioni quotidiane che entrambi vivevamo o avevamo vissuto e incoraggiamenti da padre-fratello maggiore a non temere di abbandonarsi alla vita. Questi aspetti, spesso velati, della sua persona hanno sciolto il rancore che in qualche momento ho avuto verso di lui. Nella scrittura epistolare, Luciano correggeva lo sconcerto e la rabbia in cui mi gettavano i suoi interventi in direzione. Avevo insistito per questo rapporto collaterale, anche se lo sentivo scettico: “Scriverci di più non è facile, si fa chiarezza incontrandoci, parlandoci, disputando”, mi diceva. E forse per questa sua convinzione, dopo le scintille iniziali, le lettere si diradarono e interruppero. Lo chiamavo di tanto in tanto a telefono per sentire come stava. Poi un ultimo sprazzo. Il 13 maggio 2002, mi giunse una sua inattesa telefonata. Mi chiese dove poteva mandarmi un fax. E m’inviò il giorno seguente una poesia (Il tempo) e uno scritto su Joyce Lussu, che aveva dedicato ad un suo amico da poco morto, Giuseppe Carboni. La poesia aveva versi disincantati e disperati : “ …come se/nulla più potesse accadere/ da qui al limitato orizzonte…/ Non stare a perder tempo/ per migliorare la specie/che non può diventare che peggiore./ Dalle nei suoi esemplari direttamente conosciuti/ un buffetto di affetto”. Nel leggerli, sentii di misurarmi con uno che mi precedeva lesto verso la morte. M’interrogherò ancora sulle ragioni del mancato incontro politico e di quel troppo tenue rapporto d’amicizia con Luciano Della Mea. Ho sempre pensato che fosse una conseguenza della sua esperienza militare, che perciò egli somigliasse a mio padre e ad altri di una generazione che ha trascinato in mezzo a noi, avendola iscritta nella propria carne e nella propria psiche, i segni atroci della Seconda guerra mondiale. (Tratti di durezza simile, anche se più “coltivata”, li avevo scorti in Fortini). Forse insistendo a contrastarlo, a controbattergli, a cercare un dialogo su un nuovo terreno, come avevo fatto all’inizio di Inoltre, si sarebbe smosso. Ma forse lui non ne aveva voglia. Gli altri, mi pare, lo accettavano “com’era”. Io mi rifiutai di farlo. Ma com’era Luciano Della Mea? 23 nov. 2003 Sei appunti polemici sui giochetti di prestigio di un amico filoamericano 1) Dopo l’”8 settembre irakeno” gli oppositori sono tutti nazionalisti, paragonabili ai repubblichini di Salò. Anche se le analogie possono fuorviare: dopo l' 8 settembre non ci furono solo i repubblichini di Salò, ma anche tanti ufficiali e soldati dell'esercito italiano lasciato allo sbando da Badoglio e casa 4 Savoia che formarono bande partigiane demcoratiche contro i nazifascisti. Dopo l'“8 settembre irakeno", noi non sappiamo cosa stia succedendo nel campo dell’opposizione agli invasori (che in questo caso sono la coalizione anglo-americana più aggiunte, italiani compresi). Tutti i resistenti nazionalisti e quindi paragonabili esclusivamente ai "repubblichini" di Salò e non resistenti "accettabili" (antifascisti)? Aspettiamo di saperne di più. Perché precipitarsi a proclamare che “la attuale resistenza irakena appare molto più pilotata dall'esterno, eterodiretta, organizzata dall'alto e senza un vero programma politico”? 2) La bandiera della pace si concilia con la bandiera nazionale (nel nostro caso il tricolore). Impossibile: in questo caso la bandiera nazionale (il tricolore) è issata da invasori. Ai confusionari va ripetuto che morire dietro Hitler e Mussolini non è la stessa cosa che morire per liberarsi da tiranni e invasori (e, quindi, che i morti della Resistenza non riposano placidi accanto ai morti della repubblica di Salò). Ci spiace ma non possiamo considerare martiri o eroi i carabinieri che sono andati assieme agli anglo-americani ad invadere l'Irak. Precisare, precisare sempre: oggi gli angloamericani sono invasori; quando sbarcarono a Salerno o in Normandia non lo erano. 3) Chi è contro la guerra in Irak è indifferente, altrimenti non si chiederebbe “Che c'entriamo noi con questa guerra?” (dal momento che vogliamo la pace) e “Che c'entriamo noi con l'identità nazionale e la bandiera?” (dal momento che siamo cittadini potenziali di un altro mondo possibile, senza confini). È bene riconoscere la relativa impotenza della nostra opposizione alla guerra in Irak ( o crediamo davvero alla balla del pacifismo come “seconda potenza mondiale”?), ma non sostituirei mai questa relativa impotenza con il tifo, gregario e ben più impotente, di chi parla degli invasori come “amici angloamericani che sbagliano”. 4) In ogni caso, a questo punto, il terrorismo c’è, e come…. Ma il terrorismo c'è (o meglio s'espande o s'esaspera) perché l'invasione non era (non è) la medicina giusta per debellarlo. Tra l'altro, ci sarebbe da chiedersi onestamente perché i palestinesi, che notoriamente erano tra i popoli più laici della zona, si scannano materialmente tra loro. Sharon, Bush, la politica dell'Europa non c'entrano per nulla? Come non c'entrarono nella guerra civile in Bosnia i tedeschi, etc.?. Le guerre civili, si sa, sono sempre "questioni interne" di popoli sottosviluppati… 5) Bisogna andare oltre la denunzia delle maschere che inchiodano ogni soggetto al ruolo che assume (un padrone é un padrone, un dirigente é un dirigente, un militare é un militare, e poi anche un padre é un padre, una madre é una madre, un maschio é un maschio etc.). Beh, c’è un solo modo per farlo: costringere chi ha ruoli oppressivi ad abbandonarli. Davvero “un poliziotto é un poliziotto, un carabiniere un carabiniere, etc.”, malgrado siano persone in carne e ossa e non dei mostri. Quei ruoli schiacciano tutte le eventuali buone intenzioni personali, finché non verranno combattuti e sostituiti da altri modi di essere più liberi e rispettosi degli altri. Il Perlasca fascista che salvò gli ebrei fu possibile anche perché esisteva un grande movimento antifascista. Allo stesso modo oggi, i carabinieri che si accorgessero del ruolo non certo umanitario che svolgono in Irak potranno sottrarvisi solo se crescerà un forte movimento contro la guerra. Chiedere invece di piangere o commuoversi per i carabinieri morti nell'attentato di Nassirya ? è suggerire al movimento di cancellarsi e di piegarsi alla retorica patriottarda. I nostri morti sono prima di tutto i civili uccisi dai militari invasori ( e quindi anche dai “nostri” carabinieri). La pena per la morte dei militari invasori segue, non precede. 6) Il terrorismo non colpisce solo Israele, non vuole destabilizzare soltanto il governo turco ma attacca anche il grande movimento per la pace. Insomma siamo tutti sulla stessa barca. Il movimento per la pace (cioè per forme democratiche di conflitto) è fra l’incudine e il martello: colpito sia dalla menzogna della “guerra al terrorismo” (altri sono gli scopi di questa strategia della “guerra permanente”) sia dalla menzogna della “guerra santa contro l’Occidente”. Non deve uniformarsi né a Bush & Blair né a Bin Laden. Troverà una sua via per contrastare questi opposti estremismi ( o fondamentalismi). 5 Guerra e riviste 8 novembre 2003 Caro Lelio [Scanavini], "Quale resistenza effettiva e politica potremmo costruire noialtri, qui ed ora, contro la superpotenza americana?" chiedi nella nota dedicata a "Qui. Appunti dal presente" di Parizzi nel numero 66 de IL SEGNALE che mi hai gentilmente inviato. Beh, potrei controbatttere chiedendo: come fa a non essere sterile una "resistenza simbolica" che non cura a fondo un collegamento con una "resistenza effettiva e politica"? Una resistenza solo simbolica rischia di essere pura testimonianza etica. E oggi credo che si corra proprio questo rischio, anche da parte di chi fa movimento (contro la guerra, ecc.). Il rischio è più alto da parte di chi fa una rivista (e noi tutti ne facciamo o tentiamo di farne); specie quando esse si muovono sul piano letterario o lo tengono in grande considerazione. Esso può funzionare da filtro evasivo, pur occupandosi di politica o di guerra. Ed è quanto ho rimproverato a questo numero di QUI. La forma di "resistenza simbolica" scelta (il diarismo degli interventi, ecc) a me è parsa - malgrado la varietà degli approcci che tu sottolinei particolarmente restia a porsi il problema della "resistenza effettiva e politica". Bene, poniamocelo e non diamo per scontato che "noialtri" non possiamo far nulla, se non quello che già facciamo (o che ci permettono di fare). Temo il lavoro letterario acccartocciato sullo specialismo. Ma anche le riviste letterarie meno accademiche che vogliono sfuggirlo si arrestano ad annusare troppo da lontano la "realtà". Scorrendo la vostra "Rassegna" colpisce questa disattenzione delle riviste nei suoi confronti. Tutte parlano di poesie, narrativa, ecc. (E qui non esito, pur manteneod la mia critica, a togliermi il cappello di fronte a QUI o al GABELLINO che il tema guerra almeno lo affrontano).Scusa questa mia intrusione. Disdicevole o fuoriviante non sarà mai occuparsi di poesia e narrativa, ma non fare di tanto in tanto (meglio spesso che mai) la verifica dei poteri delle nostre riviste e degli altrui Averi. La mordacchia all'arte e alla cultura qui in Occidente a Loro non serve a niente. Ma è un po' anche il dolce far niente inconcludente del Poeta che s'occupa solo di poesia del Narratore che narra solo del suo narrare (ed errare) della rivista con unica vista sulla vicina rivista a lasciare agli USA il potere di cui abusa. Esodo: "duello-duetto" con una poetessa salernitana che vive in Inghilterra 17 novembre 2003 Cara Erminia, Suoni è una bella poesia, ma mi è difficile leggerla come una risposta al discorso che vado facendo sull'esodo. E allora cerco di risponderti con questa mia. Ho messo assieme una prima parte "scavata" dal tuo testo e una seconda, già scritta da anni, sulla figura dell'esodante. Suoni di Erminia Passannanti Questi suoni, il vento, lo scroscio della [pioggia, crepitii nella paglia, fanno sognare un esodo d’uccelli, storia di sconfitte, ma, più funestamente, una cornice di bieca intimità. 10 nov 2003 Con debole insistenza Ahimè, Lelio dicevo: le riviste di poesia e narrativa vanno riviste! Natura d’un finale, esorcismo e punizione ovvero convivio di morti guidati dalla colpa e dall’ostilità, dell’anima sollievo di un’annosa avversione. Che fai? Piangi sempre? 6 Elementi forzati fuor dal nido che annotano suicidi, questioni che la taccola discute lungo la curva azzurra del confine: cinquanta tentativi entro un’adolescenza desueta. Serrato biasimo, protetta aggressione d’uccelli in cui colpa e ostilità traboccano, respiro lento dell’ingabbiato spleen, motivo dell’oggetto smarrito, ch’oggi è sicario, brandello di se stesso, la frazione essenziale commista alla spinta sincronica per rivincere il perduto, scongiuro del nido invaso dalla presenza domestica di fini intarsiati nell’artiglio nell’ala nel becco e consegnati al cielo dell’immondo universo. Prezioso accadimento che intesse mutamenti attraverso inanimate cose, gioielli nascosti sotto la paglia tiepida del nido ch’ardono e spiccano nei suoni, specchi della miseria. O l’elmo di visione e possesso che s’erge sul covo trasognato oltre il margine oscuro della taccola, picco trattenuto dal becco tenuto per prudenza al riparo, migrazione che si leva verso l’orlo, guardinga, portentosa; Nido ed esodo di Ennio Abate I Se nel mio povero nido - la pioggia fuori scroscia e il vento si dibatte sogno un esodo di miei simili, questa nostra funesta storia di sconfitte perde ogni bieca intimità, sorella taccola, che forse conobbi schivando trappole nel gelo d'un dopoguerra. Che fare dopo il pianto di sempre? Con te discuto. Convoco i padri morti. Non dei cinquanta tentativi di suicidi. Non della Cosa smarrita. Non un brandello di me stesso nell'artiglio nell'ala nel becco. Né gioielli, né suoni, né specchi di miseria o l'elmo del possesso. II Dove andare? e correre ancora? o ubriacarsi dondolando sulla soglia? I troppo lucidati intelletti hanno esaminato senza amore solo i corpi più vicini; e tramortiti ambiscono, in latino e in rancore, solo a quelli gloriosi. scuro centro del netto gheriglio, l’immagine ch’attende in agguato d’essere cantata senza tregua, Ma alla femminetta, alla giovane animosa guizza la capriola dell’esodo, quel dolce affanno che si brucia nell’altro della contingenza; e va, si consuma in sorriso, già più non oscilla. desiderio che al cuore torvamente sotto la superficie rorida del mondo sono merletto per sempre rinforzato dal pianto che si mescola al gorgheggio. Smesso l’assillo, al chiarore di altra luna e altro sole, è sbucato accanto a lei il muso dell’antica, buona bestia. 17 NOV 2003 Nell’esodo, dunque. La tana di sempre sfondata, la gabbia approntata aperta, finalmente deserta… 7 Contatti reali e contatti virtuali 16 dic. 2003: Su i tentativi di capire la situazione in cui siamo del gruppo detto “I Seminari di Lodi” Caro Carlo [Tombola], data per scontata la mia stima per l'attività de I seminari di Lodi, mi limito qui alle seguenti osservazioni (condite da qualche provocazione) sul primo gruppo d'interventi: 1. Non di sola informazione o controinformazione (d'illuminismo!) dovrebbe vivere, a Novecento concluso, un intellettuale critico e militante (è lecito ancora il secondo termine almeno nel nostro dibattito?), ma anche (o soprattutto) di contatti reali e a faccia a faccia e di quello che in essi sente e si afferra di sé e degli altri. Purtroppo però oggi, malgrado la retorica comunicativa, tali contatti sono fugaci, sfilacciati e perlopiù ridimensionati come in tempi bui alla cerchia amicale, all'ambito di lavoro, al luogo-non luogo in cui si abita. Anche se appaiono o sono palle al piede, non mi paiono sostituibili; e meno che mai da quelli - illimitati, ma solo virtuali, o effettivi, ma sempre incorporei - resi possibili dalla Rete. Le stesse conoscenzeinformazioni giuste o "rivoluzionarie" ricavabili (in teoria) dal Web e che un gruppo potrebbe riuscire a selezionare, ordinare, preordinare, per funzionare positivamente nelle nostre esistenze, dovrebbero trovarle almeno in parte già predisposte ad accoglierle, essere desiderate, mancarci, riempire dei vuoti. Non bisognerebbe fare allora anche su queste nostre esistenze (sui loro bisogni-desideri, intendo) la medesima operazione (selezionare, ordinare, preordinare) che viene proposta nel confronti del Web, affinché le giuste informazioni possano incontrarsi con i giusti bisogni-desideri? In passato quanti semi "rivoluzionari" sono stati sparsi in esistenze non predisposte ad accoglierli, idealizzate dai "seminatori" o semplicemente delirate? La questione che pongo rientra in quella del cosiddetto soggetto di cui qui si parla o può essere tranquillamente accantonata? 2. Il soggetto. A chi dovrebbero servire le giuste informazioni? Cosa vogliamo fare insieme? Sono le domande fondamentali. Le risposte finora date mi sembrano incerte, difensive e tendenti a delineare un soggetto tutto intellettuale e con una vocazione da nuovi chierici alla clausura studiosa. Provoco: ma cosa significa proporre come scelta di fondo la conoscenza e la sua comunicazione, magari con qualche concessione al rituale debole (incontri faccia a faccia periodici coi "meno allenati")? Oppure l'autoformazione di un soggetto, il cui fine è l'autoformazione di se stesso? I rischi di autoreferenzialità, a cui per tradizione il ceto intellettuale è abbonato da secoli, mi sembrano reali. Va bene studiare la storia del '900 (o del comunismo novecentesco) senza saltare il totalitarismo. Ne verranno fuori sicuramente alcuni buoni e utili seminari con un certo profitto soprattutto per i più giovani. Ma se serviranno a ribadire che il comunismo è morto, non mi pare che ci sia più bisogno di farli. Se ce li proponiamo per arginare il revisionismo storico, chiudiamo la stalla quando i buoi sono scappati. Se si spera (o si è convinti) che ci siano in quegli anni di storia ancora delle buone rovine (Fortini), qualche mattone da ricavare per una nuova civiltà da costruire, lo si dica; ma si indichino le zone da scavare e i temi siano più precisi e circoscritti. Al di là di questo, resta, a mio parere, che il soggetto non può essere il gruppo di ricerca stesso, ma dovrebbe travalicarlo, essere più esterno e vasto e magari plurale. Quale o quali, allora? Qui si apre un quasi baratro. Un accenno ad un soggetto sociale (quelli di Scanzano), non composto da intellettuali-ricercatori e che potrebbe essere, se non il protagonista, il destinatario della possibile conoscenza confezionata dal gruppo che si autoforma, affiora - mi pare - solo in uno degli interventi che mi hai mandato. Non so se, dopo la classe operaia, si possa parlare di nuovo proletariato o di moltitudine senza ficcarci in vecchi vicoli chiusi. Non so neppure se bisogna andare a vedere empiricamente cosa è questa società postmoderna o postfordista (l'inchiesta è facile a dirsi, difficile a farsi; e comunque un'ipotesi di soggetto deve preesisterle). Sono però convinto che l'autoformazione, pur intesa come aiuto reciproco (ma il termine resta per me equivoco e preferirei quello di cooperazione), andrebbe mirata fin da subito al rapporto del gruppo in formazione con un altro o con altri soggetti esistenti all'esterno del gruppo stesso. (Solo se non ce ne fossero più, avrebbe senso la clausura!...). 8 3. Il medium ‘partito’ sostituito dal Web? Solo in parte. Il partito sotto la cappa ufficiale della Linea costruiva legami sociali forti (addirittura ferrei) o la sua stessa realtà permetteva che se ne costruissero altri di "alternativi", di "eretici" contrapponendovisi in concorrenza, spesso mortale. Il medium Web ha qualcosa di labile e imbarazzante, induce al fantasmatico: è il medium ideale per una comunicazione ininterrotta tra puri spiriti e non contempla di per sé il passaggio al patto, all'impegno pratico con gli altri e le altre in carne ed ossa. Per arrivare a questo, bisogna spegnere il computer e incontrarsi, parlare, ecc. provocatoria della cultura d’élite all’universo della cultura di massa; un nuovo e più diretto rapporto fra arte e vita, in termini di interventi performativi e di installazioni ambientali; e anche come processo di riflessione autoreferenziale sulla specificità e i limiti dei linguaggi artistici e sullo stesso sistema dell’arte.. punti di riferimento essenziali per questo cambiamento sono le esperienze estetiche più avanzate avviate nell’ambito delle avanguardie storiche da alcuni grandi precursori, tra cui innanzitutto Marcel Duchamp” (Francesco Poli, Arte cont., Electa Mondadori 2003) Lenin E allora, l’avanguardia, eh, l’avanguardia! La controcultura, gli eroi trasgressivi di Jean Genet, i poeti della beat generation, le figure picaresche e deculturate di Antonin Artaud e di Samuel Beckett: lacerti di un mondo sentito dire. Il desiderio di sapere e di avvicinarlo fu frenato e deviato dall’esserti buttato nel mondo opposto (piccolissimo borghese e proletario, non borghese e sottoproletario come quello dell’avanguardia), anche se della grande città. Ha poi funzionato la censura, forse motivata forse pregiudiziale, della militanza marxista. Bene, andò così. Abbiamo fatto altro, mentre loro facevano questo. Adesso c’è uno spazio per controllare quello che hanno fatto. Colpisce questa immersione senza freni, anzi carica di antielitarismo, nella cultura di massa: “Queste pratiche, che hanno come riferimento il movimento dada ma anche il cubismo e il costruttivismo, prestano tutte la stessa attenzione al reale nelle sue componenti più ordinarie e anche svalorizzate: l’interesse per la strada, i rotocalchi, l’automobile, gli oggetti domestici, i rifiuti, direttamente prelevati sul vivo della vita quotidiana urbana” (15). La “nuova arte popolare” sarebbe la pubblicità? (15). Che tipo di antielitarismo è questo che propone la “necessaria relazione tra l’arte e la produzione di massa” (15)? [ la parola capitalismo è assente…] 23 dic. ’03 Costruì il partito all’alba (del secolo) Come Dante, quando immaginò il suo poema. E sempre la notte era stata buia, tempestosa. Né dentro ,come si dice, né fuori si presentiva la luce. Ė forse esatto un secolo da quel Che fare col punto interrogativo 22 gennaio 04 Lenin Ottantesimo anniversario della morte (21 gen. 1924). Com’è bello parlar male di Lenin oggi strizzando l’occhiolino al movimento per la pace e cancellando pezzi di storia. Eh, Bertinotti? Arte contemporanea “Ma la vera svolta che ha cambiato le coordinate di fondo della ricerca artistica definibile come strettamente contemporanea…inizia sia in Europa sia in America più o meno nella seconda metà degli anni cinquanta, sviluppandosi nel decennio successivo. Tale svolta va in direzione di un definitivo sfondamento dei confini tradizionali della pittura e della scultura… a partire da una critica radicale all’eccesso dell’espressività soggettiva ed esistenziale dell’informale e dell’action painting, e più in generale alla dimensione illusionistica dell’opera. E si caratterizza attraverso un coinvolgimento concreto della realtà oggettuale quotidiana; un’apertura 22 gennaio Ai funerali di Massimo Gorla La deformazione per invecchiamento dei corpi dei miei ex-compagni. Alcuni quasi stento a riconoscerli. 26 gennaio Felice Gandolfo 9 Elena mi telefona. È morto d’infarto. Era tirato. Situazione pesantissima per B: sola, straniera qui, senz’auto, con tre figli (due gemelle handicappate), senza lavoro. 3 febbraio 2004 Una nuova rivista Forme di vita ( Alias 31 gen. 2004) Il progetto: sforzarsi di cogliere insieme natura e condizione umana, che nella filosofia del ‘900 sono state tenute separate. La giustificazione: oggi la produzione, la tecnicizzazione investe il terreno primario delle forme di vita. Da qui viene ricavata la produzione di ricchezza. De Carolis parla di “tecnicizzazione” e non di “biopolitica”, perché i dispositivi in atto non rinviano ad un controllo politico, ad un governo, ma regolano la loro evoluzione in base a criteri interni, definiti tecnicamente. La globalizzazione tende a costruire un’unità sociale, non un’unità politica e il rischio e quello di una guerra civile planetaria (alla Schmitt). Rossanda: Ma cosa resta della invariante biologica? ( e fa gli esempi delle trasformazioni subite soprattutto dalle donne: controllo dell’attività riproduttiva ad es.). Anche la natura umana è diventata una costruzione variabile. Critica la premessa del discorso: che oggi i rapporti di produzione mettano al lavoro, tra le facoltà umane , soprattutto il linguaggio. Non è detto – afferma – che allo scalpellino medioevale impegnato nella costruzione delle cattedrali fosse richiesto un uso minore della facoltà intellettuale. E per l’oggi nei call center o nell’informatica si nota in prevalenza un abbassamento dell’umana intelligenza. Virno sottolinea che non è affatto automatico che il carattere comunicativo della produzione contemporanea produca una maggiore autonomia o autorealizzazione da parte di chi lavora. Anzi: avviene il contrario. Poesia civile e parodia del potere Dopo la lettura di "Le maschere del caos" 10 febbraio 2004 Gentile Luca Baiada, ho ricevuto e letto il suo libro. E sperando che il contatto stabilito resista, le scrivo spassionatamente le prime impressioni e qualche considerazione più generale. Mi hanno colpito positivamente il piglio battagliero, la tensione parodica, l'ampiezza dei riferimenti culturali, il linguaggio asciutto. Perplesso invece mi rendono l'enfasi epica (ad es. "La Perugia-Assisi del 2001") e certi cortocircuiti antico-contemporaneo (es.pag. 37), irriverenti e spiritosi ma facili. La riserva più consistente è per me, se posso dirlo, di ordine poeticopolitico: la parodia del potere non solo a volte si appiattisce sul lessico che esso adotta (e gli concede troppo... non condivido perciò il giudizio di Manacorda: "per denunciare la miseria delle tante parole d'oggi è sufficiente riprodurle", pag.6), ma abbandonandosi allo sberleffo e al divertimento rischia di occultare la tragicità pesante della nostra situazione. Su “prof.Samizdat” 4 marzo 2004 Cara Marina Massenz, “Prof Samizdat” è uno dei risultati più meditati della mia ricerca riflessione sugli anni Settanta, spostata però più sul dopo (l'angoscia degli anni di piombo) che sul periodo 68-76 che è stato quello della mia militanza in AO. A differenza di bilanci fatti da militanti di altri gruppi (lessi a suo tempo una “Storia di Lotta continua” di Luigi Bobbio), non mi pare che da qualcuno di Avanguardia Operaia sia mai venuto un libro decente su quello che pure era, se non si trattò di pura automitologia, il gruppo extraparlamentare più forte a Milano. Una volta ricordo di aver letto una sorta di bilancio di quell’esperienza da parte di Aurelio Campi: la svalutava, prevalendovi la giustificazione delle sue scelte, che l'avevano portato prima nel PdUP e poi nel PCI. La parte di dirigenti milanesi, che si è riciclata passando in Democrazia Proletaria e poi in Rifondazione Comunista, mi pare che abbia perpetuato soprattutto la funzione burocratica (la più pesante fra quelle che ebbe AO). Non è stata una bella cosa quell'esperienza. A me, forse anche per questa pochezza di riflessione collettiva, il periodo di AO è rimasto un buco. E non non fu un caso se per ripensare quegli anni e quello che ne è venuto dopo, mi sono dovuto 10 trasferire sugli scritti di Fortini, della Rossanda, di Bologna, di Negri, cioè di autori che non parlavano dell'esperienza da me fatta, in quel concreto gruppo e parlavano con altre categorie. Un vuoto, dunque. Se poi pensavo alla mia esperienza individuale, vissuta in AO, le cose peggioravano. Qualcosa d'ambiguo, di poco chiaro, e per me di umiliante caratterizzò quella militanza sul piano esistenziale. E qui credo di comprendere e poter concordare con quanto dici (A me allora era chiuso tutto l'universo del leggere, della poesia, dei sentimenti teneri, della mia famiglia d'origine da cui mi ero brutalmente separata, delle mie debolezze, della mia creatività). Questo è accaduto anche a me e a molti uomini e donne di allora. Eppure mi sono chiesto spesso perché, malgrado questi aspetti soffocanti e - ripeto - per me umilianti (quando li ho rievocati, mi hanno fatto pensare al periodo altrettanto frustrante di Azione Cattolica della mia infanziaadolescenza a Salerno), non ho mai pensato di ridurre quella militanza solo a questo, al mio vissuto esistenziale , che pur ritengo negativo. E perciò non mi convince la tua contrapposizione fra militanza e corpo. Ripeto: quella militanza avvenne in pessime condizioni e, se vogliamo, in un gruppogabbia più rigido e burocratico di altri. Ma era una delle poche forme possibili allora, in quegli anni e a Milano, per "dar corpo" a certi bisogni che sentivamo. Era "maschera", ho detto. Ma qualsiasi militanza doveva essere per forza (e sarà forse anche in futuro) un po' “maschera”: doveva, dovrà mascherare una parte del corpo. Mi fa un po' male a dirlo, ma devo dirlo.Troppo facile o romantico pensare che, la maschera, qualsiasi maschera possa essere abolita e possa così far emergere il corpo come verità, piacere, felicità, bontà. Tu sai bene, e lo dici, che il corpo é il luogo dell'ambivalenza, della complessità, delle emozioni. Perché lo è? Soloa causa della maschera? No. Togli la maschera (operazione eroica, dolorosa) e trovi ambivalenze, complessità, emozioni (che non è detto siano di per sé positive o negative né per l'individuo né per la collettività, ma lo diventano positive o negative, appena socializzate, appena incontrano e quasi sempre si scontrano con quelle di altri/e). Perché poi il corpo parli (e non semplicemente agisca, aggredisca, ecc.) ha bisogno non solo di qualcuno disposto ad ascoltare, desideroso di capire, di voler bene, ecc., ma di un linguaggio, di una grammatica per articolare i suoi bisogni, i suoi desideri.E qui torna, credo, ancora il mio discorso della MASCHERA, che non è soltanto posa, occultamento, dissimulazione, ma metafora di convenzione, cultura, forma che sta accanto ad altre forme, protesi artificiale, e dunque linguaggio che altri intendono o possono usare. In sintesi, anche a livello individuale, se non ci fossero stati Freud e la psicoanalisi (maschera, cultura, anche questa), il corpo dell'isterica avrebbero continuato a parlare (meglio ad essere interpretato) alla vecchia maniera (secondo le vecchie maschere positiviste). E a livello politico, se non si fossero create le maschere dei gruppi extraparlamentari, sarebbero rimaste a disposizione solo quelle dei partiti che noi chiamavamo "storici" o quelle del privato o della professione. Ora il mio ragionamento è questo: non c'è dubbio che la maschera della militanza d'allora (la cultura politica dei gruppi, di AO in particolare) lasciava ben poco intravvedere certi bisogni, disagi e ambiguità. Ma essa assolveva ad un'altra funzione: spingeva noi individui-corpi ad entrare in contatto (con tutte le nostre paure, voglie, nevrosi, ecc.) con eventi e realtà sociali. Ci avvicinava agli eventi, al "sociale", sbarrando il discorso sul "personale". Per quali motivi (in prevalenza molto materiali e psicologici assieme) un individuo si metteva quella maschera-ruolo del militante, che poi diceva di aver scelto o che si costringeva a sopportare? Qui è difficile rispondere... Resta però il fatto che per me una maschera (ma si potrebbe dire anche un ruolo) è inevitabile: è il vivere in società che l'impone. E ha delle conseguenze positive e negative: permette di capire delle cose, di agire in certe situazioni e chiude tante altre vie e possibilità di esperienza. Con quella maschera di "durezza" noi non abbiamo potuto vedere (abbiamo rimosso, abbiamo finito per rimuovere. .. le sfumature sono tante) certe cose. Con le tue parole: vedi violenza dei servizi d'ordine..su cui il silenzio incombeva ed era impossibile avere un'idea esatta di cosa "noi stessi" facessimo, ad esempio. Abbiamo invece visto e accettato altre cose con partecipazione o coinvolgimento, anche se non erano condivise da gente magari a noi cara. Tu scrivi: Altre forme di "durezza" le ho trovate giuste e sostenute "senza maschera", con i 11 vissuti veri e le contraddizioni del caso; alludo ad esempio sia alle forme di lotta molto dure nella scuola, (che però erano sempre di massa, anche se non maggioritarie) che a quelle pure molto forti a cui ho partecipato quando lavoravo all'AEG-TEKEFUNKEN ed ero sindacalista. Ma nel trovare giuste queste cose a cui hai partecipato con convinzione, non puoi dire che eri "senza maschera": avevi forse trovato un equilibrio fra corpo e maschera, fra tuoi bisogni profondi e richieste del collettivo di compagni, sopportabile o addirittura soddisfacente. A questa maschera (quella della militante di AO che accettava la durezza della lotta quando era condivisa dalle "masse") aderivi, respingendo altre maschere, che pur allora erano possibili e sono state usate: da quella del simpatizzante scettico a quella del lottarmatista. Quanto agli errori: non era possibile (non è possibile) evitare errori. Tutti, da tutte le parti in lotta, ne hanno fatti. Solo alcuni errori erano (in parte, forse) evitabili. Ma bisognerebbe pensare a fondo e tenendo conto del contesto d'allora (quello da noi percepito, non quello che magari abbiamo percepito dopo) per dire quali. Tu fai l'esempio dei servizi d'ordine. Gli errori dei servizi d'ordine era possibile evitarli solo in parte. Per evitarli tutti bisognava non fare servizi d'ordine; e, di conseguenza, non fare un certo tipo di partito, di manifestazioni, ecc. Il che, allora, equivaleva, a starsene a casa in certe occasioni (ricordo un 11 febbraio 70 o 71 mi pare... c'era Almirante in P.zza Cairoli, ecc). Certo che il silenzio incombeva sulla questione. Certo che era impossibile avere un'idea esatta di cosa "noi stessi" facessimo. Ci sono problemi legati alla lotta degli oppressi che richiedono silenzio e sacrificio di parti di noi (come del resto, per lavoro, carriera o altro sacrifichiamo parti di noi...). Qui c'è un elemento "duro", a volte tragico che o accetti o rifiuti. Ma, rifiutandolo, non lotti più (o fai un altro tipo di lotta forse). Noi, per diversi anni abbiamo accettato. Inutilmente? Che non si siano raggiunti gli obiettivi proclamati è certo. Che però solo grazie a quelle lotte si siano svelate cose che mai sarebbero emerse, anche è certo. Che molto altro era impensabile ottenerlo lo si è potuto sapere solo dopo (a seconda dei dati sulla situazione reale che si è riusciti poi ad avere). E resta, al di là dei dati reali, accertabile storicamente, che c'erano dei desideri in ballo, c'erano degli 'investimenti libidici' individuali e collettivi che ci hanno fatto procedere su quella scelta fatta per 3-4-5 anni o più. Perciò non capisco molto il senso di colpa (retrospettivo?). Un certo stato di cose (anche interno ad AO) non si muta facilmente, specie da parte di chi (era il mio caso, ma penso anche il tuo e certo di tanti giovanissimi) aveva scarsa esperienza di politica. Ma poi, studi un po' di storia, vieni a sapere di Gramsci in carcere messo quasi in quarantena dal Partito, di Bucharin al processo...; e vedi che quella forma-partito comporta questi rischi, che hanno procurato sofferenza e degenerazioni, ma hanno anche permesso conquiste politiche che nessuno ti avrebbe regalato. Chi poteva dire con sicurezza allora: alt, io in un partito che si vuole rivoluzionario non ci metto neppure il naso? Era forse sicuro già in partenza che avremmo ripetuto gli errori dei partiti del passato? Io, malgrado le umiliazioni, ho accettato di stare in AO fino al ‘76. Anch'io, come te mi pare, mi trovavo più a mio agio nel fare lavoro di base a Cologno o nella scuola, come tu alla AEG. Ma i due momenti non erano allora così scindibili. Può darsi che la spinta partecipativa era tanto forte che potevi militare anche semplicemente e con più soddisfazione in un gruppo di base o semplicemente in un CdF. Ma, come ha scritto Sandro Portelli a proposito della Resistenza, certe azioni antifasciste spontanee (es. assalto ai forni) erano possibili anche perché c'erano dei partigiani armati. Anche nel nostro periodo certe azioni forti e di massa nella scuola o altrove furono possibili anche per la presenza di gruppi organizzati (e dei servizi d'ordine!). Quindi la "maschera Samizdat" non la giudico "un nostro clamoroso errore". Non potevamo essere "interi" . Semmai lottavamo con la speranza di diventarlo assieme ad altri, quelli della nostra parte (o classe) o quella dell’ "umanità". E accettavamo le amputazioni come necessarie. Quando non c'è stata più questa convinzione o sentimento ci siamo ritirati; e abbiamo cercato altre forme di resistenza (altri hanno scelto persino di passare coi vincitori). Siamo stati sconfitti, ma non perché i nostri corpi fossero stati ammutoliti dalla militanza. Solo in parte. E del resto erano ancora più ammutoliti prima; e sai bene quante mistificazioni ci sono state anche in quelle esperienze che mettevano in primo piano il corpo: Re nudo, ecc. Siamo stati soprattutto sconfitti, perché chi aveva più 12 potere e informazioni ha puntato a chiuderci ogni sbocco: non solo rivoluzionario, ma anche riformistico. E l'ha potuto fare trascinando sui suoi obbiettivi la Sinistra. E poi ci sono gli errori di lettura degli eventi: la ristrutturazione mondiale non compresa o afferrata in tempo, lo svuotamento della funzione del lavoro, della classe operaia, ecc. Siamo stati sconfitti, ma non era sicuro che saremmo stati sconfitti, anche se la lotta con i potenti è sempre impari. Quanto ai massacri: sempre le rivoluzioni sconfitte portano massacri (e forse anche quando vincono... questo è un altro elemento tragico, che o metti in conto o trascuri, lasciando fare i massacri agli altri...). Quanto al salvare qualcosa di quell'esperienza, io proprio l'idealismo, che tu ci vedi, non salverei. Sarebbe consolatorio. Semmai mi chiederei o auspicherei che nei prossimi "assalti" ci sia meno idealismo. E se nella "durezza" di Samizdat ci fosse stato dell'idealismo e me ne accorgessi, cercherei di non valorizzarlo. La prima domanda che mi farei, per dare la giusta importanza a quella "durezza", è: quanto era arbitraria? quanto necessaria? quanto corrispondeva al mio corpo e a quello degli altri con i quali mi sono ritrovato? Le "crepe" di quella durezza, non dipendevano, secondo me, da quello che "era lasciato fuori" da noi stessi più o meno volontariamente. Ma in che senso? Lasciati fuori non significava escludere o sottomettersi ad un diktat dei capi: speravo di ottenere per via collettiva quella bellezza o quel riconoscimento o quel piacere che forse avrei potuto ottenere per via individuale solo però "lasciando fuori" (è il caso di dirlo) la mia condizione di vita (di fatto proletarizzata...) e staccandomi da quei proletari in mezzo ai quali mi ero venuto a trovare. Cosa che forse non mi era facile fare, anche se l'avessi desiderato. E ancora oggi, negli ambiti terziarizzati e non più operai che mi ritrovo a frequentare, c'è bisogno di una certa "durezza" (non quella di allora, non per nostalgia d'allora, non per abito acquisito e automatico), perché, più allentati o mascherati, i rapporti di forza vigono anche oggi. E anche ora un'altra parte di noi, quella più socievole, non corporativa, solidaristica e diciamo pure erotica (intendo: al di fuori dei canoni erotici suggeriti) è messa da parte, se non "scotomizzata" come tu dici. Infine, per rielaborare quegli anni, ci vogliono idee e sentimenti giusti ( e forse contatti con gente giusta...). E purtroppo, data la sconfitta, dobbiamo rimediarvi quasi sempre da soli. Perciò forse la poesia, la scrittura entrano in gioco come strumenti possibili. Smetto qua. Poesia: classicità e guerre d’oggi 5 aprile 2004 Caro Daniele [Santoro], le tue poesie mi sembrano ancorate ad un ideale di bellezza classica che nasconde venature d'angoscia e inqueitudine moderna.L'impressione che ne ho è ambigua: da una parte un'adesione intima (Ah, il mito della Grecia assorbito sui banchi del liceo Tasso nella mia Salerno degli anni Cinquanta!) come se ritrovassi cose preziose e una volta care, dall'altra la preoccupazione (del vecchio!) che vede il poeta più giovane aggirare la dura realtà della storia e il grigiore del presente (merci, guerra, follie quotidiane e politiche). Mi sono sempre chiesto se dall'alto della sensibilità che attribuiamo agli eroi classici si può cogliere quello che accade nelle guerre del Novecento e dei nostri giorni; e se l'immagine della dea ci accosta alle donne che amiamo o ci scorrono accanto. 29 aprile 2004 Caro Daniele [Santoro], eccoti a tempo di record e come avevo promesso alcune mie impressioniosservazioni sulle tue "Nuove poesie". Il lamento di Truganini L'andamento è sempre classico. Mi pare che ci sia sovrapposizione di questo tono classicheggiante [solennità del verso lungo, di alcuni attacchi (“perché amore...”, “felice te che...”) del lessico (prevalentemente alto..stridono, mi pare, nel contesto termini come “impiccata”, “disgraziata”, “puttana” e “spettacolo da circo”] sulla crudezza della vicenda richiamata in esergo, ma elusa e troppo sublimata. POESIE PER HIROSHIMA (I-VI) Bella e concisa la Premessa e saldo il riferimento alla tragedia di Hiroshima. Nelle quattro strofe il tema della meditazione sulla morte si fa però mano mano troppo etereo, perde di vista la materialità dei moderni genocidi. Prevale, forse con il ricorso ad immagini sin troppo belle (“frangersi a sera nel mare la luna”) e pacate 13 (“ad uno ad uno li depositiamo/sul palmo delle acque i nostri cari”), la sublimazione dell'orrendo dato storico, che diventa pretesto e non è più contenuto da non eludere, ma da sviluppare (e nella Premessa non c'era elusione...). Qui forse entra in funzione suppongo - un certo idealismo, che accentua, ad es., l'“inno all'esistenza che non smette/ ancora di stordirci con il suo trionfo” piuttosto che insistere sulla contraddizione ( fra “lieve sventagliare di fragranze” e il fatto che “lì sbocciano cadaveri”). Su VI presto un ago di luce crescono le mie riserve (o più semplicemente la mia incomprensione). “Errore... Indicibile... Grande” m'intimidiscono e mi rendono diffidente... e acini baciare sensualità di immagini preziose (fortemente letterari termini come “violacciocca” e “madida”) Lettera di Rubin Stacy... Mi pare interessante questo lavorare su spunti di eventi reali, storici. Anche l'accentuazione paradossale della propria umiltà da parte della vittima è una bella trovata: il servo, insistendo nel suo servilismo, smaschera la ferocia di quelli che l'umiliano e l'ammazzano. A certe espressioni più generiche (Mai mi sarei permesso -Glielo giurovenirLa a importunare. mi perdoni.), preferirei particolari più chiari che accentuino la crudeltà della situazione. sulle scale a frugarci la bocca a strapparci le labbra Qui il tono è concitato. L'armamentario classicheggiante è abbandonato. La sensualità espressa con immediatezza, malgrado qualche enfasi (“l'amalgamarsi folle/ ardito andirivieni in sinfonia di corpi //poi il fulminelacontrazioneilprecipizio”) Il MONTE ANALOGO: UNA NUOVA “RIVISTA DI POESIA E RICERCA” Continuano ad uscire nuove riviste. Quelle letterarie (e sono tante) oscillano fra culto dello specifico (la poesia, la narrativa, la critica) e spinta a cercare oltre, ma ancora a tentoni fra le rovine di una grande tradizione temuta/odiata/invidiata. Qui di seguito alcune mie note sui problemi in dicussione fra i redattori di una di esse. 22 apr 2004: osservazioni [da una lettera a Lorenzo Gattoni] Linea editoriale....a me una linea editoriale sembra una buona cosa. Essa non esclude la pluralità. (La mia attenzione alla moltitudine poetante è un esempio di linea – personale, non editoriale, non del gruppo attuale del MonteAnalogo – aperta alla pluralità). Ammetto che oggi non abbiamo una linea editoriale, ma ritengo utile costruirla, valutando i pro e i contro, sbarazzandosi se possibile delle remore e pregiudizi esistenti. Oggi a me pare dominare la diffidenza verso chi auspica una linea editoriale per una rivista, specie se di poesia. Gli si contrappone facilmente l’appello ad una generica apertura alla pluralità. Ma tu stesso fai giustamente presente che “appellarsi alla moltitudine [alias alla pluralità] rischia di apparire un vanto ideologico”. Ed io pure credo che la mia apertura alla pluralità (alla moltitudine poetante), se non sorretta da una linea editoriale chiara, rischierebbe una sorta di disarmo critico. Estremizzando: pubblichiamo tutto e non se ne parli più. Perciò, da subito, ho cercato di evitare questo pericolo, muovendomi su due strade: 1) un’inchiesta sia pur limitata per capire davvero cosa sia la “moltitudine poetante”; 2) una riflessione più approfondita su vari aspetti della poesia contemporanea italiana esaminati attraverso il filtro di alcune riviste...... Pubblicabilità....A me pare che stabilire che un testo sia pubblicabile sul Monte Analogo in base al fatto che rispetta il “presupposto della rivista che è il dare spazio alla ricerca, al nuovo, al movimento” sia “agire da intellettuale”. Lasciando perdere la caricatura che oggi si fa del lavoro intellettuale, è abbastanza chiaro che, per “dar spazio alla ricerca, al nuovo, al movimento”, dobbiamo avere un’idea comunicabile e abbastanza condivisa di cosa intendiamo per “ricerca”, “nuovo”, “movimento”. Che sia poi intellettuale o intuitiva (o una proporzione variabile di dati colti con l’intelletto o con quella che chiamiamo intuizione, fantasia, immaginazione, ecc.) per me è secondario rispetto al fatto che sia comunicabile e abbastanza condivisa. 14 Poeti rinomati....I poeti conosciuti (o rinomati) non devono diventare la peste da cui fuggire. A volte la loro opera potrebbe dare preziosi spunti al lavoro della rivista. E, anche se decidessimo di non pubblicare mai i loro testi (cosa ovvia perché hanno già sufficiente circolazione e non perché siano di “poeti conosciuti”), in qualche ambito (seminariale, conversativo, ecc.) dovrebbero essere oggetto di giudizio come per gli altri che vogliamo “promuovere” (o meglio: conoscere innanzitutto!). Non vorrei che ai salotti scelti contrapponessimo i ghetti dei poeti sconosciuti, con una sorta di snobismo alla rovescia. Giudizio amicale/ giudizio collettivamente motivato...Sul bloccare ogni forma di nepotismo, di cricca, di cordata concordo in linea di principio. Ma temo che le regole che impongano un’impersonalità astratta (La lettura dei testi in forma anonima) possano diventare solo di facciata ed essere aggirate da mille trucchetti. (Vedi cosa succede per “La legge è eguale per tutti”!). Io indagherei più a fondo sui comportamenti reali della gente (dei poeti, aspiranti poeti, ecc.) permettendo che si manifestino anche nei loro aspetti spiacevoli o meschini senza censure preventive troppo rigide. E poi – mi chiedo - l’essere amico di un poeta da giudicare comporta automaticamente complicità o cecità nel giudicarlo? A volte (non sempre) l’amicizia può essere anche un veicolo per entrare meglio in un testo e portare elementi di valutazione aggiuntivi preziosi. E il giudizio fazioso sul testo dell’amico o dell’amica non può forse essere corretto e rivisto dalle opinioni degli altri (comitato di lettura, ecc.)? Sono per porre obiettivi alti a tutti: il sentimento eccessivo di amicizia o di complicità cederà il passo a ragionamenti in grado di svelare verità più alte e condivisibili. Perché dovrei difendere a tutti i costi un testo di un mio amico se, discutendone seriamente con altri, venissero fuori vari difetti in modo conclamato? È vero che tante volte anche di fronte alle verità più solide si resiste e non si vuol vedere. Ma non credo che si debba rinunciare a cercare cose “più vere” (giudizi più solidi, più motivati), a farle circolare, a farle pesare. I rischi della poesia-mistero Il mistero elemento essenziale della scrittura poetica? Qui concordo ben poco. Non sono un illuminista sfegatato, ma l’esperienza personale e storica insegna che sotto la coltre oscura del “mistero” trovi di tutto: santi e assassini, truffatori e galantuomini. Che ci siano cose misteriose, ignote, inconsce o semiconsce non lo nego. Ma farle diventare l’“elemento essenziale della scrittura poetica” significa, secondo me, arruolare a priori i poeti in sette iniziatiche. Li vedrai tutti presi dalla gara a chi svela il mistero più misterioso; e avrebbero un lasciapassare in più per ignorare la realtà (tragica) del mondo in cui vivono assieme agli altri. Questo lasciapassare io non glielo do. Al massimo suggerirei di impegnarsi prima a svelare i “misteri” della nostra vita “civile”, quelli che hanno portato e portano stragi, guerre, dilapidazione del bene una volta “pubblico”, ecc. Invitare i poeti a cercare il mistero equivale ad una privatizzazione della poesia, che per me è/dev’essere bene comune. La moltitudine per sempre “senza qualità”? La poesia è stata ed è storicamente una delle tante forme di espressione dei bisogni, delle idee, dei desideri delle élite culturali. La moltitudine (vivente, lavorante) è stata (è) al massimo spunto d’ispirazione da parte dei poeti “famosi”. La moltitudine poetante (volgarmente detta: sottobosco, scribacchini, poeti della domenica, ecc.) è oggetto di scherno, di reprimenda, di diffidenza da parte delle élite di cui sopra. Oggi affiora nei nostri discorsi come “quantità”. Al massimo ci sono alcune interessanti riflessioni sociologiche sul fenomeno, che scivolano però sugli aspetti forse più interessanti del fenomeno (estetici, psicologici, stilistici, ecc.). Che – ripeto - andrebbe indagato per – lo dico rozzamente - “spremere” dalla “quantità” la “qualità”. Ma –qui sta il difficile – non si tratta di “spremere” la solità “qualità da élite” (i “grandi”, i “famosi”), ma la “qualità dei molti”. Detto così è una pura enunciazione di principio o, se vuoi, una pia intenzione. Ma avvia verso un’altra direzione. Altrimenti, guardando soltanto alla “realtà” con gli occhiali estetici a cui siamo abituati, continueremo a vedere solo sottobosco, scribacchini, poetastri, ecc. Oppure a rimanere all’interno delle questioni tecnicospecialistiche del lavoro poetico (quelle che tu elenchi: metrica, tematiche, linguaggio, poetiche, stile, ecc.). Non nego che ci sia un’etica della professione anche per i poeti, i 15 critici o i critici-poeti. Ma nei casi migliori crea ammirevoli monumenti per il piacere delle élite che vi hanno l’accesso riservato. Alle masse, che dovrebbero rimanere masse, cioè passivizzate, vanno gli scampoli. Ci vogliono invece altri occhiali (critici), riflessioni serie, categorie estetiche rinnovate per intendere cosa può nascere di buono dai testi prodotti dai molti. Crisi dei canoni e canone occulto... I canoni, i mini-canoni, le linee editoriali, ecc. imposti dall’alto o provenienti dal passato infastidiscono. Si comincia sempre, come tu dici, dall’ascolto, da una approssimativa esplorazione, dalla discussione “parziale e discutibile” di quelli che sono i nostri gusti, canoni o mini-canoni personali, desideri di linee editoriali, ecc. Si comincia oggi dal “relativismo soggettivistico”. Non si scappa. Ma attenti a non fissarlo in Canone occulto e non dichiarato, che sfugge a ogni discussione “parziale e discutibile”, perché è “naturale” pensare così, perché “così fan tutti” o “così fanno i manager culturali che contano”. Si sappia che nello “spazio soffocante e autoreferenziale, chiuso e autoreplicante della cittadella poetica nostrana” questo è lo stile che domina. Possiamo farlo nostro? Possiamo farci male con le nostre mani? Nuova serie di SAMIZDAT COLOGNOM Data: giovedì 15 aprile 2004 17.21 Cari amici, in questi mesi, dopo lo sganciamento da INOLTRE, ho oscillato fra l'ipotesi di una nuova rivista e l'ipotesi di rilanciare SAMIZDAT COLOGNOM. Ho scelto di rilanciare quest'ultima, anche perché il Centro Studi Franco Fortini ha accettato la mia richiesta di far uscire SAMIZDAT COLOGNOM come supplemento de L'OSPITE INGRATO. E' una soluzione che è in continuità con una parte della mia ricerca e che non preclude l'esplorazione del "nuovo" (la condizione postmoderna). Vi mando pertanto in allegato una proposta precisa, sulla quale chiedo che ciascuno dei destinatari si pronunci (accettando l'ipotesi di partenza, correggendola, allargandola, restringendola, ecc., o rifiutandola). Se le vostre risposte saranno sufficientemente positive, penso di convocare una prima riunione per perfezionare assieme l'ipotesi.( Rimando ad una fase successiva la discussione sull'organizzazione della rivista stessa, l'ampliamento del numero dei redattori, i costi, i destinatari, ecc.). P.s. In appendice vi mando anche lo scambio intercorso fra dicembre e marzo fra me, Piero Del Giudice e Maria Luisa Torti sull'ipotesi di una nuova rivista. Il taglio giornalistico dell'ipotesi di Del Giudice mi pare poco praticabile (da me, da voi...). Ma alcuni dei temi proposti e l'invito ad una presa sul "reale" li accetto. Vedrò (o vedremo) in seguito se è possibile mediare fra le due non contrapposte esigenze. Ipotesi di rivista apr 2004 Titolo: SAMIZDAT COLOGNOM [con possibile sottotitolo: dai luoghi/non luoghi dell’Italia in epoca postmoderna] [in evidenza: supplemento a L’ospite ingrato del Centro studi Franco Fortini] [spiegazione del titolo: Il termine russo Samizdat nel Novecento indicò gli opuscoli della comunicazione dissidente nei paesi una volta “sovietici” dell’Est e dell’Urss. Letteralmente significa autoedizione. La rivista lo eredita come emblema di atteggiamento critico e lo vuole rinnovare in senso moltitudinario ed esodante1[1] nella attuale condizione postmoderna. Il termine Colognom, abbreviazione di Cologno Monzese, allude ad uno dei tanti luoghi/non luoghi della sconvolta e straniata esperienza urbanometropolitana d’oggi, che la rivista intende indagare. ] Rubriche: Samizdat Qui vanno tutti i pezzi di dissenso o di critica della condizione postmoderna : articoli individuali o redazionali o di 1[1] Per il significato di questi termini controversi, non da tutti condivisi, ma che orientano la ricerca evitando che si collochi nell’ambito accademico e massmediale dominante rimando alla nota 5 a pag. 145 del mio articolo Poesia moltitidine esodo in Inoltre 7, inverno 2003-2004. 16 collaboratori. I pezzi tenderanno a precisare cosa sia possibile intendere per esodo oggi. Vi compariranno pezzi teorici (su autori, articoli, saggi di riferimento per la redazione) o commenti di eventi (ad es. la guerra in Irak). Saranno frutto della discussione collettiva e faranno da editoriale, da presa di posizione comune. (In caso di vedute divergenti: se esse sono ritenute ancora dialettiche, saranno presentate apertamente; se ritenute inconciliabili, si sceglierà a maggioranza). Luoghi Non luoghi Qui vanno tutti i pezzi d’inchiesta, che riguarderanno le esperienze dei singoli o dei gruppi organizzati nelle “città” in cui abitiamo, sempre più luoghi/non luoghi [Augé] da osservare, studiare e raccontare nella loro problematica centralità o perifericità e nei mutamenti decostruttivi e costruttivi possibili in questi spazi sempre più ibridi. Dizionarietto-archivio critico di scritture semiclandestine Accoglierà le scritture più varie (appunti, scambi di lettere o e-mail, poesie, racconti, stralci di ricerche più corpose, sintesi, commenti a libri letti, diari e riodinadiari, ecc.) composte dagli scrittori/scriventi esclusi o ai margini della comunicazione accademica e massmediale. Ma non si tratterà solo accogliere e pubblicare secondo una scelta casuale o amicale. Accogleiremo e pubblicheremo a turno esempi ragionati dell’esperienza della scrittura semiclandestina in epoca postmoderna. I pezzi dovranno sempre essere accompagnati da un commento critico, affidato a membri della redazione o a collaboratori di fiducia, che mostri lealmente i limiti o le potenzialità dei testi al momento in cui sono proposti dal punto di vista dell’orientamento critico della rivista. Sulla giostra delle riviste Qui andranno pezzi (riflessioni di lettura personale) di alcune delle riviste (o di singoli numeri o articoli di esse) che i redattori seguono o ritengono importante segnalare. L’obiettivo e di costruire una mappa delle zone di ricerca da conoscere o da evitare. Appendice: scambi intercorsi con Piero Del Giudice e Andrea Boeri sull’ipotesi di una nuova rivista 1) da Del Giudice [DATA...] Caro Ennio, ti mando alcuni appunti sui primi interessi che suscita in me un lavoro comune e la fondazione di una rivista. Niente voli alti, ma molta attenzione, moti tentativi di capire. Piero D. Una rivista perché? R. Perché non conosciamo il mondo in cui viviamo D. Una rivista per i propri testi? R. La realtà come testo [da indagare] Dunque una rivista perché non conosciamo e non sappiamo muoverci, pensare, prendere decisioni nella realtà che viviamo, perché abbiamo paura la sera a camminare per le strade. Allora, almeno per cominciare: Non conosciamo, vanno indagate: a) le condizioni materiali di vita e di lavoro della gente b) sono già attive le “cooperative” dei sindacati (Cisl in particolare) che procurano forza-lavoro per qualche mesec) come vive un giovane con un lavoro che dura 4 mesi? A 800 euro al mese? d) Ma più in generale come sta dentro la vita complessiva: la sua camera, la sua cucina, la sua idea di futuro, la sua idea di “incontro”, di associazione, di “amicizia”? e) Non sappiamo quanta gente lavora per es. nella scuola. Quanti sono i contratti, le condizioni concrete di lavoro nella scuola f) Non conosciamo il mutamento del rapporto del dipendente nella azienda. Nella scuola si fa “impresa”, il giovane che ha un contratto di quattro mesi fa “impresa”, è “imprenditore” di cosa? g) Trasformazione del lavoro dipendente in una società di “imprenditori” di niente Va affermato: 1) la fine del sindacato come è 2) altre esperienze oltre il sindacato come è. Perché queste esperienze, cosa è mutato 3) la fine dei partiti. Altre esperienze oltre i partiti 4) la destra, la sinistra 5) l¹alternativa e le parole d¹ordine semplici (no alla guerra) 6) la fine della ragionevolezza 17 7) la riproposta della ragione 2) da Ennio ad Andrea Boeri: chiarimenti sull’ipotesi di nuova rivista (6 maggio 2004) Caro Andrea, sei il primo dei possibili collaboratori della rivista ad avere un atteggiamento di curiosità sul tema dell'esodo. Altri hanno subito storto il naso; e forse hanno alcune buone ragioni, anche se temo che ci sia sotto un po' di pigrizia. Un'ipotesi di ricerca: questo è per me una rivista. E non credo possibile chiarire prima di partire e in modi già del tutto convincenti che cosa intendo per esodo-esodareesodante. Posso spiegare (come ho fatto per cenni nei primi numeri di SAMIZDAT COLOGNOM) come io sia arrivato ad usare questa terminologia e da quali fonti l'ho tratta. Posso accogliere le obiezioni sulla sua "vaghezza" o "astrattezza" o "gergalità". Ad usare come distintivo il termine e a volte anche in modi scolastici questi termini è una (eterogenea e internamente differenziata) area "disobbedienti-Negri-VirnoDeriveApprodi", verso la quale ho un atteggiamento di attenzione e perplessità. Da qui l'ho ricavato. A me è servito soprattutto per fissare uno spartiacque dalla Sinistra "continuista" in cui mi sono politicamente formato. Quale? Quella che sembra credere che con qualche correzione più o meno drastica si possa ritornare a lavorare sulla vecchia strada "progressista" (insomma rioccupare lo spazio che fu del PCI o che stava per aprirsi con la nuova sinistra attorno al 68-69). Questa strada mi pare bloccata. Qui concordo con Del Giudice, anche se lui non parla di 'esodo'. L'esigenza di capire il mondo "sconosciuto" in cui ci siamo ritrovati è anche mia. Forse quello che mi distingue da lui sono tre esigenze: 1) dichiarare il punto di vista (l'intenzione) di chi si pone il compito di esplorare; 2) rimuginare il passato storico, al quale comunque dei fili ci trattengono; 3) "etichettare" la società in cui siamo (col termine di "postmoderna"). Dirmi 'esodante' segnala così anche la mia insofferenza per questo mondo "sconosciuto", la volontà di fuggirlo e di andare verso un "altro mondo" anche se non nominabile (e qui mi aspetto obiezioni del tipo : come si fa a conoscere il mondo se vuoi fuggirlo; dire 'esodo' significa sempre fissare un 'telos'; rimuginare la storia è una trappola, ecc.). Anche l'uso del termine 'moltitudine' è un segnale da indagare: equivale a frammentazione delle 'classi' o ad una loro definitiva scomparsa? La "necessità d'indagare le condizioni materiali di vita e di lavoro della gente e le conseguenti analisi sulla fine del sindacato e dei partiti come organizzazioni di rappresentanza sociopolitica di massa" cozza però contro l'enormità del lavoro che un'inchiesta richiede. Già ho avuto qualche reazione sgomenta di chi non se la sente di porsi nella prospettiva dell'inchiesta, perché sa realisticamente di essere esterno a i luoghi dove questi problemi sono realtà vissuta e pensa piuttosto di poter dare alla rivista solo un contributo di scrittura più "introspettiva". L'isolamento delle esperienze è enormemente cresciuto per molti e pone un bel problema: escludere i più isolati o meno propensi a indagare la realtà (i "poeti", ecc.) dalla rivista? confinarli nello spazio delle "scritture clandestine"? tenere un collegamento anche con questi "ghetti" in cui si chiudono difensivamente tanti degli "io atomizzati", che fanno parte della 'moltitudine' (o della "gente"?) senza saperlo, senza ammetterlo, senza volerne riconoscere il significato? FORTINI:Dieci anni dopo la morte al “Punto Rosso” di Milano 1 maggio 2004 Caro Massimo [Parizzi] spero che questo ciclo al Punto Rosso di Milano di interventi sull'opera di Fortini possa servire non a creare una piccola setta di "fortiniani", col loro corredo di citazioni e lumini votivi, ma a riprendere gli interrogativi sulla sua opera, tutta la sua opera, come giustamente richiedeva Ranchetti; e partendo dall'"attualità", cioè dalle posizioni che ciascuno di noi ha o crede di avere oggi e che potranno essere più o meno distanti dalle sue. Qui a Milano, dove Fortini ha vissuto e operato dal '45 e fino alla sua morte, intessendo una fittissima rete di rapporti, a me è parso sempre un po' indecente sul piano morale e negativo su quello politico che mai finora si sia trovata la spinta necessaria da parte di quanti l'hanno conosciuto o frequentato molto più di me per fare, non dico quanto ha fatto Siena col Centro Studi F.F e il supporto dei 18 finanziamenti universitari (su un piano accademico a volte lodevole, altre volte imbalsamante), ma "qualcosa". Cosa? Beh, un ciclo di riletture della sua opera come questo che adesso siamo riusciti a far partire. Oppure una serie di interviste più o meno a ruota libera a quanti lo conobbero o hanno sue lettere, registrazioni di suoi interventi, ecc. Meglio ancora un confronto sulle trasformazioni subite almeno da alcuni dei temi da lui più trattati e che anche noi abbiamo continuato in vari modi a trattare (intellettuali, scuola, riviste, ecc). Mi si può obiettare: ma perché insistere su una continuità, riferirsi alla sua opera, se il "suo" mondo non è più il "nostro"? Certo le ragioni del silenzio su di lui o del distanziamento dalla sua opera e dal suo modello d'intervento intellettuale e politico per molti ci sono. Berardinelli è un caso, esplicito e per me infelice: demolisce male l'antico e forse mal sopportato maestro prescindendo da considerazioni storiche e affidandosi ad uno psicologismo debolista. Ma quei pochi che accettano di partecipare a questo ciclo o hanno seguito più omeno indirettamente i lavori usciti su di lui nel frattempo (Disobbedienze, Interviste 1952-94, Saggi ed epigrammi, L'ospite ingrato, ecc.) non credo che se ne occupino per dinamiche accademiche o solo perché hanno avuto modo di conoscerlo in vita; ma perché ancora interrogati o messi in discussione dalle sue opere (e magari dal suo fantasma).Chi non ne vuol più sentire parlare (e saranno parecchi) neppure si fanno vedere. Il "suo" mondo non è più il "nostro", ma il "nostro" mondo non coincide – credo - con la cancellazione della sua opera e non s'identifica con il postmodernismo, anche quando ne riconosce più o meno criticamente la presenza (imponente) o ne subisce la suggestione. Personalmente credo di dare una relativa importanza al "tradimento" o abbandono della via da lui tracciata. Valuto semmai la "qualità", le motivazioni, le argomentazioni usate. Se in questi anni siamo stati presi da altre proposte o abbiamo battuto altre vie (Manocomete, Inoltre, l'analisi del postfordismo da parte degli ex operaisti, per quanto mi riguarda), delle ragioni serie ci devono essere. Io, che pur ho cercato di non perdere di vista la sua opera e di mantenere i contatti con Siena e di curare finché ho potuto il "fortinismo" dell'Associazione IPSILON di Cologno o di fare i miei samizdat, ho dovuto lo stesso riconoscere il mio isolamento diciamo sia dai "fortiniani doc" sia dagli "antifortiniani". Resta però il fatto, che in quest'occasione in cui ho potuto riprendere in mano per una decina di giorni i suoi scritti sul tema della guerra, essi mi hanno parlato, coinvolto, posto dei problemi. Perciò mi ha fatto piacere il tuo arrivo in Via Morigi e ho aspettato un tuo intervento via e-mail o via telefono sulla serata. Passo ai tuoi appunti. Io penso che interrogandoci su Fortini e la vera o presunta svolta di Composita solvantur, ci interroghiamo sulle nostre vere o presunte svolte. Anche noi, infatti, in vari modi partecipi del clima della "sinistra critica" (o nuova sinistra) negli anni Sessanta/Settanta, non avevamo - mi pare con l'Urss e il PCI un legame di soggezione o di identificazione. Per Fortini (mi pare abbia scritto anche Rossanda) era venuto meno un avversario che aveva un forte seguito in Italia, con il quale si confrontava e "litigava" (mentre il nemico principale rimaneva quello americano, il capitalismo americano...). Suppongo che la ragione per la quale Fortini non abbia mai scritto nulla, per quanto ne so, sugli sconvolgimenti all’est di quegli anni, pur tanto traumatici, esaltanti, spettacolari anche abbia un valido motivo: lo sconvolgimento vero (per lui, per noi) era già avvenuto prima: con la fine della Cina di Mao e lo stritolamento nel corso degli anni Settanta dell'ipotesi di nuova sinistra nella tenaglia del compromesso storico da una parte e del terrorismo (o meglio lottarmatismo) dall'altra. Quelli furono i veri traumi vissuti da Fortini (e penso anche da molti di noi). Era stata la Cina il suo "paese allegorico" ed era stata la nuova sinistra (e "il manifesto") la sua "casa politica". Quando crolla l'Urss, il coinvolgimento è minore, è da "sopravvissuto", che si vede raggiunto nella sconfitta anche da quel PCI che egli aveva vanamente e disperatamente criticato. Non credo si possa dire che il crollo dell'Urss abbia significato per lui la fine di una dialettica che, nonostante tutto, l’esistenza del blocco dell’est teneva aperta per il fatto di essere, anche se soltanto di nome, un secondo polo. Penso piuttosto che abbia 19 seguito solo con simpatia il tentativo di Gorbaciov di riaprire una possibile dialettica in una società come la sovietica che non l'aveva più. E anche quando, dopo più di vent'anni, si decide - a mio parere illudendosi e aggrappandosi al puro simbolo - a votare PCI, precisa appunto che il suo non sarà un voto alla politica del Partito comunista, ma un voto al comunismo o alla falce e martello che sta ancora nel simbolo del Partito (Interviste 52-94, p.541-2). Quando scrive la perestroica ha come prima ricaduta quella di togliere una antitesi su cui l’opinione occidentale è vissuta per mezzo secolo” (Extrema ratio, p. 101), parla appunto dell'opinione occidentale, non delle minoranze che già dagli anni Trenta avevano occhi disincantati sull'Urss. E quando dice: Ciò che è stato demolito non è il comunismo, caso mai il comunismo come parte dell’eredità dell’Illuminismo” (pag. 688 delle Interviste), il comunismo è quello che senso comune e oppositori del comunismo intendono; e cioè le esperienze del "socialismo reale", dell'Urss. Non il comunismo come combattimento per il comunismo [la definizione data su "Cuore"] che scorre dentro il terreno della società del capitale come fiume carsico, quindi non sempre visibile (e con possibilità di “inondarla”, mutandone il paesaggio). Questo è uno dei punti "oscuri", ma non trascurabili, sul quale discutere, per vedere quanto Fortini sia vicino o distante da quelli che, sconfitto il socialismo reale, accettano di ridurre il comunismo a idea, o a ideale orientativo. Un altro punto: tu scrivi: La Masi diceva che oltre un terzo degli europei sarebbero “pronti” a una rappresentanza politica di cui mancano però i “mediatori”. Perché mancano? A me sembra che “manchino” perché questo oltre un terzo non è una classe, ma “gente”. E, in quanto tale, la rappresentanza politica ce l’hanno: è questa che c’è, in Italia da Bertinotti a Di Pietro. Potrebbe essere “migliore”, e di molto, ma potrebbe essere “diversa”? Non credo. Bertinotti, Di Pietro, ecc. rappresentano solo fette di questa non-classe (la "gente", invece, è quella rappresentata soprattutto da Berlusconi). Ma il termine di "moltitudine", come tu sai, a me pare più utile, perché - si può essere d'accordo o meno con Negri, Virno e compagni - pone il problema scomodo della irrapresentabilità in epoca postmoderna di questa massa sociale che ha preso il posto della classe operaia; e ci costringe a uscire dalla logica che prima o poi essa si rappresenterà o sarà rappresentata o, come tu dici, già lo è. Qui si entra in un campo scivoloso, sul quale Fortini si è addentrato sempre malvolentieri per un’ostilità verso l'operaismo e i suoi sviluppi che egli motiva anche in modo convincente (l'ho detto a proposito della sua polemica con i "filoamericani di sinistra"). Eppure la percezione del salto avvenuto con l'implosione dell'Urss e poi con la guerra del Golfo lo porta a ritenere esaurita sia la tradizione socialista che comunista e la stessa categoria di imperialismo; e a parlare di impero. Sarebbe azzardato un accostamento a Negri, che in passato pure mi ha suggestionato. Mancherebbero solidi elementi. Ma le sottolineature fortiniane delle trasformazioni della figura degli intellettuali, l'attenzione all'ampliamento del terziario sono accostabili (magari con cautela) al discorso sul lavoro immateriale, anche se riconosco che c'è attrito, c'è altro retroterra culturale. Se Negri non si concilia con Fortini, mi pare che interrogare Fortini, dopo aver conosciuto le elaborazioni di Negri , sia un'operazione interessante. (Ho già detto che a me pare pienamente legittimo interrogare Fortini dalle posizioni che ciascuno ha o crede di aver raggiunto). Non da discepoli che ascoltano solo il maestro ma anche altri, magari avversari. Tutto sta a vedere che se ne cava e se non si travisano le posizioni che si mettono a confronto. Un ultimo punto: credo anch'io che il tema “Fortini e la guerra” sia collegabile a quello “Fortini e la Storia”, con la S maiuscola. Ma parlando di guerra, Fortini parla di Storia. E di comunismo. O credi che, se spostassimo l'attenzione sul tema della Storia, verrebbero fuori cose diverse da quelle da lui dette sulla guerra? Caro Paolo [Giovannetti], quando lessi per la prima volta "Composita solvantur" anch'io ebbi l'impressione di una "svolta" e pensai che si dovesse fare uno sforzo per rileggere il Fortini precedente da quello che scriveva in "Composita". Ma non parlerei, come dice anche Massimo, di nichilismo né di tentazione del nichilismo. Del resto tu stesso presenti il dubbio (è nichilismo?) e poi lo allontani, 20 dicendo: "mi sembra che il nichilismo lui l'abbia guardato in faccia". Allora, nella sua ultima raccolta di poesie non s’infiltra il nichilismo, ma il senso della morte imminente e personale, che è preponderante in questa raccolta, anche se il pensiero di morte è stato costante in Fortini (lo scritto sulla morte di De Martino...). La "svolta" sta forse in questo: prevale il sentire la morte più del pensarla. E ci vedo poco presente anche l'idea della trasfigurazione o della rinascita. Vedo l'allarme, la raccomadazione ai vivi data dal moribondo in punto di morte. Il nuovo ordine è più che mai solo possibilità. La morte disperde le cose composte (dal poeta, dagli uomini in lotta nel tempo storico) e questa dispersione viene accettata (sopportata). Ma non annulla le verità emerse dalla vita individuale (qui foscolianamente vengono proseguite nella memoria dei vivi, amici, ecc.), da quelle lotte collettive fissate in progetti. L'appello "proteggete le nostre verità" (su uno spunto di Marcuse) consegna ai vivi quello che è da salvare, quello che conta dell'individuo o della storia umana. Siamo, mi pare, agli antipodi del nichilismo. Il comunismo è una verità presente nella storia umana come possibilità. Quindi anche quando non è visibile, quando non c'è più un soggetto che ne fa un progetto politico o tenti di attuarlo combattendo per realizzarlo, non viene meno. Come verità s'intende, come possibilità. (Qui si dovrebbe discutere quanto questa verità in Fortini diventi o meno ideale, come accennavo prima, quando vengono meno i soggetti concreti che potrebbero portarla a maturazione. Mi pare però che Fortini ha sempre respinto il comunismo come ideale astorico....). Che le "canzonette" siano promosse a poesia-poesia dubito. O almeno l'operazione dovrebbe fare i conti con la svalutazione della poesia di fronte alla guerra ( che non è neppure più guanciale per i morti....). Sulla questione del "mandato sociale" ti smentirei: della fine del mandato sociale, Fortini parlò fin da "Verifica dei poteri" e criticò i sessantottini che avevano cercato di rianimarlo. La verità (del comunismo) va protetta perché possibile, non perché una classe dia il mandato sociale (agli intellettuali) e anche in una situazione in cui , come dici, il "reale" e l'"artificiale" si sono confusi in un pastone informe. (Ma è il caso della manifestazione di Roma per la liberazione degli ostaggi italiani catturati in Irak? Che Agnoletto stia con Tremaglia nello stesso corteo o stia col papa a me non pare scandaloso. L'elemento discriminante è il no alla guerra. Se si riuscisse a fermarla e ne traessero vantaggio anche i mercenari neppure mi scandalizzerei: quando uno sciopero ottiene un buon risultato non ne traggono vantaggio anche i crumiri?). COLOGNOM: Piccoli ragionamenti candidati a sindaco di Cologno sui 5 maggio 2004 Se voti Capodici gli speculatori di Cologno saranno felici. Ma che-cazzo-dici? Guarda chi sta dietro Capodici e ai suoi amici. Se voti il verdastro Diaco Cologno verrà inquinata più di Chicago. Ma che-cazzo-dici? Quello è il verde finto che piace a Capodici e ai suoi amici. Se voti il ragionier Lo Verso il bilancio comunale t'andrà di traverso. Ma che-cazzo-dici? Quello è la calcolatrice di Capodici e dei suoi amici. Vuoi votare l'ex assessore Losi? Ti riempirà di fesserie a piccole dosi. Ma che-cazzo-dici? Quella è la musa ispiratrice di Capodici e dei suoi amici. E se votassi Soldano il diessino? Chi l'espertino del compromessino? Ma che-cazzo-dici? Quello fa politica solo in segreto, come Capodici ed i suoi amici. Giovanotti, anziani, sani, malati lavoratori flessibili, precari, disoccupati casalinghe, innamorati, artisti, nonni, impiegati, pensionati cittadini tutti, da Milan trombati e giustamente incazzati, mandiamo a casa i suoi gregari mosci e riciclati. 21 Basta coi politici del ribaltone e del mortorio. Votiamo sindaco Beretta Vittorio. Sette slogan a rimette per fare sindaco Vittorio Beretta. 1. Io sono dell'oratorio e voto Beretta Vittorio. Io non sono dell'oratorio e voto lo stesso Beretta Vittorio. 2. Gira a piedi o in bicicletta e vai a votare Vittorio Beretta. 3. Vuoi pulizia a Villa Casati? Vota Beretta e i suoi alleati. 4. Che ogni guerra sia maledetta, a Cologno l'ha detto Beretta. 5. Un sindaco che coi cittadini decide e progetta? Vota subito Vittorio Beretta. 6. Se alla motoretta preferisci la bicicletta, vota sindacoVittorio Beretta, 7. La politica dei partiti ti va stretta? Allora vota Vittorio Beretta! Contatti/ 5 racconti di Leonardo Conti Ho conosciuto Leonardo Conti ad un convegno di riviste organizzato dalla Fondazione Bianciardi di Grosseto nel 2001. Abbiamo cominciato a mandarci reciprocamente quello che scrivevamo, concordando su un punto: la possibile importanza di una “scrittura clandestina” o “esodante” o “samizdat”, da entrambi praticata da anni e da me anche “teorizzata”. Dallo scambio epistolare a due è nata l’esigenza di collaborare. Primo passo: ospitare su Samizdat Colognom alcuni suoi scritti (5 racconti e un racconto-recensione) introdotti da un mio commento partecipe e a volte perplesso. Leonardo Conti crede ancora nel mestiere di scrivere; e intende difenderlo dai tic, dalle le furbizie, dai vizietti degli scrittori e degli scriventi (quelli in vista, quelli in ombra). Il primo suo racconto, La Repubblica della Cartalettera (parodia forse della Repubblica delle lettere o delle patrie lettere di nazionale e nazionalistica memoria...) è un bozzetto di vita di provincia: scava nel sottobosco degli scriventi poco noti o dei “potenziali scrittori” e della piccola editoria che parrebbe sostenere i loro solitari sogni. Il personaggio che raccoglie confidenze dei principianti è comprensivo, leggermente più sgamato di loro, un cordiale fratello maggiore che vorrebbe evitare delusioni e raggiri ai suoi simili: Arianna, Roberto, Furio, Danilo, le “vittime” (consenzienti però). E, senza calcare troppo la mano, bacchetta il furbetto di turno.. Giallo è il sindacato parrebbe un titolo tutto ideologico e di denuncia politica. In realtà Conti non si occupa troppo di ideologia: studia i comportamenti concreti degli individui; e vede che portano nell’istituzione – in questo caso nel sindacato (Quale? Non importa...) – passioni elementari, vitalistiche. I comportamenti, in netto attrito con l’ideologia ufficiale solidaristica ed emancipativa del sindacato, a me fanno rabbrividire; ma ammetto che nel sindacato si annidano tipi come il “calunniatore professionista”, quello che “ci va duro”, quello strumentalmente nostalgico degli anni Settanta, quelli che fanno incetta di permessi sindacali, ecc.). Come nei partiti, come nei movimenti anche rivoluzionari. Tollerati o ignorati fino a quando magari non ne fanno una troppo grossa. Allora fiocca la denuncia dell’abisso creatosi fra dichiarazioni ufficiali e pratiche concrete; e scoppia, se la situazione è favorevole (perché di solito è più favorevole al silenzio: “il sindacato non vuole vedere”), lo scandalo. Chi vede all’opera questi tipi di sindacalisti trae la conclusione: “il sindacato è morto. O meglio, è giallo”. È così? Conti a questo punto si distrae con la “grande pianura che accarezza il capoluogo toscano” e i ricordi letterari. In Mio fratello sampdoriano ritorna, spostato su un piano onirico (ma cosa non è almeno un po’ onirico in letteratura?) il tema degli odierni, e più corrotti che in passato, costumi di editori e scrittori. Bersaglio: l’editore di “libri a pago”, un ex- scrittore col suo momentino di gloria (pagato questo), piccolo rais che spadroneggia sugli aspiranti. Il tono è leggero. Fucecchio: un non luogo? È ancora un bozzetto, ma di degrado: il paese è diventato “terra di nessuno”. Conti dà voce alle umoralità viscerali e xenofobe: se la 22 prende con quanti lodano “l’incontro di culture”, standosene però “in lussuose ville nel verde”; e ti pone sotto il naso la “microstoria” del “50enne, molto attivo nel volontariato, colto a sufficienza”, che ora “si trattiene a stento dal chiamare i carabinieri”. Anche in questo racconto, come in Giallo è il sindacato, Conti tira il sasso e nasconde... il giudizio: insomma gli italiani (e non solo a Fucecchio) sono razzisti? 11 settembre 1973 è, invece, una riflessione sulla morte e sull’ipocrisia che circonda la morte dei grandi personaggi storici o semplicemente famosi. Il tocco leggero è sempre lo stesso: frasi rapide, battute che lasciano in sospeso un ragionamento complicato, allusioni. Colpisce l’affetto con cui disegna il Cile di Allende. Franco, Vittorio e il postino prende spunto dall’epistolario fra Fortini, Sereni e Giudici raccolto in Scritture private. È una recensione, ma la vena profonda di Conti è quella del narratore. Il recensore, pur riferendo puntualmente tutte le notizie essenziali, di fatto afferra spunti e se ne va per conto suo, divagando, immedesimandosi o riconducendoli al suo immaginario letterario, dominato dalle figure di Bianciardi e Cassola. Oppure difende una piccola causa che a lui sta a cuore: meglio scrivere lettere che usare Internet o incontrarsi. Cosa l’ha interessato di più di quello scambio di lettere fra Franco(Fortini) e Vittorio (Sereni)? L’abitudine consolidata di Sereni a richiedere giudizi su quello che andava scrivendo, gli accenni alle beghe editoriali, le lamentele per il poco tempo libero di cui disponeva. In genere sono gli eventi letterari ad occupare l’attenzione di Conti. E Sereni con tutta in evidenza primeggia nella sua attenzione, pur riconoscendo a Fortini il merito di essere “il maieuta giusto”. La Repubblica della Cartalettera Confesso che m’infastidisce, in alcuni scrittori e poeti che ho incontrato più di una volta, quando sottintendono d’essersi fatti da soli, come fossero giunti all’esordio – a suo tempo – e all’odierna fama grazie a contingenze climatiche. Invece, ognuno ha avuto qualche santo o una circostanza avventurata, ovvio: io, ad esempio, debbo il mio debutto editoriale ad un convegno cui, fino a poche ore prima, pensavo non sarei stato presente. La modestia dovrebbe esserci compagna, spingendoci a riconoscere il ruolo ricoperto da terzi. Ma non sempre accade. Per questo la nostra è la Repubblica della Cartalettera. Menzogna e finzione producono effetti nefasti, su persone poco consapevoli – fuor di metafora, fra molti aspiranti. A tal proposito, ricordo bene certe parole di Grazia Cherchi, che assolveva parzialmente chi, circondato da cattivi maestri e di fronte a miriadi di scelte editoriali discutibili, pigia sull’acceleratore, cerca un editore qualsiasi e, in buona sostanza, cessa di lavorare su se stesso. Coloro che abboccano alla necessità di pubblicare prima possibile, diceva (più o meno) la Cherchi, hanno visto sugli scaffali molta roba indegna e udito montagne di stramberie: quei potenziali scrittori sbagliano, non c’è dubbio; ma un po’ vanno anche capiti. Per un fantomatico ruolo di potere che, secondo alcuni, deterrei, ho avuto di fronte – nel passato recente – quattro persone il cui scopo dichiarato, prefitto o già raggiunto, consisteva nell’uscire con un libro. Storie personali diverse; dissimili i caratteri e divergenti le strade scelte: ma uguale l’obiettivo. Eccole. Un giudizio sui loro operati mi pare inopportuno. Dia il via alla lapidazione chi, in tutta coscienza, pensa si sarebbe comportato in modo opposto, dentro le loro vite. • Arianna, una decina d’anni fa, subì una violenza. Pubblicando, intendeva farsi la terapia, penso (e mi pare non abbia funzionato). Dopo un penoso scaricabarile, qualcuno se ne liberò indirizzandola a me; ma troppo tardi. Arianna, dopo tre viaggi a Milano nascosti a tutti, aveva già pubblicato il romanzo. Forse, se presa sul serio, avrebbe risparmiato i 4.200 euro che una sigla delinquente le ha estorto per un’edizione piena di refusi e senza alcun editing. • Roberto l’ho ripreso in tempo, invece. Si era fatto coraggio e m’aveva chiesto di leggere i suoi scritti. Poi, iniziai a sentirlo parlare pericolosamente di RADIORAI e svariati siti internet (“Mandateci le vostre poesie!”). Ignorava l’esistenza di riviste letterarie. Era stato messo su da qualche scriteriato, si vede, ma non fu 23 difficile posizionarlo dentro un binario di massima; dovetti solo dedicargli alcune pause-pranzo. Persona intelligente, ha capito. Ora sembra diventato l’opposto. • Furio, a monte, aveva un tarlo: diventare scrittore quanto prima, meglio se entro una settimana. Arduo, rapportarsi a lui. Contestava sistematicamente ogni mio parere, che peraltro era lui stesso a chiedermi. Nonostante fossi l’interlocutore che s’era scelto, non mi riteneva autorevole: metteva tutto sulla competizione, e non avendo io pubblicato ancora nulla, in quegli anni, non dovevo sembrargli prominente. Entrò in un ginepraio di concorsi, spedizioni e letture in pubblico. Poi, quando ebbe dato il primo esame universitario, dovette pensare d’avermi superato – sapeva della mia rinuncia agli studi. Togliersi il saluto fu semplice. Oggi auguro all’uomo Furio (lo scrittore si accoderà) un maggiore equilibrio, senza il quale i capitoli di una vita, e solo in seguito di un libro, sono fondamenta fatiscenti. • Danilo ha perso il lavoro di giornalista, presso una famosa testata piemontese, circa dieci anni fa. Adesso si occupa d’altro; non è felice, e non lo nasconde. È un grande scrittore, secondo me: la difficoltà di rientrare nel suo naturale ambiente lavorativo, però, gli ha teso un’imboscata. E ha finito con l’andare in stampa con un editore serio, sì, ma che non è il suo. Invano ho cercato d’invitarlo ad una sana attesa, ché il tempo avrebbe lavorato per lui. Spero non sia tardi, per ricollocarsi sul sentiero giusto: ma la quotidianità non lo aiuta, ed io, da solo, posso ben poco. Se stessi parlando di furbizia, dovrei però incoronare il primogenito della cartolaia di Massaruvida, rione di un comune confinante col mio. Si è stampato le poesie dal tipografo del villaggio: 300 copie – monocromia, pp. 64 – per 1.000 euro di spesa. Ha poi organizzato due presentazioni (una nel suo regno, l’altra nel capoluogo); duecento esemplari venduti, a cinque euro l’uno, e immediata partita di giro: chi non avrebbe acquistato il libro del figliolo della Fedora? Infine, ha regalato gran parte della rimanenza – e gli è pure avanzato qualcosa da tenere in soffitta, ché non si sa mai. E la mamma? Ne ha beneficiato, eccome: anche se gli zaini, quest’anno, sono rincarati del 30%, vende da matti pure lei. Giallo è il sindacato Danio m’aveva salutato; e io pensavo già a che scrittura trarre dalle sue parole. Un bel titolo? Eurostar Piattaforma: fondere l’obiettivo dei suoi vicini di carrozza al nome dell’incastellatura che lancia il treno veloce. Piattaforme: lui la stava lasciando per recarsi a parlare con un bravo regista; i tre sindacalisti erano attesi dalla loro. La meta di Danio era riagganciare la vita di palcoscenico. Fino a Lambrate, mi disse, il vagone era stato ostaggio di quello con più trattative alle spalle. Gli altri due? Di complemento. “Nooo! In qui’ ccaso lì ’un si firma!” O l’idea, a caldo, scrive noi, oppure il tempo, forse, sarà galantuomo con la penna. Quel racconto è rimasto un’intenzione; per la poca voglia di scherzare, tracciare meridiani e paralleli narrativi mi è risultato impossibile. Meglio fare il cronista. Mio ex compagno di vicende teatrali, Danio Tercolon, friulano toscanizzato, lavora ai piedi del versante di quei rilievi fiorentini che permettono già di contare le antenne dei monti pisani. Non lo vedevo da anni, e il nostro incontro empolese pochi mesi fa - mi pare, oggi, davvero destinato, mosso da una serie di combinazioni. Fui invaso, come da un fiume, per quasi un’ora. Sapeva, certo, di un sindacato succube (i veri amici non si limitano a trovarti un posto…); ma gli avvertimenti sono stati surclassati dalla realtà, grottesca. Il primo giorno una pertica umana, dall’occhio grifagno, gli intimò di scendere da un mezzo di locomozione interna: era suo. Si trattava di un delegato, calunniatore professionista di chi non fa parte della sua sigla: molti, in seguito, hanno rivelato a Danio di essere stati messi in 24 guardia sul suo conto da quel personaggio. Un ragazzo divenuto operaio a più di trent’anni e con interessi ignoti - per di più un non iscritto -: deve trattarsi per forza di un provocatore! Sottovoce, qualcuno ammette che, nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie, uno alto due metri sia d’uopo. Pare inibisca le deviazioni. E mi sciorinò tutta la fauna dei rappresentanti. La “facia de can” del coordinatore, anche presidente del Milan Club aziendale: appare di rado; quando si manifesta ci va duro, offendendo senza remissione, anche in pubblico. Il suo vice (juventino, e di un’altra parrocchia pure nella delega di rappresentanza) ha sempre in bocca i nomi dei segretari nazionali del passato. Per darsi credibilità, si vede: è delegato dagli anni settanta. Ancora? Avanti! Ode proteste furiose per cambi mansione riservati a iscritti di qualunque canto, ma silenzi assordanti quando situazioni d’emergenza coinvolgono dei senzatessera; inteso che la quota di iscrizione al sindacato deve essere versata solo tramite defalco in busta paga - non in soluzione unica, annuale, presso la sede cittadina -: “Segno che qualcuno ci mangia?”. Danio non dona il sangue con l’associazione interaziendale. Fa per conto suo. È stato richiamato alla consapevolezza anche di questo. E poi - continuò - i permessi smisurati di cui godono, senz’obbligo di giustificazione? E il fatalismo con cui hanno permesso la terziarizzazione ingresso di forza lavoro in appalto, fuor di sindacalese -, coi medesimi incarichi, stipendio inferiore e solo nella fascia notturna? Pensavo non si fermasse più. Alle corte: non danno l’esempio. “Ti fideresti, te?” No, caro Danio Tercolon che pestasti con me le tavole del Niccolini, a Firenze, nel maggio del 1987. Non mi fiderei. L’ultima - la sentii in piena tramontana -: perché la sua pensione matura anche quando si assenta per i mestieri del corpo, mentre quella del collega terziario passa da Roma per raggiungere Milano, con piattaforma o no? “Le due facce della stessa moneta. Come mai il sindacato non vuole vedere?” “Perché non c’è più” Secondo Danio Tercolon concittadino di Carlo Sgorlon, scrittore e saggista -, il sindacato è morto. O meglio, è giallo. Ciao. Ci rivedremo? Nella grande pianura che accarezza il capoluogo toscano a maestro, si aggira ancora, nonostante la decantata bonifica, qualche topo di campagna: un paesaggio, insomma, che sarebbe piaciuto molto al povero Berto Bellintani, specie quando è quasi ora di accendere lucerne. Se ci passate, alzate gli occhi verso le basse pendici ponentine, tra filari di viti e una costruzione in restauro - lì, il coraggioso dottor Carlo Pariani cercò di capire qualcosa di Dino Campana -: il chiarore flavo, a volte zafferano o paglierino, che fa da campitura al brulichio sottostante non annuncia, purtroppo, il sole dell’avvenire (lo si veda omni tempore; e poi è il punto dell’occaso), ma lo stato delle relazioni sindacali che Danio vive oltre la collina. Non calcherà più le scene; ormai passa le sue giornate là, dove i prati, come nella zona pedecollinare opposta, si sono risposati con spianate di cemento e di sassi artificiali, accostando alcune decine di vite - non importa con quale contratto. Mio fratello sampdoriano Esisterà di certo un termine tecnico per designare la mia avventura onirica di stanotte: diacronica, o forse sintagmatica. Cronopiramidale? Fatto sta che abbracciava un periodo molto lungo: mesi, anni. Come prescrivono certe teorie, la storia notturna va messa su carta appena svegli. Ed eccomi qui, allora, sui tasti alle sette del mattino. Situazione classica: ero proprietario e direttore di una rivista letteraria con casa editrice collegata. La prima a rimessa, tipico; l’altra, con tutti i volumi passati e in ponte, sosteneva il mio ottimo treno di vita e foraggiava il foglio, che era utilizzato a regola d’arte, accogliendo un po’ chiunque - con la 25 responsabilità di rubriche, al caso -, nella speranza che, prima o poi, la mia sapiente blandizie avrebbe indotto pubblicazioni di libri a pago. Funzionava: qualcuno ne aveva fatti anche sette - e pure a distanza, senza nemmeno un incontro. Non c’era tempo da perdere: se dopo un annetto il nuovo arrivato non aveva dato segni d’avvicinamento a una raccolta d’autore, lo mollavo con le prime scuse passatemi per la testa, per non cercarlo più. Amen. Una trentina d’anni indietro (nel sogno la mia vita non era così squadernata, ma il fatto era noto a tutti) i miei versi erano stati accolti da un foglio importantissimo, che m’aveva regalato prestigio e, di passaggio, sganciato 120.000 lire. Dato che il valore nominale dei soldi è da moltiplicarsi per diciotto, forchetta temporale alla mano, calcolate quanto avevo intascato… Col tempo avevo creato una nuova accademia, diciamo un castellare, un areale privato. Un’élite di fatto, autoproclamatasi tale. Esaminavo e correggevo di persona i testi destinati alla rivista, senza far controllare le bozze agli autori - era già abbastanza ricevere la proposta. Un ladro di idee. Cadevo dalle nuvole, con chiara affettazione, se mi confidavano di scrivere anche su altri periodici: la mia ineffabile spocchia dissimulava con grosse difficoltà. In occasione di serate, mi ero autoproclamato intenditore di dizione: pur essendo a digiuno di esperienza specifica, esercitavo l’ascolto preventivo degli attori, a casa mia. Un’ulteriore parvenza d’autorità: non ci capivo nulla, a dire il vero. Per leggere in pubblico le mie poesie, invece, esigevo in anticipo la lista degli altri autori invitati. Declinavo le proposte alla vista di nomi a me sgraditi, ma, in qualche caso, potevo anche esercitare il diritto di veto, manco fossi parte di quel famoso consiglio. Non ho disposto di molti elementi, stanotte, e anche facendo mente locale adesso - non saprei dirvi perché: ma nella mia vicenda apparente ce l’avevo coi bigongiariani. E n’ero convinto bene! (Davvero strano, visto che mia moglie, quella vera, nella vita, fa parte di quel novero). Com’è ovvio, ciò non m’impediva di mescolarmi a quella famiglia poetica, se di convenienza. Con sorrisini. Ai convegni intervenivo anche dalla platea, interrompendo a mio piacimento: potevo, o almeno qualcuno m’aveva fatto credere che ne avessi facoltà. Facevo di tutto per parere. Il bello è che, in certi momenti della storia, realizzavo (io, Leonardo) la mia deriva immorale. “Ma come sono potuto diventare un tipo simile?”, mi chiedevo, quasi osservandomi da fuori, sdoppiato anche lì dentro, terzo incomodo di coscienza negli eventi ad occhi chiusi. Che, poi, non mi chiamavo Leonardo Conti, lì. Né so come; però noto ora una flebile traccia (unico contatto col me reale o possibile), a responsabilità della fede calcistica di mia moglie - arieccola! -, così forte da essersi insinuata anche in questa parabola da guanciale appena trascorsa: mio fratello (mai comparso neanche per un attimo) giocava nella Sampdoria, terzino. Nell’illusione della dormita si è manifestato anche il Firenze Social Forum. Aderivo, è chiaro, ma a modo mio (per affari): banchetto in Piazza della Repubblica. Di cortei e oriane a spasso per Firenze non m’accorgevo neppure. Ma il mio capolavoro era stato un altro, davvero esemplare. Ci campavo di rendita da un lustro. Pur predicando bene e raccomandando a chiunque di non accettare compromessi con l’industria editoriale, avevo razzolato male per una volta - una sola, che volete che fosse? -, cedendo ad un famoso gruppo, proprietario anche di un gran giornale d’opinione, i diritti dello straordinario libro di poesie di un adolescente, mancato per un male incurabile. Caso nazionale, soprattutto di vendite. Quanto alla ratifica culturale dell’operazione, per parare i colpi di quanti s’erano subito spesi nel rilevare che ogni ragazzino scrive delle liriche, avevo fatto inserire l’autore, con la complicità di una testata autorevole quanto quella che un trentennio prima aveva fatto la mia iniziale fortuna, in un’indagine sulla poesia del Novecento. Il ragazzo, scherzi dell’ordine alfabetico, s’era ritrovato tra Sereni e Solmi. Un bel mafioso, eh? Fucecchio: un non luogo? Luoghi/Non luoghi? Fucecchio è uno di essi: dentro e ai margini. Dentro, perché in una zona ricca - il comprensorio del cuoio -; ma, per paradosso, ai margini: a portata di quattro capoluoghi (Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia, equidistanti) ma 26 distante da tutto, fuori dalle principali vie di comunicazione. Per questo è avvertita come cittadina isolata: scherzi della viabilità, capita a tutti i posti raggiungibili solo con un viaggio apposito. La caratteristica fisica del paese (un su ed un giù) vede accentuate in negativo le peculiarità descritte spesso, in punta di penna, da Indro Montanelli che qui nacque. In questa propaggine occidentale della provincia di Firenze, i problemi non sono in periferia: la zona oltre i confini della dignità è una parte del centro storico, in alto. Il suo degrado non ha specificità, nulla lo distingue da centinaia di altri agglomerati con guai consimili. È da rilevare, casomai, come già trentacinque anni fa Piero Malvolti, grande uomo di cultura e personaggio di spicco di Italia Nostra, ne denunciasse l’abbandono (indicando anche i rischi che, per una discutibile gestione, stava già correndo il vicino padule). A chi scrive pare che i suoi ammonimenti non siano stati seguiti, e che sia in corso, ora che lui ci ha lasciato, la classica riabilitazione. Innanzitutto, bisogna cavarsela con un bar e un piccolo negozio di alimentari: non c’è altro. E poi, l’immigrazione. Quella interna data dai sessanta ed è già alla quarta generazione. L’esterna, massiccia, è partita all’inizio dei novanta. Pochi, i fucecchiesizzati: sono stati invece gli scarsi nativi rimasti nella parte alta del borgo a doversi adattare a ritmi e abitudini di connazionali e stranieri sopraggiunti. Spiace dirlo, ma sembra che l’accoglienza non abiti a Fucecchio. A meno che non la si voglia vedere nella settimana dell’interetnia, allorché selezionatissime famiglie di varia origine preparano ed offrono ricette tipiche; o riempiamo di senso il lavoro dell’associazione Popoli Uniti, che ha sede in piena trincea ma si guarda bene dall’affrontare alcune questioni spicce, quotidiane: giù il bandone abbastanza presto… - arrivederci all’indomani, come le guardie forestali di una riserva naturale chiusa al pubblico nelle ore notturne. La sarabanda ha inizio proprio allora. Mai avevo visto cazzottate per auto parcheggiate davanti ai passi carrabili (a non brillare per educazione si distinguono anche frotte di italiani…), o un totale disinteresse per le elementari regole di comportamento in occasione, per esempio, di un trasloco. La trappola della guerra tra poveri, auspicata da maggiorenti e poteri vari, è realtà, ha funzionato alla perfezione. Prevaricare è la regola: credo che, dopo un soggiorno di un mese nella zona, l’incondizionato rispetto per il diverso sarebbe messo a dura prova in chiunque. Il fatto è che (si può dire…?) tutto si basa sulla volontaria abdicazione di chi ha scelto per mestiere la sicurezza. Certi atteggiamenti poggiano sulla certezza di non veder mai passare una divisa, quale essa sia. “Occorre tolleranza”, mi disse una signora coi gradi, un anno fa, durante un nostro acceso scambio di opinioni moralmente sfalsato a mio sfavore, perché il codice penale non prevede l’oltraggio a pubblico cittadino. Nel suo insieme, inoltre, il paese sembra davvero terra di nessuno, in alcune occasioni, vittima di una singolare amnesia civile. Che le nuove regole per iscriversi al collocamento siano discutibili, è un conto: che però il competente ufficio locale abbia chiuso per ferie negli ultimi venti giorni validi per l’iscrizione è grottesco. Altro è che l’Italia tutta, il 28 settembre scorso, sia rimasta al buio: altro che il Municipio di Fucecchio sia rimasto tranquillamente serrato per l’intera giornata! Sento tanti bei discorsi, da persone che dimorano in lussuose ville nel verde. Il bello è che gran parte di esse costituisce lo zoccolo duro della rendita di posizione di cui gode chi governa Fucecchio da decenni. Facile, abitando in collina, lodare l’incontro di culture. C’è l’onda lunga di tanti successi elettorali, nonché un margine di sicurezza, molto esteso, che permette qualunque apparente distrazione e tante facili dichiarazioni. Concludendo? Una microstoria. C’è un mio conoscente, 50enne, molto 27 attivo nel volontariato, colto a sufficienza, un impiego sicuro e nessun bisogno di antagonismi rionali. Le forze di pubblica sicurezza non gli sono mai state simpatiche, anche se ha ben presenti i motivi che spinsero Pasolini a farci riflettere sulle famiglie d’origine di poliziotti e dimostranti sessantottini. Adesso, in qualche occasione, quest’uomo si trattiene a stento dal chiamare i carabinieri. È cambiato lui? Il sistema l’ha introiettato, in qualche modo? O la coesistenza di usi e tradizioni, in uno spicchio del centro storico di Fucecchio, è davvero ardua? 11 Settembre 1973 Non mi abbonerò mai, a Internet. O forse sì, se mi sarò accorto di essere rimasto fuori da tutto. Per ora, guardo. Due giorni fa, in casa di un amico. “Vieni a vedere…”. Benvenuti nel sito Mussolini. Un cielo stellato, poi un battito un pulsare. Il Duce è qui, il Duce vive. Fanno paura anche da morti, si dice. Quindi, se un tiranno cade, e un pericoloso simbolo viene a mancare, occultarne la spoglia è automatico. Non creiamo luoghi di culto laico. Non facciamo riunire la gente intorno a una lastra. Nascondiamo lo Zar e la famiglia: fra ottant’anni, vedremo. Non restituiamo ancora il corpo di Napoleone ai francesi, è presto. Budapest, 1956. Imre Nagy, condannato - e eliminato due anni dopo, pare in Romania. E un funerale degno? Quando nessuno potrà più uscire dal P.C.I. - il Muro non ci sarà più. E gli ex sovrani del Montenegro? Restituiti fuori tempo massimo. La statua di Sissi è tornata a Trieste. Anche lei è innocua, ora. Non amo le riabilitazioni, giungono sempre quando uno è sottoterra da un bel po’. Galileo o Sacco e Vanzetti, non cambia. Non credo a certi monumenti. Qualcuno voleva innalzarlo a Bresci. No, spiacente; la statua, Bresci - che piaccia o no -, se l’è fatta da solo. Non mi piacciono i pantheon politici. Aborrisco i cadaveri fondatori della patria, gli imbalsamati. Credo a Nicola Grosa, invece. Passò anni, dopo la fine della guerra, a disseppellire i propri compagni, sistemati in fretta e furia mentre tedeschi e repubblichini incalzavano. Rifletto - o almeno ci provo. Meglio il rituale vichingo inscenato da Hitler per togliersi di mezzo o chiedere, come fece Foscolo, di essere sepolto accanto ai grandi che aveva celebrato coi suoi versi? Assenza di memoria e ricordanza pregnante: due facce di un’unica medaglia. Perché si muore, altro che discorsi. Finisce tragica per tutti, in terra, nel marmo o in aria, ma solo se si è stati importanti, pare. Carlos Gardel e Jim Morrison sono morti, anche se qualcuno ha continuato a vederli. La famiglia Romanov è mancata, anche se le figlie sono state rintracciate per anni: potevano avere così poca mira, i bolscevichi? Ma fanno paura anche dopo. A Milano, sotto falso nome, ha riposato anche Evìta. Ma pensa. E dire che Peron ha continuato a vederla anche da morta, ogni tanto. In un documentario si rivelava come la seconda moglie, Isabel - una perfetta imbecille, a quanto sembra -, fosse stata sottoposta a tentativi di trasfusione di energia positiva dalla salma di Eva. Stavano a Madrid, se non ricordo male, e il testo del filmato informava che il vecchio dittatore, all’ennesimo tentativo del genere, non vedeva la prima moglie da qualche anno. Cioè non la vedeva da morta, da qualche anno. Inseparabili. Ancora Milano, ma per me. Nei miei ricordi c’è via Dante. Era settembre; guardavo da una terrazza. Da quel paese sudamericano lungo, lunghissimo, incredibilmente oblungo, giungevano brutte notizie. Mancavano due giorni alla fine di tutto, e nessuno lo sapeva. Sotto, sfilava gente per lui, i suoi, il rame - e per l’amico poeta Pablo, che sarebbe morto di crepacuore di lì a poco. Lui aveva rilasciato a Roberto Rossellini una indimenticabile intervista, pochi anni prima. Mi piaceva. Manifestavano per lui - due giorni prima della fine di tutto. Poi, sarebbe venuta una finale di Coppa Davis, facile facile. E si litigò, in Italia: non ci si deve andare, laggiù; oppure sì, che 28 c’entra il tennis, andiamo, e smettiamola di fare confusione. È rimasto qualcosa, però. C’è una ragazza - una nipote - che è diventata famosa con i libri. Ogni anno, lo stesso giorno, ne inizia uno: di sicuro non è un caso; uno scrittore, poi, che vive in Spagna, nelle Asturie: spesso è in Italia, però, e io spero di abbracciarlo, prima o poi, perché mi sembrerebbe di stringere anche un po’ lui. Troppo spesso, per i gusti miei, viene qua anche un personaggio che non rivedo volentieri, invece. Ha gli occhiali, e non poteva diventare presidente perché non è nato negli Stati Uniti - ma non ha fatto molta differenza, questo, si è rivelato un perfetto Segretario di Stato. Da noi arriva per vedere il calcio, soprattutto, ma non ho dimenticato, proprio no, e so chi è la persona ospitata in quella tribuna coperta. Sono cresciuto con la musica di un gruppo che era scappato dal paese più lungo che largo, trovando asilo qua. Ho ridiscusso tante cose - tante! -, ma non loro. Ironizzavo, mi ricordo, sul titolo di una canzone, Fiesta de San Benito: non c’entrava nulla, ma non mi tornava, quel nome, perché non amo quel sito col cielo stellato e il cuore che pulsa. Scherzavo per non pensare a quello che gli era successo, che era già finita. C’era un segreto di Pulcinella, intanto, nel paese oblungo. Una tomba. Proibito anche non proibire, lì intorno, ma tutti sapevano. Che chi stava sotto il marmo, con quel nome falso, Eduardo Grove, era lui. Franco, Vittorio e il postino Primo esempio. Caro Franco, poco c’è mancato che stamattina, venendo meno ai miei doveri d’insegnante, non ti rispondessi addirittura da scuola. Secondo. Caro Franco, ti avrei telefonato, ma forse la carta serve meglio. È un discorso vecchio, ma che assurge a nuova attualità proprio oggi, mentre il presunto lato epistolare di massa della comunicazione telematica pare aver soppiantato la busta. Occorrerà tempo, invece (del resto, la forma scritta allontanò l’oralità, a suo tempo): all’alba del nuovo millennio, carta e penna – ammettendo pure la variabile della stampa al computer – rappresentano ancora la forma regina di prima veicolazione delle idee. Perché si dura fatica; e dove c’è sforzo alberga la poesia. Altrimenti, rimarremo ancora, o quasi sempre, nella forma. I due incipit di lettera sopracitati, destinati a Franco Fortini e concepiti da Vittorio Sereni, distano sei anni (maggio 1952-marzo 1958). Nel centro dello stesso periodo, Carlo Cassola – in misura maggiore – e Luciano Bianciardi intrattengono un notevole scambio di missive con Vito Laterza, e altri corrispondenti legati all’editore barese, in vista e all’indomani dell’uscita de I minatori della Maremma. Nello splendido volume2 in cui è stata ricostruita tutta la vicenda di quel libro-inchiesta, Velio Abati si è chiesto se quella consuetudine, e la conseguente vastità del carteggio, sia da attribuire ad un’efficienza postale “per noi strabiliante”, dato che il telefono, “unica forma alternativa, sembra essere assai parcamente impiegato”. Scritture private, il bel libretto3 che le Edizioni Capannina dedicarono nel 1995 all’epistolario che Sereni tenne con Fortini e Giovanni Giudici, pare non contraddire la tesi di partenza: non è dato sapere, a chi scrive, quanto abbiano trillato i telefoni, tra quei personaggi; certo è che Vittorio Sereni (ce ne occuperemo limitandoci ai messaggi affidati al francobollo con destinazione Fortini), non si dette regolate. Le 31 lettere proposte dalla raccolta abbracciano tre decenni esatti – l’ultima è della primavera 1982 – e risultano una scelta, ci informa una nota, delle 77 buste che il poeta di Luino fece partire. Tale pratica, quando a due persone non mancano le occasioni di incontro, appare oziosa solo agli insensibili: se niente può fare le veci di un incontro, sembra altrettanto evidente che il sedersi faccia a faccia – e non solo tra intellettuali, letterati e artisti – serva a ratificare o puntualizzare ciò che può essere avanzato e proposto solo per altri tramiti. Dai contenuti degli invii sereniani all’amico intellettuale è facile accorgersi che lo scrivente si affida all’interlocutore in ambiti 2 La nascita dei “Minatori della Maremma”, a cura di Velio Abati, Quaderni 5, Grosseto-Firenze, Fondazione Luciano Bianciardi-Giunti, 1998, p. 58. 3 Vittorio Sereni, Scritture private con Fortini e con Giudici, Bocca di Magra (SP), Edizioni Capannina, 1995. 29 ben più vasti del semplice scambio di pareri o delle reciproche considerazioni sulle rispettive opere – o di terzi. Scorriamoli. Il 27 maggio 1952, Sereni, dopo aver chiarito l’atteggiamento tenuto alcune sere prima (ci si immagina una tavolata di grossi nomi), passa a rimarcare le sottili differenze tra “canto” – ovvero la poesia – e “libri”, che in altri passi sono sostituiti dall’espressione “cose serie”. Confermate stima e amicizia, conclude con una felicissima immagine, sposata ad una considerazione: “[…] bisogna aggiungere solo che il cavallo Sereni strappa ogni tanto verso il canto mentre il cavallo Fortini strappa più volentieri verso i libri. […] non è una questione d’anime ma, in rapporto a certe occasioni, di caratteri”. Sei anni esatti dopo, Sereni inaugura, almeno per lettera, una pratica destinata a farsi consuetudine: domandare consigli sul suo materiale poetico, per alcune perplessità. Oggetto della richiesta è, in particolare, la chiusa della famosa poesia in cui s’immagina la propria morte, Le sei del mattino. Poi, prima di congedarsi, passa alle consorterie che dominano il mercato della scrittura: gli editori, dice all’amico, “si scannano tra loro persino per un libro di versi, ormai. Senza accorgersi che quelli che tirano i fili sono invece d’accordo tra loro”. Pare di sentire, in anticipo, le parole di Romano Bilenchi, che, quattro anni dopo l’inizio dell’esperienza di direzione, insieme a ... i rapporto con la televisione...Mario Luzi, della collana “Narratori” presso l’editore Lerici di Milano, definirà le grandi case editrici “fabbriche di libri”4. Un argomento tipico dell’uomo Vittorio, ovvero il poco tempo libero, fa capolino il 9 marzo 1959. Il Sereni che ci è stato restituito da decine di interviste, e che esce, quasi fisicamente, da tanti componimenti – in viaggio, o desideroso di far ritorno in località già viste –, avverte che il mondo “[…] si divide in chi ha tempo (o meglio ne dispone abbastanza) e tra chi non ne ha (o meglio non ne dispone). Io appartengo alla seconda fetta […]”. Il poeta, per l’appunto, è stato definito fedele “ai luoghi ancor più che alle 4 Dialogo con Bilenchi sul romanzo, in “Quaderni Milanesi”, Milano, I, 3, 1962, pp. 8-17. persone”5, uomo che voleva viaggiare, ancora poco prima di morire, con in mente il ritorno in molti posti (Ventisei, ad esempio, è una prosa che nasce dal ritorno in Sicilia, appunto ventisei anni dopo, per cercare tracce della sua permanenza bellica in loco); anche per darsi sofferenza, forse: ma c’è bisogno di tempo libero anche per infliggersi quella cosa lì. Il 4 aprile 1960, Sereni invita Fortini a svolgere un’inchiesta su televisione e cultura per la rivista “Pirelli”: della partita è già Giuliano Gramigna, che sul “Corriere della Sera” tiene una rubrica di critica televisiva; a Fortini verrebbe affidata la parte generale. Il futuro principe dei mezzi di comunicazione esiste da poco più di quattro anni, ma qualcuno sta già cercando di guardare oltre “Lascia o raddoppia?” e Bianca Maria Piccinino – futura esperta di moda ma, per il momento, confinata in spazi che la vedono tenere in collo cuccioli di ghepardo all’interno di improbabili trasmissioni sugli animali. Oggi che l’epopea catodica ha celebrato il suo giubileo e suggerisce per Ettore Bernabei la canonizzazione in vita – poiché ad un futuro incerto è preferibile, come in tutte le cose, il vagheggiamento del pionierismo, e pazienza per difetti e censure del caso… –, sarebbe interessante rileggersi e mettere a confronto i pareri sulla televisione che, quarant’anni fa, erano espressi da personaggi come Franco Fortini, Luciano Bianciardi, Giuliano Gramigna o Pier Paolo Pasolini. Quest’ultimo insistette sovente sui rischi che l’immaginario di ogni fruitore avrebbe corso; Fortini, invece, parve non posizionarsi mai in un canto moralistico o di difesa della letteratura in quanto corporazione. Le sorprese sono relative. Sereni non conosceva il lavoro a tavolino6; e lo dichiara anche nella lettera del 25 ottobre 1962. È come se ufficializzasse ancora, di persona e prima del tempo, quanto Grazia Cherchi, 5 Grazia Cherchi, Ricordo di Vittorio Sereni, in “Linea d’ombra, I, 2, estate 1983, p. 187, poi in Scompartimento per lettori e taciturni, a cura di Roberto Rossi, Milano, Feltrinelli, 1997, p. 247. 6 Lo ha appena scritto ne Il silenzio creativo e lo ribadirà, sedici anni più tardi, in Autoritratto: la prima prosa fa parte de Gli immediati dintorni (1962), l’altra de Gli immediati dintorni primi e secondi, edizione accresciuta del 1983 (entrambi i volumi escono a Milano, per i tipi del Saggiatore). 30 molto dopo, dirà7 del suo modo di procedere, informando che la chiusa di Intervista a un suicida le era stata sottoposta dal poeta un paio d’anni prima dell’uscita8 e definendo questa caratteristica “lenti accumuli”. Come capiterà ancora spesse volte, Sereni si duole del proprio modo di portare avanti e a compimento il lavoro (tempi compresi), ponendosi anche dubbi sulla sua utilità. Fortini, invece, è connotato come un tenace, spinto “alla totalità o piuttosto all’organicità”: persona che non avrà fallito anche senza più scrivere alcunché. Pochi giorni, 18 novembre 1962, ed ecco una nuova lettera. L’attenzione di Fortini deve stavolta incentrarsi sulle poesie che comporranno Gli strumenti umani, volume che uscirà quasi tre anni dopo9. Molte i consigli chiesti, sia per singoli passi come sull’opportunità di fare uscire o meno alcuni testi. In particolare, è sollecitato un parere sull’inserimento di Sopra un’immagine sepolcrale; ovvero: Sereni, tra i massimi poeti italiani del Novecento, apre alle critiche uno dei suoi componimenti più celebri, quello delle “lagrime e seme vanamente sparso”. Una straordinaria lezione di umiltà, per tutti. Il 20-21 aprile 1963, il poeta si impone di rispondere, con una missiva lunghissima, alla corposa corrispondenza fortiniana ancora inevasa. Si intuisce che, tra i due, è in corso un gran dibattito: l’oggetto, stavolta, è la rivista trimestrale “Questo e altro”, cui Sereni ha dato vita un anno prima con Geno Pampaloni, Niccolò Gallo e Dante Isella10. Pare che Fortini non gliene faccia passare una; e il poeta, chiamato a dissipare le perplessità dell’amico, si spinge ad affermare come “Questo e altro” non sia un fenomeno consolatorio o uno strumento delle ambizioni redazionali. La lettera è lunghissima; c’è da scommettere che le tre di Fortini siano state zeppe di domande e richieste di chiarimenti. 7 Grazia Cherchi, Ricordo di Vittorio Sereni, cit., p. 187, poi in Scompartimento per lettori e taciturni, cit., p. 248. 8 Ovvero nel 1963, all’incirca, dato che Einaudi pubblicherà Gli strumenti umani nel 1965. 9 Vittorio Sereni, Gli strumenti umani, Torino, Einaudi, 1965. 10 Ne usciranno otto numeri, fino al 1964. È giusto ricordare anche la presenza di Giansiro Ferrata e di una nutrita pattuglia di giovani: tra gli altri, Piergiorgio Bellocchio, Emilio Tadini, Grazia Cherchi e Giovanni Raboni. È probabile che Franco, nel corso di quell’anno, abbia chiesto a Vittorio di formulare una sorta di dichiarazione di poetica. Ce lo fa pensare quanto Sereni spedisce l’8 dicembre, allorché sottolinea che ciò può significare solo “[…] una tendenza o una tensione del momento” (ma pure che, se chiamato ad esprimere condizioni d’animo diverse, lo farebbe senza esitazioni). Come spesso gli accade, il poeta sembra un po’ in difficoltà, vestito di panni altrui, quando viene sollecitato a parlare di sé e delle poesie che scrive. Il 30 dicembre 1963, a sera, Sereni si accorge che è tardi per andare al cinema o invitare qualcuno. Dunque, si mette a scrivere. A chi? A Fortini! Tra le righe, pare leggersi la perplessità di fronte a quanto, da qualche mese, ha preso corpo col Gruppo ’63 (che comunque non viene nominato): secondo Sereni, la parola è insostituibile, così come tono, giro di frase e piega sintattica. Un salto di quattro anni (10 luglio 1967) e scopriamo alcuni curiosi retroscena del Premio Strega. Fortini è messo al corrente dei tre motivi che, con ogni probabilità, hanno determinato la mancata vittoria di Raffaello Brignetti e del suo Gabbiano azzurro – che si imporrà nel Viareggio, comunque –: Pietro Citati ha imbucato in ritardo, “e nemmeno per espresso”, la busta contenente la scheda; un altro giurato, di cui non si fa il nome, ha spedito il voto direttamente a casa Brignetti (!); lo stesso Fortini, infine, non ha fatto pervenire la preferenza – ma, per una serie di sottintesi, non è chiaro se sua sponte o per un disguido postale. È curioso, poi, come Sereni faccia da involontario intermediario tra Anna Banti e Fortini. Accade in due occasioni agostane: nel ’67, Vittorio informa Franco che la scrittrice lo vorrebbe in “Paragone”. Due anni più tardi, invece, lo sollecita a chiarire di persona con la Banti una situazione che va facendosi spinosa a causa di una mancata risposta. Curiosamente (o forse no…), l’amico ricorda in entrambi i casi a Fortini l’indirizzo della scrittrice. A ondate, torna il tema del forte disagio che Sereni sta provando in Mondadori. Le righe dell’8 settembre 1967 ne sono un paradigma: il poeta soffre terribilmente la propria incapacità di concentrarsi sulle amate letture – o semplicemente su richieste amicali – in presenza di periodi di annullamento e angoscia determinati dalla concomitanza con 31 impegni lavorativi assillanti (e c’è un termine, “maciullato”, che la dice lunga). Tenta di darne la colpa ad un eventuale carenza di interesse o, addirittura, di fanatismo, ma il primo a non esserne convinto sembra lui stesso. Il 27 agosto 1972 (all’improvviso, potremmo dire, almeno per quanto riguarda il contesto del carteggio) è Sereni a dare suggerimenti. Al centro della lettera è Questo muro, raccolta poetica di Fortini che uscirà l’anno seguente. Strofe e titoli delle sezioni a parte, ciò che agita Sereni è un dubbio: Fortini ha o no affidato al verso quanto potrebbe essere meglio espresso in prosa? Non si snatura la poesia, così? Ad ogni buon conto, Franco può andare orgoglioso del libro che sarà, secondo Vittorio. Scritture private, nella parte finale (siamo già negli Ottanta, al poeta da vivere resta ormai poco), ospita parecchi dibattiti a due su autori da rilanciare o far esordire, nonché alcuni ringraziamenti reciproci. E Sereni, il 14 novembre 1981, definisce l’amico “il maieuta giusto”; come certificando un ruolo. Se il punto e virgola, come qualcuno ha detto, è la sentinella della letterarietà, Fortini, per decenni scolta (parola che Sereni ha spesso usato) di lettere e dibattiti, personalità vigile, attenta, concentrata sul quotidiano, può ben essere inteso come quel segno ortografico: una pausa necessaria – più del solito –, per riflettere e non chiudere ancora. Un punto e virgola, Franco Fortini: a beneficio di tutti. PER L’ESODO / Memorie: Danilo Montaldi Danilo Montaldi, Bisogna sognare. Scritti 1952-1975, Cooperativa Colibrì 1994 L’immaginazione Montaldi proletaria di Danilo Sintesi - 1. Notizie sul libro; 2. Storia e biografia; 3. Temi degli “Scritti”; 4. Sul titolo degli “Scritti 1952-1975”; 5. I caratteri dell’immaginazione proletaria di Montaldi; 6. Il riferimento di Montaldi alla rivoluzione russa; 7. I suoi contatti con la Francia; 8. L’immaginazione proletaria di Montaldi ha un suo luogo: Cremona; 9. Montaldi e la cultura di sinistra; 10. Su alcune ombre dell’immaginazione proletaria di Montaldi; 11. Conclusioni: La mia lettura degli “Scritti 19521975”. 1. Notizie sul libro Fu pubblicato nel 1994, curato da un collettivo redazionale composto da Cesare Bermani, Gabriella Montaldi-Seelhorst e dal Centro d’Iniziativa Luca Rossi di Milano. Accoglie, ordinati cronologicamente, 104 scritti, vari per lunghezza e genere recensioni, presentazioni di mostre, commenti di documentari, articoli -, che erano stati composti da Montaldi fra 1952 e 1975, anno della sua morte, e fino a quel momento inediti. Il volume è completato da una puntuale Cronologia della vita e delle opere di Montaldi e da un’Appendice con 8 documenti del Gruppo di Unità Proletaria di Cremona. Esaminati per anno, gli scritti più numerosi si concentrano nel triennio 19571959 (rispettivamente 11, 22 e 10). Dal 1962 si diradano e per diversi anni (1963, 1967,1968,1970, 1971, 1973) mancano. Si tratta di vuoti dovuti ad altri impegni (Militanti politici di base, ad esempio, è completato nel 1969 e pubblicato nel 1971, anno in cui viene anche finito il Saggio sulla politica comunista in Italia). Poco so dell’effettiva circolazione del volume o della sua ricezione in ambienti militanti o ufficiali. 2. Storia e biografia Sarà bene ricordare schematicamente lo sfondo del periodo storico in cui vive e opera Montaldi. Si parte dal fascismo; a seguire, Seconda guerra mondiale, Resistenza, fondazione della Repubblica, fine della coalizione antifascista, conflitto di classe nelle campagne tra 1949 e 1950 - e riforma agraria -, egemonia della Democrazia Cristiana, crisi del 1956 nella Sinistra, miracolo economico (1958-63, con la fuga dalle campagne e le profonde trasformazioni sociali dovute all’industrializzazione del paese), la crisi del luglio 1960 che avvia il periodo del governo del centro sinistra (195868) e, infine, “biennio rosso” (1968-69) e strategia della tensione. Ebbene; se, per comodità d’analisi, suddividiamo la vita di Montaldi in 4 periodi: 1) la formazione giovanile nel cremonese (1929 – 1952), caratterizzata da 32 subito in senso proletario e di militanza comunista; 2) i rapporti extra-cremonesi, soprattutto con Parigi e con le riviste italiane (1953 – 1956); 3) quello in cui contatti e ricerche personali confluiscono nella stesura delle sue opere principali e nella militanza del Gruppo di Unità Proletaria di Cremona (1957 – 1966); 4) quello, infine, che va dalla costituzione del Gruppo Karl Marx alla morte (1966 – 1975); vediamo dove biografia e storia tendono ad incrociarsi e come si delineano chiaramente alcuni punti chiave della sua figura. A me paiono i seguenti: - Montaldi è rimasto fedele ad un nucleo della sua formazione giovanile, proletaria e comunista. Importanti, in tal senso, sono le origini della sua famiglia, la precoce contrapposizione al regime fascista (maturata anche per la persecuzione subita dal padre), il rapporto con Giovanni Bottaioli, suo vero maestro di politica proletaria (1946); - egli maturò un suo principio etico e politico di fondo: “stare vicino al proletariato”, con coerenti scelte di vita e una selezione accurata (al limite del settario) dei suoi contatti politici e culturali (questi sì: il gruppo olandese Spartacus e Socialisme ou Barbarie, ad es.; questi no: Sartre, Camus, “il manifesto”, ad es.); - con il Gruppo di Unità Proletaria e poi col Gruppo Karl Marx, ma anche fondando la galleria d’arte Renzo Botti, riuscì a fare di una certa Cremona dei suoi anni non un “luogo esemplare” ma, sfuggendo ad ogni localismo, un punto di transito per “una concreta attività proletaria, con i suoi momenti di passione e di crisi”[qui ed altrove caporali], dovunque essa emergesse: nelle campagne, a Parigi, fra gli immigrati della metropoli milanese o in mezzo alla “nuova classe operaia” emersa dalle lotte del ’68-’69. 1) Il periodo della formazione giovanile nel cremonese (1929 – 1952), subito caratterizzata in senso proletario e di militanza comunista. Non solo sono proletarie le origini della sua famiglia, ma precoce è la sua contrapposizione al regime fascista, vissuta direttamente attraverso la persecuzione del padre (1941) e la propria autonomia, che lo spinge a studiare da autodidatta quello che gli interessa (abbandona infatti la scuola dopo la prima liceo, nel 1946) e ad impegnarsi presto in un apprendistato politico nel clandestino Fronte della Gioventù (1944), nella dissidenza del PCI del dopoguerra e nel fondamentale rapporto con Giovanni Bottaioli, vero suo padre spirituale proletario (1946), mentre già si fa strada la sua passione per la cultura francese, letteraria e cinematografica (1950); 2) I rapporti extra-cremonesi, soprattutto con Parigi e con le riviste italiane a cui comincia a collaborare (1953 – 1956). Il primo viaggio a Parigi di Montaldi è del 1953: poi, s’intensificano la collaborazione militante a Battaglia comunista, a Prometeo[per me va bene.. nomi di riviste in corsivo], i contatti con il gruppo olandese Spartacus e Socialisme ou Barbarie (1953), l’interesse per la poesia operaia (1955) e le collaborazioni a “Ragionamenti”, “Questioni”, “Opinione” e “l’Avanti” (1956); 3) Quello in cui contatti e ricerche personali confluiscono nella militanza nel Gruppo di Unità Proletaria (1957 – 1966). Può essere considerato il suo periodo della maturità. L’azione svolta a Cremona con il Gruppo di Unità Proletaria, in collaborazione (1957) con il Partito Comunista Internazionalista - ma anche con altre formazioni a livello internazionale -, è la prova della sua scelta organica di “lavorare coi proletari” (ossia in posizione autonoma rispetto al movimento operaio ufficiale). Ma altrettanto organiche sono altre scelte: una passione per la bellezza, l’arte e la musica (non “perdere il senso della musica di Mozart”, nel 1958; la sua scoperta della pittura di Cosme Tura e Francesco del Cossa (1962); il suo rapporto col pittore Guerreschi); non piegarsi al mito della carriera o della professionalità (il rapporto di collaborazione, e poi di redattore, alla Feltrinelli, iniziato nel 1960, si conclude per sua volontà nel 1962, anche se pesanti diventano le sue condizione economiche); tenersi a debita distanza dai luoghi “dove si elaborano le riviste politiche come opere d’arte”, svelando tutta la sua insofferenza all’ambiente intellettuale, e milanese in particolare (1959, 1962); entrare, invece, in contatto con gruppi che fanno agitazione sociale in ambienti proletari (1960); il consolidarsi del suo legame culturale e storico con Cremona (“per noi la Lombardia è quella”, 1963), dove fonderà, nel ’65, la galleria d’arte intitolata a Renzo Botti; 4) Quello che va dalla costituzione del Gruppo Karl Marx alla morte (1966 -1975). È 33 un periodo di nuove aperture al clima di lotta di quegli anni anche sul piano internazionale: comprende la preparazione del lavoro d’inchiesta sulla «nuova classe operaia» (1974), ma anche il consolidamento culturale e uno studio più appartato. S’intensifica il suo lavoro di traduttore (1965), arrivano le amarezze per i rifiuti della Feltrinelli di pubblicare il Saggio sulla politica comunista in Italia (1973). 3. Temi degli “Scritti” Li suddividerei, anche se spesso s’intrecciano fra loro, in quattro distinti blocchi: 1) quelli che riguardano la rivoluzione russa e lo stalinismo (che trattano la questione dell’organizzazione di lotta del proletariato); 2) quelli riferibili al suo rapporto con la Francia e la cultura, ufficiale e dissidente, della sinistra francese (si potrebbe parlare di un “risciacquare i panni della sua immaginazione proletaria nella Senna”, che dà slancio al progetto di ricerca militante perseguito nelle sue opere); 3) quelli legati a Cremona e al significato culturale e politico, ma anche intimo e personale, che la città e la sua storia hanno per lui (e qui si dovrebbe parlare di radici “mobili” dell’immaginazione proletaria di Montaldi, attento alle trasformazioni dei contadini che si fanno proletari, immigrati, nuova classe operaia o operaio-massa); 4) quelli, direi ossessivamente numerosi soprattutto negli anni CinquantaSessanta, riferibili alla critica della cultura della sinistra ufficiale, italiana e francese (che è poi critica, per lui, della cultura nazional-popolare, cioè nazional-borghese, ovvero stalinista, nonché ipotesi, complementare e alternativa, di una cultura proletaria). 4. Sul titolo degli “Scritti 1952-1975” Trovo il titolo del volume, Bisogna sognare, che sembra suggerire un Montaldi dedito ad un costruttivismo assoluto da “immaginazione al potere”, troppo sessantottino, unilaterale e equivoco (Già Baczko, studioso dell’utopia, fece notare che l’immaginazione era da sempre al potere11). Nell’immaginazione di Montaldi hanno, infatti, grande rilievo la memoria storica del proletariato rivoluzionario, i problemi complicati - e rimasti irrisolti - del rapporto partito-classe operaia e l’inchiesta sociale partecipe, profonda (la raccolta di storie di vita non è un’intervista!), che mira ad una trasformazione culturale dei soggetti implicati. E la sua concezione proletaria della cultura mi pare sia rimasta esterna e ostile forse ai processi e alle teorie che già si delineavano nell’industria culturale dei suoi tempi - e che hanno poi prodotto l’attuale inflazione di immaginario. Non so neppure quanto avrebbe potuto condividere l’enfasi sull’autonomia e la funzione unicamente creativa dell’immaginario sociale di studiosi come Castoriadis, Lefort e Morin, pure a lui vicini e presenti alla sua riflessione. Non per caso Montaldi riprende quell’indicazione “Bisogna sognare” dal Che fare? di Lenin, che mai e poi mai può essere ridotto a cultore dell’immaginazione sciolta da ogni vincolo materiale e sociale; e, d’altra parte, in questi stessi scritti, Montaldi dichiara apertamente il suo rifiuto di “giocare una parte di sognatore… suo malgrado” (1956, p. 73)[forse si possono eliminare], distingue il sogno della sua generazione da quello della precedente (di un Lombardo Radice), per la quale “dire la verità era diventato antistorico”. Egli intende, cioè, che il pur necessario sognare non si riduca a “un’altra esperienza religiosa”, ma si accompagni ad un “lavoro nuovo ad ogni livello”, a “una opportuna rilevazione di dati, condotta spregiudicatamente, nella tal fabbrica”, a “una seria elaborazione della cultura di sinistra su basi scientifiche” (e siamo nel 1965). Troppo forte è in lui, infine, il sospetto per l’estetismo, per i modi letterari di concepire la vita, la politica e la società, anche se apprezza il surrealismo (teniamo presente, però, che in quegli anni siamo lontani dall’inflazione di quel “surrealismo di massa” o “snobismo di massa” che Fortini stigmatizzerà alla fine degli anni Settanta). 11 B. Baczko, Immaginazione sociale, Encicopedia Einaudi, Einaudi, Torino, 1979, pag.55. 34 5. I caratteri dell’immaginazione proletaria di Montaldi L’immaginazione proletaria di Montaldi (insisto sul proletaria) ha perciò caratteri storici specifici di quell’epoca. Innanzitutto è legata ad una realtà sociale dove le contrapposizioni di classe erano più verificabili (da chi voleva farlo, ovviamente); e c’era davvero una classe operaia numericamente in crescita e sindacalmente in ripresa, che s’imponeva anche come problema culturale all’attenzione pubblica. Allora forse si poteva davvero sognare con qualche speranza in più e qualche rischio di delirio in meno, rispetto all’oggi in cui siamo immersi in un’enigmatica moltitudine (termine che so controverso, ma che assumo almeno per intendere che non c’è più la classe operaia come la si pensava allora), di cui non sappiamo se e in cosa sia erede di quella classe operaia o se sarà invece un suo surrogato, sintomo del declino di un’alternativa di liberazione in dimensione mondiale. L’immaginazione proletaria, che emerge in questi scritti, ha dunque una base reale per tutto il periodo che va dagli anni Cinquanta al ’68-’69; e Montaldi può polemizzare con ottime ragioni - da posizioni quanto si vuole minoritarie ma non fragili con la sinistra e la sua (potremmo dire) immaginazione borghese (patriottica, stalinista, burocratica). Essa ha due caratteristiche: non è individualistica ed è giovanile, vigorosa, aperta all’utopia. Non è, infatti, quasi mai solitaria (tranne in uno degli scritti; ne parlerò più avanti…). Scrive: “mi accorgo che in tutte le cose che ho fatto ho sempre favorito l’espressione degli altri, dei vicini, dei compagni che sono andato a cercare” (cfr. pag. XXV), e delle prove di questo primato del contatto cooperativo con gli altri informa le sue stesse opere, da Autobiografie della leggera a Milano, Corea, è documentata dal fittissimo epistolario ed ha segnato le vicende del Gruppo di Unità Proletaria e del Gruppo Karl Marx. Se, come ha di recente scritto Sergio Bologna, rifacendosi al sociologo tedesco Hans Speier, “non si è automaticamente proletari, si vuole esserlo, non si è ceto medio, si vuole esserlo. Il problema dell’identità è un problema di abitudini mentali, che solo in parte hanno a che fare con “condizioni oggettive”, quantificabili”12, la volontà di Montaldi di essere proletario assieme ad altri proletari (un proletario colto, un proletario che si costruiva le sue basi culturali nella memoria rivoluzionaria), bisogna dire, senza cadere in vecchi determinismi, che essa ha anche una base materiale reale e specifica. Si potrebbe affermare che, a partire dalle stesse condizioni familiari e dai contatti che egli intesseva sia a Cremona che altrove (e in quelli che rifiutava…), a lui riesce “più facile” essere proletario, a differenza di tanti intellettuali della sinistra del tempo; e quindi gli riesce “più facile” sfuggire alla lusinga del nazional-popolare stalinista, scegliere per maestro un Bottaioli, cioè un ex bracciante e piastrellista, che un Lukács o un Adorno, non cadere nell’identificazione partito-classe che rimproverava ad un Lombardo Radice, ad una Rossanda, ad un Sartre. Montaldi, morto purtroppo abbastanza giovane, pur avendo una memoria da elefante e avendo digerito altre sconfitte, innanzitutto quella della Resistenza, è stato esentato però dal vedere la degenerazione di tutta la cultura “dissidente” del ’68-69, ma anche la marcescenza dell’URSS e il trionfo – imperiale o imperialista – del “turbocapitalismo”. Avrebbe ribadito, adesso, quanto detto nel 1960, confermando quella sua fiducia nella classe “che sa sempre riprendere il filo e ricreare la propria avanguardia, e sa trasformare alla fine ogni sconfitta in una nuova ragione per continuare”? Non possiamo dirlo, ma la sua tenacia e il suo entusiasmo andrebbero salvati in qualche modo dallo scetticismo della nostra vecchiaia. Non è detto che l’immaginazione proletaria non possa fermentare sicuramente, in altre forme e in altre lingue, anche nella nuova dimensione imperiale o neoimperialista. 6. Il riferimento di Montaldi alla rivoluzione russa Da questi scritti emerge quanto il mito positivo della Rivoluzione russa si sia conservato intatto in lui. Montaldi accoglie persino nel linguaggio quella che possiamo definire senza giri di parole una retorica 12 S. Bologna, Per un’antropologia del lavoro autonomo, in Il lavoro autonomo di seconda generazione, Feltrinelli, Milano, 1997, pag.99. 35 proletaria, quasi majakovskiana. Tre stralci a mo’ di esempio: “Violentemente sgomberata da mani proletarie, da quel macabro parassitismo “versagliese” (130?); “L’operaio, anche singolo, che è il prodotto di questa trasformazione sente soprattutto se stesso come massa che ha un mondo da conquistare”(118); “la democrazia esiste ma là dove le masse proletarie dai milioni di teste prendono esse stesse nelle loro mani callose il martello del potere per picchiarlo sulla nuca della classe dominante” (1955, 54). La rivoluzione russa sembra poter entrare di peso nella misera storia italiana com’è entrata nell’immaginazione e nella stessa biografia di Montaldi. Egli manifesta più volte entusiasmo nella possibilità di “ricominciare tutto dalle fondamenta”, come gli pare stia accadendo in Polonia o in Francia “presso quei gruppi marxisti” di cui cerca di portare conoscenza in Italia (145). Certo dà sostanza alla sua immaginazione con tanti riferimenti teorici e storici (Lenin, il Partito Comunista d’Italia, la critica al trotzkismo, il richiamo a Rosa Luxemburg). La stessa sconfitta della Resistenza, letta in coerenza col suo pensiero come “fatto di classe” (1955, 56), pesa su di lui, ma non gli impedisce di pensare che la possibile rivoluzione proletaria debba avvenire nel solco della rivoluzione russa. Da qui il suo proposito tenace: “Rimarremo vicini al proletariato, a continuare nella resistenza quotidiana ad opporci a coloro che hanno ingannato e tradito gli operai i soldati i contadini” (1955, 58). Oggi, in tempo di revisionismo storiografico e memori dei toni caricaturali e tragici che assunse quel mito negli anni Settanta , è fin troppo facile sorridere di questo insistere di Montaldi sui soviet, Lenin, il partito. Le pagine degli Scritti dedicate all’argomento appaiono sicuramente datate. Tuttavia sottolineerei la differenza fra le prese di posizione di Montaldi sulle questioni della Rivoluzione russa e quella dei gruppi postsessantottini che pure vi si richiamarono (differenza che smentisce, mi pare, il tentativo compiuto a suo tempo da Stefano Merli di fare di Montaldi, da una parte, il continuatore del filone socialista e, dall’altra, il padre spirituale della nuova sinistra italiana). Il richiamo a Lenin di Montaldi, infatti, non è mai diventato “leninismo” (cfr. pag. 168). Il Lenin che affiora negli Scritti è quasi capovolto rispetto a quello che serviva al PCI di allora e ai gruppi dirigenti delle formazioni extraparlamentari per imporre “la linea”. Parlando della questione della disciplina, Montaldi ricava da Lenin l’insegnamento che non si deve mai impedire e soffocare la discussione (1958,168). Oppure sottolinea: “dice Lenin che il socialismo dev’essere introdotto nella classe operaia dall’esterno; ma non dice dall’alto, dice dal basso” (1958, 191). Montaldi poi in questi Scritti lascia capire che il rapporto partito/masse è qualcosa di ambiguo, importante e non del tutto importante. Il partito per lui è una “una forma contingente necessaria finché esiste la società borghese” (83), ma scrive anche che “per gli operai [il partito] è molto di più, e anche molto di meno”, poiché “oggi gli operai possono occupare le fabbriche credendo di farlo in nome del partito ma l’importante, diceva Marx, è ciò che gli operai fanno, non quello che credono di fare (83)”. Insomma, pur datato nel linguaggio, resta il fatto che la pratica di ricerca di Montaldi mal si concilia con il pedagogismo da partito o partitino - e che la sua riflessione si arrestava prudente di fronte alla schematica riproposizione negli anni Settanta del partito “rivoluzionario”. Ciò vuol dire che quel mito non operava necessariamente a senso unico e che, dall’esperienza proletaria e sociale, Montaldi sapeva trarre correttivi per la sua immaginazione pur così fortemente proletkult. 7. I suoi contatti con la Francia Il viaggio a Parigi che Montaldi, ventiquattrenne, compie nel ’53 non è una trasferta di formazione, ma di consolidamento dal vivo di precedenti contatti. Poi, di riconferma del suo muoversi in una dimensione internazionale, pur rimanendo Cremona luogo centrale e vitale del suo lavoro militante. A Parigi, Danilo legge, s’informa, vede gente, è attento a certe riviste francesi del dissenso che pongono l’esigenza di tornare ai principi fondamentali del marxismo: sono posizioni degli anni ’60, forti, vive e comuni a minoranze che stavano uscendo dall’isolamento. L’influsso di quella cultura è senz’altro determinante in generale; ma da essa Montaldi seleziona con cura i riferimenti e le posizioni coerenti con la sua visione. Apprezza Naville, che “riafferma la validità della prospettiva marxista” (1957, 131), si 36 conferma nel pensiero dialettico contro ogni metafisica che vede “da una parte tutto il bene e dall’altra tutto il male”, estende la sua critica alla cultura della “Gauche”, sorella della Sinistra italiana con cui egli già era ai ferri corti (1956,74), esaminando l’opera dei “mandarini” (come Sartre, Camus, Jeanson, Merlau-Ponty) e “prendendo “il partito delle masse” (75). Conferma dunque quel suo taglio proletario d’intervenire nel mondo degli intellettuali, che a volte è anche posa, diciamocelo, ma in lui è pratica coerente di vita, al limite del sacrificio che sempre comporta ogni militanza. In questo Montaldi è vicinissimo al costume morale se non al pensiero religioso della Weil, di cui riprende, come fossero sue, le parole di Riflessioni sulla guerra:“l’impotenza in cui ci si trova a un dato momento non può mai essere considerata come definitiva, non può dispensare dal rimanere fedeli a se stessi, né scusare la capitolazione davanti al nemico, di qualunque maschera si vesta. E sotto tutti i nomi che può assumere, fascismo, democrazia o dittatura del proletariato, il nemico principale resta l’apparato amministrativo, poliziesco e militare; non quello dall’altra parte, che non è nostro nemico se non in quanto è il nemico dei nostri fratelli, ma quello di questa parte che si dice nostro difensore mentre ci rende schiavi. In ogni circostanza, il peggiore dei tradimenti possibili consiste sempre nel sottomettersi a questo apparato e nel calpestare, in se stesso e negli altri, tutti i valori umani per servirlo” (1957,120). E un altro suo strumento per prendere le distanze da Sartre è ancora una volta la memoria: contro il Sartre (‘56?) che “nega una memoria di classe del proletariato”, Montaldi, che a quella è fin da ragazzo legato, insiste sul valore della “memoria attiva per la quale basta solo un vecchio operaio per atelier, o la lettura di un vecchio articolo o un racconto orale, e di cui si è perso il senso”. Crede al ruolo delle “minoranze rivoluzionarie” che “esistono dentro e fuori i sindacati e i partiti, che consapevolmente o inconsapevolmente cercano di superare” (84). La memoria è per lui campo di battaglia (come per noi oggi alle prese col revisionismo storiografico): si tratta di riconquistarla, poiché la si è persa. Scriveva nel 1958: “I fatti storici del passato sono visti come avvenimenti archeologici, che non ci appartengono, che fanno parte di qualcosa d’altro che non siamo noi: la Comune, la Rivoluzione russa, la Rivoluzione spagnola non vengono ricordati come fatti delle classi, quindi continui, quindi impliciti nello sviluppo della classe, quindi ripetibili in altre, adeguate forme anche in un avvenire di cui si affronti la prospettiva; sono considerati come ”passato”, come passato remoto” (1958,190). Sottolinea poi anche l’astrattezza di quel pensiero di Gauche che “quasi mai tende a diventare azione” (75), è una cultura che “non si fa momento di una politica”, “se mai la Gauche vuole influenzare solo coloro che nell’azione già si trovano immersi”, “se mai solidarizza con certe manifestazioni della vita proletaria, ma altre più particolari, più interne, le sfuggono e non le comprende” (76). Sarebbe opportuno oggi - fatte le debite differenze di epoca e di problemi confrontare questo “risciacquare i panni nella Senna” di Montaldi con altri risciacqui fatti successivamente da quanti hanno partecipato ai movimenti del ’68-’69 e del ’77. C’è da dire che l’ipotesi di abbandonare il marxismo in Montaldi è del tutto assente, mentre noi siamo stati posti di fronte a questo problema. Si può supporre che sarebbe rimasto estraneo a tutti gli sviluppi che vanno da Foucault a Deleuze e Guattari, al Negri di Marx oltre Marx? Non so. Il problema di quanto abbia inciso il rapporto con la cultura francese su Montaldi e quanto la sua immaginazione proletaria si sia difesa dalle posizioni dominanti d’allora (Sartre innanzitutto), o quanto egli avrebbe condiviso, se non fosse morto, gli sviluppi “postmoderni” dei membri di Socialisme ou Barbarie, è una questione interessante, complessa, ma che non può essere qui affrontata. 8. L’immaginazione proletaria di Montaldi ha un suo luogo: Cremona Ma dove in questi scritti davvero l’immaginazione proletaria mostra tutto il suo fondamento materiale e vissuto è nel lavoro che il Montaldi maturo ha svolto a Cremona, luogo - ribadisce ancora nel 1965 (in una 37 lettera a Monica Suter) - non felice, semmai tragico come “quel paesaggio solitario di lunghe spiagge tagliate dalla corrente del fiume”, che però è “ un mondo nel quale mi piace vivere”. Negli Scritti troviamo importanti testimonianze di questo legame personale, politico e culturale: la ricerca su “La Pignone” (36), Una inchiesta nel Cremonese (1956,90), I contadini della Valle padana (1958,161), Miglioli, Grieco e il contadino (1958, 226), il blocco di documenti su “La matàna del Po” (1959, 323), La cascina (1966, 433), Quelli del Po (1966, 442). Sono esempi del montaldiano e attivo “stare vicino al proletariato”, in dialogo, attraversando assieme la memoria, criticando con la discussione il metodo adottato, sottoponendo ad analisi la “prefigurazione”, cioè l’immaginazione (91), esplorando i “luoghi dove si fosse manifestata una concreta attività proletaria, con i suoi momenti di passione e di crisi”. Il “gruppo esterno” (97) che a Cremona nasce è l’eco intelligente (da “linea lombarda”, politicamente parlando) per quegli anni, non la scimmiottatura del partito di Lenin. Così, nel cogliere dal vivo permanenze e divenire delle forme di vita contadina, anteriori e posteriori all’industrializzazione delle campagne, Montaldi può polemizzare da posizioni di forza con certa letteratura che, in quegli anni, occupandosi di quel mondo e dell’immigrazione, era ancora orientata dal modello neorealistico, ma in modi sempre più estetizzanti (si vedano le sue critiche a Carlo Levi e a Zavattini e, per il cinema, la sua polemica col Visconti di Rocco e i suoi fratelli (382…). Egli è critico verso le “presunte immutabili costanti del mondo agrario, il quale invece come qualsiasi altra realtà storica si sviluppa, si afferma, entra in crisi, si trasforma” (201); e si potrebbe vedere nella sua ricerca un percorso che “dalla saggezza contadina” va all’“ideologia proletaria” o che già vede quest’ultima in quello che altri chiamano saggezza contadina, folklore (202). La sua attenzione è alle trasformazioni del lavoro, che stacca i giovani dagli anziani e riduce l’importanza della comunità familiare, per cui “saggezza contadina”, “dono”, “racconto”, miti vengono continuamente rielaborati. Tutte da studiare (ma esula dal mio intervento) sono le due presentazioni di Autobiografie della leggera (196) e, quasi in contemporanea, di Militanti politici di base (199), dove insiste sulla contrapposizione fra mitologia e storia. 9. Montaldi e la cultura di sinistra Negli Scritti, la fittissima serie di considerazioni, spesso contingenti e frammentarie, sulla cultura di sinistra degli anni Cinquanta e Sessanta (l’arte, il cinema, la letteratura), è volontà di contrapporre una cultura proletaria all’ottica prevalente del nazional-popolare. Ancora ritroviamo l’empito tutto giovanile “per una vita proletaria che diventi pienamente umana” e per un’azione d’avanguardia, alla quale “una falange di scrittori-operai deve contribuire, purché sia illuminata non nostalgica” (62). Simpatie e rifiuti di Montaldi sono coerenti con la sua visione e la sua pratica politica e sociale. Le preferenze vanno innanzitutto al grande cinema di Ejzenštein, alla letteratura e al cinema francesi, che sanno trattare i personaggi-operai - mentre in Italia non c’è spazio per “una originale creazione proletaria” (61) -, alla poesia di protesta (61), al lavoro delle riviste controcorrente come “Discussioni” (175) e “Ragionamenti”, alla raccolta di autobiografie (60), strada che presto Montaldi imboccherà, non limitandosi a raccogliere del mondo proletario solo i documenti “corali”, quindi di sfondo, ma anche i monumenti, spingendosi dunque verso una “valutazione letteraria del documento” (il suo riferimento era, allora, il Rocco Scotellaro dei Contadini del Sud (61), un libro di biografie scritte e orali di uomini del Meridione), alla sociologia, che egli pensa di usare come disciplina contro la burocrazia (1958,290) e contro la letteratura neorealistica diventata “fregio e ghirigoro”. Contesta il cinema italiano, di cui parla come “un mucchio di rovine” dalle quale spicca la “miseria di piccoli borghesi piagnucolosi” (51), l’uso regressivo del dialetto in letteratura, gli “esami di coscienza” degli intellettuali (bersaglio ancora Lucio Lombardo Radice, come esemplare di un “ampio settore della cultura di sinistra”), le false commozioni “per le riabilitazioni del XX Congresso”, il “togliattismo come stalinismo puro” (179), le mitologie del proletariato come “buon selvaggio”. Completamente ignorate o snobbate sono il formalismo della neoavanguardia e i raffinati giochi combinatori e fiabeschi di Calvino. 38 Impressiona la serie degli intellettuali di sinistra ufficiale e critica bersagliati da Montaldi in tutto l’arco che va dal dopoguerra alla sua morte; e mi risparmio l’elenco o gli esempi. 10. Su alcune ombre dell’immaginazione proletaria di Montaldi In genere, e non solo nella critiche all’intellettualità di sinistra, Montaldi sembra condividere in pieno l’idea marxiana che il proletariato non ha bisogno di farsi delle illusioni su se stesso, né logicamente di nascondere o abbellire interessi ed obbiettivi, e che la critica delle ideologie condotta a fondo farà del proletariato una classe perfettamente trasparente a sé stessa. Che questo poi sia avvenuto nella storia fra Otto e Novecento non possiamo certo affermarlo. Lo scivolamento fra reale e immaginario, fra mito e storia, è costante sia per i dominatori che per i dominati. Oggi, dunque, nella rilettura degli Scritti, terrei più presente la zona d’ombra che, suo malgrado, Montaldi mutua dalla visione marxiana, ancora fortemente illuminista e a tratti positivista. Anche questo è forse un condizionamento d’epoca per la sua generazione. Freud (nomino lui per indicare un simbolo di un atteggiamento più avvertito di questi problemi) è nominato una sola volta - e en passant - negli Scritti. Faccio tre esempi dove, secondo me, la sua immaginazione proletaria tocca queste zone d’ombra senza avvertire che, invece di penetrarvi a fondo, le aggira: contraddicendo, in un caso, il suo stile profondamente antiromantico. Primo esempio: sulla rivoluzione russa La preminenza che ha per lui il mito della Rivoluzione russa comporta una rimozione degli effetti profondi dello stalinismo, in cui Montaldi coglie fede e sacralizzazione del partito e del capo. Ma vi contrappone solo - sottolineo questo solo - la critica e il metodo scientifico. Non so se Montaldi potesse condividere l’idea di molti antropologi che un mito si combatte solo con un altro mito, ma mi pare che non riuscisse ad afferrare l’aspetto più oscuro di quella “religione” stalinista (come invece ha potuto fare di più un Moshe Lewin, che ha mostrato quanto l’immaginazione proletaria degli operai sovietici si fosse, purtroppo, “compromessa” con lo stalinismo, sottolineando come il “tradimento” della rivoluzione non toccasse soltanto i dirigenti o il partito). Montaldi, nel caso dello stalinismo, era frenato dalla diffusa mentalità dei militanti del tempo e forse anche delle conoscenze storiche di allora. Ma in effetti la sua critica si attesta sul piano ideologico. È soprattutto polemica contro l’ideologia del nazionalborghese. L’unico di questi scritti esplicitamente dedicato a Stalin tocca una questione davvero secondaria, come quella delle posizioni di Stalin sulla lingua. Quando accenna alla“degenerazione” (159-60) del partito o del sistema sovietico, Montaldi si ferma a considerazioni generali, generiche: “La degenerazione del partito, a giusta ragione, porta oggi il nome di Stalin. Ma questo non significa che un patrimonio ideologico come quello bolscevico sia da dimenticare. Non ci sono mai state garanzie perché un partito non degenerasse; né ve ne sono per qualsiasi altro organismo della classe” (160); e anche i pochi riferimenti a Victor Serge si fermano all’apologia del rivoluzionario, non interrogano da vicino l’esperienza che Serge ebbe della involuzione staliniana. Secondo esempio: “Su alcuni paesaggi” (1957, 134) Questo, fra gli scritti dedicati al cremonese, mi ha impressionato proprio perché scopre di più una sensibilità romantica verso un passato perduto (non dissimile mi pare da quella che rimproverava a Bosio ed altri), una sensibilità meno “proletaria”, meno “trasparente”, marxiana solo per uno scatto finale tutto verbale. In questo saggio, infatti (inviato per lettera anche a Fortini, non so se nella medesima stesura), Montaldi s’abbandona allo sguardo del promeneur: Se ne va in giro per la campagna, con un “un piccolo Goethe rilegato e di traduzione ottocentesca, che porto sempre con me”, aggiunge (135); mostra d’essere un conoscitore minuzioso della storia locale dei monumenti; costruisce analogie sottili fra le sue letture e l’ambiente circostante (“aspirazione gotica di certi paesaggi locali”,137). Sembra, insomma, affascinato dalla mentalità locale (“la 39 tetraggine del temperamento bassolombardo”), dallo “sfondo pagano” che fa persistere paure secolari “soprattutto nelle donne anziane”, copie - dice - di “quelle che dovettero essere le primitive abitatrici del fiume” (137). Qui una predilezione per il “popolare” (“le preziose notizie trasmesse in tono paesano ci guadagnano, non ci perdono”, 134) e un’attenzione acuta a “tutto un mondo patriarcale, militarista, paternalistico e cattolico che se n’è andato” (142) e ai suoi residui ottocenteschi lo conducono a un’esperienza puramente estetica, altre volte respinta (“Staccatomi dagli amici, mi diressi da solo verso quel romitorio, che sapevo […] per poterne fare una privata verifica, e godermela tutta da solo”, 140; “Né si può dimenticare la bellezza degli stendardi feudali” (142). Siamo nel 1957 e Montaldi ha 28 anni, si dirà. Ma il gusto per il diroccato e il funebre (“Le chiese più vecchie, i torrioni, questi cimiteri, sono le cose da vedere in queste campagne”,135), rafforzato da commossi “ricordi di letteratura inglese” (136), frammisto di pensieri di morte (“e mi ricordava che più di un anno fa io volevo scrivere qualcosa a proposito del sentimento della morte che si ha qui, nelle campagne”, 136), è quello romantico. L’attenzione è proprio alle permanenze dell’arcaico (“E pertanto io ci passo attraverso a queste enormità di campagna, come mi capitava di promanarmi al museo dell’uomo del Palais de Chaillot tra i monumenti della civiltà africana e oceanica. Ché questa non è meno Africa e Preistoria di quella” (138). E non manca l’accoppiata di amore e morte: la storia della “nobile P.”, una signora lesbica (141). Solo a tratti o alla fine rispunta il marxista, lo scatto materialistico e marxiano, che dal riferimento alla ““gramezza” (veramente cristiana) della vita che vi si conduce (che genera appunto quel sentimento) passa, come un pistolotto finale e improvvisato, all’affermazione: “poiché sappiamo ciò che i proletari sanno: che c’è un mondo, cioè, che è ancora tutto da guadagnare” (143). Terzo esempio: Il rapporto Montaldi-Fortini Vorrei accennare - anche per una questione personale di stima e di affetto per la memoria di entrambi - alla necessità di un confronto Fortini-Montaldi. Preciso subito: non è confronto fra un periferico e uno “scrittore europeo” (come si è detto di Fortini). Montaldi aveva i suoi circuiti europei diversi da quelli di Fortini (non casualmente sartriano). Sono due figure che, pur sapendo in contrasto (e gli Scritti mi hanno provato ancor più la loro distanza), continuo a sentire storicamente complementari, come se entrambe contenessero elementi essenziali della crisi che abbiamo vissuto lungo il secondo Novecento. Sono due volti di quella crisi - diciamo pure -, uno proletario e l’altro piccoloborghese, uno proletkult e l’altro ammantatosi della “sublime lingua borghese”, l’uno aperto all’operaismo del ‘69 e l’altro alle controverse dinamiche dell’intellettualità di massa del ’68. Ci sono pochi elementi per approfondire questo confronto. L’avvicinamento dei due avviene negli anni Cinquanta-Sessanta. Purtroppo il rapporto s’interrompe bruscamente. Il carteggio fra i due è limitato: iniziato attorno al ’55, per iniziativa di Montaldi che vedeva nell’esperienza de Il Politecnico un modello per sé e i suoi giovani compagni, si conclude già attorno al ’63, con una lettera in cui Montaldi rivendica orgogliosamente il fatto di non frequentare i luoghi “dove si elaborano le riviste politiche come opere d’arte”, rimproveramdo così Fortini - cui ha mandato dei bollettini del Gruppo di Unità proletaria -: “non ci hai mai rivolto una critica, non ci hai mai detto che avevi qualcosa da dare, da scrivere, nemmeno un’indicazione sugli argomenti da trattare, da sviluppare, non un indirizzo cui mandarlo…” (Lettera di Montaldi del 9 marzo 1963 ). Di fronte alla vastità del processo d’industrializzazione e massificazione di cultura e scuola di quegli anni, l’emissione di polemica, sia da parte di Montaldi che dei suoi avversari, appare oggi tanto più esorbitante quanto più sterile. La critica alla politica censoria del PCI, da una parte, e la difesa attardata del nazional-popolare, dall’altra, si lasciava passare sotto gli occhi l’offensiva capitalista, abilmente condotta attraverso scuola e mezzi di comunicazione di massa. A quei processi, nei Sessanta, si reagiva con l’opera anarchicheggiante di Bianciardi, con la difesa e il tentativo di 40 sviluppare la cultura proletaria di Montaldi o con il tentativo di Fortini di salvare l’insegnamento del Politecnico ponendosi in senso gramsciano il problema dell’organizzazione della cultura dal suo interno, proponendo una manualistica molto ben fatta, tentando di elaborare una “scrittura comunicativa media” (Fortini, 440), sperando di influire “attraverso il linguaggio negli strumenti di comunicazione di massa” tentativo dichiarato poi fallimentare dallo stesso Fortini (“questa idea si rivelava buona per il Manzoni, non per noi. L’immenso flusso di informazione-comunicazione avrebbe distrutto completamente una simile possibilità”, Fort., 440 …). Non si trattava più questione di censura politica esercitata dal PCI (tramite Antonio Giolitti) che colpiva l’opera di Trockij o faceva uscire Serge nella Nuova Italia, ma era – come dice ancora Fortini – che le case editrici “diventavano sempre più organi che veicolano mode” e si andava formando, anche coi tascabili, un ‘intellettualità di massa, che Fortini chiama “di secondo rango”. Di fronte a quei processi tutte le varie culture della sinistra, sono risultate perdenti o hanno dovuto in qualche modo piegarsi. Ma anche l’ipotesi montaldiana della cultura proletaria non ha retto all’urto. Anche in questo caso, perciò, penso che l’immaginazione proletaria di Montaldi sia rimasta prigioniera del mito, che ha fatto ombra ad un’analisi più spregiudicata sulla capillarità e intensità dei processi che avvenivano nell’industria culturale. Ed è strano non trovare contributi in proposito da parte di Montaldi, che pure faceva il traduttore per Einaudi, Feltrinelli e Mondadori, ed era implicato in qualche modo in questi processi dell’industria culturale, subendone anzi conseguenze sul piano personale. (La vicenda del rifiuto della Fentrinelli di pubblicare il Saggio sulla politica del PCI non è irrilevante andrebbe oggi indagata a fondo). [lettera sull‘uso della scuola] Come se egli non vedesse quanto si andasse preparando e che a noi ci aveva già coinvolto in pieno. Perciò, ritengo particolarmente esasperate e forse mal indirizzate le accuse rivolte a Fortini, specie rispetto alla traiettoria successiva da lui compiuta fino alla sua morte del ’94, che è verificabile oggi se si leggono le sue amare (e anche autocritiche diagnosi sulla politica culturale tentata in quegli anni): “Una volta si pensava che le idee determinassero delle conseguenze: oggi il margine delle conseguenze è stato eliminato nel pluralismo totale, e la democrazia delle idee è spinta all’estremo, come in quelle sette protestanti dove nel coro ognuno canta un salmo per conto suo, secondo che lo spirito detta. Nonm importa la cacofonia, tanto l’unico interlocutore è Dio. Così ognuno di noi canta la sua nota, e tutto finisce lì, nessuno mira alle conseguenze. Allora quando mi domandano se esista una cultura d’opposizione, io rispondo: non esiste, ed è meglio così. Finora la cultura d’opposizione è stata essenzialmente una cultura d’opposizione interna. Le uniche vere culture d’opposizione della prima metà del secolo, paradossalmente, sono state da un lato quella di origine leninista, dall’altro quella nazista. Le quali, beninteso, non hanno alcun rapporto tra di loro e rappresentano cose diversissime, ma entrambe sono d’opposizione sul serio, e prevedono certe conseguenze. Oggi darsi da fare per una cultura d’opposizione è ridicolo, perché i temi di quelle che erano le parti in conflitto sono oggi distribuiti nel magma dell’informazione-comunicazione attuale” (Fort,446). ( Fort, Interviste 1952- 94, 446), Certo Montaldi non si è chiuso come Fortini nella “sublime lingua borghese” e era fuori dalla sua logica di tentare dall’interno dell’editoria, del giornalismo, del mondo universitario, di contrastare questi processi: il suo tenersi legato - l’abbiamo visto più volte al mondo proletario in termini concreti ha significato per lui anche non fare carriera. L’antiaccademismo (non antintellettualismo, egli è intellettuale raffinato ma proletario), che lo distingue dagli altri intellettuali della Sinistra (il convinto rifiuto di professionalizzarsi di Montaldi è un sintomo), a me risulta sicuramente più simpatico e congeniale. Questo restare vicino al proletariato (ma memore della storia delle lotte proletarie) 41 gli permette di essere sicuramente più attento di altri alle trasformazioni di quel mondo. Rispetto ad un Pasolini, ad esempio, è politicamente molto più agguerrito, evita perciò il suo populismo; d’altro canto, non ritengo neppure sbagliato essersi distanziato anche dal lucaccianesimo o l’adornismo di Fortini. Ma - ripeto - questa fedeltà al mondo proletario ha avuto anche i suoi risvolti negativi. Certe trasformazioni, proprio sul lato che oggi chiamiamo dell’”immateriale”, quel proletariato le ha poi subite, come abbiamo visto noi in questi oltre 25 anni trascorsi dalla morte di Montaldi: per fronteggiarle, o avvantaggiarsene almeno in parte, con quella cultura proletaria non era più possibile intervenire. Questo dobbiamo dircelo, se non vogliamo abbandonarci al culto amicale. La “disattenzione” di Montaldi sul ’68 studentesco mi pare sveli una sua difficoltà. Questi fenomeni toglievano spazio alla sua visione proletaria: l’emergere di un’intellettualità di massa era qualcosa di abbastanza estraneo alla sua immaginazione, ma la storia successiva ci dice quanto le nuove figure (movimento del ’77, ecc. ) avessero il vento in poppa, ambiguo soffio capitalista e postcomunista (come si è poi detto), e quanto oggi ne siamo coinvolti. Nolenti o volenti. La polemica con la Sinistra si è svuotata, non perché si possa giustificare quella politica, ma perché anche quella è venuta meno, si è dissolta. Il tenace riferimento proletkult di Montaldi è stato fertile sul piano della sua ricerca, ma oggi dobbiamo dirci che Autobiografia della Leggera e Militanti politici di base, per non ridursi a letteratura, dovranno aspettare che si sia riaffacciato il bisogno di qualche nuova forma di memoria, che si possa aver bisogno delle verità che contengono. 11. Conclusioni: La mia lettura degli “Scritti 1952-1975) Dopo aver trattato il tema che mi sono proposto, voglio accennare al sentimento contraddittorio che ha accompagnato questa mia rilettura degli scritti di Montaldi. Avevo conservato di lui in tutti questi anni un ricordo congelato dalla sua morte e, subito dopo, dagli strascichi amari e spesso tragici del periodo di quella militanza politica - che era stata occasione e ragione del nostro incontro. L’avevo espresso in questa poesia a lui dedicata. Mi permetto di leggerla: Milano, Corea a Danilo Montaldi E qui ammutoliti stemmo: i corpi sfibrati di fatica le sopraccoperte a fiorami sulle brande le collezioni di tiepide bamboline nelle credenze vetrate. La sterpaglia, i cantieri guardammo come nuotatori che all'improvviso restringersi del mondo spengono sul vuoto d’aria attorno occhi, cuori e volere e sprofondano con la muscolatura serrata trattenendo in un unico spasimo persino l'azzurro respirato dai loro padri. Nel riprendere in mano ora questi scritti, due fatti mi si sono imposti: 1) il ribaltamento dell’immagine personale che avevo di Montaldi a causa del tempo passato: se a me, giovane immigrato e militante politico di base nell’hinterland milanese, quando lo conobbi attraverso alcuni incontri e lo scambio di poche lettere tra 1973 e 1975, egli appariva un possibile compagno-maestro-fratello maggiore, oggi mi sono ritrovato nella posizione del vecchio, che fa i conti con un giovane e sotto certi aspetti con la propria giovinezza (la mia). E mi si è posto il problema di non far pesare oltremodo questo mio invecchiamento, di difendere oggi attraverso quella di Montaldi anche la mia giovinezza - e salvare criticamente, però, quella dimensione proletaria presente nel suo/mio “tempo perduto”; 2) la consapevolezza della fine di quell’epoca e di una situazione attorno a noi completamente mutata. Nel passaggio come si dice - “dal fordismo al postfordismo”, tutto è diventato più “immateriale”, i soggetti sociali e politici a cui facevamo riferimento allora sono stati emarginati, altri più indistinti o “mutanti” li vanno sostituendo; siamo tutti meno “proletari”, più “intellettuali”, più “ceto medio” o “moltitudine”. Siamo tutti di fatto più distanti da Montaldi. 42 Questo profondo cambiamento nel reale e nel nostro modo di pensarlo mi ha suggerito di guardarmi da una lettura degli Scritti solo simpatetica o basata su un’ottimistica continuità. Al di là della possibilità di ripresa di aspetti decisivi del suo stile (un nuovo tipo di memoria, l’inchiesta fra gli strati del lavoro informatizzato o fra i nuovi immigrati), il tentativo che dobbiamo fare è quello di tradurre, per questo nuovo ceto medio o neoproletario o moltitudine di oggi, il senso alto e nobile che Danilo Montaldi ebbe della condizione proletaria. 9 maggio 2003 43
Scaricare