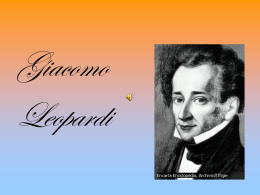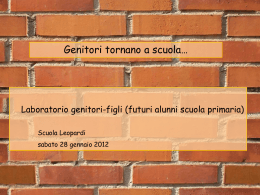I GRANDI LIBRI www.garzantilibri.it facebook.com/Garzanti @garzantilibri www.illibraio.it ISBN 978-88-11-13179-3 © Garzanti Editore s.p.a., 1982, 1984 © 2000, 2010, Garzanti Libri S.r.l., Milano Gruppo editoriale Mauri Spagnol Prima edizione digitale 2011 Quest´opera è protetta dalla Legge sul diritto d´autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata. INTRODUZIONE La vita e l’opera La famiglia Giacomo Leopardi nasce il 29 giugno 1798, a Recanati, piccolo centro dello Stato Pontificio, dal conte Monaldo Leopardi e dalla marchesa Adelaide Antici. La famiglia Leopardi è una delle prime e più importanti del contado: possiede proprietà terriere nella Marca meridionale e un grande palazzo avito in Recanati. Il patrimonio, tuttavia, male amministrato dal conte Monaldo, cattivo economo e facile alle spese, rende poco; anche perché Monaldo preferisce occuparsi di studi e si diletta nello scrivere, preso dietro a velleitarie ambizioni letterarie. Reazionario e codino, compone opere in cui si allineano, alle posizioni più retrive, religiosità bigotta, fedeltà allo Stato Pontificio, ossessione d’ordine e di conservazione, al passo con l’erudizione e la pompa formale del secolo passato. In poco tempo mette assieme, più per esteriore prestigio che per genuine esigenze, una ricca e costosissima biblioteca, che finirà con l’aprire, nel 1812, all’uso degli amici e dei concittadini influenti. Sua moglie, la marchesa Antici, preoccupata di salvaguardare il patrimonio, ne ha assunto direttamente l’amministrazione, già prima della nascita di Giacomo. Viene descritta come donna capace, decisa, severa, poco incline alle manifestazioni di affetto, rigidamente attestata sulle medesime posizioni ideali del marito e, in particolare, di una religiosità bigotta e superstiziosa. Adelaide impone in casa, per ragioni di economia e di risparmio, una disciplina severissima; con un’austerità che deve servire a mantenere le apparenze del censo e della classe sociale cui la famiglia appartiene da generazioni. Il paese Recanati, come l’intera Marca, è zona depressa e vi sopravvivono addirittura situazioni gerarchiche di specie feudale. Nel generalmente arretrato Stato Pontificio, Recanati è un’isola di arretratezza; e non solo dal punto di vista dell’economia e del lavoro. Le nuove idee, che circolano in Europa già dal secolo precedente, tardano ad arrivare nella Marca; il clero e l’aristocrazia terriera fanno buona guardia, opponendo sorda resistenza a tutto ciò che porta con sé anche solo l’idea di rinnovamento, figuriamoci poi di ridistribuzione e di trasformazione dei rapporti sociali. Sul piano culturale, le cose non vanno meglio; dove non arriva la persuasione occulta interviene la censura, che il clero sa mettere ottimamente a profitto. Contro la scienza per principio, nella Marca, trionfano l’erudizione, la vuota eloquenza, le Accademie, di cui il conte Monaldo, appunto, fornisce un buon esempio. I fratelli Giacomo e i suoi fratelli (nati, di lì a poco, nell’ordine: Carlo, nel 1799; Paolina, nel 1800; Luigi, nel 1804) stabiliscono precocemente tra di loro rapporti preferenziali, in una casa in cui regna un’atmosfera fredda e cerimoniosa e in cui i genitori sono quasi sempre assenti, uno, chiuso nel suo studio a scrivere, e l’altra, sigillata nella sua stanza a pregare o a far conti. Soprattutto Giacomo, sensibilissimo e bisognoso d’affetto, risente di questa assenza. Si lega ai fratelli e, in particolare, a Carlo e a Paolina; fin dall’età di sei o sette anni, è l’animatore di giochi e di storie raccontate e sceneggiate, in casa o nel giardino, per interminabili giornate. Intanto, spinto dalla madre sulla strada di una religiosità morbosa, è ossessionato da paure e incubi dell’aldilà e dell’inferno. L’inizio degli studi A partire dal 1807, insieme a Carlo e a Paolina, Giacomo viene affidato a don Sebastiano Sanchini, scelto come precettore di casa; ma, già dopo un anno, si rende autonomo e si getta in uno «studio matto e disperatissimo», come scriverà più tardi. Rimane ore e ore chiuso nella biblioteca paterna a leggere e a meditare. A spingerlo nell’impresa, all’inizio, è un’ansia vivissima di acquistarsi l’affetto e l’approvazione del padre; il quale, naturalmente, è lusingato: approva, nell’ombra, e non interviene a salvare Giacomo, che si va rovinando irreparabilmente la salute sui libri. L’identificazione con il padre In una identificazione assoluta con la figura del padre, fino al 1815, Giacomo compie studi eruditi, disordinati e vari, che spaziano in settori diversi del sapere, secondo un gusto enciclopedico di moda. Affronta letture di vario genere; studia il latino, il greco, l’ebraico, il francese e altre lingue moderne; coltiva interessi filologici, con traduzioni e commenti ai classici più famosi; intraprende studi di geografia e di astronomia, di scienze naturali. Alcuni di questi studi si concretizzano in operette riassuntive: nel 1813, scrive la Storia dell’astronomia; nel 1815, il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi; nel 1816, le Notizie istoriche e geografiche sulla città e chiesa arcivescovile di Damiata. I primi componimenti poetici Intanto, ha cominciato a scrivere in versi; ha una facilità notevole a mettere in versi qualsiasi cosa, favorita dall’abitudine precocissima a tradurre molto e di poesia. Si esercita sui classici, ma dà anche fondo al suo senso del ritmo e al suo spirito ironico in componimenti domestici: scherzi, filastrocche, dedicatorie ai fratelli, in cui usa tutto l’armamentario della poesia ufficiale e accademica a fini comici. Nel 1809, a undici anni, dopo aver letto Omero, compone il sonetto La morte di Ettore; nel 1810, compone il poemetto I Re Magi; del 1811, è la tragedia La virtù indiana; del 1812, sono la tragedia Pompeo in Egitto e gliEpigrammi, accompagnati da una Introduzione in prosa. E, nel frattempo, coltiva anche la prosa: in sermoni su argomenti religiosi da pronunciare in chiesa, dissertazioni di argomento filosofico, orazioni fittizie. Nel 1811, scrive leDissertazioni filosofiche; nel 1815, l’orazione Agli Italiani, per la liberazione del Piceno. Quanto poi alle traduzioni, è del 1811, a tredici anni, l’Arte poetica di Orazio travestita in ottava rima; nel 1815, traduce il poeta greco Mosco e laBatracomiomachia. Sono gli anni in cui completa è la coincidenza di idee e di modi tra Giacomo e Monaldo: erudizione, accademismo, fedeltà ai dogmi della chiesa, conservatorismo retrivo, atteggiamento politico antiunitario e antirisorgimentale. È l’identificazione che dà a Giacomo l’illusione di mantenere vivo il rapporto con suo padre; così come, per altra via, la religiosità, vissuta in maniera sofferta, si è rivelata per lui l’unico legame diretto con sua madre. La conversione letteraria Ma la crisi è nell’aria e, tra il 1815 e il 1816, matura in quella che lo stesso Leopardi ha chiamato la sua «conversione letteraria»; concretamente cioè verificabile nel passaggio dagli studi eruditi agli studi letterari, dalle nozioni al bello. E questa «conversione» è favorita dalla lettura dei classici, che gli rivelano il salto di qualità e di sostanza tra una poesia interiormente vissuta e un gusto poetico della tradizione retorica, vuoto e insulso. Il 1816 è l’anno delle molte traduzioni importanti: il primo libro dell’Odissea, il secondo dell’Eneide, ilMoretum pseudovirgiliano. Intanto, ha inviato allo «Spettatore italiano e straniero» il Saggio di traduzione dell’Odissea, che esce in due puntate e suscita l’interesse dell’editore Stella, che di lì a poco fa visita a Giacomo in Recanati, ponendo le basi di future collaborazioni. E, sempre nel 1816, Leopardi compone, in doppia redazione greca e latina, i calchi alessandrini dell’Inno a Nettuno e delle Odae adespotae. La frequentazione dei classici fa scattare in Giacomo un’adesione assoluta alla poesia come pura rappresentazione; interviene addirittura nella polemica intorno al romanticismo, che arriva a Recanati attraverso rare riviste, e indirizza alla «Biblioteca Italiana» una Lettera in risposta all’intervento della de Stäel, che esortava gli scrittori italiani ad abbandonare la tradizione e a leggere e a tradurre gli stranieri. Lettera non pubblicata dalla rivista e in cui Leopardi rifiuta la proposta della de Stäel delle traduzioni, insistendo sul fatto che la poesia non nasce dalla cultura e dallo studio degli autori ma da «un impulso sovrumano». Al 1816 risalgono due importanti prove poetiche: nella primavera, l’idillio Le rimembranze, rimpianto per una vita che si va spegnendo al suo primo apparire, e, nel novembre, Appressamento della morte, cantica in terza rima, una «visione» della propria morte ispiratagli dalle precarie condizioni di salute. La malattia Leopardi è malato seriamente: una grave forma di scoliosi, febbri ricorrenti che insidiano il già debole stato del suo fisico, la vista che si sta spegnendo. La solitudine di Giacomo è assoluta: non ha amici né conoscenti, nel paese; l’isolamento è grande anche dentro casa. I già formali rapporti con il padre si fanno più precari e tormentati, per il suo progressivo distacco dai modelli che implicitamente Monaldo imponeva. L’unico conforto è l’avvio, a partire dal 1817, di una corrispondenza con Pietro Giordani, che diviene suo interlocutore preferenziale. Al Giordani, Leopardi espone progetti e chiede consigli; a lui invia note e versi in visione. Gli manda, per esempio, il secondo libro dell’Eneideappena finito di tradurre. Col Giordani, si lamenta dell’isolamento della Marca, della mancanza di libri e di riviste, della grettezza e dell’ignoranza della gente di Recanati. E, intanto, anche su indicazione o per l’invio di Giordani, Giacomo è venuto leggendo molti moderni: l’Alfieri, il Monti, il Parini, il Foscolo, Chateaubriand, Byron, il Werther di Goethe, M.me de Stäel, gli scritti del Di Breme, del Berchet e della cerchia del «Conciliatore». Letta con emozione l’autobiografia dell’Alfieri, compone il sonetto Letta la vita dell’Alfieri. L’amore per la cugina A turbare Giacomo interviene il brevissimo passaggio da Recanati della cugina Gertrude Cassi, per la quale egli scrive in breve spazio di tempo il componimento Il primo amore e il Diario d’amore (o Memorie del primo amore), annotazioni in prosa dei sentimenti di una passione «non nutrita d’altro che di ricordanza e d’immagini». Entro l’anno, scrive gli eleganti Sonetti in persona di ser Pecora fiorentino beccaio e traduce la Titanomachia di Esiodo, che pubblica sullo «Spettatore italiano e straniero» dell’editore Stella. La conversione politica e le canzoni «politiche» Il 1818 è un anno particolarmente inquieto e tormentato, per le malandate condizioni di salute, per l’insofferenza crescente nei confronti di Recanati e della sua stessa famiglia, per le aspirazioni al rinnovamento che ormai si sono impossessate del giovane ventenne. È l’anno della cosiddetta «conversione politica»; con la presa di distanze dalle tesi reazionarie paterne espresse nell’orazione Agli Italiani, con il riconoscimento incondizionato all’azione intrapresa dalla borghesia per il processo di unificazione dell’Italia. Nell’autunno, nascono le prime canzoni: All’Italia e Sopra il monumento di Dante. Intanto, progetta di fuggire da Recanati, credendo di trovare altrove, e soprattutto a Roma, quel che a Recanati gli manca. Lo viene a trovare il Giordani e la visita rafforza in lui il proposito di lasciare Recanati, viste anche le promesse di aiuto dell’amico. Va registrando, già a partire dal 1817, tutte le riflessioni e i progetti nelle pagine dello Zibaldone. Il «Discorso» sulla poesia romantica Scrive, nell’inverno, il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, quasi in risposta all’opuscolo del Di Breme sul Giaurro del Byron, e ribadisce la sua posizione polemica nei confronti dei romantici. I romantici, secondo il Leopardi, tendono a spiritualizzare ciò che dovrebbe essere oggetto sensibile nella poesia e, pensando di fondare tutto sul sentimento, riducono invece tutto al patetico; l’ufficio della poesia è l’imitazione della natura, che è oggetto sensibile e immutabile, e il suo fine è il diletto, attraverso le illusioni che essa crea, e non per mezzo della verisimiglianza sostenuta dai romantici. L’imitazione degli antichi non è una ripetizione di modelli, ma la reinvenzione di un rapporto incontaminato e fanciullesco con la natura, ispirato all’ingenuità e lontano dalla ragione che riempie la poesia moderna. La conversione filosofica È venuta maturando nel tempo, attraverso il distacco dalla religione e l’adesione alle tesi materialistiche del meccanicismo, quella «conversione filosofica» del Leopardi che culmina, nel 1819, nel passaggio dal bello al vero: la scoperta del «solido nulla» che la ragione consegna all’uomo, cancellando qualsiasi possibilità per lui di essere felice. È una conversione che ha conseguenze enormi anche relativamente allo stesso concetto di poesia che il Leopardi aveva, fino a correggere alcune tesi espresse nel Discorso: che la «poesia d’immaginazione» non può che essere degli antichi e la poesia moderna è «poesia sentimentale», in cui non si può fare a meno del ragionamento e della filosofia. L’idillio «L’infinito» Nel 1819, Leopardi compone i due idilli: L’infinito, raro momento di serenità nella sua produzione poetica, e Alla luna; e le canzoni mai pubblicate: Per una donna inferma di malattia lunga e mortale e Nella morte di una donna fatta trucidare col suo portato dal corruttore per mano ed arte di un chirurgo, l’abbozzo della Telesilla e Odi, Melisso, ispirato alla poesia pastorale e agli idilli di Mosco. Il tentativo di fuga da Recanati Nel luglio, il tentativo di fuga da casa con meta Roma viene scoperto e sventato; i rapporti con il padre si irrigidiscono ancora di più. Giacomo si sente ormai in una prigione da cui non potrà mai evadere; la famiglia non intende fornirgli i mezzi per allontanarsi da Recanati. I dolori fisici sono riacutizzati, in questo periodo, da una malattia agli occhi che si rivela sempre più inguaribile. Il suo pessimismo si accentua; la «sepoltura di vivi» a cui si sente condannato, tuttavia, è a tratti illuminata dall’illusione di una «terra piena di meraviglie» che lo aspetta, fuori di Recanati, e dal sogno crescente di una gloria che riscatti sofferenze e privazioni che ora patisce. Canzoni e idilli: «Ad Angelo Mai», «La sera del dì di festa», «Il sogno» Il 1820 è un anno di meditazioni e di messe a punto. Leopardi, in atteggiamento sempre più critico nei confronti del mondo contemporaneo, sviluppa l’idea di una contrapposizione tra gli antichi, capaci di eroismo, e i contemporanei, morti a qualsiasi virtù. Il percorso di questo progressivo spegnersi di ogni voce alta e netta, fino al contemporaneo «secol morto», è svolto nella canzone Ad Angelo Mai, scritta nel gennaio. E di tale periodo è anche, quasi sicuramente, l’idillio La sera del dì di festa, con la sua nostalgia del mondo antico immessa in uno di quei quadri notturni «sentimentali» del poeta, dominato dalla considerazione di come tutto passi rapidamente senza lasciare traccia. E, nell’anno, lavora già all’idillioIl sogno, che testimonia di quell’alternarsi di disperazione e speranza in cui vive Giacomo, nell’intermittente e dolorosissimo dubbio di stare consumando invano la sua giovinezza; tema che diventerà dominante di lì a qualche anno. I primi progetti delle «Operette morali» Del 1820 sono anche i primi progetti e i primi appunti di quelle che in seguito, con altre scelte di personaggi, saranno le Operette morali; scrive la Novella. Senofonte e Niccolò Machiavello, il Dialogo... Filosofo greco, Murco senatore romano, Popolo romano, Congiurati. Tra il 1820 e il 1821, compone il Dialogo tra due bestie, p. e. un cavallo e un toro e il Dialogo di un cavallo e un bue. Forse, è del 1820 anche il Frammento sul suicidio. Le canzoni «filosofiche» Nel 1821, Leopardi compone alcuni dei suoi «discorsi filosofici» in versi, le canzoni: Nelle nozze della sorella Paolina, A un vincitore nel pallone e, in dicembre, il Bruto Minore, nelle quali ritornano il richiamo alla vitalità eroica del passato e il monito a farla rivivere nel presente, ma in cui si pronuncia anche la prima battuta d’arresto per le illusioni, quella della disperazione, in Bruto che deve riconoscere vana perfino la virtù. Nell’anno, finisce Il sogno e scrive, probabilmente, un altro idillio: La vita solitaria, giocato tra riferimenti letterari e motivi autobiografici. Del 1821, probabilmente, è anche il Dialogo Galantuomo e Mondo. «Alla primavera», «Inno ai patriarchi», «Ultimo canto di Saffo» Del 1822, sono Alla Primavera o delle favole antiche (gennaio) e l’Inno ai Patriarchi (luglio), in cui vivono il rimpianto per la natura primitiva e il riecheggiamento accorato di quella capacità immaginativa che era propria degli antichi, all’ epoca della giovinezza del genere umano; e l’Ultimo canto di Saffo(maggio), ancora sulla disperazione, di chi si sente escluso ingiustamente dalla bellezza e dalla felicità della natura. Leopardi compone anche la prosa:Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto vicini a morte e traduce, intanto, dal latino l’opera del Combefis Il martirio de’ Santi Padri del monte Sinai e dell’eremo di Raitu ecc. Il soggiorno romano Nel frattempo, il padre ha deciso di lasciar partire Giacomo per Roma, dove sarà ospite in casa dello zio, marchese Carlo Antici. Pieno di speranze e di progetti, il poeta parte per Roma il 17 novembre e vi resterà fino al 3 maggio dell’anno successivo. L’esperienza romana è per Leopardi una delusione clamorosa: lo infastidisce la città, grande e rumorosa, sporca e poco sicura; lo scandalizzano la corruzione e l’ipocrisia della curia; lo indignano l’ignoranza e l’abulia della società aristocratica; lo amareggia l’insulsaggine dei letterati, fermi ancora all’Arcadia. Uniche consolazioni, sono la visita ai luoghi cari al Tasso (e sulla quercia al Gianicolo si commuove come raramente gli era capitato) e la frequentazione, e in qualche caso l’amicizia, di Angelo Mai, del Niebuhr, del Bunsen, dello Jacopssen. Un altro aspetto di Roma colpisce Leopardi, fino a traumatizzarlo addirittura: il grande numero di donne che pratica la prostituzione, per di più nella capitale del Cristianesimo. È una scoperta che mette in crisi la sua figurazione idealizzata della donna e accentua quel suo misoginismo che nasceva dal sentirsi o immaginarsi fisicamente rifiutato. Tornato a Recanati, traduce la Satira di Simonide sopra le donne e scrive, per contro, la canzone Alla sua donna, consegnandosi definitivamente all’idealizzazione di quella «donna che non si trova», secondo le sue stesse parole. L’accentuarsi del pessimismo: le «Operette morali» Il soggiorno romano accentua il pessimismo del Leopardi, infrangendo la speranza di trovare fuori quella felicità che gli era sembrata irrealizzabile a Recanati. Il ritorno a casa coincide con un periodo di riflessione e di letture filosofiche, dall’atomismo all’illuminismo materialistico di un d’Holbach. Varia, via via, l’atteggiamento di Giacomo nei confronti della natura: dal riconoscimento rousseauiano della felicità di natura che l’uomo perde allontanandosi progressivamente dalla condizione originale, alla dichiarazione di responsabilità della natura nell’infelicità dell’uomo, al superamento del rapporto-contrasto tra i termini «felicità» e «natura» in una visione meccanicistica dell’universo in cui l’uomo, al pari di tutti gli altri esseri animati e inanimati, subisce le conseguenze di causa-effetto di una materia che sordamente si muove e opera alla propria conservazione. La storia di questo diverso atteggiamento è fedelmente registrata, nei suoi sviluppi e nelle sue contraddizioni, sulle pagine dello Zibaldone e, partendo di lì, riproposta con intendimenti artistici nelleOperette morali, alla composizione delle quali Leopardi attende durante il 1824. Nello stesso anno, scrive il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, sulla decadenza intellettuale e morale dell’Italia dopo la breve luce del Rinascimento, e pubblica, a Bologna, un opuscolo con le prime dieciCanzoni accompagnate dalle Annotazioni. Dalla fine del 1824 e per tutto l’anno successivo, Giacomo si dedica alla traduzione di scritti greci, dalle operette di Isocrate al Manuale di Epitteto. A Bologna e Milano Nel luglio del 1825, Leopardi riparte da Recanati; è invitato a Milano dall’editore Stella, che gli offre di sopraintendere a una nuova edizione delle opere di Cicerone. Fa tappa a Bologna, dal 17 al 27 luglio, e qui rivede il Giordani e conosce il Brighenti, direttore della rivista «Il caffè di Petronio», sulla quale è invitato a pubblicare la poesia Il sogno. A Milano, attraverso l’editore Stella ed altri nuovi amici, conosce Vincenzo Monti e l’abate Cesari, esponente del più rigido purismo nella questione della lingua letteraria. È un periodo di qualche euforia, di fronte soprattutto al progetto di potersi mantenere da solo fuori di Recanati; ma la salute è incerta e il poeta si stanca per un nonnulla. Il «Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco» Dell’ autunno è il Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco, pensato come «operetta», ma poi escluso dalle edizioni curate direttamente dal Leopardi. Ancora a Bologna Il piacevole soggiorno bolognese convince il Leopardi a fermarsi di nuovo a Bologna, al ritorno da Milano il 29 settembre, e il poeta rimane nella città emiliana fino al novembre dell’anno successivo. Qui, frequenta il Brighenti, diventa amico del conte Carlo Pepoli, è ricevuto in casa del medico Giacomo Tommasini, dove si fa due ferventi ammiratrici nelle persone della signora Antonietta Tommasini e di sua figlia Adelaide. Si invaghisce della gentildonna Teresa Carniani Malvezzi, che si diletta a scriver versi, e si crede dapprincipio ricambiato da lei. Intanto, lavora all’edizione delle opere ciceroniane per l’editore Stella e, per lo stesso, cura un commento alle Rime del Petrarca. Scrive, nel marzo, l’Epistola al conte Carlo Pepoli in versi, per l’Accademia dei Felsinei, e, nell’estate, pubblica un’ edizione dei suoi Versi. Ritorna a Recanati l’11 novembre. Le «Crestomazie», la conoscenza di Antonio Ranieri e la pubblicazione delle «Operette» A Recanati, lavora alle due Crestomazie della prosa e della poesia italiana che si è impegnato a fare per l’editore Stella già l’anno prima. Ma si stanca presto del suo «borgo selvaggio», dove si sente isolato e per nulla apprezzato, e decide di tornare a Bologna, il 26 aprile del 1827, dagli amici che lo stimano e lo esortano a lavorare. A Bologna, conosce l’esule napoletano Antonio Ranieri; frequenta i letterati Pepoli e Papadopoli; riprende a visitare casa Tommasini. Nel giugno del 1827, contemporaneamente ai Promessi sposi del Manzoni, esce a Milano l’edizione delle Operette morali che il Leopardi aveva consegnato allo Stella. A Firenze Il 21 giugno il poeta si trasferisce a Firenze, dove viene a contatto con il gruppo della rivista «Antologia»; conosce e frequenta il Vieusseux, il Capponi, il Montani, e altri esuli napoletani gli presenta il Ranieri: il Colletta, Poerio, Troya. Conosce Niccolò Tommaseo, che gli sarà sempre ostile e che, partendo dalle sue convinzioni cattoliche, opponeva il più netto rifiuto ai contenuti negativi delleOperette morali, pur definendole «il libro meglio scritto del secolo nostro». Attraverso il Vieusseux, Leopardi incontra il Manzoni, che resterà sempre sordo al mondo e alla voce del poeta di Recanati; e conosce Stendhal. Altre due operette Nel 1827, Leopardi compone altre due operette, che entreranno nell’edizione postuma del 1845, il Dialogo di Plotino e di Porfirio e Il Copernico, e compila l’Indice del mio Zibaldone. Il primo novembre, il poeta si trasferisce a Pisa, per superare l’inverno a un clima più mite di quello di Firenze e più adatto alle sue malconce condizioni di salute. A Pisa: l’idillio «A Silvia» Il soggiorno di Pisa, nella dolce misura di questa città compostamente classica e insieme incantata e magica, appare agli occhi del Leopardi come il periodo più sereno e felice della sua esistenza. Giacomo sente rinascere in sé quel sentimento poetico che si traduce immediatamente nella esemplare canzonetta Il risorgimento, scritta a distanza di ben due anni dall’epistola in versi al Pepoli, tra il 7 e il 13 aprile del 1828, e, di lì a poco, nell’intenso idillio A Silvia, rievocazione della propria giovinezza perduta nella figurazione di un fantasma femminile. Del febbraio, è un epigramma giocoso, Scherzo, sulla mancanza di stile nella poesia moderna. A Pisa, lo raggiunge la notizia della morte precoce del fratello Luigi, appena ventiquattrenne. A Firenze In giugno, Leopardi torna a Firenze e vi resta fino a novembre. Conosce Vincenzo Gioberti e stringe amicizia con lui; e con Gioberti il poeta rientra a Recanati, costretto a tornare dalle sue aggravate condizioni di salute e dal fatto che, non potendo lavorare e non ricevendo più l’assegno dall’editore Stella, non ha i soldi per mantenersi fuori. Il ritorno a Recanati Il ritorno a Recanati, dove Leopardi si fermerà un anno e mezzo, ha effetti contrapposti: sofferenza e rassegnazione, disperazione e dolce malinconia. «Sedici mesi di notte orribile» definisce il poeta il suo soggiorno recanatese; un periodo di estraneità rispetto alla famiglia e al paese e di ripiegamento su se stesso e sui fantasmi di un passato rievocato con la disperazione di chi sente ogni cosa come irrimediabilmente perduta. È un circolo chiuso dal quale il Leopardi desidera uscire e, per questo, scrive agli amici chiedendo di trovargli un lavoro che possa portarlo fuori di Recanati e salvarlo dalla desolazione. E gli amici si danno da fare: il Tommasini gli procura una cattedra di mineralogia e zoologia all’università di Parma, ma la materia è troppo distante dagli interessi del poeta e, per di più, il compenso è misero; Bunsen, ministro prussiano fondatore a Roma dell’Istituto Archeologico, gli fa balenare la possibilità di una cattedra a Bonn o a Berlino, ma il clima tedesco è assolutamente inadatto alla salute del Leopardi; il Capponi cerca di fare attribuire alle Operette morali un premio di mille scudi istituito dall’Accademia della Crusca per un’opera di grande valore letterario pubblicata nell’ultimo quinquennio, ma la giuria dà la sua preferenza alla Storia d’Italia di Carlo Botta; il Colletta gli offre, a nome degli amici di Toscana (a titolo di dono anonimo o, se preferisce, come prestito da restituire magari con i proventi di un’edizione dei Canti), un assegno che gli avrebbe permesso di vivere un anno fuori Recanati senza problemi, ma Giacomo rifiuta, chiedendo piuttosto che gli si trovi il lavoro anche più umile per mantenersi. I grandi idilli In questo stato d’animo sofferto e combattuto, tra l’agosto e il settembre del 1829, nascono alcuni dei maggiori idilli: Le ricordanze, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, in cui si pronunciano la consapevolezza della giovinezza perduta, la certezza della vanità del tutto, la denuncia dell’inesistenza del piacere, «figlio d’affanno» o di speranza. E, nell’ottobre, viene iniziato ilCanto notturno di un pastore errante dell’Asia, contemplazione disperata di un mondo senza ragioni e senza fine, proiettato nel vuoto; canto che il poeta finirà nell’aprile del 1830. Di nuovo a Firenze: l’amore per Fanny Targioni Tozzetti Deciso a partire comunque da Recanati e non trovando nient’altro di meglio, alla fine Leopardi accetta la proposta del Colletta, fatta a nome degli «amici di Toscana». Fa tappa a Bologna, dal 3 al 9 maggio del 1830; poi, raggiunge Firenze. Qui, conosce Fanny Targioni Tozzetti e si innamora di lei, non ricambiato. In settembre rivede Antonio Ranieri e stabilisce con lui una più stretta amicizia; tra l’altro, il Ranieri, in intimità con la Targioni Tozzetti, fa da buon intermediario tra i due, contribuendo non poco a contenere la cocente delusione di Giacomo. In ottobre, conosce il filologo svizzero Luigi de Sinner, con il quale mantiene frequenti contatti epistolari. «Il passero solitario» Probabilmente, nel 1830, il Leopardi compone l’idillio Il passero solitario, su appunti preesistenti, e comincia a scrivere i Paralipomeni della Batracomiomachia, ripresa della polemica contro il «secol morto» e la corrotta e decaduta società italiana, in forma di satira sugli effetti barbari della Restaurazione e sull’inconsistenza e dannosità dei movimenti liberal-moderati. A seguito dei moti rivoluzionari che da Modena si sono propagati al resto dell’Emilia e nei territori marchigiani dello Stato Pontificio, a Bologna viene creato un governo provvisorio e Leopardi viene nominato deputato all’assemblea nazionale dal Pubblico Consiglio di Recanati. Non fa neppure in tempo ad accettare la nomina: l’intervento degli austriaci ristabilisce il vecchio ordine. La prima edizione dei «Canti» A Firenze, nell’aprile del 1831, esce la prima edizione dei Canti, portata a compimento dal Leopardi con l’intenzione di ripagare con i proventi il debito nei confronti degli «amici di Toscana». Con Ranieri a Roma Nell’ottobre, Leopardi e Ranieri, che ormai hanno stretto un sodalizio, si recano a Roma, per passare l’inverno a un clima più mite e per cercare, eventualmente, qualche incarico o lavoro. Leopardi, infatti, è ridotto alla miseria e gli pesa dover accettare aiuti e prestiti dagli amici. Studia modi per raccogliere un po’ di denaro; ma la speranza di ricavare qualcosa dai suoi vecchi lavori filologici, consegnati al de Sinner, va delusa e l’idea di fare, quasi interamente da solo, un giornale, «Lo spettatore fiorentino», sul quale vivere, si arresta di fronte al sospetto della burocrazia del Granducato. Con Ranieri a Firenze Nel marzo del 1832, Leopardi e Ranieri tornano a Firenze. Nel luglio, Giacomo, dopo alcune richieste, ottiene dal padre la concessione di un mensile, a dire il vero assai modesto, ma che lo solleva almeno dai bisogni più urgenti e immediati. La soluzione di questo sussidio, tuttavia, umilia il poeta, che decide in cuor suo di non rimettere mai più piede nell’avito palazzo dei conti Leopardi e nell’odiata Recanati, «sepolcro di vivi», come la chiamava. E, ciò nonostante, Giacomo continuerà a scrivere a suo padre, non soltanto con deferenza, ma con sincero affetto; a dimostrazione della complessità del rapporto che lo legava al padre. Un rapporto di odio-amore, identificazione-rifiuto, abbandono-cancellazione, che attraversa l’intera vicenda del Leopardi e che si risolve, alla fine, nell’adesione sentimentale, nella scelta del legame di sangue; mentre il conte Monaldo persiste, fino in fondo, nella sua freddezza, nel suo sostanziale disinteresse, vinto per di più da gelosie e travolto dalla più assoluta disapprovazione nei confronti del figlio. Disapprovazione che può essere riassunta nel gesto, esemplarmente indicativo, di chiudere le Operette morali nel settore dei «libri proibiti» della sua biblioteca di casa. Le due ultime operette Nel 1832, Leopardi compone il Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere e il Dialogo di Tristano e di un amico, le due ultime operette; nel dicembre, dopo aver ormai cessato di annotare sullo Zibaldone, si dedica alla stesura dei centoundici Pensieri, che sono la summa della sua riflessione filosofica, decantata in una cristallina gnomica della negazione e del nulla. Leopardi è, a questo punto, nella posizione lucidamente illuministica e quasi distaccata in cui rappresenta il suo Tristano, mentre guarda «intrepidamente il deserto del mondo» e, «maturo alla morte», continua a denunciare gli inganni dell’intelletto, così come a spendere qualche parola in difesa di quegli «errori dell’immaginazione» alla cui eroica inutilità sente, in fondo, di votarsi. Mancano poco più di quattro anni alla morte, ma Leopardi, tormentato dai suoi «patimenti fisici giornalieri e incurabili», se la augura di giorno in giorno. Anche il clima di Firenze è divenuto insopportabile per lui e, per evitare di passare con conseguenze peggiori un altro inverno nella città, insieme a Ranieri parte per Roma. Con Ranieri a Napoli Di lì, dopo breve sosta, Leopardi e Ranieri raggiungono Napoli, per stabilirvisi definitivamente nell’ottobre del 1833. Antonio e sua sorella Paolina assistono amorevolmente Giacomo, che dapprincipio risente favorevolmente dell’ottimo clima partenopeo. L’atmosfera di Napoli non gli dispiace, anche se, culturalmente parlando, lo infastidiscono le tendenze idealistiche e cattoliche che dominano la città. Frequenta amici vecchi e nuovi: Poerio e Troya, conosciuti a Firenze; il purista Basilio Puoti, maniaco dei sinonimi anche nel parlare comune e quotidiano al punto di ripetere tutto sempre in due o tre modi; il poeta tedesco von Platen, vicino al Leopardi per la comune ostilità nei confronti delle componenti mistiche e spiritualistiche del romanticismo; l’archeologo Schulz; quel Bunsen che, conosciuto a Roma, gli aveva procurato l’offerta di una cattedra in Germania. Il ciclo di Aspasia Tra il 1833 e il 1835, Leopardi attende alla composizione del cosiddetto ciclo di Aspasia; i canti cioè ispirati al poeta dall’amore per Fanny Targioni Tozzetti.Consalvo, probabilmente, è della primavera del 1833 e apre il ciclo delle poesie per Aspasia, sia pure in chiave più romantica rispetto agli altri componimenti, che sono in parte o del tutto successivi: Il pensiero dominante (1831-1835),Amore e morte (1831-1835), Aspasia (1833-1835), A se stesso (1835), caratterizzati da una lucida e desolata considerazione, attraverso l’infelice passione per Aspasia-Fanny, dell’«infinita vanità del tutto», del potente inganno di quell’amore che rilancia l’uomo verso una vita che si rivela però, inequivocabilmente, «amaro e noia». La seconda edizione delle «Operette morali» Nel 1834, a Firenze, esce la seconda edizione delle Operette morali, presso l’editore Piatti; oltre alle venti operette della raccolta pubblicata da Stella, questa nuova edizione contiene il Dialogo d’un venditore d’almanacchi e di un passeggere e il Dialogo di Tristano e di un amico, ed è corredata delle Note. L’edizione napoletana dei «Canti» Nel 1835, appare l’edizione napoletana dei Canti, presso l’editore Starita, e per la prima volta vi compaiono, oltre ai componimenti del ciclo di Aspasia, Il passero solitario, le canzoni Sopra un bassorilievo antico sepolcrale e Sopra il ritratto di una bella donna (composte tra il 1831, data dell’edizione fiorentina dei Canti, e il 1835) e la Palinodia. Al marchese Gino Capponi (anch’essa composta tra il 1831 e il 1835). La censura borbonica sulle «Operette» Nel gennaio 1836, il primo volume della nuova edizione napoletana delleOperette morali viene sequestrato dalla censura borbonica, e viene così a cadere il progetto di pubblicazione dell’intera opera leopardiana presso l’editore Starita. Leopardi, rattristato e risentito, compone probabilmente in questa occasione il capitolo I nuovi credenti, satira irridente contro gli spiritualisti napoletani; frutto di quella stessa polemica che ispirava al poeta, quasi contemporaneamente, la caricatura del mondo contemporaneo e dei suoi sogni di progresso, nellaPalinodia, e che gli aveva ispirato, in passato, l’attacco contro le barbarie della Restaurazione, nei Paralipomeni, terminati proprio in questo periodo e pubblicati postumi dal Ranieri nel 1842 a Parigi. La casa alle falde del Vesuvio e «La ginestra» Nell’aprile del 1836, Leopardi e Ranieri si stabiliscono, tra Torre del Greco e Torre Annunziata, in una villetta ai piedi del Vesuvio. Leopardi, la cui salute è sempre più incerta, ha bisogno di un’aria più asciutta e quella delle falde del Vesuvio, impregnata delle esalazioni vulcaniche, è per di più curativa di quell’asma che lo opprime insieme a ricorrenti bronchiti e a dolori reumatici. Nella villetta alle pendici del Vesuvio, Leopardi compone entro l’anno La ginestra, suo testamento poetico, e Il tramonto della luna, che saranno pubblicate soltanto postume, nell’edizione fiorentina del 1845 delle Opere curata dal Ranieri presso Le Monnier. La morte Nel 1837, a Napoli scoppia un’epidemia di colera. Leopardi non se ne dà cura; preso tra continui malesseri, i suoi ricorrenti fastidi, non rispetta le prescrizioni mediche e si abbandona a eccessi e abusi di gelati e di dolci. Improvvisamente, il giorno 14 giugno del 1837, dà segni di aggravamento repentino e muore nel giro di poche ore, assistito dal Ranieri, da sua sorella Paolina e dal medico inutilmente accorso al capezzale. Viene sepolto nella chiesetta di S. Vitale a Fuorigrotta; nel 1838 le ossa vengono traslate a Mergellina (anche se, a una successiva ricerca, non sono state ritrovate, avvalorando l’ipotesi che fossero state fin dall’inizio inumate in una fossa comune, a causa del colera). Le «Operette morali» Libro capitale, insieme con I Promessi Sposi, le Operette morali occupano il versante laico della nostra prosa, filosofico e materialista, mentre il romanzo del Manzoni occupa quello religioso, pedagogico e morale. «Libro dei sogni poetici, d’invenzione e di capricci malinconici», le aveva definite scherzosamente il Leopardi, consegnando invece a queste pagine la dialettica drammatica del suo pensiero e della sua stessa vita. Le «Operette» come «vera filosofia» Contro ogni tentato ridimensionamento, le Operette morali sono il nostro maggiore libro filosofico, dal tempo della Scienza Nuova del Vico. Ma la pretesa del Leopardi di essere a un tempo filosofo e poeta è stata ritenuta eccessiva e il suo pensiero è stato sistematicamente screditato, con argomentazioni non pertinenti. E, invece, «la concezione leopardiana è vera filosofia», come afferma Giorgio Colli: «le Operette sono dei miti filosofici, nel senso greco». Il punto è, una volta di più, la miopia dei critici, la loro sordità (per non parlare della loro malafede); perché «l’altezza di questa espressione umana è misurata dalla sua rarità». Cosa di cui, per altro, lo stesso Leopardi era del tutto consapevole, senza illusioni; come si legge, per esempio, nel Parini ovvero della gloria. Dentro la veste del mito, il Leopardi voleva dare forma alla crudezza della verità. E il progetto è riuscito; in una chiave perfino eroica. Come ha scritto Colli: «Mentre precluse a sé l’amabilità, con la sua parola sprezzante e cristallina, agli altri offrì l’occasione di conoscere la vita, gettandoli nel bagno gelato di una ragione sana, perché si scuotessero dal torpore dei narcotici moderni.» Fin dall’inizio apprezzate per il loro valore stilistico, sia pure nell’imbarazzo dei contemporanei di fronte alle idee che vi erano espresse, le Operette moralifurono riconosciute come il più alto modello di prosa italiana dagli scrittori della «Ronda». Ma solo molto recentemente individuate come libro mirabile della conoscenza, che ha spiegato, prima di Kierkegaard e degli esistenzialisti, l’angoscia dell’uomo per la nullità di fronte all’infinito e, prima di Nietzsche, la forza trasfiguratrice dell’immaginazione. Solo cinquant’anni più tardi, Nietzsche, che conosceva e apprezzava il Leopardi, avrebbe sottolineato il profondo significato del non-senso della vita e come questo non-senso potesse essere recuperato dall’arte. E avrebbe ripercorso le stesse tappe del Leopardi; parlando del vuoto, dell’assenza totale intorno a noi, oltre il tempo storico, e del recupero in una realtà mentale di oggetti, momenti, figure che si fanno sensazioni e illusioni, in qualche modo, di eternità. Opera filosofica, libro di poetica, autentica passione laica, le Operette moralirappresentano il testo limite della nostra letteratura non soltanto ottocentesca; luogo di coincidenza di poesia e di prosa, di ragionamento e di fantasia, di invenzione e di analisi del reale. Prototipo della «nuova» letteratura Anticipando da buon profeta i tempi, nelle Operette, il Leopardi realizza il prototipo della «nuova» letteratura, che non può fondarsi ormai che sull’antifrasi e regolarsi che sull’inversamente proporzionale. Ma proprio su questo versante, delle intenzioni ironiche per esprimere il dramma, si dichiara l’altro rifiuto della nostra critica, che, succuba di una tradizione drammatica, continua a sventolare la bandierina della presunta impoeticità. La filosofia come unica forma di conoscenza C’è un momento, nell’esperienza del Leopardi, in cui la filosofia appare improvvisamente l’unica, o comunque la maggiore, forma di conoscenza possibile. La fase culminante è il periodo che va dal 1823 al 1825: segue alla clamorosa delusione romana e coincide con le fitte letture filosofiche e con la volontà di dare fondamenti razionali al crescente pessimismo. Il viaggio fuori Recanati non serve al Leopardi soltanto per scoprire che la vita è «amaro e noia» ovunque; gli fa toccare con mano come l’età dei lumi sia passata invano, e la ragione sia costantemente latitante dalla società e dalle cose degli uomini. Uomini che si abbandonano, per esempio a Roma, all’uso corrotto del potere, perfino dentro la curia, o all’ozio e ai piaceri mondani, secondo i costumi delle classi dominanti, o al bamboleggiamento dei finti buoni sentimenti, tra i letterati, o all’abbrutimento della miseria, in mezzo al popolo. Niente più del soggiorno romano ha rafforzato in Leopardi la convinzione di doversi dedicare intensivamente all’esercizio della ragione, cioè alla filosofia; in ottemperamento a un’interiore esigenza etica, che corrisponde a quell’imperativo categorico che si impone, al di là di ogni interesse personale o di classe o di casta, come aspirazione al vero e al giusto. L’abbandono della poesia e la scelta della prosa Del resto, era già avviato su questa strada. Dopo le posizioni radicali dell’antiromanticismo del Discorso del 1818, sulla poesia come pura imitazione della natura secondo i canoni classici, il Leopardi della «conversione filosofica» aveva gradualmente allargato il suo orizzonte: dalla «poesia d’immaginazione» degli antichi a quella che egli chiamò «poesia sentimentale», ormai l’unica davvero possibile per i moderni. Una poesia in cui non si può fare a meno del ragionamento e che è «piuttosto una filosofia», perché «il sentimento è fondato e sgorga dalla filosofia, dall’esperienza, dalla cognizione dell’uomo e delle cose, in somma dal vero». Ma, dopo il soggiorno romano, si impone nettamente al Leopardi la priorità della filosofia come ricerca e conoscenza dei supremi principi della realtà, con mezzi che la poesia non può e non riesce ad avere; ed è un passaggio che coincide, nell’esperienza dello scrittore, con l’abbandono della scrittura poetica e con la scelta della prosa, che gli appare l’unico strumento espressivo in grado di rappresentare l’indagine filosofica. L’analisi della ragione e dei suoi principi Dell’adesione alla filosofia, le Operette morali sono lo specchio riflesso e, insieme, il percorso risolutivo; nel senso che, recuperata dalle pagine delloZibaldone (che è il terreno preparatorio), la filosofia viene sceneggiata, nel progetto dunque di una trascrizione artistica, e nello stesso tempo, in questa sceneggiatura, trova approfondimento. Al momento di disporsi alla composizione delle Operette, il Leopardi ha già conquistato quella consapevolezza del «solido nulla» che va assestandosi sulle posizioni di una concezione meccanicistica dell’universo di matrice illuministica. E questa visione negativa il Leopardi va traducendo, con scarti e aggiustamenti, nelle pagine delle Operette. Ma a imporsi sempre più, nel corso del libro, è una sfiducia nei confronti della ragione che, altrimenti usata, dà luogo a quegli «errori dell’intelletto» che alimentano la follia dei moderni e a quella nuova forma di superstizione che è il progresso. La meditazione filosofica del Leopardi si sposta insomma, nel corso delle Operette morali, dall’analisi della realtà all’analisi dei principi della ragione stessa. Posto a definitiva premessa delle Operette, nella Storia del genere umano, il fatto che irreversibilmente l’immaginazione fu nel corso del tempo sostituita dalla ragione, nella pratica comune degli uomini, il Leopardi circoscrive molto coerentemente la sua indagine alla ragione. E si accorge che la ragione, mezzo per altro che, se correttamente usato, porta alla scoperta del vero (cioè del nulla che «è il principio delle cose»), sottratta arbitrariamente a quelle che sono le sue fonti, cioè le sensazioni, diventa creatrice di inganni mostruosi. Ma, quel che più importa, si rende conto che anche la ragione è, alla fine, inattendibile, e incapace di spiegare le cose. Scrive il Leopardi nello Zibaldone del 2 giugno del 1824: «Non si può meglio spiegare l’orribile mistero delle cose e della esistenza universale (vedi il mioDialogo della Natura e di un Islandese, massime alla fine) che dicendo essere insufficienti ed anche falsi, non solo la estensione, la portata e le forze, ma i principi stessi fondamentali della nostra ragione. Per esempio quel principio, estirpato il quale cade ogni nostro discorso e ragionamento ed ogni nostra proposizione, e la facoltà istessa di poterne fare e concepire dei veri, dico quel principio non può una cosa insieme essere e non essere, pare assolutamente falso quando si considerino le contraddizioni palpabili che sono in natura.» E si riferisce a quel principio-di-non-contraddizione, negato dal fatto che l’uomo vive, proprio al contrario, costantemente nella contraddizione, in primo luogo, tra essere solo perché tendente alla felicità e non essere mai neppure per breve tratto felice. La scoperta dell’inadeguatezza della ragione Al di là dell’indagine filosofica sui termini qui un po’ parmenidea, è la scoperta dell’inadeguatezza della ragione a dar conto della «contraddizione evidente e innegabile nell’ordine delle cose e nel modo dell’esistenza, contraddizione spaventevole, ma non perciò men vera» e che si segna esemplarmente in una natura la quale, mentre ci rivela con l’uso della ragione tutta la verità del nostro infelice destino, continua a suscitare in noi speranze, illusioni, slanci d’affetto, per spingerci non solo a vivere ma, addirittura, ad amare e desiderare la vita. L’inadeguatezza della ragione, il Leopardi la verifica prima di tutto a spiegare la sua personale contraddizione tra la consapevolezza del nulla che è la vita e il piacere di «quelle immaginazioni belle e felici, ancorché vane, che danno pregio alla vita». E la ragione, naturalmente, non può negare quello che esiste e si dichiara: un anelito oscuro a vivere, pur nella consapevolezza della vanità della vita stessa («non solo l’intelletto mio, ma tutti i sentimenti, ancora del corpo, sono pieni di questa vanità»). Si attesta insomma, nel corso delle Operette e nel costante adeguamento della teoria alla pratica della personale esperienza, un disagio crescente nei confronti della ragione, che, nel Dialogo di Plotino e di Porfirio, viene indicata come uno dei pericoli maggiori per l’uomo, se non addirittura il più grande. Il ritorno alla poesia come romanzo autobiografico, unica filosofia fedele al vero Le Operette morali sono il testo in cui il Leopardi percorre la ragione per scoprire, alla fine, che essa è quella che tradisce più crudelmente l’uomo, che gli impedisce di conoscersi fino in fondo e di accettarsi. In una sorta di viaggio di Candide, ma non tanto tra gli orrori della realtà, che è comunque a monte, quanto attraverso le teorie, le interpretazioni (l’idealismo platonico, il cristianesimo, il razionalismo, quello che di lì a poco sarà detto positivismo), considerate la causa dell’infelicità umana; per significare, in fondo, che la realtà resta quella che è ed è il modo di disporsi nei suoi confronti, cioè di conoscerla, che conta davvero per l’uomo. E, nelle Operette, il Leopardi ha la prova che la filosofia è il punto morto, in questo tentativo di conoscenza, e che non offre neppure le scappatoie, per esempio, della poesia; alla quale egli ritorna negli anni 1828-1830, perseguendo un tipo di romanzo autobiografico in versi che gli appare ormai come l’unica filosofia fedele al vero e, insieme, come la nuova poesia che non ha più per oggetto il «bello». Quale sia l’importanza delle Operette nell’evoluzione della poesia leopardiana si può verificare in quel progressivo smarrimento delle distinzioni pregiudiziali tra scrittura poetica e prosa, nei cosiddetti «grandi idilli» e, di lì a crescere, nell’ultima produzione; senza contare il fatto, a cui accennavamo sopra, di una poesia che si fa espressione di una riflessione filosofica nel suo fluire, cioè di una visione delle cose e del mondo incarnata nel soggetto cogitante. Le Operette, insomma, costituiscono la premessa e addirittura la giustificazione motivata dello spazio angusto in cui la poesia del Leopardi si attesta; nel luogo della contraddizione inevitabile, di chi si ritrova consapevole del nulla che è la vita, ma si dispone all’abbandono, perché oltre la negazione vive comunque un’ombra, un riflesso, che è quello dell’immaginazione, in cui consiste «tutto il bello di questo mondo», e che porta naturalmente l’uomo, per brevi intervalli, a quella stessa illusione che contraddistingueva la mitica felicità degli antichi. Infatti, accade che «per cagioni menomissime e appena possibili a notare, rifassi il gusto alla vita, nasce or questa or quella speranza nuova, e le cose umane ripigliano quella loro apparenza, e mostransi non indegne di qualche cura; non veramente all’intelletto; ma sì, per modo di dire, al senso dell’animo», cioè a quella facoltà di sentire, insieme come pensiero, ragione, memoria, immaginazione, anche indipendentemente dalla realtà in sé, che resta quella che è; in un flusso di atemporalità e di ubiquità che è il puro desiderio di esistere. («Esiste nell’uomo una facoltà immaginativa, la quale può concepire le cose come non sono, e in un modo in cui le cose reali non sono. Considerando la tendenza innata dell’uomo al piacere, è naturale che la facoltà immaginativa faccia una delle sue principali occupazioni della immaginazione del piacere. Ella può figurarsi dei piaceri che non esistono, e figurarseli infiniti, in numero, in durata, in estensione. Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, si trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le illusioni...»,Zib. 183). E il puro desiderio di esistere, che coincide con una vaga aspettativa di felicità, in Leopardi si è delineato sempre più consapevolmente, nelle Operette, come salto in un futuro solo mentale, inesistente se non come fantasma dell’immaginazione, tipico tanto dell’uomo comune che dell’uomo di cultura (come appare, esemplarmente, nel Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere). Questo salto nel futuro caratterizza e determina la stessa poesia della memoria, che è poesia dell’attesa; magari, dell’attesa andata delusa. Perché il ricordo, in Leopardi, è un modo di tornare a figurarsi le cose e a vagheggiarle come un bambino; e tali piacevoli fantasie, paradossalmente, sono tenute vive dalla stessa carica che le sorreggeva al tempo dell’infanzia e della giovinezza: l’illusione che si realizzasse il meglio, che poi si è rivelata fallace, ma che tuttavia resiste come potenzialità di allora. Le letture filosofiche Il percorso delle Operette morali, verificabile come abbiamo detto sulle pagine dello Zibaldone, rispecchia non solo lo svolgimento autonomo del pensiero del Leopardi, ma anche il quadro complesso delle sue letture; da quelle euforiche e disordinate degli anni della «conversione filosofica» (1819-1821): i filosofi antichi, Platone, l’atomismo; a quelle più meditate degli anni 1822-1824: i sofisti, i retori, Isocrate, Cicerone, Frontone, e la letteratura e la pubblicistica illuministiche, con particolare attenzione a Voltaire e a d’Alembert, ma anche a Thomas e a Federico II di Prussia; fino a quelle decisive del 1825: ancora Platone e Cicerone, Epitteto, Eratostene e il Système de la Nature dell’illuminista d’Holbach. La concezione meccanicistica dell’universo La concezione del mondo che il Leopardi disegna nelle Operette è quella meccanicistica degli illuministi, riconsiderata direttamente sui testi degli antichi atomisti. L’universo è un perpetuo circuito di produzione e di distruzione; e produzione e distruzione sono collegate tra loro in maniera che ciascuna serve strettamente all’ altra e alla conservazione del mondo (Dialogo della Natura e di un Islandese). Non ci sono finalità nell’universo, che funziona secondo leggi necessarie, per cui tutti i fenomeni sono connessi ciecamente in una catena di cause ed effetti; e l’uomo è uno dei tanti fenomeni dell’universo. Tutte le cose hanno un principio e una fine, ma la materia è eterna: come mai è nata, così mai si dissolve; non cresce di quantità e nemmeno diminuisce, solo si modifica; mossa da una intrinseca forza di autoconservazione, crea «infiniti mondi nello spazio infinito della eternità» e questi mondi, venendo meno col tempo, si trasformano in qualche altra cosa; anche il nostro mondo rientra in questa legge immutabile e già, quasi sotto i nostri occhi, evolve trasformandosi: con i millenni, nel suo processo di modificazione, giungerà anch’esso alla sua distruzione con tutti gli esseri che lo popolano, e le sue particelle di materia andranno ad amalgamarsi in altre forme di mondi (Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco). Il tormentato rapporto con la natura Ma più che questa concezione dell’universo, sostanzialmente mutuata dalle fonti che abbiamo citato, o più in generale il tentativo di un sistema filosofico, tutt’altro che riuscito, interessano nelle Operette la mobilità ideologica del Leopardi e il suo sforzo di correggere le proposizioni di principio di fronte al vero sperimentato sulla propria persona. Emblematico, da questo punto di vista, è il tormentato rapporto dello scrittore con la natura, che attraversa l’intero libro. L’atteggiamento del Leopardi nei confronti della natura si è assestato col tempo ed è stato sempre guidato da un sentimento di amore-odio, più tipico dell’innamorato deluso che non del distaccato osservatore (e, del resto, è anche merito del Leopardi l’aver smesso di credere presto alla possibilità in assoluto di una osservazione distaccata). La posizione iniziale, sia pure ambiguamente, è sulla linea del Rousseau: la natura ha creato il mondo meraviglioso ed esseri ingenui disposti alla felicità, ma la ragione ha prodotto contaminazione, rovinando l’uomo, e la sua infelicità deriva dal progressivo distacco dal cuore della natura; ad essere felici sono solo le «età fanciulle» (Storia del genere umano). La posizione poi cambia, decisamente contro le teorie rousseauiane: la ragione stessa è prodotto della natura, matrigna per gli uomini, indifferente e spietato strumento della macchina cosmica che lavora esclusivamente alla propria conservazione (Dialogo della Natura e di un Islandese). E alla fine, tuttavia, il contrasto tra i termini «natura» e «felicità» appare attenuato, perché va cancellandosi quasi ogni addebito di responsabilità alla natura, che anzi istintivamente opera per rendere la vita il meno infelice possibile, cercando di addormentare quella ragione di cui pure fornisce l’uomo; e, d’altra parte, il concetto di «materia», più impersonale, si impone gradualmente su quello di «natura» (Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di Tristano e di un amico). Un materialismo assolutamente negativo Allo stesso modo, interessante da valutare, oltre che poeticamente significativa, è l’energia intellettuale che il Leopardi spende nelle pagine delle Operette, per attestare su principi di conoscenza il suo pessimismo, come materialismo organico, al di là di qualsiasi riferimento o addebito biografico e sociologico. E all’accusa che qualcuno gli aveva mosso, all’indomani della prima edizione delleOperette, di aver accentuato le conseguenze negative della sua interpretazione del mondo a causa delle condizioni e delle vicende della sua vita, il Leopardi risponde con una lucida dichiarazione, nel Dialogo di Tristano e di un amico del 1832: «So che malato o sano, calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogni inganno puerile, ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita, non dissimularmi nessuna parte dell’infelicità umana, ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa, ma vera.» Contro lo spiritualismo corrente, il Leopardi afferma, per bocca di Tristano, che «il corpo è l’uomo» e, in molti luoghi delle Operette, contro il razionalismo progressista, dichiara la convinzione che la vita sia soltanto infelicità e dolore, senza possibilità di evoluzione: un appassire inarrestabile e inevitabile verso la morte. Il materialismo del Leopardi è metafisico, sulla linea che da Democrito arriva fino agli illuministi; non è dialettico. È assolutamente negativo («Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista è un male») e le sue conclusioni sono che la morte è meglio della vita e che il non essere è meglio dell’essere («Non c’è altro bene che il non essere»). Ma è una negazione che non approda tuttavia alla disperazione e che, alla fine, rifiuta consapevolmente il suicidio, che sembrerebbe invece la conseguenza più logica; per una naturale contraddizione che la lucida correttezza del Leopardi non può non rilevare sulla sua stessa persona: il fatto innegabile che, anche di fronte alla consapevolezza della realtà, resiste un sia pur tenue allettamento a vivere, magari come sentimento negativo, come «piacere di non essere» («Non siamo dunque nati fuorché per sentire, qual felicità sarebbe stata se non fossimo nati?» Zib. 676). È lo spiraglio, del resto, attraverso cui passa, per bocca di Tristano, l’adesione del Leopardi, mai negata fino all’ultimo, a quegli «inganni dell’immaginazione» in cui continua a dichiararsi l’istinto naturale a vivere secondo felicità; a conferma e a puntualizzazione di quanto il Leopardi stesso aveva scritto, anni prima, nel lucidissimo Frammento sul suicidio: «Insomma il continuare in questa vita della quale abbiamo conosciuto l’infelicità e il nulla, senza distrazioni vive, e senza quelle illusioni su cui la natura ha stabilita la nostra vita, non è possibile.» La filosofia del «non essere» e della crisi La filosofia del non essere del Leopardi, nel corso della sua esperienza, coincide prima con il rimpianto e poi con la sorda protesta (proprio in questo ordine) dinon essere più, o magari di non essere mai stato, «fanciullo», cioè felice. È la verifica, sul piano teoretico, della corrispondenza tra l’identificazione istintiva del poetico con l’indefinito e vago (cioè l’aspirazione al nulla) e la coincidenza razionalmente scoperta di piacere e inesistente o non più esistente (il futuro, il passato). È una filosofia della contraddizione sulla viva carne dell’io; una forma di esistenzialismo radicale: la conoscenza della realtà e la scoperta dell’inutilità di tale conoscenza, anzi della condanna all’infelicità che essa segna, senza possibilità di altre scelte se non l’evasione dell’«immaginazione». Una filosofia della crisi, quale si evidenzierà solo sul finire del secolo, in cui l’individuo emerge come esistenza, inquieta e dolorante, che vorrebbe non esistere, per lo meno così come è. Una filosofia che rimedia a se stessa, sapendo di non sapere rimediare ai mali che conosce. «L’apice del sapere umano e della filosofia consiste a conoscere la di lei propria inutilità... E perciò solo è utile la sommità della filosofia, perché ci libera e disinganna dalla filosofia» (Zib. 304-305). L’interesse del Leopardi per la filosofia coincide progressivamente, a conferma della sua primaria vocazione di scrittore, con il progetto di una nuova scrittura filosofica, capace di eguagliare i risultati artisticamente superlativi di quella antica. Infatti, dal confronto tra testi del presente e del passato, nelle sue varie e sparse letture, Leopardi riporta l’impressione, divenuta sempre più convinzione, che la filosofia moderna si sia fatta da specialistica settaria e abbia adottato procedimenti meccanici e un lessico arido e freddo, allontanandosi da quel linguaggio immaginoso e concretissimo dei filosofi antichi, che riusciva, e ancora riesce, a colpire la fantasia dei lettori e a farsi intendere immediatamente. «L’odierna filosofia che riduce la metafisica, la morale ecc. a forma e condizione quasi matematica, - scrive il Leopardi nello Zibaldone (p. 1360) - non è più compatibile con la letteratura e la poesia, com’era compatibile quella de’ tempi ne’ quali fu formata la lingua nostra, la latina, la greca.» E, invece, le differenze tra grandi filosofi e poeti sono più apparenti che reali e tutti debbono possedere, parimenti, capacità di ragionamento e forza immaginativa. Il progetto di una filosofia «poetica» L’idea del Leopardi, nel momento in cui gli appare sempre meno fattibile la poesia tradizionalmente intesa, è quella di una nuova prosa, insieme filosofica e poetica, capace appunto di combinare, nella lettura della realtà, filosofia e poesia, che egli definisce «le facoltà più affini tra loro» (nello Zibaldone dell’8 settembre 1823). E, certo, non gli sfuggono né il rischio di ambiguità che si corre nel tentare una pista ibrida, né le difficoltà evidenti di una coniugazione da lui stesso riconosciuta fallita tra i moderni. Ma scrive ancora il Leopardi, nelloZibaldone del 24 luglio 1821: «Malgrado quanto ho detto dell’insociabilità della odierna filosofia colla poesia, gli spiriti veramente straordinari e sommi, i quali si ridono dei precetti e delle osservazioni... e non consultano che loro stessi, potranno vincere qualunque ostacolo ed essere sommi filosofi moderni poetando e scrivendo perfettamente.» Ecco il progetto formale da cui nascono le Operette; nel segno di una prosa cui si affidano, insieme, il compito di spiegare la realtà e quello di rappresentarla. Una prosa che, per le funzioni stesse di cui si carica, mira a porsi come tentativo di superamento e come innovazione; secondo il precetto più volte dal Leopardi richiamato, a proposito del suo lavoro di scrittore, che «una lingua non è bella se non è ardita». La prosa delle «Operette»: una scrittura «di cose» e di immagini per la filosofia La prosa delle Operette ha sempre raccolto larghi consensi presso la critica ed è piaciuta spesso anche a quelli che, contemporaneamente, rifiutavano o ridicolizzavano i contenuti del libro. È una prosa che, affondando le proprie radici nella tradizione italiana migliore, realizza un esempio tutto originale di linguaggio filosofico della reificazione e dell’immaginazione. Una prosa che oscilla, secondo le esigenze, dal preziosismo arcaizzante e «peregrino» del racconto-saggio (Storia del genere umano); all’eleganza brillante dei ritratti «morali» (Il Parini, Detti memorabili di Filippo Ottonieri); al sapiente pastiche, fitto di richiami eruditi, nei finti manoscritti ritrovati (Cantico del gallo silvestre,Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco) o nei giochi sulle sorti degli uomini (Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi, La scommessa di Prometeo); alla minuta e fluida oggettivazione, che qualcuno ha definito realistica, alla maniera degli illuministi, nei dialoghi. Le fonti Le fonti italiane appartengono al Trecento, al Cinquecento e al Seicento. Con una preferenza nettissima per la prosa cinquecentesca: il Gelli, in particolare, e Castiglione, Della Casa, Firenzuola, e gli scrittori politici come Machiavelli e Guicciardini; e per la concretezza degli scritti scientifici secenteschi, del Galilei e del Redi. Le predilezioni del Leopardi sono verificabili, del resto, nella stessaCrestomazia della prosa e si concentrano, guarda caso, sugli scritti raccolti nelle sezioni «Filosofia speculativa» e «Filosofia pratica». Fine dell'estratto Kindle. Ti è piaciuto? Download/Read Online Unlimited Books
Scaricare