Giusto de’ Conti di Italo Pantani Titolo Il titolo con cui è tradizionalmente conosciuto il canzoniere di Giusto de’ Conti, La bella mano (titolo anomalo, in rapporto sia al modello petrarchesco che ad analoghi esperimenti coevi), non è attestato dai rappresentanti più autorevoli dell’opera, dove essa è di solito trascritta adespota e anepigrafa. Rimandando a quanto si dirà tra breve circa l’attendibilità dei vari testimoni, dobbiamo qui anticipare che nei piani alti dello stemma codicum i soli titoli riscontrabili sono Canzoni morali et sonecti (O), o anche, ma entro estesa didascalia conclusiva, Sonetti et canzone (PO). Al contrario, in un meno affidabile settore della tradizione, la famiglia c, è possibile riscontrare come un graduale avvicinamento al titolo poi impostosi. Il suo più autorevole rappresentante, P2, si apre con la miniatura di un monumentino (recante l’epigrafe «Ivstvs vates romanvs orator ivrisque consultus ex Isabetae bononiensis amore composvit MCCCCXL»), sul quale scorre un cartiglio contenente una citazione del ternario 150 (v. 160): La bella man ch’el cor m’inchioda. Nell’assai più scorretto codice L, aperto dal titolo «d. Ivstvs de Valmontona ad Ysabetam bononiensem amasiam suam», si legge in chiusura Finivnt cantilene nvncvpate La bella man. Questa denominazione fu definitivamente accolta come titolo nella princeps Sb: Libellvs foeliciter incipit intitvlatvs La bella mano. Un titolo quanto mai indovinato, visto che nel canzoniere la mano di Isabetta è nominata 47 volte in 32 testi differenti; ma probabilmente non d’autore. Testimoni principali 1 FL3 = Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, ms. Ashburnham 1714. Cartaceo, sec. XV, cc. III + 63 + II’. Una sola mano, corsiva. Nota di possesso 1 Si adotta la numerazione dei testi fissata in I. Pantani, L’amoroso messer Giusto da Valmontone, Roma, Salerno Editrice, 2006, pp. 225-31. a c. 3r: «Mariotto di Ser Mariotto Romani Aretino»; e proprio tratti aretini caratterizzano la patina linguistica del ms., nel quale è possibile riconoscere il codice da cui nel 1819 C. Albergotti Siri pubblicò cinquantaquattro Rime inedite di Giusto de' Conti. Va peraltro segnalato come non pochi di questi sparsi testi contiani siano riferibili a particolari contatti dell’autore con l’ambiente di Pesaro (anni 1446-47). Contiene, precedute dal titolo «Opus domini Justi de Valmontone» (c. 3r), le rime: 1-17, 19-136, 18, 151, [Galli 279], 147, 152, 145, 137-144, 146, 150, I-LV. MA1 = Milano, Bibl. Ambrosiana, ms. I. 88. Sup. Membranaceo, sec. XV, cc. II + 90 + II’. Tre mani fondamentali: α, cc. 1r-38r, 51r-68v; β, cc. 39r-47v; γ, cui si deve la trascrizione della Bella mano, cc. 71r-90v. Nota di possesso a c. Iv: «Iste liber est mei magistri Tvrae de Bagnacavalo»; altra nota a c. I’v: «in Abiate 1481 mense martii valde sofflante Borea». Le prime due mani trascrissero Canzoniere e Triumphi del Petrarca; altre seriori aggiunsero (a cc. 68v e I’v) poche rime di N. Cieco e A. Sforza. Di Giusto contiene, adesp. e anep., le rime: 1-144. O = Oxford, Bodleian Library, ms. Canoniciano ital. 50. Cartaceo, 1464 (note cronol. a cc. 7r, 231r, 236v), cc. III + 237 + I’. Fu esemplato dall’ultrasessantenne carcerato Antonio Petrucci da Siena: già podestà in vari comuni, quindi conte presso Alfonso d’Aragona, ma poi rinchiuso da Federico di Montefeltro nella rocca di Urbino per essersi ribellato a Ferdinando (nota autobiografica a c. 231r). Miscellanea di prose e rime, di cui ampia parte è rappresentata dalla Bella mano, peraltro tràdita in una forma dissestata. Ripristinando la verosimile successione iniziale di carte e testi, dopo il titolo «Cominçano cançoni morali et sonecti del doctissimo et ornatissimo misser Justo da Vallemontone» (c. 85r), si recuperano le rime, nell’ordine: 1-50, 151, 51-144. P2 = Paris, Bibl. Nationale, ms. Ital. 1034. Membranaceo, sec. XV, cc. II + 75 + I’. Una sola mano. A c. 2v è miniato un cippo a base quadrata, alla cui sommità è un Amore bendato, ai piedi del quale scorre un cartiglio contenente una citazione del ternario 150 (v. 160): «LA BELLA MAN CH’EL 1 COR M’INCHIODA». Sulla facciata frontale del monumentino è l’epigrafe, scritta in lettere dorate: «IVSTVS VATES ROMaNVS ORator IVRIsque COnsultus EX ISABETAe BONONIENsis AMORE COmPOSVIT MCCCCXL». Patina linguistica padana. Contiene: 1-37, 145-149, 38-144, 150. PO = Pesaro, Bibl. Oliveriana, ms. 55. Cartaceo, sec. XV, cc. 57. Fu vergato da Raniero degli Almerici, noto rimatore, nonché funzionario presso gli Sforza di Pesaro. Importante la nota a c. 54r: «Quisti sonetti et canzone sonno di l’amoroso miser Giusto dal Valmontone, scripti per mi Rainero degli Almerighi da Pesaro et di propria mano; et sonno tucti quigli che se ritrovino inseme, benché ne componesse molti piú; et perché varie sonno le opinione degli omini, delibero tucti quigli se ritroveranno di i soi, et a cui perveniranno, mettegli dietro a questa carta et seguire». Invito che sarà raccolto da Annibale degli Abati Oliveri, che nelle cc. sgg. introdusse (dalla stampa del 1715) le rime 148, 149 e 150. L’Almerici aveva invece trascritto i testi: 1-17, 19-136, 18, 151, 77 [2a tr.], [Galli 279], 147, 152, 145, 137-144, 146. Sb = stampa princeps, intitolata «Ivsti de Comitibvs romani vtrivsqve ivris interpretis ac poetae clarissimi libellvs foeliciter incipit intitvlatvs La bella mano» (c. 1r). [Bologna], per me Scipionem Malpiglivm bononiensem, MCCCCLXXII (c. 68v). Curatore: «Iohannis Baptiste de Reffrigeriis de Bononia, carmina in lavdem domini Ivsti» (c. Ir). 8°, cc. I + [73]. Contiene le rime 1-37, 145-149, 38-144, 150, in un ordine assai dissestato (1-19, 21, 20, 22-37, 145-149, 38-88, 91, 89-90, 98, 92-97, 103, 106-108, 99102, 113, 104-105, 114, 109-112, 142, 115-118, 122, 121, 119-120, 125, 123-124, 127-134, 126, 135-141, 143-144, 150). Ragguagli sulla tradizione La tradizione delle rime contiane comprende 93 manoscritti e 24 stampe (escludendo le tante moderne antologiche). Di tali testimoni, 31 codici e 12 edizioni a stampa trasmettono (in forma raramente lacunosa) una raccolta narrativamente strutturata, dunque un vero canzoniere, comprenden- te dai 144 ai 150 testi, il quale dalla pubblicazione della princeps (1472) porta il titolo La bella mano. I testimoni restanti, se per lo più attingono da tale corpus selezioni anche minime di componimenti, in altri casi risultano assai rilevanti, sia in quanto portatori di varianti d’autore, risalenti a stadi redazionali anteriori alla revisione compiuta dal poeta nella costituzione del macrotesto; oppure in quanto rari (o unici) documenti di 60 rime estravaganti (oltre a sei di dubbia attribuzione). I testimoni dell’intero canzoniere possono innanzitutto essere distinti, sulla base del numero e della disposizione dei componimenti, in tre grandi gruppi: la famiglia a, la più eterogenea, è comunque riconducibile a una struttura comprendente i testi 1-144; la famiglia b, caratterizzata da vari dissesti, raggiunge i 150 componimenti immettendo i nn. 145-147 e 151152 (secondo l’ordine 1-17, 19-136, 18, 151, 147, 152, 145, 137-144, 146); la famiglia c, aggiungendo i nn. 145-149, 150, perviene alle stesse dimensioni con la più compatta successione 1-37, 145-149, 38-144, 150. I codici più autorevoli del gruppo a sono MA1 e O: rispettivamente, i più affidabili testimoni dei due rami della famiglia, a1 e a2. MA1 è il manoscritto, romagnolo, che meglio conserva l’originaria configurazione dell’opera, confermata dai discendenti toscani (VM4, F4 e T) di un suo collaterale; più defilata, all’interno di a1, è la posizione di un gruppo di codici lombardi e veneti (FL1, oltre agli scorrettissimi BS, S, MA, MT), i quali, per una certa oscillazione di tratti comuni e distintivi rispetto ad a1, ma soprattutto per la mancata attestazione in essi del polimetro 144, potrebbero discendere da uno stadio del canzoniere anteriore all’introduzione del polimetro finale. Nonostante notevoli dissesti materiali, chiaramente affine ad a1 è invece il ramo a2 (di origini senesi e feltresche), nel quale, accanto al contraddittorio F5 (rarissimi errori congiuntivi, innumerevoli distintivi), si segnala per cura del copista il codice O, a sua volta imparentato con F8, e con i decisamente più scorretti V7 e F6. Nonostante la minore affidabilità strutturale, molto importante sul piano testuale è da considerarsi anche il gruppo b, localizzabile lungo una direttrice che, unendo Pesaro (PO, ma anche le fonti delle rime estravaganti aggiunte da FL3) ad Arezzo (lo stesso FL3, V2), si estese fino al territorio romano (R). In particolare, oltre alla correttezza testuale di PO e 2 V2, questa famiglia può vantare, grazie a FL3, la trasmissione in testimonianza quasi unica di una silloge di ben 55 rime estravaganti di Giusto (poche delle quali sparsamente documentate da qualche miscellanea): poesie in buona parte ancora dedicate alla protagonista del canzoniere (e da questo escluse per disomogeneità stilistica), ma comprendenti anche due brevi e successivi cicli lirici, nati negli anni ’40 da particolari contatti, si diceva, con l’ambiente cittadino di Pesaro: il primo (di dieci testi) rivolto a una Laura, morta quindicenne, e appartenente alla qui trasferitasi famiglia fiorentina Dell’Antella; il secondo (di una dozzina di rime) dedicato al più appagante amore per una Vittoria, identificabile con la Vittoria Colonna vedova di Carlo Malatesta. Originario della corte di Rimini, presso la quale il Conti trascorse i suoi ultimi anni di vita (1447-49), è invece da ritenersi l’assetto macrotestuale tràdito dal gruppo c, di cui P2 è il testimone più affidabile: a tale conclusione conducono infatti da un lato le qualifiche attribuite al poeta da vari rappresentanti di questa famiglia (come gli scorrettissimi E1 e V8), simili a quelle incise sul sepolcro riminese di Giusto, e tutte celebranti i suoi natali e i suoi titoli giuridici; dall’altro la pertinenza tipicamente malatestiana di alcune delle rime caratterizzanti tale gruppo: il son. 145, dedicato a Vittoria Colonna; il 148, ostile ai “barbari” Aragonesi; il 149, affermazione della sopravvivenza dell’amore oltre la morte; il ternario 150, visione permeata di elementi neoplatonici. Peraltro, lo stesso incoerente inserimento della maggior parte di questi testi in un’area iniziale del macrotesto (tra i sonetti 37 e 38), da riferirsi a stagione decisamente anteriore (metà degli anni ’30), impedisce di assegnare all’autore l’assetto macrotestuale di questa famiglia, probabilmente nata, al contrario, da iniziativa interna alla corte riminese. Ciononostante, una serie di circostanze fece sì che l’assetto di questo gruppo risultasse di gran lunga il più fortunato. Innanzitutto, su di esso basò il proprio notevole impegno promozionale nei confronti della Bella mano, databile ai primi anni ’60, il poligrafo veronese Felice Feliciano: estensore in proprio di O1, di miscellanee e di documentati codici perduti, decoratore di MT1 e O2, ispiratore di L. In secondo luogo, forse per impulso dello stesso Feliciano, e nonostante vistosi dissesti strutturali e il ricorso a complesse contaminazioni, nel quadro di questo gruppo (e di particolari rapporti con O2) fu elaborato il testo dell’infedele princeps Sb: stampa sulla quale si baseranno le successive edizioni dell’opera (Venezia 1474, Venezia 1492, Venezia 1531 quest’ultima solo parzialmente corretta sulla base di VM4), finché il lavoro filologico di Jacopo Corbinelli, approdato all’edizione parigina del 1589, riconsegnerà all’opera una fisionomia dignitosa, sulla base però di pesanti ammodernamenti linguistici, e di un lavoro di collazione condotto sul manoscritto P2: testimone certamente ben più corretto della princeps, ma appartenente alla medesima, poco affidabile famiglia c. Non più fortunata la successiva storia editoriale. Dopo varie ristampe, soprattutto settecentesche, sempre più impegnate nel segno di una meticolosa modernizzazione della veste linguistica (acquisita poi dalla critica come sorprendente elaborazione dell’autore), la scoperta nel 1819 di FL3, e dei molti inediti contiani da esso conservati, indusse nel 1918 L. Vitetti a pubblicare la prima (e al momento ultima) edizione “completa” delle rime di Giusto (G. de’ Conti, Il canzoniere, Lanciano, Carabba, rist. ivi 1933), seguendo purtroppo i seguenti aberranti criteri editoriali: ridistribuzione dei testi secondo la dissestata struttura di FL3 (privilegiata per la maggiore ricchezza, senza alcuna attenzione alle sue contraddizioni); veste testuale tratta non da FL3, ma dalle precedenti edizioni a stampa, con l’inserimento peraltro delle varianti (spesso erronee) attestate da FL3 e segnalate da altri studiosi; acquisizione delle estravaganti tràdite da FL3 e da altri codici, mai però trascrivendole dai testimoni, bensì desumendole da disparate trascrizioni erudite; nessuna attenzione attributiva, con conseguente introduzione, tra le estravaganti, di rime non contiane. Alla luce di questa tradizione, la futura edizione critica non potrà che ripartire dall’assetto macrotestuale tràdito dalla famiglia a, l’unico certamente d’autore; aggiungendo a seguire: le rime inserite nel canzoniere dalle altre due famiglie, la silloge di estravaganti di FL3, e infine le rime disperse in pochi altri codici. In apparato, oltre alle varianti di tradizione, non dovranno essere trascurate quelle d’autore, attestate da vari codici miscellanei, che ci hanno conservato stadi redazionali anteriori alla rielaborazione operata dall’autore ai fini dell’inserimento nel macrotesto. 3 Periodo di composizione La prima forma compiuta del canzoniere fu pubblicata nel 1440, come documentato dalla citata epigrafe miniata a c. 2v di P2 («IVSTVS VATES ROMANVS ORATOR IVRISQUE CONSULTUS EX ISABETAE BONONIENSIS AMORE COMPOSVIT MCCCCXL»). Le rime confluite nel canzoniere possono dunque essere datate agli anni 1433-40, corrispondenti ai tempi della storia (vedi oltre). Allo stesso periodo andranno anche riferite diverse liriche estravaganti dedicate a Isabetta, escluse dal canzoniere (146-147, 151152, I, XII-XXII, XXVI-XLIII). L’attività poetica del Conti tuttavia non si fermò qui. Il polimetro 144, assente in un’area (per quanto compromessa) della tradizione, ma testo conclusivo del canzoniere nei suoi più autorevoli testimoni, si direbbe aggiunto nei primi anni ’40: per la sua oscura, probabilmente allegorica ambientazione romana («qui, sotto Aventino», v. 19), non compatibile con tempi anteriori della biografia contiana; ma soprattutto in quanto prima, aperta denuncia del matrimonio dell’amata con un rivale, evento risalente al 22 ottobre 1441, se nei due sono davvero da riconoscere Isabetta Bentivogli e Romeo Pepoli. Anche tra le rime disperse se ne incontrano varie (XXIII-XXV, XLIV) risalenti a questo periodo immediatamente successivo alla definitiva sconfitta del poeta: basti pensare a versi particolarmente espliciti come «Altri possede et io piango il mio bene, / che in acquistarlo tanto tempo persi» (XXIII 1-2); o «Ch’ io sono in libertà, e questa altera, / crudele, ingrata, falsa donna, a cui / de volontà me fei servo fedele, / rivolti ha i soi pensier tutti in altrui» (XLIV 9-12). Agli anni del mandato come Tesoriere nella Marca Pontificia (144647), risalgono invece (probabilmente) le rime dedicate a Laura Dell’Antella (II-XI) e Vittoria Colonna (XLIV-LV), mentre al breve periodo riminese (1447-49) sono da ricondursi l’ultimo, visionario testo per Isabetta (il ternario 150), e alcune corrispondenze, soprattutto con l’urbinate Angelo Galli (148-149, LVIII). Numero dei componimenti 144 componimenti, nella forma certamente d’autore (famiglia a) del can- zoniere. Tale numero sale a 150 nella forma c, con contraddizioni interne, tuttavia, difficilmente ascrivibili a Giusto (certamente spuria è la struttura di b). Oltre ai 6 testi aggiunti da c (145-150) e agli altri 2 immessi da b (151-152), ci sono poi pervenute sotto il nome del Conti 55 rime raccolte nella silloge di FL3 (I-LV), altre 3 rime trasmesse da testimoni diversi (LVI-LVIII), e 6 componimenti di assai dubbia paternità contiana (LIXLXIV): escludendo i quali, si raggiunge un totale di 66 rime estravaganti (e di 210 testi complessivi). Forme metriche impiegate Nella forma a, di 144 componimenti: Sonetto - n. 131 Canzone - n. 5 Sestina - n. 3 Ballata - n. 2 Capitolo ternario - n. 2 Polimetro - n. 1 (135 nella forma c) (3 nella forma c) (3 nella forma c) Aggiungendo le rime estravaganti (ma non quelle di dubbia attribuzione), il repertorio completo delle rime contiane raggiunge le cifre seguenti: 194 sonetti, 6 canzoni, 3 sestine, 3 ballate, 3 ternari, 1 polimetro. Punto α Il canzoniere contiano è aperto da un sonetto, nel quale l’esperienza sentimentale è sì rappresentata in uno stadio molto avanzato, configurandosi, con metafora vegetale, come «amorosa spina» irreparabilmente radicatasi nel cuore del poeta; uno stadio però non ancora conclusivo, constatato che, in un presente interno al macrotesto, l’io poetante ancora «d’Amor e di madonna si ragiona». Amor, quando per farme ben felice l’alta amorosa spina nel cor mio 4 piantò con la gran forza del disio che ’nfin ne le mie piante ha la radice, mi fé pria singular più che fenice, mentre a mia voglia a morte l’alma invio, e poi mi tinse nel tenace oblio sì ch’a me ricordar di me non lice. Da inde in qua mia voce mai non tacque, ma sempre, ovunque io fusse, lagrimando d’Amor e di madonna si ragiona; così de lei parlare ognor mi piacque, el suo bel nome ne’ mei detti alzando che ’n tante parte per mia lingua sona. Punto ω Il punto ω della Bella mano può essere riconosciuto in componimenti diversi. Chi intendesse considerare i ternari finali come una sorta di riassuntiva appendice, troverebbe conferme nel carattere conclusivo del componimento che li precede, il sonetto 141; un congedo rivolto allo stesso “libro” di rime, inviato alla donna per confessarle la fine del servizio amoroso, esauritosi per consunzione da lontananza: Va, testimon de la mia debil vita, nanzi a l’altero e venerabil fronte, a piè del bel fiorito e sagro monte: mira se l’alma nostra indi è partita. Ivi è la vista ch’al ben far me invita e d’ogni mia salute il vero fonte; ivi son, lasso, quelle man sì pronte, ond’io soffersi l’immortal ferita. A lei te inchina, e di’ ch’io più non posso: il corpo è stanco, e stanchi i mei pensieri, vivendo sempre dal mio ben lontano; ma pur l’usanza, colla morte adosso, vuol che in tanta aspra guerra pace io speri dalla benigna sua pietosa mano. Tuttavia, il polimetro che chiude la forma a (n. 144) non si limita a riassumere il percorso del canzoniere dall’iniziale entusiasmo alla delusione per l’indifferenza dell’amata e per il gioco crudele delle sue lusinghe, quindi alla svolta del forzato distacco, con la nascita di sospetti e gelosie, fino, come visto, alla resa per stanchezza. In forma pastorale, il polimetro 144 denuncia esplicitamente che la donna si è data ad un rivale (in sposa, confermerà l’estravagante XXIII). Pastoris variam mentem variumque stilum nemo admiretur, quoniam quem patitur dolor extat et ipse varius ac iniuria notanda. PASTOR HERMOFRONDITUS La notte torna, e l’aria e ’l ciel s’annera, e ’l sol s’afretta a fornir il vïaggio, dietro alle spalle avendo omai la sera. E come intorno el fugitivo raggio sparisce altrui, cosí dentro io m’infosco per lo novello in me commesso oltraggio. Itene a casa, e noi lassate al bosco pasciute pecorelle, e voi d’intorno, pastori, omai venite a pianger nosco! E ben che l’ora a noi ne celi il giorno sotto ’l gravoso velo della terra, la luna ha pieno l’uno e l’altro corno. Ma tu vicin, per Dio, la mandra serra, sí tosto come a noi di su s’oscura e la gran luce se ne va sotterra: né qui né altrove è ben la fé secura, e chi no ’l sa si specchi nel meschino, che per fidarsi tal tempesta dura! Un altro Cacco qui, sotto Aventino, con orme avverse e disusati inganni fura gli armenti di ciascun vicino. Ercole è morto già, che di tanti anni gli ramentò l’offese e puní l’onte, e fé vendetta de’ passati danni. E già ’l carro stellato tocca il monte con la sua ponta, sí che l’ora è tarda: 5 mira che oscura tutto l’orizonte. Di che, per Dio, sta’ desto, e ben ti guarda: ira di stelle e di fortuna colpo uman provedimento pur riguarda. Ma chi ne incolpo in tanta mia ruina? Sentenzia divina, e mia sciocheza el volse, e la dureza de chi adoro. Se ’l serpe che guardava il mio tesoro fusse dal sonno stato allor piú desto quando per Damne Iove si fé d’oro! Né quel né questo (ond’io mi lagno ognora in guisa che m’accora, ed è ragione) sarebbe la cagione al duol ch’io provo. Ah, ch’un novo Sinone! Or basta omai, Amor, ch’assai tai guai per noi son pianti, e gli occhi santi donde ancor mi struggi. Ma tu perché mi fuggi, cor di sasso? Deh, ferma il passo, e mei lamenti ascolta; prendi una volta del mio mal cordoglio! Io sarò pur qual soglio, infin che morte le corte mie giornate no interrompa. Soperchia pompa de vederti bella te fa sí fella contra me e te stessa, in cui mia spene ho messa. Ahi, crudo Amore, non hai del mio dolore ancor pietade? Del verno estade fa per forza el tempo, e tu di tempo in tempo stai piú salda, e men ti scalda l’amoroso foco, e parti un gioco il gran martir ch’io sento: deh, perché ’l mio tormento a te non duole? Ben son le mie parole senza senso, ch’io penso far d’un orso il cor piatoso, e per trovar riposo guerra cheggio. Ma se Chi puote il vole, a che ripenso? L’immenso suo voler el m’è nascoso, e pur cercar non oso miglior seggio. S’io veggio che costei mi cela il suo bel viso e i vaghi lumi, che fé natura per mio mal sí adorni sol perch’io mi consumi, doh, cor tradito, e vani pensier mei, perché smarrito dal camin non torni? Lasso, le notti e i giorni mi vo strugendo, e pur l’ingorda voglia per tutto ciò non sbramo, né dal cor levo la tenace spene. Cosí tra due mi tiene Amor, che da l’un lato morte chiamo, da l’altro cerco d’aquetar la doglia: sí d’ogni ben mi spoglia la fiamma che mi rode nervi e polpe, né so chi, lasso, del mio mal ne incolpe. L’astuta volpe, che svegliò per forza il topo che dormiva, quando vi penso a lagrimar mi sforza. Venga Siringa all’infamata riva, dove la canna nacque e fece i fiori, perch’i’ convien che mille versi scriva! O tu ch’al mondo ancor Certaldo onori, deh, maladetto sia quando mostrasti tal arte nel trattar de’ nostri amori! Per piú mia pena, lasso, tu informasti qualunque dopo te nel mondo nacque, alor che di Guiscardo tu trattasti. Rise la mia speranza, e poscia tacque, vedendo dentro come ’l cor ardea del bel misser che a lei cotanto piacque. Seco legendo tutta si strugea, di faville d’amor nel volto accesa; poi, sorridendo, l’occhio li porgea. Allor credette il topo averla presa; né s’accorgeva ch’a sí poca forza, al parer mio, troppo alta era l’impresa. L’astuta volpe, che svegliò per forza il topo che dormiva, quando vi penso a lagrimar mi sforza, tal che dagli occhi un fonte mi diriva. Solea nel petto mio, già viva viva pietosa e schiva starsi la mia donna, come ferma colonna in loco posta; 6 e or posto ha in oblio, come a sua posta. Son posto in croce, e tormentato a torto; non spero mai conforto, né trovar porto in tanta mia tempesta: questa sirena al suo cantar m’aresta, finché m’investa l’onda che m’affonda. Non sento chi responda al mio gridar, che par già mi consume: l’altero e dolce lume degli occhi, che mi fur governo e vela, fortuna, isdegno e gelosia mi cela. Rotta è la tela, che con tanto affanno già piú d’un anno avea piangendo ordita; compita è la mia trama in sul fiorire. Chi mi rivela come andò l’inganno che tanto danno a lagrimar m’invita, sí che di vita l’alma vuol partire? Non puote piú soffrire ca quella, per chi ancora ella rispira, ver me s’è volta in ira: ond’io dí e notte piango, e non mi stanco, perché mia vita tosto vegna manco. Ha manco il manco e forsi, chi sa, il ritto; E cosí manco lui tal guerra famme! Doh, cieco Amore, or non l’hai tu a dispitto? Io fugirò in Egitto, perché ’l tuo sguardo, ingrata, non m’infiamme, dapoi che qui riposo m’è interditto. El n’è già scritto sí che mille carte ne ingombra il fiero inchiostro della mia pura fede. Il sempre sospirare, il pianger nostro rimbomba in tante parte in quante il sol ne scalda e ’l ciel se vede. Né te han mosso a mercede né mei lamenti, né mei iusti preghi; anzi a colui te pieghi a cui piú manca quel che pria si chiede. Chi l’ha veduto il crede! S’io dico il vero, deh, perché me ’l nieghi? Stolto, tu preghi il sordo: non ha ricordo delle sue impromesse, giurate e spesse, che già lei ti fé. E che mi vale el mio voler sí ’ngordo? Non vuole accordo, che ragion gli fesse, ma spesse volte dolmi di sua fé. Di ciò ne incolpo te, Amore amaro, e quella falsa vista che nel pensier m’atrista col fugir che or mi fan gli occhi sereni: con la qual forza come vuoi mi meni. Niccolò, vieni! Or chi fia chi m’intenda? Comprenda mia ragion colui a chi tocca, che scocca la balestra senza legge. Corregge il servo e regge el sire, e menda. Venda la donna, e l’uom prenda la rocca: sciocca e sinistra cosa a chiunche legge! E par che mi dilegge misser, quanto vaghegge allor per caso il giorno che di fresco lui sia raso. La mosca che mi vola intorno al naso, non altrimenti la matina a terza che quando il sole è già presso all’occaso, con altro creda che con debil ferza, lei minacciando, quindi scacciarò. Mira che a guisa d’asinello scherza. Cosí noi aren pace, e poi farò del guardo traditor crudel vendetta, ché quel che in cor non era mi mostrò. Ahi, falsa, intendi: io dico a te, aspetta! Vedi che volan l’ore e gli momenti, e come ’l tempo al trappassar s’afretta: Apollo non arà d’intorno venti volte trascorso tutto in giro il mondo, che d’esser viva converrà ti penti. Io parlo chiaro, e non mi ti nascondo. Esiste infine anche la possibilità che il Conti avesse pensato a un’ulteriore, 7 rinnovata conclusione per il suo canzoniere. Nella forma trasmessa dalla famiglia c, infatti, il polimetro è seguito da un nuovo ternario, la “visione” 150, in cui l’intera vicenda amorosa viene riletta, con sguardo rasserenato, alla luce di peculiari categorie neoplatoniche. Anche se, come detto, questa forma c difficilmente può considerarsi d’autore (a causa delle contraddizioni diegetiche determinate dagli altri cinque componimenti in essa aggiunti), non si può escludere che il ternario 150, pur certo composto negli ultimi anni di vita dell’autore, fosse effettivamente destinato a chiudere il canzoniere in una versione aggiornata di quest’ultimo. Se con l’ale amorose del pensero a volo alzar si può nostro inteletto, tanto ch’io veda immaginando il vero, Amor, il tempo e ’l mio vago concetto, acceso in fiamma di novel disire che me isgombrava ogni voler del petto, un giorno avean rivolto al mio martire ogni mio senso, già sviato altronde, per veder la cagion del mio languire; e ’l dolce immaginar che mi confonde avea ritrata la già stanca mente da quei begli occhi e dalle trezze bionde. Già sentía solevar sí dolcemente l’anima grave e l’affannato velo, che or mi fa lieto nel pensier sovente; e carco d’un soave e caldo gelo, non so se falso sonno o ver oblio mi scorse e spinse infin al terzo cielo. Ivi cosí conduto dal disio, mirai le stelle errante ad una ad una, che son principio del mio stato rio; mirai con loro il corso della luna, e vidi perché ’l mondo chiama a torto la sorte iniqua e cieca la fortuna. Poi rasembrava lor vïagio torto al vago giro del fatal mio sole, che dentro volgon gli occhi che m’han morto; suo caro riso, sue sante parole e ’l suspirar dell’anima gentile, all’armonia che lí sentir si sòle; el senno, la biltade, l’atto umile e le virtute in quel bel petto sparse, ove non si creò mai pensier vile. Pensando agli alti effetti ancor mi parse che avesse piú che loro in me possanza la vista che in un punto el mio cuor arse; e rimembrando mia dolce speranza, mentre che ’l pensier dentro piú forte ergo cosí come il pareggia e come avanza, rivolgo gli ochi al glorïoso albergo, al loco aventuroso ove oggi vive lei per che piango e sempre carte vergo: fra i dolci colli e l’onorate rive dove è colei che arà mia vita in mano finché del suo spirar morte la prive. Era in quel’ora il viso piú che umano rivolto suso al ciel, dond’è il sol degno, e gli occhi che mi strugon di lontano. Non so se ’l riso o suo legiadro sdegno, non so se ’l lume altier, che ’l cuor m’infiamma, avea di foco l’universo pregno: non era al parer mio rimasa dramma in cielo, in terra, in mare o ne l’abisso, che non ardesse de amorosa fiamma. Io non era possente a mirar fisso di lungi pur la vista di colei per che gran tempo in giaccio e in foco ho visso; cosí abagliava i fragil sensi mei quel bel ragio seren del viso adorno, che per seguirlo libertà perdei. Ma ben vedea el mondo d’ogni intorno arder già tutto, e le mortal faville nascer nel mezo del suo bel sogiorno: però credo le luce mie tranquille eran cagion, sí come della doglia perché convien piangendo io mi distille. Sapea ben come cangia ogni mia voglia, se volge el lume tra el bel nero e ’l bianco, colei che d’ogni ben mia vita spoglia; et io sentía a poco venir manco il mio debel valore, e di paura 8 tremare il fredo cor nel lato manco, e l’alma, sbigotita per l’arsura sul sangue che bollía già nelle vene, chiamar soccorso a·llei, che non ha cura. Lasso me, non poría, parlando, bene redire il modo, la stagione e l’ora, né la cagion de sí legiadre pene, mentre che ardendo Roma strugea alora, cieco; piú cara vista ormai rapella in parte ove ’l pensier piú s’inamora. Vedeame innanzi l’amorosa stella che amar ne insegna con soi rai possenti, a sí gran torto sol ver me rubella. I lumi a noi nemici eran già spenti per tutto il mondo, e li crudeli aspetti, Saturno e Marte e li contrari venti; le stelle piú felice e i cari effetti vedeanse insieme tutte in sé racolte, in luochi signorili alti et eletti; e sí benignamente eran rivolte al sacro loco di che pria parlai, che spiegar nol porían parole sciolte. Scendea dai santi e benedetti rai tal dal ciel pioggia in su l’amate trezze, che ’l non fia stelle che ’l paregi mai; et una nube carca di bellezze l’aere d’intorno avea tutto ripieno di gioia, di onestate e di vaghezze. Mirando il ciel sí lieto e sí sereno, e l’altre stelle volte nel bel viso che già il foco mortal m’ha aceso in seno, ripien di maraviglia, in paradiso credea esser portato ’nanzi morte, o spirto errante dal corpo diviso. E volea dir: «Ahi, mia spietata sorte, in ciel de quei begli occhi or si fa festa ch’io scelsi per mei segni e fide scorte, e me fra l’onde e la magior tempesta mia guida lassa ove me spinge Amore, onde è pronto il mio fine e morte presta!». Ma non piú tosto tal pensier al core giunse, ch’io mi rivolsi all’altra parte, là dove a·ssé mi trasse un novo errore. Io vidi con quest’occhi ivi in disparte l’immagine gentil, la bella idea, donde il motor del ciel tolse tant’arte. Mentre che piú da presso io mi facea, l’esempio, la figura e la bella ombra già viva viva tutta mi parea: cosí giuso nel mondo il cor me ingombra quella pietà che, schiva, talor move tra ’l lume e ’l fronte che mia vista adombra; cosí simel bontà dagli ochi piove giú nel bel monte el fronte pelegrino, cosí se adorna di vaghezze nove. Or qui conobbi quanto può destino, quanto natura e ’l ciel, e quanto possa ingegno sol, senza voler, divino; conobbi la cagion dond’e sol mossa la guerra che mi strugge et arde sempre col foco che m’è acceso in mezo l’ossa; conobbi perché a sí diverse tempre Amor governe la mia frale vita e perché de l’angoscia non si stempre. Era la mia virtú vinta e smarita già ’nanzi l’alto obietto e ’l bel sembiante che solo è adorno di beltà infinita. Videa le mie suavi luci sante non sfavilar, ma chiuse nella stampa, e ’l viso ornato di bellezze tante, e ’l chiaro impallidir de una tal vampa biancarlo tutto, e l’onorato fronte che ogni core adolcisce e ’l mio divampa; le ciglia aventurose agli occhi gionte, che gira e volge Amor cum sua man sola, porto di mia salute, albergo e fonte; le chiome sciolte intorno a quella gola, onde vien quel parlar umano e tardo, che, l’anima ascoltando, el cor m’invola. Mentre che l’idol mio fiso riguardo, veder mi parve d’un legiadro nembo 9 coperte ambe le luci ond’io tant’ardo; e sopra al fortunato e bel suo grembo la bianca man di perle star distesa, e circundata di amoroso lembo. Questa è la man da chi fu l’alma presa, e fece il laccio di che Amor l’anoda e tenla in croce, e mai non fece offesa; questa è la bella man che ’l cor m’inchioda soavemente, sí che ’l sento apena; questa è la man che tutto el mondo loda. Questa è la bella man che al fin mi mena e, vanegiando, in parte l’alma induce dove è sol pianto, doglia, angoscia e pena; questa è la man de la mia cara luce, ch’io vidi in l’alto esempio immaginato; questa è la man che a morte mi conduce. Questa è la bella man che ’l manco lato me aperse e piantovi entro el mal volere, perché convien ch’io pèra in questo stato. El stare in sé racolta, el bel tacere (e questo a tempo) e ’l riso mansueto, non lice né conviense ivi vedere; el mirar vago e fiso e ’l volger lieto non per destin ma per arte s’aquista, l’andar suave e l’atto umile e queto. Non vi era il duol che la bella alma atrista, né il suspirar che par già mi consume, né il lampegiar della soperchia vista; ma in gli ochi che m’hanno arso è spento il lume, il lume che m’abaglia non me invia: spento era nel sembiante ogni costume, suo senno, suo valor, sua legiadria; né quel velato orgoglio v’è dipinto, che m’ha inganato cum sembianza pia. Era già il sole a l’orizonte spinto, trato per forza al fondo della spera, e l’aere nostro d’ombra era già tinto; e la nimica mia già rivolta era a vaghegiar se stessa e sua beltade, e china a terra avea la vista altera (dico di lei, che adorna nostra etade e sola infiora il mondo, che nol merta, in cui se osserva il pregio di bontade): sí che di doppia notte era coperta la terra, allor che ’l santo ragio volse, che volto in su facea mia vista incerta. Non so che la memoria qui mi tolse, ch’io non so ben ridir se piú soffersi, né so se ’l mio pensier ivi piú accolse; e qui, fugendo il sonno, gli occhi apersi. Articolazioni interne Nessuna articolazione interna. Presenza di rubriche latine: = di tipo esplicativo in riferimento al contenuto, con l’unico esempio (variamente attestato) del polimetro 144: «Pastoris variam mentem variumque stilum nemo admiretur, quoniam quem patitur dolor extat et ipse varius ac iniuria notanda. PASTOR HERMOFRONDITUS». = di tipo onomastico, nei componimenti dedicati, di cui però è testimone il solo, sebbene autorevole codice O (ad es. «Ad Calimacum senensem virum clarum», «Ad Rosellum aretinum virum doctum»). Sequenze intermedie 3-7: nascita dell’amata, e celebrazione della sua divina perfezione 8-11: intervento di Amore ai danni del poeta 16-18: effetti degli occhi dell’amata 19-20: invocazioni alla mano dell’amata 26-28: l’amata come fenice e come colomba 38-39: preghiere rivolte agli occhi e alle altre bellezze dell’amata 42-43: “mentita forma”, e ingannevole “mirar vezzoso” dell’amata insensibile 54-55: crudeltà dell’amata, contenta delle sofferenze del poeta 57-58: due sequenze di “impossibili”, riferite alla libertà del poeta e alla pietà dell’amata 61-62: l’amata sorda e crudele come orso, aspide, fiera selvaggia 10 63-65: la vita del poeta come barca rovinata e alla deriva, di notte, in un mare in tempesta 84-85: orientarsi nel labirinto amoroso è ormai impossibile 94-98: scenari campestri, in cui il pensiero del poeta torna sempre all’amata lontana 100-102: sogni consolatori del poeta, al quale l’amata compare pietosa 106-109: ulteriore allontanamento del poeta dall’amata, sempre entro scenari campestri 110-112: nostalgici lamenti sul distacco dall’amata, espressi in corrispondenze con un amico di nome Francesco (probabilmente il Malecarni, o l’Accolti), e con Angelo Galli; 113-115: persistenza dell’amata nel pensiero dell’amante 116-119: poiché la dolce vista dell’amata è stata tolta al poeta, egli si aggira come cieco, cui è negata ogni luce, e il suo cuore si nutre di ricordi; per orientarsi ancora con gli occhi di lei, egli cerca di raggiungerli con l’occhio del pensiero, ma con risultati imperfetti 130-134: gli occhi dell’amata, che la gelosia altrui ha negato al poeta, sono sempre nella mente di quest’ultimo, pur se lontani 136-141: ritorno a Bologna, dichiarazione all’amata della fedeltà del proprio sentimento; rinuncia finale (congedo), dovuta alla stanchezza per l’ormai persistente lontananza da lei. 142-144, 150: serie di due, poi tre ternari e un polimetro, riassuntivi dell’intera esperienza, nel segno dei differenti generi dell’elegia (142), della disperata (143), dell’egloga (144), della visione (150) Tempo della storia ed eventuale quadro cronologico dettagliato 7 anni, dalla primavera del 1433 alla primavera del 1440 La prima e sola indicazione cronologica interna al canzoniere contiano si presenta all’altezza del sonetto 90, in cui si legge: «Tutto ’l quarto anno il ciel ha già rivolto, / e già del quinto scalda il mezzo Apollo, / dal dì ch’io porto il grave giogo al collo»; è quanto basta, tuttavia, per stabilire che ci troviamo nel 1437, in estate (il “mezzo” dell’anno, “scaldato” da Apollo), e che dunque la vicenda amorosa, durando già da quattro anni abbondanti, aveva avuto inizio nel 1433, canonicamente in primavera (come esplicitato dal son. 11, «Nella stagion che rembelisce l’anno»). In effetti, numerosi indizi, benché non espliciti, consentono la datazione del sonetto 90. Dal successivo n. 94 infatti («La bella terra ove mi giunse Amore»), e con più evidenza dal n. 107 («Quanto più mi allontano dal mio bene / seguendo il mio destin, che pur mi caccia»), il racconto presenta la svolta decisiva del distacco di Giusto dalla sua bella bolognese: distacco che sappiamo avvenuto nel gennaio del 1438, quando il Conti, entrato al servizio di Eugenio IV come cubicolario, fu costretto a seguire il pontefice a Ferrara, la città scelta per riaprire i lavori conciliari. Di tali notizie siamo debitori al più devoto ammiratore del Conti, il diplomatico urbinate Angelo Galli: il quale, in didascalie segnate sul proprio canzoniere, ci informa che «nel 1438, di magio, in Ferara, essendo lí la corte», egli scrisse il proprio sonetto 278 («Quanta invidia vi porto, erbette e fiori») «in persona di messer Giusto da Valmontone, cubiculario inamorato de una giovine bolognese, la quale in quelli dì se era partita et andata in villa, e la più singulare belleza de costei era la mano». Nella stessa occasione Angelo indirizzò al Conti anche il suo sonetto 279 («Piange misero, lasso che hai ben donde»), al quale Giusto rispose col proprio 111 («Quel tuo bel lamentar, che me confonde»); per poi inviare all’amico, dopo l’ulteriore trasferimento del Concilio a Firenze nel gennaio del 1439, il sonetto 112 («Tal son ne’ mei pensier qual io già fui»), come ancora il Galli testimonia annotando: «da messer Giusto da Valmontone mandatomi da Firenze fino a Calli». Ad una successiva stagione invernale, verosimilmente quella tra la fine del 1439 e l’inizio del 1440, risale il sonetto 124 («Ora che ’l freddo i colli d’erba spoglia»), mentre il ritorno della primavera (e del suo tipico vento) favorisce il temporaneo ritorno del poeta a Bologna («Zefiro vieni, e la mia vela carca», 136), occasione per ribadire alla donna il suo amore («Ancor vive, madonna, il bel disio», 140), ma anche per comunicarle la fine del proprio servizio amoroso, sfinito dall’ormai continua distanza («Va, testimon de la mia debil vita»). Entro quello stesso anno avvenne la pubblicazione del 11 canzoniere, come documentato dall’epigrafe miniata nel ms. P2. Testi di anniversario Quadro cronologico completo: 90, 1-3: «Tutto ’l quarto anno il ciel ha già rivolto, / e già del quinto scalda il mezzo Apollo, / dal dì ch’io porto il grave giogo al collo» 11: l’amore nasce nel 1433, in primavera («nella stagion che rembelisce l’anno») 47: la storia si protrae già da anni («È questa quella man, che già tanti anni / a l’amoroso nodo mi distrinse?») 81: è tornata la primavera («Or che ogni piaggia prende il bel colore»), siamo nel 1437 90: estate del 1437 («Tutto ’l quarto anno il ciel ha già rivolto, / e già del quinto scalda il mezzo Apollo, / dal dì ch’io porto il grave giogo al collo») 107: gennaio 1438, distacco da Bologna («Quanto più mi allontano dal mio bene / seguendo il mio destin, che pur mi caccia») in direzione di Ferrara, al seguito di papa Eugenio IV 111a-b: maggio 1438, corrispondenza con Angelo Galli; il quale con didascalie al suo canzoniere informa che «nel 1438, di magio, in Ferara, essendo lì la corte», egli scrisse il proprio sonetto 278 (vedi sopra). A tale iniziativa diede seguito la corrispondenza tra il sonetto 279 di Angelo e il 111 di Giusto («Quel tuo bel lamentar, che mi confonde») 112a-b: è successiva al gennaio 1439, cioè al trasferimento a Firenze del Concilio, questa nuova corrispondenza tra il Conti e Angelo Galli (nel frattempo tornato a Cagli, nel Montefeltro), il quale circa la proposta dell’amico («Tal son ne’ mei pensier qual io già fui») annota: «da messer Giusto da Valmontone mandatomi da Firenze fino a Calli, condolendosi del suo stato amoroso perché stava lontano da la sua amorosa che stava a Bologna» 124: mesi invernali tra il 1439 e il 1440 («Ora che ’l freddo i colli d’erba spoglia») 136: primavera 1440 («Zefiro vieni, e la mia vela carca») L’ “io” lirico Intorno all’identità personale dell’ “io” lirico, il canzoniere offre rarissime ed esili indicazioni: la sua esperienza amorosa, iniziata in primavera (11), ha luogo a Bologna (15; 123), e una durata di 7 anni; nel corso del quinto anno (90) il poeta è costretto da eventi esterni a trasferirsi in luoghi lontani dall’amata (94; 107); alla fine del settimo anno, dunque nuovamente in primavera (136), egli può occasionalmente tornare a Bologna (139), dove conferma alla donna la propria fedeltà amorosa (140), ma al contempo si congeda da lei per sempre, sfinito dalla lontananza incessante (141); infine, in vesti di pastore, impreca contro l’amata andata in sposa a un rivale (144). Altre informazioni in realtà avrebbero offerto le corrispondenze poetiche pur comprese nel canzoniere, se l’autore non avesse escluso i testi degli interlocutori. Lo scambio epistolare 111a-b con Angelo Galli indica infatti nei pressi del fiume Po (cioè a Ferrara) la nuova, provvisoria collocazione del poeta; il 112a-b rivela che il nostro poeta si chiamava «Giusto» (v. 13). Grazie poi alle citate didascalie dello stesso Galli, sappiamo che la prima delle due corrispondenze si verificò nel maggio del 1438, appunto a Ferrara; e che la proposta che originò la seconda fu inviata da Firenze, dal Conti, in una data successiva al gennaio 1439. In virtù poi di altri riscontri con dati esterni, congruenti rispetto al macrotesto, è possibile concludere che l’ “io” lirico coincide con il poeta Giusto da Valmontone, studente a Padova tra l’11.8.1433 e il 12.12.1438 (giorno in cui conseguì la «licentia privati examinis in iure civili»), ma negli stessi anni innamorato cantore di una giovane bolognese. Divenuto nel frattempo cameriere privato (cubicolario) di papa Eugenio IV, per seguirne gli spostamenti determinati dal Concilio dovette allontanarsi da Bologna (già almeno nel maggio 1438) in direzione di Ferrara e poi di Firenze. Vicende di cui, quattro anni dopo la morte di Giusto (avvenuta nel 1449), lo stesso 12 Galli avrebbe dato un commosso ricordo nella propria Operetta in laude dela belleza et detestatione dela crudeltade de la cara amorosa di Ferdinando d’Aragona, allora duca di Calabria: una visione in forma di prosimetro, nella quale, durante l’ascesa del monte Parnaso, il Galli ha la gioia d’incontrare lo spirito del suo «caro Giusto», ancora desideroso di sentir recitare dall’amico «quello già tuo primo sonetto in mia persona per te nella florida et amorosa cità de Ferrara fatto per la mia bella bolognese; il cui amore non è per morte da me ancora diviso, perché simile cure le anime di ben giusti amanti sempre retegnono ni graziosi piaceri occupate». Il “tu” Il Conti nomina l’amata solamente attraverso un acrostico, «ISABETA MIA GENTILE», collocato nella quinta stanza della canzone 36. Contrariamente ai modelli volgari più noti, sembra trattarsi di una fanciulla nubile, che non solo con le sue bellezze (in particolare la mano), ma anche con vezzi e lusinghe seduce il poeta, dimostrandogli però ben presto una sostanziale freddezza, fino a darsi a un rivale. Esito, quest’ultimo, di tipica ascendenza elegiaca, ma che aveva anche avuto un recente (e contiguo) precedente volgare nella Lia del padovano Domizio Brocardo. Isabetta vive nei pressi del fiume Reno (32): dunque a Bologna, come confermano le epigrafi dei codici P2 («Isabetae bononiensis amore») e L («ad Ysabetam bononiensem amasiam suam»). La giovane appartiene a famiglia facoltosa, in possesso di ville nel contado: più in dettaglio, nei pressi del santuario della Madonna del Sasso (oggi comune di Sasso Marconi), dove si ricreava passeggiando (14, 1-3: «O Sasso avventuroso, o sacro loco, / donde si move onestamente e posa / talor la donna mia, sola e pensosa»; 123, 9-10: «O Sasso aventuroso, che ’l bel piede / preme sì dolcemente»). Tutti elementi biografici ai quali offre ancora sostegno la citata Operetta di Angelo Galli, nella quale l’ombra di Giusto prega l’amico: «redimme el tuo sonetto, racende li miei antichi disiri! Quando colei che tenne il mio core stretto e chiuso in nella candida mano e terà sempre, uscita de la bella cità de Bologna, si stava di fuora a la delettevole villa delle sue posessione, tu in mia persona, indivino de le mie voglie, el compo- nesti». Su tali basi, la donna cantata da Giusto è stata identificata con l’Isabetta, sorella di Annibale Bentivogli, che il 22 ottobre 1441 andò in sposa a Romeo Pepoli, figlio di Guido. Un’ipotesi suggestiva, con una difficoltà: L. Frati, che l’ha avanzata, segnalando anche che la famiglia Pepoli possedeva una villa proprio nei pressi di S. Maria del Sasso, glissò sul fatto che negli anni cui si riferisce la Bella mano Isabetta non era ancora entrata in casa Pepoli. Come che sia, non dovrebbe esserci dubbio circa l’epilogo dell’esperienza cantata, che il poeta deplora nel polimetro 144 come «oltraggio» amoroso da lui subito, tra furto e tradimento; e che ancor più chiaramente lamenta in rime successive: «altri possede et io piango il mio bene» (XXIII, 1); «questa altera / crudele, ingrata, falsa donna, a cui / di volontà mi fei servo fedele, / rivolti ha i suoi pensier tutti in altrui» (XLIV, 9-12). La nuova condizione matrimoniale dell’amata, che in tutta la lirica delle origini era stata non certo ostacolo, ma premessa dell’amor cortese e della poesia che ne nasceva, e che Petrarca per primo aveva riconosciuto come problema etico (senza peraltro trarne conclusioni pienamente coerenti), per Giusto de’ Conti sembra dunque rappresentare una barriera insuperabile alla propria dedizione, termine invalicabile di ogni discorso amoroso. Va infine ricordato che, se tra le rime disperse (come accennato) due brevi cicli sono dedicati a Laura dell’Antella e a Vittoria Colonna, all’interno della Bella mano s’incontra un sonetto (il n. 49: «Alta speranza dell’aflitta mente») i cui primi sette versi formano, in acrostico, il nome di una «ANTONIA»: indicazione che non passò inosservata tra i contemporanei di Giusto, visto che il ms. F5 (c. 103r) intitolò il sonetto Pro diva Antonia. Si tratta di un testo amoroso, implorante soccorso; forse un omaggio acquisito nel canzoniere con il valore di una tentazione, già superata all’altezza del successivo testo 50 («Sia dunque benedetto il primo inganno», ossia l’amore per Isabetta): «sia benedetto, quando per mio scampo / corsi, fugendo il caldo de altro amore, / alla dolce ombra della bella mano!». 13 Testi di pentimento religioso L’ “io” lirico contiano non approda mai ad un pentimento di carattere religioso; tuttavia, più volte egli accenna a questa sua incapacità come ad una colpa, e condanna il proprio sentimento come «selvaggia e fiera voglia, e rio pensiero» (19, 9), «voglia ardita onde mi dole, / o van pensier che la mia mente allaccia» (33, 1-2), «sfrenata voglia » (80, 6), «speranza ria» (75, 107). All’altezza della sestina 64, egli già riconosce la negatività morale della passione che lo opprime, di cui però non sa liberarsi: «Ben fora tempo omai ridursi in porto […]; ma sì mi abbaglia un dispiatato lume, / ch’io sprezzo ’l segno de mie fide stelle, / e la salute mia commetto ai venti» (vv. 7, 16-18). Una ancora più distesa confessione delle proprie responsabilità emerge poi nella canzone 75: «E ’l cor chi gli diè fé ne sia punito, / perché non ben si segue ogne appetito, / e colpa, benché lieve, pena aspetta, / a ciò ch’al pronto errar si metta freno […]. / Ragion è ben che ’l peccator non godi / de alcun suo fallo, anzi ne senta doglia, / e l’alma che mal fe’, quella sol pèra […]. / Ca se mortal bellezza il cor m’ingombra, / che colpa è del destin, che a ben m’induce? […] Se un falso riso e due parole m’hanno / acerbamente a morte omai sospinto […], perché del cielo e delle cose belle / ognor mi lagno a·ttorto?» (vv. 14-17, 61-63, 88-89, 93-99). Ma cambiamenti interiori non si registrano: «così mi levo e mi rattegno insieme, / l’ale aguzando al mio dubioso volo, / che prego che a Dio piaccia non sia folle» (88, 12-14). Non a caso, il canzoniere si chiude non con un pentimento religioso, ma con i vendicativi incantesimi del ternario 143, volti a suscitare magicamente nella donna la dolorosa passione d’amore, e a propiziare viceversa la propria liberazione: «Or basta, io spero che la spera volta / due volte non arà Proserpina anco, / che l’alma mia sarà d’amor disciolta. / Quel corvo, che mi canta al lato manco, / dice che tosto se apparecchia il giorno / che l’alta mia tempesta verrà manco; / e quella fiamma che a quella altra intorno / spesso se agira e spesso arossa e ’mbruna, / segno è come ora in libertà ritorno» (vv. 184-192). Si tratta di una precisa scelta diegetica. Il Conti non mancò infatti di affrontare la sua materia in chiave religiosa, ma infine optò per escludere dal canzoniere questo percorso, di cui restano però tracce tra le rime disperse. Eloquente in tal senso il sonetto XXX (vv. 9, -14): «Donque è meglio ch’io taccia, e lena prenda; […] / e ponga il mio dolce desio più alto, / ché la mia voce al nono ciel se ’ntenda, / e infin diventi la mia alma diva». E da ricordare anche il sonetto XXXVI: «S’io spendesse il mio tempo e ’l viver frale / in laude della Vergine gloriosa / Madre eletta de Dio, Figlia e Sposa, / che né prima né poi mai ebbe equale, / com’io spendo in costei, cosa mortale, / che per più mio dolor sta sempre ascosa […], / io sarei de più fama e speraria, / per merto non, ma per superna grazia, / salire ancor nel regno de’ beati; / onde, perché ’l disio mio non se sazia / de lusingar costei per farla pia, / temo trovarmi alfine intra dannati». Testi con destinatari storici 28-29: due sonetti, che il ms. O dice indirizzati «Ad Calimacum senensem virum clarum». Almeno il secondo, in effetti, fu certamente inviato a un destinatario (cfr. vv. 5, 7-8); ma il nome indicato, se come sembra intendesse designare l’antiquario senese Domenico Callimaco, attivo nel Piceno e in documentati rapporti con Lorenzo de’ Medici (a cui offrì alcuni oggetti preziosi), sembra cronologicamente assai meglio compatibile con i tempi del copista che con quelli di Giusto. 30: sonetto al rimatore e chierico camerale Rosello Roselli d’Arezzo. 32: sonetto a un destinatario chiamato «Orso», nome particolarmente frequente tra i membri della famiglia Orsini, a sua volta legatissima (tramite molti vincoli matrimoniali) a quella dei Conti di Valmontone. Per una plausibile identificazione, si pensi all’Orso Orsini (n. 1400 ca. - m. 1456) che fu signore di Bracciano e di Nepi, attivissimo condottiero, nonché marito di Giacoma Conti, figlia di Grato Conti, di cui Giusto fu fratello o cugino. Un altro Orso Orsini da non trascurare fu il conte di Manoppello e signore di Guardia Grele, morto nel 1467: personaggio più marginale, ma interessante in quanto marito di Antonia Orsini, figlia di un altro Orso Orsini, signore di Monterotondo (morto però già nel 1424), ma soprattutto di Lucrezia 14 Conti, anch’ella probabilmente sorella o cugina di Giusto (il quale, ricorderemo, proprio ad una Antonia dedicò tramite acrostico il sonetto 49 della Bella mano). 53: sonetto a un destinatario chiamato «Giorgio», interpellato sul tema della gelosia. In mancanza di altri appigli, ricordiamo che Giorgio da Trebisonda, anch’egli come Giusto dal 1437 in poi al servizio di Eugenio IV (quindi dei papi suoi successori), nomina il Conti in una lettera a Niccolò V del 1452; ma anche che su un amico senese di tal nome (con cui erano nati dei dissapori) Giusto si sofferma nella sua lettera ad Andreoccio Gerardo Cinuzzi; e, infine, che un «Giorgio da Valmontone» figura spesso come testimone negli atti emanati dal Conti come Tesoriere pontificio della Marca, nel 1446. 83: sonetto indirizzato a un anonimo destinatario (cfr. v. 5: «Tu sai s’io già la piansi et or mi adiro»), non a caso di nuovo incentrato sul tema della gelosia (vedi sopra). 110: sonetto a un destinatario chiamato «Francesco»; da identificarsi forse con il rimatore fiorentino Francesco Malecarni, che il 12.12.1438 fu tra gli studenti presenti, a Padova, in occasione del conseguimento da parte del Conti della laurea in diritto civile; o forse con il giurista e rimatore Francesco Accolti d’Arezzo (n. 1416-17), cugino di Rosello Roselli, e anch’egli attivo tra Siena e Firenze, prima di trasferirsi a Ferrara negli anni ’40. 111: sonetto responsivo rivolto al funzionario e rimatore urbinate Angelo Galli. 112: sonetto indirizzato al funzionario e rimatore urbinate Angelo Galli. Tra le rime disperse si registrano: 148: sonetto indirizzato al funzionario e rimatore urbinate Angelo Galli. 149: sonetto indirizzato a un «messer Filippo», forse Filippo de Vadis da Pisa. LVII: sonetto responsivo rivolto al funzionario e rimatore urbinate Angelo Galli. Isotopie spaziali I soli luoghi concreti nominati, in quanto abitualmente frequentati dai protagonisti, sono il fiume Reno, «che bagna e riga il bel paese» (Bologna) «dove sì altamente Amor» prese il poeta (32, 2-3); e il «Sasso avventuroso», «sacro loco» (15, 1; 123, 9), ossia la località di S. Maria del Sasso, in cui l’amata spesso soggiornava nella villa dei familiari. Rispetto a questi luoghi, il protagonista è a un certo punto rappresentato in un non meglio precisato percorso di allontanamento («La bella terra, ove mi giunse Amore», 94; «Quanto più m’allontano dal mio bene», 107), e infine di riavvicinamento («Mentre ch’io m’avicino al bel terreno», 139). Nel polimetro 144 il furto subito risulta ambientato in territorio romano («Un altro Cacco qui, sotto Aventino […] / fura gli armenti de ciascun vicino»), anche se si può ipotizzare una valenza allegorica. Progressione del senso Il canzoniere si apre con un sonetto proemiale (1), ma coinvolto in medias res: il poeta vi effettua infatti un doloroso bilancio della sua esperienza amorosa, nella quale tuttavia è ancora pienamente coinvolto. Segue nel sonetto 2 una invocazione (di ascendenza elegiaca), a sostegno della propria ispirazione, indirizzata alla mano dell’amata. I successivi testi 3-7 rievocano la nascita di quest’ultima, e ne celebrano la divina perfezione. Con i componimenti dal n. 8 al 41 si assiste all’iniziale parabola sentimentale del poeta, dall’innamoramento nella stagione primaverile (11) a una condizione sempre più malinconica e dolente per i segnali di freddezza dell’amata; segni che non minano comunque la sua devota adorazione. Nei testi successivi, tuttavia, comincia a rivelarsi la natura feroce del cuore dell’amata, la falsità (42) dei suoi sguardi pietosi e del suo mirar vezzoso (43). Un grave errore il poeta si attribuisce nel sonetto 44: dopo essere riuscito a scovare la sua fiera, potendo quindi pervenire «al fin che ’l bel piacer ne serba», egli, dinanzi all’aspetto altero di lei, desiste; da quel momento, sdegnato, Amore cessa per sempre di intervenire in suo favore presso l’amata. Questo non ridimensiona la tenace fedeltà amorosa del poeta, nonostante il crescente dolore (45-52), ma inquietante si fa strada 15 una riflessione sulla gelosia, corollario inevitabile del diletto amoroso (53). L’amata si rivela sempre più fiera crudele (orso, aspide), malvagia, contenta del dolore del poeta (54-62); la cui esistenza è rappresentabile come barca rovinata e alla deriva, di notte, in un mare in tempesta (63-65). Egli infatti non può liberarsi del veleno amoroso, anche se l’amata (detta ora «cor di tigre», 70, o «Medusa», 79) «s’è volta in ira» (76) senza speranza (66-80). Al ritorno della fertile primavera, le speranze del poeta sono del tutto inaridite (81), mentre cresce in lui la convinzione di essere vittima di un crudele gioco di seduzione; l’amata è ormai biasimata come perfida (82), falsa, disleale, per i suoi ingannevoli «cenni», i «falsi risi», per le sue «lusinghe», gli «sguardi fisi» (83); e si fa strada un pensier geloso, «che questa ingrata per altrui sospire» (83). A metà del quinto anno dall’innamoramento (cioè nell’estate del 1437), peraltro, il poeta ribadisce l’inestinguibilità della sua passione (90), ma annuncia anche una svolta stilistica: «Convien che nostri guai con stil più ardente / senta costei»; non a caso, l’amata viene ora definita una «sirena malvagia», una «novella Deianira» (92-93). Gradualmente, tuttavia, si assiste a una decisiva svolta diegetica, che conduce il poeta a un doloroso distacco dall’amata. In un primo momento, egli si sposta in scenari campestri, nei quali il suo pensiero torna sempre all’amata lontana (94-98), mentre sogni consolatori gliela rappresentano in atteggiamenti pietosi (100-102). Frattanto, però, si conferma il tormento della gelosia (103), anche perché un ulteriore allontanamento accresce dolorosamente il distacco (106-112). L’amata, peraltro, continua a dominare il pensiero del poeta (113-115); e poiché la sua dolce vista gli è stata tolta, egli si aggira come cieco, cui è negata ogni luce, e il suo cuore si nutre di ricordi. Per orientarsi ancora con gli occhi dell’amata, egli cerca di raggiungerli con l’occhio del pensiero, ma con risultati imperfetti (116-119). Di fatto, la distanza trasforma gradualmente la precedente, risentita delusione in un nostalgico rimpianto dell’amata e delle sue bellezze: a partire di nuovo dagli occhi, negati dalla gelosia altrui al poeta, ma sempre presenti nella sua mente. D’improvviso, al poeta è data occasione di un breve ritorno a Bologna: facendosi coraggio, egli ribadisce all’amata la sua inestinguibile de- vozione (136-140). Subito dopo, però, egli le invia il libro di rime, al quale affida l’incarico di riferirle di non essere più in grado di proseguire nel servizio amoroso, per stanchezza soprattutto dovuta alla lontananza forzata (141). Nei ternari finali, oltre a riepilogare in toni elegiaci, disperati e pastorali l’esperienza vissuta, il poeta compie riti magici per liberarsi della passione amorosa, e denuncia il furto subito da parte di un rivale in amore (142-144); infine, egli rivisita l’intera esperienza nei termini di una “visione” pervasa di platonismo (150). Connessioni intertestuali Le connessioni intertestuali sono quasi sistematiche. Ad esempio, i sonetti 8 e 9 sono collegati dalla rima che intercorre tra l’ultimo verso del primo («e tanta grazia dalle ciglia piove») e quello iniziale del secondo («Quando costei ver me li passi move»); mentre congiunge il sonetto 9 a quello successivo l’inserimento della stessa parola nel verso d’apertura, ancora in sede di rima («De qual sí amaro e sí bel fonte move»). Più evidente ancora la tecnica di ripresa capfinida che connette i sonetti 11 e 12: «La debil vista, dall’obietto offesa, / lo sforzo non sostenne d’una luce» (vv. 12-13), e «Spento ha degli occhi bei l’altero lume / la debile mia vista...» (vv. 1-2); e si noti come proprio intorno al tema della luce si raccolga una ricca costellazione lessicale («abbagliare», «lume», «faville», «luci», «sfavillar»), che ricorre generosamente nei testi 11-15. Analoga connessione (è il tipo largamente più diffuso) sembra riconoscibile tra i sonetti 15 e 16 («ma più di me, che più d’altrui sempr’ardo», v. 14, e «Mentre ch’io son con gli occhi tutto intento / negli altri ove s’accende il mio gran foco», vv. 1-2), ma con chiara evidenza ricorre tra la sestina 17 e i due sonetti successivi, nel secondo dei quali del resto si ripete l’associazione ossimorica di vita e di morte, quale effetto attribuito prima al potere degli occhi, poi a quello della mano («Occhi soavi onde si pasce il core / [...] cagion sete di vita e di mia morte», 17, 37-39; «Amor negli occhi vaghi io vidi un giorno / […] sí ch’io moro», 18, 2-4; e «O man ligiadra, ove ’l mio bene alberga / e morte e vita insieme al cor m’annodi», 19, 1-2). Ma ad una dispersiva analisi sistematica, è forse preferibile un pa16 norama, corredato di pochi esempi, delle diverse tipologie connettive operanti nella Bella mano. Rileveremo allora, soffermandoci ancora sulle connessioni di equivalenza (categoria in cui si collocano gli esempi precedenti), che un analogo movimento sintattico e ritmico apre i sonetti 26-27 («Questa fenice, che battendo l’ale», «Questa ligiadra e pura mia colomba»), 57-58 («Prima vedrem di sdegno un cor gentile», «Prima vedrem le stelle a mezo giorno»), 116-118 («Poi che la dolce vista del bel volto», «Poi che il mio vivo sol piú non se vide», «Ora che il gran splendor del ciel risorge»), e chiude, in formula profetica, i ternari 143-144; mentre il verso iniziale del sonetto 27 torna, leggermente variato, come ultimo dei due testi successivi («Questa ligiadra e pura mia colomba», «Questa innocente e candida colomba», «Questa mia cara, angelica colomba»), i quali peraltro sono tra loro strettamente collegati dal presentare in rima, in tutti i versi, le stesse parole; ricorrente, infine, è la tecnica di ripresa capfinida, ad es. tra la canzone 75 (v. 106, «Non posso piú, né so di me che fia») e il sonetto successivo («Io non posso dal cor, ch’Amor martira»). Si devono invece annoverare tra le connessioni di trasformazione quelle intercorrenti tra i sonetti 33-34 (il primo dei quali si chiude con una domanda cui il secondo sembra dare una risposta), e 137-138: aprendosi il primo con un invito al ritorno all’amore rivolto a se stesso («Ritorna al foco, o mio debil coragio»), il secondo con la constatazione che ciò è avvenuto («Viemme la fiamma antica e i dolci affanni»); né si dovrà trascurare che il contenuto del v. 3 di questo stesso testo («e il discoprir dei colli ancor m’invita») è chiaro preannuncio della situazione descritta nel sonetto successivo («Mentre ch’io m’avicino al bel terreno / dove per forza Amor mi riconduce», 139, 1-2). Poesie di poetica Un accenno metapoetico compare nel sonetto 92, in cui è l’annuncio di una svolta stilistica: «Convien che nostri guai con stil più ardente / senta costei», e «Io parlo lagrimando»; in effetti, per alcuni testi l’amata viene definita una «sirena malvagia» (92), una «novella Deianira» (93), mentre in quelli successivi s’impone il registro elegiaco, specie dopo il distacco del poeta dall’amata. Il testo 92 recita così: A l’ultimo bisogno, o cor dolente, che Amor sempr’arde e ria ventura afrena colla sua propria man, de nostra pena fra bei pensier de Amor alza la mente! Convien che nostri guai con stil più ardente senta costei, del ciel nova sirena malvagia, che a morir mia vita mena; mia vita, che al morir cieca consente. Io parlo lagrimando, et vuo’ che mi oda chi pria mi strinse sì, ch’ancor non scioglie il laccio onde al martir Amor mi guida; e che de la sua man tutto mi annoda, misero mi, del lamentar mio rida, poi che de Amor triunfa e de mie spoglie. Contenuti non amorosi La forma di 144 componimenti comprende solo testi di contenuto amoroso. L’unica possibile eccezione è rappresentata dal polimetro conclusivo, nel quale, dietro il velame pastorale e amoroso, è stata intravista un’accorata condanna di eventi storici concernenti la città di Roma. In particolare, una prima lettura decodificava alcune presunte allegorie riconoscendo nella donna traditrice la Chiesa nelle mani di Eugenio IVErrore. L'origine riferimento non è stata trovata.; i pastori invitati a vegliare, nei governatori della repubblica nata dalla ribellione che nel 1434 aveva costretto alla fuga il pontefice; e nelle immagini di Caco, del serpente distratto, dell’«astuta volpe»Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., dell’«orso» e della «colonna» altri protagonisti dell’epoca, nell’ottica di una «mesta rievocazione degli anni felici che, con Martino V, videro a Roma dominare i Colonna». Questa interpretazione è stata radicalmente contraddetta da una successiva lettura, che ne ha evidenziato l’inconciliabilità con tutti i dati disponibili sulla biografia personale dell’autore, uomo di assoluta fiducia di papa Eugenio IV; e la sostanziale incoerenza allegorica, in virtù della quale un modesto poeta pretenderebbe di vantare dei diritti nei confronti della Chiesa di Roma, 17 mentre la donna stessa rappresenterebbe ora la Chiesa, ora la famiglia Colonna, ora altre figure sempre più modeste. Pur molto dubbiosa circa la reale “tenuta” di una interpretazione politica, questa seconda lettura ha comunque avanzato una sua proposta alternativa, con particolare riferimento agli anni 1439-40 (quelli in cui il canzoniere fu concluso), pur senza dimenticare le decisive premesse del 1433-34. In tale prospettiva, nella voce monologante si potrebbe riconoscere quella del pontefice esule, vero Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.«pastore tra i pastori», tradito dalla sua città (la donna amata); nel nuovo Caco il delegittimato Vitelleschi, nel 1440 imprigionato e ucciso come traditore; nel serpente guardiano, le famiglie Caetani e Anguillara, alleate malfide di Eugenio IV; e in altre figure altrettanti protagonisti dell’epoca. Anche questa interpretazione peraltro non appare molto persuasiva, a causa del carattere intermittente del presunto sovrasenso allegorico, nella lunga trama di un’effusione tutta stabilmente sentimentale. Contenuto certamente politico ha invece una corrispondenza poetica tra Giusto e Angelo Galli (148 a-b), aperta da una proposta contiana che la forma c del canzoniere, estesa a 150 testi, inserisce come n. 41: ossia in posizione del tutto incongrua, ben 70 posizioni prima dei componimenti che segnarono l’origine dell’amicizia tra i due poeti (nel 1438, come detto); il che rappresenta uno dei motivi per ritenere non d’autore questa forma ampliata. Dati i contenuti, infatti, questa corrispondenza deve ritenersi successiva al 1443, anno in cui papa Eugenio IV si rassegnò a riconoscere il dominio degli Aragonesi (malatestianamente chiamati «barbari» dal Conti) su Napoli: 148a, 5-14 deh, dimmi: è mai vendetta de nostre onte che Italia a torto in servitù rapelle, opur coniunzion de fiere stelle fermate eternalmente a l’orizonte? Ché omai tanti anni el ciel volgendo intorno, per affondarla, notte e dì la ’nveste Fortuna, che ne tien sott’al tributo; tal ch’io discerno infra le gran tempeste l’italico valor, con nostro scorno, da’ barbari già vinto e combatuto. 148b, 10-14 non giustizia de Dio che ce moleste, né da maligna stella è proceduto; ma el capo nostro, che ’l gran manto veste, l’italico giardin già tanto adorno a’ barbar che tu dice ha conceduto. Altre osservazioni Sperimentalismo metrico - I componimenti contiani più sperimentali sul piano metrico sono da considerarsi il ternario 142 («Odite, monti alpestri, gli mei versi!»), la cui connotazione elegiaca si esprime anche attraverso l’innovativa presenza del settenario all’interno di cinque terzine-ritornello; e il polimetro pastorale 144 («La notte torna, e l’aria e ’l ciel s’annera»), in cui la terza rima comprende e raccorda frottole e stanze di canzone, in una libera associazione tipica dell’egloga volgare. D’altra parte, se carattere innovativo (pur in chiave petrarchesca) si deve riconoscere al rilancio della sestina, un cauto sperimentalismo (ispirato da elaborazioni di Cino Rinuccini) si evidenzia anche nella gestione contiana della ballata. Benché infatti di ascendenza petrarchesca resti la costante opzione monostrofica, sia la n. 103 (XyX AYBCBACYxY) che la n. 146 (XyY AbABCcX) giungono a rinunciare al collegamento rimico tra l’ultimo verso della ripresa e l’ultimo della volta: un’anomalia cui la prima aggiunge l’altra particolarità del ricorso all’interno del primo piede della rima centrale della ripresa (struttura denominata da Gorni a «chiave disseminata»). Infine, se Giusto costruisce in generale le sua canzoni su schemi del Petrarca e del Serdini, meno prevedibile è la sua gestione del sonetto: il ricorso minimo alla soluzione della sirma a due rime (consueta in Petrarca, con il 40 % delle occorrenze, e dal Conti utilizzata solo 4 volte nella Bella mano, 11 in totale) è stato interpretato come rifiuto di uno schema sentito ormai come caratteristico della produzione comico-realistica. Ne derivò da un lato un impulso significativo alla serie finora rara CDE CED (assente nei Rvf, e attestata 5 volte tra le rime del Conti, di cui 3 nella Bella mano), ma anche, accanto all’alta frequenza della serie CDE CDE (38 % nei Rvf, 43 % in Giusto, 50 % nella Bella mano), quella della meno ovvia CDE DCE (22 % in Petrarca, 45 % nel nostro autore, 42 % nella Bella mano), rivelatrice di un interessante 18 percorso nella formazione metrica contiana: prevalendo infatti sulla sua più simmetrica alternativa non solo tra le estravaganti di Giusto (29 casi contro 16), ma anche tra i primi 40 sonetti della Bella mano (24 esempi contro 16), tale struttura si rivela forma privilegiata della prima attività poetica contiana, che in tal senso dobbiamo ricondurre, più che all’esempio del Petrarca, a quello del Serdini, il solo autore in cui si rinvenga un’analoga preferenza (27 prove contro 11). Modelli strutturali - Sul piano strutturale, la Bella mano si segnala innanzitutto come prima consapevole emulazione in chiave macrotestuale del modello petrarchesco: seguito solo parzialmente nelle direttrici narrative (mancando qui sia lo snodo della morte dell’amata, sia il percorso spirituale dell’amante), ma con la massima attenzione ad ogni dettaglio funzionale al percorso lirico (connessioni intertestuali, aggregazioni tematiche, testi di anniversario, ecc.). Peraltro, non a Petrarca si ispirò il Conti nel testo conclusivo del canzoniere (sonetto 141: «Va, testimon de la mia debil vita»), in cui il poeta affida al suo «libretto», nell’inviarlo all’amata, il proprio messaggio di addio; quel «libretto» al quale egli tornerà successivamente a rivolgersi (I: «Caro libretto, e più ch’altro filice»), immaginando le reazioni provocate in lei dai suoi versi. Un rapporto analogo con la propria opera si ritrova, piuttosto, nel Filocolo e nel Teseida, ma soprattutto chiude il Filostrato del Boccaccio (cfr. IX 5, 5-8); mentre in ambito lirico bisogna risalire alla prima elegia di Ligdamo (cfr. TIB., III 1, 9-18). Quanto ai successivi tre (e poi quattro) testi lunghi, si è spesso attribuita loro valenza analoga a quella dei Triumphi, quasi ad imitare la conformazione di tanti testimoni manoscritti della poesia volgare petrarchesca; più probabilmente, però, questi componimenti (estranei al canzoniere propriamente detto) intendevano rivisitare l’esperienza amorosa nell’ottica di quattro generi poetici di più o meno recente affermazione nel sistema volgare: l’elegia, la “disperata”, l’egloga, e la visione platonizzante. Infine, è opportuno ricordare che una struttura perfettamente aderente al modello petrarchesco, con 5 testi “in vita” (III - VII) e 4 componimenti “in morte” (VIII-X, II), caratterizza invece il breve ciclo per Laura Dell’Antella. Fonti più utilizzate - I Rerum vulgarium fragmenta, innanzitutto; ma finché il tono nei confronti dell’amata resta celebrativo, molto concorrono le memorie degli stilnovisti e di Dante, compreso quello del Purgatorio e del Paradiso. Con il progredire della disillusione, fermo restando il sottofondo petrarchesco, emergono con più evidenza Virgilio, gli elegiaci latini, il Dante petroso, Boccaccio, Simone Serdini, Domizio Brocardo, Leon Battista Alberti. Più in generale, pur nel quadro della dominante petrarchesca, l’intera tradizione lirica precedente concorre alla costituzione dei versi contiani. Bibliografia Edizioni Iusti de Comitibus […], Libellus foeliciter incipit intitulatus La bella mano, [Bologna, Annibale Malpigli], per me Scipionem Malpiglium bononiensem, 1472 Iusti de Comitibus […], Libellus foeliciter incipit intitulatus La bella mano, Veneciis, [Gabriele di Pietro], 1474 Iusto da Roma chiamato [sic] La bella mano, Veneciis, per Thomam di Piasis, 1492 Rime di messer Giusto di Conti […], intitolato [sic] La bella mano, in Vinegia, per maestro Bernardino di Vidali, 1531 La bella mano. Libro di messere Giusto de Conti, romano senatore. Per m. Iacopo de Corbinelli, gentilhuomo fiorentino ristorato, in Parigi, per Mamerto Patisson regio stampatore, 1589 (altre emissioni: 1590 e 1595) La bella mano di Giusto de’ Conti romano senatore, in Firenze, per Jacopo Guiducci e Santi Franchi, 1715, con una Prefazione di T. Bonaventura e Annotazioni di A.M. Salvini La bella mano di Giusto de’ Conti romano, in Verona, presso Giannalberto Tumermani, 1750 La bella mano di Giusto de’ Conti romano, in Verona, presso Giannalberto Tumermani, 1753; a pp. I-XXIII: «Notizie intorno a Giusto de’ Conti Romano, poeta volgare, scritte dal conte Giammaria Mazzuchelli» La bella mano di messer Giusto de’ Conti, in Parnaso italiano, tomo VI (Lirici antichi serj e giocosi fino al secolo XVI), a cura di Andrea Rubbi, Venezia, presso Antonio Zatta e figli, 1784 Giusto de’ Conti, La bella mano, in Parnaso italiano, vol. XI (Lirici de’ secoli I. II. III.), a cura di F. Zanotto, Venezia, Giuseppe Antonelli,1846, coll. 837-903 Giusto de’ Conti, La bella mano, a cura di G. Gigli, Lanciano, Carabba, 1916 Giusto de’ Conti, Il canzoniere, a cura di L. Vitetti, Lanciano, Carabba, 1918 (rist. ivi, 1933) 19 Il secondo volume dlle [sic] rime scelte di diversi autori, in Venetia, appresso i Gioliti, 1586, pp. 535-45 (contiene: 7, 10, 12, 31, 147, 40, 41, 56, 57, 58, 60, 67, 70, 77, 79, 80, 84, 94, 107, 122, 121) Scelta di sonetti, e canzoni de’ più eccellenti rimatori d’ogni secolo, 3 voll., a cura di Agostino Gobbi, in Bologna, per Costantino Pisarri, 1709, vol. I, pp. 111-16 (contiene: 119, 77, 107, 5, 6, 10, 14, 16, 30, 120, 3) G. Poggiali, Serie de’ testi di lingua stampati che si citano nel vocabolario degli Accademici della Crusca, possedute da Gaetano Poggiali, Livorno, Tommaso Masi, 1813, vol. I, pp. 123-27 (contiene: LVII, LVIII, LX, LIX, LXI) C. Albergotti Siri, Rime inedite di Giusto de’ Conti, Firenze, nella stamperia dell’ancora, 1819 (contiene, tratti da FL3: 151, Galli 279, 152, I-X, XII, XIVXXXIII, XXXV-L, LII-LV) F. Trucchi, Poesie italiane inedite di Dugento autori dall’origine della lingua infino al secolo decimosettimo, 4 voll., Prato, Ranieri Guasti, 1846 (pubblica da FR3: 105 e LVII) E. Rostagno, Il codice “Angelucci”, ora Laur.-Ashburnhamiano del “Canzoniere” di G. de’ Conti, in «Rivista delle biblioteche e degli archivi», VIII (1896), pp. 11-27 (contiene XI, XIII, XXXIV e LI) M. Manchisi, La fine dell’amore di Giusto de’ Conti con Isabetta ed alcune sue rime inedite, in «Studi di letteratura italiana», VII (1907), pp. 149-64 (contiene LXII, LXIII, LXIV, attribuiti al Conti dal cod. Castiglione) Id., Una canzone inedita di Giusto de’ Conti, in «Rassegna critica della letteratura italiana», XIII (1908), pp. 8-11 (contiene l’inedita canzone LVI, sulla testimonianza del cod. Estense Ital. 262) B. Wiese, Ein unbekanntes Werk Angelo Gallis, in «Zeitschrift für romanische Philologie», XLV (1925), pp. 445-583 (a p. 474 pubblica il son. LVIII) A. Galli, Canzoniere, ed. critica a cura di G. Nonni, Urbino, Accademia Raffaello, 1987 (a pp. 386-87 e 399 pubblica i sonetti 111a, 112, 148) Id., Operetta, ed. critica a cura di E. Ardissino, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2006 (a p. 23 pubblica il son. LVIII) Studi D. Alexandre-Gras, Le canzoniere de Boiardo, du pétrarquisme à l’inspiration personnelle, Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, 1980, pp. 40-49. V.A. Arullani, Dante e Giusto de’ Conti, in «Fanfulla della domenica», 7 luglio 1901 B. Bartolomeo, Le forme metriche della Bella mano di Giusto de’ Conti, in «Interpres», XII (1992), pp. 7-56. Ead., La mano, la fenice, la navigatio. Temi petrarcheschi nella rielaborazione di Giusto de’ Conti, in «Rivista di letteratura italiana», XI (1993), pp. 103-42. Ead., «Per me non basto…». Presenza delle fonti classiche nella poesia di Giusto de’ Conti, in Giusto de' Conti di Valmontone. Un protagonista della poesia italiana del ’400, a cura di I. Pantani, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 89-116 F. Bausi, Giusto de’ Conti e la poesia laurenziana, in Giusto de’ Conti di Valmontone, cit., pp. 283-95 G. Benadduci, Della signoria di Francesco Sforza nella Marca e peculiarmente in Tolentino (Decembre 1433 - Agosto 1447), Tolentino, Filelfo, 1892, pp. 355-56, 363-64, LXXV-LXXVII G. Biancardi, Appunti per l’edizione critica del Canzoniere di Giusto de’ Conti, «ACME», XLIII (1990), pp. 53-68 Id., Esperimenti metrici del primo Quattrocento: i polimetri di Giusto de’ Conti e Francesco Palmario, in «Italianistica», XXI (1992), pp. 651-78 S. Carrai, Nell’officina della Bella mano: la funzione strutturante delle canzoni, in Giusto de’ Conti di Valmontone, cit., pp. 193-99 R. Cremante, Conti, Giusto de’, in Dizionario critico della letteratura italiana, diretto da V. Branca, Torino, UTET, 1986, vol. II, pp. 53-54 (I ediz.: 1973, vol. I, pp. 630-32) A. Debanne, Per la lingua di Giusto de’ Conti: la testimonianza dei codici feltreschi, in Giusto de' Conti di Valmontone, cit., pp. 179-92. D. De Robertis, L’ecloga volgare come segno di contraddizione, in «Metrica», II (1981), pp. 68-80 D. Esposito, I tre canzonieri di Domizio Brocardo, in «Studi e problemi di critica testuale», 85 (2012), pp. 85-116. A. Fantozzi, Un canzoniere inedito del secolo XV, in «La favilla», XXI (1900), pp. 61-94 L. Frati, Giusto de’ Conti e madonna Isabetta Pepoli, in «L’Archiginnasio», XIII (1918), pp. 140-44 M. Gazzotti, Jacopo Corbinelli editore de La bella mano di Giusto de’ Conti, in La lettera e il torchio. Studi sulla produzione libraria tra XVI e XVIII secolo, a c. di U. Rozzo, Udine, Forum, 2001, pp. 167-247 G. Gorni, Atto di nascita d’un genere letterario: l’autografo dell’elegia “Mirzia”, in «Studi di filologia italiana», XXX (1972), pp. 251-73 Id., Ragioni metriche della canzone, tra filologia e storia, in Studi di filologia e di letteratura italiana offerti a Carlo Dionisotti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1973, pp. 15-24, rist. (con titolo Ragioni metriche della canzone) in Id., Metrica e analisi letteraria, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 207-17 Id., Note sulla ballata, in «Metrica», I (1978), pp. 219-24, rist. (con titolo Altre ballate, dal Boccaccio al Boiardo), in Id., Metrica e analisi letteraria, cit., 243-49 A. Lanza, La lettertura tardogotica. Arte e poesia a Firenze e Siena nell’autunno del Medioevo, Roma, De Rubeis, 1994, pp. 722-33 20 M. Manchisi, recensione a E. Rostagno, Il codice “Angelucci”, ora Laur.Ashburnhamiano del “Canzoniere” di G. de’ Conti, in «Rassegna critica della letteratura italiana», I (1896), pp. 171-74 Id., La data della Bella Mano, in «Rassegna critica della letteratura italiana», III (1898), pp. 6-10 Id., recensione a L. Venditti, Giusto de’ Conti e il suo canzoniere «La bella mano», in «Rassegna critica della letteratura italiana», VIII (1903), pp. 213-27. Id., Dell’autenticità dei sonetti di Giusto dei Conti pubblicati dal Poggiali, in «Rassegna critica della letteratura italiana», IX (1904), pp. 97-104 Id., La fine dell’amore di Giusto de’ Conti con Isabetta ed alcune sue rime inedite, in «Studi di letteratura italiana», VII (1907), pp. 149-64 Id., Una canzone inedita di Giusto de’ Conti, in «Rassegna critica della letteratura italiana», XIII (1908), pp. 8-11 P.V. Mengaldo, La lingua del Boiardo lirico, Firenze, Olschki, 1963, pp. 336-39 e passim. G. Natali, La lezione di Boccaccio, in Giusto de’ Conti di Valmontone, cit., pp. 157-76 I. Pantani, Tradizione e fortuna delle rime di Giusto de’ Conti, in «Schifanoia», 8 (1989), pp. 37-96 Id., Il polimetro pastorale di Giusto de’ Conti, in La poesia pastorale del Rinascimento, a cura di S. Carrai, Padova, Antenore, 1998, pp. 1-55 Id., «La fonte d’ogni eloquenzia». Il canzoniere petrarchesco nella cultura poetica del Quattrocento ferrarese, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 180-223 e passim Id., Fasi e varianti redazionali della Bella mano: primi appunti, in Petrarca in Barocco. Cantieri petrarchistici. Due seminari romani, a cura di A. Quondam, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 417-35 Id., «La bella mano». Tradizioni vulgate e tradizione d’autore, in «Filologia italiana», 3 (2006), pp. 97-119 Id., I poeti del Tempio Malatestiano: amore, morte e neoplatonismo, in «La cultura», XLIV (2006), pp. 215-41 Id., L’amoroso messer Giusto da Valmontone, Roma, Salerno Editrice, 2006 Id., Prima e dopo la ‘Bella mano’: le quattro donne di un altro Giusto, in Giusto de’ Conti di Valmontone, cit., pp. 201-40 E. Pasquini, Cino da Pistoia e i lirici del Quattrocento, in Colloquio Cino da Pistoia, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1976, pp. 87-127, a pp. 103107; rist. in Id., Le botteghe della poesia. Studi sul tre-quattrocento italiano, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 353-408, a pp. 364-68. F. Patriarca, Stretta osservanza, eclettica maniera. Qualche appunto su La bella mano di Giusto de’ Conti, in «Agalma. Rivista di Estetica e Studi Culturali», 13 (marzo 2007), pp. 62-67 A. Piacentini, Giusto de Conti di Valmontone. Sulla traccia del ritratto storico, Valmontone-Marino 2006 M. Praloran, Aspetti del petrarchismo contiano: metrica e sintassi, in Giusto de’ Conti di Valmontone, cit., pp. 117-55 P. Procaccioli, Conti, Giusto de’, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 28, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 435-38 L. Quaquarelli, Per l’edizione critica della Bella mano di Giusto de’ Conti, in «Studi e problemi di critica testuale», 38 (1989), pp. 11-43 Id., «Intendendo di poeticamente parlare»: la Bella mano di Giusto de’ Conti tra i libri di Feliciano, in «La Bibliofilia», XCIII (1991), pp. 177-200 Id., «Quelle pochette annotationi dalla margine tirate del libro mio»: la princeps bolognese della Bella mano di Giusto de’ Conti, in «Schede umanistiche», n.s., 2 (1991), pp. 51-79 N. Ratti, Su la vita di Giusto Conti Romano poeta volgare del secolo XV, Roma, De Romanis, 1824 (rist. in Giusto de’ Conti, Il canzoniere, a cura di L. Vitetti, Lanciano, Carabba, 1918, vol. II, pp. 99-113) M. Rosi, Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memorie dell’archivio Recanatese, Recanati, Simboli, 1895, pp. 298-99 A. Rossi, Presenza di Giusto nella poesia cortigiana. Una ricognizione bolognese, in Giusto de’ Conti di Valmontone, cit., pp. 317-332 M. Santagata, La lirica feltresco-romagnola del Quattrocento, in «Rivista di letteratura italiana», II (1984), pp. 53-106; quindi (aggiornato, con titolo Fra Rimini e Urbino: i prodromi del petrarchismo cortigiano), in M. Santagata-S. Carrai, La lirica di corte nell’Italia del Quattrocento, Milano, FrancoAngeli, 1993, pp. 43-95, passim Id., Per una storia della lirica italiana del Quattrocento, in Der Petrarkistische Diskurs, a c. di K.W. Hempfer e G. Regn, Stuttgart, Steiner, 1993, pp. 11-28; rist., con titolo Dalla lirica ‘cortese’ alla lirica ‘cortigiana’, in SantagataCarrai, La lirica di corte, cit., pp. 11-30; e in M. Santagata, I due cominciamenti della lirica italiana, Pisa, ETS, 2006, pp. 87-113, a pp. 95-96, 108-109. S. Tatti, La riscoperta settecentesca di Giusto de’ Conti, in Giusto de’ Conti di Valmontone, cit., pp. 333-42 C. Vecce, Echi contiani nella Napoli aragonese, in Giusto de’ Conti di Valmontone, cit., pp. 297-315 G. Velli, A proposito di Giusto de’ Conti, in «Belfagor», XXIII (1968) , pp. 348-55 L. Venditti, Giusto de’ Conti e il suo canzoniere “La bella mano”. Studio storico-critico, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1903 B. Wiese, Ein unbekanntes Werk Angelo Gallis, in «Zeitschrift für romanische Philologie», XLV (1925), pp. 445-583 T. Zanato, Giusto e gli Amorum libri di Boiardo, in Giusto de’ Conti di Valmontone, cit., pp. 243-82 21 Sigismondo Pandolfo Malatesta di Italo Pantani Titolo Alcuni codici ci hanno tramandato, senza titolo, un piccolo canzoniere dedicato da Sigismondo Pandolfo Malatesta alla sua amante (dal 1446) e poi moglie (dal 1456) Isotta degli Atti. È possibile che le rime pervenuteci rappresentino solo un estratto di quel libro «chiamato Isoteo, composto per il Signore messer Sigismondo da Rimini in versi vulgari», già negli anni ’70 inventariato tra i beni di Ercole d’Este (come segnalò A. F. Massera). In effetti, che la produzione lirica del Malatesta dovesse essere più abbondante di quella a noi nota sembra doversi anche ricavare dal De re militari (1455 ca.) di Robero Valturio, il quale attribuisce al suo signore «plurima materna humanarum divinarumque rerum carmina» (ed. Verona 1472, cc. [14]v-[15]r). In ogni caso, il titolo Isotteo trova conferma in un secondo inventario estense, di poco successivo, che di nuovo registrava la presenza di un «Isoteo composto per il S.re Sigismondo di Rimine» tra le «vulgari di più cose» (senza dunque confusione possibile con il latino Liber Isottaeus) possedute dal duca Ercole. Testimoni principali Sia che contenessero solo i pochi testi pervenutici, sia che al contrario ospitassero una raccolta più ampia, certamente sono per ora irreperibili i più antichi testimoni conosciuti del canzoniere di Sigismondo. Alla citata copia del suo Isotteo posseduta da Ercole d’Este, infatti, possiamo aggiungerne almeno un’altra registrata tra i beni personali del Malatesta, e così segnalata da Massera: «Un inventario dei beni mobili esistenti nel castello Sismondo di Rimini, fatto compilare […] da madonna Isotta vedova di Sigismondo nel quarto giorno (13 ottobre 1468) dalla morte del principe, ricorda, tra gli oggetti trovati nella camera detta del gienevere, tre manoscritti; il terzo dei quali è indicato dal notaio in questo modo: “uno Canzonero de sonitti compose el Signore e aprovò el Signore a Madonna”». Inoltre, sempre nella stanza del ginepro (emblema di Isotta) di Castel Sismondo, in una cassa «de madonna Bianca» si trovava un «canzonero fo del Signore», che lo stesso Massèra ipotizzava potesse trattarsi di «un altro esemplare della raccolta per Isotta». Essendo irreperibili, al momento, questi o altri codici esclusivamente destinati alle rime di Sigismondo, i soli testimoni disponibili sono rappresentati da miscellanee antologiche, non sempre affidabili nelle attribuzioni, che tuttavia consentono di riconoscere al Malatesta con relativa certezza: a) una raccolta formata da 12 sonetti dedicati ad Isotta (1. I mei lunghi pensier avran mai loco; 2. Gli antichi exempi pur me riconforta; 3. Ochi modesti, accorti et valorosi; 4. Adio, con voce mesta et cum sospiri; 5. Temo de Morte, che pospone i rei; 6. Se l’anima immortal ha ’sto volere; 7. Morte n’ha spinto quel legiadro volto; 8. Misera vita, scura et passionata; 9. Se i cieli per pietà se regge et volta; 10. Datime posso, o mei pensier amari; 11. Già fui felice sopra zascheduno; 12. Piango et sospiro l’aspra mia fortuna); b) altri 2 sonetti, ancora dedicati ad Isotta, tràditi dallo stesso codice ma separati dai precedenti (13. O mondo falso, traditor et rio; 14. Chi serrà quel che donarà mai pace); c) altri 2 sonetti, concernenti ancora Isotta, ma indirizzati come proposte poetiche al funzionario urbinate Angelo Galli, e giuntici tra le rime di quest’ultimo (15. Poi che natura, il cielo et ciascun segno; 16. Manca del bel giardino el nobil fiore). I testimoni principali di questo corpus sono i seguenti: F = Forlì, Bibl. Comunale «A. Saffi», ms. Piancastelli 267 (V 87). Membranaceo, 1466-69, cc. VI, 184, VI’. Una sola mano, umanistica posata, calligrafica. Titolo a c. 1r in capitali a linee alternate rosse e blu: «SONETTI ET CANZONE DEL SPECTABILE CAVALIERO MESERE AGNOLO DE GALLI DA VRBINO», ecc. A piè di pag. lo stemma di Napoleone Orsini. Il ms. è il principale testimone del canzoniere di Angelo Galli, nel quale confluirono anche rime dei suoi corrispondenti. Di S. P. Malatesta contiene i testi 15 («Mandato da lo excelso S. Sigismondo a messer Angelo di Galli», c. 144r) e 16 («Messivo del sopradicto Signore ad meser Angelo», c. 144v), 1 con le risposte del Galli. R = Firenze, Bibl. Riccardiana, ms. 1154. Membranaceo, sec. XV ex., cc. II, 172. Una sola mano, splendida umanistica posata. A c. 7r, iniziale dorata su fondo policromo, e sul margine basso lo stemma dei Visconti-Sforza. La numerazione antica delle cc. (180-345) prova che il ms. era il secondo tomo di una più ampia raccolta: di cui, nonostante il trasferimento a Milano, è stata già rilevata l’origine veneta. Comprende rime di J. Sanguinacci, C. Salutati, A. Loschi, S. Serdini, F. Malecarni, G. de’ Conti, M. Malatesti, D. Brocardo, F. Accolti, G. F. Suardi, I. Badoer, M. Piacentini, G. Boccaccio, Buonaccorso il Giovane, N. Cieco, A. Calderoni, N. Malpigli, Burchiello, R. Orsatto, Pucino da Pisa, Antonio da Ferrara, N. Tinucci, A. Galli, P. de’ Gualdi, L. Giustinian, e altri. Di S. P. Malatesta contiene i testi 1-12 («Dominvs Sigismondus de Malatestis», cc. 83r-86r), e 13-14 («Sigismondus de Malatestis», c. 144r-v). U = Città del Vaticano, Bibl. Apostolica, ms. Urbinate Latino 699. Membranaceo, 1474-82, cc. II, 208. I’. Una sola mano, l’elegante umanistica di Federico Veterano, bibliotecario di Federico di Montefeltro. Titolo a c. 9v in capitali a righe alternativamente azzurre e rosse, chiuse in una corona d’alloro avvolta da fregi: «IN HOC CODICE CONTINENTVR RITHIMI AC CANTILENAE MATERNA LINGVA COMPOSITAE SPLENDIDISSIMI AC ELOQUENTISSIMI EQVITIS DOMINI ANGELI GALLI VRBINATIS», ecc.; a c. 10r lo stemma dei duchi d’Urbino. Interamente dedicato al canzoniere di Angelo Galli, il ms. conserva anche le rime dei suoi corrispondenti. Di S. P. Malatesta contiene i testi 15 («Dal S. Gismondo ad Agnolo Galli domanda que fosse l’intentione del secondo», c. 164v) e 16 («Messivo da sopradetto Signore», c. 165r), con le risposte del Galli. V = Vicenza, Bibl. Civica Bertoliana, ms. 1.10.22, n. 128. Cartaceo, sec. XVI, cc. II, 124. Una mano fondamentale, di ascendenza mercantesca. Nel codice, di evidente origine veneta, si distinguono due sezioni. La prima (cc. 1-72) contiene, adesp. e anep., la raccolta quasi completa delle rime del padovano Marco Businello. La seconda (cc. 75-117) conserva una scelta di rime (molto simile a quella di FR) attribuite a F. Malecarni, G. de’ Conti, D. Brocardo, F. Accolti, M. Piacentini, G. Boccaccio, Buonaccorso il Giovane, R. Orsatto, N. Tinucci, A.Galli, P. Gualdi, M. Malatesti, P. Bianchelli, F. Capodilista, G. Roselli, J. Languischi, A. di Meglio, Pietro da Pisa. Di S. P. Malatesta contiene i testi 1-6, 8-12 («Dominus Sigismundus de Malatestis», cc. 103v-108v). Ragguagli sulla tradizione In primo luogo, sarà utile precisare (sempre partendo dalle ricerche di Massera) che non furono opera di S. P. Malatesta alcuni componimenti spesso circolanti, e anche pubblicati sotto il suo nome (in edizioni per questo, naturalmente, escluse dall’elenco finale). Testimone notevolmente confusionario si è rivelato, innanzitutto, il ms. di Firenze, Bibl. Nazionale Centrale, Palatino Capponi 152. Esso infatti intesta con la didascalia «Opus magnifici et potentis domini Sigismundi Pandolfi de Malatestis, factum 1445» il serventese Alto signor, denanti a cui non vale (cc. 130r-133v), più verosimilmente attribuito a Carlo Valturio, cancelliere di Sigismondo, dal codice di Bologna, Bibl. Universitaria, ms. 1739 (il famoso “Isoldiano”): «Karoli Valturrii ariminensis, viri ornatissimi et ill.mi d. Sigismondi de Malatestis Canzellarii etc., cantilena elegantissima pro eodem domino suo incipit» (c. 91r); poiché il componimento dà voce al Malatesta e al suo amore per Isotta, è facile capire la genesi dell’errata attribuzione del ms. Capponiano. Lo stesso codice premette la didascalia «Per magnificum dominum Sigismundum Pandolfum facta est» al poemetto in ternari Nell’ora che se colca nel ponente (cc. 185r-189v), e la sigla «SPM» al successivo sonetto Occhi mei, belli ove è la vostra luce (c. 189v): si tratta tuttavia, in entrambi i casi, di testi composti «per» Sigismondo da Angelo Galli, nel cui canzoniere figurano, rispettivamente, ai nn. 264 e 261. Nello stesso codice, infine, dopo il serventese Alto signor, s’incontra, adespoto e anepigrafo, il capitolo ternario Soccorrime per Dio, ch’io so’ a mal porto: componimento che compare intestato «Sigismundus Pandulphus Malatesta» nel ms. della Bibl. Apostolica Vaticana, Vaticano Latino 5159 (c. 275r), ma che è in realtà opera 2 di Simone Serdini (n. 78). Qualche equivoco attributivo hanno poi determinato le non sempre chiare didascalie del ms. U, nel quale non solo i componimenti 264 e 261, ma l’intera serie 261-265 è costituita da testi scritti dal Galli «per» il signore di Rimini (tra cui, ad es., il son. La lunga, aurata, ricca et bionda treza, c. 164r): componimenti anch’essi, talvolta, erroneamente attribuiti non al vero autore ma alla “voce” (di Sigismondo) a cui egli cede la parola. Tale serie, peraltro, è sia in F che in U seguita dalle due corrispondenze sopra citate (nn. 266-267 tra le rime del Galli, 15-16 tra quelle del Malatesta): da ritenersi fino a prova contraria autentiche, anche se nelle sue proposte Sigismondo mostra una sicurezza espressiva decisamente superiore rispetto al ciclo assegnatogli da R e da V. Una volta sgombrato il campo da erronee attribuzioni, la tradizione delle rime di S. P. Malatesta risulta piuttosto semplice. Il minicanzoniere di 12 componimenti è tràdito esclusivamente da due codici veneti, R e V, di cui è già nota la stretta affinità (strutturale e testuale). R è inoltre il solo testimone di altri due sonetti (13-14), di argomento identico ma trascritti a distanza di molte carte dai precedenti. Le due corrispondenze poetiche con Angelo Galli ci sono giunte invece attraverso i testimoni delle rime di quest’ultimo (F e U). Proprio sul testo di R si basano le sole due edizioni, moderne, di quanto resta della produzione lirica di Sigismondo: a cura di P. Bilancioni (1860) la prima, di A. Turchini (1983) la seconda, entrambe peraltro inaffidabili sul piano filologico, e nate del resto come occasionali doni di nozze. Miglior sorte hanno avuto le due corrispondenze con Angelo Galli, che non solo figurano nell’edizione critica delle rime di quest’ultimo, curata da G. Nonni (1987), ma erano già state pubblicate con perizia filologica da A. F. Massèra (1928). Periodo di composizione Le rime di S. P. Malatesta possono essere approssimativamente datate sulla base del mito artistico e letterario che probabilmente lo stesso signore ispirò intorno all’amata Isotta degli Atti. Come sopra ricordato, il serventese con cui Carlo Valturio diede voce alle prime invocazioni amorose di Sigismondo fu composto nel 1445: anno a cui bisogna far risalire anche l’inizio della scrittura lirica del principe, visto che a quella data Isotta non aveva più di 13 anni, e che nei primi sonetti del Malatesta (1-3) essa gli si mostra ancora insensibile. D’altra parte, numerosi documenti (medaglie, iscrizioni, nascita del primo figlio della coppia) ci dicono che già nel 1446, ancora vivente la legittima sposa di Sigismondo (Polissena Sforza), Isotta era diventata sua pubblica amante. Pur fra alterni stati d’animo, come vedremo, i testi 4-6, 14-16 lasciano presupporre un rapporto amoroso già in atto tra i due: e poiché nell’epistola I 6 del Liber Isottaeus di Basinio da Parma (vv. 45-46) relativa a situazioni proprie dei primi mesi del 1447, lo stesso personaggio di Isotta si compiace dei versi scritti da Sigismondo per lei, i nove sonetti citati dovrebbero risalire al biennio precedente. Quanto ai componimenti 7-13, il discorso è molto più complesso. Essi infatti intonano un canto in morte di Isotta: tema lirico privo di qualsiasi fondamento biografico, visto che, oltre vent’anni dopo, la morte del Malatesta (14 giugno 1468) avrebbe preceduto ampiamente quella della donna (9 luglio 1474) nel frattempo divenuta sua legittima sposa (1456). In ambito letterario, tuttavia, ben diverso era stato il destino di Isotta, che le ultime, splendide elegie del Liber Isottaeus (composto tra il 1449 e il ’51) rappresentano morta, non più che diciassettenne, già nella primavera del 1449, ossia negli stessi giorni in cui fu finita di murare, nel Tempio malatestiano, la cappella contenente il suo sepolcro. Anche le analoghe rime di Sigismondo potrebbero dunque, almeno in parte, risalire a questo periodo; ma tale ipotesi richiede alcune precisazioni. Il mito letterario della morte giovanile di Isotta, cui non pochi poeti avrebbero contribuito, sembra doversi ascrivere a intuizione dello stesso Sigismondo, visto che Basinio giunse a Rimini proprio nel 1449, a lavori sul sepolcro della fanciulla da tempo avviati (talché neppure è certa la sua paternità delle prime elegie del Liber, contesegli da Tobia dal Borgo), e avrebbe trattato il tema, come vedremo, secondo una prospettiva ben più consolatoria rispetto a quella del suo signore. Al contempo, un riferimento imprescindibile offre il sonetto 12 di Sigismondo (ultimo in R e V), in cui la morte dell’amata, compianta come evento recente («Piango che morte 3 per lo suo rapire / or m’ha lassato el cor e l’alma bruna», vv. 3-4) viene collocata a dodici anni dall’inizio del rapporto amoroso («Piango che a sua ombra dodeci anni / ho consumato, e mo’ senza sua guida / io mi ritrovo al miser mondo cieco», vv. 9-11): dunque non prima del 1457, data del tutto priva di riscontri, tanto biografici quanto letterari. Fin quando non dovessero emergere ragioni per disconoscere la paternità malatestiana del testo, se ne dovrà dedurre che quanto ci è pervenuto della lirica di Sigismondo copre un arco cronologico (1445-1457) ugualmente infedele rispetto alla vita vissuta, ma di proporzioni ben più ampie rispetto a quelle del Liber Isottaeus; e che il suo periodo di composizione si protrasse almeno fino al termine degli anni ’50. Numero dei componimenti 16 sonetti. 12 costituiscono la raccolta propriamente detta, come essa ci è stata trasmessa; 4 altri sonetti, ugualmente dedicati all’amore per Isotta, possono in origine aver fatto parte dello stesso breve canzoniere. Forme metriche impiegate Sonetti - 16. Uniformandosi a note predilezioni di questa stagione poetica, essi presentano rime esclusivamente incrociate nelle quartine, e una maggioranza quasi assoluta (15 casi su 16) dello schema a tre rime nelle terzine, di cui ben 14 nella canonica successione CDE CDE (1-13, 16), ed uno nella meno frequente CDE DCE (15); a fronte, un unico esempio con rime alterne CDC DCD (14). Punto α DOMINVS SIGISMONDUS DE MALATESTIS I mei lunghi pensier avran mai loco? Averà mai fine l’aspra mia guerra, che l’alma aflige e ’l tristo pecto afferra, e sempre se distruge a poco a poco? I suspir caldi e questo ardente foco, che nove fiame al cor ognor diserra, dovrian umiliare i mari e terra, e trovar pace che cotanto invoco. Ma quanto più riprego, più s’endura la mente di colei che non intende, anzi dispregia omne preghier umile; onde convien ch’ogne mia possa e cura cerchi de remediar a quel ch’offende, lassar l’usato e trovar novo stile. Punto ω L’individuazione di un testo ω tra quelli pervenutici di S. P. Malatesta è operazione piuttostro arbitraria. La scelta verte tra il sonetto 12, ultimo della piccola raccolta unitaria, che tuttavia come testo di anniversario, a ridosso dell’evento luttuoso, non ha i caratteri propri del componimento conclusivo; e il sonetto 13, tràdito però da R a distanza di varie carte, in coppia con il n. 14 e in successione rovesciata, visto che il primo è in morte e il secondo in vita. Si opta comunque per il sonetto 13, ultimo di quelli in morte trascritti, e più vicino al modello di una riflessione complessiva. D. SIGISMONDUS DE MAL. O mondo falso, traditor e rio, giardin de rose cum pungente spine, pien de false parol che par divine, viver crudel, ma nei sembianti pio! Ben so’ quel alme abiette, che per dio tu tene e vòle, dove poi taupine tu le conduce, misere e meschine, fermate in falsa spene e van disio. Credeva che tua forza fosse tale che potesse disporre del tuo regno senz’alcun contrasto omne tua voglia. Tu m’hai reducto in questo orribel male: madonna s’è partita, e a nui per pegno or t’ha lassato cieco, et mi cum doglia. 4 Articolazioni interne L’ “io” lirico La raccolta non ha articolazioni interne. Le didascalie sono esclusivamente attributive. Quelle che accompagnano i due sonetti di corrispondenza risalgono non all’autore ma al destinatario di quei testi, il rimatore urbinate Angelo Galli. Coincide con il signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta. La sua identità non è distinguibile finché l’amata è in vita, anche se vari caratteri gli si possono riconoscere: il dolore per il distacco dalla propria terra e dall’amata, nel suo caso (deduciano dall’Isottaeus) dovuto a missioni di guerra («Adio, con voce mesta e cum suspiri / io dico lassio, o bel volto sereno, / dolce mio caro loco, o bel terreno»: 4, vv. 1-3; e cfr. anche 16); il tedio delle proprie ambizioni inappagate («Quel che bramai or più me pesa e spiace: / avria voluto el viver immortale […]. / El tempo avanza più che non vorrei / né dir se vole: quest’è el mio disio, / ov’ho fermato i stanchi pensier mei»: 14, vv. 5-6, 9-11). Il personaggio si manifesta apertamente dopo la morte dell’amata: nel sonetto 7, in particolare, egli si rivela sia nominando la defunta, sia visitandola presso il monumentale sepolcro da lui allestitole, in toni peraltro informati né ad orgoglio, né a motivo di consolazione («o mia donna cara, / renchiusa fra questi aspri e marmi duri, / Isotta bella, sola ai nostri giorni», vv. 9-11). Sequenze intermedie 1-3: l’amata non ricambia ancora il poeta, anche se gradulmente gli si mostra più pietosa 5-6: angosciose riflessioni sulle conseguenze di una eventuale morte della fanciulla 7-12: morte dell’amata, disperazione dell’amante. Tempo della storia ed eventuale quadro cronologico dettagliato Le rime di Sigismondo pervenuteci non offrono informazioni cronologiche circa l’inizio della storia, che però tante voci della letteratura Isottea collocano nel 1445, anno in cui iniziarono le attenzioni del principe per la fanciulla (allora non più che tredicenne). Da tale termine temporale ha dunque inizio anche la storia della raccolta del Malatesta, visto che le sue prime rime rappresentano Isotta ancora indifferente nei suoi confronti, laddove fin dalla primavera del 1446 il già reciproco legame amoroso sarebbe stato pubblicamente esibito. Quanto alla conclusione della vicenda, mentre il Liber Isottaeus di Basinio da Parma, come detto, fa cadere la morte (letteraria) di Isotta nella primavera del 1449, il sonetto 12 di Sigismondo colloca tale immaginaria sciagura, atto conclusivo della storia, a 12 anni dall’inizio del suo servizio amoroso, dunque non prima del 1457. Testi di anniversario Il solo testo di anniversario è il più volte citato sonetto 12, di cui cfr. i vv. 9-11: «Piango che a sua ombra dodeci anni / ho consumato, e mo’ senza sua guida / io mi ritrovo al miser mondo cieco». Il “tu” Pur con la già ricordata, romanzesca anticipazione della data della sua morte, l’amata si identifica con una giovanissima e bionda fanciulla riminese, Isotta degli Atti, di cui A. Campana fornì un accurato profilo biografico. Nelle rime composte da Sigismondo in onore di Isotta ancora “vivente”, ella non è mai nominata, se non attraverso il suo emblema, il ginepro: «Manca del bel giardino el nobil fiore / che tien le foglie e l’arbor sempre verde […]. / Lauro, faggio, pino, accompagnate / el bel genevro transformato in donna» (16, vv. 1-2, 9-10). Inizialmente è accusata di durezza (1, vv. 9-11), ma in lei, oltre che una «beltà divina» (15, v. 3), regna anche una «summa bontà» (5, v. 5); perciò, quando decide di ricambiare l’amante, diviene per quest’ultimo unica ragione di vita («morte me tien sol per colei / che me fé servo al suo bel volto pio»: 14, vv. 15-16). Solo tuttavia dopo la morte dell’amata il poeta giunge a pronunciarne apertamente il nome: «Isotta bella, sola ai nostri giorni!» (7, v. 11). 5 Testi di pentimento religioso S. P. Malatesta non approda mai a un pentimento spirituale; anche quando accenna a temi religiosi, li affronta con animo irrequieto e con incerta speranza. Nel sonetto 6, ad esempio, il destino ultraterreno dell’anima appare funzionale non alla visione di Dio, ma a quella eterna dell’amata («Ahi, quanto adunqua me sarebbe greve, / di là staendo, e ch’el me fosse tolto! / Ma pur io spero in Quel che tucto vale», vv. 12-14). Dopo la morte di questa, nel sonetto 7, un po’ di consolazione al dolore giunge dal pensiero della sua nuova dimora celeste («qualche conforto, tu che ’l ciel adorni», v. 14); ma nel sonetto 9 il poeta giunge ad accusare la «pietà […] / de quel Factor che l’universo guida» di negarsi a lui solo: «Perché Fortuna rea o destin forte / m’ha giudicato, e privo della Grazia / ch’ognun possede dal divin Motore?» (vv. 1-2, 9-11). Nel sonetto 12, neppure più la beatitudine di Isotta è motivo di sollievo: «Piango che ’l sole, stelle e poi la luna / prendono insemi festa del salire / ch’ha facto al Ciel madonna» (vv. 5-7). Testi con destinatari storici 15: al funzionario e rimatore urbinate Angelo Galli 16: ancora al Galli Isotopie spaziali Riferimento spaziale costante della raccolta è la città di Rimini. Il sonetto 4 lamenta la «partenza dolorosa» (dovuta probabilmente a una missione di guerra) dal «caro loco o bel terreno / che fo principio» agli «alti disiri» del poeta. Il sonetto 7, annunciando la morte dell’amata, accenna al suo sepolcro riminese, in San Francesco, piangendola «renchiusa fra questi aspri e marmi duri». Nel sonetto 15, il poeta invita Angelo Galli nella sua città, per ammirare Isotta e trarne ispirazione poetica (non a caso, il Galli concluderà la sua risposta con il verso: «Senza ella Arimin tuo ogge que vale?»). Il sonetto 16 lamenta di nuovo un distacco dall’amata: che ciò sia nuovamente dipeso da una partenza di Sigismondo, lo esplicita il Galli nella sua risposta. Progressione del senso Sebbene non giustificabile in sede editoriale, una dislocazione mirata dei sonetti “dispersi” lungo la trama narrativa della raccoltina principale appare operazione necessaria, per ricostruire la progressione di senso di ciò che resta del corpus lirico malatestiano. Il primo nucleo è rappresentato dalla serie 1-3. Inizialmente, il poeta lamenta la durezza dell’amata, che non lo ricambia; tuttavia, se in 1 ella «dispregia omne preghier umìle» (v. 11), in 2 l’amante si fa coraggio, confortato da proverbiali «antichi exempi» («el continuo bussar spezza omne muro», v. 11), sicché già in 3 gli occhi di lei gli si rivolgono talora «piatosi» (v. 5). I temi della lode, e del dolore per occasionali separazioni, compaiono nei sonetti di corrispondenza 15-16 (indirizzati ad Angelo Galli) e nel sonetto 4. Nel primo il poeta, nell’invitare il destinatario a raggiungerlo a Rimini per ammirare la bellezza dell’amata e trarne ispirazione, a sua volta ne offre il ritratto. Il 16 invece lamenta il forzato distacco (che la risposta del Galli attribuirà a partenza dello stesso Sigismondo) dal «bel genevro trasformato in donna» (v. 10). Il momento iniziale di questa (o altra) separazione, ossia la «partenza dolorosa» dal «caro loco» del proprio amore, è il tema del sonetto 4. I successivi sonetti 5-6, assieme al testo 14, introducono invece altrettante riflessioni sulla morte. Il 5 esprime il timore di una giovanile scomparsa dell’amata: «Temo de morte, che pospone i rei, / non toglia di madonna el suo bel fiore» (vv. 1-2). Il successivo testo 6 è invece una preghiera agli «alti dei», affinché concedano che «l’anima immortal», quando tornerà «al loco deputato», «possa madonna rivedere». Un quadro di profonda crisi esistenziale, pur essendo ancora viva l’amata, ritrae il sonetto 14: «Chi serrà quel che donarà mai pace / al corpo tristo e a l’alma stanca e frale?» (vv. 1-2). La ragione di tale crisi è riconosciuta nello spegnersi della propria istintiva ribellione contro lo scorrere del tempo e della vita: «Quel che bramai or più me pesa e spiace: / avria voluto el viver immortale […]. / El tempo avanza più che non vorrei, / né dir se vòle: 6 quest’è el mio disio, / ov’ho fermato i stanchi pensier mei» (vv. 5-6, 911); e se la morte ancora non pone fine a questo stato, ciò avviene «sol per colei / che me fé servo al suo bel volto pio» (vv. 13-14). I sonetti in morte di Isotta sono i nn. 7-13. Il primo contiene l’annuncio del triste evento («Morte n’ha spinto quel legiadro volto», v. 1), nonché il citato accenno ai «marmi duri» in cui ora è «renchiusa» «Isotta bella». La morte dell’amata determina nel poeta uno stato di radicale disperazione, tema di questo e dei due seguenti sonetti: «D’ogne mio ben io son privato e sciolto […], / misero, lasso, e d’omne spen disciolto» (7, vv. 4, 8); «destin crudel […] / ch’hai facto l’alma al tucto disperata!» (8, v. 8); «da ogni spene è l’alma mia disciolta» (9, v. 8). Nel sonetto 9, mosso da tale disperazione, il poeta accusa la «pietà […] / de quel Factor che l’universo guida» di negarsi a lui solo, «facendo crudeltà, guerra e disfida» (vv. 1-2, 6). Il 10 è una richiesta di tregua ai propri «pensier amari, / dogliosi sogni, o visïon fallace», che negano al poeta il necessario riposo con il continuo ricordo dell’amata scomparsa. Il sonetto 11 contiene un’invettiva contro la Fortuna invidiosa: a causa della quale il poeta, già «felice sopra zascheduno / amante», si ritrova ora a chiedere la propria morte «ad uno ad uno / passo». Anche il 12, contenente l’indicazione cronologica dei 12 anni consumati all’ombra di Isotta, si apre lamentando «l’aspra fortuna» del poeta, «riducto in tenebre e martire», giacché «senza sua guida» egli si ritrova «al miser mondo cieco». «Cieco», per il sonetto 13, è rimasto anche il mondo dopo la morte di Isotta: un mondo peraltro ora riconosciuto come «falso, traditor e rio» (v. 1), tale dunque da far dapprima sentire come dèi le «alme abiette», per poi ridurle «misere e meschine, / fermate in falsa spene e van disio» (vv. 7-8). Connessioni intertestuali Anche la ricerca di connessioni intertestuali può essere esercizio artificioso, in questa raccolta di rime che non sappiamo se giuntaci completa o frammentaria; eppure, sempre sulla base di una ipotetica successione 1-3, 15, 4, 16, 5-6, 14, 7-13 (che non altera la serie 1-12, ma solo la integra con gli altri testi pervenutici), a sostegno della trama narrativa emergono tra i testi elementi lessicali di raccordo, importanti anche come indizio del carattere unitario del corpus lirico malatestiano. I sonetti 1-3, ad es., nei quali la fanciulla non corrisponde ancora il suo amante, variano il tema del rapporto tra preghiera del poeta e durezza dell’amata: «quanto più riprego, più s’endura / la mente di colei» (1, vv. 9-10); «porger sempre prieghi al duro pecto / sperando che fia umìl, benché sia duro» (2, vv. 13-14); «perché ’l dur core adonca me disface? […] / Al mio chiamar mercede è facto austero» (3, vv. 6, 11). I sonetti 4 e 16, entrambi dedicati a una separazione forzata (e in particolare il primo alla «partenza dolorosa», il secondo al senso di mancanza) potrebbero dirsi collegati dalla rima in -ore, che chiude il primo e apre il secondo. Lo stesso sonetto 16, come già rilevato, è tutto costruito sul simbolismo vegetale di Isotta, in veste di ginepro («Manca del bel giardino el nobel fiore», v. 1): proprio il motivo che, ugualmente rafforzato dalla collocazione in rima, apre il testo 5 («Temo de morte […] / non toglia di madonna el suo bel fiore», vv. 1-2), componimento con cui si introduce la riflessione sulla morte. Ebbene, può non essere un caso che l’altro sonetto dedicato a questo tema, il 6, articoli le proprie terzine su rime uguali (-ale) o simili (-olto / onto) rispetto a quelle del precedente; certo è che esso si apre sullo stesso binomio anima / corpo («Se l’anima immortal ha ’sto volere / che regge gli uman corpi in questo stato») con cui ha inizio il sonetto 14 («Chi serrà quel che donarà mai pace / al corpo tristo e a l’alma stanca e frale?»). Peraltro non solo la rima in -olto, ma le stesse parole-rima di 6 («bel volto», «me fosse tolto») aprono il sonetto 7 («ligiadro volto», «m’è stato tolto»), con il quale dalla meditazione sulla morte si passa all’annuncio della concreta, tragica scomparsa di Isotta. Una connessione ancora più forte, del resto, unisce questo testo al successivo n. 8: aperto da locuzioni sulla propria vita, dominata ormai da un dolore mortale («Misera vita, scura e passionata / a mi noiosa omai più che la morte», vv. 1-2), simili a quelle con cui si era concluso il precedente («Dolente el mondo e la mia vita amara / tu hai lassato, cum mortal dolori», vv. 12-13). Il filo conduttore della morte favorisce poi il ricorrere della relativa rima sia nel sonetto 8 che nel 9: testo quest’ultimo, del resto, che del precedente ripropone l’area semantica della disperazione del poeta perseguitato dal destino («Destin crudel et angoscioso e forte, / ch’hai fac7 to l’alma al tucto disperata!», 8, vv. 7-8; «e da ogni spene è l’alma mia disciolta, / perché Fortuna rea o destin forte, / m’ha giudicato», 9, vv. 8-10). Una connessione di tipo lessicale congiunge poi questo testo al n. 10 attraverso la ripetizione del termine amaro: inserito nell’ultimo verso del primo («or perché a me cotanto amar dolore?») e nel primo verso del secondo («Datime posso, o mei pensier amari»). Il sonetto 11 sviluppa quindi nuovamente, lungo tutte le terzine, il tema della «Fortuna aspra e cruda», che ha «gionto ai giorni dolorosi» il poeta (vv. 9, 13): esattamente il motivo, riproposto con i medesimi termini, che apre il sonetto 12: «Piango e sospiro l’aspra mia Fortuna / che m’ha riducto in tenebre e martire» (vv. 1-2). Questo componimento piange anche i dodici anni consumati all’«ombra» dell’amata, aggiungendo: «e mo’ senza sua guida / io mi ritrovo al miser mondo cieco […] / carco de doglia» (vv. 9-11, 13); e un’invettiva contro gli inganni del mondo, reso cieco da quella morte di Isotta che ha anche travolto di doglia il poeta, è anche il tema portante del sonetto 13 («O mondo falso […], / madonna s’è partita e a nui per pegno / or t’ha lassato cieco, e mi cum doglia», vv. 1, 13-14). Poesie di poetica Assenti. Contenuti non amorosi Assenti, fatte salve le già ricordate riflessioni esistenziali, comunque sollecitate dall’esperienza amorosa, e dal confronto col doloroso mistero della morte. Altre osservazioni Gli usi metrici di S. P. Malatesta presentano numerose incertezze, tipiche di un rimatore dilettante. Già il sonetto 1 ad esempio, contiene un endecasillabo con accento in 5a sede, a meno di pesanti interventi correttori («Averà mai fine l’aspra mia guerra», v. 2); e la presenza di dieresi, spesso anche dure, rappresenta fenomeno costante in queste rime: basti citare, ancora dal sonetto 1, «dovrïan umiliare i mari e terra» (v. 7). La veste linguistica d’altronde è una tipica koinè padana, foneticamente ben documentabile attraverso gli esiti certificati in rima, come quello : velo (3, vv. 9, 12); legno : sustegno (4, vv. 9, 12); breve : greve (6, vv. 9, 12); duri : doluri (7, vv. 10, 13); guida : finida (9, vv. 2-3). Sul piano grammaticale, non certo canoniche sono varie desinenze verbali, come quella della terza persona plurale: «Gli antichi exempi pur me riconforta / e porge aiuto» (2, vv. 1-2); «Se i cieli per pietà se regge e volta» (9, v. 1); «como stan quei che nel tuo fondo iace» (11, v. 14). Anche il livello sintattico presenta spesso licenze del parlato: cfr. ad es. duplicazioni pronominali come «a cui per pegno gli ho lassato el core» (4, v. 14); «di madonna el suo bel fiore» (5, v. 2); «del qual non temo ne debbian fugire» (8, v. 10). Sul piano retorico, al contrario, la scrittura lirica di S. P. Malatesta non appare affatto sprovveduta. La distribuzione dei membri sintattici nel verso risente positivamente del modello petrarchesco, prevalentemente mediante l’adozione di un ritmo binario, denso di parallelismi («che l’alma aflige e ’l tristo pecto afferra», 1, v. 2; «fortuna rea o destin forte», 9, v. 9) e di dittologie in clausola («mari e terra», 1, v. 7; «possa e cura», 1, v. 12; «scura e passionata», 8, v. 1), spesso anche sinonimiche («sbigotita e smorta», 2, v. 4; «mio cibo e mio sustegno», 4, v. 12; «dura et affannata», 8, v. 4; «trista e dolorata», 8, v. 5). Non mancano gli accumuli aggettivali («Umil, contento, pacïente e quieto», 8, v. 12), o sintagmi in successioni chiastiche («i suspir caldi e questo ardente foco», 1, v. 5; «dogliosi sogni, o visïon fallace», 10, v. 2; «ricca d’invidia e de pietate nuda», 11, v. 12). Sull’insistita anafora della voce «piango» (vv. 1, 3, 5, 9) è poi articolato il sonetto 12, né mancano aspre serie allitteranti abilmente gestite, come quando il poeta piange l’amata «renchiusa fra questi aspri e marmi duri» (7, v. 10). Anche l’impianto metaforico del discorso amoroso di Sigismondo appare fondamentalmente di ascendenza petrarchesca. L’amata, almeno inizialmente, mostra un «duro pecto», ma nei suoi occhi Amore affina «gli aurati strali»; anch’ella si identifica con un albero sempreverde, il ginepro, con le conseguenti, topiche variazioni. Invano il poeta aspira a «trovar pace» (1, v. 8: da Rvf 316, v. 1); la sua vuota aspirazione a una vita «immor8 tale» lo porta a identificarsi illusoriamente nella «fenice», finché prima le delusioni poi la scomparsa di Isotta lo spingono a desiderare la morte. Con una citazione petrarchesca (Rvf 363, v. 1; 300, v. 12), abbinata peraltro a una formula del repertorio musicale, introduce l’annuncio che «Morte n’ha spinto quel ligiadro volto» (7, v. 1); in seguito, «dogliosi sogni o visïon fallace» vengono a rinnovare il suo dolore mostrandogli «quei begli ochi» (10, v. 12). D’altra parte, una più attenta analisi del linguaggio poetico di Sigismondo rivela come in esso non solo confluiscano sostanziosi apporti di altre autorità (Dante, Cecco d’Ascoli, Antonio da Ferrara, e soprattutto Boccaccio, in particolare quello del Filostrato e del Teseida), ma molte formule apparentemente petrarchesche siano state assimilate attraverso il filtro di numerosi intermediari, tra cui il Saviozzo, e in primo luogo Giusto de’ Conti (tra il 1447 e il ’49 stabilitosi a Rimini, come consigliere dello stesso Malatesta). Così, se del Petrarca è l’immagine dell’amore come «aspra guerra» (Rvf 264, v. 111), è dal Conti (69, v. 3) che Sigismondo desume la clausola «aspra mia guerra» (1, v. 2); analogamente, se l’aretino aveva cantato i propri «caldi sospiri» (Rvf 153, v. 1), il nostro autore preferisce i «suspir caldi» di Boccaccio (Teseida, IV 26), oltre che del Malpigli. Proprio dal Boccaccio, si diceva, giungono direttamente numerose espressioni, come ad es. «preghier umìle» (1, v. 11, da Teseida VIII 51); «splendido lume» (7, v. 9, da Filostrato, Proemio 6). E lo stesso Giusto de’ Conti, oltre a farsi mediatore anche di formule già cavalcantiane, come la definizione d’Amore «ardente foco» (1, v. 5, da Cavalcanti 11, v. 2, e Conti 131, v. 3), o già boccacciane, come l’allocuzione «mia donna cara» (7, v. 9; «cara mia donna» in Filostrato, II 102, «donna mia cara» in Giusto, 169, v. 10), rappresentò unica fonte per prelievi come «spechio agli occhi miei» (7, v. 2, da Conti 21, v. 62); «crudel destin» (7, v. 3, da Conti 179, v. 9); «nostri giorni» (7, v. 11, da Conti 6, v. 10). Sigismondo, peraltro, ricorre anche ad immagini di ascendenza proverbiale, più concrete di quelle letterarie. Per incoraggiarsi nel servizio amoroso, ripete a se stesso che «la lima rode el ferro, l’aqua i marmi, / per lo spesso cader da l’alto tecto» (2, vv. 9-10). L’amata gli procura ferite profonde: «Non rose sì giamai el tarlo legno / como fa questa i tristi sensi mei» (4, vv. 9-10); però, grazie alla sua natura di ginepro, «chi ne gusta del suo cibo in verde / ritorna al stanco corpo omne vigore» (16, vv. 7-8). Più di ogni altro aspetto, comunque, la struttura della raccolta (con i suoi 9 sonetti in vita - di cui 2 di lontananza e 2 di tragico presagio - e 7 in morte dell’amata) sembra volersi uniformare ad ogni costo a quella dei Fragmenta petrarcheschi: tanto più che, come sappiamo, l’Isotta storica non fu affatto sottratta dalla morte al suo amante. Proprio come paradossale (e un po’ ridicolo) eccesso di petrarchismo è stato sempre interpretato il mito della morte giovanile del personaggio, fino a quando chi scrive, sulla base dell’intera letteratura isottea (ma soprattutto del Liber Isottaeus e dell’Hesperis di Basinio da Parma, in cui il personaggio di Sigismondo ha comportamenti assolutamente coerenti con l’autoritratto interiore offerto dalle sue rime), ha proposto di leggerlo come geniale accorgimento simbolico, funzionale a una complessa meditazione sul mistero della morte. È del resto ben noto come la morte e la vittoria su di essa fosse il rovello costante di Sigismondo: a parte la macroscopica conferma offerta dall’impostazione sepolcrale del Tempio, non dimenticheremo che egli fu scomunicato come eretico e arso in effigie, come attestò Pio II, «qui resurrectionem mortuorum inficietur, et animas hominum mortales fore testetur, nec de futuro regno quicquam speret (I commentarii, Milano 1984, p. 1448). La raccolta poetica del signore di Rimini non offre che conferme a questa chiave di lettura. Nelle rime in vita di Isotta, egli non assegna alcuna funzione salvifica alla fanciulla: non a caso, egli è uno dei suoi pochi cantori a non chiamarla mai né diva, né divina, né dea; «divina» è al massimo la sua «beltà» (15, v. 3). I «suspir caldi» (1, v. 5) di Sigismondo necessitano dell’amata come di un «cibo», grazie al quale «ritorna al stanco corpo omne vigore» (15, vv. 7-8); mentre egli deve riconoscere che «senza lei io quivi moro» (15, v. 14). Il poeta è molto lucido nell’analizzare questo suo vitale bisogno di Isotta: esso nasce dall’«acerbo male» che lo «strugge e sface» (14, vv. 3-4), consistente in un angoscioso terrore del tempo che fugge: «avria voluto el viver immortale […]. / El tempo avanza più che non vorrei, / né dir se vole: quest’è el mio disio, / ov’ho fermato i stanchi pensier mei» (14, vv. 6, 9-11); sicché la morte non viene a sottrar9 lo da questo stato «sol per colei / che me fé servo al suo bel volto pio» (14, vv. 13-14). In assenza di ogni ricerca interiore alternativa a questo amore totalizzante, il timore della morte di Isotta si manifesta come angoscia per un evento che terrebbe «in pene» i suoi «tristi sensi» (5, v. 8); e il desiderio «del bel volto», già inestinguibile «in questo tempo breve» (vv. 9-10), rende talmente intollerabile il pensiero di un distacco oltremondano («Ahi, quanto adunqua me sarebbe greve / di là staendo, e che ’l me fosse tolto!», 6, vv. 12-13), da indurre il poeta a chiedere agli «alti dei» la «grazia» di poter «madonna rivedere» (6, vv. 5-8), confidando in «Quel che tucto vale» (6, v. 14). Inevitabilmente, quando quella morte temuta si concretizza, l’autore non può altro che precipitare nella più totale disperazione: «D’ogne mio ben io son privato e sciolto […], / misero, lasso, e d’omne spen disciolto» (7, vv. 4, 8); «destin crudel […] / ch’hai facto l’alma al tucto disperata!» (8, v. 8); «da ogni spene è l’alma mia disciolta» (9, v. 8). Di nuovo egli pensa al «Factor che l’universo guida» (9, v. 2), al «divin Motore» (9, v. 11), ma per contestargli di aver solo a lui negato la sua «pietà» e la sua «grazia» (9, vv. 1, 10). In tale condizione d’animo, anche la monumentale sepoltura di Isotta, a cui tanto si era dedicato, gli appare come una crudele prigione: «o mia donna cara / renchiusa fra questi aspri e marmi duri» (7, vv. 9-10); e neppure possono consolarlo le apparizioni in sogno dell’amata, che (rovesciando il motivo petrarchesco) egli disdegna come «dogliosi sogni, o visïon fallace», pronte a presentarsi, col loro carico di dolore, proprio quando egli avrebbe bisogno di riposo: «poi me mostrate quei begli ochi sancti / in un contorno d’or, con lenti passi, / perché ben pianga el caro mio tesoro» (10, vv. 2, 12-14). Perfino il pensiero della nuova condizione celeste di Isotta, pur motivo di un «qualche conforto» (7, v. 14), non produce infine altro che dolente invidia per chi ora la può contemplare: «Piango che ’l sole, stelle e poi la luna / prendono insemi festa del salire / vh’ha facto al ciel madonna» (12, vv. 5-7); sicché al poeta non resta che chiedere morte «ad uno ad uno / passo» (11, vv. 5-6). La bipartizione petrarchesca vale dunque a veicolare un autoritratto spirituale completamente nuovo, al quale proprio e solo l’immaginaria morte di Isotta consente di esprimersi pienamente. Del resto, lo stesso mi- to permetterà viceversa a Basinio da Parma (e ad altri poeti vicini alla corte) di affrontare il tema della morte secondo prospettive diametralmente opposte rispetto a quelle del loro signore e della sua amata, al fine di confortarne le angosce esistenziali: contrapponendo alla loro mancanza di fede, e conseguente tendenza alla disperazione (puntualmente rappresentata nel Liber Isottaeus) tutti gli argomenti di cui disponevano a sostegno dell’immortalità dell’anima (su presupposti in gran parte neoplatonici) e del mito della gloria umana, eternata dalla poesia e dalla maestà del sepolcro. Bibliografia Edizioni. P. Bilancioni, Sonetti riferiti al nome di Sigismondo de’ Malatesti da un codice della Riccardiana, per nozze Fantuzzi-Spina, Ravenna, Tip. G. Angeletti, 1860 A.F. Massèra, I poeti isottèi. Appendice, in «Giornale storico della letteratura italiana», n. XCII (1928), pp. 1-55, a pp. 2-6 (pubblica le due corripondenze poetiche intercorse tra S. P. Malatesta e A. Galli) Isotta bella sola ai nostri giorni. Sonetti di Sigismondo Pandolfo Malatesti, a cura di A. Turchini, per nozze Ciccagnone-Marciano, Rimini, Luisè, 1983 A. Galli, Canzoniere, edizione critica a cura di G. Nonni, Urbino, Accademia Raffaello, 1987 (pubblica a pp. 360-63 le due corripondenze poetiche intercorse tra S. P. Malatesta e A. Galli) Studi. A. Battaglini, Della corte letteraria di Sigismondo Pandolfo Malatesta, in Basini Parmensis poetae Opera praestantiora, 2 voll., Rimini, Typ. Albertiniana, 1794, vol. II, pp. 43-255 A. Campana, Atti, Isotta degli, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 4, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1962, pp. 547-56 (rist. in Le donne di casa Malatesti, cit. sotto, pp. 585-604) La cultura letteraria nelle corti dei Malatesti, a cura di A. Piromalli, Rimini, Ghigi, 2002 (in particolare Id., I sonetti di Sigismondo, pp. 78-84) Le donne di casa Malatesti, a cura di A. Falcioni, Rimini, Ghigi, 2005 A. Falcioni, Malatesta (de Malatestis), Sigismondo Pandolfo, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 68, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2007, pp. 107-14 10 A.F. Massèra, I poeti isottèi, in «Giornale storico della letteratura italiana», n. LVII (1911), pp. 1-32, a pp. 2-15; Id., I poeti isottèi. Appendice, ivi, n. XCII (1928), pp. 1-55, a pp. 1-15 I. Pantani, L’amoroso messer Giusto da Valmontone, Roma, Salerno editrice, 2006 (in particolare il paragrafo IV.3, Implicazioni neoplatoniche dell’ultimo ternario, pp. 150-74). I. Pantani, Da “diva” a “dea”: trasfigurazioni poetiche nella corte malatestiana, in Annuario dell’Accademia d’Ungheria. 2007-2008 / 2008-2009, Roma, Aracne, 2010, pp. 310-25 I. Pantani, Responsa poetae. Corrispondenze poetiche esemplari dal Vannozzo a Della Casa, Roma, Aracne, 2012 (in particolare il cap. V, L’approdo al romanzo epistolare, pp. 133-71) A. Piromalli, La poesia isottea nel Quattrocento, in «Letterature moderne», VI (1956), pp. 519-33 (rist. in La cultura letteraria, cit., pp. 60-84) A. Piromalli, Gli intellettuali presso la corte malatestiana di Rimini, in Id., Società, cultura e letteratura in Emilia e Romagna, Firenze, Olschki, 1980, pp. 923 (rist. in La cultura letteraria, cit., pp. 37-60). Le poesie liriche di Basinio (Isottaeus, Cyris, Carmina varia), a cura di F. Ferri, Torino, Chiantore-Loescher, 1925 E. Rossi, La letteratura isottea nell’editio princeps parigina del 1539. Appunti per un’analisi testuale, in Le donne di casa Malatesti, cit., pp. 605-45) 11 162 ITALO PANTANI che di nostra natura ’l feo tiranno, non mischiava il suo affanno fra le liete dolcezze de l’amoroso gregge. DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO («SATIRE») E DEL TASSO («AMINTA») Che i capolavori poetici del pieno Rinascimento italiano debbano molto della loro fioritura ai fecondi principi elaborati e trasmessi, oltre che dai grandi modelli classici e volgari, dalla ricca esperienza letteraria neolatina del ’400, si può dire acquisizione storiografica tanto solida, ormai, sul piano teorico, quanto ancora lontana da una documentazione adeguata alle dimensioni del fenomeno. In effetti, se non altro per le difficoltà oggettive poste da una simile direzione di ricerca (costretta a muoversi fra una vasta congerie di testi mai censiti e spesso inediti), raramente gli studi dedicati a quei capolavori si sono addentrati, in cerca di riscontri, oltre il repertorio degli autori quattrocenteschi più noti; laddove persino figure quasi dimenticate, come nel caso che qui presento, possono rivelarsi modello diretto di passi tra i più celebrati della nostra letteratura. Per offrire subito la misura di ciò che intendo, difficile immaginare esempio migliore di quello offerto da un frutto tra i più squisiti del Rinascimento estense, il coro dell’atto primo dell’Aminta, e in particolare dal suo mirabile incipit (I, 65661, 669-77): O bella età de l’oro, non già perché di latte sen’ corse il fiume e stillò mele il bosco; non perché i frutti loro dier da l’aratro intatte le terre, e gli angui errar senz’ira o tosco [...]; ma sol perché […] quel che dal volgo insano onor poscia fu detto, Questa rivisitazione del tema dell’età aurea non ha ovviamente mancato di sollecitare indagini sempre più raffinate circa i modelli antichi e moderni che la ispirarono, e i tratti propriamente tassiani che la rendono unica (1). Si è così rilevato che Tasso, nel riprendere un motivo tra i più topici dell’antichità, non si allineò tanto alla profetica versione virgiliana (Buc., IV, 4-30) quanto a quella pervasa di elegiaco rimpianto propria di Ovidio e Tibullo. Dal secondo (II 3, 71-74), in particolare, egli derivò il concetto dell’età dell’oro come giardino di Venere, probabilmente tramite la mediazione di Sannazaro (Arcadia, egloga VI, 103-08), o meglio ancora di Tansillo, primo a incolpare il «desio d’onore» (nella canzone Vedendo il saggio Apollo) dei vincoli venuti a reprimere i liberi amori delle origini (2). Della rappresentazione ovidiana (Met., I, 89-112), invece, Tasso ampiamente riprese i tratti descrittivi più caratterizzanti, pur se proprio al fine di sottolineare, attraverso la loro negazione, il maggior valore da riconoscersi all’aspetto erotico, in essi assente (vv. 101-02, 111-12): Ipsa quoque immunis rastroque intacta nec ullis (1) Qui ricorro soprattutto a D. CHIODO, Il mito dell’età aurea nell’opera tassiana, in «Studi tassiani», XXXV (1987), pp. 31-58, quindi (ampliato) in ID., Torquato Tasso poeta gentile, Bergamo, Centro di studi tassiani, 1998, pp. 43-100; cfr. anche C. SCARPATI, Il nucleo ovidiano dell’«Aminta», in ID., Tasso, i classici e i moderni, Padova, Antenore, 1995, pp. 75-104; e A. CORSARO, Percorsi dell’incredulità. Religione, amore, natura nel primo Tasso, Roma, Salerno, 2003 (in partic. il par. V.3, I due volti del mito aureo, pp. 185-97). (2) I citati passi di TIBULLO («Tum, quibus adspirabat Amor, praebebat aperte / mitis in umbrosa gaudia valle Venus. / Nullus erat custos, nulla exclusura dolentes / ianua; si fas est, mos, precor, ille redi») e di SANNAZARO («I lieti amanti e le fanciulle tenere / givan di prato in prato ramentandosi / il foco e l’arco del figliuol di Venere. / Non era gelosia, ma sollacciandosi / moveano i dolci balli a suon di cetera / e ’n guisa di colombi ognior basciandosi»), oltre che importanti per l’ottica complessiva (da sempre tanto discussa) con cui il tema è affrontato nell’Aminta, più direttamente ne ispirarono i successivi vv. 682-88. Quanto alla canzone di TANSILLO, si tratta della XVI delle Poesie pescatorie e pastorali (ed. in L. TANSILLO, Il canzoniere edito e inedito, intr. e note di E. Pèrcopo, vol. I, Napoli, Tip. degli Artigianelli, 1926; rist. ivi, Liguori, 1996): «O beati coloro / che la felice età vider de l’oro: / ché, nulla procacciando, / vivean contenti […]. / Le rozze menti accese / d’altro foco non eran che d’amore; / non si sentiva né desio d’onore / né timor di vergogna». DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 163 saucia vomeribus per se dabat omnia tellus […]; flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant, flavaque de viridi stillabant ilice mella. Anche il materiale ovidiano, bisogna però ora aggiungere, s’ibridò nei versi dell’Aminta con la recente rielaborazione di un moderno; il quale, oltre a offrire a Tasso in ravvicinata successione i contenuti più utili, soprattutto gli suggerì la via per disporli secondo l’articolazione concettuale (basata sull’avversativa «non perché… ma perché») che finora risultava distinguere dalle sue fonti il testo tassiano. Prima del nome, gioverà riportare subito i versi più pertinenti del moderno in questione: Felices nimium quos aurea pertulit aetas et merito comites tunc habuere deos: non quia de querno sudabant cortice mella, omnia quod per se dona ferebat humus […], quod lac carne foret, quod vino gratior unda, quod fugeret gelidos dura puella mares; sed quia nec fraudes nec opum nec vanus honorum stabat amor, nec Mars sanguinolentus erat, et quia securae ducebant ocia gentes, et passim cunctis vita quieta fuit (3). 164 ITALO PANTANI dello sul piano del lessico: il «fiume di latte», lo «stillare» del miele, le «terre intatte» traducono infatti i «flumina lactis», i mieli che «stillabant», l’«intacta tellus» di Ovidio, non le corrispondenti soluzioni della fonte moderna. Ma al di là di ogni distinzione di messaggio e di formule, la dipendenza del coro tassiano dal brano quattrocentesco appare indiscutibile sul piano dell’articolazione concettuale e sintattica: entrambi i testi strutturandosi sulla negazione che l’età aurea fosse tale per i doni della natura, in quanto ben più determinante per l’originaria felicità del genere umano è giudicata una privilegiata condizione morale, allora (e mai più in seguito) da esso vissuta. Se poi volgiamo direttamente l’attenzione ai versi in esame, noteremo che il loro autore, senza trascurare un nitido omaggio al Virgilio bucolico (IV, 30: «quercus sudabunt roscida mella»), costruì la sua argomentazione guardando sì al nodale passo di Ovidio (di cui in particolare recepì il v. 100: «mollia securae peragebant otia gentes»), ma soprattutto ai versi della Phaedra di Seneca in cui Ippolito ricorda l’età aurea per stigmatizzare la corruzione morale successivamente dilagata tra gli uomini: Già in questi versi, come poi nell’Aminta, ai tradizionali connotati dell’età aurea veniva dunque anteposta, quale più autentica fonte di felicità, l’assenza tra i primi uomini della brama di onore. Certo, si tratta di un onore ritenuto qui responsabile di frodi e di guerre, e non, come canterà il coro tassiano, delle barriere sociali alla libera espressione dell’eros (anche se non andrà trascurato l’accenno al tòpos elegiaco del sano originario rifiuto che le fanciulle opponevano alle profferte dei vecchi). Inoltre, non c’è dubbio che il nostro passo si sovrappose solo parzialmente al testo ovidiano nella memoria di Tasso, che più direttamente guardò all’antico mo- Bersaglio polemico di Ippolito è in effetti, oltre al genere femminile, la depravata vita di città, cui immancabilmente i ver- (3) «Fin troppo felici quanti l’età aurea sostenne, / davvero come compagni ebbero allora gli dei: / non perché trasudavano mieli da corteccia di quercia, / perché la terra da sé produceva ogni dono [...], / perché il latte fosse più gradito della carne, più del vino l’acqua corrente, / perché la fanciulla, dura, fuggisse i gelidi vecchi; / ma perché né frodi né vano amore di beni e di onori / esistevano, né Marte era sanguinario, / e perché le genti passavano il loro libero tempo sicure, / e per tutti, dovunque, la vita era quieta». (4) Vv. 525-28, 537-41, 550. Per l’individuazione delle fonti latine mi sono servito del CD-ROM: BTL. Bibliotheca Teubneriana Latina, a cura di P. Tombeur, Leuven, Teubner-Brepols, 1999 (a cui rinvio per l’indicazione delle edizioni di riferimento). Altre memorie classiche del nostro testo in «pertulit aetas»: STAZIO, Theb., VII, 745; «habuere deos»: OVIDIO, Met., IV, 373, X, 489; «dona ferebat»: OVIDIO, Fasti, II, 545; STAZIO, Achill., I, 820; «gratior unda»: VALERIO FLACCO, V, 104; «dura puella»: PROPERZIO, II 1, 78; TIBULLO, II 6, 28; «stabat amor»: OVIDIO, Ep. ex P., III 3, 13. Hoc equidem reor vixisse ritu prima quos mixtos deis profudit aetas. Nullus his auri fuit caecus cupido […]; sed arva per se feta poscentes nihil pavere gentes; silva nativas opes et opaca dederant antra nativas domos. Rupere foedus impius lucri furor et ira praeceps […]. Invenit artes bellicus Mavors novas (4). DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 165 166 ITALO PANTANI si precedenti contrappongono la serena semplicità della campagna; concetti e immagini che ritroveremo disseminati in vari tratti del nostro testo quattrocentesco, in quanto ben funzionali all’ideale che lo ispira, perfettamente sintetizzato dalla formula (propriamente ciceroniana, ma che in esso vedremo sostanziarsi piuttosto della moralità di Orazio e del Seneca tragico) che conclude anche il brano sopra riportato: la «vita quieta» (5). Come a questo punto intuibile, De vita quieta è esattamente il titolo del poemetto elegiaco cui appartengono i versi citati (443-46, 449-54). Autore ne fu Bartolomeo Paganelli da Prignano (località del modenese), un umanista su cui da poco si va facendo nuova luce, ma capace di conquistarsi un buon prestigio nell’ambiente culturale della Modena di fine ’400, e una consistente visibilità anche in area più generalmente estense: come confermerà, vedremo, l’attenta rivisitazione cui proprio il De vita quieta, molti anni prima dell’incursione tassiana, fu sottoposto anche dall’Ariosto satirico, ma come già può provare la pubblicazione a stampa, tra l’87 e il ’92, di vari scritti del Paganelli, poetici e non (6). Il fatto poi che ad aprire la serie di queste edizioni, nel 1487 a Reggio Emilia, figuri appunto quella del nostro poemetto («Impressum Rhegii per Albertum de Mazalibus, anno Mccc- clxxxvii»), è dato da ritenersi ovviamente decisivo in relazione alla sua fortuna in area estense, sino almeno alla Ferrara del Tasso (7). Simpatica figura di maestro appartato, pago della semplice vita di provincia e dell’affetto dei suoi allievi, il Paganelli fu in effetti capace di legarsi in rapporti di amicizia, oltre che con Battista Guarini (di cui fu allievo) e col conterraneo Gaspare Tribraco (con cui intorno al ’65 intratteneva una corrispondenza in versi) (8), anche con più facoltosi estimatori, disposti a sollecitarne e finanziarne le stampe in questione. Fu così che nel 1487, come detto, apparve il De vita quieta con dedica al cardinale legato di Bologna Prospero Caffarello; nel 1489, su iniziativa del conte di Scandiano Giovanni Boiardo (cugino di Matteo Maria, le cui doti poetiche il Paganelli lodava già in versi dei primissimi anni ’60), furono pubblicati a Modena, presso Domenico Rocociola, gli Elegiarum libri III; nel 1492, presso lo stesso tipografo, videro la luce i tre libri del poemetto (sempre in distici elegiaci) De imperio Cupidinis; nel 1494 infine, un anno dopo la morte del Paganelli, ancora a Modena fu stampato presso Domenico Rocociola, grazie alle cure del suo allievo Giovanni Maria Parente (sacerdote e maestro di scuola), l’Opus grammatices, ossia la raccolta delle sue lezioni di grammatica (9). (5) Che Cicerone fosse più un estimatore teorico che un convinto praticante della «vita quieta», è ben noto; sicché l’espressione torna spesso e positivamente connotata nelle sue opere (Pro Rabirio, 17; Cato maior, 22; Pro Cluentio, 153; De finibus, I, 49; De legibus, II, 11), ma come diritto o legittima condizione altrui, non come valore assoluto, personalmente perseguito. Quanto a Seneca, di cui vedremo passi ben più significativi dedicati (ma con altri termini) al tema, egli adottò di passaggio la formula in Ad Helv. mat., XVIII, 2 («se ad tranquillam quietamque vitam recepit ut tibi vacet»); attribuendone l’ideale a un amico la utilizzò anche MARZIALE, X 92, 1 («Marri, quietae cultor et comes vitae»). (6) Un profilo di questo autore ha dato recentemente G. MONTECCHI, Antichità, natura, artificio e lettura negli scritti dell’umanista Bartolomeo Paganelli da Prignano, in ID., Il libro nel Rinascimento, vol. II, Scrittura immagine testo e contesto, Roma, Viella, 2005, pp. 129-43 (ma già in Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi, a cura di A. Prosperi, vol. II, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 541-54): studio particolarmente attento all’interesse del Paganelli per i lavori meccanici e per la neonata arte tipografica, secondo una prospettiva molto diversa da quella che qui interessa. Oltre che al sempre prezioso G. TIRABOSCHI, Biblioteca modenese, vol. III, Modena, Società Tipografica, 1783 (rist. Forni, Bologna, 1970), pp. 425-31, per altre informazioni (anche bibliografiche), rimando al mio «La fonte d’ogni eloquenzia». Il canzoniere petrarchesco nella cultura poetica del Quattrocento ferrarese, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 321-23, 327-29, 337-39. (7) Del resto, ancor oggi si conservano ben otto copie dell’edizione Mazzali del De vita quieta (in 4°, [16] cc., IGI 7139): due nella Bibl. Comunale di Reggio Emilia, e una ciascuna nelle Bibl. Riccardiana di Firenze, Comunale di Mantova, Braidense di Milano, Correr di Venezia, Casanatense e Alessandrina di Roma. Dell’ultima mi sono servito per questo studio; i versi sopra citati si leggono a c. [11]r. (8) Assai duratura fu l’amicizia col Guarini, al cui giudizio il Paganelli avrebbe sottoposto tanti anni dopo proprio il De vita quieta (accompagnandone l’invio con una propria elegia, la III 9 dell’ed. citata oltre). Sulla corrispondenza col Tribraco cfr. G. VENTURINI, Nota critica intorno alla vita e all’opera dell’umanista Gaspare Tribraco, in «Critica letteraria», III (1975), pp. 740-64, a pp. 744-45; ad essa coevi sono i versi del Paganelli conservati nel ms. Vat. Lat. 8914, cc. 68v-69v. (9) Le quattro stampe sono censite dall’IGI ai nn. 7139, 7136, 7138, 7137. La dedica del De vita quieta si legge a c. [3]r: «Bartholomei Prignani mutinensis, ad reverendissimum patrem ac divum Prosperum Capharellum, romanum asculanum episcopum, Bononiae legatum». Circa la familiarità del Paganelli con i conti di Scandiano, importante la premessa all’edizione delle elegie: «Insignis eques Joannes Boiardus Scandiani Caselgrandisque comes, Bartholomei Prignani familiarissimus, sciens multas elegias ab illo diversis temporibus confectas per libros eius dispersas vagari aut contemptas iacere, tum quod earum legendarum cupidus tum quod amicissimi hominis gloriae studiosus erat, ipsum vatem urgentissime rogavit ut eas colligeret, ex- DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 167 Non sarà sfuggita, ed è aspetto tra i suoi più interessanti, la sostanziale distanza di questa operosa attività dalla città e dalla corte di Ferrara (a parte l’iniziale periodo di studi), a favore del comprensorio formato da Scandiano (sede del cenacolo attivato dai conti Boiardo), e dalle vicine città di Modena (dove il Paganelli insegnò e pubblicò) e Reggio Emilia (dove debuttò editorialmente col De vita quieta); un comprensorio, nonostante la dipendenza dall’amministrazione estense, non privo in questi anni di una vivace e distinta identità culturale: aperta, ad esempio, a più fecondi contatti con l’«umanesimo accademico» della vicina Bologna (10). Di tali caratteri, anche il testo che qui ci interessa è ovviamente partecipe: come dimostra la dedica al cardinale legato di Bologna (per l’appunto), ma anche il ruolo svolto nella sua genesi e nei suoi contenuti da Roma, da dove era giunta al Paganelli l’offerta di un incarico che il nostro autore aveva rifiutato, anteponendo la serenità e le piccole gioie della vita provinciale ai compromessi e agli affanni inscindibili da pur prestigiose prospettive di carriera. Proprio il bisogno interiore di giustificare tale scelta, di fronte in particolare alla perplessità criberet atque ederet» (PAGANELLI, Elegiarum libri cit., c. [1]r). Riguardo ai rapporti con Matteo Maria, cfr. S. CARRAI, La formazione di Boiardo. Modelli e letture di un giovane umanista, in «Rinascimento», XXXVIII (1998), pp. 345-404, a pp. 348, 355, 364. L’Opus grammatices avrebbe anche avuto una ristampa nel 1516, ancora a Modena, presso Antonio Rocociola. (10) Riscontrabile anche sotto il profilo delle dinamiche sociali e istituzionali (cfr. M. FOLIN, Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano, Roma-Bari, Laterza, 20042, pp. 81-111), la relativa autonomia della Modena rinascimentale appare tema ancora tutto da approfondire in ambito culturale, nonostante la mole di notizie erudite disponibili. Per un primo orientamento cfr. comunque A. BIONDI, La cultura a Modena tra Umanesimo e Controriforma, in Storia illustrata di Modena, a cura di P. Golinelli e G. Muzzioli, vol. II, Milano, Nuova editoriale AIEP, 1990, pp. 521-40: contributo in cui attenzione particolare (a pp. 523-31) è riservata proprio al Paganelli, di cui si citano bei versi celebrativi tanto della ricca e colta Ferrara, quanto di Modena e della locale scuola poetica. Ma per suggerire un’idea della specificità modenese, gioverà forse ricordare che negli anni del governatorato di Ercole d’Este (1463-71) la piccola corte di quest’ultimo fu preferita a quella ferrarese da letterati come il Tribraco, Gian Mario Filelfo, e soprattutto Boiardo: il quale, dopo un quinquennio di studio giovanile a Scandiano (1451-56), per altri quindici anni, prima di seguire nel 1471 (ormai trentenne) Ercole a Ferrara, operò esclusivamente tra Modena, dove nel 1463-64 dedicò allo stesso Ercole le sue prime raccolte poetiche (latine), e la Reggio Emilia dell’altro governatore Sigismondo d’Este, alla cui corte ambientò la vicenda degli Amorum libri (1469-71: cfr. ancora CARRAI, La formazione cit., pp. 373-83). 168 ITALO PANTANI dei suoi amici, indusse il Paganelli alla stesura dei 714 versi del poemetto; il quale, se non altri, di certo convinse il legato pontificio che ne fu dedicatario, e che non solo si fece verosimile promotore dell’edizione, ma è presumibile ne abbia anche ispirato la prefazione in prosa (ampiamente elogiativa tanto della scelta quanto del componimento del Paganelli), redatta dal suo segretario, Panfilo Morato: Suavissimus vates Bartholomeus Prignanus, homo a natura quietus et certo animi iudicio in patria quietae vitae deditus litterarumque et praecipue musarum studiosissimus, cum propter egregias et animi et corporis dotes Romanae curiae aptissimus iudicatus saepe illuc cum magnis promissionibus a plurimis amicis et quidem magnis viris vocatus fuisset, et ipse, iam omnes eas conditiones contemnens, pulcherrimam libertatem pro turpissima servitute mutuari noluisset, et iam a multis ob eam rem ludibrio haberetur, hocque sanctum animi sui propositum non rationi sed ignaviae tribueretur, et propter ea pusillanimis ignavusque a suis censeretur, hanc tantam ac tam indignam ignominiae notam diutius non tolerare constituit, hocque opusculum ad stultas eorum opiniones reprimendas confecit: in quo non solum factum suum excusat et stulta hominum desideria improbat, sed vitam quietam in genere, et eam quam ipse nunc agit, famulorum ac dominorum curialium avarae et ambitiosae vitae longe praeponendam esse ostendit […]. Quicunque igitur hunc libellum leget, et diligenter considerabit, eum ipsum et utilissimum et priscis poetis elegantia non multo cedentem inveniet. Legant itaque illum ingenui iuvenes et poetae et philosophi omnes, et illum ante oculos semper habeant curiales; legamus, inquam, illum legamus, et vitam quietam tenentes anxias curas et perpetuas sollicitudines indoctis homnibus relinquamus (11). Concepito sullo sprone di una forte istanza argomentativa da un maestro di retorica, il poemetto si snoda ovviamente lungo una trama più che attenta ai dettami di questa. I vv. 1-92 compongono il PROEMIUM, che il poeta apre rivolgendosi a quanti hanno criticato la sua scelta di rifiutare l’invito a Roma, col proposito di dimostrare il loro torto; a tal fine, sin dal v. 7 si sviluppa una introduttiva argumentatio, basata su quattro punti: solo uno stato di necessità (che l’autore non sta vivendo) giustificherebbe i disagi dell’emigrazione e della sottomissione a un potente; inoltre, le mense dei re sono per gli ambiziosi, mentre il poeta, legato alla terra dei padri, preferisce la semplicità della propria casa al lusso di quella altrui; egli gode del resto dell’affetto di chi gli è vicino, laddove i potenti sono serviti per paura, e quindi costantemente in guardia contro l’odio altrui; tanto più che, come è noto, (11) PAGANELLI, De vita quieta cit., c. [2]r-v. Il testo riportato è un ampio stralcio della premessa firmata «Pamphilus Moratus, reverendissimi S. Mariae in Porticu cardinalis secretarius». DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 169 la Fortuna colpisce chi è più in alto. Segue, ai vv. 93-108, la PROPOSITIO: il poeta intende dimostrare agli amici che sbagliano, commiserando la sua scelta; e rivolgendosi direttamente al cardinale Caffarello, lo invita a distogliere l’attenzione dalla confusione in cui vive. Viene quindi l’INVOCATIO, alla Musa (vv. 109-110). A questa succede la NARRATIO (vv. 111-418): mosso non da odio della stoltezza ma da amore del bene, il poeta ci introduce a una sua tipica giornata, trascorsa in compagnia di giovani che gli sono amici, oltre che allievi; la brigata si riunisce in scenari campestri, allietandosi con letture (a tema storico, mitologico, geografico e astronomico, oggetto di ampie digressioni) e con l’osservazione della natura, per poi spostarsi in casa del maestro, dove ancora si immerge nel piacere di comunicarsi le letture più interessanti, ma anche condivide pasti frugali, nel servizio reciproco. Segue una prima PERORATIO (vv. 419-506): dalla lode della semplice frugalità consegue la polemica contro la stolta avidità degli uomini, e in particolare quella che affligge Roma e la Chiesa; l’invocazione a Giano perché ponga riparo alla decadenza morale dell’urbe è preceduta da una rievocazione dell’età dell’oro, tale non perché nei fiumi scorresse latte e miele, ma perché l’umanità non conosceva ancora il desiderio di ricchezze e di onori. Quindi, con una seconda NARRATIO (vv. 507-654), il poeta torna a contrapporre a questi disvalori i sani principi che ispirano la sua vita: i suoi cibi li acquista dai contadini (di cui descrive, in una nuova digressione, le tecniche di coltivazione), le sue serate le passa sempre nella lieta compagnia degli allievi, che di nuovo condividono con lui il piacere della lettura, ma anche lo seguono in passeggiate notturne animate dal canto di testi poetici. Ci si avvicina quindi all’epilogo con una nuova ARGUMENTATIO (vv. 655-698): nulla può superare questa felicità, fatta di gioie semplici; il poeta, del resto, non vive nel deserto libico, ma nella deliziosa regione di Modena, e solo un uomo insaziabilmente avido non saprebbe contentarsene. Di qui la PERORATIO conclusiva (vv. 699-714): rivolgendosi al cortigiano disposto, per ambizione, a sopportare ogni disagio, il poeta lo invita a ricredersi, a riconoscere la propria condizione di servitù affannosa; quanto a lui, non desidera altro che conservare la sua vita quieta. Ora, è evidente che un contenuto di questo tipo, con la sua impostazione moraleggiante, l’elogio delle gioie semplici, la polemica anticortigiana e anticlientelare, la forte «autoidentificazione dello speaker con la personalità storico-empirica del poeta», la sua propensione a nominare «sostanze e individui che appartengono al circolo dell’esperienza quotidiana», molto condivide (nonostante le ampie digressioni erudite e l’intonazione sempre seria e didascalica della voce poetante, mai autoironica nelle sue certezze, anzi del tutto priva di «sali» e spunti comici) con la tradizione della satira: una tradizione in fase d’iniziale rilancio negli ultimi decenni del ’400, in campo sia latino che volgare, grazie anche a un si- 170 ITALO PANTANI gnificativo contributo di letterati d’area estense (12). La satira sferzante d’ascendenza giovenaliana, che la traduzione del Sommariva acquisiva allora al volgare, aveva infatti da poco ritrovato un cultore latino proprio in un modenese, Gaspare Tribraco, autore tra il 1459 e il ’69 dei nove componimenti del suo Satirarum liber (13); d’altra parte, mentre numerose seppur generiche adesioni all’aurea mediocritas oraziana si andavano diffondendo tra le rime della lirica cortigiana di fine secolo (quelle di un Tebaldeo, di un Sasso, di un Niccolò da Correggio), l’obiettivo di far compiutamente rivivere il genere satirico nell’affabile e disincantata interpretazione di Orazio veniva assunto dal più grande poeta latino del ’400 estense, Tito Vespasiano Strozzi, autore tra gli ultimi anni del secolo e i primi del successivo di quattro Sermones (14). Di fronte a tali prove, la scelta del Paganelli di affidare il proprio ideale esistenziale al metro comunissimo (soprattutto a Ferrara) dell’elegia e dell’epigramma, e ad una struttura vicina (per dimensioni, articolazione e abbondanza di digressioni erudite) a quella del poemetto didascalico, è indubbio segno di retroguardia sul piano prettamente umanistico della distin(12) Le considerazioni citate sono di P. FLORIANI, La satira nel quadro del classicismo primocinquecentesco, in ID., Il modello ariostesco. La satira classicistica nel Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1988, pp. 9-27, a pp. 18 e 21. Sui caratteri qui sintetizzati cfr. anche G.M. STELLA GALBIATI, Per una teoria della satira fra Quattro e Cinquecento, in «Italianistica», XVI (1987), pp. 9-37: alle pp. 24-25 è il rilievo della «fisionomia dialettica e anche contraddittoria» propria del «personaggio creato da Orazio» (e invece assente nel Paganelli), sulla quale «si fonda il carattere della satira come ricerca morale e dibattito, non come requisitoria o attacco che muova da certezze». Come poi tale carattere della satira evolvesse nell’Ariosto in una complessa dialettica di ragione e follia, è stato illustrato da G. FERRONI, L’Ariosto e la concezione umanistica della follia, in Convegno internazionale Ludovico Ariosto, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei (Atti dei convegni Lincei, 6), 1975, pp. 73-92. (13) Le satire del Tribraco, un pioniere del genere dopo Francesco Filelfo, si leggono oggi in G. TRIBRACO, Satirarum liber dedicato al duca Borso d’Este, a cura di G. Venturini, «Deputazione provinciale ferrarese di storia patria», Atti e memorie, s. III, XIV (1972), pp. 3-117 (la datazione a pp. 9-10). (14) Accenni diversi, come quello elogiativo a Cesare Borgia (I, 121), datano a partire dagli ultimi anni ’90 i Sermones strozziani, per i quali bisogna ancora ricorrere all’edizione Strozii poetae pater et filius, Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Asolano, 1513, cc. 132r-[142]v (rist. Parigi, Simone Colinei, 1530, cc. 237r-245r). Su entrambi i versanti (volgare e latino) del recupero quattro-cinquecentesco della satira classica, e sulla modesta incidenza di questi precedenti nell’opera dell’Ariosto, cfr. ancora P. FLORIANI, Problematica “morale” e satira prima dell’Ariosto, e Il modello ariostesco, entrambi in ID., Il modello ariostesco cit. (alle pp., rispettivamente, 29-61 e 6393). DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 171 zione dei generi; eppure, molto prima di tornare utile al Tasso, proprio al suo scritto riuscì in più punti, come non accadde a quei più consapevoli esperimenti, d’interporsi anche tra i classici modelli antichi e il più efficace interprete italiano del genere, l’Ariosto delle Satire. Del resto, prima ancora di passare in rassegna i vistosi e fitti riscontri testuali tra le due opere, la stessa trama (se non addirittura il titolo) del De vita quieta rivela i principali aspetti che, per affinità anche casuali tra le storie personali dei due autori, dovettero attirare sul nostro poemetto l’attenzione dell’Ariosto. Il quale, innanzitutto, non poté non restare colpito dall’indole stanziale esibita dal Paganelli, anzi dal legame propriamente d’amore che lo univa alla sua Modena; anche perché, se un analogo rapporto di affetto l’Ariosto si sarebbe costantemente attribuito nei confronti di Ferrara, uno simile egli anche professava nei riguardi della stessa terra già tanto cara al Paganelli: terra che aveva visto nascere e crescere lo stesso Ludovico, nella confinante Reggio Emilia, e in cui egli facilmente poté imbattersi, nei suoi frequenti soggiorni, in una copia del De vita quieta (15). D’altra parte, un’affinità non meno singolare col maestro modenese l’Ariosto dovette riconoscere nel ruolo fondamentale da quello assegnato al tema di Roma e delle sue illusorie seduzioni: seduzioni che, se rappresentarono il primo movente della stesura del De vita quieta, ritornano anche come tentazione frequente (ugualmente respinta, ma in termini assai meno drastici) lungo l’intera raccolta delle Satire: specificamente, nella seconda, nella terza e nella settima (16). Poco conta allora che le espressioni ariostesche più dure contro le amarezze legate alla condizione di cortigiano riguardino invece, inevitabilmente, il rapporto con i signori d’Este; entrambi gli autori, di fatto, a una sottomissione umiliante contrapposero la dignitosa accettazione di uno stile di (15) Accanto alle tante ammissioni della propria inseparabilità da Ferrara (disseminate almeno dalla satira III, vv. 55-81, alla VII, 148-65), un ricordo idilliaco della natia terra reggiana l’Ariosto affidò ai vv. 115-135 della IV (basti qui ricordarne i primi: «Già mi fur dolci inviti a empir le carte / li luoghi ameni di che il nostro Reggio, / il natio nido mio, n’ha la sua parte»). (16) Sul tema è recentemente tornato A. ROMANO, La “memoria” di Roma nelle Satire, in Fra satire e rime ariostesche, a cura di C. Berra, Milano, Cisalpino, 2000, pp. 83-119. 172 ITALO PANTANI vita modesto, appartato, e qualificato da studi onorevoli benché non redditizi: anche se tale accettazione appare esibita e rassegnata in Ariosto (piuttosto che convinta), piena invece e sicura nel Paganelli. Il quale, nel perorare la scelta di vita compiuta, approdò d’altra parte a una sintesi non ancora comune (e dunque ulteriore motivo d’interesse per l’analoga operazione ariostesca) di modi e temi derivati dalle due divergenti tradizioni satiriche: in particolare, da una parte la difesa delle gioie semplici di contro alle illusioni degli ambiziosi, sostenuta nella rappresentazione di uno scambio di opinioni con amici e censori, conformemente alla lezione oraziana (dal Paganelli rivissuta peraltro attraverso il filtro della più risentita moralità senecana); e dall’altra la polemica contro le condizioni di vita di cortigiani e clienti, di derivazione invece lucianea e giovenaliana (17). Di tale incrocio di tradizioni l’Ariosto avrebbe fatto tesoro soprattutto nelle sue prime tre Satire: applicandolo limitatamente nella prima, dove il motivo anticortigiano prevale di gran lunga sulla lode dell’aurea mediocritas, e nella seconda, per la quale si può dire l’opposto, e facendone invece un tratto portante della terza, che non a caso mostra lungo tutto il suo ordito le memorie più frequenti del paganelliano De vita quieta (18). Anche in questo caso, per subito evidenziare la portata di questi ricordi, gioverà prendere direttamente le mosse dal ce- (17) Sui tratti qui ricordati della satira d’impianto oraziano, cfr. FLORIANI, La satira cit., p. 19. Rispetto a tale modello, più da lontano il modenese guardò a Giovenale per i propri passaggi anticortigiani, anche se pur minuti riscontri testuali (registrati più avanti) ne confermano il ruolo di modello operante. D’altra parte la tradizione anticortigiana si era arricchita in età medievale e umanistica di numerose altre voci, tutte altrettanto sollecitanti per il Paganelli: per un esemplare riscontro, cfr. R. GIGLIUCCI, «Qualis coena tamen!». Il topos anticortigiano del ‘tinello’, in «Lettere italiane», L (1998), pp. 587-605. (18) Per un orientamento (anche bibliografico) sull’eredità oraziana in Ariosto, cfr. R. ALHAIQUE PETTINELLI, Ariosto, Ludovico, in Orazio. Enciclopedia Oraziana, vol. III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 95-100. Sull’incidenza invece del modello satirico di Giovenale nella satira rinascimentale cfr. S. CITRONI MARCHETTI, «Quid Romae faciam? Mentiri nescio…». Il motivo giovenaliano del rifiuto delle arti indegne nella tradizione della satira regolare italiana e francese, in «Rivista di letterature moderne e comparate», 33 (1980), pp. 85-121: a pp. 92-103 le considerazioni sull’Ariosto, nel quale l’esempio di Giovenale sembra soprattutto agire nell’«incrinatura» fra la «realtà della vita cortigiana» e la persistente «illusione oraziana di un mecenatismo che permetta al poeta di seguire la sua vocazione e di conservare insieme la propria libertà» (pp. 85 e 97). DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 173 lebre passo in cui ai servili lussi cortigiani l’Ariosto contrappone la frugalità di rape condite con l’aroma della libertà (Satire, III, 40-47): Chi brama onor di sprone o di capello, serva re, duca, cardinale o papa; io no, che poco curo questo e quello. In casa mia mi sa meglio una rapa ch’io cuoca, e cotta s’un stecco me inforco e mondo, e spargo poi di acetto e sapa, che all’altrui mensa tordo, starna o porco selvaggio. Com’è registrato in tutti i commenti, il piacere ariostesco di una semplice pietanza gustata in casa propria ha il suo classico fondamento in Orazio: il quale però descrive il proprio cibo come fatto di ‘porri, ceci e frittelle’ («inde domun me / porri et ciceris refero laganique catinum»: Serm., I 6, 114-15), e non lo contrappone ai pasti grassi e servili dei cortigiani, ma ne dà cenno in una rappresentazione più generalmente moraleggiante della propria vita, semplice ma serena in quanto immune dagli assilli che tormentano gli ambiziosi e i potenti. Il ricorso all’immagine di quegli alimenti frugali in polemica antitesi con le mense di corte è stato dunque interpretato finora come innovazione dell’Ariosto; attento anche a dedurre l’uso in rima della «rapa», eletta a pietanza emblematica di vita libera e sobria, dalla lettura di un rimatore burlesco d’area estense, Antonio Cammelli, anch’egli presente a Reggio Emilia negli ultimi anni del ’400 («’l mi trattò da papa. / Il trasse for da le bragie una rapa […]. / E come el n’ebbe una scudella piena / tolse oleo, tolse aceto, sale e sapa») (19). Tale mosaico intertestuale appare tuttavia completamente da ricostruire di fronte al reimpiego in funzione anticortigiana dei materiali oraziani, e in termini che anticipano quelli ariosteschi assai più da vicino rispetto alla comune fonte classica, riscontrabile nel De vita quieta: (19) Mi servo qui del più recente commento alle Satire ariostesche, quello a cura di A. D’Orto, Parma, Fondazione Pietro Bembo - Guanda, 2002, p. 75 (nel quale si fa ovviamente tesoro dei precedenti, a partire da quello di C. Segre, Torino, Einaudi, 1987); per la fonte citata, cfr. I sonetti di Antonio Cammelli secondo l’autografo ambrosiano, a cura di E. Pèrcopo, Napoli, Jovene, 1908 (31, 1-6). 174 ITALO PANTANI Observent alii mensas et limina regum, quos spes atque fides semper inanis alat […]; dumque aliis epulas suspectum porrigit aurum, det mihi securas terrea testa dapes. Me magis oblectant in laeta et paupere lance lachana, quam tristi sumina cocta foco (20). Entro un quadro ideologico sostanzialmente conforme, il nostro quattrocentesco poemetto già contrapponeva un povero ma sereno (perché libero) pasto vegetale (lachana), gustato su rustiche stoviglie, alle carni di maiale (sumina) servite nel lusso ma cotte a un fuoco triste (perché altrui). Del resto, pur se parecchio più avanti, in esso s’incontrava anche la «rapa», nell’identica funzione emblematica che l’Ariosto tornerà ad assegnarle: surgat Fabricius, Curius, Cato, Brutus et omnes qui rapam et mensis pultem habuere suis (21). Né va trascurato che a un tale disegno il Paganelli era giunto attingendo da Orazio, essenzialmente, l’affermazione del proprio personale consumo (ben oltre dunque la lode generica) di un pasto parimenti frugale. Per poi contrapporre la propria scelta a quella di quanti si contendevano le mense dei re, egli aveva però imbandito queste ultime con ingredienti tratti da Marziale («tristi foco»: XI 56, 4) e Apicio («sumina cocta»: IV, 2), ed era ricorso a un verso delle Georgiche in cui alla pacifica serenità contadina faceva contrasto la violenza dei soldati (II, 503-04: «alii […] penetrant aulas et limina regum»); infine, per esaltare la sicurezza della sua povera mensa contro il pericolo di veleno sempre incombente sulle tavo(20) PAGANELLI, De vita quieta cit., c. [3]v, vv. 39-40, 45-48 («Altri onorino le mense e le soglie dei re, / quelli che sempre sostiene la speranza e una fede vana […]; / e mentre ad altri oro sospetto porge vivande, / a me cibi sicuri dia un vaso di terracotta. / Più mi deliziano ortaggi in un lieto e povero piatto, / che poppe di scrofa cotte ad un fuoco penoso»). Si noti che, riprendendo l’antico modello, il modenese segue la lezione «lachana» (‘ortaggi’, grecismo: cfr. A. FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis, vol. III, Padova, Gregoriana, 1965, p. 13): dai moderni editori respinta a favore di «lagana» (‘frittelle’), ma qui in grado di riassumere i «porri et cicera» di Orazio, e di svolgere una funzione analoga a quella che avrà la «rapa» ariostesca. (21) PAGANELLI, De vita quieta cit., c. [11]v, vv. 495-96 («Si alzi Fabrizio, Curio Dentato, Catone, Bruto, e tutti / coloro che rapa e polenta ebbero sulle loro mense»). DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 175 le dei potenti, si era rivolto ancora al Seneca tragico, quello della Phaedra (517-19: «regios luxus procul / est impetus fugisse: sollicito bibunt / auro superbi»), ma soprattutto del Thyestes (449-53): O quantum bonum est obstare nulli, capere securas dapes humi iacentem! Scelera non intrant casas, tutusque mensa capitur angusta cibus; venenum in auro bibitur (22). Dall’incastro di tessere così varie nacque un quadro di virtuosa vita frugale, contrapposta alla vana avidità dei cortigiani, la cui conformità con quello ariostesco non si può certo giudicare casuale. Che poi in effetti non lo sia, bastano già a confermarlo le ulteriori memorie del De vita quieta riscontrabili nei versi immediatamente successivi (49-51, 55-57) della satira terza: E più mi piace di posar le poltre membra, che di vantarle che alli Sciti sien state, agli Indi, alli Etiopi, et oltre […]. Chi vuole andare a torno, a torno vada: vegga Inghelterra, Ongheria, Francia e Spagna; a me piace abitar la mia contrada. Questo celebre rifiuto ariostesco del viaggio in nome di un ideale di vita sedentaria, pur nutrito di spirito oraziano, non aveva finora rivelato, a mia notizia, precedenti diretti (23). In realtà, il motivo era stato toccato dal solito Seneca, questa volta nel primo coro dell’Hercules furens (vv. 192-94, 196-201): Alium multis gloria terris tradat et omnes fama per urbes garrula laudet […]: me mea tellus lare secreto tutoque tegat. Venit ad pigros cana senectus, (22) Altre memorie classiche in 40 «spes … fides»: ORAZIO, Carm., I 35, 21; «semper inanis»: LUCREZIO, II, 122; 47 «magis oblectant»: GIOVENALE, XIV, 265. (23) Se si eccettuano le affinità con passi del Boiardo e del Mambriano riscontrate da A. D’ORTO, Criteri e tecniche di imitazione nelle Satire dell’Ariosto, in «Critica letteraria», XXIX (2001), pp. 419-33, a pp. 424-32 (e cfr. ARIOSTO, Satire cit., p. 76). 176 ITALO PANTANI humilique loco sed certa sedet sordida parvae fortuna domus. Ma più del modello antico, anche in tal caso nelle Satire agì il ricordo della rielaborazione che di quello aveva prodotto il Paganelli; il quale, servendosi anche di un metaforico spunto di Stazio («illo alii rursus iactantur in alto / et tua securos portus placidamque quietem / intravit non quassa ratis»: Silvae, II 2, 139-41), aveva contrapposto alla propria consapevole indole pigra e stanziale non già, come Seneca, il dinamismo della fama, ma proprio quello, che tornerà nell’Ariosto, di quanti cercano fortuna nei viaggi: Terra paterna meos videat canescere crines, et tenui et tuto me tegat illa lare […]; dumque alii pelago curis iactantur et undis, caelica cum vento regna vel imbre tonant, me iuvat in tecto molles perducere somnos, cum nullus postis nulla fenestra patet (24). L’Ariosto poi, com’è noto, intendeva sopperire alla sedentarietà con la fantasia e le carte geografiche (Satire, III, 61-66): Questo mi basta; il resto de la terra, senza mai pagar l’oste, andrò cercando con Ptolomeo, sia il mondo in pace o in guerra; e tutto il mar, senza far voti quando lampeggi il ciel, sicuro in su le carte verrò, più che sui legni, volteggiando. Analogamente il Paganelli, dopo un lungo percorso illustrativo dei più remoti luoghi del pianeta, conclude entusiasta: Mira loquar: totum mea cartula concipit orbem, et tamen est nullus discere cuncta labor (25). (24) PAGANELLI, De vita quieta cit., cc. [3]v-[4]r, vv. 43-44, 51-54 («La terra paterna veda i miei capelli ingrigire, / e con una casa semplice e sicura mi ripari […]; / e mentre altri, in mare, sono travagliati da onde ed affanni, / quando per vento o per pioggia tuonano i regni celesti, / a me piace in casa protrarre placidi sonni, / mentre nessuna porta né finestra sta aperta»; evidenzio in corsivo le corrispondenze col testo ariostesco, non quelle con i versi di Seneca). Altre memorie classiche in 43 «terra paterna»: OVIDIO, Ars am., II, 26; Her., X, 64, XIII, 100; 51: CLAUDIANO, Pan. Hon. Aug., XXVIII, 138 («pelagi vento iactatur et unda»); 53 «molles somnos»: OVIDIO, Met., I, 685; «ducere somnos»: VIRGILIO, Aen., IV, 560; ORAZIO, Ep., I 2, 31. (25) PAGANELLI, De vita quieta cit., c. [7]r, vv. 243-44 («Dirò l’incredibile: il mio DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 177 La fama di questi versi ariosteschi, e l’evidenza del contributo paganelliano alla loro genesi, rappresentavano buone ragioni per avviare da essi la nostra ricognizione. Tuttavia, l’incidenza del De vita quieta come modello della terza e (più episodicamente) della prima e della seconda satira emergerà ancor meglio da un’ordinata rassegna dei passaggi del poemetto capaci di lasciare le tracce più evidenti nella fantasia dell’Ariosto. Si noterà subito, allora, come la contrapposizione cara a quest’ultimo tra l’altrui aspirazione alla vita di corte e il proprio disinteresse verso i presunti benefici di quella, e il conseguente difficile rapporto con un uditorio incapace di comprendere tale scelta, avesse un precedente nei versi con cui il Paganelli apre il suo testo: Quisquis divitias nimiumque affectat honores, et regum mensas pontificumque colit, quisquis Romuleam mordax me invitat ad urbem, accusans vitae facta quieta meae, haec legat, et curas hominum cognoscat inanes, iudicet et partes iustior ille meas (26). Equivalente è la condizione dell’Ariosto, al di là del diversissimo registro linguistico, e della solitudine in cui egli mostra di dover vivere le sue scelte (laddove il Paganelli non cesserà di sottolineare, lungo tutto il poemetto, la complicità affettuosa degli allievi): sia nella prima satira, dove egli chiede al fratello Alessandro «se più il signor lo accusa» (v. 4) per la sua rinuncia a seguirlo, e se gli altri cortigiani cooperano a «blasmarlo oltra ragione» (v. 9); sia nella terza, dove, ancora in termini simili a quelli di due versi paganelliani già citati libretto raccoglie il mondo intero, / e tuttavia di nessuna fatica è apprendere tutto»). Memorie classiche in 243 «mira loquar»: OVIDIO, Met. VII, 549; «concipit orbem»: OVIDIO, Met., VII, 22. Interessante, ma difficilmente interpretabile come modello per l’Ariosto, l’analoga disposizione riscontrata nei Colloquia erasmiani, sulla quale cfr. ancora ARIOSTO, Satire cit., p. 79. (26) PAGANELLI, De vita quieta cit., c. [3]r, vv. 1-6 («Chiunque aspira in eccesso a ricchezze ed onori, / e frequenta le mense dei papi e dei re, / chiunque, tagliente, mi invita alla città di Romolo, / biasimando i quieti atti della mia vita, / legga questi versi, e riconosca vani gli umani affanni, / e giudichi con più equilibrio le mie scelte»). Il v. 5 deriva da uno spunto di Persio (I, 1-2: «O curas hominum! O quantum est in rebus inane! / quis legat hoc?»); al v. 3, il sintagma «Romuleam urbem» da OVIDIO, Met., XV, 625; Fasti, V, 260. 178 ITALO PANTANI («Observent alii mensas et limina regum, / quos spes atque fides semper inanis alat», 39-40), scrive al cugino Annibale Malaguzzi (vv. 28-31): So ben che dal parer dei più mi tolgo, che ’l stare in corte stimano grandezza, ch’io pel contrario a servitù rivolgo. Stiaci volentier dunque chi la apprezza. L’urgenza polemica, d’altra parte, contribuì a che entrambi i poeti si soffermassero a lungo sulle più umilianti incombenze della cortigianìa. Per il Paganelli, queste s’identificano nell’abbandono della patria, nella durezza e superbia dei potenti, nei loro richiami e minacce; così egli (sempre nei versi iniziali) le presenta, accompagnandole col proprio rifiuto: Si ceu Pausaniam stultae me gloria famae aut raperent avidi ditia vota Midae, externos possem patriae praeferre penates atque aulas pavido sollicitare gradu, difficiles perferre aditus frontemque superbam, servare et duras, sorte iubente, fores; et possem domini convicia ferre minasque arentemque sitim tristificamque famem […]: Fortuna ferrem duros cogente labores, expectans operis praemia tarda mei. At cum nec mala sors, nec opum vesana cupido, nec mea fucatus pectora tangat honos, praedia iam Licini caedant aedesque Luculli et regum lautae pontificumque dapes (27). Neanche a dirlo, è ancora in Seneca che il modenese trova sostegno al suo dettato: sia che s’impegni a descrivere lo stato dell’esule («te profugum solo / patrio penates regis externi tegunt», Phoenissae, 502-03), sia, soprattutto, che intenda caratterizzare la condizione del cortigiano: «ille superbos adi(27) PAGANELLI, De vita quieta cit., c. [3]r-v, vv. 11-18, 21-26 («Se mi rapisse la smania d’una stolta fama, come Pausania, / o le brame di ricchezza dell’avido Mida, / potrei preferire alla patria Penati stranieri / e assillare le corti con pavido passo, / subire udienze sdegnose e una fronte superba, / e a dure porte badare, se lo stabilisse la sorte; / e potrei sopportare richiami e minacce del signore, / e l’arida sete e la fame terribile […]: / dalla Fortuna costretto, sosterrei dure fatiche, / aspettando premi tardivi al mio lavoro. / Ma poiché né una sorte maligna, né un’insana avidità di beni, / né l’onore affettato tocca il mio petto, / vadano in malora i terreni e le case di Licinio Lucullo, / e i ricchi banchetti di re e di papi»). DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 179 tus regum / durasque fores expers somni / colit» (Hercules furens, 164-66): anche se i «difficiles aditus» del signore richiamano quelli che Orazio attribuisce a Mecenate (ma non nei suoi confronti) in Serm., I 9, 56 (28). Quanto all’Ariosto, tutti ricordano la lunga sequela di squallidi incarichi sciorinata nella prima satira (vv. 100-14, 142-56), tra i quali, emblematici: «a chi nel Barco e in villa il segue, dona, / a chi lo veste e spoglia […], / vegghi la notte» (100-103). Un elenco umiliante, nelle cui conclusioni (vv. 15760, 238-46) è dato ritrovare l’essenziale del precedente quattrocentesco, compreso (al v. 160, in rima) il vocabolo che gli dà il titolo e ne sintetizza il messaggio: Se far cotai servigi e raro tòrse di sua presenza de’ chi d’oro ha sete, e stargli come Artofilace all’Orse, più tosto che arricchir, voglio quïete […]. Se avermi dato onde ogni quattro mesi ho venticinque scudi, né sì fermi che molte volte non mi sien contesi, mi debbe incatenar, schiavo tenermi, ubligarmi ch’io sudi e tremi senza rispetto alcun, ch’io moia e ch’io me ’nfermi, non gli lasciate aver questa credenza; ditegli che più tosto ch’esser servo torrò la povertade in pazïenza. Non inganni l’apparente genericità di questi ultimi riscontri (impressione cui può contribuire la larga diffusione dei temi coinvolti). Alla luce delle inequivocabili corrispondenze testuali prima illustrate, particolarmente evidenti quando i (28) Altre memorie classiche in 11 «gloria famae»: MARZIALE, XVII, 1; 13: VALEFLACCO, V, 510 («ad patrios ea ferre penates»); 14 «pavido gradu»: SILIO ITALICO, X, 17-18; OVIDIO, Rem. am., 120; 15 «frontemque superbam»: CLAUDIANO, De cons. Stil., XXIV 3, 218; 16 «servare fores»: OVIDIO, Am., I 9, 8; «duras fores»: TIBULLO, I 1, 56; OVIDIO, Am., II 1, 22; «sorte iubente»: OVIDIO, Met., XIII, 242 («nec me sors ire iubebat»); 17 «dominae minas»: PROPERZIO, II 25, 17-18; OVIDIO, Her., IX, 74; 21: VIRGILIO, Aen., VI, 437 («duros perferre labores»); «Fortuna cogente»: VAL. MAX., IV 7, 6; 22 «operis mei»: SENECA, Thyestes, 906; «premia tarda»: CLAUDIANO, De cons. Stil., XXII 2, 222; 23 «mala sors»: OVIDIO, Met., XIII, 485; «opum cupido»: OVIDIO, Fasti, I, 211; 24: AUSONIO, Comm. prof. Burd., XXII, 17 («fucatus honore»); OVIDIO, Met., IV, 539 («pectora tangit»); VIRGILIO, Aen., XII, 57 («tangit honos»); 25: VARRONE, Res rust., III 5, 8 («aedificia Luculli»); 26 «regum dapes»: VIRGILIO, Georg., IV, 133-34; «lautae dapes»: MARZIALE, Apoph. (Ep., XIV) 90, 2. RIO 180 ITALO PANTANI due autori si volgono ad opporre la propria vita semplice ma serena a quella dei frequentatori di mense altrui (Paganelli, De vita quieta, 39-56; Ariosto, Satire, III, 28-66), le analogie appena segnalate meritano di essere riconosciute come ulteriori indizi della metodica rilettura cui l’Ariosto sottopose il nostro poemetto: rilettura (condotta magari, secondo i suoi usi, per «“micro-traduzioni” di particole lessicali e sintattiche», e talvolta magari anche in chiave parodica) (29) di cui è del resto agevole trovare ancora conferme in successivi passaggi dei rispettivi scritti. Veniamo ad esempio al comune tema di Roma, già sopra accennato. Per il Paganelli esso rappresenta il nucleo polemico originario, l’oggetto stesso della propria rinuncia, compiuta sulla base di una cupa visione della città dei papi (come di ogni contesto di potere), in preda a una perpetua lotta senza regole per il conseguimento dei benefici. La contrapposizione ad essa di un più semplice e sereno stile di vita conferma i parametri ideologici di ascendenza oraziana e senecana, benché questa volta dalle fonti classiche non vengano che clausole e tessere brevi: Expectant alii dominorum fata suorum, ut possint dites dilaniare locos; nilque magis cupiunt veteris quam funus amici, et mortem adiutant, ut bona templa vacent […]. Cum fida malim vitam mihi ducere gente atque intra tenues ocia tuta casas, sollicitus celso quam laurum ostendere curru, aut mytram mediis prodere flaminibus (30). (29) La citazione è ancora tratta da FLORIANI, Il modello ariostesco cit., p. 87. Per un orientamento sulla propensione del poeta a volgere l’intertestualità in «parodia della tradizione», cfr. C. BOLOGNA, Lettura delle «Satire», in ID., La macchina del «Furioso», Torino, Einaudi, 1998, p. 36. (30) PAGANELLI, De vita quieta cit., c. [4]r-v, vv. 67-70, 81-84 («Altri attendono le morti dei loro signori, / per poter dilaniare ricchi luoghi; / e niente desiderano più che il funerale di un vecchio amico, / e favoriscono la morte, perché restino libere chiese redditizie […]. / Con gente a me fidata preferirei passare la vita, / e ozi sicuri tra semplici case, / piuttosto che inquieto sfoggiare l’alloro dal carro superbo, / o la mitra esibire in mezzo ai sacerdoti»). Memorie classiche in 67 «dominae fati»: OVIDIO, Tristia, V 3, 17; «fata suorum»: OVIDIO, Met., VII, 698-99; LUCANO, IX, 735; 69 «veteris amici»: MARZIALE, VIII 18, 3; GIOVENALE, III, 1; «funus amici»: PROPERZIO, II 4, 13; 82 «tenuis casa»: STAZIO, Silvae, III 1, 82; «ocia tuta»: ORAZIO, Sat., I 1, 31; OVIDIO, Tristia, IV 10, 39-40; MARZIALE, XII 4, 3; 83 «celso curru»: LUCANO, III, 77; STAZIO, Theb., XII, 747; 84: CICERONE, Pro Milone, 46 («prodi flaminem»). DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 181 Contrariamente che nel De vita quieta, nell’economia della terza satira dell’Ariosto le prospettive di carriera nella Roma di Leone X non rappresentano lo spunto iniziale del testo; esse vengono affrontate e subito negate, in una lunga ironica digressione (vv. 82-207) condotta in chiave del tutto ipotetica, al fine di confermare l’opportunità in assoluto della scelta di vita stanziale. Forse per questo motivo allo spunto iniziale comune («S’io fossi andato a Roma, dirà alcuno, / a farmi uccellator de benefici, / preso alla rete n’avrei già più d’uno», vv. 82-84) non seguono corrispondenze evidenti; o piuttosto ciò accade perché un quadro di Roma analogo a quello del Paganelli, seppure tradotto (da grande narratore) in personaggi e situazioni, l’Ariosto già aveva disegnato nella seconda satira, ad esempio laddove (vv. 103-05, 130-34) il poeta confessava di andarvi per proveder ch’io sia il primo che mocchi Santa Agata, se avien ch’al vecchio prete, supervivendogli io, di morir tocchi […]. Sai ben che ’l vecchio, la riserva avendo, inteso di un costì che la sua morte bramava, e di velen perciò temendo, mi pregò che a pigliar venissi in corte la sua rinuncia. O dove aggiungeva, più avanti (vv. 157-59): Come né cibo, così non ricevo più quïete, più pace o più contento, se ben de cinque mitre il capo aggrevo. Che il proemio antiromano del Paganelli abbia comunque anche esteso la sua influenza sul disincantato ritratto di Roma nella terza satira, appare dimostrato dal fatto che entrambi i passi coinvolti si chiudono col topico motivo della Fortuna. Autore certo non brillante, il Paganelli non può affrontare la materia se non ricorrendo al suo imprescindibile Seneca, e sviluppandola nella direzione più comune, come ammonimento circa i colpi a cui è più esposto chi più dalla Fortuna è stato prima innalzato: 182 ITALO PANTANI Ex alto gaudet magnos devolvere reges Fortuna; in parvos non furit illa lares (31). Ma anche se, più argutamente (e giovandosi di un racconto di Abstemio) (32), l’Ariosto richiama il tema per alludere invece alla frequente amnesia (circa il proprio passato, amici compresi) che colpisce chi da quella è più beneficiato, le affinità lessicali e l’associazione al tema della «vita quieta» dimostrano che l’esempio del Paganelli è ancora operante (Satire, III, 169-71): Meglio è star ne la solita quïete, che provar se gli è ver che qualunque erge Fortuna in alto, il tuffa prima in Lete. Oltre i confini del proemio, tuttavia, il De vita quieta riuscì ancora a esercitare tale azione nella memoria ariostesca solo da due suoi segmenti a forte impatto retorico: la successiva propositio, e la sezione finale (epilogo dell’ultima argumentatio e peroratio conclusiva). Nella prima non passò inosservato all’Ariosto un accenno al risarcimento che gli studi sanno garantire all’autore, attraverso gioie e piaceri che la parte centrale del poemetto illustrerà nel dettaglio: Si vacat aut si quam dat caeca cupido quietem vos, quibus est tantum libera vita gravis, huc vacuas paulum mentes advertite. Dicam exemplo vitae commoda vestra meae […], quantum falluntur qui me miserantur amici, credentes studiis praemia nulla meis (33). (31) PAGANELLI, De vita quieta cit., c. [4]v, vv. 85-86 («La Fortuna gode di far precipitare dall’alto / grandi sovrani; non infuria su case modeste»). Di Seneca qui fondamentali Thyestes, 33-35 («dubia violentae domus / Fortuna reges inter incertos labet / miser ex potente fiat, ex misero potens»), e Phaedra, 1124-27 («minor in parvis Fortuna furit / leviusque ferit leviora deus / servat placidos obscura quies / praebetque senes casa securos»). Altre memorie classiche in 86 «parvos lares»: MARZIALE, IX 18, 2; GIOVENALE, IX, 137. (32) Cfr. ARIOSTO, Satire cit., p. 89. (33) PAGANELLI, De vita quieta cit., c. [4]v, vv. 93-96, 99-100 («Se la cieca avidità viene meno o se dà qualche tregua / a voi, cui tanto pesa una libera vita, / le menti sgombre volgete qui un poco. Io dirò / sull’esempio della mia vita cose utili a voi […], / quanto s’ingannano gli amici che mi commiserano, / credendo che dai miei studi io non riceva alcun premio»). Memorie classiche in 93: SENECA, Phaedra, 527-28 («nullus his auri fuit / caecus cupido»); «si vacat»: OVIDIO, Ep. ex P., I 1, 3; «dat quietem»: VIRGILIO, Aen., IV, 5; X, 217; «caeca cupido»: LUCREZIO, III, 59; OVIDIO, DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 183 Di questo spunto restano infatti tracce soprattutto nella prima satira, dove l’Ariosto, quasi in diretto dialogo col maestro quattrocentesco, riconosce agli studi il merito di guidarlo al riconoscimento del benessere riposto in un «quieto» stile vita, e della libertà come valore superiore ad ogni rinuncia (vv. 16063, 166-68): più tosto che arricchir, voglio quïete: più tosto che occuparmi in altra cura, sì che inondar lasci il mio studio a Lete. Il qual, se al corpo non può dar pastura […], fa che la povertà meno m’incresca, e fa che la ricchezza sì non ami che di mia libertà per suo amor esca. La sezione conclusiva del De vita quieta, a sua volta, s’incentra tutta sull’insistita antitesi tra la serenità conquistata dall’autore, e le inappagabili brame dell’uomo avido (un vero supplizio di Tantalo, personaggio di cui acutamente si richiamano le parole attribuitegli da Seneca nel Thyestes, 4-6: «peius inventum est siti / arente in undis aliquid et peius fame / hiante semper?»): Cui satis haec non sunt, cui tantus corpore venter, is comedat Vesulum, potet et inde Padum […]. Dira fames nimium, quae semper crescit edendo, dira sitis, nulla quae satiatur aqua. Si sapis, o vanos sequeris quicumque labores, quem spes grandisonis fallit imaginibus […], desere sirenes, Strophadum iam desere terras, et mecum veras carpe beatus opes: si potes hanc vitam contentus ducere, vere dives es, et nullus ditior esse potest […]. Ergo agitent vigiles avidorum pectora curae; excipiat nostros vita quieta dies (34). Met., III, 620; 94 «vita gravis»: OVIDIO, Her., VIII, 31; 95 «vacuas mentes»: VIRGILIO, Georg., III, 3; OVIDIO, Her., XV, 14; Rem. am., 150; 100 «studiis praemia»: VAL. MAX., VIII 7, 7; «praemia nulla»: CATULLO, LXVI, 86; OVIDIO, Met., VIII, 92. (34) PAGANELLI, De vita quieta cit., c. [15]r-v, vv. 693-94, 697-700, 703-06, 713714 («Colui al quale queste cose non bastano, colui che ha un sì gran ventre nel corpo, / mangi pure il Vesuvio, poi beva il Po […]. / Fame troppo feroce, che sempre aumenta mangiando, / sete feroce, che da nessuna acqua è saziata. / Se hai senno, chiunque tu sia che insegui vani affanni, / che la speranza inganna con eclatanti illusioni […], / dimentica le sirene, dimentica le terre delle Strofadi, / e beato godi con me delle vere ricchezze: / se puoi condurre felice questo stile di vita, veramente 184 ITALO PANTANI Pur facendo convergere su di sé i due termini dell’antitesi, con effetti ben più felici (e anche più fedeli, si è visto, alla lezione oraziana), l’Ariosto fece di nuovo tesoro di questi argomenti nella terza satira, per concludere anch’egli la propria riflessione circa le sue possibilità di carriera a Roma, e più in generale intorno alla vanità di ogni affannosa ambizione, con una meditazione sull’insaziabilità del desiderio umano (vv. 196-98, 244-46, 253-54): Serà per questo piena quella vasta ingordigia d’aver? Rimarrà sazia per ciò la sitibonda mia cerasta? […] Ma se l’uomo è sì ricco che sta ad agio di quel che la natura contentarse dovria, se fren pone al desir malvagio […], che mi può dare o mezza o tutta rasa la testa più di questo? Poco importa che anche in questo caso ci troviamo dinanzi a una vivace rivisitazione di concetti tradizionali, non privi di attestazione nella latinità classica (35). Anche qui infatti, come sempre quando il testo delle Satire si avvicina a quello del De vita quieta, tra le due opere è dato registrare corrispondenze di concetto e di lessico ben più puntuali di quelle reperibili nelle fonti antiche: in una continuità di riscontri men che meno riconducibile al caso. All’origine di tanta attenzione, che / sei ricco, e nessuno più ricco può essere […]. / Perciò i vigili affanni turbino i petti degli avidi; una vita quieta si riservi alle nostre giornate»). Altre memorie classiche in 693-97 «venter … semper … edendo»: OVIDIO, Met., VIII, 842-43; 697 «dira fames»: VIRGILIO, Aen., III, 256; 698 «satiatur aqua»: OVIDIO, Met., VIII, 836; CALPURNIO, II, 50; 699 «si sapis quicumque»: OVIDIO, Rem. am., 371-72; «vanos labores»: SENECA, Phaedra, 182; MARZIALE, X 82, 7; «quaecumque laborem»: VIRGILIO, Aen., I, 330; 700 «spes fallit»: VALERIO FLACCO, VI, 713; «fallit imaginibus»: LIGDAMO (in TIBULLO, III 4, 56); 703 «desere sirenes»: MARZIALE, III 64, 1-3; 705 «hanc vitam»: VIRGILIO, Georg., II, 538; 713: LUCANO, VIII, 161 («vigiles Pompei pectore curae»); «pectora curae»: LUCREZIO, V, 1207, VI, 645; CATULLO, LXIV, 72; VIRGILIO, Aen., I, 227, IV, 448, V, 701; 714 «excipiens diem»: SENECA, Troades, 10. (35) In questo caso il precedente forse più citato (cfr. ad es. ARIOSTO, Satire cit., p. 99), anche perché pertinente al genere satirico, è quello di GIOVENALE, XIV, 31118 («Sensit Alexander, testa cum vidit in illa / magnum habitatorem, quanto felicior hic, qui / nil cuperet, quam qui totum sibi posceret orbem, / passurus gestis aequanda pericula rebus / […] Mensura tamen quae / sufficiat census, si quis me consulat, edam: / in quantum sitis atque fames et frigora poscunt»). DI UN POEMETTO MODENESE ISPIRATORE DELL’ARIOSTO E DEL TASSO 185 l’antitetico impianto stilistico trascese a tal punto da fin quasi occultarla, agivano le potenzialità mediatrici del poemetto quattrocentesco: nel quale l’Ariosto trovava già sintetizzati in autoritratto unitario, eccezionalmente somigliante al suo per disegno complessivo e situazioni affrontate, molti e preziosi motivi di antica tradizione, ma dispersi negli originali tra innumerevoli carte. D’altra parte, se tali caratteri venivano a rafforzare potenzialità pertinenti all’intera letteratura del ’400 in lingua latina (cui in apertura accennavo), il Paganelli era un maestro di lettere troppo ancora condizionato da interessi eruditi e scolastici per avviarsi con rigore sui sentieri della satira: rinunciando ad esempio, pur di valorizzare istanze morali e polemiche, alle sue amene e didascaliche divagazioni. Tutt’altra strada seguì notoriamente l’Ariosto: a cui pure, dalle pagine del nostro «quieto» modenese, contenuti anche antichi si offrirono in vesti talmente appropriate alle novità dei tempi e (singolarmente) al suo personale autoritratto, da risultare non di rado funzionali alla sua moderna e scaltrita interpretazione della scrittura satirica. ITALO PANTANI
Scaricare
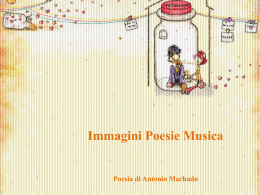


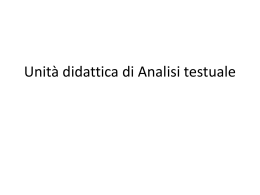


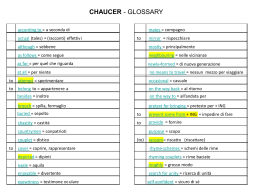
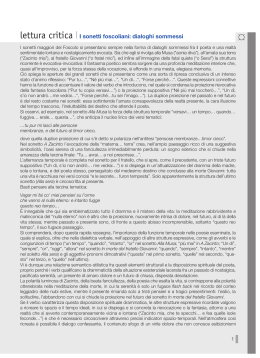
![vita, opere e poetica [s]](http://s2.diazilla.com/store/data/000069647_1-64ccea31aa9407509c3ff457eaf85678-260x520.png)
