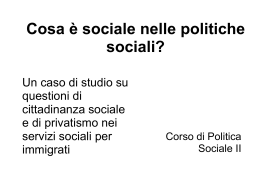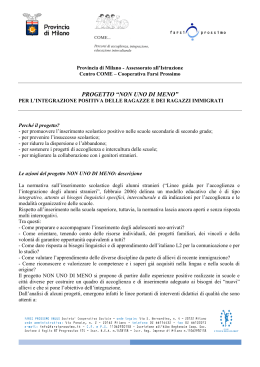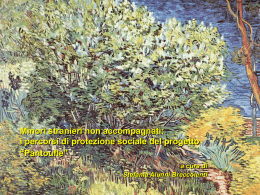edit Tempi duri per la libertà di pensiero… STEFANO VITALE L a morte di Papa Woityla ha scatenato, come si ricorderà, una tempesta mediatica senza precedenti, provocando una genuflessione mondiale che ci ha obbligati, tra l’altro, anche a prendere atto che ormai l’italico centrosinistra si è allineato deferente a questa confisca dello spazio pubblico da parte della Chiesa cattolica. Occhi disincantati potrebbero dire che, in fondo, è sempre stato così. Ma oggi c’è qualcosa di nuovo. In primo luogo il “nuovo” Papa ed il “vecchio” Cardinal Ruini hanno alzato il tiro attaccando, in nome di una “visione evangelica di pace” e di “buona laicità”, la libertà della ricerca scientifica, la liberta individuale sul piano sessuale, la legittimità della piena giurisdizione civile delle famiglie di fatto, i diritti delle donne e persino l’uguaglianza fiscale di tutti i cittadini richiedendo, come ovvio, leggi e denaro di tutti solo per sé. La reazione del centrosinistra è sconcertante: Fassino ha finalmente il “coraggio” di dichiararsi credente, Bertinotti proclama il suo distacco dall’ateismo ed il suo percorso di ricerca di Dio; Amato consacra teoricamente e storicamente l’ineluttabilità della presenza pubblica di una politica della Chiesa. Ma qui sta la novità: perché ce lo vengono a raccontare? Perché sentono il bisogno di dirlo in pubblico? Per banale calcolo politico, come rivelano Prodi e Rutelli ricordando in contrapposizione a Boselli che «il Concordato non si tocca». Ma, come diceva qualcuno, «la stupidità non è necessaria» se non, in questo caso, ad avallare pericolosamente la natura teocratica della Chiesa cattolica che non si distingue da alcun altra Chiesa islamica, o altro che sia, integralista. La Chiesa cattolica ringrazia ed alza la posta esigendo sempre più spazio pubblico riconosciuto, senza mediazioni ed usa lo Stato per i suoi fini “temporali”. Prima di tutto per rafforzarsi economicamente attraverso “politiche per la famiglia” fumose nei contenuti quanto chiare nei risultati di cassa, tanto è vero che Maroni si è affrettato a spiegare la “manovra” a Ruini, vero ministro del welfare in Italia. E poi per alzare altri muri contro la religione musulmana. I monoteismi, da sempre, sono esclusivi e cercano il potere assoluto, monocratico, appunto. Ci domandiamo come facciano la Caritas o il Gruppo Abele a riconoscersi in tali politiche tanto autoritarie quanto ipocrite. La Chiesa cattolica, tra l’altro, non esita a manipolare la stessa laicità per arginare “l’invasione dello straniero”. Patetici i discorsi di Letizia Moratti e dei cardinali sulla scuola Musulmana di Milano: è stata chiusa in nome della laicità. Quando chiuderanno allora le scuole ebraiche come fece il fascismo? E quando la sinistra avrà il coraggio di dire che nella Scuola Pubblica di tutti non si deve insegnare alcuna religione? Il doppiogiochismo della Chiesa è cosa nota, ma quello della sinistra ci lascia sconcertati e delusi. Come insegna Amato, d’accordo con Pera, la Chiesa avrebbe il diritto «sancito dalla democrazia» (e ben presto dalla Costituzione?) di intervenire come le pare nel dibattito politico. In nome del pluralismo si fa un gioco di prestigio per sottomettere non solo l’etica alla religione ma anche il politico alla religione. Ovviamente nessuno ha il coraggio di dire che se la Chiesa cattolica si arroga il diritto di “legiferare” per tutti i cittadini, allora anche i cittadini e le loro istituzioni, lo Stato per primo, ha diritto d’intervenire nel merito delle “leggi” della Chiesa. La democrazia funziona per tutti o non funziona. Tra l’altro, ci domandiamo che fine debbano fare gli atei, i “miscredenti”, in ogni caso coloro che tentano di restare lucidi e critici, liberi pensatori che s’oppongono all’occupazione dello spazio pubblico da parte della religione e della sua autorità sempre più direttamente politica, che rifiutano ogni fideismo e totalitarismo. Ci domandiamo come si sentano i credenti e i non credenti che vogliono ancora vivere assieme nel rispetto di ciascuno, pensando che essere cittadini significa almeno garantire il rispetto della libertà di coscienza nello spazio pubblico e la libertà di culto in quello privato. Certo occorre rovesciare una tendenza: laicità non è solo riconoscere il fatto religioso e il diritto di esercitare un culto, ma è essenzialmente il diritto di pensare liberamente, di possedere un’etica e di non credere. ● PAGINA 1 pre Occupiamoci di noi ENZO SCANDURRA* Cronaca di un’occupazione inaspettata ▼ PAGINA 2 Quando il ddl della Signora Moratti passò al Senato, blindato dal voto di fiducia, molti di noi docenti pensarono che ormai la battaglia fosse persa. Perché un’opposizione forte dai docenti non sarebbe mai arrivata e gli studenti da tempo ormai avevano smesso di considerarsi ancora i protagonisti dell’università. Qualche capannello, qualche stanco «Che fare?», ma già molti ostentavano rassegnazione e sfiducia; qualche volta un ironico cinismo. Altri pensavano poi che coinvolgere gli studenti in quello sgangherato Disegno di Legge sarebbe stato quasi disonesto, perché il ddl della Signora Moratti, infatti, gli studenti quasi neppure li menziona e si perde invece in quel labirinto di norme e regole dello stato giuridico che solo i docenti in attesa di promozione, o gli anziani smaliziati, riescono a capire, tanto sono astruse, corporative, criptiche al limite di un linguaggio tra compari. Fanno sul serio Qualche mormorio, qualche timido tentativo di protesta o di interrompere le lezioni (cosa ancora considerata sacrilega), qualche slogan gridato a bassa voce, pronunciato con quel gergo un po’ ingenuo che fa sorridere chi il ’68 l’ha attraversato. Poi, un giorno, di colpo l’aula 1 piena di studenti fin fuori la porta al grido: “Occupiamoci di noi”. Uno studente prende il microfono e spiega ai suoi colleghi cos’è il ddl della Signora Moratti. Nessuna ideologia, nessuno slogan politico, solo una esposizione fredda e dettagliata e, alla fine, nessun commento. Rimango stupito tanto l’esposizione è stata chiara pre come se a farla fosse stato un navigato docente che di riforme ne ha viste. E dopo seguono interventi concitati e precisi: «Sappiamo poco e male. Cosa studiamo? E perché studiamo? Questo titolo di studio non vale niente. Gli esami, fatti in tre anni, uno dopo l’altro ci tolgono qualsiasi forza, ci tolgono perfino la curiosità di conoscere, sterilizzano le nostre curiosità. Studiamo in modo parcellizzato, ingurgitiamo nozione dopo nozione senza capire a cosa ci servirà mai questo arcipelago di informazioni scollegate. E usciti di qui ci diranno/ci dicono che non abbiamo imparato un bel niente». Nessuno ha pronunciato il nome di Carlo Marx, o di Lenin e neppure quello di Prodi o Berlusconi. Nessuno accusa o difende un partito rispetto a un altro. Nessuna ideologia viene scomodata e anche le parole di moda, come globalizzazione o neoliberismo vengono mai pronunciate. Tuttavia, o anche per questo, gli studenti colpiscono il bersaglio: il ruolo sempre più declassato delle nostre università, il loro declino e la loro deriva verso la perdita di ogni tradizione e memoria storica. Proprio quel luogo – l’università – che aveva il compito di studiare il passato, trasmetterlo e rinnovarlo, appare ora sempre più simile ad un’azienda che sforna “prodotti”, che valuta con i freddi indicatori dell’economia la sua produttività ed efficienza, che ritiene che la conoscenza debba essere finalizzata a risultati immediati ed utilitaristici, quando la storia della scienza ci ha insegnato che è pressoché impossibile stabilire a priori una corrispondenza precisa tra una specifica innovazione e la ricerca particolare che l’ha resa possibile. Hanno capito, gli studenti, che le risorse pubbliche saranno sempre più convogliate altrove, verso le business schools, le scuole di management, i master e le cosiddette “scuole di eccellenza”, denominazione, questa, quanto mai ideologica e ingannatrice. Hanno capito, gli studenti, che la didattica si è paurosamente spezzettata con uno sminuzzamento incontrollato dei corsi, con una continua confusione tra corsi propedeutici, corsi di preparazione di base e corsi di approfondimento e specializzazione. Trasformano la loro frustrazione per essere stati ingannati non in rabbia, spaccando e rompendo suppellettili e banchi, e neppure in una opposizione dura nei confronti dei loro “nemici” docenti. Chiedono anzi il loro aiuto, si dichiarano dalla loro parte, solidali nei confronti di una opposizione a un disegno di sfascio e liquidazio- ne di un patrimonio pubblico che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di una paese che si ritiene ancora civile. Ma poi tenaci e per niente rassegnati puntano il dito decisi: «Cosa ci state facendo studiare e perché? Non vogliamo essere “prodotti”; voi siete dalla nostra parte? Non dovrebbe essere l’università la comunità – docenti e studenti – di coloro i quali portano avanti le frontiere di una conoscenza critica, disinteressata e non subalterna? Voi docenti siete con noi? E perché ci avete abbandonati a un 3+2 che nessuno di voi condivide?». Questi studenti fanno sul serio. Non cascano, come nel ’68, nelle trappole del leader di turno dalla parola convincente, non subiscono la dittatura del microfono. Sono tolleranti e curiosi e volentieri danno la parola a quelli che vorrebbero riprendere a frequentare le lezioni. Non li tacciano di essere “reazionari”, anzi li ascoltano e replicano con civiltà e gentilezza. Il ’68 è lontano; questa è una “specie” nuova, pragmatica, ingenua quanto tenace, tolle- rante quanto incorruttibile, sensibile, mai cinica, mai furba o scaltra. Combatte a viso aperto la propria battaglia, pone domande imbarazzanti, scuote la rassegnazione e non sta al gioco di chi è già pronto a trattare la resa. «Questi non andranno lontano, sono troppo ingenui e si cucineranno da soli», mormora qualche cinico docente che ha già fiutato la prospettiva di un qualche vantaggio personale tra le pieghe di questo sgangherato disegno di legge. La corporazione ha qualche sussulto. E quando alla sera gli studenti si preparano ad affrontare la notte in aula, nei corridoi il partito dei docenti cinici sussurra: «Non ce la faranno mai» e poi si scioglie di corsa verso le auto parcheggiate. All’indomani alcuni di loro, curiosi, si affacceranno nell’aula occupata per vedere se ancora ci sono… Purtroppo sì. È una specie nuova, sono mutanti; attenti, questi fanno sul serio. ● * Professore ordinario di Ingegneria del Territorio, Facoltà di Ingegneria di Roma, Università degli studi La Sapienza. PAGINA 3 Farfalle Rosse FEDERICO TOMASELLO * La riapertura di scuole e università ci consegna, al tramontare di questo pigro 2005, un quadro di mobilitazioni in grado di disegnare i contorni di un movimento possibile. Studenti medi e universitari per l’autoriforma ▼ Si può dire che tutto cominci lo scorso 23 settembre a Siena, quando un gruppo di studentesse e studenti contestano il cardinal Ruini. Si fanno chiamare Farfalle Rosse. Ricordate la teoria del caos? “Il battito d’ali di una farfalla in Brasile può, a seguito di una catena di eventi, provocare una tromba d’aria in Texas…” questa la teoria, ed è esattamente ciò che accade. I media comprendono la portata del caso e si scatenano, la stragrande maggioranza dei politici si mostra invece sorda alle istanze di un pezzo di gene- razione deciso a mostrare tutta la propria riottosità verso i guardiani di ogni tempio, di qualsiasi dogma, siano essi la sacra morale immutabile nei secoli, l’intoccabile ideologia del profitto o il credo di prudenza della realpolitik. Laicità e partecipazione Gli studenti e le studentesse che mettono in campo la contestazione sanno bene che la questione della laicità della scuola, così come quella dello stato, pre PAGINA 4 è decisiva e nessun governo metterà definitivamente al riparo da indebite ingerenze. Qualche giorno dopo, il 12 ottobre, alcune strutture di movimento studentesche (fra cui la Rete Sempre Ribelli) lanciano una giornata di mobilitazione nazionale, la scadenza è improvvisata e convocata in una settimana, ma quel giorno migliaia e migliaia di studenti e studentesse disertano la scuola e invadono le strade e le piazze di moltissime città italiane per gridare il loro punto di vista, la scuola come la vogliono loro, laica, partecipata, aperta, autogestita, contro il pacchetto di riforme Moratti e per l’innalzamento dell’obbligo scolastico. Poi le prime occupazioni autunnali di scuole, ma soprattutto la proclamazione dello stato di agitazione di tutti gli atenei italiani, con blocchi della didattica, lezioni in piazza o notturne, assemblee permanenti e varie occupazioni (negli atenei di Roma, Bologna, e Torino in particolare). Studenti, ricercatori, docenti si mobilitano contro il ddl Moratti teso a rendere precari i percorsi professionali nelle università. Quando il 29 settembre il ddl và in votazione al senato sotto palazzo Madama a contestarlo c’è un presidio di circa 200 ricercatori, tempestivamente caricato e allontanato dalla polizia. 26 giorni dopo lo stesso provvedimento va n votazione alla Camera, la Sapienza di Roma, in stato di occupazione, chiama alla mobilitazione nazionale, è il corteo dello scorso 25 ottobre e segna il vero punto di svolta… Il furto di tempo e di futuro Era da 15 anni, dai tempi del movimento della Pantera che non si vedeva una manifestazione studentesca tanto grande, partecipata, determinata. Il corteo assedia per 12 ore la città, mette in gioco i propri corpi per arrivare ad urlare la propria sotto il parlamento e sfida la brutalità dei manganelli con la forza di migliaia e migliaia di mani alzate, con la potenza della vita vera dei propri corpi. La cronaca è nota, racconta di alcuni deputati di AN che provocano e salutano il corteo con il dito medio alzato, di altri che intimano alla celere di caricare a freddo alcuni studenti che si allontanano dal corteo (ordine prontamente assecondato), ma soprattutto disvela tutta la sordità del palazzo che approva il ddl nonostante in piazza Montecitorio ci siano i volti del corpo vivo della formazione, di chi l’università la vive quotidianamente ed urla tutte le ragioni del no a quel provvedimento. Esistenze precarie Se è vero che quel corteo deve e può segnare un punto di svolta è qui che urge una riflessione. Il disegno di legge Moratti si chiama “Riordino dello stato giuridico della docenza universitaria” e riguarda la precarizzazione dei percorsi professionali di ricercatori, dottorandi e aspiranti tali; una questione che tocca la vita e i bisogni di una sparuta minoranza del corpo studentesco. Eppure proprio quel provvedimento provoca un’ondata di occupazioni e porta in piazza una manifestazione studentesca come non si vedeva da più di 15 anni. Di fronte a questo apparente paradosso ci viene da osservare che questo ddl in qualche modo allude e racconta la precarizzazione dell’esistenza di un’intera generazione, un processo che ha inizio fin dalle scuole e dalle università. Parla di una vita sempre più segnata da incertezza, instabilità, insicurezza e ci pare allora che chi scende in piazza rivendichi una cosa innanzitutto: il proprio futuro. Non a caso lo striscione d’apertura dell’enorme corteo recitava “Il nostro tempo è qui e comincia adesso”… riprendersi il proprio tempo, rompere la precarietà come furto del tuo futuro, della possibilità di immaginare, progettare, costruire la tua vita fuori dal ricatto e dal dominio del mercato. È in questo senso che esigenze ed aspirazioni di queste mobilitazioni studentesche rompono le mura delle scuole e delle università per nominare una condizione di vita nella sua complessità. Non è semplicemente l’università o la scuola che non vanno, è la vita, si potrebbe dire. Il movimento si è poi riconvocato nell’assemblea nazionale dello scorso 6 novembre ed ha prodotto il “Manifesto per l’autoriforma dell’università”: «[…] Fin da subito la protesta è esplosa a partire dal nostro disagio, investendo l’assetto complessivo dell’università e della formazione. All’origine di tale disagio vi sono i processi di precarizzazione e di riforma, il cui centro focale è rappresentato dal 3+2 e dal meccanismo dei crediti, introdotto dal centrosinistra e peggiorato dal centro-destra. […] Le occupazioni e le mobilitazioni sono state, da subito, laboratori di sperimentazione di nuove e molteplici pratiche di conflitto e di scardinamento dell’università attuale e nello stesso tempo di immediata costruzione di un’altra università. A partire da qui abbiamo iniziato a scrivere con i nostri conflitti l’autoriforma dell’università […]». Dalla discussione sono emerse in particolare la decisione di rendere la data del 17 novembre – scadenza di mobilitazione lanciata dal Forum sociale mondiale contro la privatizzazione della formazione e la mercificazione del sapere – una giornata di insorgenza e insubordinazione di tutto il mondo della scuola, dell’università, della ricerca in ogni territorio, l’impegno a tentare una “generalizzazione” dello sciopero generale del 25 novembre, e la volontà di costruire un’altra scadenza studentesca nazionale entro la pausa natalizia. ● * Portavoce della Rete Sempre Ribelli. pre ▼ È quello che è successo il 14 ottobre scorso, quando Moratti e Berlusconi, con la consueta sceneggiata mediatica, hanno annunciato l’approvazione da parte del consiglio dei ministri dell’ultimo decreto applicativo della legge 53/02, quello relativo alla scuola secondaria superiore. Ma per capire il tutto occorre fare un passo indietro, esattamente a un mese prima, a quel 15 settembre in cui la Conferenza Unificata Stato-Regioni arrivò alla conclusione che non c’erano le condizioni affinché la riforma delle superiori potesse partire nel 2006 e che bisognava rinviare il tutto almeno al 2007, comprese eventuali sperimentazioni della riforma stessa. Dire 2007 significava dire che tutte le procedure per la nuova attivazione e quindi la riforma stessa potevano tranquillamente essere messe in discussione da una nuova maggioranza e da un nuovo governo, esito eventuale e non improbabile delle elezioni di aprile 2006. Le mani avanti Ecco allora nei dovuti passaggi del testo alle commissioni parlamentari mettersi all’opera i guastatori dell’oltranzismo di destra, nel tentativo di sovvertire il verdetto delle Regioni. Una manfrina che tra la fretta di chiudere la partita entro la scadenza della delega e l’impossibilità di produrre una grave frattura istituzionale, non poteva che partorire un topolino: se non si può avviare la riforma nel 2006, si avvii almeno la sua sperimentazione, tanto per mettere le mani avanti. E la Moratti non si fa scappare l’occasione: alle 13 e 30 del 14 ottobre si presenta ai giornalisti, senza produrre uno straccio di testo scritto del decreto, ma dicendo, nell’ordine, che i ministri lo hanno approvato, che la sperimentazione partirà nel 2006, che la riforma vera e propria sarà avviata nel 2007 e che così la riforma è compiuta. Nonostante neppure nelle quattro cartuccelle consegnate alla conferenza stampa compaia la data del 2006, ma solo quella del 2007, i giornalisti abboccano alle parole della Moratti e agenzie e giornali riporteranno come notizia la sperimentazione a partire dal 2006. Tre ore dopo esce un comunicato della Moratti che dice che per la sperimentazione il testo del decreto non conterrà nessuna data. Ed infatti il testo, che esce cinque giorni dopo, non riporta nessuna data in merito, anzi rin- L’incompiuta (con bluff) della Moratti PINO PATRONCINI PAGINA 5 Era ormai chiaro da tempo che la Moratti aveva altri interessi, in altre città, rispetto a quelli romani di Ministro dell’istruzione, ma che non poteva certamente arrivarvi facendo la figura della cioccolataia rispetto a una riforma della scuola su cui aveva speso buona parte della sua immagine. Ma allora che c’era di meglio che inscenare un bluff di fronte ai giornalisti, facendo credere di aver portato a termine il lavoro, anche se non è vero? via il tutto al completamento di procedure che non stanno dentro ai due mesi che separano il 14 ottobre dall’avvio delle iscrizioni, e quindi anche dalle iscrizioni a eventuali corsi sperimentali. Ma ormai l’effetto notizia c’è stato, e l’errata corrige trova uno spazio angusto e inefficace nei pochi giornali che la riprendono. Lo stato dell’arte è quindi assai diverso da quello a cui i giornali hanno dato spazio, diffondendosi a descriverci ancora una volta la struttura, brutta, della riforma, come se fosse cosa fatta. Brutta perché fondata su una separazione tra sapere e saper fare che inevitabilmente diventa una segregazione sociale, dal momento che inizia alle elementari con i maestri prevalenti, spacciati come tutor, separati dai maestri “della plastilina” o delle attività motorie e finisce col separare i ragazzi dei licei da quelli del professionale. Ma anche tuttora sospesa perché nelle elementari è stata bloccata dal boicottaggio massiccio delle indicazioni da parte dei docenti, che così hanno salvato per ora il tempo pieno e la scuola dei moduli, e nelle superiori è ancora di là da venire. E se verrà sarà dopo le elezioni prossime venture: una responsabilità per chi si candida a governare in alternativa a Moratti e Berlusconi. Una responsabilità che non solo non ha l’alibi di un processo già avviato, ma neppure quello, assai minore, di una sperimentazione già avviata. Una responsabilità che non può avere altro esito che la cancellazione della legge. ● pre PAGINA 6 Il peso della Finanziaria... e non solo COSIMO SCARINZI * Scuole di parte col denaro di tutti. Tagli alla scuola pubblica. Controllo dei fondi pensione. Conflitti tra i sindacati. Fra il 21 ottobre e il 25 novembre. L’un dopo l’altro messi di sventura ▼ Torino, 20 ottobre – Ancora mentre esco da casa per recarmi in stazione a prendere il treno per Roma, dove si terrà il corteo per lo sciopero indetto dal sindacalismo di base per il 21, mi telefona un delegato aziendale della CUB di un ospedale per informarmi del fatto che due caposala diffondono la voce che lo sciopero del 21 ottobre è stato revocato. L’ordinanza della Commissione di Garanzia per (in realtà contro) l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ha vietato lo sciopero nel settore dei trasporti, ha colpito due volte, in primo luogo, ovviamente, i lavoratori dei trasporti e, in maniera più ampia, in tutte le categorie, grazie al fatto che si è diffusa la voce che lo sciopero generale è stato revocato. Nei due giorni precedenti lo sciopero siamo stati costretti ad un lavoro enorme di chiarimento, informazione, denuncia delle scorrettezze da parte delle aziende, dei sindacati istituzionali, delle amministrazioni. Lo sciopero del 21 ottobre ha dovuto, come di norma, fare i conti: con il fragoroso silenzio dei media, compresi quelli della sinistra d’opposizione; con un pesantissimo intervento della Commissione di Garanzia; con il fatto che CGIL-CISL-UIL hanno indetto uno sciopero – formalmente contro la legge finanziaria ma in realtà sulla partita dei fondi pensione – per il 25 novembre; con incredibili sabotaggi di Trenitalia, che ha negato treni precedentemente concordati, e pagati, per la manifestazione e, per quanto riguarda la scuola, con il fatto che i Cobas Scuola hanno scelto di scioperare il 25 novembre con CGIL-CISL-UIL. Uno sciopero difficile, dunque. Uno sciopero, d’altro canto, che ha messo al centro alcuni punti nodali: reddito, pensioni, scippo del TFR, opposizione alla precarizzazione, in una parola l’aperta ed esplicita opposizione alla concertazione. Non solo l’opposizione alla legge finanziaria, ma l’individuazione di una piattaforma che ha un valore di medio periodo. Familismo e senza famiglia La Legge Finanziaria per la scuola, non è leggera. Con ogni evidenza, infatti, secondo il governo italiano, gli studenti che frequentano la scuola pubblica sono dei senza famiglia, come recita il titolo di un lacrimevole libro ormai desueto. pre Infatti, nei fondi a sostegno della famiglia previsti dalla legge finanziaria, i 200 milioni di euro previsti per il sostegno allo studio andranno tutti a favore delle scuole private. Il 10% delle famiglie, di norma a reddito medio alto, avranno tutto; il 90%, quelle che hanno il torto di scegliere una scuola pubblica, non avranno nulla. Il governo, in questo modo, paga un’altra cambiale alla scuola privata, in particolare alla scuola confessionale, che è, come è noto, in grave crisi d’astinenza per l’abbandono da parte di quote della tradizionale clientela. Le scuole private, infatti, hanno perso, negli ultimi dieci anni, il 10% degli studenti, al punto che 300 scuole private superiori su 1.000 hanno chiuso i battenti. Che l’appetito venga mangiando lo dimostrano le dichiarazioni di Antonio Perrone, presidente della Fidae, l’associazione delle scuole confessionali, che dichiara: «Quello di cui abbiamo bisogno è che la scuola privata sia a costo zero, come quella statale, solo così si garantisce la libera scelta delle famiglie già prevista dalla legge 62/2000». Questi signori hanno, con ogni evidenza, un’idea tutta loro di libertà: vogliono, infatti, scuole di parte col denaro di tutti. Cosa intendano con la parola libertà, d’altronde, si capisce bene se si valuta il mercato indecente delle maturità facili presso le scuole private. In compenso, per quanto riguarda la scuola pubblica, il governo prevede tagli massicci per le spese di funzionamento degli uffici (telefoniche, di cancelleria, di rappresentanza). Sappiamo bene in che situazione si trovino a lavorare le segreterie, come vi siano già state, i giornali ne hanno parlato a lungo, difficoltà per le spese telefoniche necessarie a proporre le supplenze, per la normale produzione di materiale didattico ecc. Possiamo immaginare come lavoreremo se passerà una simile legge finanziaria. Altri tagli sono previsti per le supplenze brevi e gli straordinari, con le conseguenti ricadute sulla retribuzione del personale e sulla qualità del servizio già deterioratasi a causa del taglio, avvenuto negli ultimi anni, degli organici e delle risorse e per l’aggiornamento e per il miglioramento dell’offerta formativa, con l’effetto di negare i diritti del personale e degli studenti. Salario, pensioni, precariato La gran parte dei sindacati alternativi, in quest’occasione, ha saputo praticare l’unità e la capacità di muoversi autono- mamente. CUB, CNL, SULT, Sin Cobas, USI, Unicobas hanno trovato un accordo che ha dimostrato che, se si ragiona sui contenuti, guardando al futuro e agli interessi generali del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici, si possono metter da parte le divergenze passate. Per quanto riguarda lo sciopero del 25 novembre, è perfettamente chiaro che, per CGIL-CISL-UIL, la partita in corso riguarda il controllo dei fondi pensione. Settori della maggioranza hanno, capita ogni tanto, riscoperto una posizione ostile al sindacalismo istituzionale e proposto la possibilità di tagliargli parte dei massicci finanziamenti che negli anni passati non sono mai stati messi in discussione. Al contrario, i settori “sociali” della stessa maggioranza, democristiani interni ed esterni a Forza Italia, fascisti e leghisti, continuano nella linea della concertazione. Una partita da molti miliardi di euro, fra fautori dei fondi chiusi a gestione sindacale (come prezzo da pagare al taglio concertato delle pensioni) e fautori della liberalizzazione radicale della previdenza ma, in ogni caso, uno scontro che vede tutti questi signori d’accordo sul fatto che le pensioni vanno tagliate e che il capitalismo dei fondi pensione deve decollare. Parlare di salario, di pensioni, di precariato oggi e parlarne senza ambiguità, legare la propaganda all’azione, è una scelta non semplice che ha il pregio evidente di porre le premesse per iniziative future di lotta, qualsiasi sia la prossima maggioranza parlamentare. L’opposizione sociale Ovviamente, lo sciopero del 21 ottobre ha coinvolto gruppi di lavoratori e di lavoratrici, soprattutto nelle aree del paese e nelle aziende ed amministrazioni dove il sindacalismo di base ha un adeguato radicamento. Il corteo ha visto una presenza robusta di lavoratori del settore privato e di quello pubblico, persone non venute perché convocate dalla televisione e dai giornali, ma perché raggiunte, con una sorta di passaparola, dai sindacati di base. All’inizio, capita spesso così, sembrava si fosse in pochi, treni e pullman arrivavano in ritardo, i romani, come di norma, si sono alzati con calma. Appena, però, il corteo è partito è stato chiaro che la mobilitazione, senza enfatizzare troppo, questa volta è riuscita. Erano decine e decine di spezzoni cittadini, d’azienda, di categoria con i loro striscioni ed i loro cartelli. Laicità della scuola. Azioni concrete e comportamenti coerenti Il Comitato “Per la Scuola della Repubblica” – con l’adesione del CGD - Coordinamento dei Genitori Democratici e dell’Associazione Idee per l’educazione – ha proposto al TAR del Lazio un ulteriore ricorso per contestare l’ennesimo decreto ministeriale con cui si erogano risorse finanziarie alle scuole private. “Per la Scuola della Repubblica”, tel. 06.3337437, fax 06.3723742, [email protected], www.comune.bologna.it/ iperbole/coscost I disoccupati napoletani si distinguevano per la vivacità spettacolare, non è forse Napoli la città di Pulcinella, maschera ben più seria di quanto credano i superficiali? Lo spezzone di Vicenza ricordava il licenziamento da parte della Marzotto di un delegato della CUB Tessili, contro il quale si fanno scioperi e mobilitazioni quotidiane mentre i vigili del fuoco denunciavano la militarizzazione del corpo. I lavoratori della scuola diffondevano volantini che raffiguravano il Ministro Moratti come un untore che infetta la scuola con il virus aviario morattiano; gli spezzoni di fabbrica davano visibilità ad un lavoro industriale che il potere vuole invisibile e “superato”. Molti indossavano magliette con la scritta “A fine stipendio avanza troppo mese” o con altri slogan altrettanto efficaci. Gli stessi media istituzionali hanno dovuto rendere conto del corteo: questo risultato è importante ma, a mio avviso, secondario rispetto all’essenziale. E ora? L’unità realizzata il 21 ottobre può essere l’esperienza di un giorno ma, se si saprà lavorare sulla base di questo primo passo, pone condizioni favorevoli ad un percorso unitario di medio periodo. Già in diverse città si stanno definendo iniziative comuni sui temi che hanno caratterizzato lo sciopero. Il sindacalismo di base ha marcato la sua autonomia dal quadro politico e dal sindacato istituzionale. Quello che è nella pratica dello sciopero deve essere, però, una consapevolezza generale ed un’identità da rivendicare con orgoglio. Gli scioperi generali del sindacalismo di base sono, è bene averlo chiaro, una forma d’azione comunicativa. Quello che conta veramente è la lotta quotidiana sui temi che caratterizzano questi stessi scioperi. ● * Coordinatore nazionale CUB Scuola. PAGINA 7 LE LEGGI I PAGINA 8 l provvedimento affida la formazione degli insegnanti alle istituzioni universitarie con un percorso abbastanza farraginoso che, si può così sintetizzare: conseguimento della laurea magistrale (3+2) o diploma accademico di secondo livello; conseguimento della specifica abilitazione all’insegnamento previo superamento di un apposito esame di Stato; iscrizione degli abilitati in Albi regionali specifici; un anno di applicazione presso una scuola, con contratto di inserimento formativo al lavoro. Il decreto disciplina anche, pur non essendo stata conferita una delega a tale fine, le modalità di reclutamento del personale che ha effettuato il percorso. Il decreto legislativo non è però immediatamente operativo; difatti all’articolo 2 è prevista l’emanazione di decreti regolamentari per definire tutti gli ulteriori aspetti oparativi (le classi dei corsi di laurea magistrale e dei corsi accademici di secondo livello; il profilo formativo e professionale del docente; i relativi ambiti disciplinari; le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la possibilità di prevedere per la formazione iniziale dei docenti stage all’estero; la ridefinizione delle classi di abilitazione per l’insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo; ecc. Le innovazioni più rilevanti sono: il numero chiuso per l’ammissione al conseguimento della laurea magistrale o diploma accademico e il contratto di inserimento formativo al lavoro (coloro che conseguono l’abilitazione all’insegnamento sono ammessi a svolgere un anno di applicazione attraverso un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro stipulato con il dirigente scolastico, previa assegnazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale); il reclutamento riservato per il 50% dei posti disponibili per Il decreto sulla formazione per l’accesso all’insegnamento CORRADO MAUCERI Con il Decreto legislativo (n. 227 del 17/10/2005) che ha concluso l’attuazione della Legge n. 53/03, sono state definite «le norme generali in materia di formazione iniziale e permanente dei docenti per il loro accesso all’insegnamento nel sistema educativo di istruzione e formazione» le assunzioni (l’articolo 1 del decreto prevede che per il reclutamento del personale docente rimangono ferme le disposizioni che riservano il 50% dei posti disponibili e vacanti agli aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti; il restante 50% dei posti è utilizzato per i concorsi ai quali potranno partecipare i docenti che hanno seguito il nuovo percorso formativo dei concorsi per titoli ed esami. Il decreto richiederebbe un ampio commento sotto i diversi profili; per il momento possiamo limitarci ad alcune brevi e schematiche considerazioni. In primo luogo, questo decreto rappresenta un ulteriore passo verso il ruolo “professionalizzante” delle istituzioni universitarie sia per l’accesso che per i contenuti; i corsi universitari sono difatti finalizzati non solo ad una specifica attività professionale, ma ad uno specifico insegnamento. In secondo luogo, con buona pace dei principi di autonomia e di pluralismo culturale, la formazione del personale docente nei suoi contenuti culturali è affidata agli indirizzi culturali del Ministro; le Università hanno il compito di dare esecuzione; “il profilo formativo e professionale del docente”, gli “ambiti disciplinari” ecc. (in sostanza la formazione degli insegnanti) sono affidati al Ministro, anziché ad un organismo pluralista ed indipendente. Infine si deve ancora una volta segnalare la disinvoltura con cui il Governo e per esso il Ministro violano la Costituzione per quanto concerne l’esercizio della delega. L’articolo 5 della Legge n. 53/03 difatti aveva delegato il Governo ad emanare un decreto per quanto concerne la formazione degli insegnanti; nessuna delega era stata conferita per quanto concerne il reclutamento; il Governo invece con il decreto detta anche una nuova normativa sul reclutamento che penalizza peraltro il personale precario; difatti mentre oggi i precari possono utilizzare due canali di accesso all’insegnamento; per effetto del decreto avranno a disposizione soltanto il 50% dei posti, con esclusione da ogni possibilità di reclutamento per concorso per titoli ed esami. Infine, visto che il decreto non è immediatamente operativo e dovranno essere emanati gli ulteriori decreti attuativi; diventa obbligatoria una domanda a coloro che pensano che non sia necessario abrogare subito le leggi Moratti; il Ministro del prossimo Governo, finché non ci sarà una nuova legge, darà applicazione anche a questo decreto? ● a n l i e u e s PAGINA 9 [ L’interno della scuola materna di Lunel, nell’Herault, dopo l’incendio appiccato durante la crisi delle banlieues, 15 novembre 2005. ARO 05 b TEMA PAGINA 10 LA CITTÀ PLURALE A CURA DI STEFANO VITALE Stranieri a scuola: una questione di cittadinanza STEFANO VITALE I dati del Ministero sono eloquenti: 360.000 nel 2004, 50.000 dieci anni fa. Oggi 420.000. Poli di attrazione le grandi città, ma anche le province industrializzate. A scuola, in classe, è record di bambini stranieri: 7 su 100. La scuola italiana è una “multinazionale” registrando prima di tutto la presenza di ragazzi provenienti da Albania e Marocco, seguono Romania, Cina, Serbia e Montenegro. Risulta che poco più del 90% frequenta istituti statali, il resto quelle paritarie. E la distribuzione per nazionalità non varia tra le due strade scelte. Circa il 40% frequenta le classi delle elementari È il Nord l’area geografica dove c’è la più alta concentrazione di studenti non italiani, mentre è l’Emilia-Romagna la Regione nella quale si registra la più alta concentrazione nelle classi: l’8,4 %. E ancora Milano il capoluogo di provincia a vantare l’incidenza più alta, con l’11,6 %. In questo quadro, dicono i ricercatori «si conferma però un modello variegato, policentrico, “diffuso”, nel quale i poli di attrazione non sono solo le grandi metropoli , ma anche le città e i piccoli paesi» Una scuola che accoglie? Ma a che punto sono le reali politiche di accoglienza? La scuola è in grado di assorbire l’impatto ed accogliere culturalmente gli studenti non italiani, evitando di cancellare la loro cultura? Quale “pedagogia della cittadinanza interculturale” siamo in grado di proporre oggi? Per parte nostra abbiamo la sensazione che per affrontare con un qualche successo la questione occorra far interagire due livelli: uno di natura più pedagogica che metta a punto delle strategie didattiche e culturali che investano più profondamente la scuola. Dall’altra parte crediamo sia urgente ripensare la presenza degli stranieri a scuola in termini di processi di cittadinanza. E qui il discorso intreccia il culturale con il politico, inevitabilmente. I due aspetti non sono scindibili: o si considerano i bambini straneri come autentici “cittadini” della scuola o la scuola non sarà in grado di produrre novità per favorire la loro accoglienza. Allo stesso modo non basta riconoscere formalmente il diritto di cittadinanza senza modificare, anche profondamente, alcune strutture della scuola stessa. La scuola è un sistema e come tale non può far posto ad una novità senza cambiare. Prendiamo la questione del successo scolastico (d’altra parte si va a scuola per riuscire non per fallire). Per ovviare ai deficit, ad esempio linguistici di partenza, nel sistema scolastico finlandese i figli degli immigrati devono prima passare per un anno di socializzazione linguistica, poi vengono inseriti a pieno titolo nel sistema scolastico. In poco tempo il loro profitto raggiunge un livello pari a quello degli studenti finlandesi. Da noi, invece, il rendimento dei ragazzi stranie- ri è generalmente basso perché non c’è attenzione per la loro specificità. L’insuccesso scolastico è una fonte di esclusione, purtroppo anche dall’acquisizione di una cittadinanza. Certo dire come fanno alcuni che «La vera nuova sfida per l’intercultura, il tema ormai non aggirabile è il successo scolastico come punto chiave per una reale inclusione sociale che favorisca il sorgere di nuove cittadinanze» ci sembra riduttivo. È il diritto all’istruzione che va salvaguardato come fondamentale. Ed è alla luce di questo diritto di scolarità e cittadinanza che occorre leggere, ad esempio certi fenomeni: in Trentino la presenza degli studenti nella scuola superiore è molto bassa (2% del totale) malgrado un aumento del 51% totale degli studenti stranieri; chi prosegue si orienta verso la formazione professionale (4 su 10, i licei coprono il 18%, fonte MIUR, 2003); l’inserimento dello studente straniero non avviene nella classe corrispondente all’età anagrafica e questo finisce per generare un ritardo man mano che si cresce nel livelli scolastici; gli stranieri nella secondaria superiore vengono bocciati molto di più e dal primo anno all’ultimo c’è un divario pauroso: dal 3,24% al primo anno, allo 0,98% al quinto anno, con una variazione percentuale in negativo di oltre il 72%. La ricerca MIUR sugli esiti degli alunni stranieri rivela che il divario fra i tassi di promozione degli allievi stranieri e di quelli italiani è: – 3,36 nella scuola primaria; – 7,06 nella secondaria di I grado; – 12,56 nella secondaria di II grado, in cui più di un alunno straniero su quattro non consegue la promozione. Quindi, l’insuccesso scolastico appare senza dubbio uno degli indicatori della mancata politica di cittadinanza per gli stranieri nella scuola. Che deve diventare però il fulcro di un’azione più vasta nel quadro della promozione di una cittadinanza davvero interculturale affinché agli stranieri non sia solo concessa la titolarità formale di diritti di cittadinanza, ma vengano offerti strumenti concreti per il loro esercizio (e questo riguarda direttamente proprio la scuola). C’è un problema di inclusione che si configura come un problema di uguaglianza per favorire una piena e completa inclusione sociale, garantita da pari opportunità anche con strumenti adeguati per una didattica quotidiana interculturale di qualità. Troppo spesso, in tempi di paura del meticciato, l’intercultura si limita al solidarismo e si finisce per abbassare le aspettative didattiche pensando che questo sia intercultura o inclusione sociale. Ma quale cittadinanza? Leggiamo sul sito della Provincia di Torino che «La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. La legge n. 91 del 5 feb- braio1992 (che ha sostituito la vecchia legge n. 555 del 13 giugno 1912) prevede diversi casi di acquisto della cittadinanza, alcuni automatici al verificarsi di certe condizioni e/o subordinati alla semplice dichiarazione di volontà dell’interessato (per nascita, per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, per adozione, per discendenza, per acquisto o riacquisto da parte del genitore, per nascita e residenza in Italia), altri subordinati al verificarsi di determinate condizioni, alla dichiarazione di volontà e ad una decisione dell’Autorità (per matrimonio, per naturalizzazione, quest’ultimo legato al periodo di residenza in Italia)». Con l’attuale normativa la cittadinanza italiana è difficilissima da ottenere per uno straniero e comunque non risolverebbe il problema che la scuola e le istituzioni della formazione devono prendere in considerazione. I bambini ed i ragazzi stranieri sono “cittadini” della scuola a pari titolo e, attraverso questo status, cittadini della polis intesa come comunità diversificata che riunisce cittadini eguali tra loro in quanto tutti soggetti di diritti. Allora la scuola, per la parte che le compete, deve metterli in grado di esercitarli, altrimenti si svuota ogni idea di intercultura (che esiste in maniera costitutiva in quanto modalità di scambio già connaturata al sistema scolastico stesso). L’inclusione senza assimilazione potrebbe trovare proprio il suo riferimento nella nozione di cittadinanza. Ma ci possono essere due tipi di cittadinanza: da una parte c’è la cittadinanza «difensivista e sottrattiva» (Tarozzi, 2005) che è figlia di una visione ristretta di cittadinanza, che si richiama all’idea di un patrimonio culturale statico e presuppone sul piano educativo di insegnare le regole per la convivenza civile nella convinzione che prima di avere diritti occorre rispettare dei doveri. È una forma di cittadinanza che marca un confine fra chi ha i diritti (solo gli italiani o gli italianizzati) e chi non ha alcun diritto. Così intesa la cittadinanza nasconde un pregiudizio etnocentrico, ha una visione normativa e prescrittivi figlia di una logica essenzialmente assimilazionista. Ma c’è anche un’idea di cittadinanza interculturale che intende garantire “a prescindere” giustizia sociale per i bambini stranieri in quanto tali, intesa come equità e pari opportunità senza discriminazioni comprendendo le differenze al proprio interno quali fattori di sviluppo della convivenza civile. È questa, come detto, una questione politica che trova nella scuola un suo terreno di scontro e di applicazione al di là delle emergenze sociali che troppo spesso vengono strumentalizzate per chiudere la strada nella scuola a processi innovativi reali. ● PAGINA 11 TEMA LA CITTÀ PLURALE Volevano braccia, sono arrivati uomini e donne. E bambini e bambine. MARIA FRIGO * PAGINA 12 Migrazione degli adulti, ricostruzione delle famiglie, ricongiungimenti. Nelle scuole italiane sempre più i bimbi e i ragazzi nati altrove. In dieci anni, dieci volte tanto. Trentamila nel ‘92, quasi quattrocentomila lo scorso anno. Soprattutto al Nord, nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri. Centonovantaquattro le cittadinanze presenti. Non una scuola che deve diventare multiculturale, ma una scuola che lo è già. Multiculturale di fatto G raziella Favaro, pedagogista, guarda da tempo con cura e attenzione cosa sta accadendo a questa generazione in movimento, dentro e fuori le scuole italiane. E individua alcuni punti critici. In primo luogo il rischio di ricevere dagli adulti risposte fin troppo semplici: le scuole separate che mantengono nel tempo la separazione e rendono permanente la diffidenza reciproca. Scorciatoie a senso unico, che non portano da nessuna parte. Via Quaranta insegna. Poi, una realtà che provoca una sorta di localizzazione dei diritti, dove può succedere di tutto e anche il suo contrario. Una scuola accoglie e, nel quartiere vicino, l’altra rifiuta l’iscrizione dell’alunno straniero. Contesti scolastici ricchi di competenze consolidate e progettualità accanto a zone di assoluta negligenza e incuria didattica. Per i bambini e i ragazzi stranieri inseriti nella scuola italiana non ci sono diritti certi, ma piuttosto caso, probabilità, fortuna. Infine, la percezione di un clima sociale di conclamata assuefazione al fenomeno. Una assuefazione, però, in negativo. Gli stranieri non sono più la novità esotica che suscita curiosità e interesse, non sono più lontani, sono qui tra noi. Ma si vive in mondi separati, senza conoscersi e volerlo fare. Riserbo con antipatia, per riprendere Georg Simmel. E questo clima a volte raggela e fa inaridire quello che è sempre stato un punto di forza tra le persone della scuola: una naturale e spontanea disponibilità ad accogliere. Accoglienza, nonostante Cosa è cambiato in questi dieci anni, come è cambiato il modo di accogliere? Quali riferimenti possono trovare gli insegnanti? Vediamo in primo luogo i riferimenti legislativi. A partire dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, è sancito il diritto universale all’istruzione. Un diritto soggettivo del minore, da tutelarsi con norme specifiche. E, in effetti, la legislazione italiana prevede che la scuola sia per tutti, aperta ai bambini e ragazzi, italiani per nascita o comunque presenti sul territorio italiano. Norme precise ordinano che l’inserimento avvenga, tenendo conto dell’età anagrafica, nella scuola dell’obbligo, indipendentemente da cittadinanze o permessi di soggiorno. Si tratta di decreti e circolari del 1998. E poi? Sembra ieri e invece sono passati anni. Gilberto Bettinelli, dirigente scolastico attualmente in prestito all’Università, denuncia con forza un vuoto normativo in merito. Il vuoto normativo che ha lasciato nell’incertezza dirigenti, docenti, famiglie e alunni. Non che il Ministero non faccia niente. Il Ministero fa. Chiede alle scuole dati, monitora progetti, distribuisce soldi. Soldi che per altro, ricorda Bettinelli, sono quelli del contratto. Già comunque destinati alla scuola e accantonati nel contratto a questo scopo. Però, l’ultimo atto normativo vero risale al 1999. Nel frattempo sono aumentati (triplicati) gli alunni e sulla scuola è passato lo tsunami della riforma, la Legge 53. Diversi nodi formali riguardo iscrizione, presenze, percorsi e valutazione, sono stati lasciati irrisolti. Un esempio per tutti: la necessità di certificazione della licenza di scuola media per iscriversi agli ordini superiori di studi. Gli adolescenti, i quattordicenni/sedicenni ricongiunti alle famiglie, quali risposte trovano nelle diverse realtà scolastiche? Si ignorano, come non esistessero, i percorsi scolastici nel paese d’origine, richiedendo comunque di conseguire, prima di iscriversi, la licenza nella scuola media italiana. Oppure, si valutano le competenze in ingresso e si risolve, in regime di sanatoria, il problema formale al momento del diploma finale di scuola superiore. Anche qui, non certezza soggettiva del diritto. Caso, probabilità, fortuna. Eppure le scuole si danno organizzazione e fanno accoglienza, orientamento, interventi compensativi su lingua e contenuti, valorizzano le lingue materne, adottano pratiche e attenzioni interculturali. Una galassia di esperienze e di modelli possibili, se si vuole vederli e riconoscerli. Un lievito per la scuola italiana che, per esempio, era ben visibile nei giorni scorsi a Reggio Emilia, in occasione dell’affollato Convegno Nazionale dei Centri Interculturali. Insieme a operatori dei servizi e degli enti locali, tanti insegnanti, per confrontare esperienze e parlare di questa generazione in movimento. La ricerca di percorsi possibili, a partire da quel volano che negli anni sono stati i Centri interculturali. Luoghi di orientamento e formazione Con Graziella Favaro, Marina Carta è da sempre figura di riferimento di uno tra i più conosciuti Centri interculturali: il Centro COME di Milano. Marina Carta rileva un cambiamento nella richiesta di chi si rivolge al Centro. Se prima si trattava soprattutto di dare informazione alle famiglie sul diritto all’iscrizione nella scuola TEMA LA CITTÀ PLURALE italiana, ora, sempre più spesso, la domanda è di orientamento e di ri-orientamento. In sostanza, dove il figlio può giocarsi al meglio le sue possibilità. Accanto a questa domanda diretta delle famiglie, continua fortissima una richiesta di formazione, da parte soprattutto delle scuole, come del pubblico e del privato sociale. Un aspetto che Marina Carta tiene a sottolineare è la notevole competenza oramai raggiunta dagli operatori del Centro, che sono in grado di leggere i bisogni, non sempre espliciti nella domanda, e restituire informazioni e consigli, ma anche di usare questo osservatorio sulla realtà per raccogliere dati, progettare sul territorio e costruire reti. Una capacità di progettazione e di lavoro in rete che è testimoniata dai documenti, pubblicati autonomamente o con i partner istituzionali e privati, che descrivono progetti, percorsi e risultati. Una esperienza che si vede in altri materiali pubblicati dal Centro, quelli che vanno letteralmente “a ruba” nelle scuole: gli strumenti per la prima accoglienza, per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda, per il lavoro didattico sulle discipline. Anche il mondo editoriale comincia a offrire un ricco repertorio di strumenti specifici. Dieci anni fa c’erano solo pochi testi, in prevalenza per apprendenti adulti. Adesso, testi bilingui e plurilingui, case editrici e collane specializzate, librerie con spazi dedicati. Da un paio d’anni, anche i primi testi a carattere disciplinare pensati per bambini e ragazzi che nella scuola italiana apprendono la lingua ma, contemporaneamente, devono imparare matematica, storia, geografia, come tutte le altre materie scolastiche. E quindi la necessità di avere chiavi di accesso alle discipline. Materiali che servono a costruire ponti, zone di comunicazione tra i bambini ed i ragazzi appena arrivati e gli altri che a scuola ci stanno già. I diritti dei cittadini di domani Analisi, norme, progetti e percorsi, materiali. Ecco modi concreti per attuare il diritto a imparare dei bambini e ragazzi che frequentano le scuole italiane, nati qui o altrove. Un diritto che non può essere una pura enunciazione, che diventa il compito quotidiano per gli insegnanti. Come è l’urgenza quotidiana dei bambini e ragazzi di oggi, dei cittadini che dovranno aver cura di questo paese domani. Una questione di cittadinanza e di condizioni da costruire, perché il diritto a imparare si realizzi. Non solo braccia, ma persone. ● * Insegnante e formatrice. Collabora con il Centro Come di Milano. Come in uno specchio… MARISA NOTARNICOLA Mutazione delle forme d’accoglienza nella scuola media. Gli “stranieri” prima erano i meridionali del “nostro Sud”, oggi vengono da un “altro Sud” ed il quadro culturale e politico è profondamente mutato. Guardare al passato per capire e per ritrovare valori, guardare al presente come in uno specchio per nuove lotte di cittadinanza A rrivata nella scuola in cui lavoro (scuola media della periferia Nord di Torino) a metà degli anni ’70, la presenza di allievi nelle classi era in prevalenza di meridionali, figli degli immigrati di seconda generazione. La struttura più rispondente ai bisogni culturali di quel tipo di popolazione scolastica fu il Tempo Pieno che coesisteva, nello stesso edificio con il Tempo Normale dal quale si differenziava profondamente sia rispetto a contenuti e a metodologie, sia rispetto ad approcci relazionali. Fu quella una stagione caratterizzata da un forte spirito di rinnovamento che aveva investito la scuola già da alcuni anni prima, in cui convergevano la motivazione da parte dei docenti al cambiamento e allo svecchiamento di un ambiente permeato dal formalismo burocratico delle circolari, la lezione di grandi pedagogisti (don Milani prima e poi Tamagnini, Ciari, Rodari ed altri ancora), il fermento culturale di molte riviste pedagogiche (Riforma della scuola, Paideia, per citarne solo alcune), l’accoglimento di istanze democratiche da parte delle istituzioni con i Decreti delegati (1974), i nuovi programmi (1979), l’abolizione delle classi differenziali e l’individualizzazione dei percorsi formativi. PAGINA L’accoglienza ieri L’accoglienza, nella nostra scuola, degli allievi dell’ultimo anno di elementari, per rendere più agevole il passaggio alle medie, prevedeva una collaborazione molto stretta tra i due ordini di scuola. Nei colloqui che si organizzavano con le maestre passavano informazioni che non trovavano spazio nella pagella, utili però a fornire un quadro complessivo di ognuno di loro in rapporto a difficoltà scolastiche e relazionali e a livelli raggiunti. L’accoglienza passava anche attraverso un rapporto più stretto con le famiglie e il colloquio con loro, che avveniva poco prima dell’inizio dell’anno scolastico, andava ben al di là dell’atto burocratico delle iscrizioni. C’era la volontà comune di sviluppare insieme un percorso collaborativo di educazione, non solo da parte di quelle più sensibili ed acculturate che credevano nella scuola pubblica come palestra di democrazia e come uno dei luoghi, il più importante, entro cui lavorare per l’integrazione sociale di tutti. Anche i genitori che rappresentavano la fascia più disagiata e debole intravedevano nella scuola la possibilità di riscatto e di promozione sociale. Accogliente, per certi versi, poteva considerarsi perfino la struttura edilizia di quei brutti prefabbricati dell’epoca sorti alla veloce per soddisfare la domanda di un’utenza numericamente cresciuta che prevedevano spazi di laboratorio seppure non ampi. Il tempo pieno era, con le numerose compresenze e una struttura per laboratori, 13 TEMA LA CITTÀ PLURALE un esempio di scuola attiva che, attraverso il “fare scuola” e la possibilità di concrete esperienze, cercava di dare una risposta ai bisogni degli allievi, specie quelli più disperati che, sul quotidiano, ponevano seri problemi di adattamento e di accettazione di regole condivise. L’accoglienza ad inizio d’anno, nelle classi, era affidata ai singoli docenti che si adoperavano con attività di vario tipo di favorire i rapporti di conoscenza, ma stava soprattutto nello spirito con cui essi lavoravano con loro per integrarli nel gruppo e per accorciare le distanze tra livelli culturalmente diversi, nonostante le difficoltà e soprattutto la persistente sordità dei governi, succedutisi nel tempo, per supportare e consolidare il tempo pieno onde evitare la deriva di una ghettizzazione già incombente. L’accoglienza oggi PAGINA 14 Si fa accoglienza oggi in un quadro politico, sociale, culturale completamente mutato: c’è la scuola “riformata” dalla destra al governo mirante a spingere più avanti una cultura aziendalistica partita negli anni ’80, con molte ambiguità, in vari ambiti, anche sindacali, e ci sono una mentalità individualistica più marcata ed una perdita di senso civico più diffuso. Mutato è anche l’atteggiamento dei docenti non solo per età e stanchezze personali, ma per la difficoltà di lavorare in una scuola che va avanti all’insegna dei tagli – agli organici, all’orario degli allievi, alle ore delle materie di insegnamento, alle risorse del fondo di istituto –, a fronte di una realtà divenuta più complessa anche per la presenza di nomadi e stranieri che nel corso del tempo è numericamente cresciuta. D’altra parte si è diventati più esperti in fatto di accoglienza: i laboratori-ponte rivolti dalla media alle elementari basati sulla conoscenza dei luoghi della futura scuola, su attività accattivanti rende i passaggi meno dolorosi e più amichevoli; così come sono il segno di un’attenzione affettuosa verso chi inizia un nuovo precorso, l’incontro tra gli allievi in uscita dalle medie e quelli in entrata, quasi una sorta “di passaggio del testimone” in cui i più grandi tranquillizzano i più piccoli raccontando loro storie ed esperienze, mettendoli in guardia rispetto ai rischi o la semplice offerta di una merenda, nell’intervallo, da parte di chi è già nella scuola ai cosiddetti “primini”. L’accoglienza si prepara anche nei colloqui con le maestre con le quali i rapporti sono rimasti collaborativi e non solo per i passaggi di informazione su ogni allievo, ma anche per un lavoro cooperativo onde conoscere la situazione di partenza di ciascuno di loro e lavorare ad una pro- spettiva di aggregazione, in rete di scuole, per sostenere i minori stranieri arrivati nel corso dell’anno, ma non accolti per ragioni di capienza della scuola, nel loro precorso di iscrizione e di inserimento in quella che invece può farsene carico. Le famiglie Più complesso è diventato il rapporto con i genitori, meno disposti a capire le problematiche di una classe in cui devono convivere con i loro figli compagni provenienti da diverse parti del mondo. La richiesta è che il servizio scuola sia efficiente e produttivo, al bando tempi lenti di assimilazione o rallentamenti nello sviluppo del piano di lavoro, quando occorre, dovendo salvare il salvabile, come usano dire. Accanto a questo tipo di famiglie si collocano quelle di nomadi e stranieri che iscrivono i figli ad anno inoltrato. Si tratta della fascia più debole: non è infrequente il caso che siano affidati ad un solo genitore o a parenti o a presunti tali. Il problema della lingua è cruciale, a cominciare dall’atto di iscrizione per il quale si ricorre spesso agli allievi stranieri della stessa etnia ormai inseriti nella scuola che fanno da tramite, nella traduzione della lingua di origine a quelli appena arrivati. Ad iscrizione avvenuta, entrano nel gruppo degli alfabetizzandi, ma il cammino dell’apprendimento della lingua del posto è lungo e, in assenza di mediatori culturali che supportino il loro inserimento, tutto è più complicato, a partire da quella modulistica (solo in italiano) per usufruire dei servizi che la scuola offre (mensa, buoni-libro, visita medica agli ambulatori di medicina sportiva ed altro ancora) o semplicemente per comunicazioni alla famiglia (uscite didattiche, offerte di attività extra-scolastiche, ecc.). I minori stranieri che arrivano privi di documentazione anagrafica o semplicemente con documentazione incompleta, vengono accettati con riserva, ma si cercano tutte le vie per aiutarli a procurarsela, onde evitare che, affidati dall’assistente sociale di zona al tribunale dei minori e da questi spostati in comunitàalloggio dove il radicamento è difficile per ragioni varie, perdano i contatti con la scuola in cui si erano inseriti, vissuta come luogo di riferimento e di costruzione di legami affettivi. ● TEMA LA CITTÀ PLURALE Per voi, ragazzi, chi è diverso? LUISA RESTIVO * Anno scolastico 2001-2002. Settembre. Sono neoarrivata nell’Istituto “Don Milani” (comprende liceo, ITC, IPIA), a Montichiari, Bassa bresciana. Riunione del dipartimento di discipline umanistiche; la coordinatrice delinea la programmazione e le questioni aperte: «…E un nuovo problema che sembra emergere da quest’anno è quello di alcuni alunni neoiscritti di cittadinanza non italiana che non parlano la nostra lingua o che la conoscono molto poco… un attimo… mi dicono che da quest’anno c’è un’esperta. Va bene, allora deleghiamo a lei la questione» D opo due giorni dall’ingresso nel nuovo istituto, in quanto proveniente da esperienze didattiche con alunni stranieri adulti di un CTP, sono stata inaspettatamente additata come colei che «ne sa qualcosa». Risultato: sono responsabile del Progetto Stranieri: 9 alunni, 4 diversi livelli di competenza, 3 ore settimanali di laboratorio italiano L2 in orario curricolare, aula soprannominata “Grande fratello”, poiché la parete divisoria dal corridoio è una vetrata. Era una sistemazione non favorevole alla concentrazione ma involontariamente funzionale alla socializzazione: i compagni italiani che passavano nel corridoio per la passeggiatina a metà lezione si prodigavano in saluti e salamelecchi di altro genere. In un contesto meno inusuale non si sarebbero accorti di loro. Parte il laboratorio, a poco a poco ci si conosce. Alfabetizzazione e storie di vita Dalla Liberia: sono due fratelli neoarrivati, Jemama e Jeffrey: attenti, partecipi, interessati; come mai lui impara subito, ha una buona pronuncia, in 4 mesi viene inserito in classe e riesce ad accedere velocemente ai nostri densi e complessi testi di studio mentre lei ha tempi così lunghi? Indaghiamo un po’: abitavano al confine con la Costa d’Avorio (ex colonia francese), genitori emigrati, fin da piccolo lui va dai nonni, oltre confine, a scuola impara bene il francese, lei resta con gli zii in Liberia, frequenta poco la scuola. E così si impara che ricostruire la storia, scolastica e non, di questi ragazzi non è una variabile opzionale, ma un dovere inderogabile, perché aiuta noi, insegnanti italiani, spesso figli o nipoti di emigrati italiani (in un’Italia che, forse, fatica, perché non ricorda, a concepire quali e quante implicazioni la scelta dell’esperienza migratoria possa avere su tutti i componenti di una famiglia e sul destino dei figli), a far rientrare in un contesto di sensatezza e di coerenza atteggiamenti e comportamenti di questi studenti che spesso non riusciamo a considerare sensati, o che comunque non rientrano nella nostre logiche giustificative. Rupinder, indiana,carattere dolce, pacata, da subito pronuncia italiana quasi perfetta, sempre sorridente, curiosa, chiede, si informa, ma fa fatica; si parla di religione, porta un opuscolo sulla sua, la religione Sik, e racconta, in inglese, con pochissimo italiano. È felice, io non so niente, è lei che mi informa, insiste, vuole che lo porti a casa, che lo legga con calma. Gli anni successivi sarà la nostra in- terprete ufficiale ad ogni arrivo, ad anno inoltrato, di studenti indiani. E intanto emerge che a fianco della necessità prioritaria di conoscere e capire la lingua esiste in loro il bisogno ineludibile di parlare di sé, del proprio mondo, di essere ascoltati, di comunicare quel poco che riescono, di raccontare quei frammenti di vita frantumati, dispersi dall’esperienza migratoria, brandelli da ricucire alla stoffa appena iniziata: la nuova vita in Italia.Ma gli spazi e i tempi della classe non concedono questa possibilità, giustamente ci sono altre urgenze. Il laboratorio di italiano L2 diventa così uno spazio un po’ più a misura di ragazzo-immigrato, in cui comprendere che la propria esperienza, a volte così unica e sconvolgente, può essere capita e condivisa da altri. Finisce l’anno. Salif, 16 anni, ricongiunto al padre: «Ciao profe, buone vacanze, grazie per quest’anno». «E tu Salif, vai in vacanza quest’estate?». «Sì, ma non in Costa d’Avorio; mia mamma mi ha detto: non devi tornare per vent’anni. È dura profe». Si entra nella sofferta vita di questi ragazzi più di quanto si possa immaginare. 30 ore alla settimana in classe ad ascoltare 10-12 insegnanti che parlano («tanto, ininterrottamente, velocemente, difficile»), capendo ora l’1%, ora il 10, ora il 30%, spesso e inevitabilmente senza essere mai interpellati perché non in grado di capire nemmeno la domanda, rendono la figura del docente alfabetizzatore/ facilitatore punto di riferimento, rendono le ore di laboratorio momenti di serenità, perché durante questi i ragazzi percepiscono se stessi come esistenti e non anonimi, non invisibili, in una giornata scolastica facilmente votata alla delusione e alla demotivazione, a cui si aggiunge il quotidiano struggimento per l’assenza, in un momento in cui il conforto potrebbe alleviare la fatica, dei propri cari. PAGINA 15 TEMA LA CITTÀ PLURALE Cosa non ha funzionato? Cos’è l’intercultura? PAGINA 16 Anni scolastici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005: triplicato il numero di studenti neoiscritti non italofoni, il 50% già in Italia da 4-5 anni. Almeno questi dovrebbero camminare con le proprie gambe. I mesi di settembre e ottobre sono sempre ricchi di sorprese: «Guarda che ne ho in classe tre che non dicono neanche buongiorno e ne è arrivato un altro, non vorrai metterlo nella mia classe?». «Ma come faccio a far lezione se me li porti via!». «Parlare con i compagni parla, ma poi non studia niente». I problemi si accavallano, si fa fatica a far fronte all’emergenza e contemporaneamente organizzare in modo sistematico un piano di accoglienza, un protocollo completo, organico, provato, condiviso. Tutto viene costruito correndo e cercando di scavalcare l’ondata degli arrivi, di prevenire: dunque vediamo l’orario, quando hanno l’ora in cui gli altri fanno religione? Chi sa già l’inglese potrebbe uscire nelle ore di lingua straniera. Tanti propositi ma non si riesce a conciliare l’orario dei docenti alfabetizzatori con quello dei ragazzi, la scuola si è ingrandita, sono nati tre nuovi indirizzi di liceo, si supera il migliaio di alunni, con classi all’IPIA in cui gli stranieri raggiungono 50%. Docenti, plurale, perché nel frattempo è nata una equipe disponibile a dedicare alcune ore settimanali alla prima alfabetizzazione e all’apprendimento del livello intermedio. Siamo insegnanti di italiano, lingua, preziosissimi per le competenze glottodidattiche in lingua straniera, di diritto, matematica; si utilizzano ore di codocenza, ore a disposizione, ore eccedenti grazie al fondo d’Istituto, ci si divide il lavoro: test d’ingresso, formazione di gruppi omogenei per classe e per competenze, due-tre ore settimanali per gruppo, se si riesce anche quattro-sei per i neoarrivati. Buone pratiche Il coordinatore gestisce i nuovi arrivi, i colloqui con genitori, mediatori culturali; si stende un progetto in convenzione con i vicini CTP e CFP. Il dictat è: “sfruttare le risorse di rete”, arrivano i finanziamenti dalla Regione: bene, corso di formazione sulle Buone pratiche per l’integrazione degli alunni stranieri, viene coinvolto anche il personale ATA; attività di passerelle, primissima alfabetizzazione a cura dei docenti del vicino CTP, nascita di una biblioteca interna all’Istituto: libri di formazione, manuali, vocabolari illustrati, bilingue, giochi linguistici, materiale multimediale. Forse si comincia a ragionare. Ma a fine anno il monitoraggio non risulta positivo: è vero, imparano a comunicare, quello che si dice l’italiano funzionale, ma il salto dall’italiano quotidiano ai linguaggi dello studio è enorme, molti vengono respinti. Cosa non ha funzionato? Se ne discute, si ragiona, si elabora, ci si confronta con chi (in scuole del milanese), ha affrontato la questione con anni d’anticipo: è la delega del problema all’alfabetizzatore che non basta. È vero, l’équipe è indispensabile, risolve i problemi di prima accoglienza e favorisce la competenza comunicativa, ma poi occorre l’intervento dell’intero consiglio di classe, e lo sforzo collettivo di tutti i componenti della scuola e ci vuole tempo perché questa esigenza sia percepita, condivisa e diventi parte del sistema scuola nel suo complesso. Ci rifacciamo alla normativa: DPR 394 agosto 1999, adattamento dei programmi: si approva in collegio docenti, ma poi come gestire gli alunni stranieri durante le lezioni in classe? Nasce la collaborazione tra docente facilitatore e disciplinare: si adatta il programma, si facilita il testo, lo si semplifica: nasce il laboratorio di italiano L2 per studiare. È una strada, faticosa, si diffonde lentamente, a macchia d’olio, con molte battute d’arresto; non è l’unica, forse nemmeno la più facile da percorrere, ma laddove più docenti, collaborando tra loro, rimettono in discussione consolidate modalità di impostazione del lavoro didattico, e con esse se stessi, i miglioramenti si notano. Il punto d’arrivo dovrebbe essere la convinzione da parte di tutti che “Ogni insegnante è anche insegnante di lingua”. Questo tratto di percorso è però appena iniziato. Ma a questo punto la riflessione non può soffermarsi solo sull’aspetto linguistico, perché sfiora quello più generale del fare intercultura, che non vuol dire parlare di diverse culture o favorire la convivenza tra esse, quella è la multiculturalità, bensì portare l’attenzione su comportamenti, atteggiamenti che privilegino la visione dei diversi punti di vista, favoriscano l’attenzione per il diverso e che mirino ad un decentramento del proprio operato. Questo vale per tutti, docenti, non docenti, alunni, italiani e stranieri. Perché, gli alunni italiani, con in classe 10-12 compagni stranieri, non saranno avvantaggiati se imparano a decentrare se stessi, a riflettere sul diverso, a percepire diversificati punti di vista? «Ragazzi, ma per voi chi è il diverso?». «Il diverso, profe, è lo sfigato del gruppo». Bene, bisognerà partire col Progetto Intercultura, e si comincerà parlando non del compagno di banco straniero, ma dello sfigato italiano. ● * Insegnante, Montichiari (Brescia). TEMA La formazione civica degli stranieri e degli italiani FRANCESCO CIAFALONI * Non c’è bisogno di parlare la stessa lingua, o di avere la stessa tradizione giuridica o la stessa religione tradizionale per essere universali. Basta accettare il nucleo comune delle regole della convivenza civile C hi abbia finito le secondarie più di mezzo secolo fa, soprattutto se le aveva frequentate in un liceo di provincia, non ha ricevuto a scuola una formazione civica in senso proprio, fondata sulla Costituzione, in vigore da alcuni anni. Ha però ricevuto una formazione, di eredità gentiliana e crociana, fondata sulla letteratura e la storia, certo implicitamente nazionalistica, certo coronata dall’ora di religione, ma non necessariamente spregevole. L’ora di religione, del resto, non significava molto e non aggiungeva nulla all’importanza dei preti nei paesi e nelle piccole città. Il libro di storia poteva essere buono, come quello di Giorgio Spini, che è capitato a me, o poteva essere cattivo, ma il peso maggiore era quello della letteratura: i testi di una lingua sconosciuta ai più, da cui si apprendevano insieme le parole indispensabili alla comunicazione esterna, l’unico elemento su cui prima della industrializzazione complessiva si fondasse l’unità del paese, e i versi, le idee, dei grandi che avevano illustrato la patria, come si diceva. I sepolcri, per citare un esempio davvero alto di formazione civica e repubblicana. Ma anche i classici latini e greci, il Trecento, il Rinascimento, il Risorgimento. Col tempo, e con scelte personali, alla tradizione trecentesca, rinascimentale e risorgimentale, qualcuno aggiungeva l’Illuminismo, il movimento operaio e la Resistenza, finita solo pochi anni prima, e perciò anche vissuta, ma sostan- LA CITTÀ PLURALE zialmente esterna a molte scuole, come la Costituzione, fino agli anni Settanta. Era come cambiare l’ultimo capitolo a un percorso che fino a dieci anni prima era utilizzato per approdare a ben altro. La Resistenza, la Costituzione, lo sterminio degli ebrei sono entrati visibilmente e universalmente nelle scuole con gli anni ’70. Allora è sembrato a molti di noi che, sulla base di un comune terreno di diritti e doveri condivisi, quelli dichiarati nella Carta dell’Onu e nella Costituzione della Repubblica, malgrado la divisione del mondo in due blocchi e il dominio militare delle due grandi potenze, ci si potesse aprire all’Europa ed al mondo, accogliere, riscoprire le differenze, imparare il difficile cammino della reciproca comprensione tra tradizioni culturali diverse. Viene da ridere a dirlo oggi, ma l’universalismo, come fine, non come risultato già raggiunto, ci è sembrato scontato. Non l’universalismo per fede, magari addirittura confessionale, ma l’universalismo come ricerca di una base condivisa di diritti e doveri nella diversità delle espressioni. Testi molto diversi, come quelli di Habermas, o di Luigi Ferrajoli, o come Il diritto mite di Zagrebelsky, o Il materiale e l’immaginario di Ceserani e De Federicis, ci sono sembrati far parte di uno stesso cammino, universalistico e multiculturale. Termini che a me continuano a sembrare necessari e complementari, per nulla contraddittori. L’emergenza Costituzione Non c’è bisogno di parlare la stessa lingua, o di avere la stessa tradizione giuridica o la stessa religione tradizionale per essere universali. Basta accettare il nucleo comune delle regole della convivenza civile e il fatto materiale che in un mondo limitato chi è molto in alto deve un po’ scendere e chi è stato tenuto o è rimasto in basso deve un po’ salire. Non sono il solo ad avere pensato che la capacità tecnica delle due grandi potenze di uccidere tutto il genere umano ponesse un limite invalicabile all’uso della potenza militare e dello sterminio per reggere il mondo. Non sono neppure il solo ad aver pensato che il disfarsi dell’Unione sovietica fosse una vera liberazione e aprisse nuove possibilità alla pace. Non è andata così. Per limitarci all’Italia, che vediamo e conosciamo di più, ciò che avevamo dato per scontato, cioè la Costituzione, i diritti e i doveri condivisi, in particolare i diritti del lavoro e l’accettazione del lavoratore straniero, l’apertura al mondo, si sono semplicemente disfatti. La Costituzione ha smesso di essere un patto condiviso ed è diventato un luogo di con- flitto, anche più di quanto le due successive bordate di emendamenti, della riforma del Titolo V e della devoluzione, non comportino. È che la maggioranza che oggi ci governa è fuori dalle diverse culture politiche che la Costituzione l’hanno prodotta e che l’opposizione non sembra davvero tutta convinta di dover vincere in nome dei principi e non in deroga ad essi. Coi diritti del lavoro siamo tornati, con molti più agi per i vecchi residenti, alla situazione di un secolo fa. I nuovi residenti, i non cittadini italiani, non possono neppure sperare ragionevolmente nel diritto di voto a breve. E non c’è una nuova ondata di produttività crescente alle porte che faccia galleggiare tutti. Il movimento operaio è diventato una associazione di pensionati e di pubblici dipendenti, categorie rispettabilissime, di cui però quelli che fanno i buchi per terra, costruiscono le case e badano i malati non fanno parte di fatto e per legge. Costruire un confronto, un rapporto, una ricerca dei punti condivisi nella accettazione della diversità, dei vecchi residenti e dei nuovi, è resa difficile non dalla intollerabilità dei costumi dei nuovi, che, quando c’è, sembra delimitabile e affrontabile, ma dalla caduta del patto di convivenza tra i vecchi residenti e dalla loro paura. Conflitti sociali, divisioni culturali Sono riemersi gli aspetti peggiori della storia del paese che rischiano di rendere legittima una tesi parentetica della democrazia. Risiamo all’eterno «Se il tempo brontola/ finiam di empire il sacco./ Poi venga anche il diluvio,/ sarà quel che sarà.» (Carducci). O se si preferisce, all’ancora più antico «Io so io e voi nun zete un cazzo,/ sori vassali buggiaroni, e zitto./ Io fo dritto lo storto e storto er dritto:/ pozzo vénneve a tutti un tant’er mazzo:/ ché la vita e la robba Io ve l’affitto.» (Belli). Se è difficile il rapporto culturale con gli stranieri è anche perché è crollato il consenso civile degli italiani. La scuola si è disgregata, con qualche eccezione, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto rendere più esplicito un nucleo comune, non puramente tecnico e non esclusivamente letterario perché molti dei nuovi allievi non lo condividono. E del resto la formazione tecnica e scientifica viene rifiutata dai più perché non sembra, almeno nei sui settori più astratti, neppure un buon passaporto per il lavoro. La cosa più distruttiva mi sembra la esplosione di clericalismo, al governo, ma anche all’opposizione, che rischia di scardinare davvero la convivenza laica e civile. PAGINA 17 TEMA PAGINA 18 Non si tratta solo di atei clericali, o devoti, come si dice ironizzando, e di riscoperte di adolescenze cattoliche e di ricerche di dio, ma di cessioni al clero di risorse e prerogative, che sbilanciano ancora di più la gestione dell’assistenza verso chi può usare l’otto per mille quando gli enti locali hanno rinunciato all’intervento diretto e non hanno fondi per finanziare il terzo settore. Non è molto sensato preoccuparsi del fondamentalismo eventuale degli altri quando ministri e presidenti del senato chiedono esplicitamente l’approvazione di vescovi e papi. Stiamo rifacendo all’incontrario il cammino iniziato da Lamennais quasi due secoli fa. Cosa si può fare? Intanto non stare zitti, come se tutto fosse normale. Poi continuare quando e dove è possibile la ricerca del confronto e la conoscenza reciproca. Il lungo periodo e l’economia politica, ora sostituita da una sorta di oroscopo sull’andamento del Pil, non sono state due mode ora finite. Sono la base di ogni comprensione generale del mondo e di ogni formazione, insieme al rapporto tra diritti e doveri, tra produzione e consumo, tra importazioni ed esportazioni. Studiare anche la storia e le lingue, naturalmente. Ma è stato già detto. Alla convivenza però arriveremo, o arriveranno, con molti più sconquassi e tragedie di quanto non avessimo messo in conto. A chi ha tutto non piace scendere, neppure poco. E chi non ha nulla vorrebbe rovesciare il tavolo. ● * Presidente del Comitato “Oltre il razzismo”, Torino. LA CITTÀ PLURALE Dossier Caritas 2005. Trentacinque anni d’immigrazione in Italia: una politica a metà del guado Il 27 ottobre a Roma è stato presentato il dossier Statistico Immigrazione 2005 realizzato come ogni anno a cura della Caritas. Già il titolo è eloquente: al di là dei dati che confermano l’allargamento del fenomeno, qui esprime la preoccupazione per una politica che «non ha il coraggio di andare decisamente avanti». È vero che il rapporto insiste sul significato economico della presenza degli stranieri in Italia, aspetto per altro da non sottovalutare, ma è anche vero che il dossier sottolinea l’idea che «gli immigrati sono anche i nuovi cittadini e per loro serve un progetto più deciso di integrazione che, banditi definitivamente xenofobia e razzismo, rimedi alle vessazioni di tipo burocratico, elimini le disparità, finanzi le attività di supporto all’integrazione, riveda l’antiquata normativa sulla cittadinanza e faciliti la partecipazione degli immigrati tramite il diritto di voto amministrativo». Fini, Bossi ed il Berlusca saranno d’accordo? Il dossier ricorda anche l’importanza di una politica comunitaria più coordinata non tanto nelle soluzioni restrittive e preconfezionate quanto nella ricerca di domande specifiche e concrete (facendo riferimento al Libro Verde sull’immigrazione uscito l’11 gennaio 2005), ma la cosa più interessante è proprio l’aspetto statistico che parte dal 1970 ad oggi e che fornisce un quadro veramente esaustivo delle diverse “ondate d’immigrazione” e delle “politiche” adottate e dei contesti storici e culturali che abbiamo attraversato. Alla fine del 1970 i cittadini stranieri erano 143.838 e solo nel 1979 vengono sperate le 200.000 unità. Nel 1980 abbiamo un’impennata passando a 298.749. Poi negli anni ’80 gli incrementi sono contenuti ad una percentuale del 10% di media ogni anni sino ad arrivare ne 1987 a 572.103 soggiornanti. Ciò fu legato alla prima regolarizzazione voluta dalla legislazione. Da qui in avanti la gestione amministrativa degli stranieri in Italia diviene più complessa e laboriosa ed i dati sono poco attendibili: è un periodo di confusione. Solo nel 1998 il Ministero degli Interni riesce a riorganizzarsi e dal 1991 la riflessione sui dai può essere proficua. Negli anni ’90 c’è il raddoppiarsi dei soggiornanti: si passa dai 649.000 del 191 a 1.341.000 nel 2000. Le guerre nei Balcani hanno un ruolo importante. Dal 2001 il ritmo diviene incalzante e sostenuto sino ai 2.319.000 del 2004. Questi dati, avverte il dossier, riguardano gli immigrati adulti e non considerano l’oltre mezzo milione di minori presenti sul territorio. Davvero la questione della cittadinanza come strumento-obiettivo per la convivenza non è più rinviabile. [S.V.] Per informazioni ci si può rivolgere a Redazione Dossier Statistico Immigrazione, tel./ fax 06.54192252; Caritas Italiana, tel. 06.54192226-7; Caritas di Roma, tel. 06.69886417; Fondazione Migrantes, tel. 06.66398452. Il dossier può essere richiesto alla Caritas, viale F. Baldelli, 41 00146 Roma. educazione società Srebrenica 10 anni dopo. Impossibile dimenticare CELESTE GROSSI A Srebrenica – città con lo status di Area di Sicurezza sancito dall’ONU – nel luglio 1995, oltre 8.000 uomini bosniaci musulmani, ma anche bambine, bambini e donne, furono uccisi dall’esercito della Repubblica Srpska, con il sostegno del regime di Slobodan Milosevic. Insieme a loro morì una parte della nostra umanità. Non lasciamo che l’anno scolastico finisca senza ricordare uno dei genocidi del secolo breve ▼ «L’Europa nasce o muore a Sarajevo», diceva Alex Langer nel giugno del 1995. Pochi giorni dopo il 3 luglio Alex, l’instancabile costruttore di ponti, si tolse la vita sulle colline toscane, impiccandosi a un albicocco, perché «i pesi» gli erano «divenuti insostenibili»ı. Pochi giorni dopo, l’11 luglio, l’Europa, l’Onu e l’intera comunità internazionale morirono a Srebrenica. L’11 luglio 1995 è il giorno in cui l’armata serbo bosniaca entrò in Srebrenica. Dall’11 al 20 luglio seguirono stupri, mutilazioni, esecuzioni di civili, sepolture di vivi. Il massacro di oltre 8.000 civili di quella metà di luglio è solo l’epilogo di una storia iniziata tre anni prima, una storia di assedio. Nel corso dei mesi che hanno preceduto la caduta di Srebrenica, sperando di trovare lì salvezza, numerose persone dei villaggi vicini arrivano nella cittadina, che ha visto crescere i suoi abitanti da quattromila a quarantamila, trasformandosi in un vero e proprio campo di concentramento. Dopo il massacro di Srebrenica, all’inizio di agosto del 1995, l’esercito croato bombardò la Krajna; 250.000 serbi fuggirono dalla Croazia. Nei dieci anni trascorsi da allora il mondo intero si è balcanizzato. Le stragi e le vittime delle stragi sono aumentate; si sono moltiplicati gli attentati suicidi, le azioni terroristiche, le guerre, le invasioni, le occupazioni. Guerre e ter- PAGINA rorismo parlano lo stesso linguaggio: un linguaggio di morte sia che a parlarlo siano persone vestite di stracci, in divisa, o in doppiopetto. «Avremmo potuto fare qualcosa con il nostro impegno civile nelle strade e nelle piazze di quest’Europa assente o tristemente presente, per cambiare il corso degli avvenimenti?»2, si chiede e ci chiede Melita Richter. È una domanda che resta senza risposta, ma certo «quello che possiamo fare oggi è di non permettere di rimuovere una guerra con un’altra, non concedere che sempre una guerra stenda il velo su quella precedente, annulli e sospinga all’oblio i lutti, le sofferenze, i soprusi»3. E non stendiamo veli nemmeno su chi dall’interno della Serbia ha resistito alla guerra e resiste ancora. L’altra Jugoslavia Ci sono donne e uomini che hanno reagito in modo non violento ai veleni del nazionalismo e del militarismo che si insinuavano nei cuori e nelle menti anche di persone insospettabili, di cittadine e cittadini che non hanno condiviso le scelte degli uomini al potere (del regime, dell’esercito, della polizia, della propaganda). Sono donne e uomini scesi in piazza, obiettori e disertori e chi li ha sostenuti, donne e uomini che hanno rifiutato di sentirsi ne- mici di altre donne e di altri uomini di un’altra nazionalità. La loro esperienza e i loro saperi e le loro pratiche di resistenza nonviolenta assolutamente originali possono accompagnarci nella comprensione del presente dopo guerra che la comunità internazionale ha imposto come pace armata e farci guardare alle prospettive future di liberazione della ex Jugoslavia dal nazionalismo e dall’odio. Queste donne e questi uomini hanno sperato che, in Serbia, dopo la caduta del regime dittatoriale, nell’ottobre 2000, ci sarebbe stata una rottura con la politica criminale del regime di Milosevic. Ma proprio allora iniziava la negazione istituzionalizzata dei crimini. Negazione che continua ancora oggi, anche se un video proiettato al Tribunale internazionale dell’Aja nella scorsa primavera mostri inequivocabilmente soldati serbi che umiliano, spintono, ingiuriano, sputano addosso, prendono a calci le vittime; trasferiscono cadaveri (come se così potessero ingannare la storia, l’opinione pubblica internazionale e le famiglie delle vittime). A dieci anni dal genocidio il Parlamento serbo non riesce ad adottare una risoluzione sul massacro di Srebrenica e continua a negare i crimini commessi e non esprimere esplicite condanne per gli organizzatori, i comandanti, gli esecutori del genocidio. Ma non c’è ricon- 19 PAGINA 20 ciliazione e pace senza verità e giustizia. E per vedere una striscia di futuro è indispensabile svelare i crimini, condannarli e guardare in faccia le responsabilità. Da quelle di chi ha realmente premuto il grilletto, a quelle di chi ha dato l’ordine di farlo, a quelle di chi ha sostenuto i responsabili, a quelle di chi ha accettato un regime criminale come partner per concludere la pace, come nel caso degli accordi di Dayton sottoscritti solo qualche mese dopo Srebrenica dalle tre parti in conflitto (serbi, bosniaci musulmani e croati) e firmati da Milosevic e Karadzic, salutati da Bill Clinton come «costruttori di pace». Cronaca di un massacro L’11 luglio 1995, dopo anni di assedio, i militari della Repubblica Srpska, sotto il comando di Ratko Mladic, occuparono la città di Srebrebnica, abbandonata la notte precedente dai soldati dell’esercito della Bosnia Erzegovina, sotto il comando di Naser Oric. Garantendo loro la sicurezza, Mladic ordinò ai residenti e ai rifugiati di lasciare la città e dirigersi verso il territorio sotto il controllo della Federazione di Bosnia Erzegovina. All’uscita dalla città gli uomini furono separati dalle donne e dai bambini. In quello stesso giorno e nei giorni successivi, gli uomini furono giustiziati in varie località. Una parte dei cadaveri fu in seguito spostata nelle cosiddette “fosse secondarie”, molti corpi furono successivamente smembrati e dispersi in varie fosse per rendere impossibile l’identificazione. Altri uomini, donne e bambini furono uccisi nei boschi attraverso i quali cercavano di raggiungere Tuzla. Il Tribunale Criminale Internazionale per l’ex Jugoslavia dell’Aja ha emesso una serie di condanne per i crimini di Srebrenica. Alcuni (Erdemovic, Nikolic e Obradovic) hanno ammesso la propria responsabilità. Radislav Krstic, al tempo comandante dei Corpi della Drina, che insieme al generale Lazarevic eseguì direttamente gli ordini di Mladic, è stato condannato a 35 anni di prigione per genocidio. Ratko Maldic e Radovan Karadzic sono ancora latitanti. I soldati olandesi, che avevano la responsabilità nell’enclave e che non hanno impedito che il crimine avvenisse, hanno ricevuto la medaglia al valor militare dal proprio governo. I Balcani siamo noi E c’è un altro motivo per cui occuparsi delle guerre Balcaniche. «Perché si rimane attaccati ai Balcani? Perché è una parte di mondo che più corrisponde a noi, alla nostra vita instabile e dolorosamente scissa. Se in Asia ci sentiamo bambini persi, per le contrade balcaniche a venire a galla è l’irrisolta questione della residua adolescenza che non si decide ancora alla maturità e scherza con il sangue e con il fuoco. Dopo tanti e lunghi attraversamenti Srebrenica, fine secolo In occasione del decennale dell’eccidio di Srebrenica, l’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea di Asti, in collaborazione con l’Osservatorio sui Balcani e l’Agenzia della democrazia Locale di Zavidovici) ha raccolto nel libro Srebrenica, fine secolo. Nazionalismi, intervento internazionale, società civile (a cura di William Bonapace e Maria Perino, Israt, Asti 2005, pp. 190, euro 15) «riflessioni nate e discusse all’interno di diverse realtà che da anni a vario titolo lavorano nei e sui Balcani». Il libro presenta narrazioni di testimonianze e di esperienze (“La fine dell’innocenza”, “Sette giorni d’estate”, “Partite di calcio”); saggi di Rada Ivekovic˘ (“A proposito del paradigma bosniaco”), di Giudo Franzinetti (“I conflitti balcanici e le nuove guerre”), di Andrea Rossini (“Il tribunale internazionale dell’Aja per la Ex Jugoslavia”), di Michele Nardelli (“Oltre il conflitto. Forme e pratiche di ricomposizione sociale”), di Camillo Boano (“Ritorni. Processi simbolici e materiali per una ricostruzione sostenibile”). A come Srebrenica A come Srebrenica è uno spettacolo teatrale di Giovanna Giovannozzi, Roberta Biagiarelli, Simona Gonella. Per non dimenticare. Il monologo recitato da Roberta Biagiarelli ha debuttato al Festival del Teatro e del Sacro di Arezzo nel 1998: Da allora è stato replicato più di 200 volte. In occasione del decennale dell’eccidio di Srebrenica lo spettacolo è stato rappresentato anche a Tuzla e a Sarajevo. «Chi è sopravvissuto a Srebrenica non può dire di avere sentimenti in corpo, e chi non l’ha conosciuta, non può dire di aver visto la guerra in Bosnia». È per questo che le autrici hanno voluto raccontare l’assedio e la caduta di Srebrenica. «Io sono nata in un paese davanti al mare…», una donna torna bambina scrutando l’orizzonte. «Cosa c’è dall’altra parte?», si chiede. Un’attrice sola sul palco per più di un’ora diventa narratrice e protagonista di una storia dove la ragion di stato e gli interessi politici internazionali, hanno giocato con la vita di decine di migliaia di persone. Uno “spettacolo” che ricorda le vittime e punta il dito sui carnefici. Dov’erano i pacifisti? Un editoriale pubblicato su L’Unità a giugno del 1992 “Ma dove sono i pacifisti” si interrogava sul perché l’assedio di Sarajevo non avesse suscitato le stesse manifestazioni che c’erano state contro la guerra in Vietnam. A quella domanda don Tonino Bello aveva risposto: «[…] Voi lo sapete dove sono andati a finire i pacifisti. Li troverete negli innumerevoli laboratori d’analisi in cui si maschera la radice ultima di ogni guerra e quella ultimissima del suo archetipo di sangue: il potere del denaro. Li troverete dove si formano le nuove generazioni a compitare le letture sovversive della pace, facendo loro capire che i cannoni non tuonano mai amore di patria, ma sillabano sempre in lettere di piombo la suprema ragione dell’oro. Li troverete là dove si coscientizza la gente sulle strategie della nonviolenza attiva e la si educa a vivere in una comunità senza frontiere e senza eserciti. Li troverete là dove, scoprendo tutta l’impostura dell’antico mito della città che si fonda sul sangue, si mostra che invece è possibile fondarla sulla solidarietà». E Alex Langer aggiungeva «I pacifisti anzi sono presenti più che mai nel conflitto jugoslavo. Con meno tifo e meno bandiere, meno slogan e meno manifestazioni, ma con un’infinita quantità di visite, scambi, aiuti, gemellaggi, carovane di pace e quant’altro. Un pacifismo (finalmente!) meno gridato, ma assai più solido e concreto. Il che vuol dire più complicato, perché la vita è complicata, e la pace non si ottiene per vie semplicistiche: né con il sostegno unilaterale alle parti ritenute “buone” e neanche con l’idea che un massiccio intervento armato esterno potrebbe pacificare la regione». Insomma i pacifisti sostenevano le forze democratiche mentre i nostri governanti trattavano con le leadership nazionaliste. nelle guerre balcaniche, alla fine questa è la conclusione. I Balcani siamo noi». Scrive Tommaso Di Francesco su il manifesto del 17 luglio 2005. In Italia tante, tanti, individualmente e collettivamente, continuano ad occuparsi della ex Jugoslavia e della Bosnia in particolare. Tra le tante iniziative organizzate a dieci anni da Srebrenica e dagli accordi di Dayton (Usa, novembre 1995)4, “Pace da tutti i Balcani. Tra Europa e instabilità: l’ex Jugoslavia e la Bosnia a dieci anni da Srebrenica e dagli Accordi di Dayton”5, che si è tenuta recentemente a Como (4 - 6 novembre) è stata particolarmente significativa perché all’incontro hanno partecipato con passione e competenza, donne e uomini testimoni della guerra e di questo dopoguerra senza pace e perché il convegno si è chiuso con le toccanti testimonianze di Zumra Sehomerovic˘ e di Kada Hotic˘ dell’associazione Madri enclave di Srebrenica e Zepa. Le due donne hanno raccontato di come l’arrivo della guerra nel giro di poco tempo ha annullato i rapporti tra le persone di culture e religioni differenti. Da un giorno all’altro i vicini di casa sono diventati i nemici da cui difendersi. «Avevamo una fame tremenda, mangiavamo quello che gli animali rifiutavano, parti della piante e a volte anche le ortiche. Si potevano riconoscere i giovani dai vecchi soltanto guardandoli negli occhi perché eravamo una massa indistinguibile di esseri ridotti a pelle e ossa. Non avevamo acqua, corrente e alcuna possibilità di comunicare col mondo, solo i nostri aguzzini sapevano quello che stavamo vivendo. […] Ho visto con i miei occhi le bambine che venivano violentate ed i corpi di bambini sgozzati e senza testa. […] Siamo stati vittime della pu- lizia etnica e dopo dieci anni vivo ancora in un lager chiamato Bosnia Herzegovina. Ho vissuto la guerra con gli occhi del popolo e non del politico e con questi occhi posso dirvi che chi era al potere voleva distruggere il nostro sistema sociale, per poi fare in modo che Serbia e Croazia si potessero spartire nostri territori» ha detto ˘ E Zumra Sehomerovic˘ ha Kada Hotic. aggiunto che «Bisogna tessere il filo di fiducia che si è spezzato: nessuno crede più a nessuno e dopo dieci anni le vedove di sera mettono gli armadi davanti alle porte perché è ancora troppo vivo il ricordo di quei fatti». In Bosnia e nelle altre Terre balcaniche non è stata fatta giustizia, infatti, sebbene alcuni responsabili siano stati processati dal Tribunale per l’ex Jugoslavia e negli ultimi mesi diversi indiziati si siano consegnati volontariamente, dieci imputati – tra cui l’ex leader serbo-bosniaco Radovan Karadzic e gli ex generali serbo-bosniaci Ratko Mladic e Zdravko Tolimir – sono ancora liberi e, come dichiara la sezione italiana di Amnesty International, «a dieci anni dalla fine della guerra in Bosnia ed Erzegovina, le donne di Srebrenica sono ancora in attesa che gli uomini che assassinarono i loro figli e mariti siano consegnati alla giustizia». ● NOTE 1. A dieci anni dalla morte di Alex Langer Il Movimento Nonviolento ha raccolto in un libro – Fare la pace (Cierre edizioni, giugno 2005, pp. 193, euro 11,50) – i suoi scritti pubblicati su Azione nonviolenta dal 1984 al 1995. 2. In Melita Richter, Maria Bacchi, (a cura di), Le guerre cominciano a primavera. Soggetti e genere nel conflitto jugoslavo, Rubbettino, Catanzaro 2003, p. 34. 3. Ibidem, p. 34. 4. È dedicato alla ex Jugoslavia “I Balcani non sono lontani”, quaderno speciale n.3/ 2005 di Limes, la rivista italiana di geopolitica, in edicola e in libreria da novembre. 5. Il convegno è stato organizzato dal Coordinamento comasco per la Pace (un organismo costituito da 47 associazioni e 41 amministrazioni comunali), in collaborazione con Acli, Arci, Donne in nero, ecoinformazioni, Gruppo solidarietà e Pace, Gruppo 360° , Ipsia Como, Sprofondo, con il patrocinio dell’Università dell’Insubria. Per approfondire Sul sito di école (www.ecolenet.it) si possono trovare una bibliografia, una filmografia e una sitografia sulle Terre balcaniche per approfondire in classe lo studio di una regione vicinissima a noi, che solo pochi anni fa si chiamava Jugoslavia e che ora non esiste più. PAGINA 21 LE SOCIETÀ DELL’AVVENIRE ▼ PAGINA 22 È passato un bel po’ di tempo da quando Alvin Toffler batteva a sorpresa ogni record di vendita negli USA con i suoi saggi di futurologia in cui descriveva come sarebbe andata La terza ondata (The Third Wave, 1980) dello sviluppo economico e culturale dell’umanità. Ne è passato ancor di più da quando si è provato a prevedere come avrebbe colpito Lo choc del futuro (Future Schock, 1970) e come avrebbe travolto la soggettività del presente per produrne o realizzarne un’altra. Scarsamente considerati in Italia, tradotti e vendutissimi in Francia e osannati in America come la soluzione vincente per i problemi dell’avvenire, i libri di Toffler hanno introdotto nel circuito degli studi sociali (e anche nel senso comune) una nozione fondamentale per potersi avventurare nel labirinto delle società attuali e del suo possibile destino: quella di post-industrial society. In un tale aggregato ancora indistinto e spesso francamente lacunoso, è presente una diversità sociale diffusa a largo raggio sia nei cd – “stili di vita” più o meno alternativi (e nelle subculture che da essi originano) –, sia nelle adhocracies (in cui si afferma un’organizzazione fluida e senza particolari gerarchie come accade in Wikipedia, la comunità di ricerca svincolata da ogni subordinazione accademica); inoltre, in essa è facile adattarsi rapidamente ai cambiamenti che intervengono continuamente nell’ambito sociale. Le abitudini di massa L’informazione sostituisce la maggior parte delle risorse legate alla produzione materiale (da cui il pullulare dei simulacri o ersatz) e può diventare il principale materiale di lavoro per i lavoratori (che diventano così dei “cognitari” invece che rimanere dei “proletari” e che risultano per questo stretti da legami sociali più labili). Le abitudini di massa (Mass Customization) offrono la possibilità di focalizzarsi su forme di produzione meno costose e finalizzate a consumi di “nicchia” come Solitudini, moltitudini, società “liquida” ed “eccitata” GIUSEPPE PANELLA Inquietudini sul futuro della società a venire. Inizia con queste riflessioni una nuova serie di indagini sull’”antropologia dell’avvenire”: dall’avvento della società postindustriale all’idea di una modernità “liquida” o “eccitata” artificialmente dai media, il futuro che ci aspetta si presenta con caratteri molteplici e non sempre positivi (a differenza di quello che accadeva agli esordi del “secolo breve” novecentesco) accade applicando il principio postfordista del just in time. Lo scarto tra produttore e consumatore viene colmato dalla tecnologia e nascono così i prosumers che soddisfano da sé le proprie necessità (come accade nel caso dell’open source in informatica, dell’assembly kit per quanto riguarda l’educazione o il lavoro da freelance anche in attività tradizionalmente legate al “posto fisso”). Pur con tutte le sue approssimazioni e i suoi ammiccamenti al trionfo dei valori della realtà americana, quei saggi di Toffler individuavano nel rapporto tra tecnologia e soggettività il nodo cruciale delle società a venire. In essa il nesso tra moltitudine e solitudine si annuncia subito come il problema da risolvere. La nozione di “modernità liquida” si pone come il superamento di quell’antinomia ormai classica. In questo testo – che si può considerare l’anello di congiunzione tra altre due opere di Zygmunt Bauman, La solitudine del cittadino globale e La società individualizzata – il sociologo polacco descrive la società attuale sulla base dell’idea della “liquidità”: ogni dimensione del sociale risulta attraversata da una forte instabilità, da una sorta di fluidità, di una mancanza di punti fermi e di prospettive più adeguate che in passato erano state rese possibili dall’adesione alla tradizione culturale di appartenenza. La dimensione della “modernità liquida” è caratterizzata inoltre da un particolare sfondo spazio-temporale. Innanzitutto, molti luoghi della società presente tendono, nelle realtà urbane, a scacciare e a esiliare l’Altro oppure ad annullare le differenti specificità culturali e societarie. Inoltre, alcuni di essi si configurano come non-luoghi (come direbbe Marc Augé): «è il caso di alberghi o aeroporti, spazi privi di espressioni simboliche di identità, relazioni e storia»). Anche la sfera temporale muta freneticamente e obliquamente: attraverso l’aumento della velocità delle comunicazione e degli spostamenti, la “modernità liquida” ha reso molte esperienze accessibili con immediatezza. Proprio questa centralità dell’immediato, tuttavia, ha minato fortemente gli elementi della memoria del passato e della fiducia nel futuro che sono stati sinora i ponti culturali tra fugacità e durabilità e tra assunzione di responsabilità (individuali e sociali) e l’edonismo spicciolo basato sul carpe diem. Tale insistenza sull’“assolutezza dell’ef- PAGINA 23 fimero” ha rimesso in discussione i legami con la tradizione e la cultura basata sulla “memoria del passato” e sulla sua qualità di collante socio-culturale. È quanto sostiene anche Cristoph Türcke in un libro non ancora tradotto in Italia1 (Erregte Gesellschaft: Philosophie der Sensation, München, Beck, 2002) che cerca di verificare l’impatto della quantità “sensazionalistica” delle notizie fornite dai media sull’ormai imperante atrofia della sensibilità di chi è soggetto ad essa. Quella ricerca di “sensazione” a tutti i costi nasconde, invece, secondo il filosofo tedesco, un riemergere delle paure più profonde e nascoste dell’uomo moderno. La volontà di segnare in profondità l’attenzione di chi è la “vittima predestinata” dei messaggi imposti dai media scatena, invece, i timori profondi dell’uomo contemporaneo e comporta un arretramento culturale che l’Illuminismo (cui la pra- tica del “sensazionalismo”, secondo lo stesso Türcke, risale) non riesce più a ricacciare indietro. Nonostante l’emergenza di un nuovo modello di “uomo flessibile” (per dirla con Richard Sennett), l’apparente fluidità e “liquidità” dei soggetti rivela dei nuclei di permanenza che vengono dal passato più remoto e che inducono a pensare che tra civiltà e barbarie non c’è che lo spessore di una dimensione comunitaria sempre più fragile e più labile. Riflettere su queste potenzialità del futuro è il compito che ci proponiamo nel ciclo di interventi (Tomaso Cavallo, Vittorio Catani, Rosi Braidotti, Giovanni Spena) che seguirà nei prossimi numeri. ● NOTA 1. Della traduzione italiana di questo importante saggio di Türcke si sta occupando Tomaso Cavallo che proprio su questo libro interverrà su école, in uno dei prossimi numeri. I codici della scuola. Saper leggere RAFFAELE MANTEGAZZA Nel numero di ottobre 2005 di école abbiamo iniziato a rideclinare al presente i codici della scuola – leggere, scrivere, far di conto –. Continuiamo ancora a riflettere su cosa vuol dire oggi saper leggere. Significa soprattutto imparare a tradurre i linguaggi “altri” nel linguaggio verbale, scritto e orale ▼ PAGINA 24 La logica del libro può servire da filo conduttore per le esperienze che si fanno a scuola e per l’esperienza scolastica nel suo complesso: pensiamo ad esempio alla proposta di una pedagogia narrativa che ponga il tema della narrazione al centro del suo lavoro e del suo operato1. Si tratta di insegnare ed imparare a raccontare e raccontarsi, anche contaminando le tradizionali forme di narrazione lineare con le possibilità simultanee offerte per esempio dagli ipertesti, cercando però sempre di conferire un senso compiuto agli eventi della propria biografia: lo strumento del diario può servire soprattutto ai giovanissimi per cogliere questa coerenza o comunque per maneggiare la dimensione temporale cercando di individuare linee identificabili di senso negli eventi che caratterizzano la quotidianità. Il diario di bordo di una esperienza formativa, lavorativa, di vacanza, oltre a costituire una sfida alla logica puntuale del consumo esaustivo delle esperienze quotidiane, può essere utilizzata come un interessante strumento pedagogico. Un diario non è un romanzo di formazione, ma comunque può diventare la base per narrare la propria storia, e per autocomprendersi non come una funzione o un meccanismo di un uniforme decorso temporale, ma come un soggetto che al contempo agisce il tempo e ne è agito, e che deve trovare il punto di equilibrio tra questi due poli. E proprio attorno a questa esperienza specifica di narrazione di sé, di invenzione di un romanzo di sé e della pro- pria vita (purché contenuta dentro gli spazi e i tempi del dispositivo scolastico e non tracimante negli spazi scivolosi dell’autobiografia personale), è possibile rideclinare al presente le tre “R” del mandato istituzionale della scuola, che presiedono ai vari codici che nella scuola stessa si giocano e si alternano: Narrazione Tutti abbiamo provato l’entusiasmo vertiginoso dell’avere ancora libri da sfogliare, e la voglia di leggere un libro in più per conoscere di più, per cercare il significato del nostro esistere: chi ama la lettura non può entrare in una biblioteca senza essere sopraffatto dal fascino che promana dai libri, dalle loro copertine, dal loro profumo; il tesoro che ogni biblioteca nasconde fa dimenticare a chi vi entra lo scorrere del tempo, la materialità del reale. Ma sapere leggere significa soprattutto imparare a tradurre i linguaggi “altri” nel linguaggio verbale, scritto e orale; ascoltare musica, osservare un quadro, comunicare attraverso linguaggi non verbali sono esperienze che hanno senso a scuola se poi si passa a una verbalizzazione dell’esperienza stessa. Uomini e donne imparano a leggere da bambini e bambine perché devono poi sapere leggere il mondo che li circonda: imparano così ad ascoltare anche i suoni e i rumori della natura; anzi, è proprio nell’ascolto, inizialmente muto e rispettoso, dei suoni naturali che l’uomo e la donna possono davvero farsi interpreti della natura, articolando nel loro il suo muto linguaggio: «È una verità metafisica che ogni natura prenderebbe a lamentarsi se le fosse data la parola (...) essa piangerebbe sulla lingua stessa. L’incapacità di parlare è il grande dolore della natura (e per redimerla è la vita e la lingua dell’uomo nella natura)»2. Ma essere capaci di cogliere il suono della natura e articolarlo in lamento significa anzitutto affinare ed allenare il proprio udito all’ascolto del lamento; che esso si esprima con il grido lacerante o con l’impercettibile sussurro, si tratta sempre di articolare in parole comprensibili il rantolo del moribondo o del sofferente. Si tratta insomma di un saper leggere per saper scrivere, una capacità di restituzione di quanto letto che fa del semplice lettore un “lettore attento”. Il prototipo di lettore che abbiamo in mente come risultato finale dell’alfabetizzazione scolastica è l’ascoltatore esperto tratteggiato da Adorno a proposito dell’ascolto musicale: «colui che ascolta [legge] in modo adeguato (…) l’ascoltatore [il lettore] pienamente cosciente cui di norma non sfugge nulla e che in pari tempo sa rendersi conto in ogni istante di ciò che ha ascoltato [letto] (…) assomma nell’ascolto [nella lettura] il susseguirsi dei vari momenti (passati, presenti, futuri) in modo che gli si configura un senso compiuto»3. Non è un caso che Adorno sottolinei come «il luogo di tale logica [sia] la tecnica»4, permettendoci di ricordare come sia compito dello scolaro imparare una tecnica di lettura che comporta una ritmica, una prossemica, addirittura una respirazione adeguate. ● NOTE 1. Cfr. Raffaele Mantegazza, Un tempo per narrare. Esperienze di narrazione a scuola e fuori, Bologna, Emi, 1999 2. Walter Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo in Angelus Novus, Milano, Einaudi, 1962, p. 5. 3. Theodor W. Adorno, Introduzione alla sociologia della musica, Torino, Einaudi, 1971, p. 7. 4. Ibidem. F U O R I l regolamento per la gestione di un condominio è generalmente un elenco di proibizioni, ma può essere trasformato in un patto di convivenza in cui ciascuno si riconosce e del quale si sente responsabile, e nel quale trovino espressione anche desideri e aspettative che non possono essere garantite da “norme”; il patto come punto di arrivo di un percorso di ascolto reciproco tra gli abitanti guidato da operatori esterni. L’esperienza pilota – che ha favorito il crearsi di un clima fiducioso e sereno, solidarietà e complicità che potranno facilitare la gestione di possibili conflitti futuri – è stata realizzata a Stadera, un quartiere popolare milanese soggetto a forte degrado, sia edilizio che sociale, dove è previsto venga realizzato un Programma di Recupero Urbano. Due dei quattro edifici ristrutturati sono stati ceduti in comodato d’uso dall’ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano) alle Cooperative d’abitazione DAR-Casa e La Famiglia, che assegnano alloggi a canone moderato a famiglie immigrate e italiane. Un’équipe della cooperativa sociale ABCittà – nell’ambito del progetto “Abitare c/o” finanziato dal Comune di Milano – dal 2003 al 2005 ha accompagnato le famiglie che hanno occupato due delle quattro palazzine, nel momento dell’assegnazione, del trasloco, organizzando la presentazione del quartiere, la segnalazione delle vie, dei servizi, dei luoghi di ritrovo, la festa di quartiere per la reciproca conoscenza tra vecchi e nuovi abitanti, le prime assemblee di condominio, fino alla definizione di un patto di convivenza tra tutti gli inquilini, italiani e stranieri. Convivere Costruire la convivenza in un contesto urbano può essere una modalità utile ad affrontare positivamente questioni sociali come il disagio abitativo e altre problematiche legate all’immigrazione? I risultati di questa esperienza sono sicuramente interessanti, e vale la pena leggere il quaderno scientificoı che descrive nei dettagli anche le metodologie e i contenuti emersi dal lavoro . È proprio l’approccio metodologico utilizzato dal progetto – illustrato e motivato da Marianella Sclavi nella sua introduzione “Un’ottica interculturale per i programmi di risanamento urbano” – a suggerire un punto di vista nuovo: «…con degli stranieri è più facile ammettere che non li conosciamo, che per capirli dobbiamo dare loro voce […] chiedere quali sono i requisiti di convivenza urbana che ritengono desiderabili […] Nei riguardi dei “nostri” scatta invece un principio di auto-referenzialità per cui pensiamo di I S C Casa è… «Solidarietà, stare tranquillo, avere cura, stare insieme, stare bene, dove c’è rispetto, il mio regno». Sette significati importanti e condivisi dai quali si sono fatte discendere le regole di comportamento condominiale alle Quattro Corti di Stadera U O L A di relazioni. Un momento di transizione come il trasloco in una nuova casa consente a ciascuno – ripercorrendo la propria storia – di affrontare il cambiamento come occasione e spazio di autoaffermazione, e non come minaccia. Si è scoperto che la casa abitata da tanti stranieri fa paura agli stranieri più che agli italiani: paura degli odori, del disordine, della sporcizia, della mancanza di rispetto. “…quello magari è un po’ da preoccupare, lo so che tutti stranieri, ma io ho fiducia che (la cooperativa) ha scelto stranieri bravi come me […] straniero o italiani, basta che gente tranquilli…». (inquilino egiziano). È curioso il ricorrere frequente tra gli immigrati di Stadera di un’espressione tipica italiana come «io ho molto da fare, non sono mai in casa, mi basta che non ci sia fastidio”». La coesione sociale sapere già cosa pensano e di cosa hanno bisogno […] ci sembra sufficiente far valere il regolamento di condominio. È accogliendo il “loro” desiderio di rituali di benvenuto, specialmente i loro modi così intensi e generosi di porgere cibi, canti e musiche, che ci rendiamo conto di quanto banale, privo di spessore e di interesse reciproco sia diventato il nostro abituale modo di procedere in occasioni simili. Ci rendiamo conto che una quantità di piccole e grandi cose sarebbero importanti anche “fra di noi”, necessarie per qualsiasi programma di risanamento urbano che abbia fra i suoi obiettivi il miglioramento della qualità della vita e che voglia essere duraturo…». Come dice «[…] Michail Bachtin: “è solo agli occhi di un’altra cultura che la nostra propria cultura si rivela più completamente e più profondamente”. […] Quando in un programma di inserimento abitativo che interessa 180 famiglie (136 italiane e 44 straniere) ad alto rischio di esclusione sociale si applicano erga omnes quei criteri di ascolto attivo che a prima vista ci sembrerebbero adatti solo all’accoglienza e inserimento delle famiglie straniere, la ricetta che ne emerge può sembrare paradossale: invece di cercare di trattare lo straniero “come uno di noi” è molto meglio accoglierci anche fra noi come si accoglie uno straniero che sia il benvenuto. […]». Anche il “colloquio biografico” quindi viene sperimentato erga omnes come strumento di gestione creativa dei conflitti relazionali, sempre presenti là dove convivono diversità culturali, senza dimenticare che se il disagio abitativo per gli stranieri è parte implicita del processo migratorio per gli italiani è quasi sempre sintomo di esclusione sociale e assenza Dalle interviste e dalle storie di vita emerge un’idea di casa come luogo centrale della persona, delle relazioni private e dell’ospitalità, e le abitazioni delle Quattro Corti dove si garantisce la continuità del contratto abitativo sono vissute come una situazione di approdo definitivo o comunque situazione stabile da cui ripartire; questo si rivela un sentire comune degli stranieri e degli italiani, e favorisce l’atteggiamento di rispetto e di cura verso uno spazio comune prezioso e simbolicamente significativo. Il Progetto ha coinvolto nelle diverse tappe tre diversi livelli operativi: un Tavolo territoriale con associazioni, scuole, parrocchia, servizi, un Tavolo di Progetto con i referenti istituzionali – il Comune di Milano, ALER, le cooperative abitative, ABCittà –, e i soggetti dell’esperienza abitativa: i nuovi inquilini e gli abitanti del quartiere. In assenza di questa interazione forse la stessa esperienza non sarebbe stata possibile, o comunque avrebbe perso incisività. La sperimentazione di una dimensione pubblica attribuita a forme di agire normalmente relegate nel privato, come la costruzione di una convivenza abitativa, e gli esiti positivi di un’ottica interculturale applicata a un programma di riqualificazione urbana, dovrebbero essere assunti dalle istituzioni pubbliche come modello da studiare e applicare in molte situazioni territoriali analoghe, dove ad esempio con i Contratti di Quartiere stanno nascendo programmi di accompagnamento sociale. ● NOTA 1. Progettare l’accoglienza. Incontro tra storie di vita nel Quartiere Stadera, marzo 2005, testo a cura di ABCittà, via Pinamonte da Vimercate 9, 20121 Milano, tel. 02.29061816, www. abcittà.org. PAGINA 25 Paul Goodman. Un maestro dell’utopia concreta, nel più puro spirito libertario FILIPPO TRASATTI MAESTRE E MAESTRI P PAGINA 26 aul Goodman (1911-1972) è stato uno dei protagonisti principali della controcultura americana degli anni Sessanta. Scrittore di pamphlet, apprezzato oratore, sociologo, educatore, psicoterapeuta, attivista politico, anarchico di famiglia ebraica, per un breve periodo sull’onda lunga del movimento degli anni Sessanta, è noto in Italia come autore della Gioventù assurda (Growing up Absurd) del 1960, uno dei suoi libri più importanti, tradotto in italiano da Einaudi. Inizialmente Goodman intraprese senza successo la carriera letteraria; iniziò la sua attività politica negli anni Quaranta, durante la guerra, scrivendo articoli a favore della renitenza alla leva, il che in un’epoca di acceso patriottismo, lo portò all’isolamento anche da parte della cultura radicale di sinistra. In realtà nonostante il successo e la fama di cui per anni godette, invitato a innumerevoli conferenze pubbliche e a dibattiti televisivi, Goodman conservò sempre una certa marginalità, “negro” tra i neri, la sensazione di «non essere mai nel posto giusto», come disse lui stesso, anche a causa della sua bisessualità. La rivendicazione pubblica e politica dell’omosessualità, che gli fece perdere il lavoro in ben tre università americane progressiste, fece di lui uno degli ispiratori del movimento gay americano a cui rivolgeva l’invito a non chiudersi nel ghetto: «alleatevi con tutti gli altri gruppi libertari e gli altri movimenti di liberazione, perché la libertà è indivisibile». Maestro di libertà In campo educativo ha anticipato proposte che sarebbero state riprese e sviluppate tra gli altri da Ivan Illich e John Holt. Goodman si occupò in diversi libri esplicitamente di educazione, tra tutti Compulsory Mis-Education, (La dis-educazione obbligatoria, 1962) e il già citato La gioventù assurda, ma quasi in ogni suo saggio si trovano annotazioni e proposte sull’educazione dei giovani. Fedele alla logica anarchica del decentramento Paul Goodman propone di liberare progressivamente l’educazione dagli edifici scolastici e trasformare la città, il territorio in un luogo di apprendimento in cui, sotto la guida di educatori, piccoli gruppi di bambini e ragazzi si muovono imparando in modo meno artificioso in contesti reali La scuola progressista di Dewey cercava, secondo Goodman, di rispondere a un problema fondamentale: come conservare e sviluppare la libertà e la creatività degli individui in contesti sociali massificati, lo stesso problema amplificato di fronte al quale ci si trova negli anni Sessanta, quando Goodman scrive. La diagnosi della società affluente degli Usa, dei meccanismi patogeni che generavano la “gioventù assurda”, portava Goodman a una profonda sfiducia nell’elefantiaco sistema scolastico americano, paragonato al complesso militar-industriale: centralizzato, burocratizzato, enormemente dispendioso (rappresentava allora la voce principale della spesa pubblica Usa), e soprattutto dedito a un programma (neppure tanto) occulto di conservazione dell’esistente. Un tale sistema non poteva funzionare e sarebbe andato progressivamente in crisi per ragioni politiche ed economiche. Fedele alla logica anarchica del decentramento, Goodman propone di sostituire ai grandi e inefficienti complessi scolastici, mini scuole urbane e di campagna, parchi didattici che consentano un rapporto più diretto con l’ambiente e un’esperienza più ricca e stimolante. Liberare progressivamente l’educazione dagli edifici scolastici e trasformare la città, il territorio in un luogo di apprendimento in cui, sotto la guida di educatori, piccoli gruppi di bambini e ragazzi si muovono imparando in modo meno artificioso in contesti reali. Anche per l’università, Goodman ripropose un’idea di decentramento un po’ particolare. Come era accaduto all’università di Oxford, originata da una secessione di studenti inglesi dall’università di Parigi, o quella di Cambridge fondata da borsisti che se ne andarono da Oxford, si doveva seguire l’idea di uno studium generale, attraverso una graduale secessione di piccoli gruppi di docenti che, simili a liberi maestri medievali, dessero vita a libere società di studio e di insegnamento, facendo del tutto a meno di un’amministrazione e dei meccanismi burocratici, ma allo stesso tem- po rinunciando al crisma dell’ufficialità, per migliorare la competenza e la qualità dello studio e dei rapporti tra maestro e allievo. Dopo la pubblicazione di un libro di critica sociale e di pianificazione urbana, Communitas (1947), scritto con il fratello Percival, fu tra i fondatori dell’istituto di terapia gestaltica di New York e scrisse insieme a Perls e Hefferline un manuale fondamentale che presentava questa nuova forma di psicoterapia, La teoria della Gestalt. Lo stile di pensiero di Goodman, più adatto alla forma dell’articolo militante che a quella del trattato teorico, è vivace e mobile, capace di suggerire vie innovative riflessione e proposte pratiche, con riferimenti precisi ai fatti, al contesto storico-sociale e non di rado con spunti autobiografici. Judith Malina, fondatrice insieme a Julian Beck del Living Theatre lo descrive così: «Paul aveva un’eloquenza straordinaria ed era un grande pensatore, molto interessato agli aspetti pragmatici dell’anarchismo, ai modi concreti di operare all’interno della struttura esistente per crearne una nuova». In effetti c’è nel metodo di Goodman da una parte l’esplicito riferimento al pragmatismo americano di James e di Dewey, che gli consente di combattere apertamente ogni dogmatismo e cristallizzazione dottrinale, di non respingere il senso comune, ma nello stesso tempo di rendere aperte alla sperimentazione le proposte, anche all’apparenza più lontane dalle abitudini consolidate. ● LIBRI In italiano i testi di Goodman sono ormai da anni fuori catalogo, in attesa di qualche coraggioso editore che cominci a ripubblicarli. È stata pubblicata un’antologia degli scritti politici di Goodman in italiano, curata da P. Adamo: intitolata Individuo e comunità, Elèuthera, Milano 1995, un saggio recente di Vittorio Giacopini, La comunità che non c’è. Paul Goodman, idee per i movimenti, Nonluoghi Libere edizioni, Collana I Libertari. Sul web esistono moltissimi testi di Goodman, (si veda ad esempio http://www.preservenet.com/theory/ Goodman.html), ma alcuni sono sottoposti a copyright e disponibili solo a pagamento. @&©∑ß®¨å⁄©™ø√ƒΩʼn∆¿ _`eV Z_ T`_U`eeR Don Lorenzo e le panchine ANDREA BAGNI Verso la fine dell’anno scorso mi è capitata la possibilità di una lezione un po’ strana con una mia quinta: per un caso dell’orario, mi ritrovo un’intera mattina a disposizione – io ho tre ore consecutive e una collega mi chiede se voglio anche le sue, tipo scambio. Alcuni della classe portano il Sessantotto come argomento della tesina all’esame (un classico) e allora dico, prendiamoci tutta la mattina per leggere Lettera a una professoressa – che poi non so quanto c’entra con il Sessantotto... P er un tempo scuola così strano mi sembra giusto inaugurare il giardino davanti all’istituto. Spostiamo due panchine, le mettiamo di fronte, qualche ragazza – è il maggio odoroso – comincia a spogliarsi e arrivano anche i pensionati abituali della zona. Si legge. La prima parte mi sembra sempre potentissima. Una denuncia serrata in una lingua strepitosa, netta e tagliente come un rasoio. Un’inchiesta di sociologia politica per una scuola ospedale alla rovescia, che respinge i malati e cura quelli che non hanno bisogno. I figli dei dottori. Ma qualcuno comincia a chiedere, perché non saltiamo le note, con tutte quelle cifre, dobbiamo leggerle tutte? Il tono però non è del tipo abituale, riduzione della pena, saltiamo il saltabile. La sensazione è che quella roba si sappia. È una specie di dato. Va così il mondo. E uno dei ragazzi – quello più stile Barbiana, ripetente eccetera – dice: «a me sembrano tutti invidiosi questi qui». «Invidiosi di che?». «Di quelli più ricchi che sanno parlare e passano a scuola, mentre loro invece bocciano». Non avevo mai pensato alla banale invidia. Com’è che chi subisce qualcosa che sente un’ingiustizia (e la denuncia, certo, con il tono aspro di Barbiana) appare invidioso? Forse è il segno di come si possa accettare quell’esclusione se la si vive come una sorta di normale destino. Ma neanche destino. Condizione fra le altre. O comunque se non interessa essere inclusi, diventare cittadini sovrani, acquisire la parola. Per dire che, che c’è da dire di tanto urgente. È come se lo sdegno etico e l’etica dell’impegno della “lettera” suonassero per i miei ragazzi (tanto più ricchi, tanto più poveri) come la richiesta di un prerequisito assente; come se la risposta di lucida rabbia di Barbiana, qui non trovasse nessuna domanda. Forse è qualcosa che ha a che vedere con Pasolini, mi viene da pensare. Con quell’orrore della media istruzione (e della media ricchezza) che fa perdere la grazia dell’ignoranza – e la rabbia della povertà. Comunque la sorpresa per me arriva con la seconda parte della Lettera. Perché trovo cose che non ricordavo gran che e mica mi piacciono tanto. Una scuola missione integrale che non dovrebbe mai lasciare libera la mente e il cuore. 18 ore, lavoro ridicolo. Guai ai ritmi naturali, umani – c’è troppo da recuperare per sprecare tempo. Niente da insegnare che non abbia un uso concreto e immediato – c’è tanto di utile da imparare, il sapere disinteressato è un lusso per signorini. Quali “opinioni personali” degli studenti – in classe si viene per imparare da chi sa e si deve pendere dalle labbra del maestro. Il fine è la liberazione dalla sudditanza e dall’egoismo, ma il mezzo non è la libertà – che sarebbe presunzione. Il mezzo è l’insegnamento del maestro e il Vangelo. Conta il sapere che si riceve e si usa per il bene del prossimo, guidati da un orizzonte morale. Conta il fine. Io leggo senza interrompermi, ma qualche problema lo sento che mi sale. Penso anche al mio Sessantotto e mi chiedo quanto c’entra con Barbiana: si parlava di piacere, di antiautoritarismo, di immaginazione... Invece qui sulle panchine i ragazzi e le ragazze sono felicissimi, mi sembra. Quest’idea di una missione assoluta verso di loro dei docenti tutti, di una guida forte da non discutere, di un sapere senza foscoli e matematiche strane che non si sa a che servono... Vado in crisi io e loro festeggiano. E tuttavia forse ragazze e ragazzi prendono di Barbiana e di don Milani il verso giusto, a loro modo. Quello della passione. Del desiderio di liberazione – per quanto di massa e mai singolare. Invece paradossalmente a me sembra adesso la singolarità, l’aspetto esemplare ma non di esempio ripetibile, il fascino di Barbiana. Una passione che lì diventa autorità vera, condivisa. Ripenso alle tante discussioni avute in questi anni con i colleghi di sinistra che fanno strage agli scrutini, in nome dell’essere esigenti e non offrire ricreazioni, alla don Milani. Sono i miei amici e la mia spina nel fianco. Perché a me sembra che vada bene praticare il rigore quando c’è l’immaginazione; l’impegno quando c’è il desiderio o l’ordine nel casino. Ma quando non ci sono né immaginazione né desideri?, quando l’ordine è così zelantemente eseguito su se stessi da autoescludersi, e tu non hai niente da promettere né da minacciare perché non ci sono né attese né paure?... In questa “infelicità senza desideri” che spesso abita l’istituzione ufficiale, queste panchine al sole, una discussione intima di scuola in mezzo ai pensionati in vacanza dai piccioni, mi sembra che per oggi non sia male. ● PAGINA 27 STUDIARE PER PACE PAGINA 28 Errore di sistema NANNI SALIO “Non festa, ma lutto” è lo slogan che da molti anni i movimenti antimilitaristi, anarchici e nonviolenti contrappongono alle parate, alzabandiera e discorsi retorici con cui le istituzioni commemorano il 4 novembre “la madre di tutte le guerre”. Ciò che è grave è che non abbiamo imparato nulla dagli errori, né allora, né dopo S econdo l’opinione di molti politici e intellettuali del tempo, la prima guerra mondiale doveva essere «la guerra che metteva fine a tutte le guerre », ma è avvenuto esattamente l’opposto: è stata “la madre di tutte le guerre”. Questa è la tesi, ormai largamente accreditata da molti studi specifici1 sulle nefaste conseguenze della prima guerra mondiale, costata oltre dieci milioni di morti, difficile da trovare nei normali manuali scolastici di storia, spesso intrisi di retorica. Ma ciò che è grave è che non abbiamo imparato nulla dagli errori, né allora, né dopo. Passiamoli in rassegna, prima di chiederci il perché di tanta cecità Primo errore: demonizzare il nemico. Se il nemico è un demonio, non ci sono possibilità di negoziato, dev’essere distrutto totalmente. E la coazione a ripetere ha portato a individuare altri demoni: Hitler in primo luogo, ma poi l’«impero del male», Milosevic, Saddam Hussein, sino al più recente «asse del male» per giusti- ficare le ultime guerre (Afghanistan, Iraq). Secondo errore: reprimere e schiacciare il dissenso. Durante la prima guerra mondiale, gli obiettori di coscienza furono trattati come i peggiori criminali, chiusi in celle d’isolamento, ingiuriati, torturati. Terzo errore: una politica fondata sulla menzogna e le bugie. Purtroppo, è diventato addirittura un luogo comune dire che «la verità è la prima vittima della guerra». Oggi questo è più che mai vero, ma valeva tanto per la prima guerra mondiale, quanto per la seconda (l’ambiguo attacco a Pearl Harbour), per la guerra del Vietnam e in maniera, se possibile, ancora più clamorosa per l’Iraq, come conferma il CIAgate, tuttora in corso. Quarto errore: asservire i media. Oggi il termine corrente, coniato appositamente per la guerra in Iraq, è quello di giornalisti embedded (letteralmente “a letto con”, prostituiti). Ma questo vale anche per il clero, che giustifica la guerra in nome della religione, e per “il tradimento dei chierici” che dimenticano la loro vera funzione di ricerca critica e libera. Quinto errore: una pace punitiva. È avvenuto con la pace di Versailles, che ha aperto la strada all’avvento di Hitler e si è ripetuto in molti altri casi, da Dayton a Oslo, alla pace imposta all’Iraq dopo la prima guerra del Golfo. Questi errori hanno prodotto una lunga serie di conseguenze negative: collasso dell’economia mondiale; nascita del nazifascismo e dei sistemi totalitari; avvio del progetto inglese di colonizzazione del Medio Oriente e di insediamento dello stato israeliano in Palestina; corsa agli armamenti: armi chimiche, guerra aerea, uccisioni di massa, genocidi, bombardamento dei civili e infine militarizzazione della politica. Molti di questi errori li ritroviamo nel- l’appassionata denuncia che Robert McNamara ha avuto il coraggio e l’onestà intellettuale di fare nello splendido documentario di Errol Morris, The Fog of War (si veda il testo trascritto in italiano nel sito www.strategiaglobale.com/the_fog_ of_war.html). McNamara, già segretario alla difesa durante le presidenze Kennedy e Johnson, analizza gli errori commessi durante la guerra del Vietnam e la crisi dei missili a Cuba e individua undici lezioni che avremmo dovuto apprendere dalla guerra, ma che purtroppo non siamo ancora disposti ad apprendere. La conclusione definitiva di queste amare riflessioni è che ci troviamo di fronte a quello che, con linguaggio informatico, dobbiamo chiamare “errore di sistema”. Ma a differenza dei computer non possiamo semplicemente spegnere e riavviare. Non è così semplice. Abbiamo una pesante eredità negativa con la quale dobbiamo fare i conti e i movimenti per la pace e per la nonviolenza hanno l’impegnativo compito di aiutare l’umanità a risalire una china pericolosa prima che sia troppo tardi. Ma per far ciò è necessario riconoscere gli errori e cambiare i paradigmi dominanti nel campo della politica, dell’economia, della difesa e delle religioni. La nonviolenza ha il pregio, rispetto ad altre filosofie e culture, di permetterci di riconoscere e correggere per tempo questi errori, prima che sia troppo tardi e di ritornare sui nostri passi, se necessario. È una grande lezione di saggezza e di umiltà in un mondo pervaso dall’ansia di conquistare e consumare che si traduce facilmente in distruzione. ● NOTA 1. Si veda per esempio: Charley Reese, The War to End All Wars That Starter Them All, http:// www.antiwar.com/reese/?articleid=7560, 8 ottobre 2005. B Se vuoi la pace educa alla pace Nel 1997, a cento anni dall’istituzione del Premio Nobel per la Pace, Mairead Corrigan e Adolfo Perez Esquivel, membri autorevoli dell’IFOR. (International Fellowship of Reconciliation) coinvolsero tutti gli altri Premi Nobel per la Pace viventi in un Appello a tutti i capi di stato e di governo affinché il decennio dal 2001 al 2010 fosse dedicato allo sviluppo di una cultura di pace in grado di contrastare efficacemente la violenza, nelle sue diverse forme, fisica, psicologica, socio-economica o politica. L’assemblea generale dell’ONU con la Delibera n. 53/25 del 10 novembre 1998, ha proclamato ufficialmente il “Decennio internazionale per la promozione di una cultura di pace e nonviolenza a favore dei bambini e delle bambine del mondo” e con la delibera n. 53/ 243 del 13 settembre 1999 ha votato una “Dichiarazione e programma di azione per una cultura di pace”. A metà del decennio, si è svolto a Sanremo, dal 18 al 20 novembre, Se vuoi la pace educa alla pace, convegno internazionale sul decennio Onu per l’educazione alla Nonviolenza. L’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato alle Politiche Giovanili dal Comune di Sanremo - è stata organizzata dal Centro Studi Sereno Regis di Torino, con la collaborazione di Gruppo Assefa di Sanremo, Comitato italiano per il Decennio, Associazione per la Pace, Banca Popolare Etica, Beati i costruttori di pace, Gruppo autonomo di volontariato civile in Italia, MIR-Movimento Internazionale della Riconciliazione, MNMovimento Nonviolento. Il convegno è stato un’occasione di confronto, approfondimento e scambio tra quanti (singoli, centri, associazioni, movimenti e R E istituzioni) praticano l’Educazione alla Pace e alla Nonviolenza nelle scuole e in altri contesti formativi, convinti, come sostiene il Manifesto di Siviglia diffuso dall’UNESCO, che «la violenza non è una condizione ineluttabile e irreversibile, ma piuttosto un processo che può essere contrastato, bloccato, trasformato». Per informazioni: Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13, 10122 Torino, tel. 011.532824, e-mail [email protected]. Biblioteche scolastiche Il 24 ottobre è stata celebrata nel mondo la Giornata internazionale delle Biblioteche scolastiche (istituita nel 1999 dall’International Association of School Librarianship). Ma il CONBS - Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici ha dichiarato «il 24 ottobre giornata di compianto per le biblioteche scolastiche italiane, mai veramente nate e destinate presto a scomparire. […] A pochi esempi eccellenti si affianca una miriade di situazioni ben lontane dalle direttive internazionali ? senza computer, senza collegamento a internet, con dotazioni documentarie obsolete, addirittura senza spazi propri. […] gli unici addetti che ne assicurano il funzionamento per 36 ore settimanali sono i docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute [circa 5.000], destinati dalla Finanziaria 2003 alla mobilità in altre Amministrazioni o al licenziamento [entro il 31.12.2007]». Il CONBS ritiene imprescindibile, il mantenimento in organico dei docenti inidonei all’insegnamento (anche attraverso la costituzione della figura giuridica di Bibliotecario documentarista) e una seria politica di investimenti per dotare tutte le scuole di V biblioteche-centri di documentazione efficienti ed efficaci per la formazione delle future generazioni. Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici, http:// conbs.altervista.org/, [email protected]. Agire nel sociale Nell’ambito del percorso di formazione permanente Agire nel sociale, svolto in collaborazione con il Centro Servizi “La Sfera” e con il patrocinio della Città di Torino, i Cemea del Piemonte organizzano a Torino, il 2 febbraio 2006, “Lo sguardo obliquo. Osservazione e valutazione”. Cemea del Piemonte, via Sacchi 26, 10128 Torino, tel. 011.541225, fax 011.541339, [email protected], www.piemonte.cemea.it. Le sorgenti del narrare Dal 10 - 13 febbraio 2006 si tiene alla Casa-laboratorio di Cenci “Le sorgenti del narrare”. Per informazioni: Casalaboratorio di Cenci, strada di Luchiano 13, 05022 Amelia (Terni), tel. 0744.9803300 744.980204, e-mail: [email protected], sito www.prospettive.it/cenci. Memorie di classe Sono stati pubblicati gli atti del convegno “Memorie di classe. Lavorare a scuola con le fonti orali per leggere il mondo contemporaneo”, organizzato dal CESP-Centro Studi sulla Scuola Pubblica e dai COBASScuola, con la collaborazione del Centro di Documentazione di I Pistoia, del Circolo Gianni Bosio di Roma, dell’Istituto Ernesto de Martino di Sesto Fiorentino e della Società di Mutuo Soccorso Ernesto de Martino di Mestre (Roma, marzo 2003). Copie del libro possono essere richieste alla sede dei COBASScuola di Roma (viale Manzoni 55, tel. 06.70452452, fax 06.77206060, e-mail [email protected]. Tempo pieno e prolungato Sul sito del Cesp - Centro Studi per la Scuola Pubblica di Bologna (www.cespbo.it) si possono trovare materiali informativi sul convegno nazionale Tempo Pieno: una scuola per il futuro (Firenze 3 dicembre www.cespbo.it/ coordtempopieno.htm), sui corsi di formazione del Cesp e sulle campagne del Coordinamento nazionale in difesa del tempo pieno e prolungato. Coordinamento nazionale in difesa del tempo pieno e prolungato, c/o Cesp Bo, via San Carlo, 42 Bologna, tel./ fax 051.241336, [email protected]. Scrittura creativa Scrivere è un’esperienza perfettibile all’infinito, ma soprattutto è una forma di comunicazione che riguarda da vicino sia la personalità che la vita professionale degli adulti. Un percorso formativo a cavallo tra biografia ed esigenze educative. I CEMEA del Piemonte organizzano a Torino il 27– 28 gennaio 2006 un’iniziativa semiresidenziale di formazione CEMEA del Piemonte, via Sacchi 26, 10128 Torino, tel. 011.541225, fax 011.541339, [email protected], www.piemonte.cemea.it. PAGINA 29 le culture Educazione “difficile” tra Africa ed Europa CRISTINA MEIRELLES Dalla formazione di insegnanti in Mozambico al lavoro con il Tribunale dei Minori a Lisbona. Un’intervista alla psicopedagogista Ana Teresa Calado ▼ PAGINA 30 Ho conosciuto Ana Teresa alla Facoltà dell’Educazione all’Università di Maputo, in Mozambico dove tutt’e due insegnavamo. Da subito nacque una grande amicizia che ci lega tuttora. Eravamo, insegnanti e alunni, coscienti dei limiti che una formazione accelerata comportava, ma era enorme l’entusiasmo, l’impegno e la serietà di tutti. I futuri docenti, molto giovani, avrebbero dovuto dopo poco tempo insegnare in classi numerose, a volte localizzate in regioni del paese che non conoscevano. Inoltre tutto l’insegnamento si svolgeva in portoghese, lingua madre soltanto per pochi di loro1. Perciò si decise che nel curriculum di tutti i corsi di formazione – sia dell’area di lettere che di scienze – erano obbligatorie le materie Psicopedagogia e Portoghese. Ana Teresa faceva parte del gruppo che insegnava la prima, io del gruppo della seconda. Il lavoro attuale Ho rivisto Ana Teresa Calado l’agosto scorso, a Lisbona, dove vive e lavora. Abbiamo ricordato quel periodo e fatto un confronto con la sua attività attuale. Mi ha raccontato che quando partì per Maputo si era appena laureata (in Filosofia) e che, dopo il lavoro in Mozambico, al suo rientro in Portogallo, aveva deciso di laurearsi anche in Psicologia. Da allora si occupa dell’attività di diagnosi sociale e psicologica dei problemi dei giovani legati alla delinquenza e del loro reinserimento nella società. Parlami un po’ di quello che fai. Lavoro da qualche anno nell’Istituto di Reinserimento Sociale, organismo che dà appoggio tecnico ai tribunali. Sono legata al Tribunale dei Minori di Lisbona e riconosco quanto preziosa e determinante per il mio lavoro è stata l’esperienza nella Facoltà dell’Educazione. Ti ricordi che i nostri studenti venivano dalle diverse regioni e che erano stati quasi “forzati” a seguire la formazione per diventare insegnanti? Ciò ha richiesto un sacrificio personale, nel nome di uno sforzo collettivo, per combattere l’elevato tasso di analfabetismo che c’era in Mozambico all’epoca. Alcuni erano insoddisfatti, non erano convinti di diventare insegnanti, avevano “abbandonato” le rispettive famiglie per la prima volta, si sentivano a disagio per tanti motivi. Fu creato un gruppo di sostegno ai ragazzi (cui ho collaborato), la “Comissão de Assuntos Estudantis” che, tra altre iniziative culturali e pedagogiche, attuò dei corsi di educazione sessuale (nel centro vivevano maschi e femmine, ed era anche necessario parlare di gravidanze, di malattie a trasmissione sessuale, ecc). È stato un lavoro molto importante per la mia crescita come pedagoga e come persona. Venire a contatto con l’altro ci insegna a rapportarci con la differenza, a liberarla, rispettando nel contempo la fondamentale uguaglianza tra gli esseri umani. Oggi la mia attività si accentra sulle situazioni di giovani con problemi di marginalizzazione sociale che praticano reati. Non ci limitiamo a constatare fatti, non vogliamo fare investigazione criminale ma elaborare una diagnosi sociale e psicologica, cercando allo stesso tempo delle modalità di intervento per il reinserimento nella società. Che tipo di situazioni trovi? Gran parte di coloro che hanno proble- mi con la giustizia sono figli di immigrati africani venuti dai PALOP (Paesi Africani di Lingua Ufficiale Portoghese). Molti di questi ragazzi sono cresciuti in ambienti di violenza morale e fisica, il che li porta a essere aggressivi. Hanno storie di vita difficili, alcoolismo dei genitori, insuccesso e abbandono della scuola, povertà. Vivono situazioni di esclusione sociale, e qui si pone la questione del “diritto alla cittadinanza”. Sono nati in Portogallo ma, secondo la legge attuale, mantengono la nazionalità originale dei genitori. Anche se non è l’unico fattore che impedisce una loro vera integrazione, merita un’attenzione speciale: se si continua a considerarli “stranieri” sarà difficile che abbiano opportunità di inserimento sociale. (Per es. hanno difficoltà d’accesso alla formazione professionale e ad attività ludiche e formative come il calcio in squadre di quartiere). Lavorate anche nell’area della tossicodipendenza? La tossicodipendenza non è frequente nei “nostri” giovani, perché ci sono altri gruppi di lavoro dell’Istituto che se ne occupano a fondo. Nei ragazzi che seguiamo il fenomeno della droga si lega soprattutto al traffico: sono coinvolti nel commercio della droga dai più grandi, ovviamente perché le conseguenze legali sono meno pesanti per i minorenni. Vengono mantenuti i rapporti con le famiglie? Questo è un punto importante: a meno che non siano famiglie maltrattanti, si cerca di mantenere e rafforzare il più possibile il legame con i parenti. La maggior parte dei ragazzi ha una fami- Il lavoro pedagogico e didattico in Mozambico glia, ma questa non li segue. Alcuni hanno genitori assenti (emigrati per ragioni di lavoro), o in carcere, o alcolizzati, o assenti da casa per lavoro che per l’intera giornata. Ci sono giovani abbandonati e altri che sono scappati di casa. Una cosa importante: nei casi in cui manca un padre o una madre, cerchiamo di capire chi ha rappresentato per i ragazzi un punto di riferimento nella loro crescita. Riteniamo fondamentale coinvolgerlo e valorizzarlo (può essere stato un fratello maggiore, un altro parente o anche qualcuno al di fuori della famiglia). Che peso ha la scolarizzazione per questi giovani? È fondamentale incoraggiarli a studiare e a crearsi una professione. C’è un programma di “recupero” nella comunità, che è seguito con l’aiuto della comunità stessa (il ritorno a scuola, l’uso di programmi alternativi a quelli ufficiali, corsi di formazione professionale, ecc). Personalmente considero che la scolarizzazione aiuti a “invertire i percorsi” di esclusione sociale. I ragazzi parlano apertamente dei propri problemi? Attraverso un rapporto di fiducia reciproca, si cerca di portarli a superare la paura di parlare. All’inizio è difficile, molti hanno una grande rabbia dentro, si ribellano (a volte in modo violento). È un lavoro paziente, graduale e attento. Bisogna riuscire a trasformare in energia positiva la carica emotiva che portano in sé. Che età hanno? Tra i 12 e i 16 anni. Ai ragazzi che pra- In cosa consiste? In questo programma, l’aggressore e la vittima cercano insieme un modo di riparare il danno, e l’Istituto fa da mediatore tra i due. Penso che sia un’esperienza “umanizzante”, perché dà la possibilità all’aggressore di riconoscere l’umanità della vittima e viceversa, e di disfare stereotipi e luoghi comuni sui “giovani delinquenti”. A partire dal 1975, con l’indipendenza del Mozambico, molti professori che assicuravano l’insegnamento, fin dal periodo coloniale, soprattutto nelle scuole elementari e medie, lasciarono il paese di ritorno in Portogallo. Inoltre, la scolarità era diventata obbligatoria e gratuita per tutti i bambini del paese che nasceva, ma c’era il peso di un’eredità difficile: il 90% della popolazione era analfabeta. Siccome il ministero dell’educazione disponeva di pochissimi docenti, era urgente preparare insegnanti che, in breve tempo, potessero assicurare il funzionamento delle scuole. Fu creata la Facoltà dell’Educazione all’Università di Maputo, dove si aprirono numerosi corsi di formazione nelle varie materie. Simultaneamente, fu organizzata una campagna di sensibilizzazione e orientamento degli studenti, per invogliarli a partecipare a questo enorme progetto. Si sapeva che i giovani futuri insegnanti avevano appena finito la scuola e ora si chiedeva loro di insegnare ai più piccoli, indubbiamente una scelta coraggiosa ma non semplice. Arrivarono alla Facoltà ragazzi e ragazze della capitale e di molte altre città del paese, indipendentemente dell’origine sociale della famiglia, del suo gruppo etnico o confessione religiosa. Erano centinaia e centinaia di studenti che, ospitati in un enorme centro, ricevevano una formazione intensiva di due anni, gratuita, con un calendario scolastico pieno, ma dove c’era anche spazio per sport, cinema, teatro e altre attività. In un paese così grande (circa due volte e mezzo la superficie dell’Italia), con una diversità culturale enorme, la convivenza quotidiana è stata preziosa per la loro formazione. Hai esperienze di programmi di educazione alternativa? Alcuni anni fa, insieme a una collega insegnante di filosofia alle superiori, abbiamo realizzato un progetto di filosofia per ragazzi basato sul metodo del prof. Matthew Lipman: la “comunità di ricerca”. L’attività si sviluppò in due classi, con un curriculum alternativo quando gli studenti presentavano difficoltà d’integrazione scolastica. In questa metodologia si riduce l’asimmetria tra lo statuto dell’insegnante e quello dello studente, c’è libertà totale di fare domande e di esprimere le proprie idee, il che aiuta a sviluppare l’astrazione e il pensiero creativo, rafforzando l’autostima, la solidarietà e il rispetto verso la diversità. Quali sono i momenti più duri del tuo lavoro? Sai, per lavorare in quest’area devi crearti delle resistenze alle frustrazioni. Il ciclo d’esclusione è molto difficile da cambiare, ci sono fattori che ne determinano la persistenza. Perciò devi lavorare giorno dopo giorno, con fiducia, pensando che vale sempre la pena di “investire”. Noi siamo praticamente l’ultima “fermata” prima del carcere per alcuni di loro. Bisognerebbe che a monte s’incominciasse a intervenire di più, in modo che un giorno la mia professione non abbia più ragione di esistere. Non sarebbe l’ideale? ● ticano un atto illecito è applicata la “Legge Tutelare Educativa”. Il Tribunale dei Minori stabilisce le “misure tutelari”, di carattere pedagogico: si cerca di rieducare i giovani alla legalità, per portarli a rispettare i beni giuridici (l’integrità fisica, la proprietà, l’uguaglianza di diritti e doveri, la pace e la democrazia). Per questo motivo si chiamano “misure tutelari educative”. C’è anche un programma speciale, chiamato “di mediazione e di riparazione alla vittima”. PAGINA 31 NUOVIARRIVI T come tempo LIDIA GARGIULO Sono cinque anni che ci penso e questa volta lascio davvero, ho troppa voglia di fare altre cose. Ma l’ultimo anno sarà il più ricco il più bello il più intenso della mia carriera (!) di insegnante di italiano e latino nel triennio, perché questo maledetto mestiere lo amo e mi piace. Le cose bisognerebbe farle sempre così, come fosse l’ultima volta. E una mattina che una manifestazione aveva sfoltito le aule, mi venne più facile annunciare che me ne sarei andata. Trattiamoci bene negli ultimi mesi, conclusi, così non sarà triste lasciarci,i saluti a volte sono tristi anche perché vorremmo essere stati diversi PAGINA 32 P assammo insieme il pomeriggio dell’ultimo giorno nella palestra rimbombante della loro musica, tra dolci, bibite e chiacchiere, e intanto una scatola da scarpe si riempiva del loro regalo. Regalatemi una foto a parole, avevo chiesto, raccontate un momento della vostra vita di scuola in cui ci sono anch’io. Non dovete pensare a un elogio, dev’essere un ricordo, un fatto in cui ci siete voi e ci sono io. Non lo leggerò subito, mi farà compagnia quando sarò vecchia e penserò a voi. Ma la sera a casa ero già vecchia, era davvero finita. Smontate le impalcature di orari e scadenze, il tempo mi si era afflosciato come un sacco vuoto e, fuori del sacco, nel mucchio informe di anni e giorni e secondi il prima e il poi sbiadivano l’uno nell’altro. Chi mi impediva, allora, di essere la me che sarei stata fra quindici-vent’anni, una nonna di altri tempi o una vispa vecchietta in vena di memorie? Così la mano da sola aprì la scatola dei “ricordi”, erano tanti, fogli che ancora stentavano a rimanere piegati, pensieri freschi, parole non stagionate. Aspetta, mi dissi, che fretta c’è. Uno solo, uno solo, mi risposi, questo qui, a caso. Era scritto su una bella carta da lettera crespa, bianco avorio, piegata in tre in una busta lunga e stretta. «Con Lei, prof., il rapporto è stato breve ma intenso, proficuo per le sue grandi doti di psicologa nel trattare con i suoi alunni. Grazie prof.ssa per quanto mi ha insegnato, mi sarà di aiuto nella vita, in particolare quel suo modo di leggere che è insegnamento ma anche armonia. L’armonia e la felicità che le auguro per il futuro, quello che auguro a me stessa. Grazie. Marie Josephine Polito». Intorno alle gambe tornite i pantaloni celesti si flettono e si stendono sui gradini di marmo, il bruno crespo dei capelli addomesticato dal gel, le spalle dritte sotto lo zaino gonfio di libri e di altro. Alla sua destra un signore di testa grigia gesticola in completo grigio di buona fattura. Mi tornò così Marie Josephine, di schiena, e quest’immagine si alternava alle sue entrate ritardatarie, mentre passa senza rumore fra due file di banchi scortata da molti occhi e qualche sorriso. Ad anno scolastico inoltrato il padre era venuto a colloquio, preoccupato per “questa figlia”, e io mi chiedevo quale “incidente” li avesse messi sullo stesso cammino, loro così dissimili. Le aveva detto, in mia presenza, cose molto sagge, quelle cose che si dicono nei luoghi seri dove si fanno cose serie, e lei zitta, impermeabile; le parole cadevano come frecce senza punta. Martinica o Guadalupe? Mi chiedevo dietro di loro scendendo a lezioni finite, quale delle due ex colonie francesi? Stanno andando in presidenza a contare le assenze e i ritardi. La scuola ha avvertito i genitori, l’anno scolastico è in pericolo. Nel caso di Josephine, “genitori” vuol dire “padre” perché la madre è rimasta in Guadalupe, o in Martinica, insomma lì. L’armonia. Josephine ama la musica ma non l’ha riconosciuta nelle lingue antiche «che sono altamente formative e pie- ne di sapere», ha detto il padre. Ma l’armonia del greco è un segreto difficile, di piedi fatti di sillabe, di sale di altri mari. Avevo capito che era francofona quando in un compito avevo letto «liberò un grido»; in italiano avremmo detto “lanciò”, ma lei lo aveva pensato in francese: “livra”, cioè “liberò”. Le sue difficoltà erano quindi di lingua più che di intelligenza, ma le sue risposte erano sempre troppo brevi per essere discorso. Mentre infatti coi compagni il sorriso e poche parole erano più che sufficienti per scambiare simpatia e amicizia, il rapporto con gli adulti era ancora da costruire. E non era questione di termini e coniugazioni, si trattava di prendere le distanze dalla lingua degli affetti per entrare nella lingua dei concetti, parlare da dentro la lingua del padre, lei che era nata nella lingua della madre. Per questo parlava poco, ma le parole non erano mai chiacchiere. Fu così anche in quel primo giorno di scuola, quando dichiarai alla classe quello che mi aspettavo dagli studenti e invitai anche loro a dire che cosa chiedevano a un insegnante. Marie Josephine aspettò il suo turno con la mano alzata e disse: «Io chiedo ai professori di darci tempo, a volte noi andiamo lenti ma vogliamo capire, però abbiamo bisogno di tempo». Questa richiesta intelligente e civile fu come un fascio di luce su un angolo in ombra, per la prima volta pensai a quanto spesso liquidiamo il problema del tempo con le formule “molti compiti”, “pochi compiti”, “niente compiti”. Quindici giorni dopo, gli scrutini. Bocciata, cioè respinta, come una boccia che un’altra boccia manda in buca: ecco una parola cui non serve filologia per dire ciò che intende. Marie Josephine ragazza bruna dei Caraibi era venuta a studiare nel paese del padre in Europa dove la Cultura è antica e grande. Musei e biblioteche ne sono pieni ma loro, gli europei, corrono tra uffici e tribunali, banche, aeroporti e autostrade. Sono nervosi, poveri europei, e stanchi; ma non possono fermarsi, devono stare nei tempi e non hanno tempo per i tempi degli altri. Chissà se domani faccio in tempo per una parola fuori registro. «Pronto». «Pronto». «Volevo parlare con te di come è andata». «Me l’aspettavo». «Pensi di ripetere?». «Non so. forse torno da mia madre». «Magari qui tornerai da turista». «Fra una diecina d’anni». «Quanti ne avrai fra dieci anni?». «Ventisette». «Sarai ancora molto giovane». «Non proprio». «Vorrei che nei tuoi prossimi dieci anni entrassero cose buone. te lo posso augurare?». Dovunque andrai, Josephine, tu che sai chiedere tempo, tu che hai capito che il tempo può unire e dividere più dello spazio. ● CqVcSR UV] gZTZ_` MALTA Così vicini così lontani PINO PATRONCINI Immaginate una lingua con sostantivi e aggettivi neolatini, come quelli di un dialetto italiano, tenuti insieme da preposizioni e verbi arabi. Non è un linguaggio new global per l’area del Mediterraneo. È una lingua antica di un paese che fa parte dell’Unione Europea, anche se da non molto tempo: la Repubblica di Malta. È a due passi dalle nostre coste meridionali ma fatichiamo a considerarlo confinante. Sarà per il mare che ci separa, sarà per le dimensioni ridotte dell’arcipelago, sarà per il lungo predominio inglese. Eppure questa terra ha tante differenze quante similitudini con il nostro paese. E la scuola? L a scuola maltese è sicuramente molto diversa dalla nostra. Il sistema scolastico maltese è diviso in tre settori: statale, cattolico e indipendente. La scuola statale copre il 70% dell’utenza, il resto è coperto prevalentemente dalla scuola cattolica. La tradizione cattolica è molto forte se si pensa che lo Stato maltese fu fondato da crociati in ritirata e che La Valletta conta una densità di chiese da far impallidire persino Roma. La scuola indipendente è invece prevalentemente di origine coloniale britannica ed è piuttosto aristocratica ed elitaria. Esiste anche una scuola islamica per la piccola comunità mussulmana. L’istruzione è obbligatoria dai 5 ai 16 anni e 16 anni è l’età minima per accedere al lavoro. L’educazione prescolastica va dai 3 ai 5 anni, avviene nei kindergarten annessi alle scuole elementari, è facoltativa, ma frequentata dal 95% dei bimbi maltesi e non si fonda su insegnamenti formali, ma cerca di sviluppare le attitudini sociali e le abilità linguistiche comunicative dei bambini. L’istruzione primaria va dai 5 ai 10 anni. Ogni classe non supera i 30 alunni. Le dimensioni delle scuole variano da meno di 100 alunni a più di 800 (compresi bambini delle scuole dell’infanzia annesse). Il curriculum consiste in lingua maltese, matematica, scienze, studi sociali, religione, educazione fisica e arte. Da pochi anni è stata introdotta l’educazione tecnologica. L’insegnamento, salvo poche indicazioni, è affidato all’autonomia professionale dell’insegnante. La scuola secondaria va dagli 11 ai 16 anni. Gli alunni sono divisi in classi maschili e femminili sia nelle scuole cattoliche che in quelle statali. La maggioranza delle scuole ha meno di 550 studenti. Ma seleziona precocemente: a 11 anni lo studente affronta un esame. Se lo supera va a una scuola di eccellenza chiamata Junior Lyceum, altrimenti va alle General Secondary Schools. Qui il numero massi- mo di alunni per classe è di 30 nei primi due anni e di 25 negli ultimi tre. Ogni classe è assegnata a un Form Theacher che controlla i progressi degli studenti. L’educazione post-secondaria va dai 16 ai 18 anni. Si svolge o nel Junior College che dipende dall’Università (fondata nel 1562) o in un’altra scuola che esiste a Naxxar. Il percorso può portare all’università o ad una professione. Da non molti anni esiste il Malta College of Arts Science & Technology, nato raggruppando vari istituti e che fornisce una buona istruzione professionale a tempo pieno. I docenti hanno una carriera suddivisa in junior,ordinari e senior, e alla quale si accede previo tirocinio. Essi rispondono ad un preciso codice deontologico approvato per legge nel 1988. Il sindacato degli insegnanti è la Maltese Union of Theachers – MUT, fondata nel 1919 all’indomani di una sommossa operaia. Allora contava appena 600 membri, oggi ne conta 6.000, che, fatte le debite proporzioni, equivarrebbe a circa un milione di associati da noi. Cioè praticamente la totalità dei docenti. La MUT fu il primo sindacato ad essere riconosciuto e registrato, ma la sua opera non fu facile, dal momento che le condizioni degli insegnanti maltesi non erano all’epoca delle migliori. Solo dopo la seconda guerra mondiale si sviluppò un’azione costante di contrattazione di aumenti salariali nel ’47, nel ’53, nel ’55, nel ’59, nel ’62. Nel 1988 con l’Education Act ottenne il riconoscimento dell’insegnamento come professione e dell’insegnante come professionista. Fin dalle sue origini la MUT si diede anche compiti professionali sottolineando l’inadeguatezza della preparazione alla professione docente e invocando l’istituzione di una cattedra di Pedagogia all’Università. Ma solo nel dopoguerra vennero istituiti due college per la preparazione degli insegnanti, che poi negli anni Ottanta furono trasferiti alla facoltà di educazione dell’Università. ● PAGINA 33 B PAGINA 34 R E V I Il mondo a scuola Gerusalemme: diritto all’istruzione Portare il mondo a scuola è il nome che si è dato il gruppo scuola delle ONG lombarde che, nato nel 1994, ha promosso negli anni 95-98 con l’IRRSAE Lombardia e i Provveditorati di Milano e Como il progetto “Portare il mondo a scuola”, sfociato nel 1999 nella pubblicazione omonima. Il progetto, finalizzato alla formazione di figure di animazione e coordinamento sui temi dell’educazione interculturale e dell’educazione allo sviluppo, e organizzato per rispondere ai bisogni formativi indotti dall’ingresso di alunni migranti nelle scuole della regione, ha coinvolto circa duecento insegnanti dei diversi livelli scolari. Dopo un periodo di “latenza” dovuto sia a difficoltà interne alle ONG sia alla ristrutturazione in atto nel sistema scolastico e amministrativo (autonomia, trasformazione dei Provveditorati in CSA, ecc.), il gruppo ha ripreso stabilmente le sue attività a partire dal Seminario, tenutosi in IRRE il 9 novembre 2004, “Una bella impresa. La responsabilità d’impresa come rispetto dei diritti sociali e ambientali: quali spazi nella didattica per le scuole superiori?”, organizzato nel quadro dell’iniziativa “Cooperazione localeResponsabilità globale: responsabilità sociale delle imprese e cooperazione decentrata”, promossa dalla Regione Lombardia e dalle ONG italiane Del gruppo attualmente fanno parte: Aspem, Celim, Cespi, Coe, Cooperativa Chico Mendes, Cresmani-tese, Fratelli dell’uomo, Icei, Save the children Italia, ONG radicate nel territorio regionale, in grado di offrire interventi agli studenti e formazione agli insegnanti sui temi delle Educazioni, in un’ottica di locale-globale, ovvero di attenzione alle specificità del Territorio e alla complessità del quadro internazionale. La Fondazione Ir Amim, che da anni si occupa di stabilire e migliorare le relazioni tra gli ebrei e i palestinesi di Gerusalemme, ha reso noto un rapporto in cui si afferma che 14.500 bambini e bambine di Gerusalemme Est non sono riconosciuti dalle autorità educative e in questo momento è loro interdetto l’accesso all’istruzione presso le scuole pubbliche per mancanza di aule e spazi. Il rapporto precisa che a Gerusalemme Est sono registrati 79.000 bambini e bambine in età scolastica, ma soltanto 64.536 di questi sono registrati presso la Municipalità di Gerusalemme e il Ministero dell’Istruzione, perché frequentano le scuole, pubbliche o private. Il rapporto rivela che durante gli ultimi quattro anni la percentuale di bambini e bambine che frequentevano le scuole è calata drasticamente dal 65 al 55%. Il rapporto conclude che questo calo è dovuto alla mancanza di spazi e di aule, dal 1994 a migliaia di bambini e di bambine è stato interdetto l’accesso all’istruzione pubblica per via della mancanza di aule e delle difficoltà nel costruirne di nuove. Gli autori del rapporto chiedono alla Municipalità di Gerusalemme e il Ministero dell’Istruzione di costruire immediatamente 1.000 nuove aule nelle scuole pubbliche di Gerusalemme Est e di conferire un’indennità ai genitori palestinesi dei bambini tagliati fuori dall’istruzione pubblica, che si sono visti obbligati a pagare una scuola privata per permettere ai propri figli quello che viene universalmente e indiscutibilmente riconosciuto come un diritto fondamentale dell’umanità. Per informazioni: Fondazione Ir Amir, tel. 00972.54.6822876, www.ir-amim.org.il. Per informazioni: Fratelli dell’uomo, via Restelli 9, Milano, tel. 02.69900210, fax 02.69900203, e-mail [email protected], www.fratellidelluomo.org. de rerum natura Ambiente urbano. Come vogliamo vivere? FRANCO SCANDURRA * Le città contemporanee sono assoggettate a un duplice movimento: da una parte esse sono i luoghi di concentrazione delle funzioni del nuovo capitalismo, i luoghi di attraversamento di flussi finanziari che girano da un punto all’altro del pianeta, e, dall’altra, i luoghi dove si gioca la sfida della competizione e della solidarietà tra simili di una stessa specie ▼ Il risultato di questo movimento è la divisione in zone di guerra dove convivono, separati, mondi di vita inconciliabili: ricchi e poveri, integrati ed esclusi, cittadini e immigrati, cristiani, musulmani, indiani, giovani e anziani. La città socialdemocratica – la comunità dei simili, regolata dal welfare – che si era affermata nel primo dopoguerra, la città fordista, la città moderna, sembra appartenere ad un passato lontano quando ancora non si era affermata e non era dilagata la disintegrazione della vita comunitaria che oggi sopravvive qua e là come una reliquia del passato, quando ancora la città poteva essere considerata il luogo privilegiato dell’abitare e dell’incontro. L’effetto di questo doppio movimento è visibile ormai oggettivamente nella vita quotidiana che si svolge nelle nostre città. Da una parte esse sono abitate da cittadini del mondo legati ai processi di globalizzazione e per i quali l’abitare in una città non costituisce alcun significato di appartenenza. Essi, questi cittadini che Bauman chiama di prima fila, sono oggettivamente indifferenti ai mondi quotidiani di vita della città, se non per i benefici e i privilegi che ne derivano e di cui godono. Né, tanto meno, questi cittadini sono interessati ad un impegno per il miglioramento delle condizioni di vita in città. Dall’altra, ci sono quei cittadini che non possono spostarsi, che rimangono ancorati ai luoghi, per scelta o per costrizione, ma che sentono che qualsiasi loro impegno politico o ci- vile è sproporzionato rispetto ai guasti prodotti dai poteri forti che si muovono sulla scala internazionale e globale. La minaccia di esclusione è quella che divide queste due nuove classi sociali. Da una parte, per alcuni, la condizione è quella di essere dei cittadini di ultima fila, di essere i nuovo esclusi, coloro che, per assenza di lavoro o perché non ce la fanno, rimangono ai bordi della città occupando spazi di risulta, aree abbandonate, periferie squallide. Da città moderna a città contemporanea Anche i politici e gli amministratori vivono questa ansia di perenne instabilità tra l’adesione alla dinamica non localizzata di flussi economici e finanziari (che spesso li allettano con illusorie prospettive di sviluppo e progresso), e l’adesione a un modello statico del territorio e dei valori locali, bollata sovente come regressione romantica o nostalgica o dolce utopia. La difficoltà è quella di tentare di far fronte ai guasti prodotti dall’invasione neo liberista e dall’invadenza dei poteri forti dell’economia, con mezzi, strumenti e soluzioni locali, giacché questi solo sono i poteri di cui essi possono disporre. Sempre più le opposizioni a localizzazioni di grandi impianti distruttivi di risorse ambientali: dalle discariche alle centrali nucleari, dalle dimore di materiali radioattivi, alla protezione di coste, di ambienti naturali incontaminati, sono affidati, per così dire, alle proteste dei locali che talvolta insorgono. Una sfida ardua poiché si fronteggiano poteri fortemente squilibrati. Sempre più si avverte però lo scarto esistente tra le descrizioni che studiosi, amministratori, politici e urbanisti fanno della città e questa invisibile quanto crescente resistenza che viene offerta da una moltitudine di individui sempre più insofferenti della direzione presa dal Progresso e dallo Sviluppo. Si può sfuggire a questo destino binario? Credo che la domanda urgente sia oggi quella di: come vogliamo vivere?. Autonomia e dipendenza È difficile cercare di parlare di cittadinanza attiva senza affrontare il dilemma moderno dell’individuo conteso tra autonomia e dipendenza.La stagione liberista che si è aperta con il crollo dei mondi comunisti ha squilibrato la tradizione occidentale tra libertà ed uguaglianza a favore della prima. Un tempo, non tantissimi anni addietro, i giovani hanno conosciuto un’epoca nella quale il concetto di dipendenza (si trattasse di classe, partito, collettivo, ideologia, chiesa) era fondamentale e costitutivo per l’identità individuale. Quell’epoca, con la sua preminenza accordata al Collettivo, finì con il rimuovere il valore di individuo come ben testimonia l’emarginazione del pensiero PAGINA 35 PAGINA 36 arendtiano che tentò di mettere in guardia dai pericoli che si correvano soffocando l’individuo a favore dell’indistinto comunitario. Pare però che anche l’epoca attuale di esaltazione dell’individuo, finalmente (ci dicono) liberato dalla fitta rete dei vincoli sociali, spesso asfissianti (casa, famiglia, chiesa, paese natio, partito, ideologia), non goda di una ottima prospettiva. Al valore della dipendenza si è sostituito quello seducente e progressivo dell’autonomia che è spesso effimera in quanto mai raggiungibile veramente. I padri non avrebbero più nulla da raccontare ai figli perché ogni esperienza individuale verrebbe sganciata dalla grande storia della specie. L’esaltazione dell’individuo e delle sue effimere libertà basate sulla distruzione dei vincoli comunitari, produce insicurezza, ansia e timore di non riuscire a sopravvivere socialmente in un ambiente dominato dal mito del fai-date e dall’assenza di qualsiasi protezione sociale che possa venirci in soccorso nei momenti del bisogno. La fame di libertà, l’illusione di una libertà illimitata senza più vincoli, ha accompagnato il trionfo dell’economia sulla vita, dove l’economia non è solo l’agricoltura, il commercio, l’industria, ecc., ma una mentalità diffusa, un modo di sentire il mondo, un’interpretazione del mondo, un imperativo categorico che ci spinge alla crescita continua. La libertà illimitata avrebbe garantito qualsiasi felicità e appagamento individuale. A questo movimento ha corrisposto lo smantellamento dei vincoli sociali, del welfare, del sistema di protezione sociale. Alla tiran- nia del “noi” è succeduta quella dell’”io”, di un “io” insaziabile che tratta il mondo e gli altri come cose da buttar via. Un mutamento che potrebbe essere definito antropologico dove la realizzazione dell’individuo non è più nel lavoro, nell’incontro con l’Altro, nella cura (di sé e degli altri), nel volontariato, nella convivialità, ma nel consumo sfrenato del “tutto e subito”, rinnegando memoria, tradizioni, appartenenza. La liberta, questa “libertà”, è degenerata nella solitudine sociale, nella negazione della società, nella distruzione dei Beni comuni: la società ha mangiato la mela della libertà e l’uomo non riesce più a trascendere il confine della sua sfera individuale. cittadinanza che il mondo diverso cerca di realizzarlo con piccoli spostamenti e piccole scelte ogni giorno, non cercando fughe, sapendo che siamo esseri-inrelazione e che la libertà, l’unica libertà possibile, è dentro le relazioni. Queste “isole di resistenza” sociale si stanno moltiplicando ovunque come una sorta di rigetto biologico ai processi di omogeneizzazione e sterilizzazione della convivenza civile e sociale. Ben si comprende come questo movimento invisibile possa lasciar indifferente chi è abituato alle grandi schematizzazioni sociali o chi è vissuto nel clima di un cambiamento che poteva venire solo da un conflitto sociale violento. Il mondo che è diverso La crisi della democrazia rappresentativa La democrazia rappresentativa e la cittadinanza sono due grandi invenzioni dell’Occidente. La cittadinanza inoltre consente agli uomini di sottrarsi a due opposte derive: quella del totalitarismo che ne fa dei sudditi e quella del mercato che ne fa dei clienti. Ora io credo che noi non possiamo rinunciare all’idea della democrazia rappresentativa, non possiamo eliminarla. Ma se questo è vero, possiamo però affiancare a questa democrazia una maggiore partecipazione dei cittadini, affiancare ad essa una democrazia diretta tentando di sperimentare un ibrido tra le due che garantisca un più ampio coinvolgimento dei cittadini alle decisioni che li riguardano. Insomma non possiamo rinunciare alla politica, anche se questa è accompagnata da una cattiva fama, ma possiamo mettere sale nella coda dei partiti, non concedere più loro deleghe in bianco. Ma, come dice Cassano, la cittadinanza attiva deve essere inquieta, deve costantemente mettersi in discussione, deve, come Sisifo, sapere che gli dei non sono dalla sua parte e che la sua forza sta nella sfida orgogliosa che lancia ad essi. C’è una sterminata umanità di individui diversi che talvolta neppure sanno di condividere qualcosa insieme. È mia opinione che oggi contro questa economia dello spreco, questa vulgata neoliberista e questa tendenza alla velocità e all’innovazione continua, cittadini non sempre organizzati né tantomeno militanti di partiti, oppongono una resistenza spontanea attraverso le loro pratiche quotidiane ai tentativi di smobilitazione sociale e al consumismo. Una Walter Benjamin propose il tema in questo modo: fra gli chassidim si racconta una storia sul mondo a venire che dice: là tutto sarà proprio come è qui. Come ora è la nostra stanza, così sarà nel mondo a venire; dove ora dorme il nostro bambino, là dormirà anche nell’altro mondo. E quello che indossiamo in questo mondo, lo porteremo addosso anche là. Tutto sarà com’è ora, solo un po’ diverso. Questo pensiero non fa parte della nostra cultura occidentale secondo la quale il diverso implica un rovesciamento delle cose: la rivoluzione, un cataclisma, un evento eccezionale come per esempio è stato detto per il crollo delle Twin Towers: il mondo non sarà più lo stesso. Nella parabola del rabbino, invece, il diverso implica piccoli e piccolissimi spostamenti, ma questi spostamenti non hanno mai termine, essi sono infiniti poiché la perfezione pur non implicando un mutamento reale, non corrisponde neppure a uno stato di cose eterne , e cioè “così”. Forse, a ben riflettere è più facile un cambiamento di quelli cui siamo abituati: un rovesciamento brusco e immediato, un terremoto, una rivoluzione, un capovolgimento epocale: dov’era il basso adesso è l’alto. I piccoli spostamenti, l’altrimenti nel mezzo di un discorso o nel mezzo di un’azione, apparentemente facile e semplice, forse in realtà è più difficile. ● * Professore ordinario di Ingegneria del Territorio, Facoltà di Ingegneria di Roma, Università degli studi La Sapienza. L’articolo sintetizza la relazione tenuta al Seminario Internazionale promosso dalla FICEMEA “Costruire una cittadinanza attiva per un mondo sostenibile”, Amiens 22-25 agosto 2005. Il testo completo è reperibile sul sito www.ecolenet.it. L’educazione ambientale e il futuro della terra: un diluvio A CURA DI STEFANO VITALE Dal 3 al 6 ottobre 2005 si è tenuto a Torino il terzo Congresso Mondiale “L’educazione ambientale ed il futuro della terra”. Davvero un tema urgente di fronte al quale «educazione, formazione, comunicazione sono chiamate a riorientare valori, saperi, atteggiamenti e comportamenti per costruire una società più giusta e più attenta agi equilibri di un pianeta bello e fragile», come si legge nella presentazione ▼ È stato un grande via vai di gente (3.000 congressisti, provenienti da 115 paesi del mondo dichiarano gli organizzatori – International Secretariat World Environmental Education Congress - Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus), un diluvio di seminari, interventi (tra i quali quello di Michail Gorbaciev e di Giovanni Bollea, mostre, spettacoli. Riportare le principali tesi emerse dal congresso è praticamente impossibile: ci vorrà molto tempo per rimettere le cose a posto e tentare di tenere “tutto attaccato” (si può tentare visitando il sito, www.3weec.org, dove sono disponibili anche i materiali dei congressi precedenti). A caldo abbiamo raccolto le impressioni di un educatore ambientale, Beppe De Alteriis, e di Carlo Bonzanino, funzionario della Regione Piemonte. Visto dal campo di lavoro Beppe De Alteriis lavora da quasi vent’anni nel settore dell’educazione ambientale, ha lavorato al Parco d’Abruzzo, al Parco del Gran Paradiso, del Po e della Mandria. «Per prima cosa c’è un grosso problema logistico ed organizzativo: tutto è dispersivo, difficile orientarsi. Le hostess dell’accoglienza erano in difficoltà con il francese e l’inglese: per molti ospiti stranieri un problema. Ma anche restare in coda quasi un’ora per un pranzo al self-service non è gradevole». Sono cose che possono capitare quan- do ci sono tanti partecipanti… «Certo, ma il fatto è che i contenuti sono davvero vaghi e sicuramente troppi. Pensa che nel mio gruppo di lavoro dalle 9.30 alle 13.33 erano in programma oltre venti comunicazioni. Difficile fare un dibattito, difficile seguire lo snodarsi dei lavori. Mi è parsa una vetrina con una grossa mole di input e poche soddisfazioni per la propria curiosità». Mi vene in mente Bateson: troppe informazioni possono essere tossiche, c’è una “sostenibilità” della conoscenza che non va sottovalutata. «Forse non era questo l’obiettivo. L’importante è esserci. Il resto conta poco. I relatori italiani si sono spesso limitati a descrivere quello che fanno senza alcuna tematizzazione». «Io che lavoro sul campo ho molto apprezzato gli stand delle Regioni, ottimi per prendere contatti, conoscere iniziative, fare scambi informali, anche se resta l’impressione di essere ad una mercato dove ciascuno mostrava la sua “merce”». «Mi sono piaciute alcune delle testimonianze straniere: in particolare l’esperienza cubana che raccontava di come l’educazione ambientale sia un affare istituzionale e non un fatto privato». L’Istituzione racconta… Telefono a Carlo Bonzanino, Responsabile del settore Politiche di Prevenzione, Tutela e Risanamento Ambientale dell’assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte, uno dei massimi spon- sor di questo Congresso Mondiale sulle sorti del pianeta. Bonzanino mi racconta del grande sforzo organizzativo profuso per reperire relatori, sviluppare contatti, organizzare l’accoglienza, strutturare i lavori, seguire i mille problemi che un congresso di queste dimensioni comporta. Gli chiedo: quali sono, per lei, i principali risultati? Da uomo concreto e onesto risponde: «Riuscire a far convergere in un momento comune diverse persone, diverse esperienze ed organizzazioni sparse nel mondo Riuscire a mettere assieme partecipanti, appartenenti a diversi livelli di interesse e nazionalità, provocare e gestire l’Incontro. Questo il principale risultato». «D’altra parte il tempo per il dibattito era troppo limitato proprio per via della grande dimensione dell’Evento». Sono un po’ disorientato. Che occorra limitare il campo per cogliere qualcosa di serio? Bonzanino mi racconta che il Forum delle Regioni è la cosa, a suo avviso, più riuscita: il congresso ha «favorito lo scambio di esperienze: si è trattato di un incontro fisico sulla tematica specifica molto utile. Ma il fatto è che tutto il congresso ha avuto un impatto mediatico poco visibile. Si è visto poco specie a livello piemontese per non parlare a livello nazionale. Il congresso ha avuto poco spazio e richiamo: i media non hanno colto quest’opportunità». Infine chiedo: «ma è emerso un livello politico?». «La ricaduta non è ad oggi verificabile. È presto per dire qualcosa, vedremo solo più in là se la presenza degli amministratori al Forum delle regioni si tradurrà in un sostegno». Cosa vuol dire? Di soldi ne hanno già spesi tanti: vuoi vedere che i congressi servono a produrre nuovi congressi? Per di più di sensibilizzazione. Ed a rifinanziare questo o quel settore pubblico? Già, per Bonzazino il congresso ha avuto una funzione di sensibilizzazione (anche se i media non l’hanno capito). Cosa significa “sostegno”, chiedo: «Potenziare le strutture, potenziare le iniziative, potenziare le offerte sul territorio, potenziare i finanziamenti per l’educazione ambientale. Basterebbe l’uno per mille di altri fondi impegnati in altri segmenti del settore ambiente per poter sviluppare iniziative di Educazione alla Sostenibilità». «Il problema – aggiunge Bonzanino –, è l’educazione, la strategia di progettazione di nuove forme di intervento educativo che questo evento di richiamo ha sottolineato». ● PAGINA 37 ambiente Mal di scuola ANGELO CHIATTELLA I PAGINA 38 l riferimento questa volta assunto è il Rapporto Ecosistema scuola 2005, edito annualmente da Legambiente e basato sulle risposte fornite ad un questionario sulla qualità delle strutture scolastiche da 89 comuni capoluoghi di provincia (su 103 interpellati) e da 33 province, rispettivamente per le scuole dell’obbligo e per le scuole superiori presenti sul loro territorio. Latitanti nei confronti di questa inchiesta sono risultate diverse grandi città che hanno dato o risposte parziali (Roma, Milano, Genova) o nessuna risposta del tutto (Palermo, Napoli, Trieste). Rispetto all’anno scorso il Rapporto rileva una situazione pressoché stagnante, dove a pochissimi sostanziali progressi si contrappongono diversi peggioramenti. Mentre, ad esempio, è aumentato, dal 7% all’8,93%, il numero delle azioni di bonifica in edifici scolastici in cui sono presenti componenti con amianto ed è cresciuto il numero delle scuole dotate di aree verdi, sono nel complesso leggermente diminuiti gli interventi di manutenzione sia urgente che straordinaria. E ciò a fronte di una situazione in cui oltre al permanere, sotto il profilo della sicurezza, di antiche e numerose carenze strutturali interne derivanti dal fatto che la metà delle strutture scolastiche ha più di quaranta anni, che l’11% sono edifici nati con altre destinazioni d’uso e che l’8,3% sono edifici presi in affitto, si registra nel corso di quest’anno una sensibile crescita dei rischi derivanti dall’ambiente esterno. La ricerca di Legambiente denuncia infatti l’aumento, dall’8,85% al 9,74%, dei casi di scuole troppo vicine ad aree industriali; il quasi raddoppio, dal 6,91% al13,39%, dei casi di scuole troppo vicine ad antenne e ripetitori per telecomunicazioni; ed infine la crescita anche qui notevole, dal 2,37% al 4,29%, dei casi di scuole prossime a fonti di elevato inquinamento acustico. E questi non sono gli unici fattori di rischio esterni che incombono sulle scuole. In quest’anno di grandi catastrofi naturali quasi inevi- La fine dell’anno è tradizionalmente tempo di bilanci, e quello che, quasi doverosamente, tocca a questa rubrica riguarda, ancora una volta, la verifica dello stato di salute degli edifici scolastici pubblici, al cui interno affluiscono quotidianamente circa dieci milioni di cittadini, i più giovani dei quali hanno modo di apprendere in quale tipo di Stato e società stanno crescendo – anche sulla base delle condizioni fisiche delle aule, delle mense, delle palestre, dei servizi e dei corridoi in cui trascorrono una parte significativa della loro giornata tabile diviene il richiamo e l’evidenziazione di un ulteriore dato, segnalato anch’esso dal Rapporto, che rende particolarmente attenti ed ipersensibili: il 33,71% dei 14.328 edifici scolastici presenti sul territorio nazionale sono situati in zone a significativo rischio sismico e solo il 57,54% possiede la certificazione completa di agibilità statica. Quindi quasi seimila edifici scolastici non ancora a norma; ed anche se in molti casi si tratta di inadempienze di carattere burocratico, questo numero appare alquanto inquietante se si pensa non solo agli eventi catastrofici di quest’anno, ma alla tragedia meno recente ma a noi assai vicina della scuola elementare di San Giuliano di Puglia. Il “Decreto mille proroghe” Per rimediare a questo stato di cose e rendere più sicure le strutture scolastiche situate nelle zone a rischio sismico, alla fine dello scorso anno il CIPE aveva approvato un piano di spesa di 194 milioni di euro che avrebbe dovuto consentire il finanziamento e l’apertura dei cantieri per 738 interventi strutturali indicati come prioritari dalle Regioni competenti. A malapena il 5% della spesa complessiva, stimata intorno ai 4 miliardi di euro, ritenuta necessaria per mettere in sicurezza tutte le scuole sottoposte a tale rischio. Ma comunque un piccolo passo avanti anche se, ancora una volta, alquanto in ritardo sia rispetto l’oggettiva urgenza di tali opere, sia rispetto all’ennesima proroga (forse la quarta), concessa dal governo con scadenza al 31 dicembre 2005, per l’adeguamento degli edifici scolastici a tutte le norme di sicurezza, rischio sismico compreso. Quanti di questi 738 interventi programmati siano stati conclusi, o almeno avviati, nel corso di quest’anno è difficile saperlo. Ciò che invece con sicurezza si sa è che nella Legge 1 marzo 2005, N. 26, emanata come legge di conversione del cosiddetto “Decreto mille proroghe” del 30 dicembre 2004, N. 314, il termine ultimo per gli adeguamenti degli edifici scolastici è stato nuovamente spostato e fissato al 30 giugno 2006. Fissato, naturalmente, si fa per dire. ● media Il mondo raccontato a fumetti FRANCESCA CAPELLI Un’intervista a Art Spiegelman, l’autore di Maus, in Italia per presentare il suo ultimo lavoro L’ombra delle Torri PAGINA 39 ▼ In Italia è diventato famoso grazie al romanzo (quasi) autobiografico a fumetti Maus (Einaudi), dove racconta la storia del padre, un ebreo polacco sopravvissuto alla Shoah. Ora Art Spiegelman è tornato, con una nuova opera a fumetti, dedicata all’11 settembre, dal titolo L’ombra delle Torri (Einaudi). A settembre scorso era in Italia, ospite del Festival della Letteratura di Mantova (www.festivaletteratura.it), dove lo abbiamo incontrato. Come è nata l’idea del libro sull’attentato alle Torri Gemelle? È una promessa che mi sono fatto l’11 settembre 2001: tornare ai fumetti. Era l’unica cosa che si potesse fare dopo aver visto ciò in cui il pianeta era precipitato. Nessuno legge fiction negli Stati Uniti e la situazione è peggiorata dopo l’11 settembre. Per questo mi è sembrato normale fare un fumetto. Volevo credere ancora in un futuro, vole- vo evitare che ci si imbarcasse nella follia di una guerra dopo l’altra. Volevo tenere alto il morale della sinistra e di chi difendeva le cause liberal. Ma non ci sono riuscito. La sua decisione di dimettersi dal settimanale New Yorker sono legate anche a questo? All’indomani dell’11 settembre uscimmo con una copertina completamente nera. Un gesto minimalista, l’unica cosa da fare in quella circostanza. Poi tutto è tornato alla normalità e per me stava diventando sempre più difficile continuare a lavorare lì, perché non sopportavo il disperato tentativo di tutti di continuare a credere in un sistema che invece ha fallito. Che cosa pensa del progetto di ricostruzione delle Torri Gemelle? Erano brutte e non mi aspetto di meglio dalla ricostruzione. È impossibile realizzare un’opera “bella” quando si devono accontentare e compiacere, contemporaneamente, i familiari delle vittime, l’amministrazione di New York, i politici e i proprietari delle varie attività commerciali. La mia proposta era di costruire, al posto di 2 torri da 110 piani, 110 torri da un piano ciascuna, come simbolo di uno stile di vita più sostenibile e piacevole. Non pensa che anche la tragedia di New Orleans travolta dall’uragano Katrina meriti una graphic story? No, merita un nuovo governo alla testa degli Stati Uniti. Almeno, questo episodio è servito a far svegliare parte dei media, che hanno raccontato le storie di un’intera classe dimenticata. Katrina ha scoperchiato un verminaio: gli Usa sono un paese con una feroce divisione in classi, che si è aggravata con Bush ma che non è nata con lui. Forse sarà l’occasione per un cambiamento. Art Spiegelman Come è iniziata la sua passione per i fumetti? Sono cresciuto in una famiglia poco “esposta” alla grande letteratura. Così sono stato accolto dal mondo dei fumetti. Ho iniziato a copiare quelli degli altri, poi a fare i miei. Tutto quello che so l’ho imparato dai fumetti. Mettono insieme scrittura e immagini, rompendo il tabù secondo il quale pittura e letteratura sono due campi separati. I fumetti mimano il funzionamento del nostro cervello, che lavora con “icone” di immagini e parole. Certo, fare fumetti significa accettare il compromesso di utilizzare un linguaggio che non possiede tutte le sfumature della letteratura. PAGINA 40 Nato a Stoccolma, nel 1948, è codirettore della rivista di fumetti e grafica Raw, di cui è stato anche un fondatore. Insegna alla School of Visual Arts di New York. La sua fama in Italia (dove i suoi lavori sono stati pubblicati sulla rivista Linus) è legata al romanzo Maus, ambientato prima nel ghetto di Varsavia, poi in un campo di sterminio. Spiegelman usa la metafora degli animali (i nazisti sono gatti, gli ebrei topi, i polacchi collaborazionisti maiali). In questo modo la narrazione viene spogliata di elementi di identificazione e resta esclusivamente nella sua dimensione tragica. Maus ha vinto il premio Pulitzer nel 1992. Come è nato Maus? Le persone vogliono sentirsi raccontare storie. E mi sono chiesto quale storia avrei potuto raccontare io, se non quella della mia famiglia, che si intreccia con quella della Shoah? A 20 anni di distanza, sto lavorando a un libro che si chiama Metamaus, nel quale racconto i retroscena di Maus, con interviste, documenti, foto di famiglia. Insomma, tutto il materiale rimasto fuori. Perché i protagonisti (gli ebrei) sono topi? C’è un riferimento al topo americano più famoso del mondo? Più che Mickey Mouse, c’entra Mickey Rodent, una parodia del primo, pubblicata dalla rivista Mad che faceva il verso a “Life”. Per esempio pubblicava foto di donne orrende sotto la rubrica “La miss del mese”. Un modo per dire ai lettori: «State attenti al mondo e a chi ve lo racconta». Tornando a Maus, avevo provato a raccontare la storia con personaggi umani, ma non ci riuscivo. Ho adottato una “maschera” per mettere una distanza con la storia, sia per me, sia per il lettore. Che cosa pensa della guerra in Iraq? È stato un grande, tragico errore. E senza rimedio. Come si potrebbe rimediare? Il giuramento di Ippocrate recita: «Primo, non nuocere». Perché quando il danno è fatto, non si torna più indietro. Ecco, vale anche per questa guerra. E della questione palestinese? Vale lo stesso principio. La mia impressione è che anche lì sia stato commesso un terribile errore. Anziché affermare che il nazionalismo era stato un disastro, hanno pensato bene di insiste- re, dando una terra agli ebrei. Al limite sarebbe stata una buona idea dargli la Germania, anziché ripescare miti dell’antichità. Ormai, però, non si torna indietro. Si può solo lavorare con lentezza per tentare di rimediare agli errori fatti, perché tutti si decidano a vivere insieme. Ma temo che questo non succederà nei prossimi 10 anni. Prima o poi andrò in Palestina per un reportage, solo che continuo a rimandare. Sono stato lì soltanto una settimana, quando ero bambino, e sono molto felice che i miei genitori abbiano deciso di proseguire la diaspora emigrando negli Usa. ● cinema Cinema e fiaba. Tim Burton, affetto o dolcetto? GABRIELE BARRERA Girovagando attorno a La fabbrica di cioccolato N omen omen, il nomedel-film è un presagio. La fabbrica 1 dell’eccentrico Willy Wonka – il personaggio inventato dal novelliere Roald Dahl, anno di pubblicazione 1964, 13 milioni di copie vendute, già interpretato per il grande schermo nel 1971 da Gene Wilder, assolutamente contrario all’idea di Tim Burton di realizzare un remake del film, assolutamente d’accordo con Tim Burton dopo aver assaporato il film stesso: «Ho cambiato totalmente parere, non si può?», ha candidamente dichiarato – non è soltanto una fabbrica “del” cioccolato – fabbrica delle inimitabili tavolette Wonka, diffuse in tutto il mondo e adatte alle lingue d’ogni lingua e nazionalità, proprio com’è il cinema – ma è letteralmente una fabbrica “di” cioccolato, fatta cioè d’una materia commestibile, meglio, irresistibile. «Guardatevi attorno», delizia e si delizia Willy Wonka/ Johnny Depp nel presentare il suo regno a 5 fortunati bambini eccezionalmente ammessi a visitare la cioccomeraviglia del creato, «qui tutto è commestibile, me compreso». Alberi al caramello, erba zuccherina, cascate di cacao. Ma soprattutto: «Me compreso». Com’è d’abitudine, in Tim Burton (1958, Burbank, California: là dove sorgevano gli studi Warner, Disney e Columbia, guarda un po’…), il corpo del protagonista, il consueto alter-ego Johnny Depp, si fa etimologicamente “martire” (dal greco: “testimone”) della propria realtà emotiva. Un corpo-luogo-fabbrica in cui il vissuto interiore è letteralmente somatizzato e ricostruito, attraverso un processo di fantasioso rovesciamento dei torti subiti, di diniego degli stessi e solitaria autoriparazione. E non è una novità, a ben pensare. In “Edward mani di forbice” (1990) il corpo di Edward/ Depp, privato d’un genitore disposto a prendersi cura di lui nella crescita – a “finire di costruirlo”, “costruirgli le mani” –, dunque di un valido oggetto interiorizzato su cui fare affidamento, per così dire si ribalta e si ri-abilita attraverso la negazione e l’uso di mani-utensili che hanno appunto la caratteristica (rovesciata) di esser d’aiuto-altrui, colmando l’angoscia di non aver nessuno, fuoridentro di sé, che sia di self-help. (E su “Edward”, si riveda soprattutto M. Monteleone, Luna-dark. Il cinema di Tim Burton, Le Mani, Recco 1996). In “Ed Wood” (1994), la frammentata identità non solo sessuale del protagonista trova un “luogo di tenuta” e di “compresenza in accordo” sul corpo stesso, e voilà un Johnny Depp con pantaloni con la piega abbinati a golfino d’angora e intimi femminili, come se il territorio-corporeo fosse un’autentica fabbrica-dei-sogni, alla pari dell’industria cinematografica idealizzata da Wood… la stessa cineindustria che lo bollò e rifiutò come «il più scombinato regista del mondo». (E sulle risonanze autobiografiche, cfr. K. Hanke, “Tim Burton. An Unauthorized Biography of the Filmmaker”, St. Martin’s Press 1999). In “Sleepy Hollow” (1999) l’investigatore Ichabod Crane – nuovamente Depp, va da sé – ribalta in una coraggiosa maschera-da-detective, inclusi occhiali con bizzarro monocolo d’ingrandimento, l’angoscia di non riuscire o non tollerare di ricordare il senso di un’orrenda visione e scoperta infantile. «Molte delle cose che vediamo da bambini rimangono con noi, e spendiamo più tempo di quanto si creda nel tentativo di ricatturare l’esperienza», parola di Burton (P. Woods, a cura di, Tim Burton: A Child’s Garden of Nightmares, Plexus, London 2002). Il corpo Ergo, «me compreso». Il sé corporeo di Willy Wonka vorrebbe comprendere, per l’appunto, come la sua creazione e proiezione più grande (meglio, grandiosa), ossia la Fabbrica, una qualità nutriente e affettiva, ottimamente metaforizzata dal cioccolato, che vediamo mancargli del tutto da parte di un padre rappresentato o fantasmato come dolorosamente anaffettivo, scostante, sprezzante, terrorizzante. Cosa vi è di meglio – per negare e riscattare un parente-cadavere, ossimoro vivente, proprio come la Corpse Bride/ La sposa cadavere presentata a Venezia 2005 – di auto-rappresentarsi, a partire dal corpo, come fonte di ciò che di più dolce, energetico, euforizzante e sostanzialmente amabile – e questo è il nocciolo della questione – vi è sulla Terra? «There’s not a single no-sugar product in his factory», commenta Roger Clark (Sight & Sound, London, august 2005) a proposito del nuovo regno burtoniano. In una battuta: Burton, sul vuoto d’affetto, versa il dolcetto. Ma è possibile, davvero, che non sia rimasta una sola traccia delle antiche amarezze? Certo che no. L’intero plot di “Charlie and the Chocolate Factory” è quello di un sadico revenge-film, mascherato da zuccherosa fiaba per grandi e piccini. Addio dolcezza. Siamo in presenza di un film-divendetta (non più sullo scaffale accanto al film del 1971, ma dalle parti di Park Chan Wook, da “Mr Vengeance” ad “Old Boy” a “Lady Vengeance”, sempre a Venezia ‘05) in cui Wonka/ Depp/ Burton infierisce con squisita eleganza sui bambini che sono entrati nella fabbrica, uno per uno. E vi è nuovamente una forma di ribaltamento o spostamento, poiché in realtà le colpe per cui i bambini vengono puniti sono quelle dei loro genitori, il modo in cui la PAGINA 41 vendetta si compie è di contrappasso al tipo di rapporto (in genere mostruosamente disfunzionale) fra singolo bambino e genitore che lo ha accompagnato. Favola morale PAGINA 42 La favola divene favola morale. Esempi? Il genitore che ha saziato il suo ego coltivando l’appetito di un figlio tanto opulento quanto odioso, vede punita precisamente l’abitudine all’ingordigia. Il genitore che finge di chinare il capo di fronte ai costosi capricci della figlia, per riflettersi segretamente in uno status che non vuole limiti, troverà nell’atto di valicare un limite precisamente la sua punizione. Ad libitum. E Charlie Bucket, il piccolo superstite? Il «ragazzo più povero al mondo, che per sua fortuna non sa di esserlo», come recita l’incipit del film? Per sua fortuna è anche l’unico, evidentemente, ad avere parenti che abbiano rapporti non-narcisistici con lui. Già in partenza è emotivamente sano e salvo, perciò si salva. Ma non è l’unica ragione. Charlie (il trucco c’è, Burton fa di tutto perché lo si veda, o almeno intuisca) non è altro che una parte sana e fortemente idealizzata del bambino-Willy-Wonka (o del bambino-Burton, fa lo stesso). Ed è per questo che è destinato al “premio” su cui cresce l’attesa e fiorisce la fantasia per tutta la durata del film, premio che altro non è che la favolosa proposta di «prendere il mio posto alla guida della fabbrica» (fuori di metafora: prendere il sopravvento sulla parte sofferente dello stesso Willy Wonka). Così avverrà. E senza che Burton abbia più voglia di nascondere i trucchi da grande illusionista e affabulatore (da “big fish” del racconto?), nella sequenza in cui il piccolo Charlie porterà Willy Wonka a riconfrontarsi con il suo dolore – con un padre genialmente raffigurato come isolato e assoluto, in una casa squarciata da una strada e piovuta su un colle: un padre che, sor- presa!, ha segretamente collezionato articoli sui dolciumi del figlio e sulla sua bravura, forse è il caso di dire che con gli anni s’è addolcito… – non vi è più alcuna differenza fra il punto di vista di Charlie e il punto di vista di Wonka, fra sguardo e sguardo, fra le scoperte del bambino (che adocchia l’archivio di articoli gelosamente tenuto dal padre di Willy Wonka) e gli occhi sgranati dell’adulto (che riesce ad abbracciare e ad essere abbracciato dal padre, quasi avesse “visto” contemporaneamente con gli stessi occhi di Charlie). Nota bene. Su questa scena, la rivista succitata “Sight & Sound” è tornata esattamente un mese dopo (september 2005) capovolgendo il giudizio dato precedentemente. «Si sa che i produttori amano gli abbracci che risolvono tutto e annunciano la fine di un film, ma un regista come Burton non dovrebbe rimanere perplesso di fronte ad un eroe disfunzionale che risolve i suoi problemi in un singolo gesto?», precisa il critico Ryan Gilbey. Forse che sì forse che no. Non che la cosa cambi di molto la cinefavola, a dir il vero. E mentre a Ryan Gilbey consigliamo una buona tavoletta di cioccolato, continuiamo a ritenere che il colpo di scena finale al glucosio – ma non poteva essere altrimenti, in un cioccofilm del genere – non cambi d’una virgola, anzi rafforzi, la duplice polarità che percorre l’intera “Fabbrica di cioccolato”: affetto o dolcetto? ● NOTA 1. Charlie and the Chocolate Factory, Usa 2005, di Tim Burton, con Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Helena Bonham Carter, Deep Roy, Christopher Lee; Sceneggiatura di John August, basata sulla fiaba di Roald Dahl. Produzione: Warner Bros Pictures. Durata 115 min. La storia: Inghilterra, oggi o chissà, un altropresente. Charlie Bucket vive con la sua famiglia in condizioni di amara povertà. Dietro l’angolo la dolcezza della Fabbrica di Cioccolato del geniale e autorecluso Wonka. D’un tratto, 5 biglietti d’oro nascosti in 5 barrette di cioccolato Wonka daranno la possibilità a 5 bambini di entrare a scoprire i segreti della fabbrica. Dilemmi FILIPPO NIBBI Come si costruisce un “dizionario metaforico”? Raccogliendo i dilemmi dalla bocca dei bambini. Ovunque. I raccoglitori saranno mamme, babbi, nonni, zii e parenti tutti, maestre e maestri che frequentano la scuola “mìgnola” insieme ai Bec, per imparare con loro la nuova lingua. Alle nostre lettrici e ai nostri lettori chiediamo di collaborare alla costruzione inviandoci proposte ([email protected]) da inserire sul sito di école (www.ecolenet.it) ▼ «Balconi affiorati, di dove?, chi sono?» (Dal Canto dei Bec). I balconi “affiorati” dal Canto dei Bec, in quella posizione di verso, hanno il significato di “balconi venuti fuori, venuti a galla, venuti su, di-venuti fiori”: ecco!, affiorati, fuori dalla lingua ufficiale, è una pìcciola metafora, in virtù della quale gli interrogativi “di dove?”, “chi sono?”, espongono l’uni-verso al rischio di altri significati, fuori dall’usuale, e la parola a successivi dilemmi. Chi sono i “Bec”, ascolta il loro canto insieme a chi è Chi nel mondo. «Chi sono i Bec in Toscana?». «Sono i “bécci”, i “beccìni”, figli delle capre». «Chi sono i Bec a Soraga, in Val di Fassa?». «Sono i bambini. Tutti i bambini. “Bec” in ladino significa questo: “bambini”». «Chi sono i Bec a Ljubljana?». «Emoni, figli Emona, dal nome latino della capitale della Slovenia. E... nomi!, come dice l’anagramma». «E... i bambini di Prato?». «Sono fiori». «Sono utili i fiori? o sono PAGINA come i colori, utili solo per la felicità? Nota per essere trattata dal potere come la meno necessaria delle necessità». Sto scrivendo rincantucciato dentro la “Filozofske Fakultete” di Ljubljana (6 oktobra 2005). Intendo godermi la città. Proponendo la costruzione di un “dizionario metaforico” sarò brevissimo. Come si fa?. Si raccolgono i “dilemmi”, cioè le “pìcciole metafore” direttamente dai Bec. Dove?... Alla scuola materna, all’elementare, o alla media?. Alla mìgnola! Perché alla mìgnola? Perché è meno sotto il potere... La mìgnola può essere anche sotto un pergolato di rose, sotto una carezza, sotto un bacio. Ecco alcuni esempi di “pìcciolemetafore”. Le ho raccolte dalla Cecilia, alla scuola “mìgnola” di Monte San Savino: 1. Panciullo. La Cecilia osserva la pancia della mamma gonfiata da Giovanni, il fratellino, e dice che vuole fare “amiciccia” con lui, con il “panciullo”, che è un dilemma straordinario. 2. Venturale. La Cecilia osserva il vento che solleva le foglie dopo le doglie che ha la mamma che mette alla luce Giovanni, e dice “ventorale”. Che è un altro dilemma molto molto bello. 3. Cerchìottolo. Cos’è questo dilemma detto ancora dalla Cecilia? È un cerchio magico? O lo strumento che lo fa?... È il compasso?... Sì! Ma ho compassione di voi, se credete che sia solo il “compasso”, così utile ma così ripetitivo!... Il cerchìottolo può essere il braccio di Giotto che genera il suo O (l’O di Giotto...) Ohhh!... Ora sì! Il compasso non è una “pìcciola metafora”. Il cerchìottolo, sì! Dopo un po’ che Giovanni, il fratellino della Cecilia, era venuto alla luce, chiese alla mamma: «Mamma, perché io no posso vedere i miei occhi?». Cecilia disse alla mamma: «La mia pisella è un diamante crudo, la tua una topa pelosa». Pisella è un’altra pìcciola metafora, un altro dilemma da inserire nel “dizionario metaforico”. Il “dizionario metaforico” sarà utilissimo per la re-invenzione linguistica e la ri- fondazione della realtà. Per esempio, lo Spirito della tempesta di Paul Klee potrà essere chiamato, usando la pìcciola metafora emanata dalla Cecilia, Ventorale. Eccolo, questo Spirito! [figura in alto]. È un’immagine che esiste solo nel mondo poetico del pittore? No! È una forma fantastica che “torna a fagiolo”, come si dice in Toscana, per re-inventare una citta, ragazza di linee pulite, nitide, incurvate e spezzate, e una città che sembra fluttuare nello spazio creato dal binomio fantastico citta e città. A questo punto, ho in chiaro la proposta di registrare il dilemma ventorale nel “dizionario metaforico”. Uno potrà anche scandalizzarsi se propongo di sintonizzare il dilemma di una bambina sulla stessa lunghezza d’onda di Paul Klee, usando le sue stesse parole “spirito della tempesta”. Ma si ricrederà. Perché il Dizionario aprirà gli occhi sulle metafore a chi lo consulta, che dovrà convenire: «Io al suo posto, lo avrei detto anche prima». ● 43 script C PAGINA 44 osa si intende per storie di formazione? Si tratta di racconti, rivolti ad adolescenti ed educatori, che contengono elementi importanti, punti nodali del percorso di crescita. Trovare i propri problemi narrati in una storia fa capire ai giovani che non sono i soli ad affrontare quelle difficoltà, ciò può aiutare sia quando si vede che altri e altre hanno vissuto e risolto i problemi, sia se invece si scopre che non sono riusciti a superarli, in questo caso la riflessione e la discussione portano a indagare sui motivi dell’insuccesso e i modi per aggirare gli errori. Perché proporre storie piuttosto che saggi scientifici sull’argomento o discussioni con esperti? Perché leggere un racconto fa scattare l’immaginazione che è fondamentale per affrontare una tematica in modo emotivamente intenso. Nel processo di apprendimento, ce lo dice Bruner tra i primi, la narrazione ha un ruolo centrale. L’immedesimazione coi personaggi significa stare dentro di loro, ma con un minimo di distanza per osservarli nelle loro dinamiche. Questo permette anche di esorcizzare le proprie paure, vivendole, nella lettura, in una situazione diversa dalla propria concreta quotidianità. Quali storie racconti nel tuo libro? Ho scelto di parlare di adolescenti perché l’adolescenza è un momento chiave della vita in cui tutto è ancora possibile, tutto è in divenire. Per questo la vedo vicina al mondo della scrittura che è il mondo della possibilità. Nell’adolescenza per la prima volta cominciamo ad essere individui autonomi, è una seconda nascita. Sono storie di fughe, dalla famiglia, dalla scuola, dalla società, spesso da se stessi, la fuga è una chiave interpretativa importante. Io propongo un’altra fuga, costruttiva, quella nella lettura e nella scrittura. In questo caso lo spiraglio per volare è l’immaginario, però, nei miei racconti, è sempre legato a situazioni realistiche, possibili. Quindi leggere non per troncare il rapporto con la pro- Storie per conoscersi MARIA LETIZIA GROSSI Raccontare storie, leggerle, ascoltarle è spesso più illuminante di molti saggi articolati e documentati per riuscire a capire le situazioni e le persone che abbiamo accanto e per far capire qualcosa di noi. Una storia è uno spiraglio su qualcosa che sta fuori ma in cui portiamo una parte della nostra esperienza e del nostro desiderio. Per questo si stanno diffondendo nel mondo dell’educazione, come supporto per chi si occupa professionalmente di ragazze e ragazzi e in particolar modo per gli insegnanti, le storie di formazione. Ne parliamo con Marialuisa Bianchi, insegnante e autrice di Vie di fuga, un libro di racconti di e per adolescenti pria vita, ma per allargarne l’orizzonte, aprirsi ad altre prospettive pur continuando a restare in contatto con il proprio sé. Come si può utilizzare questo approccio, e questo libro, in classe? Leggendo una storia e discutendone. Oppure proponendo solo l’incipit e invitando ragazze e ragazzi a continuare con altre possibili soluzioni del racconto. Chiedendo loro di mutare il proprio punto di vista, ai maschi proponendo di immedesimarsi in un personaggio femminile e viceversa. Scrivere questi racconti ti è servito nel tuo lavoro di insegnante? Volendo scrivere di loro, ho osservato i miei studenti, i loro gusti, il loro linguaggio. La scrittura mi ha consentito di ritrovare l’adolescente che sono stata. La mediazione tra la mia adolescenza, pur diversa per situazioni storico-sociali, e la loro, mi ha fatto sentire con forza alcuni elementi e passaggi costanti in questa fase della vita. Questo sforzo di comprensione, inizialmente finalizzato alla scrittura, ha avuto una ricaduta positiva nelle relazioni in classe. ● Marialuisa Bianchi Vie di fuga. Storie di e per adolescenti Franco Angeli, 2005, pp.142, euro 16 Undici racconti di adolescenti alle prese con le difficoltà di inserimento nel gruppo dei pari, con le richieste della suola e della famiglia, con amori sognati o fuggiti, con i ricordi di un’infanzia troppo vicina per non far male di nostalgia, da cui ci si vuole staccare ma che è ancora invitante con la sua promessa di protezione. Percorsi che si incrociano con quelli di straniere e barboni, problemi che fanno sentire diversi, la faticosa definizione della propria identità sessuale. A incorniciare i racconti, a far da filo conduttore, la seconda parte del libro offre una chiave di lettura in classe, un’attenta riflessione sullo scrivere e usare storie nella relazione educativa, frutto di una ricerca di anni su lettura e scrittura. E alla fine tre piccole cose scritte da studenti, tra cui un racconto à la mode di Starnone, pubblicato per la prima volta in questa rubrica di école. il libro «Mi illumini professore» FILIPPO TRASATTI Antonio Scurati, Il sopravvissuto, Bompiani, Milano 2005, pp. 374, euro 16 I n una grigia cittadina della bassa padana, Casalegno, «una pustola nel mezzo della depressione geologica», il 18 giugno 2001, in un’estate afosa e infelice come tante altre, avviene un agghiacciante e incomprensibile massacro nella palestra del liceo scientifico “Paolo Sarpi”. L’autore, Vitaliano Caccia, maturando di V B ripetente, si presenta in ritardo davanti alla Commissione d’esame e con una pistola semiautomatica, uccide uno a uno sette commissari dell’esame di stato, con fredda determinazione, senza traccia alcuna di umana pietà. Tutti, tranne uno: Andrea Marescalchi, il professore di filosofia e storia, è lui l’unico sopravvissuto alla strage. «Professor Marescalchi, cosa si prova ad essere un sopravvissuto?», gli chiedono tutti, colleghi genitori, giornalisti, la Tv, senza che lui sappia cosa rispondere. E, soprattutto, perché proprio lui? Intorno a questa domanda parte e si sviluppa l’intero romanzo, secondo uno schema narrativo che parte in medias res con il fattaccio descritto con feroce esattezza, procede come in un romanzo a enigma, interrotto dalle bellissime pagine di diario del professore che scava nel suo passato per cercare una risposta appunto a quella domanda e da inserti di altri protagonisti, il medico, il poliziotto, lo psicoterapeuta, il giudice istruttore, i quali raccontano la loro verità sulla storia. Ma nessuno riesce ad arrivare a una risposta convincente, forse perché si ferma al fatto in se stesso e non si guarda né dentro né intorno. Perché Vitaliano ha risparmiato Andrea? Per dare un segnale, un esempio, per farne un nuovo messia che annuncia la salvezza, che protegge dall’angelo sterminatore? L’assassino è certamente un angelo sterminatore, bello e implacabile, portatore come tutti gli angeli di un messaggio. «Lui era quello che in altri tempi si sarebbe detto un giovane caro agli dei». Scurati riprende un motivo che ritroviamo in Teorema di Pasolini per esempio, o nel film Sei gradi di separazione, l’angelo bellissimo che arriva a sconvolgere la vita quotidiana dei buoni borghesi, ormai rassegnati alla loro routine. L’angelo non salva, uccide, stermina, ma soprattutto porta un messaggio incomprensibile e il professore di filosofia durerà fatica per cercare di avvicinarsi a comprendere il gesto dell’angelo. Ma che professore è Marescalchi, il salvato? Al collega Cesare che va a trovarlo in ospedale quando è ancora sotto shock, chiede subito: «Come stanno i ragazzi?» Nella casa in campagna, dove vive solo, nel suo studio ha appeso alla parete le foto di classe di tutte le annate in cui ha insegnato sin dal giorno delle sua prima supplenza. Dice sempre «sono tra voi ma non con voi». Ma «poteva forse un diverso sentimento della perduta giovinezza, una diversa declinazione del sentimento e del rimpianto, che faceva di lui un professore più complice con gli studenti di quanto fossero i suoi colleghi, più femmineo, Un romanzo di straordinaria forza che ha come basso continuo la domanda perché, sempre più rara nella scuola in cui viviamo, nel mondo in cui viviamo. L’autore non dà risposte facili, ma neppure si attarda, come fanno tanti che scrivono di scuola, nell’eterna inutile lamentazione del tempo perduto di chi ha di fronte tutti i giorni dei giovani che con sguardo implacabile chiedono ragione del mondo che gli abbiamo consegnato in eredità PAGINA più cedevole, dedito alla seduzione più che all’imposizione, al commercio più che al disprezzo, all’afflato più che al rifiuto, poteva la sola predilezione per una diversa posizione nel coito violento tra le generazioni tracciare il discrimine tra perdizione e salvezza?» In fondo Andrea disprezza i suoi colleghi, arriva a pensare in certi momenti che meritavano di essere ammazzati per il modo in cui ogni giorno ammazzavano gli studenti che avevano di fronte. Le pagine più straordinarie sono quelle del diario del professore, che non ci risparmiano nessuna delle miserie personali o scolastiche, ma aprono riflessioni e squarci talvolta apocalittici, non solo sulla scuola, ma sul territorio e sulla società italiana. La depressione, economica ed esistenziale, è come densa nebbia che avvolge le storie personali, in un mondo in cui i “giovani”, in cui anzi i giovani sono gli avversari di una lotta senza quartiere. Lo chiarisce in modo netto il pubblico ministero nel suo discorso. «Vitaliano Caccia ha agito in esecuzione di una sorta di mandato collettivo, proveniente dal gruppo dei suoi pari. (…) Dobbiamo prepararci a pensare e a com- battere l’intera adolescenza come un gruppo criminale, l’intera giovinezza come un’associazione a delinquere». Nessuna pietà dunque. La repressione si scatena. Si dà la caccia senza tregua non solo all’assassino, ma tutti i compagni e i giovani del paese vengono sottoposti a una pressione micidiale. Però a preoccupare il professore è soprattutto Vitaliano, il suo prediletto, quello che gli chiedeva ragione del male del mondo, brillante e sregolato, l’unico forse vero ricercatore tra gli zombie, che gli chiedeva con insistenza: «Mi illumini professore». Ma che ha davvero da dire un professore di filosofia di mezza età a un giovane come Vitaliano? Un romanzo di straordinaria forza che ha come basso continuo la domanda perché, sempre più rara nella scuola in cui viviamo, nel mondo in cui viviamo. Scurati ovviamente non dà risposte facili, ma neppure si attarda, come fanno tanti che scrivono di scuola, nell’eterna inutile lamentazione del tempo perduto di chi ha di fronte tutti i giorni dei giovani che con sguardo implacabile chiedono ragione del mondo che gli abbiamo consegnato in eredità. ● 45 libri sulla scuola PAGINA 46 Giuseppe Bagni, Rosalba Conserva, Insegnare a chi non vuole imparare. Lettere dalla scuola, sulla scuola e su Bateson, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2005, pp. 265, euro 14 portano a vedere aspetti di complessità sempre maggiore: quella dei fatti e quella delle premesse, della quotidianità scolastica e del domandarsi che cosa significa quello che a scuola tutti i giorni succede. MAURO DOGLIO Non si tratta solo di un testo che mette in luce i punti critici del sistema scuola o affronta le difficoltà in cui versano docenti e alunni, ma di un testo che aiuta a “pensare” la scuola in un modo diverso. Ciò che lo caratterizza è che i due autori guardano la scuola “attraverso” il pensiero di Gregory Bateson. Uno dei principali insegnamenti di Bateson è che il modo in cui si guarda determina quello che si vede e che una visione che utilizzi più punti di vista permette di vedere di più e in modo diverso. Questo principio viene confermato dalla struttura stessa del libro di cui ci stiamo occupando: i due autori osservano la scuola incrociando e integrando i loro sguardi e già solo questo confronto tra modi diversi di osservare la scuola in realtà geografiche diverse risulterebbe piuttosto istruttivo. Ma l’effetto della “doppia visione” non si esaurisce qui, gli autori osservano la scuola e si osservano mentre agiscono nella scuola. Non si tratta quindi solo di uno sguardo che amplia la visione quantitavamente, ma di uno sguardo che amplia la visione anche qualitativamente, modificando il modo in cui gli oggetti stessi vengono guardati. Un altro degli insegnamenti di Bateson infatti, è che quando osserviamo qualcosa siamo chiamati in causa anche noi stessi. I due autori ne sono consapevoli e il loro sguardo sulla scuola e sull’insegnamento diventa una riflessione sui pensieri e le idee che guidano le loro azioni di insegnanti e i comportamenti degli alunni. Nel raccontare episodi della vita scolastica (inquietanti, divertenti, banali e straordinari), vengono indagate le premesse che stanno alla base dell’agire e che lo determinano, in uno sforzo continuo di interrogazione e di approfondimento. Vengono discussi i rischi connessi al nostro modo di concepire la scuola e l’apprendimento in generale: «ci sono infatti dei modi di trattare il sapere che guastano “l’estetica del vivere” e rendono “morta” ogni conoscenza». E si procede per domande “spiazzanti” che ci A cura di Salvatore Pagano, Claudia Nosenghi, Alunni del mondo, strategie per l’accoglienza, Sinnos Editrice, Roma 2005, pp. 182, euro 10 L’orientamento pedagogico all’accoglienza di chi arriva in una situazione scolastica nuova, si è andato affermando negli ultimi tempi e dà luogo ad esperienze e progetti specifici, come quelli delle scuole del genovese, riportati nell’utilissimo Alunni del mondo, strategie per l’accoglienza. Questo libro si caratterizza per la centralità della persona, dei suoi bisogni e delle sue modalità di apprendimento, marcando una discontinuità rispetto al fatto che si pensava dovessero essere i minori stranieri a doversi adattare ad una realtà precostituita. Anche parlare di accoglienza piuttosto che di inserimento segnala un cambiamento di prospettiva ed in un certo senso di tonalità affettiva. Si sostituisce infatti ad una parola “fredda” come inserimento (attinente gli aspetti burocratici ed amministrativi che regolano ogni arrivo) éla parola “calda” accoglienza che cessa di essere affare personale, atteggiamento di un individuo che riceve altri individui in modo più o meno accogliente, secondo proprie inclinazioni e tratti emotivi per diventare un orientamento, una scelta della scuola collocata in un contesto territoriale specifico. Il testo mette a disposizione molto materiale sull’argomento e testimonia un percorso di dieci anni condotto in cooperazione tra il CRAS (Centro Risorse Alunni Stranieri) istituito dalla Regione Liguria, gli Enti locali ed una serie di scuole, università compresa. Ricompone le diverse esperienze e piste di lavoro realizzate nel tempo e le ripresenta in un progetto unitario e coerente. Il libro si articola in vari percorsi: la tematica dell’accoglienza collocata entro il contesto sociale e culturale dell’economia globalizzata; le strutture di sostegno delle istituzioni; l’accoglienza in rapporto agli interventi linguistici ed alla letteratura. Alunni del mondo, strategie per l’accoglienza richiama un testo parallelo per la trattazione della stessa tematica e per le affinità di metodi di lavoro pubblicato nel 2003 da Franco Angeli, Nuovi compagni di banco, a cura di Elisabetta Micciarelli. MARISA NOTARNICOLA Marco Lodoli, I professori e altri professori, Einaudi Tascabili, Torino 2005, pp. 130, euro 14 È un luogo comune duro a morire che la scuola sia maestra di vita e che sia proprio sui banchi che passino quelle nozioni indispensabili a vivere e a orientarsi nelle diverse situazioni esistenziali che seguiranno. Questa raccolta di nove racconti di Lodoli (significativamente dedicati a indagare «l’essenza della natura umana» – come recita il sottotitolo del libro) narra, con lucidità e assorta tristezza non priva di guizzi di ironica vivacità, come avvenga, invece, il contrario. E così nel libro sfilano insegnanti che si fanno turbare dalle osservazioni malevole di una loro allieva (è la professoressa Roberta in un racconto, Il rinoceronte, che deve molto alle assonanze con l’omonimo testo teatrale di Ionesco) mentre un altro personaggio segue con pervicacia il progetto di vita lasciatogli da un suo professore anche quando si accorge che sta commettendo un errore dopo l’altro (il titolo è, ironicamente, Un maestro). Ma è l’insegnare che costringe alla meditazione sulle proprie scelte passate, anche su quelle d’amore: Sisto e Milena, durante le lezioni di scuola guida, pensano al loro rapporto e si consolano per ciò che la vita non gli ha dato. In un altro racconto, gli insegnanti non ci sono allo stesso modo in cui non ci sono i voti sui quadri della propria esistenza che il protagonista cerca invano: forse non ha mai frequentato… Infine i “professori” sono gli inquietanti e furtivi ometti che si radunano in un giardinetto a decidere il destino del mondo. Il vecchio portiere di stabili che ha ormai perso il proprio lavoro li osserva perplesso: forse non ha niente da imparare da loro. GIUSEPPE PANELLA La rivista bimestrale, la lettera bimestrale, il sito (www.ecolenet.it), il cd rom annuale. L’abbonamento (5 numeri + 5 lettere di école + cd) costa 35 euro. Conto corrente postale n. 25362252 intestato a Associazione Idee per l’educazione, via Anzani 9, 22100 Como Attivazione immediata: tel. 031.268425 libri per la scuola A cura di Monica Lanfranco e Maria G. Di Rienzo, Senza velo. Donne nell’Islam contro l’integralismo, Edizioni Intra Moenia, Napoli 2005, pp. 150, euro 12 «Quando vedo per strada le donne velate, anche se fa molto caldo e noi siamo sbracciate e comode, quando camminano con i bambini e la spesa a tre passi indietro ai mariti, (loro sì in abiti occidentali) provo rabbia. Perché non possiamo cominciare a parlarne con le donne immigrate, che spesso obbligano anche le bambine allo stesso comportamento?». Si chiede e ci chiede Monica Lanfranco. È difficile e urgente in un clima da “scontro di civiltà” «discutere serenamente sulla questione del velo islamico e sul ruolo delle donne nell’Islam», senza rinunciare a esprimere critiche nei confronti dei fondamentalismi nella cultura occidentale e in quella araboislamica. «C’è bisogno di laicità» è la risposta che dà Stasa Zajovic già nel titolo di uno dei capitoli della sezione “Voci. Interviste” di Senza velo. Donne nell’Islam contro l’integralismo. È difficile e urgente tenere aperta la porta dell’interlocuzione, in un momento in cui l’attenzione è posta prevalentemente sulle conseguenze dell’impatto tra le tradizioni islamiche e il mondo occidentale e gli occhi sono puntanti sul terrorismo fondamentalista. Questo rischia di farci dimenticare i frutti possibili della convivenza e di farci perdere di vista che la realtà è assai più complessa ed articolata. Ma cosa c’è sotto il velo dell’Islam? Cosa sappiamo del mondo femminile nei paesi di religione musulmana? Quali movimenti per la laicità e i diritti esistono nel mondo arabo? La presenza nelle nostre scuole di bambine e bambini migranti provenienti da paesi arabi e il desiderio che proprio la scuola possa diventare un luogo di incontro di identità differenti, ma capaci di convivere, dove coniugare le nostre memorie culturali con una nuova realtà interculturale e mondialista, ci stimola a saperne di più. Una lettura utile ci viene proposta da Maria G. Di Rienzo e Monica Lanfranco che hanno raccolto nella sezione “Autodeterminazione. Saggi e spunti critici” scritti di studiose e interviste a coraggiose esponenti e gruppi di donne appassionate della libertà femminile (tra loro, la premio Nobel Shirin Ebadi, l’attivista Farida Mohammed, la scrittrice Nawal El Saadawi); tante narrazioni di donne che, nel cono d’ombra che avvolge quasi sempre la storia delle donne, lottano ogni giorno contro il pregiudizio, la violenza e la discriminazione (“Le storie. Profili e narrazioni”), e documenti importanti e innovativi come la Dichiarazione di Chang Mai (dove si è riunito dal 29 febbraio al 3 marzo del 2004 il Consiglio internazionale e interreligioso per la pace) e l’Appello di gennaio 2005 contro i fondamentalismi del Wluml Women living under muslim law (Donne che vivono sotto le leggi islamiche). CELESTE GROSSI Lazzaro Gigante, Giuseppe Turi, Prestami orecchio. L’uso della canzone nel dialogo tra le generazioni, Edizioni La Meridiana, Molfetta (Ba) 2005, pp.180, euro 14 Diversi piani s’intrecciano in questo libro per certi versi anomalo. Da un lato un intento culturale: le canzoni della musica “leggera” non sono subcultura, ma esprimono sentimenti, attese, emozioni che accompagnano la vita delle persone. Ed allora non sono tutte da buttare via, anzi c’è da imparare a distinguere perché una canzone di De Andrè, Fossati, Vasco Rossi o Lucio Dalla sia meglio di altre. La canzone, come insegna la pedagogia della memoria, è come un grumo poroso che raccoglie biografie e punti di vista storici diversi: la canzone più o meno d’autore è uno strumento per dialogare, per comunicare anche tra generazioni diverse raccontandosi. Di stati d’animo, di situazioni, idee, speranze, lacrime e sorrisi. Gli autori riprendono persino Winnicott e la sua teoria dell’oggetto transizionale e del gioco come spazio potenziale per la creazione di cultura. Si tratta di un modo per entrare in relazione, per dialogare con i ragazzi tentando di non fare della demagogia. Sul piano pedagogico il messaggio mi pare essere quello di stare in continuità con le esigenze ed i gusti culturali dei ragazzi, ma al tempo stesso di provocare una rottura per ascoltare la musica come potenziale strumento didattico. Le canzoni poi hanno dei testi che, in un modo o in un altro, sono in relazione con la realtà. Allora possono essere un medium per introdurre dibattiti, discussioni, ricerche. E gli autori ed interpreti hanno una loro storia artistica, culturale che può essere studiata come la letteratura “normale” cogliendo passaggi, inclinazioni, ma anche innovazioni linguistiche, stilistiche. Bob Dylan, Patti Smith, Bob Marley, Guccini, De Gregori, ma anche i Velvet Undergroud, i Nirvana persino i Lunapop possono essere degli “autori” per discutere di rivoluzione, emarginazione, droga, minoranze, esclusi e banalità quotidiane della società del consumo. Un libro che si rivolge sia agli insegnanti, ma anche agli educatori del territorio. L’educatore come mediatore culturale: questo il messaggio del libro che è diviso in due parti. Una prima in cui vengono spiegati i presupposti teorici e le esperienze didattiche che hanno generato il libro stesso. Qui sono evidenziati i passaggi metodologici: anteporre il sentire al dire, favorire la comunicazione delle emozioni, valorizzare il lavoro di gruppo, problematizzare l’ascolto. A volte può apparire semplice, ma forse qui sta l’interesse del libro. Nella seconda parte c’è un’ampia scelta antologica di testi con schede su autori e interpreti, sui temi delle canzoni. Un nuovo canzoniere senza gli accordi per proporre, a ruota libera, nuove forme di dialogo tra le generazioni. Da maneggiare con cura. STEFANO VITALE Amnesty International, Mai più! Fermiamo la violenza sulle donne, prefazione di Rita Levi Montalcini, Edizioni EGA, Torino 2004, pp. 190, euro 12 Amnesty International, I diritti delle donne, diritti umani, Edizioni Gruppo Abele (per la scuola secondaria di primo grado), Torino 2004, pp. 64, euro 4 Amnesty International, I diritti delle donne, Edizioni Gruppo Abele (per la scuola secondaria di secondo grado), Torino 2004, pp. 80, euro 5 «La violenza sulle donne è la più vergognosa violazione dei diritti umani dei nostri tempi. In ogni parte del mondo, le donne continuano a subire una silenziosa discriminazione, da parte dello Stato, della comunità di appartenenza e anche della propria famiglia, che nega loro di essere uguali agli uomini in tutti gli aspetti del vivere quotidiano». Con questa affermazione Amnesty International ha lanciato, l’8 marzo del 2004, la campagna biennale “Mai più violenza sulle donne” (per aderire: www.amnesty.it) e presentato il rapporto Mai più! Fermiamo la violenza sulle donne. Il libro analizza, in particolare, la relazione tra violenza e povertà, e tra discriminazione e militarizzazione (un capitolo è dedicato a “La violenza sulle donne nei conflitti”). Ma perché parlare della discriminazione di donne e bambine qui, in Italia, nelle nostre scuole? Alla domanda risponde il Rapporto annuale che il Population Fund dell’Onu, ha appena pubblicato e nel quale si afferma che il fenomeno del “Gender Apartheid” riguarda da vicino i paesi del primo mondo dove la discriminazione tra sessi è erroneamente considerata un retaggio del passato, tanto che è l’Australia ad avere il primato di paese in cui la violenza domestica è il rischio più grande per la salute delle donne. Insomma quando si tratta di violenza contro le donne, tutto mondo è paese. Al rapporto Amnesty International ha affiancato due strumenti didattici destinati alla scuola media e alla scuola superiore, nella convinzione che per cambiare le relazioni tra donne e uomini sia necessario un lavoro lungo e paziente di conoscenza e presa di coscienza che parte dal quotidiano, dalla discriminazione sottile che già è presente tra compagni e compagne, dai ruoli che inconsciamente ragazzi e ragazze si trovano ad assumere tra i banchi di scuola. I due quaderni presentano percorsi di lavoro, materiali di approfondimento (Legislazione internazionale; Responsabilità degli Stati nelle violazioni che colpiscono le donne; Organizzazioni non governative e associazioni; Bibliografia, Filmografia, Sitografia). Le pubblicazione si possono ordinare presso gli Uffici della Sezione Italiana di Amnesty International, via G. B. De Rossi, 10, 00161 Roma, tel. 06.44901, fax 06.4490222, e-mail [email protected]. CELESTE GROSSI PAGINA 47 8__Z gVcUZ Rimario e lame di rasoio STEFANO VITALE I bambini e la poesia. La cosa più importante non è spiegare, la poesia, ma leggere, leggere e poi ancora leggere. E provare a scriverla «C PAGINA 48 os’è la poesia?» si domanda Ferlinghetti: «è fatta/ da sillabe di sogni», si risponde. «È ciò che sta tra le righe», scrive ancora. Una parola nascosta il cui gusto non è facile da cogliere neppure per i bambini che pure fanno parte, per me, degli esseri poetici per definizione. Non tanto per una qualche innocenza presunta, quanto per la serietà delle loro profonde domande: «I bambini/ sanno giocare col destino:/ hanno la serietà/ di chi ha sempre/ il sorriso sulle labbra». Difficile da cogliere, come una mora tra i rovi spinosi o tra il ghiaccio sanguinante dell’inverno. Non è facile, allo stesso modo scrivere poesie per i bambini: è facile cadere nella retorica, nello stupidario infantilizzante. Perché c’è chi pensa che i bambini siano esseri incompiuti e non persone con una loro specifica pienezza, tutta intera, senza sconti. Si cammina allora sulla lama di un rasoio e c’è chi di quest’equilibrio incerto ne ha fatto un’arte. Penso a Rodari che s’aggrappa alla filastrocca di tradizione rinnovandola sin nel profondo grazie alla sua capacità di collegare etica civile, fantasia e psicologia. Mai banale ed ancorato al presente, sa giocare con le parole, come direbbe Giuseppe Pontremoli (Giocando parole, L’ancora del mediterraneo, 2005) ma sa anche dosare i suoi funambolismi con una misurata attenzione per la capacità ricettiva del bambino. Ed allora c’è spazio per Rodari un po’ a tutte le età, senza lode e sen- za infamia oramai. Chi lo ha seguito ha saputo far emergere un ingrediente essenziale: il pathos dell’emozione sincera, come è accaduto a Roberto Piumini in Poesie Piccole (Mondadori, 2001) ed ovviamente a Pontremoli con Rabbia Birabbia (Nuove Edizioni Romane, 1991). Dieci anni separano questi due libri, uniti dalla voglia di usare la poesia per raccontare emozioni. Il gusto di raccontare Questo gusto del raccontare pervade con spirito barocco e floreale il Pinin Carpi, di cui Piemme ci offre Oggi è un giorno tutto da giocare (2005). Il libro raccoglie proprio delle poesie-racconto inedite da cui trabocca tutta la forza narrativa di Carpi. La poesia come capriola infinita: traboccante di immagini, suggestioni, agganci acrobatici in continuo movimento: è come stare al circo, è un darsi senza sosta, un gioco infinito. Una lotta per la vita, direi, contro la stasi della morte: Pinin stava dalla parte dei bambini per poter essere eterno. Ma l’eterno può essere ghiaccio e morte senza scampo. È il caso di Vivian Lamarque (Poesie di ghiaccio, Einaudi, 2004) che si rinchiude in una visione poetica in cui domina l’ossessione per l’immobile, per la natura letteralmente morta. Non che i bambini non debbano fare i conti con il mistero più grande, ma c’è qualcosa di patologico in questo canto notturno senza speranza che è il suo poetare “per i bambini”. In compenso le illustrazioni sono splendide: Alessandro Sanna è bravissimo e col suo tocco “Art Nouveaux” ci rende meno dura la traversata della banchisa. Si può essere seri senza salire in cattedra, per fortuna: è quel che fa Francesca Lazzarato (disegni di Fabian Negrin) con Topissimamente tuo. Storie di animali in città (Orecchio Acerbo, 2004). Il paradigma sembra quello dell’intreccio tra Borges e la fiaba di tradizione mediata dalla coscienza per un nuovo animalismo senza retorica. Sarò retrò, ma a me piace la letteratura che, senza essere dottrinale, sa proporre una forma d’impegno civile. Francesca Lazzarato, chissà se mai leggerà queste mie parole, è una moralista alla Montagne, per intenderci, che però sa parlare ai bambini perché dice cose serie e profonde con parole semplici e giuste: col sorriso sulle labbra, appunto. Così si capisce perché «non s’incontrano mici a Milano: non per strada almeno»; perché in giro ci sono tanti «bambini annoiati e mamme nervose»; che cosa sogna un «criceto inquieto» o un gabbiano delle discariche, un cane chiuso nell’affetto della casa o una formica che marcia «verso un nuovo continente». Qui la poesia ancora racconta, nel mentre che scolpisce la parola. Il tono è sempre un po’ compassato, trattenuto, ma efficace nel suo scopo di “dire qualcosa d’importante”. Ma non basta: si può coniugare questa voglia con la leg- gerezza alata d’una rima. È il miracolo che accade in Rimario. Un po’ al dritto un po’ al contrario di Eduardo Polo (tradotto, guarda un po’, da Francesca Lazzarato, coi bei disegni di Arnal Ballestrel) sempre edito da Orecchio Acerbo (2005). Qui la poesia è prima di tutto musica, ritmo ed il racconto passa in seconda fila: tra lo swing ed il jazz s’improvvisa sul binario della rima, arte rara e perigliosa (che la traduttrice rende benissimo): «Per la porta di casa mia/ passa un treno tren./ Se si ferma salgo su/ e poi sali pure tu». E allora si va col «rino che sarà ceronte se varcando l’orizzonte avrà il corno sul davanti»; mentre la «colomba lomba vola dritta dritta verso il mare; velieri lieri la cercano per vederla pass passare» e «se poi fossi un niente fatto d’ombra e di fumo, tienimi sul cuscino così te lo profumo». Un libro che è anche un oggetto d’arte editoriale che occorre assolutamente avere e leggere (con furore e passione). Quella stessa passione che ci mette Elio Pecora quando in Le strade delle parole (Mondadori, 2003, illustrazioni ancora, non a caso, di Fabian Negrin) fa un’operazione alta: seleziona 53 poesie di altrettanti autori italiani da Pascoli a Zanzotto, passando per Anna Maria Ortese, Fernanda Romagnoli, Bianca Tarozzi, Antonio Porta, Sandro Penna per offrire ai bambini la poesia così com’è, senza se e senza ma, in presa diretta, con la fiducia propria di chi sa che la poesia «è ciò che sta tra le righe» e prima o poi salta fuori. ●
Scaricare