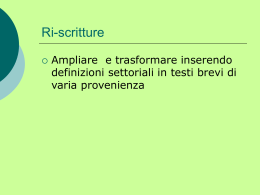casa lettrice malicuvata via vizzani, 41 – 40138 bologna [email protected] malicuvata.it progetto grafico: dogonreview.org impaginazione: giangi cavezzi illustrazioni: antonio tirelli Autori Vari | Racconti di periferie e altri racconti di periferie I edizione: maggio 2010 II edizione: ottobre 2010 ISBN 987-88-905441-0-1 licenza creative commons: attribuzione-non commerciale-non opere derivate 2.5 Italia. Gruppo Opìfice Racconti di periferie e altri racconti (di periferie) Casa Lettrice Malicuvata Dario Falconi Porco odio C’erano tutti. Mi scrutavano torvi saettando improperi dai loro sguardi severi. C’era chi pontificava tra quello che la scuola doveva essere e non era più; c’era chi blaterava improbabili avvisaglie giudiziarie e c’era, come poteva non esserci, chi smaniava per andarsene. La preside, dopo aver placato il tumulto con la sola imposizione delle mani, s’avvicinò alla mia seggiola d’imputato con fare ancheggiante. «Professore. Le chiedo per l’ultima volta: lei conferma quello che sostiene?» m’intimò in capriole di sopracciglia. «Anche» balbettai distratto pensando a voce alta un pensiero inadeguato. «Anche. Fianchi. Pressappoco significano la medesima cosa. Il vocabolario potrebbe annoverare una parola nuova: le fianche! Non male vero?!» Cercai condivisione ma trovai collerica animosità. Ero per tutti un fiancheggiatore. «Professore, adesso basta!» ribadirono con fiero piglio un paio di fiere. E via, giù, con una serie di rocamboleschi luoghi comuni col fare dignitoso dei minestroni delle pubbliche distruzioni. La scuola è così. La scuola è questo. La scuola è tuttavia. La scuola è giustappunto. La scuola è ma lei sa cos’è la scuola. 11 Rigore. Disciplina. Autorità. Non riuscivo più ad intravedere il collega di matematica ma avrei giurato che da un momento all’altro mi si sarebbe parato innanzi con la versione originale della Magna Charta. «Lei è disposto a fare una dichiarazione scritta di quello che va sostenendo?» il cosiddetto dirigente scolastico sollecitò una mia ammissione di colpevolezza. Lezzo di golpe. «Certo che sì» sostenni vivamente, «non vedo motivo di rimangiarmi la parola. Solo una volta mi rimangiai la parola: quando l’alfabeto morse!» deflagrai in una risata irriverente che non trovò complicità ma solo accessi d’ira. «Lei» ancora la fiancheggiante ingonnellata. «Persevera, quindi, col sostenere che Giannitti non bestemmia ma, altresì, suole esclamare spesso…» S’interruppe concedendomi la gloria della citazione: «Porco odio». Non volevo prendermi gioco di nessuno né tantomeno promuovere azioni delatorie contro la rispettabile istituzione ma io non udivo blasfemia dalla bocca fanciulla di quel ragazzino ma solo modalità alternative d’imprecare aiuto. Senza padre e con una madre depressa in 12 una cella d’appartamento d’una provincia arida, la sua era esistenza rabbiosamente tediosa. Altro non poteva che inventarsi adulto che per lui, emarginato e senza riferimenti nobilitanti, significava essere cattivo. Boati di beoni ululavano la sciocchezza vile del tutti vanno trattati alla stessa maniera. E che la scuola è un ammortizzatore sociale? Quante volte mi si era riproposto il vomito maleodorante di questa scempiaggine spacciata per sacrosanta verità. Cazzate. A problemi complessi ci vogliono risoluzioni complesse. I ragazzini di oggi non sono quelli dell’Ottocento, eppure tra poco qualche ministro tornerà a rimpiangere le scudisciate degli alteri maestri del secolo decimo-nono. Cazzate. Se io, insegnante di nuoto, ho due ragazzi di cui uno si regge a galla e l’altro no, dovrò necessariamente avvinghiarmi al secondo per evitare che affoghi. Tutti hanno il diritto d’imparare a nuotare. Ci si mette lì e si lavora di quadricipiti e polpacci, ma, porca puttana, si rimane in superficie. Perché se vai a fondo è finita e per riemergere non ti resta altro che aggrapparti agli altri. E allora si è perduti. Vinti. Schiavi arresi al desiderio di respirare autonomamente. Solo le piovre hanno tante braccia da offrire. E così, per il resto della vita, sarà sempre un percorso a tentacoli. Si trattava di sospendere Giannitti per la quarta volta e liberarsene definitivamente come proclamò inorgoglita la pettoruta professoressa di chimica. 13 Liberarsene definitivamente. Quelli come Giannitti sono il cancro e vanno eliminati perché non sono un buon esempio per i compagni di classe. Perché ci devono pensare le famiglie, mica sono la madre io! Perché è colpa soprattutto delle medie! Perché basta con questo assistenzialismo. Io e Giannitti avevamo un rapporto poco ortodosso. Io sapevo che non era in grado di restare più di trenta minuti seduto al proprio banco; lui sapeva che, suo malgrado, avrei dovuto fare lezione. Avevamo raggiunto un compromesso ratificato ufficialmente insieme con la classe e ribattezzato pomposamente con il velleitario nome di Banco di prova, suggellato dalle foto di rito e da strette distratte di mani dimenate. Lui, Giannitti, aveva il diritto ogni quarto d’ora d’alzarsi indisturbato ma senza recare fastidio al normale svolgimento della lezione. Ogni tanto s’inveleniva emanando il suo proverbiale Porco Odio ma subito rompeva le righe in un rogo dirotto d’autentiche scuse. Nei suoi temi sgrammaticati urlava tutto il suo disappunto d’esistere, i suoi ingrati quattordici anni che non sapeva come spendere. Le sue storie abbarbicate a un muretto di amicizie deluse e di approcci sessuali troppo precoci da lasciarlo interdetto, fugaci ombre di gioia in un ginepraio mortificante. Scriveva male, certo. Ma aveva qualcosa da scrivere: della madre che venerava perché lo aveva cresciuto e che doveva proteggere da «quello stronzo infame che se la vuole porta’ via»; del padre, morto giovane, e delle sue 14 fotografie da bel calciatore e che lui «un giorno l’avrei emulato (come è stato contento quando ha scoperto il significato del verbo emulare) perché professo’ io so forte a gioca’ a pallone; c’ha presente Goran Pandev?!». Gli mettevo la sufficienza. Mai per accondiscendenza fasulla, né per patetica commiserazione. Semplicemente perché la meritava. E lui soleva venirmi incontro incredulo a biascicarmi, tra varie volgarità e porchi odii, uno sfuggevole grazie. Lo riconosco, quel Grazie era il mio trionfo. Dentro di me stuole di bellissime ballerine brasiliane danzavano un samba tumultuoso. Poco tempo fa una giovane maestrina d’italiano era precipitata, quasi invasata, nell’aula professori con occhi sgranati di miracolata indulgendo in un ossessionante: «Oddio, questi non sanno sillabare!». Gli avrei dato una capocciata all’istante. E poi gli avrei chiesto: «Sillabami la parola Ca-poc-cia-ta!». Ovunque deresponsabilizzazione e acquiescenza di chierichetti docili, apostoli malfidi, cospiranti pilati impalati, destinati, loro malgrado, allo sberleffo tragicomico d’una insopportabilmente frugale Penultima cena. «Ma perché dobbiamo costringere uno che non vuole venire a scuola, a venirci per forza?» vecchio ammonimento da docente lindo e punto e accapo senza macchia, e piccato. «Perché è civiltà» evasi in un bignami di socratica sapienza. «Non assecondare le volontà d’un ragazzino ma bensì esaltare con ostinazione la propria acquisita maturità. È civiltà non essere arrendevoli di fronte a 15 chi è arreso; non essere vili di fronte a chi è vigliacco; non essere arroganti di fronte a chi è arrogante. È civiltà dimenticare il nostro miseramente egocentrico amor proprio e vivere ogni giorno per tramutare gli insulti di oggi nella riconoscenza di domani. Se allo sputo si risponde con lo sputo s’inaugura un codice comportamentale che accredita quel gesto. Non solo: lo sublima. Incoraggio colui che è debole di valori ad abbracciare valori deboli. È così che la società si sta frantumando. Ingannevoli dispute tra cattivi allievi e cattivi maestri. Di-sputare, non se ne può più.» La concione d’inadeguata eloquenza oratoria sortì l’effetto d’ammutolire tutti. Per qualche prezioso istante presupposi d’assaporare la fragranza aerea del famigerato settimo cielo, senonché, a blandire il fatale incantesimo, s’alzò il cenno d’una vate vigorosa, irosa, in voga di vaticinii. «Ci sono regole che vanno rispettate. A un comportamento scorretto corrisponde una ragionevole punizione. Non c’è da dissertare ma solo da applicare una norma!» «Se noi gli togliamo la scuola» mi sorpresi a urlare «a chi, al di fuori di essa, non ha niente, siamo complici del suo isolamento, della sua perdizione. Noi tutti saremo corresponsabili del male che egli ineluttabilmente stabilirà di fare agli altri e a se stesso!» Sibilò un passaparola di feroce contrarietà che s’esalò asfissiante dalla gola biliosa della burocrate sovrintendente al presidio scolastico. «D’accordo professore. Finiamola! Si metta a verbale che Giannitti verrà sospeso per quindici giorni con un 16 solo voto contrario, quello del professore. Le va bene così?» Mi rivolse un’occhiata melliflua. Annuii. Dentro di me uno sbraitante coro gregoriano la stava mandando affanculo in latino. Una suggestione linguistica affascinò un riverbero di delirante corrispondenza. Frantumare e crepare. Crepare è sinonimo di morire ed è sempre subordinato all’azione di chi frantuma. Tutto va in frantumi e si fanno le crepe. Se qualcosa crepa il decorso della frantumazione non può essere interrotto. La morte è fine a se stessa. Questo l’assioma conclusivo della mia silloge di sillogismi. Quasi per forza d’inerzia detonò nella mente una celebre poesia d’Ungaretti. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto Ma nel cuore nessuna croce manca È il mio cuore il paese più straziato 17 Questo era il mio stato d’animo eppure m’avevano raccontato che il nostro fosse tempo di pace. Qualcosa non torna? Giannitti non torna. È crepato. S’è frantumato per sempre. Il solito motorino senza casco. Una parentesi di cronaca d’un qualsiasi telegiornale dopo i servizi della politica e prima del meteo. Cose che accadono. Disgrazie. Fatalità. Nuove generazioni. Dolore. Gli amici dicono di lui. Dopo il marito anche il figlio, povera signora. Non è colpa di nessuno. No, non è vero. La colpa è soprattutto delle medie e di questo assistenzialismo esasperato. E che cosa è diventata la scuola? Un ammortizzatore sociale? Porco Odio. È colpa mia. 18 Marco Mazzucchelli La mattina prima di andare a lavorare Evado. Dalle non-stelle. Dall’era dei parcheggi dei Bennet come sconfinati Ground Zero di provincia. Bagliori radioattivi, albe perenni. Ci prendono per il culo, i campagnoli, per i nostri cieli arancioni. Evado dalla mattina di tredici giorni fa, quando uscendo per andare al lavoro ho guardato mia moglie dormire, il viso voltato vero l’armadio. Il suo zigomo pronunciato asiatico nascondeva la cavità oculare, e la fronte, col disegno dei capelli, assecondava l’impressione che quella fosse la mezza faccia di un non-essere. Non riconoscevo quella testa, ne mancava un pezzo. Avevo paura che quella cosa si girasse rivelandosi. Evado da quella vita, dove sulla gente grava un tendone che trattiene tutta la merda che può riversarsi sulle nostre esistenze. Ho sempre visto un sacco di gente andare in giro sporca di merda, ma io no, sono sempre stato molto attento a tenere separata la mia vita e la merda che ci incombeva sopra. Poi ho avuto una ragazza, mi ha sposato, e queste due cose assieme hanno preso un coltello e hanno squarciato il tendone. La vita di merda è l’omologazione. È lo stampino che le città moderne spingono verso le nostre teste, verso la settimanale colazione di sabato mattina all’Auchan, 19 seduti vicino all’entrata del supermercato che incalza, vicini a esseri osceni, brutture, i cui figli ne erediteranno le colpe genetiche. Guardavo ciò che pensavo essere la donna della mia vita, addentava croissant con uno sfondo fuori-fuoco di peli lanosi intricati nelle maglie di catenine, smorfie disgustose delle bocche, denti incatramati, pori saturi di sebo, e arroganza, e ignoranza, il mix letale, l’infezione che rende marcescente il suolo che calpestiamo e accoglie le fondamenta delle nostre case. La vita di merda è dover iniziare con gli aperitivi alle dieci di mattina di sabato all’Auchan [mi serviva], è stare in coda in autostrada per andare all’outlet di Serravalle fumando erba, rigorosamente [mi serviva], è chiudere gli occhi e congelare la mente in coda all’ufficio postale mentre chi è allo sportello strilla contro chi ci siede dietro, ancora [mi serviva]. Non potevo far altro che girare per questi grumi di cisti che sono le città, in un perenne stato confusionale. Quella mattina che sono quasi morto di paura davanti a mia moglie che dormiva, ho aspettato che andasse al mare dai miei suoceri per il weekend, ho presentato dimissioni consegnando le chiavi dello studio e chiesto e ricevuto metà dei soldi che mi spettavano. Ho prelevato e prelevato e prelevato. I soldi che erano di mia moglie e che avrebbero dovuto essere per nostro figlio. Non visto, ho venduto l’oro. Ho ammazzato il gatto, poi l’ho cucinato e mangiato, perché letteralmente mi straziava l’idea di separarmene. Ho salvato su una memoria flash i miei video porno preferiti. Ho pensato se fosse il caso di salutare mia madre e la sua malattia degenerativa. 20 Ho deciso che no, non era il caso, così mentre dormiva le ho solo rubato i soldi dal portafogli. Ecco la rivelazione. Ecco come in queste ultime ore non ho fatto altro che annientarmi, rigettare la parte peggiore di me, mostrarmi. Da giovane non ero niente male, forse fin troppo corretto, e ora eccomi corrotto. Siete stati voi a trasformarmi così, siete stati tu e tu. Mi avete reso vecchio, reso brutto. Ricordo che per voi volevo diventare una persona migliore e ora mi rendo conto che la costrizione del vivere assieme era lì, dove se mi affacciavo per vedere le stelle vedevo solo un enorme sacchetto di plastica arancione che qualcuno mi aveva legato al collo. Avete scalfito la corazza delle mie buone intenzioni, avete limato e assottigliato, ma questo non è stato un lavoro che ha impreziosito, perché non lucidava, non smerigliava niente. Mano a mano apparivano in superficie il marcio, le croste, poi i tendini sfilacciati, i tessuti morti. Scotennandomi avevate trovato il vero me stesso, nella scala evolutiva ero l’uomo che regredisce, e regredendo si dirigeva a est. Nella fattispecie, l’uomo regredito ha guidato verso l’Ungheria, per bagnarsi nel lago Balaton, rinascere nella palude del lago dove le ragazze dopo mezzora che sono fuori di casa hanno già l’alito che sa di cazzo. Ero fermo in coda da cinque ore in autostrada e mi ripetevo che quelle erano le ultime ore della mia vita di merda. Ero sobrio, avevo buttato l’erba dal finestrino. Ma fatemi solo raccontare del pomeriggio che vi sono arrivato, così è giustificato tutto quello che ho fatto. Fatemi solo dire del guidare sulla strada costiera, dei 21 villaggi che si susseguono come perle lungo una collana, i negozi di articoli per mare, i pochi vacanzieri sulle strisce pedonali, i teli mare appesi fuori dalle case a due piani, le visioni rapide del lago tra gli scorci, le vele dei windsurf, ragazze sorridenti che escono di casa. Lasciatemi dire della natura madida di questo posto, i canneti che iniziano a divorare le spiagge e i villaggi, e dopo, la palude. La natura che si rivela, marcescenze e parassiti abitano le nostre essenze più vere e lì, tutti, siamo diretti. Il mio arrivo alla parte più nascosta del lago, prima di Keszthely, camminare in questa natura slava, fendere i canneti con le mani giunte, lungo la passerella di legno verso l’acqua stagnante, scoprire il lago a mollo nell’arancione e verde oliva e ocra dei tramonti d’estate. Lasciatemi dire del gulasch per cena e delle voci provenienti da una lontana festa di paese, le sento, voci di ragazze appena uscite di casa. Del mio camminare rasente la strada, nel buio deserto e pesto e pesto e pesto della notte transdanubiana, dell’esserci nulla che illumini oltre il lattiginare dei miliardi di stelle. Non avevo mai visto niente pulsare così. E la boscaglia palpita anch’essa, con le sue cicale e gli effluvi di clorofilla. Rieccomi primigenio, ululante verso il cielo, è giunta l’ora che apra gli occhi di nuovo. Sapete cosa vuol dire, riaprire gli occhi? 22 Marco Visinoni Paradise now Ho dormito ventidue giorni questo mese. Ventidue. Cinquecentoventotto ore di sonno ininterrotto, senza sogni. Mi sveglio alla clinica, l’infermiera che mi ha accompagnato qui ventidue giorni fa mi osserva a lungo, indica i vestiti che ho lasciato su una sedia. Devono avere un aspetto migliore del mio, da come ci squadra a turno. Mi offre una sigaretta di saluto, mi tossisco addosso. È facile disimparare. Nel tragitto verso casa non parlo, la gola cerca di risollevarsi dal torpore e nessuno sull’autobus fa caso a me. Attraversiamo i tre cerchi che mi portano a casa. Sono ancora addormentato, non vedo nulla. Leila, nell’angolo, è immersa nella luce bianca, non si volta nemmeno alla chiusura del portone. Fuma anche lei, le gambe scoperte ricolme di piaghe. Mi avvicino alle sue spalle senza toccarla, le faccio sentire la mia presenza senza parlare ed è peggio che prenderla a schiaffi, peggio che mangiarsi l’un l’altro. Farei una doccia, l’acqua è scomparsa dal quartiere. In camera la polvere ha sprofondato il materasso nel granito più di quanto ricordassi. Forse ricordo male. È colpa mia, penso. 25 Nel bagno lo specchio ha una Y centrale che lo divide in tre parti, i due trapezi separano le mie guance ma per un riflesso del vetro mi appaio estraneo, sbilanciato, sofferente sotto la mia fronte che nel triangolo mostra capelli bianchi e sottili, più sottili della barba che il sonno ha impedito di tagliare. Raccolgo un vecchio rasoio da una sacca abbandonata sotto il lavandino, è doloroso farlo così. Mezz’ora dopo sono al lavoro. Raccolgo gli scarti del supermercato e a seconda della legge di riciclo mensile restituisco il cibo non eccessivamente masticato ai suoi scaffali. Questo dice la legge di riciclo mensile. La primavera è il periodo più tollerante, recupero tutto ciò che aprendosi sia privo di vermi e sostanze mucose. Lavoro sedici ore al giorno. Ne vorrei di più, il supermercato non è disposto a pagarmi tanto. A fine giornata torno da Leila, la trovo nel buio proprio come stamattina l’ho trovata immersa nella luce bianca. Resto dietro di lei per qualche minuto, vado allo specchio e sono stanco nonostante tutto, nonostante le 528 ore di silenzio e quiete che mi hanno portato fino a oggi. Il giorno dopo incontro il capo. Non gli stringo la mano, lui non me la porge. Lungo le mie dita una melma informe di yogurt e frutta marcia. Il capo non ha espressione, ha due occhiali nei quali rifletto le mie pupille e mi vedo stantio, provengo anch’io dal cassonetto che sto toccando. Il capo come ogni mese ha un calendario scritto a mano sul coperchio di un cartone per la pizza. È l’unica occasione in cui ne vedo uno, nella testa scelgo sempre il nome di un ristorante e sono felice quando scopro di aver indovinato. 26 Mi chiama per nome, da quanto tempo nessuno mi chiama per nome. Dice che non era in programma che fossi qui oggi, dice che la giornata non mi sarà retribuita. Retribuita, così parla il capo. Mentre si allontana scopro di non aver indovinato il nome sul coperchio. Raggiungo gli altri alla mensa, l’altoparlante gracchia e tutti insieme stringiamo i denti mentre il segnale si assesta su una frase pubblicitaria. Mi piace la pubblicità. Dice che la clinica è aperta anche questo mese e che il sonno non costa niente, il sonno fa risparmiare. Dormendo non puoi comprare, non puoi mangiare, dormendo. Torno al cassonetto e proseguo per altre cinque ore. Ogni tanto dal fondo del garage compare il capo, la giornata non pagata è un trucco per scoprire chi tiene al suo lavoro. A fine mese non sarò pagato, ma il capo saprà che si può fidare di me. Torno a casa, è buio profondo e dall’autobus vedo lupi in giro per la città, si cibano dei cadaveri abbandonati. Molti morti sono stretti l’uno all’altro, sono morti di freddo mentre erano addormentati. Mentre io ero addormentato, penso. A casa Leila è seduta davanti alla finestra, senza toccarla le dico che non sarò pagato per oggi e lei non ha reazioni, i suoi occhi sono chiusi. Vedo che non si è alzata neanche per andare in bagno. L’odore nella stanza non è insopportabile, ma è brutto e lascio la stanza premendomi il naso. La Y ritaglia il buio del vetro e non mi vedo più, solo le crepe emettono riflessi di luce. Dormo in terra, addosso alla sacca con il rasoio e le coperte per l’inverno. Ho sete, ma non fa più così freddo, penso. 27 Il giorno dopo l’autobus sbanda davanti a me, rischia di travolgermi ma l’esplosione di una ruota lo fa sterzare e spegnersi contro una vecchia stazione di benzina, dall’altro lato della strada. Vent’anni fa si sarebbe incendiato. Ora si limita a un rumore di metallo contorto che muore in fretta. Mi muovo nel vento stringendomi con le braccia quanto posso, per fortuna i lupi dormono di giorno. Stasera ci saranno un altro autobus e un funerale collettivo per la strada. Arrivo dieci minuti in ritardo, il capo mi guarda lavorare da lontano per due ore, poi si avvicina. Mi dice di lavorare oggi, dice che non mi farà più lavorare per il resto del mese. Salto il pranzo, nelle ore successive conto i soldi che i due giorni mi hanno portato. Passo da casa, Leila è alla finestra, dorme. Senza svegliarla lascio le banconote e raccolgo una coperta da portare con me. Leila pagherà la stanza, mangerà quello che il supermercato spedisce a noi raccoglitori come contributo per il nostro lavoro, i resti recuperati dall’immondizia e non riacquistati. Non comprerà un vestito per il funerale in strada. Non comprerà sigarette, non riceverà una pizza in un contenitore di cartone. Non verrà alla clinica a controllare che tutto vada bene. Alla clinica tutto andrà bene. Ventotto giorni e sarò fuori. Ventotto giorni. 672 ore di sonno, senza sogni. Ventotto, e sarò di nuovo fuori. 28 Simone Rossi Abbandono Oblio Deserto Abbandono La prima volta che trovo una stanza a Bologna è appena iniziato gennaio: mio nonno è ancora vivo. Costa poco, è singola, c’è internet: basta. La tipa è gentile. Fricchettona, ma gentile. È vestita come il suo cane, letteralmente: lei ha i pantaloni verdi della tuta e una felpa rosa, e il suo cane pure. Rosa è anche il nome del cane. Le faccio notare questa cosa dei vestiti uguali (lei non se n’era accorta). Ah, guarda! È vero! Non ci avevo fatto caso! Rosa, hai visto? Sei vestita come la mamma! Rosa è nera. È un mastino napoletano. Non c’è problema, penso. Il cane non è mio, dice lei. Non c’è nessun problema, penso. È del mio ragazzo, dice lei. Lui ha avuto qualche casino e allora l’ha lasciato a me. Il tuo ragazzo è un punkabbestia, penso. Adesso probabilmente è in galera, e in galera i cani non ce li fanno entrare. Non c’è problema. Non c’è davvero nessun problema. Smetto di pensare, parliamo. Sparo subito i colpi migliori: suono, scrivo, tiro su la tavoletta del cesso, la ritiro giù. Beviamo un tè, lei fuma una sigaretta, Rosa dorme. 29 Torna la settimana prossima, dice lei. Ti faccio conoscere la mia coinquilina. Un week end di metà gennaio muore Tonino Gamberini detto Bartulò, di anni 82. Sua moglie se l’aspettava, ma non se lo sarebbe mai aspettato. Sua figlia si ritrova a pensare che forse questa è una liberazione. Io mi ritrovo con mio nonno in una bara e il mio nome su una corona di fiori, e posso farci veramente poco. Però penso a una scena: la scena del nipote che chiama la nonna da un appartamento al sesto piano alla Bolognina, con i cani neri vestiti di rosa e la Verde Dorata Virginia, il Pratello monello e i muri con il pennarello, il cappuccio tirato su, la postura sbagliata e le notti a far finta di avere una macchina da scrivere, no, non ce la faccio. Come stai, nonna? Io sono a Bolo! La strada vede tutto, nascita e lutto! Ah, la scena culturale bolognese! Non puoi proprio capire, guarda! Come vuoi che stia, idiota di un nipote, tuo nonno è morto l’altro ieri e tu vai a sputtanarti i soldi che non hai vivendo in una casa che non ti serve insieme a Rosa e alla padrona di Rosa, che il cane non è nemmeno suo ma del suo moroso punkabbestia. Infatti no, scusami nonna, non ci vado. Rimango qua. Rimango a Forlì. Anzi, no: in provincia di Forlì. Mando un messaggio alla fricchettona: Scusa, è successa una cosa brutta. Non ci vengo più a Bologna. Scusa. Dai pure la stanza a qualcun altro. Scusa. Ciao. 30 La fricchettona non mi risponde. Chissà se ho scritto bene il numero. Oblio Un pomeriggio di metà marzo prendo un sasso bianco dal vaso di fiori e me lo metto in tasca. Mi siedo sul cemento, guardo la sua faccia da capo indiano incastonata nel marmo. Cimitero di campagna alle due di pomeriggio di un martedì, il niente pieno di uccellini. Nonno, mi sembra di stare dentro a quel racconto che non ho mai scritto, quello della tipa che va a piangere sulla tomba del suo insegnante di pianoforte, però se la guardi bene non sta piangendo. Nonno, ti volevo dire che vado a Bologna. Ho trovato questa stanza, un’altra, non quella del cane. Sono due mesi che mi faccio invitare a pranzo dalla nonna, mi alzo alle nove e non faccio colazione, così mi viene fame a mezzogiorno: passatelli in brodo, cotolette, pomodori in gratè, pesche sciroppate, susine sciroppate, una fetta di panettone che mi è rimasto lì da Natale. Caffè, divano, Famiglia Cristiana. La nonna mangia a testa bassa, poi mi dice: Andiamo di là, devo misurarti un paio di pantaloni. Un paio di pantaloni tuoi. Cucinare e cucire: Ada Ricci vedova Gamberini non conosce altri modi per tenere insieme i pezzi. Cucinare, cucire e andare alla Messa. E venirti a trovare a orari improbabili, così non incontro nessuno che tanto non ho voglia di incontrare nessuno. 31 Nonno, quando vengo a mangiare da voi mi siedo sempre al tuo posto: me l’ha chiesto lei. Deserto La seconda volta che trovo una stanza a Bologna è metà marzo, la settimana scorsa. Prezzo un po’ più alto, ma basso abbastanza, Fastweb, una finestra che dà sul muro della casa di fronte. Bellissima, la prendo. Le coinquiline sono pulite, troppo pulite, pulitissime. Sono altoatesine. Sul frigorifero c’è un foglio con sopra i nomi degli aspiranti coinquilini. Di fianco a ogni nome c’è il numero di cellulare e due righe di giudizio. Numero dodici, simone rossi: Simpatico. Ride sempre. Suona un sacco di strumenti. Potrebbe insegnare a suonare la chitarra a Sonja. Le altoatesine sembrano conquistate. Mi sceglieranno, sono sicuro. Non mi scelgono. Mi chiama Sonja l’altro ieri e mi dice: Guarda, avremmo scelto te. Però usi il condizionale, dico io. Lei non capisce. Cosa? No, dico: usi il condizionale. Vuol dire che c’è qualcosa che non va. Ah, sì, il condizionale. Sì, c’è qualcosa che non va: il padrone di casa vuole un universitario, perché ha la convenzione con il Comune e può prendere solo degli universitari. Se dovessi venire tu, lui sarebbe costretto ad aumentarci l’affitto. 32 Ancora il condizionale. Ma non si può dire che sono uno studente anche se non è vero? Il badge ce l’ho ancora. No, dice Sonja: non si può. Ma lui non lo deve mica sapere, dico io. Ormai gliel’abbiamo detto. Gli unici studenti universitari onesti di tutta Bologna sono due studentesse universitarie altoatesine. Affanculo voi e i vostri canederli, penso. Allora ci sentiamo, dice Sonja. No che non ci sentiamo, Sonja. Non ci sentiremo più. Checcazzomifrega di sentirti. La mia vita ha incrociato la tua perché avevi una stanza a poco prezzo da affittarmi, non me la affitti e allora ciao, addio, adesso cancello il tuo numero dalla rubrica, devo liberare un posto. La terza volta che trovo una stanza a Bologna non c’è stata, è luglio sbricioluglio e mia nonna firma ancora i biglietti d’auguri al plurale. I miei amici continuano a fare figli, io no. 33 Silvia Ancordi Gli undici giganti Parcheggio sul piazzale sterrato e l’auto nera si copre di polvere, entro nel negozio e prendo una bottiglia d’acqua dal frigo vicino alla cassa. «C’è nessuno?» «Arrivo!» sento dire da una donna anziana che cammina, lenta, aiutandosi col bastone; mi si avvicina al viso tanto da farmi sentire il profumo di acqua di rose e sorridendo dice: «Finalmente sei arrivata». Deve avermi scambiata per un’altra. Non so se spiegarle che sono la figlia del falegname che si era incatenato a Geolo, l’abete rosso secolare. Trent’anni prima, credendo alla promessa di una cittadella ricca e moderna, la gente aveva ceduto i piccoli campi e le case in mezzo al verde; mio padre lottò per impedire che il bosco venisse abbattuto, ma l’inizio dei lavori lo obbligò a partire; ci trasferimmo lontano con i pochi soldi che gli diedero per casa e bottega, mentre Tina e il marito aprirono questo alimentari. Pago, e intanto che apro la porta per uscire, sento la sua voce: «Sissi, son quasi cieca e mezza sorda, ma l’olfatto è rimasto buono. Il profumo del bosco resta im- 37 presso nelle nostre anime». E sorride nostalgicamente. «Qui non c’è più nessuno» aggiunge. Le prendo la mano grinzosa, piena di piccole macchie brune; la aiuto a mettersi seduta in poltrona dietro al bancone e gli unici rumori che sento sono il clacson dell’auto e il rombo di un aereo che vira dopo il decollo. «Per favore, vai dai giganti; se potessi ti accompagnerei» dice muovendo il bastone per aria. Si scosta appena dallo schienale per farsi abbracciare e chiede: «Passi a salutarmi dopo?». «Hai scavato il pozzo?» chiede Emma, mia sorella, mentre sgranocchia patatine. «Ho visto Tina!» «L’ho vista una volta con papà almeno dieci anni fa» dice allungando la mano per prendere la bottiglietta d’acqua. Accendo la radio e una sigaretta, poi ripartiamo percorrendo la strada principale costeggiata da negozi con scritto Cedesi attività su cartelli scoloriti dal sole. «Fermati!» Inchiodo e le gomme stridono sull’asfalto: «Guarda!» dice indicando una piccola stele di marmo bianco. Scendiamo dall’auto e leggiamo all’unisono: «Ricciolo, il castagno». «Ti ricordi la mattina in cui papà ci aveva lasciate qui in mezzo al bosco e si era allontanato per andare a funghi?» 38 «Bimbe, restate qui e non muovetevi, scendo verso la strada e torno.» Nell’attesa, guardavamo la luce filtrare tra le fronde degli alberi e illuminare le foglie a terra; cercavamo qualche riccio di castagno ancora chiuso ed Emma, con sguardo incantato, controllava il sottobosco nella speranza di vedere qualche scoiattolo o di trovare un gatto randagio come Tigre, il tricolore appena portato a casa; io annusavo l’aria che sapeva di resina, muschio e terra umida. Di tanto in tanto Emma urlava: «Papà, dove sei?». Lui batteva il bastone sulla pianta più vicina e diceva con tono pacato: «Sono qui». Una lieve eco ci confondeva: l’avevamo visto scendere a valle, verso la strada e ora, stranamente, rispondeva a monte, sopra le nostre teste. Dopo circa un’ora tornava mostrando un cestino vuoto: «Ha piovuto poco». L’olfatto di Emma, quel giorno, compensò la mancata pioggia: sul sentiero di ritorno, annusando l’aria, ripeteva: «Sento odore di porcini». In effetti, sembrava che il suo naso fosse programmato solo per quelli, come un segugio per i tartufi. Sotto un tronco bianco piegato da qualche temporale, trovò un enorme fungo porcino: quella divenne la nostra macchia di raccolta. «Ehi, abbiamo altri dieci alberi da visitare.» Mi ha chiesto di accompagnarla in questa via crucis da fare in auto, per superare muri e terrazzamenti che sostituiscono il vecchio sentiero, perché la leggen- 39 da – secondo me inventata per non fare abbattere il bosco – vuole che ogni desiderio chiesto agli undici secolari venga esaudito. Emma, su ogni lapide, fa il gioco che faceva da piccola con le piante, in attesa che papà tornasse: un giro attorno in senso orario, uno in senso antiorario, e con gli occhi a percorrere il tronco che non c’è più fino al cielo. Mi limito a fumare e ripenso ai giganti secolari che nella mia mente di bambina erano i pilastri delle case di piccoli elfi e magiche fate. Credo di aver fumato undici sigarette in due ore, una per ogni albero. Finalmente siamo alla lapide dell’ultimo secolare. «Ho finito» dice Emma soddisfatta e sorridente. È passato mezzogiorno ma il campanile della chiesa non ha suonato perché anche il parroco si è trovato senza fedeli – visto che qui non c’è possibilità di fare peccato – e se n’è andato. Torniamo all’alimentari e Tina è ancora sulla poltrona con un foglio in mano, gli occhi chiusi con il volto sorridente, una coperta di cotone sulle gambe, che prima non aveva, e il suo bastone è poggiato a terra. La figlia compare dal retrobottega in lacrime. «Tu devi essere Sissi, mi ha detto che ti aspettava.» «Sì, cosa è successo? L’ho vista circa due ore fa e stava bene» dico esitando. «Una lettera del comune per l’esproprio del negozio: vogliono ripiantare gli alberi per via dell’inquinamento della città nuova.» Resto in silenzio. 40 «Ha detto “Finalmente”, e ha fatto un lungo sospiro. Scusate, chiamo mio marito» dice uscendo asciugandosi il viso. Emma si volta verso Tina e piangendo sussurra: «Scusa». Mi abbraccia e aggiunge: «Ho chiesto che lo spirito del bosco tornasse in vita». Ricordando credo di averlo chiesto anch’io. 41 Gianfranco Franchi αλήθεια Una volta ho sognato di correre in una maratona. La maratona si teneva in un bosco. Ai nastri di partenza eravamo in tanti, ciascuno con la sua pettorina, diversi con lo sguardo spiritato. Poi c’era stato il pronti, partenza, via, e io avevo cominciato a galoppare. Man mano, avevo guadagnato la testa della corsa, e non avevo nessuna voglia di voltarmi indietro. Soltanto, correvo. Correvo. Fino a un certo punto, avevo incontrato dei cartelli, nel bosco. Indicavano, semplicemente, la direzione. Avevo rispettato i cartelli, ero convinto di non aver cambiato strada. E poi, a un tratto, avevo smesso di sentire il respiro degli altri corridori. Nessuno sbuffava, nessuno ansimava. Niente sospiri, nessuna parola. Pensavo: fantastico, sono come l’Airone nella tappa delle Alpi, me ne sono andato in fuga. Pensavo: vincerò con un distacco pazzesco. Pensavo: non credevo di essere così in forma. Pensavo: è stupendo essere solo, davanti a tutti, e correre. Avanzavo. Ma non c’era più traccia di cartelli. Non c’era più traccia di indicazioni. Il sentiero, nel bosco, era sempre più sottile, e la vegetazione sempre più fitta. Correvo tra i rovi, i rovi mi scorticavano i polpacci, le braccia. Mi graffiavano tutto, ma io non rallentavo. Sanguinavo, e correvo. Correvo. 45 E poi, mi sono fermato in una sorta di spiazzo sterrato. Mi sono messo le mani sui fianchi, mi sono guardato indietro. Sto correndo nel niente, ho detto ad alta voce. Qui non c’è più nessuno. Ho chiamato aiuto. Ho gridato dove siete?, dove siete. Ho gridato sono qui!, e ho sbuffato. Poi, come fossi un bambino, mi sono messo a piangere. Di botto. Come quando mi sono perso sulla spiaggia, avevo cinque anni. Ma piangere a cinque anni ha senso. Soprattutto in mezzo agli estranei. Qualcuno se ne accorge, di solito una mamma, e si comporta come fosse mamma tua, e senza che tu possa capire come, in men che non si dica qualcuno ti viene a prendere. Piangere a trentacinque anni, in un bosco, perché sei un maratoneta in fuga e nessuno ti sta più dietro, e pure il sentiero è cambiato, non serve a niente. Ti chiedi: sto piangendo davvero? A che serve piangere se nessuno ti guarda? Da quanto non piangevo? E intanto piangi. Piangi come uno scemo, piangi e basta. Ricominci a correre, ma è un automatismo. Fai duecento passi, non c’è nessuno, non si vede niente. Niente. Verde. Terra. Neanche due bestie. Nessun corvo e nessun pettirosso, and no bird sings. Niente. Siamo – nel sogno, eravamo – io e il mio respiro soltanto. Allora mi sono strappato la pettorina, e mi sono tolto le scarpe. Mi sono tolto i calzini, mi sono tolto la maglia. Mi sono tolto i pantaloncini, mi sono tolto le mutande. Nudo mi sono immerso nel bosco, senza dire una parola, senza pensare più a niente. Ho deciso che correre non aveva più senso. Ho capito che non avevo più 46 nessuna voglia di gareggiare con nessuno. Ho capito che stavo cercando qualcosa di diverso: una posizione, un senso, un ruolo. Una condizione, uno stato d’animo. Qualcosa che fosse immobile, che perdurasse, che non potesse essere trasformato, che non potesse cambiare. Perché correre, dico, quando in ogni caso non te ne deriva niente? E vincere, vincere cosa significa? Significa innescare meccanismi malati, rivalità, competizione, invidia. La partecipazione diventa una scatola cinese di odio, di antipatia, di ostilità. Di male. No, non me ne frega niente. Ho camminato per il bosco, spoglio di vita, e ho camminato nel bosco perché non volevo più niente. L’eredità del mio passato era una catenina d’argento, al collo. Ho cominciato a disegnare con le mani forme nel vuoto: un piccolo sole, una falce di luna, le efelidi della mia donna, il muso del mio gatto. Il vuoto assomigliava al mio simbolismo semplice, all’allegoria della mia essenza – all’aspetto della mia minima, normale appartenenza. E poi, mentre forse m’ero illuso che stesse nascendo qualcosa di diverso; che fossi, forse, finalmente approdato a una dimensione altra: e che tra non molto, in ogni caso, qualcosa sarebbe successo, qualcuno mi sarebbe apparso, allora... allora sono caduto. Sono caduto nella terra: la terra s’è spalancata, come le cosce di una donna, e mi ha ingoiato. Aveva fame di me. Sono caduto, e precipitando pensavo: non è successo niente. Sono caduto, e rotolando nel vuoto pensavo: se cado di schiena mi 47 faccio male. Sono caduto, e sbattendo contro le pareti della terra pensavo: ho un neo che non mi devo graffiare, quel neo è delicato. Sono caduto, e la caduta non conosceva fine. Quando cadi per tre secondi, non è niente. Quando cadi per dieci, ti comincia a pesare. Quando cadi per quindici, ti senti il cuore che esplode, ti fanno male le orecchie, senti freddo sotto i piedi, diventi rigido. Sono caduto, e poi non ho più sentito niente. Mi sono lasciato andare. Cancellati i pensieri, perduta l’alterità, svanita ogni forma di umanità, ho visto il mio futuro, e l’ho scelto. L’ho incarnato. Mi è sembrato divertente. So di averlo scelto. C’è un bosco in cui nessun vivo mette piede. In questo bosco c’è un grande spiazzo, e nel bel mezzo c’è una fontana. L’acqua di questa fontana è la conoscenza – è la memoria della trascorsa vita. Io però stavolta non mi volevo fermare a bere. Non volevo rinascere. Volevo restare a guardare. Volevo restare a guardare, volevo aspettare. Volevo aspettare che qualcuno – non qualcosa – capitasse. E così, ho domandato a dio di plasmarmi come una statua. Io, uomo di marmo, ero la scultura della fontana: la fontana dell’acqua del ricordo. Non avrei più gareggiato, non avrei più partecipato a nessuna corsa, non avrei più scritto o detto niente. Niente rivali, niente pettorine, niente strade da rispettare. Niente arbitri, niente spettatori, nessuna donna da conquistare. Soltanto: come pietra, innamorarsi dell’acqua. Intanto: come pietra, sbirciare le persone, quando finiscono di vivere e decidono di dimenticare quel che sono state. 48 Infine: come pietra, vagare nei sogni in cerca di una pietra simile. Ecco. Come nuda pietra, non avere più faccia, e non avere nome. Non dissolversi: annullarsi. Non respirare affatto. Goccia adesso la fontana. Per ogni stilla d’acqua, un ricordo che non brucia. Per ogni stilla d’acqua, io, pietra, scintillo di gioia. Non posso bere, e non più voglio. 49 Fabio Medda La parte del manico È la storia di una donna. Una storia dura, con il suo continuo basculare tra cinismo e tenerezza, ingenuità e calcolo. Una storia sporca. Una donna obbligata a essere coraggiosa, che va anche oltre. Ma non chiamatelo lieto fine. Facendo finta per un attimo di cadere nel tranello di questa pessima traduzione di happy end, si può dire che se il fine giustifica i mezzi, qui il fine è lieto quanto lo sono stati i mezzi. Egregio Presidente, sono una impiegata dell’impresa di pulizie che Lei ritiene essere sovradimensionata per le esigenze della sua società e, per questo motivo, ha deciso di mettere da parte. So bene come andranno a finire le cose. Il sindacato ribatterà che si devono garantire i livelli occupazionali, Lei insisterà sulla necessità di ridurre drasticamente il servizio e si arriverà al compromesso che si lavorerà meno, per lavorare tutte, oppure si salveranno soltanto la metà delle attuali dipendenti, ma con l’orario immutato. Qualcuna sarà prepensionata (non è il mio caso), qualcun’altra verrà collocata in cassa integrazione, ma- 51 gari a zero ore, altre ancora troveranno lavoro in imprese collegate. Chissà dove, chissà per quanto. Sicuramente molte di noi dovranno rivedere il bilancio familiare, perché non si potranno più permettere il lusso di contare su 800 euri al mese. Ecco, io potrei essere una di queste. Non mi spaventa, sono cresciuta dovendo quotidianamente affrontare mille difficoltà. Sa Presidente, alle privazioni ci si abitua. Sin da ragazzina ho dovuto tirare la cinghia anche se, a dire il vero, una cinghia nemmeno ce l’avevo. Abitavo con mia madre e mia sorella più piccola in un quartiere fiorente e gonfio di speranze e promesse soltanto per due mesi ogni cinque anni, durante le campagne elettorali. Trenta metri quadri in tre. Mio padre lo ricordo appena, morì che avevo pochi anni. Si viveva della sua pensione di operaio, a cui si aggiungevano pochi spiccioli per l’accompagnamento di mia madre, non vedente. Spesso stavamo al buio, per risparmiare e perché mia madre della luce non sapeva che farsene. Io e mia sorella studiavamo a lume di candela. Siamo sempre andate d’accordo. La sera, mentre mia madre ascoltava la radio per addormentarsi, giocavamo al gioco dell’oca o a battaglia navale. Sono cresciuta senza PlayStation eppure ero felice. La TV arrivò in casa nostra quando un lontano zio si comprò un nuovo televisore a colori e ci regalò il suo vecchio 14 pollici in bianco e nero, con i canali che saltavano spesso e l’audio velato. 52 Per noi l’arrivo della TV fu un evento emozionante, di cui ingenuamente ci vantammo anche a scuola. Ma fu anche l’inizio di un periodo molto doloroso. Allora avevo diciassette anni, mia sorella due in meno. Lo zio di cui ho parlato venne a portarci la nostra piccola TV una domenica mattina. Non dovette suonare il campanello perché proprio in quel momento mia sorella teneva la porta di casa aperta per poggiare sul pianerottolo il sacchetto delle immondizie. Lui salutò ed entrò. Io in quel momento stavo facendo il bagno nella vasca piena di acqua calda e sali profumati. Me lo potevo permettere soltanto la domenica e volevo gustarmelo fino in fondo. Lui non era mai stato a casa nostra. Passò davanti al bagno proprio mentre io uscivo dalla vasca. La porta era aperta, come sempre. Quando si vive con una non vedente non si fa tanto caso a certi pudori. Io e mia sorella talvolta giravamo seminude per casa, senza alcuna malizia. Mio zio mi fissò per alcuni secondi, prima che riuscissi a prendere l’accappatoio e chiudere la porta. Qualche giorno dopo squillò il telefono. Rispose mia sorella. Era lui. Non ci girò molto intorno. Mi disse che molte mie coetanee potevano fare una vita più agiata della mia perché ogni tanto facevano compagnia a persone anziane e bisognose di intimità. Si lavorava poco e si guadagnava bene. Lui controllava e faceva in modo che non succedesse niente a nessuno e che gli incontri si svolgessero nella massima riservatezza e pulizia. 53 Lo mandai a cagare. Non ero neanche sicura fosse davvero mio zio. Poche settimane dopo arrivò Natale. Un triste, tristissimo Natale. Anche mia madre era morta, i primi giorni di dicembre. L’unico reddito per me e mia sorella era ormai la pensione di mio padre. O meglio, quello che ne restava. Le prospettive dell’immediato futuro erano poco felici. Il giorno dell’Epifania lo zio chiamò ancora e, dopo le condoglianze, mi chiese se ero ancora arrabbiata con lui. Questa volta non gli sbattei il telefono in faccia. Gli incontri si svolgevano in un monolocale della costa, appartato, decoroso, abbastanza pulito ma con un forte odore di umido, arredato con gusto dozzinale e, date le circostanze, equivoco. I primi tempi lavoravo un paio d’ore una volta alla settimana, ben presto i giorni diventarono una decina al mese. Molti pensionati, qualche agente di commercio, turnisti, dipendenti in trasferta e militari. Si agitavano sul mio corpo acerbo per pochi minuti, dopo avermi toccato dappertutto rudemente, senza il minimo sentimento. Ricordo ancora l’alito puzzolente di tanti corpi sfatti, gli occhi impregnati di vino, le loro unghie sporche su di me. Ho visto tante cicatrici, tanti nei. Ho respirato tanto sudore e fumo di sigaretta. Alcuni clienti erano evidentemente abituati a certi incontri, altri invece recitavano un ruolo che non gli si addiceva, con frasi forzatamente volgari per darsi un tono. Magari a casa li stava spettando una figlia della mia età. La mia discesa all’inferno durò sei mesi. Un pomerig- 54 gio si presentarono in due, pieni di tatuaggi e di proposte insostenibili. Io, con la scusa di andare in bagno a lavarmi, scappai dalla finestra e corsi fino a sentire il cuore scoppiarmi in gola. Tornai a casa molto tardi, in autostop. Dopo due giorni lui mi telefonò. Mi riempì di insulti e, con mia grande sorpresa, mi disse che aveva già in mente di scaricarmi perché ero ormai maggiorenne, ma che un giorno l’avrei cercato io e mi avrebbe ripreso soltanto alle sue condizioni. Stavolta fu lui a sbattermi il telefono in faccia. Non l’ho più sentito né visto. Qualche mese più tardi risposi a un’inserzione sul giornale. Si trattava di un posto part-time di segretaria presso un’associazione di artigiani. Compenso da fame, tutto in nero, nessun contributo previdenziale, orari pesanti. Un ricatto per disperati, ma io ero disperata e accettai. La sede sociale era uno stanzino al piano terra di uno stabile fatiscente appena fuori città. Mi comprai un paio di pantaloni e un maglioncino dai cinesi sotto casa per assumere un aspetto dignitoso. Con un vasetto di fiori e due quadretti provai anche a rendere più grazioso ed accogliente l’ufficio così spoglio, striminzito e sperduto ma per me così importante. Il mio lavoro consisteva nel rispondere al telefono, spedire la corrispondenza e verbalizzare durante le riunioni. Per arrotondare la paga non affrancavo le lettere destinate ai soci e le consegnavo a mano. I soldi per i francobolli, tolte le spese per i biglietti del pullman, 55 restavano a me. Fu proprio in occasione di una di queste consegne che conobbi, l’anno scorso, il proprietario dell’impresa di pulizie dove ho lavorato fino a oggi. Cercava nuovo personale e mi propose di fare un periodo di prova di tre mesi. Il resto della storia lo può intuire, Presidente. Adesso Lei si starà chiedendo come mai Le ho raccontato tutte queste cose. Non si preoccupi, non intendo elemosinare una raccomandazione o chiedere la carità di una proroga dell’impiego. Il mio destino è affidato al gioco delle parti, ho un destino precario. Ricominciare non mi spaventa più. Ma ho una sorella più piccola e ho promesso a mia madre, quando era in punto di morte, di vigilare su di lei. Questo pensiero mi ha sempre dato la forza di sopportare tutte le umiliazioni che ho dovuto subire e di maturare la convinzione di risparmiarle almeno a lei. Non ho altre pretese che proteggere la sua dignità. Ma lo sa che la settimana scorsa stavo pulendo la barca del titolare dell’impresa di pulizia ormeggiata al porticciolo e all’improvviso dall’imbarcazione accanto è uscito Lei con la sigaretta in bocca e un fascio di quotidiani sotto il braccio? Aveva un bel paio di occhiali da sole, pantaloncini e ciabatte. Non mi ha vista e per non metterLa in imbarazzo anche io ho fatto finta di niente. Vede Presidente, da quel giorno mi sono chiesta spesso dove avevo già visto la cicatrice che Lei ha sotto lo stomaco. Stanotte mi sono ricordata. Io e la sua cicatrice ci siamo conosciuti nel monolocale sulla costa. Lei non può ricordarsi di me, io invece 56 fatico a non pensarci. Ma con un po’ di buona volontà potrei dimenticare. Perché esistono anche cicatrici che possono scegliere di non sanguinare. Con deferenza. 57 Angelo Zabaglio e Andrea Coffami Pianterei Dovrei semplicemente rincorrere il mio passato, guardarlo negli occhi e dirgli: «Come stai grande capo?». E lui magari mi sorriderebbe pure, mentre cerca d’intimorirmi come fosse un albero secolare. Stanotte andrò a ballare robba acida. Musica che una pasticca non basta, che tre canne non bastano, che sei rum e pera non bastano. Sarò in uno di quei locali dove entri in bagno sano ed esci con il raffreddore. E lui ballerà con me, bello come un divo naturale, con le vesti leggere che gli copriranno indecentemente le spalle e la schiena. E finiremo con il fare sesso, con il baciarci le labbra, con lo sfiorarci le dita, con il salutarci, con l’allontanarci. Mi telefona il mio socio mentre mastico del vino che serve da lubrificante per i pensieri. Gli parlo e mi rendo conto che il filtro tra cervello e lingua ha due grandi buchi che lasciano scivolare parole tipo “troia” e “cazzo” senza un vero ed essenziale motivo. La telefonata termina e vado a farmi una doccia, sperando di levarmi di dosso la puzza di lavoro che mi atrofizza il cervello. Lo vedo il mio cervello: è grigio con tre chiazze nere come 61 fosse un cavolo marcio. Puzza di vecchio e pulsa gli ultimi minuti. Devo curarlo con della musica e metto su il cd con le strumentali. Nudo sotto la doccia. Il getto d’acqua mi riscalda le spalle ed i capelli, scende per la schiena ed arriva ai piedi. La sensazione che provo è priva di emozioni. Sto diventando lentamente un uomo di sola carne. Dovrei resistere ma è troppo difficile e sinceramente non sarei pronto ad affrontare nuove emozioni, ora, in questo istante, in questo preciso periodo della mia vita. Molto più semplice bere, ascoltare musica e lavorare vivendo il 43% della mia esistenza in un ufficio con pareti chiare. Nelle ultime settimane i miei vecchi amici si sono rivelati dei simpatici burloni che amavano solo la mia anima, una volta andata a puttane non mi considerano più. Ho voglia di fumare erba, con Giuliana. La chiamo. Il numero è occupato. La chiamo di nuovo. Devo resistere a questa tentazione, dovrei capire che il telefono non è stato creato da Dio, non è un segno vitale che ci porterà alla morte. È solo un oggetto che vibra voci. È Giuliana. Risponde e revisiono la mia teoria. «Ho voglia di fumare con te» le dico. E lei: «Solo fumare». E io: «Certo, magari nudi sotto il piumone». Lei ride e poi: «Arrivo». Mi rullo una sigaretta. La saliva abbonda, lascia filamenti che partono dalla colla della cartina fino alle labbra. Non ho resistito. Avrei dovuto dirle: «No, meglio di no» anzi non avrei dovuto chiamarla per nulla. 62 Qui piove che Dio si sta proprio sfogando alla grande da due ore. Noi due sotto le coperte che fumiamo nudi. Fumiamo e basta. Giuliana si addormenta e io le cicco sui capelli, le è sempre piaciuto. Sento che sta arrivando il bisogno di alcool, non è visibile ancora, non riesco a vederne bene le mani e gli occhi, è ancora lontano. Devo resistere. Come palliativo potrei usare del the, pare funzioni. Il bere alcolici è un continuo di onde con alte e basse maree. Possono esserci delle pause ritmate o dei buchi imbarazzanti, come in una prima teatrale ma il succo della questione è che non si smette mai di bere. La sera scorsa su Rete4 davano Renzo Arbore intervistato da Sbirulino. Non potete mettere Sbirulino alle quattro di notte di un giovedì italiano. È qualcosa di altamente reazionario e allucinogeno. Nel forno ci sono sei pezzi di pizza avanzati da un giorno, ne prendo un paio. Li addento e l’ingoio, già so che riusciranno da dove sono entrati. Non resisto e afferro un terzo quadrato di margherita. Mi rimetto a tavola con gli occhi su Sbirulino che ora canta la canzone della sigla. “Cavallo, cavallo se fossi un coccodrillo, se fossi più tranquillo.” Termino l’intera teglia e corro in bagno a menarmi le dita in gola per dormire a pancia vuota. Al mattino sveglia alle 6 e mezza, non ho mal di testa per fortuna. C’è un freddo boia, chi cazzo non ha acceso il riscaldamento? Sollevo la coperta e mi butto sotto la doccia. Giuliana è andata via senza salutarmi. O forse è nascosta in un cassetto della scrivania. Imparo a credere 63 che sia nascosta nella mia stanza. La solitudine e l’abbandono non fanno per me. Ho una mezz’oretta buona per lavarmi, cagare, preparare il caffè e buttarlo giù tutto d’un sorso come fosse una medicina. Esco di casa e arrivo alla stazione dove bestemmio vedendo passare l’autobus davanti ai miei occhi. Sbraito tentando di impietosire il conducente, che con un sorriso gentile rallenta e apre la porta per farmi salire. Non si è poi così soli, penso. Lo ringrazio e lui nemmeno mi risponde, si sente superiore il tizio. Ha il coltello dalla parte del manico, può permetterselo. Mi vado a sedere nelle ultime file. La puzza di piscio inizia lentamente ad entrarmi nei vestiti, nella pelle e nel sangue. Arrivo in ufficio. A lavoro non si beve, al massimo una birra. Diventerebbe tutto più complicato, farei troppi errori, più di quanti già ne faccio da sobrio. Devo resistere fino alle quattro, poi sarò libero di dormire un po’, di scrivere e pensare al mio amore che non c’è più. La sua morte mi arrivò improvvisa e inaspettata. Una telefonata. Una semplice telefonata che mi trasformò in stazione ferroviaria deserta. Merda vacca ho finito il tabacco e fuori diluvia grandine tosta. Quel pomeriggio avrei dovuto avere un lavoro nuovo, una nuova esperienza. Ma con che faccia potevo recarmi dal tizio che mi avrebbe pagato per fare qualcosa che, sinceramente, non volevo fare. Con il pensiero della morte di lei in testa. Era inconcepibile. Non mi presentai all’appuntamento. Rimasi nascosto in un cassetto della scrivania, vicino ai calzini rossi. 64 Il giorno dopo mi chiama il capo e mi sbraita al telefono per dieci minuti. È fatto così, bisogna capirlo, è stressato e scopa poco. Mi dice che se faccio un’altra cazzata mi licenzia. Per fortuna non ho un contratto, gli rispondo. Hai appena fatto la cazzata, penso. Invece no. Il lavoro prosegue e presi a considerarlo come un pesce spada da uccidere e mangiare a tranci. Senza rimorsi. Mia zia mi raccontava sempre questa storia: Nino era un bambino povero e triste. Un giorno, mentre rovistava nella spazzatura vide una moneta d’oro. Nino non sapeva che quella moneta era magica: se immersa nell’acqua di fiume, avrebbe potuto esaudire qualsiasi desiderio. Nino raggiunse il padre che stava pescando poco distante. Per l’ansia di dare la bella notizia, il piccolo cadde in terra battendo la testa. La moneta finì in acqua ma Nino non dava più segni di vita. Al padre venne istintivo gridare: «Non morire». Ed il figlio aprì gli occhi subito, all’istante, come nulla fosse accaduto. Ecco… ora non mi sento né il piccolo Nino, né il padre, tanto meno la moneta magica. Oggi mi sento fiume… e non devo resistere a nulla. Anzi, oggi sono il pesce di fiume che ha scampato l’amo. 65 Erwin de Greef La mela caramellata Noi tutti bevevamo sulla soglia del locale di Malachìa che si affacciava su una scalinata rivestita di pasta frolla e divideva il mondo in due parti. Una era per quelli che se ne fregano e camminano col naso in su. L’altra era per chi s’interessa a tutto e cammina col naso verso terra. Noi eravamo in mezzo e scorrevano fiumi d’alcool. Io bevevo birra perché il mio fegato se n’era andato a farsi un giro. Edith beveva gin tonic perché il suo cervello voleva farsi un giro. Con noi c’era Addy che mi guardava, mi dava a parlare e credo proprio che volesse farmi il filo. Ruffo con un cappellaccio di paglia in testa e i piedi scalzi suonava il flauto di traverso nell’angolo della strada e richiamandomi con un gesto mi sussurrò: «Ti presento Kirsten, la mia donna». Fu allora che mi accorsi che gli occhi di Edith si erano fatti meno chiari e la vidi mandare giù il gin tonic d’un fiato. Lei mi sorrise ed entrò nel locale per uscirne subito dopo con un altro. Cleto mi disse: «Ma così si fa male». «No», gli risposi io. «Questo è quello che vuole lei.» Dentro il locale, la musica era suonata ad alto volume e doveva piacere a un sacco di gente perché ballavano, saltavano e battevano il ritmo sui tavolini di strudel farcito con mele cotogne e uva secca. 67 All’angolo della strada, dov’era Geppo che fotografava Viola dai capelli biondi e corti, c’era anche Fermo, vestito con abiti di pelle di capra, che stava vomitando. Le persone che camminavano col naso in giù lo scrutavano dall’alto verso il basso e preoccupate gli domandavano: «Ma cosa c’è?». Lui rispondeva: «Vomito quello di cui non avevo bisogno. È molto buono. Ne volete anche voi?». Per qualche istante lo guardavano perplessi e poi se ne andavano da quella parte di mondo dove tutti camminano col naso verso giù. Le campane suonarono a morto e subito Malachia abbassò il volume della musica perché, come lui stesso ci spiegò: «Non è giusto per il morto». Noi fummo d’accordo e decidemmo di abbassare anche il tono della voce e fare meno tin tin con i bicchieri. Andammo nel retro del locale ricoperto con mollica di pane. Vestimmo abiti di corteccia dipinta di nero, accendemmo i ceri e, portandoci un bicchiere di quello che ci andava di bere, uscimmo all’aria aperta. Silenziosi seguimmo la processione che s’ingrossava ogni momento di più. C’erano tante altre file che si univano alla nostra e per ognuna c’era una persona che suonava una campana a morto. La processione si fermò. Noi tutti ci disponemmo in cerchio, intorno alla bara e dovevamo stare attenti a non cascarci dentro. In quel caso, chi ci avrebbe tirato fuori? Dei signori incappucciati accesero le fiaccole e fu allora che s’illuminò una piazza grande, delimitata da palazzi antichi e nobiliari costruiti con croccante di mandorle 68 tostate e zucchero cotto. Al suo centro c’era una statua equestre di budino alla vaniglia. Rimanemmo immobili, immersi in quella luce. La bara era scoperchiata e dentro c’era un signore che dormiva. Era elegante, vestito con abiti di cioccolato bianco e la faccia di frutta martorana. Sembrava dormire e non morire ogni attimo di più. Il signore incappucciato si fece il segno della croce e strappò un lembo del morto. Lo mangiò con gusto. Ne strappò altri e ce ne offrì. Noi li mangiammo. Fu gentile e ci versò anche del buon vino. Qualcuno – anche lui con la faccia di martorana – lodò il morto e la sua vita esemplare. Noi tutti applaudimmo nella speranza di poter essere al suo posto in un futuro molto lontano. Poi le fiaccole furono spente, e capimmo che il funerale era finito. Ci dividemmo così come c’eravamo aggregati. Ci dividemmo per tornare ai nostri misteri. Malachìa fece un gesto con la mano e noi, che all’andata avevamo fatto strada con lui, lo seguimmo cantando in coro. Appena dentro il locale pieno di luci e bottiglie colorate, risuonò la musica di un violino e in quel preciso istante, si alzò un vento che trasportava ghirlande, margherite e petali di rose gialle. Il locale di Malachìa divenne una sala da ballo con i mattoni di wafer dipinti nero e bianco. Pieni d’entusiasmo noi tutti andammo nel retro per cambiarci d’abito. Vestimmo foglie colorate e danzammo come nessuno avrebbe saputo fare sulle corolle dei fiori e i petali delle rose. 69 Un po’ alla volta le sigarette finirono e andai a comprarne delle altre. Attraversai quella parte del mondo in cui le persone camminano con il naso rivolto verso l’alto e nessuno si accorse che ero tra loro. Nessuno vide che bevevo birra in bottiglia. Nessuno capì che andavo mendicando un bacio senza speranza. Ritornai al locale. Edith mi afferrò per mano portandomi nel retrobottega, non quello in cui c’eravamo cambiati d’abito per andare al funerale e poi ballare. Era un altro, grande e accogliente quanto il primo. La luce soffusa e rossa sagomava gli incensi profumati al sandalo e al gelsomino. Lo stereo suonava un vecchio motivo di sottofondo. Al centro della stanza di panettone con frutta candita c’era un letto a due piazze, comodo, di pandoro arricchito con gocce di rum con sopra una coperta di zucchero soffiato, leggera e molto colorata. Edith si tolse le scarpe di bambù e le mise di lato. Si tolse anche il vestito di foglie verdi intrecciate e ricamate. Io feci lo stesso. Poi tenendoci per mano ci abbandonammo sul letto fresco e soffice. Sognammo di una serata passata in un locale, che era una mela caramellata ricoperta di crema gialla. Sognammo di Malachìa, che ci offriva cocktail e vino rosso. Sognammo che Ruffo suonava il flauto di traverso mentre Fermo vomitava all’angolo della strada. Sognammo di un funerale e di una festa. Sognammo di una strada che divideva il mondo in due. Da una parte c’erano quelli col naso in su, dall’altra quelli col naso verso giù. Infine, dormimmo sodo e per quella notte non ci svegliammo più. 70 Gianluca Morozzi Matrioske Camminavo per le strade di New York dopo aver messo un oceano tra me e chi voleva cavarmi gli occhi, e a volermi cavare gli occhi erano mio padre e mia madre. Il motivo era risibile, roba da niente. Avevo solo contratto un debito con un tipo chiamato Cane Idrofobo, per pagare il debito avevo clonato i bancomat e le carte di credito dei miei genitori, e avevo prosciugato i loro conti un po’ alla volta. Poi, davanti a quei soldi, mi ero detto: perché dare questo ben di dio a uno che si fa chiamare Cane Idrofobo? Con quei soldi ci avevo attraversato l’oceano, appunto. Fino a New York. I miei genitori volevano cavarmi gli occhi, Cane Idrofobo tagliarmi la gola. Bene, avevo pensato sotto l’arco di Washington Square. Trovatemi qui, se ci riuscite. Così camminavo per Manhattan, in una bella giornata di giugno, con una manciata di dollari in tasca. Tra il volo, il cibo e qualche cd raro, il mio patrimonio si era poco a poco assottigliato. L’idea di cercarsi un lavoro rientrava tra le soluzioni estreme. Mi facevo largo tra i turisti che scattavano foto, lanciando occhiate latine alle ragazze che leccavano il gelato ai bordi della fontana, prima di sdraiarmi tra l’erba e gli 71 scoiattoli. Poco lontano suonava un’orchestrina jazz. A mezzogiorno avevo deciso di investire un dollaro in un hot dog. Stavo per uscire dal parco, quando un nero enorme mi si era parato davanti. «Sei pronto, amico?» aveva urlato. Avevo cercato di scansarlo, quello aveva continuato a urlare «Sei pronto, amico?» indicando qualcosa alle sue spalle. Stavo per dire che non volevo droghe, solo un hot dog, ma poi avevo guardato meglio. Sotto gli alberi c’erano dei lunghi tavoli. Sui tavoli, delle scacchiere. Mi stava sfidando. A scacchi. Dentro la matrioska che ero diventato, molti strati sotto l’involucro esterno, una delle matrioske più interne aveva trascorso mille sabati adolescenti tra i silenzi ovattati del circolo degli scacchi. Una matrioska piccola e interna che non rubava bancomat e non clonava carte di credito, che faceva il chierichetto, che mai e poi mai avrebbe frequentato gente chiamata Cane Idrofobo. La matrioska più grande aveva sorriso. Sapeva di poter contare su quella più piccola. Il nero somigliava in modo impressionante ad Apollo Creed, l’avversario di Rocky. Avevo ripensato a quei lontani pomeriggi al cinema, a fare il tifo per Rocky contro Ivan Drago o Mr T, troppo giovane per avere il senso del ridicolo. In piedi tra le poltrone con gli altri tredicenni, tutti ormai sepolti sotto strati e strati, dentro la matrioska che ognuno si è scelto, la matrioska che ognuno di noi è diventato. «Cento dollari» aveva fissato come posta Apollo. Avevo accettato. Bluffando. 72 In tasca, di dollari, ne avevo ventotto. Avevo studiato con la coda dell’occhio le vie di fuga più vicine. In caso di sconfitta, sarei scappato nel Village alla velocità del fulmine. In quell’angolo del parco non c’erano orchestrine jazz, o turisti che scattavano foto. Solo ciclopici guardiani neri che sorvegliavano l’andamento delle partite, pronti a placcare lo stupido italiano senza un soldo in fuga verso il Village. Le panchine, in quell’angolo di parco, erano legate agli alberi con una catenella. Mi ero grattato la testa, accettando uno scambio di pedoni. Forse non era stata una buona idea bluffare con gente avvezza a rubare panchine. La matrioska clonatrice di bancomat poteva aver sepolto le tecniche scacchistiche sotto la spessa patina del tempo, ma quella piccola aveva il senso degli scacchi ancora puro e intatto. Gli enormi rubapanchine erano tanto inquietanti quanto onesti. Avevano preso in giro Apollo e mi avevano messo cento dollari nel palmo. Ero uscito da Washington Square galleggiando felice nell’aria. Mi ero infilato nel Village per mangiare qualcosa, avevo trovato posto in un baretto messicano e mi ero ingozzato di burritos con tequila. Alla quarta tequila, ero uscito dal baretto completamente ubriaco. Ero rimasto un po’ a guardare una partita di basket di strada, ripensando a un bellissimo cofanetto dei Rolling Stones adocchiato a St Marks Place. Potevo permettermi un albergo o il cofanetto. Non tutti e due. Rinunciare al letto o al cofanetto? mi ero chiesto. E perché rinunciare a qualcosa? mi ero risposto, sbron- 73 zo marcio di tequila. Dieci minuti dopo ero di nuovo a Washington Square, a puntare altri cento dollari contro Apollo Creed. A volte faccio cose così stupide che persino io provo vergogna. La piccola matrioska ghiotta di tequila si era addormentata. Goffo e annebbiato, avevo accettato uno scambio da dilettante in avvio di partita. Da lì in poi era stato tutto un arrancare contro il terreno perduto e il cervello pieno d’alcool. Un’ora dopo il sole calava dietro l’arco, io consegnavo i soldi del letto e del cofanetto nelle mani di un sorridente Apollo. I rubapanchine, intorno a noi, sghignazzavano. Avevo lasciato Washington Square col mal di testa da doposbronza, due dollari e un gettone della metropolitana. Avrei potuto vendere il gettone, e valutare i pro e i contro di una notte in strada. Invece avevo camminato occhi a terra e mani in tasca, ero saltato sul primo treno diretto a Downtown. Ero sceso all’imbarco dei traghetti, avevo investito metà dei soldi in una ciambella, e mi ero mischiato ai pendolari che tornavano a casa dopo una giornata a Wall Street o nei tribunali. Il traghetto gratuito andava avanti e indietro tutta la notte da Manhattan a Staten Island. Avrei fatto venire giorno così. Molto meglio che dormire in un vicolo. Poi, all’alba, avrei pensato a come rivincere i miei soldi a scacchi. In bocca avevo il sapore della ciambella misto a quello della tequila. Avevo scelto un posto tra i pendolari assonnati, avevo guardato il sole tramontare dietro lo skyline. Volevo cogliere il momento sublime in cui le 74 luci dei grattacieli si accendevano tutte insieme. Invece, avevo incrociato lo sguardo di una donna. Sui quaranta, grassoccia. Niente fede al dito. Mi sorrideva. Le avevo sorriso anch’io. Avevo risolto il problema di dove dormire. 75 Gianluca Liguori Tempo di passaggio Notte. Luca, disteso sul suo letto, non riesce a prender sonno. Oggi è stata per lui una gran giornata, così dicono. Oggi Luca si è laureato dottore. Ma Luca non riesce ad addormentarsi, stanotte. Pensieri. Scorrono. Veloci, impazziti. Sono anni che ci pensa ma ancora non l’ha capito: cosa fare della sua vita. Luca è sveglio, non è per niente stanco, non ha per niente sonno. Pensa. Forse dovrebbe trovare un lavoro qualunque, il primo che capita, e sposare Manuela. Di questi tempi bisogna accontentarsi. I sogni, a volte, bisogna lasciarli solamente alla notte. Non si addormenta Luca, sogna, sogna forte, ma i suoi occhi sono aperti, è sveglio, sveglissimo. Partire. Andare lontano. Forse un viaggio, potrebbe essere un’idea. Messico, India, Africa: Luca cerca un sogno distante, Luca cerca se stesso, quella parte che non riesce a raggiungere. Stelle. Luca si alza e va alla finestra. Accende una sigaretta. Guarda le stelle e si perde oltre i suoi stessi pensieri. Ci sono limiti invalicabili per questo piccolo essere 79 chiamato uomo. Il suo tempo è inezia rispetto a qualsiasi stella che scruta nell’immensità infinita della notte. L’umanità si è complicata la vita. Il breve tempo che abbiamo, troppo spesso, viene dissipato. Cuscino. Luca spegne la sigaretta e va a distendersi sul letto. Abbraccia il cuscino, immaginando Manuela. Sogna ad occhi chiusi, ma è sveglio. Immagina. Lui e lei. Passeggiano sulla spiaggia di un luogo conosciuto anche se non ben identificato. Ridono, scherzano. Si abbracciano, si baciano. Si baciano. Continuano a baciarsi. Si amano. Sabbia. L’acqua bagna la spiaggia, poi si ritira. Luca disegna una stella, che lentamente svanisce. Manuela gli sorride. Lo bacia sulla fronte. Luca ha la fronte sudata. Non riesce a dormire. Si gira e si rigira sul letto. Le belle speranze nascono e spariscono come stelle disegnate sulla sabbia. Gesso. Luca è a scuola, alla lavagna. Nella mano sinistra ha un pezzo di gesso bianco. Il vecchio professore incute timore. Non è mai stato bravo in matematica. Non sa, non sa cosa scrivere. Il rigore dell’austera figura lo blocca, non riesce a pensare. Suda. Trema. Il prof lo manderà a sedere, prenderà nota. Impreparato. Nella sua cameretta l’avrebbe risolta quell’equazione, era semplice. Orecchini. Gli orecchini di sua madre li ricorda bene. Ha portato lo stesso paio per quasi vent’anni. Sua madre che 80 lo rimproverava quando a scuola non andava bene. Sua madre che stamattina ha pianto, perché lui si è laureato. Carta. Un pezzo di carta dove c’è scritto che Luca è dottore. Non ha imparato nulla. Le difficoltà vere iniziano adesso. Nessuno gli ha spiegato niente sinora a proposito di lavoro. Ha studiato tante cose, ma si rende conto di non essere in grado di far nulla. Tutto è inutile. Quella carta è stato un albero. Quanti alberi sono stati abbattuti per far laureare tutti questi dottori? Vento. Fuori c’è vento. Ne sente il suono, Luca. Sembra un lamento. Sembra il suo lamento. Interiore. Tum-tumtum. Batte il cuore. Forte. C’è vento e ha caldo. Suda. Pensa a quella volta che ha fatto sega a scuola con Picone, un suo compagno di classe. Luca non ha idea di che fine abbia fatto. Probabilmente sarà finito in galera per furto, spaccio o ricettazione. Ma quel giorno, a far sega con Picone, si era proprio divertito. Acqua. Luca ricorda la spiaggia dove andava da bambino. C’era una scogliera dove se ne andava con maschera, pinne e boccaglio. Guardava i pesci, la vita sotto la superficie dell’acqua. In acqua si sentiva vivo, dimenticava ogni pensiero, c’era il momento, quel momento esatto, che ora stava ricordando. Ovunque andava, da bambino, c’era sempre una ragazzina che gli piaceva. Qualcuna la ricorda, altre le ha dimenticate. 81 Fuoco. Luca ricorda suo nonno che gli raccontava le storie della guerra davanti al camino acceso, cuocendo patate, castagne, uova o mele. Il nonno di Luca era un partigiano. Un socialista, fedele al partito fino alla metà degli anni Ottanta, fino a Craxi. Suo nonno morì il 9 novembre del 1989 mentre il mondo si apprestava a cambiare. Terra. Quella volta, Nicola detto il Siciliano, gliela fece vedere sporca. I primi due pugni, come colpi sordi, lo avevano messo ko. Steso al suolo, sanguinante, un rivolo che dalla bocca finiva sulla terra secca. Luca era chiuso a riccio, il Siciliano continuava a prenderlo a calci. Gliele diede di santa ragione. Quella terra, mista al suo sangue, gli finì in bocca. Aveva sapore amaro. Aria. Respira. Inspira, espira. Cerca la calma che non trova. Si agita ulteriormente. Un brivido gli percuote la schiena. Ha paura. Non riesce, non riesce a mantenere il controllo. Vorrebbe urlare. Tace. Sono ore che prova a prender sonno, Luca. I ricordi più nascosti tornano a galla, improvvisamente ed inaspettatamente. Si alternano davanti al suo sguardo. Oggi per lui è stato un gran giorno. Tante cose non sarebbero più state come prima: la vita universitaria era terminata. Non c’era un secondo da perdere, tutto da costruire. Da dove cominciare? Avrebbe voluto dormire. Rumori esterni. Il camion della nettezza urbana. Quasi mattina. Nella notte che da ieri accompagna all’oggi, si era com- 82 piuta una strage. Un’età era finita. Egli aveva dinanzi a sé una pagina bianca sulla quale poter scrivere qualsiasi cosa. Sogno. La luce del mattino penetra nella stanza di Luca, che non ha dormito stanotte. Gli uccellini cinguettano. Sbadiglia, Luca. Sente rumori di stoviglie provenire dalla cucina, qualcuno che chiude la porta e scende le scale. Poi si addormenta. 83 Tommaso Chimenti La panchina C’era una panchina me la ricordo. Era messa là. In legno. Con le scritte sopra. Dediche, pezzi di canzone, qualche numero di telefono, offese. Qualche cazzo qua e là, disegnato male, col pennarello nero e i peli neri come baffi di gatto. Non ci stavamo a sedere. Mettevamo i piedi sulla seduta. Eravamo più in alto. I capelli sugli occhi, le spalle curve in avanti. Un cane gironzolava senza collare, senza meta, trotterellava con le gambette da bastardino, ci guardava, continuava il suo giro che sembrava fatto di appuntamenti fissi. Annusava gli alberi secchi con poche foglie ancora attaccate. Dei fuscelli piantati là in mezzo che facevano tristezza e tenerezza in ogni stagione. Davanti alla panchina c’era un piazzale immenso di cotto rosso, messo insieme da piccole piastrelle che se frenavi con la bicicletta slittavi e cadevi. Nessuno parlava. Stavamo lì. Fermi ad aspettare. Non passava mai nessuno. Il cane pisciava ogni pomeriggio su tutti gli alberi. L’odore era il suo. Marca il territorio, diceva sempre qualcuno di noi. Alle nostre spalle c’era un palazzo alto quindici piani che un tempo doveva essere stato 85 bianco. Adesso aveva più crepe che un castello assediato, più buchi di una casa di Sarajevo. Si staccava a listelli, si sfaldava a pezzi di gomma. Non era intonaco, sembravano scaglie di detersivo. Sotto c’era del catrame nero che con il caldo restava appiccicato alle dita. Le sterpaglie tra il palazzone e la panchina erano secche. Bruciate dal sole. Una volta all’anno venivano quelli del Comune a raderle al suolo, a tagliarle con il tosaerba elettrico con quell’odore fresco che si spandeva in aria che ti dava il senso della primavera, del cambiamento. Vedrai, diceva qualcuno. Ho visto. E non ho visto niente di nuovo. Né di buono. Palazzo, piazzale, panchina. Il sole perpendicolare. In casa faceva un caldo soffocante. Avevamo le pale attaccate al soffitto che emettevano un ronzio asfissiante e continuo ma che ci facevano sudare lo stesso. Non aprivamo le finestre per non far entrare le zanzare. Le pale arrugginite rintontivano, facevano perdere la bussola. Non riuscivamo nemmeno a capirci; se avessimo parlato, in casa mia, non ci saremmo capiti. Mio padre e mia madre non facevano l’amore da molti anni. Si vedeva nei loro occhi spenti, nelle loro occhiaie, nelle notti che mio padre passava alla televisione, allucinato da quei colori che si spandevano sui muri bianchi del piccolo salotto. Non c’era un quadro, una stampa, una fotografia. Nemmeno un tappeto per terra. Tutti a piedi scalzi, anche d’inverno. Ci si incrociava per le stanze, nei piccoli corridoi e ci grugnivamo saluti contro. 86 Aprivamo il frigo, facevamo colazione ognuno per conto proprio. Nessuno che abbia mai detto all’altro un buongiorno, anche stiracchiato, anche grinzoso o a mezza voce. Spettinati, annoiati dall’inizio di un’altra giornata. I pantaloni calanti sulle mutande. La passata sulla testa di mia madre a tenere fermi quei suoi capelli grigi e crespi. Il grembiule sfatto sullo schienale della sedia. Volevo solamente uscire. Prendere aria. Fuori non c’era niente, ma era un niente che potevo disprezzare, offendere, scarnificare, prendere a calci. Era uno schifo che potevo dipingere e colorare, scriverci sopra e sputarci contro. Di mio avevo soltanto quei due in casa che con la loro presenza mi ricordavano che ero figlio loro, che venivo da quel buco, da quel tugurio, e che tanto lontano non sarei potuto andare. Avevo il loro cognome, non potevo andare lontano. All’angolo del palazzo ogni tanto si trovavano, nelle sterpaglie alte, dei giornali porno con le pagine appiccicaticce. Li prendevamo con i guanti. Erano guanti gialli di pelle con le scritte stampate sopra in rosso. Li avevamo tutti. Li mettevamo per andare in motorino. D’estate ce li infilavamo nella tasca posteriore dei jeans. Li sfogliavamo tenendoli con l’indice ed il pollice. Sapevamo tutte le pagine a memoria già prima di cominciare a voltarle. La scuola era finita e mancavano tre mesi prima che ricominciasse. Saremmo stati lì ad ammuffire. Senza un nemico sul quale sfogarci eravamo persi. Senza i compagni di classe con i quali litigare, senza i profes- 87 sori da fronteggiare, ci sentivamo vuoti, persi, svuotati, perduti. E stavamo lì appollaiati ad ascoltare il treno e a voltare la testa in direzione della ferrovia ogni volta che passavano una serie di vagoni che tiravano dritto senza fermarsi nella nostra stazione. Sembrava che il macchinista accelerasse quando vedeva il nome del nostro paese. Alzavamo le teste come galline che aspettano il becchime. Conoscevamo gli orari a memoria. Quello va a Roma, diceva sempre qualcuno di noi. Se andava verso sinistra. Quello va a Milano, se andava verso destra. Esistevano soltanto Roma e Milano. E noi stavamo nel mezzo, con la possibilità di raggiungere entrambi ma con un’innata masochistica impossibilità di farlo. Sembravamo legati da corde invisibili, da giorni tutti uguali, come se dovessimo timbrare il cartellino su quella panchina, come se lasciarla per un giorno, una settimana, o un’estate volesse dire perdere noi stessi. Un giorno ho preso un treno. Quella città è troppo grande, ha detto qualcuno. Ti perderai, hanno aggiunto. Mia madre ha pianto. Mio padre è rimasto a guardare la televisione. In fondo erano tutti contenti che almeno uno non fosse più su quella panchina a veder passare gli altri. 88 Cristina Serci L’ombra del tempo Si aggirava per le strade disegnando ombre di sogni ad ogni passo cadenzato sul selciato notturno: un rumore metallico ed elastico al tempo stesso, rompeva il silenzio. Quel silenzio era un colore: tutte le sensazioni nella sua mente si definivano come colori, in una memoria astrusa, fatta di flash, di emozioni lanciate come spruzzi di un caleidoscopio. Quella sera era il bianco del silenzio: un bianco abbacinante che si sovrapponeva al buio della notte, appena per un attimo, nell’istante in cui la scarpa colpiva la pietra, una frazione di secondo, bang, rumore secco, metallico: il bianco veniva ingoiato dal buio e poi ancora, all’infinito, se fino all’infinito avesse potuto camminare alla ricerca di sé. Si chiese dove fosse: si guardò intorno, osservò palazzi sconosciuti, negozi ignoti, saracinesche abbassate, serrate come occhi che neghino la realtà, i tanti occhi chiusi che incontrava ogni giorno per strada, sull’autobus, in ufficio; occhi che guardano il mondo senza vedere, senza coglierne il senso più intimo, l’essenza alchemica al termine della lunga notte. Ma nell’attimo stesso in cui avrebbe potuto definirlo con concetti misurabili con formule, già non c’era più. L’avrebbe voluto fermare, quel 89 tempo disgraziato che fuggiva tra meandri disperati di eternità perdendosi per sempre. Sapeva che quanto gli capitava (stato di grazia o di disgrazia?) sarebbe giunto, un eone dopo, ad un altro solitario che s’aggirasse nella notte, un’altra notte, in altro spazio e in altro tempo: era questa illusione a muovere i suoi fili. Tentava di trattenerla tra le mani, come si fa con l’acqua, e il tempo lo incuriosiva, fin da quando, bambino, aveva compreso che sarebbe stato inutile cercare di fermarlo in fiammanti orefiori – così come è impossibile imprigionare l’ombra. Sollevò lo sguardo e vide l’albero, la chioma spalancata esattamente su di lui, i rami stesi verso l’alto, le foglie lucide e immobili che si lasciavano semplicemente esistere per un diritto innato. Guardò l’albero negli occhi. Questo ricambiò lo sguardo. L’uomo abbassò il suo verso terra e si disse: «È la terra che mi inghiotte, con i suoi enigmi, per mostrarmi la mia appartenenza all’argilla dai tempi della maieutica divina. E il cielo mi ignora. Ogni notte lo invoco, bramo la fredda scostante distanza delle stelle, il brillìo tremulo nel buio assoluto». Fece vagare lo sguardo per la volta celeste, per l’emisfero che lo sovrastava come se egli fosse stato un omino di creta in un paesaggio inventato, racchiuso in una palla di vetro. Avvertiva la propria estraneità al mondo e, al contempo, il proprio diritto di farne parte. Si sentiva carico di slancio verso la vita e gli altri e, nello stesso istante, alieno a tutto. Era imbarazzante essere due e tentare disperatamente di apparire uno agli occhi, seppure disattenti, degli altri. Questo non era il cosmo, era un piccolo mondo spesso insignificante a misura di palaz- 90 zo, di ufficio, di città angusta, provinciale e piena di bisbigli. Il piccolo mondo fatto di percorsi sempre uguali – fino al tedio e all’angoscia – che conduceva da casa agli squallidi corridoi del lavoro, dove incrociava colleghi che lo salutavano con un gesto composto del capo o un ciao inudibile, quasi si dovesse osservare un silenzio imperturbabile e disumano. Si soffermò sul proprio nome, masticando la parola che avrebbe dovuto identificarlo, tentando di assaporarla alla ricerca di una chiarezza del proprio esistere. Si chiese se quel nome in qualche modo gli corrispondesse; ed improvvisamente seppe che no, lui e il proprio nome erano ben distinti, forse contrapposti. Ora esisteva solo quella consapevolezza, la statica realtà di quella scoperta. La domanda, la ragione del proprio esistere era sempre la stessa: Perché sono qui? E si era reso conto che il solo pensare di definire qualcosa era un grande inganno. Come tentare di incorniciare un film: nell’attimo in cui appariva un fotogramma già se ne svelava un altro in un’epifania in divenire, come cercare di fermare l’inizio o la fine di un cerchio già chiuso. Giunse ad una piazza. La osservò stranito, certo di non esserci mai stato prima, come se, per errore, fosse entrato nella vita di un altro. Si osservava muoversi, dall’alto. L’aria era limpida – cosa inconcepibile durante il giorno – e il cielo aveva la trasparenza di un sorriso. La piccola falce di luna brillava pacata, quasi dondolando. Nell’ombra, però, era facile scorgere il resto del satellite e l’uomo si chiese chi avrebbe potuto osservarlo da lì, non visto, giudicando la sua pochezza. O la sua gran- 91 dezza. O, perché no, il suo essere semplicemente così, né piccolo né grande, un medio uomo ordinario in una grande piazza notturna con un obelisco al centro. Un essere umano felice e compiuto del proprio essere, appunto, quello che era. Qualsiasi cosa fosse. La piazza, vuota, era circondata da pallidi palazzi tardoottocenteschi con tetti spigolosi scuri sormontati da abbaini. Quei tetti lo rassicuravano facendolo sentire protetto. A grande distanza dall’obelisco, nella luce metafisica e quasi onirica dell’alba che si approssimava, stavano alcune panchine, nude nei loro scheletri metallici lucidi dell’umidità della notte. In un angolo una fontanella, di quelle che non si vedono quasi più, giacché qualcuno ha deciso per noi che sono antigienici ricettacoli di ogni sorta di virus, alimentando le nostre più riposte fobie. «Che stronzata!» esclamò ad alta voce. Si riscosse, colpito da quel suono definitivo che rimbalzò nel silenzio. Si aspettava quasi che l’eco o qualche sconosciuto abitante dei palazzi gli rispondesse oltraggiato. Tenne il fiato sospeso, in apnea, per lunghi istanti, ma non ebbe nessuna risposta. Protetto dall’invisibilità di quella solitudine, rise forte e ripeté a voce più alta: «Che stronzata!». Il suono risonò secco come una frustata. E ancora ripeté, ancora più forte, stupito del volume e del timbro della propria voce, riappropriandosi di qualcosa che non si era mai reso conto di avere. E si sentì felice, pienamente e stupidamente felice. Solo al mondo ma felice. Senza il peso di alcun giudizio, senza il fardello di alcun passato, senza neppure avere la necessità di sapere dove realmente si trovasse. Finalmente libero. 92 Consapevole di questa scoperta e della propria nuova grandezza, si mosse verso una panchina, stavolta con passo fermo. Vi si sedette, allungò le gambe con un sospiro, incrociò i piedi uno sull’altro, si stirò appena e chiuse gli occhi. 93 Barbara Gozzi Vattene Vattene. Sentiva. Il corpo si faceva pesante, inutile e il cervello lo seguiva, disperato e confuso. Affannati tutti senza una direzione precisa. Poi a casa, nel tepore di odori familiari, alla penombra di tapparelle in fessura – là – tra i suoi cimeli, trofei di memorie e solitudini, rinunce e chiusure – là – una frattura ha ghiacciato l’aria. Il battito accelerato, e quel rombo delizioso tra le orecchie. La cornetta ormai mi cadeva dalle mani e quelle parole improvvise, desiderate: «Domani» ho sentito, ricordo. «Domani sera ci sarà.» Vuoto. Vattene. Un battito. Un altro. Il sangue che dal cervello rullava e scendeva, affluiva in tutto il corpo, riscaldandolo. In quel preciso momento, con la cornetta ancora stret- 97 ta tra le dita tremanti, ha visto i programmi sbriciolarsi, le porte chiuse sciogliersi, la voglia di rintanarsi evaporarle in faccia. Lui ci sarà. E già volevo ballare, correre, vestirmi e truccarmi. Poi. Si è guardata attorno, ruotando su se stessa nella semioscurità. I mobili erano al solito posto, la gatta sui piedi ronfava curiosa. Non era cambiato niente. Guardava. Insisteva. Era lei. Lei. La maledetta tiranna di se stessa. Io. Sempre e solo io. Facevo il bello e il cattivo tempo di me, corpo e mente, tutto dipendeva da me. Da quello che volevo, credevo, pensavo, imponevo. Maledetta! Vattene. Si è fermata al centro della stanza e avrebbe voluto urlare, sbattere da qualche parte per il gusto di sentire quel dolore che già dentro la corrodeva, veleno invisibile. La gatta continuava a strusciarsi, morbida, sensuale. 98 L’adrenalina in circolo non se ne voleva andare. Era. Stava. Non realizzava. Allora una doccia veloce, trucco leggero, appena una striscia di fondotinta liquido e una passata di lucidalabbra rosato. La solita carezza alla gatta per trattenerla mentre le lasciava due pugni di croccantini nella ciotola. Borsetta di finta pelle nera, chiavi e cellulare. Non te l’avrei lasciato fare. No. Non ti avrei restituito quel potere che invece vedevo nitidamente ritornarti. No. Non avresti più deciso per me. Attraverso. Me. Deciso di imbruttirmi e rintanarmi, vecchia dentro, secca e vuota. Ma neanche il contrario. Ti avrei combattuto. Ne avevo bisogno, ormai lo vedevo nitidamente nella fatica, ne avevo più bisogno di. Di. Consapevole, tremante, questo era. Cos’avrebbe fatto domani neanche poteva pensarlo, ragionarci era assurdo. Ma in quel momento aveva deciso. Sarebbe uscita. Di corsa. Senza. Lui. Lei e lei – sola – così com’era. Occhi enormi, capelli arruffati dalla piega frettolosa, jeans e tacchi. Vattene. 99 Avrei dovuto capirlo, avrei dovuto decidermi prima di finire ridotta in quel modo, relitto di me stessa, ombra di un’illusione. Eppure avevo galleggiato per molti giorni, settimane. Avevo smesso di sentirmi, galleggiando. Forse semplicemente mi rifiutavo. Era più facile non attribuire colpe e persistere nell’apatia bulimica, nuotare in quel dolore costante e demotivante. Avere paura di tutto e cedere all’insoddisfazione latente. Era più facile qualsiasi cosa che non fosse ascoltare e abbracciare quel male potente e insopportabile che mi paralizzava. Era lui, e ormai l’evidenza la schiacciava a una strada chiusa, non c’erano vie d’uscita. Era lui che decideva nell’ombra, dove e come farla pendere. Lui si imponeva, attraverso lei. Il solo saperlo nei paraggi l’aveva mutata strappandole pelle e organi inutili. Non sarebbe stato sempre così, però. Ormai se lo rivedeva in un loop infinito proiettato nello schermo della sua mente. Non sarebbero arrivate altre telefonate. Lui non ci sarebbe stato nel suo domani, le serate non sarebbero tornate loro. Vattene. Dovevo – dovevo. Maledizione: dovevo convincermi. Toglierti lo scettro, il telecomando, riprendermi la forza di essere, senza. Essere. 100 Senza. Non avere bisogno. Smettere di aspettare. Accettare il vuoto. Fissare l’assenza – la tua – e averne paura liberamente. Ha chiuso la porta di casa con uno scatto. Mentre guidava tra il vago traffico notturno, qualche crampo allo stomaco le ha fatto mordere le labbra. Scendendo ha annusato l’aria fresca, sapeva di qualcosa che non aveva un nome preciso ma sembrava buono. Poi qualche fitta tra la gente, in mezzo a parole e risate, le solite strizzate in un non luogo che dentro la abitava. La serata è scivolata così. Ne è uscita diverse ore dopo guardandosi allo specchio del suo bagno ancora leggermente truccata, si è vista sola. Sola. Ma. Mi sarebbe mancato comunque, lo sapevo. Non c’era più, per me. E mi bruciava tutto. Sapevo anche che mi sarebbe rimasto, da qualche parte, chissà. Il potere di decidere, però, quello – quello – lo rivolevo. Subito. Vattene. Lo stava dicendo a se stessa. All’immagine di un volto fisso, stupito. Vattene! È difficile lottare contro qualcuno che non si può can- 101 cellare. Se stessi. È difficile vincere, se la battaglia non si vede e probabilmente la vittoria è inesistente per necessità. È difficile qualsiasi cosa, da soli. Vattene. Restavo io. Mi restavo e dovevo resistere. Dovevo smettere di aspettarlo, di cercarlo in silenzio, evitare di vivere dentro i ritmi che prima ci legavano. Lentamente, tra onde anomale, sperava che sarebbe sbiadito ai suoi occhi, gli stessi che vedeva riflessi nello specchio e piangevano senza lacrime. Doveva andarsene, per permetterle di riprendersi quella stessa anima lacerata eppure (Maledetta!) annegata nell’affetto. Ancora. Ma in procinto di salire su un treno pieno di fischi, sobbalzi e rallentamenti. Disamore, recitava la fiancata scrostata. Il deserto lasciato, creato dall’abbandono, chiedeva solo di essere curato, cullato. Di mutare ancora, e ancora. Solo che ora lo vedeva, se lo sentiva tra le dita dei piedi, dentro i polmoni, tra le gengive arrossate. Vattene, si stava urlando. (L’intensità cresceva, esponente imperfetto.) Vattene e restituiscimi. (Ancora più forte. Rimbombo. Eco feroce e lacerante.) Vattene. (Pausa.) È ora. 102 Alessandro Romeo Quanta scena per niente Lui, piegato sulle ginocchia, sta mangiando un pomodoro a morsi grandi e lenti. Tiene il pomodoro in una mano e un bastone nell’altra. Ai suoi piedi c’è un alveare grande quanto la testa di un cane. Lei è qualche metro più in là. «Vieni» gli dice. Hanno scelto un bel posto, pieno di alberi e con una bella vista: il prato su cui hanno steso la tovaglia termina su un salto di una ventina di metri, un burrone abbastanza ripido e costellato di sassi. Lancia quel che resta del pomodoro nell’erba e ritorna da lei. Le dà un bacio sulla fronte e si siede sulla tovaglia. Lei gli allunga un panino con la frittata. «Una volta sono stata punta sotto l’occhio» gli dice. «Basta stare fermi» dice lui masticando. «In che senso?» «Basta stare fermi e non ti succede niente.» Appoggia il panino e si mette a trafficare con una bottiglia. «Mia mamma aveva il terrore delle api» dice lei. «Una volta è stata inseguita da uno sciame.» Lui stappa la bottiglia e annusa il tappo. «Non credo succeda veramente» dice. 105 «A mia mamma è successo.» «Tua mamma ingigantisce le cose. È fatta così.» Prende un sorso di vino prima di passarle la bottiglia. «Non ti dà fastidio se penso questo di tua madre, vero?» In quel momento arriva un uomo con un piatto avvolto nella carta argentata. È sbucato dal bosco e si avvicina sorridendo. Quando è a pochi metri da loro li saluta. «Vi volevo fare assaggiare una cosa» dice l’uomo. «L’ha fatta mia moglie.» Si inginocchia e scarta il piatto. C’è una torta salata, già divisa a fette. «Grazie» fa lui. Ne prende un pezzo e lo passa a lei, poi ne prende un altro per sé. «Mia moglie fa da mangiare benissimo» dice l’uomo. Lui accenna un sorriso. Lei conferma con un movimento della testa. «Mi chiamo Mario» dice l’uomo. «Stefano» fa lui. «E lei è Anna, la mia ragazza.» «Avete la faccia simpatica» dice Mario. Rimangono in silenzio per qualche istante, mentre finiscono di masticare la torta. «Chiami sua moglie» fa Anna. «Mangiate con noi.» Dopo due minuti è già di ritorno, con un borsone a tracolla e una borsa-frigo in mano. Con lui ci sono sua moglie Lucia e suo figlio Giorgio: se ne sta abbracciato alla gamba della madre e ha lo sguardo completamente assente. «È un po’ timido» dice Mario. Poi si accuccia vicino al bambino e lo strappa dalla gamba della madre. 106 «Cosa ti ho insegnato?» gli dice. «Da’ la mano ai ragazzi.» Il bambino si afferra un polso con l’altra mano e ci gioca come fosse un elastico. Poi si lancia sulla tovaglia e comincia a rotolare, ridendo. Qualche istante dopo sono tutti seduti che si passano le cose da mangiare. Anna mangia poco come sempre. Stefano si attacca alla bottiglia: Mario ha stappato una di quelle buone, dietro ne ha altre tre, le imbottiglia un suo amico contadino. Giorgio mangia solo se imboccato. Sua madre compie il gesto con disinvoltura, come se stesse mettendo lo zucchero nel caffè. Parlano del più e del meno, soprattutto di vacanze. «In fondo non è che cambi poi tanto» dice Mario. Lucia sorride abbassando gli occhi. Restano tutti in silenzio. Stefano si guarda un po’ attorno. «Quanti anni ha?» chiede. «Otto il mese prossimo» fa Lucia. Il vento si è un po’ alzato. Il sole del pomeriggio, coperto da alcune nuvole grosse, cambia il colore alle cose. In pochi minuti tutto sembra essere diventato immobile e antico. «Abbiamo il pallone» dice Mario. Stefano scatta in piedi, apre il borsone di Mario e tira fuori il Supertele. «C’è vento» dice. «I Supertele vanno dappertutto anche con un vento così…» «Passamelo» dice Mario. Stefano ci palleggia un po’ e glielo fa arrivare dritto tra 107 le mani con un colpo di testa. Mario si mette seduto tenendo la palla alta sulla testa. «Giorgio!» dice. Giorgio si alza in piedi e si mette a saltellare. «Sei pronto?» urla. «Lo prendi?» Anna e Lucia continuano a parlare. Mario si è disteso vicino a loro. «Di cosa parlate voi donne?» chiede. «Cosa ti interessa?» fa Lucia con aria furbetta. «Siete sempre così entusiaste quando parlate tra di voi…» Anna lo guarda con una punta di fastidio. Vorrebbe dire qualcosa di ironico, ma non le viene in mente nulla. Mario si alza in piedi e si sgranchisce la schiena. Chiede a Stefano di ripassargli la palla, poi dà alcune indicazioni a Giorgio. «Ecco» dice. «Parala!» Prende la rincorsa e lancia una saetta di controbalzo che passa a dieci centimetri dalle teste di Lucia, supera Giorgio e arriva a pochi passi dal burrone. Giorgio, caduto a terra nel tentativo di prendere la palla, si rialza e comincia a correre verso il burrone. Corre come un ubriaco, barcollando a destra e a sinistra: ha della gambe fragili, piene di sbucciature. Stefano comincia ad allarmarsi solo dopo che Lucia si è lanciata all’inseguimento di Giorgio. Anna si alza sulle ginocchia, con un’espressione ebete stampata in faccia: lancia un’occhiata a Stefano come per dire “fai qualcosa”, ma si limita a chiudere e riaprire la bocca: sembra un pesce in una boccia di vetro. 108 Quando Giorgio si avventa sul Supertele, Lucia è ancora distante. Si rialza con la palla stretta tra le mani e la solleva in alto, come un trofeo. A quel punto Lucia gli è addosso. Lo strappa da terra e lo porta a sé, poi si accascia tenendolo stretto. A pochi passi da Stefano, Mario è rimasto fermo con le braccia piantate nei fianchi: «Quanta scena per niente» mormora, aprendosi l’ultimo bottone della camicia. 109 Ugo Coppari In fondo alla valle Un ragazzo se ne sta seduto su una panchina al centro di un prato verdissimo. La panchina è di legno e il cielo completamente azzurro. Non ci sono nuvole ad ostacolare i pensieri, né anima viva che possa deviarne la via. Questo prato ricopre la cima di un’alta montagna, posta al centro di una lunga catena montuosa. Questo ragazzo è venuto fin qui per non pensare ai problemi che lo assillano in città. Peraltro, negli ultimi tempi, è entrata nella sua vita una ragazza a cui non riesce a non pensare. Mentre si fa la doccia, mentre va a fare la spesa, quando è in fila alle poste: il viso di questa ragazza gli appare davanti. Un giorno questo ragazzo decide di lanciarsi col paracadute, per festeggiare la fine del corso di studi. Cerca la compagnia di paracadutisti più esperta nella zona, li raggiunge in sede e li sfianca con una raffica di domande sul rischio di morire che possiamo correre lanciandoci da un aereo, il rischio che il paracadute possa non aprirsi o cose del genere. Una volta arrivato il bel giorno, questo ragazzo decide di svegliarsi di buon mattino e di raggiungere a piedi il luogo da cui sarebbe partito l’aereo. Lungo il cammi- 111 no un uomo seduto su una panchina sta contando una manciata di monetine, raccolte sul palmo di una mano. Non appena gli passa a fianco l’uomo alza lo sguardo verso di lui e gli sorride, per poi chiedergli di avvicinarsi. In un primo istante il ragazzo rimane impietrito, poi convinto dall’affabilità di quel signore decide di accostarsi. Ma l’uomo chiede di avvicinarsi ancora di più, di avvicinare l’orecchio alle sue labbra. Il ragazzo ascolta con attenzione le parole che l’uomo gli sussurra all’orecchio. Lungo la strada s’era fermato un autobus, il motore ormai vecchiotto faceva un gran casino, il fischio dei freni aveva fatto il resto. Quando il signore lascia cadere le monetine a terra, il ragazzo s’accascia per raccoglierle e restituirgliele. Quando rialza lo sguardo, quell’uomo non c’è più. E l’autobus è appena ripartito. Lungo il tragitto il ragazzo continua a pensare intensamente alle parole di quel vecchio, di cui c’aveva capito ben poco. Una volta arrivato sulla pista di lancio, il ragazzo saluta con la mano due signori ormai vecchiotti, appoggiati alle reti metalliche che recintano il piccolo aeroporto. Uno dei due ha uno stuzzicadenti infilato tra i denti e un cagnolino che continua a ronzargli tra le gambe. L’altro indossa un cappellino rosso della Cgil, con su scritto “Uniti si può”. L’aereo prende quota, il ragazzo scherza con gli istruttori. Gli confida di essere un po’ agitato: ah, se qualcosa non va per il verso giusto dite ai miei genitori questo e quest’altro e quest’altro ancora, ai miei amici dite così e 112 cosà, e via discorrendo. Gli istruttori annuiscono con un sorriso, poi si voltano: e appesantiti dalla noia guardano il cielo dall’oblò. Il pilota comunica alla compagnia che l’aereo ha raggiunto i 4000 metri. Il ragazzo comincia ad agitarsi, le gambe tremano. E all’improvviso gli ritornano in mente le parole che quel vecchio aveva sussurrato al suo orecchio. Una lunga serie di parole gelate come l’aria a 4000 metri. L’istruttore decide che è ora di lanciarsi. I due saranno legati da una serie di cinture di protezione e il ragazzo non dovrà far altro che rimanere fermo ed evitare di agitarsi: mi raccomando, non fare stronzate, gli viene detto. I due si lanciano: è ora. Il primo impatto con l’atmosfera è terrificante, lassù il vento è talmente forte che i due vengono sbattuti di qua e di là, perdendo il controllo della situazione. Anche l’istruttore sembra essere nel panico, ché non si aspettava correnti così forti. Il ragazzo a sua volta non sa come reagire: respira forte e cerca di non perdere i sensi. D’un tratto una cintura che teneva uniti i due si trancia di netto, senza una spiegazione plausibile, in fondo. Anche l’altra fune che li teneva agganciati alla vita viene sfibrata dalle tensioni a cui viene sottoposta. L’istruttore vola via e il ragazzo senza paracadute si ritrova da solo in caduta libera. Il ragazzo viene trasportato dal vento, che lo trascina verso la costa. Non riesce nemmeno a tenere gli occhi 113 aperti, sembra che il vento gli strappi la pelle di dosso. Come un meteorite da chissà dove, fionda verso il basso, fino ad infilarsi nella superficie del mare. Una volta caduto in mare il ragazzo crede di essere morto, ma in realtà sta soltanto scendendo negli abissi, sospinto da un’accelerazione gravitazionale che l’ha visto cadere dal cielo. Durante la discesa nelle profondità del mare, il ragazzo ha ancora gli occhi chiusi, finché il suo corpo si arresta ad una profondità indefinita e il suo paracadute si apre alle sue spalle: silenzio. Il ragazzo riapre gli occhi e attorno a sé vede soltanto il grande biancore del paracadute, che lo avvolge senza possibilità di fuga. Una figura femminile, i cui seni traspaiono dalla fitta trama del tessuto, gli si avvicina. Il ragazzo, inebetito, vede quel corpo accostarsi al suo e d’un tratto si sente avvinghiare da braccia acquose, lo stringono con dolcezza. Il viso diafano di quella strana creatura gli arriva in trasparenza, deformato dalla trama del paracadute. Il giorno dopo il ragazzo si ritrova disteso su un lettino ospedaliero, il giorno successivo verrà dimesso. All’uscita dell’ospedale una folta schiera di giornalisti gli si fionda addosso, ma lui non sa proprio cosa dire. Gli chiedono come abbia fatto a sopravvivere a quella sciagura, ma lui continua a dire che non sa proprio cosa dire. Il ragazzo non ricorda nulla di cosa sia successo, nonostante quel viso rimanga indelebile nei suoi ricor- 114 di, come il vuoto lasciato sul muro da un quadro appena rubato. Cala la notte e il ragazzo è ancora seduto su quella panchina. Un lupo ulula in fondo alla valle e i ricordi volano via senza paracadute. 115 Chìo Dùpia Terapia La radio. La radio suona. La radio. La radio canta. L rad. Suo. Cant. La radi. Rmor. La radio suona. La radio. Acc. La radio è sul tavolo. Tra me e il suo lettino bianco. La radio è accesa. Dentro c’è una cassetta che gira. Gira. Il nastro magnetico canta. Canzoni. A volte voci. Sono seduta. Ascolto. La musica. Le prendo la mano. E chiudo gli occhi. Mia cugina è in coma. Da nove mesi. Sì, funziona. La terapia forse funziona. La radio intona motivi familiari. Ritornare alla luce a volte è possibile, attraverso i suoni che già conosce. Suoni familiari. A volte solo voci. Magari la mia. Parlo con lei. E talvolta, lei, si muove. Mia cugina è in coma. Da otto mesi. Per prima cosa i suoni, ancora nel grembo, e l’esterno piomba addosso alle nostre orecchie. È perché sentiamo che abbiamo i timpani. Solo dopo si viene alla luce. E, seconda cosa, respiriamo. In luminosa catarsi. Il sacrificio primo. Piangiamo. L’aria conduce il suono. Il suono è solo uno spostamento d’aria. Le cose gli fanno da membrana. Il nostro corpo è una membrana sonora. Di lunghe attese. Di lunghe pennellate. Di lunghe incomprensioni. 117 La porta a vetri vibra quando qualcuno entra o esce dalla porta principale, nel corridoio. È irritante, ma perlomeno dà la sensazione di non essere soli. Infermieri con pillole sul palmo della mano, dottori dal passo deciso con cartelle di analisi, ricette di Sereupin e cure per una pronta guarigione in mano. A volte antimonio. Entrano ed escono dalla porta principale. Fanno vibrare la porta a vetri. Lo spostamento d’aria è costante. Mia cugina è in coma da sette mesi. Ogni sera schiaccio play. Le prendo la mano e chiudo gli occhi. La sua mano è calda. Gioco con le sue dita, la sua mano e più calda della mia, forse lei non prova la mia stessa tensione, forse lei ora sta bene o forse, ascoltando vecchie canzoni, non vede l’ora di tornare. All’inizio non credevo potesse funzionare. La sperimentazione provocherà sofferenza e frustrazione. Un errore. Stacchiamo le macchine. Facciamola finita. È morta. O no. Forse. Di sicuro è in coma da sei mesi. Non è così grave. I suoi capelli sono biondo cenere. Un grigio dai riflessi gialli. I dottori continuano a camminare, a entrare e uscire dalla porta principale. Portano le medicine. Si chiamano speranza, desiderio, illusione, poi di nuovo desiderio. L’infermiera cambia la flebo ogni due giorni. Goccia dopo goccia i sui capelli si allungano. Una volta al mese il barbiere in camice bianco viene e senza dire una parola se ne va con la sua busta di plastica colma di capelli. Li ho conservati tutti. 118 Mi hanno dato un lettino, per la notte. Alla sera mi svesto e in posizione orizzontale ascolto il mio sangue scorrere: è più rumoroso ultimamente, sembra quasi più pesante o forse è solo più amaro. Passa l’emicrania, il panico, la noia, il nervosismo. Ascolto il mio sangue, risoluto, completamente rilassato. La musica finisce, apro gli occhi nel buio. L’attesa è un bisturi che taglia il dolore e intreccia con ago e filo paura e follia. Piena la carne di vita. Mia cugina è in coma da cinque mesi. Sbatto gli occhi sull’azzurro del neon, in alto, proprio di fronte a me, sul soffitto. Una coppia allunga il viso oltre la porta. Lui che le tiene la mano. Lei assente. Andiamo via. Torniamo domani. Nemmeno ciao. Faccio dalla sedia al lettino. Dal lettino alla sedia. Poi un sorso d’acqua, mi mangio l’unghia dell’anulare sinistro e un altro sorso d’acqua. E poi dalla sedia al lettino. La fisioterapista entra due volte a settimana per gli esercizi motori, a volte penso che servano solo a lei quegli esercizi, alla fisioterapista. Mia cugina è in coma da quattro mesi. È difficile. Sono stata a guardarla per ore in questi tre mesi. Accendo la radio. Il volume basso per non disturbare, per non disturbare chi? Crescono tutti ingessati dal sonno. Sognano una vita. Ma dormono. Svegli, ma dormono. Freud dice che la nostra vita è una continua ricerca della morte. La stasi assoluta. L’immobilità. La narcosi eterna. Io penso che mia cugina sia tra le poche che siano riuscite a vivere. Finalmente. Forse è proprio così. Non vuole 119 svegliarsi. Non vuole svegliarsi più. Non ne ha bisogno. Ascolta la musica. In pace. Le piace. Mia cugina è in coma da due mesi. La riempiono di farmaci con periodicità crescente. Filtri magici per spezzare la prigionia della sua mente. Alcool sull’epidermide e l’ago che entra per una puntura intramuscolare. L’appuntamento di ogni mattina. È necessario, ne ha bisogno. Soprattutto del tuo amore. Tienile la mano ogni tanto, dicono. Ogni tanto vedrai, si muoverà. Ho scelto di stare qui. Per tutto il tempo necessario. Fino a quando. Mia cugina è in coma da un mese. Qualcuno fa funzionare il tosaerba sul prato dell’ospedale. Lo vedo dalla finestra. Curano qualsiasi malattia qui. Anche l’erba che cresce. I parenti possono entrare a gruppi di cinque, a volte sei. Vengono a trovare parenti e amici con enorme stanchezza. Silenzio per favore. Senza speranza. Il coma non è una malattia come la celiachia o la varicella, la febbre il cancro il morbillo la distrofia. Il coma è un appuntamento con la speranza. Un handicap temporaneo. Molto elevato però. Quasi totale. Incurabile. O forse è un assaggio d’eternità. Una piccola rivelazione che capita solo a pochi fortunati. O forse solo a pochi fortunati capita di poter godere del risveglio. Oggi ho portato la radio. Dentro ho messo una cassetta. C’è registrato il mare, poi alcuni frammenti di Existenz, canzoni a lei care e rumori di città. L’ho visto fare molte volte. Ora è capitato a me e tutto mi sembra meno stu- 120 pido: quando è la speranza a muovere le azioni tutto è meno stupido. La musica come terapia. Uscire dall’ingorgo, col nervosismo addosso, l’ansia di non fare in tempo. I nostri ragazzi si sarebbero molto arrabbiati. La festa era per noi. Nate nello stesso giorno, lo stesso mese dello stesso anno. Uguali. Solo che lei è bionda, poi ha il naso un po’ più piccolo e gli occhi più grandi dei miei. Il mento è uguale. La bimba che era, era come me. Le foto le confondiamo. Cerca di stare calma! Ci arriviamo. Ho detto che ce la facciamo. Quindi ce la facciamo. Ti ho mai mentito? No. Ecco la differenza tra e me te. Io non mento. Sono sempre sincera. Adesso smettila. Ti ho detto che per le nove saremo state alla festa, e per le nove saremo alla festa! Ora facciamo una cosa. Per un po’ guidi tu. Sono stanca. Abbss. SAbbsa. La radio. Abbassa. L rdo. Non sento nulla. Bell’inizio, complimenti. In clausura mi sarei divertita di più. Funziona la radio? Accendila. Inghiottite dalla voragine del traffico, tentavamo di uscire. Lascia questa. Questa mi piace. M pce. A me no. E leva quella mano dai! A m n. Lev. Man dai! Che ridere. Eravamo già alla festa. Ci divertiamo così. Due aurore che solleticano radiazioni. Un crash, attrito, la macchina che gira, gira, su se stessa. La radio che canta. La radio. La radio suona. La radio. La radio canta. L rad. Suo. Cant. La radi. Rmor. La radio suona. La radio. È accesa. Acc. 121 Gianni Usai La legge dei grandi numeri «Di cosa si meravigliano? Dopotutto io l’ho sempre saputo che non sarei morto miserabile come sono nato. Fin dai tempi del liceo non facevo altro che pensare al modo col quale avrei cavato la mia vita dall’anonimo canale della semplice sopravvivenza e qualcosa dentro di me mi diceva che ci sarei riuscito. Sapevo di avere quello che gli altri solo si sognavano, la scintilla, quella che ti porta ad avere l’idea giusta, semplice e geniale allo stesso tempo, quella che fa la differenza. Non parlo di intelligenza, con quella diventi ingegnere nucleare o manager di una grande azienda, ma di quella luce che ti permette di addormentarti una notte da commesso venditore di arredi per bagni e riaprire gli occhi su un futuro da milionario proprietario di un brevetto conteso a suon di quattrini da venti multinazionali. Hanno riso i primi ai quali ho mostrato gli schizzi del mio progetto. All’inizio era un semplice profilo in alluminio da incassare tra le mattonelle alle pareti del bagno e nel quale fare scorrere gli accessori, i portasapone, i sostegni per gli asciugamani e ogni altra cazzata ti salti in mente di appendere nel gabinetto. Non hanno riso però le aziende alle quali ho proposto l’idea, intuendo l’infinita serie di varianti possibili: finiture oro, argento, cromo, satina- 123 te; versioni in ottone e acciaio inossidabile. Senza contare l’enorme numero di articoli correlati. Avevo trovato una miniera d’oro. Così ho cominciato la mia nuova vita, la vera vita, quella che mia moglie non ha capito e voluto accettare. Lei non ha mai saputo come funziona il mondo. Quando non sei nessuno passi la vita da spettatore; se vuoi lasciare il segno, devi contare qualcosa e per contare servono i quattrini. Chi si illude del contrario è un povero sprovveduto. Una volta che sei entrato nell’ingranaggio poi non puoi più tirarti indietro. Non è roba per anime pie. Devi giocare sporco quanto loro e più di loro, se puoi. E sai cosa ho scoperto? Ho scoperto che il gioco sporco mi piace, è fatto apposta per me. A mia moglie questo non andava giù, lei non ha sufficiente apertura mentale per certe cose. Fissava la sua attenzione su inutili questioni di principio, io invece non avevo tempo da perdere con lei e le sue remore morali. Così un giorno, una mattina di giugno calda come la roccia fusa, ha preso nostro figlio e se n’è andata per la sua strada. Dice che preferisce essere una morta di fame piuttosto che stare con un senza valori come me. Ma che cazzo vuol dire? Quando arriva l’occasione devi saperla cogliere, io ho colto la mia. Fanculo i valori, i principi, la morale e i perbenisti frustrati del cazzo! Se c’era da concludere un affare, facevo tutto il necessario per concluderlo. Se un importante manager aveva bisogno di chiarirsi le idee in un night con una signorina carina e poco vestita seduta sulle ginocchia, io lo mettevo nelle condizioni di chiarirsi le idee. Se poi gli serviva ancora un po’ di tempo, mi assicuravo che la signorina lo seguisse 124 nella sua camera d’albergo. Qualche volta, per evitare che il mio ospite si sentisse a disagio, dovevo fare gli onori di casa, ma per quanto fosse piacevole si trattava sempre di lavoro. Le faceva schifo, eppure i soldi che le passo ogni mese pare non suscitino in lei altrettanto ribrezzo. È l’ipocrisia che ci fotte, anche sapersi turare il naso quando serve è una dote che può fare la differenza. Mia moglie non ce l’ha. Nemmeno i miei amici la possiedono. Non facevano altro che sparare giudizi, ma forse nel loro caso si trattava solo di invidia. Avrebbero fatto molto di peggio pur di essere al mio posto, io lo so. E comunque, quando sono usciti dalla mia vita, non ho perso granché. Quando vai in giro col portafogli pieno di soldi e hai un budget di spesa illimitato trascinarti dietro degli spiantati diventa presto spiacevole per te e per loro. I soldi fanno la ricchezza di chi li possiede, mai quella di chi sta alla sua ombra. Il resto sono cazzate. Non credere a chi ti dice che il denaro non è tutto. Due anni fa una col tuo culo l’avrei vista passare per strada senza poter fare altro che stropicciarmi gli occhi e deglutire l’eccesso di salivazione. Poi ho imparato che per tutto c’è un prezzo, devi solo saperlo contrattare e poterlo pagare. Tu, per esempio, hai delle tette niente male, una faccia da copertina, io però ho un debole per queste due fossette sopra i tuoi glutei, proprio qui. Mentre ti scopo non faccio che pensare a loro. Cinquecento euro per fossetta, mica male! Un affare per te, soldi spesi bene per me. È la legge del mercato, io e te non siamo molto diversi, abbiamo entrambi qualcosa che il mercato richiede, dobbiamo solo fare in modo che frutti 125 il più possibile perché non durerà per sempre. Il tuo è un bene altamente deteriorabile, il tempo gioca contro te e le tue fossette. Anche la mia invenzione è destinata a perdere di valore, ma io posso lavorarci sopra per fare in modo che resti al passo con i tempi, a te invece non rimane che mettere da parte tutto quello che puoi, fino al giorno in cui ti accorgerai di essere fuori mercato. Adesso capisci dove sta la vera genialità della mia creazione? È una fonte di guadagno potenzialmente molto longeva, almeno molto più longeva delle fossette sul bel culo di una prostituta. Anche se al giorno d’oggi la chirurgia plastica può aiutare una come te a mantenersi accettabile fino ai quaranta o anche oltre, se si rivolge a uno bravo. Quei figli di puttana, con tutto il rispetto, sono capaci di fare dei veri miracoli. Per la cifra giusta ficcherebbero le mani sotto la pelle di un’ottantenne e le riporterebbero tette e culo in quota di crociera… Perché ti rivesti? Torna a letto, ti porto da bere.» «Devi pagarmi, si è fatto molto tardi.» «Potrai avere tutto il denaro che vuoi, se resti qui. Fai tu il prezzo. Ci chiudiamo in casa e facciamo passare questi due giorni di merda. Non vuoi sapere come vive una regina?» «Le regine lo prendono tra le cosce per il gusto di farlo, non per quattro soldi come me. Smettila di dire cazzate, devo prendere il treno delle sei, i miei mi aspettano per il pranzo di natale.» «Non sapevo che anche le puttane festeggiassero il natale.» «Pensa un po’ che sorpresa, signor genio dei gabinetti. 126 Persino le puttane hanno qualcuno che le aspetta a casa. Benvenuto tra gli esseri umani, dove ogni cosa ha un prezzo ma non tutto può essere comprato.» «Questa è bella, ti metti a dare lezioni di vita adesso? Allora aggiungi questo al tuo libro della saggezza: il fatto che ogni cosa abbia un prezzo non significa che tutto debba avere un valore. Vuoi sapere cosa vale meno di niente? La vita di una troia. Dovresti tenerne conto prima di aprire la bocca. Ricordati che posso pagare il tuo culo e anche qualcuno che lo faccia sparire dopo che ti avrò spezzato il collo.» La pressione di quella mano appena sotto la nuca le ha cristallizzato il sangue nelle vene, ne ha arrestato il circolo. Eppure il cuore batte ancora, lo sente pulsare in corrispondenza dei punti in cui le dita premono sul suo collo. Lo spinge via provando a mascherare di fastidio quella che non è altro che nuda paura. Per la prima volta da quando fa questa vita. Chiuso il cappotto raccoglie i soldi che lui ha buttato con disprezzo sul parquet, li infila nella borsa e se ne va verso l’uscita, conosce bene la strada. L’aria delle tre del mattino in quella periferia residenziale è una sferzata di realtà, dissolve le nebbie della mente mettendo a nudo terminazioni nervose che trasportano pugni nello stomaco. I pochi passi necessari per raggiungere la macchina sono sufficienti per rivelare l’irritazione sotto la sua gonna, solo l’orgoglio le impedisce di assumere un’andatura goffa e scomposta per lenire il fastidio. Ci penserà più tardi l’acqua calda della doccia a spegnere il fuoco e lavare via le scorie di 127 superficie, solo quelle, quanto basta per guardarsi allo specchio mentre asciuga i capelli prima di mandare giù le due pasticche che le permetteranno di dormire fino al pomeriggio del giorno dopo. Le forze per ricominciare da capo arriveranno per inerzia, come in qualunque altro domani uguale a qualunque altro disgraziato ieri. Strani concetti ieri e domani per chi non dorme che poche ore a notte, magari strappate allo scomodo abbraccio di una poltrona davanti alla tivù o con la faccia sulla tastiera del portatile. Passato e futuro si fondono in un lungo presente senza soluzione di continuità i cui ritmi sono scanditi dal buon odore della camicia pulita la mattina e dalle suonerie del telefono cellulare. Il percorso lo tracciano a turno ambizione e noia; questo è il momento della noia. Tre ore di sesso non sono servite a placare la sua smania e il Valium che ha ingoiato è andato giù senza produrre effetti esattamente come i bicchieri di gin che l’hanno seguito. Il dito sul telecomando non vuole saperne di fermarsi, ci saranno venti canali a luci rosse su quella maledetta televisione e in nessuno c’è niente che somigli a quelle due splendide, enigmatiche, impertinenti fossette che l’ossessionano, niente su cui valga la pena masturbarsi fino allo sfinimento. Vuota un altro bicchiere, liscio, senza intermediari liquidi o in cubetti e si avvicina alla parete in fondo alla sala, quella col grande arazzo in bella mostra, regalo dell’emiro che gli spalancò le porte per l’affare più importante della sua vita. Grande mossa non vendere il brevetto della sua creazione. Trovare i fondi per avviare la produzione gli era 128 costato il matrimonio, ma oggi nei bagni di una discreta parte delle ville di Dubai ci sono i suoi prodotti. Ecco in cosa ha sbagliato quella puttana, non ha saputo calcolare il valore della propria merce. Una così l’avrebbe anche potuta sposare una volta ottenuto il divorzio, se non si fosse venduta per quattro soldi. Le sarebbe bastato recitare la parte della ragazza per bene, sventolare un po’ quel suo culo da favola e lui ci sarebbe cascato come un coglione. Invece una misera strenna è bastata per impedirle la visione di tutto il bottino. Come al solito la prospettiva d’insieme si dimostra sfuggente alle menti ordinarie quali certamente sono la sua quasi ex moglie, la puttana col fantastico fondoschiena e tutti quelli che ha conosciuto nei suoi anni da miserabile. Scosta un lembo dell’arazzo per accedere alla piccola cassaforte che nasconde, come combinazione ha impostato la data del giorno in cui festeggiò il suo primo milione. Ne estrae una vecchia pistola a tamburo, una rivoltella già passata da suo nonno a suo padre e ora in suo possesso da ultimo retaggio della vecchia vita. Passa per la bottiglia del gin e torna a sedersi col bicchiere nella sinistra e la pistola nella destra. Solleva e abbassa il cane concentrandosi sul rumore meccanico, sulla sequenza di clic che accompagna quel breve movimento. Sente i nervi distendersi: andasse da sé, quel suono ipnotico, e continuasse per quel che rimane della notte, potrebbe finalmente dormire un po’. Il tamburo non è vuoto, contiene sempre quell’unica cartuccia caricata tempo fa, in una notte come questa. Adesso la sta guardando, si conoscono bene loro due, 129 non è il loro primo faccia a faccia, ma portata la canna alla tempia gli è sempre mancato il coraggio per premere il grilletto. Una sola possibilità su otto, dal punto di vista statistico non un grande rischio. L’uomo che racconta di essere non dovrebbe lasciarsi fermare da così poco, lui dovrebbe sapere come liberarsi di quelle ridicole ossessioni. Premere il grilletto, sentire il clic propagarsi liberatorio fino al centro del cervello e godersi la scossa dei nervi pervasi dall’adrenalina. Questo sì annienterebbe la noia. Una sola possibilità su otto, non un grande rischio. Una sola possibilità su otto... Bang! 130 Aventino Loi Lisa ha gli occhi viola Io so cos’è il bosco. Dov’è. So chi lo vive. Di sicuro c’è Lisa. Da almeno tre anni. O meglio: lo so da tre anni. In realtà credo ci sia da quando, guardandosi intorno, rifiutò il caos delle cose. Delle nostre cose. Non sapevo se per lei il bosco fosse una cosa buona. Spesso la immaginavo avvinghiata da rovi che le legavano il collo, levandole il respiro tanto da impedirle di parlare. La sognavo così. Finché un immane sforzo di uscire da quell’incubo mi svegliava di soprassalto. Sudato… Restavo così a chiedermi cos’era stato. Se solo un incubo… e giù dal letto. In fretta ma in silenzio… correvo. Correvo dove lei ancora dormiva. Sognava. Magari dei nostri giochi. La guardavo dormire. La bocca aperta sui suoi cinque anni. Le accarezzavo i capelli chiari. Guardavo gli occhi chiusi. Le ciglia lunghe. La pelle tesa… e piangevo. Nel vuoto della notte piangevo i suoi silenzi e le parole che l’indomani non avrebbe detto. A volte uscivamo presto la mattina. Soli. Anche quel giorno. Una passeggiata ai giardini. Come sempre la tenevo per mano. Come sempre lei tirava rischiando di farmi cadere e io la tenevo forte. Voleva correre. Tra le auto lente. Fuggire. Frenavo il suo braccio. Il suo cam- 133 minare. La guardavo. Lei solo di sbieco e mai negli occhi, ma rideva. Allegramente mi strattonava, giocava. Rideva ancora. Così arrivammo ai giardini e non so, un attimo di distrazione per lo squillo del telefono. Una chiamata, forse solo un messaggio. La persi. Sparita. Non c’era più. Mi prese il panico. Poteva farsi del male, tanto male da non permettermi di riparare a quella distrazione. Potevo non ritrovarla più. La cercai sudando con la paura in gola finché non intravidi il suo viso oltre gli arbusti di una grande aiuola. «Vieni fuori, Lisa! Fuori… ti sporchi…» dissi. Niente. La sentivo ridere. «Ti ho detto di venire fuori, ora. Basta!» Niente. Lei continuava a ridere. Fui costretto ad affacciarmi. Scostai gli arbusti, allungai una mano verso la sua per portarla via e invece, con forza, mi portò dentro verso di lei. L’assecondai per non farle male, per non piegare il suo braccino, ed entrai superando altri arbusti dentro quella macchia fino a ritrovarmi al centro di un ampio spazio. Tutto sembrava diverso ora. Non immaginavo ci fosse il bosco. Non pensavo che Lisa mi stesse portando dentro l’incubo di più notti, fatto di rovi e di spine, e che ora mi si presentava assolutamente diverso: uno splendido e immenso giardino. L’avevo già visto quel luogo. Da bambino. Avevo l’età di Lisa. Era di un’anziana donna che viveva sola in una grande casa… ma il giardino… era immenso, un parco grandioso fatto 134 di alberi e di arbusti in fiore. Colori e profumi mai sentiti prima. Inusuali. Essenze intense che si facevano visibili, quasi come un vapore che si levasse da quei forti colori e dall’erba che si perdeva ben oltre l’infittirsi della vegetazione più alta, dove il bosco, pensavo, si faceva una massa unica imperscrutabile. E Lisa? «Bello» disse. Solo Bello… Parlava? Quello sarebbe già stato un buon motivo per non chiedermi perché fossi lì, con lei, in quella domenica d’autunno. Mi bastava che parlasse. «Bello» aveva detto. Forse si sarebbe rivolta a me come mai avevo sentito prima e finalmente avrei colto dalla sua voce una parola per me. Qualcosa che mi desse la misura dell’amore che ero certo lei aveva per suo padre e che finalmente sarebbe stata in grado di esprimere così. In una parola. Mi misi accanto a lei e ci avviammo. Mano nella mano. Senza chiedermi se mai sarei uscito da quel luogo. Se mai saremmo tornati come prima. Camminavamo da poco. Il viale si era fatto ombroso. Coperto da alberi dal fusto imponente. Intravedevo qualcuno venirci incontro. Due bambini. «Ciao» dissero fermandosi. Entrambi indossavano maglietta e pantaloni bianchi. Scalzi. Lisa rispose al saluto, io no. C’era qualcosa di assolutamente raccapricciante in loro: non avevano la bocca. Avevano tratti regolari, ma dove avrebbero dovuto avere labbra, denti e gengive… nulla. Perfettamente lisci. «Tuo padre ci guarda con sospetto» disse uno di loro guardando Lisa. Sorrideva con gli occhi. 135 «Scusate…» dissi, e feci per tirare innanzi con Lisa. «No, non c’è bisogno» riprese quello. «È per la bocca. Lo so…» Mi chiedevo da dove venisse la voce. «La voce viene da dentro» mi disse risolvendo il quesito. Nulla. Non dissi nulla. Presi Lisa per mano e ci allontanammo. Lei si voltò per salutare, con un gesto. La guardai. Non aveva più la bocca. Anche lei. Mi prese un vago senso di confusione. «Come faremo a dirlo a tua madre?» farfugliai. Mi sembrava l’unico problema. «E come reagirà…» ormai deliravo. «Di qua» disse lei senza ascoltarmi, facendomi deviare dal percorso principale. Sapeva dove andare. Arrivammo in breve in un grande spiazzo. Al centro un piccolo stagno. Su grandi massi erano seduti tre bambini. Lanciavano sassi. Giocavano a farli saltare sul pelo dell’acqua. Ci avvicinammo. Erano biondi. Tutti. Raccolsi anch’io un sasso come stava facendo Lisa. Lo lanciai e fece cinque salti. «Bravo!» esclamò uno dei bimbi. «Ora provo io.» Era davanti a me. Piccolo. Tese il braccio e lanciò. Restò con la mano per aria. Aperta. La mano… una mano piuttosto strana. Aveva il pollice, ma al posto delle quattro dita un unico lembo di carne che articolava come se le dita fossero palmate. Ma non vi era alcun segno delle falangi. Presto mi accorsi che anche gli altri bambini erano così. Intanto Lisa gareggiava con loro a lanciare i sassi sull’acqua. Ridevano e giocavano. Presi Lisa, la caricai sulle spalle e via. Di corsa. Mi fermai quando mi sembrò di essere abbastanza lontano. Posai Lisa che era 136 rimasta tutto il tempo tranquilla. Non si preoccupava di avere le mani come piccole palette. «Ma che ti succede?» dissi prendendole la testa tra le mani. Sollevò lo sguardo oltre le mie spalle, come se vi fosse qualcuno dietro. Avevo paura di voltarmi. Quando lo feci mi trovai di fronte una donna. Pallida. Magra. «La bambina non ha nulla…» disse. Quasi fosse il gesto più naturale, Lisa le si avvicinò e carezzò una guancia della sconosciuta che la prese in braccio. L’abbracciò cingendole il collo come faceva con me quando aveva sonno o chiedeva le coccole. «Qui non vi accadrà nulla di male» disse la donna. Di quali altre trasformazioni sarebbe stata vittima, Lisa? Quella donna sembrava del tutto normale… a parte gli occhi. Viola. D’un intenso colore di ametista. Lisa si staccò da lei e mi guardò. I suoi occhi, ora, erano dello stesso colore di quelli della donna: «Ma che state facendo alla mia bambina?» urlai. «Sst» fece Lisa. «Sst» ripeté la donna. Risero. Avrei voluto capire. Avrei dovuto capire… Chiusi gli occhi e allungai una mano verso Lisa. Sentii la guancia, il naso e anche le labbra. Le aveva di nuovo. Mi baciò piano la mano. Era di nuovo normale. Lo era sempre stata. Mi chinai su di lei, la presi tra le braccia e andammo via così. Piano. Cercando un’uscita. Camminai con lei sulle spalle, dormiva. Superai la vegetazione più fitta, percorsi sentieri ripidi finché il bosco diradandosi mi fece intravedere la città. La periferia. Le strade trascurate e buie. La parte che mi teneva lontano da lei, dai luoghi 137 più ospitali. Superai cataste di immondizie mentre qua e là piccoli fuochi bruciavano residui organici indefiniti. Auto depredate di tutto erano abbandonate sui marciapiedi. Bisognava attraversare tutto per tornare alla partenza. Camminai, camminai. Lisa dormiva. Finché cedetti. Stanco. Mi sdraiai su una panchina con lei di fianco e mi addormentai. Mi svegliai col sole che filtrava dalle persiane. Ero riposato. Mi alzai e andai a cercarla nel suo letto. Ancora dormiva. Le sue mani erano distese sul lenzuolo che la copriva. Dormiva sempre con la bocca aperta. Le carezzai i capelli. Si svegliò. Aprì gli occhi e sorrise. Il viola dei suoi occhi le illuminò il viso. Erano ormai sei mesi che avevano assunto quel colore. Nessuno fu in grado di accertare se sarebbero rimasti così. Non si poteva stabilire. Ora Lisa ha gli occhi viola. Il colore del suo mondo. La luce con cui mi guarda ogni giorno. A volte lontana, altre più vicina. Ma so che c’è uno spazio che divido con lei quando smetto di guardarla o di inseguire i suoi silenzi. Con gli occhi chiusi ascolto il respiro sui miei capelli farsi vento. Sento la sua pelle sul viso. Le mie dita che incrociano le sue. Allora mi parla e capisco esattamente ciò che dice. 138 Elena Marinelli Caro Osvaldo 1. Tu sì che capisci le donne Quando posso ritardo di mezz’ora – bastano anche solo venti minuti – e sorrido perché c’è una signora coi capelli brizzolati e corti; sorride di riflesso e fa un cenno con la testa, tutte le volte, a quelli che entrano e si girano attorno per cercare un posto a sedere; ti guarda come se ti stesse aspettando. In metropolitana non incrocio lo sguardo di nessuno: al lunedì mattina ci sono i pendolari, quelli che vanno a lavorare, gli studenti del Politecnico e non c’è posto per nient’altro. La prima volta il posto vicino a lei è libero, mi siedo lì, sono ingombrante, lei sta ferma. Mi guarda, mi sorride sempre e io pure continuo a sorriderle. Ha gli occhi color nocciola, piccoli, che si fanno sottili a ogni movimento della bocca, labbra levigate, da ragazza, gli occhi sembrano due noci, m’accompagna fino a Lambrate. La prossima volta, lo so, mi dirà un segreto. Rita, dimmi che vuoi da mangiare. Niente, non voglio niente. Rita non mangia mai ed è grassissima. Non è un problema di cibo, è un problema di mente, di polmoni, di tutto 141 il resto: insomma è un problema di cuore. Da quando la conosco la metto nella rivista in cui lavoro, nella posta del cuore che non risponde alle debolezze, alle imperfezioni, alle persone, ma solo alle lettere dei lettori, lettrici per lo più. Io per mestiere scrivo una posta del cuore di una rivista e non mi sono mai domandato perché, fino al giorno in cui l’ho incontrata. È un lavoro, ci devo vivere, mica posso fare lo scrittore. In più sono maschio, mi chiamo Osvaldo, ma avere due sorelle mi aiuta molto. A volte chiedo direttamente a loro cosa rispondere, si divertono, fanno ipotesi, mettono le virgole e io non ci penso più di tanto; scrivo, spengo il pc e vado a casa. La posta del cuore è una di quelle cose che resiste a ogni innovazione culturale e tecnologica. L’editoria morirà, i libri saranno digitali ma la posta del cuore la leggeranno sempre tutti. Una signora una volta mi ha scritto: “Cara Teresa, lei sì che capisce le donne”. Sul giornale mi chiamo Teresa, come mia sorella. La lettrice era mia madre, ma non le ho risposto: non ha ancora capito cosa faccio di mestiere. Si usano sempre altri nomi per quelli che scrivono la posta del cuore, così si evita il coinvolgimento emotivo, come nei film porno quando sono finti, si è più obiettivi, si dice. Sembra facile, basta scrivere un consiglio, come a una mia amica, come a mia sorella, ma invece queste donne ci credono sul serio a quello che scrivo. Responsabilità, sento sempre responsabilità. Rita lo ha capito benissimo invece che lavoro faccio: era il suo sogno avere una posta del cuore. 142 Se qualcuno mi avesse detto una volta fai così e non così, forse chissà ora non abiterei questo seggiolino del metrò. A Lambrate scendo in fretta, ma sugli ultimi gradini sono sempre lento, non sono uno da ultimo minuto, durante l’ultimo minuto c’è sempre il pensiero sbagliato che sceglie la direzione opposta; non sono un musicista, non so improvvisare e finisce che mi perdo sempre. Federica e Gianni litigano sullo spiazzale di cemento caldo anche stamattina. Vanno avanti da quasi una settimana, forse si lasceranno tra un po’, non si baciano più ogni mattina tra le nove e le nove e dieci, prima che arrivi il treno; da quando lavoro in quella rivista noto molto più spesso come sono innamorate le persone, quello che dicono del loro amore mi interessa sempre meno, sono sempre delle bugie, incastonature dentro le righe, nella cornice delle e-mail, nel setaccio della vergogna di dire le cose come stanno. Il movimento degli innamorati non mente mai: lo scarto che si danno e gli sguardi che si lanciano, le volte che puntuale arriva l’incrocio sulla stessa canzone, lo sguardo di sottecchi per tenersi d’occhio senza far vedere di essere gelosi, mano nella mano quando non c’è nessuno, perché il segreto è il successo. I gesti sono la naturalezza e la seduzione dell’amore, l’ho letto da qualche parte, è una frase che ai miei lettori piace molto: il detto indica, il non detto seduce. Alle mie sorelle piacerebbero Federica e Gianni perché si perdono in parole, loro potrebbero ascoltarli come le soap opera in tv, tinti di giallo e verde, coi colori che fan- 143 no schifo perché l’importante è dire ti amo col tono che t’aspetti non con le reticenze. Le reticenze non piacciono a nessuno. Le lettere che ricevo parlano solo di fare qualcosa per, mettersi in animo di, ma mai di stare zitti. Eppure, dico io, se si riesce a star zitti in due senza specchio è fatta. Io la penso facile, non so che farci. La penso così da quando ho iniziato a guardare le ragazze. La penso che se ti metti a fare una dichiarazione sincera a una donna, lei non può non starci. Invece no. Eh no. Rita, t’ho fatto la frittata. Ok, la frittata la mangio. 2. Tu sì che dici le cose come stanno La prima volta in redazione mi arriva una lettera facile: fortunato. Lei ama ancora lui e lui l’ha tradita. Facile: mollalo. Me la cavo in tre righe, scrivendo anche capisco il tuo dolore, l’ho provato anche io e finendo con con affetto, Teresa. Mi risponde, un po’ risentita: Gentile Teresa, mi rendo conto che lei è nuova qui sul giornale, ma forse non ha capito bene la mia storia. Gliela rispiego. Ho un marito che mi ha tradito ed io non so più se voglio continuare a stare con lui. Mi ha fatto soffrire, non credevo sarebbe mai successo, io non l’ho mai fatto, e lui ha scelto un’altra. Non so nemmeno com’è fatta, ma ecco, è un’altra. Non sono le mie parti del corpo. Lui mi ha chiesto scusa, mi ha detto che 144 non succederà più, ma non so se credergli. La questione è il corpo, gentile Teresa, la questione che mi strangola di notte è il corpo. Il suo. Mi ha capito ora? Basito. Avevo capito benissimo e secondo me avrebbe dovuto lasciarlo: se non sopporti la condivisione del corpo, lascialo. Sicuramente lo rifarà. Male. Tu non sai consolare. Rita, ma come? Dovevo dire una bugia? No. Essere diplomatico. Ma io dico le cose come stanno. Male. A nessuno interessano le cose come stanno. Poi, chi ti ha detto che hai ragione? I fatti. Quali? Un uomo che tradisce lo rifà. Può rifarlo. Anche uno che non l’ha mai fatto. C’è meno possibilità. Non stiamo parlando di statistiche, qua. La mangi ‘sta frittata o no? Sì sì la mangio. Rita a volte è meglio di mia sorella. Quando proprio sono in crisi, al mattino vado due fermate più in là di Lambrate, mi faccio dire la sua opinione per bene: ho scoperto che le risposte articolate vincono sempre sul lettore. Ti rispondono sempre grazie, davvero grazie. Sì, davvero: con virgole e punti e la parola davvero. E Rita, volendo, può stare a parlare per ore: davvero. Le sto simpatico per via della posta del cuore, me l’ha 145 detto qualche volta, tra un sorriso e l’altro. Un giorno addirittura ha appoggiato la testa sulla mia spalla dicendomi la tua giacca profuma di velluto. Ma era di lino ed era estate. Il profumo del velluto è quando ci vuoi mettere dentro il naso, lo strusci e lo gratti e sei liscio tutto il giorno. Il velluto ha il profumo del liscio e del pelo nelle narici e te lo tieni dentro tutto il giorno così ti proteggi dal resto, non senti più niente dopo l’odore del velluto, è per questo che lo mettono attorno alle chitarre. Rita faceva la sarta. Il suo telaio lo teneva vicino alla finestra, c’era più luce e guardava la gente passare così se non sapeva come fare un orlo, vedeva come erano fatti quelli delle ragazzine che uscivano dal collegio, di fronte casa sua. Se non sapeva come fare la piega a una gonna, guardava Rosa mentre andava in collegio a insegnare italiano. Non ho mai imparato per davvero. Guardavo e rifacevo tutto, mi ha detto una volta. Com’è che hai smesso? Toglie la guancia dalla mia spalla. Mi sorride. Lambrate è passata da due fermate. 3. Tu non sai cos’è la nostalgia Il segreto di Rita non è un vero segreto: lo dice a tutti, perché non può farne a meno. È come il suo nome. Si presenta, Rita, piacere e poi aggiunge quasi sempre una volta sono impazzita per amore. Pare non sia più guarita. E lo dice con un sospiro dopo il nome, per un attimo 146 impallidisce e diventa piccola, ma non abbassa lo sguardo. Aveva un telaio e non sapeva a memoria gli orli, metteva i vestiti con le scollature forti, rideva poco perché pensava di avere una brutta bocca e si copriva le orecchie coi capelli lisci e lunghi, non li raccoglieva mai; odiava i foulard, mentre adesso ne è piena, ne ha uno intorno al collo sempre e poi alcuni sulle dita, come sua madre, quando se li legava al dito per ricordarsi le cose da fare. Il giorno del matrimonio di sua figlia aveva un fiocco per ogni dito e un foulard intorno al collo. Sono impazzita il giorno del mio matrimonio, non riuscivo a usare più le forbici. Come sei impazzita? A me non pari mica pazza. Sto bene solo sul metrò, devo muovermi, di notte vado in giro per tutta la città, sono pazza davvero, sai. Devo muovermi per pensare e sto bene solo se penso perché se penso ricordo e mi viene nostalgia. (E lo dice come se essere pazzi fosse avere i capelli neri, al massimo una colica che spunta ogni tanto.) Ma perché sei impazzita Rita? Per colpa della nostalgia. Alla nostalgia basta un ricordo solo, non serve un album intero. A me basta un ricordo, un suono, anche solo una nota, ripetuta e ricorsiva, e lei arriva, mi fa cadere, cercare la canzone mentre guardo fuori, non so nemmeno io dove, anche se ho freddo, mi fa aprire le tende anche se entra il sole delle tre dritto sulla mia 147 nuca. Un ricordo solo, nemmeno eccellente, nemmeno troppo importante: c’è, anche fermo e immobile, sono io che gli vado incontro. Allora per una volta mi sono rassegnata alla nostalgia e sono impazzita. Ma poi finisce la nostalgia a un certo punto, no? No, non finisce. Tu non sai cos’è la nostalgia. La nostalgia è cronica. Rita mangia sempre le stesse cose, è la sua nostalgia: schiava delle mosse e delle reazioni che le si strofinano sul corpo, della previsione esatta di quello che deve capitare alla prima nota di quella maledetta canzone, ogni volta che dalla finestra vede la luce spegnersi tra le undici e mezzanotte e inizia a camminare. Con gli occhi di fuori e crepati di sangue, di tristezza e d’amore Rita fa sempre lo stesso percorso, calpesta un prato a un certo punto della notte per sentire l’erba che scrocchia sotto le suole, come fossero ossa, o affonda nel fango se piove; si siede su uno scalino di una casa disabitata, a fatica, guarda il solito punto, sul marciapiede, dieci metri a destra, la mattonella dove stavano i suoi tacchi, riascolta tutte le parole e vorrebbe diventassero corpi, di nuovo, aria che esce dalla bocca a forma di nuvole bucate. Vorrebbe che quel ricordo durasse per sempre, è l’unica cosa che ho dice, è l’unica cosa che mi rimane, è l’unica cosa che posso vivere. Vive la nostalgia, ci passa dentro ogni volta che può, si rialza e se ne va, continua a cam- 148 minare, poi si appoggia a una staccionata di legno, nel mezzo, si tiene la bocca con l’altra mano e piange, con singhiozzi afoni. Tutto questo? Ogni notte? Quando mi prende la nostalgia, e mi prende spesso, quasi ogni notte. E meno male che mi prende, rifaccio tutto, meno male che mi prende. Rita... Scendi, siamo a Lambrate, ci vediamo domani. Corro via, aspetto che il treno si chiuda e riparta, la guardo dalla linea gialla: si è alzata e si tiene al poggiamani, cammina in senso contrario per sedersi da un’altra parte vicino a un posto vuoto, voltandomi le spalle. 149 Luisanna Gerace Francesca non esiste Stamattina mentre andavo a lezione di filologia romanza ho messo il piede in una pozzanghera. Posso sforzarmi di pensare che Francesca non esista, ma non che non esistano le pozzanghere. Quelle esistono e ti lasciano i piedi umidi per tutta la giornata. Credo che Francesca abbia fatto pallavolo da bambina, ha il culo di una pallavolista dilettante, ne sono sicura, è un’illuminazione da pausa sigaretta. Quasi mai prendo abbagli durante la pausa sigaretta. Francesca tutte le sere, tornando da lezione, si ferma nel baretto di Maurizio, un’accolita di artistoidi che sognano un ultimo tango e le soffitte polverose alla Rimbaud. Io ci passo di fronte, mi affaccio appena per vedere se è già arrivata e poi di filato riprendo la mia strada, rossa e con il cuore che fa tum tum perché tutti si sono girati. Scappo come una ladra, goffa e impaurita. Non ho il maglioncino giusto per entrarci, non porto treccine vezzose sotto un basco, né calzini buffoneggianti. Mi vergogno con i miei sottaceti nel cassetto della scrivania. Francesca ride poi infila le lunghe dita nell’olio torbido e tira fuori le melanzane gocciolanti. Le ingoia veloce e le sue labbra scintillano di unto. Io di Firenze conosco solo il campus e le vie centrali. 151 Firenze è tutta gialla e marrone e nell’umido di Pontevecchio sbrilluccicano coralli dalle vetrine. Sono arrivata qui con le valigie piene di sciarpe e scarponcini, come Totò a Milano, e mi trascino dietro una sfilza di otto sui temi di italiano che la professoressa Lorenzi segnava in blu con due pallini ravvicinati. Mi diceva, col suo rossetto rosso pompeiano, che ero troppo aggettivata. Me la prendevo, me la prendevo tanto. Poi si schiariva la voce e mentre scorreva la penna sul registro modulava un Veniant da far tremare i polsi. Adesso mi sento troppo pulita e troppo classica per questo posto. Troppo verde in viso per Francesca che ha le guance color Biancaneve, sangue sulla luna. Mi porto dietro questo desiderio come mani macchiate di marmellata, appiccicosa e invisibile, che tento di nascondere dietro la schiena. Quando sono partita mia nonna mi ha dato un rosario che profuma di rosa e una coperta fatta a mano per coprirmi le gambe sul divano. Qui non abbiamo un divano, in questa stanzetta da campus ci sono due letti, due scrivanie e un cucinino striminzito; ci sono i miei libri su una mensola e le tele senza telaio di Francesca. «Mi fai dipingere le tue mani?» mi chiede insistentemente. Ma le mie mani sono brutte, sembrano porcellini impauriti, sono cicciotte e corte e poi sono sporche di marmellata… le dico di no, chiudo i pugni e scappo in un libro di Joyce. Quando leggo mi tormenta il rumore del mare, penso che chi vive a due passi da una riva riesca meglio a cre- 152 dere ai miracoli, è il fatto di non vedere mai i confini. Penso che conosca la strana sensazione dell’attesa, l’arte di tessere la tela aspettando il messaggio nella bottiglia. Il mio messaggio nella bottiglia si chiama Francesca. Il mio temporale si chiama Francesca e come ogni temporale fa paura con quel bubbolìo che picchia i vetri e nasconde il ritmo del cuore. Da un po’ di tempo Francesca gira con un ragazzo biondo che porta sempre il cappuccio delle sue felpe in testa. Lui entra in camera e non saluta, si butta sonnolente sul letto e sfoglia giornali che parlano di concerti. Francesca, invece, lancia calzini in aria e cerca scarpe colorate sotto il letto. Ha sempre fretta di andare, di tornare, non risponde al telefono e segna sul calendario il suo ciclo irregolare. Sembra non sapere cos’è la noia. Io invece la noia la conosco. E non è che sia poi così male. Nella noia c’è la pausa, il rifiatare, c’è un non so che di possibilità, una sorta di potenzialità, l’inespresso. A volte questa sospensione mi serve. Di Francesca quello che adoro di più sono i suoi polsi. Sono leggeri e sottili e quando muovono il pennello sembrano ballerine di antiche danze popolari, come pizziche o saltarelli. Anche i polsi sono color Biancaneve. Una sera rientro in camera, mi chiudo dietro la porta e la trovo a piangere su un romanzo. Lei cerca di nascondere il libro, ma io intravedo il titolo, Pomodori Verdi Fritti al caffè di Whistle Stop. Si volta tirando su col naso e poi dice: «Che cazzata di libro!». Rimango ferma, cerco di capire qualcosa, mi appoggio e 153 le calze si attaccano al muro elettrizzate. Lascio la borsa sulla sedia, ma non dico niente. «Tu lo sai cos’è l’amore?» dice. Oddio, cosa posso risponderle? Non lo so, non lo so cos’è l’amore. Ma di certo assomiglia a me che faccio finta di dormire quando lei rientra tardi col sapore di vino dolce in bocca o alla sua gamba piegata sotto il sedere sulla sedia blu di camera nostra. Rispondo di no e lei fa un sospiro, poi riapre il libro e continua: «Penso che sia Dorothy sui mattoni gialli sulla via per Smeraldo… tanto lo sai, no, che il Mago di Oz non è quello che pensavi». Le si muovono gli occhi velocemente, quel color nocciola lucido e molle è instancabile. Lancia il libro, si alza, s’infila in bagno e urla tra lo scroscio dell’acqua corrente: «Stasera esco con Mat». Raramente m’informa sulle sue serate, specie se queste prevedono una coperta sotto cui nascondersi. Ogni tanto spero che mi guardi come guarda Mat e mi contagi di bellezza e dinamismo, del rossetto che non le si sbava mai. Ogni tanto spero di essere io quella coperta. Guardo Francesca da lontano, accanto alla facoltà. Tra pochi minuti ho una lezione, ma mi avvicino lo stesso all’edicola. I giornali dicono che ha il cervello bollito dalla cocaina, sarà, ma nessuno parla come lei. Quel modo morbido di dire parole vive, piene di ritmo. Francesca ha ancora i capelli lucidi e sembrano soffici come quella sera sotto 154 il quadro del Bronzino. E le sue parole ripartono, non hanno paura. Le mie parole sono morte, ma io le amo come se fosse sempre il primo giorno. Cerco di spiegare come si trasformano e come si trasformeranno ancora. Spero di dare, di far anche solo scorgere appena a ragazzi di 20 anni – tutti quegli occhi aggrovigliati e frettolosi – quanta vita esista in una lingua morta; dal primo suono di un mantra antico, la sillaba di Dio, come da un aum stentato, nascano gli uomini e le idee, come diventino storia. Ci provo, se necessario sbatto i pugni sul tavolo, non mi interessa che capiscano, mi interessa che sentano. Dalla punta della lingua fino alle vene, perché alfabeti sepolti sanno ancora far scendere desideri dalle stelle. Nulla è per caso: «Dē – venir giù – sidĕris – stella», ripeto ogni volta che sento qualcuno che si allontana e si perde avvilito. Non sono segnali, reazioni, formicolii da sputacchiare fuori in fretta, le parole sono intrecci irrevocabili, tamburi da percuotere, evocano, suonano, tracciano strade. Alle volte però sono stanca e arriva come una frenesia strana, una sorta di shock anafilattico, mi prende la fretta di passare oltre, andare, andare. Mi prende la voglia del sole e di cose fosforescenti che non hanno passati da rintracciare, di maionese, di riempirmi la bocca di gomme da masticare. Mi viene da sbattergli contro le radici, i suffissi, gli affissi, le crasi e imbrattarmi le mani di marmellata… Altre volte sono vicina, sospetto tra quegli occhi agitati un lampo che mi somiglia, un fuggitivo raccogliere. Qualcuno ogni tanto leva l’ancora e infila il mare, 155 lo aspetta un’infinita lotta. La stessa sete, lo stupore, il panico di sapere. E lì ho vinto, ci sarà un altro aum che spiegherà il mondo. Mi fermo, mi basta così. Appoggio di nuovo gli occhi su una labiale, sui suoni lunghi, su una sillaba che tintinna, mi viene una ridarella comica, non sto nella pelle. Ce l’ho fatta, Firenze finalmente è mia! A Firenze quando piove succede che le foglie si impastano. E il fiume s’ingrossa. E il tempo si mischia perfettamente agli imperativi e alle cioccolate calde. Tengo sempre la scrivania davanti alla finestra, anche lì al campus lo facevo. Ma adesso ho una ruga e una stanza tutta per me. Adesso apro la finestra quando piove, adesso tra i corpora e Calvino e con le bacchettine di incenso che spengo di corsa al primo odore di pioggia prima che piova, so raddrizzarmi le spalle che ho creduto piegate senza rimedio. Adesso è un’acquerugiola stanca, un salmodiare atono che non spande paure, adesso non sono io quel silenzio e non è lei il mio schiamazzo, il frusciare di sottofondo. Non è le porte che sbattono, tonfi di dizionari che si chiudono esausti, non è Degas appeso al muro. Adesso, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, nessun rumore le assomiglia ormai. Adesso che porto anelli alle dita e i capelli biondi, adesso so spiegare i batticuori, le nuvole, il vento dell’est. E distinguo un pioppo da un faggio, una peonia da un ranuncolo. Adesso che il mio mare è giallo di spighe di grano mature, ho le mani pulite di un amore sereno, che piega la testa di sera per una carezza 156 e che con ossa pesanti e robuste stufa verdure e pazienza, riscalda di polvere e di argilla. Adesso vivo. Di fonemi e grammatiche. Dei polsi di Francesca e del sorriso largo, dell’odore di sapone e latte, di un fiato accennato, sfiorato appena e una penna tra i suoi capelli, di ricordi, ricordo, circondata di memoria, solo la tenerezza di non sentirmi intera e non saperlo. Solo di una perduta carezza. Adesso vivo. In campagna con una donna androgina e seria che si occupa dei nostri animali e scrive poesie sugli uccelli. Io la prendo in giro, le dico che questa è invidia del pene, lei se la prende un po’ e sbuffa sempre le stesse cose: «mi incanta lo sguardo rapace, volitivo e intuitivo di questi animali». Ogni volta mi dice così e ogni volta io penso a Francesca, lo sguardo rapace, volitivo e intuitivo, anche se lei non esiste. 157 Ettore Malacarne Un ricordo di me Sono un bambino e piango. Il pianto è così improvviso e disperato che la madre del mio amico di giochi si affaccia al balcone di casa e poi scende, per verificare che non mi sia capitato qualcosa di brutto. Domanda a suo figlio cos’è successo e questo le risponde che non sa. Si avvicina a me che resto seduto al bordo della strada chiara per la sabbia di tufo. Mi chiede cos’ho e non riesco a risponderle per i singulti che mi opprimono la gola. Mia madre è a raccogliere pomodori in una campagna non lontana, mio padre in Germania. Io piango sul ciglio di una strada di quartiere, vicino muri vecchi di secoli, ricoperti da intonaci istoriati con licheni color ocra, muffe scure, crepe e graffi. Guardo attraverso la lente delle lacrime la luce abbagliante e la disperazione non ha consolazione. La madre del mio amico domanda ancora se non ho per caso sbattuto contro qualcosa, o una serpe mi ha morso. Alzo le braccia di bimbo verso di lei e poi le lascio ricadere, mi piego a terra di lato con la fronte nell’erba secca e la sabbia mi si attacca alla faccia. La donna si spaventa e si rivolge ad un’altra signora che si è affacciata alla finestra di una casa che dà sulla strada. Si domandano 161 se non sia il caso di chiamare un dottore, o mandare qualcuno ad avvisare mia madre. Arrivano altre donne. Anche un uomo che mi guarda restando a distanza, pensa che sono cose da ragazzini e conclude che il mio amico mi avrà dato un pugno o una botta e tra qualche minuto mi passerà, ma il mio amico nega, lui non mi ha toccato, non mi ha spinto né colpito. Allora cosa mi è successo gli domandano? Lui ripete che non sa. Una ragazza mi solleva da terra e mi prende in braccio, mi bacia le guance e la fronte, mi pettina i capelli con le dita e mi dice di calmarmi. Io l’abbraccio, mi appoggio alla sua spalla e al suo seno adolescente. Mi culla con colpetti delle braccia, e ripete: «Su, su». La madre del mio amico, preoccupata che si scopra alla fine che suo figlio mi ha fatto del male, insiste per sapere cosa stavamo facendo quando mi sono messo a piangere e lui le risponde che stavamo giocando. A cosa giocavamo vuole sapere. Giocavamo a fare una fortezza con la terra e gli stecchini secchi che avevamo raccolto sotto un albero di fico. Le fa vedere dove sono le torri, i ponti, le case, le strade, il palazzo del re, della nostra città invincibile cinta da una tripla cornice di mura. La donna conclude che devo essere un bambino strano a piangere a quel modo, per una ragione che non c’è. Tutta quella disperazione che non trova fine sarà forse per mio padre che è andato via, o mia madre che mi ha lasciato solo per lavorare. La ragazza non riesce più a reggermi in braccio e mi rimette giù ma mi tiene la mano, si china e cerca di guar- 162 darmi negli occhi, che mi si sono gonfiati perché li ho sfregati con le mani sporche di terra ed ancora li sfrego e piango. «Che c’è?» mi domanda. «Che succede?» La madre del mio amico riesce a sapere dal figlio che, mentre giocavamo, era arrivata una ragazzina a raccontarci che vicino alla fontana c’era un uomo che diceva alla gente di pentirsi perché tutti saremmo morti. Nessuno sarebbe sopravvissuto, era solo questione di tempo. Ogni cosa sarebbe sparita e del paese sarebbe rimasta solo sabbia sulla sabbia. Io mi ero messo in silenzio senza più la gioia di costruire con le forme di fango, avevo poi cominciato a piangere e non la finivo ancora. Sentito questo qualche donna dice che sono cose da non credere che un bambino così piccolo si faccia impressionare da un discorso come quello. Un bambino così piccolo che cosa può capire della morte? Io non ho più lacrime da versare ma continuo a singhiozzare e non riesco a dire le frasi che penso. Vorrei pregare quelle donne di avvisare mia madre in campagna che tra un po’ saremo tutti morti e di avvisare pure mio padre in Germania perché io non so come fare. Saremo morti, soli e lontani uno dall’altro. Poi arriva mia madre sconvolta, di corsa, con la sua bicicletta dalla campagna, qualcuno ha avvisato il padrone della terra che mi è successo qualcosa e che sto male. La ragazza che mi tiene per mano mi dice che adesso passa tutto e mi porta verso di lei, che vedendomi camminare e senza ferite si calma, e ancora di più quando la ragazza le dice che ho avuto solo paura per un racconto che ho sentito. Mia madre mi prende in braccio. Il suo vestito è sudato 163 e con la faccia calda e umida di lacrime mi bacia più volte sulla fronte e la testa dicendomi che tutto è passato. Adesso mi escono le parole, anche se continuo a piangere, le dico che saremo tutti morti e che un giorno non ci sarà più niente, sarà tutto scomparso. Mia madre mi risponde che non è vero. Da dove li prendo certi pensieri? Andremo a casa e mi darà fichi secchi, mandorle e pane, per merenda. Non devo avere paura perché noi non moriremo. 164 Gruppo Opìfice [Gruppo Opìfice] Il Gruppo Opìfice (Cagliari) nasce nel 2002 con l’obiettivo di coniugare pensiero e azione nella pratica metapolitica. L’attività dei 6 opificisti (Simone Olla, Simone Belfiori, Giovanni Curreli, Fabrizio Bolognesi, Alberto Carlo Dorsale, Joaquime Oréz de La Piquerra) attraversa la filosofia e l’arte in ogni sua forma. (Purtroppo non esiste un aneddoto leggendario sulla nascita del Gruppo Opìfice, ma possiamo inventarlo. Il 24 Dicembre 2002 Joaquime Orez de la Piquerra sta girando per la città alla ricerca degli ultimi regali di Natale; colto da disperazione per non aver trovato gli oggetti adatti a soddisfare la sua brama consumistica, ha una crisi mistica che lo porta a cominciare la sua personalissima rivolta contro la società moderna. Tornando a casa, infatti, non oblitera il biglietto dell’autobus e nota un giovane (Simone Olla) che come lui non ha timbrato; basta uno sguardo e nasce l’Opìfice del biglietto - teatro senza spettacolo fino al capolinea. Alle fermate successive salgono sull’autobus Simone Belfiori, Fabrizio Bolognesi, Giovanni Curreli e Carlo Alberto Dorsale che, loro malgrado, si ritrovano coinvolti in quest’atto di disobbedienza. Il toupé dell’obliteratrice in dosso a Joaquime farà il resto.) I componenti del Gruppo Opìfice hanno partecipato a 167 vario titolo a numerose conferenze sui temi più diversi (Sessantotto, Fecondazione assistita, Diritti dell’Uomo, Indipendentismo irlandese, Localismo, Decentramento, Americanismo, Destra/Sinistra). Il portale di metapolitica opifice.it è in rete dal 2004 e da subito si impreziosisce della collaborazione del filosofo francese Alain de Benoist e della casa editrice Arianna di Bologna; l’instancabile attività on line si divide fra letteratura e musica, filosofia e cinema. Nel 2006 inizia l’avventura radiofonica con Filtro Letterario, programma scritto e musicato dal Gruppo Opìfice per Radio Alzo Zero, mentre nel 2007-08 l’avventura prosegue con La gabbia del disonore, programma dissacrante che non risparmia chiunque passi per i pensieri degli opificisti. Nel 2007 esce Tutti esplosi (Giulio Perrone editore), antologia di racconti con prefazione di Massimo Carlotto; l’antologia dà il via ad un tour di presentazioni in varie città dell’Italia e della Sardegna. Nel 2008, in collaborazione con l’Arterìa di Bologna, il Gruppo Opìfice cura due rassegne letterarie: Salotto Post Litteram [segni in forme diverse] e Rassegna Minima [rassegna letteraria di soli autori Minimum Fax]. È del 2009 la prima edizione di Passaggi per il bosco, festival di lettere in musiche di periferie. 168 [racconti di periferie :: autori e indice] Dario Falconi | Porco odio | pag. 11 Nasce a Roma. Laureato in Lettere Moderne. Professore, drammaturgo, apprendista scrittore. Almeno questo dicono di lui. Il tutto è accaduto (se è accaduto) a sua insaputa. Un gran numero di racconti compaiono indisturbati su antologie e riviste. Utopsia (Di Salvo editore, 2008) è stata la sua prima fatica letteraria completa. La seconda fatica letteraria completa è un romanzo e ha per titolo Patagonìa (Prospettiva editrice – BrainGnu, 2010). Marco Mazzucchelli | La mattina prima di andare a lavorare | pag. 19 Ovvero la nascita in provincia di Varese, una laurea in urbanistica al Politecnico di Milano, un lavoro come architetto, la lontana collaborazione con la webzine “Movimenta”, la pubblicazione della raccolta di racconti Heartjob, l’apparizione sulla rivista Prospektiva n° 47, un romanzo cui manca poco per essere completato e, infine, questo racconto. Marco Visinoni | Paradise now | pag. 25 È nato a Iseo nel 1981. Il suo primo romanzo ha per titolo Macabre danze di sagome bianche (Miraviglia, 2007); 169 nel 2009 è seguita la raccolta di racconti Apocalypse Wow – Nove ballate dell’ultim’ora, selezionata da Unibook.com per la Fiera del libro di Torino 2009. Il suo sito internet è: marcovisinoni.it Simone Rossi |Abbandono Oblio Deserto | pag. 29 Laureato in Semiotica a Bologna, è uno scrittore a cui piace suonare. Il suo primo libro si chiama La luna è girata strana (Zandegù, 2008). Il suo secondo libro si chiama sbriciolu(na)glio e gliel’ha pubblicato suo cugino. Scrive su Finzioni fin dal numero zero. Tuffa i biscotti nell’acqua. Ha un sito, come tutti: simone-rossi.it Silvia Ancordi | Gli undici giganti | pag. 37 È nata a Lovere nel 1975. Ama scrivere di tematiche spirituali, extrasensoriali e misteriche. Nonostante scriva da anni, solo da pochi mesi si muove nel mondo delle pubblicazioni. Gli undici giganti è il secondo racconto pubblicato dopo Astrale terza a sinistra comparso nell’antologia Auroralia (Zona Editore, 2009). Il suo sito internet è: nirbhiti.wordpress.com Gianfranco Franchi | αλήθεια | pag. 45 “Lankelot” (Trieste, 1978), scrittore e scout editoriale, sanguemisto giuliano-romano. Laureato in Lettere Moderne a Roma III nel 2002. Ha pubblicato narrativa: Disorder (Il Foglio Letterario, 2006), Pagano (Il Foglio Letterario, 2007), Monteverde (Castelvecchi, 2009); poesia: L’inadempienza (Il Foglio Letterario, 2008); saggistica: Ra- 170 diohead. A Kid. Testi commentati (Arcana, 2009). Ha curato la plaquette Lettere alle tre amiche di Scipio Slataper (Alet, 2007) e l’audiolibro L’altro viaggio in Italia. Dal Cinquecento al Duemila (Il Narratore, 2009). Come consulente, ha lavorato per Castelvecchi, Alet, Arcana. Collabora con Radio Capodistria, Turismo Culturale e il Secolo d’Italia. Ha collaborato con “Fahrenheit” di Radio 3. Fabio Medda | La parte del manico | pag. 51 È nato a Cagliari nel 1964. Laureato in Giurisprudenza, è funzionario della Regione Sardegna. Ha collaborato con L’Unione Sarda e con il “Roxy Web” di Red Ronnie. Ha pubblicato Il dio dell’orizzonte (Cagliari, 1996) e Virato seppia (Cagliari, 2000). Un suo racconto, Edo, è apparso nella raccolta di racconti Tutti esplosi – Le trame di Opìfice (Giulio Perrone editore, 2007). Il suo sito internet è: adagioquasiandante.blogspot.com Angelo Zabaglio a.k.a. Andrea Coffami | Pianterei | pag. 61 Sceneggiatore e giullare di corte, ex rapper ed ex voto, poeta e performer, si esibisce da oltre dieci anni in reading letterari e slam poetry miscelando classicismo a futurismo, comicità a riflessione. Collabora attivamente con il collettivo romano Scrittori precari e con quello milanese Folli tra fogli. In passato ha seguito con interesse il collettivo pontino Anonima Scrittori. Ha pubblicato la raccolta di racconti Lavorare stronca (Tespi, 2008) e la raccolta di poesie Non tutti i dubbi sono di plastica (Arcipelago Edizioni, 2007), il CD Pene (Nico- 171 la Pesce Editore, 2007) con le musiche di Marco Russo. Con Vertigo ha composto i CD Maniscalco (2008) e Nonòflò (2009) entrambi scaricabili gratuitamente. Di prossima uscita il libello umoristico Sovvertire il cinema (18:30 Edizioni). Il suo sito internet è: write-soon.com/blogatuasorella Erwin de Greef | La mela caramellata | pag. 67 Giramondo per definizione e autentico bastardo mezzo sangue olandese, è nato a Palermo nel 1968. Presente in diverse antologie, ha pubblicato la raccolta di racconti Ritmi urbani (Gaefra editore, 1999) e i romanzi brevi Dio c’è e bacia benissimo (Coniglio editore, 2006) e Per il resto chiedete a Pennac (Coniglio editore, 2008). Laureato in Lingue e Letterature Straniere con più specializzazioni e un master in editoria, da anni collabora con recensioni di letteratura e saggi brevi con numerosi periodici e riviste. In editoria si è fatto le ossa lavorando a vario titolo con Gaefra Editore, peQuod Edizioni e Giunti Editore, attualmente è editor e correttore di bozze libero professionista. Gianluca Morozzi | Matrioske | pag. 71 È nato a Bologna nel 1971. Ha pubblicato i romanzi Despero, Luglio, agosto settembre nero, Dieci cose che ho fatto ma che non posso credere di aver fatto, però le ho fatte, Accecati dalla luce, Blackout, L’era del porco, Le avventure di zio Savoldi, L’abisso, Colui che gli dei vogliono distruggere, Cicatrici; i saggi L’Emilia o la dura legge della musica, Il rosso e il blu, Nato per rincorrere; le graphic novel Pandemonio e Il vangelo del coyote e la serie a fumetti in più volumi FactorY. 172 Gianluca Liguori | Tempo di passaggio | pag. 79 Nasce a Battipaglia nel 1982 e nel 2010 smette di bere perché il medico gli ha detto che se no a 30 anni non ci arriva. A 22 anni scrive il suo primo romanzo, Dio è distratto (Nicola Pesce editore, 2007). Nel 2008 pubblica Credo in un solo io (Tespi editore) una raccolta di testi giovanili, o meglio sbrodolate adolescenziali, spacciati per poesie (tipo quelli di Vasco Rossi su Satisfiction, per intenderci), e una nuova edizione di Dio è distratto con postfazione di Vincenzo Sparagna. Partecipa alle due antologie di Scrittori Sommersi ed un suo racconto lungo apre E il cagnolino rise (Tespi, 2009), omaggio a John Fante. Scriverà almeno un romanzo importante, ma finora non ha scritto ancora niente all’altezza delle sue aspettative. È fondatore, insieme a Simone Ghelli, del collettivo Scrittori precari, il cui sito internet è: scrittoriprecari. wordpress.com Tommaso Chimenti | La panchina | pag. 85 È nel mezzo del cammin di nostra vita. Ogni giorno si scorge un pelo bianco in più nella barba. Finora ha deciso di tagliarli. È giornalista. Ha un maglioncino nuovo appena comprato ed una giacca da smoking di velluto liscio verde acqua marina della quale va orgoglioso. Fa il critico teatrale. Grafomane a strati, a tratti, a strappi. Essere o fare è sempre stato il suo dilemma, come l’asino che, nell’incertezza tra l’avena e il fieno, morì di fame. 173 Cristina Serci |L’ombra del tempo | pag. 89 Vive a Cagliari dove ha studiato Medicina e Chirurgia, naturopatia, omeopatia e biopsicologia. Scrittrice e pittrice, ha vinto numerosi premi regionali, nazionali ed internazionali per la pittura, la poesia e la narrativa. Ha pubblicato i romanzi Galoppo con concerto di Brahms (Soter, 1998), Cinzia vuol mangiare la luna (Cocco, 2000), Il posto vuoto di Alma (La Riflessione, 2004). Con la silloge poetica Le jacarande, ha vinto il primo premio al concorso “Città di Cagliari”. Barbara Gozzi | Vattene | pag. 97 Nasce a Modena nel 1978 ma vive ormai da anni nel bolognese. Editor, scrittrice, collaboratrice di testate on line, cura progetti sociali e culturali. Attorno al corpo di Eluana Englaro, dal 2010, è anche performance-rappresentazione. Alcune sue storie sono finite su carta. Altre, chissà. Nella rubrica (In)ter(per)culturando che cura su “AgoraVox” vira tra storie, voci, angolazioni, sentire tra libri e società. Antonio Tirelli |periferie illustrate | da pag. 5 Nasce a Napoli nel 1979. Laureato in scienze della comunicazione, vive a Bologna lavorando in una libreria ed è fra i soci fondatori di Casa Lettrice Malicuvata. La prima pubblicazione in cui appaiono i suoi disegni è l’antologia a fumetti Sherwood Comix. Immagini che producono azioni (Nicola Pesce editore, 2009). Scrive recensioni e articoli inerenti alla letteratura. Le sue elucubrazioni su malicuvata.it e opifice.it 174 [altri racconti di periferie :: autori e indice] Alessandro Romeo | Quanta scena per niente | pag. 105 Nasce a Venezia il 26 luglio 1985. Nel 2007, insieme a un gruppo di amici, ha fondato inutile. opuscolo letterario (rivistainutile.it). Insieme a un altro gruppo di amici ha organizzato “Wimble.doc” (wimbledoc.com), il primo torneo di racconti on line. Ha vissuto a Mestre per vent’anni, a Parigi per un anno. Da due anni vive e studia a Torino. Ugo Coppari | In fondo alla valle | pag. 111 È nato a Jesi nel 1982. Nel 2005 si laurea in Comunicazione Internazionale presso l’Università per Stranieri di Perugia, con una tesi d’indagine sul fenomeno Adbusters e sulla strategia del culture jamming/détournement. Nel 2006 entra a far parte del Comitato Artistico P-gruppe, con cui tuttora collabora. Presso Morlacchi Editore sono usciti Bim bum bam! (2006), Nove anoressiche (2007), Limbo mobile (2009). Vive e lavora a Perugia. Chìo Dùpia | Terapia | pag. 117 È nato nel 1989, di pomeriggio. Ha capelli rossi ed occhi blu, pantaloni corti e uno strappo proprio lì. Amici nel quartiere non ne ha, non saprebbe che farsene. Scrive, dorme e piglia pesci. 175 Gianni Usai | La legge dei grandi numeri | pag. 123 È nato trentasei anni fa a Sinnai, in provincia di Cagliari, luogo dove attualmente vive e lavora. Scrive per riempire gli spazi, per spendere energie, per allenare il cervello e gli occhi a vedere e riconoscere ciò che spesso sfugge. Suoi racconti sono stati pubblicati in rete su Frenulo a mano, Catrame, Opìfice, Malicuvata, Isola Nera; in versione cartacea sul Giornale di Sardegna e sulla raccolta periodica Toilet. Ha scritto una raccolta di racconti intitolata Imperfetti nati e il romanzo Controvento per noia, opere tuttora in cerca di editore. Attualmente sta lavorando ad un nuovo romanzo. Aventino Loi | Lisa ha gli occhi viola | pag. 133 Poliedrico cinquantenne, alla voce professione potrebbe scrivere bancario o scrittore. Ha infatti pubblicato articoli su riviste di organizzazione e psicologia del lavoro oltre a poesie e racconti su riviste e antologie. Un suo racconto è presente nella raccolta curata dal Gruppo Opìfice, Tutti esplosi (Giulio Perrone editore, 2007). Strettamente correlata al suo lavoro in banca la sua attività di formazione degli adulti; tiene corsi di public speaking e comunicazine efficace. Si evince quindi la natura curiosa e ricca di sfaccettature dell’autore di Lisa ha gli occhi viola. Elena Marinelli | Caro Osvaldo | pag. 141 Quando scrive è Osvaldo. O Teresa, dipende. Quando non scrive sta su internet per lavoro. Quando non sta su internet per lavoro sta su internet per spasso. Poi spe- 176 gne il computer e legge un sacco di libri e va al cinema più che può e ascolta la musica, ma quello anche davanti al computer. Strimpella col basso in casa sua e suonerebbe il contrabbasso, ma il contrabbasso non riesce ad abbracciarlo (il computer sì). Fa delle gran ciambelle ed è piuttosto brava a leggere ad alta voce, ma non lo ammetterà mai (è maniaca perfezionista). In generale, vorrebbe essere il quinto dei Radiohead (cit.). O degli Atoms for Peace, anche. La centoventotto rossa è il suo primo libro. Ha un sito internet: elenamarinelli.it Luisanna Gerace | Francesca non esiste | pag. 151 Generalmente lavora in un ufficio, ma generalmente anche legge. Scrive quasi mai. Nel 2007 un suo racconto è stato pubblicato nell’antologia Parole in corsa V. Ha un scatola piena di matite. Non fuma più, si abbarbica e pensa al mar Jonio. Ah già, vive a Bologna, e ha 32 anni. Il suo sito internet è: josmarch.blogspot.com Ettore Malacarne | Un ricordo di me | pag. 161 È nato nel 1966. Collabora con la rivista letteraria Satisfiction. Ha pubblicato La conquista dello spazio e altri racconti (Eumeswil, 2008). Dipinge con uno pseudonimo e ha opere presenti in note collezioni private, musei e fondazioni. Risiede sull’Appennino modenese dove possiede un’azienda agricola in cui si coltiva l’Utopia. 177 Dogon Review [quasi fine] i lettori di Malicuvata per Racconti di periferie Giulia Pazzola Alberto Cordeddu Antonio Tirelli Giovanni Curreli Alessandra Pigliaru Fabrizio Bolognesi Rosanna Guerra Paola Paggi Davide Gianetti Carlo Schiavo Alfio Génitron Marialuisa Fascì Spurio [malicuvata.it | [email protected]] [fine] stampato per Casa Lettrice Malicuvata presso UniversalBook S.r.l. - Rende (CS)
Scaricare