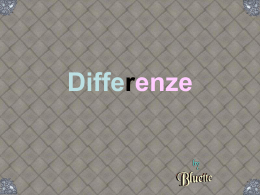Varlam Šalamov, lo scontro con la vita reale di Giancarlo Gaeta «Penso che chiunque legga le mie storie si renda conto di quanto siano futili le vecchie idee e gli schemi della letteratura tradizionale». Varlam Šalamov Soltanto di recente Varlam Šalamov e i suoi racconti sui campi di lavoro sovietici sono diventati noti al grande pubblico grazie a una performance televisiva di Roberto Saviano che ha sorprendentemente spinto in cima alle classifiche dei libri più venduti un’opera, I racconti di Kolyma, pubblicata in edizione integrale già da dieci anni e molto prima in selezioni di varia ampiezza: da quella pionieristica, curata da Piero Sinatti negli anni settanta, fino all’ampia scelta proposta da Adelphi a metà degli anni novanta.1 Peraltro, come spesso capita con gli eventi mediologici, si è fatto molto rumore per nulla, poiché se si parla di una vicenda come quella di Šalamov e dell’opera letteraria che la riflette, è pressoché nulla assumerne i potenti elementi emozionali trasferendoli in effimere suggestioni. Né l’occasione è stata colta per riavviare una seria riflessione su un’opera letteraria la cui grandezza è oramai fuori discussione, e che tuttavia stenta a ricevere un’attenzione scevra dalle polemiche di parte che ne hanno segnato la ricezione sin dal suo primo approdare in Occidente via Samizdat alla fine degli anni sessanta. Si cominciò allora a prendere le distanze dall’idea che si potesse paragonare l’internamento nei campi di lavoro sovietici, per quanto terribili ne fossero le condizioni di vita, all’orrore dei lager nazisti. Fu questo l’atteggiamento di molti intellettuali di sinistra che, seguendo l’esempio di Jean Paul Sartre, scelsero di mantenere il silenzio intorno a quelli che ritenevano danni collaterali nella costruzione della patria del socialismo. Vent’anni dopo e fino ad oggi ancora di questo si discute anche a proposito di Šalamov; ma a parti invertite, per affermare ora la sostanziale somiglianza, se non l’identità, dei due regimi totalitari e delle rispettive pratiche di annientamento di ogni forma di opposizione, di ogni rivendicazione d’identità individuale. Se ne fece in particolare portavoce Gustaw Herling, a sua volta passato per l’esperienza dei lager sovietici, che in una Conversazione su Šalamov tenuta con Piero Sinatti e Anna Raffetto nel 1998,2 argomentava a lungo contro «l’atteggiamento tenuto per anni e anni dall’intelligencija di sinistra, non solo italiana, che ha parzialmente ma 1 L’edizione integrale a cura di Irina P. Sirotinskaja, traduzione di S. Rapetti, è apparsa da Einaudi nel 1999 ne «I millenni» e dal 2005 nei Tascabili. Una prima edizione antologica fu pubblicata da Savelli a cura di P. Sinatti nel 1976 senza l’autorizzazione dell’autore (Kolyma. Trenta racconti dai lager staliniani), seguita nel 1992 da quelle di Sellerio, I racconti di Kolyma, e di Theoria col titolo Nel lager non ci sono colpevoli. Gli ultimi racconti della Kolyma, che contiene anche il saggio La mia prosa. A queste pubblicazioni, limitate a qualche manciata di racconti, Adelphi ha fatto seguire nel 1995 un’edizione che ne raccoglie più di un terzo selezionati da quattro delle sei parti dell’opera. 2 Lo scritto avrebbe dovuto servire da prefazione all’edizione Einaudi dei Racconti, ma fu respinto all’ultimo momento dall’editore con argomenti poco convincenti e quindi stampato polemicamente come opuscolo: G. Herling, P. Sinatti, Ricordare, raccontare. Conversazione su Šalamov, L’ancora, Napoli 1999. Alla propria esperienza concentrazionaria, Herling aveva dedicato il racconto di Un mondo a parte, apparso in italiano nel 1957 ma rimasto ignorato fino agli anni novanta. Si veda il minuzioso confronto tra questa opera e gli scritti di Primo Levi proposto da D. Scarpa, Lager e Gulag. Levi e Herling, scrittori della responsabilità, in «Lo straniero» 1 (estate 1997) 100-112. sostanzialmente condizionato la coscienza comune dell’Occidente», favorendo appunto l’idea dell’incomparabilità del nazismo col comunismo staliniano.3 Posizione che ha certamente avuto il suo peso, insieme alla netta rimozione del Gulag nella Russia postcomunista, nel condurre all’attuale sparizione dell’universo concentrazionario sovietico dalla riflessione critica e dunque dalla coscienza comune, per la quale, come si vede ad ogni ricorrenza della «Giorno della memoria», la realtà tragica della deportazione di massa nei lager coincide pressoché esclusivamente con la Shoah.4 In effetti sarebbe stato certamente molto più costruttivo per la maturazione della coscienza europea considerare le cose come stavano aldilà degli schermi ideologici e, bisogna aggiungere, senza spirito di parte. Ma allora si sarebbe dovuto andare ben oltre la denuncia dei «regimi gemelli», per guardare al fondo dell’abisso e leggervi lo sprofondamento di un’intera cultura e civiltà, come seppero fare i pochissimi, come Simone Weil, Albert Camus o Hannah Arendt, a cui dobbiamo per questo qualche appiglio a cui aggrapparci per tentare di capire cosa effettivamente è successo, come è potuto succedere e dunque, forse, come potremmo venirne a capo, ammesso che resti ancora una qualche volontà di interrogarsi al riguardo, al di la delle commemorazioni rituali o di occasionali indignazioni. Penso che fra queste figure d’eccezione vada oramai annoverato Varlam Šalamov e vorrei qui di seguito provare a spiegare perché. Non che non si sia scritto nulla al riguardo. Elementi importanti di riflessione, restando nei limiti delle pubblicazioni in lingua italiana, emergono ad esempio nella suddetta Conversazione, man mano che l’attenzione degli interlocutori si porta sulla personalità di Šalamov e sul valore letterario oltre che testimoniale dell’opera.5 Rilevantissimo è stato il contributo editoriale ed esplicativo di Irina Sirotinskaja, che sostenne Šalamov negli anni della creazione letteraria e si prese cura di lui in quelli ultimi, quando, «raggiunto dall’ombra dei lager, i frammenti della sua personalità, cementata dalla volontà e dal coraggio, si erano disgregati».6 Da ultimo il volume ideato da Francesco Bigazzi con la collaborazione di Sergio Rapetti e della stessa Sirotinskaja; esempio eccellente di indagine documentaria costruita assemblando racconti autobiografici e materiale inedito relativo agli interrogatori e ai processi subiti da Šalamov, nonché ai rapporti informativi stilati dai confidenti della polizia segreta anche dopo la sua riabilitazione nel 1956.7 3 Ricordare, raccontare, cit., pp. 18 sg. Sia Herling che Sinatti hanno attribuito una siffatta tendenza anche a Primo Levi; giudizio che è frutto di fraintendimento, come dirò più avanti. 4 Ma con qualche significativa eccezione; si veda ad esempio il volume che raccoglie gli atti di un convegno del 2003 dedicato ai «Giusti nel Gulag», con una bella Prefazione di G. Nissim, che nota tra l’altro «come la deriva eliminazionista introdotta in nome di un ordine superiore, non abbia colpito soltanto gli ebrei, gli armeni o le vittime sovietiche, ma abbia attraversato la condizione umana del Novecento», cosa che imporrebbe l’allargamento della memoria a vicende diverse (Storie di uomini giusti nel Lager, Bruno Mondadori, Milano 2004, pp. 14 sg.). Il volume contiene anche un’ampia bibliografia sul Gulag e i suoi testimoni. 5 Si vedano inoltre i saggi introduttivi di P. Sinatti e V. Zaslavsky alle citate raccolte edite rispettivamente da Savelli e da Sellerio,. 6 I. Sirotinskaja, Ricordi, in V. Šalamov, I racconti di Kolima, Einaudi, Torino 1999, p. XXXVI. Si veda anche il suo Responsabilità e moralità della parola in Varlam Šalamov, in Storie di uomini giusti nel Gulag, cit., pp. 95102. 7 V. Šalamov, Alcune mie vite. Documenti segreti e racconti inediti, a cura di F. Bigazzi, S. Rapetti e I. Sirotinskaja, Mondadori, Milano 2009. Bigazzi ebbe la fortuna nel 1976 di ascoltare Šalamov parlare della sua esperienza a un ristretto gruppo di ammiratori raccolti nel suo minuscolo appartamento moscovita. Sulla 2 Ciò che si rileva in questi contributi è il comune riconoscimento della straordinaria statura morale ad artistica di Šalamov, annoverato oramai tra i più grandi scrittori russi del Novecento, da affiancare a Boris Pasternak, ad Aleksàndr Solženicyn, a Vasilij Grossman, ma con un tratto di verità più forte, più universale, poiché in definitiva è nella sua scrittura che ha trovato espressione compiuta l’indicibile messa in atto dell’annichilimento dell’umano, da Auschwitz alla Kolima a Hiroshima, marchio distintivo del secolo. Dunque, sebbene con enorme ritardo, dovuto innanzitutto al cordone sanitario costruito intorno alla sua opera in prosa almeno fino alla sparizione dello Stato sovietico,8 si è infine cominciato ad interrogarsi sull’uomo, sulla sua vicenda e su come egli abbia saputo mettere il suo talento artistico integralmente al servizio della «documentazione di quel poco che è rimasto dell’uomo».9 Ma ancora moltissimo c’è da fare per passare da un apprezzamento di fondo a una comprensione ravvicinata di un’opera letteraria che come poche altre costringe a guardare senza attenuazioni di sorta al fondo dell’abisso, fino a mettere in questione lo stesso connotato umanistico della nostra cultura. Nell’Europa della prima metà del secolo scorso quella di Šalamov fu una tra le infinite vite spezzate dall’imperscrutabile volontà degli Stati totalitari.10 Arrestato una prima volta nel 1929 poco più che ventenne – era nato nel 1907 –, e condannato a tre anni da scontare in un lager nel Nord degli Urali per propaganda e organizzazione sovversiva; poi di nuovo nel ’37, l’anno terribile delle purghe staliniane, quando fu tradotto nei geli dell’estremo Nord a scavare oro e carbone nelle miniere, a tagliare boschi, infine, e fu la sua salvezza, a servire come infermiere nell’ospedale per detenuti. In mezzo c’era stato giusto il tempo per il matrimonio e la nascita di una figlia, che non avrebbe più rivisto e da cui, al suo ritorno nel 1953, sarebbe stato ripudiato.11 A quarantasei anni, martoriato nel corpo, impossibilitato a tornare a vivere con la donna il cui amore lo aveva sostenuto in una prova devastante, da cui ben pochi poterono emergere vivi e moralmente integri, Šalamov trova la forza per risuscitare in sé il poeta sbocciato negli anni della giovinezza, ma poi cancellato da una condizione di vita in cui aveva finito col perdere persino la capacità di lettura.12 collocazione di Šalamov nella letteratura ispirata al Gulag, si veda M. Martini, Oltre il disgelo. La letteratura russa dopo l’URSS, Bruno Mondadori, Milano 2002, pp. 47-63. 8 Questo malgrado fosse stato riabilitato già nel 1956 dalle accuse che lo avevano condotto nei lager della Kolyma. I Racconti sono stati pubblicati in Russia soltanto tra il 1989 e nel 1991; una prima edizione parziale in lingua russa era apparsa a Londra nel 1978, accolta con indifferenza dall’autore, a cui non interessava tanto la fama letteraria quanto agire sulla coscienza del suo popolo. L’edizione dell’opera completa di Šalamov in sei volumi è stata pubblicata a Mosca tra il 1998 e il 2004. 9 V. Šalamov, La mia prosa, in Id., Nel lager non ci sono colpevoli. Gli ultimi racconti della Kolyma, a cura di L. Salmon, introduzione di P. Sinatti, Edizioni Theoria, Roma-Napoli 1992, pp. 146 e 152. 10 Tra gli scrittori vanno ricordati almeno Osip Mandel’štam, Isaak Babel’ e Pavel Florenskij, uccisi nei campi e l’analogo destino di Valentin Sokolov, morto nel 1984 in un manicomio criminale dopo trent’anni di lager. Si veda M. Martini, Oltre il disgelo, cit., pp. 52 sg. 11 «Io ritornai dopo diciotto anni di assenza, dopo un viaggio all’inferno, ancora privo di diritti, con la salute rovinata. Avevo lasciato mia figlia in culla, la notte del 12 gennaio 1937, l’avevo baciata mentre dormiva e me ne ero andato per vent’anni. Adesso lei aveva finito la scuola, stava per entrare all’università» (V. Šalamov, B. Pasternak, Parole salvate dalle fiamme. Ricordi e lettere, a cura di L. Montagnani, Rosellina Archinto, Milano 1993, p. 189). 12 Ne riferisce nel bellissimo frammento autobiografico I libri della mia vita, a cura di A. Pasquinelli, Ibis, Como-Pavia 1994, p. 38. «Sono come quel calzolaio di Mark Twain cui sembrava di essere nato per diventare 3 Da quel momento e per i successivi venti anni, vale a dire finché gli restarono sufficienti energie fisiche e mentali, egli trasfonde nell’opera letteraria la memoria di un’intera vita, la sua, rivissuta come memoria di un’epoca tragica dalla rivoluzione alla morte di Stalin nel ’53. Dunque innanzitutto l’immenso epos della Kolyma, centoquarantacinque racconti suddivisi in sei parti, o meglio «libri» come Šalamov preferiva denominarli;13 a complemento di questo i racconti della prima esperienza del lager a Višera,14 e ancora il ricordo della sua formazione nell’amata Vologda e del destino drammatico della sua famiglia travolta dalla rivoluzione.15 Opere distinte, ma sostenute da una stessa ricerca formale al fine di consentire «l’immediata risposta ad avvenimenti esterni, l’immediata assimilazione e rielaborazione di quanto si è visto».16 Tale concezione, applicata in modo sovrano alla composizione dei Racconti, trova riscontro anche nelle altre due opere, malgrado in queste si dia maggiore unità tematica e sviluppo narrativo. Forse proprio per questo, a scanso di equivoci, Šalamov ha voluto apporre a sottotitolo di Višera un provocatorio: «Antiromanzo». Formula negativa, ad escludere una qualsivoglia etichetta su un processo di rammemorazione degli avvenimenti non così come si sono dati o come l’artista ha inteso ricrearli in un’opera d’immaginazione, bensì così come si sono inscritti indelebilmente nella sua anima. Allo stesso modo, malgrado le apparenze, egli vieta di leggere ne La quarta Vologda la storia della famiglia nel contesto della vicenda rivoluzionaria, poiché si tratta in definitiva de «la storia della mia anima – e nient’altro».17 L’ammonimento, posto già nelle prime pagine, è quanto mai opportuno trattandosi della rievocazione del passato per eccellenza, quello in cui, in prima persona o tramite un personaggio romanzesco, l’autore cerca per lo più di rappresentarsi i precedenti che hanno disposto del suo destino. Qui in effetti l’elemento autobiografico ha un peso rilevante, ma non per questo la scrittura assume un «andamento narrativo e cronistico», per usare la definizione che Pasternak ha dato del racconto della sua infanzia e giovinezza, pago di aver scritto ciò che bastava a «illuminare come, nella mia storia personale, la vita sia diventata creazione artistica, e come questa sia nata dal destino e dall’esperienza».18 In effetti, per Pasternak non meno che per Šalamov, «parlare degli anni, delle circostanze, degli uomini e dei destini che si sono trovati rinserrati nella cornice della Rivoluzione» comportava di «scriverne in modo da mozzare il fiato, da far inorridire». Per farlo egli ha però scelto la mediazione della narrazione romanzesca, proiettando e trasponendo se stesso nel personaggio del dottor Živago,19 mentre Šalamov si è vietato sia l’autobiografia sia il romanzo come generi letterari; ha cercato e Napoleone. Mi preparavo a diventare Shakespeare. Il lager ha spezzato tutto» (riferito da I. Sirotinskaja, in Ricordi, cit., p. XXXIII). 13 La composizione si è arrestata nel 1973; incompiuto è rimasto l’ultimo libro: Il guanto, ovvero KR-2. 14 Višera, Antiromanzo, traduzione di C. Zonghetti, Adelphi, Milano 2010 (scritto tra il 1970 e il 1971). 15 La quarta Vologda, a cura di A. Raffetto, Adelphi, Milano 2001 (scritto tra il 1968 e il 1971). 16 Ibid., p. 9. 17 Ibid., p. 26. 18 B. Pasternak, Autobiografia e nuovi versi, Feltrinelli, Milano 1958, pp. 97 e 107. 19 Si veda E. Pasternak, Il ruolo dell’elemento biografico nel Dottor Živago, in La Russia di Pasternak. Dal futurismo al Dottor Živago, a cura di V. Strada, Feltrinelli, Milano 1999, pp. 61-75. 4 trovato una nuova forma capace di «fornire la testimonianza documentale di un’epoca, una testimonianza la cui emozionalità fosse convincente».20 I racconti de La quarta Vologda sono effettivamente già documentazione dell’epoca; nel mentre ci dicono dell’infanzia dell’autore, dei genitori, della sua educazione, del suo carattere e delle sue disposizioni interiori, sono allo stesso tempo evocazione della storia e della geografia della città amata da Ivan il Terribile, quella dei remoti tempi ecclesiali incarnati nel pope padre di Varlam, «sciamano e figlio di sciamani», e quella più recente destinata dagli zar a luogo di confino degli esiliati politici e perciò patria del movimento rivoluzionario; la Vologda «rivolta a ovest in direzione delle due capitali – Mosca e Pietroburgo – e di quanto sta dietro a loro, l’Europa, il Mondo con la maiuscola».21 Cosicché la vicenda biografica non si risolve in una quantità di eventi rievocati sul filo della memoria e ricomposti in una sequenza temporale; è piuttosto lo spazio a dominare, il «paese dell’anima» evocato da Marina Cvetaeva, entro il quale i fatti si ridispongono a disegnare la mappa segreta del destino di Varlam, della sua famiglia e insieme della sua città sotto il segno della rivoluzione. Višera è stato scritto negli stessi anni de La quarta Vologda, quando la composizione dei Racconti era già giunta al quinto dei sei libri, ma le due opere sono del tutto diverse; Višera, libro misto di racconti e saggi, va letto come l’estremo, incompiuto esperimento letterario di Šalamov, alla ricerca incessante di nuove forme di espressione artistica.22 Eppure, collocate nella vita dell’autore, risulta una sotterranea continuità tra esse, almeno nel senso che anche Višera è storia di formazione morale, ma non più nella propria casa e città, bensì nella prigione e nel lager. La narrazione della storia familiare si chiudeva con un duro congedo dal padre espresso nel proposito di vivere all’opposto di lui e dei consigli che gli aveva impartito, nella consapevolezza di un destino già segnato: «Tu hai creduto in Dio e io non crederò, non credo da tempo e non imparerò mai a farlo. Tu ami l’attività pubblica, e io l’ignorerò, e se mai mi cimenterò, sarà in tutt’altro modo. Tu credi nel successo, nella carriera – io non farò carriera –, morirò anonimo in qualche angolo sperduto della Siberia orientale. […] Tu volevi per me un ruolo pubblico, io sarò soltanto un oppositore».23 I racconti di Višera si aprono con la rievocazione del giorno del primo arresto: «Un giorno, un’ora che considero l’inizio della mia vita sociale, il primo, vero, durissimo banco di prova».24 La prossimità tra le due opere si constata anche nella opzione per la narrazione in prima persona, molto ridotta nei Racconti; è come se solo ora, mentre il suo capolavoro giungeva a compimento, Šalamov abbia avvertita prepotente l’esigenza di rendere esplicita a se stesso la genesi di un destino drammatico, di fronte al quale non si era ripiegato su se stesso, ma al contrario aveva trovato in sé le energie morali per assumerlo e con esso assumere il proprio «ruolo specifico e peculiare nella vita» in rappresentanza di coloro che contestavano Stalin.25 Impegno quanto mai gravoso, al limite dell’impossibile nella realtà disumana del lager, che 20 V. Šalamov, La mia prosa, cit., p. 147. La quarta Vologda, cit., p. 22. 22 Nella forma attuale il libro è stato composto a partire da una raccolta di racconti e saggi messi insieme dall’Autore in modo non definitivo; altro materiale è stato aggiunto al momento della pubblicazione nel 1989. 23 Ibid., p. 203. 24 Višera, cit., p. 23. 25 Ibid., p. 27. 21 5 poté essere mantenuto, soprattutto più tardi nei geli della Kolyma e quando oramai gli era diventato chiaro che Stalin e il potere sovietico erano la stessa cosa, soltanto imponendo a se stesso regole di comportamento rigorosissime, tali da porlo pericolosamente fuori dalla logica ferrea che presiedeva alla vita del campo. Una sorta di decalogo riconducibile a due principi fondamentali: innanzitutto «la conformità tra parole e azioni» e poi «la capacità di sacrificarsi in prima persona», vale a dire non chiedere niente alle autorità, non nuocere in alcun modo agli altri, essere lo stesso con i superiori e gli inferiori, non lasciarsi degradare dalla paura, confidare soltanto nelle proprie forze; tutto questo, senza alcuna implicazione romantica, piuttosto un modus vivendi che egli riconduceva all’affinata «esperienza di generazioni e generazioni di intellettuali russi».26 Della scrittura dei Racconti di Kolima ci si è occupati spesso, appoggiandosi per lo più sui testi in cui l’Autore si è impegnato a definire uno spazio proprio nella storia della letteratura russa.27 D’altronde basta essere un lettore comune per rendersi conto della difficoltà di ricondurre la sua prosa nelle forme tradizionali del romanzo o del racconto; ma a misurare l’anomalia della scrittura di Šalamov è soprattutto la forza dell’impatto emotivo e dello sconcerto che queste narrazioni sono in grado di suscitare. Colpisce innanzitutto l’assommarsi apparentemente casuale di racconti compiuti in se stessi e narrati per lo più in terza persona.28 Certo, ciascuno di questi è spontaneamente colto dal lettore come la tessera di un immenso mosaico, la cui unitarietà tuttavia gli sfugge nell’impossibilità di collocarsi contemplativamente al di fuori della rappresentazione. In altri termini, non essendoci alcuna trama complessiva o svolgimento tematico da seguire, né una cornice che li tenga insieme, ogni racconto determina un arresto: nel giro di poche pagine tutto è detto con la maggiore nettezza e definitività; d’altra parte si è continuamente sospinti verso un altro racconto, un altro frammento di vita esposto con altrettanta crudezza, e così via in una navigazione senza meta in un universo alieno a ogni sensatezza. Perciò a nessun titolo si può inscrivere questa opera nel genere del romanzo, malgrado l’unitarietà della materia drammatica e la grandiosità di una rappresentazione ricchissima di situazioni.29 Ne è assente l’architettura complessa: tipi e psicologie, linee tematiche e intrecci orientati verso un esito necessario;30 né sussiste per il lettore la possibilità di identificare 26 Ibid., pp. 26 e 27. L’elenco delle regole si trova alle pp. 67 sg. Testi raccolti nel quinto volume dell’opera omnia: V. Šalamov, Sobranie sočinenij, 6 voll., Terza-Knižnyj Klub, Moskva 2004. In italiano si veda il già citato La mia prosa, scritto nel 1971 in forma di lettera alla Sirotinskaja. 28 La narrazione in prima persona è invece dominante nell’ultimo «libro», che ha carattere spiccatamente autoriflessivo. 29 Non aiuta a capire l’estetica di Šalamov cercare di ricollocare i Racconti nel genere romanzo «strutturato però nelle forme del racconto» (A. Raffetto, Ricordare, raccontare, cit. p. 51), o parlare di «stile del romanzo» malgrado l’opzione per l’antiromanzo (R. Saviano, La conferma del bene, introduzione a V. Šalamov, Višera, cit., p. 17). 30 Una definizione convincente della forma romanzo rispetto al racconto è offerta da A. Berardinelli: notata l’insufficienza della distinzione tra narrazione “breve” e “lunga”, egli aggiunge che «se traduciamo e specifichiamo “lunghezza” con termini contigui come: ampiezza, ritmo disteso, vastità e completezza rappresentativa, ricchezza e varietà delle rappresentazioni, gradazione e complessità nei rapporti fra personaggi, fra classi sociali e generazioni, ecco che si va abbastanza vicini ad una più accettabile e plausibile definizione di romanzo» (Il sogno della cattedrale. Elsa Morante e il romanzo come archetipo, in Per Elsa Morante, Linea d’ombra Edizioni, Milano 1993, p. 13). 27 6 l’autore con un io recitante stabile, che faccia da guida e sostegno morale in un cammino tanto angoscioso quanto insensato, pur nell’evidenza che tutto ciò che è narrato sotto più nomi e più personalità riflette un universo di esperienze personali. È un viaggio nell’inferno, come nel poema dantesco, ma senza protagonista, senza guida e senza via d’uscita; ad ogni tappa si svolge un dramma che subito si chiude su se stesso in modo lapidario. Vero è che l’enorme massa di racconti è stata ripartita da Šalamov in sei libri, ciascuno con un titolo, come a voler segnalare i motivi salienti della composizione; tuttavia queste partizioni non sono riconducibili a temi specifici, eccetto il piccolo gruppo di racconti intitolato Scene di vita criminale,31 né possono essere considerate elementi strutturanti dell’opera; sembrano piuttosto pensate come i movimenti di una sinfonia, i cui titoli segnano poeticamente la tonalità: La riva sinistra, Il virtuoso del badile, La resurrezione del larice, Il guanto.32 Di fatto vi sono soltanto singoli racconti, ciascuno dei quali si collega agli altri non perché inseriti in una cornice narrativa,33 ma in quanto espressione in sé compiuta dell’autore che, sotto molteplici figure, è l’unico punto di raccordo, o meglio il centro d’irradiazione di una molteplicità di fatti, la cui narrazione è insieme documentaria e poetica.34 Ma si badi che la stessa forma tradizionale del racconto è messa in questione; è Šalamov stesso a dichiararlo: «I miei racconti rappresentano una lotta vittoriosa e consapevole contro ciò che viene definito il “genere” del racconto. Se in pratica non ho mai pensato a come si debba scrivere un romanzo, a come si debba scrivere un racconto ci ho pensato per decenni interi fin dalla giovinezza».35 L’esito di questa lunga riflessione, accompagnata in anni giovanili da molti esercizi di scrittura, ha avuto come esito un deciso prosciugamento della frase, depurata da ogni elemento che ne allenti o ne sovraccarichi la tensione interna, che deve risultare perfettamente calibrata in modo che scatti come una molla compressa al punto giusto: «Lo schiaffo deve essere breve, sonoro».36 Questo significa che l’elaborazione letteraria dei suoi racconti non persegue lo scavo in profondità delle situazioni o delle psicologie, non si distende e articola per comprendere la complessità dei rapporti e neppure mira a perseguire una perfezione estetica. A Irina Sirotinskaja interessata a sapere «quali fossero i risvolti psicologici» dei suoi racconti e se questi «avessero delle caratteristiche puramente letterarie che potessero conferire loro un posto nella prosa russa», Šalamov risponde opponendo la finalità attiva della sua scrittura legata ad una precisa congiuntura 31 Sezione che ha peraltro una funzione molto importante nell’economia dell’opera, quella di rappresentare il fondo nero del pozzo in cui sono precipitate le vite dei detenuti, soprattutto dal momento in cui s’impose l’idea che, a differenza dei «politici», i malavitosi potevano essere «recuperati» alla causa del popolo, rafforzando così la loro propensione a dettare legge nei campi in accordo con i comandanti (si veda il racconto La guerra delle «cagne», in I racconti di Kolyma, cit. pp. 799 sgg.). Nel breve testo che fa da cornice a questo «libro», Šalamov accusa duramente la letteratura occidentale, russa in particolare, di avere «rappresentato il mondo dei criminali con simpatia e talvolta compiacimento», aprendo la strada agli esiti attuali (A proposito di un errore della letteratura, in ibid., pp. 743, sgg.). 32 Il primo libro porta lo stesso titolo dell’opera, segno che inizialmente Šalamov pensava a una sequenza continua di racconti. 33 M. Martini definisce i Racconti «un’unica grande opera, che ha come solo centro l’inferno della Kolyma e si manifesta attraverso l’esplosione di una molteplicità di racconti» (Oltre il disgelo, cit., pp. 59 sg.). 34 «Pur con l’assoluta documentabile attendibilità dei miei racconti, ho sempre tenuto presente che per un artista, per un autore, la cosa fondamentale è la possibilità di esprimersi, di mettere a disposizione del proprio flusso creativo un cervello libero» (V. Šalamov, La mia prosa, cit., p. 145). 35 Ibid., p. 143. Analoga considerazione in una lettera a Pasternak (Parole salvate dalle fiamme, cit., p.71). 36 La mia prosa, cit., p. 144. 7 storica: «Ognuno dei miei racconti è uno schiaffo allo stalinismo e, come ogni schiaffo, risponde esclusivamente a leggi di carattere muscolare»; d’altra parte rifiutando l’ideale della perfezione stilistica nella misura in cui non corrisponde alle sue intenzioni: i suoi racconti non abbisognano di limatura, sono scritti di getto, anzi si può dire che si scrivano da soli una volta «sollevata una certa leva cerebrale» che consente l’emersione di brani del passato.37 Dunque l’abbandono delle forme letterarie tradizionali non fu inteso da Šalamov soltanto quale conseguenza di una personale opzione estetica, ma corrispose innanzitutto a un’esigenza storica inderogabile; qualcosa di decisivo e di irrimediabile era successo nel ventesimo secolo che colpiva anche l’arte,38 perciò anche la letteratura, la quale se ridotta a pura creazione verbale o fantastica tradisce l’attesa del lettore, il quale, egli pensa, «non vuole leggere storie inventate, non ha tempo per destini reinventati all’infinito».39 È a questa situazione storica che egli riconduce la morte del romanzo come genere, definitivamente attestata dal «fallimento artistico del Dottor Živago».40 Giudizio tanto più sorprendente se si considera l’importanza artistica e umana che per lui ebbe Pasternak, colui a cui aveva inviato i versi composti nell’ultimo periodo di detenzione, l’unica persona che volle incontrare appena poté rimettere fugacemente piede a Mosca nel novembre del 1953, e dal quale ricevette tra i primi in lettura il manoscritto del grande romanzo.41 Di fatto l’incontro e il confronto con Pasternak, costante e intensissimo fino al 1956, consentì a Šalamov di prendere pienamente coscienza del carattere innovativo oltre che del tutto originale della propria scrittura. È stato giustamente osservato che il confronto decisivo non fu quello con l’altro grande memorialista del Gulag, cioè Solženicyn, spiritualmente e artisticamente troppo distante da lui,42 bensì proprio con lo scrittore che Šalamov aveva sentito più vicino.43 È lui stesso a rilevarlo rievocando i suoi incontri con il poeta che aveva illuminato la sua giovinezza, i cui versi appresi a memoria lo avevano sostenuto durante la detenzione: «È stata per me una gioia trovare in Pasternak una concezione dei legami tra l’arte e la vita simile alla mia. È stata una gioia apprendere che ciò che si era accumulato poco per volta nella mia anima e nel mio cuore, ciò che si era sedimentato come esperienza di vita, osservazioni e sensazioni personali – era condiviso anche da un altro uomo che io stimavo infinitamente».44 Al riguardo va tenuto presente che Šalamov inizia a scrivere i Racconti negli stessi anni in cui Pasternak era 37 Ibid., p. 143. «A me pare che l’uomo della seconda metà del ventesimo secolo, l’uomo che ha sofferto guerre, rivoluzioni e tradimenti, gli incendi di Hiroshima, la bomba atomica, e soprattutto, a debito coronamento, la vergogna della Kolyma e dei forni di Auschwitz, mi pare che l’uomo che ha vissuto la rivoluzione scientifica non possa non guardare ai problemi dell’arte in modo diverso» (ibid., p. 147). 39 Ibid. p. 146. 40 Ibid., p.147. 41 Lo scambio epistolare è contenuto in V. Šalamov, B. Pasternak, Parole salvate dalle fiamme, cit.; vi si trova anche una ricostruzione dei loro incontri fatta da Šalamov a memoria dopo la morte di Pasternak nel 1960. 42 Secondo Herling, «Arcipelago Gulag è più un’enciclopedia dei campi di concentramento che un libro paragonabile a quello di Šalamov sulla Kolyma» (Ricordare, raccontare, cit., p. 35; si veda anche p. 46). Lo stesso Solženicyn ha riconosciuto il superiore valore della testimonianza di Šalamov: «Forse nei Racconti di Kolyma il lettore avvertirà più esattamente lo spirito spietato dell’Arcipelago e il limite della disperazione umana» (Arcipelago Gulag, vol. II, Oscar Mondadori, Milano1995, p. 8). In un colloquio con F. Bigazzi Solženicyn ha dichiarato la sua ammirazione per Šalamov come poeta e scrittore pur ammettendo la grande differenza tra loro (Alcune mie vite, cit., p. 21). 43 Si veda M. Martini, Oltre il disgelo, cit., p. 60. 44 Ibid., p. 149. 38 8 impegnato a portare a compimento il suo romanzo, concluso nel 1956; è probabilmente a partire da questo momento che ha inizio il processo di distacco, man mano che la sua opera cresceva e si palesava meglio ai suoi occhi la novità di una prosa incompatibile con forme di narrazione che egli tendeva a ricondurre alla tradizione umanistica ottocentesca di matrice tolstoiana.45 I primi indizi significativi di tale processo si possono cogliere già nella valutazione del Dottor Živago, espressa in modo analitico nella grande lettera del gennaio 1954 a seguito della lettura della prima parte del romanzo ancora in gestazione. È sintomatico innanzitutto che Šalamov si dichiari disinteressato alla forma romanzo assunta dalla narrazione, poiché in questo caso, come nei vertici della letteratura russa: Tolstoj Čecov Dostoevskij, ad imporsi al lettore è «la ricchezza del contenuto morale», e dunque dei pensieri, delle immagini, del vocabolario, nonché «la verità delle azioni umane, cioè la verità dei caratteri». È su questo che egli si sente impegnato a riflettere, «separatamente dal romanzo», con riguardo soprattutto ai pensieri dei personaggi nei quali trova espressione la problematicità dell’anima umana.46 Ciò che dunque rende prezioso il romanzo di Pasternak e ne fa un evento destinato a restare per lungo tempo è per lui «la scoperta dell’uomo pensante», la figura dai molti volti emblema della letteratura russa dell’Ottocento. Con questa presa di posizione iniziale sono coerenti le osservazioni puntuali a commento del racconto, che risulta come smontato nei suoi elementi costitutivi: personaggi, situazioni, descrizioni, dei quali è colto di volta in volta un particolare: una parola, un tratto caratteriale, un atteggiamento, una considerazione profonda, una illuminazione poetica; quasi sempre ammirati dal commentatore, ma a volte criticati se ritiene che l’Autore non sia andato abbastanza a fondo o se nel ritrarre delle figure non sia riuscito a cogliere il segno, com’è il caso per gli appartenenti alla classe operaia o ancora quando propone una lingua popolare artefatta. In definitiva: «Quasi tutte le frasi del romanzo sono dense di significato. Sono così piene di contenuto, del tutto inconsueto nella sostanza, che esigono o un sottomesso stupore o un’eccitata discussione».47 Dichiarazione importante per cogliere il nucleo della poetica di Šalamov: a lui non interessa la forma letteraria, ma il dettaglio cristallizzato nella frase o in una singola parola, a cui viene attribuita una «infinita capacità evocativa».48 Non c’è allora da sorprendersi se a conclusione della lettera-recensione egli ha trascritto una serie di brevi passaggi del romanzo, una piccola parte di quelli che riteneva i punti più belli e che nell’insieme – ma questo avrebbe significato «ricopiare un buon terzo del libro» – costituivano per lui la sostanza stessa dell’opera.49 Ripresa a rovescio di un esercizio che egli 45 Nello scritto del 1971 «il fallimento artistico del Dottor Živago» consegue al fatto che oramai «nessuna forza al mondo potrà resuscitare il romanzo di Tolstoj» (La mia prosa, cit. p. 147). Ma nel 1954 in una lettera a Pasternak scriveva: «Vede, lei per me è diventato da tempo la persona che ha incarnato in sé la coscienza della nostra epoca, il suo destino. È lo stesso ruolo di Lev Tolstoj» (Parole salvate dalle fiamme, cit., p. 103). In realtà la continuità con Tolstoj è piuttosto evidente nei casi di Solženicyn e del grande romanzo di Vasilij Grossman, Vita e destino, incentrato sulla battaglia di Stalingrado. 46 Ibid., pp. 72 sg. 47 Ibid., pp. 86 sg. 48 M. Martini, Oltre il disgelo, cit., p. 60. 49 Ibid., pp. 94 sgg. In altri termini non dà rilevanza alla trama del romanzo che, al contrario, ha per M. Aucouturier «valore autonomo» e costituisce «la componente principale del senso», a differenza del romanzo realista, «dove la trama è frutto del personaggio e della società» (Il dottor Živago come “romanzo russo”, in La Russia di Pasternak, a cura di V. Strada, Feltrinelli, Milano 1999, p. 93). 9 faceva da giovane per imparare il mestiere: cancellare di un racconto tutti i passi privi di bellezza, con il risultato che ne restava assai poco, si trattasse pure dell’amato Babel’.50 E ancora nel senso di una critica alla struttura romanzesca va l’elogio a Pasternak per non aver eletto a proprio portavoce Živago, come capita nei «cattivi romanzi», ma di aver parlato con «la voce di tutti i personaggi: gli uomini, il bosco, la pietra, il cielo».51 È seguendo questi convincimenti estetici che Šalamov sta in quegli anni lavorando ai Racconti, si sta misurando a sua volta con la coscienza e il destino della propria epoca. Se è vero, come è stato rilevato, che Pasternak e Šalamov rappresentano «le punte delle due potenzialità narrative della letteratura russa novecentesca, accomunati dalla radicalità estrema della loro ricerca letteraria»,52 nonché, bisogna aggiungere, da una eccezionale consonanza spirituale ed esigenza di verità ad ogni costo, tuttavia nelle rispettive opere è passata una diversa consapevolezza dei processi distruttivi a cui la coscienza dell’umano era stata sottoposta nella prima parte del Novecento. Molto diverse sono in effetti le immagini del mondo ricreate da Il dottor Živago e da I racconti di Kolyma in forza di loro leggi proprie, così come diverse tra loro erano state le immagini offerte da Guerra e pace e da I fratelli Karamazov. Si tratta di creazioni artistiche assolutamente originali; appena confrontabile con i precedenti dell’Ottocento quella di Pasternak,53 oramai consapevolmente scissa dalla tradizione della prosa russa quella di Šalamov.54 Della originalità del romanzo di Pasternak si è oramai diffusamente consapevoli, anche se si discute ancora se si tratti davvero di un romanzo o di qualcos’altro non facilmente definibile: trattato, storia, teologia; tuttavia, osserva Andrej Sinjavskij, «l’autore, pur desiderando uscire dai confini dell’arte, in realtà non rompe con l’arte, così come non rompe radicalmente con le tradizioni del romanzo realistico, coi concetti normativi di “intreccio”, “carattere”, “verosimiglianza”, ecc.».55 Ma allora cosa dire dell’opera di Šalamov, come definire ciò che è stato concepito e redatto voltando consapevolmente le spalle al passato? E come rapportarsi a un’opera che non offre alcuna possibilità di raffigurarsi un qualche «ponte gettato verso il futuro»? Invano infatti si cercherebbe una figura dominante come quella di Živago, cioè di «un individuo di tale struttura spirituale, che se anche precipita nella rovina, rimane e prende coscienza nella storia, involontariamente crea la storia, e la storia da esso creata tende gioiosamente verso l’orizzonte del futuro, oltre i confini degli eventi rappresentati nell’immediato».56 50 La mia prosa, cit., p. 144. Osservazione contenuta in una lettera di Šalamov del 1956, dove commenta la seconda parte del romanzo (Parole salvate dalle fiamme, cit., p. 128). M. Aucouturier rileva al contrario come tratto specifico del Dottor Živago «la peculiarità del rapporto tra autore e protagonista», al punto che esso va compreso come «una autorealizzazione del poeta in forma autobiografica inventata, in cui l’autore e il protagonista sono così affini da potersi scambiare i ruoli» (Il dottor Živago come “romanzo russo”, cit., pp. 92 e 95). 52 M. Martini, Oltre il disgelo, cit. p. 61. 53 A favore di una lettura del Dottor Živago oramai emancipato dal confronto con Guerra e pace si è espresso M. Aucouturier (Il dottor Živago come “romanzo russo”, cit., pp. 89-95). 54 «Al centro della riflessione di Šalamov sulla letteratura, c’è il distacco da una tradizione ottocentesca oramai inaridita, c’è la ricerca di un’adesione stilistica alla materia narrata tale da farla rivivere in progress, con i suoi infiniti dettagli» (A. Raffetto, Ricordare, raccontare, cit., p. 56) 55 A. Sinjavskij, Aspetti della prosa dell’ultimo Pasternak, in La Russia di Pasternak, cit., p. 78. 56 Ibid., p. 80. 51 10 Vero è che l’uomo in carne e ossa che ha attraversato i gironi infernali della Kolyma era di struttura spirituale altrettanto elevata se non maggiore di quello raffigurato da Pasternak a propria immagine, ma profondamente diverso fu il modo in cui ciascuno di essi si scontrò con la potenza annichilente del totalitarismo e ne restò segnato. A Pasternak, che visse la rivoluzione come un evento apocalittico che lo travolse senza inficiarne la coscienza di uomo e di poeta, fu risparmiata quell’esperienza limite della morte della propria umanità a cui Šalamov, che del movimento rivoluzionario era stato invece parte attiva, sopravvisse a stento grazie alla straordinaria forza d’animo, uscendone però radicalmente trasformato quanto al modo di essere al mondo e di esprimersi poeticamente.57 Un’immagine di tale mutazione si trova nel racconto Cherry-brandy, in cui è sì rappresentata la morte di Mandel’štam in un lager di transito, ma che in realtà è, per ammissione dello stesso Šalamov, un racconto su lui stesso.58 Il pensiero che abita il poeta morente – un dochodjaga, un «morituro» come tutti gli abitanti della Kolyma –, è che «tutta la sua vita passata era stata letteratura, libro, favola, sogno, e solo l’oggi era la vita vera». Certo aveva già meritato l’immortalità come artista, ma soltanto ora capiva che «la poesia era la forza vivificante di cui viveva», che «il mondo intero era poesia» e che soltanto in quel momento, totalmente abbandonato al flusso dell’ispirazione, «stava componendo vera poesia». Il prima e il dopo nella vita di Mandel’štam illumina così il transito da una condizione in cui la creazione artistica rappresenta un’espressione pubblica dello spirito umano, ad una in cui soltanto «la gioia creativa», privata di qualsivoglia forma di comunicazione, «sta a dimostrare che è stata creata una poesia, che è stato creato il bello».59 Ma si badi che non si tratta qui soltanto di una superiore presa di coscienza morale sul limitare della vita, come sarebbe se il racconto si applicasse senz’altro al poeta morente, poiché questa condizione estrema è in realtà di Šalamov, anch’egli entrato corpo e anima nella dimensione della morte, anch’egli oramai «da tempo preda dell’indifferenza».60 Ciò che in effetti accomuna innanzitutto I racconti di Kolyma è la rappresentazione continuamente variata di questa condizione, prossima ad un prolungato stato agonico, di sfinimento fisico, di opacità mentale e insieme di completa indifferenza per lo svolgersi di esistenze costrette ad occuparsi spasmodicamente dei bisogni fisici elementari – l’ultimo gesto di Mandel’štam è di afferrare la sua razione quotidiana e «stringerla forte con le dita esangui premendosi il pane contro le labbra», una razione che dopo morto i suoi vicini si ingegneranno di fargli avere a loro vantaggio ancora per due giorni.61 Esemplare è al riguardo Il complotto dei giuristi, sorta di lungo viaggio allucinato di un gruppo di detenuti condannati a morte per il semplice fatto di essere a qualche titolo dei «giuristi», e in quanto tali assimilabili al destino di un presidente di tribunale colpevole di avere aiutato un suo vecchio compagno di università condannato ai lavori forzati: «Erano stati arrestati tutti i detenuti giuristi di tutte le miniere del Nord. Il seguito era semplicemente una questione di tecnica 57 Osservazioni analoghe in M. Martini, Oltre il disgelo, cit., pp. 60 sg. La mia prosa, cit. p. 145. 59 «Trascrivere, pubblicare – tutto ciò era soltanto vanità delle vanità» (I racconti di Kolyma, cit., pp. 76 sg.) 60 «(Mandel’štam) pensava a tutto questo senza animosità, in segreto, in qualche recondito luogo interiore. Le sue riflessioni erano scevre di passione. Da tempo era preda dell’indifferenza» (ibid., p. 76). 61 Ibid., p. 79. 58 11 istruttoria».62 Sorprendentemente la risoluzione della vicenda è positiva: non ci sarà esecuzione poiché nel frattempo è lo stesso ufficiale inquirente ad essere caduto in disgrazia. Anche in questo caso tuttavia ciò che conta non è tanto la vicenda di ordinaria follia, bensì lo stato di indifferenza in cui è vissuta dal protagonista e dagli altri condannati; su di essi la prospettiva della morte prossima non ha effetti rilevanti, non tali comunque da distogliere la loro attenzione dall’immediato desiderio di cibo e calore. Il lettore lo percepisce grazie alla forza espressiva di alcuni particolari che aprono degli squarci nello sviluppo omogeneo del racconto. È sul piattino con il mozzicone di sigaretta e la crosta di formaggio sbocconcellata abbandonati sul tavolo dell’ufficiale che si concentra l’attenzione del detenuto molto più che sulla minaccia rappresentata dall’interrogatorio; e quando, approssimandosi alla meta del viaggio, la temperatura si alza, i condannati trovano il modo di arrestare il camion che li trasporta per godere un momento del «tepore speciale, quasi primaverile» dei meno dieci gradi dopo i meno sessanta della tajga. Šalamov stesso ha indicato la novità assoluta di questo racconto nella «leggerezza di chi sta per morire», cosicché persino «il ritorno alla vita è disperato e non si distingue dalla morte».63 Non può esserci pertanto alcuno spazio nella sua prosa né per una rappresentazione romanzata né per la pura registrazione dei fatti. Egli respinge ambedue i versanti tra i quali si è mosso Solženicyn, dal momento che né l’una forma letteraria né l’altra gli appare capace di rappresentare adeguatamente «lo scontro con la vita reale», che è «il solo Leit-motiv, il solo quesito di questo secolo».64 Occorreva «una nuova, inconsueta forma per fissare stati d’animo eccezionali ed eccezionali circostanze», e questo sarebbe stato possibile soltanto in forza di un’esperienza personale.65 Šalamov scrive racconti, ma non vi è alcun Ivan Denisovič di cui seguire lo svolgersi emblematico di una giornata di lager; vuole documentare l’epoca senza precedenti, ma lo fa da memorialista, dunque non accumulando testimonianze per informare o denunciare, bensì assumendo un punto di vista strettamente personale che si traduce in un giudizio. Calza piuttosto il precedente delle Memorie di una casa di morti, per il suo carattere di documentazione di un’esperienza rivissuta letterariamente, anche se Dostoevskij non ha rinunciato del tutto alle alterazioni romanzesche.66 D’altronde ben diversa era all’epoca la condizione dei lavori forzati, diversa la popolazione dei detenuti e l’etica stessa che informava la vita concentrazionaria. Il confronto tra le due opere, scritte giusto a un secolo di distanza, può aiutare a cogliere elementi costitutivi del mutamento epocale consumatosi nella prima metà del Novecento e perciò anche le questioni artistiche radicalmente nuove con le quali Šalamov si è confrontato. Rileggere le Memorie dopo i Racconti, è come uscire dall’inferno e ritrovarsi in purgatorio, a scontare sì una pena, anche in forme crudeli e a vita, e tuttavia 62 Ibid., p. 201. Rileva altresì che «la leggerezza di chi sta per morire non è descritta da nessuna parte in letteratura» (La mia prosa, cit., p. 151). 64 Ibid., p. 150. 65 Ibid., pp. 152 sg. 66 Si veda ibid., p. 146 e p. 153. Peraltro Šalamov osserva come nel racconto di Dostoevskij non ci sia traccia del «vero mondo del crimine» e che se avesse conosciuto non occasionali colpevoli di delitti, ma dei malavitosi di professione, «probabilmente saremmo stati privati delle migliori pagine del libro – quelle che affermano la sua fede nell’uomo, nell’esistenza del principio del bene insito nella natura umana» (I racconti di Kolyma, cit., p 744). 63 12 conservando per lo più la coscienza della propria dignità.67 Proprio ciò che i campi della Kolyma hanno avuto l’effetto di cancellare nel novantanove per cento dei casi, ci dice Šalamov.68 Tra i testi raccolti in Višera, c’è un saggio che va letto e meditato a fondo, poiché offre con spietata lucidità la spiegazione etico-politica di tale mutamento, che non ha riguardato certo soltanto il regime staliniano, anche se di questo svela il carattere eversivo dello statuto stesso della giustizia. La tesi paradossale è che, come suona il titolo, Nel lager nessuno è colpevole,69 e non perché nei campi venissero concentrati soltanto «le vittime della legge», – vi abbondavano altresì «politici» e malavitosi come al tempo degli zar –, bensì perché il concetto stesso di colpa vi era annullata. A prescindere dagli articoli del codice penale per il quale si era stati condannati: assassinio, furto, stupro, attività controrivoluzionarie o semplicemente perché caduti più o meno casualmente sotto il mirino della legge, nel lager l’innocenza dei detenuti era data per scontata a causa dell’arbitrio giuridico che vi regnava. Mancava innanzitutto la certezza della durata della pena, che poteva essere raddoppiata o scontata in base a criteri del tutto indipendenti da quelli per la quale era stata comminata dal tribunale. Cosicché ogni condanna diventava, nella logica economico-politica che governava l’immensa impresa dei lager, convenzionale e approssimativa, o meglio «elastica» nella misura in cui per un verso dipendeva dal rendimento lavorativo dei luoghi di detenzione e più in specifico dalla capacità o meno di ogni detenuto di realizzare la «norma», vale a dire la misura di lavoro assegnata,70 per un altro verso poteva essere arbitrariamente aumentata secondo gli umori politici del momento e senza ulteriori ricorsi al tribunale. Da un siffatto sistema penale, per il quale ogni condanna era «convenzionale e approssimativa», a trarne vantaggio erano soprattutto i criminali, disposti a tutto pur di vedere ridotta la pena, e dunque pronti ad esercitare ogni sorta di violenza sui propri compagni di squadra per estorcere loro «la percentuale», indispensabile ad ottenere più cibo e rapide riduzioni di pena.71 Ora, un siffatto stravolgimento giuridico e le modalità della sua gestione politica nel lager ebbe inevitabilmente un effetto deleterio sulle persone, fossero capi o sottomessi, detenuti o liberi e dunque sull’insieme della vita sociale, che introiettava un modello corruttivo. Ma neppure – avverte Šalamov – si deve pensare al lager come all’inferno contrapposto al paradiso, poiché «il lager è fatto a immagine del mondo. In esso, nel suo ordinamento sociale e spirituale, non c’è nulla che non sia presente anche fuori. Le idee del lager non fanno che ricalcare le idee del mondo esterno, imposte dall’alto. (…) Il lager non 67 «Il detenuto medesimo sa si essere un detenuto, un reietto, e conosce il suo posto di fronte ai superiori; ma con nessun marchio, con nessuna catena potrai fargli dimenticare che è un uomo» (F. Dostoevskij, Memorie di una casa di morti, BUR, Milano 2009, p. 158). 68 «Le frontiere morali, il confine tra bene e male, sono molto importanti per il detenuto. Costituiscono anzi il problema principale della sua vita. Se sia rimasto uomo oppure no. (…) Il lager è stato un grande banco di prova delle forze morali dell’uomo, della comune morale umana, e il novantanove per cento della gente non ha superato questa prova» (L’ingegner Kiselëv, in Racconti di Kolyma, cit., p. 520). 69 Višera, cit., pp. 170-183. 70 Si legga tra i Racconti quello, terribile, intitolato: Misurato a parte, in cui il mancato raggiungimento della quota di lavoro assegnata trasforma la pena al lavoro forzato in condanna a morte. 71 «Il malavitoso veniva liberato per aver svolto il 150% o il 200% del suo piano di lavoro. I dati ufficiali spiegavano che gli amici del popolo – quali erano diventati i recidivi – svolgevano tre volte il lavoro loro richiesto, dunque meritavano un immediato sconto di pena» in applicazione della cosiddetta «norma stachanovista» (Višera, cit., pp. 177 sgg.) 13 riflette soltanto la lotta tra le cricche politiche che si avvicendano al potere, ma anche la cultura di quella gente, le loro mire più recondite, i loro gusti, le loro abitudini, i loro desideri repressi».72 Ciò che qui lo scrittore coglie acutamente è la legge universale che regola l’etica pubblica dal momento in cui il potere politico diventa pervasivo, mirando a riplasmare a propria immagine l’intera società, vale a dire la vita di ciascuno sia pubblica che privata. Fu pertanto un’intera nazione a riflettersi nei lager staliniani come in quelli nazisti, diversi nella concezione e nelle pratiche oppressive come diversi erano i caratteri e gli scopi dei rispettivi regimi, ma accomunati dallo stesso intento totalizzante e in definitiva distruttivo della dignità umana.73 In questo senso Šalamov godette, paradossalmente, di un osservatorio privilegiato sul proprio Paese e sull’epoca. Nella misura in cui egli ebbe il coraggio morale di conservare, per quanto menomata, una coscienza attiva dell’universo concentrazionario, imparò a riconoscere in esso oltre gli effetti devastanti di un regime politico aberrante, altresì l’evidenza del totale degrado morale in cui era caduta la società e la cultura russa,74 nonché il fallimento delle idee umanitarie di cui si era nutrita la sua letteratura. Né soltanto di questa si trattava, poiché ciò che era accaduto in Germania e l’avvento del terrore atomico inaugurato a Hiroshima stavano oramai a dimostrare che «l’arte e la letteratura valgono zero».75 Ciò che in altri termini Šalamov denuncia è lo scollamento tra l’opera d’arte e la vita reale, nella misura in cui l’operazione artistica falsifica il proprio oggetto: «C’è una profondissima non-verità nel fatto che il dolore umano divenga oggetto dell’arte, che il sangue vivo, il tormento, il dolore appaiano sotto forma di quadro, poesia, romanzo. Questo è un falso, sempre. (…) Peggio ancora è che scrivere significhi per l’artista allontanarsi dal dolore, alleviare il dolore, il proprio dolore, dentro. Anche questo è male».76 È a partire da questo convincimento profondo, radicato nella terribile esperienza del lager, che Šalamov ha cercato una forma espressiva che fosse la «prosa del futuro, qualcosa di simile ai racconti di Saint-Exupéry che ci hanno dato le ali»; vale a dire in grado di esprimere in maniera autentica ciò che si è vissuto attraverso un processo di rammemorazione che elimini lo schermo della letterarietà, consentendo allo scrittore di passare per intero «dalla parte del materiale medesimo».77 Pertanto e in definitiva il contributo irrinunciabile di Šalamov alla coscienza contemporanea sta nel ripensamento della relazione tra poesia e verità, reso ineludibile da eventi storici senza precedenti, tali da annichilire le anime degli individui prima ancora dei loro corpi. A tal punto che in nessun modo si può ancora credere che «la letteratura possa emendare l’uomo», come sta a testimoniare proprio l’esperienza della letteratura russa che, ispirata a sentimenti umanitari, ha creato falsi convincimenti 72 Ibid., pp. 181 sg. Lo scrittore che meglio ha colto le analogie tra i due regimi è Vasilij Grossman, coetaneo di Šalamov e anch’egli impedito a pubblicare in patria; oltre a Vita e destino, si veda Tutto scorre, ambedue tradotti da Adelphi. 74 «Compiuto il ciclo di un secolo, il tempo russo torna ad avvicinarsi, sulla propria scala, allo zero morale, come alla vigilia degni anni Sessanta del XIX secolo» (da una lettera del dicembre 1964 citata in F. Bigazzi, Prefazione a Alcune mie vite, cit., p. 15). 75 La mia prosa, cit., p. 150. 76 Passo citato da I. Sirotinskaja, Prefazione a I racconti di Kolyma, cit., p. X. 77 Inizio del racconto La cravatta, in I racconti di Kolyma, cit. p. 120. 73 14 sull’indole umana.78 È questa la prima verità con cui lo scrittore, l’artista, deve oramai commisurarsi, subendo un effetto di denudamento, poiché non ha più altro scopo da perseguire con la sua opera che non sia la pura esposizione della verità vista, per quanto spaventosa essa sia. Cade così anche l’attaccamento più pervicace, quello che spinge a cercare in ciò che si è vissuto un insegnamento per sé e per gli altri. Dall’orrore non si può trarre alcuna lezione, non c’è nulla da imparare e quindi nulla da insegnare, e quando ogni significato è venuto meno altro non resta che la realtà fattuale; di questo deve occuparsi lo scrittore che ne è testimone, questo è il suo compito. Ma come riuscirvi? In quale lingua raccontare senza cadere nell’artificio letterario o nella riflessione generalizzante? Come ritrovare lo stato d’animo preciso in cui è stato vissuto l’episodio che si vuole raccontare in modo tale che esso riviva per lo scrittore e per il lettore insieme? Šalamov si è ripetutamente soffermato su questi interrogativi nelle cornici di alcuni racconti, come a voler attirare l’attenzione del lettore sulla singolarità del processo creativo che la sua narrazione comportava. La risposta in questi casi è offerta indirettamente dalla modalità stessa della narrazione, mentre riflessioni al riguardo si trovano abbondanti in saggi, lettere e nei Taccuini, come si è visto. Ma al di là delle enunciazioni teoriche e delle prese di posizione contro «le vecchie idee e gli schemi della letteratura tradizionale»,79 importa rilevare la drammaticità del processo creativo stesso così come egli ne riferisce a Irina Sirotinskaja: «Per un racconto ho bisogno di silenzio assoluto, di una solitudine assoluta. (…) Ogni racconto, ogni singola frase è stata preventivamente urlata in una stanza vuota: quando scrivo, parlo sempre da solo. Grido, minaccio, piango. E le mie lacrime scorrono ininterrotte. Solo alla fine, terminando il racconto o parte di esso, asciugo le lacrime».80 Manifestazioni fisiche che certo attestano stati di sofferenza psichica profonda perfettamente comprensibili nell’atto di rivivere frammenti di orrore, ma che lo scrittore pone piuttosto in rapporto con la necessità di abbandonarsi alla mano estranea che guida la sua penna: «Se è una mano umana, il mio lavoro diviene imitazione e io divengo un epigono. Se invece è la mano di una pietra, di un pesce e di una nube, allora io mi abbandono a questo potere direi passivamente».81 È dunque questo quel che comporta passare «dalla parte del materiale medesimo»; una sorta di svuotamento della soggettività propensa ad appropriarsi del materiale per rielaborarlo artisticamente. Tuttavia questo è giudicato ancora un fatto esteriore eparimenti il fatto che nei suoi racconti «viene contestata l’essenza stessa della letteratura così come viene proposta dai manuali».82 Intimo è invece lo «sforzo erculeo», il «lavoro tormentoso» per «resuscitare nella mia memoria l’intero, interminabile quantitativo di immagini che ho veduto in sessant’anni» e di lasciarne fluire una piccola parte sulla carta 78 «Io non credo nella letteratura in questo senso, non credo cioè che essa possa emendare l’uomo; l’esperienza della letteratura russa, ispirata a sentimenti umanitari, ha portato, proprio sotto i miei occhi, ai patiboli del ventesimo secolo. Io non credo alla possibilità di distogliere chicchessia, prevenendolo dal ripetere gli errori del passato. La storia si ripete e qualsiasi eccidio del 1937 può essere reiterato» (dai Taccuini, cit. da I. Sirotiskaja, Responsabilità e moralità della parola in Varlam Šalamov, in Autori vari, Storie di uomini giusti nel Gulag, cit., p. 98). 79 Citato da F. Bigazzi, Alcune mie vite, cit., p. 17. 80 La mia prosa, cit., p. 156. 81 Ivi. 82 Ivi. 15 senza intromissione della volontà, senza mediazioni intellettuali né preoccupazioni estetiche.83 La potenza espressiva della prosa di Šalamov, dei Racconti innanzitutto, è inscindibile da un siffatto processo creativo. È grazie ad esso che la «vita reale» emerge dalla pagina scritta e afferra il lettore, lo rende partecipe quasi allo stato puro delle emozioni rivissute dall’autore e lo conduce, se egli si lascia portare, fino ad un centro vuoto di ogni significato attorno al quale si muovono per ogni verso, insensatamente, una quantità di frammenti di vite esplose. Ciascuno di essi indica un’esistenza oramai impossibilitata a dispiegarsi e che tuttavia dice ancora qualcosa di chi è stato e in qualche modo ancora si ostina ad essere l’individuo di cui si narra. Come il pope che in una radura del bosco innevato approfitta di un momento di «riposo» per recitare a se stesso le formule liturgiche di una messa che non può più celebrare, ma che bastano a dargli un po’ di sollievo e a fargli sentire meno la fame, estrema risorsa per «aggrapparsi a quella vita che con tanta perseveranza e ostinazione si sforzavano di toglierci».84 O come Marusja, la ragazza zoppa, che dopo aver tentato invano il suicidio si aggrappa al suo talento di ricamatrice, di cui vorrebbe far godere due compagni di sventura donando loro cravatte ricamate, che non riceveranno e che non avrebbero avuto comunque occasione di indossare.85 A questo coinvolgimento del lettore nell’insensato contribuiscono in modo decisivo i finali dei racconti; laddove ci si aspetta come esito del dramma una soluzione, prevista o sorprendente che sia, ci si scontra piuttosto con una frase che si alza come un muro, che toglie la vista e lascia senza fiato; si è rigettati indietro verso un’altra storia con analoga conclusione, e così via, all’infinito, lungo una linea del tempo che si avvolge continuamente su se stessa, senza esito e senza ripresa. Agghiacciante è la conclusione del racconto del giovane condannato a morte per non aver realizzato la misura: «E quando capì di cosa si trattava, Dugaev rimpianse di aver lavorato, di aver patito per niente anche quel giorno, quel suo ultimo giorno».86 E cosa dire del finale di Giorno di riposo, un racconto che per un momento sembra tornare alla grande prosa umanistica, ma subito l’illusione è cancellata: tornato alla baracca il pope si vede sorprendentemente offrire dai malavitosi gli avanzi di un piatto di carne che dovrebbe essere di montone ed è invece del cucciolo di cane accudito nella baracca; mangia, poi vomita quando scopre di che si tratta, ma infine non può trattenersi dal riconoscere: «La carne però era buona. Non peggio di quella di montone».87 Di fronte a questa rappresentazione dell’umano mutilato nelle sue ragioni d’essere, eseguita dall’autore attenendosi esclusivamente ai fatti, si può restare smarriti o esserne respinti come per un eccesso di nichilismo.88 Cosa resta infatti se la negazione dell’umano non è condannata in forza di un qualche umanesimo, se in definitiva non c’è alcuna lezione da trarre per l’umanità a venire? È ciò di cui si è risentito Primo Levi quando ebbe la ventura di leggere i primi racconti di Šalamov pubblicati in italiano. In essi colse una resa totale al terrore attribuita all’incapacità per i detenuti di esercitare una qualche resistenza morale, 83 Ibid., p. 157. Giorno di riposo, in I racconti di Kolyma, cit., pp. 144 sg. 85 La cravatta, in ibid., pp. 120 sgg. 86 Misurato a parte, in ibid., p. 25. 87 Ibid., p. 147. 88 Non è fuori luogo l’accostamento che è stato fatto con la scrittura di Kafka e Céline, direi anche di Camus. 84 16 malgrado sussistessero nei lager sovietici possibilità di sopravvivenza e persino di liberazione, inimmaginabili in quelli tedeschi. Resa che egli imputava al «terrore e all’isolazionismo staliniani la cui infezione paralizzante si è trasmessa anche ai loro testimoni ed ai loro contestatori». Di qui «la loro minore statura rispetto a quella dei loro corrispettivi che hanno combattuto il terrore hitleriano», usciti dai campi nazisti quando non erano ancora venuti meno «i vincoli culturali secolari che legavano la Germania con il resto del mondo» e perciò ancora in grado di far valere le ragioni della propria umanità. Quanto a Šalamov, «la sua è la disperazione muta di chi si sente distrutto e non crede più in nulla, di chi ha logorato in decenni di inutile pena ogni ragione politica, anzi, ogni ragione di vita»; cosa di cui risentirebbero i suoi racconti, accusati di «confusione, incertezza stilistica, imprecisione».89 Alcuni hanno voluto inscrivere Levi tra i detrattori di Šalamov per ragioni ideologiche, assimilandolo all’intelligencjia di sinistra refrattaria a porre sullo stesso piano Auschwitz e la Kolyma,90 ma non è così. Nel suo giudizio può avere inconsapevolmente agito quella sorta di riflesso condizionato che ancora porta sovente a sostenere acriticamente l’incomparabilità della Shoah, ma in ogni caso non è questo il punto. La sua reazione ha ragioni ben più complesse e non eludibili, che in una intelligenza del suo livello si sono manifestate non casualmente a proposito dell’opera di Šalamov, certo valutata su un campione ridottissimo, ma sufficiente a fargli cogliere ciò che l’autore poneva in questione. Direi che Levi fu piuttosto respinto dalla preminente componente tragica della testimonianza di Šalamov, generata dal convincimento della totale inutilità del sapere legato all’esperienza del lager, dalla quale, come si è visto, non c’è da ricavare alcun insegnamento che possa se non impedire almeno rendere più difficile il ripetersi degli orrori passati. Ciò che è dunque in questione è la visione umanistica, a cui Šalamov aveva volto le spalle al punto da ritenere la letteratura responsabile di aver prodotto false immagini dell’uomo, mentre per Levi rappresentava la possibilità stessa di seguitare a dare un senso positivo all’esistenza individuale e collettiva. È alla luce di questa alternativa culturale ed esistenziale che va letta la recensione di Levi, ivi compreso il duro giudizio sulla scrittura dei Racconti. Quest’ultimo anzi è la spia della difficoltà di Levi a riconoscerne la novità; suppone che essa risenta negativamente della disperante condizione esistenziale dell’autore, non immaginando che ciò che gli appare come «incertezza stilistica» sia in realtà il marchio distintivo di una forma narrativa che rifiuta programmaticamente quella entro la quale l’autore di Se questo è un uomo si era collocato naturalmente.91 Ma allora non basta riconoscere a Šalamov la rappresentanza di una potenzialità narrativa della letteratura russa opposta a quella incarnata da Pasternak, perché egli ha avuto la forza morale e culturale di sollevare una più vasta e sconcertante questione, che investe lo statuto stesso del pensiero occidentale moderno nella misura in cui ha fatto dell’umanesimo il suo fondamento. 89 La recensione all’edizione Savelli dei Racconti apparve, con il titolo Dai lager di Stalin, su «Tuttolibri» del 25 settembre 1976, p. 2. 90 Particolarmente perentorio è stato al riguardo G. Herling, Ricordare, raccontare, cit., pp. 17 sgg. Si veda anche P. Sinatti nella Introduzione a Nel lager non ci sono colpevoli, cit., pp. 13 sg. Più comprensive della questione appaiono le rapide valutazioni di V. Strada su «Tuttolibri» del 3 luglio 1999, p. 4 e di C. Ossola sul «Corriere della sera» del 5 dicembre 2005, p. 31. 91 Si veda sopra (nota 35) la risposta di Šalamov a un’analoga obiezione sollevata dalla Sirotinskaja. 17 Al termine de Il guanto, il racconto nella cui cornice è reso meglio esplicito il rapporto tra l’esperienza del lager e la scrittura, Šalamov si lascia andare ad una dichiarazione che Levi avrebbe giudicato da disperato, ma che per lui ha valore programmatico: «Ho cambiato idea sulla vita come bene, felicità. La Kolyma mi ha insegnato tutt’altro. Il principio della mia epoca e della mia personale esistenza, di tutta la mia vita – ciò che ho tratto dalla mia personale esperienza, la regola che ne ho desunto – può essere espresso in poche parole. Prima di tutto bisogna restituire lo schiaffo e solo in un secondo tempo l’elemosina. Ricordare il male prima del bene. Ricordare tutto il bene ricevuto per cent’anni e tutto il male per duecento. È in questo che mi distinguo da tutti gli “umanisti” russi del diciannovesimo e del ventesimo secolo».92 Certo, al fondo di queste parole risuona un dolore che confina con la disperazione, ma esso è sovrastato dalla potenza di un’ira che separa il molto male dal poco bene, una sorta di giudizio ultimo che muta timbro al linguaggio ed esige un nuovo genere di scrittura. Un’ira che richiama quella di suo padre nell’atto di fare in pezzi minuti a colpi d’accetta la croce d’oro pettorale per comprare di che sopravvivere, a lui e a sua moglie; ma che qui, nel figlio sopravvissuto al lager, si manifesta come presa d’atto di un mutamento epocale che impone di risignificare l’intera mappa dei saperi umani: filosofici, etici, religiosi. Né certo è a caso che quell’episodio iscritto nel calvario dei suoi genitori, l’unico a non avere nulla a che vedere con l’esperienza del lager, abbia trovato posto senza alcuna trasposizione nei Racconti,93 come a volerne indicare la chiave di lettura dell’Autore stesso: il gesto del padre prete, che di un certo umanesimo più etico e sociale che religioso era stato incarnazione agli occhi del figlio, chiude un’epoca carica di visioni illusorie sulla realtà dell’essere umano, che non possono più avere cittadinanza nella sua scrittura. Ciò di cui egli fa memoria è posto perciò unicamente come pietra d’inciampo per il lettore, affinché veda le cose come sono e ne «possa ricavare per la propria vita lo stimolo anche a fare solo un po’ di bene. L’uomo deve fare qualcosa».94 92 I racconti di Kolyma, cit., pp.1103 sg. La croce, in ibid., pp. 536 sgg. 94 «Scrivo affinché qualcuno, leggendo i miei racconti, familiarizzandosi con la mia prosa, molto lontana dalla menzogna, possa ricavare per la propria vita lo stimolo anche a fare solo un po’ più di bene. L’uomo deve fare qualcosa» (dai Taccuini, cit. da I. Sirotiskaja, Responsabilità e moralità della parola in Varlam Šalamov, cit., p. 98). 93 18
Scaricare