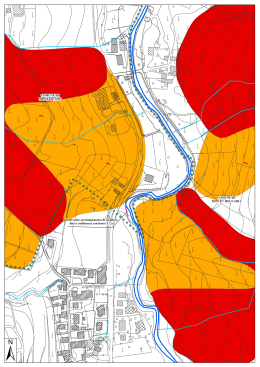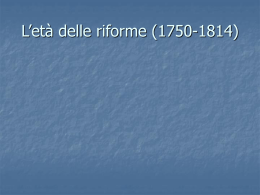Beccaria e il Trattato “Dei delitti e delle pene”. Cesare Bonesana, marchese di Beccaria, è stato un giurista, filosofo, economista, letterato italiano, figura di spicco dell'Illuminismo, legato agli ambienti intellettuali milanesi e, come molti altri uomini della “Accademia dei pugni”, anche Beccaria nasce da un’antica famiglia aristocratica. A Milano partecipa alle riunioni dell’Accademia dei Trasformati, dove paga anch’egli il suo piccolo tributo di versi, che avrebbero voluto essere satirici e che dimostrano solo come egli sia evidentemente nato per la prosa, come del resto tutti coloro che si raggruppano nell’Accademia dei pugni. Tra gli amici dell’Accademia dei pugni cerca e trova la forza di far prevalere le idee, la logica, la capacità, che ha grandissima, di penetrare con la luce della sua intelligenza i mali, i suoi errori e degli altri. Ma al di là di queste vanterie, questi giovani trovano, quasi d’istinto, la formula giusta del loro sodalizio. Non è un’Accademia nel senso tradizionale della parola, né una loggia massonica; è un libero gruppo, capace tuttavia non soltanto di leggere e discutere insieme, ma anche di agire concordemente. Nel 1760 ha ventidue anni; proprio a quel momento risale la sua “conversion à la philosophie”. Nella cerchia degli amici del “Caffè”, egli trova per un breve periodo quella confluenza di ragionamento e di passione, di calcolo e di slancio che gli fa pensare e scrivere il suo capolavoro. Gli sembra per un momento di potersi vantare di aver trovato un equilibrio, di aver saputo unire la virtù e il piacere. Egli si aggrappa agli amici, a cui scrive molte lettere, come al Verri e al caro stimato Biffi. L’”anima bella” che sente se stessa come un personaggio della Nuovelle Héloise, si è così inserita nella vita di un gruppo. In quell’ambiente, discutendo e parlando con loro, riesce a superare quel profondo senso di passività, d’assenza, d’inutilità che come un peso insopportabile grava nel suo animo, rompendo in tal modo l’isolamento che lo separa da tutti. Anche qui, come in altri momenti culminanti della vita settecentesca, l’amicizia significa qualcosa di diverso dal rapporto di due persone e si trasforma nell’intimo legame d’un gruppo di uomini animati da un lavoro e da un’idea comuni. Nell’amicizia settecentesca c’è già un germe della “fraternità” rivoluzionaria. Lo si avverte nell’”Accademia dei pugni”, nell’energia che essa infonde in Beccaria. Così nasce il libro che s’intitola Dei delitti e delle pene, che, come i Discours di Rousseau, sorge da un dialogo interno in un gruppo di philosophes. Come le pagine di Rousseau, così anche quelle di Beccaria sono disputate, contese, attribuendosi a chi le aveva viste nascere, il merito di averle suscitate o suggerite. Eppure queste opere nascono perché l’equilibrio di ragione e di passione che tiene uniti gli uomini attorno all’Enciclopèdie o al “Caffè”, trova in uno di loro, in Rousseau o in Beccaria, una forma del tutto nuova e personale. Naturalmente, in Beccaria, il riflesso del grande modello parigino fa sentire imperiosa la propria presenza. La sua ‘conversione’ alla filosofia significa per lui la lettura delle Lettres persanes, il tanto amato capolavoro del giovane Montesquieu, per cui tutta la sua visione del diritto e del modo di punire ne resta profondamente influenzata e soprattutto di De l’esprit di Helvètius, pubblicata nel 1758. Egli riesce a tenere insieme, nella sua opera principale, rigore logico e filantropia settecentesca, lucido utilitarismo e calda, appassionante sensibilità; riesce ad esprimere il tremore dell’animo davanti alle sofferenze altrui:neppure l’orrore del sangue, della sofferenza, impediscono ai ragionamenti sulla tortura, sulla pena di morte, di essere precisi e decisivi. Beccaria inizia a scrivere Dei delitti e delle pene nel 1763 e lo termina all’inizio del 1764. Lo scritto viene dato alla stampa a Livorno, presso lo stesso editore che pochi anni dopo avrebbe pubblicato la prima edizione italiana dell’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert. Beccaria preferisce far comparire come anonimo l’opuscolo, temendo ripicche e ritorsioni personali e, infatti, parecchie sono le reazioni di condanna, soprattutto da parte della Chiesa cattolica, che il 3 gennaio del 1766 inserisce l’opera nell’Indice dei libri proibiti, senza però arrivare a bruciarla pubblicamente, come invece è stato fatto per ‘L’uomo senza macchia’ di La Mettrie. Poco dopo anche negli stati austriaci il libro viene incluso tra quelli proibiti di “seconda classe” e cioè “pubblicamente non vendibile, ma vendibile solamente per la gente di giudizio”. Anche Helvètius si abbassa a sconfessare il suo libro e ciò lo porta ad accrescere le sue apprensioni. Il primo attacco, infatti, uscito dalla penna dal padre Ferdinando Facchinei, non manca davvero di violenza. Tra le tante opere mostruose e orribili quella di Beccaria è apparsa particolarmente pericolosa agli occhi del monaco che si pone il compito descriverne una confutazione, intitolata: Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene, pubblicata a Venezia all’inizio del 1765. In queste pagine il padre Facchinei intende combattere, ancora più delle idee di Beccaria, lo spirito stesso dell’opera che gli pare «vera figliola, dirò così, del Contratto sociale di Rousseau». Volontà egualitaria, visione di una società fondata sul consenso dei suoi membri, tolleranza e umanitarismo, sono elementi che sono alla radice del libro di Beccaria, ma diventano colpe, eresie ed orrori agli occhi del frate polemista. Legando tali considerazioni a quello che è il punto centrale delle obiezioni clericali contro l’opera di Beccaria, il padre Facchinei difende con ferma energia e con particolare vigore la pena di morte, la tortura, le denunzie 1 segrete, i privilegi economici degli ordini religiosi e il tribunale dell’Inquisizione. Lo consola il fatto che in molti stati d’Italia, il libo di Beccaria viene “provvidamente soppresso”. Tuttavia Beccaria ottiene anche molti pareri favorevoli; in Italia il libro viene strenuamente difeso dai Fratelli Verri sul “Caffè”. Pietro e Alessandro Verri comprendono che il libello del padre Facchinei, proprio per la sua radicale volontà di negare tutto lo spirito del secolo, presta il fianco ad una risposta che si appelli al diffuso senso di tolleranza e di benevolenza. La loro Risposta allo scritto, che s’intitola: Note ed osservazioni sul libro Dei delitti e delle pene, è calcolata con esattezza per ottenere lo scopo voluto. Essa contribuisce a mettere dalla parte di Beccaria anche quegli uomini illuminati che pure vengono colpiti, non sempre benevolmente, dalla radicale volontà di rinnovamento giuridico dimostrata dal filosofo milanese. Si allarga in tal modo anche quella corrente che, senza accettarne le basi rousseauiane o utilitariste, vede nei Dei delitti e delle pene il manifesto di una serie di riforme che è necessario operare, di trasformazioni che bisogna apportare alle basi stesse della struttura giuridica degli stati italiani. A Milano, al centro di questa corrente, è il conte Firmian, a cui Beccaria attribuisce la propria salvezza; tale corrente moderata accompagna la fortuna del libro di Beccaria che prepara un po’ alla volta la rapida attuazione del suo pensiero. Giungono a Piacenza anche gli assensi di Gianrinaldo Carli, legato bensì al gruppo del “Caffè”, ma che origine e formazione mentale diversa porteranno molto distante dal pensiero utilitarista e radicale di Rousseau; ma discussione sui principi e la polemica filosofica vengono a Beccaria soprattutto d’Oltralpe. Per un momento il mondo dei pholosophes pare non rispondere, non capire. La “Gazette littéraire de l’Europe”, nel suo numero del 13 febbraio 1765, “annuncia il libro Dei delitti e delle pene con molta freddezza e qualche disapprovazione”, come ricorda due anni dopo l’”Estratto della letteratura europea” (1767, tomo III). Ma già nel fascicolo d’agosto del 1765 “questi rischiarati scrittori “ della “Gazette littéraire” “generosamente se ne disdicono”; tra una e l’altra data i philosophes parigini scoprono Beccaria. Dei delitti e delle pene poteva essere il primo abbozzo, il primo schema di un trattato di diritto penale che rispondesse alle esigenze dell’Illuminismo, quasi la base e il fondamento di un codice criminale nuovo e moderno. Non a caso Morellet scrive la parola Traité sul frontespizio della sua versione. Modifica addirittura l’ordine dei paragrafi del libro stesso, cercando di rendere l’opera di Beccaria più simmetrica, più rigorosamente adatta allo scopo di gettare le fondamenta di una codificazione ‘filosofica’. Il tema Dei delitti e delle pene, propostogli da Pietro Verri, ben si presta ad affrontare da un punto di vista specifico e circoscritto la questione della giustizia, e dunque della politica e della società, e infine del rapporto tra società e benessere. Per questa ragione, attaccando apertamente il comportamento dei vari stati intorno alla questione della giustizia, Beccaria mette in discussione l’intero assetto del quale quel comportamento è espressione, finendo con l’adombrare, nelle proposte di un rinnovamento giudiziario, una società fondata su valori interamente alternativi. Nel Trattato si esprimono per la prima volta chiaramente, con uno stile sobrio ed efficace, le esigenze di riforma giudiziaria già da molti, se pur confusamente, sentite. Influenzato dalle teorie esposte da Rousseau nel suo Contratto sociale ed ammiratore del pensiero del filosofo inglese John Locke, nel breve Trattato Beccaria parte dal concetto della convivenza comune: gli uomini, sostiene, hanno sacrificato una parte delle loro libertà, accettando di vivere secondo le regole della comunità, in cambio di una maggiore sicurezza e di una maggiore utilità. L’autorità dello Stato e delle leggi è quindi da considerarsi legittima finché non oltrepassi certi limiti accettati dai governanti in nome del bene comune. Citando direttamente Montesquieu, l’autore ripete come ogni punizione che non derivi dall’assoluta necessità sia tirannica. Il sovrano ha il diritto di punire, ma tale diritto è fondato sull’esigenza di tutelare la libertà e il benessere pubblici dalle “usurpazioni particolari”: nessun arbitrio deve essere perpetrato, poiché nel decidere l’entità della pena l’unico criterio da seguire è “l’utile sociale”. Dei delitti e delle pene è un’opera divisa in 42 brevi capitoli, ognuno dei quali tratta un aspetto specifico della questione dibattuta. Lo scopo dell’opera nel suo insieme è di dimostrare l’assurdità e l’infondatezza del sistema giuridico vigente. Beccaria non esita a farlo passare come un sistema puramente repressivo nei suoi ingiustificati rituali di violenza. Invece di essere al servizio della giustizia, il sistema giudiziario si rivela finalizzato ad un mostruoso meccanismo di potere e soprusi, dietro il quale si profila l’ingiustizia che caratterizza l’intera società che lo esprime. Non il benessere, ma la sofferenza della maggior parte dei cittadini è infine il risultato di una struttura così irrazionale. In particolare Beccaria tuona contro la pena di morte, vertice di inciviltà gestito dallo stato, e contro le pratiche di tortura, inutili e anzi spesso fuorvianti rispetto alla verità e comunque a loro volta barbare. Gli argomenti addotti da Beccaria sono grosso modo gli stessi, che ancora oggi vengono ripetuti contro la prosecuzione di pene capitali e di torture: la tortura è quell’orrenda pratica con la quale si sottopone il presunto colpevole a parlare; ma se il compito della giustizia è di punire chi commette ingiustizia, la tortura fa l’esatto opposto perché colpisce tanto i criminali quanto gli innocenti, cercando di costringerli con la forza ad ammettere atti da loro non compiuti; e poi sotto tortura anche un innocente finirà per confessare 2 reati che non ha commesso pur di porre fine al supplizio. La tortura è poi ingiustificata perché si applica ancor prima della condanna: un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice. E, paradossalmente, con la tortura l’innocente è posto in peggiore condizione che il reo: infatti l’innocente se viene assolto dopo la tortura ha subìto ingiustizia, ma il reo ci ha solo guadagnato, perché è stato torturato ma, non avendo confessato, è risultato innocente e si è salvato dal carcere! Dunque l’innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare, nel caso in cui venga assolto. Ancora più complessa è la questione della pena di morte, ossia della vendetta istituzionalizzata: Beccaria riconosce la validità della pena di morte in Stati particolarmente deboli in cui i criminali fanno ciò che vogliono. Però nel 1700, con il progressivo rafforzarsi degli Stati tramite l’assolutismo illuminato, la pena di morte diventa assolutamente inutile: se lo Stato è forte, allora senz’altro punirà il criminale, il quale, sapendo che agendo in quel modo verrà punito, non infrangerà la legge: la pena di morte diventa quindi assurda e inutile proprio perché lo Stato è forte, capace di punire i criminali. L’importante è che le pene vengano sempre applicate, altrimenti il cittadino corretto e rispettoso della legge, vedendo che i trasgressori la fanno franca e non vengono puniti dalla legge, comincerà ad odiare la legge stessa e a trasgredirla anch’egli, proprio perché si sentirà preso in giro dallo Stato che vara leggi e poi non le fa applicarle. A sostegno della sua battaglia contro la pena di morte, Beccaria sostiene che la pena, per definizione, ha due funzioni: quella di correggere il criminale per riportarlo sulla retta via e quella di garantire alla società la sicurezza, già a suo tempo propugnata da Hobbes. Ma la pena di morte, pur rendendo più sicura la società, evidentemente, non può certo correggere il criminale, in quanto lo elimina: la risoluzione del tutto sta, per riagganciarci a quanto detto, nello Stato forte e autoritario che impone pene miti, ma garantisce la loro applicazione. Va senz’altro notato come la pena di morte, che era sempre stata una sorta di spettacolo per il popolo che si riuniva nelle piazze per assistere ai pubblici squartamenti, nel 1700 inizia a risultare odiosa al popolo: è il sentimento decantato da Rousseau che entra in gioco. Così inizia la critica sistematica di Rousseau contro la pena di morte; non è in assoluto nella storia la prima volta che si muove una critica alla pena di morte, ma è la prima volta che contro di esse vengono mosse obiezioni radicali e sistematiche. Tale critica indica una svolta nel senso comune, svolta che ha anche innegabile effetti pratici: per esempio nel 1786 Pietro Leopoldo abolisce in Toscana la pena di morte. La prima argomentazione contro la pena di morte è che essa non è legittima. La tesi a sua volta si divide in due punti: in primo luogo essa offende il diritto che nasce dal contratto sociale, stipulato per garantire la sicurezza degli individui contraenti, non per deprivarli della vita. In secondo luogo, la pena di morte è contraria al diritto naturale secondo il quale l’uomo non ha la facoltà di uccidere se stesso e non può quindi conferirla ad altri. La pena di morte non è un deterrente efficace contro la criminalità: secondo Beccaria spaventa più l’idea di una lunga pena detentiva che non l’idea di una pena durissima, ma istantanea. E’ importante che anche la pena segua in tempi molto brevi il reato commesso, per non lasciare l’indiziato nell’incertezza riguardo la sua sorte e per imprimere nella mente dei cittadini la consequenzialità di colpa e pena. In definitiva, lo scopo della pena è fare in modo che un danno commesso nei confronti della società non si ripeta e di scoraggiarne altri: la pena non è più, nella visione di Beccaria, uno strumento per “raddoppiare con altro male il male prodotto dal delitto commesso”, ma uno strumento per impedire che al male già arrecato se ne aggiunga altro ad opera dello stesso criminale o ad opera di altri che dalla sua impunità potrebbero essere incoraggiati. La pena è un mezzo di difesa, un mezzo di prevenzione sociale. Dopo aver dimostrato che la pena di morte non è legittima, ossia che non è un diritto, Beccaria passa alla seconda argomentazione, per cui essa non è necessaria. Anche questa si articola su due livelli: in primis, si dimostra che la pena di morte non è necessaria laddove regnino ordine politico e sicurezza civile; in secondo luogo si dimostra che essa non esercita una seconda funzione di deterrenza relativamente a furti e a delitti. Beccaria critica anche la religione accusandola di agevolare il delinquente nelle sua ree intenzioni, confortandolo con l’idea che un facile quanto tardivo pentimento gli assicuri comunque la salvezza eterna. Ma se la pena di morte non è un diritto e non è un deterrente, essa è anche inutile: lo Stato, infliggendola, dà un cattivo esempio perché da un lato condanna l’omicidio e dall’altro lo commette, sia in pace che in guerra. Ma Dei delitti e delle pene non si limita a criticare lo stato di cose presente, benché questo aspetto risulti decisivo in prospettiva storica. In effetti Beccaria non manca di avanzare la proposta di una nuova dimensione giudiziaria, secondo la quale lo stato non ha il diritto di punire quei delitti per evitare i quali non ha fatto nulla: la vera giustizia consiste nell’impedire i delitti e non nell’infliggere la morte. In tal modo viene posto il problema della responsabilità sociale dei delitti commessi, introducendo una concezione del tutto nuova della giustizia e dei doveri dello Stato, nonché dei rapporti tra società e singolo. Egli propone inoltre delle punizioni che non siano vendette, ma risarcimenti, tanto del singolo verso la collettività quanto di questa contro il criminale: le pene devono pertanto essere socialmente utili e dolci, volte al recupero e non alla repressione. Un altro elemento decisivo dell’opera è la distinzione tra reato e peccato. Il reato risponde ad un sistema di leggi liberamente concordato tra gli uomini: innegabile è l’influenza di Rousseau su Beccaria e della sua concezione della società 3 come contratto; dunque il reato deve essere definito in un’ottica laica e terrena, storica e immanente. In questo modo viene rifiutata l’identificazione tradizionale tra diritto divino e diritto naturale, di cui i sistemi legislativi sarebbero l’espressione diretta. Questa laicizzazione della giustizia è anche la più forte ragione del rifiuto della pena di morte: è infatti proprio arrogandosi il diritto di esprimere insieme la legge umana e la legge divina che gli Stati possono condannare a morte un presunto colpevole, quasi come se fosse Dio stesso a punirlo. Beccaria ha piena coscienza della difficoltà che ha il popolo di comprendere le leggi, tanto più che ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in tempi differenti ne ha un diverso, ed è per questo che condanna l’oscurità delle leggi, scritte in una lingua straniera al popolo, convinto che se tutti potessero intenderne il significato il numero dei delitti e dei reati diminuirebbe notevolmente. Le leggi devono essere accessibili a tutti, tutti hanno diritti di riconoscerle e, di conseguenza, di rispettarle, ma Beccaria sa bene che le cose non vanno così e che in realtà la maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di pochi. Egli è altresì convinto che il fine delle pene non sia di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso, bensì il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini. E Beccaria non esita a tuonare contro le accuse segrete che portano gli uomini a mascherare i propri sentimenti e ad errare smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni: bisogna dare al calunniatore la pena che toccherebbe all’accusato! Con le accuse segrete, infatti, basta avere in antipatia una persona, magari la più onesta che ci sia, per farla andare in carcere con false accuse infondate. Assurdo per Beccaria è anche il giuramento, proprio perché non ha mai fatto dire la verità ad alcun reo e poi mette l’uomo nella terribile contraddizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina. Il giuramento è inutile, perché non avvengano delitti basta solo che il delinquente colleghi automaticamente l’idea di delitto a quella di pena: compiuto il delitto egli otterrà inevitabilmente una pena; ed è proprio per questo che occorre la prontezza della medesima, perché il lungo ritardo non produce altro effetto che quello di distinguere sempre più queste due idee: il criminale, compiendo un delitto e non vedendosi punito, finirà per non associare più il delitto alla pena. Fatto sta che la pena deve essere sempre e comunque dolce, ma in ogni caso va applicata proprio perché la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito alla speranza dell’impunità. La fredda razionalità del pensatore milanese è il filo che tiene unita l’opera: le sue considerazioni tengono sempre presente quella che è l’utilità pratica dei provvedimenti presi o da prendere, resta ben poco spazio a considerazioni di ordine morale, come ben evidenzia la posizione dell’autore nei confronti della pena di morte. Questa va abolita perché non consegue gli scopi prefissi, soprattutto per tale motivo va eliminata: la sua crudeltà, la sua irreparabilità sono marginali, tanto è vero che Beccaria nel suo trattato indica anche alcune eccezioni nelle quali il ricorso alla pena capitale è ammissibile. Questo tipo di atteggiamento ha attirato qualche critica in tempi recenti poiché il calcolo utilitaristico dei vantaggi e degli svantaggi delle pene non deve essere la sola base dei sistemi penali, ma in essi deve trovar posto il rispetto della persona umana, quei diritti inviolabili dell’uomo che ancora oggi fanno molto dibattere. Va però detto che se è possibile ravvisare prese di posizione discutibili in alcune pagine de Dei delitti e delle pene, in altre Beccaria sottolinea come l’imputato debba sempre essere considerato persona e non cosa, e come non possa esistere libertà laddove questo principio non venga rispettato. Malgrado alcune affermazioni criticabili agli occhi moderni, l’opera di Beccaria resta un passo avanti fondamentale nella storia dello sviluppo civile nel mondo occidentale. Sia per il successo che ha avuto (dalla Russia di Caterina II che voleva l’illuminista tra i suoi consiglieri, agli Stati Uniti di Jefferson), tale da smuovere le coscienze su argomenti basilari per la formazione di una società giusta e democratica, sia per l’utilità pratica che ha dimostrato, visto che molte delle misure auspicate nel trattato sono state effettivamente messe in pratica in diversi stati. Franco Venturi, Settecento riformatore, Da Muratori a Beccaria 4
Scaricare