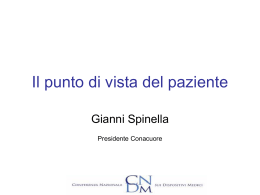Il dilemma della comunicazione di diagnosi e
prognosi al paziente oncologico: malattia e morte
si possono "dire"?
Giampiero Morelli *
"INformazione Psicologia Psicoterapia Psichiatria", n° 36-37, gennaio-agosto 1999,
pagg. 26-45, Roma
Non penso assolutamente mai alla morte.
E nel caso lei vi pensasse, le raccomando
di fare come me: scriva un libro sulla
morte (...), la faccia diventare un
problema (...). Infatti è il problema per
eccellenza. E anzi, in un certo senso,
l'unico.
(Vladimir Jankelevic, Pensare la morte?)
Introduzione
Nel tentativo di definire il sistema culturale nel quale viviamo non ci
sono molti dubbi che i termini "informazione" e "comunicazione"
possano descrivere compiutamente, almeno per quanto riguarda i paesi
più avanzati, questo specifico momento storico. La radio, la TV, i giornali
sembrano ormai insufficienti ed inadeguati a fronte delle nuove
tecnologie che permettono uno sviluppo di canali di comunicazione
sempre più raffinati. I sistemi informatici, satellitari, a fibre ottiche,
cellulari hanno permesso la realizzazione di quello che gli esperti
definiscono "villaggio globale". Ancor più che un mezzo o uno strumento
la comunicazione rappresenta un fine, un valore, un dogma: "ancora
non hai il cellulare?" "Cosa aspetti a comprarti un fax o ad abbonarti ad
internet?"
Ogni aspetto dell'esistenza si mostra ed è mostrato in tutta la sua
visibilità, ogni ambito del sapere appare accessibile, conoscibile,
"comunicabile". Nulla si cela allo sguardo neanche i luoghi più privati,
intimi, inaccessibili del nostro corpo. Anche il sesso, che come la salute
è oggetto di campagne capillari di educazione ed informazione, è uscito
da quell'aura di mistero e di indicibilità mostrandosi, raccontandosi,
rendendosi visibile.
Sappiamo tutto della vita.
Ma a volte c'è una rottura, una interruzione: "da quando ho fatto delle
analisi per quel dolore alla schiena il medico mi sembra evasivo, mi dice
che non ci sono particolari problemi ma giusto per scrupolo vanno fatti
altri accertamenti. In effetti il dolore aumenta, non mi sento molto bene
ma in famiglia mi dicono tutti che non è nulla, che sono stanco,
stressato. Forse è vero, mi sto preoccupando inutilmente". In realtà
questo paziente è l'unico a non sapere che ha un tumore ai polmoni con
metastasi cerebrali, estremamente aggressivo ed infausto. Quando le
sue condizioni si aggraveranno gli verrà detto che in effetti ha una
pleurite o una polmonite ma che non si deve preoccupare anche se
quella tosse persistente non accenna a diminuire, anche se a volte non
si sente molto lucido, anche se avverte una stanchezza "mortale". Del
resto i familiari sono sempre allegri, i medici che vengono a casa - il
malato non si può più alzare dal letto - così tranquilli ed efficienti. Presto
questo malato morirà ma prima sarà addormentato farmacologicamente.
I familiari non gli terranno la mano: "tanto non sente", "non può
comunicare"; e in splendida solitudine sparirà, entrerà nella morte senza
una parola, un saluto, un "ti voglio bene..".
Quello che abbiamo brevemente descritto è un percorso tipico che
segna tutto l'iter della malattia, dalla diagnosi fino alla morte del
paziente, accompagnato da omissioni, falsificazioni, informazioni
ambigue fino ad arrivare ad una sorta di terra bruciata intorno al
paziente, a quella "congiura del silenzio" che si realizza in modo così
tipico e per certi versi in modo così monotono e sempre uguale.
Malattia e morte, in modo particolare quando si tratta di una malattia
oncologica 1, sono tagliati fuori dalla cultura della comunicazione: "la
conoscenza completa e condivisa, da parte del malato, della propria
condizione è un caso piuttosto raro mentre tende a generalizzarsi la
dissimulazione" (Spinsanti, 1985 p.169). Anche in quei Paesi dove il
paziente viene informato circa la diagnosi e la prognosi, la
comunicazione, con il progredire della malattia, si fa più rarefatta, più
ambigua, più evasiva, all'interno di un più generale evitamento ed
isolamento del malato: "le camere dei malati di cancro inguaribili
vengono evitate dai primari (ma anche dal personale sanitario loro
destinato), e non solo nella vera e propria fase terminale, quando la
comunicazione tra medico e paziente è gia compromessa, ma molto
prima (....) ciò nonostante proprio questi pazienti, gia duramente provati
dalla sorte, e i loro parenti più direttamente coinvolti avrebbero
veramente uno speciale diritto ad un'assistenza psicologica
particolarmente buona da parte dello specialista che hanno scelto"
(Senn, in Meerwein, 1985, p. 56).
La scelta di informare o meno il malato è comunque un problema
molto ampio che coinvolge non solo il malato, i medici curanti ed i
familiari, ma anche la struttura sanitaria, il corpo sociale. E' una scelta
che si pone continuamente e ripetutamente lungo tutto l'iter della
malattia: al momento della diagnosi, nel corso dei diversi interventi
terapeutici (operazioni, chemio-radio terapia), nel caso di recidive, di
terapie palliative e nell'eventuale fase terminale. Ma soprattutto è un
problema che investe direttamente le fondamenta culturali ed etiche di
ogni modello sociale. In altre parole il dilemma circa la comunicazione di
diagnosi e prognosi al malato oncologico rispecchia il rapporto che una
determinata cultura intrattiene con l'idea della vulnerabilità-malattia e
della finitudine-morte.
Aspetti deontologici ed etico-giuridici dell'informazione in
oncologia. Due modelli a confronto
Gli atteggiamenti nei confronti del malato oncologico si organizzano
intorno a due modelli prevalenti: nei paesi latini si tende a non
informare il paziente attraverso omissioni, informazioni ambigue,
parziali o vere e proprie falsificazioni dei referti, mentre nei paesi
anglosassoni e nord-europei si informa il paziente circa la diagnosi e la
prognosi anche se spesso la comunicazione viene fornita ex abrupto
attraverso un atto formale, asettico e generico, senza tatto e gradualità
(McIntosh, 1979; Smith, 1982; Santosuosso, 1996).
Tuttavia ad uno sguardo più attento, queste diverse modalità nella
gestione dell'informazione si differenziano una dall'altra più per motivi di
ordine pratico-formale che sostanziale. Entrambe sembrano comunque
caratterizzate da un sostanziale evitamento della relazione con la
"persona" del malato e delle istanze di cui è portatore. La stessa
credenza dell'esistenza di un dualismo, di una contrapposizione ideale,
di uno scontro ideologico tra opzioni culturali ed etiche diverse, appare
piuttosto discutibile. Non abbiamo l'impressione, infatti, di essere in
presenza di due scuole di pensiero, espressione di un diverso modo di
intendere la relazione medico-paziente, né tantomeno di modelli
culturali e sociali che si ispirano ad una diversa visione dell'uomo. Più
semplicemente sembra di assistere ad una complessiva e progressiva
riorganizzazione e modernizzazione della medicina che procede con
diversa velocità e tempestività nelle diverse aree socio-culturali e che,
come vedremo, non risponde minimamente alle questioni di fondo che
malattia e morte sollevano.
Cerchiamo, comunque, di approfondire contenuti e modalità di questi
modelli circa la gestione dell'informazione.
In Italia, e più in generale all'interno della cultura sud-europea,
raramente i medici informano i pazienti circa una diagnosi di cancro e
quasi mai della prognosi quando questa è sfavorevole (Santosuosso,
Tamburini, 1990; Holland et al. 1987). In alcuni casi anche altri
familiari, in genere bambini ed anziani, non vengono informati circa la
malattia del loro congiunto. In una delle ultime ricerche
sull'orientamento dei medici riguardo al dire "la verità" ad un malato
oncologico, i risultati appaiono inequivocabili. Infatti, circa il 90% degli
intervistati (oncologi, medici di base, medici ospedalieri del nord Italia)
ritiene che è meglio decidere con i familiari che cosa comunicare al
malato di cancro, mentre il 50% ritiene negativo, su un piano
psicologico, comunicare al malato una prognosi sfavorevole (Tamburini
et al. 1988). A distanza di 10 anni questi dati sono sostanzialmente
confermati. In una indagine svolta su 424 malati terminali entrati in
assistenza dal 1996 al 1998 presso la Ryder Italia (una associazione di
assistenza domiciliare medico-infermieristica), è risultato che il 65.2%
dei pazienti, pari a 279 soggetti, non era, al momento dell'ammissione, a
conoscenza della diagnosi, mentre al 34% dei pazienti "informati" sono
state fornite attivamente informazioni false sia da parte dei medici
curanti che dagli stessi familiari ("l'intervento chirurgico ha
completamente rimosso la massa tumorale", "la terapia farmacologica o
radiante sta funzionando" "la situazione è stazionaria" ecc.), oppure sono
state omesse informazioni circa la presenza di metastasi e/o di altri
problemi significativi per il paziente 2.
Appare evidente, a partire da questi dati, il ruolo dei familiari nella
scelta di comunicare o meno la diagnosi al malato. In una recente
indagine realizzata in Spagna, un Paese del tutto simile all'Italia per
quanto riguarda l'orientamento verso l'informazione sulla malattia, il
73% dei familiari di malati terminali ha risposto negativamente circa la
possibilità che il loro congiunto venisse informato della diagnosi
(Espinosa et al. 1993). La cultura della non-informazione, trova
frequentemente nei parenti del malato un valido sostegno all'interno di
un gioco di collusioni e reciproche deresponsabilizzazioni. Molto spesso
il medico, nell'informare i familiari, viene il più delle volte esplicitamente
invitato da quest'ultimi a non dire nulla al loro congiunto. A loro volta i
familiari leggono, a partire da questo colloquio preliminare e riservato,
un'analoga intenzione, da parte del medico, di nascondere al malato la
propria condizione.
La prassi di non informare trova un supporto giuridico-deontologico
nel concetto di beneficialità, per cui l'atto medico viene legittimato dalla
necessità di fare il bene ed evitare il male del paziente. L'insieme di
queste valutazioni circa il bene ed il male, e quindi rispetto alle diverse
scelte terapeutiche, è una facoltà che appartiene esclusivamente al
medico. In tal senso le disposizioni contenute nelle diverse stesure del
codice deontologico, se si esclude l'ultima stesura del 1995, lasciano
ampia discrezionalità al medico circa il "quantum di informazione da
dare al paziente onde evitare che la comunicazione di una prognosi
infausta finisca col danneggiare la sua salute" (Fucci, 1996 p. 47). Il
codice deontologico del 1989 stabilisce, ad esempio, che "il medico potrà
valutare, segnatamente in rapporto con la reattività del paziente,
l'opportunità di non rivelare al malato, o di attenuare, una prognosi
grave o infausta, nel qual caso questa dovrà essere comunicata ai
congiunti" (Codice Deontologico 1989 art. 39 comma III) 3.
A partire dagli anni '90 lo scenario che abbiamo descritto viene a
mutare, almeno su un piano etico-giuridico, all'interno di un più ampio
disegno intorno al concetto di consenso informato nella relazione
medico-paziente. In altre parole negli ultimi anni il modello
anglosassone si è fatto strada anche in Italia e più in generale all'interno
della cultura sud-europea passando dallo stato di "mera opzione
culturale a quello di comportamento richiesto dai giudici e dato per
necessario dalle massime istanze etiche" (Santosuosso, 1996 p. XI). La
particolare attenzione che nel nuovo codice di deontologia medica del
1995 viene dedicata alla relazione medico-paziente ne è una evidente
riprova. L'atto medico "si legittima non solo per le sue finalità
terapeutiche ma soprattutto in virtù del consenso del paziente" (Fucci,
op. cit. p. 5) cui è richiesto di partecipare attivamente al processo
decisionale in merito alla sua salute. Il medico non può più omettere o
rivelare a terzi informazioni circa la salute del paziente che diventa il suo
principale interlocutore, tuttavia "le informazioni riguardanti prognosi
gravi o infauste (...) devono essere fornite con circospezione, usando
terminologie non traumatizzanti, senza escludere mai elementi di
speranza" (Cod. deontologico 1995, art. 29 IV comma). L'obbligo di
informare, trova comunque il suo limite nella volontà del paziente di
rinunciare a conoscere la verità.
I cambiamenti che il nuovo codice deontologico prevede nella
relazione medico-paziente, sono stati introdotti sulla base di un parallelo
cambiamento giuridico-legislativo: "il quadro normativo del consenso
informato è il frutto della combinazione di leggi specifiche, pronunce
giudiziarie su casi specifici, elaborazioni teoriche e, in alcuni casi, di
norme deontologiche" (Santosuosso, op. cit., p. 27). Tuttavia, il diritto da
parte del malato, ed in particolare del malato oncologico, di ricevere
adeguate informazioni è ben lungi dall'essere garantito e realizzato.
Infatti, gli intendimenti, le linee guida, che in pochi anni hanno portato
a quella che è stata considerata una "rivoluzione copernicana" e che ha
visto coinvolte le massime istanze etiche, giuridiche e legislative, non
sembrano trovare un significativo riscontro sul piano applicativo, né
tantomeno una sostanziale accettazione da parte dei diversi soggetti
coinvolti. I dati precedentemente esposti che evidenziavano come più del
60%-70% dei malati oncologici non siano informati della diagnosi (per
non parlare della prognosi), non possono non testimoniare dell'esistenza
di un forte scarto tra opzioni legislative-deontologiche e la realtà della
prassi quotidiana. Non solo la classe medica appare sostanzialmente
ostile a questa nuova regolamentazione dei rapporti medico-paziente
vista come "fonte di intralcio nella pratica quotidiana e di negative
conseguenze sul piano della responsabilità professionale (...) come
qualcosa di cui si farebbe volentieri a meno, se non da rigettare del
tutto" (op. cit., p. IX), ma anche i potenziali fruitori di questa nuova
regolamentazione dei rapporti nel campo della salute, manifestano una
forte resistenza ad una più franca ed onesta comunicazione tra medico e
paziente. Se abbiamo già detto dell'atteggiamento da parte dei familiari
di pazienti oncologici, che nella assoluta maggioranza dei casi esprimono
contrarietà circa la possibilità che il proprio congiunto sia informato,
resta da indagare intorno al desiderio di conoscenza da parte di un
eventuale malato oncologico.
In una indagine condotta su 964 soggetti sani, il 52% degli intervistati
ha risposto di non voler conoscere, o di non essere sicuro di voler
conoscere una diagnosi relativa ad una malattia grave (Toscani et al.,
1990). Un analogo risultato è stato ottenuto in Giappone intervistando
324 medici ed infermieri (!) e 789 pazienti ambulatoriali. Solo nel 56%
dei casi gli intervistati hanno espresso una piena disponibilità ad essere
informati di una diagnosi di tumore (Mizushima et al., 1990). In altre
ricerche, comunque effettuate in contesti culturali diversi da quello
italiano, viene evidenziata una maggiore disponibilità, tra il 70% e il
90%, da parte dell'intervistato circa la possibilità di essere messo a
conoscenza di una diagnosi di tumore (Kai et al.,1993; Cassileth,
Zupkis,1980; Blanchard et al., 1988). In questi casi, tuttavia, gli
intervistati erano malati oncologici e quindi più sensibilizzati o
comunque con una esperienza diretta della solitudine e
dell'emarginazione tipica di un malato oncologico.
Come interpretare questi dati? Come possiamo comprendere questo
conflitto tra l'azione legislativa ed etico-giuridica e la sostanziale
resistenza dei soggetti direttamente coinvolti rispetto a queste nuove
normative?
Prima di proporre delle chiavi di lettura rispetto a questo "empasse" ci
sembra opportuno introdurre il modo in cui il problema
dell'informazione viene affrontato all'interno del modello anglosassone e
nord-europeo dove, diversamente da quanto avviene in Italia e nei paesi
latini (ma anche in Giappone, Iran, nei paesi africani ecc.), il paziente
viene informato della diagnosi e della prognosi. In realtà, quando
parliamo del modello anglosassone ci stiamo riferendo ad un approccio
relativamente recente. Negli Stati Uniti, infatti, nel corso degli anni '50 il
69% dei medici non informava i pazienti circa la diagnosi (Fitts et al.
1953). Allo stesso modo all'inizio degli anni '60 la maggioranza dei
medici esprimeva una sostanziale contrarietà all'idea di comunicare con
franchezza al paziente la diagnosi di cancro (Okem et al. 1961). Pochi
anni dopo, nel 1965, quando la Kübler-Ross in una grande città come
Chicago cercò di avviare un seminario sulla morte che potesse
coinvolgere alcuni malati terminali, dovette sperimentare resistenze
molto forti da parte dell'ambiente ospedaliero. Medici ed infermiere
insorsero davanti alle intenzioni della Kübler-Ross dichiarando di voler
difendere i loro pazienti da esperienze traumatiche (Kübler-Ross, 1969).
A partire dagli anni '70 si assiste ad un radicale e sorprendente
cambiamento di prospettive. Nel 1970, solo il 9% dei medici interpellati
non informa il paziente (Friedman, 1970), mentre alla fine degli anni '70
quasi nessun medico (il 3%) nasconde la diagnosi al paziente (Novak,
1977).
Questa repentina inversione di tendenza appare singolare e
difficilmente si può attribuire ad un profondo cambiamento delle
coscienze e dei valori. Forse è più semplice comprendere questa nuova
stagione nella transazione medico-paziente, a partire da una serie di
pronunce da parte della magistratura circa la necessità che il medico
informi il paziente della diagnosi, della eventuale terapia e in genere di
tutti i diversi aspetti dell'intervento sanitario, affinché quest'ultimo
possa, essendo stato informato, dare il suo consenso. L'intervento della
magistratura nel regolare i rapporti tra medici e pazienti, va compreso a
partire dal fatto che la salute sembra "sempre più un bene di consumo,
per il quale valgono le stesse regole vigenti, a tutela del consumatore,
per gli altri beni di consumo. E' chiaro che qualsiasi consumatore non
può non sapere cosa sta comprando" (Casali, in Santosuosso, op. cit., p.
112). Con la nascita di associazioni di tutela dei diritti del malato ed il
contemporaneo prevalere del concetto di autodeterminazione del
paziente, si è modificata la contrattualità del malato nei confronti del
medico e più in generale della struttura sanitaria. Ciò ha comportato che
gli ospedali sovvenzionati da sistemi assicurativi e, più di recente, le
istituzioni sanitarie finanziate dallo Stato (con la formulazione della
legge federale Self Determination Act, dic. 1991), dovevano dimostrare
che all'atto di ricevimento del paziente questi era stato informato dei
suoi diritti ed aveva dato il suo consenso informato. In sostanza a tutti i
pazienti "devono essere comunicate diagnosi, prognosi e alternative di
trattamento, così da dare libera scelta delle terapie" (Costantini et al.,
1998 p. 47). Tuttavia, con la nuova ed imponente regolamentazione
giuridica dell'attività medica si sono inevitabilmente diffuse frequenti
controversie legali tra pazienti e medici che hanno comportato, in
particolare negli Stati Uniti, l'assunzione di un atteggiamento difensivo
("defensive medicine") da parte del medico che "pone in essere o evita
una certa pratica terapeutica secondo una prevalente valutazione delle
possibili conseguenze legali e non dell'interesse del paziente"
(Santosuosso, op. cit. p. XI). Con tali presupposti "etici" non appare così
sorprendente che l'informazione venga fornita dal medico al di fuori di
qualsiasi relazione, lasciando al paziente "l'onere di farvi fronte con gli
strumenti che ha a disposizione" (Casali, Gamba, Santosuosso in op. cit.
p. 112). Non è difficile in questi paesi raccogliere lamentele da parte di
pazienti e familiari non tanto circa il fatto di essere informati, quanto
della modalità.
A questo punto, come possiamo utilizzare l'esperienza nordamericana per comprendere la nostra realtà? E' possibile, partendo dal
modello anglosassone, chiarire le difficoltà, l'empasse circa
l'applicazione, in Italia, della nuova normativa sul consenso informato?
In effetti il modello anglosassone, che come abbiamo visto sembra
nascere più in un'aula di tribunale che all'interno di un dibattito sui
fondamenti etici propri di una cultura, si rivela decisamente
paradigmatico nel momento in cui prendiamo in considerazione i suoi
aspetti costitutivi, il suo sviluppo e gli effetti pragmatici della sua
applicazione. Appare, infatti, caratterizzato da una modalità
burocratizzata, in cui i rapporti medico-paziente sono regolati dal codice
civile e penale e l'informazione è fornita del tutto svuotata degli aspetti di
comunicazione e relazione, lasciando irrisolto se non amplificato il
dilemma che ruota intorno a malattia e morte, nemmeno sfiorato da
questa "rivoluzione" giuridica e legislativa.
Lo ripetiamo: lasciando irrisolto se non amplificato il dilemma che
ruota intorno a malattia e morte. Infatti, se con la cultura della noninformazione si mantiene comunque un confronto, seppur negativo, con
la malattia e la morte, talmente riconosciuta e temuta, quest'ultima, da
non poter essere annunciata, detta, nominata, con la nuova
regolamentazione del rapporto medico-paziente, come ci indica
l'esperienza anglosassone, ha luogo una sostanziale negazione non solo
del confronto con la morte ma del dilemma stesso. Ciò che conta infatti,
è la correttezza delle procedure che, nell'adempimento formale di una
informazione obbligatoria, "garantiscano" sia l'erogatore che il fruitore
del servizio sanitario; quasi che mettere al corrente il malato della
presenza di un tumore maligno possa equivalere al gesto con il quale si
stampiglia la data di scadenza su un prodotto commerciale. In questo
modo, all'interno di un sistema "politicamente corretto" in grado di
garantire il rispetto delle procedure, affinché il paziente-consumatore
possa servirsi nel supermarket delle terapie vagliando le diverse e
concorrenziali offerte di beni di consumo sanitario, ha luogo un
progressivo passaggio di consegne tra un vecchio e un nuovo modo di
agire la fondamentale scotomizzazione e fuga da quello che nella cultura
moderna non è più accettabile e rappresentabile: la morte e il morire.
La posta in gioco non è infatti il diritto o meno all'autodeterminazione
del paziente né tantomeno la risoluzione del conflitto tra il principio di
autonomia e il principio di beneficialità. Non si tratta di difendere o
piuttosto di stigmatizzare un approccio medico di tipo paternalistico, che
più in generale rimanda al problema dei rapporti di potere che si
stabiliscono all'interno di ogni relazione d'aiuto. La posta in gioco nel
dire la verità o piuttosto nel negarla ed occultarla è se sia realmente
possibile confrontarsi nella nostra cultura con l'idea della propria
finitudine come sembrano comprendere, molto meglio degli estensori di
leggi e norme deontologiche, quei medici, familiari e malati che,
all'interno di un reciproco gioco di simulazioni, si rifiutano di dire o di
sapere. Cos'è, infatti, che non si può dire o sapere neanche quando il
tumore appare guaribile o curabile?
Che resiste ai vari tentativi di medici e psicologi di collocare la
discussione, circa una diagnosi oncologica, all'interno di un contesto
fatto di ragionevolezza e buon senso? Al riguardo c'è da chiedersi se il
rifiuto di di capire e di sapere non sia piuttosto l'espressione di una
impossibilità: "e se non volessero sapere semplicemente perché, per
qualche ragione, non possono sapere?" (Bersaïd, 1988 p. 101).
Il dilemma che ruota intorno alla "verità" si inscrive in un registro del
tutto diverso e rimanda, su un piano socio-culturale, psicologico e
spirituale, a questioni ben più complesse di quelle che vengono
solitamente affrontate anche dagli addetti ai lavori. Non si può, ad
esempio, non sorridere, come nel caso di un recente dibattito in
occasione della presentazione di un libro sui rapporti tra tumore e
psicologia, quando autori e relatori sembrano ridurre il tema
dell'informazione della diagnosi alla presenza o meno di umanità
nell'operatore sanitario. All'operatore freddo e disumano si contrappone
quello caldo, accogliente, con una mentalità "psicologica", in una parola
"umano". Quasi che, sia detto per inciso, freddezza, paura, repulsione,
indifferenza non siano qualità tipicamente "umane".
E' così difficile rendersi conto che il medico "paternalista" che
nasconde la diagnosi al proprio paziente per evitargli "inutili sofferenze"
e il medico che, anche costretto da articoli di legge, norme e codici,
comunica la diagnosi in modo impersonale e distaccato, sono la stessa
persona. E' così difficile comprendere che l'insensibilità, il distacco, la
freddezza ma anche il silenzio, l'atteggiamento protettivo e/o evitante,
sono modalità per difendersi dall'angoscia e in questo caso dall'angoscia
della propria morte evocata dagli occhi spaventati e confusi del paziente.
E' così difficile comprendere come lo stesso dibattito - quel domandarsi
se sia meglio dire la verità piuttosto che nasconderla - sia il risultato di
un chiaro empasse psicologico che ha luogo quando la domanda stessa
viene accolta acriticamente. In realtà l'insolubile conflitto si genera
proprio con la formulazione della domanda. La domanda è il problema di
cui vorrebbe essere un iniziale tentativo di soluzione. Prima di porre agli
altri e a noi stessi questa domanda, dovremmo chiederci: "esiste" la
morte nella nostra cultura? E' possibile rappresentarla, immaginarla?
Esiste un linguaggio per poterla "dire"?
Il cancro: la malattia indicibile.
Nel momento in cui ci chiediamo se esiste uno spazio, un luogo, un
linguaggio per rappresentare e dire la morte e il morire, non possiamo
evitare di far cenno alla malattia oncologica che per le sue
caratteristiche appare un osservatorio privilegiato per poter cogliere
l'irruzione della morte nella nostra vita e che più di ogni altra malattia
rende visibile le forme e i modi della morte. Per una sorta di nemesi,
quanto più nella nostra cultura la morte e il morire sono occultati,
nascosti, esiliati tanto più nel cancro la morte si esibisce, si mostra, si
spoglia. Una morte che non è solo biologica ma che spesso è preceduta
da morti parziali, da perdite e separazioni fisiche, sociali, emotive e
relazionali. Il cancro, a prescindere dalla sua curabilità, evoca profonde
angosce che non hanno uguali rispetto a nessuna altra malattia (se si
esclude forse l'AIDS), altrettanto pericolosa e mortale 4. Il cancro appare
scandaloso in quanto, a prescindere dalla reale gravità, sabota illusioni e
fantasie di onnipotenza costringendoci a pensare e a rivedere il nostro
rapporto con l'idea della finitudine: "non si può più negarla, si è costretti
a considerarne d'improvviso l'eventualità" (Costantini et al., op. cit. p.
7).
Ci aspettiamo, a questo punto, che qualche lettore insorga. Cos'è
tutta questa insistenza sulla morte? Non si sta forse riproponendo, in
questa sede, quella nefasta equivalenza cancro=morte che ha reso il
tumore una malattia a statuto speciale? Non è forse vero che più del
50% dei malati è ancora vivo dopo 5 anni dalla diagnosi? Non è forse
vero che molte forme tumorali offrono possibilità di sopravvivenza
maggiori rispetto ad altre malattie: cardiopatie, cirrosi epatica,
insufficienza renale, ecc.? Non dobbiamo cercare, considerando i
miracolosi progressi della medicina nella cura del cancro, di smitizzare
questa malattia piuttosto che rinforzare pregiudizi ed emozioni del tutto
irrazionali? Condividiamo, almeno in parte, queste osservazioni. Il
cancro non è più, come nel passato una malattia praticamente
incurabile, di cancro si vive. Tuttavia, i messaggi, le "informazioni" che
passano attraverso i mass-media appaiono spesso propaganda di una
medicina onnipotente e miracolistica. Da uno studio condotto
dall'Istituto nazionale dei tumori di Milano in collaborazione con
l'Istituto Superiore di Sanità si evince che nel 1990, a 5 anni dalla
diagnosi, il 39% (e non il 50%) dei pazienti oncologici sono ancora in vita
vs il 37% del 1980. In 10 anni dopo importanti investimenti economici
nel campo della ricerca, della clinica, della prevenzione la percentuale di
sopravvivenza entro i 5 anni è aumentata del 2%! Come è stato
evidenziato da ricercatori ed epidemiologi "i miglioramenti osservati negli
ultimi anni sono risultati nel complesso scarsi; purtroppo non si sono
ancora registrati quei sostanziali progressi annunciati nel recente
passato che avevano indotto nell'opinione pubblica la speranza di
vincere la guerra contro i tumori all'inizio del millennio" (Zanetti et al.,
1998, p. 82). Anche il concetto di guarigione appare relativo, sia perché i
pazienti oncologici continuano a morire, in un'alta percentuale, dopo i
fatidici 5 anni, sia perché il rischio di recidive permane per tutta la vita,
a tal punto che il concetto di guarigione è ormai sostituito da quello di
lungosopravvivenza: "soltanto a posteriori, al limite soltanto alla morte
per altra causa del paziente, si può concludere che egli non è andato
incontro ad una recidiva e che dunque era guarito" (Casali in
Santosuosso op. cit., p. 114). In Italia, ad esempio, secondo una
casistica molto recente, solo il 15% dei tumori possono essere guariti,
mentre nel 50% dei casi non vi sono speranze di guarigione anche in
presenza di una diagnosi precoce (Zanetti et. al., op. cit.). Non mancano
poi le critiche, da parte di autorevoli fonti mediche e scientifiche nei
confronti di alcuni dogmi della medicina, ed in particolare della
oncologia, quali la prevenzione, la diagnosi precoce, la farmacoterapia
(Zola, 1975; Illich, 1976; Pickering, 1979; Mc Keown, 1979; Black, 1984;
Bailar, Smith, 1986; Bensaïd, 1988; Skrabanek, Mc Cormick, 1989;
Cagliano, 1993; Berlinguer, 1994) 5.
Per tornare al nostro discorso, non essendo questa la sede per un
ulteriore approfondimento intorno ai limiti della medicina nella lotta
contro le diverse malattie oncologiche (Cfr. McKeown, 1979; Bailar,
Smith, 1986; Bensaïd, 1988; Skrabanek, Mc Cormick, 1989), il cancro
nel suo manifestarsi, per quanto possa rimanere silenzioso e discreto
per molto tempo, pretende attenzione, grida la sua presenza, si impone
alla coscienza, mal sopporta la clandestinità. In altri casi si presenta in
modo più soft, con un atteggiamento di basso profilo, quasi un non voler
disturbare. In ogni caso non si cela alla vista, non mostra imbarazzo,
non fa mistero sulla sua presenza. E' necessario un certo impegno per
evitare di incontrare il suo sguardo. In una ricerca condotta su 76
pazienti con sospetto diagnostico di carcinoma mammario il 73% di esse
"faceva affermazioni adeguate sulla natura della propria malattia, prima
che si fosse loro comunicata la diagnosi" (Meerwein, 1985 p. 87). Questo
dato rende ancora più sorprendente, almeno ad una prima lettura, la
significativa tendenza da parte dei pazienti nell'evitare e/o rinviare, in
presenza di sintomi sospetti, la visita con il medico di base o con lo
specialista. Negli Stati Uniti, dal 1923 al 1973, nonostante il significativo
aumento di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sulla
necessità di una diagnosi precoce, non è diminuito l'arco di tempo che
intercorreva tra la scoperta dei primi sintomi e la visita medica (Hackett
et al. 1973). In Francia, dove si distribuisce ad ogni sposa, con il
certificato prematrimoniale, un opuscolo che descrive le tecniche di
autopalpazione del seno, le donne aspettano "tre anni, in media, per
farsi visitare dopo che hanno constatato qualcosa di anormale nel loro
seno" (Bensaïd, op. cit. p. 247). I medici stessi, secondo uno studio non
molto recente ma comunque impressionante condotto su 229 sanitari
malati di cancro, mostrano la stessa tendenza a procrastinare che si
registra nella media della popolazione e spesso vanno a farsi visitare dai
colleghi meno adatti (Robbins et al., 1953 cit. in Meerwein op. cit.). Il
rifiuto nel riconoscere di essere o di poter essere malati, si evidenzia in
tutta la sua intensità e drammaticità, in quel 10% di pazienti che, dopo
essere stati informati circa una diagnosi di cancro, sostenevano, a
distanza di una settimana, di non conoscere la propria diagnosi
(Weisman e Worden, 1976).
"E se non volessero sapere semplicemente perchè non possono
sapere?" Questa domanda si impone con tutta la sua forza gettando
un'ombra sull'ormai "presunto" dilemma circa la comunicazione della
diagnosi. In una indagine svolta sui parenti di pazienti con tumore
polmonare è emerso che nell'82% dei casi al paziente non era stata
comunicata la diagnosi ma l'impressione dei familiari era che il 72% di
essi avesse "capito" (Costantini et al., 1992). O forse più che capire
hanno sempre saputo, non hanno mai smesso di sapere. Tutto parla,
tutto appare loquace. Lo dice il corpo che invia sensazioni sconosciute,
lo dicono i medici e i parenti che svelano involontariamente al malato
proprio quello che cercano di nascondergli: "i parenti più stretti si
comportano in modo diverso e il loro modo di parlare si fa imbarazzato e
contraddittorio, le risposte dei medici sono sfuggenti e cambiano da una
visita all'altra, il tempo passa e non si notano miglioramenti: sono tutti
indizi che portano il paziente a capire la situazione" (Leoni, 1992 p.
312).
Dunque si "sa". Ma quel che conta, in fondo, non è che il malato
sappia o no, quanto che nasconda di sapere a se stesso e agli altri.
Questa situazione è stata descritta con grande umanità da Tolstoj nel
romanzo la morte di Ivan Il'ic. In questo racconto un personaggio
apparentemente mediocre e senza profilo scopre dopo un banale
incidente di essere affetto da una malattia mortale: "Ivan Il'ic vedeva che
stava morendo ed era in preda a una continua disperazione. In fondo
all'anima sapeva che stava morendo (..) Il principale tormento di Ivan
Il'ic era la menzogna - la menzogna chissà perché adottata da tutti - che
lui fosse soltanto malato, non già sulla via di morire... (...) Era questa
menzogna a tormentarlo, era il fatto che non volessero riconoscere
quello che tutti sapevano e che anche lui sapeva, ma mentissero invece
sulla sua orribile condizione e costringessero anche lui ad aver parte
nella menzogna. (...) parecchie volte quando loro venivano a contargli le
loro storielle, era stato ad un pelo dal gridare: smettetela di mentire, voi
sapete benissimo, come lo so io, che sto morendo, perciò smettetela
almeno di mentire. Ma non aveva mai avuto il coraggio di farlo." (Tolstoj,
1886 p. 65-74).
Ma qual'è il coraggio di cui avrebbe bisogno il malato? Cosa c'è di più
pericoloso della morte e del morire? Cosa lo porta a mentire a se stesso,
a non credere a quello che vede, sente, pensa? A partecipare alla
menzogna collettiva, alla creazione e al mantenimento del "segreto"?
Il paziente, e con lui i familiari, i medici e tutti coloro che mantengono
un rapporto con questi, non possono e non devono trasgredire una
norma non scritta, e forse per questo anche più vincolante: la malattia,
la morte, e soprattutto il morire, al pari di tutte le esperienze che
intrattengono una relazione con ciò che è basso, dipendente, debole,
lento, imperfetto e vulnerabile, non si possono dire, vanno, ancor prima
che negati, taciuti. Come molti autori hanno evidenziato, nella moderna
cultura occidentale, con il venir meno di un linguaggio, di uno spazio
culturale, di una dimensione psichica e rituale in cui inscrivere la morte
e il morire, questi eventi naturali sono stati negati, rimossi dalla
coscienza individuale e collettiva (Gorer, 1963; Glaser e Strauss, 1968;
Kübler-Ross, 1974; Ziegler, 1975; Aries, 1975; Urbain, 1980; Elias,
1982; De Marchi, 1984; Di Mola, 1988; Bersaïd, 1989; De Hannezel,
1995; Carotenuto, 1996, 1997).
La morte ed il morire hanno preso il posto del sesso come nuovo tabù
della nostra epoca: "la morte è divenuta l'innominabile. Ormai tutto
avviene come se né io, né tu, né quelli che mi sono cari, fossimo più
mortali" (Aries, op. cit. p. 84). Tutto quello che riguarda la morte ed i
suoi rituali (cordoglio, lutto, sepoltura), attraverso l'interdizione e la
censura di ogni discorso sull'evento "morte", assume un aspetto
vergognoso, ripugnante e pornografico. Per far ciò occorre "una strategia
che privi l'uomo della sua agonia, del suo lutto e della coscienza stessa
della sua finitudine, bisogna che la morte diventi un tabù, che venga
rifiutato uno status sociale agli agonizzanti e che sia resa patologica la
vecchiaia. La morte diventa sinonimo del nulla" (Carotenuto, 1997 p.
159). Anche il malato ed i parenti durante la malattia devono negare e/o
minimizzare la sofferenza. Il malato infatti, "deve confidare nella
guarigione oltre ogni realtà, in ciò sostenuto dall'ottimismo ostentato dei
parenti e, qualora egli non possa che arrendersi all'evidenza, è bene che
dimostri saggezza ed altruismo, risparmiando agli altri sofferenza,
panico e disperazione" (Carotenuto, op. cit. p. 61).
Il malato e soprattutto il malato grave, che ha perso ogni diritto, ogni
status sociale, deve rinnegare e rifiutare se stesso, in quanto malato, se
non vuol "morire al mondo". Che sappia o meno, che sia stato, unatantum, "correttamente" informato o piuttosto depistato ed ingannato,
non può esimersi dal partecipare, nel tentativo di essere accettato, di
non essere lasciato solo ed abbandonato, a quella rituale commedia di
reciproca simulazione che va regolarmente e continuamente in scena:
nulla deve interferire con la "necessità d'essere felici, il dovere morale e
l'obbligo sociale di contribuire alla felicità collettiva evitando ogni causa
di tristezza o di noia, dandosi l'aria di essere sempre felici, anche se si
tocca il fondo della desolazione" (Aries, op. cit. p. 74). Questa sorta di
inimicizia con se stesso, con quanto egli è, viene costantemente
rinforzata e confermata quando il malato: "in risposta alle proprie ansie
e ai propri dubbi, alla paura per l'imperscrutabile sorte che lo attende,
trova solo un mutismo omertoso, un muro di silenzio che gli rimanda
un'immagine di sé ancor più angosciante perché esclusa da ogni
discorso, da ogni tentativo di condivisione" (Carotenuto, op. cit. p. 88).
Nessuna identificazione è possibile con quel sé malato, nessuna
indulgenza verso quel corpo ferito, nessuna accettazione per la propria
debolezza, dipendenza, bisognosità; piuttosto, con una totale
identificazione con le istanze sociali, il malato sperimenta la sua
presenza come una presenza colpevole, vergognosa, inutile.
L'immagine della morte e del morire nella società moderna
Secondo una interpretazione molto accreditata, il moderno
atteggiamento di rimozione e fuga dalla morte, dai morenti e dalle
manifestazioni del lutto, diversamente da quanto avveniva nei secoli
scorsi dove prevaleva una sostanziale accettazione della morte e del
morire, appare una modalità peculiare delle società più sviluppate ed
avanzate: "la morte un tempo così presente, tanto era familiare, si
cancella e scompare. Diventa oggetto di vergogna e di divieto" (Aries, op.
cit. p. 68). Nelle società tradizionali e rituali gli uomini morivano sereni e
consapevoli intrattenendo con la morte un rapporto di familiarità - "per
secoli l'uomo è stato il padrone indiscusso della sua morte e delle
circostanze della sua morte" (op. cit. p.) - e di controllo: "in primo luogo,
sono avvisati. Non si muore senza aver avuto il tempo di sapere che si
sta per morire" (op. cit. p. 18).
Per altri autori (Elias, 1982; De Marchi, 1984), questa interpretazione
circa l'evoluzione storica dell'atteggiamento dell'uomo, ed in particolare
dell'uomo occidentale, rispetto alla morte e al morire, appare ispirata da
un atteggiamento moralista che, attraverso la laudatio temporis acti, si
fa portatore di un ideale romantico e nostalgico circa l'esistenza di un
tempo, di un luogo e soprattutto di un uomo in grado di intrattenere un
rapporto sereno con la morte. L'idea che, prima l'uomo primitivo e poi
quello antico e medievale, fossero esenti dall'angoscia di morte e dalla
necessità di costruire una serie di formazioni reattivo-difensive di fronte
a questo evento, appare poco credibile sia da un punto di vista
antropologico che storico. Infatti, in ogni cultura e società, allo stesso
modo delle principali esperienze esistenziali e alle diverse fasi (nascita,
pubertà, accoppiamento, maturità, invecchiamento) del ciclo vitale, la
morte è sempre stata oggetto di regolamentazioni e prescrizioni.
Tuttavia, la sostanziale immutabilità, circa la necessità di contenere, di
"legare", attraverso codici di comportamento ben definiti (rituali, sistemi
di credenza ecc.), le emozioni suscitate da una minaccia così radicale,
tende ad assumere, in ogni epoca storica, forme e manifestazioni
cangianti ed aderenti allo spirito del tempo (Zeitgeist). In altre parole, ciò
che muta nel corso dei secoli è la rappresentazione della morte e la
risposta dell'uomo a questo evento in quanto: "l'immagine della morte
che domina nella coscienza di un uomo è strettamente legata
all'immagine di sé e di uomo che prevale nella società in cui egli vive"
(Elias, op. cit. p. 69). La morte, o meglio la sua rappresentazione
collettiva ed individuale, appare dunque un evento essenzialmente
culturale allo stesso modo delle malattie che sono influenzate, a loro
volta, dagli stimoli sociali e culturali all'interno dei quali si sviluppano
(Shorter 1993).
Per un approfondimento di questo tema così complesso ed articolato
si rimanda all'articolo di Di Mola. In questa sede, invece, ci limiteremo
ad accennare brevemente ad alcuni cambiamenti di carattere sociosanitario che, modificando l'immaginario collettivo, hanno contribuito
alla formazione dell'attuale modalità di rappresentazione della morte e
del morire. A partire dal XIX secolo, infatti, con il prevalere di un
sistema economico di tipo mercantile che ha reso necessaria la
ridefinizione di ogni ambito dell'esistenza all'interno di una logica di
produttività e consumo, malattia e morte sono state razionalizzate ed
inserite all'interno di un universo medico ed ospedaliero ordinato ed
efficiente, perdendo progressivamente il loro carattere comunitario,
sociale, pubblico per diventare sempre più un "affare" privato,
individuale, gestito da specialisti. Inoltre, lo sviluppo tecnologico e
scientifico, i progressi nel campo sociale ed economico, il miglioramento
delle condizioni di vita (igieniche, lavorative, abitative, alimentari) e il
conseguente prolungamento della vita hanno reso, nella società
occidentale, meno ravvicinato e quotidiano il confronto con la morte:
"più s'allunga la vita più s'allontana la morte. La vista dei moribondi e
dei morti non è più un elemento del nostro quotidiano; nel normale
corso della propria esistenza diventa più facile dimenticare la morte"
(Elias, op. cit. p. 26). Allo stesso tempo con la nascita della clinica
moderna, la scienza medica ha assunto su di sé le funzioni
precedentemente svolte dalla religione. La dialettica vita-morte, salutemalattia viene sottratta alle speculazioni religiose e filosofiche per essere
secolarizzata e trasformata in oggetto di ricerca scientifica e di pratica
medica. Con le conquiste della tecnologia, applicabili anche al campo
biomedico, l'uomo, per la prima volta nel corso della storia, è diventato
creatore di se stesso: "data di nascita, lotteria del sesso, parentela
biologica, costituzione genetica, capacità mentali e fisiche, destino
sanitario, sofferenza, invecchiamento, modalità della morte; tutte queste
casualità solitamente ineluttabili, forgiate dal fato e avvolte in un'aura di
sacralità, sono ora suscettibili di modificazioni affidate alla deliberazione
volontaria del soggetto (...) saremmo in grado di dare forma inedita alle
esperienze della vita, del dolore, della morte, della stessa differenza tra i
generi, di creare le condizioni per l'emancipazione umana dalle ataviche
dipendenze dei vincoli biologici" (Zizola, 1997 p. 73). Con il diffondersi
nelle società industrializzate di un'immagine razionale della vita e della
morte, intesa, quest'ultima, non più come evento misterioso ed
enigmatico ma piuttosto come fenomeno biologico che può essere
spiegato e reso comprensibile, le diverse ritualità che accompagnano la
morte e il morire, si svuotano di significato (Fuchs, 1973), perdono ogni
senso: "con l'età moderna l'ordine del Tutto perde il suo incanto e con il
disincanto del mondo gli esseri umani non vengono più visualizzati in
riferimento agli ordinamenti presunti sacri che li trascendono (...) si
riduce lo spazio dell'immaginazione in cui l'anima si esprime creando
quell'incanto del mondo in cui è riconoscibile la cultura di un popolo e
l'interpretazione di quelle situazioni limite che sono la nascita, la morte,
l'amore, l'odio, la colpa, la vita e il suo enigmatico senso" (Galimberti,
1996 p. 125).
All'interno di questo "nuovo" mondo si vengono a modificare, in modo
radicale, anche quell'insieme di fantasie e credenze che l'uomo coltiva
rispetto a se stesso, agli altri e al suo rapporto con la realtà in riguardo a
tutte quelle situazioni limite a cui fa riferimento Galimberti. Ecco allora
che, con l'attenuarsi della coscienza religiosa e della credenza dell'aldilà,
e con l'accresciuta possibilità di controllare e prevedere i pericoli che ci
minacciano, diventa sempre meno acuto il bisogno di potenze protettive
soprannaturali: "crediamo sempre meno nell'aiuto di numi tutelari, ci
affidiamo sempre meno alla protezioni di riti magici, confidiamo sempre
più in noi stessi, nella potenza della nostra ragione e della nostra
volontà" (Carotenuto, 1997 p. 85). Nell'incessante e costante
superamento del "limite", in questo giocare il gioco dell'onnipotenza, i
sistemi religiosi ultraterreni sono stati progressivamente sostituiti da
forme secolari di fede e da nuove mitologie e sistemi di credenza: dalla
fede nel progresso, nello sviluppo, nella crescita illimitata, alla credenza
mitica dell'esistenza di un soggetto, di un "Io", che pensa se stesso come
unica istanza di riferimento: "nelle società avanzate gli uomini per lo più
pensano a se stessi come ad esseri indipendenti, a monadi senza
finestre, a <<soggetti>> isolati, a cui si contrappone il <<mondo
esterno>> e quindi anche altri uomini (...) In queste condizioni ognuno
cerca di trovare un senso alla propria vita, un senso che abbia valore
solo per sé, indipendentemente dagli altri" (Elias, op. cit. p. 53-69).
Con la progressiva affermazione e strutturazione di un sistema sociale
e culturale dove gli uomini sono immaginati e si immaginano come
individui singoli, indipendenti, separati e isolati l'uno dall'altro, le idee
collettive d'immortalità, con cui nel passato l'uomo attenuava l'angoscia
di morte difendendosi dalla consapevolezza della propria caducità, sono
state sostituite da fantasie d'immortalità "personalizzate" in cui la
tendenza a ricercare la salvezza dai pericoli e dalla morte si è
"attualizzata", assumendo forme secolari sempre più "letterali", oggettive,
concrete e sempre meno simboliche e metaforiche. La nostra cultura,
infatti, è fondata e si regge su principi e prescrizioni intorno alla "reale
necessità" di essere in salute e in forma, ma anche giovani, felici,
realizzati, liberi da ogni condizionamento. Il concetto di vita si
"letteralizza", si reifica. La vita, diventando l'unico punto di riferimento,
diventa importante di per sé: "non ci resta che la vita per giustificare la
vita (...) da condizione necessaria si trasforma, ben presto, nel suo
stesso fine (...) l'essenziale non è di vivere la vita che conduciamo ma di
essere e restare vivi" (Bersaïd, op. cit. p. 98-100).
In un contesto socioculturale dove la "salvezza" va conquistata nel
"qui ed ora", salute e malattia vengono investite di qualità etico-morali.
La medicina, nelle sue diverse espressioni ufficiali ed alternative, viene a
costituirsi come nuovo sistema secolare di fede, quasi che con
l'affievolirsi delle religioni e con la "rinuncia - talvolta compiaciuta - alle
ideologie non ci lascino altra risorsa, per attenuare le nostre angosce,
che quella di credere nella medicina e nei suoi poteri" (op. cit. p. 273).
Con il procedere della medicalizzazione della vita, il malato si rivela come
trasgressore dell'ordine medico mentre la sua sofferenza è la sanzione
per la disubbidienza, infatti se la vita e la mia realizzazione nell'aldiquà
sono il bene assoluto, la malattia e la morte diventano sinonimo del
male: "la salute e la malattia si contendono l'uomo come il Bene e il
Male: la sanità è diventata sinonimo di salvezza e la malattia evoca lo
spettro del peccato" (Carotenuto, 1997b, p. 31). La malattia diventa un
crimine e ogni morte criminale e scandalosa: "se uno muore di infarto, è
perché non ha corso abbastanza, ha fumato e mangiato troppo (...) se ci
viene un cancro alla pelle, è perché ci siamo esposti al sole (...) E' colpa
nostra, sempre" (Bersaïd, op. cit. p. 106). La stessa società con le sue
contraddizioni e i suoi mali, diventa un problema medico e/o
psicologico: "siamo solleciti nel medicalizzare molti mali sociali (...)
curiamo l'abuso di droghe, così come la cleptomania la pulsione verso il
gioco d'azzardo, e molte altre co-dipendenze" (Angell, cit. in Berlinguer,
op. cit., p. 47). Non è più tollerabile la minima devianza, la più piccola
marginalità o imperfezione: "si afferma una spinta pericolosa a
considerare fenomeni fisiologici, per esempio la menopausa e la
vecchiaia, come condizioni patologiche richiedenti misure terapeutiche
(...) Le centinaia di società medico-chirurgiche, specializzate
nell'occuparsi di un organo o di una malattia, emettono ciascuna
bollettini allarmanti, calcolata solitamente in milioni di casi, dei soggetti
che sarebbero assolutamente bisognosi (corsivo nostro) di cure
specialistiche" (op. cit. p. 46). La tendenza della medicina, ma anche
della psicologia, ad assumere una funzione di regolamentazione e
controllo sociale, nel tentativo di rispondere alle più profonde angosce
umane, rischia di trasformarsi, in modo paradossale, in una minaccia
per la salute: "stiamo scivolando verso un Mc Donald's medico, nel quale
fobie e terapie superflue possono mettere a repentaglio la salute più
delle stesse malattie" (Porter cit. in Berlinguer, op. cit. p. 51).
In un tale contesto, la malattia, l'infirmitas, già privata del suo valore
simbolico e rituale e di ogni potere di trasformazione, viene a smarrire
anche le sue qualità comunicative, relazionali e sociali per affermarsi
come non senso (Hilmann, 1985, 1992; Galimberti, 1996; Carotenuto,
1997). La "salvezza" non si fonda più sull'elaborazione rituale delle
esperienze "limite", lì dove ha luogo "la nostra anima, con le sue
depressioni, il suo male sacro, la sua impotenza" (Carotenuto, 1997 p.
9), ma sul loro assoluto rifiuto. La scienza medica non promette la vita
dopo la morte ma assume la malattia e la morte come limiti da superare,
nemici da vincere hic et nunc: "niente infatti appare oggi più urgente e
più sacro della mobilizzazione di tutte le energie nella lotta che la
medicina conduce contro la malattia e la morte" (Bersaïd, op. cit. p. 39).
Già negli anni '70, Alvin Silverstein, l'allora presidente dell'Associazione
americana per la lotta contro i tumori, scrisse un libro "La conquista
della morte" con il seguente sottotitolo: "Perché potremmo essere l'ultima
generazione che muore. Come e quando la medicina sconfiggerà
definitivamente le malattie". La credenza millenaria, secondo la quale ci
si ammala perchè si deve morire viene rovesciata: si muore perchè ci si
ammala.
La guerra contro "il male" totale e definitivo, che la morte rappresenta,
si radicalizza. Le stesse fantasie di immortalità perdono il loro carattere
immaginativo, metaforico, "come se", per essere assunte, in modo
letterale, come "vere". In questo modo, la vita, ormai reificata, diventa un
dogma, un imperativo categorico, una Weltanschaunng intorno a cui
organizzare l'esistenza, mentre, con il venir meno di ogni cosmogonia e
di uno spazio simbolico dove poter liberare e risolvere l'angoscia
esistenziale, il "male" estremo, il "nemico", ciò che de-limita la vita, viene
demonizzato come evento concreto e reso irrapresentabile, impensabile
ed indicibile come discorso, come logos: "Se la morte non è più un sacro
trapasso, un passaggio verso un'altra forma di esistenza, essa è solo un
orribile buco nero (...) l'unica scappatoia consiste nella sua negazione,
nella sua rimozione (...) Il che significa non solo la permanenza di
quell'oggetto nel nostro orizzonte emotivo, ma addirittura un
potenziamento del timore che esso è in grado di ispirarci non avendo più
una forma precisa che ci consenta di definirlo e controllarlo. Una cosa è
temere un evento preciso (...) altra cosa è temere senza sapere bene
quale sia l'oggetto del timore: rifiutarsi di dare un volto e un nome a una
paura significa fatalmente ingigantirla" 6 (Carotenuto, 1997 p. 65-66).
Morte del "limite", morte del senso
E' giunto il momento di cercare di rispondere alle domande che ci
eravamo posti in precedenza: "esiste" la morte nella nostra cultura? E'
possibile rappresentarla, immaginarla? Esiste un linguaggio per poterla
"dire"?
A nostro avviso, in ogni cultura esiste ed è rappresentabile solo ciò
che ha un significato. Ciò che permette di comunicare segni e parole ad
altre persone (signum - ficare = fare segno), che è dotato di un "senso"
inteso come categoria sociale, comunicabile e condivisibile. Ma quale
senso, quale significato è possibile di fronte a quelle esperienze che nella
nostra cultura sono vissute non solo come il principale demone ma
anche come espressioni estreme del non senso, del nulla, dell'orrore per
eccellenza? La morte e il morire non hanno nessun significato in quanto
espulse da ogni possibilità di farne una esperienza sociale, comunitaria
al pari di tutte le manifestazioni che rimandano alla fondamentale
precarietà, imperfezione, "limitatezza" dell'essere umano. E allora, non
solo la morte e il morire ma anche ogni discorso circa il "limite", appare
in-sensato, deviante, controculturale.
La mancanza di un tessuto sociale e culturale in grado di sostenere,
almeno in parte, il confronto con l'idea della propria finitudine, getta
l'uomo moderno nell'impossibilità da rappresentarsi la sparizione, la
fine, la "necessità" della fine, rendendo invece necessarie le nuove
fantasie di immortalità a cui gli uomini affidano la speranza di poter
oltrepassare il limite umano "che non è solo la morte, ma il
prolungamento artificiale della vita, lo stesso sorgere artificiale della vita,
il mito dell'eterna giovinezza, il rifiuto ostinato ed infelice della vecchiaia,
l'incapacità di tollerare il dolore, persino il disordine della propria anima
(...) incapacità dell'uomo d'oggi di convivere con il dolore che, da che
mondo è mondo, è componente dell'esistenza, almeno di quella umana.
Ciò che scava nel volto dell'uomo il suo tratto umano" (Galimberti, 1997
p. 6).
La morte, o meglio la sua rappresentazione, perdendo di senso non
trova più uno spazio mentale che la possa con-tenere, un sentimento
che la possa sentire e "soffrire", un linguaggio, un dialetto, un sistema di
segni che la possa "dire": "oggi si muore così; non perché non si sappia,
ma perché non si sa parlare. Il linguaggio del sentimento è stato
dimenticato (...) l'uomo non sa più dire ciò che pensa e ciò che sente e
allora <<chiude la porta>>" (Campione, in Di Mola, op. cit. p. 20).
C'è qualcuno che può dire e qualcuno che può ascoltare? E anche
ammesso che sia possibile "dire" o "sapere" intorno a vita e morte, cosa
ci fa un malato di questa informazione, di questa consapevolezza? Dove
trova un contesto in grado di contenere ed elaborare i sentimenti
suscitati dal sapere, quando "la società gli rifiuta il suo aiuto e la sua
partecipazione, lasciandolo solo di fronte alla morte e costringendolo a
comportarsi come se la morte non esistesse" (op. cit. p. 18)?
Il dilemma circa l'informazione di diagnosi e prognosi va dunque
inserito all'interno di un discorso più ampio che investe quell'insieme di
opzioni culturali che in ogni sistema sociale orientano ed organizzano i
comportamenti e i modi di pensare e sentire i grandi temi universali su
cui si struttura e si poggia la nostra vita. Affrontare il tema
dell'informazione, e quindi il complesso dibattito intorno al "se", al
"come" e al "quando" informare il paziente (cfr. Kübler-Ross, 1974;
Smith, 1982; Meerwein, 1981; Leoni, 1992; Morasso, 1998),
prescindendo delle strutture e sovrastrutture sociali e culturali
all'interno delle quali si sviluppa lo stesso dibattito, ci mette nelle stesse
condizioni di quell'ubriaco che cerca la chiave smarrita sotto al lampione
non perché l'abbia persa in quel posto ma perché lì c'è luce.
In questo modo, non accorgendoci di quanto la morte sia esclusa
dalla nostra cultura, ci si impegna ad umanizzare il morire: "non si
tratta di familiarizzare con la morte, di reintegrarla nella nostra cultura,
ma soltanto di sistemare ciò che la circonda (...) si vuole "umanizzare" la
morte come si vuole "umanizzare" la vita (...) come se riumanizzare una
vita e una morte disumanizzate fosse altrettanto facile che reidratare
delle verdure liofilizzate" (Bersaïd, op. cit. p. 101). Oppure, si scivola in
un riduzionismo psicologico che, sopravvalutando la dimensione
individuale, rimanda al singolo, con il suo mondo intrapsichico e le sue
caratteristiche di personalità, la responsabilità di fronte alle diverse
problematiche connesse alla malattia e alla morte. In altre parole, i
diversi modi di gestire le dinamiche che ruotano intorno al tema
dell'informazione - come nel caso del familiare che si oppone a dire la
verità o del malato che si rifiuta di capire la propria condizione vengono spiegati e compresi a partire dalle vicissitudini pulsionali, dalla
organizzazione dei meccanismi di difesa, dalla evenienza di traumi
infantili ecc. In questo modo, il macrocosmo della cultura viene risolto
"nel microcosmo solipsistico della vita psichica, dove (...) il soggetto
psichico, divora quello che per la cultura è storia delle religioni,
antropologia, filosofia, simbologia" (Galimberti, 1996 op. cit. p. 55). O,
infine, di fronte alle barriere comunicative erette intorno al malato,
attribuirne la responsabilità ad una società ingiusta, crudele, "malata",
non riuscendo a comprendere che in un sistema sociale fortemente
individualizzato, dove è comune l'idea che si vive soli, contando sulle
proprie risorse, dove si assiste ad un progressivo scioglimento di vincoli,
di legami sociali così come del sentimento di comunità, di appartenenza
che fa di un individuo un essere comunitario, la solitudine ed il silenzio
che circondano il malato ed il morente non possono essere ascritti ad
una sorta di patologia sociale. Non siamo nel campo della patologia ma,
che piaccia o meno, della fisiologia. Il nostro modello di sviluppo, infatti,
si costituisce a partire dalla rimozione del limite, dalla rimozione
dell'angoscia di morte e dei sentimenti "panici, depressivi, inquietanti
connessi all'esperienza della caducità e del limite" (Carotenuto, 1997 op.
cit. p. 85); un modello in cui gli aspetti più istintivi della condotta
umana sono organizzati e strutturati in modo artificiale, mentre le
emozioni più forti e "i moti dell'animo più profondi vengono vissuti con
un senso di vergogna e di insicurezza e giudicati dalla collettività quasi
come manifestazioni di debolezza e di fragilità" (op. cit. p. 85-86).
Come sostiene lo storico e sociologo Elias, si possono identificare
all'interno dell'attuale stadio di sviluppo e di civilizzazione precisi fattori
comuni che, a prescindere dalle intenzioni soggettive così come dalle
differenze di classe e di gruppo, rendono difficile se non impossibile la
comunicazione, l'identificazione, la vicinanza fisica e psichica tra sani e
malati, tra vivi e morenti. Il malato, e ancor di più il morente, appare
"estraneo, alieno, già abitatore di una realtà di cui l'uomo laico, privo di
vita simbolica, non riesce a decifrare nulla" (op. cit. p. 57). La tendenza
all'informalizzazione, l'elevato livello di individuazione, il controllo di ogni
affetto ed emozione, la spinta all'isolamento e alla negazione di qualsiasi
interdipendenza tra gli esseri umani, limitano le capacità degli individui
di identificarsi gli uni con gli altri, di sviluppare un sentimento di
empatia, così che "la reticenza, l'assenza di spontaneità nell'esprimere la
propria compassione in una situazione critica per gli altri, non si
verificano unicamente in presenza di un moribondo o di una persona in
lutto. Al nostro stadio di civilizzazione si manifestano in tutte quelle
occasioni che richiedono l'espressione di una forte partecipazione
emozionale" (Elias, op. cit. p. 42).
In una tale condizione culturale appare particolarmente ingrato il
compito di chi come medico, infermiere, psicologo nell'assistere un
malato oncologico cerca anche di fornire al paziente una informazione
più realistica, chiara ed onesta, in quanto le strutture culturali
sottostanti, da cui malati, familiari ed operatori sono determinati e
pensati, possono rendere, quando misconosciute o sottovalutate,
illusorio o quantomeno frustrante ogni intervento informativo.
Note
1 In questo contesto ci occupiamo esclusivamente delle malattie
oncologiche. Ovviamente anche per altre malattie gravi o potenzialmente
gravi la comunicazione e l'informazione circa la diagnosi e la prognosi si
rivela problematica, tuttavia la malattia oncologica presenta, come
vedremo, degli aspetti del tutto peculiari e specifici.(ritorna)
2 E' importante segnalare che quest'ultimo dato appare incompleto per
difetto in quanto è relativo a dichiarazioni spontanee dei parenti presenti
al colloquio. In realtà, e ci riferiamo all'esperienza diretta degli operatori
dell'associazione, la quasi totalità dei pazienti non è informata della
propria condizione ed è oggetto di falsificazioni circa i diversi aspetti e
problemi della malattia.(ritorna)
3 In riguardo a questo articolo alcuni autori hanno messo in evidenza la
presenza di palesi contraddizioni rispetto ad altre norme del codice
deontologico. Ad esempio, la possibilità, prevista dal codice, di
comunicare ai parenti informazioni segrete e nascoste al paziente si
pone in palese violazione del segreto professionale (Fucci, op.
cit.).(ritorna)
4 Questo è dovuto al fatto che il cancro: 1) nel passato era praticamente
una malattia inguaribile; 2) è associato ad uno spegnersi lento, in preda
ad atroci tormenti, in modo non dignitoso; 3) è accompagnato, in modo
spesso molto intenso, da un dolore non solo fisico ma anche morale,
psicologico, sociale, e spirituale. Infatti, nell'immaginario collettivo il
tumore è associato al rischio reale di perdere la propria integrità fisica,
l'identità, l'autonomia, il proprio ruolo sociale, il proprio valore nel
"mondo" e all'interno del nucleo familiare; 4) è associato al timore di
essere abbandonato, isolato per una sorta di paura del "contagio"; 5)
attiva profonde angosce rispetto a terapie mutilanti (es. mastectomia),
invasive (es. colostomia), tossiche (effetti collaterali di chemioterapia,
radioterapia); 6) rispetto ad altre malattie come le cardiopatie che
rimandano ad altre fantasie (morte immediata, cedimento strutturale),
attiva la fantasia di un nemico interno, invisibile, vivo, cattivo,
persecutorio, vampirizzante mentre siamo in una condizione di totale
impotenza. E' il nostro stesso corpo che ci tradisce, ci attacca. (ritorna)
5 Un esempio per tutti. Il valore predittivo di molti esami per la diagnosi
precoce dei tumori come il pap-test, la mammografia, la ricerca del
sangue occulto, si colloca tra l'1% e il 10%. In altri termini su 100 tests
con risultati positivi (presenza di cellule neoplastiche) ce ne sono fra i 90
e i 99 che si rivelano falsi positivi (Skrabanek, Mc Cormick, op.
cit.). (ritorna)
6 Nel corso della storia umana, la gestione, l'elaborazione di questa
esperienza tremenda e totalizzante, con tutta la sua incomprensibilità e
misteriosità, si è resa possibile attraverso modalità sempre più
simboliche, affinché fosse possibile includerla nel proprio pensiero e non
viverla come spettro o come non senso. Dalla primordiale fuga dal
cadavere, ad esempio, si è passati alla costruzione di immagini mitiche
inizialmente interpretate da figure animalesche (lupo, serpente, drago)
poi con aspetti sempre più antropologici (demoni, creature miste in cui
si univano caratteri animali ed umani) fino a leggere la morte come
opera di una divinità che agisce in base ad una logica, magari misteriosa
ma nondimeno necessaria. Con la nascita dei grandi sistemi religiosi, in
grado di infondere la speranza o la certezza dell'aldilà, la morte, e con
essa l'angoscia di morte, è stata addomesticata ed esorcizzata venendo
considerata, come del resto la vita, un atto sovraindividuale e quindi
legata ad un rituale da celebrare in modo collettivo e simbolico:
l'accettazione da parte del morente della malattia e della morte, la scena
degli addii, i messaggi dati al morente da portare nell'aldilà, i riti del
cordoglio e della sepoltura.(ritorna)
7 Di fronte ad un tale abisso si può comprendere come il sistema che
comprende il malato, i familiari e le diverse figure sanitarie affronti la
malattia oncologica come qualcosa di indicibile, su cui non si può
gettare lo sguardo, come una sorta di tradimento rispetto a tutte le
nostre fantasie di immortalità. Come ci ha espresso una nostra paziente:
"mi sono comportata bene, non ho ecceduto in nulla, sono stata attenta
alla pressione, al colesterolo ed ora sono ammalata di cancro con tutte
queste macchine e sacchetti, attaccati al corpo. Mi sento defraudata,
imbrogliata. Ora non CREDO più che comportarsi bene, condurre una
vita sana ed igienica serva a qualcosa. Ci hanno promesso una morte
senza malattia, senza dolore, senza traumi ed ora eccomi qui a 48 anni,
con dolori insopportabili, incapace di controllare gli sfinteri, mentre
colgo negli sguardi di parenti, amici ed anche del medico stesso
imbarazzo, rifiuto, paura, ripugnanza".(ritorna)
Psicologo, Psicoterapeuta - Servizio di psicologia Ryder
Italia (ritorna)
Bibliografia
Aries P., (1975) Storia della morte in occidente, tr. it. Rizzoli, Milano,
1978
Bailar J.C., Smith E.M., Progress against cancer, New England Jour.
Medicine, 314, 1986, pp. 1226-1241
Berlinguer G., Etica della salute, Il Saggiatore, Milano, 1994
Bensaïd N., (1981) Le illusioni della medicina, tr. it., Marsilio, Venezia,
1988
Black D., An anthology offFalse antitheses, Nufflield Provincial
Hospitals, London, 1984
Blanchard C., Labrecque M., Ruckdeschel J., Blanchard E., Information
and decision-marking preferences of hospitalized adult cancer patients,
Socials Science in Medicine, 27, 1988, pp. 1139-1145
Cagliano S., Viaggio intorno alla medicina, Laterza, Bari, 1993
Campione F., Guida all'assistenza psicologica del malato grave, del
medico e della famiglia, Patron Editore, Bologna, 1986
Carotenuto A., Le lacrime del male, Bompiani, Milano, 1996
Carotenuto A., L'eclissi dello sguardo, Bompiani, Milano, 1997
Cassileth B., Zupkis R., Informed consent: why are its goals imperfectly
realised, New England Journ. Medicine, 302, 1980, pp. 896-900
Costantini A., Grassi L., Biondi M., Psicologia e tumori. Una guida per
reagire, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1998
Costantini A., De Marinis F., Noseda M., Fusillo L., Pallotta G., La
famiglia del paziente con cancro polmonare: indagine psicologica
preliminare all'istituzione di assistenza domiciliare, Annali dell'Istituto
Forlanini, 12, 1992, pp.276-82
De Marchi L., Scimmietta ti amo, Longanesi, Milano, 1984
De Hannezel M., (1995) La morte amica, tr. it. Rizzoli, Milano, 1996
Di Mola G., (A cura di), Cure palliative. Approccio multidisciplinare alle
melattie inguaribili, Masson, Milano, 1988
Elias N., (1982) La solitudine del morente, tr. it. Il Mulino, Bologna,
1985
Gorer, G., Death, grief and mourning in Contemporary Britain,
Doubleday, New York, 1963
Glaser B.G., Strauss A.L., Time for dying, Aldine, Chicago, 1968
Espinosa E., Baron G.M., Poveda J., The information given to the
terminal patient with cancer, European Jour. of Cancer, 29A, 1993, pp.
1795-1796
Fitts W.T., Ravdin I.S., What Philadelphia psysicians tell patients with
cancer, Journ. of American Medical Assoc., 153, 1953, 901-904
Friedman D., Psysician management of dying patiens: an exploration,
Psychiatric Medicine, 1, 1970, pp.295-305
Fucci S., Informazione e consenso nel rapporto medico-paziente,
Masson, Milano, 1996
Fuchs W., Le immagini della morte nella società moderna, Nuovo
Politecnico, 1973
Galimberti U., Paesaggi dell'anima, Mondadori, Milano, 1996
Galimberti U., Il vero limite della vita, "La Repubblica", 7 Maggio 1997
Hackett, T., Cassem N., Raker J., Patient delay in cancer, New England
Journal Medicine, 289, 1973, pp. 14-20
Hillman J., (1974-1985) La vana fuga dagli dei, Adelphi, Milano, 1991
Hillman J., (1992) 100 anni di psicoterapia e il mondo va sempre peggio,
tr. it, Garzanti, Milano, 1993
Holland J.C., Geary N., Marchini A., Tross S., An international survey of
physician attitudes and practice in regard to revealing the diagnosis of
cancer, Cancer Invest., 5, 1987, pp.151-154
Illich I., (1976) Nemesi medica. L'espropriazione della salute, tr. it.
Mondadori, Milano, 1977
Jankelevic V., (1994) Pensare la morte?, tr. it. Cortina, Milano, 1995
Kai I., Ohi G., Yano E., et al., Communication between patient and
psysician about terminal care: a survey in Japan, Social Science in
Medicine, 36, 1993, pp. 1151-1159
Kübler-Ross E., (1969) La morte e il morire, tr. it. Cittadella Editrice,
Assisi, 1979
Kübler-Ross E., (1974) Domande e risposte sulla morte e il morire, tr. it.
Edizioni Red, Como, 1981
Leoni M., L'assistenza psicosociale nella malattia inguaribile, Cittadella
Ed., Assisi, 1992
Mc Keown T., (1979) La medicina: sogno, miraggio o nemesi, tr. it.
Sellerio, Palermo, 1987
McIntosh J., Communication and awarness on a cancer ward, Croom
Helm, London, 1979
Meerwein F., (1981) (a cura di) Psicologia e oncologia, tr. it. Bollati
Boringhieri, Torino, 1989
Mizushima Y., Kashii T., Hoscino K., et al., A survey regarding the
disclosure of the diagnosis of cancer in Toyama Prefecture, Japanese
Jour. of Medicine, 29, 1990, pp. 146-155
Morasso G., (A cura di), Cancro: curare i bisogni del malato. L'assistenza
in fase avanzata di malattia, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 1998
Novack D.H., Plumer R., Smith R.L., Ochitill H., et al., Changes in
physician attitudes toward telling the cancer patient, Jour. of the
American Medical Assoc., 241, 1977, pp. 897-900
Oken D., What to tell cancer patients: a study of medical attitudes, in
Ethical issues in death and dying, a cura di Weir R.F., Columbia
University press, New York, 1961
Pickering G., Therapeutics. Art or science? Journ. American Med.
Association, 242,1979, pp. 649-53
Senn H.J., (1985) La franchezza con il malato, in tr. it. Psicologia e
oncologia (a cura di) Merwein F., Bollati Boringhieri, Torino, 1989
Skrabanek P., Mc Cormick J., (1989) Follie e inganni della medicina, tr.
it. Marsilio, Venezia, 1992
Santosuosso A., (a cura di) Il consenso informato. Tra giustificazione per
il medico e diritto del paziente, Cortina, Milano, 1996
Santosuosso A., Tamburini M., Dire la verità al paziente. Alcuni motivi
psicologici e giuridici, Federazione Medica, XLIII, 1990, p. 503
Shorter E., Psicosomatica. Storie dei sintomi e delle patologie
dall'Ottocento ad oggi, tr. it. Feltrinelli, Milano, 1993
Smith C., (1982) Vicino alla morte, tr. it. Edizioni Centro studi "M.H.
Erickson", Trento, 1990
Spinsanti S., Bioetica, ISU - Università Cattolica, Milano, 1985
Tamburini M., Gamba A., Morasso G., Selmi S., Ventafridda V.,
Comunicazione della diagnosi di cancro e terapia dei malati in fase
terminale, Federazione Medica, XLI, 1988, 487-492
Tolstoj L.,(1886) La morte di Ivan Il'ic, tr. it. Adelphi, Milano, 1996
Toscani F., Cantoni L., Di Mola G., Mori M., et al., Death and dying:
perception and attitudes in Italy, Palliative Medicine, 5, 1991, pp. 334343
Urbain J. D., Morte, in Enciclopedia Enaudi, Torino, 1980
Weisman A., Worden J., The existential plight in cancer: significance of
the first 100 days, International Journal of Psychiatric Medicine, 7,
1976-77, pp. 1-15
Zanetti R., Buiatti E., Federico M., Micheli M., Fatti e cifre dei tumori in
Italia, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1998
Ziegler J., (1975) I vivi e la morte, tr. it. Mondadori, Milano, 1978
Zizola G., La ricerca si misura con l'etica della vita, Telema, 3, 1997, p.
73
Zola I.K., Medicine as an istitution of social control, in Sociology of
medical practice, a cura di Cox C., Mead A., Collier-Macmillan, London,
1975
Scarica