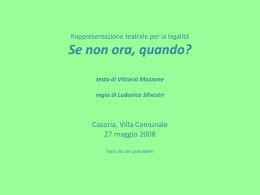Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT Corpo e salute nella Grande guerra. Dal mito della rigenerazione ai processi "degerogeni" del conflitto Barbara Bracco Ci sono molti modi di ricostruire una guerra e la Prima guerra mondiale in particolare. Ma un racconto dell’esperienza bellica attraverso la storia della alimentazione non è una scelta di marginale interesse o di semplice annotazione folklorica perché il rapporto tra cibo e guerra fa emergere un nodo centrale del primo conflitto mondiale, ovvero il rapporto fondamentale tra corpo, salute e nazione. Su questo intreccio una ricca e preziosa letteratura storiografica ha messo in luce del periodo precedente alla guerra gli elementi essenziali e non poco contraddittori. Negli anni della belle èpoque, che videro il trionfo dei modelli di “rispettabilità borghese” (per dirla con George Mosse) per uomini e donne, l’orizzonte di attesa sembrava essere caratterizzato essenzialmente da due aspetti apparentemente conflittuali; da un lato la consapevolezza di una progressiva – ancorché lenta - conquista della salute, grazie ai progressi della scienza, dell’igiene, della alimentazione in settori sempre più ampi della società europea, e dall’altro la speranza di poter assistere a un evento di totale rigenerazione, cioè a una grande guerra, vera occasione di rigenerazione non solo in senso morale, culturale, politico, sociale ma anche fisico, corporale delle nazioni europee. Il lungo Ottocento con le sue aspirazioni alla rigenerazione del corpo e della salute entrava in contatto e in conflitto con le pulsioni del nuovo secolo che vedeva nella guerra prossima ventura l’evento in omaggio a un diffuso darwinismo sociale e nazionale – che avrebbe determinato la selezione e la sopravvivenza delle migliori energie sociali, politiche, culturali e fisiche. Una felice sovrapposizione tra queste due linee dello sviluppo socio-culturale sembrò realizzarsi nell’esperienza del conflitto italiano. Nonostante, infatti, la evidente impreparazione delle strutture militari, grande attenzione - almeno teorica - venne data alla cura della salute dei militi. Come recitavano i molti opuscoli medici e militari, il corpo del soldato rappresentava la “macchina” più preziosa della guerra. In un conflitto che avrebbe visto il trionfo della scienza e della tecnologia, sopravviveva infatti la convinzione che l’efficienza fisica del fante fosse ancora l’arma più importante. Ecco che allora - sulla base di un interessante dibattito medico-politico che dall’impresa di Libia arrivò fino al 1918 e oltre - speciale impegno venne messo nella profilassi igienica e medica di morbi e malattie largamente diffusi tra i fanticontadini (e destinati spesso a ripresentarsi massicciamente nelle zone di guerra), come d’altra parte qualche sforzo venne fatto per vestire al meglio il soldato nei vari scenari del fronte italiano. Ma fu soprattutto nella alimentazione che venne individuato il fattore essenziale della resa fisica del soldato; almeno sulla carta, la dieta prevista dall’esercito italiano superava di gran lunga quella per esempio dell’esercito austriaco decimato negli ultimi mesi di guerra proprio dalla fame. Nutrire il corpo degli uomini mandati al fronte rappresentò dunque una delle sfide organizzative, economiche e politiche (aver cura del corpo del soldato voleva dire dare prova dell’attenzione dello Stato verso i suoi militi) più impegnative. Sfida che come è noto non sempre venne vinta dall’esercito e dallo Stato italiano. In molti settori dei combattimenti (e non solo nelle zone della guerra bianca) far arrivare le “gamelle” con il rancio e soprattutto l’acqua potabile si rivelò impresa disperata. E anche quando – a costi economici e umani onerosi – giungevano quantitativi sufficienti ai vari reparti militari, la qualità dei pasti si rivelava del tutto inadeguata. Lo scarto tra lo sforzo dello Stato italiano, che per la prima volta nella sua storia si era imposto la sorveglianza e la cura del corpo di 5 milioni di uomini, e la realtà dell’esperienza fisica dei soldati emerge non solo dai dati forniti dai ministeri alla fine della guerra ma anche e soprattutto dalle lettere e dalle memorie dei combattenti. Moltissimi furono gli uomini che lamentarono perdita di peso, avvilimento fisico Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT per la carenza di cibo e di acqua. Soprattutto tra gli uomini di estrazione sociale più elevata la differenza tra la precedente vita civile e quella militare si faceva sentire soprattutto nella quantità e nella qualità dell’alimentazione, assurta a simbolo della degradazione fisica e morale che la guerra aveva imposto anche ai più convinti interventisti. Ma anche tra i contadini e gli uomini di origine sociale più modesta, lo sforzo fisico sulla linea del fuoco e nelle retrovie sembrava non essere sufficientemente compensato dalla dieta reale fornita dalle cucine militari. Tuttavia, nel leggere le testimonianza di allora, è bene tenere conto di un processo psicologico che riguardò i soldati di tutte le estrazioni sociali. Le “storie del corpo” narrate nella corrispondenza e nei diari svelano l’intreccio tra corpo e disagio emotivo. Non è raro infatti trovare nelle parole di questi uomini sull’ alimentazione, sull’ acqua, sulla perdita di peso riferimenti a una condizione più generale di deperimento non solo fisico ma anche e, in molti casi, soprattutto psicologico: il disagio del corpo diventa testimonianza più o meno diretta di un rifiuto più generale verso la guerra che se non può esprimersi a chiare lettere – per via della censura, autocensura o per non allarmare gli interlocutori – finisce per trasparire dalla condizione fisica. Non è un caso che per rassicurare amici e famigliari molti soldati contadini (e non solo loro) non si limitino a espressioni di circostanza ma facciano esplicito riferimento al cibo e al peso corporeo come prova del loro buon stato di salute psico-fisica. Parlare di cibo vuol dire trasmettere percezioni, sensazioni, pensieri profondi; fino al punto che alcune pietanze e bevande divennero simbolo o sinonimo delle esperienze più terribili. Risaputo è per esempio che la distribuzione di vino e liquori (la “benzina” secondo la definizione di Emilio Lussu in Un anno sull’Altipiano) preannunciava un prossimo attacco e forse la morte in battaglia. Per molti aspetti forse più difficile e problematica fu l’approvvigionamento del fronte interno. L’impegno di rifornire le truppe ridusse ulteriormente il già povero regime alimentare dei civili, imponendo razionamenti assai rigidi di alcuni generi di prima necessità. Le restrizioni imposte poi dalle vicende belliche alla fornitura del grano, per esempio, impoverì ulteriormente l’alimentazione della popolazione italiana che vide – non a caso – il riacutizzarsi della pellagra, malattia tipica dei paesi arretrati contro la quale il giovane Stato italiano aveva duramente combattuto cogliendo qualche parziale successo. Come nel caso del fronte militare, anche tra i civili il problema del cibo rivelò però altro. I moti di Torino del 1917 e le proteste, che ciclicamente coinvolsero la città di Milano negli anni della guerra soprattutto per iniziativa delle donne, denunciarono non solo le difficili condizioni materiali dei ceti popolari (gli operai ma anche i contadini che facevano la spola con i grandi centri urbani) ma anche le resistenze politiche verso la guerra che avevano caratterizzato e ancora caratterizzavano ampi settori della società italiana. Ancora una volta il cibo finiva per essere il tramite elementare, diretto, semplice, per esprimere sentimenti e opinioni di rifiuto della guerra e del suo carattere “degerogeno”. Il bilancio finale della guerra consegnò – con i suoi 670.000 caduti, quasi mezzo milione di invalidi e mutilati, un milione di feriti e malati tra i soldati – un quadro assai lontano dalle attese di inizio secolo. L’evento che avrebbe dovuto rigenerare la società italiana e europea, sembrò aver prodotto l’esatto opposto, una selezione a rovescio. Un impoverimento di energie sociali, economiche e emotive che trova la sua più drammatica espressione nei dati forniti dalle molte pubblicazioni del dopoguerra che denunciarono un arretramento nella lotta che lo Stato e la società italiana aveva da tempo intrapreso contro la fame, origine – con la scarsa igiene – dei mali della povera Italia. Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT Orientarsi nell’«Archivio della Guerra» Saverio Almini L’«Archivio della Guerra», che oggi ha la denominazione di «Archivio di Storia contemporanea», viene istituito a Milano nel 1924 dal professor Antonio Monti, allo scopo di raccogliere il materiale occorrente allo studio della prima guerra mondiale attraverso il lascito documentario degli uomini che l’avevano combattuta. L’Archivio è concepito come la continuazione coerente del Museo del Risorgimento, di cui la «grande guerra» costituisce – secondo l’interpretazione ufficiale – il completamento ideale e politico. Ma l’«Archivio della Guerra» voluto da Monti si distingue nettamente dal contenuto e dalle finalità di una raccolta civica: esso ha un esplicito carattere nazionale. Vengono così acquisiti gli archivi di alcuni generali di primo piano del regio esercito italiano, e innumerevoli contributi provenienti dai singoli combattenti o dalle loro famiglie. Le fonti dell’Archivio si devono pertanto considerare migliaia. I fondi archivistici appartenuti ai generali rispondono appieno all’istanza dell’ideatore dell’Archivio, cioè di raccogliere le testimonianze documentarie della grande guerra direttamente dai protagonisti, distinguendo così l’«Archivio della Guerra» di Milano dagli archivi delle istituzioni pubbliche civili e militari, ai quali tradizionalmente attinge la produzione storiografica ufficiale. La parte preponderante della documentazione conservata negli archivi personali è costituita da carteggio di natura privata e dalla documentazione preparatoria di opere di carattere memorialistico, destinate, nell’intenzione dei rispettivi autori, a riaffermare la verità storica di fatti circostanziati ma rilevanti per la storia nazionale, oscurata già durante il conflitto o nell’immediato dopoguerra dalla diffusione di versioni ufficiali ingiuste nei giudizi, parziali o incoerenti nella ricostruzione. Nell’approccio metodologico dei suoi due primi decenni di esistenza, l’organicità dell’«Archivio della Guerra» viene vista consistere nella continuità e unitarietà data al criterio scientifico adottato per costituirlo, mentre non vi è nessuna selezione critica nella ricezione delle fonti. Con gli anni esse pertanto si ampliano a comprendere documentazione sulle guerre coloniali in Libia e nell’Africa orientale, sulla guerra civile spagnola, e quindi sulla seconda guerra mondiale, sulla repubblica sociale italiana, sulla Resistenza. La caratteristica originale di eterogeneità e frammentarietà del materiale ne viene ingigantita. Nel contempo, non è più possibile interpretare il corpus documentario dell’«Archivio della guerra» come una fonte che riflette, in senso unificante e autentico, la patria italiana, sia pure secondo una prospettiva retorica. Al contrario, esso rimane la testimonianza documentaria delle generazioni di uomini che – con diverso grado di responsabilità – hanno partecipato ai più gravi eventi collettivi della nazione, seguendone il destino. Avviene così la trasformazione dell’«Archivio della Guerra» in «Archivio di Storia contemporanea». Nel 1970, all’interno delle collezioni documentarie delle Civiche raccolte storiche del Comune di Milano viene creato, in modo del tutto fittizio, un «Archivio generale», nel quale vengono rifuse indiscriminatamente le due principali raccolte pregresse, vale a dire l’Archivio del Risorgimento – parte generale e l’Archivio della Guerra (Archivio di Storia contemporanea). Nel 2004, le Raccolte storiche hanno voluto ripristinare l’originaria suddivisione della documentazione nel rispetto delle due partizioni storiche. Al termine di questo intervento, l’Archivio di Storia contemporanea è costituito da un’unica serie archivistica, che ha come solo criterio di ordinamento il numero di ingresso delle carte. Nell’ultimo biennio, le Raccolte storiche hanno avviato uno studio analitico sullo stato di organizzazione e sistemazione della documentazione che costituisce l’attuale «Archivio di Storia contemporanea», a partire dai fondi organici risalenti agli anni della prima guerra mondiale, in linea con la politica di aggiornamento degli strumenti catalografici specifici delle proprie collezioni realizzata nel corso degli ultimi decenni. Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT Orientarsi nell’Archivio della Guerra. Fonti sull’alimentazione Gregorio Taccola Lo studio analitico dell’ultimo biennio sullo stato di organizzazione dell’Archivio della Guerra ha evidenziato la frammentarietà dei fondi, delle collezioni e delle raccolte che lo compongono e la sua complessa stratificazione. Gli strumenti di ricerca (inventari e cataloghi) oggi a disposizione non permettono di leggere questi complessi documentari né d’altra parte danno conto di tutto il materiale conservato. Una ricerca tematica sull’alimentazione all’interno delle fonti riguardanti la Grande Guerra risulta possibile solo attraverso una selezione sistematica e ragionata dei documenti per ottenere dei risultati che, seppur parziali, contribuiscano all’analisi dell’Archivio nel suo insieme. Il metodo di selezione dei documenti si basa su quattro criteri: 1) luogo di conservazione 2) estremi cronologici 3) tipologia documentaria 4) provenienza dei documenti L’analisi topografica del materiale conservato ha permesso di identificare, sulla base del primo criterio, i fondi archivistici organici conservati nella serie dell’Archivio e numerose collezioni e raccolte di varia natura: es. disegni, manifesti, stampe, cartoline, albi, cimeli, dipinti, carte geografiche, fotografie, ex votis, lastre fotografiche. L’ordinamento dei documenti all’interno dei fondi e delle collezioni è riconducibile soltanto in parte ad una precisa cronologia, tipologia documentaria e provenienza; l’individuazione delle fonti sull’alimentazione durante la guerra 1914-18 deve pertanto essere subordinata all’analisi approfondita di ogni nucleo documentario. Contestualizzare ogni singolo documento nell’esperienza di guerra della persona che ha donato le proprie memorie private a questa istituzione pubblica segna il passo tra la descrizione archivistica e l’analisi storiografica. Come varia nel tempo il numero di pezzi raccolti, la tipologia documentaria e l’interpretazione del fatto storico cui i documenti si riferiscono? Si possono individuare diversi gruppi di donatori ed identificare nel materiale versato caratteristiche precipue di ogni gruppo? Nel determinare che cosa è stato versato nelle collezioni, quando e in che modo è possibile spiegare anche il perché? Le fonti sull’alimentazione così riconosciute, che già nella loro individualità possono contribuire significantemente all’approfondimento di questo particolare aspetto dell’esperienza di guerra, acquisiscono un valore ulteriore una volta ricondotto il singolo documento al complesso documentario o alla raccolta di cui fa parte. In discontinuità con la sistemazione elaborata da Antonio Monti e ora perduta, da inquadrarsi nella tradizione neoidealistica e nella visione teleologica della storia, il riordino in corso dell’Archivio della Guerra risponde alle nuove sensibilità della scienza archivistica e storiografica: si tratta di offrire ai ricercatori strumenti per orientarsi nell’archivio, evidenziando la rete di legami con biblioteca e (ex)museo, dando conto, in modo non arbitrario, delle visioni multifocali del passato testimoniate nei fondi delle Civiche Raccolte Storiche, come ha evidenziatola ricerca sulle fonti sull’alimentazione. Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT Le fotografie di guerra nell’Archivio delle Civiche Raccolte Storiche di Milano Daniela Scala La storia della fotografia vive con la Prima guerra mondiale una svolta importante: è la prima volta che il mezzo fotografico viene largamente adottato durante un conflitto bellico, sia da fotografi dilettanti sia attraverso l’istituzione di specifici Corpi militari dedicati alle riprese fotografiche. Merito di questo allargamento è dovuto anche ai miglioramenti intercorsi nell’industria fotografica e in particolare alla comparsa nel 1912 dell’apparecchio fotografico maggiormente in uso tra gli ufficiali, il Vest Pocket Kodak, commercializzato con un’appropriata campagna pubblicitaria che sottolineava le caratteristiche di leggerezza, maneggevolezza ed economicità. Di questo sviluppo sono testimonianza le migliaia di fotografie conservate nell’Archivio delle Civiche Raccolte Storiche di Milano, di diversa provenienza e che sono una fonte documentale rilevante e imprescindibile non solo per l’analisi delle zone di guerra, di cui le riprese aeree hanno dato una dettagliata mappatura, ma anche per la studio e la conoscenza dei protagonisti, delle vicende belliche e del vissuto del Regio Esercito durante la Grande Guerra. Attraverso lo scorrere della sequenza di immagini, datate dal 1915 al 1918, è possibile prendere visione dell’equipaggiamento in dotazione agli appartenenti dell’esercito quali borracce, tascapane e gavette, dei momenti di preparazione e somministrazione del rancio al fronte e anche della distribuzione del pasto ai prigionieri, infine del sistema dei rifornimenti che giungevano per lo più grazie a muli e a teleferiche. Sono testimonianze visive tratte sia dalle fotografie ufficiali, prodotte dal Servizio fotografico del Comando Supremo a fini anche propagandistici, sia scatti spontanei che mostrano scene di vita quotidiana, in una dimensione talvolta quasi domestica. Si tratta di circa 60 immagini provenienti unicamente dalle raccolte fotografiche dell’archivio denominato “Archivio della Guerra” e accuratamente selezionate per i soggetti, che trattano a vario titolo del tema dell’alimentazione, a iniziare dalle stampe fotografiche schedate da chi scrive nel corso di un progetto di catalogazione avviato nel luglio 2013, e che si è allargato agli altri fondi presenti in archivio e a tutt’oggi ancora privi di inventariazione. Un aspetto interessante, anche per ricostruire l’autorialità della ripresa e le vicende legate a ciascun scatto fotografico, rivestono i timbri di appartenenza e le iscrizioni presenti sul verso dei supporti, come ad esempio i timbri del Comando Supremo, dei fotografi professionisti quali Strazza, Argo e Arguse della Censura determinata dal Decreto Luogotenenziale del 1916, oppure le didascalie e indicazioni tipografiche. Numerose fotografie furono infatti eseguite per essere divulgate nel Paese tramite i periodici tra cui “L’Illustrazione italiana” e “La Domenica del Corriere”, oppure grazie alla pubblicazione dei fascicoli La Guerra. Dalle raccolte del Reparto Fotografico del Comando Supremo del R. Esercito editi dai Fratelli Treves. La presentazione di questa selezione di stampe fotografiche si ritiene possa essere di stimolo per approfondire l’analisi delle migliaia di stampe fotografiche e negativi, che ancora sono in attesa di essere sottoposti a un lavoro di ricerca, di ordinamento e di studio. Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT La mobilitazione per la guerra a Milano, crocevia di vecchie e nuove élites Michela Minesso Nel quadro della situazione sociale e politica, determinatasi a Milano tra il 1915 e il 1918, l’intervento analizza il sistema complesso della mobilitazione civile e industriale, una imponente macchina organizzativa e produttiva realizzata per far fronte alla crisi prodotta dal conflitto. Diversi e numerosi furono i protagonisti di quella pagina di storia milanese. Da un lato, le istituzioni locali, in particolare il Comune e la giunta socialista di Emilio Caldara, che predisposero il piano dell’Assistenza civile, scontrandosi con le direttive del loro stesso partito. Dall’altra, le istituzioni centrali dello Stato che, dopo la costituzione del Comitato centrale di Mobilitazione industriale, promossero la nascita a Milano di uno dei sette Comitati regionali: il Comitato lombardo di Mobilitazione industriale. Infine, la società civile che partecipò allo sforzo bellico, entrando negli organismi promossi dalle istituzioni, operando all’interno delle numerose associazioni già presenti in città, dando vita a nuovi enti come il Comitato nazionale scientifico-tecnico per lo sviluppo e l’incremento dell’industria nazionale. Si trattò di uno sforzo poderoso, che vide intrecciarsi segmenti diversi delle élites politiche e sociali milanesi e nazionali: amministratori locali, uomini delle forze armate, rappresentanti del mondo dell’industria, dell’economia e delle professioni, figure appartenenti a generazioni diverse, a culture politiche diverse, uomini dalla formazione scientifica, tra i quali svolsero un ruolo non secondario i rappresentanti del mondo tecnico e del Politecnico come Giuseppe Colombo, Cesare Saldini, Giuseppe Belluzzo e tanti altri. La guerra pose gli uni accanto agli altri tutti questi protagonisti, modificando alleanze politiche consolidate e creandone di nuove, costrinse al lavoro comune, mentre Milano, affrontando le emergenze che si presentarono nel corso di quegli anni terribili e specialmente dopo Caporetto, quando la città, di fatto retrovia del fronte, diveniva quel laboratorio politico dal quale sarebbero scaturiti nel dopoguerra gli assetti futuri del Paese. Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT La logistica alimentare al fronte Andrea Bianchi L’l’Italia nel 1915 aveva una popolazione di 37 milioni di abitanti e il numero di combattenti stimato durante il periodo bellico fu di 5.900.900 uomini circa. A questi ultimi si dovette predisporre un’organizzazione logistica atta a nutrirli quotidianamente. Fu l’Esercito italiano capace di far fronte a questo enorme sforzo? L’applicazione teorica dei regolamenti dell’epoca per far giungere il cibo ai combattenti fu corrispondente alla realtà? Infine, le decisioni politiche annonarie quanto incisero sulla popolazione combattente nelle trincee e quanto su quella civile all’interno della Nazione? In certi casi vedremo che molti luoghi comuni non corrispondono esattamente alla realtà. Questo intervento ha lo scopo di illustrare per sommi capi il modo con cui l’Esercito italiano riforniva i combattenti al fronte con tutta la trafila burocratica dallo sbarco nei porti delle derrate alimentari importate dall’estero fino agli stabilimenti di lavorazione; si accennerà ai mezzi, dai più complicati ai più semplici, impiegati per il trasporto del rancio e i modi per prepararlo: sorprendentemente evidenzieremo anche una particolare attenzione nell’equilibrare i gusti che all’epoca erano molto vari nella popolazione italiana. Verrà illustrato un elenco con le principali derrate alimentari e l’apporto calorico che il soldato riceveva quotidianamente con un accenno a quelli degli altri Eserciti, cercando di evidenziare gli aspetti che oggi potrebbero essere delle curiosità, ma che all’epoca erano situazioni comuni. Infine, a titolo d’esempio, si citerà un documento inedito relativo alla preparazione alimentare per i combattenti sull’Adamello nel maggio 1916. Queste brevi considerazioni saranno poi supportate da immagini tratte dall’Archivio della Guerra e dalla collezione privata del relatore. Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT La Grande Guerra al cinema Maria Canella Fra tutti i generi artistici, il cinema durante la Prima Guerra Mondiale è la forma d’arte che più raggiunge il grande pubblico e influenza maggiormente il modo in cui la guerra viene immaginata durante gli anni successivi alla sua conclusione. Durante gli anni del conflitto il cinema si sviluppa notevolmente, tanto da diventare il principale divertimento di massa. La Grande Guerra ha ispirato centinaia di pellicole, sia come soggetto principale che come pretesto per trame che della guerra si servono solo come sfondo temporale. Dalle prime pellicole girate durante il conflitto e proiettate a scopo propagandistico nelle retrovie e nelle città dei paesi in conflitto, dove nerboruti alpini prendono a calci piccoli e bruti nemici (Maciste Alpino, 1916, regia di Giovanni Pastrone) alle produzioni Hollywoodiane, il cinema bellico ha sempre sopratutto cercato di mitizzare il concetto di guerra toccando gli estremi con storie che trattano del ritorno dei morti e altre che per esorcizzare la paura del nemico, appunto, ne evidenziano l’aspetto grottesco (vedi anche i cortometraggi di Chaplin, Stallio e Ollio e i fratelli Marx). Altri titoli hanno messo in rilievo il tema del cameratismo, altri ancora hanno puntato tutta la loro drammacità sugli scenari di guerra, con i bombardamenti e le trincee sconvolte. Spesso si è caduti nella retorica, sopratutto durante il periodo tra le due guerre, dovuta anche ai regimi che sono sorti in Europa dopo il conflitto e che richiedevano una visione della guerra “addomesticata” secondo le loro esigenze di propaganda. Con il passare degli anni e sopratutto dopo essere usciti da un secondo e tremendo conflitto mondiale, il cinema ha saputo darci sempre più realisticamente un’immagine degli orrori e assurdità del conflitto in maniera disillusa e priva di ogni retorica nazionalista, riuscendo a portare nella vita di tutti quello che è il vero essere di qualsiasi guerra: lacrime, dolori, sangue, morte. È in questa serie di film più realistici che si evidenzia uno dei grandi problemi durante la Grande Guerra che fu quello dell’alimentazione sia per la popolazione civile che per i militari. Le battaglie, la militarizzazione dei territori e le razzie (specie nel Friuli e Veneto orientale dopo Caporetto) provocarono devastazioni nei raccolti e lo svuotamento dei magazzini. Le famiglie nelle retrovie furono vittime di carestie e di malattie dovute a carenze alimentari gravi (come la pellagra) mentre il rancio dei soldati diventava ogni giorno più esiguo e scadente. La scarsa qualità era dovuta alla scelta di cucinare i pasti nelle retrovie e trasportarli durante la notte verso le linee avanzate. Così facendo, la pasta o il riso contenuti nelle grandi casseruole arrivavano in trincea come blocchi collosi. Il brodo si raffreddava e spesso si trasformava in gelatina mentre la carne ed il pane, una volta giunti a destinazione, erano duri come pietre. Scaldarlo una seconda volta non faceva che peggiorare la situazione, rendendo il cibo praticamente impossibile da mangiare. Il problema della qualità era parzialmente sopperito dalle quantità distribuite. A differenza infatti del rancio austro-ungarico (molto più esiguo, specialmente nell’ultimo biennio), l’esercito italiano dava ogni giorno ai suoi soldati 600 grammi di pane, 100 grammi di carne e pasta (o riso), frutta e verdura (a volte), un quarto di vino e del caffé. L’acqua potabile invece era un problema e raramente superava il mezzo litro al giorno. Per coloro che si trovavano in prima linea la gavetta (o gamella) era leggermente più grande. Prima degli assalti inoltre venivano distribuite anche delle dosi più consistenti con l’aggiunta di gallette, scatole di carne, cioccolato e liquori. Oggi in diversi musei si possono ancora ammirare i contenitori di metallo che custodivano i 220 grammi di carne o, a volte, delle alici sott’olio e frutta candita. Ogni scatola era decorata con motti patriottici come “Savoia!” o “Antipasto finissimo Trento e Trieste”. Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT Filmografia sulla prima guerra mondiale 1918. Charlot in trincea, Gran Bretagna, regia di Charlie Chaplin 1918. Heart of the world ( Il cuore della Terra), USA, regia di David W. Griffith 1919. J’accuse, Francia, regia di Abel Gance 1921. I quattro cavalieri dell’Apocalisse, Stati Uniti, regia di Rex Ingram 1923. La suora bianca, Stati Uniti, regia di Henry King 1925. La grande parata, Stati Uniti, regia di King Vidor 1928. Ali, Stati Uniti, regia di William Wellman 1928. Verdun,visioni di storia, Francia, regia di Léon Poirier 1929. Arsenale, URSS, regia di Alexandre Dovjenko 1930. Somme, Germania, regia di Heinz Paul 1930. Westfront, Germania, regia di Georg Wilhelm Pabst 1930. Gli angeli dell’inferno, Stati Uniti, regia di Howard Hughs 1930. All’Ovest niente di nuovo, Stati Uniti, regia di Lewis Millestone 1930. Journey’s End, Stati Uniti, regia di James Whale 1931. Mata Hari, Stati Uniti, regia di George Fitzmaurice 1931. Berge in flammen (Montagne in fiamme), Germania, regia di Hartl - L.Trenker 1932. Il compagno B, Stati Uniti, con Stan Laurel e Oliver Hardy 1932. Terra di nessuno, Stati Uniti, regia di Victor Travis 1932. Addio alle armi, Stati Uniti, regia di Frank Borzage 1933. Ero una spia, Gran Bretagna, regia di Victor Saville 1933. La guerra lampo dei Fratelli Marx, Stati Uniti, con i Fratelli Marx 1934. Stosstrupp 1917, Stati Uniti, regia di Ludwig Schmid-Wildye Hans Zöberlein 1935. L’angelo delle tenebre, Stati Uniti, regia di Sidney Franklin 1935. Le scarpe al sole, Italia, regia di Marco Elter 1936. Le vie della gloria, Stati Uniti, regia di Howard Hawks 1936. Cavalleria, Italia, regia di Goffredo Alessandrini 1937. La grande illusione, Francia, regia di Jean Renoir 1937. J’accuse, Francia, regia di Abel Gance (remake) 1939. La storia d’Edith Cavell, Gran Bretagna, regia di Herbert Wilcox 1941. Il sergente York, Stati Unit regia di Howard Hawks 1952. La leggenda del Piave, Italia, regia di Riccardo Freda 1957. Orizzonti di gloria, Stati Uniti, regia di Stanley Kubrick 1957. Addio alle armi, Stati Uniti, regia di Charles Vidor 1959. La grande guerra, Italia, regia di Mario Monicelli 1962. Lawrence d’Arabia, Gran Bretagna, regia di David Lean 1965. Per il re e per la patria, Gran Bretagna, regia di Joseph Losey 1966. La caduta delle aquile, Stati Uniti, regia di John Guillermine 1969. Oh che bella guerra!, Gran Bretagna, regia di Richard Attenboroug 1970. E Johnny prese il fucile, Stati Uniti, regia di Dalton Trumbo 1970. I recuperanti, Italia, regia di Ermanno Olmi 1971. Uomini Contro, Italia, regia di Francesco Rosi 1977. La Battaglia delle Aquile, Gran Bretagna, regia di Jack Gold 1979. All’Ovest niente di nuovo, Stati Uniti, regia di Delbert Mann (remake) 1979. Fraulein doctor, Italia, regia di Alberto Lattuada Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT 1981. Gli anni spezzati, Australia, regia di Peter Wair 1987. Light Horsemen, attacco nel deserto, Australia, regia di Simon Wincer 1989. La vita e niente altro, Francia, regia di Bertrand Tavernier 1989. Mino (sceneggiato per la TV), Italia, regia di Gianfranco Albano 1996. Amare per sempre, Stati Uniti-Gran Bretagna, regia di Richard Attenborough 1996. Capitan Conan, Francia, regia di Bertrand Tavernier 1997. Regeneration, Inghilterra-Canada, regia di Gillies MacKinnon 1999. The Trench, Francia-Inghilterra, regia di William Boyd 2001. Il Battaglione perduto, Stati Uniti, regia di Russel Mulcahy 2002. Deathwatch - La trincea del male, GB, Germania, Francia, Italia, Michael J.Basset 2003. Una lunga domenica di passioni, Francia, regia di Jean-Pierre Jeunet 2005. Joeux Noel (La tregua di Natale), Francia, regia di Christian Carion 2006. Giovani Aquile, Usa-Francia, regia di Tony Bill 2007. L’amore e la guerra (sceneggiato per la TV), Italia, regia di Giacomo Campiotti 2008. Passchendaele, Canada, regia di Paul Gross 2009. The Somme from defeat to victory, Inghilterra, regia di Detlef Siebert 2011. WarHorse, Stati Uniti, regia di Stephen Spielberg Giornata di Studi “GUERRA E FAME 1915-1918. L’alimentazione al fronte e in città” ” 14 maggio 2014, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento - Milano ABSTRACT Crisi alimentare e politiche assistenziali materno-infantili durante la Grande Guerra. Il caso milanese. Flores Reggiani L’emergenza sociale prodotta dalla Grande Guerra costituì, in generale, un momento importante per la sperimentazione e la modernizzazione del sistema assistenziale milanese. Un ruolo centrale nella mobilitazione civile sul fronte interno fu svolto, per incarico della Giunta comunale socialista presieduta dal sindaco Emilio Caldara, dall’Ufficio II del Comitato centrale di assistenza per la guerra che doveva organizzare e coordinare gli interventi a «Tutela e cura della fanciullezza». Di questa rete entrò a far parte anche il brefotrofio che, staccato dall’Ospedale Maggiore, dal 1866 era passato in gestione alla Provincia. L’azione del brefotrofio – che si collocava all’interno di un panorama nazionale caratterizzato da forti disomogeneità locali e da un sostanziale stallo legislativo nel campo della tutela dell’infanzia abbandonata – si sviluppò in due direzioni. La prima, straordinaria, consistette nella concessione del baliatico gratuito, fino al compimento del primo anno, ai figli dei combattenti e dei profughi, orfani di madre o la cui madre era «impotente ad allattare». La seconda, ordinaria e molto più significativa, continuò ad essere destinata a quelli che venivano chiamati ancora esposti, cioè «i figli illegittimi non riconosciuti, abbandonati o presentati all’istituto ed appartenenti per nascita alla Provincia di Milano» e «i figli illegittimi riconosciuti da uno o da entrambi i genitori, quando questi comprovino di essere privi di mezzi per provvedervi». Negli anni di guerra nutrire migliaia di neonati (5.615 fra il 1915 e il 1918) divenne un serio problema per una struttura che, oltre a non prevedere limiti alle accettazioni, da almeno da due secoli evitava – se non per brevi periodi e per i casi di disabilità – l’istituzionalizzazione degli assistiti e basava l’efficacia del proprio intervento sul reclutamento volontario, benché retribuito, di balie e di famiglie affidatarie, perlopiù contadine: una strategia che, sensibile alle dinamiche sociali, economiche e demografiche più generali, entrò in crisi in seguito agli sconvolgimenti che su quelle dinamiche furono prodotti dal conflitto. Crollato (1917), nonostante gli incentivi economici offerti, l’afflusso delle balie «da latte», a causa del calo della natalità legittima, del carovita e della necessità, per le donne sposate, di sostituire gli uomini nella attività agricole, si rivelarono insufficienti sia il tradizionale reclutamento coatto delle puerpere illegittime nella clinica ostetrico-ginecologica, sia la recente (1892) e contestata pratica del «baliatico materno a domicilio», concesso, ma con severe restrizioni, alle madri nubili che riconoscevano legalmente i figli. Scartata l’ipotesi di ricorrere estesamente all’allattamento artificiale, per i suoi esiti letali nei primi mesi di vita, nel 1917 la Deputazione provinciale diede via libera alla richiesta del direttore, Ernesto Grassi, e subordinò l’accettazione dei neonati nel brefotrofio all’obbligo, salvo impossibilità fisica, dell’allattamento materno in istituto per almeno sei mesi. L’iniziativa, che non ridusse immediatamente la mortalità infantile, a causa dell’epidemia di spagnola, evitò tuttavia – come accadde altrove – la decimazione degli assistiti e fu mantenuta dopo la fine del conflitto, perché, oltre a meglio garantire la sopravvivenza dei neonati, induceva le madri nubili al loro riconoscimento legale, riducendo la presenza dei “figli di ignoti”, secondo la linea progettuale di riforma inaugurata nel 1868 con la chiusura della ruota (1868).
Scarica