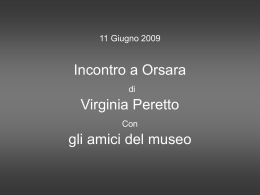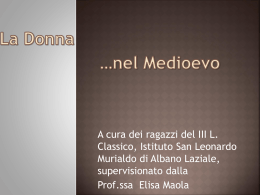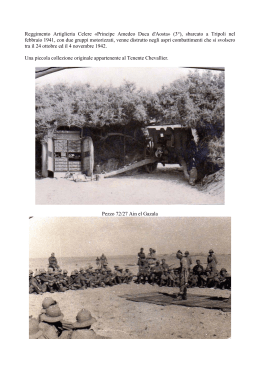Consorzio Culturale del Monfalconese www.grandeguerra.ccm.it Proposte per la scuola 7. LA MEMORIA DELLA GUERRA [a cura di Massimo Palmieri e Angelo Visintin] APPROFONDIMENTO A I sacrari di Redipuglia Afferma Gaston Bouthoul che nell’uomo “si produce a poco a poco quel ben noto processo della memoria che consiste nell’abbellire i ricordi e nel lasciare esistere soltanto quel che in essi c’è di piacevole, di poetico e di lusinghiero: Bergson ha scritto che c’è, per la guerra, un meccanismo simile a quello che fa dimenticare alle donne i dolori del parto” (G. Bouthoul, Le guerre, Milano 1961). Le radici del processo di formazione della memoria della guerra attengono dunque ai campi della fisiologia e della psicologia. Redipuglia da visitare in ginocchio e la mente al Cielo (Fototeca CCM) Nondimeno, il primo conflitto mondiale alimenta tra i reduci, nella collettività, nell’opinione pubblica, nelle nuove generazioni la crescita di un più articolato sentimento di revisione mentale dell’esperienza bellica. Da una parte la portata epocale della guerra, che non trova riscontri nel passato, dall’altra il clima storico e politico che innalza il valore dell’edificazione della “coscienza nazionale” e dell’ “educazione nazionale” delle masse rendono in gran parte nuove le linee conduttrici del consolidamento della memoria del conflitto. Le tendenze autoritarie e nazionaliste che nel dopoguerra si affermano in molti paesi dell’Europa non fanno che accentuare e rendere istituzionale un fenomeno in atto. Le vicende dei sacrari di Redipuglia sembrano ripercorrere le fasi di un itinerario monumentale, simbolico e politico che accompagna l’Italia dalle convulsioni dei governi tardoliberali all’avvento e rafforzamento di un regime, quello fascista, le cui velleità conducono ad una concezione “totalitaria” dello stato. Il cimitero sul Sant’Elia La prima necropoli di Redipuglia, edificata subito dopo il conflitto, esprime uno specifico criterio del ricordo, fondato sulla vicinanza dell’esperienza bellica e su un vigoroso rapporto con il contesto del territorio. Il Cimitero “Invitti della Terza Armata” venne ideato dal generale Giuseppe Paolini e progettato dal colonnello Vincenzo Paladini dell’Ufficio COSCG (Cura e onoranze salme caduti in guerra) con sede a Udine, l’ente che si occupò anche della realizzazione del manufatto. L’opera venne terminata nel 1923. La consacrazione ebbe luogo nella simbolica data del 24 maggio di quello stesso anno e fu officiata dal vescovo castrense monsignor Angelo Bartolomasi, alla presenza del Capo del Governo, Mussolini, e del Duca d’Aosta. Il complesso raccoglieva ben trentamila salme (oltre 400 di ufficiali), riesumate dai cimiteri di guerra dei dintorni o disseppellite di recente dal campo di battaglia. “È il più vasto cimitero di guerra d’Italia e del mondo”, commentava una pubblicazione dell’epoca (Il Santuario della Patria. Cimitero militare di Redipuglia “Invitti della Terza Armata”, Padova 1927). Il sacrario voleva rappresentare una figurazione emblematica del sacrificio nazionale, ma si poneva già come luogo di richiamo per il turismo bellico. La struttura cimiteriale possedeva una grande originalità ed offriva un impatto visivo di facile emozione. Un’altura situata di fronte all’altipiano carsico, il colle Sant’Elia, era stata modellata con la creazione di sette balze concentriche – allusione ai gironi del Purgatorio dantesco – il cui sviluppo raggiungeva una lunghezza lineare di 22 chilometri. Sette ampi settori circolari digradavano dalla sommità ed erano separati da larghi vialoni, anch’essi discendenti a raggiera. La sommità del poggio, livellata a formare un ampio piazzale, aveva al centro un obelisco in forma di faro, la cui base era una cappella votiva. Le sepolture erano collocate nella struttura paesaggistica in una maniera tale da riproporre, pur nella serialità e nell’ordine di un complesso cimiteriale, la casualità della morte. Scriveva un opuscolo di quegli anni: “Qui non viali coperti di ghiaia, non alberi, non fiori, non verde né ombra; ma l’aspetto sassoso e brullo del Carso, con sterpi e ciuffi d’erba scolorata, e qualche rado arbusto dai fiorellini pallidi, come quelli che, nelle assolate pietraie, furono l’ultima visione dei morenti” (ivi). Completavano l’artificiale riproduzione del teatro di combattimento una selva di cimeli, oggetti personali, suppellettili, brandelli di armi, proietti, confusi tra istrici e reticolati: “Non, sulle tombe, i consueti simboli cristiani in legno o in cemento, ma tutti i cimeli di guerra, diverso l’uno dall’altro” (ivi). Più della pietas cristiana, una religio guerriera, testimonianza di sofferenza quotidiana ed anonimo eroismo, di religiosità intima e minimalista. Ancora: “Resti e rottami vedi qui raccolti / lungo le tombe, a nobile ornamento / con industre pensier d’arte rivolti. / E appaion sacri come un monumento / la gamella il Consorzio Culturale del Monfalconese bidone la marmitta, / comune ordigno ed umile strumento” (dalla lirica Redipuglia, di Giulio Navone). Vi era, a questo riguardo, una contiguità semantica con i tumuli spontanei propri dei cimiteri improvvisati del periodo di guerra: i soldati onoravano la memoria dei commilitoni con cumuli di pietre sovrastati da croci costruite con bossoli, fino spinato ed altri reperti (Fabi, 1993). Cartolina edita in occasione dell'inaugurazione del cimitero (F. Todero, Il Carso nei ricordi di Luigi Bartolini in Il Territorio, anno XVIII, numero 4-5, nuova serie, dicembre 1995, Centro Culturale Pubblico Polivalente, Ronchi dei Legionari, p.89) Un trionfo del minimalismo L’aspetto selvoso, irto, intricato dei residuati, l’arsa rocciosità dell’altura carsica assurgono a metafora e fenomenologia della guerra moderna, fatta di casualità e distruzione, parcellizzazione e sconvolgimento. Anche le targhe e le epigrafi sulle tombe vogliono rammentare, attraverso versi caserecci dovuti in gran parte all’inventiva del maggiore Giannino AntonaTraversi, vero curatore del cimitero, il vissuto bellico più modesto, le funzioni più umili, l’oggettistica apparentemente più dimessa, lo sforzo umano e materiale per la vittoria. In molti casi, gli affetti più profondi del soldato sono correlati alla virtù del sacrificio di sé. L’amore filiale per la madre è il sentimento più evocato: “Mamma, sii forte: deve il patrio amore tramutare in orgoglio il tuo dolore!”; “Mamma mi disse: «Và!» ed io l’attendo qua”, è scritto sulla tomba di due Ignoti. L’arte è in realtà sopraffatta dagli intenti di celebrazione: un trionfo di reminiscenze scolastiche, di pretese letterarie che sanno di provincia. Il michelangiolesco “Grato m’è il sonno…” ispira una strofe di ricordo per l’umile ricovero di trincea. Famosi versi danteschi, opportunamente adattati (“E il Duca non Virgilio, ma Emanuele Filiberto di Savoia - a lui: «Caron non ti crucciare. Vanno per altra via, per altra piaggia. Sono i miei Fanti. E più non dimandare!»”) elogiano l’operato del genio pontieri; e così via, con richiami ad autori da silloge scolastica, ma anche all’ingenuo motteggiare del soldato. Una tipologia poetica semplice, basata sui versi a rima accoppiata. L’esito letterario si colloca tra la declamazione e la banalità: detriti pseudo eroici che – è stato notato – possono risultare persino offensivi ai caduti (Rochat, www.grandeguerra.ccm.it 1986). Ma è altrettanto vero che i modelli letterari, la metrica, il registro lessicale rimandano alle pubblicazioni per ragazzi, ai giornali di trincea, ai lunari sentenziosi della tradizione rurale, alla volgarizzazione carducciana e dannunziana. Insomma, vanno rapportati al contesto di conoscenze e di riconoscibilità dei ceti scarsamente alfabetizzati (in questo senso, i versi potevano apparire dotti!). Viene quindi da pensare si tratti di un disegno comunicativo molto meno improvvisato ed inefficace di quanto possa sembrare, le cui finalità anzi bene si allineano agli aspetti immaginiferi della modificazione del territorio. Il grande Sacrario La struttura funeraria del monte Sant’Elia per la sua stessa conformazione era esposta al deterioramento. Le spoglie, i cimeli, i residuati bellici subivano l’offesa delle intemperie. Per ovviare ai danni metereologici, agli inizi degli Anni Trenta il cimitero era stato al centro di importanti lavori, all’interno di un progetto di ristrutturazione: tra l’altro, i muri a secco erano stati sostituiti da solide costruzioni in pietra, le salme riconosciute erano state deposte in cassette di eternit, i nomi erano stati scolpiti per evitare scolorimenti. Erano soluzioni provvisorie. Si accavallavano nel frattempo altre esigenze. Innanzitutto si sentiva la necessità di disciplinare la questione dei numerosi cimiteri ai piedi del Carso (come il “Filippo Corridoni” di Sagrado o quello degli Asfissiati di Sdraussina), sul Vallone o sull’altipiano, traslando le salme in un unico ossario. Fattore di non minore importanza, il regime fascista intendeva appropriarsi del culto dei morti della Grande Guerra e della trasmissione della memoria ai fini dell’educazione nazionale. L’intenzione delle autorità fasciste era di trasformare Redipuglia nel centro nazionale della necrolatria bellica, ancor più degli altri grandi sacrari che si stavano allestendo o pianificando, sulla base della stessa progettualità politica, sui campi di battaglia “Sacri alla Patria”: il Montello, il Grappa, Oslavia (per il medio Isonzo). Il nuovo sacrario di Redipuglia sorse di fronte al vecchio cimitero. Fu edificato tra il 1936 e il 1938 su un progetto di Giovanni Greppi, che recuperava nella monumentalità funeraria l’esperienza architettonica dell’ultimo decennio. I motivi stilistici dell’enorme costruzione si ispiravano ad un razionalismo controllato ed impersonale, che rovesciava compiutamente la prospettiva vitalistica ed esperienziale propria della precedente struttura cimiteriale, ridotta poi a parco della Rimembranza e a silenzioso deposito antiquario. Sul monte Sei Busi saliva una imponente scalea formata da 22 gradoni, luogo di sepoltura per i centomila caduti, una parte dei quali ignoti. Sulla sommità era posizionata una cappella votiva sormontata da tre croci. Ai piedi del colle una larga spianata raccoglieva le urne dei generali della III Armata morti in battaglia, e, in una posizione isolata e gerarchicamente rilevata, la monolitica cubatura in porfido della sepoltura del comandante della grande unità, Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d’Aosta. Evidente ed esplicita era l’allegoria dell’esercito schierato con i suoi comandanti, come pure l’allusione Consorzio Culturale del Monfalconese cristiana dell’ascesa all’empireo: apoteosi della resurrezione, nella doppia valenza cristiana e nazionale. Il progetto di Greppi, coadiuvato nell’impresa dallo scultore Giannino Castiglioni, si proponeva non a caso di sviluppare il tema “Le anime dei Caduti salgono al Cielo”. Un modello funebre aereo e sublimato, ben diverso da quello caotico e terragno del primo cimitero. È pure notabile una specifica rilevanza del tema della sacralità delle frontiere. Al confine orientale il Carso e il Sacrario, che in esso è incastonato, diventano i testimoni e i custodi della “più grande Italia” e marcano la sovranità italiana su queste terre contrastate. Un muto esercito di centomila caduti, “vigile e sicura scolta alle frontiere d’Italia” – come recita l’epigrafe apposta alla tomba del Duca d’Aosta – sorveglia la Porta Orientale. “Presente” Il sacrario è volutamente privo di elementi eccessivamente differenzianti o di decorazioni. L’ambientazione vuole essere ieratica, rarefatta, alludere all’egualitarismo della morte (peraltro, sessantamila caduti sono ignoti). Se il cimitero del Sant’Elia lusingava il reduce con i ricordi vivi del campo di battaglia e sollecitava le pieghe del ricordo, ora il mausoleo mussoliniano rispondeva alle coordinate di gerarchia militare e civile propria dello stato “totalitario”. Il culto massificato della sepoltura come riproposta del rapporto capo-folla. Il sacrario, insomma, celebrava la massa ignota, l’oscura gregarietà del combattente, ma citando il modello di stato e società postulati dal regime. L’appropriazione del mito della grande guerra da parte del fascismo era visibile nei particolari minuti: fasci littori, un’aquila imperiale, la cadenza ossessiva del lapidario “Presente”. Il Sacrario di Redipuglia (Fototeca CCM) Anche la simbologia cristiana era piegata, con le sue implicazioni semantiche e psicologiche, al nuovo modello monumentale. Non più l’evocazione del CarsoCalvario, non Cristi dolenti, non angeli e Madonne pietose (come la Pietà e l’Angelo della Carità del cimitero militare di Aquileia), ma l’essenzialità sobria e astratta di nude e severe croci, di campane votive, www.grandeguerra.ccm.it di sarcofagi di pietra e rilievi bronzei: immagini riflesse di una guerra non più tanto vicina, vividamente presente, ma rilanciata in un’atmosfera sacrale, impersonale e sintetica. [Angelo Visintin] APPROFONDIMENTO B Scritture di guerra Vite parallele In questa sezione vengono presentate scritture di guerra non di autori più o meno noti, ma brani tratti da diari poco conosciuti dal grande pubblico, scritti da testimoni che hanno cercato di strutturare in modo organico le proprie esperienze, accompagnandole con riflessioni sul loro vissuto. Le vicende narrate riguardano principalmente il territorio del fronte del basso Isonzo e due persone che si sono trovate a vivere la guerra su fronti opposti: don Carmine Cortese, dapprima in servizio nel reparto di sanità del 19° Reggimento Fanteria, schierato tra le falde del San Michele e il Carso, poi assegnato all’8° Reggimento Alpini – Battaglione “Val Natisone” – e Virginia Marinaz, crocerossina volontaria presso il Reserve-Spital des Landeshilfsvereins von roten Kreuze für Görz und Gradisca. Come si può immaginare, i diari riflettono punti di vista particolari: entrambi gli autori non sono militari, ma persone che mettono al primo posto i sentimenti umani e la pietà, dettata dalla religione e dalla solidarietà, senza che ciò implichi il disconoscimento dell’amor di patria. Don Carmine Cortese proviene da lontano, dalla Calabria e più precisamente da Tropea (ora in provincia di Vibo Valentia), e ha compiuto un lungo percorso che lo ha portato ad abbracciare la vita sacerdotale. Fino alla vigilia della Grande Guerra l’assistenza religiosa alle truppe non era prevista nell’esercito italiano, perciò i sacerdoti e i seminaristi erano tenuti al servizio di leva. Solo nel 1915 le autorità militari disposero l’assegnazione di un cappellano per ogni reggimento, individuando nella loro presenza un fattore che avrebbe contribuito alla coesione e alla disciplina dei reparti. Don Cortese, dunque, prima di diventare cappellano deve rispondere alla chiamata alle armi, così che nel 1912 è inviato in Libia, dove fa le prime esperienze della dura realtà della guerra. Divenuto sacerdote, nel 1915 si trova sul fronte dell’Isonzo e vi rimarrà fino al ’17; trasferito sul fronte trentino, nonostante una ferita, ritorna accanto ai soldati fino alla rotta di Caporetto, quando fatto prigioniero viene internato nel campo di Josephstadt (Boemia) e liberato solo il 24 dicembre del 1918. L'approccio alla guerra Dal diario che egli scrive dal fronte dell’Isonzo, (C. Cortese, Diario di guerra (1916-1917), Rubbettino, Soneria Mannelli (CZ), 1998), proponiamo alcuni brani, tralasciando le sue esperienze successive. Le sue prime note risalgono al 1° gennaio 1916 Consorzio Culturale del Monfalconese www.grandeguerra.ccm.it dall'Hermada posto di medicazione di Sdraussina (oggi fiume, che ò varcato per ben sette volte. Sette volte! Poggio Terza Armata, frazione del Comune di Sagrado): con [sic] una tensione di nervi – con una malinconia invadente». Da parte avversa, Virginia Marinaz inizia a stendere il suo diario qualche giorno prima dello scoppio della guerra con l’Italia. È probabile che Virginia con la sorella avesse cominciato il suo servizio presso l’ospedale già durante i primi mesi della sua apertura, quando Gorizia era ancora lontana dai fronti. I passi citati sono tratti da R. Lepre, Gente dell’Isontino e Grande Guerra: scritti e testimonianze di protagonisti (senza altre indicazioni). Il 25 maggio cominciano ad arrivare i primi feriti e Virginia segnala le prime vittime; in seguito, con l’intensificarsi delle morti, annota: «All’ospedale tutto come al solito, molti muoiono, io non li conto quasi neanche più; per la maggior parte la morte è l’angelo buono, che li solleva dalle loro sofferenze. È molto avvilente il pensiero che essi muoiono lontano dalla loro famiglia, dai loro cari, e forse nell’ultimo attimo li tormenta la nostalgia per le guerre, per la loro patria. (…) Si diventa davvero tristi, quando si pensa che questi eroi sono morti lontano dai loro cari e giacciono qui completamente soli. Dio sa, come hanno desiderato ardentemente un istante prima del trapasso un caro viso conosciuto. Così è la guerra». Don Carmine Cortese [C. Cortese, Diario di guerra (1916-1917), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 1998, p. VIII] «Primo dell’anno: quanta malinconia in questa giornata che in altri tempi e in altri luoghi diceva: “Vita nuova”, “Resurrezione”. E quanta differenza col primo dell’anno scorso! In questi campi, in queste colline piene d’insidie permanenti e micidiali, con questa spada di Damocle che pesa sulla nostra testa di guerrieri – come si può cominciare l’anno? (…) Con quale entusiasmo, con quali propositi? Un giorno che passiamo qua, in questo posto di medicazione, in questa scatola che basterebbe un 75 per sfondarla, è un giorno guadagnato – un giorno che abbiamo rubato alla morte – a questa morte che (…) vigila sulle nostre teste, oramai stanche di pensare tante sventure, su questi nostri occhi che tanto sangue rosso hanno visto scorrere! E pure bisogna per gli interessi della nostra Patria, perché l’Italia viva, (…) anche spiritualmente, che noi portiamo pazienza; che soffriamo tutte le miserie e tutte le sventure: soffrire in silenzio – ecco; piangere tutte le nostre lacrime in disparte, aspettando la risurrezione di questa anima oramai invecchiata. Come abbiamo passato il giorno? Si è mangiato più o meno. Ma nelle ore p.m. ci è stato fuoco fuoco fuoco d’artiglieria nemica a Sdraussina e contorni con pochissimi danni, come à voluto il Signore. Eppure vivere sotto l’artiglieria, col pensiero che d’un momento all’altro potesse cadere su questo posto di medicazione un proiettile micidiale, è un palpito continuo. (…) Come si sente forte la voce dell’Isonzo in questa nottata d’inverno! Una voce che scende nell’anima: quante lacrime e quante amarezze e quanti eroismi porta seco verso l’adriatico [sic] – verso l’amarissimo mare. Ma più amarissimo è questo Estraniazione e monotonia Come si vede, in entrambi i casi emerge principalmente il senso di straniamento rispetto alla normalità della vita: la guerra ha travolto abitudini, legami consueti, ha sbalestrato i combattenti lontano dalle loro case, dalle loro famiglie, dai luoghi dove hanno vissuto da sempre; la nostalgia e la malinconia dei soldati sono dunque una costante. Tuttavia, sia Don Cortese sia Virginia Marinaz non mettono in discussione il dovere di combattere per la patria, soltanto il pensiero di Dio e la fede possono alleviare le sofferenze e offrire una qualche consolazione per le perdite umane e per il tempo che si consuma in questo stravolgimento della vita. Nel diario della crocerossina sono forse più accentuati gli elementi che rimandano ai concetti patriottici di valore e onore, per altro frequenti in molte scritture di guerra. Nelle parole di Don Cortese si legge forse una malinconia derivante dalla visione della guerra come una parentesi, che esclude la normalità della vita e impone ritmi e abitudini completamente estranei: «Domenica oggi? Ma chi ne sapeva nulla! Come la guerra ci à fatto perdere il senso reale delle cose e degli avvenimenti! La notte l’ò passata male male senza poter chiudere occhio…Avevo in me una preoccupazione che io stesso non so donde venisse: chiusi a dormire in questa scrofolosa casetta, risparmiata fino adesso non so come, a dormire non so come si faccia – e pure le dure necessità della guerra sono queste – fatalmente queste. E questa giornata, che la serata di jeri con le sue stelle prometteva buona, come non è diversa dalle altre, malinconiche, tristi, insignificanti, stupide - direi». Anche lo sguardo sul paesaggio è costantemente annebbiato dal persistere di una cupa tristezza che si Consorzio Culturale del Monfalconese distende su tutto ciò che si vede, uomini e cose: «Fa un tempo magnifico: chiaro il cielo splendido: lontananze circonfuse di luce. Il Carso, fatale, terribile, micidiale – tomba di tante giovinezze – è chiaro, distinto, rossiccio, impervio. S. Michele cova, con le sue cime, lo sterminio e la sventura. Stasera noi andremo a rivederlo e a provare le sue lacrime, il suo boato e ruggito, che uccide e strozza. E ripasseremo ancora una volta il ponte: quel ponte che con tremore ò passato, con nelle mani il solito mio crocifisso e la mia santa Madonna della Romania. Ed essi mi dovranno aiutare – come nel passato ancora stasera – questa sera lustre, luccicante di stelle che oggi promette. Nei soldati c’è il solito movimento e – scoramenti soliti – e malinconie dei più vecchi, al solito. O lacrime e malinconie di guerra… o sensazioni che invecchiate le giovinezze più floride…o emozioni che rovinate il cuore dei giovani più magnifici… stasera ritorneremo a piangere le nostre lacrime sole e amare – fatali conseguenze di questa guerra sterminatrice. Cerco d’incoraggiare – cerco di dire una parola a tutti. Ma la malinconia vela ancora la faccia di tutti. (…) E ci avviamo. È il funerale che avanza. Dove sono le canzoni, i versi, i motteggi di cui parlano tanti stravaganti giornalisti?». Pure sull’altro fronte la situazione, altrettanto drammatica per le orribili ferite riportate dai soldati, per le sofferenze patite e le numerosi morti, diviene progressivamente monotona, poiché nulla si sblocca e spesso chi si trova al fronte è risucchiato in un clima di noia e di ripetitività: «La giornata trascorre in modo monotono come le precedenti; si dimentica che si è in guerra, solo il vuoto e il silenzio della città ce lo ricorda. E sempre la stessa cosa violenti combattimenti interrotti da pause silenziose. (…). Non naturale, è la quiete prima della tempesta». In entrambi i diari, insomma, si manifesta chiaramente la percezione dell’ eccezionalità del tempo trascorso al fronte, di una sospensione che impone agli uomini di trascurare le loro normali attività, i loro interessi e affetti per lasciarsi trascinare dal fiume ineluttabile delle vicende belliche, che spesso sembra non portare a nessuna meta, continuando semplicemente a scorrere con il suo seguito di sofferenza e di senso di vanità, che si insinua sempre più nell’animo dei combattenti. Probabilmente la scrittura, privata o indirizzata a un qualche possibile pubblico futuro, risponde all’esigenza di sottrarsi a questo senso di esclusione dalla vita, di riflettere sulla condizione propria e altrui, di cercare di dare senso ai mesi e agli anni che passano. Ci si aggrappa ai valori che hanno animato l'intervento nella guerra, e, in generale, al sentimento di lealtà verso la patria e il proprio paese, nonostante che questi valori, durante lo svolgimento delle vicende belliche, vadano sempre più rivelandosi insufficienti a giustificare la carneficina in atto. Altri appigli iniziano così gradualmente a farsi strada, tra questi l’attaccamento solidale ai compagni di reparto, che a poco a poco si trasforma in spirito di corpo - piuttosto distante da quello militaresco postulato dai comandi - in spirito di condivisione, determinato dal comune destino di www.grandeguerra.ccm.it sottomissione a ordini che provengono dall’alto, non compresi pienamente negli scopi o, ancor peggio, subiti e accompagnati da effetti disastrosi per la vita stessa dei soldati. La guerra, il sangue Anche i diari di entrambi i nostri narratori sottolineano come progressivamente gli animi si assuefacciano a quegli orrori, inizialmente assolutamente insopportabili: «Si lavora alla baracchetta e lavoriamo all’Ufficio informazioni. Ma, nel frattempo, dobbiamo fuggire spesso nella buca, perché si tira terribilmente verso le tre sulle seconde linee nostre (…): un paio di granate scoppiano a Sdraussina davanti alla fontana, massacrando, massacrando tre soldati del 20° e qualche altro del genio. Ne estremo uno [= porgo ad uno di essi l’estrema unzione, N.d.C.], moribondo: il mio cuore non reggerebbe più allo spettacolo sanguinoso degli altri due, ma mi faccio coraggio: è il mio apostolato. Sono due toscani e padri di famiglia. Il sangue corre – la carne fuma – i lamenti si moltiplicano, le gambe sono un ammasso di lacerazioni. Oh Gesù, Gesù, Gesù da loro la forza di resistere – Però credo che non arriveranno nemmeno a Sagrato. Ma vale tutto S. Michele, tutta Gorizia, tutta Trieste davanti al massacro d’una vita, d’un’esistenza, davanti al sangue giovane di questi padri di famiglia? Dio mio, che barbarie, che controsenso della vita – questa guerra. Ma perché gli uomini si dilaniano, (…) mentre siamo tutti fratelli – perché, mentre il Signore fa levare il suo sole su tutti ugualmente? Mentre tutti fummo redenti col medesimo sangue divino di G. Cristo? Di chi è mai la colpa? – Della superbia umana». Per il sacerdote è evidente il controsenso rappresentato dalla guerra rispetto al fatto che tutti gli uomini sono figli di Dio e perciò fratelli; tanto più orribile gli appare, quindi, la strage quotidianamente compiuta. Ma ciò non impedisce a Don Cortese di compiere con disciplina il proprio dovere. Non la contesta l’obbedienza, pur consapevole della sua influenza sulla valutazione degli avvenimenti. Virginia Marinaz, trovandosi ad assistere le vittime dei combattimenti, ha modo di constatare non solo le sofferenze e le mutilazioni fisiche, ma anche gli sconvolgimenti psicologici prodotti dalla partecipazione ai combattimenti e dalle ferite: «È triste per i nostri poveri malati, che tremano ad ogni sparo, e in particolare per quei tre che in seguito all’esplosione di una granata soffrono di trauma cranico. Loro non sono ancora convinti di essere liberi, ma credono di essere prigionieri degli italiani». Di fronte alle sofferenze che quotidianamente si presentano agli occhi della crocerossina, essa non può che constatare amaramente: «Tutti i letti sono occupati, si vede sangue dappertutto. Chirurghi e infermiere lavorano giorno e notte. (…) I feriti sono molti e hanno un aspetto terribile. Di qualcuno si vedono poi soltanto brandelli pendenti di carne e di sangue. Uno piange, quell’altro si lamenta, il terzo implora aiuto. E si deve rimanere qui accanto a loro impotenti». Per il cappellano la vita al fronte e la guerra fanno Consorzio Culturale del Monfalconese emergere le contraddizioni dell’animo umano: «Vita di guerra…12 mesi di guerra – 12 mesi di guerra cruda, persistente, micidiale – come dritti dritti, taglienti, lampanti, con tutte le vostre sfumature di dolori, di tristezze nella memoria, nella mia sempre desta memoria! Quante vicende, quante variazioni, quante lacrime, quante poche gioie, in questi mesi…A questo tempo sarei dovuto diventare inebetito: la memoria dei corpi squarciati, delle fronti rotte, dei petti lacerati, dei visi trasformati, delle lacrime fredde, raccolte, asciugate sulle guancie fredde degli agonizzanti avrebbero dovuto dissecarmi tutte le vene del sentimento mio misterioso, scuro, enigmatico cuore. Ma esso è rimasto integro, intatto, reso però più sensibile più amaramente sensibile. Che mistero in questo mio muscolo, che labirinto intricato: fatto per vedere morire placidamente l’uomo sul letto della sua casa, tra un lungo rimpianto di squilla, à subito l’onta della carneficina e dell’odio fraterno e à recitato le ultime preghiere tra il rombare dei cannoni. Ironia amara amara amara – vita cruda, da omicida, da macello!…E l’Europa manda nei suoi diversi macelli i suoi figliuoli. Almeno per questa nostra cara Italia questo martirio fecondi la vittoria, faccia sbocciare la gloria!… Le sorelle Virginia ed Enrica Marinaz, infermiere volontarie della Croce Rossa [M. Masau Dan, A. Delneri (catalogo a cura di) Provincia di Gorizia, 8-9 agosto 1916 La prese di Gorizia. Immagini, documenti, memorie, Edizioni della Laguna , Mariano del Friuli 1990, p.51] Anche oggi ò benedetto morti: sono tre (…) – e tutti fracassati nella parte più nobile, più bella – la testa!». Continua: «E i feriti vengono: e il sangue cola. L’aria è triste; accenna sempre a piovere: sembra che la giustizia divina ad ogni barbarie umana risponda col basta! (sottolineato nell’originale). (…) E non si dorme. A tutti bisogna dire una parola – un conforto. Ne www.grandeguerra.ccm.it estremo due che mi muoiono nel posto di medicazione – vittime sante, vittime nobilissime, vittime indimenticabili – gli altri sono più o meno gravi. Viene, da Romans, un battaglione del 47° come rinforzo: si mette al cavalcavia. Il secondo delle cave si porta al valloncello e alle prime linee – transito micidiale per la pioggia delle granate austriache. Ma i feriti non tutti possono venire a questo posto di medicazione: preferiscono stare lassù, non fasciati anziché trovare la morte per via». Natura snaturata I resoconti, naturalmente, non possono non riguardare anche l’ambiente nel quale si svolgono le vicende narrate, ma qui le prospettive dei due narratori in parte divergono: mentre Virginia Marinaz guarda con occhi triste lo sconvolgimento della terra in cui è abituata a vivere, Don Cortese, che viene da lontano e ha altre origini, pur constatando le distruzioni e la presenza della morte, coglie la serenità e la bellezza della natura e l’inevitabile contrasto tra gli elementi del paesaggio. Scrive la Marinaz: «Lunedì di Pentecoste. Il silenzio delle campane ci annuncia lo stato di guerra; ora è qui, la guerra terribile e temuta. I nostri bei pacifici paesi risuonano al tuono dei cannoni e agli spari della fucileria. La popolazione è molto abbattuta, tutto è in agitazione, tutto, trema e piange. (…) La città [Gorizia] è immersa in un silenzio mortale, il tram elettrico non corre più; nessun rumore, tranne quello che fanno le truppe o le automobili militari mentre passano marciando; regna una calma inquietante». Annota invece Don Cortese: «Il solo che veglia è il monte santo [sulla cui sommità si trova un santuario dedicato alla Madonna, N.d.C.], a fianco a noi, in lontananza su Gorizia, con i suoi osservatorii potenti. Bianco si delinea sulle cime. Mentre un tempo era asilo di conforto e di pace, mentre a quest’ora l’anno scorso, vi risuonavano le note gravi della liturgia della quaresima e le sue campane, per i monti e per i piani, diffondevano la nota religiosa, oggi rammenta, forse, le artiglierie nemiche, che gittano nella vallata, da S. Lorenzo a Podgora, la morte e lo sterminio. E più indietro c’è la neve, i monti eterni e bianchi, una bianchezza che fa bene all’anima e sulla quale l’occhio, abituato a vedere tanto rosso di sangue, si posa tanto volentieri. E si snodano giocondamente, sempre bianchi, sempre solenni, fino a che si perdono nelle lontananze, al di là di Udine…Farra, invece, dal campanile smussato, dalle casettine distaccate, varie, mezze rovinate, pare voglia ridere, tanto s’intona con l’armonia della natura e par che stenda il suo braccio di casette bianche fino alla cittaduzza di Gradisca che specchia il suo convento intatto sul fiume. (…) E tutti, dal piccolo fantaccino, sentiamo quest’onda, questa luce, questa musica, questa gamma di colori, che è in contatto con la guerra, con il carnaio di questi giorni». Lo stile dei due autori è diverso. Il linguaggio del cappellano risulta infatti articolato, ampio, a volte colto, tuttavia, il suo scrivere non sembra destinato al pubblico, appare piuttosto una sorta di promemoria personale, con cui conservare le frequenti riflessioni di carattere religioso e umano. Consorzio Culturale del Monfalconese Nella Marinaz, invece, oltre all’evidente buona competenza linguistica (il testo originario è in lingua tedesca), si coglie una particolare attenzione a mantenere la scrittura fedele alle notazioni come erano state redatte sul momento, seppur contenenti delle trascuratezze dovute probabilmente alla fretta e alla mancata rilettura di quanto scritto. La fabbrica della morte Ciò che accomuna, invece, i due narratori è la meraviglia di fronte ai nuovi mezzi utilizzati da entrambi gli eserciti. Non va, infatti, dimenticato che la Grande Guerra è anche il primo conflitto moderno in senso stretto, in cui vengono impiegati su vasta scala le nuove tecnologie e i nuovi mezzi tecnici che l’industria mette a disposizione dei paesi belligeranti. Dal diario della Marinaz: «Dalla veranda della nostra abitazione vedevamo le bombe illuminati che rischiaravano tutto il campo, poi gli shrapnel e le granate che esplodevano sul monte Calvario. (…) Alle 3 siamo andati con un automobile accompagnate dal nostro capitano medico a Valvociana per visitare il treno dell’Ordine di Malta. Il treno è veramente magnifico e contiene tutte le comodità immaginabili, che si possono desiderare. Però la cosa più interessante di tutte è il cosiddetto “Dietro-il-fronte”, del quale non ci si può fare proprio nessuna idea se non lo si è visto. Una confusione di tende, cavalli, manzi, vagoni per le munizioni, cannoni, vagone per i viveri, un brulichio di soldati e malati: sul terreno aperto c’è un ospedale da campo improvvisato, dove ai feriti vengono cambiate le bende, prima di essere caricati sul treno. (…) Il viaggio è interessantissimo, si possono vedere le trincee, molti reticolati e altre fortificazioni vengono preparate per respingere un eventuale avanzata da parte del nemico. Ma ciò che è più interessante di tutto, è un cannone da 38 cm. che viene trascinato sulla superficie da circa 200 operai». Il treno affascina evidentemente la crocerossina, che vi dedica ancora altre righe: «Anche questa giornata appartiene a quelle memorabili, noi abbiamo visitato un treno corazzato, un privilegio, che non viene concesso a tutti. In compagnia del signor primario alle 5 del pomeriggio andammo fino al tunnel di Castagnevizza [oggi in Slovenia, nei pressi di Gorizia, N.d.C.], dove durante il giorno si fermava il treno. È magnifico, alla prima occhiata fa pensare a una gigantesca tartaruga. Si compone di 4 vagoni e alla locomotiva; i vagoni non hanno nessuna finestra, ma delle fessure, dalle quali durante la battaglia spuntano mitragliatrici e bocche di cannoni. Attraverso una piccola porticina si giunge all’interno; due vagoni hanno quattro, due sei mitragliatrici e due cannoni a tiro rapido prodotto dalla Skoda; un cannone automatico occupa l’ultimo vagone. Di sopra sul tetto si apre una finestrella per aprire il fuoco contro gli aeroplani. Naturalmente è tutto molto scomodo e anche il servizio è faticosissimo ma per la guerra un treno simile offre grossi vantaggi». Anche Don Cortese nota le novità che la guerra presenta: www.grandeguerra.ccm.it «Il nemico oggi sul Nad Logen e sulle posizioni del 20° davanti alla strada di Loevika si sbizzarrisce con tiri numerosi di grosse granate e shrapnel: Che intenzioni à? Il 20° à vari feriti e ancora qualche morto! Nelle prime ore di notte c’è in giro un aeroplano: si sente benissimo il rumore del motore. Si smorzano tutti i lumi: i battaglioni del 9° e 10° e del 29° attendati alle falde occidentali del Nad Logen fanno segni col fischietto per smorzare le candele. A furia di fischiare si vanno smorzando mano mano. E’ nostro, è loro? Dove andrà?». Non si può non fare caso a come gli uomini facciano presto ad adattarsi alle necessità imposte dalle nuove armi: si impara presto a spegnere le luci, a farsi invisibili agli occhi che d’alto possono scovare chiunque, non si sta a investigare se il velivolo sia nemico o meno, ci si affretta a nascondersi nel buio e a mettersi al riparo, tanto più che il rombo degli aerei incute spavento perché non si sa quali siano le conseguenze della loro presenza: «Nella serata passa un aeroplano nemico: à forse tirato delle bombe. Il fatto è che son caduti colpi nelle nostre vicinanze e noi siamo fuggiti da tavola». Certo, la guerra è sempre spaventosa, ma a renderla ancor più terrificante è l’uso delle armi di distruzione. Ancora Don Cortese: «Mattinata di operazioni di guerra questa: grande lancio delle nostre grosse bombarde per rompere i reticolati, sconvolgere trincee, per far la via alla fanteria che domani deve avanzare. Spettacolo terrificante - per rumori e per fumo. La loro artiglieria tira con grossi calibri, cercherebbe scoprire dove sono impostate le bombarde. A Cotici, verso mezzogiorno, tirano cinque granate di grosso calibro – di 280 certo. Tirano nelle nostre vicinanze. Momenti indescrivibili. Il Santo e il Sabotino sono dietro una cortina rossiccia di fumo. Il vento è favorevole al nemico: porta il fumo verso il Vallone prima e verso S. Michele poi: ci appanna il bersaglio mettendosi davanti alle batterie». E il giorno seguente: «Contrariamente a quanto dicevo jeri – questa mattina abbiamo la pioggia e la nebbia [siamo nei primi giorni dell’ottobre del 1916, N.d.C.]: una pioggerella fine, lenta, penetrante, fredda, una nebbia fitta, invadente, cinerea, dilagante Vallone (sic), e altipiano. Già il Santo e il Sabotino e tutta quella parte di vallata goriziana che si scorgeva da quì (sic), è scomparsa: è scomparso il Nad Logen: appena il Brestovic mostra tenuemente il suo cocuzzetto sonnecchiante – Verso Sinistra – Cotici e poi S. Michele, e la gobba di San Martino sono completi nell’ombra cinerea e malinconica. (…) Ma il fuoco è ricominciato lo stesso – impressionante: di artiglieria e di bombarde. Queste nostre bombarde danno un suono nuovo, differente da quello che dà lo scoppio della granata. E’ lacerante e terribile! Il fuoco però è più violento dalla parte di Monfalcone – fino da jeri sera. Anche l’artiglieria nemica tira di qua e di là – ma anch’essa che fare se il bersaglio è coperto? Qualche colpo cade nella strada di Devetake, qualche altro giù nella vallata. Anche il nostro 280 tira qualche colpo: la nostra baracca – trema, è scossa dalle fondamenta». Consorzio Culturale del Monfalconese Le operazioni proseguono e il lettore seguendo le vicende esposte nel diario si accorge che quanto più il tempo passa, tanto maggiore è la frequenza con cui Don Cortese ricorre al termine “spaventoso” fino a giungere alla seguente considerazione: «Dovrei usarne di più terribili se il vocabolario di questo mio cervello stanco ne avesse: bisogna esserci tra questa musica infernale!…E quelli che sono in prima linea? E gli austriaci? Non debbono esserci; altrimenti bisognerebbe ammettere l’impossibile: un organismo affatto impressionabile, un organismo anormale, una cocciutaggine che va fino alla pazzia. Speriamo quindi per il bene di tutti siano fuggiti. E dove? Nelle seconde linee? E ritorneremo al medesimo punto! Sprecare tanto materiale e stroncare tante giovinezze per una linea più o meno – non vale la pena». Epiloghi All’inizio del nuovo anno Don Cortese lascerà il reparto per raggiungere il battaglione alpino “Val Natisone” a Treviso, dove rimarrà fino all’estate del 1917, quando, ferito in zona di operazioni, verrà ricoverato all’ospedale di Cremona, per tornare poi in prima linea rimanendovi fino alla ritirata di Caporetto. L’altra nostra testimone, Virginia Marinaz, presterà servizio da crocerossina, anche nella seconda guerra mondiale, meritandosi, assieme alla sorella Enrica, numerose onorificenze da parte della Croce Rossa, dal governo austriaco e da quello italiano. A conclusione di questo contributo riportiamo le parole di Virginia Marinaz scritte in procinto di lasciare la sua città, caduta in mano italiana: «Cosa ne è della nostra città. Ovunque macerie e pietre sulle strade, dei cavalli morti sono distesi qui e non possono essere portati via. Si vede a stento della gente e quelli che si vedono sembrano degli spettri. Noi stesse possiamo appena reggerci in piedi, tanto queste ore terribili ci hanno spossato. Dopo le 11 vogliamo andare ancora in via vetturini (sic) per avere informazioni su una famiglia di nostra conoscenza. Noi corriamo, così come siamo, in abito da casa, mentre dappertutto ancora esplode. Velocemente facciamo la visita e corriamo a casa. Dietro di noi esplode ancora tutto terribilmente e siamo appena arrivati in Via Rastello che la Piazza Grande è piena di pesanti nuvole nere. Ci bombardano con granate da 28 cm. Dappertutto scoppi, ovunque cadono calcinacci e pietre sulla strada. La nostra fine è vicina. Un po’ prima delle12 vengono fatti saltare tutti i ponti, i nemici sono vicini alla periferia della città. (…) È stato tutto inutile. Siamo nelle mani del nemico». Infine, la famiglia Marinaz deve partire: «Nessuna persona, che non abbia vissuto una situazione simile, può comprendere cosa significa: dover lasciare in questo modo la propria casa, la casa alla quale sono legati molti ricordi belli e tristi, la casa, dove rimangono dei ricordi così preziosi, ricordi che ha conservato dall’infanzia con devozione. Io credevo si spezzasse il cuore quando salutai per l’ultima volta la mia stanza. (…) Come noi fuggivano anche molti altri. Povera gente, che cercava di mettere in salvo i suoi tesori: materassi, coperte, www.grandeguerra.ccm.it pentole addirittura maialini e polli vivi in un variopinto miscuglio caricato su carriole, accanto a cui si trascinavano dei bambini scalzi che piangevano. (…) Da quel momento in poi non avevamo più nessuna patria, nessuna casa. La nostalgia per Gorizia ci abbatteva, il solo pensiero di poter essere nelle vicinanze di questa amata città ci alleggeriva il cuore». Virginia ritornerà a Gorizia dopo Caporetto, ma lo spettacolo della città sarà ancor più terribile di quello che aveva lasciato: «Das ist die Umgebung der Stadt, welche früher als Rosenstadt bezeichnet wurde, als die Schmuckstadt, in Gartenanlagen überall bekannt. Wird sie nochmals auƒblühen?». («Questi sono i dintorni della città che in passato veniva indicata come la città delle rose, come la città famosa ovunque per i suoi giardini. Rifiorirà ancora?»). [Massimo Palmieri] Riferimenti bibliografici : - R. Lepre, Gente dell’Isontino e Grande Guerra: scritti e testimonianze di protagonisti (senza altre indicazioni) - C. Cortese, Diario di guerra (1916-1917), Rubbettino, Soneria Mannelli (CZ) 1998.
Scarica