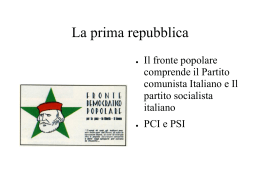FONDATA DA FILIPPO TURATI NEL 1891 DIREZIONE Ugo Finetti - Stefano Carluccio (direttore responsabile) Email: [email protected] Grafica: Gianluca Quartuccio Giordano Rivista di Cultura Politica, Storica e Letteraria Anno CXXII – N. 2-3 / 2013 GIORNALISTI EDITORI scarl Via Benefattori dell’Ospedale, 24 - Milano Tel. +39 02 6070789 / 02 683984 Fax +39 02 89692452 Email: [email protected] Registrazione Tribunale di Milano n. 646 / 8 ottobre 1948 e n. 537 / 15 ottobre 1994 – Stampa: Industria Grafica - Editoriale Pizzorni - IGEP srl - Via Castelleone, 152 - 26100 Cremona - Abbonamento annuo: Euro 50,00 Euro - 10,00 ■ UN DURO ATTO DI ACCUSA PER L’“IMPERDONABILE NULLA DI FATTO” IN MATERIA DI RIFORME SOPRATTUTTO DELLA LEGGE ELETTORALE DI FRONTE AD UN DRAMMATICO ALLARME RINNOVAMENTO DELLO STATO, CONTRO PULSIONI EVERSIVE ULTIMO AVVISO D “Dal discorso per il Giuramento di Giorgio Napolitano ai Grandi Elettori dopo la sua riconferma alla Presidenza della Repubblica”. Giorgio Napolitano È 9 POSTE ITALIANE S.p.A. Spedizione in a.p.D.L. 353/03 (conv. L. 46/04) Art. 1 comma 1, DCB Milano - Mens. 778000 057003 13002 emerso da tali incontri, nella mattinata di sabato, un drammatico allarme per il rischio ormai incombente di un avvitarsi del Parlamento in seduta comune nell’inconcludenza, nella impotenza ad adempiere al supremo compito costituzionale dell’elezione del Capo dello Stato. Di qui l’appello che ho ritenuto di non poter declinare per quanto potesse costarmi l’accoglierlo - mosso da un senso antico e radicato di identificazione con le sorti del paese. La rielezione, per un secondo mandato, del Presidente uscente, non si era mai verificata nella storia della Repubblica, pur non essendo esclusa dal dettato costituzionale, che in questo senso aveva lasciato - come si è significativamente notato - “schiusa una finestra per tempi eccezionali”. Ci siamo dunque ritrovati insieme in una scelta pienamente legittima, ma eccezionale. Perché senza precedenti è apparso il rischio che ho appena richiamato : senza precedenti e tanto più grave nella condizione di acuta difficoltà e perfino di emergenza che l’Italia sta vivendo in un contesto europeo e internazionale assai critico e per noi sempre più stringente. Bisognava dunque offrire, al paese e al mondo, una testimonianza di consapevolezza e di coesione nazionale, di vitalità istituzionale, di volontà di dare risposte ai nostri problemi : passando di qui una ritrovata fiducia in noi stessi e una rinnovata apertura di fiducia internazionale verso l’Italia. E’ a questa prova che non mi sono sottratto. Ma sapendo che quanto è accaduto qui nei giorni scorsi ha rappresentato il punto di arrivo di una lunga serie di omissioni e di guasti, di chiusure e di irresponsabilità. Ne propongo una rapida sintesi, una sommaria rassegna. Negli ISSN 1827-4501 a almeno tre anni abbiamo operato perchè nel sistema politico in declino nascesse una reazione vitale per favorire le riforme istituzionali con i caratteri essenziali delle trasformazioni sociali che la prima parte della Costituzione aveva indicato. La crisi dei partiti ha provocato la disfatta sociale, la disgregazione della coesione sociale e minaccia di travolgere le istituzioni. Un nuovo virus è penetrato nel corpo vivo della nazione: il fascismo mediatico. Un mezzo di comunicazione è diventato un fine, senza regole, senza guida e senza cultura politica. Questo virus ha intaccato tutti i partiti ed ha paralizzato i sindacati. La democrazia politica e sociale nelle sue forme storiche organizzate è senza ossigeno. Il Parlamento sempre più impotente ne ha preso atto e ha rivolto il suo disperato SOS all’anziano Capo dello Stato, ultimo figlio generoso e forte della grande generazione dei padri repubblicani. Napolitano non imporrà niente. Ha già dato molto e, forse, troppo. Ora sono i partiti che dovranno offrire la loro rivoluzione culturale. Se non lo faranno sappiano che il Presidente della Repubblica ha due pistole cariche: lo scioglimento delle Camere e la sua lettera di dimissioni. Se non sarà costretto ad impugnare queste armi vorrà dire che il fascismo telematico è stato distrutto nella sua fase ascendente più pericolosa. s Rino Formica PER ABBONARSI Abbonamento annuo Euro 50,00 c/c postale 30516207 intestato a Giornalisti editori scarl Banco Posta: IBAN IT 64 A 0760101600000030516207 Banca Intesa: IBAN IT 06 O 0306901626100000066270 E-mail: [email protected] Editore - Stefano Carluccio ultimi anni, a esigenze fondate e domande pressanti di riforma delle istituzioni e di rinnovamento della politica e dei partiti - che si sono intrecciate con un’acuta crisi finanziaria, con una pesante recessione, con un crescente malessere sociale - non si sono date soluzioni soddisfacenti : hanno finito per prevalere contrapposizioni, lentezze, esitazioni circa le scelte da compiere, calcoli di convenienza, tatticismi e strumentalismi. Ecco che cosa ha condannato alla sterilità o ad esiti minimalistici i confronti tra le forze politiche e i dibattiti in Parlamento. Quel tanto di correttivo e innovativo che si riusciva a fare nel senso della riduzione dei costi della politica, della trasparenza e della moralità nella vita pubblica è stato dunque facilmente ignorato o svalutato : e l’insoddisfazione e la protesta verso la politica, i partiti, il Parlamento, sono state con facilità (ma anche con molta leggerezza) alimentate e ingigantite da campagne di opinione demolitorie, da rappresentazioni unilaterali e indiscriminate in senso distruttivo del mondo dei politici, delle organizzazioni e delle istituzioni in cui essi si muovono. Attenzione : quest’ultimo richiamo che ho sentito di dover esprimere non induca ad alcuna autoindulgenza, non dico solo i corresponsabili del diffondersi della corruzione nelle diverse sfere della politica e dell’amministrazione, ma nemmeno i responsabili di tanti nulla di fatto nel campo delle riforme. Imperdonabile resta la mancata riforma della legge elettorale del 2005. Ancora pochi giorni fa, il Presidente Gallo ha dovuto ricordare come sia rimasta ignorata la raccomandazione della Corte Costituzionale a rivedere in particolare la norma relativa all’attribuzione di un premio di maggioranza senza che sia raggiunta una soglia minima di voti o di seggi. La mancata revisione di quella legge ha prodotto una gara accanita per la conquista, sul filo del rasoio, di quell’abnorme premio, il cui vincitore ha finito per non riuscire a governare una simile sovra-rappresentanza in Parlamento. Ed è un fatto, non certo imprevedibile, che quella legge ha provocato un risultato elettorale di difficile governabilità, e suscitato nuovamente frustrazione tra i cittadini per non aver potuto scegliere gli eletti. Non meno imperdonabile resta il nulla di fatto in materia di sia pur limitate e mirate riforme della seconda parte della Costituzione, faticosamente concordate e poi affossate, e peraltro mai giunte a infrangere il tabù del bicameralismo paritario. Molto si potrebbe aggiungere, ma mi fermo qui, perché su quei temi specifici ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione, vanificati dalla sordità di forze politiche che pure mi hanno ora La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7/08/1990 n.250 Continua a pagina 24 2 ■ CRITICAsociale 2-3 / 2013 IL LIBRO ■ L’INTRODUZIONE DAL LIBRO DI PAOLO FRANCHI SUL “SOCIALISTA” DEL PCI NAPOLITANO, DA BOTTEGHE OSCURE AL QUIRINALE H Paolo Franchi o intervistato per il «Corriere della Sera» Giorgio Napolitano un’infinità di volte, imparando subito a conoscerne, come tutti i suoi intervistatori, la proverbiale pignoleria: «Alla terza riga della quarta risposta, hai scritto: “dunque”. Ma a me sembra proprio di aver detto “quindi” ... », Almeno altrettante ho scritto di lui, delle sue posizioni politiche. dei suoi libri e anche del suo ottantesimo compleanno, festeggiato con una bella cena sulla fantastica terrazza di un ristorante al Campidoglio. È ospite di una trasmissione che conducevo alla radio, Radio Tre Mondo, sul finire del 2005, quando per la prima volta gli viene pubblicamente pronosticata, da un’amichevole radioascoltatrice, l’imminente ascesa al Quirinale, e lui smentisce ogni possibilità, ma prima ancora ogni personale interesse al riguardo. lo gli credo. Sbagliavo, ovviamente, quanto alle possibilità. Ma sull’assenza di ambizione personale penso di essere stato nel giusto. Napolitano, comunque, non l’ho conosciuto da giornalista. La circostanza esatta in cui ho parlato con lui per la prima volta non la saprei indicare con precisione: di sicuro risale a quaranta e passa anni fa, quando guidava la commissione culturale del Pci, e io, ventenne o poco più, ero il responsabile nazionale degli studenti comunisti. Di quel tempo ho, credo, una discreta memoria politica. Ma i miei ricordi di allora più vivi sul Nap, come lo chiamavamo, riguardano episodi che con la politica propriamente detta c’entrano fino a un certo punto. Storie minime, si capisce, visto che all’epoca Napolitano è uno dei dirigenti più autorevoli del partito, e io un giovanotto. Se mi sono rimaste impresse nella memoria, però, è perché le ho sempre trovate, nel loro piccolo, illuminanti. Mi ha detto con affettuosa ironia partenopea Raffaele La Capria - cui ho chiesto lumi, per questo libro, sul Napolitano giovane, anzi, giovanissimo, nella Napoli dei primi anni Quaranta - che, a pensarci su adesso, quello studentello di tre anni più giovane di lui, così a modo, così equilibrato, così per bene, era l’unico, tra gli studenti del liceo Umberto, per il quale si sarebbe potuto pronosticare (c’era ancora il fascismo, c’era ancora il re) un futuro da capo dello Stato. Non so se dai miei ricordi dovrei trarre un’analoga riflessione. Ma quando Napolitano, il lO maggio del 2006, è stato eletto presidente della Repubblica, nella lettera di congratulazioni e di auguri che gli ho inviato, una delle tantissime che gli sono piovute addosso in quei giorni, alcuni glieli ho (brevemente) rievocati. E nella sua (brevissima) risposta al mio messaggio il presidente ha voluto vederci « il segno di un’antica amicizia». Di cui vado, ovviamente, orgoglioso. Ma che ho cercato di non far pesare più di tanto nella scrittura di questo libro, Aprile 1972, campagna elettorale. Siamo a Nola, un grosso centro dell’entroterra napoletano. Nel settembre del ‘43, dopo lo sbarco di Salerno, qui c’è stato forse il più feroce eccidio tedesco nell’Italia meridionale, quattordici vittime, quasi tutti militari; poi, il primo di ottobre, i nolani si sono impadroniti di armi e munizioni custodite nella caserma dei Carabinieri, è scoppiata una mezza insurrezione e le truppe di Kesselring sono state costrette ad andarsene in tutta fretta. Ma la storia più recente, anche al cinema, parla d’altro. Della camorra, per cominciare: questa è la terra di Pascalone ‘e Nola e di Pupetta Maresca (testimoni di nozze del boss sono stati, nell’aprile del ‘955, Giovanni Leone e Silvio Gava), alla cui storia un vecchio amico di Napolitano, Francesco Rosi, ha dedicato un film famoso, La sfida, con José Suarez nel ruolo di lui, Rosanna Schiaffino in quello di lei. Quella sera di aprile del ‘972, sulla piazza centrale di Nola, dove Napolitano, il filosofo Biagio de Giovanni e il sottoscritto debbono arringare la folla, la camorra forse non c’è, o se, come più probabile, c’è, se ne sta sullo sfondo, tra i tanti cittadini che comunista non voteranno mai, ma sono venuti lo stesso, com’è d’uso nel Mezzogiorno, a sentire il comizio, perché all’epoca il comizio è ancora pure una forma, e non secondaria, di spettacolo popolare, e l’ars oratoria è apprezzata, avrebbe detto Totò, «a prescindere». Più vicino al palco, e sono in tanti, c’è un partito in gran parte tuttora bracciantile; e poi molti giovani, soprattutto studenti, perché la scolarizzazione di massa è arrivata anche qui, con le loro bandiere e i loro slogan. Il segretario della sezione locale, prima di salire sul palco, mi ha preso da parte per manifestarmi una preoccupazione e una richiesta, partendo da una premessa. La premessa è che «qui piacciono i toni forti». La preoccupazione è per Napolitano che, ovviamente, parlerà per ultimo: niente da dire sulle sue posizioni politiche, per carità, ma con quel suo eloquio così forbito, che concede così poco alla passione e alla pancia della piazza, rischia di raffreddare gli animi, quando invece bisogna riscaldarli. La richiesta, visto che il professor de Giovanni è, se possibile, ancora meno comiziante di Napolitano, è naturalmente per me: sei giovane, scaldali tu, i compagni. lo non mi faccio pregare, anzi, probabilmente (mi viene facile) esagero un po’: soprattutto i ragazzi applaudono, scandiscono le loro parole d’ordine, sventolano le loro bandiere, ma i «toni forti» qui funzionano benissimo anche con i compagni più stagionati. Poi, tocca a Napolitano. Proprio quel giorno «l’Unità» ha pubblicato una pagina intera di dichiarazioni di voto al Pci di docenti universitari, intellettuali, personalità dello spettacolo: il rito è antico, ma per molti dei firmatari è la prima volta. Il responsabile della commissione culturale le cita quasi tutte, si sofferma sul significato di questo o di quel messaggio, da ultimo tiene a precisare, siamo sempre a Nola, siamo sempre nel 1972, quanto piacere in particolare gli abbia arrecato, e qui il tono della sua voce si fa quasi musicale, la pubblica testimonianza di voto di uno storico eminente come il professor Ernesto Sestan. Comincio a preoccuparmi un po’, fino a qualche minuto prima ho inneggiato al Fronte nazionale di liberazione del Vietnam del Sud, e mi sono guadagnato un’ovazione (siamo negli anni della strategia della tensione) assicurando gli astanti che i reazionari non dovevano illudersi, perché saremmo stati in grado di rispondere loro «su tutti i terreni». Preoccupazione infondata. Napolitano, esaurito l’elenco degli intellettuali, rafforza i toni del suo discorso abbastanza da mandare a casa soddisfatto il pubblico. Poi, sebbene siano passate le dieci, e lui non sia certo un nottambulo, mi invita a cena in città, anche perché, dice, magari sarò un po’ estremista ma, visto che sto sopravvivendo da settimane a Napoli con la povera diaria della Federazione giovanile, avrò pure diritto a un pasto come si deve. Non ricordo di che cosa abbiamo parlato a cena, soprattutto di politica, immagino. Ricordo però bene il suo atteggiamento: l’atteggiamento di chi non parla soltanto, ma ascolta anche, prova a spiegare, ma cerca pure di capire le ragioni dell’interlocutore. La cosa, tra i dirigenti comunisti, non è poi così frequente. Può darsi che, quella sera, gli sia sembrato un po’ diverso, migliore, rispetto all’aspirante demagogo che dovevo essergli parso in piazza. Se è così, qualche mese dopo, sarà stato settembre, devo avergli dato una delusione. In agosto, in vacanza sulla Costiera amalfitana, a Praiano, mi sono lasciato crescere, per estiva pigrizia, la barba che, tra l’altro, porto ininterrottamente da allora. Quando, di ritorno, vado a trovarlo nel suo ufficio al quarto piano delle Botteghe Oscure, mi guarda più allibito che perplesso, e non mi nasconde, seppure in tono semiserio, la sua contrarietà. La barba .. un cedimento così grave allo spirito del tempo, da me, che gli avevo dato l’impressione di essere una persona seria, non se lo sarebbe mai aspettato. Qualche punto, forse, almeno sul piano personale, l’ho recuperato poco più di un anno dopo in Piemonte, a Torre Pellice, dove entrambi eravamo stati convocati dall’infaticabile Piero Fassino, allora segretario della Fgci torinese, per un seminario degli studenti comunisti del Nord. La data, in qualche modo, conta: 28 settembre del 1973. Di primo mattino, Fassino e io aspettiamo, nell’atrio sgangherato della federazione comunista torinese, in via Chiesa della Salute, l’automobile che ci deve portare a Torre Pellice. Per terra, ancora nel cellophane, ci sono pacchi di copie dell’ultimo numero di «Rinascita» appena scaricati dai camion. È un numero importante perché ospita il famoso articolo di Enrico Berlinguer sul compromesso storico. Ne facciamo una rapida lettura trasversale, io molto colpito, e alquanto perplesso, Fassino meno. Poi, partiamo. Nel seminario valdese che ci ospita, Napolitano è arrivato direttamente da Roma. Fassino, che tiene molto al rapporto con la comunità valdese, ci spiega le severe regole della casa: l’ospitalità è spartana, ma è opportuno mangiare e dormire lì. Napolitano risponde che non c’è problema, e io, ovviamente, mi adeguo. Ma non possiamo sapere né come si mangia né soprattutto quanto freddo, e freddo feroce, fa. Così che a sera, terminata la prima giornata di lavori, ciascuno con la propria valigetta, e all’in- CRITICAsociale ■ 3 2-3 / 2013 saputa dell’altro, ci ritroviamo davanti al cancello del seminario: avevamo adocchiato, arrivando, una piccola locanda in paese, e la tentazione di raggiungerla si è rivelata irresistibile per entrambi. Credo di essere stato, da giovanotto, uno dei pochi che abbiano condiviso così con Napolitano il piacere della trasgressione: ricordo quel vago senso di complicità meglio del classico menù piemontese della cena e della calda trapunta sul mio letto. Parliamo, a tavola, anche dell’articolo di Berlinguer, Se ha dei dubbi (ma penso di no), non li manifesta certo a me, Che, oltretutto, porto la barba. I VECCHI E I GIOVANI «Il presidente della Repubblica lo farà Giorgio.» Manca ancora una settimana all’inizio delle votazioni, ma Emanuele Macaluso, al quale ho chiesto lumi sull’imminente corsa per il Quirinale, sembra proprio non avere dubbi. So bene quanto sia amico di Napolitano, ma so pure che Emanuele è testa politica fine, una delle pochissime rimaste in circolazione. Quindi, sebbene il nome di Napolitano, nelle ore della vigilia, non circoli affatto, prendo mentalmente nota. Oltretutto, il primo a farmelo non è stato lui, bensì, qualche giorno prima, un altro vecchio, lucido combattente della sinistra italiana, il socialista Rino Formica, che con Napolitano ha un antico e collaudato rapporto, di quelli in grado di reggere al brusco mutare delle stagioni politiche. E io Formica lo sto a sentire, perché non è solo molto più appassionato, ma anche parecchio più informato di tanti giovanotti, o ex giovanotti, che calcano le scene della cosiddetta Seconda repubblica. Con Napolitano, Macaluso ha vissuto tutta la storia dei miglioristi e poi dei riformisti: e, prima ancora, la storia del Pci, sin dai giorni della Liberazione. Sono stati entrambi, per formazione, homines togliattiani, e forse in un certo senso, seppur convertiti da un pezzo (Napolitano sicuramente per primo) al socialismo democratico, seppure fatti oggetto nel loro vecchio partito, tra il 1989 e il ‘994, di una campagna martellante Ce infamante) che li rappresenta come una specie di quinta colonna di Bettino Craxi, lo sono ancora. Formica proprio no, la sua storia nella sinistra italiana, dal giovanile Ce mai del tutto dismesso) trotz-kismo al craxismo irrequieto degli anni della maturità, è tutta diversa. Con Napolitano, ha condiviso prima una tenace resistenza al dilagare della guerra civile, a sinistra, tra comunisti e socialisti; poi, probabilmente fuori tempo massimo, il tentativo di trovare la strada di una ricomposizione unitaria. Ma, se gli chiedi cosa pensi di lui, comincia con una citazione che attribuisce, con ogni probabilità arbitrariamente, a Giuseppe Stalin: «L’inflessibilità del comunista consiste nella capacità di oscillare allo stesso ritmo della linea del partito». Poi, alla citazione fa seguire una domanda: «E quando non ci sono più né la linea né il partito, come fa a oscillare un figlio dell’aristocrazia intellettuale napoletana, di formazione crociana, togliattiano di destra più ancora che amendoliano? Gli restano due ancoraggi soltanto, ma molto forti. Il primo se lo è conquistato in prima persona, sulla scia di Giorgio Amendola: ed è l’Europa. Quanto al secondo, capisco che qualcuno salterà sulla sedia, ma, almeno in parte, glielo ha lasciato in eredità, basta rileggere i suoi interventi alla Costituente, Palmiro Togliatti: ed è il costituzionalismo liberale» .1 Macaluso e Formica non sono più in Parlamento da un pezzo: per estese che siano le loro frequentazioni, e tuttora intensi i loro rapporti politici, è difficile rappresentarli come i grandi elettori di Napolitano. E sarà stata sicuramente una pura coincidenza, il fatto che a farmi per primi il nome del (quasi) coetaneo Napolitano per il Quirinale siano stati loro. Ma a me piace vedere in questa coincidenza anche qualcosa di emblematico. Non certo una congiura di ottuagenari. E neppure una specie di vendetta della parte migliore della sinistra storica e, più in generale, della Prima repubblica sulla Seconda, entrata in agonia prima ancora di essere venuta compiutamente al mondo (e già questa, non lo nascondo, sarebbe una discreta soddisfazione). Quanto, piuttosto, il manifestarsi, ora sì, di qualcosa di effettivamente inedito, o comunque di largamente inesplorato: di una possibile alleanza riformatrice tra i nonni e i nipoti, che, per cominciare, accompagni più o meno cortesemente alla pensione, riforma Fornero permettendo, la gran parte di una generazione (forse quella del Sessantotto; di sicuro la mia). Una generazione che, non essendo riuscita a prendere il potere con le cattive, prima lo ha circuito spregiudicatamente, lasciandosi però sedurre persino dai suoi segni esteriori; poi, quando, ormai con i capelli grigi, lo ha finalmente avuto, e senza particolari meriti, ne ha fatto un uso ora duro ora tragicomico, ma sempre strumentale, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Dei giovani, da presidente, Napolitano ha parlato molte volte, e non retoricamente. Non saprei dire, però, se condivida o no questa mia personalissima tesi. In tre circostanze soprattutto mi ha dato l’impressione di sì. La prima volta è il 22 dicembre del 2010, quando accetta di ricevere al Quirinale una delegazione del movimento degli studenti in lotta contro il disegno di legge del ministro Gelmini, con la sola condizione che cessassero subito le violenze e gli scontri di piazza. Non farà proprie, ovviamente, le posizioni degli studenti, ma li ascolterà con un’attenzione vera, e si sorprenderà anche un poco della loro disponibilità: nel ‘968, o nel ‘977, a nessun giovane contestatore sarebbe passato per l’anticamera del cervello di chiedere udienza al presidente della Repubblica; persino quelli che accettarono di partecipare a una discussione con il segretario del Pei, Luigi Longo, vennero duramente criticati. La seconda volta è nel novembre del 2011, quando, facendo tornare alla mente dei più anziani il suo antico maestro Amendola alle prese con il Sessantotto, coglie l’occasione niente meno che della Giornata dell’ Albero per bacchettare un po’ i ragazzi e le ragazze convenuti al Quirinale: «Organizzatevi come studenti e, se permettete, organizzatevi non solo per dire dei no a come vanno la scuola e l’università, ma per fare proposte, sollecitare scelte, indicare le necessità vitali per lo sviluppo del Paese». La terza è il 23 maggio del 2012, ventesimo anniversario della strage di Capaci, quando, a Palermo, visibilmente si commuove, strappando un applauso caldo e sincero alla platea, mentre si appella ai giovani affinché compiano il loro apprendistato civile, aprano porte e finestre, scendano al più presto in campo. Non sono mancate in altri casi, naturalmente, le contestazioni nei suoi confronti di gruppi più o meno estesi di giovani. Ma, in queste circostanze, Napolitano ha sempre risposto per le rime. Com’è giusto che sia, per chi cerca un confronto vero, non un consenso formale. LEIBNIZ E BILDERBERG Napolitano è ministro degli Interni del primo governo Prodi, quando, il 19 giugno ‘997, gli viene conferito, ad Hannover, un premio prestigioso, il Leibniz-Ring. Raramente, che io sappia, la motivazione di un premio «per l’opera di una vita», di un premio alla carriera, insomma, è stata più puntuale nel mettere a fuoco i meriti e le caratteristiche del premiato. Recita così: «In tutti questi anni si è impegnato in modo sistematico e flessibile, e con successo, nell’indirizzare la politica italiana in senso europeistico; e ha contribuito in grande misura all’avvicinamento del Pci alla sinistra europea e a quella che si può chiamare la “socialdemocratizzazione” dei comunisti italiani». E si conclude rimarcando, tra i tratti distintivi dell’uomo, la «riflessività», la «predisposizione al dialogo», 1’« apertura antidogmatica». Sistematico, flessibile, riflessivo, dialogante, aperto, antidogmatico. Sono tutti aggettivi importanti, che sotto ogni cielo qualificano, o dovrebbero qualificare, gli esponenti di maggior rilievo non di una casta, ma di classi dirigenti al passo con i tempi, aperte, inclusive: quelle élites la cui latitanza è forse l’aspetto più grave, e inquietante, della crisi italiana. Altrove, questi aggettivi sono indubbi titoli di merito. Da noi, no. Talvolta, anzi, alimentano addirittura sospetti, dicerie, qualcosa di simile a moderne, o postmoderne, leggende nere. 0, per meglio dire, rosso-nere. Nel senso che a raccoglierle e a rilanciarle, soprattutto ma non solo sul web, sono gruppi e personaggi magari agli antipodi, eppure accomunati dal culto ossessivo delle più diverse e strampalate teorie del complotto, segugi sempre lanciati sulla pista di qualche cospirazione, meglio se mondiale, contro la libertà degli individui e delle nazioni. Napolitano non ne è certo risparmiato, alcune, anzi, lo accompagnano sin dai primi passi in politica. La più antica, e la più nota, è quella che, per via di una forte rassomiglianza fisica, lo vuole figlio naturale di Umberto, il re di maggio. Sembrava se ne fossero ormai smarrite le tracce, ma è tornata come d’incanto a materializzarsi quando è stato eletto presidente della Repubblica: di nuovo un Savoia al Quirinale. Poi c’è la storia, chiamiamola così, di un Napolitano che non sarebbe così «anglosassone» (e quindi sistematico, flessibile, predisposto al dialogo e via elencando) solo per stile, gusti, inclinazioni culturali, ma anche per antichi, più o meno oscuri legami con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna: legami risalenti addirittura alla Napoli appena liberata del ‘944’945, mai del tutto interrotti nemmeno nei tempi più duri della guerra fredda, pienamente riattivati negli anni Settanta, quando l’attuale capo dello Stato è, tra i dirigenti comunisti, il primo a ottenere il visto per gli Stati Uniti. Più o meno allo stesso filone, infine, appartengono le teorie che indicano in Napolitano una specie di garante, e in Monti il rappresentante, di potentissimi circoli internazionali in cui, manco a dirlo, giocherebbero un ruolo primario la massoneria e, si capisce, gli ebrei (un tempo era in gran voga la Trilaterale; poi le attenzioni dei cospirativisti si sono in parte spostate sull’Aspen Institute; adesso, soprattutto sulla rete, spopola il Club Bilderberg) che tramano, con fortune crescenti, per sostituire il dominio internazionale della grande finanza al potere, ormai allumicino, degli Stati nazionali. In un Paese che ha tante pagine bianche, tutte ancora da scrivere, nella sua storia, ma è affollato di gente, importante o minuta, che la sa lunga o almeno vuole fartelo credere, le leggende, anche le più strampalate, sembrano non morire mai. Si inabissano, magari, ma poi tornano d’improvviso a galla, arricchite di nuovi particolari, non fa nulla se stravaganti, e di presunte pezze d’appoggio; e si combinano tra loro fino a prendere le fattezze di un’unica pseudostoria, del tutto indifferente ai vincoli dello spazio e del tempo, Se di populismo si tratta, è un populismo che non fa proseliti soltanto tra i semplici. In una bella serata d’estate ho conosciuto un autorevole banchiere, il quale, davanti ad altrettanto autorevoli commen- sali, mi ha chiesto, dando per scontata una mia risposta affermativa, se sapessi che Napolitano è da sempre, o quasi, un uomo degli americani. Quando gli ho risposto di no, contestandogli pure, cortesemente, questo modo di discutere delle persone e dei problemi, mi ha guardato sorpreso. E mi ha domandato se non ero neppure a conoscenza del fatto che Napolitano aveva condotto per mano Silvio Berlusconi alle dimissioni, e portato Monti a Palazzo Chigi, su mandato imperativo del presidente degli Stati Uniti. Alla mia seconda risposta negativa, con le ulteriori contestazioni di merito e di metodo annesse, ho avuto chiara l’impressione che mi considerasse uno sprovveduto totale. O peggio. Si tratta, ovviamente, di sciocchezze; anche se di una specie particolare e pericolosa, soprattutto in tempi di crisi, quando chi prova a ragionare, a distinguere, a storicizzare rischia di passare per scemo o per complice, e i dietrologi non faticano a trovare adepti più o meno interessati, perché, se siamo così inguaiati, vuoI dire che da qualche parte ci deve pur essere una potente Spectre che trama incessantemente contro di noi. Ma, per la parte che, direttamente o indirettamente riguarda Napolitano, viene da chiedersi perché mai, si tratti del principe Umberto o del club di Bilderberg, ai complottologi di turno venga più facile associarlo ai disegni oscuri di grandi poteri sovranazionali che, per esempio, a qualche capitolo ancora inedito del Libro nero del comunismo. C’entra, sicuramente, la diffusa avversione (in parte, temo, meritata), per le élites, che si mescola, formando una miscela esplosiva, a quella, dilagante, per la politica e i politici. Non c’è al mondo, credo, e comunque di sicuro non c’è in Italia, un ex comunista (perché così si è più volte definito Napolitano, anche di fronte a interlocutori della stazza di Henry Kissinger: aformer communist, non un pallido postcomunista) che si muova, e non da oggi, nell’establishment politico, economico e culturale mondiale come se ne facesse parte da sempre, senza incontrare mai qualche obiezione da parte dei protagonisti e dei comprimari per così dire «storici» dell’establishment in questione. Per chi lo descrive partecipe Co succubo) di una qualche congiura universale, naturalmente, questa è una specie di prova regina. Per chi invece alle congiure universali non crede, e a una partecipazione di Napolitano alle medesime ovviamente meno ancora, fermarsi a riflettere un attimo su questa banalissima domanda può essere utile, può aiutare, forse, anche a comprendere meglio la cifra del personaggio. O addirittura «l’opera di una vita», la sua. LA SCUOLA NAPOLETANA N apolitano delle élites italiane ha sempre, in un certo senso, fatto parte. Anche ai tempi del Pci. C’entrano, non c’è dubbio, la sua origine sociale (un tempo si sarebbe detto: di classe), la Napoli di Benedetto Croce e di Giorgio Amendola, le buone letture. Non è una storia a sé: tra i giovani della sua generazione che scelgono l’impegno a tempo pieno nelle federazioni o nei giornali del Pci, e spesso percorrono il cursus honorum sino ai gradi più alti, gli intellettuali di matrice alto, medio e piccolo borghese sono tanti. C’è un filo che unisce molti di loro, e li rende diversi dai compagni cresciuti nella clandestinità, nelle galere, nell’emigrazione a Mosca. Non tanto il mito di Stalin, che pure c’è, eccome. Quanto, semmai, quello di Stalingrado. La convinzione cioè, o l’illusione, che, con la vittoria sul nazismo e sul fascismo, sia giunto il tempo non della rivoluzione mondiale, ma di una stagione nuova di democrazia e di giustizia: «Molti giovani in 4 ■ CRITICAsociale Italia divennero comunisti, riconoscendo in quel partito la forza politica che aveva dato il contributo maggiore [...] alla lotta antifascista, e che esprimeva la maggiore capacità di mobilitazione sociale. Si respirava un’atmosfera di unità della sinistra e di unità nazionale. Appariva possibile un’ evoluzione democratica in tutta Europa, sembrava aprirsi la più ampia prospettiva di unità europea. Quando cala anche in Italia la cortina di ferro, e arriva il tempo della contrapposizione frontale sul piano ideologico, politico e, prima ancora, militare, quasi nessuno di questi giovani dà particolari prove di anticonformismo: se in questo clima si sentono stretti, in attesa di tempi migliori, non lo danno a vedere. Napolitano non fa eccezione. In questi anni bui, semmai, si segnala per una concezione della politica (e forse del mondo) cui resterà fedele a lungo. Mai uno scarto improvviso, mai un coinvolgimento pericoloso in qualche avventura della dialettica. Piuttosto, appena se ne dà la possibilità pratica, un procedere lento pede sul cammino del togliattiano «rinnovamento nella continuità», e un perfezionamento sempre crescente negli «esercizi di dialogo» in cui il Pci comincia a impegnarsi, prima in Italia, poi, molto prudentemente, nel mondo, già all’indomani della sconfitta della legge truffa, nel ‘953. Lo caratterizzano il fastidio ostentato, verrebbe da dire di pelle, verso ogni forma di radicalismo, il culto dell’understatement, la pignoleria al limite del maniacale nel pesare le parole e persino le virgole. Nonché, certo, la riluttanza a dare battaglia in campo aperto, anche quando ad accendere le polveri è Amendola, massimo punto di riferimento di quella «scuola napoletana» di cui Napolitano, assieme a Gerardo Chiaromonte, è molto più di un allievo brillante. Scarsa predisposizione alla lotta politica, connaturata tendenza a non distaccarsi dal gruppo e a tenersi lontano dalla soglia oltre la quale non si fa più parte di quel vasto centro che, quasi per definizione, governa il partito, non solo a Roma? Di contestazioni e di critiche di questo tipo, parecchi anni, anzi, vari decenni più tardi, Napolitano ne riceverà molte, anche da parte di alcuni esponenti di primo piano di quell’area «migliorista» prima, «riforrnista» poi del Pci-Pds di cui è stato il capo naturale: «Il coraggio non sa nemmeno dove sta di casa» dirà di lui, nel momento di una dolorosa rottura, anche personale, Napoleone Colajanni. Ne parleremo. Ma intanto resta il fatto che nel Pci di Togliatti, e anche, almeno sino alla fine degli anni Settanta in quello dei suoi successori, queste sono considerate virtù, anzi, virtù cardinali, buone per il tempo della guerra di posizione e tanto più per quell’imprecisato domani in cui finalmente si ravvicinerà una prospettiva di governo: è solo praticandole rigorosamente («Via i pagliacci dal campo della lotta») che un partito non plebeo e nemmeno operaista, certo, ma comunque in primo luogo espressione delle classi subalterne, può ambire a diventare forza dirigente del Paese. La disciplina di partito è dura, ma forse l’autodisciplina individuale e collettiva, o se si preferisce l’autocensura, conta anche di più: praticare queste «virtù», prima che un dovere, è un costume politico e intellettuale. Che si incrina nei passaggi più drammatici (salvo poi faticosamente ricomporsi) quando ciascuno o meglio, chiunque abbia l’autorevolezza per farlo - dà più sfogo alle proprie inclinazioni e al proprio carattere. Rossana Rossanda ricorda bene, mettendoci anche un po’ di veleno, le visite a Milano di quei dirigenti meridionali e meridionalisti che all’epoca le paiono sin troppo influenti, sul piano culturale prima ancora che su quello politico, nel partito: «Nel 1956 2-3 / 2013 [...] Alicata meridionalista si batteva per un partito rinnovato, così sembrò e a Milano anche fu, con il risultato che c’è di lui una immagine persecutoria a Roma e una diversa in noi settentrionali. Non che fosse un mite né liberale, non lo era per niente neanche Amendola - ma Alicata era spagnolesco, appassionato, rischiatutto, con un gusto dell’impopolarità, Amendola freddo, ragionante e calcolatore, capace di menare una sola botta ma decisiva, “alla bolscevica” [...]. Alicata si spostava su e giù per l’Italia seminando spavento, Amendola si accattivava i più con quel fare da gran borghese comunista. Veniva spesso con Giorgio Napolitano, cortese e annuitore. SIAMO UNA MINORANZA C ortese, Napolitano lo resterà sempre. «Annuitore», ammesso che, sulla trentina, lo sia stato, no. Arriverà anche il momento, a cavallo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, in cui comincerà, seppure a modo suo, a puntare i piedi, e a far sentire il proprio dissenso, a costo di ritrovarsi, se non fuori, ai margini del sancta soncrorum. L’atto iniziale - cosa abbastanza clamorosa per lui, e anche per i tempi, considerando che all’epoca il confronto interno al Pci è ancora così cifrato che i giornalisti più versati nel ramo si fregiano del rango di «bottegologi» - è un articolo in prima pagina sull’e Unità»: anche senza essere «bottegologi» si comprende facilmente che il principale bersaglio delle sue critiche è Berlinguer. Ma attenzione. Quell’articolo, che esce il 21 di agosto del 1981, a mo’ di commemorazione del Migliore nel diciassettesimo anniversario della morte, si intitola: Perché è essenziale il richiamo a Togliatti. Ed è a colpi di citazioni di Togliatti - il Togliatti che ha insegnato al partito a tenere ben distinta la politica dalla propaganda, a evitare le «pure contrapposizioni verbali» e le «vuote invettive», nonché ad applicare un metodo, quello dell’«analisi differenziata», fondamentale per evitare il grave errore «di non saper distinguere cose diverse» - che Napolitano contesta la linea del segretario generale. Un paradosso? Forse sì, ma fino a un certo punto. Negli anni della solidarietà nazionale, gli homines togliattiani della destra comunista, da Paolo Bufalini a Chiaromonte, da Napolitano a Macaluso allo stesso Luciano Lama, non sempre hanno marciato all’unisono, ma comunque hanno contato moltissimo nella politica del partito. A unirli, al di là di ogni divergenza, è stata l’idea che l’ingresso nell’area di governo rappresentasse il primo, fondamentale compimento di una lunga, difficilissima marcia, iniziata fin dal ritorno in Italia di Togliatti nell’ormai lontanissimo 1944. Della politica di unità nazionale hanno vissuto prima le speranze, poi le difficoltà, infine la crisi, diventata drammaticamente evidente già tra il 16 marzo e il 9 maggio del 1978, cioè tra il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro. Alcuni (è il caso di Chiaromonte, non di Napolitano) hanno convenuto con Berlinguer sulla necessità di chiuderla il prima possibile, pena un rapido, inarrestabile declino di un Pci sempre più insofferente all’idea (l’immagine, desunta dal titolo di un’opera teatrale del drammaturgo russo Leonid Andreev e di un famoso film muto degli anni Venti, è di Eugenio Scalfari) di interpretare il ruolo dell’e uomo che prende gli schiaffi». Ma adesso tutti avvertono, seppure non tutti con la medesima chiarezza, che, abbandonata quella strategia dalle radici antiche, il Pci si ritrova, per la prima volta, privo di una qualsiasi prospettiva politica, ed esposto al rischio, ai loro occhi esiziale, di ritrovarsi esposto alle sirene di un massimalismo impotente e di un radicalismo verbale che hanno combattuto per tutta la vita come dei pericoli mortali. È qualcosa più di un dissenso politico, o della denuncia di un cambio degli equilibri (dal centro-destra al centro-sinistra) al vertice del Pci, la contestazione mossa da Napolitano sull’e Unità» a Berlinguer. È un segnale esplicito di allarme sulle sorti di un partito, il suo, di cui considera messi pericolosamente in discussione, assieme ai passi avanti compiuti nell’ultimo decennio, alcuni tratti distintivi, politici e culturali, considerati a lungo, forse a torto, come qualcosa di acquisito e di maturato in profondità. Da quel 21 di agosto del 1981 tutti sanno che i contrasti nel gruppo dirigente comunista non solo esistono, ma non sono più pudicamente ascrivibili alle diverse «sensibilità» presenti al suo interno: prima e, soprattutto, dopo la morte di Berlinguer, nel 1984, saranno proprio questi contrasti, sempre meno sotterranei, a fare la storia del Pci, che è la storia di una crisi di identità e di prospettive di gran lunga precedente la caduta del Muro di Berlino, nel 1989, e la successiva «svolta» di Achille Occhetto. Ma una cosa sono i contrasti, ancorché ricorrenti, e spesso, come vedremo, pure assai aspri, e talvolta clamorosi, un’altra è una lotta politica chiara e conseguente. Quest’ultima non ci sarà, in realtà, nemmeno dopo la costituzione dei «riformisti» in corrente, in ultima analisi perché Napolitano non la apre: per indole, per realistica valutazione dei reali rapporti di forza, per riluttanza ad assumersi la responsabilità di incrinare il bene, considerato fino all’ultimo prezioso, dell’unità del partito, per tutti questi motivi insieme, o per qualche altro motivo ancora. È una storia che da giornalista del «Corriere» ho seguito molto da vicino quasi giorno per giorno: e in questo libro, posto che possa interessare ancora qualcuno, provo a raccontarla, soffermandomi anche su qualche dettaglio inedito, o pressoché sconosciuto ai più. Dovessi anticiparne una morale, ammesso che una morale ci sia, direi che la cosiddetta «pavidità» di Napolitano, «coniglio bianco in campo bianco», secondo la nota, sarcastica definizione di Giuliano Ferrara, sia un luogo comune. E, anche se la cosa può sembrare alquanto rétro, tornerei piuttosto alla massima antica di Romain Rolland, di cui chi in Italia è stato comunista si è nutrito, nell’interpretazione di Antonio Gramsci, fin da ragazzino. A un «pessimismo dell’intelligenza» che, con il trascorrere degli anni, si fa in Napolitano sempre più marcato. E nello stesso tempo, non contraddittoriamente, a un «ottimismo della volontà» che lo induce comunque a stare sempre puntigliosamente «sul pezzo»: si tratti della collocazione internazionale del partito o dei rapporti con Bettino Craxi e i socialisti, della politica economica o, nei giorni delle picconate di Francesco Cossiga, di quella istituzionale. Due esempi soltanto per spiegarmi. Il primo risale a più di vent’anni fa. Dice lapidario Napolitano il 28 dicembre del 1989, nelle settimane drammatiche successive alla caduta del Muro, davanti a un consesso di miglioristi divisi tra chi vuole, come lui, associarsi, seppur «motivatamente», alla svolta di Occhetto, e chi invece ritiene che non basti e occorra dare battaglia in autonomia, su una linea apertamente socialdemocratica, di non essersi mai illuso su uno spostamento nel partito verso posizioni socialdemocratiche. I riformisti erano e restano una minoranza. E una minoranza può scegliere solo tra testimoniare (una prospettiva che non lo appassiona affatto) o cercare, nei limiti del possibile, di condizionare la linea generale. Sempre che, naturalmente, una linea generale ci sia: la qual cosa, negli anni delle segreterie di Occhetto prima, di Massimo D’Alema poi, è, quanto meno, tutta da stabilire. Un secondo esempio è molto più recente. Nel giugno del 2012, alla vigilia di una visita di Stato a Varsavia, Napolitano concede un’intervista ad Adam Michnik, direttore del più importante giornale polacco, la «Gazeta Wyborcza». Non è «solo» un giornalista, Michnik, esponente storico del dissenso polacco, figlio di un ex segretario dei comunisti dell’Ucraina occidentale, fondatore nel 1976, con Jacek Kuron, del Kor, il comitato di difesa degli operai polacchi: proprio in quella veste Napolitano lo ha incontrato per la prima volta trentacinque anni fa. Gli chiede, Michnik, che ha conosciuto le galere democratico-popolari della Polonia, se, parlando degli «errori» del passato, intendesse riferirsi all’età staliniana. E lui: «Intendo il periodo in cui ero membro attivo di un Partito comunista che non era un partito stalinista come molti altri, in quanto aveva una fondamentale matrice antifascista e democratica e comprendeva forti componenti liberali, ma era pur sempre nato nel solco dell’Internazionale comunista, e quindi portava nel suo Dna il mito dell’Unione Sovietica e il legame con il movimento comunista mondiale. Questi elementi originari, a un dato momento, sono diventati una prigione dalla quale il Pci doveva liberarsi. SOTTO I MURI CHE CROLLANO N on c’è dubbio che, anche da «ministro degli Esteri» di un Pci ormai non più stalinista da un pezzo, Napolitano si sia spinto molto in là nel predisporre i piani di fuga da questa prigione, e per non lasciare i fuggiaschi in una terra di nessuno, cercando rifugio invece nel socialismo europeo. Non un minuto prima, ma un minuto dopo la caduta del Muro di Berlino, il grosso del Pci è riuscito comunque, grazie al coraggio (qualcuno dice alla temerarietà, altri addirittura alla più o meno lucida follia) di Achille Occhetto, a fuggire dalla «prigione», o meglio a evitare di restare intrappolato sotto le sue macerie. Non solo: grazie all’avallo concesso in extremis da un Craxi ormai peggio che periclitante, il nuovo partito postcomunista, il Pds, riuscirà pure, nel 1992, a entrare a far parte a pieno titolo dell’Internazionale socialista, conseguendo così l’obiettivo - un obiettivo storico - cui Napolitano ha lavorato con pazienza certosina per tanti anni. Paradossalmente però il Pds, socialista, o socialdemocratico, in Europa e nel mondo, in Italia non solo non si chiama così, e non ha nel proprio simbolo il più vago riferimento al socialismo o al laburismo, ma non si considera e non vuole essere considerato tale. Solo perché nell’Italia di allora dire «socialista» è come dire Craxi, o craxismo, con tutto quello che ne consegue? Certo, anche in questa scelta pesano, eccome, gli effetti della lunga e feroce guerra civile a sinistra che ha imperversato in Italia per tutti gli anni Ottanta; e ancor più pesa il fatto che l’età dell’ oro craxiana, se mai c’è stata davvero, sta finendo nel peggiore dei modi. Ma il gran rifiuto del Pci-Pds, e in primo luogo della giovane guardia berlingueriana che con Occhetto è andata al potere, ad alzare bandiera socialista ha radici più profonde, più antiche: probabilmente inestirpabili. Lungo tutto il decennio precedente, quello della guerra civile, Napolitano non ha cercato solo di individuare, di volta in volta, le tregue e gli armistizi possibili. Ha lavorato, spes contra spem, per tenere aperta la strada opposta, quella di una ricomposizione unitaria della sinistra italiana sull’unico terreno possibile, quello della socialdemocrazia e del riformismo. Può darsi, anzi, è probabile che non abbia dato battaglia con la nettezza e con la forza necessarie. Ma CRITICAsociale ■ 5 2-3 / 2013 quello che hanno fatto, lui e i suoi compagni miglioristi prima, riformisti poi, è bastato per vedersi affibbiata la peggiore delle etichette, quella di essere, in due parole, succubi e complici del nemico: al diciottesimo congresso del partito, nel marzo del 1989, quello che improvvidamente indica l’obiettivo di un «nuovo Pci», la destra comunista è stata letteralmente falcidiata nell’elezione degli organismi dirigenti. La stessa caduta del Muro e la stessa svolta di Occhetto, che pure i riformisti, per via dell’ ottimismo della volontà, sono impegnati a sostenere, non bastano a modificare in profondità questo stato di cose. E Napolitano, per via del pessimismo dell’intelligenza, ne è perfettamente consapevole: niente illusioni, «siamo una minoranza» . Negli anni immediatamente successivi, in specie dopo che sarà il Psi a finire seppellito dal crollo di un altro muro, quello di Tangentopoli, i fatti si incaricheranno di rafforzare tutte le ragioni del pessimismo. Diventerà presto senso comune il riconoscimento che, se mai c’è stato un tempo utile per superare la particolarissima anomalia che ha fatto dell’Italia l’unico Paese democratico europeo privo di un grande partito di ispirazione socialista, questo tempo è scaduto. Stabilire chi porti le responsabilità maggiori di questa occasione perduta è, ormai, materia di lavoro per gli storici: il Pci non ha varcato, forse perché non poteva varcarlo, il fatidico guado, il Psi non c’è praticamente più, nell’Italia della cosiddetta Seconda repubblica la moneta politica socialdemocratica non ha dunque corso, se non in minoranze destinate in partenza a esercitare, al massimo, un ruolo di testimonianza. Il comunista italiano che per primo si è incamminato e si è inoltrato per questa strada prende atto senza clamori, ma con lucidità e amarezza nello stesso tempo, della sconfitta. Che è una sconfitta sua, certo, ma non soltanto sua. A Ovest e ancor più a Est, investe, in alcuni casi tragicamente, quel che resta dei «riformatori» di un movimento comunista rivelatosi, nell’ora decisiva, irriformabile. Non vorrei esagerare. Ma qualcosa in più su quel frangente si può forse intuire da tre pagine dell’autobiografia di Napolitano dedicate alla triste storia di una persona del tutto ignota alla grande maggioranza dei lettori italiani, il suo compagno e amico Gyorgy Aczel, responsabile della politica culturale del partito ungherese, il Posu, negli stessi anni in cui lui lo è di quella del Pci. La storia, scrive, di «un riformista sconfitto». Comunista già nella clandestinità, resistente, Aczel è stato gettato in galera per cinque lunghi anni dal leader stalinista Màtyàs Ràkosi; dopo il 1956, ha collaborato con Jànos Kàdàr, e nel 1967 è entrato a far parte della segreteria del partito, ma ne è stato estromesso nel 1974, su richiesta sovietica, sotto l’accusa di liberalismo e revisionismo. «Credo di [...] essere profondamente autocritico in merito al mio operato» scrive al suo amico Napolitano il 13 novembre del 1989, ma, aggiunge, ora che si è finito per «dipingere completamente di nero tutto il passato», è diventato «il bersaglio principale dell’opposizione di destra e di quei [comunisti] dogmatici di ieri che cercano di salvare se stessi come ultrariformisti». Dunque, conclude, «sono un uomo che ormai vede il senso di tutta la propria vita rovinare». La vicenda, spiega Napolitano, è «emblematica della complessità tenebrosa della storia dei partiti comunisti»; ma di questa storia bisogna evitare «condanne indiscriminate», per rendere omaggio «a figure di riformisti e moderati sconfitti e umiliati come Gyorgy Aczel». Roma dista da Budapest 1231 chilometri, Napoli 1415, da noi lo stalinismo non ha mai disposto del potere politico di Stato e carri armati sovietici per le strade non se ne sono mai visti: nel 1989 Napolitano può uscire tranquillamente da casa, a differenza di Aczel, senza vedersi «segnato a dito come [ ... ] esponente del vecchio regime». Ma, lette e rilette quelle tre dolenti paginette, e fatte ovviamente tutte le differenze di questo mondo, la tentazione di trovare una qualche analogia tra la tragedia del «riforrnista sconfitto» ungherese e lo stato d’animo del «riformista sconfitto» italiano di allora è, almeno per me, molto forte. L’ABITO FA IL MONACO G li stati d’animo sono una cosa. La politica un’altra. Si compie sostanzialmente qui (dovendo indicare una data: il 3 giugno del 1992, con l’elezione alla presidenza della Camera) il percorso di Napolitano uomo di partito e dirigente della sinistra italiana. Ma ne comincia subito uno molto diverso, quello dell’uomo delle istituzioni e dell’Europa, che trova il suo coronamento nell’elezione a capo dello Stato, avvenuta quando l’allora ottantunenne Napolitano non si considera certo un pensionato, ma ritiene comunque giunto ormai da qualche anno il tempo della riflessione storico-politica, della memoria, degli affetti. Tra le due stagioni, non c’è alcuna cesura netta (e, in fondo, ce- sure evidenti, databili con precisione in questo o quel passaggio storico non ce ne sono nemmeno nel Napolitano «politico», che transita dal togliattismo alla socialdemocrazia gradualmente, passo dopo passo, e sempre cercando un filo che possa legare la parte migliore del passato al presente e al futuro). In ogni caso, non si tratta certo di storie contrapposte. Perché la seconda non solo non si spiega, ma non si lascia nemmeno raccontare senza la prima. Qualcuno ha provato, e ogni tanto torna a provare, a scagliargliela addosso, la sua militanza di una vita nel Pci, anzi, nel gruppo dirigente del Pci: ma sempre senza successo. Altri si sono meravigliati, naturalmente apprezzandolo, del fatto che, in tempi calamitosi, Napolitano presidente abbia saputo rappresentare, oltre che una imprescindibile garanzia istituzionale, anche l’unica, forte risorsa politica a disposizione del Paese sul piano interno come su quello internazionale, nonostante un simile passato alle spalle. Forse però è vero, o più vicino al vero, il contrario, e cioè che tutto questo Napolitano presidente abbia potuto e saputo farlo non malgrado, ma in buona misura grazie a quei sessant’anni e passa di politica, in Italia, in Europa e nel mondo; non fosse altro perché, nel tempo dei dilettanti allo sbaraglio, aver fatto studi regolari in una scuola di tutto rispetto aiuta, eccome, anche se questa scuola ha chiuso da un pezzo i battenti, e dei limiti (chiamiamoli così) dei suoi docenti, nonché dell’infondatezza di molte (molte, non tutte) delle materie che vi si insegnavano ci si è resi conto da un pezzo. In questo libro cerco, raccontando la storia del borghese Giorgio Napolitano dai suoi primi passi nel Pci al Quirinale, di renderne anche quello che, almeno a me, pare esserne il senso. Giudicheranno i lettori, come si diceva una volta. Ma un giudizio mio, personalissimo, in cui conta anche, credo, una conoscenza antica, lo voglio comunque anticipare. Napolitano è stato un uomo politico di primo piano, mai però un leader politico. Forse non ne ha avuto la stoffa, sicuramente non ne ha avuto l’ambizione: la lotta per il potere, in primo luogo in casa propria, non è mai stata nelle sue corde. Ma questo non gli ha impedito, anzi, di essere un capo dello Stato al quale gli italiani hanno guardato con una stima, un rispetto e una fiducia inversamente proporzionali a quelle, pressoché nulle, riservate (con sua crescente preoccupazione) alla politica, ai partiti, alle assemblee elettive. Di più: non gli ha impedito, anzi, di essere proprio lui, alieno quasi per carattere da ogni forma, anche la più larvata, di populismo, un capo dello Stato popolarissimo. I motivi sono tanti, naturalmente. Per quanto mi riguarda, credo sia anche perché Napolitano è riuscito a essere il punto di riferimento di una domanda di serietà e di compostezza (se questi due termini non fossero così abusati, si potrebbe anche dire: di sobrietà e di rigore), che nel profondo della società italiana è venuta maturando, di contro al caos dilagante, forse più di quanto in genere si creda. All’opposto di quel che recita il proverbio, l’abito fa il monaco. E l’abito presidenziale Napolitano lo ha indossato da subito come se non ne avesse mai portati altri, o, almeno, come se nella sua vita precedente lo avesse provato un’infinità di volte. Persino quelli che gli avversari, e anche molti amici, hanno sempre considerato, in lui, dei limiti congeniti, sono sembrati trasformarsi, nel nuovo incarico, in virtù preziose. Sia nella prima fase del settennato, quando Napolitano ha incarnato il senso della misura repubblicana in un Paese straziato da una tragicomica simulazione di guerra civile a bassa intensità, rifiutando di lasciarsi tirare per la giacca da chi in sostanza gli chiedeva, a fin di bene, di esorbitare dai propri poteri e, in sostanza, di surrogare un’ opposizione troppo debole e divisa. Sia nella seconda, la più diffi- cile e anche la più controversa, quando questo senso della misura repubblicana non gli ha impedito affatto, anzi, di essere il regista, in uno dei momenti più difficili della vita nazionale, della ritirata di Silvio Berlusconi e dell’avvento di Mario Monti. In entrambe le circostanze, la grande maggioranza degli italiani, compresi molti elettori del centrodestra, e più in generale molti di quelli che, come me, preferirebbero di gran lunga vivere in un Paese almeno relativamente normale, in cui sono gli elettori a decidere chi sarà a governarli, gliene è stata grata. Non credo che Napolitano si sia mosso, in questa circostanza, come se in Italia vigesse una sorta di presidenzialismo, o di semipresidenzialismo, di fatto, facendo leva su una crisi politica ed economica gravissima per esercitare poteri dei quali, in una democrazia parlamentare, il capo dello Stato non dispone: e non solo perché, per storia e per cultura politica, tutto è fuorché un presidenzialista. Di certo non è stato un presidente notaio. Ma, ammesso e non concesso che i suoi predecessori lo siano stati, sarebbe difficile, anche per i critici più severi, indicare quali contratti un Napolitano «notaio» avrebbe mai potuto stipulare. La promessa fatta al Parlamento di non identificarsi nella (risicata) maggioranza che lo ha eletto l’ha mantenuta alla lettera. L’auspicio di un graduale superamento del «clima di pura contrapposizione e di incomunicabilità» tra maggioranza e opposizione, «a scapito della ricerca di possibili impegni comuni», invece, è rimasto nella sostanza tale, almeno fino all’autunno del 2011, quando, dopo una lunga, imbarazzante agonia, il centrodestra ha dovuto ritirarsi senza però che il centrosinistra fosse in grado di candidarsi ragionevolmente a governare l’Italia. Non si vive di soli auspici, specie quando il Paese è sull’orlo del baratro. Nella circostanza (drammatica) Napolitano l’antidecisionista ha voluto, dovuto e saputo decidere, e lo ha fatto attenendosi alle proprie prerogative, così come le determina una Costituzione che non prevede affatto né l’obbligo di sciogliere le Camere in presenza della crisi di un governo e della sua maggioranza né, tanto meno, presidenti del Consiglio indicati sulla scheda dagli elettori. Non solo. Se la politica, o quanto meno i simulacri di governi, partiti e coalizioni che nella cosiddetta Seconda repubblica l’hanno incarnata, sono stati, come si dice spesso, commissariati, non c’è dubbio che hanno provveduto da soli a creare tutte le condizioni, nessuna esclusa, per il loro (presunto) commissariamento. Gli interrogativi (tutti legittimi) sul futuro prossimo non tanto del bipolarismo, che, per lo meno nella sua versione selvatica, un futuro non lo ha, ma della nostra stessa democrazia preesistono in larghissima misura al governo Monti e alla sua «strana maggioranza». Tuttavia, non c’è dubbio che tra il 9 novembre del 2011, quando Napolitano ha nominato Monti senatore a vita, e il 13, quando lo ha incaricato di formare il governo, sia accaduto, nella storia politica italiana, qualcosa di assolutamente inedito, non circoscrivibile alla necessità di fare fronte subito, e con la necessaria autorevolezza anche sul piano internazionale, all’attacco al nostro debito sovrano e alle pressanti richieste della Bce. Un tempo della storia nazionale si è (fortunatamente) concluso ma, oltre le luci e le ombre del governo dei tecnici, del tempo nuovo che dovrebbe succedergli, e che suscita più timori che speranze, non si intravede granché: se una cosa sappiamo è, come avrebbe detto Aldo Moro, che il futuro non è più, in parte, nelle nostre mani. È questa, credo, l’eredità sospesa di un settennato che ha fatto onore a Giorgio Napolitano e, nonostante tutto, alla Repubblica. s Paolo Franchi 6 ■ CRITICAsociale 2-3 / 2013 DOCUMENTO ■ INTERVENTO DI NAPOLITANO ALLA DIREZIONE DEL PCI DEL NOVEMBRE 1989 (DOPO IL MURO) V “SUPERARE LE DIVISIONI DELLE FORZE DEL SOCIALISMO DI LIBERTÀ E DEMOCRATICO” i è un’accelerazione dirompente della nostra storia europea che investe anche noi: c’è una crisi, un crollo ma da esse nascono anche possibilità nuove. Noi, come Pci, non siamo del tutto fuori da quella crisi anche se abbiamo da rivendicare posizioni autonome in tutta la nostra storia. Oggi dobbiamo saper essere protagonisti di queste possibilità nuove… le politiche dei piccoli passi non reggono più. Come salvare e inverare la nostra funzione storica? O meglio come riproporre la nostra funzione storica in contesti così mutati evitando quelli che D’Alema ha indicato come rischi di logoramento? Partiamo dalla nostra funzione nazionale e internazionale. Per quel che riguarda la nostra funzione internazionale, sono d’accordo con Occhetto, asse essenziale della nostra scelta è il rapporto organico da stabilire con l’Internazionale Socialista. Abbiamo percorso un lungo cammino nei rapporto con l’Internazionale Socialista dimostrando sempre grande serietà e dignità di comportamenti. Il compagno Longo prese molte iniziative all’epoca della Ostpolitik, ricordo le prese di posizione di Enrico Berlinguer e di Natta per arrivare sino alla recente lettera di Occhetto diretta al presidente dell’Internazionale socialista in occasione del Convegno di Milano. Tutto questo percorso, lo voglio ripetere, è stato segnato dalla nostra serietà e dignità. Le gradualità sono necessarie anche nel rapporto con l’Internazionale Socialista. E’ da sottolineare oggi l’importanza della Presidenza di Willy Brandt, testimone della nostra linea e rinnovatore dell’Internazionale Socialista. Si può dire che oggi l’Internazionale Socialista si è aperta al contributo della parte valida e più viva dell’esperienza comunista. Il nuovo Partito socialista Jugoslavo ha chiesto l’ammissione all’Internazionale Socialista per portarvi dentro la parte più viva della tradizione comunista (come ha sottolineato Nyers che pur è di estrazione socialdemocratico). Rakowsky parla delle socialdemocrazie e del Pci e si rivolge a Brandt con il programma del nuovo Partito polacco. Vi è quindi l’esigenza di trarre questo dado dell’Internazionale Socialista perché abbiamo toccato il culmine in termini di autorevolezza nostra negli ambienti dell’Internazionale Socialista per il ruolo da noi svolto. Dobbiamo rivendicare il nostro ruolo verso Est e verso Ovest, respingendo tutte le falsificazioni: un ruolo per il cambiamento, per le riforme, per la libertà e la democrazia. Ho riletto le posizioni nostre del dicembre dell’81 e del gennaio 1982: lì sono scritte le nostre proposte per l’Est europeo e sono terribili le ritorsioni polemiche che ci sono state indirizzate dalla “Pravda”. … Oggi coroniamo l’opera da noi svolta … Qualcuno afferma che siamo troppo a ridosso di decisioni esterne altrui (Polonia, Ungheria) e di avvenimenti drammatici (RDT). Ma l’8° Congresso del Pci l’abbiamo fatto a ridosso del XX Congresso del Pcus … NATTA: …era diverso… NAPOLITANO: …Non siamo stati travol- ti… dal crollo del muro di Berlino né dagli avvenimenti polacchi e ungheresi. La nostra odierna decisione è il compimento di una nostra presa d’atto che supera la distinzione e la divisione tra le forze che pensano un Socialismo di libertà e democratico. I rischi sul piano internazionale: è interesse del Psi di conservare anche la rendita di posizione che gli deriva dal suo diritto di veto all’entrata del Pci nella Internazionale socialista. Il Psi si è già sentito stretto dalla lettera di Occhetto al Presidente dell’Internazionale Socia- lista, iniziativa che ha bruciato la volontà di Craxi di fare del Convegno di Milano una tribuna contro di noi. Ma i rischi ci sono anche per il Psi se vuole usare il suo diritto di veto e ciò in dissonanza con noi e con le maggiori forze socialiste e socialdemocratiche europee. Il nostro Partito non può presentarsi come la sola forza di ispirazione socialista in Italia: non è, cioè, di sinistra solo ciò che si raccoglie alla sinistra del Psi. Dobbiamo continuare ad avanzare proposte di avvicinamento e di unità tra noi e il Psi. Riconosciamo che nell’Internazionale Socialista vi possono essere forze socialiste anche in competizione tra di loro. Respingo invece la prospettiva di una nostra confluenza nel Psi e osservo che neanche quella tra Psi e Psdi si è realizzata. … MACALUSO: …Veti del Psdi contro il Psi nell’Internazionale Scocialista… NAPOLITANO: …Massima unità nelle forme possibili, concrete, propositive, credibili come spetta ad una forza di “governo” come la nostra. Noi siamo un Partito riformista di massa, che si è innovato e si innova, politicamente, non un semplice “antagonista” come vuole Magri. La nostra scelta va presentata come volta a suscitare energie. Una rapida fase costituente deve affrontare anche la questione del nome, che è punto di arrivo non di partenza. Occorre lavorare subito ad una ipotesi di un percorso per la fase costituente e per questa opera occorre associare tutte le forze che trovino ruoli dirigenti, al di là degli schemi organizzativi attuali. s CRITICAsociale ■ 7 2-3 / 2013 ■ CON OCCHETTO IN MAGGIORANZA LA PARTE MINORITARIA DEL PCI, INDIVIDUALISMO E MOVIMENTISMO ALL’ESTERO NELL’INTERNAZIONALE SOCIALISTA, MA PDS IN ITALIA: FU AMBIGUITÀ L Gianni Cervetti a prima considerazione che va fatta leggendo l’“intervento di Giorgio Napolitano” alla Direzione del PCI del 14 novembre 1989 è che esso si configura come uno “strappo” rispetto al modo con cui i comunisti italiani hanno operato per determinare l’evoluzione del loro partito. Salvo forse, infatti, ciò che accadde nel periodo ’43-’45, quando l’allora PCdI (partito comunista d’Italia, sezione dell’Internazionale, et nomina sunt consequentia rerum) si trasformò in “partito nuovo” attraverso una rifondazione di tipo nazionale, la storia del partito comunista italiano è stata caratterizzata da successive modificazioni basate sul principio del “rinnovamento nella continuità”. Oggi, al contrario, “le politiche dei piccoli passi – dice Napolitano – non reggono più”. Occorre prendere atto della “accelerazione dirompente” determinatasi nella “storia europea” e perciò, si deve innovare. E’ proprio in questa costatazione, e nella relativa necessità di innovazione, che si trova la radice della prima e fondamentale distinzione tra la posizione di Napolitano e coloro che verranno denominati del “fronte del No”, i quali, come si sa, non saranno solo disposti a far valere nell’opera di trasformazione del PCI “la parte più viva della tradizione comunista”, ma si proporranno di mantenere un rapporto di “continuità” con quella intera tradizione. Del resto, anche la relazione di Occhetto che aveva aperto i lavori della Direzione, così come la sua azione nel periodo (piattaforma avanzata alla Bolognina, ecc.) si presentarono in forma di rottura nei confronti del metodo comunista tradizionale. Lo stesso Napolitano, nella propria autobiografia “Dal Pci al Socialismo europeo”, riferendosi al comportamento di Occhetto sia in quella specifica riunione del 14 novembre, sia più in generale nella attuazione della “svolta”, parla di “estrema determinazione” e di “non comune coraggio” del segretario, sottolineando così – a mio avviso – anche un modo di agire che differiva da quelli tenuti nel passato allorché dsi impressero nella vita del PCI elementi di novità più o meno marcata. In realtà nell’”intervento di Giorgio Napolitano” e nella relazione di Occhetto vi è un’altra coincidenza la quale non concerne soltanto la metodologia, ma attiene agli intenti e allas volontà politica. Nell’un discorso e nell’altro si sostiene, neppure con diversi accenti, che una pagina di storia – quella del comunismo in genere e quella del PCI in quanto tale – la si deve considerare superata dal momento in cui “il rapporto organico da stabilire” è “con l’Internazionale Socialista” (IS). Detto tutto ciò, è nella pars costruens o, se si vuole, sulla prospettiva politica, che le due posizioni o proposte si differenziano nettamente. Quella avanzata dall’allora segretario è racchiusa nella denominazione che il nuovo partito assumerà: “democratico della sinistra”. Si tratta, in sostanza, per Occhetto e il gruppo che si raccoglie intorno a lui, una formazione politica a sfondo ELITARIO, ma con forti connotati che possono essere definiti, magari sbrigativamente, da un lato movimentisti e dall’altro democratico-individualisti. Sono connotati che erano già presenti nel PCI, ma in quel corpo si trovavano in condizioni di minoranza e che ora, invece, nella nuova formazione, diventano maggioranza. Sì, è vero, e lo abbiamo appena più sopra ricordato, anche Occhetto e coloro che si raccoglieranno attorno alla sua piattaforma si esprimono e si adoperano (la lettera a Willy Brandt, richiamata da Napolitano varrà da esempio di ciò) per l’adesione alla Internazionale Socialista, ma la particolare torsione che intendono imprimere, e nei fatti imprimeranno, al nuovo partito “democratico della sinistra” determina una ambiguità di fondo e indica quali siano i propositi con cui avanza la richiesta di adesione. D’ altra parte, anche le due successive “trasformazioni” del PdS in DS e dei DS in PD non cancelleranno l’impronta originaria e, semmai, auspici le iniziali e le ulteriormente acquisite contraddizioni, imprimeranno alle formazioni via via susseguitesi un carattere politicamente sempre più discostato dalla proposta di Napolitano e, organizzativamente, una struttura di tipo “tribale”. D’Alema, succeduto a Occhetto, riuscirà ad ottenere con il Congresso di Firenze, detto della “cosa due” e enfaticamente presentato come una operazione di allargamento a forze socialiste e cattoliche, nient’altro che il risultato emblematicamente racchiuso nella fortunata formula di Emanuele Macaluso: “da cosa non nasce cosa”. La formale confluenza, poi, di DS e Margherita nel PD si risolve, in assenza di una autentica riflessione critica per elaborare una piattaforma di governo rispondente all’interesse generale del Paese, in una giustapposizione di forze eterogenee o particolaristiche. Ma qui siamo chiamati soprattutto a commentare l’”intervento di Giorgio Napolitano”. Il quale intervento, spogliato drella comprensibile e opportuna veste con cui si presenta al PCI per convincerlo a superare la propria storia (la rivendicazione del “nostro ruolo”; il richiamo alla “nostra serietà e dignità”; il riferimento as Longo, Berlinguer, Natta, ecc. ecc.), contiene tre elementi caratterizzanti la natura e la prospettiva della nuova formazione politica. Innanzitutto, vi si trova un rapporto con alcuni tratti essenziali del PCI, e ciò non è in contraddizione con lo “strappo” metodologico in quanto, appunto, il rapporto concerne la parte viva della passata esperienza e non l’intera storia e natura del “vecchio” partito. E quali sono i tratti riproposti? Napolitano definisce il PCI “un Partito riformista di massa”. O ra, che esso sia stato un partito di massa è del tutto chiaro. Quanto, poi, al connotato “riformista” occorre procedere a una netta distinzione. Effettivamente, il PCI è stato una formazione politica e culturale riformistica nella sua azione e nella pratica fin dal momento in cui si è impegnato a fornire il proprio pieno contributo per dare all’Italia una Costituzione e una Repubblica democratiche. Nella teoria, invece, o se si vuole, nei suoi riferimenti ideali e storici, esso è stato qualcos’altro e, come è noto, tali riferimenti non sono mai, per chiunque e per qualsiasi istitu- zione, un semplice orpello poiché, in realtà, influenzano il modo di pensare ec di agire, la coscienza insomma, degli uomini e delle donne che aderiscono al disegno proposto e perseguito. In sostanza, anche in ragione di ciò, per il PCI è giustificato l’appellativo di strano animale, di “giraffa”, con il quale era solito definirlo lo stesso Togliatti., Non è, quindi, un caso che Napolitano sottolinei, da un layto, l’esigenza di collegarsi alla part viva della passata esperienza tralasciando quel che è superato e caduco, e dall’altro, nel farlo, chiarisce che vivo è il carattere “riformista di massa”. Il secondo elemento caratterizzante della piattaforma proposta è dato dall’approdo nell’Internazionale Socialista. Napolitano sa bene che, a questo proposito, sono presenti nella dirigenza del PCI due differenti tipi di ostacoli da superare: la tesi di chi ritiene che si debba entrare nell’Internazionale Socialista per rafforzare l’”ala sinistra” o, addirittura, che occorra costituire una forza europea minoritaria dei raggruppamenti comunisti rimanenti (cosa che effettivamente sarà poi promossa da “Rifondazione”) la quale potrebbe convergere con la famiglia socialista solo in alcuni obiettivi; la posizione di chi considera l’ingresso nell’Internazionale Socialista – che pure necessita, secondo norma statutaria dell’Internazionale, dell’avvallo del PSI, e che lo otterrà nei fatti – come un modo di garantire alla “nuova formazione” una sorta di mandato internazionale di primaria rappresentanza in Italia, confidando su una maggiore forza politica e numerica nei confronti del PSI. È, dunque, per superare il primo ostacolo che nell’”intervento” si insiste nel “lungo cammino” già percorso o nella “importanza della Presidenza di Willy Brandt”, o nel fatto che è l’Internazionale Socialista in quanto tale che “si è aperta al contributo della parte valida e più viva della esperienza comunista”, o su altri analoghi argomenti ancora. Anche al fine di superare il secondo ostacolo si usano vari argomenti, il principale dei quali, però, si identifica con il terzo elemento che dovrebbe caratterizzare il nuovo partito. E questo terzo elemento, come è evidente, si esprime nei concetti che nell’immediato definiscono il rapporto con il PSI e nella prospettiva di medio termine delineano la costruzione di ciò che in Italia non è mai esistito, cioè una grande forza del socialismo europeo. Con queste motivazioni si respinge “la nostra confluenza nel PSI” perché, tra l’altro, “neanche quella tra il PSI e il PSDI si è realizzata”, mentre si sollecitano “proposte di avvicinamento e di unità tra noi e il PSI” e, soprattutto, si afferma che “la nostra odierna decisione è il compimento di una nostra presa d’atto che supera la distinzione e la divisione tra le forze che pensano un socialismo di libertà e democratico”. Nell’insieme, l’“intervento di Napolitano”, in specie attraverso i tre ricordati elementi caratterizzanti, configura èer l’essenziale la piattaforma e la natura della nuova annunciata formazione politica; dell’una, come si sa, l’auspicio rimarrà tale e la strada che sarà concretamente e principalmente imboccata non sarà quella del “socialismo europeo” bensì quella del “partito democratico della sinistra” e delle sue successive trasformazioni. In sede storica è, tutavia, opportuna, accanto allas costatazione dell’accaduto, una ulteriore riflessione volta a ricercare e a spiegare i motivi che hanno impedito la realizzazione della “proposta Napolitano”, fatta, peraltro, immediatamente propria da quel gruppo minoritario, ma sicuramente autorevole, di esponenti del PCI, i quali dapprima si raccolsero attorno alla piattaforma della cosiddetta “adesione ragionata” alla formazione del nuovo partito e in seguito diedero vita all’”area riformista”. Ha, infatti, poco senso attribuire la responsabilità della mancata realizzazione di un disegno politico a cause astratte o, di contro, quali, nel caso, da un lato l’anomalia che impedirebbe all’Italia di contenere forze – in specie un partito di massa del “socialismo di libertà e democratico” - esistenti in altri Paesi europei, oppure, dall’altro lato, l’opposizione di chi perseguiva altri obiettivi: in specie, la creazione di un “generico” partito della sinistra la “rifondazione” comunista. In realtà una analisi ravvicinata degli eventi e dei movimenti verificatisi nel periodo in questione (1989-’91), due motivi, tra gli altri, appaiono a nostro avviso, concomitanti e determinanti nell’ostacolare il disegno ALLOCATO. Fatto è, in primo luogo, che la prospettiva indicata nell’intervento di Napolitano e sostenuta dai riformisti del PCI non ha trovato i necessari referenti e contraenti “esterni” o, per dirla altrimenti, una vera e propria sponda politica che potesse rendere realizzabile l’idea della edificazione in Italia di un grande partito del socialismo europeo. Il PSI aveva scelto di percorrere la strada dell’”unità socialista”, cioè dell’allargamento della propria base organizzata ed elettorale, illudendosi semmai di replicare ciò che Mitterrand aveva ottenuto nella sinistra francese: e anche quelle forze che tra i socialisti italiani, magari di tendenza “autonomista” avevano perorato e proposto, qualche anno prima, altre e più realistiche soluzioni unitarie per la intera sinistra italiana erano state sconfitte. Le stesse forze sociali – e, innanzitutto, la cooperazione e i sindacati dei lavoratori che, pur nella loro autonomia, erano e sono componente essenziale per la costruzione di una formazione politica socialista e riformista di massa – non si dimostrarono disponibili nella loro maggioranza e con le loro divisioni, a costruire il disegno delineato. In secondo luogo, tra i riformisti del PCI continuava ad agire, più o meno consapevolmente, la tradizionale idea di ascendenza comunista, secondo la quale l’unità, pur essendo in sé un bene prezioso, è prima di tutto da salvaguardare come unità del partito in cui si milita. E pure ciò non poteva che rappresentare una barriera per il raggiungimento dello scopo proposto e l’anticamera della sconfitta politica. N aturalmente, i due suddetti motivi avevano le loro radici sia in varie “occasioni mancate” per far decisamente convergere, se non unificare, le grandi forze della sinistra (1945; 1964; ecc.), sia in una insufficiente preparazione politico-culturale all’unità fondata sulla “pari dignità” di ciascuno. E ciò è qui una lezione su cui anche oggi varrebbe la pena di meditare. s 8 ■ CRITICAsociale 2-3 / 2013 ■ LA BATTAGLIA DI NAPOLITANO NELLA DIREZIONE DEL PCI (DOPO IL MURO) PER UNA SCELTA SOCIALISTA MA OCCHETTO FU IL GATTOPARDO: “INNOVARSI AL FINE DI CONSERVARE L’ESSENZIALE” Q Ugo Finetti uando il 14 novembre 1989 Giorgio Napolitano prende la parola nella Direzione del Pci che discute la relazione del segretario, Achille Occhetto, dopo la caduta del Muro di Berlino, nella sala al secondo piano delle Botteghe Oscure si va delineando una piattaforma di “rilancio” del Partito con nuovo nome sulla base di una rivendicazione della sostanziale autonomia e specificità della storia del Pci rispetto alla storia di ciò che nelle relazioni di Togliatti, Longo e Berlinguer era denominato “Movimento Comunista Internazionale”1. Una tesi che - come aveva rilevato criticamente Emanuele Macaluso intervenendo subito dopo Occhetto - doveva però essere adattata al fatto che la stessa decisione di cambiare nome veniva presa in un quadro di “effetto domino” ovvero sull’onda di analoghe decisioni di altri partiti comunisti al potere nell’Europa dell’Est. L’obiettivo di entrare nella Internazionale Socialista veniva infatti non più contrastato ed era ormai accettato nel vertice del Pci tenendo presente che in tale direzione si stavano già muovendo anche i “partiti unici” di Stati che avevano cessato di chiamarsi comunisti. Nello stesso Pcus infatti si stava discutendo il mutamento del nome2. Naturalmente, nel discorso di Occhetto e nel dibattito, il cambio del nome porta in primo piano il rapporto con il Psi. Negli interventi che si succedono è evidente la preoccupazione di conservare una sorta di primogenitura nella sinistra italiana, di evitare cioè una riabilitazione delle tesi dell’autonomia socialista ovvero il rifiuto di una svolta sulla base di un riconoscimento delle ragioni provenienti da altre esperienze. I discorsi sullo sconvolgimento in corso nei paesi dell’Est e tra i partiti comunisti dell’Ovest, le sue origini e conseguenze, sembrano spesso svolgersi prevalentemente come un monologo interno al comunismo negando qualsiasi legittimità a ciò che si trova alla propria destra. Prende così forma una politica continuista, di “innovazione senza revisione”3 per cui Occhetto, da un lato, propone di non chiamarsi più comunisti e, dall’altro, ribadisce la “lezione” di Togliatti e Berlinguer. Quel che colpisce nella lettura del verbale della riunione infatti è – sia pur con propositi diversi ed anche divergenti – il prevalere di un clima di arroccamento e rifiuto di una soluzione di continuità mentre non solo il Muro di Berlino è caduto, ma l’intera muraglia del sistema dei partiti e paesi comunisti d’Europa andava franando. I dirigenti comunisti tengono comunque a rivendicare la sostanziale giustezza e superiorità del comunismo italiano senza mettere in campo una revisione dei giudizi espressi in passato nei confronti di movimenti e persone che nei paesi comunisti si erano opposti ai regimi dittatoriali o che nella sinistra italiana avevano denunciato la natura repressiva del comunismo sovietico e dei suoi satelliti. Anzi si rivendica una storia del Pci svoltasi in un quadro di sostanziale autonomia – e di aperta contrapposizione - rispetto al Pcus e ai regimi comunisti. Eppure, anche dopo l’approvazione della svolta da parte del Comitato Centrale del Pci il 25 novembre, Achille Occhetto, intervistato in dicembre da Eugenio Scalfari, sembra an- cora condividere le ragioni che portarono Togliatti nel 1956 ad approvare l’invasione sovietica dell’Ungheria (“evitare un trauma al popolo comunista”, non “varcare una soglia che avrebbe probabilmente disperso quelle energie solo a vantaggio degli avversari”, “probabilmente fu un errore, ma chi può fare la storia con i se?”)4. Vediamo quindi nel corso della riunione del 14-15 novembre 1989 che il gruppo dirigente tende a “far quadrato” nel senso che – come dirà Occhetto – si respinge l’idea secondo cui “tutto ciò che è avvenuto mettesse in discussione soltanto l’esperienza del movimento comunista”5. E quindi: “Non si tratta di delineare un percorso di fuoriuscita da una tradizione comunista, per abbracciarne un’altra, quella socialdemocratica”6. Insomma la caduta del Muro di Berlino significa la caduta paritaria del bipolarismo tra comunismo sovietico e democrazia occidentale ed il superamento paritario sia del comunismo sia della socialdemocrazia. Occhetto definisce quindi “la collocazione del nuovo partito e della costituente al di fuori della scelta tra comunismo e socialismo: non si tratta di scegliere tra quelle due tradizioni ma di superarle entrambe”7. L’adesione all’Internazionale Socialista si delinea da parte di Occhetto pertanto, da un lato, come salvacondotto proveniente “dall’alto” – al di fuori della vita nazionale – a mo’ di benevola assoluzione senza penitenza e, dall’altro, come una sorta di “entrismo”, di missione in cui mantenendo “diversità” e “specificità” ci si propone non di “socialdemocratizzarsi”, ma di “rigenerare” l’organizzazione del socialismo europeo (vi è quasi una lontana eco della rivoluzionarizzazione della socialdemocrazia”8) insieme agli altri partiti ex comunisti dell’est europeo che vi entreranno nel segno di un nuovo e diverso impegno dell’Internazionale Socialista a favore della “democrazia globale” ovvero dell’ambientalismo, del femminismo e dell’antagonismo secondo quello che il segretario del Pci definirà “un nuovo internazionalismo planetario”9. “Non si tratta – secondo Occhetto - di abiurare, ciascuno, le proprie tradizioni, ma di inventare qualcosa di nuovo … di farci promotori di un allargamento della stessa Internazionale socialista” con “l’ambizioso compito di contribuire a riformare l’Internazionale socialista”10. Una prospettiva alimentata dal fatto che nello stesso vertice dell’Internazionale Socialista, con Willy Brandt presidente, si coltiva l’idea della fine del comunismo come vittoria di una sua “autoriforma” gorbacioviana che può tradursi in una confluenza destinata a fornire una vasta ed irreversibile maggioranza socialista nelle istituzioni europee. “I ragazzi di Berlinguer”11 si propongono quindi di entrare nell’Internazionale Socialista con l’obiettivo di evitare di dover recitare un “mea culpa” nazionale ed, anzi, meglio contrapporsi alla politica del socialismo autonomista che ha preso forma nel Psi. Questa reazione va anche considerata alla luce del fatto che in Italia – man mano che si è andata sviluppando la politica autonomistica di “governabilità” dopo la fine della “solidarietà nazionale” degli anni 1976-1978 – il de- clino del comunismo era già in atto da un decennio. La flessione elettorale iniziata nel 1979 – salvo il risultato del 1984 all’indomani della morte di Berlinguer – era costante e crescente in particolare tra le nuove generazioni che erano sempre state invece un punto di forza del voto comunista. La “questione comunista” negli anni ’80 è sempre meno centrale nella scena politica nazionale rispetto al decennio precedente tra il ’68 ed il ’79 e la dialettica politica tendeva a ruotare sempre più intorno allo scontro per la leadership del Paese tra Psi e Dc. D’altra parte nel dibattito del 14-15 novembre dell’89 emergono anche i punti di forza del comunismo italiano. A differenza degli altri partiti comunisti occidentali, il Pci non era stato tenuto né si era fatto tenere in un “ghetto” e vediamo in campo dirigenti che hanno alle spalle non solo una storia di lotte anche vinte e di movimenti ampi e ben radicati, ma che hanno svolto ruoli di governo nelle principali metropoli e regioni italiane e che soprattutto sono stati per anni determinanti nella maggioranza di governo fronteggiando negli anni ‘70 la più difficile crisi economica del dopoguerra e la più lunga e cruenta stagione di terrorismo politico non “nazionalista”, ma di sinistra. A ciò si aggiunge l’originalità del “centralismo democratico” del partito italiano. Prefigurazione leninista all’interno del partito della “dittatura del proletariato” da instaurare nel Paese, “scelta di vita” nel segno della rinuncia alla libertà in nome della giustizia, della sottomissione dell’individuo alla “volontà generale”, esso si era snodato nel Pci lungo i decenni con confini “elastici”12 ed in termini – più con Togliatti e Longo, meno con Natta e Occhetto – di sostanziale meritocrazia nella selezione del gruppo dirigente. Per comprendere il reale clima in cui si svolgeva quel “vertice” del Pci può essere utile fare un passo indietro e cioè tener presente la sua precedente riunione dell’8 novembre 1989. Il giorno dopo la televisione tedesca annuncerà la caduta del muro di Berlino, ma solo la vedova di Palmiro Togliatti, Nilde Iotti, richiama in modo esplicito l’attenzione su quel che sta accadendo all’Est. Quell’8 novembre il gruppo dirigente comunista appare scosso e attraversato da forti tensioni interne, ma sostanzialmente concentrato sulla situazione interna. In particolare scotta la sconfitta romana nelle elezioni amministrative del 28 ottobre con la flessione di 4 punti. Secondo il filosofo Umberto Curi, il direttore dell’Istituto Gramsci di Venezia che all’epoca faceva parte del Comitato centrale del Pci, per Achille Occhetto “il vero crollo del Muro di Berlino è stato l’esito della consultazione romana”13. Nella capitale il Pci aveva svolto una campagna elettorale molto aggressiva nei confronti della Dc e del Psi al motto di “Liberiamo la città” e accusando il capolista socialista, Franco Carraro, di essere un “milanese”. Il candidato craxiano è però diventato Sindaco e la Dc è aumentata tornando al livello del 1981, mentre il Pci, rispetto all’81, è sceso dal 36 al 27 per cento. Più in generale la sconfitta comunista in quelle elezioni parziali “sembrava addirittura prefigurare a breve termine il sorpasso elettorale da parte dei socialisti”14. CRITICAsociale ■ 9 2-3 / 2013 Proprio all’inizio dei lavori15 vi era stato un battibecco tra Occhetto e Napolitano dopo che il segretario lo aveva indicato come esempio da non seguire per l’intervento “fuori tema” del leader della destra comunista, cosiddetta “migliorista”, al precedente Comitato Centrale. E Giorgio Napolitano intervenendo dopo la relazione di Occhetto aveva attaccato la conduzione del Pci da parte del segretario. “Sono preoccupato per le difficoltà del Partito rivelatesi anche a Roma” aveva detto attribuendole alle “contraddizioni della nostra linea”, ad una “opposizione convulsa, esasperata, ‘becera’ sul piano concreto”. Napolitano aveva contestato la linea di Occhetto non da posizioni filocraxiane16, ma in nome di un maggior equilibrio e realismo: “Nel Partito – aveva affermato Napolitano usando negativamente un’espressione tipica di Berlinguer – si manifesta la sindrome che sta per chiudersi il cerchio ‘tutti contro di noi’”. “Ci sono – aveva polemizzato Napolitano – rappresentazioni catastrofiche sulla libertà e la democrazia in Italia e sulle situazioni delle nostre grandi città”. Gian Carlo Pajetta, con l’autorità di essere l’unico superstite della Direzione del Pci della Resistenza e della Liberazione, aveva tratteggiato una rappresentazione impietosa della situazione interna al Partito: “Al mio seggio non c’era il rappresentante di lista. In Sezione c’erano due soli compagni. Le Sezioni non sanno più preventivare i risultati, né se si andrà avanti o indietro”. Ed aveva citato un’analisi del sondaggista di fiducia del Partito, Stefano Draghi: “Circa il 40 per cento del nostro elettorato o ci nega il voto o vota Dc e Psi”. A sua volta un altro leader “storico” del Partito, Nilde Iotti, che da dieci anni è Presidente della Camera dei Deputati, aveva lamentato il “nostro isolamento” causato da polemiche estremistiche nei confronti della stessa Dc: “E’ giusto criticare la Dc, ma non dobbiamo dimenticare le sue radici”. Occhetto si era quindi difeso sostenendo che “il 26 per cento è il livello elettorale nostro, realistico, oggi” citando il risultato delle elezioni europee svoltesi nel giugno precedente anche se – gli era stato già obiettato - quella percentuale andava “letta” tenendo presente che si erano persi 700 mila voti. Achille Occhetto aveva comunque cercato di essere rassicurante, ma tra i dirigenti comunisti prevaleva l’insicurezza e il pericolo di perdere il controllo della situazione. “Non dimenticherei ciò che sta avvenendo all’Est” aveva detto la Iotti criticando la relazione ed aveva aggiunto: “E’ stato colpito l’ideale che anima i nostri elettori. Dobbiamo (…) riprecisare, rivedere i nostri ideali”. Il giorno dopo il portavoce del partito comunista della Germania dell’Est (Sed), Gunther Schabowky, avrebbe annunciato che non vi sarebbero più stati divieti per andare a Berlino Ovest. Intanto Occhetto era partito per Bruxelles per andare a parlare con Neil Kinnock. Era la prima volta che un segretario del Pci incontrava il segretario del partito laburista. Ed è appunto insieme al leader inglese che la mattina del 10 novembre Occhetto segue in televisione le immagini dei tedeschi che da Berlino Est passano liberamente a Berlino Ovest. “Chiesi ad Occhetto – ricorderà Kinnock – se il Pci potesse cambiare nome e lui mi rispose scandendo tre volte: «E’ molto difficile, molto difficile, molto difficile»”17. Nello stessa mattina alle Botteghe Oscure l’ex segretario del Pci ora presidente del Partito, Alessandro Natta, esclama: “Ha vinto Hitler. Si realizza il suo disegno, dopo mezzo secolo. … Non considero intoccabile il nome. Ma … qui crolla un mondo, cambia la storia.”18. Lo smarrimento con Occhetto cede però ra- pidamente il passo ad una reazione finalizzata a porre il Pci non sulla difensiva. Per Occhetto la caduta del Muro e lo sgretolarsi dei regimi comunisti esaltano la differenza del Pci dagli altri partiti comunisti confermandone la politica seguita da molto tempo. “Questo – dichiara il segretario del Pci quel 10 novembre appena rientrato a Roma – conferma la linea del nostro ultimo congresso. … E’ in corso un grande processo del quale noi comunisti italiani ci sentiamo partecipi e protagonisti, a cui abbiamo dato, con le nostre idee e la nostra iniziativa politica, un deciso contributo”. Gorbaciov è pur sempre al vertice del Pcus e dell’Urss ed è sulla sua scia – nella convinzione di un’autoriforma del comunismo – che il Pci ha disegnato un “nuovo corso” dopo il dimissionamento di Alessandro Natta. Occhetto imposta quindi la reazione come se egli fosse di fronte a una vittoria ovvero come la caduta in italia dell’anticomunismo. E’ un’accelerazione solitaria in quanto – ricorda Claudio Petruccioli che era “coordinatore” della segreteria – “la concezione che Occhetto ha di un gruppo dirigente è molto elementare. … A me sembra che somigli all’idea di un branco. C’è un capobranco che prende la testa e decide dove andare: gli altri seguono”. Decisione solitaria, ma non improvvisata? Piero Fassino nel 2009 ha sostenuto che da mesi tutto era pronto per la “svolta”, ma l’operazione sarebbe stata, secondo lui, rinviata a dopo le elezioni amministrative di quell’autunno e poi ancora a dopo i primi di novembre per evitare la coincidenza con il giorno dei morti. Per Emanuele Macaluso però quelle “rivelazioni di Fassino … sono facezie ridicole”.19 Quel che è certo è che proprio alla vigilia del XVIII Congresso del marzo 1989, Occhetto aveva voluto incontrare Gorbaciov per avere una sorta di “imprimatur” moscovita per il suo “nuovo Pci” e al rientro in Italia, “entusiasta” per il colloquio con il premier sovietico, aveva detto che “il vero problema sarebbe stato quello di dare vita a una grande Internazionale democratica, di cui Gorbaciov doveva essere ‘magna pars’; e, quanto all’Internazionale che già c’era, quella socialista sostenne che non era poi il caso di sopravvalutarla”20. Il XVIII congresso era stato quindi impostato guardando non allo sbocco verso il socialismo europeo, ma nel segno di un “riformismo forte” in contrapposizione a quello “debole” del socialismo italiano e delle socialdemocrazie che agivano “all’interno del sistema”. Quella che Alberto Asor Rosa chiamò la “reidentificazione del partito” ha come origine il fatto che in dieci anni il Pci ha perso un terzo dell’elettorato. E’ una crescente difficoltà di caratterizzarsi come “spinta propulsiva” nella vita nazionale in cui si intrecciano aspetti diversi: dai mutamenti della società e la loro lettura sempre classista alle destabilizzazioni nei paesi comunisti che minano il consenso ideale fino alla leadership meno carismatica di Alessandro Natta dopo la scomparsa di Berlinguer. Occhetto al XVIII Congresso tenta di voltar pagina e gioca la carta di un “nuovo Pci” nel segno dell’apertura ai “movimenti” in primo luogo femministi ed ecologisti mettendo come temi centrali quelli della “differenza sociale” e del “governo mondiale” per tutelare i beni della terra. Occhetto su questa linea spazierà dall’impegno per la tutela delle foreste dell’Amazzonia alla proposta di un piano per la bonifica del deserto del Sahel21. Richiamandosi esplicitamente all’appello pacifista contro le armi nucleari e per la salvezza dell’umanità lanciato da Palmiro Togliatti al X congresso del 1962, Achille Occhetto dalla tribuna congressuale romana lancia il grido di allarme per il “vero e proprio genocidio degli indigeni dell’Amazzonia” e addita “le foreste pluviali dell’Amazzonia” come simbolo della “catastrofe ecologica, sociale, umana”. I soggetti che il “riformismo forte” di Occhetto annovera sono i “soggetti che nell’Ottocento non c’erano” ovvero una costellazione di movimenti antagonisti: “la rivoluzione femminile, il rapporto tra quantità e qualità dello sviluppo, e quello tra Nord e Sud del mondo, la questione ambientale e quella degli armamenti”22. Gli osservatori sono pressoché unanimi nel definire il “nuovo Pci” di Occhetto come espressione di “movimentismo” (da Enzo Bettiza su “La Stampa” a Giuliano Zincone sul “Corriere della Sera”) 23. Napoleone Colajanni lasciando il Partito accusa Occhetto di “radicalcomunismo” e “partito radicale di massa” è la definizione convergente - in senso positivo - di Paolo Flores d’Arcais e - in senso negativo - di don Gianni Baget Bozzo. In questa “reidentificazione del Pci” è però essenziale per Occhetto “coprirsi a sinistra”, evitare l’accusa o soltanto il sospetto della “socialdemocratizzazione” o di “abbassare la guardia” nei confronti del Psi. Una preoccupazione che sarà nel segretario del Pci e poi Pci-Pds costante e prevalente anche dopo il cambio del nome. Ciò lo spinge da un lato all’ansia di non perdere il consenso di Ingrao e dall’altro di scavare come un fossato di salvaguardia sulla destra cercando di ridimensionare al massimo la presenza degli ex amendoliani (Napolitano e Chiaromonte) e della “destra togliattiana” (Bufalini e Macaluso). Di fronte alle sollecitazioni a cambiare nome al Pci reagisce quindi così: “Il nome che portiamo non evoca soltanto una storia, ma richiama un futuro nel quale il libero sviluppo di ciascuno sia condizione del libero sviluppo di tutti. Questa espressione, che è il più nobile e alto riconoscimento della libertà umana, è stata scritta da un grande uomo, cui si è ispirata la II Internazionale, è stata scritta dall’autore del ‘Manifesto dei comunisti’. E allora diciamo che non si comprende perché dovremmo cambiare nome. Il nostro – proferì Occhetto sollecitando un uragano di applausi – è stato ed è un nome glorioso che va rispettato”. E’ così che a conclusione del congresso, nel momento della elezione degli organismi dirigenti, si attua quel che Macaluso ricorda come un autentico “massacro” nei confronti di quanti maggiormente e più coerentemente spingevano verso l’integrazione nel socialismo europeo: “Un marcato recupero dell’ingraismo inspirerà nel 1989 il diciottesimo congresso, quello del ‘nuovo Pci’. Un congresso in cui per massacrare noi riformisti la maggioranza si organizza come una frazione”24. “Si era, insomma, - ricorderà Giorgio Napolitano – voluto dare un colpo a quella che si considerava “la destra” del partito, anche se non si aveva il coraggio di definirla tale e di combatterla attraverso un dibattito aperto”25. E’ quindi con questa discriminante interna al Partito nei confronti di Napolitano e della “destra socialdemocratica”26 che nell’89, prima della caduta del Muro, Achille Occhetto agitava il tema di una sorta di rifondazione o generale riposizionamento ideale e strategico del Pci come “nuovo Pci”. Nel giugno 1989, protestando contro la repressione di Tien An Men ordinata dal Partito comunista cinese, il leader del Pci aveva dichiarato: “Non possiamo più chiamarci allo stesso modo”27. A fine luglio 1989 Michele Salvati e Salvatore Veca sul settimanale del Partito, “Rinascita”, avevano sostenuto la necessità di abbandonare la denominazione “comunista” ed avevano proposto come nuovo nome “Partito democratico della Sinistra”28. Il commento editoriale è affidato ad uno dei più stretti collaboratori di Occhetto nella segreteria nazionale, Fabio Mussi, che dava però una risposta ancora negativa. In quell’estate 1989 il dibattito su nuova identità e critica della tradizione comunista si anima quindi tra gli intellettuali e nel gruppo dirigente del Pci. Biagio De Giovanni sull’”Unità” del 25 agosto scrive un articolo intitolato “C’era una volta Togliatti e il comunismo reale”, ma è dall’ala “migliorista”, messa in minoranza da Occhetto al XVIII congresso, che viene la più decisa pressione ad una “svolta”: Gianni Cervetti scrive ad Achille Occhetto sollecitando il mutamento del nome e Giorgio Napolitano ai primi di settembre ricorda sull’”Espresso” che “il nome nasce da una delle ventun condizioni per l’ammissione all’Internazionale comunista dell’agosto 1920”. L’ex inquisitore berlingueriano, Adalberto Minucci29, gli replica sul settimanale di Scalfari che “per cambiare il nome occorreva un congresso straordinario”30. Ma di fronte alla caduta del Muro di Berlino Achille Occhetto supera ogni dubbio e già in aereo mentre torna a Roma da Bruxelles, il segretario del Pci confida ai suoi collaboratori: “Per quanto riguarda il nuovo nome, i due concetti di riferimento dovrebbero essere comunità e libertà. Peccato che comunione e liberazione esista già!31”. E’ così che si arriva all’annuncio della possibilità di abbandonare il nome “comunista” fatto tre giorni dopo la caduta del Muro, la domenica mattina del 12 novembre, all’assemblea di ex partigiani comunisti in un quartiere di Bologna. In verità nel suo discorso il segretario del Pci si era limitato a prefigurare “grandi trasformazioni” e ad esaltare “l’incitamento a non continuare su vecchie strade ma ad inventarne di nuove per unificare le forze di progresso”. Fu il cronista dell’Ansa che al termine della manifestazione lo avvicinò e gli chiese se le “grandi trasformazioni” di cui aveva parlato avrebbero riguardato anche il nome. E Occhetto aveva risposto: “Lasciano presagire tutto”32. L’”Unità” di lunedì mattina 13 novembre – direttore Massimo D’Alema - non valorizzò l’annuncio e riportò la frase solo nell’”occhiello” sopra il titolo: “Dobbiamo inventare strade nuove”. E’ nel corso della riunione della segreteria, che come ogni lunedì si riunisce alle Botteghe Oscure, che Achille Occhetto avvia il processo decisionale33. Sul modello di Togliatti e Berlinguer, Achille Occhetto mette il gruppo dirigente del Partito di fronte al fatto compiuto e procede dal vertice più ristretto a via via quelli più ampi – dalla Direzione al Comitato Centrale fino al Congresso nazionale - per far approvare la propria iniziativa. Achille Occhetto torna quindi il martedì 14 novembre in Direzione non più sulla difensiva, ma la direzione di marcia che il segretario prospetta non è verso una ricomposizione unitaria della sinistra italiana. “Craxi – è da tempo la convinzione di Occhetto – non apre strade nuove … Proudhon contro Lenin, Garibaldi contro Pisacane, liberali contro giacobini”34. Come sottolinea l’allora “vice” di Occhetto, Claudio Petruccioli, “incombeva però lo spauracchio di Craxi, di fronte al quale ogni difficoltà passava in secondo piano”35. E cioè la direzione di marcia non può essere quella verso destra, verso la “socialdemocratizzazione”. La stessa adesione all’Internazionale socialista appare dettata dall’intento di poter in tal modo svolgere con maggior forza – ovvero accreditamento internazionale – una politica di contrapposizione ai socialisti italiani. “Io ricordo bene – precisa Emanuele Macaluso – le riunioni della Direzione in quel periodo (prima della caduta del Muro, ndr). La questione dell’ingresso nell’Internazionale la avevamo posta via via in modo sempre più esplicito noi 10 ■ CRITICAsociale riformisti. Prima ci si rispose di no, poi con mugugni, infine con un ‘sì, benissimo, ma … ’. Ma – spiega Macaluso – senza dimenticare che l’internazionale socialista era vecchia, arrugginita, senz’anima. E che sarebbe toccato a noi, al Pci-Pds, portarle sangue fresco, rivitalizzarla, cambiarla”. Era – afferma Macaluso – “una logica spocchiosa”36. E Giorgio Napolitano preciserà nella sua autobiografia che “è un dato di fatto che non si era ancora mai affrontato negli organismi dirigenti del Pci il tema di un’eventuale domanda di ammissione all’internazionale socialista e di ciò che essa avrebbe potuto comportare. Ci eravamo prefissi di intensificare le relazioni con l’internazionale socialista, ma non di più. Magari si pensava che si potesse entrare a far parte dell’Internazionale senza metterci in discussione come Pci”37. Di fronte alla caduta del Muro e per sostenere il cambio del nome Achille Occhetto quindi si richiama a due precedenti in cui l’innovazione fu accompagnata dalla condanna della esperienza dei partiti socialisti europei. Il primo è il dibattito che vi fu nel 1964 sulla proposta di Giorgio Amendola di dar vita ad un partito unico della sinistra che in concreto significava appunto cambiare nome al partito dopo la morte di Togliatti e la traumatica destituzione di Krusciov (che aveva determinato in Urss un raffreddamento della destalinizzazione). In quell’occasione ad Amendola che aveva sostenuto un parallelo fallimento dei partiti comunisti e socialdemocratici in Europa occidentale, Achille Occhetto, all’epoca segretario ingraiano della Federazione giovanile comunista, aveva replicato sostenendo che il parallelo fallimento riguardava la socialdemocrazia e lo stalinismo. Il secondo precedente è quello della dichiarazione sull’”esaurimento della spinta propulsiva dell’Urss” che nel 1981 Enrico Berlinguer accompagnò con un rilancio del terzomondismo (recandosi in America latina per incontrare Fidel Castro e i leader sandinisti del Nicaragua) e della condanna della socialdemocrazia “anche seria” (cioè tedesca e svedese) perché nella sua storia si era occupata solo dei lavoratori sindacalmente organizzati e “poco o nulla degli emarginati, dei sottoproletari e delle donne”. “Noi – affermò Berlinguer – abbiamo messo al centro della nostra politica non solo gli interessi della classe operaia propriamente detta e delle masse lavoratrici in generale, ma anche quelli degli strati emarginati della società”38. Achille Occhetto torna quindi la mattina del 14 novembre in Direzione non sulla difensiva. “Occorre tenere i nervi a posto” esordisce e quindi svolge una relazione meditata che sembra anticipare la prevalente storiografia italiana sul comunismo secondo cui “i comunisti hanno seguito i percorsi più diversi nella storia del XIX secolo. Quando hanno avuto il potere hanno contribuito a lotte di emancipazione sociale e di liberazione. Quando lo hanno avuto hanno instaurato regimi oppressivi e liberticidi”39. Relazione e dibattito, in quella seduta della Direzione del Pci all’indomani della caduta del Muro di Berlino, ruotano appunto intorno a questa tesi: nessuna corresponsabilità dei comunisti italiani che si sentono, anzi, “parte lesa” di fronte ai regimi comunisti e rivendicano di essere stati promotori del loro rovesciamento. “Ciò che è accaduto a Berlino - afferma Occhetto - ha messo in luce ciò che sapevamo”. Ed aggiunge: “La differenza e l’originalità del nostro tragitto ideale e politico è davanti a tutti”. “La crisi dei Paesi dell’Est – precisa – è per noi un fatto scontato”. “Al congresso avevamo visto ciò. … Non abbiamo nulla a che 2-3 / 2013 vedere con il crollo di quel passato”. Il Pci non è quindi coinvolto ed ha, anzi, agito per provocare la crisi del comunismo: “Noi abbiamo operato freddamente affinché ciò che sta accadendo si realizzasse”, “Se si fossero accolte le nostre sollecitazioni, tutto ciò, si sarebbe potuto fare prima e meglio”40. La relazione del segretario del Pci imposta una lettura critica “da sinistra” della storia comunista e della crisi in corso. “Salvando” Lenin, Achille Occhetto accusa: “Lo stalinismo e la sua variante brezneviana ha trasformato la grande vittoria politica e morale della resistenza in una politica di potenza che, alla luce dei fatti, si è ridotta ad una dissipazione di quel patrimonio ideale”. “Politica di potenza” e quindi “collettivismo burocratico di Stato”: la crisi è configurata come conseguenza di una sorta di tradimento di un’idea originaria, giusta, di comunismo a cui il Pci è sempre invece rimasto fedele. “Il Muro di Berlino – dichiara Occhetto – è stato una vergogna per la storia e la civiltà che noi vogliamo continuare a rappresentare”. to come spostamento politico a destra. La tensione con il Partito socialista è il principale fronte aperto. Nella relazione l’”accelerazione dei rapporti con l’Internazionale socialista” si sfuma nel quadro di “una gigantesca ricollocazione delle forze in campo” che porta il Pci “nella direzione di una nostra originale volontà di aggregare una sinistra nuova, capace di parlare alle forze di progresso, all’ovest e all’est”. La via del nuovo partito è nel rifiuto sia del rimanere comunisti sia del diventare socialdemocratici. “La discussione vera non può essere quella tra due formule contrapposte: l’unità socialista (proposta dal Psi, ndr) e il neocomunismo”, che per Occhetto sono “due posizioni entrambe settarie”. Cambiando nome secondo Occhetto si azzera il cosiddetto “fattore K”. “Nessuno d’ora in avanti può definirsi solo in quanto anticomunista” e si può quindi “togliere ogni alibi”, “rendere possibile l’alternativa”, “sbloccare la situazione italiana”. La caduta del Muro di Berlino è intesa come la caduta dell’anticomunismo in Italia. La storia del Pci è una storia “a parte” che così Occhetto riepiloga: con Palmiro Togliatti “siamo stati la parte più dinamica e intelligente del movimento comunista”, con Enrico Berlinguer “siamo divenuti un partito che con lo ‘strappo’ si poneva in una collocazione autonoma e di stimolo … ivi compresa l’influenza sulla stessa ‘perestroika’” ed infine con la sua segreteria “siamo oggi partito della Sinistra europea”. “Questa caratterizzazione – sottolinea – è chiamata adesso a svolgere tutte le potenzialità”. Una storia da continuare è quindi la motivazione di fondo che anima la svolta che Occhetto in quanto “anche il meglio della nostra tradizione è stato vissuto entro la logica dei blocchi”. Ma – aggiunge Occhetto – “ciò vale anche per gli altri”. In sostanza per Occhetto va tenuto fermo come punto centrale che la caduta del comunismo significa “il superamento del bipolarismo” e ciò va interpretato non cer- La prospettiva non è quindi una mera adesione all’internazionale socialista, ma una di evoluzione e rigenerazione grazie all’ingresso dei comunisti italiani di quell’organismo secondo “il progetto congressuale di una democratizzazione globale” e quindi, oltre l’Internazionale socialista, Occhetto esalta “il Progetto dell’eurosinistra” e “di una nostra autonoma funzione in questo quadro”. La direzione di marcia in Italia non è pertanto quella della ricomposizione della sinistra italiana, con il Psi (“E’ da comunque da respingere ogni visione subalterna che si acconciasse alla richiesta di altri di accedere ad una non meglio definita unità”), ma la ricomposizione di tutto ciò che è a sinistra del Psi come gli sarà contestato dai “miglioristi” nel corso del dibattito. Achille Occhetto sembra cioè esortare a vivere la caduta del Muro di Berlino come se fosse una sorta di nuovo Sessantotto: rinnova- re il Partito proponendolo come rappresentanza per nuovi movimenti e nuovi soggetti di una nuova sinistra. Il Partito deve – precisa Occhetto – “raccogliere energie nuove”, “rimettere in moto tutte le forze disperse di una sinistra diffusa, di una sinistra sommersa e scoraggiata”. Con il mutamento del nome, i comunisti, “fondando il ‘riformismo forte’”, secondo Occhetto, possono in modo più libero e convincente far sì che “questi altri ‘soggetti’ … possono riconoscere la loro funzione in qualcosa di nuovo a cui essi partecipano”. Il cambio del nome, prosegue il segretario del Pci, significa quindi dar vita ad “una formazione politica capace di aggregare forze nuove: si può così aprire la strada ad una vera e propria costituente, a un processo alla cui fine vi sia una cosa nuova e un nome nuovo”. La conclusione sembra una citazione del “Gattopardo”: “Occorre oggi avere … coraggio di innovazione, anche al fine di conservare l’essenziale, altrimenti il rischio è che tutto vada superato”. Achille Occhetto rivolge quindi un appello al voto positivo alla sua proposta di cambiare il nome proprio per salvaguardare “ciò che è stato essenziale e ha reso grande il Pci”, “ciò che c’è di meglio della nostra storia”. “Non a caso – sottolinea – ho voluto scegliere una assemblea di veterani per porre il problema”. Conclusa la relazione – sono le 13.30 – Achille Occhetto sospende la seduta e, senza preoccuparsi del dibattito sulle sue proposte, scende nella sala stampa ed annuncia la “Costituente per la rifondazione del partito”41. Massimo D’Alema, che dirige “L’Unità”, nel pubblicare la dichiarazione di Occhetto la farà seguire da un commento “più prudente sulla discontinuità”42. Infatti nel dibattito non c’è solo la linea di demarcazione tra chi appoggia la svolta e chi si oppone in quanto chi contesta Occhetto in seno all’organismo di 54 membri, sono voci isolate: Luciana Castellina dell’ex “Manifesto” (che definisce la proposta di Occhetto “una risposta pigra, nominalistica, preoccupata più dell’involucro che della sostanza” che rischia di determinare “una perdita di identità”), Gianluigi Cazzaniga che era stato segretario della federazione giovanile del Psiup e soprattutto Lucio Magri che era stato il primo (ed unico nella prima giornata di dibattito) a pronunciare un “no secco”43. Per l’ex radiato del “Manifesto” che era rientrato nel Pci, dopo lo scioglimento del Pdup, nel 1984 “il cambiamento del nome del partito è anzitutto un fatto simbolico” e rischia di essere interpretato come segnale “che si esaurisce, o almeno si attenua di molto, la nostra ambizione di costituire una forza antagonista”. La replica di Occhetto a queste parole di Magri sarà risentita: “Quel che è inaccettabile è l’accusa infamante di cedimento. Non l’accetto perché ho servito sempre questo partito con passione, non ho mai sentito il bisogno di abbandonarlo”. Anche Giuseppe Chiarante, pur senza opporsi, esprime riserve: “Si rischia di dare un’immagine liquidatoria della storia del Pci”. I dirigenti cresciuti da Togliatti, Longo e Berlinguer seguono in blocco il segretario, ma gli accenti sono diversi. Emanuele Macaluso intervenendo subito dopo la relazione avverte “il rischio, in definitiva, di legare la nostra vicenda a quella dell’Est”. Egli preferirebbe una maggiore decisione nell’avere come obiettivo “lo sbocco nell’alveo del socialismo europeo”. “Superiamo – esorta - le ambiguità della parola ‘siamo nella sinistra europea’, siamo nel socialismo europeo, verso la sua area….Non rientro, - tiene a precisare - ma entrata con la storia che ci appartiene”. Il cambio del nome deve rappresentare per Macaluso una reale soluzione di CRITICAsociale ■ 11 2-3 / 2013 continuità con le posizioni “antagoniste” coltivate in campo comunista: “Il Paese ha bisogno di una sinistra di governo e non di una sinistra di opposizione”. Ma anch’egli si preoccupa di ribadire la continuità con la sostanza dell’esperienza storica che si ha alle spalle (”Il partito non si scioglie, il nucleo essenziale della sua politica resta l’asse di ogni futuro”) e di evitare cedimenti verso il PSI in quanto Craxi punta a “guadagnare una egemonia sulla sinistra con un collasso del Pci. E’ un progetto suicida per la sinistra. Dobbiamo contrastarlo”. Ma il predecessore di Occhetto, Alessandro Natta, e lo stesso Aldo Tortorella (che era stato tra i principali sponsor della ascesa di Occhetto), appaiono esitanti. Tortorella rivendica l’orgoglio di Partito: “Deve essere chiaro che noi siamo l’opposto dei partiti dell’est: noi che siamo stati non gli oppressori, ma i discriminati”. Ed anche nell’ambito degli ex “ragazzi di Berlinguer”, che costituiscono il gruppo più fedele ad Occhetto, si intravedono le differenziazioni che segneranno la vita del postcomunismo dallo scontro per la successione ad Occhetto fino ad oggi. Walter Veltroni, più in sintonia con il segretario, guarda ai movimenti della cosiddetta “società civile” e auspica “una maggiore capacità di aggregazione di quella sinistra diffusa e sommersa di varia ispirazione che non riesce ad esprimersi sul piano politico”. Massimo D’Alema, più preoccupato della tenuta di ciò che è già organizzato, si erge invece a custode e garante della tradizione (“Non abbiamo un passato da cancellare o di cui vergognarci”) e più aperto verso quanti svolgono ruolo frenante nei confronti di Occhetto. Il nuovo nome, precisa, significa che non si dà vita ad un “partito neo-comunista”, “ma – aggiunge al fine di riassorbire le preoccupazioni di sinistra - una speranza di questo tipo deve poter vivere nella nostra formazione”. L’intervento di D’Alema è quindi volto a difendere la esperienza del PCI nel suo complesso e a ribadire la condanna del socialismo autonomista come “tradimento”. “L’originalità e il valore del Pci sono stati – afferma - nella sua capacità di rappresentare un punto di confluenza tra la tradizione democratica europea e l’esperienza che si era aperta con la rivoluzione d’ottobre”. “La discriminante tra noi e il Psi – precisa – non passa tra democrazia e totalitarismo”. Senza svolgere considerazioni autocritiche D’Alema propone una linea di attacco al PSI dato che è per lui evidente “la rinuncia del partito socialista ad una battaglia che si ispiri ai valori e alle idealità del socialismo. … Il Psi non conduce una battaglia socialista”. E quindi di fronte alla caduta del Muro di Berlino il comunismo italiano trova più conferme che smentite alla sua storia: “Questa crisi può anche liberare nuove forze… Rilanciare su basi nuove la funzione internazionale del Pci”. E’ significativo che al termine della riunione Massimo D’Alema tiene a sottolineare il proprio distinguo da Occhetto. Rivolgendosi al capo ufficio stampa di Occhetto, Massimo De Angelis, dirà: “Guarda che sto con voi solo perché dall’altra parte (tra gli oppositori al cambio del nome, ndr) sento puzza di morto”44. Sulla stessa lunghezza d’onde di D’Alema è Piero Fassino. Il cambio del nome, per il responsabile dell’organizzazione del PCI, “non è né una rottura, né una svendita, ma lo sbocco naturale, il coronamento di un lungo itinerario che il Pci non percorre da oggi”, ma “da almeno vent’anni”. La storia comunista “è un patrimonio che ora … il Pci mette a disposizione di un processo politico più ampio”. Nella maggioranza degli intervenuti emerge comunque l’insistenza sulla continuità in nome della autonomia e della diversità del Pci da un lato verso i partiti comunisti al potere e dal- l’altro verso i partiti italiani che hanno governato l’Italia. “Noi – dichiara Nilde Iotti - che abbiamo una così gloriosa storia alle spalle, non possiamo essere costretti alla difensiva”. La vedova di Togliatti esprime così un autorevole ‘salvacondotto’ al segretario del Partito sollecitando ad “andare senza indugi e speditamente all’esperimento che ci propone Occhetto” proprio, afferma, per “onorare la nostra storia”. Anzi gli sconvolgimenti in corso possono essere l’occasione per “riacquistare nei confronti del Psi quell’autorità che negli ultimi anni abbiamo perduto”. Giancarlo Pajetta appare invece più prudente ed esprime dissenso “sulle motivazioni della svolta proposta” criticando “chi ha ripetuto il termine di accelerazione e di inevitabile”. Soprattutto non condivide l’idea di dare vita a una “Costituente” che rischia di determinare un dialogo in sostanza solo sulla sinistra, con la cosiddetta “nuova sinistra”: “C’è il rischio – afferma – di sentirci rispondere di sì soltanto da chi rappresenta briciole di movimenti dispersi anche se vi sono stati errori nostri che sono durati nel tempo….Non siamo a rimorchio degli avvenimenti”. Anche per Zangheri dopo la caduta del Muro i comunisti possono allargare lo spazio di penetrazione denunciando “gli indirizzi neoliberistici su cui il Psi si è adattato”. Ugualmente per Ugo Pecchioli il cambiamento si iscrive in una linea di sostanziale continuità: (“Esso in fondo realizza idealità che furono pure della Resistenza”) e mette in guardia da “i rischi di una svendita alle richieste di Craxi”. Quando però il più stretto collaboratore di Achille Occhetto, Claudio Petruccioli, per sostenere il cambio del nome afferma “da tempo non siamo comunisti”, in sala scoppia quel che egli ricorderà come “un putiferio”. “In molti mi interruppero, ma Natta sovrastò gli altri. Con il viso alterato, mi urlò: ‘Parla per te!’. La comunità era rotta”45. E’ quindi la destra che reagisce all’arroccamento che può portare a un isolamento. Paolo Bufalini in contrasto con il rilancio di una politica antisocialista a protezione della transizione che si deve affrontare sostiene in- o ci offre il contributo spesso confuso di idee che non possiamo condividere”. E’ invece Gianfranco Borghini a sollecitare Occhetto affinché la caduta del comunismo ed il cambio del nome non aprano una nuova stagione di offensiva sulla destra, ma, al contrario portino ad “interrompere la spirale polemica con il Psi”. Alfredo Reichlin, che da posizioni “ingraiane” è diventato un autorevole collaboratore prima di Berlinguer e poi di Occhetto, sottolinea la attualità dell’”insegnamento di Togliatti” e, in polemica con il PSI, sostiene che nella storia della sinistra italiana ”in verità i riformisti siamo stati noi”. Anche Renato Zangheri invita a legare il cambio del nome alla riconferma della continuità con la storia del partito: “Si pensi al Palmiro Togliatti della Costituente e dell’VIII Congresso. Si pensi a Gramsci che è un gigante del pensiero socialista del ‘900. Possiamo dunque parlare a fronte alta vece che “si tratta di lavorare per una ricomposizione unitaria delle forze del socialismo italiano”. “Ci si deve – afferma - proporre nell’immediato un miglioramento di rapporti tra le forze della sinistra ed in particolare tra Pci e Psi….Non giova a tal fine una deformazione polemica della proposta di unità socialista”. Anche Gerardo Chiaromonte butta acqua sul fuoco nei rapporti tra Pci e Psi dichiarando – in riferimento alle prese di posizione socialiste - “non mi sento turbato se altri ci chiedono di cambiare il nome”. ”Ad ogni modo – insiste - dobbiamo tendere a un miglioramento radicale dei rapporti tra noi e il Psi”. E rivolto al segretario del partito aggiunge: “Critico il metodo che è stato seguito parlandone prima all’esterno.… Ne faccio un problema sostanziale … Nessuno deve avere l’impressione di trovarsi di fronte a un dilemma fra prendere o lasciare, a una decisione (presa dalla Direzione o dalla Segreteria) che non si può modificare e anche respingere”. Anche l’ex numero due di Berlinguer all’epoca della “solidarietà nazionale” tiene a sottolineare la continuità con il passato: “Abbiamo commesso certamente molti errori politici e di giudizio, ma non abbiamo niente di cui vergognarci per il nostro lavoro in Italia”. “Davvero – insorge Chiaromonte – milioni di persone sono state preda per 70 anni di una colossale mistificazione?”. La polemica politica di Chiaromonte è quindi verso Veltroni e lo stesso Occhetto: “Non ci può essere discorso sulla sinistra diffusa o sommersa che possa sostituire quello dei rapporti positivi fra noi e il Psi”. E’ in questo quadro che si colloca l’intervento di Giorgio Napolitano. dedicato soprattutto al “rapporto organico da stabilire con l’Internazionale Socialista”.che viene commentato in queste pagine per “Critica Sociale” da Gianni Cervetti. In realtà da tempo Giorgio Napolitano aveva prefigurato una svolta in quella direzione. Già nel 1988 egli aveva sostenuto che il Pci era “ben oltre Togliatti e la sua scelta di campo” e si poteva considerare “uscito dai confini della tradizione comunista”46. Ancora ai primi di giugno del 1989, in occasione delle elezioni europee, Napolitano aveva dichiarato che “il cambiamento del nome può essere preso seriamente in considerazione”47. Napolitano sembra convinto che la forza delle cose, i processi ormai in atto sulla scena mondiale, siano destinati a determinare comunque un’evoluzione positiva della crisi del Pci in quanto è ormai inevitabile la confluenza nel socialismo europeo. Nel raggiungimento di questo traguardo obbligato anche il percorso è obbligato e cioè il riconoscimento del ruolo di chi nel Pci è più affidabile agli occhi dei partiti dell’Internazionale. Parallelamente, anche i rapporti con il Psi sono destinati a migliorare in quanto Napolitano sa benissimo che Craxi, se si vuole entrare nell’I. S., non può essere ‘scavalcato’. Proprio in quelle ore il presidente dell’Internazionale Socialista, Willy Brandt, da Bruxelles ha dichiarato in modo inequivocabile che “davanti ad una domanda di adesione del Pci all’Internazionale Socialista avrei difficoltà”. E così ha chiarito: “C’è una regola non scritta secondo la quale i partiti membri dell’I. S. dovrebbero dare il loro parere. Di fronte ad un’eventuale domanda del Pci – ha spiegato Brandt – il Psi e il Psdi dovrebbero mettersi d’accordo”48. Ma la replica conclusiva di Achille Occhetto delinea invece la priorità di guadagnare consensi soprattutto alla propria sinistra: nel partito e fuori dal partito. Nel suo discorso il segretario del Pci continua a ripetere che non si tratta né di rinnegare la propria storia né di andare a destra. La sua proposta, egli sottolinea, rappresenta “una sfida in avanti che non ha nulla di liquidatorio, ma esprime il meglio della nostra tradizione”. “Nulla va disperso. … Siamo – rassicura - con i compagni che mostrano oggi grande affetto per il Pci e per la sua grande storia. E’ anche l’affetto mio e di tutti noi”. Il cambio del nome è motivato dal dare vita a “una nuova forza politica che sia il risultato di un processo di aggregazione a sinistra”. Per riscuotere consenso alla sua proposta Occhetto insiste quindi sul pericolo di destra che altrimenti si favorirebbe come mostrano diverse situazioni nell’Est: “In Ungheria si cerca tra grandissime difficoltà di salvaguardare una prospettiva socialista e democratica” di fronte a “seri pericoli di destra”; in Urss ci sono “fenomeni nazionalistici” e “lotte cruente” che “indicano rischi”. Sul piano della gestione interna il segretario si mostra disponibile ad accettare la richiesta 12 ■ CRITICAsociale 2-3 / 2013 di maggiore “collegialità” venuta non solo da destra, da Macaluso e Chiaromonte, ma anche da Tortorella arrivando persino a ridimensionare il suo discorso della “Bolognina”. Essendogli stato contestato di aver messo la Direzione di fronte ad un fatto compiuto, Occhetto si difende sostenendo di aver solo detto genericamente che “si poteva discutere di tutto”. Ma, soprattutto, Occhetto tiene a rassicurare che egli sarà contro chi volesse “spacciare il nostro sforzo come un processo di omologazione verso un’unità socialista indistinta”. Quindi, insiste, “niente di liquidatorio” e ribadisce “tutto l’orgoglio che ci ha portati sin qui” contro “ogni rischio di cedimento subalterno”. “Con i socialisti il rapporto va posto come sfida sul terreno dell’alternativa”. Verso il Psi secondo Occhetto “vi sono differenze programmatiche rimarchevoli che – assicura il resoconto dell’Unità - non c’entrano nulla con la situazione dell’Est”49. “Non c’è bisogno di omologazione, - conclude Occhetto - ma di un conflitto”. Dalla caduta del Muro di Berlino, secondo il leader del Pci, viene la conferma del “nucleo delle idee-forza del XVIII congresso”. L’unico condizionamento che il segretario del Pci nella replica prende in considerazione è solo sulla sua sinistra. Ingrao non è presente e Occhetto prevede e teme il suo dissenso. Cossutta non è più membro della Direzione, ma è già sicuro il suo voto contrario in Comitato Centrale. In seno alla Direzione il suo predecessore ora presidente del partito, Alessandro Natta, capeggia l’ala frenante che non vuole ancora decidere sul cambio del nome. Dopo due giorni di dibattito attraverso quarantacinque interventi quando la sera del 15 novembre si tratta di concludere è appunto Natta a sostenere di andare al Comitato Centrale convocato per lunedì 20 novembre senza un voto della Direzione che potesse “in qualche modo apparire vincolante”. Occhetto accetta dichiarando che ciò era già “implicito” nel suo discorso conclusivo. La riunione si chiude così senza un voto. Rimangono a verbale “il dissenso completo” di Magri e Castellina, le “critiche” di Pajetta e le “riserve” di Chiarante. “Scelta giusta. Tuttavia – rifletterà poi Emanuele Macaluso - a quella svolta non fu data una base politica in grado di parlare non solo al partito, ma al paese. … Quale Pds aveva in mente il nuovo gruppo dirigente del partito ce lo dice il fatto che a Leoluca Orlando, come ha dichiarato più volte lo stesso sindaco di Palermo senza essere smentito, era stato offerto l’incarico di segretario con Occhetto presidente. Cosa aveva a che fare Orlando con il riformismo e l’area socialista italiana ed europea non si capisce. O si capisce abbastanza”50. s Ugo Finetti NOTE 1 Tra i tanti esempi può essere ricordato l’uso di questa espressione da parte di Enrico Berlinguer nell’incontro Pci-Pcus del 14 novembre 1968 (dopo la “riprovazione” espressa in agosto nei confronti dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia) quando egli ricorda, senza alcuna revisione critica, come nel 1956 per la repressione in Ungheria vi fu “l’appoggio all’azione delle truppe sovietiche da parte di tutto il movimento comunista internazionale” (Verbale dell’incontro in Pietro Folena, “I ragazzi di Berlinguer”, Baldini&Castoldi, Milano 1997, pag. 212). 2 Intervista di A. Zypko del C.C. del Pcus in Chiara Valentini, “Il nome e la cosa”, Feltrinelli, Milano 1990, pag. 50. 3 E’ rispuntata l’illusione dello sfondamento verso di noi alle amministrative del 1990 e in altre occasioni, con provocazioni indegne e grottesche”. APC 8912, Direzione 8 novembre 1989. 17 Achille Occhetto, “Il sentimento e la ragione (Un’intervista di Teresa Bartoli)”, Rizzoli, Milano 1994, pp. 63-64. 18 Claudio Petruccioli, “rendiconto”, Il Saggiatore, Milano 2001, pag. 26. 19 Emanuele Macaluso, “Bolognina: una svolta senza progetto”, “Le nuove Ragioni del socialismo”, dicembre 2009, pag. 15 20 Paolo Franchi, op. cit., pag. 140. 21 De Angelis, op. cit., pag. 61. 22 Achille Occhetto, “Un indimenticabile ’89”, pag. XIII. 23 Per questi commenti v. Nello Ajello, “Il lungo addio. Intellettuali e Pci dal 1958 al 1991”, Laterza, Bari 1997, pp. 373-375. 24 Emanuele Macaluso, op. cit., pag. 138. 25 Giorgio Napolitano, “Dal Pci al sociali- 12 smo europeo. Un’autobiografia politica”, Laterza, Bari 2005, pag. 238. 26 Definizione solitamente già in uso durante la segreteria Berlinguer per definire polemicamente Napolitano e Chiaromonte, mentre Bufalini e Macaluso erano definiti “destra storica” (v. Luciano Barca, “Cronache dall’interno del vertice del Pci”, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, in particolare il vol II, “Con Berlinguer”, ad es. pag. 715). 27 Claudio Petruccioli, op. cit., pag. 21. 28 Michele Salvati, Salvatore Veca, “E se non ora quando? Cambiare nome”, Rinascita, 29 luglio 1989, n. 25, pp. 35-38. 29 A Minucci nel settembre 1981 Enrico Berlinguer aveva affidato la relazione-requisitoria contro Giorgio Napolitano nella Direzione del Pci per il “processo” che si sarebbe concluso con l’allontanamento di Napolitano dalla segreteria nazionale ‘degradandolo’ a presidente del gruppo parlamentare comunista della Cfr. in proposito Massimo De Angelis, “Post. Confessioni di un ex comunista”, Guerini Associati, Milano 2003, pp. 48-52. 4 Eugenio Scalfari (intervista a Achille Occhetto), “Ho fatto quel che dovevo”, “La Repubblica”, 17 dicembre 1989. 5 Achille Occhetto, “Un indimenticabile ’89 (a cura di Massimo De Angelis)”, Feltrinelli, Milano 1990, pag. XIII. 6 Ibidem, pag. XIV. 7 Achille Occhetto, “Il sentimento e la ragione. Intervista con Teresa Bartoli”, Rizzoli, Milano 1994, pag. 86. 8 Cfr. Giorgio Dimitrov, “Dal fronte antifascista alla democrazia popolare”, Edizioni Rinascita, Roma 1950, pp. 88-90. 9 Achille Occhetto, op. cit., pag. 89. 10 Achille Occhetto, op. cit., pag. 87. 11 Titolo del libro di ricordi di Pietro Folena - che nel 1989 era segretario nazionale della Federazione giovanile comunista (FGCI) edito da Baldini&Castoldi nel 1997. Già nella Direzione del 17 dicembre 1980, Giorgio Napolitano, all’epoca responsabile organizzazione, aveva affermato: “Il centralismo democratico è stato nella storia ‘elastico’ (come dice Gramsci). Anche in Lenin, si è dimostrato, che vi sono più visioni del Partito, più ‘concezioni’ del Partito a seconda delle situazioni storiche” (Atti Direzione PCI, Fondazione Istituto Gramsci, APC 8107). 13 Umberto Curi, “Lo scudo di Achille. Il Pci nella grande crisi”, Franco Angeli, Milano 1990, pag. 29. 14 Carlo Baccetti, “Il Pds”, Il Mulino, Bologna 1997, pag. 50. 15 Tutte le citazioni del dibattito sono tratte dal verbale custodito presso la Fondazione Istituto Gramsci, APC 8912, Direzione 8 novembre 1989. 16 Giorgio Napolitano: “E’ prevalsa [nel Psi], per scelta di Craxi, una risposta negativa a qualsiasi proposta di dialogo e di alternativa. Camera. 30 Iginio Ariemma, “La casa brucia. I Democratici di Sinistra dal PCI ai giorni nostri”, Marsilio, Venezia 2000, pag. 43. 31 Massimo De Angelis, “Post. Confessioni di un ex comunista”, Guerini e Associati, Milano 2003, pag. 31. 32 Achille Occhetto, “Secondo me”, Piemme, Casale Monferrato 2000, pag. 304. La frase di Occhetto nell’articolo viene sintetizzata in un “Tutto è possibile” nella titolazione. Walter Dondi “Occhetto ai veterni della Resistenza”, L’Unità 13 novembre 1989. 33 Nella segreteria eletta al XVIII congresso Achille Occhetto oltre a riconfermare lo “staff” di cui si era circondato dopo l’elezione a segretario nel 1988 (Claudio Petruccioli, Piero Fassino, Fabio Mussi e Livia turco) aveva aggiunto Antonio Bassolino come “garante” della sinistra ingraiana controbilanciato dall’ingresso di altri due, suoi ‘fedelissimi’: Walter Veltroni ed il segretario amministrativo Marcello Stefanini. 34 Ferdinando Adornato (intervista a Achille Occhetto), “Siamo figli dell’’89”, “L’espresso”, 23 gennaio 1989. 35 Claudio Petruccioli, op. cit., pag. 22. 36 Paolo Franchi, Emanuele Macaluso, “Da cosa non nasce cosa”, Rizzoli, Milano 1997, pag. 140. 37 Giorgio Napolitano, op. cit., pag. 246. 38 Sugli incontri di Enrico Berlinguer con i dittatori castristi e sandinisti in America Latina e la conferenza-stampa contro le socialdemocrazie europee v. anche Ugo Finetti, “Storia di Craxi”, Boroli, Milano 2009, pag. 135. L’ultima giornata di Berlinguer a Managua, capitale del Nicaragua, coincise con l’arresto di dirigenti della Confindustria locale e del partito comunista deciso nella notte dal regime sandinista. Berlinguer, alla notizia degli arresti, reagì dichiarando ai giornalisti che “i comunisti italiani risolverebbero le divergenze con metodi politici” (v. l.f., “Incontro di Berlinguer con I leaders della guerriglia in Salvador”, La Stampa, 24 ottobre 1981). Il giorno prima Berlinguer era stato a pranzo con il ministro dell’Interno Borge e al “coordinatore” della giunta sandinista, Daniel Ortega, il segretario del Pci aveva espresso “l’amicizia e la solidarietà concreta con la vostra rivoluzione” e le “affinità che sentiamo nei confronti della vostra esperienza” (Ugo Baduel, “I colloqui di Berlinguer in Nicaragua”, L’Unità 22 ottobre 1981). 39 Sivio Pons, Robert Service (a cura di), “Dizionario del comunismo, Einaudi, Torino 2006, pag. XVII. 40 Tutte le citazioni del dibattito sono tratte dal verbale custodito presso la Fondazione Istituto Gramsci, APC 8912, Direzione 14 novembre 1989. 41 “Un nuovo partito per la sinistra”, “L’Unità”, 15 novembre 1989. 42 Luciano Barca, op. cit., Vol. III. “La crisi del Pci e l’effetto domino”, pag. 1072. 43 Lucio Magri, “Il sarto di Ulm. Una possibile storia del Pci”, Il Saggiatore, Milano 2009, pag. 394. 44 Massimo De Angelis, op. cit., pag. 51. 45 Claudio Petruccioli, op. cit., pag. 27. 46 Giorgio Napolitano, “Parole e silenzi di Togliatti”, L’Unità, 21 febbraio 1988. 47 Nello Ajello, “Il lungo addio. Intellettuali e Pci dal 1958 al 1991”, Laterza, Bari 1997, pag. 385. 48 “Brandt: Devono accordarsi Psi e Psdi”, L’Unità 16 novembre 1989. 49 Giorgio Frasca Polara, “il nostro patrimonio va arricchito, non disperso”, L’Unità 16 novembre 1989. 50 Paolo Franchi, Emanuele Macaluso, “Da cosa non nasce cosa”, Rizzoli, Milano 1997, pp. 25-26. CRITICAsociale ■ 13 2-3 / 2013 ■ QUANDO SCALFARI SPINSE BERLINGUER SULLA STRADA DELLA “DIVERSITÀ” E DELLA “QUESTIONE MORALE” L’OPPOSIZIONE DI NAPOLITANO ALLA TRASFORMAZIONE “AZIONISTA” ETERODIRETTA DEL PCI (1984) “L Ugo Finetti a regia scalfariana delle vicende politiche della sinistra non aiuta certo la ricerca di convergenze”: così, un “fedelissimo” di Enrico Berlinguer come Luciano Barca, commenta la pubblicazione dell’intervista del segretario del PCI su “Repubblica” del 2 agosto 1978. In effetti Eugenio Scalfari svolse un’influenza non secondaria sull’“ultimo Berlinguer”. In una lettera del 1996 - proprio a Luciano Barca - il fondatore di “Repubblica” ricorda con una certa commozione: “L’incontro con lui (con Berlinguer, ndr) è stato uno dei più fecondi che io abbia avuto, e quando dico con lui dico con tutto un gruppo che con lui ha operato per la trasformazione senza perdere di vista la radice ma puntando su nuovi fiori e nuovi frutti”. E aggiunge: “Ho cercato dal canto mio di contribuire da fuori a questa operazione, forse tra le più importanti alle quali – a mio modo – abbia partecipato”. “Questa operazione” di “trasformazione” è soprattutto la politica condotta da Berlinguer dal momento in cui abbandonando la maggioranza di “solidarietà nazionale” ripropone la “diversità” comunista, non più in nome del leninismo (centralismo democratico e internazionalismo proletario) ma della “questione morale”. E’ appunto il periodo in cui cresce il contrasto tra Napolitano e Berlinguer. Quando nel gennaio 1984 Giorgio Napolitano si trovò nuovamente in contrasto con Enrico Berlinguer, Giorgio Ruffolo scrisse su “Repubblica” un articolo intitolato “Il caso Napolitano”. Di che si trattava? Giorgio Napolitano era già entrato in polemica con Berlinguer nell’estate 1981 dopo l’intervista del segretario del PCI del 28 luglio sulla “questione morale” ed era stato “processato” nella Direzione del 10 settembre e quindi estromesso dalla segreteria nazionale e destinato a dirigere il gruppo parlamentare a Montecitorio. Come capogruppo comunista alla Camera, tra la fine del 1983 e l’inizio del 1984, Giorgio Napolitano aveva nuovamente suscitato il dissenso del segretario del PCI in relazione al modo di contrastare alla Camera l’azione del governo guidato dal segretario del PSI. Napolitano anziché boicottare il dibattito sulla finanziaria e provocare l’esercizio provvisorio aveva – con l’appoggio (ed anche la pressione) di Nilde Jotti presidente comunista della Camera – concordato il calendario dei lavori ottenendo in cambio maggiori risorse per gli enti locali e un incremento del fondo investimenti. Berlinguer lo avrebbe definito un “increscioso episodio”. Contro Napolitano erano allora insorti Renato Zangheri e Alfredo Reichlin della segreteria nazionale. Napolitano reagì spiegando le sue ragioni in un articolo sull’”Unità” del 4 gennaio intitolato “Il ruolo dei comunisti oggi in Parlamento”. In esso Napolitano aveva polemicamente giustificato un “confronto non settario … che può portare risultati positivi”. “La Repubblica”, titolò in prima pagina: “Napolitano attacca la linea Berlinguer”. Giorgio Napolitano dovette quindi scrivere immediatamente, il 6 gennaio, un secondo articolo (“Ancora sulla nostra opposizione”) per respingere “il pettegolezzo”. Ufficialmente la Direzione del PCI negò contrasti. Sull’Unità però in quei giorni compaiono non solo lettere a favore e contro il presidente dei deputati, ma persino una vignetta di Staino che ritrae “Molotov” che attende mi- naccioso l’arrivo di Napolitano alla Festa invernale dell’Unità. Secondo Alberto Jacoviello (“Napolitano, il laico”, La Repubblica 12 gennaio 1984) il malumore del segretario del PCI si riversava non solo su Napolitano, ma anche sul comportamento di Nilde Jotti e del leader della CGIL Luciano Lama. Giorgio Ruffolo era quindi intervenuto il 18 gennaio come esponente della sinistra socialista a sostegno della posizione assunta dal capogruppo comunista alla Camera. Entrando più nel merito, Ruffolo vedeva nella politica di attacco frontale alla presidenza socialista la riduzione dell’alternativa da parte di Berlinguer ad una dimensione sostanzialmente “escatologica” e solo futuribile, mentre con Napolitano, nella linea di “un’opposizione che – scriveva Ruffolo - voglia diventare domani governo con i socialisti”, vi era la ricerca di un’alternativa “politica”. Vi era tra Napolitano e Berlinguer una sostanziale divergenza. La tensione del gennaio 1984 infatti crebbe nelle settimane successive in relazione al dibattito parlamentare sul decreto sulla scala mobile fino a cristallizzarsi, subito dopo l’approvazione definitiva del decreto, tanto che il capogruppo comunista alla Camera il 22 maggio invia una lettera (scritta a mano “per evitare qualsiasi indiscrezione”) a tutti i membri della segreteria nazionale come promemoria per una futura discussione, dopo che Berlinguer aveva annunciato il proposito di voler giungere a un definitivo chiarimento interno dopo le elezioni europee. Nella lettera Napolitano dichiarava la propria disponibilità a dimettersi da capogruppo e di essere pronto ad abbandonare l’impegno “in prima fila”. “Berlinguer – ha detto Natta rievocando nel 1992 quel dissidio – aveva l’impressione, l’opinione di essere stato non aiutato, di essere un po’ tradito”. E nel malcontento di Berlinguer per un insufficiente sostegno nello scontro con Craxi, secondo Alessandro Natta (all’epoca “ presidente della Commissione centrale di controllo” della segreteria nazionale del PCI), c’era anche la Jotti “perché Berlinguer avrebbe voluto che la Presidente della Camera fosse d’accordo con noi”. Il contrasto tra l’arroccamento di Berlinguer e la tessitura di rapporti di Napolitano rispecchia una dialettica di “lungo corso” in seno al PCI. In Berlinguer, cresciuto all’ombra di Togliatti all’interno delle Botteghe Oscure, vi è il primato della tradizione “centrista”: “Non so – volle puntualizzare Berlinguer nel Comitato Centrale del novembre 1979 in polemica con la “destra” di Giorgio Amendola - che cosa sarebbe avvenuto, da trentacinque anni a questa parte, se il nostro partito non avesse avuto sempre a dirigerlo un ‘centro’. Essere il ‘centro’ – affermava Berlinguer - non significa essere equidistanti, … significa, di volta in volta, combattere contro quegli scarti, quelle incoerenze rispetto alla linea del partito, che si manifestano, e che si rivelano, ora in un senso ora in un altro più pericolose: non dimenticando che la tendenza più pericolosa è quasi sempre quella contro cui si cessa di lottare”. Sono parole che molto chiaramente dipingono come Berlinguer dirigesse il PCI e cioè secondo una logica di stato di lotta permanente contro “tendenze pericolose”. Diversa era la militanza di Giorgio Napolitano, cresciuto sulla scia di Giorgio Amendola, nella realtà campana come segretario di federazione, consigliere comunale e parlamentare (sin dal ’53) secondo due direttrici: rapporti unitari con gli altri partiti e analisi della situazione economica. Con tutti i suoi limiti, contraddizioni ed errori la storia “di destra” nel PCI di Napolitano non può non suscitare rispetto e simpatia per due ragioni: il livello culturale e l’indiscutibile coerenza politica. Si deve a Paolo Franchi una seria ricostruzione di questo itinerario che intreccia la storia del Partito comunista con quella della vita nazionale, dall’immediato dopoguerra a oggi, con il suo “Giorgio Napolitano. La traversata da Botteghe Oscure al Quirinale” (Rizzoli, 425 pagine, 18 euro)”. Paolo Franchi gran parte di queste vicende le aveva seguite, soprattutto negli anni dell’”ultimo Berlinguer” e poi dell’”ultimo PCI” per il “Corriere della Sera”, scrutando e rendendo intellegibile la dialettica interna delle Botteghe Oscure. Oggi la sua ricostruzione consente di seguire la coerenza di un impegno politico rivolto a vincere le posizioni antioccidentali e antieuropeiste presenti nel PCI e, più in generale, nell’ambito della sinistra italiana. Un’azione che Paolo Franchi mette in rilievo nel quadro, da un lato, di una capacità di confronto con le altre forze politiche e, dall’altro, di una crescita comunista nelle relazioni istituzionali. Vediamo quindi come il ruolo di Napolitano nel PCI si è esercitato in particolare nella definizione della politica economica e di quella internazionale. A Napolitano si rimprovera però mancanza di coraggio, di non aver dato battaglia aperta. In verità di scontri aperti – in particolare con Berlinguer all’apice della sua popolarità e padronanza del partito – non ne sono mancati pagando il prezzo anche di “processi” e retrocessioni. La questione di fondo – modo e spazio politico per le posizioni “di destra” sotto Berlinguer - non è quella personale circa l’aver avuto sufficiente “coraggio” oppure no, ma riguarda le ragioni per cui le posizioni “riformiste-miglioriste” nel PCI non sono state “popolari”. Il traguardo di dichiarare il PCI “parte integrante della sinistra europea” fu raggiunto (solo) nel Congresso di Firenze del 1986 grazie ad una azione di vertice. Perché proclamarsi “parte integrante della sinistra europea” non fu raggiunto “a furore di popolo”? L’intervento che in quell’assise riscosse la più grande ovazione fu quello di Pietro Ingrao quando scandì il rifiuto della “de-berlinguerizzazione”. La “sinistra europea” nell’interpretazione di Ingrao erano “i movimenti” (pacifisti, ecologisti e femministi, ecc,) e non i partiti dell’Internazionale socialista. Così come sempre in quel periodo della segreteria Natta – tra Berlinguer e Occhetto – Giorgio Napolitano riuscì ad introdurre nella Direzione del PCI – per la prima volta – il tema del debito pubblico. Non senza registrare crisi di rigetto. Il “caso” Napolitano è il “caso” Italia nel senso che è da chiedersi come mai nel popolo di tradizione comunista e poi di identità postcomunista (la maggioranza della sinistra italiana) l’alternativa “escatologica” ha scaldato gli animi e ha trascinato consensi mentre l’alternativa “politica” è risultata sostanzialmente minoritaria ed “impopolare”. Infatti la storia dei congressi del PCI dal XV del 1979 con Berlinguer fino all’ultimo, il XX, del 1991 con Occhetto è quella di una sistematica contestazione e ridimensionamento delle posizioni “di destra” e del timore di perdere il consenso di quelle “di sinistra”. Prima di parlare di “regime” e di “manipolazione” nell’elettorato italiano si dovrebbe guardare con occhio più critico alla “mancanza di coraggio” che vi è stata nella sinistra italiana nei confronti di posizioni irrealistiche ed estremiste. Non è una questione di casi personali. Nella storia del comunismo e del postcomunismo bisogna anche tener presente la “mancanza di coraggio” (come lamentava Giorgio Amendola) non solo della “classe politica”, ma anche della cosiddetta “società civile” di sinistra. s 14 ■ CRITICAsociale 2-3 / 2013 ■ “SENZA IL SOSTEGNO DELLA CORRENTE RIFORMISTA LA SVOLTA DELLA BOLOGNINA NON SAREBBE STATA POSSIBILE” FORSE FU UN ERRORE CREDERE POSSIBILE L’APERTURA AI SOCIALISTI CON L IDIOSINCRASIA PER CRAXI L Emanuele Macaluso fondo del primo centro-sinistra fu il fatto che il Partito Comunista dopo il ’56 ungherese rimase legato al mondo sovietico e nel momento in cui il centrismo entrava in crisi non poteva concorrere come forza di governo. È chiaro che Craxi avrebbe dovuto sfidare Occhetto sul terreno dell’alternativa della sinistra, come aveva fatto nel ‘78 al congresso di Torino. Invece pensò di tornare a Palazzo Chigi attraverso il CAF, attraverso l’accordo con la Democrazia Cristiana e approfittando della crisi comunista. Fu un errore politico profondo. Fu un errore che lo portò anche a fare alcune operazioni finanziarie di partito che lo avrebbero poi danneggiato e portato alla rovina. Ti racconto un episodio per capire come Craxi intendeva il rapporto con il PCI che si stava sciogliendo. Craxi tramite Borghini (una volta che io ero a Milano) mi mandò a dire che si poteva fare per le elezioni del ‘92 una lista assieme, socialisti e area riformista dell’ex PCI. a svolta della Bolognina si è fatta sulle macerie del Muro di Berlino che crollò sei mesi dopo il congresso che rilanciava il nuovo PCI e l’orgoglio comunista. Ma perchè arriviamo alla Bolognina? Perchè gli sviluppi politici mondiali e poi quelli taliano spingevano verso un revisionismo più di fondo della politica del PCI in direzione del socialismo democratico. E questa fu la stretta in cui si è trovato Occhetto, il quale da un canti chiese a Craxi di agevolare l’ingresso dei postcomunisti nel’Internazionale socialista, dall’altro fece tuta una serie di operazioni per presentare il nuovo partito come un partito addirittura più a sinistra del PCI (rompendo, tra l’altro, con la tradizione e offrendo a Leoluca Orlando, un ex DC, la condirezione di un partito che sembrava prefigurare l’attuale PD). Ora è chiaro, diciamo le cose come stanno, che se ci forse stato un gruppo dirigente saggio, avrebbe dovuto capire che a quel punto se si voleva fare una svolta verso il socialismo il candidato segretario sarebbe dovuto essere Napolitano. Era lui quello che si era mosso con più coerenza in questa direzione. Questa era la questione. C’era invece alla guida del partito Occhetto e fu lui a fare la svolta, ma la svolta si potè fare anche perchè l’area riformista aderì. Deve essere chiaro che se l’area riformista non avesse appoggiato la svolta di Occhetto, questa non sarebbe passata. L’area riformista aderì, infatti, con un suo documento autonomo in cui la motivazione di fondo era questa: dobbiamo entrare nel socialismo europeo. Senza la presenza di quel gruppo che aveva avuto una storia nella vita del PCI - e che storia! - la svolta si sarebbe arenata. Parlo di un gruppo di dirigenti in cui c’erano Napolitano, Bufalini, io, Chiaromonte, Lama, Lina Fibbi, Cervetti e altri. D’altra parte per il no c’erano: Ingrao, Cossutta, Tortorella, c’era Natta, c’era Pajetta... Parliamoci chiaro, il congresso successivo alla svolta fu vinto perchè c’era questa parte del gruppo dirigente comunista che si spese a suo favore. Tutta l’area che si definiva berlingueriana, invece, si divise: una parte, compresi Adalberto Minucci e Angius, che erano stati a lungo collaboratori di punta di Berlinguer, dissero di no, e un’altra parte, penso a Reichlin e altri, rimasero a sostenere Occhetto. Ma perchè ci fu in quest’ultima area di dare al dopo PCI uno sbocco socialista? Cosa impediva di fare questa scelta? Intanto c’era stata la guerra con Craxi. Ma c’era anche una riserva di fondo sula socialdemocrazia. La guerra con Craxi, quella ha segnato un’ epoca, una generazione. Tutti quelli che pensavano ad un rapporto diverso con il partito socialista erano bollati di essere al servizio di Craxi. Ho scritto nella mia biografia che credo di essere il solo dirigente del PCI che non ha mai parlato con Craxi. Non ho mai avuto un rapporto con Craxi. Avevo un rapporto molto affettuoso, ho anche delle lettere, con Pietro Nenni, con De Martino, con Giacomo Mancini, con Formica... con tanti socialisti che sono stat miei compagni e amici. Ho avuto un rapporto amichevole con Saragat. Craxi, no. Con Craxi non ho mai parlato, non l ho mai incontrato. Mi ricordo che una volta Napoleone Colajanni mi disse: “Craxi ti vorrebbe incontrare”. “Ma per parlare di che?”, dissi io e non lo incontrai. Ma non per diffidenza politica, è che non c’era tra di noi questa consuetudine di rapporti. Altri dell’area riformista, per esempio Gianni Cervetti, avevano un rapporto con lui, e anche Napolitano ne aveva...Io no. Però fui bollato come “craxiano”. In Sicilia ci fu una campagna fatta da Pietro Folena e da altri dirigenti contro di me quando si discusse la ia candidadura alle elezioni del ’92. Dissero che se fossi stato eletto sarei andato con Craxi. Tutti i segretari di Federazione si mobilitarono dicendo: “Macaluso è già con Craxi”. E tutti provenivano dall’area del partito che sosteneva Occhetto. Come poteva lo stesso Occhetto fare una politica verso l’area socialista con un gruppo dirigente che aveva, diciamo così, questa idiosincrasia verso i socialisti? E anche sul ruolo dei magistrati e sulle culture che nascono da quella stagtone? E.M: Anzitutto, vorrei fare un’osservazione proprio per entrare in quest’argomento. E cioè, la crisi del sistema politico italiano si apre prima di Tangentopoli. Anche le vicende di cui abbiamo appena parlato dicono che la crisi del sistema politico e delle forze politiche era grave. P.C.: Fermiamoci qui e facciamo un punto su Craxi. E.M.: Su questo punto voglio fare una premessa, Craxi è stato un uomo politico forte e capace, sia quando ricostruì un ruolo autonomo del PSI, sia quando costituì il primo governo diretto da un socialista. Il sistema politico italiano era anomalo e consentì a leader autorevoli di partiti minori, Spadolini e Craxi, di guidare governi in cui la DC manteneva la maggioranza relativa. Tuttavia Craxi fece un governo autorevole: Scalfaro agli Interni, Andreotti agli Esteri, Martinazzoli alla Giustizia, Visentini alle Finanze, Spadolini alla Difesa. C’era la solita paccottiglia dei partiti, ma i ministeri chiave erano in mano a forti personalità. Io, allora direttore dell’Unità, fui molto critico sul governo. Seguendone l’attività capii però che sia in politica estera che in politica interna era un gran governo. Quando poi fu cambiato il Presidente del Consiglio, la staffetta con De Mita, si ebbe il segno del degrado della politica. Craxi non seppe reagire bene, non capì che la situazione cambiava e fece errori assai gravi. Il più evidente, molto serio, riguarda come lui lesse l’89. Noi sappiamo quel che avvenne, lo abbiamo detto più volte nel corso di questa nostra chiacchierata. Riassumendo: ci fu la svolta di Occhetto del PCI, una svolta a metà, Occhetto con la svolta non volle andare nella direzione del socialismo, perché avrebbe dovuto fare i conti col socialismo italiano. Dall’altro canto Craxi pensò che l’89 metteva in crisi solo il Partito Comunista e pensava di poter prendere con sé frange dei comunisti. Fu allora che Piero Borghini dirigente comunista, diventò sindaco di Milano. Craxi pensava appunto che il Partito Comunista avrebbe avuto una crisi profonda e lui avrebbe raccolto pezzi importanti di quel partito per tornare rafforzato a Palazzo Chigi. Cioè, rinunciò a sfidare Occhetto sul terreno dell’unità socialista vera, non quella che lui mise nel nome del simbolo. Avrebbe potuto dire: ora si apre una fase nuova, finisce la ragione di fondo per cui Pietro Nenni fece il centrosinistra (Nenni appoggiato da Lombardi e De Martino). Infatti la ragione di P.C.: Quindi era un invito alla scissione. E.M.: Era un invito alla scissione, con una motivazione. La motivazione era che il suo gruppo dirigente si era esaurito, che i più noti esponenti socialisti erano diventati dei boiardi di partito. Bisognava riformare e rinsanguare il gruppo dirigente, e lo si poteva fare attraverso l’arca riformista dell’ex PCI. Io gli dissi che era pazzo, che la cosa non esisteva. Non ottenendo la nostra adesione, lui cosa fa? Fa un’operazione tutta personale, non si fida più di nessuno e affida il denaro delle tangenti a personaggi che non hanno mai avuto rapporti col suo partito: l’architetto, l’amante della contessa, il suo amico d’infanzia, non ricordo neppure più come si chiamavano, gente che non era mai stata iscritta al Partito Socialista. Si affida a loro perché non si fidava più del suo partito, dei suoi uomini e volle fare un’operazione leaderistica di fondo, cioè rifondare tutto attorno alla propria persona. Qui c’è un elemento che a mio avviso non è stato bene esaminato, tipico di questo tipo di leader, che si innamorano del loro ruolo, che lo ritengono essenziale ed esclusivo. Craxi riteneva che da Palazzo Chigi avrebbe rifatto il verso a Mitterrand. Fu un errore. E che errore! Quindi abbiamo avuto un doppio errore: l’errore di Occhetto di non collocarsi nell’area socialista per sfidare anche Craxi su quel terreno, e l’errore di Craxi di non sfidare Occhetto sullo stesso terreno. La crisi esistenziale del Partito Socialista e della sinistra ha origine lì, perché l’unica possibilità che quella situazione consentiva era quella di un esame critico della storia del PCI e del PSI, e ognuno avrebbe dovuto farsi carico degli errori dell’altro e non usarli per ditruggere l’altro. Bisognava concludere con una forte iniziativa politica il grande duello che aveva diviso la sinistra. Io penso che la vicenda di Tangentopoli, che arriva dopo, risente di questo clima, nel senso che le forze politiche si sono lentamente sfibrate, la crisi di sistema era già aperta. La stessa Democrazia Cristiana cambia nome e diventa Partito Popolare perché pensa di dar vita a un sistema nuovo, perché avverte che il suo rapporto col popolo e forse anche con la Chiesa è cambiato. s (da “Politicamente s/corretto” Emanuele Macaluso con Peppino Caldarola) CRITICAsociale ■ 15 2-3 / 2013 ■ RACCOLTA A CURA DI STEFANO CARETTI CON UN SAGGIO INTRODUTTIVO DI MAURIZIO DEGL'INNOCENTI GIACOMO MATTEOTTI. EPISTOLARIO 1904-1924 Maurizio Degl’Innocenti polo italiano privo di materie e ansioso di occupare la sua manodopera sia in casa sia all’Estero”. Matteotti scrive sulla pressione tributaria nei Comuni, su Come può diventare “attiua” la gestione privata dei servizi pubblici, e infine, nel novembre 1923, su Smontature finanziarie e La serie dei disavanzi italiani, “con dati ... sbalorditivi”. C on l’Epistolario 1904-1924, che consta 207 tra lettere e cartoline, edite e inedite, Stefano Caretti presenta al lettore il decimo volume delle Opere di Matteotti, che già consentono una puntuale ricostruzione del personaggio. L’Epistolario (il carteggio familiare è già stato pubblicato) si pone a utile corredo, disvelando stati d’animo e retroscena, e soprattutto ponendosi come insostituibile chiave di lettura del fattore “situazionale”, oltre che strettamente biografico. Così dalla corrispondenza di Matteotti datata dal 27 settembre 1904 con Giulia e Ada Gherardi, che lo hanno ospitato da studente a Bologna, si hanno interessanti informazioni sul suo apprendistato politico. A quella data risulta militante già “da un po’ di tempo”, e l’impegno si traduce nella istituzione di un circolo o di una lega di contadini “con un’infinità di discussioni”, nonché nella collaborazione a “La Lotta”, foglio socialista del Polesine. All’azione di propaganda e di organizzazione si accompagna quella per le elezioni politiche dell’ottobre-novembre 1904 a fianco di Nicola Badaloni, riuscito eletto a Badia Polesine, dopo avere perso per pochi voti a Lendinara contro il moderato Eugenio Valli. Matteotti appoggia Badaloni anche nelle elezioni politiche del 1909, e gli è ancora legato nell’ aprile 1912 se raccomanda a Gino Piva di recensire sull”‘Avanti” e sull”‘Adriatico” il volumetto di A. Gherardini, Il Pensiero e l’opera di Nicola Badaloni, edito a Badia Polesine nel 1912, prendendone le distanze solo dopo la scissione dei bissolatiani dal Partito socialista al congresso di Reggio Emilia del 1912, che produce effetti laceranti anche nel Polesine prima nelle elezioni politiche del 1913 e poi di fronte alla guerra mondiale. Contro recenti tentativi di attribuire a Giacomo Matteotti la responsabilità di azioni violente che avrebbero “giustificato” la reazione fascista il “carteggio” off????? una piena e documentata smentita. “La lettera inviata in data 3 marzo 1921 ad Aldo Parini, segretario della Camera del lavoro di Rovigo e collaboratore di Matteotti, è illuminante sulla realtà polesana, sempre in movimento non risultando mai gli accordi faticosamente raggiunti né stabili né condivisi da tutti. La posizione di Matteotti non è occasionale, ma il frutto di una meditata riflessione, perché ribadisce concetti già rappresentati ad altri organizzatori e esponenti socialisti. Sotto l’apparenza di difendere l’interesse” di classe”, con ciò intendendo l’interesse generale, e di non escludere “le ultime chiamate e i maggiori sacrifici per tutti”, egli denuncia la miopia inconcludente di coloro che vogliono estendere l’agitazione e ne taccia i comportamenti come “meschinamente egoisti”. Certo, non è: in grado di respingere in linea di principio lo sciopero generale, ma lo colloca in una dimensione est rema e, al buon fine, “col massimo vigore”, rifiutandosi alla pratica scioperaiola che tanto ha caratterizzato il biennio rosso, Come comportamento “egoistico” indica la pretesa di estendere lo sciopero anche “nelle campagne dove gli agricoltori (i proprietari) accettino la manodopera”, e di coinvolgere obbligati e bovai. Sul problema scottante delle compartecipazioni, è dell’avviso che occorra accettarle laddove i proprietari accolgano l’imponibile di manodopera, anche per dividere il fronte degli agrari, ammettendo T solo l’opportunità, che per consolidare “la vera solidarietà”, bovai, obbligarti avventizi impiegati versino una piccola quota per la cassa comune. Per le semine si dice convinto che non sia “il momento per ora di pensare ti semine forzare, a invasioni di terre e simili”, consigliando piuttosto alle leghe di garantire pubblicamente la fornitura di manodopera a giornata ncccssaria. Chiara è la raccomandazione contro “le violenze stupide e dannose”: “Non precipitate nulla. Chi vuol precipitare è perché nell’anima si sente incapace di resistere”. È evidente la preoccupazionc di tenere unita l’organizzazione, unico strumento valido d’unione, ma l’atteggiamento è pragmatico, attento di non dare agio a “comportamenti egoistici” o a “violenze stupide e dannose”. Esce una figura ben diversa da quella dell’incendiario! E sono i giorni nei quali verrà sequestrato e minacciato di morte. I rapporti con la Kuliscioff e Turati si fanno più stretti. La collaborazione su “La Critica sociale”, e in parte sull’“Avanti!”, si sviluppa su temi di grande rilevunza, in parallelo alla crescente autorevolezza acquisita dal giovane deputato all’interno del Partito. In una lettera dell’agosto 1919 richiama l’attenzione sulla “ingiustizia” dell’art. 12 della legge elettorale, perché consente la somma dei voti personali a quelli di lista. Si occupa di recensire il libro di J.M. Keynes critico sulla pace di Versailles (La revisione di Versailles secondo J.M. Keynes), cogliendo lucidamente il pericolo dell’oppressione della “nuova Germania democratica”. Nella corrispondenza con il pubblicista francese Charles Omessa del dicembre 1921, Matteotti ne condivide la percezione del “raffreddamento postbellico” tra Italia e Francia, lamentando come la prima si stia accodando alla seconda in una politica di armamenti contro la Germania disarmata, e prevede che così operando “resusciteranno e faranno rimpiangere al popolo tedesco l’antico regime militarista e prussiano come quello che almeno incuteva rispetto ai nemici”. Critica la politica francese in Polonia e in Jugoslavia dove, “anziché mirare alla pace e alla ripresa dei rapporti con la Russia e con l’Italia, attizza gli odi e provoca armamenti e sospetti di qua e di là dei confini”, cosicché “il nazionalismo italiano profitta della tattica del nazionalismo francese, per ripeterne gli errori e i danni contro l’Europa lavoratrice che anela il ritorno della pace”. Ritiene infine che in economia le pretese francesi a danno della Germania sollecitano il protezionismo che è “specialmente dannoso al po- urati è e resterà il suo punto di riferimento. A proposito dell’ odg del congresso nazionale del PSI che si terrà a Milano dallO al 15 ottobre 1921, in relazione al quale Turati rinunzia alla designazione di relatore sul tema: “collaborazione, partecipazione al potere, tattica parlamentare”, Matteotti condivide il rifiuto del tema “collaborazionismo”, in quanto esso sarebbe “la collaborazione portata a sistema e metodo”, laddove si potrebbe ammettere solo come “incidente” o come mezzo per meglio attuare la lotta di classe che resta il fondamento del partito. Non è su questo, pertanto, che si determina la disputa con gli “estremissimi”, quanto sul “metodo per la conquista del potere politico”, essendo la posizione dei massirnalisti incerta tra violenza e conquista legale, mentre quella dei riformisti ferma nella “conquista legale graduale”. Ma auspica che sul tema sia lo stesso Turati (o il comitato di frazione) a prendere posizione. N e riemerge qui il retroterra ideologico classista, del resto comune e comunque ora un inevitabile pedaggio da pagare a fronte dell’ offensiva polemica massimalista e comunista, ma l’impianto di fondo è inequivocabilmente democratico, non prescindendo dall’ azione graduale e riformatrice e dal metodo legale. Ciò trova conferma nelle polemiche con Serrati del marzo 1922 e con il massimalista trentino Lionello Groff del settembre successivo, quando respinge l’accusa ai riformisti di patteggiamento “coi nemici del proletariato”, concludendo che il programma massimalista (“proselitismo, propaganda avveniristica, pressione continua, opera di critica”) è un equivoco o un errore, essendo di fatto ormai tutt’uno con quello comunista, e cioè “formazione di quadri di forza che con un assalto violento si impadroniscano del potere, mediante una dittatura”. A fronte della proposta del PCdI di un blocco tra i tre partiti di classe, Matteotti risponde a Palmiro Togliatti in data 25 gennaio 1924 che essa contrasta “con l’obiettivo preliminare della restaurazione pura e semplice delle “libertà statutarie”, tanto più che il proponente ha posto tre condizioni inaccettabili: l’indirizzo tattico comunista (“antitetico al nostro”); la partecipazione alla lotta elettorale in qualunque condizione, rendendo così impossibile l’astensione del blocco che più immediatamente esprimerebbe la protesta di tutto il proletariato contro il regime di dittatura fascista, e soprattutto perché si vorrebbe escludere a priori “qualsiasi blocco di opposizione al fascismo e alla dittatura da esso instaurata che si proponga come scopo una restaurazione pura e semplice delle libertà statutarie”, magari con l’appoggio di elementi non appartenenti ai tre partiti. T aIe posizione è confermata nella riposta alla Direzione del Partito comunista in data 16 aprile 1924 in merito all’ipotesi di una manifestazione unitaria per il I maggio. Matteotti respinge la tesi del fronte unico, di cui coglie la strumentalità polemica da parte di chi ha inasprito le ragioni di scissione e di discordia nella classe lavoratrice. E scrive: “Restiamo quel che siamo. Voi siete 16 ■ CRITICAsociale comunisti per la dittatura e per il metodo della violenza delle minoranze; noi siamo socialisti e per il metodo democratico delle libere maggioranze. Non c’è quindi nulla di comune tra noi e voi”. Per lui il nemico è uno solo: il fascismo, ma complice involontario di esso è il comunismo, perché la violenza e la dittatura predicata dall’uno, diviene il pretesto e la giustificazione della violenza e della dittatura in atto dell’ altro. Il distacco con i comunisti è ormai incolmabile. Troppo diversi gli obiettivi tattici e di fondo, perfino il linguaggio. Quello socialista unitario parla ormai di libertà e di democrazia. Nell’aprile 1923 Matteotti presenta a Turati il manifesto redatto per il I maggio (“Di tutta l’Europa civile, solo l’Italia mancherà alla festa del lavoro”). Oltre a denunciare la perdita della “libertà”, e cioè dei diritti di associazione, riunione, propaganda e di stampa, e del peggioramento delle condizioni salariali, la riflessione è finalmente portata anche sulla debolezza della sinistra, sulle esagerate illusioni, sui rapidi sco ram enti dei facilmente accorsi dopo la guerra e facilmente passati più tardi alle violenze opposte, sui seminatori e sugli autori di continue scissioni, sugli egoismi delle categorie più pronte a mutare colore, sulla trascuranza degli elementi morali ed intellettuali. La revisione della dottrina pare una necessità ineludibile: “saggiarla al confronto della esperienza, è cosa degna di un partito d’avvenire”. Nella lettera del 4 maggio 1923 a Turati, a cui trasmette la prefazione all’opuscolo Direttive del Partito socialista unitario italiano, ricorda la feconda opera di redenzione delle plebi svolta in trenta o quarant’anni dal partito socialista e i significativi risultati ottenuti in tutti i campi dalla” civiltà del lavoro”, e con orgoglio constata come “l’ascesa e lo sviluppo dell’Italia nella corte civile delle nazioni, coincidano perfettamente con 1’ascesa e lo sviluppo del partito socialista e delle libere organizzazioni operaie”. L’immagine è quella di un graduale, ma profondo processo di emancipazione popolare, e quindi dell’intera nazione, che prima la guerra, poi le illusioni comuniste, e infine “la reazione e la violenza fascista” hanno interrotto e distrutto in larga parte. L’attesa è di riprendere il lavoro avviato improntato alla “grande solidarietà umana” (“]«, rifaremo! “), essendo “il socialismo un’idea che non muore! Come la libertà!” Il carteggio evidenzia il precipitare della crisi delle istituzioni liberali, che dimostrano tutta la loro fragilità. Nell’estate 1921 la partita sembra già compromessa. Le amministrazioni locali sciolte, le cooperative in liquidazione o infiltrate da fascisti, alcuni esponenti socialisti, come il massimalista Antonio Zilli, passati al fronte avverso, minacce vengono costantemente rivolte contro la casa e la persona stessa della madre settantenne di Matteotti, le autorità di polizia sono troppo spesso conniventi con i fascisti. I compagni di Badia Polesine continuano a informare dettagliatamente sugli accadimenti, come richiesto con insistenza da Matteotti (nell’ attesa di tradurre la protesta in atto parlamentare). Matteotti palesa grande lucidità, e percepisce tra i primi la drammaticità della svolta che si va compiendo nell’ ottobre 1922, convinto che l’avvitamento della crisi sbocchi nella dittatura, termine che usa precocemente e senza incertezza. Di fronte alla crisi del Governo Facta e alla marcia su Roma la posizione è quella dello spettatore passivo, a testimonianza dell’inanità politica dei socialisti così come delle altre forze di opposizione (“del resto tutto si è svolto fuori di ogni azione o possibilità di azione”). Nella lettera a Treves dell’ottobre 1922 segnala la natura “extrapar- 2-3 / 2013 lamentare della crisi” preannunciando le dimissioni di Facta, e indica la parvenza di “un movimento per Orlando” (“ma non è ancora chiaro”), ben presto abortito. In una successiva a Turati osserva: “Se il Governo o il Re avessero voluto resistere, sarebbe stato facilissimo. Si dice che il Re dapprima avesse consentito allo Stato d’assedio, e solo poi abbia pensato altrimenti. Si dice che i comandi d’esercito abbiano risposto che essi erano pronti a resistere solo se il Governo voleva fare sul serio. Ciò che ... naturalmente Facta non voleva”. Dà conto dell’ipotesi di un Ministero Salandra e delle voci di un dissidio tra i liberaI-nazionali e i fascisti, del coinvolgimento presunto di Baldesi. E proposito della marcia su Roma: “molti studi distrutti, una ventina di morti, indifferenza pubblica. Viltà generale alla Camera: tranne il vecchio Cocco. Tutti pronti a entrare nel Ministero ... con lo strazio nel cuore!”, e “l’aria di non sicurezza, perché tutto è affidato all’ arbitrio”, nonostante che la grande maggioranza delle squadre è partita. In quanto al Partito socialista unitario, nato da pochi giorni dalla scissione con il Partito socialista italiano, a maggioranza massimalista, il neo segretario si trova di fronte a due opzioni: l’aperta opposizione, o “se bisognerà per vivere, vellutare la nostra opposizione, considerare il fatto rivoluzionario esclusivamente dannoso alla democrazia, e portarci sui problemi concreti”. Lascia la decisione alla Direzione che sarà convocata alla vigilia dell’ apertura della Camera per sapersi meglio regolare secondo i fatti. E intanto pubblica un manifesto “abbastanza largo da poterei lasciare libero l’esame degli avvenimenti successivi”. E al socialista teramano Giuseppe De Dominicis in data 4 novembre 1922 ammette che è “probabile che permanga ancora quello stato di cose in virtù delle quali ci siano rese impossibili le nostre attività di organizzazione e di propaganda”, e allora “in attesa che la situazione si chiarisca” é necessario continuare a lavorare com’è possibile, riunendo le sezioni e “continuando soprattutto la pubblicazione del giornale, tenendo presente che la stampa è il solo mezzo di propaganda utile in questo momento”. Il consiglio è di evitare” gli atteggiamenti che possono dare al nostro lavoro un carattere cospiratorio”. L’opposizione è ridotta alla stampa! E per giunta le pubblicazioni de “La Giustizia” sono sospese: vengono riprese solo 1’8 novembre. È ormai una lotta solo di “difesa delle posizioni”. L’opposizione si sta sfaldando. Riducendosi la funzione del Partito alla stampa (“aiutiamo la stampa nostra ultima fiaccola di un libero pensiero”), che sembra parlare all’interno più che all’ opinione pubblica, i problemi di diffusione, di redazione, di costi sono destinati a ingigantirsi, e ben poco valgono le sottoscrizioni raccolte da Gregorio Nofri o gli appelli rivolti agli emigrati socialisti nelle Americhe. E poi c’è il disorientamento, del resto comune alle altre forze politiche, ma per i socialisti unitari ancora più grave per le ripercussioni sull’universo organizzativo, sindacale e cooperativo. Nella lettera a Treves del 9 novembre 1922 Matteotti parla “di tutto un movimento di circuizione, esercitato su molti dei nostri uomini, dagli emissari del dittatore”, convinto com’ è che si voglia indurre il Partito “a piegare, a consentire, cioè a permettere il più comodo sviluppo della Dittatura”. Si conferma “l’opera perfida di assalto a tutto l’ultimo rimasuglio di ciò che possediamo, non più con la violenza certamente, ma con la semplice minaccia del terrore, con la corruzione degli elementi più resistenti, con la prigionia morale di chiunque dei nostri sarebbe capace di agire”. Matteotti è convinto che anche ai soli fini di prendere per buone “le inevitabili tendenze demagogiche (cosiddette di sinistra) del Governo Mussolini”, la migliore tattica resti comunque “la più ferma e dignitosa resistenza”. A Treves, che dirige a Milano “La Giustizia”, la quale sembra individuare i più impellenti problemi del nuovo Governo nell’ordine pubblico e nel pareggio di bilancio, oppone che sarebbe meglio parlare semplicemente di “libertà” e di “vita, cioè del pareggio nella economia dei lavoratori”. E ammonendo: “aspettiamo a venderei, quando ci pagheranno un prezzo conveniente, cioè una vera e non una falsa garanzia di libertà”. A Turati scrive il 18 dicembre 1922: “Le cose interne sembrano accomodate, e le corporazioni divengono fasciste, mentre le milizie che divengono del Presidente del Consiglio dovrebbero aprire gli occhi a tutti”. Nello stesso Gruppo parlamentare serpeggia verso il Governo una linea attendista, che fa capo a Enrico Ferri (,’leale attesa”), e con qualche difficoltà Matteotti riesce a imporre la propria in una riunione del 6 febbraio 1923, e decisa opposizione, e se ne lamenta: in un “momento grave come questo, non fanno che danneggiare proprio l’unica cosa che ci resta, il nostro bagaglio ideale”. Ancora più grave si presenta “la crisi di persone per la particolare situazione in cui ci troviamo”: l’accenno è alle visite a Mussolini di Baldesi nella prospettiva di un’improbabile unificazione sindacale, di Vergnanini sul futuro delle cooperative, e ancora di Alessandri. E polemizza con lo stesso Turati, che cerca di evitare personalisrni e si dimostra più comprensivo dei timori dei dirigenti della CGdL di salvaguardare il possibile dell’ organizzazione confederale. Matteotti continua a vedere nella linea di Baldesi un pericolo mortale, e quando al convegno confederale di Milano del 23 -25 agosto 1923 questi pretende che spetti al sindacato “la difesa degli interessi immediati dei lavoratori organizzati” e dunque di valutare le condizioni “della solidarietà e dell’ aiuto a quei partiti e a quei governi che si trovino sulla stessa linea del programma minimo di attuazione pratica e immediata del Sindacato”, vi coglie un assist agli avversari per colorare i socialisti di scopi piccolo-borghesi di bassa utilità immediata, e interpreta la rivendicata autonomia politica del sindacato come premessa per un possibile accordo col Governo. In ogni caso, capisce che una volta accettata la rinuncia all’azione “mediata di tutta la classe e di tutta la collettività produttrice” attraverso il Partito in Parlamento e in paese, sarebbe stata inarrestabile la condanna all’ assoluta marginalità del PSU. A Giuseppe Parpagnoli, emigrato in Argentina, trae.ia nell’agosto 1923 un breve bilancio del biennio di “reazione [ascista”: “le organizzazioni economiche e politiche del proleI ariato vennero in gran parte assorbite o distrutte. Molti giornali perirono. Infinito numero di lavoratori dovettero per fame piegarsi al nuovo giuoco. Quelli che non si piegarono furono boicottati economicamente quando non anche banditi, carcerati o uccisi”. In quanto al PSU assicura la volontà di tenersi “ritto fra tutte queste macerie. Impoverito di soci, di denaro, di istituzioni e di consensi attorno, con voce affiocata e coperto di ferite, pure rimane in piedi circondato di squallore, grazie alla tenacia, e, ben può dirsi, talvolta anche dell’eroismo dei compagni superstiti”. Dice di una sua Direzione operante a Roma, ma “vi funziona come può, incoraggia, traccia le linee della nuova I attica, mantiene unite le scarse forze rimaste”; e di un suo organo centrale a Milano, che registra quotidianamente i misfatti del fascismo e “riafferma la nostra dottrina modificata secondo Ic terribili esperienze, e col solo fatto di uscire, dà ogni giorno ad amici e a nemici la prova provata che il socialismo in Italia, percosso e sconvolto dall’ ondata fascista, non ne fu sommerso, resiste, si abbarbica al suolo della Patria ed è deciso a riaversi non appena le circostanze lo permetteranno”. Occorre prendere atto che “La Giustizia” è boicottata dai fascisti in molti centri, cosicché sarebbe necessario l’aiuto d’Oltre Oceano, per consentire al PSU “per le incontrate esperienze” di sperare di tornare a guidare la classe lavoratrice” a raggiungere i suoi destini per una vita piena, assennata e conforme a natura”. Chiosando: “Alcuni affermano che questa via è più lunga di altre che vengono additate, ma in realtà non è tale perché quelle altre vie, in apparenza più spicce e più estetiche, conducono solamente al disastro o ad una sterile contemplazione”. Si ribadisce così che l’obiettivo essenziale è ora non fare morire “La Giustizia”, perché si ha la possibilità di “parlare ai lavoratori solo attraverso la stampa”. Ma mentre si cerca di ritessere i contatti con i socialisti europei, anche in vista della ricostituzione dell’Internazionale socialista, il tesseramento incontra grande difficoltà (“mal connesse trincee della nostra difesa”), e amaramente si deve ammettere che non è “lieta prospettiva per chi è abituato a vedere nella milizia socialista l’onesto e tranquillo esercizio di qualche carica pubblica”. Cosicché “la tessera è il legame simbolico che fa delle nostre anime insofferenti un fascio resistente all’irrompere della tracotanza avversaria, ma è anche il mezzo per dare alla Direzione la possibilità di esplicare vantaggiosamente per il Partito il programma di riorganizzazione delle nostre forze”. Matteotti punta su un blocco di alleanze per la libertà, e così si dispiace per il fatto che non si sia riusciti a includere nella lista elettorale per le amministrative milanesi del 10 dicembre 1922 “anche persone e competenze fuori del partito, a destra e a sinistra”. Nel dicembre 1923 aderisce ad un’Associazione nazionale per il controllo democratico fondata da antifascisti a Milano su un precedente inglese durante la prima guerra mondiale, ma insorge quando per il raggruppamento antifascista Prampolini propone il nome “Democratico” insorge perché lesivo delle legittime aspirazioni del partito (“Io e T argetti troviamo la cosa di una inopportunità straordinaria”). Nel maggio 1923 al socialista campano Menotti Bucco, che si rende disponibile a recarsi a Chieti per propaganda, raccomanda di “raccogliere in quella provincia adesioni e possibilmente, con i rimasti nel capoluogo, formare un gruppo o una sezione”, e tuttavia sa bene che nei piccoli paesi ciò è diventato impossibile, e per il resto non si può fare affidamento che su alcuni studi di avvocati, di cui viene fornito 1’elenco. Tra momenti di grande disillusione e incoercibili impulsi a fare, Matteotti non perde comunque la speranza di fare del PSU il centro aggregativo delle opposizioni (“l’unione di tutte le forze che onestamente e lealmente intendono di opporsi alla dittatura fascista”), e in tale prospettiva giunge a considerare l’ipo[(‘si di una riunificazione con i massimalisti. Tale eventualità, su (Id Turati resta molto tiepido, è considerata opportuna per non pvrdere completamente il contatto con le masse. Sta lavorando .ill’opusco]o Mussolini nel 1919-20 (uscirà postumo con il titolo Fascismo della prima ora. Pagine estratte dal “Popolo d’Italia”) e pOlta avanti il lavoro preparatorio per il libretto Un anno di douriuazione fascista, terminato poi agli inizi del dicembre 1923, e pubblicato nel febbraio 1924. L’opuscolo è pronto, è diventato ,Ii 200 pagine e potrebbe “uscire ora per lo scioglimento CameIII”. Gli acclude solo CRITICAsociale ■ 17 2-3 / 2013 una premessa breve, ma di grande efficacia, .love alla pretesa del Governo fascista di giustificare “la conqui~I il armata del potere politico, 1’uso della violenza e il rischio di lilla guerra civile, con la necessità urgente di ripristinare l’autorità .lella legge e dello Stato, e di restaurare l’economia e la finanza sulvandole dal pericolo”, oppone “i numeri, i fatti e i documenti ruccolti (che) dimostrano invece che mai, come nell’ anno fascista, l’arbitrio si è sostituito alla legge, lo Stato asservito alla fazione, e clivisa la Nazione in due ordini, dominatori e sudditi”. Per rilanciare il partito considera l’opportunità di un concorso a premi per il “distintivo” o per la tessera del 1924, la quale infine sarà oggetto di studi e vari tentativi. Ha in mente di organizzare convegni a Napoli, Roma e, il più importante, a Milano tra settembre e ottobre. Conta ancora sulla autorevolezza di Turati, come dimostra la lettera del 29 agosto 1923: sarebbe un suo discorso quel “qualcosaltro”, più forte, su cui far leva per cercare di aggregare ceti e persone interessate ad “un’ azione per la riconquista della libertà, e per toccare l’opinione pubblica”. Ipotizza come sede Torino, alla presenza dello stato maggiore del Partito, e come “programma” la riaffermazione di che cosa ci sia di vivo nella dottrina socialista, per poi ribadire “l’avversione ai metodi che hanno discreditato il partito nel dopoguerra e a tutti gli eccessi negli scioperi, negli appetiti di categoria, nei servizi pubblici” e quindi concludere con obiettivi immediati per la riconquista della libertà e per “la ricostruzione economica e morale del paese”. La prospettiva è ambiziosa: solo così sarebbe possibile “preparare una piattaforma nuova e a larga base, che abbia ripercussione non soltanto negli strati popolari, ma anche nei più colti e moderni della borghesia”. Turati è molto dubbioso “sull’opportunità - direi anche sulla serietà e sulla possibilità - di aprire il fuoco così presto, e di aprirlo proprio a Torino, dove il comunismo e il fascismo ci prendono tra due fuochi, dove, non è molto, si poterono assassinare a varie diecine di compagni (ciò dice l’ambiente) e dove un insuccesso comprometterebbe tutto per un pezzo”, anche se si dice convinto che in caso di elezioni, i socialisti sarebbero costretti a tentare, non fosse che per constatarne l’impossibilità. Ma infine accetta di aprire la campagna elettorale il 20 gennaio 1924 al Teatro Scribe di Torino, il testo integrale del discorso appare su “La Critica sociale” e poi viene raccolto in opuscolo: resterà uno dei documenti più alti dell’ antifascismo italiano. I rapporti con lo stesso Turati non sempre sono all’unisono, anche perché ben presto 1’attività di partito ha due centri: a Roma è la Direzione, a Milano si stampa “La Giustizia” e l’influenza del gruppo di “Critica sociale” è più forte. Un caso significativo è dato dalla celebrazione del Milite Ignoto. Matteotti per primo pensa di non lasciare ad altri “la brutta ipoteca bellicosa su un simbolo così sentimentale”, e ritiene possibile richiamarsi al Milite come colui che è morto “per la patria libera e per un mondo senza guerre”. Ma non tutti i compagni sono dello stesso parere. A Milano, senza coordinamento alcuno con la Segreteria, i socialisti cercano di prendere parte al corteo del 4 novembre, ma vengono aggrediti e allontanati da nazionalisti e fascisti. Intanto, anche “La Giustizia” si è aggregata alla celebrazione della Vittoria. Del mancato coordinamento e del tono esagerato del giornale (“nessuno finora era mai arrivato a questo”) Matteotti si lnrnenta con Turati in una lettera del 6 novembre 1923: “si comI) rende - scrive -1’ esaltazione di una Difesa vittoriosa, ma non di lilla Vittoria che per un altro proletario si risolve in una Sconfitta (‘ in una oppressione. Perciò io ti avevo sempre scritto nel senso (klla Patria libera e mondo senza guerre. Ma mai più oltre”. Poi nuutisce la critica dichiarandosi comprensivo della situazione particolare di Milano e dell’ Associazione combattenti, e come già per la Confederazione, “nelle circostanze attuali, a cose fatte”, non intende recriminare pubblicamente. Anzi si ripromette “di difendere il fatto” e di trarne argomento contro l’avversario. Un motivo di maggiore dissenso è dato dall’attesa risistemazione dell’organico del giornale. In data 8 gennaio 1924 Turati lnmenta la frettolosità e la scarsa preparazione di certe decisioni della Direzione (“inutili e, dato il momento, pericolose”). Matrcotti si sente spiazzato, lamenta l’assenza di un minimo di disciplina, alza i toni parlando di “disfattismo”, che “trova tutti i pretesti e tutte le ragioni”, fino a coinvolgere lo stesso Turati (“mi duole soprattutto quando arriva a far presa su di te che ‘l’i uno dei pochissimi che resistevi all’inerzia dei molti. Io non comprendo codesto eterno dire e disdire”), fino a minacciare le dimissioni (“se ciò non va, dite di riconvocare la Direzione, affinché provveda altrimenti. Io così non vado avanti”). Ma poi Matteotti si ributta nella lotta con inalterato impegno. Tramite Canepa e Zaniboni nel febbraio 1924 favorisce una riunione con repubblicani, bonomiani, sardisti, Italia libera e “Patria e libertà, “Volontà” per rilanciare 1’obiettivo del blocco elettorale per la libertà, cioè di una lista nazionale comprendente tutta l’opposizione, ovvero della comune deliberazione per l’astensione. Una volta tramontata l’idea della lista nazionale delle opposizioni riunite, il partito preferirebbe l’astensione purché in questo proposito convengano tutti i partiti d’opposizione, da Amendola e Bonomi ai massimalisti, “non richiedendo invece il concorso dei popolari e dei comunisti”. Anche l’ipotesi dell’ astensione svanisce ben presto, come risulta in una lettera a Giulio Zanardi del febbraio 1924. Resta il fatto che già si preannuncia l’Aventino. Le enormi difficoltà incontrate nella preparazione della campagna elettorale inducono Matteotti a rivolgersi ancora a Turati per annunciare le dimissioni dalla segreteria dopo le elezioni. In realtà, percepisce chiaramente che la lotta politica è entrata in una fase nuova, per la quale larga parte dei vecchi quadri del Partito non sembrano più idonei (“ gente arrivata in altri tempi e per altri modi”). I tempi richiedono gente di volontà e non scettica, per una “resistenza senza limite” contro la dittatura fascista (“Cerco la vita, voglio la lotta contro il fascismo. Per vincerla bisogna inacerbirla”). Tale presupposto si base sulla convinzione, rivelatasi corretta, che il fascismo dominante non avrebbe deposto le armi né tantomeno restituito spontaneamente all’Italia un regime di legalità e di libertà perché “tutto ciò che esso ottiene, lo sospinge a nuovi arbitri a nuovi soprusi. È la sua essenza, la sua origine, la sua unica forza, ed è il temperamento stesso che lo dirige”. Da politico persegue sempre la “ricostituzione delle nostre file” con fede nella libertà, ma l’appello è sempre più rivolto ai “puri di cuore”. Va dunque a ricercare “gli atti di coraggio e di fermezza compiuti dai compagni in nome del Partito, perché d’ora in avanti intendiamo più che mai attingere alle energie morali del partito che fortunatamente rimangono intatte in mezzo al frantumarsi dell’inquadramento materiale della nostra organizzazione”. La dimensione della lotta al fascismo è spostata sul piano dei simboli, dei valori, delle idee. Il martirio di Matteotti ne rappresenterà l’apoteosi. s Maurizio Degl’Innocenti Lettera 93. Giacomo Matteotti a Giuseppe De Dominicis “1922: Quanti morti e feriti da parte nostrsa?” Roma, 4 novembre 1922 Caro compagno. Durante gli avvenimenti di questi giorni, la Direzione dci Partito, non ha interrotto che in parte la propria attività. I suoi membri residenti in Roma si sono più volte riuniti per esam i nare i mutevoli aspetti della grave situazione e per raccogliere notizie su quanto avveniva in altre parti di Italia. In questo periodo, come sempre, i compagni che corrispodono con noi possono assolutamente confidare nella oculatezza e nella prudenza della Segreteria e perciò possono indirizzare le loro lettere al solito indirizzo. Intanto la situazione politica è da noi seguita con grande attenzione e cerchiamo di trarre da quella insegnamenti utili per l’avvenire. È probabile che permanga ancora quello stato di cose in virtù delle quali ci siano rese impossibili le nostre attività di organizzazione e di propaganda. In attesa che la situazione si chiarisca è necessario continuare a lavorare come e dove si può; riunendo dove è possibile le nostre sezioni e continuando soprattutto la pubblicazione del giornale, tenendo presente che la stampa è il solo mezzo di propaganda utile in questo momento. Siate molto circospetti e prudenti nel prendere contatti con i compagni e con le sezioni, ma evitate quegli atteggiamenti che possono dare al nostro lavoro un carattere cospiratorio. Poiché dalla cronaca dei giornali apprendiamo che ovunque sono state compiute nuove distruzioni, necessita che ci facciate conoscere dettagliatamente la situazione locale, indicandoci: 1) quanti morti o feriti di parte nostra o meglio di parte sovversiva ci sono stati da quando è cominciata l’azione fascista a tutto il 4 corrente mese; 2) quante sono state le case private bruciate o devastate a compagni o comunque a militanti in partiti od organizzazioni avversate dal fascismo; 3) quanti sono i giornali che sono stati soppressi; 4) quanti bandi sono stati emanati dal fascismo; 5) quante amministrazioni hanno dovuto dimettersi in seguito alle violenze; 6) quali sono stati i compagni che hanno dato esempi di fermezza e di coraggio di fronte alle violenze fasciste; 7) quali sono stati i compagni che avendo cariche rappresentative hanno dato prove evidenti di non saper tenere con dignità ti posto occupato di fronte alle violenze suddette. Tutte queste notizie ci occorrono al più presto tenendo presente lo spazio di tempo che va dal novembre 1920 a1 4 del c.m. e indicando per i colpiti oltre ai nomi la professione e la località. Intendiamo segnalare gli atti di coraggio e di fermezza compiuti dai compagni in nome del Partito, perché d’ora in avanti intendiamo più che mai attingere alle energie morali del partito che fortunatamente rimangono intatte in mezzo al frantumarsi dell’inquadramento materiale della nostra organizzazione. La Direzione, in questo momento veramente critico per il Partito, intende assolvere a costo di qualunque sacrificio il compito che le fu affidato dal Congresso e perciò fa appello a tutti i compagni perché le si stringano attorno con rinnovata fiducia. Il nostro quotidiano che fra giorni riprenderà le pubblicazioni continuerà ad essere il nostro più efficace mezzo di propaganda. Non tralasciate quindi di procurare abbonamenti e di raccogliere sottoscrizioni inviando il tutto a Milano al compagno Nofri, via della Signora 8. Ricordare ai compagni il dovere di prelevare immediatamente la tessera la quale serve non solo a testimoniare la inscrizione di ciascuno al Partito, ma anche e soprattutto per dare i mezzi necessari alla Direzione per continuare il programma di lavoro stabilito. Sicuro che tu ed i compagni di codesta provincia farete tutto il possibile per sormontare con dignità la situazione presente, vi porgiamo i nostri più affettuosi saluti. Il Segretario Matteotti (Da “Avanti!”, a. LXXXI, n. 191, 24 agosto 1977, pp. 8-9 . Giuseppe De Dominicis (18831967), principale esponente dei socialisti unitari di Teramo) Lettera 95 Giacomo Matteotti a Claudio Treves (Il 2 dicembre, insieme a Tito Zaniboni, Baldesi aveva avuto un colloquio con Mussolini sulla possibilità di unificare tutte le organizzazioni sindacali. Antonio Verganini (18611934) segretario della Federazione delle cooperative, il 120 novembre aveva discusso con Mussolini questioni inerenti il movimento cooperativo. L’episodio era poi abilmente sfruttato dala stampa fascista per contrapporre lo spirito collaborativo di Vergnanini, nei confronti del governo Mussolini, alla rigida intransigenza di Turati e Treves) Roma, 2 dicembre 1922 Caro Treves, Avrai visto la nuova esposizione Baldesi. Come al solito, a noi è stata comunicata solo dopo avvenuta; e non sappiamo se conosciamo esattamente il contenuto del colloquio. Per Vergnanini abbiamo dato il comunicato che egli non è inscritto al P [artito] S [ocialista] Unitario. Non sappiamo cosa se ne pensi a Milano; ma da tutte le altre parti di Italia arrivano consensi alla nostra opera, contro gli esibizionismi personali. Noi crediamo ancora e fermamente che si tratti di tutta una montatura e crisi di persone per la particolare situazione in cui si trovano. Ci ha però fatto meraviglia l’articolo della “Giustizia” Governo e lavoratori(1) che io credevo di Mazzoni, ma che questi afferma essere probabilmente tuo. Ciò che io non credo. Ad ogni modo cerco di convocare al più presto la Direzione; o a Milano, o a Roma. Magari in settimana se si può farla a Milano. Ti saprò dire. Musatti voleva dimettersi anche dalla Direzione. Saluti cordiali, Matteotti Nel blocco amministrativo’ come mai non vi è riuscito includere anche persone e competenze fuori del partito, a destra e a sinistra? NOTA (1) L’articolo era apparso sulla “Giustizia” del 30 novembre 1922. Nino Mazzoni (18741954), dirigente sindacale e parlamentare socialista dalla XXIV alla XXVII legislatura 18 ■ CRITICAsociale Lettera 96 Giacomo Matteotti a Claudio Treves Roma, 4 dicembre 1922 Caro Treves, Profitto di un messaggero per dirti rapidamente qualcosa. Qui nulla di nuovo veramente importante. Ieri il Direttorio (Modigl. - Musatti - Donati - Bocconi - Garib.) deliberava di mandare un telegramma urgente a Baldesi per invitarlo a spiegazioni sui colloqui mussoliniani. Egli ci ha risposto oggi che non può e che mercoledì vedrà Turati a Milano. Il colloquio è avvenuto naturalmente senza preavvisare alcuno di noi. Dopo il colloquio egli cercò me e informò Modigliani che si trattava soltanto dell’unità sindacale, e che anzi Mussolini non si era opposto alla adesione ad Amsterdam. Naturalmente Mussolini volle sapere come la pensasse ciascuno di noi. Modigliani e altri credono che nel colloquio vi sia stato molto di più da parte almeno di Baldesi. Così a Silvestri e a qualcun altro ha invece detto che partiva per Gardone!! Certo così non si può andare avanti. Mentre da tutte le Sezioni e da tutte le Province ci vengono incoraggiamenti a stare fermi e diritti, il primo che vuole, fa per conto proprio e impegna il partito compromettendolo. Volevo fare la riunione di Direzione a Milano perché voi siete certamente impegnati nella lotta elettorale; ma i due o tre rappresentanti del mezzogiorno non potrebbero venire. In caso sarà quindi a Roma subito dopo. Ciao Matteotti P.S.: Bararono ha indetto per stasera una riunione tra alcuni massimalisti e alcuni nostri (Musatti, Donati”, ecc.). Sono invitato anch’io. Pare che egli voglia affermare superato il concetto democratico e nello stesso tempo negare la III Internazionale (non so poi come risolva la contradiz.!). Temo sia ingenuamente succube di De Pazzi. Lettera 97 Giacomo Matteotti a Filippo Turati Roma, 8 dic. 1922 Caro Turati, Mi dispiace dei tuoi giudizi, fondati sull’ audizione di una sola campana, e precisamente di quella interessata personalmente. 1°) «Tutti noi sapevamo». Non so chi siano i noi. lo potrei dire «tutti noi non sapevamo». Cioè tutti coloro che appartengono al Direttorio ed alla Direzione e si trovavano a Roma non sapevano nulla. Né Modigliani, né Bocconi’, né Buozzi, né D’Aragona, né Musatti, né altri che pure non si chiamano Matteotti. Per lo meno Baratono è venuto a chiederlo, e non ha trovato in noi «la ostilità preconcetta». 2°) «Invitato da Mussolini - invitato da D’Annunzio». Tutto ciò risulta evidentemente a te solo e a nessun altro. Noi sappiamo benissimo invece come sono combinati codesti colloqui e purtroppo sappiamo ora anche di quello Baratono «invitato da Mussolini», L’invito era il parto di uno dei soliti intriganti. E se avessimo saputo, avremmo detto di no anche a quello. Se ne sono viste le conseguenze. 3°) «Ritardo per non piegarsi ai comodi del dittatore». Anche questo risulta a te solo. Qui a Roma solo dopo il colloquio, Modigliani ebbe qualche resoconto da Baldesi che non aveva trovato me. Ma Baldesi non disse a Modigliani 2-3 / 2013 che poi sarebbe andato a Gardone né a nessun altro di noi; lo disse solo ai soliti giornalisti che dovevano lanciare la réclame. Perché? 4°) In seguito a questo fatto si riunì il Direttorio, anzi pochi membri del Direttorio, tra i quali Modigliani, che propose di telegrafare a Baldesi perché venisse ad informare prima che avvenisse qualche cosa di non riparabile. Da noi nessuno ha saputo della spedizione del telegramma, il quale quindi non voleva affatto lo scandalo dell’ad udendium verbum. Ma trapelò per i giornali solo tre giorni dopo spedito, cioè dopo che fu recapitato. Perché? 5°) Non sento che noi gli dobbiamo alcuna «riconoscenza per essersi esposto alle malignità» ecc. Oggi ci vuole assai poco coraggio ad esporsi a tali specie di malignità. Ce ne voleva nel 1919-20 quando ti ci esponevi tu. Non oggi che tutti sanno con grande facilità buttarsi verso il vincitore nei più diversi atteggiamenti, ma in ogni caso ritrovandosi sempre in una situazione assai più favorevole dei compagni che resistono fermi. E questi, questi soli hanno il diritto alla nostra riconoscenza. Questi soli perché essi soli rischiano veramente qualche danno effettivo. Vedi infatti articolo del “Popolo d’Italia” che è perfettamente l’opposto di quei propositi di libertà che attribuisce adulatoriamente Baldesi a Mussolini. 6°) Il Comunicato della Direzione non ha cercato, neppure esso, lo scandalo. Anzitutto non lo abbiamo comunicato ai giornali, ma alla sola “Giustizia”. Poi, prende in un fascio tutti gli intervistaioli di questo tempo, da Baratono a Zirardini’, da Baldesi a Vergnanini che hanno veramente mosso il disgusto e la nausea in tutti - per lo meno in tutti che vengono da noi e scrivono alla Direzione. 7°) La tua pregiudiziale si applica quindi non a noi, ma a quelli che con i loro fatti, con il loro scarso riserbo provocano tutti gli argomenti di scissione. Noi abbiamo avuta fin troppa pazienza e usate tutte le strade per evitare quel troiaio di cui ora sono riempiti i giornali. Tanto è vero che di noi non si parla affatto, ma si parla soltanto di tutti i nuovi avventurieri. Stamattina il “Messaggero” porta invettive di Zaniboni’ contro di noi. L’altro ieri Cabrini mi comunicava un’intervista Zaniboniana sull’emigrazione che era un’ira di dio, e così di seguito ogni giorno. 8°) Che Baldesi abbia salvata la Confederazione, nessuno si è accorto né Buozzi, né Baglion ai quali abbiamo parlato. Evidentemente voi avete notizie speciali. O siete entrati anche voi nella mentalità miracolista. 9°) Per tua norma, Baratono è quasi sulla linea stessa di Baldesi. La parte della riunione coi vecchi massimalisti non terzinternazionalisti era ancora peggio. Ma il putrido era nella suggestione De Pazzi, che chiariva e sviluppava poi l’avvicinamento a Mussolini (il solo temperamento rivoluzionario secondo Baratono); dando a noi la precisa sensazione di tutta la manovra che si ordisce per avvincere questo e quello e sgretolare l’ultima forza ideale che ci resta. Noi non siamo né abbastanza disonesti, né abbastanza ingenui per aderirvi. E abbiamo consenzienti quasi tutti i compagni delle Federazioni Provinciali che ci hanno scritto. Tutto ciò senza entrare nell’ulteriore merito delle questioni interne sindacali ed internazionali, di cui parleremo in una prossima occasione. La lettera è per te, per la signora Kuliscioff e per Treves - esclusivamente - per non provocare nuovi pettegolezzi. Scusami, ciao, tuo G. Matteotti P.S.; E (in tutta confidenza) ti ha informato Baldesi delle sue intenzioni giornalistiche?! Tieni nota anche di questo. Mi duole anche che si parli o almeno si accetti da te alcun accenno di mia «ostilità preconcetta» contro Baldesi. lo non ho nessuna ragione personale; non gli sono nemmeno ... collega di lista di collegio. Fino a quando occuperò il posto di segretario del partito agirò obbiettivamente come tale, e pretendo di essere creduto. Se i compagni non credono non hanno che un mezzo, sostituirmi. Lettera 184 Giacomo Matteotti a Filippo Turati Roma, marzo-aprile 1924 Caro Turati Vorrei fermare un pensiero, nella tua rivista affinché non abbia neppure il sospetto di ripercussioni elettorali, e prima delle elezioni affinché non sembri più tardi conseguente a un esito qualsiasi delle medesime. L’esito darà la misura della violenza e del terrore, non del consenso dei singoli partiti. E vorrei fermarlo personalmente, non come segretario del Partito, tanto più che io sono deciso e spero, subito dopo le elezioni, che mi vorrete aiutare a liberarmi da un incarico che doveva essere provvisorio per due mesi e si è prolungato invece per oltre un anno. «Anzitutto è necessario prendere, rispetto alla Dittatura fascista, un atteggiamento diverso da quello tenuto fin qui; la nostra resistenza al regime dell’ arbitrio deve essere più attiva; non cedere su nessun punto; non abbandonare nessuna posizione senza le più recise, le più alte proteste. Tutti i diritti cittadini devono essere rivendicati; lo stesso Codice riconosce la legittima difesa. Nessuno può lusingarsi che il fascismo dominante deponga le armi e restituisca spontaneamente all’Italia un regime di legalità e di libertà; tutto ciò che esso ottiene, lo sospinge a nuovi arbitrii a nuovi soprusi. È la sua essenza, la sua origine, la sua unica forza; ed è il temperamento stesso che lo dirige. Perciò un Partito di classe e di netta opposizione non può raccogliere che quelli i quali siano decisi a una resistenza senza limite, con disciplina ferma, tutta diretta ad un fine, la libertà del popolo italiano. D’altro canto bisogna tornare a considerare la posizione del Partito Socialista Italiano. Purgato dai terzinternazionalisti e nettamente discorde da Mosca, ormai non è diviso da noi che da minori divergenze teoriche, più o meno equivoche o avveniristiche. Nella pratica e nel momento attuale non vi è poi alcuna differenza rilevante; e si potrebbe anzi dubitare se non sia minore la rigidezza e la combattività, in quelli che riparano sotto il pretesto formale che tutti i Governi borghesi sono eguali. Ora, per tali divergenze tutte astratte o proiettate nel più lontano futuro, non è permesso tenere divisa la classe lavoratrice italiana, e toglierle tutto quel lievito di speranze, di ardimenti, di consensi, che soli possono permettere un’ azione efficace, entusiastica e concorde nel momento attuale. Il nemico è attualmente uno solo: il fascismo. Complice involontario del fascismo è il comunismo. La violenza e la dittatura predicata dall’uno, diviene il pretesto e la giustificazione della violenza e della dittatura in atto dell’ altro. I lavoratori italiani, ammaestrati dalle dure esperienze del dopoguerra, devono riunirsi concordi contro il fascismo che opprime, e contro l’insidiosa discordia comunista; così nel campo dell’azione politica, come nella economica. I fatti del resto lo impongono, anche al di sopra delle nostre minori antipatie, risentimenti, ecc. Se non possono muoversi i Partiti ufficialmente, i socialisti dell’uno e dell’ altro campo devono porre la questione e risolverla. Senza ritardo. Le cose non avvengono da sé; ma ad opera degli uomini. Il ritardo serve soltanto a diffondere un più largo scetticismo nelle masse, e a lasciare quindi penetrare negli spiriti indeboliti i veleni più opposti. Le obiezioni sono facili, e le sento; ma bisogna superarle ad ogni costo, per agire rapidamente. G. Matteotti (L’articolo, proposto da Matteotti, non vide mai la luce. Sulla “Critica Sociale” (1-15 aprile) veniva invece pubblicato un commento di Turati contrario ad ogni ipotesi di riunificazione dei due partiti socialisti) Lettera 186 Giacomo Matteotti alla Direzione del Partito comunista “Non c’è nulla di comune tra noi e voi” Da “La Giustizia”, a. XXXIX, n. 93, 17 aprile 1924, p. 1. 1) La lettera della Direzione del Partito comunista per una manifestazione unitaria in occasione del 1 o maggio era apparsa sull”‘Unità” del 15 aprile 1924. La pubblicità data alla lettera aveva suscitato la reazione negativa non solo dei socialisti unitari ma anche dei socialisti massimalisti (cfr. “Avanti!”, 17 aprile 1924) che la giudicarono strumentale. 2 Il riferimento è al fallimento delle trattative tra i tre partiti della sinistra per una strategia comune in occasione delle elezioni politiche dell’aprile 1924. Roma, 16 aprile 1924 Riceviamo la vostra lettera contenente la solita proposta poligrafata per tutte le occasioni”. L’esperienza delle altre volte e dell’ ultima in particolare’, ci ha riconfermati nella convinzione che codeste vostre proposte, apparentemente formulate a scopo di fronte unico, sono in sostanza lanciate ad esclusivo scopo di polemica coi partiti socialisti e di nuove inutili dispute. Ciò può recare piacere e vantaggio a voi, come al governo fascista dominante con gli stessi metodi di dittatura e di violenza che voi auspicate. Ma non fa piacere né a noi, né alla classe lavoratrice, che subisce il danno delle vostre disquisizioni e dei riaccesi dissensi. Chi ha moltiplicato e inasprito le ragioni di scissione e di discordia nella classe lavoratrice è inutile e ridicolo si torni a camuffare da unitario e da «fronte unico». Restiamo ognuno quel che siamo: Voi siete comunisti per la dittatura e per il metodo della violenza delle minoranze; noi siamo socialisti e per il metodo democratico delle libere maggioranze. Non c’è quindi nulla di comune tra noi e voi. Voi stessi lo dite ogni giorno, anzi ogni giorno ci accusate di tradimento contro il proletariato. Se siete quindi in buona fede, è malvagia da parte vostra la proposta di unirvi coi traditori; se siete in mala fede, noi non intendiamo prestarci ai trucchi di nessuno. Perciò, una volta per tutte, vi avvertiamo che a simili vostre proposte non abbiamo nulla da rispondere. Tanto per vostra norma e definitivamente; e indipendentemente da quella che sarà la decisione della nostra Direzione intorno alla festa dello Maggio. Il Segretario del Partito Socialista Unitario, Matteotti CRITICAsociale ■ 19 2-3 / 2013 ■ UN NUOVO STUDIO SULLA TRANSIZIONE INCOMPIUTA IN UN LIBRO DI LUDOVICO FESTA STORIA DI VENT’ANNI. IL CROLLO DELLA PRIMA REPUBBLICA Lodovico Festa CAPITOLO I - IL CROLLO 1992 23 gennaio 1992: Francesco Cossiga, «sotto accusa» per Gladio, lascia il Quirinale il 28 aprile. 17 febbraio 1992: è arrestato Mario Chiesa. Lo stesso giorno si firma il trattato di Maastricht. 5 aprile 1992: politiche: il centrosinistra (Dc, Psi, Pri, Pii e Psdi) ha più del 50 per cento dei voti. 24 aprile 1992 :retata di imprenditori milanesi. 3 maggio: avvisi di garanzia per gli ex sindaci di Milano Tognoli e Pillitteri. 23 maggio 1992: assassinato Giovanni Falcone. 25 maggio: Oscar Luigi Scalfaro eletto al Quirinale. 28 giugno 1992: Giuliano Amato presidente del Consiglio. 10 luglio: I. Gli sconfitti Dura manovra patrimoniale (case e conti correnti). 19 luglio 1992: ucciso Paolo Borsellino. 25 settembre: Luciano Violante all’Antimafia. 17 dicembre: Gian Carlo Caselli alla procura di Palermo. 2 settembre 1992: si suicida il senatore socialista Sergio Moroni. Arresti e avvisi di garanzia colpiscono De Michelis, Ligresti. 13 settembre 1992: svalutazione della lira, uscita dallo Sme, perdite fino al 25 % su marco e franco. Fino al 30% sul dollaro. 12 ottobre 1992: Martinazzoli sostituisce Forlani alla guida della Dc. 15 dicembre: primo avviso di garanzia per Bettino Craxi. La liquidazione del Partito socialista italiano e quella dell’area moderata della Dc non possono essere affrontate con i giudizi sommari (sia pure di segno opposto) dei tanti antipatizzanti o dei non pochi nostalgici. Bettino Craxi non è Nicolae Ceausescu, Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani non sono politicanti sudamericani: sono gli uomini di governo che negli anni Ottanta portarono l’Italia al rango di sesta economia globale. La ripugnanza, però, per volgarità, ancora in corso, contro i politici magna-magna (talvolta impreziosite da riflessioni sul familismo delle nazioni mediterranee o sulla mancata riforma protestante) non impedisce di dubitare delle analisi consolatorie che individuano nel mero uso della «forza» (dei magistrati) la causa della sconfitta del riformismo socialista e delle tendenze liberali della Dc. Partendo dall’esaminare le basi della sconfitta del Psi non si possono sottovalutare gli errori craxiani sui «tempi»: le mancate elezioni nel 1991, il non accordo sul Quirinale’. E il controllo dei «tempi» è essenziale nella manovra politica. Sono evidenti, poi, anche alcune ingenuità nelle alleanze, altro elemento fondamentale dell’iniziativa politica. U go Finetti in un importante saggio (Storia di Craxi, editore Boroli 2009) sottolinea l’errore di Craxi nel proporsi di sostituire Andreotti alla guida del governo e di mettere Forlani al posto di Cossiga’, senza pensare a collocazioni alternative per i due potenti esponenti dc privati delle loro cariche. Conversando con Finetti si è ragiona- to pure su un condizionamento del leader socialista derivante dagli antichi rapporti nell’associazionismo universitario’’ con Marco Pannella e Achille Occhetto: dal primo, il leader del Psi si farà convincere a scegliere come presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro (peraltro suo efficiente ministro dell’Interno) provocando così la rovina principale; del secondo sorprendentemente si fiderà, acconsentendo all’entrata dell’ex Pci nell’Internazionale socialista, rinunciando al voto nel 1991 per evitare guai a Botteghe Oscure, senza ricevere in cambio alcuna reale apertura. Ci sono stati dunque difetti di presunzione rispetto alla propria forza concreta da parte di Craxi (e, più in generale, dei leader moderati del centrosinistra). Certo ha contato anche il quadro internazionale che giocò contro il centrosinistra senza che né socialisti né moderati dc lo percepissero appieno. Alcune dinamiche strutturali, però, del quadro nazionale spiegano in sé la parte fondamentale di quello che è avvenuto. In questo senso «il crollo» del 1992 non può essere compreso solo attraverso la politique politicienne. Di fatto si consumarono i margini di uno Stato che formatosi tra il 1943 e il 1948 non era riuscito a includere definitivamente parti essenziali della società. A iniziare dalla cultura liberale” che, dopo avere guidato la nazione per un cinquantennio, venne considerata responsabile dei difetti politici che avevano portato al fascismo (elitismo, trasformismo, protezionismo) ed emarginata anche nella nuova Repubblica. Proseguendo con una borghesia che nel Secon- do dopoguerra non assunse a pieno il ruolo di classe dirigente anche per le compromissioni con il precedente regime. Con i ceti medi, poi, ci fu più un rapporto di delega ambigua (si consideri solo la largamente consentita evasione fiscale) che una vera integrazione nello Stato. Infine gli orientamenti di larghi settori popolari furono segnati da un atteggiamento antagonistico verso il nostro sistema economico-sociale: Craxi impiegherà cinque anni di segreteria per riuscire a definire il Psi «riformista»; i comunisti «pragmatici» solo dopo la caduta del Muro di Berlino (13 agosto 1961 - 9 novembre 1989) inizieranno a chiamarsi pubblicamente «riformisti». E queste difficoltà derivano direttamente da radicati atteggiamenti classisti di parte decisiva del lavoro dipendente. Anche la «questione cattolica», inoltre, è stata affrontata più con la surroga anticomunista assunta dalla Chiesa nel 1947 e poi col ruolo dello Stato fanfaniano, che con un vero confronto tra tendenze secolarizzatrici e cultura religiosa. Quando saltarono le «protezioni» collegate al ruolo internazionale dell’Italia, si interruppero meccanismi che saldavano più o meno precariamente questa società (solo parzialmente responsabilizzata) e questo Stato (con basi sociali non adeguate). Craxi propose la Grande riforma: era consapevole delle «scollature», ma poi i movimenti che perseguirono attivamente obiettivi di riforma istituzionale (e quelli più o meno connessi di riforma fiscale) ebbero segno ora leghi sta ora pannellian-segniano, non craxiano. La svolta del 19845 sulla scala mobile aprì una discussione tra i lavoratori, ma il passaggio dalla testimonianza riformista alla lotta per l’egemonia riformi sta nei sindacati ha dovuto attendere sostanzialmente fino al 2008. Il Psi colse l’emergere di una nuova borghesia modernizzatrice dell’Italia ma poi i rapporti fondamentali furono tenuti con Gianni Agnelli e solo quando questi sarà fischiato nel 1994 (perché antiberlusconianamente si lamentava che non fosse stato eletto presidente del Senato Giovanni Spadolini) a un’assemblea di industriali a Verona, inizierà concretamente a cambiare qualcosa nella rappresentanza degli imprenditori. Verso intellettuali che uscivano dall’ estremismo sessantottesco, Craxi fece aperture nel 1985 aiutando a far pubblicare il quotidiano Reporter”, una costola della vecchia Lotta continua. Si sarebbe potuto così creare un legame come quello tra Gerhard Schroeder e Joschka Fischer? che, pur con limiti, ha favorito modernizzazione e integrazione della società tedesca. Ma nel 1988 grazie a un rapporto tra corpi dello Stato, procura di Milano e ambienti del Pci che ri.hiama in modo impressionante la prossima stagione di Mani pulite, venne incriminato Adriano Sofri per l’omicidio di Luigi Calabresi”, Gran parte degli ex lottacontinuisti (con generose eccezioni anche a sinistra come Marco Boato) finirà, poi, per una sorta di sindrome di Stoccolma, a ispessire le file dei giustizialisti. Forse senza l’uso abnorme della magistratura, con più xmsapevolezza su tempi e alleanze, i leader del centrosinistra avrebbero potuto superare la crisi del ‘92 per via politica. Seppure valutazioni strutturali indichino un deficit di forza per questo obiettivo. Ma così non andò, e azione di pm e «distrazioni dei leader» non provocarono solo una crisi polit ica, bensì quella radicale - ancora in atto - dello Stato. 1. I disertori I risultati politici principali di Mani pulite sono la distruzione del Psi e poi quella dell’area moderata della Dc: del partito di !\ Icide De Gasperi resterà in piedi sostanzialmente il nucleo della «sinistra», solo sfiorata da qualche indagine su singoli esponenti. Intorno a questo nucleo si formeranno i vari «ParI i (o popolare», «Margherita» fino al «Partito democratico»? rnsieme agli eredi del Partito comunista italiano, l’altra forza lurgarnente risparmiata dalle inchieste giudiziarie. Nonostante diffuse nostalgie, l’esperienza storica della l Jc si è consumata. Chi ne agita ancora il vessillo ricorda i honapartisti dopo la morte di Napoleone: persone che vivo- 110 in un passato senza più prospettive. Finita la fase iniziale della Dc, sorretta dall’impegno della Chiesa a evitare la tin, quest’ultimo alla fine si dimetterà sia per le insensate posizioni del Pds di Occhetto, sia per i limiti della Cgil, sia per la maturazione di un «erede» che appariva (poi deluderà ampiamente) più credibilmente riformi sta come Sergio Cofferati”. Grazie a nuove intese si definirà un sistema salariale che porta strutturalmente sotto controllo l’inflazione, non risolvendo però, a causa dell’eccesso di centralizzazione contrattualistica («totem» cigiellino), i problemi di fondo della produttività. Le altre scelte (tagli, privatizzazioni, assestamento del sistema del credito) continueranno sulla linea amatiana: scelte utili, in parte inevitabili per l’emergenza, caratterizzate però dalla mancanza di visione, intrinseca all’operare - al fondo irresponsabile - di un governo tecnico. Molto di quel che avviene tra il 1992 e il 1993 è frutto di un’emergenza incontrollata (e forse incontrollabile), in parte a causa di un eccesso di influenze esterne, in parte della crisi di uno Stato troppo disegnato su’un’altra stagione storica, e anche di una tendenza di settori rilevanti delle classi dirigenti (innanzitutto di quelli decisivi della grande borghesia) a cercare una guida del governo insieme forte per mancanza di alternative e fragile per la deresponsabilizzazione inevitabile che comporta la mancanza di alternative. Con una fondamentale conseguenza: la mancanza di verità tipica di governi strutturalmente irresponsabili come quelli tecnici. Non sempre la verità conduce al bene: la storia del Novecento testimonia come certe «verità» (la rabbia popolare per la guerra 20 ■ CRITICAsociale ‘14-’ 18, o la successiva umiliazione della Germania) abbiano prodotto devastanti tragedie. Ma la «non verità» programmati ca preclude qualsiasi tipo di visione e quindi di proiezione nel futuro. 2. Cose nostre, cose loro & cose di tutti La mafia italiana, racconta Louis Freeh in My Fbi (le sue memorie pubblicate da St. Martin’s Press, 2005), viene riorganizzata, sull’ orlo dello sfaldamento, da Lucky Luciano esiliato dagli Stati Uniti negli anni ‘50, che convince i boss locali a darsi un’organizzazione centralizzata (la «cupola»). È allora che la principale risorsa di Cosa nostra, lo scambio politico, viene razionalizzata. La riflessione di Freeh, grande amico di Giovanni Falcone e Gianni De Gennaro? come scrive nelle memorie, è rilevante perché svolta dal direttore del Bureau che non solo non considerava Cosa nostra invincibile, ma la smantellò nel caposaldo americano. La seconda rivoluzione di Cosa nostra si colloca alla fine dei Settanta con l’inserimento nel traffico degli stupefacenti, che conferisce nuovo potere anche finanziario. Da qui l’incremento delle iniziative, poi su una linea più accentuatamente militare (la politica serve meno) con lo sterminio dei «diplomatici» palermitani e l’affermarsi dei «duri» corleonesi, e l’ondata di assassini di uomini delle istituzioni (da Rocco Chinnici a Cesare Terranova, a Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Pio La Torre)”. Contro la svolta mafio sa vi sarà sia una risposta popolare (la «primavera palermitana») sia giudiziaria-istituzionale con Falcone. L’efficacia politica e repressiva delle risposte di fine anni Ottanta porterà la volontà di potenza e lo spirito militare dei corleonesi ad aumentare in modo drammatico la ferocia dei crimini provocando però un intervento dello Stato che colpirà seriamente Cosa nostra. Così si arriva al ‘93, quando in settori dello Stato impegnati contro la mafia (sia forze di polizia sia pm) tende a prevalere l’idea che Cosa nostra non sia tanto un’organizzazione criminale in sé quanto la funzione di un assetto di potere interno alle istituzioni, senza lo smantellamento del quale non si risolverà mai la partita. Da qui l’incriminazione di Giulio Andreotti, di Calogero Mannino e tanti altri politici di prima fascia, e poi la persecuzione giudiziaria di Marcello Dell’Utri” come nuovo re ferente del patto organico tra Stato e mafia. In un libro magicamente delirante (Patria 1978-2010, editore il Saggiatore 2009), Enrico Deaglio racconta così - dando epicità alle posizioni di certi settori della magistratura inquirente - la storia nazionale. La nostra discussione pubblica è permanentemente nevrotica, tende a non affrontare argomenti razionali ma si propone perlopiù di suscitare emozioni. Nelle discussioni attuali sulla lotta alla mafia questa cifra nevrotica si esprime innanzitutto nell’appello a quello che è -sacrosantamente - considerato dalla comunità nazionale un martire: Falcone. Giustamente Violante fa rilevare’ (nel suo Magistrati già citato) ad alcuni falconiani dell’ultima ora, la loro opposizione al magistrato espressa negli anni Ottanta. Non mancò, allora, un’ampia ala garantista (non solo pelosamente ma anche sinceramente garantista) che criticò certe forzature nella gestione del maxiprocesso falconiano. Particolare impressione suscitò l’attacco che devastò la vita del giudice di Cassazione Corrado Carnevale>, finissimo - talvolta sin troppo - giurista che faceva prevalere il «testo» della legge sulle «esigenze materiali» di colpire la criminalità organizzata. Su questo tema del rapporto tra emergenza e norma giuridica alla fine degli anni Ottanta il «folle» Cossiga osservò (innanzitutto contro 2-3 / 2013 Andreotti’”) - e il politico sardo si era così espresso anche nel contrasto al terrorismo che era meglio una specifica legislazione di emergenza piuttosto che piegare la giurisdizione corrente a fini emergenziali. Senza dunque togliere nulla a certe durezze falconiane e a certi contrasti con aree garantiste, non è impossibile però ricostruire una linea del giudice palermitano che si discosta dall’idea del grande complotto criminale caratterizzante la storia nazionale di cui la mafia sarebbe in effetti solo un terminale: la scelta stessa di Falcone di lavorare con Andreotti e Martelli (atto che concretamente «terrorizza» i corleonesi), il suo insistere sull’ «indipendenza» di Cosa nostra da altri poteri, la sua operazione per isolare i mafiosi dalla politica piuttosto che indicarli come frutto di uno Stato criminogeno, la sua idea di una risistemazione della magistratura (a partire dalla separazione delle carriere) per ridare responsabilità alla politica, sono sufficientemente delineate per non essere smentibili. E determinarono allora rotture sia con l’antimafiosità più radicale di Leoluca Orlando!” (peraltro connessa all’inevitabile assistenzialismo necessario per sostenere socialmente il suo estremismo) sia con le posizioni in quegli anni prevalenti nella Magistratura democratica più legata al Pci, a partire da Violante. La commistione tra contrasto della criminalità e lotta politica, oltre un certo livello, produce sempre perversioni incontrollabili: lo dimostra efficacemente il caso della Campania, dove un Antonio Bassolino” divenuto figura centrale di quella regione proprio sull’ onda di questa impostazione (smantelliamo il sistema camorristico centrato sul «gavismo» e risolveremo anche i problemi della criminalità locale) non solo non ha, in oltre un decennio, eliminato l’emergenza criminalità ma l’ha gravemente peggiorata, anche grazie al prevalere di una linea politicizzata sintonica in molte delle procure campane (persino un pm ultragiustizialista come Agostino Cordova fu allontanato da N apoli perché troppo di destra). D’altro verso proprio il caso Salerno, comune guidato da un antagonista del bassolinismo nel Pci poi Pds-Ds come Vincenzo De Luca, dimostra che è possibile percorrere una via opposta in cui la politica batte i criminali facendo politica. La linea che non si pone il problema di separare i criminali da una società pur ricca di elementi di corruzione, finisce invece per criminalizzare ampiamente tutta una società. Il che è di fatto politicamente non tollerabile e porta inevitabilmente all’offuscamento della verità come emerge con chiarezza da un episodio centrale del ‘93: la decisione da parte di Giovanni Conso, allora Guardasigilli, di alleviare l’applicazione del 41 bis, dispositivo di aggravanti penali e carcerarie connesse al reato di associazionismo mafioso, per qualche centinaio di aderenti a Cosa nostra. Dopo una lunga fase durante la quale si è cercato di «incastrare» Dell’Utri sostenendo che aveva scambiato l’appoggio della mafia a Forza Italia con la promessa di alleviare il 41 bis (richiesta peraltro mai materialmente soddisfatta da esecutivi di centrodestra) si è scoperto improvvisamente - dopo circa 17 anni - che un più o meno simile provvedimento era stato assunto da un giurista senza macchia come Conso considerato da Violante uno dei suoi maestri, con Ciampi a Palazzo Chigi che sostiene di «non aver saputo niente»; con uno Scalfaro che sul caso ha balbettato mentre il suo «badante» Gaetano Giffuni - figura centrale prima a Montecitorio e poi al Quirinale nell’ affiancare Oscar Luigi - ha confermato (nello sconcertante silenzio della stampa «indipendente») una discussione sul caso tra presidente e capo della polizia, un’altro «badante» dello scalfarismo, Vincenzo Parisi”. È evidente come uno Stato sottoposto a un duro attacco terroristico possa avere la necessità di articolare i comportamenti (naturalmente senza giustificare in nessun modo alcune eventuali scelleratezze come complicità con l’assassinio di Paolo Borsellino). È chiaro che alcune manovre, al netto delle scelleratezze, non determinano automaticamente una trattativa criminogena, come si è imputato a un perfetto servitore dello Stato quale il già capo dei Ros dei carabinieri Mario Mori”. Ma è l’idea del governo dei puri (e in quanto tecnici irresponsabili) che impedisce quel minimo di verità su cui è possibile costruire la discussione pubblica. L’operazione del 1993, che nessuno conosceva sino al 2010, sul 41 bis, ha la stessa impronta di rinuncia alla verità che si verifica nell’impedire a Conso di legiferare sul finanziamento illecito, della deplorevole operazione «non verità» di Scalfaro sul Sisde (per non parlare dei casi Marcello Gavio o Cornelio Valletto), dell’imbarazzante silenzio con cui si accolse uno dei discorsi più tragici della storia repubblicana, quello di Bettino Craxi nell’aprile del ‘93 sul sistema di finanziamento dei partiti in Italia, dello sbeffeggiamento del Parlamento da parte del pool di Milano, della mancanza di rispetto verso i padri costituenti con cui si accolse senza discutere il superamento di un’immunità parlamentare pensata, con funzione di bilanciamento dei poteri, come perfettamente simmetrica all’indipendenza dei pm. Sono questi i suggelli della politica di un governo pur non privo di meriti ma di fatto «senza (sufficiente) verità» come quello di Ciampi. CAPITOLO SECONDO 3. Un riformismo ubriaco Mentre i governi Amato e Ciampi contrastano le emergenze della crisi con qualche efficacia (ma senza verità e prospettiva), mentre i leader del Psi e della Dc moderata sono sempre più sconfitti, la «diserzione» di forze «costituenti» fondamentali come sinistra Dc ed eredi del Pci, abbandona i problemi di assetto delle istituzioni a un movimento referendario che gode sia della geniale capacità organizzativa di Marco Pannella (uomo talora indispensabile alla Repubblica quando apre spazi di libertà, ma vera piaga quando passa alla parte costruens) sia del protagonismo di un Mariotto Segni” senza dubbio tenace ma non privo delle fragilità caratteriali tipiche di certi figli di uomini autorevoli. Segni si batte negli anni Ottanta dentro la Dc per scelte modernizzatrici, lavora con personalità anche di qualità (tra tutte, Roberto Mazzotta). E nella tempesta degli anni Novanta sceglie di (e viene scelto per) dare un colpo agli assetti istituzionali della Prima Repubblica. Con una serie di referendum nel 1991, nel 1992, nel 1993 porta ad abolire la preferenza plurima nelle elezioni locali, promuovere l’elezione diretta dei sindaci, scardinare il sistema quasi perfettamente proporzionale del voto politico: modifica così il quadro istituzionale complessivo in punti decisivi. Sono in sé scelte largamente condivisibili, ma che non producono quella riforma dello Stato che la chiusura della Guerra fredda imponeva. Alla fine nonostante tutto resterà centrale la posizione degli adoratori fanatici della Costituzione (razza ben diversa da quella degli estimatori consapevoli) che sostengono la spericolata tesi per cui l’Italia sarebbe stata un Paese completamente corrotto nonostante il suo perfetto sistema istituzionale. Tesi assolutamente simmetrica a quella di tanti destalinizzatori dell’Est europeo: il socialismo era un si- stema meraviglioso, solo che Giuseppe Stai in l’aveva applicato male. Alcuni opinionisti «sostanzialisti» ritengono che di fatto tutto ciò che serviva è stato portato a casa: abbiamo amministratori scelti dal popolo, c’è un sistema bipolare di alternative politiche. L’essenziale va! L’intendenza napoleonicamente seguirà. Anche senza accettare integralmente gli arrabbiati argomenti di un fine scienziato della politica come Giovanni Sartori, che insiste su come alla politica servano sistemi coerenti e non patchwork improvvisati, non è azzardato osservare come il riformismo ubriaco degli anni Novanta abbia fallito su un obiettivo decisivo: costruire l’ambiente per una nuova generazione di partiti. Ed è l’incoerenza di sistema che produce questo effetto: la mancanza di contrappesi politici fa sì che ogni razionalizzazione sia vissuta con preoccupazione (e tendenzialmente respinta) da una società che ha pagato già prezzi esagerati ai troppi poteri della politica. L’anarchico sistema di voto imperante (dai comuni alle province alle regioni alla Camera al Senato all’Europa, l’elettore italiano ogni volta vota in modo diverso), il caos della divisione di responsabilità tra assemblee ed esecutivi - evidente anche su scala nazionale ma esplosivo in regioni ed enti locali hanno impedito la costituzione di veri soggetti politici nazionali, consentendo - perché si mantenesse quella minima funzione unificante che la politica non può non esprimere - solo la formazione non di movimenti leaderistici ma «personali» (dal berlusconismo al bossismo al dipietrismo, al prodismo, al vendolismo fino al casinismo e al finismo con persino un tentato renzismo) con la parziale eccezione di quella ensemble scombinata di cacicchi che sono le aree ex Dc ed ex Pci del Pd. Sempre gli opinionisti sostanzialisti affermano che questo esito non sarebbe un gran male: in fin dei conti anche negli Stati Uniti non esisterebbero reali partiti. Il che non è vero: i grandi partiti americani non sono affatto aggregazioni volta per volta di interessi e idee, bensì luoghi di maturazione nella lunga durata delle posizioni per governare una società e uno Stato federale complessi come quelli americani. Confederalismo o federalismo, centralità dell’agricoltura o dell’industria, isolazionismo o interventismo, regolazione o assoluta liberalizzazione, integrazione dei ceti popolari o sviluppo di comunità e libertà centrate sull’individuo. Dagli inizi dell’Ottocento la vita politica americana è segnata da una discussione delle idee interna ai partiti prima che nelle istituzioni. Poi, certo, il carattere aperto della nazione americana fa sì che sia la società a organizzare i partiti, e a determinare una mobilità particolare del ceto politico al contrario di quel che è avvenuto in parte decisiva della storia d’Italia, dove sono stati i partiti a organizzare la società. In realtà il mancato decollo di nuovi partiti post Guerra fredda è il frutto più avvelenato del riformismo ubriaco che abbiamo vissuto. Tutto ciò non nasce solo dal caso, che pure ha avuto un ruolo rilevante. La stessa scelta di Segni come leader del rinnovamento da parte di ampi settori dell’establishment nazionale scaturisce da una certa logica. Dai tempi in cui per risolvere i conflitti più aspri si cercava «l’uomo forte» si è giunti a quelli in cui per non disturbare certi equilibri di potere si punta solo su «uomini deboli». Dai gorilla ai chihuahua. Così Segni, così Ciampi, così Prodi (poi si è visto che «mordeva» più del previsto), Rutelli, così un politico di rara inconsistenza come Walter Veltroni e poi Gianfranco Fini, Luca Cordero di Montezemolo, Mario Monti e via evanescendo. s Lodovico Festa CRITICAsociale ■ 21 2-3 / 2013 ■ NEL CELEBRARE L’UNITÀ D’ITALIA IL RICONOSCIMENTO AL RUOLO DELLA RIVISTA DI TURATI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA NAZIONE ALLA CRITICA SOCIALE L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO I l Comitato Promotore delle Celebrazioni per i 120 anni della rivista Critica Sociale, fondata da Filippo Turati nel 1891, è stato ricevuto in Udienza al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano che ha concesso alle iniziative l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica per l’anniversario dela Rivista storica del socialismo italiano. Nel corso del “cordiale incontro” – come è stato giudicato nel comunicato del Quirinale la delegazione ha sottolineato come “La Critica Sociale”, nella continuità delle pubblicazioni e delle sue iniziative editoriali, rappresenta il punto di riferimento politico della tradizione del riformismo anche per l’attualità della lezione delle idee e dei valori del socialismo riformista nell’affrontare i problemi della società italiana di oggi.. Nel consegnare la raccolta originale della prima annata è stato evidenziato come il socialismo riformista attraverso i suoi Autori - da Filippo Turati, ai due Presidenti della Repubblica, Luigi Einaudi e Giuseppe Saragat, all’ex Presidente del Consiglio, Bettino Craxi - rappresenti una tradizione politica e culturale vitale della storia nazionale. Nel quadro delle Celebrazioni in corso, i partecipanti all’Udienza hanno preannunciato un grande Convegno conclusivo che si prevede per il mese di novembre e al quale hanno invitato lo stesso Giorgio Napolitano. Molto ascoltati ed utili sono stati i preziosi suggerimenti rivolti dal Presidente al comitato promotore affinché il convegno sia un’occasione seria di studi approfonditi sulla storia del riformismo socialista. Il programma, che sarà realizzato con la collaborazione scientifica della Fondazione Filippo Turati di Firenza, prevede quattro seminari di studio in preparazione del Convegno nazionale conclusivo, che si svolgerano in una sede istituzionale della Camera dei Deputati, sui temi della costruzione della società nazionale – anche in riferimento al 150mo anniversario del’Unità dello Stato Italiano: dal municipalismo, alla cooperazione, alla mutualità, all’economia pubblica, alla conquista dei diritti politici come il suffragio universale e la legge elettorale proporzionale, ai diritti del lavoro. Al Presidente Napolitano, è stato fatto il dono personale del Primo Volume rilegato da Turati, con i fascicoli della prima annata, quella del 1891, tratto dal Fondo Faravelli che raccoglie l’intera collezione della Critica Sociale e gran parte dei libri che costituivano la biblioteca della redazione. Il Fondo si trova ora nella nuova sede della Critica situata nella canonica della ex chiesa di San Carpoforo, nel quartiere Brera a MIlano, che verrà inaugurata con una mostra sui 120 anni del riformismo socialista in autunno e che ospiterà la Biblioteca e l’Archivio storico della Critica Sociale e dell’Avanti! di Milano. Al Presidente Napolitano è stata inoltre consegnata la prima copia “master” del Volume e dei Dvd che costituiscono una opera di grande valore storico culturale, raccogliendo in oltre 8.000 voci l’indice generale degli Autori della Critica negli anni della direzione di Filippo Turati e tutte le pagine di trentacinque anni di pubblicazione nei fascicoli consultabili off line nei dvd allegati Si tratta di un volume di 170 pagine che cosituisce una sorta di “postumo borereau di redazione” dei Padri del riformismo socialista italiano e della loro corrispondenza con i leaders del socialismo europeo a cavallo tra la fine dell’800 e l’avvento del fascismo. Quest’ultimo documento – è stato preannunciato al Presidente della Repubblica dalla Direzione della rivista - sarà donato a tutti i sindaci italiani, affinchè loro tramite il patrimonio di cultura politica e di storia de “La Critica sociale”, sia reso disponibile in tutte le biblioteche civiche e scolastiche del Paese. Per parte sua l’Associazione nazionale degli “Amici della Critica sociale” ha sottolineato come il suo impegno nell’organizzare la distribuzione di questo documento nei Comuni italiani, sarà anche l’occasione per promuovere manifestazioni celebrative dei 150 anni dell’Unita d’Italia che il riformismo ha contribuito a realizzare coniugando all’unità politica del nuovo Stato, l’unità sociale della nuova società nazionale nel segno della democrazia e dell’eguaglianza. s ■ 120 ANNI DI CRITICA SOCIALE NEI 150 ANNI DELL' UNITÀ ITALIANA L’ANTOLOGIA PER LE CELEBRAZIONI I MAESTRI DEL PENSIERO RIFORMISTA L a citazione del fondatore di Critica Sociale che riportiamo nel titolo, indica l’ampio ventaglio delle ragioni che ci inducono a ricordare i 120 anni della rivista in stretta relazione con la celebrazione del 150 anniversario dell’Unità d’Italia attraverso un ciclo di conferenze, con la pubblicazione dell’edizione digitale dell’intera Collezione storica (1891-1926) e con una Mostra “Il riformismo socialista da Turati a Craxi” : iniziative che si svolgeranno lungo il corso del 2011. La Critica Sociale, nata nel 1891, è stata testimone e protagonista, con i suoi Autori, di analisi e di dibattiti decisivi per il progresso socio-economico, istituzionale e civile del nuovo Stato Unitario. Con un suo contributo specifico in più: l’obiettivo dell’emancipazio- ne delle plebi post-unitarie in una classe educata alla democrazia, il primo concreto tentativo di ingresso del movimento dei lavoratori nel nuovo Stato unitario per realizzare con la Nazione le più ampie aspettative del Risorgimento, sia sociali che politiche, di giustizia e di libertà. Un programma di riscatto dalla “vergogna” non solo della divisione e della dipendenza dallo “straniero”, ma anche dalla “vergogna” del degrado civile e sociale delle popolazioni italiane pre-unitarie, per le quali Turati attribuiva alla Nazione la missione di dare soluzione all’ “Eterna questione”, come definiva la “questione sociale”. Si tratta di un punto essenziale del significato che attribuiamo a questo anniversario di Critica Sociale, poichè il rapporto successivo tra i socialisti e il concetto di Nazione non è stato, nella storia, lineare e facile. Viceversa spesso è stato di conflittuale. Intendiamo proseguire sulla strada aperta dalla revisione iniziata da Craxi negli anni ’80 del concetto di Nazione, intesa come fondamento della stessa democrazia, poichè fu così alle origini del socialismo italiano e lo fu in particolare per la Critica Sociale. Come scriveva Arduino Agnelli, “le istanze nazionali democratiche sono state assunte dai primi socialisti con una fermezza ed un rigore frequentemente superiori a quelle di movimenti che ad esse avevano fornito l’espressione originaria”. Lo sottolineava bene anche Rodolfo Mondolfo su Critica Sociale in un saggio del 1923: “Nazione, Patria, Umanità” nel rivalutare la continuità del socialismo con la democrazia risorgimentale in uno studio comparativo tra Engels e Mazzini, nel solco di quanto lo stesso Jean Jaures scrisse in un articolo pubblicato postumo nel 1915, “La Nazione è la patria di tutti”: “Io mi azzardo a dire che manca oggi alla classe operaia, per essere una grande forza dello Stato, soltanto la conoscenza di tutto ciò che essa può conseguire, con l’azione metodica, nella democrazia”. La lunga continuità delle pubblicazioni di Critica Sociale, che copre un arco di 35 anni dalla sua fondazione al fascismo, consente la disponibilità di una continuità ininterrotta (salvo le censure del momento) di documentazione storica sulla progressiva costruzione della società nazionale post-unitaria, quasi “ad horas”. Da questi presupposti si sviluppa il programma delle celebrazioni dei 120 anni di Critica Sociale, nel segno della divulgazione di un patrimonio nazionale (non solo di parte) di conoscenze storiche e di cultura politica, che illustriamo di seguito. 22 ■ CRITICAsociale IL PROGRAMMA Un’antologia dei Maestri del pensiero Riformista incentrata sui temi della costruzione della Nazione Il riformismo socialista e l’emancipazione: da plebe a cittadini. La creazione dell’opinione pubblica e le grandi campagne sociali di “national building”: i programmi scolastici di “evoluzione”, l’organizzazione degli insegnanti e i provvedimenti contro l’analfabetismo, la lotta contro le piaghe dell’alcolismo, del lavoro minorile, la questione femminile. Il ruolo dell’associazionismo economico e politico nella educazione ai diritti civili. Le realizzazioni sociali (“le conquiste dei lavoratori”) come nuove istituzioni pubbliche: il mutualismo, la previdenza, la sanità, le biblioteche popolari, i teatri comunali. Il movimento cooperativo, la legislazione sociale e del lavoro. Il ruolo dei lavoratori nell’economia nazionale attraverso l’impresa sociale e i consorzi. La democrazia economica e i progressi del diritto civile nei rapporti di proprietà. Le organizzazioni di resistenza dei lavoratori e la nascita di relazioni industriali su base normativa. Il socialismo giuridico, l’arbitrato e il sindacato. Le Camere del lavoro per la formazione e l’avviamento professionale contro la disoccupazione. L’ esperienza della Società Umanitaria. Democrazia come civiltà: il socialismo municipale, la rappresentanza politica. L’ esercizio della democrazia come leva del- 2-3 / 2013 la riforma sociale. Il “socialismo dei margini” nei comuni e l’autogoverno nei servizi pubblici, di igiene, per l’occupazione e nella lotta alla povertà. Il suffragio universale e la legge elettorale proporzionale, il voto alle donne. L’organizzazione dei partiti politici di massa, le battaglie per la libertà di espressione e la divulgazione della stampa. Gaetano Salvemini: meridionalismo e federalismo. Rifare l’Italia, lo sviluppo economico e il progresso sociale. Capitalismo e progresso sociale: alleanza e conflitti. La riforma agraria e la piccola proprietà. I piani di sviluppo delle infrastrutture nazionali. Le bonifiche e la nascita della programmazione territoriale. Le società municipalizzate, l’azionariato popolare e la finanza locale. “Nazione, Patria, Umanità”: la proiezione internazionale dell’Italia.. La prima esperienza di “Public Diplomacy”: l’ internazionalismo socialista e i diritti dei popoli. L’idea del federalismo europeo. Il sostegno alla Società delle Nazioni. Le politiche commerciali e le opere internazionali di collegamento per la crescita economica. Il sostegno all’emigrazione. Edizione digitale della Collezione Storica. E’ stata predisposta l’edizione digitale della Collezione storica diretta da Turati dal 1891 al 1926 (quando si interrompono le pubblicazioni per l’ esilio in Francia) in un cofanetto di sette DVD con navigazione offline nella ricer- ca per autore, per numero, per anno, per argomento. Il cofanetto contiene una guida alla consultazione, con un indice generale e un vocabolario per l’organizzazione degli argomenti. Dell’opera intendiamo fare dono gratuito alle biblioteche comunali e scolastiche. Attraverso una campagna di sottoscrizione a cura dell’Associazione nazionale degli “Amici di Critica Sociale”. Crediamo che il conferimento del dono possa essere l’occasione anche per promuovere pubbliche manifestazioni nei comuni italiani in collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali, sulla storia e le prospettive dei valori della democrazia nazionale, momenti di adesione spontanea alle manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Le registrazioni e le trascrizioni delle Conferenze saranno collocate in un sito web verso cui sarà possibile essere reindirizzati dai DVD della collezione. In tal modo il materiale raccolto potrà essere successivamente oggetto di approfondimenti e di interventi specifici che potranno pubblicamente aggiornare l’opera e attualizzarla senza interruzione. recensite, citate nei suoi fascicoli. Sono i testi sui quali si è formata la cultura democratica dei giovani animatori della rivista, e attraverso cui ha avuto ingresso il socialismo scientifico in Italia, la sua elaborazione riformatrice, fino al liberalsocialismo e alla sua ripresa nella recente storia italiana con il Socialismo liberale del “nuovo corso” del PSI di Craxi. La vastità delle collaborazioni è molto ampia: si tratta di personalità di spicco della cultura italiana ed internazionale dell’epoca, provenienti da un arco di tendenze aperto ad ogni contributo. In questo quadro, tra gli Autori della Critica vogliamo sottolineare la collaborazione di due futuri Presidenti della Repubblica, Luigi Einaudi e Giuseppe Saragat. Il primo iniziò giovanissimo a scrivere sulle colonne della Rivista, ancora responsabile degli studenti universitari socialisti di Torino, e proseguì per dieci anni dal 1893 al 1903, già editorialista economico del Corriere della Sera. Saragat ebbe nella Critica un punto di riferimento della sua posizione politica, in particolare durante la direzione di Giuseppe Faravelli, che ne fece per qualche anno una vera e propria corrente socialdemocratica all’interno del Partito socialista. La Mostra conclusiva: “Il riformismo socialista da Turati a Craxi”. La mostra costituirà una “biblioteca ideale” della Critica Sociale, attraverso un percorso tra i suoi principali Autori, le loro biografie ed opere, con una esposizione di opere e di autori a cui ha attinto la Critica organizzata per “pannelli-schede” dei libri e delle riviste segnalate, Il Comitato Promotore. Al momento il Comitato promotore delle Celebrazioni dei 120 anni di Critica Sociale è costituito dalla “Critica Sociale” e dagli “Amici della Critica Sociale”, dalla “Società Umanitaria”, dalle “Ragioni del Socialismo”, da “Mondoperaio”. La collaborazione scientifica è curata dalla “Fondazione Filippo Turati”. s ■ LA CONSEGNA AL QUIRINALE DEL “MASTER” DELL’OPERA IL DONO A GIORGIO NAPOLITANO DELL’EDIZIONE DIGITALE L’INTERA COLLEZIONE DELLA RIVISTA DI TURATI Q uella che presentiamo è la copia Master in edizione digitale della Collezione storica di Critica Sociale negli anni della direzione di Filippo Turati, dalla sua fondazione il 15 gennaio1891, fino all’ottobre del 1926, anno di cessazione delle pubblicazioni per l’esilio in Franciadel suo Fondatore. Il Master comprende il volume con l’indice generale alfabetico degli Autori, con l’indicazione degli articoli, suddivisi per anno, fascicolo e numero di pagina, oltre al riferimento al Dvd in cui sono stati collocati. È un documento esso stesso, un “bordereau di redazione” a posteriori - che consente di farsi un’idea generale delle personalità e degli argomenti agli esordi del Novecento italiano - ed è anche una guida alla consultazione delle pagine della Collezione storica riprodotte in jpeg nei sei dvd allegati. La Collezione storica archiviata in edizione digitale, non cambia l’abituale metodo di consultazione di un qualunque volume o rivista cartacei. Infatti, grazie al programma di navigazione interna - off line - si può giungere direttamente all’Autore o all’articolo desiderati per poter successivamente curiosare, sfogliando il fascicolo dalla sua prima pagina in poi, avanti e indietro. O passare ad altro numero della Rivista come si fa con qualunque libro o giornale. Le offriamo, Signor Presidente, questa “prima pietra” dell’opera che sarà editata per farne dono a tutti i Sindaci italiani, affinché i Comuni d’Italia abbiano nelle loro biblioteche civiche e scolastiche una documentazione, altrimenti introvabile, che permette di conoscere fin nei dettagli lo sforzo iniziale del movimento dei lavoratori di contribuire con la propria educazione e con la democratizzazione del nuovo Stato, a rafforzare con l’unità sociale di un popolo unito nella sua nuova Nazione indipendente. Raccogliendo con sollecitudine il suo richiamo a celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, abbiamo cercato di dare il nostro contributo rendendo disponibile al pubblico una documentazione storica che non rappresenta più la vicenda di una fazione, ma che nel segno dell’Alto Patronato da Lei concesso alla Rivista in occasione dei suoi 120 anni evidenzia il contributo dai riformisti all’unità nazionale affrontando la questione sociale e che rende la Critica Sociale e il riformismo socialista un patrimonio di tutti, un patrimonio nazionale. s Critica Sociale, nell’11 luglio del 2011 ■ FIGURA COMPLESSA DELLA STORIA POLITICA ITALIANA RICORDO DI RENATO MIELI UN GRANDE PERSONAGGIO DI CULTURA LIBERALE L Piero Ostellino a ragione principale per la quale voglio ricordare Renato Mieli è che egli è stato un grande personaggio della cultura liberale. Se in giro ci sono ancora “quattro gatti” liberali, lo si deve soprattutto al CESES (Centro Studi e Ricerche su Problemi Economico - Sociali) di Mieli, che ha influenzato la cultura politica di coloro che, allora giovani italiani, oggi genericamente si possono definire democratici liberali. Renato ha rappresentato una figura complessa nella storia culturale e politica del nostro Paese, persino, sotto certi aspetti, una figura unica. Nato come studioso di Fisica, aderì al Partito Comunista Italiano, nel ’38 fu costretto a lasciare l’Italia per due ragioni evidenti, era ebreo e comunista, e a riparare in Medio Oriente dove era nato. Sarebbe poi ritornato con l’8a armata alleata e avrebbe risalito tutta la Penisola assieme agli altri alleati come ufficiale di collegamento con i partiti antifascisti e con la resistenza italiana. Qui compare il primo aspetto complicato della vicenda, cioè abbiamo come elemento importante dell’esercito alleato un comunista. Non è possibile che i servizi di sicurezza inglesi e gli alleati non sapessero chi fosse Mieli, ma sia gli uni che gli altri non si posero il problema. Per una ragione molto semplice: durante la Seconda Guerra Mondiale, non vi erano dubbi sul fatto che le democrazie liberali e gli antifascisti, di qualsiasi colore, dovessero collaborare, perché c’era un nemico comune, il nazifascismo. Questo spiega tanto della figura di Renato. Io l’ho avuto come collaborare del Corriere della Sera, chiamandolo dal Giornale con grande irritazione di Montanelli. L’ho chiamato al Corriere perché malgrado non fosse più un comunista, malgrado fosse uscito dal Partito Comunista e avesse scritto un libro importante come “Togliatti 1937” che racconta le “malefatte” non solo di Togliatti ma della dirigenza comunista e staliniana dell’epoca - e malgrado avesse diretto un Centro Studi sui problemi del comunismo non tenero nei confronti del comunismo stesso, Mieli non è mai stato uno spretato. Non è mai stato uno spretato perché, credo, non sia mai stato un prete della chiesa comunista. Non so se Mieli, quando aderì al Partito Comunista, credesse o meno alla rivoluzione bolscevica, resta il fatto però che come ex comunista mai assunse quell’atteggiamento che di solito hanno i preti quando lasciano la tonaca e conservano una forte astiosità nei confronti della chiesa alla quale sono appartenuti. Mieli ha tenuto sempre un atteggiamento estremamente oggettivo anche nei confronti del comunismo cui era appartenuto e, come direttore del CESES, ha avuto un approccio assolutamente scientifico, cioè basato sui dati di fatto, sui documenti, non su pregiudizi o giudizi ideologici. Certo, il suo processo politico e culturale lo allontanò dal comunismo e lo trasformò compiutamente in un democratico liberale e quindi, di conseguenza, contrario a ogni forma di autoritarismo e di totalitarismo. Ebbene Renato era questo e quando lo chiamai al Corriere lo feci perché sapevo che da quel momento avrebbe scritto sulle pagine del giornale che dirigevo senza atteggiarsi a prete spretato, ma ponendosi CRITICAsociale ■ 23 2-3 / 2013 piuttosto come uno studioso dei problemi del comunismo, senza particolare animosità ma con un grandissimo rigore scientifico, senza astiosità e senza ricordare che aveva indossato la tonaca del prete della chiesa comunista. Tuttavia, il fatto stesso che egli non fosse uno spretato e non si comportasse come uno spretato spiega forse anche la ragione per la quale da giovane laureato in Fisica e docente avesse aderito al Partito Comunista, ed è quello che io credo di aver scritto nella prefazione alle sue memorie: Mieli era innanzitutto, almeno allora, un democratico. Era un signore che combatteva il fascismo in quanto il fascismo era esattamente la negazione della democrazia, oltre a essere una forma di autoritarismo e di intolleranza nei confronti di chiunque non la pensasse allo stesso modo, cioè non fosse fascista. Quindi, la sua visione era stata probabilmente quella di qualsiasi altro giovane che in Italia si collocava su posizioni antifasciste e aveva individuato nel Partito Comunista l’unica organizzazione in grado di fornire un supporto a chi fosse antifascista, cioè che non lo lasciasse da solo nella battaglia contro il fascismo. In questo senso la visione di Renato spiega anche che cos’è stato il Partito Comunista nella vita del nostro Paese. Io come liberale non posso che essere stato anticomunista, però riconosco a Mieli di aver guardato al comunismo sotto il profilo storicistico e non sotto il profilo strettamente ideologico. Sotto questo aspetto, per un periodo di tempo, soprattutto per il periodo di tempo della lotta al fascismo, il comunismo ha avuto una valenza estremamente positiva nella storia politica del nostro Paese, perché aveva come obiettivo la libertà di ciascuno di noi, la libertà del Paese esattamente come l’avrei avuta io se avessi avuto a quel tempo nell’animo di essere un antifascista, ma allora ero soltanto un ragazzo. Questo spiega ad esempio, almeno lo spiega rispetto alla mia esperienza personale, perché durante tutta la mia vita intellettuale io non abbia mai avuto degli scontri personali con un esponente del Partito Comunista, ma anzi i miei rapporti con il mondo comunista siano stati sempre molto buoni, indipendentemente dal fatto che io non condividessi minimamente ciò che voleva il Partito Comunista. Non lo condividevo proprio perché, accanto al desiderio di combattere in favore della libertà e della democrazia in questo nostro Paese, nel Partito Comunista c’era anche un altro obiettivo, quello di instaurare un regime che assomigliasse alle democrazie popolari dell’Europa centrale e orientale, per non parlare dell’Unione Sovietica. Ecco, su questo la differenza non poteva che essere dura e feroce, però ciò non toglieva che io fossi in buonissimi rapporti con gente come Giorgio Amendola, Giancarlo Pajetta e lo stesso Enrico Berlinguer, cioè con persone che in fondo avevano l’esigenza di combattere in favore della libertà nei confronti di qualsiasi tentativo di mortificarla. Che poi loro avessero un progetto diverso dal mio, quello della cultura liberale, era un altro paio di maniche, ed era quello che ci divideva ma che non ci impediva di avere dei rapporti civili e persino molto positivi, senza bisogno di atteggiarmi a servo del comunismo. Ho partecipato a diverse feste dell’Unità perché mi faceva piacere esporre le mie idee, ben sapendo che il mio interlocutore, ad esempio Pajetta, che era diventato anche un amico, esponeva delle tesi diametralmente opposte alle mie e pur sapendo che quando parlavo l’uditorio se ne stava zitto-zitto e quando lo faceva Pajetta pareva di essere allo stadio. Ciò nondimeno quando finivano questi nostri dibattiti, molti iscritti del Partito Comunista salivano sul palco, mi battevano la mano sulla spalla e mi invitavano a mangiare assieme dicendo una cosa che tutto sommato mi faceva piacere e persino onore: “Certo che hai un bel coraggio a venire a esporre le tue idee da noi”. CULTURA LIBERALE Come detto, Mieli aveva aderito al Partito Comunista come vi avevano aderito tanti democratici italiani perché era l’unico partito organizzato che in qualche modo fornisse un sostegno a chi in Italia si professava antifascista. Gli altri partiti erano anch’essi antifascisti (il Partito Liberale, quello Cattolico e quello Socialista) ma non avevano la stessa organizzazione e la stessa capacità di mobilitazione dei comunisti. Quindi, molti giovani non aderirono al Partito Comunista perché sognavano la rivoluzione bolscevica egualitaria o la dittatura del proletariato. E tra questi Mieli. La sua organizzazione (e la relativa debolezza strutturale degli altri partiti) fu la forza del Partito Comunista; spiega perché il Partito Comunista abbia avuto un’influenza tanto importante sulla cultura politica del nostro Paese e perché ancora oggi si avverta così fortemente la presenza di questa cultura politica che in qualche modo rappresenta, purtroppo, un bagaglio un po’ pesante e negativo nei confronti di un Paese che pure dovrebbe essere oggi definitivamente e stabilmente democratico e liberale. Dopo la rottura col Partito Comunista e la Fondazione del CESES, il resto della vita di Mieli ha coinciso con la democrazia liberale. Renato, uomo di studio più che uomo strettamente di azione (anche se aveva fondato l’ANSA e la prima edizione dell’Unità), con la sua riflessione è giunto a fondere assieme due principi che almeno all’inizio, nel momento dell’adesione al Partito Comunista, gli apparivano probabilmente antitetici - come in realtà sono antitetici o perlomeno sono di difficile conciliazione - e cioè il principio democratico e il principio liberale. Antiteticità, o quantomeno parziale contrapposizione, che già nell’ ‘800 alcuni grandi liberali avevano segnalato. Infatti, la tradizione che ci arriva dalla Rivoluzione francese è una cultura democratica, è una cultura egalitaristica, ma rischia di essere scarsamente liberale: la democrazia diventa liberale quando si coniuga con il liberalismo attraverso il costituzionalismo e cioè quelle regole del gioco che ci dicono che le minoranze devono essere rispettate, che le maggioranze governano ma non possono governare oltre certi limiti. In Mieli vi era la convinzione che tra democrazia e liberalismo non ci fosse contrapposizione, né storica né teoretica, e per questo finì con l’essere un grande democratico liberale anticomunista, sia nella gestione del CESES sia negli articoli che avrebbe scritto prima sul Giornale e poi sul Corriere della Sera. Questa è la ragione per cui siamo stati molto amici, per cui frequentavo casa sua e lui frequentava casa mia e del perché è venuto al Corriere. Insomma, in lui vedevo tutte le caratteristiche che consentono a noi quattro gatti liberali di riconoscerci l’un l’altro. Mieli sapeva di essere in minoranza, come capita di norma ai liberali, ma non aveva paura di essere in minoranza così come non aveva avuto paura di dirsi comunista. Venendo all’oggi, devo dire francamente che ho una certa diffidenza nei confronti di quelli che si vergognano di essere stati comunisti e si dichiarano adesso democratici liberali. Non c’è ragione di rinnegare la propria militanza nel Partito Comunista, se non quella di aver aderito a un progetto di Stato e di organizzazione sociale fondamentalmente totalitaria, come si è rivelato il comunismo realizzato. Se fossi stato per qualche ragione iscritto al Partito Comunista non me ne vergognerei, perché in fondo mi sarei battuto per una certa idea di libertà (come fece Mieli). Nella mente di molti giovani comunisti, prima ancora di esserci un’idea della società nella quale si voleva vivere, vi era un’idea forte, che era quella democratica. Peccato che poi quell’origi- naria idea all’interno del Partito Comunista non abbia progredito, come ha fatto nella testa di Mieli, fino al punto di farlo diventare democratico liberale con l’accento più sull’aggettivo liberale che sul sostantivo democratico. Mi rendo perfettamente conto che qualche mio lettore si sentirà scandalizzato da queste affermazioni (a parte il fatto che è un po’ la mia vocazione quella di essere un bastian contrario e di non andare dentro la corrente del conformismo nazionale), ma non è possibile sminuire la figura di grandi personaggi della cultura politica italiana, come appunto Renato Mieli, solo per il fatto che sono stati comunisti. Sono stati comunisti poi, a un certo punto, hanno smesso di esserlo perché non aderivano più a quel progetto di società, a cui avevano aderito prima in nome della libertà dal totalitarismo nazi-fascista. Qui sta la ragione profonda che fece sì che al CESES partecipassero tanti giovani. Il fatto è che in una società complessa e pluralista, come la nostra, v’è un tale eccesso di “domanda politica” che è impossibile prevedere delle risposte da dare a tutte le domande che emergono. Questo è il limite innanzitutto gnoseologico del comunismo e del socialismo in generale e cioè la pretesa di avere in tasca la risposta alle domande che una moltitudine di uomini fa sul mercato politico. Qual è la differenza fra una cultura di tipo comunistico-socialistico-dirigistico-collettivistico, chiamiamola come vogliamo, e una cultura liberale, che si fonda semplicemente su una osservazione empirica della realtà (e la realtà è complessa, fatta da una molteplicità di opinioni e di interessi che pongono ciascuno, a modo loro, delle domande al potere politico)? E’ la differenza tra la pretesa Verità e le tante piccole verità. Il potere che pretende di trovare una risposta univoca alle domande che si formano sul mercato politico tende inevitabilmente all’autoritarismo o al totalitarismo, ci tende perché ha la presunzione di avere in tasca la verità con la V maiuscola, mentre in una società aperta come la nostra (e di questo Mieli era maestro come direttore del CESES) esiste una molteplicità di verità, disperse, con la v minuscola. Il bene comune in una società aperta non nasce perché c’è qualcuno che sa quale sia la Verità e pretende di imporla genericamente, ma perché ci sono tante piccole modeste verità, tutte empiriche, tutte dettate persino dall’egoismo o dagli interessi personali, che concorrono assieme ma inconsapevolmente (cioè ciascuna non sapendo com’è l’altra o non interessandosene tanto da volerle riunire in un’unica grande verità) al bene comune. Tante piccole verità che consistono nel fatto che ciascuno cerca il proprio ideale di felicità a condizione di non fare il danno degli altri; tutte assieme e così diverse l’una dall’altra e così razionali al loro interno nella ricerca del proprio interesse, tali verità concorrono dunque a un bene che sarebbe non il bene comune ma una tragedia dal punto di vista della cultura politica, della libertà e della democrazia se ci fosse qualcuno che pretendesse di sapere quale dovrebbe essere. Ora, qualsiasi democratico liberale perlomeno è borderline con una certa idea libertaria e anarchica, come del resto lo era anche Marx da giovane. Un anarchismo però positivo, non un anarchismo che pensa che lo Stato debba estinguersi, perché una delle peculiarità delle culture ottocentesche, non solo del razzismo ma persino del liberalismo sotto certi aspetti, era la convinzione che lo Stato fosse un nemico e che prima o poi esso si dovesse estinguere e che la società (come avrebbe detto Lenin) potesse esser governata persino da una cuoca. No invece! Il liberale riconosce un valore e un’importanza allo Stato, ma a condizione che la funzione dello Stato sia quella sua propria, cioè di tutelare i tre diritti fondamentali della cultura della pratica liberale, che sono quelli individuali: la vita, la libertà e la proprietà degli individui. Noi invece (ed è questa la ragione per cui il liberaldemocratico si distingue dalla cultura politica oggi imperante) viviamo in una società che privilegia un’astrazione ideologica che chiama collettività. Potremmo chiamarla status, sarebbe la stessa cosa, però, siccome fa più nobile chiamarla collettività, la chiamiamo così. Tuttavia, quando si sacrificano i diritti individuali a una collettività, a un’astrazione ideologica, viene meno la democrazia e viene meno la libertà. Ciò non significa che non viviamo in un paese democratico, ma viviamo in un paese in cui spesso c’è qualcuno che tende a sacrificare le libertà dei diritti individuali a quell’astrazione ideologica. Fino all’altro giorno, l’Italia era il paese più democratico del mondo. Da quando è nato un governo tecnico, abbiamo improvvisamente smesso di essere democratici e ci auguriamo che non ci siano più le elezioni. Vorremmo che durasse a lungo il governo tecnocratico del professor Monti. E perché ce lo auguriamo? Perché c’è una strana convinzione in Italia, che la democrazia ci sia quando vincono i nostri e che non ci sia quando vincono gli altri, mentre invece la democrazia è sempre un rischio, la democrazia mai è una certezza, non è qualcosa di stabile, ma è in continuo movimento e dobbiamo conquistarla giorno per giorno. E il modo per conquistarcela è quello di vivere in una società plurale dove ci siano molteplici interessi e che di tanto in tanto i cittadini vengano chiamati a scegliere tra questa pluralità di concezioni del mondo, compatibilmente con l’altra parte, cioè quella che finisce per essere minoritaria sul piano degli interessi e degli ideali. In altri termini, uno dei limiti della nostra cultura politica è di essere ancora prigioniera di una certa memoria storica, che è la stessa del 1945, quando abbiamo sconfitto il fascismo e fatto nascere la nostra Costituzione. Nel ’45-’48 e negli anni successivi, molti intellettuali italiani erano convinti che il comunismo fosse ormai il superamento della democrazia liberale e del capitalismo. La storia ha dimostrato che non era così perché, fortunatamente, le filosofie della storia si misurano dentro la storia, che è giudice delle filosofie medesime. E se non fosse dipeso dall’uomo qualunque, dalle beghine che uscivano dalla parrocchia e andavano a votare Democrazia Cristiana e se fosse invece dipeso dagli intellettuali italiani, noi saremmo diventati una democrazia popolare come quelle oltre cortina. Anche un grande maestro di liberalismo, com’è stato il mio maestro all’Università di Torino Norberto Bobbio, era convinto che la pianificazione sovietica – sta scritto in un libro sul quale quelli della mia generazione sono cresciuti – fosse il superamento del capitalismo, cioè della concorrenza e della competizione. Fortunatamente, non hanno vinto gli intellettuali italiani. Quindi, se a margine del ricordo di un grande, come è stato Renato Mieli, devo dare un consiglio, suggerisco di dare mai retta agli intellettuali: state ad ascoltare cosa dice l’uomo qualunque, quello che passa per la strada, sulle spalle del quale si annida la democrazia, perché è quello che vota e che vota meno peggio di quanto gli intellettuali pensino, perché la tendenza dell’intellettuale è quella di pensare che il popolo sia bue e che, se non è guidato da una mente illuminata, non sia in grado di sapere qual è il suo bene comune. Invece, fortunatamente, l’uomo qualunque, quello di cui si parla volentieri male, sa benissimo quali sono i suoi interessi e qual è il suo bene comune, però se lo ricerca da solo cioè non cerca di trovarlo collettivamente. Il fatto stesso che non lo trovi o non lo cerchi collettivamente lo rende diffidente verso chi cerca il bene comune attraverso quell’astrazione che chiamiamo “collettività”. s 24 ■ CRITICAsociale Segue da pagina 1 chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità per far uscire le istituzioni da uno stallo fatale. Ma ho il dovere di essere franco : se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al paese. Non si può più, in nessun campo, sottrarsi al dovere della proposta, alla ricerca della soluzione praticabile, alla decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana. Parlando a Rimini a una grande assemblea di giovani nell’agosto 2011, volli rendere esplicito il filo ispiratore delle celebrazioni del 150° della nascita del nostro Stato unitario : l’impegno a trasmettere piena coscienza di “quel che l’Italia e gli italiani hanno mostrato di essere in periodi cruciali del loro passato”, e delle “grandi riserve di risorse umane e morali, d’intelligenza e di lavoro di cui disponiamo”. E aggiunsi di aver voluto così suscitare orgoglio e fiducia “perché le sfide e le prove che abbiamo davanti sono più che mai ardue, profonde e di esito incerto. Questo ci dice la crisi che stiamo attraversando. Crisi mondiale, crisi europea, e dentro questo quadro l’Italia, con i suoi punti di forza e con le sue debolezze, con il suo bagaglio di problemi antichi e recenti, di ordine istituzionale e politico, di ordine strutturale, sociale e civile.” Ecco, posso ripetere quelle parole di un anno e mezzo fa, sia per sollecitare tutti a parlare il linguaggio della verità - fuori di ogni banale distinzione e disputa tra pessimisti e ottimisti - sia per introdurre il discorso su un insieme di obbiettivi in materia di riforme istituzionali e di proposte per l’avvio di un nuovo sviluppo economico, più equo e sostenibile. E’ un discorso che - anche per ovvie ragioni di misura di questo mio messaggio - posso solo rinviare ai documenti dei due gruppi di lavoro da me istituiti il 30 marzo scorso. Documenti di cui non si può negare - se non per gusto di polemica intellettuale - la serietà e concretezza. Anche perché essi hanno alle spalle elaborazioni sistematiche non solo delle istituzioni in cui operano i componenti dei due gruppi, ma anche di altre istituzioni e associazioni qualificate. Se poi si ritiene che molte delle indicazioni contenute in quei testi fossero già acquisite, vuol dire che è tempo di passare, in sede politica, ai fatti; se si nota che, specie in materia istituzionale, sono state lasciate aperte diverse opzioni su varii temi, vuol dire che è tempo di fare delle scelte conclusive. E si può, naturalmente, andare anche oltre, se si vuole, con il contributo di tutti. Vorrei solo formulare, a commento, due osservazioni. La prima riguarda la necessità che al perseguimento di obbiettivi essenziali di riforma dei canali di partecipazione democratica e dei partiti politici, e di riforma delle istituzioni rappresentative, dei rapporti tra Parlamento e governo, tra Stato e Regioni, si associ una forte attenzione per il rafforzamento e rinnovamento degli organi e dei poteri dello Stato. A questi sono stato molto vicino negli ultimi sette anni, e non occorre perciò che rinnovi oggi un formale omaggio, si tratti di forze armate o di forze dell’ordine, della magistratura o di quella Corte che è suprema garanzia di costituzionalità delle leggi. Occorre grande attenzione di fronte a esigenze di tutela della libertà e della sicurezza da nuove articolazioni criminali e da nuove pulsioni eversive, e anche di fronte a fenomeni di tensione e disordine nei rapporti tra diversi poteri dello Stato e diverse istituzioni costituzionalmente rilevanti. Né si trascuri di reagire a disinformazioni e polemiche che colpiscono lo strumento militare, giustamente avviato a una seria riforma, ma sempre posto, nello spirito della Costituzione, a presidio della partecipazione italia- 2-3 / 2013 na - anche col generoso sacrificio di non pochi nostri ragazzi - alle missioni di stabilizzazione e di pace della comunità internazionale. La seconda osservazione riguarda il valore delle proposte ampiamente sviluppate nel documento da me già citato, per “affrontare la recessione e cogliere le opportunità” che ci si presentano, per “influire sulle prossime opzioni dell’Unione Europea”, “per creare e sostenere il lavoro”, “per potenziare l’istruzione e il capitale umano, per favorire la ricerca, l’innovazione e la crescita delle imprese”. Nel sottolineare questi ultimi punti, osservo che su di essi mi sono fortemente impegnato in ogni sede istituzionale e occasione di confronto, e continuerò a farlo. Essi sono nodi essenziali al fine di qualificare il nostro rinnovato e irrinunciabile impegno a far progredire l’Europa unita, contribuendo a definirne e rispettarne i vincoli di sostenibilità finanziaria e stabilità monetaria, e insieme a rilanciarne il dinamismo e lo spirito di solidarietà, a coglierne al meglio gli insostituibili stimoli e benefici. E sono anche i nodi - innanzitutto, di fronte a un angoscioso crescere della disoccupazione, quelli della creazione di lavoro e della qualità delle occasioni di lavoro - attorno a cui ruota la grande questione sociale che ormai si impone all’ordine del giorno in Italia e in Europa. E’ la questione della prospettiva di futuro per un’intera generazione, è la questione di un’effettiva e nel solco di uno sforzo di politica economicofinanziaria ed europea che meriterà certamente un giudizio più equanime, quanto più si allontanerà il clima dello scontro elettorale e si trarrà il bilancio del ruolo acquisito nel corso del 2012 in seno all’Unione europea. Apprezzo l’impegno con cui il movimento largamente premiato dal corpo elettorale come nuovo attore politico-parlamentare ha mostrato di volersi impegnare alla Camera e al Senato, guadagnandovi il peso e l’influenza che gli spetta : quella è la strada di una feconda, anche se aspra, dialettica democratica e non quella, avventurosa e deviante, della contrapposizione tra piazza e Parlamento. Non può, d’altronde, reggere e dare frutti neppure una contrapposizione tra Rete e forme di organizzazione politica quali storicamente sono da ben più di un secolo e ovunque i partiti. La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all’aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c’è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all’imperativo costituzionale del “metodo democratico”. Le forze rappresentate in Parlamento, senza alcuna eccezione, debbono comunque dare ora piena valorizzazione delle risorse e delle energie femminili. Non possiamo restare indifferenti dinanzi a costruttori di impresa e lavoratori che giungono a gesti disperati, a giovani che si perdono, a donne che vivono come inaccettabile la loro emarginazione o subalternità. Volere il cambiamento, ciascuno interpretando a suo modo i consensi espressi dagli elettori, dice poco e non porta lontano se non ci si misura su problemi come quelli che ho citato e che sono stati di recente puntualizzati in modo obbiettivo, in modo non partigiano. Misurarsi su quei problemi perché diventino programma di azione del governo che deve nascere e oggetti di deliberazione del Parlamento che sta avviando la sua attività. E perché diventino fulcro di nuovi comportamenti collettivi, da parte di forze - in primo luogo nel mondo del lavoro e dell’impresa - che “appaiono bloccate, impaurite, arroccate in difesa e a disagio di fronte all’innovazione che è invece il motore dello sviluppo”. Occorre un’apertura nuova, un nuovo slancio nella società ; occorre un colpo di reni, nel Mezzogiorno stesso, per sollevare il Mezzogiorno da una spirale di arretramento e impoverimento. Il Parlamento ha di recente deliberato addirittura all’unanimità il suo contributo su provvedimenti urgenti che al governo Monti ancora in carica toccava adottare, e che esso ha adottato, - nella fase cruciale che l’Italia e l’Europa attraversano - il loro apporto alle decisioni da prendere per il rinnovamento del paese. Senza temere di convergere su delle soluzioni, dal momento che di recente nelle due Camere non si è temuto di votare all’unanimità. Sentendo voi tutti - onorevoli deputati e senatori - di far parte dell’istituzione parlamentare non come esponenti di una fazione ma come depositari della volontà popolare. C’è da lavorare concretamente, con pazienza e spirito costruttivo, spendendo e acquisendo competenze, innanzitutto nelle Commissioni di Camera e Senato. Permettete che ve lo dica uno che entrò qui da deputato all’età di 28 anni e portò giorno per giorno la sua pietra allo sviluppo della vita politica democratica. Lavorare in Parlamento sui problemi scottanti del paese non è possibile se non nel confronto con un governo come interlocutore essenziale sia della maggioranza sia dell’opposizione. A 56 giorni dalle elezioni del 24-25 febbraio - dopo che ci si è dovuti dedicare all’elezione del Capo dello Stato - si deve senza indugio procedere alla formazione dell’Esecutivo. Non corriamo dietro alle formule o alle definizioni di cui si chiacchiera. Al Presidente non tocca dare mandati, per la formazione del governo, che siano vincolati a qualsiasi prescrizione se non quella voluta dall’art. 94 della Costituzione : un governo che ab- bia la fiducia delle due Camere. Ad esso spetta darsi un programma, secondo le priorità e la prospettiva temporale che riterrà opportune. E la condizione è dunque una sola : fare i conti con la realtà delle forze in campo nel Parlamento da poco eletto, sapendo quali prove aspettino il governo e quali siano le esigenze e l’interesse generale del paese. Sulla base dei risultati elettorali - di cui non si può non prendere atto, piacciano oppur no - non c’è partito o coalizione (omogenea o presunta tale) che abbia chiesto voti per governare e ne abbia avuti a sufficienza per poterlo fare con le sole sue forze. Qualunque prospettiva si sia presentata agli elettori, o qualunque patto - se si preferisce questa espressione - si sia stretto con i propri elettori, non si possono non fare i conti con i risultati complessivi delle elezioni. Essi indicano tassativamente la necessità di intese tra forze diverse per far nascere e per far vivere un governo oggi in Italia, non trascurando, su un altro piano, la esigenza di intese più ampie, e cioè anche tra maggioranza e opposizione, per dare soluzioni condivise a problemi di comune responsabilità istituzionale. D’altronde, non c’è oggi in Europa nessun paese di consolidata tradizione democratica governato da un solo partito - nemmeno più il Regno Unito - operando dovunque governi formati o almeno sostenuti da più partiti, tra loro affini o abitualmente distanti e perfino aspramente concorrenti. Il fatto che in Italia si sia diffusa una sorta di orrore per ogni ipotesi di intese, alleanze, mediazioni, convergenze tra forze politiche diverse, è segno di una regressione, di un diffondersi dell’idea che si possa fare politica senza conoscere o riconoscere le complesse problematiche del governare la cosa pubblica e le implicazioni che ne discendono in termini, appunto, di mediazioni, intese, alleanze politiche. O forse tutto questo è più concretamente il riflesso di un paio di decenni di contrapposizione - fino allo smarrimento dell’idea stessa di convivenza civile - come non mai faziosa e aggressiva, di totale incomunicabilità tra schieramenti politici concorrenti. Lo dicevo già sette anni fa in quest’aula, nella medesima occasione di oggi, auspicando che fosse finalmente vicino “il tempo della maturità per la democrazia dell’alternanza” : che significa anche il tempo della maturità per la ricerca di soluzioni di governo condivise quando se ne imponga la necessità. Altrimenti, si dovrebbe prendere atto dell’ingovernabilità, almeno nella legislatura appena iniziata. Ma non è per prendere atto di questo che ho accolto l’invito a prestare di nuovo giuramento come Presidente della Repubblica. L’ho accolto anche perché l’Italia si desse nei prossimi giorni il governo di cui ha bisogno. E farò a tal fine ciò che mi compete : non andando oltre i limiti del mio ruolo costituzionale, fungendo tutt’al più, per usare un’espressione di scuola, “da fattore di coagulazione”. Ma tutte le forze politiche si prendano con realismo le loro responsabilità : era questa la posta implicita dell’appello rivoltomi due giorni or sono. Mi accingo al mio secondo mandato, senza illusioni e tanto meno pretese di amplificazione “salvifica” delle mie funzioni ; eserciterò piuttosto con accresciuto senso del limite, oltre che con immutata imparzialità, quelle che la Costituzione mi attribuisce. E lo farò fino a quando la situazione del paese e delle istituzioni me lo suggerirà e comunque le forze me lo consentiranno. Inizia oggi per me questo non previsto ulteriore impegno pubblico in una fase di vita già molto avanzata ; inizia per voi un lungo cammino da percorrere, con passione, con rigore, con umiltà. Non vi mancherà il mio incitamento e il mio augurio. Viva il Parlamento! Viva la Repubblica! Viva l’Italia! s Giorgio Napolitano
Scaricare