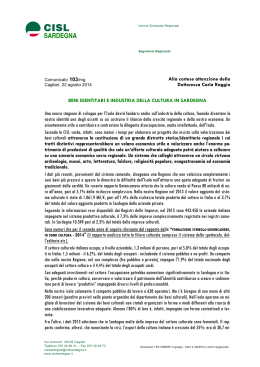C. Cavalleri: L’altra storia del banditismo 1 C. Cavalleri / L’altra storia del banditismo : Potere costituito, autodeterminazione, “criminalità” in Sardegna Prima edizione: (a cura di) Comitato di solidarietà con il proletariato prigioniero sardo deportato / Colonizzazione, autodeterminazione, criminalità in Sardegna : L’altra storia del banditismo. Arkiviu-bibrioteka “T. Serra”, Guasila 1993. Seconda edizione, 2004 Arkiviu-bibrioteka “T. Serra” di C. Cavalleri Via Melas n. 24 09040 Guasila (CA) Tel. mobile: 349 64 19 847 E.mail: [email protected] La struttura non esercita attività d’impresa né persegue alcun lucro 2 Costantino Cavalleri L’altra storia del banditismo Potere costituito, autodeterminazione, “criminalità” in Sardegna Editziones de su Arkiviu-bibrioteka “T. Serra” Guasila 3 4 Indice 5 6 Introduzione 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Prefazione La questione sarda Vi è un mito – e i contemporanei che si sono in qualche modo occupati di cose sarde l’hanno fatto proprio, contribuendo a divulgarlo fino all’inverosimile – o, se si vuole, una falsità che pur nata in epoca a noi recente ha finito per essere generalmente accettata come verità. Tale falsità vorrebbe che verso la fine del VI secolo A.E.V. (Avanti l’Era Volgare) cacciati i sardi indigeni dalle coste, questi si sarebbero ritirati in quella sorta di «riserva indiana» costituita dai monti del centro Sardegna. Da ciò la presunta spaccatura dell’isola in due: «quella coloniale delle coste e delle pianure, e quella dei partigiani resistenti». È a tale epoca ed a tale avvenimento che risalirebbe la «formazione all’interno dell’isola di una comunità costretta ad organizzare una sua autosufficienza e a procedere, nelle condizioni di assedio permanente e di isolamento, alla faticosa individuazione e realizzazione di una propria fisionomia culturale, morale e giuridica» (Cabitza). Questo punto di partenza, un vero e proprio assioma storico della Sardegna e dei sardi, merita un minimo di riflessione e di attenzione critico-analitica, perché unitamente a qualche altro momento soggiace a tutte le proposte di risoluzione, finora avanzate, della Questione nazionale sarda (titolo di un interessante lavoro di G. Contu). Il problema non sta, per quanto ci concerne, sulla ancora dibattuta questione se invasione cartaginese vi sia stata oppure no; sta, invece, nel dare per scontato il fatto secondo cui sarebbe incontrovertibile che sia dovuta all’approccio col colonizzatore la “formazione” delle comunità interne, della loro fisionomia culturale e pertanto anche morale e giuridica. 17 Potrebbe pure sembrare, di primo acchito, che si stia ponendo un falso problema, ma così non è. Vediamo l’ipotesi corrente e la nostra un po’ più nei particolari ed esaminiamone le relative estreme conseguenze. A) Nascita/formazione ex-novo di comunità e cultura È la teoria più accreditata, almeno sul piano dell’analisi politicoideologica. Però è contraddetta dal fatto che la specifica civiltà sarda, quella nuragica, nel periodo in cui si sarebbe verificata la conquista cartaginese dell’isola era di già secolarmente costituita ed operante. Inoltre, i punici lungi dal “cacciare” i sardi dalle coste, se davvero avessero occupato l’isola, li avrebbero semmai sottomessi per assoggettarli a tributi o schiavizzarli, essendo questo l’interesse di ogni potenza imperial-coloniale. Se invasione vi fu – come è storicamente accertato per i romani – i sardi almeno in parte scapparono dalle coste e dai Campidani dopo aver subito la sconfitta militare. Ma dato che scapparono – rifugiandosi nelle zone interne di già popolate – non è forse, questo atteggiamento, resistenziale di per se stesso? Ciò non significa altro che la resistenzialità dei sardi era preesistente all’invasione ed alla sottomissione. Se, infine, le zone interne erano di già abitate – ne costituiscono prova evidente i ritrovamenti d’epoca neolitica ma soprattutto i Nuraghi – potevano forse gli “esuli costieri” dare vita ex-novo ad una loro propria cultura e comunità specifiche, oppure – come è assai più realistico credere – si inserirono, divenendone parte attiva, nelle comunità già preesistenti, accettandone la cultura? B) Comunità di già operanti al momento della colonizzazione È l’ipotesi da noi sostenuta, che trova conferma diretta nei ritrovamenti archeologici ed anche in tutte le più recenti analisi etnoantropologiche, in particolar modo nella antropologia politica. Sconvolge, è vero, tutti gli assunti storici e politici che finora l’hanno fatta da padrone, ma questo poco importa. Meglio, importa tantissimo nel momento in cui, finalmente liberato da tali assiomi, il processo di liberazione, se liberazione vi deve essere, nazionale-etnica e sociale, viene a poggiare necessariamente solo sull’autoctonia, cioè in tutti quei luoghi elaborati autonomamente dalle genti sarde. Il che, come è facile intuire, elimina ogni possibilità di sovrapposizione ideologica ed ogni speculazione politica. Come per ogni popolo, anche per quello sardo delle coste la resistenzialità è atteggiamento proprio, intimo all’essere entità culturale specifica. 18 Data la presenza in terra isolana dell’uomo fin dalla notte dei tempi (un periodo si risaliva ad un massimo di circa cinque mila anni A.E.V. ma oggi tale datazione è retrocessa di parecchi millenni), questo, nel bene e nel male, in epoca di colonizzazione (punica o romana, per prima, poco importa) aveva di già elaborato propri tratti morali, sociali, giuridici, linguistici ecc. Tenuto conto della diversità geografica, delle attività lavorative/produttive, della sostanziale alterità fra le popolazioni neolitiche e megalitiche da una parte (le prime genti che in ondate successive popolarono l’isola), e dall’altra gli Shardana (le genti che nell’ultima ondata vennero in Sardegna stabilendosi nelle coste e dando vita alle città-Stato marinare; contrariamente alle precedenti, che si insediarono nel retroterra) è chiaro che sul piano dell’organizzazione del potere tra quelle e questi vi erano altrettanto differenti modi di praticarla. Ora, mentre è possibile delineare l’organizzazione politico-sociale delle città-Stato Shardana – che non poteva essere sostanzialmente dissimile dalla organizzazione di tutte le altre città-Stato contemporanee dell’area Mediterranea e del vicino Oriente –, riguardo la civiltà neolitica e megalitica tutti gli storici avanzano le più inverosimili ipotesi. Come se i dati provenienti dalle ricerche etnologiche non potessero dare indizi sufficienti – unitamente ai ritrovamenti archeologici – ad interpretare realisticamente l’assetto politico delle comunità interne. Per cui in parecchi popolano le tribù selvagge della civiltà nuragica di ... re, regine e – non potendo mancare, presupponendo l’esistenza di quelli – di eserciti e di guerrieri, la cui differente gerarchia tra gli uni e gli altri sarebbe “documentata” dai bronzetti, che ci mostrano guerrieri con borchie e senza, con l’elmo ad uno oppure a due corna e così via. Appositi lunghi studi e relative minuziose descrizioni ci mostrano una società ... gerarchicamente strutturata, che poi cozza “stranamente” non solo con la vivente realtà sociale dell’entroterra, sostanzialmente egualitaria, sostanzialmente comunistica/collettivistica e sostanzialmente individualistica. Tant’è che tutti gli studiosi di cose sarde hanno riconosciuto – ovviamente ciascuno per motivi propri – l’ostilità dei sardi, anche attuali, verso ogni forma di struttura gerarchica. Ostilità che altro non è se non quella resistenzialità cui fa riferimento l’autore prima citato. Se è vero che il potere nelle città Shardana era concentrato nelle mani del Giudice (Yudike) e dei Maggiorenti, non è cosa strana che proprio ai fuggiaschi da tale situazione – una volta iniziata la conquista da parte dei colonizzatori – si attribuisca la formazione di una “fisionomia culturale, morale e giuridica” che ad altro non corrisponde se non ai tratti culturali della “società selvaggia” delle zone interne, preesistente non solo all’invasione coloniale ma finanche alla venuta delle genti Shardana? Non 19 è più conseguente affermare e credere esattamente il contrario? Che poi tale cultura sia stata sottoposta a continui tentativi di distruzione finendo per essere arginata, può anche essere condivisibile; purché si precisi che, lacerata quanto si vuole, latente quanto si vuole, alcuni suoi tratti sono rimasti attivi in ogni parte della Sardegna. Semplicemente perché l’isola non venne affatto “spaccata in due” ma tra le due condizioni decretate dalla colonizzazione: dominio diretto nelle coste ed accerchiamento delle popolazioni dell’interno, legalmente, illegalmente, pacificamente o cruentemente, sempre vi son stati comunicazione, reciproco scambio materiale e spirituale, nonché umano. Se spaccatura vi era fra l’interno e le coste, sul piano politico – e anche noi ne siamo in parte convinti – essa era preesistente, risaliva cioè alla sostanziale diversità sussistente fra città-Stato Shardana e comunità nuragiche, quelle essendo dimidiate, queste indivise. Spaccatura che comunque non deve essere intesa come assoluta mancanza di contatti, che invece vi erano. Pensiamo alla religione comune, agli scambi materiali/ commerciali – ossidiana, bronzo, manufatti, ecc. – e alla partecipazione di guerrieri nuragici alle imprese “commerciali” degli Shardana, popolo di naviganti. Che si trattasse di universi comunicanti e non confusi fino a rappresentare una sola entità, ci è confermato da fatti storici inconfutabili. Primo: nessuna potenza colonialista di allora avrebbe mai potuto occupare l’isola, se a difenderla in quei pochi porti facilmente approdabili vi fosse stata l’intera popolazione, per quanto scarsa potesse essere in quei tempi. Secondo: quando i romani, attraversando il Campidano di Cagliari, tentarono di conquistare Kornus, il Giudice di tale città-Stato, Amsicora, si trovava in una qualche zona interna alla ricerca di possibili alleati nelle schiatte dei Pelliti; ciò è come dire che i due universi umani erano sì comunicanti ma non certo in sintonia. Terzo: non ci è dato sapere quante schiatte di pelliti si unirono all’esercito di Amsicora, ma tutti gli storici concordano nell’asserire che dovette trattarsi solo di una, al massimo qualche tribù; se vi avessero partecipato in gran numero l’esercito romano sarebbe stato sconfitto non una volta sola (la prima) ma espulso definitivamente dall’isola. Questi fatti confermano indirettamente qualche altra nostra conclusione: l’universo sociale interno non era affatto strutturato in una qualche forma politica “pre-statale”, bensì ogni tribù, così come ai giorni nostri ogni paese, era un microcosmo a sé stante, autodeterminato, che scuciva e cuciva alleanze alla maniera tipica di tutte le culture selvagge. Quanto si verificava in larga misura fino a qualche lustro addietro, e in minima parte si verifica anche oggi, cioè l’attrito perenne fra paesi vicini/confinanti, doveva a maggior ragione verificarsi nel passato più remoto, 20 ciascuna comunità riconoscendosi esattamente nel contrasto rispetto all’altra, o alle altre, in una rapportazione che imponeva una sempre mutevole composizione tra lo schieramento degli amici e quello dei nemici. Tale fenomeno è tipico di tutte le società selvagge e deve esserlo anche della nuragica. Il perenne stato di guerra contribuisce all’unità interna di ciascuna specifica comunità, che con l’altro da sé, speculare ad essa, costituisce quel macrocosmo che è l’entità etnica isolana. È, questa, la medesima situazione degli indiani d’America all’atto della colonizzazione, e di ogni popolo selvaggio. Ed è su tale condizione che una qualsiasi potenza coloniale, anche di dimensioni molto più ridotte di quella romana, poteva imporsi: giocando sulla dispersione/frantumazione della forza delle popolazioni da colonizzare. A quanto ci è dato ricordare e sapere, solo poche nazioni selvagge ritennero opportuno confederarsi, tra cui ad es. gli Irochesi, riuscendo così almeno ad arginare, ad opporre valida resistenza ed attacco alle forze imperialiste esterne. Ciò non avvenne tra i Sardi, né fra quelli delle zone interne, né fra essi e le città Shardana. Addirittura forse neppure tra queste ultime, tanto radicata dovette essere l’autodeterminazione. La causa della sconfitta dei Sardi o, meglio, della riuscita opera di colonizzazione nonché della progressiva debolezza dei Giudicati, è da ricercarsi proprio nella ancestrale autodeterminazione che, a partire dall’individuo fino al clan e poi al villaggio, permea la cultura isolana. Un limite? Certamente sì, in rapporto al potere accentrato: perché se è vero che quello originatosi nelle città Shardana prima, nei Giudicati in seguito può sempre essere delegittimato colpendo gli uomini, le famiglie, i gruppi che lo costituiscono, al contrario quello proveniente dae su mare (dal mare) non può essere sconfitto nell’indivisione, richiedendo una forza che sia la concentrazione di tutte le energie esistenti. Che fare? È il problema per eccellenza, su cui ogni forza politica presente in Sardegna ha cercato di sovrapporre la propria ideologia. Come quella che è partita dall’assunto che propone la cultura sarda dell’interno “nata” a seguito della prima colonizzazione. Ovviamente non si tratta di semplice “coincidenza”. Verità è che presupponendo che le culture nascono così, come i funghi nell’arco di un avvenimento, per quanto traumatico questo possa essere – e la colonizzazione è comunque un trauma – anche la sua fine può aversi allo stesso modo: ridando vita “ad un’altra cultura” ovvero impo- 21 nendo o sostituendo questa a quella ideologia partitica. Così, chi si è occupato della Sardegna e delle sue sorti – in buona o in malafede – ha infine proposto la propria strada di liberazione: mai che fosse quella di già preesistente. Tutti, almeno in seguito alla strutturazione in codice giuridico dei tratti fondamentali della prassi della vendetta elaborata dal Pigliaru, riconoscono che si tratta di una vera e propria normativa operante al cui centro vi è l’individuo, la famiglia, il clan, il villaggio; tutti concordano sul fatto che si tratta della nostra cultura, cioè di ciò per cui siamo noi stessi e non altra cosa; però nessuno dice che anche la liberazione è la nostra cultura, che è a partire da essa ed in essa che possiamo procedere nel processo di liberazione nazionale e sociale. Inutile negare che fa una gran paura quella realtà che, ponendo l’individuo al centro del mondo umano e negando così validità a qualsiasi momento che sovrasti l’individuo, è ogni singola persona umana che stabilisce e ristabilisce l’ordine e la giustizia. Fa senza dubbio orrore la prassi della vendetta, cioè il farsi giustizia da sé per i torti ricevuti, senza delegare ad altri la risoluzione dell’offesa. Suscita senza ombra di dubbio repulsione e terrore anche il semplice pensare che, in situazione di reale autodeterminazione, mancano il politico che decide in nostra vece cosa è il bene e cosa è il male, il giudice che condanna chi opera il male, il carabiniere che ci protegge dai delinquenti ed il militare dal “nemico”! Paura, terrore ed orrore aggrediscono in buona misura quanti auspicano una “società diversa”, talmente diversa da quella attuale che la sognano così bella da immaginarsela priva di contrasti, opposizioni, interessi diversi; così che secondo tale concezione tutto d’un colpo l’attuale “cultura” dovrebbe scomparire per lasciare il posto all’uomo completamente rinnovato, buono fin nelle midolla delle più minuscole ossa e pertanto incapace di fare del “male” al prossimo suo. Ma terrore ed orrore aggrediscono anche coloro che non sanno concepire alcuna forma di vita fuori dell’ideologia del “progresso”, e stanno male finanche al semplice prospettare la distruzione della coca-cola e delle patatine fritte in busta di plastica. «Per carità – affermano costoro – l’autodeterminazione sarebbe un ritorno indietro! Bisogna invece superare ...» e bla bla bla. E ch’è!? La distruzione non è superamento? Ma forse è il concetto stesso di distruzione a creare i maggiori problemi ... In verità buona parte di quanti fino ad oggi hanno parlato e straparlato di sardità, di sardismo, di liberazione sarda e finanche di rivoluzione nazionale sarda, o vi hanno costruito sopra carriere politico-amministrative o ancora non vi sono riusciti; in ogni caso, evidentemente, i “sardi” da 22 sardizzare e da liberare erano e sono essi in quanto hanno sempre avuto di mira il potere sui sardi, non dei sardi. Vogliono dei sardi deculturati, privi cioè delle caratteristiche principali della propria cultura. Ad essere completi, parrebbe che qualche eccezione vi sia, ma a ben vedere non si tratta di eccezioni. Gianfranco Pintore, tanto per fare un esempio, che pure ha colto indubbiamente i momenti centrali della questione sarda, alla fine non fa altro che concludere la sua interessante analisi sovrapponendole il paraocchi ideologico. Afferma infatti: «Circa la Sardegna, ... , c’è una sorta di rifiuto a considerare i termini reali del conflitto tra uno Stato di conquistatori e una società con una civiltà autonoma che, nonostante l’oppressione, ha “progetti di vita” costantemente in evoluzione grazie soprattutto al marxismo e al leninismo, ma anche grazie alla resistenza, ormai quasi bimillenaria ... » (pagg. 106/ 107). Beh! Il testo è pur vero che risale ad un ventennio addietro, ma il rapporto tra marx-leninismo e resistenza, almeno per pudore di ... logicità, poteva essere invertito perfino allora; che ne so, magari scrivendo: «grazie al marxismo e al leninismo, ma soprattutto grazie alla resistenza ... ». Viene da chiedersi in base a quale “progetto di vita” i sardi hanno resistito dal VI secolo A.E.V. fino al XVIII secolo; quando non erano manco nati né Marx né Lenin. Ma è probabile, a questo punto, che l’unico loro progetto sia stato di resistere fino alla nascita dei due. Tutta malignità nostra, si dirà, ma così non è purtroppo. Perché il medesimo autore, nella sua propositività, è conseguente all’affermazione ora riportata. Dopo aver negato “l’individualismo” del pastore sardo, come dimostrerebbe “la straordinaria varietà di forme associative inventate dai pastori” (negando all’individualismo ogni forma di associazione) attribuisce a questi un “atteggiamento precapitalista nei confronti della proprietà”. Ergo: «Il dibattito su chi debba essere l’artefice principale della liberazione dallo sfruttamento coloniale non lascia spazi a dubbi: è la classe operaia sarda. Ma non ci sono dubbi che sono i pastori a rappresentare per ora in Sardegna il nucleo più forte, più omogeneo e soprattutto portatore di valori culturali, civili, giuridici e sociali che se bisogna forse spogliare di arcaismi, si debbono recuperare per la loro contemporaneità: la resistenza contro il capitalismo e al colonialismo, la difesa di valori comunitari e, come si dice in Barbagia, della “comunione delle terre”» (pag. 145). Conclusione in perfetta linea con le premesse. Certo marxleninismo di maniera non può concepire una realtà storico-sociale non in perfetta linea con il dogma del “progresso storico” e delle fasi necessarie per arri- 23 vare infine alla liberazione. Così che gli risulta impensabile che il pastore sia in funzione di sé stesso, autofondato e nel momento negativo – la resistenza – ed in quello propositivo – la liberazione dalle catene che lo costringono in schiavitù. Al più bisognerebbe “recuperare” alcuni valori culturali di cui è portatore, adeguatamente spogliati da “arcaismi”. Insomma è lo schema trito e ritrito della funzione storica della classe operaia. Ma oggi, a tanti anni di distanza da quando vennero redatte quelle righe, quale sarà mai il destino storico di una classe che tra una reverenza al politico, un baciamani al pontefice e le messe in piazza contro il licenziamento ad altro non pensa che al mantenimento del posto del lavoro, anche se completamente controproducente, e ... alla necessità di un partito, sola avanguardia che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male, pertanto gli “arcaismi” di cui spogliarsi? Giuliano Cabitza in proposito (1968) è esplicito, togliendosi dai denti ogni pelo. Riferendosi alle vicende del passato afferma: « ... Tuttavia, preziosi insegnamenti si potrebbero trarre da quelle lontane vicende. Insegnamenti sulla necessità di un’organizzazione rigorosa delle lotte, della formazione di una direzione politica ferma nei suoi propositi ... » (pag. 108). Questi sono autori che, in un modo o nell’altro, direttamente o indirettamente, hanno fatto epoca. Entrambi, per non citarne degli altri, a decine, sono ancora arrampicati sugli specchi della formazione di un direttivo di potere. In tanti sono oggi ingranaggi della mastodontica macchina statale e dei suoi meccanismi politici ed amministrativi, sempre più invadenti e perfettamente funzionali alla ricerca di una direzione politica. Le vecchie volpi vi stanno ben annidate ed anche dopo il crollo dei muri imperialistici della democrazia occidentale e della dittatura sul proletariato hanno tutto l’interesse a rimanervi. Ciò evidenzia quanto colonizzata sia buona parte della intellettualità isolana, finanche quella ritenuta – spesso autoritenuta – la più “radicale”. Non è forse negare fin dal principio l’autodeterminazione delle genti sarde il voler far credere che l’autoctona cultura altro non sia se non il riflesso della colonizzazione? Ma, viene giustamente da chiedersi, se colonizzazione mai vi fosse stata, questi strani animali di isolani avrebbero da soli dato corpo ad una specifica cultura? Oppure avrebbero atteso che menti così illuminate aprissero loro gli occhi, a chissà quale stadio di a-socialità? Il fatto più tragicomico di questa intellettualità pseudoradicale e pseudoindipendentista, è che arriva ad ipotesi interpretative a dir poco ridicole, storicamente infondate, scientificamente false e politicamente di estrema pericolosità, che evidenziano al massimo grado non tanto l’imbecillità dei proponenti quanto la volpina malafede, intenzionata a giustificare ogni 24 sorta di costituendo potere centralizzato che decreta, stavolta dall’interno, l’esproprio dell’individuo e quindi delle comunità di base. Arroccati in quello schematismo ideologico di derivazione metropolitana, secondo cui la storia dell’umanità sarebbe indiscutibilmente unica e costituita dalla progressione meccanica delle tappe proprie della società capitalistica, se per altri versi negano all’etnia sarda ogni autoctona formazione arrivano addirittura all’assurdo storico di definire i pastori sardi “un ceto, uno strato particolare della classe borghese”, perché sono “proprietari di mezzi di produzione”. Per cui: «Non è assurdo pensare che dai pastori, attraverso una serie di processi che non vale la pena di cercare d’indovinare, sarebbe potuta uscire una borghesia questa si “locale” o se si preferisce “nazionale”, capace di svolgere un ruolo autonomo e positivo» (Cabitza). Capito? Seguendo una tale logica, i Nuer, o anche le donne Irochesi, o che so io, gli Eschimesi, proprio perché proprietari dei mezzi di produzione (ad esempio, degli armenti, dell’arco, delle frecce e delle fiocine), altro non sarebbero che “ceti particolari” della borghesia che, se non impediti nel loro sviluppo autonomo dalla colonizzazione, avrebbero accumulato ingenti risorse dalle quali, adeguatamente “investite”, sarebbe sorto il capitalismo interno a quelle rispettive comunità. Le quali, ad un dato grado del loro sviluppo avrebbero ciascuna avuto il proprio Marx, Lenin e persino un Bakunin tutto specifico oltre, naturalmente, un ... proprio Cabitza, atti a dirigere, in modo ferreo, senza tentennamenti o debolezze di sorta, il trapasso al socialismo ... di Stato. Poi si sarebbe visto! Queste le rivoluzionarie conclusioni degli intellettuali radical-indipendentisti. Senza dilungarci oltre, è facile intuire quale mai possa essere stata, e ancora sia, la loro posizione nel contesto sociale. Abbiamo accennato al fatto che non si tratta semplicemente e solo di imbecillità o di bestialità teorico-ideologiche, perché in realtà fin troppi “rivoluzionari” sono andati a finire giusto giusto ad alimentare le file della burocrazia del potere coloniale che verbalmente dovevano invece sconfiggere. È fin troppo opportuno definire – usando concetti assai blandi ed “educati alla buona creanza” – simili atteggiamenti puro carrierismo politico-partitico, cioè volontà di tagliarsi una bella fetta del potere costituito per fini prettamente personalistici. Né, questo fatto, ci avrebbe fatto perdere spazio e tempo prezioso se non fosse in qualche modo legato, o slegato a quella che invece è la nostra analisi della questione sarda e pertanto a quel progetto di liberazione di cui non siamo né vogliamo essere noi i soli portatori. Se così fosse lo attueremo e basta ... senza dilungarci a chiarire a chicchessia il nostro senso di 25 liberazione, che crediamo di ravvisare, invero, nel sociale isolano, nella nostra cultura, sia pure spesso deviata dal sovrapporsi ad essa di momenti degeneranti che gli fanno imboccare tutt’altre strade dalla reale autodeterminazione. La cultura sarda non è nata affatto nel contesto della colonizzazione e neppure è una “degenerazione” attuale rispetto a se stessa o ad una qualche altra entità mistico-ideologica presupposta dagli assunti teoretici di schematismi politici beffati dalla storia e, nello specifico, dalla medesima storia sarda. Si tratta della nostra cultura, elaborata autonomamente fin dalla notte dei tempi, che i vari colonizzatori hanno senza dubbio arginato, sospinto, contrastato, limitato, parzialmente frantumato con lo scopo non tanto e non solo di soddisfare esigenze sadiche e perverse, ma di spezzare la resistenza dei suoi portatori a fini di profitto e di dominio totale. I colonizzatori non necessariamente sono venuti, e vengono, dae su mare; vi sono anche quei momenti, strutture, organismi, personalità, tutte interne all’isola, più precisamente quei momenti di potere accentrato che, preesistenti nelle città Shardana al momento dell’impatto con i primi colonizzatori, si sono manifestati a livello generale anche nei Giudicati, decretando l’esproprio o il tentativo di esproprio, del potere diffuso nel sociale. Nulla differenzia, dal punto di vista del reale interesse delle genti isolane, la prassi genocida ed etnocida propria dei Giudicati, da quella degli statalismi provenienti dae su mare. Di conseguenza il processo di liberazione deve attuarsi non passando al setaccio ciò che a ciascuno di noi è gradito, secondo una riduzione dei momenti della nostra cultura a quelle categorie ideologico-politiche apprese per altro da indottrinamento; bensì spogliando di ogni costrizione i tratti caratteristici delle nostra esistenza come individui e come comunità. Il fine che si pone l’individuo sottraendosi all’imperio della legge, non è quello di dare vita ad una autonomia più o meno ampia e comunque solo politico-amministrativa della Regione Sarda; e neppure di dare corpo ad uno Stato tutto sardo che, come per i Giudicati, altro non significherebbe se non repressione, oppressione, impedimento, limitazione, disciplina e così via; si tratta invece del rifiuto puro e semplice di ogni imposizione esterna a se stessi, ai propri canoni morali, comportamentali, materiali e spirituali. È proprio la cultura sarda che indica chiaramente l’antistatalismo dei sardi, e ogni operazione – peraltro malamente messa in piedi – di bassa dialettica politica, improntata sul nudo e crudo opportunismo carrieristico o leaderistico, non è altro che strumentalizzazione della disgrazia dei più a fini di potere personale o di partito che sia. Né ci spaventano le sicure accuse di arcaismo, di barbarie, di inco- 26 scienza “sanguinaria” che in parecchi ci sputeranno addosso. Vedremo che in fatto di barbarie la civiltà di Stato, esterna ed interna alla Sardegna, ben poco ha da apprendere da chicchessia. Contro un fatto di sangue dovuto a fattori propri della prassi della vendetta (che pure è quotidianamente “acuita” dalla pressante opera di colonizzazione) si ergono le più sanguinarie stragi di Stato, le forche, le sofferenze inaudite, le deportazioni, gli stati d’assedio, l’affamamento, l’espoliazione, il sistematico furto, gli imprigionamenti e le torture che colpiscono ad una volta migliaia di sardi. Che civiltà è mai quella che ha elaborato il sistema di punizione come giustizia e questa l’ha fatta coincidere con l’esproprio delle condizioni di vita materiali e spirituali degli individui, decretandone in tal modo l’impazzimento e sottoponendoli poi a reclusione a vita, in uno stato di sequestro di persona permanente, con il confessato scopo di estorcere al prigioniero, oltre al frutto del suo lavoro ed al territorio che gli appartiene, finanche l’anima? Che civiltà è quella che mi offende quotidianamente e mi impedisce poi di vendicarmi? Che civiltà è mai quella che impedisce all’ente offeso di riscattarsi direttamente, imponendogli il ricorso ad una entità estranea, “professionale” che giudica e punisce secondo metodi, regole, norme, leggi elaborate astrattamente e pertanto fuori da ogni contesto della vita reale? No! Tale sistema non è espressione di civiltà al massimo grado, bensì – semmai esistesse una scala di valori per misurarla – all’infimo grado. Non è espressione della vita reale ma di finzione, falsificazione di tutto e di tutti, in quel teatro universale che il potere accentrato vuole estendere a ogni angolo del pianeta. Noi, come sardi, come individui, come comunità concrete abbiamo la nostra, di civiltà, forse cruenta come quella ma senz’altro più vera, sincera, umana. Ma l’essere cruento della nostra cultura è poi da addebitare esclusivamente al fatto che siamo e vogliamo essere “selvaggi”? Sicuramente no! Ed in questo caso ben ragione hanno avuto tutti coloro che hanno denunciato puntualmente i danni, le lacerazioni, le opposizioni, le vendetta e le faide scatenate in seno alla società sarda dalla colonizzazione. Spesso l’abigeato (per es.) non è decretato da semplici motivazioni interne al sistema di vita (balentìa, prima di tutto) bensì dall’affamamento imposto dal regime di dominio, oppure perché lo Stato medesimo offre esempi di come vivere del furto, della rapina ai danni degli altri. E nello stato di perenne scarsità dei mezzi di sussistenza imposto dalla colonizzazione, ben si comprende come non solo il furto è reso obbligatorio per troppe persone, ma anche con quale facilità esso può essere interpretato – da chi lo subisce – quale offesa che richiede risposta vendettale. 27 Se poi, tra le motivazioni che incrementano a dismisura, fuori da ogni comprensione ed immaginazione, il furto e finanche il sequestro di persona, invece che la scarsità oggettiva dei mezzi di sostentamento poniamo i miti consumistici della vita capitalistica, propagandati dai caroselli del sistema, sagomati su di una vita lussuosa ed all’insegna dello sperpero e del superfluo, con la maschera dell’uomo vero in auto roboante o che sappiamo noi, la questione è sempre la medesima. Anzi, man mano che avanza la colonizzazione, la cosiddetta criminalità avanzerà sempre più, per il semplice motivo che i codici autoregolamentativi dell’autoctonia, scomparendo con sempre maggiore intensità, non rappresenteranno valido argine atto a mantenere in certo equilibrio le forze prorompenti degli individui e dei raggruppamenti d’individui. Aumenterà a dismisura la lacerazione sociale e lo Stato canterà vittoria, la nazione sarda essendo definitivamente sconfitta. Sarà anche la fine della criminalità? Basta dare uno sguardo alla metropoli per trovare la risposta. Qui la disumanizzazione alimenta le cause della delittuosità; solo che – ed è questo fatto che impone allo Stato di impegnarsi fino in fondo nell’opera di denazionalizzazione – nella metropoli la delinquenza non è frutto di un sostrato culturale in atto di resistenza contro la propria scomparsa, ma semplicemente rivolta per la sussistenza, senza rappresentare reale alterità al potere costituito. Proprio perché progettualmente carente, il sistema ha facilmente ragione di essa, o meglio la introietta quale momento essenziale della propria esistenza, facendo della lotta alla criminalità, della difesa dei cittadini contro l’opera dei delinquenti, uno dei pilastri portanti su cui si regge l’ordine sociale vigente. Illusione, quando non malafede, vi è nell’assunto che la lotta alla criminalità, se portata avanti decisamente, alla fine sarà vittoriosa. La criminalità è nello Stato stesso, nel suo essere potere esclusivo e pertanto frutto e fautore di ineguaglianze sostanziali. I contrasti interindividuali fanno parte della vita, così come quelli fra i diversi gruppi umani (famiglie, clan, tribù, villaggi, ecc.) e sono ineliminabili. La cultura selvaggia ha elaborato metodi di equilibrio fra le varie componenti il corpo sociale, per evitare che la vittoria dell’una significhi la sottomissione dell’altra. Pur nell’infinità di varianti tra un popolo e l’altro, il sostrato politico proprio di ciascuna cultura selvaggia è che il potere deve essere diffuso nel sociale, quindi facente capo ad ogni singolo individuo, che si esplica attraverso la balentìa e si afferma nella prassi della vendetta. La cultura sarda è cultura selvaggia, senza e contro lo Stato, per cui il processo di liberazione nazionale e sociale, è unico. Fine del processo di liberazione non è la “vera” autonomia della Re- 28 gione Sarda; non è neppure una sorta di federazione italiana di Stati etnici. Neppure è la costituzione di uno Stato tutto sardo, presunto indipendente e libero di federarsi con chi vuole perché in ogni caso non significherebbe reale liberazione dei sardi, il cui potere sarebbe comunque espropriato ed accentrato nelle mani di pochi. Il fine del processo di liberazione è la cultura selvaggia, il potere diffuso, l’autodeterminazione a partire dai singoli individui, con tutto l’armamentario della balentìa e della prassi della vendetta, delle disamistades e delle faide. Ma – ci si potrebbe obbiettare –, dato il grado di acculturazione raggiunto e la disgregazione sociale in atto, le faide e le inimicizie correnti, un tale processo non solo sarebbe impensabile, ma addirittura controproducente. Una tale obbiezione non ha ragione di essere se si colgono anche le estreme e logiche conseguenze cui perviene il medesimo processo. Si tratta di seguire fino in fondo la estrema logicità della prassi della vendetta, di porre in essere le balentìe di tutti i sardi sfruttati e colonizzati quindi di esplicare le personalità di ciascuno di noi contro quel grande nemico di tutti che è lo Stato, i suoi uomini, le sue istituzioni giuridiche, civili ed economiche. L’offesa alla integrità fisica e spirituale, alla famiglia, al villaggio, alla gente sarda, non viene solo dal vicino di pascolo, da colui che mi ruba le pecore o l’auto; l’offesa mi viene anche dal posto di blocco; da chi vuole controllare i miei spostamenti, limitando la mia libertà. Sono offesa l’interrogatorio del giudice e dello sbirro, le tasse e sovrattasse estorte, l’arresto, il furto del mio lavoro, la disoccupazione forzata, l’obbligo delle tangenti per ammazzare il maiale e per vendere il bestiame, il ladrocinio operato nelle coste dal capitale turistico; è offesa l’importazione di quel marciume che chiamano alimenti; è offesa la recinzione delle terre, dei fiumi, delle nostre coste; è offesa il rombo degli aerei militari e civili nei nostri cieli, di cui lo Stato-capitale si è impadronito; è offesa il costringermi all’emigrazione. Tutto questo e mille altre cose sono reale offesa alla nostra dignità di uomini liberi, alla nostra integrità, impediti come siamo nel manifestare la nostra potenza, la nostra personalità. E la rivolta a simile offesa non è altro che vendetta atta a contrastare il disegno genocida ed etnocida che vuole fare di noi e dei nostri figli dei bambocci ammaestrati per la produzione di profitto e consenso ad un padrone. Di conseguenza la vendetta non deve essere arginata, limitata, soffocata bensì – al contrario – radicalizzata, estesa, ampliata contro tutto ciò, di interno e di esterno, che vuole soffocarci come individui e come popolo. 29 30 Parte Prima Delitto e castigo 31 32 Capitolo Primo Delitto e castigo 1.1.1 Norma e società Ogni società umana, in quanto aggregato stabile di individui, elabora specifiche norme atte a garantire l’integrità sociale, la persistenza nel tempo della comunità e dell’ordine specifico interno che le è proprio. La norma (o “legge”) può essere di contenuto positivo (in quanto prescrive come ci si deve comportare in una data contingenza) oppure di contenuto negativo (perché prescrive cosa non si deve fare in uno specifico frangente). Il contenuto della norma è comunque atto a salvaguardare l’ordine peculiare ad ogni comunità; oppure – il che è la medesima cosa – a ristabilire l’ordine preesistente nel caso questo venga infranto. Contrariamente a quanto da più parti si vuole far credere, non esiste alcuna norma universale, valida cioè in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Ciascuna società ha propri valori, spesso irripetibili, e la norma garantisce tali valori. Finanche l’omicidio, il togliere la vita a qualcuno, è valutato in maniera assai diversa a seconda del popolo (è fra gli eschimesi, probabilmente, che l’omicidio è un atto valutato – in una ipotetica scala di gravità – ai minimi livelli). Tuttavia sarebbe altrettanto errato credere che la norma, una volta data, non possa subire dei mutamenti. Questi vi sono, nel corso nel tempo, e concernono spesso suoi momenti sostanziali, altre volte formali. Crimine, o “delitto”, è l’infrazione di una norma vigente, quindi dell’ordine sociale. È chiaro però che il medesimo atto assume valenza diversa a seconda della specificità culturale. In particolare, la medesima azione, 33 o lo stesso comportamento possono rappresentare delitto per una società, ma momento non ritenuto tale per un’altra. Le differenze fra le norme non concernono solo il loro contenuto bensì anche le modalità di emanazione e quelle fissate per ristabilire l’ordine qualora venga infranto. La comprensione esatta di come ciò si verifica richiede un sia pur breve richiamo all’antropologia politica (cioè a quella branca dell’antropologia che si occupa del manifestarsi del potere – e delle sue diverse forme – nella società). 1.1.2 Potere e società Il potere è il luogo sociale di emanazione delle norme e della capacità di farle rispettare. Per individuare tale luogo il nostro immaginario ricorre immediatamente al governo, al parlamento, al re o ad un capo di Stato, oltre che a tutto l’armamentario di contorno. Si percepisce in tale maniera il luogo di emanazione delle leggi. Sarebbe tuttavia assai limitato il credere che il potere si manifesti esclusivamente secondo i canoni dello Stato (in generale, dell’ordine imposto nelle società organizzate verticisticamente). In realtà questo è un modo, una maniera – non la sola, evidentemente –, attraverso cui la società stabilisce le proprie norme (il proprio ordine). Alle società con lo Stato fanno riscontro quelle senza Stato, ma non per questo senza potere (sarebbe assurdo il crederlo anche se, ovviamente, non tutti sono disposti a rompere gli schemi ideologici in cui sono chiusi). L’antropologia politica descrive due realtà, a seconda del modo in cui il potere si esplica nel sociale: società con lo Stato (divise al proprio interno, dimidiate); società senza e/o contro lo Stato (società selvagge – che vivono nella selva, pertanto non urbanizzate –, indivise al proprio interno). Le società con lo Stato sono divise in ceti, classi, gruppi alcuni dei quali privilegiati e nelle cui mani è concentrato il potere. I ceti privilegiati personificano le istituzioni che provvedono ad emanare le norme ed a farle rispettare. Qui la legge è stabilita dall’alto sull’intero corpo sociale e specifiche istituzioni repressive ne garantiscono il rispetto. Nelle società senza Stato il corpo sociale è indiviso. Le norme si trovano di già emanate, quasi poste fuori dal tempo. Nessun ente concreto le ha emanate e nessun ente può mai modificarle, o annullarle. Ciò – è bene ribadirlo – in senso relativo, in quanto non è concepibile l’immobilità assoluta. Inoltre, è chiaro che pur non essendo possibile far risalire una nor- 34 mativa particolare a questo o quell’individuo concreto, è pur sempre possibile cogliere la reale portata di una legge interpretandola attraverso i miti, le leggende, la funzione sociale. In queste società il rispetto delle leggi non è imposto da alcuna istituzione particolare, bensì dall’introiezione di esse da parte di ogni individuo. Di conseguenza pure la rottura dell’ordine esistente e la sua ricomposizione viene attribuita ai singoli componenti il corpo sociale. Così, mentre nelle società con lo Stato la norma e la sua infrazione sono momenti di competenza delle istituzioni, in quelle selvagge il tutto è posto nelle mani dei singoli componenti la comunità. Nel primo caso i membri del corpo collettivo accettano (o subiscono, poco importa in questa sede precisarlo) la delega ad altri; nel secondo caso invece sono i diretti interessati ad agire in prima persona. In quelle vi è lo sbirro, il giudice, il sovrano che garantiscono l’ordine; in queste sono tutti i componenti la società che direttamente autogestiscono i propri interessi e le proprie concezioni della vita. L’etnografia chiarisce anche che nelle società senza Stato, qualora venga infranto l’ordine vigente, la collettività interviene quando l’infrazione colpisce tutto il gruppo, tutti i suoi componenti, o rischia seriamente di colpirli; ma non quando a subire un torto, una offesa, in altre parole non quando sono stati lesi interessi materiali e/o spirituali di una sua parte (individuo, famiglia, clan). In questo ultimo caso la ricomposizione dell’ordine è rimessa nelle mani delle parti in contesa. La società, attraverso le norme consuetudinarie che si materializzano nel comportamento pratico dei suoi membri, può spingere la parte lesa ad agire per salvare il proprio onore; può anche prestabilire la gradualità con cui l’ordine infranto può essere ricomposto, ma mai interviene fra due parti in contesa anche se ciò dovesse avvenire in maniera cruenta e sanguinosa. Salvo che alla fine la lotta stessa non finisca per interessare/coinvolgere il corpo collettivo, determinando così il pericolo di frantumazione dello stesso. 1.1.3 Contenuto della norma Ai due modi di manifestarsi del potere corrispondono contenuti normativi contrastanti. È evidente che chi emana le leggi dà ad esse un contenuto atto a garantire uno specifico ordine, più precisamente l’ordine di quella particolare società, le coordinate, i valori su cui l’intero corpo collettivo sussiste. Nelle società dimidiate (divise al proprio interno) si hanno delle norme atte a salvaguardare la struttura piramidale e pertanto i privilegi dei 35 pochi a scapito delle moltitudini. Al contrario, le società indivise elaborano norme che garantiscono esattamente l’indivisione, l’unità del corpo collettivo, l’ordine sociale basato sulla parità di condizioni. In genere nelle società con lo Stato, in quanto politicamente riferite al centro da cui vengono emanate, le leggi mirano ad un controllo sempre più totale e ramificato nel territorio, al fine di tutto regolare e pianificare secondo le direttive del centro (o del vertice). All’opposto, nelle società senza o contro lo Stato la normativa si riduce a relativamente pochi momenti e mira a garantire l’indivisibilità della comunità, a graduare le risposte alle offese subite, a salvaguardare i rapporti che il corpo collettivo ha instaurato col resto dell’universo. 1.1.4 Delitto e castigo Le diversità che abbiamo fatto emergere tra i due tipi di società riflettono anche il modo in cui i due mondi sociali sogliono ristabilire l’ordine infranto e, non ultimo, sul modo stesso di concepire il delitto e il castigo. Nelle società con lo Stato emerge, nell’infliggere il castigo contro il reo che ha infranto le leggi, la volontà di punizione; nelle società senza Stato, invece, emerge la volontà di rivalsa dell’ente offeso (individuo, clan o l’intera collettività che sia), che rivendica la propria sovranità, il proprio ruolo messo in discussione dall’offesa subita. Riteniamo di fondamentale importanza questo diverso atteggiamento, se non altro perché l’attuale concezione della pena se da una parte include il momento del pentimento che redime il reo, dall’altra è esattamente il proseguimento del vecchio modo di intendere il castigo (come punizione). Considerato che le società selvagge concepiscono l’esistenza del contrasto di interessi fra i propri componenti, e che pertanto mirano più che a debellare il “delitto” tra privati a regolarne l’evoluzione – affinché si salvaguardi l’unità collettiva – per crimine vero e proprio è da intendersi, in questo caso, l’infrazione alle norme della comunità. Più che a punire, le leggi mirano ad eliminare, espellere dalla collettività quanti manifestano di non accettarne le sue norme. È esclusa in ogni caso la galera, la restrizione della libertà del reo, la punizione come momento di salvezza e di estinzione dell’azione che ha infranto la legge. La stessa uccisione di colui che si è macchiato del delitto più atroce viene posta in essere in casi davvero eccezionali e l’infrazione riguarda sempre le regole fondamentali del consorzio umano. In genere è il capo (o lo sciamano) ad essere ucciso, qualora voglia trasformare il prestigio di cui gode in privilegio, in potere effettivo concentrato nelle sue mani a scapito 36 della collettività. In queste società, infatti, la funzione del capo è esclusivamente quella di rappresentare il corpo collettivo nei contatti con altre società. Non è concepibile il rapporto comando-obbedienza ed il capo non può pretendere più del prestigio di cui gode. Particolare rilevanza assume, in tale contesto sociale, il tabu, ovvero il non rispetto di specifiche leggi che sono poste a fondamento dei rapporti fra la comunità e l’universo spirituale. L’infrazione di un tabu è in genere ritenuto come la traumatica rottura di un ordine che immediatamente significa la separazione del gruppo dagli “spiriti” del mondo, e pertanto il soggiacere alla vendetta degli stessi che vengono così offesi. A pagarne le conseguenze, disastrose, non è tanto il singolo – sia pure il reo che materialmente ha posto in essere l’offesa – bensì tutta la comunità. Perciò la sua uccisione, spesso, più che intendersi come punizione è da considerarsi quale prevenzione della vendetta degli “spiriti”, oltre che momento di deterrenza per tutti i componenti. La società di cui stiamo discorrendo è data dall’equilibrio sempre precario delle varie forze individuali e familiari (claniche) che la costituiscono. La rottura di detto equilibrio si ha ogni qualvolta che viene sminuito o negato il prestigio di una parte. Ciò accade per mille motivi, spesso per questioni di interesse materiale ma altrettanto spesso per motivi di natura morale-spirituale. I contrasti che ricadono in questa sfera, genericamente definita “privata”, vengono regolati tra i diretti interessati e trovano espressione nell’orbita della vendetta. Tale “istituto”, prassi rimasta in vigore fino ai giorni nostri in diversi popoli anche “civilizzati”, è esattamente l’opposto della pena. Chi si vendica, nell’azione che pone in essere contro il proprio nemico, più che a punire mira a ristabilire la propria integrità materiale-morale posta in discussione all’atto dell’offesa. È l’onore della parte lesa, il prestigio messo in discussione, la sovranità che devono essere salvaguardati e reintegrati, e ciò è l’aspetto fondamentale di tale istituto. Nelle società con lo Stato la trasgressione delle norme, in tutti i casi estranee e quindi astratte per il reo, viene concepita sempre e comunque quale a-socialità. Contrariamente al caso precedente però, non si mira ad espellere il colpevole dalla società, ma a costringerlo in essa, violentandone la volontà. La punizione inflitta mira non tanto a “salvare l’onore” dello Stato, bensì anche a convincere il “criminale” ad accettarne le leggi, volente o nolente. In quest’ordine sociale non è neppure concepibile che i singoli individui, o gruppi d’individui si sottraggano all’imperio della norma stabilita. Non a caso, nel neppure tanto lontano passato, i delinquenti venivano mutilati o marchiati; segno indelebile della prepotenza di Stato che marchia all’infamità chi non accetta le sue norme. 37 1.1.5 La pena come redenzione Se in origine lo Stato mirava a punire i criminali evidenziando l’atto di forza e d’imperio del potere costituito sui sudditi, col tempo la prassi della punizione viene giustificata anche come momento di salvezza. In realtà, quanto più si modifica il sistema Statale tanto più emerge la necessità di cercare il consenso dei sudditi per potersi perpetuare. Anche il concetto di castigo subisce così sostanziali modificazioni. La punizione del criminale diventa prassi attraverso cui egli, scontando il castigo che gli è stato comminato, può mirare alla redenzione. In altre parole, considerato che la società statale è fondata essenzialmente sulla contraddizione principale della divisione sociale, causa ed effetto di ulteriori contraddizioni politiche ed economiche date dalle ineguaglianze materiali e spirituali fra gli uomini, il delitto è suo momento ineliminabile. Per cui è sorta la necessità di atteggiamenti diversi nei suoi confronti. Non vige più l’illusione della sua eliminazione, neppure tramite l’uso della forza più brutale. Prende piede un’altra illusione: quella di infliggere a quanti ledono le leggi una pena che funga da punizione e contemporaneamente significhi per il delinquente la redenzione. Sconto di penalità che lavi il peccato, provochi pentimento e pertanto l’intima convinzione dell’errore commesso. In tal modo del criminale se ne vuole fare un apologeta del sistema. Il trapasso dal vecchio concetto di punizione al nuovo di pena come salvezza non poteva che essere posto in essere dalla religione cristiana. 38 Capitolo Secondo Il concetto cristiano di pena 1.2.1 Il concetto cristiano di pena Il potere, nelle prime forme di Stato imperiale (azteco, incaico, egizio, romano, ecc.), è relativamente esclusivo e totale, essendo mediato dall’attenzione rivolta ai popoli via via sottomessi, dei quali si rispettano formalmente riti e miti, credenze ed usanze. La prassi, pur costante, del genocidio e dell’etnocidio, non è affatto sempre funzionale agli interessi dell’impero. La conquista di nuovi territori ha un senso solo se questi sono popolati, in quanto è dallo sfruttamento delle popolazioni che si traggono i tributi. Da ciò la necessità, una volta attuata la conquista, di forme di dominio che manifestino rispetto dell’identità dei conquistati. Così gli Incas se da una parte impongono il culto del loro dio, dall’altra non estirpano o vietano i culti tradizionali delle popolazioni conquistate. Egiziani, Romani e via dicendo agiscono nello stesso modo, almeno nel breve periodo e nei confronti delle popolazioni non particolarmente ostili. Una tale politica evita che i popoli soggiogati siano in perenne rivolta contro il conquistatore; nello stesso tempo agevola la riscossione dei tributi, che poi è il fine dell’assoggettamento. Ovviamente vi sono le eccezioni, ma in generale questa è la prevalente tendenza nella storia di ogni impero. Si tratta, in definitiva, del processo di acculturazione ai suoi primordi, non certo di spirito di “tolleranza”. L’intelligenza del potere imperiale è del tutto assente nel cristianesimo, almeno nella sua forma compiuta che si è istituzionalizzata nella Chiesa 39 cattolica apostolica romana. Tale assenza rimarca finanche il trapasso dal concetto tradizionale di castigo al duplice significato che esso assumerà. Per il cristianesimo, al castigo quale punizione verso il responsabile che ha infranto la norma deve affiancarsi l’atto del pentimento mirante a riconciliare il criminale con l’ordine costituito, con la legge, quindi con dio. Il criminale è peccatore, ma in quanto figlio di dio può redimersi, riconciliarsi col suo creatore. La riconciliazione impone lo sconto della pena, ma determina la salvezza, la rinascita, la resurrezione solo se include il pentimento; altrimenti non vi può essere salvezza, ma dannazione. San Tommaso l’ha chiarito a sufficienza questo aspetto. La Chiesa nasce cattolica, cioè universale. Suo fine è portare il verbo, la “verità” su tutto il globo, convertendo – ove possibile – pagani e senzadio, quindi distruggendo ogni forma di eresia. 1.2.2 Fondamenti del cristianesimo Il primo fondamento della dottrina cristiana è il triste monoteismo ebraico, che pone Jeova signore assoluto e creatore (padrone esclusivo, quindi) di tutte le cose dell’universo. Ogni esistente ad egli è riferito, ogni cosa in egli si annulla ed esiste solo in grazia sua. Il modo di manifestarsi di questo terribile Moloch è l’ordine perentorio e la più sanguinaria ritorsione verso quanti violano i suoi dettami. Rintuona, nel triste universo ebraico-cristiano, l’altisonante ed irata voce di Jeova, quando, rivolto ad Eva, la maledice per tutta la durata della vita terrena: Moltiplicherò assai le tue pene e le doglie della tua gravidanza; avrai i figli nel dolore, tuttavia ti sentirai attratta con ardore verso tuo marito, ed egli dominerà su di te. (Genesi) Non meno grave è la maledizione che scaglia ad Adamo: ... La terra sarà maledetta per cagion tua; con lavoro faticoso riceverai da quella il tuo nutrimento per tutti i giorni della tua vita, essa ti produrrà spine e triboli ... col sudore di tua fronte mangerai il pane, finché ritornerai alla terra, da cui sei stato tratto, poiché tu sei polvere e polvere ritornerai. (Genesi) Con questa visione, non certo gaia, della vita il popolo cristiano prima, la sua gerarchia fattasi Stato poi, si rapportano con gli altri popoli e la natura. La setta che nel mito della passione e della resurrezione del Cristo 40 vede la salvezza dell’umanità dalla dannazione eterna, nega (nella di già disgraziata sorte dell’essere umano decretata dal barbaro Jeova) finanche ogni valenza nell’alterità. Né viene accettata ogni formale conversione. La salvezza, la rinascita è possibile solo nella “passione”, nel doloroso travaglio, nell’intimo convincimento dell’errore. Le “spine” che lacerano la carne viva rappresentano la passione necessaria, la sofferenza del corpo e dello spirito che, indulgenza del peccato, redime, lava l’anima nel pentimento, fa rinascere alla vita eterna dell’al di là. Ecco la struttura mentale, l’orizzonte ideologico-culturale con cui la Chiesa, religione imperiale, imporrà se stessa ed il potere che rappresenta e che la rappresenta, ai popoli dell’Europa prima, del mondo intero poi. 1.2.3 L’avvento della Chiesa cattolica al potere Quando l’imperatore Costantino eredita quel che resta del vecchio impero romano, si trova ad affrontare una situazione sull’orlo del collasso. Crisi economica, burocrazia in stato di completo sfacelo, disorganizzazione dell’esercito, province in perenne rivolta, nemici esterni che premono ai confini del “regno”, un’infinità di popoli e culture assai diverse fra loro che neppure l’ampio rispetto dei propri riti, miti, usi e costumi riesce più a tenere soggiogati sotto un’unica sferza. Il paganesimo, nella sua variante latina è in crisi. Al contrario, il cristianesimo – assai trasformato rispetto alle sue origini – è diffusissimo non solo, ormai, negli strati sociali inferiori di quella società schiavistica, ma in tutti i ceti, finanche i più alti. L’estendersi del cristianesimo fra tutte le classi sociali (fenomeno dovuto alla crisi che imperversa ed alla caduta dei valori che sostenevano spiritualmente l’impero) ha trasformato radicalmente la struttura della setta, fino allora soggetta a terribili persecuzioni. Contrariamente al passato la Chiesa è, ai tempi di Costantino, una vera e propria società organizzata e strutturata gerarchicamente. Nel contesto dell’impero in profonda decomposizione, si presenta come Stato entro lo Stato. La comunità cristiana è ormai divisa al proprio interno in due componenti: clero, cioè parte eletta (la burocrazia); e laos, cioè i laici (i semplici credenti). Costantino, nel suo progetto di ripacificazione e ricostituzione in unità stabile dello Stato imperiale, non poteva non tenere conto della Chiesa, sia perché numericamente consistente e diffusa in tutte le province sia, soprattutto, perché entità gerarchicamente strutturata e ramificata nel territorio. Si profila l’utilizzo della Chiesa nella più vasta politica costantinia- 41 na, che si concretizza da una parte in sgravi fiscali, quindi nella pratica del culto pagano del dio-sole (egli medesimo verrà eletto Pontefice Massimo del culto), infine nell’Editto di Milano (313) che sancisce il cristianesimo religione di Stato. Così le gerarchie della Chiesa ricoprono le cariche istituzionali, spesso le più alte e delicate. Lo Stato è Chiesa, la Chiesa è Stato! Potere sacrale e potere regale sono entrambi di origine divina, il primo però di livello superiore, anche se sopra l’imperatore vi è soltanto dio. Il cristianesimo popolare delle origini è soppresso nel sangue (donatisti, ecc.) ed ogni “eresia” soffocata nella più sanguinaria repressione. I santi padri ed il clero tutto si affrettano a sancire il nuovo assetto di potere. Paolo esplicita la nuova situazione: O schiavi, che siate obbedienti ai vostri padroni della carne; o padroni, date agli schiavi giustizia e comprensione! Non la libertà, evidentemente. I Concili approvano, chiariscono, aggiungono. Così quello di Granges: Se qualcuno, sotto il pretesto della pietà, incita lo schiavo a disprezzare il suo padrone, a sottrarsi alla schiavitù, a non servire con buona volontà e rispetto, anatema lo colpisca!!! Per diversi secoli avvenire lo schiavo, un tempo unico elemento della comunità cristiana, diventa “una persona vile che non può adempiere alla funzione ed alla dignità sacerdotale”, salvo non riesca a liberarsi. 1.2.4 La pena cristiana nel Medioevo: genocidio, tortura, rogo Nonostante la riorganizzazione attuata da Costantino, l’Impero Romano è destinato a soccombere. I popoli “barbari” lo invadono, frantumandolo e sottoponendolo a diverse angherie. A partire dal IV secolo l’Europa assume via via una nuova fisionomia politica, sociale, economica. I nuovi invasori paiono trovare popolazioni pronte ad accoglierli, tanto misera doveva essere la loro condizione. Tuttavia si rivelano ben presto simili ai precedenti. Delle antiche forze, l’unica rimasta in vita e radicata nel territorio è la Chiesa; pertanto su di essa ricadono le speranze di pace e di sollievo delle martoriate popolazioni, ma anche dei nuovi invasori che in essa ripongono speranze di collaborazione per un razionale dominio sulle genti. Così per gli uni si fa portatrice di pace, per gli altri fautrice di attiva collaborazione. In realtà, però, il suo agire è finalizzato al mantenimento dei privi- 42 legi e del potere (nonché alla loro estensione) di cui beneficiava nel periodo imperiale. Nel V secolo la Chiesa si presenta come una società indipendente, fortemente costituita, posta in mezzo ai padroni del mondo, ai sovrani, ai detentori del potere temporale, da un lato, e ai popoli dall’altro, servendo da legame tra costoro ed agendo su tutti. (Guizot) La sua politica, durante l’Alto Medioevo (Impero romano-barbarico) si esplica nel cristianizzare i barbari e nel barbarizzare le popolazioni, imponendo ai primi il proprio ruolo di compradore ed alle seconde una visione della vita consistente nell’accettazione passiva del dominio (il potere non è forse volontà di dio?). Facendosi forte del possesso esclusivo dei valori dell’antica civiltà greca e di quella romana, modifica, falsifica tutto il preesistente a suo profitto esclusivo, fino ad inventare di sana pianta donazioni che solo dopo secoli si scopriranno spudoratamente false. Unica depositaria del “diritto” non conoscerà rivali in grado di contrastare la sua concezione del delitto e del castigo. Guizot si rende conto assai bene di quanto la visione cristiana della pena influenzi e preceda la concezione moderna: Vi è, nelle istituzioni della Chiesa, un fatto generalmente pochissimo notato, e cioè il suo sistema penitenziale, e l’esaminarlo è oggi tanto più interessante in quanto, per tutto quanto concerne i principi e le applicazioni del diritto penale è quasi completamente d’accordo con le idee della filosofia moderna. Se voi studiate la natura delle pene della Chiesa, delle penitenze pubbliche che erano la sua maniera principale di castigo, vi accorgerete che avevano soprattutto lo scopo di eccitare nell’animo del colpevole il pentimento, e in quello degli astanti, il terrore morale dell’esempio. Vi si unisce pure un’altra idea: l’idea di espiazione. È, ai suoi primordi, l’ideologia da cui scaturisce il penitenziario in epoca moderna. Il rapporto economico, politico, sociale viene fatto gravare sui contadini, soggetti ad una sorta di schiavitù che li lega indissolubilmente alla terra, e pertanto ai suoi “legittimi proprietari” che concedono gli uni e l’altra in feudo. In cima alla piramide sociale sta il sovrano, padrone asso- 43 luto del regno per grazia divina e concessione della Chiesa. Il sovrano concede le terre ai feudatari, i quali la concedono ai vassalli, che a loro volta la concedono ad altri. I vari feudatari, così come i diversi sovrani, si contendono fra di loro i feudi, per cui le guerre imperversano in lungo ed in largo per il continente. La Chiesa ha propri feudi, in più riscuote ovunque la decima parte di ogni prodotto del lavoro. Di conseguenza è l’entità economica più potente dell’Impero. Inoltre il dominio spirituale sulle genti è esclusivamente suo, non avendo le altre entità alcuno strumento o potere in questo settore. Ovvia la politica della Chiesa, mirante a far coincidere potere economico, potere spirituale e potere politico, concentrandoli nelle sue mani. Alle guerre tra feudatari, tra città, tra queste e quelli, ed alle perenni sollevazioni dei contadini per scuotersi dal giogo della servitù, si aggiungono le guerre papali a scapito degli uni e degli altri. Fanno da contorno le lotte cruente alle cosiddette eresie, che altro non sono se non progetti sistematici di annientamento totale (genocidio vero e proprio) di popolazioni che non si riconoscono nel sistema dominante. Da questo crogiuolo di rapporti, col trascorrere dei secoli, emergono via via nuove forze economiche e sociali, soprattutto a partire dai secoli X e XI. Il collante che trascina nel tempo l’esplodere delle contraddizioni è rappresentato proprio dalla Chiesa, presente ovunque, nei tuguri dei servi della gleba come al castello del feudatario ed alla corte del sovrano. È in questa epoca che nasce e si afferma la pratica della confessione, a significare l’insinuazione del potere chiesastico nella coscienza di tutti. È la Chiesa che, manipolando le menti ed i corpi alla disciplina ed i rigori del dominio, ha dimostrato storicamente che la stabilità del potere costituito è possibile finanche ed oltre il possesso diretto di strumenti brutalmente coercitivi: il dominio è possibile col consenso dei dominati. Ma si ottiene non solo nella punizione del corpo, bensì nella manipolazione, assimilazione delle menti ai valori della classe dominante. Signori, la Chiesa cristiana ... si proponeva appunto di governare il pensiero umano, la libertà umana, i costumi privati, le opinioni individuali ... essa mirava all’interiorità dell’uomo, al pensiero, alla coscienza, ossia a quanto vi è di più intimo, di più libero, di maggiormente ribelle alla coazione. (Guizot) Quando teniamo presente il modo di manifestarsi della Chiesa nei contraddittori rapporti economici, sociali e politici del Medioevo, chiaro ci appare il ruolo giocato da essa e la lungimiranza della sua politica. Essa è 44 sì potente, economicamente e spiritualmente; la forza più potente. Eppure, salvo che nei suoi diretti domini è priva di forza militare adeguata alla sua influenza. Se ciò le impedisce il potere politico incontrastato, sa comunque utilizzare nel migliore dei modi la potenza spirituale per esercitare il dominio sull’Europa. Le “sue” guerre, le lotte all’eresia, le crociate possono attuarsi solo col ricorso alle armi ed ai militari altrui; eppure riesce anche in ciò. Il suo operare, però, produce ulteriori contraddizioni che rafforzano esattamente le potenze ad essa antagoniste: soprattutto i sovrani, futuri costruttori dello Stato moderno. Le lotte alle eresie, ad esempio, se distruggono dei nemici della cristianità eliminano finanche le popolazioni più refrattarie all’assimilazione, all’acculturazione necessaria per dare vita agli Stati-nazione. Le future monarchie si trovano così ad agire in un campo sgombro di importanti nemici: etnie non soggiogate. È tuttavia in tali lotte che si esplica la volontà della Chiesa di assolutizzare il dominio e di conseguenza il sistema penale, e getta le basi della concezione moderna di intendere la pena, quindi il delitto e il castigo. L’eresia è combattuta nella sua essenza: è disubbidienza ai valori, all’ordine costituito, agli interessi del potere; è contestazione, rifiuto, alterità, rivolta che mette in discussione l’ordine sociale, politico, economico in quanto non riconosce nell’emanatore della norma (intesa come verità) alcun ente accreditato. L’eretico è chiunque non si adegua al comando ed all’ordine vigente. Per questo va brutalmente punito, castigato. Tuttavia può redimersi. Il suo atteggiamento è senza dubbio da interpretarsi come peccato, ma la terribile pena, la maciullazione del corpo è attuata in vista della salvezza dell’anima; deve suscitare nel peccatore il travaglio intimo, sincero, sofferto del pentimento. Tutto il processo ha per scopo l’interiorizzazione della norma non accettata. La prassi della tortura, non certo esclusiva del cristianesimo, acquisisce nel Medioevo, nello specifico con l’Inquisizione, non più solo il semplice significato di atto d’imperio della legalità-dominio, bensì assurge a vera forza propedeutica atta a determinare il pentimento e quindi la salvezza del peccatore. Non è solo castigo, ma anche espiazione ed indulgenza. 1.2.5 L’Inquisizione L’inquisizione si trova in nuce negli stessi principi del cristianesimo, ma come istituzione stabile, con apparati, uomini e mezzi propri si formalizza nei primi secoli del secondo millennio e coincide con la lotta fra 45 papato ed impero per la supremazia. Essa si erge minacciosa su tutti i ceti ed ordini sociali; a significare la potenza della Chiesa, ma anche a ... incrementarla, incamerando i beni sottratti agli inquisiti. Il che ancora una volta provoca la repulsione di tutti. Ogni azione della Chiesa provoca inevitabilmente delle contraddizioni che poi le si ritorcono contro. Per il sistema inquisitoriale la pena, il castigo vertono sul corpo e sulla mente. La reclusione non è castigo di per se stessa, ma momento di transito verso il tormento fisico e psichico. Alle sofferenze del corpo il cristianesimo chiesastico ha affiancato la tortura dell’anima, dello spirito, nel tentativo di assimilare, snaturare, correggere, alienare l’altro a sé. Il potere potrà perpetuarsi solo se all’ubbidienza dei sudditi corrisponde l’intimo convincimento, l’adesione volontaria ai principi che lo sorreggono. È la concezione, in nuce, della società come penitenziario e del penitenziario come società. È questa grande eredità che la Chiesa lascia allo Stato moderno, ormai ai suoi albori. Essa non poteva concretizzarla se non nei modi brutali del suo tempo, così come lo Stato troverà anch’esso una situazione contraddittoria che determinerà il suo operare sul carcerario a tentoni, a tentativi che sono pregni e della contingenza storica e dell’idealità del sistema penitenziario perfetto. Il modello è concepito, ma richiede oltre che “fede”, strumenti scientifici e materiali atti a concretizzarlo. 1.2.6 Alle soglie dello Stato moderno: i primordi del penitenziario La sconfitta del Papato e della stessa concezione teocratica del potere è inevitabile. Le contraddizioni che minano la sua supremazia si risolvono nel vantaggio politico altrui. Il persistere nel rafforzare la potenza temporale fa sì che anche le plebi s’allontanino sempre più dalla Chiesa. Infine le città, vere e proprie potenze economiche tormentate dall’invadenza inquisitoriale, non tardano a comprendere che dietro il castigo delle anime e dei corpi di ... facoltosi cittadini, si cela la bramosia della Chiesa di impossessarsi delle loro ricchezze. Tutto converge contro la teocrazia. Potenti progressi tecnici e culturali investono via via le campagne, innovazioni tecnologiche, ricchezze enormi, nuove professioni ed arti traboccano dalle città. Le menti si aprono a nuove prospettive, e nuove prospettive decretano valori nuovi. Nella cristianità del periodo la rottura col vecchio, col superato non può che avvenire come scontro col potere della Chiesa. La frattura è totale, irreparabile. È l’epoca della Riforma, che contesta non i massacri, i genocidi, le torture perpetrate in nome e per conto dell’unico signore del creato. 46 Quel che si contesta al Papato è di ridurre la vita dei cristiani ad un inferno sulla terra. È la struttura mentale del borghese, del mercante, del cittadino che si ribella. È la necessità del capitale, della ricchezza accumulata che pretende nuovi rapporti sociali, politici, ideologici atti a garantirne lo sviluppo in ogni sua potenzialità. Per i Riformatori il corpo è si momento di passaggio, veicolo in cui alberga solo momentaneamente l’anima cristiana; ma questo non deve significare abbrutimento, lassismo, passività. Tutt’altro! La vita dev’essere manifestazione di attività, di grandezza, di servizio all’immensità dell’opera divina, che è anche questo mondo materiale, per cui deve concretizzarsi in operatività. Così, una volta esplose le contraddizioni, gli effetti devastanti – spopolamento delle campagne, radicalizzazione ed espansione della miseria, pestilenze, guerre, vagabondaggio di immense schiere di indigenti, disoccupazione, ecc. – sono differentemente valutati ed arginati da parte dei paesi riformati, da un lato, e dall’altro da parte di quelli fedeli alla Chiesa di Roma (paesi della Controriforma). In tale contesto emerge con evidenza chi e che cosa viene valutato come crimine e criminale. Nell’area della Riforma anche la disoccupazione assurge a delitto il più assurdo, sia pure addebitabile a fattori totalmente estranei alla volontà individuale. Il non lavorare, il non produrre è valutato crimine vero e proprio, e pertanto viene punito. Nell’area cattolica tradizionale emerge invece, almeno nel primo periodo, la pratica della pietà, che meglio si adegua alla struttura ideologica in vigore. In tal modo è possibile intravedere negli uni e negli altri paesi una politica atta a limitare i nuovi fenomeni a seconda degli indirizzi mentali propri della Riforma e della Controriforma. Nei secondi la risposta è in prevalenza il pietismo, proprio del signore feudale nei confronti del disgraziato, dell’accattone, manifestantesi nell’elargizione dell’elemosina. In pieno Medioevo il mendico era figura di grande rilievo sociale in quanto il “ricco” poteva esercitarsi cristianamente nell’accoglierlo e nel rifocillarlo, cosa assai gradita al dio cristiano. Nell’area della Controriforma, almeno nel primo momento, agli impestati, ai vagabondi, ai mendici, ai disoccupati, alle prostitute, ai bambini orfani, ecc. si elargisce la pietà, in linea con il passato. Ma la peste impone l’isolamento del malato – e tutti costoro vengono considerati in certo qual modo al pari dei malati, peccatori “veniali” incorsi nel castigo divino – onde tenerlo lontano dalla popolazione sana. A tale scopo si costruiscono specifici luoghi, edifici ove rinchiudere i derelitti della società emergente. Nascono gli Hospital, le Case di Ricovero, ove vengono am- 47 massati gli indigenti, gli esclusi dal consorzio umano. Qui la pietà e la bontà si elargiscono a piene mani. È il ‘500, anno del signore controriformato. Nel medesimo secolo, nei paesi della Riforma le menti cristiane scissioniste ed aperte al “nuovo”, onde arginare il crescente fenomeno del vagabondaggio e della miseria nonché l’atteggiamento refrattario verso la nuova disciplina richiesta dal lavoro, proprio di decine di migliaia di poveri cacciati dalle campagne ed esuberanti nelle città, scandalosamente “dediti” alla vita passiva consumata nell’ozio, qui le menti “illuminate” costruiscono le Workhouse, le Case di Lavoro. Veri e propri laboratori di produzione artigianale, le Case di Lavoro “rigenerano” gli internati, ovviamente secondo i canoni ed i valori emergenti: la produzione di beni e di profitto, il lavoro produttivo a costo zero. Siamo ai primordi del carcere moderno. Il castigo verso la vittima del sistema, o comunque verso quanti non si adeguano o non possono adeguarsi, è ormai concepito non solo come ritorsione ma anche come momento di “pulizia” interiore, di intimo pentimento che lava il peccato e ricongiunge l’anima del reo a dio (inteso come il sistema vigente). La pena è finalmente disciplina del corpo e della mente ai nuovi valori religiosi, morali e materiali. Malgrado le differenze che inizialmente caratterizzano l’intervento repressivo nei paesi della Riforma e della Controriforma, la medesima universalizzazione del modo di produzione capitalistico imporrà via via, nelle due realtà, una progressiva convergenza, se non ideologica sicuramente pratico-operativa. La Chiesa, nel corso dei secoli ha ampiamente dimostrato che la gestione del dominio richiede, per essere stabile e duraturo, la disciplina delle menti; la Riforma dimostra le possibilità della disciplina del corpo, come richiesto dalla produzione capitalistica. L’uno e l’altro momento convergono infine, alle soglie della modernità, per razionalizzare il dominio dell’uomo sull’uomo. 1.2.7 Lo Stato moderno Fino all’avvento del cristianesimo al potere, ed in parte per tutto il Medioevo cristiano, la pena inflitta al delinquente altro non rappresentava se non punizione assoluta, supplizio. Il potere medesimo, coincidente con la persona del sovrano, determinava una tale realtà. Alle soglie dello Stato moderno le leggi penali non prevedevano affatto il carcere, la reclusione – se non momentanea – come luogo di estinzione del castigo. La pena consisteva in altri momenti, a seconda del ceto di appartenenza del reo-inquisito: carcere per i nobili, fustigazione pubbli- 48 ca per i servi della gleba; sanzioni pecuniarie per i primi, lavori forzati per i secondi; assoluzione per i ricchi, la forca per i poveri. In genere era la “legge del taglione” a farla da padrone, almeno per gli strati inferiori della società, quindi per la maggiorparte degli uomini. Nel Medioevo soprattutto, delitto e castigo erano realtà dal contenuto assai variegato, essendo il feudatario stesso per lo più a determinare, entro il proprio feudo, il buono e il cattivo tempo, l’ingiusto ed il giusto; che così variavano anche sostanzialmente da un luogo all’altro. Il potere essendo personale anche la norma lo era, come il castigo da infliggere a colui che infrangeva la volontà del signore. Un argine poderoso al personalismo del sistema di potere feudale era rappresentato dalle consuetudini delle popolazioni, che regolamentavano i rapporti vuoi tra appartenenti alla comunità che fra questa ed il feudatario. Tuttavia, col trascorrere dei secoli e col mutare dei rapporti di forza a vantaggio di quest’ultimo, ogni impaccio sulla strada dell’accentramento del potere veniva man mano eliminato. Eliminazione che significava – sia detto per inciso – la scomparsa delle culture e delle popolazioni soggette al dominio feudale. In questo processo di assoggettamento ed omologazione, di esproprio del potere delle popolazioni, il Papato sia pure contraddittoriamente ha gettato le basi ideologiche del nuovo modo di dominio, che poi sfocerà nella costituzione degli Stati moderni. Se gli imperi tradizionali facevano coincidere il potere con il sovrano, concreto, visibile – sia pure concepito ideologicamente e posto materialmente in uno spazio deificato – la Chiesa cattolica apostolica romana ha dato vita ad un potere spirituale concepito astrattamente, che va ben oltre la persona del sovrano. È lo Stato in essenza, esattamente lo Stato moderno, così come viene concepito oggi. Lo Stato quale entità astratta che non rappresenta né il governo né i governati né l’unione di entrambi ... Stato impersonale, oggetto di dedizione e di rispetto universali sia da parte dei governanti che da parte dei governati. (Shennan) Un tale nuovo concetto di potere politico, per estendersi dal campo religioso a quello sociale, ha dovuto attraversare i secoli tra i più bui dell’umanità, in un processo di incredibili mutamenti culturali ed economici, oltre che politici, che ha attraversato i popoli europei in lungo ed in largo. Il processo di accumulazione originaria del capitale ha richiesto l’individuazione e la circoscrizione di aree geoumane da omologare, che garantissero, con una politica economica adeguata, l’esclusione della concorrenza, la “libera” circolazione della manodopera (proletarizzazione dei servi della gleba), l’intervento di un potere sovrano (e riconosciuto tale da tutti) in grado di salvaguardare l’integrità delle nuove forze economico-sociali 49 emergenti. Il moderno Stato è richiesto anche dai nuovi modi di produzione, ma ideologicamente la Chiesa l’aveva di già concepito. Inoltre, la sua battaglia “all’eretico”, promosse il processo di omologazione delle genti, che nella prassi dell’etnocidio e del genocidio arrivò quasi a compimento. Ma la Chiesa introduce anche alcune varianti nel principio stesso di concepire il domino. Se dio è uno, una è la verità, una la legge. Si toglie così ogni valenza – finanche come entità nemica – a tutto ciò che non si riconosce, non si riconduce e non si fa ricondurre a tale unità. È il principio assolutista per eccellenza. Il diverso, l’altro, chi non si adegua, sia pagano o eretico, oppure criminale, viene concepito, riconosciuto solo se, rinunciando alla propria specificità, si confonde con l’uno (dio, verità, legge, Stato), in esso si annulla. È questo il principio fondamentale che sta alla base della prassi cristiana di intendere e vivere il rapporto con l’altro da sé; è in esso che si esplicano le ragioni dei roghi purificatori, della tortura, dei genocidi interni ed esterni all’Europa. Ed è su questa visione, implicita nel nuovo modello di Stato (Stato-nazione), che emergono i concetti moderni del delitto e del castigo. Il principio-guida è l’assimilazione, la disciplina delle menti e del corpo all’ordine richiesto dall’assetto politico-economico nuovo. Pur tra mille contraddizioni, il modello di carcere che prende piede con la nascita dello Stato moderno è quello atto a disciplinare il reo, punendolo ma dandogli anche la possibilità della redenzione. La nuova società richiede non semplici schiavi, ma schiavi consenzienti. Non è forse, lo Stato-nazione, quella entità ideale ed impersonale che può sopravvivere solo nella dedizione e nel rispetto universali? 50 Capitolo Terzo Nascita e sviluppo del penitenziario 1.3.0 Il trapasso dal vecchio al nuovo In quasi tutta l’Europa il periodo che va dal XV al XVIII secolo è caratterizzato dal progressivo emergere, fino a diventare dominante, del modo di produzione capitalistico. Sul piano politico si ha il superamento della figura del Principe/sovrano come entità “proprietaria” del regno e delle popolazioni; superamento che si concretizza infine nella nascita dello Stato modernamente inteso. Il potere temporale acquisisce in tal modo l’accezione di esclusiva competenza degli uomini, eventualmente illuminati dalla religione, in un primo periodo, dalla sola ragione in quello successivo; ragione mitigata magari dalla certezza del divino, se non altro perché necessaria all’accettazione del dominio da parte dei subalterni. “Se dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo”, ha tenuto a precisare un illuminista. Dopo la colonizzazione interna all’Europa, l’omologazione delle etnie preesistenti alla ragione del capitale e del nuovo assetto del potere politico, prende avvio il processo di colonizzazione dei nuovi continenti via via scoperti. Il mercato si forma e si amplia su scala planetaria; l’intensificazione della produzione artigianale nel giro di qualche secolo sfocerà nella nascita della media officina, preludio alla fabbrica vera e propria; nuove tecniche agricole determineranno l’aumento delle derrate alimentari. Insomma un nuovo mondo viene via via alla nascita. L’economia tipica feudale è superata: i servi della gleba, costretti ad abbandonare le campagne ormai privatizzate, si riversano sulle città o ai 51 suoi bordi. Immense schiere di indigenti, vagabondi, miserabili rappresentano col trascorrere del tempo un problema consistente per l’ordine costituito, e richiede interventi atti ad arginarlo. Data la gravità del fenomeno la risoluzione non può avvenire secondo il classico metodo della pietà cristiana; altri momenti debbono essere adottati. I valori emergenti dalla fase di accumulazione originaria del capitale, innanzittutto l’etica del lavoro, rappresentano momenti che, affiancati alla pietà, mirano ad arginare l’espandersi dei delitti e l’indecenza della miserabile condizione in cui sono costretti decine di migliaia di uomini e donne. All’atto della scissione dei paesi in Riformati e Controriformati le soluzioni divergono, prevalendo nei primi l’intervento mirante alla disciplina del lavoro (pura etica capitalistica), nei secondi la razionalizzazione della pietà (pura etica cattolico-cristiana). A nostro avviso, però, una tale divergenza non deve essere interpretata in senso assoluto. La risposta delle autorità ad un fenomeno sconosciuto fino allora in quelle proporzioni, è – nel primo periodo – assai contraddittoria. L’apparente arretratezza della risposta dei paesi Controriformati, in realtà nasconde il progetto che nei secoli si manifesta vincente. D’altra parte sarà proprio una delle tendenze della Riforma che, per prima, concepirà il penitenziario come luogo di isolamento totale del detenuto, che così potrà “confrontare” la propria nullità innanzi al nuovo potere, assoluto, invisibile, onnipossente; isolamento che non verrà interrotto neppure dal sacrosanto dovere del lavoro. I due modi di procedere convergeranno verso non una ma molteplici soluzioni, l’una non escludente affatto tutte le altre. 1.3.1 I primordi del penitenziario: Workhouse e Hospital Nel ‘500 vengono costruite le Case di Lavoro e gli Hospital. Ciò che viene perseguito, com’è facile intuire, non è tanto un nuovo modello di pena, che ancora per qualche secolo continuerà ad essere quello tradizionale della forca, della fustigazione pubblica, della tortura e della deportazione-condanna ai lavori forzati nelle navi (galere) del sovrano/Principe. Si cerca, più che altro, di arginare il fenomeno del vagabondaggio e della miseria, nonché di disciplinare le schiere di nuovi proletari alle esigenze della produzione, quindi di alienarli ai valori emergenti che ripudiano “l’ozio”. Non crediamo tuttavia di dover attribuire alle Workhouse (Case di Lavoro) un ruolo produttivo o esclusivamente produttivo, come paiono avanzare diverse interpretazioni. Non sono penitenziari nel vero senso della parola ed anche il disciplinamento è ancora brutale, riguardando esclusivamente il corpo dei reclusi. Il ruolo “produttivo” delle Case di Lavoro è 52 assai limitato, come evidenzia Ignatieff, che afferma essere assai scarsa la richiesta di reclusi, a causa della loro poca redditività, da parte degli imprenditori privati, che prefereiscono rivolgersi alla manodopera disponibile sul mercato dei liberi. L’ideologia della Riforma, che eleva a valore assoluto il lavoro, la produzione, la vita attiva ha ben poca influenza sulle masse diseredate se non accompagnata da riscontri concreti sul livello di vita materiale. Ma la fase di accumulazione del capitale non è affatto adatta ad un tale riscontro. Sarà, al contrario, l’ideologia della Controriforma che saprà portare a sintesi le esigenze della produzione (disciplinamento dei corpi) e del nuovo assetto del potere (disciplinamento delle menti, plasmazione, assimilazione ai nuovi valori). La disciplina, l’adeguamento del corpo dei lavoratori ai ritmi della produzione via via sempre più accelerati, è possibile ai suoi massimi livelli solo se i lavoratori, o una fetta consistente del proletariato, ricevono un incentivo almeno spirituale dato che la fase di accumulazione del capitale non può garantirne di materiali. Sarà l’ideologia che sottende lo Stato moderno a dare una tale incentivazione. Il nuovo Stato non è il regno del Principe, dominio esclusivo del Signore/Sovrano. È, al contrario, la “patria di tutti”, signori e servi, padroni e diseredati. Il nuovo Stato è tutta la popolazione (l’insieme dei “cittadini”, appositamente omologati) intesa come entità reale, viva, organica. Per cui ogni singolo deve riconoscersi in esso. È lo Stato-nazione, concepito come territorio, corpo collettivo con una sorta di intelligenza, una sola propria comune storia e specifici tratti culturali: linguistici, di usi e costumi, di riti e credenze, di miti e razionalità. Poco importa – e perciò viene taciuto e negato – se il Moloch di nuovo conio viene costruito sulle ceneri del genocidio e dell’etnocidio, della omologazione forzata di popoli, etnie e territori alla presupposta unica base dello Stato-nazione! È tale ideologia che, unitamente al disciplinamento dei corpi per esigenze produttive, può incentivare le menti a lasciarsi plagiare, all’interiorizzazione dei valori della nuova società capitalistica-statuale. Lo Stato, inteso modernamente, richiede per la grandezza di se stesso la sottomissione di ciascuno. La sua è la grandezza di tutti, per cui tutti devono riconoscervisi e contribuirvi attivamente, fino ad annullarsi in esso. L’ideologia richiesta affratella i “cittadini” al di là della loro condizione materiale; fra gli uni e gli altri sovrana deve regnare la comprensione e ciascuno deve svolgere il proprio ruolo con convinzione. In quest’ottica chi pecca, delinque, sbaglia è pur sempre figlio dello stesso consorzio umano. Di conseguenza se deve essere punito, anche nella maniera più dura, deve pure potersi riscattare, poter lavare col pentimento 53 e lo sconto della pena il peccato/delitto consumato, rinascere con adeguate cure nel corpo e nella mente alla grande famiglia di cui alla fine condividerà i valori. È in questo spirito che il modello di correzione “workhouse” viene superato ancora una volta da quel potere antico che conosce, prevede ed in parte determina le esigenze del nuovo assetto politico ed economico: il papato. Il superamento è nella logica delle cose. Così, alla costruzione del primo carcere per recalcitranti (figli di ricchi non del tutto consapevoli del proprio ruolo sociale) e vagabondi (Casa di Lavoro), avvenuta nel 1650 a Firenze per opera di Filippo Franci, segue ad appena mezzo secolo di distanza, ancora per ispirazione di Franci e del francese Jean Mabillon, la costruzione del carcere vaticano di San Michele (Roma, 1700 circa). Per la sua struttura architettonica, per le regole che vi dominano, per l’intrecciarsi razionale del momento della costrizione al lavoro e di quello alla preghiera, della forzata riflessione cui sono costretti i detenuti il carcere di S. Michele è da ritenersi, a nostro avviso, il primo vero penitenziario della storia. I modelli successivi, dal Panopticon fino al Filadelfia ed all’Auburn, non sono che modifiche architettoniche ed accorgimenti tecnici di disciplina e manipolazione fisica e psichica dei detenuti, determinati in parte dai progressi delle tecniche e delle scienze di manipolazione delle menti, in parte dalla specificità del potere che li concretizza. Fra la costruzione della prima Casa di Lavoro e degli Hospital da un lato, il carcere di S. Michele dall’altro, vi è l’esperienza del carcere di Great Law, il modello quacchero del 1628, realizzato sotto progettazione di William Penn, in quello che diverrà lo Stato di Pennsylvania, nel Nord America. Mentre nelle workhouse il momento saliente della segregazione è il lavoro, e di conseguenza l’intero arco della giornata del recluso è in funzione della produzione e della disciplina del corpo, l’Hospital privilegia il momento della pietas, della consolazione, della preghiera. Il carcere quacchero supera l’uno e l’altro, ponendosi come preludio al S. Michele. Il modello realizzato da Penn elimina completamente il lavoro e la tortura fisica (prassi rimasta costante, altrove, fino ai giorni nostri, anche se sempre più sostituita da quella psichica). Poi assegna ad ogni detenuto una singola cella, per quanto piccola, priva di ogni arredo se non dello strettamente necessario. In questo spazio limitato e nudo, nel glaciale silenzio, nel soffocamento di ogni attività sensoriale il detenuto trascorre il suo tempo. Solo con se stesso, con la propria coscienza, con i propri “peccati”. Condizioni ottimali per il confronto fra il singolo ed il nuovo potere, onnipossente, invisibile ma presente, Moloch immaginato ma reale in tut- 54 ta la sua potenza, che annulla, soffoca l’infinita piccolezza del recluso. Contemplazione mistica, confronto, pentimento, plasmazione (autoplasmazione), soggiogamento dell’anima del prigioniero non debbono essere interrotti neppure per l’attività lavorativa. Questa la mistica visione del penitenziario quacchero. Considerata la strana somiglianza con il carcere speciale dei giorni nostri, viene spontaneo chiedersi come mai, da allora, non si sia imposto come modello universale. La risposta è possibile, a nostro avviso. Prima di tutto è necessario rifarsi alle condizioni materiali del periodo e valutare concretamente la possibilità di estendere il modello anche ai paesi europei di allora, quando il fenomeno criminale comprendeva vagabondaggio, ed ozio, furtarelli e miseria, prostituzione e ribellione ... tale da renderlo di immense proporzioni: era mai possibile, nella fase di accumulazione capitalistica, dedicare una consistente parte del profitto ad alimentare decine di migliaia di persone improduttive? Certamente no. Inoltre il modello di Penn non sentiva l’esigenza, nella sua misticità assoluta, di realizzare anche architettonicamente un penitenziario che fosse simbolo del potere emergente, dello Stato moderno, onnicomprensivo, onnipresente, da cui tutto si diparte ed in cui ogni cosa confluisce annullandosi. È infine carente sotto l’aspetto della individuazione delle caratteristiche peculiari del detenuto; in altre parole non prevede la personalizzazione della pena, della correzione, dell’omologazione. Più che un modello “troppo avanzato” il carcere Great Law risulta, alla nostra analisi, assai carente rispetto alle condizioni del periodo in cui venne realizzato. 1.3.2 Il carcere vaticano: San Michele Il carcere di Firenze prima e quello di S. Michele in seguito (ed i numerosi altri che furono man mano costruiti in numerose città: Venezia, Napoli, Torino, ecc.), pur essendo nati come Case di correzione per ricchi giovani recalcitranti, abbiamo affermato essere, dopo quello quacchero, i prototipi del penitenziario vero e proprio. Già l’architettura circolare, in cui le celle sono disposte sulla circonferenza e separate dal centro da un ampio spazio, è il primordio del Panopticon. L’obelisco centrale, la navata della struttura domina su tutto; al suo apice la cappella simboleggia la potenza della Chiesa, del potere. La segregazione in singole celle è, in atto, la pratica della differenziazione, con l’aggiunta che stavolta il recluso non è lasciato solo a contemplare se stesso e la propria miserabilità rispetto al “centro/potere”. La navata da cui si dipartono i raggi che delimitano le celle è punto di domi- 55 nio e di osservazione non solo dello spazio fisico ma di ogni detenuto, in tutti i momenti della sua esistenza. Esso viene individuato, controllato, seguito, classificato, valutato. A ciascuno è applicata “la correzione specifica”, in base alle sue propensioni, ai suoi reali comportamenti ed atteggiamenti, alle “carenze” manifestate. Il lavoro, pur essendo momento essenziale non è quello esclusivo: si vuole correggere mens et corpore, anima e corpo ed è tutto funzionale a tale correzione. Solo l’armamentario ideologico e pratico del cattolicesimo poteva concepire una siffatta architettura, rispecchiante simbolicamente certo il potere della Chiesa ma riflettendo finanche il potere del nuovo Stato, assoluto come quello, totale come quello, onnipossente ed onnipresente come quello. È la realizzata fusione dei due modelli di potere costituito: invisibili ma altrettanto reali e potenti, impersonali ma materialmente accessoriati di orecchi ed occhi, di armi e di uomini per punire, condannare, correggere. Il nuovo potere aveva necessità di essere simboleggiato in maniera tale da venire introiettato nella coscienza di ciascuno, soprattutto dei non omologati. Solo la Chiesa cattolica, dominio ormai millenario, era in grado di assolvere questo compito. Ecco perché il suo modello, ulteriormente perfezionato, verrà fatto proprio anche dai paesi riformati e che per volere ed ispirazione di Bentham prenderà esattamente il nome di Panopticon (letteralmente “visione totale”). Si tratta, invero, della laicizzazione del modello cattolico. Il progetto benthamiano fu realizzato a Richmond, nella Virginia, alla fine del ‘700 (1797). È il modello che realizza pienamente la sintesi fra simbologia, controllo totale, disciplina, differenziazione: la nuova autorità è ormai nella sua piena maturità. 1.3.3 Il carcere moderno: modelli e finalità Prima di concludere questa prima parte del lavoro, crediamo utile una breve parentesi per mettere a fuoco alcuni momenti su cui i vari studiosi hanno basato l’esistenza del penitenziario, la sua funzione, le eventuali contraddizioni e le riforme che hanno imposto modelli nuovi. Il carcere è nato esattamente nel momento in cui è sorta la necessità per il potere costituito di amalgamare le coscienze, i comportamenti, i corpi e le menti vuoi alle esigenze del modo di produzione capitalistico, vuoi ai nuovi valori. Ma sia il modo di produzione, sia i nuovi valori generano contraddizioni insanabili: se vi è padrone vi è pure schiavo; il privilegio richiede come contropartita la miseria dei più; l’accumulazione è esproprio; il potere istituzionalizzato si esercita sui comandati. La ribellione è 56 ineliminabile per cui il processo di omologazione delle coscienze non è facile, soprattutto nel momento in cui la soppressione fisica, il massacro di singoli e di popoli non è più giustificabile. Il pretendere l’adeguamento, comunque, ai valori fondamentali di un sistema sostanzialmente basato sulla ineguaglianza, sfruttamento, obbedienza cieca, necessita di giustificazioni ideologicamente fondate. I principi su cui si basa il penitenziario, vale a dire quel sistema punitivo che prevede lo sconto della pena inflitta entro una struttura architettonicamente definita e regolata da proprie norme, che privano l’internato della libertà e dei rapporti propri della società civile, sono stati individuati in: 1) rieducazione del condannato; 2) deterrenza della pena e del carcere; 3) proporzionalità fra delitto e castigo. Oltre alle contraddizioni che verranno fatte emergere più avanti, è bene chiarire che per rieducazione del condannato si intende la sua assimilazione ai valori che in un modo o nell’altro non ha rispettato, quindi che non gli appartengono. Il principio della deterrenza è quello che vuole letteralmente terrorizzare e il condannato e la società tutta, affinché non incorrano in disubbidienze all’ordine decretato. La proporzionalità fra il delitto commesso ed il castigo inflitto denuncia la consapevolezza della ineliminabilità del fenomeno delinquenziale in un sistema socialmente, economicamente e politicamente ingiusto, per cui è necessario usare nell’atto repressivo una sorta di graduatoria tra gli attacchi sostanziali e quelli invece marginali. Tutti e tre principi sono stati posti in discussione anche di recente, quando è divenuto ormai evidente alla coscienza comune il divario tra i fini perseguiti ed i pratici riscontri. La rieducazione è marginale: non a caso la recidivia è comune fra i reclusi. La deterrenza manifesta i propri limiti nel momento in cui il fenomeno criminale diventa sempre più consistente. La proporzionalità fra delitto e castigo è del tutto invalidata vuoi dalla carcerazione preventiva, vuoi dal fatto che la galera comminata è in funzione, oggi, più che del delitto commesso, della persona che lo commette. Anche l’analisi che ha fatto dipendere meccanicisticamente il carcere e le sue riforme dai momenti salienti dell’evoluzione del modo di produzione capitalistico, si è dimostrata alla luce dei fatti sostanzialmente ideologica. Così ci appare del tutto inconsistente il tentativo di far coincidere il penitenziario nei suoi modelli storici, con le varie “fasi” del capitalismo: “carcere mercantile”, quello “capitalistico-industriale” nelle sue pratiche 57 realizzazioni di “carcere concorrenziale” e “carcere monopolistico”; fino all’apice che si presume ultima fase del capitalismo, il modello di “carcere imperialista” (Controinformazione). Se è indubbio che il momento economico ha contribuito in qualche misura alla “forma carcere”, ci appare peraltro forzato parlare di variante produttiva e variante improduttiva del penitenziario. In realtà il sistema penitenziario, a nostro parere, non è altro che l’esito per tentativi ed errori di razionalizzare più che sul momento prettamente economico su quello del consenso al potere costituito le contraddizioni, le opposizioni, le alterità etniche, culturali ed individuali, entro un progetto di massima mirante all’assenso generalizzato necessario per tenere in piedi un sociale lacerato e lacerante. Tentativi ed errori che si affinano via via nell’utilizzo delle scienze e delle tecniche di manipolazione delle menti e dei corpi (psicologia, psichiatria, sociologia ecc. ecc.). Un tale progetto lascia ampio spazio ai diversi sostrati ideologici propri delle aree specifiche ai singoli Stati, e propri delle riforme che in ciascun’area poi si verificano. Superata la fase primordiale del penitenziario, che vede divergere sul piano pratico il modo di intendere il carcerario da parte della Riforma e della Controriforma, tutto converge verso un’unica soluzione che, oltre le differenze di ordine tecnico, si confondono nel contenuto e nelle finalità. Sarà la Chiesa tradizionale ad individuare contenuti e finalità perseguiti, proprio in quanto forte dell’esperienza millenaria di gestione del potere. Anche la prassi della pena capitale, della tortura, della differenziazione, nonché della deportazione trovano nell’ideologia cristiano-cattolica il proprio fondamento, estremamente funzionale al nuovo potere tanto che neppure i riformatori razionalisti la elimineranno del tutto. Il teorizzare “Dei delitti e delle pene” (Beccaria) sulla inutilità della tortura, se può essere soddisfacente dal punto di vista teoretico in quanto conforme all’ideologia che permea lo Stato moderno, nella sua applicazione pratica deve scontrarsi da una parte con l’irriducibilità alla ragion di Stato di individui perciò definiti “criminali incalliti irrecuperabili”, dall’altra con l’alterità di culture e di etnie assolutamente estranee ai valori della civiltà dell’Europa capitalistica. Da qui la prassi della tortura ancora ai nostri giorni, se si vuole più “pulita” ma non per questo meno tortura; da qui il mantenimento della pena capitale in tanti luoghi; da qui la prassi del genocidio, della sistematica eliminazione fisica di quanti, singoli individui o popoli non si riconducono alle ragioni imposte dal dominio. Il carcerario dei nostri giorni è appunto ancora tutto ciò. Vi è contraddizione con l’ideologia della religione cristiana della sal- 58 vezza? Assolutamente no! La contraddizione è solo apparente. Il principio fondante vuoi della Chiesa vuoi dello Stato-nazione risiede nel loro ritenersi assoluti, esclusivi, unici. Tutto ciò che ad essi si riconduce ed in essi si annulla è degno di valenza; è privo di ogni valore tutto ciò che invece è altro, irriconducibile ad essi, irriducibile alle loro ragioni. Si mira al recupero per quanti si rendono disponibili; alla tortura, alla forca, all’annientamento per gli altri. I primi assurgono a fratelli che “sbagliano”, i secondi vengono ridotti a quello che in realtà rappresentano: entità altre, non riconosciute, e pertanto appartenenti ad una sorta di esseri subumani (eretici secondo le categorie cristiane). È il duplice atteggiamento di chi ripone ogni valore nell’ente assoluto, nell’uno onnipotente; di chi in patria rifocilla il derelitto, la prostituta, il mendico, ma che contemporaneamente impala, arrostisce, tortura, squarta ... e perpetra genocidi. È la prassi dello Stato che fa la ramanzina alla prostituta, al drogato o allo scippatore, ma che allo stesso tempo lacera le ossa e l’integrità psichica dei compagni prigionieri e dei proletari irriducibili. L’alterità può essere immediatamente politica oppure indirettamente tale, ma non muta assolutamente nulla. Per questo motivo il carcere speciale di oggi è la cayenna vuoi dei compagni rivoluzionari, vuoi dei proletari che per un motivo o l’altro rappresentano alterità rispetto ai canoni prefissati e propri del potere costituito. L’illusione secondo cui il progresso delle scienze e delle tecniche di controllo e di manipolazione delle coscienze alla fine avrebbe determinato la scomparsa della tortura, dell’esecuzione capitale, della deportazione e del carcere ha perso ogni consistenza. L’epoca del positivismo è stata forse quella che maggiori speranze ha dato in questo senso, quando pareva aver individuato nelle orecchie a sventola, nella forma cranica e nel naso aquilino l’origine del crimine. Ma poi il tutto è finito nel nulla. Il “superamento” del penitenziario, l’estendere su tutto il sociale la funzione propria del carcerario è ipotesi che presuppone l’adeguamento sempre e comunque di tutti alle norme vigenti. Il che è praticamente assurdo. È necessaria, unitamente a quella forma di “carcere diffuso nel sociale”, l’esistenza della variante definita “Torre di Londra”, luogo di annientamento, di isolamento totale e di tortura degli irriducibili; pena l’esistenza dello stesso sistema vigente. Il quale deve pur sempre fare i conti con tutta una serie di varianti: realtà individuali, territoriali, collettive altre. A fianco del carcere “normale” vi sarà sempre quello “speciale”, a regime duro. Il penitenziario come deterrenza nel sociale ha sicuramente perso consistenza. Però continua a manifestarsi uno dei momenti ideologici che 59 nella pratica perenne dell’emergenzialità assolve una reale funzione: assume il ruolo di catalizzatore dell’attenzione della civile società in tutti quei momenti critici in cui il sistema vede vacillare il consenso. Il regime della differenziazione dei detenuti e della detenzione richiede pure la sussistenza dei “braccetti speciali”, la cui funzione è prettamente interna, di deterrenza per il corpo prigioniero “comune”. Frantuma i carcerati tra “buoni e cattivi”, tra “speciali e comuni”. Ciò spiega da un lato l’esistenza del carcere nella sua variante “speciale” (la Torre di Londra) e dall’altro la contemporanea esistenza del circuito carcerario “comune”. L’uno e l’altro non risolvono il “problema criminale” in alcun modo, ma rappresentano la più razionale sistematizzazione della contraddizione propria della società divisa in classi ed il suo utilizzo per la creazione del consenso, in un progetto che manipola le coscienze e le utilizza a fini di stabilità. 60 Parte Seconda Il fenomeno criminale sardo nella sua specificità’ 61 Capitolo Primo La cultura resistenziale 2.1.0 La problematica Il processo politico ed economico generale che ha caratterizzato l’Europa dalla dissoluzione dell’impero romano ha interessato la Sardegna solo parzialmente. Nello specifico non vi è stato né processo di accumulazione originaria del capitale, né quel movimento politico che ha determinato la costituzione dello Stato Moderno. Non perché fosse assente un qualche impulso in tal senso, bensì in quanto, paradossalmente, gli impulsi autoctoni vengono soffocati nel rapporto di colonizzazione determinando, a partire dalla occupazione iberica (intorno al XIV secolo), un’evoluzione storica inversa a quella del resto del continente. Vedremo infatti che a seguito della dissoluzione dell’impero bizantino – di cui l’isola è stata una provincia per diversi decenni – l’antica realtà della città-Stato Shardana, liberata dalla presenza di occupanti, si evolve in Stato vero e proprio (Giudicato) grazie anche alla struttura millenaria del colono ed ai danni da questo fatti a scapito delle comunità selvagge dell’entroterra. Il Giudicato, che per certi versi rappresenta in nuce, con mille anni d’anticipo, lo Stato-nazione, si erge sullo sviluppo del potere accentrato della civiltà Shardana da un lato, e dall’altro sul tentativo che mira a snaturare, quindi ad espropriare il potere autodeterminato e diffuso nel sociale, proprio delle comunità interne. La brutalità con cui vuole imporsi, estendendosi dalle città costiere alle zone interne, è in un certo qual modo mediata dalla strumentalizzazione di alcuni istituti comunitari, attraverso i 62 quali si manifesta l’autodeterminazione delle comunità selvagge. Il tentativo di trasformare i bonos omines dei villaggi in burocrati del Giudicato è un esempio della politica statale autoctona. Ciò prova da una parte l’estrema intelligenza dei “Principi” nostrani, d’altra parte l’alta probabilità della statizzazione delle popolazioni dell’interno se un tale processo non fosse stato bruscamente interrotto dall’occupazione spagnola. L’avvento della colonizzazione iberica rompe il meccanismo di intelligente progressivo esproprio del potere selvaggio e determina l’imposizione del sistema feudale “puro” in tutta l’isola, nell’esatto momento in cui altrove ha di già preso piede il processo del suo superamento. Così importato, il feudalesimo rimarrà in pieno vigore in Sardegna fino alla metà del XIX secolo. Le comunità dell’entroterra, come vedremo ben poco consenzienti alla politica di deculturazione avanzata dai Giudicati nell’arco di sei secoli, si irrigidiscono del tutto con gli iberici, in una posizione di resistenzialità che non è solo umana, fisica, ma culturale. Tuttavia sono gli spagnoli ad attuare una radicale inversione di tendenza nei confronti della società selvaggia, ampliando a dismisura le maglie di quei limes che, eretti dai romani e riedificati dallo Stato giudicale, hanno la funzione di arginare la dirompente forza delle comunità dell’interno, che fino ad allora non hanno mai dismesso la possibilità/utopia della riappropriazione dell’intera isola. Gli iberici, infatti, applicano la politica della relativamente libera circolazione delle genti e soprattutto degli armenti, bisognosi stagionalmente dei pascoli delle Baronie e dei Campidani; liberalizzazione che avviene ovviamente dietro compenso (tot a capo di bestiame). La transumanza delle greggi e la circolazione delle genti se da un lato ravvivano i mai dismessi contatti fra le popolazioni dell’interno e quelle prossime alle coste – contribuendo in tal modo a mantenere in vita la cultura autoctona in lungo ed in largo –, dall’altro lato (e lo vedremo meglio più avanti) creano le condizioni per la nascita delle prime contraddizioni che sono alla base della divisione sociale delle comunità dell’entroterra. È in questo frangente che il “banditismo” assume una fisionomia strutturalmente diversa rispetto al passato, e che – accentuato a partire dalla occupazione piemontese (1720) – caratterizzerà il fenomeno fino ai giorni nostri. La “criminalità” specifica sarda altro non è che il momento saliente del rapporto di forza che si instaura tra l’entità statuale esterna (colonizzatore) ed interna (prima la città-Stato Shardana, poi il Giudicato) da una parte, e dall’altra la società selvaggia costituita dai villaggi dell’entroterra; rapporto di guerra totale il cui esito finale è o la statizzazione delle genti isolane, oppure la sconfitta della società con lo Stato. È la guerra tra due 63 culture altre, irriconducibili a simbiosi. La vittoria di una decreta la sconfitta totale dell’altra, senza possibilità di compromessi. È in questo quadro succintamente anticipato che prendono forma il banditismo e la specificità della repressione statale, la resistenzialità culturale isolana e la particolare conformazione della “lotta alla criminalità” sarda. 2.1.1 Società selvaggia e città-Stato Shardana: l’autoctonia Non entreremo nel merito della questione relativa al fatto se l’isola abbia oppure no sofferto del dominio punico. Si tratta di questione controversa su cui le antiche e le recenti interpretazioni storiche possono essere ribaltate da sempre più accurate ricerche archeologiche. D’altra parte, però, ci sembra evidente che le più accreditate – fino a qualche decennio addietro – tesi storiche “unilaterali”, sono destinate ad essere completamente capovolte, soprattutto rispetto al ruolo attribuito alla Sardegna, troppe volte costretta a subire, in tali ricostruzioni, una situazione di assoluta passività, culturalmente, militarmente, politicamente. Nello specifico, il suolo isolano sembrerebbe – fin dalla notte dei tempi – una sorta di foglio bianco su cui tutti i potenti dell’area mediterranea hanno scritto qualcosa; unici esclusi gli stessi sardi, ovvero quelle genti che, in tre ondate successive, sono approdate all’isola, stabilendovisi definitivamente almeno dal 5000 circa Avanti la Nostra Era (A.N.E.). A tale epoca infatti i “reperti” archeologici daterebbero la prima ondata di genti neolitiche che hanno popolato l’isola. In tempi a noi più recenti, una seconda ondata, stavolta di schiatte megalitiche, vi si stabilisce ugualmente, amalgamandosi con le prime. Da questa confusione di genti diverse si sviluppa la civiltà nuragica, vera e propria cultura “circolare” che anche architettonicamente riflette la società selvaggia isolana. La civiltà nuragica si estende, almeno fino alla parziale occupazione romana, in tutta l’isola, dalle coste al più remoto entroterra. Ne fanno fede i circa 8 mila nuraghi che la costellano in lungo ed in largo, di cui diverse centinaia hanno resistito quasi integri alla barbarie del tempo e degli uomini. Indelebili testimonianze di una società caratterizzata dalla indivisione economica e sociale, il cui “principio che reggeva la loro organizzazione era di libertà e uguaglianza” (R. Carta Raspi). Gli studi etno-antropologici hanno definitivamente chiarito che l’organizzazione, la struttura primordiale della specie umana sul piano sociale, non è la famiglia ma la tribù: insieme di famiglie strutturate in clan. Non potrebbe fare eccezione la società nuragica, per cui non condividiamo appieno la tesi di Carta Raspi che afferma essere, i “villaggi” attorno ai 64 grandi plessi nuragici, strutture atte ad ospitare quanti vi si recavano in occasione delle fiere, feste comuni ecc. Si tratta, a nostro parere, di strutture di villaggio abitate stabilmente, quindi di spazi occupati dalle singole tribù, più o meno distanti le une dalle altre, sia pure in stretto rapporto tra di esse. Rapporto che non è da intendere come pacifico o solo pacifico, ma anche cruento, in quell’universo di precario ordine intertribale, in cui gli amici ed i nemici vengono costantemente rivalutati a seconda delle specifiche circostanze. Fatto che trova conferma ancora oggi nella costellazione dei paesi “amici” e di quelli invece considerati “nemici”, tipica di ciascuna comunità. Anche la composizione della singola tribù è attraversata all’interno dai contrasti interindividuali e interclanici, per cui l’ordine sociale è costituito dall’equilibrio sempre precario dei rapporti di forza presenti. Infine, i singoli clan sono a loro volta legati da vincoli di sangue a clan di altri villaggi, per cui, spesso, si intrecciano amicizie e contrasti che finiscono per coinvolgere diverse tribù. Come in tutte le società selvagge, anche in quella nuragica il potere non è accentrato in alcuna componente né individuale né collettiva. È indiviso nell’amalgama dei rapporti dei singoli e dei clan. Ciascuno gode del suo specifico prestigio, che mantiene manifestando la propria valenza, il proprio valore, la propria balenthìa. Per balenthìa è da intendersi forza fisica, intelligenza, astuzia, capacità di relazionarsi nel sociale, di stringere amicizie, di allargare il proprio ambito d’influenze, di ben selezionare i possibili alleati. È pure possibile avanzare l’ipotesi che anche per quella nuragica l’indivisione interna della tribù sia almeno in parte determinata dal perenne stato di guerra-guerreggiata con l’altro da sé, cioè il “nemico”, identificato ora con questo ora con un’altro villaggio, in quella sempre mutevole composizione cui abbiamo accennato più sopra, che è l’universo degli amici e dei nemici. Ciò non è affatto da escludersi perché solo la guerra – concepita più che col fine di annientare l’altro da sé, come momento capace di ammortizzare i contrasti interni a ciascuna tribù – verso l’esterno ridetermina un nuovo sia pur precario equilibrio tra le varie componenti il gruppo sociale. Per equilibrio interno non deve intendersi l’assenza di contrasti, competizioni, diversità, antagonismi. Questi, al contrario, sono momenti sempre presenti, scaturenti dal fatto che reali sono i particolari interessi di ogni individuo, ogni famiglia, ogni clan, e per questo motivo vengono a scontrarsi con l’interesse degli altri. Particolare attenzione merita, nell’economia del nostro lavoro, il modo in cui nascono i contrasti e la prassi posta in essere per ricomporli. Vedremo che la costante che emerge nei singoli casi trattati, concernenti il fenomeno del banditismo sociale e delle faide, è 65 il porre in essere alcuni specifici momenti della cultura selvaggia sarda; per cui non possiamo esimerci dal trattarne sia pure molto succintamente in questa sede. La cultura selvaggia garantisce ed è espressione della sovranità degli individui, delle famiglie, dei clans, della comunità. La sovranità è determinata da un ambito materiale e spirituale posto in essere dall’ente specifico, che manifesta la forza di tenerselo e ne pretende il rispetto dagli altri (kustu est su meu – questo è il mio). Nel momento in cui un ente esterno mette in discussione tale sovranità, il contrasto è inevitabile. A questo punto l’equilibrio preesistente è posto in discussione. Si tratta di valutare se tra le parti in conflitto vi sia oppure no volontà di offesa ai danni dell’avversario. L’offesa nell’universo culturale che trattiamo, è da intendersi come negazione di valore, non riconoscimento della sovranità altrui. Chi subisce l’offesa deve dunque porre in essere atteggiamenti atti a dimostrare il possesso effettivo del proprio spazio di sovranità, in altre parole deve manifestare la propria balenthìa (il proprio valore, in quanto entità che vale). Tali atteggiamenti si concretizzano come prassi della vendetta, attraverso cui l’ente offeso dimostra all’altro ed a se stesso la propria validità nell’ordine sociale e pretende il rispetto della sua sovranità. Se offesa non vi è il contrasto può essere ricomposto vuoi dalle trattative dirette intercorrenti fra le parti in causa, vuoi facendo ricorso a quanto dice il bon’omine (figura che non è da intendersi sovra pares, semmai fuori dalle parti). Nella ricomposizione degli attriti, avvenuta in questo modo – cioè pacificamente – può anche esservi il risarcimento del danno subìto da una delle due parti, a seconda dei casi reali specifici. Se invece la ricomposizione non avviene, si entra nell’ambito della disamistade (inimicizia), caratterizzata da ritorsioni vendettali graduate sulla base dell’offesa che si riceve. In una situazione non determinata da fattori esterni (quali la presenza di una entità che dall’esterno coarta la situazione conflittuale, ad esempio in situazione di colonizzazione) anche la disamistade può trovare soluzione senza spargimento di sangue da ambo le parti. La comunità, infatti, è ben attenta a valutare la gradazione delle ritorsioni, seppure non interviene in altro modo nel conflitto. La valenza di un ente è strettamente connessa alla sua adesione alle normative della comunità, tra cui si annovera la risposta adeguata all’offesa ricevuta. Pertanto, di solito, le fazioni in lotta si attengono a su konnotu (il conosciuto, quindi la normativa vigente). Anche nella vera e propria faida, che inizia quando le ritorsioni vendettali causano la morte di qualcuno, la comunità non interviene; al- 66 meno fino a quando non viene posta in discussione l’esistenza di tutti e l’ordine sociale comunitario. Spesso le faide finiscono per vedere schierata nelle fazioni contrapposte anche quasi la totalità dei componenti dei villaggi interessati, ma ciò è documentabile esclusivamente in epoca di pieno dominio coloniale, per cui è intuibile l’influenza che l’occupante esercita allo scopo di determinare l’autoconsunzione delle comunità. La prassi della vendetta è la logica conseguenza dell’autodeterminazione del singolo e del corpo collettivo. Gli enti in contrasto agiscono direttamente, in prima persona, senza delegare ad altri la ricomposizione dell’ordine che sentono infranto. È esclusione dell’altro da sè dall’orbita della propria sovranità, è azione diretta, non delegata ad alcuno, mirante a ristabilire l’equilibrio in cui deve trovare posto la propria valenza, messa in discussione dalla rottura dell’ordine preesistente. Nella società selvaggia è assai rilevante il ruolo svolto dal “capo”. Contrariamente a certa concezione eurocentrica però, il “capo” selvaggio – al pari di tutti gli altri componenti la comunità – non ha effettivo potere di comando: se pure desse ordini a qualcuno, nessuno gli ubbidirebbe, e non avrebbe alcun mezzo per supportare l’imperio. Il “capo”, nonostante tutto, ha grande prestigio e ciò è dovuto alle sue doti di uomo saggio, ponderato, ricco di esperienza, pertanto in grado di dare credibili consigli. Le comunità riconoscono queste doti non solo in uno, ma in più individui; si tratta dei bonos omines. La funzione sociale di tali figure ed il prestigio di cui godono sono strettamente derivanti dal fatto che dicono il vero, cioè esprimono pareri validi, giudizi saggi qualora interpellati. Il bono omine incarna la figura ebraica del giudice; così come incarna la figura del capo selvaggio amerindio – ben descritto da Clastres – il cui compito è di parlare, quindi di esprimere giudizi, pareri. La lingua latina ha egregiamente tradotto il termine ebraico che la esprimeva: iusdicis (da cui judex dicis) cioè colui che dice il dritto, il giusto. Fino a quando rimarrà una traccia di cultura sarda, il ricorso a sos bonos omines (andare a omine) avverrà ogni qualvolta i contrasti fra componenti la comunità rischiano di scadere in faida. L’esistenza stessa del bon’omine, ancora oggi – sia pure nelle sole comunità dell’interno – pregna di prestigio, ma assolutamente priva di potere d’imperio, testimonia della sopravvivenza fino ai giorni nostri di tratti e momenti della cultura selvaggia elaborata nel corso dei millenni dalle genti neolitiche e megalitiche che popolarono l’isola. Sappiamo pure, però, che lo judex dicis, il giudice ebraico, nel trascorrere dei secoli ha finito per accentrare su di sé potere d’imperio effettivo, quindi la capacità di emanare norme e di farle rispettare: in altre parole 67 è divenuto “re”. La medesima cosa possiamo constatare in quella realtà a cui hanno dato vita le ultime genti approdate il Sardegna, gli Shardana, stabilitisi in riva al mare quando la civiltà nuragica ha ormai raggiunto la propria piena fisionomia: si tratta delle città-Stato costiere (Nora, Bithia, Tharros, Kornus, ecc.). È certo che fra le prime genti neolitiche e megalitiche da una parte, gli Shardana dall’altra, si è stabilito una sorta di modus vivendi che ha permesso un reciproco scambio spirituale e materiale, provato dal fatto che l’arte nuragica del bronzo è presente in molteplici coste del Mediterraneo. Il fatto poi che i bronzetti rappresentino, tra le altre cose, navicelle con indubitabili guerrieri nuragici è pure prova incontrovertibile della partecipazione dei componenti le popolazioni dell’interno alle “imprese” marinare – commerciali o di altra natura poco importa in questa sede stabilire – delle città Shardana. Si tratta quasi di sicuro non di partecipazione di “massa”, bensì individuale: mercenari, hanno avanzato alcuni, ma non è da escludersi qualsiasi altra forma di compartecipazione alle imprese via mare. Imprese guerresche o commerciali che fossero i sardi Pelliti (così vengono appellati i sardi delle zone interne dai cronisti latini o romanizzati, a causa delle loro vesti in pelle, o meglio della mastruca sulle vesti), possono così manifestare le proprie energie di valorosi guerrieri finanche nel difendere sul mare ed altrove i propri carichi, o nell’aggredire nei posti di sbarco chi volesse opporsi alla loro presenza. Contatti stretti e continui fra Shardana e Pelliti, ma non simbiosi, soprattutto sul piano politico. Possiamo presupporre anche un certo livello di sincretismo culturale (specialmente sul piano religioso); ma è chiaro che la società nuragica non perverrà, per millenni ancora, al potere accentrato, come invece si verifica nelle città Shardana. Non poteva essere altrimenti! La città, grosso agglomerato di popolazione e strutture edificate, impone un sistema di vita che nel villaggio è escluso. Nella città la stessa realizzazione di strutture ed infrastrutture (strade, fogne, porti, acquedotti ...) richiede da una parte competenza, dall’altra la delega ad organi preposti non solo alla costruzione ma finanche alla loro gestione. Contrariamente a quanto accade nella vita di villaggio, in cui tutte le funzioni fanno capo ad ogni individuo, autofondato ed autosufficiente, nella città il capo, o i capi hanno nel corso del tempo possibilità non solo di stabilire definitivamente il proprio ruolo ma finanche di concentrare su di sé, via via, tutta una serie di funzioni che in seguito sub-delegheranno ad altri (funzionari). Così è per le città-Stato Shardana. Qui, le istituzioni in cui si esplica il potere sono: il Giudice, il Senato e l’Assemblea dei cittadini. Si tratta di strutture tipiche di tutte le città-Stato conosciute. Il che è sicuro indizio per 68 approfondire – oltre le schermature ideologiche – la tematica propria dell’antropologia politica, sull’origine del potere accentrato dalla situazione di potere diffuso nel sociale. Le tre istituzioni ora dette rappresentano la forma compiuta della città-Stato. È lo stadio in cui il potere accentrato è limitato in un certo qual modo dall’assemblea dei cittadini che ratifica o rettifica le decisioni del Giudice, oppure che decide ex-novo su qualcosa di importante. È evidente che si tratta dello stadio in cui emerge la figura del “re” da quella di “capo” (judex dicis). Non raramente il capo selvaggio è anche colui che ha doti di condottiero in guerra. Nella situazione determinata dallo stanziamento della tribù in un dato territorio, in cui si da corso alla guerra-scaramuccia tra villaggi più o meno vicini, il fattore belligerante, se pure è momento costante della vita viene ad inserirsi comunque entro una situazione più generale, consistente anche in rapporti di continue pacificazioni ed altrettanti mutamenti nella costellazione dell’universo degli “amici” e dei “nemici”. Questa condizione viene a mancare nel momento in cui si verifica lo sciamare di una tribù, di un popolo, di una schiatta alla ricerca di quello che infine diverrà il proprio territorio. Soprattutto qualora il pellegrinaggio perduri nel tempo. In tale frangente i ruoli di judex dicis e condottiero vengono non solo a confondersi ma a stabilizzarsi definitivamente. Non esistendo più limite alcuno fra la guerra e la vita civile, essendo in realtà la medesima condizione, il capo finisce per trasmutare il prestigio originario in potere effettivo. Il rapporto comando-obbedienza, riconosciuto solo in particolari frangenti (precisamente nell’ambito della guerra e della caccia), prende consistenza. La stessa carica di capo-re, date le condizioni, diviene infine ereditaria e gli stessi guerrieri finiscono per diventare un vero e proprio ceto. La dimidiazione della comunità ha fatto la sua comparsa. A questo punto il fatto che la società intera cerchi di erigere argini da frapporre al progressivo accentramento del potere da parte del re (Giudice) e dei ceti privilegiati (Senato, costituito dai Principas, nelle città Shardana), le periodiche assemblee a null’altro servono se non a legalizzare l’esproprio del potere collettivo, quindi la dimidiazione sociale. La società selvaggia è ormai scomparsa per lasciare il posto a quella statuale. Riteniamo che la civiltà nuragica sia rimasta selvaggia o perché la sciamatura dei neolitici e megalitici che hanno popolato l’isola sia durata relativamente poco tempo, per cui non si è verificata la condizione di guerra appena descritta; oppure in quanto i meccanismi della dimidiazione, una volta stabilitisi in Sardegna, sono stati in certo qual modo riassorbiti dalla cultura a-statale. Al contrario, riteniamo che la cultura dei Shardana – anche perché si tratta di schiatte già urbanizzate – o ha di già introiettato 69 gli elementi di organizzazione statale al momento della sciamatura; oppure ha subìto la condizione di cui sopra prima di approdare nell’isola. Il Giudice Shardana assomma nelle proprie mani il potere “civile” e quello militare. Contrariamente a quanto potrebbe credersi, almeno nel primo periodo non ha affatto il potere di giudicare gli eventuali “criminali” (tale compito spetta ai magistrati civili). Egli rappresenta l’unità, l’identità politico-umana del gruppo sociale e contemporaneamente è il capo militare. Come tale ha imperio nell’ambito della guerra ed è in quest’ambito che si concretizza il rapporto comando-obbedienza. Il potere civile altro non è che la rappresentanza della comunità nei confronti delle entità altre (amici, nemici, ecc.). Esattamente come il capo dei selvaggi delle Americhe, che è allo stesso tempo “colui che dice il giusto” (jus dicis), condottiero in guerra, e rappresentante della tribù nei contatti con “l’estero” (una sorta di ministro degli esteri – Clastres – solo che questi rappresenta lo Stato, non le popolazioni). Il Giudice Shardana quasi sicuramente è affiancato da un altro suo pari, in parte per coadiuvarlo nelle sue funzioni o per controllarlo allo scopo di evitare che agisca oltre i compiti che gli sono propri. Come in tutte le altre città-Stato, anche in quelle degli Shardana la carica di Giudice è elettiva ed annuale. Il controllo sul suo operato spetta al Senato, costituito dai Principas, rappresentanti dei ceti privilegiati per ricchezza . L’Assemblea cittadina si riunisce solo per eventi straordinari e nel suo seno viene eletto il Giudice, ma non si sa con certezza se anche il Senato. Per cittadini si intendono i liberi ed i servi. Quando tratteremo dei Giudicati vedremo meglio la condizione di questi ceti. Come è facile vedere, la situazione politica delle città Shardana è pre-statale; non a caso da esse si svilupperà lo Stato Giudicale. Si tratta di una condizione affatto diversa da quella nuragica. Sul piano della giustizia l’individuo è del tutto espropriato del potere che invece vanta nell’ambito della vendetta. Sul piano della normativa sociale basta pensare che mentre la interna società selvaggia non accorda privilegi ad alcuno, quella Shardana non ammette che i principas, per quanto caduti in miseria, possano comunque essere ridotti alla infima classe dei servi (Carta Raspi). Ciò a significare quanto distanti siano i due universi sociali. Nel momento in cui avviene la sicura occupazione romana la situazione dell’isola è caratterizzata dalla presenza sulle coste delle città-Stato presumibilmente con un loro entroterra, da una parte, e dall’altra i nuragici (i pelliti, secondo alcuni, gli iliensi secondo altri appellattivi), occupanti il resto della Sardegna ed equamente presenti dai limiti dell’entroterra cit- 70 tadino fino ai più interni monti. I rapporti tra questi due universi, pur esistenti, data la sostanziale diversità politica non possono pervenire a confusione e quando i colonizzatori conquistano le città e il loro entroterra, ed estendono la loro presenza fin nelle pianure, i nuragici si ritraggono per quanto possono verso le impervie zone montuose dell’interno, senza rinunciare ancora per secoli all’attacco contro l’invasore per cacciarlo dalle terre un tempo loro. Impediti nell’utilizzo di quei territori e costretti ad una assai limitata circolazione, si adattano ad una vita materiale che nell’allevamento del bestiame e nella scarsa agricoltura praticabile, nonché nella caccia trova i suoi elementi principali. 2.1.2 La “bardana” classica: attacco all’occupante Romano Nel III secolo A.E.V. i Romani conquistano prima Olbia (236), l’anno successivo Cagliari e quindi le altre città-Stato, eccetto Kornus. Fino al 231 una sola volta vengono a contatto con i Pelliti, quasi di sicuro nell’attuale Trexenta, dove inizia il Campidano di Cagliari, anche questo occupato dalle legioni dell’invasore. Nel 215 A.E.V., sconfitte tutte le altre città costiere, i romani s’apprestano a conquistare Kornus. Nel momento in cui intrattengono la prima battaglia con le armate della città, il Giudice Amsicora non vi può partecipare, essendosi recato a chiedere aiuto alle tribù dell’interno, di cui solo alcune si uniscono ad esso. Dopo la prima vittoria sugli invasori (ben 4 legioni romane sono sconfitte, secondo alcuni storici) l’esercito sardo è sgominato. Kornus viene completamente distrutta tanto che ancora oggi è difficile trovarne i resti e l’esatta ubicazione. Caduta Kornus per l’occupante vi è la certezza della definitiva conquista di tutta l’isola, ma così non è. La stessa situazione or ora descritta dimostra incontrovertibilmente non solo la separatezza dell’universo Shardana da quello nuragico, ma altresì l’assoluta indipendenza di questo e la totale autonomia di ciascuna tribù (non a caso solo una, al massimo qualche tribù delle miriadi che costellano l’isola si uniscono ad Amsicora). Per i Romani inizia non l’epoca della “pacificazione” ma quella più cruenta della perenne difesa dei territori occupati (Baronie, Campidani e città costiere) dai quotidiani attacchi dei Pelliti per liberarli. Ogni tentativo di sottomettere i nuragici è destinato a fallire. Come già accennato, i nuragici presenti nelle zone costiere si ritraggono verso l’interno. Qui cercano di mantenere integri gli istituti socioculturali propri, nella piena indipendenza. Ben presto però devono fare i 71 conti con la presenza romana che non solo pretende la loro resa, ma impedisce perfino la libera circolazione delle genti e degli armenti. Costretti ad una sorta di monocoltura pastorale (data la conformazione dei territori) i Pelliti si trovano ben presto nella necessità di attaccare l’invasore. La particolare composizione delle tribù però non permette una alleanza generale entro una qualche sorta di confederazione che, unendo le energie, concretizzi una possente forza militare in grado di sconfiggere l’occupante. Carenza che col trascorrere del tempo decreta la sopravvivenza nella ristrettezza monocolturale, una trasformazione sia pure lenta della cultura d’attacco in cultura di difesa, resistenziale, quindi lo svanire nel corso dei secoli dell’utopia della liberazione. È l’inizio della storia della colonizzazione materiale e spirituale della Sardegna, ove si scontrano da un lato la volontà degli autoctoni di resistere ai colpi inferti, dall’altro quella degli invasori mirante e ridurre a ragione gli appellati barbari (per i romani erano barbari tutti i popoli che non soggiacevano all’imperio della loro colonizzazione, così anche i sardi Pelliti. Barbagie venivano di conseguenza definite le zone non conquistate, ed occupate dai nuragici). Scontro cruento in cui ciascuno perde qualcosa, modifica qualcosa, inventa nuove strategie per non cedere definitivamente al nemico. È nel processo di questa perenne guerra che la cultura selvaggia sarda è costretta a modificare alcuni dei suoi tratti, a perdere alcuni suoi istituti, ad accentuare alcuni suoi momenti. È il processo della lotta per l’esistenza non solo fisica ma anche culturale, per mantenere integra non solo la vita ma l’essere se stessi, autofondati, autodeterminati. D’altro canto l’occupante si rende conto assai presto che la vittoria sui Pelliti è possibile solo se si frantuma, si spezza, si lacera la loro cultura, di conseguenza se verranno a mancare loro gli istituti dell’unità sociale e dell’autodeterminazione. Non si tratta di ottenere delle vittorie militari, bensì di lacerare all’interno il sostrato culturale della società contro lo Stato. Si apre così l’altra storia della Sardegna, quella che esprime nel rapporto di colonizzazione l’alterità delle sue genti rispetto al colono di turno; alterità che nel processo storico diviene resistenza, criminalità, banditismo, delitto. I Romani, dopo molteplici tentativi di penetrare e stabilirsi nei barbari montes, data l’opposizione radicale dei Pelliti, decidono infine di abbandonare il progetto e di costruire invece degli argini, i famigerati Limes, che a semicerchio delimitano le zone occupate. Non è una “muraglia cinese”; sono presidi stabili di soldatesche e strutture del colono atte a contenere vuoi i movimenti delle genti per scopi diciamo “civili”, vuoi soprattutto 72 le sistematiche invasioni degli armenti Iliensi nelle pianure, vuoi infine le periodiche razzie poste in essere da bande di armati di intere tribù allo scopo di approvvigionarsi delle derrate che altrimenti non possono avere. Sono, queste ultime, le epiche bardanas, che permettono agli iliensi di superare le ristrettezze di sopravvivenza decretate dalla monocoltura pastorale. Vere e proprie forme di esproprio ai danni dell’occupante, alle bardanas partecipano tutti i guerrieri del villaggio, presumibilmente anche di diversi villaggi amici, considerato che si tratta di eserciti guerriglieri consistenti spesso in centinaia di armati. La strategia posta in essere è quella di aggredire all’improvviso, fare razzia di tutto (bestiame, cereali, ecc.) quindi di riportarsi velocemente verso le zone interne, conosciute palmo per palmo e pertanto garanti della incolumità per i bardaneris, che bruciano durante la fuga di rientro nei propri territori quanto non possono trasportare. Fino a quando le tribù dell’interno hanno goduto del pieno possesso del territorio, le bardanas vengono compiute da tutti gli uomini validi del villaggio. Situazione perdurata, secondo alcuni studiosi, fino all’occupazione spagnola, quindi periodo Giudicale compreso. A caratterizzare la bardana classica da quella successiva (in particolar modo da quella del XIX secolo) è da un lato l’indivisione del gruppo sociale che la attua, quindi la spartizione egualitaria del frutto della razzia fra tutti i suoi componenti. Il relativo isolamento fa si che la cultura selvaggia si manifesti integra almeno fino al XVII secolo. Tuttavia la politica attuata dagli Iberici è quella di porre fine agli antichi limes romani, permettendo la libera transumanza delle greggi dall’interno verso Baronie e Campidani. Fatto questo che secondo alcuni ha decretato la divisione sociale. Riteniamo utile soffermarci un attimo sull’argomento perché sarebbe a questo punto, per i motivi che ora diremo, che si verificherebbe il trapasso dalla bardana al cosidetto banditismo sociale. 2.1.3 Dalle bardanas al banditismo sociale: l’autoctonia nel processo di colonizzazione Mentre alle bardanas classiche partecipa attivamente l’intera collettività, il banditismo sociale è caratterizzato dal fatto che a bardanare, e quindi alla macchia si danno, per quanto numerosi siano, solo alcuni componenti (che tuttavia continuano a godere dell’appoggio materiale e spirituale del gruppo). Evidentemente l’una e l’altra realtà sono espressione di assai diversi momenti sociali. 73 Di sicuro almeno parecchie delle tesi che hanno voluto dare ragione del trapasso dalle prime bardanas a quelle successive risentono dell’assunto – mai provato storicamente – secondo cui fino ai tempi recenti le “Barbagie” (intese nell’accezione generica di “zone interne”) non avrebbero subìto la presenza dello Stato/colono. Di conseguenza si cerca esclusivamente in presunti meccanismi interni il trapasso dalle une alle altre. Rilevante la tesi sostenuta da chi (come A. Ledda) ha voluto interpretare come statizzazione della famiglia i legami di sangue ed affettivi, quindi quella particolare componente della comunità “pastorale” che vivrebbe in funzione di se stessa, sempre vigile sulle altre, con le quali intratterrebbe rapporti più di antagonismo che di solidarietà. Secondo tale ottica il perenne antagonismo si ripercuoterebbe anche in seno alle bande, nella vita alla macchia; ciò avrebbe impedito la persistenza della resistenza collettiva manifestantesi nelle bardanas, quindi decretato il trapasso alla resistenza individuale, identificata nel banditismo. È a nostro parere, un modo di interpretare le cose assai carente. Innanzittutto perché fa retrodatare l’occupazione delle Barbagie fino all’epoca Romana, cosa smentita dall’esistenza dei limes, riportati alla luce da indubitabili scavi archeologici (a meno che non si escludano le originarie bardanas dal fenomeno che si è voluto interpretare. Ma allora non avrebbe senso alcuno parlare del trapasso da quelle al banditismo). Infatti, se le zone interne, occupate dai Pelliti, non sono invase dal colono, che senso ha affermare che le bardanas sono attuate da gente “alla macchia” che tuttavia non si darebbe una struttura organizzativa stabile a causa del frapporsi dei rapporti antagonistici dovuti alla statizzazione della famiglia? Fino all’occupazione anche delle zone interne da parte dei colonizzatori, i Pelliti non hanno alcuna necessità di bandidare, possono tranquillamente vivere nei loro villaggi, stanziali!!! Altra carenza cogliamo poi nell’assolutizzare l’antagonismo tra i gruppi familiari, fino a non rendersi conto che la dialettica che anima la società selvaggia è esattamente dell’unità nel contrasto. La società “pastorale” sarda (rurale, precisiamo noi) è data dal sempre precario equilibrio tra i contrastanti interessi materiali e spirituali dei singoli e delle famiglie. Non si tratta, è evidente, di “contraddizioni” che, superate da sintesi sempre nuove, pervengono al fatidico assoluto. Ben al contrario, se di sintesi è lecito parlare, l’unica possibile è data dagli equilibri sempre nuovi e sempre precari, che ricostruiscono l’universo collettivo sulla base dei continui rapporti di forza in evoluzione. Rapporti propendenti da un lato dalla parte di interessi soggettivi e dall’altro dalla parte dell’intero gruppo sociale, il quale richiede sempre la propria integrità. Il collante di tutto ciò è precisamente l’orizzonte politico-culturale, il contenuto normativo condiviso da 74 tutti e pertanto garante dell’ordine e della sostanziale unità della comunità. Dal contrasto, preso per sé stesso, non può nascere la divisione/ dimidiazione. Ovviamente il discorso muta radicalmente nel contesto della colonizzazione, che inibisce qualche meccanismo oppure ne apporta altri, disgreganti. Né ci appare sufficiente, a sostegno della tesi, far coincidere la rottura interna alla collettività col sorgere della ricchezza privata a seguito dell’apertura dei limes da parte degli occupanti Iberici. Prima di tutto perché la ricchezza non è sempre espressione di una classe, né esprime un ceto, una categoria di persone socialmente privilegiata. Poi perché è senza dubbio “permessa” in ogni società selvaggia, allo scopo di non frustrare il processo di esplicazione della libertà individuale. Solo che, nel momento in cui essa tende a concentrarsi in maniera tale da rappresentare pericolo serio di effettivo privilegio, scattano una serie di meccanismi culturali atti a redistribuirla nel sociale. Così, per gli indiani delle praterie il possesso di cavalli era non solo permesso ma addirittura stimolato, rappresentando fonte di grande prestigio per il proprietario. Ma ancora più prestigio acquistavano coloro che ne facevano dono a conoscenti, amici, vicini di tenda ... Invece, qualora manifestassero poca generosità perdevano ogni considerazione, oltre che stima, amicizia, conoscenze e vicini di tenda. Cosa ovviamente poco gradita nell’universo selvaggio, ove i rapporti nel sociale contano ... tutto. Presso i Nuer, popolo pastorale nilotico, la proprietà privata delle mandrie era sacra (intoccabile). Quanta più numerosa e di ottima qualità era la mandria, tanto più prestigio poteva vantare il proprietario. Ma allo scopo di ridimensionare l’ingente quantità di capi che spesso raggiungevano gli armenti, i Nuer usavano inventarsi di sana pianta i più che quotidiani pretesti onde festeggiare in giganteschi e collettivi “spuntini” a base di carne di bufala. Eppure la loro dieta-base escludeva il consumo di carne, salvo non si trattasse di eventi “sacri”. Da qui l’invenzione del “sacro”, delle feste. Oltre a ciò vigeva l’obbligo morale di “prestare” le proprie bestie a quanti, per un motivo o per l’altro, ne erano privi. Aspetto assai molto simile, questo dei doni e dei prestiti “obbligati”, a quanto vige nei paesi sardi, ad esempio quando qualcuno perde il proprio armento, che gli viene almeno in parte “ricostruito” con poste collettive a cui difficilmente si risponde in maniera negativa; oppure quando si uccide il maiale, parte del quale finisce nella pratica ad imbandire le tavole di amici, parenti e vicini. Sono meccanismi attraverso cui la ricchezza viene fatta circolare, ridistribuendola, quindi evitandone l’eccessiva concentrazione, che inevi- 75 tabilmente creerebbe effettivo privilegio, quindi potere accentrato, quindi dimidiazione. Ciò prova incontrovertibilmente che la ricchezza, di per se stessa non produce divisione sociale. Per cui, salvo l’intervento di momenti estranei all’ambito culturale selvaggio, i ricchi (cioè i proprietari di beni altamente significanti per il corpo collettivo) non sono da confondersi né con sos printzipales (concetto che esprime la classe o il ceto dei privilegiati quando la società è perdavvero divisa) né, tantomeno, con sos meres (identificati, secondo il modo d’intendere comune, con quanti sono altri rispetto alla comunità e che per di più intrattengono con essa un rapporto di colonizzazione). Eppure è anche vero che nel momento in cui i documenti storici “parlano” di una qualche forma di “criminalità” sarda (periodo iberico senza dubbio, ma anche quello precedente Giudicale), questa assume di già la conformazione di banditismo sociale, a cui si deve pur dare una origine ed una ragione d’essere. Noi crediamo che scomparsi i Bizantini per “naturale estinzione” (tesi sostenuta da Carta Raspi) il mondo sociale isolano si sia in un certo modo rifatto alla situazione preesistente all’occupazione Romana, con in più le storture dovute a mille anni di esperienza coloniale subìta. Almeno in un primo tempo, armenti e popolazioni possono ricircolare liberamente in tutta l’isola, fino a quando il costituirsi dello Stato Giudicale lo permette. Dopo di che, compiuto il processo di maturazione, prende avvio la sistematica repressione della cultura e delle genti nuragiche, con una sostanziale modificazione rispetto al passato: a differenza del periodo Romano lo Stato è penetrato o vuole penetrare fin nei più remoti villaggi ed insinua dall’interno l’autodeterminazione e l’indivisione sociale. Anche se non ci è possibile confermare quanto dicono coloro che vogliono che pure i Giudicati abbiano ripristinato i limes di antica data (P. Marongiu, per tutti), è indubbio però che i quattro Stati sardi impongono limiti alla sopravvivenza della società selvaggia. La sopportata transumanza delle greggi, dai monti in pianura, l’allargarsi dei commerci e delle attività sicuramente decretano il parziale arricchimento anche di individui e famiglie Pellite; che tuttavia rientrando ai propri villaggi stagionalmente – o finanche risiedendovi stabilmente – sono costretti a fare i conti con i meccanismi della cultura tradizionale, cioè con la prassi della redistribuzione della ricchezza. Meccanismi che – come vedremo in seguito – lo Stato giudicale insinua ma che solo parzialmente riesce a scalfire. La divisione sociale non è ancora avvenuta. Una tale situazione ereditano gli Iberici. Che gli Spagnoli, così come i Giudicati, siano in qualche modo presenti istituzionalmente nei villaggi dell’entroterra non abbiamo dubbi, anche se la loro presenza non è così radicata e lacerante quanto lo sarà quella 76 dei Piemontesi e degli Italiani in seguito. Così che con gli iberici è ancora possibile per le comunità interne mantenere vivi i legami e l’unità sostanziale del gruppo sociale, nonché i tratti dell’autodeterminazione. “Semplicemente” sono soggette non solo ai tributi feudali ma anche ad un “controllo” per quanto superficiale delle autorità, le quali, così come avviene fin da epoca Giudicale, con il mantenimento dell’istituto dell’inkarriga, addossano all’intera collettività le responsabilità di quei momenti identificati dal sistema statale come “crimini”. È, questa, la sola condizione da cui può prendere realtà il fenomeno del banditismo perché: a) i villaggi non godono più del controllo assoluto ed esclusivo dei propri territori, dovendo fare i conti con la presenza dello Stato; b) se sono ancora possibili forme della bardana delle origini, tendono comunque a scomparire sotto la repressione delle collettività decretata dall’inkarriga; c) data la presenza delle istituzioni, che possono risalire all’identificazione dei “criminali” o comunque possono addossare all’intero gruppo sociale i “delitti” consumati, ai presunti e reali colpevoli non rimane che darsi alla macchia, sia perché si pongono (o vengono obbligati) fuori dalla legge, sia perché da banditi possono agire indisturbati. Una volta costretti fuori dalla comunità i banditi si aggregano in bande, organizzativamente strutturate secondo i principi validi nella società civile d’origine. In tal modo i banditi non solo si fanno garanti dell’incolumità del villaggio ma questo, nella sua totalità, garantisce loro protezione, solidarietà, ospitalità, “connivenza” materiale e spirituale. Questo fenomeno non avviene da un giorno all’altro, ma si manifesta come lungo processo le cui origini risalgono al definitivo crollo dei limes romani, passando quindi attraverso l’espansione dei Giudicati all’interno dell’isola. Il trapasso dal vecchio al nuovo segna tuttavia finanche la fine di un atteggiamento culturale e l’inizio di un altro. Il banditismo sociale assume la fisionomia di sola resistenza, il fenomeno si caratterizza per la volontà di non perire: è l’atteggiamento della difesa, non dell’attacco. La liberazione, sia pure come processo più o meno lungo, viene a scomparire. Per quanta simbiosi vi possa essere tra bandito e comunità originaria, data la condizione generale or ora sommariamente descritta, le popolazioni risultano essere comunque non solo assediate dall’occupante, ma anche monche di certi suoi validissimi componenti. Inoltre le comunità risultano sempre più impossibilitate a porre in essere la prassi della redistribuzione della ricchezza: quella di quanti sono alla macchia non è neppure più 77 valutabile con estrema sicurezza, sfuggendo ad ogni controllo sociale; quella delle famiglie pastorali più forti, sempre più consistente anche grazie alla possibilità della transumanza, pur se ancora non raggiunge dimensioni di privilegio (o tale non è ancora valutata) le raggiungerà durante l’occupazione piemontese Fino ad allora però è, a nostro avviso, impossibile parlare di printzipales come ceto/classe scaturita dal sociale selvaggio. Una cosa è il colono, che determina con l’uso della forza il pagamento dei tributi ed il controllo sulla comunità a cui si sovrappone; altra cosa sono i meccanismi interni alla popolazione colonizzata, ogni gruppo della quale, a seconda delle condizioni storiche concrete, può autogestire le autoctone forme sociali in maniera più o meno integrale. Non ci è possibile perciò confondere la figura ed il ruolo del princep con quella del printzipale, come invece fanno alcuni studiosi. Il princep è il condottiero, il capo militare nelle azioni di razzie; la sua funzione è limitata pertanto a tale contingente ma, oltre esso, non presuppone nessun rapporto di tzerakìa (servaggio) con i componenti la banda, o in seno al villaggio. Di conseguenza anche nella spartizione del bottino non vi sono privilegi o iniquità. Il printzipale, al contrario, presuppone di già la dimidiazione del corpo sociale: è non solo figura privilegiata economicamente e socialmente, ma rappresenta finanche il padrone in un rapporto di servitù (tzerakìa, appunto). 2.1.4 Printzipales e Bardanas nei secoli XVIII e XIX I limes eretti dai Romani vengono dunque “superati” vuoi dai Giudicati vuoi dalla “liberale” politica iberica, determinando in un certo qual modo anche l’arricchimento di pastori/famiglie delle zone interne. Senza approfondire l’argomento, è anche probabile che limitatamente ad alcune comunità diverse famiglie se ne siano separate per far parte, come alcuni studiosi avanzano sulla base della toponomastica e nomenclatura di alcune casate, della nobiltà e della burocrazia Giudicale prima, “spagnolizzata” in seguito. Tuttavia, al limite, si tratta non di printzipales, ma di meres veri e propri, postisi pienamente fuori e contro la collettività. La figura del printzipale emerge invece a partire dall’epoca iberica per definirsi durante l’occupazione piemontese, soprattutto a seguito della introduzione per decreto (e per forza) della perfetta proprietà capitalistica (in un arco di tempo che copre i primi tre quarti dell’800). Il concetto stesso, a nostro avviso, non deve essere confuso con quelli di princep o principas a cui è etimologicamente legato. La sua significanza, ben al contrario, è da ricercarsi nel rapporto che 78 si instaura fra il ricco (proprietario in un primo momento di armenti) ed il sotziu (“socio”) che si dedica ad accudire le greggi quando quello ne è impossibilitato (perché alla macchia, ad esempio). Si tratta di una forma di “mezzadria” (soccida) del tutto particolare in quanto su sotzu (il rapporto di “società”) pressuppone l’equa ripartizione una volta terminata la durata temporale stabilita (che varia a seconda del bestiame). Salvo un sotzu particolare (anche questi previsti) tra su sotziu che pone quel che si dice il lavoro vivo, e su sotziu printzipale che ha messo il bestiame, si divide a metà. Sia il contratto che i due concetti sono tuttora viva attualità. Chi pone il bestiame viene definito sotziu printzipale semplicemente perché l’armento è considerato la ricchezza sociale per eccellenza. Infatti tra i due non vi è in origine, e neppure oggi, alcun rapporto di servitù (tzerakìa). Il rapporto di servitù ha iniziato a prendere piede quando su printzipale si garantisce il cumulo della ricchezza non più secondo i meccanismi stabiliti dalla normativa selvaggia (astuzia, bravura, abigeato, ecc.), bensì da quelli statali. Ciò si verifica radicalmente ed in modo capillare nell’inversione di tendenza imposta dagli occupanti di casa Savoia, che così inaugurano la fine del relativo liberismo iberico. Prima di tutto i Piemontesi non si accontentano più dei tributi tradizionalmente riscossi dai predecessori: abbisognano di ben altro per saziare la bramosia di regno e la politica espansionista di cui sono fautori; in secondo luogo devono imporsi militarmente su una situazione politico-sociale determinata dalla compresenza di due poteri entrambi nemici: la feudalità spagnola/sarda (e per un breve periodo anche filoaustriaca) da un lato, le collettività autodeterminate dall’altro. La rigidità del suo intervento è nella logica delle cose. La radicale trasformazione imposta colpisce feudalità e comunità, salvaguardando però – in seno a quest’ultima – gli interessi delle realtà economicamente forti, i printzipales, la cui ricchezza è non solo stimolata ma garantita dalle leggi dello Stato. Ciò emerge chiaramente quando, con le leggi dette delle chiudende (chiusura), si istituisce la “perfetta” proprietà privata delle terre. In tal modo i printzipales, che dispongono delle energie necessarie a costruire i muri di recinzione ed hanno tutto l’interesse a farlo, consumano ai danni della propria comunità un vero e proprio crimine. La loro consistenza economica non è più sentita (giustamente) come il frutto della loro balenthìa, ma finanche quale esproprio dei beni fondamentali della comunità (terra e diritti su di essa). In tale contesto pure il rapporto di su sotzu viene fatto rientrare entro i limiti dei contratti determinati da servitù: nasce così sa tzerakìa. Il printzipale non è più solo il proprietario del gregge e, ora, delle 79 tankas (grossi appezzamenti di terra), ma assume funzioni di comando sul sotziu. Questi non è più un pari, bensì un subalterno, è ridotto a tzeraku (servo, appunto). Il rapporto padrone-servo raramente scade però nella lesione della dignità (onore, sovranità) del secondo; il ruolo di su tzeraku non riesce a determinare la scomparsa del sostrato fondamentale su cui si regge tutta la cultura selvaggia, in particolar modo l’istituto della salvaguardia della sovranità individuale: se questa viene posta in discussione o lesa, scatta comunque il meccanismo della vendetta. Su tzeraku, ora, mette a disposizione del printzipale tutta la sua capacità personale, non più in uno specifico campo (cura delle greggi e della terra), ma in tutti gli interessi del padrone contemporaneamente e indistintamente. Come accudisce gli armenti, deve essere disponibile nella caccia, oppure nella grassazione, o anche (infine) nel sequestro di persona (sa fura ‘e s’omini). Il tutto per conto del proprio printzipale. Ovviamente, essendo iniquo il rapporto di tzerakìa, anche la spartizione del bottino è iniqua, la maggior parte (quando non tutto) venendo incamerata dal padrone. È questo contorto meccanismo che sta alla base di numerosissime faide del passato ed attuali. Tuttavia rimane ancora da chiarire il perché sos printzipales, pur ricchi, si danno alla grassazione, alle bardanas, al sequestro di persona, all’abigeato; momenti senza dubbio criminali per la normativa del dominante, tanto più che questo garantisce ai printzipales la ricchezza rispetto ai tentativi mai dismessi delle comunità di risocializzare tutto. Qui, più che altrove, è necessario cogliere l’atteggiamento del ceto ormai realmente privilegiato nel contesto culturale autoctono insinuato senza dubbio dalla dimidiazione. Ormai la collettività valuta la ricchezza dei printzipales come esproprio, per cui agisce su di essi facendo sentire tutto il disprezzo possibile e la volontà di vendetta per il tradimento consumato. D’altro canto i printzipales si sentono nella grande maggioranza dei casi parte integrante della comunità d’origine, ed in essa vivono. Raramente abbandonano il proprio villaggio per trasferirsi in città; ciò significherebbe porsi fuori definitivamente dalla comunità per integrarsi nel sistema del colono. Un tale atteggiamento l’hanno assunto sos meres, che occupano finanche posti di rilevanza nel meccanismo della colonizzazione, divenendo di fatto compradores. Malgrado il loro sentirsi parte integrante – spesso la più balente – della comunità, i printzipales da questa sono fatti oggetto della propria azione vendettale. Le sommosse contro le chiudende confermano quanto affermiamo; fenomeno costante non solo a partire dalla prima legge del 1820, ma ogni qualvolta si lede l’interesse collettivo: dal divieto di pascolo in alcune zone 80 arbitrariamente adibite a coltura – già operante in periodo Giudicale – fino ai recenti e recentissimi tentativi di privatizzare il poco di “comunale” scampato alle chiusure, ed istituire i parchi “nazionali” (leggi statali) volendo così portare a compimento il processo di esproprio alle comunità del loro territorio. Il ceto dei printzipales sente quindi tutto l’odio nei suoi confronti, ma non vuole estraniarsi dal resto della società isolana. Però non ha neppure alcuna intenzione di rinunciare alle ricchezze possedute. La via d’uscita viene “trovata” ponendo in essere la balenthìa, tanto più che da essa possono trarre ulteriore ricchezza e contemporaneamente farne circolare nella comunità, gratificandola. Ecco perché i printzipales sono parte rilevante nel banditismo del XVIII e soprattutto del XIX secolo; ciò definisce anche la specificità delle bardanas ottocentesche, in cui la balenthìa si esplica in tutto il suo antico splendore. Ma vi è pure da dire che non di raro alle azioni criminali (bardanas, sequestri o altro) i printzipales non vi partecipano di persona, soprattutto in tempi recentissimi, bensì vi mandano gli tzerakus. Per i printzipales, pertanto non vi è rischio alcuno, essendo gli tzerakus eventualmente a pagarne di persona le conseguenze. Col trascorrere del tempo il rapporto di tzerakìa viene sostenuto non più soltanto dall’imporsi del printzipale, ma anche dalla servitù volontaria: man mano che i decenni si susseguono e la colonizzazione culturale avanza, il ricco non è visto come colui che si è impossessato della ricchezza collettiva, ma sempre più come colui che “dando lavoro” permette agli espropriati di tutto di campare. Al mutamento dei tempi corrisponde finanche un adeguarsi del fenomeno; prendono il via tutte quelle nuove forme di razzia adeguate alla contingenza storica. Non a caso il primo sequestro di persona a scopo di estorsione risale all’ultimo quarto del secolo scorso. E quando il danaro inizia a circolare ampiamente anche in Sardegna – ciò che si verifica nel secondo dopoguerra – prende forma pure il fenomeno della rapina, con metodi guerriglieri nelle pubbliche vie, con metodi semi-metropolitani nelle banche e negli uffici postali. Questa valutazione dà ragione non solo delle bardanas dell’800 nella loro specificità, ma anche del perché la comunità infine garantisce protezione, solidarietà e rispetto non solo ai printzipales costretti a darsi alla macchia dalla repressione statale, ma all’intero ceto nella sua generalità, che così è riuscito in un certo qual modo ad evitare l’ostracismo. È evidente che i printzipales non hanno operato consapevolmente la scelta di porsi “fuori” da quella stessa legge di Stato che li protegge e garantisce nel privilegio: il comportamento del ceto è nell’ottica delle cose. 81 Non a caso il nuovo corso del banditismo in cui i printzipales hanno un ruolo non secondario, è tutto riversato verso l’esterno della comunità, secondo il dettato normativo che stabilisce essere delitto il rubare in casa propria (furat kini furat in domu sua), ma non il farlo in casa altrui. Inoltre, essendo mutati i tempi, solo i printzipales, che godono di credito nell’alta società (quella del dominio) sono in grado di conoscere perfettamente non solo territori e paesi lontani, bensì anche le specifiche abitazioni su cui operare bardanas, rapine e sequestri. Tuttavia la dimidiazione, persistendo la colonizzazione, non è stata ricomposta. Alla gratificazione della comunità non corrisponde una reale redistribuzione della ricchezza. Inoltre il rapporto di tzerakìa determina comunque una spartizione iniqua del bottino. Infine il ceto dei printzipales rappresenta – ancora oggi, per certi versi – l’appendice del sistema coloniale ramificato nel territorio. Conta amicizie e legami con i potentati politici ed economici dell’occupante, che ben sfrutta a suo vantaggio ma che richiedono anche, in cambio, attiva “collaborazione” nel momento della bisogna. Non è affatto raro che sos printzipales rappresentino veri e propri carrozzoni politico-elettoralistici legati/dipendenti da questo o quel pilastro del sistema. D’altro canto la loro “mentalità” è tale che non sono e non saranno più, ormai, sostanzialmente capitalisti. Radicati nei propri villaggi, alla loro cultura ma anche alla loro ricchezza (sempre più ridotta al rango di relativo privilegio materiale), non hanno voluto o potuto trasmutarsi in veri e propri capitalisti. Per cui se da un lato i propri interessi particolari ne fanno un ceto compradore (che media cioè la penetrazione del sistema dominante in colonia), dall’altro hanno contribuito a mantenere in vita momenti essenziali della cultura autoctona, spesso pagandone di persona le conseguenze; in termini di repressione ma anche sullo stesso piano della vita materiale, ridotti come sono nell’attualità a semplici benestanti. Una condizione contraddittoria, la loro, che ineluttabilmente la generale contingenza dell’attualità chiama a definitiva risoluzione, determinando il loro schieramento anche spirituale o dalla parte del sistema (di cui saranno dei semplici inclusi, ma non parte essenziale e privilegiata), oppure dalla parte della liberazione totale dal regime di servitù. Le condizioni sono tali da poter prevedere che in buona parte opereranno la scelta di ricomporsi pienamente nelle comunità, essendo ai giorni nostri ridotti economicamente a condividerne non soltanto orizzonti culturali ma finanche i bassi livelli di vita materiale. 2.1.5 La criminalità quale esito del rapporto di colonizzazione 82 La cultura sarda trova espressione in quel sostrato della “pastoralità” di cui è pregna. Per pastoralità non deve affatto intendersi esclusivamente il modo di concepire la vita ed i rapporti sociali propri del ceto pastorale. Non riteniamo valido neppure l’assunto secondo cui la cultura isolana “vera” sarebbe quella propria delle aree a “prevalente economia pastorale”. Una simile visione concettualizza assunti sostanzialmente ideologici e storicamente falsi, partendo come fa dal dogma della riserva assolutamente chiusa, assolutamente popolata da pastori, assolutamente pura nei suoi fondamenti. In realtà il pastore puro è caso raro; di norma svolge anche altre attività, specialmente la coltivazione del suolo. Inoltre la circolazione umana e pertanto spirituale e materiale, se pure è stata arginata e controllata è costante in tutta la storia dell’isola; per cui se vi sono indubbiamente delle varianti zonali, spesso da comunità a comunità anche viciniore (esemplare la diversità di linguaggio), comune a tutti vi è un sostrato culturale che caratterizza il modo di comportarsi, gli atteggiamenti, la significanza attribuita a determinati eventi, la risposta che suscitano alcuni accadimenti. Fatta eccezione di specifiche aree oramai del tutto acculturate/ denazionalizzate (anche a causa del loro ripopolamento con genti di altri siti: è il caso delle città, spesso e volentieri riservate alla burocrazia coloniale; oppure degli attuali siti turistici popolati per lo più da forestieri), l’offesa tale è sentita da Nuraminis a Orgosolo, e come tale provoca la reazione tipica della vendetta. Semmai, il grado di disgregazione della specifica comunità determina il tipo di gradazione della ritorsione vendettale, o anche il consenso o il dissenso ad essa. Sostanzialmente, pertanto, è possibile proporre una assai vaga distinzione tra aree in cui la cultura autoctona opera ancora a livello collettivo, ed aree in cui – essendo la comunità lacerata – si manifesta come sostrato ancestrale sul piano individuale. Per pastoralità intendiamo quei valori di autoctonia, di autodeterminazione in parte ancora vivi nella attività pastorale, ma fino al recente passato impregnanti anche l’attività agricola, quella artigianale ed ogni altra. È l’orizzonte di quanti intendono la propria vita fondata essenzialmente sul possesso del frutto del proprio lavoro e degli strumenti ad esso necessari, la padronanza vuoi degli strumenti, che della tecnica, che del prodotto del lavoro. Questo orizzonte spirituale è alla base della concezione della vita autodeterminata, autofondata e si concretizza, come meglio vedremo, nel potere diffuso nel sociale, facente capo ad ogni singolo componente. Al limite la pastoralità – secondo l’accezione che noi diamo a tale termine – 83 potrebbe persistere finanche dopo la scomparsa dei pastori, come tessuto culturale in grado di determinare una specifica visione della vita e dei rapporti sociali. È il codice autoregolamentativo delle comunità dell’interno che – sopravvissuto fino ai giorni nostri – ci dice assai più di tutto l’inchiostro messo assieme che è stato versato sull’argomento, sia rispetto alla composizione sociale che sui momenti propri della civiltà sarda. Scopriamo così che non si tratta di civiltà “pre-statale”, secondo concetti propri della “scienza politica positivistica-deterministica”, ma più esattamente di civiltà antistatale o a-statale. Prima di tutto non vi è sostanziale differenza fra i membri della comunità, individui o famiglie, tutti essendo posti nelle medesima condizione, se non rispetto alla ricchezza sicuramente rispetto ai valori che la permettono. L’onore leso, l’offesa ricevuta va lavata secondo i meccanismi previsti che neppure il più ricco, o la figura più prestigiosa del gruppo possono infrangere impunemente. Il bestiame, ovviamente quello ovi-caprino ed anche suino in un primo tempo, è il simbolo della ricchezza e del prestigio sociale; di conseguenza su di esso si catalizza l’attenzione di tutti. Quanto più se ne possiede tanto più prestigio sociale si ha. Esso è di proprietà del singolo, o della sua famiglia. Tuttavia ricchezza e prestigio non possono scadere in concentrazione di potere, per cui il principio sostanziale del comunitarismo prevede la prassi della redistribuzione della ricchezza: il furto del bestiame (abigeato) è lecito, purché salvaguardi l’onore dei derubati, cioè che non rechi loro offesa in altro modo. L’abigeato da un lato limita l’accumularsi eccessivo della ricchezza nelle mani del singolo, dall’altro – in tempi di ristrettezza imposti dalla colonizzazione – permette la sopravvivenza anche di quanti sono più sfortunati o non hanno capacità di gestione degli armenti. Sicuramente prima che la dimidiazione assumesse consistenza percettibile, l’abigeato e la razzia (bardana), erano diretti esclusivamente all’esterno del gruppo. Tuttavia, l’esclusione dal campo del lecito del furto “operato in casa” più che su di un fattore etico è fondata su una questione di ordine sociale più ampia: evitare che si creino in seno alla comunità attriti dannosi che possono essere evitati indirizzando verso l’esterno le tensioni esistenti; se non altro perché il furto ai danni del “vicino” (appartenente alla medesima comunità) può essere sempre interpretato più che come “fura” (furto), come offesa vera e propria, che in quanto tale richiede ritorsione vendettale. L’esistenza stessa di un codice atto a garantire la liceità dell’abigeato, quindi la redistribuzione della ricchezza sociale, testimonia dell’impossibilità della dimidiazione in seno alla collettività per motivi “interni”. 84 Molti studiosi hanno confuso la figura del princep, cioè del valente condottiero delle opere di razzia (bardanas), con quella di una sorta di printzipale – pertanto con un compradore effettivo –, ma in verità si tratta di letture effettuate con gli schemi mentali di coloro che non concepiscono organizzazione sociale senza potere accentrato. Il princep, il condottiero di bardanas e delle azioni guerrigliere era – come tutti i “capi” selvaggi –, un valido organizzatore di azioni di guerra, ma fuori di quell’ambito non possedeva alcun potere d’imperio, alcuna possibilità d’imporre il proprio volere. L’ordinamento barbaricino, così come sintetizzato ed interpretato da Pigliaru, proprio perché esclude gerarchie ed ogni principio di potere accentrato, economico e politico, non può che essere scaturito da una cultura contro lo Stato, da una civiltà espressa da una società indivisa ed autofondata e che tale vuole restare. Se vi fosse un ente, individuo o ceto, che assommasse in sé le possibilità del privilegio, la ritorsione vendettale verrebbe esclusa dalle norme (sia pure non scritte) e la punizione farebbe capo non agli enti offesi, ma a tali individui o ceti privilegiati. Tale dato di fatto chiarisce anche, secondo quanto si sa dalle fonti scritte, l’atteggiamento di Ospitone, eretto a “re” di alcune tribù barbaricine dalla fantasia ristretta dei suoi contemporanei stranieri. Ospitone avrebbe dichiarato di essersi convertito al cristianesimo, ma le “sue” genti, ben al contrario, non manifestarono affatto conversione alcuna. Ospitone, sicuramente valida figura di resistente, non poteva che parlare di sé e per sé; se credette di rappresentare le genti di cui faceva parte, lo fece o per prendere per i fondelli i colonizzatori papalini, oppure lo fece esclusivamente per vantare un prestigio che non aveva. Nell’uno e nell’altro caso è storicamente certo che nessun Ospitone ha mai potuto imporre la propria volontà alle popolazioni dell’interno. Come le altre culture antistatali, anche quella sarda esclude il rapporto comando-obbedienza ed il “capo” non è dotato di alcun effettivo potere per imporre a chicchessia la propria volontà, se non nello specifico campo in cui dimostra specifica competenza. L’abigeato, e mille altri atteggiamenti, è considerato delitto esclusivamente nel rapporto che le genti isolane sono costrette a subire dal colonizzatore. ´È per il colonizzatore che rappresenta crimine da punire, finanche nella maniera più brutale, considerato che le ragioni risiedono non tanto e non solo nelle disperate condizioni economiche in cui versa chi lo pone in atto, quanto nell’essere prassi costante di una cultura altra, irriducibile all’ordine che si vuole imporre. Non a caso ancora oggi, nel 1993, vige nella Sardegna – unico caso – la legislazione sull’abigeato. La particolare crudeltà con cui la legge giudicale puniva i “crimini” 85 propri della cultura delle collettività dell’interno, lascia trasparire almeno due fatti di capitale importanza. Primo: che le stesse genti soggette a dominio statuale (sia pure di origine interna, Shardana per l’esattezza) non erano – come non lo sono ancora oggi – del tutto acculturate almeno rispetto ai tratti legati alla prassi della vendetta ed al modo di intendere la ricchezza sociale; infatti, se vige la legislazione contro il furto di bestiame, significa che l’abigeato è prassi corrente; se inoltre come punizione è prevista le “legge del taglione” e non la sanatoria in “multe”, come per altri delitti, significa ancora che il fenomeno è ben radicato; il fatto poi che spagnoli e piemontesi abbiano puntualmente rispolverato la legislazione giudicale non può significare altro se non che il fenomeno, pure sotto il loro dominio, è assai radicato; come lo è anche sotto l’imperio dello Stato italiano che mantiene in piedi una legislazione risalente al secolo scorso. Secondo: che il periodo giudicale non è affatto un passo avanti verso condizioni di vita migliori per le genti isolane, dato che il sistema venne eretto non solo a scapito delle popolazioni delle città-Stato, ma finanche di quelle dell’entroterra, nel miraggio di snaturarle della loro autodeterminazione; inoltre le leggi sulla ricettazione, dure quanto quelle sull’abigeato, lasciano intravedere come gli argini, i limes di antica data imposti fra il centro dell’isola e le zone costiere non fossero in realtà tenuti in grande conto dalle popolazioni sarde, intercorrendo fra di esse perenni e mai dismessi contatti di ogni genere che hanno permesso fin nelle zone di perenne occupazione il mantenimento di un sostrato dell’antica comune cultura. Lungi dall’essere codificazione scritta degli istituti culturali dell’entroterra, la legislazione dei Giudicati altro non fù se non il tentativo di soffocare, stavolta dall’interno, i codici comunitari, accentrando il potere nelle sole mani dei ceti privilegiati delle antiche città Shardana, costituitisi in vero e proprio Stato. L’accecamento di un occhio, il taglio di una o di entrambi le mani dell’autore del furto, non rappresentano altro che delega allo Stato, impersonato dal Giudice, nel mantenimento dell’ordine sociale. La punizione dell’omicida da parte del Giudicato (dello Stato) altro non è che espropriazione del potere degli individui, delle famiglie, delle comunità, a vantaggio di un Ente che si pone fuori e al di sopra di tutti, tentando così per la prima volta nella storia dei sardi la realtà del rapporto comando-obbedienza. Quanto vale per l’abigeato vale a maggior ragione per la prassi della vendetta ed in genere per l’intera normativa sociale autoctona. Ciò che è crimine per lo Stato, spesso non lo è per le genti sarde; ciò che è crimine per entrambi, per i sardi trova risoluzione attraverso un meccanismo che 86 nega lo Stato e le sue leggi. Di conseguenza, seppure i colonizzatori di turno avessero posto in essere una strategia diversa nel loro impostare i rapporti con le genti isolane, se avessero finanche favorito lo “sviluppo” dell’agropastorizia, con gli interventi miranti a modificare strutturalmente l’assetto della proprietà fondiaria che si è venuta evolvendo a partire dai primi del secolo scorso, è pur sempre ipotetica la reale soluzione del problema nazionale sardo. Perché non è affatto scontato – e questi ultimi anni lo dimostrano – che ad un consistente innalzamento del tenore di vita materiale (secondo i parametri del capitale) e la trasmutazione del pastore in “imprenditore”, segua necessariamente e meccanicamente la scomparsa del sostrato culturale vecchio di millenni. Non a caso riteniamo, proprio nel momento in cui ridotti al minimo sarebbero dovuti essere gli influssi della cultura originaria, che alla sua vitalità attuale sia in realtà dovuta l’incredibile impennata che hanno assunto fenomeni storicamente riconducibili entro “la specifica criminalità”: latitanza, banditismo, sequestro di persona, estorsioni e via dicendo. A significare che, sia pure accomodati nel salotto in vera pelle, con la TV a colori davanti ed il fuoristrada nel garage, la mentalità del sardo non è ancora del tutto soffocata. Anche il fatto che, spesse volte, l’atteggiamento “bardaneri”, criminale, venga visibilmente a coincidere con l’arricchimento (personale e/o familiare) non vuol dire assolutamente – come in troppi ormai sogliono significare – che il fenomeno nella sua variante contemporanea abbia perso l’antica significanza culturale, che tanti continuano ad interpretare in modo esclusivamente romantico, secondo l’ottica del “buon selvaggio” posto in un suo ambiente fuori del tempo e dello spazio. L’abigeato, il furto, la grassazione, l’assalto ai mezzi carichi di danaro, le rapine in banca ... sono azioni che mirano di per se stesse anche ad incrementare la ricchezza privata, o a crearne per chi non è ha. Ma anche il dopo lavoro, lo straordinario, l’investimento in BOT e CCT, incrementano o creano ricchezza. Evidentemente però non è solo questa la molla che fa scattare a così ampio raggio il fenomeno. Ciò che lo caratterizza rispetto per esempio alle medesime azioni poste in essere nella metropoli, è il fatto che emergono da un sostrato sociale caratterizzato da una vitalità propria, da un visione di vita ancora altra rispetto all’esistente, da una concezione individualista e collettivista che permane tuttora come possibilità reale di alternativa alla miseria materiale e spirituale imposta. Tanto più che la avversata condizione statuale non crea e non può creare neppure volendolo, concrete alternative che decretino condizioni sociali in cui certi valori persistano, e siano superate contemporaneamente 87 le condizioni inumane che fanno degenerare in conflitti insoluti normali contrasti che invece troverebbero rapida e sicura soluzione nell’autoctonia autodeterminata. Perché mai, infatti, l’ente offeso dovrebbe porre nelle mani della justitzia la risoluzione di una offesa subìta? Nell’atto vendettale è l’ente offeso che deve confermare a se stesso ed agli altri la propria valenza, il proprio ruolo nell’ordine sociale. Una simile visione della vita, non può di certo annullarsi meccanicamente con la scomparsa di alcuni momenti materiali e/o spirituali, o con l’adozione di tecniche e di strumenti nuovi per quanto estranei questi possano essere. Si potrebbe obiettare che la vendetta, soprattutto quando esplode nel sangue, è barbara, incivile ed altre amenità. Ma, come vedremo, la legislazione penale dello Stato non è certo contornata da principi di nonviolenza e fratellanza. Inoltre non rende affatto giustizia all’ente offeso, chiedendogli in pratica di rinunciare alla propria vita. La “specifica criminalità” sarda si riduce pertanto a quelle azioni che pur non infrangendo l’ordine sociale interno alle comunità, sono però in contrasto con l’ordine di Stato, lo negano; così come negano i suoi meccanismi atti a ristabilire l’ordine una volta infranto. 2.1.6 Sugli interventi dello Stato in Sardegna La società isolana, soprattutto quella dell’interno che più ha avuto possibilità di conservare “integra” la cultura, esprime quella civiltà fuori dalla legge dello Stato, che uno studioso della tematica del banditismo ha ipostatizzato nel titolo della propria fortunata ed interessante opera (Alberto Ledda: La civiltà fuorilegge). Ma l’essere, il vivere, lo svilupparsi fuori, oltre la legge dello Stato non significa affatto essere fuori da ogni ordinamento. Si vive semplicemente entro un ordinamento altro, ma ugualmente valido per la convivenza sociale. La comprensione di questo dato di fatto è propria di molti studiosi delle cose sarde ma tutti, infine (tra cui lo stesso Ledda), nelle loro conclusioni manifestano una qualche devianza e contraddizione rispetto agli assunti di base, dovute al paraocchi ideologico di ciascuno. Tutti concordano, a conclusione delle loro analisi, sulla necessità per lo Stato – che tutti vogliono oggi democratico-repubblicano, ieri ovviamente di altro genere – di impostare una radicalmente diversa politica d’intervento per “risollevare” le sorti della Sardegna. Per cui propongono, chi interventi miranti a ridurre la prepotenza dei latifondisti onde favorire il mondo pastorale; chi la costituzione del Monte Pascoli; chi l’eliminazione del fenomeno della transumanza; chi 88 l’industrializzazione secondo poli di sviluppo; chi, sicuramente tra i più solerti in termini di sostegno al sistema dominante e pertanto alla politica di denazionalizzazione, dagli scranni comodissimi dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, propaganda come risoluzione definitiva la distruzione dell’intero assetto pastorale. La trasmutazione di un problema essenzialmente politico (cioè di potere) in questione prettamente tecnico-economica è in tal modo il punto fermo di ogni meditazione ed intervento statale. Né le cose mutano se al posto degli intellettuali organici ai partiti italiani, poniamo quelli organici ai partiti nostrani. A parte il ruolo di appendice compradora del sistema di potere vigente che questi (in particolar modo i vertici dei partiti incluso il P.S.d’Az.) hanno storicamente svolto, non si capisce quale radicale mutamento potrebbe verificarsi nel momento in cui al tribunale dello Stato italiano si sostituisce il tribunale dello Stato cagliaritano! Forse che muterebbero le condizioni e la struttura mentale (la cultura) che tiene in vita l’ordinamento della vendetta? Sarebbe semplicemente travolto, distrutto. Non si tratta, conviene rimarcarlo, neppure di rendere più “celere” e giusta la prassi della giustizia statale (sarda o italiana poco importa; la prassi della vendetta le esclude entrambe). Anche il ricorso a quelle figure che nella comunità assolvono il compito di paceri, perché altamente prestigiose, di cui la tradizione e l’attualità traboccano, ha la funzione non di comminare ed eseguire condanne, bensì di valutare secondo il giusto, e come tale riconosciuto dalla comunità. La pacificazione tra le parti, oppure la disamistade (e la consumazione della eventuale vendetta) è di esclusiva competenza delle parti in causa; ovvero dell’intera comunità qualora essa si senta lesa come tale. È il caso dell’uccisione del padre snaturato di Bithi, che usò prima violenza e poi uccise la propria figlioletta. Ed è anche il caso, almeno così vuole una versione dei fatti, della tragica fine di Tandedhu, il cui atteggiamento dittatoriale gli costò la vita. Il ricorso ad uno “Stato giusto”, a soluzioni economiciste e via discorrendo, altro non è che porre in essere misure atte a perpetrare, in maniera quanto più indolore possibile, l’etnocidio, poco importa se ingenuamente oppure astutamente voluto. La reale soluzione, se problema vi è, sta nel riprendersi, il sardo, come individuo e come comunità, l’autodeterminazione, la libertà, il potere di disporre di se stessi e del proprio territorio, liberando da fattori esterni – economici, politici nonché ideologici – la propria forza materiale e spirituale. Autodeterminazione implicita nel nostro codice comportamentale, nella nostra cultura, che pone il potere non nelle mani di pochi privilegiati ma di tutti, indistintamente. 89 Vero criminale è chi impedisce, rinchiude in riserve, limita, impone; non chi viene impedito, rinchiuso, limitato ed a tale condizione si ribella, secondo propri metodi e mezzi. Non sono pertanto le riforme “giuste”, la giustizia più “giusta” che risolverebbero le sorti dell’isola, quanto il reale processo di liberazione nazionale e sociale. Ci pare altresì chiaro che ogni soffocamento, ogni strumentalizzazione della cultura degenerano in perdita di identità e quindi in perdita di potere reale da parte dei sardi, a livello individuale e collettivo. Non a caso tutti gli interventi statali, e/o delle sue appendici locali, a partire esattamente da quelle “radicali trasformazioni” dell’assetto economico-produttivo dell’agropastorizia, hanno in realtà espropriato dignità, identità, potere di gestione e di controllo alle genti isolane. 90 91 Capitolo Secondo Il banditismo sardo 2.2.0 Il banditismo Non faremo né la cronologia storica né un’analisi complessiva del fenomeno. Ci soffermeremo su alcuni momenti salienti da cui emergeranno chiaramente i più significativi tratti della cultura autoctona che confermano l’analisi fin qui avanzata. Ci è sufficiente riassumere il perché ci si dà alla macchia e al “delitto”, la consistenza del fenomeno, la struttura organizzativa delle bande, il sostrato culturale che sorregge le aggregazioni, l’emergere di “figure storiche” che più di altre condensano la concezione resistenziale isolana, infine l’ambiente in cui le bande ed i singoli banditi/ latitanti possono trovare relativa libertà e rispetto. Si tratterà di una sorta di preludio alla trattazione del sistema punitivo applicato in Sardegna, del modo e delle finalità che caratterizzano l’intervento della giustizia di Stato nell’isola. Evidenzieremo in altre parole le ragioni del manifestarsi della specificità dell’opposizione culturale sarda ad una entità non riconosciuta. Ragioni che risiedono non nella “cattiva amministrazione” ma nella consapevolezza della propria alterità, vera molla propulsiva che caratterizza il fenomeno. Il banditismo, inteso nelle due accezioni di aggregazione in bande di “malfattori”, e di banditi (espulsi) dalla legge, ha attraversato la storia della Sardegna fin dal principio della occupazione straniera. Per il periodo precedente l’occupazione iberica, però, i documenti e le fonti sono sporadiche, per cui non vi è possibilità di una rigorosa ricostruzione delle vicende relative. I resoconti degli “storici”, per lo più apologeti della civiltà 92 coloniale, mirano non alla descrizione della struttura interna, dei motivi, dei modi di agire dei banditi, bensì all’elogio delle “meravigliose” gesta, del coraggio, dell’arditezza delle milizie dell’occupante, nonché a infiorire fino all’assurdo periodiche quanto improbabili stragi di isolani. Secondo qualche cronista latino, addirittura in un sol colpo sarebbero stati trucidati o fatti prigionieri ben 80 mila sardi irriducibili alla ragion di Roma. Tenuto conto del periodo (177 A.E.V.) in cui tale evento si sarebbe verificato, chiaro ci appare che una simil balla mirava a porre la “storica impresa” del console Tiberio Sempronio Gracco né più né meno nel medesimo ambito delle molteplici conclamate “sconfitte definitive” della resistenza sarda. Come spesso accade, a dire molto di più che tali “verità storiche” ci rimangono altri documenti, nello specifico le legislazioni degli Stati: Codici Civili, Codici Criminali, Pregoni ecc., da cui è possibile attingere sia pure indirettamente aspetti fondamentali per la comprensione dei fenomeni esaminati. La repressione di questo o quel “delitto”, la gravità attribuita a questo o quel fenomeno, ci mettono in condizione di comprendere l’organizzazione delle bande, i rapporti fra queste e la comunità, il luogo d’azione e di permanenza, i vincoli di varia natura che legano la società civile ed i banditi. Fonti preziosissime che confermano come, al di là delle contingenze storiche determinate dal particolare infierire sulle popolazioni da parte dell’occupante, il fenomeno del banditismo è sorretto sostanzialmente dal perdurare di tratti culturali endogeni che si manifestano attuali e propulsori fino ai giorni nostri. 2.2.1 Il banditismo fino al termine dell’occupazione spagnola Ovviamente, così come oggi la ricchezza sociale è concentrata su precisi beni, in passato lo era su altri, specifici dell’epoca (bestiame, oro, e così via). Il bandito, nel suo persistere alla macchia si riversa, per ottenere i mezzi necessari alla propria sopravvivenza, su tali beni. Diviene bandito colui che si pone fuori dalla cerchia della legge di Stato. Se la legge di Stato domina nella civile società, il bandito è costretto ad una esistenza fuori da essa: dalla propria casa, dal proprio ovile, dai propri interessi materiali ed affettivi. Condottosi fuori dalla normale esistenza, volontariamente o perché vi è spinto dalla repressione, deve pur sopravvivere. Essendo e sentendosi, ogni individuo isolano, autofondato non si ridurrà mai – di sua spontanea volontà – ad elemosinare per sé e per la propria famiglia i mezzi di sostentamento. Dal momento che la legalità gli impedisce la cura dei propri inte- 93 ressi, è nella totale illegalità che si procura i mezzi di cui necessita. Anche nella latitanza, per quanto i codici comunitari gli garantiscano l’ospitalità ed i mezzi di sostentamento che un’infinità di amicizie gli fanno avere, il bandito non rinuncia al proprio orgoglio e non rappresenta, se non in momenti veramente imprevedibili, un peso economico per chi gli offre protezione. Dignità, necessità, mentalità sono elementi che, nell’insieme, determinano chi si da alla macchia a prendersi il necessario. Soprattutto oggi, necessità di costosissime difese giudiziarie, di garantire i bisogni della famiglia, di mantenersi nella latitanza per mesi, anni, spesso decenni spingono il latitante all’unica strada che gli resta percorribile: consumare reati su reati. L’epoca della dominazione iberica è caratterizzata dalla massiccia presenza di bandeados e di saltadors de camins. In genere, si dà alla macchia colui che, accusato dalla giustizia statale di un qualche delitto – colpevole o meno che sia – ad essa si sottrae stabilendosi nelle campagne. Centinaia, in alcuni periodi migliaia di banditi abitano monti e foreste. Nella vita alla macchia hanno occasione, o necessità, di tessere rapporti gli uni con gli altri e di organizzarsi in vista di azioni comuni, nonché di razzie di bestiame e di assalto e rapina ai danni di viandanti facoltosi. Le bande, spesso a composizione stabile, operano una strategia prettamente guerrigliera, attuando il colpo e spostandosi velocemente da un luogo all’altro. Perfetti conoscitori dei territori e delle genti sanno con profitto sfuggire la persecuzione, sfruttando ogni contraddizione a loro favore, come l’immunità garantita dai luoghi e dall’ospitalità propri del clero nel contesto rurale e, spesso, finanche dei ceti nobili. Il banditismo di quest’epoca è talmente diffuso e numericamente consistente che gli iberici sono costretti ad incrementare la repressione a livelli inauditi, fino a ricorrere alle più subdole armi miranti a snaturare il fenomeno dal di dentro. Non solo lasciano in vigore le normative proprie della Carta de Logu, ma le integrano con las pragmaticas (leggi emanate dal sovrano) e los capitulos (leggi proposte dai tre ordini del parlamento – stamento – ed approvate dal sovrano), quindi nel disporre l’impunità (purché non si sia commesso crimine di lesa maestà) per qualsiasi delitto oltre ad eventuale compenso e salvacondotti per altri criminali, per chiunque uccida o catturi un bandito. Si incitano in tal modo gli appartenenti stessi alle bande a consumare il tradimento. Già in questa epoca è documentabile il fenomeno che vede darsi alla macchia migliaia di persone dei centri rurali, allo scopo di non sottostare ad un regime non riconosciuto. Il fatto poi che, copiando per l’isola quanto avviene nel continente, vengano repressi il cosiddetto ozio e vagabondaggio, alimenta enormemente le schiere di latitanti e quindi la consistenza 94 delle bande, in molti non essendo disposti a fungere da servi. Soprattutto nel 1600 i bandeados esasperano il “pacifico” sistema coloniale iberico. La banda più famosa è quella di Filippo de Campo, che gode della vasta solidarietà della popolazione del Logudoro, nonché di una vasta rete di amicizie su un immenso territorio. Oltre al Logudoro, le zone ospitanti le bande si estendono dal Nord più estremo (Gallura, Nurra, Anglona) fino alle soglie del Campidano di Cagliari (Barbagie, Trexenta, Marmilla, ecc.). I decenni a cavallo fra il XVII e il XVIII secolo segnano anche l’affiancarsi al banditismo tradizionale di una sorta di banditismo politico dato dal contrasto fra una parte della feudalità sarda e gli interessi spagnoli della corona. Fenomeno che ritroveremo in tutto il ‘700, scaturente dai contrasti antipiemontesi della feudalità iberica o filospagnola. Nella seconda metà del 1600, parte della feudalità sarda tenta di strappare più potere al sovrano, nel momento in cui la Corona richiede un donativo (prestito) di 70.000 ducati per far fronte ai suoi impegni militari nel continente. La lotta viene a concentrarsi, per vecchi rancori tra le famiglie, tra il Marchese di Castelvì e il Vicerè Marchese di Camarassa. Nel 1668 viene ucciso Don Agostino di Castelvì da sicari/funzionari del vicerè; un mese dopo la sua morte identica sorte tocca al vicerè per mano di uomini della opposta famiglia. La lotta fra le fazioni del potere costituito determina la fuga dall’isola di alcuni nomi della feudalità isolana, ed il darsi alla latitanza di altri. Ciò che a noi qui interessa cogliere è il fatto che pur di sconfiggere i marchesi-banditi (prima di tutti il marchese di Cea, Don Giacomo Artal, che una volta datosi alla macchia si unisce con propri fedeli a schiere di altri banditi con i quali ingaggia guerra alla corona) il nuovo vicerè promette ai banditi la completa libertà in cambio di Don Giacomo. Ovviamente l’offerta viene rifiutata con sdegno, ed anzi valido sostegno i latitanti danno affinché il nobile sardo sia fatto fuggire in Corsica. In questo frangente il tradimento arriva da altri banditi, esattamente da appartenenti alla medesima feudalità isolana i quali, col pretesto di contare sull’appoggio di innumerevoli bande sarde pronte alla lotta contro gli spagnoli, riescono a far rientrare in Sardegna il Marchese di Cea ed altri feudatari sardi riparati all’estero, quindi a farli cadere nella trappola all’uopo preparata unitamente al vicerè. A tradire furono i banditi Don Giacomo Alivesi e Don Gavino Delitala. A cadere sotto i colpi del loro tradimento sono il marchese Aymerich, il Cao e il Portogues (uccisi dai primi). Il marchese di Cea, consegnato al vicerè, è costretto a percorrere in lugubre corteo l’intera Sardegna fino a Cagliari e qui viene decapitato nel 1671. Il corteo è preceduto dalle teste 95 dei tre nobili uccisi nell’imboscata. La civile legge iberica impone che le teste dei nobili sardi siano tenute in vista, entro apposita gabbia appesa alla Torre dell’Elefante (a Cagliari), per ben 17 anni. In questo episodio inizia ad avere un minimo di luce quell’aspetto che sarà poi più evidente nel XVIII secolo: cioè il tentativo delle fazioni che, venute a rottura col potere costituito e risultando perdenti, nella vita alla macchia mirano a strumentalizzare per propri fini il banditismo sociale. 2.2.2 Il banditismo nel ‘700 savoiardo Contrariamente ai dominatori precedenti, i reali di Savoia intraprendono, fin dal primo giorno di occupazione dell’isola (avutala grazie al Trattato di Londra, nel 1720) la lotta per la sottomissione totale di essa, non ammettendo che una parte del suo territorio e della sua popolazione possano essere in relativa libertà. Dal 1720 per le genti rurali sarde inizia un ciclo nuovo, decretato dal terrore delle forche, degli assassinii in massa, della perseguita sistematicamente denazionalizzazione. La strategia etnocida, tipica del periodo in esame, determina un radicale mutamento nella forma del banditismo. Fino ad allora le comunità dell’interno oltre a garantire ai banditi/ latitanti solidarietà e ospitalità, godono esse stesse del controllo quasi esclusivo dei propri territori. In un certo qual modo sono, nel complesso, padrone del proprio destino, sia pure entro i limiti costituiti dalla presenza dell’occupante. Dal 1720 i piemontesi si impongono nei villaggi con la propria forza militare, i propri codici, la propria “cultura”. In tal modo sopprimono o riducono notevolmente la di già scarsa libertà precedente; gli antichi limes non sono più ai margini del territorio, bensì nel bel mezzo di ogni comunità. La legge del colonizzatore non deve più essere sistematicamente rispettata solo nei Campidani e nelle Baronie, ma nelle medesime “Barbagie”. Prassi e codici millenari di autoregolamentazione e distribuzione della ricchezza sociale diventano in un attimo proibiti, e perseguiti in modo il più sanguinario. Quanti non hanno responsabilità di famiglia si sottraggono alle prepotenze dei nuovi arrivati dandosi alla macchia ed accettando lo stato di guerra imposto. L’essersi spinti fino all’interno, nei villaggi più sperduti e pergiunta stabilendovisi con armi armati e funzionari, permette ai piemontesi di ricattare chi si è dato alla macchia tormentando i suoi familiari, i sospettati di “connivenza”, i presunti che “sanno ma non parlano”. È l’inizio, questo, della rottura dell’unità delle comunità. 96 La prassi del ricatto, le promesse di immunità ed impunità, spesso le taglie, il denaro offerto a traditori e delatori e spie, alla fine decretano odi reciproci, lacerazioni, inimicizie, sospetti vergognosi anche tra persone legate da lunga amicizia e da vincoli parentali. I piemontesi per primi mettono in pratica la strategia della disintegrazione del nemico “dall’interno”; non solo nei confronti delle bande di latitanti, ma delle stesse intere comunità. Ciò determina disamistades ed infine faide che incrementano il numero dei latitanti in misura da non credersi. La politica di occupazione totale e di denazionalizzazione viene completata con l’istituzione della “perfetta proprietà privata”, sancita da una legislazione dilatata nell’arco di mezzo secolo, a partire dal 1820 (singoli decreti però risalgono all’inizio del medesimo secolo e prevedono specifiche agevolazioni: rispetto alla recinzione di terreni adibiti ad uliveti, ad es.). In coincidenza di un tale sconvolgente avvenimento, le comunità manifestano una crisi al proprio interno caratterizzata dalla rottura degli equilibri fra le varie componenti. La compattezza della resistenza al processo di acculturazione risulta fortemente inclinata, anche se non distrutta. Alla rottura dell’unità della risposta collettiva segue il definirsi del nuovo corso del banditismo: quello caratterizzato dall’emergere di spiccate personalità che catalizzano su di sé l’attenzione e delle comunità e della medesima entità colonizzatrice. Intorno alla metà del XVIII secolo emergono la figura e la banda di Leonardo Marcedhu, di Putzumajore. Datosi alla latitanza per un delitto “d’onore”, grazie alle sue doti di coraggio lealtà onestà ed intelligenza, catalizza attorno a sé diversi banditi. La banda lo fa suo portavoce nel momento in cui l’autorità savoiarda, non riuscendo a sconfiggere con le armi il fenomeno, promette a Marcedhu ed agli altri capibanda, tra cui Giovanni Fais di Kiaramonti, a cui si era unito, impunità e danari purché abbandonino e denuncino i propri compagni di latitanza. Marcedhu risponde a tale promessa che pur essendo la grazia governativa cosa assai gradita in quanto permette il rientro/ritorno alla pacifica vita familiare di persone da anni e decenni ai margini del consorzio civile, più “cara è la fede verso gli amici”. Pertanto il re deve estendere a tutti loro il condono: “o rientrerebbero tutti nelle loro case o continuerebbero insieme quella vita di asprezza e di pericoli” (Lodho Canepa). Purtroppo il coraggioso e leale bandito cade a sua volta nelle mani di un altro latitante (Francesco Bazzone), che non si fa scrupoli nel consegnarlo alle autorità in cambio di impunità e di un premio in danaro. Il tradimento inzia ad essere, più che per il passato, prassi costante che periodicamente mina all’interno il fenomeno. 97 Anni dopo, lo stesso Giovanni Fais che si unì a Marcedhu, rimpatriato dalla vicina Corsica su cui riparò dopo la battaglia epica a Montecuccaro fra banditi e truppe regie (1745), ormai settantenne viene ucciso da altri due latitanti ai quali è promessa amnistia e premio in danaro (1774). Anche Fais, appena quindicenne, si diede alla macchia dopo aver ucciso un uomo nella piazza del paese, sottraendosi così alla legge di Stato. Parteggiò per una delle due fazioni che a Nulvi diedero corso alla lunga faida della nobile famiglia Delitala, che espresse anche la bellissima ed interessantissima figura di Donna Lucia, banditessa passata alla storia per il grande coraggio e la destrezza manifestata nell’uso delle armi e nel cavalcare, superando addirittura il più valoroso degli appartenenti all’altro sesso. Verso la fine del ‘700, quando la occupazione savoiarda compie l’80° anno, la repressione dei moti antifeudali decreta un fuoriuscitismo politico ed il darsi alla latitanza di numerosi personaggi appartenenti agli strati sociali alti. Gli esuli, spesso nella vicina Corsica, ed i latitanti politici devono ben presto fraternizzare col mondo dei banditi, e con esso condividere se non ideali sicuramente condizioni di vita e di lotta contro il comune nemico. Tuttavia, così come avvenne per il banditismo della feudalità “antispagnola”, anche in questo caso i contatti non sono altro che un dato contingente. Gli anjoyani infatti, pur accolti fraternamente dalle bande di “fuorilegge” che agiscono tra la Sardegna e la Corsica dedicandosi in modo particolare al contrabbando ed alla esportazione di bestiame rubato, devono ben presto rendersi conto che l’accoglimento è occasionale. Non sappiamo fino a che punto possa essere accreditata l’ipotesi secondo cui la collusione fosse vista dai banditi esclusivamente in funzione della sicura amnistia di cui avrebbero beneficiato nel caso i repubblicani fossero davvero riusciti a sconfiggere la monarchia savoiarda. Ma una tale ipotesi dà comunque il senso della distanza fra gli ideali degli uni e la concezione degli altri. Con ciò è facile intuire che dopo il primo sofferto appoggio ai rivoluzionari, nel momento in cui questi credono di strumentalizzarlo per propri fini, i latitanti lo tolgono definitivamente. Pietro Mamia, che catalizza attorno a sé decine di banditi, appoggia all’inizio l’idea di una generale sollevazione popolare che, a partire dal Capo di Sopra, getti le basi per la proclamazione dell’indipendenza. Dopo però si sottrae a un tale impegno, sicuramente perché ha compreso fin troppo bene che il suo concetto di indipendenza è affatto diverso da quello dei repubblicani francesizzanti. Ciò dimostra che non vi è possibilità di strumentalizzazione del banditismo da parte di alcuna ideologia “alternativa”. Essendo espressione di una cultura che resiste e si manifesta valida pur nel concreto rapporto determinato dalla colonizzazione, il banditismo 98 non abbisogna di alcuna ideologia atta a giustificarlo, di programmi che non gli appartengono. Semplicemente perché trova in se stesso ogni fondamento e giustificazione. Non è un “alternativo sistema politico” che mira ad instaurare; bensì a sconfiggere, anzi a sottrarsi a, quello dominante. Per assurgere “alla dignità di forza storica” il banditismo non dovrebbe affatto divenire una componente subordinata (Pietro Marongiu) della rivoluzione “anjoyana”, né di qualsiasi altra rivoluzione a carattere partitico/ideologico. Bensì, esattamente il contrario, è nel suo manifestarsi stesso che assurge a dignità umana e politica in quanto resistenza di un popolo e di una cultura che non vuole perire sotto la sferza della colonizzazione. Ed è in se stesso che per non perire di autospossamento deve trovare oltre la resistenza, oggi più che mai, la necessità dell’attacco contro l’occupante e tutti quei momenti che non gli sono propri. 2.2.3 Il banditismo nell’800 Caratterizzata dai momenti messi precedentemente in risalto, la dominazione piemontese deve infierire massimamente nel XIX secolo quando, con appositi atti normativi (le Leggi delle Chiudende) decreta tra il 1820 ed il 1868 l’esproprio delle terre comunitarie, dei diritti ademprivili delle collettività sulle terre comunali e feudali, insomma quando si consuma il massimo dei delitti ai danni delle genti sarde: l’introduzione per decreto della perfetta proprietà capitalistica. Come è facile intuire viene stravolto l’assetto economico su cui si sostenta la specifica cultura. Ciò determina non solo l’incremento dei latitanti e del banditismo ma anche l’emergere dei printzipales, che parteciperanno direttamente al nuovo corso delle bardanas. Al rifiuto delle popolazioni di recintare le terre comunitarie in cui trovano per buona parte il proprio sostentamento, corrisponde l’azione opposta dei feudatari, dei borghesi cittadini che vantano ancora interessi nelle campagne, delle famiglie ricche pastorali che recintano tutto: boschi, strade, sorgenti. Le comunità vengono espropriate della terra, dei pascoli, del diritto di fare legna e di cacciare. Inevitabile la ribellione nei villaggi, che si sollevano uniti dal Capo di Sopra fino agli estremi Campidani. I grossi printzipales dell’interno, avendo costruito la propria ricchezza non più secondo i canoni accettati dalla cultura, bensì grazie alla condivisione del colonizzatore, hanno definitivamente posto in essere la dimidiazione, la divisione sociale. Sicuramente individui e famiglie rinomate e stimate, altamente valorose secondo i canoni tradizionali, sentono ora su di sé l’odio della comunità, nei confronti della quale hanno consu- 99 mato il più alto tradimento. La loro ricchezza non corrisponde più alla balentìa e neppure allo sfruttamento sapiente delle conoscenze ed amicizie vantate in seno ai colonizzatori: per buona parte è stata estorta con le armi dello Stato alla comunità, nella quale gli stessi printzipales devono pur vivere. In queste condizioni si acuiscono le inimicizie, avanzano le vendette, nascono nuove faide. Gli omicidi intracomunitari non si contano più e coloro che si danno alla macchia assommano a diverse migliaia. L’insofferenza dei printzipales è tale che pur di alleviare odio e disprezzo nei loro confronti, sono pronti a dimostrare, armi alla mano, non solo le proprie qualità di balentes, ma finanche le capacità di condottieri in quelle antiche razzie che furono le bardanas, procurando ricchezza a tutta la comunità. Particolarmente interessante, perché possibile ricostruirne quasi tutti i momenti, è la bardana di Tortolì, ridente paesone nella costa orientale, consumata il 13 novembre 1894. La grassazione avviene ai danni del ricchissimo cav. Vittorio Depau. Un centinaio di uomini armati assediano l’intero paese, occupandone i punti strategici in modo tale che eventuali impreviste visite, in entrata ed in uscita dall’abitato, siano immediatamente comunicate a quanti, invece, si occupano della razzia nella casa prescelta. Uno dei servi di Depau, che si oppone armi in pugno alla rapina, viene eliminato. La stessa caserma dei carabinieri è circondata ed adibita per l’occasione a carcere degli stessi militari, costretti dai bardaneris a restarvi rinchiusi. Com’è d’obbligo in casi del genere, nessuno del paese interviene per evitare la grassazione, anche se l’intero abitato è centro di una vera e propria sparatoria. L’abitazione è saccheggiata; il bottino assai consistente: monete e marenghi d’oro, gioielli e posate in metallo prezioso, ecc. Durante l’azione uno dei bardaneris viene gravemente ferito, per cui nella strada del rientro verso casa, a saccheggio terminato, muore. I compagni gli mozzano la testa e lo denudano, affinché non possa essere riconosciuto, né si possano facilmente individuare il suo ceto sociale ed il paese di origine (ciò che potrebbe portare a scoprire anche l’identità degli altri). Il centinaio di uomini a cavallo è sceso dai monti del nuorese verso la ridente cittadina. Il cadavere decapitato del bardaneri rimasto mortalmente ferito porta calzini delicati e le bianche e tenere mani lasciano intendere che trattasi di persona appartenente a ceto sociale elevato. Così gli “indizi” lasciati sul terreno danno ad intendere che almeno alcuni componenti la banda appartengono al ceto dei printzipales, che dopo la grassazione hanno tranquillamente goduto della normale vita civile. Questo fatto è confermato indirettamente dalla testimonianza di altra personalità che, invitata ad una festa in casa di benestanti di un paese 100 dell’interno, si accorge che le posate in metallo prezioso di cui si serve per la consumazione dei pasti, sono state precedentemente rapinate in casa di un altro suo conoscente, in altro lontano paese. A questo aspetto del banditismo, che rimanda alle antiche razzie contro romani, bizantini e così via, si affianca l’emergere delle più alte e rinomate figure di banditi/latitanti che ancora oggi son rimaste vive nella memoria di chi ha vissuto la tradizione orale come unico mezzo di trasmissione della storia. Una di queste è Giovanni Corbedhu, di Oliena, pastore. Accusato ingiustamente di abigeato si sottrae alla justitzia dandosi alla macchia. Qui si unisce in banda ad altri latitanti ed in un agguato teso dai carabinieri, appositamente informati da un printzipale del paese, certo Saggia, perde la vita un suo carissimo amico. La vendetta viene puntualmente consumata: Saggia è ucciso da Corbedhu in una imboscata. Della sua morte sono accusati però due accompagnatori dell’ucciso; per evitare che lo Stato consumi l’ennesima ingiustizia condannando due innocenti, Corbedhu, in una dichiarazione giurata scagiona i due, attribuendosi la paternità dell’eliminazione del “traditore del popolo”. Continua a vivere di abigeato ed altri “reati” restando nel contempo nell’ambito del proprio paese. Qui partecipa, “anonimamente” alle pubbliche feste, significando ciò l’assoluta simbiosi e simpatia con la comunità d’origine. Epica la vendetta ai danni del maggiore dei carabinieri di Nuoro, certo Spada, che promette a Corbedhu l’assoluzione per sé ed i suoi compagni di macchia qualora si fossero costituiti. Se il bandito rifiuta non senza sdegno, forse annusando puzza d’imbroglio, altri latitanti della sua banda, sicuri della promessa di avere un processo equo, si costituiscono ma al dibattimento subiscono pesantissime condanne rispetto ai reati loro ascritti. Spada si manifesta soddisfatto dell’esemplarità delle pene e pubblicamente porta vanto di aver sconfitto (!) il banditismo nell’isola. Il 4 maggio 1887 Corbedhu assalta la diligenza che da Nuoro porta a Macomer, in cui si trova finanche il maggiore Spada. Fattolo scendere si impossessa tranquillamente delle sue armi, quindi lo denuda completamente lasciandolo in balìa del pubblico disprezzo e della derisione popolare. Ma anche il bandito di Oliena è destinato a cadere, il 2 settembre 1898, sotto i colpi dei carabinieri che gli tendono una trappola a riu de Monte, dietro delazione. Viene eliminato assieme al sedicenne Francesco Dore, con fucilate alla schiena sparate dal franco tiratore scelto Aventino Moretti, vero e proprio cecchino che troverà la morte nella zona di Morgogliai, il 9 luglio dell’anno successivo, per mani dei latitanti con i 101 quali le forze armate intrattengono un’altra storica battaglia-carneficina. Mentre la giunta comunale di Oliena plaude alla vigliaccata del cecchino, elogiandone il coraggio e la bravura, nessun olianese ritiene opportuno rendere omaggio alla justitzia di Stato, tanto che il Procuratore Generale deve pubblicamente ricordare il “vergognoso atteggiamento degli olianesi” (segno che si viveva per davvero assai diversamente dall’oggi, se si pensa e si confronta tale dignitoso comportamento con quanto è accaduto in tempi recenti, a Osposidha). All’atto dell’eliminazione, a Corbedhu viene trovata addosso la scimitarra sottratta al maggiore Spada, portante la scritta “viva il re di Sardegna” che tanto ha fatto teorizzare studiosi di banditismo sociale, politici e criminologi, senza che mai, tuttavia, nessuno abbia chiarito e stabilito se tale incisione fosse dovuta al bandito oppure al carabiniere. Significativo, infine, il suo intervento, sicuramente richiesto da persone a cui non poteva negare favori, per la liberazione dell’imprenditore del legno, il francese Regis Pral, sequestrato assieme a due suoi accompagnatori (subito rilasciati, di cui uno sardo) nelle campagne fra Aritzo e Seulo il 25 luglio 1884. L’intervento, fruttuoso, di Corbedhu solleva lo Stato da una vergognosa vertenza internazionale e pone in evidenza che fra le diverse bande sparse per la Sardegna esistono comunque contatti, spesso assai stretti, basati non sulla “temibilità” di questo o quell’altro bandito – che dominerebbe in tal modo sugli altri – bensì sulla reciproca stima e, perché no, sullo scambio di favori. In quel frangente il bandito olianese, a quanto si dice, rifiuta sdegnosamente ricompense, ma malgrado tutto non è affatto certo che alcuno abbia mai pagato il riscatto richiesto (lo fece, come è presumibile supporre, lo Stato medesimo). Per sottrarsi alla legge, un’infinità di altri sardi, spesso ingiustamente accusati, dopo aver operato la vendetta così come richiesto dal proprio codice, si danno alla macchia. È il caso di Giovanni Tolu, di Florinas, latitante dal giorno in cui tenta invano di uccidere il parroco del paese che insinua sua moglie; la sua latitanza dura circa mezzo secolo. Così è anche per Vincenzo Fancellu, di Dorgali, noto col soprannome di “Berrina”, che subisce un processo in cui notevole importanza accusatoria ha il printzipale Antonio Dore. Su quest’ultimo si riversa quindi tutto l’odio del latitante, fino a che lo costringe a barricarsi in casa, impedendo chiunque di accudire alle sue proprietà. Per aver ucciso in una colluttazione il presunto abigeatario che gli ruba un toro, si dà alla macchia anche Giovanni Moni Godhe di Orune, nel 1891, conosciuto come “Lotze”. Michele Moro “Torracorte” e Liberato Onano condividono circa 102 trent’anni di latitanza nella zona del Sarcidano e delle Barbagie di Seulo e Belvì, senza necessità di effettuare grassazioni perché contano sul pieno appoggio e protezione delle locali popolazioni. Significativo il caso di Paolo Solinas, di Sarule, il cui padre è condannato a due anni di galera dietro accuse del maestro/possidente del paese, Antonio G. Porcu. Allo scopo di vendicare il padre, Solinas diffida i compaesani (come hanno fatto innumerevoli altri banditi) dal mandare i figlioli a scuola e dall’accudire le proprietà del nemico. Giovanni Serritu, di Mamoiada, dopo aver subito l’esproprio di un fazzoletto di terra per non aver pagato le tasse all’erario, si vendica contro gli esattori dai quali “riscuote” gli oneri fiscali e li ridistribuisce ai più bisognosi del paese. Il XIX secolo si conclude assai tristemente per il banditismo isolano, che nella trappola tesagli in località Morgogliai, agro di Orgosolo, deve subire un duro colpo infertogli all’unisono da carabinieri e militari dell’esercito, assommanti ad oltre 200 uomini. La “Caccia grossa” (titolo di un famigerato libro dell’altrettanto famigerato autore, il militare Giulio Bechi che partecipò a tutte le operazioni di “pulizia” negli ultimi anni del secolo), a Morgogliai costa la vita ai fratelli Elias e Giacomo Serra-Sanna, di Nuoro, a Pau ed a Virdis, mentre “Lovicu” (Giuseppe Lodho) riesce a sfuggire all’agguato. La trappola in agro di Orgosolo fa parte di un intervento complessivo che anticipa di decenni la pratica nazista antiebrea, e decreta l’arresto e la deportazione in massa di intere popolazioni, l’uccisione di 8 latitanti, l’arresto di altri 31 mentre 30 si costituiscono in seguito all’arresto-ricatto dei propri familiari. 2.2.4 Il banditismo nel XX secolo L’intervento “civilizzatore” dello Stato italiano raggiunge l’apice alla fine dell’800. Il processo repressivo, destinato comunque a fallire pur nella brutalità dei metodi, data la consistenza sociale del banditismo, può essere meravigliosamente riassunto nella storica notte di “San Bartolomeo” (G. Bechi), a cavallo fra il 14 ed il 15 maggio 1899, quando il capitano Petella, con schieramento militare segretamente organizzato, irrompe allo scoccare della mezzanotte in tutti i centri del circondario di Nuoro e Otzieri, arrestando circa 500 persone fra donne, bambini, vecchi ed uomini i quali, dopo un primo concentramento in “depositi” di prigionieri, vengono deportati nelle galere del capoluogo sardo, di Sassari e della terraferma. Stessa civile operazione viene ripetuta la notte tra il 14 ed il 15 agosto del medesimo anno nei paesi della Barbagia di Seulo. 103 Queste operazioni di alta civiltà, unitamente alla strage di Morgogliai chiudono in bellezza un secolo di colonizzazione e segnano l’inizio del successivo, destinato come il precedente a subire medesima sorte. Viene decretata la “definitiva sconfitta” del banditismo sardo, e all’inizio del 1900 se ne fa portavoce l’allora procuratore del re in Nuoro, Efisio Marcialis. A partire dal 1903 prende il via la faida di Orgosolo, che terminerà solo nel 1916 quando i morti da ambo le parti assommano a diverse decine. In questo specifico caso diviene evidente il ruolo giocato dalle istituzioni statali nell’acuire il contrasto, parteggiando visibilmente per una delle parti in causa e pertanto logorando entrambi nella lotta fratricida. Il contrasto iniziale nasce per questioni legate all’eredità di Diego Moro, frutto di una consistente bardana a quanto si dice non spartita. Le fazioni si costituiscono attorno ai nipoti del ricco scomparso: Giovanni Antonio e Angela Rosa Corraine (i Corraine) da una parte; Domenica Corraine (in Podha) e la sorella Giovanna in Cossu (i Cossu) dall’altra. Falliti i tentativi di risolvere pacificamente i contrasti tra le due fazioni, non deve trascorrere molto tempo prima che il sangue faccia la sua comparsa. I Corraine (la fazione economicamente e politicamente più debole ed ininfluente) subiscono la morte di Carmine, figlio di Giovanni Antonio, ucciso con una fucilata dal cugino Egidio Podha. Giovanni Antonio, considerata l’evidenza del delitto, ma anche perché consapevole della delicatezza del momento e della sua posizione svantaggiata, denuncia il nipote alla magistratura. Il perché della denuncia rimane comunque ipotetico, non potendosi escludere che il padre dell’ucciso abbia fatto ricorso allo Stato allo scopo di “garantirsi” nel momento in cui porrà in atto la propria vendetta. Malgrado le prove e l’evidenza del fatto, però, l’uccisore viene assolto. Ciò pone in evidenza l’influenza dei Cossu che vantano anche l’appoggio del prete don Diego, le cui amicizie spaziano ovunque. Da questo momento è un susseguirsi di morti da entrambe le parti, anche se all’inizio i Corraine devono subire la peggio. Carabinieri e magistratura fanno sempre pendere l’ago della bilancia a favore dei Cossu, per cui alla fine i Corraine si danno alla latitanza per meglio agire nella vendetta. Alla macchia la loro debolezza politica ed economica viene superata dall’arditezza delle azioni e dalla completa libertà. Sotto la spinta dei Cossu, i carabinieri allora attuano una ennesima “notte di San Bartolomeo”, stavolta a scapito dei Corraine, prorogata per ben sei giorni. Nel solo primo tempo dell’operazione vengono arrestati sei donne e quindici uomini. Alla fine gli arresti ammontano a 52. I Corraine rispondono dalla macchia, tra l’altro uccidendo anche 3 ragazzi dei Cossu. 104 Questi, alla fine, accettano in certo qual modo la sconfitta ed avanzano trattative di pace, effettivamente avvenuta nel 1916 (pages de sanbene). Contrariamente alle interpretazioni romantiche, questa ed altre documentate “recenti” faide e disamistades, provano che la guerra tra fazioni avverse avviene, una volta scatenata, con pochissime regole, soprattutto perché la costante presenza delle istituzioni statali impedisce i meccanismi dell’autoregolamentazione. Inoltre le istituzioni intervengono direttamente fra i contendenti al fine di acutizzare i momenti degeneranti dello scontro. La faida è comunque esclusivamente guerra per sconfiggere l’avversario, per cui ogni metodo alla fine è buono, finanche il tentativo di utilizzare le istituzioni. La fine della disamistade è un atto pubblico, che viene sancito dall’intera collettività. Giganteschi banchetti chiudono un’epoca e ne aprono una nuova. Data la presenza dello Stato, delle sue leggi e soprattutto delle sue istituzioni civili e militari, che perseguitano i coinvolti nella faida, è giocoforza decretare la pace alla presenza delle massime autorità locali, che di solito portano vanto di averla esse stabilita. Invero, il loro reale coinvolgimento non avviene per altri motivi se non quello di ottenere la chiusura definitiva di tutti i procedimenti giudiziari, assolvendo gli imputati di tutte le fazioni. Così accadde per la disamistade di Orgosolo. Anche Onorato Succu, della fazione dei Corraine, rientra “assolto” ad Orgosolo, dopo anni alla macchia. Si unisce in matrimonio sicuro di poter godere la vita che gli resta in relativa tranquillità. Ma l’odio dei carabinieri nei suoi confronti è tale che lo sottopongono sempre a particolare controllo e repressione. Tanto che, nel 1920, viene da essi accusato di aver ucciso l’appuntato Mayocca. Deve quindi darsi di nuovo alla latitanza. Onorato Succu è una prestigiosa figura di bandito, che riesce ad ottenere la simpatia e l’appoggio della popolazione. Quando è alla macchia, nel corso della disamistade, la banda di cui fa parte viene in un dato frangente dimezzata ed in quella occasione perdono la vita suoi fratelli di sangue. Amico di Samuele Stocchino (di Artzana, ancora oggi vivo nella memoria dei sardi per le sue gesta e per la determinazione con cui combattè le spie) con egli condivide vita randagia ma anche coraggio, astuzia, determinazione ... e morte violenta per mano dei carabinieri, in seguito a delazioni. Di Succu è interessante il fatto che, nella seconda latitanza, avendogli addebitato la responsabilità del sequestro di alcuni bambini (sicuramente per il fatto che nel corso della faida di Orgosolo a lui si addebitarono le morti dei tre ragazzi della fazione dei Cossu) riesce a scrollarsi di dosso 105 tale infamità scoprendo i veri responsabili e denunciandoli pubblicamente. Accrescono in tal modo la fama ed il rispetto di cui gode. Ma l’infamia è in agguato. In agro di Mamoiada, in località sas Fossas, il 29 maggio del 1927 una spiata ai carabinieri decreta la morte di Onorato e della sua banda. I sempre fedeli allo Stato, ora fascista, compiono la solita efferata strage: vengono crivellati di colpi Succu e tre suoi compagni che perdono così la vita; sono invece arrestati il fratello Giovanni Antonio, Antonio Tandedhu e Agostino Mele. Il regime esulta e decreta l’ennesima sconfitta del banditismo sardo. Ma ... 2.2.5 Il banditismo del secondo dopoguerra In tempi a noi più recenti, esattamente negli anni a cavallo tra il ’50 ed il ’60 a Sedilo, paesone sito ai margini nord occidentali della Barbagia di Ollolai, si scatena un’altra faida di gigantesche proporzioni. Stavolta però la causa non è una eredità, bensì pare che nasca da contrasti tra fazioni operanti nel medesimo territorio, su cui una vorrebbe il predominio assoluto. La posta in gioco è il controllo del bestiame rubato, presumibilmente di grassazioni, rapine e anche di sequestri di persona. La faida stavolta non termina nella page de sanbene, ma nella vittoria/sconfitta di una fazione: vittoria sugli avversari; sconfitta perché infine il “vincitore” viene condannato all’ergastolo, tradito anch’egli “dall’interno”. Ma le figure che forse più di altre meritano una pur breve cronistoria sono Pasquale Tandedhu e Liandru, entrambi di Orgosolo. Alla fine del 1948, appena ventiduenne, Tandedhu si dà alla macchia perché rifiuta di mettersi a “disposizione della magistratura” che, interrogatolo per un tentato furto, gli impone la permanente disponibilità per ulteriori accertamenti. Nel Supramonte vi sono all’epoca più di cento latitanti, per cui anche se assai giovane trova maestri adatti alla bisogna e ben presto impara a guadagnarsi da vivere. Al Supramonte è di casa anche Giovanni Battista Liandru, rinomato personaggio scomparso di recente. Liandru, servo-pastore di un printzipale di Orgosolo, viene da questi licenziato. Liandru ruba pertanto un cavallo all’ex-printzipale, cosa che gli costerà assai cara. Il proprietario riesce a catturarlo e proprio nel Supramonte lo sottopone a tortura ed a morte certa lasciandolo appeso ad un alto albero per le mani. Il che però non è così offensivo come l’atteggiamento successivo: non contento di aver inflitto una così pesante ritorsione all’ex-servo pastore, il printzipale lo denuncia alla magistratura per il furto del cavallo. Recidivo, Liandru viene condan- 106 nato a ben otto anni di galera, da scontare in quella di Mamone. Per il printzipale è la condanna a morte. Liandru riesce ad evadere e si vendica su colui che lo ha mortalmente offeso, uccidendolo nello stesso modo a cui egli invece scampò: il suo nemico viene appeso ad un albero del Supramonte e così trova la morte. Per Giovanni Battista Liandru l’atto gli vale il massimo rispetto. Nel periodo, oltre al bestiame la ricchezza sociale inizia ad essere rappresentata sempre più finanche dal denaro, che circola maggiormente che in passato. Normale di conseguenza l’estendersi del furto anche alla “nuova” ricchezza. All’abigeato si affianca l’assalto agli autobus di linea, ma soprattutto agli automezzi che trasportano danaro, spesso rappresentato dalle buste-paga dei dipendenti delle imprese che operano nella zona. A Monte Maore, il 13 agosto 1949, viene assalito un furgoncino della “Società Flumendosa”, che trasporta le buste-paga degli operai della costruenda diga sul fiume omonimo: 9 milioni di lire, a quanto si viene a sapere. I carabinieri di scorta, anche in questo periodo fedeli al capitale e allo Stato, aprono il fuoco. Sfortunatamente per essi i banditi però non sono sprovveduti, stavolta, per cui rispondono prontamente al fuoco. È una strage: tre carabinieri rimangono uccisi, uno gravemente ferito, un altro perirà in seguito alla ferita riportata. Prima dell’assalto guerrigliero i banditi ben pensano di isolare i civili in transito, imponendo loro di starsene buoni e quieti. La reazione all’assalto di Monte Maore da parte dei carabinieri è, come sempre, delle più barbare: pestaggi e torture ai danni di chi cade nelle loro mani, così che possono infine fare incetta di diversi latitanti. L’anno successivo (1950) cade nelle loro mani lo stesso Liandru, ormai semi-cieco, stanco, distrutto dalla malattia. La sua cattura è sempre stata oggetto di ipotesi, tutte più o meno plausibili. Comunque sia lo Stato fa pagare a quest’uomo tutto ciò che gli fa comodo, ma Liandru, malgrado l’età e le sue condizioni fisiche, manterrà sempre un atteggiamento distaccato, negando ogni addebito. Subirà le condanne in assoluto silenzio ed in galera farà altrettanto. Infine, graziato, potrà rivedere la libera luce del Supramonte, non prima di aver subito trent’anni di galera, da cui riuscì a strappare la sua esistenza. Arrestato Liandru le istituzioni trovano subito chi porre, a capo del banditismo sardo, quale suo sostituto, Pasquale Tandedhu, ispirato a quanto si racconta dal più anziano zio Giovanni. È evidente che in tutta la storiografia che vuole ricostruire il fenomeno vi è presente sempre il tentativo di attribuire al momento aggregativo dei latitanti gli stessi metodi e le stesse norme valide nella società di Stato. Questo modo di procedere emerge nelle ricostruzioni operate sul “perso- 107 naggio Tandedhu”, messo a capo di una banda gerarchicamente strutturata che avrebbe avuto in eredità da Liandru. In realtà una tale interpretazione cozza mirabilmente con la forma mentis propria di chi si è dato alla macchia, che esclude il volontario sottoporsi ad un comando esterno all’individuo medesimo. Così tutto ciò che viene addebitato quale opera esclusiva di Tandedhu deve essere in effetti inteso come opera collettiva, cui tutti hanno contribuito ciascuno nella sua specificità. Sicuramente quest’uomo aveva doti non comuni, non escluse certe manie di accentramento di potere, e vi è come al solito colui che afferma che voleva imporsi se non sul resto dei latitanti, sull’intera comunità di appartenenza. Ma la sua tragica fine è l’evidente prova che la presunta mania di cui era vittima non trovò spazio – se non nei termini di prestigio (riconoscimento della balentìa) – nell’ambiente culturale in cui viveva. Pare che dietro ispirazione di Pasquale venga affissa, nella porta della chiesa di Orgosolo, quella assai nota lista dei 25 nomi corrispondenti ad altrettante spie-confidenti-delatori della justitzia. Il che, come già fece Stocchino e tanti altri, significa la loro eliminazione. Lo Stato è nemico, il nemico numero uno e qualsiasi collaborazione con esso, da parte di chiunque, altro non è se non tradimento dei valori della comunità, e della sua autodeterminazione. Pertanto dev’essere eliminato per non nuocere più. Tra le vittime, la medesima moglie di Liandru, Madalena Soro, che pare avesse più volte manifestato il proposito di confessare alla polizia, pur di salvare il marito dall’ingiusta condanna, chi fossero i reali responsabili dei reati ascritti all’anziano latitante. Errore imperdonabile che gli costa la vita. Anche questa uccisione viene attribuita a Tandedhu, ma nulla vi è di certo anche se, a dire il vero non si può escludere. Pochi giorni prima dell’uccisione della Soro, esattamente il 9 settembre 1950, in agro di Nuoro, località Sa Ferula, vi è l’assalto ai danni di un automezzo dell’ERLAA, l’ente americano che sperimenta nella nostra isola, per la prima volta su larga scala (verrà irrorato in elicottero sull’intera isola) il D.D.T. col pretesto della lotta antimalarica. Il conflitto che ne segue coi carabinieri della scorta è sanguinoso: tre di essi restano uccisi ed altri feriti. Così come si comportano le forze militari nei confronti della popolazione isolana, i latitanti-guerriglieri si comportano coi carabinieri. Viene resa pariglia finanche degli sfregi che, spesso, i militari sogliono fare sui corpi dei caduti: i cadaveri dei carabinieri vengono crivellati di proiettili. Anche l’assalto di Sa Ferula viene attribuito alla “banda Tandedhu”. Poco tempo dopo una spiata decreta la fine dello zio di Pasquale, Giovanni, e di altri latitanti. Puntualmente nuovi nomi di delatori compa- 108 iono nella lista affissa alla chiesa di Orgosolo: si tratta di individui da eliminare. In 4 anni ben 30 persone vengono uccise. Altre epiche gesta guerrigliere si contano a decine, in questo immediato secondo dopoguerra, con sequenza impressionante, come quella del 9 maggio ’51 nei pressi di Urtzulei. Comunque sia, l’attività di Tandedhu e la sua giovane vita sono bruscamente interrotte da una ventagliata di mitra che quasi divide in due il latitante. Sconosciuto l’autore dell’omicidio anche se, come al solito, la versione dello Stato vuole che il famoso bandito sia stato fatto fuori dalle sue forze armate. Sembra però più consona a verità la versione che lo dà giustiziato per mani della medesima popolazione del paese d’appartenenza, o di altri latitanti, che mal sopportavano il rigido atteggiamento e la risolutezza di Pasquale. L’uccisione del fratello Pietro, ad egli attribuita vox populi, anche se la responsabilità di fronte alla magistratura se la prese il padre della fidanzata, Pasquale Rubanu; il fatto che Tandedhu manifestasse prepotentemente il potere di vita e di morte che mai nessuno gli aveva dato né voleva dargli; questi ed altri elementi propendono a pensare che l’uccisione del, per certi versi eroico, latitante sia avvenuta per mani di quanti ormai sentono l’esigenza di porre fine ad un uomo i cui atteggiamenti rischiano di imporsi su tutti. La testimonianza di un pastore, l’unico in grado di sapere lo svolgimento delle cose nella loro verità, afferma che in seguito alla ventagliata di mitra che uccide Pasquale, non carabinieri vi sono attorno al cadavere bensì solo la fuggevole sagoma di uno “del posto” che s’allontana velocemente. 2.2.6 Abigeato furto sequestro vendetta: la costanza del fenomeno Dal punto di vista diacronico il “banditismo” in Sardegna si presenta come costante che risale fino all’epoca della dominazione romana (IV secolo Avanti la Nostra Era). Fino alla dominazione spagnola era caratterizzato dal fatto che, le comunità essendo indivise, le azioni di razzia e di attacco contro l’accerchiamento politico ed economico del colonizzatore avvenivano “in massa”. A partire dalla presenza spagnola il carattere di massa è attenuato dalla lungimirante politica di apertura dei limes imposti precedentemente alle comunità, favorendo dietro ricompensa, la transumanza libera degli armenti e lo spostamento delle genti. Questo fatto determina da un lato l’arricchimento di alcuni pastori/famiglie di pastori, dall’altro l’inizio del- 109 la dimidiazione delle comunità. È necessario però rammentare che non è la ricchezza per se stessa a determinare la divisione, bensì il fatto che questa, soprattutto dopo l’occupazione piemontese, venga garantita dallo Stato. La proprietà privata garantita dallo Stato (ed in parte espropriata alle comunità) è il momento che determina la reale separatezza del ricco dal resto della comunità di appartenenza, in quanto ciò che possiede non è più solo il frutto della propria balenthìa, bensì in parte esproprio della collettività, per il resto garanzia che lo Stato offre ai privati in cambio dell’alienazione. Entro un periodo durato quattro secoli circa, prende forma anche una sorta di banditismo “politico” determinato dalle lotte intestine ai vari gruppi di potere (feudatari). È possibile ipotizzare una certa connivenza, oltre che forme di convivenza, fra il banditismo “politico” e quello resistenzialesociale, ma in ogni caso si è trattato di rapporti marginali ed occasionali. Fin dall’inizio della presenza piemontese (1720) il banditismo si attua nelle storiche bardanas, nell’abigeato, nella grassazione. Segno evidente vuoi della relativa autonomia delle comunità dell’entroterra, che della necessità per queste di saccheggiare in altri territori quanto viene ad esse negato di produrre nei propri. L’occupazione savoiarda decreta un mutamento radicale delle cose. Le popolazioni sono assediate al loro interno per cui più che come nemiche vengono trattate da criminali. La guerra non è più oltre i limes, è nel proprio villaggio, per la sopravvivenza fisica e culturale delle comunità, in quanto entità collettive specifiche, etniche. Le radicali “riforme” operate dai reali più pezzenti d’Europa, che stravolgono le secolari maniere di vivere e concepire i rapporti interindividuali, determinano la criminalizzazione dell’intera Sardegna, periodicamente soggetta a sistematiche operazioni genocide. Il ceto dei printzipales, ormai proprietari perfetti di terre e di armenti, economicamente legato allo Stato coloniale, determina la dimidiazione definitiva delle comunità. L’introduzione anche nell’isola di metodi, uomini ed attività prettamente capitalistici, amplia l’orizzonte delle possibilità di azioni predatorie nuove: verso la fine del XIX secolo prende via il fenomeno “sequestro di persona a scopo di estorsione”. Le bardanas dell’800 inoltre, sono caratterizzate rispetto al passato dal fatto che spesso vengono attuate con l’attiva partecipazione dei printzipales, non deculturati del tutto. Sicuramente trattasi di un fenomeno nuovo, anche perché la divisione del bottino frutto delle grassazioni non avviene secondo equità, come per il passato, bensì sulla base del rapporto di tzerakìa, esistente tra il printzipale (che organizza la bardana e 110 che spesso dirige) e parte dei bardaneris, spesso legati a quello in quanto suoi servi (tzerakus). Questo fenomeno si trascina fino ai giorni nostri e decreta in un certo qual modo l’emergere della contraddizione del rapporto printzipale-tzeraku (padrone-servo), alla base spesso di fratture per “questioni di mala divisione” dei frutti dell’attività “delittuosa”. Le comunità anche dell’entroterra subiscono in tal modo la divisione sociale, cui corrisponde il nuovo corso del banditismo, la militarizzazione permanente, l’acculturazione sempre più insinuosa. Ciò decreta l’arroccarsi sul piano della resistenzialità, la riduzione della prassi dell’attacco a momenti contingenti per di più all’insegna dell’avvenuta dimidiazione che si ripercuote su tutti i livelli. La perenne presenza dello Stato influenza negativamente anche il manifestarsi di quei tratti più autoctoni non ancora scomparsi nel processo deculturante. Così, per esempio, se da un lato il modificarsi degli schieramenti nell’ambito di una faida – cioè la modificazione della struttura compositiva delle fazioni – è prassi costante e propria del medesimo universo culturale, l’interferire dello Stato in seno a tale sviluppo ha conseguenze disastrose, in cui i vantaggi finiscono per essere esclusivamente di quest’ultimo. La medesima cosa accade nel momento in cui una delle fazioni, per motivi propri, ricorre alle istituzioni nel tentativo di indebolire l’avversario, oppure nell’illusione del loro utilizzo a proprio vantaggio. In entrambi i casi chi viene indebolito è comunque l’universo culturale sardo. Così che, nel presente storico, affermare la vitalità e l’integrità come nel passato delle genti sarde e della loro cultura, sarebbe oltre che falso del tutto fuorviante. Invero, oggi la criminalità sarda se da un lato si manifesta come la legittima erede del processo di resistenza definito “banditismo”, è ancora più lacerata nelle sue componenti fisiche, spirituali, umane, culturali. Sicuramente perché oggi lo Stato è molto più presente di ieri e più potente rispetto ai mezzi di acculturazione e denazionalizzazione (TV, radio, giornali, scuole, ecc.). Ma non si tratta solo di questo. Idealità (non in quanto tali malefiche) esterne sono piombate nell’isola nella loro degenerazione in ideologie, a cibarsi del banditismo e della “specifica criminalità”; e cibarsi significa alimentare se stessi, non il cadavere da cui si trae alimento. Le ideologie hanno mirato sempre alla strumentalizzazione, a cavalcare questo come ogni altro dissenso sociale diffuso contro l’ordine presente. Oggi forse vi è la consapevolezza, in tanti di noi criminali e criminalizzati, dei tentativi strumentalizzanti di ogni ideologia, ma spesso è assente la volontà di portare alle estreme conseguenze politiche tale consapevolezza, preferendo ciascuno combattere la propria battaglia isolata- 111 mente, individualmente pur di non riconoscere che l’unica possibilità per evitare il genocidio o, nel migliore dei casi, l’etnocidio, è di porre a fondamento del nostro operare esattamente quei codici comportamentali che come popolo e in quanto individui caratterizzati da questa nostra specificità ci hanno permesso di vivere fino ad oggi, con due millenni e mezzo di dominio coloniale sulle spalle. Anche lo Stato ha compreso che può vincere la battaglia continuando a criminalizzare da una parte, e dall’altra accentuando le fratture, le divisioni, l’isolamento, la parcellizzazione di noi stessi in quanto entità individuali ma collettivamente legate. L’uccisione, il massacro, la strage di massa non è più la sola strada per con-vincere un popolo; l’emarginazione, la galera, il confino ed infine la deportazione dei non omologati ed omologabili sono altrettanto funzionali, soprattutto in periodo di formale rispetto dei diritti “umani”. 112 Capitolo Terzo Il crimine di stato 2.3.1 Il “crimine” in Sardegna Dall’esame sia pure sommario del fenomeno del banditismo sardo emergono con chiarezza alcuni tratti che costituiscono sue fondamentali caratteristiche: la vendetta, l’abigeato, la grassazione, e così via. Possiamo ascrivere alla vendetta tutte quelle azioni poste in essere da chi si sente offeso ai danni di chi (o quanti) lo hanno offeso. Il “meccanismo” che scatta nel momento in cui una persona (o una famiglia) si sente lesa nella propria integrità, è di lavare l’onta subìta. L’ordine infranto viene ricomposto solo nella ritorsione diretta. Ciò non esclude, ovviamente, che si ricorra, in casi “dubbi” a entità riconosciute come imparziali (ma non sovra-pares), allo scopo di intervenire in senso pacificatorio, oppure per confermare l’interpretazione data ai fatti. Tali entità tuttavia si limitano a dare consigli, a valutare le cose, ad esprimere giudizi assolutamente senza possibilità di imporre alcunché a nessuno (anche in quanto non ne hanno la forza reale). Si tratta di personalità riconosciute nell’ambito della comunità, il cui prestigio è punto di riferimento per entrambe la fazioni in lotta. Di recente è divenuta prassi anche il ricorso alle istituzioni statali, molte volte da parte della fazione più debole, non tanto nella speranza che non scatti il meccanismo della vendetta, quanto per garantirsi rispetto alla repressione. Non è escluso, anzi è spesso appositamente posto in essere, il ricorso alla justitzia con il fine del suo utilizzo ai danni della fazione nemica. 113 Tale “apertura” è comprensibile se pensiamo non solo alla persistente acculturazione, ma al fatto che oggi le vendette che terminano nelle faide vanno combattute con mezzi ed uomini le cui possibilità tecniche hanno raggiunto livelli talmente sofisticati da richiedere disponibilità economico-finanziarie e cognizioni scientifiche che non tutti possono avere. Inoltre le clientele politiche, quindi le conoscenze in alto loco (politici, giudici, ecc.), possono far pendere la bilancia della justitzia da una parte delle fazioni in guerra; il che determina anche il ricorrere ad essi prima che alla prassi dell’azione diretta. In definitiva si ricorre più spesso alle istituzioni statali in parte per convinzione (acculturazione), in parte nell’illusione di determinare scompensi nel campo della parte avversa (ciò emerge con evidenza dalla faida di Sedilo cui accenniamo più avanti); in parte per l’impossibilità materiale, per le entità più deboli, di contare su mezzi ed uomini capaci di condurre alla vittoria la lunga stagione della faida. È evidente che, acculturazione o meno, la prassi della vendetta oggi rischia comunque di degenerare più che altro per il ricorso sempre più consistente alle capacità altrui (sia in quanto si ricorre appunto agli apparati di Stato, sia perché si possiede danaro per cui si può pagare una persona estranea per far fuori il nemico, ecc.). Sarebbe un errore il credere che la vendetta sfoci sempre nel sangue, nella faida. Questa è la conclusione sanguinosa di molti attriti non ricomposti in modo pacifico, ma è in ogni caso l’ultimo stadio che il codice comportamentale cerca di evitare graduando le ritorsioni sulla base della gravità dell’offesa. Solo il sangue richiede vendetta con altro spargimento di sangue. Il furto, di norma, non deve essere inteso come offesa, salvo non sia attuato in certi modi ed in determinate contingenze: ai danni di chi è impossibilitato alla cura dei propri beni (carcerati, ecc.), ad esempio. Fino a quando le azioni predatorie e guerriere vengono dirette fuori dalla comunità specifica in cui si vive le faide sono circoscritte, limitate, più controllate in seno al gruppo (salvo non si verifichino per altri motivi, come ad esempio accade nel rapporto di tzerakìa già esaminato). Col manifestarsi della divisione sociale però, le azioni predatorie si verificano sempre più anche in seno alla medesima comunità, ai giorni nostri soprattutto, anche per l’estendersi dei fenomeni tipici della criminalità metropolitana. I ceti privilegiati (kompradores) hanno sempre tentato di riversare fuori dal villaggio le azioni predatorie (bardanas del secolo scorso) senza tuttavia riuscire a superare non solo la contraddizione sociale ma finanche le cause del furto, spesso dettate da necessità di ristrettezze economiche. La persistenza della miseria e della ricchezza non è contrasto che possa essere superato se non nella redistribuzione di quest’ultima. 114 D’altra parte la miseria rompe spesso gli argini decretati dai codici. Chi nulla possiede, per sopravvivere prende ciò di cui necessita da chi lo possiede, anche se questi fa parte della stessa comunità (ad Orani viene classificato thitule – persona di poca valenza, miserabile – colui che, pur necessitato, invece di operare il furto nelle altre comunità lo fa nella propria, ai danni dei suoi stessi paesani). Così, oggidì, non sono affatto rari i furti, l’abigeato non solo nella medesima comunità ma addirittura ai danni di chi poco possiede. Ciò determina l’insorgere a catena di odi, disamistades, tensioni che esasperando gli animi rappresentano il primo passo verso le faide. È assai facile interpretare in condizioni di esasperazione come offese gravi quanto invece è semplice furto. Tanto più che, essendo i legami individuali e quelli interfamiliari assai indeboliti rispetto al passato, non è più tanto facile neppure contare, come un tempo, sulle figure dei personaggi pregni di prestigio. Con lo Stato ormai insinuato in ogni villaggio, in ogni via a rendere assai ardua la ricomposizione del gruppo, anzi significativamente acutizzando le tensioni ed alimentando disamistades, faide e sospetti, a chi vive secondo il proprio codice altra via non rimane che quella di sottrarsi all’imperio degli organi militari e giudiziari dandosi alla latitanza. Chi si attiene ai propri codici per non sottostare all’imperio di una legge altra, diviene criminale, “bandito” in una accezione assai ampia del significato. Anche l’abigeatario, figura valorosa per ogni sardo non metropolizzato, viene additato dallo Stato come delinquente, malgrado non via sia isolano che, almeno una volta nella sua vita (se vissuto dalla/nella campagna) non abbia rubato una bestia. Se fattori propri del meccanismo della faida spingono uno o più componenti a darsi alla macchia anche per meglio operare nella ritorsione vendettale, se non vi fossero la repressione e la presenza costante delle istituzioni giudiziarie e militari mai nessuno si darebbe alla latitanza perché autore del furto di bestiame. Dato di fatto che pone in evidenza come buona parte della criminalità sarda, è creatura dello Stato. 2.3.2 La criminalità di Stato Un altro momento, che è necessario sottolineare, è che le istituzioni, oltre alla criminalità indiretta (di cui al precedente paragrafo) creano anche direttamente ulteriore criminalità. L’assoluta negazione dell’alterità fa sì che la justitzia colpisca “nel mucchio”. In questo modo “colpevoli” ed “innocenti” sono accomunati al medesimo destino della persecuzione perenne. Gli innocenti, al pari di coloro che hanno posto in essere le azioni 115 considerate delitto dallo Stato, non possono che sottrarsi ad esso dandosi alla macchia. Qui, salvo rare eccezioni, la vita dev’essere condotta da tutti alla medesima maniera: nella palese illegalità. È indispensabile infine considerare, per le implicanze anche di carattere più propriamente politico, i contatti reali e sempre possibili fra il fenomeno criminale e le ragioni culturali che lo sottendono, da una parte, e dall’altra le ideologie proprie di alcuni partiti politici che paiono con quelle affini e che tentano di sussumerle smussandone i contenuti radicali. Nello specifico sia il P.S.d’Az., sia il P.C.I. sembra abbiano esercitato su alcune personalità un certo fascino, che i due partiti hanno poi tentato in qualche modo di utilizzare per portare ovviamente acqua al proprio mulino di potere, facendosi portatori – dopo apposita opera di snaturamento – di alcuni contenuti che sostengono il banditismo e l’articolazione sociale sarda. Tuttavia, alla fine, possibili legami ed influenze nonché ricercate similitudini si son concretizzate palesemente come manipolazioni effettuate a scopo speculativo. Fatto è che risulta assolutamente impossibile una vera e propria simbiosi fra le due realtà. Il banditismo è in ultima istanza il frutto scaturente da un dato assetto culturale nel rapporto di colonizzazione e non vuole scomparire di fronte alla repressione imposta da una entità altra. È autofondato ed ogni possibile “somiglianza” con ideologie sia pure “rivoluzionarie” è di esclusivo carattere contingente. Tanto più quando l’ideologia è emersa dal seno della medesima realtà a cui si oppone. La forma di organizzazione partito, modernamente inteso come stabile corpus teorico e struttura di uomini gerarchicamente organizzati non è altro che, nel suo piccolo, esattamente lo specchio fedele di quella realtà combattuta dal banditismo, quindi precisamente l’opposto della cultura che nel banditismo si esprime. Appartenere ad un partito, se pure l’ideologia che lo anima può essere attraente e condivisibile a titolo personale, significa rinunciare comunque alla libertà di singolo ente, sottomettersi a rapporti di obbligo e di rinuncia che annullano l’individuo, alienato all’ideologia. Se ciò avviene per parecchi sardi, banditi o meno, per altrettanti scatta la molla del rifiuto, almeno fino a quando vive ed operanti sono le ragioni del persistere della propria cultura, della identità etnica ed individuale. Il bandito sardo, meno di qualsiasi altro, non potrà mai essere “organico” ad un partito politico, poiché mai accetterà la disciplina che questo richiede ai suoi membri. È un’aspetto della tragedia di Tandedhu, ad esempio, sicuramente esaltato nello spirito e nelle gesta dall’ideologia del P.C.I. Ma il partito sempre ripudierà ogni Tandedhu, esattamente a causa della 116 sua manifestata indisciplina e libertà. Nessuna ideologia potrà mai risolvere il banditismo, così come nessun economicismo di maniera. La risoluzione deve essere globale, come globale è la questione sarda; questione di potere, quindi politica per eccellenza, cioè concernente la capacità di emanare le norme sociali e di farle rispettare. Il che non può avvenire se non nella piena e totale messa in atto dell’autodeterminazione delle genti sarde, che hanno mantenuto vivi parte almeno di quei momenti della propria autonomia che pongono il concreto individuo al centro dell’universo ed i rapporti fra gli enti reali nelle mani di ciascuno. Non vi è ideologia e tantomeno partito in grado di ricomporre la giustizia sociale che decreterà la definitiva scomparsa della “criminalità” sarda. Gli elementi esterni alla società selvaggia, materiali ed ideologici, se pure hanno oggi una qualche ragione per essere presi comunque in considerazione “critica”, non devono soffocare, sovrapponendosi ad essi, i momenti di autodeterminazione. Sono questi che, dall’interno, devono superare se stessi negli aspetti negativi e contraddittori, così come l’uomo adulto supera se stesso fanciullo senza con ciò dare vita ad un altro ente. È questo l’immane compito della lotta di liberazione nazionale ed è tale lotta che il colonizzatore, nel processo di denazionalizzazione, acculturazione e repressione mira a soffocare, impedendogli di svilupparsi. A ben vedere in tale processo trova apposito spazio anche l’ideologizzazione di tutti i momenti dell’autoctonia appositamente assimilati ora a questo ora a quell’altro momento che nulla di più sono se non strumenti della acculturazione: cristianismo, comunismo ideologico, costituzionalismo, democraticismo e via discorrendo. 2.3.3 Lotta alla criminalità: la justitzia (di Stato) in Sardegna Affermare oggi che lo Stato italiano è incapace di cogliere l’alterità e le ragioni che la sottendono, se pure corrisponde a verità è comunque operazione tautologica mistificante in assoluto. In realtà più che di incapacità dovuta ad incomprensione si tratta di impossibilità storica del potere accentrato (e quindi dello Stato) di accettare l’alterità, dovendo la propria esistenza precisamente alla negazione dell’autodeterminazione, quindi alla soppressione dell’altro da sé. Il potere accentrato deve omologare tutto a coordinate che, nella sostanza, da esso partono e ad esso riconfluiscono. Anche quei momenti di formale riconosciuta autonomia di cui godrebbero individui e gruppi umani, non sono che dipendenza a doppio filo dal centro. Non a caso la cosiddetta unità politica dello Stato è inviolabile. Al più, se ciò è più convenien- 117 te, si concede una più o meno vasta “autonomia amministrativa”. Si tratta di palliativi formali che lasciano intatta la sostanza della dipendenza/subalternità dal centro, tanto più pericolosi quanto più sono accettati non solo dai kompradores ma finanche da quanti sono davvero altri rispetto all’esistente. Questo meccanismo centripeto (motropolicentrico, secondo la felice coniazione di un compagno) mirante a sopprimere l’altro da sé, scatta anche riguardo al fenomeno della lotta alla “criminalità”. Il potere accentrato crea il crimine, e per perpetuarsi non può eliminarlo. Il suo intervento mira però a costringerlo in precisi momenti, a snaturarlo del suo contenuto più proprio per assimilarlo ai valori del presente storico. Lo crea in maniere assai diverse: a) tramite le sue leggi, che stabiliscono essere delitto anche azioni che per i più non lo sono; b) accusando, imprigionando, additando al pubblico disprezzo, col suo “sparare nel mucchio”, gente innocente e pertanto ponendola in condizioni di delinquere per poter sopravvivere alla macchia; c) impedendo (negando loro ogni validità) ai codici di autocontrollo e di autoregolamentazione comportamentale delle specifiche comunità di esplicarsi, allargando così a dismisura la frantumazione sociale e l’autospossamento; d) intervenendo direttamente nelle contraddizioni emergenti dalla situazione di decretata illegalità dei codici comunitari, nonché con ricatti e premi garantiti a spie e traditori; continuando ad alimentare le cause di disgregazione e di guerra fratricida. La sistematicità di tali interventi pongono in chiaro che non si tratta di possibili “errori”, bensì di razionale esplicazione del potere accentrato che mira all’etnocidio, quando il genocidio non è più compatibile con il galateo del mondo “civile”. Tutte le “riforme” poste in essere, così come le “controriforme”: dall’istituzione della “perfetta proprietà” all’industrializzazione per poli di “sviluppo”, altro non sono che interventi mirati al raggiungimento esattamente di ciò che si è raggiunto. Ogni altra operazione o non avrebbe dato gli stessi risultati, oppure non è stata presa in considerazione perché temporaneamente utopica. Basti pensare che parecchio dei cosiddetti piani di rinascita, altro non fù che quanto proposto, di volta in volta, dai massimi cultori della razionalizzazione dello sfruttamento capitalistico e della penetrazione statale; per essere espliciti, quanto elaborarono gli allora riformisti “avanzati” dei partiti della sinistra storica. Essendo tutti nell’alveo del potere, chi più chi meno non poteva che proporre “soluzioni” alla criminalità che invero hanno mirato a distruggere l’autoctonia, soprattutto il potere autodeterminato della comunità: 118 capitalistizzazione di momenti materiali non riducibili direttamente alla logica del mercato; smembramento delle collettività; riduzione a “necessità create da bisogni materiali di sopravvivenza” di ciò che invece altro non è che manifestazione di una cultura antagonista all’esistente basata sull’azione diretta, sull’autodeterminazione dei singoli e dei gruppi umani. Per questi motivi, tutti coloro che furono, sono e saranno tra i promotori/fautori anche vagamente “critici” delle soluzioni colonizzatrici adottate – eufemisticamente definiti “piani di rinascita sarda” – devono invero annoverarsi tra coloro che si sono resi responsabili della tragedia della Sardegna. Spetterà ai liberi adottare appositi “piani” di lotta contro tali veri criminali. 119 Parte Terza La Sardegna criminalizzata 120 121 Capitolo Primo La repressione di stato 3.1.1 La giustizia romana Non ci è dato sapere della resistenza opposta dalle città Shardana ai molteplici tentativi romani d’invasione, prima dell’occupazione di Cagliari. Sappiamo che dopo Cagliari cadono via via tutte le altre; la stessa Kornus, infine, che viene rasa al suolo. Inizia così l’era infelice delle genti isolane che, direttamente o indirettamente, devono subire storia di massacri e schiavitù, tuttavia conservando viva, se non integra, almeno la dignità di popolo autodeterminato, con quel senso autoctono della giustizia che verrà d’ora in poi ad essere loro sempre negato. Lo negano i romani, che di giustizia applicano la loro: quella appositamente elaborata per i più fervidi nemici del barbaro impero. Riteniamo che le città Shardana, pur se federate fra loro, non potessero competere per mare e per terra, a lungo andare, con la straordinaria forza militare della gigantesca macchina imperiale romana, disponente di uomini e mezzi, soprattutto di finanze estorte ad una miriade di altri popoli. Tuttavia non dovette essere estranea alla sconfitta la divisone interna della società cittadina isolana, lacerata in signori, liberi e servi, che comunque si dica frantuma in rivoli semisterili l’immane forza dell’unità collettiva. Cadute le città marinare, i loro antichi traffici e le altre attività vengono poste in mano ai discendenti dei “figli della lupa”. Ma la conquista di un territorio e del suo popolo non è affatto completa con la semplice occu- 122 pazione di una parte delle terre. In Sardegna si instaura invero un rapporto di forza che tanto costa ai sardi ma che altrettanto costa ai colonizzatori, se non altro in consumo di energie per tenere l’isola perennemente sotto la sferza di un contingente di armati, che secondo alcuni storici non è inferiore alle 20-25 mila unità. Non disperse/distribuite in tutta la Sardegna, si badi bene, ma concentrate nelle città e nel loro immediato entroterra, territori sicuramente i più fertili per lo sfruttamento agricolo considerato che assumono ben presto il ruolo di uno dei grandi granai di Roma. Giustizia e codici romani nell’isola sono queste decine di migliaia di armati che costringono in schiavitù quanti, cittadini e non, sono impediti nella fuga verso i barbari montes. Le città non completamente rase al suolo diventano decentramenti amministrativi e politici dell’impero. Le campagne sono militarizzate permanentemente, allo scopo di difenderle dagli attacchi dei Pelliti liberi. Anche gli agglomerati urbani, in complesso, ancora dopo secoli non sono affatto amici dei figli di lupa. Alla schiavitù i sardi rispondono con l’ostilità, con la fuga, con gli attacchi. Non è un caso che, allo scopo di ripopolare la parte dell’isola occupata, i romani effettuano periodicamente deportazioni massicce di genti di ogni dove, che vengono poi a costituire la forzalavoro necessaria per la produzione cerearicola e per lo sfruttamento delle altre risorse fatte confluire nella capitale imperiale. D’altra parte, che giustizia potrebbe mai essere quella sancita dalle XII tavole dei romani, pergiunta valida solo per i riconosciuti “cittadini”? Giustizia del taglione, decretata da magistrati e da birri eseguita, sia pure camuffata sotto le vesti della democrazia repubblicana. Quella, per intenderci, che da un canto stabiliva: Chiunque rechi danno a parte del corpo di una persona ... sarà punito con danno uguale a quello commesso. (Tavola VIII) Sicuramente in un secondo tempo, quando il potere del patriziato è ormai dominante e gli stessi schiavi sono merce pregiata, si affianca alla legge del taglione quella della ... multa; ovviamente per quanti possono pagarla. Chiunque con la mano o col bastone rompa un osso ad altra persona, sarà condannato a pagare una multa di 300 assi; se il colpito è uno schiavo, la multa sarà di 150 assi. Curiosa e tragica la sorte dei debitori – ed è facile intuire il loro ceto – che non possono onorare il dovuto. Se dopo alcuni tentativi, nessuno 123 garantisce il pagamento del debito, il creditore può tenere il debitore “legato a ceppo di peso non inferiore alle 15 libbre” per 60 giorni; dopo di che, se ancora insolvibile, deve essere “tagliato a pezzi. Se i pezzi saranno più o meno grandi non importerà” (Tav. III). Per equità, la giustizia romana stabilisce che ogni “pezzo” del disgraziato vada in mano a ciascun creditore, fortunatamente senza stabilire la proporzionalità fra il credito vantato ed il pezzo ricevuto. Che dire inoltre quando la civiltà latina sancisce, in codice di Stato, la facoltà del padre di vendere quali schiavi i propri figlioli per ben tre volte, prima che possano essergli sottratti dal barbaro imperio (Tav. IV)? Inutile ricordare la condizione legale della donna, schiava del padre, poi del marito, poi dei fratelli e nel caso venissero a mancare tutti costoro, schiava di chiunque altro purché di sesso maschile? I sardi ridotti ovviamente nella stragrande maggioranza dei casi a barbari, se liberi, a schiavi, se “civilizzati”, si vedono le proprie membra valutate appena la metà di quelle dei cittadini della lupa; perché solo in casi contingenti sono valutati “cittadini” dell’impero. Vedremo nel successivo capitolo che tanta della giustizia romana verrà fatta propria dallo Stato Giudicale; a significare che, qualunque veste indossi il potere accentrato, per le comunità sarde nulla muta. In tale infinita inciviltà, agli isolani altro non rimane che tacere, meditando vendetta e fuga verso i propri montes, da cui dare vita a quella forma di guerriglia ed alle azioni predatrici (bardanas) che, se non altro, limitano i danni del furto delle risorse operato dagli occupanti. Inutile e pesante sarebbe in questa sede elencare tutte le operazioni di “alta civiltà” imperiale operate in Sardegna, soprattutto sul piano della giustizia. E che altro può apportare quel potere la cui barbarie arriva a tal punto di degenerazione da fare pubblico spettacolo dello scannarsi a vicenda e del dare in pasto alle belve inferocite dalla fame esseri umani indifesi? Per quanto concerne i nostri avi, oltre all’appellativo di barbari, di ladruncoli mastrucati (così il savio Cicerone), Livio li appella: «sardi da vendere», onorando quel Tiberio che ottiene “tra le altre cose il Trionfo per la quantità numerosa di schiavi che seco trasse il vincitore” dalla Sardegna (Manno). Tralasciamo l’elenco delle stragi che, se per davvero ed in tali proporzioni perpetrate, secondo i cronisti romani o latinizzati, avrebbero sicuramente almeno dieci volte desertificato l’isola. Ci sembra indispensabile invece ricordare che la Sardegna, in periodo imperiale, poi vandalico ed infine bizantino, diviene sistematicamente terra di deportazione di cristiani, di pagani, di “eretici” che a troppe vengono fatti approdare nelle coste, a portare ciascuno la sua fede nel riscatto e nella resurrezione ... in altro 124 vissuto, oltre il terreno, e la sopportazione stoica di ogni tormento inflitto in questa vita. Sicuramente le ingenti schiere di schiavi, ora cristiani “puri” ora eretici (a seconda di chi li valutava), costituiscono quelle forti braccia e, almeno in parte, quelle docili creature acculturate alla romanità ed al dominio che riempiono periodicamente i granai di Roma, fino ad essere necessario costruirne di nuovi per contenere tutto il frumento rapinato all’isola. Non è insensato credere che, nel corso dei secoli, il perseverare di questi schiavi nella propria fede, nonostante le persecuzioni, finanche il loro sottrarsi alla schiavitù per raggiungere i liberi “barbari” delle zone interne, abbiano gettato i semi vuoi della cristianizzazione – sia pure con mille ed un contenuto pagani – vuoi della latinizzazione linguistica dei sardi Pelliti. Ai romani seguono i Vandali, nel 455 della nostra era. Il loro dominio non è diverso da quello precedente. Nota ricordarlo sia per la deportazione di un’intera comunità di Mauritani (i Maurredhinus, che poi si stabiliscono liberi nella zona del Sulcis), sia per essersi cimentati nella rapina delle risorse e delle terre di già occupate dai romani, senza peraltro modificare alcunché. Dopo appena (!) 50 anni di presenza vandalica, inizia l’occupazione bizantina, a dire il vero assai poco radicata. Questa si caratterizza per la particolare struttura burocratica, civile, militare e per la pesante presenza anche degli impiegati alla contabilità finanziaria che, secondo i disegni dell’assai distante corte imperiale, eviterebbero lo “sperpero” delle ricchezze estorte in colonia, nel passaggio dalla Sardegna a Bisanzio! Le schiere imperiali di impiegati e di armati, nella lontana colonia dell’estremo Mediterraneo, mai rinunciano di loro spontanea volontà non solo ad estorcere i propri stipendi legali ed illegali, ma neppure a spedire alla corte i tributi dovuti. In quale maniera ci dicono le fonti storiche, mirabilmente riassunte da Carta Raspi: Difficilmente l’ingente somma necessaria per pagare gli stipendi a tutti i funzionari e agli impiegati di rango inferiore ... e più ancora dell’esercito, poteva essere raggiunta da tributi regolari imposti agli abitanti dell’isola, o, per meglio dire, a quelli sottoposti all’azione fiscale ... Conosciamo però di quali metodi si servisse il fisco bizantino ... In questo, sì, aveva ereditato dal governo romano ... angherie di ogni genere che gli agenti fiscali imponevano ai soggetti affidati alle loro cure; l’intervento dello stesso Giustiniano per combattere le vessazioni dimostra come il male fosse radicato profondamente ... I governatori provinciali taglieggiavano le popolazioni senza misericordia ... vendevano 125 la giustizia a chi meglio pagava ... trovavano man forte nei militi per costringere le popolazioni al pagamento delle molteplici imposte dirette e indirette ... [infatti] Al fianco dell’amministrazione civile vi era quella militare ... A conclusione della breve attenzione rivolta alla “giustizia” bizantina non possiamo non fare almeno un cenno a due avvenimenti di importanza storica. Il primo è relativo alla trattativa di pace intercorsa fra le genti barbaricine ed i colonizzatori, verso la fine del VI secolo. Ciò dimostra l’irriducibilità delle prime ed il perenne conflitto in corso. Il secondo è relativo alla lettera del papa Gregorio Magno ad uno dei supposti capi barbaricini, Ospitone, in cui esorta quest’ultimo a cristianizzare le “sue” genti, troppo aduse ai riti pagani. Questa fonte, l’unica sicura in mezzo a secoli di quasi assoluto silenzio, è stata interpretata dagli storici come il primo passo verso la cristianizzazione delle Barbagie. Ma più che fatto certo è ipotesi poco credibile. Prima di tutto perché Ospitone, per capo che sia, lo è sicuramente di una sola tribù, al massimo è “portavoce” di qualche sorta di confederazione di villaggi, non dei barbaricini, come si è voluto leggere. In secondo luogo, al pari di tutti i capi selvaggi, non ha potere di imporre alcunché a nessuno: è un semplice bon’omine, nulla di più. Infatti in tempi successivi, altri papi monsignori vescovi e prelati vari hanno reclamato per la paganità delle genti dell’interno, che evidentemente se ne sono strafottute dei presunti comandi del loro presunto capo cristianizzato, Ospitone. In ogni caso il processo di penetrazione del cristianesimo, nel VI secolo, è di già in fase avanzata, iniziato sicuramente dalle ampie schiere dei deportati. Ciò non esclude, come si può documentare in tutte le sagre di ogni nostro paese, che la nuova ideologia, lungi dallo far scomparire i riti e le credenze autoctone, ad esse si sovrappone, spesso impossessandosene, ma senza riuscire mai a decretarne la morte. Per cui è più realistico credere che Bonifacio non voglia affatto, in quella sua lettera, dolersi del naturale sincretismo dei riti religiosi, ma sfruttare a suo profitto, niente affatto spirituale, la conversione di Ospitone. La Chiesa contava in Sardegna immense ricchezze estorte alle popolazioni fin dall’Editto di Milano. Terra di martirio e deportazione di santi, santoni, santini e papi, nel momento in cui Costantino pone in mani cattoliche la riorganizzazione dell’impero, ben si capisce lo scempio operato dai cristiani, novelli burocrati dello Stato nell’isola. Accaparrano ricchezze immense che dopo il breve periodo di presenza vandalica ritengono di 126 proprietà della Chiesa. Non a caso il patrimonio di questa nell’ultimo periodo Giudicale è incommensurabile. Così il Gregorio poco santo e molto pratico di cose terrene, temendo la perdita delle ricchezze qualora l’isola cada in mano ai barbaricini – data la fragilità e la imminente dissoluzione dell’impero di Bisanzio –, sapendo della conversione di uno stimato capo selvaggio tenta di strumentalizzarlo, trattandolo con reverenza e “stima”, come si trattasse di un vero e proprio capo di Stato. Non ci è dato sapere degli ulteriori avvicendamenti di Ospitone, né se sia andato a finire dalla parte del papa. Certo è, invece, che nonostante il frenetico costruire di chiese, il processo di cristianizzazione dell’isola, nell’epoca, non ha avuto brusche accelerate, soprattutto non ha affatto decretato la resa delle genti dell’interno. È certo anche che la brutalità con cui i prelati amministrano i beni della chiesa, il barbaro trattamento che riservano ai propri schiavi, donati ad essa o catturati direttamente, incutono in Gregorio Magno la convinzione matematica che i Pelliti, se vittoriosi nei confronti dell’occupante, non avrebbero di certo riservato ai possedimenti cattolici nell’isola sorte migliore di quella degli altri colonizzatori. 3.1.2 La giustizia in periodo Giudicale A partire dai primi anni del secolo VIII la presenza bizantina, se pure ancora se ne può parlare, è del tutto ininfluente, fino a che scompare completamente. L’isola si libera anche degli ultimi suoi coloni. Il declino del vecchio mondo, con le sue inaudite vicende di barbarie è ormai cosa certa, decretato dalla stessa sua terribile evoluzione. Per i sardi, distanti dalla terraferma e pertanto franchi da nefaste influenze si presenta l’occasione di ricominciare daccapo. Su quali basi? Esattamente su quelle che i romani secoli addietro avevano cercato di distruggere. Le genti mai dimenticarono, nella loro triste sorte che le tormentò per un millennio, la libertà originaria. D’altro canto, a moltitudini rifugiatesi in quelli “insani montes” che le orde romane non riuscirono a penetrare, e qui unendosi ai preesistenti abitatori che mai abbandonarono al proprio destino il resto dell’isola, hanno potuto mantenere le autoctone forme di vita e di convivenza sociale. Così, nell’esatto momento in cui in Europa la millantata civiltà cattolico-romana si abbrutisce ulteriormente nell’invasione delle orde barbariche, i sardi si riprendono la loro terra integralmente. Non vi sono fonti (o almeno non sono state ancora storicamente esaminate) per stabilire con esattezza cosa accade nei secoli dall’ VIII al XII. 127 Tuttavia è possibile tracciare a grandi linee gli avvenimenti. Si rimette in piedi il sistema sociale preesistente: da un lato l’organizzazione delle città-Stato Shardana e dall’altro quella delle comunità dell’interno. Stavolta però più amalgamate che nell’antichità. Ricompaiono il Giudice, i Maggiorenti, i bonos omines, oltre alla Corona (il Consiglio della comunità), più o meno interagenti. Ciò che stupisce è che – nel momento in cui parlano le fonti dirette, risalenti alla fine dell’XI secolo – la Sardegna si presenta suddivisa in quattro Giudicati, veri e propri Stati moderni per certi versi ancora in embrione. Le collettività dell’interno mantengono i propri istituti di autodeterminazione, ma sono minacciate dall’opera di svuotamento progressivo di cui diremo appresso. Il che parrebbe contrastare la tesi da noi fin qui sostenuta, circa l’antistatalismo della cultura isolana. Tuttavia anche questo fatto è spiegabile, e semmai viene a sostegno del nostro modo di intendere le cose, soprattutto circa la costituzione del potere accentrato come progressivo esproprio del potere diffuso nel sociale. Per secoli le genti isolane restano separate dal resto del continente (VIII-XI secolo). Pertanto possono autogestire la propria vita esclusivamente basandosi sui valori tradizionali e ... tenendo conto delle continue aggressioni degli arabi che sul finire del VI secolo hanno di già conquistato l’Africa del nord e parte della penisola Iberica. Non si tratta – come avverrà in seguito – di semplici razzie limitate alle zone costiere. Al contrario, sono vere e proprie spedizioni miranti a conquistare l’isola al fine di occuparla perennemente. La Sardegna, una volta assoggettata verrebbe a costituire nella strategia di conquista araba dell’intero continente, una solida base, tanto più che in Spagna l’invasione ha trovato un rigido argine. Nel 710 vi è il primo tentativo arabo di occupare l’isola; in seguito sarà un continuo ritentare. Il Mediterraneo a quei tempi è in mano ai musulmani e nessuna potenza è in grado di contrastarli. Ai sardi non resta che trasformarsi in popolo perennemente in armi per scongiurare il pericolo di nuove occupazioni. È quanto può constatare il geografo arabo Edrisi, riportato da Carta Raspi, che afferma sulla base dei riscontri della sua gente in Sardegna: “i sardi sono gente valorosa, che non lascia mai l’arme”. Dopo numerose sconfitte gli arabi si rendono conto dell’impossibilità di assoggettare l’isola, per cui mutano radicalmente strategia: sbarcano sulle coste all’improvviso, assaltano i villaggi immediatamente a portata di mano, fanno razzia di tutto che, senza spingersi oltre, stivano nelle navi, poi scompaiono in mare. È questa la ragione per cui gli isolani son costretti perennemente in armi, pronti a respingere gli invasori che, da un momento all’altro possono arrischiarsi a penetrare nell’interno. È la condizione che determina anche la stabilità della funzione di 128 capo di guerra del bono omine (lo “jus dicis”). Inoltre i villaggi hanno dato vita ad una sorta di rete confederale per meglio disporre la difesa in tutta l’isola. Sia pure lentamente, per avere a tempo indeterminato l’ufficio di capo militare, il jus dicis finisce per acquisire definitivamente tale incarico, momento essenziale per crearsi vuoi un sostrato economico grazie ai donativi delle comunità, vuoi un necessario stuolo di armati permanenti ai suoi ordini (vero e proprio apparato burocratico-militare). Fino all’anno Mille è assodato che il potere non è ancora concentrato nelle sue mani. Ciò emerge dal fatto che l’amministrazione della giustizia non riguarda il contenuto penale, essendo questo regolato secondo la prassi della vendetta. Infatti i Giudici (a cui compete l’amministrazione della giustizia nella Corona de Logu, cioè il Giudicato), i Mayores de Villa (i Giudici della Corona della Villa) i Curatori (i Giudici della Corona di Curatoria, divisione amministrativa del Giudicato) “dirigevano il processo ma non giudicavano” (Carta Raspi). Il verdetto è dato dal collegio dei bonos omines. In questa prima fase le Corti di Giustizia giudicano esclusivamente su controversie relative al diritto privato – come diremmo oggi – e più che mirare alla condanna, in verità cercano la conciliazione delle parti. Se l’accordo non è possibile la Corte costringe il soccombente a risarcire la parte lesa della cosa danneggiata o sottratta. Si può già qui notare il primo parziale esproprio dell’autodeterminazione individuale da parte del collegio dei bonos omines, che hanno non solo la funzione di esprimere pareri, ma anche il potere di emettere vere e proprie sentenze, nonché di imporre in certo qual modo il verdetto a scapito della parte uscita perdente dal “processo”. La fase successiva vedrà il Giudice non solo portavoce della sentenza della Corona, ma egli medesimo giudicante. Compito e potere del Giudice non son più limitati a dirimere controversie di carattere civile-privato, bensì a reprimere il “crimine” comminando sentenze penali vere e proprie, quindi a porre in essere la punizione. Non è possibile stabilire fino a che punto una tale strutturazione della giustizia sia in questa fase ramificata nel territorio. È presumibile però che essa sia più accentuata nella città e nelle zone ad essa più prossime, mentre in quelle più interne sia meno accentuata, semplicemente perché la città è la sede dello Stato giudicale. Senza alcun dubbio, però, il Giudicato tende a trasformare i bonos omines in funzionari Statali. Fin da questo stadio sono evidenti la sperequazione economica e una sostanziale divisione sociale, in misura maggiore in prossimità delle città capoluogo del Giudicato. 129 È la prima fase dell’organizzazione statuale. Al vertice del Giudicato (su Logu) vi è il Giudice, cui fa capo il potere civile (di rappresentanza dell’intero logu) e militare (capo di guerra) entrambi delegati alla burocrazia che via via si ramificherà sempre più. Al suo fianco, in tutti gli atti da esso compiuti, siede un secondo Giudice, una sorta di controllore degli atti e delle azioni poste in essere dal primo, allo scopo di garantire il suo conformarsi alla volontà di “su Logu”. I Mayorales (sorta di consiglieri sul piano politico amministrativo), cioè i Maggiorenti, ricoprono le cariche più alte della burocrazia amministrativa; il Giudice agisce con il loro consenso. I liveros, o liberos (cittadini liberi) occupano solo in parte incarichi burocratici minori. Infine vi sono i servi, che rappresentano la stragrande maggioranza della popolazione. I bonos omines dei villaggi, cui fanno capo le diverse funzioni giudiziarie ed amministrative, appartengono a tutti i ceti, anche a quello dei servi. I Mayorales (al cui ceto appartiene il Giudice) anche se cadono nella miseria più assoluta, non possono mai ridursi allo stato di servaggio. Alla Corona de Logu (l’assemblea generale dei “delegati” di tutta la popolazione del Giudicato) partecipano anche i servi. La proprietà delle risorse: terre, fiumi, sorgenti, miniere, stagni, saline, ecc. dovette essere originariamente collettiva; ciò che è provato, indirettamente, dal modo in cui si costituisce in seguito la proprietà dei Mayorales, del Giudice, della Chiesa e degli altri ceti. Il processo di nascita di tali proprietà avviene “senza dubbio per sekatura de rennu, e cioè concesse staccandole (sekare = segare, tagliare ecc.)” dalla proprietà collettiva (Carta Raspi). È opportuno tentare di ricostruire il modo in cui presumibilmente si verifica la sekatura de rennu. I Mayorales, in origine, altri non potevano essere che i bonos omines che ogni comunità esprime. Il perenne stato di guerra decretato dai tentativi di conquista degli arabi impone la costanza dell’esercizio delle armi ed una rete organizzativa in grado di attuare una strategia di difesa su tutta l’isola. È probabile che la rete organizzativa confluisca verso le città costiere (Cagliari, Oristano, Olbia, Sassari), siti più soggetti agli attacchi del nemico. I bonos omines della città, e i numerosi altri a stretto contatto con essi, sono perennemente impegnati nel disporre una valida e sicura difesa. Inoltre vi è necessità di una struttura militare – esercito permanente – immediatamente disponibile, ai loro ordini. La collettività si addossa il sostentamento degli uni e degli altri. Ma se la truppa può essere costituita semplicemente dalla rotazione dei guerrieri, non così accade per la struttura nelle cui mani ricade il compito dell’organizzazione strategica generale dei bonos omines. Nasce la necessità di garantire collettivamente il sostentamento de sos bonos omines 130 e delle loro famiglie. Nelle comunità pastorali tutti gli uomini accudiscono, a rotazione, gli armenti del bono omine. In un momento successivo dev’essere parso assai più razionale adibire un salto in cui pascere le sue greggi. Qui, con turni di ore o di giornate di lavoro, gli uomini non impegnati nell’uso delle armi, accudiscono gli armenti e si dedicano a coltivare gli interessi dei bonos omines. Con il trascorrere del tempo, un arco di ben tre secoli, sia il salto (parte del territorio di una comunità) che la prestazione d’opera diventano prassi comune tanto che alla fine vengono intesi quali diritti acquisiti. D’altro canto non è neppure possibile supporre che senza una qualche necessità vitale la collettività rinunci alla proprietà collettiva della terra ed alla prassi della redistribuzione della ricchezza. Inoltre una tale ipotesi dà conto finanche della particolarità del regime di servaggio del periodo Giudicale. La condizione dei servi è affatto dissimile da quella dei servi della gleba del sistema feudale europeo; sono “cittadini” liberi e possono riscattare la loro condizione; infine sono completamente slegati, senza vincoli cioè, dal fondo (proprietà) in cui svolgono la loro opera. Il servaggio è di natura esclusivamente economica (debito di lavoro, diremmo oggi): i servi devono prestare tot ore o giornate di lavoro nella terra del Giudicato, del Giudice, della Chiesa, dei Mayorales e finanche dei liberos (o liveros). La servitù non va oltre questa prestazione. Si tratta, invero, di servo-colliberto, per cui è ignorato il “possesso” di esso materialmente inteso. “La persona fisica non era asservita; anzi era completamente libera”. (Carta Raspi) La prestazione di lavoro è ripartita secondo un massimo di giornate mensili: può trattarsi di servu integru (alla lettera “servo integrale”, che risulta debitore del massimo delle giornate previste, stabilite in 16 al mese); servu latu (dal latino latus = ladus in sardo = la metà del massimo delle giornate mensili di debito, 8 giorni); servu de pede (un piede = unu pede, cioè un quarto, 4 giornate mensili di lavoro). Tale misura, è evidente, viene stabilita in riferimento a come si suole valutare la bestia (in latino pecus = in sardo pegus = pecunia/moneta/unità di misura negli scambi). Ciò dimostra come l’orizzonte di valutazione delle cose sia tipico della cultura pastorale sarda. Il massimo di 16 giorni al mese di debito è rispettato anche se il servo deve prestarle a più persone. Solo nell’ultimo periodo Giudicale, con l’influenza nefasta della politica dello Stato e del sistema statale anche continentale, la realtà sarda sarà sempre più infeudata, fino ad esserla del tutto a partire dalla occupazione iberica. Col trascorrere dei decenni, dei secoli, la originaria indivisione perviene alla dimidiazione. I Mayorales trasformano la momentanea conces- 131 sione delle terre in proprietà privata. Esattamente come accade per gli armenti. Infine la proprietà si trasferisce di padre in figlio, permanendo anche sotto forma di debito la prestazione del lavoro servile. Anche se il Giudice e i Mayorales hanno le rispettive proprietà ben distinte da quelle del Giudicato, il sempre maggiore potere dell’uno e degli altri decreta il privilegio di effettuare donazioni a manca e a dritta, ovviamente a scapito della proprietà collettiva rimanente. Accade così l’irreparabile, nonostante le comunità frappongano argini alla potenza Giudicale. Nel XIII-XIV secolo l’esproprio del potere comunitario è lapalissiano. Il Giudice è ormai un vero e proprio Principe, il Giudicato una Signoria. A portare a compimento il processo contribuisce la necessità di cercare alleati nella difesa contro i mai cessati tentativi arabi. A chi rivolgersi? Non ai pontefici cui non tornava mai il conto fra il miglio e le castagne, non all’imperatore ed ai suoi lurchi non ancora usciti dalle tane, non alle navi di Pisa e di Genova che se ne stavano chiuse nei loro porti, tantomeno ai marchesi ed ai conti e visconti pisani e lunigiani che dalle loro capanne non erano ancora saliti ai castelli. (Carta Raspi) Non restano che i Franchi, di già alleati con i Corsi per far fronte comune contro gli insistenti arabi. Così nell’815 delegazioni dei quattro Giudicati rompono l’accerchiamento e l’isolamento recandosi in Francia. Da quell’anno in poi è un susseguirsi di dannazioni che decretano il sempre maggiore interesse per l’isola da parte prima del papato (che alla fine, tra le altre cose, vanta finanche il pieno diritto sulla Sardegna), quindi dei vari mercanti attratti dalle ricchezze sarde, infine di casate più o meno principesche e marinare che accentuano pure i conflitti fra le diverse famiglie di Mayorales che vantano ormai un patrimonio ed un potere inestimabili (e che a più d’uno fa gola impossessarsene). In questa bolgia di interessi i Giudici elargiscono a piene mani il patrimonio collettivo a Chiese e conventi, e richiedono a più riprese l’invio nell’isola di “letterati” frati, da adibire a scribacchini di latino nelle corti Giudicali, incrementando in tal modo la burocrazia statale e la sua potenza, sempre più coincidente con quella dei Mayorales. Giudice e mayorales intrattengono sempre meno matrimoni fra di loro preferendo le dame delle aristocrazie pisana e genovese che – soprattutto l’aristocrazia pisana – finiscono per rappresentare vere e proprie potenze straniere che ributtano l’isola nelle condizioni dei secoli di dominazione romana. 132 Mano a mano che la situazione evolve in tal senso, le popolazioni sempre più espropriate si ritirano in se stesse, fino a restringersi nuovamente in quelli insani montes di latina memoria, i cui confini stavolta si estendono fino alle soglie della città. Chi resta sotto l’influenza del Giudicato deve sottostare ad un destino che si vuole dimenticato: quello della schiavitù. «Nel breve giro di pochi decenni, troviamo stabiliti nel Logudoro i Doria e i Malaspina, in Cagliari i Massa e i Donoratico; nell’Arborea i Basso; in Gallura i Visconti». (Carta Raspi) Verso la fine del XIII secolo, invece, ... di tutta l’isola almeno la metà era in mano ai Pisani: gli antichi Giudicati di Cagliari e di Gallura, varie terre del Logudoro e alcune dell’Arborea, che garantivano a Pisa un reddito di circa 100.000 fiorini all’anno». «A titolo di curiosità ricordiamo che un fiorino corrispondeva grosso modo al guadagno settimanale d’un artigiano. (G. Todde) Ma non è ancora tutto; mancano coloro che nell’immediato futuro saranno i reali padroni della Sardegna: gli Spagnoli e la Chiesa. Alla fine dell’XI secolo le ricchezze della Chiesa nell’isola sono in pratica incalcolabili. Alla fine del XII secolo i monasteri sono i più grossi proprietari di terre, di servi e di bestiame, assieme a pochi maggiorenti che hanno conservato intatto il loro patrimonio (Pais Serra). E vediamo qual’è la giustizia dei pisani in terra sarda. Prima di tutto è vietato ai sardi il pernottamento nel “castello” di Cagliari (cioè nella città) e precise disposizioni legislative proibiscono gli ufficiali di pranzare con gli isolani. Le amorevoli cure riservate alle popolazioni sono di tal tenore che lo stesso vescovo di Civita (Olbia) si «lamentava che i villaggi della sua diocesi avevano subito un notevole calo di popolazione perché molti abitanti, non essendo in grado di far fronte alle imposizioni [fiscali], erano fuggiti [alla macchia]... ». (G. Todde) Lo stesso studioso riporta quanto annota Clemente Lupi in proposito: La guarnigione pisana era di stipendiati tanto oltremontani [cioè neppure peninsulari] che italiani ... Ufficiali del Comune nell’isola (tutti pisani salvo poche eccezioni) ... Malgoverno: incetta frumento (tutto portato a Cagliari e di là a Pisa), in Sardegna non ne rimaneva, vessazioni alle persone sarde, estorsioni. Dai documenti nostri si fa evidente che i sardi non dovettero nulla temere l’invasione aragonese ... 133 Quando arrivano gli Aragonesi, espellono senz’altro dal “castello” di Cagliari i Pisani, ma il posto di questi non è certo preso dai sardi bensì dalla migliore “crema” dei Catalani, Aragonesi, Valenziani e Maiorchini. Gli Iberici vengono in Sardegna nel secondo decennio del XIV secolo, invitati dal Giudice d’Arborea, Ugone II, dietro promessa di “incoronamento” dell’isola. A tal punto arriva la degenerazione di quanti sono ancora oggi valutati i “difensori” della libertà sarda, e del loro sistema! Ma ne vedremo di peggio e ne parleremo più avanti. Ora dedichiamo un po’ d’attenzione a quell’altra potenza che nell’isola avrebbe determinato vera libertà e vera giustizia: la Chiesa cattolica apostolica romana, che a partire dall’anno Mille – grazie alla “lungimirante” politica dei Giudici e dei Mayorales – si ramifica in tutta l’isola sottoponendola alla “vera civiltà”. La varietà di monaci benedettini chiamati in terra sarda dai nostrani capi di Stato è assai ricca: Vittorini, Lerinensi, Cassinesi, Camaldolesi, Vallombrosani e infine Cistercensi. “Ufficialmente” – cioè quanto viene fatto credere alle popolazioni sulle cui spalle poi ricadono – l’orda di santi padri dovrebbe occuparsi di cultura e della rinascita dell’agricoltura, il cui abbandono è in parte dovuto alla monocoltura imposta dai romani, in parte alla fuga delle genti decretata dalla politica repressiva Giudicale. In realtà ben altri sono i motivi della loro calata. Ricordiamo di sfuggita che fino al 1080 la Chiesa, nella nostra isola, non possiede più nulla, le sue proprietà essendo state redistribuite alla collettività a cui le aveva estorte in epoca imperiale. Solo per intercessione dei Giudici vengono fatti prima dei donativi al papato in conto crociate antiinfedeli, che putacaso si trasformano in tributi annuali. In seguito i donativi per sekatura de rennu si fanno più consistenti, via via che degenera l’operato del sistema Giudicale in Stato vero e proprio. All’inizio del 1200 la Sardegna contava, all’incirca, una cinquantina di monasteri benedettini, tra maggiori e minori, nonché un numero ancora vistoso di chiese proprietarie di ricche aziende agrarie ... Erano, nell’isola, vere e proprie baronie ecclesiastiche ... veri e propri feudi, comprendenti numerose ville e parrocchie, con una imponente massa di servi con le loro famiglie». (F. Cherchi Paba) La proprietà del monastero di S. Maria di Bonarcado, tanto per fare qualche esempio, consiste in una estensione superiore ai 30 mila ettari, con tutto ciò che vi è dentro: cose, case, villaggi, animali ed uomini. Quella 134 di S. Nicolò di Trullas era di 20 mila ettari. Contrariamente ai miserabili sardi, tutti i monasteri hanno quote di proprietà nelle saline ed inoltre vantano diritti annuali di pesca negli stagni. Considerata la nomea di monasteri, che si vorrebbe poveri o comunque costituiti da miseri lasciti dei credenti, è opportuno precisare che in Sardegna così non è mai stato. Vi è senz’altro qualche donazione di poveri straccioni, ma è cosa risibile in confronto alle donazioni fatte dai Mayorales ed ancor più dai Giudici (i quali, per intenderci, non donano certo le loro private proprietà). Così se il nobile Murtinu dona al Monastero di Bonarcado 800 pecore, 30 vacche, 200 capre ecc. ecc.; il Giudice di Torres dona ad altro monastero 10.000 pecore, 500 vacche, 2.000 porci, 1.000 capre ... oltre a sconfinate estensioni di terre. Ma è un’inezia anche questo donativo, se confrontato con quello che Costantino Giudice d’Arborea fa, ancora al monastero di Bonarcado, nei primi anni del 1200: tutto ciò che era stato delle chiese greco-bizantine, con “masones d’omnia sinnu de grussu e minudu”; qualcosa di incommensurabile, di cui non è possibile fare neppure oggi l’elenco, per approssimativo che sia. Per avere un’idea della ricchezza monacale basti pensare che uno dei monasteri pisani che ha proprietà nella nostra terra, di dimensioni assai piccine a dire il vero, solo dagli affitti riscuote annualmente 200 fiorini d’oro. Monaci e papato navigano nell’oro. Ma sono poi essi dediti alla cura della mastodontica ricchezza, in regime di vita claustrale e parsimoniosa come si addice ai papalini? Assolutamente no! I santi padri, nel loro permanere in Sardegna sono sempre occupati a diffondere la “cultura” scribacchina del Giudicato a peso d’oro; che costa un occhio di dio (Carta Raspi) ai miserabili abitanti, tanto da rappresentare una vera e propria lucrosa attività svolta all’ombra dell’altare e dello Stato in regime di assoluto monopolio. Anche perché i Giudici, col fine confessato di magnificare la ricchezza dei loro Stati, hanno reso obbligatoria ogni prassi burocratica con l’uso del paperi bullatu (carta bollata), e pertanto redatta come si conviene ai “civili”, ricorrendo agli unici scribi dell’epoca: i frati. Terminata l’opera civilizzatrice di scribacchini a peso d’oro, i santi padri non si dedicano di certo alla attività agropastorale, bensì si trastullano in partite di caccia, grossa e minuta, nonché in odisseici banchetti ed orge cui partecipano, debitamente selezionati tra i Mayorales, gli indigeni. Nonostante tutto questo daffare, i frati trovano il tempo di dedicarsi anche all’amministrazione della giustizia nei propri possedimenti. Ed in ciò si distinguono perdavvero come sinceri cristiani. Sentiamo ancora Cherchi Paba, che riassume quanta bontà emani dai bordelli infernali dei 135 monaci: A servizio di queste grandiose baronie ecclesiastiche erano i cosiddetti quadrupedia [cioè i servi integrus]... La bassa, inumana considerazione che si aveva da parte dei monaci di questa umile, derelitta umanità, ci è data dagli stessi condaghi [resoconti della vita non solo amministrativa nei possedimenti monacali] dove, specie in quello di Trullas, i figli piccoli delle serve-schiave vengono chiamati “fedu”, dal latino dispregiativo “foedus”, che in Sardegna si usa oggi, come ieri, per il nato da bestia. Può il lettore immaginare quali angherie, torture morali ed anche fisiche subissero detti servi-schiavi che, spesso si ribellavano e fuggivano cercando pietà e libertà ad un tempo, ma invano perché, ripresi, venivano sottoposti a giudizio e legati nuovamente alle loro pesanti catene dalle Corone giudicali, di curatoria o De Logu. «Né per essi vi era possibilità di scampo, a giudicare dalle sentenze riportate da certe schede dei condaghi: possibios ut serviant a Sancta Maria de Bonarcatu, et filios suos, et nepotes nepotorum suorum usque in sempiternu. La giustizia monacale prevede, tra le altre gioie terrene, che il servo possa essere fustigato, strozzato, impiccato, molto probabilmente anche marchiato col fuoco (Cherchi Paba). La barbarie non ha limiti, per questi santi padri. Allo sposo, liberu, che voglia in sposa una serva, si impone di essere a sua volta sottoposto a servitù; pena il rifiuto del matrimonio. Pur di ottenere quanto desiderano non si fanno scrupoli nel mentire, ordire, servirsi di falsi testimoni; così che possono ridurre a serva certa Maria Capra, strappandola alla libertà ed al proprio marito. Il martirio viene a cessare nel momento in cui, per cause dipendenti da fattori economici propri della città-metropoli, Pisa “libera” i servi schiavizzati. In tale contesto, circa 40.000 di essi scappano letteralmente dalle baronie monacali, rifiutando ogni forma di lavoro “libero” alle dipendenze degli infernali tonacati. Tanto che da questo momento la fine della ricchezza dei monasteri è decretata dalla mancanza di manodopera. Ed i santi padri non si ingegnano di certo a rimboccarsi le maniche! Ma se i sardi si liberano da una forma di schiavitù, un’altra ancora peggiore li attende: quella tutta laica posta in essere, stavolta per iscritto, dai propri capi di Stato. Già da tempo questi cercavano in ogni modo il sostegno della Chiesa al loro potere, tanto che hanno pure concesso ad essa 136 in esclusiva l’acqua delle sorgenti naturali, vietandone così l’uso alle popolazioni. Ancora nel 1321, a “liberazione” avvenuta, i Giudici sardi permettono al papato di fare mercato dei servi schiavi, né più né meno come gli altari e le bestie. Così, Fra’ Severino del monastero di Solio, può dare in affitto a Federico de Campo, di Bonifacio, unitamente a Chiesa ed altari, anche ancelle e schiavi (Cherchi Paba). Nonostante tutto, non ci è possibile perché contrasterebbe con i dati di fatto, affermare come si tende a fare, che il degenerare dei Giudicati in Signorie semifeudali sia dovuto esclusivamente a sos ki benin’ dae su mare (a quanti vengono dal mare). È ipotesi tendente ad accreditare la tesi della “purezza”, della giustizia, della libertà che sarebbe propria dello Stato tutto sardo. L’accentramento progressivo del potere, in verità, è processo di già in atto nel momento in cui parlano le fonti storiche. E lo Stato sardo non potrebbe essere diverso da ogni altro. I contatti col papato, come anche con pisani, genovesi, iberici e francesi avviene tra corti sovrane, tra Principi e quelli sardi non sono a meno degli altri. Inoltre tutti i sistemi delle cittàStato dell’antichità hanno degenerato in tirannia; così è avvenuto per i Giudicati nostrani. Il fatto che nei Giudicati siano incorporati i territori dell’interno dell’isola ci fa propendere per la tesi di Carta Raspi, che vuole le comunità dell’entroterra soggette al loro sistema politico. Diversi Giudici sarebbero di origine barbaricina e ciò non può che significare il coinvolgimento diretto almeno dei ceti che si sono separati da quelle comunità (sos meres). Nel momento in cui il processo di esproprio del potere di autodeterminazione individuale e collettivo avanza inesorabilmente però, avviene la rottura tra il Giudicato e l’entroterra. Il mondo della “pastoralità” si ritrae in sé stesso, opponendosi alla degenerazione politico-economica ed alla spregiudicatezza giudicale degli intrighi e delle alleanze, atti a determinare l’emergere della Signoria vera e propria. Quando il sovrano iberico, dopo oltre un secolo di cruente lotte, riesce ad occupare l’isola, gli istituti Giudicali, per unanime consenso degli storici hanno di già operato il parziale esproprio delle comunità e l’accentramento in Stato. Nel momento in cui ci parlano le fonti storiche, il Giudice non è più il capo selvaggio, né il bono omine, ha il potere politico effettivo che subdelega ad una stabile burocrazia di maggiorenti, accomunati da un unico interesse materiale e spirituale: mantenere ed estendere i propri privilegi di classe. Ed è esattamente per contrasti dovuti alla spartizione del potere che si sviluppano in seno al ceto dominante le lotte tra famiglie. Formalmente resta in piedi l’istituto della democrazia che, tramite 137 delegati della collettività (bonos omines) esprimono via via le Corona de Villa, de Curatoria, de Logu. Ma la politica dei Giudici crea una fitta rete di intrighi, di interessi tali che alla fine Bonifacio VIII, precisamente nel 1297 proclama Giacomo II d’Aragona legittimo possessore della nostra terra. Pur tralasciando ogni diatriba su di un tale “diritto” del papa sulla Sardegna, è necessario ricordare che fin dai secoli precedenti i Giudici isolani accordano al papa, per ingraziarselo in vista di formali investiture, un volontario tributo, che poi per volontà “divina” diventa annuale, creando uno stramaledetto precedente storico a scapito delle popolazioni, senza che per altro queste ne abbiano in qualche modo avuto un minimo di beneficio. Salvo che tale non voglia intendersi l’opera di eccelsa civiltà materiale e spirituale dei monaci, cui abbiamo già accennato. Poi ci sono i donativi che, strappati alle sarde genti dal Giudice Mariano, vanno in sostegno alle crociate a seguito della intercorsa corrispondenza tra questi e Caterina da Siena. Che prò possono averne le popolazioni sarde a cui il nome del santo sepolcro da riconquistare non dice assolutamente nulla di nulla? Infine, logico corollario di tutta la vicenda che puntualizza da che parte realmente stanno Giudici e Mayorales, non bisogna dimenticare il riconoscimento di Pietro II d’Arborea, avvenuto il 3 aprile del 1237 a Bonarcado, del supremo dominio della Chiesa romana sopra il suo Giudicato, “prestando giuramento di fedeltà e vassallaggio nelle mani di Alessandro, legato pontificio inviato espressamente in Sardegna da Gregorio IX” (Cherchi Paba). Tale investitura – sia detto tra parentesi – costa alle plebi sarde il censo annuo di 1.100 bisonti d’oro da versare alla poco spirituale cassa apostolica. Inoltre, decedendo il Giudice senza prole legittima, il regno – viene statuito – deve finire in mani al papato!!! Possiamo immaginare lo scompiglio che tutti questi intrighi di palazzo decretano nelle masse. Ad evidenziare ancor più la degenerazione dell’antica forma di potere cittadino, compaiono negli ultimi secoli di vita giudicale i codici scritti, che vogliono sancire il definitivo esproprio del potere sociale. Qui la giustizia raggiunge il suo apice, tanto che la famigerata Carta de Logu, emanata sul finire del XIV secolo da Eleonora giudicessa d’Arborea, dai colonizzatori spagnoli prima e piemontesi dopo non solo non viene modificata ma addirittura estesa a tutta la Sardegna, lasciandola in vigore per ben quattro secoli e mezzo. Non certo per la presunta “alta civiltà” che emanerebbe e “l’alto senso di giustizia” che da più parti le viene attribuito; quanto perché neppure la più infernale mente al servizio del potere costituito di allora ne ha potuto escogitare di ancor più barbara per tenere aggiogate al bestiale sfruttamento le sarde plebi. Non a caso! La Carta de Logu è la razionale sintesi della “scienza” 138 del dominio dei maggiorenti genovesi, della foga di potere della casata degli Arborea, della diabolica potenza materiale e spirituale del papato ed infine della più raffinata efferatezza della corte aragonese-catalana, a cui attinsero in abbondanza non solo il padre ma tutta la famiglia della sconsiderata giudicessa. Al padre di Eleonora d’Arborea spetta la responsabilità dell’emanazione della precedente Carta Rurale che in certo qual modo mira a ricondurre alla ragione dello Stato la ribellione delle genti isolane ridotte alla vergognosa e miserabile condizione di dover abbandonare la coltura agraria a causa della politica compradora del giudicato. È a questo periodo ed a tali condizioni che risale la rottura dei vecchi vincoli di solidarietà comunitaria: la contrapposizione fra pastori e contadini che perdura in certa misura anche oggi. Così, sia per salvaguardare il minimo di produzione colturale ancora praticata, sia per incrementarla, sia per ricondurre a ragione l’atteggiamento centrifugo delle genti pastorali, al bestiame – secondo la Carta Rurale – è fatto divieto di transito, e non solo di pascolo, nelle zone adibite a coltura. L’agricoltore deve, dal canto suo recintare il podere con siepe o fossato e qualora qualche bestia sconfini nel fondo, può sopprimerla addebitando poi il danno al proprietario. Viene altresì fatto obbligo di denuncia alla burocrazia di Stato del pur minimo sconfinamento del bestiame; a quanti si esonerano da tale obbligo vengono comminate salate multe. Ciò non può non determinare odi, vendette, faide. Naturalmente le pene per i contravventori sono “ben umane”: fustigazione, mutilazione, accecamento, morte cruenta come precisiamo più avanti. Quel che è più barbaro – e che nessun’altro potere costituito, a quanto ci è dato sapere, ha mai posto in essere così sistematicamente – è l’istituto dell’inkarriga, cioè l’addebitare non più solo al Curatore ma all’intero villaggio, danni e multe qualora non venga scoperto e consegnato alla giustizia il cosiddetto criminale. Secondo gli emanatori, l’applicazione della legge dev’essere inesorabile, e tale è! Inizia una nuova tragedia, che apprendiamo dalla Carta de Logu, frutto della insana mens accecata dal potere dei principi d’Arborea, piissimi e coltissimi per i più, famigerati semplicemente per le genti che ne sostengono tutto il peso. Anche uno dei più grandi apologeti dei Giudici d’Oristano (o d’Arborea, che infine sono la medesima cosa), il Carta Raspi più volte da noi citato, non può esimersi dal confermare (sia pure dubbiosamente) la triste condizione in cui versano i sardi sotto la sferza del Giudicato. Attraverso la legislazione dei tre Giudici [Mariano, Ugone ed 139 Eleonora] si ha quasi l’impressione di assistere al dilagare della criminalità, coi reati di sangue, le rapine, i venefici, per non parlare della violenza, dei furti e dell’immoralità; e nello stesso tempo le leggi e le ordinanze che via via, come argini, vengono elevati, sempre più alti ... Con le pene sempre più severe, più che intimorire si vuole atterrire, con la mutilazione delle membra e una morte atroce, oltre alla confisca dei beni». Appare chiaro che la terribile condanna se da un canto serve a “sos malos” (i “delinquenti”) da “pena e terrori”, dall’altro mira ad essere “de exemplu at assos ateros” (esempio per gli altri). La politica dei Giudici ed il loro accanimento contro le popolazioni rurali soprattutto, non viene meno neppure quando, nel corso delle trattative per la pace fra Eleonora ed il sovrano aragonese, vengono “convocate” dalla giudicessa le “popolazioni “ delle città e delle ville, per sottoscrivere il trattato. Qui Carta Raspi non fa che contraddirsi; da un lato perché ritiene ancora operanti le “strutture assembleari” delle comunità, dall’altro perché le svuota, a seconda della convenienza, di ogni contenuto e potere. In tal modo, durante il giudicato di Ugone è sicuro di ritrovare un’assemblea di popolo (ad Oristano) riunita per decidere sulle trattative in corso tra il giudice ed il fratello del sovrano di Francia, Luigi d’Anjou. A sostegno della sua incredibile tesi, riporta le annotazioni di viaggio di uno degli ambasciatori Franchi. Il quale a dire il vero fa la cronistoria di una convocazione dei cittadini, a cui assiste direttamente, ove il principe arborense a mezzo della bocca del vescovo di Ales rende edotti i propri sudditi della sua baldanzosa potenza e del proprio modo di operare, finanche con i reali di Francia qualora questi vengano meno alla parola data. Ma non si tratta di assemblea, come appare agli occhi del nostro Carta Raspi, ma di semplici bandi giudicali, in cui viene ripetuto continuamente ai sudditi, fatti appositamente convenire: “Udite e giudicate”! In tale frangente ai sudditi non viene affatto data opportunità di valutare collettivamente, di approvare oppure disapprovare quanto stabilito dal Principe. Se ciò fosse accaduto, in pieno 1378, possiamo essere certi che i cronisti ambasciatori del sovrano francese l’avrebbero annotato di sicuro, essendo l’assemblea di popolo decisionale luogo politico scomparso ormai da diversi secoli in tutto il mondo allora conosciuto. Pur interpretando tale convocatoria (che possiamo con più realismo considerare comizio di un dittatore) come fosse una assemblea popolare con potere decisionale, lo stesso autore esaminando un fenomeno simile di appena dieci anni successivo, assicura i propri lettori che si tratta di una “montatura” appositamente orchestrata. È, quest’ultimo, il caso della con- 140 vocazione delle comunità sarde per decidere sul Trattato fra Eleonora ed il sovrano aragonese nel 1388. Secondo Carta Raspi tale assemblea sarebbe fasulla (!) e per buona parte le genti non sarebbero in grado di comprendere quel che fanno (per un apologeta dello Stato sardo e della democrazia non c’è che dire!). A dimostrazione della sua tesi afferma: Non priva di significato è pure l’assenza tra i partecipanti alle assemblee, ... dei maggiorenti, ... Molti dei nuovi cognomi che ora compaiono tradiscono inoltre la condizione sociale: mercantucci ... agricoltori, salariati, “pastori di bestiame”, tutta gente sollecitata in vario modo dai potestà e dai sindaci i quali erano stati nominati dalla cancelleria giudicale ... Ora, o l’istituto della democrazia è in vigore, oppure non lo è. I fautori della prima ipotesi debbono essere conseguenti oppure non ha senso alcuno la loro presa di posizione. Non è possibile affermare, per un trattato di capitale importanza come quello con gli iberici, che i convocati non erano in grado di comprendere. Se poi si afferma che le assemblee erano una semplice montatura, beh! inutile insistere sulla tesi della democrazia in vigore ... Fatto è che ormai da qualche secolo la “gente adunata” (soprattutto i ceti sociali che l’autore di cui sopra sembra portare in spregio) non conta più nulla, se non in quanto forza da sfruttare. La “Carta de Logu” – il codice di Stato sardo per eccellenza – è la prova più evidente della nostra asserzione. Il potere civile e penale è tolto dalle mani dei diretti interessati ed anche le storiche figure dei bonos omines vengono ridotte al rango di appendici del potere giudicale nella comunità. Lo Stato li trasforma in suoi funzionari, i più infimi; se ne serve adibendoli a quelle funzioni che più ritiene opportuno allo scopo di non inimicarsi le comunità che li esprimono. Il Codice tutto sardo mira a gestire e regolare i momenti della vita economica e sociale di assoluta rilevanza: dissesto dell’agricoltura; il dilagare delle grassazioni; la prassi della vendetta; l’abigeato; il furto; ecc. Momenti contrastanti le esigenze del potere accentrato e del privilegio economico. La repressione brutale si erge ormai, superandolo ed annullandolo, su ogni intervento pacificatorio tra le parti in causa. In mezzo all’umanità ferita a morte da cicliche pestilenze, da guerre perenni fra maggiorenti sardi, pisani, genovesi, catalani, aragonesi e papalini, dall’ingordigia di un potere ormai senza fondo che spreme tributi su tributi, l’ultimo dei 141 giudici isolani porta a compimento l’infame tragedia ai danni del suo popolo, non volendo rinunciare neppure in tale frangente alla propria vanità di sovrano sui sardi. Le tristi sorti decretate sugli isolani dalla stupida ingordigia e dai fasti degli antichi giudici, vengono ricambiate con impiccagioni e torture, squartamenti ed accecamenti nonché mutilazioni di ogni genere, in modo sistematico. Solo grazie alla ormai quasi bimillenaria resistenza le popolazioni e la cultura potevano uscire quasi indenni, in ogni caso vive, da simile macello. CARTA DE LOGU, A LAUDE DE JESU CHRISTU I. Se persona dovesse offendere la famiglia reale [giudicale], o ciò consentisse: «depiat esser posta supra unu carru, ed attanaggiada per tottu sa terra nostra de Aristanis, e posca si deppiat dughiri attanaggiandolla infini assa furca, ed innie s’infurchit» (dev’essere caricata su di un carro ed attanagliata, percorrendo tutto il territorio del regno poi, condotta alla forca, qui attanagliata e quindi impiccata). II. Se persona dovesse mai togliere alla famiglia reale: «terra, over castellu ... deppiat esser istraxinada a choa de cavallu per tota sa terra nostra d’Aristanis e posca infini a sa furca, ed innie s’infurchit ch’indi morgiat, ed issos benis suos siant appropiados a su rennu» (terre o castelli ... dev’essere legata ad un cavallo e trascinata per tutto il regno, così portata alla forca e qui impiccata fino a causarne la morte; i suoi beni devono essere incamerati in quelli del regno). III. Se: «persona occhirit homini ... siat illi segada sa testa in su logu dessa justicia» (persona uccide altra persona ... venga ad essa mozzata la testa nell’apposito Logu della giustizia). Se poi, quanti fossero per disgrazia in compagnia dell’omicida non si presentassero a testimoniare «ch’issos siant punidos, e condennados a morti» (che siano puniti [cioè sottoposti a tortura] quindi condannati a morte). V. Chi somministrasse veleno a persona: «siat infurcadu» (sia impiccato); se la persona avvelenata non dovesse morirne, al tentato omicida «siat illi segada sa manu destra» (gli venga mozzata la mano destra). VI. In questo ed altri Capidulos della Carta de Logu, per la prima volta nella storia è codificata l’espulsione (bandire) dal Rennu dell’omicida: “isbandidu dae sas terras nostras”. Ovvia- 142 mente i suoi beni vengono annessi a quelli del regno. IX. Per il feritore si comminano grosse multe (come per tutto il resto, d’altra parte) e, qualora non le pagasse “siat affrustadu” (venga frustato); ma se la qualità (calidade – ceto) del ferito è assai quotata, il feritore sia “affrustadu per sa terra”, cioè pubblicamente per tutto il regno. Se per disgrazia poi il ferito dovesse perdere qualche membra, il feritore “perdat su simigianti membru” (gli venga recisa membra uguale). Le multe non mancano mai, dal “delitto” considerato più grave a quello più infimo e se qualcuno non potesse pagarle – e non ci vuole molto a comprendere a quali ceti sociali possa appartenere – immediatamente subentra la pena corporale, dopo qualche settimana di attesa (massimo due mesi) in carcere. X. In caso di rissa senza ferimenti, qualora non fosse possibile stabilire o scoprire chi l’avesse originata, tutti indistintamente devono pagare la multa stabilita. XIII. De robaria de strada publica (sulla grassazione nella pubblica via). Il grassatore “siat impiccadu” (impiccato). Qualora la grassazione avvenga fuori dalla pubblica strada è previsto il pagamento di una multa, diversamente “infurchintillu” (venga inforcato-impiccato). A queste pene capitali fanno seguito quelle più “leggere”: – per stupro: taglio di un piede oppure di un orecchio, a seconda dei casi; – falsificazione di atti notarili: taglio della mano destra; – furto di cosa sacra: se si tratta di primo furto viene punito col cavamento di un occhio, ma per la seconda volta è prevista l’impiccagione; – per l’abigeato, a seconda che sia il primo oppure il secondo furto ed a seconda della quantità e qualità delle bestie: taglio di orecchio-forca, taglio dei due orecchi-forca; – il furto in casa è cristianamente punito con l’impiccagione “peri sa gula” (per la gola); – “chi spiantasse vigna altrui” paghi multa salata, e se non paga dopo 15 giorni di prigione “seghitsilli sa manu destra” (che gli venga mozzata la mano destra). Potremmo proseguire col taglio della lingua, il rogo, l’essere trascinati per tutto il regno poi affondati nel letamaio quindi impiccati; oppure con l’essere la lingua infilzata da un amo, ma ... ci fermiamo qui. Con questa amorevole cura degli interessi delle sarde genti, proprie degli Statisti autoctoni, chiudiamo il 143 paragrafo. È evidente che ormai si punisce, non si riconciliano le parti in disaccordo. Inoltre si punta a favorire la delazione (facendo sempre obbligo di denuncia per ogni infrazione, anche da parte di colui che avesse subito il danno) espropriando in tal modo le parti direttamente interessate a dirimere le controversie fra di esse. 3.1.3 La giustizia iberica Secondo alcuni storici la dominazione iberica in Sardegna si caratterizza per l’infeudazione dell’isola. Ciò corrisponde a verità solo in parte, essendo di già preesistenti (e ne fanno fede in primo luogo e le Condaghi e la medesima Carta de Logu) forme avanzate di rapporti tipici del sistema feudale. I rapporti tra le istituzioni della Chiesa ed i “liberti”, ricalcano a pieno titolo forme di puro sistema feudale, tanto che questi ultimi vengono ceduti né più né meno unitamente ai possedimenti. Vero è però che nel momento in cui i sovrani iberici – dopo la centenaria guerra contro il Giudicato di Arborea – prendono pieno possesso dell’isola, buona parte della Sardegna viene concessa in feudo ai fedeli della Corona che nella conquista si compromisero con armi, uomini e finanze. Solo le città, ed il relativo entroterra, sono direttamente amministrate dalla Corona e godono di un’infinità di privilegi che gravano, plumbei ed opprimenti quanto mai, sulle ville rurali, pertanto sulla di già impossibilitata situazione economico-sociale agropastorale. Fare l’elenco dei privilegi di cui godono le città sarebbe assai lungo e tutto sommato inutile, in questa sede; per cui ci limiteremo ai termini assai generali della questione. I “cittadini” sono esenti dai tributi feudali, usufruiscono delle cariche relative all’amministrazione della colonia, concentrano le ricchezze, i danari, i commerci, l’artigianato ed inoltre sono garantiti nell’approvvigionamento delle derrate alimentari di prima necessità a prezzi politici (il pane, ad es.). Infine, gravame il più infido e vergognoso, le città devono comunque essere approvvigionate di un quantitativo prestabilito di cereale; finanche nelle annate pessime. La ruralità viene letteralmente soffocata da mille ed un tributo e da incredibili gravami che ogni singolo feudatario ritiene opportuno imporre, non esistendo se non formalmente alcun controllo effettivo da parte della Corona sul modo in cui i signori amministrano il proprio feudo. In un tale sistema non può non svilupparsi discrasia, inimicizia, contrapposizione, antagonismo fra la città e le campagne. Fra i due mondi si compie quella insanabile frattura che perdura ancora ai giorni nostri. Non 144 a caso le sommosse, le ribellioni, i sollevamenti che accompagnano la storia delle classi subalterne sarde sono caratterizzati dalla assoluta mancanza di contatti fra la città e la campagna. Assenza che finisce per alimentare il facile gioco del potere coloniale e la sua presenza nell’isola, agevolata dalla realtà del dividi et impera. La divisione arriva a tal punto che, spesso e volentieri, i privilegi cittadini finiscono per ledere finanche gli interessi della Chiesa e dei feudatari (o, meglio, degli amministratori dei feudi, in quanto i titolari effettivi risiedono tranquillamente in Spagna malgrado l’obbligo formale imposto dalla Corona di risiedere ciascuno nei relativi feudi concessi). L’immobile sistema di sfruttamento della ruralità, insostenibile in tempi normali, determina genocidio, stragi, pestilenze ad ogni brutta annata, raccolto andato a male, aumento delle derrate per le necessità cittadine, che riducono a livelli insostenibili le già precarie condizioni di vita di pastori ed agricoltori, provocando infinite sollevazioni delle ville al fianco delle quali non è assolutamente impossibile contarvi prelati e signori feudali, in tema di veder diminuite le entrate di loro competenza. Ad accentuare la rabbia delle popolazioni rurali, contribuisce l’assoluta libertà con cui gli amministratori dei feudi riscuotono tributi e ne impongono di nuovi. Inoltre, nell’ambito del feudo, la stessa amministrazione della giustizia è nelle mani del signore feudale, per cui si può immaginare con quanta ferocia questi dominino. Da qui il fenomeno della “criminalità” in bande più o meno stabili, e la consistenza numerica che raggiunge dimensioni incredibili. Il fenomeno del banditismo, come noi oggi lo conosciamo in Sardegna, affonda le proprie radici esattamente nel trapasso dalla situazione Giudicale (in cui non ha avuto il tempo di svilupparsi) a quella del dominio spagnolo. Tuttavia la condizione dell’isola non ha ancora raggiunto il peggio (cui si perverrà con la colonizzazione piemontese prima ed italiana in seguito). Non a caso risulta che diverse ville “montane” abbiano mai pagato tributi feudali alla corona “spagnola”; sintomo che gli iberici sono ben consapevoli del fatto che imporsi brutalmente su situazioni caratterizzate da particolari avversità umane e culturali, avrebbe sicuramente decretato insurrezioni di non facile soffocamento. Le genti pellite, hanno quasi “libero” accesso nella transumanza degli armenti verso le pianure e colline dei Campidani e delle Baronie, vera e propria valvola di sfogo e di contenimento della rabbia covata da quelle comunità. Anche se non esistono dati certi, il fenomeno della ribellione tipica delle genti sarde, il banditismo “modernamente” inteso, in periodo iberico raggiunge punte altissime tanto che la Carta de Logu, dev’essere integrata dall’autorità regia nel 1574 con le tristi Prammatiche sui bandeados. Ri- 145 spetto al periodo Giudicale, il banditismo è ormai sviluppato ed articolato, con i dentellati che affondano nell’humus della collettività e civiltà agropastorale. Ciò che l’autorità iberica vuole stroncare è esattamente questo legame, criminalizzando la società intera nel tentativo di dissuaderla dall’ospitare nel suo seno i banditi. Le Prammatiche stabiliscono ed ordinano: che ogni persona accusata di crimine o delitto che sfugga la giustizia, anche se mai citata in giudizio né “schedata” come criminale, tale deve comunque essere considerata; che chiunque dia loro aiuto, rifugio, solidarietà venga punito con le stesse pene in cui incorrono “i protettori” di banditi, oppure in pena minore (a seconda del ceto di appartenenza) ad esclusiva volontà del giudice (Cap. Primo). Inoltre, “essendo le terre del Regno di Sardegna popolate di uomini perversi che vanno in bande uccidendo e trafugando bestiame”, per il solo fatto di essere armati è prevista la pena di 10 anni di galera (cioè di lavori ai remi delle navi del sovrano), oppure in altra pena minore, corporale o pecuniaria, a esclusivo giudizio del luogotenente, a seconda del genere di persona e del delitto commesso (!). Infine, cosa notevole, che estende la famigerata inkarriga anche ai singoli, chiunque fosse visto, o comunque si accompagnasse ai banditi, dev’essere punito e castigato con le stesse pene previste per i banditi. Ciò che maggiormente turba la “tranquillità” dei colonizzatori è il fatto che i banditi si strutturino in bande di più persone, dando vita ad organizzazioni anche militarmente consistenti. Per cui particolare attenzione viene posta nel Capitolo Quarto a questo riguardo. In tale Capitolo si fa divieto di girare armati, da soli o in più di tre persone, di congetturarlo semplicemente, sotto pena “dell’allontanamento” dal regno o della condanna all’ergastolo oltre che della confisca dei beni. Qualora, pur non ospitando i banditi, questi venissero “rifocillati” in armi o polvere da sparo, la pena prevista è assai pesante: 1.000 ducati di multa e 10 anni di galera, oppure anche di più, sempre a seconda del censo e ceto del “favoreggiatore”. Le Prammatiche altro non sono se non gravami, pene, torture, deportazioni, galera previsti per le genti agropastorali. Al contrario, le Prammatiche prevedono privilegi per le città, per i nobili, per i feudatari, per gli ecclesiastici (Carta Raspi). Di conseguenza, nel momento in cui prende vigore l’Inquisizione spagnola le genti di campagna poco hanno di che terrorizzarsi. La giustizia inquisitoriale ha un gran daffare negli intrighi di palazzo, fra le diverse fazioni del potere costituito in perenne lotta. A farne le spese tra gli altri è il cagliaritano d’origine aragonese, Sigismondo Arquer, che paga con il rogo la denuncia della bestialità e barbarie con cui il clero partecipa in 146 Sardegna allo sfruttamento coloniale. Arquer non manca di denunciare il “Generale” inquisitore che in Sardegna: Procede contro le persone sospette con tanta severità che è persino difficile spiegare a parole. Infatti, i malcapitati vengono rinchiusi in carcere per diversi anni e qui interrogati e torturati prima di essere condannati oppure assolti. Arquer, nel 1571, dopo il solito internamento nel carcere dell’Inquisizione, non avendo “nulla confessato”, viene arso vivo. Ha avuto il torto di appartenere alla fazione contraria di un potentato politico-economico che in Sardegna, e non solo in essa, non vuole dividere il potere. Se ben triste è la sua sorte, non migliore è quella dei vassalli sotto l’impressionante milizia regia che nell’isola garantisce “l’ordine” con ben 20.000 unità. 3.1.4 La giustizia savoiarda Quando la Sardegna viene data in Regno ai Savoia, e questi ne prendono possesso indirettamente (1720), a significare il loro disprezzo per quella terra e per quelle genti da cui trarranno prestigio, ricchezze e la medesima corona reale, l’isola è a tal punto prostrata che le sue condizioni devono apparire del tutto stomachevoli ai nuovi colonizzatori. Ai secolari malanni dovuti al furto operato dagli iberici, al sistematico sfruttamento di ogni risorsa naturale ed umana, alle cruenti e feroci lotte intestine alle varie fazioni del potere, si aggiungono le altrettanto sanguinose contrapposizioni tra filo-austriaci, filo-spagnoli e filo-piemontesi. Infatti, la dominazione dei Savoia è preceduta da una breve occupazione austriaca che ha modo di allacciare promettenti legami con parte della nobiltà e del clero fino a dar vita ad un vero e proprio partito che offre ai ceti privilegiati presenti in Sardegna ben altre prospettive, in ricchezze e privilegi, di quanto possa dar loro la stracciona casa savoiarda. A completare il quadro concorre il fenomeno del banditismo, ormai di gigantesche proporzioni di massa. Nel concedere ai Savoia il privilegio di re, il Trattato relativo impone ai nuovi sovrani il rispetto dei diritti di feudatari, clero e città. La presa di possesso della Sardegna è caratterizzata dal fatto che apparentemente e sostanzialmente nulla deve mutare rispetto al passato. La bramosia di trarre ricchezze dall’isola malgrado la sua condizione, la necessità di domarla alla civiltà del colono per poterla così vendere a non improbabili interessati in cambio di territori nella terraferma, deter- 147 minano i colonizzatori piemontesi nell’intraprendere quella politica di progressivo accentramento del potere a scapito non solo delle popolazioni rurali ma finanche di ogni altra forza economico-sociale antagonista. Il processo di esautoramento del potere delle realtà sociali preesistenti non è né semplice né lineare, tuttavia sistematico a partire dall’ultimo quarto del XVIII secolo. Ai tentativi di cessione dell’isola si affianca l’opera di trasformazione radicale per spremerne più sostanziosi tributi da far convergere, quali capitali da investire, nella terraferma. La radicale trasformazione abbraccia ogni campo: politico, sociale, economico, linguistico, culturale in genere. Lungi dall’essere un intervento malauguratamente irrazionale, o semplicemente burocratico-autoritario-militare, in realtà la politica dei Savoia è sapientemente e scientemente indirizzata ad un ben preciso fine. Tralasciamo le affermazioni sul presunto impegno civile, sociale, umanitario, paternalistico – a sentire alcuni storici – dei sovrani, miranti per amor dei sudditi isolani a “risollevarli dalle tristi sorti” riservate loro da un “destino” maligno. I Savoia sopprimono le “illegalità” dei feudatari e della Chiesa e ancor più soffocano nel sangue, seminando il terrore fra le popolazioni rurali, ogni minima ribellione ed autoctonia delle genti agropastorali. Ma la repressione, per quanto sistematica sia, non produce ricchezza. Questa, secondo la visione del tempo, deve scaturire dalla terra e dal regime di perfetta proprietà capitalistica (fisiocrazia), per cui il “progresso ed il benessere della nazione” impongono di liberarla dai vincoli che ne impediscono il pieno possesso ed il massimo della rendita. Ciò significa rivoluzionare l’assetto feudale e, soprattutto, decretare la morte del regime comunitario di gestione dell’agricoltura e della pastorizia. È dalla necessità di estrarre tributi che casa Savoia medita la strategia a lungo termine. Il che è ben altra cosa dal conclamato umanitarismo ed affezionamento dei sovrani alle genti sarde. Il progetto di trasformazione radicale richiede l’accentramento nelle mani della burocrazia statale di ogni momento della vita economica, civile, culturale. Per cui la corte mira fin da subito a creare – soprattutto nelle città, centri propulsori della colonizzazione e del nuovo potere – una schiera di fedelissimi compradores che col tempo assumono le alte cariche burocratiche. Nel contempo concretizza la lotta più dura per soffocare ogni “covo” di ribellione chiesastica e feudale, incrementando le “simpatie” nei più dubbiosi e meno schierati nelle file dell’antipiemontesismo, sopprimendo gli altri. Alle popolazioni rurali, considerate alla stregua di banditi nella loro 148 totalità, tocca invece il ruolo di teatro permanente in cui vicerè seguiti da schiere di assassini prezzolati, si cimentano in impalamenti, squartamenti, roghi, forche, nel tentativo di spezzare ogni resistenza e residuo di “barbarie” ed “inciviltà”. Ovviamente quei feudatari che manifestano rispetto e partito preso per i sovrani savoiardi, possono continuare nelle antiche scorrerie nei propri feudi; l’essenziale è che comunque assicurino agli umanissimi reali i donativi che questi chiedono di volta in volta. Ai primi del XIX secolo i sovrani possono sconfiggere il partito avverso dei feudatari e le ultime frange della ribellione filo-francese; poi si cimentano, progressivamente, nel porre giuridicamente fine al sistema feudale, risarcendo i feudatari in modo tale da soddisfare pienamente le loro esigenze quindi accollando alle comunità espropriate di tutti i tradizionali diritti, usi e costumi i costi della gigantesca “rivoluzione”. È col vicerè don Carlo Amedeo Battista, marchese di S. Martino di Rivarolo, vice sovrano dal 1735 al 1738 che inizia ad emergere la sistematicità della giustizia novella in Sardegna. A questo sanguinario uomo si deve la prima caccia grossa ai banditi, identificati con tutti gli isolani poco soggetti alle “virtù” dei Savoia. La sua intenzione è di radere al suolo il sostrato umano-culturale, cioè la società sarda che alimenta il banditismo. In soli tre anni, questo portatore di vera civiltà, impicca 532 persone ed altre 3.000 le fa arrestare oppure deportare dall’isola. Intendendo lo stretto rapporto fra le popolazioni e quanti nel mondo rurale si pongono fuori dalla legge, i suoi non sono altro che atti di guerra contro un nemico ostile. Il semplice sospetto, pur se infondato, nei riguardi di chicchessia, determina il sanguinario vicerè nella “impiccagione, l’attanagliamento coi ferri roventi, la combustione dei cadaveri e la dispersione al vento delle ceneri”, nonché lo squartamento, la tortura e finalmente il rogo purificatore. La malata ossessione del tristo figuro lo determina finanche, nell’ultimo anno del suo viceregno, nell’emanare quel famigerato e stupido pregone (del 9 maggio 1738) “sull’abolizione delle lunghe barbe” esplicitamente riservato ai soli sardi, in cui, ribadito che è “propizio ai delinquenti meritevoli, di essere estirpati con ogni mezzo”, ordina e comanda che nell’avvenire nessuno, per alcun motivo possa portare la “barba cresciuta più d’un mese”, sotto pena la prima volta di un mese di carcere e quattro scudi di multa; del doppio per la seconda volta, ma per i più ostinati anche “altre pene arbitrarie”. Ovviamente un terzo della pecunia deve andare “all’accusatore ed al ministro che ne fa l’esecuzione” (e possiamo ben immaginare quante denuncie ed esecuzioni questi sono interessati a fare). Il tutto è minutamente elaborato e trascritto in carta regale anche se 149 poi la miserabile operazione viene posta in essere a causa dell’estrema ignoranza del civile Rivarolo, il quale crede di trovare “l’etimologia” del termine barbaricini nel fatto che molti di essi portano la barba lunga ... Operazione ancor più ridicola se pensiamo che in altri tempi, un altro civile suo pari impose che i sardi Pelliti ... portassero invece la barba lunga in modo da non confondersi con gli stranieri (e rendere così più agevole l’opera dei boia). Pago degli assassinii perpetrati e della strage compiuta, il miserabile ignorante vicerè porta vanto d’aver finalmente “estirpato” il banditismo sardo. Ma la gloria ben poco dura, se solo qualche anno di poi della sua dipartita, il successore vicerè marchese Carretto di S. Giulia (in azione dal 1745 al 1748) deve nuovamente organizzare l’esercito di lanzichenecchi savoiardi per dare corso a quella tristemente ricordata guerra contro Leonardo Marcedhu e le altre innumerevoli bande. Talmente barbara e crudele è la politica genocida del Rivarolo che lo stesso sovrano lo richiama ripetutamente alla moderazione, senza tuttavia riuscire a porgli in qualche modo il freno. I suoi successori non sono comunque da meno, tanto che uno di essi è passato alla storia (oltre che per le stragi compiute) per non riuscire a prendere sonno se prima non impicca almeno 6 o 7 sardi (il lettore ci perdonerà per la nostra imprecisione sull’esatto numero necessario a dare sollievo all’emerito assassino, ma siamo convinti di non tralasciare, in fondo, alcuna cosa di estremamente importante ...). Quanto accaduto col Rivarolo si ripete esattamente con il viceregno di Valguarnera, che sale agli allori dell’ambita carica nel 1748. Questi, solo con l’utilizzo sistematico dell’esercito e le armi del tradimento riesce a fare strage di ribelli in Gallura, fino al 1751. È tuttavia sotto le direttive del ministro Bogino che i vicereali effettuano ancor più stragi, in maniera matematica tanto che le civili cure del Conte sono ricordate dai sardi nel conio di un nuovo vocabolo: su Bujinu (su bujinu così è sinonimo di dimoniu = demonio). Sotto l’egida di questo barbaro statista alla prassi genocida si affianca l’intensa opera della politica colonialista sabauda, mirante a modificare a vantaggio del colono vuoi gli ordinamenti amministrativi, vuoi le colture minerarie, vuoi l’agricoltura. Mentre le miniere vengono date in concessione a capitali forestieri, la pastorizia è sottoposta ad un regime di ulteriori ristrettezze, costretta a ripiegarsi su territori sempre più poveri ed insufficienti, a causa dell’estensione e del privilegio accordati alle vecchie e nuove coltivazioni (tabacco, per es.). Come se non bastasse tutto ciò e la Carta de Logu, i Pregoni e le Prammatiche di vario genere, nell’esatto momento in cui nell’intera Euro- 150 pa prende piede l’abolizione della tortura (non dimentichiamo che il testo di Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene, viene stampato nel 1764), l’Editto “per l’amministrazione della giustizia nel Regno di Sardegna” del 13 marzo 1759 non solo la estende in maniera ancor più sistematica di prima, come pena aggiuntiva/collaterale alle altre di diversa natura, bensì ne rimarca il fine di essenzialità nell’incutere terrore. Corregge la Carta de Logu ed in generale adegua ai tempi, anche sul versante criminale del “diritto”, la lotta al banditismo ed alla specifica criminalità. Ricettatori ed acquirenti di cose rubate hanno la stessa pena dei ladri; se poi s’inseriscono (mèdiano) semplicemente nel commercio delle cose rubate la pena può estendersi fino alla galera perpetua. Ed è il caso di ricordare che per galera, in un tale contesto e per decenni ancora, è da intendersi come lavori ai remi nelle navi del sovrano. Il Capitolo Quinto dell’Editto, esplicita la prassi prettamente inquisitoriale che l’amministratore della justitzia (di Stato) deve tenere nell’assolvere le sue funzioni di boia. In particolare afferma che, per i reati commessi “si avranno, fra gli altri, sospetti specialmente i vagabondi, e quelli sfaccendati senza esercizio di mestiere” che “si vedranno pubblicamente a frequentare i giuochi, osterie, taverne e luoghi simili” (vedremo che a tutt’oggi su questi punti significativi nulla è mutato per i sardi). Alcuni capitoli successivi riguardano le pene da comminarsi ai ladri ed agli abigeatari con una gradualità che, se esistente per i primi, è sostanzialmente inesistente per i secondi. Il furto “egregio”, sia pure il primo, viene punito con la morte. Ai domestici ladri è data la medesima pena, anche se il valore della cosa rubata non è “egregio”, bensì pari almeno al valore di 50 scudi. Nel caso di valore inferiore per la prima volta viene comminata la galera a vita, per la seconda la morte. Il primo furto con scasso è punito, se di lieve entità, con la galera a 5 anni e la marchiatura a fuoco sul braccio destro ... Anche il semplice possesso di “chiavi false”, ferri o grimaldelli di varia natura “adatti allo scasso”(!), è punito con la galera per almeno tre anni; se si tratta di minore di anni venti, ma d’età superiore ai diciotto, la pena è di almeno un anno alla catena. Il primo furto semplice viene punito con la catena a tempo; se supera i 50 scudi di valore con la fustigazione in pubblico. Per il secondo furto la pena è la morte. Il “contorno” dell’Editto è tutta una dolcezza: galera, fustigazione, marchiatura a fuoco, ergastolo, morte. Soffermiamoci brevemente sulle pene previste per l’abigeato. La prima volta 10 anni di galera, la seconda volta galera a vita, la 151 terza volta morte. Se però il valore del bestiame rubato supera i 125 scudi la pena prevista è di morte, anche se si tratta del primo furto. Se poi i furti, anche semplici, o l’abigeato, vengono commessi in gruppo di almeno cinque persone la galera a vita è assicurata, con l’aggiunta obbligatoria della pena seguente: i banditi devono “esser condotti per mano del boia nelle strade pubbliche passando sotto il patibolo col laccio al collo e con il remo in spalla”. In caso di grassazione è prevista la pena di morte. A scanso di dimenticanze da parte degli esecutori della justitzia, ed anche del possibile fraintendimento dei nostri dieci lettori, il Capitolo Ottavo, paragrafo VI, stabilisce ed impone che le sentenze, quantunque solo a tempo, devono prescrivere sempre la tortura, che si praticherà anche per altri furti, abigeati, grassazioni non dedotti in processo, allo scopo di scoprirne i complici. Sempre lo stesso Editto dispone che ogni anno devesi redigere il Catalogo dei banditi condannati in contumacia, ad iniziare proprio da quel fatidico 1759. Ed è dal Catalogo di tale anno che estraiamo qualche significativa sentenza a titolo di esempio della civiltà savoiarda in terra sarda. Francesco Usai: condannato ad essere “strascinato e squartato”; Michele Perreddu: condannato “alla frusta ed a tre anni di esilio”; Francesco Artea: ha la condanna più mite, 10 anni ai remi. Viene anche chiarito che i banditi di cui al Catalogo sono “esposti alla pubblica vendetta, si possono arrestare nonché impunemente uccidere”. Si potrebbe obiettare che questi sono i tempi in cui ovunque si agisce in tal modo e di conseguenza i Savoia si comportano esattamente come ogni altro sovrano. Il che è senza dubbio vero, almeno in parte! Ma se così è tutti i sovrani sono degli emeriti criminali, compresi i Savoia. Non vi è di che attribuire a questi ultimi propositi mai avuti né manifestati, tantomeno una sorta di illuminato umanitarismo e paternalismo, nonché “fraterna attenzione” per le sorti dei “regnicoli” (come ci classificavano). Non a caso, nel momento in cui i savoiardi boia in vesti da vicerè riducono l’isola a una immensa bolgia infernale di impiccati, squartati, torturati, con sperpero di finanze inaudite, nella sola Cagliari i sovrani “fraterni ed umanitari” lasciano crepare di vaiolo ben 500 bambini, senza che per contrastare la crudele morte spendano un solo scudo, né garantiscano misure igienico-sanitarie atte a limitare la diffusione della terribile pestilenza. Nessuna pietas dunque per le popolazioni sarde, né sentimenti di presunto “affetto”. Solo razionale intervento genocida mirato a strappare alle genti isolane più di quanto possano e vogliano dare. 152 A dover semplicemente riassumere le carneficine compiute dalla giustizia piemontese non basterebbero interi volumi. Tuttavia non possiamo non accennarne almeno qualcuna. Per esempio, quanto accade a Bono (villa non tanto distante da Sassari e Nuoro), nell’ambito della lotta contro i moti popolari antifeudali. Nel 1796 i presunti reali umanitaristi ed amici del popolo sardo reputano necessario costituire un vero e proprio esercito atto a radere al suolo il paese di Bono (ed altri paesi che si sono sollevati contro il regime feudale), e fare carneficina degli abitanti con tale crudeltà da terrorizzare l’intera isola. Ma neppure per tali loro esigenze i sovrani più pezzenti d’Europa rinunciano agli introiti del dominio; per cui, allo scopo di non intaccare la cassa reale, per costituire l’esercito di cui necessitano ricorrono all’immunità di quanti vengono considerati fino al giorno prima “criminali da estirpare con ogni mezzo”. Questi possono avere completa ... remissione dei peccati, un po’ di denaro e salvacondotti purché si arruolino nelle orde di Stato il cui compito è null’altro che compiere impunemente stragi, stavolta legali ed altamente civili in quanto decretate dal re. Uomini alla macchia da anni, spesso da decenni, sottoposti a vita raminga e miserevole, permanentemente rincorsi da spie e militari allo scopo di assicurarne morte crudele, non possono in tanti rinunciare all’occasione loro offerta dalla justitzia della civiltà, per cui non disdegnano l’arruolamento. Ovviamente gli arruolati intervengono contro popolazioni ad essi sconosciute, nemiche, ostili (è esattamente quanto ogni colonizzatore ha fatto in tutti gli angoli del globo, sfruttando a suo esclusivo vantaggio l’antagonismo permanente della società selvaggia). La villa di Bono viene letteralmente rasa al suolo, saccheggiata, bombardata e quindi incendiata. I militi del civile sovrano si accaniscono sull’unica persona che non vuole scappare dal paese assieme ai compaesani, forse sicura che nulla le può accadere: una povera vecchia paralitica! La furia bestiale dell’orda reale si accanisce sull’impotente donna, che viene orrendamente straziata ed alla quale, miserevole atrocità savoiarda, vengono recise finanche le mammelle. Non trovandovi altri villici, fortunatamente fuggiti, la furia omicida dell’esercito reale viene riversata sugli animali abbandonati dai bonesi nella fuga: delle bestie abbandonate in parte viene fatta razzia e quante non possono essere razziate vengono squartate vive, fatte a pezzi e quindi sparse su tutto il territorio del villaggio. Purtroppo non si tratta di una eccezione; simili barbarie si ripetono quotidianamente ad un ritmo incalzante. Ogni paese nostro porta impresso nella memoria almeno uno di tali truci episodi, tramandato di generazione 153 in generazione, a disprezzo della “più avanzata civiltà” che oltre il nostro mare si vuole abbia preso piede. Così gli Orrolesi più anziani tramandano lo strazio subito in epoca precisamente non databile, da certo Mathia Anedha, orribilmente torturato, mutilato quindi impiccato e lasciato appeso al patibolo per un tempo indeterminato, col fine di terrorizzare i popolani. Anche per tale avvenimento il poeta della comunità di Orroli, ha immortalato alla vergogna della storia la civiltà dello Stato: Sa morti de Mathia Anedha Non dha fatza’ nemus Mama de filhu batiau Ka pro dh’inpikai Fuant una xedha E non dhu ia’ nemus A ki’’ dhu lhastimai! (La morte di Mattia Anedha, non possa mai farla nessun’altro; madre di figlio battezzato. Ad impiccarlo furono in molti, ma nessuno vi era che lo rimpiangesse [e consolasse]). Il nuovo secolo non conclude le atrocità. Anzi, nella prima metà dell’800 le popolazioni rurali vengono costrette a subire l’attacco più radicale ed incisivo al proprio modo di vita che questo ne rimane sconvolto per sempre. Assicuratosi il consenso dei feudatari, del clero (almeno in parte ) e dei compradores, umiliate e decimate le popolazioni, divise le comunità in laceranti odi, disamistades, vendette che sconvolgono interi paesi di cui le migliori energie spesso sono alla macchia, i dispensatori di civiltà portano a compimento l’opera iniziata dal Bujinu. Nel 1820 viene emanato il primo Editto (detto delle “chiudende”) che sancisce l’inizio dell’esproprio della terra e dei suoi frutti ai danni delle popolazioni rurali, nonché l’introduzione forzata di rapporti capitalistici che, lungi dall’indebolire gli antichi privilegi dei ceti feudali, non solo li rafforzano, ma di nuovi ne aggiungono. I ceti compradores delle città sono a questo punto talmente piemontesizzati, per cultura ed interessi, che nel 1848 chiedono ed ottengono la “perfetta fusione” con gli Stati di terraferma, rinunciando d’ora innanzi a qualsiasi richiesta di pur velleitaria “autonomia”. Ai ceti rurali ben poco sarebbe importata una tale rinuncia, se non che la prima immediata conseguenza hanno a soffrirla proprio essi: dall’oggi al domani, infatti, viene estesa pure “ai regnicoli” la leva obbligatoria, fino allora del 154 tutto sconosciuta. Nel contempo, mentre altrove viene abolita la tortura ed ogni paese via via si adegua, in Sardegna ciò avviene solo in contemporanea (puta caso) con l’emanazione dell’Editto delle Chiudende, nel 1820 (quando si dice la logica “del bastone e della carota”...). Finanche l’abolizione delle “esemplarità” (l’infierire sul cadavere), viene decretata (con Pregone del 13 luglio 1832) nella nostra terra ben un anno dopo rispetto agli Stati di terraferma. È necessario però chiarire che si abolisce non tanto la barbarie sui vivi, quanto sul corpo ... dei sardi cadaverizzati. Da tale giorno in poi non è più tollerato “il taglio e l’affissione al patibolo del capo del giustiziato”, nonché la riduzione in quattro (squartamento) del cadavere dello sventurato. In tutti i modi, l’introduzione o l’abolizione di una legge, per quanto importante sia, non scalfisce manco per un poco il trattamento riservato agli isolani, né gli insani rapporti tra Stato sabaudo e la Sardegna. Quotidianamente gli armati di Stato irrompono nei villaggi massacrando e torturando col fine di ricondurre le plebi ora proletarizzate alla civiltà del perfetto sfruttamento capitalistico. Lo stato d’assedio viene quotidianamente decretato, così che quanto abolito formalmente da una legge, viene comunque praticato nella realtà della guerra permanente. Qualora i giudici siano assai “lievi” nell’infliggere condanne, intervengono, come per il passato, direttamente i sovrani, i vice, i loro ministri, tutti abituati a trattare l’isola ed i sardi come personali possedimenti. Finanche poco prima della conquista di quelle terre e popolazioni che poi saranno costrette a costituire lo Stato italiano, ed esattamente nel 1852, il famigerato conte/ministro Camillo Cavour, rimprovera aspramente i magistrati sassaresi che non infliggono pene cruente ed esemplari ai popolani arrestati in massa a seguito di una rivolta determinata dalla miseria in cui è costretta la città dalla rapace politica coloniale. Come conseguenza immediata dell’intervento ministeriale, un popolano che in un primo tempo si diede alla macchia (e non venne processato assieme agli altri), costituitosi in seguito alla relativamente mite pena comminata nel primo processo, subisce condanna tanto grave da suscitare “scandalo” finanche nei benpensanti. Lo stato d’assedio, infine, è misura talmente comune che i civili sovrani la decretano per un nonnulla. Ad Oskiri, ad esempio, viene addirittura decretato nel corso dell’imperversare del colera! Suscita scalpore, poi, quando è decretato per l’uccisione di un ingegnere che segue la costruzione di una strada, anche se l’assassinio è dovuto, e subito si scopre e si sa, a motivi esclusivamente di natura privata!!! 3.1.5 La “justitzia” italiana 155 Nel momento in cui si costituisce, per estensione del regno dei Savoia, lo Stato italiano, la Sardegna è una delle realtà che malgrado il proprio passato di colonizzazione si mantiene come specificità etnoculturale, affatto integrata in quelle “magnifiche sorti e progressive” che già altrove hanno decretato la nascita dei cosiddetti Stati-nazionali. Se i centri propulsori e gangli della struttura politica, amministrativa, militare della colonizzazione, in altre parole se le città isolane e qualche altro centro dell’entroterra hanno “optato” per la simbiosi – sia pure a titolo di subalternità – col potere costituito, che elargisce carichi ed incarichi nonché privilegi ai compradores, a tutto scapito dei villaggi e dell’agropastorizia, il mondo rurale, ben al contrario, si mantiene come alterità rispetto alla presunta patria italiana. Ovviamente i processi di espropriazione a cui abbiamo accennato nel corso di tutto il lavoro, hanno in qualche modo scalfito tradizioni e potere autodeterminato, così come hanno esacerbato le tensioni interne alle singole comunità e tra di esse. Ed è sulle fratture interne, su odi e vendette sanguinose che il novello Stato affonda il coltello, col fine di portare a compimento il processo di denazionalizzazione ed acculturazione. In tale ambito sorge l’esigenza della nuova entità politica, di plasmare tutte le popolazioni alle necessità del capitalismo di terraferma ed agli interessi dei gruppi di potere economico-finanziario che al Nord hanno impiantato il proprio quartier generale. Il convogliamento delle risorse verso tali interessi deve essere affiancato però dalla prassi della mistificazione assoluta della storia dei popoli assoggettati al nuovo regime, col fine neppure tanto inconfessato di dare corpo a quella chimera che è lo Stato-nazione italiano. Dopo essere stata presuntamente punica, quindi romana, quindi vandalica, quindi bizantina, quindi spagnola, quindi austriaca, quindi piemontese, la Sardegna diviene infine “italiana”. Finalmente! secondo alcuni che di chiunque l’anno voluta fuorché delle sue medesime genti. Così, gli stessi compradores col ruolo di storici che fino alla fine del regime precedente s’arrabattavano sulle cattedre della “storia” a convincerci di essere senza ombra di dubbio e iberici e austriaci e piemontesi, d’ora in avanti si danno l’illustre compito di falsificare, nascondere, travisare con l’intento, lautamente retribuito dalla patria loro di scoprirci “italiani”. Ci raccontano che isola ed isolani si sarebbero ricongiunti alla loro vera patria, culla della “meravigliosa civiltà” la più civile, nonché della giustizia la più giusta. Ed ecco sociologi, glottologi, psicologi, antropologi, criminologi, e via discorrendo, patrii, a scrivere i loro lunghi e falsi “trattati” in cui dimo- 156 strerebbero le ricercate radici italiane di una terra di già fondamentalmente costituita da milioni d’anni, quando lo stivale italico altro non era che uno sputo di minuscoli isolotti immersi nell’acqua stagnante dei pantani. E sarebbe questo melmoso sputo ad avere “attratto” l’isola nostra, ad avere ad essa dettato le ragioni dell’incivilimento, togliendo dalla barbarie presunta i “mastrucati” padri nostri, che invero a tutt’altro pensavano fuorché a quell’originario popolo di sanguinari figli di lupa che dovettero torturare e schiavizzare, per l’ingordigia dei suoi ceti privilegiati e delle sue plebi abbrutite, tutto il mondo a quei tempi conosciuto. I signori della Storia, quella tutta vera per carità, ci propinano in un’infinità di salse la lunga serie di piccole o giganti falsità che dimostrerebbero da un lato le nostre radici italiche (ovviamente gli iberici avevano l’interesse a dimostrarci la nostra “ibericità”, i piemontesi la “piemontesità”, e così via), dall’altro quanta cura, modestia, impegno, interesse, solidarietà, soprattutto quanta umanità avrebbero caratterizzato i sovrani – reali ieri, oggi semplici parlamentari – nell’incivilirci tutti, costringendoci a buttare a mare mastruca e barbarie ... nonché la nostra incivile e sanguinaria giustizia. Nostro malgrado! Ed arriva l’italiana, di giustizia, foriera di gentilezze e libertà, di uguaglianza e diritto! Che ci accingiamo succintamente a raccontare. Come per spagnoli e piemontesi, già al primo impatto l’isola si presenta ai coloni più che domata materialmente e spiritualmente, in un profondo stato di abbrutimento, lacerazione, miseria, sfruttamento inaudito. Questa condizione non può che emergere nella caratteristica propria della società isolana rurale: la criminalità ed il banditismo. Nel pieno della miseria e della fame che strazia gli ormai proletarizzati isolani, il governo italico ben pensa di affinare le armi degli interventi ... della repressione e del genocidio. Si inizia con una inchiesta che è tutto un programma: riorganizzazione della giustizia (quella di Stato); riorganizzazione delle prigioni esistenti e costruzione di nuovi penitenziari, ovviamente moderni come il carcere di S. Sebastiano di Sassari, a struttura cellulare; aumento dei contingenti dell’esercito e dei carabinieri, nonché istituzione di nuove provincie e pertanto di nuovi prefetti militari. Vengono così moltiplicati giudici e magistrati, corti di giustizia e carabinieri ... Gli isolani si ribellano alla chiusura e spartizione delle proprietà collettive? All’abolizione dei loro diritti sulle terre comunali ancora scampate alla “perfetta” privatizzazione? Al pagamento dei tributi non più in natura ma in sonante danaro, ora più che raddoppiati rispetto al passato? Un buon apparato militare e giudiziario porrà le cose al posto giusto, nell’ambito della vera civiltà! Qualche civilizzato manifesta dubbi in proposito? Le varie Commissioni, fra cui quella parlamentare (la prima in assoluto) can- 157 celleranno ogni dubbio. Esempio concreto: le carceri sarebbero sotto stretto e costante controllo di una Commissione visitatrice, costituita dai più “eminenti e rinomati” cittadini, che avrebbe lo scopo di sorvegliare “internamente tutto ciò che concerne il vitto, il materiale, la salubrità, la disciplina, le punizioni” ecc. Peccato, però, che lo stesso sottoprefetto, a ben due anni di distanza dalla costituzione di tali Commissioni, con circolare del 5 ottobre 1863, lamenti che mai nessuna visita sia stata effettuata dalla stessa, ad es. nel carcere di Nuoro! E che mai potrebbe apparire di sconcio ai “più eminenti e rinomati” cittadini nuoresi, o cagliaritani, in quel terribile inferno riservato ad individui di ben altra estrazione e provenienza? Ben più solleciti sono, siffatti “eminenti” cittadini nel chiedere che il governo mandi più sbirri e magistrati, nonché nel chiedere al medesimo il domicilio coatto nelle provincie continentali, con trasporto a viva forza, per gli “oziosi ed i vagabondi”, oltre al ripristino del giuramento nei dibattimenti affinché gli eventuali testimoni d’accusa non si sottraggano al dovere “civile” di fare la spia contro i propri simili. La prova generale dell’applicazione della giustizia tutta italiana, avviene nel momento in cui l’ultimo decreto delle leggi eufemisticamente denominate di “abolizione del feudalesimo”, sancisce l’esproprio delle lande di terre comunali in cui trovano ancora spazio gli autoctoni modelli materiali e spirituali di convivenza collettiva: si tratta della vendita a “perfetti privati” delle centinaia di migliaia di ettari (500 mila circa) di terre comuni scampate alla rapacità dei latifondisti, in cui le plebi rurali hanno diritto di pastura e di legnatico, di coltura e di raccolta. Non pago delle precedenti leggi che decretarono la chiusura e la concentrazione nelle mani di exfeudatari, borghesi e preti vari, della più parte dell’isola, lo Stato italiano deve completare l’esproprio delle collettività. Come per il passato, le rivolte popolari scoppiano ovunque e subito. Nel 1868 prendono il nome di “motti per su konnotu”, per salvare il conosciuto e ritornare al conosciuto, cioè alla tradizione. I motti rivendicano quindi l’intoccabilità almeno delle porzioni di autoctonia materiale scampate allo scempio della privatizzazione. In tale anno, a Nuoro, la sollevazione si scatena a seguito della delibera del consiglio comunale che pone in vendita i terreni di sa Serra; di conseguenza i pastori che vi tengono le greggi devono trasferirle altrove. Alla rivolta le istituzioni rispondono con lo stato di assedio, l’arresto in massa, la più dura repressione. Il medesimo consiglio provinciale di Sassari (sotto cui cade il Circondario di Nuoro) è costretto ad una petizione al ministro dell’Interno (4 ottobre 1868), tanta è la brutalità con cui si proce- 158 de. I Consiglieri del Circondario di Nuoro ... non invocavano in questo momento rimedi eccezionali ... in quantoché credono che coi soli mezzi ordinarii, ove di fatto e subito vengano adottati si possa far cessare tanta colluvie di mali. Il rimedio più pronto e più efficace nella via degli ordinari rimedi, essi lo riconoscevano nell’aumentare il numero dei RR.CC. [Regi Carabinieri], nello spendervi una forza imponente di truppa come quella dei Bersaglieri, che, negli anni addietro, unitamente all’arma, prestarono ottimi servizi, e vi mantennero l’ordine. Osservavano eziandio, come a seguito dei fatti che si ebbero a deplorare nella sommossa dell’aprile scorso, l’autorità giudiziaria, volendo mantenere forza alla legge, fece procedere ad una cinquantina di arresti di molti padri di famiglia, i quali, ora, languiscono nelle carceri con danno delle famiglie prive del loro sostegno, con scapito gravissimo dell’erario dello Stato, che deve alimentare tanta gente. Che a seguito di tanti arresti, centinaia di persone, per tema di essere arrestate, si sono rese latitanti e si rifugiano nei monti. E siccome questi individui sono tutti nullatenenti, vivono rubando, e ciò che più conta, somministrano un grosso contingente alle bande dei facinorosi ... Quindi il ridonarli alle loro famiglie sarebbe opera provvida e salutare, ciò che si potrebbe conseguire con un decreto di amnistia, esclusi, ben inteso, i Capi ed i promotori dei disordini ... Coloro i quali dovessero intravedere in questa Petizione la volontà umanitaria semplicemente, o più in generale un alto senso di giustizia dei Consiglieri provinciali e del Circondario di Nuoro, miranti a liberare i padri di famiglia razziati dalla giustizia di Stato, prendono un grosso abbaglio, quando non sono veri e propri mistificatori della realtà. In verità, i Consiglieri (a quel tempo ancor più di oggi selezionati fra i “più eminenti e rinomati” cittadini), da un lato mirano a farsi scudo delle vendette dei rivoltosi (di cui chiedono amnistia) dall’altro vogliono finalmente convincere il governo a porre in essere le loro antiche richieste di militarizzazione totale dei paesi allo scopo di meglio garantirsi nelle ricchezze e nella vita. Non a caso la Petizione ripropone: Primo: ricorrere, seduta stante, al Signor Ministro dell’Interno perché interponga i suoi uffici presso il Ministro della Guerra 159 onde l’Arma dei RR.CC. venga aumentata nella stazione di quel Circondario e vi spedisca prontamente una forza imponente non minore ad un battaglione di bersaglieri. Il logico coronamento di siffatta visione avviene l’anno successivo, quando i medesimi Consiglieri del Circondario di Nuoro avanzano alla detta Commissione d’Inchiesta il famigerato Memoriale in cui: Si richiede la riunione della Regione di Nuoro in un ente morale, ossia in una separata Provincia, con bene organizzata polizia e quel numero di carabinieri e d’altra truppa che saranno necessari alla prevenzione e scoperta dei delitti, destinandovi almeno per le prime un militare per prefetto ... ripristinazione del giuramento nel processo scritto ed adozione del domicilio coatto. Quanti affermano che tali repressioni sanguinarie e tali richieste vergognose da parte dei compradores sono dovute ai tempi lontani e pertanto ad una visione alquanto ristretta di intendere i rapporti con la giustizia di Stato, potrebbero aver ragione se si trattasse di cose risalenti a sempre più remoti periodi storici. Tuttavia, il vedere la storia costellata di quotidiani episodi simili, che scorrono fin sotto i nostri occhi e le nostre vite e che scorreranno sotto gli occhi e le vite dei nostri figli se non vi poniamo rimedio, toglie ogni pur minima significanza alle loro affermazioni. Anzi, proprio negli storici, che possono più di ogni altro constatare la costanza e sistematicità dell’intervento della justitzia, mirante a sottrarre alle comunità ogni spazio di autoctonia, è impossibile oggi trovare obbiettività e buonafede. Il 1868 è solo la prima tappa del processo di abbrutimento che vede soggette le popolazioni sarde all’imperio della legge italiana. Ricordiamo qualche altro episodio. La rivolta che scoppia a Sanluri nel 1881, quando gli interventi governativi mirano a garantire l’applicazione di una sovraimposta di circa 40.000 lire per sopperire ed incrementare le dilapidazioni degli amministratori locali, in pasta con i perfetti proprietari prima francesi poi genovesi a cui i sovrani, sempre di manica larga quando si tratta di togliere ai sardi e dare agli altri, hanno donato stagni e circa 1.000 ettari di terreni sottratti alle popolazioni contadine e pastorali di Sanluri, Samassi e Villacidro. La donazione è del 14 agosto del 1838 da parte di Carlo Alberto a favore di U. Ferrand, R. Ehrsam ed E. Cullet, tutti di Montarfier. Si tratta degli stagni di Sanluri e di Samassi nonché dei territori circostanti, che 160 vengono ceduti per il prosciugamento e la costituzione di “poderi modello” da far vergognare i sardi, in regime di perpetua, libera ed assoluta proprietà. Al podere si da il nome di “stabilimento Vittorio Emanuele” per glorificare il civile sovrano. Ovviamente stagni e terreni vengono sottratti alle popolazioni locali, che prima vi vantavano ogni diritto collettivo! Manco a farlo apposta il “Vittorio Emanuele” fallisce miseramente! Tuttavia, con imbrogli e speculazione di bassa lega, nonché con l’ulteriore corruzione degli amministratori locali e del medesimo governo, i concessionari trasformano il fallimento in ... Società Anonima e riescono a farsi dare, previo esproprio alle popolazioni, altri 800 ettari delle migliori terre del Circondario, nonché altro stagno di S. Gavino, di 37 ettari d’estensione. Ciò facendo vantano di aver tenuto fede all’impegno della concessione, facendo bella mostra dei terreni “risanati” che in verità altri non sono se non quelli sottratti al lavoro degli agricoltori locali. Ma neppure siffatte miserabili operazioni e la camorra governativa riescono ad impedire il fallimento della società. Lo Stabilimento viene venduto per sole 570.000 lire al Marchese Pallavicini di Genova. Fino a quel punto, attenendosi alle sole somme gettate nello stagno per il prosciugamento, vi si erano spesi ben 5 milioni di lire del periodo. Insomma, un vero affare per il genovese! Quale il danno a scapito dei pastori e dei contadini? Non solo gli espropri delle terre, non solo il divieto sugli stagni di pesca ed altro, non solo l’impedimento del pascolo nelle terre un tempo loro, ma finanche l’inondazione dei propri terreni sui cui, impunemente, vengono fatte confluire le acque nei tentativi di prosciugamento. Inoltre sono impediti nell’utilizzo delle sorgenti che, pur interne allo stabilimento sono tuttavia ancora di gestione pubblica. Così pastori e contadini sanluresi invadono il Vittorio Emanuele con le loro greggi, prendendosi di fatto quanto il diritto Statale ha loro estorto. In tale occasione però vengono cacciati da un’armata di ben 500 villacidresi. Questo il contesto in cui si impone la sovrimposta e nascono i motti di Sanluri. Malgrado l’iniquità che i popolani soffrono nei confronti del “Vittorio Emanuele” ed il convogliare delle risorse locali verso questo, i tributi che dovrebbero pagare nel 1880 ammontano a ben 120 mila lire, cioè circa 80 lire per abitante. Per rendersi conto di quanto gravoso sia un tale strozzinaggio basti pensare che la giornata di un bracciante agricolo è di appena 75 centesimi, percepiti per sole tre stagioni all’anno. Nonostante ciò nell’81 l’amministrazione comunale decreta l’ulteriore gettito fiscale di 37 mila lire. I popolani stufi delle continue truffe e della pesante situazione, si concentrano il 7 agosto di fronte alla casa del sindaco pretendendo la definitiva abolizione della sovrimposta. I tre sempre fedeli carabinieri della locale caserma non si pongono scrupoli nello sparare sulla folla, 161 uccidendo una donna incinta e ferendo gravemente un contadino. All’eccidio i popolani si infuriano a tal punto che, armatisi di bastoni e tridenti, zappe e quanto altro possono racimolare, ben pensano di fare fuori l’ex sindaco Antioco Murru, uno dei maggiori responsabili della disastrosa dilapidazione delle finanze comunali. La justitzia a questo punto fa convogliare nel paese, la medesima sera, un battaglione di linea e numerosi carabinieri che si danno alla brutale mira sulla plebe, lasciando sulla piazza Eleonora morti e feriti quanti non mai. Nonostante la strage perpetrata a due riprese, la civiltà di Stato non si appaga, e impone il famigerato processo alla fame: un centinaio di popolani, costretti alla vergogna dell’agonia in carcere, nel 1883 vengono condannati a pene ben poco civili. Degli 82 individui processati ben 44 vengono condannati: 12 a tre mesi di carcere e 51 lire di multa 4 a sei mesi di carcere e 102 lire di multa 1 a sei mesi di carcere 1 a un anno di carcere 1 a tre anni e tre mesi di carcere e 51 lire di multa 1 a un anno e tre mesi di carcere e 51 lire di multa 1 a tre anni ed un mese di carcere 2 a tre anni di carcere 1 a dieci anni di carcere 2 a sedici anni ai lavori forzati 17 ai lavori forzati a vita 1 ebbe estinta la pena ... perché suicidato in prigione. Tenuto conto delle ruberie, provate, messe in atto dagli amministratori, del fatto che solo i carabinieri erano armati e spararono sulla folla, che questi arrestarono senza aver visto nulla e nessuno, eccetera eccetera la sentenza inorridisce finanche i cuori più duri ed abituati alla repressione; tanto più che dei sempre fedeli nei secoli solo due – e non vi è di che meravigliarsi, essendo essi armati di schioppi e la folla di sole pietre – hanno leggere escoriazioni. Roba dell’800 si dirà, e così è. Ma il trapasso al nostro secolo, ancora per fare un qualche esempio, non è da meglio. Tra le stragi perpetrate fino alla fine del XIX secolo ed i primi anni del ‘900 (tra cui quella di Cagliari del 1906, quella di Bugerru del 1904 ... ) ci soffermeremo un attimo sulla guerra sistematica decretata dallo Stato e dalla sua giustizia a scapito delle popolazioni delle Barbagie, così come ci viene raccontata da uno dei mas- 162 simi lanzichenecchi della benemerita arma dei sempre fedeli (anche quando si tratta di trucidare donne, vecchi e bambini). Ormai è in auge il combattere il “banditismo” con ogni mezzo militare, tra cui anche l’arruolamento di volontari o finanche la costituzione di truppe di civili, ovviamente “di rinomati ed eminenti cittadini”. Così avviene nel Circondario di Nuoro tra il 1871 ed il 1872, quando una squadriglia di ben 40 borghesi, organizzata e comandata dal nobile Gavino Bellisai, si da alla caccia grossa, dando man forte ai RR.CC. ed ai militari. Ma la strategia genocida di fine secolo viene posta in essere dal presidente del consiglio Pelloux che, anche questi, vuole porre fine al banditismo isolano. Invia così in Sardegna adeguati rinforzi e la notte tra il 14 ed il 15 maggio 1899 prende il via la triste diaspora dei barbaricini che la bandiera della civiltà a centinaia sbatte in carcere, o al cimitero. In quella notte, nei Circondari di Nuoro e di Otzieri vengono arrestati in massa: I parenti, gli amici, i manutengoli dei latitanti, e scortati dai soldati e dai carabinieri vennero immediatamente portati alle caserme od alle vicine stazioni ferroviarie, dove altri soldati e altri carabinieri attendevano e vigilavano. E nelle prime ore del mattino i treni, ai quali si era segretissimamente fatto dare un largo sussidio di vetture, toglievano da ogni stazione tutto quel dolore, tutta quella sciagura, quell’orda di pezzenti e di proprietari, di madri e di sorelle piangenti, di sindaci, segretari, preti, vecchi e fanciulli trasportandoli nei capoluoghi delle due provincie e nelle altre città dell’isola, dove per alcuni giorni una immensa folla continuò ad attendere altri treni di arrestati, fra mille commenti a casaccio di altri arrestati, di stato d’assedio, di rigore e di forca, ... (Castiglia, Undici mesi nella zona delinquente, Sassari 1899, riportato da AA.VV., La Sardegna contemporanea) Ma è Giulio Bechi, sottufficiale dei RR.CC. a dirci quanta simpatia hanno i lanzichenecchi di Stato nei confronti della nostra terra e delle sue plebi. Non possiamo esimerci dal riportare almeno alcune considerazioni del primo approccio che il carabiniere ha avuto con l’isola. Nuoro: un brulichio nerastro di villaggio steso fra le stoppie giallicce, in uno scenario fantastico di monti, dei pastori vestiti [di] pelli, delle vie di granito battute dal vento, delle campane martellanti un eterno tintinnio di tarantella, la capitale del brigantaggio ci appare come un grosso e squallido borgo, dove il 163 vescovo mitrato, il sottoprefetto e il comandate del presidio fanno l’effetto di una commenda sulla casacca di un villano. Umanissima poi la considerazione che nel significativo testo (Caccia grossa) il Bechi fa dire ad un suo amico, ovviamente R.C. in servizio a Lula: «Bella giornata! peccato che non si impicchi nessuno! fa rabbia quel bell’azzurro sprecato su questo sporco paese!» Ed è con questo alto spirito di civiltà ed abnegazione umanitaria che arriva la notte di S. Bartolomeo. La bomba è scoppiata: nella stessa notte, alla stessa ora, una gran retata di tutti i grossi favoreggiatori in tutti i comuni del circondario. Quel diavolo di capitano, zitto zitto, aveva già ideato un piano d’assedio. La città spartita in sette rioni, il personale, carabinieri e questurini, in sette gruppi: pronti i depositi dei prigionieri: mucchi di manette, di catene, di corde: tutto calcolato e preparato da mesi, senza che ne trapelasse nulla ad anima viva ... Scocca la mezzanotte: è uno sguinzagliare in tutti i sensi di carabinieri, guardie, soldati. Un fremito è nel cuore di tutti. Riuscirà il colpo audace che deve tagliar le gambe al brigantaggio addormentato? Il giovine prefetto si gioca in questa notte la sua brillante carriera. Egli si è addossato ogni responsabilità, facendosi garante del successo, ma certo a quest’ora veglia nella smania dei primi dispacci. Guai se un barlume di sospetto è balenato a quelle quattro o cinque barbe che spadroneggiano in paese! Guai se esse sobillano il popolo! Si avrà la rivoluzione, le fucilate per le vie e correrà del sangue! Ma è tutto scuro e silenzio; una notte da assassini ... Il civile carabiniere, in quella terribile notte di assassini che si prendono tutt’intera i suoi colleghi, si preoccupa per la brillante carriera del giovane sottoprefetto, ma non batte ciglio alla consapevolezza del fatto che se solo vi è un’avvisaglia sulla retata infame, per le vie dei paesi sarebbe corso parecchio sangue. Tutti i “civili” sono cinici par suo, per cui non ci si meravigli se un suo collega, in quel frangente, manifesta il proposito di legare in un sol fascio tutte le donne che sarebbero l’origine di tutti i mali ... Trattasi delle donne sarde, è evidente, non della civile “marchesa B o di lady K”, che nel bel mezzo della miseria in cui giacciono i sardi a causa del convogliar le loro ricchezze nelle mani di quelle, possono dedicarsi a preparar “pranzi squisiti, fatti a soffi” da consumare nel “flirt”, in mezzo 164 “ai cristalli e ai fiori, in cui lo champagne corre giocondo come il riso” (ancora G. Becchi). Così a quell’ora della notte, si bussa alle porte di ogni casa, buttandole giù nel caso non vengano aperte all’istante dagli occupanti. Al settantacinquenne padre dei Serra-Sanna non viene risparmiata neppure la vergogna di essere ammanettato, a quella età e nel bel mezzo del tramortimento del sonno. Alla figlia accade uguale, per cui legati entrambi, lui ancora scalzo, vengono trascinati in strada nel mezzo delle carabine della benemerita. E quando: da una casa vicina scaturiscono col lanternino in mano due vecchie in berretta gesticolanti e fanno per abbracciar Maria Antonia [la sorella dei Serra-Sanna]... una guardia fa un salto, taglia la strada, e ... patapum! con una botta sola le manda a ruzzolare entro la porta di faccia, si sbacchia dietro l’uscio ... non c’è tempo di veder quel che c’è stato. Quella notte vengono arrestate 450 persone a Nuoro e dintorni. E lì uno spavento pazzo, un correr via all’aperto, strascinandosi dietro i fagotti e i figlioli, come se in paese battesse il terremoto», ci racconta della mattina successiva il civile Bechi. Man mano che gli arresti vengono compiuti, «quel mazzetto, che va crescendo via via come la spazzatura» viene fatto confluire al “deposito” centrale, ove è sito il comando. Dal deposito centrale, ogni poco, una lunga sfilata di gente ammanettata, fiancheggiata dal luccichio delle baionette e seguita da un codazzo di donne in pianto, si avvia alla ferrovia, dove un treno è pronto a riceverla. Anche su tali inumane tragedie la gente civile è sempre pronta a sprecare cinismo ... L’audacia del colpo è stata tale, che dopo tre giorni ne sono ancora sbalorditi. Si è creduto a uno stato d’assedio, a una grande repressione ... Nuoro è nostra». Dopo gli arresti, i sequestri. A chiunque è in odore di amicizia con qualche bandito, si sequestra il bestiame e si manda a pascolare altrove sotto la paterna vigilanza della benemerita. – Volete le vostre bestie? sta bene: fateci avere il vostro amico. Chi è ormai famoso per queste razzie è il brigadiere di Oliena. Si 165 è rifatto vivo dalla madre del latitante Pau. Va là col suo bravo bollo [S.G. = Sequestro Giudiziario] e: – Dimmi un po’: o che aspetta tuo figlio per costituirsi? – Mah! che ne so io? – Ah si? Allora guarda. E tac, tac si mette a bollare tutto ciò che gli capita sotto. Va all’ovile, fa una razzìa di tutti i porci e li manda al camposanto nuovo, dove carabinieri e soldati non riparano a timbrare a fuoco le natiche delle bestie, tra una sinfonia di grugniti, di belati. Poi sgranando due occhiacci spiritati e levando il terribile arnese sul viso sbigottito della vecchia: – E se in settimana non mi fai costituire il tuo figliolo ... quant’è vero Dio bollo anche te! Indi a suon di tamburo fa un bando in piazza. – Pochi discorsi e buoni: avete visto dove sono andati i porci del Pau? Se fra otto giorni l’amico non si costituisce, piglio tutte le vostre vacche, tutte le vostre bestie e faccio viaggiare anche quelle. Ovviamente i metodi della “grande patria” dei sardi e della vera justitzia, ricattando in tal modo tutta la popolazione dell’entroterra sortiscono effetti notevoli. Vedendo tanta sofferenza abbattersi sui familiari e sugli innocenti, i latitanti sono costretti ad arrendersi a troppe. E si costituiscono infatti. Da due a tre giorni vengono, vengono circondati dalla famiglia, sui cavallucci, sui carri; e uno tira l’altro come i matrimoni e gl’impiccati! L’esito di siffatta azione giustiziera è l’arresto e l’incriminazione di ben 700 persone, accusate tutte, oltre di delitti specifici, di associazione a delinquere. Inizia quindi la deportazione delle centinaia di “criminali”, 600 dei quali vengono tenuti in galera dalle cure dei magistrati. Poco importa se poi, dopo mesi, dopo anni di galera solo 320 sono rinviati a giudizio per cui gli altri dopo mesi di carcere preventivo vengono rilasciati. Risulteranno comunque pre-giudicati. Ed ancor meno interessa alcuno dei civili se al processo, lo stesso procuratore generale non può esimersi dal chiedere per circa 300 dei 320 rinviati a giudizio, il pieno proscioglimento ... L’esito del dibattimento è alquanto pesante ugualmente. In ogni caso il problema che si è voluto risolvere non è rappresentato solo dai condannati, ma dall’intera popolazione che si è torturato ... Come al solito, non vi è stato alcun errore giudiziario, quindi ... 166 3.1.6 La contemporaneità: il secondo dopoguerra Leggiamo dalla Relazione del Gruppo Carabinieri di Nuoro al Prefetto, del 25 novembre 1944: Il perdurare dello stato di guerra con i suoi profondi sconvolgimenti d’ordine morale, sociale, economici e politici, aggravati dalla disfatta militare [!], non lasciano sperare in una sollecita normalizzazione della situazione. L’abolizione della pena di morte [!], pena che era una remora specie in Sardegna, per gli elementi pericolosi per delitti di sangue e reati gravi contro il patrimonio, ha influito [!] ad aumentare la delinquenza; ed a ciò devesi aggiungere la rallentata azione dell’autorità giudiziaria nel portare sollecitamente a termine almeno i procedimenti più gravi. ... L’ordine pubblico si mantiene ancora normale, ma l’insufficienza della razione del pane, la mancanza di grassi alimentari, di sapone, di vestiario, di calzature e di molte altre cose indispensabili alla vita, nonché il vertiginoso aumento dei prezzi, potrebbero in un momento all’altro portare ad esplosioni di malcontento. Nonostante ciò e, quanto più conta, malgrado la sobrietà dell’analisi sullo stato in cui versano le genti sarde (tralasciamo le allucinanti premesse dei semprefedeli ... al proprio ruolo di servi e di forcaioli), la justitzia non demorde. E sulle di già miserevoli vite degli isolani brutale e violenta si accanisce la furia assassina della legge di Stato. Qualche esempio concreto. Anni ’70, una sera di gennaio, in campagna i benemeriti sono in servizio per “prevenire i crimini”. Secondo la loro versione intravedono un “tipo sospetto” per cui gli scaricano addosso le armi. Nel compilare il rapporto della brillante operazione anticrimine, armano addirittura l’assassinato con un moschetto, allo scopo di farne un terribile e pericolosissimo bandito. In realtà si tratta di un ragazzo sordomuto, minorato, di appena 17 anni: Matteo Fois, di Illorai. Il ragazzo, accorgendosi dei semprefedeli, tenta di scappare, intimorito dalla loro presenza. Semplicemente si trova in campagna a gironzolare, a farsi i fatti propri. Già quest’avvenimento, 167 nella sua allucinante assurdità, rileva che tipo di rapporto “civile” è instaurato nella Sardegna democratico-repubblicana. Un altro caso, tra le migliaia che si potrebbero raccontare. 1964, una mattina di marzo. Giuseppe Murredhu, di Fonni, dalla sua campagna ove è al lavoro viene prelevato dalla polizia del commissariato di Orgosolo. Formalmente viene “indagato” per una rapina avvenuta in un lontanissimo paese. Non si conoscono affatto gli indizi a suo carico; ma poco importa ai poliziotti di averne e di giustificarne. Nel commissariato viene letteralmente maciullato dalle torture e massacrato di botte tanto che, dopo aver cercato di mascherare il tutto, i poliziotti lo consegnano morto all’ospedale e pretendono pure che il registro d’ingresso venga redatto dando Murredhu per vivo. Anche in questo caso, come per il precedente e tutti gli altri simili, non ci saranno assassini: solo servi dello Stato che hanno fatto il loro mestiere di ... servi! Casi isolati, si dirà, e comunque da inserire in quel generale contesto riguardante specifiche persone ed addebitabili a pochi “sconsiderati” poliziotti, o carabinieri, o giudici. Invero, si tratta di “parecchi” casi. Ma non proseguiremo oltre, in questa sede. Ci interessa maggiormente, prima di terminare il capitolo, accennare almeno ai “metodi di massa” che caratterizzano l’intervento della justitzia democratico-parlamentare in Sardegna, in questo ultimo scorcio di secolo. Non possiamo esimerci dal riportare ampi stralci di un testo, di quelli che venti anni addietro solevano dedicarsi ai fenomeni di criminalità, anche se, a dire il vero, ai nostri occhi il libello ci appare più una apologia della Criminalpol e del suo funzionario Guarino, che un qualcosa di serio (ma questo nostro giudizio, ne siamo sicuri anche noi, non può di certo significare l’inficiamento della “notevole opera” di civiltà che, “nel suo complesso” la forma Stato ha apportato all’isola di Sardegna). Stiamo parlando di “L’Anonima sequestri”, di Mario Guerrini. Cagliari, fine novembre del 1968. Polizia e carabinieri si logorano alla ricerca di Antonio Mannatzu e dei suoi rapitori. Arriva una telefonata in questura. È mezzogiorno e mezzo. Presto, venite. Mi vogliono rapire! È Franco Trois. Pantere e gazzelle cariche di agenti e carabinieri sono in un baleno nel viale Trieste. È qui che Trois ha i suoi uffici, a cento metri da quelli di Nanni Fodde. È da qui che ha telefonato. Fermano tre persone. Gente di fuori, dei paesi dell’interno dell’isola. Li riconoscono subito dall’aria contadina, dall’abbigliamento goffo. Sono due pastori di Ollolai, Antonio Arbau e Michele Casula, e il proprietario d’una cava di marmo 168 di Borore, Francesco Angelo Ibba. Un’auto dei carabinieri va sino a Sarule. Fermano una quarta persona. Salvatore Sini, un commerciante. Vengono incriminati per tentato sequestro di persona. La stessa sorte, giorni più tardi, toccherà ad altri due uomini e ad una donna, moglie di uno degli indiziati. È un bel colpo per le forze di polizia. Finalmente sono riuscite a mettere le mani sui fuorilegge prima ancora che attuassero il loro piano criminoso. È un fatto senza precedenti. Questo di sparare sentenze pare sia abitudine di coloro che dall’alto degli scranni del potere (stavolta da quelli dei pisciainchiostro), appena si dedicano a trattare di cose sarde, si sentono in dovere di dire tutto ciò che passa loro per la testa! Anche le cose più assurde e più false. Così è per il sig. Guerrini, che evidentemente non s’è affatto preoccupato di andare a vedere se il caso avesse oppure no dei precedenti. Se l’avesse fatto si sarebbe accorto di sicuro che questi vi sono, eccome. Però, vogliamo credere, quel senza precedenti, lo abbia voluto riferire al fatto che, ormai – così come per il vicerè Rivarolo (ricordate?) che accomunava barba e banditi – inizia l’identificazione dei criminali non più in base all’essere sardi, bensì “sull’aria contadina”, o sull’essere “pastori” o ancora più semplicemente sul fatto di essere “delle zone dell’interno”. Questi sono di per sé se non sicure prove, altrettanti indizi sufficienti per sbattere la gente in galera. Se poi a tali indizi si aggiunge il fatto che persone aventi “l’aria” di cui sopra, se ne stanno a gironzolare per la metropoli cagliaritana, magari alla ricerca di un bar in cui bersi ciò che si ha voglia di bere; beh, questa è prova che sicuramente stanno pensando di organizzare un possibile delitto. Se poi si fanno coincidere i neppure tanto insani timori di ricchi compradores che in ogni persona sconosciuta, solo però se non indossa giacca e cravatta, vedono un possibile sequestratore, si ottiene per davvero un “bel colpo per le forze di polizia”! In realtà il tentato sequestro di persona di cui vengono accusati i “contadini ed i pastori”, insomma “quella gente dei paesi dell’interno”, altro non è se non pura immaginazione di Franco Trois, che deve farsi “curare una forma d’insonnia ... da quando ha rischiato d’essere rapito” (Guerrini). Per lui, ormai, per il sig. Guerrini e le forze di polizia, ogni ombra di pastore o contadino è un attentato al privilegio! E come Franco Trois ve ne sono a decine, in Sardegna. Così che prende piede, via via, una nuova strategia altrettanto sistematica ed altrettanto “scientifica” di reprimere l’alterità sarda. In pieno periodo repubblicano! 169 La nuova strategia è semplice. Se sei delle zone interne (cioè “cittadino” non statizzato) sei sicuramente un pericoloso criminale per cui vai arrestato; se sei pastore sicuramente sei un sequestratore e quindi vai arrestato; se poi non sei un criminale, stai progettando di esserlo, e quindi vai arrestato; se infine non stai neppure progettando alcun crimine, al momento stai pensando di farlo, e vai arrestato! Che il sig. Guerrini, nel suo approfondito studio sul banditismo isolano, sentenziando che l’arresto delle persone di cui sopra, sia “un fatto senza precedenti”, intendesse in verità affermare il battesimo di questa nuova “logica” inquisitoriale che d’ora in avanti prende piede? Glielo auguriamo di cuore! Se così non è farebbe bene – se ancora in vita – a mutare il mestiere di scribacchino per dedicarsi alle barzellette. Vediamo il clima in cui la nuova “logica” repressiva si innesta. Peppino Marotto: In annate di ghiande, con i maiali si guadagna. Nel ’49 avevo un bel branco, ma in agosto è passata le peste suina, i maiali ebbero giramenti di testa e vomito e mi sono morti tutti. Tutti i maiali sono morti a Orgosolo nel ’49, e i pastori si videro all’improvviso disoccupati e avviliti dai debiti. Ero segretario dei giovani comunisti, volevamo cancellare la stupida tradizione secondo cui “chi non è buono a rubare non è buono a nulla”. Difficile. Molti presero a rubare bestiame, per rifarsi il gregge, e avvenivano rapine e vendette, episodi gravi di banditismo, e la polizia metteva a soqquadro le case, andava negli ovili, prendeva indiscriminatamente gli uomini trovati a lavorare in punti vicini al luogo del delitto e se non c’erano le prove niente processo, ma ugualmente li getta al confino. Più oltre: Il 16 settembre 1950 uccisero a Orgosolo il barbiere Taras. L’indomani mattina presto, trecento carabinieri assediano il paese persino con mitragliatrici: fanno perquisizioni, rovesciano le stanze, arrestano un’infinità di gente. Io mi alzavo e vedo entrare in casa, pallidi in faccia, il mitra spianato, una ventina di carabinieri. Nonostante le mie proteste, fui ammanettato. Mamma guardava disperata. Vedendomi rapito, cadde nelle scale con forte dolore al cuore e non si rialzò più. Dopo due mesi è morta, senza che ci rivedessimo. M’hanno tenuto incarcerato e non dicevano l’accusa. Poi eccola: 170 favoreggiatore di banditi. Non c’erano prove. Inventandosi la mia pericolosità sociale, riuscirono a spedirmi al confino, quattro anni da passare a Ustica. È stato un viaggio terribile, quaranta giorni nei vagoni cellulari, sostando in prigioni di transito, sporchi, maltrattati nel rancio. Non potevamo cambiarci il vestito, non ci permettevano di fare la doccia, perché eravamo in transito. Arrivati a Ustica ci mettono a gruppi in cameroni che erano scuderie per cavalli ... Percepivamo una “mazzetta” di 150 lire al giorno, delle 300 che ci spettavano. Il fatto è che la metà andava in tasca a un industriale palermitano, padrone delle terre migliori di Ustica. Cioè un suo dipendente tratteneva 150 lire per la pulitura dei lenzuoli, distribuzione di brande eccetera. Questo lavoro lo faceva un confinato per 150 lire al giorno, e così l’industriale ingrassava dai soldi succhiati a noi. Eravamo una quarantina di sardi ... Se si fosse aggiornato un attimino di più, il sig. Guerrini, si sarebbe accorto che l’arresto preventivo, addirittura prima anche di aver pensato di progettare ... era prassi costante da parecchio tempo. Tuttavia, ci si potrebbe opporre che in ogni caso si tratta di tempi remoti e che oggi certe cose non accadono più. Dicembre 1979. Orune (NU). Località sa Yanna bassa. Notte fonda. In una cruenta sparatoria muoiono 2 persone, centrate dal fuoco dei carabinieri, non più Regi ma semplicemente democratico-repubblicani anche se ancora benemeriti e semprefedeli. La loro versione dei fatti: nel corso di una perlustrazione, dopo un controllo ad un posto di blocco di alcune persone che viaggiavano in auto e le cui spiegazioni non ci hanno convinto, illuminiamo l’ingresso di un ovile in cui ci siamo recati per prevenire eventuali azioni criminali, e da cui provenivano delle voci “sospette”. Tre persone che stavano fuori, illuminate dal fascio di luce, ci sparano addosso, ferendo il comandante dell’intrepida squadra. Rispondiamo al fuoco e mentre uno del terzetto riesce a fuggire, gli altri due restano cadaveri per terra. Nel corso del “conflitto” rimane ferito il comandante, che per l’eccezionale azione anticrimine viene promosso, oltre ad essere medagliato dall’allora presidente della repubblica Sandro Pertini, oggi sicuramente in paradiso. Vengono arrestati tutti coloro che al momento si trovano dentro l’ovile: si tratta di persone tutte pre-giudicate (e infatti la gigantesca condanna non gliela toglie nessuno). I due cadaveri si scopre, poi, che appartengono a “pericolosi” latitanti. La versione, diciamo così, ufficiale, è posta in dubbio da tutta una serie di riscontri contraddittori, e cozza con fatti 171 incontrovertibili. Seguiamo quanto afferma Carmelino Coccone, proprietario dell’ovile e quella notte arrestato assieme ad altre sette persone che, o erano con lui, dentro l’ovile, al momento della sparatoria, oppure lo erano molto prima. La presenza dei latitanti, anche se fuori dalla casa, “dimostrava” che il mio ovile era un “covo di banditi”, come dicevano loro, un nido di vespe che andava distrutto. E la brama distruttiva andavano sfogandola man mano che si adoperavano nella ricerca di chissà quali cose. Iniziarono un centinaio di sacchi di mangime per il bestiame, squartandoli e spandendone il contenuto, tagliuzzarono tutte le forme di formaggio; il tetto della casa fu scoperchiato, i muri ed il pavimento scavati. Per un paio di giorni non fu permesso a nessuno di avvicinarsi all’ovile, neppure per mungere le pecore: le ricerche continuarono per mesi ... In occasione del nostro arresto, in Sardegna erano in corso diversi sequestri di persona, tra i quali quello dei noti cantanti Dori Ghezzi e Fabrizio De Andrè, nonché quello degli Schild, una famiglia inglese: due coniugi con la loro figlia. Per gli inquirenti, la presenza di tante persone nel mio ovile, tra cui due latitanti, stava a significare che si stava operando su qualcosa di “losco”. Immancabilmente doveva essere nelle nostre mani qualcuna, almeno, delle persone che si trovavano ancora in ostaggio. Nei primi giorni anche la stampa si fece interprete degli innumerevoli motivi che dovevano giustificare quella “grossa riunione”, avanzando sospetti ed illazioni in modo particolare sul sequestro dei cantanti. Ma dopo qualche giorno dal nostro arresto venne rilasciata la Ghezzi e subito dopo anche il compagno, entrambi ad un centinaio di km dal mio ovile. Dalle loro dichiarazioni fu chiaro che il luogo della prigionia non era così lontano dal luogo del rilascio, perché entrambi furono d’accordo nel sostenere d’aver percorso poca strada prima della liberazione. Però un ruolo ed una finalità a quella che gli organi informativi definirono, già condannandola, una “riunione d’affari” bisognava pur trovarli e poco importava se tutti i presenti, dico tutti, persino i latitanti, avevamo ragioni “quotidiane”, se non banali, per trovarci in quel luogo (diversi eravamo nel nostro posto di lavoro e i latitanti, ancora più naturalmente, vicino ai familiari). Non si poteva ridurre al vero “quella riunione” ridimensionandone così la portata criminale senza rischiare di rendere ridicola la “brillante operazione” che l’aveva interrotta. La morte delle due per- 172 sone ed il ferimento del militare dovevano essere presentati in una luce ancor più cruenta di quanto non si presentasse spontaneamente. La sanguinosa sparatoria non doveva significare la fine della fuga di due latitanti in cerca di riparo per l’imperversare del cattivo tempo, ma il solito eroico “arrivano i nostri” che aveva ragione di una pericolosa banda in azione. L’azione ... apparentemente non c’era, ma doveva esserci, diversamente bisognava inventarla. Per cui, vista naufragata in quel momento la “tesi” riguardante il sequestro dei due cantanti, l’attenzione di giornalisti e inquirenti, virò in altra direzione: il pluri-sequestro Schild. Il giudice di Tempio, già una settimana dopo il nostro arresto, inviò a tutti una comunicazione giudiziaria inerente tale sequestro. Qualche mese dopo pure questa “verità” giornalistica e giudiziaria venne clamorosamente smentita: quelli che si dissero responsabili del sequestro Schild ammisero la loro partecipazione al fatto. Nessuno dei presenti quella notte nel mio ovile vi risultò implicato. Esattamente come per il sequestro Troffa che a suo tempo si cercò di addebitarmi ... ... La versione del capitano [l’ufficiale che rimase ferito nello scontro a fuoco avvenuto la notte del dicembre ’79 a sa Yanna bassa, di cui sopra] che nessuno potè smentire, perché nessuno vide, oltre i carabinieri che erano con lui. Forse neppure questi erano in grado di dire come veramente si erano svolti i fatti, in quelli attimi drammatici. In ogni caso è evidente che neanche volendolo avrebbero potuto smentire il loro superiore. Tuttavia anche solo leggendo le carte processuali i dubbi sulla veridicità di quanto raccontato, e fatto credere dall’ufficiale, risultavano innumerevoli. Uno, il più lampante, arriva dal ritrovamento dei bossoli della pistola del capitano nel punto esatto dove avrebbe dovuto trovarsi quando dice di aver dato l’alt e acceso il faro. Non è vero quindi che abbia sparato solo dopo essere stato colpito, perché da questo punto a dove sono stati trovati i bossoli della sua pistola vi sono circa dieci metri di distanza. Ed è poco credibile quando dice di essersi limitato, all’inizio, solo a seguire con la luce della torcia il terzo fuggitivo (quasi volesse aiutarlo a fuggire illuminandogli la strada, senza badare invece agli altri due che avrebbe visto nell’atto di impugnare le armi). È più logico pensare che appena i tre vennero illuminati dalla luce del faro e istintivamente presero a fuggire, lui iniziò a sparare (come la posizione dei bossoli confermava), sicuramente colpendoli prima che riuscissero a varcare il cancello. Tant’è 173 che caddero entrambi appena qualche metro più in là. Uno di essi, poi, vedendosi colpito, ha fatto partire i due o tre colpi di fucile che si dice abbia esploso. Così si spiega il fatto che, nonostante la breve distanza (un paio di metri) ed il facile bersaglio, considerato che l’ufficiale doveva avere in mano la torcia, raggiunse lo stesso solo con due o tre pallini. Non c’è dubbio, quindi, che quei colpi siano partiti dall’arma di uno dei due latitanti che moriva, negli spasimi dell’agonia. L’altro, che si dice fosse ugualmente armato sino ai denti, non esplose neppure un colpo. Se quei latitanti avessero voluto sostenere una sparatoria, invece di fuggire, una volta varcato il cancello sarebbe stato sufficiente mettersi dietro il muretto (che a dire del militare avrebbero superato subito indenni) per far fronte, senza correre alcun rischio di essere colpiti a loro volta, non a una ma a cento persone armate. È ancora inspiegabile, infine, il perché gli altri due carabinieri sentendo sparare, non abbiano anche loro fatto uso delle armi. Eppure erano lì, davanti alla porta e ad un metro dai morti, quando mi affacciai appena finiti gli spari, mentre il capitano, ferito, era ancora a terra ed il faro lo teneva in mano un altro carabiniere non l’ufficiale. Per questi, è chiaro, non sarebbe cambiato niente se avesse ammesso di aver sparato prima, anziché dopo, sui latitanti; ma ha voluto inventare questa storia, alquanto dubbia per chi si prende la briga di esaminarla attentamente, semplicemente per “argomentare” il suo eroismo esagerando volutamente il pericolo corso. Viene anche da pensare che con la sua favola abbia voluto nascondere la realtà dei fatti per chissà quali motivi ... Certo, i misteri su quella notte restano tanti, né mi sento in grado di scoprirli completamente. Sarà il tempo stesso, forse, a spazzare le ombre che per il momento celano la verità. Al processo queste cose furono argomentate dagli avvocati, ma ovviamente non sono state prese in considerazione. Del resto, dato il clima del periodo, non c’era neppure da sperarlo. Si potevano forse mettere in dubbio le parole di quel valoroso militare ferito, che aveva rischiato la propria pelle per compiere il suo dovere? A sparare per primi, si sa, devono per forza essere i latitanti, i banditi, i fuorilegge, individui che non vogliono sentire di rientrare in prigione! 174 I carabinieri sono sempre corretti e non sparano mai se non per difendere la legge o se stessi. E se anche succede che a cadere sotto il “piombo giusto” sia gente inerme, evidentemente qualcuno di loro, come sempre, è scivolato. I latitanti invece saranno sempre colpevoli e la loro eliminazione sarà un fatto legale a priori. Gente senza valore, persone nocive, che diritto hanno alla vita? E poi girano armati ... Quale prova migliore per dirli colpevoli? Solo un uomo della legge può girare armato! Gli altri devono assoggettarsi. Chi si arma, fosse pure soltanto per difendersi dai cacciatori di taglie, coperti e armati dalla legge, è di per se un criminale: è il rispetto delle regole che sancisce l’onestà, non quello della vita. Perché uno sfugge alla cattura? Se non è un criminale il “cittadino” deve restare bello e tranquillo ad aspettare che vengano a prelevarlo per seppellirlo vivo, a volte per il resto dei suoi giorni. Questa è la legge e la legge è la “Giustizia”. Non per niente, dopo alcuni mesi da questi fatti, a quell’ufficiale, oltre ad un nuovo grado, gli venne conferita una medaglia d’oro al valore militare dal capo dello Stato. L’anno seguente, mentre era in appostamento alla periferia di Orgosolo, uccise un altro giovane, padre di famiglia, che rientrava pacifico a casa dopo aver sistemato le bestie. Non aveva addosso nessun’arma, ma il valoroso ufficiale ritenne ugualmente di fare fuoco più volte su di lui, sicuro in ogni caso di non finire in prigione come un qualsiasi assassino. Per questo ennesimo atto di eroismo non ha avuto altri encomi, ma neppure alcun ... rimprovero». (Carmelino Coccone: Autobiografia / Zustiscia mala) Beh! tra la versione di un pre-giudicato e quella di un “onesto” benemerito, fregiato della medaglia al valor, sicuramente i più pii ed onesti cittadini accreditano quest’ultima. Ma è possibile che almeno una volta ci si possa sbagliare? Ed è sempre vero che un capitano dei CC dev’essere per forza un galantuomo? Manco a farlo apposta, ci viene in aiuto una notizia ampiamente riportata e commentata dai due quotidiani isolani, esattamente del 3 aprile 1992. L’Unione sarda: ... il tenente colonnello Enrico Barisone [l’allora capitano della squadriglia CC che nei fatti di sa Yanna bassa restò ferito ed ebbe medaglia e gradi assicurati], comandante del Gruppo di 175 Vercelli, è stato denunciato per abuso di potere, concorso in detenzione illegale di armi, falso ideologico, calunnia nei confronti della polizia e peculato militare. La Nuova Sardegna, è più precisa: Per la seconda volta, Enrico Barisone, ..., infaticabile inquirente, si trova nella scomoda posizione di inquisito ... Sempre in una storia di armi, ma questa volta si trattava di un traffico a livello internazionale, era spuntato il suo nome nel corso della maxiinchiesta condotta dal giudice Palermo. Era l’85. Allora gli inquirenti ritenevano che avesse smerciato 44 rivoltelle. Lui si difese dicendo di averle acquistate per sondare [!!!] l’effettiva portata del canale di rifornimento nel quale i due principali imputati del processo avrebbero avuto la parte dei fornitori. Ora, si può certo comprendere la strategia investigativa dell’onesto CC semprefedele, ma siccome non siamo imbecilli al punto di non usare un minimo di logica, siamo purtuttavia convinti che i conti non quadrano. Se, infatti, il medagliato tenente colonnello neo doveva sondare i rifornitori di armi – e pertanto acquista da essi le rivoltelle e non sappiamo se pure altro ... – che necessità aveva poi di smerciarle? a che prò? per sondare forse anche, dopo i rifornitori, gli acquirenti, dato che le ha rivendute? Misteri inquisitoriali. Certo è che in quel primo processo il neo tenente colonnello “fu convincente”, tanto che ovviamente venne assolto del tutto. Il cronachista de “La Nuova” quindi prosegue: L’ufficiale è ora coinvolto in una vicenda poco chiara che riguarda il ritrovamento di due pistole in possesso di un pregiudicato. Insieme con lui devono rispondere degli stessi reati tre sott’ufficiali dell’Arma ... Il tenente colonnello Barisone, per il momento è stato sospeso dall’incarico, così come i tre sott’ufficiali. Secondo quanto ha rivelato il procuratore della repubblica ..., la vicenda che vede coinvolti i cinque prende le mosse nel dicembre scorso, quando i carabinieri inviarono un verbale alla magistratura sul ritrovamento di una vecchia pistola Beretta in una cantina della casa del Domis [il pregiudicato confidente dei CC]. Qualche tempo dopo, la stessa arma fu trovata dalla polizia dopo una perquisizione in casa del pregiudicato. Quest’ultimo, che pare sia un “collaboratore” delle forze dell’ordine, inviò un esposto alla magistratura, dicendosi perseguitato 176 dagli uomini della Questura di Vercelli. Interrogato dalla magistratura l’uomo avrebbe chiamato in causa il tenente colonnello Barisone, dicendo che da lui aveva avuto la Beretta e anche un’altra pistola, una calibro 7,65, custodita nella sede del comando carabinieri di Vercelli. Dall’inchiesta, sempre secondo quanto ha affermato il procuratore Scalia, è poi emerso che il verbale di rinvenimento della pistola Beretta era fasullo e che sarebbe stato redatto con la complicità dei sottufficiali su ordine dell’ufficiale. Beh! come onorabilità del semprefedele e compagnia varia non vi è che dire. Ma siamo comunque sicuri che anche stavolta il medagliato semprefedele riuscirà ad essere “convincente” con i giudici. A ciascuno le sue conclusioni. A noi basta ricordare che, come riporta il medesimo cronista della “Nuova Sardegna”, nel 1984 arrivarono in Sardegna due commissari del ministero di Grazia e Giustizia per vedere chiaro su un interrogatorio del giudice Lombardini al boss Raffaele Cutolo, interrogatorio al quale avrebbe partecipato Barisone. Ma in quel caso si stabilì [come al solito] che il maggiore dei carabinieri era presente all’Asinara solo casualmente proprio il giorno in cui Lombardini sentiva “don” Raffaele. A noi tale “casualità” pare una bella balla: primo perché simile coincidenza non poteva mai avvenire; secondo perché, che noi si sappia, un carabiniere per quanto medagliato non ha certo libero accesso ad un carcere, pergiunta speciale e pergiunta in una isola dove vi si sarebbe dovuto recare appositamente; terzo perché Barisone ed il giudice Lombardini rappresentano un’accoppiata che insieme a tanti altri, hanno posto in essere nell’isola, negli ultimi due decenni, quel sistematico terrorismo di massa la cui logicità è la sapiente repressione preventiva a suon di ricatto, arresti di interi nuclei familiari, costruzione di megaprocessi neppure indiziari ma basati esclusivamente sui parametri individuati dal sapiente cultore di banditismo sardo qual’è lo scribacchino Guerrini. Stavolta con l’uso scientifico di “pentiti” appositamente creati nelle caserme e negli uffici giudiziari. Ce lo rammenta lo stesso cronista della “Nuova Sardegna”: Certo è che il suo campo attivo [di Barisone], in Sardegna, aveva un ampio raggio, ma pur spaziando in diverse direzioni trova- 177 va nelle inchieste sui sequestri le sue migliori performance. Tant’è che i contorni dell’Anonima Gallurese andarono delinenandosi proprio nella sua caserma di Abbasanta: è lì che Contini e Balia iniziarono a pentirsi, mentre arrivava da Tempio il giudice Lombardini. Un centinaio di sardi “di quelli delle zone interne”, per intenderci, furono allora internati nelle galere, e deportati poi in Italia sulla base delle indicazioni di “colpevolezza” di pentiti in seguito liberati, nonostante la loro confessata partecipazione attiva a delitti truci. Ancora prima della “Superanonima Gallurese”, vi fu la altrettanto gigantesca operazione politico-terroristica-giudiziaria denominata “Superanonima Sarda”, con 91 imputati alla sbarra, il cui processo si concluse nel dicembre del 1982. Inutile rimarcare il fatto che, nonostante spie e delatori, confidenti e comunque pseudo-pentiti manipolati e manovrati neppure tanto abilmente dalle febbrili mani e menti di magistratura e forze dell’ordine, per decine di imputati vi fu l’assoluzione per “non aver commesso” nulla. Restò sulla loro gobba l’atto repressivo, dilapidazioni patrimoniali per spese processuali, avvocati, confino, soggiorni, abbandono delle attività ...; poi il carcere in totale isolamento anche per 6, 8 e pure 9 mesi. Ma quanti, dei condannati, sono effettivamente innocenti? Noi possiamo dire e documentare solo alcuni casi, neppure tanto esemplari: il fenomeno è di proporzioni talmente gigantesche che sarebbe impossibile, anche volendolo, riuscire a condensarlo in centinaia di volumi. Speriamo solo di aver dato – sia pure per linee generali – i contorni di un fenomeno in evoluzione continua, che ha preso piede a partire sicuramente dal III secolo avanti la nostra era. 178 179 Capitolo Secondo Repressione e carcere in Sardegna 3.2.0 La repressione sociale Il momento saliente dei rapporti tra i diversi colonizzatori che si sono susseguiti nell’isola, da una parte, ed i ceti sociali della ruralità, dall’altro, è stato sempre il tentativo di spezzare la resistenzialità materiale e spirituale di quest’ultimi. Pur di raggiungere tale fine, romani e successori non disdegnano il ricorso alla prassi della “emergenzialità”, che giustifica ogni azione, anche la più brutale ed illegale rispetto agli stessi codici dello Stato. I romani se da un lato decretano l’isola una provincia dell’impero, dall’altro non dismettono neppure per un attimo lo stato di guerra permanente contro i sardi non romanizzati. Da qui la costante prassi della depotazione di ampie schiere di ribelli, trascinati in catene nella capitale della “civiltà”. Se gli iberici alla fine rinunciano a conquistare alla “spagnolità” i vassalli isolani, non sono affatto pietosi nei loro confronti ogni qualvolta il dominio viene posto in essere. Per cui è praticamente un controsenso parlare di diritto, diritti e giustizia in Sardegna, riducendosi ogni rapporto con le istituzioni (incluse quelle giudicali) allo stato di guerra ed alle sue ferree leggi basate sul rapporto di forza reale. Inoltre il sistema penale elaborato dallo Stato Giudicale è rimasto sostanzialmente inalterato fino alla metà del XIX secolo, integrato solo dei momenti sovvenuti nel trascorrere del tempo. Già le pene giudicali abbiamo visto essere assai esplicite sul come 180 s’intenda combattere l’autodeterminazione delle comunità e la loro cultura. Fustigazione, marchiatura a fuoco, tortura, squartamento, impiccagione sono i momenti essenziali della penalità “civile”; il massacro genocida è invece quello saliente dello stato di guerra. Entrambi talmente in simbiosi che non è affatto possibile separare e distinguere gli uni dagli altri. La prigione, in un sistema simile, si riduce a ben poca cosa: i possidenti possono evitarla pagando la multa, mentre per i nullatenenti non rappresenta affatto l’essenza della punizione, essendo questa o corporale o di natura più violenta. In tutti i casi la prigione è prevista per le pene di lieve entità oppure per chi è in attesa di giudizio. Per cui anche il tempo di reclusione è assai ristretto. La condizione dei carcerati è, a dir poco, miserevole. Ad amministrare la giustizia sono preposti nei singoli feudi gli stessi feudatari; nei territori della corona le Corti di giustizia. Queste giudicano in appello sulle sentenze emesse nei feudi, sui delitti considerati “gravi”, sui contrasti tra feudatari e vassalli. I ricorsi in appello sono, in pratica, inesistenti almeno per i vassalli, per il semplice fatto che non possono permettersi di affrontarne le spese. Eccessive ed insostenibili anche per i piccoli possidenti, perché avvocati e burocrazia, come concordano storici e contemporanei, fanno di tutto per allungare i tempi delle cause onde giustificare parcelle enormi ed incrementare illeciti introiti “sottobanco” dagli inquisiti facoltosi. I feudatari hanno il compito di gestire le prigioni ed i prigionieri dei propri feudi, per cui usufruiscono di uno specifico tributo. Ma nessuno di essi ha la benché minima volontà di spendere un soldo per le une e per gli altri. Così le carceri feudali, quando esistono, altro non sono che edifici pericolanti, spesso privi di infissi ed affatto insicuri, quando non addirittura mancanti di qualche parete perché crollata nell’incuria. Qui i detenuti e gli stessi carcerieri possono solo pernottare in un miserabile giaciglio. I “detenuti” di giorno vengono lasciati completamente liberi di circolare nelle vie delle ville ad elemosinare la propria sopravvivenza, in quanto il feudatario, o chi per esso, nulla stanzia né per vitto né per altro. Non è affatto raro il caso che i prigionieri (!) vengano liberati da bande di armati, che assaltano i carceri baronali più sicuri, tanto che a più riprese, soprattutto i piemontesi, si lamentano della deplorevole questione. Tale condizione perdura fino alla fine del ‘700 e, modificata solo superficialmente, per tutta la prima metà del secolo successivo, quando anche in Sardegna vengono costruiti i carceri cellulari ed il sistema feudale è scomparso, ultimo in tutta Europa, per lasciare il posto al penitenziario come luogo (quasi) unico ove scontare le condanne. “Ritardo” funzionale alla politica colonialista spagnola e piemontese, che lasciano intatto lo sta- 181 to di guerra permanente contro le popolazioni rurali, non addomesticate alla sferza della rapina economica e dell’acculturazione. Una caratteristica che emerge di già nel periodo iberico, ma che si evidenzia in modo assoluto durante la dominazione piemontese ed italiana, è il fatto che qualora i responsabili delle repressioni siano sardi, superano sempre in ferocia gli stessi colonizzatori, andando ben oltre il compito loro assegnato. Ciò, in parte per ingraziarsi i padroni, latori del loro incarico, ma soprattutto al fine di perpetrare vendette ed eliminare impunemente pericolosi concorrenti ed avversari. È il caso delle ritorsioni cui viene costretto il Sulis, capo delle milizie della città di Cagliari, che godrebbe di vasta stima fra le masse popolari del capoluogo. I suoi nemici, pur di eliminarlo, non si fanno scrupoli nell’inventare di sana pianta un complotto contro la famiglia reale, di recente sbarcata per la prima volta nell’isola, in seguito alla fuga dai ducati di terraferma invasi dalle truppe francesi. Corre l’anno 1799. In un primo tempo (il 13 aprile) due sostenitori del Sulis vengono arrestati ed immediatamente tradotti nelle celle della torre dello Sperone, ad Alghero. Successivamente altre cinque persone vengono catturate e deportate a Minorca, all’epoca sotto il dominio inglese. Sono però rifiutati da tali autorità, per cui vengono tradotti nelle segrete della Torre dello Sperone. In seguito numerosi altri vengono arrestati, tra cui diversi esponenti della borghesia cagliaritana. Infine viene arrestato lo stesso Sulis e tradotto sotto scorta di circa 200 militari piemontesi nelle celle della Torre dell’Aquila (14 settembre 1799). Data la personalità dell’imputato questi ha salva la vita, ma è condannato al carcere perpetuo. Solo nel 1821 ottiene la grazia. I giudici impiegano ben 5 settimane nel dibattimento. Si oppongono energicamente le due fazioni della borghesia cittadina: da una parte i progressisti, che il Sulis difendono sostenendone l’innocenza; dall’altra i reazionari/assolutisti, che quello accusano. Gli atti processuali dimostrano con quanto accanimento gli stessi compradores isolani vogliono far fuori una persona non gradita ai piemontesi a causa della vasta simpatia che gode presso le masse cagliaritane. Si deve ricordare, infatti, che il Sulis, grazie all’ascendente sui cagliaritani riesce a frenare sempre la radicalità delle loro proteste, incanalandole verso il mantenimento dello status quo. Le sue milizie non condividono il moto antifeudale poi cavalcato dall’Anjoy, e solo dopo che sottoscrive la petizione ai sovrani questi si degnano di trasferirsi a Cagliari; il Sulis garantendo, in pratica, la loro incolumità da eventuali aggressioni di popolo. Tuttavia è proprio il suo carisma a rappresentare un serio pericolo per lo Stato coloniale. I Savoia mal sopportano che un sardo goda di tal 182 prestigio; meglio non fidarsi, per cui viene fatto di tutto per esautorarlo da capo delle milizie cittadine. Caduto il Sulis in disgrazia, si provvede alla radicale riforma delle truppe militari, in modo che dipendano completamente dai sovrani o da uomini di loro assoluta fiducia. La “Centuria Leggera” composta esclusivamente di elementi sardi, viene soppressa e molti dei suoi uomini finiscono nel “Corpo dei dragoni leggeri”, gli addetti alla repressione del banditismo. Al posto della “Centuria Leggera” viene istituita la “La Centuria di Cacciatori Esteri”, i cui miliziani, tutti “esteri” appunto, vengono posti sotto il comando del capitano tedesco Pruner. Solo nel 1808 questi sono inquadrati nel “Corpo dei Cacciatori di Savoia”, in cui vengono ammessi, ma solo per mancanza di elementi esteri, anche i sudditi isolani. Già il “riordino” delle truppe, la loro composizione e funzione, giocano un ruolo fondamentale nella repressione sociale. Altro elemento connesso al dichiarato coprifuoco è che “per motivi di ordine pubblico” si impone il disarmo dei sardi, la limitazione dei loro movimenti ... Tanto timore incutono le armi in mano ai sudditi isolani che vengono proibiti persino i fuochi artificiali in tutte le occasioni, anche religiose! Il carcere rimane un sistema di punizione nella pratica inesistente per i poveri. I “tratti di corda” e la “bastonatura” sono i sistemi più comuni di infliggere pene di “lieve entità”. Tanta è l’umiliazione nel subire tali pene corporali, pergiunta in pubblico, ancora ai primi dell’800 che, racconta nei suoi diari l’avvocato Lavagna, cagliaritano, un pescatore si vide rifiutare dalla promessa sposa il matrimonio, di già stabilito (1802). Bastonatura pubblica subiscono anche 4 sanluresi, di cui due vecchi, nel 1799 allorché in delegazione (in tutto un centinaio di persone) si recano a Cagliari per protestare contro l’iniqua ripartizione dei tributi feudali nel grosso centro campidanese. 3.2.1. Il carcere in Sardegna Ancora in pieno ‘800 il sistema carcerario isolano si riduceva alle due realtà di tipo feudale: Cagliari che disponeva delle carceri della Torre di S. Pancrazio, della Torre dell’Aquila e della Torre dell’Elefante (le ultime due per i detenuti politici); Alghero che disponeva delle celle della Torre dello Sperone. Erano queste le carceri reali, ovvero quelle atte a contenere i prigionieri incorsi nella giurisdizione della giustizia del sovrano. Vi finivano i popolani delle città per brevi periodi di tempo; oppure gli appartenenti ai ceti privilegiati se condannati o indagati per reati gravi o politici (il Sulis, come abbiamo visto, per esempio); infine coloro che erano in attesa di 183 giudizio, ma sempre di competenza della giurisdizione reale. L’esistenza delle altre molteplici punizioni (corporali, ai remi, capitali, ecc.) limitava enormemente la funzione di carcere come deterrenza sociale, ed il suo scopo, riguardo al prigioniero, non era affatto teso al “recupero”, quanto all’afflizione. Il carcere integrava, semplicemente, il resto del sistema penale. Il terrorismo repressivo di massa sosteneva l’intero sistema, con le forche permanentemente innalzate per ridurre a ragione i ribelli sociali. Nelle terre feudali, lo abbiamo anche accennato, vi erano le prigioni del feudo in ogni capoluogo di circoscrizione e nelle ville di dimensioni ragguardevoli. Mentre le carceri regie rappresentavano vere e proprie “torri di Londra”, vuoi per la sicurezza che per l’architettura, quelle baronali erano nelle miserevoli condizioni che abbiamo accennato più sopra. Inoltre nelle prime almeno agli albori dell’800 vi erano dei medici col compito di vegliare sulla salute dei prigionieri e, pare, vi fosse istituita – almeno nella Torre di S. Pancrazio – una sorta di infermieria. Se i baroni feudali mai ebbero ad occuparsi più di tanto delle proprie carceri, dei carcerieri e dei carcerati, nella pratica lasciando che questi fossero dipendenti finanche nella sopravvivenza dall’elemosina dei villici, non migliori erano le condizioni di vita nei carceri reali. Vi si moriva in entrambi di stenti, di malattia, per denutrizione, per l’assoluta carenza d’igiene, per il freddo e l’umidità, per l’aria malsana ... Nel 1805, in pochi mesi, perirono in queste condizioni ben tre prigionieri (Lavagna). Cosa assai tragica era il trasferimento dei detenuti, nel tempo prassi costante a causa della noncuranza dei feudatari, dalle carceri feudali a quelle reali. Nei piccoli centri rurali se non altro i prigionieri potevano contare sugli alimenti e gli altri sostegni provenienti dai parenti; ma una volta trasferiti nelle città, per tanti di essi veniva decretata morte sicura, finanche se ancora in attesa di giudizio. Le tre morti cui si riferiva Lavagna avvennero esattamente a seguito di un tal nutrito trasferimento. Tanto più che anche i sovrani, o chi per essi, ben poco disponevano per il sostentamento dei reclusi preferendo ingaggiare lanzichenecchi tedeschi o fare sfarzo di corte sulla miseria del popolo sardo. Anche i carcerieri reali rimanevano per lungo tempo senza stipendio, ma questi infami parassiti potevano cavarsela... togliendo ai prigionieri quel poco che loro proveniva dall’elemosina di Enti o dai propri familiari. I sovrani, spinti sicuramente da quella notevole umanità che sempre nutrirono nei confronti dei villici isolani (da loro definiti spregiativamente vassalli “regnicoli”) non mancarono di porre le cose al posto giusto ... non 184 tanto rinunciando semplicemente a qualche sfarzo per alimentare i prigionieri, bensì impedendo che i detenuti delle carceri feudali venissero trasferiti nelle reali, salvo gli imputati di “gravi reati” per i quali a nessuno era permesso di togliere al re ed alla sua corte la soddisfazione di infliggere il giusto castigo. Così, nel 1806 Vittorio Emanuele I, nel 1815 Carlo Felice dovettero affrontare di petto il grosso problema della “frequente fuga dalle Carceri di molti delinquenti in esse detenuti” (Carlo Felice), “procurata in alcune eziandio colla forza, e violenza de’ facinorosi, e prepotenti in disprezzo della Regia autorità” (Vitt. Emanuele), “e dalla facilità di rimettere a quella di S. Pancrazio gli arrestati, e ditenuti senza previa partecipazione al Governo” (Carlo Felice). Per cui si rifecero entrambi ad una circolare del 1804 (7 febbraio) che cercò fin da quell’anno di responsabilizzare i feudatari sul loro compito, ma tutto rimase esattamente come prima: i detenuti potevano tranquillamente crepare! La situazione rimase formalmente tale fino al 1828, data di emanazione del Codice delle “Leggi civili e criminali” di Carlo Felice; ma nella realtà fino alla costruzione delle prime carceri cellulari dell’isola. È solo intorno alla metà dell’800 che i sardi conobbero il carcere vero e proprio, nella sua variante cellulare. I più importanti penitenziari vennero costruiti a Cagliari (Buoncammino) ed a Sassari (San Sebastiano); ma in seguito nei furono costruiti ad Oristano, Tempio, Lanusei, Nuoro. A questi devono aggiungersi le prigioni site, in pratica, nelle caserme o negli altri edifici pubblici (municipi, ecc.) in ogni paese dell’isola, consistenti in qualche cella sita spesso al pian terreno ma anche negli scantinati di tali edifici, evidentemente atte a prigione per il solo momento dell’arresto o per qualche giorno; oppure come “stazione” di transito all’atto delle traduzioni dei detenuti. Il carcere di S. Sebastiano, a Sassari, venne terminato nel 1872 circa, ma i lavori di costruzione iniziarono molti lustri prima, tanto che lo scandaloso sperpero di finanze nonché il prorogare a tempo indefinito il “cantiere di lavoro” furono oggetto a suo tempo di una denuncia parlamentare di un noto personaggio politico sardo. San Sebastiano copre un’estensione di circa settemila metri quadrati, tra spesse mura, gelide celle, cortili interni e disimpegni vari. Sito alla periferia della città, all’atto della costruzione, oggi è invece parte integrante del circuito urbano. Proprio perciò fa tanta stizza ad un sacco di buoni cittadini che lo vorrebbero chiuso per erigerne uno tutto nuovo nella attuale estrema periferia, lontano dalla tranquillità di quanti sogliono godersi in santa pace il sistema vigente. La capienza del maschio sassarese è di circa 200 detenuti, ma una tale cifra è da considerarsi oggi del tutto esagerata, essendo totalmente 185 diversi rispetto al passato i criteri di spazio – anche semplicemente fisico – , sufficiente per non ridurre in bestialità l’essere umano. In questi anni in media vi soggiornano oltre 100 detenuti in più ma, a quanto affermano le fonti giornalistiche, le condizioni di sopravvivenza “non sarebbero stravolgenti”. Tuttavia, a parte il sovraffollamento (in pratica vi stanno il doppio di prigionieri di quanti dovrebbero esserci), i casi di autolesionismo ed una presenza di tossicodipendenti non indifferente lo rendono una vera e propria cayenna, pur senza raggiungere il record del famigerato carcere cagliaritano. Come se non bastasse il 50% dei detenuti di S. Sebastiano è di “passaggio”, in transito cioè verso altre carceri; il che la dice assai lunga sul tipo di rapporti con cui devono fare i conti i prigionieri “stabili”. Più bestiale di tutti è l’inferno di Buoncammino, a Cagliari, costruito verso la metà del XIX secolo. Si racconta che l’ideatore/progettista, una volta visto terminato il frutto della sua insana mens, consapevole della disumana struttura che aveva partorito e resosi conto delle inaudite sofferenze che avrebbe causato a decine di migliaia di esseri umani, si fosse con coraggio tolto la vita, non riuscendo a sopportare tanto peso nella propria coscienza. Non sappiamo se ciò corrisponda a verità; sappiamo però di certo che nessun altro responsabile delle atrocità che vi si consumano si è tolto l’esistenza, contribuendo in tal modo a che tanti dei reclusi se la tolgano dalla disperazione. In ogni caso, il fatto stesso che circoli una tal “verità”, la dice assai lunga su che tipo di struttura infernale possa mai essere Buoncammino. A noi, che pure seguiamo le vicende di carceri e carcerati, comuni e “speciali”, non ci è mai capitato di leggere tanta unanimità sulle brutture che animano questo penitenziario. Non solo per la struttura, di per se stessa; non solo per lo spazio lugubre; non solo per il personale e la direzione; bensì per tutte queste cose messe assieme. Gli stessi direttori e secondini, tanta dev’essere la loro immedesimazione con il lavoro che svolgono e con la struttura medievale della galera, con essi entrano in piena simbiosi, si confondono. Per cui è assai difficile scindere di chi mai possa essere la responsabilità della inumana condizione che son costretti a sopportare in media ben oltre – ormai – 700 reclusi, qualche decina di donne incluse. Tanti sono oggi i detenuti, eppure la struttura, quando venne realizzata, già a quei tempi non poteva contenere che un massimo di 300-350 prigionieri. La composizione dei reclusi, allo stato attuale, è per l’80% di tossicodipendenti, un quarto dei quali sieropositivi di cui un imprecisato numero di malati riconosciuti di AIDS. Considerate le assolutamente inesistenti condizioni igienico sanitarie, gli “spazi” non solo malsani ma finanche ridotti a zero, Buoncammino è considerato da tutti i prigionieri che 186 malauguratamente vi hanno soggiornato, sardi e no, come un vero e proprio lazzareto, sicuramente il reclusorio più infamante e peggiore della non piccola collezione che vanta lo Stato. Tanto che tutti – dal sindaco della città al ministro delle galere – sono concordi nel decretarlo “bolgia infernale” da distruggere, ma nessuno lo fà ... Evidentemente vi sono parecchi interessi politici, economici e di altra natura, che lo tengono in piedi. Né è da addebitare, una tale efferatezza, a questo particolare periodo storico, che tutti affermano essere caratterizzato dalla massiccia presenza in galera dei tossicodipendenti. Riportiamo la descrizione fattane da un detenuto e riferita alla situazione di qualche decennio fà: A Cagliari in quel periodo si viveva la segregazione più allucinante: dai trenta ai quarantacinque minuti d’aria al giorno (secondo il turno nella rotazione dei cortili). In un cortile quadrato di 7 o 8 metri per lato – nessun riparo per il sole o la pioggia – venivano rinchiusi da 40 a 50 detenuti. I muri divisori erano alti poco più di due metri, ma era vietatissimo affacciarsi dall’altra parte. Chi contravveniva questa regola pagava con la cella sotterranea a pane ed acqua, da 5 a 10 giorni. Vi era un unico cesso fuori dai cortili di cui si servivano a turno, in quei minuti d’aria, i detenuti di tutti i cortili (sei complessivamente). Non sempre era consentito accedervi, C’era il “pericolo” di incontri non “legali” tra compagni di causa durante il tragitto obbligatorio. Era impedito, del resto, qualunque contatto non predeterminato dalla amministrazione carceraria: ogni detenuto poteva avere rapporti soltanto con i compagni di cella o di cortile. Le celle erano quelle di adesso con le ottocentesche bocche di lupo. Ognuno aveva la sua branda pieghevole che poteva, anzi doveva, aprire per restarvi coricato dalle otto di sera fino alle sette del mattino. Durante tutto il giorno doveva restare piegata. Anche per mangiare ci si sedeva nella pedana fissata alla branda tenendo la gavetta nelle mani. Allora non esistevano tavolini o sgabelli. Come posata ci veniva consegnata una palettina di legno che doveva fungere da cucchiaio, forchetta e all’urgenza anche da coltello, ma di fatto era un problema utilizzarla per ognuno di questi servizi. Alle sette del mattino suonava la sveglia e ci alzavamo. Dovevamo alzarci perché alle otto la conta doveva trovarci tutti in piedi, ognuno davanti alla sua branda piegata. Se qualcuno si attardava 187 a letto senza aver “segnato visita” medica finiva in cella di punizione. Chi chiedeva visita medica non poteva andare all’aria, altrimenti era evidente che stava simulando. Alle otto di sera passava la guardia ordinandoci di andare a letto ed alle nove silenzio totale. Una domenica sì e una no eravamo obbligati ad assistere alla Messa che veniva celebrata al piano terra della sezione. Per tutta la durata della funzione restavamo in piedi, inquadrati a piccoli gruppi separati uno dall’altro da una fila di guardie, per evitare che qualcuno potesse scambiare qualche parole con prigionieri dell’altro “quartino”. Chi trasgrediva il regolamento finiva nel sotterraneo, dove c’erano apposite celle a seconda della gravità della punizione, o il tipo di detenuto: c’era quella col pancaccio; quella col letto di contenzione per i detenuti ritenuti violenti; quella con la camicia di forza e, infine, quella imbottita di crine. In tutti i casi l’alimento non cambiava: una minestra al giorno, due pagnotelle e mezzo, acqua a volontà. Da queste tombe per vivi ogni notte ci giungevano i lamenti dei “sofferenti”. Avevamo l’impressione, durante quelle ore, di essere in contatto con le anime dell’aldilà. Qualcosa di vero però nelle nostre brutte impressioni doveva esserci, visto che molti da quelle celle se ne sono andati al cimitero. Nè può dirsi un caso se questo carcere ha sempre tenuto il triste primato dei suicidi e delle proteste autolesioniste e disperate: non passava giorno che non trovassimo le scale che conducevano al passeggio imbrattate di sangue fresco... (C. Coccone) Alle condizioni di vita di già inumane dettate dalla triste struttura architettonica e dalla invivibilità dell’ambiente, si aggiunge la prassi terroristico/paternalistica e ricattatoria posta in essere da direzione e personale secondino. L’utilizzo del ricatto, della “selezione” rispetto a quel pochissimo lavoro che vi è (scopino, biblioteca e ... basta!), ad esempio, crea di per sé divisione ed antagonismo fra i reclusi; ciò che porta acqua al mulino della politica criminale del dividi et impera. Ma il peggio è il timore di finire in “foresta”, ove la bestialità dei guardiani di uomini in gabbia si sfoga contro il corpo dei reclusi, le cui orripilanti urla impregnano l’aria e terrificanti si sollevano fino alle celle più alte, penetrando nelle ossa e nei nervi di ogni altro prigioniero. È questo l’inferno che detiene il primato assoluto dei morti suicidi: i detenuti son spinti verso l’atto estremo vuoi dal sistema giudiziario, vuoi 188 da quello carcerario, ma non raramente finanche dalla sozza bestialità secondina, abbruttita ulteriormente dal “mestiere più infame”, che spinge direttamente o indirettamente il prigioniero più debole – o attraversante un periodo di crisi esistenziale dovuta a tanta scempiaggine inumana – a togliersi la vita. Buoncammino è il maschio isolano per antonomasia, vero museo degli orrori e centro di irradiazione della civiltà di Stato, che domina sulla città capoluogo. A Nuoro esisteva, tristemente noto fino al termine degli anni ’60 il vecchio carcere di via Roma, brutale, zozzo, malsano. Ma in tali anni venne “dismesso” ed al suo posto iniziò a funzionare il nuovo modello di Badu ’e karros, sito nell’omonima zona, ancora all’estrema periferia della cittadina. Fù il generale Dalla Chiesa che incluse il penitenziario di Badu ’e karros tra quelli da trasformare in speciali, cioè in circuiti di annientamento totale, psico-fisico, dei detenuti irriducibili, “terroristi” politici o comuni che fossero. La Prima Sezione della galera nuorese divenne in tal modo particolarmente famigerata, e non solo in Sardegna, purtroppo, avendo “ospitato” tanti compagni e proletari di ogni sito. Luogo di “massima sicurezza” e deterrenza in cui rivoluzionari ed antistatalisti si sono a lungo scontrati con il potere genocida. Oggi vi sono rinchiusi 300 prigionieri (tra cui alcune donne) ma venne progettato per una capienza massima di poco più della metà. In progetto vi erano anche le strutture (poi costruite) atte a laboratorio per lavori artigianali per i detenuti, ma i macchinari non sono mai stati acquistati. Anche qui, come in tutte la galere isolane, l’attività lavorativa non è altro che una chimera. Contrariamente alle altre prigioni isolane ed alle colonie penali, a Badu ‘e karros la stragrande maggioranza dei detenuti è sarda (circa l’80%). Solo una dozzina però sono ergastolani (i restanti essendo deportati ...) e di questi ve ne sono alcuni non sardi. Il 70% ha subito condanna per omicidio, il 38% per sequestro di persona, solo il 7% per associazione mafiosa o camorristica (deportati dalla loro terra). Il fatto che la metà dei reclusi sia originario del nuorese, rende ad oggi le condizioni generali assai “migliori” – se questo dovesse essere il termine adatto – rispetto agli altri sardi deportati o ai reclusi dei due maggiori penitenziari isolani, se non altro perché i prigionieri possono avere colloqui periodici con familiari e parenti, per cui mantengono stretti legami con l’ambiente di appartenenza. Badu ’e karros, da questo punto di vista parrebbe almeno in parte smentire una delle tesi qui sostenute (sulla deportazione) ma vedremo più avanti che invece viene confermata. 189 Contrariamente a quanto più volte prospettato dalle autorità per i carceri di Buoncammino e S. Sebastiano, nessuna istituzione ha mai creduto opportuno protestare per la presenza del penitenziario nuorese, venuto ad occupare spesso le prime pagine dei media per l’orribile trattamento riservato ai reclusi. Proprio nel mentre che volge a termine questo nostro lavoro, i secondini della galera sono ormai da mesi che avanzano proteste – per motivi loro ovviamente – che, come al solito, finiscono per gravare, plumbee, sulla gobba dei detenuti e dei familiari, costretti a condizioni ancora più restrittive del solito e finanche a vedersi i colloqui impediti. Ebbene politici, pretaglia, sindacalisti, e compagnia varia hanno solidarizzato e si stanno impegnando per risolvere la questione. Mai che si siano sentiti, ‘sti becchini (e potevano mai farlo, visto che tali sono in virtù del sistema?) a favore delle lotte dei prigionieri ... Non ci soffermeremo sui carceri di Oristano, a suo tempo tra i più famigerati ed orripilanti per le vergognose e scandalose condizioni subumane cui erano costretti i reclusi da parte della barbarie secondina e della direzione (oggi vi sono 100 detenuti); su quello di Alghero, oggi dismesso (ma verrà riaperto dal sig. Amato, così come tutti gli altri); sulla Rotonda di Tempio, coi suoi quasi cento detenuti; né su quello di Lanusei, circa 50 prigionieri. Nel complesso carcerario sardo hanno oggi perso d’importanza almeno rispetto ai moloch cagliaritano, sassarese, nuorese ed a quello dell’Asinara, anche se, come appena detto rifunzioneranno presto a pieno ritmo. La cayenna dell’Asinara, già “protocollata” come parco naturale quando si stavano lentamente trasferendo gli ultimi prigionieri in altri siti, ridiventerebbe per decreto cayenna di massima sicurezza per presunti boss mafiosi e camorristi, tanto che nel giro di qualche settimana, ad inizio estate ’92, si riempie nuovamente fino a contenere 350 detenuti. In via di smantellamento fino ad un anno addietro vuoi a causa dell’invivibilità delle sue strutture, in parte diroccate dalla rabbia dei reclusi qualche anno addietro, vuoi per porre fine alla famigerata, ladra e veramente criminale gestione del boss legale Cardullo e gentile signora sua pari, pare ormai destinata a riprendere il ruolo di primaria importanza che aveva nel passato. Non solo nella specifica realtà sarda ma finanche nel complesso del sistema carcerario statale. Su l’Asinara, già dall’estate scorsa, si scatena la gigantesca guerra tra i vari trusts politico- economici, alcuni dei quali avevano preparato i piani di intervento per lo sfruttamento turistico “ecologico”. Ma le fazioni contrapposte (capitale politico-carcerario) non sono disposte a mollare né a cedere di un millimetro i propri interessi; ben più generali che la semplice speculazione alberghiera. Non che questa manchi del tutto, per carità; 190 solo che per volontà democratico-parlamentare i soli turisti ammessi dovranno essere rigorosamente appartenenti alla razza padrona, quindi accuratamente selezionati fra i politici (e relative famiglie ed amanti) ed i dipendenti del ministero di Grazia e Giustizia (con relativo seguito di magnaccia e baldracche). Saranno i soli, a poter osservare da vicino quell’umanità ridotta in servitù rappresentata dalle centinaia di proletari costretti a fare le scimmie per divertire alcuni dei pilastri del sistema! A pagarne le conseguenze sono stati per prima la medesima isola, per buona parte incendiata a più riprese; poi i detenuti, costretti in condizioni “ai limiti della tortura” (dichiarazione di tre deputati, in visita all’Asinara ai primi di settembre ’92); quindi le popolazioni costiere, espropriate di un pezzo del loro territorio e letteralmente sommerse di militari in divisa ed in borghese, il cui compito è garantire che dalla cayenna non fuoriesca nessuno. Inutili le democratiche proteste dei cittadini di Portotorres, che già sognavano finito un incubo: i democratici responsabili se ne sono democraticamente strafottuti!!! È però necessario precisare che non è oro colato lo strombazzare opportunistico delle diverse fazioni del potere costituito. Prima di tutto non esistono carceri “per boss” e quello rinnovellato dell’Asinara (come anche quello gemello di Pianosa) non può fare eccezione. Non esistono semplicemente perché non vi sono tanti “boss” quanti ne servirebbero per raggiungere neanche la centesima parte dei soli detenuti dell’Asinara. E neanche per raggiungere la decima parte di quelli classificati “speciali”, della sola sezione di fornelli (150), riverniciata per l’occasione. Non stiamo certo affermando che mafia, camorra e ‘ndrangheta non esistono: ben al contrario! Solo che, essendo strutture organizzate in maniera piramidale, i vertici cui tutto fa capo e da cui tutto si diparte, non possono che essere costituiti da poche persone, con addentellati – come in parte stà venendo fuori in questo periodo – nel sistema legale. Per questo motivo i boss non finiscono in galera, e se pure vi finiscono, stiamo pur certi – salvo rivoluzioni all’interno degli equilibri del sistema – non saranno centinaia, ma qualcuno più compromesso e solo per poco tempo. In galera vi finiscono i poveri mortali criminali, spesso costretti alla “affiliazione” a causa delle miserabili condizioni cui li relega la legalità. Le galere sono piene esattamente di questi proletari. Se così non fosse, ma avesse ragione l’informazione di regime che afferma esserci in galera centinaia di boss, il problema della criminalità di stampo mafioso sarebbe risolto da un bel pezzo. Così non è; tant’è vero che continuano ad arrestare “boss” ogni settimana, ma il problema è sempre più consistente. Che ci sia imbroglio, in tutta questa messinscena? Si tranquillizzino quindi “le anime belle” della Sardegna che si scan- 191 dalizzano non per le galere di per se stesse, ma semplicemente perché si sono convinti siano piene di capi-mafia. Dai proletari siciliani, calabresi, campani che le popolano e che non sono nostri nemici, non hanno nulla temere!!! Per terminare vi sarebbe da dire qualcosa sulle colonie penali nell’isola: Is Arenas, Mamone, Isili. Ma i dati riportati nelle tabelle allegate sulla consistenza delle prigioni e sulla composizione dei detenuti parlano da soli. 3.2.2 Diffida, ammonimento, sorveglianza speciale, confino Anche nella modernità sarda, che sul fronte della penalità di Stato abbiamo visto essere iniziata circa tre secoli dopo che altrove, il carcere non è il solo o il prevalente sistema di punizione vigente. Perché ciò che si mira a punire non è tanto e non solo il “delitto”, quindi l’infrazione ad una specifica legge penale, quanto l’individuo e le comunità che persistono nell’essere altri, irriducibili. Questo fatto spiega la criminalizzazione vera e propria di un’intera area, la politica repressiva-militare cui è stata sempre sottoposta, la strategia permanente dello stato di guerra e d’assedio della ruralità. In carcere vi finiscono a migliaia, perché in attesa di giudizio o condannati sommariamente per lo più popolani. Quando però non è possibile nulla di tutto ciò, si ricorre allo stato d’assedio; alle terroristiche retate che trafugano ogni angolo di tutte le case proletarie; alle misure di polizia ancora più arbitrarie perché le forze dell’ordine non debbono provare assolutamente nulla, ma solo “accusare” nella più fumosa genericità i motivi per cui una persona, sarda, specialmente se della “zona pastorale”, deve subire restrizioni alla propria libertà e dignità personali, oppure la deportazione in Italia. Fino ad appena tre lustri addietro la sorveglianza speciale, la diffida, il confino (poi definito più democraticamente soggiorno obbligato) coprivano interi paesi. Da allora il fenomeno sembrerebbe ridimensionato, ma proprio a partire dal momento in cui volge a termine questo lavoro pare abbia subìto un’improvvisa impennata. Che coincide con la nuova strategia etnocida messa in atto dal potere democratico. Il “primo grado” delle misure restrittive di polizia è la diffida, che consiste nell’imporre anche verbalmente da parte delle forze armate di Stato, alla persona inquisita, di non frequentare certi posti, locali ed amicizie, di cercarsi un lavoro (!) se ne è privo, di rientrare a casa ad una certa ora, di non effettuare continui spostamenti, ecc. Si tratta, in pratica, di umiliazioni alla dignità di qualsiasi uomo che 192 si senta tale anche solo al 10%. Figurarsi poi chi si dovrebbe o non dovrebbe frequentare nei nostri paesi, spesso di poco più di un migliaio di anime; dove i locali e le amicizie che si hanno solo quelle che ... vi stanno. Escluso il Comune, il prete e la caserma, tutto il resto rientra benissimo nel calderone del “diffamato”, diffamante e pre-giudicato. Per cui è assai chiaro a cosa si mira, essendo praticamente impossibile, anche volendolo, adeguarsi a tali inaudite restrizioni. La diffida, per quanto infima, ha conosciuto tempi in cui accompagnava la stragrande maggioranza dei componenti la comunità interna. In generale ogni pastore, ogni famiglia di pastori risulterebbe diffidata almeno una qualche volta, nel passato o nel presente. Considerata la materiale impossibilità per i diffidati di non fare quanto ad essi vietato, i più incorrono nel travaglio successivo: la sorveglianza speciale. Se quella era lesiva della dignità di una persona, questa è un’offesa vera e propria che rinchiude l’individuo entro un territorio più o meno limitato ed entro certi orari, che gli cadenzano l’esistenza. Si tratta, in pratica, di un vero e proprio carcere nel sociale, psicologicamente peggiore del penitenziario perché si è sempre in bilico tra l’incertezza e la certezza del minuto, del luogo, dell’azione, della persona con cui si stà. Un nonnulla e si finisce in galera per non aver rispettato la misura di polizia decretata. Eventualmente però, si passa prima nella via crucis del confino (misura abolita formalmente alla fine degli anni ’50 – venne istituita nel 1926 dal regime mussoliniano – ma praticamente in vigore nella sorveglianza speciale, che può essere imposta in un comune qualsiasi dello Stato italiano, pertanto anche diverso dal proprio). Qui si è in balia vuoi del proprio carattere che di quello di birri, sindaci, preti e popolazioni spesso appositamente aizzate e manipolate per cui risulteranno immediatamente ostili ai confinati. Non ultimo, infine, questi devono fare i conti con ... le proprie finanze, sempre scarse o inesistenti in quanto colpiscono per lo più dei semplici proletari. In quanti riescono, e per quanto tempo, a sopportare simili torture che dissanguano ogni risorsa dei deportati e delle loro famiglie, costretti come sono alla fine a ridursi a nulla più che elemosinanti? Unu pedulianu bagamundu de me’ nd’ant fatu, pro s’antzianìa. Ma su ruolu mi paret anzenu e nde crepo de rabbia e belenu. (Un questuante vagabondo / han fatto di me, per l’anzianità. / Ma 193 tale ruolo non mi appartiene / e ne soffro avvelenato dalla rabbia). Matteo Calia, nel suo Cantigu dae presone, ha voluto riassumere in versi cocenti quanto grande sia la sofferenza di coloro che vengono sottoposti a tali vergognose angherie. Qualche verso prima riporta la “calorosa accoglienza” riservatagli dal sindaco di un paese sardo, in cui dovette risiedere dopo l’esperienza del confino a Lampedusa e Ustica. Una parte de tempio est in rissa; tramite s’istampa allumadu ant su focu. Su sindacu respinghet cun orrore un’ipotetico secuestradore. (Una parte degli abitanti di Tempio [il paese sardo in cui gli viene assegnato il nuovo “confino”] è in rissa / le notizie di stampa han scatenato un incendio / Il sindaco respinge con orrore / un’ipotetico sequestratore). Che il lettore non inorridisca; non si tratta di esperienze di un lontano passato, ma risalgono semplicemente alla fine degli anni ’80 di questo nostro secolo! Nè si pensi che ormai tali misure siano ricordi del passato. Il documento recentissimo di cui all’appendice documentaria, e relativo alla richiesta della Questura di Nuoro per l’applicazione della sorveglianza speciale a Carmelino Coccone – da appena un anno uscito dal carcere dopo averne scontato circa 13 per i fatti di sa Yanna Bassa di cui abbiamo detto prima – è esattamente del 14 dicembre 1992. La Commissione veramente “speciale” si è riunita ai primi di gennaio ’93 ed ha ammesso quanto chiesto dalla Questura, su ogni punto. Da tale richiesta possiamo apprendere con più cognizione di causa uno dei modi con cui le forze armate vogliono arginare ufficialmente il “fenomeno criminale”, in realtà soffocare quei sardi non ancora statizzati. Il contenuto della proposta avanzata dalla Questura di Nuoro merita un minimo di attenzione da parte nostra. Si inizia con l’esprimere un giudizio sprezzante sulla famiglia della persona inquisita, definita dalle “pessime qualità morali”; come se la polizia, i poliziotti, la Questura siano un qualche ente di elevata notoria moralità ed il loro compito istituzionale fosse di esprimere giudici etici. Il “nominato in oggetto” inoltre, sarebbe “insofferente nei riguardi delle Istituzioni dello Stato e delle norme sulla civile convivenza”. Qui viene consumata ancora una volta una delle falsificazioni che vorrebbero ricondurre la civiltà statale alla civile convivenza, confondendole appositamente. Se poi, nei confronti delle leggi si nutre “insofferenza”, beh allora siamo punibili tutti quelli non integrati. I solerti poliziotti di Nuoro dovrebbero però fare in modo che una qualche novella legge del loro Stato punisca l’insofferenza ... 194 I richiami “all’ordine” avanzati verbalmente dai questurini nei confronti del “nominato”, l’avrebbero stimolato sulla “via del delitto e dei reati in genere”. Questo è addirittura grottesco e, per i questurini stessi, semplicemente vergognoso e disonorevole. Ma come! una persona che controllano così minutamente compirebbe delitti e reati ed essi, tutori dell’ordine, non fanno che ... proporre la sorveglianza speciale, invece di denunciarlo per i crimini commessi o arrestarlo! Suvvia, tutto ciò è semplicemente ridicolo! Agghiacciante poi “l’escursus criminale”, subdolamente ricostruito e manifestamente tendenzioso e sprezzante finanche della medesima magistratura sarda ed offensiva per lo stesso Tribunale Penale di Nuoro, al quale la Proposta è inviata. Prima di tutto si fa un unico fascio tra delitti che il “nominato in oggetto” avrebbe commesso, e per i quali comunque ha scontato la pena inflitta dai tribunali, con quelli che non ha commesso per ammissione degli stessi giudici che lo hanno di volta in volta processato ed assolto, non prima che avesse scontato la galera preventiva. Ora, le cose sono due, non tre come propone la Questura. Dato che per i delitti di cui è stato condannato, Carmelino ha scontata per intero la pena inflitta, i poliziotti non si capisce in base a quale criterio possono impunemente aggiungere o togliere qualcosa che la stessa legge di Stato non prevede. Se per i delitti non commessi, e per i quali vi è stata assoluzione da parte della Magistratura, nessuna legge almeno per il momento prevede la punibilità, in base a quale criterio, se non la repressione pura e semplice, una qualche condanna può essere decretata e comminata dalla Questura? Si dichiara il falso asserendo, come si fa, che l’inquisito era colpevole dei delitti per i quali il medesimo Stato lo ha assolto, ma siamo certi che nessun questurino per ciò verrà condannato. Più che il “curriculum criminale” di Coccone, la Questura di Nuoro, a dire il vero, ha esposto il curriculum criminale dello Stato nei confronti dell’orunese. Perché emerge con quanta determinazione le istituzioni repressive si diano da fare per creare ad arte un delinquente: repressioni per motivi legati alla legge sull’abigeato (contravvenzioni per la dimenticanza di bollettini al pascolo, non dichiarazioni di spostamento del bestiame, ecc.; insomma per questioni strettamente burocratiche vigenti esclusivamente in Sardegna); incriminazioni e assoluzioni su assoluzioni si susseguono nell’elenco. Denunciando vistosamente con quanta “facilità” si ingaleri, si ricatti, si torturi le persone pre-giudicate, più che una condanna di Coccone, il curiculum è la condanna dello Stato, delle sue istituzioni criminali, del suo sistema. Ridicola la menzione sugli spostamenti dell’inquisito (addirittura ... sarebbe salito sull’autobus, ad una data ora, in partenza per Sassari!); mi- 195 serabile, infine – e chiudiamo così – l’elenco delle amicizie (ampiamente selezionato) nonché il far presente che “si intrattiene a lungo nei pubblici esercizi ove spende ingenti somme di danaro in generi voluttuari”. E dove mai, nei “pubblici esercizi” (leggi bar) a Nuoro si potrebbero spendere ingenti somme? Dove dovrebbe trascorrere il proprio tempo una persona che è stata rinchiusa per oltre vent’anni in galera, di cui tredici anni di filata terminati di scontare appena un anno prima? Tanto più se fa parte di quella non indifferente quantità di sardi (oltre 200 mila per l’esattezza) che godono il privilegio della disoccupazione? Per vedere quanto sia consistente il fenomeno delle misure di polizia ricordiamo che per il solo anno 1966-67 si hanno i seguenti dati: 119 proposte di soggiorno obbligato fuori dall’isola, 58 assoluzioni, 45 provvedimenti di sorveglianza speciale, 35 provvedimenti di soggiorno obbligato in comuni dell’Italia, un divieto di soggiorno nella provincia di Nuoro (Cabitza). 3.2.3 La deportazione: ultima fase dell’etnocidio? Ad iniziare dalla colonizzazione spagnola la deportazione – cioè la traduzione forzata all’estero (della Sardegna ovviamente) – è fenomeno costante, quotidiano, strategico del processo di denazionalizzazione. Fenomeno di massa fino al recentissimo passato, oggi è applicato in maniera sistematica ai danni degli ultimi “mohicani” sardi, “liberi” o carcerati che siano. Il mutamento dei tempi registra lo smembramento sia pure relativo delle comunità originarie, l’acculturazione “di massa”, l’esproprio di una buona fetta del potere di autodeterminazione. In questa realtà determinate è l’allontanamento dal corpus sociale di quanti in un modo o nell’altro sono tuttora radicati nella cultura tradizionale, esprimendo tratti sostanzialmente altri rispetto al sistema vigente. La loro presenza in seno alle comunità è di impedimento al definitivo trionfo del processo etnocida. In generale, l’alterità viene espressa oggi dalla ruralità delle zone interne, che ancora mantiene vivi diversi momenti dell’autodeterminazione (economico-produttiva e sociale nel complesso). Inoltre, la specifica “criminalità” essendo espressione del sostrato culturale autoctono rimane tutt’oggi il fenomeno macroscopicamente meno sussumibile entro i parametri del sistema vigente. È questo “mondo” che subisce in maniera sistematica la repressione criminalizzante. La sua persistenza nel sociale rischia di riconnettere diverse maglie ormai lacerate della totalità culturale, permanendo sul piano individuale e per certi versi familiare, in modo ancestrale, quei momenti 196 dell’autodeterminazione originaria che non scompaiono meccanicamente con il venire meno del tessuto autoctono nella sua integrità. Nel passato remoto la deportazione veniva ideologicamente travestita dai concetti penali di galera (lavoro ai remi), esilio, lavori forzati. I sardi, ritenuti criminali incoercibili, scampati alla justitzia sommaria delle forche e degli stati d’assedio, venivano prima puntualmente torturati spesso in pubblico, e fustigati, quindi deportati. L’unico scampo a siffatta sorte era l’arruolamento volontario in quelle barbare orde che erano le armate agli ordini dell’occupante. Dalla mattina alla sera “tali incalliti criminali” diventavano in tal modo “onorabili ed onorati” cittadini di Stato, che svolgevano un immane e sacro compito di civiltà. Ma evidentemente non erano poi molti “gli arruolati civilizzati”, data la costanza della deportazione. Diaspora assai rilevante ai tempi delle rivolte per su konnotu; diaspora a fine secolo, in pieno periodo di “caccia grossa”; diaspora sarda nel secondo dopoguerra; diaspora oggidì. I “confinati”, quelli sottoposti a soggiorno obbligato, i prigionieri sardi deportati, rappresentano oggi, al pari di ieri, il filo rosso della sistematica repressione del mondo agropastorale che pur avendo ceduto tanto nel processo di acculturazione forzata, manifesta ancora una propria vitalità, nell’intero corpo sociale e non solo nelle “categorie” degli agricoltori e dei pastori. Nel passato, data la condizione di alterità di massa, si trattava di colpire nel mucchio, deportando interi paesi dal proprio territorio o almeno le forze più vive. In tal modo gli abitanti venivano privati del sostrato geoumano su cui manifestare la propria alterità. Chi veniva spedito in galera, chi al confino, chi in “villeggiatura”, chi subiva la sorveglianza speciale. Per quanti restavano era facile ricattarli, intimorirli, sequestrarli nel loro stesso mondo, facendo leva esattamente sugli ostaggi di Stato sui quali gravavano misure sempre più restrittive alla dignità ed alla personalità. Ciò si verifica, a partire dal secondo dopoguerra, in modo radicale e sofisticato, perché accompagnato dal sistematico indottrinamento sul “necessario cambiamento”, sul civile progresso, sulla necessità di far accettare la civiltà, l’ineluttabile progresso storico sinonimo di travolgimentosuperamento della barbarie di cui la cultura sarda sarebbe portatrice. Insomma è l’ideologia del/dominante che si impone sul colonizzato facendogli sentire/pesare la sua vergognosa diversità. La sincronia dei media – tv, radio, giornali – ha quindi dato l’esito sperato, accompagnata dagli interventi distruttivi in campo economico, scolastico, religioso, sociale in generale. Con quanti, deportati o meno, hanno manifestato in qualche modo cedimenti, ragionevolezza, “senso di responsabilità”, lo Stato democratico si è dimostrato generoso, elargendo ad ampie mani pensioni risibili ed 197 elemosine di ogni tipo, nonché la “revisione” della fedina penale e la remissione dei peccati. Anche questo poco, per quanti tutto hanno avuto espropriato, ed hanno vissuto sempre in condizioni di repressione e precarietà, finendo nel non avere/vedere alcuna prospettiva di reale liberazione (cultura resistenziale, appunto), anche questo poco dovette apparire qualcosa, se non altro la fine della sistematica repressione. La fase di pacificazione ricattatoria è accompagnata, per i più fortunati ovviamente, dall’apertura verso l’impiego, pubblico e privato. È il boom tutto sardo: il tempo delle gigantesche ciminiere dei petrolieri che avrebbero dovuto importare tanta civiltà e ben 75 mila posti di lavoro. A tanto assommavano i nuovi occupati secondo i propagandati calcoli dei centri del potere politico coloniale. E la fabbrica significa “classe operaia cosciente” cioè inquadrata in seno alle clientele partitiche sindacali; e dignità, moralità, civiltà ... che avrebbero dovuto finalmente eliminare alla radice le cause materiali della vitalità di un mondo e della specifica criminalità di cui è portatore. Venne così anche il tempo di dedicare particolare attenzione ai contadini ed ai pastori, non deportati o ex-deportati; in nome dei quali vennero e vengono elargiti migliaia di miliardi confluiti nelle tasche degli industriali dei mezzi agricoli, dei mangimifici, dei concimi chimici e degli anticrittogamici, delle sementi manipolate e del monopolio italo-europeo, nonché di società sportive, pubblicitarie, di marchi doc esistenti soltanto sulla carta ma che pure costano centinaia di miliardi. Infine venne il tempo di tutta una serie di enti inutili e spesso dannosi e dei tanti convegni ed incontri e pranzi e viaggi “tutto pagato” dalla cassa della sarda regione. Che ha decretato l’affossamento quasi definitivo dell’autoctonia produttiva e l’introduzione in regime di monopolio del sistema capitalistico di sfruttamento ... dei pastori e dei contadini, della terra e degli armenti. Boom durato poco, a dire il vero, appena due lustri a ben fare gli esatti calcoli, ma che sapientemente accompagnato dalla repressione politico-poliziesca, dal continuo lavorio dei media e della scuola di Stato, ha determinato l’esproprio di parte consistente del potere di autodeterminazione. Perciò è mutata anche la consistenza della deportazione, infierendo oggi in maniera articolata su specifici “elementi”. Non si tratta più di incidere sulla compattezza del gruppo comunitario, almeno in parte di già intaccato, quanto di isolare dalla comunità lacerata gli elementi ritenuti più pericolosi non per la presunta efferatezza dei delitti di cui li si vuol fare portatori – che spesso non ne hanno commesso alcuno – quanto per l’ascendente che vantano tuttora su una parte consistente della collettività, come persone dignitose, stimate, e per l’ampia cer- 198 chia di amicizie di gui godono. Ascendente non generico, bensì portatore/ fautore di valori tradizionali. È attorno a tali figure ed al loro ascendente – su cui negli ultimi anni lo Stato ha indirizzato l’opera repressiva – che si innesta il nuovo modo di applicazione del sistema penale in Sardegna, e la deportazione. Il sistema di “individualizzazione” del criminale mira a colpire non tanto l’entità o la gravità del reato, quanto la personalità e le motivazioni di fondo dell’aver leso la legge. Da questa prospettiva si esamina il comportamento assunto durante la prigionia, l’incriminazione, nel rapporto con la magistratura e la polizia, nel dibattimento, di coloro che cadono nella mani della justitzia. Poco importa la “gravità” del reato. L’abigeato è pur sempre furto, per cui non si può più, oggi, comminare l’ergastolo o il taglio della mano destra. Anche il sequestro di persona non è più, semmai lo è stato, monopolio dei sardi. Pertanto, nonostante le rinnovellate proposte “umanitarie” sul ripristino della pena di morte, non si possono tranquillamente da un lato ammazzare i sardi come tordi, nei raccordi anulari e nelle operazioni di “caccia grossa”, e dall’altro essere semplicemente ... paternalistici poniamo con gli industrialotti nordici che sequestrano le figlie del loro socio in affari. Sarebbe ridicolo per lo Stato democratico proseguire su questa strada, che pure è quella fino ad oggi sostanzialmente in vigore. Meglio agire sulla personalità del detenuto-inquisito-condannato. Un Ligresti, un Craxi, un ladro arcivescovo o cardinale (senza fare nomi, per carità, tanto ... sono esattamente tutti nello stesso brodo) possono così immediatamente pentirsi, rinnovellarsi e rinascere alla piena libertà di continuare a fare ciò che hanno sempre fatto: rubare, sfruttare, affamare. Pur colti con le mani nel sacco! Un certo Tanassi, così come un tal Longo, ministri onorevoli della repubblica democratica “antifascista”, dopo aver rubato tutto quello che hanno potuto, una volta finiti in galera perché è venuto fuori un tantino della loro opera realmente criminale, si sono affidati subito a quanto previsto dalle leggi in materia di delinquenza e carcere. Per cui dopo appena una notte in galera, in camera singola e col telefono a portata di mano, valutati all’uopo dalla Commissione prevista per la valutazione dei detenuti, si sono subito resi conto dell’errore commesso e ravveduti, quindi scarcerati immediatamente. Possiamo star certi che tutti coloro che in questo frangente storico risultano la fazione perdente del sistema di dominio di statale, si ravvederanno come per incanto ... Anche il sardo che si è fatto il suo bel sequestro, orribile crimine quando ad essere sequestrati sono i pilastri umani del sistema vigente, possono anch’essi usufruire, se lo vogliono, di tutta una serie di benefici ... purché dimostrino pentimento, collaborazione e soprattutto non manifesti- 199 no con ostentazione le ragioni della propria identità etno-culturale, cioè atteggiamenti ostili al lavaggio del cervello. Situazione che parrebbe contraddetta dal recentissimo, liberticida, famigerato decreto Scotti-Martelli il quale ha decretato per certi delitti, tra cui il sequestro di persona, il ristabilimento, in pratica dell’ex art. 90 (oggi 41 bis). Anche una bella comunità di sardi (circa 50) condannati a lunghe pena e già usufruenti del regime di semilibertà, sono ritornati in galera e sottoposti ad inaudite restrizioni. Inutile blaterare che la criminalità sarda non è strutturata “mafiosamente”! Che accade dunque? Semplice. A questi si chiede “più convinzione” nel pentimento, maggiore collaborazione con lo Stato, cioè delazione, tradimento, rinuncia sicura alla propria dignità personale ed etnica. Ci sarà, crediamo, qualche tentativo di forzatura, ma lo Stato è ben attento a non svegliare il can che dorme. Non a caso dopo un primo periodo di rinchiusura in galera, i sardi sono stati rimessi in regime di semilibertà; il loro è diritto acquisito, ormai. Tuttavia, d’ora in poi non sarà più permesso alcun atteggiamento di formale rispetto delle leggi e dei regolamenti carcerari, si pretenderà la intima convinzione, la manifestazione esplicita del riconoscimento della legalità di Stato; ciò che presuppone il farsi spie, delatori, traditori. Non a caso tutti i grandi delinquenti che nell’ultimo mezzo secolo hanno rubato impunemente stanno cantando a ruota libera; ciò è dimostrazione dell’introiezione in essi del sistema e possiamo stare certi che il tutto, per loro, si risolverà con accordi di alta politica democratica. Per i sardi ribelli il nuovo corso della repressione si risolverà invece – salvo una reale opposizione – nella sicura deportazione, più massiccia di quanto accade oggi; nella reclusione nei braccetti speciali (la “Torre di Londra”) fino all’espiazione a regime duro della pena comminata (a cui si debbono poi aggiungere le misure di polizia). Non caso, semplici proletari in galera per rapina, condannati a pene risibili (5, 6, 7 anni) se la sono fatta tutta negli speciali, da deportati. Si tratta invero, come per il passato, di spedire alla cayenna gli irrecuperabili, gli anarchici, i sovversivi, insomma le “mele marce” per evitare che contagino il sociale. Nel 1991, un elenco incompleto dei detenuti deportati sardi, compilato nell’arco di pochi mesi dal Comitato di Solidarietà con il Proletariato Prigioniero Sardo Deportato, contava circa 150 nomi; ma si trattava di una lista manchevole in quanto le notizie scarse, la censura delle autorità carcerarie ecc., avevano eretto un muro che impedì di andare oltre. Dei deportati di allora, dopo la clamorosa iniziativa dell’ultimo quadrimestre del 1989, numerosi sono stati rimpatriati o avvicinati per colloquio con i familiari. Tuttavia il problema resta in tutta la sua gravità, essendo fenomeno 200 esclusivamentepolitico non certo dovuto alle solite paventate e propagandate carenze di tipo strutturale e burocratico. La risposta del ministero di Grazia e Giustizia per il trasferimento dagli speciali di Francesco Catgiu (Sirbone), ed in un carcere isolano per Claudio Cadinu, di questi ultimissimi mesi ne è la conferma. I deportati, salvo coloro che tali non si sentono, da anni in galera, o anche neo-incarcerati, sono coloro che nel corso del tempo hanno sempre manifestato integrità etnica ed etica, cioè attaccamento ai propri valori culturali, e che spesso hanno partecipato attivamente, e promosso le battaglie dei prigionieri contro l’annientamento psico-fisico e la distruzione della dignità personale. Altrettanto spesso non sono state molle politicoideologiche a fare scattare il loro atteggiamento di irriducibilità, quanto quella ancestralità culturale, etnica, che pone l’individuo autodeterminato, autofondato quale entità irrinunciabile, contro ogni Stato, ordine, valore, giustizia esterna-estranea. Ed è la loro autodeterminazione che deve essere, nel modo più assoluto, tenuta lontano dalle comunità originarie, in cui il seme dell’addomesticamento ha già fatto parecchie vittime. La loro presenza, sia pure nelle galere dell’isola, sarebbe estremamente pericolosa; o tale è comunque ritenuta. Potrebbe infatti contrastare il processo di totale denazionalizzazione. Per questo motivo sono deportati! 201 Conclusioni e prospettive Le diverse strategie del potere costituito hanno intaccato il potere individuale e sociale dei sardi. Sarebbe un errore nascondercelo, o tacerlo; non servirebbe ad altro se non a dare vita ad una gigantesca illusione, troppo preziosa per lo Stato, troppo dannosa per noi. Ma un’altra illusione pare abbacinare le genti proletarie sarde: quella secondo cui la perdita del “vecchio”, di “su konnotu” non sarebbe poi una sconfitta bensì una vittoria, il “nuovo” avendo dato un “benessere” impensato, inimmaginabile fino a pochi lustri addietro. Il che potrebbe essere anche vero, in parte, ma soprattutto se ... fosse vero! In realtà il boom, per i proletari sardi come per tutte le aree marginali e marginalizzate dallo Stato e dal capitale, è una comparsa che dura poco: quanto un sogno, per bello che sia. Ed il nostro è di già terminato, è durato lo spazio di una sola generazione. Nel frattempo abbiamo avvelenato le nostre terre, dimenticato almeno in parte i nostri valori, consumato ettolitri di birra , coca-cola, whisky, “vecchia” e mille altre delizie del capitale, che così si è rafforzato ulteriormente ai nostri danni. Abbiamo goduto del “sano minestrone” usa e getta e poi dell’automobile ultimo modello, quello che sprigiona chissà quanti cavalli di potenza tanto da fare invidia al vicino di casa. Abbiamo abbandonato vestiario e scarpe tradizionali, per indossare gli stivali “ultimo grido”, molto simili a quelli degli sceriffi USA. Poi ci siamo talmente civilizzati che invece di usare i barbari sissi, nossi o andat beni, pure noi usiamo il civile okay. Ci glorifichiamo di fronte allo schermo TV, che trasmette messaggi della “civiltà”, di quella a cui tanti di noi si sono ormai alienati. 202 Hanno rinunciato in molti a gestire direttamente, in prima persona, la loro esistenza, tanto che il pastore non riesce più a farsi il formaggio neppure per il proprio consumo familiare. In tanti hanno delegato ai politici i loro interessi, i loro scazzi, la giustizia. In cambio si sono ingozzati di cose non nostre e creduto che il consumo, lo spreco (che altri peggio di noi pagano a caro prezzo) sia la vita, il vero vivere. Fatto ancora più inverosimile, le condizioni in cui ci hanno costretto millenariamente, rinchiudendoci in galere o riserve nella nostra stessa terra, espropriandoci della nostra vita materiale e spirituale, del territorio e delle sue risorse, depredandoci del frutto del nostro lavoro, ci hanno infine ridotto alla improduttività, beffardamente definita non-competitivita, quindi ad un popolo di elemosinanti, quindi a criminali incalliti. Proprio i criminalizzati, quanti rifiutano i valori del capitalismo e dello Stato, la sacralità della proprietà privata propinataci per decreto, le leggi che sanciscono l’ineguaglianza e l’iniquità della distribuzione della ricchezza sociale, il sacrificio e il lavoro servile; proprio i criminali, gli irriducibili, i non cedenti manco un millimetro della propria dignità, paiono aver assunto la bandiera della resistenzialità ad oltranza, incuranti della repressione e delle possibili “offerte” che il potere costituito concede a quanti rinunciano ad essere se stessi. Ma ciò, se assume indubbiamente un alto valore positivo, rappresenta anche – oggi e sempre più nel futuro – la fondamentale contraddizione della resistenzialità isolana. L’abigeato, il furto, la rapina, lo stesso sequestro di persona ed in generale tutti i fenomeni della specifica criminalità, pur rappresentando resistenzialità nel processo etnocida e genocida, se non pervengono ad un più ampio progetto di attacco e di liberazione sociale, si riducono a “crimine metropolitano”, a semplice azione di sopravvivenza. E la sopravvivenza non è mai buona consigliera per cui determinerà alla fine un tipo di organizzazione strutturata gerarchicamente, quindi la definitiva separazione del “criminale” dalla collettività, la sua alienazione dal reale processo di liberazione, finendo egli medesimo vittima dell’organizzazione di tipo mafioso a cui ha dato vita. Moralismo, il nostro? Oppure consapevolezza della contraddizione sorta dall’avanzare della acculturazione? Sicuramente non moralismo! Non è più sufficiente la sola resistenza, cioè l’atto di difesa. Partendo dall’analisi dei rapporti di classe e della nuova composizione politica, economica, sociale, culturale che si è venuta a determinare in Sardegna, è necessario inserire l’attacco in un progetto complessivo che proceda verso la individuazione di ciò che è nostro e di quanto, invece, non lo è, e come tale da eliminare-contrastare-combattere. È solo tramite l’analisi e l’individuazione di precisi obiettivi, che si 203 porrà fine alla disgraziata guerra fratricida che in parte sta logorando le nostre energie, ed alla politica di annientamento propria del potere costituito nei confronti nostri come individui e come etnia. Il che significa attuare il delitto non più indistintamente, ma ai danni di questo o quel sostenitore del potere costituito; indirizzare la balentìa, la nostra rabbia non più indistintamente contro gli altri, ma ai danni di precise strutture coloniali, delle istituzioni, del capitale che ci stà riducendo in elemosinanti. Si tratta, è evidente di semplici indicazioni di natura generale per intendere le ragioni di un modo diverso di concepire la resistenzialità. Il progetto complessivo, da elaborare nell’ambito del progressivo attacco, deve essere più ricco, sapientemente articolato in base a quanto esprime e recepisce il sociale isolano. È chiaro che il “criminale”, anche quello sardo, non ha in mente alcuna liberazione, limitandosi a porre in essere ciò che egli è, una entità in parte autofondata e che pertanto trova in sé stessa i valori materiali e spirituali. Ma si tratta di entità limitata, contrastata, ostacolata, repressa in quanto i suoi stessi valori o vengono riassorbiti dall’etica dominante – il possesso della ricchezza in funzione del consumo di merci –, o vengono comunque annullati nel processo di deculturazione. Questo è innegabile; da ciò il progressivo allontanamento dalla società civile di persone ed azioni che appena un decennio addietro avevano alta valenza culturale. Il “criminale” e, in senso più ampio il resistente, si limita a vivacchiare negli spazi sempre più ristretti che l’esistente impone a quanti gli sono contro, finendo in tal modo per diventare parte integrante di questo sistema, sia pure ai suoi margini e solo apparentemente ad esso antagonista. È oggi indispensabile superare tali limiti e porsi come strategia il mutamento radicale dell’esistente, in un progetto basato sulla ricchezza dei valori etnici che impregnano ciascun sardo, soprattutto i valori dell’autodeterminazione individuale e comunitaria. Progetto che, come abbiamo visto, non è da intendersi come organizzazione partitica, gerarchica, verticistica, essendo questa letteralmente l’opposto dei nostri valori, dell’autodeterminazione. Al contrario, deve essere la materiale articolazione di un processo individuale e collettivo, di resistenza e di attacco, che pone l’individuo sardo come punto di partenza e di arrivo di ogni lotta, senza forzature e schermature ideologiche che non ci appartengono. 204 205 Bibliografia essenziale alla parte analitica OPERE A CARATTERE GENERALE: Villari, R.: La formazione del mondo moderno (dal XIII al XVII secolo), Laterza, Bari 1974; AA.VV.: Il tempo storico, 3 Volumi, Zanichelli, Bologna 1983; Barbagallo, C.: Storia Universale, 11 Volumi, UTET, Torino 1974; Montanelli, I.: Storia di Roma, Rizzoli, Milano 1959; Columba, C.M.: Storia politica d’Italia, Secondo Volume – Impero Romano (dal 44 a.C. al 395 d.C.), Vallardi, Milano s.d.; Brancati, A.: Fra Oriente e Occidente, Secondo Volume, La Nuova Italia, Firenze 1969; Nicolini, V.: Storia Romana, S.E.I., Torino 1952; Silva, P.: Lezioni di Storia civile ed economica, Primo Volume, Principato, Milano-Messina 1956; Saitta, A.: Civiltà del passato, Sansoni, Firenze 1957; Saitta, A.: Storia e tecnica nella Civiltà umana, Primo Vol., Sansoni, Firenze 1969; Landogna, F.: Antologia della critica storica, Petrini, Torino 1955; Cherubini, G.: Signori contadini borghesi – ricerche sulla società italiana del Basso Medioevo, La Nuova Italia, Firenze 1974; Storia politica del mondo, 8 Volumi, Edizioni UNEDI, Roma; Guizot, F.: Storia della civiltà in Europa, Il Saggiatore, 1973; Shennan, J.H.: Le origini dello stato moderno in Europa (1450 — 1725), Il Mulino, Bologna 1976; Braudel, F.: Il mondo attuale, 2 Volumi, Einaudi, Torino 1966; De Bosschère: I due versanti della storia, 2 Vol. (1°: Storia della colonizzazione; 2°: Storia della decolonizzazione), Feltrinelli, Milano 1972; Turberville, A.S.: L’inquisizione spagnole, Feltrinelli, Milano 1965 (V); Tamburini, P.: Storia generale dell’Inquisizione, 2 Volumi, Bastogi, Foggia (ristampa dell’Edizioni Sanvito, Milano 1862). Le citazioni dalla Bibbia sono state fatte da: Sacra Bibbia, Ediz. Paoline, Roma, febbraio 1962. POTERE, STATO, SOCIETÀ: IL «POLITICO» NEL PENSIERO OCCIDENTALE Platone: La Repubblica, La Nuova Italia, Firenze; Machiavelli, N.: Il Principe / Istorie fiorentine, Bietti, Milano 1974; Bonanate, L.: Diritto naturale e relazioni tra gli stati, Loescher, Torino 1976; Marx, K.: Il Capitale, Editori Riuniti, Roma 1974 (a cura di D. Cantimori); Bakunin, M.: Opere complete, Edizioni Anarchismo, Catania (in corso di stampa, ad oggi sono usciti i primi 6 Volumi), In particolare si segnala il IV vol.: Stato e anarchia; Rossi, M.: Da Hegel a Marx, il sistema hegeliano dello Stato, Feltrinelli, Milano 1976; Lefebvre, H.: Lo Stato, 4 Volumi, Dedalo Libri, Bari 1978; Lasswell / Kaplan: Potere e società, Etas Kompass, Milano 1969; Sennet, R.: Autorità, Bompiani, Milano 1981; Russell, B.: Il potere, Feltrinelli, Milano 1976; Messeri, A.: Il problema del potere nella società 206 occidentale, Sansoni, Firenze 1978; Onofri, F.: Potere e strutture sociali nella società industriale di massa, Etas Kompass, Milano 1967; Bottomore, T.B.: Elite e società, Il Saggiatore, Milano 1967; Rawls, J.: Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 1984; Rizzi, B.: Il collettivismo burocratico, Sugarco, Milano 1977; Bellomo, M.: Società ed istituzioni in Italia tra Medioevo ed età Moderna, Giannotta, Catania 1980. ANTROPOLOGIA: TESTI DI BASE / STUDI / RICERCHE / DESCRIZIONI Cirese, A.M.: Cultura egemonica e culture subalterne, Palumbo, Palermo 1976; Cirese, A.M.: Folklore e antropologia, Palumbo, Palermo 1972; AA. VV.: Dibattito sul folklore in Italia, Cultura Popolare, Milano s.d.; Benedict, R.: Modelli di cultura, Feltrinelli, Milano 1974; Angioni, G.: Tre saggi sull’antropologia dell’età coloniale, Flaccovio, Palermo 1973; Durkheim / Mauss: Sociologia e antropologia, Melita, La Spezia (ristampa 1976); AA. VV.: Il concetto di cultura — i fondamenti teorici della scienza antropologica (a cura di P. Rossi), Einaudi, Torino 1970; Harris, M.: Materialismo Culturale, Feltrinelli, Milano 1984. Forno, M.: L’acculturazione dei popoli primitivi, Studium, Roma 1968; Goody, J.: L’addomesticamento del pensiero selvaggio, Angeli, Milano 1987; Lomdardi Sartriani, L.M.: Folklore e profitto — tecniche di distruzione di una cultura, Guaraldi, Firenze 1976. Harris, M.: Cannibali e re — le origini delle culture, Feltrinelli, Milano 1984; AA.VV.: Potere senza Stato (a cura di C. Pasquinelli), Ed. Riuniti, Roma 1986; Montagu, A.: Il buon selvaggio, Eleuthera, Milano 1978; Clastres, P.: Archeologia della violenza, La Salamandra, Milano 1982; Clastres, P.: La società contro lo Stato, Feltrinelli, Milano 1980 (II); Landucci, S.: I fiolosofi e i selvaggi (1580-1780), Laterza, Bari 1972. Crichton, M.: Mangiatori di morte, Garzanti, Milano 1977; Mead, M.: Popoli e paesi, Feltrinelli, Milano 1982; Scotti, P.: I popoli della terra, S.E.I., Torino 1947; Malinowski: Argonauti del Pacifico occidentale, Newton Compton, Roma 1978; Evans-Pritchard, E.E.: I Nuer — un’anarchia ordinata, Angeli, Milano 1985; Bircher, R.: Gli Hunza — il popolo della salute, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1980; Zavatti, S.: Il misterioso popolo dei ghiacci — vita e cultura degli ultimi Eschimesi, Longanesi, Milano 1977; Washburn, W.E.: Gli indiani d’America, C.D.E., Milano (su licenza Ed. Riuniti, 1981); Neihardt, J.G.: Alce nero parla, Adelphi, Milano 1990; Sul sentiero di guerra (a cura di C. Hamilton): Scritti e testimonianze degli Indiani d’America, Feltrinelli, Milano 1982 (V); Indiani d’America : Identità e memoria collettiva nei documenti della nuova resistenza indiana (a cura di Hansen D.), Savelli, Roma 1977; Messaggio degli Irochesi al mondo occidentale: Per un risveglòio della coscienza, La 207 Fiaccola, Ragusa 1986 (riedizione nel 1989); Snow, D.: Gli Indiani d’America — archeologia e civiltà, Melita, Roma 1987; L’America violata — Antologia della conquista (a cura di Pranzetti L.), Feltrinelli, Milano 1981; l’UTOPIA SELVAGGIA — Teoria e prassi della liberazione indigena in America Latina, La Fiaccola, Ragusa 1984; Busatta S.: Cavallo pazzo è morto! — Il nazionalismo Sioux e tante altre cose narrate da una femminista, Edizioni Senzapatria, Sondrio 1992 (il testo è assai critico sulla posizione assunta dei Sioux e demistifica parecchio dell’atteggiamento tipico di certa versione del “buon selvaggio”, proprio degli europei). Segnalamo, infine, alcuni saggi della rivista VOLONTÀ la cui redazione attualmente è a Forlì: - Clastres, P.: Il problema del potere nelle società primitive, n. 6 (1977); - L’anarchico e il selvaggio, n. 1 (1986) — tutto il fascicolo, monografico; - Uomini e lupi, n. 3 (1990), tutto il fascicolo, monografico; Nella stessa rivista la tematica del POTERE è stato oggetto di ampie riflessioni: - Potere autorità dominio, n. 2 (1983) — fascicolo monografico; - Il potere e la sua negazione, n. 3 (1983); - Creagh, R.: Il fascino della legge, n. 1 (1980); - Holterman, T.: Una concezione anarco-comunista della legge, n. 3 (1980); - Nel n. 4 del 1980 vedere gli articoli di Crespi, Flecchia, Colombo. IL CARCERARIO / LA REPRESSIONE / IL “CRIMINE” / LA PUNIZIONE - Foucault, M.: Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, Milano 1978; Foucault, M.: Microfisica del potere / Interventi politici, Einaudi, Torino 1977; Foucault, M.: (a cura di): Io, Pierre Riviere, avendo sgozzato mia madre...., Einaudi, Torino 1976 (II); Basaglia: La maggioranza deviante / L’ideologia del controllo sociale totale, Einaudi, Torino 1978 (VI); Goffman, E.: Asylum / Le istituzioni totali, Einaudi, Torino 1978 (VI); AA. VV.: Crimini di pace, Einaudi, Torino 1976 (II); AA. VV.: Psicologia dinamica Antropologia culturale Antropologia criminale, Ghisoni, Milano 1973; Rosenthal B.: Fine delle utopie del buon governo / Le politiche della repressione e le nuove forme di addomesticamento sociale, Arcana, Roma 1979; Gallo / Ruggiero: Il carcere in Europa, Bertani, Verona 1983; Corderp, F.: Criminalia / nascita dei sistemi penali, Laterza, Roma-Bari 1985; Ignatieff, M.: Le origini del penitenziario, Mondadori, Milano 1982; Il carcere imperialista, Controinformazione-Bertani, Milano-Verona 1979; Ricci / Salierno: Il carcere in Italia — inchiesta, Einaudi, Torino 1976 (IV); Invernizzi, I.: Il carcere come scuola di rivoluzione, Einaudi, Torino 1973; Greganti, G.: Carcere e comunità, Ed. Paoline, Roma 1976; Tesi di 208 laurea sul carcere/rario, di un compagno torinese che vuole mantenere l’anonimato; Foucault, M.: La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 1986; Jadis, P.: Piaceri e crudeltà storiche, Nerbini, Firenze 1953 (interessante per il resoconto sulla PUNIZIONE in diverse epoche e contesti storici); Ordine pubblico e criminalità, Mazzotta, Milano 1975; Rapporto da una scuola in carcere, Padova 1978; Vivian, R.: La fogna del comportamento sociale, Editrice Friulana, Udine 1977; Carceri e riforme, Atti del Convegno della Fondazione Luigi Einaudi, Gasperini Edit., Cagliari 1976; L’istituzione carcere nella società postindustriale / ricerca a “La Sapienza”, Stampa ECIR, Roma s.d.; Micozzi / Pais: La complessità carceraria / Un invito alla critica, Quaderno 1 del Centro di Documentazione Anarchica, Roma 1985; Salierno, G.: La spirale della violenza / Memoriale di un detenuto, De Donato, Bari 1969; Cavallina, A.: Lager speciale di Stato, Ediz. Senza Galere, Milano [1978?]; Guiso, G.: L’uomo senza diritti / Il detenuto politico, Collettivo Editor. Librirossi, Milano 1977; Vitale, G.: Delinquenza giovanile, Armando Armando, Roma 1978; Criminalizzazione e lotta armata, Quaderni d’informazione politica 1, Collettivo Edit. Librirossi, Milano 1976; Grupos marginados y peligrosidad social, Campo Abierto, Madrid 1977 (in Castigliano); L’amministrazione della giustizia in Italia / Convegno tenuto all’Università statale di Milano nel maggio 1973, Mazzotta, Milano 1974; Canosa / Santosuosso: Magistrati, anarchici e socialisti alla fine dell’Ottocento in Italia, Feltrinelli, Milano 1981; Merlino, F.S.: L’Italia qual’è / Politica e magistratura / Fascismo e democrazia, Feltrinelli, Milano 1974; Tanta gente: Come sempre meno libero, Bertani, Verona 1980; Bovio, G.: Filosofia del diritto, Anfossi, Napoli 1885; I cinque codici (risalenti alla metà dell’800, dopo la costituzione dello Stato italiano. L’edizione da noi consultata, essendo stata rilegata, non ha indicazioni); Molinari, L.: Il tramonto del diritto penale, Vulcano, Treviolo (BG) 1984; Mariani, G.: Nel mondo degli ergastoli, Torino 1954 (stampa a cura dell’autore, tip. Fratelli Garino); Fantazzini, H.: Ormai è fatta! Cronaca di un’evasione, Bertani, Verona 1976; Duval, C.: Memorie autobiografiche, Biblioteca del “L’Adunata dei Refrattari”, Newark 1929; Berkman, A.: Un anarchico in prigione, Anarchismo, Catania 1978; Beccaria, C.: Dei delitti e delle pene, Rizzoli, Milano 1950; AA. VV.: Beccaria e i diritti dell’uomo, Studium, Roma 1964. 625: libro bianco sulla legge Reale, a cura del Centro di Iniziativa Luca Rossi, Milano 1990; C’era una volta la Costituzione / Analisi della legislazione contro il terrorismo, Stampa Alternativa, Roma 1980; Ascheri, G.: Tortora storia di un’accusa, Mondadori, Milano 1984; Coordinamento Nazionale Anarchico contro la Repressione (a cura di): Dossier Gattinara / Storia di follia giudiziaria in provincia, Anarchismo, Catania 1984; Speciale Asinara / La settimana Rossa 209 (agosto-settembre 1978), Anarchismo, Catania 1978; Gentis, R.: Contro l’istituzione totale, Savelli, Roma 1974; Il caso Coco / Processo a Giuliano Naria, Quaderni d’informazione politica, Collettivo Edit. Librirossi, Milano 1978; Italia 1983 / Prigionieri processi progetti, Ediz. Cooperativa Apache, Roma 1983; Polizia / Controinchiesta su abusi ed eccidi delle forze dell’ordine in Italia dal 1943 al 1976 (a cura di Viole G. e Pizzola M.), Stampa Alternativa, Roma [1976?]; Tarantini, D.: La maniera forte, elogio della polizia / Storia del potere politico in Italia (1860-1975), Bertani, Verona 1975; Viola, G.: Polizia / Cronache e documenti della repressione in Italia (1860-1977), Bertani-Stampa Alternativa, Verona-Roma 1978; Vanni, R.: Trent’anni di regime bianco, Giardini, Pisa 1976; Cavallina, A.: Distruggere il mostro / San Vittore ’75-’76, Collettivo Edit. Librirossi, Milano 1977; Rizzo, G.: I segreti della polizia, Rizzoli, Milano 1953; Valcarenghi, M.: I manicomi criminali, Mazzotta, Milano 1975; Lo Giudice, E.: Processo penale e politica, Coop. Libraria Editr. Centofiori, Piacenza 1981; Collettivo Controinformazione Sardo: Dentro fuori oltre le mura — Documenti sulla lotta dei prigionieri sardi contro la deportazione ed il razzismo, Ediz. Arkiviu-Bibrioteka “T. Serra”, Guasila (CA)1989. Indispensabili i seguenti periodici: Il Bollettino dei Comitati contro la repressione, redazione Milano (in corso); Crocenera: bollettino anarchico di controinformazione sociale, redaz. Milano (non più pubblicato); Carcere informazione, Redazione Candeglia (PT), non più pubblicato; Anarchismo, redaz. Catania (in corso), numeri sparsi; Solidarietà Proletaria, redaz. Milano (in corso); Anarkiviu:bulhitinu bibriografiku de s’Arkiviu-Bibrioteka “T. Serra”, redaz. Guasila (CA), in corso (numeri sparsi, sulla condizione e denuncia di alcuni prigionieri sardi); Antagonismu: fuzu de su muymentu rivolutzionariu sardu, redaz. Orani, Quartu S. Elena, tutti e 4 i numeri (interventi del Comitato di Solidarietà con i detenuti Sardi in lotta — PPSD); lIBERASSIONE, Numero Unico del Comitato di Solidarietà PPSD, Gennaio 1990, Riprodotto a Guasila (CA). STORIA DELLA SARDEGNA E DEL BANDITISMO Carta Raspi, R.: Storia della Sardegna, Mursia, Milano 1971; Manno, G.: Storia di Sardegna, 5 Volumi (incluso studi di Martini), Tipografia Elvetica, Capolago 1840 (ristampa anastatica Ediz. 3T, Cagliari); Pais, E.: Storia della Sardegna e Corsica durante il dominio romano, 2 Volumi, Nardecchia, Roma 1923 (ristampa 3T, Cagliari); Pais, E.: Civiltà dei nuraghi / Sardegna preromana, Accademia dei Lincei, Roma 1909 (ristampa 3T, Cagliari); Struglia, G.: Sardegna nostra, Fossataro, Cagliari 1962; Branca, R.: Sardegna segreta, S.E.I., Torino 1956; Casula, F.C.: La Sardenya catalo- 210 aragonesa / Perfil historìc, Dalmau R., Barcelona 1985 (in castigliano); La Sardegna contemporanea (Boscolo / Brigaglia / Del Piano, Della Torre, Cagliari 1983; Tola, P.: Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, Tipogr. Chirio e Mina, Torino 1857 (ristampa 3T, Cagliari); Lamarmora, A.: Itinerario dell’isola di Sardegna, 3 Volumi, Tipogr. Alagna, Cagliari 1868 (ristampa 3T); Studi Ogliastrini, Ediz. Castello, Cagliari 1984; Cocco, F.: Dati relativi alla storia dei paesi della diocesi d’Ogliastra, Secondo volume, Tipogr. T.E.A., Cagliari 1985; Cocco, F.: Terzo volume di cui sopra, Cagliari 1986; Cocco, F.: Omicidi nei paesi della Sardegna Centro-Orientale dal 1600 al 1980, Tip. T.E.A., Cagliari 1988; Sotgiu, G.: Storia della Sardegna sabauda, Laterza, Bari 1984; Fiori, G.: La società del malessere, Laterza, Bari 1968; Ledda, A.: La civiltà fuorilegge, Mursia, Milano 1974; Marongiu, P.: Teoria e storia del banditismo sociale in Sardegna, Della Torre, Cagliari 1981; Corda, E.: La legge e la macchia / Il banditismo sardo dal Settecento ai giorni nostri, Rusconi, Milano 1985; Pirastu, I.: Il banditismo in Sardegna, Edit. Riuniti, Roma 1973; Secchi, P.: Per una sociologia del banditismo sardo, Dessì, Sassari 1972; Rossani, O.: L’industria dei sequestri, Longanesi, Milano 1978; Massaiu, M.: Mesina perché?, Fossataro, Cagliari 1976; Medici, G.: Relazione del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, Tipogr. del Senato, Roma s.d.; Guerrini, I.: L’anonima sequestri, Sardegna Nuova, Milano 1969[!!!]; Ghirotti, G.: Mitra e Sardegna, Longanesi, Milano 1968; Cabitza, G. (pseudonimo): Sardegna / Rivolta contro la colonizzazione, Libreria Feltrinelli, Milano 1968; Dessy, U.: Quali banditi? Controinchiesta sulla società sarda, 2 Volumi, Bertani, Verona 1977; Porru Coiana, G.: Lotte sociali e rinascita della Sardegna, Tipogr. Mulas, Cagliari s.d.; Sotgiu, G.: Movimento operaio ed autonomistico / La questione sarda da Lussu a Togliatti, De Donato, s.l. 1977; Centro Ragionale di Programmazione CENSIS: Sardegna / Scenario di una società che cambia, TEST, s.l. s.d.; R.A.S.: Atti della 2^ Conferenza Reg.le dell’emigrazione (1981), Tipogr. STEF, Cagliari 1983; Eleonora D’Arborea: Carta de Logu, A. Fulgoni, Roma 1805 (Ristampa 3T, Cagliari 1974); Il mondo della Carta de Logu: Atti del ciclo di conferenze sulla Carta de Logu (Oristano 1976), Ediz. 3T, Cagliari 1979;Del Piano, L.: Il processo della fame e il verdetto della paura — I fatti di Sanlòuri dell’agosto 1881..., ESA, s.l. 1982 (Stampa: Sardalito, Quartu S.Elena); Contu, G.: La questione nazionale sarda, Alfa Editr., Quartu S. Elena (CA) 1990; Contu, A.: Federalismo, autonomie, nazionalità, Alfa Editr., Quartu S. Elena (CA) 1992; Sardegna oggi: No! al parco del Gennargentu / Relazione al pubblico dibattito di Baunei (1969), Libreria Feltrinelli, Milano 1969; Carta Raspi, R.: Verso l’autonomia / La Sardegna dalla Prima alla Seconda guerra mon- 211 diale, Il Nuraghe, Cagliari 1944; Almanacco della Sardegna (a cura di F. Fiori), Ass. Stampa Sarda, Cagliari s.d.: Pintore, G.: Sardegna / regione o colonia?, Mazzotta, Milano 1974; Sotgiu, G.: Questione sarda e movimento operaio, Ediz. Sarde, Cagliari 1969; Sardegna al di la del mito / le radici della violenza (a cura di P. Follesa), Istituto di Psicoanalisi, Cagliari 1991; Birocchi, I.: Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna / provvedimenti normativi ... dal 1839 al 1851, Giuffré, Milano 1982; Cavalleri, C.: Sardegna / anarchismo e lotta di liberazione nazionale, Ediz. La Fiaccola, Ragusa 1983; Hobsbawm, E.J.: I banditi, Einaudi, Torino 1971: Bechi, G.: Caccia grossa / scene e figure del banditismo sardo, Gasperini, Cagliari 1973. Assai importanti sono stati, per la comprensione del modo di imporsi delle istituzioni giudiziarie-militari di Stato in Sardegna i seguenti testi autobiografici: - Ticca, G.: Io e la legge, Fossataro, Cagliari 1970; - Podda, L.: Dall’ergastolo, La Pietra, Milano 1970; - Costa, E.: Giovanni Tolu / Storia di un bandito sardo narrata da lui medesimo, Tip. Operaia, Sassari 1926; - Costa, E.: Il muto di Gallura / Racconto storico sardo, G. Tortu, Tempio (SS) 1912; - Calia, M.: Cantigu dae presone / Storia di ordinaria follia giudiziaria, Ediz. Arkiviu-Bibrioteka “T. Serra”, Guasila (CA) 1991; - Coccone, C.: Autobiografia / Zustiscia mala — La vera storia di un bandito sardo costruito su misura dal potere coloniale, Ediz. Arkiviu-Bibrioteka “T. Serra”, Guasila (CA) 1989. Un testo complementare al presente dossier è da ritenersi: Frarìa: “Forza Parìs” fallimento di un’operazione coloniale / Dossier Sardegna il conflitto nascosto, Ediz. Arkiviu-Bibrioteka “T. Serra”, Guasila (CA) 1992. 212 213 214
Scarica