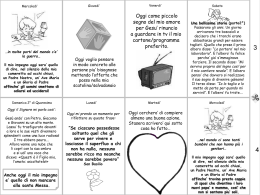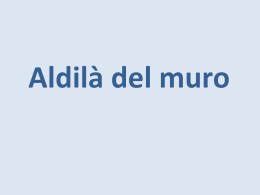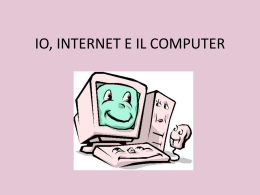Bad Clouds Writers Vol I Nota Writers Volume I è una raccolta di storie brevi scritte da alcuni scrittori che si sono candidati per essere autori per la Bad Clouds Agency Su ogni racconto non è stato effettuato alcun editing tranne che da parte di ogni scrittore. Quest’opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Per maggiori informazioni riguardo il progetto Bad Clouds visitate il sito http://badclouds. altervista.org 1 56 di Pasquale Aversano Stanza 56 del Dormicchio Hotel. L’avvocato Giulio Fermentus aveva appena posato la sua ventiquattrore sopra al letto della camera. Le prime cose che fece, dopo aver controllato l’interno della stanza, fu sistemare sul comodino i sonniferi, il cellulare spento e il portafogli bello pesante. Il suo respiro era agitato e la fronte sudata. Aveva trovato il nome dell’hotel su un quotidiano di scarsa importanza ed era certo che lì i paparazzi non l’avrebbero mai trovato. Si era anche assicurato di non far sapere della sua presenza in quell’edificio. Ovviamente, in cambio, aveva lasciato al custode una generosa mancia. La stanza che gli era stata affidata era piccola ma soddisfacente. Una volta aperta la porta, si accedeva a una piccola sala che fungeva da ingresso, salotto e stanza da letto. Sulla sinistra si poteva accedere al bagno mentre in fondo, c’era un’ampia finestra dai vetri opachi. Giulio era agitato, il suo ultimo caso era andato benissimo, aveva guadagnato come mai nella sua vita. Poteva permettersi una casa e un’auto nuova, oltre a poter saldare ogni debito che gli restava con i suoi rivali di poker. Sul piano economico, Giulio era pienamente soddisfatto. Quindi, perché essere agitati? Il problema era il piano etico. Un problema che lui raramente si poneva, ma quest’ultimo caso lo aveva turbato particolarmente. DRIN! DRIN! Improvvisamente, il telefono della stanza 56 iniziò a suonare. L’avvocato restò a fissare il telefono con disgusto, scuotendo il capo e stendendosi comodamente sul letto. Non aveva la benché minima voglia di rispondere. Voleva solo rilassarsi e non pensare. DRIN! DRIN! Il telefono riprese a suonare dopo pochi minuti ma Giulio non sembrò reagire a quel suono, restando comodamente disteso sul letto a fissare il soffitto giallastro. 3 Fuori era bel tempo e dalla finestra era possibile osservare i numerosi passanti impegnati nella loro vita. E pensare che ognuno di loro, con le giuste costruzioni, poteva diventare un potenziale omicida. Giulio questo lo sapeva fin troppo bene. Eccome se lo sapeva. DRIN! DRIN! Il telefono riprese vita e l’avvocato imprecò bruscamente, portandosi seduto sul letto a fissare il telefono. Ma non rispose, attendendo il cessare di quel fastidioso trillare. BUM! BUM! Questa volta la fonte del rumore fu la porta d’ingresso della stanza 56. Qualcuno stava bussando e anche con una certa urgenza. Giulio sospirò e, con scarsa voglia, aprì la porta. Non c’era nessuno. L’avvocato si affacciò adocchiando il corridoio elegante che univa le camere tra loro. Niente. Non c’era anima viva e tutto era splendidamente silenzioso. Giulio richiuse la porta, facendola sbattere. Il nervosismo non lo aveva ancora abbandonato e non sembrava intenzionato a farlo. Non appena si avvicinò al letto, infatti... DRIN! DRIN! ... il telefono riprese vita. « PRONTO!? » in uno scatto d’ira, Giulio afferrò la cornetta del telefono e se la portò all’orecchio rispondendo con tono agitato ed isterico. «...» « Pronto?! Chi è!? » Niente, dall’altra parte non si sentiva assolutamente niente. L’avvocato attaccò e si guardò intorno. Da quando era uscito dal tribunale, il suo respiro non si era ancora regolarizzato, così come non aveva smesso di sudare. Sotto le braccia, sulla camicia a quadretti celesti che indossava, si erano formati due grossi e disgustosi aloni giallastri. La sua fronte continuava a essere vittima del sudore. 4 DRIN! DRIN! «Pronto?! PRONTO!? Rispondete dannazione... se è uno scherzo, non è divertente!» Questa volta, dall’altra parte della cornetta, si sentì un respiro seguito da un leggero sbuffo. « Ti ho sentito! Chi sei? Che cosa vuoi?! Ti avverto che sono un avvocato, non ti conviene giocare con me! Non è giornata! » « Eheh.» « Cosa c’è da ridere?! CHI sei?! » « Eheheh. » «Ho capito. Ti piace perdere tempo. Addio. » e attaccò. Dalla risata, l’interlocutore di Giulio sembrava essere un uomo. Ma cosa voleva? E soprattutto, come poteva chiamarlo nella stanza? Possibile che fosse il custode? In effetti, l’uomo gli era sembrato tanto anziano quanto rimbambito, seppur la mancia non se l’era fatta di certo scappare. Ma perché un perfetto sconosciuto doveva dare fastidio ad un cliente generoso, famoso e ricco? DRIN! DRIN! « PRONTO!? » «Abbassiamo i toni. » era la stessa voce della risata di poco prima. Una voce familiare ma di cui non riusciva a ricordarsi il viso. « Chi sei? » « Non ha importanza. » « Cosa vuoi da me? » « Dovrebbe saperlo bene, avvocato. » « In che senso? » « Suvvia, sta sudando come un maiale sotto al sole. » « Cerchi rogne? Posso denunciarti e rovinarti la vita. » « Lo so bene. » « E allora dimmi cosa diavolo vuoi da me o smettila di chiamarmi. » «Lei non può darmi ordini. » « Allora non ci siamo capiti. Chiunque tu sia, io posso distruggerti. Non ci metterò molto a risalire a te tramite la rete telefonica. Da lì a decidere di accusarti per un qualsiasi crimine sarà un gioco. Ti farò restare in carcere fino alla morte. » 5 «Ahahahahah! » Giulio tentennò per alcuni secondi, stringendo la cornetta del telefono e spostando gli occhi verso la finestra della stanza « Ti fa tanto ridere questa cosa? « Sì. » « Ma davvero? Come mai? Spiegamelo, perché voglio capire cosa ci sia da ridere. Inizio a pensare che tu sia mentalmente instabile il che mi agevolerà non poco quando ti trascinerò in tribunale. » « AHAHAHAHAHA! » « SMETTILA DI RIDERE! » e attaccò bruscamente. Giulio ansimava e continuava a sudare. Era inutile, non riusciva a calmarsi e quel tizio al telefono non faceva altro che alterargli ulteriormente i nervi. DRIN! DRIN! «BASTAAAA! » si ritrovò a urlare da solo contro il telefono che continuava a squillare incessantemente. DRIN! DRIN! Niente, Giulio si allontanò dal telefono imprecando e massaggiandosi la fronte. « Non le piace il telefono, avvocato? » la stessa voce dello sconosciuto iniziò a riempire la stanza 56. Giulio sgranò gli occhi e osservò il telefono. La cornetta era al suo posto, nessuno l’aveva toccata. Ma quindi la voce da dove proveniva? « Ma cosa?! Da dove stai parlando?! » « Eh, sapesse... Almeno così non può concludere la nostra chiacchierata. Eheh. » L’avvocato iniziò a vagare per la stanza, si affacciò dalla finestra e poi si ritrovò a fissare la parete destra. Lì. Era da lì che sembrava provenire la voce dello sconosciuto. Possibile che a parlargli era il vicino di stanza? « Che altro vuoi disgraziato?! » « Attaccare il telefono in quel modo è maleducazione. » « Anche assillare gli sconosciuti lo è. » « Mi vuole trascinare in tribunale perché rido al telefono? » « Oh, non sono così idiota. Se insisti nel rompermi le scatole, come ho 6 già detto, non impiegherò molto a inventare un’accusa per incastrarti. Anzi, inizia a cercarti un avvocato decente. Anche se sarà inutile.» « Inventare? » « Non lo conosci come verbo? Ti è nuovo? » « Avvocato, lei inventa le accuse? » « Per tipi come te farei ben altro. » « Ahi ahi. » «Fatto male? » « Non io, lei. » « Io sto benissimo. » «Per ora. » « Mi stai minacciando? Così non avrò bisogno di inventare niente. » « Non ho bisogno di muovere un dito, avvocato. Lei si sta uccidendo da solo. » « Che vuoi dire?! » « Vogliamo parlare del suo ultimo caso in tribunale? » « Lo sapevo. Sei un dannato e viscido giornalista. » « Non ne vuole parlare? » « NO.» « Perché mai? » « Perché non rilascio interviste, specialmente quando sono in un hotel per rilassarmi! » « “Rilassarsi”, bella questa. Ma se la sua vita è un relax continuo. » « Detto da un giornalista... » « Un relax che costruisce sul sangue e sulle lacrime della gente. » « Gente colpevole. » « Come una ragazza che, picchiata dal proprio fidanzato, finisce in prigione. » « Lui aveva pagato di più. » « Quindi chi ha più soldi è innocente? » « Ho capito, ti piace provocare eh? Perché non la smetti di parlarmi di nascosto ed esci fuori, umh?» « Così mi uccide come ha fatto col suo ultimo cliente? » « Non ho mai toccato nessuno. » « No?E i cadaveri di suicidi e colpevoli innocenti? Quelli non li conta?» « Sono un professionista. » 7 « Lei è un serial killer. » « Le mie mani sono pulite. » « E la sua coscienza?! » « BASTA! - esclamò di colpo Giulio, voltandosi contro il muro e iniziando a prenderlo a pugni - Esci fuori! » « Ahahahah! Lei è divertente avvocato. Doveva fare il comico. » « Io ti ammazzo! » « Visto? avevo perfettamente ragione. » « Vieni fuori, lurido bastardo!» Giulio continuava a prendere a pugni la parete fino a farsi sanguinare le mani. Ma non provava dolore, solo cieca e furiosa rabbia. « Avvocato ho un’altra domanda per lei. » « Tienitela, non voglio saperla...» imprecò l’avvocato, guardandosi le mani insanguinate e indietreggiando di qualche passo. Il muro era ancora lì dinanzi a lui, perfettamente integro. « Come fa a prendere sonno la notte? Usa diversi medicinali da come vedo. » « Io dormo ben... come fai a sapere dei medicinali?! » « Semplice, sono lì, sul suo comodino. » Giulio sgranò gli occhi e si voltò a guardare il comodino che stava vicino al letto della camera. I suoi sonniferi non erano stati mossi. Erano ancora lì, vicino al portafogli e al cellulare. «Come hai fatto a vederli? Dimmi come diavolo hai fatto?! » l’avvocato tornò ad urlare contro il muro, studiandolo con ravvivato interesse e rabbia. « I miei occhi funzionano ancora, avvocato. » « I tuoi occhi eh? Ci sono dei buchi che collegano le due stanze! Ecco perché ti sento così chiaramente... » imprecò, iniziando a togliere quei pochi e anonimi quadri che decoravano la parete. Niente, non c’era alcun foro o qualcosa di simile. Il muro era perfettamente integro e apparentemente spesso e resistente. Giulio fece viaggiare le sue mani lungo l’intero perimetro della stanza, in cerca di crepe, buchi o fessure, ma senza alcun riscontro positivo. « Ha finito di smontare la stanza? » « Se ti prendo...» « Cosa? Cosa mi fa se mi prende? Mi uccide? Devo ricordarle che mi 8 ha già minacciato a sufficienza? » « Ti faccio a mille pezzi. » « Il pezzo più grande quale sarà? » « Zitto. Devi stare zitto! » « Suvvia, avvocato, si arrenda. » « A cosa?! A chi?! A un pazzo che parla nascosto dietro ad un muro? Non stai bene. Devi farti curare. » « Visto? abbiamo un punto in comune io e lei. » « Eh?! » « Già, ha sentito bene. Abbiamo un punto in comune. » « Quale sarebbe?! » « Dobbiamo curarci. » « Io sto benissimo! » « Come si può stare bene quando si hanno le mani sporche di sangue e la coscienza in pasto alle fiamme dell’inferno? » « Ho detto che ho le mani pulit... » la frase gli morì in gola. Si guardò le mani sporche di sangue, il suo sangue. « Inizia a vedere la realtà, avvocato? » « Lasciami in pace. » « Abbiamo quasi finito, non si preoccupi. Piuttosto, mi dica, com’è sorridere alle telecamere sapendo che stiamo mentendo al mondo e a noi stessi? » « Telec... ora ho capito! Telecamere! Ci sono telecamere nascoste, microfoni, pulci... microspie! » Giulio si spostò per la stanza, rovesciando sedie, smuovendo il lenzuolo del letto e tastando ogni parete « Vuoi incastrarmi! Per chi lavori?! » guardò perfino sotto al letto, tastando la rete del materasso. « Il suo si può chiamare lavoro? » « TU per chi lavori?! » sbraitò, continuando a sudare e a cercare per tutta la stanza. « Risponda alla mia domanda se vuole che io risponda alla sua. » « Sì, il mio è un lavoro al contrario del suo! » « Lo ha detto.» Giulio imprecò nuovamente e prese a calci una parete «Dove sono?! Dove sono le videocamere?! » « Ma pensa davvero che sia necessario spiarla per incastrarla? Lei si è già rovinato da solo. I suoi migliori clienti sono criminali che continueranno a chiamarla per ogni loro problema e lei sarà costretto a proteggerli a scapito di innocenti. E se lei oserà anche solo pensare di contraddirli... sappiamo benissimo cosa le succederà. » « ZITTO. » « Ma non si è chiesto come so queste cose su di lei? » « Non so di cosa stai parlando. Nego tutto. Nego tutto!!! » « So cosa prova. Quante notti insonni. I dolori di testa. Il sudore incessante. I mancamenti. Gli incubi. Va ancora in chiesa a pregare? » « ZITTO. » « Che poi che ci va a fare in chiesa? Non si confessa neanche. » « Non ho nulla da confessare!!! » « E i morti? » « Si sono uccisi da soli!!! » « Perché lei li ha incastrati. » « Se erano veramente innocenti si sarebbero protetti da soli. » « Idiozie! Lei ha protetto omicidi seriali. Sono innocenti quelli?! » « ZITTO! BASTA! » « Lei fa schifo, avvocato. Lei ha sputato sul suo mestiere e sulla sua vita. La nostra. » « ZITTO! » « Non si vergogna? Che cosa dirà a suo figlio quando nascerà? » « NON METTERE IN MEZZO LA MIA FAMIGLIA! » « Sua moglie incinta... povera donna. Non sa niente di tutto questo. E lei deve proteggerla dai suoi stessi clienti. Quei clienti che le hanno dato i soldi per conquistarla con auto e gioielli di lusso. Gli stessi soldi con cui ha comprato la casa. Gli stessi soldi che ora la tengono lontana da lei! » « ZITTO! Basta... ho detto basta... non voglio più sentire... non voglio... - Giulio iniziò a indietreggiare, sbattendo contro la finestra, aprendola di colpo - Basta... zitto...» «Abbiamo sbagliato e ora dobbiamo pagare. Dobbiamo dire la verità o continueremo a perdere altri pezzi! » « No, zitto. Non c’è verità... non c’è...» « Non possiamo vivere così, lo sa bene. » « No... no... » Giulio si voltò, guardando fuori la finestra. « Non è fuggendo che risolveremo le cose. Siamo forti, possiamo. » « No... no...» « POSSIAMO! » « ZITTO! » La discussione cessò di colpo. La stanza 56 restò improvvisamente priva del suo ospite. 56, “la caduta”. Tombola! *** Possibile che Giulio Fermentus si era suicidato lanciandosi dalla finestra della stanza del Dormicchio Hotel? Dalle analisi della polizia e dal dire del custode dell’albergo, per tutto il tempo che Giulio è stato nella stanza 56, non ha ricevuto alcuna chiamata al telefono né ha avuto modo di interagire con i vicini di stanza visto che queste erano vuote. C’è chi dice che la giustizia ha perso un elemento importante e chi, invece, festeggia la caduta di un demone venduto al male. L’albergo di Bud Bambino Ricordo ancora quel giorno quando io e Ken, amici da sempre, ci eravamo recati in agenzia per scegliere, dopo un anno di studi, la nostra vacanza. Avevano l'intenzione di visitare l’Italia, perché dei nostri colleghi ci avevano raccontato delle storie veramente entusiasmanti sui loro viaggi nel Bel paese. Mentre la ragazza dell’agenzia mostrava le brochure di posti incantevoli come la Toscana, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il mio amico esclamò: «JD, questo è il posto per noi!!!» «Fai vedere??» dissi, prendendo l’opuscolo che Ken teneva in mano; era un paese della Liguria, le foto erano incredibilmente belle, spaziavano dalla collina al colore cristallino del mare, piccoli paesi decoravano il promontorio con le loro luci la sera. Ero rimasto anch’io incantato da quelle immagini. Una frase in particolare aveva attirato la mia attenzione: “Vieni a scoprire le Cinque Terre” così, chiesi alla ragazza cosa fossero; lei spiegò che le Cinque Terre sono un tratto della costa ligure che godono, ogni estate, di un affluente turismo, difatti, proprio in quei tratti della riviera, è anche possibile incontrare personaggi famosi italiani e stranieri. Continuò la sua spiegazione facendoci vedere sullo schermo del computer gli altri luoghi da poter visitare, i locali più frequentati dai ragazzi e qualsiasi altra forma di divertimento desiderassimo. Tutto ciò ci sembrò spettacolare e, senza pensarci ulteriormente, optammo per la Liguria; la ragazza ci fece vedere una serie di alberghi ma Ken rimase colpito da uno in particolare, un vecchio fortino su un promontorio che si affacciava sul mare. Avremmo preso l’aereo fino a Genova, per poi spostarci in bus fino a La Spezia e, in taxi, fino all’albergo in un paesino in provincia di Lerici. Ricordo, con estrema chiarezza, l’ansia che accompagnò il giorno della partenza, scaturita dalla paura di perdere l’aereo; così arrivai, con netto anticipo, all’appuntamento. Ken, invece,arrivò con la calma che lo contraddistingueva sempre, eravamo agli opposti forse era per quello che eravamo così legati. Alle nove e trenta ci avviammo al gate d’imbarco; il viaggio durò, in tutto, quattro ore che, fra una chiacchiera e l’altra, passarono velocemente. L’unico sbattimento furono i bagagli, sempre da movimentare, L’albergo era un fortino ristrutturato, passammo col taxi sotto l’arcata principale e scendemmo proprio nel giardino che portava all’ingresso, il giardinetto spezzettato da piastrelle in pietra viva finiva, di colpo, sulle alte mura esterne che recintavano l’albergo, superando il portone il piano terra aveva sulla sinistra il banco dell’accettazione, mentre, sulla destra un piccolo salottino con una grossa televisione accesa; in quel momento, stavano trasmettendo una soap locale. Al centro c’erano le scale che portavano al ristorante, mentre le camere erano ubicate ai piani superiori. Nella hall ci aspettava la proprietaria, un’anziana signora con i capelli grigi, il corpo leggermente ricurvo e magro con con gli occhi semi chiusi. «Buongiorno» dicemmo in contemporanea. «Buongiorno, voi dovete essere il signori Van Cramer e Shene, dall’Olanda» disse in un perfetto inglese. «Si, siamo noi» rispose Ken. «Bene, lasciate pure i documenti al banco e vi accompagno nella vostra camera» disse. Lasciammo i documenti e seguimmo la signora dall’aria gentile; salendo le scale mi accorsi che il soffitto era molto alto, tanto che si poteva notare l’ammodernamento del fortino con l’aggiunta di piani ammezzati e stanze soppalcate. Erano in tutto tre i piani che, nonostante i recenti rinnovamenti, mantenevano alcuni tratti distintivi del periodo di costruzione, come ad esempio alcune pietre che costituivano le pareti. Le stanze erano una di fronte all’altra e nel mezzo non vi era un corridoio ma un salottino in stile moderno, le porte erano in abete, anticipando così lo stile rustico delle stanze. Entrati, notammo subito dei quadri che raffiguravano il fortino durante i secoli; durante i lavori di restauro era- no stati aggiunti anche i balconi. Mi colpì soprattutto una foto dove si intravedeva un casolare che, fino a quel momento, non avevo notato, era dello stesso periodo del fortino e dell’arcata principale. Il resto della stanza aveva due letti singoli, sul lato destro sotto i quadri, due comodini, una scrivania e un grande armadio. Disfacemmo le valige e, per l’ora di cena, andammo al ristorante al piano inferiore. La sala del ristorante era molto grande anche se con pochissimi tavoli, capimmo subito che non avevano molti posti letto e che, soprattutto, i clienti erano pochi; pensammo fosse dovuto all’orario, quindi non ci preoccupammo molto. Finito di cenare tornammo in camera dove ci addormentammo fra le chiacchiere, evidentemente stanchi del viaggio appena concluso. La mattina seguente ci svegliammo tardissimo, ma in tempo per pranzare in albergo, nella sala, oltre a me e Ken, erano occupati altri due tavoli. Il nostro era il primo di destra avanti a noi c’era una coppia di ragazzi, evidentemente appena arrivati, più avanti una famiglia di quattro persone. Finito di pranzare ci spostammo nella hall, per riposare un po’ prima di andare in giro per la città. Fu proprio in quel momento che vidi un quadro che non avevo visto il giorno prima, raffigurava una bambina, una bellissima bambina, con occhi e capelli scuri. Il quadro era sopra un vecchio mobile al centro ed aveva, oltre una antica cornice, anche due tende rosse ai lati, come una specie di sipario, dove il quadro, appunto, faceva da scenografia ad un palco immaginario. «JD che fai lì impalato? Dai che dobbiamo andare in spiaggia!!! Vogliamo iniziarla sta vacanza da urlo o dobbiamo stare a fare i babbei qui nella hall??!» sbraitò Ken. Distolsi lo sguardo dal quadro ed andai fuori per seguire il mio amici; uscendo, incontrai la proprietaria e le chiesi: «Scusi, signora ma ho visto quel quadro, è lei la bambina del dipinto?» . «No, giovanotto, è lì da quando il mio trisavolo comperò questo hotel, prima ancora che con la buon anima di mio marito decidessimo di cambiare la destinazione d’uso. Abbiamo avuto quel quadro, sempre lì, non l’abbiamo mai tolto. Come disse il proprietario del fortino durante l’atto di vendita, nel quadrò vi è rinchiusa l’essenza della figlia morta durante un terribile incendio, dove fu distrutto il casolare che si vede raffigurato in molte stanze.» rispose gentilmente. «Capisco, quindi è un ricordo. Grazie della risposta.» dissi salutandola. Ken era fuori sotto la grande arcata d’ingresso e cercava di leggere la mappa del paesino per dirigersi verso il mare, dato che dal fortino era presente solamente uno strapiombo che finiva nell’acqua, che non offriva possibilità di discesa. Facemmo quindi il giro del paese, incontrando molta gente; ricordo che una volta arrivati al centro della cittadina l’asfalto lasciava spazio a pietre incastonate nel cemento, quei vicoli molto stretti ci facevano apprezzare i rumori del pomeriggio estivo. Ad un certo punto, con Ken, osservammo un paio di ragazze uscire in pareo e bikini e decidemmo di seguirle perché di sicuro loro sapevano come arrivare in spiaggia. Quel pomeriggio passò velocemente, fra una sgamata e l’altra alle ragazze che prendevano il sole; entrando in acqua, io e Ken provammo a fare conoscenze con le nostre coetanee ricevendo rifiuti, per timidezza, agli inviti a prendere una granita insieme. Dopo aver fatto la doccia e aver cenato uscimmo dall’albergo con la speranza di aver più fortuna rispetto al pomeriggio, anche grazie all’alcol che girava nei locali. Conoscemmo quella sera due ragazze italiane, che eravamo riusciti ad abbordare offrendo loro da bere, Melissa e Cristina, entrambe coi capelli scuri; avevamo scambiato poche chiacchiere ma eravamo subito riusciti a scambiarci i numeri. Ci eravamo dati appuntamento per la mattina successiva per andare a mare, le ragazze avevano proposto un terrazzino dove andavano tutti, in modo da presentarci altri loro amici. Tornati in stanza di colpo fui preso dalla paranoia: mentre cercavo di addormentarmi mi venne in mente l’immagine del quadro e mi ricordai di aver visto, anni prima in un programma televisivo, la storia di una bambina il quale spirito girava per un casale in Italia. Non ricordavo dove fosse e detti per scontato che quell’albergo non fosse il luogo dei fatti che venivano narrati e cercai disperatamente di liberarmi da quel pensiero perché certe storie mi mettevano in agitazione; però, più cercavo di non pensarci più i pensieri tornavano prepotentemente, iniziai ad agitarmi nel letto tanto che Ken disse: «Minchia, oh, vabbé che abbiamo conosciuto due top class, ma non c’è bisogno di agitarsi così. Domani ci proviamo meglio.» «No, Ken non è come pensi, non c’entrano loro ma quel dannato quadro.» risposi in preda all’ansia. «Ma che cazzo, JD sai che ti caghi sotto di ste storie e sei andato a rompere i coglioni a quella povera vecchia. Dormi che domani ci attende una grande giornata.» disse Ken interrompendo la conversazione. Tentai di addormentarmi e, stremato, ci riuscii verso le cinque del mattino, anche se il sonno non fu lieto come quello della sera precedente. Il mattino dopo uscimmo presto dall’albergo, Ken era euforico e voleva andare subito al terrazzino sul mare, il posto che ci avevano indicato le ragazze. Stranamente però il piccolo paesino era più vuoto rispetto al giorno prima, desolato, quasi come se fosse spento. Non ci demmo molta importanza pensando che forse gli abitanti erano tutti a godersi il sole estivo. Così ci incamminammo per la scogliera, ci accorgemmo di essere arrivati a destinazione dalla moltitudine di gente che ci circondava. Ken decise di mandare un messaggio alle ragazze in modo da venirci incontro. Dopo cinque minuti Melissa arrivò e ci porto dagli altri ragazzi. Anche se noi eravamo interessati a ben altro, ci presentarono i loro amici; dalla conversazione capimmo che loro non erano del posto ma di un paesino lì vicino e si spostavano con la macchina per arrivare al mare. Ad un tratto, mentre parlavamo, un ragazzo del gruppo iniziò a raccontare una storia riguardante alcuni turisti scomparsi improvvisamente dalla propria stanza d’albergo. Non ricordava il nome dell’albergo, però gli altri confermarono la storia e dissero che l’estate scorsa erano sparite ben tre persone. Io ero abbastanza spaventato e cercai un modo per distrarmi, cosi dissi loro se gli andava di giocare in acqua col pallone. Restammo in spiaggia per tutta la giornata, invitando alla fine le ragaz- ze in albergo per cenare insieme da qualche parte in paese. Tornati in stanza Ken disse: «Non pensare minimamente alla storia che ci ha detto Luca! Non voglio passare un’altra notte con te che tremi nel letto ac- canto. Pensiamo di farci le tipe e almeno togliere dalla nostra lista due cose: farlo con due italiane e farlo con due donne nella stessa stanza.» «Non ci stavo pensando proprio – mentii – magari le due sono facili da portare a letto.» «Tutto dipende da noi, se ti fai prendere dalla paranoia magari va male, se stai preso bene chissà.» sentenziò. «Avrai ragione, solo che tutta sta storia non mi convince, e poi onestamente siamo in pochi in questo albergo, e....» «E allora sei stronzo, ti ho detto di non farti prendere dalla paranoia e subito inizi a dirmi i tuoi pensieri circa la storia di Luca? Prendila come uno scherzo che ti hanno fatto, perché si vedeva nettamente che eri terrorizzato.» «Non c’è bisogno di fare tante storie, era solo un pensiero, onestamente prima dici di non pensarci, facendomi tornare alla mente la storia, poi cerco di esprimere mezzo pensiero e mi aggredisci. Sei proprio fuori di testa.» «Non è che sono fuori di testa è che fra tre giorni torneremo a casa e voglio aver almeno scopato con una italiana.» «Ma si dai, stasera se non va con queste le molliamo e ci buttiamo su altre, tanto sappiamo dove vanno tutti ora.» dissi. Erano ormai le nove e mezza, quando Melissa e Cristina ci raggiunsero in albergo, tutto stava procedendo bene quella sera, Melissa aveva un vestito nero che finiva con una gonna non troppo corta, mentre Cristina ne aveva uno bianco a pois con una profonda scollatura a V: entrambe mostravano il loro fisico tonico e abbronzato. Andammo in un ristorantino che ci aveva consigliato un passante, volevamo fare bella figura e lui, viste le ragazze, ci rassicurò. Il locale si presentava a noi con una piccola veranda in legno, dentro c’erano due divanetti ed un tavolino, più un piccolo banco con due sgabelli, entrati dalla porta principale la sala era molto elegante, c’erano molti tavoli occupati, si vedeva però che era uno di quei locali lussuosi, un cameriere che ci venne incontro ci accompagnò al tavolo, era situato sulla sinistra della sala, notammo subito una particolarità del posto, i tavoli non erano quadrati o rettangolare ma avevano forma circolare e tutti erano apparecchiati in grande stile. Nell’attesa di ordinare parlammo un po’ dei nostri interessi, scoprimmo che Cristina era appassionata di arte, mentre Melissa di scrittura: entrambe infatti erano desiderose di fare un viaggio in giro per le capitali artistiche andando nei teatri, nelle mostre, cose che sia a me sia a Ken interessavano relativamente. Dalla nostra dicemmo che eravamo appassionati di videogame e che per noi anche quelli erano una forma di espressione artistica, ma le ragazze guardandoci perplesse scoppiarono a ridere. Alla fine la serata trascorse fra una risata e l’altra. Forse avevamo fatto centro, così Ken le invitò in albergo con la scusa di prendere un caffè nella hall. Entrati un po’ per l’ora tarda non vedemmo nessuno, ci accomodammo nel salone cercando di fare meno rumore possibile, Ken andò verso il bar sperando che qualche cameriere si presentasse, era tutto acceso, così Melissa disse: «Se vuoi provo a farlo io?» «Sicura di saperlo fare??» domandò il mio amico. «Beh se un’italiana non sa fare il caffè potrebbe essere un dramma nazionale.» rispose ridendo la ragazza. «Ok, ok mi fido.» iniziò a preparare i quattro caffè mentre noi ci eravamo spostati al bancone del bar. Melissa, ci mise i caffè sul bancone e si mise seduta con noi sugli sgabelli, era strano ritrovarsi in un albergo senza nessuno della proprietà. Ad un tratto una signora entrò urlando facendoci girare di scatto «Aiuto, aiuto, qualcuno mi aiuti...mia figlia...non trovo più mia figlia...» disse in italiano. «Si calmi signora, non capiamo quello che sta dicendo.» dissi «Ha bisogno di aiuto, credo abbia perso la figlia....» ci disse Cristina traducendo per noi. Ken disse alla signora se riusciva a tradurre in inglese, ma lei negò con un cenno del capo, così si fece aiutare da Cristina. « Signora ci spiega cos’è successo?» domandò la ragazza. La signora aveva sui quarant’anni, leggermente in sovrappeso, capelli scuri come i suoi occhi, aveva un abito tendente al blu e delle ballerine ai piedi. «Eravamo in macchina, qui vicino, quando mia figlia ha visto un cane in mezzo alla strada, siamo scese per prenderlo con noi, ma... Poi lei è corsa via... Ed ora non so più dove trovarla... Aiutatemi, per favore!!» disse scoppiando a piangere. Ken decise di andare fuori a cercare la bambina con la signora, io dissi a Cristina di andare con lui in modo da continuare con il suo ruolo di traduttrice mentre io e Melissa avremmo cercato qualcuno dell’albergo disposto a darci una mano. I ragazzi uscirono con la signora mentre noi iniziammo a cercare nelle stanze superiori se ci fosse qualcuno, dopo circa un’ora di continui bussare alle porte ci arrendemmo. Provammo, quindi a chiamare aiuto con il telefono ma mi accorsi che non era presente. Facemmo un altro tentativo con i cellulari: «Maledetto telefono, ha ripreso a non farmi effettuare le chiamate!!!» imprecai credendo che la sfiga si fosse accanita contro di noi. «No, JD, qualcosa non va perché anche a me....» «Ma che cazzo succede??!!!» «Sembra tutto così surreale, è la prima volta che mi capita di andare in un albergo completamente vuoto!!!» mi disse innervosita. Dopo altri dieci minuti di inutili tentativi entrò, dalla porta, Cristina. «Che ti è successo??» domandai, correndo incontro alla ragazza che stava perdendo sangue dalla testa. «La signora... La signora ha preso Ken... Io... Io stavo andando con loro mi sono fermata un attimo per parlare con lei e mi ha colpito con un sasso mentre Ken era lontano, stava correndo verso il sentiero che ci ha indicato... Quella pazza!!» disse biascicando. «Che sentiero??? Dove??? » le urlai preso dal panico. Il mio amico era in balia di chissà che psicotica ed io dovevo andare ad aiutarlo. «Sono andati verso la parte esterna del giardino... sentivo la signora dire che la bambina era entrata nel casolare... E... » disse; un attimo dopo svenne. «Prendi dell’acqua fredda e pulisci la ferita con dello spirito, io vado a stenderla sul divano» ordinai a Melissa. Appoggiai Cristina mettendole la testa delicatamente sul braccio del divano e mi girai guardando in direzione del quadro. «Oh merda!» dissi saltando all’indietro, mentre arrivava verso di me Melissa con delle garze e dello spirito. «Oh porca merda!!!» ripetei indicando il quadro «Cosa???» domandò lei, voltandosi nella direzione del mio sguardo. Il quadro era caduto dalla sua postazione spaccandosi da un lato, al suo interno c’era la stessa ambientazione ma era sparita la figura della bambina. «Che ha il quadro che non va???» mi chiese allarmata Melissa. «La bambina, cazzo, la bambina che era raffigurata nel quadro, è sparita!!» le dissi terrorizzato. «Di che bambina stai parlando??» ancor più allarmata. «Vedi questo spazio vuoto? – dissi avvicinandomi alla cornice qui c’era una bambina ed ora non c’è più...» dissi «Luca, la storia che diceva Luca, parlava di una bambina giusto?» domandò. «Si, ed ho paura che sia questo il luogo che non ricordava...» dissi tremante. «Ora tutto è più chiaro siamo capitati in un albergo infestato, ecco perché non c’è nessuno...Li avrà fatti sparire il fantasma.... Non dovevamo venire qui, perché siamo venute qui??? Potevamo andare in spiaggia??? Ad un bar qualsiasi??? Perché siamo venuti qui??? »disse lei sbattendo sul tavolino le garze. Corsi verso di lei e l’abbracciai «Calmati, calmati non è il momento di perdere il controllo.» dissi tentando timidamente di rassicurarla, appena si calm ò le dissi di tornare ad occuparsi di Cristina mentre io andavo a cercare nel buio Ken. Ricordandomi della storia che mi aveva raccontato la vecchia proprietaria mi diressi verso la parte del giardino dove, una volta, era ubicato il casolare. «Ken??? Ken sei qui??? Ken, amico, sono io JD.» gridai, intorno a me l’aria era secca, si sentiva odore di legna bruciata, ma non riuscivo ad udire il mio amico, anche se provavo una sensazione strana, quasi come se qualcuno mi stesse osservando. «Ken, dai Ken, rispondimi! Cazzo! Non puoi mollarmi proprio ora??? » continuai a parlare urlando. Volevo farmi sentire, anche da Melissa e Cristina in modo da far capire loro dove fossi. Ad un tratto mentre mi aggiravo per il giardino completamente scuro, sentii in lontananza come un sibilo, uno squittio, pensando che ci fossero dei topi cercai con il cellulare di farmi luce e trovare un pezzo di legno, ma nulla. Continuai a camminare verso quel suono, piano piano divenne più costante, non erano animali ma, sentivo qualcuno piangere pensando fosse il mio amico. Con quella poca luce che mi aiutava, arrivai a vedere un ombra scura. «Ken??? Ken sei tu??? » «No... Io sono Laura... Papà e mamma mi hanno lasciato qui sola in casa, io non volevo... Stavo giocando quando per colpa di un tuono mi sono spaventata ed ho fatto cadere il lumino.... Fa caldo qui....» Cercai di illuminare e la bambina col cellulare, aveva i capelli neri, un vestito nero,bruciacchiato e cercai di vederla in viso preoccupato che non fosse carbonizzato ma, invece era soltanto sporco di cenere e fumo «Che ci fai qui?» domandai stentando un italiano pessimo. «Aspetto i miei genitori, mi hanno lasciato con la serva ma non si è svegliata.... Ho provato a chiamarla ma niente...» mi rispose singhiozando. «Dove sarebbe??» le chiesi. La bambina mi afferrò la mano e mi porto nel buio, verso sinistra, era come se conoscesse a memoria la strada. «E’ lì!.» disse indicando con la mano qualcosa nel buio. Alzai la luce del cellulare verso dove indicava la bambina e piano piano mi avvicinai. Era la signora che avevamo visto prima in albergo, o meglio quel che restava, era un corpo carbonizzato, la riconobbi grazie a quel vestito rosso che ormai era ridotto in brandelli. Sobbalzai spaventato e mi girai verso la bambina. «Ti porto via di qui.» dissi sollevandola da terra e avviandomi verso l’albergo. «Fermo, JD!!» mi urlò qualcuno alle spalle. «Ken sei tu??Fatti vedere» gli urlai. «Lascia quella bambina JD è pericolosa.» mi ordinò. Di colpo fui scaraventato a terra, vidi la bambina fare un salto lunghissimo ed entrare con i piedi sul petto di Ken. «Ahhh! Lascialo stare lui è mio!!» urlò la bambina mentre faceva cadere il mio amico. «Cos... Ma che...» non riuscii a completare la frase che la bambina era nuovamente su di me. Presi il cellulare nuovamente per fare luce, la bambina aveva la testa girata verso Ken e gli urlava «Dopo verrò da te non muoverti. Ora tocca a lui giocare con me!!! Mamma e papà non ci sono ed io voglio giocare un po’.» Girò piano piano la testa, in quel momento sentivo l’aria appesantirsi un odore terribile entrava di prepotenza nei miei polmoni, un misto di bruciato e putrefazione, quell’odore pesante che mi prese lo stomaco facendomi rigurgitare in un attimo, il cuore stava pian piano aumentando il battito.Mentre risalivo con lo sguardo mi accorsi che le mani della bambina avevano una strana forma, le dita erano diventate secche e rattrappite, quasi come se fossero deformi. Alzai il volto sperando che fosse stato solo un allucinazione dovuta a quella puzza nauseante che mi aveva circondato. Feci nuovamente luce verso la bambina, che stava girando la testa verso di me, notai subito che le guance avevano cambiato colore erano più scure, sul nero. Come si girò completamente dallo spavento urlai. La sua faccia era per metà carbonizzata. Potevo vedere le gengive nere, non aveva più parte delle labbra. I capelli erano bruciati sopra la testa tanto che si poteva vedere la calotta cranica fra il cuoio capelluto bruciato. Rigurgitai nuovamente. «Ken... Toglimi questa cosa da dosso... Ken!!» urlai pietrificato. Non riuscivo a sentire nessuna risposta «Ti prego non uccidermi, non uccidermi io non ho fatto niente!!» «Mamma e papà non vogliono che giochi fuori di casa...Dicono che è pericoloso...Buck.» si incupì. Fortunatamente non arrivò nessuno. «Ah... Stupida Laura...Buck è morto tempo fa... Ecco perché mamma e papà non vogliono che esca fuori.... Io cercavo di insegnargli a nuotare a Buck» disse «Dove?? Dove gli insegnavi?» domandai cercando di prender tempo nell’attesa che Ken si riprendesse. Non riuscivo a muovermi, quel corpo seppur così esile mi bloccava, era come un masso sopra al mio stomaco. «Io ho buttato Buck nel pozzo, lio vedi???» disse indicandomi qualcosa nel buio. «Io... Non volevo ho provato anche a buttargli il secchio dicevo... Buck... Buck afferra il cestello, entraci dentro.... Ma Buck non si muoveva, ho ritirato il secchio giù... Buck è entrato ma era troppo pesante... Ho chiamato aiuto... Ma Buck... Lui era troppo pesante ed è caduto giù... Mamma e papà hanno chiuso il pozzo ed hanno messo me in punizione...» La bambina si mise nuovamente a piangere, io cercavo di muovere le mani ma niente,eravamo al buio con la luce del cellulare che serviva a ben poco. «Cattivo Buck...sei stato cattivo...» disse con lo sguardo rivolto verso di me. La bambina iniziò a colpirmi violentemente sul petto, ed ogni suo pugno, con quelle sue mani quasi scheletriche era come una grossa pietra che si abbatteva con grande forza su di me. «Aaah... Aaaah... Fermati ti prego... Ken.... Aiutami... Ken levami questo mostro da addosso... » urlai. Nessuno rispose, Ken aveva perso conoscenza durante la caduta, cercai di muovermi e di alzarmi ma niente, immobile. Sentii le forze che iniziavano ad abbandonarmi mentre la bambina mi colpiva ancora. Stavo perdendo i sensi quando, da lontano, vidi arrivare due luci. «Ehi!!!Ehiii... Aiuto... Sono qui!!! Vi prego salvatemiii!!!» iniziai a piangere dal dolore. Con la vista che mi si annebbiava vidi le luci avvicinarsi velocemente, riconobbi due figure. «JD?? Parlaci...Abbiamo bisogno di sentire la tua voce per avvicinarci!!!» sentii. «Qui... Sono quii!! Aiuto...Qualcuno la fermi sento le mie ossa rompersi...Aiutoo!!!!!Fe..fermati...ti prego...qualcuno mi salvi» «Ken è li con te??» questa volta riconobbi la voce era quella di Melissa. «Si...si è qui...credo sia svenuto...è stato colpito da questo mostro...vi prego se non riuscite a salvare me portatelo via di qui!» gridai. Le due fiamme si avvicinavano ulteriormente, la bimba smise di colpo di picchiarmi, vidi che girò la testa dove era svenuto Ken, vidi dipingersi sul suo volto un ghigno, la sentii quasi ringhiare. Seguii il suo sguardo, stava osservando minacciosamente le ragazze. Notai che avevano dato fuoco alla cornice del quadro per farsi luce. «Ehi!!!Ehiii... Laura... ti chiami così...che ti prende hai smesso di picchiarmi???» dissi capendo che voleva aggredire le due ragazze. «Ehi!!!Prendete Ken e fuggite...non pensate a me...» urlavo loro tenendo d’occhio la bambina. La bambina era ferma, immobile che li osservava, non mi riuscivo a capacitare perché non si muovesse, tentai quindi di usare le mie ultime forze e levarmela di dosso, ma riuscii soltanto a muovere le gambe e portarle dietro la sua schiena. Lei si girò per osservarmi meglio, mi accorsi per un secondo che piangeva, quasi terrorizzata da qualcosa. Poi si rigirò nuovamente verso i miei amici. Notai che non guardava loro, ma fissava costantemente le fiamme che ardevano su quelle torce fatte con la cornice. «Ehi!!!Voi...siete ancora li??!!!»urlai. «Si...abbiamo preso Ken...si sta riprendendo...Lo portiamo in albergo e torniamo non ti muovere!!! »urlo Melissa. «Aspettate un secondo....aspettate...il fuoco...ho capito...»dissi. «Cosa?? che hai capito??» domando Cristina. «La storia...la bambina....la bambina è morta in un incendio...ha paura del fuoco...forse potremmo porre fine a quest’incubo. Avvicinatevi lentamente!!» ordinai in preda all’ultima speranza. Vidi una delle due ragazze avvicinarsi mentre l’altra rimanere vicino a Ken, si muoveva lentamente mentre la bambina si ritraeva, si alzò di scatto liberandomi ed io tentai di alzare la schiena ma ero ridotto male e non riuscivo a resistere al dolore. La bambina andò verso Melissa, anche lei si muoveva lentamente, continuava a ringhiare. Melissa si portò la torcia avanti al corpo, quasi come se fosse una spada in posizione di difesa. «Lasciaci in pace!!! – disse – noi non ti abbiamo fatto niente, sparisci e lascia liberi i nostri amici!!!» continuò parlando in italiano. Vidi la ragazzina continuare ad avanzare e fermarsi con il viso fisso sul fuoco ardente. Come Melissa vide il volto mezzo carbonizzato della bambina urlò e fece dei passi indietro «Ma è un mostro??!!»esclamò. «Cristina, prendi Ken e scappa, non so se potrò fare molto...ho paura.» disse all’amica continuando ad indietreggiare. Laura, invece, proseguiva dritta verso di lei. «Melissa – gridai – usa la torcia, cerca di darle fuoco....» «Non ci riesco!!! Mi fa senso.» disse lei continuando ad indietreggiare. Io mi poggiai su un lato, cercando di rotolare verso di loro, per non pertderle di vista. Mi rotolai una prima volta provando un dolore tremendo come appoggiavo il petto sul pavimento. Così decisi di muovermi rimanendo di lato, in modo che il dolore non fosse lancinante. «Provaci!!! Ehi Laura, sono io la tua preda!!! Vieni qui!!» gridai cercando di distrarre quel mostro. Era come stregata da quella fiamma, quasi non ci ascoltava. Continuava a camminare verso Melissa. La ragazza aveva raggiunto Ken e Cristina, fece cenno all’amica di aiutarla a difendere il ragazzo che si stava pian piano riprendendo, io ero distante solo una decina di metri e, lentamente, avanzavo. Vidi Cristina muovere la torcia minacciosamente verso quel mostro orribile, nessuna delle tre però era pronta ad attaccare l’altra. «Mamma e papà...non erano in casa...io non ho fatto niente stavo solo giocando in camera...quando è successo...sono scappata a svegliare la serva.... ma niente...le fiamme mi hanno circondata...»scoppiò nuova- mente a piangere. «Vai via!! Allontanati da noi!!!!»urlò Melissa. Mi ero avvicinato di un paio di metri, grazie alla luce delle fiamme vedevo che anche Ken si stava rialzando piano piano, lui stava sdraiato su un fianco in posizione fetale, e stava prendendo conoscenza. «Melissa... Cristina...gra...grazie per esserci venuti a salvare...» disse con un filo di voce. «Ken...sei vivo??» urlai, senza però ricevere risposta, vidi solamente la sua testa muoversi. Mi avvicinai ancora, cercando di capire cosa stesse succedendo. «Ehi voi!! Che aspettate a colpirla?» dissi «Non riusciamo a muoverci...siamo come paralizzate dal suo sguardo.» disse Melissa. «Cos...lo sguardo??»ci pensai un attimo e mi passò per la mente che anche io poco prima non ero riuscito a muovermi anche se fosse un corpo piccolo ed esile sprigionava un energia che mi aveva immobilizzato, capii quindi che un altro suo potere era proprio nello sguardo. Cercai di avvicinarmi più in fretta che potevo, dolori permettendo, a quella cosa. Dovevo provarci almeno, non potevo permettermi di lasciare le cose senza aver fatto nulla. Vidi Ken che ormai seduto stava alzandosi. «Ehi amico sono contento di rivederti in piedi, senti...ho un piano, cercherò di distrarre la bambina tu appena puoi colpiscila con una delle torce e dalle fuoco, solo così potremmo salvarci!!»dissi. «Cercherò di farlo, tu non fare l’eroe però...non potrei permettermi di ritornare a casa senza di te!» disse con la sua solita parlantina. «Tranquillo...ho vissuto momenti peggiori pochi istanti fa...se riusciremo a sopravvivere però dovrai portarmi all’ospedale!»risposi. «Che discorsi di merda stai facendo...ovvio che ti porterò!» «Perfetto! Ah non guardarla negli occhi, potresti rimanere immobilizzato» dissi «E come faccio a colpirla senza guardarla?» «Usa gli occhi delle ragazze, loro sono ferme, loro ti guideranno verso la bambina..» urlai. «Proviamoci!!» disse mentre prendeva la torcia amatoriale dalle mani di Cristina, mentre con una mano si copriva gli occhi. «Laura...mi dicevi di Buck! Quindi, l’hai ucciso?» dissi rivolto alla bambina. Niente nessuna risposta, la colpii leggermente alla gamba, tanto mi ero avvicinato. «Allora...che fine ha fatto Buck?» ripetei, dandole un altro calcio più forte del precedente. La bambina ritornò a parlarmi. «Buck è caduto col secchio infondo al pozzo...non è stata colpa mia» mi disse «Ora Ken colpisci ora!!!» urlai. «Dove??? Ditemi dove???» «Qui, a sinistra!» disse mentre il mio amico colpiva a vuoto sopra la ragazzina. «Più in basso...in basso..»disse la ragazza Ed ecco che il mio amico riuscì a colpire con la torcia il volto della ragazza, la colpi più di una volta, usando la torcia come se fosse una mazza da baseball, i capelli iniziarono a prendere fuoco e lei ad urlare come se sentisse nuovamente dolore. Il buio stava facendo posto alle prime luci del mattino, mentre il corpo di Laura prendeva fuoco, riuscivo a vedere nuovamente le sagome dei miei amici senza bisogno delle luci. Ken prese anche l’altra torcia poiché la prima si era spezzata durante i primi colpi, e continuava a colpirla nonostante i resti di quel colpo non si muovevano più. «E’ finita Ken...smettila!» dissi prima di svenire. Mi risvegliai il giorno dopo in ospedale al mio fianco c’erano Ken e le due ragazze. Ken mi raccontò che era tornato in albergo subito dopo avermi portato in ospedale ed essersi fatto medicare, ma era sparito tutto, i resti della serva, la bambina e il quadro. Il fortino era rimasto, al posto del quadro c’era un immenso poster che raffigurava il paesino e nessuno si ricordava di aver mai saputo cosa ci fosse prima di quello. Incredibilmente nessuno si ricordava di quella storia, solo noi avevamo visto, solo noi avremmo potuto raccontarlo in giro, anche se nessuno forse ci avrebbe creduto. Lieto fine di Marco Sorbara Che cosa faresti se un giorno dovessi prendere coscienza del fatto che mai, in questa vita, dipingerai una nuova Gioconda? Che non sarai ricordato per aver scritto un’altra “Penny Lane”? Penseresti di aver sprecato la tua vita riducendola a una semplice esistenza, ecco cosa faresti. Mentre sto al volante della mia auto, i Roxette nel mio stereo cantano che la vita è gradevole come un pomeriggio di Giugno. Leggera, come un canticchiare spensierato. La-la-la. Io non lo credo. Non riesco a crederlo. Neanche in una giornata così soleggiata. Credo, piuttosto, che alcune vite siano – o rischino di essere –, a conti fatti, dei disgustosi coaguli di tempo sprecato. Per fortuna esite un lieto fine: morire sapendo di non aver buttato via la propria vita. Ma ovviamente dipingere la Gioconda non è esattamente la cosa più facile del mondo. Questa storia è piuttosto illuminante. È una storia accaduta anni fa nel quartiere in cui vivevo da ragazzo. Una storia che inizia con quattro pneumatici squarciati. Quella mattina, come ogni mattina, l’ingegner Mariotti usci- va con passo svelto dal cortile condominiale per raggiungere la sua BMW, che era solito parcheggiare all’ombra di una quercia enorme che torreggiava nel cuore del quartiere. Come ogni mattina, l’ingengere teneva lo sguardo basso, concentrato sul telecomando che teneva in una mano e che serviva a sbloccare le portiere dell’auto. Bli-blip! e le sicure erano disinserite. Ma quella mattina trovò la sua macchina poggiata su quattro ruote avvolte da pneumatici tanto flosci da sembrare in liquefazione. Mariotti girava intorno alla vettura con un’espressione incredula stampata in faccia. La voce rauca del signor Rosi, alle sue spalle, gli chiese: «Tutto bene?» e i suoi pensieri furono spazzati via in un attimo. «Beh... - rispose - dei figli di buona donna mi hanno fatto un bel servizietto alle gomme. A tutte e quattro!» «Oddio! Quanto mi dispiace...!» esclamò Rosi da dietro l’inferriata bianca che definiva il perimetro di un ampio cortile. Mariotti rise: «E cosa vuole farci? Non è mica colpa sua!» Poi chiese: «È già al lavoro?» «Io...? Sì» sorrise Rosi, «stamattina finisco di mettere in sesto il tavolino della signora Pucci». Da quando era in pensione, Rosi si dedicava spesso al fai-da-te. Oltre a prendersi qualche soddisfazione riusciva anche a tirar su qualche soldo per arrotondare un po’ la sua pensione da ex dipendente INPS. I due, divisi da quelle sbarre bianche, chiacchierarono per qualche minuto. Poi Mariotti si congedò dicendo che sarebbe tornato su, nel suo appartamento, per prendere in prestito le chiavi dell’auto di sua moglie. Rosi salutò l’ingegnere agitando un martello che teneva stretto in mano. Lo stesso martello di cui si servì per bucargli le ruote della macchina. Un mazzuolo e delle puntute forbici da sarto sottratte alla sua ignara signora. E il gioco era fatto. Semplice come canticchiare una canzone di poca cosa. La-la-la. O forse no. Forse non era così semplice: forare qualche pneumatico non portava alcun vantaggio concreto a Rosi. Non era l’atto in sé. Se qualcuno lo avesse visto, meglio ancora, scoperto, il piatto si sarebbe arricchito e di molto. Tutto sarebbe diventato più intrigante per lui. Ma quella volta non successe, perciò Rosi stabilì che sarebbe stato giusto andare avanti: alle gomme squarciate di Mariotti si sommarono altri atti vandalici. Altre notti folli e altri danni a vetture incustodite, parcheggiate in giro per il quartiere. Rosi metteva fuori uso le serrature di cofani e portiere con della colla istantanea oppure spezzandoci dentro delle linguette di metallo. Con un cacciavite a punta piatta dava sfogo alla sua creatività, il più delle volte incidendo dei cazzi giganti sulle carrozzerie. Con un mattone avvolto in un’asciugamano ammaccava cofani e portiere, mandava in frantumi finestrini, sfondava parabrezza e lunotti posteriori. Se questo agire senza essere scoperto poteva eccitarlo, col senno di poi ho ragione di pensare che un polipetto senza peli sulla lingua, in fondo al suo cervello, continuava a pregare che qualcuno lo cogliesse con le mani nel sacco. E ogni giorno di più si faceva sedurre da questa idea che poco alla volta trasformò in un vero e proprio desiderio. Voleva che qualcuno lo punisse, era evidente. Armato di bastone o semplicemente di un avvocato, in qualunque modo purché la stampa facesse da cassa di risonanza all’intera vicenda, infilando il suo nome nella bocca di quante più persone possibile. Cercò anche di autodenunciarsi dopo aver versato del liquido freni sul cofano di una vecchia Ford Orion. Quando il mattino seguente il proprietario dell’auto decise di denunciare il fatto, Rosi segnalò di aver trovato sul posto il flacone di fluido corrosivo utilizzato per danneggiare la carrozzeria. Perciò chiese ai carabinieri di rilevare la presenza di impronte digitali sulla bottiglietta. Gli ufficiali gli risero in faccia. Nel quartiere prese a circolare voce che l’autore di quei gesti fosse una gang di ragazzini, forse resi cinici e aggressivi dalla violenza televisi- va o forse desensibilizzati dalle brutalità dei videogames. Le cose non stavano andando esattamente come avrebbe voluto Rosi: la gente del suo rione continuava a non sospettare minimamente di lui. Aveva ancora tanto da lavorare. Così decise di calcare la mano e di far saltare in aria a un po’ di macchine. Così, colpendo senza un criterio, senza un preciso modus operandi: a volte agiva servendosi di bombe carta, altre volte co- spargeva le auto di benzina agricola e le dava in pasto alle fiamme. Nel giro di poche settimane, diverse automobili subirono questo particolare trattamento. La gente del quartiere cambiò immediatamente versione: fanculo i ragazzini, deve trattarsi per forza di avvertimenti mafiosi. Anche dei piccoli giornali locali iniziarono a interessarsi alla cosa, ali- mentando la tesi delle intimidazioni mafiose. “Che branco di imbecilli! Non avete capito un cazzo!” pensò Rosi. Come dichiarò lo stesso Rosi più avanti, trovava divertente quell’andirivieni di macchine della polizia e autobotti dei vigili del fuoco, ma da un certo punto in poi iniziò seriamente a stancarsi di vedere attribuita ad altri la paternità dei suoi crimini. Certo, se anche fosse stato lui a confessarlo sotto giuramento davanti a tutti, nessuno sarebbe stato disposto a dargli credito. Il signor Rosi. Con la sua camminata zoppicante, l’incedere lento. Con quel sorriso gentile a fargli da scudo in un mondo ripugnante. Impossibile! “È solo un mitomane” avrebbero detto al massimo. Ecco perché avrebbero dovuto pizzicarlo. Lui pregava di essere scoperto. E magari si stupiva anche di come quell’impicciona della signora Pucci, sempre nascosta a sbirciare da dietro le serrande semichiuse, non lo avesse mai visto in azione. E quell’altra vecchia babbiona della signorina Fino, con la sua insonnia del cazzo, sempre a vigilare affacciata a quella cazzo di finestra. Possibile non avesse mai visto nessun movimento sospetto? Rosi allora corresse il tiro. Lo indirizzò un po’ più in alto, ancora un po’ più su. Dopo circa una decina di giorni di tregua, la gente del quartiere sem- brava aver dimenticato tutto. Sia i ragazzini, sia la mafia. Tutto apparentemente cancellato. Almeno fino al giorno in cui il ragionier Scola non si accorse che i suoi cani perdevano sangue dal culo. Le bestiole furono portate di corsa da un amico di Scola, un giovane veterinario che diagnosticò ai cani delle lesioni alle pareti del retto. Alcune si trovavano in profondità, molto vicine al colon, ma erano di lieve entità. Qualche giorno e sarebbero tornati come nuovi, quei cagnacci. La cosa curiosa, però, restava la causa di quelle lesioni. Il medico disse che erano state causate da una penetrazione violenta dell’ano praticata con un oggetto appuntito e ruvido, a giudicare dalle abrasioni viste durante la rettoscopia. Non ci era andato lontano: si trattava infatti di una lima da ferro, un arnese che non poteva mancare nell’arsenale di un appassionato di bricolage. I cani – cinque trovatelli di taglia media – avevano la loro casa sul suolo condominiale, di fronte al garage di Scola: un’area di tre metri quadri delimitata da un reticolo verde smeraldo. La notte precedente, Rosi si introdusse nel recinto. Portò con sé del sonnifero, giusto per evitare che mentre levigava gli sfinteri di uno di quei cani con la sua lima, gli altri quattro gli saltassero addosso per masticargli la faccia. E questo spiegava quelle tracce di Bromazepam rinvenute dal veterinario nel sangue degli animali. L’ennesima bravata del signor Rosi che non diede i frutti sperati: la voce dello stupro ai danni di quei poveri animali dilagò velocemente nel quartiere, da un condominio all’altro, ma niente di più. Così, un paio di settimane dopo, il ragionier Scola trovò nel recinto verde smeraldo tre cani morti e due agonizzanti. Uno aveva un taglio che andava dall’inguine al collo. Smembrato, aperto in due come una sacca sportiva. Le sue interiora erano sparse dappertutto. Un altro era stato decapitato. La testa non fu mai trovata. Un altro ancora la testa ce l’aveva, ma era completamente frantumata e il cervello gli stava colando in poltiglia fuori dal cranio. I due sopravvissuti agonizzarono per poco: morirono nel giro di un paio d’ore per aver ingerito chiodi e schegge di vetro infilati in una polpetta di carne. Dopo quel terribile atto di violenza contro dei cani indifesi, lo sdegno della gente era altissimo. Ricomparve lo spettro dei ragazzini desensibilizzati e un filo nichilisti. Nonostante la gravità di quegli ultimi fatti, nessuno tra forze dell’ordine e l’amministrazione comunale dichiarò di voler adottare un qualche provvedimento di qualunque tipo. Perciò la gente del quartiere decise di costituirsi in un corpo di vigilanza, una sorta di presidio popolare che fosse attivo di giorno ma soprattutto di notte. Rosi accolse talmente bene la cosa che si diede da fare più degli altri: chiese e ottenne l’autorizzazione dal Comune a organizzare un presidio, si fece fare dei preventivi per comprare un gazebo, acquistò anche dei gilet fucsia con bande catarifrangenti da un suo amico ferramenta che glieli cedette a un prezzo davvero ridicolo, visto il colore bizzarro e poco richiesto di quei giubetti. Scrisse e fotocopiò per l’intero comitato di quartiere un regolamento da osservare nelle ore in cui si effettuava il servizio di vigilanza. Un punto che colpì particolarmente la mia fantasia era: dopo le ore 00:00 diffidare da qualsiasi cosa sia poco visibile al buio. Questo poteva significare dover controllare qualsiasi movimento di qualsiasi auto scura avesse attraversato il quartiere, o di qualsiasi persona che non fosse vestita da clown. A ogni modo, l’iniziativa fu un vero successo e tutti vi collaborarono. La signorina Fino, per esempio, nonostante i suoi settant’anni, riuscì a trarre profitto dai suoi disturbi del sonno passando molte delle sue notti in bianco al presidio. Anche il ragionier Scola era di pattuglia, spesso e volentieri. Con lui c’era sempre quell’impicciona della signora Pucci, che quando si trattava di ficcare il naso in qualcosa sgomitava per saltare la fila e passare davanti a tutti. A quei tempi, mai avrei potuto immaginare il signor Rosi intento a sfregarsi le mani, crogiolandosi nell’idea di essere beccato. Probabilmente fu allora che iniziò a prepararsi davvero all’idea di essere scoperto. Di essere indicato da tutti come l’insospettabile, eppure, diavolo in terra. Di essere destinato all’immortalità. Una volta istituita quella parodia grottesca di un corpo di polizia privata, Rosi si prese ancora qualche giorno prima di guadagnare la scena a maschera calata. Prima di mettersi al centro dell’occhio di bue. Immagino non avrebbe provato lo stesso gusto a farsi cogliere nel bel mezzo di una delle sue bravate notturne a pochi giorni dalla nascita del comi- tato di sorveglianza. Rosi voleva giocare con noi. E voleva che tutti noi giocassimo. Il presidio aveva il colore immacolato di un gazebo bianco. Le guardie, quello del fucsia argentino di una pasticca di propifenazone: si muovevano nel buio, e tutto ciò che di loro si riusciva a vedere erano quegli stupidi gilet fluorescenti. A coppie, pattugliavano il quartiere, muniti di walkie-talkie per contattare il presidio nel caso avvistassero un’ombra sospetta o un qualsiasi movimento di cui dover dubitare. Anche il signor Rosi partecipava alle ronde, quelle inutili e infruttuose battute di caccia alle streghe. Al presidio solitamente c’era la signorina Fino coadiuvata da altri abitanti del rione. Il suo compito consisteva nel piantonare la strada d’ingresso che conduceva alle nostra palazzine, e gestire le segnalazioni che arrivavano via radio dai vigilantes che perlustravano la zona. In caso di appurato pericolo, l’ingegner Mariotti avrebbe dovuto avvertire le autorità richiedendone il tempestivo intervento. Una volta andai al presidio per tenere compagnia a mio padre. Magari ho solo un opaco ricordo di quella notte, ma potrei giurare di aver visto la sagoma scura di Rosi affacciata al balcone di casa sua. Durò un istante: vidi il suo sorriso nel buio. Lo smalto bianchissimo dei suoi denti scintillava alla luce fioca dei lampioni. Circa un’ora dopo, la signora Pucci, di ritorno da un giro di ricognizione in compagnia del ragionier Scola, fu colpita a una mano dal gommino giallo di una pistola ad aria compressa. La torcia spenta che stringeva tra le dita cadde a terra rimbombando nel silenzio opprimente di quella notte. La signora Pucci urlò terrorizzata. Pochi minuti dopo sbucò dal nulla il signor Rosi che non la smetteva di chiedere informazioni sull’accaduto. Io ero sicuro di averlo visto affacciato al suo balcone un po’ di minuti prima. Nonostante ciò, rimasi in silenzio. La sera in cui tutto venne a galla, Rosi non era ancora pronto. Dichiarò che fu costretto ad agire subito, istintivamente, come un animale selvatico. Quella notte il presidio era gestito dalla signora Pucci e da “quel bel giovane del ragionier Scola” – lei lo definiva così. Mio padre e Rosi erano di pattuglia insieme, quando accadde il fatto. Il poco attendibile occhio della Pucci aveva scorto movimenti sospetti tra le siepi del parchetto che tagliava a metà il quartiere, passando in mezzo a due file di palazzine. Avvisò via radio i due di pattuglia raccomandandosi per ben due volte di tenere alta la guardia. Immagino quanta fatica facesse Rosi in quel momento a trattenere le risate davanti a mio padre. “Miss Marple del cazzo!”, disse stringendo i denti. Rosi e mio padre si muovevano nel buio coi loro gilet sgargianti ben abbottonati. Avevano acceso le torce elettriche e sparavano quei fasci di luce dappertutto. Oltre ogni cancello di ogni condominio. Tra le fronde di ogni albero. In ogni singola crepa presente sui muretti che delimitavano i cortili condominiali. Mio padre, dritto e attento a ogni più insignificante fruscìo o movimento di foglie, avanzava tenendo stretto in una mano il suo walkie-talkie, pronto a mettersi in contatto con la sentinella Pucci che avrebbe pensato poi ad avvertire le autorità competenti. Rosi prendeva parte alla farsa continuando a recitare il suo ruolo in modo impeccabile. I due avanzavano lentamente guidati dalla luce gialla di due torce argentate. Mio padre di tanto in tanto gridava un “chi va là?” d’avvertimento, nella speranza di ricevere risposta da una voce familiare. Rosi, al suo fianco, imitava i suoi gesti: agitava la torcia fingendo di cercare qualcuno, gridava “chi va là?” pensando che mai nessuno gli avrebbe risposto. Ma all’improvviso, in fondo alla strada, le loro torce illuminarono una figura minuta vestita con una giacca a vento scura e dei pantaloni sportivi celesti. Doveva essere un ragazzino. Lo videro per pochi secondi, giusto il tempo che ci mise a scavalcare un’inferriata per intrufolarsi in uno dei cortili. Mio padre allungò il passo tenendo la torcia puntata davanti a sé. Probabilmente voleva avvicinarlo per vederlo in faccia, ma non ci riuscì: il ragazzino era sparito chissà dove, protetto da un’appiccicosa colata di oscurità. Quando Rosi vide il ragazzo in fondo alla via si sentì mancare. Dalla sua sciarpa grigia in acrilico divamparono fiamme invisibili che gli scaldavano il volto rendendogli le guance livide. Il resto del corpo ridotto a un pezzo di ghiaccio. Nelle orecchie, il fischio continuo e fortissimo che avvertì in un primo momento, fu presto sostituito dai battiti tuonanti del suo cuore che pulsava come impazzito. Il signor Rosi sapeva benissimo che se avessero acciuffato il giovane, magari intento a rubare qualcosa, con buona probabilità gli avrebbero sbolognato il carico di tutte le sue bravate. Peggio se il furfantello era straniero: lo avrebbero fatto di certo, senza neanche dargli troppo ascolto. La situazione era fin troppo chiara: quello stronzetto in calzoni di tuta poteva rubargli la scena. Bisognava agire immediatamente, o tutto il lavoro svolto fino a quel momento sarebbe andato in fumo. Rosi tirò fuori da una tasca del suo gilet una piccola lima da ferro appuntita. Ad ampie falcate raggiunse la schiena di mio padre, che si era appena avvicinato il walkie-talkie alle labbra per chiede alla Pucci di avvisare la polizia. Non fece in tempo a finire la frase. La punta gelida della piccola lima da ferro gli entrò dritta nell’orecchio destro. Rosi la spinse così in profondità e con una violenza tale da incastrargliela nel foro acustico, alla base del cranio. Al presidio capirono che era il caso di prestare immediatamente soccorso ai due, ma quando quel-bel-giovane-del-ragionier-Scola li raggiunse, era troppo tardi. Mio padre annaspava steso sull’asfalto, e il signor Rosi, a cavalcioni sopra di lui, stava per finire il lavoro buche- rellandogli il collo con la punta della sua lima. Quando Scola giunse sul posto mio padre non urlava più. Aveva la laringe e l’esofago intasati di sangue, la sua bocca era un piccolo vulcano che eruttava lava marrone. Dall’orecchio destro colava luccicante una specie di muco scuro. Rosi aveva in mano il suo gioco, era riuscito a salvarlo dalle luride manine di quello che doveva essere uno stupido ladro. Ma gli ci volle qualche minuto per realizzare. Lo capì quando il ragionier Scola gli si attaccò alle spalle strattonandolo per staccarlo da mio padre. Lo capì quando vide decine e decine di occhi che dalle palazzine intorno puntavano verso di lui. Occhi di persone corse ad affacciarsi a finestre, balconi e lucernai, attirate dalle urla di un uomo. Persone che si erano trasformate all’istante in testimoni oculari di un unico orribile fatto, di cui avrebbero poi rilasciato una propria versione. Forse alla polizia, meglio ancora se alla stampa. Rosi vedeva nascere i frutti di quanto aveva seminato nei mesi precedenti. Si sentiva come un attore che, guadagnata la scena, si lascia illuminare da un potente riflettore per mostrarsi al suo pubblico. Nudo, senza abiti di scena o strane fisionomie suggerite dal trucco. Il suo occhio di bue era la luce fredda e debole di un lampione comunale. Il quartiere aveva finalmente il suo mostro. Quando arrivò la polizia, il signor Rosi sorrideva. Sorrideva alle telecamere di una TV locale chiamata da chissà chi. Lo faceva a piena bocca, tenendo il mento alto. Sorrideva tra due agenti che se lo portavano via tenendolo per le braccia. Le mani dietro la schiena, tenute vicine da lucenti manette strette attorno ai polsi. Sorrideva, mentre uno dei due poliziotti gli metteva una mano sulla testa e lo spingeva sui sedili posteriori della volante. Mio padre fu caricato su una barella. Il suo collo era punteggiato da ferite profonde dai bordi rigonfi, indolenziti. Del liquido vischioso continuava a effluire dal suo orecchio destro. La bocca impastata di sangue appiccicoso. Anche mio padre sorrideva alle telecamere. Tutti sorridevano. Anche quel-bel-giovane-del-ragionier-Scola. Tutti. Il mostro ci trasformò in suoi comprimari. Personaggi importanti quanto lui. Destinati all’immortalità esattamente come lui. La gente si appassionò moltissimo a questa vicenda, soprattuto quando i TG annunciarono la morte di mio padre. Sui giornali e in TV non si parlava d’altro. Ogni giornalista, ogni sociologo, ogni soubrette dimenticata voleva dire la sua. Esprimere un parere personale, offrire la propria analisi dei fatti agli spettatori affamati. Quando ci fu il processo a Rosi, la trasmissione Un giorno in tribunale offrì una cifra assurda per accaparrarsi l’esclusiva. Un successo di pubblico senza precedenti nella storia della televisione. Picchi mai registrati, neanche durante le dirette da Berlino per la caduta del muro nell’89. Giornali e TV definirono Rosi in vari modi: prima mitomane, poi sociopatico, poi volgare assassino. In ogni caso il tempo diede ragione a lui: i media lo trasformarono in un personaggio, e il suo nome volò da una bocca all’altra, la sua faccia viaggiò a bordo di copertine di riviste e quotidiani nazionali. Ebbe ciò che aveva sempre sognato. Poi il silenzio. Anni di silenzio durante i quali Rosi trovò il coraggio di reinventarsi, forse aiutato da un curatore d’immagine. Scivolò nella pelle di un nuovo personaggio. Come una popstar. Scrisse – lui o chi per lui – un paio di lettere aperte ai maggiori quotidiani nazionali in cui denunciava la condizione dei detenuti nelle carceri italiane, non mancando di esporre alcune sue possibili e controverse soluzioni al problema. Si infilò un maglione di cachemire e si mise in testa un cappello in feltro. Si fece crescere un’ombra di barba. Inforcò degli occhiali da vista perfettamente tondi e il carcere aprì le sue porte a fior di psicologi, docenti di antro- pologia sociale, professori di diritto penale. Tutti volevano parlare con lui, analizzare da vicino la sua personalità, conoscere il suo pensiero. Scrissero articoli e articoli su di lui. Rilasciò un’infinità di interviste. In alcuni atenei lo trasformarono in materia d’esame. Gli studenti aprivano le orecchie e prendevano appunti non appena ne riconoscevano la voce. Addirittura un tale Professor Lio dedicò un libro alla sua figura, a metà tra la biografia romanzata e il saggio. Il libro fu tradotto e venduto in diciotto paesi. A molti anni dalla sua pubblicazione è ancora oggi nelle prime venti posizioni della classifica dei libri più venduti in Italia. Tra i dieci libri stranieri più apprezzati in Brasile. Rosi raggiunse il traguardo più importante nella vita di un uomo: mattone su mattone, costruì la sua assicurazione per sopravvivere a se stesso, a quel sacco di carne pieno di ossa, interiora e fluidi che era il suo corpo. Al contrario di tanti altri, il suo nome non sarebbe mai stato dimenticato. Soprattutto da me. E non solo perché assassinò mio padre, ma perché da lui ho imparato che non c’è ragione di temere la morte se nel corso della tua vita hai impresso il tuo segno in qualcosa. Con un’esperienza pluriennale allo sportello informazioni di un ufficio INPS e un livello culturale piuttosto basso, difficilmente Rosi sarebbe stato in grado di lasciare la sua impronta nel campo della letteratura, della pittura o che so io. Non avrebbe mai dipin- to una nuova Gioconda. Affermò se stesso scatenando quell’inferno. Definì con violenza il suo ruolo di mostro nelle vite di tutti noi, dandoci la possibilità di confrontarci con lui e di affermare, a nostra volta, i nostri ruoli. E con lui, diventare immortali. Fu così per l’ingegner Mariotti e per tutte le altre povere, povere vittime degli atti vandalici: tutti, anche facce che nel quartiere non avevo mai visto, dichiararono ai giornalisti di aver subito torti o violenze da Rosi. Fu così per la signora Pucci, che provò l’ebbrezza di giocare a fare Miss Marple: scrisse una serie di romanzi noir di grande successo, tutti ambientati nel nostro quartiere. Il primo della saga era chiaramente ispirato alle bravate del signor Rosi. Fu così per il ragionier Scola, che ebbe il suo momento di gloria affrontando la bestia in un corpo a corpo: ospite fisso in decine di trasmissioni TV, grazie alla sua bella faccia divenne testimonial di un marchio assai noto. Fu così per mio padre, eroe e unico martire di tutta la storia: per molto tempo in televisione si parlò di lui. Gli dedicarono perfino una serie televisiva. Il suo ruolo fu assegnato a Beppe Catena, il principe della fiction italiana. E così sarà anche per me. Il sole di giugno picchia forte, stamattina. Davanti ai cancelli del carcere c’è una folla di poliziotti e di giornalisti agitati. In mezzo a questa foresta di corpi, in questo groviglio di braccia tese, si compone la sagoma del signor Rosi. Trascina i piedi. Li trascina sull’asfalto caldo. Le gambe leggermente piegate mal sopportano il peso degli anni trascorsi in cella. Sia chiaro: se mi trovo qui in questo momento, è solo per ragioni di copione. Forse Rosi neanche voleva ucciderlo, mio padre. Non provo assolutamente più nulla per questo ottantenne malandato che oggi torna a riprendersi la sua libertà. Né odio, né niente di simile. Tutto ciò che faccio, lo faccio per noi. Sono venuto a prendere il mio posto in questa storia, a scrivere il mio lieto fine. Tutto ciò che faccio, lo faccio per regalare al nostro pubblico la conclusione che merita. Il buono che ripara con le sue mani il torto che ha subito. È questo il genere di giustizia che il pubblico vuole, hai voglia a parlare di funzione rieducativa della pena! Rosi è avvolto da un nugolo di giornalisti che gli puntano in faccia microfoni e telecamere. Un altro suo pezzettino offerto in pasto a un pubblico mai sazio. Il nostro pubblico ha certamente apprezzato il Rosi impegnato socialmente, il Rosi con sfumature da intellettuale. Ma il nostro pubblico ama il mostro. Credo li faccia sentire migliori. Mi avvicino e vedo Rosi muovere la bocca ma non ho idea di cosa stia dicendo. Impugno la mia 92F con matricola abrasa. Il braccio teso davanti a me, pronto ad assorbire il contraccolpo. Azione! La voce della mia pistola zittisce la folla di fotografi, giornalisti e cameramen. Il primo proiettile riduce l’orecchio di una reporter a uno straccetto di carne mangiucchiata. Il secondo ferisce solo l’udito ma non colpisce niente che sia in grado di sanguinare. Il terzo fa saltare via il naso dalla faccia di un poliziotto. Il quarto proiettile apre in due la guancia di Rosi e gli scardina la mascella. Un’esplosione di schizzi vermigli, piccole gocce luccicano eccitate dai raggi del sole. Sporcano i volti, i vestiti, i capelli, gli occhi dei giornalisti e degli uomini in divisa che stanno vicino all’uomo. La mandibola, attaccata solo da un lato, penzola dal volto. Qualche dente è schizzato via, qualcuno si è frantumato. Riesco a vedergli la lingua per intero. Gonfia e lucida di sangue, Le guardie iniziano a sbucare da ogni angolo, e un attimo dopo sono al centro di un girotondo di divise. Canne lucide di pistole che puntano verso di me. Qualcuno mi urla qualcosa che non riesco a capire. Qualcun altro arricchisce il discorso dicendo cose poco carine sul conto di mia madre. Le troupe televisive si dividono tra me e Rosi non sapendo bene su chi dei due posare gli obiettivi. Io lascio scivolare in terra la pistola e alzo le mani. Una guardia alle mie spalle mi spinge sul cofano caldo di un’auto e mi ammanetta tenendomi le braccia dietro la schiena. Glielo lascio fare. Gli occhi neri delle telecamere si fanno largo tra gli agenti. Sono decine, a pochi centimetri dal mio naso. Resto piegato sul cofano caldo che mi intiepidisce la guancia e penso che è stato facile. Sicuramente più facile che dipingere una nuova Gioconda. Facile, come canticchiare a mezza voce una canzonetta senza spessore. La-la-la. Chiudo gli occhi. Sorrido alle telecamere. Lo Schiaccianoci di Maria Vernuccio Cristina era rimasta sola, dopo aver riposto nella sua storia con Franco, le speranze di tutta una vita. Aveva sperato che la loro convivenza evolvesse in un matrimonio, ma dopo nove anni... tutto finito. La depressione era dietro l’angolo, ma complice l’avvicinarsi delle ferie estive, si era vista proporre dalla sorella, di recarsi nell’appartamento al mare con la nipotina Titti, che era proprio una bambolina adorabile di cinque anni. Si lasciò convincere e partì per Iesolo, che sapeva essere una bella località con una lunga spiaggia dorata e una fresca pineta. Appena un paio di giorni, ed era iniziata già la routine: risveglio, colazione con Titti, ed erano pronte per recarsi in spiaggia, dove trascorrevano gran parte della giornata consumando sul posto un leggero spuntino. Era piacevole al ritorno, attraversare la pineta così fresca e quieta dopo la calura della spiaggia, e poi c’era sempre qualche attrazione: artisti di strada, giocolieri, venditori di palloncini. Quel giorno dei volantini attaccati agli alberi pubblicizzavano uno spettacolo di marionette: «Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, come non l’avete mai visto!» Il tutto con le foto delle marionette con dei bellissimi costumi. Titti era incantata e diede inizio al rituale a cui ricorreva per ottenere qualcosa: « Dai zia, ti prego, andiamoci stasera, così almeno facciamo qualcosa di diverso!» Cristina, vuoi il tono supplichevole, vuoi la monotonia dell’uscita serale, si lasciò convincere. All’imbrunire si avviarono verso la pineta ed erano proprio un bel vedere, soprattutto Titti, che aveva il suo bell’abitino rosso a fiori e due bei fiocchi nei riccioli biondi che la facevano sembrare una bambola. Nell’ampia radura in pineta, videro subito che era stato montato un piccolo palcoscenico, circondato da un grosso tendone nero e, disposte a semicerchio, delle panche che aspettavano solo di essere occupate dai piccoli spettatori. Un po’ più indietro, delle sedie per gli adulti che avrebbero accompagnato i bambini. La rappresentazione ebbe inizio e i bambini si zittirono, presi dalla storia che veniva raccontata con la musica di Tchaikovsky in sottofondo. Le marionette avevano un aspetto curatissimo negli abiti e nel trucco e la voce che dava loro la parola, era calda e ammaliatrice. Un’ora trascorse in fretta ma quando scese il sipario, apparve sul palcoscenico un bell’ uomo, che spiegò ai bambini che la favola era troppo lunga per essere raccontata in una sola volta, e che li aspettava il giorno dopo per assistere al seguito. Titti era eccitatissima e aspettava con ansia che arrivasse l’indomani: non vedeva l’ora di sapere in che modo il giovane Hans, trasformato in schiaccianoci, avrebbe sconfitto il Re-Topo. Cristina e Titti stavano per andare via quando il burattinaio si avvicinò loro chiedendo se volevano visitare le quinte: «Sai - disse rivolto a Titti - rassomigli moltissimo alla mia protagonista, Clara!» Le parole erano certo dirette alla bambina, ma lo sguardo dell’ uomo aveva catturato l’attenzione di Cristina che, un po’ titubante ma affascinata, accettò. Titti osservava ammirata le marionette appoggiate alle pareti, anche se, la loro espressione non sembrava più vivace come durante la rappresentazione, ma era certo perché mancava la voce ad animarle. Stava per aprire una tenda, quando l’uomo la bloccò: « No, piccolina, lasciamo quella parte per domani! » Uscirono dal tendone e, mentre Titti giocava con Mirko, il bimbetto suo vicino di panca, il burattinaio accompagnò fuori Cristina e le fece una garbata corte. La sera dopo, non saprei dirvi chi avesse più voglia di andare in pineta... se Titti o Cristina; erano ormai tre sera che si ripeteva la magia dello spettacolo, i bambini si conoscevano ormai tra di loro e aspettavano che altre marionette si aggiungessero a quelle che già erano comparse. Le note dello Schiaccianoci invitarono a prendere posto e il sipario si aprì, mostrando una fila di marionette: le bambole della favola, che lottavano per difendere il coraggioso soldato-giocattolo, che avrebbe dovuto sconfiggere il RE-Topo. Cristina si guardò intorno e: «Che peccato che Mirko non c’è, pensandoci bene anche Ketty, l’altra bambina con la quale Titti gioca spesso sull’altalena, non è venuta.» La battaglia delle bambole contro il Re-Topo era in pieno svolgimento, quando sul palco apparve... il burattinaio, nelle vesti del «Mago» che deve aiutare Clara a salvare lo Schiaccianoci e farlo acclamare Principe. Una leggera nebbia avvolse tutta la radura mentre i bambini erano come ipnotizzati e anche Cristina subiva il fascino e dello spettacolo e dell’uomo mentre la sua fantasia galoppava veloce. Uno strano pensiero però le attraversò la testa: «Ma come fa a stare in scena il burattinaio? Chi manovra le marionette?? e poi... Che strano! Il principe Schiaccianoci assomiglia in modo impressionante a Mirko... e la bambola è la copia esatta di Ketty. Certo, le facce hanno lo sguardo fisso e il trucco e i fuochi d’artificio scoppiettavano intorno. Cristina si accorse di non vedere più Titti si precipitò per andare a cercarla, attraversando una folla di bambini scalmanati che si allontanavano per raggiungere i propri genitori. Il panico la stava assalendo, non riusciva a trovarla: « Titti, dove sei? » gridava aggirandosi nella radura ormai vuota... Sentì una mano appoggiarsi sulla spalla e sobbalzò nel trovarsi di fronte il burattinaio che sorridendo le diceva di calmarsi, che Titti si era rifugiata sul palcoscenico non vedendola arrivare. La prese per mano e insieme entrarono nel tendone, dove effettivamente Titti si aggirava tra le bambole-marionette. «Posso offrirvi qualcosa di fresco? - chiese loro il burattinaio - Ho giusto dello sciroppo alla menta pronto per voi! » Così dicendo, alzò la spessa tenda nera che aveva attirato l’ attenzione di Titti la sera precedente, rivelando un piccolo salottino. Preso posto, il burattinaio portò loro le bibite fresche e iniziò a raccontare dei posti magnifici che visitava portando in giro il suo spettacolo itinerante. Le parole quasi prendevano forma ma Cristina sentì di non essere più lucida, incominciò a vedere le immagini sfuocate e poi... più nulla. Quando riaprì gli occhi, si accorse di non potersi muovere, aveva una cavigliera che la teneva legata alle assi del pavimento, ma vedeva e sentiva tutto «Ascoltami bene - le stava dicendo il burattinaio, - stai buona e non accadrà nulla a te e a Titti, ma la vostra vita sta per cambiare. Avevo giusto bisogno di una nuova Clara per il mio spettacolo e tua nipote fa proprio al caso mio. Le mie marionette sono eccezionali, ma o lavorano o sono morte per sempre!». Nel mentre lui parlava, Cristina guardandosi intorno, si accorse con orrore che Titti era appoggiata al muro con le altre marionette... il viso imbellettato, lo sguardo fisso nel vuoto e alle estremità delle braccia e delle gambe aveva dei fili. «Titti, scappa! » provò a urlare Cristina, ma la bambina restò immobile, solo dagli occhi spenti, scivolò una lacrima. Doveva essere trascorso molto tempo da quando lui l’aveva addormentata, perché si rese conto che stava iniziando un nuovo spettacolo, ma stavolta lei era dietro le quinte. Al ritmo incalzante della musica, si combatteva la lotta tra il Re-Topo e le bambole che sembrava danzassero, saltellando sul palcoscenico, ma lei sapeva che quella era una danza di morte, lenta e inesorabile. Ormai la parola vita, per loro aveva assunto un altro significato. La storia stava finalmente arrivando alla fine e a Cristina non restava che aspettare, per vedere come si sarebbe conclusa anche per loro. Sarebbero riuscite a riappropriarsi delle loro identità, o il destino avrebbe fatto di loro delle marionette nelle mani del «Mago»? Spente le luci, nella radura tornò il silenzio e Cristina fu raggiunta dal burattinaio il cui sguardo non lasciava presagire niente di buono. Sparito il sorriso dal suo viso, sostituito con un ghigno che incuteva timore, le sue parole suonarono come una condanna a morte: « Svelti, bisogna togliere le tende e se non volete che vi tronchi quei fili che avete addosso, datevi da fare. Avete visto quello che è successo all’altra Clara? Non potete scappare, potete solo accontentarvi del poco tempo che vi concedo alla fine degli spettacoli! » Detto ciò si allontanò per tornare con un unguento col quale unse la fronte delle marionette, che fino a quel momento erano rimaste immobili e rigide appoggiate al muro. Come per magia acquistarono morbidezza, le bocche si schiusero, e lo sguardo non più perso nel nulla si accese. Anche a Titti successe lo stesso, era questo il suo primo risveglio e come vide che nella stanza c’era la zia, corse a stringersi forte a lei «Zia, è terribile sai, vedere, udire e non poter fare nulla. L’unica cosa che ci permette di muoverci è la volontà del Mago che ci dice cosa fare. Ora lo so, è proprio un mago e noi siamo i suoi schiavi! » Cristina avrebbe voluto trovare le parole per rassicurarla, dirle che tutto sarebbe andato a posto, ma aveva ormai capito che tutti loro erano succubi di quell’uomo che era padrone delle loro vite. Avrebbero pagato a caro prezzo quelle ore di vita vera che lui era disposto ad offrire, avrebbero lavorato per lui pur di avere un po’ del suo unguento. La sua unica speranza era che qualcuno collegasse le sparizioni dei bambini alle rappresentazioni di Marionette... ma era così inverosimile. Anche lei non ci avrebbe mai creduto se non le fosse capitato in prima persona. Tutti i bambini si strinsero intorno a lei, ognuno di loro cercava conforto nel suo abbraccio, tanti braccini che la strattonavano, la tiravano per i vestiti e lei si sentiva impotente e confusa... Un pianto isterico le arrivava come da lontano e: «Signora, signora...forza si riprenda, smetta di urlare, così spaventa la bambina! » Un uomo in divisa, forse un vigile la stava scrollando dandole dei leggeri schiaffetti sul viso mentre il suo sguardo incrociò quello di Titti che piangeva singhiozzando. «Ma cosa è successo?Perché tutta questa gente mi sta intorno?» Mentre tornava in se, si rese conto che era accasciata sulla panchina sulla quale aveva preso posto per assistere allo spettacolo e che in lontananza il teatro delle marionette era quasi del tutto smantellato. «Zietta, che paura mi hai messo! Non riuscivo a svegliarti, dormivi agitandoti tutta e urlavi: “Lasciaci andare!” » Ormai tornata in se, Cristina si rese conto che era stato un brutto incubo e perciò abbracciò forte Titti e, ringraziando il vigile e le persone che le avevano prestato soccorso, si incamminò sulla strada del ritorno. Fu solo dopo aver fatto qualche passo che si accorse di un dolore alla gamba... e sollevando un lembo del pantalone scoprì con raccapriccio la cavigliera che ancora la stringeva forte. Ringraziamenti Un sentito ringraziamento ai nostri autori, che hanno creduto nel progetto Bad Clouds, a tutte le persone coinvolte nel progetto e a tutti i nostri fans che ogni giorno aumentano. A presto con altre storie targate Bad Clouds Agency! 5
Scarica