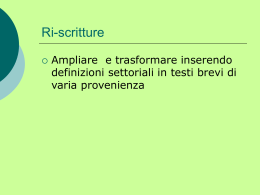Questo libro è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi e accadimenti sono prodotti dell’immaginazione dell’autore o sono utilizzati in maniera fittizia. Ogni somiglianza a eventi, luoghi o persone reali, vive o morte, è del tutto casuale. È proibito qualsiasi utilizzo non autorizzato del materiale presente in questo libro, sia totale che parziale. Copyright © 2014 by Austin Grossman. All rights reserved. TITOLO ORIGINALE: YOU Mulholland Books / Little, Brown and Company Hachette Book Group 237 Park Avenue, New York, NY 10017 mulhollandbooks.com Mulholland Books is an imprint of Little, Brown and Company, a division of Hachette Book Group, Inc. The Mulholland Books name and logo are trademarks of Hachette Book Group, Inc. Edizione italiana a cura di: Multiplayer.it Edizioni Coordinamento: Alessandro Cardinali, Francesco Giannotta Traduzione: Veronica La Peccerella Revisione: Giovanni Grotto Impaginazione: Andrea Turrini Cover: Stampato in Italia presso Grafiche Diemme - Perugia Prima edizione italiana: Maggio 2014 Finito di stampare nel Maggio 2014 ISBN: 978-8-8635526-1-4 http://edizioni.multiplayer.it A tutti coloro che creano giochi Perché sono azioni che un uomo potrebbe mimare; ma io ho tal cosa dentro me che è al di là di ogni mostra... —WILLIAM SHAKESPEARE, AMLETO SPADA IN UNA MANO, BLASTER NELL’ALTRA! REALMS OF GOLD è l’ultima novità nell’intrattenimento interattivo computerizzato sviluppata dai vostri amici di BLACK ARTS STUDIOS! SEGUI le avventure di QUATTRO EROI ETERNI attraverso MONDI INFINITI nella più grande esperienza interattiva mai creata. Nel continente FANTASTICO di ENDORIA, VIVI la lotta per ricostruire il mondo dopo le battaglie della SHATTERWAR, mentre la TERZA EPOCA giunge al termine. Nella GUERRA FREDDA DEL VENTESIMO SECOLO, confrontati con il maestro dello spionaggio KAROLY nell’eccitante mondo di CLANDESTINE. Nel LONTANO FUTURO, forgia il destino della razza umana in una GUERRA PER LA GALASSIA con SOLAR EMPIRES. * Incredibile grafica in Real Time a tre dimensioni. * Scegli tra quattro personaggi: Guerriero, Mago, Ladro, Principessa. * Tecnologia di simulazione all’avanguardia per rendere il mondo più vivo che mai. * TU determini la storia! TU scegli il tuo destino! CONQUISTA I REAMI! PUBBICITÀ BLACK ARTS STUDIOS GAMELORDS MAGAZINE, MAGGIO 1992 PRIMA PARTE IL GIOCO DEFINITIVO Capitolo uno “Allora, qual è il gioco definitivo secondo te?” La faceva suonare come una domanda perfettamente normale, e immagino che in quel contesto lo fosse. Il mio lungo pomeriggio di colloqui si era ridotto a un dialogo con quei due estranei. Un tipo alto, sulla ventina, con la faccia spigolosa e i capelli già grigi legati in una coda di cavallo, che pronunciava ogni cosa con estrema precisione, come se parlasse a un programma di riconoscimento vocale ipersensibile: l’altro che non arrivava al metro e sessanta, moro, con i capelli lunghi e ondulati tipo Gesù e una maglietta nera scolorita, data 1988, che recitava CTHULHU FOR PRESIDENT. PERCHÉ SCEGLIERE IL MALE MINORE? “Ok”. Deglutii. “Com’è che lo definireste esattamente?” Nessuna delle domande che mi avevano posto era come me l’aspettavo. Per lo più si era trattato di esoterici esperimenti mentali: “Come trasformeresti Orgoglio e pregiudizio in un videogame?”, e “Se dovessi aggiungere un comando a Pac-Man, cosa vorresti che facesse?”, oppure indovinelli tipo: “Come mai quando Mario salta può cambiare direzione a mezz’aria?” E ora questa. “Hai presente, il gioco che faresti se avessi carta bianca”, spiegò il designer con i capelli lunghi. “Dimentica il budget”, aggiunse il tipo basso. “Hai tu il comando. Puoi fare qualunque cosa! Il miglior videogame di sempre!” Aprii la bocca per rispondere e poi mi fermai. Era chiaramente una domanda buttata lì per chiudere il pomeriggio in allegria, 10 Austin Grossman e quindi era strano che la mia mente si fosse svuotata davanti all’unico quesito al quale avrei dovuto saper rispondere, dato che stavo facendo un colloquio per un lavoro come game designer. Avevo trascorso le ultime ore in uno stato di lieve shock intellettuale. Ero arrivato con quaranta minuti di anticipo all’indirizzo che un manager mi aveva dato al telefono – un anonimo complesso di uffici all’estremo limite della Red Line, oltre Harvard e Porter, dove Cambridge svaniva totalmente estinguendosi in parcheggi vuoti e ristoranti sul lato sbagliato di Alewife Brook Parkway, e poi nelle paludi, con le loro acque salmastre e le specie vegetali protette come il calamo aromatico e la pontederia. Oltre le paludi c’erano le colline boscose e i sobborghi, Arlington e Belmont e Newton, dove sono cresciuto. Alewife era costruito per essere un punto di scambio tra Cambridge e la periferia vera e propria. Era anche la sede di interi acri di spazio per uffici preteso da compagnie hi-tech nate dalla ricerca accademica e fondate dal dipartimento di difesa, da scuole di specializzazione in IT, da uffici per le risorse umane, agenzie immobiliari e commercialisti. Ritornare lì mi faceva sentire come se ce l’avessi fatta nella grande città, e ora fossi sul punto di andare di nuovo alla deriva nel nulla. Era lì che la software house Black Arts Studios aveva iniziato la sua attività. Questo edificio in particolare era stato costruito nei primi anni Ottanta, quando il dipartimento della difesa finanziava ancora compagnie hi-tech con progetti astrusi. Le pesanti porte di vetro conducevano a un atrio su tre piani e a un cortile con fontana, piastrelle dalle morbide tinte mediterranee e un’incongrua vegetazione a foglia larga in stile finto tropicale. Aveva un odore umido, da serra, persino nella tarda primavera stranamente fredda del 1997; i lucernari ghiacciati lasciavano filtrare una luce eternamente tenue. Circa metà dello spazio degli uffici sembrava vuoto. Black Arts era al terzo piano. Non c’erano cartelli o numeri YOU - Crea il tuo Destino 11 sulla porta, e così vagai avanti e indietro lungo la galleria finché vidi la scritta “BLACK ARTS” segnata con un pennarello nero su un foglio di carta, che era attaccato con lo scotch all’interno di una finestra di vetro rinforzato con della rete metallica. Non c’era nessun campanello. Attraverso il quadrato di vetro potevo vedere un’area di ricevimento vuota, e dietro di essa un’entrata aperta che conduceva a un ufficio mal illuminato. Non mi sentivo esattamente a mio agio nei colloqui di lavoro, e stavolta era persino peggio, perché conoscevo già quelle persone, e anche piuttosto bene. Ci eravamo incontrati tutti al liceo, quattordici anni prima. Adesso avrei chiesto un lavoro nell’azienda che avevano creato. Darren e Simon erano i cofondatori. Erano amici da tempo immemore, da sempre. Simon me lo ricordavo piccolo e con i capelli scuri, il viso tondo, la pelle olivastra che pareva non aver mai visto la luce del sole. Indossava camicie a scacchi e pantaloni di velluto a coste, e sembrava perennemente imprigionato in un corpo da ragazzino – a quindici anni ne dimostrava dodici. In teoria era molto intelligente, ma per qualche ragione non seguì mai i corsi avanzati. Era patetico, talmente goffo da sconfinare quasi nell’inquietante. La gente andava raccontando che aveva costruito delle bombe artigianali e che una volta aveva hackerato i voti di un ragazzo sul computer della scuola. Ridevano di lui, ma non in sua presenza. Darren era più alto, aveva la faccia da cavallo e una corporatura decentemente atletica. C’era stato un anno in cui aveva partecipato alle gare di corsa, ma arrivato al liceo si fece crescere i capelli, mollò l’atletica e i corsi avanzati, trovò una vecchia giacca dell’esercito e cominciò a indossarla continuamente. Erano un’istituzione, uno alto e l’altro basso, lo stesso tipo di perdente in due gusti diversi. Li vedevi tornare a casa a piedi ogni giorno, le mani di Simon che modellavano l’aria. Di cosa parlavano? Fumetti, film, battute che si portavano dietro dalla quarta elementare e che capivano solo loro? Un’altra amicizia tra adolescenti, un altro piccolo universo misterioso. 12 Austin Grossman Li avevo conosciuti alla presentazione di un corso di programmazione e sei anni dopo erano leggende, i due ragazzini scoppiati che avevano fondato una casa di produzione di videogiochi ed erano diventati ricchi. Ancor più dei soldi era allettante l’idea che avessero trasformato i videogame nel loro lavoro, persino prima che fosse chiaro che quella dei giochi per computer stava diventando un’industria, un business grande quanto il cinema, o ancora di più secondo alcuni. Simon e Darren facevano soldi... beh, in modo veramente figo. Anche Don e Lisa andarono con loro – diventarono ricchi, restarono lì, vinsero. Nel frattempo io proseguii con una laurea in Inglese, un anno di scuola di legge, uno stage in un giornale fallito di Dallas, subaffitti a Cambridge, nel Queens, a Somerville, San Francisco (un nuovo inizio!), Austin, Madison e, prossimamente, nel bel mezzo del nulla. Simon non prese mai la laurea. Morì quattro anni fa, in un ridicolo incidente che ebbe il risultato di far piazzare delle telecamere di sicurezza dentro i pozzi degli ascensori di tutti gli edifici di quel campus. Che non era neanche il suo. La gente aveva già iniziato a parlare di lui come di un genio pari a Bill Gates o Steve Jobs, e di cosa avrebbe potuto fare se fosse sopravvissuto. Il software che lasciò al mondo era ancora all’avanguardia, in un certo senso, anche se lo aveva scritto negli anni Ottanta, prima che i videogiochi fossero in 3D, prima dei drive per CD, prima della grafica fotorealistica. Il motore si chiamava WAFFLE, ed era una pozione miracolosa di simulazione di mondi e generazione procedurale di contenuti, ossia ciò che spinse i giochi della Black Arts prima al successo di critica, poi al guadagno e infine alla fama. Era ancora alla base di ogni gioco che facevano: aveva uno strano x-factor geniale, non era mai stato sorpassato e neanche duplicato. Prima di morire, Simon stava lavorando a un progetto che secondo lui avrebbe costituito la prossima generazione della tecnologia. Usò la parola “definitivo” più di una volta – in effetti, proprio nel titolo del suo progetto di ricerca (che doveva finalmente valergli una laurea al MIT; gliel’avevano anche offerta, una volta, ma lui non aveva mai dato seguito alla cosa). “Il gioco definitivo: un solido YOU - Crea il tuo Destino 13 schema per la Narrazione Generata Proceduralmente”. C’era stata persino una conferenza stampa, ma non ne era mai stata trovata neanche una copia. L’idea era ancora nell’aria alla Black Arts, come il teorema di Fermat della tecnologia videoludica. Dovrei aggiungere che la gente aveva l’impressione che Simon si fosse ucciso, oppure che fosse morto come parte di un gioco. È così che la notizia venne riportata dalla maggior parte dei giornali: “Morte di un gamer al campus”, come se una frase del genere avesse senso. Più di una testa di cazzo di professore di psicologia disse cose come: “Non è insolito, per coloro che si definiscono ‘gamer’, perdere la capacità di distinguere tra ciò che è gioco... e ciò che è realtà”. Prima di tutto, questo è un punto di vista francamente idiota. Gli appassionati di videogiochi non restano uccisi né impazziscono più spesso di chiunque altro. È solo che la gente lo sottolinea quando succede. Secondo, Simon aveva una vocazione, era una delle poche persone che avessi mai incontrato di cui si potesse dirlo senza alcun dubbio. Non aveva poco contatto con la realtà, le era semplicemente contrario. Terzo, vaffanculo la realtà. Se a Simon non piaceva il mondo in cui era cresciuto, aveva tutta la mia solidarietà e comprensione. Andai al suo funerale, come fecero i suoi molti amici. Non si trattava di un qualche zoccolo duro di giocatori incalliti; e poi, alla fin fine, anche un tizio in kilt che si presenta come “Griffin” può a buon diritto sentirsi sconvolto per la morte di un amico in un ridicolo incidente. Quando venni a sapere che Simon era morto, cercai di trovare qualcosa di appropriato da sentire. Quello che effettivamente provai non era lodevole. Non eravamo più amici dall’inizio degli anni Ottanta, ed ero ancora abbastanza giovane da considerare la morte di qualcuno che conoscevo come una cosa nuova, come se fosse solo un altro aspetto dell’eccentricità o del genio di Simon. Un altro posto in cui era arrivato prima di noi. Mi dispiaceva non essere rimasto in contatto con lui, mi doleva perché entrambi avevamo giurato di fare l’impossibile. Era l’unico voto che avessi mai fatto, e non ero riuscito a rispettarlo, mentre Simon – beh, era questo il punto... In parte 14 Austin Grossman ero lì perché volevo sapere cos’era successo esattamente, fino a che punto si era spinto Simon. Entrai. C’era odore di vernice fresca, potevo sentire qualcuno che rideva. “Ciao?”, chiamai verso il buio. Un adolescente con una maglietta nera guardò fuori. La sua corporatura aveva delle proporzioni da casa degli specchi – era alto quanto me, però era grosso il doppio, un ragazzo corpulento con le braccia e il petto di un linebacker. “Oh hey. Sei Russell?” “Sì, sono io”, risposi sollevato. “Io sono Matt. Aspetta un attimo”. Si voltò e gridò verso il corridoio: “È qui!” Mi fece entrare in una stanza che si rivelò grande quasi come metà del terzo piano dell’edificio. Era una caverna in penombra, tenuta nella semioscurità dalle veneziane alle finestre. Da ciò che potevo vedere era per lo più un open space. Lattine di bibite gassate e quantità industriali di pop-corn erano ammucchiate negli angoli, insieme a una palla da yoga, a pile di manuali illustrati a colori e a quella che pareva essere una balestra funzionante. Parevano i residui di una festa tenuta nel fine settimana da una banda di ragazzini di dieci anni terribilmente ricchi. In effetti c’era un uomo rannicchiato sotto una scrivania, in un sacco a pelo blu rigonfio. Una giovane donna con i capelli biondi legati in complicate trecce, un vestito batik e dei sandali era seduta con le spalle al muro e batteva sulla tastiera di un laptop, ignorandomi. Mentre aspettavo che Matt ritornasse osservai una parete con copertine di riviste incorniciate e premi “Game of the Year”. Mi avvicinai a uno dei computer che mostrava quella che all’inizio credetti la scena di una battaglia spaziale in un film, ma quando toccai il mouse la telecamera fece una panoramica e io mi resi conto che era un gioco, un vero mondo tridimensionale in cui si poteva navigare. Non avevo seguito molto i videogame negli ultimi anni, dopo che YOU - Crea il tuo Destino 15 avevo lasciato il college. Si erano trasformati in qualcosa di totalmente diverso, mentre non stavo guardando? Ero nato nel 1969, l’età perfetta per tutto ciò che aveva a che fare con i videogiochi. Significa che avevo otto anni quando uscì la console Atari 2600, undici quando nacque Pac-Man e diciassette ai tempi di The Legend of Zelda. I Personal Computer arrivarono proprio mentre i nostri cervelli stavano entrando nel primo fermento dello sviluppo cognitivo, giusto in tempo per marchiarci a fuoco. Era il 1978 quando presero a far uscire dalla classe i bambini nel bel mezzo della mattinata. Una donna dell’ufficio del preside (di cui non seppi mai il nome) li chiamava fuori con discrezione, due alla volta, in ordine alfabetico, e tornavano un quarto d’ora dopo. Quando arrivò il nostro turno, andai con un ragazzo di nome Shane. Sentii un formicolio d’eccitazione per la particolarità del momento, l’interruzione della routine. Venimmo condotti lungo il corridoio per sederci in un angolo dell’ufficio della segreteria, davanti a un aggeggio a forma di scatola che si rivelò essere un computer. Era nuovo, un Commodore PET. Il case del PET era un tutt’uno: monitor, tastiera e un drive per cassette integrato che formavano una piramide tronca ed enigmatica. Era un oggetto alieno, visibilmente costoso, futuristico in modo accecante in una stanza che puzzava del mimeografo usato per stampare opuscoli monocromatici di un pallido viola – una macchina azionata da una manovella nello stesso modo in cui si faceva alla fine dell’Ottocento, quand’era stata inventata. La donna ci fece sedere e si allontanò in silenzio. Io e Shane ci guardammo. Non so cosa provasse lui, ma dentro di me iniziò a smuoversi una consapevolezza: loro non sapevano cosa fosse quella macchina. Gliel’avevano data, ma non erano capaci di usarla. Non faceva granché. Non capiva né le imprecazioni né le parole normali. Ci giravano un paio di giochi: Snake e Lunar Lander. Dopo un quarto d’ora la signora ci riportò in classe e fece uscire altri due bambini, che avrebbero digitato altre parolacce. Eppure fu probabilmente il gesto più generoso e umile che abbia ricevuto da un adulto nei sedici anni passati a scuola. 16 Austin Grossman Quella donna ci stava semplicemente lasciando soli con il nostro futuro, un futuro di cui lei non sarebbe stata parte. Non sapeva cosa fosse né cosa farne, ma stava cercando di darlo a noi. Quel mezzo crebbe insieme a noi. I giochi arcade ebbero un boom alla fine degli anni Settanta e negli anni Ottanta, portando alla diffusione delle sale giochi, costruite in grandi magazzini riadattati e uffici con affaccio sulla strada, che facevano soldi a quarti di dollaro – un torrente di monetine rese scivolose dal sudore di mani adolescenti. Erano i cugini scemi e più cool del PET, così tranquillo e diligente. I videogame avevano il passo da bullo e l’insolenza becera del flipper, con in più l’aura inevitabilmente nerd dell’high-tech digitale. Ero più grande quando iniziai ad andare nelle sale giochi, forse avevo undici anni. Mi rilassavo in quell’oscurità tiepida e rumorosa, il muro di suono degli arcade e l’aria calda che sapeva di sudore, adolescenti ed elettronica. Il buio era rotto solo dai tubi di neon, dalle sfere da discoteca sfaccettate e dalla luce del botteghino dove si cambiavano i soldi. Quando ci si guardava intorno, era come vedere trenta cartoni della Warner Bros contemporaneamente, ma iperluminosi e a velocità raddoppiata. Il livello della tecnologia implicava che i personaggi fossero disegnati su griglie di pixel da 8X12: una scala primitiva, stranamente potente, con cani, postini e robot che divenivano luminosi pittogrammi sospesi nel buio. Le storie, sbrigative e buttate giù alla bell’e meglio, sembravano aver tirato fuori una vivida e capricciosa creatività dalle menti dei programmatori e degli ingegneri della prima ora. Quelle stesse limitazioni proiettarono i giochi in strani spazi non prospettici. Titoli come Berzerk e Wizard of Wor erano ambientati in un luminoso scenario à la Escher in cui una prospettiva aerea si combinava con quella laterale. E le trame, con la loro logica onirica... Mondi in cui toccare qualunque cosa significava morte istantanea, in cui i funghi sono amici e le tartarughe nemiche. In ognuno di essi percepivo la presenza di una logica profonda che esisteva appena al di là dello schermo, ognuno era un quadro dai YOU - Crea il tuo Destino 17 colori accesi, che raccontava una storia non del tutto spiegata: perché sono un idraulico che lotta con uno scimmione per una principessa? Perché sono un triangolo solitario che combatte contro una flotta di quadrati? Chi lo ha deciso? Gli adulti detestavano stare lì dentro. Gli dava il mal di testa, e poi li faceva sembrare stupidi, mentre tutti noi sapevamo già come giocare e cosa fare perché stavamo crescendo insieme a una tecnologia di cui capivamo le regole nascoste. Nel vorticoso brodo primordiale di bambini e adolescenti, gli ormoni e la tecnologia si stavano combinando per formare una nuova idea culturale. C’erano giorni in cui passavo fino a tre ore lì dentro, dopo la scuola, vagamente consapevole del fatto che eravamo le prime persone in assoluto a fare quelle cose. Sentivamo qualcosa che loro non avevano mai sentito, un collegamento fisico al mondo della finzione, che attraverso i muscoli scheletrici del braccio passava per il joystick arrivando fino al minuscolo tizio sullo schermo – una persona in un mondo immaginario. Era grezzo ma reale: ci eravamo costruiti un avamposto nell’ostile, inaccessibile mondo dell’immaginazione, come se avessimo fatto dondolare una batisfera nel buio schiacciante dell’oceano profondo, un reame fino ad allora inaccessibile all’umanità. Era questo che i videogiochi erano diventati. I computer avevano avuto origine nella crittografia militare – in un certo senso, ogni videogame rappresenta la conquista, da parte del desiderio di espressione umana, di un apparato militare per decifrare codici. Avevamo fatto questo, avevamo preso quell’idea e l’avevamo trasformata in qualcosa che i suoi creatori non avevano mai immaginato: la nostra personale, incandescente mitologia. Un’estate delle scuole medie finalmente ebbi un Apple IIe, un grosso cuneo beige di plastica con computer e tastiera in un solo pezzo, e uno schermo monocromatico a nove pollici. Scoprii il brivido criminale di usare programmi come Locksmith per duplicare giochi protetti su floppy disk da 5.25’’, e il trucco di sfruttare entrambi i lati del disco incidendo una mezzaluna da una parte con un buca-fogli. L’idea di simulare un mondo alternativo aveva conquistato migliaia di cervelli promettenti. Fu il progetto Apollo della 18 Austin Grossman nostra generazione, anche se forse l’analogia più adatta sarebbe con il progetto Manhattan: perché tutti volevano partecipare e ogni anno la tecnologia migliorava e diventava più veloce. Potevo sentirla, l’opportunità, la fortuna di una generazione nata insieme a una nuova forma artistica – proprio come Orson Welles era nato al momento giusto per fare Quarto Potere e definire così la grandezza di un medium. Era un’occasione per impossessarsi della rivoluzione artistica del nostro tempo, come Jane Austen o D.W. Griffith avevano fatto con il proprio. Quando avviavo un gioco, la schermata di caricamento mostrava la firma dell’hacker che l’aveva craccato – nomi come Mr. Xerox, The Time Lord, Mr. Krac-Man. Chi erano queste persone, chi craccava i giochi? E soprattutto, chi li faceva? Come diavolo si poteva ottenere un lavoro del genere? Era tempo di scoprirlo. Era tempo di dire qualcosa. Adesso avevo un pubblico di cinque o sei persone. Era tutto il giorno che la gente entrava e usciva svogliatamente dalla sala conferenze per ascoltare o fare qualche domanda. Tutti uomini, però, finché non arrivò Lisa. La terza fondatrice della Black Arts aveva l’aspetto che ricordavo: pallida, con una grande fronte che la faceva sembrare un alieno da cartone animato. Aveva abbandonato i vestiti a fiori in favore di un’enorme T-shirt nera tipo tenda. La ricordavo ai tempi del liceo, in quei viaggi in macchina per tornare a casa alle due o alle tre del mattino: d’inverno guidava con il finestrino abbassato e il riscaldamento sparato al massimo. “Il gioco definitivo”, dissi. “Posso fare tipo... qualunque cosa?” Loro annuirono. Io mi sentii ridicolo. Il gioco definitivo era quello in cui galoppavo per le strade in sella a un rinoceronte rosa alto una trentina di metri, inseguendo i miei nemici? Quello in cui i pezzi degli scacchi prendevano vita e parlavano in strane rime? Oppure era semplicemente un gioco in cui vincevo sempre? “Rilassati, amico”, disse il tizio basso. “Qualunque cosa ti piaccia. Il tuo gioco”. YOU - Crea il tuo Destino 19 Era difficile dire cosa ci fosse di particolarmente strano in quei due. Magari il fatto che, anche se tutto in loro gridava “sfigato”, non sembrava importargliene, anzi tenevano un portamento da re in T-shirt... “Allora... Ok, ok. Si gioca a scacchi, no? Ma tutti i pezzi sono dei mostri, e quando ne prendi uno devi... davvero... combatterci?” Perché mi stavano guardando così? “Intendi come in Archon? Quello per il Commodore 64?” “Uhm. Esatto”. Lisa aggrottò le sopracciglia ancora un po’. Un tizio con la barba, più in fondo, alzò gli occhi al cielo, come se non credesse a che razza di perdente fossi. Indossava un cappello da giullare. Eravamo arrivati a questo. Quello che avrei voluto dire, senza riuscirci, quello che sentivo davvero aveva a che fare con ciò che provai scendendo dall’auto quella fredda mattina di settembre, il mio primo giorno a Dartmouth, il primo giorno in cui avevo avuto l’opportunità di essere una persona nuova e di far funzionare le cose dopo l’inferno del liceo. Quanto avrei voluto tornare a quel momento! Simon e Darren avevano scelto di essere, come dire, grandi, e io non l’avevo fatto, mi ero comportato da bravo soldatino e avevo tentato di diventare adulto, dimenticandomi della donna della segreteria, del computer PET e di cosa significasse vedersi offrire il futuro. Prima di andarmene mi fermai da Don, il quarto fondatore e attuale CEO dell’azienda. A differenza degli altri impiegati aveva un vero ufficio, in una stanza laterale, con una finestra panoramica che guardava sulla distesa buia dell’area di lavoro. “È bello rivederti”. Mi strinse la mano con forza, un saluto da adulti. “KidBits, giusto? Come stai?” Era persino più alto di come lo ricordavo. Si era fatto crescere la barba, e gli si addiceva. “Bene, bene. Darren è qui?”, domandai 20 Austin Grossman “È ancora in Nepal. È lo stesso di sempre. Allora, vuoi davvero lavorare qui?”, mi domandò. Questo era il momento per cui mi ero preparato meglio: avevo persino fatto delle prove davanti allo specchio. Distolsi lo sguardo e scivolai in un falso atteggiamento noncurante. “Mi sa di sì, Don. Il diritto sta diventando un po’ noioso – vorrei passare ad altro, capisci?” “Design? Programmazione? Produzione?” “Design, direi. Ma anche produzione. Non sono sicuro. Come programmatore faccio schifo più o meno come sempre”. “Jared ti ha fatto la domanda sul gioco definitivo?” “Già. Era una buona domanda”. “Lo è, vero? Credo che ti chiameremo”. “Grazie, amico”. Ci stringemmo di nuovo la mano. Mentre uscivo incrociai Lisa, che aveva l’aria di tornare da una sosta al distributore automatico. “Bella risposta”, disse. “Archon”. Negli anni Ottanta non sapevano ancora cos’era l’Asperger, altrimenti gliel’avrebbero affibbiata. “Grazie”, risposi. “Ci vediamo”. Volevo fermarmi per dare un’altra occhiata ai giochi, ma non avevo pretesti per farlo, così mi avviai nel freddo della sera. Fuori continuai a pensare a come sarebbe stata la mia vita se fosse divenuta un videogame. Il gioco più palloso di tutti i tempi. “Sei in un parcheggio mezzo vuoto accanto a un palazzo di uffici in una periferia del Massachusetts. Il colloquio è finito e il sole sta tramontando. Cosa fai adesso?” GUARDA “Puoi vedere le auto che accendono i fari mentre risalgono la collina della Route Two e poi iniziano la lenta discesa verso Cambridge, per imboccare la rotatoria di Alewife. Inizia a fare freddo. Non hai nessun posto dove andare”. YOU - Crea il tuo Destino 21 INVENTARIO “Un logoro portafoglio di cuoio. Indicazioni per arrivare all’ufficio scritte sul retro di un volantino per un reading di poesie aperto a tutti. Un blazer blu navy. Ti sei vestito in maniera del tutto esagerata per l’occasione”. OVEST “Cammini lungo la pista ciclabile. Passi dietro a un ristorante di pesce. La maggior parte dei terreni intorno al parcheggio non è mai stata edificata. Qui crescono liberi dei lillà, piccole querce ed erba alta. Dove credi di andare esattamente?” OVEST “Riesci a stento a sentire l’autostrada alle tue spalle, e presto il suono svanisce del tutto. Puoi ancora vedere il sole attraverso i rami sopra la tua testa. Stranamente, trovi dei binari che attraversano il sentiero. Da quando qui c’è una linea ferroviaria? Non viene usata da molto tempo, ma la segui comunque. Camminare ti tiene al caldo. Le querce crescono tra le traversine. In alcuni punti riesci a stento a trovare il binario in mezzo alla terra e alle foglie. Presto o tardi imboccherai una svolta, troverai Massachusetts Avenue, prenderai un autobus per tornare a Cambridge e fine della storia. Mah. Secondo te, comunque, perché devi interpretare questo personaggio?” OVEST OVEST OVEST “Dio, cammineresti per sempre se servisse ad andarsene da qui. I binari ti portano su una salita, e poi vedi un’altalena attraverso una fila di alberi. Sei sul retro di una scuola elementare, ed è lì che ti colpisce il ricordo, quello che ti ha tormentato tutto il tempo. Sono passati anni dall’ultima volta che ci hai pensato, ma ritorna, 22 Austin Grossman lo respiri a pieni polmoni come l’odore di tappeto bruciato della macchina con cui Darren ti portava in giro”.
Scarica