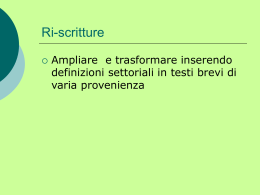Prima edizione: giugno 2013 © 2013 Newton Compton editori s.r.l. Roma, Casella postale 6214 Published by agreement with Trentin e Zantedeschi Literary Agency ISBN 978-88-541-5024-9 www.newtoncompton.com Realizzazione a cura di TAB Stampato nel giugno 2013 presso Puntoweb s.r.l., Ariccia (Roma) su carta prodotta con cellulose senza cloro gas provenienti da foreste controllate e certificate, nel rispetto delle normative ecologiche vigenti. Corrado Spelli La stanza del dipinto maledetto Newton Compton editori A Riccardo, Elettra e Francesca La città di Perugia, fin dall’Alto Medioevo, aveva fatto parte dello Stato pontificio, pur mantenendo una sostanziale autonomia dal punto di vista civico. Nel corso del xv secolo i legami si erano ulteriormente allentati, anche grazie all’egemonia esercitata sulla città dalla famiglia Baglioni, inizialmente filopapale. A partire dal 1531 ci furono alcuni tentativi di liberare quei territori dal controllo di Roma, alcuni di questi guidati dal condottiero di ventura Ridolfo Baglioni, che fu allontanato a più riprese dalla città. Nel 1539, in un momento di dura carestia, papa Paolo iii propose un aumento della tassa sul sale, che venne respinta dal Consiglio dei priori, che governava la città. Nel marzo del 1540 giunse la dura risposta del pontefice: la bolla di scomunica per l’intera popolazione perugina. Il Consiglio dei priori si sciolse e il suo posto venne preso dal Consiglio dei Venticinque, composto da cinque rappresentanti per ogni porta della città. Mentre il papa preparava l’intervento militare, la fiducia della popolazione nel governo dei Venticinque scemava ogni giorno di più, di fronte alla sua incapacità di agire. Il primo aprile del 1540 fecero ingresso nel territorio perugino le truppe pontificie, condotte da Pier Luigi Farnese, figlio di papa Paolo iii. Le speranze del popolo si riversavano sul valoroso condottiero Ascanio della Corgna e sul possibile intervento di Ridolfo Baglioni, in quel momento di stanza a Cortona, al soldo di Cosimo de’ Medici, in guerra con il papa. Ma altri cavalieri, figli delle più nobili casate perugine, erano pronti a combattere. 7 1 10 maggio 1540 «Se ad avverarsi sarà quello che temo, il buio tornerà a regnare su questa città per diversi anni a venire. Io me ne andrò, Morgante, non potrei sopportarlo». L’anziano Giuseppe di Fortebraccio, piegato dal peso dagli anni e avvolto in un lucco che sembrava ancorarlo al pavimento, guardava il misero mercanteggiare che si spegneva nella piazza ai piedi della sua finestra. Una manciata di poveri contadini erano giunti in città a portare i loro scarsi raccolti: verdure raggrinzite e selvaggina con più ossa che carne. Li vedeva raccogliere i loro quattro stracci e incamminarsi verso lontane dimore, fuori dalle porte della città. Chiuse gli occhi, pensando al loro destino. Da alcuni mesi una tosse antipatica gli si era aggrappata alla gola, ogni frase proferita veniva accompagnata da due colpi di fiato che gli sferzavano l’esofago, come una frusta di spine. Ma il suo pensiero si staccava e andava altrove. I suoi occhi si alzavano, di tanto in tanto, a scrutare l’orizzonte che si stagliava oltre i tetti che scendevano lungo il colle, disordinati. Gli pareva di poter vedere l’avanzare delle truppe di Pier Luigi Farnese, anche se ancora non erano così vicine. Suo figlio Morgante sapeva che il padre non se ne sarebbe mai andato da Perugia, a malapena usciva dal suo palazzo, a dirla tutta, per cui era certo che sarebbe morto lì, qualsiasi cosa fosse successa. Ma non era questo il punto. «Non andrà così, padre, siamo tutti uniti, non riusciranno a entrare in città». C’era tutta l’incoscienza dei vent’anni nelle parole del figlio, Giuseppe lo sapeva, e questo gli 9 strappò un pur debole sorriso. Morgante era alle sue spalle, stretto in un farsetto color lionino che a malapena tratteneva l’agitazione del giovane. «Siamo quindici, tutti uniti, abbiamo giurato ieri sera, combatteremo fino alla morte, se sarà necessario», continuò Morgante, che mal sopportava la scarsa considerazione che, talvolta, suo padre aveva di lui. Eppure la voce tremava, usciva con esitazione dalla bocca, tradendo i suoi timori e dando ragione all’anziano genitore. «Sarà necessario, temo», rispose il padre, girandosi verso di lui. Non era un tentativo di spaventarlo ancor di più, sapeva che il suo rampollo non sarebbe indietreggiato, almeno a parole, ma era una considerazione dettata dalle forze in campo, perché la guerra che si preannunciava era impari. Le truppe papali erano in numero nettamente maggiore e molto meglio organizzate. La furia del Farnese si era già abbattuta su Bastia e Foligno, e puntava dritta a Perugia, incontrando solo deboli resistenze, accompagnando ogni metro percorso con devastazioni e saccheggi. «Ascanio della Corgna è con noi». Il padre, udito quel nome, sembrò indugiare, ma solo per un attimo. «Ci ha già rimesso un occhio, a combattere e dar di spada, non vi sarà di grande aiuto, almeno se non trova il suo tornaconto. Radunate una bella somma, vi assicurerete i suoi servigi, almeno fin quando non ci sarà qualcun altro che gli offrirà di più». «E allora, padre, cosa dovremmo fare?» «Non so. Io andrò a morire lontano da queste strade, per quanto mi costerà fatica». A quelle parole Morgante non riuscì a rispondere, deluso. La saggezza del vecchio sembrava svanita e rimpiazzata da una stanca codardia. Il giovane capiva la sfiducia che avvolgeva i pensieri del padre, mentre l’anziano invidiava lo sfrontato vigore che il ragazzo ostentava. Ma tra loro non c’era punto d’incontro, se non il timore che l’impresa da compiere, per difendere quelle strade, fosse più grande delle loro possibilità. 10 Allora Morgante salì a cavallo e galoppò verso sud per raggiungere la dimora di Goffredo Trabalza, posta all’altro lato della città. Lungo la strada gli parve di incrociare soltanto pezzenti che, come topi impauriti, si infilavano furtivi nei pertugi delle loro abitazioni. Il rossore del tramonto gli fece pensare che la stola del pontefice si fosse già arrotolata a quei palazzi, soffocandoli. «Hai notizie?». Morgante si era tolto il mantello e aveva raggiunto Goffredo all’interno del suo studiolo. I legni lavorati che rivestivano le pareti di quell’ambiente riuscivano a sorprendere ogni volta il giovane Fortebraccio. Mirabili intarsi narravano il panegirico delle virtù del Trabalza, il quale, come se non bastasse, era rappresentato in alcuni dipinti appesi alla zona alta delle pareti, la sua figura si alternava a santi e filosofi dell’antichità. «Considerando che hai solo tre anni più di me», lo provocò Morgante, «devi averne trascorsi almeno la metà in posa davanti a pittori e scultori». Alle sue spalle, Goffredo abbozzò un sorriso, mentre i suoi lunghi boccoli biondi uscivano da un copricapo a spicchi e si andavano ad appoggiare ordinati su di una corta guarnacca color porpora, sormontata da un numero imprecisato di perle. Una rigida gorgiera di pizzo gli circondava il collo fin sotto al mento e sembrava rapirgli il fiato, mentre le mani erano protette da raffinati guanti di velluto color verde, tagliati all’altezza dell’anulare sinistro per lasciar spazio a un anello d’oro sormontato da pietre di lontana provenienza. Morgante non faceva più caso a questi vezzi di cui il suo amico era schiavo. «Dovresti curare la tua barba», lo ammonì bonariamente Goffredo, «sembra una boscaglia inesplorata su cui si è abbattuto un temporale estivo». «Il mio cavallo è troppo veloce, la barba si scompiglia». Goffredo sorrise, poi lo aggiornò su quello che sapeva. «Le truppe del Farnese non trovano resistenza, eppure non corrono, vagano in tutte le direzioni, non sembrano 11 aver fretta di arrivare qui. Questo mi hanno riferito». Era serio, mentre riportava ciò che alcuni mercanti di tessuti gli avevano raccontato quella stessa mattina. «E qual è il tuo pensiero?» «Chi voleva mettersi in mezzo, con l’idea di portar pace, ha fallito. Perché la pace bisogna volerla, da entrambe le parti. Invece il papa vuole questa città, a ogni costo. Tasse e scomuniche sono soltanto pretesti per rimettere le mani su queste terre. La gente ha paura, lo si sente nell’aria. Un mese fa, quando la guerra era lontana, erano tutti pronti a combattere, ma ora che questa ipotesi sembra l’unica strada percorribile hanno cambiato idea. Ci sono famiglie in procinto di partire, pronte a fuggire o ad alzare le mani in resa, sperando di essere risparmiate. Altri hanno già riparato altrove». «Non hai fiducia nel Consiglio?» «Perché, tu ne hai, Morgante?» «Ormai poca, ad essere sincero». «È un’accozzaglia di nomi rispettabili, brava gente che saprà soltanto trattare la resa, e temo che non sarà nemmeno dignitosa». «Sai qualcosa di Ridolfo Baglioni?» «Sei per caso andato in pellegrinaggio sotto al crocifisso appeso nel duomo, come fanno tutti?». Goffredo rispose stizzito, per quelle che, secondo lui, erano le inutili speranze riposte nel condottiero. «Ho sentito dire che sta rientrando in città, con il suo esercito al seguito». «Allora prepariamoci a far festa, caro Morgante, perché soltanto quello ci porterà Ridolfo. Un paio di giorni di festa. Fumo negli occhi per questo popolo di miserabili». Goffredo era del tutto pessimista, ma al tempo stesso risoluto e pronto a imbracciare le armi. Più di altri aveva motivo di difendere Perugia: lì aveva enormi ricchezze, che mai avrebbe voluto vedere depredate. «Solo noi», continuò guardando l’amico dritto negli oc12 chi, «soltanto noi, che ieri abbiamo incrociato occhi e spade, possiamo salvare Perugia, non aspettiamoci altri aiuti, tantomeno dal Baglioni, che per due denari andrebbe a combattere contro sua madre». Morgante apprezzò quelle parole. La sicurezza che Goffredo sapeva trasmettere era di grande aiuto per lui, la cui anima vacillava dinanzi alla possibilità di sguainare le armi. L’ultimo rimasto dei Trabalza, invece, era già stato in battaglia, tre anni prima, proprio al fianco del Baglioni. A Montemurlo avevano assalito le milizie di Sandrino da Filicaia. In quella occasione, Goffredo aveva perso il fratello maggiore, Ferrante, ucciso da un colpo di archibugio. Straziato dal dolore aveva così deciso di rientrare a Perugia, riportando a casa il corpo del fratello, perché il loro padre, ormai malato, potesse omaggiarlo. In seguito non si era più aggregato alle truppe di Ridolfo, convinto che la morte di Ferrante fosse stata causata dalla impudente condotta in battaglia del Baglioni. «Preparati», concluse Goffredo, estraendo da una nicchia la sua cinquedea bolognese, «verranno giorni gloriosi». 13 2 Oggi Ero rassegnata. Contavo quante volte, negli ultimi cinque anni, la mie valigie si erano adagiate sul letto per lasciarsi riempire fino a scoppiare. Sapevo stipare in maniera razionale vestiti e oggetti, come in un tetris di jeans, libri e felpe. Sbuffavo, a dir la verità non avevo più voglia di fare e disfare bagagli e scatoloni a distanza di pochi mesi. Intanto mio fratello restava sdraiato sul divano, a gambe all’aria; armato di un cucchiaio, andava a caccia di nocciole nella vaschetta del gelato. Lui era immune, ciò che stava accadendo non lo sfiorava neppure. Come in tutte le occasioni precedenti, mi attendevano chilometri di asfalto da macinare pigiati in una Mercedes blu notte con gli ammortizzatori esausti, più simile alla macchina di un’agenzia di pompe funebri che all’automobile di una famiglia inglese benestante. Papà alla guida, mamma di fianco, mio fratello alle spalle dell’autista e io al lato. Nessuna colonna sonora concessa, nell’abitacolo regnava un silenzio di tomba, salvo qualche radiogiornale oppure saltuari scambi di banalità tra marito e moglie. Io mi estraniavo, cuffie nelle orecchie e palpebre chiuse. Siviglia, Strasburgo, Firenze, Parigi, Praga, Avignone, Segovia, Ingolstadt e, prossima fermata, Perugia, che non sapevo nemmeno dove fosse. Un continuo allontanarmi da Londra, la mia città, dove ero nata e avevo trascorso i primi quindici spensierati anni della mia vita. Tutto questo peregrinare soltanto per rincorrere le glorie professionali di mio padre, direttamente proporzionali alla tristezza che provavo ogni volta che mi trovavo a creare 14 una nuova cerchia di amici, che non sarebbero mai stati amici veri. «Stavolta sarà tutto più facile», aveva detto mio padre, solo un mese prima. A tavola, mentre masticava un pezzo di pane, subito dopo aver annunciato l’ennesimo trasloco. Mamma, nel frattempo, portava in tavola patate al forno e bistecche impanate, fingendo, senza riuscirci, di non sapere. «Siamo già stati in Italia e ci siamo trovati bene…», guardava soltanto me, ero l’unico scoglio da superare, ogni volta. Ci trovavamo bene a Firenze? Certo, giugno e luglio dei miei sedici anni, con i cugini di Reading nostri ospiti per l’intero soggiorno. Ma stavolta loro non ci sarebbero stati. «Lì la gente è aperta, solare, e poi Perugia è una città piena di ragazzi che arrivano da tutto il mondo. Ti ambienterai in poco tempo, fidati. Conoscerai anche tanti studenti inglesi, starai meglio che a casa». Insisteva, tra un boccone e l’altro, frenetico nel parlare e nel mangiare, eccitato dalla sua nuova avventura. La mia reazione era sempre la stessa, spegnere il cervello: non sopportavo questa enfasi nel volermi convincere che si andava in un posto speciale. Ogni volta la stessa storia. Avrei preferito un ordine secco e perentorio come “si parte, non si discute!”, tanto il succo del discorso era quello: non erano mai previste alternative. «Ci vuole poco a migliorare, papà», gli avevo risposto, senza alzare gli occhi dal piatto. «Peggio di Ingolstadt non c’è nulla». Lui aveva sorriso, gli bastava che lo seguissi. Ammucchiavo vestiti, libri, qualche cd a cui ero affezionata e altri ricordi; traslocare è molto più semplice che andare in vacanza: non devi scegliere cosa portarti dietro, devi raccogliere tutto, dalla a alla zeta, resettare la mente e ricominciare, memorizzare qualche strada, il nome di un paio di locali, trovare tre o quattro mezze amiche per sopravvivere giusto qualche settimana. 15 Per mia madre, invece, non cambiava nulla; lei non lavorava e non coltivava amicizie, non perdeva tempo a imparare la lingua del luogo e le bastava conoscere due vocaboli utili per uscire vincenti da un pomeriggio al centro commerciale; riempire una busta di generi alimentari era l’unico compito da svolgere al di fuori delle quattro mura domestiche. Da devota donna delle Midlands, sposata con un londinese di successo, aveva come unico scopo nella vita quello di portare le ciabatte al marito e friggergli, di tanto in tanto, un trancio di merluzzo appena commestibile. Anche Michael, mio fratello minore, non avrebbe avuto difficoltà a inserirsi: aveva l’istinto del branco ben sviluppato, lui. Poi era un fuoriclasse nel pallone, e questo gli bastava per essere amato e accettato ovunque andassimo. Io, invece, non avevo carte da giocare per farmi accogliere in qualche gruppo: lo sport era una cosa che non mi apparteneva; pigra e scoordinata, nello studio ero mediocre, facevo il minimo indispensabile per non avere problemi in famiglia. Mi potevo ritenere carina, perlomeno basandomi sulle reazioni dei ragazzi ogni qualvolta mi presentavo al primo giorno di scuola. Alta un metro e settanta, coi capelli neri e lisci che scendevano composti appena sotto le spalle, avevo una carnagione più scura di quella che ci si aspettava da una ragazza inglese. I miei occhi erano verdi, il dono migliore fattomi da mio padre, e spuntavano da una frangia ben curata e volutamente asimmetrica, idea geniale di un parrucchiere tedesco, un ex punk convertito ai saloni di bellezza. Mi bastavo così, non facevo nulla di più per mettermi in mostra, non avevo mai curato troppo la mia immagine. Odiavo rivestire il ruolo della preda esotica, nella gara “vediamo chi è il primo che si fa la straniera”. Avevo deciso che mai avrei dato alcun segnale di interesse per i maschi, tedeschi, spagnoli, italiani o francesi che fossero: nessuno mi avrebbe mai avuta in premio, fino al mio definitivo ritorno a Londra, dove nessuno, tuttavia, mi attendeva. “Perugia è una città di una bellezza straordinaria”, reci16 tava la guida per turisti che avevo preso in mano in un momento di sconforto durante il lungo viaggio dalla Baviera all’Umbria. C’era scritto che il clima era piacevole, la cucina saporita, e il centro storico tra più antichi del mondo, vale a dire che era composto da chiese e palazzi tetri. Scenari angoscianti che, già lo sapevo, non mi avrebbero di certo sollevato il morale. Se proprio non potevo tornare in Inghilterra, avrei preferito Barcellona, Madrid o qualcosa di simile: necessitavo di luce, spazi aperti e strade larghe, non di cupi vicoli medievali e piazze in perenne penombra. Chiusi di nuovo guida e occhi e alzai il volume dell’iPod fin quando la voce di Badly Drawn Boy non coprì qualsiasi rumore esterno. Mancava ancora un mese all’inizio dei corsi universitari, meglio così. Nel frattempo, forse, mi sarei trovata un’amica, un’alleata con la quale affrontare il debutto in società. Più probabilmente sarei rimasta chiusa in casa, a leggere libri e a tramortirmi di musica, scegliendo la strada di un’abulica sopravvivenza, cercando di passare inosservata fino al successivo incarico di mio padre che mi avrebbe spedita in una nuova prigione. Mi addormentai. Dopo undici ore di viaggio praticamente ininterrotte, arrivammo a Perugia. Avevamo preso casa in un quartiere periferico, una villetta fuori porta a Santa Susanna, con strade in saliscendi e giardini curati; mi chiedevo chi, in famiglia, avrebbe preso a cuore siepi e fiori. Tutt’attorno c’erano costruzioni bianche e gialle: guardavo svogliata attraverso il finestrino, in attesa che mio padre infilasse l’automobile dentro un cancello qualsiasi. In fondo non potevo lamentarmi, sembrava una zona tranquilla, abitata da gente rispettabile. «Eccoci, numero 93!», gracchiò lui eccitato, mentre rallentava, incollando la faccia al parabrezza. La macchina saltò sul marciapiede, facendomi sobbalzare. Svogliata, presi in mano l’iPod, pronta a scendere. 17 «Vedrete, vi piacerà!». Era in fibrillazione, non gliene importava nulla della casa, lo sapevo bene, voleva soltanto immergersi nel suo nuovo incarico. Avrebbe messo avanti le lancette del tempo, se solo avesse potuto. Nel momento in cui aprii la portiera dell’auto, un’ondata di caldo sembrò avvolgermi come gelatina, una secchiata di umidità che mi piegò le ginocchia. Dovetti fermarmi un attimo per riprendere fiato e dar modo alla mia pressione sanguigna di allinearsi alle condizioni ambientali. Poi, trascinandomi a fatica sotto il sole che mi bruciava la pelle, entrai per la prima volta nella nuova casa. Era buia, con le tapparelle ancora abbassate che trattenevano un piacevole profumo di vernice fresca, ben diverso dal puzzo di stantio dell’ultimo appartamento in cui eravamo stati. «Qual è la mia camera?», chiesi subito. «La prima a sinistra, una volta salite le scale», rispose mio padre, affannato dal peso delle tre valigie che si portava dietro. Corsi su per la rampa, impaziente di chiudermi nella mia gabbia. La stanza era grande e luminosa. Considerando che durante il soggiorno a Perugia avrei passato lì la maggior parte del tempo, potevo dirmi soddisfatta. Avevo perfino un bagno tutto mio. Sistemate le valigie nelle rispettive camere, ci eravamo ritrovati tutti a tavola per pranzo; avevamo gli occhi rossi, carichi di stanchezza, e ci sentivamo spaesati. «Questa è una delle città d’arte e storia più rinomate d’Italia!», disse papà, cercando di tirar su il morale della truppa. La pennellata di buonumore era diventata una tradizione. «Io sono stanca morta, penso che andrò a letto, oltretutto fa un caldo infernale». Lasciai sul piatto mezza bistecca e mi andai a rinchiudere in camera. Subito, però, mi assalì il senso di colpa: non volevo che mio padre si facesse prendere dai rimorsi, in fin dei conti lavorava duro per mantenerci; d’altra parte, io non ero capace di fingermi felice, avevo 18 quasi vent’anni ed ero a centinaia di chilometri da quella che ritenevo essere la mia vera vita. Mi sdraiai sul letto, mentre il resto della famiglia andava in avanscoperta nella nuova città. Non capivo dove trovassero la forza, dopo tutte quelle ore di auto. Accesi l’aria condizionata al massimo. Mi arrivava addosso un getto d’aria gelida, sapevo che non era salutare ma ammalarsi poteva essere una buona scusa per rintanarsi a casa fino all’inizio dei corsi. Non mi addormentai: con le cuffie nelle orecchie saltai di pezzo in pezzo, non oltre i venti secondi per brano, come mia abitudine; mi bastava assaggiare il ritornello per passare oltre. Nelle ultime settimane non mi ero più sentita neppure con Christine, la mia amica e anima gemella. Le avevo scritto alcuni messaggi, ma non mi aveva risposto; il tempo, forse, ci stava dividendo, e questo acuiva la mia insofferenza. «Elizabeth, Perugia ti piacerà un sacco, vedrai…», papà si affacciò alla mia stanza, bussando con educazione, con uno sguardo estasiato, per ribadire ancora una volta il suo concetto. «Tra l’altro abbiamo incontrato il signor Santucci, l’agente immobiliare che ci ha trovato questa casa, quello che ho conosciuto quando sono venuto a fare i primi sopralluoghi. Domani sera siamo invitati a cena da lui!». Abbassai il volume dell’iPod e annuii in modo convincente, tanto per dargli corda. Lui riprese: «Hanno una figlia che ha la tua stessa età, magari è simpatica e trovi un’amica con cui passare un po’ di tempo». Sprizzava gioia in maniera nauseante. Tornai ad annuire, sforzandomi di non essere scortese, di lasciar trasparire addirittura un briciolo di felicità; ma in verità no, dio santo, ero a dir poco terrorizzata, reputavo le amicizie combinate peggio dei matrimoni. Stavo per alzare il volume della musica, quando lo vidi varcare la porta. Non intendeva mollare. 19 «Lo so che non è facile per te», disse in tono di scusa. «Ma ormai sei grande, se vuoi prendere la tua strada lo puoi fare, se vuoi tornare a studiare in Inghilterra, o andare altrove, ne possiamo parlare, ti aiuterò e ti capirò. Però, fidati, questa è la città giusta, con una grande tradizione universitaria… staremo qui per diversi mesi e avrai tempo di ambientarti. Stavolta sarà diverso. Ma ti ripeto, se vuoi tornare a Londra, non ti fermerò». Non mi aveva mai detto una cosa simile, e non mi aveva mai appoggiato una mano sulla spalla con tale delicatezza. Ci rimasi male. Tolsi le cuffie dalle orecchie, non sapevo cosa rispondere, mi sentivo incastrata, sotto scacco. «Io non ho intenzione di andarmene da nessuna parte, papà», dissi con voce ferma, alzandomi dal letto. «Semplicemente sono stanca di cambiare posto in continuazione… non appena riesco a fare amicizia, arriva il momento di ripartire. Ma mi abituerò anche qui, non ti preoccupare». Mi abbracciò e io ricambiai con sufficiente forza per farlo felice. Dentro di me sapevo di avergli fatto un regalo immenso. In quel momento il bene che gli volevo era sincero, tuttavia mi proposi di non dimenticare la sua promessa, che avrei tenuto a mente. Quello per me sarebbe stato l’ultimo trasloco: alla partenza successiva sarei rientrata a Londra, e ci sarei rimasta per sempre. Come da prassi mi trascinai indolente per casa fino alla sera seguente, quando andammo a cena dai Santucci. Mentre scendevo le scale mio padre aveva storto il naso, vedendomi vestita con la solita noncuranza: All Star consumate, jeans sdruciti, una maglietta a maniche corte dei Kaiser Chiefs e il giubbotto di pelle arrotolato in vita, tra l’altro inutile vista la temperatura tropicale che opprimeva ancora la città. Casa Santucci distava poche centinaia di metri dalla nostra. Metri che, per fortuna, affrontammo in automobile. 20 Appena entrata, notai che era arredata con gusto, mobili semplici ma scelti con cura, senza troppi orpelli a sormontarli, alle pareti opere d’arte moderna di grandi dimensioni illuminavano le stanze, il legno in terra era talmente lucido che ci pensavi bene prima di pestarlo. Notai subito che i Santucci erano cordiali fino alla nausea, un meravigliarsi continuo per i successi professionali di mio padre, che raccontava le sue faccende trattenendo a stento l’imbarazzo, lui che era di poche parole e dalla timidezza innata. Mia madre non capiva una parola e sorrideva. Mio fratello s’ingozzava masticando a bocca aperta, e le mie occhiatacce non bastavano a contenerlo. «Ti va di venire in centro?». Erica, loro figlia, sembrava una ragazza a posto, e conquistò la mia simpatia quando, a metà della seconda portata, con uno sguardo furtivo mi fece capire che quella cena era qualcosa di insopportabile e che ci avrebbe pensato lei a trovare una scappatoia. «Elizabeth», disse ad alta voce in un momento di silenzio, «vuoi venire in camera mia? Ti faccio vedere alcuni opuscoli dell’università». «C’è ancora il dolce!», la interruppe sua madre, squadrandola in malo modo. «Sì, certo», accettai, e mi scappò una risatina che tentai di celare: figuriamoci cosa poteva fregarmene degli opuscoli universitari, ma avevo intuito la strategia e mi ero prontamente accodata. Erica era già in piedi, non aveva nemmeno atteso la mia risposta. «Scendete per il dolce?», insistette la madre. Io tentennai, per educazione, ma finsi di non sentire. «Sì, scendiamo. Fidati che scendiamo», la rassicurò Erica, distrattamente. Non lo avremmo fatto, lo sapevamo già entrambe. «Geniale», mi complimentai sottovoce, mentre la seguivo per le scale. 21 «Non è per i tuoi genitori… anzi. Il fatto è che proprio non sopporto queste cene». «Non sei l’unica». «Vieni, dai», mi invitò sorridendo nella sua stanza, ma mi bloccai sulla soglia. Non avevo mai visto tanta confusione: montagne di vestiti stropicciati su una sedia, sulla scrivania, sul computer; una pila di libri di fianco al letto, riviste e iPod sul materasso, bottiglie d’acqua mezze vuote sparse ovunque, e ancora libri e cd. Non avevo idea di dove sedermi. «Non si sopportava più», sbuffò. Ora potevamo parlare ad alta voce. «Erano due anni che non partecipavo a una “cena ufficiale” con ospiti! Queste cose sono una vera rottura». Allargò le braccia, poi si mise a cercare qualcosa. «Dillo a me…». «Senti una cosa… ma tuo fratello, lo vuoi salvare? Se vuoi possiamo chiamare anche lui, non ho molto da offrire ma…». «Lascialo dove sta, si trova bene. Lui pensa solo a mangiare, dormire e giocare a football, gli basta quello», biascicai in italiano. Mi guardò confusa. «Il calcio», precisai. «Pensa solo al calcio». «Buon per lui», rispose, e prese un pacchetto di sigarette nascosto sotto un paio di felpe. Poi si spostò in terrazza e si sedette per terra, accese un fiammifero sfregandolo contro il muro ruvido, lasciando una strisciata di zolfo rosso, e incominciò ad aspirare. «Sono proprio maleducata: fumi?». Allungò il pacchetto verso di me. «No, grazie». L’avevo seguita e mi ero sistemata davanti a lei. A Londra, intorno ai tredici anni, avevo provato a fumare, ma non mi era piaciuto. Fumavano tutti, in quel periodo, e io, non volendo essere da meno, facevo qualche tiro insieme 22 alle mie amiche e poi rientravo a casa masticando gomme alla menta. «I miei non lo sanno. Te lo dico così, a titolo informativo. Giusto per… ecco… be’ nel caso, sì, non si sa mai. Hai capito…». Parlava alla velocità della luce, gesticolando come una forsennata, si mangiava le parole, la seguivo a malapena, mi concentravo cercando di stare al passo con le frasi sconnesse che le uscivano dalla bocca. «Non lo sanno e fumi in casa? Non hai paura che ti scoprano?» «Vengo in terrazza». Lo disse come fosse la cosa più semplice di questo mondo. «Poi diciamo che, in verità, secondo me lo sanno, ma fanno finta di niente per evitare il problema, capisci?». Sarà, pensai. Annuii. «Quieto vivere», disse. «Abbiamo le nostre zone franche, ognuno si fa un po’ di fatti propri, e così siamo in grado di sopravvivere sereni sotto lo stesso tetto». Aspirò ancora e sputò fuori una nuvola di fumo grigio. «Io mi faccio qualche sigaretta, mio padre naviga sui siti porno… non sa cancellare i file temporanei», precisò, «così l’ho scoperto». Sorrise maliziosa. «E tua madre?» «Oddio…». Ci pensò per qualche secondo. «Lei è senza peccato, troppo buona, troppo innocente». Questa è pazza, pensai ancora, proprio l’amica di cui avevo bisogno. La sua pelle era più chiara della mia, molto più bianca di quanto ci si aspetti da un’italiana. Attorno al naso aveva i rossori tipici di una bruciatura, e si portava addosso qualche chilo di troppo. I capelli a caschetto erano castano chiaro, con dei residui biondi di vecchie tinte; era fasciata da jeans attillati e da una t-shirt ancora più stretta, e questo la rendeva molto simile a una ragazza delle mie parti. Mi raccontò della scuola superiore appena finita e dell’università che, proprio come me, stava per cominciare. 23 Sconfessò in meno di un minuto tutte le teorie di mio padre, precisando che Perugia era una città «di merda» ma che, in fondo, c’era di peggio, ad esempio tutto quello che stava a sud di Perugia, Roma esclusa. Insomma, in Italia si salvavano Milano e la capitale, tutto il resto era un agglomerato di contadini e io, che ero nata in Inghilterra, potevo dirmi baciata dalla fortuna. Poi con una sfilza di luoghi comuni, iniziò a blaterare sulle sue due trasferte a Londra. «Appena puoi torna là», sentenziò, cercando di convincermi con lo sguardo. «Voglio farlo. Presto». «Qui non si sta da schifo, per la verità», aggiunse dopo un attimo, quasi ritrattando. «Obiettivamente è una bella città, ci sono un po’ di turisti e parecchi studenti stranieri, quindi si vedono facce nuove tutti i giorni e c’è una certa vita. Ce la spassiamo, tutto sommato!». Fece spallucce, poco convinta. Si era pentita di avermi terrorizzata e ora cercava di rimediare. «Ma tu mi capisci bene?», chiese, parlando sempre più veloce. «L’italiano, dico, lo capisci bene?» «Abbastanza». Mi fissò con aria interrogativa. «Sono già stata in Italia per un lungo periodo, a Firenze, poi per parecchio tempo in Spagna… ho fatto qualche corso… però tu parli molto veloce, a volte mi perdo qualcosa… ma va bene comunque». Rise. «Lo so, me lo dicono tutti. Faticano anche le mie amiche». Spense la sigaretta nella terra di un vaso di gerani, poi avvolse il mozzicone in un foglio di carta e andò a gettarlo in un cestino sotto la scrivania; prima di tornare in terrazza accese lo stereo. Dalle casse usciva musica dance, un poco pacchiana. «Però», concluse, «un conto è se ci vieni a fare un weekend, oppure per un anno di studio, un altro è se ci vivi: in 24 questo caso Perugia non può offrirti nulla più di un posto da segretaria o da cameriera». E si infilò due dita in gola. «Tutte le piccole città sono così». «Penso di sì, sono d’accordo con te, per cui la fuga è l’unica soluzione. Comunque adesso sei qui, e non puoi capire quanto sei stata fortunata a conoscermi, perché la tua nuova amica Erica ti spiega in due minuti tutto quello che devi sapere per sopravvivere in questo posto. Vuoi una penna per prendere appunti?». Fece finta di alzarsi. «No, memorizzo, grazie». Sorrisi, mi stavo divertendo davvero. Dovevo sforzarmi per seguirla nei suoi ragionamenti sconnessi, ma mi piaceva e il mio impatto in quella nuova avventura sembrava essere meno duro del solito. «Qui tutto comincia verso le sei di sera, quando si va in centro a fare l’aperitivo. Ci sono diversi locali carini; l’aperitivo spesso sostituisce la cena, si mangia e si beve e si fa direttamente serata. Poi ci sono alcune discoteche decenti, ma spesso si finisce per gironzolare tutta notte, entrando e uscendo dai locali, sempre più ubriachi. A cena fuori si va soltanto con il ragazzo, oppure ci vanno le studentesse straniere sfigate… per “cena fuori” intendo stare seduti a ordinare guardandosi negli occhi. Ci sono tanti posti pieni di ragazzi, per cui è inutile starsene fermi nello stesso buco per due o tre ore consecutive». «Ho capito». Non era vero, mi ero persa a metà discorso. «Ora vorrai saltare subito al capitolo ragazzi, immagino». Si alzò per prendere una scatola di gomme da masticare. «Non importa», risposi. «Non importa? Dici davvero?». Mi guardò stralunata e tornò a sedere. Continuò come una macchinetta sputa parole. «Be’ se ci tieni… passiamo al capitolo ragazzi». Mi scappava da ridere, mi veniva difficile spiegare che al momento non ero troppo interessata all’argomento. 25 «Guarda che se un giorno dovessi venire io a trovarti a Londra, la prima cosa che voglio fare è il tour dei ragazzi del quartiere». «Con me capiti male, davvero, sono fuori dal giro». «Con due occhi così? Non si esce dal giro con due occhi così». Arrossii. «Hai il ragazzo?» «No. Niente ragazzo». «Wow… hai tendenze lesbo per caso?». Spalancai gli occhi, non avevo proprio capito. «Ti piacciono le ragazze?» «Nooo!». Scoppiai a ridere ancora più forte. Era pazza, in tutto e per tutto. «E allora ascolta ché ti servirà!». Dio santo, un fiume in piena. «Faccio una premessa… sei molto carina, per cui ti salteranno addosso tutti. Ascolta la mia lezione, perché è necessario fare selezione fin da subito, ti eviterà molti problemi in futuro». «Ok», feci per ricompormi, come fossi una scolaretta diligente. «Io punto soltanto gli stranieri, in linea di massima americani, inglesi o nord-europei, posso fare eccezione per gli australiani e i brasiliani, ma sono rarissimi da trovare. Se pesco quello giusto, che magari può portarmi via da qui, a Los Angeles per esempio, allora bene, se non è quello giusto, poco male, tornerà presto a casa sua e chi si è visto, si è visto. Tu sei inglese, magari ragionerai in altra maniera, no?» «No, no, mi sembra un pensiero logico». La sua sfrontatezza mi metteva a disagio. «Allora ascolta…». Erano ormai le dieci e mezza passate, il tempo era volato, Erica mi aveva sommersa di parole, senza darmi tregua. Dal piano inferiore, nelle rare pause di silenzio, giungevano le voci divertite dei nostri genitori. 26 «Non voglio dire che a Perugia ci conosciamo tutti…». Si stava truccando davanti allo specchio che aveva di fianco al letto. «Ma almeno di vista ci si conosce quasi tutti. Però, come ti dicevo, c’è molto turismo, perlopiù famiglie o coppie, anche qualche giovane, tipi da InterRail, per intenderci, molti inglesi e tedeschi, o giù di lì. Magari trovo un inglese, e vengo a Londra anch’io», disse ridendo, mentre buttava oggetti alla rinfusa nella sua borsa. «E ora dalla teoria alla pratica! Andiamo a fare un giro, dai!». Si era messa addosso un abito a fiori, stretto sui fianchi, che le arrivava appena sopra le ginocchia, e finiva per metterle in risalto almeno due rotoli di grasso. Non era una scelta azzeccata, ma non glielo dissi. Poi calzò scarpe con i tacchi e niente altro, solo una piccola borsa di Louis Vuitton. «Secondo te è meglio se mi vado a cambiare il vestito?», le chiesi, mentre indicavo la sua mise griffata paragonandola alla mia divisa da concerto rock. Non mi andava e non avevo nient’altro da mettere, ma volevo comunque evitare di essere guardata di traverso. «No, non ci sono problemi, qui ti fanno entrare dappertutto, vai benissimo come sei». Sorrise. Io non capii se lo avesse detto in tono dispregiativo o se stesse scherzando, ma non insistetti. Per guadagnare l’uscita fummo costrette a passare di fianco alla tavola dei nostri genitori, così il padre di Erica si lasciò andare a una serie infinita di raccomandazioni; non mi ci volle molto a capire che la mia nuova amica aveva la patente da pochi mesi. Sua madre ci puntava, sconsolata: il resto del suo dolce sarebbe tornato in frigorifero. «Guido piano, non bevo e non mi drogo! Tutto chiaro papino», lo interruppe Erica bruscamente a metà della predica. Io la seguivo, sapendo di avere il tacito consenso di mio padre, che si fregava le mani nel vedermi già integrata. 27 Lasciammo l’auto in un grande parcheggio a pagamento, poi mi fece strada sulle scale mobili. «Be’… non mi posso lamentare…», dissi a un certo punto, lasciando in sospeso la frase. «Cosa?» «Prendere le scale mobili per andare in centro, mi ricorda Londra». «Ah, capito», sorrise lei, «bene, le similitudini con Londra finiscono qui, rassegnati». «Mi accontenterò». «Però queste scale non bastano, dovrai comunque scarpinare in salita, preparati». «In che senso, scusa?». Non ero sicura di aver capito bene. Non scherzava: fuori dal tubo in plexiglass che conteneva le scale ci aspettava una ripida scalinata. Pochi gradini e incominciai ad avere il fiatone, la mia condizione fisica era pessima. Quando Erica, che mi precedeva di pochi passi, girò a destra, alzai lo sguardo e mi trovai dinanzi un lungo vicolo ancora più ripido. Non vedevo la fine, ed Erica procedeva con un passo da guida alpina. Rassegnata mi misi in marcia, cercando di nascondere l’affanno. I palazzi antichi ci scrutavano dall’alto: i vicoli, che trafiggevano la strada da entrambi i lati, mettevano l’ansia per quanto erano angusti, e la vista non andava oltre qualche manciata di metri. Ritornai con il pensiero in Francia, a Carcassonne, quando dieci anni prima mi ero smarrita in una viuzza affollata. I ricordi non erano nitidi, ovviamente, ma la sola idea di quel momento mi angosciava ogni volta. Rivedevo quella donna che insisteva per farmi entrare nel suo negozio di souvenir. Poi mio padre che mi raggiungeva, mi alzava da terra e mi metteva sopra le sue spalle. Per fortuna bastarono pochi passi per raggiungere la strada principale. Era larga e gremita di gente. «Questo è corso Vannucci», disse Erica voltandosi verso 28 di me. Si era accorta di come la breve salita mi avesse stesa, e si era fermata. «Due minuti di attenzione poi ti porto a bere, così ti riprendi. Dicevo, questo è corso Vannucci, e più o meno il centro della città è tutto qui», concluse quasi schifata. Mi guardai attorno ed ebbi l’impressione che tutti gli abitanti si fossero riversati in strada: c’era un mare di gente appollaiata ovunque, sulle sedie fuori dai bar, sui gradini delle porte dei palazzi, ragazzi appoggiati alle saracinesche dei negozi, a statue, ringhiere, tutti con in mano qualcosa da bere, e poi qualche turista attempato che si riconosceva dall’abbigliamento d’ordinanza: pantaloni corti, sandali e macchina fotografica al collo. Come sottofondo un vociare incessante. «Voglio portarti in un posto, poi la visita è finita». «Va bene». Arrancavo dietro di lei, che andava come un treno. «Ecco», disse dopo un centinaio di metri, «questa è la piazza principale di Perugia: il Duomo, il Palazzo dei Priori con la Galleria d’Arte, la Fontana Maggiore…». Gesticolava come un vigile. «Di qua, di là, a nord e a sud. Chiese, palazzi antichi, vicoli stretti e bui, fontane, salite e discese a volontà. Sembra di stare in un cavolo di museo. Meglio andare a bere!». Qualcuno si era fermato a guardarla. «Ho capito, ho capito», risposi, frastornata e ancora una volta sorpresa da quel modo di fare. «Andiamo a divertirci, dai, che è meglio». Mi prese sotto braccio, marciando con baldanza. Salutò un paio di persone e io per educazione feci altrettanto con una smorfia imbarazzata che doveva somigliare a un sorriso. Raggiungemmo una terrazza che si affacciava sulla vallata aperta ai piedi della città. Perugia alta ci dava le spalle e ci avvolgeva, davanti a noi il vuoto e le luci in lontananza. Non avevo la minima idea di cosa ci fosse là sotto ma l’atmosfera era splendida: un sacco di ragazzi che cercava29 no refrigerio su quella enorme palafitta, con la musica in sottofondo che lasciava spazio alle parole. Non era affatto male. «Vieni, le mie amiche saranno qui in giro», gridò Erica, anche se non ce n’era bisogno. Poi mi afferrò per un braccio, facendomi strada. Era su di giri, ancheggiava vistosamente, guardandosi a destra e a sinistra. La sua andatura, impetuosa e sgraziata quando eravamo celate dai vicoli, ora sembrava quella di una sinuosa pantera a caccia della sua preda. Le amiche di Erica erano quattro: Carlotta, Eva, Rebecca ed Eleonora. Stavano in piedi nell’angolo estremo della terrazza, appoggiate alla ringhiera di metallo, proprio sotto un amplificatore, l’unico punto dove il volume diventava fastidioso. Mi accolsero con baci e abbracci: sapevano già del mio arrivo, Erica le aveva avvisate con un messaggio. In meno di un minuto mi ritrovai in mano un bicchiere che conteneva un intruglio rosso poco rassicurante. «Se non ti piace lo bevo io e ti faccio fare qualcosa di diverso, tanto grazie a Erica siamo raccomandate, non facciamo la fila e non paghiamo». Da quanto avevo capito dalle presentazioni, chi parlava doveva chiamarsi Rebecca. «Scema», la interruppe Erica, fingendo di colpirla con la borsetta. «Lasciamo stare, non sei nemmeno degna di essere colpita con una Louis Vuitton». «Lo sanno tutti che ti sbava dietro», disse Rebecca rincarando la dose. «E allora? Dovresti essermi riconoscente, grazie a me bevi gratis senza fare la fila». «Riconoscente a vita». Alzò le mani e fece cenno di inchinarsi. Mi girai a guardare, c’erano almeno tre ragazzi dietro al bancone, tutti e tre carini a prima vista, assediati da una folla assetata. «Quale sarebbe?», domandai per rompere il ghiaccio. 30 Erica si avvicinò. «Quello con la maglietta bianca attillata». «Dai, non male». «No, però… non rientra nei canoni…», fece roteare la mano, come a riportarmi indietro fino alla sua lezione di un paio d’ore prima. «Ho capito», la rassicurai, fingendo di prenderla sul serio. «Lo tengo un po’ sulla corda», precisò subito. «Almeno per un altro mesetto, fin quando questo locale non chiude, giusto per evitare la fila e risparmiare qualche euro sulle bevute». «Seee!», intervenne Rebecca. «Un ragionamento sensato». Cercai di darle corda, mentre le altre ridevano. Erica fece un passo indietro, quindi le indicò tutte, a una a una. «Bevono e se la spassano alle mie spalle, irriconoscenti puttanelle!». Strabuzzai gli occhi. Aveva notevolmente alzato la voce, e tutti si misero a ridere, non soltanto noi. Finii il mio bicchiere, mentre quelle quattro continuavano a farsi passare le bevute sottobanco: cocktail azzurri, birre in bottiglia, calici di vino, gin tonic, vodka Red Bull; bevevano a una velocità impressionante, ricordavano certe ragazze inglesi. Mi lasciai prendere la mano e andai oltre i limiti a cui ero abituata negli ultimi tempi. Mi guardavo attorno, soddisfatta per come stava andando quella prima serata. Tutte le ragazze che vedevo sembravano belle, abbronzate, ben curate nel trucco e nel taglio di capelli. Mostravano una collezione di borse monomarca, jeans attillati e scarpe con i tacchi. Più volte mi giustificai per il mio abbigliamento, lasciando intendere che alla successiva uscita avrei rimediato. Per la verità non avevo scarpe con i tacchi e neppure borse firmate, ma in qualche modo mi sarei arrangiata. Poi raccontai a turno a ognuna di loro la mia vita passata, come ero finita in quel posto e cosa avrei fatto nel 31 futuro. Tutte mi chiesero se ero fidanzata, sembrava l’unica cosa a cui erano interessate veramente. «Non ho il ragazzo», dissi per quattro volte, senza aggiungere altro. «Giusto, fai bene», risposero tutte. Probabilmente erano appena uscite da storie d’amore fallite. Evitai di indagare, le ginocchia mi tremavano e i miei pensieri erano ovattati dall’alcol. Più tardi ci sedemmo a un tavolo, avevo la vista annebbiata e mettevo a fuoco con notevole fatica. C’era un continuo viavai di ragazzi che si avvicinavano a noi, alcuni un po’ ubriachi ma mai molesti. Io ero nuova, carina, straniera, attiravo la curiosità di tutti, ma nessuno, tutto sommato, si prendeva troppa confidenza; sganciai qualche sorriso di prassi, probabilmente risatine da ebete, visto com’ero ridotta: ormai in dirittura d’arrivo. Vedevo il letto alla fine del tunnel, e pregavo in silenzio perché qualcuna di loro decretasse la fine della serata. «Conosci tutti?», chiesi a Erica, che salutava gente in continuazione. «Più o meno…», gridò, anche lei decisamente alticcia, «però vengono in processione per chiedere di te», indicandomi e fingendosi gelosa. Risposi con un cenno del capo, in leggero imbarazzo ma allo stesso tempo lusingata. «Voglio dire, sei appena arrivata, sei carina, sei straniera, è normale, no?» «Immagino di sì». «C’è da dire una cosa…». Continuava a urlarmi nelle orecchie. «Qui le straniere si danno da fare un casino, insomma parecchio… sono una preda facile da conquistare e quindi attirano subito le attenzioni di questi sfigati qui attorno. Noi solitamente le odiamo… è concorrenza sleale». Si mise a ridere. «Comunque sia, il novanta per cento dei maschi locali sono dei buoni a nulla… lascia perdere, te l’ho già spiegato». Sì, era ubriaca e un po’ gelosa. Avevo afferrato il concetto. 32 «Sei ubriaca?», mi chiese. «Un po’». «Ottimo inizio allora». «Già… gran bel debutto». Buttai giù un sorso di Smirnoff, l’ultimo della serata, poi mi accasciai su un divanetto, fissando il cielo stellato. Avevo raggiunto il limite. Quando alle tre di notte imboccai l’uscita insieme a Eleonora, di Erica non c’era traccia, così come delle altre ragazze. Avevo perso di vista la mia vicina di casa senza nemmeno rendermene conto. Tornai sulla strada schivando alcuni reduci, che come zombi erranti cercavano la via del ritorno o un altro riparo. Tra loro rividi Erica: era in un angolo buio, tra due palazzi, avvinghiata a un ragazzo. Cercai di mettere a fuoco la situazione. Tutto il mio corpo era intorpidito e i ragionamenti avevano bisogno di diverso tempo per potersi definire tali. Li formulavo in inglese, e per come ero ridotta, fra tradurli e riferirli al prossimo in modo comprensibile ci voleva una vita. Così restai a guardarli senza dire niente, finché non mi venne da ridere: lui allungava le mani ovunque, lei si dimenava quasi per difendersi, ma restava lì. «Chissà chi cazzo è quello», disse Eleonora. Poi riprese a camminare, mentre io continuavo a fissarli. «Vieni dai!», urlò Eleonora per distogliermi. Anche lei barcollava, si era sfilata le scarpe, nonostante per terra ci fossero diversi cocci di vetro. «Ho capito», aggiunse sconsolata. «È quello stronzo di Mioni». «Il barista?», domandai. «Macché barista», rispose Eleonora. Si era appoggiata a una macchina per massaggiarsi i piedi. «È un cretino che la prende in giro da due mesi. Dopo aver fatto lo stesso con Rebecca, con Eva e con metà delle ragazze che c’erano in quel locale». Indossò nuovamente le scarpe e riprese a 33 camminare come se stesse su dei trampoli; i tacchi finivano inesorabilmente tra un sampietrino e l’altro e le sue esili caviglie si piegavano come bacchette. Tornai con il pensiero a Erica e alla sua “lezione” sui ragazzi italiani sfigati. «Io cerco solo stranieri», aveva detto, e mi scappò da ridere. Intanto seguivo Eleonora, senza sapere dove fosse diretta, aspettando istruzioni sul da farsi. «Senti», mi disse, «Erica non la recuperi più, ti conviene prendere un taxi per tornare a casa, io sto dall’altra parte della città, quindi non vengo con te, però ti accompagno e ti faccio vedere dove ne puoi trovare uno». Sembrava mantenere una certa lucidità. «Da qui a casa tua spendi poco… andare a piedi da sola alle tre di notte è una cazzata, anche qui c’è brutta gente, extracomunitari, drogati, ubriachi…». Dovevo aspettarmelo, mica poteva essere il paradiso. «Sì, certo. Se mi mostri la fermata dei taxi mi fai un favore». Ci avviammo per la stessa strada già percorsa quando ero arrivata, fino a raggiungere la piazza in fondo a corso Vannucci. La città era cambiata, svuotata: alle tre e mezza il silenzio era calato ovunque, il rumore dei tacchi di Eleonora echeggiava lugubre. C’era una coppia che fumava una sigaretta sui gradini di un palazzo, altre persone stavano sedute sul selciato della chiesa mentre un gruppetto di uomini dalle facce poco raccomandabili vigilava davanti a un bar con la serranda a metà. Passammo accanto al Duomo e ci insinuammo in una strada in parte coperta, camminammo per circa trecento metri senza incontrare nessuno. Il buio e il silenzio di quei vicoli non erano solo motivo d’ansia, mi facevano paura. Paranoie da cocktail, pensai. Di tanto in tanto un lampione arancione illuminava a stento qualche metro di strada, ma subito tornava a regnare l’oscurità. «Non c’è più nessuno in giro?», chiesi. Avevo bisogno di sentire una voce, dopo tutta l’allegra confusione di quella 34 serata il silenzio mi innervosiva. Mi mancava la petulante Erica, Eleonora era di poche parole. Poi mi stava montando il mal di testa e la nausea post bevuta. «A quest’ora quelli buoni sono dentro ai locali, in giro restano gli sballati e gli spacciatori… c’è brutta gente, te l’ho detto! Una volta Perugia era diversa». «E noi?» «E noi, appunto, rientriamo nella categoria degli sballati». Eleonora era molto più tranquilla di me, di certo abituata a camminare avvolta da quel silenzio. Stavo per risponderle quando esplose un tuono fragoroso, roba da far tremare i muri di quegli antichi palazzi. Ci arrestammo in mezzo alla strada. Ebbi un sussulto e il cuore, per un attimo, sembrò salirmi in gola. «Pensa un po’», esclamò lei alzando gli occhi al cielo. «Ora viene a piovere». Mi guardò. «Che hai? Sei pallida, tremi». «Sì». Avevo le pupille sgranate. «Mi è preso un colpo», ammisi con molta sincerità, riprendendo fiato e tenendomi il petto, poi sorrisi allo scampato pericolo. Guardai in alto: in quella piccola fetta di volta lasciata libera dai palazzi non si vedevano stelle. «Comunque», continuò Eleonora per tranquillizzarmi, «Perugia non è Londra… con un po’ di cautela si può girare tranquille. A quest’ora però è sempre meglio farsi accompagnare». Imboccammo una strada ancora più stretta, dove poteva passare a malapena uno scooter; non c’era illuminazione e quel poco che si vedeva era grazie ai lampioni delle due strade che la incrociavano. L’aria era molto più fredda e umida rispetto a quella che si respirava pochi metri prima. Per quella manciata di passi trattenni quasi il fiato, guardando fissa davanti a me, poi in breve raggiungemmo una via un po’ meno buia, dove transitava qualche automobile. Tornai a rilassarmi, cercando di non farmi notare. Fu lì che trovammo due taxi parcheggiati di fianco al marciapiede. 35 Gli autisti dormivano entrambi, uno di loro con un cappello a coprirgli la faccia. «Eccoti sana e salva!», disse Eleonora sorridendo. «Dove hai la macchina?», le chiesi. «Qui dietro». Indicò un incrocio a poca distanza. «Ti porterei a casa io se non fosse che mi tocca attraversare tutta la città e a quest’ora ci sono diversi posti di blocco, rischio la patente». «Figurati, non importa». «Allora ci vediamo domani». «Sicura? Se la macchina è lontana vieni in taxi con me». «Macché… è proprio qui dietro, stai tranquilla, sono salva». Sorrise ancora. Lasciai andare la mia nuova amica da sola, la guardai camminare per alcuni metri. Le avrei voluto dire che era comunque meglio il taxi, perché aveva bevuto parecchio, ma non mi andava di fare la mammina. Giocava in casa e sapeva quello che faceva. Bussai sul finestrino e svegliai l’autista. Le prime gocce di pioggia, tanto grosse da riempire una tazza da caffè, colpivano la carrozzeria dell’auto provocando un sordo rumore metallico. «Sei tedesca?» «Inglese». Cominciò a piovere a dirotto. Passammo di fianco a un paio di locali ancora aperti nei quali si era rintanata la poca gente rimasta in giro. Il tergicristallo iniziò a fare il suo mestiere, graffiando sul vetro. Il finestrino era un po’ aperto ed entrava l’odore di asfalto bagnato, che adoravo. La testa aveva ripreso a girarmi, l’alcol voleva riprendersi il mio corpo e la pioggia aumentava d’intensità. «Potresti chiudere il finestrino?», chiese il tassista. «Ah, sì, subito». Avevo chiuso gli occhi, cercando di tornare con il pensiero alla pioggia inglese, così diversa da quello scroscio violento che in pochi istanti aveva invaso le strade e riempito 36 di odori e rumori l’abitacolo. Il tergicristallo non riusciva a togliere tutta l’acqua che si riversava sul parabrezza, non capivo come facesse quell’uomo a guidare, non si vedeva che a pochi metri di distanza e sentivo gli strattoni che subiva la macchina quando finiva immersa nelle pozzanghere. «Un bel temporale», disse, girandosi verso di me, «t-e-mp-o-r-a-l-e, capito?». Mimò la pioggia che cadeva, lasciando per un istante il volante. Un tassista con la voglia di parlare non potevo sopportarlo, non a quell’ora e in quelle condizioni fisiche. «Sì, sì, ho capito, io parlo italiano», tagliai corto nella speranza che tornasse a guardare la strada, portandomi a casa sana e salva. Lui mi guardò e ridacchiò, più compiaciuto dalla rinnovata possibilità di comunicazione che preoccupato dal mio tono. Stava per replicare quando una figura scura sbucò dal lato sinistro della strada e ci si parò davanti all’improvviso. L’autista riuscì a schivarla per un soffio, incrociando le mani sul volante in una sterzata quasi disperata. Il taxi finì sul marciapiede, sobbalzando con violenza e arrestandosi a una manciata di centimetri da un muro. Io mi ero tenuta stretta ai sedili che avevo davanti, sballottata di qua e di là. Fermata la corsa, alzai la testa e guardai l’uomo che avevamo quasi investito. Era in piedi, immobile in mezzo alla strada, sotto la pioggia battente: non sembrava per nulla turbato da quello che era successo, anzi, alzò lo sguardo verso di noi. Il suo viso, avvolto dalla penombra, sembrava giovane, gli occhi si facevano strada nel buio, scuri e profondi, bellissimi e cupi. La pioggia gli schiacciava i riccioli neri sulla fronte. Fu solo un istante ma mi sentii paralizzata, e il sangue si gelò nelle vene. Poi, veloce come era apparso, si dileguò sotto il diluvio. Era sbucato da un vialetto privato, circondato da siepi, 37 non si vedeva altro, era buio e la strada scompariva in discesa. Mi appoggiai allo schienale e respirai a pieni polmoni. Il tassista, invece, era uscito dall’auto imprecando; si copriva la testa con una mano e malediceva lo spazio vuoto lasciato da quell’uomo. Non mi chiese nemmeno se stavo bene, girò attorno al suo mezzo per capire se si fosse rotto qualcosa, lisciò la carrozzeria in un paio di punti e poi, grondando d’acqua, tornò nell’abitacolo, con tutti i capelli appiccicati alla fronte. «Ma l’abbiamo preso?», mi chiese voltandosi. «Direi di no, altrimenti non sarebbe scappato come un matto», risposi. Ne ero convinta, il rumore che avevo sentito era quello della ruota finita sul marciapiede, e anche se mi ero coperta il volto e non avevo visto nulla ero certa che non l’avessimo preso. «Diamine!», imprecò ancora il tassista, girando la chiave. «Questo imbecille mi fa quasi venire un infarto e poi se ne va così. Se lo ribecco…». Il tassista lanciò, per quello che potevo capire, una serie infinita di bestemmie in dialetto. Se l’era presa a morte, sbuffava in continuazione picchiando le mani sul volante. Una volta ripartito, a ogni semaforo si lasciava andare a una nuova sfilza di improperi, fin quando non arrivammo davanti alla porta di casa mia. Non vedevo l’ora di sdraiarmi sul letto. Pagai senza dire altro, e lasciai due monete di mancia. Rientrata in casa feci una doccia e, finalmente, mi infilai a letto. Poco prima di addormentarmi ripensai allo sguardo fugace di quell’uomo che pareva essersi materializzato dal nulla, nel bel mezzo di un temporale. Faticai a togliermi dalla testa i suoi occhi. Mi turbavano, come se in quei pochi istanti mi avessero scrutata a fondo. Era una sensazione difficile da descrivere. Appoggiai la testa sul cuscino, reprimendo la nausea e il mal di testa. Il sonno arrivò liquido, viscoso, come l’alcol che avevo bevuto in quella mia prima notte a Perugia. 38
Scarica