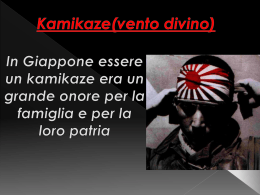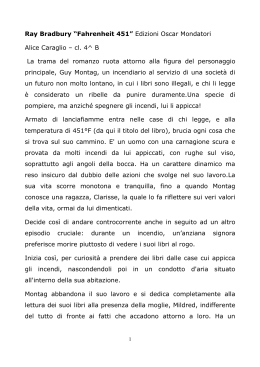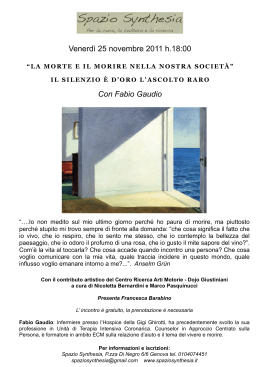PANORAMA INTERNAZIONALE La sfida delle donne kamikaze Dott.ssa Carla Selvestrel Cap. (sanivet) Ris. Sel. M olto si è detto e scritto su un fenomeno che, soprattutto per la cultura occidentale, rimane inspiegabile, quello dei kamikaze, nel tentativo di incasellare tale fenomeno nella categoria della causalità andando a cercare l’origine dell’attentato suicida ora nel fanatismo religioso, ora nel nazionalismo. Addirittura qualcuno ha tentato di ricondurre il tutto ad un mancato o alterato sviluppo cerebrale in un’ottica psico-biologica. E se l’azione distruttiva del kamikaze è già di per sé difficile da motivare, tanto più lo diventa quando l’attentatore è di sesso femminile. Quando colei che sarebbe preposta a dare la vita diventa una macchina di morte scagliata, come la cronaca recente ci informa, anche contro i bambini verso i quali, almeno così la nostra cultura ci ha da sempre insegnato, la donna dovrebbe nutrire un naturale istinto di protezione. Eppure il fenomeno delle donne kamikaze è in rapida espansione. Hamas e Jihad, le due formazioni islamiche, proibiscono alle donne di accedere all’Intifada, veto peraltro ignorato dalle truppe di al-Aqsa. Lo sceicco Yassin avanzava perplessità sull’uso delle donne nella jihad anche se, in realtà, non esi- 32 ste alcuna fatwa che proibisca espressamente ad una donna di immolarsi. La scelta di shahida (martire per Allah) donne sembra incontrare il favore dell’opinione pubblica: un sondaggio condotto a Nablus ha rivelato che oltre il 60% degli intervistati la approva. Si potrebbe a questo punto pensare che l’adesione ad una cultura del martirio e del sacrificio umano nasca in un ambiente di profonda ignoranza. Non è così: nei campus universitari di Gerusalemme studentesse colte e di ottima famiglia affermano di essere pronte a morire e orgogliose di coloro che già lo hanno fatto. Per piegare – e per plagiare - in questo modo la volontà di donne e uomini colti in favore del terrorismo suicida vengono utilizzate svariate forme di propaganda le quali danno alle missioni suicide un valore di affrancamento dalla ghettizzazione cui sono da sempre relegate le donne nella mentalità islamica. E’ così che le donne kamikaze diventano icone di un movimento sociale di matrice quasi “femminista”. Nei territori palestinesi, ad esempio, vengono diffusi opuscoli con l’obiettivo di arruolare le suicide, vengono organizzate riunioni, vengono fatte circolare testimonianze ad hoc che raccontano di La sfida delle donne Kamikaze come le suicide dell’Intifada non fossero affatto ignoranti o sfortunate, ma donne colte e di buona famiglia. È così che ragazze appena adolescenti si dichiarano pronte a morire ed approvate in pieno, in quello che a noi appare come un desiderio delirante, dalla famiglia. Affermano di saper maneggiare lanciagranate, di avere dimestichezza con gli esplosivi e che questi erano i loro sogni di bambine. Nel Corano al martire maschio si promettono settantadue splendide vergini in paradiso, la shahida donna avrà come premio di diventare la responsabile delle settantadue vergini, la più bella tra loro. Le cronache sulle prime donne kamikaze in Medio Oriente risalgono al 4 aprile 1985. La prima è la diciassettenne libanese Saana Muhaidily che si fa saltare in aria gettandosi con la sua Peugeot bianca contro un posto di blocco israeliano a Batr Shaouf uccidendo due soldati e ferendone altri due. Prima di morire, secondo un tragico rituale divenuto ormai classico, la ragazza aveva registrato un videomessaggio in cui si dichiarava pronta a morire per cacciare gli Israeliani dal Libano. Fino a questo momento le donne, per motivi di ordine religioso e sociale, erano escluse da azioni di questo genere. È Saana a cambiare l’ordine delle cose. Il suo gesto viene interpretato come un monito alla coscienza di milioni di uomini arabi. Diventa un’icona popolare per tutto il Medio-Oriente negli anni ottanta, riceve pubbliche lodi dal presidente siriano Assad, le vengono dedicate poesie e preghiere. Ma soprattutto si scatena un pericoloso spirito di emulazione. Il 9 luglio dello stesso anno un’altra donna sempre al volante di una vettura imbottita di esplosivo si lancia contro un posto di blocco a Ras Bayada nel Libano meridionale uccidendo due soldati. Il 27 gennaio 2002 Wafa Idris, infermiera ventottenne, arriva a Gerusalemme probabilmente a bordo di un’ambulanza della Mezzaluna Rossa. Entra in un negozio di calzature per chiedere il prezzo di un paio di scarpe. Una volta uscita si incammina lungo via Jaffa. Alle 12.20 i dieci chili di esplosivo che Wafa porta nella borsa esplodono uccidendo un’anziana guida turistica e ferendo decine di civili. Ai soccorritori si presenta un macabro spettacolo: sull’asfalto una testa dai lunghi capelli neri. L’attentatore è una donna. La Idris diventa una vera e propria eroina per l’opinione pubblica palestinese: dall’inizio della seconda Intifada nessuna donna si era ancora immolata. Questo primato vale a Wafa paragoni illustri: moderna Giovanna d’Arco, accostata talvolta addirittura alla Vergine Maria e a Gesù. La vita di Wafa scatena la fantasia popolare: orfana di padre, allevata dal fratello, ripudiata dal marito in quanto sterile. Al di là delle suggestioni, la vicenda di Wafa lascia ancora qualche dubbio: è stato impossibile stabilire se fosse sua volontà morire o se la sua tragica fine fosse determinata da un innesco anzitempo che non le aveva lasciato scampo. Come accaduto per Saana, il gesto di Wafa viene imitato da altre ragazze. Un tentativo maldestro quello di Moura Shaloub che si lancia contro un posto di blocco israeliano di Tulkasem in Cisgiordania armata solo di un coltello da cucina. Morirà crivellata dalle pallottole. Moura è una ragazza cristiana, circostanza che conferma che il kamikaze femminile non trova ispirazione religiosa islamica, quanto piuttosto nasce dall’incapacità totale di trovare una soluzione alla loro vita: l’ultimo e l’unico mezzo per orientare la propria vita è quello di finirla oppure utilizzarla in qualcosa di meglio di stare in attesa per la lenta fine. Il 27 febbraio 2002 si fa saltare in aria ad un posto di blocco nei pressi di Maccabim la ventunenne Darin Abu Aishe, studentessa. Darin studiava inglese all’università Al-Najah di Nablus, una vera e propria base di reclutamento di terroristi dal momento che il consiglio studentesco è controllato da Hamas. Il suo ultimo messaggio, registrato su videocassetta, è un messaggio di odio nei confronti di Ariel Sharon. Il 12 aprile è Andaleeh Takatka a farsi esplodere alla fermata dell’autobus 6, nei pressi di un mercato nella tristemente famosa via Jaffa. Il 4 ottobre la morte arriva anche sul lungomare di Haifa, è l’avvocato Hamady Tayer Jaradat a portarla. Le avevano ucciso il fratello. Cercava vendetta. La prima donna-bomba degli islamisti di Hamas si chiama Reem al-Reyashi. Reem era la 33 La sfida delle donne Kamikaze giovane mamma di due bambini di tre ed un anno. Il videomessagio che lascia è una dichiarazione d’amore per loro. Reem ha ucciso quattro israeliani al valico di Erez presso una palazzina adibita al controllo dei manovali che si recano a lavorare in Israele. Giunta davanti al metal detector ha spiegato di avere una placca metallica nel ginocchio, riuscendo così ad entrare nella stanza dove si trovavano i militari senza destare sospetto. E qui ha azionato il meccanismo di esplosione. Non tutti gli attentati programmati sono stati portati a termine. Obeida abu Aisha voleva a tutti i costi diventare una martire, come suo fratello e come due cugini. Per Obeida, però, non è stato possibile arrivare fino alla fine. Obeida è stata arrestata nel giugno 2002, prima di mettere a segno il suo piano di morte, probabilmente denunciata da qualcuno che conosceva la sua determinazione. È stata condannata ad una detenzione di cinque anni. Nella stessa sezione del penitenziario di Ha Sharon dove Obeida sconta i suoi cinque anni ci sono 37 donne, tutte incriminate per terrorismo, tre di loro aspiranti kamikaze. Fin qui la cronistoria di un fenomeno che scuote violentemente le nostre coscienze evocando il fantasma dell’inspiegabilità dell’esistenza di persone per le quali la lotta per un ideale è più importante della vita stessa nonché dell’esistenza di una religione che sdogana il suicidio dall’aura di tabù a cui il cristianesimo l’ha relegato. Paradossalmente il confronto con uomini e donne disposti all’estremo sacrificio ci pone di fronte ad una realtà culturale che attribuisce più valore alla morte che alla vita, che porta alle estreme conseguenze il confronto tra la pochezza della vita terrena e la grandezza della vita eterna. Non è più Dio che decide del tempo della vita e di quello della morte, è l’uomo che stabilisce quando donare la vita sua e di altri alla divinità sfuggendo in questo modo ad ogni controllo esercitato dalla legge o dalla religione stessa. Il valore propagandistico che assume l’atto del kamikaze è assolutamente impareggiabile. È un messaggio al proprio popolo: la causa per cui si combatte è più forte di tutto, anche della propria vita. È un messaggio, ancora più forte e drammatico, agli altri popoli: noi arriviamo a quel- 34 lo che per voi è il valore fondamentale, l’esistenza. E, a ben vedere, tale messaggio è ancora più impressionante e simbolico quando a portarlo è una donna, colei che crea, che alleva, che protegge. Come precedentemente ricordato, la morte è arrivata in centri commerciali, strade centrali, mercati, celata dentro borsette o occultata sotto le vesti a simulare una gravidanza. A portare la morte una donna, attraverso quelli che sono i simboli della femminilità: il vezzo della borsetta, la dolcezza di una prossima maternità. Le donne vengono perquisite meno degli uomini. Il pregiudizio, valido a quanto sembra a livello transculturale, della non-aggressività femminile fa sì che da una donna non ci si aspettino atti crudeli e distruttivi. Questo è uno dei motivi che concorre a fare dell’attentato suicida un fenomeno assolutamente imprevedibile. Questa imprevedibilità ha portato molti psicologi ad interrogarsi sulle forme di reclutamento degli attentatori suicidi. Tali tentativi sono pervenuti a conclusioni come la programmazione mentale, ossia una sorta di lavaggio del cervello che passerebbe attraverso processi di deindividuazione aiutati dalla privazione di cibo, dalla somministrazione di droghe, dall’induzione di stati d’animo come la paura e il senso di colpa. Va rilevato, a questo punto, che tali interpretazioni si collocano in un’ottica squisitamente occidentale e pertanto profondamente individualistica che prescinde dal contesto ambientale in cui il fenomeno del kamikaze nasce. Ricostruendo le vicende umane dei giovani martiri ed analizzando il contenuto del loro testamento spirituale consegnato spesso, come già detto, ad una videocassetta, spicca il valore di utilità sociale che attribuiscono al loro atto. Come opportunamente osservato dal ricercatore francese Scott Atran, ciò che determina una rottura forte tra l’Occidente e le società asiatiche, arabe ed africane è che il criterio con cui si compie una scelta sembra legato a valori più comunitari che individuali. Questa etica riesce più facilmente a trasformare la sofferenza e il sopruso personale in sofferenza e sopruso collettivo e, in ultima istanza, il sacrificio personale in sacrificio per il bene comune. L’atto suicida diventa così facilmente atto eroico. La sfida delle donne Kamikaze Più debole è un individuo, più il martirio lo eleverà. E questo concetto è particolarmente appropriato nella spiegazione del comportamento della donna kamikaze. Diventerà un idolo, un eroe popolare capace di incutere timore con il suo solo nome. Non sarà dimenticata e servirà da esempio per altre donne come lei. Per capire ulteriormente il fenomeno dei kamikaze ed il ruolo della donna nella società islamica è opportuno calarsi in una cultura profondamente a contatto con la morte, una sorta di cultura della morte. Pare che una delle massime gratificazioni per una donna islamica sia diventare madre di uno shahid. A tale obiettivo si giunge attraverso una complessa formazione pedagogica nella quale la donna gioca un ruolo di primaria importanza. Deve insegnare ai figli a nutrire un profondo odio verso il nemico attraverso il gioco, la somministrazioni di video ed altro materiale inneggiante all’Islam. Una volta compiuto il massimo sacrificio, quello della vita del figlio, saranno le donne della famiglia ad organizzare cerimonie funebri dove non verseranno nemmeno una lacrima. La donna che piange al funerale di un martire è una vergogna agli occhi di Allah. Dovrà invece offrire dolci e confetti per ringraziare la bontà di Allah. Sono circolati video di madri che si auguravano il martirio dei figli. In una cultura in cui i valori sono improntati più alla collettività che all’individualismo, una madre sa che i figli non sono suoi ed è pronta a perderli per il bene comune. Va a questo punto considerato che le stesse regole pedagogiche destinate ai figli maschi formino anche le figlie femmine creando in esse la mentalità del sacrificio. Ogni donna ed ogni uomo palestinese è prima di tutto soldato, combattente. Un Hassan, definita da più parti come “madre” delle donne kamikaze per l’impianto teorico che ha saputo costruire attorno a questo fenomeno, sostiene che l’incapacità degli israeliani di dare una risposta al fenomeno delle donne suicide ha aumentato la loro frustrazione. E questo viene vissuto come un primo successo che, presumibilmente porterà ad ulteriori recrudescenze dell’Intifada. Il fenomeno delle guerriere suicide non è limitato al conflitto tra israeliani e palestinesi. Cecenia, Sri Lanka e Kurdistan sono altri teatri di morte anche se meno citati nelle cronache. In Cecenia le due parti in conflitto sono l’esercito russo, che si è reso colpevole di atrocità di ogni genere nei confronti della popolazione cecena, e gli estremisti islamici, che si avvalgono di un esercito di kamikaze. Il motivo di fondo di questa guerra sanguinosa è il petrolio, ossia il controllo dell’oleodotto che attraversa la regione. Il wahabismo, corrente islamica integralista di matrice sunnita, arriva in Cecenia nei primi anni novanta insieme ai finanziamento di Osama Bin Laden. Della causa cecena non si è parlato molto fino alla sera del 23 ottobre 2002, data della tragica presa del teatro Dubrovka, a Mosca ad opera di un commando ceceno che si definiva smertniki (“squadra di morte suicida”). Si tratta di un commando composto anche da donne, sei per l’esattezza: Aishat, Amnat, Sekilat, Mariam, Rajana ed Arimani. Alcune di loro erano incinte. Tutte avevano alle spalle storie di famiglie decimate dai russi. È così che il mondo prende consapevolezza dell’esistenza di quelle che sono state denominate “vedove nere”. Si susseguono gli attentati. È il 12 maggio 2003 quando esplode un veicolo, un kamaz, presso il palazzo che ospita l’amministrazione ed i servizi segreti a Znamnenskoye. A bordo quattro persone tra cui una donna. Due giorni dopo, in occasione della visita di Powell a Putin, due donne si fanno esplodere durante una funzione religiosa nei pressi della tribuna dove si trova il presidente Kadirov. Kadirov, reale obiettivo dell’attentato, rimane illeso ma muoiono una trentina di persone. Il 5 giugno dello stesso anno una donna si fa esplodere ad un passaggio a livello uccidendo quattordici persone, per lo più impiegate della base di Mozdok nell’Ossezia del Nord. Diciotto morti, tra cui le due giovanissime kamikaze, sono il bilancio dell’attentato compiuto nell’aerodromo di Tushino dove si stava svolgendo un famoso festival di musica rock. Nella cintura che le ragazze portavano in vita 500 grammi di esplosivo TNT e frammenti metallici per rendere gli effetti della deflagrazione ancora più distruttivi. Ma nel settembre del 2004 viene scritta una delle pagine più tragiche della storia della guerriglia cecena. 35 La sfida delle donne Kamikaze L’8 settembre, durante la cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico, studenti, genitori ed insegnanti della scuola di Beslan, nell’Ossezia del Nord, vengono sequestrati da un commando di terroristi ceceni, tra cui molte donne. Ed è tragedia: i terroristi promettono l’uccisione di cinquanta bambini per ogni componente del commando ucciso e di venti per ogni ferito. Non si conosce il bilancio definitivo, ma si parla di più di trecento vittime. In comune con la causa palestinese, si può individuare in Cecenia innanzitutto l’effetto di una religiosità incomprensibile agli occhi dell’Occidente, capace di forgiare giovani pronti a morire per vendetta. Le testimonianze che arrivano da questa terra tormentata parlano di torture, sparizioni, stupri compiuti da parte di soldati russi e dei mercenari. Pare che proprio lo stupro costituisca una buona motivazione per l’azione delle donne kamikaze cecene. Ci troviamo in una cultura che enfatizza il valore della verginità e della purezza, nel senso di noncontaminazione. Lo stupro rappresenta allora l’estrema perdita della purezza, la contaminazione da parte dell’estraneo. Il corpo violato ed offeso della donna non ha più alcun tipo di valore sociale. L’unico modo per vendicare la violenza subita e, in un certo senso, per purificarsi, è morire trascinando con sé il nemico, colpendolo negli affetti. Allora vengono colpiti i bambini, le donne, gli ignari spettatori a teatro. A spingere queste donne alla missione suicida non è, a ben vedere, solo l’odio e non è solo il fondamentalismo religioso. A forgiare la loro etica della scelta, anche della scelta estrema, è una sorta di codice d’onore che, una volta violato, decide della vita e della morte sociale. In un clima culturale di questo tipo è facile pensare che l’emarginazione sociale ed il desiderio di riscossa da questo punto di vista costituiscano importanti fattori motivanti per queste donne. L’emancipazione sociale può essere invece la motivazione che spinge la donna a prendere parte ad uno dei più sanguinosi conflitti interetnici in atto: quello che vede fronteggiarsi in Sri Lanka la maggioranza cingalese buddista e i tamil indù. Quello delle tigri tamil è il movimento che si è macchiato del maggior numero di attentati suicidi: 36 centosessantotto tra il 1980 ed il 2000. Almeno un terzo delle circa diecimila tigri è costituito da donne, per la maggior parte minorenni. Grande enfasi viene data all’emancipazione femminile: dal 1984 reparti femminili partecipano agli scontri con l’esercito dello Sri Lanka, dal 1987 è attivo un campo di addestramento riservato alle donne nell’isola di Jaffa, nel 1990 il comando di una intera guerriglia è stato affidato ad una donna. In questo ambito, l’attentato che ha suscitato maggiore impressione è stato quello ai danni di Rajiv Gandhi, Presidente del Congresso e Capo del Governo, estremo oppositore dell’indipendenza dei tamil. Nel maggio 2001, Malli Dahew, durante un comizio elettorale, dopo aver omaggiato Rajiv di una ghirlanda di legno di sandalo, attiva la bomba che porta con sé. È una strage. E sempre la gratificazione dell’emancipazione femminile viene utilizzata per reclutare donne dal Partito dei lavoratori curdi (PKK). In Kurdistan la mentalità è estremamente conservatrice. La donna vive subordinata all’uomo: viene venduta al marito e vive segregata in casa. Il PKK nasce proprio dal malcontento femminile per il reclutamento delle donne, descrivendo la guerriglia come riscatto della loro condizione. È così che dei quindici attentati kamikaze messi a segno dal PKK, undici sono stati compiuti da donne. La panoramica tracciata restituisce un’immagine forse meno stereotipica della kamikaze, meno focalizzata sugli effetti, se pur tragici, del suo atto estremo e più interessata a restituire questo fenomeno al suo proprio retroterra culturale. Si è partiti, infatti, da una descrizione dei fatti cercando poi di ricostruire gli antefatti, consapevoli che l’occhio occidentale falsa la visione e la corretta interpretazione di fenomeni come quello dei kamikaze che all’Occidente, inteso come ambiente culturale, non appartengono. Si delinea così un’immagine delle donne kamikaze ancora più complessa e, forse, ancora meno comprensibile per chi non vive in prima persona in scenari di conflitto continuo, di prevaricazione, di frustrazione ma anche di orgoglio. Un orgoglio personale capace di fondersi, attraverso un bagno di sangue, con l’orgoglio nazionale.
Scaricare