A. A. 2012-2013 SP 2013 Prof. Uberto MOTTA Le forme brevi della narrativa tra Ottocento e Novecento Orario delle lezioni Martedì, 17.00-19.00, AULA MIS 3026 CALENDARIO 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 19 febbraio 26 febbraio 5 marzo 12 marzo 19 marzo GIOVEDÌ 21 marzo, 17-19h (recupero del 23 aprile) MIS 3026 26 marzo 2 aprile: vacanze di Pasqua 8) 9 aprile 9) 16 aprile 23 aprile: lezione sospesa – recupero: 21 marzo 10) 30 aprile 11) 7 maggio 12) 14 maggio: la lezione è anticipata: ore 15-17, MIS 3026 21 maggio: lezione sospesa – recupero: 23 maggio 13) GIOVEDÌ 23 maggio, 17-19h (recupero del 21 maggio) MIS 3026 14) 28 maggio Due date simboliche • 1880 G. Verga, Vita dei campi C. Dossi, Goccie d’inchiostro 1985 G. Celati, I narratori delle pianure A. Tabucchi, Piccoli equivoci senza importanza Bibliografia • Storia della letteratura italiana, a c. di E. Malato, Salerno Editrice, voll. VIII e IX • Letteratura italiana Einaudi, vol. Le forme del testo, II (1984): Pieter De Meijer, La prosa narrativa moderna, pp. 759-847 • SLI 79,1-4: Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi (a c. di Brioschi-Di Girolamo) • SLI 88,1-4: Testi nella storia (a c. di Segre-Martignoni) • SLI 112,1-11: Storia della letteratura italiana (a c. di Ferroni et alii) • SLI 18,1-3: Letteratura.it (a c. di Langella et alii). Quattro libri fondamentali • G. Verga, Vita dei campi (1880) Ed. consigliata: Verga, Tutte le novelle, a c. di G. Zaccaria, Einaudi • L. Pirandello, Dal naso al cielo, vol. VIII di Novelle per un anno (1925) Ed. consigliata: Pirandello, Novelle per un anno, a c. di S. Campailla, Newton Compton 2011 • C.E. Gadda, L'Adalgisa (1944) Ed. consigliata: a cura di C. Vela, Adelphi 2012 • I. Calvino, Ultimo viene il corvo (1949) Ed. consigliata: Mondadori Oscar C. Baudelaire, Le Salon de 1846 « Le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. Ils l’ont cherché en dehors, et c’est en dedans qu’il était seulement possible de le trouver. […] Qui dit romantisme dit art moderne, – c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimées par tous les moyens que contiennent les arts ». Cletto Arrighi, La Scapigliatura Milanese, 1858 In tutte le grandi e ricche città del mondo incivilito esiste una certa quantità di individui di ambo i sessi – v’è chi direbbe: una certa razza di gente –, fra i venti e i trentacinque anni non piú; pieni d’ingegno quasi sempre; piú avanzati del loro secolo; indipendenti come l’aquila delle Alpi; pronti al bene quanto al male; inquieti, travagliati, turbolenti - i quali - e per certe contraddizioni terribili fra la loro condizione e il loro stato, vale a dire fra ciò che hanno in testa e ciò che hanno in tasca - e per una loro particolare maniera eccentrica e disordinata di vivere […] meritano di essere classificati in una nuova e particolare suddivisione della grande famiglia civile, come coloro che vi formano una casta sui generis distinta da tutte quante le altre. Questa casta o classe - che sarà meglio detto - vero pandemonio del secolo; personificazione della storditaggine e della follia, serbatoio del disordine, dello spirito di indipendenza e di opposizione agli ordini stabiliti, questa classe, ripeto, che a Milano ha più che altrove una ragione e una scusa di esistere, io, con una bella e pretta parola italiana, l’ho battezzata appunto: la Scapigliatura Milanese. […] Essa mi rende, quasi a cappello, il concetto di questa della popolazione milanese, tanto diversa dall’altra pei suoi misteri, le sue miserie, i suoi dolori, le sue speranze, i suoi traviamenti, sconosciuti ai giovani morigerati e dabbene, ed agli adulti gravi e posati, che della vita hanno preso la strada maestra, comoda, ombreggiata, senza emozioni, come senza pericoli. […] La speranza nell’avvenire è la sua religione; la povertà il suo carattere essenziale. Camillo Boito (1836-1914) • Storielle vane (1876) ► dare voce a quel “demonio muto” che si nasconde nel cuore dell’uomo, come memoria o desiderio inconfessabile di peccato; come “piccola ulcera venefica [che] un po’ alla volta s’allarga, si estende e incancrenisce via via l’anima intera. Ci credevamo giusti, ci troviamo iniqui” • Nuove storielle vane (1883) ► comprende: Vade retro Satana, Macchia grigia, Il collare di Budda, Santuario, Quattr'ore al Lido, Meno di un giorno, Il demonio muto, Senso Boito, Senso (1) Ho bisogno di mortificare la vanità. Alla inquietudine, che rode la mia anima e che lascia quasi intatto il mio corpo, s'alterna la presunzione della mia bellezza: né trovo altro conforto che questo solo, il mio specchio. Troverò, spero, un altro conforto nello scrivere i miei casi di sedici anni addietro, ai quali vado ripensando con acre voluttà. Lo scartafaccio, chiuso a tre chiavi nel mio scrigno segreto, non potrà essere visto da occhio umano, e, appena compiuto, lo getterò sul fuoco, disperdendone le ceneri; ma il confidare alla carta i vecchi ricordi deve servire a mitigarne l'acerbità e la tenacia. Mi resta scolpita in mente ogni azione, ogni parola e sopra tutto ogni vergogna di quell'affannoso periodo del mio passato; e tento sempre e ricerco le lacerazioni della piaga non rimarginata; né so bene se ciò ch'io provo sia, in fondo, dolore o solletico. O che gioia, confidarsi unicamente a sé, liberi da scrupoli, da ipocrisie, da reticenze, rispettando nella memoria la verità anche in ciò che le stupide affettazioni sociali rendono più difficile a proclamare, le proprie bassezze! Boito, Senso (2) Era il luglio dell'anno 1865. Maritata da pochi giorni, facevo il viaggio di nozze. Per mio marito, che avrebbe potuto essere mio nonno, sentivo una indifferenza mista di pietà e disprezzo: portava i suoi sessantadue anni e l'ampia pancia con apparente energia; si tingeva i radi capelli e i folti baffi con un unguento puzzolente, il quale lasciava sui guanciali delle larghe macchie giallastre. […]Lo avevo pigliato spontaneamente, anzi lo avevo proprio voluto io. I miei erano contrarii ad un matrimonio così male assortito; né, bisogna dire la verità, il pover'uomo ardiva di chiedere la mia mano. Ma io mi sentivo stufa della mia qualità di zitella: volevo avere carrozze mie, brillanti, abiti di velluto, un titolo, e sopra tutto, la mia libertà. Ce ne vollero delle occhiate per accendere il cuore nel gran ventre del conte; ma, una volta acceso, non provò pace finché non m'ebbe, né badò alla piccola dote, né pensò all'avvenire. Io, innanzi al prete, risposi un Sì fermo e sonoro. Ero contenta di quello che avevo fatto, ed oggi, dopo tanti anni, non ne sono pentita. Boito, Senso (3) La mia corte si componeva in massima parte di ufficialetti e d'impiegati tirolesi piuttosto scipiti e assai tronfii, tanto che i più dilettevoli erano i più scapati, quelli che avevano nella scostumatezza acquistato non foss'altro l'audacia petulante delle proprie sciocchezze. Tra questi ne conobbi uno, il quale usciva dal mazzo per due ragioni. Alla dissolutezza sbadata, univa, per quanto i suoi stessi amici affermavano, una così cinica immoralità di principii, che niente gli pareva rispettabile in questo mondo, salvo il codice penale e il regolamento militare. Oltre a ciò era veramente bellissimo e straordinariamente vigoroso: un misto di Adone e di Alcide. […]Questo tenente di linea, il quale aveva solo ventiquattro anni, due più di me, era riuscito a divorarsi la ricca sostanza paterna, e continuando sempre a giuocare, a pagar donne, a scialarla da signore, nessuno oramai sapeva come vivesse; ma nessuno lo vinceva nel nuoto, nella ginnastica, nella forza del braccio. Non aveva mai avuto occasione di trovarsi in guerra; non amava i duelli, anzi due ufficialetti mi raccontarono una sera, che, piuttosto che battersi, aveva più volte ingoiato atrocissimi insulti. Forte, bello, perverso, vile, mi piacque. Boito, Senso (4) La perfetta virtù mi sarebbe parsa scipita e sprezzabile al paragone de' suoi vizii; la sua mancanza di fede, di onestà, di delicatezza, di ritegno mi sembrava il segno di una vigoria arcana, ma potente, sotto alla quale ero lieta, ero orgogliosa di piegarmi da schiava. Quanto più il suo cuore appariva basso, tanto più il suo corpo splendeva bello. Boito, Senso (5) — Non ti amo? io che ti darei volentieri tutto il mio sangue. — Queste sono parole. Se non hai denaro, dammi i gioielli. Non risposi e mi sentii impallidire. Accortosi della impressione che mi avevano fatto le sue ultime parole, Remigio mi serrò tra le braccia di ferro, e mutato tono, ripeté più volte: — Sai che ti amo infinitamente, Livia mia, e ti amerò finché avrò un soffio di vita; ma questa vita salvamela, te ne scongiuro, salvala per te, se mi vuoi bene. Mi prendeva le mani, e le baciava. Ero già vinta. Andai alla scrivania a prendere le tre piccole chiavi dello scrignetto: temevo di far romore; camminavo in punta di piedi, benché avessi i piedi nudi. Remigio mi accompagnò nel gabinetto dietro l'alcova; serrai l'uscio, perché il conte non potesse udire, ed aperto lo scrigno con qualche difficoltà, tanto ero agitata, ne trassi un fornimento intiero di brillanti, mormorando: — Ecco, prendi. Costò quasi dodicimila lire. Troverai da venderlo? Remigio mi tolse di mano l'astuccio; guardò i gioielli e disse: — Usurai ce n'è dappertutto. Boito, Senso (6) — Generale — mormorai — vengo a compiere un dovere di suddita fedele. — La signora contessa è tedesca? — No, sono trentina. — Ah, va bene — esclamò, guardandomi con una cert'aria di stupore e d'impazienza. — Legga — e gli porsi in atto risoluto la lettera di Remigio, quella che avevo ritrovata nel taschino del portamonete. Il generale, dopo avere letto: — Non capisco; la lettera è indirizzata a lei? — Sì, generale. — Dunque l'uomo che scrive è il suo amante. Non risposi. Il generale cavò di tasca un sigaro e lo accese, s'alzò da sedere e si pose a camminare su e giù per la sala; tutt'a un tratto mi si piantò innanzi e, ficcandomi gli occhi in volto, disse: — Dunque, ho fretta, si sbrighi. — La lettera è di Remigio Ruz, luogotenente del terzo reggimento granatieri. — E poi? — La lettera parla chiaro. S'è fatto credere malato, pagando i quattro medici — e aggiunsi con l'accento rapido dell'odio: — È disertore dal campo di battaglia. — Ho inteso. Il tenente era l'amante suo e l'ha piantata. Ella si vendica facendolo fucilare, e insieme con lui facendo fucilare i medici. È vero? — Dei medici non m'importa. Il generale stette un poco meditabondo con le ciglia aggrottate, poi mi stese la lettera, che gli avevo data: — Signora, ci pensi: la delazione è un'infamia e l'opera sua è un assassinio. — Signor generale — esclamai, alzando il viso e guardandolo altera — compia il suo dovere. Igino Ugo Tarchetti (1839-1869), Racconti fantastici, Milano 1869 Il volume contiene 5 testi: I fatali; Le leggende del castello nero; La lettera U; Un osso di morto; Uno spirito in un lampone. I. U. Tarchetti, I fatali Esistono realmente esseri destinati ad esercitare un'influenza sinistra sugli uomini e sulle cose che li circondano? È una verità di cui siamo testimonii ogni giorno, ma che alla nostra ragione freddamente positiva, avvezza a non accettare che i fatti i quali cadono sotto il dominio dei nostri sensi, ripugna sempre di ammettere. […] Noi non possiamo non riconoscere che, tanto nel mondo spirituale quanto nel mondo fisico, ogni cosa che avviene, avvenga e si modifichi per certe leggi d'influenze di cui non abbiamo ancora potuto indovinare intieramente il segreto. Osserviamo gli effetti, e restiamo attoniti e inscienti dinanzi alle cause. Vediamo influenze di cose su cose, di intelligenze su intelligenze, e di queste su quelle ad un tempo; vediamo tutte queste influenze incrociarsi, scambiarsi, agire l'una sull'altra, riunire in un solo centro di azione questi due mondi disparatissimi, il mondo dello spirito e il mondo della materia. Fin dove la penetrazione umana è arrivata noi abbiamo portato la nostra fede; il segreto dei fenomeni fisici è in parte violato; la scienza ha analizzato la natura; i suoi sistemi, le sue leggi, le sue influenze ci sono quasi tutte note: ma essa si è arrestata dinanzi ai fenomeni psicologici, e dinanzi ai rapporti che congiungono questi a quelli. Essa non ha potuto avanzarsi di più, e ha trattenuto le nostre credenze sulla soglia di questo regno inesplorato. C. Dossi, Prima e dopo, da Goccie d’inchiostro, 1880 E, spesso, Giulio e Antonietta passàvano verso le tre, innanzi alle scuole del pomo; di cui, apèrtasi a un tratto la pìccola porta, rovesciàvasi fuori, come fantocci da un sacco, la melonìa de’ scolaretti, isparpagliàndosi tosto per la contrada, a corsa, dimèntica già della noja sofferta, e saltellante e giojosa; e spesso, di dopo-pranzo, sedèvano tristamente su’na panchetta ai Giardini, Gullìveri nuovi in mezzo alla gentile frugaglia del Lillipùt, che trottolava di su e di giù, vero moto perpetuo, senza fastidi, senza pensieri e tutta amica; là, a fare i grandi occhi intorno al bossolottajo, mago del buon comando; quà, a leccare il cucchiajo, il piattello e le labbra intorno a quel dal sorbetto dell’unghia, o a bevucchiare a due mani la consolina entro un tazzone; in ogni parte, correndo coi cerchi, coi palloncelli, coi draghi-volanti o sui bastoni dei babbi; facendo al signore e al soldato innocentemente, o a rimpiattino dietro le gonne dell’aje; mentre i bebè dalle dande, che incominciàvano a sentirsi i pieducci, con l’agitar delle alette e la voce, credèvano còrrere anch’essi. Oh quanti maluzzi da unguento sputino, tavane da pulci! oh liti, temporali di monte! o dispettini e capricci e cattiverie adoràbili! oh paci! senza riserve, senza capi segreti. Racconti della Scapigliatura piemontese, a cura di G. Contini, Milano, Bompiani, 1953. Autori antologizzati: Giovanni Faldella (Vercelli 1846-1928), Roberto Sacchetti (Asti 1847-1881), Achille Giovanni Cagna (Vercelli 1847-1931), Edoardo Calandra (Torino 1852-1911) La storia letteraria secondo G. Contini (da La letteratura italiana. Otto-Novecento, 1974: Premessa) “Che la storia letteraria, cioè una storia della cultura morale (come per esempio delle poetiche), sia un mero schema empirico volto ad abilitare alla conoscenza dei singoli momenti poetici (e sarebbe meglio dire, per fuorviare i residui di psicologismo inerenti al procedimento monografico, delle singole unità espressive), è teorema che non francherebbe neppur la pena di ripetere. […] Ma sarebbe forse tempo di praticare la così intesa storia letteraria secondo l’approssimazione più probabile dell’atto espressivo, cioè a dire quale storia della cultura linguistica”. G. Faldella, A Vienna. Gita con il lapis, 1874 (cap. Autobibliografia) Vocaboli del Trecento, del Cinquecento, della parlata toscana e piemontesismi; sulle rive del patetico piantato uno sghignazzo da buffone: tormentato il dizionario come un cadavere, con la disperazione di dargli vita mediante il canto, il pianoforte, la elettricità e il reobarbaro... Così seguiterò finché avrò carta e fiato. Tale il mio stile, come venne ridotto dal mondo piccino e dai libri grossi. G. Faldella, A Vienna. Gita con il lapis, 1874 La diligenza Pernottiamo a Fluelen; e poi, appena giunto il mattino tagliente, montiamo sopra una diligenza. Povera diligenza perseguitata dal vapore, che fra breve ti caccerà dai valichi delle montagne, dove ti sei rincantucciata! Sono lieto di essere venuto al mondo in tempo per conoscerti personalmente, per udire il sonaglio dei tuoi cavalli e il corno de' tuoi postiglioni, e per vedere il loro cappello incerato ed i loro bottoni gialli sul panciotto rosso. I miei posteri non conosceranno più queste cose fuorché a qualche teatro diurno o filodrammatico assistendo alla rappresentazione del Vetturale del Moncenisio. Per montagne irrugginite, per verdi di velluto, per ponti del diavolo e per ponticini angelici, per nevi sucide e per fiorellini da portafogli, per cascate che lanciano prismi di colori e sfondano la pietra incavandola in conche, e per festoni vegetali, che si insinuano fra gli spacchi delle roccie e ne secondano l'architettura, la diligenza ci conduce al San Gottardo, che l'ingegneria sta per trafiggere luminosamente da parte a parte. Quindi da una scala a zighizzaghi precipiti roviniamo in Italia. G. Faldella, A Vienna. Gita con il lapis, 1874 Ritorno in Italia Come sono dolci a chi ritorna gli spropositi di lingua italiana sulle insegne del Canton Ticino! È tempo che io ricapitoli ciò che io ho imparato nella mia gita ed assodi, se un viaggio allarga come un bistorî la intelligenza. Ho visto gli stessi tipi e le stesse faccie che io già conoscevo prima, salvo che le trovai spostate ridicolosamente. Così un ministro italiano lo scopersi che suonava il tamburo a Zurigo, ed il padre di un mio amico che fa il farmacista in Italia lo rinvenni colonnello degli Ulani a Vienna. Tutto il mondo è paese: Tirolesi, Bavaresi, Austriaci, Würtemberghesi, Badesi, Svizzeri ed Italiani siamo tutti figli dello stesso Adamo, anziché pronipoti di un orangotango diverso. Questo pensiero di fratellanza cosmopolitana mi consola, e non mi toglie la contentezza di rivedere la bella Italia e le amate sponde, dove mi sento più fratello con il mio prossimo. Racconti della Scapigliatura piemontese, a cura di G. Contini “In Faldella l’impressionismo (poiché per lui si trattava qui, e in fondo sempre, di rendere delle superfici, di rendere profondamente delle superfici) porta a una tecnica, pur trattata con mano di dilettante più che di scienziato, di giustapposizione alla Monet, di divisionismo o puntinismo verbali. La finalità intrinseca di Faldella, quel tanto d’innovazione gnoseologica che gli compete, è infatti… rappresentare cose che non sono nel dominio dell’espressione del pensiero che si giova delle lettere dell’alfabeto”. G. Faldella, Degna di morire “Nel principio dell’inverno seguente il cavaliere Alfredo, già fatto deputato, si sentì stomacato dalla vita. Gli pareva che l’umanità in generale e l’Italia in particolare fossero carcasse fruste, e che i nostri scrittori e artisti più adulati d’adesso, succeduti immediatamente alle olimpiche, pelasgiche, basilicali intelligenze di Canova, di Leopardi, di Gioberti e di Rossini fossero scarafaggi ischeletriti […] che il resto del prossimo fosse bestiame di Sallustio; e che intorno alla sua persona non si aggirasse più un solo cervello integro. E sentiva una smania prepotente di dare una presa di somaro a tutti, compreso il signor sé stesso”. E. Zola, Il romanzo sperimentale, 1880 (I) Lo scopo del metodo sperimentale in fisiologia ed in medicina è di studiare i fenomeni per divenirne padroni. […] Dunque questo è lo scopo, questa è la moralità della fisiologia e della medicina sperimentali: divenire padroni della vita per dirigerla. Supponiamo che la scienza abbia proceduto nel suo cammino e che la conquista di ciò che è sconosciuto sia compiuta: […] allora il medico sarà padrone delle malattie; guarirà infallibilmente agendo sul corpo umano per la felicità ed il vigore della specie. Si entrerà in un secolo in cui l'uomo, divenuto onnipotente, avrà soggiogato la natura utilizzandone le leggi per far regnare su questa terra tutta la giustizia e la libertà possibili. Non vi è scopo più nobile, più elevato, più grande. In esso consiste il nostro compito di esseri intelligenti: penetrare il come delle cose per dominarle e ridurle allo stato di meccanismi ubbidienti. Ebbene, questo sogno del fisiologo e del medico sperimentale è anche quello del romanziere che applica allo studio dell'uomo nella natura e nella società il metodo sperimentale. E. Zola, Il romanzo sperimentale, 1880 (II) Il nostro scopo è il medesimo; anche noi vogliamo essere padroni dei fenomeni della vita intellett uale e passionale, per poterli guidare. In una parola siamo dei moralisti sperimentali che mettono in luce mediante l'esperimento come si comporta una passione in un dato ambiente sociale. Il giorno in cui ci impadroniremo del suo meccanismo, si potrà curarla e placarla o almeno renderla il più inoffensiva possibile. Ecco dunque in che consistono l’utilità pratica e la elevata moralità delle nostre opere naturalistiche, che sperimentano sull’uomo, e rimontano pezzo per pezzo la macchina umana farla funzionare sotto l’influenza dei vari ambienti. Col procedere del tempo, col divenire padroni delle leggi, si tratterà soltanto di agire sugli individui e sugli ambienti, se si vuole arrivare allo stato sociale migliore. In tal modo facciamo della sociologia pratica ed il nostro lavoro avvantaggia le scienze politiche ed economiche. Non conosco, lo ripeto, un lavoro più nobile, né una più ampia applicazione. Essere in grado di controllare il ben e il male, regolare la vita, guidare la società, risolvere alla lunga tutti i problemi del socialismo, conferire soprattutto solide basi alla giustizia dando una risposta con l’esperimento ai problemi della criminalità, non è forse essere gli operai più utili e più morali del lavoro umano? Fantasticheria: pubblicata per la prima volta sul settimanale “Fanfulla della domenica”, il 24 agosto 1879; poi testo d’apertura di Vita dei campi (1880) Definizione generale del tema del libro: “le tenaci affezioni dei deboli”, “l’istinto che hanno i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita”. Incipit del testo: «Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo sportello del vagone, esclamaste: "Vorrei starci un mese laggiù!"». G. Verga, Fantasticheria (I) Di tanto in tanto il tifo, il colèra, la malannata, la burrasca, vengono a dare una buona spazzata in quel brulicame, il quale si crederebbe che non dovesse desiderar di meglio che esser spazzato, e scomparire; eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so dirvi come, né perché. Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare un esercito di formiche tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? Qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro ombrellino, torcendosi di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di viavai, saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno. Voi non ci tornereste davvero, e nemmen io; ma per poter comprendere siffatta caparbietà, che è per certi aspetti eroica, bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l'orizzonte fra due zolle, e guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori. Volete metterci un occhio anche voi, a cotesta lente, voi che guardate la vita dall'altro lato del cannocchiale? Lo spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà. G. Verga, Fantasticheria (II) - Insomma l'ideale dell'ostrica! direte voi. - Proprio l'ideale dell'ostrica, e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo che quello di non esser nati ostriche anche noi. Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere mentre seminava principi di qua e duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano, mi sembrano - forse pel quarto d'ora - cose serissime e rispettabilissime anch'esse. Parmi che le irrequietudini del pensiero vagabondo s'addormenterebbero dolcemente nella pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione in generazione. […] Mi è parso ora di leggere una fatale necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell'istinto che hanno i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita, e ho cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto che deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Un dramma che qualche volta forse vi racconterò e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dal gruppo per vaghezza dell'ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo, il mondo da pesce vorace com'è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. - E sotto questo aspetto vedete che il dramma non manca d'interesse. Per le ostriche l'argomento più interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio. G. Verga, Rosso Malpelo • I ed. in 4 puntate sul quotidiano romano «Fanfulla» (2-5 agosto 1878). • Genesi ispirata da L. Franchetti – S. Sonnino, La Sicilia nel 1876: cap. su Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare siciliane, Firenze 1877. • Lettera di G. Verga a Filippo Filippi, 11.X.1880: «Il mio studio è di fare eclissare al possibile lo scrittore, di sostituire la rappresentazione all’osservazione, metter per quanto si può l’autore fuori del campo d’azione, sicché il disegno acquisti tutto il rilievo e l’effetto da dar completa l’illusione della realtà. […] Io non giudico, non m’appassiono, non m’interesso, o piuttosto non devo mostrare nulla di tutto questo, sotto pena di veder mancare uno dei più efficaci effetti dell’opera d’arte, e giudico, m’appassiono, m’interesso soltanto colla scelta dei tipi che presento». G. Verga, Rosso Malpelo Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane di otto giorni, come fanno le bestie sue pari; e ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. G. Verga, L’amante di Gramigna (I) Caro Farina, eccoti non un racconto ma l'abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di esser brevissimo, e di esser storico un documento umano, come dicono oggi; interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come l'ho raccolto pei viottoli dei campi, press'a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l'efficacia dell'essere stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne; il misterioso processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditorî, costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che dicesi l'argomento di un racconto, e che l'analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi ti dirò soltanto il punto di partenza e quello d'arrivo, e per te basterà, e un giorno forse basterà per tutti. G. Verga, L’amante di Gramigna (II) Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con metodo diverso, più minuzioso e più intimo; sacrifichiamo volentieri l'effetto della catastrofe, del risultato psicologico, intravvisto con intuizione quasi divina dai grandi artisti del passato, allo sviluppo logico, necessario di esso, ridotto meno imprevisto, meno drammatico, ma non meno fatale; siamo più modesti, se non più umili; ma le conquiste che facciamo delle verità psicologiche non saranno un fatto meno utile all'arte dell'avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà inutile il proseguire in cotesto studio dell'uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le risorse dell'immaginazione che nell'avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti diversi? G. Verga, L’amante di Gramigna (III) Intanto io credo che il trionfo del romanzo, la più completa e la più umana delle opere d'arte, si raggiungerà allorché l'affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane; e che l'armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, e il romanzo avrà l'impronta dell'avvenimento reale, e l'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sorta spontanea come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore; che essa non serbi nelle sue forme viventi alcuna impronta della mente in cui germogliò, alcuna ombra dell'occhio che la intravvide, alcuna traccia delle labbra che ne mormorarono le prime parole come il fiat creatore; ch'essa stia per ragion propria, pel solo fatto che è come dev'essere, ed è necessario che sia, palpitante di vita ed immutabile al pari di una statua di bronzo, di cui l'autore abbia avuto il coraggio divino di eclissarsi e sparire nella sua opera immortale. G. Flaubert sul canone dell’impersonalità • lettera del 9 dicembre 1852 a Louise Colet: « L'auteur, dans son oeuvre, doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout, et visible nulle part. L'art étant une seconde nature, le créateur de cette nature-là doit agir par des procédés analogues : que l'on sente dans tous les atomes, à tous les aspects, une impassibilité cachée et infini. L'effet, pour le spectateur, doit être une espèce d'ébahissement. Comment tout cela s'est-il fait ! doit-on dire, et qu'on se sente écrasé sans savoir pourquoi ». • lettera del 6 novembre 1853 a Louise Colet: « Rappelonsnous toujours que l'impersonnalité est le signe de la Force. Absorbons l'objectif et qu'il circule en nous, qu'il se reproduise au-dehors, sans qu'on puisse rien comprendre à cette chimie merveilleuse. Notre coeur ne doit être bon qu'à sentir celui des autres. - Soyons des miroirs grossissants de la vérité externe». L. Franchetti – S. Sonnino, La Sicilia nel 1876, Prefazione Noi abbiamo inteso d'indagare le ragioni intime dei fenomeni morbosi che presenta la Sicilia, e di ritrarre un quadro succinto delle sue condizioni sociali, così diverse da quelle di alcune altre regioni del nostro paese. Esprimendo in ogni singolo caso la nostra opinione schiettamente e senza reticenze o falsi riguardi di convenienza, crediamo di dimostrare nel miglior modo possibile la nostra gratitudine verso i Siciliani, e abbiamo fede di giovare all'Isola più coll'esposizione della verità che non coll'adulazione. Non ci siamo lasciati distogliere dal timore di esser tacciati d'arroganza, perchè trattandosi di quistioni che interessano l'avvenire del paese, riteniamo che ogni cittadino abbia lo stretto dovere di dire apertamente la propria opinione. Convinti che i fenomeni da noi descritti hanno la loro prima origine nelle leggi della Natura, noi, nell'esporli, non intendiamo giudicar nessuno, e tanto meno condannare. Non sappiamo vedere nei Siciliani che altrettanti Italiani, e i mali dell'ultima estremità della Penisola ci fanno provare dolore nel modo medesimo che quelli della nostra provincia natale. G. Verga, La roba (Novelle rusticane) I Della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista, ed egli aveva la vista lunga - dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, nel monte e nella pianura. Più di cinquemila bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiavano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca la quale mangiava meno di tutte, e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e in furia, all'impiedi, in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, che non ci si vedeva, mentre i contadini scaricavano i sacchi, o a ridosso di un pagliaio, quando il vento spazzava la campagna gelata, al tempo del seminare, o colla testa dentro un corbello, nelle calde giornate della messe. Egli non beveva vino, non fumava, non usava tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, colle foglie larghe ed alte come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del giuoco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata anche 12 tarì, quando aveva dovuto farla portare al camposanto. G. Verga, La roba (Novelle rusticane) II Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua, ed aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata, nel mese di luglio, a star colla schiena curva 14 ore, col soprastante a cavallo dietro, che vi piglia a nerbate se fate di rizzarvi un momento. Per questo non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba; e adesso i suoi aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivano in novembre; e altre file di muli, che non finivano più, portavano le sementi; le donne che stavano accoccolate nel fango, da ottobre a marzo, per raccogliere le sue olive, non si potevano contare, come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle; e al tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne, e fin dove sentivasi cantare, nella campagna, era per la vendemmia di Mazzarò. G. Verga, La roba (Novelle rusticane) III Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha niente! Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me! G. Baldi, L’artificio della regressione. Tecnica narrativa e ideologia nel Verga verista, 1980 Verga vuole mostrare gli effetti negativi prodotti nel personaggio dalla dedizione totale all’accumulo, l’impoverimento umano, l’alienazione nelle cose, l’insensibilità ai valori più sacri, come la famiglia e gli affetti […], la brutalità dello sfruttamento esercitato sui deboli […]. Ma lo scrittore non si arresta solo all’atteggiamento di rifiuto moralistico, da destra, della realtà del denaro, della proprietà, dell’interesse individuale, alla constatazione desolata e radicalmente pessimistica dell’ineluttabilità della lotta per la vita. Ai suoi occhi Mazzarò possiede veramente qualcosa di “grandioso”, i suoi “vizi” si trasformano davvero in virtù; le proporzioni smisurate della ricchezza da lui creata […] il suo ascetismo non possono non suscitare stupefatta, sgomenta ammirazione, e finiscono per ammantarsi a buon diritto di un alone mitico e leggendario. C'era un uomo ricco, che era vestito di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi. E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi (Lc 16, 19-31). Le ‘raccolte’ di Verga • • • • • • Vita dei campi, 1880 Novelle rusticane, 1883 Per le vie, 1883 Vagabondaggio, 1887 I ricordi del Capitano d’Arce, 1891 Don Candeloro e C.i, 1894 • Luigi Capuana (1839-1915) Le appassionate, 1893 → «casi di coscienza dolorosi o tragici» Le paesane, 1894 → «studi di carattere e d’ambiente» • Federico De Roberto (1861-1927) La sorte, 1887 Documenti umani, 1888 Processi verbali, 1890 → «la nuda e impersonale trascrizione di piccole commedie e di piccoli drammi colti sul vivo». L’albero della scienza, 1890 F. De Roberto, Prefazione a Processi verbali (1890) Processo verbale […] significa una relazione semplice, rapida e fedele di un avvenimento, svolgentesi sotto gli occhi di uno spettatore disinteressato. Processi verbali, io intitolo delle novelle, che sono la nuda e impersonale trascrizione di piccole commedie e di piccoli drammi colti sul vivo. Se l'impersonalità ha da essere un canone d'arte, mi pare che essa sia incompatibile con la narrazione e con la descrizione. Nell'esporre in nome proprio gli avvenimenti, nel presentare i suoi personaggi, lo scrittore si tradisce inevitabilmente; ch'ei voglia o no, finisce per giudicare gli uni e commentare gli altri; e le fioriture di stile, con cui egli traduce le impressioni suscitate dal mondo materiale, sono cosa tutta sua. L'impersonalità assoluta, non può conseguirsi che nel puro dialogo, e l'ideale della rappresentazione obiettiva, consiste nella scena come si scrive pel teatro. L'avvenimento deve svolgersi da sé, e i personaggi debbono significare essi medesimi, per mezzo delle loro parole e delle loro azioni, ciò che essi sono. L'analisi psicologica, l'immaginazione di quel che si passa nella testa delle persone, è tutto il rovescio dell'osservazione reale. […] La parte dello scrittore che voglia sopprimere il proprio intervento deve limitarsi, insomma, a fornire le indicazioni indispensabili all'intelligenza del fatto, a mettere accanto alle trascrizioni delle vive voci dei suoi personaggi quelle che i commediografi chiamano didascalie. F. De Roberto, Il rosario (da Processi verbali, 1890) I Un leggiero colpo di martello all'uscio del giardino: tanto leggiero, da non poter essere udito se non dalle donne che stavano ad aspettare lì dietro. —Chi è? —Io, Angela... Aprirono. —Che notizie? — chiesero tutte, a bassa voce. La comare Angela, trafelata, con la fronte in sudore sotto il fazzoletto rosso, rispose, piano. —Niente!... È morto!... Potete far conto che gli recitino il de Profundis... A stasera non ci arriva!... Le sorelle Sommatino fecero tutt'e tre lo stesso gesto di stupore doloroso, guardando il cielo dell'alba. —Ma che non ci ha da essere un rimedio? —Se vi dico che puzza già di cadavere! Restavano un poco in silenzio, le une in giardino, l'altra nella via; l'uscio era aperto a metà e Caterina, la maggiore delle vecchie zitelle, ci teneva sopra una mano, per poterlo subito richiudere, come in tempo di peste. —Adesso, che cosa volete fare? — riprese la donna. Le sorelle si guardarono, tutte imbarazzate, senza rispondere. —Quella creatura non potete lasciarla così! È vostra sorella, finalmente. Può restar sola, stanotte, col morto dentro? Agatina Sommatino alzò di nuovo gli occhi al cielo, e le altre fecero come lei. —Noi non possiamo nulla, senza mammà!... F. De Roberto, Il rosario (da Processi verbali, 1890) II —È morto!... — diceva don Vincenzo, gesticolando. — Vostro cognato è morto!... —E non gridate così!... Don Vincenzo, turbato, agitatissimo, ripeteva a voce più bassa, dietro il cancello: —È morto... or ora... Vostra sorella sembra una pazza... lo chiama, lo bacia, non c'è verso di levarla di lì... Adesso, come si fa? —Come si può fare? — si chiesero a vicenda le due zitellone, con un imbarazzo costernato. —Non lo volete dire neanche adesso a donna Antonia? —Caro don Vincenzo — rispose Filippina — voi lo sapete meglio di noi com'è mammà... e che non le si può nemmeno nominare questa figliuola... —Ma ora? anche ora che le restano i soli occhi per piangere? Scusate, questa è una cosa che non si è letta mai!... Neanche se avesse ammazzato qualcuno!... Finalmente, il male l'ha fatto a sé e non a voi... —Che possiamo farci?... Lo sa Dio, se la disgrazia di nostra sorella ci affligge... —Davvero, lo sa Dio!... — confermò l'altra. —Con mammà, lo sapete, non si può parlare. Tutto il giorno chiusa nelle sue stanze: mangia sola, non vuol veder nessuno. La sua conversazione è la sera, quando diciamo il rosario... Stasera, vedremo... —E intanto la gente vi legge la vita, che siete dei senza cuore, che è una porcheria tutta nuova, dopo che li avete lasciati morir di fame!.. Lo sapete che non c'è di che pagare il becchino, da vostra sorella? F. De Roberto, Il rosario (da Processi verbali, 1890) III Le tre sorelle Sommatino si erano già raccolte nello stanzone del presepe, al lume di una lampada a olio, quando l'uscio di mezzo si schiuse e comparve donn'Antonia, col bastone in mano. Malgrado l'età, si manteneva sempre dritta e ferma; era vestita tutta a nero, con un fazzoletto nero in capo che le chiudeva il viso magro, ossuto, dal naso ricurvo e dagli occhi scintillanti. Con un mazzo di chiavi, le pendeva dalla cintura la corona del rosario. —Buona sera, mammà! — augurarono le tre sorelle, ad una voce. —Buona sera. […] —Vi ha disobbedito, è vero, mammà... si è preso uno che non era del suo stato... vi ha dato tanti dispiaceri... ma adesso! se la vedeste, non si riconosce più... Vuole buttarsi ai vostri piedi... per chiedervi perdono... Sapete: non ha come fare, non ha più nulla!... Volete che venga a domandarvi perdono?... —Padre nostro che state in cielo, santificato il vostro nome... — Interrompendosi un poco, cogli occhi sempre socchiusi, donn'Antonia disse: — Di chi stai parlando? —Di Rosalia, mammà... di vostra figlia... —Venga a noi il vostro regno, sia fatta la vostra santa divina volontà... Io non ho figlie di nome Rosalia. Mia figlia è morta... Così in cielo come in terra... — E suggerendo la ripresa alle figliuole, che restavano mute, con le schiene sulle seggiole, continuò sola sino in fondo: — Dateci oggi il nostro pane quotidiano... perdonate i nostri peccati, come noi perdoniamo i nostri nemici... Federico De Roberto, Il paradiso perduto, da L’albero della scienza (1890) Matilde Serao, Il ventre di Napoli (1884) La serva napoletana si alloga per dieci lire il mese, senza pranzo: alla mattina fa due o tre miglia di cammino, dalla casa sua alla casa dei suoi padroni, scende le scale quaranta volte al giorno, cava dal pozzo profondo venti secchi di acqua, compie le fatiche più estenuanti, non mangia per tutta la giornata e alla sera si trascina a casa sua, come un'ombra affranta. Ve ne sono di quelle che pigliano due mezzi servizi, a sei lire l'uno e corrono continuamente da una casa all'altra, continuamente rimproverate per le tardanze. Ne ho conosciuta una, io, si chiamava Annarella, faceva tre case al giorno, a cinque lire: alla sera era inebetita, non mangiava, morta dalla fatica, talvolta non si svestiva, per addormentarsi subito. Queste serve trovano anche il tempo di dar latte a un bimbo, di far la calza, ma sono esseri mostruosi, la pietà è uguale alla ripugnanza che ispirano. Hanno trent'anni e ne dimostrano cinquanta, sono curve, hanno perso i capelli, hanno i denti gialli e neri, camminano come sciancate, portano un vestito quattro anni, un grembiule sei mesi. Matilde Serao, Il ventre di Napoli (1884) Non si lamentano, non piangono: vanno a morire, prima di quarant'anni, all'ospedale, di perniciosa, di polmonite, di qualche orrenda malattia. Quante ne avrà portate via il colera! […] Sono brutte, è vero: si trascurano, è verissimo: fanno schifo, talvolta. Ma chi tanto ama la plastica, dovrebbe entrare nel segreto di quelle esistenze, che sono un poema di martirio quotidiano, di sacrifici incalcolabili, di fatiche sopportate senza mormorare. Gioventù, bellezza, vestiti? Ebbero un minuto di bellezza e di gioventù, furono, amate, si sono maritate: dopo, il marito e la miseria, il lavoro e le busse, il travaglio e la fame. Hanno i bimbi e debbono abbandonarli, il più piccolo affidato alla sorellina, e come tutte le altre madri, temono le carrozze, il fuoco, i cani, le cadute. Sono sempre inquiete, agitate, mentre servono. Racconti dell’Italia post-unitaria (1880-) • Renato Fucini (1843-1921), Le veglie di Neri (1882) • Carlo Lorenzini, detto Collodi (1826-1890), Macchiette (1880) e Occhi e nasi. Ricordi dal vero (1881) • Mario Pratesi (1842-1921), In provincia (1883) • Alfredo Oriani (1852-1909), Gramigne (1878) e Quartetto (1883) • Edmondo De Amicis(1846-1908), Cuore (1886) E. De Amicis, Cuore, mese di ottobre (I): Il piccolo patriota padovano Non sarò un soldato codardo, no; ma ci andrei molto più volentieri alla scuola, se il maestro ci facesse ogni giorno un racconto come quello di questa mattina. Ogni mese, disse, ce ne farà uno, ce lo darà scritto, e sarà sempre il racconto d'un atto bello e vero, compiuto da un ragazzo. Il piccolo patriotta padovano s'intitola questo. Ecco il fatto. Un piroscafo francese partì da Barcellona, città della Spagna, per Genova; e c'erano a bordo francesi, italiani, spagnuoli, svizzeri. C'era, fra gli altri, un ragazzo di undici anni, mal vestito, solo, che se ne stava sempre in disparte, come un animale selvatico, guardando tutti con l'occhio torvo. E aveva ben ragione di guardare tutti con l'occhio torvo. Due anni prima, suo padre e sua madre, contadini dei dintorni di Padova, l'avevano venduto al capo d'una compagnia di saltimbanchi; il quale, dopo avergli insegnato a fare i giochi a furia di pugni, di calci e di digiuni, se l'era portato a traverso alla Francia e alla Spagna, picchiandolo sempre e non sfamandolo mai. Arrivato a Barcellona, non potendo più reggere alle percosse e alla fame, ridotto in uno stato da far pietà, era fuggito dal suo aguzzino, e corso a chieder protezione al Console d'Italia, il quale, impietosito, l'aveva imbarcato su quel piroscafo, dandogli una lettera per il Questore di Genova, che doveva rimandarlo ai suoi parenti; ai parenti che l'avevan venduto come una bestia. Rosso Malpelo Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. […] Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane di otto giorni, come fanno le bestie sue pari; e ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Il piccolo patriotta padovano C'era, fra gli altri, un ragazzo di undici anni, mal vestito, solo, che se ne stava sempre in disparte, come un animale selvatico, guardando tutti con l'occhio torvo. E aveva ben ragione di guardare tutti con l'occhio torvo. Due anni prima, suo padre e sua madre, contadini dei dintorni di Padova, l'avevano venduto al capo d'una compagnia di saltimbanchi; il quale, dopo avergli insegnato a fare i giochi a furia di pugni, di calci e di digiuni, se l'era portato a traverso alla Francia e alla Spagna, picchiandolo sempre e non sfamandolo mai. Arrivato a Barcellona, non potendo più reggere alle percosse e alla fame, ridotto in uno stato da far pietà, era fuggito dal suo aguzzino, e corso a chieder protezione al Console d'Italia, il quale, impietosito, l'aveva imbarcato su quel piroscafo, dandogli una lettera per il Questore di Genova, che doveva rimandarlo ai suoi parenti; ai parenti che l'avevan venduto come una bestia. E. De Amicis, Cuore, mese di ottobre (II): Il piccolo patriota padovano Il povero ragazzo era lacero e malaticcio. Gli avevan dato una cabina nella seconda classe. Tutti lo guardavano; qualcuno lo interrogava; ma egli non rispondeva, e pareva che odiasse e disprezzasse tutti, tanto l'avevano inasprito e intristito le privazioni e le busse. Tre viaggiatori, non di meno a forza d'insistere con le domande, riuscirono a fargli snodare la lingua, e in poche parole rozze, miste di veneto, di spagnuolo e di francese, egli raccontò la sua storia. Non erano italiani quei tre viaggiatori; ma capirono, e un poco per compassione, un poco perché eccitati dal vino, gli diedero dei soldi, celiando e stuzzicandolo perché raccontasse altre cose; ed essendo entrate nella sala, in quel momento, alcune signore, tutti e tre, per farsi vedere, gli diedero ancora del denaro, gridando: — Piglia questo! — Piglia quest'altro! — e facendo sonar le monete sulla tavola. Il ragazzo intascò ogni cosa, ringraziando a mezza voce, col suo fare burbero, ma con uno sguardo per la prima volta sorridente e affettuoso. Poi s'arrampicò nella sua cabina, tirò la tenda, e stette queto, pensando ai fatti suoi. Con quei denari poteva assaggiare qualche buon boccone a bordo, dopo due anni che stentava il pane; poteva comprarsi una giacchetta, appena sbarcato a Genova, dopo due anni che andava vestito di cenci; e poteva anche, portandoli a casa, farsi accogliere da suo padre e da sua madre un poco più umanamente che non l'avrebbero accolto se fosse arrivato con le tasche vuote. Erano una piccola fortuna per lui quei denari. E. De Amicis, Cuore, mese di ottobre (III): Il piccolo patriota padovano E a questo egli pensava, racconsolato, dietro la tenda della sua cabina, mentre i tre viaggiatori discorrevano, seduti alla tavola da pranzo, in mezzo alla sala della seconda classe. Bevevano e discorrevano dei loro viaggi e dei paesi che avevan veduti, e di discorso in discorso, vennero a ragionare dell'Italia. Cominciò uno a lagnarsi degli alberghi, un altro delle strade ferrate, e poi tutti insieme, infervorandosi, presero a dir male d'ogni cosa. Uno avrebbe preferito di viaggiare in Lapponia; un altro diceva di non aver trovato in Italia che truffatori e briganti; il terzo, che gl'impiegati italiani non sanno leggere. — Un popolo ignorante, — ripeté il primo. — Sudicio, — aggiunse il secondo. — La... — esclamò il terzo; e voleva dir ladro, ma non poté finir la parola: una tempesta di soldi e di mezze lire si rovesciò sulle loro teste e sulle loro spalle, e saltellò sul tavolo e sull'impiantito con un fracasso d'inferno. Tutti e tre s'alzarono furiosi, guardando all'in su, e ricevettero ancora una manata di soldi sulla faccia. — Ripigliatevi i vostri soldi, — disse con disprezzo il ragazzo, affacciato fuor della tenda della cabina; — io non accetto l'elemosina da chi insulta il mio paese. D’Annunzio novelliere • • • • • 1882 (II ed. ampl. 1894) Terra vergine (9+2 testi) 1884 Il libro delle vergini (4 racconti) 1886 San Pantaleone (17 novelle) 1892 I violenti (3 novelle) 1902 Le novelle della Pescara (18 testi: 1 da LV, 15 da SP e 2 da IV) G. D’Annunzio, Fiore fiurelle, in Terra vergine (1882) Che rosseggiare lussurioso di peperoni e di pomidori, al sole di luglio, tra la verzura folta, mentre Nara abbeverava i solchi arsicci cantilenando! L'acqua fresca spariva con un gorgoglìo di schiume dentro la terra arida: tutta quella plebe di piante, oppressa dall'afa enorme del meriggio, rilucente di riflessi metallici, bruciacchiata qua e là, rabbrividiva di piacere sentendo ascendere per tutte le fibre, dalle radici alle ultime cime, il succo trionfale; la canzone pigra di Nara vi si sperdeva dentro, sotto le larghe foglie flosce, tra le zucche simili a mostruosi teschi gialli, tra i poponi verdastri e i cocomeri lucidi come di smalto. Nara, china, con la schiena al solleone, colla gonna bianca, pareva una pecora, da lontano; ma quando si rizzò su, tutta, parve una bella femmina fiorente di salute in mezzo alla rifioritura violetta dei ramolacci. Cantava più forte: il petto pregno di latte le ondeggiava in un alenare largo e profondo; rossa nella faccia, ombrata dalla pezzuola sgargiante, e su il rossore due grandi occhi grigi, sereni più di quelle infinite lontananze estive, sereni più di quelle immense azzurrità adriatiche dove le vele arance sciamavano. Il canto fluiva limpidamente per la calma meridiana: era una scaturigine selvatica e fresca di note... Verga, Rosso Malpelo Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. D’Annunzio, Dalfino Nella spiaggia lo chiamavano Dalfino; e il nomignolo gli stava a capello, perché dentro l′acqua pareva proprio un delfino, con quella schiena curvata dal remo e annerita dalla canicola, con quella grossa testa lanosa, con quel vigore sovrumano di gambe e di braccia che gli facea far guizzi e salti e tonfi da raccapriccire. Bisognava vederlo buttarsi giù con un urlo dallo scoglio de′ Forroni, come un aquilastro ferito all′ala, e poi ricomparire venti braccia più in là, fuor dell′acqua verde, con tanto d′occhiacci aperti contro il sole: bisognava vederlo! Ma forse era più bello su la paranza, aggrappato all′albero, mentre lo scirocco sibilava a traverso le funi e la vela rossa stava lì lì per stracciarsi e la tempesta mugghiava sotto che pareva se lo volesse ingoiare. G. D’Annunzio, Fiore fiurelle, in Terra vergine (1882) Fiore de line, / lu line ca le fa lu fiore chiare; / la donne ci ji tesse lu panne fine. Tutto l'orto d'intorno e il campo di fave e l'aia accanto risonavano; il grecale alitante dal mare invadeva quell'altro piccolo mare verde, con un fruscìo odoroso; più sopra, Francavilla dal gentile profilo moresco, candida, in una gloria di sole, intarsiata sul fondo azzurro del cielo. Malamore, che era a mietere sotto l'arsura crudele, riconobbe la voce della sua donna, e stette in ascolto: pensava al refrigerio di una bella fetta di cocomero diaccio, a un'allegria di risa là nell'aia fra le ruote de' tacchini, al borbottìo del bimbo brancicante in un canestro di ciliege mature... E il canto: Fiore de mende, / senza la mende nen ze po 'mmendare; / senza l’amande n’n ze po fa’ l’amore! L. Pirandello, Lettera alla sorella Lina, 31.X.1886 Noi siamo come i poveri ragni, che per vivere han bisogno d’intessersi in un cantuccio la loro tela sottile, noi siamo come le povere lumache che per vivere han bisogno di portare a dosso il loro guscio fragile, o come i poveri molluschi che vogliono tutti la loro conchiglia in fondo al mare. Siamo ragni, lumache e molluschi di una razza più nobile – passi pure – non vorremmo una ragnatela, un guscio, una conchiglia – passi pure – ma un piccolo mondo sì, e per vivere in esso e per vivere di esso. Un ideale, un sentimento, una abitudine, una occupazione – ecco il piccolo mondo, ecco il guscio di questo lumacone o uomo – come lo chiamano. Senza questo è impossibile la vita. Quando tu riesci a non avere più un ideale, perché osservando la vita sembra un’enorme pupazzata, senza nesso, senza spiegazione mai; quando tu non hai più un sentimento, perché sei riuscito a non stimare, a non curare più gli uomini e le cose, e ti manca perciò l’abitudine, che non trovi, e l’occupazione, che sdegni – quando tu, in una parola, vivrai senza la vita, penserai senza un pensiero, sentirai senza cuore – allora tu non saprai che fare: sarai un viandante senza casa, un uccello senza nido. Io sono così. [...] Io scrivo e studio per dimenticare me stesso – per distormi dalla disperazione. L. Pirandello, Lettera alla sorella Lina, 31.X.1886 I. Noi siamo come i poveri ragni, che per vivere han bisogno d’intessersi in un cantuccio la loro tela sottile, noi siamo come le povere lumache che per vivere han bisogno di portare a dosso il loro guscio fragile, o come i poveri molluschi che vogliono tutti la loro conchiglia in fondo al mare. Siamo ragni, lumache e molluschi di una razza più nobile – passi pure – non vorremmo una ragnatela, un guscio, una conchiglia – passi pure – ma un piccolo mondo sì, e per vivere in esso e per vivere di esso. Un ideale, un sentimento, una abitudine, una occupazione – ecco il piccolo mondo, ecco il guscio di questo lumacone o uomo – come lo chiamano. Senza questo è impossibile la vita. II. Quando tu riesci a non avere più un ideale, perché osservando la vita sembra un’enorme pupazzata, senza nesso, senza spiegazione mai; quando tu non hai più un sentimento, perché sei riuscito a non stimare, a non curare più gli uomini e le cose, e ti manca perciò l’abitudine, che non trovi, e l’occupazione, che sdegni – quando tu, in una parola, vivrai senza la vita, penserai senza un pensiero, sentirai senza cuore – allora tu non saprai che fare: sarai un viandante senza casa, un uccello senza nido. III. Io sono così. [...] IV. Io scrivo e studio per dimenticare me stesso – per distormi dalla disperazione. L. Pirandello, L’umorismo, 1908 Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di qual orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d'abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s'inganna che, parata così, nascondendo le rughe e le canizie, riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l'umoristico. L. Pirandello, L’umorismo, 1908 (II) In certi momenti di silenzio interiore, in cui l’anima nostra si spoglia di tutte le finzioni abituali, e gli occhi nostri diventano più acuti e più penetranti, noi vediamo noi stessi nella vita e in sé stessa la vita, quasi in una nudità arida, inquietante; ci sentiamo assaltare da una strana impressione, come se, in un baleno, ci si chiarisse una realtà diversa da quella che normalmente percepiamo, una realtà vivente oltre la finzione colorata dei nostri sensi, oltre la vista umana, fuori delle forme dell’umana ragione. Lucidissimamente allora la compagine dell’esistenza quotidiana, quasi sospesa nel vuoto di quel nostro silenzio interiore, ci appare priva di senso, priva di scopo, e quella realtà diversa ci appare orrida nella sua crudezza impassibile e misteriosa, poiché tutte le nostre fittizie relazioni consuete di sentimenti e d’immagini si sono scisse e disgregate in essa. Il vuoto interno si allarga, varca i limiti del nostro corpo, diventa vuoto intorno a noi, un vuoto strano, come un arresto del tempo e della vita, come se il nostro silenzio interiore si sprofondasse negli abissi del mistero. Con uno sforzo supremo cerchiamo allora di riacquistar la coscienza normale delle cose, di riallacciar con esse le consuete relazioni, di riconnetter le idee, di risentirci vivi come per l’innanzi, al modo solito. Ma a questa coscienza normale, a queste idee riconnesse, a questo sentimento solito della vita non possiamo più prestar fede, perché sappiamo ormai che sono un nostro inganno per vivere e che sotto c’è qualcos’altro, a cui l’uomo non può affacciarsi, se non a costo di morire o d’impazzire. È stato un attimo; ma dura a lungo in noi l’impressione di esso, come di vertigine, con la quale contrasta la stabilità, pur così vana, delle cose: ambiziose o misere apparenze. La vita, allora, che s’aggira piccola, solita, fra queste apparenze ci sembra quasi che non sia più per davvero, che sia come una fantasmagoria meccanica. E come darle importanza? come portarle rispetto? L. Pirandello, L’umorismo, 1908 (II) I. II. III. IV. In certi momenti di silenzio interiore, in cui l’anima nostra si spoglia di tutte le finzioni abituali, e gli occhi nostri diventano più acuti e più penetranti, noi vediamo noi stessi nella vita e in sé stessa la vita, quasi in una nudità arida, inquietante; ci sentiamo assaltare da una strana impressione, come se, in un baleno, ci si chiarisse una realtà diversa da quella che normalmente percepiamo, una realtà vivente oltre la finzione colorata dei nostri sensi, oltre la vista umana, fuori delle forme dell’umana ragione. Lucidissimamente allora la compagine dell’esistenza quotidiana, quasi sospesa nel vuoto di quel nostro silenzio interiore, ci appare priva di senso, priva di scopo, e quella realtà diversa ci appare orrida nella sua crudezza impassibile e misteriosa, poiché tutte le nostre fittizie relazioni consuete di sentimenti e d’immagini si sono scisse e disgregate in essa. Il vuoto interno si allarga, varca i limiti del nostro corpo, diventa vuoto intorno a noi, un vuoto strano, come un arresto del tempo e della vita, come se il nostro silenzio interiore si sprofondasse negli abissi del mistero. Con uno sforzo supremo cerchiamo allora di riacquistar la coscienza normale delle cose, di riallacciar con esse le consuete relazioni, di riconnetter le idee, di risentirci vivi come per l’innanzi, al modo solito. Ma a questa coscienza normale, a queste idee riconnesse, a questo sentimento solito della vita non possiamo più prestar fede, perché sappiamo ormai che sono un nostro inganno per vivere e che sotto c’è qualcos’altro, a cui l’uomo non può affacciarsi, se non a costo di morire o d’impazzire. È stato un attimo; ma dura a lungo in noi l’impressione di esso, come di vertigine, con la quale contrasta la stabilità, pur così vana, delle cose: ambiziose o misere apparenze. La vita, allora, che s’aggira piccola, solita, fra queste apparenze ci sembra quasi che non sia più per davvero, che sia come una fantasmagoria meccanica. E come darle importanza? come portarle rispetto? Numeri e dati della novellistica pirandelliana • La prima novella pubblicata si intitola Capannetta, ed esce nel 1884, sul supplemento domenicale della “Gazzetta del Popolo”. • La novella Effetti di un sogno interrotto esce sul CS il 9 dicembre 1936, il giorno precedente la sua morte. • Tra il 1894 di Amori senza amore e il 1919 di Il carnevale dei morti escono 17 raccolte. • Dopo il 1920 viene concepito il progetto Novelle per un anno disegno originario = un vol. di 365 testi; progetto definitivo = 24 libri di 15 testi; realizzazione effettiva = 15 libri (1-13: 1922-28; 14: 1934; 15: 1937), per un totale di 225 novelle B. Terracini, Analisi stilistica, 1966, pp. 327-8 «Le novelle sono l’espressione più genuina di quel suo dicotomismo spirituale cui lo scrittore si è sforzato di dare una giustificazione poetica ne L’umorismo. Da quel dualismo sorge nitida tutta la problematica che è stata alla base della sua produzione narrativa, l’angoscia cioè dell’individuo, dinanzi al disgregarsi di ogni realtà, contenuta nelle dimensioni di una tragedia soggettivamente umana che ad ogni caso si profila, si risolve e si ripropone». Luigi Pirandello, Romanzo, racconto, novella, «Le Grazie», 16.II.1897 (poi rifuso nel saggio Soggettivismo e oggettivismo nell’arte narrativa, in Arte e scienza, 1908) Ogni letterato nel trarre dalla vita presente o passata o dalla propria fantasia una favola qualsiasi, o la considera nel suo complesso, sinteticamente, nei suoi momenti culminanti e più determinanti, e ne farà allora una novella, o la considera in tutti i suoi particolari, analisicommento, per gradi evolutivi, e ne farà allora un romanzo. Di questo o di quella potrà tuttavia far sempre un racconto lungo o breve, quante volte gli piaccia a seconda del modo che presceglierà nell’esporlo. Giacché racconto è componimento d’arte narrativa condotto in una data maniera e con propri caratteri, senza delimitazione alcuna nella lunghezza o nella brevità. […] La novella e la tragedia classica […] pigliano il fatto, a dir così, per la coda; e di questa estremità si contentano: intese a dipingerci non le origini, non i gradi della passione, non le relazioni di quella con i molti oggetti che circondano l’uomo, e servono a sospingerla, a ripercuoterla, ad informarla in mille modi diversi, ma solo gli ultimi passi, l’eccesso insomma. Antologia pirandelliana • 1911 (9 agosto CS) La patente (vol. III, La rallegrata, 1922) • 1912 (29 dicembre CS) Ciaula scopre la luna (vol. VIII, Dal naso al cielo, 1925) • 1914 (22 febbraio CS) Il treno ha fischiato… (vol. IV, L’uomo solo, 1922) • 1915 (17-18 gennaio «Giorn. di Sic.») La carriola (vol. XIII, Candelora, 1928) • 1914-15 Berecche e la guerra (vol. XIV, Berecche e la guerra, 1934) • 1934 (6 maggio CS) Di seria un geranio (vol. XIV, Berecche e la guerra, 1934) • 1936 (24 settembre CS) Una giornata (vol. XV, Una giornata, 1937) La patente • CS, 9 agosto 1911 • Nel volume La trappola, Milano 1915 • Nel volume La rallegrata, Novelle per un anno III, Firenze 1922 • 1917-18, Adattamento teatrale (commedia in un atto o «novella sceneggiata»), a stampa per la prima volta nel 1918 (31 gennaio, «Rivista d’Italia») La patente (I) Così sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di traverso, come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere, non aveva potuto vedere molte cose, il giudice D’Andrea; ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più triste, cioè di notte. […] Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute. L’arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che hanno in sé una certezza su la quale non possono riposare, la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo, qualche seria costipazione. Costipazione d’anima, s’intende. E al giudice D’Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo, ch’egli dovesse recarsi al suo ufficio d’Istruzione ad amministrare – per quel tanto che a lui toccava – la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci. La patente (II) Era veramente iniquo quel processo là: iniquo perché includeva una spietata ingiustizia contro alla quale un pover’uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. C’era in quel processo una vittima che non poteva prendersela con nessuno. […] Perché, in verità, era un caso insolito e speciosissimo quello d’un iettatore che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell’atto di far gli scongiuri di rito al suo passaggio. Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di iettatore? se innumerevoli testimonii potevano venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente? Come condannare, in coscienza, quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri, e primi fra tutti – eccoli là – gli stessi giudici? La patente (III) Quella volta il giudice D’Andrea, appena alzò gli occhi a guardar il Chiàrchiaro, che gli era entrato nella stanza, mentr’egli era intento a scrivere, ebbe uno scatto violentissimo e buttò all’aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: – Ma fatemi il piacere! Che storie son queste? Vergognatevi! Il Chiàrchiaro s’era combinata una faccia da iettatore, ch’era una meraviglia a vedere. S’era lasciata crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata; si era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d’osso, che gli davano l’aspetto d’un barbagianni; aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce: – Lei dunque non ci crede? – Ma fatemi il piacere! – ripeté il giudice D’Andrea. – Non facciamo scherzi, caro Chiàrchiaro! O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua. La patente (IV) Il Chiàrchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D’Andrea; si levò in piedi, gridando con le braccia per aria: – Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza, non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l’unico mio capitale! […] – E poi? – E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dov’ero scritturale, con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni; mi hanno buttato in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie; viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, quattro bambini, e non può fare a lungo questo sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione del iettatore! Mi sono parato così, con questi occhiali, con quest’abito; mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la patente per entrare in campo! Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico! – Io? – Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono! E ci son tante case da giuoco in questo paese! Basterà che io mi presenti; non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via! Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche; mi pianterò innanzi a tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei dice dell’ignoranza? io dico la tassa della salute! Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa umanità, che veramente credo d’avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta una intera città! La patente (V) Il giudice D’Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l’angoscia che gli serrava la gola desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori; e allora egli, socchiudendo dietro le lenti i piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiàrchiaro a lungo, forte forte, a lungo. Questi lo lasciò fare. – Mi vuol bene davvero? – gli domandò. E allora istruisca subito il processo, e in modo da farmi avere al più presto quello che desidero. – La patente? Il Chiàrchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d’India sul pavimento e, portandosi l’altra mano al petto, ripeté con tragica solennità: – La patente. Ciàula scopre la luna Tradizione editoriale del testo • • • • 29.12.1912 sul CS 1914 nel volume Le due maschere 1920 nel volume Tu ridi 1925 nel volume VIII delle Novelle per un anno, Dal naso al cielo Ciàula scopre la luna (I) I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senz’aver finito d’estrarre le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara. Cacciagallina, il soprastante, s’affierò contr’essi, con la rivoltella in pugno, davanti la buca della Cace, per impedire che ne uscissero. – Corpo di... sangue di... indietro tutti, giù tutti di nuovo alle cave, a buttar sangue fino all’alba, o faccio fuoco! – Bum! – fece uno dal fondo della buca. – Bum! – echeggiarono parecchi altri; e con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto, e chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti, meno uno. Chi? Zi’ Scarda, si sa, quel povero cieco d’un occhio, sul quale Cacciagallina poteva fare bene il gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò addosso, che neanche un leone; lo agguantò per il petto e, quasi avesse in pugno anche gli altri, gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente: – Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giù tutti alle cave, o faccio un macello! Zi’ Scarda si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo, quel povero galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio com’era, poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto, aveva anche lui, a sua volta, sotto di sé qualcuno più debole, sul quale rifarsi più tardi: Ciàula, il suo caruso. Ciàula scopre la luna (II) Ciàula stava a rivestirsi per ritornare al paese. Rivestirsi per Ciàula significava togliersi prima di tutto la camicia, o quella che un tempo era stata forse una camicia: l’unico indumento che, per modo di dire, lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la camicia, indossava sul torace nudo, in cui si potevano contare a una a una tutte le costole, un panciotto bello largo e lungo, avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino (ora il luridume vi aveva fatto una tal roccia, che a posarlo per terra stava ritto). Con somma cura Ciàula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano, e poi se lo mirava addosso, passandoci sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava superiore a’ suoi meriti: una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche, durante quell’ammirazione, gli si accapponavano, illividite dal freddo. Se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone e gli allungava un calcio, gridandogli: – Quanto sei bello! – egli apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca sdentata a un riso di soddisfazione, poi infilava i calzoni, che avevano più d’una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi: s’avvolgeva in un cappottello d’albagio tutto rappezzato, e, scalzo, imitando meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia – cràh! cràh! – (per cui lo avevano soprannominato Ciàula), s’avviava al paese. […] Cosa strana: della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava in agguato la morte, Ciàula non aveva paura, né paura delle ombre mostruose, che qualche lanterna suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, in uno stagno d’acqua sulfurea: sapeva sempre dov’era; toccava con la mano in cerca di sostegno le viscere della montagna: e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo alvo materno. Aveva paura, invece, del bujo vano della notte. Ciàula scopre la luna (III) Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava di sopra, e su la cui lubricità la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su, dal ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. E non vedeva ancora la buca, che lassù lassù si apriva come un occhio chiaro, d’una deliziosa chiarità d’argento. Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiarìa cresceva, cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. Possibile? Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. Grande, placida, come in un fresco luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna. Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato mai importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la Luna... C’era la Luna! la Luna! E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore. Il treno ha fischiato • CS, 22 febbraio 1914 • 1915, nella raccolta La trappola • 1922, nel vol. IV delle Novelle per un anno intitolato L’uomo solo. • 1936, ulteriori aggiustamenti Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non sembrerà più tale; ma quale dev'essere, appartenendo a quel mostro. Una coda naturalissima. Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, vecchissime, per cataratta; l'altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa; palpebre murate. Tutt'e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche ajuto alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt'e dodici, non trovavan posto nei tre soli letti della casa. Il treno ha fischiato Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d'una nòria o d'un molino, sissignori, s'era dimenticato da anni e anni - ma proprio dimenticato - che il mondo esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d'addormentarsi subito. E, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tant'anni, chi sa come, d'improvviso gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s'era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt'intorno. […] C'erano, mentr'egli qua viveva questa vita «impossibile», tanti e tanti milioni d'uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch'egli qua soffriva, c'erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti... Sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così... c'erano gli oceani... le foreste... E, dunque, lui - ora che il mondo gli era rientrato nello spirito - poteva in qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Gli bastava! Il treno ha fischiato Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S'era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d'un tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo-ufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo-ufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l'altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo. Il treno ha fischiato La conclusione di Il treno ha fischiato: giudizi a confronto • L. Lugnani: “Non è la felicità quella che il misero Belluca ha trovato, ma un modesto talismano per la sopravvivenza e, contro le ridicole diagnosi iniziali, un surrogato alla vera pazzia e nel contempo un rudimentale farmaco contro il rischio della follia”. • P. Rocchi: “Egli tornerà al mondo delle forme, ricomincerà a vivere tra obblighi e costrizioni, ma senza più sentirne il peso, nella consapevolezza del vuoto che è nascosto al loro interno. Chiedere di fare dal mondo delle forme, di tanto in tanto, una capatina in cerca d’aria, è la più piccola delle pretese per chi ha conosciuto la forza dirompente delle vita”. • G. Langella: “È la rivincita, per quanto esclusivamente virtuale, della vita, libera e varia, sulla forma che opprime tutte le creature di Pirandello. Belluca può tornare, così, alla sua sorte grama, ma non una risorsa che prima non aveva: il piacere di evadere lontano. […] L’immaginazione che lo trasporta in un batter d’occhio nei luoghi più remoti della terra, salvandolo dalla sua condizione infelice, è in fondo l’espressione galoppante di una facoltà poetica. La sua via di fuga è la magia dell’arte”. L. Pirandello. Una giornata Strappato dal sonno, forse per sbaglio, e buttato fuori dal treno in una stazione di passaggio. Di notte; senza nulla con me. Non riesco a riavermi dallo sbalordimento. Ma ciò che più mi impressiona è che non mi trovo addosso alcun segno della violenza patita; non solo, ma che non ne ho neppure un’immagine, neppur l’ombra confusa d’un ricordo. Mi trovo a terra, solo, nella tenebra d’una stazione deserta; e non so a chi rivolgermi per sapere che m’è accaduto, dove sono. Ho solo intravisto un lanternino cieco, accorso per richiudere lo sportello del treno da cui sono stato espulso. Il treno è subito ripartito. È subito scomparso nell’interno della stazione quel lanternino, col riverbero vagellante del suo lume vano. Nello stordimento, non m’è nemmeno passato per il capo di corrergli dietro per domandare spiegazioni e far reclamo. Ma reclamo di che? Con infinito sgomento m’accorgo di non aver più idea d’essermi messo in viaggio su un treno. Non ricordo più affatto di dove sia partito, dove diretto; e se veramente, partendo, avessi con me qualche cosa. Mi pare nulla. Italo Svevo, Pagine di diario: 1902 “Io, a quest’ora e definitivamente ho eliminato dalla mia vita quella ridicola e dannosa cosa che si chiama letteratura. Io voglio soltanto attraverso queste pagine arrivare a capirmi meglio. [… ] Dunque ancora una volta, grezzo e rigido strumento, la penna m’aiuterà ad arrivare al fondo complesso del mio essere”. Italo Svevo, Diario per la fidanzata (1896) Un uomo può avere solo due grandi fortune a questo mondo: quella di amare molto oppure quella di combattere vittoriosamente nella lotta per la vita. Si è felici in un modo o nell’altro ma non avviene spesso che il destino conceda ambidue queste felicità. Mi pare perciò che dei caratteri umani, i felici son quelli che sanno rinunciare all’amore o quelli che si tolgono dalla lotta. Infelicissimi son quelli che si frazionano come desiderio o come attività nei due campi tanto opposti. Strano che pensando alla mia Livia io ci veda e l’amore e la vittoria. La mia indifferenza per la vita sussiste sempre: anche quando godo della vita a te da canto, mi resta nell’anima qualche cosa che non gode con me e che m’avverte: Bada, non è tutto come a te sembra e tutto resta comedia perché calerà poi il sipario. Di più l’indifferenza per la vita è l’essenza della mia vita intellettuale. In quanto è spirito o forza, la mia parola non è altro che ironia ed io ho paura che il giorno in cui a te riuscisse di farmi credere nella vita (è cosa impossibile) io mi troverei grandemente sminuito. Quasi, quasi, ti pregherei di lasciarmi stare così. Ho un grande timore che essendo felice diverrei stupido e, viceversa poi, son felice (quale confessione ti faccio) soltanto quando sento movermi nella grossa testa delle idee che credo non si movano in molte altre teste. I racconti di Italo Svevo La stagione dell’esordio • Una lotta (1888); personaggi: Rosina, Arturo Marchetti e Ariodante Chigi • L’assassinio di via Belpoggio (1890); personaggi: Giorgio e Antonio La stagione della maturità • La novella del buon vecchio e della bella fanciulla e altri scritti (1929): comprende i racconti Vino generoso, Una burla riuscita e altri • Corto viaggio sentimentale e altri racconti inediti (1949) Un sogno atroce: mi trovai in una costruzione complicata, ma che subito intesi come se io ne fossi stato parte. Una grotta vastissima, rozza, priva di quegli addobbi che nelle grotte la natura si diverte a creare, e perciò sicuramente dovuta all’opera dell’uomo; oscura, nella quale io sedevo su un treppiedi di legno accanto ad una cassa di vetro, debolmente illuminata di una luce che io ritenni fosse una sua qualità, l’unica luce che ci fosse nel vasto ambiente, e che arrivava ad illuminare me, una parete composta di pietroni grezzi e di sotto un muro cementato. Come sono espressive le costruzioni del sogno! Si dirà che lo sono perché chi le ha architettate può intenderle facilmente, ed è giusto. Ma il sorprendente si è che l’architetto non sa di averle fatte, e non lo ricorda neppure quand’è desto, e rivolgendo il pensiero al mondo da cui è uscito e dove le costruzioni sorgono con tanta facilità può sorprendersi che là tutto s’intenda senza bisogno di alcuna parola. Io seppi subito che quella grotta era stata costruita da alcuni uomini che l’usavano per una cura inventata da loro, una cura che doveva essere letale per uno dei rinchiusi (molti dovevano esserci laggiù nell’ombra) ma benefica per tutti gli altri. Proprio così! Una specie di religione, che abbisognava di un olocausto, e di ciò naturalmente non fui sorpreso. Era più facile assai indovinare che, visto che m’avevano posto vicino alla cassa di vetro nella quale la vittima doveva essere asfissiata, ero prescelto io a morire, a vantaggio di tutti gli altri. Ed io già anticipavo in me i dolori della brutta morte che m’aspettava. Respiravo con difficoltà, e la testa mi doleva e pesava, per cui la sostenevo con le mani, i gomiti poggiati sulle ginocchia. Vino generoso E allora io urlai ancora: – Se non si può altrimenti, prendete mia figlia. Dorme qui accanto. Sarà facile. – Anche questi gridi furono rimandati da un’eco enorme. Ne ero frastornato, ma urlai ancora per chiamare mia figlia: – Emma, Emma, Emma! Ed infatti dal fondo della grotta mi pervenne la risposta di Emma, il suono della sua voce tanto infantile ancora: – Eccomi, babbo, eccomi. Mi parve non avesse risposto subito. Ci fu allora un violento sconvolgimento che credetti dovuto al mio salto nella cassa. Pensai ancora: “Sempre lenta quella figliuola quando si tratta di obbedire”. Questa volta la sua lentezza mi rovinava ed ero pieno di rancore. Mi destai. Questo era lo sconvolgimento. Il salto da un mondo nell’altro. Ero con la testa e il busto fuori del letto e sarei caduto se mia moglie non fosse accorsa a trattenermi. Mi domandò: – Hai sognato? – E poi, commossa: – Invocavi tua figlia. Vedi come l’ami? Fui dapprima abbacinato da quella realtà in cui mi parve che tutto fosse svisato e falsato. E dissi a mia moglie che pur doveva saper tutto anche lei: – Come potremo ottenere dai nostri figliuoli il perdono di aver dato loro questa vita? Ma lei, sempliciona, disse: – I nostri figliuoli sono beati di vivere. La vita, ch’io allora sentivo quale la vera, la vita del sogno, tuttavia m’avviluppava e volli proclamarla: – Perché loro non sanno niente ancora. Vino generoso
Scaricare
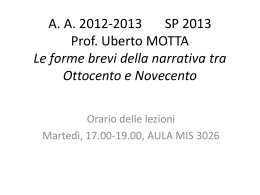
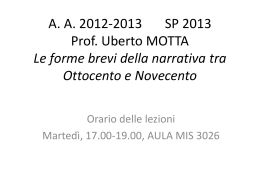
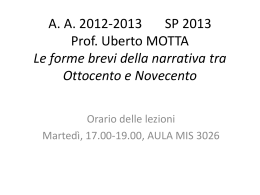

![La vita e le opere [m]](http://s2.diazilla.com/store/data/000049770_1-b54436b069442c0a3aaf727de1a5e86b-260x520.png)