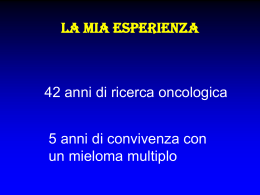Luigi Alici Essere, agire, patire: l’anomalia della finitezza 1. Tra homo patiens e homo sapiens “Fuori splendeva il sole e la gente sbrigava le solite faccende d’ogni giorno. Una donna si precipitò. Un’altra stava rientrando con la spesa. Nella mente di Charlotte si affollavano mille domande: Quanto tempo ci resta ancora? Come supereremo le difficoltà? E come pagheremo i conti? Dal canto suo il mio vecchio professore era strabiliato dalla normalità di quanto vedeva intorno a sé: Non dovrebbe fermarsi il mondo? Non sanno quel che mi è capitato? Ma il mondo non si era fermato, era rimasto completamente indifferente e, mentre apriva fiaccamente la portiera della macchina, Morrie si era sentito sprofondare in un baratro”1. Con questa toccante annotazione ci viene descritto, ne I miei martedì col professore, il primo incontro di Morrie Schwartz con il male che lo avrebbe ben presto portato alla morte; un incontro dal quale, tuttavia, egli sarebbe riuscito a ricavare e trasmetterci una esemplare lezione di vita. La scoperta di una grave malattia, che s’intromette di prepotenza nella nostra vita, iniziando una lenta e inesorabile opera di aggressione distruttiva, avviene quasi sempre sotto il segno di uno stupore quasi irreale, che sembra sospendere il ritmo naturale dell’esistere, facendoci sentire di colpo soli ed emarginati in una irreparabile condizione di anormalità. Non sono, dunque, soltanto i filosofi a ricordarci che le rivelazioni più intense e profonde, nel bene e nel male, nascono sempre dalla meraviglia. Una meraviglia, in questo caso, vissuta tragicamente in prima persona: una sorta di assurda estasi negativa sembra sospendere, per alcuni istanti, il corso ordinario delle cose, prima che incominci un lento ritorno alla realtà, fatto di domande troppo grandi per una ragione capace di offrire risposte troppo piccole: “Perché? Perché proprio io? Perché adesso? Perché così?”. Eppure il compito della riflessione filosofica è proprio quello di misurarsi con tale stupore: quando esso nasce dalla rivelazione positiva di un dono, o quando accompagna l’avvertimento lacerante di una minaccia che investe la nostra vita. In entrambi i casi, lo stupore segnala uno scarto, per eccesso o per difetto, rispetto ai parametri ordinari dell’esistenza, tenuti apparentemente sotto controllo dalle false sicurezze del senso comune o di un’ideologia utilitaristica. Ebbene, non è difficile rilevare che la solitudine dell’homo patiens oggi appare in qualche misura raddoppiata: accanto alla scoperta improvvisa di un coinvolgimento diretto, assolutamente non delegabile, in un inatteso calvario da percorrere (nel quale tuttavia sarà non secondario incontrare qualche cireneo misericordioso), c’è anche un orizzonte allargato di solitudine, indotto da una cultura sempre più evasiva e indifferente dinanzi all’irrompere di eventi difettivi che alterano irreversibilmente il corso ordinario dei giorni: dal dolore fisico, che investe il nostro organismo, alla sofferenza, intesa come esperienza vissuta più complessa e profonda che tocca le radici stesse della vita personale; dal decesso alla morte, che riproducono nell’orizzonte della fine il medesimo divario tra episodio biologico ed evento biografico. Misurarsi con una cultura incapace di sorprendersi, e forse nemmeno di accorgersi dell’enigma del negativo, può essere il primo passo, la pars destruens di questo modesto contributo, che s’accontenta di suggerire poche tracce stentate sulla strada di una 1 M. Albom, I miei martedì col professore. La lezione più grande: la vita, la morte, l’amore, tr. it. di F. Bandel Fragone, Rizzoli, Milano 1998, p.16 1 riconsiderazione in chiave ontologica e antropologica di questo tema, nella speranza che possano dischiudere una prospettiva metafisicamente orientata. Le difficoltà di lasciarci interpellare dal volto dell’homo patiens sul piano della riflessione possono essere, essenzialmente, di due generi diversi. Su un piano congiunturale, esse si collegano ad una difficoltà, tipicamente postmoderna, di oltrepassare il piano dell’immediatezza esperienziale e istituire un rapporto tra logos e pathos, che sfugga alla doppia tentazione di un razionalismo vuoto o di un esperienzialismo cieco. Interrogarsi sui fattori che sono all’origine di un atteggiamento culturale oscillante tra afasia e amnesia equivarrebbe, di per sé, ad avviare una riflessione sul nostro tempo, che, in questa sede, sarà necessario limitare a qualche suggestione puramente evocativa. Accogliendo la proposta di Vergely, potremmo intendere quella oscillazione come il risultato di un’antitesi irrisolta fra due atteggiamenti opposti, che guardano alla sofferenza come fonte di senso o, al contrario, di non-senso della vita2. Nel primo caso, siamo in presenza di un tentativo, variamente declinato, di razionalizzazione della sofferenza, che si risolve sempre, in ultima analisi, in una cieca volontà di senso. L’asse esplicativo si può spostare considerevolmente, anche se l’esito ultimo non sembra molto diverso: il destino, un male inteso provvidenzialismo, il sogno titanico di ingaggiare una lotta contro il limite e il negativo per riscattarsi in un processo di autotrascendenza, sono forme diverse di un “senso che fa soffrire”, rivelandosi ultimamente un non-senso. D’altro canto, anche il tentativo contrario di screditare completamente la via del logos, appellandosi all’assoluto non-senso del soffrire, sembra abbandonare l’esistenza ad una forma di cieco esperienzialismo, in qualche modo fatalistico, che alla fine si traduce in un rovesciamento della logica provvidenzialistica. In una certa misura si potrebbe leggere in questi due diversi paradigmi la parabola stessa della modernità, che ha conosciuto il declino progressivo di una ragione forte, capace di gestire in proprio l’eredità secolare della grande promessa cristiana, fino all’ultima spiaggia del nihilismo. Questa parabola sembra oggi essersi a tal punto consumata, continua Vergely, che entrambi gli approcci, quello che si sforza di dare un senso al soffrire e quello che, al contrario, si sforza di negarglielo, appaiono sempre più sfocati e inaccettabili: troppo ambiziosi, figli di un’epoca che ha messo in campo questioni ingestibili, metastorie ingombranti e patetiche. Il vero problema, allora, non è di trovare risposte, ma di normalizzare le domande accettabili e di rimuovere quelle ostinatamente indecifrabili. Nasce così, all’incrocio di quella singolare ibridazione postmoderna di cultura debole e tecnologia forte, la Grande Illusione Riduzionista: il senso dell’umano non è nel sovrumano, ma nell’infraumano, dove esso però appare disperso nella forma di un’insuperabile disseminazione. E’ meglio dunque abbandonare ogni ambizione dell’intero: sia quella che riguarda il senso ultimo della felicità, sia quella che s’interroga sull’enigma della sofferenza. Eppure l’accanimento riduzionista che domina l’epistemologia contemporanea (e che è cosa ben diversa dalla scelta metodica di un approccio settoriale, sulla quale si fonda l’intera impresa della scienza moderna) non sembra garantire, di per sé, la sconfitta del dualismo, lasciandolo anzi risorgere nella forma di un antagonismo sordo fra la logica impersonale della riduzione naturalistica e la logica soggettiva della insaziabilità del desiderio. Nel momento stesso in cui si nega dignità ontologica alla polarità spirituale, questa riafferma i propri diritti sul versante psicologico, attribuendo ad essi la forma di pulsioni incontenibili. 2 Cfr. B. Vergely, La souffrance, Gallimard, Paris 1997. E’ precisamente in risposta a questa falsa alternativa che l’A. invita a porsi, nella IV parte del libro, “À la recherche du sens perdu” (pp. 232-333). 2 Il dualismo non è sconfitto, ma riappare nella sua forma peggiore, affidando a due logiche assolutamente incommensurabili il compito di governare il fisico e lo psichico: da un lato il corpo, ridotto ad infrastruttura biologica neutra, dall’altro il vissuto, assimilato ad una sovrastruttura estetica autoreferenziale. In un caso il dolore è considerato come sintomo di un’alterazione periferica nell’economia funzionale di un equilibrio biochimico, nell’altro caso la sofferenza appare come l’antagonista assoluto del principio di gratificazione, contro cui combattere solo le battaglie che si possono vincere, prima di rassegnarsi e cedere le armi, a costo d’invocare un insindacabile diritto di morire. Da una parte, alla tecnica viene appaltata la gestione di un organismo da trattare secondo criteri di mera efficienza operativa, che possono spingersi fino ad una forma di cieco furor sanandi; dall’altra la gratificazione del desiderio disegna la fisionomia dell’autenticità esistenziale, dalla quale la sofferenza è espulsa per principio. L’antropologia dell’homo patiens qui appare attraversata da una frattura profonda: l’epistemologia ispeziona il naturale, l’estetica coltiva il virtuale; sapere e salvezza appaiono così perfettamente sdoppiati, in nome di una cultura “politicamente corretta”, che allontana il pubblico e il privato fino a farne due regioni assolutamente impermeabili. In un caso, per usare una terminologia cara a Marcel, il dolore è finalmente solo un problema, in un altro caso la sofferenza non è più nemmeno un mistero. C’è però anche una difficoltà di ordine strutturale, che oltrepassa il crinale della nostra cultura, alle prese con l’eredità irrisolta della modernità: questa difficoltà nasce da una correlazione costitutiva di logos e pathos, che lascia coabitare nell’esistenza le chances dell’homo sapiens con i limiti dell’homo patiens. Questo legame va ben al di là di una cultura che pure stenta a riconciliarsi con la cifra antropologica del difettivo; investe una forma di paradossale discontinuità che non sembra rimediabile con una qualche rettifica epistemologica. Sembra, anzi, invocare al suo massimo grado quella che Ricoeur ha chiamato una “rottura metodologica nella continuità della riflessione”3, in cui il discorso sembra doversi arrestare dinanzi ad un ostacolo abile. La discontinuità è paradossale e come tale assume il carattere di un dislivello irriducibile e nello stesso tempo indisgiungibile: logos e pathos convivono come modalità originarie dell’esistenza personale e non possono essere separati e classificati come eventi occasionali e irrelati. La persona è il mistero tangibile dell’incontro tra opacità del pathos e lucidità del logos. Di conseguenza, se appare epistemologicamente problematica la domanda intorno al senso della sofferenza, non lo è di certo la domanda intorno al senso della persona sofferente. La persona che conosce e che agisce, che media le differenze, innalzandosi dal visibile all’invisibile, dal particolare all’universale, è la stessa che patisce, cioè che sperimenta una situazione di passività, subita nella forma di una immediatezza irri-mediabile. Il paradosso sta dunque non solo nella difficoltà di dire la sofferenza, ma prima ancora di pensare una distanza che è tutta interna all’essere umano e che, in nome di una difficile fedeltà alla sua radice indivisa, non può essere scomposta in due regioni impermeabili e sovrapposte. Almeno su questo punto converrà dichiararsi d’accordo con la via stretta che ci è additata da Kierkegaard: “Non bisogna pensare male del paradosso; perché il paradosso è la passione del pensiero, e i pensatori privi del paradosso sono come amanti senza passione: mediocri compagni di gioco. Ma la potenziazione estrema di ogni passione è di volere l'urto, 3 P. Ricoeur, Finitudine e colpa, tr. it. di M. Girardet, Il Mulino, Bologna 1960, p. 623. 3 benché l'urto possa in qualche modo segnare la sua fine. E' questo allora il supremo paradosso del pensiero, di voler scoprire qualcosa ch'esso non può pensare”4. Nel nostro caso, ciò significherà provare a cercare di rompere la falsa alternativa tra una razionalizzazione provvidenzialistica e il nichilismo di una regressione fatalistica, facendo proprio l’ammonimento di Vergely a non cercare il senso della vita a partire dalla sofferenza, interrogandosi piuttosto sull’enigma della sofferenza a partire dal senso della vita5. Il che nel nostro percorso, impegnato a ritrovare un legame profondo tra la malattia e il male, equivarrà ad interrogarsi sulla radicalità del male a partire dall’originarietà del bene6, scegliendo un approccio che tenti di situare l’enigma della passività nel cuore stesso dell’agire. 2. Agire e patire La via che cercherò di abbozzare, in una pars construens, punta quindi ad assumere questa compresenza di logos e pathos, dietro alla quale s’intravede la cifra etica del negativo e la cifra ontologica del fragile, che custodisce un presagio di trascendenza. La tradizione fenomenologica da un lato e gli sviluppi più recenti della filosofia analitica e postanalitica dall’altro ci suggeriscono due approcci fondamentali, che, opportunamente incrociati, possono dischiudere un campo tematico entro il quale provare ad avanzare un percorso di possibile approfondimento. Nel primo caso, com’è noto, un’opera rigorosa di scavo, da Husserl alla Stein, da Scheler a Merleau-Ponty, ha difeso con forza lo scarto tra il piano naturalistico del dato corporeo e l’orizzonte del vissuto, che evidenzia, nel suo strato elementare e più proprio, una tensione intenzionale attraverso la quale l’apertura al mondo appare originariamente segnata dalla duplice cifra della originarietà appartentiva e della trascendenza7. Nel secondo caso, invece, il sospetto nei confronti di ogni forma di equivoca introspezione, accusata di preferire imprudentemente lo spazio pubblico dell’analisi linguistica alle profondità di una riflessione a sfondo solipsistico, ha conosciuto un lento, ma significativo approdo verso una “Action Theory” che riporta in primo piano la domanda intorno all’identità personale, non più però a partire dalla regione dell’interiore e dello spirituale, ma da quella dell’esteriore e del naturale8. Tale impostazione ha il merito di sottrarre la tematica della corporeità ad una cattura culturalista, che rischia di far dimenticare la sua dimensione naturale e persino di occultarne la valenza ontologica9. 4 S. Kierkegaard, Briciole di filosofia, in Opere, tr. it. di C. Fabro, Sansoni, Firenze 1972, p. 219. 5 Cfr. Vergely, La souffrance, p. 47. 6 “Il male - scrive Ricoeur - non è simmetrico al bene, la cattiveria non sostituisce la bontà dell'uomo, ma l'avvizzimento, l'oscuramento, l'imbruttimento di un'innocenza, di una luce e di una bellezza che permangono. Per quanto radicale, - egli conclude - il male non potrà mai essere originario come la bontà” (Ricoeur, Finitudine e colpa, p. 415). 7 Varie riletture interessanti, in tale direzione, sono contenute nel volume di Aa. Vv., Corporeità e pensiero, “Studium”, 96, n. 3-4 (2000). In particolare cf. P. Prini, Pensiero ed esistenza, pp. 473-480: A. Ales Bello, L’analisi della corporeità nella fenomenologia, pp. 481-494; A. Rigobello, La corporeità propria come luogo dello stupore originario, pp. 495507. 8 Cfr. al riguardo AA.VV., Azione e persona: le radici della prassi, a cura di L. Alici, Vita e Pensiero, Milano 2002. 9 In questa direzione si segnala l’opera di M. M. Marzano Parisoli, Norme e natura: Una genealogia del corpo umano, Vivarium, Napoli 2001, che però rivendica la necessità di “una cultura capace di rispettare la struttura metafisica e naturale dell’essere umano” (p. 177). 4 La distanza fra queste due tradizioni è ben esemplificata dal confronto fra Ricoeur e Changeaux, che porta in primo piano la difficoltà di pensare e insieme di neutralizzare ogni riferimento autoimplicativo quando ci si interroga intorno a Ce qui nous fait penser 10. Eppure un dialogo appare possibile e persino doveroso, almeno in quanto può apportare al medesimo ambito tematico i guadagni di approcci metodologici diversi, depurati da irrigidimenti più o meno estremistici. Schematizzando, si potrebbe arrivare a dire che la via fenomenologica inscrive il corpo nella scala temporale del vissuto, lasciando però sullo sfondo il grande tema del rapporto tra vita personale e vita biologica, mentre la via analitica arriva a riconoscere nella dinamica dell’azione il proprio di un comportamento intenzionale irriducibile al piano degli eventi, senza tuttavia riuscire a riconoscerne una paternità personale. Alla base di quest’intervento sta dunque il confronto con alcuni sentieri in qualche modo illuminanti, anche se interrotti da una cesura, ritenuta metodologicamente pregiudiziale, tra il vissuto, fenomenologicamente inteso, e il corporeo, empiricamente descritto. Un percorso speculativamente fecondo potrà essere, quindi, quello che, assumendo la centralità strategica dell’azione e la sporgenza intenzionale che essa custodisce, cercherà di ritrovare al suo interno il riflesso di un dislivello ancor più originario. Non è certamente nuova l’attenzione della filosofia al tema della prassi, problematico luogo di frontiera e d’intersezione fra mondi diversi, apparentemente così distanti, da sembrare quasi incommensurabili. Dinanzi a questo paradossale Giano bifronte, il logos filosofico sembra essere continuamente sfidato a prendere le distanze da ricorrenti tentazioni riduzionistiche: il riduzionismo naturalistico, che restringe l‘agire umano a pura fattualità esteriore, e il riduzionismo spiritualistico, che la riduce ad interiorità autosufficiente. Cercando dunque di articolare una via del senso originariamente ancorata nell’orizzonte del bene e mantenendo un contatto con alcuni contributi del pensiero contemporaneo, cercheremo di confrontarci con la dimensione dell’agire, riconosciuta soprattutto a partire dal suo versante passivo, da intendere come emergenza interna alla stessa polarità attiva. Ciò che il logos è chiamato a decifrare è essenzialmente il carattere pratico dell’esistere, che il soggetto sperimenta attraverso le forme concrete dell’agire. E l'azione rappresenta l'unità elementare di base del pratico nel suo versante attivo, costantemente accompagnato, però, dal versante passivo, che il soggetto cioè “patisce”, non solo all'esterno, ma anche nella propria dinamica esecutiva. Già a questo livello l’azione manifesta uno statuto complesso, che sembra costantemente mettere in scacco ogni tentativo di spiegazione naturalistica11: in un senso, infatti, essa rappresenta una forma tipica di mediazione pratica, attraverso la quale gli esseri umani perseguono, in forme socialmente comunicabili e potenzialmente cooperative, delle finalità più o meno condivise12; in un altro senso, però, tale processo sembra avere la sua 10 Così il filosofo francese sintetizza la sua posizione: “Je suis donc dans ce rapport continuitè-discontinuité. Enraciner très profondément l’éthique dans la vie, mais réserver le moment d’une sorte de rupture” (J.-P. Changeaux - P. Ricoeur, Ce qui nous fait penser. La Nature et la Règle, Ed. Odile Jacob, Paris 2000, p. 30). E rispetto allo scienziato che rivendica la possibilità di una “physique de l’introspection”, Ricoeur ribadisce che la radice ultima del dislivello sta proprio nella nozione “de forum de soi à soi. Ce for intérieur a un statut propre dont vous n’arriverez jamais, semble-t-il, à rendre compte dans votre science” (p. 77). 11 Cf. in proposito E. Runggaldier, Che cosa sono le azioni? Un confronto filosofico con il naturalismo, tr. it. di A. Giordani, Vita e Pensiero, Milano 2000. 12 In tal senso si esprime anche Hannah Arendt: “L'azione, la sola attività che metta in rapporto diretto gli uomini senza la mediazione di cose materiali, corrisponde alla condizione umana della pluralità, al fatto che gli uomini, e non l'Uomo, vivono sulla terra e abitano il 5 condizione necessaria, anche se non sufficiente, in una insuperabile forma di mediazione corporea, che rende possibile e nello stesso tempo passibile tale processo. Anzi, a ben vedere, rendere possibile qui significa propriamente rendere passibile: il dato passivo della resistenza non è, infatti, un momento esteriore e posteriore rispetto ad una prassi altrimenti dotata di un’assoluta autonomia operativa; s’annuncia invece come ineliminabile componente interna di un dinamismo che, per attuarsi, deve assoggettarsi ad una logica del movimento, abilitato (in termini di forza e insieme di debolezza) dalla nostra costituzione somatica. Già a questo livello, la soggezione al patire sembra essere il prezzo dell’agire. Proviamo a dirlo con le parole di Jankélévitch: “La passion n’est pas ici une suite de l’action, mais elle en est le contre-coup immanente et nécessaire”13. Su un piano diverso, a considerazioni analoghe giunge anche Hans Jonas: a differenza di qualsiasi oggetto fisico, che non manifesta la sua identità attraverso una qualche forma di agire, ogni organismo vivente si autocostituisce attraverso il flusso del ricambio con l'ambiente; l'attività metabolica è una sua proprietà fondamentale. La possibilità del limite e della fine è, in un certo senso, il prezzo che il metabolismo deve pagare per introdurre questa nuova modalità di essere nell'inerte regno inorganico, la minaccia con la quale la vita deve costantemente misurarsi, per poter affermare se stessa. In tal senso, nascita e morte appaiono come condizioni fondamentali della vita organica sulla terra, unico modo attraverso il quale, nell'avvicendarsi del cominciare e del finire, la spontaneità vitale della natura riafferma il primato dell'essere sul non essere. Il bene supremo della vita, principio e scopo finale dell'intero dinamismo evolutivo, compensa quindi ampiamente, secondo Jonas, ogni “dazio di sofferenza” che tutti i viventi possono pagare attraverso la morte14. Questo primo risultato dev’essere però ripreso in un orizzonte diverso da quello puramente fenomenico-naturale. Il compito della riflessione filosofica consiste propriamente nell’esercizio di una distanza critica, che si realizza attraverso una ricognizione trascendentale, per così dire di secondo livello, capace di interrogarsi intono alle condizioni di possibilità dell’agire. Anche Heidegger ce lo ricorda: “Più in alto della realtà si trova la possibilità”15. Qui può essere recuperata la più autentica lezione fenomenologica: “I fenomeni cinestesici degli organi – scrive Husserl – scorrono nell’io faccio e sottostanno al mio io posso”16. Allo stesso modo, potremmo aggiungere, al di sotto delle sofferenze concrete che irrompono in forme diverse nella nostra esistenza, sta il poter soffrire come condizione stessa dell’essere umano. A questo punto il confronto ineludibile con la centralità del corpo proprio, come organo della mozione volontaria, ci porta a riconoscere quello che Ricoeur ha chiamato lo strato dell’”involontario assoluto”17: “Nell’azione – egli scrive – io provo il mio corpo come ciò che non solo sfugge alle mie intenzioni, ma anche che mi precede nell’azione. Questa anteriorità mondo” (H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, tr. it. di S. Finzi, Bompiani, Milano 19913, p. 7). 13 V. Jankélévitch, L’alternative, Alcan, Paris 1938, p. 4. 14 H. Jonas, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, tr. it. di P. Becchi e A. Benussi, Einaudi, Torino 1997, pp. 206-221. 15 M. Heidegger, Essere e tempo, § 7, tr. it. di P. Chiodi, Longanesi, Milano 19866, p. 59. 16 E. Husserl, Meditazioni cartesiane, § 44, tr. it. di F. Costa, Bompiani, Milano 1970, p. 107. 17 Cfr. Ricoeur, Philosophie de la volonté. 1. Le volontaire et l’involontaire, Aubier, Paris 1950. Per una interessante lettura retrospettiva di questo percorso, cfr. Ricoeur, Promenade au fil d’un chemin, in F. Turoldo, Verità del metodo. Indagini su Paul Ricoeur, Il Poligrafo, Padova 2000, pp. 15-20. 6 disposizionale del corpo si rivela in un certo numero di esperienze-limite […]: esperienza di essere già nato – esperienza di avere o di essere un carattere non scelto – esperienza di essere ‘portato’ da un fondo pulsionale largamente inconscio, che è come la terra sconosciuta della sfera psichica”18. Qui è all’opera la lezione di Husserl, che ha tematizzato lo statuto fondamentale della corporeità propria, distinguendo, anche terminologicamente, ciò che è Körper, cioè corpo tra i corpi, da ciò che posso riconoscere come Leib, il mio “più proprio” corpo vissuto, quella primordialità originaria che precede ogni scelta, radice irraggiungibile dell’”io voglio”19. Alle spalle si potrebbe intercettare un’ampia tradizione speculativa, come ci suggerisce anche Ricoeur: dall’idea aristotelica di enérgeia come “fondo di essere, ad un tempo potente ed effettivo, sul quale si staglia l’agire umano”20 alla nozione spinoziana di conatus, inteso come “lo sforzo, col quale ciascuna cosa si sforza di perseverare nel suo essere” e che dunque “non è altro che l’essenza attuale della cosa stessa”21, fino al contributo decisivo di Maine de Biran, che ha avuto il merito, sempre secondo Ricoeur, di aver dissociato la nozione di esistenza da quella di sostanza, connettendola a quella di atto22. Riconoscendo che l’appercezione tiene insieme l’io agente e il corpo proprio, il quale, attraverso vari livelli di passività, ha la funzione di mediare tra intimità dell'io ed esteriorità del mondo, Maine de Biran ci ricorda, secondo la rilettura offerta da Michel Henry, che io agisco sempre nell’immanenza patetica della mia carne23, intesa come “autodonazione primitiva” nella quale ciascuno dei nostri poteri attinge la possibilità d’agire24. Non resterebbe, a questo punto, sempre secondo Henry, che ricercare nella passività radicale della Vita, assunta come assoluta autorivelazione e autogiustificazione, l’unica via della salvezza, nella prospettiva però di una problematica interpretazione del Cristianesimo come una sorta di “Archi-gnose”25. Si aprirebbe a questo punto la possibilità di un approfondimento d’estremo interesse, che in questa sede non è possibile percorrere. E’ però necessario segnalare un deficit ontologico, che rappresenta un problema non risolto per l’intera tradizione fenomenologica; la preoccupazione di trovare un approccio antiformalistico e antisostanzialistico al vissuto sarebbe in realtà ampiamente soddisfatta da un confronto critico con la nozione tommasiana 18 P. Ricoeur, La semantica dell’azione. Discorso e azione, tr. it. di A. Pieretti, Jaca Book, Milano 1986, p. 170. 19 Nel medesimo § 44 della quinta delle sue Meditazioni cartesiane, interrogandosi sull’identità della natura appartentiva, “purificata da ogni senso di soggettività estranea”, Husserl riconosce “il mio corpo nella sua peculiarità unica, cioè come l’unico a non essere mero corpo fisico [Körper] ma proprio corpo organico [Leib], oggetto unico entro il mio strato astrattivo del mondo”, ed aggiunge: “Questo corpo è la sola ed unica cosa in cui io direttamente governo ed impero, dominando singolarmente in ciascuno dei suoi organi” (Husserl, Meditazioni cartesiane, § 44, p. 107). 20 Ricoeur, Sé come un altro, p. 421. 21 B. Spinoza, Etica, III, prop. VII, tr. it. di G. Durante, Sansoni, Firenze 1963, p. 254. 22 Cfr. Ricoeur, Sé come un altro, p. 435. Un’ampia analisi del pensiero biraniano è sviluppata nel recente volume di M. Fabris, Itinerari biraniani. Intorno a Maine de Biran, filosofo francese, Levante, Bari 2002. 23 Cfr. M. Henry, Incarnation. Une philosophie de la chair, Seuil, Paris 2000, p. 206. 24 Cfr. Henry, Incarnation, p. 214. 25 “Le christianisme, il faut le reconnâitre, est une Archi-gnose” (Henry, Incarnation, p. 372). 7 di actus essendi26, che può restituire ben altra profondità metafisica ad un’analisi che rischia altrimenti di attestarsi ad un livello di velleitario esigenzialismo. 3. Il primato del bene Siamo in ogni caso ricondotti, attraverso questi riferimenti, ad una corporeità che s’annuncia come una sorta di linea vivente di frontiera tra la dimensione dell’essere e quella dell’avere: il ‘corpo che abbiamo’ e il ‘corpo che siamo’ attestano una duplicità, una sorta di ambivalenza originaria, che dischiude, come ci ricorda Marcel, l’orizzonte del metaproblematico27. La dimensione dell’essere incarnato “significa apparire a sé come corpo, come questo corpo qui, senza potersi tuttavia identificare con esso, e tuttavia senza potersene neanche distinguere – dal momento che l’identificazione e la distinzione sono operazioni correlative l’una all’altra, ma tali da non potersi esercitare se non nella sfera degli oggetti”28. Per questo, potremmo concludere con Emmanuel Mounier, bisogna pensare “a due poli fra i quali è tesa l’esistenza incorporata”29; è precisamente questa tensione inseparabile che ci costituisce: “io esisto soggettivamente ed io esisto corporalmente formano un’unica e medesima esperienza”30. Sullo sfondo di questo dislivello, il complesso movimento deliberativo ed esecutivo della persona umana la conferma entro l’orbita insuperabile del proprio limite: la dialettica transitiva di agire e patire si ripropone come insuperabile dialettica immanente di volontario e involontario, cifra di una libertà personale magnifica e deludente. In tal senso la libertà dell'agire appare inseparabile da una dialettica antagonista del patire, che Kierkegaard riconosce nella forma dell'interesse per l'esistere, della sofferenza interiore, del dramma del peccato; in una parola del pathos dell'azione. A differenza della sfera della possibilità, infatti, dove “il pathos supremo si esprime in parole, nella sfera della realtà - è ancora Kierkegaard - il pathos supremo è l'azione”. Dunque “il pathos dell'etica è di agire […] Dappertutto, dove l'etica è presente, tutta l'attenzione è richiamata sull'individuo stesso e sull'azione”31. Tale dialettica di agire e patire, se ripensata in un contesto più ampio, meno condizionato dalla diffidenza del filosofo danese nei confronti di ogni oggettivazione esteriore, si ripercuote in forme differenziate su tutta la gamma delle mediazioni storico-sociali, generate dalla dinamica dell'azione. 26 Più che mai attuali, in tale prospettiva, i risultati delle ricerche di C. Fabro, Partecipazione e causalità secondo S. Tomaso d’Aquino, Sei, Torino 1960. 27 Fondamentali, in proposito, le annotazioni riportate nel saggio Traccia di una fenomenologia dell’avere, del 1933: cfr. G. Marcel, Essere e avere, tr. it. di I. Poma, Esi, Napoli 1999, pp.131-149. 28 G. Marcel, Dal rifiuto all’invocazione. Saggio di filosofia concreta, tr. it. di L. Paoletti, Città Nuova, Roma 1976, pp. 46 s. Su questa lunghezza d’onda anche Prini: “E’ infatti questa compresenza di soggettività e di oggettualità, di essere e di avere, ciò che costituisce il paradosso centrale del nostro esser uomini” (P. Prini, Il corpo che siamo. Introduzione all’antropologia etica, Sei, Torino 1991, p. 67). 29 E. Mounier, Il personalismo, tr. it. di A. Cardin, Ave, Roma 19878, p. 68. Secondo Mounier, perciò, “non bisogna […] contrapporre troppo violentemente l’essere e l’avere”, come secondo lui avverrebbe in Marcel. 30 Mounier, Il personalismo, pp. 36 s. 31 Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle “Briciole di filosofia”, in Opere, p. 474. 8 Questa singolare compresenza di attività e passività nella sorgente stessa del pratico non va però intesa come il risultato di un dualismo ontologico originario (che riaprirebbe la strada ad un’antica tentazione gnostica), ma come condizione antropologica abilitante, strutturalmente in bilico tra la pienezza della vocazione ontologica e l’esperienza storica del limite e della privazione. L’apertura all’ulteriorità attraversa quindi l’intero asse dell’appercezione del corpo proprio, evidenziandone una strutturale e sintomatica ambivalenza prospettica. Ma i fattori costitutivi di questa ambivalenza non possono essere posti sullo stesso piano, come ci ricorda anche Melchiorre: mentre il referto dell’unità personale identifica l’ontologia della persona, quello della scissione testimonia la sua condizione esistenziale. Nello scarto di corpo e persona affiora un’empirica del limite che non si traduce però in un’insanabile frattura eidetica: “la duplicità – conclude Melchiorre – si traduce in dualismo solo per astrazione”32. Possiamo allora conseguire un guadagno metafisico di primaria importanza: la differenza che affiora storicamente nella sfera dell’esistere può essere riconosciuta com’espressione di una complessità antropologica, alla quale corrisponde un’opposizione irriducibile d’ordine etico, non ontologico. Il male è voluto dalla libertà umana come una possibilità pratica interna alla finitezza dell’esistere, non è subìto come una minaccia esterna all’ordine dell’essere. Mentre il bene, in linea di principio, non si definisce in rapporto al suo contrario e può stare senza di esso, il male di per sé non può stare senza il bene. Non esiste dunque nessuna simmetria tra i due termini, poiché essi non sono il riflesso etico di due opposti referenti ontologici, come Agostino ci ha insegnato, dopo il confronto drammatico e istruttivo con la gnosi manichea: tutte le nature, egli ci ricorda, in quantum vitiosae sunt, malae sunt, in quantum naturae sunt, bonae sunt 33. Per questo il vitium non può essere ipostatizzato, né ad un estremo né all’altro della scala ontologica; non può impiantarsi, per definizione, nel sommo bene e nemmeno contrapporglisi frontalmente come sommo male. Non resta quindi che intendere il vitium come una sorta di patologia difettiva che può insediarsi solo in aliquo bono: Malum est enim male uti bono34. La sua genesi va ricercata su un piano diverso da quello dell'ontologia: il percorso a ritroso dagli effetti alla causa non conduce in questo caso ad una natura, ma ci porta dinanzi alla soglia di autodeterminazione della volontà35; ad essa soltanto, infatti, si può ascrivere questa forma anomala di causalità difettiva (non enim est efficiens, sed deficiens, quia nec illa effectio sed defectio36). Qui la ricerca della radice del male s’interrompe; come afferma Agostino: Radicem radicis quaerere non possum37. Assecondando l'inclinazione al male, l'uomo apre un punto di fuga nell’orbita del bene, che non arriva però a sconfessarne la positività originaria. Il male infatti non “è”, ma “esiste”, cioè entra storicamente nel mondo come forma pratica della mala voluntas. In tal senso non si dà un’assolutizzazione ontologica del male, così come invece si dà un’assolutizzazione del bene. Il male assoluto, in quanto nulla assoluto, nega se stesso; come il cancro, che può 32 Ivi, p. 85. De civ. Dei 12,3: NBA 5/2,152-154. 34 De nat. boni 36: NBA 13/1,380. 35 Lasciamo parlare ancora Agostino"Se si ricerca la causa efficiente di questa cattiva volontà, - egli scrive - non si trova nulla; che cos'è infatti che rende la volontà cattiva, se è essa stessa a rendere un atto cattivo? Perciò è la volontà cattiva la causa di un atto cattivo, mentre non c'è una causa della volontà cattiva" (De civ. Dei 12,8: NBA 5/2,158) [trad. personale]. 36 De civ. Dei, 12,7: NBA 5/2, 162. 37 C. Fort. 21: NBA 13/1,300. 33 9 sussistere solo in quanto forma parassitaria di un organismo vivente: nel momento in cui il cancro riesce a sopraffare il corpo di cui si nutre, esso si condanna all’autodistruzione. La sua vittoria è il suo annullamento. Ma parlarne in termini di patologia degenerativa non equivale ad una sua minimizzazione: come il male, anch’esso può essere radicale, ma non originario. La negazione non ha dunque il medesimo statuto originario dell’affermazione, ma s’impone sempre, per così dire, in seconda battuta: rispetto all’equazione originaria di bene ed essere, che consente di riconoscere un’autoaffermazione, una sorta d’originario “sì ontologico”38, come costitutivo dell’atto di essere, il male è dunque strutturalmente nemico dell’essere, potendo però manifestare questa “ostilità ontologica” solo nella forma di un’aggressione condannata all’autoannientamento. Nella nostra prospettiva, il medesimo scarto si può ritrovare nel rapporto tra salute e malattia: al primato naturale della salute corrisponde, come ci ricorda anche Gadamer, il primato della cura come “un fenomeno originario dell’essere umano”39. Per converso, la malattia appare come la perdita di un equilibrio naturale, in senso medico-biologico, così come biografico e sociale: essa segnala non soltanto una deficienza e un danno positivo, ma anche un danno percepito dolorosamente, con un generale riverbero di sofferenza esistenziale. Ancora una volta, il negativo attesta il primato del positivo: “I misteri della malattia testimoniano il grande prodigio della salute, che noi tutti viviamo e che ci regala sempre la fortuna di dimenticare, la felicità dovuta al benessere e la leggerezza di vivere”40. Siamo a questo punto rinviati alla medesima contraddizione esistenziale, che riflette lo scompenso di logos e pathos di cui s’è detto: il pensiero legge la dinamica intenzionale del desiderio come una dinamica orientata strutturalmente al suo compimento, in cui il bene è anche pienezza di essere, mentre l’esperienza vissuta ci attesta un’alterazione sperimentata essenzialmente nella forma di un’estraneità mortificante. Quello che ci è prossimo quanto alla nostra condizione esistenziale ci è estraneo quanto alla nostra intenzionalità ontologica. Questo paradosso testimonia una fragilità antropologica per così dire aggiuntiva, che ci consente appunto di parlare di una modalità anomala della finitezza41, rispetto al più ampio orizzonte naturale, al quale pure tutti noi apparteniamo. Infatti, a differenza di una finitezza interamente paga e appagabile di se stessa, per la quale il confine naturale è misura insuperabile della propria identità, la finitezza umana risulta costituita da un’apertura trascendentale, che sporge rispetto a qualsiasi oggetto determinato e, per questo, appare strutturalmente orientata all’oltrepassamento di ogni determinatezza. L’insufficienza e la volatilità dell’appagamento empirico sono, da questo punto di vista, la testimonianza inconfutabile di un rimando all’ulteriore. La sofferenza segnala la misura di questo scarto e il fatto che in tale dinamica di trasgressione s’infiltra un fattore di disorientamento, di disordine, di perversione. Essa interrompe bruscamente la lievitazione impropria del desiderio nel circuito immanente della cattiva infinità e ci ricorda il nostro limite insuperabile di soggetti che non producono il proprio bene, ma possono solo intenzionarlo; che non sono il fondamento della propria vita e 38 Anche Jonas parla di “assioma ontologico” (Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, tr. it. di P. Rinaudo, Einaudi, Torino 1990, p. 102), di “forza normativa del sì ontologico” (p. 104). 39 H.-G. Gadamer, Dove si nasconde la salute, tr. it. di M. Donati, Cortina, Milano 1994, p. 3. 40 Gadamer, Dove si nasconde la salute, pp. 97 s. 41 Siamo qui, ovviamente, ben oltre la equivoca ammissione di un “monismo anomalo” e di un’”anomalismo del Mentale”, come s’accontenta di dire D. Davidson, Azioni ed eventi, tr. it. di R. Brigati, Il Mulino, Bologna 1992. 10 della propria salute, ma possono solo custodirla. In tal senso si può parlare di malattia in un orizzonte metafisico, come di una fondamentale patologia del desiderio umano, frutto di un radicale disadattamento della finitezza, di cui la sofferenza esistenziale, che si fa angoscia e disperazione, è un sintomo primario42. Questo statuto paradossale offre la possibilità di un’importante distinzione: sul piano dell’esperienza individuale, il soffrire appare sempre come una lesione dell’integrità personale, come un’aggressione dalla quale occorre difendersi, con intenzioni buone, mezzi leciti e risorse proporzionate; sul piano della condizione trascendentale, invece, il poter soffrire attesta un vulnus profondo nell’ordine antropologico, che ricorda al logos la compagnia storicamente inseparabile del pathos, rivelando un tratto originale della finitezza. Proprio la distinzione tra “la mia malattia” e “la malattia” consente a Laín Entralgo di concludere che “la realtà dell’uomo è corporea, coesistente, vulnerabile, dolorabile, appropriatrice, interpretabile e preziosa”43. Rispetto ad una rilevazione per così dire “fisiologica” del limite, la sofferenza ci rivela il suo risvolto “patologico”, che si manifesta nella forma di una mortificazione inaccettabile, sperimentata come un sfida alla nostra integrità, come una minaccia al nostro stesso essere. Se quindi, sul piano individuale, in presenza di una sofferenza determinata la risposta analgesica è possibile e può conoscere quelle estensioni, doverose o semplicemente lecite, che sono richieste dal dovere della cura, intesa ovviamente nel senso più ampio, sul piano trascendentale lo statuto dell’homo patiens testimonia una profonda verità: “l’uomo non è soltanto eventualmente, e deprecabilmente, malato; è ontologicamente malato”44. A questo livello, come ci ricorda Angelini, la malattia pone la questione del senso, sfida la libertà e chiama in causa le risorse morali della persona45; anziché inseguire il sogno prometeico di una rimozione assoluta della sofferenza, il compito primario che ci si presenta è essenzialmente quello di un riequilibrio ontologico del desiderio, al quale non può non corrispondere il dovere di imprimere una rettifica energica alle nostre abitudini morali. 4. La relazione ferita L’enigma dell’homo patiens, a questo punto, sembra rinviare ad una prospettiva in cui l’ambivalenza della passione dice la passività del patire, ma anche l’attività della pazienza46, alla quale deve poter corrispondere, sul piano della reciprocità interpersonale, la figura simmetrica della compassione, che è appunto una forma attiva di condivisione del patire. In tale prospettiva soffrire significa vivere una condizione di fragilità esposta, sperimentando l’alterità nella forma mortificante dell’alterazione, ma, nello stesso tempo, significa anche 42 Su questo punto resta insuperata l’analisi di Kierkegaard, il quale, dopo aver identificato la disperazione come la “malattia mortale”, aggiunge: “La possibilità di questa malattia è il vantaggio dell’uomo rispetto all’animale; rendersi conto di questa malattia è la prerogativa del cristiano di fronte al pagano; esser guarito da questa malattia è la beatitudine del cristiano” (Kierkegaard, La malattia mortale, in Opere, p. 626). 43 P. Laín Entralgo, Antropologia medica, tr. it. di S. Roberti Aliotta e S. Spinsanti, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1988, p. 238. 44 G. Angelini, La malattia, un tempo per volere. Saggio di filosofia morale, Vita e Pensiero, Milano 2000, pp. 27 s. 45 Cfr. Angelini, La malattia, un tempo per volere, pp. 7 ss. 46 Se infatti soffrire significa, nello stesso tempo, provare e sopportare il male (nel corpo, nell’anima, nella vita tutta intera), allora la sensibilità ha bisogno della pazienza e la pazienza della sensibilità: cfr. Vergely, pp. 226-227. 11 riequilibrare il passivo del patire con il contrappeso attivo delle virtù del sopportare e del resistere: “la patience qui ‘souffre’ la vie - è ancora Vergely - n’est pas séparable de l’indignation qui s’insurgit contre le mal”47. Quando l’equilibrio della salute è turbato dallo squilibrio della malattia, la persona umana può trovare il suo riscatto su un altro piano: il piano della vita morale, che ci addita il cammino eroico della pazienza, da percorrere affidandosi alla cura di compagni compassionevoli e all’esempio di testimoni coraggiosi. Si dischiude, a questo punto, un nuovo orizzonte del discorso, in cui la dialettica di agire e patire appare letteralmente rovesciata: se il patire, come il male, è la controfigura dell’agire, non si dà un patire assoluto, che non lasci spazio alla dinamica del re-agire; una dinamica che il paziente non più validus affida alla compassione operosa di chi gli sta accanto. Dunque nel momento in cui restituisce un valore retroattivo alla salute perduta, la malattia ci chiama ad una nuova interpretazione di noi stessi, raggiunta mettendo a nudo le pieghe più profonde del nostro limite, a partire dal quale rilancia un appello ad una solidarietà radicale, chiamata a percorrere tutta la gamma della cura, fatta di presenza e di ascolto, di parole e di gesti, in cui i requisiti tecnici della competenza sfumano nei requisiti spirituali della tenerezza e del dono, arrivando a mettere in questione non solo il piano della disponibilità individuale, ma anche quello, economico e politico, della destinazione sociale delle risorse48. Ma c’è di più. Percorrere l’intero perimetro orizzontale del rapporto intersoggettivo non esaurisce la profondità del mysterium doloris. Definendo la sofferenza in termini di compagnia estranea non intendiamo soltanto riconoscere la sofferenza che ci sopraggiunge dall’esterno, in modo assolutamente imprevedibile e immotivato, come un’estraneità non voluta. Ci può essere un livello ben più grave e insidioso ed è quello che proviene dall’interno, dal nostro stesso io; accanto alla sofferenza dell’io innocente e aggredito, c’è la sofferenza di cui l’io si rende colpevole, scegliendo il male ed assecondando la sua logica autodistruttiva. L’alterazione qui non si manifesta come un episodio marginale e circoscritto, esterno al circuito del desiderio, ma come il risultato di un vitium radicato, di una condizione internamente squilibrata, di progressivo autoasservimento. In tal caso il male s’annuncia come una forma di alienazione, che attraversa il nostro stesso io; come enigmatica lesione antropologica, che destabilizza la sinergia di intelligenza e volontà e compromette l’equidistanza della libertà, attivando un’oscura e diabolica voluttà di autodistruzione, accecata dal fascino del nulla. Si soffre non solo per l’alterazione del desiderio, per l’esperienza frustrante di una distanza incolmabile dal proprio oggetto, ma molto di più per un disordine interno alla logica stessa del desiderare, che cerca di reagire alla distanza infinita scatenando una voracità predatoria nei confronti del finito, dalla quale scaturisce un’infernale escalation nichilistica, la vera malattia mortale dell’uomo contemporaneo. Un esito che nasconde uno squilibrio etico, una fragilità alla seconda potenza, testimoniata da un’esperienza avversa e perfino ribelle, che rende drammaticamente conflittuale la voce stessa della coscienza, radice di quel video meliora proboque, deteriora sequor, in cui si può riassumere la più radicale fragilità dell’essere umano. A questo livello, l’appello ad una forma di resistenza etica, nonostante mantenga intatto il suo alto valore morale ed umano, appare sempre più come una pericolosa forma d’illusione volontaristica. Mi sia consentito far propria, ancora una volta, la lezione di Agostino, maturata attraverso un severo confronto con la promessa di autosufficienza avanzata dall’etica stoica, 47 Vergely, p. 311. Sulla natura e gli orizzonti dell’atto medico, in rapporto alle condizioni del malato, è dedicata tutta la terza parte del volume citato di Laín Entralgo, Antropologia medica, al quale si rinvia. 48 12 che presumeva di neutralizzare la fragilità dell’io dinanzi alle passioni, in nome di una illusoria blindatura della “cittadella dell’anima”. Non è possibile, per Agostino, deporre il proprio involucro somatico ai piedi del rifugio sicuro dentro una interiorità “pura” e compatta. L’itinerario di interiorizzazione non coincide con un allontanamento dalle regioni esteriori del male, ma al contrario avvicina all’incontro con il mistero della sua genesi personale, dove il conflitto, perso ogni referente esterno, si fa interno alla volontà, diventa quasi una malattia radicale dello spirito. Quest’interiorizzazione del conflitto fa emergere il tema drammatico della duplicità della voluntas: “Qual è l’origine di questo fenomeno straordinario? - si chiede Agostino in una pagina intensa e drammatica delle Confessioni - Quale la causa? Lo spirito comanda al corpo e questo obbedisce immediatamente: lo spirito comanda a se stesso e incontra resistenza”49. E più avanti: “Mentre io stavo decidendo di servire ormai il Signore Dio mio, come da tempo avevo progettato, ero io a volere, io a non volere; io in entrambi i casi”50. In tal senso la passività dell’homo patiens è il sintomo di una relazione ferita, che arriva a destabilizzare persino la relazione dell’io con se stesso, che è la forma, più radicale e insieme più fragile, in cui si riassume la nostra identità relazionale51. Vincere il dolore e la sofferenza, guarire la malattia vuol dire quindi, in senso ampio, ristabilire l’equilibrio originario della relazione: non solo con il nostro corpo e la nostra esperienza vitale, ma anche con la nostra volontà, il nostro desiderio, il nostro io lacerato. E quest’ultima frontiera, quella interiore, è, per definizione, una frontiera sempre aperta, l’ultimo rifugio della speranza, dove attestare la soglia estrema di resistenza etica, quando le altre frontiere della salute sembrano franare. Ma chi potrà arrivare a curare questa interiorità ferita, se non colui che è interior intimo meo et superior summo meo52? Chi potrà “guarire le ferite dello spirito – potremmo chiederci con Hegel - senza lasciare cicatrici”53? Qui il registro della riflessione razionale cede il passo al registro dell’invocazione religiosa. Qui il pathos sfida il logos (che è essenzialmente facoltà di relazione) a cercare un senso più alto e più profondo della relazione, dove l’alterità non parli il linguaggio della distanza ferita, ma quello della comunione e della prossimità riconciliata. 49 Conf. 8,9,21: NBA 1,240 [trad. personale]. Conf. 8,10,22: NBA 1,242 [trad. personale]. 51 Ho cercato di esplorare le valenze etico-teoretiche di questo tema, a partire dal paradigma agostiniano, nel volume L’altro nell’io. In dialogo con Agostino, Città Nuova, Roma 1999. 52 Conf. 3,6,11: NBA 1,66. 53 Citato da Gadamer, Dove si nasconde la salute, p. 107. 50 13
Scaricare