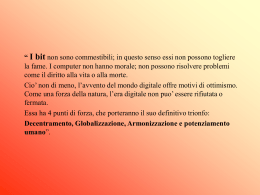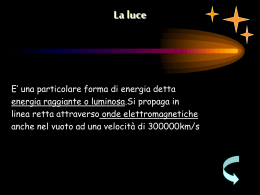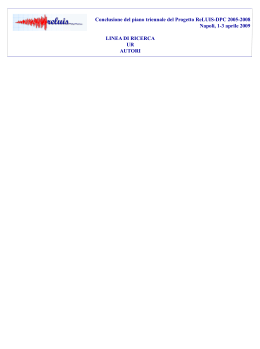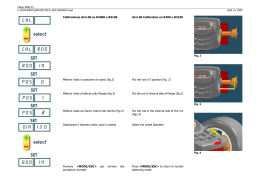SALTERNUM SEMESTRALE DI INFORMAZIONE STORICA, CULTURALE E ARCHEOLOGICA A CURA DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERNITANO REG. TRIB. DI SALERNO N. 998 DEL 31/10/1997 ANNO XIII - NUMERO 22-23 GENNAIO/DICEMBRE 2009 GABRIELLA d’HENRY E D I TO R I A L E C soprattutto a Creta (si ricordano in proposito gli scavi di Festòs e di Aghia Triada). Ma uno dei grandi meriti di Doro Levi fu quello di estendere gli interessi degli studiosi italiani verso la Turchia, la Siria, l’Albania, l’Egitto e Cipro, oltre alla Libia che era già stata interessata da missioni di scavo italiane. Dopo la lunga esperienza di Levi, che si interruppe nel 1975, furono direttori della Scuola d’Atene Antonino Di Vita ed il nostro quasi-concittadino Emanuele Greco, che ha dato un nuovo impulso a scavi e ricerche in terra greca, coinvolgendo nella sua organizzazione diverse università italiane. Qualche anno fa la Scuola corse il pericolo di chiusura, essendo entrata, erroneamente ed incredibilmente, nell’elenco dei cosiddetti “Enti inutili”: per fortuna si accorsero in tempo dell’errore e la cosa non ebbe seguito; ora combatte, come tutte le istituzioni culturali, con il problema dei fondi, ed ha dovuto, a malincuore, ridurre il suo personale. Nell’occasione del Centenario la Scuola ha pubblicato un simpatico ‘amarcord’, nel quale alcuni ex allievi della Scuola, ora docenti universitari o funzionari del Ministero per i Beni Culturali, parlano della loro prima esperienza in Grecia, con nostalgia e tenerezza; e tutti, senza eccezione, legano la loro formazione culturale all’esperienza ateniese. Ritengo che sia necessario riflettere su tutto questo, e non scordarsi mai che l’Italia è fatta anche di queste eccellenze. Gabriella d’Henry ento anni fa, il 9 maggio 1909, con Regio Decreto n. 373 venne fondata la Scuola Archeologica Italiana di Atene (ora chiamata, secondo la discutibile moda delle sigle, SAIA); il decreto venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno dello stesso anno. E la Scuola venne inaugurata l’anno seguente, il 7 aprile 1910. Si era a qualche decennio dall’Unità d’Italia e dalla nascita dello Stato italiano; fino a quel momento, nonostante l’attiva presenza di alcuni archeologi di valore, la cultura antichistica italiana era dominata dagli studiosi tedeschi, di stampo prevalentemente positivista. Per la prima volta un’Istituzione culturale italiana si affiancava a storiche Istituzioni dei maggiori Paesi, europei e non, che avevano nella Grecia classica il loro punto di riferimento ed il loro centro di ricerca. Già precedentemente un grande archeologo italiano, il trentino Halbherr, aveva lavorato nelle isole greche. Ma il primo direttore della Scuola fu Luigi Pernier, che rimase ad Atene diversi decenni: i suoi interessi di studioso si concentrarono a Creta e Lemno; oltre a Rodi, che in quegli anni era soggetta all’occupazione italiana. Per un breve tempo fu poi direttore lo storico dell’arte antica Alessandro Della Seta. Nel marzo 1948, dopo le vicissitudini del conflitto mondiale, la Scuola venne ufficialmente riaperta, sotto la direzione del triestino Doro Levi, che, prima delle leggi razziali di cui fu vittima, aveva già lavorato a lungo in Grecia, -3- GIANCARLO BAILO MODESTI Le popolazioni indigene dell’entroterra Bisaccia, 12.03.1997 N ell’incontro di oggi scenderemo di molto nel tempo rispetto alle cose di cui abbiamo discusso insieme l’ultima volta, in cui - se vi ricordate - eravamo rimasti, a seconda delle cronologie, tra i 3000 e i 2000 a.C., dunque in un tempo molto remoto. Adesso saltiamo tutto un lungo periodo, che è quello dell’età del Bronzo, e ci spostiamo invece alle soglie dell’epoca storica, in quella che gli archeologi chiamano tradizionalmente prima Età del Ferro: siamo quindi, in termini di cronologia assoluta - per le cose più antiche che vedremo già nel corso del IX secolo a.C. Faremo poi una veloce carrellata di quattrocinque secoli per cercare di vedere lo sviluppo di questa cultura indigena detta di ‘Oliveto-Cairano’ nelle tappe più significative dei suoi mutamenti e per capire appunto come si evolve questa cultura indigena di fronte alle sollecitazioni della storia e ai suoi stessi sviluppi. La prima Età del Ferro è un momento essenziale per l’assetto più generale della penisola italiana. Sono trascorsi gli anni cruciali intorno al 1000 a.C., che sono quelli durante i quali si verificano tutta una serie di fenomeni di cui non parlerò in questa sede, e che soprattutto si concludono con il formarsi di vere e proprie unità nazionali, quelle che, praticamente, ci hanno accompagnato fino quasi ai nostri giorni. Sto parlando delle unità nazionali in senso regionalistico, per cui già negli assetti delle popolazioni protostoriche che vivevano in quel periodo si vedeva una partizione dell’Italia che corrisponde grosso modo a quella che sarà poi delle regiones augustee - naturalmente con qualche piccola variante - e, tutto sommato, anche alla nostra divisione regionale odierna. Fa eccezione proprio la Campania, i cui confini odierni, come sapete, sono poco più che un’espressione geografica, mentre al suo interno essa è un crogiolo di culture campane e di altre culture - come quelle di cui parleremo - che guardano a volte più verso il versante pugliese o verso il versante lucano. La Campania nell’Età del Ferro è percorsa essenzialmente da due grandi filoni culturali: quello degli incineratori villanoviani, che sono in pratica i Protoetruschi, e poi gli indigeni cosiddetti della ‘Cultura delle tombe a fossa’. E’ una distinzione che, soprattutto nella definizione, rivela già un’opposizione del rituale funerario tra popolazioni che incineravano, e cioè bruciavano i propri morti e li deponevano in un’urna costituita generalmente da un vaso o da una forma fittile di capannna, e popolazioni che invece, come facciamo noi, inumavano in semplici fosse terragne i resti dei propri antenati. I centri più importanti del gruppo villanoviano sono, a Nord, Capua e, nelle nostre zone, Pontecaganano; vi sono poi delle piccole appendici a Capodifiume, già in territorio pestano, e l’ultimo avamposto di Sala Consilina, nel Vallo di Diano, che probabilmente nell’Età del Ferro è una sorta di enclave degli Etruschi di Pontecagnano. Sala Consilina poi, per la sua stessa vocazione a metà tra Campania, Lucania e area enotria, deciderà molto presto, già nelle fasi finali dell’Età del Ferro, per la vocazione enotria e se ne andrà nel corso del suo sviluppo in tutt’altra direzione rispetto a Pontecagnano e a Capua. La ‘Cultura delle tombe a fossa’ si divide a sua volta in due sotto-filoni, uno costiero, detto di Cuma-Torre Galli perché raggiunge anche le coste calabresi, che ha i suoi centri nelle zone vicine a noi, come ad esempio S.Valentino Torio, -5- SALTERNUM l’epoca più antica, che è la prima Età del Ferro. Le tombe sono - come dicevamo - tombe a fossa terragna che quasi sempre hanno una copertura in pietre e ciottoli di fiume. Tolta la copertura, nelle tombe appaiono i morti, con lo scheletro deposto supino nella fossa e, accanto a questo, degli oggetti che lo accompagnavano come corredo personale. Proprio dall’esame di ciò che compare in queste tombe cercheremo ora di ricavare dei dati per quello che riguarda l’assetto di queste comunità. Nella prima Età del Ferro i corredi sono generalmente abbastanza poveri e non particolarmente esuberanti; rarissimi sono gli oggetti di ornamento: si trovano infatti solo ornamenti funzionali, come la spilla che serviva a chiudere il vestito sul petto. Le donne, oltre alla spilla, raramente hanno qualche anellino o qualche bottoncino di bronzo, ma si tratta nel complesso di corredi molto sobrî. C’è poi il corredo ceramico, che generalmente è costituito dalla grande brocca biconica, all’interno della quale spesso c’è un piccolo attingitoio - una tazza o un’anforetta -, mentre, nei corredi più esuberanti, a questi due vasi si aggiunge una tazza più grande che noi chiamiamo ciotola-attingitoio, perché rappresenta una via intermedia tra una forma aperta e una forma chiusa. Il servizio ceramico era costantemente deposto ai piedi del defunto sia nelle tombe maschili sia nelle tombe femminili e il dato interessante, che a volte non si ritrova in altre popolazioni indigene contemporanee, è che si tratta sempre dello stesso servizio sia per l’uomo che per la donna. L’elemento che cambia, però, e che distingue i due sessi già a livello dell’esame degli oggetti nel momento della deposizione finale, è invece rappresentato dagli oggetti di ornamento, perché gli uomini hanno sempre spille del tipo ad arco serpeggiante, mentre le donne hanno la caratteristica fibula ‘ad occhiali’ (o a doppia spirale), che è uno degli elementi di tradizione adriatica che rimanda all’area illirica e che non compare a Pontecagnano o nella Valle del Sarno. Se il servizio ceramico ai piedi del defunto è lo stesso per uomini e per donne, l’uomo però è a volte connotato con oggetti tipicamente maschili come le armi - la punta di lancia ad esempio - o con strumenti a lui funzionali, come il rasoio. La S. Marzano e numerosi altri centri. Vi è poi, derivata probabilmente da questa dopo l’impatto con i Greci, una cultura dell’interno che se na va però verso Caudium-Montesarchio passando per Avella, e che corrisponde a una sorta di ristrutturazione del mondo campano in un momento successivo alla destrutturazione avvenuta per l’incontro con i Greci che, almeno per alcuni indigeni e in particolare per quelli di Cuma, dovette essere particolarmente violento. Ma il secondo sotto-filone, quello che a noi interessa, è invece rappresentato dal gruppo detto di Oliveto-Cairano, che ha i suoi centri principali nell’alta valle del Sele a Oliveto Citra, probabilmente a Montecorvino Rovella e a S. Maria a Vico - dove sono attualmente in corso alcuni scavi -, e lungo il versante ofantino, appena superato il varco appenninico e la Sella di Conza, a Cairano, Calitri, Bisaccia, Conza della Campania e in tutta un’altra serie di centri, tra i quali i più esplorati sono quelli alto-irpini di Cairano e di Bisaccia. Si tratta probabilmente, da quelli che sono i dati archeologici, di una popolazione venuta un giorno dall’altra parte del mare, dall’altra sponda della costa adriatica e cioè dall’area cosiddetta illirica. I confronti più stretti si hanno ad esempio con materiali dalla Macedonia. Probabilmente attraversarono il mare, risalirono il corso dell’Ofanto, arrivarono nei dintorni del varco appenninico e si collocarono un po’ su tutte le alture strategicamente importanti a dominare il corso dell’Ofanto e del Sele. La via di comunicazione naturale Ofanto-Sele, attraverso la Sella di Conza e il varco appenninico, è nell’antichità una delle vie più importanti proprio per creare un passaggio, senza andare per mare, tra la costa tirrenica e quella adriatica ed è quindi una via di fondamentale importanza strategica, il cui controllo come vedremo - era ricco di conseguenze. Le popolazioni di Oliveto-Cairano non raggiungono mai un livello urbano, vivono sempre sparse in villaggi - ma in villaggi uniti da un rapporto di solidarietà -, creando un sistema che permetteva di controllare tutto il territorio circostante. Come si presenta questa cultura al momento della sua comparsa nelle nostre zone? L’evidenza che abbiamo è ancora una volta soprattutto funeraria: non abbiamo gli abitati nemmeno per -6- GIANCARLO BAILO MODESTI donna invece, quando vuole connotare il proprio sesso, presenta la fusaiola, che è un oggetto connesso con l’arte del filare e, quindi, con attività tipicamente femminili. Questo quadro già ci offre dati interessanti, perché bisogna pensare che una tomba a fossa, anche una tomba semplice come queste, deve essere interpretata quasi alla stregua di una fonte scritta o di un messaggio, ossia come un insieme di segni che gli antichi hanno lasciato non casualmente, ma volutamente, e che noi ora dobbiamo cercare di interpretare. Non è casuale, ad esempio, la forma stessa di una tomba, o se in una tomba è presente un oggetto piuttosto che un altro, o, ancora, se un particolare oggetto si trova in un punto preciso della tomba piuttosto che in un altro. Tutto questo insieme di segni costituisce un sistema dietro il quale c’è un’elaborazione e una volontà cosciente ed è proprio questa che noi dobbiamo cercare di leggere e interpretare, senza lavorare troppo con la fantasia. Che immagine ci restituisce, dunque, una necropoli fatta di tombe di questo tipo? Ci restituisce l’immagine di una comunità non particolarmente ricca, che non aveva quindi un grande surplus del quale poteva privarsi per donarlo, ad esempio, come corredo funebre ai morti, e una società tutto sommato abbastanza egualitaria. In realtà, come l’antropologia moderna ci insegna, una società veramente egualitaria probabilmente non è esistita mai; diciamo però che era egualitaria dal punto di vista delle nostre categorie moderne, le categorie economiche attraverso cui noi oggi misuriamo uguaglianze e disuguaglianze. Probabilmente, poi, va considerato che ci sono segni che non sono rimasti all’archeologo - si ricordi che spesso non si trovano neanche tutti gli oggetti della cultura materiale che eventualmente erano stati deposti in una tomba -, oppure segni, non della cultura materiale, che nella tomba a livello funerario non venivano indicati e che segnalavano però, all’interno di quella comunità, una differenza tra individui (si pensi ad esempio all’ipotesi che i cadaveri avessero tatuaggi, che noi non abbiamo più ma che magari rappresentavano un elemento di prestigio all’interno della comunità). Fig. 1 - Bisaccia (AV). Fibula ‘ad occhiali’ (o a doppia spirale). Possiamo comunque dire che ricaviamo l’immagine di una comunità che, almeno dal punto di vista economico, non aveva al suo interno grandi differenze e in cui probabilmente esistevano ancora forme di gestione comune delle risorse, che dovevano essere quelle agricole con integrazioni di allevamento e di attività pastorali. Soprattutto, il dato che colpisce e che risulta insolito rispetto alle altre popolazioni contemporanee, è questa equivalenza sociale dell’uomo e della donna: l’uomo e la donna si connotano, sì, per la loro differenza sessuale, ma il servizio che rappresenta l’individuo adulto ai piedi del morto è assolutamente identico e vi è dunque una sostanziale equivalenza dell’uomo e della donna all’interno del gruppo; vi è, cioè, una divisione di ruoli, ma un’uguale dignità e un uguale peso all’interno della comunità. La differenza passa invece, come spesso accade per queste popolazioni primitive, per le classi d’età. Se andiamo ad analizzare le tombe degli individui non ancora adulti, quindi non ancora iniziati alla comunità, vediamo che anche quando hanno un corredo particolarmente esuberante di ceramica, hanno, sì, la tazza e lo scodellone, ma non hanno mai il servizio tipico che comprende la grande brocca e l’attingitoio. Hanno poi -7- SALTERNUM anch’essi le spille, che connotano, quando sono bambini avanti nell’età, il sesso maschile e femminile. Ma a loro è negato il servizio che identifica l’individuo adulto. Talvolta addirittura sono privi del corredo ceramico e hanno solo ornamenti. Dopo questo secondo livello di classi d’età, a un livello ancora più basso si collocano i neonati o i bambini nella prima infanzia, che di solito sono deposti in piccole fosse sul terreno nelle quali lo scheletro spesso non è rimasto se non sotto forma di piccoli frustuli di ossa. Le tombe di neonato si mostrano particolarmente interessanti perché al loro interno hanno sempre e soltanto la grande spilla maschile dei vari tipi ad arco serpeggiante, presente con esemplari di dimensioni normali - quindi non miniaturizzate per un bambino - se non, a volte, addirittura di dimensioni considerevoli. Vi è poi un esempio di tomba di infante in cui il neonato non era deposto nella fossa, ma vi era un buco nel terreno con un grande vaso che conteneva all’interno le spoglie del bimbo. Insieme alle spoglie del bambino si rinvennero un coltello di ferro, assolutamente improbabile come oggetto d’ornamento personale del neonato, un’enorme spilla ad arco serpeggiante e una punta di lancia di bronzo, identica a quella degli adulti maschi. In un’altra tomba di infante, invece, non c’era alcun oggetto di corredo, ma soltanto una punta di lancia in bronzo, deposta a metà della piccola fossa. L’immagine che suggerisce questo modo di deporre il neonato risulta abbastanza anomala: il neonato, in pratica, non ha un corredo personale e anche la spilla che chiude il vestito sul petto non appartiene al corredo dell’infante, anche perché in qualche caso, come in quello dell’enchytrismos (la sepoltura entro vasi), la spilla serviva piuttosto per chiudere il panno in cui i resti del neonato erano inseriti. L’infante non ha dunque diritto al servizio ceramico e neanche agli oggetti personali; quando poi si rinvengono elementi di tipo personale come la spilla, si tratta sempre della spilla maschile di grandi dimensioni. A volte, addirittura, a ribadire questa connotazione maschile di individuo adulto, sono presenti la punta di lancia e il coltello di ferro. Il neonato, dunque, in qualche modo non esiste di per sé e non ha ancora una sua individualità, ma esiste in quanto collegato con la figura paterna, perché è il padre che è garante del neonato e nelle tombe di neonato dà la sua impronta. Anche questo è un dato che non trova confronto nelle culture indigene contemporanee, in cui fin dalla primissima età i maschietti e le femminucce vengono connotati in maniera autonoma, anche se mai con tutte le prerogative proprie del maschio o della donna adulti. Questo è il quadro che dagli inizi della cultura, quindi dal pieno IX secolo a.C., prosegue fino circa a tutta la metà l’VIII secolo a.C. Poi improvvisamente, in modo anche abbastanza repentino e senza passaggi intermedi, le tombe più recenti, che vanno dalla seconda metà dell’VIII agli inizi del VII secolo a.C., si mostrano completamente diverse. Sono tombe generalmente molto più ricche di materiali e soprattutto si osserva che si è spezzata quella antica equivalenza tra il servizio dell’uomo e il servizio della donna ai piedi del morto. L’uomo, infatti, ha costantemente ai piedi una grande olla che non è più l’olla biconica del passato ma è la grande olla da derrate, quella che costituisce il simbolo della ricchezza agricola e il bene sostanziale del gruppo; al suo interno si trova ancora spesso l’attingitoio, costituito da un’anforetta o da una tazza. Per l’uomo, poi, si può individuare tra il resto della suppellettile un secondo servizio ceramico, che è deposto generalmente sulle gambe, sotto il bacino, e comprende un grande scodellone con, al suo interno, un ulteriore vaso. Il corredo maschile presenta la punta di lancia ormai realizzata in ferro e non più in bronzo ed è anch’esso caratterizzato da specifici oggetti di ornamento: continua infatti anche nelle spille la distinzione tra maschio e femmina, con la spilla ad arco serpeggiante per gli uomini e la spilla ‘ad occhiali’ per le donne, anche se vi sono alcuni tipi di fibule -come quelle a navicella o a sanguisuga - che condividono sia gli uomini che le donne. Come avevamo già visto comparire nelle sepolture femminili dell’età precedente, nelle tombe delle donne c’è adesso costantemente quello che è il fossile-guida della cultura, ossia il bracciale ad arco inflesso, che diventa in questo -8- GIANCARLO BAILO MODESTI momento molto più diffuso e canonico. Il bracciale ad arco inflesso, infatti, è presente in tutte le tombe femminili e quando si trova in una sepoltura, anche al di fuori dai centri della cultura di Oliveto-Cairano, si può essere certi di essere in presenza di una donna di Oliveto-Cairano, perché evidentemente questi bracciali erano qualcosa che, nell’immaginario di quelle genti, ribadiva l’identità culturale e l’appartenenza delle donne a quel gruppo ben definito. Le tombe femminili, a differenza di quelle maschili, non hanno la grande olla da derrata ai piedi, ma ai piedi hanno soltanto lo scodellone, a volte accompagnato da un altro vaso: in sostanza, le donne hanno ai piedi quello che nell’uomo costituisce il servizio secondario e complementare, che è posto sulle gambe o vicino al bacino. E questa è una differenza fondamentale rispetto alla fase precedente. Che immagine ci restituiscono già questi pochi dati? Per quanto riguarda la società in generale, che senza dubbio ha fatto un salto di crescita, i corredi sono tutti sensibilmente più ricchi e, nonostante questo, cominciano ad avvertirsi al loro interno le prime differenze di ricchezza. All’interno dei corredi funebri si comincia a rinvenire anche suppellettile ceramica che non è prodotta in loco ma che è prodotta dalle culture indigene vicine, in particolare della Daunia. E questo ci dice che si tratta ormai di una comunità che produce anche più di quanto le basti per la sua stessa sussistenza e che ha qualche cosa che può scambiare. Mentre l’immagine della comunità precedente era quella di una comunità tesa alla sopravvivenza e chiusa al suo interno, questa è l’immagine di una comunità invece in fase di sviluppo, che si apre all’esterno e che è in un momento di profonda crescita. Quello che cambia è, come si diceva, l’equivalenza tra uomo e donna: improvvisamente l’uomo rivendica nella tomba i simboli propri e sostanziali che ricordano la ricchezza del gruppo e che vengono rappresentati dall’olla da derrate. Ma non è soltanto questo. Tranne qualche rarissima eccezione, gli oggetti di ferro, che costituisce il metallo di valore sostanziale e di valore tecnologico all’interno del gruppo, sono prerogativa dell’elemento maschile. Fig. 2 - Bisaccia (AV), Museo Civico Castello Ducale. Askos dauno dalla T. 110 - Prima metà VII sec. a.C. Fig. 3 - Bisaccia (AV), Museo Civico Castello Ducale. Goliera di bronzo dalla T. 110 - Prima metà del VII sec. a.C. Fig. 4 - Bisaccia (AV), Museo Civico Castello Ducale. Anforetta d’impasto decorata a lamelle metalliche dalla T. 11 - VII sec. a.C. -9- SALTERNUM Fig. 5 - Bisaccia (AV). La tomba della ‘Principessa’ in corso di scavo (foto G. Bailo). Si delinea dunque un quadro in cui ci sono corredi di donne che non possono definirsi povere, ma i simboli più importanti del potere reale all’interno del gruppo sono appannaggio dell’elemento maschile. Rimane da chiedersi che cosa ha fatto fare questo salto di qualità alla cultura. Fondamentale a questo proposito è il rinvenimento di una tomba che fu messa in un luce un giorno imprecisato della fine degli anni ’70 sulla collina di Bisaccia. Sulla collina si rinvenne una sepoltura che immediatamente si differenziava dalle altre. Innanzi tutto si trattava di una tomba a fossa, di grandi dimensioni, che aveva la normale copertura in pietre e ciottoli; da questo punto di vista, dunque, l’immagine era identica a quella delle altre tombe della collina, si differenziava però già dal grande lastrone di pietra bianca che si rinvenne reclinato e piegato tra le pietre della copertura, ma che in origine, probabilmente, doveva essere innalzato a formare una sorta di sema, ossia di segnacolo della tomba e che già si poneva come elemento di distinzione rispetto alle altre tombe. Ma, soprattutto, il dato più curioso era rappresentato dal fatto che questa tomba era circondata, almeno per tutta la sua metà inferiore, da un recinto di pietre che le altre tombe non avevano. Vi era un primo recinto, quello probabilmente originale e più ampio, che venne poi ribadito da un ulteriore recinto, aggiunto forse quando il primo si era in parte interrato o era stato risistemato. Prima ancora di sapere che cosa ci fosse dentro la tomba, dunque, si osservava che questa sepoltura voleva presentarsi già dall’immagine esterna come diversa dalle altre tombe della collina. L’aspetto più importante di questa diversità è senz’altro rappresentata dal recinto, perché il recinto presso tutte le popolazioni antiche, e soprattutto quelle vicine a noi, ha uno spiccato valore di limite ed è capace di creare un limite, oltre il quale non si può andare, tra lo spazio interno e lo spazio esterno al recinto stesso. Il recinto, quindi, isola un elemento di - 10 - GIANCARLO BAILO MODESTI una certa importanza e rappresenta un limite che distingue ciò che è all’interno del limite stesso - che è sacro e di notevole importanza da ciò che è all’esterno (si pensi ad esempio al solco che Romolo traccia quando deve disegnare il perimetro di Roma e si pensi al fatto che quando Remo, suo fratello, supera il solco, Romolo non esita ad ucciderlo, proprio perché era stato in qualche modo commesso un sacrilegio che soltanto la morte e il sacrificio potevano intervenire a sanare). Questi limiti dunque, anche se non fisicamente invalicabili, sono simbolici, e in quanto tali invalicabili sostanzialmente. Il messaggio che se ne può ricavare è dunque che all’interno di questo limite era posto qualcosa di importante e che il recinto costituiva un limite oltre il quale non si doveva andare. Sotto le pietre uscì il corredo particolarmente ricco dell’individuo che vi era deposto, che era sicuramente una donna per la presenza dei numerosi bracciali ad arco inflesso. Colpiva l’esuberanza del corredo non solo per la quantità dei vasi, ma anche per la qualità di alcuni di essi: vi erano infatti dei vasi di bronzo e i vasi di bronzo nell’antichità, in questo orizzonte cronologico, hanno anche un valore economicamente molto più rilevante rispetto ai vasi di ceramica. Soprattutto, questi oggetti erano degli status symbol, degli oggetti di prestigio. Molti di essi, come la phiale baccellata, sono quelli che si ritrovano costantemente in tutte le tombe dell’élite di Età orientalizzante, per esempio, dell’Etruria, nelle grandi tombe come la ‘Bernardini’, la ‘Barberini’ o la ‘Regolini Galassi’. Ma al di là della preziosità di alcuni oggetti che uniformano il corredo di questa donna, che era databile agli inizi del VII secolo a.C., a quello dei principi di Età orientalizzante di Pontecagnano per il confronto di due bacini di bronzo con prese lunate, che si trovano soltanto nelle tombe principesche di Pontecagnano -, al di là di ciò, questa tomba femminile conteneva degli elementi anomali, rispetto all’assetto della comunità, anche all’interno della fossa. Aveva ai piedi, ad esempio, la grande olla da derrate. Il suo corredo ceramico comprendeva vasi d’argilla e, oltre alla phiale baccellata e ai due bacini bronzei di cui abbiamo Fig. 6 - Bisaccia (AV). La ‘Principessa’ sulle colline. Fig. 7 - Bisaccia (AV), Museo Civico Castello Ducale. Phiale baccellata di bronzo dalla T. 66 - VII sec. a.C. appena parlato, un grande calderone anch’esso di bronzo. Tolto il corredo che più o meno rivestiva la defunta, uscì il vestito di quella che a questo punto possiamo chiamare ‘principessa’. La donna era interamente rivestita di bronzo. Tutte le donne sepolte sulla collina hanno in quest’epoca un corredo particolarmente abbondante nei bronzi – è tipico appunto delle comunità che hanno un riferimento con la sponda illirica dell’Adriatico - e tutte hanno oggetti di bronzo distribuiti dalla testa ai piedi; anche quando ve ne sono solo due o tre, infatti, si cerca di fare in modo che l’intero corpo sia toccato dal bronzo. La nostra principessa aveva migliaia di piccoli bottoncini di bronzo disseminati fino al bacino, che andavano disegnando una sorta di scialle; - 11 - SALTERNUM bottoni più grandi erano verosimilmente applicati sulla gonna, che era poi ulteriormente appesantita da grandi dischi di bronzo, in qualche caso decorati. Aveva 51 bracciali ad arco inflesso, 25 al polso sinistro e 26 al polso destro: in questo caso il numero era singolare, poiché ci sono donne con più bracciali, ma questo numero è rimasto finora senza confronti. Va osservato, a questo punto, che le donne di OlivetoCairano avevano costantemente un bracciale in più al braccio destro e che i bracciali non sono mai in numero pari, sia quando sono in numero minore, sia fino al numeFig. 8 - Bisaccia (AV), La ro maggiore, che è Principessa. appunto 51. Ad oggi non è possibile spiegare il significato di questo dato. Negli unici casi in cui i bracciali sono pari - perché, come sempre ci sono delle eccezioni -, si tratta o di bambini, oppure, come nella T. 4 di Cairano, della sepoltura di una donna che aveva un solo bracciale al polso sinistro e uno al polso destro, che per il resto era priva di corredo e che era una donna zoppa, con un difetto di articolazione agli arti inferiori. Una delle ipotesi che si potrebbero suggerire potrebbe essere che le donne che presentano un numero dispari di bracciali sono le donne adulte, maritate, quindi le donne che a pieno titolo hanno avuto il ruolo di elemento femminile della comunità. La nostra principessa aveva un numero notevole di spille di bronzo, tra cui alcune enormi, ricoperte di ambra e di avorio. Aveva poi anche le fusaiole, ma mentre le altre donne della cultura avevano spesso esemplari in impasto deposti ai piedi della fossa, la principessa le aveva in ambra e addirittura in metallo, quindi abbastanza improbabili come oggetti d’uso allusivi al duro lavoro quotidiano, ma da interpretare piuttosto come oggetti d’ornamento, appartenenti forse ad una lunga e complessa serie di elementi ornamentali che probabilmente adornavano i capelli o una treccia che correva lungo le spalle. Si trattava, dunque, di una donna che risultava trasgressiva rispetto all’elemento maschile della comunità e che rivendicava atteggiamenti impensabili per le altre donne; una donna che rivendicava in qualche modo anche la propria femminilità perché aveva poi tutti gli elementi che connotano le figure femminili, come la fibula ‘ad occhiali’, la fusaiola e tutta una serie di elementi che caratterizzano anche le altre donne del gruppo. La principessa non era però l’unica ad avere una tomba dotata di recinto: di fianco a lei, infatti, c’era una tomba maschile che aveva anch’essa un accenno di recinto e che era dotata di un corredo particolarmente ricco, anche se poi non aveva al suo interno tutti quei simboli così significanti che aveva la principessa, ma questo perché si trattava di un uomo e l’uomo non doveva esibire nulla. Ai piedi di queste due tombe maggiori c’erano, disposte perpendicolarmente e quindi con un orientamento diverso da tutte le tombe del resto della collina, due tombe di giovani guerrieri, una ai piedi della principessa, una ai piedi dell’uomo che le era a fianco. Non avevano un corredo particolarmente esuberante: uno solo aveva un piccolo accenno di recinto, quindi uno di quegli elementi forti che avevano le tombe maggiori, ma che chiaramente gli derivava di riflesso dall’essere legato in qualche modo da un rapporto – non sappiamo quale, ma possiamo presumere un rapporto quasi di sudditanza o di complementarità e difesa - agli individui della parte superiore della collina. C’erano infine due tombe di bambino, con corredi dai bronzi molto belli, che, anche se non di particolare ricchezza, risultavano comunque sicuramente più ricche delle altre tombe di bambino coeve. Tutto questo insieme di sepolture, in una collina in cui le tombe sono disposte abbastanza fittamente una vicino all’altra, era distribuito invece su uno spazio che lasciava molta libertà. - 12 - GIANCARLO BAILO MODESTI Oltre tutto, ai piedi della principessa c’erano i resti di un vaso rituale che non si ritrova nei corredi funerari e che probabilmente è testimonianza, insieme alla reduplicazione del recinto, che la persona che vi era stata deposta, non solo era stata molto importante in vita, ma probabilmente aveva lasciato una memoria che era stata coltivata e in qualche modo anche acuita nel corso del tempo. E’ probabile, quindi, per arrivare alle conclusioni di questi segni, che siamo in presenza del gruppo di vertice della comunità che ha ormai abbandonato la prima Età del Ferro ed è entrata nell’Età orientalizzante e che rappresenta pertanto la comunità di seconda Età del Ferro di Oliveto-Cairano. Un gruppo di vertice sensibilmente staccato dal resto della comunità, dotato sicuramente di un potere incredibilmente forte rispetto ai propri simili e quindi, si può dire, di un potere di tipo più o meno assoluto. Riguardo alla ‘Principessa’ vi è, però, un’altra sorpresa. Al momento dello scavo, sotto il vestito si trovarono pochissime ossa e in un primo momento si pensò che il motivo andasse cercato nel bronzo stesso, che aveva corroso le ossa, o nell’acidità del terreno. In realtà, le analisi degli antropologi hanno dimostrato che si trattava dei resti di una bambina di pochi anni di età, sepolta con il vestito di una adulta. A questo punto, viene giustamente da chiedersi se non vacilli l’intero discorso. In realtà io penso che il discorso si rafforzi: proprio perché c’era un gruppo familiare dotato di un potere così forte, questa bimba è stata probabilmente deposta in questo modo in quanto predestinata: è stata cioè deposta secondo l’immagine che avrebbe assunto se avesse continuato a vivere all’interno del gruppo di vertice. E questo è ancora più significativo del nucleo sociale a cui la ‘principessina’ apparteneva. Adesso bisogna cercare di capire che cosa ha creato questa accelerazione improvvisa all’interno della comunità, questa ricchezza maggiore e questa frammentazione, disarticolazione e ricomposizione ad altri equilibri della compagine sociale. Sicuramente motivi interni, ma anche un elemento esterno che inevitabilmente deve avere accelerato il processo. A questo punto, se si va alla ricerca di spie che possano offrire una chiave di lettura, per me si tratta dei vasi dauni, i bei vasi di ceramica geometrica dipinta che cominciano a comparire improvvisamente a Bisaccia, e non negli altri centri della cultura di Oliveto-Cairano, nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. e che compaiono, non in tutti i corredi, ma con una certa frequenza, soprattutto nei corredi femminili fino alla prima metà del VII secolo a.C. Che cosa sta succedendo in questo volgere di tempo? Poco prima della metà dell’VIII secolo a.C. è stato fondato nell’isola di Ischia l’emporio greco di Pithekoussai. Non è probabilmente la prima colonia greca d’Occidente - infatti gli antichi stessi a partire da Strabone parlano di Cuma come prima colonia greca d’Occidente -, ma è l’ultimo esito del processo precoloniale e delle frequentazioni delle coste campane da parte dei Greci risalenti ancora all’epoca micenea, quando i navigatori greci facevano rotta verso il litorale tirrenico per approvvigionarsi dei metalli e in particolare dei metalli dell’isola d’Elba. Pithekoussai è un momento di strutturazione forte di questo processo: si crea fisicamente e per la prima volta un avamposto stabile e residente a fare da testa di ponte proprio verso le coste tirreniche. Sappiamo, poi, che Pithekoussai era il polo occidentale di un sistema che il mondo euboico completava con l’emporio orientale di Al-Mina, alle foci dell’Oronte, e attraverso questi due poli si giocava la loro leadership sul Mediterraneo e quindi, più in generale, la leadership del commercio nel mondo allora conosciuto. Subito dopo, dopo la metà dell’VIII secolo a.C., viene fondata Cuma che è invece la prima vera e propria colonia greca d’Occidente, nel senso che è un insediamento nato per essere stabile, per sfruttare anche il territorio agricolo e non solo per istanze commerciali o di alto artigianato. Cuma nasce in base a un progetto politico di conquista per sempre, un progetto politico di ampio respiro. Noi sappiamo che questo porta al contatto con alcune delle popolazioni indigene: con alcuni, gli abitanti di Cuma per esempio, tale contatto fu sicuramente violento e gli indigeni scomparvero o furono massacrati, anche se le fonti lo adombrano - 13 - SALTERNUM soltanto; le popolazioni dell’Etruria con cui i Greci entrarono in contatto fecero invece un notevole salto di qualità, anche perché erano depositarie dei metalli che i Greci andavano a cercare. Ma essendo i Greci finalmente qui e dovendo fare i conti per sempre con il retroterra indigeno, anche le nostre popolazioni indigene, quali più e quali meno, vennero in rapporto con i nuovi venuti. E reagiscono diversamente: quelli più saldamente strutturati, come i Protoetruschi di Pontecagnano, parlano con i Greci in condizioni quasi di pari dignità, mentre le popolazioni della ‘Cultura delle tombe a fossa’ in un modo un po’ più subalterno. Quello che prima del ritrovamento della tomba della ‘Principessa’ pensavamo è che questi fenomeni non avessero lasciato traccia sulle popolazioni indigene dell’interno, come quelle di Bisaccia, poiché nell’alta Irpinia non appariva materiale d’importazione greca. Invece, proprio la presenza di questi vasi dauni ha messo in sospetto. La Daunia nell’antichità, da Aristotele in poi fino alla tarda antichità, era famosa - soprattutto il centro di Canosa - per la qualità della sua lana. I centri greci, nel momento del loro primo insediamento, avevano da costruire tutto il loro assetto e approvvigionarsi di tutte le materie prime. E’ il momento in cui, in attesa di strutturarsi, i Greci hanno bisogno dagli indigeni di materie prime di qualunque tipo. Ed è probabile che la lana dauna in questa direzione giochi un ruolo fondamentale: è solo in questo momento infatti che noi troviamo i vasi dauni qui a Bisaccia, ma anche a Pithekoussai nell’isola di Ischia e poi in altri centri campani del retroterra più vicino, e vasi dauni giungono anche a Pontecagnano. Successivamente, invece, dopo il periodo collegato a questi avvenimenti, la presenza di tali oggetti scomparirà. A Pithekoussai i grandi archeologi Buchner e Ridgway scavarono negli anni Ottanta la tomba di una donna con un’associazione insolita di oggetti: si trattava dell’orecchino tipico di OlivetoCairano, della spilla di Oliveto-Cairano e di un tutulus, un copricapo come quello che aveva anche la principessa di Bisaccia. Questa era sicuramente la tomba di una donna della cultura di Oliveto-Cairano, probabilmente originaria di Bisaccia stessa, deposta a Pithekoussai. E anche a Pontecagnano c’è, ad esempio, il corredo di una donna che, sia dalla suppellettile ceramica sia dalla presenza dei bracciali ad arco inflesso e da altri elementi, rivela di essere una donna di Oliveto-Cairano, contraddistinta peraltro da un notevole status sociale. Tra gli oggetti di corredo che aveva questa donna ci sono due strani uncini che si sono trovati anche in altre tombe di donne indigene e che generalmente venivano interpretati come strumenti per cardare la lana anche se, per la verità, gli oggetti funzionali alla cardatura della lana non sono così, ma presentano più punte. Io ho cercato altri confronti, pensando sempre che fossero collegati all’attività della lana, e per ora ho trovato solo un confronto in un orizzonte lontano, con uno strumento del Kashmere che viene utilizzato vicino ad un telaio dove si fabbricano i famosi tappeti di quelle zone. Per farla breve, io credo che a un dato punto si avvertano queste esigenze di materie prime da parte del mondo greco, che non le richiedeva soltanto per sé, ma anche in vista di una redistribuzione sul mercato, visto anche il complesso sistema di commerci a cui abbiamo accennato poco fa. A quel punto, vengono coinvolte le popolazioni dei dintorni: uno degli elementi forti che interessano ai Greci per qualche motivo è la lana della Daunia. La Daunia e i centri dauni sono a breve distanza da Bisaccia e Bisaccia si trova sugli antichi tratturi di tradizione pastorale che già dall’Età preistorica funzionavano proprio in riferimento al fenomeno della transumanza. Le popolazioni di Oliveto-Cairano sono collocate, come abbiamo detto all’inizio, in punti strategici, controllano tutti i nodi viari fondamentali, non solo il sistema Ofanto-Sele, ma - Bisaccia in particolare - anche i corsi fluviali del Calaggio, del Carapelle e le varie direttrici che portano poi verso la costa campana e verso la Daunia. Penso che i Dauni fossero i produttori della lana e che, poiché erano legati anche per la comune origine illirica da una sorta di somiglianza culturale con le genti di Oliveto-Cairano, venga loro spontanea la collaborazione con queste popolazioni. Le genti di Oliveto-Cairano approfittano della loro collocazione strategica per fare poi da mediatori nei riguardi della costa, probabil- - 14 - GIANCARLO BAILO MODESTI mente non direttamente con i Greci, ma con i centri indigeni forti, come Pontecagnano. Ma non è solo il commercio della lana che mettono in campo le genti di Oliveto-Cairano, bensì anche l’alta capacità tecnologica e artigianale delle proprie donne, di cui è un esempio la defunta che abbiamo vista sepolta a Pontecagnano con gli strumenti del mestiere. Addirittura, in un determinato momento, queste donne creano, come succede a Pontecagnano, dei veri e propri ateliers, delle piccole comunità di immigrati nei centri più vicini ai luoghi di mercato, dando così vita ad un sistema complesso. Questo, oltre probabilmente ad altri fatti, fa fare un salto di qualità enorme alla cultura di Oliveto-Cairano e alla sua gente. La figura femminile è quella che di fatto contribuisce, nella misura che abbiamo detto, a questi fenomeni; succede tuttavia, per apparente paradosso, che nel momento in cui la donna diventa ancora più importante per lo sviluppo del gruppo, improvvisamente è poi l’elemento maschile che detiene il controllo dei mezzi di produzione. Soltanto in una fase viene recuperata la grande dignità della donna, almeno nel livello del gruppo di vertice: si tratta della ‘principessa’, che in qualche modo raduna in sé, con i suoi elementi trasgressivi e tutto quanto abbiamo detto, l’immagine nuova e forte della donna all’interno della comunità. C’è poi un’altra tappa - ed è l’ultima - nella storia di Oliveto-Cairano. Dopo questo momento, databile entro la metà del VII secolo a.C., la vita di Oliveto-Cairano dura abbastanza simile per alcuni decenni. Dobbiamo arrivare al VI secolo a.C. per vedere un altro momento di rottura, questa volta non più a Bisaccia ma a Cairano. A Cairano era stata trovata in anni precedenti una necropoli simile a quella di Bisaccia e della stessa epoca; poi, improvvisamente, sulla collina del Calvario che dominava strategicamente tutta la zona, è uscito un nucleo abitato e una necropoli limitata, circondata da un ampio fossato. L’abitato si presenta come una sorta di grande palazzotto, non certo il villaggio di capanne della gente normale di quell’epoca. Le tombe della necropoli a volte hanno dimensioni notevoli - anche se ve ne sono alcune di dimen- sioni e di corredo normali -, sono incavate nel banco di roccia e hanno un aspetto quasi architettonico, assomigliando sempre più alle tombe a camera. Nelle tombe ricche, in questo orizzonte cronologico, finalmente compare anche il materiale importato dall’area etrusca e dall’area greca, come le coppe ioniche, il bucchero etrusco, i vasi di bronzo, le oinochoai di tipo rodio, e un elmo corinzio. L’abitato ha un grande magazzino con decine di olle da derrate, che si configura come un vero e proprio palazzotto dei signori locali dell’età arcaica e tardo-arcaica. I corredi delle sepolture sono poi particolarmente ricchi. Che cosa è successo? Siamo in un momento particolare: nel corso del VI secolo a.C. avviene lungo la costa quello scambio di leadership sulle rotte marittime tra Etruschi e Greci che segna gli eventi storici di quegli anni. Alla fine prevalgono i Greci, e gli Etruschi, che erano gli antichi re del mare, vengono definitivamente sconfitti. É il momento in cui nasce il centro di Fratte, perché proprio mentre Pontecagnano ha una vocazione costiera che segue il destino degli Etruschi, Fratte è rivolta verso la valle dell’Irno e verso l’interno, ed è il momento in cui i riferimenti per l’interno non sono più centri come Pontecagnano, ma altri come Capua. É il momento in cui rispetto all’elemento etrusco marittimo prevale l’elemento etrusco costiero, che però, ricacciato dalle coste, tende a spostare la sua produzione verso l’interno: non potendo infatti più farlo liberamente sul mare, se non a pena di gravi rischi, gli Etruschi cercano le vie dell’interno per portare gli oggetti con cui fare mercato dalla costa tirrenica a quella ionica e a quella adriatica. In questo frangente una via come quella dell’Ofanto-Sele - questa volta percorsa al contrario, non nel senso della lana che scendeva dalle colline, ma nel senso della merce che dai centri etruschi della costa andava verso l’interno - diventa fondamentale. Il controllo di quelle vie fa fare alla gente - forse in particolare più alla gente di Cairano e di Calitri, che si trovano più vicini all’Ofanto - un salto di qualità ulteriore. Il modello è probabilmente quello del prelievo in presenza di un passaggio obbligato, ma anche quello del - 15 - SALTERNUM dono e di rapporti di reciprocità che si creano tra lo straniero che deve passare per quelle zone e gli indigeni. E’ probabile che all’interno delle comunità di Oliveto-Cairano i gruppi già emergenti traggano da questo movimento un elemento per fare un ulteriore salto di qualità. E a questo punto non solo distinguono la loro tomba all’interno delle altre, ma, come ad esempio a Cairano, addirittura spostano il loro abitato, non il villaggio di capanne dove stanno gli altri, sulla collina del Calvario. Anche la loro necropoli risulta separata da quella degli altri: è la necropoli ai piedi del palazzotto, circondata da un ampio fossato, in cui si trovano tombe ricche e meno ricche, il che fa pensare alla presenza, all’interno di un clan gentilizio, di signori e di loro clientes, secondo il modello che avremo poi in età romana. Concettualmente, anche se non si può pensare a una filiazione diretta di uno dall’altro, il fossato che circonda le tombe della collina del Calvario è l’estensione del recinto della ‘Principessa’. Il fatto appunto che il recinto, nel caso della principessa e dell’uomo sepolto di fianco a lei, isolasse una sola tomba per volta ha un significato; il fatto che un intero nucleo sociale sia circondato da un fossato significa che gli equilibri sono mutati e che anche l’aspetto culturale cerca di ricalcare nell’immaginario funerario questa realtà diversa. È un po’ tutto il gruppo di vertice che si è ormai distaccato anche fisicamente dal resto della comunità e si colloca sulla collina. Questo quadro dura per tutta la seconda metà del VI secolo a.C. e per buona parte del V secolo a.C. Improvvisamente poi arriviamo alla fine della storia: proprio nel suo momento di massimo sviluppo la cultura di Oliveto-Cairano finisce e scompare in tutti i centri. Le necropoli non hanno seguito e non ci sono centri abitati contemporanei che si sviluppano. Cosa è successo? Dalla metà del V secolo a.C. in poi sono anni cruciali per le nostre zone e per la Campania in generale, perché comincia quel fenomeno che è stato chiamato di sannitizzazione, che riconduce tutta la regione a un forte grado di omogeneità politica, culturale e militare. Le nostre genti peraltro sono quelle sospette nelle fonti antiche per aver sostenuto l’elemento sannitico dell’interno: sappiamo infatti che la sannitizzazione è anche una presa del potere delle città greche da parte dell’elemento sannitico, ma è probabile come ci testimoniano le fonti - che per fare questo abbiano chiamato a raccolta anche le tribù dell’interno con cui avevano rapporti di solidarietà. Due sono quindi le eventualità. Visto che sono mutati gli equilibri sulla costa e che tutto quel sistema di commerci di cui abbiamo parlato entra in crisi e cambia radicalmente, come l’antropologia moderna ci dimostra, è probabile che una cultura che ha fatto dei passi in avanti rispetto al proprio trend normale, se vengono improvvisamente a cadere i motivi che le hanno fatto fare questo salto di qualità, non solo torni ai livelli precedenti, ma addirittura, a volte, si estingua. Oppure, come io credo più probabile, finisce la cultura di Oliveto-Cairano, ma l’éthnos di Oliveto-Cairano si scioglie in questo momento più vasto di sannitizzazione della Campania. Noi non lo riconosciamo più perché è chiaro che esso assume, anche nella vita materiale, dei modelli e degli atteggiamenti consoni alla nuova realtà e alle nuove esigenze. Alla fine non sappiamo che fine hanno fatto le genti di OlivetoCairano, ma sappiamo che si è aperto un capitolo completamente diverso un po’ in tutta la Campania e molte pagine all’interno di esso vanno verso un nuovo destino. - 16 - GIANCARLO BAILO MODESTI CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA di GIANCARLO BAILO MODESTI - Il 21 giugno 1972 consegue, presso l’Università degli Studi di Milano, la laurea in Lettere e Filosofia con tesi in Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana (110 e lode). - Nell’anno accademico 1972/73 è ammesso alla Scuola Nazionale di Archeologia di Roma e frequenta il primo anno, superando le prove d’esame previste (Preistoria del Vicino e Medio Oriente, 30 e lode; Protostoria Europea, 30 e lode; Topografia di Roma e dell’Italia antica, 30 e lode; Paletnologia, 30 e lode). - Risulta vincitore di un assegno biennale di formazione scientifica e didattica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, a decorrere dall’1/11/1974 e rinnovato per i bienni successivi. - È immesso in ruolo come Ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, con decorrenza giuridica dall’1/8/1980. - a partire dall’a.a. 1997/98 gli viene affidato l’insegnamento di Preistoria e Protostoria presso l’Università degli di Studi di Napoli – L’Orientale. ATTIVITA’ SCIENTIFICA A) Ricerca sul terreno Ha condotto numerose campagne di esplorazione archeologica su incarico della Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, Benevento e della Soprintendenza Archeologica della Basilicata. Nel 1970, 1971 e 1976 ha la direzione scientifica degli scavi nelle necropoli e nell’abitato di Cairano (AV). Sempre nell’alta valle dell’Ofanto dirige l’esplorazione dell’insediamento preistorico, della necropoli protostorica e dell’abitato d’età sannitica di Bisaccia (AV), (1975, 1976, 1989, 1990, 1991) e quello dell’insediamento arcaico di Calitri (AV), (1976). Nel corso degli anni ’70 effettua anche interventi di scavo e recupero nei centri della valle del Sarno (S. Marzano; S. Valentino Torio) e della piana del Sele (Eboli; Serra d’Arce; Oliveto Citra). Dal 1974 al 1979 dirige gli scavi effettuati nelle necropoli e nell’abitato del centro etrusco-campano di Pontecagnano (SA). Nello stesso sito, dal 1981 al 1987, ha la direzione scientifica delle annuali campagne di scavo condotte nell’area della città antica dalla cattedra di Etruscologia ed Antichità Italiche dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, su apposita concessione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. Nel 1989 conduce l’indagine archeologica nella necropoli d’età orientalizzante e nell’abitato di IV-III sec. a.C. di Noepoli (PZ). Dal 1992 al 1996 conduce numerose campagne di scavo nelle necropoli di Pontecagnano, riportando tra l’altro alla luce la necropoli d’età eneolitica riferibile alla facies del Gaudo. Nel 2001, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Salerno e la Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma, conduce una campagna di scavo a Paestum, all’interno del programma di ricerca sulle testimonianze pre-greche del territorio pestano, di cui è coordinatore. Nel 2002 ha la direzione scientifica dell’esplorazione archeologica preventiva del tratto di Pontecagnano in occasione dei lavori per l’ampliamento dell’Autostrada SA-RC, in base all’apposita convenzione stipulata tra la Soprintendenza Archeologica di Salerno, AV, BN e l’Università degli di Studi di Napoli – L’Orientale. - 17 - SALTERNUM B) Convegni, Mostre, Musei Collabora alla promozione e organizzazione delle seguenti iniziative: - Seconda Mostra della Preistoria e Protostoria nel Salernitano, curata dalla Soprintendenza alle Antichità di Salerno e dall’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Salerno-Pontecagnano, 1974). - Convegno Temi e problemi dell’istruzione storico-artistica preuniversitaria, promosso dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli (Napoli, 1976). - Primo Convegno Internazionale sull’Ideologia Funeraria nel Mondo Antico a cura dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, del Centre des Recherches Comparées sur les Societés Anciennes e della Maison des Sciences de l’Homme di Parigi (Napoli-Ischia, 1977). - Colloquio Cronologia e diffusione della ceramica geometrica dipinta della Daunia, a cura del Seminario di Studi del Mondo Classico dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli (Napoli, 1978). - Riordino dei depositi, allestimento ed apertura al pubblico del Museo Nazionale dell’Agro Picentino (Pontecagnano 1978). - Convegno Internazionale Metodi e Tecniche dell’Archeologia, promosso dall’Istituto Universitario Orientale di Napoli (Napoli, 1979). - Tavola rotonda L’iscrizione di Amina (...) e le altre testimonianze epigrafiche dalla ricerca archeologica nell’abitato di Pontecagnano, a cura del Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli (Pontecagnano, 1984). - Progetto per la fruizione del patrimonio archeologico di Pontecagnano (AA.VV., Parco archeologico di Pontecagnano - recupero di un ambiente urbano, Ercolano 1993). - Mostra L’Ultima Pietra, il Primo Metallo - sentieri della Preistoria, a cura della Soprintendenza Archeologica di Salerno, dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli e del Comune di Pontecagnano, Pontecagnano (SA), 1993). - Congresso L’Antica età del Bronzo, Viareggio 1995. - Mostra e Convegno La Pietà degli Dei - santuari e culto a Pontecagnano (Pontecagnano, 19 dicembre 1996). - Convegno Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente alla definizione delle forme vascolari del Neolitico/Eneolitico e del Bronzo/Ferro, Lido di Camaiore 1998. - Mostra e Convegno Prima di Pithecusa – i più antichi materiali greci del golfo di Salerno, Pontecagnano (SA), 1999. - Riordino dei materiali preistorici e protostorici del Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sele di Eboli in occasione della sua apertura al pubblico. - Partecipazione al coordinamento scientifico dei lavori per l’allestimento del nuovo Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano (SA), in base all’apposita convenzione stipulata tra la Soprintendenza Archeologica di Salerno, AV, BN e l’Università degli di Studi di Napoli – L’Orientale. - Riordino dei materiali preistorici e protostorici del Museo Archeologico Nazionale di Paestum in vista del riallestimento dell’esposizione. É intervenuto con propri contributi a: - XV, XVI e XVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 1975, 1976, 1978). - XX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria in Basilicata (Melfi 1976). - Colloquio Cronologia e diffusione della ceramica geometrica della Daunia (Napoli 1978). - Tavola rotonda L’iscrizione di Amina (...) e le altre testimonianze epigrafiche dalla ricerca archeologica nell’abitato di Pontecagnano (Pontecagnano 1984). - IV Convegno di Acquasparta, L’emergenza del politico tra le popolazioni osco-lucane (Acquasparta 1986). - Congresso Internazionale L’età del Rame in Europa (Viareggio 1987). - 18 - GIANCARLO BAILO MODESTI - Congresso L’antica età del bronzo in Italia (Viareggio 1995). - Congresso Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente alla definizione delle forme vascolari del Neolitico/Eneolitico e del Bronzo/Ferro (Lido di Camaiore, 26-29 marzo 1998). - Convegno di Studi in onore di L. Bernabò Brea, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Lipari 2000. - Convegno Depositi votivi e culti dell’Italia Antica – dall’età arcaica a quella tardo-repubblicana, Perugia 2000. - Convegno Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia meridionale tra Indigeni e Greci, Matera 2002. - Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in Etruria Miti simboli decorazioni, Pitigliano (GR) Valentano (VT), 2002. È stato responsabile scientifico di due programmi di ricerca CNR sui seguenti temi: - Sistemazione dei beni culturali ed ambientali: l’evidenza archeologica dei Campi Flegrei nella prospettiva d’uno sviluppo alternativo. - Culture indigene dell’Italia meridionale tra VIII e IV sec. a.C. C) Pubblicazioni Ha prodotto una monografia sulle popolazioni indigene della Campania interna in età arcaica, una sull’Età del Rame in Campania; contributi vari e schede negli Atti di diversi Convegni scientifici e contributi su Riviste specialistiche. Ha collaborato anche alla realizzazione di opere di divulgazione scientifica ed ha partecipato alla stesura di progetti finalizzati alla valorizzazione dei Beni Culturali e del territorio. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI Contributi scientifici: 1- G. BAILO MODESTI, Eboli, necropoli eneolitica, in Seconda mostra della Preistoria e della Protostoria nel Salernitano, Salerno 1974, pp. 25-42. 2- G. BAILO MODESTI, Cairano, in Seconda mostra della Preistoria e della Protostoria nel Salernitano, Salerno 1974, pp. 113-121. 3- G. BAILO MODESTI, Bisaccia: campagna di scavo 1975, in Atti del XV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1975, Napoli 1976, pp. 511-514. 4- G. BAILO MODESTI, L’alta valle dell’Ofanto, in Atti del XVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 805-811. 5- G. BAILO MODESTI, Aspetti della cultura di Oliveto-Cairano, in Atti della XX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria in Basilicata, 16-20 ottobre 1976, Firenze 1978, pp. 321325. 6- G. BAILO MODESTI et Alii, Pontecagnano, in Atti del XVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 298-301. 7- G. BAILO MODESTI, Cairano nell’Età arcaica - l’abitato e la necropoli, in “AION ArchStAnt”, Quaderno 1, Napoli 1980. 8- G. BAILO MODESTI, Il Periodo arcaico, in Storia del Vallo di Diano, I, Salerno 1981, pp. 85-122. 9- G. BAILO MODESTI, Oliveto-Cairano: l’emergere di un potere politico, in G. GNOLI, J. P. VERNANT (edd.): La Mort, les Morts dans les sociétes anciennes, Cambridge 1982, pp. 241-256. 10- G. BAILO MODESTI, Lo scavo nell’abitato antico di Pontecagnano e la coppa con l’iscrizione AMINA(...), in “AION ArchStAnt.”, VI, 1984, pp. 215-245. 11- G. BAILO MODESTI, Cairano, in Bibliografia Topografica della Colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, IV, 1985, pp. 244-246. - 19 - SALTERNUM 12- G. BAILO MODESTI, L’Eneolitico in Campania e la facies del Gaudo, in Atti del Congresso Internazionale L’età del Rame in Europa, Viareggio 15-18 ottobre 1987, in “Rassegna di Archeologia”, 7, 1988, pp. 319-328. 13- G. BAILO MODESTI, Oliveto Citra, in Bibliografia Topografica della Colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, XII, 1993, pp. 457-460. 14- G. BAILO MODESTI et Alii, L’ultima Pietra il primo Metallo - sentieri della Preistoria, Salerno 1993. 15- G. BAILO MODESTI, A. SALERNO, Il Gaudo di Eboli, in “Origini”, XIX, 1995, pp. 327-393. 16- G. BAILO MODESTI, M. CRISTOFANI, Pontecagnano, in Rivista di Epigrafia “Studi Etruschi”, Etrusca, LXII, 1996, n. 11. 17- G. BAILO MODESTI, A. SALERNO, La Campania tra culture eneolitiche ed età del bronzo antico in D. COCCHI GENICK (ed.): L’antica età del bronzo in Italia, Firenze 1996, pp. 119-122. 18- G. BAILO MODESTI, A. SALERNO, Pontecagnano II. 5. La necropoli eneolitica - L’età del Rame in Campania nei villaggi dei morti, in “AION ArchStAnt”, Quad. 11, Napoli 1998. 19- G. BAILO MODESTI, Coppe a semicerchi penduli dalla necropoli di Pontecagnano, in M. BATS, B. d’AGOSTINO, Euboica - l’Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente, Napoli 1998, pp. 369-375. 20- G. BAILO MODESTI, A. SALERNO, P. TALAMO, L’Eneolitico in Campania: criteri per una definizione tipologica e terminologica del repertorio vascolare, in D. COCCHI GENIK (a cura di), Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente alla definizione delle forme vascolari del Neolitico/Eneolitico e del Bronzo/Ferro, Atti del Congresso - Lido di Camaiore, 26-29 marzo 1998, Firenze 1999, pp. 207-215. 21- G. BAILO MODESTI et Alii, Strutture morfologiche e funzionali delle classi vascolari del Bronzo Finale e della prima Età del Ferro in Italia meridionale, in D. COCCHI GENIK (a cura di), Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente alla definizione delle forme vascolari del Neolitico/Eneolitico e del Bronzo/Ferro, Atti del Congresso - Lido di Camaiore, 26-29 marzo 1998, Firenze 1999, pp. 441- 467. 22- G. BAILO MODESTI, P. GASTALDI (a cura di), Prima di Pithecusa - i più antichi materiali greci del golfo di Salerno, Catalogo della Mostra - 29 aprile 1999, Pontecagnano Faiano, Museo Nazionale dell’Agro Picentino, Napoli 1999. 23- G. BAILO MODESTI, Pontecagnano (Salerno), in E. PELLEGRINI, R. MACELLARI (a cura di), I lingotti con il segno del ramo secco – considerazioni su alcuni aspetti socio-economici nell’area etrusco-italica durante il periodo tardo arcaico, in “Biblioteca di Studi Etruschi”, 37, Pisa-Roma 2001, pp. 102-105. 24- G. BAILO MODESTI, Rituali funerari eneolitici nell’Italia peninsulare: l’Italia meridionale in Atti del Convegno di Studi in onore di L. Bernabò Brea, Lipari 2000, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 2003, pp. 283-297. 25- G. BAILO MODESTI et Alii, I santuari di Pontecagnano in Atti del Convegno Depositi votivi e culti dell’Italia Antica – dall’età arcaica a quella tardo-repubblicana, Perugia 1-4 giugno 2000. 26- G. BAILO MODESTI et Alii, I santuari di Pontecagnano: paesaggio, azioni rituali e offerte in Atti del Convegno Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia meridionale tra indigeni e greci, Matera 27-29 giugno 2002. 27- G. BAILO MODESTI, P. AURINO, L’enigma della semplicità: schemi decorativi nella ceramica della cultura del Gaudo in Atti del Sesto Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in Etruria, Pitigliano (GR) 13 settembre 2002, Valentano (VT) 14-15 settembre 2002, Milano 2004, pp. 67-81. 28- G. BAILO MODESTI, Le tombe e la morte nell’Età del Rame in Campania, in F. MARTINI (a cura di): La cultura del morire nelle società preistoriche e protostoriche italiane, Firenze 2006, pp. 187-192. 29- G. BAILO MODESTI 2006, Interpretare il Gaudo, Atti del Settimo Incontro di Studi di Preistorie e Protostoria in Etruria, Pitigliano (GR) 13 settembre 2004, Valentano (VT) 14-15 settembre 2004, Milano 2006, pp. 447-453. 30- G. BAILO MODESTI, Preistoria e Protostoria nel territorio di Paestum, 2008, in cds. - 20 - GIANCARLO BAILO MODESTI 31- G. BAILO MODESTI, A. GOBBI, Le genti delle dune e del mare, le tribù delle colline: egemonia dei centri etruschi e ristrutturazione del mondo indigeno in Campania nella seconda metà dell’VIII sec. a.C., Atti del Nono Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in Etruria, Pitigliano (GR) 12 settembre 2008, Valentano (VT) 13-14 settembre 2008, in cds. 32- G. BAILO MODESTI, P. AURINO, Pontecagnano (SA) - between the city and the sanctuary: the excavations along the motorway’s SA/RC extension, in “Newsletter Archeologia (CISA)”, 2009, pp. 6-21. Schede 33- Schede nn. 5.9; 5.10; 5.11, in M. CRISTOFANI (a cura di), Civiltà degli Etruschi, Milano 1985, p. 131. 34- Schede PC 23; PC 24-25, in G. COLONNA, L’Etruscità della Campania meridionale alla luce delle iscrizioni in AA.VV., La presenza etrusca nella Campania meridionale, Firenze 1994, pp. 376-377. 35- Scheda n. 34, in M. CIPRIANI, F. LONGO (a cura di), I Greci in Occidente - Poseidonia e i Lucani, Napoli 1996, pp. 46-47. Attività di divulgazione scientifica 36- G. BAILO MODESTI et Alii, La Preistoria, in Storia, Arte e Cultura della Campania, Milano 1976, pp. 7-12. 37- G. BAILO MODESTI et Alii, L’area tra il Sarno e il Sele, in Storia, Arte e Cultura della Campania, Milano 1976, pp. 18-22. 38- G. BAILO MODESTI et Alii, Preistoria e Protostoria, in Storia della Campania, I, 1978, pp. 27-46. 39- G. BAILO MODESTI et Alii, Museo Nazionale dell’Agro Picentino, Salerno 1978. 40 - G. BAILO MODESTI, Le genti delle alte valli del Sele e dell’Ofanto, in Cultura materiale, Arti e Territorio in Campania, Salerno 1978, pp. 35-38. 41- G. BAILO MODESTI et Alii, Pontecagnano: un centro etrusco-italico - storia ed immagini, Salerno 1989. 42- G. BAILO MODESTI, L’età del Ferro, in Storia Illustrata di Avellino e dell’Irpinia, I, Salerno 1996, pp. 33-48. Saggi ed altri contributi 43- G. BAILO MODESTI, B. d’AGOSTINO, Archeologia e Arte Classica nei manuali di Storia dell’Arte, in C. DE SETA (a cura di), Quale Storia dell’Arte, Napoli 1977, pp. 35-45. 44- G. BAILO MODESTI et Alii, Parco archeologico di Pontecagnano - recupero di un ambiente urbano, Ercolano 1993. - 21 - LUIGI PICCARDI Geomitologia ed origini geologiche del culto dell’Arcangelo Michele Relazione tenuta dall’Autore a Paestum - Venerdì 14 Novembre 2008 nell’ambito del Convegno Geologia…Mito, organizzato dai Gruppi Archeologici d’Italia e dall’Associazione Italiana di Geologia e Turismo, tenutosi durante l’XI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. N ell’ambito della XI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, Novembre 2008), si è tenuto per il secondo anno un Convegno in collaborazione fra l’Associazione Italiana di Geologia e Turismo ed i Gruppi Archeologici d’Italia, per promuovere l’interazione fra geologia e archeologia. Tale interazione fornisce un valore aggiunto sia per un sito archeologico, dove spesso gli aspetti geologici sono poco rappresentati, che per un sito di interesse geologico, dove le implicazioni storiche consentono di ampliarne l’interesse ad un più vasto pubblico. Nel Convegno è stato affrontato in particolare lo studio delle relazioni fra geologia e mito, un campo estremamente interdisciplinare noto come ‘geomitologia’1 che può costituire un ulteriore contributo innovativo e rilevante, non solo per la possibilità di valorizzazione turistica e culturale del territorio, ma anche per le implicazioni ai fini della prevenzione dei rischi naturali2. Nello studio delle fonti storiche si arriva inevitabilmente a chiedersi dove sia il limite fra storia e leggenda. Per questo leggende e miti vengono setacciati alla ricerca di informazioni anche dai geologi, soprattutto per aree o per periodi con scarsità di notizie storiche in senso stretto. D’altro canto vi è anche un costante interesse per la comprensione del significato e delle origini dei miti, radici della nostra cultura. Finora lo studio della mitologia è rimasto appannaggio esclusivo di discipline umanistiche, quali storia, antropologia o psicologia, senz’altro le più atte a studiare il fenomeno nel suo complesso. Le fondamenta naturalistiche di gran parte della mitologia, fatto ben noto, sono state però considerate principalmente solo in termini generali, senza tener conto del singolo caso specifico. Alle discipline umanistiche è finora mancato infatti un elemento fondamentale per poter interpretare il contenuto di quei particolari miti nei quali la base naturalistica ha un ruolo determinante, cioè la conoscenza scientifica del fenomeno naturale implicato. Quello che possiamo defïnire come lo studio geologico della mitologia è un campo emergente, di carattere fortemente interdisciplinare. E’ infatti necessario avere una conoscenza sufficiente del quadro storico e culturale dell’epoca, del contesto religioso e della complessità del mito, dell’archeologia locale, del fenomeno naturale in questione e della geologia dei luoghi di ambientazione. In questi studi non si può disporre di tecniche standard che possano essere applicate indiscriminatamente. Ogni caso va valutato a sé, e in genere si ottengono risultati utili solo per alcuni casi specifici, dove le relazioni con la geologia sono chiaramente espresse e vi siano chiari ancoraggi con il territorio e con l’archeologia locale riscontrabili ancora oggi. E’ necessario risalire quanto più possibile alle fonti originarie, valutandole criticamente, ed integrando le informazioni contenute nelle diverse versioni del mito con i vari dati geologici. Infine, essendo impossibile la verifica sperimentale della fondatezza delle deduzioni fatte, si deve ricorrere ad evidenze di analisi comparativa. Mentre l’interpretazione di alcuni miti rimane ancora nel campo speculativo, in mancanza di una evidenza conclusiva, come nel caso di Atlantide o del Diluvio Universale, l’origine geologica di altri miti famosi è palese. Il titano Tifone, schiacciato da Zeus al di sotto del vulca- - 23 - SALTERNUM no Etna, continua a scuotersi e a vomitare fiamme. La lingua di fuoco della indistruttibile Chimera, unico resto del famoso drago a tre teste, dardeggia ancora oggi sulle coste della Turchia, dove delle emissioni gassose naturali bruciano ininterrottamente da millenni. La natura eziologica di miti come questi è evidente, ma questi racconti contengono al loro interno anche memorie della evoluzione della religione locale: dall’essere orientata verso le potenze ctonie della Terra all’essere rivolta alle potenze celesti dell’Olimpo. La religione pre-olimpica era infatti dominata dalla figura della Dea Madre, la multiforme dea dai molti nomi la cui rappresentazione più sentita era quella di Gea, la Madre Terra. I culti allora non erano diretti verso l’alto, agli dei del cielo, ma verso il basso, verso la Terra, verso quegli inferi fecondi dai quali sgorgava incessantemente la vita e ai quali l’uomo ritornava dopo la morte. Non sorprende quindi che tanta attenzione sia stata data dalla mitologia primitiva proprio ai fenomeni geologici, e fra questi in particolare a quelli più impressionanti e più direttamente in relazione col sottosuolo, come vulcani e terremoti. Tali fenomeni, che incutevano terrore e meraviglia al tempo stesso (ingredienti base della sacralità), interessavano proprio l’elemento che rappresentava il nucleo stesso di tutta l’esistenza umana: il grembo di Madre Terra, alfa e omega di ogni creatura. Alcuni miti che mantengono ancora oggi un forte aggancio con il territorio, essendo riferiti a determinati luoghi sacri ed a particolari eventi geologici, come ad esempio i terremoti, risultano più facilmente interpretabili nelle loro specifiche origini geologiche. Anche le relazioni più propriamente storiche sui terremoti non sono mai del tutto libere da un certo senso soprannaturale dell’evento. L’attribuzione di fenomeni naturali a cause soprannaturali a volte risulta essere stata operata anche coscientemente ed in maniera deliberata. Ad esempio, nella relazione sugli effetti del terremoto del 1456 l’Abate del Monastero di Santo Spirito, ubicato presso la faglia attiva di Sulmona, ammette esplicitamente la volontaria codificazione in termini religiosi di fenomeni da lui ritenuti naturali3. Descrivendo alcuni suoni insoliti uditi da due monaci «Di sera, circa la prima ora della notte di quel sabato che precedette il terremoto, mentre ogni cosa era immersa nel più profondo silenzio», l’Abate racconta infatti come «La mattina, avendo essi raccontato il miracolo pieni di stupore, non demmo importanza alla cosa. Ma dopo il terremoto, sebbene non ignorassi che spesso un vento sotterraneo, passando attraverso le fenditure della terra come attraverso una canna emette voci inarticolate ma melodiose, tuttavia non esitai a riferire pubblicamente che questo prodigio era stato compiuto dai santi angeli». E’ proprio dallo studio dei terremoti, in particolare dalla ricerca di testimonianze di passati eventi di fagliazione superficiale, che sono emersi risultati particolarmente interessanti per l’interpretazione geologica di alcuni miti famosi. E’ la convergenza di due principali concause che fa sì che solo oggi si possa giungere ad interpretazioni attendibili. In primo luogo il fatto che la nozione stessa di faglia sismica e di fagliazione superficiale sono concetti solo recentemente acquisiti dalla geologia. In secondo luogo, solo nell’ultimo secolo sono stati condotti diffusamente accurati scavi archeologici che hanno riportato alla luce i luoghi dell’ambientazione mitologica. In questo testo, l’esame di una serie di casi esemplari che nel loro insieme presentano una notevole coerenza4, mostra come le influenze geomitologiche non siano limitate a singole curiosità naturali locali, ma abbiano anche segnato profondamente la nostra cultura. Lo studio di questi casi ci permette di vedere come esista da sempre una sostanziale coincidenza fra alcuni luoghi sacri e geomiti. I principali santuari esaminati infatti spiccavano in primo luogo proprio per la singolarità dei fenomeni geologici che ospitavano, la cui interpretazione soprannaturale faceva sì che questi luoghi venissero protetti, preservati e visitati dai pellegrini, non molto diversamente dai nostri geositi o musei geologici moderni. Il caso più eclatante di questo tipo, dove è più direttamente espressa e comprensibile la relazione fra mito, geologia e archeologia, è quello del millenario Oracolo di Apollo a Delfi, - 24 - LUIGI PICCARDI il più famoso santuario dell’antichità5. Delfi, ombelico del mondo, doveva la sua fama alla radicata convinzione dei contemporanei che il luogo ospitasse una voragine nella terra dalla quale esalavano vapori che invasavano la profetessa con lo spirito della divinità: della Terra all’inizio e di Apollo in seguito. Questa voragine era messa in stretta relazione con i terremoti. Era infatti assieme a Poseidone - lo scuotiterra - che Gea regnava sulla sua voragine oracolare. Ed è in seguito al terremoto scatenato dai sussulti agonizzanti del drago guardiano della voragine ed ucciso da Apollo, e dalle esalazioni provenienti dal cadavere dell’immane serpente, che si estendeva per miglia ai piedi del Monte Parnaso, lasciato ad imputridire nella voragine, che Delfi acquista il suo nome originario: Pito (pytho = putrefatto, in greco). Alcuni dicevano che il drago vivesse nella voragine stessa, altri che vi fosse lasciato da Apollo ad imputridire. Questo caso illustra anche gli effetti della scissione fra discipline umanistiche e scientifiche. L’esistenza di tale voragine è stata da sempre oggetto di dibattito fra filosofi, religiosi e storici, e la sua ricerca è stata uno degli obiettivi primari degli scavi archeologici iniziati nel 1891. Poichè niente di simile fu allora riscontrato, la famosa voragine oracolare fu bollata come invenzione mitologica6. Dal punto di vista geologico lo stesso mito assume invece tutta un’altra prospettiva. Delfi si trova infatti sulla traccia della faglia attiva che borda le pendici del Monte Parnaso (2457 m) e la cui scarpata di faglia conserva chiare tracce di passati eventi di fagliazione superficiale. Leggende locali, tramandateci da Pausania (II sec. d.C.), descrivevano voragini che si sarebbero aperte nella terra e che avrebbero inghiottito il tempio dell’Oracolo poco avanti il VII secolo a.C., e rotture sismiche del terreno lungo la faglia di Delfi si sono verificate anche nei terremoti del 373 a.C., del 551 d.C. e del 1891. La possibilità che qui un terremoto crei una voragine nella terra esalante gas solforosi (H2S, l’odore della putrefazione) e anidride carbonica (CO2 , l’ebbrezza della profetessa) appare quindi del tutto verosimile in questo scenario sismo-tettonico. La descrizione in questo luogo di una tale Fig. 1 - Solofra (AV). Statua dell’Arcangelo Michele. spaccatura sismica esalante gas potrebbe quindi risultare addirittura scontata e irrilevante, se non fosse che proprio su questo si è basato uno dei più importanti miti del passato, un santuario che ha direttamente influenzato la storia del Mediterraneo per almeno due millenni. Anche in Italia esiste un caso importante di una simile associazione fra un famoso luogo sacro, paragonabile a Delfi per importanza storica, e la locale faglia attiva: quello dell’apparizione dell’Arcangelo Michele sul Gargano, tradizionalmente datata alla fine del V sec.7. Il santuario di Monte Sant’Angelo, costruito sul luogo dell’apparizione, ha successivamente svolto un ruolo cruciale come propulsore della conversione dell’Europa pagana, divenendo anche la principale meta di pellegrinaggio nell’Alto Medioevo8. La figura altamente sincretica dell’Arcangelo guerriero, vincitore del dragone, ha infatti facilitato la conversione sia dei miti greco-romani che di quelli nordici longobardi. Le origini geologiche del santuario sono dichiarate nella leggenda, che descrive un forte terremoto associato all’apparizione, ed il successivo rinvenimento di particolari tracce nella roccia nella zona epicentrale. La descrizione degli effetti del terremoto trova chiari riscontri geologici nelle evidenze di eventi di fagliazione superficiale in prossimità del santuario lungo la traccia della faglia di Monte Sant’Angelo che fa parte del sistema di faglie attive di Mattinata. In - 25 - SALTERNUM Fig. 2 - Polistena. Chiesa Matrice di Santa Marina Vergine, statua dell'Arcangelo. Fig. 3 - Roma, Chiesa dei Cappuccini. San Michele Arcangelo (Guido Reni, 1635). base alle evidenze geologiche, si può stimare una magnitudo massima possibile di circa 6.7, superiore cioè alla 5.4 stimata per il terremoto di Mattinata del 1893, ritenuto la massima intensità macrosismica risentita in quell’area. Il terremoto riportato nella leggenda sembra quindi essere l’unica descrizione di un evento ben documentato dalle evidenze geologiche. Il catalogo sismico è d’altronde notoriamente incompleto per il periodo antecedente all’anno Mille. Il riconoscimento o meno del terremoto riportato nella leggenda come evento storico, benché con tutti i limiti connessi ad una informazione estratta dalla tradizione orale, viene quindi ad avere un peso decisivo per l’adeguata stima della pericolosità sismica dell’area, anche in considerazione del lungo periodo di quiescenza della faglia (> 1000 anni) rispetto a simili forti terremoti. E’ da notare che fu proprio la presenza tangibile delle tracce fisiche di quell’evento soprannaturale, cioè le ‘orme dell’Arcangelo’, ossia le spaccature nella roccia conseguenti al sisma, ad avvalorare la credibilità di questa leggenda, rendendo questo uno dei luoghi cardine della fede in epoca medievale. Pur decaduto come importanza, il santuario esiste da oltre 1500 anni e continua ad attrarre oltre un milione di visitatori all’anno. I due casi citati sopra risultano fortemente interconnessi, con un legame molto più diretto della semplice similarità iconografica fra le figure di Apollo e l’Arcangelo Michele. Entrambi i culti provengono infatti da una stessa area geografica in Asia Minore, la Frigia, ed in particolare dal bacino di Denizli. Qui, a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, si trovano due siti archeologici e geomitologici di grande importanza9. Uno è l’antica Hierapolis di Frigia, la città sacra ad Apollo, costruita sul plateau delle cascate bianche di travertino di Pamukkale, uno dei geositi più famosi del mondo. Poco a Sud di questo vi sono i resti della città di Colossae, dove sarebbe originato il culto di Michele, a seguito della sua prima e più famosa apparizione in era moderna. Hierapolis presenta la stessa associazione di elementi geologici e mitologici di Delfi, cioè la sovrapposizione di luoghi di culto della Dea madre e di Apollo in corrispondenza di una voragine nella terra esalante gas tossici, che corrisponde ad una faglia sismica. A Colossae invece il culto di Michele si sarebbe originato a seguito dei vistosi fenomeni geologici verificati- - 26 - LUIGI PICCARDI si col terremoto che distrusse la città nel 60 d.C. Questi due siti di rilievo sono uniti fra loro dalla figura del testimone oculare dell’apparizione dell’Arcangelo Michele a Colossae: Archippo. Questi risulta essere stato un religioso proveniente da Hierapolis, apparentemente iniziato alla religione presso il tempio di Apollo, e poi successivamente formatosi a Colossae nella cultura altamente sincretica del locale culto degli angeli noto come ‘eresia Colossese’. San Paolo scrisse la sua lettera ai Colossesi proprio per combattere questa forma di adorazione degli angeli. Anche in questo caso, come per Monte Sant’Angelo, la leggenda dell’apparizione risulta fondata su precisi fenomeni geologici conseguenti al terremoto. Al tempo della proclamata apparizione la fede cristiana era arrivata a Colossae da meno di cinque anni. La leggenda mostra infatti più le caratteristiche del culto degli angeli tipico della ‘eresia Colossese’ che non della fede cristiana professata da San Paolo. Lo studio geo-mitologico consente quindi di approfondire l’esegesi dei testi sacri, non solo della leggenda paleocristiana, le cui fondamenta naturalistiche sono state poi riconosciute anche dalla Chiesa ufficiale10, ma anche della lettera di San Paolo ai Colossesi. La chiusura di questa lettera (Col. 4.17) contiene infatti il passaggio ritenuto il più oscuro ed enigmatico dei testi di San Paolo11 e si riferisce proprio all’esortazione ad Archippo: «Dite ad Archippo: Considera il ministero che hai ricevuto nel Signore e vedi di compierlo bene». A Colossae, come a Delfi e Monte Sant’Angelo, è dunque possibile riconoscere ancora oggi gli elementi costitutivi della leggenda sia dal punto di vista archeologico che geologico. Lo studio dei casi qui esposti riguardanti Apollo e Michele ci mostra come alcuni dei più importanti culti del passato, che hanno influenzato la società per interi millenni, abbiano avuto le loro fondamenta proprio in eventi geologici, e proprio da questi traessero la convalidazione di base. La conoscenza di queste fondamenta geologiche rappresenta quindi un elemento di cruciale importanza non solo per la corretta comprensione dell’archeologia e della storia locale, ma anche dell’evoluzione culturale e religiosa della nostra società. A Delfi e a Monte Sant’Angelo erano infatti conservate le evidenze di fagliazione superficiale cosismica, non diversamente da quanto realizzato in tempi diversi in vari musei espressamente creati per preservare proprio parte della rottura sismica sulla faglia sismica (ad es. il Nojima Fault Museum in Giappone, a seguito del terremoto di Kobe del 1995). Hierapolis, col suo famoso Plutonium dove gli animali venivano sacrificati per soffocamento da CO2 introducendoli nella camera sotterranea dove invece i sacerdoti rimanevano illesi, non era diverso da quello che veniva mostrato nella famosa Grotta del Cane dei Campi Flegrei, una delle tappe obbligate del Grand Tour in Europa fra 1600 e 1800. A Colossae, famosa già prima dell’apparizione per il lungo corso sotterraneo del fiume Lycus, era possibile osservare la voragine dovuta al crollo cosismico della volta del fiume sotterraneo per circa un chilometro, e in concomitanza del quale era stato osservato il manifestarsi di una enorme fiamma scaturita in corrispondenza della voragine «tamquam columna ignea pertingens a coelum in terra». Analoga situazione geo-mitologica si riscontra per un altro famoso mito, quello del mostro di Loch Ness. Quello che rende unico questo mito è da un lato il fatto che possiamo vivere l’esperienza diretta dell’ultimo dragone mitologico esistente (gli altri sono stati tutti ‘fatti fuori’ da schiere di eroi, santi o dei), dall’altro il fatto che si tratta di un mito paleocristiano che è stato riesumato solo di recente, negli anni Trenta. Il Loch Ness, luogo di indiscussa suggestione, sembrerebbe infatti dovere la sua fama al verificarsi di particolari fenomeni naturali legati alla presenza e all’attività della faglia della Great Glen sulla quale il lago è impostato12. Tali fenomeni, inusuali per gli osservatori comuni, ma del tutto comprensibili per un geologo, avrebbero generato e alimentato la credenza criptozoologica. Risalendo alla fonte originale della leggenda (Vita di S. Colomba, scritta da Adomnan, VII sec. d.C.), nella versione in latino troviamo che un forte tremore (ingenti fremitu) fu associato alla prima apparizione del mostro (VI sec. d.C.). Curiosamente anche qui, come a Monte Sant’Angelo, nessuna delle molte versioni - 27 - SALTERNUM moderne del testo traduce correttamente il termine, riportandolo invece come ‘boato’ o ‘ruggito’. Inutile dire che l’interpretazione geologica non è stata molto apprezzata dai vari fans di Nessie. I santuari qui discussi sono collegati da uno stesso motivo di fondo, cioè il fatto che questi miti sono originati su punti particolari relazionati a faglie sismiche. Il posizionamento di luoghi sacri al di sopra delle tracce di faglie attive non sembra d’altronde essere un fenomeno isolato, limitato a pochi casi fortuiti. Esistono numerosi casi analoghi, e sembra quindi che questa sia stata in realtà una modalità di elezione dei luoghi sacri abbastanza diffusa nell’antichità13. Come abbiamo visto, il loro studio può fornire contributi utili sia per la conoscenza storica e culturale dei luoghi, in modo da permettere anche una loro miglior valorizzazione turistica, che per un’adeguata stima della pericolosità sismica locale. NOTE 1 Sensu, VITALIANO 1973; PICCARDI 2007.a 2 PICCARDI - MASSE 2007. 3 DELL’AQUILA 1456. 4 Per una cui trattazione estesa si rimanda a precedenti lavori: PICCARDI 1998; 2000a; 2005: 2007b; PICCARDI et Alii 2008. 5 PICCARDI 2000a; DE BOER et Alii 2001; ETIOPE et Alii 2006; PICCARDI et Alii 2008. 6 BIBLIOGRAFIA CARLETTI C. - OTRANTO G., (a cura di) 1994. Culto e insediamenti Micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo, Atti del Cong. Int. Monte S. Angelo, Bari. CARAFFA F. 1967, Michele. in Bibliotheca Sanctorum, Pontificia Università Lateranense, pp. 410-446. DE BOER J. Z. - HALE J. R. - CHANTON J. 2001, New evidence for the geological origins of the Ancient Delphic oracle (Greece), in “Geology”, 29, 707-711. DELL’AQUILA M. 1456, Tractatus de cometa atque terraemotu. (Cod. Vat. Barb. Lat. 268). Trad. by B. Figliuolo, Osservatorio Vesuviano e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Salerno, 1990. DUNN J. D. G. 1996, The Epistles to Colossians and to Philemon: a commentary on the Greek text, Michigan, Carlisle, USA. ETIOPE G. - PAPATHEODOROU G. - CHRISTODOULOU D. - GERAGA M. - FAVALI P. 2006, The geological links of the ancient Delphic Oracle (Greece): a reappraisal of natural gas occurrence and origin, “Geology”, 34, pp. 821-824. PARKE H. W. - WORMEL D. E. W. 1956, The Delphic Oracle, The History, Oxford. PICCARDI L. 1998, Cinematica attuale, comportamento sismico e sismologia storica della faglia attiva di Monte Sant’Angelo (Gargano): la possibile rottura superficiale del ‘leggendario’ terremoto del 493 d.C., “Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria”, 21, pp. 155-166. IDEM 2000a, Active faulting at Delphi: seismotectonic remarks and a hypothesis for the geological environment of a myth, in “Geology”, 28, pp. 651-654. IDEM 2000b, Adoration of active faults in the East Mediterranean region. Abstracts CD-ROM, 31 International Geological Congress, Rio de Janeiro. PARKE - WORMELL 1956. PICCARDI 1998; 2005. 8 CARLETTI - OTRANTO 1994. 9 PICCARDI 2007b. 10 CARAFFA 1967. 11 DUNN 1996. 12 PICCARDI 2001a. 13 PICCARDI 2000b; 2001b. 7 IDEM 2001a, Seismotectonic Origin of the Monster of Loch Ness. Earth System Processes, Joint Meeting of G.S.A. and G.S. L., Edinburgh. IDEM 2001b, Fault-Related Sanctuaries. Abstracts of the International meeting of the American Geophysical Union, San Francisco, USA. IDEM 2005, Paleoseismic evidence of legendary earthquakes: the apparition of Archangel Michael at Monte Sant’Angelo (Gargano, Italy), in “Tectonophysics”, 408, pp. 113-128. IDEM 2007a, Preface, in PICCARDI L. - MASSE W.B. (eds.), 2007, Myth and Geology. Geological Society, London, Special Publications, 273, pp. VII-VIII. IDEM 2007b, The AD 60 Denizli Basin earthquake and the apparition of Archangel Michael at Colossae (Aegean Turkey), in PICCARDI L. - MASSE W. B. (eds.), 2007: Myth and Geology, Geological Society, London, Special Publications, 273, pp. 95105. PICCARDI L. - MASSE W. B. (eds.), 2007, Myth and Geology. Geological Society of London Special Publications, 273, Geological Society Publishing House, Bath, UK. PICCARDI L. - MONTI C. - VASELLI O. - TASSI F. - GAKIPAPANASTASSIOU K. - PAPANASTASSIOU D. 2008, Scent of a myth: tectonics, geochemistry and geomythology at Delphi (Greece) in “Journ. of the Geological Society”, London, 165, pp. 5-18. VITALIANO D. B. 1973, Legends of the Earth: Their Geologic Origins, Indiana University Press, Bloomington. - 28 - NICOLA FIERRO Di una iscrizione rinvenuta a Lacedonia (AV) L ’epigrafe, depositata nel Museo Diocesano di S. Gerardo Maiella a Lacedonia (AV), era stata reimpiegata in epoca moderna come stipite di una finestra. Si tratta dell’iscrizione funeraria di un veterano che aveva militato nella terza coorte pretoria, databile alla fine del II o inizi del III sec. d. C. Il blocco di calcare, spezzato al centro in senso orizzontale, misura cm 47 x 47,5 x 14. L’altezza delle lettere è di cm 5. Il centro dello specchio epigrafico presenta un foro rettangolare, scalpellato in profondità, di cm 9 x 6, entro cui forse era inserito un angolo di una grossa cancellata. Questo foro, praticato nell’epigrafe, nel secondo rigo, ha tagliato a metà, in senso orizzontale, le ultime due lettere di VETERA[ni] e, nel terzo rigo, ha obliterato le ultime due lettere di MILITAV[it]. Dopo un’accurata pulizia, negli ultimi tre righi dell’epigrafe sono apparse sigle di difficile lettura e interpretazione. Ecco l’iscrizione integrale: L(uci) DOMITI FORTV[nati] VETERA(ni) AVGG(ustorum) N[n(ostorum), qui] MILITAV[it] COH(orte) III [praetoria —- ] M(unicipium) AQVILONI(ae) E(x) A(uctoritate) PU(blica) DOMITI S(enatus) C(onsulto) AE(re) P(ublico) M(onumentum) D(edicavit)) C(larissimo) V(iro) «Di Lucio Domizio Fortunato, veterano, il quale militò nella terza Coorte Pretoria dei nostri Augusti. Il Municipio di Aquilonia per il prestigio pubblico di Domizio, in seguito alla decisione del Senato, con denaro pubblico dedicò il monumento all’uomo illustrissimo». Fig. 1 - Epigrafe di Lacedonia. L’epigrafe (fig. 1) inedita, ci presenta il veterano Lucio Domizio Fortunato come militante nella terza Coorte Pretoria dei due Augusti: era, in altri termini, guardia del corpo imperiale di due principi. Vediamo chi sono gli Augusti citati nell’epigrafe. Il veterano Lucio Domizio Fortunato, vissuto nell’età dei Severi (193-235 d.C.), militò nella Terza Coorte Pretoria al servizio di Geta e Caracalla (211-217). Erano questi i due Augusti citati nell’epigrafe di Lacedonia. La data della morte di Lucio Domizio Fortunato, perciò, va collocata nel biennio 211-212, quando il potere era gestito ancora dai due Augusti, figli dell’imperatore Settimio Severo. Nella storia militare di Roma ciò che costituì un cambiamento radicale fu lo stanziamento permanente nella stessa città delle coorti pretorie, comandate da un prefetto agli ordini diretti dell’imperatore. Le coorti inizialmente erano nove, alle quali bisognava aggiungere altri seimila uomini, che avevano funzioni di polizia e altre sette coorti di mille uomini ciascuna, i vigiles. - 29 - SALTERNUM Lo scopo palese degli imperatori romani era appunto questo: garantire la propria sicurezza personale e l’esercizio incontrastato del loro potere sovrano. La vita militare era di per sé un grave sacrificio. Per chi si voleva arruolare, l’età base era di venti anni. I pretoriani godevano di un trattamento economico privilegiato, che era quasi il doppio di quello dei legionari. Però l’impegno militare di servizio per i pretoriani era di sedici anni. La statura minima richiesta era di m 1,72. A questo bisognava aggiungere il divieto di matrimonio fino al congedo. La ferrea disciplina militare fu uno dei pilastri su cui si costruì e si conservò il più grande impero della storia. Nell’ambito di questa disciplina militare si svolse la carriera di Lucio Domizio Fortunato. Come è noto, Caracalla non volle dividere il potere con suo fratello: dopo averlo fatto assassinare, per calmare l’indignazione dei pretoriani aumentò la loro paga a 750 denari argentei. Lo storico Elio Spaziano ci informa che Settimio Severo (193-211), dopo aver lasciato la prima moglie, venuto a sapere che in Siria vi era una donna il cui oroscopo prediceva che sarebbe andata sposa ad un re, la fece cercare per averla in moglie. Infatti l’ottenne attraverso la mediazione di amici. Questa donna colta, Giulia Domna, intelligente e di tempra volitiva e ambiziosa, non cessò mai di consigliare e spronare il marito in tutte le sue imprese. Settimio Severo, da parte sua, non mancò mai di manifestarle una riconoscente venerazione. L’imperatore ebbe da lei due figli: Caracalla e Geta. Un’iscrizione ateniese attesta anche l’esistenza di un culto ufficiale dedicato a Giulia Domna. Sotto la sua intelligente guida, la corte imperiale di Roma pullulava di dotti giureconsulti, poeti ed eruditi. Nessuno avrebbe potuto mai immaginare che la corte del rude Severo sarebbe divenuta un centro di vita mondana e di attività intellettuale1. Grazie all’Imperatrice, la corte fu un centro di sincretismo culturale e religioso tra Occidente e Oriente. Infatti ella indusse il marito ad incrementare i culti orientali a Roma. In molte iscrizioni e monete è salutata con i titoli significativi di Augusta, Pia, Felix, mater patriae. Ufficialmente era denominata mater Augustorum, madre degli Augusti. Settimio Severo, finché fu in vita, condivise il potere con i suoi due figli. Il primogenito, Marco Aurelio Antonino Bassiano, introdusse in Roma la tunica gallica (caracalla), munita di cappuccio e maniche, che scendeva come una sottana fino alle caviglie. Da quest’indumento sarebbe poi derivato il suo soprannome: Caracalla. Settimio Severo nell’anno 198 d.C. indicò ufficialmente al Senato la successione dei due figli Caracalla e Geta. L’autoritario imperatore, secondo Erodiano, però era succube del suo prefetto Plauziano, che esercitava su di lui un’inspiegabile supremazia psicologica. La sfrontatezza e l’arroganza di Plauziano giungevano fino al punto di insultare e maltrattare Giulia Domna. Si attribuisce a lui anche l’uccisione di Emilio Saturnino, suo collega nella carica di prefetto, per assicurarsi l’incontrastato dominio nell’incarico. Avido, ambizioso, brutale, durante il periodo trascorso in Oriente al seguito dell’Imperatore egli avrebbe predato province e città. Rientrato in patria, assicura Dione Cassio, avrebbe fatto castrare ben cento cittadini romani di nobile nascita per poter assicurare la verginità della figlia Fulvia Plautilla andata in sposa a Caracalla. Questi, insofferente dell’autoritaria ingerenza del suocero negli affari del suo governo e della sua condotta privata, disgustato anche dal comportamento spudorato della moglie, dopo aver accusato il suocero Plauziano di un complotto ai danni di Settimio Severo, dette ordine a uno schiavo di ucciderlo. Era il 22 gennaio del 204 d.C.. Plautilla, dopo la morte del padre, fu esiliata insieme al fratello nell’isola di Lipari, dove morì più tardi per ordine di Caracalla. Al posto di Plauziano fu nominato il giurista Papiniano, a cui furono attribuite vaste competenze giudiziarie. In questo periodo a Roma c’erano nove coorti pretorie: il veterano Lucio Domizio Fortunato militava nella terza Coorte, come attesta l’epigrafe. È certo, dicono gli storici contemporanei, che Caracalla attendeva con impazienza la morte del padre. Il destino non tardò ad assecondare la sua ambizione. Il vecchio e indomito Settimio Severo, mentre si accingeva in Bretagna ad intraprendere una nuova campagna contro i ribelli Calcedoni, morì improvvisamente il 4 feb- - 30 - NICOLA FIERRO braio del 211 d.C. Toccò al figlio Caracalla concludere le condizioni di pace e ricondurre l’esercito in Italia. La morte di Settimio Severo alimentò le ostilità, il crescente antagonismo e il sospetto tra i suoi due eredi. Il progetto di dividere l’Impero poteva forse rappresentare un tentativo di risolvere una situazione di crescente antagonismo, di continui litigi e intrighi. Davanti al Senato e alla madre Giulia Domna, Caracalla e Geta espongono i termini della ripartizione dell’impero: al primo sarebbero andate l’Europa e l’Africa, al secondo le province dell’Asia e dell’Egitto. Il Senato, sia pure a malincuore, diede il suo assenso, ma Giulia Domna contrastò con veemenza il piano divisorio. Il prestigio dell’imperatrice s’impose e la riunione si concluse con un nulla di fatto. Così si aggravò l’inconciliabilità dei due eredi di Settimio Severo. Intanto, scontri violenti accadevano continuamente fra i due fratelli: Caracalla era sempre più geloso del fratello Geta perchè questi godeva notevole stima e crescente popolarità sia nell’esercito sia nel mondo culturale del tempo. Dione Cassio attesta che Caracalla avrebbe voluto assassinare il fratello il giorno dei Saturnalia2, ma non era in grado di realizzare il suo piano: troppo manifesto era il suo malvagio proposito. Diversi soldati ed atleti sorvegliavano Geta giorno e notte. Caracalla allora indusse la madre ad invitarli da soli nel suo appartamento allo scopo di conciliarli. Appena Geta fu entrato, alcuni centurioni, già istruiti da Caracalla, irruppero nella stanza e l’uccisero. Eliminato il fratello, si affrettò a conquistarsi il favore dei soldati facendo spargere la voce di essere stato lui la vittima designata del complotto. Il tentativo di rivolta dei pretoriani e dei soldati della legione di Albano fu sedato con promesse di forti donativi. L’Historia Augusta narra i fatti che seguirono l’assassinio di Geta: notevole era l’indignazione e il malcontento dei soldati che avevano promesso fedeltà ai due principi. Anche Lucio Domizio Fortunato, in qualità di pretoriano, aveva promesso fedeltà agli imperatori. Egli forse fu spettatore diretto di questa vicenda. Fig. 2 - Busto di Geta. Caracalla per calmare l’ira dei soldati mise in atto promesse di elargizione e una dura repressione dei sostenitori del fratello ucciso. Il giorno dopo il Senato non potè fare altro che prendere atto della morte di Geta e accettare la versione dei fatti fornita da Caracalla. Intanto, alleati e sostenitori veri e presunti di Geta vennero mandati a morte. La memoria di Geta venne cancellata e il nome fatto sparire da tutti monumenti, da luoghi pubblici e religiosi. Era la damnatio memoriae. Durante quella lotta fratricida era stato assassinato anche Papiniano, emerito giurista del tempo, amico di Geta. Un sicario, inviato da Caracalla, uccise il giurista con un colpo di scure, ma fu aspramente rimproverato dallo stesso perchè non aveva usato la spada. Ad Orvieto di recente è stato scoperto il fanum Voltumnae, il santuario federale degli Etruschi. In quest’area sacra sotto la rupe di Orvieto, durante gli scavi condotti dall’Università della stessa città, in località Campo della Fiera, è stato rinvenuto un busto di Geta (fig. 2). La ricostruzione storica di questo rinvenimento è stata fatta dall’archeologo Filippo Coarelli. Caracalla, com’è noto, aveva impartito l’ordine di distruggere tutte le immagini del fratello assassinato. Agli ordini arrivati da Roma non era consentito opporsi: il busto, ivi esistente, doveva essere distrutto. Ma nel fanum Voltumnae, qualcuno, fedele a Geta, forse un soldato o un sacerdote, seppellì il busto con molto rispetto senza danneggiarlo: collocò sotto la nuca una pietra a guisa di cuscino. Il busto di Geta, salvato da un suo oscuro partigiano, non fu spezzato o frantumato. Così è - 31 - SALTERNUM stato trovato integro. Di questo importante rinvenimento ha dato notizia Giuseppe M. Della Fina, in un articolo, L’Imperatore cancellato, pubblicato su La Repubblica, sabato 30 agosto 2008, p. 52 e nel n. 10 di Archeo, ottobre 2008, p. 12, Il fratello “scomodo” di Caracalla. L’importanza di questa inedita epigrafe, dedicata al militare Lucio Domizio Fortunato, sta nel fatto che per la prima volta nella storia si ha la testimonianza precisa che l’attuale Lacedonia in antico si chiamava Aquilonia, un centro sannitico; non è però confermato che si trattasse 1 BESNIER M. 1901, L’Île tiberine dans l’antiquité, in “Rivista italiana di numismatica e scienze affini”, Paris, p. 193. dell’Aquilonia menzionata da Tito Livio (X, 38 e ss.), nota per la battaglia tra Sanniti e Romani del 293 a.C. Ad oggi autorevoli storici e studiosi dibattono sull’esistenza di due o più Aquilonia (G. Grasso) senza aver trovato la soluzione più convincente. Infatti vengono ubicate sul monte Vairano (Gianfranco De Benedittis) o sul monte S. Paolo nel comune di Colli al Volturno (Stefania Capini). Quello che risulta è che l’epigrafe inedita scoperta a Lacedonia menziona esplicitamente Aquilonia, sede di municipium in età romana. Festività romana in onore del dio Saturno che si svolgeva nel mese di dicembre. 2 - 32 - PIETRO CRIVELLI La schiavitù a Roma L ’asservimento d’uomini da parte d’altri uomini ha rappresentato per secoli e secoli, fin dagli albori dell’umanità, uno dei pilastri, forse il più importante, su cui si è fondata l’economia di tutte le società umane. Diciamo anche che, a mano a mano che le condizioni di vita progredivano, aumentando le esigenze della società e di conseguenza il fabbisogno di forza lavoro, il ricorso agli schiavi diveniva sempre più pressante. Osservando le comunità umane del passato non ne troviamo nessuna, almeno fra quelle di cui abbiamo una qualche conoscenza, in cui non ci fosse il lavoro degli schiavi ad assicurare condizioni di vita più agiata ai loro padroni. Sembra che una delle prime distinzioni fra gli uomini, se non proprio la prima, sia stata quella tra gli uomini liberi e i non liberi asserviti ai primi. Non sappiamo quando e come abbia avuto origine questa condizione umana. Certamente l’aggressività, caratteristica della nostra specie, unitamente allo spirito di affermazione e di sopraffazione, ha avuto una parte preponderante nello sviluppo e nel radicamento di questa realtà sociale, ma si può anche supporre che si sia affermata in modo quasi spontaneo, nel senso che, in seguito a scontri fra gruppi di uomini primitivi, coloro che erano stati fatti prigionieri si siano sottomessi di buon grado ai vincitori al fine di evitare più gravi conseguenze. Possiamo anche pensare che gli individui divenuti dominanti nel gruppo abbiano preteso sempre di più da quelli gerarchicamente inferiori fino a privarli della libertà. Sono tutte queste delle ipotesi che qui interessano relativamente. Dalle prime notizie di cui disponiamo in forma scritta l’istituto della condizione servile di non liberi appare già da molto tempo bene affermato e consolidato: ne parlano i testi ittiti, egizi, sumerici, le tavolette fittili rinvenute a Pilo e a Cnosso, l’esame delle quali ci mostra con evidenza che la produzione dei beni era affidata ad una manodopera servile; è ripetutamente citato nel codice di Hammurabi, nel quale si determinava il risarcimento dei danni personali calcolato in modo differente secondo che il danneggiato fosse uno schiavo o un uomo libero. Accettato comunemente, né nella Bibbia né nei Vangeli troviamo il minimo accenno di riprovazione per ciò che allora sembrava essere nella società una condizione assolutamente normale, ma si avverte al più solo una compassionevole considerazione. Nella Bibbia sono contenute alcune norme relative al differente trattamento degli schiavi di stirpe israelita e di quelli appartenenti ad altri popoli: «Quando alcuno dei tuoi fratelli, Ebreo o Ebrea, si sarà venduto a te, sèrvati sei anni, e al settimo anno mandalo in libertà d’appresso a te (Dt. 15,12)». Appare evidente che l’unica limitazione imposta dalla legge ebraica è quella temporale: dopo sei anni di sfruttamento lo schiavo deve essere affrancato. Ma la norma non sembra estendersi agli schiavi non ebrei. E’ anche possibile che sia limitata a coloro che si sono venduti spontaneamente e non agli schiavi acquisiti in altro modo. Essere ridotti in schiavitù è un accidente come un altro che può capitare a chiunque. Così come nascere schiavo è un evento sul quale l’uomo non ha alcun potere allo stesso modo d’essere biondo o bruno o nascere in una famiglia ricca o povera. - 33 - SALTERNUM La parola ‘schiavo’ evoca in noi, uomini del XXI secolo, un senso di ripugnanza, d’oppressione e di sofferenza non facile a descriversi. In quel concetto si avverte la compressione della personalità umana al punto da essere esposti a qualsiasi arbitrio senza alcuna possibilità di difesa, di essere collocati in una condizione animalesca pur conservando, e questo è l’aspetto più tragico, emozioni, sentimenti e intelletto propri dell’uomo, perché essi prescindono dall’essere schiavi o padroni. Per quanto riguarda la posizione degli schiavi a Roma sono diffuse molte convinzioni inesatte nelle quali è opportuno tentare di mettere ordine. Osserviamo per prima cosa che l’unico paragone che sembra possibile è quello con la condizione degli schiavi in Grecia per una certa somiglianza culturale fra le due società in esame. Possiamo dire subito che le condizioni in Grecia dei doùloi (schiavi, in contrapposizione ai liberi eleùteroi) erano in media meno dure di quelle esistenti a Roma, anche perché erano diverse le due economie. L’agricoltura era fatta in appezzamenti di dimensioni piccole o medie, coltivate prevalentemente dagli stessi proprietari, magari con l’aiuto di qualche servo. Lì non esistevano grandi estensioni di terreni agricoli tali da richiedere torme di personale per coltivarle. Anche per questo motivo il numero degli schiavi di sesso maschile era in Grecia di gran lunga inferiore a quello delle schiave e ciò inoltre perché, soprattutto nel periodo miceneo e poi in quello arcaico, quando una città era conquistata, gli uomini sopravvissuti al combattimento erano uccisi, mentre le donne ed i bambini erano ridotti in schiavitù. Dall’esame delle tavolette fittili rinvenute a Pilo risulta un totale di popolazione servile di circa settecentocinquanta donne oltre ad un numero equivalente di bambini di entrambi i sessi, ma non vi appare nessun uomo adulto. Una situazione particolare era quella degli Iloti a Sparta, schiavi non tanto di singoli padroni quanto di una classe cittadina superiore, quella degli Spartiati, che li aveva confinati in una condizione d’inferiorità sociale mantenendoli in uno stato continuo di terrore. Nell’età classica anche in Grecia il fabbisogno di schiavi aumenta notevolmente ma non raggiunge, né mai raggiungerà, neanche lontanamente, quello che si riscontrerà a Roma. E il numero ridotto è in qualche modo una garanzia di migliore trattamento. Sia in Grecia sia a Roma le condizioni peggiori per uno schiavo erano, come vedremo, quelle di coloro che erano impiegati nelle miniere. Un aspetto degno di riflessione è quello che riguarda gli schiavi statali (demòsioi) che in Grecia assolvevano compiti di un certo rilievo, erano utilizzati come uscieri ma anche come funzionari della pólis di grado non molto elevato, e talvolta potevano essere addirittura armati per svolgere compiti di polizia. Qualche cosa di simile accadeva anche a Roma e nelle altre città dell’Italia e dell’Impero, ove esisteva una categoria di servi publici populi Romani che erano adibiti a varie funzioni, da quelle più modeste d’inservienti addetti alle terme o alla manutenzione delle latrine pubbliche a quelle più dignitose d’assistenza ai magistrati; in questo caso si trattava ovviamente di persone di cultura piuttosto elevata o con adeguate cognizioni tecniche che spesso ricevevano una retribuzione più che apprezzabile. Diversa era anche la legislazione fondamentale dello Stato che a Roma conferiva al pater familias dei poteri particolarmente estesi: egli aveva la potestà di vita e di morte sui suoi familiares, di vendere i figli o di adottare uno schiavo, il quale diventava per conseguenza un uomo libero a tutti gli effetti. Questo era sancito dalle leggi note come delle ‘XII Tavole’, risalenti alla metà del V sec. a.C. Nel corso degli anni la posizione dello schiavo a Roma era divenuta molto più varia ed articolata di quanto non lo fosse altrove; inoltre qui egli poteva nutrire la speranza di ottenere la libertà con maggiore facilità di quanto non la potesse ragionevolmente nutrire quello greco. La condizione di ‘liberto’ era molto frequente e chi la raggiungeva si veniva a trovare in uno stato non molto dissimile da quello degli altri uomini liberi, conservando semplicemente alcuni doveri d’ossequio e l’obbligo di alcune prestazioni (operae) da fornire all’ex padrone - le - 34 - PIETRO CRIVELLI caratteristiche e l’entità delle operae erano stabilite di volta in volta nell’atto d’affrancazione -; non solo, ma i figli dei liberti divenivano cittadini romani senza alcuna limitazione, quasi che il periodo di vita servile e poi quello nella condizione di liberto del genitore siano stati una specie di apprendistato familiare alla cittadinanza romana; perciò anche il figlio dell’ex schiavo trace o siriaco o altro ancora poteva affermare con orgoglio: «civis romanus sum». Ne abbiamo conferma a Pompei ove un’iscrizione (titulus) sull’architrave all’ingresso del tempio di Iside ci informa che «N. Popidius N. f. Celsinus Aedem Isidis terrae motu conlapsam a fundamento p(ecunia) s(ua) restituit. Hunc decuriones ob liberalitatem, cum esset annorum sexs, ordini suo gratis adlegerunt» («Numerio Popidio Celsino, figlio di Numerio, ricostruì interamente, a sue spese, il tempio di Iside abbattuto dal terremoto. Per questa sua munificenza i decurioni, benché avesse solo sei anni, lo accolsero gratis nel loro ordine»). Il padre di questo piccolo benefattore si chiamava Numerio Popidio Ampliato, era un liberto, già schiavo della gens Popidia, eminente famiglia pompeiana, che, come tale, non poteva aspirare a cariche pubbliche, ma che per quelle preparava la strada al figlio. Quest’iscrizione si riferisce ad un tempo successivo al terremoto che devastò la città nell’anno 63 d.C.: non sappiamo di quanto successivo, se di mesi o di anni, né se il piccolo Popidio Celsino abbia fatto in tempo ad occupare effettivamente la sua carica di decurione prima dell’eruzione del 79 che distrusse definitivamente Pompei. Un certo legame tra l’ex schiavo ed il padrone permaneva nel fatto che colui che era affrancato da un cittadino romano accedeva automaticamente alla cittadinanza, mentre quello che fosse stato affrancato da un peregrinus, cioè da un suddito libero, che però non godeva della cittadinanza, si veniva a trovare nella stessa posizione dell’ex padrone e diveniva peregrinus anche lui. Forse anche in questa norma s’intravede quell’idea di ‘apprendistato’ ipotizzata in precedenza. Viceversa, la condizione dello schiavo liberato in Grecia era più articolata e soprattutto più dura: basta rileggere le Leggi di Platone, ove si prospetta l’idea che si possano rimettere le catene al liberto che sia venuto meno a qualcuno dei suoi doveri nei confronti dell’ex padrone, ma anche che per contrarre matrimonio dovrà fare quanto quello stabilirà per lui e perfino che non gli sarà lecito arricchirsi più di chi l’ha liberato; in tal caso la differenza sarebbe andata a vantaggio di colui che era stato, ed in parte continuava ad essere, il suo padrone. Per di più il liberto non potrà rimanere nella pólis per più di venti anni. La conclusione di quelle norme è che se qualcuno fosse risultato colpevole della violazione di una di esse doveva essere condannato a morte ed i suoi beni confiscati a vantaggio dell’erario. Normalmente il liberto greco aveva ben poche possibilità di ottenere la cittadinanza, alcune eccezioni come quelle dei banchieri Formione e Pasione debbono considerarsi come assolute rarità. Sembra che, a differenza di quanto accadeva a Roma, la preoccupazione di evitare ogni commistione della cittadinanza con elementi estranei ad essa sia stata prevalente su ogni altra considerazione. Una legge della seconda metà del V secolo a.C., forse voluta da Pericle, stabiliva che potevano essere cittadini d’Atene solo coloro che fossero stati figli di genitori entrambi ateniesi. Per questo motivo gli schiavi, normalmente non ateniesi, non avrebbero mai potuto aspirare alla cittadinanza. A Roma la cerimonia di affrancamento (manumissio) di uno schiavo avveniva sostanzialmente in due modi: la manumissio vindicta (lett. con la verga) era la forma solenne: nel corso del rito il padrone o altra persona da lui designata toccava con una verga l’uomo da affrancare, proclamandolo libero; la manumissio per testamentum o per litteram avveniva allorché la liberazione dello schiavo faceva parte delle disposizioni testamentarie lasciate dal padrone o in conseguenza di una lettera con cui questi manifestava chiaramente la volontà di affrancare il servo. A partire dal III sec. d.C. (ma forse già da prima), si trova attestata una terza pratica, la manumissio per mensam, consistente nell’invito che il padrone rivolgeva allo schiavo a prendere posto alla sua mensa rendendolo perciò suo pari1. - 35 - SALTERNUM Fig. 1 - Osca (Spagna). Iscrizione col decreto di Emilio Paolo a favore degli schiavi della città. Quale fosse l’atteggiamento mentale dei Romani nei confronti dello schiavo affrancato lo si può arguire da un papiro della collezione di Ossirinco (Poxy IV, 706) risalente al 115 d.C. Vi si parla di un contenzioso fra un certo Heracleides ed un suo ex schiavo Damarion. Dai nomi si arguisce che doveva trattarsi di elementi entrambi di origine greca. Il primo accusava il secondo di avergli negato alcune prestazioni. Il convenuto non negava il fatto, ma asseriva che non era tenuto a quanto gli era richiesto in virtù del documento scritto di affrancazione, che esibiva al prefetto dell’Egitto M. Rutilius Lupus incaricato di giudicare il caso. Questi non tenne conto alcuno della prova, pure così evidente, apparendogli forse assurdo che un liberto non avesse più alcun dovere nei confronti dell’ex padrone, espresse quindi un giudizio di condanna2. Va anche osservato che molto difficilmente tanto in Grecia, quanto a Roma gli schiavi erano della stessa nazionalità dei padroni. Ad Atene vigeva un’antica legge - risalente a Solone, arconte in un anno compreso fra il 594 ed il 591 secondo le notizie forniteci da Diogene Laerzio e da Aristotele – in forza della quale era vietato ridurre qualcuno in schiavitù per debiti3. A Roma, con la sola eccezione dei condannati per alcuni reati e dei debitori insolventi, la maggior parte della popolazione servile proveniva da territori considerati barbari o comunque non romani. Tuttavia anche qui con la lex Poetelia Papiria del 326 a.C. fu di fatto abolita la possibilità di ridurre in schiavitù il debitore insolvente. Fu una conquista civile di notevole importanza. Noteremo anche che Platone (La Repubblica) ed Aristotele (La Politica) erano giunti a teorizzare che alcune popolazioni erano naturalmente destinate alla schiavitù. Per Aristotele era tra l’altro la robustezza fisica dello schiavo a destinarlo ‘geneticamente’ al lavoro servile. La quasi totalità della forza lavoro a Roma era costituita da manodopera servile. Questo almeno a partire dalla fine del III sec. a.C. quando l’espansione politica della città, prima nella penisola e poi nel bacino del Mediterraneo, aveva modificato profondamente l’assetto economico dell’agricoltura. I piccoli e medi proprietari furono sottratti al lavoro dei campi e costretti in armi per periodi sempre più lunghi. La conseguenza fu il passaggio di mano delle terre agricole dai coltivatori diretti, che avevano dovuto abbandonare i poderi, al grande latifondo dei patrizi, accresciuto spesso anche dall’occupazione di ager publicus (oggi diremmo di terreni demaniali) tenuto a coltura o a pascolo con l’impiego sempre più esteso di schiavi che affluivano sui mercati in quantità crescenti e conseguentemente a prezzi più accessibili, come diretto ‘prodotto’ delle guerre. A Roma, ma ancora di più in Grecia, era diffusa l’attività di alcuni imprenditori che possedevano un certo numero di schiavi da dare in affitto a chi ne avesse bisogno per periodi di tempo limitati o per lavori occasionali o stagionali e trarne quindi un reddito. Sappiamo da Senofonte (Sulle entrate 4,14) che Nicia, il generale e politico ateniese morto nel 413 a.C. a Siracusa durante la disastrosa spedizione avvenuta nel corso della guerra detta ‘del Peloponneso’, aveva dato in affitto mille schiavi, al prezzo di un obolo giornaliero ciascuno, ad un proprietario di miniere d’argento, con l’impegno da parte dell’affittuario di rimpiazzare a sue spese quelli che fossero venuti a mancare. Una clausola che è di per sé rivelatrice delle condizioni lavorative cui erano sottoposti quegli infelici. Queste considerazioni ci portano ad un primo interrogativo: come si diventava schiavi. I prigionieri di guerra rappresentavano certamente un numero molto rilevante del totale, ma c’erano anche altri modi. Già nei poemi omerici si parla - 36 - PIETRO CRIVELLI di servi come Euriclea, la nutrice di Odysseo, o Eumeo, il porcaro, entrambi di origine ragguardevole, rapiti dai pirati quando erano bambini e venduti come schiavi. Le scorrerie piratesche erano dunque, per importanza, il secondo canale di approvvigionamento. A queste due fonti si debbono aggiungere, in quantità non sappiamo quanto minore, coloro che erano ridotti in schiavitù per altre cause, come i debitori insolventi, i figli venduti, abbandonati o non riconosciuti dai padri, i condannati a pene che comportavano la perdita della libertà personale; in qualche caso accadeva che degli agricoltori che, per debiti, avevano perduto il podere, di propria iniziativa vendessero se stessi come schiavi, magari per coltivare lo stesso terreno che era prima di loro proprietà. Perdevano la libertà ma si assicuravano la sopravvivenza. Ma c’erano anche coloro che nascevano schiavi perché figli di genitori schiavi essi stessi, non importava se entrambi o solo uno. A mano a mano che si avanzava nel tempo, si affinavano i gusti e quelli che una volta erano considerati dei lussi divenivano esigenze di normale amministrazione e di conseguenza cresceva la richiesta di personale servile specializzato: se prima bastava disporre di braccia da far lavorare, ora la domanda diventava più differenziata e i prezzi di mercato aumentavano soprattutto quando si trattava di elementi con doti particolari, destinati a servire da coppieri, cuochi, camerieri, portatori di lettighe (lecticarii), ma anche come medici, architetti o grammatici. Questi ultimi erano prevalentemente di origine o cultura greca. Plinio il Vecchio (Nat. Hist. VII, 128) ci riferisce che un grammatico fu pagato ben 700 mila sesterzi, una somma sbalorditiva se si pensa che normalmente a quei tempi il prezzo di uno schiavo che non avesse doti particolari si aggirava sui 2500. Il commercio degli schiavi era sorvegliato dagli aediles, i magistrati che avevano l’incarico di prendersi cura dei templi innanzi tutto, ma anche delle vie cittadine, dell’ordine pubblico, degli spettacoli, della polizia urbana e della vigilanza sui mercati. I mercanti, non diversamente da quelli che trattavano il bestiame, erano abili a nascondere i difetti della loro merce ed a farla apparire migliore di quanto fosse realmente. Il mercato si teneva in genere nel Foro, ove i venditori esibivano la mercanzia umana su un palco in modo che tutti potessero vederla e ne decantavano i pregi. Ma nella città esistevano pure altri posti in cui si svolgeva il commercio degli articoli di lusso e qui si potevano acquistare servi di maggior pregio dei due sessi, da destinare a funzioni di rappresentanza o ad appagare i piaceri dei padroni. Ma il gran commercio degli schiavi avveniva in particolare proprio in Grecia, a Delo e, in misura leggermente minore, ad Atene ove, Fig. 2 - Aphrodisias (Turchia). Statuetta in marmo nero di giovane schiavo. - 37 - SALTERNUM secondo quanto ci riferisce il geografo e storico Strabone, ai suoi tempi, cioè in età augustea, giornalmente si acquistavano e si vendevano migliaia di uomini. La tecnologia moderna ci fornisce i mezzi per rendere la vita più facile e soprattutto meno faticosa, ma duemila anni prima del nostro tempo la situazione era completamente differente e coloro che volevano e potevano avere un’esistenza agiata sottraendosi alle esigenze quotidiane dei lavori di casa, di quelli agricoli e di tutte le altre necessità erano costretti a ricorrere all’opera dei servi. In questo contesto sociale quanti ne possedevano solo uno o due erano classificati tra i poveri, mentre il poter ostentare una numerosa servitù costituiva una rappresentazione sociale di sé a quella proporzionata. Il poeta Orazio (Sat. I.6, v. 78) ricordando la cura che il padre, liberto, aveva messo nella sua educazione, afferma che se qualcuno avesse posto attenzione al numero dei servi che lo seguivano quando andava a scuola lo avrebbe creduto appartenente ad un ceto sociale notevolmente superiore a quello di cui faceva parte. La sua condizione di figlio di un liberto, evidentemente benestante, non gli aveva impedito di prestare il servizio militare con il grado di Tribunus militum nell’esercito di Marco Bruto a Filippi, di godere dell’amicizia di Mecenate e d’Augusto e di potersi permettere di opporre un rifiuto a quest’ultimo quando gli chiese di fargli da segretario particolare, senza che la cosa gli creasse alcun problema. Alcune fonti storiche (quali Ateneo II-III sec. d.C., l’autore de I Dipnosofisti ovvero I Sofisti a banchetto, VI, 272) ci riferiscono che molti Romani possedevano da 10 mila a 20 mila schiavi. Naturalmente solo in minima parte erano impiegati nel servizio domestico del padrone e dei familiari; si trattava di grandi proprietari terrieri che destinavano quella moltitudine alla coltivazione delle loro terre in Italia ed in Sicilia ed a tutte quelle attività accessorie che rendevano le grandi villae rusticae autosufficienti per quanto riguardava l’approvvigionamento di attrezzi da lavoro, di carri, di contenitori fittili e d’altro tipo o di mattoni; perciò in quelle trovavano impiego, oltre alla massa dei lavoratori agricoli veri e pro- pri, anche fabbri, falegnami, muratori, calderari, ceramisti, calzolai, tessitori ed ancora il personale amministrativo, i sovrintendenti, i sorveglianti, i guardiani perché la condizione servile non escludeva una gerarchia. Era anzi proprio questa gerarchia a creare per coloro che erano ai livelli inferiori le condizioni di vita più dure, perché i preposti, per ben figurare di fronte ai padroni, imponevano ai dipendenti ritmi e carichi di lavoro sempre più gravosi anche ricorrendo a mezzi coercitivi particolarmente violenti. Negli ergastula annessi alle villae rusticae gli schiavi erano tenuti rinchiusi per evitare possibili fughe, talvolta incatenati quando vi era ragione di temere che ciò potesse accadere. Plinio il Vecchio definisce questa categoria ‘uomini senza speranza’. In compenso spesso erano ben nutriti, sia perché fossero nelle condizioni fisiche più idonee per lavorare proficuamente, sia perché il nutrimento era a portata di mano. Frequentemente in queste fattorie esisteva anche una specie d’infermeria (valetudinarium), ove erano curati gli schiavi ammalati. Talvolta era presente anche un medico, spesso schiavo anche lui. Si dava così anche il giusto peso alla salute e all’igiene personale dei servi, in qualche caso mettendo a loro disposizione dei bagni (balnea), ove potessero lavarsi e anche ritemprarsi dalle fatiche. Il tutto in una visione dell’ottenimento della massima produttività. Una situazione molto peggiore era quella degli schiavi utilizzati nelle miniere: al trattamento disumano si aggiungeva l’ambiente di lavoro duro già di per sé. Se solo pensiamo che allora l’unica fonte di illuminazione artificiale era fornita da torce e lucerne è facile immaginare quale aria dovevano respirare coloro che lavoravano in miniera. Non per nulla era un lavoro al quale erano destinati, oltre gli schiavi, i condannati per delitti molto gravi. La damnatio ad metalla era una pena inferiore, forse, solo a quella di morte, la damnatio capitis. Diodoro Siculo (Bibliotheca historica V, 36-8) narra che in Spagna, nel corso dell’ultimo periodo repubblicano, gli schiavi lavoravano nelle miniere in condizioni tremende, fino a morire. Chiaramente le condizioni degli appartenenti alla familia urbana erano molto migliori: - 38 - PIETRO CRIVELLI l’aspetto dello schiavo contribuiva a dare prestigio al padrone, pertanto, soprattutto a partire dalla tarda età repubblicana, erano vestiti non di vecchi stracci, come suggeriva una volta Catone al figlio, ma con abiti più dignitosi, talvolta sfarzosi ed erano nutriti in modo adeguato. Naturalmente esistevano condizioni molto differenti in ragione delle possibilità economiche dei padroni e della loro maggiore o minore generosità o avarizia. Nell’insieme quelli che vivevano nella stessa casa del padrone erano dei privilegiati che potevano anche sperare in un futuro meno brutto di quello che avevano avanti a sé gli appartenenti alle familiae rusticae. Se questi nella migliore delle ipotesi avevano la speranza di salire solo qualche gradino nella scala gerarchica servile, gli altri potevano augurarsi anche la libertà, la manumissio. Anche per questo il trasferimento dalla casa cittadina alla campagna era da considerare un provvedimento fortemente punitivo. E’ quanto minaccia Orazio ad un suo servo eccessivamente chiacchierone: «...se non sparisci subito andrai come nono lavoratore agricolo in Sabina», («…ocyus hinc te ni rapis, accedes opera agro nona Sabino», Sat. II, 7, vv. 117-118). Le commedie di Plauto ci presentano tipi di servi furbacchioni, imbroglioni, pronti a tutto a danno del padrone, soprattutto se è un avaro, spesso in accordo con il figlio di questo. Facendo salve le esigenze della comicità teatrale, si deve però pensare che dei comportamenti piuttosto ‘liberi’ di alcuni elementi della servitù non dovessero essere del tutto insoliti. Sono prevalentemente i servi della familia urbana quelli che vanno ad ingrossare le fila dei liberti, mentre al contrario le grandi rivolte di schiavi traggono origine da coloro che erano impiegati in agricoltura od in altre attività gravose. Nel 136 a.C., in Sicilia, uno schiavo d’origine siriaca, Euno, capeggiò una rivolta che in poco tempo divenne una vera e propria guerra. In breve gli insorti raggiunsero il numero complessivo di 200 mila, anche se non tutti combattenti, e divennero padroni di tutta la Sicilia, massacrarono le popolazioni di alcune città, sconfissero un esercito romano e la lotta si protrasse per circa quattro anni. Alla fine, la ribellione fu sof- focata nel sangue, anche se, stranamente, i Romani non infierirono eccessivamente, limitandosi per lo più a restituire gli schiavi catturati ai proprietari, che altrimenti avrebbero subito un ulteriore danno patrimoniale; anzi Euno morì in cattività, ma di morte naturale. Ma la rabbia rimase e un’altra sommossa, anche se di minore portata, avvenne nuovamente dal 104 al 101 a.C. Più pericolosa delle precedenti fu la ribellione guidata da Spartaco, che si spinse a minacciare la stessa Roma. Iniziò verso la metà del 73 a.C. per opera di uno schiavo originario della Tracia, un valido guerriero, che aveva militato nelle legioni ausiliarie romane e che forse in precedenza era già stato un comandante di truppe nel suo paese d’origine; passato a servire nelle truppe ausiliarie romane, era poi finito, chissà come e perché, in schiavitù. Spartaco, proprio per la sua abilità nell’uso delle armi, era stato destinato a fare il gladiatore e condotto nella scuola di Capua; ribellatosi, fu a capo di una sollevazione che si estese a buona parte dell’Italia meridionale. I rivoltosi formarono un esercito ben armato a spese dei Romani stessi, che, ripetutamente colti di sorpresa, erano stati battuti dal Trace, il quale aveva mostrato capacità tattiche non comuni. I consoli eletti per l’anno 72 a.C. si dimostrarono inferiori alle attese e assolutamente incapaci di opporsi adeguatamente ai rivoltosi che ormai avevano raggiunto il numero di 40 mila combattenti, più o meno l’equivalente di sette legioni romane, e sicuramente, a differenza dei rivoltosi di sessanta anni prima, annoveravano fra di loro un numero considerevole di soldati che erano stati fatti prigionieri nel corso delle recenti campagne di Mario, Silla e Pompeo e perciò addestrati all’uso delle armi. Spartaco marciò verso il nord Italia nell’intento di raggiungere le Alpi e di lì dare la possibilità ai ribelli di raggiungere i loro paesi d’origine. Giunse fino a Modena, ma l’odio che i suoi uomini nutrivano contro Roma era così forte e ben radicato che pretesero di essere condotti ad espugnarla. Nella circostanza egli dimostrò le doti di un vero capo, intuì subito che in quel modo non si sarebbe ottenuto nulla di buono, ma, non potendo opporsi del tutto alla volontà - 39 - SALTERNUM dei suoi, li guidò in Lucania seguendo la costa adriatica. Il Senato finalmente comprese che il male era tale da richiedere una cura energica ed affidò la direzione della guerra, ricordata come bellum servile, ad un veterano dell’esercito di Silla: M. Licinio Crasso, il futuro triumviro, che si era già distinto nella guerra civile. Questi, con pugno di ferro, ripristinò la disciplina nelle legioni e quindi avanzò verso il nemico, che frattanto si era ritirato nel Bruzio (attuale Calabria) con l’intento di passare in Sicilia e da lì in Africa, e tentò di bloccarlo costruendo una fortificazione che dal mar Tirreno raggiungeva lo Ionio. Ancora una volta il suo avversario riuscì a sgattaiolare fuori dalla trappola per raggiungere nuovamente la Lucania e l’Apulia. Ma ora Crasso gli era addosso ed in due battaglie consecutive distrusse l’esercito dei ribelli (71 a.C.). Spartaco cadde combattendo, gli schiavi sopravvissuti furono crocifissi lungo la via Appia fino alle porte di Roma, come monito per coloro che fossero stati tentati di ripetere le stesse gesta. E’ importante osservare che nella circostanza la sollevazione prese corpo tra i gladiatori e gli schiavi delle campagne, mentre fu del tutto insignificante il numero degli insorti e dei fuggitivi fra gli schiavi di città: ciò dimostra ancora una volta quanto fossero differenti le condizioni di vita tra le due categorie servili. Dobbiamo considerare indicativo il fatto che in Grecia non si siano riscontrate rivolte come quelle citate, che hanno creato non poche preoccupazioni a Roma; probabilmente ciò potrebbe confermare quanto già detto: che gli schiavi di sesso maschile non erano molto numerosi e che nel complesso le condizioni di vita a cui erano assoggettati non dovevano essere particolarmente dure. Abbiamo fin qui esaminato gli aspetti più brutti dell’esistenza degli schiavi, ma c’erano anche aspetti meno negativi, riconducibili ad un insieme di fattori. Innanzi tutto non bisogna trascurare il fatto che gli schiavi avevano un costo che, come abbiamo visto, poteva essere anche molto elevato e ciò spingeva di per sé i proprietari ad avere cura di un bene di valore. Certamente il gramaticus che era costato una cifra rilevante era trattato con ogni cura e sicuramente aveva a sua volta altri servi a disposizione per le necessità quotidiane (questi servi dei servi erano chiamati vicarii): il prezzo pagato era la migliore assicurazione e senza dubbio un suo semplice malanno normalmente trascurabile provocava al padrone una sensazione dolorosa, se non all’animo certamente alla tasca. Il valore intrinseco del servo, per funzioni o per bellezza non importa, costituiva la misura delle sue migliori o peggiori condizioni di vita. In fondo un cavallo da corsa, soprattutto se è un campione, gode di un trattamento ben diverso da quello che è destinato a tirare il carretto del fruttivendolo. E la posizione giuridica del servo è analoga a quella degli animali. Nella legislazione di molte città greche una stessa legge prende in considerazione tanto gli animali domestici quanto gli schiavi. Catone il Censore (234-148 a.C.) nel suo trattato De Agricultura (56-59) parla delle razioni alimentari destinate ai servi quasi contestualmente all’alimentazione dei buoi. L’accostamento non è casuale perché effettivamente servi e buoi erano considerati sullo stesso piano: semplice forza lavoro. Domizio Ulpiano - illustre giurista romano, prefetto del pretorio sotto Alessandro Severo e morto assassinato nel 228 d.C. - autore di molte opere di dottrina giuridica, considera la fuga degli schiavi equivalente alla perdita di bestiame. Prima di lui Gaio, altro giurista romano del II sec. d.C. autore di un’opera giunta a noi molto lacunosa con il titolo di Institutiones, divide tutti gli uomini in due categorie fondamentali: liberi e schiavi ed i primi in ingenui e liberti, a seconda che fossero nati liberi o fossero stati liberati dalla schiavitù (1; 9-11). Anche coloro che erano stati destinati a combattere come gladiatori potevano sperare di salvare la pelle, magari con qualche cicatrice. Sembra che di solito quando un gladiatore avesse conseguito almeno dieci vittorie in combattimenti nell’arena venisse liberato, intascando anche un discreto gruzzolo. D’altra parte non dovevano passarsela proprio male se anche molti uomini liberi si arruolavano spontaneamente per combattere nei giochi del circo, i circenses. - 40 - PIETRO CRIVELLI I proprietari delle colonie di gladiatori investivano cifre molto alte per addestrare e mantenere convenientemente i loro combattenti ed erano restii a perderli con facilità; per questo motivo, con molta frequenza, intercorrevano degli accordi con gli organizzatori dei giochi perché le perdite umane fossero ridotte al minimo. Sappiamo che nell’anno 59 d.C., nel corso di uno spettacolo gladiatorio offerto dal senatore Livineio Regolo, scoppiò a Pompei una colossale zuffa tra Nocerini e Pompeiani, a causa della quale ci furono anche dei morti. Per conseguenza Nerone decise la ‘squalifica’ dell’anfiteatro cittadino per dieci anni. Sembra che i disordini siano stati causati da motivi politici, ignoriamo però se all’origine delle violenze popolari e come causa scatenante delle stesse non ci sia stato anche qualche accordo del tipo citato che abbia fatto inferocire gli spettatori e provocato la loro reazione. Molti gladiatori, come avviene oggi per i calciatori, quando giungevano al termine dell’attività nel circo, diventavano istruttori (lanistae) delle nuove leve destinate a sostituirli nell’arena. Questi erano considerati persone che esercitavano un mestiere spregevole, alla stessa stregua dei lenoni e anche degli attori, ma la riprovazione non si estendeva agli impresari. Tutte queste attività erano perciò affidate a schiavi od a liberti. Forse la maggioranza di coloro che morivano nei circhi era, in realtà, rappresentata dai condannati a morte mandati a combattere senza alcun addestramento preliminare e perciò destinati a soccombere di fronte ad avversari più agguerriti. Aumentando il numero degli schiavi cresceva di conseguenza quello degli affrancati, cioè dei liberti. Il passaggio dalla categoria servile a quella dei liberti poteva avvenire in vari modi. Per benevolenza del padrone, è il caso per esempio di Tirone, segretario di Cicerone, inventore di un sistema di scrittura abbreviata, una specie di stenografia, le notae tironianae. Fra i due si era stabilito un rapporto d’amicizia ed affetto e Tirone che, pur di salute cagionevole, sopravvisse di molti anni al suo ex padrone, curò anche la pubblicazione di molte opere ciceroniane, tra cui l’orazione In Verrem. Ma lo schiavo aveva anche la possibilità di raggranellare un po’ di denaro, il cosiddetto peculium, con cui acquistare la propria libertà. Naturalmente anche in questo caso occorreva che vi fosse un atteggiamento non negativo da parte del padrone, il quale, volendo, avrebbe potuto semplicemente appropriarsi della somma, in quanto il servo, soprattutto ai tempi della Repubblica, non aveva diritti. C’era però un aspetto particolare che riguardava gli schiavi che esercitavano un’attività artigianale o professionale: il peculium con la prospettiva della libertà rappresentava un potente stimolo a lavorare di più e meglio e ciò andava a vantaggio anche del padrone, che partecipava agli utili del lavoro del suo servo. Un’altra spinta verso la concessione della libertà agli schiavi era data dal fatto che ai patrizi era fatto divieto di svolgere attività commerciali. La legge romana prevedeva che a questa categoria superiore di cittadini fosse consentito solo il reddito derivante dal possesso della terra. Forse era un modo di vincolare al territorio le persone e renderle perciò più sollecite verso la patria comune; d’altra parte non si deve dimenticare che in origine il popolo romano era un popolo di agricoltori che, anche successivamente e soprattutto nelle classi più elevate, ha conservato un legame profondo con il mondo agricolo: nomi come Agricola, Cornelio, Asinio, Porcio sono una prova di questa connessione. Fatto sta che si trovò il modo di aggirare la legge affidando la gestione degli affari commerciali ad uomini liberi, ma che conservavano pur sempre un legame con gli antichi padroni, e che, a differenza dei servi, erano abilitati ad agire a proprio nome. Molti liberti così raggiunsero condizioni economiche invidiabili e il loro stato giuridico li collocò in una posizione analoga a quella degli altri cittadini già a partire dal periodo delle guerre sannitiche: infatti nel 306 a.C. la legge voluta da Fabio Rulliano li integrò come cittadini, disponendo la loro iscrizione nelle quattro tribù urbane. Con il passare del tempo la loro importanza nella città andò progressivamente accrescendosi, per raggiungere sotto l’impero un rilievo sempre maggiore. L’imperatore Claudio fece di alcuni suoi liberti (ricordiamo Narciso e Pallante) una specie di - 41 - SALTERNUM ministri imperiali e allo stesso modo si regolarono altri imperatori; vero è che la loro fortuna era strettamente legata a quella del loro patrono ed in quei tempi non era facile che gli imperatori finissero di morte naturale. I due liberti di Claudio ora citati fecero una brutta fine per mano di Nerone. Si salvò invece un altro liberto di Claudio, Elio, che anzi fu nelle grazie di Nerone al punto che durante il viaggio di questi in Grecia ebbe l’incarico di reggere l’impero in sua vece. Con la seconda guerra punica si assistette ad un fenomeno che deve far pensare che in fondo la condizione servile in quel periodo non doveva essere particolarmente dura, perché, lungi dall’approfittare della circostanza che vedeva Roma in condizioni di gravi difficoltà, schiavi e liberti si mantennero fedeli come se fossero tutti Romani a pieno titolo, meritando di essere premiati con una legge plebiscitaria del 189 a.C. che stabilì che i figli dei liberti godessero di tutti i diritti civili al pari degli altri cittadini. Tito Livio (Hist. XXII 57) riferisce che dopo la sconfitta di Canne furono riscattati a spese dell’erario ottomila schiavi che si dichiararono disposti ad arruolarsi nell’esercito. A Roma, così come in Grecia, i non liberi erano esclusi dalla milizia. Continuando nell’esame delle condizioni di vita e giuridiche degli schiavi, è interessante osservare un caso in cui Cicerone fu avvocato di un tale Quinto Roscio. Questi era una specie d’impresario teatrale, forse un liberto, che aveva curato la preparazione all’attività scenica di uno schiavo di proprietà di un certo Fannio. Tra Roscio e Fannio si era creata una società per lo sfruttamento delle capacità teatrali dell’uomo, con una ripartizione degli utili. Un brutto giorno però lo schiavo fu ucciso. Ne seguì un contenzioso, prima con l’uccisore e poi fra i due ex soci, per la divisione del risarcimento. In tutto il dibattimento si parla di soldi, di danni subiti dall’uno o dall’altro contendente, ma del povero schiavo se ne parla come ora si parlerebbe di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale. Con l’andare dei tempi si venne attenuando il potere assoluto del pater familias nei confronti di tutti gli appartenenti alla sua casa, la familia appunto, che comprendeva anche la servitù. La politica di Augusto introdusse gradatamente una maggiore liberalità nei rapporti fra padroni e schiavi ed un più incisivo intervento dello stato. In proposito si deve porre attenzione ad un senatusconsultum del 9 d.C., noto come Silanianum dal nome del proponente, che prevedeva la condanna a morte dello schiavo che si fosse astenuto dal soccorrere il padrone qualora questi fosse stato aggredito. La portata giuridica del provvedimento era rafforzata dal fatto che il testamento di un dominus, morto per morte violenta, non doveva essere aperto se prima non fosse stata conclusa l’inchiesta sul decesso del testante e non fossero state eseguite le eventuali sentenze di condanna. Questo nel timore che gli eredi, da un lato potessero essersi accordati con gli schiavi per accelerare l’iter successorio e da un altro potessero essere indotti a salvare i servi, anche se colpevoli, al fine di non depauperare il patrimonio. L’attenzione degli imperatori ebbe anche dei risvolti più umanitari per il trattamento degli schiavi, come la libertà accordata ope legis a coloro che fossero stati abbandonati dai proprietari perché malati o troppo vecchi per lavorare: questi rappresentavano per i loro padroni un peso inutile e l’imperatore Claudio (41-54 d.C.) dovette addirittura emanare un provvedimento di proibizione di ucciderli. Ciò significa che in precedenza era una pratica non insolita. Circa un secolo dopo fu l’imperatore Adriano (117-138) a vietare, sempre ed in ogni caso, l’uccisione degli schiavi. Infine Costantino (312-337) equiparò l’uccisione di uno schiavo all’omicidio di un libero. Contemporaneamente a queste misure umanitarie ne furono adottate anche altre repressive, per cui se uno schiavo uccideva il suo dominus dovevano essere messi a morte tutti gli altri servi della familia presenti nel luogo ove era avvenuto il delitto (Nerone aveva così riesumato e reso più dura la legge risalente al periodo augusteo): evidentemente la norma era intesa a proteggere i padroni, punendo la corresponsabilità o anche la sola indifferenza. Tuttavia la norma non dovette essere sufficiente, perché Traiano (98117), che pure era uomo equilibrato, la estese fino a comprendervi i liberti. Poiché le leggi nascono, si formano e si sviluppano in relazio- - 42 - PIETRO CRIVELLI ne a quanto accade nella società, si deve pensare che il criterio che ispirò Traiano sia nato dal fatto che anche dei liberti si fossero macchiati o resi complici di quel delitto o per sottrarsi ai residui doveri che avevano nei confronti degli ex padroni oppure per qualche altro motivo. E’ pur vero che molto spesso i liberti erano crudeli e viziosi tanto più quanto più erano divenuti ricchi. Ci è giunta memoria di un tale Vedio Pollione, un liberto, che gettava gli schiavi da punire nelle vasche ove si allevavano le murene (Seneca, De Clem. I, 18, 2). Il fatto non doveva essere nella consuetudine, altrimenti Seneca non lo avrebbe ricordato, ma sicuramente manifestazioni di crudeltà si dovevano registrare con una certa frequenza e che spesso gli autori fossero degli ex schiavi si può spiegare con il desiderio, certamente riprovevole, ma in fondo miserevolmente umano, di rivalersi, non importa come e su chi, delle mortificazioni precedentemente subite. Era tuttavia naturale che tra i liberti fossero abbondantemente presenti anche personaggi poco gradevoli, ricchi sì di denaro, ma anche di volgarità e di pessimo gusto. Petronio, il raffinato arbiter elegantiarum, ci ha lasciato il divertente ritratto di Trimalcione, uno di questi buzzurri arricchiti, dal comportamento ridicolmente disgustoso. Fortunatamente non sempre le cose erano così brutte: Tacito (Hist. I, 3 ed Ann. XV, 57) ci fornisce notizie ed esempi, come quello famoso di Epicharis, in cui schiavi e liberti sopportarono le più atroci torture per difendere i padroni accusati di aver preso parte alla congiura di Pisone contro Nerone. Per comprendere meglio la vita degli schiavi a Roma nel I sec. d.C. è interessante rileggere le lettere a Lucilio di Seneca, in particolare la 47, che, mentre consiglia mitezza e tolleranza nei confronti della servitù, ci illumina anche su un aspetto particolare del problema, quello dell’inversione dei ruoli; dice il filosofo: «Quanti di questi schiavi hanno alle loro dipendenze i padroni di un tempo! Vidi stare in attesa davanti alla porta di Callisto il suo antico padrone e lui che gli aveva fatto appendere al collo il cartello di vendita e che l’aveva esposto al pubblico fra i rifiuti degli schiavi ora veniva lasciato fuori mentre gli altri entravano». Come era potuto accadere ciò? Forse il padrone in difficoltà economiche era stato costretto a vendere gli schiavi fino a ridursi in miseria, mentre Callisto otteneva la libertà dal nuovo padrone, che sappiamo essere stato l’imperatore Caligola. Certo è che Callisto fu un altro liberto che ebbe poi importanti incarichi sotto Claudio e ciò gli diede la possibilità di vendicarsi. Sembra che Seneca, fino a quando rimase nelle grazie di Nerone, sia stato il capofila di quanti sostenevano il diritto dei servi ad un trattamento umano, in contrasto con un atteggiamento di chiusura del senato. Non sappiamo poi come il filosofo si comportasse nel privato: come si sa, era un personaggio piuttosto contraddittorio. Un altro aspetto della condizione servile era quello che consentiva allo schiavo di scegliersi una compagna tra le schiave di casa, una conserva e di vivere con lei come se fossero sposati. Questa convivenza, che si chiamava contubernium, non era riconosciuta giuridicamente ma, in fondo, era quasi sempre ben vista dai proprietari, che con la nascita di figli vedevano accresciuto il loro patrimonio. Era certamente questa una grande consolazione per chi fosse costretto a vivere nella condizione servile. Una piccola stele funeraria di marmo di età augustea recita: «NEBULLUS MARTHAE CONSERVAE – Fleui, Martha, tuos extremo tempore casus ossaque composui. Pignus amoris habes». «NEBULLO A MARTA, COMPAGNA NELLA SCHIAVITÙ. Piansi o Marta, i dolorosi eventi dei tuoi ultimi momenti e composi le tue ossa. Ricevi questo pegno d’amore», poche commoventi parole che valgono più di un poema. Nell’età imperiale si ebbe un’ulteriore protezione per i conviventi, con il divieto di venderli separatamente. Uno dei problemi che si poneva a tutti, liberi, liberti o servi che fossero, era quello di avere alla morte un funerale decente. A parte i ricchi, per i quali la questione non esisteva, chi non poteva assicurarsi esequie dignitose quando era in vita era destinato a finire gettato in una fossa comune. Per evitare questa squallida conclusione della propria esistenza si formarono dei col- - 43 - SALTERNUM passo per raggiungere la libertà. Non erano perciò solo i liberti che raggiungevano posizioni economiche invidiabili: molti schiavi utilizzavano il loro peculium investendolo in attività che potevano accrescerlo, anche acquistando in proprio altri schiavi. Abbiamo accennato ai vicarii: il rapporto giuridico intercorrente fra questi e lo schiavo-padrone era identico a quello esistente fra quello ed il dominus. Sesto Pomponio, Fig. 3 - Hadrumentum (Tunisia). Particolare di un mosaico con la messa in scena di una commedia, forse di giurista del II secolo, autoPlauto, con uno schiavo incatenato. re di un compendio di storia del diritto romano, cita legia funeraticia, cioè delle confraternite che il caso di uno schiavo che praticava il lenocinio avevano lo scopo di assicurare delle onoranze facendo prostituire delle schiave acquistate col funebri quanto meno passabili ai propri soci, i suo peculio. Il diritto consolidato dell’epoca prequali pagavano al sodalizio una certa somma vedeva che i vicarii fossero proprietà dello mensile o annuale a questo fine. A tali associaschiavo e non del loro padrone. zioni di tenuiores, vale a dire di persone piuttoUn vecchio studio, basato sull’esame di molte sto povere, molto spesso partecipavano anche epigrafi funerarie4 arrivò a stabilire che gli artidegli schiavi, naturalmente con il consenso dei giani a Roma erano così suddivisi: 27% liberi, loro padroni. Anche in questo caso si deve regi66,75% liberti e 6,25% schiavi. Nel resto strare una diversità tra coloro che vivevano in dell’Italia le percentuali diventavano rispettivacittà e quelli delle villae rusticae i quali, oltre ad mente 46,25% – 52% – 1,75%. Come si può avere incontri sporadici con i padroni, difficilvedere, la presenza dei liberti era preponderanmente potevano venire a contatto con quelle te, ma è lecito pensare che questi svolgessero la associazioni che erano prevalentemente cittadistessa attività anche quando non erano liberi. ne. In ogni modo ci sono pervenute molte epiD’altra parte la statistica prende in esame comgrafi funerarie di schiavi - come quella di cui plessivamente le epigrafi che ci sono pervenute sopra - e naturalmente ancora più di liberti. e non quelle – sarebbe stato pressoché impossiTra gli schiavi esisteva una minoranza, esigua bile – relative ad un determinato momento stoma non trascurabile, che poteva dirsi benestanrico, per cui l’attendibilità e l’utilità del calcolo te. Erano coloro che per conto dei padroni svoldivengono praticamente irrilevanti, anche pergevano lavori artigianali o comunque professioché non è possibile sapere quanti non abbiano nali; lo schiavo architetto, o medico o fabbro avuto una sepoltura corredata da una lapide e che fosse, metteva certamente la sua professioquante epigrafi siano andate perdute. nalità a disposizione del padrone, ma anche di La condizione servile non escludeva del altri, dividendo con quello i guadagni, in una tutto dalla vita pubblica; nelle città romane il sorta di società in accomandita ed il peculium quartiere aveva una sua rilevanza politica e così formato poteva accrescersi fino a raggiunreligiosa: quella politica si esplicava nel sostegere una cifra di un certo rilievo. Era il primo gno anche robusto che gli abitanti accordavano - 44 - PIETRO CRIVELLI ai candidati alle cariche pubbliche, quella religiosa nel culto dei Lares compitales, le divinità che proteggevano il quartiere ed i suoi abitanti. Entrambe queste funzioni si esercitavano attraverso i Collegia compitalicia (il compitum era il quadrivio) che erano guidati dai magistri vici et compiti, detti anche vicomagistri, e questa funzione era affidata a personaggi che potevano essere di condizione libertina o anche servile. Non solo, altri sacerdozi minori erano aperti agli schiavi: alcune iscrizioni rinvenute a Pompei (Corpus Inscriptionum Latinarum, X, 888 - 890) testimoniano, ad esempio, l’esistenza anche in quella città del collegio sacerdotale detto degli Augustales, che curava il culto del genius dell’imperatore Augusto, fra i componenti del quale erano compresi degli schiavi alla pari degli altri sacerdoti. E’ chiaro che il commercio d’uomini poteva produrre un profitto notevole; meno noto, ma importante, è che da alcune di queste transazioni commerciali, sia pure fittizie, si potevano trarre vantaggi d’altro genere. Come ormai tutti sanno, il capo di un casato, di una familia, era il paterfamilias, l’autorità del quale non era mai in discussione: si poteva perdere solo per morte o per la privazione dei diritti civili. Pure, in certe circostanze era importante che un figlio potesse acquisire una piena libertà: in tal caso l’unico mezzo legale disponibile era l’emancipatio; tuttavia quest’istituto appare solo in un secondo tempo, come derivazione laboriosa di una norma contenuta nella legge delle XII Tavole: «si pater filium ter venum duit, filius a patre libero esto». In pratica, se il padre vendeva per tre volte il figlio, questo otteneva la piena libertà. Accadeva perciò che chi intendesse emancipare un figlio lo vendeva in modo simulato ad un amico accondiscendente, il quale subito dopo lo liberava, facendolo tornare così nuovamente sotto l’autorità paterna; la vendita era poi ripetuta per altre due volte, in modo che il figlio potesse acquistare la piena libertà e divenire così il paterfamilias di un nuovo casato che poteva allearsi a quello originario nella vita pubblica o in eventuali speculazioni d’altro genere. Lo studio del fenomeno servile a Roma ci fornisce dunque molte notizie interessanti sulla vita Fig. 4 - Schiavi al lavoro in una cava di marmo. Rilievo scultoreo. Fig. 5 - Uno schiavo porta un piatto con del cibo. Frammento di rilievo da un monumento funerario. - 45 - SALTERNUM Fig. 7 - Collare in bronzo per schiavi. Fig. 6 - Statuetta in bronzo di giovane schiavo di colore, copia romana di un originale di età ellenistica. dell’epoca, un periodo di oltre mille anni nel corso del quale, tra progressi e ripensamenti, il problema posto dalla schiavitù, perché di un problema si tratta, ha tentato di trovare una soluzione che tuttavia era impossibile trovare in nessun altro modo che non fosse la sua semplice e completa abolizione. Ma l’economia di quei tempi era quasi del tutto fondata sul lavoro servile: ne conseguiva che la sua soppressione avrebbe portato inevitabilmente al collasso le città e gli stati e ciò anche prescindendo dall’egoismo delle classi dominanti. La quasi totalità degli artigiani dell’epoca era di condizione servile, mentre i liberi delle classi più povere erano per la maggior parte nullafacenti che campavano a carico dello Stato, mercé la distribuzione gratuita di vettovaglie (frumentationes). Liberare gli schiavi e contemporaneamente ricondurre la massa oziosa dei cittadini ad un’attività produttiva era un’impresa superiore alle forze di qualunque governante, pericolosa per il politico e per la stessa res publica: per questo motivo le cose dovevano necessariamente restare com’erano, in attesa di tempi migliori. Lo stesso Seneca che, come abbiamo visto, predicava moderazione e magnanimità nei confronti degli schiavi, non sarà neppure sfiorato dall’idea che la schiavitù potesse essere un abominio di per sé. Il sistema schiavistico nondimeno diverrà col tempo una delle cause della decadenza economica dell’Impero Romano. Arrestandosi l’espansione su nuovi territori in seguito alla progressiva diminuzione delle guerre di conquista e riducendosi l’Impero su posizioni di difesa, cesserà anche quel flusso di manodopera servile che in precedenza aveva favorito lo sviluppo dello Stato. Conseguentemente si registrerà una contrazione della parte attiva della popolazione, non compensata da un ceto di lavoratori liberi che era praticamente inesistente; i liberi disdegnavano d’impegnarsi in lavori manuali, tanto più che la loro impreparazione tecnica li avrebbe costretti facilmente ad operare alle dipendenze di maestri di condizione servile. Con queste premesse il declino economico era assolutamente inevitabile. Bisognerà attendere il tardo Medioevo perché si possa affermare che in Europa, ma solo in Europa, la schiavitù era (quasi) scomparsa. - 46 - PIETRO CRIVELLI Resisterà ancora per effetto delle razzie e degli atti di pirateria compiuti sia da parte cristiana sia araba in tutto il bacino del Mediterraneo, nonché sotto l’aspetto dei servi dominici - persone semilibere che erano nei fatti del tutto asservite, che operavano nelle corti dei signori, NOTE 1 Se l’autore del Satyricon è il Petronio arbiter elegantiarum vissuto al tempo di Nerone (qualcuno ne dubita), si deve ritenere che già verso la metà del I secolo d.C. la pratica della manumissio per mensam fosse affermata, dal momento che si trova descritta nel corso della cena che Trimalcione offre ai suoi ospiti; ma è anche possibile che l’Autore abbia voluto solo presentarci un aspetto ridicolo nel comportamento dell’anfitrione. 2 PIATTELLI D. 1990, Tradizioni giuridiche d’Israele, Torino, p. 34. laici o ecclesiastici che fossero - anche nei paesi di cultura germanica, donde ci viene la parola ‘schiavo’ (‘sclavus’), indicante in origine (X – XI sec.) i prigionieri di guerra d’etnia slava assoggettati e commercializzati dai vincitori. In realtà la legge di Solone interveniva più sulle cause che sugli effetti, nel senso che vietava che si potessero contrarre debiti offrendo come garanzia la propria persona fisica (epì tois sòmasin). In tal modo l’ipotetico creditore poteva rivalersi solo sui beni del debitore ed in conseguenza era costretto ad erogare il prestito unicamente sulla valutazione di quelli. Nello stesso tempo quella legge aboliva o almeno riduceva una parte dei debiti (chreòn apocopé). 4 BRUNT P. A. 1989, Il lavoro umano, in Il Mondo di Roma Imperiale, a cura di J. WACHER, vol. III, p. 199. 3 - 47 - MARCO AMBROGI L’anfiteatro atinate. Lineamenti storici, epigrafici e topografici di un monumento sepolto dell’antica Atina colta dei dati significativi e caratterizzanti dell’antico monumento, alla luce di un’ipotetica indagine di rilevamento stratigrafico da aerofoto, che ne accerterebbe la posizione reale. «Fra gli altri monumenti Atinati sta anche l’Anfiteatro, ammesso dalla maggior parte degli Archeologi… E di vero, una grandiosa città come si era la nostra, guerriera sotto gli antichi dominatori, non poteva essere privata di quel pubblico luogo, dove si esercitavano gli spettacoli ed i ludi punici… Noi avremmo desiderato, e ne feci rimostranza al Municipio, che, per monumento antico del paese, lo si fosse lasciato intatto e tal quale trovavasi scavato, ma, la necessità della strada, ne lo impedì, e si dovè colmare, però senza guastarne le mura, che peraltro non arrivavano al suolo»1. I l narratore del passo riportato è Giovan Battista Curto, storico ed archeologo di Atena Lucana, che nel 1892 ebbe modo di osservare direttamente i notevoli resti dell’anfiteatro romano dell’antica Atina. In un periodo storico in cui le necessità di pubblico servizio innegabilmente prevalevano sugli interessi culturali, la riscoperta dell’anfiteatro di Atina non seguì l’epilogo sperato dallo storico atenese, che però ebbe a parlarne estesamente nel suo lavoro sulla propria città natale dall’età classica al periodo moderno. In virtù di quest’unica testimonianza archeologica all’interno della storia antica del Vallo di Diano, la ricerca si presenta attraente ed interessante, per via delle derivazioni di carattere ricognitivo e di riscoperta di un luogo scomparso ormai da tempo. La ricerca qui presentata2 si articola su tre punti essenziali e significativi, intercomunicanti e strettamente connessi: l’analisi delle fonti storiche, la ricostruzione metrica ed architettonica dei ruderi osservati dal Curto ed il posizionamento dell’anfiteatro all’interno del tessuto antico ed attuale di Atena Lucana. Pertanto questo studio riguarda la rac- Le fonti storiche L’anfiteatro atinate, oltre a presentarsi come un’architettura monumentale antica all’interno di Atena Lucana, nelle memorie storico-archeologiche viene ricordato da vari studiosi, che a più riprese si occuparono delle vicende in età classica di Atina. La prima analisi di questo scritto, relativa alle note cronologiche sull’anfiteatro, si rivolge alle fonti bibliografiche che hanno citato o descritto il monumento. Spesso la non attenta lettura analitica e storica dell’edificio da parte di alcuni eruditi ha fatto sì che l’identificazione dell’anfiteatro non apparisse certa e definita, confondendolo più volte con il teatro romano, che pure ha lasciato traccia nel tessuto urbano della cittadina. Tra le prime fonti autorevoli, Costantino Gatta ci offre una sintesi descrittiva, di certo attinta da autori precedenti, ma particolarmente valida per l’attendibilità storica dello studioso: - 49 - «Il dilei territorio [Sala Consilina], che per miglia otto s’estende, da occidente confina con Atena, di cui come celebre luogo ne fa Plinio onorata memoria, e ben si può credere essere stati ne’ gli antichi tempi prodi e generosi li dilei popoli, per scernersi ivi, ancora al presente ne’ sobborghi di detta Terra le reliquie di magnifico anfiteatro d’opera laterizia, come altresì perchè vi si veggono scolpite in marmi memorie di famiglie illustri dell’ordine patrizio, e vi s’osservano innumerabili vestigie di caduta grandezza»3. SALTERNUM Fig. 1 - Atena Lucana, veduta da Oriente; sulla sinistra l’area dell’anfiteatro (Borgo). quasi tutto l’Ottocento) coincidevano con gli ultimi palazzotti e le abitazioni rurali del Borgo. Sulla scorta dell’erudito salese, il barone Giuseppe Antonimi, pur non confermando la presenza della struttura ludica di età romana, riporta nel suo scritto l’esistenza dell’iscrizione che fa riferimento all’anfiteatro4 e di cui meglio si parla in seguito. Nell’Ottocento la fortuna degli studi sulle antichità classiche portò numerosi studiosi ed eruditi più o meno noti a soffermarsi, anche se brevemente, sull’anfiteatro di Atena; uno di questi fu il Romanelli5, che offrì la seguente versione: Fig. 2 - Atena Lucana dall’alto (da Google Earth). Il Gatta, a cui hanno attinto anche altri studiosi successivamente, rimane una fonte certa, perché residente nel paese contiguo di Sala, con evidente conoscenza diretta della cittadina atenese. L’osservazione delle vestigia, in questo caso, denota un riferimento alquanto puntuale per la localizzazione dell’anfiteatro: i sobborghi della cittadina, che ai tempi dello storico (come per - 50 - «Tutto il suo recinto presenta tuttavia gli avanzi delle mura, da cui veniva circondato, e nel sito del così detto Borgo restano pur oggi gli avanzi del suo anfiteatro…»6 Ed in seguito riprese il Giustiniani: «Ella [Atena] fu antica città dei Lucani, e di qualche grandezza, e distinzione, come attestano i ruderi di molte speciose fabbriche, che vi MARCO AMBROGI erano ne’ vecchi tempi, e specialmente quelli, che credonsi i fondamenti del suo anfiteatro di figura ovale»7. Giunone Petilia, come rilevasi dalle lapidi, con iscrizioni ivi scoperte, ed un teatro od anfiteatro, i cui ruderi veggonsi ancora oggidì vicino alla Croce al Borgo.”12 L’Albi-Rosa, erudito locale frequentemente ripreso negli studi riferiti al Vallo di Diano quale voce attendibile dell’ambito geografico, ampliò la citazione con i riferimenti epigrafici: «Tutti i geografi dell’antichità ne han fatto chiara menzione, parlando pure dei suoi Templi, dell’anfiteatro, delle feste, dei giuochi, e del conio numismatico… Divenuto Atena Romano Municipio essendovi una lapide rinvenuta sui ruderi dell’anfiteatro vicino alla casa De Marino, che mostra un segno di devozione al genio del Municipio Atenate…»8. Ancora sul cadere del secolo13 e prima dei rilievi del Curto, un altro erudito lucano, Michele Lacava, si soffermò sulla storia di Atena in antichità: «Di edifizii pubblici, le iscrizioni non parlano; ma naturalmente la città, dovè avere teatri ed anfiteatri, il foro, le terme, e pubblici condotti di acqua»14. Il Corcia nel suo studio sul Regno delle Due Sicilie non mancò di riportare un breve passo sull’antico monumento: In realtà il Lacava appare ricognitore d’antichità più intenzionato a smentire le leggendarie origini dell’antico nome di Atena che a rilevarne attentamente le vestigia; in questo caso commette l’errore di confondere ancora una volta la presenza del teatro con l’anfiteatro. Infatti in un passo del suo scritto riporta: «…si può supporre nondimeno che fosse allora [Atina] in qualche splendore, perché senza attribuirle la palestra, non è dubbio ch’ebbe un anfiteatro, ed è noto non solo da’ ruderi che ne rimangono con quelli della città nel piano sotto l’odierna terra di Atena, nel sinistro lato della Valle di Diano, ma anche da questa mutila epigrafe…»9. La vicenda della diretta osservazione delle vestigia dell’anfiteatro non poteva sfuggire allo storico teggianese Stefano Macchiaroli, pur se egli nel resoconto su Atena si riferisce espressamente al teatro, e non all’anfiteatro: Fig. 3 - Atena Lucana con lo sfondo del Vallo di Diano. «Ove giace attualmente Atena, vi era probabilmente un teatro della prisca Atina, la quale, a quel che pare, era sita nel piano a piè del monte, dove la tradizione popolare la vuole, e dove, i ruderi, e gli oggetti antichi che si sono scavati e si disseppelliscono tuttora, ne rendono indubitata testimonianza”10. È probabile che il Macchiaroli abbia attinto all’Eterni, che pure parlò, anche se in modo confuso, di teatro romano11. Incertezza ripresa da un dizionario storico di fine Ottocento: “In quei tempi [Atena] ebbe monete proprie e contava molti pregiati edifizii, fra i quali primeggiavano un superbo tempio dedicato a Fig. 4 - Atena Lucana, veduta aerea del Largo Borgo-Braida (da Google Earth). - 51 - SALTERNUM zione di pubblici spettacoli, che si facevano in quegli antichi tempi: che ciò sia vero, non solo si rileva da pochi segni, che pur ora, vi si veggono, ma ancora giova qui riportare una iscrizione trovata in un marmo, che tra gl’altri molti va disperso ne’ poderi Atenesi»18. Fig. 5 - La Braida di Atena Lucana, sulla sin. l’area dell’anfiteatro. Non vi è dubbio che la memoria a noi più vicina, e probabilmente la più autentica nella puntuale descrizione, sia quella del Curto. Egli nella cronaca sulle scoperte di Atena antica riserva particolare attenzione all’anfiteatro, segno che la ricognizione diretta delle strutture superstiti fu accompagnata da un ipotetico rilievo metrico e descrittivo: «Vestigia di antichi edifizii – Un edifizio, possibilmente teatro, dovè esistere nell’area che si distende dall’angolo orientale della casa Marino, ad andare verso la cappella di S. Giuseppe Murano. Con grande probabilità vi fu un anfiteatro, ove è l’attuale piazza Vittorio Emmanuele, scoverto con lo scavo delle fondazioni della casa Caporale, nel 1866»15. Pur volendo ammettere che le strutture successivamente osservate dal Curto fossero di un teatro, anziché di un anfiteatro, resterebbe da esaminare l’ipotesi di un’ulteriore struttura ludica (in questo caso dell’anfiteatro) in un’area prossima (la piazza Vittorio Emanuele) al Largo BorgoBraida; però nessun altro studioso ne fa menzione. Le ipotesi di un ritrovamento archeologico nel tracciare le fondazioni della casa Caporale riportano, secondo il Curto, ad un tempio pagano dedicato a Giove16. Si presenta qui una chiara discordanza tra quanto asserito dai due maggiori studiosi di Atina: mentre il Lacava annota il rinvenimento dell’anfiteatro a seguito dello scavo di fondazione della casa Caporale nel 1866, il Curto invece narra che nello stesso anno il sito su cui insisteva la croce su colonna (il Largo Borgo-Braida) posta sui resti dell’anfiteatro, fu ‘appianato’ dal maggiore Pessolani. La nota discordante sui due edifici dell’antica Atina riportata dal Lacava appare ancora più evidente dai passi stampati nell’ultima parte del suo volume, che citano le memorie antiche di Atena Lucana, tra cui l’anfiteatro. Da un antico manoscritto17, di cui l’autore non fornisce dettagli precisi della collocazione archivistica, si rileva che: “Oltre a che, ultimamente, nel 1892, dovette il Municipio attuare la strada Borgo-Braida, e, nello scavamento uscì per intero a luce l’Anfiteatro, consistendo in due paralleli semicircolari muraglioni, per otto metri l’uno distante dall’altro, racchiudenti un’area capiente per migliaia di persone, e della spessezza ognuno oltre a due metri; il primo alto circa 40 palmi, ed intorno tutto finestroni alla metà dell’altura di esso, da cui, mediante grossi gradoni, si discendeva nell’area; ed il secondo di minore spessezza, era costruito tutto ad archi fino al suolo, sotto i quali corrispondevano i gradoni, che partivano dai finestroni del primo muro. Insomma l’anfiteatro occupava l’intera piana largura o piazzale che ora si trova innanzi al palazzo Marino e tira fino alla Cappella di S. Giuseppe ed alle case Mango; e la sua area o suolo era costruita a selciato di ben connesse e regolate pietre, da sembrare ordinario mosaico.”19. Lo studioso atenese porse le sue rimostranze al Municipio locale per la conservazione del monumento, ma la sua richiesta non ebbe seguito; il Curto annota successivamente dei preziosi riferimenti di carattere storico, congruenti con l’attuale toponomastica: «Ove oggi dicesi il Borgo, eravi un nobile e sontuoso anfiteatro, che serviva per la celebra- - 52 - «Forse all’epoca in cui, cioè nel medio Evo, l’Anfiteatro non agiva più, era stato rovistato, per cui niente più si vedeva conservato, di fossetti, colonnato ed altro. Proprio dove corrispondeva il centro dell’area, nei primi secoli del cristianesimo, per un’antichissima Bolla Pontificia, riportata dalla MARCO AMBROGI Storia Ecclesiastica del Corbacher e da noi riscontrata, l’allora antico Municipio vi eresse sopra tre circolari e grandi gradoni di pietra, una colonna a croce di finissimo marmo, bene architettata e così connessa da sfidare i secoli, a base della quale grandissima croce, l’effigie di Atteone con l’iscrizione: Ego sum Acteon ecc., allora favoloso emblema Municipale. Imperocchè la Bolla prescriveva che, dovunque fossero stati anfiteatri, si avesse dovuto impiantare la Croce; ed in Atena, a cominciare dall’anno 500 circa dell’Era volgare, vi rimase fino al 1866, quando venne tolta, e fatto appianare quel sito, sotto il Sindacato del Maggiore Giuseppemaria Pessolani, uno dei mille di Marsala. Sicchè, a conchiudere, abbiamo la dimostrazione indubbia, avere avuto anche l’Anfiteatro l’antica nostra Atina»20. Un punto fermo sul quale si è generato il dubbio tra gli scrittori antichi se si fosse trattato di teatro o anfiteatro, si traspone nella reale presenza degli edifici entrambi collocati all’interno della forma urbis di Atina in epoca romana. A tal proposito viene in ausilio all’argomento nuovamente il Curto: Fig. 6 - Atena Lucana, lo stemma di Atteone con il tronco di colonna marmorea. «Evvi chi vi ammettè il solo Anfiteatro, chi l’uno e l’altro, cioè Teatro e Anfiteatro; e non poteva mancare in una tanto grandiosa città come Atina»21. Circa un decennio dopo la stampa del volume di Giovan Battista Curto, il Giliberti, attento descrittore delle antichità del Vallo di Diano, confermò quanto detto dal primo erudito: «Fra gli altri monumenti Atena ebbe anche l’anfiteatro, ammesso da quasi tutti gli archeologi ed una iscrizione lapidaria, venuta a luce, ne fa fede. Ed infatti, una città grandiosa e guerriera non poteva essere priva di un luogo dove si esercitavano i ludi gladiatorii. Nel 1882 riattando il Municipio la strada Borgo, che conduce alla Braida, nello scavare uscirono interamente a luce i ruderi dell’anfiteatro, consistenti in due muraglioni semicircolari paralleli, racchiudenti un’area capiente per migliaia di persone»22. Fig. 7 - Atena Lucana, Largo Garibaldi ove è collocato lo stemma di Atteone, con tronco di colonna marmorea. In realtà il Giliberti non fa che ripetere testualmente ed in forma abbreviata quanto asserito dal Curto, ma pur se di testimonianza secondaria trattasi, val la pena ricordare che la dovizia di ricerca del Giliberti porta conferma alle tesi del Curto, che allo stato attuale risultano le più accreditate e veritiere. Ciò al fine di dare sostegno all’ipotesi che di anfiteatro si debba parlare più che di teatro, ciò stante la confusione dell’esistenza nel medesimo punto topografico dell’u- - 53 - SALTERNUM un’analisi approfondita, sono risultate false. Il Curto nella parte terza del suo studio su Atena antica24, traduce i versi di una dedica ad un gladiatore: «CAFFIUS BIS CONF ENSE POMPONII HIC STAT ALBA UXOR T.F.F. (Caffio due volte trafitto/ Dalla spada di Pomponio/ Qui riposa/ Sua moglie Alba mise l’urna). Fig. 8 - Atena Lucana, Largo Borgo-Braida (disegno dell’Autore). A sin. la cappella del Purgatorio. na o dell’altra struttura, entrambe di carattere teatrale. L’eco delle note di Curto, ma certamente più dello scavo di fine Ottocento effettuato nel Borgo, contribuì alla diffusione tra gli storici dell’epoca della ripresa d’interesse attenta ed analitica sulle antichità atenesi, dopo alcuni decenni d’abbandono. Il Racioppi nella sua opera sulla Lucania antica, a proposito dell’anfiteatro, riporta le seguenti parole: «Ivi [Atena Lucana] sono ancora le reliquie di antiche costruzioni, tra cui si riconoscono le vestigia d’un anfiteatro»23. A conclusione del breve sunto sulle testimonianze storiche del Sette-Ottocento, possiamo affermare con certezza che l’anfiteatro ad Atena ci fosse. Queste basi di carattere storiografico pongono ancor di più l’attenzione su un importante monumento e sulla reale consistenza dei suoi ruderi. Fonti epigrafiche false Lo studio di un’antica architettura non può prescindere dall’analisi delle fonti epigrafiche, siano esse attendibili o meno. Nel caso delle iscrizioni atenesi, si assiste ad un ampio e ricco repertorio (tra l’altro molto variegato ed assortito sulla tipologia e sul significato delle stesse) di epigrafi celebrative, funerarie e dedicatorie, tra cui due si possono riferire all’anfiteatro. Ma, pur essendo riportate da più eruditi (antichi e moderni) ed epigrafisti, le fonti incise su pietra, ad - 54 - Note storiche. Questa epigrafe può dirsi storica e mortuaria, perché ricorda un defunto a causa dei giuochi gladiatori nell’Anfiteatro Atinate. Caffio e Pomponio erano due servi della patria, per cui fatti discendere all’arena nell’Anfiteatro, a spettacolo d’una principale solennità di quell’Atinate popolo. Quale sia stata questa festa solenne non risulta; ma era costume degli antichi popoli, in festevoli occasioni, il certame nel circo, fra gli altri barbari divertimenti. Pomponio fu il vittorioso, e, in premio, n’ebbe la manomissione. Caffio fu lo sconfitto, e morto per doppio ferimento di spada, e la moglie Alba innalzogli l’epigrafe e la tomba, vicino all’Anfiteatro. L’epoca dell’avvenimento risale all’incremento dei Lucani, e precede i primi due secoli di Roma. Quest’epigrafe è riportata da Antonini, Albirosa, Gatta ed altri, sebbene il Mommsen la reputasse apocrifa, senz’addurne la ragione. Stava fabbricata nel muro esterno della Taverna del Principe in sull’abitato, dove noi, insieme all’archeologo Pecori di Salerno, la leggemmo, pria che il tremuoto del 1857 facesse cadere la Taverna, e ridurre la detta epigrafe in frantumi»25. Un’altra iscrizione del seguente tenore: LVCIVS X . L . MILES R P . HONORIB . GEN MVN . SVB AMPHITEA - - - - R.F.P.P MARCO AMBROGI anch’essa falsa, secondo gli studi del Bracco26, fu ascritta al corpus atinate, insieme alla prima, da altri studiosi dell’antichità, tra i quali l’Antonini (che osservava a suo tempo entrambe le epigrafi sui muri delle case dei signori Deliunettis, successivamente Cicchetti)27. L’appartenenza alle dediche celebrative non attendibili28 non inficia il discorso sulla presenza stessa dell’anfiteatro di Atena Lucana29, pur se la probabilità (per rimanere in ambito di incertezza rispetto alle recenti acquisizioni di falsità delle epigrafi) che queste fossero state architettate ad hoc dal primo studioso che le analizzò, sembra alquanto sostenibile. In un’epoca in cui il senso di appartenenza alle proprie radici e il persistente attaccamento al municipalismo influenzava decisamente gli scritti degli autori locali, rimarcare la storia e l’esistenza di monumenti di età classica della propria cittadina serviva quasi ad offrire vigore all’amor patrio. Di certo non possiamo affermare con esattezza che le iscrizioni siano del tutto false (non essendo visibili e non potendo accertare l’assoluta fedeltà di chi le ha studiate). Deduzioni ed ipotesi ricostruttiva L’anfiteatro di Atena, come gli altri edifici di questo genere, era destinato a duelli tra gladiatori e a venationes, cioè alla cattura di animali feroci con relativo combattimento tra uomini e bestie. I giochi, ad Atina, con molta probabilità venivano organizzati in occasione di funerali (i cosiddetti munera) con cerimonie celebrate per rendere onore alla memoria dei defunti. In seguito divennero lo spettacolo preferito dai Romani con l’usanza diffusa da parte di cittadini ricchi e desiderosi di onori di assumersi molte delle spese occorrenti agli spettacoli altrimenti spettanti alle città; di conseguenza il favore del pubblico fece dei giochi gladiatori uno strumento di propaganda politico-elettorale per la classe dirigente. In un territorio ove l’occupazione militare romana non era stata ben vista dagli indigeni (si pensi alla massiccia utilizzazione della centuriazione per l’intero territorio del Vallo di Diano), il divertimento ludico del teatro e dell’anfiteatro fu un pretesto per i cittadini romani trapiantati in loco per attirarsi la simpatia della gente locale. Figg. 9 - 10 - 11 - Fasi costruttive di un anfiteatro romano (disegni dell’Autore). Un elemento alquanto usuale che caratterizza i maggiori monumenti antichi di Atina, tra cui l’anfiteatro, è la presenza della pietra quale materiale da costruzione, in un’area (il Vallo di Diano e la Lucania) ove i reperti di epoca romana riconducono il più delle volte all’utilizzo massiccio della stessa, sia per le opere pubbliche che per le abitazioni rurali e cittadine. Non abbiamo però riferimenti certi circa le componenti dell’ossatura strutturale del monumento, se fosse costituita da laterizi (dei quali pure parla il Curto a - 55 - SALTERNUM Fig. 12 - L’anfiteatro di Grumentum (disegno dell’Autore). Fig. 13 - Atena Lucana, la cappella di San Giuseppe al Borgo. proposito di altri monumenti dell’antica Atina), oppure da opus caementicium, con il quale si presenta invece il corpo centrale del Mausoleo di Caio Utiano Rufo a Polla, unica struttura di età romana di una certa mole tuttora visibile nell’area valligiana. Per simili tipologie di anfiteatro in area campano-lucana si assiste ad un proliferare dell’uso dell’opus reticulatum e dell’opus latericium con cui erano strutturate le ossature portanti dei monumenti pubblici e privati. L’anfiteatro dell’antica Capua è costituito da un’arena circondata da tre ordini di fasce di mattoni rivestiti di marmo e travertino, che testimonia il doppio utilizzo di materiali: meno nobili per le strutture, di elevato pregio (marmorei o di travertino) invece per i paramenti. Per quanto riguarda l’anfiteatro di Venosa, sappiamo che fu costruito (come per la maggior parte di questi edifici) in zona periferica rispetto all’abitato, per permettervi un maggior flusso dei materiali edilizi da costruzione e per facilitare l’accesso degli spettatori provenienti dalle zone rurali. Le strutture primarie dell’edificio sono state realizzate in opus reticulatum con utilizzo di cubilia dai 6 agli 8 cm, ciò soprattutto nelle sostruzioni del primo anello; le strutture murarie di un probabile restauro del monumento sono invece eseguite in diverse tecniche edilizie, tra cui prevale l’utilizzo del laterizio e di pietre calcaree irregolari con faccia più o meno lisciata messa di taglio30. Analoga situazione si rileva a Grumentum, con l’utilizzo consistente dell’opus reticulatum. Quanto all’individuazione topografica dell’anfiteatro nella parte periferica della città, ancora una volta la somiglianza con Grumentum appare evidente; qui, per la costruzione, venne scelta l’estremità a Nord-Est dell’impianto urbano, sia per sfruttare il dislivello esistente tra le terrazze morfologiche del sito, sia per facilitare l’afflusso e il deflusso degli spettatori, senza intralciare la circolazione all’interno della città31. Ad Atena Lucana invece il sito dell’anfiteatro è posto a Sud-Est rispetto al nucleo abitato indigeno, nel vasto pianoro su cui si ampliò la primitiva cittadina in età romana. In quest’area ed in quelle prossime si addensano infatti sia i ritrovamenti che le descrizioni storiche sulla presenza di numerosi edifici pubblici e privati, dalle terme ai templi e alle dimore aristocratiche. Se le fonti storiche dei secoli XVIII e XIX costituiscono una valida base per analizzare la presenza a vista dell’anfiteatro, dalla sua costruzione ai lavori della metà Ottocento, la descrizione del Curto rimane l’unica ‘voce’ a cui poter attenersi al fine di ricostruire l’aspetto, la struttura e le dimensioni dell’anfiteatro atinate. I due paralleli muraglioni semicircolari osservati dall’erudito atenese dovrebbero coincidere con le strutture portanti dell’anfiteatro stesso e la misura in altezza del primo (il più esterno quasi certamente) pari a circa 40 palmi, ossia intorno ai dieci metri32, lascia supporre che le sostruzioni del monumento riconducano ad un’architettura di età classica ben conservata, pur sepolta per metà della sua area sotto le attuali abitazioni. Se così fosse, l’anfiteatro di Atina costituirebbe uno dei reperti meglio conservati della Lucania antica e del territorio a Sud di Salerno. Un termine di paragone, sul quale ‘testare’ le misure dell’anfi- - 56 - MARCO AMBROGI teatro atinate per verificarne l’attendibilità, si ritrova ancora una volta nel monumento di Grumentum; è evidente il parallelismo non solo per la vicinanza delle due città romane, ma anche per la verosimile medesima importanza che le stesse ricoprivano all’interno della Lucania classica. Oserei dire, stessa importanza politicoeconomica, stessa tipologia di edifici, per cui se il primo assunto (ai quali gli storici hanno già dato affermativa risposta) fosse vero, ne scaturirebbe la validità del secondo. Un’analisi attenta dell’anfiteatro di Grumentum secondo i parametri metrici e costruttivi trova corrispondenza nelle misure rilevate dal Curto; infatti la distanza tra i due muri ossia quello esterno (largo proprio due metri circa e provvisto di contrafforti) e l’altro interno che sorregge il corridoio anulare (di minore spessore) è di otto metri e gli stessi muraglioni sono strutturati ad arcature, secondo la tipologia riservata a tali strutture. In effetti i due muri osservati dal Curto si identificavano con le sostruzioni della cavea, di cui lo stesso ha potuto vedere i grossi gradoni che scendevano nell’area e i finestroni. Si faccia attenzione però che le parole dello studioso atenese contengono comunque delle incertezze descrittive, rilevabili ad esempio dalla confusione sulla misura del secondo muro (vicino al corridoio anulare), che in prima analisi accomuna al primo nella profondità e poi specifica esser di minore spessore. Incerta appare la definizione dell’area costruita a selciato, anche se l’ipotesi più probabile è che si tratti dell’arena, la cui tessitura pavimentale poteva dare l’effetto del mosaico, se vista da lontano (di contro le gradinate potevano essere in blocchi di pietra o al limite in opus caementicium). Una simile supposizione trova conferma nell’anfiteatro nocerino, ove uno degli ambulacri presenta il piano di calpestio in opus signinum ossia in un impasto di cubetti minuscoli di marmo e pietre con l’utilizzo di pozzolana e sabbia. Analizzando la struttura dell’anfiteatro di Grumentum risalta il rispetto dei canoni classici dell’architettura assegnati a questa tipologia con i quattro ingressi principali, dei quali due riservati alle autorità e gli altri varcati dalle persone più ragguardevoli; i restanti accessi (diagonali) erano utilizzati dalla plebe. In questa disposizione si rende evidente come gli ingressi, nel processo cronologico di disfacimento della struttura attraverso i secoli, siano le parti più labili ed esposte al crollo; tale riferimento potrebbe confermare l’ipotesi, più avanti esposta, che le differenze di quota intorno all’ellisse dell’anfiteatro di Atena corrispondano esattamente a queste parti dell’antica architettura. L’anfiteatro grumentino si è strutturato in origine in una forma che solo in apparenza è ellittica: in realtà è la risultante di una successione di spezzate ad angoli ottusi33. È da notare infine, che pur presentandosi simile ai grandi anfiteatri di età imperiale, l’impianto si compone di un’arena priva di ambienti ipogei, mentre la stessa è circoscritta da un corridoio anulare ricoperto da una pseudo-volta a pseudobotte. La sua struttura portante è caratterizzata inoltre da due sistemi costruttivi diversi, con gradinate che appoggiano direttamente sui vani di sostruzione34. Dagli ingressi principali accedevano all’arena i gladiatori, ossia dai vani posti sull’asse maggiore oppure dal corridoio anulare interno; i percorsi per il pubblico erano distinti in accessi alle gradinate e al podio, a cui si perveniva dalle scalinate a due rampe disposte a raggiera lungo l’anello ellittico35. La mancanza delle complesse strutture di sostruzioni, utilizzate come ambienti di servizio o per la custodia degli animali (tipiche di anfiteatri quali Pozzuoli, Capua o lo stesso Colosseo), rimanda ad un periodo anteriore allo sviluppo massiccio di questo tipo di costruzioni (in modo simile all’anfiteatro di Nola). Le evidenti somiglianze tecnicocostruttive tra gli anfiteatri di Grumentum ed Atina fanno supporre un identico ambito cronologico. L’erronea confusione con il teatro Pur se i riferimenti descrittivi ed eruditi riconducono per maggior voce alla presenza di un anfiteatro e non di un teatro nell’area del Largo Borgo-Braida, per dovere d’esattezza bisogna spendere qualche riga sulla confusione generatasi nel tempo tra la presenza dell’uno o dell’altro monumento36. Una distinzione precisa può essere elaborata alla luce di due fattori di carattere architettonico e topografico: innanzi tutto la struttura portante di un teatro differisce, anche se - 57 - SALTERNUM non vistosamente, da quella di un anfiteatro. Infatti, in quest’ultimo i setti portanti radiali sono intervallati da murature ortogonali con un passo maggiore di quegli otto metri rivelati dal Curto. L’altro elemento che smentisce l’ipotesi che si tratti di un teatro viene dalla situazione altimetrica dell’area Borgo-Braida, che si presenta con un pianoro alla medesima quota, di forma ovoidale. La presenza di un teatro avrebbe definito un’area di colmatura a semicerchio, ove l’interruzione della stessa sarebbe stata ascrivibile alla presenza della scena; tale colmatura a semicerchio in effetti non è rinvenibile nell’altimetria e nelle tracce visibili dall’alto del sito di Largo BorgoBraida. Infine, se di teatro si fosse trattato, il Curto ne avrebbe almeno visto parte della terminazione rettilinea della scena, dato che il suo testo narra di un monumento emerso durante lo scavo «per intero a luce». Su questa ultima nota è evidente la dissonanza dal reale intendimento dell’erudito atinate; infatti il monumento non poteva di certo essere visto per intero in un’area limitata come la piazzetta antistante il palazzo Marino; in questo caso la descrizione del Curto allude al visibile accertamento di una struttura di anfiteatro, con il rinvenimento di differenti parti delle gradinate in due punti distinti ed opposti della via, ossia sul sagrato della cappella di San Giuseppe e davanti alle case dei Mango. In ogni caso l’incontrovertibile ‘narrazione’ di Giovan Battista Curto segna un passo notevole nella riscoperta dell’antico monumento di Atina. La ‘Croce al Borgo’: un indizio prezioso Un termine di riferimento da non scartare nello studio dell’anfiteatro atinate è la presenza dell’antica croce astile una tempo infissa nel terreno al centro del Largo antistante palazzo Marino. Del riferimento della croce su colonna abbiamo due testimonianze particolari: l’una di carattere toponomastico, riferita alla presenza della ‘Via Stretta della Croce’, che si diparte in direzione sud-est dal Largo Borgo e che segna inequivocabilmente l’antica presenza in loco di un ‘segnacolo’ religioso; l’altra di carattere monumentale, con l’attuale collocazione in Largo Garibaldi di uno rilievo rappresentante Atteone, risalente al XVIII secolo, sormontato da un tron- co di colonna in marmo di Carrara. Nella descrizione dei lavori operati sotto l’amministrazione di Giuseppe Maria Pessolani37, e riportata dal Curto38, si afferma che la croce di «finissimo marmo» sopra una colonna era posta al centro dell’arena, bene architettata e connessa da sfidare i secoli. Non sappiamo se il tronco di colonna in marmo di Carrara (di grana fine e di provenienza da cave di prima scelta) che attualmente è sostenuto dalla base con stemma settecentesco di Atteone possa essere una modesta reliquia di quell’antico ‘segnacolo’ dei primi Cristiani di Atena, ma la connessione con lo stemma civico (attuale gonfalone comunale) pur se di fattura tardo barocca, ne potrebbe convalidare l’ipotesi. Nulla però sappiamo della «grandissima croce», che venne rimossa insieme alla sottostante colonna con gradoni di pietra, anche se una ricerca d’archivio approfondita potrebbe rivelarne indizi favorevoli, dato che la rimozione avvenne nell’anno 1866. Di certo in età medievale l’anfiteatro costituì una vera e propria cava di pietra, con sistematico saccheggio degli elementi architettonici ed il successivo reimpiego in edifici sacri e civili; tanto più che il posizionamento della croce sull’arena costituiva quasi una legittimazione per la religiosa popolazione locale alla spoliazione dell’antico monumento. Sappiamo dalle note di Luca Mandelli39 che Atena fu distrutta da Alarico, il quale «atterrò quanto di grandioso vi era nella scorreria che fece da Roma a Reggio… sicchè appena vi si ravvisano i vestigi, di un magnifico teatro, nel quale solevano gli antichi ragunarsi per celebrarvi gli spettacoli e feste». Localizzazione topografica All’esame delle fonti storiche, della tradizione locale e dell’attenta descrizione di Giovan Battista Curto, si evidenzia che la localizzazione topografica dell’anfiteatro sia ben delineata nella piana antistante il palazzo Marino40, anche se un’indagine fotometrica dall’alto secondo le recenti tecnologie per il rilievo di strutture nel sottosuolo potrebbe definire con certezza la puntuale traccia dell’ellissi del grande monumento. Nello studio di altri anfiteatri sepolti in Italia e nel - 58 - MARCO AMBROGI resto del mondo romano, si evidenzia una traccia costante a cui potersi affidare, in ambito urbano, per la determinazione delle strutture dell’architettura ludica: la curvatura o perimetrazione ellissoidale di alcune abitazioni o strutture edilizie. Senza affrontare argomenti di carattere più ampio, sulle sovrapposizioni medievali a monumenti di età classica (quali la piazza di Lucca sulle rovine dell’anfiteatro o situazioni simili), dal rilevamento di tracce di ellissoidi sul terreno da fotografie aeree si può esaminare una ricca serie di similitudini. È noto il caso di Ancona ove solamente una piccola parte del perimetro del monumento viene marcata dalla presenza di un gruppo di edifici che ne segue l’andamento in curvatura, mentre altre costruzioni vicine, o si presentano ‘estranee’ alla traccia del perimetro ellissoidale o ne riportano discosto il parallelismo. Per rimanere in area campana, basti confrontare l’addensamento edilizio di Nocera Inferiore sull’area dell’anfiteatro, del quale si riconosce l’andamento osservando la disposizione curvilinea delle case sul lato meridionale, l’andamento curvo della via Portaromana nel tratto in cui lambisce l’ellissoide ad Est, e ad Occidente, ove l’andamento ricurvo del muro del giardino del Convento francescano di Santa Maria degli Angeli conferma quanto prima riportato41. Ad Atena Lucana, osservando in prima analisi il tessuto urbano, emerge con chiarezza che tutta l’area alle spalle della cappella delle Anime del Purgatorio (posta nel largo antistante il palazzo Marino) si presenta in forma frammentaria, con piccole particelle edilizie, che si dispongono a ‘ventaglio’ rispetto al largo stesso; tale curvatura, che riprende una parte di un’ipotetica ellisse, si prolunga anche verso Nord, nell’isola di abitazioni tra le vie BorgoBraida e Roma (per intenderci, le abitazioni sulla destra delle case Mango). Del gruppo di costruzioni citate solo alcune sono strettamente sulla linea di perimetro di un’ipotetica ellisse, mentre quelle contigue ne rimarcano (in modo frammentario e disomogeneo) l’andamento verso l’esterno. Se a questa condizione ne affianchiamo un’altra di carattere altimetrico, la situazione diventa più chiara. Fig. 14 - Atena Lucana, la cappella delle Anime del Purgatorio al Borgo. Fig. 15 - Atena Lucana, Palazzo Marino al Borgo. Infatti sulla carta aerofotogrammetrica si può notare che l’area in questione si presenta in posizione rialzata rispetto a quella circostante. Prendendo in considerazione una quota media di 625,00 metri s.l.m. si presenta (sul suolo stradale e di campagna) un’area grosso modo corrispondente ad una macchia di forma circolare, con sfrangiamento verso Ovest, in direzione del centro indigeno antico. Tale pianoro secondo la tradizione locale sorge sull’area dell’anfiteatro e l’aspetto visivo ne conferma la validità. Anche se di labile consistenza, un filare di alberi, disposto sull’ellisse ipotetica sul retro del palazzo Marino e di alcune abitazioni contigue, potrebbero confermare il segno della curvatura dell’anfiteatro. - 59 - SALTERNUM Una perfetta localizzazione dell’antico monumento sarebbe impossibile da stabilire in quanto le tracce sulla cartografia e le descrizioni del Curto sono contraddittorie. A conclusione del discorso, l’analisi e lo studio sulla presenza dell’anfiteatro e soprattutto sulla sua esatta ubicazione trova validità in due diverse soluzioni, frutto essenzialmente di un disegno cartografico e delle tracce precedentemente riportate. Su questi riferimenti si innestano in modo inequivocabile le descrizioni del Curto, che circoscrive i ruderi a lui visibili durante lo scavo della strada Borgo-Braida, tra il palazzo Marino, le case Mango e la cappella di San Giuseppe. Tenendo fermi questi punti di carattere storico-topografico, l’anfiteatro di Atina potrebbe avere due soluzioni differenti di orientamento: con l’asse maggiore in direzione nord est, oppure ruotato di 70° circa in senso orario (si confrontino i due aerofotogrammi con sovrapposizione dell’ellisse planimetrica del monumento). Nella prima versione (la più credibile), il centro dell’arena si collocherebbe all’inizio di Via Stretta della Croce, nel punto antistante il palazzo Marino, mentre le tracce dell’ellissoi- de verrebbero a conformarsi a quelle già descritte precedentemente (abitazioni in curva, filare di alberi, suolo rialzato) con la conferma della presenza di strutture dell’anfiteatro sull’area di sedime dello scavo di fine Ottocento. Nella seconda ipotesi, con tracce dell’ellissoide più labili, ci troveremmo con l’arena collocata sul Largo BorgoBraida, con centro esattamente sul sagrato della Cappella delle Anime del Purgatorio, mentre l’abbassamento della via in direzione est verrebbe confermato dalla presenza di uno dei due accessi (sull’ellisse maggiore) all’edificio antico, quindi maggiormente soggetto a crollo, con relativa diminuzione della quota del piano stradale. In questo secondo caso la maggior parte delle strutture si celerebbe sotto l’abitato urbano. In ognuna delle due ipotesi ci troveremmo di fronte ad un caso eccezionale di ‘archeologia moderna’, la cui unica certezza potrebbe essere offerta, più che da intenzionali saggi di scavo, da indagini fotografiche aeree secondo le recenti strumentazioni di rilevamento altimetrico, che potrebbero, almeno in parte, rivelare la forma, la geometria e le dimensioni di un antico monumento di Atina romana. - 60 - MARCO AMBROGI NOTE 1 CURTO 1901, p. 40. 2 Una precedente analisi di studio su Atina e il suo anfiteatro è ampiamente elaborata da parte dello scrivente nella tesi di laurea Il Vallo di Diano, morfologia e fasi insediative, discussa presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, a.a. 2001/2002 (Relatore: prof. G. Calza). Parziali approfondimenti sull’argomento sono stati pubblicati in AMBROGI 1994. 3 GATTA 1723, p. 38. 4 ANTONINI 1984 (17841), p. 116. 5 ROMANELLI D., Antica topografia istorica del Regno di Napoli, Vol. I, p. 425, in LACAVA 1893, pp. 88-89. 6 IDEM, Ibidem, p. 89. 7 GIUSTINIANI 1804. 8 ALBI-ROSA 1840, pp. 56-57. 9 CORCIA (Vol. III, p. 96), in LACAVA 1893, p. 95. Di seguito (con rimando al Lacava), l’Autore riporta l’iscrizione dichiarata apocrifa dal Mommsen. 10 MACCHIAROLI 1995 (18681), p. 38. 11 ETERNI 1982, p. 67. Lo studioso sanrufese così riporta: «dove era ad Atena un nobile, ed antico teatro, del cui pochi vestigi si vedono, nel quale celebravano i Gentili Romani le loro feste, e giochi». Nella nota di approfondimento al testo, V. Bracco specifica che si tratta di anfiteatro, dato che lo stesso Eterni annotava la presenza di feste e giochi, dimostrando quindi la confusione o l’erronea trascrizione sulla tipologia del monumento. 12 L’Italia sotto l’aspetto fisico, storico, artistico e statistico, Vol. I, lettera A, in LACAVA 1893, p. 99. 13 Tra i grandi nomi degli eruditi viaggiatori stranieri, che citarono la presenza dell’anfiteatro di Atena Lucana, figura Francois Lenormant, che nella sua pubblicazione A travers l’Apulie et la Lucanie, II, Paris 1883, p. 85, fa un breve cenno al monumento. Di altre opere antiche (NISSEN, Italische Landeskunde e Friedlander, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms) di cui non mi è stato possibile effettuare un’attenta consultazione, si fa riferimento nell’attento studio curato da Vittorio Bracco, Inscriptiones Italiae, Volumen III-Regio III, Roma 1974, p. 79. Lascio ad approfondimenti maggiori la consultazione dei pochi riferimenti (spesso solo citazioni) non inseriti nel presente studio, come pure la disamina di documenti ottocenteschi di carattere locale. 14 LACAVA 1893, p. 50. In nota lo studioso riporta, con incontrovertibile prova dei dubbi sulla topografia antica di Atina: «Nell’attuale paese vicino all’abitazione del signor Marini sono appariscenti gli avanzi di un anfiteatro» (Ivi, n. 2). 15 IDEM, Ibidem, p. 73. 16 CURTO 1901, p. 41. 17 Isquarcio delle antichità di Atena, tratto da un ragguaglio Topografico della medesima, composto in grazia di chi ansioso fosse saperne le sue vaghezze, ms. ined. conservato dalla Società di Storia Patria di Napoli, in LACAVA 1893, p. 84-87. 18 LACAVA 1893, p. 87. L’iscrizione viene riportata nello stesso saggio di Lacava come apocrifa. L’aver annoverato il testo dal Lacava tra quello del Troyli e l’altro dell’Antonini, colloca l’epoca del passo inedito probabilmente alla seconda metà del XVIII secolo. 19 CURTO 1901, p. 40. 20 IDEM, Ibidem, pp. 40, 41. 21 IDEM, Ibidem, p. 38; lo studioso riporta anche la descrizione del materiale rinvenuto, tra cui un’eloquente iscrizione (poi ricondotta alla presenza del foro), nella parte alta dell’abitato antico (sopra la Piazza) che riconduce, secondo la fonte, ad una struttura architettonica teatrale. Sul teatro, probabilmente costruito ‘alla greca’ sull’acropoli cittadina, lo stesso Curto discorre a p. 38, con il ritrovamento di frammenti di laterizio formanti delle colonnette. 22 GILIBERTI 1913, pp. 27-28. 23 RACIOPPI 1970, p. 499. 24 L’epigrafe viene riportata anche dal BRACCO 1974, pp. 166167, insieme all’altra del seguente tenore: LVCIUS X . L . MILES R/ P . HONORIB . GEN/ MVN . SVB/ AMPHITEA - -/ R . F . P . P; le due iscrizioni vengono ritenute false, perché non corrispondono le citazioni di importanti eruditi antichi, quali il Mommsen, il Corcia e l’Antonini e quelli locali (Lacava, Albirosa, Macchiaroli e Curto). La tradizione storica locale (Curto), collocava un’iscrizione sul muro esterno della Taverna del Principe nell’abitato e l’altra nell’agro ove anticamente si trovava una villa di un militare romano. 25 CURTO 1901, pp. 85-86. 26 BRACCO 1974, pp. 166-167. Il Lacava la riporta come apocrifa (LACAVA 1893, p. 48). 27 ANTONINI 1984 (17971), p. 116. 28 BRACCO 1974, pp. 166-167. 29 Come rimarca lo stesso BRACCO 1974, p. 167 ed anticipa nella presentazione delle iscrizioni di Atena Lucana (IDEM, Ibidem, p. 79). 30 DISCEPOLO 2007, p. 117 ss. 31 BOTTINI 1997, p. 217. 32 Il riferimento per la conversione delle misure è stato attinto da DI DONATO 1997, p. 18 (cap. sulle antiche misure in uso nel Vallo di Diano). Il palmo in area valligiana corrispondeva a cm 26, 4550. 33 BOTTINI 1997, p. 217. 34 BALLETTI et Alii, 2002. Cfr. inoltre Gli anfiteatri in Basilicata 2002. 35 II, Ibidem. 36 Incertezza che ha coinvolto anche la studiosa atenese D’ALTO 1985, pp. 90 e 90 bis. Al volume della D’Alto si rimanda per una comprensione globale della storia antica di Atena Lucana e dei suoi ritrovamenti, giusta l’affidabilità analitica e descrittiva della studiosa, che per anni ha ricoperto il ruolo di Ispettrice Onoraria dei Monumenti atenesi, soprintendendo agli scavi degli anni ’60 e successivi effettuati nel paese. 37 Figlio di Saverio Arcangelo e di De Stefano Serafina, nacque ad Atena Lucana il 27 febbraio del 1807 ed ivi passò a miglior vita il 23 novembre 1876. Fu tra i rivoltosi del 1848 nel Vallo di Diano, marciando alla testa di duemila volontari contro l’esercito borbonico; processato e condannato a morte, gli venne commutata la pena in 18 anni di carcere e nel 1852 venne liberato, trovando rifugio in Inghilterra. Ritornato in Italia, nel 1860 si arruolò al seguito di Garibaldi e nella battaglia di Milazzo fu promosso capitano. Ferito nella marcia dei ‘Mille’ in Sicilia venne ricoverato in diversi ospedali, dai quali uscì inabile, con l’assegnazione di una pensione. Tornò nella natia Atena Lucana e ne fu nominato sindaco, amministrando il Comune con saggezza ed operosità. Nel paese si trova tutt’ora una targa a lui dedicata, (dal sito: www.pisacane.org/documenti/1860/Pessolani...) Del Pessolani parla anche il LACAVA 1893, p. 74. 38 CURTO 1901, p. 41. - 61 - SALTERNUM MANDELLI L., La Lucania sconosciuta, ms. della Biblioteca Nazionale di Napoli, tratto da LACAVA 1893, p. 57. 40 Durante uno scavo in loco di circa quindici anni fa per i lavori ad una conduttura idrica, nella parte di strada prospiciente il palazzo delle Suore (accanto a quello Marino), il Sig. Michele Ciro Langone, ebbe modo di osservare un grosso 39 lastrone ricurvo, probabilmente testimonianza dell’antico monumento ivi sepolto. Alla cortesia del sig. Langone devo la consultazione del prezioso testo di Michele Lacava. 41 Le note sull’anfiteatro di Nuceria sono osservazioni personali tratte dalla cartografia cittadina. BIBLIOGRAFIA ALBI-ROSA G. 1840, L’osservatore degli Alburni sulla Valle di Diano, ossia descrizione istorico-topografica della medesima, Napoli. ETERNI P. 1982, La Descrizione seicentesca della “Valle di Diana”, a cura di V. Bracco, Napoli. AMBROGI M. 1994, Monumenti sepolti. L’anfiteatro atinate, in “Il Saggio”, IX, n° 101. GILIBERTI L. 1913, Le antiche civiltà della Valle di Tegiano, Napoli. ANTONINI G. 1984 (17971), La Lucania, discorsi, Napoli (rist. anast. Bologna). GIUSTINIANI L. 1804, Dizionario geografico ragionato del regno di Napoli, Napoli, s.v. Atena Lucana. BALLETTI C. et Alii, L’arena di Grumentum: misura, geometria, forma, Università IUAV di Venezia, Laboratorio di Fotogrammetria (testo tratto da Internet). Gli anfiteatri in Basilicata, Città e spettacoli in età romana 2002, Catalogo della Mostra del Museo Archeologico dell’Alta Val d’Agri di Grumento Nova, a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Matera. BOTTINI P. 1997 (a cura di), Il Museo Archeologico dell’Alta Val D’Agri, Lavello (PZ). BRACCO V. 1974, Inscriptiones Italiae, Volumen III-Regio III, Roma. CURTO G. B. 1901, Notizie storiche sulla distrutta città di Atinum Lucana dai tempi incerti fino al secolo XIX, Sala Consilina (SA). GATTA C. 1723, La Lucania illustrata, Napoli. MACCHIAROLI S. 1868, Diano e l’omonima sua valle, Ricerche storico-archeologiche, Napoli (rist. anast. - con L’ambone della cattedrale di Diano, Napoli 1874 -, Teggiano (SA) 1995). RACIOPPI G. 1970 (19021), Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, Vol. I, Roma (rist. anast., Roma). D’ALTO E. 1985, Atena Antica, Galdo degli Alburni (SA). DI DONATO F. P. 1997, Trucioli della memoria, Salerno. DISCEPOLO V. 2007, L’anfiteatro di Venosa, in “Basilicata Regione Notizie”, Periodico del Consiglio Regionale di Basilicata, n. 117, Potenza. - 62 - FRANCESCO MONTONE Orazio e la Campania O razio, nel corso della sua produzione poetica, fa numerosi riferimenti alle città della costa e dell’entroterra campano. Il poeta venosino aveva conoscenza diretta di molte località, soprattutto di quelle situate nell’area flegrea; le puntuali allusioni del poeta, perciò, rivelano aspetti molto interessanti per la ricostruzione della storia dei centri campani. Nella divisione che Augusto fece dell’Italia, la Campania formò la Regio I insieme con il Latium vetus ed il Latium adiectum; in seguito comprese anche il territorio degli Irpini e parte del Sannio. Nel nuovo ordinamento dell’impero alla fine del sec. III d.C., con gli stessi confini della regione di Augusto, formò una delle province in cui fu allora divisa l’Italia. In base alla descrizione di Strabone (V, 4, 3), al tempo di Orazio la Campania comprendeva la regione costiera pianeggiante che si estendeva tra Sinuessa e la penisola sorrentina con le isole di Pitecussa, Procida, Capri, l’entroterra fino alla linea delle città dislocate lungo la via Appia e il tratto della via Latina che da Venafrum, attraverso Teanum Sidicinum e Cales, giungeva a Capua insieme ai centri dell’estremo limite orientale della pianura campana (Suessula, Nola, Acerrae, Abella) a ridosso dei territori sannitici sud-occidentali1. Gli Epodi, o Iambi, come li chiama Orazio, costituiscono l’esordio poetico del Venosino e furono composti tra il 42 ed il 31 a.C., cioè tra la battaglia di Filippi e quella di Azio, e pubblicati intorno al 30 a.C. Il poeta voleva rinnovare quel genere lirico che aveva dato tanta fortuna ad Archiloco e ad Ipponatte, molto adatto all’invettiva e alla satira, ma che consentiva anche qual- Fig. 1 - La regio I dell'Italia augustea. Fig. 2 - Cartina dei Campi Flegrei. che abbandono lirico. Nell’epodo II l’usuraio Alfio sogna una vita diversa dalla sua, nella quiete e nei piaceri della vita campestre, ma di fatto non riesce a cambiare le sue abitudini e continua a svolgere la sua ripugnante attività. Al v. 49 compare un riferimento alle ‘ostriche del Lucrino’. Il Lucrino è un bacino lacustre dei - 63 - SALTERNUM Fig. 3 - Il Lago Lucrino. Campi Flegrei, separato dal mare da un argine, in parte naturale in parte artificiale, che congiungeva Baia a Pozzuoli; Agrippa fece costruire una strada su di esso e tentò di mettere in comunicazione il lago Lucrino con il vicino lago d’Averno, trasformato da lui in porto (Portus Iulius). La coltivazione delle ostriche del Lucrino è ricordata da Orazio anche nella IV satira del II libro, al v. 32. Nel IV epodo il poeta attacca con sarcasmo un ex-schiavo divenuto un ricco e arrogante cavaliere, ricordandogli le sue origini. Ai vv. 134 il Venosino ricorda l’ager Falernus, famosissimo per la produzione vinicola, situato nella parte settentrionale della Campania, nella zona di Sessa Aurunca e di Massico, a Nord del Volturno. Nell’epodo V, Orazio descrive il turpe sortilegio della maga Canidia ai danni di un giovinetto caduto nelle sue grinfie; al v. 26 il Venosino fa riferimento alle Avernales aquae con cui Sagana, un’amica di Canidia, asperge la casa. L’Averno è il lago craterico situato nei Campi Flegrei, dove, secondo i Greci, si situava l’ingresso dell’Ade. Al v. 43, inoltre, è citata l’otiosa Neapolis, città fondata nella prima metà del V a.C., come ampliamento di un centro più antico, che Cuma, la più potente delle colonie greche del golfo, avrebbe insediato sul luogo di un precedente stanziamento rodio, al quale risalirebbe il nome Parthenope (una delle Sirene)2. Napoli si accordò con i Romani quando i Sanniti l’assediarono tra il 328 ed il 326 a.C. e fu fedelissima all’Urbs, seguendo le sue sorti, prima come città federata, poi come municipio. Offuscata da Pozzuoli come porto e come centro commerciale dopo l’82 a.C., la città conservò un certo rilievo in qualche ramo manifatturiero (unguenti e profumi), ma fu soprattutto centro dalle tenaci tradizioni elleniche nella lingua, nella cultura, nel costume: città di piaceri, di famosi spettacoli teatrali e sportivi e di studi. L’otiosa Neapolis di Orazio fu anche la dolce e colta città dall’incomparabile scenario paesistico di Virgilio e di Stazio, la città prescelta da Nerone per le sue esibizioni sceniche, la città apprezzata da Marco Aurelio per i suoi filosofi. Come osserva il Della Corte3, tuttavia, Napoli era per Orazio città dell’otium ma non già nell’accezione virgiliana (Georg. IV, 563-4: «illo Vergilium me tempore dulcis alebat / Parthenope studiis florentem ignobilis oti»: «in quel tempo me, Virgilio, nutriva la dolce Partenope, tra felici opere di un ozio senza gloria»), cioè città adatta agli studi, bensì in quella ovidiana (Met. XV, 711-2: «in otia natam / Parthenopen»: «Partenope, città nata per la vita tranquilla»), dal momento che Napoli (in particolare il suo golfo) era luogo di vacanze per i Romani. Nell’epodo XVI, nell’ambito di una dolorosa rievocazione delle guerre civili, in un elenco di nemici di Roma, in cui si ricordano i pericoli rappresentati da Annibale, Porsenna, Spartaco, i Germani, compare un riferimento a Capua, che era arrivata a minacciare l’Urbe (v. 5); di fondazione etrusca, essa era il centro più importante dell’entroterra campano ed è definita ‘rivale’ di Roma. Orazio, sottolinea il Mandruzzato4, «sembra esprimere un giudizio interessante: se Roma fosse stata eliminata nel suo momento cruciale è pensabile che proprio Capua sarebbe diventata il centro del mondo greco-italico». La città è ricordata, inoltre, tra le tappe dell’iter Brundisinum (Sat. I, 5, 47) ed è citata anche nelle Epistole (I, 11, 11-12), nell’ambito di un riferimento topografico alla via Appia. Orazio pubblicò due libri di Satire, il I verso il 35 a.C. e il II verso il 30, rifacendosi a Lucilio, capostipite del genere; in queste composizioni, che il poeta definiva Sermones, conversazioni alla buona, compaiono considerazioni filosofico-morali, questioni di critica letteraria, scene di - 64 - FRANCESCO MONTONE vita quotidiana, considerazioni autobiografiche, favole mitologiche. La satira V del I libro, il famoso iter Brundisinum5, ricorda il viaggio compiuto da Orazio, Mecenate, Virgilio e altri da Roma a Brindisi nel 37 a.C., secondo il modello luciliano del viaggio in Sicilia. È, quindi, una satira odeporica. All’origine del viaggio vi erano gravi motivi politici, dal momento che Ottaviano, in difficoltà a causa della guerra per mare con Sesto Pompeo, era stato costretto a chiedere aiuto ad Antonio, che giunse a Brindisi con 300 navi, richiedendo, in cambio, legionari per combattere contro i Parti. Orazio, tuttavia, fa un solo cenno ai motivi politici alla base del viaggio, ai vv. 28-29, quando ricorda che erano presenti alla spedizione Mecenate e Cocceio («missi magnis de rebus uterque /legati...»6: «l’uno e l’altro mandati come ambasciatori per trattare di cose grosse»). Il viaggio, come spiega il Fedeli7, è soprattutto conoscenza di luoghi e di persone, considerati con l’occhio del viandante frettoloso, cui non interessa tanto osservare i dati etnografici e antropologici, ma piuttosto presentare rapidi bozzetti e squarci di vita locale. La Campania è attraversata nella VI e nella VII giornata. I viaggiatori percorrono le 38 miglia che separano il ponte Campano da Caudium, fermandosi a Capua per una sosta. Mecenate si diletta giocando a palla, mentre Virgilio e Orazio, che soffrono l’uno di stomaco, l’altro a causa degli occhi infiammati, vanno a dormire. I viandanti cenano nella ricca villa di Cocceio, dove assistono alla divertente tenzone8 tra il buffone Sarmento e Messio Cicirro. Il primo ironizza sui difetti fisici dell’avversario, mentre Messio mette alla berlina lo stato sociale del rivale che, muovendo da origini servili, è diventato scriba. Il giorno dopo i viaggiatori da Caudium si rimettono in viaggio alla volta di Benevento. Lì un oste troppo premuroso per poco non brucia anche se stesso mentre arrostisce i suoi tordi. Il fuoco si sparge e le fiamme arrivano a lambire il soffitto. Orazio fa una descrizione squisita dell’allarmismo che coglie i clienti affamati e i servi spaventati, che portano fuori la cena e si impegnano, tutti insieme, a spegnere l’incendio. Il giorno dopo i viaggiatori lasciano a Benevento la via Appia, non più Fig. 4 - Bonea (BN) - Villa di Cocceio (fine II - I sec. a.C.) opus signinum. Fig. 5 - Egnazia (BR) - La via Minucia ricalcata dalla via Traiana. lastricata fino a Brindisi, e prendono la via Minucia, che collegava, appunto, Benevento a Brindisi. Nella già menzionata IV satira del II libro Orazio ferma un tale Cazio, che si affretta a tornare a casa per scrivere dei nuovi precetti: non si tratta di precetti filosofici, ma di ricette e consigli culinari. Ai vv. 30-34 il poeta ricorda, oltre al murex di Baia e alla peloris di Lucrino, anche i molluschi di Miseno, l’estrema punta occidentale del golfo di Pozzuoli. Al v. 51 della stessa satira Orazio fa riferimento al vino prodotto nella zona del Mons Massicus, che segna il confine tra la Campania e la parte del Lazio a Sud del fiume Liri. Ai vv. 68-69 Orazio fa riferimento alla bontà dell’olio di Venafro, consigliato da Cazio per condire una salsa molto elaborata («insuper addes / pressa Venafranae quod baca - 65 - SALTERNUM Fig. 6 - La Campania costiera. remisit olivae»: «aggiungi sopra ciò che emette la bacca spremuta degli olivi di Venafro»). Venafro è una città di origine sannitica nel territorio occidentale dei Pentri, attribuita alla Regio I dall’ordinamento augusteo. La bontà dell’olio di Venafro è menzionata anche in Carm. II, 6, 15-16. Al v. 55 della stessa satira è menzionata Sorrento, località situata su un altro terrazzo tufaceo che domina a picco sul mare, ben conosciuta da Orazio, che ne esalta la salubrità del clima e la bontà del vino, consigliato per le sue proprietà anche dai medici. Sorrento è definito centro amoenum nella XVII epistola del I libro, al v. 52. Nell’VIII satira del II libro, Orazio dialoga con Fundanio che gli descrive la cena a casa di Nasidieno Rufo, cafone arricchito che fa sfoggio delle sue ricchezze attraverso piatti e vini prelibati. Ai vv. 39-40 Orazio ricorda le tazze potorie di Alife, molto capienti, nelle quali due personaggi partecipanti alla cena, Vibidio e Balatrone, rovesciano intere anfore. Alife è una città di origine sannitica situata sul versante campano del Matese, nella valle del Volturno, posta sulla diramazione dalla via Latina che congiungeva Venafrum a Beneventum. Ai vv. 45-46 è nuovamente menzionato l’olio di Venafro, utilizzato per condire il sugo di una salsa di gamberi che accompagna una murena, offerta durante la cena, per desiderio di ostentazione, dal parvenu. È ai quattro libri delle Odi, i primi tre composti tra il 30 ed il 23 a.C. ed il quarto pubblicato nel 13 a.C., tuttavia, che Orazio si affida per ottenere fama imperitura di poeta, aspirando ad eguagliare Alceo e Pindaro. In Carm. I, 31, 9 e IV, 12, 14 Orazio menziona Cales, città aurunca della Campania (oggi Calvi Vecchia, frazione di Calvi Risorta). Il Venosino ne ricorda la pregiata qualità del vino. In Carm. II, 18, 17-22 Orazio descrive il fervore dei lavori edilizi a Baia, città dei Campi Flegrei, sulla sponda occidentale del golfo di Pozzuoli, famosa per le acque termali, che divenne una stazione balneare di moda: «tu secanda marmora / locas sub ipsum funus et sepulcri / inmemor struis domos marisque Bais obstrepentis urges / submovere litora, / parum locuples continente ripa»: «tu commissioni tagli ampi di marmi nell’imminenza della sepoltura e levi casa e scordi la tua tomba, sconvolgi coste, argini il mare che percuote Baia: per confine una spiaggia, è poco signorile». Orazio attesta la prima fase dell’espansione edilizia di Baia9, centro di cui ha conoscenza diretta, come sottolinea in altri due luoghi (Carm. III, 4, 24 e Epist. I, 15, 19). Nella I epistola del I libro Orazio irride chi è smanioso di far costruire la propria villa a Baia, al punto da considerare quel sito superiore a tutti gli altri (v. 83). La città divenne simbolo di lusso e corruzione mondana: Properzio, ad esempio, si scaglia contro Baia, luogo di corruzione per le fanciulle caste, ed esorta l’amata Cinzia ad allontanarsi da quei vergognosi lidi (Prop. I, 11, 27-30: «Tu modo quam primum corruptas desere Baias: / multis ista dabunt litora discidium, / litora quae fuerant castis inimica puellis: / a pereant Baiae, crimen Amoris, aquae!»: «Ma tu abbandona prima possibile la corrotta Baia: codesti lidi produrranno la separazione di molti lidi da sempre ostili alle caste fanciulle. In malora le acque di Baia, vergogna di Amore!»). Seneca, a sua volta, nell’epistola LI, 13, afferma di aver lasciato Baia dopo un giorno, dal momento che è divenuta un luogo che induce al vizio: «nos... contenti sumus Bais; qua postero die quam attigeram reliqui, locum ob hoc devitandum, cum habeat quasdam naturales dotes, quia illum sibi celebrandum luxuria desumpsit»: «mi sono dovuto accontentare di Baia, ma l’ho lasciata il giorno dopo che vi ero arrivato. Pur avendo l’attrattiva delle sue bellezze naturali, è una città da evitarsi, poiché è ormai un noto centro di corruzione». - 66 - FRANCESCO MONTONE I due libri di Epistole furono pubblicati nel 20 a.C. e nel 13 a.C. Il primo comprende 20 epistole, il secondo ne raccoglie tre, tra cui la famosissima Ars Poetica. A differenza delle Satire, le Epistole non hanno toni aggressivi: permangono i temi della ricerca della saggezza e della morale (autárkeia e metriótes)10. Nella I epistola del I libro, ai vv. 85-87, è menzionata Teano, città fondata dalla tribù sannitica dei Sidicini e centro principale di questa popolazione; era situata alla congiunzione tra la via Latina e un’importante variante della via Appia e dotata di un ampio anfiteatro («cui si vitiosa libido /fecerit auspicium: cras ferramenta Teanum / tolletis, fabri»: «poi gli viene un capriccio amoroso, come un’ispirazione divina: domani gli operai portino le attrezzature a Teano»). Teano era una delle città più importanti della Campania e Orazio irride il ricco volubile che, mentre sta per farsi edificare una villa a Baia, ordina ai suoi operai di portare le attrezzature a Teano. Arriviamo, finalmente, alla già menzionata epistola XV del I libro, in cui Orazio cita Salerno. Orazio si rivolge a Numonio Vala per chiedere notizie sulle condizioni climatiche e sulla vivibilità di Salerno e di Velia, dal momento che il famoso medico di Augusto, Antonio Musa, gli ha prescritto cure di acqua fredda per i disturbi di cui soffriva agli occhi. Salerno11 è situata sulla costa settentrionale dell’antico sinus Paestanum, a destra del fiume Irno, nell’agro Picentino. Essa nacque come colonia marittima di diritto romano nel 194 a.C. (Liv. XXXII, 29, 3; XXXIV, 45, 1-5; Vell. I, 15, 13), insieme ad altre quattro colonie costiere (Volturnum, Liternum, Puteoli e Buxentum), in base alla Lex Atinia de coloniis deducendis del 197 a.C. Come ricorda Strabone (V, 4, 13), Salerno aveva una funzione essenzialmente militare, dal momento che è troppo esiguo il numero dei primi coloni perché si possa parlare di una colonia di popolamento. Era un centro fortificato per controllare gli inquieti Picentini, colpevoli di essersi schierati con Annibale dopo la battaglia di Canne. Attraversata dalla via RegioCapuam che la collegava con l’interno della Lucania, da un lato, con Napoli e Pompei dall’al- tro, Salerno divenne un centro molto importante. Fu saccheggiata nell’89 a.C. dall’esercito degli alleati italici guidato da Papius Mutilus, che in tale occasione arruolò nelle proprie schiere prigionieri e schiavi salernitani. Orazio domanda, inoltre, quale dei due siti abbia le messi migliori, quale sia più provvisto di lepri e cinghiali, quali acque siano più dotate di pesci e frutti di mare. Egli dà per scontato che la selvaggina pregiata non mancherà dalla sua tavola. Per quanto riguarda il vino, egli non fa proprio conto dei poco raffinati vini locali e cerca un vino nobile, d’alta classe, che non dovrà essere né pesante né di alta gradazione, ma tale da rendere vivace e piacevole chi lo beve, senza ubriacarlo. Orazio affida al vino il compito di lenire i suoi affanni, di fargli venire la parlantina (secondo il tòpos del vino che scioglie la lingua) e di renderlo gradito ad un’amante lucana: il Fedeli12 ritiene che un tale accenno alla regione d’appartenenza della donna consenta di cogliere una leggera preferenza del Venosino per Velia. Al v. 24 il poeta, lasciati da parte i problemi di salute, chiarisce che lo scopo del suo viaggio a Velia o a Salerno è quello di tornarsene a casa ben pasciuto come un Feace («pinguis ut inde domum possim Phaeaxque reverti»: «perchè possa tornare a casa grasso, novello Feace»); ai Feaci il poeta aveva già accennato in Epist. I, 2, 28-29 e anche in quel caso con un ironico riferimento alla loro propensione per i piaceri della tavola. Il melancholicus13 Orazio cerca un luogo dove svernare e deve rinunciare, per rispettare i precetti di Musa, ai graditi soggiorni a Baia, che altrove il poeta arriva a personalizzare. Il medico di Augusto era un convinto sostenitore dei benefici terapeutici offerti dai bagni di acqua fredda. Orazio ricorreva, per seguire le osservanze del medico, al frigidarium della sua casa, mentre altri si recavano a Chiusi o a Gabii. Come osserva giustamente il Bracco14, Salerno e Velia non sono menzionate perché offrissero bagni freddi (non è nota nelle due città la presenza di sorgenti di acqua con proprietà terapeutiche): se il Venosino deve scegliere tra Salerno e Velia per curare la gotta e i disturbi agli occhi è perché quelle località offrivano un - 67 - SALTERNUM sodalizio di medici esperti. Sono attestati nomi di medici a Velia e a Salerno è ricordato, dalle testimonianze epigrafiche, il nome di un medico di età giulio-claudia, Tiberio Claudio, che ha cognome greco come il padre: Diogene. La frequenza delle relazioni con l’Oriente dovette favorire il trasferimento nei due centri campani di individui esperti nell’arte medica. Il Bracco15 afferma che è attestata fin dall’età di Cesare quella tradizione medica che raggiungerà fama pienissima nel Medio Evo. Nella parte conclusiva dell’epistola Orazio ricorda un personaggio già citato in Sat. I, 3, 21, un certo Mevio, noto per essere un ingordo e un inguaribile spendaccione, e rimprovera se stesso, in grado di condurre, nel suo campicello, una vita frugale, ma incapace di resistere ai piaceri di una vita comoda quando gli si presenta l’occasione. Compare anche qui quella continua opposizione tra valori e modelli etici e scelta individuale, che ha indotto il La Penna ad affermare che Orazio opera una relativizzazione della morale16. Il poeta stesso, come sottolinea acutamente Italo Lana17, in Epist. I, 8 confessa di essere afflitto da un funestus veternus, uno stato di torpore e di inquietudine che genera in lui l’incapacità di agire coerentemente con le sue convinzioni morali. Egli non vive nec recte nec suaviter (v. 4) ed è assalito da un continuo stato di irrequietezza, che lo spinge a desiderare Roma quando è a Tivoli e Tivoli quando è a Roma (Epist. I, 8, 9-12: «...irascar amicis / cur me funesto properent arcere veterno; / quae nocuere sequar, fugiam quae profore credam, / Romae Tibur amem, ventosus Tibure Romam»: «con gli amici mi inquieto, perché s’affannano per salvarmi da un torpore che mi porta alla tomba, e faccio quello che mi ha fatto male e scappo da quello che mi farebbe - e lo so - assai bene. A Roma mi piace Tivoli; a Tivoli mi piace Roma. Sono come il vento»). Oltre all’amata Baia, Orazio deve rinunciare ad andare a Cuma (vv. 11-12: «...quo tendis? Non mihi Cumas / est iter aut Baias»: «Dove vai? La meta non è più Cuma o Baia»). Cuma, città situata sul litorale campano, sulla costa flegrea, fu la più antica colonia greca in Italia. La via Domiziana entrava in città da Nord, tagliando il monte Grillo e superando un profondo avvallamento con un ardito cavalcavia, un’opera cementizia rivestita di laterizio e tufelli, detto ‘Arco Felice’. In conclusione, la lunga frequentazione da parte dell’inquieto poeta venosino delle località campane e le allusioni ad esse nelle sue opere ci offrono la possibilità di un viaggio affascinante all’interno di tradizioni locali, prodotti tipici, tendenze culturali della nostra regione, un percorso che ci conduce alla riscoperta, mai priva di emozione e di meraviglia, delle nostre radici. - 68 - FRANCESCO MONTONE NOTE 1 Si veda il fondamentale contributo FERONE C. 1996, pp. 424-432. 2 Nell’Alessandra, il poeta ellenistico Licofrone fa predire a Cassandra la triplice direzione che avrebbero preso le tre Sirene, Parthenope, Leucosia e Ligeia, dopo il salto in mare e descrive i tre luoghi di approdo, sulle coste campane, dove si diffonde il loro culto: Napoli, Punta Licosa e Sant’Eufemia. L’insediamento collettivo si sarebbe situato, per gli antichi, nelle isolette sorrentine dette Sirenusse (oggi ‘Li Galli’). Sulle varie versioni del mito delle Sirene cfr. BETTINI - SPINA 2007. 3 DELLA CORTE 1996, p. 517. 4 Orazio, Odi ed Epodi, p. 535. 5 FEDELI 1996, pp. 248-253. Si rimanda anche a FEDELI RONCONI 1991. 6 Il testo di Orazio è citato secondo le edizioni critiche allestite da P. VENINI (Odi ed Epodi) e da P. FEDELI (Satire ed Epistole) per il Bimillenario oraziano (Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1991, 1994, 1997). 7 Orazio. Tutte le poesie, p. 828. 8 A proposito della tenzone scrive il LA PENNA: «La tenzone comica sembra di una comicità gratuita e festosa; ma non è escluso che Orazio questa volta provi gusto a farci vedere un troppo furbo parassita di città messo alle strette da un campano spiritoso. Non parlo di morale a tesi: è una morale meno cosciente che in altre satire, ma non assente: anzi è la morale che si confonde col gusto della vita e circola nel racconto con naturalezza, senza che la si possa isolare e definire» (LA PENNA 1968, p. 39). 9 FERONE 1996, p. 426. 10 LA PENNA 1968, pp. 40-44. 11 PANEBIANCO 1991; BRACCO 1981, p. XVIII; FERONE 1996, pp. 429-430; AVALLONE 2008, pp. 61-73. Si vedano anche i fondamentali contributi di LEONE – VITOLO 1982; ROMITO 1996. 12 Orazio. Tutte le poesie, p. 928. 13 Sull’irrequietezza di Orazio, che trapela sotto la marmorea superficie dei suoi versi, sulla tensione che vive il Venosino tra quello che sentiva di essere e quello che avrebbe voluto essere, insiste, in un bel volume, A. Traina (TRAINA 1993). 14 BRACCO 1979, pp. 47-51. 15 IDEM, Ibidem, p. XVIII. 16 LA PENNA 1993, pp. 241-274. 17 LANA 1993, pp. 73-91. - 69 - SALTERNUM FONTI E BIBLIOGRAFIA FONTI Orazio, Le Epistole; L’Arte Poetica, a cura di P. FEDELI - C. CARENA, Roma 1997. FEDELI P. 1996, L’iter Brundisinum, in Enc. Oraz., I, RomaFirenze, pp. 248-53. Orazio, Le Odi; Il Carme Secolare; Gli Epodi, a cura di F. DELLA CORTE - P. VENINI, Roma 1991. FEDELI P. - RONCONI A. 1991, Con Orazio da Roma a Brindisi, Venosa. Orazio, Le Satire, a cura di F. DELLA CORTE e P. FEDELI, Roma 1994. FERONE C. 1996, Campania, in Enc. Oraz., I, Roma-Firenze, pp. 424-32. Orazio, Odi ed Epodi, a cura di A. TRAINA - E. MANDRUZZATO, Vol. II, Milano (rist.) 2001. LANA I. 1993, Orazio: dalla poesia al silenzio, Venosa. Orazio, Tutte le poesie, a cura di P. FEDELI e C. CARENA, Torino 2009. LA PENNA A. 1968, Orazio e la morale mondana europea, Firenze. IDEM 1993, Saggi e studi su Orazio, Firenze. BIBLIOGRAFIA LEONE A. – VITOLO G. 1982 (a cura di), Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, Salerno. AVALLONE R. 2008, Salerno romana, in AA. VV., Visitiamo la città, Salerno, pp. 61-73. PANEBIANCO V. 1991, La colonia romana di Salernum: introduzione allo studio di Salerno romana, Salerno (rist.). BETTINI M. - SPINA L. 2007, Il mito delle Sirene, Torino. ROMITO M. 1996, I reperti di età romana da Salerno nel Museo Archeologico Provinciale della città, Napoli. BRACCO V. 1981, Inscriptiones Italiae, Regio I, vol. I, fasc. I, Roma. TRAINA A. 1993, Autoritratto di un poeta, Venosa. IDEM 1979, Salerno romana, Salerno. DELLA CORTE F. 1996, Napoli, in Enc. Oraz., Roma-Firenze, p. 517. - 70 - MARIA AMORUSO Lo stato di conservazione degli affreschi di San Pietro a Corte in Salerno I l complesso monumentale di San Pietro a Corte si colloca nel centro storico della città di Salerno. La sua storia, molto articolata dal punto di vista architettonico, ha inizio nel I-II sec. d.C. con la costruzione di un complesso termale. Il frigidarium di queste terme costituisce la parte più antica e di conseguenza pone un termine certo per l’identificazione del primo periodo di frequentazione della struttura. Nel V sec. d.C., in seguito ad un precedente abbandono delle terme, il frigidarium continuò ad essere frequentato, non più come ambiente termale, ma con funzioni totalmente differenti. Infatti esso diventò un luogo di culto che con opportune modifiche fu utilizzato come chiesa paleocristiana e coemeterium. La chiesa e il cimitero, destinato ad ospitare le tombe delle personalità e delle famiglie più importanti di Salerno, vennero frequentati e utilizzati fino alla prima metà del VII sec. d.C. Nella seconda metà dell’VIII sec. d.C., Arechi II, duca di Benevento, scelse la città di Salerno per la costruzione di un secondo palazzo, che includeva al suo interno una cappella privata. Come luogo di costruzione per la sua cappella palatina, Arechi II individuò la chiesa e il cimitero paleocristiano e dopo aver apportato alcune modifiche architettoniche (abbattimento delle volte romane e costruzione di pilastri e murature di sostegno) innalzò su di essi la cappella, dedicandola ai santi Pietro e Paolo. Le fondamenta del palatium, costituite dalle strutture del frigidarium, dalla chiesa e dal cimitero, diventarono un ambiente ipogeo frequentato non solo dalla famiglia principesca ma forse anche dai comuni cittadini. Con la fine del dominio longobardo e con il conseguente avvento dei Normanni a Salerno, la struttura ipogea fu trasformata in oratorio. In quel periodo storico (XII-XIII sec. d.C.) vennero realizzate una serie di pitture murali con la tecnica dell’affresco, con soggetti religiosi di stile bizantineggiante. Successivamente, la struttura fu anche utilizzata come sala pubblica in cui venivano conferite le lauree della Scuola Medica Salernitana, finché, alla fine del 1500 si verificò l’abbandono dell’intero complesso. In seguito agli scavi archeologici effettuati negli anni ’80 del secolo XX, gli affreschi furono sottoposti ad una serie di restauri finalizzati a preservare la loro integrità strutturale e decorativa. Attualmente il loro stato di conservazione suscita non poche preoccupazioni, poiché sono ben evidenti svariate forme di degrado che nel corso degli anni hanno agito sugli affreschi, creando danni consistenti allo strato pittorico e all’intonaco sottostante. I materiali che costituiscono l’affresco, ma anche tutti quelli che costituiscono ogni altro bene culturale, sono soggetti a questi fenomeni di alterazione e degrado per l’ interazione che si verifica tra essi e l’ambiente in cui sono situati. L’alterazione è un fenomeno che modifica il materiale senza provocare un peggioramento delle sue proprietà. Essa influisce non sulla consistenza dell’opera ma sul suo aspetto, alterandone il colore o comunque la superficie esterna. Il degrado invece modifica le proprietà del materiale, provocando quindi una perdita di parte dell’opera. Esso agisce sul bene con fenomeni di consumo e distruzione, attraverso trasformazioni di natura chimica, fisica e biologica. - 71 - SALTERNUM Fig. 1 - San Pietro a Corte (SA). Madonna regina in trono con Bambino e Santa Caterina d’ Alessandria. Sul pilastro arechiano situato nella zona della chiesa (ambiente D), c’è l’affresco della Madonna regina in trono con Bambino e Santa Caterina d’ Alessandria (fig. 1), realizzato nel XII sec. d.C. L’intera immagine è circondata da una cornice rossa che risulta mancante in molti punti. Inoltre si può notare una notevole lacuna nella zona destra, che occulta una parte del corpo del Bambino. Lo stato di conservazione dell’affresco è mediocre. Le forme di degrado che hanno agito e continuano ad agire su di esso sono in gran parte leggibili sullo strato pittorico, ma si esten- dono anche all’intonaco sottostante. Infatti si sta verificando una graduale disgregazione della muratura che in alcune zone ha provocato la perdita dei colori originali e l’esposizione in primo piano dello strato di intonaco sottostante. La disgregazione è la separazione spontanea di grani di materiale senza che si eserciti alcuna azione meccanica su di essi. La sua manifestazione può verificarsi in seguito al passaggio dell’acqua, che può circolare in una parete attraverso vari fenomeni come la capillarità o l’infiltrazione. Il suo passaggio può provocare lo scioglimento dei sali che incontra lungo il - 72 - MARIA AMORUSO suo cammino depositandoli altrove; i danni dovuti alla presenza di sali si verificano in seguito all’evaporazione dell’acqua, quando essi cristallizzano e quindi aumentano di volume. Si verifica a questo punto una prova di forza tra i cristalli in espansione e le pareti dei pori del materiale in questione; infatti uno dei due dovrà cedere a seconda della sua resistenza. Se l’intonaco è più resistente, il cristallo verrà espulso sotto forma di efflorescenza, se invece è più forte il sale, le pareti dei pori si romperanno, causando la disgregazione dell’intonaco. Nella fig. 2 è possibile osservare la disgregazione della superficie pittorica, che ha provocato l’esposizione dello strato di intonaco sottostante. Nella fig. 3 si può osservare, nel particolare dell’ampollina, ciò che resta del colore originale e il risultato cromatico verificatosi in seguito all’azione della forma di degrado. Nell’affresco inoltre è possibile osservare la formazione in alcuni punti di una leggera patina biancastra o patina carbonatica. Negli intonaci a base di calcio, l’azione combinata dell’acqua e dell’anidride carbonica sul calcio può provocare alterazioni chimiche. Quando l’intonaco di un affresco inizia a far presa, l’acqua evapora progressivamente, trasformando la malta in un composto sempre più compatto. Contemporaneamente, in superficie inizia a formarsi una crosta di carbonato di calcio che può rallentare la penetrazione dell’anidride carbonica nella profondità dell’intonaco. Di conseguenza, in superficie risulterà uno strato molto duro perché completamente carbonatato, mentre sotto lo strato sarà più debole, perchè l’acqua è evaporata prima che tutto l’idrato di calcio sia entrato in contatto con l’anidride carbonica e quindi in profondità resterà uno strato di idrato di calcio. A questo punto, se l’intonaco viene bagnato dalla pioggia o se si trova in ambienti altamente umidi, l’idrato di calcio può reagire di nuovo con l’anidride carbonica dell’aria e quando l’acqua evapora, può venire in superficie, dove carbonatandosi, continua ad indurire l’intonaco. Quando tutto l’idrato di calcio avrà reagito, l’umidità, non potendo più rea- Fig. 2 - San Pietro a Corte (SA). Particolare dell’affresco con evidente disgregazione dello strato pittorico. Fig. 3 - San Pietro a Corte (SA). Particolare dell’ampollina dell’affresco di S. Caterina d’Alessandria. Fig. 4 - San Pietro a Corte (SA). ‘Madonna Eleusa’ o ‘della tenerezza’. - 73 - SALTERNUM Fig. 5 - San Pietro a Corte (SA). Particolare con sollevamento e caduta dello strato pittorico. Fig. 6 - San Pietro a Corte (SA).Teoria di Santi. gire con esso, provocherà un processo di disgregazione, poiché l’anidride carbonica inizierà ad esercitare la sua azione acida sul carbonato di calcio, trasformandolo in bicarbonato solubile che, quando l’acqua sarà evaporata, si ridepositerà altrove, sotto forma di un velo bianco di carbonato di calcio. Alla destra dell’affresco sopra citato c’è una parete anch’essa di costruzione arechiana sulla quale sono stati realizzati tra la fine del XII sec. e l’inizio del XIII sec. d.C. una serie di affreschi ovvero, una ‘Madonna Eleusa’ o ‘della tenerezza’ (fig. 4) e una Teoria di Santi in piedi. Partendo dall’analisi dello stato di conservazione della Madonna Eleusa, la situazione risulta molto grave: è visibile una netta differenza tra la parte alta dell’affresco, che risulta leggibile e in uno stato di conservazione migliore, e la parte inferiore, notevolmente rovinata. In questa zona manca almeno il 40% della superficie pittorica. Anche su questo affresco la forma di degrado più evidente consiste nella disgregazione, che in questo caso, oltre allo strato pittorico, ha interessato anche lo strato di intonaco immediatamente al di sotto. È probabile che su di esso abbia agito una percentuale di umidità notevolmente maggiore che sull’affresco precedente. La realizzazione dell’affresco in una struttura ipogea, il cui piano di calpestio si trova attualmente a circa 5 m dall’attuale piano stradale, ha reso possibile la risalita dell’umidità dal sottosuolo. Questo fenomeno spiega perché la maggioranza delle forme di degrado si sia sviluppata nella parte inferiore dell’affresco, che si trova molto più vicina al piano di calpestio. Nella zona sinistra dell’affresco, ancora una volta nella parte inferiore, è possibile osservare in uno stesso punto le varie fasi di avanzamento di altre forme di degrado, quali rigonfiamento, distacco e caduta dello strato pittorico. (fig. 5). Anche in questo caso la principale causa dello sviluppo di queste forme di degrado è l’umidità e ancora una volta la parte di affresco interessata è lo strato pittorico. La superficie esterna di un affresco, quella che riceve lo strato pittorico, si trova sempre in condizione di instabilità maggiore rispetto alla superficie sottostante. Ciò si verifica perché essa costituisce il piano di separazione tra la struttura murale sottostante e l’ambiente, e quindi la manifestazione su di essa di fenomeni come l’evaporazione, la condensazione e il semplice passaggio dell’acqua possono creare forme di degrado che generano la disgregazione della materia. Alla destra della Madonna si possono osservare due Santi (fig. 6). Il primo risulta essere S. Giacomo, il secondo invece non offre le caratteristiche necessarie per una chiara identificazione. - 74 - MARIA AMORUSO Nel verificare il loro stato di conservazione si possono riscontrare le medesime forme di degrado che hanno interessato l’affresco precedente, soltanto con qualche minima differenza. La parte inferiore dell’affresco continua ad essere quella maggiormente colpita dal degrado, ma anche la parte superiore risulta danneggiata. Per S. Giacomo la situazione è migliore e il suo volto risulta perfettamente leggibile, ma procedendo verso il basso si può osservare che le mani sono interessate da rigonfiamento, distacco e da una minima caduta della pellicola pittorica (fig. 7). Ancora più in basso aumentano le aree interessate dal degrado. L’umidità che risale dal sottosuolo ha generato la comparsa di patine carbonatiche (fig. 8), ancora una volta cadute dello strato pittorico (fig. 9), efflorescenze (fig.10) e concrezioni, dovute al deposito di sali da parte di acque circolanti sul materiale. La situazione dell’altro Santo è ancora più grave: oltre alla presenza di lacune, il suo volto risulta sbiadito a causa di patine e concrezioni. La stessa situazione conservativa si può osservare sul resto del corpo, oltre ad una serie di lacune nella parte superiore dell’affresco. Alla destra dei due Santi si possono osservare gli ultimi due personaggi affrescati. Si tratta di due Santi Vescovi (fig. 11); anche per questi l’umidità proveniente dal sottosuolo e quella presente nell’ambiente sono le cause principali della manifestazione delle forme di degrado. Sull’intera superficie dell’affresco insiste una patina biancastra (fig. 12) di diverso spessore, la cui intensità è maggiore nel vescovo di sinistra. Per la caduta dello strato pittorico, l’esatta lettura dei volti risulta compromessa. Nella parte inferiore dell’affresco si ripresenta la situazione riscontrata nei casi precedenti. La zona è maggiormente degradata per la risalita dell’ umidità che ancora una volta ha generato patine, concrezioni e cadute dello strato pittorico (fig. 13). Frontalmente al pilastro arechiano si innalza un setto murario, anch’esso di fattura arechiana, che divide la sala termale in due parti. La parete, un tempo interamente decorata con affreschi, conserva oggi soltanto un soggetto iconografico nell’area sinistra e alcuni frammenti in alto a destra. Fig. 7 - San Pietro a Corte (SA). Particolare della mano di S. Giacomo, con evidente distacco e caduta dello strato pittorico. Fig. 8 - San Pietro a Corte (SA). Particolare con patine di tipo carbonatico. Fig. 9 - San Pietro a Corte (SA). Particolare con distacchi e cadute della pellicola pittorica. La situazione conservativa di questo affresco che ritrae ‘San Nicola e il cavallo’ è particolarmente grave (fig. 14). Diverse tipologie di forme di degrado si alternano e/o si sovrappongono sull’intera superficie pittorica, estendendosi allo strato di intonaco sottostante. Ancora una volta è l’umidità, presente in alte percentuali nella struttura, che regola l’azione e lo sviluppo di - 75 - SALTERNUM Fig. 10 - San Pietro a Corte (SA). Particolare con efflorescenze. Fig. 11 - San Pietro a Corte (SA). Santi Vescovi. Fig. 12 - San Pietro a Corte (SA). Particolare con patine dello strato pittorico. tutti i processi di degrado che mettono a rischio la conservazione di questo dipinto murale. La grande azione devastatrice dell’acqua si può osservare gradualmente in questo affresco se si analizzano diverse aree dello stesso in cui le forme di degrado sono avanzate con tempi differenti. La risalita dei sali in superficie si colloca tra le prime manifestazioni evidenti del passaggio dell’acqua all’interno della struttura muraria (fig. 15). La fase successiva comporta il rigonfiamento della pellicola pittorica, il suo distacco e infine la caduta. Contemporaneamente si possono osservare sulla superficie altre efflorescenze saline, che continuano la loro azione disgregativa anche all’interno dell’intonaco (fig. 16). Le ultime fasi di questa tipologia di degrado mostrano la disgregazione dello strato pittorico e dell’intonaco immediatamente al di sotto. In questo affresco inoltre si può osservare una particolare forma di degrado che ha provocato la formazione di piccoli buchi che si estendono dallo strato pittorico a quello di intonaco (fig. 17). Procedendo con un’ulteriore analisi della superficie, si possono notare altre manifestazioni di degrado, tra cui una frattura verticale nella zona in basso a destra e anche in altre zone in cui manca lo strato pittorico (fig. 18). Attualmente in questa area non è presente nessuna forma di umidità, ma la disgregazione che si sta verificando è probabilmente il risultato del passaggio dell’acqua in tempi passati. Dallo studio effettuato su tutte le pitture, in considerazione dell’ambiente in cui esse sono situate e in base alle forme di degrado riscontrate, risulta evidente che la causa principale dell’alterazione e del degrado è l’acqua. Sia che essa abbia agito in forma liquida o di vapore, la sua azione è stata costantemente attiva nel corso degli anni, così da lasciare danni ingenti su buona parte delle pitture. Nella struttura di San Pietro a Corte l’umidità si è diffusa in vari modi. L’umidità di condensazione, che evaporando tende a saturare l’aria nell’ambiente e quindi a provocare condensazioni sulle altre pareti, giustifica la formazione dei veli bianchi di carbonato di calcio e delle efflorescenze sugli affreschi. - 76 - MARIA AMORUSO L’umidità di capillarità, che circola nei pori dei materiali che compongono le murature, giustifica la formazione di efflorescenze e causa l’erosione e la distruzione delle malte e degli intonaci per solubilizzazione e ricristallizzazione dei sali nelle zone di evaporazione. Infine l’umidità proveniente dal sottosuolo, dovuta alla struttura ipogea, spiega il motivo della maggiore diffusione delle forme di degrado nelle zone inferiori degli affreschi. A queste forme di degrado sviluppatesi per cause fisiche bisogna aggiungere alcune forme di degrado generate da cause biologiche. La probabile presenza di funghi o batteri ha generato la nascita di chiazze nere sulla superficie muraria dell’abside della chiesa paleocristiana. Complessivamente la condizione conservativa dell’apparato decorativo di San Pietro a Corte richiede un immediato intervento di restauro. Le principali fasi del lavoro di conservazione e restauro dovrebbero basarsi sul consolidamento delle parti di strato pittorico che risultano in fase di distacco e sull’eliminazione delle efflorescenze e delle patine carbonatiche. Queste operazioni hanno il compito di bloccare almeno temporaneamente il lento ma costante processo di distruzione che sta agendo sugli affreschi. Per rendere duraturo tale intervento bisognerebbe creare le condizioni idonee per ristabilire l’equilibrio tra le opere, la struttura e l’ambiente in cui esso di trova. Ciò potrebbe essere concretizzato con la creazione di un microclima che mantenga costantemente la temperatura ideale per la migliore conservazione degli affreschi. In questo modo potrebbe essere eliminata l’umidità di condensazione. Molto difficile, se non impossibile invece è riuscire ad eliminare l’umidità proveniente dal sottosuolo. Nonostante questo impedimento, l’attuazione degli interventi precedentemente descritti garantirebbe comunque una vita più lunga agli affreschi e all’intera struttura e con l’attuazione di un intervento di restauro pittorico si potrebbe ammirare nuovamente lo splendore originario delle pitture. Fig. 13 - San Pietro a Corte (SA). Particolare con caduta dello strato pittorico. Fig. 14 - San Pietro a Corte (SA). San Nicola e il cavallo. Fig. 15 - San Pietro a Corte (SA). Particolare con risalita dei sali in superficie. - 77 - SALTERNUM BIBLIOGRAFIA San Pietro a Corte. Recupero di una memoria nella città di Salerno, 2000, a cura del Gruppo Archeologico Salernitano, Napoli. AMAROTTA A. R. 1982, La cappella palatina di Salerno, Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia di Salerno. Salerno. AMORUSO M. 2007, Le pitture parietali di Pompei: analisi delle forme, delle cause e dei meccanismi di degrado. Tesi di laurea in Chimica del restauro, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli, a.a. 2006-2007 (Relatore: prof. C. Piccioli). Fig. 16 - San Pietro a Corte (SA). Particolare con rigonfiamento, distacco e caduta della pellicola pittorica ed efflorescenze saline. BOTTICELLI G. 1992, Metodologia di restauro delle pitture murali, Firenze. CAMPANELLA L. et Alii 2007, Chimica per l’arte, Bologna, pp. 43-278. PICCIOLI C., Dispense del corso di Chimica del restauro, a.a. 2004-2005. FIORILLO R. 1998, Sepolture e società nella Salerno medioevale: il caso di San Pietro a Corte, in “Apollo”, XIV, pp. 2035. GASPAROLI P. 1999, La conservazione dei dipinti murali, Firenze. MATTEINI M. - MOLES A. 1989, La chimica nel restauro. I materiali dell’ arte pittorica, Firenze. MAURO D. 1988, Gli affreschi, in PEDUTO P. et Alii 1988, pp. 46-57. Fig. 17 - San Pietro a Corte (SA). Particolari con formazione di buchi nello strato pittorico e in quello di intonaco. EADEM 1999, Note sulla pittura medievale a Salerno. Gli affreschi di San Pietro a Corte e di Santa Maria de Lama, in “Apollo”, XV, pp. 46-60. MORA P. E. L. 1999, La conservazione delle pitture murali, Bologna, pp. 173-228. PEDUTO P. 1988, La costruzione del documento e la sua interpretazione stratigrafica, in PEDUTO P. et Alii 1988, pp. 9-28. PEDUTO P. et Alii 1988, Un accesso alla storia di Salerno: stratigrafie e materiali dall’area palaziale di Salerno, in “Riv. Storica Salernitana”, n. 10, pp. 9-63. ROMITO M. 1988, Le terme romane, in PEDUTO P. et Alii 1988, pp. 28-41. EADEM 11984, Strutture romane in San Pietro a Corte, in “Riv. Storica Salernitana”, n. 2, pp. 33-47. Fig. 18 - San Pietro a Corte (SA). Frattura dell’affresco sulla superficie muraria che interessa anche l’affresco. - 78 - GIANMATTEO FUNICELLI Picturae in ecclesiae S. Marie de Casalucio Gli affreschi di Casaluce. Una parentesi medievale Premessa a prima idea che si ha nel varcare l’uscio della Cappella Palatina di Santa Barbara in Castel Nuovo presso Napoli è quella di trovarsi in un conciliante spazio mistico profuso di luce e di un’amena essenza cultuale. Ma se si acutizza l’osservazione e ci si accosta con lo sguardo alle pareti dello spazio chiesastico, si ha l’impressione lucidissima di essere a contatto con un contesto medievale di grande portata. La struttura trecentesca lascia trasparire finissime monofore ed elementi in muratura frutto delle architetture catalane di primo Trecento: gli unici elementi fortunatamente sopravvissuti al recupero della chiesa Palatina e che nel loro insieme costituiscono l’apparato più antico del complesso castellare napoletano. Il particolare che più di tutti coglie il visitatore è la sistematica esposizione di pareti affrescate, disposte l’una accanto all’altra su entrambi i muri intonacati e sullo spazio di fondo. Sono spezzoni di pittura italiana, smembrati dalle accurate ‘stagioni degli stacchi’ promosse negli anni ’701 e desiderosi di emergere dai lacunosi ‘rimpiazzi’ in cemento per rivendicarsi il pregio interpretativo di un tempo ormai remoto. Il ciclo affrescato racchiude di primo acchito, tra forme e stile, ‘frammenti’ di pittura tardogotica di notevole valenza artistica, se si evidenzia che il magister degli elaborati è un giottesco fiorentino catapultato in una stagione artistica napoletana del tutto propizia per la corrente artistica di metà del Trecento2. La committenza in questione ci rimanda nella Terra di Lavoro angioina, in particolare a Casaluce. È nel casertano difatti che sopravvive tutt’oggi il grande castello nobiliare, trasformato poi in monastero celestino con L annessa chiesa che diventerà il fulcro della vicenda artistica qui esposta. Essa rimane tutt’oggi viva testimonianza delle molteplici esperienze pittoriche medievali in Italia meridionale. Del grande complesso castellare, di origine non precedente al periodo normanno3, oggi rimane una minima configurazione esterna di tufo che in ogni modo perpetua il suo antico valore di grande costruzione fortilizia seppure resa indefinita da una forte obliterazione, ma non è questa occasione per trarne spunti critico-descrittivi. Quello che spetta in questo scritto è delineare il frutto di un ‘miracoloso’ intervento di recupero, promosso dalla Soprintendenza del Polo Museale Napoletano, e con la cooperazione direttiva del Museo San Martino di Napoli, i quali hanno contribuito a preservare, rivalorizzare e musealizzare un pezzo di arte italiana che nel tempo è rimasto eclissato nello sfascio e il dimenticatoio comune. L’altro fondamentale scopo è presentare uno degli elementi clou della pittura tardo-medievale campana estratta dal contesto di Casaluce, ossia il ciclo delle Storie di San Guglielmo di Gellone e alcuni passi dalla Vita di Cristo dalle due cappelle laterali della Chiesa di Santa Maria ad Nives, sacrario facente parte del castello sunnominato. L’altro intervento sarà dedicato alla bottega del capomastro fiorentino in questione, composta da due affrescanti di notevoli abilità esecutive, che percorrono a Casaluce il loro specialistico apprendistato. Risultano scarse le ricerche sul recupero delle pitture al riguardo, e tali sono anche i dibattiti storico – critici esposti tra le recenti monografie, ma nella complessiva rivalorizzazione del cantiere pittorico si è ricorso anche a contributi scientifici e pubblicazioni di notevole apporto - 79 - SALTERNUM Fig. 1 - Niccolò di Tommaso, San Pietro Celestino (papa Celestino V) in trono accompagnato dai monaci celestini (particolare), XIV sec. (Napoli, Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). alla memoria artistica del luogo in esame. Questo scritto si propone anch’esso tale scopo. Ovvero vuole essere di ulteriore contribuzione alle scarse ma nel contempo esaustive ricerche che studiosi e ricercatori espongono tra le pagine di svariate pubblicazioni atte alla memoria del complessivo patrimonio storico-artistico campano. La committenza. Un valore ‘devozionale’ La pittura pertinente agli affreschi casalucensi ci porta alla consapevolezza di un vasto progetto esecutivo realizzato da ben tre figure distinte, un capomastro e due discepoli anonimi. Le indagini iconografiche eseguite da Ferdinando Bologna designano sulle esecuzioni un maturo contesto angioino, dove operò senza dubbio la mano di Niccolò di Tommaso, pittore fiorentino, che riservò particolari setti murari a due altre personalità di bottega, allievi di cui però non conosciamo l’identità e ci limitiamo a proporli come Secondo e Terzo Maestro di Casaluce. Sulle figure dei committenti e patrocinatori del ciclo, si apre un vasto capitolo di discussione, tale da percepire appieno il valore che assumono i nobili nei moventi di siffatte esecuzioni. La richiesta di un’opera da parte di figure di alto potere è determinata da interessanti punti di vista in cui il richiedente si presenta come il ‘vero ideatore’ dell’opera desiderata. Questo sta a giustificare nel commissionario uno specifico bisogno di ‘richiesta’ verso la figura a cui viene destinato l’ex voto. Per il ciclo di Casaluce i nobili concessori Raimondo Del Balzo, conte di Soleto, e sua moglie Isabella D’Apia si presentano nell’argomento in esame come i diretti committenti, tanto da rientrare anch’essi nelle scene figurate. Per inquadrare i due personaggi nel contesto politico della fine XIV secolo, basterà - 80 - GIANMATTEO FUNICELLI notare che la famiglia De Baux, volgarizzata in ‘del Balzo’, risulta di antiche origini provenzali, come i reali d’Angiò i quali rientrano anch’essi nel discorso artistico per essere stati gli iniziatori del successo della coppia. I d’Angiò stringeranno con la coppia un forte legame politico. Dopo essere stato insignito da Giovanna I del titolo di Gran Camerlengo, e facendosi così strada politica nel grande esercito reale angioino, Raimondo convola a nozze dapprima con Caterina de Lagonesse, per poi scegliere come seconda compagna Isabella D’Eppes (D’Apia)4. La famiglia di Raimondo risulta essere, dalle attestazioni artistiche campane, una delle tante in cui le committenze ricorrono come elemento peculiare nel riconoscimento pubblico, quasi come un dato distintivo. Non a caso l’enfasi del ruolo di promotori di cui si vestono i nobili coniugi si manifesta in continuo crescere tra i dati artistici del Castello5, mentre ricorrono spesso committenze anche nelle singole direttive artistiche di Isabella D’Apia6. Un documento dell’abate celestino Donato Siderno7, redatto quando l’archivio del castello era ancora del tutto agibile (1622), fa luce sull’acquisizione del maniero da parte del nobile francese, il quale lo ottenne annesso al casale di Casaluce nel giorno 8 febbraio del 1359 da Roberto D’Ariano, identificato come «cavaliero napolitano». Lo scopo dell’acquisto non fu solo quello di affermarsi politicamente, ma di fondarvi all’interno un micro-complesso monastico in cui venerare la sua importante collezione sacra: l’icona bizantina della c.d. Vergine di Casaluce e due idrie di sua proprietà e da egli stesso ritenuti i recipienti che il Cristo utilizzò per tramutare l’acqua in vino durante le Nozze di Cana. L’idea di istituire e annettere al castello di Casaluce un insediamento monastico celestino, intorno al 1365, è collegato ad un suo precedente intervento di edificazione monastica presso la Diocesi di Aversa. Non è certamente un caso che il Balzo abbia apportato alla circoscrizione diocesana di Aversa e al suo castello delle strutture conventuali (di cui una a carattere privato). I del Balzo con queste operazioni progettuali puntarono ad un fondamentale disegno di propaganda sacra per garantirsi una solida salvezza ‘per la vita eterna’, ovvero assicurarsi una protezione di carattere spirituale. Gli affreschi Meritevoli di una prima discussione sono le Storie di San Guglielmo di Gellone, in cui prevale l’unica ed inconfondibile mano lesta e sintetica di Niccolò di Tommaso. Queste, concentrate sul secondo ambiente congiunto alla navata di destra della chiesa di Santa Maria ad Nives, presentavano le vicende avventurose di Guglielmo d’Orange, il valoroso soldato che prestò servizio in Aquitania contro i Saraceni al servizio di Carlo Magno. Egli fondò a Gellone, a conclusione della sua carriera militare, l’abbazia in cui si rifugiò seguendo un’intensa vita monastica. Una prima dipintura del Maestro, però, verrà dapprima applicata per la raffigurazione dei committenti sullo spazio esterno del luogo sacro, e precisamente sull’intradosso della nicchia sinistra del portale di accesso alla chiesa. La scena descrive la coppia di nobili inginocchiati al cospetto di San Pietro Celestino (fig. 1), dove Isabella risulta accompagnata da Ludovico da Tolosa (fig. 2), questi in veste monacale. Nello spazio centrale vi è San Pietro Celestino assiso su di un monumentale trono8 in atto di benedire e con lo sguardo fisso verso l’osservatore, mentre il fitto gruppo dei Celestini in atteggiamento di preghiera assiste ai suoi piedi. Ferdinando Bologna individua lampanti affinità stilistiche nei tratti somatici del San Pietro casalucense e nel Sant’Antonio abate datato al 1371, facente parte del Trittico di Forìa, che tutt’oggi si conserva presso il Museo Nazionale di Capodimonte9. Si notano, oltre a ciò, anche delle contrapposizioni esecutive nel dipinto sacro. Differenze di resa che riguardano ad esempio il preciso vigore nel realizzare il Pietro Celestino in opposizione al sintetico ed inespressivo volto di Isabella che la studiosa Francesca Larcinese, in un suo intervento sul Pittore10, afferma essere stato realizzato da uno dei due collaboratori, in quanto i particolari anatomici ed il panneggio della figura femminile risultano essere approssimativi e di sommaria definizione. Lo si deduce dalla «diversità del medium pittorico», giustificato (probabilmente) dal fatto che il personaggio - 81 - SALTERNUM Fig. 2 - Niccolò di Tommaso, Isabella d’Eppe prega dinanzi a San Pietro Celestino accompagnata da San Ludovico di Tolosa (particolare), XIV sec. (Napoli, Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). Fig. 3 - Niccolò di Tommaso, L’incontro tra Guglielmo di Gellone e Carlo Magno (particolare), XIV sec. (Napoli, Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). risultava scarsamente visibile nella composizione. Così Niccolò decise di mettere alla prova uno dei due collaboratori. San Ludovico da Tolosa viene, al contrario, egregiamente raffigurato. Nell’affresco verrà commemorato per aver donato a Raimondo gli oggetti sacri da venerare nel santuario. L’attività artistica di Niccolò di Tommaso presso Casaluce, iscritta in un arco temporale che va dal 1365 al 1371, proviene da una più ampia e ‘fortunata’ committenza reale per mano di Giovanna I d’Angiò intrapresa dapprima nella Chiesa di Sant’Antonio abate a Forìa, dove eseguì il Trittico sunnominato. Alle mura gotiche del santuario casertano, invece, il maestro giottesco dedica dei passi tratti dalle Storie di San Guglielmo I di Tolosa, che gli storici ricordano più spesso come Guglielmo d’Aquitania. Il valoroso paladino franco, che visse tra il 755 e l’812 d.C., era figlio di un merovingio e nipote di Carlo Martello, per cui cugino di Carlo Magno; a lui vennero riconosciuti i titoli di conte di Tolosa, duca di Narbona e Gotia. Dopo varie vicissitudini legate alla vita militare, il guerriero abdicò presso Gellona, dove fondò un monastero (806). Le sue vicissitudini vengono tramandate dai passi poetici della ‘Chanson de geste’, dove l’animoso soldato è il protagonista di una guerra contro i Saraceni del Sud francese. È da questa leggendaria vicenda letteraria che si possono trarre particolari accadimenti che trovano eco nelle raffigurazioni degli affreschi in esame. In tal modo si potrà ricreare, nel parziale itinerario affrescato, un percorso narrativo sequenziale tale da costituire una rara trascrizione pittorica della saga. Il racconto si apre sulla prima storia del capitolo, ossia quella riguardante l’episodio di Guglielmo inginocchiato dinanzi a Carlo Magno (fig. 3) che presenta non poche zone lacunose: al centro della scena campeggia il giovane cavaliere prostrato dinanzi ad una figura assisa su di un trono (Carlo Magno) in presenza di un gruppo di monaci acefali, in quanto dallo stacco del complesso ci perviene solo la parte inferiore dei dipinti. Così come si presentano trinciati nella zona superiore la raffigurazione dei cavalli sull’esterno della scena a sinistra, i quali alludono alla lunga galoppata che precedentemente Guglielmo intraprese per raggiungere l’imperatore ad Arles. Il Santo è raffigurato intento a descrivere a Carlo il sogno nel quale la Vergine gli avrebbe dettato una missione: «conservare la corona del figlio Luigi nei sette anni che separano il delfino dall’età matura, essendo prossima la morte dell’Imperatore». Dopo questa vicenda, la pittura percorre uno scenario di combattimenti sostenuti dal guerrie- - 82 - GIANMATTEO FUNICELLI ro contro i Saraceni, sviluppato dapprima nel frammento raffigurante l’imperatore sul suo fedele destriero bianco – purtroppo tanto lacunoso da cancellarne l’intera area superiore – al di sotto del quale compare un soldato sopraffatto. Nella scena raffigurante il combattimento tra Guglielmo e il gigante, viene presentato un personaggio ciclopico, dalla corazza rossa e la possente clava, identificabile in Renoardo, Re dei Saraceni (fig. 4). L’affascinante duello, in cui il fulcro della scena è la lancia di Guglielmo saldamente tesa verso il gigante, viene assistito da tre donne che si Fig. 4 - Niccolò di Tommaso, Duello tra Guglielmo di Gellone e il gigante Rinoardo (particolare), stagliano sullo sfondo cupo del XIV sec. (Napoli, Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). bosco. Solo una delle gentildonne dalle mani legate volge lo sguardo alla scena, Guiborc, moglie di Guglielmo. La forte ed affannosa espressività dei volti delle donne rimanda alla Deposizione di Niccolò nella Pinacoteca di Parma, dove i volti delle donne attorno al Cristo riprendono lo stesso schema del sopracciglio congiunto alla canna del naso, nonché lo stesso lieve vigore emotivo delle ‘pie donne’. La conclusione del ciclo rimanda alla scelta del Santo verso la vita monastica. Una delle testimonianze è descritta su di un pannello conservato presso il Museo di San Martino, in cui campeggia una figura di spal- Fig. 5 - Niccolò di Tommaso, Scena non identificata tratta dalla vita di Guglielmo di Gellone le intenta a trasportare del materia- (particolare), XIV sec. (Napoli, Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). le da costruzione in un contesto vago e montuoso. Si tratta delle montagne di completa identificazione, risulta operazione Gellona, l’attuale Saint-Guilhelm-du Desert e le ardua quella di riconoscerne sia le giuste temapietre trasportate dall’uomo indicano la prima tiche che gli elementi intrinsechi: si tratta di un fase della Fondazione del monastero di Gellone brano in cui si leggono due figure, un uomo ed sui monti rocciosi, dove una visione divina gli una donna con un’espressione affranta e recancomunica verbalmente: «In questo deserto ti un bambino in fasce. I due si allontanano costruirai la tua casa, servirai il Signore giorno e mentre alle loro spalle una figura, che esce da notte». una porta sulla destra e armata con un bastone, Per i rimanenti affreschi, data la loro notevoallontana altre persone piangenti (fig. 5). Un le frammentarietà, tale da non permetterne la altro lacerto non individuabile è la struttura di - 83 - SALTERNUM Fig. 6 - Niccolò di Tommaso, Angelo entro cornice cosmatesca, XIV sec. (Napoli, Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). un edificio con arcate a tutto sesto e riccamente rivestito da modanature policrome e particolari quali bifore goticheggianti e colonnine tortili. Privati della lettura della parte inferiore, si scorge a malapena sul lato sinistro una figura femminile panneggiata di bianco e rosa e recante un oggetto, probabilmente un cesto con del pane, teso verso un uomo genuflesso che in cambio offre alla figura femminile un libro. Infine si evidenzia un terzo elemento pittorico identificato come un angelo iscritto in una cornice costituita da finte tarsie marmoree e dove lo spazio presenta elementi decorati in stile cosmatesco (fig. 6). Nell’intelaiatura geometrica compare un angelo riccamente vestito e dalle ali bianche. La grazia e l’armonia celeste è trasposta da Niccolò sul volto dell’angelo con abile e consapevole ingegno, tale da sottolinearne un raffinato valore emotivo. La continuità della Bottega. Il Secondo e il Terzo Maestro di Casaluce. In linea di continuità, agli affreschi del sacrario parteciparono attivamente altri allievi che la storiografia ha variamente interpretati11. Le ultime attribuzioni li riferiscono all’opera di due artisti non del tutto riconoscibili, il Secondo ed il Terzo Maestro di Casaluce, ai quali Niccolò riservò gli spazi della prima cappella dell’ingresso alla chiesa. Le tematiche affrontate dagli apprendisti hanno i seguenti contenuti: sugli interi spazi della cappella vennero raffigurate Scene della vita di Cristo e le Storie di Sant’Antonio abate. Nello spazio murario dell’altare vi erano inoltre due Santi in trono incorniciati e sormontati da una lunetta in cui si presenta una figura femminile entro un clipeo. Nella zona superiore dell’arco d’accesso alla cappella vi era raffigurato Il Sogno di Giacobbe, mentre nel registro inferiore erano affrescate delle singole figure di Santi, ovvero Antonio abate, un Santo certosino non del tutto identificato, e una Maria Maddalena (fig. 7). Gli ultimi due personaggi sacri rimangono i più enigmatici ed in attesa di un’appropriata identificazione agiografica. Difatti resta puramente indicativa l’ipotesi che la figura monacale maschile, recante un vaso nella mano destra, sia un personalità eminente nella cerchia ecclesiastica del contesto, così come la figura recante il ramoscello di fiori è stata maldestramente individuata come Santa Maria Maddalena, in cui tutti riconosciamo una simbologia lontana dall’ideale di purezza. Per quel che concerne le scene della Vita di Sant’Antonio, assegnate al Secondo Maestro, la Larcinese interpreta l’artista come un possibile fiorentino in quanto risultano lampanti alcuni ravvicinamenti alla pittura giottesca di Maso di Banco. Se si osservano i particolari paesaggistici della suggestiva scena di Sant’Antonio nel deserto (fig. 8), si notano forti richiami ai paesaggi murari che eseguì Giotto nella più fortunata stagione assisiate. Un paesaggio dalla vegetazione netta, e di notevole spazialità, di larga campitura e profondità prospettica: l’ideale ambientazione per inquadrare il Santo anacoreta che, attorniato dai demoni, si presenta verso il Cristo, mentre la folla incuriosita osserva la scena. Risulta fondamentale notare i particolari della resa chiaroscurale nei tratti somatici, che variano dalle linee mimiche dei volti attoniti alle mani dolcemente segnate dai tocchi chiaroscurali, sino ai leggeri panneggi, sia dei personaggi centrali della scena, che nel Cristo benedicente. Questi i segni peculiari di una minuziosità effettiva che ricorre anche nelle opere di Niccolò di Tommaso. - 84 - GIANMATTEO FUNICELLI Passando all’esecuzione delle Esequie di Sant’Antonio abate (fig. 9), per la cui paternità artistica si continuano ad accettare entrambi i pittori anonimi, ci soffermiamo su di una scena abilmente iscritta in una sontuosa parentesi architettonica, a prospettiva centrale e di grande resa spaziale, tale da contenere il corpo spento del Santo nello spazio del centro e il corteo di monaci affollati sullo spazio di destra. Il punto culminante della scena dovrebbe focalizzarsi sul corpo del Santo in primo piano, ma l’attenzione del critico stavolta si riversa sui particolari della Fig. 7 - Secondo Maestro di Casaluce, Santo benedettino e Santa vergine, XIV sec. (Napoli, Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). costruzione architettonica riccamente espressa nei valori goticheggianti. Il considerevole alzato presenta un vano centrale aggettante sovrastato da un soffitto intelaiato sotto cui si iscrivono i pennacchi dell’arco di sostegno a decorazione cosmatesca, attraverso il quale si presenta sullo sfondo un altro vano in cui è inclusa una bifora con estremità trilobate e con oculo. Gli spazi attigui a quello centrale si allineano al vano di fondo e presentano le stesse decorazioni intarsiate. Sullo spazio frontale di questi si aprono due archetti a sesto acuto schiacciato. La teoria secondo la quale l’opera potrebbe essere il Fig. 8 - Secondo Maestro di Casaluce, Sant’Antonio nel deserto (particolare), XIV sec. (Napoli, risultato di una collaborazione a Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). quattro mani tra il Secondo ed il nella Rinuncia e donazione dei beni di Terzo Maestro risulta da un attenta analisi che Sant’Antonio ai poveri. Potrei avanzare, a mio compie P. Leone De Castris nel rapportare attiavviso, che le architetture del registro sinistro nenze di gusto compositivo tra le architetture della lunetta (quella meno lacunosa) presentano delle Esequie del Secondo Maestro, e lo spazio una particolare soluzione di inquadramento proarchitettonico nella Distribuzione dei beni ai spettico più contenuta, ma nel contempo del poveri attribuita invece al Terzo Maestro (fig. tutto spaziata invece negli interni, a differenza 10). La raffigurazione seguente, erroneamente dell’affannoso edificio sacro delle Esequie di identificata come Storia della vita di San Sant’Antonio del Secondo Maestro (si noti come Lorenzo, trova una più valida interpretazione - 85 - SALTERNUM Fig. 9 - Secondo Maestro di Casaluce, Esequie di Sant’Antonio abate, XIV sec. (Napoli, Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). Fig. 10 - Terzo Maestro di Casaluce, Distribuzione dei beni ai poveri (Storie di San Lorenzo ?) (particolare della lunetta sinistra lacunosa), XIV sec. (Napoli, Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). il Santo si lascia alle spalle una porta socchiusa, tale da localizzare la scena probabilmente in un’anticamera o nello spazio di un porticato). Basti notare la leggerezza dei due archi a tutto sesto in cui si inserisce la scena. Dell’altro registro, quasi del tutto obliterato, ci rimane una figura di spalle in abito sacerdotale che varca una più complessa architettura d’interno. Dell’abilità del Terzo Maestro, infine, mi limito ad annoverare la parete destra di un’ulteriore lunetta, ossia quella in cui è decritta, tra le parziali scene della cristologia casalucense, La chiamata di Giacomo e Giovanni intenti a pescare col padre Zebedeo (fig. 11). L’affresco, identificato anche come Chiamata di Pietro e Andrea12, raffigura il Cristo che giunge verso la barca dei pescatori Giacomo e Giovanni per indurli a seguire la predicazione cristiana. La scena, modulata in un’ambientazione fluviale, presenta i due fratelli che lasciano il padre Zebedeo - raffigurato in barca sull’estrema destra mentre ricompone la rete, ignaro dell’accaduto - per ascoltare le parole del Cristo. A questo elaborato pittorico si dovrà giustamente riconoscere una sommarietà nelle esecuzioni dei volti, in cui emergono di buona qualità solo i tratti gentili del Cristo, personaggio chiave, in relazione a quelli attoniti dei fratelli pescatori, di resa più grossolana. Altrettanto indicativi sono i particolari anatomici delle mani e dei piedi di tutti i personaggi. Per i panneggi si ricorre a sommarie campiture cromatiche (povere quantitativamente e limitate al giallo-ocra, rosso, blu e verde) su cui vengono registrati sintetici tratti chiaroscurali, resi essenzialmente tramite solide e scure pennellate verticali, alternate a lievi biancheggiature. Elementi di pregio nell’esecuzione dell’elaborato sono da riconoscere soprattutto nella rappresentazione spaziale che, seppur impostata nel condizionato e disarticolato spazio della semilunetta di destra, si presenta del tutto esaustiva; presenze urbanistiche sullo sfondo, il fiume reso in prospettiva sull’area centrale, e la piccola ambientazione, fortemente marcata da ritmi chiaroscurali, sullo spazio di destra in cui viene centrata la scena rappresentata. In conclusione, nello stesso Terzo Maestro è da evidenziare una resa minore del naturalismo presente invece nelle dipinture del Secondo Maestro. Il Terzo Maestro agisce su composizioni dai forti verticalismi ed allungamenti anatomici enfatizzanti: elementi riscontrabili palesemen- - 86 - GIANMATTEO FUNICELLI Fig. 11 - Terzo Maestro di Casaluce, La chiamata d Giacomo e Giovanni, intenti a pescare col padre Zebedeo, XIV sec. (Napoli, Castel Nuovo, Cappella di Santa Barbara). te nei volti e nei corpi allungati dell’Apparizione di Cristo alla Vergine, facente ugualmente parte del ciclo. Conclusioni A termine di questo breve excursus pittorico, sarebbe opportuno soffermarsi su altri elementi che in questo esame non sono stati menzionati. Trattasi di ulteriori pareti affrescate che denunciano una notevole alterazione e necessitano di un urgente restauro per ritornare a descrivere una parentesi dell’arte italiana del XIV secolo, che tutt’oggi vive in condizioni fatiscenti tra gli stucchi e le intonacature barocche della Chiesa di Santa Maria ad Nives di Casaluce, uno scrigno di storia dell’arte medievale. - 87 - SALTERNUM NOTE Trattasi della ‘Stagione degli stacchi degli affreschi’, attività di recupero promossa dalla ‘Scuola di restauro’ fiorentina a partire dal 1971. 2 Per comprendere validi punti sulla promozione dell’artista nel tardo Medioevo alla corte dei grandi Imperatori si rimanda a WARNKE 1995, p. 216. 3 Per la storia del maniero casalucense si veda DI NARDO 1969, pp. 20-25. 4 Risultano scarse le informazioni su Isabella d’Apia: probabilmente figlia del Cavaliere Giovanni d’Eppes, siniscalco del Regno di Sicilia. Nata nel 1305 e morta tra il 4 e il 14 luglio a Napoli del 1375. Alle nozze col del Balzo risultava già vedova di due matrimoni precedenti. Le sue origini possono essere chiaramente attestabili in Francia, come si evince dall’epigrafe iscritta sulla sua tomba che recita: «ISABELLA CELEBRI SIC NOMINE DICTA / DEQUE APIA CLARUM TRAXIT COGNOMEN AVORUM / FRANCIA QUOS GENUIT […]». 5 Al ruolo di committenza che ebbero i del Balzo fa riferimento una lunga iscrizione in caratteri gotici posta nel portico del sacrario, precisamente sul lato destro del portale. L’epigrafe, in cui i consorti vengono esaltati in maniera egualitaria, elogia la fondazione della chiesa dedicata alla Vergine come frutto della stretta volontà di entrambi i personaggi. 6 Esiste nel Castello una commissione unicamente diretta da Isabella. Essa si trova in una lunetta cuspidata nel portale d’ingresso alla chiesa. Nell’interno vi è un gruppo marmoreo raffigurante una ‘Madonna con Bambino’ mentre ai lati vi sono due figure di Santi. Nella figura maschile canuta 1 BIBLIOGRAFIA ALABISO A. – GIUSTI L. 2006, Il restauro del patrimonio artistico dal secondo dopoguerra: criteri, scelte, risultati, in Napoli e la Campania del Novecento. Diario di un secolo, Napoli, vol. II, pp. 219-237. BOLOGNA F. 1969, I pittori alla corte angioina di Napoli, 1266-1414, e un riesame dell’arte nell’età federiciana, Roma. BRANDI C. 1963, Teoria e storia del restauro, Torino. CAMPANILE F. 1618, Dell’armi, ovvero insegne de’ nobili, seconda impressione, Napoli. CAPECELATRO F. 1769, Origine della città e delle famiglie nobili di Napoli, Napoli. CLOETTA W. 1946, Les deux redactions en vers du Moniage Guillaume, chanson de geste du XIIe siècle, Paris. COPPOLA G. 2003, Tipologie fortificate nell’Italia meridionale normanna, XI-XII secolo, in Le opere fortificate di epoca normanna. Un problema di conservazione, a cura di S. FRANCESCHI - L. GERMANI, Firenze, pp. 9-14. DI NARDO M. 1969, Il Castello di Casaluce, in Arte in Aversa, 2, pp. 20-25. FASSO’ A. 1995 (a cura di), La canzone di Guglielmo, Parma. LEONE DE CASTRIS P. 1990, Castel Nuovo, Il Museo Civico, Napoli, pp. 75-83. IDEM 1995a, L’Italia meridionale, in Pittura murale d’Italia. Dal tardo Duecento ai primi del Quattrocento, a cura di M. l’iconografia riconosce S. Giacomo Maggiore, mentre l’altro personaggio intagliato, dai tratti incisivamente femminei, si presenta come Giovanni, fratello di Giacomo. Sul gruppo statuario spicca lo stemma nobiliare dei d’Apia, ma questa volta non integrato a quello dei del Balzo. 7 Donato Pullieni de’ Lupari da Siderno, monaco celestino dalle alte cariche ufficiali, nacque a Siderno probabilmente tra il 1570 e il 1575. Dopo aver compiuto i primi studi teologici ed essere entrato nell’ordine dei Celestini di Bologna, giunse a Napoli nel 1609, dove si trasferì dapprima nel monastero di San Pietro a Majella per poi stabilirsi definitivamente nel Monastero di Casaluce. Qui guidò la sua comunità come Abate (1609). 8 Nel soggiorno artistico napoletano, Niccolò di Tommaso si concesse una breve villeggiatura a Capri, dove sulla lunetta d’ingresso alla Certosa realizzò una Vergine assisa tra due committenti. Il trono caprese è identico a quello di Celestino V dell’affresco casalucense. 9 Lo stesso Bologna afferma che Niccolò lasciò rapidamente Firenze per raggiungere Napoli e realizzare il progetto della regina angioina Giovanna I, ovvero il Trittico per la Chiesa di S. Antonio abate a Forìa. Per questo punto si veda BOLOGNA 1969, p. 326. 10 STRINATI 2007, pp. 49-52. 11 Ottavio Morisani attribuì la paternità dell’intero ciclo ad Andrea Vanni, autore di un vasto polittico di cui una sezione è conservata presso il Museo di Capodimonte (MORISANI 1947, pp. 91-92). 12 LEONE DE CASTRIS 1990, p. 80. GREGORI, Torino, pp. 180-202. IDEM 1995b, A margine de “I pittori alla corte angioina”: Maso di Banco e Roberto d’Oderisio, in Napoli, l’Europa: ricerche di storia dell’arte in onore di Ferdinando Bologna, a cura di F. ABBATE – F. SRICCHIA SANTORO, Catanzaro, pp. 45-49. MAIURI A. 1940, Picturae Ligneis Formis inclusae. Note sulla tecnica della pittura in Campania, in “Accademia dei Lincei”, fasc. 7-10, pp. 138-160. MILANESI G. 1901, Nuovi documenti per la storia dell’arte toscana dal XII al XV secolo, nuova ed., Firenze. MORSANI O. 1947, Pittura del Trecento a Napoli, Napoli. PARENTE G. 1857, Origini e vicende ecclesiastiche della città di Aversa, frammenti storici, Napoli, pp. 157-163. RUSSO B. 1934, Il santuario della Madonna di Casaluce e il suo castello, Aversa. STRINATI T. et Alii 2007, Casaluce. Un ciclo trecentesco in terra angioina, Milano. TARTUFERI A. 1985, Appunti tardogotici fiorentini: Niccolò di Tommaso, il Maestro di Barberino e Neri di Bicci, in “Paragone”, n. 425, pp. 3-16. WARNKE M. 1995, Artisti di corte. Preistoria dell’artista moderno, Roma. - 88 - MARIA GIOVANNA VESPASIANO La Natività della tradizione apocrifa nella cripta della cattedrale di Nusco (AV) Fig. 1 - Gruppo statuario in stucco con la Vergine distesa dopo il parto e S. Giuseppe. Nusco, Cripta della Cattedrale. U na rappresentazione presepiale decisamente inusuale connota una piccola cappella laterale nella cripta della chiesa vescovile di Nusco, in provincia di Avellino. A marcare l’originalità della Natività é la composizione della scena: in parte affidata a due singolari statue (fig. 1), entrambe in pesante stucco cementizio, che mostrano un San Giuseppe sonnolente e la Vergine distesa dopo gli sforzi del parto, in parte raffigurata mediante pitture murali databili alla prima metà del XV secolo, un parato a fresco che occupa la quasi totalità delle pareti della piccola cella e che successivi lavori di sistemazione della soprastante area presbiteriale hanno in parte compromesso. Mentre la scoperta e la lettura del ciclo pittorico e della statua del vecchio dormiente è questione recente (gennaio 1999), la figura femminile adagiata su di un catafalco è stata oggetto nel tempo di diverse interpretazioni. Per secoli è stata ritenuta come la Vergine del Soccorso, cui affidare la supplice preghiera delle partorienti; aspirazione taumaturgica comune per tutto il Medioevo, quando il parto costituiva un grave - 89 - SALTERNUM Fig. 2 - Vergine puerpera, statua lignea donata dalla regina di Napoli Sancia di Maiorca alle Clarisse del Convento di Santa Chiara. Napoli, Museo di S. Martino (secolo XIV). pericolo, tale da suggerire alle donne gravide di rivolgersi in primo luogo alla Madre di Dio per chiedere a lei, in quanto Madre, aiuto e protezione. Il successivo ritrovamento, nel 1959, di un’epigrafe tombale lasciò intendere poi che quell’ambiente ipogeo potesse essere la cella sepolcrale dei Gianvilla (Janville) e la scultura la maschera sepolcrale di Ilaria, la nobile feudataria di Nusco morta nell’aprile del 1522, visibile solamente attraverso una sorta di fenestella confessionis che si apriva nel sacello ipogeico. Bisognerà attendere l’esecuzione dei lavori successivi al terremoto del 19801 per arrivare all’esplorazione del piccolo ridotto e conseguentemente al ritrovamento del ciclo pittorico; cosa che ha reso certamente più attendibile l’ipotesi che in quell’ambiente fosse stata ricreata un’ambientazione presepiale, una ricostruzione fortemente scenografica, letta alla luce dei Vangeli apocrifi e realizzata secondo i canoni iconografici ancora consentiti nei primi secoli del secondo Millennio. Nusco, sulla dorsale della linea spartiacque appenninica, a cavallo dell’alta Valle dell’Ofanto e del tratto superiore della Valle del Calore, è città di antica cristianità, sul cui seggio episcopale, nel 1048, salì per primo S. Amato, grazie alla nomina ottenuta dall’Arcivescovo di Salerno Alfano I e con il consenso di Roberto il Guiscardo. E proprio al Santo Vescovo di Nusco si deve la costruzione, nel 1093, e la dedicazione della maggior chiesa al protomartire S. Stefano. Una dedicazione solo formale, però, poiché da subito la chiesa fu per tutti quella di Sant’Amato, come si evince anche da un’ordinatoria di re Roberto d’Angiò del 1311, nella quale la chiesa vescovile di Nusco veniva denominata col titolo di Ecclesia Sancti Amati. La cattedrale si trova al centro della struttura urbanistica medievale, individuata nella città murata con il castello. In diretta relazione con la chiesa maggiore è la piazza, a cui si giunge attraverso la strada principale che dalla porta urbis conduce alla cattedrale, il cui impianto fa riferimento ad una tipica configurazione di stampo romanico della quale non sono sopravanzati particolari elementi, tranne poche tracce nella cripta sottostante il transetto e riferibili alla chiesa preesistente, forse la primitiva struttura del complesso di Santo Stefano. E in questa cripta, dove tra l’altro è conservata la preziosa urna con le ossa di Sant’Amato, si apre la cella con la singolare rappresentazione presepiale di cui ci stiamo occupando. Nella raffigurazione pittorica della Natività arcaica, mutila purtroppo in molte parti, anche se perfettamente leggibile, si riconoscono tutti gli elementi compositivi che si ritroveranno poi nella tradizione presepiale occidentale: c’è la grotta, che poi diverrà una capanna; l’asino e il bue; gli angeli che danno l’annuncio ai pastori; i Magi e le levatrici, che in seguito dovranno scomparire. A tenere la scena, però, sono le due figure statuarie: la Madonna, distesa su un prezioso drappo rosso, come nelle più classiche delle raffigurazioni bizantine, e S. Giuseppe, raffigurato nell’atteggiamento meditabondo di chi va interrogandosi sulla reale paternità di quel bambino. Praticamente la stessa ambientazione che M. Piacenza, già presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, descrive in un suo contributo, La rappresentazione della Natività nell’arte, raccolto in una nota dell’Agenzia Fides del 23 dicembre 2005: «A partire dal IV secolo la Natività divenne uno dei temi più frequentemente rappresentati nell’arte religiosa, come dimostrano il prezioso dittico in avorio e pietre preziose del V secolo conservato nel Duomo di Milano, i mosaici della Cappella Palatina a Palermo, del Battistero di - 90 - MARIA GIOVANNA VESPASIANO Venezia e delle Basiliche di Santa Maria Maggiore e di Santa Maria in Trastevere a Roma. In queste opere la scena si svolge in una grotta, utilizzata per il ricovero degli animali, con Maria distesa come una puerpera, Giuseppe assorto in un angolo e gli Angeli che portano l’annuncio ai pastori, mentre a volte in lontananza si intravedono i Magi. Il centro della composizione è costituito dal Bambino Gesù, avvolto in fasce, talmente strette da parere quelle di un morto, e deposto in una culla, che a volte sembra un sarcofago, a preannunciare simbolicamente la sua morte e la risurrezione. La rappresentazione è inoltre arricchita da particolari tratti dai Vangeli apocrifi, come il bagno del Bambino, a sottolineare la realtà dell’incarnazione del Verbo, vero Dio e vero uomo». A incoraggiare la tesi che quella della cripta di Nusco sia una Natività, anche se manipolata nel tempo, c’è la fattura dei due altorilievi, formati da parti originali e da altre ricomposte secoli dopo da mani più inesperte, in una diversa postura e con materiale differente. Della Vergine, ad esempio, solo la parte superiore, il busto e il capo sono primigeni, mentre il resto è lavoro di restauro, confermato dalla circostanza che tra il materiale di risulta nella cripta sono stati poi rinvenuti un piede femminile e una mano su uno sfondo rosso, facilmente riconoscibili come il piede e la mano originali. Un coerente raffronto iconografico rimanda la lettura della figura della Madonna della cripta nuscana a quella della Vergine puerpera donata dalla regina di Napoli Sancia di Maiorca alle Clarisse del Convento di Santa Chiara e conservata nel Museo di S. Martino a Napoli (fig. 2). Questa Madonna, si legge sul pannello didascalico del sito museale, «é raffigurata distesa, secondo un’iconografia di provenienza siriaca, diffusa fin dal VI secolo. Ancora pensosa per il solitario travaglio ed assorta nell’arcano mistero, la Vergine aveva, presumibilmente, come in altre iconografie coeve, il Bambino alle sue spalle riscaldato dal bue e dall’asino. In questa fase di svolgimento del tema iconografico la figura di Giuseppe appare estranea alla scena sacra, mentre compaiono le nutrici, Zelomi e Salomé citate nei Vangeli apocrifi». Fig. 3 - Scena presepiale, il primo bagno di Gesù Bambino. Nusco, Cripta della Cattedrale. Una descrizione di come si presentasse quella che a Nusco, ab antiquis temporibus, era ritenuta la Vergine delle partorienti l’ha lasciata un avveduto storico locale, G. Passaro, che ebbe modo di vedere la statua prima che la successiva opera restauratrice recuperasse le originali fattezze e la primitiva postura per consegnarcela come la si vede oggi: «Nell’ipogeo della cattedrale di Nusco è un simulacro in gesso, venerato sotto il titolo di Madonna del Soccorso. Con le mani giunte, senza Bambino, è vestita di tunica e di pallio, che, dalla testa, ricadendo sugli omeri e sulle braccia, finisce quasi nel mezzo della figura. Porta sul capo una corona, a punte, di legno dorato; i piedi poggiano su di una mensola di tiglio; giace distesa sopra un piano leggermente inclinato». Della statua di Giuseppe, invece, sono originali solo la testa e le piante dei piedi, pure queste ritrovate tra il materiale di riempimento della cella. I reperti rinvenuti sono in pietra e calce impastata e rivestita di stucco, lo stesso materiale con cui è fatta la statua della Madonna. La riproduzione di tutti gli altri personaggi del Presepe, invece, è affidata alle pitture murali e al pennello di un anonimo frescante che operò sulle pareti della cripta-grotta dell’antica cattedrale di Nusco. L’esegesi teologico-iconografica di questa Natività rende evidente l’umanità di Maria, collocata al centro della ricostruzione scenografica; una condizione che fa da contraltare alla divinità del Bambino. Tale centralità trova la sua ragion d’essere nei canoni del Concilio di Efeso - 91 - SALTERNUM Fig. 4 - Scena presepiale, Gesù Bambino nella culla tra il bue e l’asino. Nusco, Cripta della Cattedrale. Fig. 5 - Scena presepiale, l’annuncio ai pastori. Nusco, Cripta della Cattedrale. Fig. 6 - Scena presepiale, i Magi in cammino. Nusco, Cripta della Cattedrale. del 431, che indicò la Vergine come il più perfetto esempio di umanità, proclamandola con il titolo di Theotókos, Madre di Dio; in questo richiamando con maggiore pregnanza quanto già i Vangeli avevano fatto comprendere, là dove si legge di Maria che ha concepito e generato un figlio, il quale è il Figlio dell’Altissimo, Santo e Figlio di Dio (Lc 1,31-32.35); Maria inoltre è chiamata ‘Madre di Gesù’ (Gv 2,1.3; At 1,14), ‘Madre del Signore’ (Lc 1,43) o semplicemente ‘madre’, ‘sua madre’ come più volte nel capitolo 2 di Matteo. Con l’intento di sottolineare l’assoluta naturalità della nascita del Bambino, la Vergine della cripta nuscana rimanda, per la sua posizione sdraiata, all’immagine di una puerpera che si è appena sgravata. Il suo volto, però, è sereno e per niente provato dalle fatiche del parto, così come vuole la concezione teologica di alcuni Padri della Chiesa, tra i quali S. Girolamo, che ritengono che il parto di Maria sia avvenuto senza degradazione e senza dolore. Nella scena presepiale di Nusco è del tutto evidente che la Madonna ha occhi solo per il Bambino, immerso già grandicello in una conca che ricorda il fonte battesimale, mentre due donne si occupano di lavarlo (fig. 3). La più anziana di queste, vestita con abiti più sontuosi, è certamente Salomè, l’ostetrica che, secondo i Vangeli apocrifi, ha dubitato della verginità di Maria. L’altra, invece, vestita più poveramente, è Zelomi. E occorre rifarsi ancora ai testi apocrifi (Protovangelo di Giacomo 18-19; Vangelo dello Pseudo-Matteo; Vangelo dell’infanzia arabosiriaco; Vangelo dell’infanzia armeno) per leggere l’altra scena della Natività, visibile alle spalle della Madonna, quella dove campeggia il Bambino con le fattezze di un neonato che sta ad indicare che tutto è presente, che il moto della natura è sospeso. Assecondando la teologia per immagini della tradizione bizantina, l’Infante è raffigurato tra il bue e l’asino (fig. 4), avvolto in fasce che ricordano le bende della sepoltura e in una vasca in pietra che ha le fattezze di una cassa sepolcrale, aperta per anticipare quello che sarà il destino umano del Salvatore dell’umani- - 92 - MARIA GIOVANNA VESPASIANO tà. In entrambe le scene la divinità del Bambino viene espressamente fatta risaltare dai nimbi dorati che cerchiano il capo delle due figure infantili. Un angelo, intanto, non molto lontano, annuncia solennemente ai pastori la nascita del Messia (fig. 5), mentre i Magi già sono in cammino, a piedi o su cavalcature le cui briglie sono rette da un paggio (fig. 6). Il paesaggio che fa da sfondo alla Natività è segnato da una rada vegetazione che si alterna a rocce taglienti e a spigoli vivi, quasi a volere significare che il Salvatore è nato in un mondo arido e freddo e quindi ostile. Dall’alto, infine, scendono tre raggi della stella di Giacobbe, evocata dall’oracolo messianico del mago Balaam, la cui storia si legge nel libro biblico dei Numeri (24, 17). Insieme a tutto questo, al disotto della scena pittorica e giusto ai piedi della Madonna, c’è la statua di S. Giuseppe, mostrato come un uomo anziano; peculiarità che viene ancora una volta ripresa dai Vangeli apocrifi. Il vegliardo, infatti, è rappresentato distante, in atteggiamento pensieroso, rinchiuso di fronte al mistero nel mantello dei propri pensieri e nel suo umanissimo dubbio. Lui sa di non essere il padre del neonato, per cui pare quasi che non voglia lasciarsi coinvolgere dalla scena e nella scena che si svolge attorno a lui. Questa tipologia di raffigurazione si ritrova assai di frequente in affreschi quattrocenteschi del Cilento, come la Natività nella cripta di Santa Maria dei Longobardi a Novi Velia (fig. 7), pure questa chiaramente ispirata dai Vangeli apocrifi. Testi la cui influenza sarà riconosciuta acriticamente, almeno fino ai veti imposti dal Concilio di Trento, come un valido strumento didattico e didascalico. L’arte e la letteratura, infatti, hanno guardato attentamente per tutto il Medioevo e il Rinascimento all’intensa carica di umanità e al fin troppo esplicito realismo che contraddistinguono, ad esempio, i Vangeli dell’infanzia, che a differenza dei testi canonici raccontano con maggiore senso narrativo la nascita miracolosa di Gesù fino a coinvolgere personaggi nuovi. Cosicché, anche nella cripta della Cattedrale di Nusco, immaginata come la Fig. 7 - Natività. Novi Velia, Cripta di S. Maria dei Longobardi. Fig. 8 - Natività. Laurito, Chiesa di S. Filippo d’Agira. grotta sotterranea «in cui non c’era mai stata luce, ma sempre tenebre», secondo il Vangelo dello Pseudo-Matteo XI, si vedono le levatrici impegnate a fare il bagno a Gesù. La presenza delle donne colloca gli affreschi di Nusco tra gli epigoni delle rappresentazioni presepiali che hanno attinto alla tradizione apocrifa, e per questo assumono un valore e un significato decisamente più interessante. Riprendendo il discorso sulle prescrizioni imposte dal Concilio tridentino, è utile ricordare la Natività della Chiesa di S. Filippo d’Agira a Laurito (fig. 8), cittadina prossima a Novi Velia, dove, mentre continuano ad esserci tutte le figure e gli elementi arcaici, la Vergine è ora in piedi, in posizione adorante. Altra evoluzione iconografica è quella che si ritrova nel battistero paleocristiano di S. Maria Maggiore a Nocera Superiore, dove la ‘grotta’ della natività è diventata la ‘capanna’ immaginata da San - 93 - SALTERNUM Francesco. Già prima che la Chiesa vietasse con il Concilio di Trento la riproduzione nelle raffigurazioni iconografiche di soggetti dottrinalmente non corretti, quale era la scena del bagno e il parto della Vergine simile a quello di una comune donna, le elaborazioni dogmatiche di San Tommaso e le Meditazioni sulla vita di Cristo dello Pseudo-Bonaventura (il francescano Giovanni De Caulibus di San Gimignano) influenzarono l’operato degli artisti. Santa Brigida di Svezia, destinataria di suggestive Revelationes su alcuni episodi della storia sacra, tra i quali la nascita del Cristo, contribuì con maggiore determinazione a suggerire nuove figurazioni iconografiche, affermando che sul corpo di Gesù non c’era ombra di lordura. La descrizione della Natività fatta dalla Santa svedese, così dettagliata e ricca di particolari, ebbe maggiore impatto sugli artisti rispetto alle Meditationes vitae Christi, cosicché l’impianto rappresentativo del Natale conobbe, allora, una considerevole innovazione nei contenuti e nel linguaggio figurativo. In particolare, la formulazione di questa nuova rappresentazione andò presumibilmente sviluppandosi a Napoli ad opera del fiorentino Niccolò di Tommaso, pittore di corte della regina Giovanna negli anni Settanta del XIV secolo. L’artista toscano, che con molta probabilità aveva incontrato Brigida proprio alla corte angioina2, dove la visionaria svedese, di ritorno dal viaggio in Terra Santa, era giunta alla fine del 1372 per restare ospite per qualche tempo nel palazzo di Aversa, ripropose in tre piccoli pannelli la visione della Natività secondo i canoni dettati da Brigida, che venne raffigurata mentre riceve le rivelazioni a Betlemme. In questi dipinti, oggi conservati in diversi musei3, la nobildonna svedese, priva di aureola perché non ancora santa, viene rappresentata genuflessa intanto che assiste adorante alla visione di Maria inginocchiata di fronte al Figlio che giace sul pavimento della grotta. Per tornare alla lettura critica della Natività della chiesa vescovile di Nusco, occorre dire che la ricostruzione riempie tutta la volta della grotta, mentre la Vergine puerpera, pur nella sua centralità scenografica, guarda il divino Bambino in piedi in una conca tondeggiante che ricorda il fonte battesimale. Gesù, identificato da un’aureola crucesignata, dorata ed evidenziata da perline bianche, è già grandicello. Nell’affresco Salomé é raffigurata vestita di verde, con uno scialle che le fascia la testa fin sotto il mento; nella mano sinistra regge una brocca monoansata, mentre con la destra sembra saggiare la temperatura dell’acqua nella vasca. L’altra donna, Zelomi (negli apocrifi viene identificata anche come Eva), con una tunica rossa e pure lei con il capo coperto da una sorta di cuffia, è intenta a lavare il divino giovinetto. La scena si consuma sulla soglia di quella che l’anonimo frescante nuscano ha immaginato, con una suggestiva costruzione scenografica, come una grotta segnata da massi sporgenti e irregolari che ne delimitano l’ingresso. L’affresco si rivela ancora arcaico nella costruzione dello spazio, nella mancanza di prospettiva e di profondità e nella piattezza di talune figure. Ciò nonostante si possono cogliere in alcune parti di esso i caratteri dell’innovativa pittura che già andava caratterizzandosi in contesti geografici e culturali più vicini alla modernità, con un contrasto stilistico che denuncia come evidente la presenza, sulla parete frontale, di un secondo frescante nell’angelo che annuncia a due pastori la nascita del Salvatore: probabile segno che nella cripta era stato avviato un cantiere. Vicino al Cristo bambino, nel lacerto di affresco, sono evidenti poche tracce pittoriche relative alla presenza del bue e dell’asino; purtroppo assai danneggiate dai lavori che interessarono la cripta. Del ruminante, alla destra del neonato e di color marrone, sono visibili solo una piccola parte delle zampe anteriori mentre è molto chiaro il ciuffo di fieno che viene fuori dalla bocca; dell’asino, invece, di colore grigio, si possono vedere gli zoccoli e parte della testa con un occhio. Purtroppo i lavori che tra il 1740 e il 1780, per iniziativa dei vescovi del tempo, servirono per consolidare la soprastante area del coro comportarono l’abbassamento della volta della cella e la conseguente distruzione della parte superiore dell’affresco. - 94 - MARIA GIOVANNA VESPASIANO Con queste opere strutturali sono state troncate di netto anche la testa e parte delle ali di un angelo annunciante, la cui figura si staglia dalla sommità di una colonna spezzata, della quale sono fin troppo delineate le scanalature verticali con gli spigoli smussati. La creatura celestiale, che indossa una preziosa veste damascata, una dalmatica nei colori rosso-oro, regge con la mano sinistra un lungo rotolo che gli arriva fino ai piedi e dal quale ha appena proclamato l’annuncio ai pastori. Questi, che puntano increduli lo sguardo sul messaggero divino, indossano una veste corta al ginocchio e la mantellina, calzano stivali morbidi e imbracciano un lungo bastone alla maniera dei pellegrini in viaggio. Alle loro spalle, sulla parete sinistra, la stessa mano ha raffigurato una scena pastorale (fig. 9) dove si vede un recinto per gli animali con alcune pecore che si rincorrono, mentre altri ovini bianchi e neri pascolano nei pressi, sorvegliati da un cane decisamente minaccioso. Tutt’intorno il paesaggio mostra alberi e arbusti cespugliosi. Nel trattamento degli animali raffigurati, questa scena pastorale richiama ancora una volta l’impianto pittorico che si ritrova nella già citata Natività quattrocentesca di Novi Velia. Si diceva di almeno due mani che, probabilmente intorno ai primi decenni del XV secolo, erano al lavoro nella cripta della Cattedrale di Nusco. La prima, quella che si impegna nella descrizione del Bambino, può ben essere quella di un pittore locale, sicuramente colto ma con scarsa predisposizione alla raffigurazione dei dettagli anatomici. Basta vedere come dipinge le braccia e le mani di Gesù, o quelle delle levatrici: arti tozzi, dove non c’è soluzione di continuità tra braccio e avambraccio, tra polso e mano. Doveva trattarsi di un pittore erudito, però, perché mostra di conoscere la Natività del Maestro della Cappella Barrile a San Lorenzo in Napoli (fig. 10), al quale si ispira con sorprendente evidenza nel disegno della cuffia che raccoglie i capelli di Zelomi e nei colori della veste di Salomè, pressoché identica nella gradazione di verde scelto per il tessuto dell’abito. Fig. 9 - Scena pastorale. Nusco, Cripta della Cattedrale. Fig. 10 Natività. Napoli, chiesa di S. Lorenzo, Cappella Barrile. Molto più eloquente è il secondo frescante, al cui pennello si deve attribuire l’annuncio dell’angelo ai pastori, la scena pastorale con lo stazzo e gli ovini, e ancora le figure dei Magi giunti seguendo la stella. Qui, con un netto distacco dei colori, il maestro ha rappresentato la scena e i personaggi con modi quasi miniaturistici, capaci di trasferire figure e personaggi dalla ben nota ritualità del mondo rurale e pastorale ad un’ambientazione immaginifica che si poggia su un paesaggio agreste, dove la caratterizzazione degli animali e della realtà circostante è enfatizzata da un’insolita e marcata sproporzione rispetto ai pastori, che nulla toglie però ad un’ammirevole sensibilità naturalistica. Se non ci fu proprio un vero cantiere, è lecito pensare che nella cripta nuscana abbiano operato in stretta collaborazione due pittori. Non è facile dire, considerata l’innegabile coerenza e la logica organicità, se operanti in contemporanea ovvero in successione, con il - 95 - SALTERNUM secondo che riprende l’impostazione già data al programma dal suo predecessore. L’impostazione pittorica ricorda iconograficamente anche i cicli di affreschi dell’alto casertano, ed in particolare quello della Chiesa di Sant’Antonio Abate a Sant’Angelo d’Alife, datato intorno agli anni Trenta del ‘400 e inizialmente attribuito a Perrinetto da Benevento; attribuzione che negli ultimi anni pare non trovare più sufficiente fondamento. Il nostro frescante sembra aver guardato, almeno un decennio dopo, ai cantieri dell’area matesina-alifana, e in particolare agli affreschi della Chiesa di San Biagio a Piedimonte Matese, a quelli di Sant’Antonio abate a Pantuliano di Pastorano e alle citate pitture dell’omonima chiesa santangiolese, assimilando e cercando di far propria quella cultura. Un contesto geografico e culturale, quello alifano, in qualche modo legato alla storia delle comunità dell’alta valle del Calore grazie ad una lunga signoria feudale avuta in comune, che fa ipotizzare frequenti contatti e scambi di servizi artistici tra le due realtà territoriali. È provato, infatti, che le terre irpine e quelle del medio Volturno (fiume affluente del Calore) fossero, dal 1194 al 1269, nel possesso feudale dei Schweisspeunt prima e dei d’Aquino dopo, e dal 1307 al 1345 dei Gianvilla, casate che contemporaneamente tenevano anche Nusco. E ancora più stretto fu il rapporto quando Ceccarella, figlia secondogenita di Amelio Gianvilla, conte di Sant’Angelo dei Lombardi e della terra di Nusco, tra la fine del 1300 e i primi anni del 1400 andò in sposa a Goffredo di Marzano, conte di Alife. Che ci fosse un consolidato contatto tra l’area alifana e l’alta valle del Calore è provato, inoltre, anche dall’acquisto che gli Origlia, signori di Alife dal 1407 al 1419, fecero del feudo irpino di Volturara, ricomprato ancora una volta alla fine del 1530 dal nuovo feudatario, il Conte Antonio Diaz Garlon. La scena pastorale degli affreschi alifani, così come la raffigurazione degli animali e la vegetazione, infatti, impongono inevitabilmente il confronto con gli analoghi soggetti della cripta nuscana, che divide con gli affreschi delle cita- te chiese dell’area matesina anche la rappresentazione morfologica degli elementi lapidei, che si presentano uniformemente aspri e frastagliati. Va detto, in ogni caso, che mentre è indubbio che questi motivi erano ricorrenti nelle aree interne, e per il momento solo con esse, visto il paragone già proposto con l’affresco di Novi Velia, il confronto con la pittura napoletana resta assolutamente impossibile, dal momento che nella Capitale quasi nulla ci è pervenuto quanto a cicli tardogotici. Per di più è singolare la notevole analogia della figura di San Giuseppe nella scena cilentana con il sonnolente patriarca di quella a S. Angelo d’Alife. Riprendendo il discorso sulle pitture della cripta di Nusco, va notato che mentre vicino alle ali dell’angelo annunciante si intravedono appena le punte estreme di quella che doveva essere la stella di Giacobbe, meglio conservata è invece la scena dei Magi che arrivano al cospetto del Messia. La regalità dei tre sapienti, preannunciati dalla stella che due di loro sembrano indicare con l’indice destro puntato verso l’alto, è contraddistinta dalle corone che portano con sicurezza e che danno ad ognuno un prestigio che incute deferenza anche da parte del paggio di colore che li accompagna e che resta un passo indietro, compreso anche lui dalla considerazione che sta vivendo un’ora grande e decisiva. Il rispetto per i Magi, che esibiscono barbe lunghe e ben tenute che ci permettono di attribuire loro un’età giovane, adulta e anziana, è enfatizzato pure dal loro abbigliamento semplice e severo, caratterizzato da un mantello sopra una lunga tunica da cui fuoriescono gli stivali alti, di morbida pelle, che tendono ad afflosciarsi con pieghe di originale sinuosità. Scrive ancora M. Piacenza: «Dal secolo XIV anche l’aspetto dei Magi comincia a differenziarsi. Identificati con i tre popoli discendenti dai figli di Noè, diventano i rappresentanti rispettivamente delle tre razze umane, dei tre continenti allora conosciuti e delle tre età dell’uomo…». I tre saggi, infine, hanno tra le mani una sorta di pisside lungiforme e sfaccettata, che - 96 - MARIA GIOVANNA VESPASIANO contribuisce a dare valore ai doni che ognuno di loro porta a Betlemme. Del cielo nel ciclo pittorico di Nusco, di colore blu e trapuntato di stelle, è rimasto ben poco a causa dei citati lavori per l’abbassamento della volta. Ma l’osservazione attenta delle pitture mostra con evidenza che l’affresco doveva proseguire anche al di fuori dell’attuale perimetro della cella, dove un muro di sostegno del vano ipogeo le ha purtroppo interrotte. L’importanza delle pitture murali della cattedrale di Nusco non deriva esclusivamente dalla loro particolare cifra artistica, ma anche e soprattutto dal fatto di avere la capacità di riassumere, in uno spazio fisico limitatissimo, il complesso ed articolato universo della Natività nella cultura religiosa dell’epoca. Del resto il tema della Natività aveva assunto, fin dall’antichità, un ruolo primario nell’iconografia dell’arte sacra, essendo, insieme alla Passione, l’evento centrale della Cristianità. - 97 - Questo studio riprende e sintetizza uno degli argomenti della tesi di laurea in Storia dell’Arte Medievale ‘Affreschi del XIV e XV secolo nell’Alta Valle del Calore’, Istituto Universitario ‘Suor Orsola Benincasa’ - Napoli (a.a. 2007-2008, Relatore: prof. P. Leone De Castris). NOTE 1 PASSARO 1980, p. 171. 2 La presenza a Napoli della nobile svedese è confermata da una testimonianza raccolta nelle udienze per la canonizza- zione della futura santa, avvenuta nel 1391 ad opera di Papa Bonifacio IX (cfr. SVANBERG 2003, p. 101, n. 60). 3 Dei tre dipinti uno, Santa Brigida di Svezia e la Visione della Natività, è nella Pinacoteca Vaticana; un secondo, commissionato dalla Regina Giovanna per la chiesa di S. Antonio abate, è conservato nella Johnson Collection del Philadelphia Museum of Art; il terzo, infine, è alla Yale University tra le opere dell’Art Collection. BIBLIOGRAFIA SITOGRAFIA ABBATE F. 1990 (a cura di), Il Cilento ritrovato: la produzione artistica nell’antica diocesi di Capaccio (Catalogo della Mostra, Padula), Napoli. BERGAMO M. 2003, Da Maria puerpera a Maria adorante Evoluzione della postura della Madre di Dio nelle immagini della Natività, in Engramma, Rivista on-line del Centro studi ‘Architettura, civiltà, tradizione del classico’ dell’Università IUAV di Venezia, n. 29, dic. 2003. http://www.engramma.it/engramma_v4/rivista/esperidi/29 /029_nativita_home.html PIACENZA M. 2005, La rappresentazione della Natività nell’arte, in Agenzia Fides, 23/12/2005. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commi ssions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20051223_nati vita-arte_it.html CARAFA R. 1998, La chiesa di S. Maria dei Lombardi, in “I beni culturali”, VI, 3/98, pp. 40-42. CASAZZA C. 1860, Sulla statua della beata Vergine detta del Soccorso esistente nell’ipogeo della chiesa vescovile di Nusco in provincia di P. U., Napoli. PASSARO G. 1980, Cronotassi dei Vescovi della Diocesi di Nusco, Napoli, vol. IV, parte II, Tavv. 51-100. SVANBERG J. 2003, Niccolò Di Tommaso’s paintings in the Naples area and Birgitta, in AILI H. - SVANBERG J. 2003, Imagines Sanctae Birgittae: the earliest illuminated manuscripts and panel paintings related to the revelations of St. Birgitta of Sweden, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm. LORELLA MAZZELLA Origini e sviluppo dell’architettura rurale nella piana del Sele: l’esempio della Masseria Fosso Premessa a Piana del Sele ha offerto sin dal Paleolitico felici condizioni di insediamento a piccole comunità che, agevolate dal clima dolce e dal suolo fertile, ne sfruttavano i molteplici fiumi e torrenti. Tra il 730 e il 580 a.C. Etruschi e Greci si stabilirono rispettivamente alla destra e alla sinistra del fiume Sele, traendo potere e ricchezza dai commerci, dallo sfruttamento cerealicolo della terra e contrastando, in tal modo, l’espandersi della palude, oltre che favorendo la diffusione di fattorie e santuari agresti. A partire dal III secolo a.C., con l’avvio della politica di espansione da parte di Roma, si consolidò il processo di omologazione culturale, cominciato con la comparsa nella Piana degli Oschi, dei Sanniti, dei Lucani. Iniziò, quindi, un periodo di prosperità con la costruzione di ponti, strade, ville e con l’impianto di canali, atti a prosciugare le aree acquitrinose. Tuttavia, il trasferimento della capitale a Bisanzio e le invasioni barbariche determinarono anche in queste aree l’estendersi della palude e la conseguente malaria; inoltre, già con l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. il lapillo si era depositato nei canali di drenaggio, contribuendo alla loro definitiva scomparsa. Le popolazioni della Piana, stremate dalle difficoltà ambientali, si ritirarono sui monti, in luoghi più salubri e sicuri. La ricostruzione demografica delle campagne iniziò durante il periodo di massimo splendore della Repubblica di Amalfi e del Principato di Salerno: parallelamente al sorgere di vari monasteri benedettini, centri di comunità religiose ed agricole, cominciarono a disseminarsi piccole L Fig. 1 - Localizzazione della Masseria Fosso sulla mappa catastale. Fig. 2 - ASNa, Archivio Privato Doria d’Angri, parte I, 1827, busta 863. abitazioni rurali al fine di ospitare i contadini trasferitisi in zona a seguito della messa a coltura delle terre appartenenti alla Badia di Cava e alla Chiesa salernitana. Origini e sviluppi Il Medioevo, dunque, diede inizio alla fioritura economica della Piana, poiché i principi longobardi, oltre a fondare vari monasteri, promossero un diffuso tentativo di bonifica e di recupe- - 99 - SALTERNUM Fig. 3 - Masseria Fosso.Veduta esterna. ro di terreni incolti, provato dall’impianto di vigneti anche in zone malsane, dalla costruzione di numerosi mulini ad acqua e dall’edificazione di cappelle rurali allo scopo di provvedere alla vita spirituale dei contadini. Le costruzioni rurali vennero ubicate nei punti meno pericolosi per le infezioni malariche, con possibilità di irrigazione sfruttando attraverso sistemi rudimentali le acque di fiumi e torrenti, e lungo le grandi strade di comunicazione che conducevano al Cilento o alle Calabrie. In un primo momento le peculiarità di tali abitazioni - orientamento, materiali e tecniche costruttive, distribuzione interna, utilizzo di scale esterne, porticati, terrazze - furono fortemente condizionate dalle caratteristiche geologiche e climatiche del territorio, connesse alle limitazioni economiche e alle esigenze funzionali della società contadina; successivamente, la progressiva estensione del patrimonio terriero ecclesiastico e baronale rese tali costruzioni espressione tangibile e irriproducibile dei cambiamenti sociali, economici e culturali in atto. Aggiunte e ampliamenti vennero realizzati a partire dal nucleo primitivo delle abitazioni, proporzionali all’estensione della proprietà o alla potenza della casata, fino alla trasformazione di esse, nel XVII secolo, in importanti aziende condotte da grandi feudatari o affittate o affidate in dote per matrimoni o monacazioni. A seconda delle possibilità di irrigazione e delle comodità che la masseria offriva (attrezzi per la pigiatura e la fermentazione del mosto, pozzo di acqua sorgente, stalla, forno, aia), le proprietà potevano comprendere terreni arbustati, vitati, seminatori e fruttiferi. Dunque, l’acquisto di una masseria ben attrezzata richiedeva somme piuttosto consistenti e, conseguentemente, accanto ai grandi Ordini Religiosi, i grandi feudatari della Piana furono i Grimaldi, i Filomarino, i Genovese, i Pignatelli Noja, i Doria d’Angri. Inoltre, allo sfruttamento agricolo della Piana promosso dalle masserie si lega la nascita della città di Battipaglia - il cui spunto venne offerto dalla volontà di ospitare i terremotati di Melfi (1857) - ed alla creazione di tabacchifici, conservifici, caseifici. Dei molteplici organismi di architettura rurale disseminati nel territorio della Piana, si indaga il caso della masseria Fosso che, per vicende storiche, peculiarità e caratteristiche costruttive, rappresenta il monumento/documento esplicativo di quanto detto finora. La Masseria Fosso Vicende storiche Fosso è un’importante costruzione rurale ubicata in località Tusciano, posta immediatamente ad Ovest del fiume omonimo, in un territorio che ora appartiene al comune di Battipaglia, ma che fino ad un passato recente apparteneva a quello di Montecorvino. Essa, probabilmente, deriva il suo nome dall’utilizzo dei ‘fossi’, canali artigianali realizzati per irrigare i campi incanalando le acque del Tusciano; infatti, i canali erano limitati proprio a solchi scavati nel terreno a seconda delle esigenze e della posizione dei fondi che venivano irrigati. Non si conosce la data di fondazione della masseria ma nell’anno 940 Guaimario II arricchì il patrimonio arcivescovile con la donazione di alcuni terreni ubicati a poca distanza dal Tusciano e dal suo affluente, il Cornea1. Successivamente, nel 977, il principe Gisulfo I donò all’Arcivescovo tutte le terre di cui non era ancora proprietaria poste tra il fiume Tusciano e la riva del mare2; tale lascito fu confermato dai suoi successori, mentre nel 982 la Mensa Arcivescovile salernitana ottenne anche il diritto del «decursus aquarum» sui fiumi Tusciano e Sele da Ottone II3. - 100 - LORELLA MAZZELLA In epoca normanna anche Roberto il Guiscardo confermò i possedimenti della Chiesa4, la quale conduceva i suoi beni con contratti di locazione «ad amphiteosim perpetuam», mediante i quali si richiedeva ai locatari il dissodamento delle terre incolte e il miglioramento di quelle già coltivate; in cambio si concedeva il godimento del fondo e la facoltà di trasmetterlo agli eredi. In un documento del 1321, Bartolomea, badessa del monastero di S. Lorenzo di Amalfi, cedette in locazione a «(…) Nicolao f. qd Francisci de Rodoerio da Girono terram seminatoriam sitam in Tussano ubi a lu Fossu dicitur (…)» 5. Nel 1331 Petrus de Vallone di Salerno fittò a Bernardo de Morcono per parte del monastero di S. Lorenzo di Amalfi una terra situata fuori Salerno «(…) in loco Tussiani seu Fossi»6. Il 19 novembre del 1367 la località Fosso è nuovamente citata in una lite giudiziaria per il possesso del Priorato di S. Maria de ‘dopmo’ e di S. Massimo, tra l’Arcivescovo di Salerno Guglielmo e l’abate di Cava Golferio; ma in questo caso la citazione è marginale, in quanto serve solo ad indicare che il vastatario di S. Mattia è ‘prope fossum’ 7. Il potere arcivescovile sul territorio della Piana durò fino al 1550 circa: nel 1494 Alfonso d’Aragona stabilì che Montecorvino entrasse a far parte del Regio Demanio; la disposizione fu successivamente confermata da Ferdinando il Cattolico nel 1509 e, definitivamente, da Carlo V nel 1536. Successivamente i sovrani spagnoli posero in vendita alcuni territori del Demanio e il Feudo di Montecorvino fu venduto nel 1572 a Nicolò Grimaldi, marchese di Eboli e duca del Vallo di Diano. Nel 1590 Montecorvino ottenne la reintegrazione nel Regio Demanio ma ancora posta in vendita nel 1638 e acquistata dal principe di Noja, don Giulio Pignatelli «mediante publico Istrumento rogato al 26 agosto dell’anno sudetto 1638 stipulato per il q: Notar Massimo Passaro di Napoli, regente di Notaro della Regia Corte»8; questi, a sua volta, donò lo Stato nel 1644 al figlio secondogenito Aniello che acquistò, nel 1649, anche i Feudi Rustici di Fosso e Verdesca e i Suffeudi o Difese di Ortogrande e Tufarella. Inoltre, egli ottenne dal re Cattolico il privilegio di essere nominato principe dello Stato di Montecorvino e di poter trasmettere il titolo ai suoi eredi. Defunto Aniello, Stato e Feudi Rustici furono ereditati dal primogenito Giulio, duca di S. Mauro, e alla morte di quest’ultimo dal fratello Giacomo. In occasione di tale passaggio venne commissionato al Tavolario Antonio Galluccio l’apprezzo dei due Feudi Rustici9. Anche i Pignatelli, come tutti i feudatari della Piana, erano soliti affittare le proprietà terriere e, attraverso un contratto stipulato nel 1700 dal notaio Albinente, si conoscono i particolari delle condizioni di affitto di Fosso: il locatario, Paolo Salvatore di Olevano, oltre a pagare il canone nel tempo stabilito, doveva curare la vigna murata, seminare e provvedere agli animali. Della casa palaziata egli poteva usufruire solo delle stanze terranee e della camera nella torre per riporre le vettovaglie. Le altre camere soprane dovevano restare a disposizione del principe e del suo amministratore; inoltre, era assolutamente vietato all’affittuario abbattere con scoppiettate i piccioni, che erano del padrone10. Nel 1719 Giacomo vendette lo Stato di Montecorvino e i due Feudi Rustici di Fosso e Verdesca a Nicola Ippolito Revertera, duca della Salandra; in tale occasione venne eseguito un nuovo apprezzo dal Tavolario Pietro Vinaccia. La somma che il duca doveva versare per l’acquisto doveva essere versata per una parte al monastero di S. Liguori a Napoli per il vitalizio di due sorelle del principe, per un’altra parte ai creditori di Giacomo, mentre il resto della somma avrebbe dovuto essere pagato dopo nove anni con un interesse del 3,5%. Tuttavia, il duca della Salandra non estinse i suoi debiti in tempi convenienti, sicchè Giacomo vendette il credito che gli spettava dalla vendita al principe di Marsico Nuovo, don Giovanni Battista Pignatelli. Nel 1737 venne ordinato al duca della Salandra di soddisfare i suoi debiti, ma questi si rifiutò di pagare l’intero prezzo poiché nel frattempo erano stati resi demaniali i due Feudi Rustici di Fosso e Verdesca. Pertanto, dopo una lunga transazione, il duca vendette a Girolamo Pignatelli, figlio di - 101 - SALTERNUM Giovanni Battista, lo stato di Montecorvino «(…) colle sue Giurisdizioni, e Corpi annessivi e cogl’anzidetti due Feudi rustici, per il prezzo di ducati quarantottomila centocinquanta»11. A sua volta, nel 1744, il principe vendette lo Stato di Montecorvino a Matteo Genovese al prezzo di sessantamila ducati insieme al Feudo del Fosso «(…) la maggior parte seminatorio di capacità tomola cento, e dieci in circa, comprendente una vigna murata (…)»12, e alla Difesa della Verdesca «(…) di estensione tomola trecento in circa (…)»13. Così nel catasto conciario del 1753 venne censita la proprietà di Matteo Genovese: «L’Ill.mo Sig. Barone Genovese possiede nel luogo detto il Fosso una masseria di fabrica e terra seminatoria, e d’uso d’uva, e vigna in ununo di capacità tomoli centottanta, confina col fiume Toscano e colli beni di Giuseppe Capograsso. Simile di rendita dedotta la spesa di coltura della vigna annui ducati trecento quaranta e resta da appezzarsi la rendita del casamento della masseria nella discussione»14. Infine, una relazione fatta eseguire dalla Mensa Arcivescovile, in occasione di visite pastorali, sostiene che «nella massaria dell’Ill.mo Sig. Barone dove si dice il Fosso vi è una cappella sotto il titolo di Santo Mauro»15. Nel 1795 i Corpi feudali di Fosso e Verdesca furono venduti a Marcantonio Doria, principe di Angri16; ma già nel 1641 i Doria avevano acquistato Eboli, Capaccio e quattro Feudi Rustici (Lagopiccolo, Isca di Comora, Isca di S. Nicola, Isca S. Felice), di cui Eboli era l’Università con l’agro più grande della Campania poiché comprendeva oltre ventimila ettari di superficie. I contratti d’affitto dei Doria andavano da un minimo di tre anni ad un massimo di dodici; sappiamo che nel 1799 Fosso era affidata alla conduzione di un certo Schiavone17 e che, in tale periodo, i guardiani di Fosso e Verdesca ricevevano i salari più alti degli altri dipendenti dei Doria d’Angri18. Nel 1827 la masseria in questione era affittata a don Lorenzo Carrara, a cui il terreno serviva perché confinante con i suoi beni, ma spesso veniva inondato dalle acque del fiume Tusciano19. Inoltre, i beni di Marcantonio siti in località Fosso sono segnalati nel Catasto provvisorio20 di Montecorvino e descritti in un apprezzo del 184321. Nei periodi di più intensa attività erano soprattutto i forestieri ad affluire in grandi quantità nelle varie masserie, ospitati nei piani terreni, nelle stalle, nei fienili; infatti, il Galanti scrive: «Vengono gli uomini dalla Basilicata, dalle Calabrie e fino dal lontano Abruzzo a fare i lavori necessari per una miserabile mercede»22, mentre il Liber defunctorum documenta che «il giorno 1 gennaio 1805 in località lo Fosso passava a miglior vita Luigi Palermo di Moliterno, che fu sotterrato nella Chiesa della SS. Annnunziata»23. Dopo la morte di Marcantonio il vasto patrimonio terriero fu sottoposto ad una frammentazione ereditaria lunga e difficile, che si concluse solo nel 1878 e che comportò la vendita di molti beni all’asta, acquistati dagli antichi affittuari, soprattutto dai Bellelli, dai Pastore, dai Conforti. È molto probabile che proprio in occasione di tali vendite Fosso sia passato ai baroni Sorvillo, una ricca famiglia di Vietri sul mare, la cui ultima discendente vendette la proprietà, nel 1968, agli antichi affittuari, i Rinaldi. Questi ultimi, a loro volta, furono costretti a vendere all’asta la masseria che attualmente è posseduta dai baroni Sorvillo. Peculiarità e caratteristiche costruttive L’analisi relativa alle peculiarità e alla storia delle trasformazioni di Fosso è stata condotta integrando tutte le informazioni ottenute su di essa, sia attraverso le fonti archivistiche e bibliografiche, sia attraverso l’operazione di attento rilievo del manufatto stesso, operazione fondamentale per la conoscenza e la comprensione di qualsiasi organismo architettonico. Essa si presenta come un’imponente costruzione a due livelli, priva di qualsiasi decorazione e racchiusa da massicce mura perimetrali, con una forte estensione longitudinale e sormontata da torre colombaia. - 102 - LORELLA MAZZELLA Fig. 4 - Sezione longitudinale e prospetto interno alla corte (rilievo dell’Autore, 2004). Fig. 5 - Sezione longitudinale e prospetto interno alla corte (rilievo dell’Autore, 2004). Fig. 6 - Pianta I livello (rilievo dell’Autore, 2004). Fig. 7 - Pianta II livello (rilievo dell’Autore, 2004). La sua nascita può risalire al periodo in cui il terreno era posseduto dal monastero di S. Lorenzo di Amalfi, che lo affittava a forestieri affinché venisse coltivato: sarà stata dunque necessaria la costruzione di un primitivo rudimentale impianto che ha condizionato e posto le basi per il più grande e posteriore edificio di abitazione. Quest’ultimo è probabilmente riconducibile alla metà del Cinquecento, quando la Mensa Arcivescovile di Salerno concedeva terreni «ad perpetuam laborandum» per il fittavolo e i suoi successori con la clausola che questi si impegnasse ad «edificare due membra di casa»24 per sé e la famiglia entro sei anni, o ad ampliare l’abitazione esistente. Ad ogni modo, in tale periodo l’abitazione vera e propria non faceva parte dell’attuale masseria, ma era situata a pochi metri da questa, ove - 103 - SALTERNUM Fig. 8 - Masseria Fosso, interno della primitiva abitazione. Fig. 9 - Masseria Fosso. Resti della primitiva abitazione. attualmente sorge la casa dei Rinaldi; di essa sono ancora visibili pochi resti. Indicata già come fatiscente dal Tavolario Vinaccia nel 1717, era formata da quattro bassi, coperti con travi in legno, sui quali vi erano quattro camere da letto coperte a tetto. Resti della primitiva abitazione L’attuale masseria era adibita a funzioni agricole: il primo livello era costituito da cinque ambienti non comunicanti - destinati a stalla, deposito per attrezzi e macchine, magazzini per materiali e forno - coperti con volte a botte o a specchio e caratterizzati da doppio accesso; il secondo livello consisteva solo nella torre colombaia e in una camera adibita a cucina, posta ad Ovest della torre stessa, collegate da una grande terrazza. Ad Ovest della cucina vi era un portico, da cui si accedeva al forno, che sosteneva una dispensa, coperta a tetto, a servizio della cucina stessa. Il collegamento tra i due livelli, poi, avveniva attraverso una scala scoperta, retta da eleganti rampanti in pietra, situata nell’angolo nord-est della fabbrica. Conduceva ad un piccolo corridoio, anch’esso scoperto, attraverso cui si accedeva alla menzionata cucina «uno stanzone grande coverto a tetto a due penne con comodità di focolaro»25. Inoltre, due piccoli vani seminterrati, coperti da volte a botte a sesto ribassato, venivano utilizzati come cantine per la conservazione di quei prodotti che, come il vino o il latte, avevano bisogno di locali più freschi. Sempre all’interno del perimetro murario, ma nell’angolo nord-ovest, era la cappella rurale dedicata a S. Mauro, oggi destinata a deposito attrezzi e perciò alterata da numerose modifiche. L’antica copertura a tetto è stata sostituita, nel XX secolo, da una latero-cementizia; così come l’arco di ingresso, originariamente a sesto ribassato, è stato tamponato con una porta in ferro, mentre l’interno è stato completamente reintonacato. Entrambi gli edifici furono costruiti con muratura del tipo a sacco, con paramenti in pietra calcarea e, soprattutto, ciottoli di grandi dimensioni coadiuvati dall’impiego di malta; il nucleo era costituito da spezzoni di pietrame e malta. L’utilizzo di tali materiali è riconducibile alla natura calcarea del terreno su cui i due edifici sono stati edificati, associato alla loro grande economia di impiego, poiché, quasi sempre, il contadino stesso cavava, lavorava e metteva in opera la pietra. A loro volta, i ciottoli, facili da reperire nei greti di fiumi e torrenti, consentivano di ridurre il costo di estrazione, oltre ad eliminare la fatica della lavorazione, poiché venivano messi in opera così come cavati o, al massimo, dopo una semplice spaccatura. Dunque, la pietra diveniva muro, arco, pilastro, pavimentazione, arco, arcotrave e volta. Le volte si impiegavano a coprire particolari ambienti quali stalla, fienile, magazzini, allo scopo di eliminare i pericoli di incendio, possibili, invece, con solai in legno e perciò destinati alle zone abitative. Ulteriore elemento caratterizzato da precisa funzionalità è la colombaia: essa permetteva di sorvegliare il lavoro condotto sulla vasta distesa dei campi e anche l’allevamento dei volatili. - 104 - LORELLA MAZZELLA Presentava una copertura in legno a quattro falde e un solaio con travi a sezione circolare, oggi crollati. Attraverso il contratto stipulato nel 1700 dal notaio Albinente, in cui sono stabilite le condizioni di Giacomo Pignatelli e l’apprezzo del Tavolario Vinaccia nel 1717, in occasione della vendita di Fosso al duca della Salandra, si possono conoscere i ‘miglioramenti’26 apportati dal Principe alla masseria. Egli fece piantare una nuova vigna e, siccome la primitiva abitazione era fatiscente, venne costruito un secondo livello sull’edificio utilizzato a scopo agricolo, con camere poste in sequenza e dotate di camini. Queste erano caratterizzate da grandi finestroni schermati da robuste ante in legno e aperti sia a Sud-Ovest, per ricevere un soleggiamento ottimale, sia a Nord-Est. Di queste camere, quelle ad Ovest della torre colombaia avevano funzioni di rappresentanza e presentavano una pavimentazione in cotto e copertura di capriate in legno di quercia; quelle ad Est della torre erano destinate a camere da letto e avevano pavimentazione in battuto oltre che copertura con tetto a due falde. Questa sopraelevazione comportò un sovraccarico alla muratura del primo livello e, siccome la muratura in ciottolate ha scarsa coerenza dovuta alla forma rotondeggiante dei pezzi - sebbene per colmare eventuali vuoti si inserivano ricorsi in argilla - il Principe fece erigere degli speroni di sostegno atti a consolidare la muratura stessa; essi vennero posti in vari punti del prospetto esterno e negli angoli del fabbricato. Inoltre, Giacomo fece erigere, nell’angolo sud-ovest del fabbricato, «tre bassi per comodità di rimesse e coverti a lamia»27 che, privi di mura perimetrali, erano completamente aperti verso la vigna, oggi terreno incolto, e verso il cortile. Successivamente il Feudo venne acquistato dai baroni Genovese e anche questi apportarono delle modifiche a seconda delle loro esigenze funzionali. Innanzi tutto venne rinforzato anche il prospetto nord-est da un ulteriore portico che, attraverso la profondità delle arcate a guisa di speroni, aveva la funzione di sostenere il loggiato occupato dal corridoio in modo da facilitare l’accesso alle varie camere di rappre- Fig. 10 - Masseria Fosso, resti di una volta della primitiva abitazione. sentanza, disposte in maniera sequenziale; venne consolidata la volta della stalla attraverso un arco che ne seguiva il profilo, giacchè un muro trasversale del livello superiore era stato poggiato in falso al suo centro. Venne poi tamponato con muratura a sacco l’ingresso alla stalla stessa, che affacciava sulla vigna. Nello stesso tempo, la scala esterna venne coperta con una piccola tettoia in legno e vennero tamponate anche le rimesse fatte costruire da Giacomo. Ad esse si poteva accedere, ora, solo dal cortile interno e non dalla vigna e furono destinate a nuove funzioni: la prima fu adibita a fienile, la seconda a stalla e la terza a forno. Il fienile era coperto con una volta a botte a sesto ribassato in conci di arenaria e arieggiato da una feritoia, la stalla era coperta da due volte a botte in conci di arenaria che si innestavano su un arco centrale, oggi in parte crollate a causa del pesante rinfianco in ciottoli. Il vano adibito a forno era coperto da un tetto a falda costituito da travi in legno, anch’esso crollato e, di fronte a questo, venne costruito il pozzo con abbeveratoio. Tutti e tre gli ambienti presentavano l’estradosso piano a formare una grande terrazza, a cui si accedeva tramite la costruzione di una nuova scala esterna che, priva di copertura, aveva la funzione principale di condurre direttamente alle camere da letto senza dover attraversare le camere di rappresentanza. Nel 1858 le disposizioni del re riguardo la fondazione di una Colonia Agricola spinsero i contadini della Basilicata e del Vallo di Diano a muoversi verso - 105 - SALTERNUM la contrada di Battipaglia, con la speranza di una casa e di un pezzo di terreno da coltivare. Nel frattempo essi si accamparono in casoni per braccianti agricoli e nella masseria Fosso vennero ospitati in piccoli vani-dormitorio di muratura, dotati di camino, che vennero addossati alla facciata esterna dell’edificio. In tale periodo, Fosso apparteneva ai Doria d’Angri. Questi, per non investire capitali, privilegiavano l’allevamento brado e le aree seminative si riducevano a pochi terreni, a differenza degli affittuari che, come in Fosso, sfruttavano nel modo migliore la fertilità dei campi. Inoltre, i grandi feudatari spesso negavano le riparazioni richieste, ritenendole ingiustificate. Il più evidente intervento effettuato nell’Ottocento è infatti l’inserimento nelle murature del secondo livello di catene in ferro disposte longitudinalmente e trasversalmente ad esse, necessarie per contenere la sconnessione dei giunti dovuti ad una non buona ammorsatura. Agli inizi del Novecento i vani costruiti per ospitare i nuovi braccianti vennero ricostruiti con muratura in mattoni e copertura laterocementizia, mentre le camere di rappresentanza vennero suddivise da tramezzi. Ma di lì a poco, nel periodo cosiddetto ‘moderno’, e soprattutto nel dopoguerra, con l’introduzione della prefabbricazione e con il mutare delle tecniche di coltura e di allevamento, si assiste all’abbandono delle masserie. Ciò accade anche per Fosso, considerata un rudere privo di importanza, la cui sorte appare tuttavia ‘fortunata’ rispetto alle forti modifiche strutturali e funzionali subite da altri organismi agricoli, che hanno totalmente perso la loro identità culturale e architettonica. NOTE 1 La notizia si legge in una pergamena pubblicata in appendice da SCHIPA 1968, p. 254. 2 CARLONE 2000, p. 6. 3 PAESANO 1846, p. 68. 4 ADS, Arca I, n° 21. 5 MAZZOLENI - OREFICE 1987, pp. 819-822. 6 IIDEM 1987, pp. 954-958. 7 AAC, arca LXXV, n°52. 8 ASS, Archivi privati, Archivio Genovese, Platea di tutti i beni della famiglia Genovese formata dall’illustre Marchese D. Mariano Genovese e terminata nel mese di Xembre dell’anno 1788, busta 54. La Platea, eseguita dopo che la famiglia Genovese acquista Montecorvino e i due Feudi Rustici, è suddivisa in vari paragrafi in cui vengono descritte notizie sulle condizioni della vendita, sui ‘Pesi’ annessi ai beni, sulle proprietà che la Mensa ha nello stato di Montecorvino, ecc. Di grande importanza per la ricostruzione delle vicende storiche della masseria Fosso sono le notizie preambole a tale ‘Compra’ eseguita da Matteo Genovese. 9 ASNa, Apprezzi, Antonio Galluccio, Montecorvino Rovella, 1641, scheda 460. «(…) come mi viene commesso l’apprezzo della Difesa della Verdesca e del Fosso (…) mi sono conferito nelle pertinenze della terra di Montecorvino (…) ed avendo camminato circuì circa ho ritrovato che quella è tutta piana, e buona parte di essa è padulognola dove che s’ingorga l’acqua, e detto padulognolo è tutto boscoso con alberi di salocomi, olma ed altre frutte, e pieno di per azze, sicchè detto territorio conforma oggi si ritrova non è buono peraltro che per il pascolo di bufale, ma quando si sterpassero le dette per azze varia buono il territorio anco per seminarsi (…)» 10 ASS, Protocolli Notarili, Montecorvino 1700, Notaio Albinente, fascicolo n° 331. 11 ASNa, Apprezzi, Pietro Vinaccia, Montecorvino Rovella 1717, scheda 1717, scheda 161, prot. 32. «(…) ed in primis il territorio detto il Fosso sito, e posto in detto Stato di Montecorvino, distante dal detto Casale di Rovella circa miglia sei camminando verso Ostro, confina il medesimo con il fiume di Battipaglia, via vicinale che confina con li Pinti, colli Beni della Reverenda Mensa Arcivescovile di salerno, colla strabella, che viene dalla via Regia, e va alla scafa d’Eboli, ed altri confini consiste il medesimo in un territorio, la maggior parte del quale seminatorio di capacità tomola 110 in circa, e parte in una vigna murata, che si descriverà, e per ultimo in un comprensorio di casa, quale consiste, ecc. In primis un portone, avanti del quale vi è aria da batter le vittovaglie, e dal medesimo si entra nel cortile murato scoverto, a sinistra del quale vi è una picciola Cappella coverta a tetto sotto il titolo di S. Mauro, a detta siegue un vano distretto di mura, quale serve per carcere degli animali, e quattro bassi coverti a travi, sopra dei quali vi giacciono quattro camere coverte a tetto antiche, oggi mezzo dirute, in testa poi del detto cortile per porta s’ave l’uscita all’enunciata vigna, qual è tutta murata, e di capacità tomola cinque in circa, dove si fa mediocre vino, e detta è stata piantata a spese dell’odierno principe, e seguitando in giro il sudetto cortile vi sono tre bassi fatti nuovamente dal suddetto principe per comodità di rimesse, uno però dè quali scoverto, e senza astrico; a destra poi girando vi sono cinque porte, per le quali si entra in magazzeni, e cantina per riponer vino coverto a lamia, dopo detti siegue porta della grada, che si descriverà; sta inoltre un supportico coverto a lamia però antico, in testa del quale per porta s’entra in un basso coverto a lamia per uso di forno. - 106 - LORELLA MAZZELLA Ritornando alla grada, con l’appianarne tre d’essa si trova porta, per la quale s’entra in una stanza per uso magazzeno, e con una tesa scoverta di gradi num. 17 si trova un corridoio, seu picciola loggia scoperta, a destra della quale per porta s’entra in uno stanzone grande coverto a tetto a due penne, e tiene due finestre affacciatore a mezzodì, e comodità di focolaro, detta però è antica; accosto il detto focolaro vi è porta per la quale s’entra in una piccola stanza coverta a tetto. Segue a destra altra stanza fatta nuovamente dal detto illustre Principe coverta a travi numero 8, e vi è comodità di focolare e due finestre; a detto focolaro segue piccola stanza per uso di dispensa anche nuova coverta a travi, in cantone della detta stanza segue un’altra camera coverta a travi numero 6, anche nuovamente fatta da detto Principe con comodità di focolaro, e due finestre, e sopra dette camere vi è il tetto; a sinistra poi del detto stanzone sieguono della stanze una dopo l’altra, delle quali una è antica, e l’altre quattro nuovamente fatte, secondo fu deposto sopra la faccia del luogo, tutte però dette stanze si ritrovano coverte, a travi con tetto sopra, con comodità di focolaro, e finestre, con torretta, seu palombara sopra una d’esse, e nell’ultima di dette si trovano due porte, per una delle quali si entra in un piccolo camerino per dispensa, e per l’altra s’esce sopra una loggia giacente sopra le dette rimesse, ed in questo consiste il suddetto comprensorio, e feudo detto il Fosso, su del quale volendosi da me assignare il giusto prezzo per intiero, tanto al territorio, quanto casa, e vigna, siccome al presente sta senza niuna servitù, e che tutto il frutto annuale vada a beneficio del padrone; che perciò riflettendo alla capacità del Territorio, sito ove risiede, qualità del medesimo, rendita ottenuta, e che se ne può ottenere, riflettendo ancora alla descrizione, ed apprezzo fatto dal Tavolario Gio. Battista de Marino nell’anno 1640, che si legge nel secondo volume fol. 611, ove similmente vi enuncia esser parte feudale, e parte burgensatico, che perciò fatte tutte le dovute diligenze sopra tale affare, considerando la diversità dei tempi dà allora ai presenti, valuto il suddetti Feudo del Fosso con casa, e vigna, come descritto di sopra, franco da ogni peso per ducati seimila…6000. Le migliorazioni fatte dall’odierno principe sì in materia di fabbrica, vigna e altro secondo la comune deposizione de testimonj esserne quelle state fatte da lui, ed a minuto a me dimostrate dagl’Esperti assegnatimi, iportano ducati millecento…1100. È ben vero però Riverito Signore, che da quel tanto appare nell’unisona deposizione di tutti i testimonj sopra l’articolato feudo del Fosso asserentino, che l’Università vi abbia sopra del medesimo l’azione, e servitù del pascolo, come sono tutti gli altri rimanenti territorij dè particolari e che intanto tutto il frutto del detto territorio và in beneficio del suddetto Principe, non per altro, se non per mera cortesia, e grato affetto di detta Università verso il Principe; del che riverito Signore non v’ha dubio, che se la detta Università avesse tale auto- rità, e jus, volesse di quello avvalersene, minorerebbe tal distinzione, stimandosi dal V. S. necessaria, lo potrà con suo decreto ordinare, cha da me ne formerà relazione a parte (…)». 12 ASS, Archivi privati, Archivio Genovese, IDEM. 13 ASS, Archivi privati, Archivio Genovese, IDEM. 14 ASNa, Catasto Conciario, 1753, b.3802, p.287. 15 ADS, Visite Pastorali, Cappellanie Rurali che stanno nel ristretto della Carta di Montecorvino situata nella Piana, R. 78, 1730-1769. 16 I corpi Feudali di fosso e Verdesca furono venduti a Marcantonio Doria «con Istrumento di 27 Aprile 1795 per Notar Lucantonio Ferraro di Napoli dai Demanisti D. Pompeo Maiorino, Don Sabbato Pizzuto, tanto nei propri nomi, quanto come Cessionarii di D. Giuseppe M. Sparano, D. Luca Cavaliere, D. Diego Carrara, D. Francesco di Simone, D. Scipione della Corte, D. Lorenzo Denza nomine proprio, D. Ambrogio Meo nomine proprio, D. Pietro Corrado nomine proprio e D. Tommaso Corrado tanto nomine proprio, quanto come Cessionario di D. Ludovico Sparano». I Demanisti cedettero i loro feudi in quanto Marcantonio Doria aveva prestato loro una somma di danaro affinché si liberassero dal dominio dei Genovese. 17 MOSCATI 1964. 18 ASNa, Relevi Feudali, Eboli e Montecorvino, voll. 269-272 e 1799. 19 ASNa, Archivio Privato Doria d’Angri, parte I, 1827, busta 863. 20 ASS, Catasto Provvisorio, Montecorvino Rovella, 1827, Stato di Sezioni, vol. 18, pp. 103-104 21 ASNa, Archivio Privato Doria d’Angri, parte I, Apprezzo dei beni di Marcantonio Doria, 1843, n° 967 A/3. Fondi siti nel tenimento del comune di Montecorvino Rovella. «1° Vastissima tenuta denominata Picciola (…). 2° Feudo denominato Fosso, di natura scampia seminatorio ed arbosto, confinante con i beni di Domenico Granozio, dei Signori Bellelli e dei Signori Mauro di Salerno». 3° Altra vasta tenuta appellata Verdesca (…). Questi detti stabili sono riportati nel catasto provvisorio del comune di Montecorvino Rovella sotto l’articolo 1799 in testa di Doria Francesco fu Marcantonio Principe di Angri (…) con la rendita complessiva di ducati 9861,11». In questi stabili vanno compresi i vari casamenti colonici, fattorie dei rispettivi Feudi. 22 GALANTI 1790, p. 187. 23 Archivio della Parrocchia dello Spirito Santo di S. Martino, Liber defunctorum, 1794-1845, f. 25. 24 ADS, Mensa Arcivescovile, Reg. II, pp. 308-364. 25 ASNa, Apprezzi, Pietro Vinaccia, Montecorvino Rovella 1717, scheda 1717, scheda 161, prot. 32. 26 Ibidem. 27 Ibidem. - 107 - SALTERNUM ABBREVIAZIONI “BSSPC”: “Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra”. ASNa: Archivio di Stato di Napoli. LEPRE A. 1973, Feudi e Masserie, problemi delle società meridionali nel’ 600, Napoli MAZZOLENI J. - OREFICE R. 1987, Il Codice Perris - Cartulario Amalfitano, sec. X-XV, Napoli. ASS: Archivio di Stato di Salerno. ADS: Archivio Diocesano di Salerno. AAC: Archivio Abbazia di Cava de’ Tirreni. MIGLIORINI E. 1949, La Piana del Sele, in Memorie di geografia economica, Napoli. BIBLIOGRAFIA MILELLA O. 1992, Torri e masserie nel giardino mediterraneo, Roma. BIASUTTI R. 1926, Per lo studio dell’abitazione rurale in Italia, in “Rivista Geografica italiana”, a. XXXIII. MOSCATI R. 1964, Una famiglia ‘borghese’ del Mezzogiorno e altri saggi, Napoli. BRUNO G. - LEMBO R. 1982, Acque e Terra nella Piana del Sele, Salerno. PAESANO G. 1846, Memorie per servire alla storia della Chiesa salernitana, Napoli, vol. I. CARLONE C. 2000, Documenti per la storia di Eboli, Salerno. PENTA F. 1936, I materiali da costruzione nell’Italia meridionale, Napoli. CARLONE C. - CICENIA S. 1999, Cultura e scienza tra ‘500 e ‘600 nel Principato Citra, Salerno. PLATZER F. 1942, La bonifica in Destra Sele, Roma. CESTARO A. 1994, Il terremoto del 1857 e la fondazione della ‘Colonia Agricola’ di Battipaglia, Venosa. REPPUCCI G. 1986, La proprietà fondiaria a Montecorvino rovella (1806-1827), in “BSSPC”, a. IV. CIRILLO G. 1997, Il Barone Assediato. Terra e riforme in Principato Citra fra Seicento e Ottocento, Salerno. ROSSI L. 1997, I caratteri regionali del modello nobiliare italiano, Salerno. DEL GROSSO M.A. 1996, Un esempio di feudalità ecclesiastica, in “BSSPC”, aa. XIV-XVI. SERFILIPPO F. 1856, Ricerche sulle origini di Montecorvino nel Principato Superiore, Napoli. DI MURO A. - VISENTIN B. 1993, Attraversando la Piana, dinamiche insediative tra il Tusciano e il Sele dagli Etruschi ai Longobardi, Salerno. SCHIPA M. 1968, Il Principato di Salerno, in HIRSCH F. - SCHIPA M., La Langobardia Meridionale. Il Ducato di Benevento. Il Principato di Salerno, a cura di N. ACOCELLA, Roma. FONDI M. - FRANCIOSA L. - PEDRESCHI L. - ROCCO D. 1999, La casa rurale nella Campania, Firenze. STORCHI M. L. 1978, La gestione del patrimonio fondiario di Marcantonio Doria in Eboli nel primo quarantennio del XIX secolo, in Studi sulla Società meridionale, Napoli. GALANTI G. M. 1790, Della descrittione geografica e politica delle due Sicilie, Napoli. - 108 - ELISA BASILE Il restauro della scultura lapidea di S. Pietro Martire nella chiesa di S. Domenico a Matera L ’opera è ubicata nella chiesa San Domenico a Matera in una nicchia sul IV altare della navata sinistra. La scultura, raffigura San Pietro martire, il frate domenicano Pietro Rosini, nato a Verona nel 1206, inquisitore, ucciso in un agguato in Brianza da alcuni eretici lombardi. La scultura, di notevoli dimensioni (h 1,75 x 0,74 x 0,35 m), è in pietra calcarea policroma, scolpita a tutto tondo, e non è dipinta sul retro. San Pietro Martire è rappresentato in abito domenicano; ha il capo lievemente inclinato verso il basso è coperto da una calotta di capelli lisci, il volto segnato da rughe è incorniciato dalla corta barba. Il Santo, in piedi, avvolto nel mantello, regge con la mano sinistra un lembo del manto e il Vangelo. Uno stiletto è conficcato nel petto e un rozzo coltello gli trapassa il capo. La scultura è attribuita a Stefano da Putignano, attivo negli anni 1470-1540. Protagonista della scultura pugliese del Rinascimento, autore di un numero considerevole di sculture in pietra locale vivacemente dipinte. Il confronto stilistico con la scultura raffigurante la Madonna della salute, nella stessa chiesa, è evidente soprattutto nell’accentuazione grafica del panneggio reso con cordonature parallele, confermata dall’autografia dell’autore, Stefano da Putignano, e la data di esecuzione dell’opera: «1518» sulla base (figg. 3-5; 19-21). Stato di conservazione La visione complessiva sullo stato di conservazione della scultura e l’attenta osservazione ravvicinata hanno evidenziato, prima del restauro, alcuni segni di alterazione presenti sulla superficie lapidea e pittorica: - depositi incoe- Fig. 1 - La statua prima del restauro. Evidenti ridipinture su tutta la superficie scultorea. Fig. 2 - Prima del Restauro, dettaglio del volto. Evidenti ridipinture su tutta la superficie scultorea. - 109 - SALTERNUM Sull’incarnato del volto sono particolarmente evidenti microfratture, sollevamenti e cadute della pellicola pittorica. Metà palmo e le dita della mano destra del Santo sono in legno, testimonianza di un rifacimento del secolo scorso. La base, blocco unico con la scultura, è chiaramente posticcia, non in linea stilisticamente con la scultura, è ridipinta e ricoperta da un corposo strato di gesso (figg. 1-2; 10; 15-16). Figg. 3 - 4 - Statua della Madonna della Salute, prima del restauro. Fig. 5 - Statua della Madonna della Salute, dopo il restauro. Particolare della base con la firma autografa dell’autore e la data di esecuzione dell’opera: «Stephanus Apulie Poteniani me celavit 1518». renti; - vistose ridipinture; - alcuni parziali rifacimenti scultorei; - strati pittorici sollevati dal supporto e a tratti delle cadute di colore. La scultura, rimaneggiata più volte, presenta vari strati di colore e due strati di gesso di notevole consistenza, evidente soprattutto sulla veste del Santo. Il mantello è ricoperto da una evidente ridipintura di colore nero con vernice lucida alterata e non uniforme, mentre uno strato di gesso e una ridipintura più corposa di colore grigio chiaro opaco ricopre il cappuccio. Fig. 6 - Prima del restauro. Evidenti ridipinture su tutta la superficie scultorea. Fasi di Restauro I tre strati di ridipinture che ricoprivano gli incarnati e la veste del Santo e i cinque strati sulle mani sono stati rimossi a secco, con mezzo meccanico (bisturi), uno dopo l’altro, recuperando la policromia originale sottile, delicata, opaca, fredda nei toni, ma a contrasto con i toni caldi dei particolari; sul mantello del Santo, l’unica ridipintura applicata direttamente sul colore originale è stata asportata con una miscela di solventi adeguati. Con la rimozione degli strati sono stati recuperati il realismo dell’intaglio soprattutto sul volto, la data di esecuzione dell’opera - «1517» - sul bordo inferiore della veste e l’oro zecchino quasi integro sul Vangelo del Santo. La base posticcia è stata demolita con molta cautela, a secco; è stato asportato il gesso superficiale, e successivamente, sono stati rimossi i pezzi di gesso più compatto che inglobavano la base originale leggera e arrotondata, liberandola totalmente. Con il recupero della base originale è stata riportata alla luce la firma autografa dell’autore scolpita sul bordo: «STEPHANUS APULIAE POTENIANI ME CELAVIT». Fig. 7 - Durante il restauro. Pulitura e rimozione degli strati con il bisturi. - 110 - ELISA BASILE La ripresentazione estetica è stata eseguita con pigmenti puri; le mancanze di colore si sono accordate ai toni della policromia originale con piccoli ritocchi e leggere velature. Documentazione Fotografica: Beatrice Carriero Soprintendenza per i Beni Artistici Storici ed Etnoantropologici della Basilicata - Matera Fig. 8 - Le operazioni di restauro, pulitura e rimozione degli strati con il bisturi. Fig. 9 - Le operazioni di restauro, pulitura e rimozione degli strati con il bisturi. Fig. 10 - Statua di San Pietro martire, in corso di restauro. Fig. 11 - Statua di San Pietro martire, particolare del volto. Pulitura parziale. - 111 - SALTERNUM Fig. 13 - Statua di San Pietro martire, dopo il restauro: particolare del volto Fig. 12 - Statua di San Pietro martire, dopo il restauro. Fig. 14 - Statua di San Pietro martire, dopo il restauro: particolare della mano sinistra. Fig. 15 - Statua di San Pietro martire, rifacimento parziale (in legno) della mano destra. Fig. 16 - Statua di San Pietro martire, particolare della mano destra dopo il restauro. - 112 - ELISA BASILE Fig. 18 - Statua di San Pietro martire, particolare degli occhi dopo il restauro. Fig. 17 - Statua di San Pietro martire, particolare del volto dopo il restauro. Fig. 19 - Statua di San Pietro martire, base originale con la firma autografa dell’autore (fase di rimozione dello strato di gesso posticcio). Fig. 20 - Statua di San Pietro martire, la data di esecuzione dopo il restauro. Fig. 21 - Statua di San Pietro martire, base originale con la firma autografa dell’autore. - 113 - FRANCESCA ANGELLOTTI Libri e Recensioni La Redazione, salutando l’uscita del nuovo romanzo della prof.ssa D. Memoli Apicella, accoglie le considerazioni suscitate dalla sua lettura in una giovane Socia. I l libro di Dorotea Memoli Apicella dal titolo Sighelgaita tra Longobardi e Normanni (Laveglia&Carlone, Salerno 2009, 204 pp.) oltre alle tante novità storiche riportate, sicuramente apprezzate dai suoi lettori, potrebbe suscitare anche forti emozioni, non solo perchè rende partecipi delle vicende del tempo in cui la vicenda si colloca, ma soprattutto perché l’Autrice considera protagonista del suo libro una figura femminile dotata di grande personalità, la principessa Sichelgaita, vissuta in una Salerno medievale che aveva segnato il passaggio dalla stirpe longobarda a quella normanna. Ed è proprio in questo periodo storico-politico che la Memoli ambienta il suo racconto storico, facendo brillare la principessa di luce propria rispetto al marito, il normanno Roberto il Guiscardo, che ella, pur riconoscendogli il ruolo di dominatore incontrastato del Mezzogiorno d’Italia, riteneva debole e vulnerabile, circondato com’era da tanti nemici. Alla luce di queste considerazioni, emerge il carattere forte della principessa, la quale maturò la ferma volontà di seguirlo nelle campagne militari. La storica bizantina Anna Comneno, descrivendone la personalità nei momenti della sua esaltazione guerriera, la descrive come una donna forte che combatte valorosamente in sella al suo cavallo, fianco a fianco al marito, gettandosi nella battaglia con grande coraggio. Voleva proteggere non solo il suo sposo, ma soprattutto, prevalendo in lei il sentimento di madre, difenderlo da forze ostili e preparare senza traumi il terreno alla successione del figlio primogenito Ruggero Borsa, frutto della loro unione. Gli avvenimenti di quel tempo, attraverso una serie di circostanze favorevoli avevano portato i Normanni a impadronirsi dell’Italia meridionale nel volgere di pochi anni. Essi avevano conquistato la Sicilia nel gennaio del 1061 occupando Messina, su sollecitazione dell’Emiro Ibn-Thimna. In quella occasione Roberto affidò il comando delle operazioni al fratello Ruggero, poiché da circa tre anni la sua vita privata era intervenuta incisivamente su quella pubblica. Aveva conosciuto Sichelgaita di Salerno e le sue notevoli virtù dovettero colpirlo in maniera così forte tanto che dalle sue parole traspare subito l’intenzione di sposarla: «... è giunto a me ed alla mia gente la fama di donna avvenente, saggia, pudica e religiosa: sarà grande onore e gioia per il Popolo normanno vederla sposa e signora del suo duce...» Ella aveva ventidue anni ed era nel pieno della sua avvenente bellezza e della sua forza fisica di donna valorosa. Sposando il più temuto e rispettato condottiero dell’epoca, avrebbe - 115 - SALTERNUM mantenuto non solo lo status di principessa longobarda, ma avrebbe anche acquisito il titolo di duchessa normanna. Amato di Montecassino, autore di una Historia Normannorum, la definisce nobile, bella e saggia, e il primate Romualdo di Salerno, onesta, pudica, virile nell’animo e provvida di saggi consigli. Sichelgaita versò in quella unione ogni possibile contributo culturale e politico utile al successo del coniuge, con il quale ebbe rapporti sostanzialmente conflittuali: la sua raffinatezza intellettuale ed il suo acuto talento diplomatico si scontravano con la rozzezza pragmatica di lui, spietato ed ambizioso. Era nata nel 1036, terzogenita di Gemma di Teano e del Principe Guaimaro IV della dinastia longobarda di Spoleto; era sorella di Gisulfo II e di Gaitelgrima, a sua volta coniugata col Principe Giordano I di Capua e poi con il Conte Alfredo di Sarno. Sichelgaita aveva vissuto l’infanzia e l’adolescenza nel monastero salernitano di San Giorgio, vicino al Palatium, coltivando, parallelamente agli studi dei Classici latini e greci ed all’analisi delle Sacre Scritture, anche la passione per la medicina e l’erboristeria, come discepola di Trotula de Ruggero, esponente di spicco della Scuola Medica Salernitana. Gli anni dorati della formazione erano stati però sconvolti dalla morte del padre, il Principe più influente dell’Italia meridionale, Grimoaldo IV. La descrizione del suo assassinio fatta dalla Memoli raggiunge momenti di grande commozione: poco prima dell’evento, l’incontro del principe con la moglie, «in quell’addio supremo, fatto di struggente rimpianto di ciò che avevano insieme vissuto…», poi l’arrivo sulla spiaggia di santa Teresa, raggiunta passando da una postierla del palatium, dove si svolge l’ultimo atto della sua vita. Sono le prime luci dell’alba del 3 giugno 1052 e i tiepidi raggi del sole illuminano la triste scena della fine del Principe. Assistiamo così, da spettatori, a quell’episodio sanguinoso, perpetrato da parte di un gruppo di ribelli amalfitani e bizantini e dai quattro nipoti, figli del cognato Pandolfo V di Capua. Nell’occasione il giovane Gisulfo II, già associato al trono nel 1042, era stato catturato e poi liberato dall’abilità dello zio Guido di Sorrento, che aveva assediato la città e preso in ostaggio le famiglie dei congiurati, per barattarle per il rilascio del nipote. Gisulfo II, riconosciuto legittimo erede, fu influenzato nelle sue scelte politiche dal temperamento della sorella: infatti, Sichelgaita era coltissima ed esercitò grande ascendente a corte, distinguendosi per le attività sociali. Pochi anni dopo l’assassinio del padre, a cui probabilmente non erano estranei gli stessi Normanni, nel 1058 Sichelgaita sposa il Guiscardo - il quale, per sospetta consanguineità, aveva divorziato dalla prima moglie, la normanna Alberada di Buonalbergo -; da questa unione nacquero ben otto figli: Mafalda, Ruggero Borsa, Guido d’Amalfi, Roberto Scalio, Sibilla, Mabilia, Emma, Olimpia. Si deve all’abilità politica di Sichelgaita la riconciliazione della Chiesa con i Normanni e la portata di quell’evento sarebbe stata esaltata, alla fine di quell’anno, dalla nascita di Ruggero Borsa, a conferma della sua capacità di armonizzare il ruolo diplomatico e politico con quello di sposa e di madre. Ella visse in un periodo di eccezionale rilevanza storica, che vide il processo di rinnovamento della Chiesa di Roma nel segno della riforma gregoriana, la lotta delle investiture, l’espansione dei nuovi ‘barbari’ nella Langobardia meridionale, il declino dell’antico Principato di Salerno, il trionfo dei Normanni. I protagonisti furono: Gregorio VII, Enrico IV, Desiderio di Montecassino, Alfano I di Salerno, Roberto il Guiscardo e, tra questi, la principessa Sichelgaita. Purtroppo un pesante pensiero la tormentava da sempre: era interiormente angosciata per la sorte della figlia Olimpia, che era stata inviata alla corte di Costantinopoli quale promessa sposa. L’evolversi degli eventi, nel 1078, comportò, però, la deposizione dell’imperatore Michele Dukas, per cui Olimpia fu relegata in un convento, dove prese il nome di Elena. Tale situazione portò Sichelgaita ad appoggiare il progetto di Roberto di ribellarsi a Bisanzio: fu una spedizione che assunse il carattere di una ‘precrociata’. Venne allestita una flot- - 116 - FRANCESCA ANGELLOTTI ta imponente sulla quale ella stessa si imbarcò. Dopo Corfù, l’esercito normanno volse alla conquista di Durazzo. Lo scontro fu di inaudita violenza, un’ala delle colonne normanne, guidata da Roberto e Boemondo, ebbe la meglio sulle truppe greche e veneziane alleate, mentre un’altra ala stava per ripiegare. Sichelgaita si sentì investita dalla responsabilità del momento: saltò a cavallo ed alla testa dei suoi uomini si lanciò impavida nella mischia. Una freccia la colpì alla spalla sinistra e rischiò di essere fatta prigioniera, ma il suo coraggio risvegliò a tal punto l’ardire dei Normanni che li portò alla vittoria. Era il 18 ottobre 1081, Durazzo era conquistata. Roberto corse incontro a Sichelgaita e l’abbracciò tra le acclamazioni dei soldati. L’atto di coraggio fu così commentato da Guglielmo Appulo: «Dio la salvò perché non volle che fosse oggetto di scherno una signora sì nobile e venerabile». Dopo meno di due mesi, nel 1085 Roberto moriva nei pressi di Cefalonia, in circostanze misteriose, forse colpito da una malattia epidemica. Sichelgaita, Boemondo e Ruggero, immersi nel più straziante dolore, sciolsero le vele verso la Puglia con le sue spoglie mortali, che furono sepolte nella chiesa della SS. Trinità di Venosa. L’autorevole cronista Guglielmo Appulo descrive con vivo realismo la commozione di Sichelgaita: «Oh dolore! che sarò io sventurata? dove potrò andarmene infelice? Quando apprenderanno la notizia della tua morte i Greci non assaliranno forse me, tuo figlio e il tuo popolo, di cui tu solo eri la gloria, la speranza e la forza?». In quell’anno la morte colpì, oltre il Guiscardo, altri due personaggi-chiave della storia di quell’epoca: papa Gregorio VII e l’arcivescovo di Salerno, Alfano I. Fu un ulteriore dolore per la principessa. Ormai sola, si ritirò in Castel Terracena e continuò a prodigarsi in favore del figlio Ruggero, a mediare con Boemondo, al quale furono assegnate le sue conquiste in Grecia e varie città pugliesi, quali Bari, Otranto e Taranto. Anche questa volta ne uscì vincitrice. La scelta del ‘bicefalismo ducale’, come fu definito dagli storici, fu il modo più intelligente per scongiurare le lotte intestine ed assicurare il rilancio di un forte governo del ducato. Sichelgaita, pur senza Roberto, riuscì, in forza delle sue doti di carattere, a portare Salerno al culmine della sua potenza. Negli ultimi anni si dedicò ad una vita di preghiera. Fu un’assidua frequentatrice della Badia di Cava, alla quale aveva fatto donare, sin dai tempi del Guiscardo, molti conventi. Allo stesso modo fu benefattrice di Montecassino, cui la legava il vincolo di parentela con l’abate Desiderio, il futuro Papa Vittore III. Fu questo un periodo finalmente tranquillo, di pieno ardore religioso, in cui ella poté sostenere l’opera di moralizzazione della Chiesa. In un momento di sconforto spirituale, rivelò alla sorella Gaitelgrima la sua ultima volontà: chiedeva d’essere sepolta a Montecassino. I Longobardi si sentirono privati di una madre, i Normanni ebbero chiara coscienza che si dileguava l’ultima testimonianza del loro potere, gli umili la piansero affettuosamente. Mentre il Guiscardo si era fatto seppellire nella SS. Trinità di Venosa, nel sacrario dei duchi normanni, dove più tardi Boemondo fece tumulare anche sua madre Alberada, Sichelgaita scelse, come sua ultima dimora, Montecassino. Fu l’ultimo grande gesto di una figura maestosa nella storia: volle farsi in disparte dando un forte segno d’umiltà, di quell’umiltà che connota i forti e che la pose nella leggenda. - 117 - SALTERNUM Adriano Caffaro - Giuseppe Falanga, Isidoro di Siviglia. Arte e tecnica nelle etimologie, Edizioni Arci Postiglione, Salerno 2009, 207 pp. I l nuovo libro di Adriano Caffaro e di Giuseppe Falanga, dedicato al grande erudito del VII secolo, presenta aspetti che meritano di essere considerati alla luce dei recenti indirizzi che hanno orientato lo studio storico delle tecniche artistiche, indirizzi che mirano per lo più ad offrire una visione comparatistica delle fonti letterarie, allo scopo di tratteggiare la linea evolutiva di quel processo complesso, quanto affascinante, che è la codificazione scritta delle pratiche artistiche. Il merito da riconoscere all’opera dei due studiosi è, innanzitutto, l’aver calato una fonte poliedrica di portata eccezionale, come le Etymologiae di Isidoro di Siviglia, nell’ambito settoriale della storia tecnico-artistica, affinché se ne potessero ricostruire le corrispondenze ragionevoli tra le notizie d’arte in essa raccolte e le informazioni contenute in altri testi-chiave della trattatistica occidentale. In quest’ottica, l’opera di Isidoro si è illuminata di una luce nuova, perché è stata rapportata - con le dovute misure critiche e filologiche ai testi canonici della letteratura artistica, come il noto De diversis artibus del monaco Teofilo o le Compositiones ad tingenda Musiva, contenute nel Codice 490 di Lucca. Ne è emersa una lettura trasversale di un’opera che ha fatto parlare di sé per secoli. Al pari delle note grammaticali e retoriche, metriche e bibliche, le notizie tecniche ed artistiche tramandate da Isidoro nelle Etymologiae sono, infatti, sviluppate con significativa ricchezza di dettagli e con varietà di indicazioni supplementari, anche se in molti brani è proprio la ridondanza informativa a togliere alla trattazione isidoriana i caratteri di organicità e di ordine, che saranno tipici della trattatistica moderna. L’opera è tra le più rinomate dell’Alto Medioevo ed appartiene al genere enciclopedico mediolatino, cui non si può di certo chiedere la completezza sistematica perseguita dai trattatisti, che, dopo di Isidoro, faranno tesoro della sua immensa erudizione e potranno da quella attingere argomenti a sostegno delle proprie tesi. Il nuovo libro di Caffaro e Falanga si compone di quattro capitoli, preceduti da una nota introduttiva, che illustra il progetto culturale sotteso alla collana editoriale «L’officina dell’arte», ideata proprio da A. Caffaro e promossa dall’Arci Postiglione per offrire al vasto pubblico una trama di testimonianze letterarie utili alla ricostruzione unitaria della tradizione tecnico-artistica. Ad inaugurare la collana nel 2004 era stato un altro fortunato saggio dei due studiosi, dedicato al Papiro X di Leida, ritenuto il testo capofila della storia trattatistica della tecnica artistica in Occidente. Guardiamo, ora, il nuovo volume. Il primo capitolo presenta le Etymologiae in relazione all’enciclopedismo medievale e ne svela la chiave ‘etimologica’, quella scelta dal vescovo ispanico per la compilazione dei dati. Il secondo capitolo tratteggia il profilo religioso e culturale di Isidoro, per far sì che il suo pensiero e la sua azione campeggino nel più ampio affresco storico. Il terzo capitolo propone una ricca antologia di brani isidoriani, utili alla lettura intertestuale latina ed italiana - delle notizie di rilievo artistico. L’ultimo capitolo raccoglie le analisi e le considerazioni sviluppate intorno ai temi dell’arte e della tecnica, che nel testo isidoriano appaiono codificati, attraverso l’esercizio etimologico, in una dimensione teologica ed estetica non immune dalle citazioni di altre fonti enciclopediche, per lo più antiche. Corredano il volume una copiosa bibliografia, strumento utile per la consultazione della storiografia tecnico-artisti- - 118 - GENEROSO CONFORTI ca, ed un accurato ‘Indice degli argomenti’, che, invero, non sono pochi, spazianti dalla metallurgia all’oreficeria, dall’edilizia militare e civile all’arte plastica, vetraria e alla tintura dei tessuti. Il nuovo libro di Caffaro e Falanga illustra, in sintesi, la tesi secondo cui il progresso tecnicoartistico passa anche per le copiose pagine delle Etymologiae, le quali non possono essere assimilate in toto ai ricettari artistici che trovarono fortuna nelle botteghe artigiane di tutti i secoli, ma possono essere annoverate tra le fonti ‘trasmissive’ di un sapere tecnico antico, che sarebbe altrimenti andato perduto, ossia tra le fonti letterarie che, pur non capaci di apporti speculativi originali, hanno trovato dignità e funzione nel ‘convertire’ la sapienza antica nella moderna. Nell’inserire l’opera isidoriana nel lungo filone della tradizione artistica e letteraria occidentale, i due storici dell’arte hanno verificato l’ipotesi dell’inclusione sommativa dei saperi, perché anche il vescovo sivigliano ha posto al centro dei propri interessi il complesso patrimonio di conoscenze pratiche accumulato nei secoli dagli artisti e dagli artigiani, dagli alchimisti e dai tintori, dai monaci e dai bibliofili. Vissuto a cavallo del VI-VII secolo, Isidoro ha animato la complessa stagione delle invasioni visigotiche fino a divenirne ‘anima’ culturale, padre di una civiltà ispanica e già europea. Basti pensare al grande contributo dato per l’unificazione linguistica occidentale, nella ricerca quasi spasmodica di conservare le radici vive di una lingua, quella latina dei dotti, che sopravvisse anche grazie all’impresa isidoriana, seppure in un sostrato romanzo, che sarà destinato a contaminarsi. E, come per i dati linguistici, così è per i contenuti desunti dai grandi repertori delle arti dell’Antichità. Isidoro è stato un grande raccoglitore di excerpta estratti dalla tradizione ed ha tentato di organizzare il sapere in una cornice argomentativa unitaria. I 20 libri che compongono l’opera originale sono ‘farciti’ di citazioni tratte dai testi di Omero, Plauto, Terenzio, Varrone, Cicerone, Palladio, Virgilio, Orazio, Lucrezio, Ovidio fino a Plinio il Vecchio e a Vitruvio, i cui trattati di portata enciclopedica basterebbero da soli a dire la grandezza degli antichi. Considerati i tempi in cui il Sivigliano è vissuto, può oggi dirsi che Isidoro sia riuscito nella folle impresa. Si tenga conto, tra l’altro, della lunga gestazione dell’opera, che impegnò Isidoro per circa ventuno anni, tra il 615 ed il 636. Ne sarebbe seguita un’eccezionale vicenda editoriale, costellata dalle edizioni cinquecentesche di De Grial e Arevalo, dalle ottocentesche del Migne e del Lindemann e, al di sopra delle altre, quella curata nel 1911 dal Lindsay, edizione critica che riunisce l’intera opera in due volumi e mette fine alla ‘diaspora’ dei manoscritti isidoriani. Lo studio di Caffaro e Falanga mostra quanto Isidoro sia stato capace di interpretare e di sintetizzare la vivente e indefinita tradizione precettistica, ossia di trasmetterla ai posteri e di farne il pretesto per educare alle arti e alla religione, per avvicinare il popolo, attraverso l’etimo, al mistero della bellezza e a Dio. Le conclusioni giungono naturali: l’enciclopedia isidoriana è degna di essere valutata corne l’esito significativo di un percorso evolutivo che risale all’antichità egizia e greco-romana, attraversa il medioevo e giunge nell’età moderna. Il testo enciclopedico, seppure connotato da stile compilativo, rivela insieme alla profonda erudizione dell’autore anche la sua sensibilità estetica, intrisa, come è ovvio, di toni moralistici ed afflato spirituale. Isidoro non si limita a raccogliere le informazioni tramandate dagli Auctores pagani e tardoantichi, ma le investe di spirito nuovo e dà loro una rinnovata forma e funzione culturale. La grande cultura permette ad Isidoro di selezionare brani d’interesse della sapienza tecnica antica, pur senza che sia sviluppato un notevole livello critico; egli ribadisce i contenuti tecnici salienti, tratti dai testi delle scienze naturali o delle arti meccaniche, per dilatare gli orizzonti conoscitivi e applicativi a ciò che, in precedenza, era indirizzato soltanto a scopi pratici ed operativi. - 119 - SALTERNUM Storia di una collaborazione L a mia collaborazione con l’Associazione ARCI POSTIGLIONE ebbe inizio nel 1994. Ricordo quando fui contattato dal Presidente, il dott. Generoso Conforti, instancabile coordinatore di tutte le attività culturali che si svolgono nei Paesi degli Alburni. La telefonata mi fece molto piacere, perché mi venne chiesto di scrivere un articolo per la Rivista “Il Postiglione”1. La conoscenza con il dott. Conforti risaliva ad alcuni anni prima, quando mi divertivo a fare l’allenatore della squadra di calcio del mio Paese, Sicignano degli Alburni. In quel tempo mi trovavo spesso di fronte, da avversario, un eccellente giocatore, difficile da affrontare perché era tatticamente disciplinato e non dava punti di riferimento nella marcatura. Ho voluto citare questo spaccato calcistico per evidenziare come la sua applicazione nel fare le cose sia rimasta immutata e si sia riversata anche in quella sua attività culturale di cui oggi si celebra il ventennale2. Agli inizi degli anni ’90 ero tornato da una lunga permanenza lavorativa a Milano, dove avevo avuto l’opportunità di fare un’esperienza giornalistica: il dott. Enrico Moneta Caglio, uomo dalle grandi virtù morali, Direttore della Rivista “Agrisport e Agriturismo”, mi aveva invogliato a scrivere un articolo per il giornale e, una volta iniziata la collaborazione, mi aveva affidato l’incarico di curare la pagina culturale di quel mensile. Quando, alcuni anni dopo, ho accettato l’invito dell’ARCI POSTIGLIONE ero abituato a dare ai miei articoli un taglio rigoroso, ma divulgativo e privo di apparato critico. Allorché consegnai alla Redazione de “Il Postiglione” il mio testo, il Direttore mi fece notare che mancavano le note bibliografiche! Ne nacque un diverso modo di impostare gli scritti, improntato alle esigenze della ricerca scientifica, che sempre espli- cita e documenta le proprie fonti. Un criterio al quale mi sono ispirato anche quando, nel 1997, eletto Direttore del GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERNITANO, ho dato vita a “Salternum”, Rivista semestrale di informazione storica, culturale e archeologica. Ho tuttavia continuato a collaborare con l’Associazione per diversi anni, durante i quali ho scritto articoli che hanno trattato spaccati di vita e personaggi storici del mio Paese e ho partecipato a diversi incontri letterari dell’estate postiglionese3. Esperienze entrambe dalle quali ho sempre tratto l’emozione che si prova quando si espongono i risultati di ricerche svolte negli archivi storici e nelle biblioteche non meno che sulle evidenze storico-artistiche ed archeologiche. È successo anche per la chiesa di Santa Maria del Serrone extra moenia castrum Siciniani4. Durante il restauro, sulla sua parete sud è stata rinvenuta una finestra romanica dalla quale si può spaziare su gran parte del territorio di pertinenza del Priorato, così come descritto nel documento n. 247 dell’Arca XII della Biblioteca dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni, ritrovato grazie all’attenzione di alcuni studiosi5: si tratta di un caso esemplare del binomio ‘documento – monumento’, sul quale ogni ricercatore si augura di poter lavorare. I nostri Paesi degli Alburni hanno quella sete di conoscenza che permette di ricostruire una storia ancora in gran parte da scoprire. A noi spetta il compito più importante: fare ricerca sul territorio per riportare alla luce il patrimonio culturale che ci appartiene e per riappropriarci delle nostre origini. In questa ottica è di fondamentale importanza che la collaborazione oggi ventennale tra le due Associazioni, l’ARCI POSTIGLIONE e il GRUPPO - 120 - FELICE PASTORE ARCHEOLOGICO SALERNITANO, venga mantenuta in vita e costantemente alimentata da una ‘linfa’ capace di generare nuove idee e suscitare interessi e collaborazioni soprattutto da parte dei giovani. Abbiamo il dovere morale di trasmettere alle future generazioni l’esempio di come un Bene Culturale possa essere tutelato e valorizzato attraverso la conservazione della sua memoria storica. Al termine di una conferenza che ho tenuto a Postiglione nell’agosto del 2005, ho proiettato un’immagine di un tramonto sull’isola di Capri, ripreso in una limpida giornata da un terrazzo naturale di quel lontano paese alburnino. Le parole conclusive, nelle quali continuiamo a riconoscerci, erano: «la memoria storica di un territorio è arte, è fuoco, è luce. Facciamo di tutto per non farla tramontare come l’ultimo sole che ogni giorno tramonta nell’azzurro mar Tirreno». 1 PASTORE F. 1994, A Sicignano degli Alburni in un luogo di pace: il convento dei Frati Cappuccini, in “Il Postiglione”, VI, n. 7, pp. 213-216. 2 CAFFARO A. - CONFORTI G. - MELE R. 2009, In viaggio da vent’anni. Arci Postiglione 1989 - 2009, Ed. Arci Postiglione, Penta (SA). 3 PASTORE F. 1996, Girolamo Brittonio: la famiglia, la vita, le opere, in “Il Postiglione”, VIII, n. 9, pp. 289-296. 4 IDEM 1997, Il Priorato di Santa Maria del Serrone a Sicignano degli Alburni, in “Il Postiglione”, IX, n.10, pp. 271-284. 5 FORES D. P. 1988, L’inventario dei beni di S. Benedetto di Salerno a Sicignano, in Appunti e documenti per la storia del territorio di Sicignano degli Alburni, a cura di C. CARLONE - F. MOTTOLA, Ed. Studi Storici Meridionali, Nocera Inf. (SA), pp. 361-381. - 121 - FELICE PASTORE Notizie dagli scavi MONDRAGONE (CE). Dallo scavo preistorico un paleosuolo di 50.000 anni fa. Dallo scorso mese di settembre 2009 è in corso la nona campagna di scavo nella grotta di Roccia San Sebastiano in loc. Incaldana, condotta, con il contributo finanziario del Comune di Mondragone, dall’Università di Roma ‘Sapienza’, in regime di concessione da parte della Soprintendenza Archeologica delle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. Lo scavo di quest’ anno, che terminerà verso la metà di Ottobre, ha permesso di ampliare l’esplorazione dei livelli più antichi del Paleolitico superiore, al di sotto del livello Gravettiano datato a circa 20.000 anni fa. La sequenza messa in luce finora dimostra, in modo evidente la continuità e l’intensità della frequentazione preistorica dell’area del Comune di Mondragone e delle pendici del Monte Massico. Al di sotto dei livelli già noti fino al 2008, è stato possibile accertare la presenza di un importante livello con resti di fauna e manufatti litici attribuibili alla cosiddetta Cultura Aurignaziana, che si colloca in Europa agli inizi del Paleolitico superiore, con datazioni, in altri giacimenti italiani, intorno a 30.000 anni fa circa. «Si tratta di un risultato sorprendente - commenta entusiasta l’Assessore alla Cultura Antonio Taglialatela - che premia la volontà di incrementare le risorse per gli scavi a partire dall’anno 2008». La scoperta certamente più significativa di questa campagna di ricerche è stata tuttavia quella relativa all’esistenza di un livello ancora più antico, databile tra 45.000 e 50.000 anni fa, caratterizzato da un notevole ricchezza di manufatti riferibili al Musteriano, la Cultura che precede l’arrivo in Europa dell’Uomo moderno. La scoperta e lo scavo in corso di questo livello documentano la presenza di gruppi umani Neanderthaliani, la specie che popolò l’Europa e parte dell’Asia, tra 200.000 e poco meno di 30.000 anni fa circa. «Con questa scoperta - commenta il Sindaco Achille Cennami cambia la storia di Mondragone e la Preistoria dell’Alta Campania: Mondragone diventa terra di uomini Neanderthaliani e i prossimi anni potranno essere ricchi di ulteriori importanti scoperte. Ci troviamo di fronte a reperti che non hanno valore commerciale, ma un grandissimo valore scientifico, trattandosi di reperti in pietra e in selce. Il Museo Civico Archeologico ‘Biagio Greco’ si conferma una punta di eccellenza nel campo dei Beni Archeologici, grazie anche all’intensa collaborazione della Soprintendenza Archeologica e la direzione del dottor Luigi Crimaco». MONDRAGONE (CE). Dal Monte Massico riemerge un vigneto dell’antico Falerno. All’interno di un vigneto fossile individuato lungo uno dei fianchi del Monte Massico (Caserta), sono state rinvenute tracce di polline di una vigna di età romana, analizzate presso un laboratorio dell’Università degli Studi di Padova. Ad annunciare i risultati è stato l’archeologo Luigi Crimaco, durante il Seminario ‘Dal Falernum al Falerno’, svoltosi al Museo Civico ‘Biagio Greco’ di Mondragone. «Da uno dei terrazzamenti antichi, ubicato alle pendici del Massico, proviene una delle più interessanti scoperte archeologiche - spiega Crimaco - che ha restituito le tracce fossili di un - 123 - SALTERNUM vigneto risalente all’età imperiale romana. La scoperta, fatta negli ultimi anni del secolo scorso dopo i lavori di sbancamento per la costruzione della strada Panoramica del piccolo borgo di Falciano del Massico, ha permesso di individuare una serie di sulci (filari), in cui dovevano essere sistemate le viti per la produzione del vino. All’interno dei solchi, al momento della scoperta, furono rinvenuti esclusivamente frammenti di ceramica fine di produzione africana, tipica del mondo imperiale romano. Si tratta di 15 solchi paralleli, disposti a una distanza di circa 2,70 metri l’uno dall’altro e ricavati nel paleosuolo composto di ignimbrite campana. Le recenti analisi polliniche hanno fornito risposte adeguate e possiamo affermare che il fossile rinvenuto nell’area del Massico apparteneva ad un vigneto di Falerno». All’incontro - che ha avuto la finalità di fare il punto sugli studi su una delle aree più importanti nella diffusione della vite nel Mediterraneo, l’Ager Falernus - sono intervenuti l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianfranco Nappi, il sub-Commissario della Provincia di Caserta Michele Petruzzelli, il deputato Mario Landolfi, il Presidente di AGRISVILUPPO Giuseppe Falco, il Sindaco di Mondragone Achille Cennami, ed i professori Luigi Moio, ordinario di enologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Nicola Trabucco, agronomo. Ha moderato il dibattito il giornalista Luciano Pignataro. Il Seminario è stato organizzato nell’ambito del Programma Speciale di Marketing Territoriale ‘Costiera dei Fiori’, ideato e promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e realizzato da una partenariato locale costituito dalla Camera di Commercio di Caserta, Stapa Cepica ed Amministrazione Provinciale, di cui AGRISVILUPPO è soggetto attuatore. In quell’occasione l’agronomo Trabucco ha trattato della composizione del suolo della ricca terra del Falerno, analizzando le singole aree di produzione; a tracciare un percorso dell’origine del Falerno, a spiegare i metodi di vinificazione nell’epoca romana e le caratteristiche sensoriali del vino come riportato dagli autori classici, è stato il professor Moio. Per valorizzare questa risorsa antica che può rinnovarsi al presente, il Presidente di AGRISVILUPPO ha illustrato tre importanti progetti: «L’idea è quella di realizzare una Fondazione per la promozione del vino Falerno, che associ Camera di Commercio, Comuni interessati e produttori di vino. Poi avvieremo la pratica necessaria per chiedere all’Unesco la tutela del vinum falernum e abbiamo l’intenzione di ricostruire tre vigneti sul modello di quelli degli antichi Romani, in tre diverse zone quali il Teatro Romano di Sessa Aurunca, la Villa di San Limato a Cellole e gli Scavi del Castello di Mondragone». Il Sindaco di Mondragone e l’Assessore regionale all’Agricoltura hanno annunciato la realizzazione di un’enoteca dedicata all’importante vitigno, per la quale è già stato fatto un cospicuo stanziamento. MONDRAGONE (CE). Rinvenimento di un fonte battesimale medievale. Dopo il rinvenimento di una staffa di cavallo, un’ulteriore sorprendente scoperta ha premiato la IX campagna di scavo in corso sulla Rocca Montis Dragonis, diretta da Luigi Crimaco, Direttore del Museo Civico Archeologico ‘Biagio Greco’. Si tratta di un fonte battesimale medievale, del peso stimato in 350 kg. «Si tratta di una bellissima scoperta archeologica - commenta L. Crimaco - sulla quale ci riserviamo, dopo i necessari studi, di pronunciarci in modo completo. Ad una prima analisi possiamo affermare che forse si tratta di un fonte battesimale medievale, ma è opportuna la cautela. Quello che mi preme è formulare un vivo ringraziamento al parroco di S. Angelo, Don Roberto Gutturiello, presente durante le operazioni di recupero del reperto archeologico. Senza l’aiuto dei componenti del Comitato Festa di S. Angelo non sarebbe stato possibile portare immediatamente al Museo questa importante testimonianza del passato». Le operazioni di trasporto, eseguite nella giornata di giovedì 24 settembre, sono state infatti possibili grazie alla fattiva collaborazione del Comitato della Festa Patronale di S.Michele, presenti sul luogo in quanto impegnati a montare l’illuminazione del - 124 - FELICE PASTORE Castello. Il fonte battesimale è stato trasporto lentamente dalla sommità del Castello fin dalle prime ore della mattinata ed è giunto in località Cantarella verso le ore 15.00, quando è stato preso in custodia dagli operai del Comune Giuseppe Rao e Vincenzo Crimaldi. Sotto la supervisione della restauratrice del Museo, la dott.ssa Marianna Musella, il reperto è stato poi collocato nella sala medievale, posta al secondo piano, che ospita anche lo stemma dei Duca Grillo. «Ritengo che con la scoperta di questo importate reperto archeologico di epoca medievale - commenta il Sindaco Achille Cennami confermiamo una vocazione di eccellenza del nostro Museo Civico e della sua Direzione Scientifica. Ringrazio anche io la comunità di Sant’Angelo, nella persona del parroco don Roberto Gutturiello, per il prezioso aiuto dato alla nostra équipe scientifica dai componenti il Comitato Festa nell’operazione di salvataggio e mi piace sottolineare come il fonte battesimale possa essere già visto nelle sale del nostro Museo. La continua collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, attraverso la persona della dott.ssa Ruggi d’Aragona, ci permette di mettere in risalto e di offrire all’attenzione di tutti quanto di bello e prezioso la nostra storia ci ha lasciato». MARIGLIANO (NA). Riportato alla luce un tratto della via Popilia. Il 2 febbraio 2009 è stato individuato un tratto dell’antica via Popilia. Superate iniziali difficoltà legate principalmente alla mancanza di fondi, si sono avviati gli scavi in via Sentino per riportare alla luce completamente l’antica strada romana, costruita nel 132 a.C. per collegare Capua con Reggio Calabria; l’importante arteria passava per Acerra, Marigliano, Nola, Nocera e il territorio salernitano fino ad arrivare a Reggio. A dirigere i lavori è la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei diretta dal funzionario di zona, Giuseppe Vecchio, con l’archeologo Nicola Castaldo. «Mi sono subito reso conto dell’importanza della scoperta – spiega Castaldo - che apre nuovi e inaspettati orizzonti sulle potenzialità archeologiche di Marigliano». L’individuazione della via romana si aggiunge ad altri rinvenimenti di particolare rilevanza, avvenuti nel 2007 e nel 2008, tra cui una necropoli romana stratificata, una villa in via Sentino, un’altra di Età imperiale in via Ponte delle Tavole, ai confini con San Vitaliano, ed una capanna dell’Età del Bronzo risalente a 1700 anni a.C. In mancanza di finanziamenti per la prosecuzione degli scavi, tali emergenze erano state temporaneamente reinterrate, per evitare atti di vandalismo e furti. Uno spiraglio si è aperto con l’ingresso di Marigliano nel piano strategico di valorizzazione di Beni Culturali dell’area nolana, finanziato dall’Unione Europea con 21 milioni di euro; al Comune sono stati assegnati circa 2 milioni di euro per la realizzazione del Parco Archeologico e di un centro per lo studio e la catalogazione delle tradizioni locali. Con la ripresa degli scavi della via Popilia si riaccendono i riflettori sull’area archeologica di Marilianum e a sostenere la causa del Parco Archeologico si è aggiunto anche uno splendido vaso in sigillata italica del I secolo d.C., rinvenuto nella villa sannitica. Il vaso, dopo il restauro, verrà esposto in una sala del nuovo Museo Archeologico di Nola. NOLA (NA). Reperto di età augustea ‘esposto’ in un giardino privato. Conservava una reperto archeologico in marmo di età augustea nel giardino di una villa, usandolo come elemento ornamentale; il proprietario è stato denunciato in stato di libertà. A effettuare la scoperta i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, i quali hanno eseguito un sopralluogo all’interno di una lussuosa residenza utilizzata per ricevimenti. Il reperto è una metopa finemente decorata con bassorilievi, che doveva far parte di un mausoleo o di un edificio pubblico di età augustea, probabilmente situato nel territorio nolano, in un sito archeologico che con ogni probabilità negli anni passati è stato visitato da un gruppo di tombaroli. Dopo un rapido accertamento, il titolare della villa è risultato sprovvisto di autorizzazioni che giustificassero il possesso dell’og- - 125 - SALTERNUM getto sequestrato ed è stato denunciato per il reato di ‘impossessamento illecito di Beni Culturali appartenenti allo Stato’. La metopa è stata sottoposta a perizia tecnica da parte di un funzionario archeologo della Soprintendenza di Napoli e Pompei il quale, oltre ad attestarne l’autenticità e la datazione, ha anche evidenzia- to che si tratta di un opera di grande pregio artistico e scientifico. Il reperto è stato trasportato al Museo Archeologico di Nola. (Notizie tratte da: Archemail. L'archeologia in Campania "Notiziario on-line del Gruppo Archeologico Napoletano", mesi sett. - ott. 2009). - 126 - ROSALBA TRUONO Appunti di Viaggio Scoprendo il Perù... S coprire il Perù e lasciarsi sorprendere dai suoi mille volti è un’esperienza gratificante. Le diversità geografiche, climatiche ed etniche che coesistono in questa magica terra, gli usi e i costumi dei suoi abitanti, anche da lontano, non finiscono di emozionarti. I mille aspetti di questa realtà ti incuriosiscono e ti rincorrono, coinvolgendoti. Sono i lunghi deserti, i maestosi e innevati vulcani andini a lasciarsi ammirare; sono le greggi di alpaca o di vigogne che ti corrono davanti agli occhi e i versi dei leoni marini o dei volatili, stanziati nelle isole Ballestas, in mezzo all’oceano, a richiamarti. E poi i volti dei bambini bruciati dal sole e dal vento di altitudini impossibili da abitare e i loro piedi scalzi nei recinti insieme coi lama, o le madri pazienti che trasportano i loro piccoli in spalla nei panni multicolori, a parlarti di una realtà diversa e difficile. Il Perù è anche la grande lezione di vita trasmessa dalla mitezza e dall’essenzialità in cui vivono popolazioni umili, come gli Uros delle isole galleggianti del lago più alto del mondo: il Titicaca. Esse sono riccamente paghe di vivere in armonia con una natura non sempre confortevole. Coinvolgente è anche il mistero dei giganteschi segni, prodotti chissà da quali civiltà, ora nel deserto, come quelli di Nasca, ora su dune sabbiose, come quelle di Paracas. E intanto ti interroghi sulla grandezza di megalitiche costruzioni, testimoni di antiche civiltà millenarie che ti affascinano insieme a riti, danze e musiche, che come l’Inti Raymi, ancora oggi le rappresentano. Fig. 1 - Isole galleggianti. Donne di etnia Uros. Fig. 2 - Festa dell’Inti Raymi. Fig. 3 - Festa dell’Inti Raymi. - 127 - SALTERNUM Fig. 4 - Pisac. I ‘terrazzamenti incaici’. Fig. 5 - Vigogne e misti - Il vulcano simbolo di Arequipa. Fig. 6 - Isole Ballestas - Parco Naturale. ...come un incantesimo La veduta di Machu Picchu è un’emozione mozzafiato; all’alba poi, avvolta dalla nebbia che si dirada, man mano che il sole del solstizio d’inverno incede, ti ripaga degli ostacoli e dei disagi di un viaggio faticoso. Un traguardo irrinunciabile per gli amici naturalisti e per gli appassionati di archeologia, che in quest’atmosfera da favola possono ben capire ciò che dovette provare Hiram Bingham quando, nel 1911, vide questo luogo incantato per la prima volta. E’ qui che ti sorprende la bellezza di una Natura prepotente e la sapienza di mani esperte ed antiche. Tutto è uno spettacolo nello spettacolo: i picchi verdi delle montagne che appaiono e scompaiono tra la nebbia, i terrazzamenti maestosi che degradano verso il fondo valle, l’acqua trasparente del fiume Urubamba che scorre laggiù nelle gole profonde, i lama pazienti che brucano l’erba, le mille orchidee che fanno capolino tra il verde rigoglioso della vicina foresta e infine le antiche costruzioni incaiche, che ordinatamente si adagiano in ogni dove, come perle incastonate nella loro più naturale cornice. Sono queste pietre, magistralmente incastrate in un luogo quasi inaccessibile, sono i lunghi sentieri incaici, sofisticati canali che un tempo consentivano l’irrigazione costante delle colture, le numerose scalinate di pietra, incassate nei muri i cui blocchi intagliati e levigati sono giustapposti senza margine di errore, sono le enigmatiche forme scultoree cerimoniali, i templi, le terrazze affacciate su vertiginosi precipizi a porci misteriose domande sulla grandezza e sulla organizzazione delle civiltà andine. Nascosto nella nebbia dell’umido bosco e nella sua rigogliosa vegetazione, il complesso di Machu Picchu è ben a ragione considerato una delle meraviglie del mondo. Probabilmente fu una città sacra, abitata da persone scelte, forse appartenenti alla nobiltà incaica e alle alte gerarchie religiose, una città che tuttavia gli Spagnoli durante la conquista non attaccarono mai e che forse fu abbandonata dai suoi abitanti, che scapparono verso la selva per sfuggire all’esercito nemico. La complessa struttura urbanistica di Machu Picchu e la sua possente architettura rendono alquanto difficile i tentativi di identificarne la funzione e l’origine. Qui, più che altrove, gli elementi tipici dei centri cerimoniali e dei luoghi di culto sono commisti a quelli propri delle fortezze - 128 - ROSALBA TRUONO difensive e degli insediamenti agricoli. Perciò ancora oggi questo complesso non cessa di stupirci ed essere fonte di dibattiti tra gli archeologi, che, forse in un prossimo futuro, ne sveleranno nuovi, affascinanti aspetti. E intanto, mentre nella nostra mente si affollano come flasches le immagini di un paesaggio incantato, i cui luoghi riecheggiano della poesia di nomi quecheea - Machu Picchu (cima vecchia), Huayna Picchu (cima giovane), Intiwatane (luogo che cattura il sole) e così via -, noi non possiamo che essere d’accordo con le parole di Hiram Bingham: «…la visione mi catturava lo sguardo come un incantesimo!». Fig. 7 - Machu Picchu. - 129 - SALTERNUM Indice Editoriale......................................................................................................................................pag. 3 di Gabriella D’Henry Le popolazioni indigene dell'entroterra ........................................................................................pag. 5 di Gianni Bailo Modesti Geomitologia ed origini geologiche del culto dell’Arcangelo Michele ........................................pag. 23 di Luigi Piccardi Di una iscrizione rinvenuta a Lacedonia ......................................................................................pag. 29 di Nicola Fierro La schiavitù a Roma....................................................................................................................pag. 33 di Pietro Crivelli L’anfiteatro atinate. Lineamenti storici, epigrafici e topografici di un monumento sepolto dell’antica Atina ..............................................................................pag. 49 di Marco Ambrogi Orazio e la Campania..................................................................................................................pag. 63 di Francesco Montone Lo stato di conservazione degli affreschi di San Pietro a Corte in Salerno ....................................pag. 71 di Maria Amoruso “Picturae in ecclesiae S. Marie de Casalucio” Gli affreschi di Casaluce. Una parentesi medievale ........................................................................pag. 79 di Gianmatteo Funicelli La Natività della tradizione apocrifa nella cripta della cattedrale di Nusco ................................pag. 89 di Maria Giovanna Vespasiano Origini e sviluppo dell’architettura rurale nella piana del Sele: l’esempio della Masseria Fosso ....................................................................pag. 99 di Lorella Mazzella Il restauro della scultura lapidea di San Pietro Martire nella chiesa di S. Domenico a Matera ......pag. 109 di Elisa Basile RECENSIONI Dorotea Memoli Apicella, Sichelgaita tra Longobardi e Normanni,............................................pag. 115 di Francesca Angellotti Adriano Caffaro - Giuseppe Falanga, Isidoro di Siviglia. Arte e tecnica nelle etimologie ........pag. 118 di Generoso Conforti Storia di una collaborazione ....................................................................................................pag. 120 di Felice Pastore Notizie dagli scavi ....................................................................................................................pag. 123 di Felice Pastore Appunti di viaggio ..................................................................................................................pag. 127 di Rosalba Truono - 131 - Finito di stampare nel mese di novembre 2009 da Arti Grafiche Sud Salerno
Scaricare