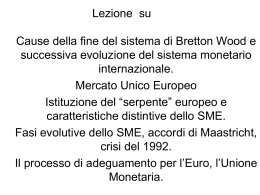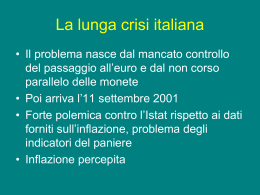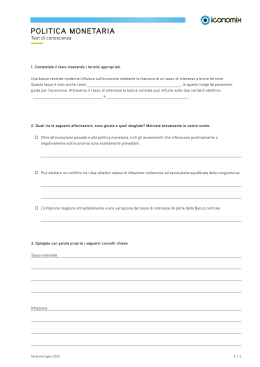Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Università di Siena, 2014-15 Francesco Farina Politica Economica Internazionale Parte Prima L’equilibrio macroeconomico di un’economia aperta 1.Introduzione Questa Parte Prima richiama i concetti fondamentali dell’equilibrio macroeconomico di un’economia, rappresentata come l’insieme del settore privato (costruito mediante l'aggregazione dei comportamenti di mercato delle famiglie e delle imprese), del settore pubblico e del settore estero. Le microfondazioni dell’equilibrio macroeconomico di un’economia in concorrenza perfetta richiedono le seguenti ipotesi: A) informazione completa e perfetta: gli agenti sono razionali, hanno accesso allo stesso insieme informativo e sono quindi a conoscenza sia delle caratteristiche dei mercati che dei comportamenti degli altri agenti; B) assenza di costi di transazione: gli agenti, nell’effettuare scambi a pronti (spot) oppure nello stipulare contratti non incorrono in costi (i prezzi sono legati soltanto ai costi di produzione). Le transazioni si svolgono mediante la moneta, che funge da unità di conto dei contratti, da mezzo di pagamento e da riserva di valore, secondo una struttura temporale basata sulla successione di singoli periodi (si suppone che un periodo corrisponda ad un anno); C) le imprese godono di libertà di entrata e di uscita dal mercato e sono pricetakers: le decisioni di produzione vengono prese sulla base dei prezzi di equilibrio esogenamente dati. 2. Nuova economia classica e nuova economia keynesiana L’analisi macroeconomica si è interrogata sull’esistenza, l’unicità e la stabilità dell’equilibrio macroeconomico risultante dall’aggregazione delle equazioni del 1 modello di equilibrio economico generale walrasiano. Una volta descritta l’esistenza dell’equilibrio con i modelli IS-LM prima e AS-AD poi, definiti i concetti di NRU e NAIRU e analizzati i processi di inflazione e di disinflazione, confronteremo i modelli con aspettative razionali della nuova economia classica e della nuova economia keynesiana che individuano ciascuno un diverso equilibrio macroeconomico. Le principali proposizioni della visione NCE sono: 1) il sistema economico si caratterizza per la dicotomia fra settore reale (il modello walrasiano determina i prezzi relativi) e settore monetario (la teoria quantitativa della moneta nella versione del monetarismo di Friedman, determina i prezzi assoluti in piena occupazione); 2) l’equilibrio macroeconomico Pareto-efficiente è garantito dalla flessibilità di tutti i prezzi che permette l’aggiustamento di mercato ed il ripristino della piena occupazione successivamente ad uno shock; 3) un’accelerazione della crescita monetaria non ha effetti reali e provoca soltanto un incremento del livello dei prezzi. Le principali proposizioni della visione NKE sono: 1) l’incertezza sul futuro causa frequenti shock, in primo luogo, della domanda aggregata; 2) la disoccupazione ciclica può mettere capo ad un equilibrio di disoccupazione strutturale a causa della vischiosità dell’aggiustamento di mercato; 3) le politiche macroeconomiche hanno effetti reali e sono quindi in grado di ridurre la perdita di benessere sociale connessa alla disoccupazione. 2.1. La critica di Lucas alle politiche macroeconomiche Il modello di Lucas ha influenzato notevolmente la teoria macroeconomica, fino a divenire la basi concettuale per la visione della Nuova Economia Classica, si fonda sulla nota ipotesi delle “aspettative razionali” utilizzata nella moderna teoria macroeconomica. L’idea di fondo è che i soggetti, disponendo di tutte le informazioni (compresi gli “annunci” sulle rispettive manovre fatti delle autorità monetarie e fiscali”) a costo zero, sono in grado di inserire tali dati nelle equazioni che esprimono gli eventi strutturali (il funzionamento normale di lungo periodo del sistema economico) ed a calcolare i prezzi futuri e le quantità future dei beni, valori che 2 determinano le loro decisioni di investire (le imprese) e di consumare (i lavoratori). Eventuali errori possono scaturire solo da eventi stocastici che – essendo inattesi – sconvolgono il funzionamento dell’economia così com’è sintetizzato dalle equazioni del modello utilizzato dai soggetti: ad esempio, shock di domanda negativi, dovuti al pessimismo dei soggetti dopo colpi di stato, gravi attentati, etc.; shock di offerta negativi che riducono l’offerta aggregata: cataclismi, terremoti, etc.; ma anche shock positivi di domanda (nuovi mercati di sbocco per le proprie esportazioni), e di offerta (l’aumento delle risorse di un paese a seguito della scoperta di giacimenti di petrolio o gas), oppure da manovre economiche delle autorità monetarie e fiscali che non tengano fede agli “annunci” fatti. Infatti, in base all’ipotesi di aspettative razionali, i soggetti sbagliano le loro previsioni su prezzi e quantità solo se non hanno l’informazione corretta. Il messaggio del modello di Lucas riguardo ai tentativi delle autorità monetarie e fiscali di “ingannare” i soggetti è che è illusorio ritenere che politica monetaria e politica fiscale possano modificare durevolmente il livello del reddito. Le manovre espansive “non annunciate” generano cicli espansivi dell’economia reale (aumenti di produzione ed occupazione) nel breve periodo. Tuttavia, quanto più frequenti e ripetuti sono i tentativi di manipolare l’equilibrio macroeconomico con espansioni monetarie o fiscali non annunciate, tanto meno le autorità risulteranno “credibili” agli occhi dei soggetti, tanto più rapido sarà l’apprendimento degli agenti sul comportamento delle autorità, e quindi l’errore sulle aspettative su prezzi e quantità nel lungo periodo scomparirà. Pertanto, nel lungo periodo la AS tende a divenire verticale, ovvero, un’espansione monetaria o fiscale “non annunciata” non realizza alcun aumento dell’attività produttiva. Dall’ipotesi che il comportamento degli agenti in basi sulla teoria delle aspettative razionali discendono le seguenti conseguenze: 1) gli imprenditori razionali delle imprese del settore privato fissano i prezzi di listino dopo avere valutato le richieste salariali sulla base di prezzi futuri attesi correttamente “anticipati” mediante l’utilizzo del modello di funzionamento 3 dell’economia. Nell’ipotesi di autorità monetarie e fiscali che tengono fede agli annunci, non si determinano variazioni di reddito e occupazione. Gli annunci di politica monetaria e fiscale mettono in grado gli agenti di prevedere gli incrementi futuri di salari e prezzi. Se gli agenti (imprese e sindacati) correggono salari e prezzi nel loro modello di funzionamento dell’economia, dalle manovre espansive non sortiscono effetti sul piano delle grandezze reali. Gli imprenditori correggeranno verso l’alto i prezzi di vendita, ed i sindacati contratteranno nelle negoziazioni salariali un più elevato salario monetario, tale da impedire una perdita di potere d’acquisto. Ad eguali incrementi di salari e prezzi consegue un immutato livello del salario reale. Poiché il salario reale resta invariato, le imprese non hanno incentivo a variare la produzione. 2. Le politiche keynesiane di stabilizzazione “annunciate” con le quali le autorità monetarie e fiscali tentavano di modificare l’equilibrio macroeconomico del settore privato fino agli anni ’80 fallivano nell’innalzare occupazione e reddito perché non tenevano conto del modello delle aspettative razionali (ovvero dell’immediata correzione di salari e prezzi che manteneva immutato il costo del lavoro per le imprese). I modelli di simulazione per la politica economica devono quindi considerare endogenamente le reazioni degli agenti agli annunci di politica monetaria e fiscale. Poiché le autorità monetaria e fiscale hanno il potere di agire per prime, è sempre possibile che gli agenti vengano ingannati da una manovra della quantità di moneta o del bilancio pubblico diversa da quella annunciata. Il mancato manifestarsi dell’incremento del livello di attività atteso dalle manovre espansive e la salita dei tassi di inflazione negli anni ’70 e ’80 a livelli sempre più elevati, sono stati considerati dalla comunità scientifica la “prova” che convalida la teoria di Lucas. Analizziamo il modello di offerta aggregata (AS) e di domanda aggregata (AD) in forma ridotta: (2.1) Yt D AE t 1 (ln mt ln pt ) 1t (2.2) Yt S Y * 2 (ln pt ln pte ) 2t 4 dove YDt è la domanda aggregata; YSt l’offerta aggregata; Y* il livello di produzione potenziale; AEt la spesa autonoma (privata e pubblica); β1 e β2 sono costanti positive; mt indica le scorte liquide reali; pt il livello del prezzo (la differenza lnmt-lnpt è quindi eguale al logaritmo di M/p); pet è il livello atteso del prezzo; µ1t denota uno shock di domanda; e µ2t uno shock di offerta. Per ipotesi gli agenti conoscono i valori dei coefficienti del modello. Se dunque sono noti i valori dello stock di moneta (ipotesi di politica monetaria “anticipata”) e della spesa pubblica (ipotesi di politica fiscale “anticipata”), posizione e inclinazione della curva AD e posizione e inclinazione della curva AS sono conosciute dagli agenti. L’adozione di una posizione verticale della funzione di offerta di lavoro – e quindi anche della curva AS - viene giustificata con l’idea che i lavoratori considerino permanenti i movimenti del salario reale, cosicché la sostituzione di lavoro a tempo libero per effetto di un aumento di salario reale risulta assai contenuta. Se gli agenti formano aspettative razionali, e quindi l’aspettativa di prezzo si rispecchia nel prezzo realizzato (pet=pt) e non vi sono disturbi stocastici alla produzione, l’offerta aggregata è al suo valore naturale (YSt=Y*). In quali circostanze la curva di offerta aggregata assume una pendenza positiva? La risposta di Lucas è che scostamenti della produzione dal livello di equilibrio (Y*) possono verificarsi soltanto in seguito a shock stocastici, o a politiche macroeconomiche “non annunciate”. Nel modello di Lucas un incremento non atteso del livello dei prezzi può dipendere da: 1) una politica monetaria espansiva non annunciata da parte dell’autorità monetaria: (mt>mte); 2) una politica fiscale che crea un deficit pubblico non atteso da parte dell’autorità fiscale: (AEt>AEte); 3) uno shock sulla AD, con variazioni nella stessa direzione della produzione e del livello dei prezzi; 4) uno shock sulla AS, con variazioni di segno opposto della produzione e del livello dei prezzi. Queste considerazioni sono state riassunte nella cosiddetta “Proposizione di inefficacia della politica monetaria”: la moneta è neutrale (cioè, un suo incremento 5 non ha effetto sulle grandezze reali: reddito e occupazione) se la variazione della quantità di moneta corrisponde alle aspettative, cioè è pari all’annuncio sull’obiettivo di inflazione effettuato dalla banca centrale; non è neutrale, e quindi la politica monetaria è efficace e produce effetti sul settore reale, se la banca centrale inganna gli agenti, immettendo una quantità di moneta diversa da quella annunciata (se maggiore, si determina inflazione). Più complesso è il discorso riguardo alla politica fiscale, che esamineremo nel capitolo sul Settore pubblico. In molti paesi avanzati, negli anni ’70 e ’80, si sono registrati periodi di incrementi “non annunciati” della quantità di moneta e della spesa pubblica in deficit. Le conseguenze furono, rispettivamente: una forte “monetizzazione” dell’economia e ingenti emissioni di titoli di debito pubblico. Gli agenti progressivamente “impararono” a non farsi sorprendere da annunci che si rivelavano ogni volta poco veritieri. La tendenza fu cioè a stimare aumenti di quantità di moneta e di spesa pubblica superiori agli annunci. Alle politiche espansive non si accompagnarono perciò aumenti del reddito, quanto soprattutto aumenti dei prezzi. 2.3. L’equilibrio macroeconomico nella Nuova Economia Classica (NCE) e nella Nuova Economia Keynesiana (NKE) Consideriamo un modello AS-AD con aspettative razionali. Data l’ipotesi di perfetta informazione sul funzionamento dell’economia, gli agenti aggiornano continuamente il proprio modello e sono perciò in grado di prevedere correttamente il livello futuro dei prezzi. Poiché le variazioni di prezzo dei beni non hanno conseguenze sulla domanda e sull’offerta di lavoro, l’offerta aggregata è determinata unicamente dai fattori reali (tecnologia, dotazione di capitale e scelta dei soggetti tra lavoro e tempo libero) assumendo nel piano una posizione verticale ((AS*LP in Figura 1). Supponiamo si manifesti uno spostamento verso l’alto della funzione di domanda aggregata da AD0 a AD1. Nei modelli NCE, il funzionamento del mercato del lavoro è definito dalle seguenti condizioni: 6 1) informazione perfetta sui posti disponibili, sulle caratteristiche dell’attività lavorativa e sulla sua remunerazione; 2) comportamenti razionali da parte di imprese e di lavoratori con caratteristiche omogenee; 3) costi di mobilità territoriale dei lavoratori e degli impianti nulli; 4) assenza di vincoli di tipo istituzionale, ovvero la piena flessibilità dei salari e dei prezzi. Da tali condizioni consegue un aumento del prezzo (p) e del salario monetario (w) nella stessa proporzione, lasciando invariati salario reale (w/p), occupazione (L) e reddito (Y) in corrispondenza dell’intersezione dell’offerta verticale di lungo periodo (AS*LP) con la nuova funzione di domanda aggregata (AD1). La funzione di offerta aggregata (AS*LP in Figura 1) è verticale sia nel breve che nel lungo periodo, perché tutti gli agenti scontano le variazioni del livello dei prezzi (p). Uno shock reale, invece, modifica la posizione della curva di offerta aggregata, spostandola da AS*LP a AS’LP, in corrispondenza di un più alto tasso di disoccupazione naturale. Passiamo ora all’equilibrio macroeconomico che viene a determinarsi nel modello della Nuova Economia Keynesiana (NKE) (Figura 1). Le negoziazioni salariali fra le organizzazioni degli imprenditori e quelle dei lavoratori di ciascun settore produttivo sono scaglionate nel tempo, sicché l’esito dell’incremento della domanda aggregata è diverso dall’immediato incremento di salario nominale e prezzi assunto nel modello NCE. Nel modello NKE è in primo piano un fattore istituzionale: la contrattazione collettiva del salario realizzata dai sindacati settore per settore. In seguito ad una politica espansiva (monetaria o fiscale), poiché gli aumenti salariali hanno luogo nel tempo, ovvero alla scadenza del contratto collettivo di ciascun settore. Pertanto, l’incremento di salario per tutta la forza lavoro occupata si completa lentamente, mentre l’aumento dei prezzi di listino delle imprese è immediato. Per semplicità espositiva, analizziamo il caso di un’espansione di politica fiscale (benché esamineremo in modo dettagliato la politica fiscale successivamente, quando 7 includeremo il settore pubblico nell’equilibrio macroeconomico). Supponiamo che un’espansione fiscale (ad esempio, una spesa pubblica in deficit) produca lo spostamento della domanda aggregata (da AD a AD’ ). Figura 1. Offerta aggregata e domanda aggregata Si ricorderà che l’equilibrio congiunto dei mercati dei beni e della moneta IS-LM (grafico a sinistra) ha luogo in base ad un livello di prezzi costante esogenamente determinato. Per potere tenere conto dell’incremento dei prezzi, ovvero del fenomeno dell’inflazione, occorre considerare che la LM (la retta determinata dai punti di equilibrio fra domanda ed offerta di moneta) si determina nel piano ad un’altezza più elevata quanto più alto è il prezzo (LM’, LM’’, etc.). La logica è che quanto più alto è il livello generale dei prezzi tanto minore è il potere d’acquisto delle scorte monetarie dei soggetti e quindi il reddito sull’asse orizzontale. Nell’ipotesi di offerta di moneta data, ci si deve chiedere da dove provenga la moneta necessaria a permettere ai soggetti di realizzare – ad ogni aumento dell’attività economica - le accresciute transazioni di beni (la velocità di circolazione della moneta è costante e legata alle abitudini di pagamento). La risposta sta nel funzionamento del mercato monetario e finanziario. Dopo lo spostamento in senso espansivo della IS (da IS a IS’), l’accresciuto volume di produzione induce le 8 famiglie a smobilizzare titoli dal proprio portafoglio, allo scopo di disporre di un livello di scorte liquide (domanda di moneta) sufficiente a consentire le maggiori transazioni. A questa offerta di vecchi titoli si vanno ad aggiungere le nuove emissioni a copertura della spesa pubblica in deficit. L’eccesso di offerta di titoli si riflette nella riduzione del loro prezzo di mercato e nell’aumento del tasso di interesse. All’aumentare del reddito durante un ciclo espansivo, l’incremento della produzione è vincolato dal più alto tasso di interesse indotto dall’incremento della domanda aggregata AD, che ha l’effetto di “tagliare” le decisioni di investimento. In altre parole, poiché una parte dei progetti di investimento del settore privato hanno ora una redditività attesa inferiore al tasso di interesse, e quindi vengono “spiazzati”, una parte dell’incremento di reddito viene ad essere “tagliato”. Un nuovo equilibrio si realizzerà quindi nella misura determinata dalla pendenza della LM, che dipende dalla derivata della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse, e dalla pendenza della IS, che dipende dalla derivata dell’investimento rispetto al tasso di interesse. Si osservi che l’offerta aggregata AS è –nel breve periodo – inclinata, a causa dell’ipotesi di “vischiosità” dell’aumento del salario determinato dallo scaglionamento delle contrattazioni salariali. Poiché il salario reale (w/p) si riduce (infatti, al denominatore i prezzi salgono immediatamente dopo l’impulso fiscale espansivo, mentre al numeratore i salari aumentano settore per settore, una volta concluso ciascun rinnovo), le imprese trovano conveniente aumentare la produzione. Se il salario fosse aumentato contestualmente ai prezzi, l’offerta aggregata sarebbe stata verticale anche nel breve periodo, dopo l’espansione di politica fiscale il reddito non si sarebbe mosso da Y*. In tal caso, tutto l’aggiustamento sarebbe avvenuto attraverso l’aumento del livello dei prezzi che riduce le scorte liquide reali dei soggetti nella stessa misura in cui sono aumentati i loro redditi monetari. Fintantoché i prezzi aumentano più velocemente dei salari, il salario reale scende al di sotto della produttività del lavoro e le imprese trovano conveniente assumere più lavoratori e produrre di più. Il livello di Y cresce lungo l’offerta aggregata di breve periodo (AS) fino al punto di equilibrio temporaneo nel punto di intersezione con la 9 domanda aggregata (AD’). Nel punto di intersezione fra la nuova funzione di domanda aggregata determinata dall’aumento della spesa pubblica (AD’ ) e l’offerta aggregata di breve periodo (AS) si determina un livello di prezzo più elevato. Come si realizza l’equilibrio finale nel punto di intersezione fra la (AD’ ) e l’offerta aggregata di lungo periodo (AS-LP)? Appena i salari si adeguano tutti verso l’alto, il salario reale aumenta, tornando al livello precedente all’assunzione dei nuovi lavoratori. Pertanto, in presenza di un salario reale che ora eccede la produttività del lavoro (che è andata diminuendo a mano a mano i lavoratori aumentavano), le imprese cominciano a licenziare e la produzione scende per eguagliare la produttività del lavoro al più elevato salario reale. Con l’incremento ulteriore dei prezzi parallelamente alla riduzione dell’occupazione, e la conseguente risalita della produttività del lavoro, viene raggiunto il nuovo equilibrio, caratterizzato da un più alto livello generale dei prezzi, nel punto di incrocio fra la domanda aggregata (AD’ ) e la offerta di lungo periodo AS-LP verticale. Il fatto che l’aggiustamento verso l’alto del salario monetario al crescere della domanda di lavoro sia stato lento, a causa del funzionamento delle negoziazioni contrattuali dei vari settori scaglionate nel tempo, ha fatto sì che l’economia fintantoché la produttività del lavoro (PML) eccedeva il salario reale (w/p) – potesse godere di un periodo di maggiori livelli di occupazione e di produzione. In conclusione, oggi sia in neo-classici che i keynesiani adottano l’ipotesi di aspettative razionali. Tuttavia, secondo la NCE politiche monetarie e politiche fiscali espansive sono inefficaci nell’aumentare occupazione e produzione e producono solo incremento dei prezzi e quindi il rischio di aspettative inflazionistiche al rialzo. Secondo la NKE, invece, ragioni “istituzionali” fanno sì che la salita del salario dopo un’espansione monetaria o fiscale sia più lenta di quella dei prezzi; fintantoché il salario reale w/p risulterà inferiore alla PML, la politiche macroeconomiche espansive sono efficaci nel permettere un incremento dell’occupazione e della produzione. 10 3. La politica fiscale di stabilizzazione macroeconomica L’introduzione del settore pubblico nel modello macroeconomico di breve periodo di un’economia aperta comporta che nell’equazione del reddito nazionale si tenga conto della tassazione e della spesa pubblica. Consideriamo la tassazione (T) una proporzione del reddito (T=τY); il livello della spesa pubblica (G) e delle esportazioni (E) un dato; il consumo una funzione del reddito disponibile (C=cYd) definito per differenza tra il reddito e l’imposizione fiscale (Yd=Y-T); l’investimento una grandezza autonoma (I) e le importazioni (M) una funzione lineare del reddito (M=α1Y). Sostituendo nell’equazione che descrive la condizione di equilibrio: Y=C+I+G+X–M le componenti della domanda aggregata che dipendono dal reddito interno (Y), si ottiene: Y 1 (G I X ) 1 c (1 ) I Questa equazione pone il livello del reddito in funzione delle componenti della spesa autonoma attraverso il moltiplicatore di un’economia aperta, ovvero la frazione al cui denominatore compaiono la propensione al consumo (c), la proporzione della tassazione sul reddito (τ) e la propensione all’importazione (α1). Il moltiplicatore della politica fiscale nei modelli keynesiani è positivo: ad un impulso espansivo di spesa pubblica, consegue un incremento del reddito, in base al valore della frazione che esprime il moltiplicatore. La dimensione dell’incremento del reddito attivato ad esempio da un impulso espansivo della spesa pubblica dipende positivamente dalla propensione al consumo (c) e negativamente da τ e da α1. In particolare, la propensione ad importare (α1) ha un effetto riduttivo sulla moltiplicazione del reddito attivato da un impulso di spesa pubblica. Tale effetto si spiega con l’apertura agli 11 scambi con l’estero che dirotta dalle imprese nazionali alle imprese estere una parte dell’effetto moltiplicativo sulla produzione. Dato il reddito disponibile (Yd), il risparmio privato è il complemento al consumo: S = Y – T - C. Sostituendo il reddito (Y) con il lato destro della condizione di equilibrio e riordinando i termini, scriviamo la condizione di equilibrio tra produzione e reddito in economia aperta e con settore pubblico in modo da evidenziare la relazione tra risparmi al netto degli investimenti nel settore privato (SI), disavanzo del settore pubblico (T-G) e saldo della bilancia commerciale (M-X): (S - I) + (T - G) + (M - X ) = 0 Prendendo le mosse dal settore privato, supponiamo che il termine (S-I) sia in disequilibrio. Un eventuale eccesso del risparmio sugli investimenti (S>I) va a finanziare un deficit pubblico (T<G) e/o un avanzo commerciale (M<X). Nel primo caso, il flusso di risparmio in eccesso va ad acquistare le obbligazioni pubbliche emesse a copertura del deficit di bilancio. Nel secondo caso, un disequilibrio del settore estero ( un eccesso delle esportazioni sulle importazioni) vede un deflusso all’estero dell’eccesso di risparmio – attraverso il sistema bancario e i mercati finanziari internazionali - che va a finanziare la parte di domanda dall’estero delle esportazioni del paese che ecceda il valore delle sue importazioni. Per semplicità, concentriamo l’attenzione sul secondo caso ed ipotizziamo che tutto il debito pubblico sia posseduto dai residenti e che non vi sia un reddito netto da investimenti finanziari all’estero. In altri termini, il risparmio netto del paese nei confronti del “resto del mondo” coincide con il saldo primario delle partite correnti. Esattamente come accade nel caso del settore privato e del settore pubblico, un eventuale disavanzo corrente dei conti primari delle partite correnti richiederà la formazione di avanzi nei periodi futuri per poter restituzione del debito con operatori esteri. In un mondo di mercati globalizzati e in un sistema monetario internazionale incentrato sui cambi flessibili fra le tre principali valute – dollaro USA, euro e yen –il canale dei tassi di cambio è centrale nel determinare il nesso moneta-reddito. Ad 12 esempio, una manovra di restrizione monetaria induce un incremento del tasso di interesse e così causa una preferenza relativa a favore dei depositi denominati in quella valuta; i capitali attratti nel paese provocano l’apprezzamento della valuta, con conseguente possibile perdita di competitività e calo delle esportazioni e del reddito. Definiamo le esportazioni nette: NX = (X-M) e consideriamo il caso in cui le esportazioni nette (NX ) siano positive: X – M = NX > 0. Come si è detto, possiamo interpretare tale eccesso di esportazioni sulle importazioni di un paese come l’esito di un finanziamento del sistema bancario internazionale all’aggregato degli importatori esteri, che consente loro di effettuare pagamenti pari al valore dei beni acquistati dal paese che eccede il ricavato dalle importazioni domandate dal paese. Ricordando che in contabilità nazionale un surplus di bilancio pubblico viene definito risparmio pubblico (T–G), pensiamo l’equazione precedente in termini di una eguaglianza fra investimenti (all’interno ed all’estero) e risparmi (privati e pubblici): I + (X - M) = S + (T – G) che non è altro che l’equilibrio macroeconomico completo (relativo cioè a tutti e tre i settori: privato, pubblico ed estero) sopra descritto: (S - I ) = (G - T) + (X - M) Alle esportazioni nette NX corrispondono le importazioni nette di capitali (investimenti stranieri nel paese meno investimenti del paese all’estero): NKI. Quindi: NX = NKI . Nella seconda metà del XX secolo, l’incremento della spesa pubblica non ha trovato in molte economie avanzate un adeguato corrispettivo nell’incremento delle entrate 13 fiscali; si è reso necessario il ricorso all’indebitamento, con conseguente accumulazione di ingenti stock di debito pubblico. Come sappiamo, nel modello IS-LM (dove nel mercato monetario sono presenti solo moneta e titoli) l’emissione di titoli per il finanziamento della spesa è una domanda di fondi liquidi che va ad aggiungersi a quella proveniente dalle decisioni di investimento delle imprese. Il conseguente eccesso di domanda sull’offerta di fondi liquidi, provocando un innalzamento del tasso di interesse “taglia” le decisioni di investimento (effetto di “spiazzamento”). Se consideriamo portafogli composti da tre attività finanziarie (moneta, titoli ed azioni), sotto l’ipotesi di alta sostituibilità fra titoli e azioni, l’effetto sulle decisioni di investimento non muta: l’aumento del tasso di interesse si trasmette anche ai rendimenti azionari; al più alto rendimento corrisponde la discesa delle quotazioni che riduce la convenienza ad emettere azioni deprimendo l’attività di investimento delle imprese. Nei paesi in cui ha rilievo la propensione a finanziare il consumo nel mercato del credito (prestito al consumo, rateizzazioni, etc.), la discesa della domanda aggregata riguarda anche la componente dei consumi privati. In economia aperta, si può determinare un ulteriore effetto depressivo sulla domanda aggregata: il fenomeno dei “deficit gemelli”, ovvero la formazione di un disavanzo sia nel bilancio pubblico che nella bilancia commerciale. Tali “deficit gemelli” sono spiegati nel modello Mundell-Fleming come l’esito di un elevato tasso di interesse causato dall’eccesso di emissioni pubbliche per il finanziamento del deficit di bilancio. L’aumento del tasso di interesse sui titoli pubblici (ed eventualmente dei tassi di rendimenti azionari) genera un afflusso di capitali dall’estero e il conseguente apprezzamento della valuta che ha di norma un impatto riduttivo sulle esportazioni. Un forte ricorso del settore pubblico all’indebitamento può dunque causare la discesa delle tre componenti della domanda aggregata (consumo, investimento ed esportazioni) e spegnere completamente l’incremento del reddito generato dal moltiplicatore della spesa pubblica. 14 Questa conclusione è tuttavia molto attenuata in un sistema di finanziamento dell’economia imperniata sul credito bancario piuttosto che sul mercato finanziario. Gli aspetti istituzionali riguardanti i nessi fra economia reale e mercati monetari e finanziari sono importanti. Il finanziamento dell’economia attraverso il flussi creditizi implica infatti la centralità del mercato monetario dove si finanziano in prima istanza sia le imprese che lo Stato. Il grado di sostituibilità fra obbligazioni ed azioni tenda ad essere basso, in quanto sono questa volta moneta e obbligazioni a formare un unico aggregato. In presenza di un grado di sostituibilità del debito pubblico maggiore con la moneta che con il capitale azionario, ad una più elevata quota di titoli pubblici in portafoglio dovrà accompagnarsi un corrispondente adeguamento verso l’alto della quota di azioni. Tale aggiuntiva domanda di azioni provoca una salita delle quotazioni di borsa (e la correlata riduzione dei tassi di rendimento azionario) che agisce da stimolo sulle decisioni di investimento delle imprese che si finanziano nel mercato dei capitali. L’espansione della spesa pubblica in deficit causerà un “effetto spiazzamento” di ampiezza inferiore a quello del modello di finanziamento in cui obbligazioni ed azioni formano un unico aggregato. Pertanto, gli aggiuntivi titoli emessi per finanziare un’espansione della spesa pubblica hanno un effetto espansivo sul livello del reddito. 4. "Equivalenza ricardiana” ed effetti non-keynesiani della politica fiscale Una delle conseguenze della fondazione microeconomica della macroeconomia è stata quella di porre il comportamento razionale massimizzante dei soggetti alla base della formazione dell’equilibrio macroeconomico. Ciò rende necessario superare lo schema analitico nel quale è solo il reddito corrente ad influenzare il consumo: il soggetto massimizza il suo benessere attraverso la scelta del paniere di consumo corrispondente alle sue preferenze su un arco temporale pluri-periodale. I piani di consumo dei soggetti vengono decisi in relazione al reddito permanente, che si definisce come il valore medio annuale del flusso di reddito atteso lungo tutto il periodo di vita: in breve, lo stock di ricchezza dell’individuo. Il piano di consumo 15 risultante dalla tangenza del vincolo intertemporale di bilancio costituito dal valore attualizzato dei flussi di reddito futuro atteso con la curva di indifferenza più elevata rappresenta la combinazione di consumo presente e di consumo futuro che rende massima la soddisfazione dell’individuo. Nell’equazione del “moltiplicatore” la propensione al consumo dei soggetti è uno dei parametri che legano un impulso di spesa pubblica alla moltiplicazione del reddito. Come si interrelano allora settore privato e settore pubblico riguardo alla formazione della complessiva domanda di consumo in una prospettiva pluriperiodale? Analizziamo l’approccio alla politica fiscale basato sulla teoria dell’ “equivalenza ricardiana”. Le ipotesi sono le seguenti: i soggetti hanno vita infinita; i mercati dei capitali sono perfetti; la capacità previsionale dei soggetti è perfetta; la tassazione, per non risultare troppo distorsiva, è a somma fissa. Presentiamo ora le equazioni che esprimono il vincolo intertemporale di bilancio del settore privato e del settore pubblico su un arco temporale ridotto per semplicità a due anni (i valori del secondo periodo sono attualizzati al presente). Per il settore privato, tenendo presente che il consumo dipende dal reddito disponibile al netto delle tasse, il vincolo di bilancio intertemporale relativo a due periodi è espresso dall’equazione dove la somma di consumo presente e consumo futuro del consumatore “rappresentativo” eguaglia la somma del reddito disponibile dei due periodi (t=1,2): C1 C2 Y T2 (Y1 T1 ) 2 1 r 1 r Per il settore pubblico, esprimiamo il vincolo nei termini dell’eguaglianza fra la spesa pubblica presente e futura e le entrate fiscali dei due periodi: G1 G2 T T1 2 1 r 1 r 16 Nel caso in cui un incremento di spesa pubblica venga finanziamento con emissione di titoli invece che con le tasse, i soggetti ritengono che una eventuale variazione dello stock di debito pubblico posseduto in portafoglio non rappresenti una effettiva variazione della loro ricchezza. La ragione è semplice. La consapevolezza che lo Stato, per essere in grado di restituire il debito contratto con il settore privato, dovrà aumentare le tasse, li induce a non considerare il valore dei titoli pubblici una aggiunta alla loro dotazione di ricchezza. Troviamo conferma analitica di questa visione sommando i due vincoli di bilancio considerati nelle due equazioni precedenti: C1 C2 Y G2 (Y1 G1 ) 2 1 r 1 r Come si vede, nell’equazione il consumo (valore presente e valore futuro attualizzato) risulta eguagliare la differenza fra reddito e spesa pubblica (valore presente e valore futuro attualizzato). Nell’equazione non compare quindi nessuna delle due forme di copertura della spesa pubblica: né le tasse, nè i titoli. La spiegazione è appunto che per la determinazione dell’equilibrio non conta il modo in cui la spesa pubblica viene finanziata: nel periodo t, la spesa pubblica può essere finanziata con tassazione, oppure, alternativamente, con l’emissione di titoli. In quest’ultimo caso, i soggetti “ricardiani” sono razionali: in seguito ad un aumento di valore (aumento del prezzo o della quantità) dei titoli pubblici detenuti in portafoglio non si sentono più ricchi e perciò non adeguano verso l’alto i piani di consumo. Il motivo è che essi - prevedendo un aumento della tassazione nei periodi futuri, perché il prestito ottenuto dagli acquirenti dei titoli pubblici andrà restituito dallo Stato – razionalmente si aspettano che il loro reddito permanente (calcolato su due periodi) non abbia subito variazioni: nel primo periodo, attraverso la spesa pubblica, lo Stato ha fatto rifluire redditi monetari nelle tasche dei soggetti del settore privato; ma nel 17 secondo periodo lo Stato dovrà aumentare il prelievo fiscale per avere i fondi necessari al pagamento dei titoli pubblici perché giungono a scadenza. Esaminiamo in dettaglio questo ragionamento. Con il primo tipo di finanziamento (tasse), la copertura della spesa avviene in ciascun periodo: T1=0 ; con il secondo tipo di finanziamento (emissione di titoli: B=G), il reddito verrà decurtato domani dalle tasse future: T2 = B(1+r) + G2 . Nei modelli che inglobano la teoria dell’“equivalenza ricardiana” , gli agenti sono dotati di aspettative razionali e sono indifferenti rispetto alla modalità di finanziamento (incremento della tassazione oppure emissione di titoli) di un aumento del deficit pubblico. I piani di consumo non vengono infatti modificati né nel periodo t né nel periodo t+1 (né in tutti i periodi successivi, nel caso in cui estendessimo l’analisi a tutti i redditi percepiti nell’intera vita lavorativa). L’equilibrio del bilancio pubblico comporta che ad un deficit creato in uno o più periodi debba necessariamente corrispondere un successivo incremento della tassazione pari al deficit creatosi nel bilancio (possiamo tralasciare di tenere conto degli interessi, in quanto potranno essere finanziati dalla crescita del Pil dell’economia). Pertanto, per ogni euro in più di deficit pubblico (e perciò di tasse future), un euro in più sarà risparmiato dagli agenti razionali. L’”equivalenza ricardiana” destituisce di valore l’intervento pubblico nell’economia. I livelli del reddito e dell’occupazione, diversamente dalla visione keynesiana, non dipendono dalla capacità del settore pubblico di compensare eventuali deficienze del settore privato. L’invarianza del reddito al variare della spesa pubblica fa sì che non risultino rilevanti né il sostegno di breve periodo alla stabilità macroeconomica svolto dal moltiplicatore della spesa pubblica, né il sostegno alla formazione del reddito svolto nel lungo periodo dalla produzione dei beni pubblici (in primo luogo le infrastrutture e la formazione del capitale umano). Pertanto, nei modelli NCE che adottano l’ipotesi di “equivalenza ricardiana” nell’esaminare il moltiplicatore della politica fiscale vale la medesima “proposizione 18 di inefficacia” che abbiamo già visto a proposito della politica monetaria. Se ne conclude che mentre nella visione neo-keynesiana il moltiplicatore della politica fiscale è positivo ∆Y / ∆G > 0, nella visione neo-classica è invece pari a zero: ∆Y / ∆G = 0. Va tuttavia osservato che l’ipotesi di ’“equivalenza ricardiana” è valida sotto due ipotesi molto restrittive: 1) la condizione di assenza di vincoli di liquidità. Tale assunzione è contraddetta da molte indagini quantitative che mostrano l’esistenza di una quota ampia di soggetti che sono costretti a procrastinare i consumi a causa del basso reddito. Essi tendono ad assumere un comportamento “miope” di fronte ad un taglio delle tasse, oppure alla percezione di trasferimenti attivati dal bilancio pubblico. Invece di attuare una programmazione intertemporale del consumo in base al reddito permanente, i soggetti aumentano la propria domanda cosicché le politiche fiscali di stabilizzazione risultano efficaci nell’accrescere il reddito; 2) il trasferimento intergenerazionale del debito pubblico, ovvero l’idea che i figli sono gravati dal debito acceso dei loro padri, cosicché ogni generazione vede il proprio reddito ridotto dalle tasse future attese. In effetti, a fronte dell’accumularsi di debito pubblico va considerato che la spesa pubblica delle generazioni successive dovrebbe accrescere la dotazione di risorse attraverso gli investimenti del settore pubblico (Easterly e Rebelo, 1994) e l’operare delle istituzioni del welfare, che hanno lo scopo di ridurre i rischi in cui incorrono i soggetti del settore privato (Sen, 1993). All’“equivalenza ricardiana” viene perciò mossa la critica di non essere valida se i soggetti sono vincolati nel consumo a causa del basso reddito. Per realizzare i piani di consumo, non potendo offrire beni in garanzia (collateral) a fronte di un prestito, questi soggetti sono costretti a pagare alti tassi di interesse (se poi le banche seguono una politica di “razionamento” del credito a tasso costante, le loro richieste di prestito saranno certamente respinte) (Stiglitz e Weiss, 1981). Qualora la spesa pubblica non sia finanziata con la tassazione ma a copertura del deficit vengano emessi titoli pubblici, i soggetti con vincoli di liquidità sono avvantaggiati. La 19 ragione è che i tassi di interesse sui titoli pubblici sono inferiori ai tassi sopportati dai privati nel momento in cui accendono un mutuo (di norma, la solvibilità di uno Stato sovrano è ritenuta superiore a quella di un privato). È “come se” il governo “aiutasse” indirettamente i soggetti privati ad ottenere dalle banche un finanziamento allo stesso tasso di interesse che le banche praticano al governo. Ad essere avvantaggiati dal finanziamento in titoli pubblici saranno soprattutto i soggetti a basso reddito, il cui consumo sarà più ampio nel caso di finanziamento in titoli che nel caso di finanziamento mediante la tassazione. Ad esempio, il consumo del disoccupato al netto della spesa per interessi è maggiore nel caso in cui il finanziamento sia costituito dal sussidio di disoccupazione che nel caso di un (peraltro improbabile) prestito bancario. Contrariamente alla tesi dell’”equivalenza ricardiana”, la modalità di finanziamento della spesa pubblica in deficit non è irrilevante ed il moltiplicatore della spesa pubblica presenta un valore positivo. Nell’originaria funzione del consumo introdotta da Keynes, fondata sul reddito corrente, un aumento del tasso di interesse avvantaggia i risparmiatori-prestatori (che incrementeranno il consumo) e penalizza i consumatori-debitori (che ridurranno il consumo a causa di un ammontare di pagamenti per interessi più elevato). Nell’aggregato, si realizza una redistribuzione di reddito a favore dei soggetti a più alto reddito, e quindi a minore propensione al consumo, con conseguente effetto deflazionistico sulla domanda aggregata. Nella prospettiva intertemporale fondata sul reddito atteso nei periodi futuri, l’impatto delle variazioni del tasso di interesse sul consumo è più complesso. L’impatto, ad esempio, di un aumento del tasso di interesse è la risultante di due effetti ambedue di segno incerto: 1) l’effetto reddito, che è diverso nel caso dei creditori (che aumentano il consumo presente e futuro) e dei debitori (a fronte della decurtazione del reddito causata dai più ingenti esborsi per interessi, questi soggetti ridurranno il consumo presente); 2) l’effetto sostituzione che induce il consumatore a ridurre il consumo presente perché è aumentato il costo del credito potrebbe causare una riduzione della domanda nel presente; ma il tasso di interesse rappresenta il prezzo intertemporale del consumo, cosicché la caduta del 20 reddito futuro potrebbe generare un effetto riduttivo sul consumo futuro ancora più rilevante. Pertanto, l’impatto complessivo di un aumento del tasso di interesse sulla spesa di consumo risulta essere incerto. Facciamo ora un esempio recente di moltiplicatore del reddito relativo ad un decremento della spesa pubblica, per effetto di “tagli” nella spesa pubblica. In questi ultimi anni, i paesi dell’Eurozona gravati da elevati rapporti fra debito pubblico e PIL a causa della grave recessione conseguita alla crisi finanziaria hanno dovuto adottare la cosiddetta politica dell’”austerità” sotto la sorveglianza delle autorità internazionali (la “troika” formata da IMF, ECB ed European Commission). In breve, l’ipotesi è che soltanto attraverso una formazione di surplus nel bilancio pubblico da destinare alla restituzione del debito sovrano, in un’ampiezza tale da creare nei mercati finanziari l’aspettativa di un ritorno a livelli meno allarmanti del rapporto debito pubblico / PIL, sia possibile per questi paesi riguadagnare la sostenibilità fiscale. Quest’esempio ci consente di aggiungere una terza ipotesi sul segno del moltiplicatore della politica fiscale. La visione alla base dei “tagli” alla spesa pubblica, come strategia diretta ad accrescere il PIL, è chiamata degli “effetti nonkeynesiani” della politica fiscale. Tale teoria, affermata in alcuni modelli neo-classici, prende le mosse dalla visione dell’ “equivalenza ricardiana” e la porta alle sue estreme conseguenze. Se i soggetti razionali percepiscono i “tagli” come permanenti, non si avrà l’effetto di neutralità della politica fiscale sopra analizzato ( ∆Y / ∆G) = 0, ma un “effetto neo-keynesiano” – di fatto l’effetto opposto a quello affermato da Keynes, e cioè un moltiplicatore di segno negativo: (∆Y / ∆G) < 0. In breve, nella visione neo-classica tradizionale l’aspettativa di reddito disponibile invariato successivamente ad un impulso fiscale espansivo implica assenza di incrementi di domanda e di reddito; nei modelli neo-classici che all’equivalenza ricardiana aggiungono anche l’aspettativa di un taglio permanente e “credibile” della spesa pubblica - il che implica l’aspettativa di un abbassamento duraturo della pressione fiscale, ovvero un incremento del reddito disponibile nei periodi futuri – si ottiene il 21 risultato secondo cui a una minore spesa pubblica conseguirebbe un incremento del reddito. La percezione di una “credibile” riduzione duratura della spesa pubblica avrebbe luogo in particolare quando la spesa pubblica è di tipo strutturale e la sua riduzione è sostanzialmente irreversibile (ad esempio, una riforma delle pensioni viene di solito percepita come un “contratto sociale” di lunga durata). In tal caso, i soggetti razionali “ricardiani” modificheranno le loro previsioni sul reddito permanente adeguandolo verso l’alto. Il reddito permanente più elevato indurrà i soggetti ad aumentare il proprio consumo. L’effetto sul reddito di una variazione della fiscal stance in senso restrittivo sarebbe dunque opposto rispetto alla visione keynesiana. Il reddito non aumenta in seguito ad un’espansione della spesa pubblica. Al contrario, una restrizione fiscale creerebbe l’aspettativa di un ridimensionamento del settore pubblico, e quindi di un sentiero declinante della tassazione futura con conseguente incremento del reddito disponibile. Come si è detto, nella derivata ∆ Y / ∆ G , al segno positivo assunto da Keynes, la teoria dei cosiddetti “effetti nonkeynesiani” sostituisce il segno negativo. Il reddito aumenterebbe quando si taglia la spesa pubblica, non quando la si aumenta. È robusta questa tesi scaturita dall’ipotesi dell’“equivalenza ricardiana” di fronte alla suddetta critica dell’ ipotesi stessa? In altre parole, se aumentiamo il grado di realismo del complesso di ipotesi che fondano l”equivalenza ricardiana” - ad esempio, supponendo che un certo numero di soggetti siano vincolati nel consumo a causa delle condizioni imperfette del mercato del credito sopra dette - si ottiene ancora il risultato non-keynesiano di un aumento della domanda privata come conseguenza di una contrazione della spesa pubblica? Sembra che la risposta debba essere negativa. Nei modelli che ipotizzano la presenza di una certa quota di soggetti non-ricardiani all’interno della popolazione, ad una contrazione fiscale non conseguono di norma risultati non-keynesiani. Si può dimostrare che quanto più alta è la percentuale di soggetti non-ricardiani, quanto più basso il tasso di sconto sul consumo futuro (i consumatori sono poco impazienti) e 22 quanto più bassa nella percezione dei soggetti è la persistenza della spesa pubblica da un periodo all’altro, tanto meno è probabile che si riscontri un effetto non-keynesiano della politica di spesa pubblica (Creel et al., 2005). La continua caduta del reddito e dell’occupazione registrata in questi ultimi anni nelle economie che sono state costrette a severi piani di restrizione fiscale (attuati soprattutto attraverso tagli della spesa pubblica) sembra confermare che la debolezza della visione teorica degli “effetti non-keynesiani”. 5. Il vincolo intertemporale del bilancio pubblico Approfondiamo ora l’analisi del vincolo del bilancio pubblico, considerando – oltre alla tassazione – anche il finanziamento in moneta e titoli. Nell’equazione che segue, tale vincolo viene espresso mediante l’eguaglianza fra disavanzo e suo finanziamento: (1) G T iB dB / dt dM / dt dove G è la spesa pubblica in beni e servizi, T è il gettito fiscale, i è il tasso di interesse nominale sul debito pubblico, B è il debito pubblico, dB/dt è la derivata prima rispetto al tempo dello stock di titoli pubblici e dM/dt è la derivata della quantità di moneta rispetto al tempo, ed esprime la quota di deficit pubblico che viene finanziata con l’espansione di base monetaria attraverso l’acquisto di titoli pubblici da parte della banca centrale. L’espansione della spesa pubblica, non accompagnata da un proporzionale incremento della tassazione, ha determinato in molte economie avanzate l’accumulazione di uno stock di debito pubblico. Pertanto, esprimiamo il vincolo del bilancio pubblico nel periodo t con l’equazione: (2) Bt 1 it Bt 1 (Tt G t ) M t M t 1 23 Essa indica che la variazione del debito pubblico (nel periodo t rispetto al periodo t-1) sarà positiva se lo stock di debito ereditato dal periodo precedente - comprensivo della spesa per gli interessi su tale ammontare di debito - non sarà eguagliato dalla somma algebrica fra la differenza fra spesa pubblica ed entrate fiscali e la variazione della quantità di moneta. Eliminando la notazione di tempo ed annullando il finanziamento in moneta (abolito nel corso degli ultimi decenni nelle economie avanzate), risulta che la variazione del debito sarà positiva o negativa a seconda che la somma algebrica fra saldo primario (G – T) e spesa per interessi (iB) sia positiva o negativa: (3) B G T iB Per normalizzare le poste della finanza pubblica fra paesi di dimensioni diverse, e quindi di diversa ampiezza assoluta del PIL, si suole considerare deficit e debito pubblico come percentuali del PIL. Deriviamo totalmente B/Y, ottenendo: (4) B 1 B d dB 2 dY Y Y Y il che equivale ad esprimere il lato destro della (2), una volta annullato il finanziamento in moneta, in termini di differenze: (5) B B Y B Y Y Y Y Ponendo b=B/Y e g=Y/Y, si ottiene: 24 (6) b B bg Y Sostituendo la (3) nella (6) si ottiene: (7) b G iB T bg Y Ponendo =G/Y e =T/Y, si ricava: (8) b (i g )b Questa equazione evidenzia la questione fondamentale che sta alla base del concetto di sostenibilità del debito pubblico, ovvero il cosiddetto “effetto palla di neve” (snowball effect). Sottraendo il tasso di inflazione () sia dal tasso di interesse nominale (i) che dal tasso di crescita del reddito nominale (g) si ottengono, rispettivamente, (r) ed (x). Un eccesso del tasso di interesse reale (r) rispetto al tasso di crescita reale (x), benché esprima la condizione di efficienza dinamica del sistema economico (in breve, la crescita economica è garantita, in quanto l’attività di investimento è sostenuta da un tasso di rendimento del capitale che è più alto del tasso a cui cresce l’economia), mette a rischio la sostenibilità del debito pubblico. L’autorità fiscale è costretta a ricorrere a nuove emissioni di titoli, aggravando il problema del debito pubblico. Intuitivamente, al dato valore di b l’ammontare delle risorse necessarie a finanziare la spesa annua per interessi risulta essere di ampiezza maggiore rispetto alle risorse aggiuntive che si rendono disponibili nel periodo. Se infatti il tasso di interesse eccede il tasso di crescita dell’economia, il rapporto debito pubblico / PIL è destinato a crescere, perché le risorse aggiuntive che vengono a formarsi in ogni anno non generano entrate fiscali in misura sufficiente a finanziare i 25 deficit primario (D1) e secondario (D2), è inevitabile procedere a nuove emissioni di titoli pubblici. La credibilità di un programma di riduzione del debito pubblico dipende quindi molto dalla capacità di crescere dell’economia, in modo che il governo non debba ricorrere al mercato finanziario e cioè all’emissione di nuovi titoli per coprire i deficit primario (D1) e secondario (D2). Il cosiddetto Ponzi Game rappresenta il caso estremo di insostenibilità prospettica di una posizione debitoria. Ponzi è il nome del banchiere che, nella Boston dei primi anni Venti del secolo scorso, inventò uno schema di investimento finanziario ad alto rischio: gli interessi sulle somme prestate venivano pagati con le somme ricevute dai nuovi investitori. Ponzi trascinò con sé in una rovinosa bancarotta migliaia di risparmiatori americani. Molti suoi emuli hanno fatto lo stesso in Europa, anche in tempi recenti (si pensi alle crisi bancarie, come la “corsa agli sportelli” della Northern Bank, al fallimento della banca franco-belga Dexia, al virtuale fallimento della Bankia, salvata dal governo spagnolo, e agli scandali finanziari causati dalla City nel Regno Unito, e da imprese produttive come la Parmalat e la Cirio in Italia). Al pari dei soggetti del settore privati, neppure i governi sono immuni dalla tentazione di volere condurre un Ponzi Game. Esempi recenti sono l’Argentina e la Grecia. Il governo argentino ha fatto ricorso nel 2001 al ripudio del proprio debito pubblico, una significativa quota del quale era detenuto da risparmiatori stranieri, dando poi vita ad una lunga trattativa che ha condotto ad una restituzione del prestito ai creditori (banche, fondi pensione, risparmiatori, etc.) pari a circa il 30% del valore nominale. Il caso della Grecia è un po’ diverso. Il governo greco nella prima metà ha occultato molte poste di spesa pubblica, comunicando dati inesatti di bilancio pubblico all’agenzia ufficiale di statistica della Commissione Europea. Quando è scoppiata la crisi finanziaria, ad ancora più quando la conseguente recessione ha prosciugato il danaro nelle casse dello stato, la Grecia ha dovuto dare conto dei dati effettivi di bilancio per ricevere gli aiuti dell’EFSF (European Financial Stability Fund), il fondo salva-stati dell’Eurozona. L’evidente impossibilità che la debole economia del paese potesse 26 generare in futuro surplus di bilancio pubblico tali da riassorbire l’ingentissimo debito pubblico accumulato ha indotto la Commissione Europea ad imporre alla Grecia un accordo nel quale l’erogazione di fondi è stata subordinata a drastiche riforme (a cominciare dal ridimensionamento del settore pubblico ed a un taglio medio del 30% agli stipendi pubblici)e ad un hair-cut, ovvero un taglio del debito pubblico (con parziale recupero del danaro investito nei titoli greci garantito solo ai prestatori privati). Considerando la gravità della crisi economica, con tassi di crescita del PIL ancora negativi, è probabile che la Grecia non sia in grado di annullare il notevole ammontare di debito pubblico ancora in essere. Nel marzo 1933, nel corso della Grande Depressione che seguì il crollo di Wall Street dell’ottobre 1929, il presidente degli Stati Uniti F. D. Roosevelt presentò una "Legge bancaria d'emergenza", che venne subito approvata dal Congresso. Essa rendeva possibile anche delle ristrutturazioni fallimentari con la cancellazione delle esposizioni speculative delle banche. Anzitutto fu creata e applicata la legge GlassSteagall che separava le banche commerciali da quelle di investimento con il divieto di utilizzo dei risparmi dei cittadini per operazioni fatte nell'interesse delle banche. Fu inoltre creata la Federal Deposits Insurance Corporation, a cui oggi l'Europa vorrebbe ispirarsi, che dava la garanzia dello Stato ai risparmi delle famiglie e dei privati. Venne riorganizzata la Reconstruction Finance Corporation, istituzione statale fino ad allora utilizzata per il salvataggio delle banche decotte, e trasformata in una specie di fondo di sviluppo per l'emissione a lungo termine di crediti per la "ripresa economica", per gli investimenti in infrastrutture e per la creazione di posti di lavoro. Purtroppo, poco è stato fatto – negli Stati Uniti ed in Europa – per rafforzare la regolamentazione dell’attività delle banche e elle Borse, per riformare a legislazione sugli istituti finanziari che hanno dato origine alla crisi e per combattere l’attuale recessione. L’equazione contiene anche altri due aspetti del problema della sostenibilità del debito pubblico. Il primo è che una eventuale differenza positiva fra tasso di interesse e tasso di crescita è tanto più grave quanto elevato è il valore di b (con un rapporto 27 pari al 100%, un punto di eccesso del tasso di interesse si scarica in un punto in più di debito pubblico in rapporto al PIL). Il secondo è il seguente. Definendo il debito pubblico come: (9) bt - bt-1 = ( it – gt) bt-1 + D1 affinché lo stock di debito rispetto al PIL sia almeno stabilizzato – e cioè: (bt - bt-1 ) = 0 - è necessario che il lato destro dell’equazione sia pari a zero. Ovvero che, nel caso di valore positivo del primo termine a causa di un eccesso del tasso di interesse sul tasso di crescita, il surplus primario strutturale (il saldo di bilancio al netto delle variazione di breve periodo indotte dalle fasi cicliche di espansione e di riduzione del PIL) sia tale da generare nel secondo termine il valore negativo di ampiezza sufficiente a validare il segno di eguaglianza con il lato destro. Tornando alle equazioni precedenti da 1 a 8: Pertanto, la sostenibilità del debito pubblico dipenda sia dal’evoluzione del PIL, sia dall’accumulazione di debito pubblico avvenuta in passato, sia dall’andamento dei deficit primario e secondario. La Tabella qui sotto disaggrega le diverse fonti di alimentazione del debito pubblico nei paesi dell’Eurozona a 12 paesi (prima cioè dell’ingresso di Malta, Cipro, Slovenia, Slovacchia, Estonia e Lettonia). Prendiamo l’esempio dell’Italia: dal 2002 al 2007 dalla tabella risulta una variazione in aumento del rapporto debito pubblico /PIL (-1,6%). Tale valore risulta dalla somma algebrica fra l’apporto riduttivo sul debito pubblico (alla scadenza, è possibile ripagare l’importo dei titoli di debito pubblico, senza doverli nuovamente emetterli) determinato dalle aggiuntive entrate fiscali generate dalla crescita del PIL (1,4%) e da altre voci (1,8%) da un lato, ed i deficit primario (- 0,9%, ovvero entrate fiscali inferiori alla spesa pubblica) e secondario (il valore della spesa per interessi pari al 4%) dall’altro. Poiché l’apporto riduttivo sul debito pubblico (3,2%) è inferiore alla 28 spesa per interessi (4%), fra 2002 e il 2007 si è determinato un incremento del rapporto debito pubblico /PIL pari a -1,6%. Possiamo anche aggiungere che in Europa, negli anni ’70 e ’80, oltre alle due suddette fonti di incremento del rapporto debito pubblico/PIL (un aumento del deficit primario ed un eccesso del tasso di interesse nominale rispetto al tasso di crescita del reddito nominale), anche l’alta inflazione ha giocato un ruolo nell’andamento di deficit e debito pubblico. Considerando che il tasso di crescita (g) consta di una componente reale (x) e di una componente monetaria (): g=x+ e tenendo conto dell’equazione di Fisher: r=i-e, poniamo eguale a zero il tasso di crescita dell’economia (x), in modo da isolare l’impatto dell’inflazione sulla dinamica del debito pubblico. Dall’equazione (9) si ottiene il vincolo del bilancio pubblico espresso in termini reali: (10) b b r e 29 L’equazione (10) esplicita questa terza fonte di incremento del rapporto debito pubblico / PIL: e>. Contrariamente all’ipotesi di aspettative razionali, il tasso di inflazione che effettivamente si realizza ex post può discostarsi per difetto dal tasso atteso. Quando le aspettative di inflazione non si realizzano perché il tasso di inflazione ex post risulta superiore all’inflazione attesa, la tassa da inflazione (una forma di signoraggio) riduce il valore reale del debito pubblico; ma se le aspettative di inflazione non si realizzano perché il tasso di inflazione ex post risulta inferiore all’inflazione attesa, il governo ha aumentato il tasso di interesse nominale in una misura superiore all’incremento da riconoscere ai possessori del debito pubblico. Di conseguenza, le emissioni di nuovi titoli a copertura della spesa per interessi sono in eccesso rispetto all’effettivo bisogno, provocando un incremento non dovuto dello stock di debito pubblico. Vediamo ora come si misura la sostenibilità di lungo periodo del debito pubblico. In base alle equazioni (9) e (10) formuliamo ora il vincolo intertemporale del bilancio pubblico (VIBP) in termini reali: (11) b t 1 r b t 1 t t Risolvendo per bt-1 ed iterando per i periodi successivi, dopo k iterazioni si ottiene la seguente espressione del VIBP: k (12) bt i 1 r v t i 1 r k btk i 0 dove alla differenza fra entrate ed uscite fiscali (al netto della spesa per interessi) è sostituito il simbolo del saldo di bilancio primario rispetto al PIL v (se maggiore di 30 zero, il saldo si definisce surplus). La spia del problema della sostenibilità risiede nella presenza del termine b nel secondo termine del lato destro dell’equazione: nulla garantisce che non possa aumentare. L’equazione non vincola infatti b per ogni valore del programmato surplus v nel primo termine. Il soddisfacimento del vincolo intertemporale del bilancio pubblico è rispettato se e soltanto se – oltre gli importi della serie futura dei surplus di bilancio primario t i t i t i che compaiono al primo termine sono opportunamente commisurati ai valori dei tassi di interesse e di crescita - vale anche la “condizione di trasversalità”, che esclude per ipotesi ogni eventuale incremento di b causato dall’ eccedenza del tasso di interesse sul tasso di crescita. In breve, non è possibile programmare l’ampiezza dei surplus in modo tale da finanziare anche il deficit aggiuntivo provocato da tale eventuale eccedenza. Tale condizione consiste nell’azzeramento del valore del secondo termine sul lato destro della (12) all’avvicinarsi del tempo all’infinito ( k ): (13) lim 1 r k k bt k 0 Quando il debito pubblico in rapporto al PIL aumenta nei periodi t+k ad un tasso inferiore al fattore di sconto 1+r la “condizione di trasversalità” è soddisfatta. Si noti che l’analisi intertemporale del vincolo del bilancio pubblico presuppone la validità dell’“equivalenza ricardiana”: soggetti ricardiani che “internalizzano” il valore presente del vincolo di bilancio ed il soddisfacimento della condizione di trasversalità. Dopo un impulso di politica fiscale, la mancata modifica dei piani di consumo fa sì che il moltiplicatore della spesa pubblica sia pari a zero. Riscriviamo la (12) con il segno di disuguaglianza. Ciò riflette l’esistenza di due diverse possibili strategie a disposizione dell’autorità fiscale nel perseguimento dell’obiettivo della decumulazione del debito pubblico: 31 k i k bt 1 r vt i 1 r bt k (13’) i 0 Assumiamo nella (13) che il secondo membro sul lato destro sia pari a zero, cosicché la “condizione di trasversalità” sia rispettata. Poniamoci la seguente domanda: il valore attualizzato al presente dei surplus futuri in rapporto al PIL che compare al primo termine deve essere di ampiezza tale da ripagare completamente il debito pubblico in essere al tempo t? In altre parole, l’equazione (4.19) deve essere necessariamente soddisfatta con il segno di uguaglianza, oppure è ammissibile anche il segno di disuguaglianza? Distinguiamo due posizioni teoriche: 1) nella visione della New Clasical Economics (NCE) - soprattutto nella versione Real Business Cycle dove le tasse sono sempre distorsive e la gran parte della spesa pubblica è considerata un “male pubblico” - l’obiettivo deve essere il completo “ritiro” del debito. Deve quindi valere il segno di eguaglianza a zero: bt 0 . In altri termini, il governo deve programmare una serie di surplus futuri tale da produrre l’azzeramento del debito pubblico; 2) nella visione della New Keynesian Economics (NKE), invece, un valore positivo - ma non troppo elevato - del rapporto debito pubblico / PIL non è di per sé una minaccia per l’equilibrio macroeconomico. L’intervento pubblico si giustifica sia in base al contributo della spesa pubblica alla stabilizzazione di breve periodo del reddito dopo uno shock negativo, sia per le politiche pubbliche dirette a sostenere la crescita nel lungo periodo. Infatti, quanto maggiore è la qualità dell’intervento pubblico nell’economia, tanto maggiore il contributo che la spesa pubblica dà alla TFP, alla crescita del capitale umano attraverso il sistema educativo, alla sostenibilità del sistema pensionistico pubblico, date le condizioni demografiche, e della sanità pubblica. 32 Pertanto, al pari di quanto vale nel caso delle imprese private, il bilancio del settore pubblico con il settore creditizio e finanziario può presentare un saldo negativo, ma la questione della solvibilità non può essere elusa. Benché sia difficile quantificare in un “numero magico” l’obiettivo di abbattimento del debito pubblico, un valore-limite per la consistenza dello stock di debito pubblico (b*) è indispensabile. Da tale valore discende infatti il rating assegnato al paese emittente dalle agenzie internazionali di valutazione. Nell’attuale contesto di mercati finanziari globalizzati, la valutazione delle attività finanziarie emesse dai governi dei paesi ad alto debito pubblico – e quindi il “premio per il rischio” da cui dipende il tasso di interesse da riconoscere ai risparmiatori ed operatori finanziari che le detengono in portafoglio - sono legati alla credibilità dei piani di decumulazione. In definitiva, la visione NKE propone la riduzione del debito pubblico fino a quel valore predefinito, che è considerato – nelle date condizioni dell’equilibrio macroeconomico del paese - il massimo tollerabile stock di debito pubblico. Al pari di quanto vale nel caso delle imprese private, il bilancio del settore pubblico con il settore creditizio e finanziario può presentare un saldo negativo, ma la questione della solvibilità del governo non può essere elusa. Benché sia difficile quantificare in un “numero magico” l’obiettivo di abbattimento del debito pubblico, un valore-limite per la consistenza dello stock di debito pubblico (b*) è indispensabile. Da tale valore discende infatti il rating assegnato al paese emittente dalle agenzie internazionali di valutazione. Nell’attuale contesto di mercati finanziari globalizzati, la valutazione delle attività finanziarie emesse dai governi dei paesi ad alto debito pubblico – e quindi il “premio per il rischio” da cui dipende il tasso di interesse da riconoscere ai risparmiatori che le detengono in portafoglio - sono legati alla credibilità dei piani di decumulazione. In definitiva, la visione NKE propone la riduzione del debito pubblico fino a quel valore predefinito, che è considerato – nelle date condizioni dell’equilibrio macroeconomico del paese - il massimo tollerabile stock di debito pubblico: bt b * . 33 6. Dominanza monetaria Ipotizzando una struttura del gioco di tipo sequenziale, i pay-off in Figura 1 riflettono l’assegnazione alla banca centrale del ruolo di Stackelberg leader nell’interazione strategica con il governo al fine di conseguire l’obiettivo prioritario dell’inflazione “zero”. Il pay-off massimo per l’autorità monetaria si realizza con il coordinamento di entrambe le autorità nella strategia restrittiva. Il governo ha invece l’ordine di preferenza opposto: il livello di reddito è anteposto ad un obiettivo di inflazione ed il pay-off massimo è quindi associato al coordinamento di entrambe le autorità nella strategia espansiva. La soluzione del gioco fra autorità monetarie e fiscali viene presentata da questo approccio mediante gli equilibri di Nash del Chicken Game (CG) in Figura 1. I possibili equilibri di Nash sono due: l’equilibrio di “dominanza monetaria” - la comune adozione della strategia di restrizione, dove è massimo il payoff delle autorità monetarie – e l’equilibrio di “dominanza fiscale” - la comune adozione della strategia di espansione, dove è massimo il pay-off delle autorità fiscali. Dalla matrice dei pay-off risulta essere Pareto-ottimo l’equilibrio denominato di “dominanza monetaria” (MD): le autorità monetarie fissano la strategia in grado di assicurare la stabilità monetaria ed il governo assume un comportamento restrittivo, conforme all’obiettivo prioritario prescelto dalla banca centrale. Il motivo risiede nell’assunto secondo il quale il coordinamento fra le due autorità su politiche di segno espansivo fornisce un pay-off sociale inferiore al coordinamento su politiche di senso restrittivo. Vediamo, in Figura 1, come viene concepito il gioco. Qualora il governo fosse orientato a perseguire una manovra espansiva, nonostante la strategia di “restrizione” annunciata dall’autorità monetaria, il gioco rischierebbe di concludersi con l’esito peggiore per ambedue le autorità: la coppia di pay-off (–1, -1) corrispondente all’espansione fiscale e alla restrizione monetaria. Nell’agire da Stackelberg leader, la banca centrale evita di essere indotta a adottare, dopo un’espansione fiscale, la strategia “espansione” (il basso pay-off rispecchia il 34 fallimento dell’obiettivo prioritario della stabilità monetaria). La banca centrale è in grado di imporre la convergenza del governo sul coordinamento di “restrizione” a condizione che abbia una reputazione anti-inflazionistica tale da rendere credibile l’impegno annunciato di non deflettere dalla scelta della strategia “restrizione”. Figura 1. Chicken Game tra politica monetaria e politica fiscale POLITICA FISCALE Restrizione Espansione 4,2 -1 , -1 0,0 1, 3 Restrizione POLITICA MONETARIA Espansione Nel perseguire con coerenza un orientamento rigidamente restrittivo, l’autorità monetaria riesce a costringere il governo a condividere la decisione sulla monetary stance e perciò ad imprimere un indirizzo restrittivo alla politica fiscale. In questo approccio la comune strategia restrittiva delle due autorità configura l’equilibrio di Nash di “dominanza monetaria”, che - per i valori assegnati ai pay-off - è anche la soluzione più vantaggiosa per la società (la somma dei pay-off è massima). Quando le autorità monetarie perseguono rigorosamente una strategia antiinflazionistica la politica monetaria è definita “attiva”. Il comportamento del governo deve rimanere “passivo” rispetto alla strategia di politica monetaria della banca centrale e seguire una fiscal stance coerente con il vincolo intertemporale del bilancio pubblico (VIBP), anche definita Regime Ricardiano (RR). La subalternità del governo all’autorità monetaria trova legittimazione nella teoria dell’“equivalenza ricardiana”. Con soggetti ricardiani, gli interventi fiscali di stabilizzazione non hanno efficacia sull’equilibrio macroeconomico. Nell’inglobare la proposizione di “inefficacia della politica fiscale”, l’equilibrio Pareto-ottimo di dominanza monetaria implica la validità della teoria dell’equivalenza ricardiana. 35 7. Dominanza fiscale Le cose cambiano se si assume che sia invalida l’ipotesi di “equivalenza ricardiana”. Ad esempio, perché la razionalità limitata degli agenti impedisce il formarsi di aspettative razionali; oppure, perché la realizzazione dei loro programmi di consumo è soggetta ad un vincolo di liquidità. Nel cosiddetto “Regime Non-Ricardiano” (RNR), le politiche fiscali di stabilizzazione possono essere efficaci nell’aumentare il livello di occupazione e di reddito. Pertanto, nel gioco fra le due autorità, il governo assume il ruolo di Stackelberg leader e la politica fiscale viene definita “attiva” (Leeper, 1991). Una parte delle scorte liquide aggiuntive che la formazione di un deficit pubblico rende disponibili per gli agenti viene destinata al consumo e si mette in moto un processo di moltiplicazione del reddito. Gli agenti non prendendo in considerazione l’eventualità di tasse future considerano i titoli pubblici emessi a fronte della spesa pubblica un’aggiunta alla propria ricchezza netta; di conseguenza anche l’“effetto ricchezza” contribuisce ad aumentare le decisioni di consumo. Abbiamo visto che nell’approccio della “nuova sintesi neoclassica” la matrice dei pay-off è costruita in modo che si realizzi l’equilibrio Pareto-ottimo di “dominanza monetaria”. Quale equilibrio si raggiunge nel caso di “dominanza fiscale”? In effetti, il quadro teorico si presenta meno chiaro che nel caso di “dominanza monetaria”. Nell’accettare la visione monetarista secondo la quale la determinazione del livello dei prezzi è di competenza esclusiva della politica monetaria, l’approccio della “nuova sintesi neoclassica” interpreta il VIBP come un’identità (Buiter, 2002). Essa afferma che il governo, al pari delle famiglie e delle imprese, è obbligato a soddisfare il vincolo per qualunque livello dei prezzi e dei tassi di interesse futuri. Di fronte ad ogni possibile causa di peggioramento delle finanze pubbliche, e quindi di un eventuale mancato rispetto del VIBP, il governo è obbligato a provvedere, programmando più elevate entrate fiscali nei periodi futuri. Se non lo fa, oppure se la strategia annunciata non è credibile, gli operatori finanziari reagiranno imponendo nei mercati un incremento del tasso di interesse, cosicché ai possessori di titoli pubblici 36 verrà riconosciuto un “premio per il rischio” di default del governo. Quale che sia la modalità, quindi, il VIBP è soddisfatto come identità. La revisione dei prezzi e dei tassi di rendimento che consegue a ciascuna emissione di titoli del debito pubblico trova però un limite nella credibilità del governo agli occhi degli operatori finanziari. Nel Chicken Game, in presenza di una banca centrale che tiene fede all’impegno a giocare “restrizione”, data l’ipotesi di RR, una fiscal stance espansiva non può che condurre all’esito peggiore. Nella visione monetarista, l’incapacità delle politiche fiscali keynesiane di incidere sul livello di attività economica implica che la spesa pubblica finanziata con emissione di titoli finirà nel lungo periodo per costringere la banca centrale ad innescare un processo inflazionistico. Due economisti statunitensi, Thomas Sargent e Neil Wallace (1975), hanno elaborato un modello di “unpleasant arithmetics” dove si dimostra che l’accumulazione di debito pubblico causata dalle politiche fiscali di stabilizzazione è destinata ad imbattersi in un “limite massimo”, in ultima analisi riconducibile alla solvibilità fiscale del governo. Nel processo di ottimizzazione dei propri portafogli, infatti, i risparmiatori finiscono per non aumentare al di sopra di una soglia massima la quota di ricchezza finanziaria in titoli pubblici. L’autorità monetaria è quindi costretta ad intervenire per soddisfare il VIBP attraverso il “signoraggio”. La politica che prende il nome di “signoraggio” intende evocare la potestà del signore medievale si attribuiva di mutare a proprio piacimento il valore della moneta, ad esempio modificando il contenuto aureo della moneta-merce. Ai nostri giorni, la principale fonte di signoraggio consiste nell’incremento del tasso di inflazione che consegue all’immissione di moneta nei mercati primario e secondario per acquistare titoli. 8. Il modello IS – LM - BP Completiamo l’analisi dell’equilibrio macroeconomico di un’economia analizzando l’equazione che esprime il bilancio del settore estero. 37 Consideriamo un’economia aperta agli scambi con l’estero utilizzando per semplicità il modello IS-LM. L’equilibrio macroeconomico di un’economia aperta è descritto dalle relazioni di equilibrio del mercato finanziario (LM), del mercato del bene prodotto (IS) e della bilancia dei pagamenti (BP). La BP consiste nella somma fra conto corrente (CC) e conto capitale (CK). Il conto corrente riguarda transazioni di conto corrente in beni e servizi. Esse vengono contabilizzate nella BP una volta come credito e una volta come debito. Infatti, il soggetto che riceva da una società degli Stati Uniti un assegno per una esportazione in quel paese può depositarlo presso una banca USA. Pertanto, nella BP degli Stati Uniti comparirà a credito il deposito bancario ed a debito l’esborso della società. Naturalmente, un paese che presenti un indebitamento netto dovrà fare fronte alla restituzione del proprio debito con l’estero. Possiamo quindi considerare il saldo di conto corrente come commercio intertemporale, una sorta di scambio di consumo nel tempo. Il conto capitale consiste nei trasferimenti all’estero di capitali (investimenti in attività finanziarie o in attività produttive) più il disavanzo nel conto corrente, che come si è appena detto costituisce un debito da ripagare. Per compensare in tutto o in parte un deficit che compaia nella propria situazione contabile, un paese può ottenere prestiti dall’estero o vendere attività ad operatori esteri. Si definisce conto finanziario la somma algebrica di conto corrente e conto capitale da un lato, e il saldo fra prestiti dall’estero e vendita di attività all’estero dall’altro. La bilancia dei pagamenti è in equilibrio quando primo e secondo termine sono in pareggio, sicché le riserve internazionali rimangono invariate. Un saldo di conto corrente negativo può essere virtuoso per il paese nel caso in cui le risorse prese a prestito diano un buon tasso di rendimento una volta investite all’interno del paese. Pertanto, al di sotto di un certo livello di deficit di conto corrente, e ad esclusione dei paesi che dipendono strutturalmente dai prestiti esteri (i paesi poveri), non necessariamente un paese deve portare rapidamente in pareggio il saldo di conto corrente. 38 Le importazioni dipendono positivamente sia dalla domanda aggregata interna (Y) che dal tasso di cambio reale. Poiché le esportazioni di un paese compaiono come importazioni da parte del resto del mondo, le esportazioni EX EX(YW ,) dipendono positivamente dalla domanda aggregata estera (YW) e negativamente dal tasso di cambio reale (ε) . Le esportazioni nette ( NX EX IM ) sono positive quando la differenza fra la produzione (Y) e la spesa interna (C+I+G) è positiva: NX=Y-(C+I+G). Escludendo per semplicità la spesa pubblica (G), scriviamo la funzione di importazione IM IM(Y,) esportazione esplicitamente come: IM 1Y 2 EX EX(YW ,) analogamente come: e la funzione di EX 3Y W 4 . Sostituendo le funzioni di importazione ed esportazione nella condizione d’equilibrio del mercato dei beni (Y=C+I+EX-IM), insieme alle funzioni di consumo (C=cY) e di investimento (I=-zi) nelle quali per semplicità si trascurano le componenti autonome, si ottiene l’espressione: (3.1.) Y cY zi3YW 4 1Y 2 da cui si ricava la funzione IS: (3.2) i 1 c 1 Y z 2 z 4 3 Y z W Il segno negativo con cui nella (3.2) compare il coefficiente del reddito (Y) indica la relazione inversa della domanda aggregata con il tasso di interesse, rappresentata graficamente dall’andamento discendente della IS nel piano (Y, i), dove la parte rimanente dell’espressione individua la posizione dell’intercetta. La variazione di uno o più degli elementi del coefficiente del reddito ne fa mutare l’inclinazione, mentre una variazione di qualcuno dei restanti coefficienti, modificando il valore dell’intercetta, sposta la IS nel piano parallelamente a sé stessa. 39 Dato un certo tasso di cambio reale, un incremento della propensione al consumo (c) o una riduzione della propensione all’importazione (α1) determinano una maggiore domanda di moneta transattiva. Con offerta di moneta data, esattamente come accade nel caso di economia chiusa, ne consegue la discesa del prezzo dei titoli e l’incremento del tasso di interesse. La conseguente riduzione dell’investimento compensa, nella condizione di equilibrio nel mercato dei beni, l’incremento del consumo o la diminuzione delle importazioni. Il segno negativo con cui nella (3.2) compare il coefficiente del tasso di cambio reale ne indica la relazione inversa con il tasso di interesse. Un deprezzamento reale determina uno spostamento verso l’alto della IS: a parità di reddito, ciò comporta un aumento del tasso di interesse. La diminuzione del tasso di cambio reale induce infatti un aumento delle esportazioni nette. A parità di prodotto (Y) si genera un eccesso della domanda aggregata sull’offerta aggregata Y<C+I+NX. Il ristabilimento dell’equilibrio richiede perciò, a parità di Y, una riduzione degli investimenti e quindi un aumento del tasso di interesse. Uno spostamento verso il basso della funzione IS è invece causato da un apprezzamento del tasso di cambio reale e da un decremento della domanda mondiale. La bilancia dei pagamenti (BP) registra: 1) le transazioni che riguardano i beni esportati (EX) ed importati (IM) (per semplicità, tralasciamo i servizi, i noli, le rimesse degli emigrati); 2) gli afflussi (AFA) e i deflussi (AFD) di capitali; 3) le operazioni in valuta straniera svolte dalla banca centrale. Gli scambi di beni con l’estero vengono riportati dalla bilancia commerciale e determinano il conto corrente (CC=EX-IM). I movimenti di capitali, vale a dire la variazione delle attività del paese detenute dagli stranieri e delle attività di un paese all’estero, determinano il conto capitale (CK= AFA - AFD). Dato il livello della domanda estera (YW) ed il tasso di cambio reale , un surplus (deficit) del conto corrente (CC) si determina in seguito ad una diminuzione (aumento) della domanda interna che riduce (accresce) le importazioni. Il conto capitale (CK) contempla entrate e uscite di capitali investiti nel paese in relazione a scostamenti del tasso di interesse interno rispetto al tasso di 40 interesse mondiale. Tali deviazioni sono spiegate con la “parità scoperta dei tassi di interesse”, dove il tasso di interesse interno (i) eguaglia il tasso di interesse mondiale (iW) a meno di aspettative di deprezzamento della valuta del paese. Se le aspettative sono di costanza del tasso di cambio, ma il tasso di interesse interno eccede (è inferiore a) quello mondiale, si ha un afflusso (deflusso) di capitali. Infine, si riportano le riserve ufficiali (RU) le cui variazioni non obbediscono unicamente alle forze di mercato, ma sono anche orientate dalla politica monetaria e valutaria (le autorità monetarie possono disporre da questa riserva valutaria da utilizzare nei mercati a sostegno della fiducia nella propria valuta). Un sistema di tassi di cambio fissi si configura come un accordo multilaterale. Allorché due o più paesi sottoscrivono un accordo di cambi fissi, le banche centrali si impegnano a variare le riserve ufficiali in modo da mantenere il rapporto di cambio (la parità bilaterale) all’interno della banda di oscillazione intorno alla parità centrale. La banca centrale provvede a realizzare l’equilibrio (pareggio della bilancia dei pagamenti) mediante variazioni delle riserve ufficiali che compensino eventuali squilibri in conto corrente e/o in conto capitale ( CC CK 0 ). Prescindendo dalle riserve ufficiali (RU=0), l’equilibrio della bilancia dei pagamenti è determinato dall’interazione fra conto corrente (CC) e conto capitale (CK). Sostituendo nella BP=CC+CK le relazioni che descrivono le sue due componenti: CC=EX-IM e CK=υ(i - iW) si ottiene l’equazione della curva BP: (3.3) i iW 1 Y 3 Y W 2 4 La curva BP rappresenta l’insieme delle combinazioni (Y, i) tali da porre in equilibrio la bilancia dei pagamenti per un dato tasso di cambio reale, cosicché CC+CK=0. Le partite correnti e i movimenti di capitale si compensano: un avanzo (disavanzo) della bilancia commerciale è controbilanciato da un deflusso (afflusso) netto di capitale di pari importo. La curva BP dovrebbe essere inclinata positivamente nel piano (Y, i) delle Figure 3.13.4. Infatti, all’aumentare del reddito, si accrescono le importazioni; per mantenere in 41 equilibrio la bilancia dei pagamenti, occorre che il tasso di interesse interno aumenti, in modo da attrarre capitali dall’estero. Nei mercati dei capitali globalizzati, oggi gli scambi di valuta rappresentano la quasi totalità (circa il 98% del totale) della mobilitazione dei flussi finanziari. I movimenti di capitali esercitano quindi l’effetto di gran lunga predominante sulla inclinazione della BP. Essi reagiscono immediatamente ad eventuali divergenze fra i due tassi di interesse. Ogni sia pur piccola divergenza del tasso di interesse interno da quello mondiale mette in moto un movimento di capitali tale da ripristinare in brevissimo tempo la parità dei tassi di interesse. Pertanto, il coefficiente υ assume di norma un valore molto elevato e per convenzione la curva BP viene ad assumere una posizione orizzontale nel piano (Y, i) delle Figure 3.1-3.4 e i suoi spostamenti seguono gli scostamenti del tasso di interesse interno dal tasso di interesse mondiale. 9. Regimi di cambio e bilancia dei pagamenti I due principali regimi di tasso di cambio fra le valute sono: 1. il regime di tassi di cambio flessibili consiste nella determinazione del rapporto di cambio mediante le libere contrattazioni che avvengono fra gli operatori nei mercati valutari (il prezzo di una valuta nei termini di un’altra viene determinato dalla domanda e dall’offerta presenti nel mercato); 2. il regime di tassi di cambio fissi consiste nell’accordo cooperativo mediante il quale le banche centrali di vari paesi fissano le parità bilaterali fra le loro valute - con bande di oscillazione sufficientemente strette, definite da un livello massimo e da un livello minimo del cambio rispetto alla parità centrale - e si impegnano a difenderle, mediante appropriati interventi di compravendita nei mercati valutari, in presenza di movimenti che rischiano di provocare uno scostamento dalla parità centrale di ampiezza superiore all’oscillazione massima concordata. 42 Molti paesi adottano altri regimi di cambio, definiti intermedi in quanto si collocano all’interno della sequenza di regimi che va dalla completa fluttuazione della valuta alla rigidità del cambio: 1. pegging unilaterale (ancoraggio ad un’altra valuta), nel quale un paese decide di regolare la creazione di moneta in modo da mantenere invariato nel medio periodo il cambio con una valuta “forte” (ad esempio, allo scopo di aumentare la credibilità della propria banca centrale, nel corso di un processo di disinflazione) conservando ovviamente l’opzione di modificare la parità; 2. pegging rispetto ad un paniere di valute; 3. il currency board, che definisce la scelta di un paese di istituire un comitato incaricato di aumentare (diminuire) la moneta nella circolazione interna nella misura strettamente corrispondente all’afflusso (deflusso) di valuta forte (l’obiettivo consiste nel ridurre drasticamente l’inflazione, ristabilire la credibilità della valuta nazionale e provocarne la rivalutazione); 4. target zones , un accordo di cambio fra più paesi, dove il tasso di cambio è fissato ad esempio rispetto ad una valuta artificiale (l’ECU durante il Sistema Monetario Europeo) ma può essere flessibile all’interno di un intervallo ampio ma definito. Infine, va ricordata la fissazione “irrevocabile” del tasso di cambio fra due o più valute. Essa prelude al passaggio ad una nuova valuta oppure alla adozione di una valuta straniera (la “dollarizzazione” scelta da alcuni paesi Centro-americani, l’”eurizzazione” scelta da alcuni paesi dell’ex-Iugoslavia, l’adozione del franco francese da parte di alcuni paesi dell’Africa occidentale). Recentemente, si va affermando la scelta “secca” fra regime di cambio flessibile e regime di cambio fisso. Qual è il motivo? Una risposta semplice è che il predominio dei mercati finanziari, con cui le scelte dei governi devono necessariamente fare i conti, si esprime in una forte volatilità (fino a veri e propri attacchi speculativi, che spesso hanno successo nonostante le banche centrali si impegnino a difendere il tasso di cambio ufficiale concordato). La insoddisfazione degli operatori finanziari per i regimi intermedi si spiega con l’elevato grado di incertezza sul cambio futuro che subiscono allorché i governi scelgono uno dei vari tipi di pegging (non è chiaro fino a che punto le banche centrali si impegneranno a difendere il tasso di cambio, che viene 43 spesso modificato). Pertanto, meglio sia la trasparenza del regime di cambio flessibile (che i mercati possono liberamente manovrare), sia la chiarezza di un cambio fisso, poiché quanto più una banca centrale ha una bassa credibilità di politica monetaria tanto più sarà indotta a difenderlo essendo sempre soggetto alla minaccia di un attacco speculativo. Il tasso di cambio nominale indica il rapporto in cui due valute vengono scambiate. Esprimendo il prezzo di una valuta relativamente ad un’altra, il tasso di cambio nominale può essere definito in due modi: 1) quotazione certo per incerto (e): la quantità di valuta estera richiesta per l’acquisto di un’unità di valuta nazionale; 2) quotazione incerto per certo (ê): la quantità di valuta nazionale richiesta per un’unità di valuta estera. Poiché le due quotazioni sono l’una il reciproco dell’altra (e=1/ê), nel valutare gli effetti di una variazione del tasso di cambio occorre fare attenzione alla definizione cui si fa riferimento. In seguito all’introduzione dell’euro è divenuta di uso più comune la prima quotazione: quanti dollari vengono richiesti per un euro nei mercati valutari internazionali. Un apprezzamento della nostra valuta, l’euro, si traduce in un aumento del tasso di cambio dollaro / euro. Si noti che al denominatore di e compare la valuta con valore noto e certo (cioè 1) e al numeratore la quantità (variabile, in base all’andamento del mercato valutario) di dollari; mentre finché la valuta era la lira, il tasso di cambio rilevante era quello lira/marco, al denominatore di (ê) compariva (di nuovo con valore noto e certo, cioè 1) il marco tedesco (come valuta àncora fra le valute dell’accordo di cambi fissi dello SME) e la lira compariva al numeratore (la quotazione era infatti “incerto per certo”). È facile constatare che, se il valore del tasso di cambio dollaro-euro aumenta quando l’euro si apprezza e, quindi, il dollaro si deprezza, lo stesso valore rappresenta per un cittadino statunitense la quotazione “incerto per certo”. L’aspettativa di una svalutazione futura provoca una crisi di bilancia dei pagamenti, che si manifesta sotto forma di riduzione delle riserve (una “fuga dei capitali” consiste nella decisione dei residenti di vendere rapidamente le attività finanziarie denominate nella propria valuta ed acquistare dalla banca centrale valuta estera da 44 investire all’estero) e aumento del tasso di interesse interno al di sopra di quello internazionale. L’aspettativa di una rivalutazione futura provoca un aumento delle riserve (gli stranieri acquistano la valuta interna cedendo la propria alla banca centrale) e una riduzione del tasso di interesse interno al di sotto di quello internazionale. Facciamo un esempio. Il prezzo della moneta estera (dollaro) in termini della moneta interna (euro) sia: 1,30$ = 1€. Al converso, il prezzo della moneta nazionale in termini di moneta estera sarà: 0,7€ = 1$ il tasso di cambio Euro/US dollar è il tasso di cambio nominale come prezzo della moneta estera in termini della moneta nazionale: quante unità della moneta estera (US dollar) sono necessarie per acquisire una moneta nazionale (euro) (certo per incerto). Nel regime di tassi di cambio fissi (ma aggiustabili) dello SME il tasso di cambio veniva così calcolato: quante unità della moneta nazionale (lira) erano necessarie per acquisire una moneta estera (DM). Il valore “incerto” veniva attribuito alla valuta interna; “certo” era il valore della valuta estera. Con l’Euro, al contrario, “certo” è divenuto il valore della valuta interna e “incerto” il valore della valuta estera. Pertanto, il tasso di cambio reale con la quotazione certo per incerto è: Tasso di cambio reale: ε = e p / pW E con la quotazione incerto per certo è: Tasso di cambio reale: ε’ = e’ pW / p Ricordiamo infine due definizioni: 1. La “Legge del prezzo unico”: il libero scambio rende eguale il prezzo di un bene in tutti i mercati del mondo, a meno della conversione da una valuta all’altra (e naturalmente di eventuali costi di transazione). 2. La Parità dei Poteri d’Acquisto: secondo questa condizione (di ancora più difficile realizzazione rispetto alla precedente, perché riguarda tutti i beni), il tasso di cambio di equilibrio fra due paesi è uguale al rapporto fra i loro livelli dei prezzi, a meno naturalmente dei costi di trasporto e delle condizioni tendenzialmente non concorrenziali che caratterizzano il settore dei servizi. 45 L’evidenza empirica non può fornire conferma né alla PPP né alla legge del prezzo unico. Le condizioni di invalidità delle due condizioni sono rappresentate innanzitutto dal grado di scostamento dei mercati dalla condizioni di concorrenza perfetta, dalla presenza di barriere commerciali e di beni non commerciabili, e dalle differenze internazionali nella misura ufficiale del livello dei prezzi. Il tasso di cambio reale (o ragione di scambio) indica il rapporto di scambio tra beni nazionali ed esteri: in altre parole, determina la quantità di beni esteri che è possibile ottenere contro un’unità di beni nazionali. Si definisce tasso di cambio reale effettivo il rapporto fra l’indice dei prezzi ed il livello medio dei prezzi esteri (una media ponderata i cui pesi esprimono la rilevanza che ciascun paese estero riveste nell’interscambio commerciale). Con la quotazione certo per incerto, il tasso di cambio reale ( ) di un paese in relazione ad un paese estero (le cui variabili saranno indicate con W in apice) è definito dal rapporto tra il livello del prezzo interno (p) ed il livello del prezzo estero (pW) espressi nella stessa valuta attraverso il tasso di cambio nominale: ep / p W ( ˆ eˆp W /p se si utilizza la quotazione incerto per certo). Se, ad esempio, esistesse un solo bene e fosse prodotto sia negli Stati Uniti che nell’Unione Europea, per calcolare il tasso di cambio reale un europeo dovrebbe trasformare in euro il prezzo del bene estero espresso in dollari - dividendo il prezzo in dollari per il tasso di cambio nominale (e) quotato certo per incerto (oppure moltiplicandolo per la quotazione (ê=1/e) incerto per certo) - e rapportarlo al prezzo del bene nazionale espresso in euro. Estendendo questo ragionamento all’insieme dei beni prodotti nell’UE e negli US, il tasso di cambio reale raffronta l’indice dei prezzi delle due economie espressi nella stessa valuta. Data la piena libertà di circolazione dei beni, la condizione di “parità dei poteri d’acquisto” (PPA) ci dice che – nelle 46 condizioni ideali di assenza di costi di transazione – il libero scambio fa sì che ciascun prodotto abbia lo stesso prezzo in qualsiasi luogo del mondo, a meno della conversione da una valuta all’altra effettuata in base al tasso di cambio nominale. La W e p / p. “legge del prezzo unico” vuole che Nel lungo periodo, l’evoluzione dei fattori reali – le preferenze dei consumatori ed il progresso tecnico - influenza il tasso di cambio reale (ε ). Un maggior gradimento delle merci di un paese nei mercati internazionali provoca l’apprezzamento del tasso di cambio reale di lungo periodo del paese. Un innalzamento del progresso tecnico nella produzione di un paese provoca la riduzione dei prezzi, con conseguente deprezzamento del tasso di cambio reale di lungo periodo del paese. Definendo pUS e pUME come il prezzo di un paniere di beni rispettivamente negli Stati Uniti e nell’Unione Monetaria Europea (UME), e tenendo conto del fatto che il livello dei prezzi dà un peso maggiore ai beni prodotti e consumati all’interno, il tasso di cambio reale dollaro/euro q $ / € rappresenta il prezzo in dollari del paniere europeo rispetto a quello statunitense. Il tasso di cambio reale è dunque il valore in dollari del livello dei prezzi nell’UME diviso per il livello dei prezzi negli Stati Uniti: q $ / € = (E $ / € x pUME ) / pUS dove E $ / € è il tasso di cambio nominale dollaro / euro. Pertanto, un aumento della domanda mondiale di beni USA causa l’apprezzamento reale di lungo periodo del dollaro, ovvero una riduzione del prezzo relativo del paniere di spesa europeo rispetto a quello degli Stati Uniti q $ / € (è aumentato il livello dei prezzi US rispetto a quello UME); mentre un aumento del progresso tecnico negli USA determina l’espansione relativa della produzione USA, e quindi il deprezzamento reale di lungo periodo del dollaro, ovvero un aumento del prezzo relativo del paniere di spesa europeo rispetto a quello degli Stati Uniti: q $ / € (è diminuito il livello dei prezzi US rispetto a quello UME). L’equazione del tasso di cambio reale può essere anche scritta ponendo in evidenza il tasso di cambio nominale: E $ / € = q $ / € x (pUS / pUME) 47 Pertanto, il tasso di cambio nominale di lungo periodo risulta dall’andamento congiunto delle variazioni del tasso di cambio reale di lungo periodo (che a loro volta, come si è visto, dipendono da variazioni delle preferenze e del progresso tecnico) e delle variazioni del cambio nominale dollaro/euro (che a loro volta dipendono da variazioni della domanda e dell’offerta di moneta negli Stati Uniti e nell’UME). Il tasso di cambio reale, essendo il rapporto tra prezzi interni e prezzi esteri espressi nella stessa valuta, è il principale indicatore della competitività con l’estero. Un apprezzamento reale della valuta ( un aumento del prezzo relativo del paniere di beni prodotto nel paese) riduce la domanda del paniere; un deprezzamento reale della valuta (una riduzione del prezzo relativo del paniere di beni prodotto nel paese) aumenta la domanda del paniere. La competitività del paese rimane costante quando il differenziale di inflazione del paese rispetto all’estero si trasmette completamente in una variazione del tasso di cambio nominale. Ad esempio un deprezzamento nominale della valuta nazionale (in regime di cambi fissi: una svalutazione) indica una riduzione del suo potere d’acquisto e corrisponde ad una diminuzione del tasso di cambio quotato certo per incerto (ad un aumento, se quotato incerto per certo). Un deprezzamento nominale dell’euro rende meno conveniente per i residenti nell’UE l’acquisto dei beni di importazione dagli US e più conveniente per i cittadini statunitensi acquistare i beni prodotti nei paesi dell’UE. Un effetto prevedibile è l’incremento delle esportazioni dall’UE verso gli US. La condizione di Marshall-Lerner prescrive che, affinché tale riequilibrio possa avvenire, l’aggiustamento nelle quantità scambiate deve essere più che proporzionale rispetto alle variazioni dei loro prezzi relativi. Ciò richiede che la somma delle elasticità della domanda di importazioni e di esportazioni rispetto al tasso di cambio sia maggiore di 1. In altre parole, nel medio termine l’aumento del valore delle esportazioni deve essere superiore all’aumento del valore delle importazioni. Gli operatori esteri troveranno conveniente accrescere la domanda di beni prodotti nel paese la cui valuta è divenuta più a buon mercato. 48 Tuttavia, per quanto si debba ipotizzare una riduzione delle importazioni divenute più costose, il valore degli esborsi per pagare i beni importati si accresce per il loro maggiore costo unitario. Dopo un deprezzamento della valuta, l’aumento immediato del valore delle importazioni peggiora il saldo commerciale; solo dopo alcuni mesi la bilancia commerciale conosce una ripresa (di qui, la definizione di “effetto J”); Il saldo netto positivo nella bilancia commerciale durerà fintantoché l’incremento dell’inflazione importata non si sarà tradotto in un adeguamento verso l’alto dei salari e del livello generale dei prezzi, sicché il miglioramento della competitività garantito dal deprezzamento del cambio si esaurirà. Con riferimento alla quotazione (e) certo per incerto che qui seguiremo, la variazione percentuale del tasso di cambio reale ( / ) è data dalla somma della variazione percentuale del tasso di cambio nominale ( e e / e ) e del tasso di inflazione nazionale ( ) al netto del tasso di inflazione estero ( W ): e W . In termini di tasso di cambio nominale tale relazione è: e W . In regime di cambi flessibili, il tasso di apprezzamento nominale è dato dalla somma fra il tasso di apprezzamento reale ed il differenziale di inflazione che si registra tra i due paesi. Un tasso di inflazione interno più basso del tasso di inflazione estero (πW – π > 0) si riflette in una corrispondente differenza fra tasso di cambio nominale e tasso di cambio reale. Il tasso di cambio nominale della valuta interna si apprezza, mentre il tasso di cambio reale rimarrà invariato al livello naturale di lungo periodo corrispondente alla PPA. In regime di cambi fissi invece ciò non accade: poiché il tasso di cambio nominale rimane costante è il tasso di cambio reale a ridursi. Quando il tasso di cambio reale ( ) di un paese scende, si realizza un deprezzamento reale della valuta nazionale. Il contrario accade nel caso di apprezzamento reale. Se i due paesi non producono gli stessi beni e/o producono beni non commerciabili, il tasso di cambio reale può essere diverso da 1 anche nel lungo periodo. In altre parole, 49 viene meno la validità della versione assoluta della parità dei poteri d’acquisto (la cosiddetta “legge del prezzo unico”). L’epoca successiva alla fine nel 1971 del sistema di cambi fissi di Bretton Woods è stata caratterizzata da un notevole incremento della volatilità dei cambi. I disallineamenti del tasso di cambio reale fra le principali valute, rispetto al valore di equilibrio di lungo periodo indicato dalla PPA, risultano molto più ampi in regime di cambi flessibili che in regime di cambi fissi e presentano una durata molto maggiore di ciò che intendiamo per “breve periodo”. L’evidenza empirica di lunghi cicli di allontanamento del tasso di cambio reale effettivo dal suo valore di equilibrio di lungo periodo può essere ricondotta all’incremento della produzione dei beni non commerciabili (NT) rispetto alla produzione di beni commerciabili (T). In assenza di barriere tariffarie, l’integrazione dei mercati fa sì che si determini l’eguaglianza dei prezzi dei beni commerciabili fra i paesi, ma nei settori dei beni non commerciabili – non esposti alla concorrenza internazionale e con una dinamica della produttività più lenta – tale processo di livellamento non si genera. Ad esempio, alcuni dei periodi, lunghi anche un decennio, di fluttuazione del tasso di cambio tra il dollaro USA e il marco tedesco e tra il dollaro USA e lo yen sono interpretati in base ad una più lenta crescita della produttività del lavoro rispetto alla dinamica salariale, con conseguente variazione del cambio della valuta. Consideriamo due paesi, il paese 1 dove è in corso il passaggio ad una quota prevalente del PIL generata dal settore dei servizi (prevalentemente “non commerciabili”:NT) e quindi la produttività complessiva sia rallentata dall’espansione dei servizi (settore dove i guadagni di produttività sono molto più lenti che nell’industria) e il paese 2 dove tale passaggio si è già compiuto. Mentre i prezzi per i beni commerciabili (pT) vengono determinati sui mercati internazionali, i prezzi dei beni non commerciabili sui mercati esteri (pNT) vengono definiti dalle condizioni prevalenti sul mercato interno. Poiché il livello generale dei prezzi al consumo di un’economia (p) riflette sia i beni commerciabili che quelli non 50 commerciabili, le variazioni nel livello dei prezzi nazionali rifletteranno l’andamento di entrambi i settori dei due paesi (i = 1,2): p i p Ti (1 ) p NTi dove Φ è il peso del settore dei beni commerciabili sul totale del PIL. Supponiamo che la dinamica della produttività abbia un’accelerazione nei settori “commerciabili” (T) sia nel paese 1 che nel paese 2. La dinamica salariale, cui la dinamica della produttività si eguaglia nel settore T, si trasmette anche al settore NT, dove invece la produttività aumenta più lentamente. Quanto più ampio è il divario paese 1 rispetto al paese 2 nella distanza della dinamica della produttività del settore NT da quella del settore T, tanto maggiore sarà il differenziale di tasso di inflazione nel paese 1 relativamente al paese 2. Infatti, il differenziale di tasso di inflazione risulta dal divario fra i rapporti tra il settore T ed il settore NT nei due paesi: quanto più è in espansione è il settore NT nel paese 1, tanto più il divario che si apre nel settore NT fra incremento del salario legato al settore T e incremento della produttività si tradurrà in un aumento più rapido del livello generale dei prezzi nel paese 1. Il cosiddetto “effetto Balassa-Samuelson” prevede appunto che - a causa dell’impatto inflazionistico della bassa dinamica della produttività nel settore in rapida espansione - il tasso di inflazione sia più elevato nel paese 1 che nel paese 2: il differenziale di tasso di inflazione fra i due paesi è determinato dal divario di produttività nel settore T moltiplicato per la quota sul PIL del settore NT. Supponendo che nella formazione del prezzo dei beni non commerciabili conti unicamente il salario, il tasso di variazione dei prezzi al consumo è: i Ti (1 ) wi . Data l’eguaglianza fra salario del e produttività marginale lavoro (PML), ed il divario ( P M L 2 P M L1 ) , il differenziale di inflazione del paese 1 rispetto al paese 2 è determinato dalla lentezza nella dinamica della propria produttività procurata dall’accelerata espansione del settore NT: 51 1 2 (1 ) P M L 2 P M L1 . Nel breve periodo, il conseguente disavanzo commerciale potrebbe essere compensato da un avanzo nei movimenti di capitali. Nel lungo periodo, tuttavia, il ritorno al tasso di cambio reale di equilibrio di lungo periodo può realizzarsi solo per effetto di un aggiustamento strutturale. Menzioniamo due possibili percorsi: a) un prolungato periodo di crescita monetaria nel paese 1 inferiore a quella del paese 2, tale da annullare il differenziale di inflazione attraverso la deflazione dei consumi in beni del settore T; b) una traslazione verso l’esterno della frontiera delle possibilità di produzione (indotto da un aumento del progresso tecnico, oppure da un aumento delle risorse disponibili, qual è ad esempio la scoperta di un giacimento petrolifero) che produce un innalzamento del tasso di cambio reale e colloca stabilmente il paese 1 ad un più alto livello di benessere. Una tesi alternativa sull’impatto della dinamica dei servizi sul tasso di inflazione è stata elaborata negli anni ’80 da Bhagwati, Kravis e Lipsey. Il più elevato livello complessivo dei prezzi che empiricamente si riscontra nei paesi avanzati sarebbe da imputare al settore dei servizi. Infatti, tale settore, che è tipicamente in gran misura NT e ad alta intensità di lavoro, presenta nei paesi poveri un livello di salario inferiore a quello dei paesi avanzati, tipicamente a più alto rapporto capitale/lavoro. Tale divario nel costo del lavoro giustificherebbe l’impatto minore del settore dei servizi sul livello complessivo dei prezzi nei paesi poveri. Nel lungo periodo, in un’economia in piena occupazione un incremento dell’offerta di moneta si traduce nel proporzionale incremento dei prezzi, senza effetti sul tasso di interesse sul reddito reale. Un incremento permanente dell’offerta di moneta, in quanto provoca un processo di inflazione, causa un proporzionale deprezzamento della valuta del paese nel lungo periodo. Nel breve periodo, tuttavia, forti oscillazioni nel tasso di cambio sono riconducibili ad una causa diversa. Come ora vedremo, il fenomeno più importante, l’overshooting del tasso di cambio, è spiegabile con la rigidità di breve periodo del livello dei prezzi. 52 10. Le politiche monetarie e fiscali in regime di cambi fissi e cambi flessibili Nelle Figure 3.1-3.4 sono illustrate le politiche monetarie e fiscali: variazioni della moneta o del bilancio pubblico hanno effetti diversi in regime di cambi fissi e cambi flessibili. Figura 3.1. Politica fiscale espansiva in cambi fissi i IS1 IS0 C B A BP LM0 LM1 0 Y0 Y1 Y Una politica fiscale espansiva è efficace nell’aumentare il livello del reddito in cambi fissi e inefficace in cambi flessibili. In cambi fissi, infatti, uno spostamento verso destra della IS implica un aumento della domanda transattiva di moneta; il tasso di interesse sale, attirando nuovi capitali da investire nelle attività finanziarie interne, cosicché la domanda della valuta nazionale aumenta; per mantenere fede all’impegno di preservare i cambi fissi evitando che il tasso di cambio si apprezzi, la banca centrale deve accrescere l’offerta di moneta. Nel punto B si realizza un nuovo equilibrio ad un livello più elevato del reddito (e tasso di interesse mondiale 53 invariato). In cambi flessibili, ad uno spostamento verso destra della IS segue di nuovo una tensione al rialzo del tasso di interesse interno, ma in assenza di intervento della banca centrale si determina l’apprezzamento della valuta nazionale e la riduzione della domanda di esportazioni che riporta la IS nella posizione iniziale. Tale processo configura uno “spiazzamento” completo realizzato dal tasso di cambio. Una politica monetaria espansiva è efficace nell’aumentare il livello del reddito in cambi flessibili e inefficace in cambi fissi. Supponiamo che la banca centrale desideri innalzare il livello dell’output. In cambi flessibili uno spostamento verso destra della LM comporta una discesa del tasso di interesse interno; la conseguente vendita di attività finanziarie interne aumenta l’offerta di valuta nazionale, il che causa un deprezzamento del cambio. Figura 3.2. Politica fiscale espansiva in cambi flessibili i IS0 IS1 C LM A 0 Y0 BP Y1 Y L’espansione delle esportazioni consente alla IS (che si sposta anch’essa verso destra) di incontrare la LM ad un livello più elevato di reddito. In cambi fissi, l’accresciuta offerta di valuta nazionale sposta verso destra la LM; alla discesa del tasso di 54 interesse consegue un deflusso di capitali, il disavanzo della bilancia dei pagamenti, la riduzione delle riserve ufficiali e della base monetaria (la LM ritorna nella posizione iniziale). La banca centrale, infatti, avendo preso l’impegno di difendere le parità fisse, non interviene. Dati il grado elevato di mobilità dei capitali fra i diversi mercati internazionali ed il regime di cambi flessibili fra le tre principali aree valutarie (dollaro, euro e yen), si suole dire che la crescita di un paese risulti oggi meno vincolata alla formazione interna di risparmio. All’origine di questo mutamento strutturale sarebbe la seguente catena causale. Gli investimenti diretti esteri e da diversificazione internazionale dei portafogli di attività finanziarie assumono crescente importanza. Il grado di correlazione fra risparmio ed investimento in ciascun paese tende quindi a ridursi. L’aumento delle decisioni di investimento di una grande economia, che trovi un limite nella disponibilità interna di risparmio, crea un eccesso di domanda di fondi nei mercati internazionali. La conseguente tensione al rialzo del tasso di interesse internazionale genera un incremento dell’offerta – sia interna che internazionale – di fondi investibili, fino al ripristino dell’equilibrio. La globalizzazione finanziaria, accrescendo la rapidità degli spostamenti dei capitali da un mercato all’altro, scolora i confini fra gli stati-nazione ed appanna il loro ruolo nell’economia internazionale. D’altro canto, la stessa globalizzazione, nell’aumentare l’incertezza degli operatori e la complessità del funzionamento dei mercati finanziari, provoca una crescente volatilità dei mercati ed una maggiore avversione al rischio. La diversificazione di portafoglio è orientata, piuttosto che dalla massimizzazione del rendimento per un dato livello di rischio, dalla preferenza per le imprese e le forme di investimento finanziario che offrono una rischiosità minore, caratterizzandosi per maggiore informazione e ridotti costi di transazione. Questa “fuga dall’incertezza” spiega la persistenza della “distorsione verso l’interno” (home bias) nella composizione dei portafogli di attività finanziarie dei risparmiatori. 55 Figura 3.3. Politica monetaria espansiva in cambi fissi i LM0 IS0 LM1 A B BP D 0 Y0 Y1 Y Figura 3.4. Politica monetaria espansiva in cambi flessibili i IS1 IS0 LM0 LM1 B A BP D 0 Y0 Y1 Y 56 11. Parità scoperta e coperta dei tassi di interesse Il rendimento di un’attività finanziaria può divergere in un paese dal rendimento nei mercati internazionali principalmente per due fattori: 1) il premio per il rischio di cambio richiesto dagli investitori finanziari a fronte di un’aspettativa di deprezzamento del cambio; 2) il premio per il rischio di default richiesto dagli investitori finanziari a fronte di un’aspettativa di insolvenza del debitore, sia questi un’impresa privata oppure uno stato sovrano. Un ulteriore scostamento, di cui non si terrà conto, è provocato dal divario fra i paesi nella legislazione sulle attività finanziarie, in primo luogo riguardante la tassazione dei rendimenti finanziari. La speculazione internazionale è pronta a sfruttare ogni divergenza fra i rendimenti dei titoli dovuta a variazioni dei due premi per il rischio. Nei mercati dei capitali globalizzati, gli operatori spostano continuamente capitali – praticamente in tempo reale, grazie anche alle contrattazioni on-line - da un mercato all’altro. L’attività di arbitraggio fa sì che in equilibrio il rapporto tra i rendimenti dei titoli sia pari al rapporto tra i tassi di cambio: a parità di rischio, liquidità e durata, un euro investito nell’UE deve rendere come un dollaro investito negli US. Supponendo una perfetta mobilità dei capitali, che si traduce in assenza di costi di transazione nell’operazione di cambio delle valute, un operatore europeo può decidere indifferentemente di investire un euro sul mercato nazionale dei titoli al tempo t ed ottenere al tempo t+1 la restituzione dell’euro investito oltre al tasso di interesse nominale corrisposto (1+iUME), oppure può decidere di cambiare l’euro in dollari (moltiplicandolo per il tasso di cambio e) ed investire gli e dollari così ottenuti sul mercato US riscuotendo, al termine del periodo, e(1+iUS) dollari che verranno a loro volta cambiati in euro dividendoli per il tasso di cambio atteso. In assenza di variazioni attese nel tasso di cambio a pronti, si realizzerà l’eguaglianza (1+iUME)=(1+iUS). 57 Supponiamo ora che l’operatore europeo sappia che sui mercati internazionali si è formata la comune opinione che il tasso di cambio fra dollaro ed euro nel e prossimo anno vedrà un apprezzamento dell’euro ( et 1 arbitraggio dovrà tener conto di tali et ). La condizione di aspettative. Il rendimento atteso dall’investimento di un euro negli Stati Uniti, tenuto conto della variazione attesa del valore del dollaro, in equilibrio sarà dato da: (1 iUMEt ) (1 iUSt ) et e te1 Facciamo un esempio. Supponiamo che il tasso di interesse sulle attività finanziarie denominate in dollari dal 3% salga al 4% (iUS=0,04), mentre quello sulle attività finanziarie denominate in euro resti al 3% (iUME=0,03) e che occorrano 1,21 dollari per un euro. In base all’equazione della parità scoperta, il verificarsi di una variazione nei tassi di interesse comporta una variazione nel tasso di cambio atteso. Nell’equazione si otterrà un apprezzamento atteso dell’euro che verrà scambiato a 1,22 dollari per un euro: (1 iUMEt ) (1 iUSt ) et ete1 (1+0,03)=(1+0,04)(1,21/1,22) Questa equazione definisce la parità scoperta dei tassi di interesse. Se gli operatori fossero neutrali rispetto al rischio, l’equivalenza fra gli investimenti nei due mercati si raggiungerebbe in corrispondenza del tasso di cambio atteso al quale l’investitore europeo ottiene, negli Stati Uniti, lo stesso tasso di interesse che guadagnerebbe nell’Unione Monetaria Europea. L’equazione della parità scoperta dei tassi di interesse può essere scritta come: 1 iUMEt e et 1 iUSt et 1 1 iUSt ete1 e t 1 da cui, riordinando i termini: 1 iUMEt et 58 Per valori contenuti dei tassi, il tasso di interesse nazionale può essere approssimato dalla somma algebrica tra tasso di interesse estero e tasso di variazione attesa della valuta nazionale: ete1 et iUMEt iUSt et ovvero: iUSt ete1 et iUMEt et Un deprezzamento atteso dell’euro rispetto al dollaro, che equivale ad un apprezzamento atteso del dollaro (( ete1 et ), ), implica quindi un valore negativo del secondo termine sul lato destro dell’equazione (3.5) e comporta un eccesso del tasso di interesse UME rispetto al tasso di interesse US. Al converso, un apprezzamento atteso dell’euro rispetto al dollaro, che equivale ad un deprezzamento atteso del dollaro (( ete1 et ),), implica un valore positivo del secondo termine sul lato destro e comporta un eccesso del tasso di interesse US rispetto al tasso di interesse UME: ete1 et iUMEt iUSt et ovvero: i USt i UMEt e te1 e t et Abbiamo finora assunto che l’operatore europeo accetti di sostenere il rischio del rendimento incerto connesso all’aspettativa di apprezzamento atteso del dollaro. Infatti, all’operatore si è attribuita una neutralità al rischio. Tuttavia, l’alta volatilità del tasso di interesse e/o del tasso di cambio rende molto plausibile l’ipotesi che l’operatore non sia neutrale, ma sia avverso al rischio. Il differenziale fra tassi di interesse e deprezzamento di una valuta rispetto all’altra nella realtà si discosta spesso da zero. Come vedremo, a meno che non si tratti di allontanamento dall’ipotesi di aspettative razionali (i soggetti non riescono a prevedere con esattezza il cambio futuro), la divergenza viene attribuita alla ricompensa per l’avversione al rischio. 59 La parità scoperta deve allora essere corretta per tenere conto del fattore di rischio: il premio che l’operatore europeo desidera ricevere per il rischio connesso all’investimento in dollari. Nell’equazione che descrive la parità scoperta dei tassi di interesse dovremo perciò aggiungere un termine ((t)) legato al possesso dell’attività finanziaria denominata in dollari: i UMEt i USt e te 1 e t et t Esiste tuttavia il mezzo per coprirsi dal rischio connesso al possesso del titolo estero: l’informazione sul prezzo futuro a pronti di ogni valuta è disponibile nei listini finanziari. Il mercato finanziario offre infatti – sotto forma del valore del tasso di cambio a termine ( f t ) - la propria aspettativa riguardo al valore del dollaro rispetto all’euro ad una data futura. Il premio per il rischio (φt), che deve coprire proprio un eventuale errore di previsione sull’ampiezza del futuro apprezzamento del dollaro, dipende dalla differenza fra l’aspettativa del futuro cambio a pronti (( ete1 ) ) ed il tasso di cambio a termine ( f t ). Sottraendo il tasso di cambio da ambedue i termini e dividendoli entrambi ancora per (et), possiamo scrivere: e te1 e t f et t t et et In effetti, è l’insieme di tutte le operazioni sul futuro realizzate da tutti gli investitori del mercato finanziario a determinare l’informazione sul cambio a termine ( f t ) che riflette l’aspettativa riguardo al futuro cambio a pronti (( ete1 ). ). Nell’ipotesi di aspettative razionali, tale previsione risulta confermata ex post: ete1 et1. . Prendiamo perciò le mosse dal comportamento del singolo investitore, osservando 60 che l’eventuale errore di previsione sul tasso di cambio a termine in cui incorre può avere due cause: 1) la presenza del premio per il rischio: t (ete1 f t ) / et 2) un errore di previsione sul tasso a pronti futuro a causa di condizioni di “razionalità limitata”, la ridotta capacità di calcolo e di previsione probabilistica relativamente agli eventi futuri: (et 1 ete1 ) / et . Sotto l’ipotesi di aspettative razionali l’errore di previsione sul futuro tasso a pronti è eguale a zero. A determinare un errore di previsione del cambio a termine residua allora solo la presenza del premio per il rischio. L’operatore ha due possibilità. Se ritiene di possedere una corretta informazione sul premio per il rischio tenterà di “battere” il mercato e farà guadagni da arbitraggio se la sua aspettativa sul futuro cambio a pronti risulterà più precisa di quella prevalente nel mercato. Se, invece, l’operatore si è formato il convincimento che le aspettative prevalenti nel mercato siano effettivamente “aspettative razionali”, preferirà allinearsi all’aspettativa prevalente e fare riferimento all’informazione offerto dal mercato, rappresentata dal tasso di cambio a termine ( f t ). L’operatore si coprirà dal rischio costituito dal rendimento incerto del titolo estero, contrattando la vendita a un anno da oggi - al prezzo rappresentato dal tasso di cambio a termine - del ricavo in dollari che riceverà dall’investimento nei titoli USA. In assenza di controlli dei capitali, di nuovo per approssimazione, si ottiene la formulazione della parità coperta dei tassi di interesse: i UMEt i USt ft et et Il termine che si aggiunge al tasso di interesse statunitense è detto “sconto” se di valore negativo (si accetta un tasso di interesse più basso nell’UME se il mercato prevede un apprezzamento dell’euro) e “premio” se di valore positivo (l’operatore richiede un differenziale positivo di rendimento se il mercato prevede un 61 deprezzamento dell’euro). Data l’ipotesi di aspettative razionali, il mercato dovrebbe essere in grado di prevedere con sufficiente esattezza (di norma, più è lungo il periodo, meno precisa è la stima) quale sarà il futuro tasso di cambio a pronti. In tal caso, il tasso di cambio a termine, che esprime appunto l’aspettativa di mercato sul tasso di cambio a pronti futuro, risulterà a posteriori eguale al tasso di cambio a pronti atteso: f t e te 1 . Se nelle due equazioni i rispettivi termini risultano ex ante diversi fra loro: e te 1 e t f et t et et Ricapitolando, la differenza fra cambio atteso e cambio a termine ex post sarà e t 1 f t e t 1 e te 1 e te 1 f t data da: et et et . Tale differenza può avere due origini. La prima è una previsione errata: l’aspettativa sul tasso di cambio non viene convalidata ex post (un valore positivo del primo termine a destra). Se escludiamo tale eventualità adottando l’ipotesi di aspettative razionali, a spiegare il mancato realizzarsi della previsione sul tasso di cambio a pronti futuro sarà la seconda causa: il premio per il rischio (un valore positivo del secondo termine a destra). Sotto l’ipotesi di aspettative razionali a determinare un errore di previsione del cambio a termine residua solo la presenza di un premio per il rischio. L’operatore ha due possibilità. Se ritiene di valutarlo meglio del mercato tenterà di “batterlo” : farà guadagni da arbitraggio se la sua aspettativa sul futuro cambio a pronti risulterà più precisa di quella prevalente nel mercato. Sotto l’ipotesi di aspettative razionali a determinare un errore di previsione del cambio a termine residua solo la presenza di un premio per il rischio. L’operatore ha due possibilità. Se ritiene di valutarlo meglio del mercato tenterà di “batterlo” : farà 62 guadagni da arbitraggio se la sua aspettativa sul futuro cambio a pronti risulterà più precisa di quella prevalente nel mercato. Dopo che il Premio Nobel 2013 E.Fama sostenne che i prezzi di mercato di borsa incorporano rapidamente le nuove informazioni (sicché non ha senso sfidare il mercato in quanto il futuro andamento delle quotazioni non può essere previsto), Shiller (l’economista che il comitato di Stoccolma – un po’ tartufescamente – ho premiato assieme a Fama ed allo statistico Hansen) ha al contrario sostenuto che le quotazioni sono spesso frutto di comportamenti “irrazionali”. Il fatto che le quotazioni sono molto più volatili dei dividendi dimostrerebbe l’irrilevanza della rapidità con cui gli operatori utilizzano le informazioni nelle transazioni finanziarie. L’effetto “contagio” sarebbe di gran lunga più importante: gli operatori e i risparmiatori investono o vendono nelle azioni non solo in base al calcolo razionale sui futuri dividendi attesi, ma spesso essendo influenzati dall’andamento impresso ai prezzi azionari dalle ondate speculative di “esuberanza” oppure di “panico” (di qui l’elevata volatilità verso l’alto e verso il basso, ed anche una certa predicibilità dei prezzi azionari, quanto meno nel medio periodo). Il dibattito sulla possibilità che si possa o meno “battere” il mercato resta dunque aperto. Se, invece, l’operatore si è formato il convincimento che le aspettative prevalenti nel mercato siano effettivamente “aspettative razionali”, preferirà allinearsi all’aspettativa prevalente e fare riferimento all’informazione offerto dal mercato, rappresentata dal tasso di cambio a termine ( f t ). L’operatore si coprirà dal rischio costituito dal rendimento incerto del titolo estero, contrattando la vendita a un anno da oggi - al prezzo rappresentato dal tasso di cambio a termine - del ricavo in dollari che riceverà dall’investimento nei titoli USA. Il termine che si aggiunge al tasso di interesse statunitense è detto “sconto” se di valore negativo (si accetta un tasso di interesse più basso nell’UME se il mercato prevede un apprezzamento dell’euro) e “premio” se di valore positivo (l’operatore richiede un differenziale positivo di rendimento se il mercato prevede un deprezzamento dell’euro). Data l’ipotesi di aspettative razionali, il mercato dovrebbe 63 essere in grado di prevedere con sufficiente esattezza (di norma, più è lungo il periodo, meno precisa è la stima) quale sarà il futuro tasso di cambio a pronti. In tal caso, il tasso di cambio a termine, che esprime appunto l’aspettativa di mercato sul tasso di cambio a pronti futuro, risulterà a posteriori eguale al tasso di cambio a pronti atteso. 64 Parte Seconda Aree valutarie ottimali e integrazione monetaria europea 1. Introduzione Per introdurre l’analisi dell’Unione Europea (UE), e in particolare dell’ Unione Monetaria ed Economica (UME), affronteremo ora la questione della costituzione di un’area valutaria da parte di paesi che hanno proceduto all’integrazione dei propri mercati di beni e servizi attraverso l’abbattimento delle barriere tariffarie e non tariffarie. L’unione fra i paesi europei nacque come progetto politico. L’obiettivo di assicurare un futuro di pace ai popoli europei portò i padri fondatori a concepire un processo di unificazione sia economica che politica. Fra loro ricordiamo Altiero Spinelli, uno degli estensori del Manifesto di Ventotene del 1941; Robert Schuman, l’autore della dichiarazione del 9 maggio, giorno in cui oggi celebriamo l’Europa unita; Jean Monnet, l’ispiratore del primo concreto passo verso l’integrazione europea: la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), creata nel 1951 da Belgio, Francia e Germania Italia, Lussemburgo e Olanda allo scopo di favorire l’impiego comune di queste materie prime per la ripresa industriale post-bellica ed accelerare al contempo la ripresa delle relazioni politiche. Nel marzo 1957 a Roma vennero firmati i Trattati con i quali quegli stessi sei paesi istituivano la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom). Nel 1968 fu completata l’eliminazione delle tariffe e delle quote sul commercio interno e si proclamò la libera circolazione di merci, servizi, capitali e lavoro. Successivamente, aderirono alle Comunità Europee (CE) altri nove paesi (Regno Unito, Danimarca e Irlanda nel 1972, Grecia nel 1981, Spagna, e Portogallo nel 1986, Austria, Finlandia e Svezia nel 1995), sei dei quali avevano inizialmente fatto parte di un progetto alternativo: l’Accordo Europeo di Libero Scambio (EFTA) siglato nel 1960. L’abolizione delle barriere non tariffarie ed 65 il graduale passaggio a votazioni a maggioranza furono le principali decisioni contenute nell’Atto Unico Europeo (AUE) del 1986. La cornice istituzionale dei tre pilastri - Comunità Europea, Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e Giustizia e affari interni (GAI) - in cui si articola l’UE venne istituita nel 1991 con il Trattato di Maastricht (TUE) che diede anche avvio all’ UME. Nel 2004 l’adesione di dieci nuovi paesi (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) ha segnato il passaggio dell’Unione Europea da 15 paesi (UE-15) a 25 paesi (UE-25). Il 1 gennaio 2007, l’allargamento a Bulgaria e Romania ha portato l’Unione Europea a ventisette paesi (UE-27). L’ultima adesione, quella della Croazia (1 luglio 2013), ha portato a 28 i paesi dell’Unione Europea. Il lungimirante obiettivo dell’unificazione politica si è finora rivelato troppo ambizioso. L’eterogeneità dei valori e degli interessi ha impedito l’affermarsi di un modello condiviso di organizzazione dell’economia e della società. L’orizzonte del progetto originario è stato così delimitato all’elaborazione di accordi di “mutuo vantaggio”, consistenti in politiche pubbliche comuni in campo economico e più recentemente anche nella cooperazione nel campo della politica estera, della difesa e della sicurezza. La formazione del mercato unico ha visto il progressivo abbattimento delle diverse forme di barriere al libero scambio – tariffarie e non-tariffarie (contingentamento, etc.) – e l’armonizzazione fra le regolamentazioni nazionali (ambientale, sanitaria, etc.). Le imprese hanno beneficiato del libero accesso su tutti i mercati, nei quali si sono al contempo confrontate con la concorrenza delle imprese degli altri paesi dell’UE. La pressione al ribasso esercitata sui prezzi ha accentuato la competizione nel mercato dei prodotti, stimolando le imprese alla riduzione dei costi ed all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto. L’attuale fase di integrazione si contraddistingue per il complesso intreccio fra diverse finalità. L’obiettivo di aumentare il grado di concorrenza dei mercati mediante i processi di liberalizzazione e di privatizzazione nel campo dei servizi e dell’energia entra spesso in conflitto con la ricerca di economie di scala attraverso fusioni ed 66 acquisizioni che stanno dando origine a grandi compagnie multinazionali. L’obiettivo di rafforzare la protezione sociale di fronte all’aumento dell’incertezza economica e delle diseguaglianze determinati dalla globalizzazione si scontra con l’eterogeneità delle comunità e delle economie europee, che rendono difficile l’armonizzazione dei sistemi di Welfare. La legislazione presente nei singoli paesi frappone ostacoli alla regolazione a livello europeo dei mercati dei beni, del lavoro e dei servizi finanziari. Negli ultimi decenni le economie europee si sono sviluppate all’interno di un quadro di regole affatto nuovo. Alle istituzioni nazionali si è affiancato un livello istituzionale sovranazionale con lo scopo di dare attuazione alle politiche di integrazione. Il mercato unico ha sancito la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. L’UME ha dato vita ad un’unica moneta e ad un’unica autorità monetaria. La Commissione Europea ha esteso gli interventi di regolazione diretti a rafforzare la concorrenza nei mercati. Il Patto di Stabilità e Crescita (PSC) ha vincolato i bilanci pubblici delle autorità fiscali nazionali. Le politiche di coesione hanno finanziato lo sviluppo delle aree arretrate. Sulle vicende storiche dalle quali nascono le istituzioni cui fa capo la produzione dei beni pubblici di un paese – magistratura, polizia, difesa, sistema fiscale, istruzione, sanità, etc. - la produzione scientifica è abbondante e prodiga di interpretazioni. Lo stato dell’arte è invece insoddisfacente per quanto riguarda un’altra istituzione fondamentale: la moneta. Non è infatti semplice dare una definizione perspicua di che cosa sia la moneta; tanto meno nell’area dell’euro, giacché i paesi che adottano la nuova valuta non formano uno Stato federale. Nello studiare le unioni monetarie, la teoria economica fa ricorso al classico strumento della scelta massimizzante: un’area valutaria si definisce “ottima” se la sovranità monetaria esercitata della valuta comune produce - per l’aggregato degli stati che l’adottano - benefici che eccedono i costi. Se i criteri in base ai quali si dà vita ad un’area valutaria fossero esclusivamente quelli economici, una nuova valuta che subentri ad una pluralità di valute “regionali” non dovrebbe estendere la propria sovranità oltre la “regione marginale”, da intendersi come la regione che presenta 67 l’eguaglianza al margine fra benefici e costi dell’inclusione nell’area valutaria. Tuttavia, un processo di integrazione vede di solito coinvolti sistemi economici anche molto distanti fra loro, per livello tecnologico delle produzioni, istituzioni politiche ed economiche, meccanismi di aggiustamento macroeconomico. Le vicende storiche finiscono quindi per determinare entità statuali – o comunque unioni circoscritte ad uno o più ambiti, come l’Unione Economica e Monetaria europea – la cui estensione geografica spesso non è conforme a quella che sarebbe stata determinata dai criteri di ottimalità economica. Per decidere la propria adesione all’unione monetaria europea, i governi hanno dovuto valutare se le politiche economiche che erano chiamati a realizzare avrebbero consentito di soddisfare il “vincolo di partecipazione”, ovvero la condizione che per il paese la differenza attesa fra benefici e costi fosse positiva. D’altro canto, le interdipendenze economiche sono pervasive: un paese caratterizzato da forte instabilità macroeconomica può infatti rappresentare un’esternalità negativa per tutti i membri dell’area valutaria. La formazione dell’area valutaria si è quindi configurata come un gioco strategico in condizione di incertezza, dove il calcolo del “vincolo di partecipazione” di un paese dipendeva da quello di tutti gli altri ipotetici membri dell’area valutaria. Lo SME, il Trattato di Maastricht, il PSC, e la più generale cornice istituzionale hanno permesso il raggiungimento del “miglioramento paretiano” di una minore instabilità macroeconomica, dopo i decenni di alta inflazione e disoccupazione. Ciascun governo ha dovuto accettare un trade-off intertemporale: intraprendere politiche macroeconomiche dirette a creare nel breve periodo la disinflazione ed il riequilibrio delle finanze pubbliche, nell’aspettativa di ricevere un “dividendo” dall’incremento di benessere comune che si sarebbe realizzato nel medio-lungo termine. In effetti, anche il progetto dell’area valutaria europea è stato avviato nell’aspettativa che ne sarebbe sortito un incremento del benessere comune. Non esisteva, d’altro canto, alcuna garanzia che dal passaggio ad una moneta comune sarebbe scaturito un “miglioramento paretiano”, ovvero che dal valore positivo della somma algebrica dei guadagni e delle perdite attesi per l’area 68 valutaria nel suo complesso sarebbe conseguito un valore positivo anche per ciascuno dei paesi che ne avrebbero fatto parte. L’opinione prevalente è che al suo nascere l’UME non rappresentasse un’area valutaria “ottima”. La relativa facilità con cui i paesi dell’UME hanno ciò nonostante raggiunto l’accordo sulla composizione dell’area valutaria è così sintetizzabile. L’incertezza sul futuro rende il “velo di ignoranza” sui guadagni e sulle perdite che si realizzeranno nel corso degli anni sufficientemente spesso da impedire una precisa valutazione sulla loro distribuzione fra i singoli paesi. La Germania ed i paesi dell’ “area del marco” osteggiarono a lungo la nascita dell’UME a dodici paesi, nel timore che la somma algebrica fra benefici e costi potesse risultare collettivamente negativa nel caso fossero stati ammessi i paesi mediterranei. La Germania, di fronte alla spinta politica per una unione monetaria che non discriminasse i paesi del Sud Europa, non volle opporre considerazioni relative al proprio puro tornaconto economico; tuttavia, il governo tedesco impose condizioni molto precise: uno Statuto della Banca Centrale Europea (BCE) che ricalcasse quello della Bundesbank (e la sede non a caso venne fissata a Francoforte, non a Bruxelles) e un accordo che impedisse politiche fiscali espansive tali da mettere a rischio la credibilità della nuova valuta. Inoltre, la scelta di aderire si svolgeva in condizioni di incertezza: negli anni che precedettero la decisione, infatti, fu evidente che esisteva uno spesso “velo di ignoranza” su costi e benefici che si sarebbero realizzati in ciascuno dei paesi aderenti. Alla fine, la ragionevole aspettativa che il varo di una moneta unica - andandosi ad affiancare al mercato unico - avrebbe permesso un sostanzioso allargamento della “torta” (ovvero, un poderoso incremento del PIL), fece sì che la scelta politica di una “grande UME” finisse per prevalere sui dubbi suggeriti dalla teoria economica. 2. Ottimalità di un’area valutaria I costi dell’adozione di una valuta comune si connettono innanzitutto alla perdita dell’opzione alternativa della flessibilità del cambio nominale: tanto maggiore è la probabilità per un paese di subire uno shock asimmetrico, tanto maggiore è il costo del passaggio alla valuta comune (il costo-opportunità di non potere utilizzare il tasso 69 di cambio della propria valuta come strumento di politica economica). L’aspettativa di benefici eccedenti i costi si fonda sull’idea che all’integrazione commerciale conseguirà una maggiore simmetria negli shock. Con la riduzione dell’eterogeneità dei cicli economici nazionali, ovvero della diversità fra paesi riguardo al periodo in cui hanno luogo gli shock o all’ampiezza dello scostamento di inflazione e output dai valori di equilibrio, dovrebbe declinare nel tempo l’antinomia fra l’uniformità dell’esposizione alla politica monetaria comune e l’eterogeneità delle condizioni macroeconomiche dei singoli paesi. In primo luogo, la liberalizzazione dei movimenti di capitale - nel rendere possibili rapidi spostamenti di attività finanziarie da un mercato all’altro di dimensioni tali da influenzare in modo significativo i tassi di cambio - ha vanificato il ruolo di stabilizzazione della politica valutaria. In secondo luogo, la moderna teoria macroeconomica, nell’attribuire importanza prioritaria alla stabilità monetaria, ha ridimensionato l’importanza di possedere una propria valuta. Un’economia che presenta una divergenza reale (una minore dotazione o produttività delle risorse) rispetto alle economie più “forti” con le quali è in competizione sui mercati, non deve porvi rimedio con politiche macroeconomiche “non annunciate” che inneschino un’inflazione “a sorpresa” e la conseguente svalutazione del cambio. Politiche monetarie e fiscali incoerenti con i valori-obiettivo di inflazione ed output hanno la sola conseguenza di aggiungere alla divergenza reale la divergenza nominale (il tasso di inflazione). Alla strategia di breve periodo di sostenere le esportazioni attraverso la flessibilità del tasso di cambio andrebbe preferito il commitment di evitare la tentazione dell’aggiustamento nominale “legandosi all’albero maestro”. Nel caso dei paesi dell’UME, l’albero maestro è l’euro. L’adozione di una valuta comune sancisce l’impegno a non farsi “guerre commerciali”e ad adottare le politiche più appropriate per migliorare i “fondamentali” dell’economia. D’altronde, i costi di uscita dalla valuta comune sarebbero elevatissimi: gli alti tassi di interesse che graverebbero su attività finanziarie nuovamente denominate nella valuta nazionale, la fiducia nella quale si è però azzerata con il passaggio all’euro. Nella prospettiva teorica 70 dell’impulso che l’euro dovrebbe dare alla formazione di un unico ciclo economico europeo è stata avanzata la tesi che un’insieme di paesi non debba necessariamente possedere ex ante la caratteristica di essere un’area valutaria “ottima” per decidere l’introduzione di una valuta comune. Il crisma dell’ottimalità sarebbe stato acquisito dall’UME ex post (Frankel e Rose, 1998; Rose, 2000). Alcuni benefici, relativi alle funzioni di unità di conto e mezzo di scambio della moneta, sono invero immediati. Ad esempio, la maggiore trasparenza dei segnali di mercato, conquistata con l’uniformità valutaria del prezzo dei beni in tutti i mercati dell’eurozona è un impulso alla concorrenza. Benefici immediati non secondari sono anche l’azzeramento dei costi di transazione legati al cambio da una valuta all’altra (le commissioni bancarie) e, più in generale, la maggiore efficienza nei servizi di liquidità. I più importanti benefici saranno però appropriabili e verificabili solo nel medio-lungo periodo, in seguito all’impulso all’integrazione commerciale ed ai vantaggi che potrebbero discendere da un più rilevante ruolo dell’euro come mezzo di pagamento internazionale. La fine della volatilità del tasso di cambio nominale sembra avere esercitato nell’eurozona un forte impulso all’incremento delle imprese esportatrici: le prime analisi quantitative sull’impatto dell’introduzione dell’euro sul commercio intraUME stimano un incremento del loro numero compreso fra il 5% ed il 10% (Baldwin, 2006). Con l’annullamento del rischio di cambio, le aspettative sulla domanda futura nei mercati dell’UME risultano meno aleatorie. Un rilevante beneficio per il finanziamento degli investimenti proviene dall’abbassamento del tasso di interesse seguito all’annullamento del “premio per il rischio” di tasso di cambio. Ci si attendeva anche che la valuta comune riducesse notevolmente il rischio sistemico sulle decisioni di investimento, producendo così un effetto propulsivo sulla crescita economica. 71 ____________________________________________________________________ Teoria delle aree valutarie ottimali Quanto più un paese è soggetto a shock asimmetrici (bassa simmetria), tanto più è necessario che sia alta l’integrazione fra i mercati per compensare l’eccesso del costo della rinuncia alla valuta nazionale rispetto ai benefici della valuta unica. HighSymmetry= Low asymmetric costs OCA-zone OCA High integration = low specialization ____________________________________________________________________ Va però aggiunto che la riduzione del costo del danaro non è un beneficio irreversibile. Benché i vincoli del PSC non concernano direttamente il debito pubblico, tutti i paesi dell’eurozona con uno stock di debito pubblico superiore al 60% del PIL continuano ad essere soggetti all’impegno di provvedere al ritiro del quantitativo eccedente il limite. Né i mercati finanziari internazionali paiono disposti ad accettare che i governi nazionali confidino sull’euro quale perenne garanzia della propria solvibilità fiscale per dilazionare l’abbattimento del debito pubblico. La violazione del limite del 3% per il rapporto deficit / PIL ed un livello troppo elevato del rapporto debito pubblico / PIL, possono in ogni momento indurre gli operatori finanziari a chiedere un “premio per il rischio“ di default, innalzando il tasso di interesse sul debito pubblico di uno o più paesi dell’UME. Nella figura sulla teoria delle “aree valutarie ottimali” della pagina precedente, sull’asse verticale compare il grado di simmetria di un paese con il resto dell’area 72 valutaria e sull’asse orizzontale compare il grado di integrazione economica dell’insieme dei paesi dell’area valutaria: tanto più elevato è il valore del grado di simmetria per tutti i paesi e tanto più elevata l’integrazione economica, tanto più probabile è l’ottimalità dell’area valutaria.. Ad alti (bassi) livelli delle due variabili, i paesi si collocano al di sopra (sotto) della linea OCA, costituita da punti per i quali costi e benefici dell’adozione di una valuta comune si eguagliano. Per una data (intermedia) probabilità di essere colpito da uno shock asimmetrico, tanto più alta è l’integrazione (e quindi bassa la specializzazione produttiva), tanto più è probabile che i benefici del passaggio ad una valuta comune superino i costi. Così pure, per un dato (intermedio) grado di integrazione (specializzazione produttiva), tanto più bassa è l’esposizione ad uno shock asimmetrico tanto più è probabile che i benefici del passaggio ad una valuta comune superino i costi. Il grado di simmetria di ciascun paese è l’inverso del suo livello di esposizione ad uno shock simmetrico che colpisca l’area valutaria (alternativamente, si può parlare di esposizione ad uno shock asimmetrico consistente nel propagarsi, con una diversa ampiezza in ciascun paese, di uno shock simmetrico che colpisca uniformemente tutta l’area valutaria). Esempi di shock asimmetrico sono: una dinamica del CLUP di un paese particolarmente veloce; un tasso di inflazione più elevato che nel resto dell’area valutaria a causa dell’effetto Balassa-Samuelson. Tanto minore è il grado di esposizione di un paese ad uno shock asimmetrico (ci si muove verso il basso sull’asse verticale, dove è misurata la simmetria del paese con il resto dell’area), tanto minore l’importanza per il paese dello strumento della variazione del tasso di cambio, e cioè il costo della rinuncia alla propria valuta. Nel grafico, appare evidente che tanto più alto è il valore della “simmetria” sull’asse verticale (tanto minore cioè è l’esposizione del paese a un shock asimmetrico), tanto minore il grado di integrazione economica (sull’asse orizzontale) necessario affinché il paese si collochi al di sopra della retta che divide l’area OCA da quella NON-OCA. Ma cosa esattamente si intende per “integrazione economica”? E perché un alto grado di integrazione può compensare un basso “grado di simmetria” di alcuni paesi e 73 portare l’insieme dei paesi nella zona del grafico al di sopra della retta di separazione fra area OCA e area non-OCA? Molto in breve, vi sono due spiegazioni delle cause e degli effetti di un’alta integrazione dei mercati: 1. un alto grado di integrazione intesa come differenziazione produttiva di un’economia riduce l’importanza del tasso di cambio come strumento di politica economica, perché se uno shock negativo (un calo della domanda estera) colpisce uno o più settori, ci sarà una buona probabilità che una fase espansiva in altri settori possa fungere da compensazione ed evitare la caduta del PIL, senza che occorra spingere le esportazioni mettendo in atto una svalutazione del tasso di cambio (Kenen fu il primo economista a proporre questa visione); 2. un elevato grado di integrazione intesa come forte apertura agli scambi internazionali fa sì che il tasso di cambio come strumento di politica economica sia poco utile, in quanto i vantaggi in termini di maggiori esportazioni sarebbero compensati dagli svantaggi dovuti al maggior costo delle importazioni (McKinnon fu il primo economista a proporre questa visione). Il grado di integrazione economica dell’area valutaria rappresenta dunque un antidoto all’esposizione di un paese ad uno shock asimmetrico: tanto maggiori sono l’integrazione e l’apertura dei mercati, tanto maggiore è la loro capacità di assorbire rapidamente uno shock negativo attraverso la flessibilità di salari e prezzi. Il successo di un processo di integrazione economica può essere infatti valutato in base all’incremento conseguito nell’elasticità del salario all’occupazione (all’aumentare della disoccupazione si riduce la resistenza dei lavoratori alla riduzione del salario reale) e nella flessibilità dei prezzi necessaria a ripristinare la competitività nei mercati dei beni e dei servizi. Come si è accennato, un aspetto importante dell’integrazione dei mercati è rappresentato dal livello del commercio intra-settoriale, favorito dal diffondersi dei 74 mercati di concorrenza monopolistica. Nell’essere al contempo esportatori ed importatori di beni pressoché uguali, i paesi entrano in una competizione di prezzo sempre più serrata. E’ facile comprendere che la concorrenza fra paesi diversi come offerenti e domandanti negli stessi settori è un potente fattore di unificazione dei mercati che porta all’omogeneizzazione fra i paesi dei livelli dei salari e dei prezzi. Tanto maggiore è il commercio intra-settoriale, tanto più integrati sono i mercati dei paesi dell’area valutaria e tanto più – successivamente ad uno shock asimmetrico che colpisca un paese – la tempestiva discesa di salari e prezzi, ovvero la deflazione interna, rende irrilevante la perdita dello strumento della svalutazione del cambio. Ci si può chiedere: ma non esiste un’alternativa alla necessità di abbattere con una “svalutazione reale” i costi di produzione (per aumentare la competitività e quindi accrescere le esportazioni), invece che ottenere lo stesso effetto attraverso la politica del tasso di cambio, ovvero la svalutazione nominale cui si è accettato di non ricorrere più, nel momento in cui si è rinunciato ad una propria valuta? La risposta è positiva; anzi di alternative ce ne sono addirittura due. La prima è la mobilità del fattore lavoro: negli Stati Uniti, dove è elevata, il superamento di una crisi di competitività di uno Stato, prima ancora che con la discesa di salari e prezzi, viene facilitato dal fatto che un’alta mobilità del lavoro permette un rapido ripristino di un CLUP che consente alle imprese di reggere la competizione internazionale. L’economista canadese e Premio Nobel, Robert Mundell, ha sostenuto che, se la mobilità del lavoro è alta, il passaggio ad una moneta unica non crea problemi: una crisi economica non determinerà infatti un incremento della disoccupazione, per il semplice motivo che la parte più debole della forza lavoro preferisce l’emigrazione in un altro Stato ad un salario più basso oppure all’aspettativa di licenziamento. Com’è noto, non è questo il caso dell’Europa, dove l’emigrazione fra gli Stati dell’UME è piuttosto bassa, a causa soprattutto di ragioni linguistiche e culturali. La seconda alternativa è la costruzione di un’unione fiscale che si affianchi all’unione monetaria. In alternativa all’aggiustamento di mercato consistente nella discesa di salari e prezzi dopo uno shock negativo (la deflazione interna, o “svalutazione 75 reale”), e in assenza di alta mobilità del fattore lavoro, l’ottimalità di un’area valutaria può essere garantita da un bilancio pubblico comune finanziato da una tassa elevata in ciascun paese dell’Eurozona. La centralizzazione della politica monetaria, nell’imporre politiche fiscali nazionali restrittive dirette a difendere la credibilità della moneta comune, indebolisce i flussi di redistribuzione del reddito derivanti dall’operare della politica fiscale nazionale all’interno dei paesi. L’unione fiscale, ovvero la creazione di un vero e proprio bilancio pubblico sovra-nazionale – il passaggio al federalismo fiscale, con tasse e voci di spesa comuni - permetterebbe di assorbire l’impatto degli shock asimmetrici trasferendo risorse dalle economie a più alto tasso di crescita del PIL rispetto alla media dell’area (di norma, quelle meno esposte a shock asimmetrici) alle economie a più basso tasso di crescita del PIL rispetto alla media dell’area (di norma, quelle più esposte a shock asimmetrici). Tuttavia, le istituzioni dell’Unione Europea, in primo luogo la Commissione ed il Parlamento, non si sono finora poste con convinzione l’obiettivo di centralizzare i bilanci pubblici nazionali. In primo luogo, un’unione fiscale – ovvero un budget ampio in luogo dell’attuale magro bilancio (poco più dell’1% del PIL europeo) destinato prevalentemente alla politica agricola comune e ai fondi di coesione – non incontra il favore né dei governi dei paesi più forti dell’UME, né della Commissione europea. I conflitti di interessi fra i governi nazionali hanno rallentato l’“integrazione positiva”, ovvero politiche comuni tali da portare non solo all’effettiva realizzazione delle “quattro libertà” (la libera circolazione fra i paesi di lavoro, capitali, beni e servizi, la cui piena attuazione è ancora parte impedito dalle legislazioni nazionali), ma anche al federalismo fiscale. L’Europa ha infatti proceduto sulla strada dell’“integrazione negativa” – in breve, l’abbattimento delle barriere doganali e delle altre normative protezionistiche (Scharpf, 2002) – senza prevedere la costruzione di istituzioni comuni in grado di attuare politiche fiscali aventi come obiettivo i suoi tre classici obiettivi: 1. la stabilizzazione macroeconomica (ovvero, come sopra 76 accennato, l’attuazione di una politica anti-ciclica comune in casi di recessione, che sostenga il reddito dei paesi colpiti da una variazione del PIL inferiore rispetto al tasso di crescita medio del PIL dell’UME); 2. la redistribuzione del reddito (le varie voci della protezione sociale di norma operano trasferimenti netti di reddito a favore dei soggetti “svantaggiati”; 3. la funzione di allocazione delle risorse, ovvero la produzione di beni pubblici. La mancata centralizzazione della politica fiscale ha anche avuto l’effetto di permettere a singoli paesi di usare la propria politica fiscale per difendere la propria competitività attraverso la bassa tassazione. La competizione fiscale replica il coordinamento spontaneamente realizzato dal mercato. Fintantoché la Commissione europea di Bruxelles non persegue una policy di armonizzazione fiscale, ed il coordinamento fiscale spontaneo fra i governi dell’area valutaria non decolla, le aliquote della tassazione di beni e capitali vengono naturalmente determinati dalle forze di mercato. Prendiamo l’esempio della tassazione del capitale. I governi nazionali si trovano di fronte a due incentivi in conflitto: 1) all’interno di un’area valutaria si determina una interazione strategica in cui ciascun paese tenta di fissare un saggio di tassazione sul capitale più basso di quello degli altri paesi membri, per assicurarsi un vantaggio decisivo nella competizione per gli FDI; 2) fissare un alto saggio di tassazione per sottoporre ad un forte prelievo fiscale i proprietari esteri di imprese localizzate nel proprio paese. A prevalere è la strategia di attrarre investimenti dall’estero attraverso un livello di tassazione tanto più ridotto quanto più mobile è il fattore capitale. La prova che sia questa la strategia dominante è rappresentata dalla chiara tendenza di tutti i paesi – costretti a mettere in pareggio il bilancio pubblico senza aumentare la pressione fiscale complessiva - a trasferire il peso maggiore della raccolta fiscale dal fattore capitale al fattore lavoro. Integrazione finanziaria e risk sharing I sistemi di protezione sociale, a cominciare dalla difesa del tenore di vita attraverso i sussidi di disoccupazione, una volta che una crisi economica abbia creato 77 disoccupazione, sono di norma organizzati dal settore pubblico. Nell’unione monetaria potrebbero tuttavia maturare le condizioni per una condivisione fra gli individui - invece che fra gli Stati - del rischio delle fluttuazioni nel livello del reddito. Per chiarire tale ipotesi di un autonomo ruolo dell’individuo nell’assicurazione dei rischi occorre fare un passo indietro. Robert Mundell, nel 1961, escluse la formazione di un’area valutaria in Europa, poiché non avrebbe potuto risultare “ottima” per un insieme di paesi caratterizzati da un’alta frequenza di shock asimmetrici, essendo troppo basse sia la reattività dei salari alla disoccupazione che la mobilità del lavoro. In un lavoro del 1973, comunemente definito “Mundell II”, l’economista canadese ha però rivisto la sua posizione. Fra i mutamenti strutturali che hanno indotto Mundell a cambiare opinione, il principale è la liberalizzazione dei movimenti dei capitali. La globalizzazione finanziaria ha accresciuto il peso degli operatori dei mercati dei capitali nella determinazione della parità relative fra le valute, e si è parallelamente ridotto il potere di regolazione dei cambi fino ad un trentennio fa saldamente detenuto dalle autorità monetarie nazionali. È conseguentemente diminuita l’efficacia della svalutazione come strumento di superamento delle fasi recessive; il costo della rinuncia ad una propria moneta ne è uscito ridimensionato. Un corollario di questa revisione teorica è l’esternalità positiva di cui gode un soggetto che risieda in un’ampia area valutaria, nel momento in cui cerca di assicurarsi contro il rischio macroeconomico. L’adozione di una valuta comune annulla per definizione il rischio di cambio fra i paesi dell’area valutaria e quindi favorisce la diversificazione verso i titoli esteri. Può la gestione di un portafoglio di titoli dei mercati finanziari dell’intera area valutaria - da parte di una massa critica di risparmiatori residenti nei vari paesi dell’area - rappresentare uno schema efficace di assicurazione? Robert Mundell, e molti altri economisti, rispondono positivamente. In assenza del rischio di cambio, l’investitore dell’area valutaria godrà dei vantaggi offerti dal processo di integrazione economica, a cominciare dall’opportunità di investire in azioni denominate in un’unica valuta ed emesse da un sistema di imprese 78 che beneficia dell’apertura dei mercati ad un crescente interscambio commerciale. La decisione dei risparmiatori di ciascun paese di impiegare una quota crescente del proprio risparmio in un portafoglio diversificato di attività finanziarie degli altri paesi dell’area si configura di fatto come uno strumento di livellamento nel tempo di reddito e consumo. Qualora infatti uno shock macroeconomico colpisca il proprio paese ed il flusso di reddito individuale si riduca (riduzione dell’orario nel caso di lavoro dipendente, del giro d’affari nel caso di lavoro autonomo) o si interrompa (perdita del lavoro o chiusura dell’attività), i risparmiatori che hanno diversificato constateranno che il proprio livello di consumo intertemporale è in una certa misura protetto dagli effetti dello shock negativo. Il comportamento razionale del risparmiatore, ovvero l’ottimizzazione di portafoglio consistente nell’aggiustamento delle quote relative delle attività finanziarie in funzione dei rispettivi rendimenti attesi, di fatto svolge una funzione assicurativa del rischio macroeconomico. In presenza di cicli economici non sincroni fra i paesi dell’UE, la discesa del reddito da lavoro dipendente o autonomo percepito nel proprio paese dovrebbe trovare compensazione nell’incremento dei redditi finanziari conseguenti al ciclo economico favorevole attraversato da altre economie dell’area valutaria. Quanto maggiore è la diversificazione di portafoglio da parte del lavoratore-risparmiatore, tanto più i titoli (azioni o obbligazioni) emessi dalle imprese dei paesi in espansione – che conseguentemente conoscono alti profitti e perciò guadagni nelle quotazioni di borsa - possono garantire lo “smussamento” delle fluttuazioni del reddito negative causate dai titoli dei paesi a bassa crescita. In un’unione monetaria, all’aggiustamento di mercato ed alle politiche macroeconomiche di stabilizzazione andrebbe dunque ad aggiungersi la funzione assicurativa che i soggetti privati possono affidare ai mercati finanziari. Questa ottimistica tesi tende a sottovalutare che soltanto in un sistema di mercati dei capitali perfetti si potrebbe guardare ai titoli come a delle polizze dalle quali ci si attende un flusso di reddito in caso di futuri eventi negativi. L’efficacia della diversificazione di portafoglio come strumento di assicurazione dei 79 risparmiatori contro il rischio di instabilità macroeconomica è direttamente proporzionale al grado di concorrenzialità e di trasparenza che il processo di integrazione finanziaria europea riuscirà a trasmettere ai mercati. Tanto più efficiente diverrà il funzionamento dei mercati integrati dei capitali europei, tanto maggiori saranno la profondità finanziaria e le potenzialità di diversificazione dell’investimento, e quindi tanto maggiori saranno le opportunità di fare svolgere a tali mercati la funzione di risk-sharing fra i risparmiatori europei. I mercati dei capitali europei sono ancora lontani dall’avere raggiunto una capacità di assicurazione tale da permettere un effettivo livellamento intertemporale del reddito individuale. Il test di Feldstein e Horioka (1980) misura l’integrazione dei mercati finanziari mediante un coefficiente che esprime il grado di correlazione fra formazione di risparmio e volume degli investimenti: un basso valore di tale coefficiente – nell’indicare una scarsa dipendenza del finanziamento dell’investimento dal risparmio nazionale – segnala al contempo che i risparmiatori del paese tendono a formare un portafoglio di attività finanziarie molto diversificato verso le attività trattate nei mercati finanziari esteri. L’ottimo risk-sharing si realizza allorché in un paese la crescita del consumo si presenta perfettamente correlata (valore uguale ad 1) con la crescita media del PIL e del consumo dell’area valutaria di appartenenza. I dati statistici dicono che si è avuto, nell’ultimo quarantennio, un forte incremento dell’integrazione fra i mercati finanziari e che è notevolmente aumentata la propensione dei risparmiatori verso i titoli degli altri paesi membri dell’UE nella composizione dei portafogli: a fine anni ’90, il coefficiente di Feldstein – Horioka per l’UE-15 è sceso dall’iniziale 80% al 18% (similmente, il coefficiente è diminuito dal 91% al 20% per USA, Canada, Giappone, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda). Tale cifra è ancora molto inferiore rispetto al valore pari ad uno della correlazione del PIL e del consumo nazionali dei singoli paesi con i valori medi UME che rappresenta la pre-condizione affinché i mercati finanziari possano svolgere una funzione assicurativa. La presenza di una significativa “distorsione paese” (home bias) nella 80 diversificazione dei portafogli finanziari del risparmiatori europei è un indicatore indiretto di un’insufficiente capacità assicurativa dei diversi mercati finanziari europei, che deriva in primo luogo dalla lentezza del processo di armonizzazione delle normative nazionali. In effetti, il coefficiente di correlazione fra risparmio nazionale ed investimento nei paesi dell’UME era significativamente diminuito nei primi anni della moneta unica, in particolare dal 2004 al 2007. La crisi finanziaria e la successiva Grande Recessione hanno provocato tuttavia un brusco arretramento nella integrazione finanziaria stimolata dall’introduzione dell’euro. I capitali delle banche e delle istituzioni finanziarie del Centro, che erano stati investiti in attività finanziarie dei settori pubblico e privato della Periferia per godere del differenziale di tasso di interesse (seppur limitato, data la fine del premio per il rischio sulla valuta) sono stati disinvestiti e rivolti a più sicuri investimenti in patria. 3. Dal Sistema Monetario Europeo all’Unione Monetaria Europea Uno dei motivi per i quali un gruppo di paesi ha raramente dato vita ad un’unione monetaria senza avere in precedenza realizzato un’unione politica è la fiducia che deve accompagnare la nuova valuta una volta introdotta nei mercati. Una moneta circola fra i cittadini di una entità statuale in quanto è unanime la fiducia che il segno monetario verrà accettato come mezzo di estinzione dei debiti. Naturalmente, il crisma della sovranità monetaria non viene acquisito da una valuta nel momento in cui un atto giuridico ne dichiara l’entrata in circolazione. I problemi di credibilità che la lira incontrò nei mercati finanziari europei nei primi due decenni del Regno d’Italia, al punto da rendere necessaria l’introduzione del corso forzoso, indicano che la reputazione viene conquistata nel corso di un lungo processo di costruzione della fiducia. Con la costituzione dell’UME si è creata una valuta che non porta sui biglietti e sulle monete il sigillo di un potere statuale, ma sarebbe sbagliato pensare che l’euro sia nato per una sorta di supremazia acquisita dall’economia sulla politica. Anche nel 81 caso di questa “moneta senza stato”, le motivazioni politiche si sono infatti fortemente intrecciate con le motivazioni di efficienza economica, e spesso hanno fatto aggio su queste ultime. L’aspirazione all’unificazione monetaria è una costante della storia europea da quasi due secoli. Sebbene abbia avuto realizzazione soltanto a cavallo del millennio, essa trovò espressione già nel XIX secolo. La formazione dello stato unitario in Italia (1861) ed in Germania (1871) generò due unioni monetarie. In quegli stessi anni videro la luce anche due accordi valutari. Il primo fu l’Unione Monetaria Latina, l’accordo del 1865 (che durò, fra alterne vicende, fino al 1926) fra Belgio, Francia, Italia e Svizzera, con l’adesione della Grecia nel 1868 e poi anche di altri paesi, consistente nell’emissione di monete di oro e di argento con eguale contenuto. Il secondo fu l’Unione Monetaria Scandinava, creata nel 1872 da Danimarca, Norvegia e Svezia e imperniata sulla doppia circolazione della moneta nazionale e di una moneta comune, nell’ambito del sistema del gold standard e dissolta con la prima guerra mondiale. L’aspirazione all’unificazione monetaria ha ricevuto un nuovo impulso nel 1970, quando il Consiglio dei ministri della Comunità Europea diede l’incarico ad un comitato di esperti presieduto dal Primo ministro lussemburghese Pierre Werner di studiare la possibilità di dar vita all’unione monetaria. Il Rapporto Werner, fissava una serie di tappe per la realizzazione dell’unione monetaria, da portare a compimento entro il 1980. Fra la dissoluzione dell’ordine monetario di Bretton Woods e la crisi petrolifera del 1973-74, ebbe breve vita (dall’aprile 1972 al dicembre 1974) un accordo, conosciuto con il nome di “serpente valutario”, cui parteciparono Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo e, per periodi brevi, anche Italia, Francia e Regno Unito. I paesi aderenti si impegnavano al coordinamento fra i tassi di cambio con l’obiettivo di ridurre le esternalità negative che reciprocamente si determinavano fra i paesi europei a causa dell’autonoma fluttuazione delle loro valute rispetto al dollaro USA. L’accordo tuttavia fallì il suo obiettivo: tutto il peso della correzione necessaria a preservare la catena di parità fra i tassi di cambio avrebbe dovuto essere sostenuto dai paesi a valuta debole, senza che fossero previsti strumenti di 82 concessione di credito che permettessero loro di fronteggiare gli attacchi della speculazione internazionale. Nel marzo del 1979 per iniziativa del Cancelliere tedesco Helmut Schmidt e del Presidente francese Valery Giscard d’Estaing, i paesi della CEE sottoscrissero un accordo per l’introduzione di cambi fissi fra le rispettive valute. L’accordo valutario, al quale non aderì il Regno Unito, prese il nome di Sistema Monetario Europeo (SME). 4. L’assetto istituzionale del Sistema Monetario Europeo L’ambizioso obiettivo che i fondatori dello SME si posero nel 1979 era quello di instaurare in Europa la stabilità monetaria dopo le turbolenze degli anni precedenti. Di fronte alla forte instabilità macroeconomica che negli anni ’70 succedette a due decenni di crescita equilibrata, i paesi europei si erano trovati impreparati. Nel 197374, a seguito della guerra dello Yom Kippur, il prezzo del petrolio quadruplicò; un ulteriore forte incremento si ebbe poi nel 1979-80. La traslazione degli accresciuti costi sui prezzi dei beni non fu sempre completa, perché dipendeva dalla capacità delle imprese di mantenere rigido il mark-up. I rinnovi dei contratti salariali, e l’introduzione di meccanismi automatici di indicizzazione, alimentavano una spirale salari-prezzi. In molte economie europee, si registrò un forte incremento del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP). Alla crescita dei prezzi contribuiva una politica monetaria diretta ad “accomodare” la domanda di finanziamento sia del settore privato che del settore pubblico. I processi inflazionistici indebolivano le bilance commerciali e quindi anche i tassi di cambio delle valute dei paesi a più alta dinamica del CLUP. Poiché il meccanismo di inflazione-svalutazione consentiva di recuperare la perdita di competitività subita nei mercati esteri a causa dell’inflazione, i governi vedevano con favore che il cambio venisse lasciato libero deprezzarsi. Tuttavia, le politiche monetarie e fiscali espansive, comportando aspettative e tassi di inflazione in crescita, accentuavano il conflitto distributivo interno; e le svalutazioni competitive non riuscivano a garantire che brevi periodi di incremento delle esportazioni. Nel corso degli anni ’70, il sostegno assicurato alla domanda dalle esportazioni andò 83 declinando. Le difficoltà incontrate nell’affrontare in maniera non cooperativa l’instabilità macroeconomica convinse gli otto governi dei paesi aderenti allo SME ad un mutamento radicale di strategia. L’impegno a seguire una politica monetaria orientata alla difesa di cambi fissi significò “legarsi le mani” con un vincolo esterno (Putnam, 1988). L’adesione allo SME esprimeva la speranza che la bassa inflazione si sarebbe imposta a imprese e sindacati come il bene pubblico da cui tutti avrebbero tratto vantaggio (Giavazzi e Pagano, 1988). L’accordo prevedeva che i tassi di cambio fossero fissi ma aggiustabili. Nei primi anni di vita dello SME, quando una o più banche centrali dichiaravano di non riuscire a tenere fede all’impegno di difendere le loro parità con manovre restrittive, si fece spesso ricorso – durante i week-end, a mercati finanziari chiusi - al riallineamento delle parità centrali. Lo strumento tecnico consisteva nella modificazione delle parità bilaterali del cosiddetto meccanismo dei tassi di cambio (MTC). La duplice banda di oscillazione (verso l’alto e verso il basso) attorno alla parità centrale definiva l’intervallo di tolleranza entro il quale le banche centrali erano al riparo da attacchi speculativi alle rispettive valute. Fino al 1993 la banda fu del ±2,25%, ma margini più ampi (±6%) vennero concessi all’Italia (fino al passaggio alla banda stretta fra il gennaio 1990 ed il settembre 1992) e al Regno Unito durante la sua adesione fra il 1990 ed il 1992. L’assetto istituzionale dello SME è stato definito di tipo asimmetrico. Le politiche monetarie nazionali non venivano coordinate, in quanto si affermò progressivamente l’egemonia del marco tedesco. Vediamo allora le ragioni dell’asimmetria di politica monetaria. Alla nascita dello SME, i divari fra i tassi di inflazione superavano a volte i 10 punti percentuali. Questi divari posero gravi problemi alle banche centrali. Benché il cambio della valuta tendesse ad indebolirsi, esse non potevano deflazionare le proprie economie mediante un’improvvisa “gelata” di liquidità: la cura avrebbe avuto probabilmente l’effetto di uccidere il malato. Supponiamo che in un paese ad alta inflazione, ad esempio l’Italia, un peggioramento della bilancia dei pagamenti con la 84 Germania provochi la riduzione dell’offerta di moneta. È quanto accadde nella prima metà degli anni ’80 quando l’economia italiana subì una perdita di competitività, che causò un saldo commerciale di segno negativo. Un’economia con una dinamica dei costi di produzione più rapida di quella dei principali concorrenti europei incontra difficoltà a frenare la perdita di competitività. Un riallineamento delle parità bilaterali della lira poteva essere solo ritardato dallo strumento amministrativo del controllo dei movimenti dei capitali e dagli interventi di vendita di marchi nei mercati valutari. Per ridurre la frequenza delle richieste di riallineamento, fu creata l’unità di conto europea (European Currency Unit: ECU), una valuta fittizia consistente nel paniere delle valute, ciascuna pesata per il PIL del proprio paese sul PIL totale. In caso di tensioni sui cambi, l’ECU avrebbe dovuto segnalare tempestivamente se, all’interno della banda bilaterale di oscillazione, andasse considerata responsabile del raggiungimento del margine massimo di deprezzamento la valuta a rischio di svalutazione o invece la valuta in apprezzamento. Pertanto, l’ECU avrebbe dovuto fungere da indicatore di divergenza, segnalando alla banca centrale della valuta “deviante” la necessità di porre un deciso ed immediato freno alla crescita monetaria. L’ECU non venne di fatto mai utilizzato allo scopo di individuare la valuta “deviante”. Lo SME divenne presto un sistema di cambi fissi nel quale le condizioni di liquidità all’interno dell’area non venivano determinate su base cooperativa dalle banche centrali ma piuttosto in modo egemonico dalla Bundesbank. Non è difficile comprendere le ragioni che portarono a questo assetto asimmetrico dello SME. In un sistema di cambi fissi fra n paesi occorre stabilire solo n-1 parità bilaterali. Se le parità bilaterali fossero state determinate come il valore di ciascuna valuta rispetto all’ECU, si sarebbe dato vita ad uno SME “cooperativo”. In assenza di un credibile meccanismo di coordinamento, le n-1 parità bilaterali finiscono per essere vincolate al tasso di cambio determinato dalla politica monetaria della banca centrale che si guadagna il privilegio di essere considerata quella che emette l’n-sima valuta. In un accordo finalizzato al ripristino della stabilità monetaria, la Bundesbank emerse come la banca centrale che mostrava maggior determinazione a seguire una rigorosa 85 strategia anti-inflazionistica, ed al contempo apparteneva al paese dotato della struttura produttiva più forte e con estese ramificazioni nel sistema finanziario europeo (l’area finanziaria formata da Germania, Danimarca e Benelux si presentava molto integrata già all’avvio dello SME). Le parità bilaterali del MTC furono concepite come rapporto di ciascuna delle n-1 valute rispetto ad una n-esima valuta. Alla Bundesbank fu di fatto riconosciuta la posizione di n-esima banca centrale. Di conseguenza, il marco tedesco conquistò il ruolo di àncora nominale del MTC e la Bundesbank poté godere del privilegio consistente nella libertà di determinare un obiettivo quantitativo di crescita monetaria tarato sulle condizioni macroeconomiche della sola Germania, piuttosto che su quelle dell’intera zona valutaria a cambi fissi. Nei paesi ad “alta” inflazione, la svolta restrittiva di politica monetaria imposta dalla partecipazione allo SME limitò l’autonomia delle banche centrali nell’accomodare gli incrementi dei costi di produzione attraverso l’aggiustamento delle grandezze nominali. Tuttavia permaneva il problema della divergenza reale, ovvero una dinamica del CLUP tale da mettere a repentaglio la competitività sui mercati esteri e spingere il deprezzamento della valuta fino al limite superiore della banda di oscillazione. Tutti i paesi partecipanti al MTC – ad eccezione della Germania - dovettero ricorrere a numerosi aggiustamenti delle parità di cambio nel periodo 1979-86. I riallineamenti fra le valute non compensavano in tutta la loro ampiezza i differenziali inflazionistici. La logica dei cambi dello SME era quella di essere fissi ma aggiustabili. Tale grado di flessibilità andava però interpretato in modo che non venissero vanificati né l’impegno alla difesa dei cambi né l’incentivo a perseguire l’obiettivo della disinflazione. Pertanto, fra i governatori delle banche centrali si affermò la convenzione per cui la percentuale di aggiustamento delle parità bilaterali da concedere alle valute in difficoltà non dovesse coprire l’intero differenziale di tasso di inflazione di quei paesi con l’ECU. Una prima prova del fatto che il funzionamento dello SME andò progressivamente imperniandosi sulla posizione dominante della Germania è la 86 politica di pegging col marco tedesco. Attraverso la strategia di legare la propria creazione di base monetaria alla crescita monetaria stabilita dalla Bundesbank, le altre banche centrali hanno cercato di “importare” la strategia anti-inflazionistica seguita dalla banca centrale tedesca. Con la politica di pegging, i governatori delle banche centrali degli altri paesi dello SME si prefiggevano l’obiettivo di acquisire – attraverso una maggiore credibilità dell’orientamento anti-inflazionistico della politica monetaria – la fiducia nella serietà dell’impegno a difendere i cambi fissi. Seguire tale regola di crescita monetaria rendeva quindi meno impervio il conseguimento dell’obiettivo della stabilità del cambio delle rispettive valute con il marco in presenza di ampi differenziali inflazionistici con la Germania. La Bundesbank ha potuto di fatto decidere la liquidità dell’intera area dello SME appunto perché le n-1 banche centrali degli altri paesi regolavano la propria politica monetaria sulla crescita monetaria del paese con l’n-esima banca centrale. Una seconda prova dell’assetto egemonico assunto dallo SME è il fatto che l’autonomia della Bundesbank nella determinazione della crescita del proprio aggregato monetario non ha sostanzialmente incontrato ostacoli (Farina, 1990). Le banche centrali impegnate a superare una fase di instabilità macroeconomica ed a difendere la propria valuta da attacchi speculativi effettuano di routine interventi nei mercati valutari impiegando le proprie riserve internazionali nel riacquisto della propria valuta. Per facilitare tali operazioni di mercato aperto, lo SME prevedeva la concessione di credito della durata di 3 mesi (very short-term financing facility) da prelevare da un fondo comune alimentato dai contributi di tutti i paesi partecipanti. Poiché questo strumento non era in grado di entrare in funzione tempestivamente, le banche centrali dello SME le cui valute attraversassero una fase di deprezzamento hanno spesso fatto ricorso a manovre di acquisto della propria valuta nel mercato – mediante la vendita di marchi detenuti nelle proprie riserve internazionali – al fine di sostenere il tasso di cambio all’interno della griglia delle parità bilaterali. Tali operazioni di mercato aperto contrastavano però con la politica monetaria della Bundesbank, orientata a stabilizzare le condizioni macroeconomiche della 87 Germania. Ogniqualvolta la banca centrale di un paese con una bilancia dei pagamenti in rosso (ed eventualmente sottoposta ad un attacco speculativo allo scopo di lucrare profitti puntando alla revisione della parità ufficiali nei mercati valutari) abbia operato un intervento di vendita di marchi per sostenere la propria valuta, la Bundesbank ha provveduto a ripristinare le condizioni monetarie preesistenti. Onde impedire l’incremento della quantità di marchi in circolazione provocato dalle vendite effettuate dalle banche centrali della valuta in difficoltà, la Bundesbank attuava una manovra di “sterilizzazione”: la distruzione, attraverso operazioni di mercato aperto di segno opposto, dell’eccesso di marchi rispetto alla circolazione fissata dal proprio obiettivo di crescita monetaria. Le autorità monetarie tedesche non hanno mai voluto tenere in conto l’eventualità che all’origine di una forte deviazione del marco dalla parità centrale - piuttosto che la debolezza di una o più valute dello SME - vi fosse la propria politica del cambio (ad esempio, una manovra diretta a contrastare una tendenza del marco a svalutarsi rispetto al dollaro). È stata questa una ragione non secondaria del mancato impiego dell’ECU come strumento di individuazione della valuta deviante. Con la strategia di volere stabilire in piena autonomia le complessive condizioni di liquidità dell’area dello SME, la Bundesbank ha inteso comunicare a banche centrali, governi e mercati che la Germania non era disposta a condividere con le banche centrali di altre valute il costo dell’aggiustamento di tensioni in cui fossero coinvolte le proprie parità bilaterali. 5. L’evoluzione del Sistema Monetario Europeo Esamineremo ora la performance macroeconomica delle varie economie partecipanti allo SME lungo i venti anni che vanno dalla sua costituzione (1979) al passaggio ai cambi irrevocabilmente fissi (1999), preludio all’introduzione dell’euro il 1 gennaio 2002. Ripartiamo i paesi in tre gruppi: 1) Centro, costituito dalla Germania, dai cosiddetti paesi dell’area del marco (Belgio, Olanda, Lussemburgo e Danimarca) e dalla Francia (che, dopo i primi anni di alta inflazione, nel 1989-91 raggiunse una stabilità monetaria pari a quella tedesca); 2) Periferia A, costituita da Italia, Spagna e 88 Regno Unito; 3) Periferia B, costituita da Irlanda, Portogallo e Grecia. Come è noto, Danimarca e Regno Unito non hanno poi partecipato al varo dell’Eurozona. Questa ripartizione, benché aggreghi paesi che hanno aderito allo SME in date differenti – tra i paesi della Periferia, soltanto Italia ed Irlanda hanno partecipato allo SME fin dall’inizio - mette in luce la loro diversa posizione riguardo ai due caratteri di fondo del cammino verso l’integrazione monetaria ed economica: 1) il processo di convergenza nominale, che è riflesso dalla distinzione fra Centro e Periferia, in quanto la Germania (e gli altri paesi della cosiddetta “zona del marco”) hanno mediamente presentato tassi di inflazione e di interesse nominale alquanto inferiori rispetto a quelli dei paesi periferici; 2) il processo di convergenza reale, che vede i paesi della Periferia A collocarsi a metà strada fra il Centro ed il gruppo di paesi della Periferia B che nel 1979 presentavano un ritardo in termini di reddito pro capite più elevato rispetto al Centro. Per i paesi che di volta in volta vi hanno aderito, lo SME ha rappresentato il sistema di incentivazione per la lotta all’inflazione. Il conseguimento della convergenza nominale era infatti la pre-condizione per affrontare il problema della convergenza reale. Le vicende dello SME si possono suddividere in tre periodi. Il primo periodo dello SME (1979-86) vide molte revisioni delle parità centrali. Il secondo periodo (1987-1993) fu caratterizzato dall’assenza di riallineamenti dei cambi fissi. Dopo la crisi dello SME del 1992-93, il margine di oscillazione fu allargato dal ±2,25% al ±15%. Consentire un deprezzamento di ben 15 punti rispetto alla parità centrale mette di fatto una valuta al riparo dal pericolo di attacchi: gli speculatori internazionali non sono in grado di mobilitare gli enormi quantitativi di capitale necessari a provocare una svalutazione. Durante il terzo periodo dello SME (1993-98), il meccanismo di imposizione della regola (enforcement) della stabilità monetaria, rappresentato dall’impegno delle banche centrali a difendere le parità fisse – pena la svalutazione e la conseguente perdita di credibilità della politica monetaria come principale strumento della lotta all’inflazione – era ormai privo di efficacia. L’enforcement della convergenza nominale passò così dallo SME ai “criteri di 89 Maastricht”. All’impegno a difendere le parità bilaterali del MTC si sostituì la “regola fissa” dei valori cui fare convergere tasso di inflazione, tasso di interesse, deficit pubblico e debito pubblico. A conclusione di questa ricostruzione dell’avvio del processo di unificazione monetaria in Europa, descriviamo sinteticamente l’evoluzione dello SME e l’andamento delle principali variabili coinvolte nella convergenza nominale. I molti riallineamenti che ebbero luogo nel corso della prima fase dello SME (1979-86) erano la conseguenza della debolezza della bilancia commerciale causata dagli ampi differenziali di tasso di inflazione. Se non avessero potuto beneficiare dello “scudo” dei controlli sui movimenti dei capitali, molti paesi dello SME non sarebbero stati in grado di partecipare al MTC al fianco di paesi con una più ridotta dinamica dei prezzi. Gli ampi differenziali di inflazione, dovuti al fatto che le dinamiche dei costi di produzione ed il grado di rigore di governatori e ministri del Tesoro differivano molto fra i vari paesi, rendevano poco credibili le parità bilaterali (Farina, 1993). Nonostante il controllo sui movimenti di capitali consentisse di allontanare nel tempo l’aggiustamento delle parità bilaterali, i riallineamenti dei tassi di cambio – soprattutto nei primi quattro anni - furono numerosi. L’intonazione restrittiva della politica monetaria non riusciva infatti a porre un freno alla spirale salari-prezzi alimentata da aspettative di inflazione al rialzo. Il conseguente basso grado di credibilità della politica monetaria spingeva gli operatori dei mercati finanziari a frequenti attacchi speculativi nei confronti delle valute che si avvicinavano al margine superiore della banda. Nella Tabella 1, sono riportate date ed ampiezza degli aggiustamenti nelle parità centrali espresse in rapporto al marco tedesco, conformemente alla strategia “egemonica” mediante la quale la Bundesbank finiva per regolare la quantità di moneta circolante in tutta l’area dello SME. Nonostante i riallineamenti, l’impegno delle banche centrali a realizzare la disinflazione non venne meno. L’adeguamento del cambio nominale alle divergenze fra le economie reali veniva di volta in volta attuato in una misura tale da annullare solo una percentuale mediamente compresa fra un mezzo e i due terzi del 90 differenziale di inflazione maturato da una svalutazione all’altra. Lo scopo era quello di rendere efficace la partecipazione allo SME “legandosi all’albero maestro”, secondo la nota metafora ispirata al comportamento di Ulisse di fronte alle sirene, e cioè tenere a freno la tentazione di risolvere le tensioni inflazionistiche sul piano dell’ “accomodamento” monetario. Tabella 1 – Riallineamenti delle parità bilaterali con il marco tedesco: 1973-1993 (Il trattino indica che la parità della valuta con il marco non ha subito variazioni nel riallineamento delle parità bilaterali) Francia Italia Olan Belgio Danimarc Irlanda Spagna Portogal Regno (*) da a (*) lo (*) Unito (**) 24/09/1979 -2,00 -2,00 -2,0 -2,00 -5,00 -2,00 30/11/1979 - - - - -5,00 - 23/03/1981 - -6,00 - - - - 05/10/1981 -8,50 -8,50 - -5,50 -5,50 -5,50 22/02/1982 - - - -8,50 -3,00 - 14/06/1982 -10,00 -7,00 - -4,25 -4,25 -4,25 21/03/1983 -8,00 -8,00 -2,0 -4,00 -3,00 -9,00 22/07/1985 - -8,00 - - - - 07/04/1986 -6,00 -3,00 - -2,00 -2,00 -3,00 04/08/1986 - - - - -8,00 12/01/1987 -3,00 -3,00 - -1,00 -3,00 -3,00 08/01/1990 - -3,70 - - - - 14/09/1992 - -7,00 - - - - - 16/09/1992 - - - - - -5,00 23/11/1992 - - - - - -6,00 01/02/1993 - - - - -10,00 - - 14/05/1993 - - - - - -6,50 cumulativa -25,50 - - 44,1 -4,0 -24,40 -27,00 -8,00 - -6,00 -37,10 -17,80 -12,10 (*) Una casella vuota indica che la valuta non faceva parte al meccanismo di tassi di cambio nell’anno in questione: è il caso della peseta spagnola e dello scudo portoghese fino al 1990 e della lira italiana dopo all’uscita dallo SME nel 1992; (**) la sterlina inglese non ha subito alcun riallineamento durante la permanenza del Regno Unito nello SME 1990- 92. 91 L’ancoraggio della propria valuta a quella emessa da una banca centrale ad elevata reputazione anti-inflazionistica era considerata la strategia migliore per convincere da un lato le imprese ed i lavoratori a migliorare l’efficienza del sistema produttivo contenendo la dinamica dei costi, e dall’altro i mercati finanziari del rigore con cui venivano difese le parità di cambio della propria valuta. La seconda fase (1987-92) si caratterizzò per l’assenza di riallineamenti. Il processo di completamento del mercato unico si riverberava sullo SME attraverso un più deciso impegno delle banche centrali a rafforzare l’orientamento restrittivo della politica monetaria a difesa delle parità bilaterali con il marco. Una certa convergenza nominale fra le economie - dovuta alla riduzione nei differenziali di costo del lavoro per unità di prodotto, ed alla strategia di disinflazione perseguita da banche centrali e governi – stava producendo l’effetto di rallentare la perdita di competitività dei paesi a più alta inflazione e perciò di rendere le valute “deboli” meno esposte ad attacchi speculativi. La stabilità delle parità fra le valute indusse molti economisti a formarsi l’opinione che lo SME stesse conoscendo un “cambiamento strutturale”. Le autorità monetarie e fiscali dei paesi della Periferia, considerando come ormai acquisita la fiducia dei mercati internazionali nella credibilità delle politiche macroeconomiche, finirono per ritenere che non sussistessero più motivi per attacchi speculativi alla griglia di parità fisse del MTC; in altre parole, che si fosse ormai realizzato il passaggio ad uno SME “forte” (Giavazzi e Spaventa, 1990). Tale convinzione aprì le porte alla decisione dei governi europei ad adeguarsi senza indugi alla tendenza internazionale alla liberalizzazione dei movimenti dei capitali. Benché i persistenti differenziali fra i valori del CLUP non lasciassero presagire una diminuzione della pressione delle bilance commerciali sulle parità di cambio, si procedette con rapidità al definitivo smantellamento degli ostacoli amministrativi alle operazioni finanziarie e valutarie. In tal modo, si finì per aggiungere una fonte nuova di volatilità dei cambi – i movimenti dei capitali – alla tradizionale tendenza a deprezzarsi delle valute delle economie meno competitive. La decisione di 92 liberalizzare conferì ai mercati finanziari internazionali il ruolo di arbitri dell’operato delle banche centrali e dei governi. L’esposizione delle valute dello SME alla speculazione internazionale ne risultò notevolmente accresciuta. In presenza di una progressiva crescita dimensionale degli spostamenti di capitali da un mercato finanziario all’altro, l’andamento dei cambi a termine divenne un segnale rilevante per comprendere le aspettative dei mercati sulle prospettive delle valute “deboli” all’interno delle bande di oscillazione delle parità di cambio. Tale segnale esercitava una pressione sulle banche centrali delle economie con un alto differenziale di inflazione rispetto alla Germania affinché realizzassero una difesa più rigorosa del tasso di cambio fisso con il marco. Il timore che le aspettative di svalutazione causate dai differenziali di inflazione innescassero tensioni speculative contro la valuta indusse le banche centrali dei paesi più esposti ad innalzare i tassi di interesse in una misura superiore a quella richiesta dal pegging con il marco. D’altro canto, la politica fiscale discrezionale si manteneva espansiva, soprattutto nei paesi con alta disoccupazione. Di conseguenza, l’incremento dei tassi di interesse si rendeva necessario anche per la necessità di piazzare i titoli a copertura dei crescenti deficit pubblici. La lunga fase di alti tassi di interesse, perdurata fino a metà anni novanta, si affermò sia per segnalare la credibilità alla difesa dei cambi fissi sia per la necessità di accomodare per tutta la sua ampiezza - e cioè senza il contributo di una riduzione del tasso di interesse tedesco – la remunerazione da riconoscere agli operatori finanziari per due tipi di rischio: 1) il rischio di svalutazione; 2) il rischio di ripudio del debito pubblico. Il differenziale di rendimento (rispetto alle attività finanziarie denominate nella valuta leader dello SME) delle attività finanziarie denominate nelle valute “deboli”, ed emesse da governi gravati da un elevato rapporto tra debito pubblico e PIL, si è mantenuto molto ampio per tutti gli anni ‘80. Gli istogrammi in Figura 7.4 mostrano come i paesi della Periferia A - in presenza di tassi di interesse molto elevati – 93 abbiano presentato nella seconda metà degli anni ottanta tassi di crescita molto bassi, inferiori persino a quelli della Periferia B. Figure 7.4. Inflation rates, real growth rates and short term interest rates 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 1979/86 1987/92 1993/98 1979/86 1987/92 1993/98 1979/86 1987/92 1993/98 Centre Centre Centre Periphery A Periphery A Periphery A Periphery B Periphery B Periphery B Inflation rates Real GDP growth rates Real short term interest rates L’adesione alla Comunità Europea ed il diffondersi in Europa di un clima intellettuale favorevole ad una bassa inflazione indusse altri governi a chiedere ed ottenere l’ammissione nello SME. Il MTC si estese così a tre nuove valute: la peseta spagnola nel giugno 1989, la sterlina inglese nell’ottobre 1990 e lo scudo portoghese nell’aprile 1992. La contraddizione fra cambi fissi ed egemonia del marco tedesco continuava però a rappresentare una minaccia per la stabilità dello SME. Questa debolezza strutturale non era destinata ad emergere fino a che il ciclo economico del paese leader non si fosse distaccato drasticamente dal ciclo economico degli altri paesi dello SME. Quando ciò avvenne dopo la riunificazione tedesca, i meccanismi di mercato innescati dalla diversità della fase ciclica di espansione inflazionistica attraversata dalla Germania, mentre le altre economie dei paesi del MTC erano in recessione, a determinare lo spostamento di fondi da un paese all’altro. 94 In quei convulsi anni che videro il crollo dell’Unione Sovietica e dei regimi dei paesi dell’Europa dell’Est, lo shock istituzionale dell’unificazione politica tedesca andò a sommarsi allo shock che le bilance dei pagamenti stavano subendo con il progressivo passaggio alla piena libertà dei movimenti dei capitali: la liberalizzazione dei mercati finanziari fu completata entro la data stabilita del luglio 1990, e la proclamazione della repubblica di Germania avvenne nel novembre del 1990. Questi due shock si rivelarono troppo destabilizzanti per un accordo di cambi fissi che aveva nella “dominanza tedesca” il suo punto di forza ed al tempo stesso la sua principale debolezza. Le tensioni valutarie che ne conseguirono portarono nel settembre 1992 all’uscita di lira e sterlina dallo SME. Il cambio lira/marco passò dal livello di 765,4 lire (venerdì 11 settembre 1992) a 983,7 lire (24 febbraio 1993), per poi stabilizzarsi nella fascia 900-1.000 lire. La lira si svalutò del 30% in quattro mesi raggiungendo nel marzo 1995, il deprezzamento massimo pari a 1.274 lire contro il marco: + 66% rispetto al settembre 1992. Esaminiamo allora brevemente le cause di fondo del collasso dello SME, introducendo il concetto del “Quartetto impossibile”. Secondo questa analisi, i seguenti quattro potenziali caratteri di un’unione economica e monetaria in economia aperta - 1. Mercato unico; 2. Tassi di cambio fissi; 3. Autonomia della politica monetaria e 4. Liberalizzazione movimenti di capitale - sono mutualmente incompatibili. Prescindendo per semplicità dal mercato unico, obiettivo ormai consolidato, si fa riferimento alla “Tripletta impossibile”. “Tripletta impossibile” CAMBI FISSI STABILI ↑ controlli sui mov. capitali ↓ ↑ pegging ↓ AUTONOMIA POL.MON.← cambi flessibili → LIBERTA’ MOV. CAPITALI 95 Soltanto due obiettivi sui tre indicati in stampatello sono al contempo realizzabili. In corsivo e grassetto, i regimi monetari corrispondenti alla scelta di ciascuna possibile coppia di obiettivi (rinunciando al terzo). Con mercati dei capitali liberalizzati, la stabilità dei cambio fissi implica la rinuncia all’autonomia di politica monetaria (e quindi uno stretto pegging delle banche centrali all’àncora del sistema di cambi fissi). Così pure, autonomia della politica monetaria e liberalizzazione dei movimenti di capitale rendono impraticabile la difesa dei cambi fissi (e quindi inevitabile l’adozione di tassi di cambio flessibili). Infine, per garantire al contempo l’autonomia della politica monetaria e la stabilità dei cambi fissi, è necessaria l’imposizione di controlli sui movimenti di capitale. Una volta realizzato nel 1990 anche in Europa la libertà di movimento dei capitali (punto 4), la politica monetaria era destinata a perdere la residua autonomia. La crisi dello SME mise in luce la debolezza di un accordo di cambi fissi in presenza di mercati dei capitali liberalizzati, dove la fiducia nella capacità delle banche centrali di difendere le parità bilaterali con gli altri membri del sistema può essere in ogni momento revocata in dubbio. Le crisi valutarie del 1992-93 fecero emergere il problema che si determina in ogni processo di integrazione sia reale che monetaria fra paesi caratterizzati da diverse condizioni macroeconomiche. Tale problema è appunto rappresentato dal “quartetto impossibile”: in presenza di un mercato unico (la libera circolazione di merci, servizi e lavoro), di cambi fissi e di libertà dei movimenti dei capitali, non si dà anche l’autonomia della politica monetaria. La metafora del “quartetto impossibile” intende suggerire che l’obiettivo che aveva dato origine allo SME - il bene pubblico della stabilità monetaria attraverso politiche monetarie che impedissero il verificarsi di processi di inflazione-svalutazione - diventava di dubbia realizzazione una volta giunto a compimento il processo di liberalizzazione dei capitali. I mercati finanziari, consapevoli del fatto che i “fondamentali” di un paese non potevano più a lungo permettere alla banca centrale di mantenere fisse le parità della valuta nella griglia del MTC, avrebbero con ogni probabilità proceduto ad un attacco speculativo. Infatti, fino a che esercitano il potere di emettere moneta, le 96 autorità monetarie dispongono di un’autonomia decisionale che rende incompleto il “contratto” con il quale si sono impegnate con gli altri banchieri centrali a difendere i cambi fissi. Il potere di signoraggio fa sì che le banche centrali, anche se sono vincolate da un accordo di cambi fissi, possano pur sempre venire meno all’impegno della difesa del cambio e mettere in atto un’ “inflazione a sorpresa”. Il problema del “quartetto impossibile” da questione teorica divenne realtà appena dopo il manifestarsi dello shock asimmetrico dell’unificazione tedesca. A tale evento va infatti ricondotto il forte “scollamento” che per la prima volta dalla nascita dello SME si determinò fra il ciclo economico della Germania e quello degli altri paesi dell’Europa continentale (e in particolare l’Italia) che attraversavano una fase recessiva. Questi paesi seguivano il ciclo economico declinante degli Stati Uniti; la Germania conosceva invece un’espansione caratterizzata da forti tensioni inflazionistiche: dal lato della domanda, a causa dei programmi di spesa in investimenti pubblici all’Est e della conversione del marco della DDR con il marco occidentale secondo l’irrealistico rapporto di 1 a 1; e dal lato dell’offerta, a causa del vuoto di produzione creatosi con il collasso industriale nei Laender della Germania Orientale. Nel settembre 1992 la lira italiana e la sterlina inglese, dopo che le rispettive banche centrali ebbero dilapidato nel corso dell’estate ingenti riserve valutarie per resistere ai forti e ripetuti attacchi speculativi, vennero costrette ad uscire dal MTC. Nel corso del 1993, una nuova ondata speculativa investì il franco francese, la peseta spagnola, il franco belga e la corona danese. Questa seconda fase speculativa portò alla decisione di ampliare al 15% i margini di oscillazione. Dal momento che il tasso di inflazione francese era divenuto il più basso dello SME, apparve evidente (quanto meno con riferimento al caso francese) che la valuta alla quale attribuire lo scostamento dalla normale oscillazione attorno alla parità centrale, fosse il marco e la causa risiedesse nelle difficoltà post-unificazione attraversate dalla Germania. Nel dibattito sui regimi di cambio, un orientamento teorico sostiene che le aspettative di svalutazione degli operatori impegnati in attacchi speculativi ad una 97 valuta tendano ad auto-avverarsi (Obstfeld, 1986). Questa tesi delle aspettative che si auto-realizzano (self-fulfilling expectations) è senza dubbio attraente. Ed è vero che la liberalizzazione e la globalizzazione finanziaria hanno messo la speculazione internazionale in grado di mobilitare ingenti flussi di moneta trasferibili in tempo reale da un mercato all’altro e da una valuta all’altra. Riguardo allo SME, tuttavia, attribuire ai mercati finanziari la responsabilità ultima del collasso sarebbe una conclusione affrettata. In effetti, diversamente da quanto sostiene la tesi delle selffulfilling expectations, si può dire che il MTC con margini di oscillazione del ±2,25% avrebbe potuto superare lo shock asimmetrico della riunificazione tedesca. Se infatti la Bundesbank avesse accettato di concedere un ampio finanziamento ai governatori in difficoltà, il coordinamento fra le operazioni valutarie delle banche centrali avrebbe posto a difesa dello SME un ammontare di riserve internazionali da impegnare nell’acquisto delle valute sotto attacco ben superiore all’ammontare dei capitali mobilitati dalla speculazione finanziaria (Buiter, Corsetti e Pesenti, 2001) Nell’estate del 1992, di fronte all’indisponibilità della Bundesbank a rinunciare alla propria politica monetaria restrittiva, molti speculatori internazionali si convinsero che la debolezza di lira e sterlina rendeva elevata l’aspettativa di profitti da speculazione sui cambi. La speculazione si realizzò attraverso la vendita di posizioni non coperte in lire e sterline, per poi riacquistare lo stesso ammontare di titoli venduto al più basso prezzo conseguito alla svalutazione di queste valute ed onorare i contratti a termine. Lo SME “a banda stretta” ebbe termine con la nuova ondata speculativa dell’estate del 1993, quando la banca centrale tedesca non volle invece accordare pieno sostegno alle richieste di crediti in marchi avanzate dalla Francia, la cui valuta era sotto attacco speculativo nonostante i fondamentali fossero sani. Il timore fu che un ampliamento della circolazione monetaria del marco avrebbe messo a repentaglio la strategia anti-inflazionistica diretta a contrastare l’instabilità macroeconomica seguita alla riunificazione. D’altro canto, le pressioni esercitate nel 1993 sulla Banca di Francia, perché si assumesse l’onere di risolvere la crisi svalutando il franco 98 all’interno della griglia delle parità bilaterali del MTC, non andarono a buon fine. La Francia, promotrice dello SME di concerto con la Germania, non volle che il franco francese figurasse fra le valute dello SME in posizione subordinata rispetto al marco. 6. Shock di offerta e politica monetaria di stabilizzazione Nei due decenni che hanno preceduto il varo dell’euro fino al torno del nuovo secolo, furono gli shock negativi di offerta la principale fonte di instabilità macroeconomica. Si ricordi che uno shock negativo di offerta – ad esempio un aumento del prezzo delle materie prime - ha un effetto di incremento della dinamica dei prezzi e di diminuzione dell’occupazione e della produzione. Nel modello del ciclo reale con mercati perfettamente concorrenziali, l’aggiustamento di mercato ha luogo mediante la riduzione dei salari e dei prezzi dei beni. Le autorità monetarie adottano una politica anti-inflazionistica e le imprese sono indotte a ridimensionare la forza lavoro occupata (per un’ampiezza negativamente correlata alla flessibilità del salario nominale), in modo da ottenere l’incremento nella produttività necessario ad eguagliarne il livello al salario reale e ripristinare l’equilibrio macroeconomico. Se invece fattori istituzionali frenano l’aggiustamento di mercato, la fase ciclica negativa rischia di protrarsi per più periodi. In un quadro di instabilità macroeconomica caratterizzato da inflazione crescente e produzione calante, è probabile che le autorità monetarie scelgano la strategia di politica economica diretta a riassorbire gli effetti dello shock di offerta attraverso l’accelerazione non annunciata della crescita monetaria. Alla luce del modello del ciclo con rigidità nominali, questa strategia ha una sua coerenza. La presenza di rinnovi contrattuali scaglionati nel tempo, settore dopo settore, rallenta la dinamica salariale. Come si è visto nella Parte Prima, se in presenza di un’espansione monetaria l’adeguamento del salario nominale è vischioso, il learning degli agenti razionali sulla funzione di comportamento delle autorità monetarie non ha l’effetto di annullare gli effetti reali della manovra 99 espansiva. Venendo a mancare l’immediato adeguamento verso l’alto delle richieste salariali da parte dei sindacati a fronte dell’aumento dei prezzi da parte delle imprese, non si determina l’invarianza del salario reale. Al contrario, poiché il salario nominale cresce lentamente per il suddetto motivo istituzionale, l’aumento più rapido dei prezzi ha l’effetto di abbassare il salario reale, stimolando quindi la produzione. A differenza della tesi sull’”inefficacia delle politiche macroeconomiche”, da una politica monetaria espansiva ha generato un effetto reale, l’incremento della produzione. Non occorre che il salario reale venga ridotto attraverso una “inflazione a sorpresa”. Anche se la strategia diretta a sfruttare l’“incoerenza temporale” della politica monetaria fosse sistematicamente adottata, e quindi agenti razionali sono consapevoli che la creazione di moneta eccederà la quantità annunciata, la contrattazione scaglionata impedisce che il salario nominale cresca di quanto stanno crescendo i prezzi. Applichiamo questo schema interpretativo al contesto europeo di mercati di concorrenza imperfetta. Interpretando in base al modello dell’ “incoerenza temporale” l’alta inflazione che si stabilì in Europa dalla prima metà degli anni ’70 alla prima metà degli anni ’90, si suole attribuire la forte accelerazione dell’inflazione a politiche monetarie e fiscali espansive non annunciate, dirette a contrastare la recessione causata da shock negativi di offerta. La crescita del prezzo delle materie prime (causata dai due shock petroliferi del 1973-74 e del 1979) e del costo del lavoro (determinata dai rinnovi contrattuali e dal recupero dell’inflazione attraverso meccanismi automatici come scala mobile) comportarono un ingente incremento dei costi di produzione delle imprese. L’erosione del salario reale provocata dalla traslazione degli accresciuti costi sui prezzi da parte delle imprese, e l’aumentata incertezza macroeconomica che abbassava la propensione ad investire, determinarono il fenomeno della “stagflazione”. Le cosiddette “svalutazioni competitive” degli anni ‘70 generarono tassi di inflazione in continuo aumento, la stagnazione della domanda, ed un forte aumento della disoccupazione. I sindacati furono perciò indotti a chiedere maggiore protezione sociale: il recupero del potere di acquisto del salario attraverso 100 meccanismi di indicizzazione all’aumento del costo della vita (in Italia, prese il nome di “scala mobile”), ed una difesa dell’occupazione mediante la legislazione a protezione dei posti di lavoro e istituzioni di Welfare che garantissero una più forte e più estesa rete di protezione sociale. Nei paesi i cui parlamenti trasformarono queste richieste in leggi, il mercato del lavoro divenne più rigido. In molti paesi dell’Europa continentale, le banche centrali perseguirono l’obiettivo della lotta all’inflazione attraverso la difesa della distribuzione del reddito antecedente al primo shock petrolifero. Per approfondire questo problema dobbiamo ritornare all’equazione sottesa all’analisi dell’inflazione svolta all’inizio mediante la curva di Phillips corretta con le aspettative. Il tasso di inflazione era lì presentato come una funzione della variazione del tasso di disoccupazione u rispetto al tasso di disoccupazione naturale uN (è infatti con il tasso di disoccupazione di breve periodo e quello “naturale” di lungo periodo che abbiamo in precedenza ragionato sulla curva di Phillips corretta con le aspettative). In tal caso, ad ogni variazione del tasso di disoccupazione rispetto al suo valore naturale corrisponderà una variazione in senso opposto del tasso di inflazione. Alternativamente, potremmo anche considerare il tasso di inflazione funzione dell’output gap, Definiamo il tasso di inflazione con π, l’output gap (l’allontanamento del reddito Y dal suo livello potenziale Y*) con (Y – Y*), e il coefficiente che lega l’output gap al tasso di inflazione con α (ovviamente, dovremo passare sul lato destro dell’equazione dal segno più al segno meno, e dire che il tasso di inflazione al tempo t (πt ) si differenzierà (aumenterà o diminuirà) dal suo valore al tempo t-1 (πt-1 ) in funzione dello scostamento (verso l’alto o verso il basso) del reddito rispetto al suo valore potenziale: (πt ) = (πt-1 ) + α (Y - Y*) L’incremento del tasso di inflazione conseguente ad un output gap positivo sarà tanto maggiore quanto più sensibili sono i prezzi al mutare del livello del reddito rispetto al 101 suo valore potenziale, ovvero quanto più alto è il coefficiente α. Si ricorderà che la teoria delle aspettative razionali afferma che la politica monetaria può influenzare il livello di attività economica solo se ha luogo un evento stocastico, cioè non calcolabile all’interno del modello di funzionamento dell’economia perché ne manca l’informazione. Se il governatore della Banca centrale gode di una sufficiente reputazione, e la sua politica monetaria è dunque credibile, il venire meno all’annuncio di politica monetaria – la realizzazione di un’espansione della quantità di moneta contrariamente all’annuncio - costituisce un evento non prevedibile. Le decisioni di domanda di lavoro e di produzione saranno così influenzate positivamente dall’annuncio. Il tasso di inflazione che si determina nell’economia non poteva infatti essere previsto. In seguito alla maggiore circolazione monetaria, occupazione e produzione salgono lungo la curva di Phillips. Come si ricorderà, cresceranno anche i prezzi, fino a che le decisioni vengono riviste, occupazione e produzione tornano al livello iniziale, ed i soggetti inglobano nelle aspettative il più alto tasso di inflazione. Per quanto ripida fosse divenuta in Europa nel corso degli anni 70 la curva di Phillips - e cioè alto il valore del coefficiente α, e conseguentemente ridotto, a fronte di un forte impatto inflazionistico, il guadagno di reddito e di occupazione che ci si poteva attendere da un’espansione monetaria non annunciata - le banche centrali mostrarono una tendenza ad affidarsi a politiche monetarie “accomodanti”, celando le loro reali intenzioni e cioè “ingannando” i soggetti. Lo scopo era naturalmente quello di evitare che la disoccupazione aumentasse troppo in seguito agli shock di offerta (ma in alcuni paesi anche di domanda) negativi, anche a costo di lasciare che il tasso di inflazione salisse senza freni. La scelta politica fu quella di accogliere la domanda di “monetizzazione”, concedendo la liquidità necessaria ai più elevati livelli di salario nominale concordati fra imprese e sindacati. La strategia consisteva nel “sorprendere” i soggetti, favorendo una dinamica dei prezzi tale da abbassare il salario reale. Tale strategia permetteva alle imprese la traslazione degli accresciuti costi di produzione sui prezzi, limitando il ricorso alla riduzione dell’occupazione. 102 Il mutamento strutturale delle ragioni di scambio con i principali paesi produttori di petrolio inasprì il conflitto distributivo. Il mancato accordo fra imprese e organizzazioni dei lavoratori sulla divisione dell’onere dello shock esogeno rappresentato del più elevato costo delle materie prime ebbe come conseguenza un innalzamento della disoccupazione. Soprattutto nei paesi della Periferia, dopo la perdita di reputazione determinata dall’ “accomodamento” delle tensioni inflazionistiche, le banche centrali incontrarono notevoli difficoltà ad accrescere il grado di credibilità della propria condotta monetaria. Per tutti gli anni ’80 (ed in alcuni paesi anche fino alla prima metà degli ’90) i soggetti mantennero fisse le aspettative di inflazione. In altri termini, si rifiutarono di “scendere” verso una curva di Phillips di livello inferiore. Poiché le banche centrali non osavano attuare una “gelata monetaria” per non rischiare una disoccupazione di massa, in nessun paese la banca centrale realizzò una “shock therapy”. Il processo di disinflazione fondato sul vincolo del cambio imposto dallo SME e la convergenza nominale imposta dai criteri di Maastricht avanzarono con grande lentezza. La persistenza di aspettative costanti di inflazione fu all’origine di un elevato costo in termini di occupazione dei processi di disinflazione (il cosiddetto sacrifìce ratio). Le spiegazioni della mancata capacità dei paesi della Periferia di abbassare l’inflazione al livello dei paesi del Centro dello SME focalizzano l’attenzione sulla tendenza della politica monetaria a permettere la rincorsa fra salari e prezzi e della politica fiscale a realizzare la stabilizzazione dei redditi degli agenti. Dopo i vari shock negativi di offerta (i due incrementi del prezzo del petrolio, gli incrementi dei salari nominali, la salita del salario reale per effetto dei meccanismi di indicizzazione), si generò il fenomeno della stag-flazione: il livello del reddito nominale presentava uno scostamento per difetto dal suo valore “naturale” (stagnazione della domanda) ed il tasso di inflazione eccedente le aspettative inflazionistiche veniva incorporato in aspettative di inflazione più elevate (inflazione crescente). 103 6.1. Tassi di inflazione Applichiamo l’analisi di un processo di disinflazione, precedentemente svolta nell’analisi della curva di Phillips “corretta con le aspettative”, identificando un paese della Periferia (I) con l’Italia e uno del Centro (G) con la Germania. Alla luce del “quartetto impossibile”, la lunga fase di stabilità valutaria che caratterizzò lo SME fra il 1987 ed il 1992 provocò in molti paesi della Periferia una situazione di incompatibilità fra gli obiettivi della disinflazione e del mantenimento del livello di attività economica. Data la scelta, maturata a metà anni ’80, di evitare aggiustamenti del MTC, il tasso di cambio nominale con le altre valute doveva mantenersi fisso e quindi la monetary stance doveva seguire l’orientamento restrittivo della Bundesbank. Le economie dei paesi della Periferia avevano però performance troppo difformi da quelle dei paesi del Centro. Il tasso di inflazione nel primo paese (πI) superava il tasso di inflazione nel secondo (πG), nella misura determinata dall’eccesso del tasso di crescita del salario ( w ) rispetto alla dinamica della produttività del lavoro ( ). Dato il divario nel costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) : w I / I w G / G , si determinava un differenziale inflazionistico: πI>πG. Nella misura determinata da tale divario di CLUP, ne conseguiva un differenziale inflazionistico: πI > πG. Pertanto, una dinamica del CLUP costantemente maggiore in Italia che non in Germania costituiva un fattore di squilibrio di competitività fra i due paesi. Precedentemente al regime di cambi fissi ma aggiustabili dello SME, la compensazione di un valore minore di uno del rapporto fra il tasso di inflazione in Germania ed il tasso di inflazione in Italia (pG / pI < 1) si realizzava attraverso il deprezzamento della lira rispetto al marco (un innalzamento di ê) proporzionale al differenziale inflazionistico determinato dal divario fra i due CLUP, in modo da mantenere invariato il tasso di cambio reale ε . Con il passaggio ai cambi fissi, il tasso di cambio nominale deve essere mantenuto fisso dalla politica monetaria della Banca d’Italia ( eˆ 0 ). Poiché la produttività non è modificabile nel breve periodo, la discesa 104 del rapporto G / I è sanata dalla variazione del valore del tasso di cambio reale , nella misura richiesta dall’eccesso di salario che si registra in Italia. In luogo dell’aggiustamento del cambio nominale (una maggiore quantità di lire per acquistare un marco) si realizza l’apprezzamento del cambio reale (una maggiore quantità di beni italiani per acquistare la medesima quantità di beni tedeschi). Il tasso di cambio reale subisce pertanto una riduzione al di sotto del suo valore di lungo periodo ( N ) corrispondente alla parità dei poteri d’acquisto: N . Con il passaggio dalle frequenti svalutazioni della fase 1979-1986, la stabilità delle parità di cambio degli anni dal 1987 al 1992 - il cosiddetto SME “forte” - riflette il successo delle banche centrali nella difesa delle parità bilaterali all’interno del MTC. All’apparenza, al comportamento virtuoso delle autorità monetarie, che rispettavano la regola di non discostarsi mai troppo dalla crescita monetaria implicata dalla parità centrale con il marco, corrispondeva un atteggiamento fiducioso dei mercati finanziari. Poiché l’impegno a non attuare un’inflazione “a sorpresa” veniva mantenuto, possiamo definire il periodo 1987-1992 come quello in cui nello SME venne seguita la strategia di second best. Tuttavia, il problema della divergenza reale era tutt’altro che risolto: il CLUP della Periferia continuava ad avere una dinamica superiore a quella del CLUP del Centro, il paese la cui banca centrale di fatto dettava la crescita monetaria per tutta l’area. Durante gli anni dello SME “forte”, l’Italia compensava con afflussi di capitali (attirati dal differenziale dei tassi di interesse positivo rispetto alla Germania) il disavanzo delle partite correnti con l’estero generato dalla divergenza reale. Si trattava in prevalenza di posizioni in titoli di tipo speculativo, dei finanziamenti creditizi che le imprese italiane chiedevano alle banche estere per godere del più basso tasso di interesse, ed in minore misura di investimenti in obbligazioni e di partecipazioni finanziarie. Tali afflussi finanziari consentivano la formazione di un attivo dei movimenti di capitali che andava a compensare il deficit della bilancia commerciale, rappresentando così un fattore di riequilibrio di breve periodo della bilancia dei pagamenti. Rimanendo fisso il cambio nominale, l’apprezzamento reale 105 della lira indotto dal differenziale inflazionistico rinnovava però la perdita di competitività delle merci italiane sui mercati europei. Il disequilibrio fra i CLUP continuava a tracimare nei deficit della bilancia commerciale. Nel breve periodo, l’abbassamento del CLUP dell’Italia al livello del CLUP della Germania era perciò affidato a due modalità di aggiustamento in termini reali: un incremento della produttività del lavoro (ottenuto con la razionalizzazione o la riduzione nell’utilizzo del fattore lavoro) e/o una riduzione indotta nel salario reale da una dinamica più moderata del salario nominale rispetto a quella della produttività del lavoro. Nel lungo periodo, l’incompatibilità fra cambio fisso con il marco e divario nei “fondamentali” si rifletteva nell’aspettativa che l’aggiustamento del cambio attraverso la svalutazione della lira fosse ineludibile. In assenza di una revisione delle parità della lira, la lenta evoluzione della domanda aggregata, ed in particolare la discesa della componente di domanda per esportazioni a causa della perdita di competitività, avrebbe reso inevitabile il ridimensionamento della forza lavoro occupata. Pertanto, il basso grado di credibilità delle autorità monetarie della Periferia è in ultima analisi riconducibile all’opinione dei mercati che la banca centrale non avrebbe tollerato un aumento della disoccupazione. Paradossalmente, il tentativo di conferire credibilità alla propria politica monetaria non modificandone l’intonazione restrittiva, proprio perché amplificava il rischio di portare a livelli politicamente non gestibili la disoccupazione, finiva per indebolire la credibilità della stabilità del cambio con il marco ed aumentare le aspettative di svalutazione. L’incompatibilità tra il pegging con il marco e la stabilità dei livelli occupazionali ingrossava le fila degli operatori finanziari che aderivano all’aspettativa secondo la quale la disoccupazione crescente avrebbe costretto la banca centrale ad abbandonare il sistema di cambi fissi. L’indizio che la fiducia dei mercati riguardo alla solvibilità creditizia dell’economia italiana era crollata fu la strategia valutaria seguita dalle stesse banche italiane: all’inizio del 1990, infatti, i grandi istituti cominciarono a mantenere all’estero i pagamenti in valuta ottenuti dagli esportatori italiani ed a rifinanziarsi sui mercati 106 creditizi esteri a tassi di interesse molto più bassi rispetto a quelli elevatissimi praticati in Italia. Un incremento della disoccupazione, ad aspettative di inflazione rigide, è rappresentabile come un movimento lungo una stessa curva di Phillips, ad esempio da B a C in Figura 1.4. Gli agenti, non intendendo correggere al ribasso le aspettative di inflazione, non si spostano su una curva di Phillips inferiore e nei mercati finanziari si allarga il differenziale di interesse fra Italia e Germania. Il motivo risiede nell’aspettativa che le autorità monetarie avrebbero reagito con un’espansione monetaria ad uno shock negativo - sfruttando ad esempio la temporanea costanza del salario nominale fra una contrattazione salariale e quella successiva – induceva gli operatori finanziari a dubitare della irrevocabilità dell’impegno anti-inflazionistico della Banca d’Italia. La risposta alla nostra domanda è allora questa. Liberalizzazione dei mercati dei capitali e unificazione tedesca crearono le condizioni perché la politica monetaria di molte banche centrali dello SME avesse luogo in un contesto di aspettative ormai rivolte verso un’inflazione “a sorpresa”. Tale aspettativa indusse gli operatori finanziari internazionali, già all’inizio del 1992, ad elaborare strategie di attacchi speculativi diretti a realizzare profitti. Con la strategia di disinvestimento delle attività finanziarie denominate in lira, la speculazione internazionale si prefiggeva l’obiettivo di provocare una svalutazione;. Come si è detto, successivamente alla revisione delle parità relative della lira, la quota in titoli italiani nei portafogli degli speculatori avrebbe potuto essere ricostituita con un esborso di importo inferiore, nella misura determinata dalla perdita di valore della lira. La terza fase dello SME (1993-98) vide il MTC divenire un semplice simulacro di regime di cambi fissi: la banda allargata del ±15% metteva le banche centrali al riparo da attacchi speculativi. La crisi del 1992-93 segnò lo spartiacque fra la strategia dei cambi fissi e quella dei criteri di convergenza che avrebbe condotto all’unificazione monetaria. La convergenza nominale venne affidata all’impegno 107 delle autorità monetarie e fiscali a raggiungere gli obiettivi fissati dai criteri quantitativi di Maastricht. I quattro criteri per superare l’esame di ammissione alla terza fase del programma di unificazione monetaria, che ha portato alla nascita dell’euro, furono i seguenti: 1) un tasso di inflazione che non eccedesse di più dell’1,5% la media dei tre più bassi valori dei tassi di inflazione nello SME; 2) un tasso di interesse a lungo termine che non eccedesse di più del 2% i tre più bassi valori registrati nei paesi dello SME; 3) un rapporto deficit pubblico / PIL che non eccedesse il 3%; 4) un rapporto debito pubblico / PIL che non eccedesse il 60%. Inoltre, nei due anni precedenti l’ingresso nell’unione monetaria, la valuta doveva fare parte del MTC e non subire svalutazioni. La storia dello SME è racchiusa nelle seguenti evidenze empiriche più significative: 1) La lenta riduzione dell’inflazione (Figura 7.1). Dopo la discesa iniziale del 198286 (favorita dal contro-shock di riduzione del prezzo del petrolio) il tasso di inflazione subisce una risalita alla fine degli anni ’80 (soprattutto nei paesi della Periferia) e soltanto dopo le crisi del 1992 e del 1993 si avvicina o raggiunge il basso livello cui l’inflazione era stata portata in Germania. 2) L’incremento della disoccupazione (Figura 7.2). Successivamente alla riduzione degli anni 1987-89, la disoccupazione si stabilizza attorno a valori ancora piuttosto elevati, in particolare nella Periferia A (dove si registrarono tassi di interesse in salita ed una prolungata caduta del tasso di crescita del reddito). Questi dati hanno indotto a formulare l’ipotesi che la devoluzione di fatto alla Germania della determinazione dello stock di moneta in circolazione nell’area dello SME abbia comportato una restrizione monetaria superiore all’obiettivo di sconfiggere l’inflazione, e cioè ad una distorsione in senso deflazionistico della crescita europea. 3) Lo squilibrio nei flussi commerciali intra-SME (Figura 7.3). I paesi che hanno dato vita all’Unione monetaria europea costituiscono un’area relativamente chiusa. Di conseguenza, i flussi commerciali intra-SME hanno rappresentato un indicatore di 108 competitività molto importante nella valutazione della credibilità del MTC da parte dei mercati finanziari, esercitando un’influenza rilevante sull’andamento dei cambi. Figura 7.2. SME: tassi di disoccupazione Figura 7.1. SME: tassi di inflazione 25 16 20 14 12 15 10 10 4 Centro Periferia A 19 78 7 8 98 0 98 2 98 4 98 6 98 8 99 0 99 2 99 4 99 6 99 8 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Periferia B 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 0 19 82 6 19 80 8 5 Centro Periferia A Periferia B Figura 7.2. SME: tassi di disoccupazione Figura 7.1. SME: tassi di inflazione 25 16 20 14 12 15 10 10 4 7 8 98 0 98 2 98 4 98 6 98 8 99 0 99 2 99 4 99 6 99 8 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Centro Periferia A Periferia B 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 0 19 82 6 19 78 5 19 80 8 Centro Figura 7.3. SME: part ite corrent i / P IL Periferia A Periferia B Figura 7.4. T assi di inflzione, tassi di crescit a reali e t assi di interesse a breve t ermine 8 18 6 16 14 4 12 2 10 8 0 6 -2 4 2 -4 0 -6 -2 80 19 82 19 84 19 Germania 86 19 88 19 Italia 90 19 92 19 Spagna 94 19 96 19 98 19 Regno Unit o 1979/ 86 Cent r o 1987/ 92 Centr o 1993/ 98 Ce ntr o 1979/ 86 Pe r if er ia A 1987/ 92 1993/ 98 Pe r if er i a P er if e r ia A A Tas s i d i inflazio ne 1979/ 86 P er i f er ia B 1987/ 92 P er if er ia B 1993/ 98 Pe r if er i a B Tas s i d i cres cita d el PIL reale Tas s i d i int eres s e reali a b reve termine 109 Dall’andamento dei valori del rapporto Partite correnti / PIL in alcuni paesi dello SME si rileva come il surplus commerciale della Germania cresca dalla costituzione dello SME fino allo shock asimmetrico rappresentato dalla riunificazione politica tedesca. All’opposto, si registrano trend decrescenti e caratterizzati da forti deficit per le tre economie della Periferia A (ad esempio, nella fase di cambi stabili 1987-92 l’Italia registra crescenti passivi della bilancia commerciale). Negli anni successivi alle crisi 1992-93, invece, ai valori negativi del rapporto in Germania (causati dalle conseguenze economiche del processo di riunificazione) corrispondono notevoli recuperi nella Periferia A, con il passaggio ad elevati surplus in Italia. Si può ipotizzare che questa robusta correlazione fra gli andamenti speculari dei flussi commerciali del Centro e della Periferia abbia contribuito a determinare i trend di deprezzamento reale del marco e di apprezzamento reale delle valute della Periferia. 4) La stagnazione della crescita (Figura 7.4). Il forte incremento dei tassi di interesse ed i bassi valori del tasso di crescita sono probabilmente legati da un rapporto di causalità. Questa evidenza empirica di alti tassi di interesse e bassa crescita è particolarmente chiara nei paesi della Periferia. Nella seconda e nella terza fase, nei paesi della Periferia la tendenza dei tassi di inflazione a decrescere è accompagnata da un forte incremento dei tassi di interesse e dalla caduta dei tassi di crescita dell’economia (tali fenomeni appaiono meno evidenti nella Periferia A che non nella Periferia B perché due paesi - Spagna e Regno Unito - hanno partecipato allo SME per un numero di anni molto esiguo). Il bilancio complessivo dello SME è moderatamente positivo sul piano della disinflazione, e alquanto negativo per quanto riguarda l’incremento della disoccupazione. Il risultato della bassa inflazione è maturato molto lentamente ed è stato pienamente conseguito dallo SME soltanto successivamente ai 15 anni di funzionamento del MTC con banda “stretta” del 2,25%, e cioè nella terza fase, durante la quale la strategia di integrazione monetaria si è imperniata sui criteri di 110 Maastricht, che imponevano politiche macroeconomiche restrittive. Una possibile spiegazione per la vischiosità delle aspettative di inflazione deriva dalla semplice osservazione che il progressivo – per quanto lento - restringimento del differenziale di tassi di inflazione fra un paese della Periferia e la Germania (il paese con il più basso tasso di inflazione nello SME fino al 1990) non chiudeva, ma rendeva soltanto progressivamente più lento, l’ampliarsi della “forbice” di prezzo fra le merci del paese della Periferia e quelle tedesche. Questa evidenza empirica fa sorgere un interrogativo sul rapporto fra i costi e i benefici di una strategia di disinflazione rigidamente imperniata sull’acquisizione di credibilità delle n-1 banche centrali. L’impegno delle autorità monetarie dei paesi partecipanti allo SME a promuovere la disinflazione si confrontava con un forte disincentivo. Mantenere la valuta all’interno delle bande di oscillazione attorno alla parità centrale del meccanismo di cambi fissi era in contraddizione con il desiderio di politiche monetarie e fiscali “attive”, in grado cioè di sostenere il livello di attività economica con impulsi espansivi sul reddito. In effetti, si tratta di un conflitto fra obiettivi che si presenta ogni volta che un paese accetti di adottare un regime di cambi fissi: l’esigenza di segnalare l’impegno alla difesa del cambio fisso costringeva le n-1 banche centrali – in misura ovviamente diversa, in ragione della diversa reputazione delle autorità monetarie e della diversa affidabilità dei governi – a mantenere elevati i livelli dei tassi di interesse. Un processo di disinflazione che dura più di 15 anni rappresenta un periodo troppo lungo perché la “cura” (le politiche macroeconomiche restrittive) non provochi l’effetto collaterale di debilitare l’organismo. Sono state forse sottostimate le ricadute sull’espansione produttiva e occupazionale della strategia di difendere le parità con il marco legando la creazione di moneta alla politica monetaria della Bundesbank. Se è vero che gli “alti” tassi di interesse hanno contribuito a determinare la bassa a crescita economica, ci si deve chiedere se la stabilità monetaria avrebbe potuto essere ottenuta ad un costo inferiore. 111 6.2. La crisi dello SME (1992-93) La crisi dello SME, che nel 1992-93 determinò l’uscita di lira italiana e sterlina inglese dal meccanismo di tassi di cambio, portò al superamento dei cambi fissi come strategica dell’unificazione monetaria. La causa di fondo della crisi fu il “quartetto impossibile”. Dopo la crisi dello SME del 1992-93, occorreva prenderne atto ed accelerare la realizzazione dell’unione monetaria, sottoponendo il processo di integrazione monetaria alla convergenza nominale descritta dai criteri di Maastricht. L’aspettativa era che l’eliminazione delle valute nazionali - che per definizione annullava il rischio sulla valuta - avrebbe eliminato la soggezione dei paesi alle volatili aspettative dei mercati finanziari. Una volta adottata una moneta unica e fondata una banca centrale comune si sarebbe ripristinata l’autonomia della politica monetaria. 7. L’Unione Monetaria Europea Con l’adozione da parte del Consiglio europeo del rapporto Delors (dal nome del presidente della Commissione Europea dell’epoca), nel 1989 si diede l’avvio alla costruzione dell’Unione Economica e Monetaria. Il rapporto Delors prevedeva tre tappe per il cammino che avrebbe condotto all’unificazione monetaria. La prima tappa (1990-1993) consisteva nel rafforzamento della cooperazione nella politica monetaria, dopo la completa liberalizzazione dei movimenti di capitale. Per le tappe successive, che comportavano la creazione della banca centrale e il varo della moneta comune, fu necessario un adeguamento costituzionale. La ratifica del Trattato sull’UE (TUE) - detto anche Trattato di Maastricht, dal nome del luogo in cui fu firmato nel 1991 – rese possibile la seconda tappa (1994-1998) rivolta alla creazione dell’Istituto Monetario Europeo, un’istituzione designata alla preparazione all’integrazione monetaria. Tale organismo ha provveduto a mettere i mercati monetari e finanziari ed il sistema dei pagamenti nelle condizioni di affrontare il passaggio ai cambi 112 irrevocabilmente fissi e l’entrata in operatività della Banca Centrale Europea (BCE). La terza tappa, che corrisponde al periodo di cambi irrevocabilmente fissi (1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), vide l’adozione dell’euro nelle transazioni finanziarie, l’emissione di titoli pubblici in euro e la possibilità per risparmiatori ed imprese di optare per conti bancari in euro. I criteri di Maastricht segnarono l’accelerazione del processo di integrazione monetaria e l’ampliamento della strategia di coordinamento dalla moneta al bilancio pubblico. La logica del cambio di strategia dai cambi fissi dello SME a banda stretta ai quattro indicatori di convergenza è così riassumibile. Fra il 1979 ed il 1993, l’enforcement della monetary stance anti-inflazionistica era stato affidato alla sanzione dei mercati finanziari internazionali nella forma del riconoscimento di un “premio per il rischio” di svalutazione e di default del governo, da inglobare nel tasso di interesse sulle attività finanziarie denominate nella valuta “debole”. Con l’adozione della banda larga del ±15%, i paesi impegnati nel processo di integrazione monetaria posero virtualmente fine agli attacchi speculativi nei confronti della valuta della banca centrale inadempiente all’impegno anti-inflazionistico. Dal 1993 al 1998 il processo di convergenza nominale venne a fondarsi sulla strategia di enforcement basata su indicatori numerici. Poiché il rispetto dei criteri di Maastricht rappresentava la condizione per la definitiva fissazione delle parità, all’enforcement della minaccia di attacchi speculativi si sostituì l’enforcement della minaccia dell’esclusione dall’unione monetaria. Il criterio aggiuntivo che imponeva la permanenza nel MTC per almeno due anni prima della fissazione definitiva delle parità bilaterali fu soddisfatto con l’adesione dello scellino austriaco nel gennaio 1995, del marco finlandese nell’ottobre 1996 e con il rientro nel MTC della lira italiana nel novembre 1996. Nel maggio 1998, al momento della verifica di congruenza dei quattro indicatori macroeconomici con i parametri di Maastricht, l’obiettivo della convergenza nominale risultò sostanzialmente raggiunto. Undici paesi rispettavano il limite massimo fissato per tassi di inflazione e di interesse, nonché i criteri per deficit e debito pubblico sul PIL. In base ad un comma del 113 Trattato, fu infatti possibile considerare in “sicuro trend decrescente” i rapporti debito pubblico/PIL ben più alti del limite del 60%, di Italia e Belgio e poi anche della Grecia. Una volta stabiliti ufficialmente i tassi di cambio irrevocabilmente fissi, undici valute diedero vita all’unione monetaria europea il 1 gennaio 1999. Esattamente un anno dopo, l’ingresso nell’UME della dracma greca (rientrata nel MTC solo nel marzo 1998) portò a dodici il numero di paesi dell’UE che il 1 gennaio 2002 misero in circolazione l’euro. La Slovenia è entrata nell’UME il 1.1.2007, seguita poi da Malta e Cipro (2008), Slovacchia (2009), Estonia (2011), Lettonia (2014). L’ingresso della Lituania è previsto per il 1 gennaio 2015. Nel gioco strategico del coordinamento monetario per ciascuno dei paesi dell’UME, il pay-off della partecipazione ha un valore che è funzione del numero degli aderenti. Molti paesi – a cominciare dalla Germania – avrebbero voluto che alcuni paesi dello SME non fossero nel gruppo dei paesi fondatori dell’UME per timore che la loro instabilità macroeconomica e l’inaffidabilità dei loro governi si riverberassero sulla credibilità del nuovo segno monetario. L’“uscita” da un accordo di cambi fissi ma aggiustabili come lo SME, e a maggior ragione l’“uscita” da un accordo di cambi irrevocabilmente fissi, comporta la sanzione di mercato consistente nella perdita di reputazione da parte della banca centrale e del governo che si erano assunti l’impegno di difendere le parità bilaterali. Benché la valuta europea sia un segno monetario cui non corrisponde il potenziale economico di uno stato. I legami fra paesi che si stabiliscono in un’unione monetaria sono ben maggiori di quelli implicati da un accordo di cambi fissi. Il ripristino dell’autonomia di politica monetaria si configura come una vera e propria “secessione”. Si può dire che se un qualunque paese dell’UME decidesse di ritornare al proprio segno monetario i “costi” di uscita (exit) - quelli sopportati dal paese stesso e quelli a carico dei paesi membri sarebbero molto elevati. In generali, i benefici della riduzione dei costi di transazione e dell’incertezza sul cambio, nonché il probabile incremento della quota in euro sul totale delle riserve 114 ufficiali detenute dalle maggiori banche centrali non europee una volta consolidatosi il ruolo dell’euro nei mercati internazionali, sono fattori che innalzano il costo dell’uscita e dovrebbero accrescere il valore della lealtà ai comuni obiettivi (loyalty). In particolare, la grave crisi conosciuta dall’Eurozona negli ultimi anni - in seguito agli elevati livelli raggiunti dallo spread dei titoli pubblici dei paesi della Periferia rispetto al tasso di interesse sul Bund tedesco a 10 anni, che hanno innalzato il rischio di default di tali paesi, l’uscita del paese maggiormente in difficoltà – la Grecia – è stata evitata attraverso il ricorso a sostegni finanziari (condizionati a tagli di spesa nel bilancio pubblico) ed ad un “haircut” del suo debito pubblico. La commissione europea di Bruxelles e la BCE hanno infatti ritenuto, concordemente con i governi più influenti (in primo luogo, la Germania) che l’interdipendenza finanziaria creata dall’unione monetaria avrebbe potuto estendere il “contagio” di crescenti spread in altri paesi e causare situazioni di default che avrebbero messo a repentaglio la sopravvivenza stessa dell’euro. 8. Deficit pubblico e debito pubblico Nel processo di convergenza nominale, uno dei criteri da soddisfare per la partecipazione all’unione monetaria era il limite del 3% per il rapporto deficit pubblico/PIL. La Commissione Europea ha imputato ai governi europei di non avere introdotto le riforme necessarie a rendere la struttura delle finanze pubbliche adeguata ai due obiettivi della stabilizzazione macroeconomica e della decumulazione del debito pubblico. Le fiscal stance dei paesi dell’UME sono state oggetto dei seguenti rilievi: 1) non avere applicato il Tax Smoothing, lasciando incrementare il rapporto deficit pubblico/PIL nelle fasi espansive del ciclo invece di accantonare un surplus di bilancio da utilizzare nei periodi di “vacche magre”; 2) avere rinunciato ad una strategia di lungo periodo rivolta alla riduzione degli alti rapporti debito pubblico/PIL, lasciando che nelle fasi recessive la lenta dinamica del denominatore accrescesse il valore del rapporto debito pubblico/PIL. 115 La tesi sostenuta dalla Commissione Europea è che nei paesi dell’UE - ad esclusione di Lussemburgo, Regno Unito, Finlandia, Irlanda e Svezia - “la maggior parte dell’incremento del rapporto debito pubblico/PIL ebbe luogo nei periodi di nonrecessione, allorché le politiche di bilancio non controbilanciarono gli effetti della recessione sulla dinamica del debito, ma lo aumentarono ulteriormente” (Buti, et al., 1997). Sulla base del seguente grafico, la Commissione lamenta che nei periodi di espansione (output gap positivi) i paesi non hanno ottemperato al principio del Tax Smoothing, dal momento che deficit e debito hanno continuato a crescere. Figura 9.1. Deficit e debito nell'area dell'euro Output gap positivo 6 80 75 5 70 4 65 60 3 55 2 50 45 1 40 0 35 -1 77 19 30 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 deficit in % P IL (scala sinistra) 93 19 95 19 97 19 99 19 01 20 03 20 05 20 debito pubblico in % P IL (scala destra) La prima domanda che allora ci dobbiamo porre riguarda le cause dell’incremento registrato dal rapporto fra il deficit pubblico ed il PIL nei paesi dell’UE fra gli anni ’70 e gli anni ’90. La politica fiscale si compone dell’operare degli stabilizzatori automatici nel corso del ciclo economico e della politica discrezionale del governo. Rispetto agli effetti sul saldo di bilancio pubblico che gli stabilizzatori automatici determinano nel corso del ciclo economico attraverso gli effetti di “smussamento” delle oscillazioni del reddito, ogni manovra discrezionale attuata dal governo opera una variazione in aumento o in diminuzione. La “regola fiscale” seguita dal governo consiste appunto nella 116 variazione del saldo di bilancio, e cioè nella variazione da imprimere ogni anno alla fiscal stance, al fine di renderla conforme agli obiettivi della politica fiscale. La misurazione della fiscal stance avviene isolando la componente strutturale del saldo di bilancio, e cioè sottraendo dal saldo complessivo la componente ciclica del saldo di bilancio determinata dall’operare degli stabilizzatori automatici del ciclo economico. Per calcolare la componente ciclica occorre misurare l’output gap, la divergenza della produzione effettiva dalla produzione potenziale di lungo periodo. Per ottenere una proxy di quest’ultima, si ricorre al reddito “tendenziale” mediante l’applicazione alla serie del prodotto lordo effettivo del filtro Hodrick-Prescott. Questo metodo di livellamento dei valori annuali mediante medie mobili concatenate, benché comporti una distorsione della stima per gli anni più recenti, è solitamente preferito al metodo alternativo - la stima econometrica del prodotto potenziale – che implica il ricorso ad una funzione Cobb-Douglas. Pertanto, la componente ciclica del bilancio pubblico dal saldo complessivo viene calcolata moltiplicando l’output gap per il valore che esprime la sensibilità al ciclo delle entrate e delle uscite fiscali (l’elasticità delle entrate moltiplicato il rapporto (τ) tassazione/PIL e l’elasticità delle uscite moltiplicato il rapporto (γ) spesa pubblica/PIL). La variazione della fiscal stance viene così stimata mediante la sottrazione di questa componente ciclica dal saldo di bilancio complessivo. Come valutare il comportamento del governo? Un giudizio sulla politica fiscale può essere espresso con la semplice comparazione fra questa stima della variazione della fiscal stance al netto degli effetti del ciclo nell’anno t e l’effettivo saldo di bilancio primario nell’anno precedente. Ci chiediamo, di fatto, quale fiscal stance sarebbe risultata dalla politica discrezionale se il livello del PIL fosse rimasto invariato rispetto al periodo precedente (depurando cioè il saldo dalla sua componente “ciclica”. Il saldo di bilancio “corretto per il ciclo” (cyclically adjusted) può essere anche definito come il valore che il saldo primario del bilancio pubblico avrebbe assunto se il PIL fosse rimasto costante dal tempo t-1 al tempo t: vt(Yt-1)/Yt. 117 Il saldo primario registra, per ogni periodo, le decisioni di diretta emanazione delle autorità fiscali. Non essendo incluse le spese per interessi sul debito, si tratta in effetti – è bene sottolinearlo - del “saldo primario strutturale”. Il metodo statistico per determinare il saldo primario strutturale è la stima econometrica dei parametri che legano la crescita dell’occupazione (Blanchard, 1990) oppure del reddito ai rapporti Tt/Yt e Gt/Yt (Farina e Tamborini, 2002). I valori stimati vanno inseriti come parametri noti in una nuova regressione che lega questa volta la crescita del reddito all’incognita che vogliamo determinare, il valore in ogni anno della fiscal stance. La variazione del saldo primario strutturale del bilancio pubblico è misurata dalla differenza fra valore stimato (il saldo primario corretto per il ciclo) e valore effettivo del periodo precedente: vt(Yt-1)/Yt - vt / Yt La variazione della fiscal stance al netto degli effetti del ciclo si definisce anche “impulso fiscale”. Se il valore della differenza è positivo, l’“impulso fiscale” è in senso restrittivo; se è negativo, l’“impulso fiscale” è in senso espansivo. Valutiamo allora la prima critica della Commissione Europea. Per analizzare la strategia di politica fiscale perseguita dai paesi dell’UE, abbiamo scelto l’andamento del rapporto deficit pubblico/PIL in Germania ed Italia (Figura 7.6). Questi due paesi di grandi dimensioni e di lunga partecipazione al sistema di cambi fissi dello SME presentano un grado di stabilizzazione del ciclo attraverso gli stabilizzatori automatici, ed anche di correlazione della sensibilità del bilancio con la dimensione del settore pubblico, abbastanza rappresentativi della media UE. Nella Figura 7.6, con v si indica il rapporto vt-1 / Yt-1 e con ύ si indica il rapporto vt(Yt-1)/Yt . L’indice di variazione della fiscal stance di Germania mostra che nel complesso gli impulsi fiscali paiono avere seguito, in quasi tutti gli anni, la logica del Tax Smoothing. I tracciati degli impulsi fiscali hanno infatti un andamento pressoché speculare rispetto a quello del saldo di bilancio effettivo, oscillando attorno alla linea di bilancio neutrale. 118 Figura 7.6. Impulsi fiscali (a) Germania (b) Italia 8 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 1970 1975 1980 1985 ύ(t)-v(t-1) 1990 1995 v(t-1) 1970 1975 1980 ύ(t)-v(t-1) 1985 1990 1995 v(t-1) Fonte: Farina e Tamborini (2002) Se si escludono la crisi dello Yom Kippur (1973-74) e la riunificazione tedesca (1989-90), a saldi di bilancio effettivo vt-1 di segno espansivo (il tracciato è sotto la linea di bilancio neutrale) corrispondono di norma interventi discrezionali restrittivi (l’istogramma dell’impulso fiscale (ύt–vt-1) è sopra la linea di bilancio neutrale). La manovra discrezionale di riduzione del deficit primario strutturale creato nel periodo precedente è di norma di ampiezza sufficiente. Il grafico dell’Italia delinea uno scenario affatto diverso. La variazione del saldo primario strutturale operata dall’autorità fiscale non è mai tale da riportare in pareggio il saldo primario del bilancio pubblico. Alla tendenza espansiva dei deficit pubblici al netto del ciclo (valori costantemente negativi del saldo primario strutturale intorno al 4%) corrispondono per tutto il periodo 1976-91 variazioni compensative della fiscal stance ampiamente insufficienti (intorno al 2%). Di conseguenza, i deficit primari contribuivano di anno in anno ad alimentare la formazione di debito pubblico. Dopo il varo dello SME, a valori del deficit pubblico via via più moderati seguono impulsi fiscali restrittivi sul saldo strutturale primario via via più rilevanti. A partire dal 1991 si registra il passaggio del rapporto saldo di bilancio pubblico primario / PIL 119 a un valore positivo. Sebbene il comportamento delle autorità fiscali non appaia incline a fare lievitare senza limiti la spesa pubblica, la gestione del deficit non appare conforme alla “disciplina fiscale”, in quanto vengono sottovalutate le conseguenze dei deficit in termini di accumulazione di debito pubblico. Nel loro complesso, questi risultati suggeriscono che le autorità fiscali tedesche, ma non quelle italiane, orientarono le fiscal stance al rispetto del Tax Smoothing. La seconda critica della Commissione Europea mette in questione la volontà delle autorità fiscali dei paesi dell’UE di realizzare una stabilizzazione compatibile con il vincolo intertemporale del bilancio pubblico. Ricordando le prime due fonti di incremento di debito pubblico nell’equazione (4.10), in ciascun anno il rapporto debito pubblico/PIL viene stabilizzato – e cioè il suo tasso di variazione è nullo - se il saldo del bilancio pubblico primario è : ν = (i – g) b. Per valutare questa critica della Commissione Europea, occorre individuare il saldo strutturale di stabilizzazione del debito (ύ*). Suddividendo il saldo del bilancio pubblico nella componente strutturale (ύ) e nella componente ciclica (νc), possiamo definire (ύ*) come il valore del saldo strutturale primario di ogni anno t che stabilizza il debito pubblico primario al livello t-1. Il saldo strutturale di stabilizzazione del debito (ύ*) si ricava calcolando la differenza fra il tasso di interesse nominale al netto della dinamica del reddito nominale moltiplicato il rapporto debito pubblico/PIL e la componente ciclica del saldo di bilancio pubblico: ύ* = (i - g) b - νc Il perseguimento dell’obiettivo del debito pubblico dipende dai due fattori del prodotto (i–g)b. Quanto più elevati sono la differenza fra tasso di interesse e tasso di crescita e/o l’indebitamento pubblico in rapporto al PIL, tanto più ampia deve essere la restrizione fiscale da attivare. Benché sia una strategia di politica fiscale diretta a mantenere il bilancio pubblico mediamente in pareggio, il Tax Smoothing non coinvolge questi due fattori, ma esplicita soltanto un criterio riferito al saldo primario. 120 Tale criterio non è però sufficiente, in quanto per valutare l’operato dei governi la Commissione Europea prende in considerazione la somma dei deficit primario e secondario. Un giudizio formulato unicamente in base al Tax Smoothing conduce ad ambiguità interpretative. Supponiamo che gli stabilizzatori automatici – a partire da un bilancio pubblico in pareggio - creino un deficit primario nel corso di una fase recessiva. Supponiamo anche che una precedente fase espansiva abbia consentito l’accantonamento di entrate fiscali che possano ora esse impiegate a copertura del deficit. Possiamo concludere che l’attuazione del principio del Tax Smoothing – ovvero un valore costante del saggio di tassazione ed un andamento oscillatorio delle finanze pubbliche conforme alla fase del ciclo – sia sufficiente a garantire la permanenza in pareggio del bilancio nel medio periodo? La risposta non può che essere negativa. Infatti, tale principio prescinde dalla copertura del deficit secondario. Un esogeno aumento livello del tasso di interesse potrebbe aprire nel bilancio pubblico un deficit destinato a durare per più periodi. Egualmente, una caduta strutturale del tasso di crescita potrebbe causare un innalzamento del rapporto deficit pubblico complessivo / PIL (il che renderà necessario un adeguamento verso l’alto del saggio di tassazione e/o verso il basso della spesa pubblica). Il problema è allora che la Commissione Europea misura correttamente la fiscal stance dei paesi dell’Unione Europea con riferimento al saldo strutturale primario (escludendo cioè la spesa per interessi), ma emette il suo giudizio con riferimento al deficit pubblico complessivo. Viene abbracciata la concezione della regolazione del bilancio pubblico in funzione dell’obiettivo di lungo periodo di mantenere in equilibrio il VIBP. Non è solo l’indebitamento consistente negli aggiuntivi titoli (emessi a copertura di una nuova spesa pubblica) e la relativa spesa per interessi come vuole il Tax Smoothing a dovere essere estinto nel breve termine (nel corso della successiva ripresa economica). Quale che sia infatti l’origine di un deficit pubblico (deficit primario oppure deficit secondario), al fine di mantenere in equilibrio il VIBP, l’autorità fiscale deve farsi carico del deficit pubblico complessivo e non solo di quello primario. Se la differenza (i–g) presenta un valore positivo, la 121 restrizione fiscale dovrà eccedere la semplice copertura di un eventuale saldo negativo primario per tutto l’importo della differenza moltiplicata per il “peso”, il rapporto (b) debito pubblico / PIL. Ogniqualvolta si determini un trade-off fra stabilizzazione del debito pubblico (o decumulazione, nel caso di un paese con rapporto debito / PIL superiore al 60%) e stabilizzazione del reddito attraverso una politica fiscale discrezionale espansiva, deve essere quest’ultima a cedere il passo. La Commissione Europea riconduce ogni incremento del rapporto (b) deficit pubblico/PIL ad un eccessiva formazione di deficit primario da parte delle autorità fiscali. Nell’avanzare la tesi secondo la quale negli ultimi decenni molti paesi dell’UE non si sarebbero comportati in accordo con le prescrizioni del Tax Smoothing, viene così sottaciuto che il primo termine dell’equazione (7.10) può costituire un’importante causa della salita dei rapporti medi di deficit pubblico/PIL dell’UE. Se nei periodi di output gap positivo tale rapporto ha continuato ad aumentare, anche se ad una velocità minore, l’origine potrebbe risiedere nell’avvitamento fra salita dei tassi di interesse ed incremento delle emissioni di titoli pubblici. La domanda da porsi è allora la seguente: quali fattori hanno causato nei paesi europei fiscal stance non conformi alla stabilizzazione del rapporto debito pubblico/PIL e alla decumulazione del debito pubblico in eccesso? Figura 7.7. Stabilizzazione del debito pubblico (a) Germania (b) Italia 8 6 4 2 0 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -2 -4 -6 -8 -10 -12 1970 1975 1980 1985 ύ(t) 1990 ύ*(t) 1995 1970 1975 1980 ύ(t) 1985 1990 1995 ύ*(t) Fonte: Farina e Tamborini (2002) 122 I tracciati della Figura 7.7 mettono a confronto, per ciascun paese, il saldo strutturale primario che la fiscal stance ha determinato (ύ(t)) ed il saldo strutturale primario che sarebbe stato necessario per stabilizzare il debito pubblico sul PIL (ύ*(t)). In Germania, gli andamenti speculari dei tracciati dei saldi primari effettivi e stimati dimostrano che la differenza (i–g) non ha contribuito ad alimentare il debito pubblico. Il saldo strutturale primario oscilla prima attorno alla linea di neutralità, per poi conoscere variazioni della fiscal stance di segno restrittivo, soprattutto nel corso degli anni ’90, quando gli elevati valori raggiunti dal debito pubblico provocano picchi molti alti del saldo strutturale primario che stabilizza il debito pubblico. Di nuovo, il quadro si presenta completamente diverso in Italia. Le insufficienti manovre discrezionali di restrizione fiscale aprirono ampi divari fra spesa pubblica e entrate fiscali e richiesero quindi emissioni di titoli tali da alimentare l’accumulazione di debito pubblico. Il trend di impulsi fiscali sempre meno espansivi, che ha inizio nel 1976 e che prosegue quasi costantemente fino al passaggio a variazioni della fiscal stance sempre restrittive già nel 1988, appare sovrastato dal tracciato dell’attivo strutturale di bilancio pubblico che sarebbe stato necessario – dal 1980 fino al 1989 – per stabilizzare il rapporto (b) debito pubblico/PIL: solo nella seconda metà degli anni ’90, con la discesa dei tassi di interesse, si determinò un’inversione nei valori del nuovo indicatore. La valutazione dell’operato delle autorità fiscali è allora la seguente. Dai primi anni ’80 in poi, le autorità fiscali hanno avuto come punto di riferimento per i loro interventi discrezionali la compensazione di medio periodo di tendenze espansive del deficit di bilancio pubblico. I governi non si preoccupavano dello squilibrio che l’andamento del deficit pubblico complessivo andava producendo nell’equazione del VIBP. D’altro canto, la crescente dinamica del rapporto debito pubblico/PIL fu alimentata da un’espansione della spesa per interessi in buona misura determinata dalla politica di difesa del cambio della lira nello SME, che richiedeva ampi differenziali di tasso di interesse con la Germania. I tracciati mostrano che la distanza fra fiscal stance effettiva e fiscal stance “di stabilizzazione del debito pubblico” è stata notevole: per neutralizzare l’impatto di 123 incremento del rapporto causato dalla fonte “esogena” tasso di interesse, sarebbero state necessarie rilevanti manovre fiscali restrittive. Nel corso degli anni ’80, le autorità fiscali italiane non riuscirono ad avviare la decumulazione; negli anni ‘90 ad alimentare la formazione di nuovo debito non è stato il deficit primario ma il deficit secondario, a causa degli alti tassi di interesse. Una strategia di rapida decumulazione avrebbe richiesto, piuttosto che la semplice rinuncia a politiche fiscali discrezionali, manovre restrittive anche durante le fasi di recessione. Considerando anche l’orientamento restrittivo della politica monetaria, tali impulsi di restrizioni fiscali avrebbero probabilmente generato effetti deflazionistici. 9. Tassi di interesse L’ultimo criterio di Maastricht che rimane da esaminare è la convergenza fra i tassi di interesse. Questa grandezza rileva non solo nella determinazione della dinamica dei deficit pubblici attraverso la spesa per interessi ma influenza anche direttamente il sentiero di crescita di un’economia. L’evidenza empirica suggerisce che i differenziali di tasso di interesse di molti degli n-1 paesi del MTC nei confronti del paese leader dello SME non sempre ha rispecchiato l’andamento del tasso di cambio (vedi in Figura 8.2 i differenziali (spread) rispetto ai titoli pubblici tedeschi). Perché la “parità dei tassi di interesse” è stata spesso in disequilibrio? La teoria macroeconomica ci propone le seguenti possibili spiegazioni della divergenza: 1) il premio per il rischio di cambio (svalutazione). I valori attesi e realizzati delle parità bilaterali fra le valute del MTC erano influenzati da un insufficiente grado di credibilità della politica monetaria delle n-1 banche centrali impegnate a perseguire la disinflazione delle rispettive economie mediante la strategia di pegging nei confronti del marco; 2) il premio per il rischio di ripudio del debito pubblico da parte di un governo. Come spiega il modello di Sargent e Wallace, i mercati finanziari si attendono che la banca centrale, di fronte alla difficoltà del 124 governo a piazzare le nuove emissioni, faccia ricorso alla “monetizzazione” del debito pubblico. Ricordando l’equazione (4.16), che esplicita la terza fonte di incremento del rapporto debito pubblico / PIL, è possibile che l’eccesso del livello dei tassi di interesse, rispetto alla svalutazione registrata ex post, in molti paesi della Periferia dello SME sia stato causato da un errore di previsione. Le aspettative razionali non vengono realizzate: (πe–π) ≠ 0. L’impulso alla crescita del rapporto debito pubblico/PIL sarebbe quindi provenuto da aspettative di inflazione superiori al tasso di inflazione realizzatosi ex post (πe – π > 0). Un eccesso di inflazione attesa nei mercati rispetto al valore che si realizza ex post comporta un livello dei tassi di rendimento nominale dei titoli pubblici più elevato di quello che risulta nella condizione di “parità dei tassi di interesse”, e l’aumento della spesa per interessi viene finanziato con emissione di debito. In molti paesi dello SME, il divario (πe > π) ha rappresentato un’importante determinante della crescita del rapporto debito pubblico/PIL. Se il divario (πe > π) si ripresenta per più periodi, l’accelerazione nell’accumulazione di debito pubblico può essere notevole. Infatti, la crescita della spesa per interessi verrà alimentata sia nella sua componente di prezzo (i) che nella sua componente di quantità (B). Non è però semplice, anche ricorrendo a stime econometriche, stabilire in che misura l’errore di previsione spieghi il divario fra differenziale di tasso di interesse e variazione del tasso di cambio e/o la spinta verso l’alto che la crescita del debito pubblico imprime al tasso di interesse. Le aspettative di inflazione e le aspettative di variazione del tasso di cambio, non essendo misurabili ex ante, non sono verificabili ex post. Prescindiamo allora da questa possibile causa di divergenza e concentriamo l’attenzione sul ruolo avuto dal “premio per il rischio” di svalutazione e/o “ripudio” sull’evoluzione del rapporto debito pubblico / PIL. Per essere nelle condizioni di effettuare questa indagine, occorre assumere che – anche riguardo a mercati molto volatili come quelli finanziari e valutari - sia formulabile l’ipotesi di aspettative razionali. Se adottiamo l’ipotesi che gli agenti abbiano aspettative razionali di variazione del tasso di cambio (ragionando su una valuta dello SME rispetto al marco 125 si tratta di aspettative di svalutazione), la svalutazione attesa è misurabile con la svalutazione effettivamente determinatasi ex post. Nell’attuare una politica di pegging del marco, a causa di entrambi i “premi per il rischio”, le banche centrali dei paesi ad alta inflazione furono costrette a riconoscere a risparmiatori ed operatori finanziari ampi margini di tasso di interesse in eccesso rispetto a quelli pagati sulle attività finanziarie denominate nel marco. Naturalmente, il problema della scarsa credibilità dell’impegno al rispetto della parità bilaterali con il marco tedesco e della solvibilità dei governi riguardava essenzialmente le valute delle economie ad alta inflazione, quelle dei paesi della Periferia. Nella Figura 7.5, abbiamo visto che, successivamente ad uno shock di ampiezza pari a quella della Germania, sarebbe occorsa una manovra restrittiva della Banca d’Italia per fare scendere l’economia lungo la curva di Phillips di breve periodo fino al punto I” ed evitare che il differenziale di inflazione con la Germania si allargasse. La stretta monetaria avrebbe però comportato una contrazione troppo drastica dell’output e dell’occupazione. Le banche centrali della Periferia lasciavano così che i differenziali di inflazione si ampliassero, con conseguente ampliamento anche dei differenziali di tasso di interesse. Ricordando le equazioni (3.4-3.8) del § 3.4, nell’equazione (7.11) il primo termine esprime il divario fra il tassi di interesse (i) di un paese rappresentativo della Periferia e quello del paese leader dello SME, la Germania (iG); il secondo termine rappresenta il deprezzamento atteso della valuta della Periferia (ad esempio, l’Italia) rispetto al marco; inoltre sia ft il tasso di cambio a termine: (7.11) eˆte1 eˆt f t eˆt f t eˆt eˆte1 eˆt G (it i ) [(it it ) ][ ] ˆet ˆet ˆet ˆet G t Se si adotta l’ipotesi di aspettative razionali e si misura la variazione attesa del tasso di cambio mediante il tasso di cambio ex post (et+1), dal computo della (7.11) risulta 126 che i valori del primo termine sono stati sistematicamente in eccesso rispetto a quelli del secondo termine. Come si è spiegato nel § 3.4, in equilibrio il differenziale di interesse eguaglia il deprezzamento del tasso di cambio. Nell’equazione (7.11), un’eventuale divergenza fra differenziale di inflazione con la Germania e deprezzamento rispetto al marco può dipendere da un valore diverso da zero della somma algebrica delle due parentesi che compaiono sul lato destro. Descriveremo ora le probabili cause di tale divergenza (Farina, 1990). Nella prima fase dello SME (1979-1986), la differenza sul lato sinistro assunse valore negativo. Come sappiamo, dal momento che i primi anni dello SME furono caratterizzati da frequenti riallineamenti fra le valute, questo risultato non può derivare da un’elevata credibilità della politica monetaria del paese della Periferia nel perseguire la difesa delle parità di cambio. L’evidenza empirica suggerisce che questa diseguaglianza dipese essenzialmente dal valore negativo del primo termine sul lato destro. La parità scoperta dei tassi di interesse assunse valore negativo in molti paesi della Periferia a causa di un divario positivo fra cambio a termine e cambio a pronti che presentava un’ampiezza maggiore del differenziale di interesse. Ciò accade se è presente il “rischio paese”. Il grado di libertà che i controlli amministrativi adottati nella prima fase dello SME in alcuni paesi a valuta debole (ad esempio, Italia e Francia nei primi anni ’80) assicuravano alla politica monetaria condusse alla formazione di un “cuneo” fra i differenziali di tassi di interesse on shore (determinato sul mercato finanziario interno) e off shore (determinato sui mercati finanziari internazionali) con la Germania. I vincoli posti alla fuoriuscita di capitali permettevano infatti ai tassi di interesse del mercato interno di evitare un aggiustamento verso l’alto di ampiezza congrua all’ ampliamento dei differenziali di interesse con la Germania – approssimati dalle variazioni percentuali del “premio a termine” della valuta rispetto al marco, e cioè l’aspettativa di mercato sul futuro tasso spot – che si veniva a determinare sui mercati finanziari internazionali. Nella seconda metà degli anni ’80, parallelamente 127 all’abolizione dei controlli, tale “cuneo” andò restringendosi, fino ad annullarsi con il completamento della liberalizzazione dei movimenti dei capitali in tutti i paesi dello SME nel maggio del 1990. Nella seconda fase dello SME (1987-1992), in molti paesi della Periferia la “parità scoperta” dei tassi di interesse tese a discostarsi ancora dallo zero, ma per assumere questa volta valori positivi. L’origine di tale inversione di segno risiede questa volta nell’andamento della seconda parentesi quadra sul lato destro. La differenza positiva fra cambio a termine e cambio a pronti con il marco – risultando più ampia del deprezzamento registrato dalla lira ex post - indica la presenza di un “rischio valuta” che sostanzialmente dà origine alla divergenza positiva – sul lato sinistro – fra differenziale di interesse con la Germania e deprezzamento ex post della valuta nei confronti del marco. Lungo tutto il periodo di perfetta stabilità dei tassi di cambio all’interno del MTC si riscontra un eccesso del differenziale di tasso di interesse rispetto a variazioni di tasso di cambio. Questa persistenza non può che riflettere l’incompatibilità – percepita nei mercati finanziari – fra cambi fissi e credibilità della politica monetaria dei paesi ad alta inflazione che seguivano una strategia di pegging nei confronti del marco. La spiegazione della diseguaglianza fra differenziali di interesse e variazione del cambio con il marco risiede quindi nella sfiducia nutrita dagli operatori dei mercati finanziari nei confronti dell’annuncio di una monetary stance anti-inflazionistica da parte delle autorità monetarie (premio per il rischio di svalutazione) e/o nella solvibilità del governo (premio per il rischio di ripudio del debito pubblico). Il sospetto dei mercati era che tali autorità fossero indotte ad adottare politiche monetarie o fiscali tali da rinnegare gli “annunci” fatti. Questa sfiducia faceva anche sì che le aspettative di svalutazione implicite nei differenziali di tassi di interesse della Periferia con la Germania - benché trovassero una conferma soltanto parziale nel successivo deprezzamento del tasso di cambio delle valute più deboli nei confronti del marco – venissero corrette con molta lentezza. 128 10. La politica monetaria nell’Unione Monetaria Europea La moneta comune è entrata nella vita quotidiana dei cittadini europei nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 1 luglio 2002, quando le banconote e le monete in euro sostituirono le valute nazionali in 12 paesi. Figura 8.1. Convergenza nei tassi di interesse a breve termine, area dell'euro (deviazione standard) 6 5 4 3 2 1 0 1980 1984 1988 nominali 1992 reali 1996 2000 reali senza Grecia Il successo della moneta unica non va circoscritto alla conferma dell’acquisita stabilità monetaria, con un tasso di inflazione dell’area valutaria che si è sempre mantenuto intorno al 2%, fino a crollare a valori intorno allo 0,7% nella recessione provocata dalla crisi finanziaria. In effetti, parallelamente alla convergenza dei tassi di interesse nominali, indotta dall’accelerazione nella discesa dei tassi di inflazione, già a partire dal 1994, anche la dispersione dei valori tassi di interesse reali a breve termine conobbe una riduzione rapida e di ampiezza crescente. Successivamente alla decisione di dare avvio all’unione monetaria, il processo di convergenza nominale fra i paesi dell’UME subì una ulteriore accelerazione. Dal 1999 in poi, si è registrato il sostanziale uguagliamento fra i tassi di rendimento dei titoli pubblici a breve termine (Figura 8.1) ed un notevole restringimento degli 129 spread dei titoli pubblici decennali dei maggiori paesi rispetto ai corrispondenti titoli tedeschi. (Figura 8.2). Figura 8.2. Spread dei titoli pubblici decennali rispetto ai corrispondenti titoli tedeschi Figura 8.1. Convergenza nei tassi di interesse a breve termine, area dell'euro (deviazione standard) 6 5 4 3 2 1 0 1980 1984 1988 nominali 1992 reali 1996 2000 reali senza Grecia 130 È infatti aumentata la fiducia sulla solvibilità fiscale dei paesi ad alto debito pubblico, come dimostra il sostanziale azzeramento del premio per il rischio sui titoli pubblici. Per quanto si sia manifestata una tendenza all’avvicinamento fra i tassi di rendimento azionari, la percezione del rischio-nazione è invece ancora elevata riguardo alle attività finanziarie del settore privato. 11. L’euro nei mercati internazionali La letteratura economica si interroga sul futuro ruolo dell’euro come valuta internazionale. I fattori da cui tale ruolo dipende sono: 1) la velocità con cui procederà l’integrazione dei mercati finanziari europei; 2) le fusioni e le concentrazioni delle imprese bancarie europee, favorite dalle notevoli dimensioni dell’area finanziaria europea. Una tesi pessimistica associa lo status di valuta di riserva internazionale al potenziale economico dell’area valutaria di riferimento (in questo caso, i paesi aderenti all’UME). Benché la quota di commercio mondiale dell’UME sia pari all’11% (contro il 9% del dollaro e l’8% dello yen), l’euro non potrebbe affermarsi come valuta internazionale a causa delle debolezze strutturali delle economie europee: in primo luogo, la lenta dinamica della produttività totale dei fattori che genera una bassa crescita e la dimensione dei deficit e debiti pubblici dei paesi membri. Un’altra tesi è più ottimistica. Molte banche centrali asiatiche hanno programmato il progressivo incremento della quota in euro delle proprie riserve internazionali. Inoltre, giunge a prevedere per l’euro la stessa quota del dollaro USA nelle riserve delle banche centrali. Le motivazioni politiche vi giocano un ruolo centrale. Dopo tutto, così come alcuni paesi del Centro-America hanno risolto il problema della reputazione monetaria con la “dollarizzazione”, due regioni dei Balcani dall’incerto status giuridico come il Kosovo e la Bosnia-Erzegovina (di fatto, “protettorati” affidati dall’ONU all’Unione Europea) ed il Montenegro hanno ritenuto politicamente ed economicamente conveniente adottare unilateralmente l’euro come 131 propria valuta. Più in generale, l’affermazione dell’euro nei mercati finanziari internazionali dovrebbe derivare dal crescente impiego nelle economie emergenti dell’Asia parallelamente alla tendenza dell’UE a competere con gli US quale principale partner finanziario e commerciale. Ma il successo futuro dell’euro è anche legato alla soluzione della crisi dell’Eurozona ed all’evolversi del nesso fra finanza e sistema bancario. La tendenza delle banche centrali a detenere ingenti quantitativi di dollari nelle proprie riserve ufficiali è direttamente proporzionale all’utilizzo della valuta USA come mezzo di pagamento per le transazioni internazionali. Ancora nel 1998, il dollaro statunitense veniva impiegato nell’87% del totale delle transazioni internazionali. Questa percentuale fa ormai parte del passato. Quanto più si accelererà il processo delle fusioni e delle concentrazioni fra le banche europee, e l’attuazione dell’accordo sull’Unione bancaria favorirà la stabilità dei sistemi bancari nazionali, tanto maggiori saranno i flussi di capitali attirati dalle opportunità di investimento nelle attività finanziarie interne e tanto più si determinerà un processo di path dependence. Il mercato unico europeo delle attività finanziarie che dovrebbe scaturire dai processi di integrazione fra le principali “piazze” finanziarie sarà più “spesso” e più liquido dei mercati attuali. Gli investitori europei saranno in grado di operare in modo più efficiente in euro ed i differenziali di tassi di interesse euro-dollaro avranno un impatto maggiore sulle variazioni del tasso di cambio fra le due valute. In questa prospettiva interpretativa, la maggiore profondità finanziaria dell’economia europea produrrà due effetti: 1) i costi delle transazioni commerciali in euro si ridurranno, cosicché il possesso della valuta europea diverrà più attraente; 2) l’incremento degli scambi di titoli denominati in euro da un mercato dei capitali all’altro comporterà una diminuzione nel costo dell’utilizzo dell’euro anche nelle transazioni finanziarie internazionali. Se ne conclude che l’utilizzo crescente dell’euro nei mercati lo porterà a competere con il dollaro come principale valuta per gli scambi internazionali e la quota in euro delle riserve ufficiali delle banche centrali mondiali verrà adeguata in 132 relazione all’aumento delle transazioni di merci ed attività finanziarie effettuate con i paesi dell’UME. La quota di euro come riserva internazionale detenuta dalle banche centrali di tutto il mondo ha raggiunto nel 2009 il 28%, mentre il dollaro è al 62% (era al 71% nel 1999) e la sterlina, fino agli anni ’20 del secolo scorso principale valuta mondiale, è al 4%. Un più elevato grado di correlazione delle fluttuazioni di euro e dollaro rispetto allo yen costituirebbe la spia che le due principali valute occidentali sono divenute complementari, e quindi entrambe in grado di favorire la diversificazione del rischio. Ne potrebbe scaturire la fine del comportamento di benign neglect da cui ha finora tratto vantaggio l’autorità monetaria statunitense rispetto al cambio del dollaro con l’euro e lo yen, e l’inizio di un maggiore coordinamento fra le politiche macroeconomiche fra le due sponde dell’Atlantico. La BCE ha finora dichiarato di non volere influenzare l’andamento dell’euro nei mercati valutari internazionali e di volere lasciare che la determinazione del suo valore - in un contesto di crescente liberalizzazione ed integrazione dei mercati delle merci e dei capitali - sia esclusivamente guidata dalle forze di mercato. Nella concezione “liberista” delle autorità monetarie europee, il ruolo internazionale dell’euro dovrà essere il risultato non intenzionale delle transazioni di mercato effettuate da una moltitudine di operatori nei mercati liberalizzati ed integrati dei beni e dei capitali. Tuttavia, una completa integrazione fra i mercati obbligazionari ed azionari europei implica naturalmente il superamento dell’eterogeneità fra le “regole” nazionali: l’assetto societario (corporate governance), la tassazione di obbligazioni ed azioni, la normativa sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA), le condizioni contrattuali sui mutui, la regolamentazione Anti-Trust del settore bancario, il potere di vigilanza delle banche centrali nazionali. Pertanto, non va sottovalutata la rilevanza dei processi che avverranno nei fondamenti istituzionali dei mercati: in primo luogo, l’armonizzazione fra i sistema legali di common law e di civil law e fra i regimi fiscali nazionali. D’altro canto, la storia economica insegna che i processi di 133 omogeneizzazione fra le istituzioni che presiedono all’attività finanziaria e bancaria hanno di volta in volta seguito strade diverse. La convergenza istituzionale fra i paesi dell’UME potrebbe svilupparsi secondo due metodi: 1) Il “reciproco riconoscimento” nella normativa dei paesi membri. L’adozione di tale principio metterebbe in moto un processo di omologazione orientato dal mercato: l’obbligo per un paese a riconoscere tutte le istituzioni finanziarie autorizzate negli altri paesi dell’UME, il che quasi inevitabilmente sfocerebbe nell’abbattimento delle diversità nazionali. Tale indirizzo strategico non è molto gradito ai governi nazionali, che in tal modo perderebbero la capacità di governance sul funzionamento dei proprio mercato di borsa e la funzione di vigilanza sull’attività delle proprie imprese bancarie; 2) Un’autorità centrale di regolazione. Tale scelta istituzionale innescherebbe il processo opposto: un’armonizzazione fra le istituzioni nazionali tale da accelerare l’integrazione dei mercati azionari, obbligazionari e del credito. Una tale evoluzione avrebbe come naturale corollario l’estinzione delle istituzioni nazionali di regolazione e la nascita di un insieme di regole europee. L’attuale tendenza dei mercati europei - sia dei beni che dei capitali - fa ritenere improbabile questa seconda linea evolutiva. Il PIL dei paesi dell’UME è di poco inferiore a quello degli Stati Uniti, mentre il valore monetario delle obbligazioni e delle azioni quotate nei mercati finanziari USA è circa il doppio di quelle quotate nell’Eurozona. Ma gli attuali sviluppi indicano che l’evoluzione futura va nel senso di un incremento della “duplicazione finanziaria” del capitale delle imprese e quindi verso una progressiva chiusura del divario con gli US sia riguardo alla “profondità” che alla liquidità dei mercati finanziari. Ne sono esempi evidenti lo sviluppo dei mercati europei dei derivati ed i fenomeni di “cartolarizzazione” (la raccolta di liquidità da parte delle banche e dei governi mediante la collocazione nel mercato di obbligazioni rappresentative di crediti il cui rendimento è legato al loro diverso grado di “esigibilità”). 134 L’esito più probabile sembra essere l’omologazione dei mercati dell’Europa continentale al modello istituzionale anglosassone. In linea di principio, questo modello è orientato a preservare le “regole del gioco” della piena liberalizzazione dei mercati (Arrow, 1994). L’obiettivo è quello di mettere il loro funzionamento al riparo dalle interferenze dei governi, dalle tendenze monopolistiche e dalle turbative create dalle asimmetrie informative fra gli agenti. Il modello istituzionale dell’Europa continentale è incentrato sulla regolazione. Quindi è meno in grado di garantire l’indipendenza dei mercati dai governi, ma forse più attento a frenare gli squilibri nel potere di mercato che derivano da concentrazioni e fusioni e dai conflitti di interesse che si sviluppano con le partecipazioni incrociate nei mercati privi di agenzie di regolamentazione. Un mercato europeo che rispecchi entrambi i modelli istituzionali, integrandone gli aspetti migliori, è probabilmente possibile oltre che auspicabile. Una tale evoluzione sembra però impedita dagli ostacoli che si frappongono alla progettazione delle istituzioni comunitarie di regolazione dei mercati. Primo fra tutti, l’opposizione dei governi e dei mercati finanziari e creditizi alla centralizzazione del potere di regolazione a Bruxelles e Francoforte. Recentemente, un passo avanti è stato compiuto con la definizione dell’Unione bancaria (vedi oltre). Più difficile, data l’opposizione di paesi come Regno Unito e Lussemburgo, che traggono notevole vantaggio dalla bassa tassazione sui capitali, raggiungere un accordo sull’armonizzazione sulla tassazione dei redditi (salari e profitti), dei beni e delle attività finanziarie. 135 12. Il Meccanismo dei Tassi di Cambio MTC II Il MTC II è il meccanismo dei tassi di cambio disegnato nel Consiglio europeo di Amsterdam del 1997 ed ha ereditato le bande ampie di oscillazione che il MTC dello SME assunse a partire dal 1993. Esso ha lo scopo di regolare le parità ufficiali fra l’euro e le valute dei paesi interessati ad una futura ammissione all’UME, favorendo la convergenza nominale ai valori implicati nei criteri di Maastricht. Il criterio aggiuntivo sull’adozione dell’euro prevede la partecipazione al MTC II nei due anni precedenti all’ingresso. Fra le valute dei paesi che rinunciarono ad aderire all’euro e non si impegnarono a soddisfare i criteri di Maastricht alla data del 1 gennaio 1999 (Danimarca, Regno Unito e Svezia), ed escludendo la Grecia (ammessa nell’UME solo dal 1 gennaio 2001), soltanto la Danimarca partecipa al MTC II; Regno Unito e Svezia hanno l’impegno, in base al Trattato di Maastricht, di considerare la strategia di politica valutaria “di comune interesse” con l’UME, per non creare turbative al funzionamento del mercato unico. Nella stessa data del loro ingresso nell’UE, il 1 maggio 2004, i dieci nuovi paesi del quinto “allargamento” hanno acquisito il diritto a fare parte del MTC II. Per quanto non esista un regime di cambio che sia appropriato per ogni paese ed in ogni fase storica (Frankel, 1999), la letteratura di economia monetaria internazionale è oggi incline a ritenere sub-ottimali i regimi di cambio “intermedi”, dalla “fluttuazione manovrata” (managed floating), alla “zona valutaria” (target zone), dal MTC I dello SME all’attuale MTC II (cambi fissi con banda di oscillazione e pegging di una valuta “forte”), fino al currency board, ultimo stadio prima dell’abbandono del proprio segno monetario con l’adozione della valuta rispetto alla quale si effettua il pegging. Tali regimi, caratterizzati dal riferimento ad una valuta che funga da àncora per la politica monetaria hanno il difetto di esporre le banche centrali che li adottano alle volatili aspettative che si formano negli odierni mercati dei capitali liberalizzati. In contrasto con tale posizione teorica, i paesi dell’ultimo 136 ampliamento hanno scelto una strategia di graduale passaggio all’euro. Il sostanziale successo della creazione della moneta europea ha indotto i Paesi dell’Europa CentroOrientale ad accelerare l’ingresso nell’UME. Tali paesi, oltre ad adeguare norme giuridiche e regolamentazione dei mercati monetari e finanziari, sono impegnati nella realizzazione delle politiche macroeconomiche necessarie per ridurre inflazione e deficit pubblico. I tre paesi di maggiori dimensioni (Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria) e la Slovacchia hanno scelto regimi che permettono di contemperare un legame con l’euro con una certa flessibilità del cambio e cercano di contrastare tassi di inflazione più elevati rispetto all’UE-15 adottando l’inflation targeting come obiettivo di politica monetaria, attraverso la fissazione di un target in termini di indice dei prezzi al consumo; la Slovenia partecipa all’eurozona dal 1 gennaio 2007; i restanti cinque paesi sono entrati a fare parte del MTC II. A questi paesi si sono poi aggiunti i tre paesi baltici. Le tre grandi economie dell’Est Europa non hanno compiuto il passo dell’adozione dell’euro. Al contrario, data la relativa facilità con cui una economia di piccola dimensione può mantenersi competitivo attraverso i bassi salari, due dei tre paesi baltici - come si è già accennato, l’Estonia il 1.1. 2011 e la Lettonia il 1.1. 2014 - hanno portato l’Eurozona a 18 paesi. Pertanto gli Stati dell’Unione Europea che non utilizzano l’euro sono: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Lituania, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria. La principale ragione che consiglia i maggiori paesi dell’Europa Centro-orientale a non affrettare il passo verso l’euro è la difficoltà a conseguire al contempo stabilità dei prezzi e stabilità dei tassi di cambio in presenza di differenziali di inflazione con i paesi dell’UME. Un’altra ragione è la crisi che ha recentemente investito l’Euro nei mercati finanziari. Tale difficile contingenza comporta il rischio di subire attacchi speculativi che renderebbe inevitabile il prezzo di politiche macroeconomiche fortemente restrittive. Un ulteriore temibile fattore di instabilità macroeconomica è la volatilità delle aspettative dei mercati finanziari sui tassi di conversione e sulla effettiva data di adesione all’euro. Né va dimenticato che uscire dall’Eurozona dopo 137 avervi aderito è una scelta soggetta al grave svantaggio – a norma di Trattati - di dovere al contempo uscire anche dall’Unione Europea. Questo fattore di rigidità, finalizzato a rendere “costosa” l’uscita dall’euro di un paese, accresce l’avversione al rischio di aderire ad un’unione monetaria in crisi. 13. La Banca Centrale Europea Il sistema europeo delle banche centrali comprende la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) dei paesi membri dell’UE che hanno introdotto l’euro. Con la nascita della moneta unica la politica monetaria è stata centralizzata presso la BCE; la funzione di vigilanza sul sistema bancario e sulla stabilità finanziaria – in osservanza del principio di sussidiarietà – sono invece rimaste prerogativa delle BCN. Tale scelta risponde all’obiettivo di minimizzare i problemi informativi. Essa è tuttavia opinabile, perché la contiguità dell’autorità monetaria nazionale con le banche ad azionariato nazionale potrebbe distorcerne la scelta operativa. L’accesso alle facilities di liquidità che la BCE deve mettere a disposizione delle BCN in caso di rischio sistemico mette tali istituti potenzialmente in grado di procedere al salvataggio non solo degli istituti in “crisi di liquidità” ma anche di quelli per i quali si configura una vera e propria “crisi di insolvenza”. In una situazione di crisi bancaria, una BCN potrebbe orientarsi a privilegiare il perseguimento della stabilità del sistema finanziario sull’obiettivo dell’efficienza del sistema bancario e quindi svolgere il ruolo di “prestatore di ultima istanza”. In conformità con il principio di salvaguardia del sistema di incentivi del mercato, si dovrebbe invece permettere che le banche insolventi falliscano. In effetti, almeno due fattori sembrano militare a favore della centralizzazione della sorveglianza (prevista dall’accordo sull’Unione bancaria) e della concessione della funzione di “prestatore di ultima istanza” alla BCE, sull’esempio degli US dopo la crisi del 1929: 1) la globalizzazione finanziaria, in particolare la tendenza alla concentrazione fra le imprese bancarie europee. Tale processo sta creando assetti proprietari trans-nazionali, cosicché il vantaggio 138 informativo della banca centrale del paese della sede legale di una banca è destinato a venire meno; 2) Il sistema Target (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer). La creazione di tale gestione centralizzata dei flussi di liquidi - rivolta ad equiparare gli standard di concorrenza - non è in grado di impedire comportamenti di “azzardo morale” delle BCN nei confronti di banche commerciali nazionali in difficoltà. L’assetto istituzionale della politica monetaria nell’UME ricalca la struttura tipica degli stati federali. Vi convivono sia l’accentramento decisionale - rappresentato dal fatto che le decisioni di politica monetaria, benché siano preparate sul piano statistico ed econometrico sia dalla BCE che dalle BCN, vengono prese al livello centrale - che il decentramento operativo - in quanto le singole banche centrali provvedono ad attuarne le direttive nei rispettivi stati. Gli organismi decisionali della BCE sono il Comitato Esecutivo e il Consiglio Direttivo. I membri del primo organismo, chiamati a svolgere un mandato non rinnovabile di otto anni, sono sei: un Presidente, un Vice Presidente e quattro “esperti” di alto profilo professionale in campo monetario. Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogni due settimane nella sede centrale di Francoforte, è invece composto dal primo organismo e dai governatori delle banche centrali nazionali. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice; ognuno dei membri dispone di un singolo voto (ma gli Stati aderenti di piccole dimensione dovrebbero passare al sistema di voto a rotazione), in ossequio al principio accolto nel Trattato di Maastricht secondo il quale i governatori devono servire l’interesse comune dei paesi dell’UME nel loro complesso e non gli interessi nazionali. 14. La regola di politica monetaria Fra i cambiamenti strutturali avvenuti negli anni ’70 ed ’80 va annoverato anche l’affermarsi di un nuovo clima intellettuale riguardo al dilemma di fronte al quale le autorità monetarie si trovano, la scelta fra discrezionalità e regole di politica 139 monetaria. Il principale schema interpretativo di questi due decenni di “alta inflazione” è stato il modello dell’ “incoerenza temporale” della politica monetaria. Tale modello ha contribuito a diffondere nella teoria della politica monetaria un’opinione sfavorevole riguardo al potere discrezionale delle autorità monetarie ed al loro comportamento “attivistico” nelle politiche di stabilizzazione. I sostenitori dell’adozione di una “regola fissa” hanno proposto una commitment technology (ad esempio, la sanzione della penalità pecuniaria a carico del governatore che non si attenga alla regola) che vincoli in modo credibile l’azione delle autorità monetarie. Un evidente vantaggio della regola fissa, rispetto alla discrezionalità, è che una banca centrale la cui volontà di tenere fede alla regola risulti credibile riesce ad ottenere comportamenti di minore incremento dei prezzi da parte delle imprese price-setter. Il problema di determinare la regola ottima consiste nell’incompletezza dell’informazione a disposizione delle autorità monetarie. Riguardo al meccanismo di trasmissione della politica monetaria e alle determinanti dell’inflazione, è difficile stabilire in che misura il governatore debba tenere conto dello scostamento dell’inflazione e dell’output dai valori-obiettivo e di quanto occorra variare il tasso di interesse. Va rilevato, tuttavia, che nell’ultimo decennio l’affidabilità delle stime delle variabili rilevanti è notevolmente migliorata. Concentreremo l’attenzione sulla Regola di Taylor, che oggi rappresenta la funzione di reazione delle principali banche centrali. Con l’adozione di questa regola di politica monetaria, il tasso di interesse ha soppiantato la quantità di moneta quale strumento di attuazione della politica monetaria. Ecco l’equazione che esprime la Regola di Taylor: it*(r *)1(te1 *)2(Yt Y*)1et 2et1 l’equazione in base alla quale le autorità monetarie determinano il valore dell’obiettivo di tasso di interesse i* (la variabile sul lato sinistro dell’equazione) 140 perseguito in funzione dei valori noti dello scostamento del tasso di inflazione e dell’output gap dai rispettivi valori-obiettivo (tasso di inflazione perseguito: π*; reddito potenziale: Y*) e dall’andamento del tasso di cambio (le variabili sul lato destro dell’equazione). Se il tasso di interesse ed il reddito sono in linea con i rispettivi valori-obiettivo (le differenze in parentesi sono eguali a zero), e se la politica monetaria trascura il tasso di cambio e (il lato destro si riduce ai primi tre termini), l’equazione il tasso di interesse eguaglia quello che si stima essere il suo valore di lungo periodo (r + π*). Altrimenti, attraverso la variazione del tasso di interesse-base fissato dalla Banca centrale, il valore corrente del tasso di interesse viene ricondotto ad eguaglianza il suo valore di lungo periodo (r + π*). La contraddizione fra l’obiettivo di un rigoroso perseguimento della stabilità monetaria e l’obiettivo della stabilizzazione del reddito è meno rilevante di quanto appaia con riferimento ad un modello macroeconomico di concorrenza perfetta con perfetta flessibilità di salari e prezzi. Tasso di inflazione e output gap non sempre sono perfetti sostituti nel segnalare le tensioni di domanda presenti nel sistema economico. Un processo di aggiustamento divergente fra i due mercati – ad esempio, per una disomogeneità fra wage gap e price gap in concorrenza monopolistica - può influenzare la strategia di politica monetaria. Se la flessibilità del mercato dei beni differisce da quella del mercato del lavoro, soprattutto nel caso di una manovra di stabilizzazione diretta ad assorbire uno shock negativo di offerta, le autorità monetarie – per determinare l’opportuna variazione del tasso di interesse - debbono tenere conto sia dell’uno che dell’altro scostamento delle due grandezze dai rispettivi valori-obiettivo. L’originario studio di Taylor determina il tasso di interesse della Federal Reserve sulla base dei due termini noti (inflation gap e output gap) ed attribuendo dei valori noti ai parametri λ1, λ2. Affinché la determinazione del tasso-obiettivo it* sia precisa, è tuttavia necessaria la stima econometrica dei valori dei parametri. Essa consiste nell’utilizzare come termine noto il valore corrente del tasso di interesse sul lato 141 sinistro dell’equazione, cosicché i due parametri diventano le incognite da determinare. Una regressione condotta sulla politica monetaria degli anni 1987-89 ha stimato i seguenti coefficienti: per la Bundesbank λ1=1,3 e λ2= 0,2, e per la Federal Reserve i λ1=1,0 e λ2=0,9. Il confronto mostra che nel trade-off inflazione-disoccupazione la banca centrale che guidato la creazione di moneta in Europa negli anni dello SME dava all’obiettivo di inflazione un peso superiore ed all’obiettivo di reddito (e di riduzione della disoccupazione) un peso molto inferiore a quelli della banca centrale degli Stati Uniti. I coefficienti recentemente stimati per la BCE (λ1=1,5, e λ2 =0,5) indicano come la banca centrale europea sia ancora più rigorosa della Bundesbank nel fissare un alto valore del parametro relativo alla stabilità monetaria; il valore superiore a quello della Bundesbank del parametro relativo all’obiettivo della stabilizzazione dell’output sembra da attribuire al fatto che nei primi anni dell’euro si è manifestato un forte shock di domanda, a fronte della dominante presenza di shock di offerta negativi negli anni dello SME. Non va poi dimenticato che le politiche di stabilizzazione sono la risultante delle due stance monetaria e fiscale. Il policy mix che scaturisce dalle decisioni delle due autorità può alternativamente consistere in un equilibrio di Nash, dove ciascuna autorità massimizza la propria funzione di comportamento sulla base dell’aspettativa sulle credenze e sulle strategie dell’altra autorità, oppure in un equilibrio cooperativo, dove le autorità agiscono di concerto. La Commissione Europea si attende che la politica fiscale – in particolare nei paesi dell’UME ad “alto” debito pubblico privilegi l’obiettivo della decumulazione del debito su quello della stabilizzazione dell’output. L’obiettivo della stabilizzazione dell’output viene così a ricadere sulla sola politica monetaria. Una interpretazione rigida della regola monetaria stabilisce come unico obiettivo di policy il tasso di inflazione. Si tratta del cosiddetto inflation targeting, la regola coerente con il modello NCE, che afferma l’irrilevanza delle politiche 142 macroeconomiche ed attribuisce all’aggiustamento del mercato la funzione di superare uno shock negativo. Come si è accennato, diversamente dalla Fed, dove il valore del λ2 dimostra l’impegno a perseguire anche l’obiettivo di reddito ed occupazione, la BCE ha una funzione obiettivo “lessicografica”, cioè che pone la stabilità dei prezzi al primo posto e non ammette trade off tra gli obiettivi: si tratta di un inflation targeting rigido. Inoltre, la BCE è una delle poche che ha il potere (sancito dal Trattato di Maastricht) di fissare l’obiettivo di inflazione senza concordarlo con il “suo” governo (cioè la Commissione). Tuttavia, diversamente dalla BCE, le altre banche centrali che adottano l’ inflation targeting fanno ricorso spesso ad una sua versione meno rigida. Il Regno Unito dal 1992 e altri paesi con banche centrali indipendenti (Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti, da ultimo Giappone). prevedono un trade off tra variabilità dell’inflazione intorno all’obiettivo e variabilità del Pil intorno al livello (o al tasso di crescita) potenziale. In altri termini, di fronte ad uno scostamento del tasso di inflazione dal valore-obiettivo, modificano il tasso di interesse in maniera da tenere conto anche dell’obiettivo di reddito. Facciamo un esempio. In presenza di uno shock d’offerta negativo simmetrico, che innalza i costi di produzione e quindi l’inflazione al di sopra del valore-obiettivo, la regola dell’inflation targeting implica che la restrizione monetaria abbia un effetto pro-ciclico (finisce cioè per accentuare la discesa dell’output successivamente all’abbassamento rispetto al reddito potenziale causato dallo shock negativo). Una banca centrale può rendere l’obiettivo prioritario della stabilità monetaria compatibile con il perseguimento dell’obiettivo di stabilizzazione del reddito se realizza una correzione al rialzo del tasso di interesse meno che proporzionale rispetto alla variazione del tasso di inflazione. Il tasso di interesse-obiettivo viene perciò determinato mediante la somma fra tasso di interesse-obiettivo della Regola di Taylor e tasso di interesse del periodo precedente moltiplicati ciascuno per un “peso” (θ<1 e µt è l’errore stocastico): 143 (8.1) it it * (1 )it 1 t Tanto minore è il valore attribuito al “peso” che la banca centrale applica al tasso di interesse-obiettivo di lungo periodo (θ) – e, quindi, tanto più conta il tasso del periodo precedente (1-θ) - tanto più “lento” è l’adeguamento del tasso di interesse di mercato al valore-obiettivo it* perseguito dalla banca centrale, tanto minore è l’effetto prociclico. La scelta di esplicitare la sola stabilità dei prezzi come obiettivo della politica della BCE è stata interpretata come un segnale rivolto ai mercati finanziari internazionali: la BCE ha voluto presentarsi come l’erede dell’impegno anti-inflazionistico che valse alla Bundesbank il ruolo di guida della formazione di liquidità nello SME. Nei mercati valutari, i maggiori pericoli di tensioni inflazionistiche all’interno dell’UME vengono associati all’eventualità che uno o più governi possano esercitare pressioni sui governatori delle BNC perché il Consiglio Direttivo adotti una politica monetaria più accomodante. Nell’UME, il Chicken Game fra le due autorità è diverso dall’interazione strategica descritta precedentemente, perché la BCE fronteggia diciotto ministri del Tesoro. Come vedremo, l’esternalità negativa che la politica fiscale di un governo può trasmettere all’eurozona ha consigliato di sottomettere le politiche fiscali nazionali al coordinamento delle regole del PSC, nella convinzione che – in mancanza di un meccanismo di enforcement sulle fiscal stance dei governi nazionali - l’assetto istituzionale dell’UME abbia un’elevata probabilità di dare luogo ad una restrizione monetaria ed un’espansione fiscale, l’esito del Chicken Game con la peggiore somma dei pay-off. 15. Il Patto di Stabilità e Crescita Il PSC, entrato in vigore il 1 luglio del 1998, è l’istituzione preposta al coordinamento delle politiche fiscali dei paesi dell’UME. Il varo dell’unione monetaria, il 1 gennaio 1999, era destinato ad annullare l’incentivo a sorvegliare i 144 conti pubblici rappresentato dalla sanzione di esclusione dall’euro in caso di eccessivo deficit e/o debito pubblico. Fu indubbiamente tale sanzione a stimolare la convergenza nominale entro i limiti stabiliti. Una volta ammessi nell’UME, i governi avrebbero riconquistato piena autonomia, con il rischio di vedere una ripresa della formazione di deficit tale da mettere in dubbio la sostenibilità del debito pubblico. In breve, il primo dei due criteri di Maastricht sul settore pubblico, essendo stato recepito dal PSC, è rimasto in vigore nell’UME. Il PSC ha introdotto un sistema di “disciplina fiscale” più articolato rispetto al Trattato di Maastricht (TEU). Nel vietare il finanziamento in moneta dei deficit pubblici, l’art. 104 del TEU e l’art. 21.1 dello statuto della BCE, avevano affidato alle sole autorità fiscali nazionali la responsabilità dei bilanci pubblici. Il TEU afferma che una posizione fiscale solida è condizione necessaria per il buon funzionamento di un’unione monetaria; se i conti pubblici tendono verso il limite del 3% viene avviata una procedura che, in caso di infrazione, culmina in una sanzione. Gli articoli del PSC precisano le condizioni di validità del limite del 3% prevedendo che lo “sfondamento” si giustifichi soltanto in presenza di tre condizioni 1. l’eccezionalità: la causa deve essere una grave recessione, definita come una caduta improvvisa del reddito reale almeno pari allo 0,75%; 2. la transitorietà: il rientro nel limite deve avvenire subito dopo il primo anno e 3. la prossimità: il valore del rapporto non deve allontanarsi di molto dal 3%. Le principali integrazioni successivamente inserite al Patto sono state: 1) la Risoluzione che introdusse la formula “close to balance or in surplus”, che impone l’obbligo di raggiungere nel medio termine un bilancio pubblico “vicino al pareggio o in surplus”. La logica economica di questo vincolo aggiuntivo è che, nell’equilibrio macroeconomico, la posizione fiscale “normale” è il bilancio in pareggio. Una volta raggiunto il pareggio, in occasione di uno shock un paese si troverà nella condizione di potere sfruttare in tutta la sua ampiezza l’intervallo fra 0 (bilancio in pareggio nel medio termine) e 3% (vincolo sul deficit pubblico annuale), senza il timore che l’effetto espansivo, anche quello generato dal più robusto fra i sistemi di stabilizzatori 145 automatici, possa causare lo “sfondamento” del limite. Per rimanere ancorati al pareggio di bilancio nel medio termine, i paesi membri dovrebbero rinunciare a politiche discrezionali di stabilizzazione ed affidare la correzione del ciclo economico ai soli stabilizzatori automatici (vedi § 4.5); 2) l’Opinione del Consiglio Europeo del 2002 secondo cui la misura appropriata per valutare la posizione fiscale di un paese è il saldo di bilancio pubblico depurato dal ciclo (saldo strutturale); 3) il “nuovo PSC”, ovvero la revisione che nel marzo 2005 ha introdotto modifiche rivolte a rendere meno cogenti i vincoli del PSC: un periodo più esteso entro il quale correggere i deficit eccessivi; una maggiore discrezionalità nella valutazione delle suddette tre condizioni; in particolare, per i paesi con un “basso” rapporto debito pubblico/PIL, il limite non soggetto a sanzione è elevato al 3,5%, il periodo di tolleranza è esteso a due anni e dal computo del deficit pubblico sono deducibili alcune specifiche spese dirette a promuovere la crescita. L’applicazione delle regole del PSC avviene all’interno di un sistema di check and balances fra i poteri dell’UME. Qualora uno squilibrio nei conti pubblici abbia posto il deficit su un sentiero tendenziale di “sfondamento” – e non sussistano le condizioni per applicare i tre criteri di tolleranza - il Consiglio dei Ministri dell’Economia (Ecofin), su indicazione della Commissione, emette un “preavviso di infrazione” (early warning). La “procedura di deficit eccessivo” (PDE) prevista nel TEU assegna alla Commissione Europea il compito di monitorare l’andamento dei deficit e dei debiti pubblici rispetto al PIL dei paesi dell’UME ed eventualmente proporre la sanzione; la competenza per la decisione finale di esigere la sanzione spetta però all’Ecofin. Se la moral suasion affinché l’autorità fiscale del paese persegua le misure di contenimento suggerite non ha esito, viene comminata una sanzione: l’accantonamento in un deposito infruttifero di una forte pena pecuniaria. La potestà condivisa fra Commissione Europea ed Ecofin riguardo all’attuazione delle sanzioni rivela un precario compromesso fra scelta politica e vincolo economico. Assegnare la decisione finale ad un organo politico - ineccepibile sotto il profilo, per così dire, costituzionale – sotto il profilo economico rappresenta un 146 indebolimento del meccanismo di enforcement della politica fiscale che riduce la credibilità del PSC agli occhi dei mercati finanziari. Si pensi alle deliberazioni finora assunte dall’Ecofin nei casi di sfondamento del limite del 3%: la sanzione fu comminata (benché non eseguita) quando ad eccedere il “tetto” nel 2002 fu un paese meno influente come il Portogallo; ma quando a trovarsi in condizioni di inadempienza simili sono state nel 2003 Francia e Germania, la proposta di sanzione formulata dalla Commissione non è stata accolta. D’altro canto, il fatto che la Commissione debba render conto delle proprie decisioni (accountability) soltanto al Parlamento Europeo, da cui viene eletta, indebolisce il suo potere di proporre una sanzione a carico di un paese membro. La logica sottostante all’introduzione di un limite sul deficit pubblico / PIL ha ricevuto molte interpretazioni. La spiegazione di teoria economica più frequentemente addotta consiste nella turbativa della capacità della BCE di controllare il tasso di interesse sull’euro. Ingenti emissioni di titoli pubblici da parte di uno o più paesi dell’UME, generando un eccesso di domanda di fondi liquidi, potrebbe innescare tensioni al rialzo del tasso di interesse nei mercati finanziari europei. Tuttavia, le stime econometriche indicano che un punto di incremento nel deficit pubblico di un paese europeo di media grandezza ha un impatto di incremento del tasso di interesse molto basso: all’incirca 1/10. Un’espansione fiscale in uno o più paesi dell’UME non dovrebbe quindi riflettersi in un incremento del tasso di interesse per l’area valutaria nel suo complesso, quanto piuttosto nella formazione di un “premio per il rischio” di default sui titoli emessi da un particolare paese, soprattutto se è ad “alto” debito pubblico. Le cose cambierebbero una volta che si esaurisse l’offerta di liquidità molto ampia prodotta a livello mondiale dalla forte interdipendenza consolidatasi fra i mercati dei capitali successivamente alla completa liberalizzazione. In una fase di tassi di interesse crescenti, un eccessivo ricorso dei governi ai mercati finanziari dell’UME potrebbero causare l’esternalità negativa dell’incremento del tasso di interesse nell’eurozona. 147 Una seconda argomentazione si fonda sul timore che la BCE sia indotta a concedere credito ad un paese in difficoltà. Se un governo si vede costretto a rifinanziare il proprio debito a tassi crescenti e si nutrono dubbi sulla sua solvibilità fiscale, alla BCE è fatto divieto dallo Statuto di procedere al salvataggio (no bail-out clause). Tale clausola è rivolta ad evitare che la crisi di solvibilità di uno stato provochi un effetto sistemico sui mercati finanziari europei. Tuttavia, anche senza tirare in ballo il fattore politico, e cioè l’implausibilità di una “bancarotta” di uno stato europeo, è lo stesso impegno di no bail-out assunto dalla BCE ad apparire poco credibile. In qualsiasi momento la BCE potrebbe causare un’esternalità negativa ai danni degli altri paesi dell’UME intervenendo sul mercato secondario con operazioni di mercato aperto di acquisto dei titoli pubblici (e corrispondente creazione di euro) di un paese in crisi di insolvenza. Il “salvataggio” costringerebbe però la BCE ad accettare come collaterale delle operazioni di rifinanziamento al tasso “repo” anche titoli pubblici che gli istituti finanziari internazionali classificano ormai come “junk bond”. La BCE pagherebbe così il sostegno concesso ad un singolo paese con una grave perdita di credibilità. Nei mercati finanziari si diffonderebbe l’aspettativa di “monetizzazione” del debito pubblico dei paesi dell’UME e gli operatori tenderebbero a ridurre le proprie posizioni in euro. Un altro aspetto controverso è il fatto che il PSC è circoscritto alle regole riguardanti il deficit pubblico e non prevede un vincolo sul debito pubblico. Nessun divieto aggiuntivo venne previsto per i paesi il cui rapporto debito pubblico / PIL superava nel 1998 il 60% e che furono ammessi nell’UME sulla base del giudizio – ex post risultato mal fondato - dell’esistenza di un trend di “riduzione tendenziale”. Benché il PSC sia silente riguardo a questo secondo criterio di Maastricht di politica fiscale – il rapporto debito/PIL - dall’analisi del debito pubblico condotta nel § 4.5 è facile desumere che un nesso fra i due criteri di Maastricht esiste ed è rappresentato dal tasso di crescita dell’economia. Riprendiamo e sviluppiamo l’analisi delle relazioni fra deficit pubblico, debito pubblico e tasso di crescita. La stabilizzazione del rapporto debito pubblico/PIL : (bt 148 - bt-1 = 0) , implica che il deficit complessivo - la somma fra deficit primario e spesa per interessi – in percentuale del PIL non superi il prodotto fra tasso di crescita e rapporto debito pubblico/PIL. A condizione che l’equazione (4.15) può essere scritta come: g ( ) / b i . Poiché ( ) / b i rappresenta il deficit complessivo / PIL, utilizzando i valori percentuali imposti alla politica fiscale dal Trattato di Maastricht il 3% per il rapporto deficit complessivo / PIL ed il 60% per il rapporto debito / PIL (b) - si determina l’incognita (g): 0,05 = 3% / 60%. I due limiti risultano quindi compatibili con una crescita del reddito nominale pari al 5%. Non casualmente, all’epoca in cui i due limiti vennero concepiti per essere inseriti nel Trattato di Maastricht, il tasso di crescita in Germania era pari al 5% nominale (il 2,5% in termini reali). L’attuale tasso di incremento del reddito nominale nell’UME è però soltanto il 3% circa, pari al 40% in meno. Nella tabella qui sotto, nella prima riga si ricorda che i valori fissati a Maastricht di limite da rispettare per deficit e debito pubblico rispetto al PIL erano coerenti con un tasso di crescita nominale al 5% (supponendo un obiettivo di stabilizzazione del rapporto debito pubblico / PIL); nelle righe che seguono, si presentano alcuni nessi fra le tre variabili: deficit, debito e tasso di crescita. Il fatto che l’andamento del debito pubblico sia fortemente condizionato dalla dinamica del reddito rende problematico per i paesi ad alto debito pubblico / PIL il soddisfacimento del limite del 60%. Con un’inflazione che permane attorno al 2%, se il PIL reale non cresce al 3%, affinché un paese con un rapporto debito/PIL intorno al 60% possa rispettare il vincolo, il rapporto deficit/PIL deve necessariamente essere al di sotto del 3%. Sappiamo che non si tratta di un semplice esempio ma di una situazione reale, dato l’abbassamento del tasso medio di crescita registratosi in Europa. Ragionando secondo il modello del RBC, la perdita di un punto percentuale nella crescita media della produttività del lavoro nell’UE (dal 2,3% del quindicennio 197590 all’1,3% degli anni ’90) non si riflette in una fluttuazione ciclica ma va interpretata come una caduta strutturale del tasso di crescita del reddito dal 2,5% 149 all’1,5%. Se la Commissione Europea avesse abbracciato questo punto di vista, in base all’attuale tasso di crescita nominale del 3% (1,5% in termini reali: i valori del reddito reale sono compresi nell’Europa continentale fra 0,5% e 2%) il limite sul deficit dovrebbe essere molto più severo di quello attuale. Avrebbe infatti dovuto essere apportata la correzione del limite dal 3% all’1,8% (Gros, 2005). Oggi che il tasso medio di crescita annuo nell’Eurozona è caduto a valori vicini allo zero, tale correzione è divenuta improponibile. 16. La politica monetaria della BCE Il lungo processo di integrazione monetaria era stato caratterizzato da un lungo periodo di “alti” tassi di interesse reale determinati dalla Bundesbank per l’intera area dello SME. Una spiegazione alternativa della lenta crescita del decennio 1985-95 è stata individuata nei bassi tassi di crescita del reddito, che vengono messi in relazione con gli alti tassi di interesse e con l’abbandono in Europa delle politiche macroeconomiche di sostegno ai livelli di attività economica (Phelps, 1994; Fitoussi et al., 2000). L’evidenza empirica presentata nella Figura qui sotto mostra come per tutto il periodo centrale dello SME, il tasso di interesse fosse superiore al tasso di crescita. Se si escludono episodi particolari (il picco della recessione nel 1982 per gli Stati Uniti e nel 1993 per Germania, Francia ed Italia) , il confronto fra i tracciati per i tre maggiori paesi dello SME e gli Stati Uniti è particolarmente illuminante. Mentre i valori delle due variabili sono mediamente in equilibrio negli Stati Uniti, si registra mediamente un eccesso del tasso di interesse sul tasso di crescita, che a volte raggiunge una notevole ampiezza (in tutto il decennio 1985-95 i tassi di interesse sono stati in Europa superiori a quelli statunitensi; nel periodo 1989-93 i tassi a breve hanno sopravanzato i tassi a lungo termine). Nei tre paesi dello SME, il periodo di maggiore eccesso del tasso di interesse rispetto al tasso di crescita è quello che va dalla fine della prima fase (1979-86) alla fine della seconda fase (1987-92) dello SME. I tracciati di Germania da un lato e Francia ed 150 Italia dall’altro, sono molto diversi. In Italia, i divari positivi appaiono molto più pronunciati rispetto a quelli del paese leader dello SME già a partire dalla prima fase: nel § 6.6 ne abbiamo individuato l’origine nel differenziale di tasso di interesse dovuto ai premi per il rischio di cambio e di default. Nelle principali fasi recessive conosciute dai paesi dello SME (1980-82 e 1991-93), si può ipotizzare che l’orientamento restrittivo della politica monetaria della Bundesbank abbia finito per penalizzare non solo l’evoluzione del rapporto deficit pubblico/PIL (a causa dell’impatto negativo che alti tassi inducevano sul deficit secondario al numeratore e della lenta dinamica del PIL al denominatore) ma anche la crescita economica. Come viene illustrato nella Figura, in Germania, Francia ed Italia soltanto la drastica discesa dei tassi di interesse determinata dal passaggio all’unione monetaria rende nuovamente possibile quell’eccesso del tasso di crescita sul tasso di interesse che era scomparso con l’inizio dello SME. Figura. Tassi di interesse e tassi di crescita (valori reali): Germania, Francia, Italia e Stati Uniti (1979-2004) Germania crescita tasso di interesse a breve termine crescita 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 -2 1981 2003 2001 1999 -2 1997 0 1995 0 1993 2 1991 2 1989 4 1987 4 1985 6 1983 6 1981 8 1979 8 1979 Francia tasso di interesse a breve termine 151 Italia Stati Uniti 10 8 8 6 6 4 4 2 -6 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 -2 1983 -4 0 1981 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 0 -2 1979 2 -4 crescita tasso di interesse a breve termine crescita tasso di interesse a breve termine L’unione monetaria ha anche coinciso con una fase di bassi tassi di interesse reali nei mercati finanziari internazionali. L’ambiente economico in cui la BCE si trova ad operare è dunque fondamentalmente diverso rispetto a quello in cui erano venute a trovarsi la Bundesbank e le altre banche centrali europee. La politica monetaria comune dei primi cinque anni è stata condotta sotto il segno della prudenza. Una delle principali motivazioni risiede nel difficile equilibrio fra l’esigenza della BCE di costruirsi una reputazione anti-inflazionistica e l’esigenza di impedire che i fattori di instabilità macroeconomica – ad esempio, lo shock di domanda negativo rappresentato dall’attacco alle “torri gemelle” - compromettano le già molto deboli prospettive della crescita economica nell’area dell’euro. Questa difficoltà è stata accresciuta dalla circostanza che, se si esclude un breve intervallo fra metà 2000 e metà 2001, l’obiettivo intermedio della politica monetaria – un tasso di crescita dell’aggregato M3 (la base monetaria, più i suoi più vicini sostituti del mercato monetario) fissato dalla BCE al 4,5% annuo - è stato sempre mancato per eccesso, in una misura fra i 2 ed i 4 punti percentuali per anno. Una possibile spiegazione chiama in causa i valori immobiliari. Il rapido abbassamento dei tassi di interesse potrebbe avere stimolato la domanda di abitazioni con conseguente esplosione dei prezzi, oppure, all’inverso, l’alta percentuale europea di residenti proprietari potrebbe avere beneficiato di un effetto ricchezza da incremento dei valori 152 immobiliari tale da provocare un notevole innalzamento della domanda di moneta. Diversamente da altre banche centrali, la BCE non utilizza un indice del costo della vita che includa anche il prezzo delle case. La lentezza e la timidezza con cui la BCE ha corretto il tasso di interesse al ribasso potrebbe avere origine dall’incertezza sull’effettivo significato del livello abnorme di M3. Una strategia di politica monetaria sostanzialmente imperniata sull’inflation targeting, ma che si sviluppa senza un relativo annuncio e basandosi sul monitoraggio della M3, non è in grado né di intervenire con prontezza né di comunicare segnali credibili ai mercati. 153 Parte Terza Crisi finanziaria e Grande Recessione mondiale 1. Introduzione La crisi finanziaria 2007-09 ha gettato un’ombra sugli anni della “Grande Moderazione”. Con tale espressione si intende la crescita del reddito e dell’occupazione in presenza di inflazione bassa e stabile che caratterizzò le economie avanzate negli anni ’90. Alla Federal Reserve è stato da molti economisti attribuito il merito di avere saputo favorire quest’epoca di crescita continua con alto tasso di occupazione e senza inflazione. Benché il 2000 fu l’anno in cui scoppiò la bolla dot.com, fino all’esplodere della crisi finanziaria del 2007-09 il giudizio sulla politica monetaria del governatore Greenspan era più che lusinghiero. Al governatore veniva solo imputato di avere troppo a lungo favorito con bassi tassi di interesse la crescita dei listini finanziari, senza rendersi conto che alla fine degli anni ’90 i prezzi delle azioni erano troppo elevati rispetto alle aspettative di profitto futuro delle imprese dei settori ICT. La crisi finanziaria 2007-09, nel dimostrare quanto tali economie fossero in effetti esposte a gravi pericoli, ha anche smosso molte certezze. Ci si interroga, ad esempio, sull’intonazione costantemente espansiva che Greenspan diede alla politica monetaria della Fed, con l’effetto di sostenere dal 1992 al 2000 una crescita dell’economia statunitense mai interrotta da fasi cicliche negative, ma anche di generare un trend di crescita delle quotazioni di Wall Street che si è rivelato non conforme alle prospettive di profitto delle imprese. Come ha documentato Robert Shiller, una bolla finanziaria si caratterizza per un'anomala convergenza delle opinioni e delle aspettative degli investitori e degli intermediari finanziari sull'andamento dei prezzi delle attività patrimoniali: non solo diminuisce la percezione del rischio, ma viene meno la normale differenza di opinioni che, quando i prezzi salgono, induce alcuni a 154 comperare e altri a vendere. Questo accade quando la giusta preoccupazione delle autorità monetarie e governative di intervenire nei mercati allo scopo di impedire crisi di sfiducia è usata male dal sistema bancario. Negli anni precedenti le bolle speculative di fine secolo scorso, a Wall Street si consolidò l'opinione secondo cui la Federal Reserve americana e il Tesoro sarebbero intervenuti per salvare i finanzieri dai loro errori, da un lato con la creazione di moneta, dall'altro evitando il fallimento delle banche troppo esposte. Questa aspettativa ha creato un perverso incentivo per le banche, invogliandole ad assumere un atteggiamento opportunistico. Le banche hanno scambiato la giusta preoccupazione di proteggere i risparmiatori per la licenza di accrescere a dismisura il grado di rischio della loro attività. A favorire l’azzardo morale delle banche è stata anche la presenza di un grave conflitto di interessi: i ministri del Tesoro provengono spesso dai ranghi di Wall Street. Dopo la grande crisi degli anni ’30, la riforma del sistema bancario degli Stati Uniti si articolò in tre provvedimenti: 1) la Banca centrale assunse la funzione di prestatrice di ultima istanza (lender of last resort) del sistema economico; 2) lo Stato istituì il meccanismo dell’assicurazione pubblica dei depositi (con l’istituzione della Federal Deposit Insurance, il governo dà la garanzia della restituzione della liquidità ai depositanti delle banche insolventi, il che sollevò le banche dal timore di “corsa agli sportelli” in caso di panico finanziario); 3) la regolamentazione del sistema bancario divenne più stringente: il Glass-Steagall Act introdotto nel 1933 istituì la separazione fra banche commerciali (autorizzate a raccogliere depositi presso i risparmiatori) e banche di investimenti (che si finanziano esclusivamente sui mercati finanziari). Quest’ultima riforma ha incontrato sempre più oppositori in Europa dopo la deregolamentazione bancaria attuata negli anni ’80 negli Stati Uniti, culminata nel novembre 1999 con la promulgazione del Gramm-Leach-Bliley Act, che ha abolito tale separazione. Il motivo di fondo di tale rilevante cambiamento fu l’evoluzione della teoria economica a favore di una sempre più radicale attuazione del liberismo. 155 2. Squilibri macroeconomici nell’Eurozona Approfondiamo il problema dell’equilibrio macroeconomico complessivo di un’area valutaria con sistemi produttivi eterogenei qual è l’Eurozona. L’equilibrio macroeconomico complessivo di una economia risulta dalla somma algebrica dei bilanci dei settori privato, pubblico ed estero. In sintesi, un’eventuale divergenza (positiva o negativa) fra risparmi (S) ed investimenti (I) nel settore privato viene annullata dalla somma algebrica di eventuali divari fra le spesa pubblica (G) e le entrate fiscali (T) nel settore pubblico, e fra importazioni (M) ed esportazioni (X) nel settore estero: (S – I) = (G - T) + (X – M) Nel caso il risparmio ecceda l’investimento, il flusso in eccesso viene trasmesso dai mercati finanziari al settore pubblico per coprire un deficit (l’eventuale eccesso di spesa pubblica sulla tassazione: G>T) e/o per permettere agli operatori esteri di pagare l’eccesso di importazioni (i beni esportati dal paese stesso in eccesso rispetto alle proprie importazioni: X>M). Nel caso in cui sia l’investimento a sopravanzare il risparmio (S < I), l’eccesso di domanda interna deve essere compensato da un surplus del bilancio pubblico (G < T) e/o di capitali provenienti dall’estero (un eccesso di importazioni sulle importazioni: X < M). In altri termini, i flussi di capitale finanzieranno l’eccesso di spesa pubblica sulla tassazione (il deficit pubblico interno) e/o l’eccesso di importazioni sulle esportazioni. Se il volume degli investimenti cade al di sotto dei risparmi, come viene soddisfatta la condizione di equilibrio di economia aperta: S – I = (G - T) - (X - M) ? Lo squilibrio macroeconomico non può essere annullato con l’assorbimento dell’eccesso di risparmio da un eccesso della spesa pubblica sulle entrate fiscali: il PSC infatti vincola la politica fiscale al perseguimento del pareggio di bilancio ed esclude il ricorso alle politiche discrezionali. Non è d’altronde neppure facile 156 ipotizzare che il riequilibrio avvenga attraverso la creazione di un eccesso delle esportazioni sulle importazioni. Una domanda debole è infatti spesso la spia di una difficoltà ad espandere la propria quota di mercato estero. Un paese il cui CLUP presenti una dinamica più rapida rispetto a quelle degli altri paesi dell’UME soffrirà di una tendenza all’apprezzamento reale all’interno dell’area valutaria con conseguente formazione di deficit commerciale. L’indebolimento delle politiche di stabilizzazione ha così finito per lasciare la flessibilità del salario quale unico strumento disponibile di politica economica. La politica dell’offerta suggerita dai modelli NCE implica il ridimensionamento del ruolo dei sindacati e delle istituzioni del mercato del lavoro. Tali riforme microeconomiche dovrebbero consentire il rallentamento della dinamica salariale rispetto alla dinamica della produttività ed innescare il deprezzamento del tasso di cambio reale necessario a ripristinare la competitività e rilanciare le esportazioni (Allsopp e Artis, 1999). Una risposta agli shock completamente affidata all’operare dell’aggiustamento di mercato presenta tuttavia il rischio di innescare una competizione fa i paesi dell’UME attraverso uno strumento, come la svalutazione reale, che potrebbe perpetuare invece che superare la tendenza deflazionistica della domanda aggregata. Tale rischio è accentuato dalla notevole asimmetria che in Europa si registra nell’efficacia delle politiche economiche, riconducibile alla forte eterogeneità dimensionale. Dalla comparazione degli indicatori delle piccole economie con quelle delle economie di grandi dimensioni risulta che le prime ricorrono in misura maggiore alla competizione fiscale ed alle politiche microeconomiche (supply-side) e le seconde in misura maggiore alle politiche macroeconomiche (Elmeskov e Duval, 2005). L’evidenza empirica sembra convalidare l’ipotesi che il ricorso alla competizione fiscale è particolarmente vantaggioso per le economie di piccole dimensioni: data la limitata dimensione del settore produttivo nazionale, un più basso saggio di tassazione non causa gravi perdite nel bilancio pubblico, perché le entrate aggiuntive generate dagli afflussi di capitale dall’estero tendono ad eccedere la riduzione del gettito fiscale ricavato dalle imprese domestiche. I paesi di piccole 157 dimensioni possono inoltre trarre notevole vantaggio da riforme del mercato del lavoro: la forte apertura verso l’estero fa sì che un’alta flessibilità del salario al tasso di disoccupazione, permettendo un rapido aggiustamento dell’output al suo valore potenziale, porti alla riduzione del CLUP ed al miglioramento della competitività. D’altro canto, presentando una matrice intersettoriale molto meno “piena” di quella dei grandi paesi, i piccoli paesi hanno una elevata propensione ad importare, che è causa di un basso valore del moltiplicatore di economia aperta, troppo basso perché le politiche di espansione della spesa pubblica possano risultare vantaggiose. Al contrario, i paesi di dimensioni medio-grandi, grazie al più alto valore del moltiplicatore di economia aperta, contano sul sostegno della spesa pubblica alla domanda interna e sono quindi penalizzate dai vincoli posti dal PSC sulle manovre fiscali discrezionali e dalla mancata applicazione della “regola aurea” che permetterebbe di escludere dal vincolo del 3% le spese per grandi progetti di infrastrutture. Gli incentivi che il principio di sussidiarietà adottato da Bruxelles offre all’attuazione di politiche di competizione fiscale e di deregolamentazione del mercato del lavoro appaiono concepiti sul modello di una piccola economia aperta qual è ad esempio l’Irlanda - e sottovalutano come al problema della bassa crescita delle grandi economie dell’eurozona contribuisca il mancato sostegno delle politiche pubbliche alla domanda aggregata. Lo squilibrio macroeconomico all’interno dell’Eurozona, che vede il surplus di conto corrente della Germania contrapporsi (anche nel senso di impedire il riassorbimento dei deficit presenti in molti paesi della Periferia) presenta analogie con quello esistente fra Cina e Stati Uniti. Prima della crisi finanziaria, lo squilibrio macroeconomico interno USA era all’ingrosso così quantificabile: (S - I) = (G - T) + (X - M) -3 +4 -7 158 In breve, l’eccesso degli investimenti sul risparmio veniva finanziato dal resto del mondo. E’ stata in primo luogo la Cina a finanziare il deficit pubblico USA, acquistandone i titoli pubblici, e il deficit commerciale USA, acquistando le azioni delle imprese private. Dopo che la recessione seguita alla crisi finanziaria ha fortemente ridotto la domanda interna, ed il deficit pubblico viene alimentato dal trasferimento dei debiti delle banche al governo federale, il settore privato presenta uno squilibrio in diminuzione, il settore pubblico ha accresciuto la propria esposizione debitoria, mentre il settore estero ha visto ridursi il proprio deficit: (S - I) = (G - T) + (X - M) -1 +5 -6 Questo lento processo di riequilibrio vede in primo piano il ruolo del tasso di cambio. Con l’alleggerimento dei controlli sui movimenti di capitale, che limitano la conversione in renmimbi dei dollari ricevuti dagli esportatori dei settori pubblico e privato cinesi, l’eccesso di offerta di dollari a Pechino ha apprezzato il cambio della valuta cinese con il dollaro. La rivalutazione consentita dalle autorità cinesi al renmimbi ha ridotto il surplus commerciale della Cina ed il deficit degli Stati Uniti. Lo stesso riequilibrio non può accadere nell’UME, dal momento che la valuta comune rende impossibile la rivalutazione nominale della Germania e la svalutazione nominale dei paesi periferici. Un eventuale riequilibrio rimane così affidato ad un apprezzamento reale della Germania - attraverso un tasso di inflazione più alto della media UME che ne riduca le esportazioni nette verso il resto dell’UME - e un deprezzamento reale dei paesi periferici – attraverso quella discesa dei salari e dei prezzi che renderebbe più competitive le merci di queste economie a più alto CLUP. Il processo di riequilibrio si presenta difficile per due motivi principali: 1. Il rifiuto della Germania a concordare nel Board della BCE un obiettivo di tasso di inflazione più alto del 2%; 2. l’indisponibilità dei governi delle economie “deboli” ad affrontare, 159 in una fase di grave recessione, il costo sociale della deflazione (meno salario e più disoccupazione). I valori dei tre settori, da cui risulta l’equilibrio macroeconomico per la media dell’UME, possono essere all’incirca quantificati come segue: (S - I) = (G - T) + (X - M) +6 +6 0 Dal momento che i paesi periferici non posseggono potere di contrattazione rispetto alla Germania, è stata quest’ultima a dettare le condizioni per la sopravvivenza dell’euro. La strategia suggerita ai paesi periferici dalla Germania consiste in una restrizione fiscale che elimini o quanto meno riduca il deficit pubblico in modo da tranquillizzare i mercati finanziari ed in riforme economiche di flessibilizzazione dei mercati del lavoro e dei prodotti tali da avviare una deflazione di salari e prezzi e da spostare la domanda dal mercato interno al settore esterno in modo da volgere ad un valore positivo le esportazioni nette: (S - I) = (G - T) + (X - M) +6 +4 +2 Come la tabella qui sopra mostra, dal 2008-09 l’Irlanda è riuscita a realizzare un eccezionale processo di deflazione degli Unit Labour Costs (CLUP) relativamente alla media UME 1970-2010. La svalutazione interna consistente nella discesa del CLUP ha permesso all’Irlanda di recuperare la competitività perduta. 3. La divergenza macroeconomica all’interno dell’Eurozona L’unione monetaria diede un forte impulso all’integrazione finanziaria. Sull’onda della fine del rischio di tasso di cambio e dell’abbattimento del premio di rischio sui 160 titoli pubblici per il grande valore attribuito alla loro denominazione in euro, si ebbero importanti fusioni fra grandi banche europee ed acquisti reciproci in notevoli quantità di titoli pubblici degli altri paesi dell’Eurozona da parte di banche e operatori privati. Gli squilibri macroeconomici che si sono successivamente formati fra Centro e Periferia dell’Eurozona hanno due spiegazioni, probabilmente complementari (vedi le due Figure qui sopra: la prima mette in relazione l’andamento del rapporto conto corrente / PIL con l’evoluzione della domanda interna; la seconda mostra la dinamica della REER - real effective exchange rate - divergente nella Periferia rispetto alla Germania). La prima spiegazione consiste nel fatto che la forte espansione indotta dall’integrazione finanziaria nei finanziamenti cross-border ed i bassissimi tassi di interesse hanno causato eccessi di domanda di credito da parte delle imprese, ma l’espansione della domanda ha riguardato – oltre che le attività finanziarie, con la formazione di bolle speculative - soprattutto settori non suscettibili di accelerare la crescita e favorire la convergenza del PIL pro capite verso i valori dei paesi più avanzati. Total domestic demand growth rate, % w.r.t. EMU average Figure 1c- Domestic demand and current account (average 2002-2007) 1,5 ES IE GR 1 0,5 FI FR AT IT Eurozone PT 0 BE NL -0,5 DE -1 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 Current account balance, % of GDP 161 La tabella qui sopra mostra una correlazione negativa per i paesi dell’Eurozona fra tasso di crescita della domanda interna rispetto alla media UME (asse verticale) e rapporto saldo del conto corrente / PIL (asse orizzontale). In particolare, si osserva che 4 su 5 paesi periferici presentano un valore della crescita della domanda interna superiore alla media UME, conseguenza della forte integrazione finanziaria seguita all’unione monetaria, che ha portato molti capitali in questi paesi, generando una forte espansione e tassi di inflazione superiori alla media UME. Al contempo, gli stessi paesi hanno conosciuto un peggioramento della bilancia commerciale, dovuta non solo alla crescita delle importazioni causata dall’espansione produttiva, ma anche ad una perdita di competitività che penalizzava le esportazioni. La tabella qui sotto mostra come in quasi tutti i paesi, dopo l’avvio dell’unione monetaria, il CLUP (unit labour cost , in inglese) sale rispetto alla media UME del 1999. Posta tale media eguale a 100, l’Irlanda, e poi anche la Grecia, la Spagna e l’Italia vedono crescere il valore della REER; la Germania (ed in misura molto minore l’Austria) migliorano invece notevolmente la REER rispetto al 1999. La spiegazione è semplice. La Germania, a partire dal 2002-03 ha realizzato riforme delle istituzioni del mercato del lavoro che le hanno permesso di moderare la crescita salariale e di abbattere i costi e divenire più competitiva.. I paesi periferici a più rapida crescita del CLUP (più che per la dinamica salariale a causa del lento miglioramento della produttività del lavoro), una volta private della “valvola di sfogo” della svalutazione del tasso di cambio, hanno visto progressivamente peggiorare il loro REER. Si è perciò ridotta la loro competitività sui mercati esteri, con perdite di quote di mercato. Come si è visto con i due grafici qui sopra, le bolle speculative alimentate da tassi reali di interesse vicini allo zero negli anni 2004-07 – soprattutto in Irlanda e Spagna erano chiari segnali di una crescita poco solida, ben prima dell’arrivo della crisi finanziaria nata oltre-oceano. Evidentemente, le prospettive di facili guadagni indussero gli operatori finanziari – in primo luogo le banche – a puntare sui profitti di 162 breve periodo. In nome dello short-termism, l’attrazione esercitata da prospettive di profitto a breve termine, in alcuni paesi della Periferia si alimentò un ciclo espansivo imperniato sul settore immobiliare e sulla continua salita dei listini della borsa. Attratti dai più elevati rendimenti, i capitali si trasferivano dal Centro alla Periferia. Si preferì ignorare che a risparmi in calo per la crescita dei consumi si sommavano decisioni di investimento che erano lungi dal garantire un sano processo di catchingup basato sui settori produttivi avanzati. D’altro canto, i paesi periferici non seppero affrontare il problema di sostituire l’aggiustamento del tasso di cambio nominale con investimenti produttivi diretti a realizzare guadagni di efficienza economica. Tabella. Paesi periferici: ULC relativi alla media UME (1970-2010) =100 Soprattutto in Grecia, Portogallo ed Italia, la conseguenza è stato il declino della competitività. Alla domanda estera in diminuzione si è poi aggiunto il drastico calo della domanda interna, a causa delle politiche di consolidamento del bilancio pubblico imposte e monitorate dal PSC. 163 Questi due fattori di debolezza del sistema economico nella Periferia – eccessiva espansione della domanda interna e bassa competitività – vennero quindi sottovalutati. Il fatto è che nei mercati dei paesi periferici si determinarono erronei segnali di prezzo: dal momento che gli operatori finanziari chiedevano un premio per il rischio quasi nullo, i tassi di interesse permanevano bassi e si discostavano di poco dal tasso di interesse benchmark tedesco. Il tasso di interesse sui titoli pubblici del Sud Europa, che dovrebbe essere sensibile all’andamento di deficit e debito pubblici, presentava quindi spread molto bassi con i Bund tedeschi. I mercati non tenevano quindi conto né delle condizioni di insufficiente capitalizzazione delle banche, né del fatto che il tasso di interesse reale era quasi zero (per i differenziali positivi di tasso di inflazione nella Periferia rispetto ai paesi del Nord dell’unione monetaria). In questa ”bolla” di “illusione finanziaria”, i mercati mantenevano bassi i tassi di interesse nonostante valori del rapporto debito pubblico / PIL non coerenti con la sostenibilità finanziaria, come se si fosse in presenza di un’area valutaria che prevedesse la funzione di prestatore di ultima istanza per la banca centrale e/o una garanzia “comune” sullo stock di titoli sovrani dei paesi del Nord come del Sud Europa. La questione della declinante solvibilità dei governi tese perciò ad aggravarsi. Primo, le banche centrali nazionali (BCN) dei paesi periferici sottovalutavano il rischio preso da istituti bancari fortemente esposti a breve termine nel finanziamento di investimenti di lungo termine, cui si aggiungeva l’azzardo di portafogli squilibrati verso titoli ad alta volatilità. Secondo, la condizione di “sostenibilità” del debito pubblico era clamorosamente assente. Qualche anno di crescita accelerata non basta a generare aspettative di flussi di reddito futuri – e perciò di entrate fiscali - adeguati al rimborso del debito pubblico. Su tale miopia delle BCN si innestò la crisi economica. All’insolvenza delle banche, a fronte di crediti inesigibili, si sommò - una volta che il loro debito privato veniva trasformato in debito pubblico – il perverso “moltiplicatore” della crisi determinato dall’intreccio debito bancario-debito sovrano. Seguirono la stasi del credito, il crollo della domanda, la sfiducia dei consumatori a 164 basso reddito e la forte restrizione fiscale (l’”austerità”) imposta dall’esplosione del rapporto debito pubblico / PIL . 4. La crisi dell’Eurozona Si può dire che l’euro nacque sull’onda di una scommessa. Nella valutazione prevalente fra gli economisti al momento della sua progettazione agli inizi degli anni ’90, l’unione monetaria europea (UME) non era giudicata un’”area valutaria ottima”. La previsione prevalente fu che i costi (essenzialmente, la fine delle svalutazioni competitive) si sarebbero rivelati in eccesso rispetto ai benefici (essenzialmente, la drastica riduzione del costo del danaro e la minore aleatorietà dei progetti di investimento). Mundell (1961) giudicava improbabile che i vantaggi di efficienza legati all’accelerazione dell’integrazione economica ed alla accresciuta competizione fra i sistemi produttivi potessero compensare l’elevata esposizione al rischio di shock asimmetrici di paesi eterogenei. Successivamente ad uno shock negativo,. la rigidità del mercato del lavoro avrebbe impedito di ridurre il salario reale l’aggiustamento di mercato non si sarebbe realizzato e l’economia sarebbe entrata in recessione. In Europa, i paesi a più alta dinamica dei salari e più bassa dinamica della produttività del lavoro (relativamente ai paesi “forti” come la Germania) avrebbero maggiormente sofferto dell’impossibilità di recuperare competitività attraverso il meccanismo di inflazione-svalutazione del cambio. L’aspettativa di non-ottimalità dell’Eurozona non influenzò i politici, in quanto l’avvio nel 1991 del processo di unificazione monetaria culminato nella fissazione di tassi di cambio irrevocabili nel 1999 fu una decisione eminentemente politica promossa da Kohl e Mitterrand, che scaturì dallo “scambio” fra rinuncia al marco tedesco ed avallo alla riunificazione delle due Germanie. Paradossalmente, anche gli economisti ortodossi sostennero il progetto, attratti non tanto da un’Unione Europea sempre più integrata quanto dai cambiamenti strutturali da loro da tempo auspicati. Infatti, per varare la moneta unica si sarebbero finalmente realizzate in gran numero 165 privatizzazioni e liberalizzazioni dei mercati, la politica monetaria sarebbe stata rigorosamente anti-inflazionstica e la politica fiscale rivolta al ridimensionamento dei deficit e debiti pubblici, con la rinuncia alle manovre discrezionali di segno espansivo. Inoltre, come si è detto sopra, Mundell aveva corretto l’iniziale giudizio negativo sulla moneta unica in Europa, sottolineando come le probabili fasi di congiuntura negativa delle economie più deboli sarebbero state sostenibili anche dopo la perdita dello strumento di politica valutaria. Infatti, la liberalizzazione dei movimenti dei capitali avrebbe permesso un costante flusso di capitali verso le economie più arretrate e la fine del rischio di cambio avrebbe assicurato una più facile gestione dei portafogli dei risparmiatori. I timori sull’investimento dei risparmi nelle deboli economie dei paesi della Periferia venivano nell’analisi di Mundell fugati dalla diversificazione del rischio: le perdite sui titoli delle imprese dei paesi deboli sarebbero state compensate dai guadagni su quelli dei paesi forti; a garantire poi la solvibilità fiscale dei governi avrebbe provveduto la BCE, attraverso la credibilità che la denominazione nella nuova valuta avrebbe conferito al debito. Le conseguenze negative degli shock asimmetrici erano quindi affrontabili anche dalle economie periferiche. Il sostegno all’avvenuta decisione di varare l’euro venne infine razionalizzato con l’idea rassicurante che il computo costi-benefici andasse fatto tenendo conto del mutamento strutturale, e calcolato in base a modelli macroeconomici dove i coefficienti delle variabili considerate fossero quelli ex post (per ipotesi, migliori) e non quelli ex ante (si veda Frankel e Rose, 1998). L’ottimistica previsione di Mundell non ha finora trovato conferma. L’incentivo all’attività di investimento rappresentato dalla forte riduzione del costo del danaro (per la fine del rischio di cambio e la sostanziale riduzione del premio sul rischio di default) non ha dato i frutti sperati, neppure negli anni iniziali dell’Eurozona (19992006) che hanno preceduto la crisi finanziaria e la successiva Grande Recessione. E’ vero che l’integrazione finanziaria ha visto le banche del Nord Europa acquistare attività emesse sia del settore pubblico che da quello privato dei paesi della Periferia, 166 che fino al 2005-06 hanno conosciuto i tassi di crescita più elevati. Ma ciò ha solo creato l‘illusione delle virtù della ricetta supply-side: più liberalizzi i mercati, riduci le tasse e ridimensioni il sistema di protezione sociale, più sprigioni le forze progressive dei mercati. In realtà, la carenza di capacità imprenditoriali nei settori tecnologicamente avanzati fece sì che nella Periferia dell’Eurozona l’espansione degli investimenti favorita da bassissimi tassi di interessi reali si concentrassero nei settori finanziari ed immobiliari. Il forte processo di integrazione finanziaria avvenuto all’interno dell’Eurozona non ha prodotto lo sperato rafforzamento dei fattori di crescita delle economie periferiche, rimanendo solo una tessera del più generale fenomeno della globalizzazione. Inoltre, ci troviamo oggi di fronte ad un’inversione di tendenza dell’integrazione finanziaria in Europa. Le operazioni della BCE di rifinanziamento delle banche (le LTRO) hanno avuto l’effetto di favorire una “ri-nazionalizzazione” del debito pubblico dei paesi dell’Eurozona e dei capitali bancari. Per sostenere le quotazioni dei titoli nazionali massicciamente venduti dalle banche del Centro, le banche della Periferia hanno infatti utilizzato la ampia liquidità resa disponibile dalla BCE. Riassumiamo la crisi dell’Eurozona con riferimento all’equazione : (S – I) = (G – T) + (X – M) Come si è già detto, ogni diseguaglianza fra le variabili all’interno di ciascuno dei tre settori - Risparmi e Investimenti nel settore privato, Spesa pubblica (G) e Tassazione nel settore pubblico, ed Esportazioni (X) ed Importazioni (M) nel settore estero viene a scomparire nella somma algebrica delle varie poste. Ciò vale sia riguardo ai singoli settori all’interno di ciascun paese, sia nell’annullamento degli squilibri reciproci all’interno di un’area valutaria. L’equilibrio macroeconomico dell’Eurozona nel suo complesso è naturalmente un’identità contabile. Al netto dell’interscambio dell’Eurozona con il resto del mondo (il cui bilancio non si allontana mai troppo dal pareggio) una posizione di squilibrio in surplus in un paese o gruppo di paesi (Centro 167 o Periferia) corrisponde una posizione di squilibrio in deficit in un altro paese o gruppo di paesi (Centro o Periferia). L’Eurozona si presenta oggi fortemente divaricata fra un Centro in surplus di bilancia commerciale ed una Periferia in deficit di bilancia commerciale. Nella Periferia, in particolare in Irlanda e Spagna dove il tasso di crescita è stato fino al 2007 superiore alla media UME, l’origine del problema risiede nella rapida espansione della domanda domestica, dove alla discesa del risparmio hanno corrisposto le “bolle speculative” invece che gli investimenti produttivi necessari alla crescita e alla “sostenibilità” dell’indebitamento bancario e sovrano. In Portogallo ed Italia, dove il tasso di crescita è stato fino al 2007 inferiore alla media UME (come anche in Grecia, alla luce della revisione dei dati sul PIL) un ruolo importante nel favorire l’accumularsi di deficit commerciali con l’estero (il cui corrispettivo è in molta parte il surplus commerciale del Centro) è stato svolto in anni passati anche dai deficit presenti nel bilancio pubblico. Il messaggio di questa contabilità macroeconomica è semplice. I paesi della Periferia non hanno individualmente le risorse non solo per realizzare il catching-up di lungo periodo, ma neppure per uscire dalla recessione e stimolare la ripresa economica per bloccare i deficit con l’estero di breve periodo. L’attuale crisi dimostra come la struttura istituzionale dell’unione monetaria fosse inadeguata a fronteggiare un grave shock esogeno, qual è stata la crisi finanziaria nata negli Stati Uniti. Per riequilibrare nel breve periodo esportazioni ed importazioni, i paesi della Periferia hanno come unica politica ammessa dalla “troika” quella di deflazionare l’economia, provocando una discesa del CLUP, e quindi del reddito e dei consumi. Gli elevati costi sociali di una tale strategia sono sotto gli occhi di tutti. La conseguente risalita del risparmio, da cui ci si aspetta un miglioramento della bilancia commerciale, potrebbe non bastare a risolvere il problema della caduta del PIL. Essa, infatti, causa una variazione di segno positivo sul lato sinistro dell’equazione, proprio 168 mentre sul lato destro la forte restrizione fiscale produce nel bilancio pubblico una variazione negativa. Il fatto è che nel settore estero si registra un andamento diverso da paese e paese (in 3 delle 5 economie periferiche le esportazioni conoscono una riduzione superiore alla discesa indotta dalla recessione nelle importazioni) ma complessivamente ben lontano dal generare quel valore ampiamente positivo di ripresa delle esportazioni che sarebbe necessario per ripristinare l’equilibrio macroeconomico complessivo e frenare così la recessione evitando ulteriori cadute del reddito. In sintesi, al prezzo di una drastica deflazione anche la Periferia ora presenta un risparmio netto nel settore privato, ma lo squilibrio macroeconomico persisterà fintantoché non verrà alleviato il divario di efficienza con il Centro. La contabilità macroeconomica suesposta mostra come l’unione monetaria non possa andare avanti senza tenere conto della divergenza reale che mina la coesione economica e sociale al suo interno. A Maastricht si puntò su una progressiva convergenza fra i sistemi economici, nell’aspettativa che le condizioni di minore incertezza conseguenti al processo di unificazione monetaria avrebbero favorito il catching-up. Nel breve periodo, occorre una ripresa della domanda tedesca, tale da favorire la riduzione dei deficit di conto corrente della Periferia. Bisognerà poi, nel medio periodo, creare le strutture istituzionali necessarie a sostenere un progetto per la crescita, dove l’idea di integrazione della Periferia con il Centro abbia la stessa dignità dell’idea di convergenza spontanea, guidata dalle sole forze di mercato, da parte delle economie “meno avanzate”. Supponendo per semplicità che sia stato già conseguito il pareggio del bilancio pubblico richiesto dal Fiscal Compact: (G = T), l’equilibrio macroeconomico del Centro si può schematicamente rappresentare così: Centro: (S >I) = (G = T) + (X > M) 169 A partire dall’avvio dell’unione monetaria – ed in misura crescente all’indomani della crisi finanziaria - in alcuni paesi del Centro (in primis la Germania, seguita da Austria e Finlandia) si registra un surplus dei risparmi sugli investimenti, cui corrisponde un surplus di bilancia commerciale. Le condizioni finanziarie delle banche dei paesi del Centro-Nord dell’Eurozona (pure essendo banche internazionali, il loro capitale è in maggioranza ancora in mani nazionali) hanno potuto naturalmente giovarsi delle buone performance economiche delle economie “forti” in cui svolgono la maggior parte della propria attività, contribuendo a favorire la formazione dei flussi di capitale che operatori esteri hanno destinato all’acquisto delle esportazioni nette del Centro. L’equilibrio macroeconomico della Periferia si può schematicamente rappresentare così: Periferia: (S < I) = (G = T) + (X < M) I flussi di liquidità provenienti in primo luogo dalle banche del Centro hanno finanziato le passività emesse a copertura dei deficit pubblici (G > T) in alcuni paesi (Irlanda e Spagna) e di conto corrente (X < M) in altri paesi (Grecia e Portogallo). Nell’equazione qui sopra, il dato complessivo del settore pubblico per la Periferia– il bilancio in pareggio – si è progressivamente determinato grazie ai surplus compensativi conseguiti dagli altri paesi della Periferia. La Grande Recessione ha ridimensionato il disavanzo di conto corrente, accumulatosi in seguito alla rapida espansione delle importazioni (in particolare, in Irlanda, Grecia e Spagna), ed a causa della continua crescita, dal 1999 in poi, del costo del lavoro per unità di prodotto, che misura il tasso di cambio reale effettivo rispetto alla media dell’Eurozona. Il costo del lavoro per unità di prodotto (relativamente al valore medio dell’Eurozona) si è andato notevolmente accrescendo in Grecia e Portogallo (ed in minore misura in Italia) a causa di una sostanziale stasi della produttività. Seguendo un andamento speculare rispetto alla Germania (ed in 170 minore misura ad Austria e Finlandia), la dinamica salariale ha finito per causare una progressiva perdita di competitività che ha notevolmente penalizzato le esportazioni. Figura 7. conto corrente/PIL 6 4 2 0 -2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -4 centro periferia -6 -8 -10 -12 Fonte: AMECO La notevole espansione delle esportazioni tedesche è il frutto - oltre che della competitività sul piano della qualità - della moderazione salariale e della buona dinamica della produttività, che hanno permesso un forte recupero della competitività di prezzo rispetto ai primi anni del nuovo millennio. Il conto corrente in rapporto al PIL del Centro, nel quale è naturalmente molto rilevante l’interscambio della Germania, è così stato strutturalmente in surplus, a fronte del deficit della Periferia, in diminuzione in seguito al crollo delle importazioni degli anni più recenti (vedi Figura 7). Pertanto, una riduzione durevole dello squilibrio macroeconomico fra Centro e Periferia potrà realizzarsi in seguito ad uno dei due seguenti cambiamenti strutturali: 1) un trasferimento di domanda dal Centro alla Periferia, attraverso un decremento e un incremento del risparmio in ciascuna area, rispettivamente; 2) una ancora più drastica deflazione reale nella Periferia, tale da ridurre il divario di competitività con 171 il Centro e riportare a valori positivi il tasso di crescita attraverso l’aumento delle esportazioni. Le due soluzioni non sono equivalenti. Dall’analisi fin qui svolta risulta evidente che i problemi in cui oggi si dibatte l’Eurozona sono stati innescati dall’intreccio fra banche e governi scaturiti dalla crisi finanziaria, ma affondano le loro radici nella mancata convergenza fra Centro e Periferia acuita dalla debole crescita economica. I paesi della Periferia non hanno individualmente le risorse non solo per realizzare il catching-up di lungo periodo, ma neppure per uscire dalla recessione e stimolare la ripresa economica per bloccare i deficit con l’estero di breve periodo. L’attuale crisi dimostra come la struttura istituzionale dell’unione monetaria fosse inadeguata – in particolare per l’assenza un meccanismo di mutual risk insurance fra i paesi dell’Eurozona - a fronteggiare un grave shock esogeno, qual è stata la crisi finanziaria. Per riequilibrare esportazioni ed importazioni, questi paesi non hanno che la strategia di deflazionare l’economia, provocando una discesa del CLUP, e quindi del reddito e dei consumi. A Maastricht si puntò su una progressiva convergenza fra i sistemi economici, nell’aspettativa che le condizioni di minore incertezza conseguenti al processo di unificazione monetaria avrebbero favorito il catching-up. Si è probabilmente trattato di un eccesso di fiducia nella capacità di convergenza delle economie più arretrate. La divaricazione fra il Centro e la Periferia dell’Eurozona potrà ridursi solo se una crescita più rapida del PIL riuscirà a frenare la crescita del rapporto debito pubblico / PIL della Periferia. Il problema della sostenibilità finanziaria del debito pubblico non accenna a trovare soluzione (vedi l’incremento dei rapporti debito pubblico / PIL in Figura 3). In Irlanda e Spagna, i rapporti debito pubblico / PIL sono balzati rispettivamente al 110% ed al 90%. In altri paesi, la crisi economica è conseguita all’eccesso di spesa pubblica rispetto alla tassazione (in primo luogo, in Grecia), ed alla diminuzione delle 172 esportazioni a causa della progressiva perdita di competitività del sistema produttivo (di nuovo la Grecia, ma anche il Portogallo e fino al 2010 l’Italia). L’aumento del debito al numeratore si è andato così a sommare al crollo del PIL al denominatore, aggravando le aspettative pessimistiche degli investitori, anche a causa del persistente intreccio fra banche e governi. Figura 3 debito pubblico/PIL 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2011 Fonte: AMECO Uno dei limiti della struttura istituzionale dell’Eurozona è l’assenza di meccanismi finalizzati a contrastare l’avvitarsi di una crisi bancaria dopo un forte shock negativo. Il principale cambiamento finora adottato è stato il varo nel 2014 dell’Unione bancaria, cui si è accennato sopra, che prevede tre pilastri: 1. Il Meccanismo Unico di Vigilanza (Single Supervisory Mechanism, SSM) conferisce alla BCE la responsabilità di supervisionare le più grandi banche europee. 173 Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) ricapitalizzerà direttamente le banche, rompendo così il circolo vizioso tra banche e debito pubblico. 2. Il Meccanismo Unico di Risoluzione (Single Resolution Mechanism, SRM) consentirà alle autorità bancarie europee il potere di intervenire per attuare piani di recupero e per sostituire i manager bancari nel caso in cui una banca non dovesse soddisfare i requisiti patrimoniali minimi. Le autorità nazionali dell’SRM saranno in grado di prendere controllo di una banca in difficoltà, e di usare strumenti di terminazione, come il trasferimento delle attività, la creazione di una “bad-bank” (un salvataggio nel quale le perdite siano sostenute in primo luogo dagli azionisti, poi dalle obbligazioni subordinate e a seguire dalle obbligazioni di categorie maggiori e dai depositi superiori a €100.000). Le banche sarebbero tenute a mantenere sufficienti fondi propri e a esprimere le passività ammissibili come percentuale delle passività totali dell’istituto. Gli stati membri dovranno istituire un fondo di risoluzione, che deve raggiungere lo 0,8% dei depositi coperti. Così, in linea di principio, i contribuenti non dovranno pagare per le banche insolventi. 3. Un Sistema di Garanzia dei Depositi Europei (European Deposit Guarantee Scheme, EDGS) dovrebbe fornire una garanzia per i depositi fino a €100.000, in modo da superare la contraddizione tra banche internazionali e sistemi bancari nazionali. Nel prossimo paragrafo, si valuterà la strategia scelta dal consesso dei ministri dell’economia dei governi nell’UME, sotto la guida della Germania, per combattere la crisi di credibilità dell’Eurozona. 5. La politica dell’”austerità” ed il debito pubblico sul PIL L’accumulazione di un elevato rapporto fra lo stock di debito pubblico ed il PIL, una volta escluso che si faccia ricorso al finanziamento monetario del Tesoro, è derivato dall’esigenza di coprire i deficit primari annuali ed una crescente spesa per interessi. In questo quadro, più alto è il tasso di interesse nominale e più basso il 174 tasso di crescita del reddito nominale, più alto dovrà essere il surplus primario che stabilizza il rapporto debito pubblico/PIL. L’aumento del premio di rischio sul debito pubblico dei paesi periferici riflette appunto la valutazione dei mercati di un peggioramento della sostenibilità fiscale, dopo che il tasso di crescita è calato molto al di sotto del tasso di interesse, con la conseguenza che per stabilizzare il debito pubblico i governi debbono programmare un più ampio surplus primario per gli anni futuri. Come si è detto, il nuovo strumento di controllo sulle finanze pubbliche nazionali, il Fiscal Compact varato nel 2012 stabilisce che in 20 anni i paesi dell’Eurozona debbano completare il rimborso di tutto il debito pubblico in rapporto al PIL in eccesso rispetto al 60% . Ciò comporta una programmazione di surplus di bilancio - per venti periodi futuri - di ampiezza direttamente proporzionale al livello del rapporto debito/PIL rispetto del vincolo del 60%. L’ampiezza dei surplus annui da realizzare è particolarmente gravosa per i paesi della Periferia: i rapporti debito/PIL, notevolmente aumentati fra il 2007 ed il 2011 a causa della crisi (vedi Figura 4) vedono a fine 2012 quattro paesi al di sopra del 100% del PIL: Grecia (152,6%), Italia (127,3%), Portogallo (120,3%), Irlanda (117%) (dati Eurostat). La Grecia, oggi in deflazione (-1,35%), e con un rapporto debito/Pil oltre il 177% e un tasso d’interesse sul debito calmierato al 3%, non potrà mai rispettare le regole fissate dal Fiscal Compact: per farlo dovrebbe registrare una crescita superiore al 5-6%. Il Portogallo, con un avanzo primario dello 0,4%, un tasso d’inflazione leggermente negativo, una crescita prevista dell’1,2% e un rapporto debito/Pil al 129%, dovrebbe crescere anch’esso più del 5%. L’Italia sta molto meglio, ma come gli altri non è comunque in grado di soddisfare alla lettera il Fiscal Compact. Già nel 2015, mancherebbero circa 30 miliardi, considerando l’avanzo primario al 2,2%, l’inflazione attorno allo 0,5% e un tasso di crescita annuo vicino allo zero. L’aspetto paradossale della deflazione attuale è che verrà ancora più aggravata dal Fiscal Compact. Mentre quest’ultima è una istituzione di governance macroeconomica finalizzata a vigilare sui governi di un’area valutaria con debito 175 pubblico più che sostenibile: l’Eurozona presenta infatti - relativamente al Regno Unito e Stati Uniti, ormai al di sopra del 100% rispetto al PIL, per non parlare del Giappone (236%) - un rapporto di debito pubblico sul PIL di gran lunga più basso. Consideriamo le due visioni dell’impatto atteso dall’”austerità” sull’andamento del PIL. La prima, assimilabile alla prospettiva keynesiana, ritiene che la ricerca del pareggio di bilancio attraverso impulsi di restrizione fiscale comporterà un calo del reddito. La seconda, la tesi degli “effetti non-keynesiani”, riflette l’analisi macroeconomica della Nuova Economia Classica (NCE). Come si è detto nella Parte Seconda, questa modellistica sostiene che il consolidamento fiscale induce un effetto espansivo sull’output: il ridimensionamento dell’intervento pubblico indurrebbe infatti soggetti razionali ad accrescere la domanda di consumo intertemporale, dando quindi impulso alla crescita. Infatti, se è credibile una strategia del governo di abbassamento permanente della spesa pubblica, la conseguente aspettativa di riduzione permanente delle tasse fa sì che i soggetti si attendano un incremento del proprio reddito disponibile, il che li induce ad aumentare il consumo (Giavazzi e Pagano, 1990). Pertanto, una restrizione fiscale di tipo strutturale, che portasse ad un ridimensionamento della spesa sociale (ad esempio, una riforma pensionistica che fa scendere stabilmente questa voce della spesa pubblica), sortirebbe l’effetto di cambiare il segno del moltiplicatore del reddito – da negativo, come accade nel modello keynesiano – a positivo. Va ricordato che l’ipotesi degli “effetti non-keynesiani” della politica fiscale (Giavazzi e Pagano, 1990; Alesina et al., 2012; Alesina e Ardagna, 2013), è stata più enunciata che verificata. Recenti stime econometriche (Guajardo, 2011; Perotti, 2011) hanno confermato le conclusioni da tempo note riguardo ai limiti teorici e metodologici di tale ipotesi (Farina e Tamborini, 2002). Deboli effetti espansivi sono stati rilevati in piccole economie aperte (Danimarca, Irlanda, Svezia e Finlandia), ma solo in concomitanza con episodi di deprezzamento del cambio (Barrios et al, 2011). A generare gli effetti espansivi sull’output è stata quindi la domanda estera, non i 176 tagli di bilancio pubblico. Ciononostante, l’influenza intellettuale di questo approccio teorico sulla Commissione Europea è stata costante. Di fatto, il Patto di Stabilità e Crescita (PSC) - che è stato in vigore dal 1997, poi rivisto nel 2005, fino alla sua sostituzione con i vincoli ancora più stringenti del Fiscal Compact - si è configurato come l’applicazione dell’ipotesi degli “effetti non-keynesiani” alla politica fiscale nell’unione monetaria, in quanto prometteva che il ridimensionamento del bilancio pubblico avrebbe dato impulso alla ripresa del PIL. In letteratura, la maggior parte delle verifiche econometriche sono condotte mediante modelli neo-keynesiani DSGE, che alle rigidità nominali dei modelli neokeynesiani affiancano molte ipotesi neo-classiche favorevoli al verificarsi degli “effetti non-keynesiani”. Nelle simulazioni su questi modelli, tale risultato non trova però conferma. In realtà, per la Periferia dell’Eurozona vale l’esito affermato dalla prospettiva keynesiana. In altre parole, una restrizione fiscale aumenta il surplus di bilancio necessario a stabilizzare il rapporto debito pubblico / PIL. In un paese periferico, l’”austerità” è destinata a causare un incremento del surplus necessario ad impedire un’ulteriore accumulazione del debito pubblico in rapporto al PIL. I mercati si chiedono: riuscirà il governo a tagliare la spesa pubblica? Se non ci riesce, dove troverà le aggiuntive entrate fiscali? Il vero discrimine fra la prospettiva teorica ortodossa e quella keynesiana si coglie nei modelli con eterogeneità fra i soggetti, dove la principale fonte di eterogeneità è rappresentata dalla disparità di reddito. Affinché si realizzi il risultato keynesiano – il segno positivo del moltiplicatore fiscale - è sufficiente abbandonare l’ipotesi di mercati finanziari perfetti - che livellano redditi e piani di consumo intertemporale di tutti i soggetti in virtù dell’apertura di linee di credito illimitate da parte delle banche – e tenere conto del fatto che una quota di popolazione è soggetta a “vincolo di liquidità”. Il “vincolo di liquidità” riveste un ruolo cruciale per il determinarsi del risultato keynesiano: se nelle mani di persone che in passato sono state costrette a non 177 realizzare i propri piani di consumo un reddito aggiuntivo, è attendibile una propensione a destinarlo al consumo per la quasi totalità. Questo ragionamento, e cioè che tanto più calano occupazione e reddito tanto più alto è il moltiplicatore del reddito. rappresenta la cartina di tornasole dell’importanza della diseguaglianza di reddito nella determinazione dell’equilibrio macroeconomico. Un impulso fiscale espansivo ha l’effetto sia di innalzare il livello della domanda globale che di alleviare le conseguenze di una distribuzione del reddito sperequata. Una volta che, per effetto dell’espansione fiscale, un incremento del reddito corrente (la variabile indipendente della funzione del consumo, secondo l’originaria formulazione di Keynes) abbia liberato i soggetti dal “vincolo di liquidità”, al posto dei tagli ai piani di consumo cui tali soggetti erano stati costretti subentra l’incremento delle decisioni di spesa e si innesca un processo di espansione del reddito. In Europa gli stimoli fiscali si sono troppo precocemente esauriti. Dopo le timide manovre fiscali di sostegno all’economia seguite allo scoppio della crisi finanziaria, i governi hanno dovuto sottostare all’obbligo di continue manovre restrittive per ridurre il deficit complessivo (primario e secondario) fino al pareggio di bilancio, nonostante i loro paesi non fossero affatto usciti dalla fase recessiva. L’”austerità” però non riduce ma aumenta il rapporto debito pubblico/PIL, in quanto la restrizioni fiscali hanno l’effetto di deprimere il reddito. E’ allora probabile che il principale fattore che fa temere agli investitori il default degli Stati non sia tanto rappresentato da un alto debito pubblico quanto dall’impulso negativo che l’austerità determina sulla crescita. La restrizione fiscale imposta ai paesi periferici, riducendo il livello del reddito, fa lievitare il tasso di interesse (per la richiesta di un più alto premio per il rischio sul debito pubblico rispetto a quello sul Bund tedesco), che a sua volta fa aumentare il surplus necessario a stabilizzare il debito pubblico. L’obiettivo perseguito dall’austerità, ovvero mettere un freno all’accumulazione di debito e recuperare la sostenibilità fiscale, è destinato ad auto-distruggersi. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, l’“austerità” si rivela essere self-defeating, perché le manovre di 178 restrizione fiscale hanno determinato una perdita di output tale da fare aumentare – invece che diminuire - il rapporto debito pubblico / PIL. 6. Gli effetti deflazionistici della politica dell’“austerità” Proviamo a misurare l’impatto sulla crescita della politica di austerità imposta ai paesi dell’Eurozona. . Nella Figura 5, per ciascun paese dell’Eurozona, il tasso di crescita del PIL (asse verticale) è messo in relazione con l’“austerità” rispetto al PIL (asse orizzontale). La variabile ”austerità” è misurata come differenza fra l’effettiva variazione del saldo di bilancio pubblico e il valore che tale saldo “avrebbe dovuto assumere” in base ai valori “normali” della quota della tassazione sul PIL e del tasso di crescita dell’Eurozona. L’ipotesi è che l’impulso fiscale restrittivo induce una caduta del PIL, con la conseguente diminuzione delle entrate fiscali. Qual è l’impatto dell’austerità sul tasso di crescita del PIL? Una sua contrazione, come sostengono i keynesiani, oppure una sua espansione come sostengno il neo-classici? La variabile dipendente è dunque il tasso di crescita di lungo periodo dell’Eurozona. Per calcolare la variabile indipendente, il valore simulato, si è moltiplicata la variazione della crescita del PIL (in quattro bienni fra il 2007 e il 2012) al netto del valore medio di lungo periodo del tasso di crescita (2% annuo, quindi 4% su due anni) per il valore medio della tassazione dell’’Unione Europea (0.45%). Come si vede dall’interpolante nei vari grafici, in tutto il periodo successivo alla crisi finanziaria, l’impatto dell’austerità sulla crescita è negativo. L’analisi statistica condotta sulle due variabili rivela che il moltiplicatore è quasi pari ad 1 nel 2007-09 e raggiunge il valore più alto (1,43) nel biennio 2009-11, allorché le misure di restrizione fiscale imposte ai paesi periferici hanno finito per bloccare la ripresa della crescita dopo il primo crollo del PIL nel 2009. 179 Figura 5. Tasso di crescita del PIL (asse verticale) e “austerità” / PIL (asse orizzontale) nell’Eurozona (2007-2012) 20 2007-9 10 2008-10 15 5 10 5 0 -20 0 -15 -10 -5 0 -15 -10 -5 5 0 5 10 15 -5 -5 -10 -10 -15 -20 20 -15 20 2009-11 15 15 10 10 5 5 0 -10 -5 2010-12 0 0 5 10 15 -15 -10 -5 0 -5 -5 -10 -10 -15 -15 5 10 15 20 25 Il risultato di austerità self-defeating illustrato dalla Figura 5 è compatibile con vari “paradossi” descritti in letteratura, ciascuno riconducibile a diverse ipotesi sull’inclinazione delle rette di offerta e domanda aggregata (il modello AS-AD). Keynes introdusse il “paradosso della parsimonia”: quanto più si risparmia, tanto più il risparmio declina a causa della discesa del reddito da cui viene a formarsi. La necessità di accrescere il risparmio per fare fronte ad un abbassamento atteso dei 180 redditi futuri (o al ripianamento di debiti accumulati) ha l’effetto di ridurre il reddito perché le imprese prevedono che la domanda aggregata subirà un calo. Poiché l’”austerità” implica una riduzione del reddito disponibile delle famiglie, le imprese non aumentano la produzione e si innesca un moltiplicatore negativo di abbassamento del reddito. Un secondo paradosso discende dall’”effetto Fisher”: il deleveraging attuato per fare fronte alla crisi sortisce effetti negativi sulla domanda. Il deleveraging, invece di migliorare le condizioni di liquidità dei soggetti, provoca una deflazione che ha l’effetto di aumentare il valore del debito, che a sua volta costringe famiglie e imprese ad una spirale di continui tagli di spesa. Il terzo paradosso prende il nome di “paradosso della fatica” (Eggertsson, 2010a e 2010b). La contrazione della componente pubblica dei redditi delle famiglie determinata dal ridimensionamento dei trasferimenti monetari e/o dei servizi pubblici gratuiti goduti – induce la forza lavoro ad aumentare le ore di lavoro offerte. Per quanto l’aggregato dei lavoratori si sforzi di ridurre il livello di disoccupazione con un aumento dell’offerta di lavoro a salario invariato, la flessibilità verso il basso di salari e prezzi innesca un processo deflattivo. L’aumento dell’offerta di lavoro resta puramente nozionale, poiché la domanda aggregata e quindi il livello di attività economica si riducono, vanificando il miglioramento delle condizioni di costo del lavoro ottenuto dalle imprese (Eggertsson e Krugman, 2010). Questi luoghi teorici sono poco praticati dal cosiddetto “Brussels – Frankfurt consensus”, le visione macroeconomica di molti economisti delle due principali istituzioni Europee (Commissione Europea e BCE) ispirate alla teoria ortodossa. Un influente approccio alla crisi dell’Eurozona elaborato dalla Commissione Europea vuole che tanto più è alta la credibilità del programma di consolidamento fiscale e l’impegno del governo nell’attuarlo, tanto più i paesi in difficoltà per l’innalzamento dello spread potranno limitare le riforme strutturali di aggiustamento reale dell’economia (Buti, Roeger e Turrini, 2009). Di fatto, si propone ai governi un tradeoff: un più rapido consolidamento fiscale in cambio di un’ampiezza minore della 181 deflazione di salari e prezzi. Se i governi fanno mostra di non accettare tale scambio, resistendo ad un rapido consolidamento fiscale, Bruxelles potrebbe fare ricorso ad una strategia di “complementarietà”: il consolidamento verrebbe comunque imposto, minacciando il ricatto della sospensione degli aiuti finanziari. L’impostazione che il “Brussels – Frankfurt consensus” dà al problema del riequilibrio dei conti pubblici non tiene conto di un problema di breve periodo e di uno di lungo periodo. Il problema di lungo periodo è che la riduzione della spesa pubblica consiste sostanzialmente nel ridimensionamento dei trasferimenti e delle tutele del Welfare, dimenticando che il ritorno dei paesi della Periferia su un sentiero di crescita e di convergenza economica di lungo periodo è incompatibile con l’ingente costo sociale di riforme strutturali che si sostanziano in tagli alla sanità e all’istruzione. Nel lungo periodo, la diseguaglianza inter-regionale di reddito è infatti fortemente correlata con la diseguaglianza di opportunità di popolazioni residenti in aree con diverso grado di sviluppo, il che a sua volta presenta una serie di interrelazioni con la diseguaglianza interpersonale di reddito (Wilkinson e Pickett, 2009; Aghion e Cage, 2011). Il problema di breve periodo è che sia il taglio del deficit pubblico realizzato con la riduzione della spesa pubblica e l’aumento delle tasse, sia il taglio dei costi di produzione realizzato con l’abbassamento del salario ed i licenziamenti, esercitano un effetto depressivo sulla domanda. Una strategia di rientro da un alto debito pubblico deve tenere conto del fatto che quando il tasso di crescita si trova al di sotto del tasso di interesse – come accade ormai da anni nell’Eurozona - il surplus generato dai governi (attraverso consolidamenti fiscali che richiedono grandi sacrifici per i cittadini) si rivela fatalmente insufficiente a causa della concomitante caduta dell’output e quindi delle entrate fiscali. La questione del moltiplicatore fiscale non si esaurisce tuttavia nel dibattito teorico sulle relazioni analitiche che presiedono alla variazione dell’output dopo un impulso espansivo o restrittivo di politica fiscale. C’è anche la questione delle ipotesi che presiedono ai modelli economici utilizzati nell’analisi previsionale delle 182 principali istituzioni internazionali di analisi macroeconomica, che risentono del’influenza intellettuale del pensiero economico dominante. Non è stato ad esempio adeguatamente sottolineato che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) – nell’ambito della troika formata con la Commissione Europea e la BCE – ha potuto obbligare i governi dei paesi periferici a misure fiscali fortemente restrittive proprio sulla base di una valutazione dei loro effetti in termini di produzione ed occupazione perdute che è risultata ex post largamente sottostimata. In un recente lavoro (Blanchard e Leigh, 2013), Olivier Blanchard, l’economista capo del FMI, ha riconosciuto che l’effetto negativo che il moltiplicatore fiscale ha esercitato sul reddito si è rivelato durante la crisi molto superiore a quanto la teoria economica e le analisi econometriche avevano indotto a credere. L’utilizzo di parametri sottostimati nella previsione dell’impatto sul reddito dell’”austerità” ha determinato un significativo errore di misurazione rispetto all’effettiva caduta del PIL (l’errore per difetto è stato di - 1,2 nel caso del FMI e di 0,4 nel caso dell’OECD) (IMF, 2012). Che la distorsione verso il basso delle previsioni sull’impatto dell’”austerità” sia la conseguenza dei modelli teorici utilizzati è dunque un dato oggettivo: lo testimonia l’erroneità dei valori dei parametri inseriti nei modelli econometrici. Il vasto consenso sviluppatosi nella teoria macroeconomica attorno alla più recente versione della “sintesi neo-classica” ha orientato i policy-makers ad attribuire autorevolezza assoluta a verifiche empiriche condotte in base a modelli rigorosamente basati sulle ipotesi di aspettative razionali e mercati perfetti. Hanno così acquisito indiscussa reputazione scientifica le tesi secondo le quali l’espansione della spesa pubblica ha un impatto poco rilevante sull’attività economica (Ramey, 2012) e che il valore del moltiplicatore fiscale più elevato sia quello relativo alla tassazione (Alesina et al., 2012). Ben diversi sono i risultati cui pervengono gli studi il cui schema teorico non è ancorato alla “sintesi neo-classica” dominante e le cui stime econometriche tengono conto: 183 1) della quota di popolazione con “vincolo di liquidità”. Un indizio dell’importanza del “vincolo di liquidità” cui sono soggette le famiglie a basso reddito è l’elevato valore del moltiplicatore negativo - la forte perdita di output ed occupazione - prodotto dalle misure di austerità (Auerbach e Gorodnichenko, 2012). In presenza di tali condizioni, una espansioni quantitativa della liquidità può generare un moltiplicatore del reddito non inferiore ad 1,5 (in alcuni casi superiore a 2) e di valore di norma più alto in relazione alla spesa pubblica che non alle tasse (Coenen et al., 2012a e 2012b). Questa evidenza empirica suggerisce che nella formulazione di piani di consolidamento fiscale si sarebbe dovuto tenere in maggior conto la distribuzione del reddito e che per accrescere l’effetto moltiplicativo degli auspicabili impulsi fiscali espansivi sarebbe opportuno attivare trasferimenti monetari mirati ai soggetti in condizioni di “vincolo di liquidità”. Se si vuole, una minore quota della restrizione del bilancio pubblico a carico della spesa sociale si impone per ragioni di teoria macroeconomica, prima ancora che di equità; 2) delle condizioni del ciclo economico. Il risultato keynesiano di valore positivo ed elevato del moltiplicatore sconfessa le politiche di “condizionalità” imposte dalla troika per invertire il trend di aumento del rapporto debito pubblico / PIL causato dai salvataggi e dalla caduta dell’output. Quando, a partire dal 2009-10, molti governi dell’Eurozona hanno dovuto attuare gli interventi fiscali restrittivi, si sono generati aspettative pessimistiche ed effetti pro-ciclici sul reddito (Creel e Saraceno, 2010). Allo stesso modo, il risultato keynesiano accresce l’importanza di attivare la spesa pubblica. Nelle condizioni macroeconomiche di domanda di consumo particolarmente depressa che oggi caratterizzano le economie avanzate, è molto probabile che ad un impulso fiscale espansivo si associ un moltiplicatore positivo ed elevato (Baum, 2012). 3) del grado di “accomodamento” della politica monetaria. Una forte espansione monetaria ad un tasso di interesse nominale vicino allo zero, in assenza di tensioni al rialzo dell’inflazione, genera un moltiplicatore positivo, tanto più elevato quanto più la manovra “accomodante” si prolunga fino a due anni (Christiano et al., 184 2011). In presenza di una recessione molto grave come quella in corso, probabilmente caratterizzata anche dalla “trappola della liquidità” , la strategia di politica monetaria più appropriata consiste in una decisa azione espansiva diretta a ribaltare le aspettative degli agenti economici. La BCE potrebbe condurre una politica monetaria più aggressiva, mediante un tasso di interesse che non si mantenga di fatto a ¾ di punto al di sopra del livello fissato dalla Fed. Il cambiamenti strutturale risolutivo per generare l’aspettativa di maggiori guadagni e dare un forte stimolo all’attività di investimento, ma precluso ad una banca centrale non sostenuta da un potere sovrano, consisterebbe nell’inserimento di un più alto valore-obiettivo di tasso di inflazione nella “regola di Taylor”, in modo da determinare un eccesso di inflazione attesa rispetto al tasso di inflazione corrente (Eggertsson e Krugman, 2012). 4) dell’impatto espansivo sul PIL esercitato dalla spesa pubblica per investimento. In generale, l’impatto della variazione della spesa pubblica risulta essere superiore a quello della tassazione, il che smentisce la tesi sopra menzionata molto propagandata ma poco verificata - secondo la quale la ripresa della crescita è subordinata alla riduzione dell’intervento pubblico nell’economia, per l’impatto espansivo che una minore tassazione determinerebbe sull’economia reale. Per quanto riguarda le regole di politica fiscale, l’impatto sulla domanda sta diventando sempre più grande. L’accordo del Fiscal Compact, siglato nel 2012, prevede che in 20 anni tutti i paesi – con restrizioni fiscali commisurate alla distanza dal limite massimo di debito pubblico /PIL pari al 60% - conseguano questo obiettivo di Maastricht da cui quasi tutti i paesi dell’Eurozona si sono allontanati dopo la crisi finanziaria. Inoltre, l’accordo prevede che il deficit pubblico strutturale (ovvero al netto dell’impatto che il ciclo economico produce sul bilancio pubblico attraverso l’operare degli ammortizzatori sociali) non debba superare lo 0,5% del PIL; per i paesi che superano il limite ammesso nel corso di una recessione (il 3%) la Commissione europea commina automaticamente una sanzione – diversamente dal PSC, che prevedeva la ratifica dal sanzionamento da parte dell’Ecofin, il gruppo de ministri dell’economia). 185 Questa rapida ricognizione della vasta letteratura empirica sulla crisi induce a ritenere che, in presenza dei due dati oggettivi del “vincolo di liquidità” e della grave recessione, l’”austerità” dovrebbe lasciare il posto ad un’intonazione ancora più espansiva della politica monetaria e ad una maggiore spesa in investimenti pubblici. L’elevata spinta sul reddito esercitata dalla spesa pubblica in investimenti dimostra quanto miope sia rigorismo di Bruxelles e di Berlino, che hanno respinto la richiesta di mitigare l’impatto sulla crescita delle misure di rientro dagli alti deficit pubblici attraverso l’esclusione delle spese per investimenti dal calcolo del bilancio pubblico (la cosiddetta “regola aurea”). Se poi la politica monetaria della BCE avesse seguito quella della Fed, che all’indomani della crisi finanziaria ha portato fino a zero il tasso di interesse – a fronte dell’0,75 cui ancora permane in Europa - e realizzato programmi di Quantitative Easing ben molto più ampi, la successiva recessione sarebbe probabilmente stata meno pronunciata. I valori del moltiplicatore corrispondenti al più forte impulso alla risalita del PIL sono infatti quelli attivati dagli investimenti pubblici sotto le due condizioni già citate ( cioè realizzati durante una fase di grave recessione e da consumi famigliari “liberati” dal vincolo di liquidità) ma anche in presenza di un tasso di interesse nominale vicino allo zero (Auerbach e Gorodnichenko, 2013). Una politica monetaria della BCE più “attiva” avrebbe ridotto i guasti dell’”austerità” (nel 2011 il governatore Trichet persino aumentò due volte per contrastare inesistenti tensioni inflazionistiche). Mentre la Fed ha drasticamente ridotto il tasso di interesse base dal 5,25% dell’agosto 2007 all’intervallo fra 0 e 0,25% già nel dicembre 2008, la BCE lo ha diminuito molto lentamente dal 4,25% del luglio 2008 allo 0,5% del maggio 2013, al 0,25% nel settembre 2013, allo 0,15% nel giugno 2014, allo 0,05% nel settembre 2014. L’idea che una più aggressiva azione di politica monetaria permetterebbe all’Eurozona di raggiungere e mantenere un più elevato livello di attività economica converge con la tesi spesso sostenuta da Olivier Blanchard. Per evitare il rischio che la politica monetaria finisca per essere sub-ottimale, e cioè per peggiorare il livello 186 del benessere della popolazione, la monetary stance determinata dai modelli macroeconomici dovrebbe riflettere la resilienza delle istituzioni del mercato del lavoro in Europa (Blanchard e Galì, 2009). In breve, in regime di rigidità nominali, la politica monetaria ottimale deve abbandonare l’inflation targeting e assumere l’obiettivo di un tasso di inflazione non troppo vicino allo zero. In coerenza con tale prospettiva teorica, in lavori precedenti la crisi finanziaria Blanchard suggerì implicitamente che il presupposto per risollevare la domanda aggregata nell’Eurozona con una politica monetaria espansiva di stabilizzazione consiste in un valore-obiettivo del tasso di inflazione più vicino al 4% della Fed che non al 2% della BCE. La tendenza espansiva impressa alla politica monetaria da Fed e BoJ – che da molti mesi accettano l’innalzamento dell’inflazione e manifestano un benign neglect nei confronti della debolezza del tasso di cambio di USD e Yen – risponde all’esigenza di rilanciare la crescita guadagnando quote di mercato estero attraverso un cambio più competitivo. La BCE non pare però orientata ad impedire che il rafforzamento dell’Euro deprima ulteriormente il livello della domanda aggregata nell’Eurozona. Eppure, come si vedrà nel paragrafo successivo, la soluzione del problema della domanda nell’UME è urgente, in quanto si connette strettamente con la questione dello squilibrio macroeconomico esistente all’interno dell’Eurozona, che vede una forte divaricazione fra un eccesso di risparmio nel Centro (essenzialmente in Germania, date le dimensioni della sua economia) ed un deficit di risparmio nella Periferia. Di fronte al rifiuto della Germania ad indirizzare la propria economia verso un aumento della domanda interna - invece di puntare tutto sul traino delle esportazioni - il rilancio della domanda nell’Eurozona sembra essere affidato soprattutto alle politiche monetarie e fiscali comuni. Concludiamo analizzando, con riferimento all’economia italiana, le conseguenze che il protrarsi dell’impasse dell’Eurozona potrebbe causare. Ci serviremo ancora una volta di una semplice verifica sull’identità contabile dell’equilibrio macroeconomico completo: (S-I) = (G-T) + (X-M) . 187 Nel corso della recessione seguita alla crisi finanziaria, le famiglie hanno teso a mantenere i livelli di consumo, supplendo ai minori trasferimenti pubblici (dovuta ai tagli alla spesa pubblica per gli stabilizzatori automatici, indotti dalla necessità di ottemperare al Patto di stabilità) con la contrazione del risparmio. Tuttavia, la recessione ha provocato in Italia una caduta degli investimenti che ha sopravanzato la riduzione del risparmio (S < I), sicché il moltiplicatore negativo ha prodotto la discesa del PIL ad un livello più basso. Il nuovo equilibrio macroeconomico vede il saldo negativo del settore privato sul lato sinistro dell’equazione trovare compensazione nel saldo negativo del settore pubblico (G < T) dopo la creazione di surplus generata dai tagli di spesa pubblica; il saldo del settore estero è pressoché in pareggio (X = M ), dal momento che la caduta del reddito ha determinato l’annullamento dell’eccesso delle importazioni sulle esportazioni. Come abbiamo argomentato in precedenza, nell’attuale fase di profonda recessione, e di pesanti “tagli” nei piani di spesa delle famiglie, una volta esaurito lo smobilizzo dei risparmi, una politica fiscale keynesiana è l’alternativa alla deflazione (la “svalutazione reale” consistente nell’abbassamento dei salari e dei prezzi). Il rilancio degli investimenti pubblici e una riduzione delle tasse sui redditi bassi innescherebbero un moltiplicatore dei consumi, generando così la ripresa economica. 7. La struttura istituzionale dell’Eurozona Il passaggio alla centralizzazione della politica monetaria, in presenza di un controllo della Commissione sui bilanci nazionali orientato soltanto alla disciplina fiscale, ha rappresentato un percorso di unificazione delle politiche pubbliche europee lasciato a metà. Nel contesto di marcata eterogeneità che caratterizza i sistemi produttivi dei paesi dell’UME, un tasso di interesse sull’euro “uguale per tutti” può causare una sotto-stabilizzazione in un paese il cui output gap ha un’ampiezza superiore alla media UME, oppure un tasso di interesse reale negativo per i paesi a più alto tasso di inflazione (come è avvenuto in Irlanda e Spagna nel 2004-07) con conseguente 188 eccesso di espansione della domanda. Così pure, la crisi finanziaria ha mostrato come un mix di politica monetaria e fiscale ambedue di segno restrittivo possa creare una tendenza deflazionistica in tutta l’Eurozona. La recessione conseguita alla crisi imporrebbe una politica fiscale anti-ciclica. Un ciclo economico recessivo, attraverso il prolungarsi della disoccupazione, può infatti causare un abbassamento durevole del tasso di occupazione, indebolendo la crescita fino al punto di generare una stagnazione di lungo periodo. Il fatto è che con la perdita dell’autonomia di politica monetaria e valutaria ed i vincoli stringenti posti dal PSC sulla politica fiscale, la cassetta degli strumenti di politica macroeconomica si è pressoché svuotata. I governi sono così più indifesi di fronte agli effetti perversi degli shock sull’espansione di lungo periodo. Come si è già accennato, uno shock esogeno che non sia sufficientemente contrastato a livello nazionale dall’aggiustamento mercati del lavoro e dei beni vede Bruxelles priva di un bilancio comunitario che possa impegnare risorse per una politica di stabilizzazione del reddito degna di questo nome. Né il varo dell’Unione bancaria rappresenta un passo risolutivo nella direzione della coesione macroeconomica dell’Eurozona. L’obiettivo dell’unione bancaria è quella di impedire il propagarsi di una recessione attraverso insolvenze bancarie, ma residua in ogni caso il problema di misure atte a ridurre l’impatto di uno shock sui PIL nazionali sui livelli di occupazione e di domanda dei paesi dell’Eurozona. Come la crisi in corso ha abbondantemente dimostrato, dato che le condizioni dei rapporti debito pubblico / PIL impediscono politiche anti-cicliche dei governi nazionali, è indispensabile una modifica dei Trattati, in modo da introdurre un’Unione fiscale dotata di un meccanismo di aggiustamento centralizzato a Bruxelles. Le prospettive di ripresa economica di lungo periodo dell’Eurozona sono legate soprattutto alla revisione del suo assetto istituzionale, con il varo dell’Unione bancaria ora in corso, e con un futuro approdo all’Unione fiscale. Tuttavia, anche le istituzioni attuali possono contribuire nel breve periodo al rilancio della crescita. La BCE è indebolita da uno Statuto che le vieta di svolgere la funzione di prestatore di 189 ultima istanza e di effettuare acquisti di debito sovrano nel mercato primario per ripristinare il canale di trasmissione della propria politica monetaria nei paesi in cui i mercati finanziari reputano sia in dubbio la sostenibilità fiscale e quindi provocano una tendenza al rialzo dei tassi di interesse. La funzione di comportamento del governatore della BCE – precedentemente illustrata con riferimento alla Regola di Taylor - consentirebbe tuttavia di utilizzare due strumenti importanti di politica monetaria – per favorire la ripresa delle economie più colpite dalla recessione. Primo, la fissazione di un tasso-obiettivo di inflazione più elevato permetterebbe di aumentare l’efficacia della politica monetaria in due modi: 1a. Accrescendo la flessibilità dello strumento di politica monetaria, il tasso di interesse, mediante un più alto obiettivo di inflazione. Il tasso di interesse base (il tasso di rifinanziamento alle banche) potrebbe essere maggiormente ridotto: con un obiettivo di inflazione П = 4% invece che П = 2%. Supponiamo di essere in recessione e che occorra un drastico abbattimento del tasso di interesse. In presenza di inflazione effettiva pari al valore-obiettivo del 2%, e di un tasso di interesse nominale al 5%, il tasso-base potrebbe essere ridotto di ben 3 punti senza che il tasso di interesse reale. Una tale riduzione è però impedita dall’incremento del tasso di inflazione al di sopra del valore-obiettivo che conseguirebbe dall’espansione produttiva divenga negativo. Con un obiettivo pari al 4%, ci sarebbe invece “spazio” per il necessario drastico abbattimento del tasso di interesse, con conseguente aumento sia della produzione reale sia del tasso di inflazione (che potrebbe aumentare anche di 2 punti). 1b. Supponiamo nuovamente la presenza di recessione economica e che occorra un drastico abbattimento del salario reale. Con un’inflazione effettiva pari al valoreobiettivo del 2%, una dinamica salariale pari al 2% non può essere contrastata – se non al prezzo di una violazione del limite del 2% di inflazione - da una espansione monetaria inflazionistica (indotta dalla riduzione del tasso di interesse) che riduca il potere di acquisto del salario nominale. Il salario reale potrebbe invece essere ridotto se la banca centrale potesse sfruttare con un’espansione monetaria i 2 punti d 190 aumento dell’inflazione disponibili. Tale manovra espansiva avvicinerebbe il tasso di inflazione-obiettivo al 4%, parallelamente alla ripresa dell’occupazione (favorita dalla riduzione in termini reali del salario reale) e della produzione. Secondo, se la BCE, nel fare politica monetaria in base alla Regola di Taylor, modificasse il tasso di interesse anche in funzione del tasso di cambio con il dollaro, una sopravvalutazione come l’attuale rapporto 1,40 dollari circa per 1 euro andrebbe subito corretta. La riduzione del tasso di interesse avrebbe l’effetto di rendere meno profittevole l’acquisto di attività finanziarie dei paesi dell’Eurozona, innescando così un deflusso di capitali, che finirebbe per indebolire l’euro rispetto al dollaro. Tutti i paesi dell’Eurozona si avvantaggerebbero per il conseguente aumento delle esportazioni. In particolare, però, sarebbero i paesi della Periferia – costretti dai vincoli di politica fiscale a seguire politiche di austerità - a goderne maggiormente. I paesi della Periferia avrebbero infatti la possibilità di rilanciare le loro economie: la ripresa delle esportazioni non sarebbe infatti più legata alla capacità di realizzare la deflazione reale (al prezzo della discesa dei salari e/o dell’occupazione), ma scaturirebbe dall’espansione della domanda extra-UME. In altri termini, la Periferia potrebbe conseguire la ripresa economica accrescendo la domanda estera a domanda interna invariata (avendo evitato la contrazione del monte-salari) senza dovere ricorrere all’”austerità”, cui non segue un aumento del Pil, ma - come si è visto – una sua ulteriore contrazione. 8. Cenni sul sistema monetario internazionale Il sistema monetario internazionale rappresenta la cornice di relazioni fra le valute entro la quale hanno luogo le transazioni di beni, servizi e capitali fra i paesi. Com’è noto, il passaggio nell’antichità dall’economia di baratto all’economia di scambi di beni mediati dalla moneta è stato interpretato dalla teoria economica in base al concetto di moneta-merce: il valore di una moneta corrispondeva al contenuto aureo o d’argento con cui veniva realizzato il mezzo di pagamento. Successivamente, si è affermata l’idea che il potere del principe o del sovrano il cui volto è stampigliato su 191 una faccia della moneta fosse la vera base su cui poggiava la fiducia nella moneta con cui si viene pagati quando si vende un bene. Ad esempio, la ricerca storica ha evidenziato come le monete circolassero nonostante la pratica di limare le monete ne riducesse il contenuto aureo. Nella teoria economica è così maturato il concetto di moneta-segno: i cittadini di uno Stato sono disposti a riconoscere alla moneta la capacità di estinguere un debito perché le si riconosce non solo la funzione di unità di conto e di mezzo di pagamento, ma anche quella di mezzo per trasferire valore nel tempo senza timore (sempre che sussista la fiducia che le autorità monetarie impediranno che il suo potere di acquisto venga a ridursi per l’inflazione). Nella circolazione interna ai singoli paesi, la moneta – cartacea e metallica – ha in effetti progressivamente perso il legame con il contenuto metallico nel corso del XIX secolo, fino alla dichiarazione dello Stato che la moneta circola a corso forzoso (ovvero, lo Stato impone la sua sovranità attribuendo al proprio segno monetario un valore non correlato al contenuto metallico). Per quanto riguarda la circolazione dei mezzo di pagamento fra Stati, il discorso è più complesso. Per comprendere il ruolo svolto dai tassi cambio fra le valute, in congiunzione con la politica monetaria delle banche centrali, analizzeremo ora i due principali sistemi monetari internazionali della storia recente. Il primo sistema, che possiamo datare dal 1870 al 1914 (ma che venne ripristinato per alcuni anni da alcuni paesi fra il 1918 ed i primi anni 1930), è denominato Gold Standard. In questo sistema monetario internazionale ciascuna valuta aveva un tasso di cambio fisso con l’oro. Le banche centrali fissavano il valore della propria valuta in termini di oro, sicché dal rapporto di ciascuna moneta con l’oro scaturivano i tassi di cambio fissi fra le valute. L’oro veniva detenuto come riserva internazionale ufficiale: ogni eccesso di pagamenti da effettuare all’estero rispetto alle entrate dall’estero - ad esempio, un eccesso delle importazioni sulle esportazioni comportava il trasferimento di oro all’estero in modo da estinguere il debito (gradualmente, le banche centrali si dotarono però anche di valuta estera, essenzialmente sterline, per regolare il debito con l’estero). 192 Ad ogni scostamento della propria valuta del suo prezzo in oro, ogni banca centrale era tenuta ad intervenire (acquistando o vendendo oro, a seconda di una tendenza della valuta ad apprezzarsi o a deprezzarsi). L’autonomia di una banca centrale, e in particolare la possibilità di condurre una politica monetaria avente un obiettivo distinto da quello della preservazione del tasso di cambio con l’oro – ad esempio, un obiettivo di livello del reddito e dell’occupazione – erano dunque precluse. Se una banca centrale creava moneta in quantità eccessiva, il tasso di interesse (il prezzo dei fondi prestabili) tendeva al ribasso e gli investitori erano indotti a vendere i propri depositi alla banca centrale per poi investire al’estero e realizzare un maggior tasso di rendimento. Mentre in cambi flessibili la valuta si deprezza attraverso gli scambi degli operatori privati, nei cambi fissi del Gold Standard l’aggiustamento ha luogo attraverso la fuoriuscita dell’oro. Pertanto, per estinguere un debito con l’estero, si vendeva attività denominate nella valuta della banca centrale ottenendo in cambio un quantitativo di oro al tasso di cambio fisso, oro che provvedevano a presentare alla banca centrale di un paese dove il tasso di interesse era più elevato, per ottenere in cambio depositi in tale valuta. A questo punto, la banca centrale registrava un decremento della propria riserva in oro e la banca centrale straniera godrà di un incremento della propria riserva in oro. Il sistema tendeva naturalmente al riequilibrio. In seguito al fatto che beni ed attività finanziarie del primo (secondo) paese erano diventate meno (più) appetibili lo squilibrio tendeva ad annullarsi. Alla riduzione della quantità di moneta nel primo paese conseguiva una riduzione delle transazioni economiche e quindi un abbassamento dei prezzi, compreso il tasso di interesse. A tale contrazione corrisponderà l’incremento della quantità di moneta nell’altro paese, con opposta variazione di livello di attività economica e dei prezzi, compreso il tasso di interesse. Pertanto, la politica monetaria eccessivamente espansiva del primo paese – che era stata all’origine dello squilibrio – non ha avuto effetti permanenti nell’economia reale. Come si è già accennato, il risultato è che nel Gold Standard era assente 193 l’autonomia della politica monetaria (la creazione di moneta era stata eccessiva, cosicché la parte eccedente viene distrutta). Per ottemperare all’impegno di mantenere fisso il tasso di cambio con l’oro, una banca centrale doveva disporre di un ammontare sufficiente di oro. La vendita di attività finanziarie era la via seguita dalle banche centrali per fare salire i tassi di interesse in modo da attrarre flussi di capitale e dotarsi di riserve in oro (prima del 1914, le banche centrali avevano però cominciato a detenere riserve in valuta estera, in primo luogo sterline) per non trovarsi in difficoltà nel fare fronte al proprio impegno di conversione in oro delle valute. Una perdita prolungata di oro avrebbe infatti avuto l’effetto di impedire alla lunga alla banca centrale di onorare l’impegno a convertire in oro le attività finanziarie interne. Come sopra accennato, questo meccanismo - definito “price specie flow” funzionava automaticamente: le banche centrali riuscivano a far sì che un disequilibrio nelle partite correnti trovasse compensazione in un disequilibrio di segno opposto nei movimenti di capitale e viceversa, preservando così l’equilibrio della bilancia dei pagamenti. Infatti, le banche centrali reagivano ad una perdita di oro vendendo le attività finanziarie interne per attrarre capitali e continuare ad onorare l’impegno di convertibilità della valuta. Il conseguente aumento del tasso di interesse deprimeva l’attività economica e la conseguente discesa dei prezzi favoriva la formazione di un attivo nelle partite correnti, che compensava il disavanzo finanziario, senza che fosse necessario un trasferimento di riserve. Tale strategia di vendere attività interne per evitare di dovere continuare a cedere oro aveva però una grave conseguenza: innescare una deflazione interna, con relativa perdita di produzione ed occupazione. Il meccanismo di riequilibrio automatico previsto dal Gold Standard si rivelò poco virtuoso, in quanto finiva per penalizzare le economie più deboli. Il costo del riequilibrio ricadeva infatti tutto sui paesi in disavanzo di conto corrente. La tendenza a generare deflazione dipendeva dalla caratteristica del gold standard di causare un aggiustamento asimmetrico, eccessivamente a carico delle economie più 194 deboli. Tale caratteristica è stata successivamente condivisa anche dal SME, e dopo la crisi finanziaria si è ripresentata nell’UME. Nello SME, il cambio fisso delle valute, in luogo dell’oro, era mantenuto con il DM, la valuta di riferimento del sistema. Se l’accordo di cambio fosse stato di tipo cooperativo, la valuta di riferimento sarebbe stata l’ECU. Ciò avrebbe comportato che l’aggiustamento del cambio avrebbe potuto essere richiesto anche alla Germania e non solo – come invece è sempre accaduto dal 1979 al 1999 - ad uno o più degli altri paesi. Ad esempio, durante il progressivo rafforzamento del dollaro sui mercati valutari internazionali fra il 1980 ed il 1985, il marco seguì il trend ascensionale del dollaro creando notevoli problemi a molti paesi dello SME che dovettero subire più di un aggiustamento verso il basso del valore della propria valuta. Con l’accordo SME cooperativo si sarebbe potuto spesso verificare - attraverso l’esame delle variazioni dei cambi in ECU delle varie valute - che le deviazioni dalla parità centrale erano determinate dal legame del marco con il dollaro, e che quindi le tensioni all’interno dello SME andavano risolte con l’apprezzamento del marco rispetto all’ECU. Al contrario, dato il carattere egemonico dell’accordo di cambi fissi, la Germania rifiutava di essere costretta a perdere competitività rispetto a tutte le altre economie dello SME ed impose che fosse di volta in volta il paese che rischiava di sfondare la banda di oscillazione superiore a svalutare, formalmente rispetto all’ECU ma sostanzialmente rispetto al marco. La scelta di accelerare l’integrazione monetaria, culminata con il varo dell’UME nel 1999, fu indotta dal cambiamento strutturale rappresentato dalla completa abolizione dei controlli sui capitali nel 1990. Il problema della “tripletta impossibile”, messo in luce proprio dalla piena liberalizzazione dei flussi di attività finanziarie fra i vari mercati globali, consiste nella mutua incompatibilità dei tre obiettivi che gli Stati dello SME avevano raggiunto: cambi fissi, autonomia della politica monetaria, libertà dei movimenti dei capitali. Per gli N-1 paesi del Sistema monetario europeo (in quanto si deve omettere di considerare la Germania, la nazione che di fatto forniva la valuta di riferimento per 195 le parità bilaterali), la scelta a favore della completa mobilità dei capitali non poteva essere contemperata con tassi di cambio stabili, se non accettando la rinuncia totale all’autonomia di politica monetaria. In altri termini, le banche centrali erano sotto la continua minaccia di attacchi speculativi contro la valuta da parte di operatori finanziari interessati a realizzare extra-profitti una volta provocata una svalutazione. Ciò apparve chiaro ad Italia e Regno Unito, che decisero di non tentare di restare nello SME dopo l’attacco dell’estate 1992 a lira e sterlina, quando gli stessi titoli che erano stati venduti per indebolire il cambio, e provocare il riallineamento rispetto al marco, potettero poi essere riacquistati al più basso prezzo della valuta nella quale erano denominati). Era ormai chiaro che, in assenza di un impegno cooperativo a sostenere la valuta sotto attacco per l’indisponibilità della Germania, il carattere selffulfilling degli attacchi speculativi avrebbe a breve portato ad una nuova svalutazione. Pertanto, il costo della rinuncia allo strumento della variazione del cambio apparve molto più basso di quanto non fosse stato prima del 1990 (fra il 1987 ed il 1992 era stato possibile fare fronte a deficit commerciali attirando capitali con appropriati differenziali di tasso di interesse senza che intervenissero attacchi alla valuta) il che spianò la strada alla moneta unica. La prima guerra mondiale lasciò il retaggio di alti tassi di inflazione, che continuarono a crescere una volta che i governi aumentarono la spesa pubblica per favorire la ripresa economica post-bellica. Gli Stati Uniti tornarono al gold standard nel 1919; il Regno Unito nel 1925; nel 1922 Regno Unito, Italia, Francia e Giappone si accordarono per il varo di un Gold Exchange Standard (GES), che prevedeva che i paesi più piccoli detenessero come riserve le valute dei paesi più grandi, le cui riserve fossero totalmente rappresentate da oro. Poiché la banca di Inghilterra fu costretta a politiche monetarie restrittive per combattere l’inflazione, la stabilità del GES era in dubbio: da un lato, la sterlina era la valuta di riserva per eccellenza. Dall’altro le riserve della Banca di Inghilterra erano limitate e l’economia ristagnava. Fu quindi proprio dopo la prima guerra mondiale che ebbe inizio il declino del Regno Unito. Gli Stati Uniti, che erano tornati nel 1934 al Gold Standard dopo averlo abbandonato 196 l’anno precedente, assieme ai paesi che restarono nel gold standard senza svalutare, conobbero una prolungata fase di caduta del Pil e dell’occupazione, la Grande Depressione degli anni ‘30 . La soluzione di cercare il riequilibrio attraverso il ritorno al protezionismo – dopo la fase di accentuata globalizzazione degli scambi commerciali fra il 1870 ed il 1914 – fallì a causa dell’avvitarsi dei paesi in una deflazione sempre più grave. La lunga fase di elevata disoccupazione degli anni ‘30 venne superata solo con lo scoppio della seconda guerra mondiale. L’accordo di cambi fissi denominato Bretton Woods, dal nome della cittadina del New Hampshire in cui venne siglato a sorti della guerra mondiale ormai acquisite, ha rappresentato il sistema monetario internazionale operante dal 1944 al 1971. A Bretton Woods, gli Stati Uniti si erano opposti alla proposta avanzata dal Regno Unito di dare vita ad un sistema monetario internazionale con una distribuzione paritaria del potere economico. La delegazione inglese, avanzò la proposta ideata da Keynes di creare una valuta fittizia – il Bancor – rappresentativo del potenziale economico di tutte le grandi economie invece di assegnare la supremazia economica mondiale agli Stati Uniti. La proposta venne però rifiutata dalla delegazione americana, forte dell’influenza politica guadagnata con i soldati morti per salvare l’Europa dal nazismo. Al termine delle negoziazioni, il sistema stabiliva che una sola valuta – il dollaro statunitense – mantenesse un valore fisso in termini di oro e fungesse da valuta di riserva per tutte le altre banche centrali, la cui valuta veniva legata da un tasso di cambio fisso con il dollaro (e per questa via, indirettamente, con l’oro). Pertanto, poiché gli N-1 paesi con valuta non riserva internazionale fissavano il proprio tasso di cambio con la valuta ennesima, soltanto la politica monetaria del paese che emetteva tale moneta riserva internazionale era libera da vincoli. In altri termini, essendo la Federal Reserve impegnata a preservare il rapporto fisso del dollaro unicamente rispetto all’oro (garantendo agli altri paesi la conversione di dollari in oro), la creazione di dollaro da parte della Fed poteva essere effettuata secondo le esigenze di 197 pagamento degli Stati Uniti, senza riguardo al rapporto con le altre valute del sistema. Fra le N valute degli altri N paesi si determinavano N-1 tassi di cambio fissi, ed era quindi responsabilità di ciascuna delle loro N-1 banche centrali il mantenimento del rapporto di cambio fisso con il dollaro. L’esigenza delle N-1 banche centrali di avere un ammontare di riserve in dollari - di ampiezza tale da fare fronte alla necessità di effettuare nei mercati transazioni in valuta nazionale contro attività finanziarie denominate in dollari - comportò la necessità di detenere ingenti capitali in Buoni del Tesoro USA e depositi a breve termine in dollari. Poiché il tasso di cambio che le banche centrali si impegnavano a mantenere fisso era solo quello con il dollaro, ogni eventuale discrasia nel tasso di cambio - di ciascuna valuta con ciascuna altra valuta priva del ruolo di riserva internazionale - stimolava gli operatori di mercato ad operazioni di arbitraggio. Supponiamo ad esempio che in seguito ad una perdita di valore del marco tedesco rispetto al franco francese il tasso di cambio franco/marco si discostasse dalla parità “indirettamente” fissata dai rispettivi tassi di cambio con il dollaro. In tal caso, le forze di mercato realizzavano acquisti di franchi in cambio di dollari nella misura tale da riportare in equilibrio il tasso di cambio franco/marco, ovvero da renderlo nuovamente coerente con i rispettivi tassi di cambio di franco e marco con il dollaro. Il varo del sistema di Bretton Woods cercò di trarre frutto dalla lezione della depressione degli anni ’30. Venne creato un sistema nel quale una perdita di capitali – causata da deficit commerciale o da una politica monetaria espansiva che riducesse gli afflussi di capitali nel paese - non rendesse inevitabile una tendenza deflazionistica. Come si è accennato, i pilastri del sistema di Bretton Woods erano i seguenti: 1. la centralità del tasso di cambio fisso con il dollaro; 2. politiche macroeconomiche espansive condotte dagli Stati Uniti; 3. i controlli sui movimenti di capitale, necessari a garantire che fluttuazioni economiche divergenti fra i diversi paesi non minacciassero la stabilità dei tassi di cambio fra USD e le varie valute. 198 L’accordo di Bretton Woods del 1944 sancì l’inizio dell’egemonia degli Stati Uniti sull’economia mondiale post-bellica, il paese che forniva la valuta mezzo di pagamento internazionale, la cui domanda faceva da traino all’espansione economica delle economie occidentali. Tale regime di cambi fissi ebbe le caratteristiche del Gold Exchange Standard. Le valute erano infatti convertibili non solo in oro (sebbene all’interno dei paesi naturalmente circolassero in regime di corso forzoso) sicché i deficit di conto corrente potevano essere coperti con la cessione sia di oro che di dollari,ma anche in valuta. Gli Stati Uniti hanno così sostenuto per trenta anni - con la loro domanda - la crescita delle economie europee, consentendo l’espansione degli apparati produttivi erano stati fortemente ridimensionati dalle distruzioni belliche. Il dollaro fu così elevato al rango di unica valuta di riserva internazionale e la funzione di prestare capitali (mediante un fondo finanziati da tutti i paesi aderenti) ai paesi la cui bilancia dei pagamenti fosse in difficoltà venne attribuita al Fondo monetario internazionale (IMF International Monetary Fund). I controlli sui movimenti di capitale svolgevano un ruolo fondamentale, in quanto permettevano di contrastare un allontanamento del cambio fisso con il dollaro, la valuta àncora del sistema perché convertibile in oro ad un tasso fisso. I controlli davano agio ai governi di condurre politiche di stabilizzazione del reddito anche in presenza di deficit commerciale, evitando così la distorsione deflazionistica del GS, senza che i mercati finanziari – attraverso l’imposizione di premi per il rischio di cambio (basati sulle aspettative di svalutazione) e per il rischio di default (basati sulle aspettative sulla sostenibilità del debito pubblico) - avessero il potere di condizionare la loro autonomia in campo monetario e fiscale. In particolare, i controlli riducevano l’esigenza di attrarre capitali dall’estero - con l’apertura di un differenziale positivo di tassi di interesse con l’estero attraverso una restrizioni monetaria - a compensazione dei deficit commerciali, impedendo perciò che tassi di interesse e tassi di cambio fossero soggetti a forti fluttuazioni. 199 Pertanto, Bretton Woods difese l’Europa dall’instabilità macroeconomica che sarebbe scaturita dai differenti livelli di efficienza (e quindi di competitività sui mercati) dei sistemi produttivi, e permise l’”età dell’oro” di tassi di crescita reale dell’ordine del 5%. I controlli sui movimenti di capitale mitigarono il rischio per le economie europee che un’espansione della creazione di moneta portasse ad instabilità macroeconomica e deficit commerciale, fino a rendere inevitabile la svalutazione del cambio. Con Bretton Woods, il ruolo dell’oro venne considerevolmente ridimensionato. Diversamente dal Gold Standard, non era necessario difendere un tasso di cambio sopravvalutato ed evitare la perdita di oro attraverso una dolorosa deflazione. In aggiunta ai controlli sui movimenti dei capitali, fu infatti costituito – come si è già detto - l’IMF, con l’obiettivo di aiutare i paesi a mantenere il tasso di cambi fisso con il dollaro. Lo strumento era l’erogazione di credito per permettere ai paesi di tenere in equilibrio la bilancia dei pagamenti, senza essere costretti alla deflazione di salari e prezzi allo scopo di creare un surplus commerciale per compensare una tendenza ai deflussi di capitale. La centralità del dollaro rappresentò al tempo stesso la forza e la debolezza di questo sistema monetario internazionale. Infatti, la fiducia nella valuta emessa dalla principale potenza economica mondiale permise il rispetto della fissità dei tassi di cambio bilaterali e perciò una prolungata fase di stabilità monetaria internazionale. D’altro canto, a partire dagli anni ’60, divenne progressivamente meno credibile l’impegno della Federal Reserve USA ad accettare il cambio in lingotti di oro di qualsiasi ammontare di dollari presentato alla Fed da una qualsiasi altra banca centrale. Una enorme massa monetaria venne creata negli anni dagli Stati Uniti per il pagamento del deficit commerciale del paese, per finanziare le truppe NATO in Europa e per gli interventi militari (in particolare, per la guerra nel Vietnam). Ciò esponeva la banca centrale statunitense al rischio di dovere rifiutare il cambio ed il governo statunitense ad una perdita di prestigio. L’ingente quantità di valuta USA in 200 circolazione, in notevole eccesso rispetto alle riserve in oro di Fort Knox, fu la causa efficiente dell’abbandono del sistema di Bretton Woods. Dopo che la Francia ebbe a più riprese minacciato di chiedere il cambio in oro delle proprie riserve in dollari, allo scopo di indebolire il primato statunitense di prima potenza economica e militare del mondo, il 15 agosto 1971 il presidente Nixon prese la decisione di dichiarare unilateralmente il dollaro non più convertibile in oro. Da quel momento in poi, le valute dei paesi avanzati hanno circolato in regime di cambio flessibile con un dollaro ormai privo di qualsiasi “tallone aureo”, sicché per definire l’attuale regime si parla di dollar standard. I controlli sui movimenti di capitale svolgevano un ruolo fondamentale. Poiché la convertibilità introduceva la possibilità di una perdita di valore rispetto alla valuta àncora del sistema, i controlli: 1. davano agio ai governi di condurre politiche di stabilizzazione, evitando così il bias deflazionistico tipico del Gold Standard, senza che i mercati finanziari – attraverso l’imposizione di premi per il rischio di cambio (basati sulle aspettative di svalutazione) e per il rischio di default (basati sulle aspettative sulla sostenibilità del debito pubblico) - avessero il potere di condizionare la loro autonomia in campo monetario e fiscale; 2. impedivano che tassi di interesse e tassi di cambio fossero soggetti a forti fluttuazioni. Bretton Woods difese l’Europa dall’instabilità macroeconomica che sarebbe scaturita dai differenti livelli di efficienza (e quindi di competitività sui mercati) dei sistemi produttivi, e permise l’età dell’oro di tassi di crescita reale dell’ordine del 5%. Per le economie europee, furono i controlli sui movimenti di capitale a mitigare il rischio che un’espansione della creazione di moneta portasse ad instabilità macroeconomica e deficit commerciale, fino alla svalutazione del cambio. L’età dell’oro durò dal 1945 al 1973, quando la quadruplicazione del prezzo del petrolio nel 1973-74 segnò la fine dell’espansione post-bellica a bassa inflazione e disoccupazione calante. La nuova epoca fu segnata da forte instabilità macroeconomica, a cominciare dalla riduzione drastica degli investimenti conseguita 201 al conflitto intorno alla distribuzione del reddito (da cui per un breve periodo scaturì una breve fase di aumento della quota del salario sul reddito a scapito di quella del profitto in alcune economie europee). Agli incrementi dei salari monetari del 197374, e poi di nuovo nel 1979 soprattutto nel Regno Unito ed in Italia, seguirono la tendenza delle imprese a sostituire capitale a lavoro al fine di contenere la crescita del costo del lavoro, e tensioni inflazionistiche per l’aumento continuo dei prezzi. L’obiettivo di preservare le quote di mercato estero, indebolite dalla discesa della competitività portò a svalutazioni competitive indotte da politiche monetarie espansive dirette ad abbassare i salari in termini reali. Il sistema monetario europeo (SME), l’accordo di cambi fissi - ma aggiustabili - in vigore fra il 1979 ed il 1999, nacque dalla consapevolezza che una flessibilità illimitata dei tassi di cambio stava portando ad un “gioco a somma zero” riguardo al livello di attività economica in Europa, perché nessun paese riusciva a sostenere la crescita attraverso il breve recupero di competitività permesso dalla svalutazione nominale, ed “a somma negativa” riguardo al tasso di inflazione, perché le aspettative di inflazione, continuamente confermate, alimentavano una crescita esponenziale dei prezzi in tutti i paesi. La scelta di convertirsi ad una strategia anti-inflazionistica, diretta conseguenza del predominio culturale riguadagnato dal pensiero neoclassico-monetarista, implicò non solo un drastico freno all’inflazione alimentata dalle aspettative di continuo incremento, ma significò di fatto per l’Europa anche un’evoluzione verso un nuovo potere egemonico. Con uno SME soggetto all’egemonia dell’economia tedesca l’Europa si distanziava dalla predominante influenza degli Stati Uniti, che sul piano economico si imperniava sulla crescita garantita da sostanziosi flussi di domanda e dalla concessione ai partners sia del proprio mercato interno che dalla autonomia di politica macroeconomica. Oggettivamente, la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro in oro dell’agosto 1971 aveva indebolito tale rapporto gerarchico. I paesi europei, che uscivano dagli anni turbolenti della stagflazione, finirono così per trovare la promessa di un nuovo 202 ordine economico nell’egemonia della Germania. La Germania non volle tenere conto del fatto che ogni apprezzamento del marco sul USD costringeva gli altri paesi membri ad inasprire le politiche monetarie e fiscali di segno restrittivo che la difesa dei cambi fissi già imponeva (infatti, non venne mai utilizzato l’ECU, lo strumento pensato per stabilire quale fra due valute in avvicinamento ciascuna al proprio limite della banda di oscillazione rispetto alla parità centrale fosse responsabile per l’imminente necessità di modificare la parità bilaterale. In molti casi, l’utilizzo di tale strumento avrebbe finito con lo stabilire che il deprezzamento non era l’effetto di una declinante competitività delle altre economie ma dell’apprezzamento marco sul dollaro USA. In alcuni casi, infatti, l’ECU avrebbe segnalato che la tensione sul tasso di cambio non dipendeva da una tendenza a deprezzarsi della valuta di un’economia poco competitiva, ma da una tendenza del marco tedesco ad apprezzarsi sul dollaro). La rigida intonazione deflazionistica della Bundesbank, la banca centrale che imponeva di fatto la creazione di base monetaria compatibile con la difesa del cambio a tutte le altre, era in evidente collisione con l’eventualità che gli accordi dello SME imponessero alla banca centrale tedesca una espansione monetaria inflazionistica diretta ad abbassarne il valore all’interno delle parità fisse dello SME. Questa opposizione ad una interpretazione non egemonica dello SME fece sì che la politica monetaria di tutte le banche centrali fosse sempre rigorosamente restrittiva. La vittoria sull’inflazione venne così pagata dai paesi dello SME con un forte incremento del tasso di disoccupazione e con due decenni di crescita lenta. In assenza del traino delle esportazioni verso la maggiore economia europea, i divari di produttività maturati negli anni dalle economie più deboli costrinsero spesso le n-1 valute dello SME a riallineamenti delle parità centrali con il marco. In definitiva, la messa in comune del segno monetario da parte di realtà eterogenee ha rafforzato l’ integrazione, soprattutto quella dei mercati finanziari, ma ha anche allontanato Centro e Periferia dalla convergenza. A differenza dalla dipendenza del ciclo economico delle economie europee dal traino dell’economia statunitense, l’interdipendenza con l’economia tedesca imponeva 203 un’ipoteca deflazionistica sull’equilibrio macroeconomico. I paesi a CLUP più elevato della Germania pagarono la progressiva rinuncia alla periodica svalutazione del cambio nominale con la perdita di competitività che veniva provocata dal conseguente apprezzamento reale, la penetrazione commerciale delle merci tedesche, e quindi anche più bassi livelli di reddito e di occupazione. Il vero spartiacque fra l’epoca di Bretton Woods ed il mondo in cui viviamo non fu tuttavia l’integrazione monetaria, avviata nel 1979 con il passaggio ai cambi fissi per combattere l’inflazione, ma il completamento della liberalizzazione dei flussi di capitale nel 1990. Fino al 1990, infatti, i cambi fissi dello SME sostanzialmente riflessero la logica di Bretton Woods. I controlli sui movimenti di capitale in Europa proteggevano infatti la convertibilità rispetto alla valuta àncora – prima il dollaro, poi il marco - del sistema di cambi fissi. Tuttavia, la natura dell’egomonia esercitata dal paese-guida era affatto diversa. Al traino della domanda mondiale garantito dalla sostenuta domanda interna degli SU durante il regime di Bretton Woods si era sostituita la bassa crescita economica indotta nelle economie europee dalla strategia deflazionistica della Germania, la cui espansione dipendeva, all’opposto che negli SU, dalla domanda estera. Si può dire che nel passaggio da SME a UME si è andata rafforzando l’egemonia della Germania Germania sull’Eurozona. Il mancato utilizzo dell’ECU aveva permesso alla Germania di ottenere che fossero sempre i paesi la cui valuta si deprezzava a procedere all’aggiustamento attraverso una svalutazione della parità di cambio con il DM, in modo da mantenere alla Bundesbank il ruolo di unica banca centrale ad avere il privilegio dell’autonomia nella creazione di base monetaria. Nell’UME, abolite le valute nazionali, i paesi più deboli (a più alto CLUP rispetto alla Germania) non hanno più la possibilità di recuperare competitività mediante la svalutazione del cambio. In un certo modo, con l’unione monetaria si realizza l’equivalente della sostituzione del gold standard al gold exchange standard. Infatti, con l’abbandono della propria valuta, venne meno la funzione svolta dal processo di deprezzamento all’interno delle 204 bande di oscillazione del tasso di cambio rispetto alla parità centrale: dare il tempo alle misure restrittive fiscali e monetarie di ridurre il differenziale di inflazione e recuperare competitività, prima che si rendesse improcrastinabile il ricorso alla svalutazione con la definizione di una nuova parità centrale con il DM. Nell’Eurozona, esattamente come nel gold standard, se l’economia “debole” non realizza un immediato aggiustamento di mercato allineando il CLUP a quello del paese egemone con una drastica deflazione di salari e prezzi, cioè con il ridimensionamento del benessere della popolazione (il reddito pro capite si abbasserà infatti in proporzione alla discesa dei salari), il prezzo del divario di efficienza andrà comunque pagato con l’equivalente moderno del trasferimento di oro: la perdita dei guadagni sui mercati esteri ormai non più raggiungibili da un paese che non esporta più, vendendo le merci a prezzi troppo cari. Una soluzione non egemonica ma cooperativa non era realizzabile nello SME e non è disponibile nell’UME. La Germania, forte della propria egemonia politica in Europa, conquistata con la propria maggiore efficienza economica, non è disponibile a un accordo cooperativo. Nello SME, un accordo cooperativo sarebbe consistito nella rivalutazione del DM, in modo da rendere più competitive le merci degli altri paesi. Nell’UME, esso consisterebbe nella disponibilità della Germania ad aumentare la domanda interna tedesca, cosicché la più alta inflazione in Germania renderebbe minori le esportazioni tedesche nell’Eurozona, permettendo una ripresa negli altri paesi trainata dalle maggiori esportazioni. La situazione attuale fa assomigliare l’Eurozona ad una sorta di Bretton Woods, con l’euro al posto della stabilità dei cambi ed il sistema Target2 al posto dei controlli sui capitali. Come si è già sottolineato, una differenza fondamentale con Bretton Woods rimane: in luogo del traino della domanda USA, che permise elevati tassi di crescita del PIL in Europa, oggi c’è il rischio di una depressione di lungo periodo a causa della tendenza deflazionistica indotta dalla strategia di politica fiscale della Germania, orientata a comprimere la domanda interna puntando alla creazione di reddito incentrata sull’espansione sui mercati esteri. Tuttavia, c’è un’altra differenza 205 egualmente importante. Nel sistema di cambi fissi di Bretton Woods, vedendo deperire la propria competitività molti paesi – Stati Uniti escluso, naturalmente – si trovarono nelle condizioni di dover chiedere un sostegno finanziario, il che permise loro di evitare il ricorso ad una svalutazione reale. Contesto tutt’affatto diverso è quello dell’UME. Così come nel Gold Standard nei vari paesi avanzati una politica di espansione monetaria era vincolata alla capacità di accumulare oro preservando condizioni di competitività sui mercati esteri, pena il ricorso alla svalutazione reale (la deflazione, con forte riduzione di salari e prezzi), nell’UME i singoli paesi non hanno il controllo sulla valuta in cui è denominato il proprio debito pubblico. Non possono quindi chiedere alla banca centrale di “monetizzarlo” per tranquillizzare i mercati sulla solvibilità del proprio debito sovrano e sono costretti ad attuare una svalutazione reale. Pertanto, sia nel Gold Standard che nell’UME i paesi sono esposti ad attacchi speculativi ul debito pubblico nel caso viene meno la fiducia dei mercati nella solvibilità dei governi. Inoltre, il Fiscal Compact e la politica monetaria della BCE, con un obiettivo di tasso di inflazione al 2%, non permettono ai paesi periferici di ridurre il salario reale – invece con tagli ai salari monetari socialmente insostenibili – con politiche fiscali espansive che attraverso un aumento dell’inflazione ne riducano il potere d’acquisto rendendo conveniente per le imprese accrescere la domanda di lavoro Perché all’inizio degli anni ’90 non si comprese in Europa che si stava creando un unico segno monetario per economie con livelli di efficienza ancora troppo distanti fra loro? Proviamo a dare una risposta. Come si è già accenntato, la crisi del 1992 - con gli attacchi speculativi che portarono all’uscita di lira e sterlina dallo SME - rese evidente la necessità di avere non solo la convergenza nominale ma anche la convergenza reale prima di adottare una valuta unica. Il motivo della scelta di accelerare ugualmente l’integrazione monetaria con il varo nel 1991 del trattato di Maastricht fu essenzialmente politico: lo scambio – concordato fra i governi tedesco e francese, ed accettato dagli altri partners - 206 dell’accettazione dell’unificazione politica fra le due Germanie contro la rinuncia al DM. La crisi dello SME del ’92 fu un chiaro segnale: con l’unione monetaria scompariva il rischio di cambio, ma in ogni momento i mercati finanziari avrebbero potuto reagire ad una perdità di credibilità di un paese. In altre parole, gli operatori finanziari non avrebbero continuato a detenere il debito pubblico, anche se denominato in euro, una volta che la sua sostenibilità fosse revocata in dubbio, come è accaduto dopo la bancarotta di Lehman Brothers. Il segnale del 1992 non venne quindi recepito, e si continuò a mantenere in piedi un simulacro di SME. Si decise infatti di passare dalla banda stretta alla banda di ± 15%, un regime fittizio di cambi fissi unicamente diretto a mettere i governi al riparo da attacchi speculativi (una volta resa ammissibile un deprezzamento entro la banda di oscillazione fino al 15% rispetto alla parità centrale, troppo ingente era l’ammontare di capitali necessario ai mercati per mettere in crisi una valuta). Il conseguimento del premio della partecipazione all’unione monetaria venne quindi subordinato al perseguimento di politiche monetaria e fiscale rigorosamente di segno restrittivo, al fine di ottemperare ai criteri di Maastricht (una bassa inflazione, un basso tasso di interesse ed una sana gestione del bilancio pubblico). Il calcolo erroneo, come si è detto, consistette nel ritenere che bastasse ottenere la convergenza fra i valori nominali – e non anche fra quelli reali – di economie a diverso grado di efficienza. Nel limitarsi ad indicare l’obiettivo della convergenza nominale, senza organizzare un meccanismi di condivisione dei rischi di divergenza reale connessi all’instabilità macroeconomica ed ai ritardi delle economie periferiche, il Trattato di Maastricht volle ignorare il fatto che – per dirla con Joe Stiglitz – la “Mano Invisibile” è tale per il preciso motivo che non c’è. In modo un po’ inconsapevole, si affermò la previsione fin troppo ottimistica che sotto la spinta del completamento del processo di liberalizzazione nel 1993 dei mercati dei beni, dei servizi e del lavoro, l’impegnativo processo di catching-up da parte dei paesi periferici potesse essere affidato alle sole 207 forze di mercato (con il piccolo aiuto dei fondi dell’Unione Europea a vantaggio delle aree più arretrate, destinati alle politiche strutturali e di coesione). Si è voluto credere che integrazione fosse sinonimo di convergenza. Al contrario, l’integrazione realizzata in Europa è prevalentemente “negativa”: l’abbattimento delle barriere tariffarie e non-tariffarie, e una parziale armonizzazione della regolamentazione dei mercati, che non a caso non ha toccato la libertà di competere attraverso la tassazione. Si è voluto credere all’ottimistica tesi di Robert Mundell sulla suddivisione e condivisioni dei rischi di shock asimmetrico nei mercati finanziari. Il che si è tradotto nell’esporre a regole comuni sistemi produttivi ed istituzionali molto differenti. E’ molto dubbio che i risultati del gioco del mercato possano consistere in un armonioso processo di convergenza economica senza uno sforzo coordinato di politica industriale fra i paesi dell’Eurozona. Nel mondo della piena libertà di movimento dei capitali, per guadagnare profitti con la strategia degli hedge funds – i fondi a carattere speculativo che nel vendere e comprare titoli danno seguito, con estrema prontezza, alle aspettative rispettivamente al ribasso ed al rialzo delle quotazioni dei titoli) non è necessario disporre di una pluralità di valute e giocare sulle aspettative sul loro tasso di cambio futuro. Una strategia speculativa è realizzabile anche con paesi che condividono la valuta. Come i paesi periferici hanno a loro spese constatato, basta mettere sotto pressione – con ondate di vendite coordinate che ne abbattono il valore di mercato provocando la salita del tasso di rendimento - il debito sovrano e i titoli delle banche che li hanno in portafoglio, ancorché denominati nella valuta comune. Né è necessario che vi sia una ragione perché ad un dato bond si applichi un più alto premio per il rischio. E’ sufficiente una aspettativa pessimistica innescata da un esogeno shock negativo (ad esempio, una crisi come quella dei sub-prime) perché si decida di ristrutturare il proprio portafoglio scaricando sui governi maggiormente in difficoltà il proprio desiderio di “coprirsi dal rischio”. In Europa si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che anche nell’unione monetaria gli investitori internazionali - divenuti arbitri dei destini delle economie dopo la 208 rinuncia ad ogni governance dei flussi monetari - avrebbero potuto non solo lucrare profitti speculativi ma anche diventare i “padroni” del destino dell’euro. Un grave shock simmetrico subito dai paesi dell’Eurozona, quale è stato la trasmissione in Europa della crisi dei titoli sub-prime, ha così provocato una crisi finanziaria che si è propagata in modo asimmetrico all’interno dell’Eurozona, mettendo a nudo le debolezze dei sistemi produttivi della periferia, la vulnerabilità del debito pubblico e la fragilità delle istituzioni bancarie di molti paesi. 9. Eurozona e sistema monetario internazionale La creazione dell’euro ha senza dubbio rappresentato il più importante cambiamento nel sistema monetario internazionale avvenuto dopo il 1971. Nel 1992-93, come si è detto, fu evidente che una volta completata la liberalizzazione dei movimenti dei capitali era divenuto molto più difficile preservare i cambi fissi. La creazione dell’euro, in un certo qual modo, non fece altro che trasformare un regime di cambi fissi “ma aggiustabili” in un regime di cambi “irrevocabilmente” fissi. La stabilità dei mercati finanziari, favorita dalla fine del rischio di cambio, è durata fino al collasso di Lehman Brothers. All’avvio della crisi finanziaria nel 2008, le economie deboli dell’Eurozona – che pure non erano più chiamate a difendere un tasso di cambio fisso e non erano dunque esposte alla sfiducia dei mercati in un segno monetario la cui credibilità era stata ridotta dalle politiche inflazionistiche adottate dalla propria banca centrale – si trovarono di nuovo sotto l’attacco della speculazione internazionale a causa della vendita di grandi quantitativi del loro debito pubblico. Come mai i paesi periferici dell’UME, pur avendo aderito all’euro e quindi rinunciato ad usare la propria valuta per difendere la competitività della propria economia attraverso il meccanismo di inflazione-svalutazione, andavano perdendo la fiducia degli operatori finanziari? Il fatto è che i paesi dell’Eurozona non hanno tenuto conto non solo delle difficoltà dei paesi “deboli” una volta rinunciato allo strumento della politica del cambio, ma 209 anche dell’handicap rappresentato dall’essere formata da tanti governi nazionali. In presenza di tanti debiti pubblici, si determinano tanti diversi premi per il rischio di default del governo. In altre parole, generando un differenziale di tasso di interesse con la Germania, i mercati esprimono un premio per il rischio legato ai fondamentali macroeconomici di ciascun paese, generando uno spread di tasso di interesse rispetto al paese-leader. E’ difficile non condividere il giudizio di Stiglitz sull’errata teoria economica in base alla quale è stato costruito l’assetto istituzionale dell’unione monetaria: “Much of the euro’s design reflects the neoliberal economic doctrines that prevailed when the single currency was conceived. It was thought that keeping inflation low was necessary and almost sufficient for growth and stability; that making central banks independent was the only way to ensure confidence in the monetary system; that low debt and deficits would ensure economic convergence among member countries; and that a single market, with money and people flowing freely, would ensure efficiency and stability”. La creazione dell’euro non poteva di per sè risolvere i problemi di squilibrio economico fra i paesi europei. Si può dire che gli economisti ed i politici responsabili dell’assetto istituzionale dell’Eurozona non hanno tenuto conto degli insegnamenti della storia monetaria: la condizione dei paesi deboli dell’Eurozona è contigua con la condizione di questi stessi paesi nel gold standard. Una valuta unica condivisa da Stati diversi, con sistemi produttivi di differente efficienza e debito pubblico di differente ampiezza, finisce per causare nei paesi periferici un avvitamento della crisi prodotta da uno shock esogeno del tipo della crisi finanziaria dei sub-prime. Al pari del gold standard, che imponeva la deflazione interna per evitare la perdita di oro, i paesi periferici debbono restringere la spesa pubblica e deregolamentare l’economia per tornare ad essere competitivi attraverso la deflazione interna. L’obiettivo è quello di facilitare una discesa di salari e prezzi tale da ridurre il costo del lavoro rispetto ai paesi con cui sono in competizione. La speranza di una ripresa economica si fonda però sulla visione del recupero di efficienza sostenuta dai teorici 210 della supply-side, mentre la crescita può riprendere soltanto se la domanda effettiva risale. Tale ripresa non può però realizzarsi, perché i consumatori sono indotti a procrastinare i piani di consumo (in quanto salari bassi e disoccupazione crescente fanno ristagnare la domanda monetaria) e le imprese non investono per le basse aspettative di profitto. Inoltre, i mercati possono essere rassicurati sulla solvibilità del debito sovrano soltanto se il bilancio pubblico è sostenuto da un flusso crescente di entrate fiscali, il che ha come precondizione la risalita del tasso di crescita del PIL. Inoltre, al traino della domanda mondiale garantito dalla sostenuta domanda interna degli Stati Uniti durante il regime di Bretton Woods si è oggi sostituita la bassa crescita economica indotta nelle economie europee dalla strategia deflazionistica della Germania. L’espansione del paese dominante dell’UME dipende sempre più dalle proprie esportazioni, dopo avere contratto il proprio mercato interno, mentre gli Stati Uniti durante il regime di Bretton Woods espandevano la domanda interna, fornendo domanda estera agli altri paesi. I saldi Target2 di ciascun paese dell’UME registrati presso la BCE rappresentano la contabilità degli squilibri macroeconomici fra i vari paesi. A partire dalla costituzione dell’UME, i crediti target della Germania sono aumentati proprio perché la Germania ha accumulato surplus delle partite correnti con il resto dell'Eurozona, senza che una corrispondente quantità di capitale privato fluisse nei paesi in deficit. Fra il 2004 ed il 2007, tuttavia, ai surplus commerciali dei paesi del Centro, in primo luogo la Germania (ai deficit della Periferia) hanno corrisposto deflussi di capitali investiti in attività finanziarie private e pubbliche dal Centro verso la Periferia. La mancanza nei paesi in deficit di fondi per acquistare l’eccesso di importazioni sulle esportazioni è principalmente coperta da tali afflussi. I deficit Target2 sono quindi liquidità che supera lo stock di moneta disponibile per quella data banca centrale dell’UME e che è stato impiegato per l’acquisizione di beni e attività di altri paesi dell’euro. Corrispondentemente, il surplus Target2 misura il surplus di stock di moneta della banca centrale in circolazione in un paese al di 211 sopra della moneta creata all’interno, e che nasce dalla vendita di beni e di attività ad altri paesi dell’euro In assenza del sistema Target2, le relazioni economiche fra i paesi dell’UME tornerebbero ad un contesto simile a quello vigente nel Gold Standard. In luogo del trasferimento di oro, dovrebbero essere regolate con compensazioni di natura reale. Ovvero: 1.una profonda deflazione reale attraverso gli opportuni aggiustamenti del CLUP e quindi dei prezzi relativi nei mercati dei beni; in assenza di tale drastica forma di aggiustamento di mercato, si assisterebbe all’impoverimento causato dalla progressiva perdita di redditi legati all’esportazione di beni verso i mercati delle altre economie UME, con corrispondente progressiva cessione di quote del mercato intraUME alla Germania. L’Eurozona naviga ancora fra la Scilla della prima opzione (una profonda deflazione di salari e prezzi si è realizzata solo in Irlanda e Grecia, e più recentemente, ma in minore misura, in Portogallo e Spagna) e la Cariddi della seconda opzione (al surplus di conto corrente della Germania corrispondono i deficit di conto corrente di molti paesi della Periferia e del Centro, solo in parte riassorbitisi a seguito della politica dell’austerità imposta ai paesi a rischio di default; l’auspicato riequilibrio, con politiche di stimolo della domanda interna in Germania, non si è ancora realizzato). Dopo la crisi, l'aumento dell'incertezza riguardante il futuro e l'aumento del rischio di default hanno portato alla crescita dei premi per il rischio e ad una riduzione dei volumi delle transazioni nel mercato interbancario. Le banche hanno iniziato ad accumulare liquidità invece di offrire le loro eccedenze al mercato impedendo la riallocazione di moneta tra le banche. Il sistema Target2, concepito quindi come un semplice strumento tecnico contabile per il regolamento delle partite correnti e dei pagamenti, è diventato un vero e proprio mezzo per mantenere solvibile l’Eurosistema, in quanto evita che le imprese di un paese con un saldo contabile di deficit di conto corrente presso la BCE debbano estinguere immediatamente il proprio debito. 212 Il fatto che i crediti netti della Bundesbank nei confronti dell'Eurosistema sono aumentati più velocemente del rispettivo avanzo di conto corrente suggerisce che ci sono stati flussi di capitale in Germania che riflettono - oltre che l'esportazione di beni e servizi - il rimpatrio di fondi tedeschi precedentemente investiti nella Periferia. I fondi privati dall'estero verso l'Italia sono crollati di 200 miliardi: circa il 14% del Pil. Ad essi si è sostituita la Bce comprando direttamente titoli di Stato, oppure prestando alle banche italiane perché lo facessero. Il risultato è che nel sistema dei pagamenti interno del sistema di banche centrali l'Italia o la Spagna sono sempre più in debito e la Germania sempre più in credito. Al momento del concepimento del sistema Target2, la convinzione prevalente era che i saldi si sarebbero pressoché compensati ogni giorno, e non si è ritenuto necessario l’installazione di un meccanismo che poteva evitare gli squilibri. I crediti Target2 avevano la caratteristica di essere crediti a breve termine per appianare i picchi di operazioni monetarie, inizialmente solo i pagamenti di grandi dimensioni dovevano essere erogati tramite il sistema e in aggiunta a questo le banche commerciali dei singoli paesi avevano i propri sistemi di compensazione. La visione del sistema Target2 propagandata dalla Bundesbank riflette la logica del Gold Standard. Affinché la stabilità macroeconomica non venga compromessa dal diverso livello di efficienza dei sistemi produttivi del Centro e della Periferia, si vuole che ciascun paese trovi capitali in entrata non grazie alla benevolenza delle istituzioni comuni (la BCE) ma in modo più appropriato nel mercato. Come si è detto, l’abolizione della convertibilità esterna con l’oro aveva concesso ai governi un’autonomia di creazione di moneta a sostegno della crescita (anche al prezzo di svalutazione del cambio). Tuttavia, nello stabilire la convertibilità ad un cambio fisso di ciascuna valuta con l’oro, il ritorno al Gold Standard finiva per legare strettamente alle riserve di oro la quantità di moneta da immettere in circolazione, impedendo che la politica monetaria potesse svolgere quelle manovre espansive di stabilizzazione del reddito che sarebbero state necessarie dopo la crisi del ’29. Qualcosa di molto simile si sta ripetendo oggi in Europa, con le manovre di austerità 213 imposte all’indomani della crisi finanziaria alle politiche fiscali di stabilizzazione dalla commissione di Bruxelles. Pertanto, la Grande Depressione degli anni ’30 e la Grande Recessione degli anni 2010 sono entrambe state aggravate da tesi economiche oscurantiste, orientate a privilegiare l’aggiustamento deflazionistico esterno sulla ripresa dell’espansione interna. Nello SME prima del 1990, i controlli sui flussi di capitale e l’aggiustamento delle parità centrali garantivano l’autonomia di politica monetarie; nello SME dopo il 1990, aboliti i controlli era divenuto molto difficile orientare la politica monetaria ad obiettivi diversi dalla difesa del cambio. Nell’UME, abolita la politica della svalutazione del cambio, i mercati finanziari hanno di fatto sottratto alle banche centrali europee l’autonomia di politica monetaria (già di molto limitata, negli anni precedenti, dall’impegno a difendere i cambi fissi). Il principale tratto distintivo dell’UME rispetto al Gold Standard ed al Gold Exchange Standard è che a coprire i disavanzi formatisi nella bilancia dei pagamenti non è il trasferimento di oro oppure di riserve valutarie internazionali, ma la semplice iscrizione a debito dei finanziamenti che la BCE concede alle banche nazionali. Il sistema Target2 che regola i flussi di liquidità all’interno dell’Eurozona, dà la possibilità alle banche dei paesi che soffrono per l’aumento del deficit commerciale di contrarre un debito con la BCE ottenendo liquidità senza vincoli. La principale differenza fra Gold Standard e Bretton Woods è che nel Gold Standard non era presente quell’asimmetria, consistente in tassi di cambio pari ad N-1, che sarà tipica del sistema con valuta di riserva vigente dal 1944 al 1971. La principale differenza fra Gold Standard e SME è che mentre in questo accordo i cambi fissi erano aggiustabili, e quindi in presenza di deficit commerciale crescente era possibile moderare la stretta deflazionistica di politica monetaria in virtù del miglioramento di competitività ottenuto con una nuova parità centrale conseguente ad una svalutazione, nel GS non v’è alternativa al trasferimento di oro, sicché i governatori hanno come obiettivo prioritario della politica monetaria la costituzione di riserve di oro e di valute internazionali attraverso l’afflusso di capitali. 214 Nonostante l’uso dello strumento per l’aggiustamento macroeconomico del tasso di cambio della propria valuta sia stato per definizione abolito e quindi una deflazione reale non sia procrastinabile, il sistema Target2 di contabilizzazione delle transazioni valutarie consente ai paesi con deficit commerciale di non dovere estinguere immediatamente un disavanzo e di evitare perciò una brusca manovra deflattiva. 10. La divergenza reale all’interno dell’Eurozona Una interpretazione “dalla parte della Germania” della mancata convergenza fra i PIL pro capite dei paesi dell’Eurozona viene proposta dell’ European Economic Advisory Group (EEAG), che fa capo all’istituto di ricerca tedesco di indirizzo “ortodosso” CESifo. L’idea è che all’interno di un’area valutaria europea gli squilibri macroeconomici siano fisiologici: i paesi impegnati nel catching-up - conoscendo tassi di crescita maggiori di quelli dei paesi più avanzati - finiscono necessariamente per trovarsi in deficit commerciale. La più rapida integrazione finanziaria determinatasi dopo il passaggio alla moneta unica avrebbe quindi opportunamente favorito il trasferimento di capitali dal Centro alla Periferia, la cui dotazione di capitale relativamente inferiore garantisce il conseguimento di tassi di rendimento dell’investimento più elevati (Blanchard e Giavazzi, 2002). Il fatto è che tale processo virtuoso, che avrebbe dovuto culminare nel catching-up della Periferia, non si è realizzato, perché i mercati sono perfetti soltanto nei manuali di economia. Come uno dei due suddetti autori ha recentemente riconosciuto nel lavoro appena citato (Giavazzi e Spaventa, 2011), il trasferimento di capitali non ha imboccato la strada degli investimenti in settori innovativi, ma la più facile via della speculazione. Secondo la ricerca dell’EEAG guidata da Sinn, l’economista tedesco che guida la “guerra santa” contro i governi dei paesi periferici (Sinn e Wollmershäuser, 2012), il sistema Target2 è una sorta di finanziamento che la BCE fornisce per il catching-up della Periferia. Nel momento in cui la BCE fa fronte agli squilibri macroeconomici 215 dell’Eurozona fornendo liquidità ad libitum alle banche dei paesi in deficit commerciale, si determina una sorta di crowding-out (un “taglio” dei fondi disponibili) ai danni della Germania. A causa del dirottamento del risparmio verso i paesi periferici, l’economia tedesca avrebbe subito una caduta dell’attività di investimento (EAAG, 2013). Non sussisterebbe poi alcun motivo di invocare un riproporzionamento della domanda fra Centro e Periferia, incentivando una espansione della domanda interna soprattutto in Germania, in quanto con la discesa delle importazioni provocata dalla Grande Recessione gli squilibri macroeconomici si sarebbero di molto ridimensionati. Questa interpretazione non corrisponde ai dati della realtà. In primo luogo, l’analisi dell’EAAG è inficiata dal fatto che i flussi di liquidità di gran lunga più consistenti non sono le partite correnti ma i movimenti di capitali, che sono in gran parte ritornati al Centro dopo il raid speculativo in Sud Europa. In secondo luogo, la prova addotta dall’istituto di ricerca per dimostrare l’esistenza di convergenza reale è inconsistente. Il catching-up che viene misurato nel Rapporto dell’EAAG – mediante l’evidenza empirica di una forte correlazione fra tasso di crescita del PIL pro capite e deficit commerciali - è quello dei paesi dell’Europa Centro-Est nei confronti dei 12 paesi che hanno dato avvio all’UME, non quella dei paesi della Periferia nella loro “rincorsa” dei paesi del Centro. Il buon andamento del catching-up dei paesi CEEC è una di pochi aspetti positivi nell’evoluzione dei redditi pro capite all’interno dell’Unione Europea (Farina, 2012). La Germania, attraverso l’influenza intellettuale di un gruppo consistente di economisti molto presenti nei media e nelle riviste scientifiche, lamenta l’”azzardo morale” dei paesi periferici. Nella loro interpretazione dell’EEAG, il sistema Target2 non rappresenterebbe lo strumento operativo dei rapporti istituzionali fra la BCE e le BCN preposto alle poste attive e passive contabilizzate a Francoforte, ma lo strumento per dilazionare il necessario aggiustamento reale delle economie periferiche. Per provare la loro tesi, gli economisti tedeschi mettono in luce come il rifinanziamento delle banche greche oberate dai debiti a seguito di crediti inesigibili 216 si presenti perfettamente correlato con l’indebitamento della Banca di Grecia nell’ambito del Target2. Gli economisti tedeschi fanno notare come, a fine 2011, il 93 % dello stock di moneta creato dall’Eurosistema (l’autorizzazione data dalla BCE alle BCN a stampare moneta) prevenisse dai 5 paesi periferici (Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo and Spagna) che rappresentano solo il 34% del PIL dell’Eurozona. Come ha ironicamente osservato Sinn, il più rigorista fra gli economisti tedeschi “(t)he European system may prove more robust than the Bretton Woods system, given that the national central banks of the Netherlands, Finland, Luxembourg and Germany, which accumulated Target claims instead of dollar claims, will be unable to follow General De Gaulles’s example and convert their claims into gold (…) The Target imbalances show that a system with idiosyncratic country risks and international interest spreads for public and private bonds is incompatible with a monetary system that allows countries to finance their balance-ofpayments deficits with the printing press, without having to pay for the extra money-printing with marketable assets as is the case in the USA. Such a system will always induce the less-solid countries to draw Target credit to avoid the risk premium that the market demands, leading eventually to a balance-of-payments crisis. To avoid this problem, Europe has only two options. Either it socializes national debts in order to eliminate the international differences in interest rates (by creating a uniform default risk for all countries), limiting excessive borrowing through the imposition of politically mandated constraints. Or it ensures that the Target balances are redeemed annually with marketable assets, keeping the debt burdens within the national responsibility and allowing for country defaults and interest differentials The US obviously chose the second route. States can go bankrupt, excessive capital flows are prevented by state-specific interest spreads, and the Target balances are unattractive, since they have to be settled with marketable assets. This system is stable, because it avoids excessive capital flows between the states and thus excessive US-internal trade imbalances.” Questa posizione interpretativa rivela una incomprensione della differenza fra integrazione e convergenza. Se il sistema USA prevede la responsabilizzazione dei singoli Stati è proprio perché ha attraversato una lunga fase di integrazione economica, coordinata dagli interventi di politica economica del governo federale, che ha permesso a tutti gli Stati di raggiungere un certo livello di sviluppo. L’assenza 217 di tale coordinamento nell’Unione Europea ha lasciato che l’integrazione fosse affidata alla sola convergenza di mercato. 218
Scaricare