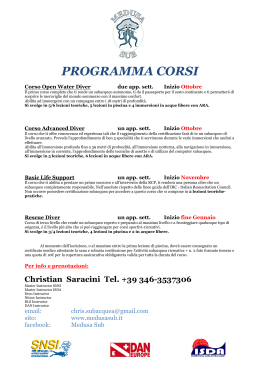www.pure - tech - agency.net
Pure Tech Agency
Modulo 1
Pure Tech Agency
Open Water Diver
CMAS-PTA - P1✶
Manuale per immersioni con
autorespiratore ad aria
" Dopo l'istante magico in cui i miei occhi si
sono aperti nel mare, non mi è stato più
possibile vedere, pensare, vivere come prima
— Jacques-Yves-Cousteau —
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
3
Pure Tech Agency
Modulo 1
Open Water Diver - CMAS-PTA P1✶
Autori:
Giorgio Amadei, Roberto Menzaghi
Testi:
Progetto grafico:
Giorgio Amadei, Roberto Menzaghi
Barbara Albrigo - Graficamente
Progetto editoriale:
Pure-Tech-Agency
Si ringrazia per la
consulenza
Per le fotografie:
l'Azienda Gravity Zero, il Dott. Fabrizio Pirrello,
Dott.ssa Laura Vernotico,
TF PTA Argentario Scuba Point,
TF Mare Nostrum, Enrico Pati,
Paolo Alemanni
A cura del PUBLISHING OFFICE PTA
www.pure-tech-agency.net/IT/PTA/Publishing_Office/index.html
Prima Edizione
Copyright © 2011 Pure Tech Agency
Via Torino, 28 - 21013 Gallarate (VA) - www.pure-tech-agency.net
Nessuna parte del presente manuale può essere copiata, riprodotta,
elaborata e neppure trasmessa in alcuna forma tramite mezzo elettronico
o meccanico senza previo consenso scritto dell’editore, tranne nel caso di
brevi citazioni contenute in articoli di critica o recensioni.
La presente pubblicazione contiene le opinioni dell’autore e ha lo scopo di
fornire informazioni precise e accurate.
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non
può comportare specifiche responsabilità in capo all’autore e/o all’editore
per eventuali errori o inesattezze.
Nomi e marchi citati nel testo sono depositati o registrati dalle rispettive
aziende.
Pure Tech Agency detiene i diritti per tutte le fotografie, i testi e le
illustrazioni che compongono questo libro.
Finito di stampare nel mese di maggio 2011
4
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Questo è il manuale che devi usare durante il tuo corso per apprendere le
conoscenze e le tecniche necessarie ad effettuare immersioni divertenti e
sicure.
Esso deve focalizzare la tua attenzione sugli aspetti teorici, ma soprattutto
sulle applicazioni pratiche.
Il manuale è da supporto al corso, ne è parte integrante, ma non
è sufficiente per fornirti tutte le informazioni e conoscenze per
immergerti: ulteriori informazioni e conoscenze le apprenderai dal
tuo Istruttore PTA, un professionista altamente qualificato che ti seguirà
durante il tuo addestramento teorico e le successive applicazioni pratiche.
Il manuale è strutturato in 6 moduli, ogni modulo prevede degli obiettivi
d’apprendimento che dovrai raggiungere durante le lezioni di teoria e che
saranno in seguito verificati dal tuo Istruttore durante gli esami finali.
Il testo è volutamente semplice ed è stato strutturato in modo da facilitare
lo studio. Se hai dei dubbi, prendi appunti e chiedi delucidazioni al tuo
Istruttore.
LEGENDA
Leggendo il manuale noterai delle caselle contrassegnate da
simboli, esse ti forniranno preziosi consigli ed informazioni per
meglio comprendere la materia di studio.
ATTENZIONE
identifica un’informazione basilare
per la tua sicurezza
FERMATI
E RIFLETTI
sottolinea e rimarca un concetto
chiave
RICORDA
focalizza la tua attenzione su un
concetto
IDEA
esprime un consiglio
dall’esperienza
ESEMPIO
contraddistingue un esercizio, un
esempio pratico
NOTA
fornisce un’informazione generale o
di approfondimento
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
dettato
5
Modulo 1
INTRODUZIONE
Pure Tech Agency
Modulo 1
AVVERTENZE
Tu e il tuo Istruttore avete delle responsabilità precise durante questo
corso.
Durante tutte le fasi del corso l’Istruttore valuterà le tue conoscenze e la
progressione del livello d’addestramento sempre e comunque in funzione
della sicurezza.
L’Istruttore dovrà:
•
•
•
•
•
•
•
Organizzare le lezioni di teoria
Sovrintendere alla pianificazione dell’immersione
Svolgere il briefing pre-immersione
Assicurarsi del tuo equipaggiamento
Supervisionare direttamente tutte le attività in acqua
Svolgere il de-briefing post immersione
Compilare i moduli richiesti per il corso
L’Allievo dovrà:
• Presentare e compilare la documentazione richiesta per la
partecipazione allo specifico Corso PTA ed attenersi a quanto viene
dichiarato
• Studiare e comprendere i sussudi didattici PTA e le lezioni integrative
svolte dall'Istruttore
• Pianificare l'immersione con i sistemi proposti dal corso
• Attenersi a ciò che viene pianificato, salvo diverse, esplicite ed
inconfutabili decisioni dell'Istruttore
• Essere responsabile delle proprie azioni e della personale sicurezza
• Mantenere un adeguato stato di salute fisica e mentale
• Informare l’Istruttore tempestivamente di eventuali cambi di condizioni
personali o sofferenze psicofisiche
• Immergersi secondo il principio del Sistema di Coppia, non separarsi
mai dall’Istruttore ne dall’eventuale gruppo d’immersione
Benvenuto in PURE TECH AGENCY
6
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Modulo 1
Pure Tech Agency
Manuale
Open Water Diver
CMAS-PTA P1✶
Pure Tech Agency
www.pure-tech-agency.net
MODULI
1
2
3
4
5
6
Equipaggiamento
Fisiologia del corpo umano e leggi fisiche
Adattamento all'ambiente e riconoscimento
dei problemi
Tabelle di immersione e Computer subacquei
Pianificazione dell'Immersione
Ambiente subacqueo
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
7
Pure Tech Agency
Modulo 1
INDICE
MODULO 1 ...................................................................................19
1.1 Equipaggiamento di base ....................................................21
Maschera ............................................................................. 21
Pinne ................................................................................... 22
Aeratore .............................................................................. 23
Muta .................................................................................. 24
Guanti, Calzari, Cappuccio ...................................................... 27
Zavorra................................................................................ 28
1.2 Equipaggiamento A.R.A. ......................................................29
Bombola .............................................................................. 29
Acciaio o Alluminio? ............................................................... 31
Erogatore, Il primo stadio ....................................................... 32
La frusta .............................................................................. 34
Il secondo stadio ................................................................... 35
L'erogatore completo ............................................................. 36
Fonte d'Aria Alternativa (FAA) ................................................. 37
Consigli per l'acquisto ............................................................ 38
Sintesi delle raccomandazioni Primo Stadio .............................. 39
Secondo Stadio, Manometro ................................................... 40
GAV - Giubbetto ad Assetto Variabile ....................................... 41
Come assemblare un gruppo A.R.A. ......................................... 43
1.3 Strumentazione ed accessori ..............................................44
Orologio subacqueo, Profondimetro, Boa segna-sub ................... 44
Legislazione, bandiera Alfa, Boa Gonfiabile ............................... 45
Mulinello, Torcia Subacquea .................................................... 46
Coltello, Bussola.................................................................... 49
Fischietto, Lavagnetta, Borsa o Contenitore rigido ...................... 51
1.4 Preparazione e vestizione dell'attrezzatura ........................52
La vestizione ........................................................................ 52
Configurazione dell’attrezzatura .............................................. 53
1.5 Conclusioni .........................................................................54
Verifica dell'apprendimento ..................................................... 55
MODULO 2 ...................................................................................57
2.1 Cenni sull'immersione in apnea...........................................59
2.2 La Respirazione...................................................................60
2.3 l'Apparato respiratorio e circolatorio ..................................61
2.4 Corretta eliminazione dell'anidride carbonica .....................64
2.5 Approfondimento sulle vie aeree superiori ..........................66
2.6 Le leggi fisiche ...................................................................67
La pressione ......................................................................... 67
La pressione esercitata dai fluidi .............................................. 68
Torricelli ............................................................................... 69
Pascal .................................................................................. 70
La legge di Archimede o spinta idrostatica ................................ 71
La legge di Boyle e Mariotte .................................................... 73
La densità dei fluidi e la respirazione ........................................ 76
8
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
La legge di Dalton ................................................................. 77
Effetti dell'aumento di pressione: la compensazione ...........78
Sintesi delle raccomandazioni ................................................. 80
2.8 Effetti della diminuzione di pressione .................................81
2.9 La vista ...............................................................................82
2.10 L'udito.................................................................................83
Verifica dell'apprendimento ..................................................... 84
2.7
MODULO 3 ..................................................................................87
3.1 La Legge di Henry ...............................................................88
3.2 Assorbimento e cessione dell'Azoto ....................................89
3.3 La Decompressione .............................................................91
3.4 La Patologia da Decompressione .........................................92
3.5 La Narcosi di Azoto .............................................................94
3.6 Riconoscimento dei problemi e incidenti subacquei ............94
3.7 Gestione delle emergenze ..................................................98
La sovradistensione Polmonare................................................ 99
Embolia Gassosa Arteriosa.....................................................100
3.8 Lo stress ...........................................................................103
Gestione dello Stress ............................................................106
Verifica dell'apprendimento ....................................................107
MODULO 4 .................................................................................109
4.1 Pianificazione dell'Immersione: Tabelle ............................110
Procedura ...........................................................................119
4.2 Pianificazione dell'Immersione: Computer subacqueo ......121
Scopo, Storia, Funzionamento ...............................................121
Precauzioni .........................................................................122
Funzionalità .........................................................................124
Verifica dell'apprendimento ....................................................125
MODULO 5 .................................................................................127
5.1 Sistema di coppia ..............................................................129
5.2 Comunicazione Subacquea ................................................131
5.3 Preparazione all'immersione .............................................134
5.4 Pianificazione dell'Immersione .........................................135
Il Briefing ............................................................................136
5.5 Il consumo d'Aria ..............................................................136
5.6 Controlli pre-immersioni ...................................................138
5.7 Aspetti generali e abilità di base .......................................139
Verifica dell'apprendimento ....................................................141
MODULO 6 .................................................................................143
6.1 Caratteristiche fisiche e adattamento all’ambiente acquatico...... 144
6.2 La vita acquatica ...............................................................147
6.3 La catena alimentare ........................................................148
6.4 L’atteggiamento verso la vita marina e l’ambiente ...........148
Verifica dell'apprendimento ....................................................151
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
9
Modulo 1
Pure Tech Agency
Modulo 1
Pure Tech Agency
Acque Confinate ........................................................................153
Acque Libere .............................................................................167
Appendice .................................................................................177
La fotografia subacquea ................................................................178
Consigli e suggerimenti .................................................................181
Alimentazione e attività subacquea .................................................182
Attività subacquea e Fitness ...........................................................187
La donna e l'immersione ................................................................191
Tabelle ........................................................................................194
Personal Dive Log .........................................................................196
Modulo Addestramento Diver .........................................................199
10
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Se il tuo desiderio è divertirti, imparare cose nuove, scoprire nuovi
ambienti, stare a contatto con la natura, viaggiare, conseguire una buona
forma fisica ed incontrare nuovi amici, allora le immersioni subacquee sono
lo sport che fa per te!
Qualsiasi luogo nel quale effettuare un'immersione subacquea, sia esso
il tepore di un mare tropicale, oppure le acque ricche di fascino e storia
del mediterraneo finanche le fredde e misterioso acque dei mari del
nord o di un lago alpino, ti potrà offrire qualcosa di nuovo ed intrigante
per permettere alla tua fantasia ed immaginazione di provare sensazioni
meravigliose.
La subacquea è una disciplina sportiva i cui strumenti di conoscenza ci
permettono di esplorare il mondo sommerso. La subacquea ricreativa ne
è il compendio delle conoscenze di base.
Possiamo differenziare il modo in cui esploriamo gli ambienti sommersi in
due tipologie:
• L'immersione in apnea: quando l'esplorazione avviene per brevi
e ripetuti lassi di tempo grazie unicamente alla nostra capacità di
"trattenere il fiato";
• L'immersione con autorespiratore: quando l'esplorazione avviene
per mezzo dell'equipaggiamento che indossiamo - l'autorespiratore - il
quale ci permette di "respirare" sott'acqua per periodi prolungati.
Potremmo definire l'immersione con autorespiratore proprio come Immersione
in Eupnea. Eupnea è un termine il cui significato è il contrario di Apnea, ovvero
"respirazione regolare e tranquilla di un individuo
Questo manuale si prefigge di mettere a disposizione ed organizzare
le nozioni di ingresso al mondo dell'immersione con autorespiratore
collocandosi ad un livello di apprendimento adatto alla subacquea ricreativa
di primo livello, ovvero il corso sommozzatore CMAS-PTA P1.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
11
Modulo 1
L' Immersione Subacquea Ricreativa
T. F. PTA - Mare Nostrum - Palermo
Modulo 1
Pure Tech Agency
12
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Il corso CMAS-PTA P1✶ sarà l’inizio di un’avventura senza fine, il biglietto
d’ingresso in mondo nuovo e meraviglioso, un pianeta sconosciuto di cui
sino ad ora ne avrai sentito solo parlare o potuto ammirare in foto o nei
documentari.
Con il superamento del Corso Open Water Diver otterrai la certificazione
internazionale CMAS-PTA P1✶.
Potrai quindi condividere le tue avventure subacquee con gli amici o con i
tuoi familiari, potrai conoscere nuovi luoghi e fare nuove amicizie.
Hai iniziato a praticare un’attività che non ha eguali al mondo e che ti
proietterà in una nuova dimensione.
Consultati con il tuo Istruttore CMAS-PTA, il quale ti fornirà le indicazioni
utili per ottenere le informazioni necessaria o ti indicherà presso quale
Centro CMAS-PTA convenzionato e di fiducia potrai rivolgerti per le tue
prossime immersioni o per le tue vacanze subacquee.
Il brevetto che riceverai riporta il tuo nome e cognome, il nome il cognome
e il numero dell’Istruttore CMAS-PTA che ha rilasciato il brevetto, la data
di rilascio, il numero di matricola del brevetto e il riepilogo di tutte le
abilitazioni all'immersione conseguite con tutti i Brevetti PTA.
Pure Tech Agency è stata la prima didattica al mondo a riportare su ogni
brevetto subacqueo le abilitazione del titolare.
Con il tuo brevetto potrai:
Immergerti entro una profondità massima di 18 metri
(internazionalmente stabilita) insieme a un altro subacqueo
brevettato di almeno pari livello
Eseguire immersioni sotto la supervisione di una guida subacquea
presso i Centri Immersione.
Ottenere la ricarica della bombola presso i centri ricarica.
Ottenere il noleggio di attrezzature subacquee
Accedere al Corso Avanzato CMAS-PTA P2✶✶
(Advanced Scuba Diver)
Accedere ai Corsi di Specializzazione
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
13
Modulo 1
Open Water Diver - CMAS-PTA P1✶
Pure Tech Agency
Modulo 1
CMAS
Confédération Mondiale Des Activités Subaquatiques
www.cmas.org
Jacques-Yves Cousteau, il noto esploratore di mari, propone di costituire la
CMAS, in francese Confédération Mondiale des
Activités Subaquatiques. Il 28 settembre 1958 i
delegati delle federazioni sportive membri della
CIPS si incontrarono a Bruxelles in occasione del
Congresso per l'indipendenza della Confederazione
United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization
Internazionale di tutte le discipline subacquee.
Con questo intento viene convocata dal 9 all’11
gennaio 1959 nel Principato di Monaco, dove Cousteau è direttore del Museo
Oceanografico, l’assemblea costituente della Confederazione Mondiale delle
Attività Subacquee, in breve CMAS. La Confederazione successe, nelle specifiche
competenze e funzioni, al "Comitato degli Sport Subacquei" della CIPS. Cousteau
viene acclamato Presidente e chiama alla Vicepresidenza Luigi Ferraro.
CIO - Comitato Olimpico
UICN - Unione Internazionale per la
Internazionale
Conservazione della Natura
C'è tanto da fare: innanzi tutto creare ex novo una didattica grazie alla
quale sia possibile insegnare in tutto il mondo come ci si immerge in
modo sicuro utilizzando l'aria come gas respiratorio. Inoltre bisogna
regolamentare la pesca subacquea, specialmente quella praticata con le
bombole in quanto i sub (ormai hanno un nome comune, sommozzatori
e pescatori subacquei) sono migliaia, e potrebbero infliggere seri danni
all'ambiente, erpetrando autentiche mattanze; occorre assicurare ai vari
paesi i mezzi per difendere e tutelare il proprio patrimonio archeologico
sommerso, ormai facilmente raggiungibili da qualsiasi sub dilettante;
Avviare una stretta collaborazione con la scienza medica affinchè si
risolvano i troppi misteri che ancora ammantano la fisiologia del corpo
umano in immersione.
IWGA - Associazione Internazionale Campionati Mondiali
AGFIS Associazione
Generale delle Fedrazioni
Sportive Internazionali
La CMAS oggi raggruppa numerose federazioni e associazioni che operano
nel campo della subacquea e ne organizza le attività didattiche e sportive.
Ha attraversato momenti di difficoltà economica e organizzativa da cui
l’italiano Achille Ferrero, assumendone la presidenza, l’ha saputa risollevare
e riorganizzare in maniera efficiente e moderna. Ne fanno parte 116
membri tra federazioni nazionali e organismi affiliati in rappresentanza di
più 3 milioni di praticanti. É riconosciuta dall’UNESCO, dal CIO, dall’Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura (IUNC) ed membro di
altre importanti organizzazioni internazionali come AGFS e IWGA.
14
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Oltre la subacquea ricreativa inizia un altro "mare" di conoscenze e possibilità
che vanno sotto l'insieme definito come subacquea tecnica. Questa,
rispetto alla subacquea ricreativa, consente il raggiungimento di profondità
ben maggiori anche utilizzando miscele respiratorie diverse dall'aria.
PTA affonda le sue radici nell’agenzia di didattica tecnica P.S.A. (Professional
Scuba Association), un’associazione statunitense fondata nel 1967 in Orlando
(Florida) da uno dei vecchi miti della subacquea americana, Hal Watts.
Nel 1993 la società HdueO Diving Activities diventa franchiser di PSA per
diffonderla in Italia e in Europa, Inghilterra esclusa.
La subacquea tecnica comincia il cammino per affermarsi nel Vecchio
Continente finchè, nel 2000, HdueO Diving Activities si rende conto che sono
necessari cambi radicali sia nella struttura sia nel metodo d’insegnamento:
nasce così PTA (Pure Tech Agency), un’agenzia di didattica tecnica che si
impone sul panorama subacqueo internazionale come punto di riferimento
per tutti quei subacquei che vogliono fare un salto di qualità abbandonando
l’approccio della "subacquea ricreativa" per approfondire tutti quegli aspetti
e quelle tecniche necessarie per diventare dei subacquei tecnici veri, puri.
Il marchio PTA viene gemellato al marchio PSA su tutti i Brevetti e nel
2006 arriva il riconoscimento di qualità della CMAS che promuove PTA
come prima didattica tecnica appartenente alla confederazione
che raggruppa le organizzazioni di addestramento alla subacquea a livello
mondiale.
Nel 2010, PTA introduce nei propri programmi didattici anche una linea
ricreativa, applicando gli Standard Ricreativi CMAS e sviluppando un
percorso dinamico, moderno, e orientato al tecnico con cammini didattici
integrati, che sviluppano Crediti Formativi.
PTA dispone pertanto di due aree ben distinte ma non distanti. Molto
diverse ma compenetrate. La Subacquea Tecnica PTA è un mondo intero,
un ambiente completo e composito, diverso dal ricreativo L’approccio PTA
dei primi Corsi è atto a costruire le basi fondamentali mantenendo basse le
profondità e le richieste operative. Solo successivamente, quando si sono
stabilite le basi, i Corsi diventano più performanti ed esigenti.
In conclusione l’approccio PTA muove verso una nuova piattaforma
didattica, evolutiva e comportamentale.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
15
Modulo 1
PTA - Pure Tech Agency
Pure Tech Agency
Modulo 1
Struttura del Corso
La struttura del corso è flessibile per facilitare le tue esigenze, la logistica
e le necessità dell’Istruttore. Le informazioni sono di carattere generale,
approfondirai i particolari assieme al tuo Istruttore che risponderà a tutte
le tue domande e risolverà i tuoi dubbi.
IL corso è suddiviso in 3 parti distinte:
T=
Teoria: acquisizione delle informazioni, dei principi e delle regole
d’immersione;
AC = Acque Confinate: apprendimento delle tecniche per le Immersioni
subacquee
AL = Acque Libere: applicazione in Acque Libere, delle tecniche imparate
durante l'addestramento in AC
Ogni parte può essere scomposta o unita ad altre parti, eseguita in una o
più volte secondo le esigenze logistico od organizzative.
La parte di teoria si deve ritenere superata solamente quando l’allievostudente ha superato positivamente la prova scritta (test).
La parte pratica in acque confinate si deve ritenere superata quando l’allievostudente, a discrezione dell’Istruttore, ha mostrato di avere eseguito,
sufficientemente, tutti gli esercizi previsti dagli standard del corso praticato.
Le prove in acque confinate sono propedeutiche a quelle in acque libere,
pertanto si deve dare importanza alla qualità dell’esecuzione e non solo ad
una mera ripetizione.
La parte pratica in acque libere si deve ritenere superata quando l’allievostudente ha superato tutte le esercitazioni richieste in modo adeguato.
L’allievo ha l’obbligo di effettuare tutte le esercitazioni richieste.
Sessioni di Teoria:
Imparerai molte cose importanti, non solo durante le lezioni in aula,
bensì anche durante le attività pratiche in acqua, durante i briefing e i
debriefing che il tuo Istruttore svolgerà così come prevede il programma di
addestramento CMAS-PTA.
Al termine di ogni lezione di teoria vi è un ripasso delle conoscenze
rappresentato da alcune domande sui punti principali della lezione appena
appresa. Il ripasso delle conoscenze non è valutativo.
Esami di Teoria:
Gli esami di teoria del corso CMAS-PTA P1✶ (OWD) si svolgono con il
sistema "multirisposta".
Ti sarà consegnato un questionario contenente le domande di esame,
per ogni domanda sono riportate diverse risposte delle quali soltanto
una è quella esatta; devi contrassegnare la risposta esatta. La massima
percentuale di errori consentita per superare l’esame è il 20%. Le domande
errate saranno in seguito discusse con l’Istruttore in modo tale che tu abbia
la possibilità di comprendere l’errore e di conoscere la risposta corretta.
16
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Sessioni in Acque Confinate:
In concomitanza o dopo ogni lezione di teoria, a secondo la logistica del
Corso; si svolgeranno le sessioni in Acque Confinate.
Prima di accedere alle prove in acqua, dovrai aver consegnato il tuo
certificato medico sportivo attestante l’idoneità alle attività subacquee.
Durante la fase delle Acque Confinate, prima di eseguire gli esercizi
in acqua, dovrai assistere alla loro dimostrazione pratica da parte
dell’Istruttore e/o dell’Ass. Istruttore CMAS-PTA.
Sessioni in Acque Libere:
Le Sessioni in Acque Libere si svolgeranno dopo che avrai dato prova della
corretta esecuzione degli esercizi standard del programma CMAS-PTA P1✶
Durante le Sessioni in Al, ripeterai gli esercizi principali appresi durante le
Sessioni in Acque Confinate.
Le Sessioni si articolano su 5 immersioni in Acque Libere, le quali sono
precedute da un briefing e seguite di un debriefing durante i quali
l’Istruttore CMAS-PTA avrà modo di fornire consigli e suggerimenti per
migliorare l’esecuzione degli esercizi e migliorare il proprio comfort,
divertimento e sicurezza.
Al termine di ogni sessione, l’Istruttore CMAS-PTA provvederà alla
registrazione sul Modulo di Addestramento Diver CMAS-PTA e alla
convalida sul Personal Log Book (libretto d’immersioni) dell’addestramento
effettuato.
Già dalla tue prime esercitazioni dovrai interagire ed utilizzare l’attrezzatura
subacquea. La conoscenza di base dell’equipaggiamento, ti permetterà una
migliore consapevolezza ed una maggiore operatività. Consultati con il
tuo Istruttore CMAS-PTA, il quale ti fornirà le indicazioni utili per ottenere
l’attrezzatura necessaria o ti indicherà presso quale negozio CMAS-PTA
convenzionato e di fiducia, potrai rivolgerti per i tuoi acquisti.
T. F. PTA - Argentario Scuba Point
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
17
Modulo 1
Pure Tech Agency
Modulo 1
Pure Tech Agency
18
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Modulo 1
Pure Tech Agency
MODULO 1
Equipaggiamento
Panoramica
•
•
•
•
•
Equipaggiamento di base
Equipaggiamento A.R.A.
Strumentazione ed accessori
Preparazione e vestizione dell'attrezzatura
Conclusioni
Obiettivi
Al termine di questo modulo saremo in grado di:
•
•
Conoscere l'equipaggiamento di base necessario per l'attività
subacquea;
Comprendere gli usi specifici di ogni attrezzatura
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
19
Pure Tech Agency
Il corpo umano è perfettamente adattato alla vita terrestre ed agli habitat
aerei. Per poter perlustrare gli ambienti sommersi è necessario indossare
apposite attrezzature, appendici ed indumenti al fine di riappropriarsi di
parte di quelle abilità proprie del corpo umano che diminuiscono o vengono
a mancare allorquando si è in immersione. Sott'acqua infatti i nostri occhi
non sono più in grado di vedere nitidamente, l'epidermide è incapace di
trattenere efficacemente il calore corporeo, le gambe ed i piedi sono inadatti
a garantire un'efficiente moto e, più di ogni altra cosa, i nostri polmoni sono
assolutamente incapaci di permettere la respirazione.
L'equipaggiamento subacqueo è un bagaglio, un tutt'uno integrato
composto da più parti grazie alle quali ci viene quindi restituita una buona
parte della perduta efficienza e con essa la possibilità di esplorare, in modo
prolungato, gli habitat sommersi. In ragione di ciò possiamo considerare
le varie parti di un'attrezzatura come delle vere e proprie protesi ed in
quanto tali si comprende benissimo quanto sia importante capirle, usarle e
conservarle in modo adeguato.
T. F. PTA - Mare Nostrum
Modulo 1
Considerazioni generali
20
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
1.1 Equipaggiamento di base
Maschera
I nostri occhi riescono a mettere a fuoco gli oggetti soltanto in ambiente
aereo, pertanto la funzione principale della maschera è quella di interporre
uno strato d'aria tra l’acqua e gli occhi.
Questo consente ai nostri occhi di mettere a fuoco gli oggetti in immersione
evitando l'alterazione visiva che si avrebbe per la differente rifrazione
dell’acqua rispetto all'aria. La maschera quindi ci restituisce la vista; è
lo strumento grazie al quale è possibile avere una visione nitida quando si
è in immersione.
Le parti principali che compongono una maschera sono:
• le lenti: che devono essere in vetro infrangibile ed antigraffio
• il corpo: di silicone, trasparente o nero, o in gomma, deve avere una
forma anatomica che si adatti alla conformazione del viso evitando
il passaggio di acqua all’interno. Deve inoltre avere un comodo
alloggiamento sagomato per il naso che permetta di stringere il naso
tra indice e pollice in modo tale da poter compiere le manovre di
compensazione
• la montatura: fissa le lenti al corpo e a volte supporta il sistema di
regolazione del cinghiolo
• il cinghiolo: consente di regolare la pressione e quindi la tenuta della
maschera sul viso mantenendola in posizione corretta
Per scegliere la maschera che meglio si adatta al nostro viso occorre
indossarla nella giusta posizione (senza il cinghiolo) ed inspirare
leggermente con il naso: la depressione che si crea deve mantenersi stabile
e far aderire bene al viso la maschera fino a quando non si espira. Sono
da preferire maschere che permettono un ampio campo visivo e che siano
al contempo non troppo ingombranti. La scelta del materiale, silicone o
gomma, non influisce sulle prestazioni della maschera quanto sulla durata:
la gomma subisce più rapidamente l'invecchiamento provocato dal sole e
dalla salsedine.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
21
Modulo 1
Pure Tech Agency
Modulo 1
Pure Tech Agency
I materiali usati dalle aziende costruttrici in fase di lavorazione e
stampaggio dei componenti delle maschere stesse talvolta tendono a
nebulizzarsi in piccole quantità e questo crea un residuo oleoso sulle lenti
che le fa appannare facilmente durante l'uso.
É buona norma pulire i vetri di una maschera appena acquistata che
manifesta questo fastidioso fenomeno con del semplice dentifricio o sapone
liquido piuttosto che usare prodotti chimici anti-appannanti.
L'effetto leggermente abrasivo che si produce strofinando le lenti tende a
risolvere il problema.
Buona parte delle maschere in commercio possono essere equipaggiate con
lenti correttive temperate.
La maschera dopo l’uso va sciacquata in acqua dolce, va tenuta lontano
da fonti di calore, al riparo dai raggi diretti del sole (per evitare il
deterioramento precoce delle parti in gomma), e riposta in modo tale da
evitare che la parte morbida si deformi.
Pinne
Le pinne ci restituiscono parte della mobilità consentendoci di spostarci
con una certa rapidità senza l'ausilio delle braccia e mani. Sono delle
appendici che si applicano ai piedi del subacqueo per aumentare la
velocità di spostamento e l'efficacia di movimento in acqua, sia in superficie
sia in immersione.
Ne esistono in commercio di vario tipo, forma e dimensione, in gomma o
altro materiale, galleggianti oppure no e sono composte sostanzialmente
da due parti principali che assieme formano un corpo unico:
• La calzata o scarpetta, ovvero l'alloggiamento del piede: la scarpetta
può essere chiusa sul tallone oppure aperta e munita di cinghiolo. La
scarpetta chiusa la si indossa direttamente a piede nudo oppure con
una calza in neoprene o altro materiale coibente. Per indossare la
scarpetta aperta si rende necessario l'uso di apposite calzature munite
di suola semi-rigida
• La pala: è la parte della pinna che imprime la spinta sull'acqua e che
determina di conseguenza il moto. La rigidità è variabile e combinata
alla reattività specifica del materiale con cui sono realizzate le rendono
più o meno performanti
La scelta di un modello piuttosto che di un altro va fatta in base al tipo
di attività che si vuole praticare:
• Apnea: si usano pinne a scarpetta chiusa ed a pala lunga capaci
di imprimere una spinta molto elevata. Alcuni sub che praticano
l'immersione con autorespiratore preferiscono comunque usare le pinne
da apnea proprio per la loro elevata capacità di spinta. In anni recenti
è comparsa sul mercato la monopinna (un particolare tipo di pinna che
ricalca la forma delle pinne caudali dei mammiferi marini) che obbliga
il sub che la indossa a muoversi in modo sinuoso con i piedi saldati tra
loro.
Questo particolare tipo di pinna è molto efficiente, ma richiede delle
buone doti atletiche e non è adatta per l'immersione con l'ARA.
22
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
• A.R.A.: si usano generalmente pinne di lunghezza media o addirittura
piuttosto corta aventi la pala proporzionalmente più larga
La ricerca tecnologica degli ultimi anni ha portato a realizzare forme e
materiali innovativi al fine di ridurre lo sforzo senza diminuire eccessivamente
le prestazioni e quindi la potenza di spinta. Questa "innovazione" talvolta
ha il solo scopo di rendere più commercialmente e stilisticamente attrattivo
il prodotto. Prima dell'acquisto sarebbe opportuno provare più modelli in
acqua: è l'unico modo per stabile se una tal pinna fa al caso nostro.
Oltre a questo occorre considerare la comodità della calzata: le pinne non
devono essere troppo strette, per evitare rallentamenti della circolazione,
con conseguente eccessiva sensibilità al freddo e rischio di crampi; e non
devono neppure essere troppo larghe, per evitarne la perdita durante l’uso.
Aeratore
L'aeratore, chiamato anche Snorkel, ci permette di respirare in superficie
con la faccia immersa in modo da avere una visione continua del fondale.
In immersione non serve a nulla e potrebbe essere di intralcio, mentre in
superficie ci permette ad esempio di individuare il punto esatto di inizio
della discesa senza sprecare l'aria contenuta nella
bombola.
L’ aeratore è formato da due parti: boccaglio e tubo.
Il boccaglio deve essere morbido ed avere una forma che
consenta di adattarsi comodamente alle arcate dentarie.
Il boccaglio viene trattenuto dalle labbra senza fatica
e senza passaggio d’acqua. Il tubo può essere rigido
o semirigido, dritto o leggermente curvo per meglio
adattarsi alla forma della testa.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
23
Modulo 1
Pure Tech Agency
Modulo 1
Pure Tech Agency
La parte interna del tubo deve essere liscia e con curvature non accentuate
per non trattenere acqua e per evitare turbolenze nel flusso d’aria.
Per consentire l’individuazione del subacqueo è consigliabile che nella parte
terminale
del tubo che emerge dall’acqua
ter
sia presente una fascia di colore ben
visibile.
vis
Per chi lo desidera esso è dotabile di un
attacco
ad anello elastico per poter essere
att
fissato
al cinghiolo della maschera.
ss
Occorre
però prestare attenzione al
Oc
posizionamento
(che deve consentire
po
sia un comodo utilizzo sia una eventuale
rapida
rimozione), all'ergonomia ed alla
rap
semplicità
costruttiva.
sem
Muta
La muta ci permette di limitare la perdita di calore del corpo umano
immerso in acqua in ragione dell'elevata conducibilità termica di
quest'ultima (circa 25 volte maggiore rispetto all’aria).
Essa si comporta come una seconda pelle e ci protegge non solo dal
freddo ma anche dalle abrasioni in caso di contatto con il fondale marino,
e, di rado, anche dagli animali urticanti. Senza una muta anche con l'acqua
a 20 gradi dopo un tempo piuttosto breve inizieremmo a sentire freddo.
Esistono 3 tipologie di mute:
• Umide: Queste sono realizzate in neoprene, un tipo particolare
di gomma piuttosto morbida e isolante con la quale è possibile
confezionare dei veri e propri indumenti. La pellicola di acqua che
si forma tra la fodera interna applicata sul neoprene ed il corpo del
subacqueo si riscalda fino a raggiungere la temperatura della pelle;
questo contribuisce a mantenere una condizione termica abbastanza
stabile e duratura che evita una dispersione di calore troppo
accentuata
Per questa ragione le mute umide devono essere di misura adeguata,
aderenti ma non strette, con parti a tenuta sui polsi, alle caviglie, sul
collo o sul cappuccio al fine sia di contenere quanto più possibile il
ricambio d'acqua della pellicola, sia impedire la formazione di sacche
d'acqua che annullerebbero l'isolamento termico. Gli spessori del
neoprene con il quale si confezionano le mute possono variare da un
minimo di un paio di millimetri fino a 7 millimetri.
Ovviamente maggiore è lo spessore e migliore sarà la protezione al
freddo.
24
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Sono disponibili sul mercato numerosi modelli di mute in un unico
pezzo oppure in più pezzi (giacca e salopette), con o senza cappuccio,
a manica o gamba corta, con o senza cerniere, con spessori di
neoprene differenziati, di taglie fisse o su misura e la scelta di
un modello piuttosto che un altro è dettata dal tipo di condizioni
ambientali prevalenti nelle quali dovrà operare. Se ci immergiamo
solamente in mari caldi tropicali, probabilmente un mutino di poco
spessore a maniche e gamba corta fa al caso nostro
• Semistagne: Sono mute umide in monopezzo che hanno la
caratteristica di garantire un ridottissimo ricambio d'acqua cosi da
aumentare l'isolamento termico del subacqueo.
Le opinioni a proposito delle mute semistagne sono discordanti: taluni le
ritengono particolarmente adatte alle temperature riscontrabili durante tutte
le stagioni nel mar mediterraneo; altri le descrivono come un capo scomodo da
indossare, troppo caldo d'estate e meno versatile di una umida classica magari
in due pezzi ed in ogni caso di fatto destinato a cedere presto il posto alle
mute stagne (appena l'esperienza del subacqueo, maturando, lo consente).
Il prezzo, talvolta un po' elevato, tende a condizionare la scelta in sfavore di
questa tipologia di mute.
• Stagne: Queste sono realizzate con particolari tessuti o neoprene ed
hanno la caratteristica che il corpo del subacqueo in immersione non si
bagna. Pertanto è possibile indossare sotto di esse indumenti di vario
genere al fine di aumentare notevolmente il comfort termico anche in
acque molto fredde con temperature inferiori o vicine ai 10/12 gradi
centigradi. Sono le mute più costose.
Muta umida
Muta semistagna
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Muta stagna
25
Modulo 1
Pure Tech Agency
Pure Tech Agency
Modulo 1
Distinguiamo 3 tipologie di neoprene:
Classico, ad Alta Densità e Precompresso.
Il neoprene Classico è una gomma porosa sintetica in forma di fogli la
cui massa è costituita da cellule gassose uniformemente distribuite che gli
conferiscono sia elasticità sia capacità isolanti.
Esso è lavorabile come fosse un tessuto e come tale può essere tagliato,
cucito ed ovviamente incollato per confezionare le mute subacquee. Viene
generalmente impiegato per il confezionamento di mute umide.
Il neoprene ad alta densità è di un tipo di neoprene caratterizzato
da una minor quantità di cellule gassose rispetto al neoprene classico. É
più resistente del neoprene classico e mantiene buone doti di flessibilità,
leggerezza e vestibilità e lo si utilizza per il confezionamento di tutti i tipi di
mute con prevalenza di semistagne e stagne.
Il neoprene precompresso viene ottenuto partendo da un foglio di
neoprene ad alta densità che viene "compresso" con un particolare
trattamento in autoclave per un periodo di tempo di circa 48 ore. Si ottiene
così un materiale molto robusto, di buona coibenza termica, discretamente
elastico e maggiormente pesante rispetto agli altri tipi di neoprene. Pur con
una certa approssimazione possiamo dire che una muta realizzata con uno
spessore di 2,5 mm di precompresso pesa quanto una muta da 5,5 mm in
neoprene tradizionale, mentre la coibenza termica si avvicina a quella di un
neoprene da 3,5 mm.
Questo tipo di materiale è indicato per il confezionamento di mute stagne
destinate ad immersioni particolarmente impegnative ed in acque fredde.
A tutti i tipi di neoprene viene di solito applicata internamente una fodera
(generalmente in nylon) che oltre ad avere una funzione antibatterica aumenta la
vestibilità e protegge la pelle dal contatto diretto con le parti cucite ed incollate.
Insieme alla muta è consigliabile utilizzare anche guanti e calzari, in quanto
le estremità degli arti sono molto sensibili al freddo. I guanti in neoprene
offrono un’ ottima protezione ed in commercio se ne trovano molti tipi e
di differente livello protettivo. I calzari vanno scelti in base al tipo di pinna
utilizzata: dai calzari semplici in neoprene da 2-5 mm, per le pinne con
scarpette chiusa, a quelli integrati in un vero e proprio scarponcino con
suola rigida, per le pinne con scarpetta aperta e cinghiolo.
26
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
I Guanti devono proteggere le mani sia dal freddo sia da accidentali
abrasioni od escoriazioni. I più comuni sono in neoprene da 3 o 5 mm, ma
per acque più calde si trovano anche misti neoprene e nylon.
É da tenere presente che guanti di spessore oltre i 3 mm offrono si una
maggiore protezione ma allo stesso tempo ne riducono la manualità.
Guanti nylon
Guanti neoprene
Guanti moffola
Calzari
I Calzari, proteggono i piedi dal freddo in acqua e dalle asperità in superficie.
Come i guanti sono prodotti in vari spessori e formati, a forma di calze (per
un uso con pinne a scarpetta chiusa) o con suole rigide (per un uso con
pinne a scarpetta aperta) e con cerniera. Questo agevola la vestizione ma
consente una maggiore penetrazione dell’acqua con una ovvia riduzione
di protezione termica. Sia primi sia i secondi possono essere usati
contemporaneamente per unire i vantaggi di entrambi.
Cappuccio
Durante una immersione il 75% del calore umano viene disperso dalla
testa, la quale è insieme alle mani e ai piedi una delle zone a più alta
dispersione di calore del corpo umano. Per tale motivo una muta subacquea
deve essere sempre abbinata ad un cappuccio, che riveste una funzione
fondamentale come protettore termico.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
27
Modulo 1
Guanti
Modulo 1
Pure Tech Agency
La sua taglia deve essere attentamente provataperché deve adattarsi
perfettamente al viso senza creare strozzature al
collo ed impedire una normale respirazione.
Il cappuccio è necessario laddove l’immersione viene
svolta con temperatura dell’acqua inferiore ai 24°C,
o dove la permanenza in acqua è prolungata.
Il cappuccio viene realizzato in neoprene di vari
spessori e può essere incorporato o separato dalla
muta. Questo ha una cornice di neoprene liscio che
aderisce al viso per minimizzare le infiltrazioni di
acqua.
All'inizio di ogni immersione si deve allargare leggermente i bordi del cappuccio
in maniera tale da allagare il condotto uditivo delle orecchie. Questo favorisce
la compensazione (vedremo in seguito cosa significa) e non solo.
Se vi è presenza di aria nel condotto uditivo questa, in uscita verso l'esterno
in conseguenza di movimenti della testa, potrebbe tendere ad imprimere un
effetto risucchio a danno del timpano con senseguente lesione dello stesso.
Zavorra
Il neoprene utilizzato per confezionare le mute è un materiale che
galleggia; in conseguenza di ciò tende a far rimanere il subacqueo che
lo indossa perfettamente a galla. Per permettere quindi al subacqueo di
scendere in profondità, oppure per rimanere sospesi a mezz'acqua senza
modificare la profondità, è necessario indossare una zavorra. Essa è
formata da una cintura dove vengono posizionati pesi mobili, solitamente
in piombo, in forma di lingotti dotati di fori passanti.
Questi lingotti devono essere fissati in modo tale che non si sfilino
accidentalmente per mezzo di apposite fibbiette in plastica o altro
meccanismo ritentore. La cintura viene fissata al corpo del subacqueo
attorno alla vita per mezzo di una fibbia a sgancio rapido. In commercio
si trovano cinture e giberne (simili a grosse bretelle) dotate di tasche
dove alloggiare le zavorre cosi da rendere meno problematica l'aggiunta o
la rimozione dei pesi per una corretta regolazione del peso complessivo
della zavorra.
Cintura a tasche
28
8
Zavorre a pacchetto
Open
p
Water Diver
Dive
er - CMAS-PTA P1
L'e
L'esatto
peso della zavorra è determinato
da alcuni fattori: tipologia di muta in
uso, comportamento proprio del corpo
us
del subacqueo in acqua (alcune persone
de
tendono a manifestare una maggiore o
te
minore tendenza all'affondamento rispetto
m
ad altre), dall'acqua (dolce o di mare) e
dal tipo di equipaggiamento indossato.
da
1.2 Equipaggiamento A.R.A.
Maschera, pinne, muta e zavorra formano il complesso di equipaggiamenti
definito come "attrezzatura leggera o di base", laddove l'A.R.A. è l'insieme
delle attrezzature che specificatamente ci permettono di respirare sott'acqua.
La complessità e numero di attrezzature che definiscono tale insieme variano
in funzione della tipologia di immersione che si intende affrontare.
L'A.R.A. è la parte di attrezzatura più pesante: il complesso bombola
- GAV - erogatore può arrivare a pesare anche una ventina di chili. Si
comprende benissimo come questo renda i movimenti fuori dall'acqua un
po' impacciati ed insicuri soprattutto le prime volte che lo si indossa, mentre
una volta in acqua tutto il peso sparisce. Nelle immersioni novizie, ovvero
quelle contraddistinte da bassa profondità e basso grado di difficoltà, il
"bagaglio", ovvero la somma degli apparati che dobbiamo portarci appresso
durante un'immersione, si compone delle seguenti attrezzature:
Bombola
La bombola è il serbatoio che permette al subacqueo di portare sott’acqua
una scorta d’aria respirabile. La bombola è formato da una bottiglia in
acciaio oppure alluminio sormontata da una rubinetteria che consente o
non consente il flusso d’aria. Le bombole sono in grado di contenere gas ad
elevatissima pressione fino a 200 atmosfere ed anche oltre (i pneumatici
delle automobili vengono riempiti ad un massimo di 4 atmosfere di
pressione e questo rende l'idea della formidabile pressione che viene
contenuta all'interno delle bombole).
Le bombole si caricano per mezzo di un apparato chiamato compressore ad
alta pressione. Queste macchine sono in grado di pompare l'aria catturata
dall'atmosfera nelle bombole ad elevata pressione: fino a 200 atmosfere di
pressione ed oltre. Questo processo avviene per mezzo di appositi cilindri che
comprimono l'aria per stadi successivi. Per questa ragione è importante che
il compressore sia in buono stato manutentivo e che che la presa d'aria del
compressore sia messa in posizione protetta da fonti di inquinamento quali
strade trafficate, esalazioni di motori termici in genere, polveri e altre fonti di
inquinamento.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
29
Modulo 1
Pure Tech Agency
Modulo 1
Pure Tech Agency
Le dimensioni delle bombole più comuni sono quelle da 10, 12, 15 e 18 litri.
Quando l'esplorazione subacquea richiede tempi di permanenza prolungati,
e di conseguenza la disponibilità di un'elevata scorta d'aria, si usa unire due
bombole in maniera tale da formare un sistema denominato bibombola.
Moltiplicando la capienza della bombola per la pressione di ricarica si ottiene la
capacità complessiva. 200 atm x 15 lt = 3000 lt
Sulla parte alta della bottiglia (denominata ogiva) subito sotto il collo,
vengono stampigliati tutti i dati che servono per il riconoscimento e l’
idoneità della bombola tra i quali: volume, peso della bottiglia vuota,
numero di matricola, pressione massima di esercizio, data di fabbricazione
e ditta costruttrice.
In ragione delle elevate pressioni a cui sono sottoposte le bombole vanno
collaudate presso centri autorizzati con scadenze variabili a seconda
delle regole imposte nella nazione in cui vengono utilizzate. Il collaudo
consiste nel controllo della corrosione interna ed esterna ed in una prova di
resistenza.
In Italia il primo collaudo si fa dopo quattro anni dalla data di costruzione, i
successivi ogni due anni. La data del collaudo viene solitamente stampigliata
sotto quella di costruzione.
Le bottiglie di acciaio sono corredate con un fondello di plastica forato sul
fondo, che le permette di rimanere in piedi. Quelle di alluminio hanno già
il fondo piatto. La tenuta della rubinetteria, che è avvitata al collo della
bottiglia tramite una parte filettata, è assicurata da una guarnizione detta
O-ring. Il complesso rubinetteria può avere 1 o 2 rubinetti con altrettante
uscite di aria.
Per il montaggio dell’erogatore esistono due tipi di attacco:
• l’attacco internazionale (INT), altrimenti detto a staffa, si compone di
una sede circolare in cui alloggia un O-ring
30
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
• l’attacco DIN (Deutsches Industrie fur Normung) si contraddistingue
da una filettatura visibile nella parte interna del breve condotto di
uscita dell'aria
É possibile passare da un tipo di attacco all’altro per mezzo di apposite
riduzioni.
Dopo l’uso in acqua di mare, cosi come per tutta l'attrezzatura, anche la
bombola va sciacquata con acqua dolce e riposta in un luogo asciutto.
Attacco DIN
Biattacco
Attacco INT
Acciaio o Alluminio?
Una bombola da 10 litri in acciaio pesa mediamente poco meno di 11
Kg. mentre una di alluminio, di capacità corrispondente, ne pesa quasi
tredici!. Questa notevole differenza deriva dal fatto che l’alluminio possiede
una minore resistenza meccanica rispetto all’acciaio, è più ‘’tenero’’,
e quindi la bombola deve avere pareti e fondo più spessi (circa 12 e 18
mm. rispettivamente, contro i circa 5 mm. di quelle in acciaio) per poter
sopportare le stesse sollecitazioni di pressione.
Ciò potrebbe indurre a pensare che indossando una bombola in alluminio,
essendo più pesante, sia sufficiente indossare meno zavorra, invece
avviene l’esatto contrario. L’alluminio, infatti, ha un peso specifico di gran
lunga inferiore a quello dell’acciaio ed in acqua, quindi, ha una maggior
galleggiabilità; pertanto a parità di capacità, la bombola d’alluminio
necessita di 1-2 Kg di zavorra in più.
Di contro, però, l’acciaio rispetto all’alluminio va incontro a maggior usura
a causa dei fenomeni di corrosione.
Sembra incredibile per un oggetto destinato all‘uso in acqua, ma il pericolo
numero 1 è proprio l’umidità, in quanto essa agisce come catalizzatore nel
processo di ossidazione ed il sale, in quanto igroscopico (attrae l’umidità),
peggiora la situazione.
Nelle bombole d’acciaio, la ruggine (ossido di ferro) è un vero problema:
quella che si forma all’esterno è facilmente rimovibile anche perché ben
in vista mentre quella al suo interno è particolarmente dannosa, perciò
è bene sempre non scaricare del tutto la pressione nella bombola perché
così aumenterebbe al suo interno l’umidità, il principale responsabile del
fenomeno.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
31
Modulo 1
Pure Tech Agency
Modulo 1
Pure Tech Agency
Anche l’alluminio è soggetto ad ossidazione ma in questo caso, a differenza
della ruggine che scava in profondità, il sottile strato di ossido che si forma
in superficie inibisce l’ulteriore corrosione
Le bombole devono essere manipolate con attenzione e trattate delicatamente.
Durante il trasporto devono essere fissate saldamente al fine di evitare cadute,
rotolamenti e sfregamenti.
Erogatore
L' erogatore è l'apparato che ci permette di respirare sott’acqua l'aria
contenuta nelle bombole
Questo dispositivo riduce la pressione dell’aria contenuta nella bombola, la
quale, come si è visto, essendo elevatissima è irrespirabile, ad un valore
uguale a quello ambiente permettendone l’utilizzo.
Il salto di pressione necessario per ridurre la pressione del gas all'interno
della bombola a dei valori respirabili avviene in due fasi successive.
I moderni erogatori sono composti da 3 parti principali:
• Primo stadio
• Frusta
• Secondo stadio
Descriviamoli nel dettaglio.
Il primo stadio
Il primo stadio è il componente che si fissa al rubinetto della bombola per
mezzo di un attacco INT (formato da staffa munita di brida di fissaggio
entrambi chiaramente visibili) oppure DIN (un innesto filettato fissato ad
una ghiera girevole). La tenuta dell'aria che transita dalla bombola al primo
stadio è garantita, per entrambe le tipologie di attacco, da delle piccole
guarnizioni chiamate O-R (dall'inglese O-Ring). Questa è posizionata sul
terminale della ghiera filettata nell'attacco DIN, mentre l'attacco INT è privo
di O-R trovandosi questo direttamente attorno al foro di uscita dell'aria
sul rubinetto della bombola. Per queste ragioni anche le rubinetterie
DIN e INT delle bombole sono immediatamente riconoscibili: la prima è
contraddistinta da un innesto femmina filettato privo di O-R, la seconda da
una battuta circolare nella quale è collocato in modo visibile l'O-R.
32
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Le rubinetterie moderne, come già accennato nel paragrafo precedente, hanno
il foro di uscita dell'aria già predisposto con attacco DIN e con inserito un
nottolino filettato rimovibile per mezzo di una chiave a brugola. Questo deve
essere munito di O-R su entrambe le estremità ed è gergalmente chiamato
"la caramella". Quando è avvitato nell'alloggiamento di tipo DIN del rubinetto
permette la connessione di primi stadi tipo INT
Il primo stadio svolge la funzione di ridurre la pressione presente all'interno
della bombola (qualunque essa sia) ad una pressione di taratura (costante
e determinata) più la pressione ambiente. Solitamente la pressione di
taratura si aggira attorno alle 8/10 atmosfere.
I primi stadi si dividono in due tipologie: a "pistone" ed a "membrana".
Entrambi hanno un pistoncino al loro interno quale responsabile principale
della riduzione di pressione, soltanto che nel primo tipo il pistoncino si trova
a contatto con l'acqua, mentre nel secondo tipo una membrana lo separa
completamente dall'acqua cosi da mantenerlo asciutto.
Sono le stesse variazioni di pressione dell'acqua ad agire sul sistema di
regolazione della pressione del primo stadio.
Pistone o membrana?
Il dubbio su quale tipo preferire non può essere basato su motivazioni
definitive, in quanto non esiste un sistema migliore in assoluto.
In linea di massima possiamo affermare che un primo stadio a pistone è caratterizzato
da un'architettura più semplice e per certi aspetti più robusta rispetto al membrana.
In ragione di questo le operazioni di manutenzione risultano più semplici.
Di contro i primi stadi a membrana, in virtù della funzione "isolante" della
membrana, garantiscono maggior protezione al pistone da condizioni usuranti
quali la salsedine, la sabbia ed altri agenti dannosi.
I progressi più recenti in campo meccanico tendono comunque sempre più ad
annullare le differenze "comportamentali" tra le due tipologie.
La scelta tra un tipo e l'altro è soprattutto una questione di sintonia personale
verso uno dei due sistemi.
Benché l'attacco INT sia più diffuso nei centri di immersione di tutto il
mondo, l'attacco DIN permette una connessione tra primo stadio e rubinetto
molto più salda e sicura proprio in virtù dell'attacco filettato che oltre a
fissare il primo stadio mantiene l' O-R in posizione più protetta. Inoltre gli
attacchi DIN muniti di filettatura lunga sono in grado di collegarsi a bombole
la cui pressione di esercizio arriva fino a 300 atmosfere (purché la filettatura
sui rubinetti delle bombole sia altrettanto lunga). L'attacco INT invece è in
grado di lavorare con pressioni massime non superiori alle 230 atmosfere ed
è più vulnerabile ai colpi eventualmente ricevuti sulla rubinetteria.
In buona sostanza gli attacchi tra primo stadio e rubinetteria possono
essere sinteticamente descritti nella tabella seguente:
Tipo
INT
DIN 230
DIN 300
Caratteristica
della connessione
Composta da staffa e
brida di fissaggio
Ghiera filettata corta
Ghiera filettata lunga
Collocazione
O-R
Rubinetto
bombola
Primo Stadio
Primo Stadio
Pressione di
esercizio max
Compatibilità con
rubinetto bombola
230 atmosfere
INT
230 atmosfere
300 atmosfere
DIN 230
DIN 230 e DIN 300
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
33
Modulo 1
Pure Tech Agency
Modulo 1
Pure Tech Agency
Ingresso alta pressione (HP)
Filtro
Membrana
Pistone
Uscita bassa pressione (BP)
PRIMO STADIO BILANCIATO
Uscita alta pressione (HP)
PRIMO STADIO NON BILANCIATO
Bisogna sempre prestare attenzione affinché non si ecceda la pressione di
esercizio di una connessione, e comunque i centri di ricarica non caricano
quasi mai le bombole oltre le 220 atmosfere di pressione. Questa regola
vale soprattutto per le connessioni di tipo INT: in esse in fatti l'O-R è fissato
solo a pressione ed è quindi più soggetto a fuoriuscite con conseguente
perdita violenta di aria. Inoltre le bombole munite di attacco DIN a 300
bar, ovvero con filettatura lunga, sono piuttosto rare.
Bilanciato e non bilanciato?
Primi stai bilanciati o non bilanciati.
I primi stadi non bilanciati, diventati una minoranza, sono dei primi stadi
a pistone che hanno a loro favore l'assoluta semplicità e convenienza
economica, di contro offrono prestazioni inferiori rispetti ai bilanciati. Il
meccanismo di regolazione della pressione di erogazione dei primi stadi
non bilanciati è meno sofisticato rispetto agli altri, pertanto in alcune
condizioni offrono un erogazione meno generosa di aria. I più recenti
disponibili sul mercato sono comunque talmente evoluti che, a profondità
poco impegnative, non si discostano quasi per nulla dalle prestazioni dei
bilanciati, sono molto affidabili, facili e veloci nella manutenzione. Molti
centri di immersione offrono ai propri clienti erogatori con primi stadi
non bilanciati perché a basse profondità sono comunque validi e sono più
economici e semplici da gestire nelle operazioni di manutenzione.
La frusta
La frusta è il tubo flessibile che mette in comunicazione il primo stadio con
il secondo stadio consentendo il trasporto dell'aria.
Queste vanno posizionate in modo tale da non creare grovigli, e che in
immersione non sporgano eccessivamente dalla sagoma del subacqueo.
34
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Il secondo stadio è il componente al quale il subacqueo si connette
(addentandolo sul boccaglio) e dal quale si respira. Ha in carico la seconda
e finale fase di riduzione della pressione alla sola pressione ambiente.
É composto dalle seguenti parti principali:
Boccaglio
Tasto Dive - Pre-Dive
Convogliatore di scarico
Pulsante di spurgo
Pomolo regolazione sforzo
inspiratorio
• Una cassa che contiene una membrana che a sua volta, a seconda se
stiamo inspirando o espirando, aziona i leveraggi ed una valvola che
permettono o interrompono l'erogazione
• Un innesto (generalmente filettato) per la frusta
• Vie di fuga per l'aria espirata (queste possono trovarsi nella parte
inferiore o laterale rispetto al boccaglio)
Per poter prendere contatto con un secondo stadio quando si ha già la
testa immersa è necessario, dopo averlo addentato, eseguire prima una
espirazione e solo successivamente l'inspirazione.
Questo per svuotare la cassa dall'acqua ed evitare quindi di ingoiarla.
Il secondo stadio è contraddistinto da una vistoso pulsante, (chiamato
"push" dall'inglese) generalmente posto nella parte frontale della cassa,
con il quale è possibile comandare l'emissione dell'aria da respirare. Il push
viene impiegato soprattutto in due situazioni:
• Durante l'apertura del rubinetto della bombola per evitare che arrivi
al secondo stadio una botta di pressione che potrebbe alla lunga
accelerare l'usura delle sue parti interne;
• In immersione quando si deve prendere contatto con un erogatore e non
si è in grado di eseguire una espirazione prima di incominciare a respirare
normalmente per espellere l'acqua penetrata nella cassa del secondo stadio.
Le regolazioni del secondo stadio
L'estrema sensibilità del push può portare ad uscite d'aria involontarie, ad esempio
quando si nuota in senso contrario alla corrente. Se è presente un regolatore di
sensibilità, si può ridurre quest'ultima con l'apposito comando che agisce sulla molla
di contrasto. Al contrario, in situazioni diffi cili (grande profondità, un momento
di affanno) basta portarlo sulla posizione di massima apertura per facilitare
l'erogazione. A sua volta, il regolatore dell'effetto Venturi, ad azione progressiva o
con le due posizioni estreme max-min (dive/pre-dive), permette di variare lo sforzo
d'inspirazione successivamente al momento d'innesco dell'erogazione (stacco
respiratorio o primo stacco) e si apprezza particolarmente alle profondità maggiori.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
35
Modulo 1
Il secondo stadio
Pure Tech Agency
Modulo 1
L'erogatore completo
Ogni primo stadio è dotato di almeno due uscite di alta pressione (HP =
high pressure) alla quali si connette il manometro (che è l'indicatore
dell'aria disponibile), e di 4 uscite di bassa pressione (LP = low pressure)
alle quali si connettono le fruste con i relativi secondi stadi. Le connessioni
frusta-primo stadio avvengono tramite giunzioni maschio femmina filettate.
La filettatura delle uscite di bassa pressione e alta pressione sono differenti
tra loro per evitare errori nella connessione delle fruste.
É bene sapere che non è sempre possibile connettere primi stadi di una
determinata marca o modello di erogatore, con i secondi stadi di un altro
modello o marca. Le pressioni di taratura dei primi potrebbero essere diverse
dai secondi e questo può determinare incontrollate uscite di aria.
Esistono numerosi modelli di erogatore: alcuni offrono varie forme di regolazione
del flusso e/o della portata dell'aria sul secondo stadio, altri ne sono privi ma
questo non significa che siano meno performanti, tutt'altro.Generalmente sono
quasi tutti affidabili ed ampiamente collaudati, almeno per le immersioni novizie,
quindi decidere quale modello sia migliore di un altro è abbastanza soggettivo.
L'esperienza farà preferire un modello piuttosto che un altro.
L'erogatore è per ovvie ragioni la parte più importante della nostra attrezzatura.
Prima di ogni immersione è opportuno eseguire alcuni atti respiratori, sia in
superficie, sia con il volto immerso nell'acqua, per verificarne la perfetta efficienza.
Al minimo dubbio di malfunzionamento non si prosegue con l'immersione.
PULIZIA: Dopo l’uso asciugare, anche con l’aria rimasta nella bombola, il tappo
di protezione, per evitare infiltrazioni d’acqua nel primo stadio. Proteggere il
filtro sinterizzato coprendolo con il tappo di protezione e sciacquare l’erogatore
con acqua dolce.
AVVERTENZA: durante l’operazione di risciacquo non premere il pulsante di
erogazione manuale del secondo stadio per evitare infiltrazioni d’acqua nella
valvola di richiamo. Lasciare asciugare l’erogatore in un luogo asciutto non
esposto direttamente ai raggi solari. Riporlo in un luogo protetto da temperature
elevate ed assicurarsi che il tubo di bassa pressione, che collega il primo stadio
al secondo stadio, abbia un raggio di curvatura non inferiore ai 150 mm.
36
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Il fenomeno dell'autoerogazione
Per autoerogazione (in inglese free-flow) si intende un uscita incontrollata di aria
dal secondo stadio. Questa può essere determinata da vari fattori quali: scarsa
o incorretta manutenzione dell'erogatore (pressioni di taratura male impostate),
scarsa qualità costruttiva dell'erogatore in relazione alle condizioni d'uso, acqua
molto fredda oppure eccessivo uso del push. Solitamente quando questo avviene
è necessario intervenire per interrompere il flusso di aria chiudendo il rubinetto
al quale l'erogatore è collegato. Si passa quindi alla FAA soprattutto nel caso in
cui l'auoterogazione sia cosi intensa da impedire la normale respirazione. In molti
casi l'erogatore incorso in autoerogazione tornerà a funzionare normalmente
durante l'immersione dopo che si è riaperto il rubinetto. É consigliabile continuare
a respirare con la FAA, rimanere molto vicino al compagno, ridurre la profondità
ed eventualmente decidere di terminare l'immersione soprattutto nel caso in cui
la perdita di aria sia stata importante.
Fonte d'Aria Alternativa (FAA)
Insieme all’erogatore principale è necessario avere una seconda fonte di
aria per avere un margine di sicurezza maggiore durante l’immersione.
Disporre di un fonte d'aria alternativa ci permette sia di sostituire
l'erogatore principale in caso di malfunzionamento, sia "donare" aria al
compagno di immersione nel caso in cui questo si trovi completamente
privo di aria oppure impossibilitato a respirare dalla propria attrrezzatura.
Questo scenario appena descritto ci fa capire una cosa molto importante,
ovvero quali sono le fonti di approvvigionamento dell'aria in immersione in
ordine di accessibilità:
1. L'erogatore principale
2. L'erogatore secondario o di emergenza
3. Il compagno di immersione
Le fonti di aria alternative per essere tali devono essere costituite da:
• Un secondo stadio addizionale: questo viene montato su una delle
uscite di bassa pressione (LP) del primo stadio tramite una frusta
solitamente più lunga del normale. L'utilizzo del colore giallo per frusta
e secondo stadio oltre a renderli maggiormente visibili li qualifica quale
fonte d'aria alternativa
• Secondo erogatore completo: ogni qual volta le bombole sono munite
di doppia rubinetteria è possibile e opportuno montare un secondo
erogatore completo (primo e secondo stadio)
• Essere ed avere un compagno di immersione attento alle proprie ed
altrui necessità.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
37
Modulo 1
Pure Tech Agency
Modulo 1
Pure Tech Agency
Collarino ritentore
per secondi stadi
Non date retta a chi vi consiglia di acquistare un secondo erogatore di
basse prestazioni perché tanto lo si usa solo in emergenza, oppure di
acquistare un secondo erogatore di prestazioni ancora migliori del primo.
Entrambe le affermazioni sono errate. Vediamo perché:
• Un secondo erogatore, essendo impiegato in un ipotetico caso di
emergenza, deve essere adeguato proprio alle situazioni più gravose
tipiche di un emergenza e quindi deve essere di qualità
• Un secondo erogatore migliore del primo finirebbe per essere utilizzato
come erogatore primario, perché non avrebbe senso alcuno respirare
sempre da un erogatore di basse prestazioni
La soluzione corretta è adottare, da subito, due erogatori separati di ottimo
livello in modo da alternarne l’uso in immersione (cosi si è sempre sicuri
del corretto funzionamento di entrambi), inoltre, sfruttandoli appieno
entrambi in modo sincronico, coincideranno i periodi di manutenzione.
Consigli per l'acquisto
Quando si acquista un erogatore non si devo soltanto guardare la sua
portata di aria (spesso sono talmente elevate da soddisfare le esigenze
respiratorie di un paio di elefanti in corsa), piuttosto sono da verificare
le modalità con cui l’erogatore fornisce aria respirabile, ovvero la qualità
dell’erogazione.
Se possibile chiedete al negoziante di farvi provare l'unità prima
dell'acquisto infatti è importante controllare quanto l’erogatore ci consente
di respirare in immersione in maniera naturale. Sia lo sforzo inspiratorio
sia lo sforzo espiratorio devono essere molto bassi, l’erogazione deve
essere lineare, "nutritiva", senza inutili quanto fastidiose "sparate" d’aria.
Se consideriamo quindi l’erogatore sotto questi molteplici aspetti, l’offerta
del mercato diventa decisamente più ristretta anche in ragione del fatto
che a fronte di un’offerta apparentemente molto diversificata, poche sono
le novità di rilievo nella produzione. Molte aziende offrono, nei propri
cataloghi, numerosi modelli di erogatore che si distinguono dai modelli
vecchi soltanto nella forma esteriore, restando spesso nella sostanza le
medesime macchine. Alcuni modelli rimangono nei cataloghi delle aziende
per diversi anni segno che sono modelli ben collaudati e affidabili a riprova
della validità dei progetti iniziali.
38
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Sul versante dei materiali è difficile valutare le loro qualità specifiche per un
non addetto al settore. Alcuni materiali, come ad esempio le leghe leggere
o il titanio, non aggiungono nulla in termini di prestazioni ma offrono
delle differenze dai materiali tradizionali (generalmente ottone satinato o
cromato) soprattutto in termini di peso e di durata.
Nella scelta dell’erogatore va tralasciato il più possibile il discorso estetico.
La scelta cadrà sulla robustezza, l’affidabilità e la qualità. Verifichiamo l’ergonomia
dello strumento. Il numero di attacchi di alta e bassa pressione devono essere
sufficienti e ben distribuiti sul corpo del I° stadio per tutte le necessità.
Le torrette girevoli di molti primi stadi sono inutili se le prese LP e HP sono
ben orientate.
Sul secondo stadio verifichiamo invece la presenza o meno di pomelli vari di
regolazione e poi chiediamoci se effettivamente ci servono o costituirebbero
solo un’ulteriore complicazione in fase di manutenzione. La presenza di un
boccaglio (morso) anatomico e ben conformato aggiunge parecchio comfort
all’erogatore nell’uso prolungato.
Da considerare anche con attenzione l’uso che faremo del nostro erogatore:
se prevediamo di immergerci in acque fredde, talvolta torbide, o comunque
aventi temperature inferiori ai 12 gradi (come al lago o al mare d'inverno)
è bene orientarsi verso erogatori le cui doti in acque fredde sono provate.
Non ultimo dovrebbe essere considerata la facilità di reperimento dei pezzi
di ricambio e la relativa assistenza: alcuni erogatori, pur essendo molto
validi, sono poco serviti dalle reti commerciali italiane.
La marina militare americana, la US NAVY, sottopone a dei test abbastanza
rigorosi alcuni erogatori presenti sul mercato. Le valutazioni che emergono
da questi test forniscono delle indicazioni molto valide anche per i subacquei
sportivi.
Sintesi delle raccomandazioni
Primo Stadio
• Meglio se con attacco DIN.
• Torretta girevole: spesso, se le uscite di alta e bassa pressione sono
ben disposte (e vi consentono di assemblare tutte le fruste di servizio
senza creare un groviglio), la torretta girevole è inutile. Inoltre alcuni
costruttori hanno accertato che l’uscita fissa garantisce un 10% di
portata d’aria supplementare.
• Il Filtro sinterizzato che si trova all'ingresso del condotto dell'aria può
essere conico o piatto: in teoria è meglio quello che garantisce la
maggior superficie filtrante.
• I materiali: il titanio non aggiunge nulla alle prestazioni dell’erogatore
(eccetto longevità e peso) ma influisce sul costo in modo sensibile.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
39
Modulo 1
Pure Tech Agency
Pure Tech Agency
Modulo 1
Secondo Stadio
• Con scarico aria espirata frontale o laterale? Valutare con il proprio
Istruttore a cosa serve la possibilità di rendere destro o sinistro
l’erogatore. Gli erogatori con scarico laterale per essere svuotati
in immersione dall'acqua obbligano il subacqueo ad assumere una
posizione inclinata della testa durante la prima espirazione.
• Valvola di scarico: maggiore la luce di scarico, minore lo sforzo
espiratorio. Ottimi gli erogatori con doppia membrana di scarico o con
valvola di scarico integrata in quella di carico.
• Metallo o tecnopolimero? Il metallo è più adatto all'impiego in
acque fredde è nell’uso normale conferisce un migliore comfort alla
respirazione in quanto l’effetto radiatore della cassa metallica crea
una piccola condensa in grado di umidificare l’aria. L'aria caricata dai
compressori nelle bombole è piuttosto secca in ragione della presenza
di filtri lungo il percorso di carica. L’erogatore con cassa in metallo
tende a renderla nuovamente umida.
Il tecnopolimero garantisce leggerezza e inossidabilità. Alcuni
produttori più attenti hanno realizzato le casse degli erogatori in
carbonio: leggerezza, robustezza e stesso comportamento del metallo.
Rivolgiti al tuo Istruttore o Training Facility CMAS-PTA per avere consigli e
orientarti nel panorama delle attrezzature subacquee disponibili sul mercato
Manometro
Il manometro è l'indicatore del livello di
pressione all'interno della bombola, ovvero
della quantità d'aria disponibile. Grazie al
manometro è possibile monitorare i
consumi di aria durante tutta l'immersione
al fine di prevenire il rischio di rimanere
senz'aria. Esso si collega tramite una frusta
ad una delle uscite di alta pressione (HP) del
primo stadio.
Il manometro, per quanto da molti
sia considerato un accessorio e parte
integrante dell’erogatore, fa parte della
strumentazione.
É uno strumento la cui lettura deve essere precisa, veloce e comoda. Nella
scelta si consiglia un modello poco ingombrante e che abbia un quadrante
con una impostazione grafica semplice per avere una lettura immediata. Il
manometro deve essere posizionato in modo tale da permettere una rapida
presa e la massima comodità di lettura. Chiedi consiglio al tuo Istruttore
quali possono essere le soluzioni migliori.
40
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Il G.A.V. è un apparato che si comporta proprio come la vescica
natatoria dei pesci. Esso migliora il galleggiamento del subacqueo, sia in
immersione sia in superficie, riducendo gli sforzi necessari per mantenersi
ad una determinata profondità oppure in superficie. In buona sostanza
ci permette di mantenere una posizione corretta e rilassata a qualunque
profondità.
I GAV moderni hanno una forma simile ad un giubbotto di salvataggio
(jacket) e si compongo di:
• Un "sacco", ovvero la vescica, che avvolge la schiena ed i reni del
subacqueo (oppure solamente la schiena) e che si presta per essere
riempito o svuotato di aria
• Pulsantiera di comando per il riempimento e svuotamento del sacco
(V.I.S. Valvola Immissione Scarico)
• Spallacci sulla parte anteriore per essere indossati dal subacqueo
• Fasce sul lato posteriore per essere fissate alla bombola
Per adempiere alla sua funzione si devono introdurre o evacuare opportune
quantità d’aria al fine di compensare le variazioni di volume provocate
dall’aumento o dalla diminuzione della pressione ambiente.
Scendendo in profondità infatti la muta si schiaccia per l'aumento
di pressione, e diminuendo di volume tende a perdere la propria
galleggiabilità, mentre la zavorra continuerà a trascinarci verso il basso. Per
fermare la discesa si deve immettere nel GAV un quantitativo d'aria tale da
farci rimanere immobili a mezz'acqua (le pinne servono principalmente per
spostamenti orizzontali).
Comando scarico rapido
Valvola scarico rapido
Corrugato
Regola cinghie
Fasce di chiusura
Sacca
Fascia ventrale
Fissaggio bombola
Tasca
Valvola Immissione Scarico
Anello fissaggio accessori
Per comandare l'immissione o evacuazione dell'aria il GAV è munito di
una pulsantiera posizionata sulla parte terminale di un tubo corrugato. Il
corrugato è il passaggio principale di entrata ed uscita dell'aria dal sacco,
mentre la pulsantiera è collegata per mezzo di una frusta ad una delle
uscite di bassa pressione del primo stadio.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
41
Modulo 1
GAV - Giubbetto ad Assetto Variabile
Modulo 1
Pure Tech Agency
Una valvola di sicurezza di svuotamento, in grado di azionarsi anche
autonomamente, evacua l'aria in caso di eccessivo riempimento.
Detto ciò il tutto può sembrare un poco complicato, in realtà appena si avrà
acquisito familiarità con questo strumento il suo utilizzo sarà molto spontaneo
e naturale, proprio come i pesci fanno con la propria vescica natatoria.
Scarico rapido
Frusta bassa pressione
Attacco BP
Corrugato
Innesto
Pulsante di carico
Apertura gonfiaggio bocca
Pulsante di scarico
IL CORRUGATO
Sacco a volume posteriore
La conformazione del sacco influenza la postura
del subacqueo in immersione. I GAV dotati di
sacchi che avvolgono anche i reni del subacqueo
facilitano il mantenimento della posizione verticale
del subacqueo soprattutto in superficie.
Esistono dei GAV che hanno il sacco posizionato
solamente sulla schiena del subacqueo; questi
GAV soo detti a volume posteriore.
Questa tipologia di GAV favorisce la posizione
orizzontale del subacqueo che li indossa, inoltre in
condizioni di massimo gonfiaggio non opprimono i
fianche del subacqueo.
La scelta di un modello piuttosto che un'altro è soggettiva. Ill tuo Istruttore
potrà guidarti tra i pregi e le caratteristiche dei vari modelli.
42
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
1
Esamina la condizione globale della bombola e della rubinetteria. Controlla
le marcature della bombola (data collaudo). Apri la rubinetteria per pulire
l’orifizio e annusa l’aria: deve essere pulita, secca e inodore. Controlla
l’O-ring.
2
Monta il GAV sulla bombola in modo che il meccanismo di bloccaggio della
bombola sia rivolto verso di te. Sollevando il gruppo ARA tenendo il GAV,
la bombola non deve scivolare. Possibilmente bagna le cinghie di nylon
prima di stringerle perché il nylon si allunga quando è bagnato.
3
Togli dall’erogatore il tappo di protezione contro la polvere, controlla il
filtro del primo stadio e connetti il primo stadio al rubinetto della bombola.
La maggior parte degli erogatori devono essere montati in modo tale
che le fruste ed i relativi secondi stadi passino sopra la spalla destra del
subacqueo e comunque dal lato destro del GAV.
4
Prima di aprire il rubinetto dell’aria tenta di espirare attraverso il secondo
stadio. A differenza dell’inspirazione, dovresti essere in grado di espirare
facilmente. Se non si riuscisse, sciacqua l’erogatore in acqua e poi
riprova.
5
Prima dell'apertura del rubinetto tenta di inspirare da ogni secondo stadio.
Se avverti un qualche passaggio di aria potrebbe significare che c'è una
perdita di qualche genere nella membrana del secondo stadio.
6
Controlla il manometro che deve indicare zero.
7
Soltanto a questo punto si procede con l'apertura dei rubinetti della
bombola. Ruota il manometro verso il basso, allontanandolo da te e dagli
altri e lentamente apri il rubinetto della bombola tenendo schiacciato il
push. Se non ci sono perdite rilascia il push e apri completamente il
rubinetto. Prova a inspirare e espirare controllando il manometro: se l’ago
indicatore oscilla, significa che c’è un ostruzione o che il rubinetto non è
ben aperto.
8
Una volta che il gruppo ARA è assemblato, se non lo indossi subito
sdraialo a terra e raccogli le parti penzolanti in modo ordinato.
Open Water Diver
Dive
er - CMAS-PTA P1
43
Modulo 1
Come assemblare un gruppo A.R.A.
Pure Tech Agency
Modulo 1
1.3 Strumentazione ed accessori
Oltre all'ARA è necessario indossare un ulteriore bagaglio di strumenti
grazie al quale è possibile monitorare i parametri di un'immersione
(profondità e tempo) e non solo.
Vediamo nel dettaglio gli strumenti più importanti:
• Orologio subacqueo:
Serve per monitorare i minuti di immersione,
ovvero il tempo di immersione. Quelli a lancette
sono muniti di ghiera girevole unidirezionale grazie
alla quale si "azzera" la lancetta dei minuti.
• Profondimetro:
Il profondimetro è lo strumento con il quale si
misura la profondità. Più precisamente è un manometro che converte
la pressione ambiente in profondità equivalente della
colonna
co
d'acqua.
I profondimetri moderni sono di tipo elettronico
(digitale)
(d
e sono muniti di display a cristalli liquidi
sui
su quali vengono visualizzate sia la profondità sia il
tempo
di immersione in minuti. Tutti i profondimetri
te
indicano
sia la profondità attuale sia la profondità
in
raggiunta
durante il corso dell'immersione.
ra
• Boa segna-sub
L'utilizzo della boa segna-sub, è indispensabile ed obbligatorio per
legge in quanto avverte i natanti della presenza di subacquei sia in
immersione sia in superficie.
Questa funzione la rende un componente essenziale dell’equipaggiamento,
espressamente dedicato alla sicurezza personale in acqua.
La presenza della boa con la bandiera segna-sub può evitare pericolose
collisioni tra imbarcazioni in transito e subacquei in superficie, oltre a
fornire l' individuazione del luogo in cui i subacquei sono immersi.
44
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Modulo 1
L'obbligo di segnalare la propria presenza sotto
la superficie dell'acqua non è dettato solo dal
buonsenso, ma in Italia, ed in molti altri stati, è
anche prescritto dalla legge. Il DPR n° 1639 del
2 ottobre 1968 "Regolamento per l'esecuzione
della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente
la disciplina della pesca marittima", all'articolo
130 prevede che "Il subacqueo in immersione ha
l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante
una bandiera rossa con striscia diagonale bianca,
visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico
di appoggio, la bandiera deve essere messa issata
sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare
entro un raggio di 50 metri dalla verticale del
mezzo nautico di appoggio o del galleggiante
portante la bandiera di segnalazione". Va aggiunto
che solo dal 2003, con la circolare 82/033465 del
26 maggio 2003 emessa dal Comando Generale
delle Capitanerie di Porto, all'imposizione fatta
ai subacquei si contrappone l'imposizione ai
natanti di mantenere una distanza di sicurezza
dal galleggiante, è infatti solo da quell'anno che
il transito di una imbarcazione, ad una distanza
inferiore a 100 metri da una boa segna-sub,
costituisce un illecito penale.
Legislazione all'estero
Anche in altri paesi, come ad esempio Stati Uniti e Canada, la bandiera
bianca e rossa è obbligatoria per legge. Vi sono però molti altri paesi che
invece riconoscono unicamente la Bandiera di segnalazione ALFA. Per
questo motivo quando ci si trova all'estero, per evitare possibili sanzioni, è
sempre meglio utilizzare entrambe le bandiere di segnalazione.
Bandiera di segnalazione ALFA
Anche se in alcuni paesi, come ad esempio l'Italia, la sola bandiera di
segnalazione internazionale ALFA non è sufficiente,,
a
anch'essa può essere utilizza per segnalare la
o
presenza di un sub in immersione, tuttavia il suo uso
o
e il suo significato sono leggermente diversi. Secondo
n
la normativa internazionale essa indica infatti un
vascello impegnato in operazioni sottomarine e quindii
con ristretta capacità di manovra.
Di conseguenza, mentre la bandiera di segnalazione
ne rossa e bianca ha lo
scopo di aumentare la sicurezza del subacqueo, la bandiera di segnalazione
ALFA ha lo scopo di prevenire collisioni tra navi.
• Boa gonfiabile/Pedagno
Il pedagno è un pallone, generalmente di forma
allungata, che può essere riempito di aria in
immersione in modo tale da poterlo "lanciare"
da sott’acqua verso la superficie. In questo
modo un subacqueo può segnalare la propria
posizione in modo preciso.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
45
Pure Tech Agency
Modulo 1
Il pedagno non sostituisce la bandiera segna-sub, tuttavia è uno
strumento addirittura obbligatorio in alcune località.
Ha dimensione piuttosto contenute e può trovare posto in una tasca
del GAV o in una eventuale tasca presente sulla muta.
Può essere usato agganciato alla cima che ha in dotazione o meglio
ancora se viene utilizzato in abbinamento con un mulinello. Il suo uso
diventa necessario nel caso in cui si è costretti a riemergere distanti
dalla bandiera segna-sub.
• Mulinello
Il mulinello, chiamato anche reel, trova varie
applicazioni alcune importanti.
É fatto generalmente in alluminio oppure in
acciaio inox, dotato di un rocchetto attorno al
quale può essere avvolta una sagola più o meno
lunga in considerazione delle sue dimensioni e
dello spessore della cima utilizzata.
In ambito ricreativo trova il suo naturale uso in
abbinamento alla boa segna-sub o con il pallone
sparabile (pedagno). Può essere usato anche
come filo di arianna purchè ci si addestri in modo
adeguato per questo utilizzo.
• Torcia subacquea
La torcia è uno strumento indispensabile non solo per illuminare gli
ambienti scarsamente illuminati o bui, ma anche per comunicare tra
subacquei. Con essa è infatti possibile scambiarsi numerosi segnali
luminosi percepibili anche da grande distanza.
46
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Le tipologie di torce disponibili sul mercato sono sintetizzate nella tabella
seguente:
Tipologia
Alogena
Sorgente luminosa
Tonalità della luce
Efficienza
emessa
Lampada
dotata
di Luce dal colore caldo 25 Lumen/W
filamento al tungsteno
tendente al giallo
Lampada priva di filamento Luce dal colore freddo 70-80 Lumen/W
HID o
scarica di gas costituita da una ampollina tendente all'azzurro
di quarzo riempita, a bassa intenso
pressione, di gas xeno
o miscele di gas affini,
all’interno della quale si
causa una scarica elettrica
allo scopo di creare un
plasma di gas che emette
luce
Led
Diodo
ad
luminosa
emissione Luce tendente
bianco e azzurro
al 40-60 Lumen/W
Dalla tabela si evince che i sistemi di illuminazione che utilizzano lampade
alogene sono i più energivori, pertanto, a parità di efficienza luminosa,
richiedono batterie molto più performanti e quindi voluminose.
Lampada alogena
Efficienza luminosa
= 25 Lumen/W
Lampada HID
Efficienza luminosa
= 70-80 Lumen/W
Led
Efficienza luminosa
= 40-60 Lumen/W
TIPI DI SORGENTI LUMINOSE
Il lumen (simbolo: lm) è l’unità di misura del flusso luminoso.
Detto ciò quanto più un fascio di luce è concentrato maggiore sarà sia la
sensazione di potenza percepita dal subacqueo, sia la capacità oggettiva di
penetrazione nel buio della luce stessa.
Le torce a lampada alogena hanno potenze che variano generalmente tra i
10 ed i 100 watt; anche per le HID la potenza è espressa in Watt, mentre
per quelle a LED è più corretto esprimere l'intensità luminosa in lumen.
Facciamo alcune considerazioni:
Una alogena di 50 watt emette 25 x 50 = 1250 Lumen. Una HID puo’
arrivare anche a 70-80 lumen per ogni watt, quindi una 15w emette
all’incirca 80 x 15 = 1200lm. Se ne deduce che con soli 15w ho la
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
47
Modulo 1
Pure Tech Agency
Modulo 1
Pure Tech Agency
stessa luminosità di una 50w alogena, oppure con un 50w HID avrei ben
4000lumen, l’equivalente di una alogena da ben 160w.
Questi numeri esprimono un rapporto, tra torce alogene e HID, di circa 1
a 3. Questo puo’ essere usato a tutto vantaggio dell’autonomia, a parità
di pacco batteria, oppure a vantaggio della luminosità con pari durata del
caso alogeno.
Altrimenti si privilegiano dimensioni e pesi ridotti del pacco batterie
mantenendo resa luminosa e autonomia di una alogena 50 watt.
Il maggior difetto delle lampade HID è, oltre al costo, la loro relativa
fragilità: un colpo ricevuto anche non troppo forte è in grado di danneggiare
l’ampolla tale da rendere necessaria la sostituzione.
Tutto ciò detto vale anche per i led, i quali però si differenziano dalle
lampade HID in quanto hanno a loro vantaggio il basso costo, la
lunghissima durata (intesa come vita operativa dei led, misurabile in
migliaia di ore) e la robustezza. Inoltre i led sono da un punto di vista
tecnologico in continua evoluzione: tra non molto saranno disponibili led
con efficienze paragonabili alle lampade HID o addirittura superiori.
Le lampade alogene, per quanto siano le più energivore, sono ancora
richieste in virtù della tonalità “calda” della propria luce in grado di far
risaltare i colori in modo molto naturale.
Per quanto riguarda le batterie ci sono attualmente in commercio svariate
tipologie di batterie: nichel-cadmio, nichel–idrati metallici, al piombo,
alcaline.
I primi due tipi hanno maggiore potenza in proporzione al peso e alle
dimensioni, per contro hanno lo svantaggio di una rapida caduta di potenza
quando giungono alla fine della loro durata. Le batterie al piombo ed
alcaline perdono meno rapidamente la loro potenza.
Volt e Ampere.
Le batterie si distinguono in base a queste due unità di misura: la prima
esprime la tensione, ovvero la forza che spinge la corrente nel circuito, la
seconda l’intensità. E’ un po’ come dire “ho un bacino di acqua ad una certa
altezza collegato con un tubo di scarico”: la grandezza del dislivello sono i volt
mentre l’ampiezza o portata del tubo di scarico sono gli ampere.
Oltre alle considerazioni espresse precedentemente, una buona torcia
subacquea deve ovviamente essere robusta ed impermeabile. In
commercio si trovano numerose torce differenti tra loro per dimensione,
efficienza e ovviamente autonomia. E’ meglio preferire le torce con almeno
50 minuti reali o più di autonomia.
Vi sono altri due elementi distintivi principali delle torce:
• Torce definite a blocco unico: sono formate in un unico pezzo che
contiene sia la sorgente luminosa sia le batterie;
48
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
• Torce con batterie separate: si contraddistinguono dal fatto che la
parte contenente la sorgente luminosa è collegata alla parte contenente
la batteria per mezzo di un cavo stagno.
Il primo tipo ha il vantaggio di non avere cavi che potrebbero impigliarsi, di
contro ha lo svantaggio di pesare sul brandeggio.
Il secondo tipo permette invece di distribuire meglio il peso della torcia
sull’attrezzatura così da avere in mano solo la “testa” più leggera e comoda
da brandeggiare.
Come utilizzare correttamente le lampade subacquee:
• non dirigere la lampada negli occhi di altri subacquei
• muovi lentamente la lampada per non creare confusione
• non dirigere la lampada direttamente sugli strumenti, sfruttando
la fosforescenza dei quadranti per non restare abbagliati dalla luce riflessa
• sfrutta la luce riflessa della lampada per indicare i segnali
• codificare l’uso della lampada per segnali particolari
• movimenti circolari equivalgono ad un OK
• movimenti orizzontali servono per richiamare l’attenzione
• indirizza la luce della lampada davanti al subacqueo se vuoi attirare la
sua attenzione
• Coltello subacqueo
Il coltello subacqueo è necessario al fine della propria sicurezza. Il suo
scopo primario è quello di tagliare eventuali reti, lenze da pesca
o cime con le quali un sub, inavvertitamente, può essere entrato in
contatto e aggrovigliatosi.
Il coltello deve avere una lama affilata, a doppio filo (liscio da una
parte, seghettato dall’altra), non
deve essere usato impropriamente
ad esempio come attrezzo da leva, in
quanto ne causerebbe un suo
deterioramento e perdita della
capacità di taglio.
Il coltello deve essere in acciaio
inox, con lama passante nel manico;
trova la sua migliore collocazione
posizionato all'altezza del tronco del subacqueo
bacqueo generalmente sul GAV,
e in ragione del fatto che deve essere garantita la facilità di estrazione
e brandeggio così come un sistema di ritenzione antismarrimento.
• Bussola
La bussola è uno strumento molto semplice che
permette di individuare il nord magnetico.
La bussola è costituita da un ago magnetico,
libero di ruotare su un piano orizzontale,
montato su un perno posto al centro di un
quadrante circolare chiamato rosa (nome
derivato dalla rosa dei venti), suddiviso in 360
gradi.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
49
Modulo 1
Pure Tech Agency
Pure Tech Agency
Modulo 1
La terra è attraversata da un
potente campo magnetico che ha
il suo polo "positivo" leggermente
spostato dal Nord geografico
(quello della terra) ed è chiamato
appunto nord magnetico. Su
ogni carta nautica, ad uso locale,
viene riportato un angolo (detto
di deviazione o declinazione
magnetica) che esprime la
differenza tra nord magnetico
e geografico. É grazie a questa
declinazione che i naviganti sono
in grado di calcolare la giusta
direzione.
Nell'uso subacqueo la declinazione
magnetica non impone nessuna
correzione.
L'ago della bussola si orienta esattamente verso il nord magnetico
soltanto se nelle vicinanze dello strumento non vi sono masse di
acciaio che interferisconoo con l'ago magnetico.
La bussola ci permette di seguire una determinata direzione
anche in assenza di riferimenti.
Annotando la lettura direzionale indicata dalla bussola, si è in grado
di ripercorrere un percorso reciproco o di effettuare cambi di direzione
programmati. Per far si che la bussola dia informazioni corrette si deve:
• tenere lo strumento non vicino a masse metalliche o a campi magnetici
che influenzerebbero il posizionamento dell'ago magnetico verso il
Nord
• tenere la bussola in piano, parallela alla superficie dell'acqua, per
dare modo all'ago di ruotare liberamente e di non bloccarsi toccando
l'interno della cassa
• allineare la linea di fede e l'asse del proprio corpo con la direzione da
seguire, spostando tutto l’insieme qualora si dovessero effettuare delle
correzioni ed evitare di correggere la rotta con spostamenti della sola
bussola o di una parte del nostro corpo
• effettuare la lettura guardando la bussola al di sopra del quadrante
o sulla finestrella laterale della cassa utilizzando sempre i riferimenti
dell'ambiente.
L'uso di questo strumento richiede una preparazione ed un addestramento
specifici.
50
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
• Fischietto
É un accessorio importante perché in caso di bisogno permette di
segnalare la posizione ad una notevole distanza
• Lavagnetta
La lavagnetta subacquea permette di comunicare direttamente con il
compagno d’immersione qualora si vogliano trasmettere informazioni
precise e dettagliate. É composta da una tavoletta in materiale
plastico sulla quale si scrive con un normalissimo lapis e si una una
normalissima gomma per cancellare.
I compagni devono essere molto vicini in modo da riuscire a leggere
anche in condizioni di visibilità limitata.
• Borsa o contenitore rigido
Per il trasporto dell'attrezzatura ed altro. Inoltre è bene premunirsi
di scorta di ricambi minimi contenente: guarnizioni (o-ring), cinghioli
per la maschera e le pinne, chiavi inglesi e brugole per il serraggio e
la rimozione delle fruste sul primo stadio, sagola e/o cima, colla per
mute.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
51
Modulo 1
Pure Tech Agency
Pure Tech Agency
Modulo 1
1.4 Preparazione e vestizione dell'attrezzatura
La preparazione ed il riordino dell'attrezzatura non sono momenti
separati dall'immersione, tutt'altro. Dalla preparazione dipende
buona parte del buon esito dell'immersione, e durante il riordino, oltre a
predisporre l'attrezzatura per l'immersione successiva, si metabolizza e si
fa tesoro della gioia e dell'esperienza appena provata. Tutto questo, per
quanto possa sembrare banale, di fatto allunga di molto il piacere connesso
all'attività subacquea soprattutto in considerazione del fatto che il lasso di
tempo in cui siamo effettivamente sott'acqua di rado supera l'ora.
La vestizione
Muta, calzari e guanti si indossano come qualsiasi altro indumento.
Ovviamente le caratteristiche proprie del neoprene, per quanto morbido
e foderato, rendono la vestizione talvolta un poco faticosa. Può risultare
utile cospargere di talco i punti più difficili quali polsi, caviglie, piedi e collo.
Oggi le mute sono abbastanza comode da indossare, ma un tempo taluni
usavano eseguire la "saponata" che consisteva in immergere i capi da
indossare in un catino di acqua dolce con abbondante sapone.
Con l'esperienza si impara ad indossare le mute umide direttamente in
acqua persino in galleggiamento. Nelle calde giornate estive è una pratica
utile e divertente.
La cintura di zavorra è' per ovvie ragioni abbastanza pesante. Nell'indossarla
bisogna fare attenzione soprattutto a non farla cadere sui propri piedi.
É molto importante controllare che la fibbia sia ben chiusa e propriamente
posizionata in modo tale da evitare sganci accidentali: si partirebbe verso la
superficie come palloni!
Le pinne vanno sempre indossate prima di entrare in acqua e bisogna
assicurarsi che questo sia fatto in modo da non perdere l'equilibrio e cadere.
52
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Il cinghiolo della maschera non deve essere troppo stretto ed in caso si
indossi anche un cappuccio bisogna fare in modo che il bordo in gomma
aderisca sul viso e non sul neoprene.
L'aeratore viene fissato alla maschera semplicemente facendolo passare
sotto il cinghiolo oppure tramite appositi anelli di ritenzione. Senza questi
anelli il rischio di perderlo in immersione è elevato di contro è possibile
sfilarlo velocemente e lanciarlo con tanti saluti sulla barca d'appoggio
oppure infilarlo in una delle tasche del GAV.
Per indossare l’ARA da in piedi è meglio poter contare sul compagno il quale
solleverà la bombola abbastanza in alto in modo tale da permetterci di
infilare le braccia negli spallacci del G.A.V.. Solamente quando gli spallacci
saranno indossati e gli agganci rapidi serrati il compagno potrà lasciare la
presa. Naturalmente si dovrà rendere il favore!
Se il compagno non c'è meglio indossarla da seduti, che è la condizione più
comoda ma purtroppo non sempre attuabile sia a terra sia in barca.
Un altro sistema abbastanza comodo è quello di indossare l’attrezzatura
in acqua, purché non vi sia un eccessivo moto ondoso oppure correnti.
Richiede una certa agilità e rapidità altrimenti meglio vestirsi all'asciutto.
Configurazione dell’attrezzatura
Per Configurazione si intende il modo di disporre l’equipaggiamento che
userai per una determinata immersione.
In particolare Configurare significa applicare determinate regole, finalizzate a
disporre e a gestire al meglio la tua attrezzatura dal punto di vista della:
• sicurezza (mezzi per gestire un’emergenza)
• operatività (facilità nei movimenti - buona idrodinamicità - possibilità
di compiere un lavoro)
• comfort (facile accesso ai singoli elementi che compongono il nostro
equipaggiamento - corretta distribuzione delle masse)
Sarà cura del tuo Istruttore CMAS-PTA verificare la tua configurazione e fornirti
indicazioni e consigli per eventuali modifiche o correzioni
Le regole che determinano una configurazione, pur dovendo rispondere
tutte a requisiti di Sicurezza, Operativita’ e Comfort, si diversificano tra loro
nella fase applicativa dando origine a configurazioni differenti.
A ciò, si aggiunge il fatto che le aree occupate rispettivamente da
Sicurezza, Operativita’ e Comfort, spesso si sovrappongono generando così
la necessità di dover avvantaggiare l’una rispetto all’altra.
Riferendoci all’elenco di tutta l’attrezzatura utilizzabile, dovrai attuare un
processo logico che porterà a definire una configurazione personale (tagliata
su misura per te e le tue esigenze) ricordandoti che essa dovrà sempre
rispondere a requisiti di Sicurezza, Operativita’, Comfort (Obiettivi Primari)
e alle generali esigenze logistiche, personali e/o di team (Obiettivi Logistici).
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
53
Modulo 1
Pure Tech Agency
Pure Tech Agency
Modulo 1
1.5 Conclusioni
Come si è visto l'attrezzatura è composta da numerose parti. Questo
non deve indurre a pensare che il loro uso finirà per limitare il piacere
dell'immersione, tutt'altro. Abbiamo detto all'inizio di questo modulo che
l'attrezzatura è un po' come una protesi grazie alle quale ci vengono
date delle abilità senza le quali sarebbe impossibile esplorare il mondo
sommerso. L'attrezzatura quindi diverrà parte di noi stessi, impareremo
non soltanto ad utilizzarla in modo adeguato, bensì a sentirla proprio come
un estensione di noi stessi.
A questo punto dell'apprendimento è necessario soffermarsi sull'attrezzatura
più importante di tutte: il nostro corpo.
54
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
inserisci le parole mancanti
Le pinne ci restituiscono parte della ............................ consentendoci di
spostarci con una certa rapidità senza l’ausilio delle braccia e mani
La muta ci permette di limitare la ............................ del corpo umano
immerso in acqua in ragione dell’elevata conducibilità termica di
quest’ultima (circa .......... volte maggiore rispetto all’aria).
L’esatto peso della zavorra è determinato da alcuni fattori: .....................
............ in uso, comportamento proprio del corpo del subacqueo in acqua
Maschera, pinne, muta e zavorra formano il complesso di equipaggiamenti
definito come “............................ o di base”, laddove l’................. è
l’insieme delle attrezzature che specificatamente ci permettono di respirare
sott’acqua
Nella parte alta della bottiglia, subito sotto il ....................., vengono
stampigliati tutti i dati che servono per il riconoscimento e l’ idoneità
della bombola trai quali: ...................., .................... della bottiglia
vuota, .................... di matricola, .................... massima di esercizio,
.................... di fabbricazione e .................... costruttrice
I moderni erogatori sono composti da 3 parti principali:
Il primo stadio svolge la funzione di .................... la ....................
presente all’interno della bombola (qualunque essa sia) ad una pressione
di taratura (costante e determinata) ........ la pressione ambiente
Ogni primo stadio è dotato di almeno due uscite di alta pressione
(.........= ....................) alla quali si connette il manometro (che è
l’indicatore dell’aria disponibile), e di 4 uscite di bassa pressione (........ =
....................) alle quali si connettono le fruste con i relativi secondi stadi
Disporre di un fonte d’aria alternativa ci permette sia di ....................
l’erogatore principale in caso di malfunzionamento, sia “....................” aria
al compagno di immersione nel caso in cui questo si trovi completamente
privo di aria oppure impossibilitato a respirare dalla propria attrrezzatura
Il G.A.V. è un apparato che si comporta proprio come la ............................
dei pesci. Esso migliora il galleggiamento del subacqueo, sia in immersione
sia in superficie, riducendo gli ............................. per mantenersi ad una
determinata profondità oppure in superficie
La boa segna-sub, è stata considerata, erroneamente, per molto tempo un
...................., ora il suo utilizzo è .................... ed .................... per
legge in quanto rende visibile la presenza di persone in immersione
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
55
Modulo 1
Verifica dell'apprendimento
Modulo 1
Pure Tech Agency
Dalla preparazione dipende buona parte del buon ..............................,
e durante il riordino, oltre a predisporre l’attrezzatura per l’immersione
successiva, si metabolizza e si fa tesoro della gioia e dell’esperienza appena
provata
Le regole che determinano una configurazione, pur dovendo rispondere
tutte a requisiti di ...................., .................... e ...................., si
diversificano tra loro nella fase applicativa dando origine a configurazioni
differenti
56
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Modulo 2
Pure Tech Agency
MODULO 2
Fisiologia del corpo umano e
leggi fisiche
Panoramica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cenni sull'immersione in apnea
La respirazione
L'Apparato respiratorio e circolatorio
Corretta eliminazione dell'anidride carbonica
Le leggi fisiche
Effetti dell'aumento di pressione: la compensazione
Effetti della diminuzione di pressione
La vista
L'udito
Obiettivi
Al termine di questo modulo avremo appreso:
•
•
•
•
•
Cenni sull'immersioni in apnea
Alcune conoscenze di base relative al corpo umano;
Le informazioni di base di alcune leggi fisiche inerenti alcuni
fenomeni relativi all'attività subacquea;
Gli effetti che questi fenomeni hanno sul corpo e sull'attrezzatura;
I comportamenti da adottare sott'acqua per armonizzare le nostre
azioni con le limitazioni imposte dalle leggi fisiche.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
57
Pure Tech Agency
Modulo 2
Considerazioni generali
Il corpo umano è un meccanismo meraviglioso grazie al quale possiamo
fare moltissime cose e tra queste l'andare sott'acqua è una delle più
emozionanti.
Per fare questo con cognizione di causa è necessario imparare cosa
avviene al nostro corpo quando scendiamo in profondità. Inoltre questa
conoscenza deve essere completata dallo studio di alcune leggi fisiche
in ragione del fatto che queste leggi spiegano i fenomeni che avvengono
sott'acqua, e soprattutto ci consentono di fare delle previsioni su cosa
accadrà o potrà accadere allorquando siamo in immersione.
I paragrafi che seguono sono una descrizione molto semplificata di questi
fenomeni, e benché questi siano spesso già patrimonio conoscitivo di
base della maggior parte delle persone, essi ci forniscono le informazioni
necessarie per andare sott'acqua in modo consapevole.
58
Open Water Diver
Dive
er - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
L'immersione in apnea è il più antico, semplice e puro metodo di
immersione subacquea. Purtroppo consente permanenze sotto la
superficie dell'acqua piuttosto brevi, misurabili in decine di secondi, dato
che l'unica scorta d'aria disponibile è quella contenuta nei nostri polmoni.
Eppoi se sott'acqua è richiesto un certo lavoro fisico questo tempo si riduce
ulteriormente.
I fenomeni che avvengo allorquando un subacqueo, trattenendo il fiato, si
immerge, sono stati studiati sotto molteplici aspetti: fisiologico, chimico,
fisico e mentale. Oggi, immergersi in apnea, almeno oltre certi livelli
di abilità, è una vera e propria "arte" che coinvolge diversi aspetti della
preparazione psicofisica di un atleta. La capacità di conoscere e percepire
il proprio corpo in modo approfondito, l'abilità di muoversi sott'acqua in
modo armonioso senza sprecare energie in movimenti inefficaci, sono solo
alcuni degli aspetti che contraddistinguono questa disciplina.
Indipendentemente dal proprio livello ii preparazione per immergersi in
apnea vi sono 2 regole di base che devono essere sempre rispettate:
Regola n. 1: Verificare le proprie condizioni psicofisiche. Un vita
sana, allenamento, giusto riposo e serenità sono le basi per immergersi in
modo gioioso ed in sicurezza;
Regola n. 2: Mai da soli in acqua. Il compagno ci osserverà
costantemente dalla superficie equipaggiato con pinne, maschera e
aeratore durante tutta la nostra sommozzata e una volta raggiunta la
superficie fino a quando non comunichiamo un chiaro segnale di "tutto a
posto". Egli è il nostro angelo custode, noi faremo altrettanto quando sarà
il suo turno di immersione.
Gli apneisti sono degli ottimi subacquei perché sviluppano elevate
doti di acquaticità e di controllo della respirazione. Per queste ragione
l'allenamento di base per le immersioni in apnea è anche un eccellente
preparazione per le immersioni con ARA.
Uno dei fenomeni più particolari che avviene nel corpo umano nelle
discese profonde in apnea, è lo spostamento del sangue dalle zone
periferiche del nostro corpo (mani, braccia, piedi, gambe), verso il torace.
Questa
vera
e
propria
migrazione di sangue viene
chiamata emocompensazione
(in inglese "blood shift"),
essa determina all'interno dei
nostri polmoni una massa
liquida incomprimibile che ne
impedisce l'implosione.
Questa particolare capacità di
adattamento accomuna l'uomo
a tutti i mammiferi marini.
Open Water Diver
Dive
er - CMAS
CMAS-PTA
PTA P1
59
Modulo 2
2.1 Cenni sull'immersione in apnea
Pure Tech Agency
2.2 La Respirazione
Modulo 2
La respirazione è la funzione biologica attraverso la quale scambiamo
l'aria fra il nostro corpo e l'ambiente esterno. Dall'aria libera nell'ambiente
esterno ci rifocilliamo di Ossigeno (inspirazione) ed in cambio gli
cediamo un po' di Anidride Carbonica (espirazione).
"Deep Breath" di Melanie Weidner
L'aria è il gas che avvolge il nostro pianeta e che forma l'atmosfera. Pur con
una certa approssimazione possiamo dire che essa è composta principalmente
da due gas distinti: Azoto ed Ossigeno.
La percentuale di Azoto è pari al 78% del totale, quella dell'Ossigeno è pari al
21%. Il restante 1% è composto da altri gas.
Scopo della respirazione è proprio quello di introdurre l'Ossigeno indispensabile
alla vita ed espellere l'Anidride Carbonica prodotta dal nostro corpo.
Grazie all'Ossigeno il nostro corpo è in grado di utilizzare i cibi di cui ci
nutriamo come carburante per le nostre attività: le sostanze nutritive, in
forma di carboidrati, proteine ed altro, vengono "bruciati" dai nostri muscoli
i quali producono come scarto l'Anidride Carbonica, la quale deve essere
per l'appunto espulsa. Un po' come fanno i motori degli autoveicoli con il
60
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Composizione
dell'aria
Simbolo
chimico
Aria
inspirata
Aria
Espirata
Ossigeno
O2
21,00%
16,40%
Azoto
N2
78,00%
79,00%
Anidride Carbonica
CO2
0,03%
4,00%
Modulo 2
tubo di scappamento: bruciano benzina ed espellono gas di scarico.
Nella tabella che segue vengono confrontati i dati di composizione tra aria
inspirata, ovvero dell'ambiente, ed aria espirata.
Osservando la tabella possiamo dire:
• Il quantitativo di Ossigeno dall'aria espirata è minore rispetto a quello
dell'aria inspirata;
• Il quantitativo di Azoto rimane invariato;
• Il quantitativo di Anidride Carbonica dell'aria inspirata è praticamente
zero, mentre aumenta in modo visibile nell'aria espirata.
Le variazioni dell'Ossigeno e dell'Anidride Carbonica sono dunque dovute
al fatto che questi gas prendono parte alle reazioni metaboliche che
avvengono all'interno del nostro corpo, mentre l'Azoto ne rimane del
tutto estraneo. Questo non significa che l'Azoto sia un gas che dobbiamo
ignorare, tutt'altro, ma le modalità con cui questo gas interagisce con il
nostro corpo le vedremo successivamente.
2.3 l'Apparato respiratorio e circolatorio
L’apparato respiratorio è responsabile della funzione respiratoria. Esso
cattura l'ossigeno dall'atmosfera e lo distribuisce a tutti i muscoli e
tessuti del corpo per mezzo dell'apparato circolatorio. Apparato circolatorio
e respiratorio assolvono anche alla funzione di espellere l'anidride carbonica
dal corpo verso l'atmosfera.
Possiamo immaginare i polmoni come una grossa spugna contenuta in un
mantice. I movimenti ritmici di contrazione ed espansione del mantice
comprimono e rilassano la spugna cosicché l'aria che riempie i polmoni
viene continuamente sostituita con aria nuova
L'apparato respiratorio è composto dalle seguenti parti:
• Le vie aeree superiori: hanno il compito principale di convogliare
l'aria verso i polmoni e sono composte dalla bocca, naso, seni
paranasali e frontali, faringe e laringe. Tutte queste sono delle vere
e proprie, cavità tutte collegate tra loro, all'interno delle quali l'aria
è sempre in moto, da e verso i polmoni, tranne ovviamente quando
tratteniamo il respiro. Quasi tutte possiedono un certo grado di
elasticità tranne i seni in quanto sono cavità completamente rigide
essendo posizionati nella parte frontale della scatola cranica.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
61
Pure Tech Agency
Modulo 2
• Le vie aeree inferiori: sono la parte più profonda dell'apparato
respiratorio e sono composte da trachea, bronchi, bronchioli e alveoli;
ovverosia i polmoni.
In buona sostanza i compiti dell'apparato respiratorio e circolatorio sono
quelli di catturare l'ossigeno dall'atmosfera, distribuirlo in tutto il corpo
ed espellere l'anidride carbonica.
Lo scambio dell'ossigeno tra l'apparato respiratorio e circolatorio avviene
negli alveoli. Possiamo immaginare gli alveoli come piccole sacche riunite
in grappoli all'interno dei polmoni. Gli alveoli sono la "soglia" che mette in
comunicazione l'apparato circolatorio con quello respiratorio permettendo
quindi l'assorbimento dell'ossigeno e l'espulsione dell'anidride carbonica.
Raffigurazione schematica di un alveolo
Una persona in stato di riposo ventila circa 0,5 litri al minuto, se sottoposta ad
un leggero sforzo passa a 20-25 litri al minuto
L'apparato circolatorio a sua volta è composto dal cuore, dalle vene,
dalle arterie ed ovviamente dal sangue che è preposto al trasporto
dell'ossigeno e della CO2 . Esso è suddiviso in due parti:
• Piccolo circolo: mette in comunicazione, o per meglio dire "mette a
sistema" il cuore con i polmoni;
• Grande circolo: dal cuore si diffonde in tutto il corpo con una via di andata
(le arterie nelle quali scorre il sangue ricco di ossigeno) e ritorno (le vene
nelle quali scorre il sangue carico di anidride carbonica).
Si comprende come il cuore sia centrale nello schema dell'apparato
circolatorio: esso risucchia il sangue ossigenato dai polmoni verso se stesso
per pomparlo successivamente nelle arterie. Simultaneamente risucchia il
sangue ricco di anidride carbonica dalle vene di nuovo verso se stesso, per
poi pomparlo verso i polmoni cosicché questo si possa ossigenare e cosi via.
62
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
I compiti del sistema circolatorio sono:
Trasporto dell’Ossigeno dai polmoni ai tessuti
Trasporto dell’Anidride Carbonica dai tessuti ai polmoni
Trasporto di alimenti, vitamine ecc
Distribuzione del calore nell’organismo
Modulo 2
•
•
•
•
Schema dell'apparato cardio-respiratorio
L'apparato respiratorio viene più o meno sollecitato in funzione del livello di
moto del nostro corpo. Un intenso lavoro muscolare comporta un elevato
consumo di energia e quindi un elevata produzione di anidride carbonica.
Lo stimolo ad una serie più o meno prolungata di potenti atti respiratori
ci viene dato proprio dall'aumento di anidride carbonica nel sangue.
Maggiore sarà la produzione di questo gas e maggiore sarà la risposta del
nostro corpo per espellerlo. Difatti lo stimolo ad una respirazione sostenuta
incomincia poco dopo aver intrapreso uno sforzo e termina dopo aver
concluso lo stesso sforzo.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
63
Pure Tech Agency
Le varie condizioni che identificano le quantità di ossigeno ed anidride
carbonica all'interno del nostro corpo sono sintetizzate nella tabella
seguente.
Condizione
Modulo 2
Ipercapnia
Ipocapnia
Ipossia
Iperossia
Descrizione
Effetto sull'individuo
Aumento dello stimolo della
respirazione, sensazione di fame
d'aria.
Diminuzione dello stimolo della
Bassa concentrazione di CO2
respirazione. Sensazione di lieve
nel sangue
vertigine.
Riduzione delle capacità percettive,
Bassa concentrazione di O2
stato confusionale, svenimento
nel sangue
(sincope)
Elevata o eccessiva
concentrazione di CO2 nel
sangue
Riscontrabile solamente in condizioni
Eccessiva concentrazione di
estreme, impossibili nelle immersioni
O2 nel sangue
subacquee ricreative
Lo stimolo ad un'intensa respirazione non è provocato dalla scarsità di ossigeno
nell'organismo, ma da un abbondanza di anidride carbonica nel sangue
É molto importante che gli atti respiratori in immersione siano "calmi" e
prolungati al fine sia di eliminare efficacemente l'anidride carbonica, sia
di nutrirsi adeguatamente di ossigeno. Atti respiratori corti e frequenti
sono inefficaci e portano ad un innalzamento repentino dell'anidride
carbonica nel corpo. Questa condizione è definita come affanno ed
appena si presenta (a seguito magari di uno sforzo prolungato oppure per
un innalzamento dello stress), è bene fermarsi, concentrarsi sul respiro e
fare in modo che gli atti respiratori ritornino ad essere lunghi e profondi
soprattutto in espirazione.
Approfondiamo questo aspetto della respirazione nel paragrafo seguente.
2.4
Corretta eliminazione dell'anidride carbonica
L’apporto di aria fresca all’interno dei polmoni non ricambia totalmente
l’aria "vecchia" ricca di anidride carbonica, bensì soltanto una parte.
Affinché vi sia un ricambio quanto più ottimale di aria nei polmoni occorre
"lavare" i polmoni dall’anidride carbonica. L’unico metodo efficace per fare
ciò è respirare in modo calmo e profondo, in modo che l’aria fresca, ricca di
ossigeno, possa giungere anche negli angoli interni più lontani dei polmoni
dove altrimenti può trattenersi aria ricca di anidride carbonica.
Respirare in modo frettoloso, corto e superficiale non ricambia l’aria viziata dai
polmoni: all'opposto non fa altro che amplificare la sensazione di bisogno di
aria, altrimenti detta fame d'aria, in modo pressante. Il soggetto in crescente
affanno respira in modo rapido, corto, le bolle in uscita dall'erogatore sono
pressoché continue, e questo lo porta in breve tempo in uno stato di malessere
64
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
1°) Eccessivo impegno muscolare dovuto ad esempio da: nuoto
controcorrente, lavoro fisico, prestare soccorso a un altro sub.
2°) Respirazione scorretta, ovvero rapida e superficiale.
3°) Stress. Una o più intense emozioni posso determinare la perdita
del controllo della respirazione e passare repentinamente da un
respirazione rilassata a una respirazione affannata.
4°) Erogatore malfunzionante o poco performante.
5°) Zavorratura eccessiva sia in immersione sia in superficie, oppure
postura poco idrodinamica tali da aumentare lo sforzo fisico.
Proviamo ad immaginare un professore di ginnastica che impone degli
esercizi dal notevole impegno fisico. Dopo un certo tempo il professore
interviene fermando gli studenti ed incitandoli ad inspirare ed espirare
profondamente facendo ridurre nel contempo quasi tutte le attività. Il
risultato di tale comportamento potrebbe essere definito come una tecnica
di rilassamento respiratorio estremamente efficace, un vero e proprio
antidoto contro l’affanno. Difatti, dopo pochissimo tempo la respirazione
torna regolare senza più alcuna traccia dell’affanno.
In immersione se ci troviamo in una condizione di affanno dobbiamo
interrompere ogni sforzo fisico, cercare di rilassarci magari adagiandoci
o aggrappandoci ad un punto accessibile del fondale marino (se non
riusciamo a mantener un assetto neutro) e riprendere un regolare e
profondo ritmo respiratorio. Risalire lentamente verso la superficie, anche
solo di qualche metro, può risultare utile.
L’anidride carbonica non deve tuttavia essere considerata come un nemico
della respirazione, tutt’altro. Essa regola il nostro ritmo respiratorio ed agisce
come spia di allarme di eventuali anomalie della respirazione. Senza di essa
rischieremmo di finire la benzina proprio come l'autista di un automobile priva
della spia della riserva
In questo modulo abbiamo appreso come sia la quantità di anidride carbonica
a stimolare la sensazione di fame d'aria (durante la fase iniziale di aumento
della concentrazione di questo gas nell'organismo) ed il ritmo respiratorio (se
la concentrazione continua ad aumentare). La carenza di ossigeno invece, non
produce gli stessi effetti.
Per queste ragioni è molto pericoloso eseguire una sommozzata in apnea se
questa è preceduta da numerosi e profondi atti respiratori, ovvero se si esegue
la manovra di iperventilazione. Tale manovra spesso produce una leggera
sensazione di vertigine, ma non necessariamente, e se questa viene avvertita
non si deve procedere con la sommozzata.
L'iperventilazione serve solamente ad abbassare il livello di anidride carbonica
nell'organismo, ma al contempo non aumenta il livello di ossigeno. Questo
significa che un apnea prolungata preceduta da iperventilazione può condurre
ad una ipossia profonda prima che si manifesti ipercapnia. Se questa
condizione ha luogo si verifica uno svenimento subacqueo, ovvero la sincope
da apnea prolungata.
Se non si interviene immediatamente, riportando il malcapitato in superficie,
il subacqueo colto da sincope è destinato ad annegare in quanto si troverà
sott'acqua al momento del risveglio.
MAI EFFETTUARE APNEE PRECEDUTE DA IPERVENTILAZIONE
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
65
Modulo 2
respiratorio (come se l'aria respirata non fosse in grado di apportare ossigeno)
e di elevato stress. Le più comuni cause scatenanti l'affanno sono:
Pure Tech Agency
2.5 Approfondimento sulle vie aeree superiori
Modulo 2
Come abbiamo detto le vie aeree superiori sono composte da numerose
cavità in un modo o nell'altro collegate tra loro. Tra tutte due gruppi
ricoprono un ruolo distintivo durante i cambiamenti di profondità a cui un
subacqueo è soggetto durante un'immersione. Questi sono i seni frontali
e l'orecchio. Descriviamoli più approfonditamente.
I seni
I seni paranasali sono cavità scavate
all’interno delle ossa del cranio e del
massiccio facciale ed in quanto tali
alleggeriscono il cranio. Svolgono un
ruolo importante nella respirazione
in quanto agiscono come sistema di
filtraggio dell'aria inspirata dal naso.
seni sfenoidali/
etmoidali
Queste cavità infatti sono irrorate
di muco il quale trattiene le polveri
ed i batteri che vengono inspirati;
inoltre
riscaldano
e
umidificano
l’aria inspirata. I seni paranasali sono
5 per lato e si distinguono in base alla
posizione in cui si trovano nel cranio cosi come illustrato in figura.
L'orecchio
Più complesso il caso dell'orecchio. Esso è l'organo dell'udito ed è composto
dalle seguenti parti:
• Orecchio esterno: è la parte visibile composta dal padiglione
auricolare ed il condotto uditivo che termina con il timpano. E' il
condotto da cui entrano i suoni;
• Orecchio medio: oltre il timpano vi è una cavità aerea in cui sono
contenuti dei piccoli ossicini che trasmettono le vibrazioni del suono
catturate dal timpano a dei
Orecchio
Orecchio
Orecchio
terminali nervosi. E' il tramite
esterno
medio
interno
tra l'esterno e l'interno;
• Orecchio interno: sede di
terminazioni
nervose
che
hanno l'incarico di trasformare
le vibrazioni sonore catturate
dal timpano e trasmesse dagli
ossicini, in impulsi elettrici.
Questi vengono quindi trasmessi
al cervello sotto forma di
“informazione suono”. Qui sono
contenuti anche organi deputati
al
controllo
dell'equilibrio
dell'individuo.
66
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Modulo 2
In buona sostanza possiamo dire che al termine del condotto uditivo
il timpano, che è una sottile membrana sensibile alle onde sonore che
vengono a infrangersi su di essa, trasmette le vibrazioni sonore agli
ossicini che con il loro movimento “eccitano” le terminazioni nervose poste
nell'orecchio interno. Gli ossicini sono contenuti in una cavità, l'orecchio
medio, che comunica con la faringe (la parte terminale della gola) per
mezzo di un condotto chiamato Tromba di Eustacchio.
2.6 Le leggi fisiche
La pressione
Il termine "pressione", ed il significato ad esso associato, è onnipresente
nel mondo della subacquea. Esso è espressione di un fenomeno al quale
sia il subacqueo sia l'attrezzatura sono soggetti.
Definizione di Pressione: è la forza che esercitano i fluidi (liquidi e
gas) sui corpi con cui vengono a contatto. Più precisamente parleremo di
PRESSIONE IDROSTATICA quando la forza in questione è quella esercitata
da un liquido (acqua dolce o salata) su di un corpo in essa immerso,
mentre più in generale parleremo di PRESSIONE AMBIENTE quando
ci riferiamo alla pressione del luogo nel quale ci troviamo, sia aereo sia
acquatico.
É noto a tutti che la Pressione
Ambiente a livello del mare è
leggermente
superiore
della
pressione che avremo in alta
montagna,
laddove
invece
aumenta man mano che si scende
in profondità. Questo fenomeno è
chiaramente
avvertito
come
dolore o fastidio ai timpani delle
orecchie sia nuotando in apnea
verso il fondo, sia percorrendo in
auto una strada di montagna.
Esistono
diversi
sistemi
di
misurazione per esprimere la
pressione. Alcune tra quelle
Confronto tra le pressioni esercitate su un piano di
più comunemente usate sono
due corpi identici ma differentemente disposti
le atmosfere (atm) oppure i
chilogrammi
su
centimetro
quadrato (kg/cm²).
La
pressione
esprime
un
valore che è direttamente collegato con il peso e la forma del corpo che
la esercita. Ciononostante due corpi identici di forma e peso possono
esercitare pressioni diverse cosi come illustrato nella figura.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
67
Pure Tech Agency
Modulo 2
La pressione esprime un valore che è direttamente collegato con il peso
e la forma del corpo che la esercita. Ciononostante due corpi identici di
forma e peso possono esercitare pressioni diverse cosi come illustrato nella
figura seguente.
La pressione è la forza che imprime un corpo per unità di superficie. In
altre parole è il peso che esercita il corpo sulla superficie di appoggio.
Esistono diversi sistemi di misurazione per esprimere la pressione dei gas.
Quelli che più comunemente vengono utilizzati sono:
•
•
•
•
atmosfere (atm)
chilogrammi su centimetro quadrato (kg/cm²)
bar (bar)
libbre su pollice quadrato (psi)
1 atm
1 kg/cm²
=
=
1 kg/cm²
1,013 bar
1 bar
=
14,5083 psi
1 atm
=
760 mm di hg
Le conversioni tra le varie unità di misura
sono sintetizzate nella seguente tabella.
La pressione esercitata dai fluidi
Per comprendere ulteriormente il fenomeno della pressione è necessario
indagare quando questa viene manifestata dai fluidi. Con il termine "fluido"
si intende uno stato della materia che comprende sia i gas (come l'aria) sia
i liquidi (come l'acqua di mare o di un lago).
La tabella seguente illustra le caratteristiche principali dei fluidi.
Fluido
Liquido
Gas
Volume
Forma
Proprietà
Prende la forma
del contenitore che Incomprimibile
lo contiene
Definito
Tende ad
occupare lo spazio
a sua disposizione
Indefinita
Comprimibile
Si deve all'opera di due noti scienziati del 600', Evangelista Torricelli e
Blaise Pascal, la comprensione del fenomeno della pressione nei gas e nei
liquidi.
Sintetizziamone, non senza approssimazioni, il pensiero:
68
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
La terra è circondata da uno strato d'aria chiamato atmosfera. Dato che
tutti i gas hanno un peso proprio, anche se minimo, questo strato d’aria
esercita sulla superficie terrestre una pressione detta pressione barometrica
o atmosferica, la cui unità di misura è il "bar" o il "mm hg" (millimetri di
mercurio).
L’aria, essendo comprimibile, presenta la sua massima densità nei suoi
strati inferiori (ovvero da quota zero fino a circa 10mila metri di quota),
dove è compressa dallo spessore totale dell’atmosfera (che si estende fino
a 20mila metri sopra la superficie terrestre). Le variazioni di pressione
nell’atmosfera non sono costanti in quanto al variare dell’altezza varia
anche la densità dell’aria, e quindi il suo peso.
In altre parole la pressione barometrica varia al variare dello spessore dello
strato gassoso ed è massima al livello del mare, dove lo spessore della
colonna d'aria sovrastante è massimo, e dove potremo rilevare 1 Bar di
pressione ambiente.
Dal momento che l’acqua possiede densità costante, e quindi un "peso
costante", quando si scende in profondità, l’incremento della pressione,
altrimenti detta pressione idrostatica, è costante ed è pari ad 1 atmosfera
ogni 10 metri.
Per determinare con precisione la pressione a cui è soggetto un corpo che
nuota sotto il pelo dell'acqua è necessario quindi sommare la pressione
barometrica con la pressione idrostatica e più precisamente:
La terminologia corretta per identificare a quale pressioni ci si riferisce è la
seguente:
PRESSIONE ATMOSFERICA
PRESSIONE
ASSOLUTA
PRESSIONE IDROSTATICA
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
69
Modulo 2
Torricelli
Pure Tech Agency
Modulo 2
• ATA:
pressione
assoluta
ovvero
determinata
dalla somma di colonna
d'acqua + colonna
d'aria
• ATR:
pressione idrostatica o
relativa, ovvero quella
determinata dalla sola
colonna d'acqua
• ATM:
pressione atmosferica
o barometrica, ovvero
quella
determinata
dalla
sola
colonna
d'aria
La figura qui a lato
sintetizza quanto fin
qui esposto.
Pascal
Abbiamo visto poc'anzi l'intensità con la quale si manifesta la pressione,
ora descriviamo le modalità:
"La pressione esercitata su un punto qualsiasi di un fluido si
trasmette in tutte le direzioni con uguale intensità".
In buona sostanza questo sta a significare che un corpo immerso in un
fluido, quale può essere un subacqueo in immersione, viene uniformemente
avvolto dalla pressione che lo circonda.
Sempre rapportando il principio all'attività subacquea, si ha lo stesso
fenomeno nel corpo umano quando la pressione dell’aria respirata da una
bombola si trasmette sempre con la stessa intensità in tutte le direzioni e
in tutte le cavità delle vie aeree.
70
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Modulo 2
Un corpo immerso in un fluido non viene quindi schiacciato dalla colonna di
fluido che lo sovrasta, bensì la pressione tende ad avvolgerlo esercitando
un’uguale forza su tutta la sua superficie.
Questo consente di sopportare pressioni altrimenti impensabili. Basti
pensare che nella normale vita di tutti i giorni siamo sottoposti ad una
pressione barometrica complessiva di circa 15.000 kg confortevolmente
distribuiti sul metro quadrato e mezzo di pelle del nostro corpo.
Per visualizzare il Principio di Pascal si è
soliti citare un esperimento che prevede di
riempire d'acqua una bottiglia di plastica
alla quale vengono praticati una corona
di fori lungo una sua circonferenza. I fori
generano degli zampilli in tutte le direzioni
e tutti i getti arrivano alla stessa distanza
dalla bottiglia.
Da questo si deduce che a parità di
"quota", ovvero di profondità, la pressione
all'interno del fluido è uguale in tutte le
direzioni.
La legge di Archimede o spinta idrostatica
Archimede, il noto scienziato storico, enunciò la seguente legge:
"Un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta dal basso
verso l'alto pari al peso dell'acqua che sposta, ovvero pari al
peso del volume d'acqua occupato dal corpo stesso".
In parole semplice un corpo a contatto con l'acqua può comportarsi nei
seguenti modi:
• Galleggia: l'acqua spostata ha un peso superiore rispetto al corpo, il
quale tende ad andare verso la superficie, se non vi è già, ed una volta
raggiunta rimane in galleggiamento.
Condizione di ASSETTO POSITIVO.
• Affonda: l'acqua spostata ha un peso inferiore rispetto al corpo, il
quale si muovere verso il fondo.
Condizione di ASSETTO NEGATIVO.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
71
Pure Tech Agency
Modulo 2
• In equilibrio: l'acqua spostata ha un peso identico a quello del corpo,
il quale non subirà alcun spostamento in verticale. Condizione di
ASSETTO NEUTRO.
Positivo
Neutro
Negativo
Una delle abilità che deve acquisire il subacqueo è la valutazione
del proprio equilibrio idrostatico in funzione dell'equipaggiamento
indossato.
La chiara comprensione di questo fenomeno è la base per avere un assetto
in immersione il più possibile neutro e, di conseguenza, una maggiore
sicurezza ed un miglior comfort.
Per conseguire tutto ciò occorre considerare che:
• L'attrezzatura è formata da parti che hanno assetto sia positivo sia
negativo;
• L'acqua può essere dolce o salata, quindi produrrà una minore
o maggiore spinta idrostatica (l'acqua salata peso di più rispetto
all'acqua dolce);
• Il corpo umano tende ad assumere un assetto positivo o negativo
a seconda che i polmoni siano pieni d'aria (inspirazione) oppure
collassati (espirazione).
72
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Nella tabella seguente troviamo un elenco di attrezzature, del loro assetto
ed il relativo comportamento in immersione.
Assetto
Comportamento
Muta
Positivo
Man Mano che si scende in profondità l'aumento della
pressione ambiente schiaccia la muta. Diminuendo
di volume tenderà a perder parte del proprio assetto
positivo.
Zavorra
Negativo
Sempre negativo.
GAV
Positivo e neutro
É la parte di attrezzatura preposta al mantenimento
di un assetto neutro. Avendo la capacità di gonfiarsi
e sgonfiarsi, e quindi di variare il proprio volume, è
in grado di aumentare di molto la propria capacità di
spinta idrostatica, oppure di ridurla a zero.
Bombola
Le bombole hanno assetto negativo all'inizio
dell'immersione, quando sono piene di aria che ha un
Negativo, neutro e peso. Man mano che l'aria si esaurisce tenderanno
positivo.
ad acquisire inizialmente un assetto neutro finanche
lievemente positivo (soprattutto le bombole in
alluminio).
Strumentazione Negativo
Sempre negativo.
Osservando la tabella precedente si comprende benissimo come la zavorra
deve essere calibrata per annullare tutte le "spinte positive" ed il GAV
debba essere abbastanza capace al fine di contrastare tutte le spinte
negative.
Per calibrare correttamente il peso della zavorra è necessario eseguire una
prova in acqua: il nuotatore, con indosso l'attrezzatura leggera, in posizione
verticale, espirando non dovrebbe affondare oltre la linea degli occhi.
La legge di Boyle e Mariotte
La legge di Boyle e Mariotte descrive il comportamento dei gas soggetti a
pressione.
Essa afferma che "a temperatura costante il prodotto della pressione
di un gas per il volume che esso occupa è costante, ovvero che
in condizioni di temperatura costante la pressione di un gas è
inversamente proporzionale al suo volume".
Questa legge spiega perché un palloncino gonfio d'aria se venisse portato
ad una profondità di 10 metri (2 ATA di pressione ambiente) lo vedremmo
rimpicciolire della metà del suo volume di partenza, a 20 metri (3 ATA) di
un terzo, a 30 metri (4 ATA) di quarto e cosi via.
Al contrario se fossimo in grado di riempire un palloncino a 10 metri
di profondità, lo vedremmo raddoppiare di volume appena giunto in
superficie.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
73
Modulo 2
Attrezzatura
Pure Tech Agency
DISCESA
Modulo 2
profondità pressione volume
0m
1 bar
1
10m
2 bar
1/2
20 m
3 bar
1/3
30 m
4 bar
1/4
volume non
compensato
volume
compensato
RISALITA
profondità
pressione
volume
polmoni
aperti
volume chiuso
aumento
di volume
0m
1 bar
x4
10m
2 bar
x2
20 m
3 bar
x 1+1/3
30 m
4 bar
x1
In termini matematici la legge di Boyle e Mariotte si esprime come segue:
P1 x V1 = P2 x V2 = K (costante)
Riprendiamo l'esempio del palloncino ed immaginiamo che questi avesse
un volume di 10 litri in superficie, avremo:
1
ATA in
superficie
74
x
10
Volume in
superficie
=
2
ATA a
10 metri
x
5
Volume a
10 metri
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
=
3
x
3,3
e cosi via
=
...
Pure Tech Agency
Esempi applicativi: la carica delle bombole
Esempio 1. Si vuole calcolare il volume di gas a pressione atmosferica
contenuto in una bombola da 18 litri caricata a 200 atm.
=
=
=
=
200 atm
18 litri
1 atm
?
V2 = (P1 x V1)/P2 = (200 x 18)/1 = 3.600 litri.
Esempio2. Si vuole calcolare il massimo volume di gas trasferibile, per mezzo
di una frusta di travaso, da una bombola di 40 litri (V1) caricata a 200 bar (P1
iniziale) ad una bombola di 12 litri vuota (V2).
La risoluzione di questo esercizio richiede qualche passaggio in più.
P1 iniziale = 200 atm
V1
= 40 litri
P2 iniziale = 0 atm
V2
= 12 litri
P1 finale = P2 finale = ?
Le bombole messe a sistema per mezzo di una frusta di connessione hanno
un volume complessivo di 52 litri, pertanto gli 8.000 (200 x 40) litri contenuti
in P1 si diffonderanno in questo maggior volume disponibile e la pressione del
sistema si ridurrà a circa 154 atm (8.000/52).
Il volume di gas contenuto in V2 sarà di circa 1
.846 litri (154 x 12).
Le operazioni eseguite vengono schematizzate nella tabella seguente.
P1 x V1
200 x 40
=
=
(154 x 12 ) + (154 x 40)
P finale x V sistema
=
154 x 52
Questi esercizi descrivono matematicamente l'atteggiamento mentale più
comune in questo genere di operazioni: riportare il volume di un gas contenuto
in una bombola a pressione ambiente.
La
pressione
è
influenzata
dalla
temperatura.
Se una bombola carica viene lasciata al
sole, la pressione al suo interno aumenta,
per ritornare poi ai valori di partenza
appena la si raffredda; ad esempio
mettendola in acqua. É per questo che i
controllo sulla pressione di carica devono
essere eseguiti considerando questo
aspetto.
Non lasciare mai le bombole cariche al sole, ne tanto meno all'interno di un
veicolo se esposto al sole e con i finestrini chiusi. L'aumento di pressione,
al seguito dell'aumento di temperatura, potrebbe eccedere le capacità di
contenimento del gas della bombola con conseguente espulsione violenta della
valvola.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
75
Modulo 2
P1
V1
P2
V2
Pure Tech Agency
Modulo 2
La densità dei fluidi e la respirazione
L'acqua è più densa dell'aria. Cosa vuol dire?
Scientificamente la densità esprime il rapporto tra la massa di un corpo ed
il suo volume. L'acqua è molto pesante quindi a parità di volume avrà una
densità ben maggiore rispetto all'aria. Nei fluidi (ovvero i liquidi ed i gas)
i corpi con densità minore galleggiano nei corpi con densità maggiore e
questo è la base della legge di Archimede.
L'acqua di mare, essendovi disciolto il sale, è più densa dell'acqua dolce
perché a parità di volume pesa di più, conseguentemente è in grado di
produrre una maggiore spinta di galleggiamento. Ecco perchè, nel caso
in cui avessimo calibrato la nostra zavorra in acqua dolce, dovremo
aggiungere almeno un paio di chili se ci immergessimo nel mare.
Un fluido più è denso e maggiore sarà l'attrito che questo manifesta sui
corpi che lo attraversano o che lo incanalano. Un aereo può sfrecciare
veloce nell'aria perchè questa sviluppo poco attrito, laddove una barca
non può essere altrettanto veloce di un aereo in quanto l'acqua sviluppa
un attrito ben maggiore (avete mai provato a trainare una barca con una
corda dalla riva? Scoprirete quanto sia faticoso farle acquistare una certa
velocità e mantenerla).
Benchè esistano delle similitudini tra densità e peso specifico essi non
vanno confusi in quanto esprimono due concetti un poco differenti: la
densità non è influenzata dalla gravità mentre il peso specifico si. Senza
addentrarci ulteriormente in questioni scientifiche possiamo dire che la
densità dell'acqua ha principalmente a che fare con il galleggiamento,
mentre la densità dell'aria con la facilità di respirazione. La galleggiabilità
non viene influenzata dalla profondità mentre la respirazione si, vediamo
come.
Abbiano già parlato dell'affanno,
ebbene questo fenomeno è favorito
o
anche dalla densità dell'aria che
e
respiriamo. Se siamo a 10 metrii
di profondità l'aria che respiriamo
o
avrà una densità doppia di quella
a
che si respira normalmente in
n
superficie perchè doppia è la sua
a
massa (legge di Boyle e Mariotte).
o
In ragione di ciò l'attrito prodotto
à
dall'aria respirata in profondità
e
sulle pareti interne delle nostre vie
a
aeree superiori aumenta in maniera
a
direttamente proporzionale alla
profondità stessa.
Tutto questo non significa affatto
o
che in profondità "si fa fatica
a
a respirare", semplicemente cii
conferma quanto sia importante
e
adottare una respirazione corretta
a
in immersione.
76
Open Water
er Diver
Dive
er - CMAS
CMAS-PTA
PTA P1
Pure Tech Agency
La legge di Dalton
La legge di Dalton afferma che "la pressione totale esercitata da una
miscela di gas è uguale alla somma delle pressioni parziali che
sarebbero esercitate dai gas che la compongono se occupassero da
soli tutto il volume a disposizione".
Modulo 2
In termini matematici si esprime come segue:
Ptot = Pp1 + Pp2 + Pp3 + ... + Ppn
Pensiamo all'aria: essa è composta da Azoto per il 79% e da Ossigeno per
il 21%. Questo significa che se ho un volume V di aria ad 1 bar di pressione
esso sarà cosi composto:
0,79 bar di N2 e 0,21 bar di O2
Se lo stesso volume di aria lo porto ad una profondità di 10 metri avremo
che il volume è diventato V/2 e la pressione è diventata 2 bar, da cui
avremo:
(0,79 x 2) bar di N2 e (0,21 x 2) bar di O2
ovvero
1,58 bar di N2 e 0,42 bar di O2
ovvero 2 bar di aria
1, 58 e 0,42 sono le pressioni parziali di Azoto ed Ossigeno dell'aria a
10 metri di profondità. La somma delle pressioni parziali deve essere
ovviamente identica alla pressione ambiente.
Calcoliamo le pressioni parziali dell'aria contenuta in una bombola caricata a
150 bar:
avremo
(0,79 x 150) = 118,5 bar di N2
(0,21 x 150) = 31,5 bar di O2
come verifica sommiamo
118,5 + 31,5 = 150 bar di aria
Questa legge ci offre la possibilità di prevedere gli effetti che l'Azoto e
l'Ossigeno, presi singolarmente, hanno sul nostro organismo quando
scendiamo in profondità.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
77
Pure Tech Agency
Modulo 2
2.7 Effetti dell'aumento di pressione: la
compensazione
Abbiamo appreso come sottoponendo un contenitore elastico pieno di gas
ad un aumento della pressione ambiente questo tende a collassare su
se stesso. Per mantenerne inalterato il volume del contenitore occorrerà
aumentare la pressione interna fino ad equilibrarla con quella esterna:
abbiamo effettuato una manovra di compensazione seguendo quanto
stabilito da Boyle e Mariotte.
Come si è detto il nostro corpo contiene delle cavità piene di aria. Queste,
per la maggior parte, e se si è in condizioni generali di buona salute,
quando vengono sottoposte ad un aumento di pressione si compensano
spontaneamente per il semplice fatto di essere a contatto con l'aria fornita
dall'erogatore. Altre, come lo stomaco e l'intestino, pur contendendo aria, si
compensano grazie alla loro elasticità e solitamente la compensazione non
impone di eseguire manovre di un qualche tipo da parte del subacqueo.
Diverso è il caso dell’orecchio medio. Esso è, come già descritto
precedentemente, una cavità piena di aria compresa tra il timpano e la
tromba di Eustachio. Questa è un condotto che mette in comunicazione
l'orecchio medio con la gola. A causa della costrizione della tromba di
Eustachio, la cavità dell'orecchio medio si trova isolata dalle vie aeree
"irrorate" dalla aria a pressione ambiente respirata dall'erogatore; questa
condizione la rende quindi incapace di compensarsi in modo autonomo.
Questo comporta una flessione del timpano verso l’interno provocata
dall'aumento di pressione esterna dell'acqua man mano che si scende in
profondità.
Per evitare questo occorre introdurre aria per riportare il volume
dell’orecchio medio alle dimensioni originali ed il timpano in posizione
naturale, mediante una manovra di compensazione.
Le manovre più usate ed efficaci per ottenere la compensazione sono:
• Valsalva (espirazione forzata con naso e bocca chiusi, sviluppa una
notevole pressione intrapolmonare).
• Marcante-Odaglia (compressione dell’aria contenuta nel retrofaringe).
• Deglutizione (È la manovra più semplice, purtroppo poco efficace ai
fini dell'immersione subacquea)
La manovra di Valsalva, più facile da apprendere, ha come inconveniente
quello di richiedere l’uso dei muscoli preposti all'espirazione con
conseguente contrazione del torace.
La Marcante-Odaglia si esegue chiudendo il naso e portando la base della
lingua in alto e indietro verso il palato molle; è una manovra efficace perchè
provoca il movimento delle pareti faringee cosi da facilitare l’apertura delle
trombe di Eustachio. Ciò si ottiene con l’uso di pochi muscoli potenti, con
minimo sforzo e senza interferire con la circolazione.
78
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Inoltre anche una leggera introflessione
del timpano può comunque causare danni
all’orecchio (otite barotraumatica).
A certi individui particolarmente fortunati basta la semplice deglutizione,
magari effettuata tenendosi il naso tappato, per produrre una efficace
compensazione.
I seni sono collegati con il naso e si compensano spontaneamente nel
momento stesso in cui si respira aria la cui pressione aumenta man mano.
Nel caso in cui vi è in corso un raffreddore, oppure una sinusite magari con
eccessiva produzione di muco, è altamente possibile che i percorsi che mettono
in comunicazione i seni vengano ostruiti rendendo impossibile e fastidiosa la
loro compensazione.
Alcune persone particolarmente sensibili sperimentano dolore nella zona
frontale della testa sia in discesa che in risalita anche nel caso in cui l'orecchio
medio sia stato agevolmente compensato. Non è infrequente avere delle
piccole perdite di sangue dal naso dovute alla rottura di capillari sanguigni
all'interno dei seni. Se questo fenomeno dovesse persistere è meglio consultare
un medico al riguardo.
É bene porre l'attenzione su due aspetti impo rtanti della compensazione: il
primo è che una leggera introflessione del timpano può comunque causare
un'otite barotraumatica, il secondo è che la manovra deve svolgersi in
modo sostanzialmente agevole, ovvero che se per compensare si rende
necessario uno sforzo "sproporzionato" questo dovrebbe indurci a riflettere
sull'opportunità di rinunciare all'immersione.
Se non si riesce a compensare si deve rinunciare all’immersione
Compensazione della maschera
Durante l’immersione, mentre si scende in
profondità, avviene una riduzione del volume
tra maschera e viso in ragione dell'aumento
della pressione ambiente. Questa riduzione,
ovvero una parziale compensazione, può
avvenire fino ad un certo punto grazie al
contorno elastico che aderisce al viso. Oltre
una certa pressione la riduzione di volume si arresta
t (il ttelaio
l i rigido
i id viene
i
a contatto con il viso) e si avrebbe cosi una differenza di pressione tra
ambiente esterno ed interno della maschera tale da determina un vero
e proprio "effetto ventosa" sui tessuti molli del viso e soprattutto sui
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
79
Modulo 2
Qualunque
sia
la
tecnica
scelta,
la
compensazione deve essere effettuata
prima che compaia dolore all’orecchio, in
quanto, se si attende troppo, si può verificare
una diminuzione del volume dell’aria all’interno
dell’orecchio medio tale da rendere difficoltosa la
manovra.
Pure Tech Agency
capillari del bulbo oculare. Per evitare ciò, basta ricordarsi di soffiare un
poco di aria nella maschera attraverso il naso, per mantenerne costante il
volume interno equalizzando cosi la pressione interna con l'esterna. Benché
sia un incidente fastidioso e che provoca arrossamento degli occhi, di
norma l'assorbimento dell'ematoma avviene spontaneamente dopo qualche
giorno.
Modulo 2
Sintesi delle raccomandazioni
Una tra le più probabili patologie che possono coinvolgere tutti coloro
che praticano attività subacquea, indipendentemente dalle profondità
raggiunte, è la lesione timpanica anche di tipo perforativo.
Questo trauma è causato da variazioni di pressione sulla membrana
timpanica non controbilanciate da una corretta manovra di compensazione.
Esistono varie tecniche di compensazione ma tutte con il fine di introdurre
aria, attraverso la tuba di Eustachio fino alla membrana del timpano.
Qualunque manovra si decida di eseguire, è comunque opportuno
compensare prima di avvertire qualunque fastidio all’orecchio (e tantomeno
dolore). Inoltre è sempre buona norma non insistere troppo e in
maniera ostinata nel tentativo di compensare l’orecchio se questo
non riesce con semplicità.
Se proseguendo nella discesa, si continuano ad avvertire dolori alle
orecchie, bisogna assolutamente non forzare la compensazione, bensì
si deve risalire di qualche metro e ritentare la compensazione.
Infine non deve essere dimenticato quanto è stato già appreso a proposito
del cappuccio, ovvero bisogna allagare il condotto uditivo all'inizio di ogni
immersione.
Se nonostante tutto le difficoltà di compensazione permangono, è tassativo
interrompere immediatamente l’immersione, per evitare di incorrere in
incidenti che possono avere conseguenze anche molto serie. Infatti, quando
viene impedito il riequilibrio della pressione nelle cavità dell’orecchio
medio, si ha una progressiva introflessione verso l’interno della membrana
timpanica, che provoca già nei primi metri della discesa forti dolori, fino alla
sua lacerazione. In questo caso, oltre al forte dolore, si deve considerare
il violento passaggio di acqua, in genere piuttosto fredda, nelle cavità
dell’orecchio medio, causando una alterazione del normale funzionamento
del senso dell’equilibrio, con conseguente perdita di orientamento, oltre a
vertigini e nausea.
Chiaramente, con la rottura della membrana timpanica dovranno essere
assolutamente evitate le immersioni finché non vi sarà una cicatrizzazione
completa della membrana stessa.
80
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Come si è detto le variazioni di volume sono inversamente proporzionali
all’aumento della pressione. Durante la risalita, ed in particolar modo negli
ultimi 10 metri di profondità, occorrerà prestare molta attenzione in quanto
l’aumento di volume dei gas all’interno del nostro corpo sarà sempre elevato.
Per questa ragione il subacqueo durante la risalita deve continuare
a respirare regolarmente dall'erogatore, senza mai trattenere il
respiro. Nel caso non si abbia l'erogatore in bocca, è necessario continuare
ad espirare, ovvero emettere delle bolle, mantenendo aperte le vie aeree
per evitare che i nostri polmoni si dilatino come un palloncino in risalita.
I nostri polmoni difatti non sono elastici come lo è un palloncino
e finirebbero per lacerarsi se in risalita non ci si attiene a questa
fondamentale regola di sicurezza. L'incidente che avviene trattenendo il
respiro in risalita è chiamato sovradistensione polmonare, e benché sia
l'incidente più grave che possa capitare ad un subacqueo esso è il più facile
e semplice da prevenire: basta continuare a respirare normalmente.
Essere sempre presenti e concentrati su quest'aspetto
dell'immersione è da considerarsi come la prima regola generale di
sicurezza delle immersioni con ARA: mai trattenere il respiro.
REGOLA GENERALE DI SICUREZZA delle immersioni
con ARA: mai trattenere il respiro, bensì continuare a
respirare regolarmente dall'erogatore. Emetti sempre le
bollicine quando l'erogatore non è in bocca
Un altro fenomeno che può avvenire durante la risalita è la vertigine
alternobarica: essa è è una vera e propria vertigine dovuta ad un
disequilibrio tra le pressioni dei due orecchi medi. É un fenomeno che
può avere una notevole intensità ma di solito dura pochi istanti e non
comporta nessuna conseguenza. In caso di vertigine alternobarica è
utile interrompere la risalita e dare il tempo alle orecchie di equiparare
la pressione. Può essere utile, nel caso in cui la vertigine sia molto forte,
aggrapparsi a se stessi (o ad un qualunque appiglio fisso) oppure guardare
verso un punto fisso (ammesso che ve ne sia uno a disposizione).
In ultimo è importante descrivere la sovradistensione intestinale,
chiamata anche colica del palombaro ed il parotrauma dei denti.
La colica è dovuta alla formazione di gas da digestione nell'intestino che
espandendosi in risalita possono procurare qualche fastidio. Se questo
avviene, e se è possibile farlo, una sana pernacchia dovrebbe risolvere la
situazione. Come prevenzione sarebbe meglio evitare quelle pietanze che
sappiamo ci procurano una certa flatulenza.
Il barotrauma dei denti, benché non sia di per se pericoloso, può risultare
talvolta doloroso. I denti che in conseguenza di carie hanno subito un
intervento nel quale è stata applicata un'otturazione possono avere al
loro interno delle micro-cavità di aria. In risalita questa può espandersi e
provocare dolore interferendo con le terminazioni nervose e può persino far
saltare l'otturazione. L'età dell'otturazione o la cattiva qualità dell'intervento
odontoiatrico possono influire sull'insorgenza di questo evento.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
81
Modulo 2
2.8 Effetti della diminuzione di pressione
Pure Tech Agency
Modulo 2
2.9 La vista
Quando l’occhio è a diretto contatto con l’acqua la visione è sfuocata e
tutto appare confuso ed indistinto in quanto i raggi luminosi che
provengono
dall’oggetto
osservato
subiscono una rifrazione diversa rispetto
alla visione in aria, e l’immagine non si
forma più sulla retina. Per poter vedere
chiaramente sott’acqua e quindi far sì che
l’immagine sia nitida, occorre che il globo
oculare sia a contatto con aria, così come
avviene indossando la maschera. Solo in
questo caso, infatti, le immagini saranno
a fuoco sulla retina.
La visione così ottenuta è dunque chiara ma soffre di leggere alterazioni
che sono prodotte dalla diversa densità dei materiali che i raggi luminosi
debbono attraversare per arrivare all’occhio: acqua, cristallo della maschera
ed aria. Gli oggetti osservati sott'acqua per mezzo di una maschera
appaiono quindi più vicini e più grandi di circa un terzo.
L’acqua inoltre assorbe la luce, non permettendogli di penetrare oltre una
certa profondità, fino ad arrivare al buio assoluto degli abissi.
Questo fenomeno ha importanti conseguenze sulla visione dei colori.
Per esempio il colore rosso già a 5 metri perde di brillantezza ed a 15 metri
si presenta scurissimo, quasi nero.
IIl secondo colore che viene assorbito è
l’arancione, poi il giallo, il verde e il blu,
l’
fino ad avere una colorazione per lo più
grigia o nera. Per questa ragione per
g
poter vedere i colori reali di ciò che si sta
p
osservando si deve usare una torcia
o
ssubacquea. Puntando gli oggetti con la
luce della nostra torcia questi riprendono
lu
il colore proprio originale.
82
Open Water Dive
Diver
er - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
La velocità di propagazione e la distanza percorribili dai suoni in acqua
sono molto più elevati rispetto a quanto avviene in superficie in ragione
della maggiore densità dell'acqua rispetto all'aria. Il suono prodotto per
richiamare l’attenzione del compagno battendo con il coltello sulla bombola,
può essere udito anche da grande distanza. Di contro sott'acqua è molto
difficile capire la provenienza di un suono, ovvero i suoni udibili avvolgo il
subacqueo quasi in modo uniforme.
In superficie siamo in grado di capire la direzione di un suono perché esso
r
raggiunge
prima un orecchio e poi
l'
l'altro.
Questa differenza di tempo,
b
benché
piccolissima, è percepita ed
e
elaborata
dai nostri sensi i quali ci
fo
forniscono
una
direzione
di
p
provenienza.
Sott'acqua, essendo la
v
velocità
di propagazione dei suoni
m
molto
elevata, la differenza di
"
"ricezione"
tra un orecchio e l'altro
s assottiglia troppo oltre la nostra
si
c
capacità
di
elaborazione
ed
i t i i
d ll provenienza
i
d
intuizione
della
dell suono. Si comprende benissimo perché si
debba prestare sempre molta attenzione durante la risalita al rumore
prodotto delle imbarcazioni a prescindere dalle nostre sensazioni di
vicinanza o lontananza: non si può mai essere sicuri dell'esatta posizione
della fonte di emissione di un suono.
La velocità del suono varia a seconda del mezzo (ad esempio, il suono si
propaga più velocemente nell'acqua che non nell'aria), e varia anche al
variare delle proprietà del mezzo, specialmente con la sua temperatura.
Nella tabella seguente vengono riportati i valori della velocità del suono in
aria e in acqua.
mezzo
Velocità
(metri al secondo)
Aria
331
Acqua
1450
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
83
Modulo 2
2.10 L'udito
Pure Tech Agency
Verifica dell'apprendimento
inserisci le parole mancanti
Modulo 2
Uno dei fenomeni più particolari che avviene nel corpo umano nelle discese
profonde in apnea, è lo spostamento del sangue dalle ..............................
del nostro corpo (mani, braccia, piedi, gambe), verso il .......................
Dall’aria libera nell’ambiente esterno ci rifocilliamo di .......................
(inspirazione) ed in cambio gli cediamo un po’ di .................................
(espirazione)
L’apparato respiratorio è responsabile della ................................... Esso
cattura l’................ dall’atmosfera e lo distribuisce a tutti i muscoli e
tessuti del corpo per mezzo dell’apparato circolatorio
Lo scambio dell’ossigeno tra l’apparato respiratorio e circolatorio avviene
negli .......................
L’apparato circolatorio a sua volta è composto dal .................., dalle
................, dalle ................. ed ovviamente dal sangue che è preposto al
trasporto dell’ossigeno e della ............
Più precisamente parleremo di ............................. quando la forza
in questione è quella esercitata da un liquido (acqua dolce o salata) su
di un corpo in essa immerso, mentre più in generale parleremo di
............................ quando ci riferiamo alla pressione del luogo nel quale
ci troviamo, sia aereo sia acquatico
L’aria, essendo comprimibile, presenta la sua massima densità nei suoi
strati inferiori (ovvero da quota zero fino a circa ................. metri di
quota), dove è compressa dallo spessore totale dell’atmosfera (che si
estende fino a .................. metri sopra la superficie terrestre)
“La pressione esercitata su un punto qualsiasi di un fluido si trasmette in
tutte le .................. con uguale intensità”.
Archimede, il noto scienziato storico, enunciò la seguente legge:
“Un corpo immerso nell’acqua riceve una spinta dal .......................
verso l’....................... pari al peso dell’acqua che sposta, ovvero pari al
....................... del ....................... d’acqua occupato dal corpo stesso”.
Al contrario se fossimo in grado di riempire un palloncino a 10 metri di
profondità, lo vedremmo ....................... di volume appena giunto in
superficie
84
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
L’acqua di mare, essendovi disciolto il sale, è ....................... dell’acqua
dolce perché a parità di volume pesa di più, conseguentemente è in grado
di produrre una ....................... spinta di galleggiamento
1. .......................
2. .......................
3. .......................
Il naso e seni paranasali costituiscono il primo tratto delle .......................,
e comunicano per mezzo delle narici con l’ambiente esterno
Per questa ragione il subacqueo durante la risalita deve continuare a
....................... regolarmente dall’erogatore, senza mai trattenere il
respiro
Gli oggetti appaiono più vicini e più grandi di circa un .......................
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
85
Modulo 2
L’orecchio, è composto da tre parti
Modulo 2
Pure Tech Agency
86
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Modulo 3
Pure Tech Agency
MODULO 3
Adattamento all'Ambiente e
Riconoscimento dei Problemi
Panoramica
•
•
•
•
•
•
•
La legge di Henry
Assorbimento e cessione dell'Azoto
La patologia da decompressione
La narcosi di Azoto
Riconoscimento dei problemi e incidenti subacquei
Gestione delle emergenze
Lo stress
Obiettivi
Al termine di questo modulo avremo appreso:
•
•
•
I fenomeni che avvengono nel nostro corpo al seguito dell'aumento
di pressione ambiente;
I comportamenti da adottare durante le diverse fase di
un'immersione;
Gli incidenti subacquei e come prevenirli.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
87
Pure Tech Agency
Considerazioni generali
Come si è ormai chiaramente capito durante una esplorazione subacquea
si è soggetti a dei repentini cambiamenti delle condizioni ambientali.
Questi cambiamenti si manifestano in quanto si hanno variazioni di:
Modulo 3
• Temperatura: in quanto l'acqua disperde calore maggiormente dell'aria
e spesso la temperatura tende a diminuire con l'aumento della
profondità;
• Intensità luminosa: in quanto l'acqua assorbe la luce;
• Pressione: in ragione dell'aumento o diminuzione della profondità.
Temperatura e luce si controllano grazie all'utilizzo di adeguate attrezzature
(una idonea muta ed una buona torcia), laddove le variazioni di pressione
si gestiscono grazie a specifici comportamenti ed azioni.
É necessario ora comprendere ulteriori aspetti relativi agli effetti che i
singoli gas componenti la miscela aria, ovvero azoto ed ossigeno, hanno
sul nostro corpo quando questi vengono respirati ad alta pressione.
Apprenderemo come una parte di questi effetti si prevengono grazie ad
una attenta programmazione dell'immersione, mentre gli altri si controllano
attraverso un attento e corretto comportamento da adottare quando si è in
immersione.
3.1 La Legge di Henry
Pur con una certa approssimazione possiamo dire che l'aria è composta dal
21% di ossigeno e dal 78% di azoto. Per la Legge di Dalton la pressione
totale esercitata da una miscela di gas è uguale alla somma delle singole
pressioni parziali dei gas componenti la miscela stessa. A livello del mare,
quindi alla pressione di 1 Bar, la pressione parziale dell’Ossigeno sarà di
0,21 Bar, mentre quella dell’Azoto sarà di 0,78 Bar.
Quando un subacqueo è in immersione e respira dalla bombola, la
pressione dell’aria che respira è maggiore della tensione dell'azoto presente
nel corpo (vedi paragrafo 3.2 - concetto e differenze tra pressione e
tensione). La pressione dell'azoto nell'aria respirata "vince" sulla tensione
dell'azoto presente nel corpo cosicché una certa quantità di azoto si
introduce, ovvero si scioglie nel corpo umano. Più il subacqueo si spinge in
profondità e più tempo vi rimane, più azoto si discioglie nell’organismo.
Mentre l’Ossigeno viene in larga parte metabolizzato dal corpo umano
e trasformato in Anidride Carbonica, l’Azoto non viene utilizzato, per cui
rimane nel sangue ad una pressione parziale di 0,78 Bar.
Il subacqueo in immersione respira aria a pressione ambiente. Alla
profondità di 10 metri la pressione all’interno dei polmoni è equivalente
alla pressione ambiente, ovvero 2 bar. In queste condizioni i nostri
polmoni conterranno una quantità di gas doppia rispetto a quella respirata
normalmente in superficie a parità di volume. Anche le pressioni parziali di
ossigeno ed azoto saranno ovviamente doppie, ovvero:
88
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Pressione parziale ossigeno
0,21 x 2 =
0,42 bar
Pressione parziale di azoto
0,78 x 2 =
1,56 bar
1,98 bar
Abbiamo già accennato al fatto che l'ossigeno viene utilizzato dal nostro
organismo mentre l'azoto, in quanto gas inerte, non viene metabolizzato
dal nostro organismo. Esso si trova nella condizione di venir assorbito
dal nostro corpo per il semplice fatto di venirsi a trovare a contatto con il
sangue all'interno degli alveoli. Difatti è scientificamente provato che un
gas viene assorbito da un liquido, proprio come potrebbe fare una spugna
con l'acqua, quando la pressione del gas che viene a contatto con il liquido
è superiore alla pressione del liquido stesso.
La legge di Henry descrive in modo scientifico proprio questo fenomeno:
"un gas che esercita una pressione sulla superficie di un liquido,
vi entra in soluzione finché avrà raggiunto in quel liquido la stessa
pressione che esercita sopra di esso".
In buona sostanza tutto ciò significa che aumentando la profondità
aumentano di conseguenza le quantità di ossigeno e di azoto nel sangue.
Mentre l’aumento di ossigeno, nelle immersioni alle quali abilità questo
corso, non comporta alcuna ripercussione durante e dopo l’immersione
(possono manifestarsi dei problemi molto seri solamente oltre profondità
molto elevate, per la precisione oltre i 66 metri di profondità), l'aumento di
azoto nel sangue determina un conseguente assorbimento di questo gas da
parte dei tessuti con i quali il sangue viene a contatto. Le modalità con cui
questo gas viene assorbito e rilasciato dal nostro corpo sono trattate nel
prossimo paragrafo.
3.2 Assorbimento e cessione dell'Azoto
Gli studi scientifici che indagano le modalità di assorbimento dell'azoto nei
tessuti del corpo a seguito di aumento di pressione sono notevoli, ma mai
quanto gli studi che sono stati condotti per capire come, finita la fase di
assorbimento, l'azoto venga rilasciato.
Un subacqueo inizia ad assorbire azoto nell'istante in cui incomincia la
discesa verso il fondo. Pur con una certa approsimazione possiamo dire che
questa fase di assorbimento termina allorquando si incomincia la risalita
verso la superficie. La fase di assorbimento-discesa non implica alcun
particolare accorgimento da parte del subacqueo, mentre la fase di rilasciorisalita deve essere gestita dal subacqueo in modo adeguato.
Per capire come l'azoto si libera nel nostro corpo proviamo ad immaginare
una bottiglia di acqua gasata sigillata. Aprendola noteremo la formazione
di numerose bolle (sono composte da anidride carbonica che viene
addizionata proprio per ottenere la "gasatura") le quali, dopo un certo
tempo, tenderanno a diminuire cosi come illustrato nel disegno seguente.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
89
Modulo 3
totale
Pure Tech Agency
Descriviamo dettagliatamente il
fenomeno delle bollicine nella
bottiglia:
Modulo 3
A.
Fase
disciolta
ovvero
dii
saturazione: il gas si trova disciolto
o
nel liquido. La pressione all'interno
o
del collo della bottiglia, grazie all
tappo, è identica alla tensione dell
gas all'interno del liquido. Tensione e
pressione nel collo della bottiglia sono
o
superiori alla pressione ambiente all'esterno
della
bottiglia.
t
d
ll b
tti li
B. Fase libera il gas disciolto nel liquido, a seguito della rimozione repentina
del tappo, migra in modo repentino verso l'atmosfera formando numerose
bollicine.
C. La tensione tende, nel tempo, a diminuire fino ad eguagliare la pressione
ambiente. Dopo un certo numero di ore l'acqua non sarà più gassata.
La differenza tra pressione e tensione può essere sintetizzata in questo modo:
- Pressione: la esercita il gas sui liquidi oppure i corpi con cui è a contatto;
- Tensione: la esercita il gas nel liquido in cui è disciolto.
Si comprende benissimo come sia importante evitare che all'interno del
nostro corpo si formino delle
bollicine analoghe a quelle nella bottiglia.
DOMANDA: come possiamo impedire la formazione di bolle nella
bottiglia, ovvero nel nostro corpo?
RISPOSTA: dobbiamo aprire il tappo molto, ma molto, lentamente,
ovvero dobbiamo eseguire la risalita con lentezza.
SECONDA REGOLA GENERALE DI SICUREZZA delle
immersioni con ARA. La velocità di risalita non deve
superare i 9/10 metri al minuto e questo significa che se
ci troviamo a 20 metri di profondità impiegheremo due
minuti a raggiungere la superficie.
Provate a coprire a piedi la distanza di 10 metri in un minuto: ci si renderà
conto di quanto lenta debba essere la risalita.
In immersione quindi la tensione di azoto nel nostro corpo tenderà ad
eguagliare la pressione di azoto che stiamo respirando istante per istante
dall'erogatore. In risalita invece l'azoto accumulato tenderà a dirigersi verso
la parte del sistema circolatorio che convoglia il sangue verso i polmoni
(sistema venoso) e da li, per mezzo degli alveoli, si libererà nell'ambiente
con l'aria espirata.
90
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
La quantità di azoto assorbita o ceduta dipende invece dal tempo.
Si comprende benissimo come PROFONDITA' E TEMPO SONO I
PARAMETRI FONDAMENTALI DI OGNI IMMERSIONE.
Dopo l'uscita dall'acqua il nostro corpo conterrà ancora una certa quantità
di azoto in eccesso da espellere e ci vorranno non meno di 12 ore per fare
in modo che questo avvenga.
Questo è un aspetto molto importante che verrà approfondito in seguito.
Benché l'azoto in fase desaturativa tenderà a formare comunque delle
bolle, queste nella stragrande maggioranza dei casi non determinano alcun
effetto visibile. Se la dimensione delle bolle raggiunge però dimensioni
fisiologicamente ragguardevoli (parliamo sempre di bolle piccolissime),
queste possono creare delle vere e proprie patologie, specificatamente
definite Patologie da Decompressione o PDD. La gravità di queste patologie
è in relazione con il tipo di tessuto nel quale si forma la bolla.
3.3 La Decompressione
Per decompressione si intende una tecnica grazie alla quale si rilascia in
modo controllato l'eccesso di azoto accumulato nei tessuti durante
l'immersione. La decompressione deve compiersi prima dell'uscita
dall'acqua e di fatto si svolge durante tutta la fase di risalita finale verso la
superficie.
CORRETTA DECOMPRESSIONE = DESATURAZIONE ASINTOMATICA
Possiamo distinguere due gruppi principali di immersioni che si distinguono
tra di loro a seconda del tipo di decompressione che si deve effettuare.
Descriviamo questi due gruppi.
I)
Immersioni in curva di non decompressione/sicurezza: sono
immersioni che richiedono soltanto il rispetto della velocità di risalita
ed una sosta ad una profondità di 5 metri per almeno 3 minuti;
II)
Immersioni fuori curva di non decompressione/sicurezza:
sono immersioni che richiedono, oltre al rispetto della velocità
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
91
Modulo 3
I tempi con cui un tessuto tende a diventare saturo di azoto, ovvero essere
in condizione di saturazione, variano da tessuto a tessuto.
Le ossa hanno tempi di saturazione molto elevati, mentre il sangue, anche
in ragione del fatto che è un liquido, ha tempi di saturazione piuttosto
rapidi dell'ordine di pochi minuti. I tempi di saturazione e desaturazione
sono uguali a parità di tessuto, e sono noti per numerose tipologie di
tessuti.
La velocità di saturazione, e quindi di desaturazione, è direttamente
proporzionale al valore della differenza tra pressione e tensione e
viceversa; ovvero alta pressione e bassa tensione significa velocità di
saturazione elevata; pressione di poco superiore alla tensione significa
bassa velocità di saturazione.
Pure Tech Agency
di risalita, di effettuare una o più soste a determinate profondità
e per determinanti tempi. Le profondità ed i tempi di queste
soste si determinano grazie ad apposite tabelle definite tabelle
di immersione, oppure per mezzo delle indicazioni fornite dai
computer da immersione (approfondiremo nei paragrafi successivi
questo argomento).
Il corso P1 PTA-CMAS abilita ad immersioni condotte entro la curva di non
decompressione.
Modulo 3
3.4 La Patologia da Decompressione (PDD)
Il termine "Patologia Da Decompressione" identifica la formazione di
bolle d’Azoto nei tessuti e nei vasi sanguigni.
L’Azoto che è assorbito durante l’immersione, essendo un gas inerte e non
metabolico, non è utilizzato dal corpo e, al momento dell’emersione, deve
essere eliminato attraverso il normale atto respiratorio.
Più è alta la pressione della miscela di gas che respiriamo, tanto più
questa si discioglie ed entra in soluzione nel sangue; durante questa
fase i tessuti del nostro corpo assorbono una quantità di Azoto superiore
al normale, pertanto raggiunta la saturazione, cominciano a rilasciarlo nel
circolo sanguigno.
Durante la risalita l’Azoto, soggetto ad una minore pressione, ritorna
allo stato gassoso aggregandosi in bolle di varie dimensioni che
possono provocare danni laddove si depositano.
Nel caso in cui il salto tra tensione e pressione sia troppo rapido queste bolle
raggiungono dimensioni notevoli anche in ragione del fatto che tendono ad
unirsi tra di loro. Queste bolle di fatto si comportano come dei tappi che
impediscono la libera circolazione del sangue in un determinato punto.
L’ingresso dell’Azoto nel nostro corpo avviene tramite gli alveoli polmonari,
dove la superficie di contatto è molto estesa e il gas può passare per
osmosi nel circolo sanguigno con estrema rapidità. Per questo motivo si
considera il sangue come il tessuto più "rapido" per ciò che riguarda
l’assunzione d’Azoto.
Dal sangue il gas è distribuito in tutto il corpo umano; in generale i tessuti
più irrorati, (muscoli, organi interni, ecc.), saranno quelli che si saturano
più velocemente, mentre quelli meno irrorati (grasso, cartilagini ecc.)
saranno i più lenti.
La PDD è la diretta conseguenza di un’inadeguata desaturazione, il processo
desaturativo comprende sia una corretta risalita, la sosta di sicurezza e
l'intervallo di superficie.
Poiché le bolle d’Azoto possono formarsi od essere trasportate ovunque nel
corpo, i segni e sintomi di una loro presenza in quantitativi e dimensioni
patologiche sono i più vari:
92
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Nel 50% dei casi circa i sintomi della PDD compaiono entro 30’ dopo
l’uscita dall’acqua e in ogni modo nel 95% dei casi entro 3 ore.
Tieni sempre presente che un corretto intervento prevede di agire
anche nel dubbio in quanto il comportamento umano in questi casi è
distorsivo: tende ad allontanare il problema adducendo la responsabilità
dei dolori, dei malesseri o della spossatezza ad uno sforzo fisico, a
problemi digestivi o a qualunque altra presunta causa. La malattia
da decompressione può sopraggiungere, anche se sono state
rispettate tutte le norme di sicurezza.
Il subacqueo deve segnalare ogni sintomo che accusa senza per questo
pensare di fare brutta figura o di rovinare la giornata agli altri (aspettare
peggiorerà l’evoluzione della malattia). La PDD è un evento piuttosto raro,
nelle immersioni condotte entro i 18 metri di profondità.
Fattori di predisposizione alla PDD
I processi descritti fino ad ora sono aggravati e velocizzati da condizioni
ambientali e personali particolari quali:
FATTORI DI PREDISPOSIZIONE ALLA PDD
• sforzo fisico durante e dopo l’immersione
• scarsa forma fisica
• obesità (20% oltre il peso forma)
• freddo durante e dopo l’immersione
• disidratazione
• problemi circolatori generali o locali
• uso di farmaci, droghe ed alcool
• fumo
• lesioni varie (traumi, strappi, lussazioni, rotture)
• precedenti episodi di PDD
• Risalita troppo rapida
• Profilo dell'immersione a yo yo (ovvero notevoli e ravvicinati cambi di profondità)
• Omessa sosta di sicurezza
• Immersioni in apnea dopo un'immersione con ARA
• Portarsi in quota dopo un'immersione oppure viaggiare in aeroplano
Evitare i comportamenti sopra citati riduce il rischio che si verifichi una PDD.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
93
Modulo 3
SEGNI E SINTOMI DELLA PDD
• stato di stanchezza persistente
• fastidioso prurito alla pelle
• eruzione a macchie sulle pelle
• insensibilità, formicolio e paralisi locale
• dolore articolare alle braccia e alle gambe
• dolore al torace o alle giunture
• vista annebbiata
• difficoltà d’udito e pronuncia
• capogiri e vertigini
• incapacità di orinare
• difficoltà respiratorie
• aerofagia; colpi di tosse
• collasso, perdita dei sensi
Pure Tech Agency
NOTA DI PRIMO SOCCORSO
Il trattamento per una PDD è l’immediato ricovero in camera iperbarica. Gli
interventi da effettuarsi in attesa dei soccorsi, che devono essere allertati
prima di ogni altra azione, sono la somministrazione di ossigeno e liquidi.
La respirazione di ossigeno puro garantisce una migliore ossigenazione
dei tessuti allontanando i rischi di un loro danneggiamento (talvolta la sola
somministrazione di ossigeno risolve le PDD di tipo lieve). La somministrazione
all’infortunato di notevoli quantitativi di liquidi migliora la fluidità del sangue
con una più facile eliminazione delle bolle.
Modulo 3
3.5 La Narcosi di Azoto
Benché sia un fenomeno non ancora del tutto compreso a livello scientifico,
ne sono ben noti gli effetti a livello corporeo. Respirare azoto ad alte
pressioni può provocare un rallentamento o distorsione delle capacità
percettive di un individuo. Questo fenomeno è abbastanza soggettivo ed
in genere non avviene prima dei 30/35 metri di profondità. É difficile per
il subacqueo novizio riconoscere tali sintomi che comunque si presentano
a profondità ben maggiori di quelle per le quali si è abilitati nel corso P1.
Rimanere entro i limiti del proprio brevetto sottrae il subacqueo da questo
fenomeno potenzialmente pericoloso. Questo argomento verrà approfondito
nei corsi successivi quando si acquisirà la specialità di immersione
profonda.
Questo argomento verrà approfondito nei corsi successivi quando si
affronteranno le problematiche connesse con l'immersione profonda.
3.6 Riconoscimento dei problemi e incidenti
subacquei
Una poderosa opera documentale prodotta da diverse agenzie di
addestramento, assicurazione ed istituzioni scientifiche dimostra come
praticare l’attività subacquea sia più sicuro di molti altri sport ben più
popolari. Intorno all'attività subacquea si sono prodotti spesso timori
ingiustificati, paragonabili a quelli che si hanno per il volo aereo,
nonostante questo sia incontestabilmente più sicuro di qualsiasi altro
mezzo di trasporto.
Quasi tutti gli incidenti che avvengono sott'acqua sono imputabili al
superamento dei propri limiti di addestramento oppure il ritenere
che le cose che si apprendono non hanno un valore decisivo ma
soltanto indicativo.
Le varie iniziative che promuovono l’attività subacquea ai principianti,
generalmente, tendono ad "ammorbidire" le informazioni riguardanti il
rischio e/o le probabilità di incidente in questa nostra disciplina sportiva.
Il rischio, ovviamente, come in tutte le attività esiste e con esso anche le
probabilità di incorrere in un incidente. Benché sia difficile calibrare questo
genere di informazioni senza che queste generino un senso di diffidenza
verso l'attività stessa, anche un argomento cosi "difficile" deve essere
affrontato in modo chiaro nei corsi per il conseguimento delle certificazioni
94
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
subacquee.Affinché qualsiasi attività (sportiva o professionale) sia il più
possibile sicura e con rischi
ridotti, è importante conoscere
gli aspetti negativi e pericolosi e
soprattutto conoscere i sistemi
per prevenirli e trattarli (Primo
Soccorso
e
Autosoccorso).
Soltanto cosi è possibile rendere
questa disciplina estremamente
piacevole e con una bassa
percentuale di rischio.
Per quanto possa sembrare
assurdo, il più delle volte, il
rischio si genera proprio dall'eccessiva
denza con l'
l'ambiente
i confi
fid
bi t acquatico.
ti
La subacquea ricreativa è semplice, rilassa e questo tende ad abbassare il
livello di attenzione del praticante.
L'emozione di scalare anche solo una piccola parete di roccia "tiene
vigili" nei confronti delle proprie azioni e dell'ambiente, mentre l'attività
subacquea al contrario "assopisce" proprio per la sua godibilità. Due basilari
quanto semplici regole sono dei veri salvavita in moltissime situazioni:
• Non eccederò i limiti imposti dal mio brevetto e dal mio livello
di preparazione
• Farò in modo che le mie azioni non obblighino il mio compagno
ad eccedere i limiti imposti dal suo brevetto e dal suo livello di
preparazione
Con il termine "incidente" ci si riferisce ad un evento che, in modo più o
meno repentino, interrompe il regolare procedere di un'immersione. Ad
esser precisi questi eventi spesso non sono la causa diretta del nostro
rischio o danno, piuttosto lo sono gli effetti della reazione che noi stessi
inneschiamo per contrastarli.
Facciamo un esempio pratico:
Evento
Reazione
Risultato
Malfunzionamento
dell'erogatore
primario
Passare all'erogatore secondario
o FAA (fonte d'aria alternativa) il
quale è stato mantenuto in buono
stato e pronto all'uso
Si
raggiunge
la
superficie
con tranquillità e si completa
l'immersione
come
da
addestramento
Malfunzionamento
dell'erogatore
primario
La FAA non è raggiungibile perché
messo in posizione scorretta
oppure è anch'essa malfunzionate,
il compagno di immersione non è
nelle vicinanze.
Il livello di stress sale a razzo, si
cerca di raggiunge la superficie
come siluri, spesso in preda al
panico, con tutti i rischi derivanti
dalla legge di Boyle e Mariotte
oppure
di
Henry
(incidenti
meccanici e PDD)
Si comprende benissimo come un banale evento, peraltro piuttosto raro,
possa avere due ben distinti risultati.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
95
Modulo 3
Pure Tech Agency
Pure Tech Agency
Modulo 3
I colori del pronto soccorso
Al fine di descrivere gli incidenti subacquei si è deciso di evidenziarli
adottando la colorazione in vigore nei pronto soccorso degli ospedali.
Questa colorazione indica il grado di reattività che dobbiamo mettere in
atto nel caso si verifichi un problema.
La tabella nella pagina successiva descrive sinteticamente gli incidenti
subacquei. É importante che questi siano compresi e memorizzati da ogni
subacqueo al fine di comprendere chiaramente i metodi e le tecniche per
evitarli.
96
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Incidenti di tipo meccanico afferenti alla legge di Boyle e Mariotte
Fase
immersione
Causa
Sovradistensione
polmonare
Risalita
EGA
Embolia
Gassosa
Arteriosa
Risalita
Sovradistensione Respirare
polmonare
sempre mai
trattenere il
Gas nel circolo respiro
arterioso
Rispettare
la velocità di
risalita
Colpo di
ventosa della
maschera
Discesa
non si
compensa la
maschera
Barotraumi
dell' orecchio
Barotrauma
dei denti
Vertigine
alternobarica
Trattenere il
fiato in risalita
Prevenzione
Rottura alveoli
polmonari
Discesa
Rapide e
frequenti
variazioni di
quota
Somministrare
ossigeno
trasporto
urgente
ospedale
Tosse,
difficoltà
respiratoria,
rigonfiamento
del collo,
coma
Somministrare
ossigeno
trasporto
urgente
ospedale
Rottura dei
capillari del
viso e occhi
Dolore
all'orecchio,
vertigini
Rottura del
timpano
Interrompere
l'immersione
Visita medica
successiva
Interrompere
l'immersione
Visita medica
successiva
Informare il
proprio dentista
della propria
attività di
subacqueo
Dolore al
dente,
l'otturazione
può "saltare"
in bocca
Interrompere
l'immersione
Corretta
compensazione
Perdita di
orientamento
Assistenza del
compagno
Vertigini
Fermarsi e
guardare un
punto fisso
Compensazioni
unilaterali
Sovradistensione
intestinale
(coliche)
Azioni di
soccorso
Tosse,
difficoltà
respiratoria,
rigonfiamento
del collo,
coma
Rsalare un poco Fastidio nella
di aria dal naso zona degli
nella maschera occhi
Omessa
Eseguire
compensazione corretta
manovra di
compensazione
Discesa/risalita Otturazione
dentale debole
Soprattutto
in risalita
Respirare
sempre mai
trattenere il
respiro
Sintomi/
Effetti
Movimenti
NON coordinati
Visita medica
successiva
Visita medica
successiva
Discesa/risalita Alimenti
Espulsione
Produzione gas Accortezza
assunti prima
naturale dei gas intestinali
nell'assunzione
dell'immersione
di cibi
Scendere e/o
Dolori
risalire piano
addominali
flettendo le
gambe
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
97
Modulo 3
Descrizione
Pure Tech Agency
Incidenti di tipo fisco afferenti alla legge di Henry
Descrizione
PDD
Fase
immersione
Risalita e/o
dopo
emersione
Causa
Prevenzione
Sintomi
Eccessiva
velocità di risalita,
omessa tappa di
sicurezza, profilo
immersione a yo
yo, disidratazione
Corretta velocità
di risalita, sosta
di sicurezza,
corretta
idratazione
Da lievi quali
pruriti e dolori
articolari a
gravi quali
sensazione
di formicolio,
paralisi
Azioni di
soccorso
Somministrare
ossigeno
trasporto
rapido in
camera
iperbarica
Incidenti di tipo chimico afferenti alla legge di Dalton
Descrizione
Fase
immersione
Causa
Prevenzione
Sintomi
Azioni di
soccorso
Tutte
Scorretta
respirazione,
eccessivo sforzo
fisico
Limitare
gli sforzi,
mantenere un
atteggiamento
rilassato, respiri
lenti e profondi
Respiro corto,
fame d'aria
Autosoccorso:
interrompere
ogni attività
che comporta
sforzo,
eseguire atti
respiratori
profondi ed
espirazioni
prolungate.
Narcosi
In profondità
La profondità
stessa
Limitare la
profondità
Rallentamento
delle capacità
analitiche
Risalire a
quote poco
profonde
Il compressore
ha immesso aria
non pura
Rivolgersi a
centri di ricarica
di qualità
Mal di testa,
sensazione di
disagio
Autosoccorso:
interrompere
l'immersione.
Modulo 3
Affanno
Avvelenatutte
mento
da CO
(monossido
di carbonio)
Dopo aver analizzato la casistica degli incidenti si comprende benissimo come
tutti siano direttamente correlati con il nostro modo di condurre l'immersione.
Di rado soltanto la PDD lascia margini, seppur minimi, alla sfiga.
L'avvelenamento da monossido di carbonio è una tipologia di incidente molto rara.
Nei casi più gravi la sensazione di mal di testa persiste per cui è meglio consultare
un medico nel qual caso potrebbe essere necessario la somministrazione di
Ossigeno in camera iperbarica. Molte persone soffrono di mal di testa, per cui
stabilire se effettivamente questo ne sia la causa è difficile. Dovrebbe capitare a
tutti i subacquei che hanno caricato le bombole nella medesima stazione di ricarica.
3.7 Gestione delle emergenze
Per gestire una emergenza in modo adeguato è necessario seguire dei corsi
specifici. Detto questo anche il subacqueo novizio può rendersi utile nel
caso in cui sia necessario un suo intervento per portare assistenza ad un
infortunato. Abbiamo già elencato una casistica di possibili problemi che si
possono riscontrare sott'acqua nel precedente paragrafo. La maggior parte
di essi non richiedono un tempestivo ricorso alle strutture sanitarie, altri
richiedono invece un intervento immediato ed un rapido oppure urgente
98
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Il sangue in profondità, salvo che sia illuminato da una torcia, assume, in
conseguenza dell'assorbimento dei colori prodotto dall'acqua, una colorazione
verdastra, scura. Potrebbe quindi non essere riconosciuto immediatamente
come tale.
Gli infortuni più seri sono la Sovradistensione polmonare, l'EGA ed i
casi gravi di PDD.
La sovradistensione polmonare
L'aria respirata in profondità, come abbiamo appreso, è a pressione
ambiente. Al diminuire di tale pressione, ovvero risalendo verso la
superficie, quest'aria, per la legge di Boyle e Mariotte, si espande
aumentando di volume. Tale aumento può causare la rottura degli alveoli
polmonari provocando il passaggio di quest'aria nella cavità pleurica con
conseguente collasso del polmone (pneumotorace). Tal volta questo
collasso avviene tra il polmone destro e il polmone sinistro (mediastino)
e nell'eventualità peggiore, questo collasso determina un passaggio di
bolle d'aria (emboli) direttamente nel circolo arterioso (Embolia Gassosa
aArteriosa-EGA).
I sintomi possono essere molteplici: senso di vertigine, senso di debolezza,
problemi alla vista, dolore al torace, disorientamento, alterazioni della
personalità o paralisi. Questi sintomi si manifestano immediatamente,
l'insorgenza di una EGA si manifesta con fuoriuscita di schiuma rossastra
da bocca o naso, debolezza muscolare o paralisi, convulsioni, perdita di
coscienza, arresto respiratorio.
Anche solo interrompere la respirazione per pochi metri di risalita espone
il subacqueo a rischio di sovradistensione polmonare; questo rischio si
presenta soprattutto in vicinanza della superficie dove il gradiente di
diminuzione di pressione è massimo.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
99
Modulo 3
trasporto verso una struttura sanitaria. Ovviamente possono capitare degli
incidenti in immersione, per esempio
un malore di qualche genere, non
direttamente
collegati
all'attività
subacquea, ma in ragione del fatto che
questi capitano sott'acqua il loro
riconoscimento e gestione diventano
più problematici.
Le ferite, con conseguente perdita di
sangue, sono un evento piuttosto raro, cosi
come traumi di natura fisica (salvo che ci
cada una bombola su un piede!), è comunque importante avere a disposizione
una cassetta di pronto soccorso con almeno disinfettante, cerotti e bende.
Pure Tech Agency
Invero possono sussistere eventuali stati patologici, quali la bronchite,
l'asma, o eventuali malformazioni anatomiche, che possono provocare
l'intrappolamento di aria in zone polmonari circoscritte per questo è
sempre doveroso non immergersi in presenza di tali patologie ed effettuare
ricorrenti controlli medici.
Modulo 3
Il trattamento di una sovradistensione polmonare è di pertinenza medica
e prevede un intervento di drenaggio polmonare e Ossigenoterapia
iperbarica.
EGA
L'embolia gassosa arteriosa è una patologia molto seria a cui può andare
incontro un subacqueo. Essa si manifesta a seguito di sconfinamento di
bolle di aria all'interno della circolazione sanguigna arteriosa dai polmoni.
La principale causa dell'EGA è un'estrema sovradistensione polmonare che
arriva al punto di provocare una lacerazione nel tessuto polmonare stesso.
Questo fa penetrare nella circolazione arteriosa degli emboli gassosi che
possono occludere la normale circolazione del sangue verso il cervello.
L'EGA si manifesta in forma traumatica in risalita ed i sintmi più frequenti
sono: vertigini, difficoltà respiratoria, disturbi cardiaci, vari problemi
neurologici, perdita di conoscenza e coma. Soltanto un urgente trattamento
in ospedale può risolvere la situazione.
Analizziamo differenze ed identità tra sovradistensione polmonare, EGA e
PDD di tipo grave.
Infortunio
Zona del corpo
Manifestazioni
gravi
Azioni di soccorso
Sovradistensione
Polmonare
Lacerazione dei
polmoni
Difficoltà respiratorie;
Rigonfiamenti del
collo;
Dolore al petto;
Tosse persistente
Trasporto in
ospedale;
Somministrare
Ossigeno.
Ega
Aria nel circolo
arterioso
(a seguito di
sovradistensione
polmonare)
Paralisi di un
emicorpo (ovvero
parte sinistra o
destra);
Coma;
Trasporto in
ospedale;
Somministrare
Ossigeno.
PDD di tipo grave
Formazione di bolle Paralisi di metà corpo
di azoto nei tessuti (paralisi alle gambe);
nervosi.
Dolori al petto;
Dolori in genere;
Vertigini e nausea;
Intorpidimenti
Difficoltà respiratorie;
Perdita di
conoscenza.
100
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Trasporto in
ospedale;
Somministrare
Ossigeno
Pure Tech Agency
Soltanto personale medico specializzato è in grado di prestare le adeguate
cure a questo genere di infortuni. Noi possiamo soltanto contattare le
strutture sanitarie e assistere l'infortunato in attesa dei soccorsi.
Per
P eseguire in modo adeguato tale procedura dobbiamo
disporre
di una bombola di ossigeno di tipo medicale
d
così
come illustrato nella fotografia. Queste sono dotate
c
di
d una mascherina da posizionare sul volto e da un
dispositivo
“ad offerta” continua di ossigeno. Questo tipo
d
di
d bombole sono necessarie soprattutto nel caso in cui
l'infortunato
è incosciente, quindi non sarebbe in grado
l'
di
d respirare da un semplice erogatore di qualche tipo
collegato
ad una bombola di ossigeno.
c
Per
P queste ragioni dobbiamo pretendere che il centro di
immersioni
a cui ci rivolgiamo abbia a disposizione tale
im
apparecchiatura
e che il personale sia qualificato per
a
usarla.
u
Il
I tuo istruttore CMAS-PTA ti saprà dare indicazioni
specifi
che al riguardo.
s
ogni subacqueo dovrebbe essere addestrato a praticare il BLS (Basic Life
Support) e a somministrare Ossigeno normobarico.
Nella pagina successiva viene riportata la procedura di emergenza da
eseguire nel caso comparissero dei sintomi di qualche tipo, anche dubbi, a
seguito di un'immersione
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
101
Modulo 3
In tutti i casi comunque la somministrazione di ossigeno è molto utile
soprattutto durante l'attesa dei soccorsi. Benché anche la somministrazione
di
d ossigeno debba essere fatta da persone che hanno
ricevuto
una adeguata istruzione in tal senso (come ad
r
esempio
i corsi DAN: http://www.daneurope.org/web/
e
guest/training/ofa),
questa rimane il più efficace metodo
g
di
d soccorso a disposizione.
Modulo 3
Pure Tech Agency
Sia l'EGA sia le PDD richiedono
trattamenti in camera iperbarica.
La camera iperbarica è un'ambiente
confinato in grado di aumentare la
pressione dell'aria al suo interno e
di ospitare una o più persone. In
questo modo è possibile sottoporre
ad un trattamento iperbarico (che
prevede la respirazione di Ossigeno
puro ad alte pressioni) subacquei
colpiti da PDD o EGA. La terapia
iperbarica è la più efficace per il
trattamento di patologie derivanti
da attività subacquee.
102
Istituto Iperbarico di Zingonia (BG)
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Lo stress è una condizione emotiva che p
può influenzare di molto
l'andamento di un'immersione. Aldilà
dell'accezione che questo termine ha
nella
contemporaneità,
la
sua
conoscenza
e
la
sua
gestione
rappresentano un fattore di importanza
fondamentale nella gestione della
sicurezza in acqua.
Di solito il termine stress si usa per
indicare una condizione nella quale non
ci sentiamo a nostro agio; la sua azione
è applicabile a tutte le manifestazioni
della nostra vita, anche se i significati che
h assume neii varii contesti
t ti sono
abbastanza diversi.
É bene precisare che nella subacquea lo stress non è sempre qualcosa di
negativo: esiste infatti una fase iniziale dello stress, quando il suo livello
è basso e sotto controllo, che facilita la concentrazione e l’applicazione
verso un compito da svolgere. In buona sostanza questo stresso positivo
è un’energia attiva che ci tiene in stato di vigilanza.
In ambiente subacqueo quando il livello di stress aumenta ben oltre questa
soglia di positività, il suo effetto benefico si annulla fino a sviluppare
proprio l'effetto contrario, ovvero incapacità a risolvere anche compiti
molto semplici.
Le più comuni cause di stress sono:
• Cause fisiche dovute alla fatica;
• Cause
dovute
all'equipaggiamento
malfunzionante
che
impongono manovre di emergenza;
• Cause ambientali come il freddo, la scarsa visibilità, il buio, il moto
ondoso;
• Cause psicologiche dovute al ritenere un compito eccessivo per le
nostre capacità del momento;
• Mancanza di capacità tecniche e livello di preparazione
inadeguato a svolgere un determinato compito.
Le cause di tipo interno (ovvero gli ultimi due punti in elenco) sono
quelle più pericolose perché rendono di fatto il subacqueo maldestro o
addirittura incapace a svolgere un compito preciso. La somma di queste
due condizioni, ovvero quando si è insistito ad eseguire un'azione ritenuta
eccessiva e nel contempo emerge un circostanza critica verso la quale
si è impreparati, rendono il quadro molto serio e soltanto un adeguato
intervento del compagno può fare la differenza.
I tipici esempi di incidenti subacquei scaturiti a seguito del verificarsi in
simultanea di ambedue le condizioni sopra descritte sono quelli che,
puntualmente ogni anno, si verificano in grotta.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
103
Modulo 3
3.8 Lo stress
Pure Tech Agency
Le immersioni in grotta, benché emozionanti e ricche di fascino, richiedono
una preparazione completamente diversa da quella conseguibile in un
normale corso di immersione ricreativa. Inoltre gli ambienti ostruiti possono
provocare forti sensazioni di disagio per cui al minimo problema lo stress
sale a mille ed il malcapitato non è più in grado di risolvere i compiti che la
situazione richiede. L'esito è quasi sempre tragico.
Modulo 3
Non immergerti mai in grotta o in altro ambiente ostruito senza una
adeguata preparazione al riguardo. Rifiutati di entrare in una grotta se hai
dei dubbi sull'adeguatezza della pianificazione dell'immersione che prevede la
penetrazione
Le cause di tipo "esterno", le prime 3 in elenco, sono tutte condizioni
maggiormente risolvibili purché non si permetta allo stress di salire
eccessivamente di intensità. Ripensiamo criticamente alla luce di quanto
appreso in questo paragrafo all'esempio dell'erogatore malfunzionante
descritto nel paragrafo precedente.
Conoscere le cause che possono portare allo stress significa avere uno
strumento per disattivare la catena di eventi che portano una situazione ad
essere incontrollabile. Infatti non è mai un solo fattore stressante a causare
un incidente, bensì una serie di concause.
Si è già detto come l'estrema piacevolezza delle immersioni rischi di
assopire il livello di attenzione del subacqueo; ebbene se questo
benessere viene interrotto bruscamente per un evento improvviso il rischio
è trovarsi impreparati proprio perché si hanno le difese abbassate.
L'effetto più evidente quando un alto livello di stress ci coglie impreparati
è l'affanno. Lo stress può produrre affanno, l'affanno produce stress e via
il cane che si morde la coda: compiti facili diventano difficili. Si dice che la
calma è la virtù dei forti, noi possiamo aggiungere che "la calma è anche la
virtù migliore del subacqueo".
In situazioni estreme, che difficilmente possono verificarsi a questo livello
di apprendimento, la fase ascendente dello stress può raggiungere livelli
talmente alti di apprensione da sfociare in panico. Questo momento
finale, nell’evoluzione dello stress, rappresenta il limite critico di
gestione dell’immersione, raggiunto il quale le proprie facoltà d’azione e
reazione vengono del tutto compromesse e sfuggono al nostro controllo;
più realisticamente, potremmo affermare che non esiste più un "nostro
controllo".
Il panico si può manifestare sia con azioni scoordinate, sia con passività
assoluta; in entrambi i casi, la perdita totale di controllo in immersione ti
espone a rischi seri. In questo stato controllare l’incontrollabile istinto a
risalire velocissimamente in superficie è molto difficile!
104
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
AFFANNO - STRESS - PANICO
Non è solo un evento stressante a causare un incidente, ma il concatenarsi di più fattori stressanti che, se non
riconosciuti e risolti, espongono al possibile incidente.
Riprendiamo alcuni aspetti riguardanti la prevenzione e rimedi dell'affanno.
Nel caso ci si trovi in una condizione di affanno in immersione, occorre:
• Sospendere ogni attività
• Respirare profondamente curando particolarmente l’espirazione
e riposare.
L’affanno può presentarsi anche in superficie: in questo caso occorre
stabilire prima possibile un galleggiamento positivo gonfiando il GAV,
chiedere assistenza al proprio compagno d’immersione e valutare se sia
necessario persino sganciare e abbandonare la zavorra.
Insistere con uno sforzo controcorrente mentre si vede la barca appoggio
allontanarsi sempre di più genera un certo stress ed affanno. Meglio valutare
se non sia il caso di smettere di pinneggiare, assicurarsi un buon assetto
positivo e segnalare opportunamente la propria condizione agli occupanti della
barca
Prevenire l’Affanno significa ridurre un fattore di rischio. É Per questa
ragione che bisogna incominciare l'immersione sempre in uno stato di
calma vigile.
Utilizzando un corretto sistema di coppia (vedremo in seguito di cosa si
tratta) unito ad una sana consapevolezza dei propri limiti, ad un buon
allenamento, ad un corretto equilibrio idrostatico, ad una respirazione
tranquilla si rende l’immersione ancora più sicura. Questa è la ricetta giusta
per tutte le immersioni.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
105
Modulo 3
Un trittico esplosivo!
Pure Tech Agency
Gestione dello stress
Sullo stress, sebbene sia un tema di approfondimento di corsi successivi,
è importante sapere fin da un suo aspetto fondamentale: esso è gestibile
proprio come un qualunque altro aspetto dell'immersione ed in quanto tale
si può imparare a mantenerlo sotto controllo e ben entro la sua soglia di
positività.
Modulo 3
Il vecchio detto "Prevenire è meglio che curare", insegna: non si deve mai
esporsi a livelli di tensione che eccedono il nostro livello di preparazione.
Per fare questo, occorre quindi allenarsi a valutare lo stress presente in noi
nelle varie situazioni, nei nostri compagni e, soprattutto, riuscire a capire
i propri limiti. Alla luce di quanto appreso e discusso fin qui con il tuo
Istruttore, le due regole esposte nel paragrafo precedente ("riconoscimento
dei problemi") assumono un significato ancora più indiscutibile.
Se raggiungere un punto di immersione comporta un impegnativo percorso
di avvicinamento a nuoto, prima di incominciare l'immersione è importante
rilassare il ritmo respiratorio e solo successivamente iniziare la discesa
106
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Verifica dell'apprendimento
inserisci le parole mancanti
Più
il
subacqueo
.............................
nell’organismo
si
spinge
in
vi rimane, più
.............................
e
più
azoto si .............................
Un subacqueo inizia ad assorbire azoto nell’istante in cui
............................. .............................. Questa fase di assorbimento di
fatto termina allorquando si .............................
Respirare azoto ad alte pressioni può provocare un ............................. o
............................. delle capacità percettive di un individuo
Quasi tutti gli incidenti che avvengono sott’acqua sono imputabili al .......
.............................................. di addestramento oppure il ritenere che
le cose che si apprendono non hanno un ............................. ma soltanto
indicativo
Tale aumento può causare la rottura degli .............................
provocando il passaggio di quest’aria nella cavità pleurica con conseguente
............................. (pneumotorace)
L’embolia gassosa arteriosa è una ........................................ a cui
può andare incontro un subacqueo. Essa si manifesta a seguito di
sconfinamento di bolle di aria all’interno della ......................................
dai polmoni
In ambiente subacqueo quando il livello di ............................. aumenta
ben oltre questa soglia di positività, il suo effetto benefico si ...................
fino a sviluppare proprio l’effetto contrario, ovvero ................... a
................... anche compiti molto semplici
L’affanno può presentarsi anche in ...................: in questo caso occorre
stabilire prima possibile un ........................... gonfiando il GAV, chiedere
................... al proprio compagno d’immersione e valutare se sia
necessario persino ................... e ................... la zavorra
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
107
Modulo 3
Il termine “Patologia Da Decompressione” identifica la formazione di .........
.................................... e nei vasi sanguigni
Modulo 3
Pure Tech Agency
108
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Modulo 4
MODULO 4
Tabelle di immersione e
Computer subacquei
Panoramica
• Pianificazione dell'immersione: Tabelle
• Pianificazione dell'immersione: Computer subacqueo
Obiettivi
Al termine di questo modulo avremo appreso:
•
•
•
La conoscenza delle tabelle di immersione
La conoscenza del computer di immersione
Come pianificare un'immersione utilizzando le tabelle e i computer di
immersione
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
109
Pure Tech Agency
4.1 Pianificazione dell'Immersione: Tabelle
Profondità e tempo sono i parametri principali di una immersione. Entrambi
vengono monitorati per mezzo di profondimetro e timer.
Questo però non ci solleva dalla responsabilità di programmare in anticipo
lo svolgimento dell'immersione che ci accingiamo a fare. Prima di ogni
immersione è quindi necessario porsi le seguenti domande:
• quanto profondo mi spingerò?
• per quanto tempo?
É ormai chiaro che per portare a termine un’immersione in modo corretto
si deve consentire all’azoto accumulato nei tessuti per effetto dell'aumento
di pressione, di uscire dal nostro organismo senza produrre bolle di
dimensioni o quantità tali da provocare una malattia da decompressione.
Per ottenere questo bisogna attenersi a due regole fondamentali:
1.
Modulo 4
2.
Rispettare la velocità di risalita per permettere ai tessuti,
tramite il sangue, di liberarsi dall’azoto con la semplice
respirazione.
Effettuare una sosta di sicurezza, ovvero una pausa dalla
risalita, di almeno 3 minuti a 5 metri di profondità. Dai 5 metri
alla superficie è opportuno risalire in un minuto e comunque
non meno di 30 secondi.
Il corso sommozzatore P1 della CMAS abilita ad effettuare immersioni entro
la curva di non decompressione. Durante lo svolgimento di questo corso
vengono trattati solo casi di immersioni effettuate rispettando i limiti di non
decompressione.
Ovviamente queste due regole da sole non bastano: bisogna infatti dare al
subacqueo la possibilità di stabilire con certezza se esso si trovi, durante
lo svolgersi di una immersione, all'interno oppure all'esterno della curva di
non decompressione.
Nel corso degli anni sono state quindi sviluppate delle tabelle di immersione
che forniscono i dati grazie ai quali ogni subacqueo è in grado di stabile in
quale “posizione decompressiva” esso si trovi in ogni istante dell'immersione.
Le tabelle da immersione altro non sono che un prospetto di
informazioni numeriche, ovvero un tabulato in cui sono corelati a dei
valori di profondità i relativi tempi i permanenza entro i quali il subacqueo
deve attenersi per rimanere all'interno della curva di non decompressione.
Le tabelle forniscono anche i dati per eseguire una corretta decompressione
nel caso in cui si uscisse erroneamente dalla curva di non decompressione
(così come spiegato nel paragrafo 3.3) e non solo.
Le prime tabelle, di cui si ha avuto la disponibilità , sono state quelle
della US Navy (Marina Militare degli Stati Uniti) pubblicate da John Scott
Haldane, Arthur Boycott e Guybon Damant nel 1912.
110
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Le tabelle, nate inizialmente per esigenze militari, sino alla metà degli anni
ottanta, hanno rappresentato l’unico supporto a disposizione dei subacquei
sportivi, ovviamente con alcuni limiti a causa del diverso scopo di utilizzo a
cui erano stati elaborati e destinati.
Successivamente, con il crescente interesse della industria petrolifera ricerca scientifica - lavori subacquei e delle associazioni didattiche, sono
state elaborate anche altre tabelle, eccone alcuni esempi:
Su questi nuovi studi all'inizio degli anni novanta hanno fatto la loro
comparsa sul mercato i primi computer subacquei che semplificano la
gestione delle immersioni sportive. Non bisogna dimenticare che essendo
apparecchi elettronici, possono essere soggetti a guasti e quindi si deve
sempre avere con sè orologio, profondimetro e tabelle.
Tuttavia, le tabelle che a tutt’oggi rappresentano il maggior riferimento a
livello mondiale sono quelle della Marina Militare Americana, le cosiddette
tabelle “U.S. Navy”. Il 14 aprile 2008 la U.S. Navy ha pubblicato la revisione
del U.S. Navy Diving Manual, rivedendo le procedure d’immersione che la
U.S. Navy adottava dal 1956 con successive modifiche (rev. 4 nel 1999
–Rev. 5 nel 2005).
CMAS-PTA adotta le Tabelle per Immersioni in aria della US NAVY, pubblicate
nel U.S. Navy Diving Manual Rev. 6 (aprile 2008)
Una tabella di decompressione può, e deve, essere usata anche per
poter programmare le immersioni subacquee; ovvero per prevedere quali
saranno gli obblighi decompressivi oppure i parametri massimi (profondità
e tempo) grazie ai quali non uscire dalla curva di non decompressione.
Non solo, le tabelle forniscono l'indicazione di quale sarà l'eccesso di azoto
all'interno dei nostri tessuti alla fine di un immersione. Questo eccesso è
chiamato azoto residuo e viene quantificato correttamente grazie a dei
coefficienti alfabetici definiti coefficiente di azoto residuo oppure gruppo di
appartenenza.
Le tabelle disponibili oggi nei corsi ricreativi di primo livello sono state
elaborate in modo tale da garantire ampi margini di sicurezza a chi le
utilizza. Le indicazioni che in esse vengono fornite riguardo le immersioni
fuori curva sono, a questo stadio di apprendimento, minime. Le attrezzature
e la configurazione a cui questo corso abilita non sono adeguate per
affrontare immersioni fuori dalla curva di non decompressione.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
111
Modulo 4
• Tabelle Bühlmann (redatte dal Dott. Albert Bühlmann, ricercatore
nell'ambito della teoria della decompressione al Laboratory of
Hyperbaric Physiology dell'Ospedale Universitario di Zurigo. Il frutto
dei sui studi fu riportato in un libro che venne considerato come il più
completo saggio sulla malattia da decompressione
• DCIEM (Istituto Civile del Canada di Medicina Ambientale)
• Royal Navy/BSAC (British Scuba Aqua Club)
• GERS (Gruppo Studi e Ricerche Marina Francese)
Pure Tech Agency
Le tabelle sono disponibili sia in forma cartacea sia stampate su
supporti plastici in modo tale da essere portate sott'acqua. LA possibilità
di consultare le tabelle sott'acqua non ci solleva dalla necessità di
programmare sempre prima ogni immersione.
Modulo 4
Le Tabelle di immersione sono indispensabili per una corretta e sicura gestione
dell’immersione; tuttavia è bene tenere presente che lievi fenomeni di Malattia
Da Decompressione (MDD) possono verificarsi anche rispettando i limiti imposti
da esse. Nessuna Tabella può eliminare una eventuale possibilità di incorrere
in una MDD! Le Tabelle della US NAVY sono valide per immersioni in aria e a
livello del mare.
Prima di proseguire con l'apprendimento è opportuno familiarizzare con la
seguente terminologia:
Tempo di Discesa
É il tempo trascorso da quando un subacqueo lascia la superficie sino a
quando raggiunge il fondo
Tempo di Fondo
É il tempo che un subacqueo trascorre da quando lascia la superficie sino a
quando si stacca dal fondo per iniziare la risalita sino alla sosta di sicurezza
o alla prima tappa di decompressione (quando certificato per questa
tipologia d’immersione)
Tempo Totale di Risalita (o decompressione)
É il tempo che trascorre dal momento che un subacqueo stacca dal fondo
sino a quando non raggiunge la superficie
Tempo Totale d’Immersione
É il tempo che un subacqueo trascorre in immersione, considerando il
tempo di discesa più il tempo di fondo e il tempo totale di risalita
Profondità Massima
É la profondità massima (rilevata dallo strumento) che un subacqueo
raggiunge durante la sua immersione.
112
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Questa profondità serve per poter utilizzare le tabelle, a prescindere dal
tempo che effettivamente viene trascorso solo sul fondo
Immersione Quadra
Viene considerata tale, un’immersione il cui tempo di fondo viene trascorso
tutto alla massima profondità
Immersione Multilivello
Viene considerata tale un’immersione nella quale un subacqueo trascorre
parte del tempo totale d’immersione alla profondità massima e parte a
profondità inferiori. Per poter utilizzare le tabelle, in queste immersioni, si
deve considerare come se il tempo totale d’immersione sia stato trascorso
sempre alla profondità massima
Tempo Limite di Non Decompressione
É il tempo massimo di fondo che un subacqueo può trascorrere ad una
certa profondità, senza avere l’obbligo, in risalita, di dover effettuare delle
soste di decompressione obbligatorie.
Nelle tabelle questo tempo limite viene raffigurata da una linea creata da
una seri di valori evidenziati con colori diversi
Immersione in Curva di Sicurezza/Non decompressione
É un’immersione che non obbliga un subacqueo a dover effettuare delle
soste di decompressione obbligatorie in risalita, ad esclusione della Sosta di
sicurezza (consigliata), Ogni profondità ha una suo limite di tempo di fondo
Immersione fuori Curva di Sicurezza o Con decompressione
É un’immersione che obbliga un subacqueo ad effettuare, in risalita, delle
tappe (soste) obbligatorie
Ogni profondità richiederà determinate soste e tempi precisi, in funzione
del tempo di fondo trascorso alla massima profondità
Intervallo di Superficie
É il tempo che un subacqueo, dopo aver effettuato una prima immersione,
trascorre in superficie prima di effettuare ulteriori immersioni consecutive.
Il tempo dell’intervallo di superficie inizia quando un subacqueo riemerge al
termine della prima immersione e termina non appena lascia la superficie
nell’immersione consecutiva
Azoto Residuo
É la quantità di Azoto in eccesso che rimane disciolto nei tessuti di un
subacqueo al termine della propria immersione. Durante l’intervallo in
superficie, tale quantità di Azoto viene eliminata, pertanto tanto maggiore
è l’intervallo di superficie, tanto maggiore sarà la sua quantità eliminata.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
113
Modulo 4
Tappa (sosta) di Decompressione
É la profondità (quota) alla quale un subacqueo, in risalita, deve
effettuare una sosta obbligatoria per un determinato tempo (tempo di
decompressione) prima di poter riemergere
Pure Tech Agency
Se vengono effettuate immersioni consecutive, la quantità di Azoto
residua deve essere considerata ai fini di una corretta pianificazione di
un’immersione
Gruppo di Appartenenza (G.A.)
É una lettera (per altre tabelle può essere anche un numero) che
viene utilizzata per indicare la quantità di Azoto che rimane disciolta
nell’organismo di un subacqueo al termine di un’immersione
Tempo di Azoto Residuo
É un determinato tempo, indicato da una tabella, che deve essere aggiunto
al tempo di fondo in una successiva immersione. La somma del tempo di
fondo effettivo e il Tempo di Azoto Residuo, determina il tempo totale da
consultare nelle tabelle per il calcolo della durata dell’immersione (sempre
in curva di sicurezza). Va tenuto ben presente che il tempo da trascorre
effettivamente sul fondo, non deve prevedere anche il tempo di Azoto
Residuo
Modulo 4
Immersione singola
É la prima immersione della giornata, oppure un’immersione effettuata
solo dopo che tutto l’Azoto Residuo, di una precedente immersione, è stato
completamente eliminato dall’organismo
Immersione Ripetitiva
É un’immersione che viene effettuata quando, non tutto l’Azoto
accumulato in una prima immersione non è stato completamente eliminato
dall’organismo
Quando parliamo di Tabelle per immersione, prendiamo in considerazioni
tre tabelle specifiche:
A.
B.
C.
Tabella 1 per Immersioni Senza Decompressione (limiti di
non decompressione - in curva di sicurezza e designazione gruppo
residuo d’Azoto)
Tabella 2 intervallo di superficie (tra termine immersione e inizio
della successiva)
Tabella 3 immersione ripetitiva (tempo da aggiungere all’immersione
successiva)
Vi è una quarta tabella, per immersioni con decompressione, ma questa
tecnica d’immersione esula dal livello di apprendimento e di addestramento
a cui si rivolge questo corso. Si rimanda la loro conoscenza ed applicazione
a successivi e specifici corsi PTA.
Prima di vedere da vicino le tabelle, apprendiamo, quelle che sono
considerate delle Regole Generali di Utilizzo:
Velocità di Discesa
La velocità di discesa al fondo deve essere inferiore o uguale a 23 metri
al minuto
114
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Velocità di Risalita
La velocità di risalita deve essere non superiore a 9 metri al minuto.
Secondo U.S. NAVY Manual Rev 6.0, sono permessi rallentamenti
occasionali, se eseguiti mai al disotto dei 6 metri al minuto ed accelerazioni,
occasionali, ma mai oltre i 12 metri al minuto
Modalità di Decompressione
PTA-CMAS raccomanda che le immersioni di questo corso siano pianificate
ed eseguite in curva di non decompressione ed utilizzando aria come
miscela di gas respiratorio. Le tabelle pubblicate in questo manuale sono
orientate esclusivamente per pianificare ed eseguire immersioni in curva
di sicurezza. Per effettuare immersioni diverse, per modalità e uso di gas
diversi dall’Aria, si rimanda ai Corsi specifici PTA.
Immersioni ripetitive
Si considera come immersione ripetitiva, un’immersione eseguita entro
un intervallo inferiore o uguale al valore contrassegnato con un asterisco
nella specifica tabella: Tabella 2 Gruppi di Appartenenza e Intervallo di
Superficie
Rispetto alle precedenti versioni delle Tabelle U.N. NAVY, e ad altre differenti
tabelle, l’intervallo in superficie, per considerare un’immersione ripetitiva, non
è più previsto se costante o pari a 12 ore, ma deve rientrare nel Gruppo di
Appartenenza all’inizio dell’intervallo di superficie e può variare da un minimo
di 2 ore e 20 minuti (2:20) ad un massimo di 15 ore e 50 minuti (15:50)
NOTA GENERALE
Non devono essere eseguite immersioni fuori curva di sicurezza se non
adeguatamente addestrati e certificati.
Le tabelle U.S. NAVY, adottate da PTA-CMAS, sono il risultato di lunghi anni di
studi e sperimentazioni e sono supportate da una poderosa opera documentale
affinché siano utilizzate al meglio delle loro possibilità. Ovviamente per i corsi
ricreativi si deve fare un estrema sintesi di questa opera in maniera tale da
adattare le tabelle alle esigenze di un subacqueo sportivo.
Alcuni fattori ambientali possono influire sull'efficacia di queste tabelle. Nella
tabella seguente sono elencati alcuni di questi fattori “aggravanti” con le
relative contromisure da adottare per mantenere un elevato livello di sicurezza
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
115
Modulo 4
Un eventuale superamento, non previsto, della curva di non decompressione
durante un’immersione in curva di sicurezza, deve essere considerato come
una misura eccezionale, da utilizzare solo in situazioni di emergenza dove vi
siano stati eventi che non sono stai precedentemente pianificati.
Pure Tech Agency
Freddo
Corrente
Visibilità
Variabili fisiologiche,
psico/fisiche personali
Età
Disidratazione
Assicurarsi una adeguata protezione termica
Non insistere con lo sforzo fisico
Privilegiare condizioni ambientali ideali
Controllo medico periodico
Utilizzare le tabelle in modo conservativo
Mantenersi adeguatamente idratati
L’uso delle Tabelle U.S. NAVY Rev 6.0 cosi come adottate da PTACMAS, non escludono, da parte di un subacqueo, un comportamento
prudenziale come qui di seguito elencato:
Modulo 4
-
-
116
Rispettare sempre i limiti di brevetto
Rispettare quanto è stato precedentemente pianificato
Non immergersi se non si è in perfette condizioni psico/fisiche
Non immergersi mai al limite della curva di sicurezza
Se in presenza di fattori di rischio (freddo, stress, fatica, ecc) deve
essere utilizzato il tempo di tabella successivo a quello che effettivo
di permanenza che è stato pianificato
In forma cautelativa, effettuare eventuali arrotondamenti di calcolo
Non superare la velocità massima di discesa
Rispettare la velocità di risalita
Rispettare la sosta di sicurezza
Arrivare alla massima profondità all’inizio dell’immersione e non al
termine
Non effettuare immersioni a “YO.YO”
Aspettare almeno 2 ore tra la prima immersione e quella successiva
Rimanere immersi per almeno 15 minuti in un’immersione ripetitiva
Un’immersione ripetitiva, la profondità non deve essere superiore a
quella della precedente
Non esagerare con immersioni ripetitive per più giorni (ad esempio
crociere subacquee), è consigliato interrompere almeno con una
sosta di riposo e preferire l’utilizzo di miscele iperossigenate (Nitrox)
se adeguatamente addestrati e certificati (Nitrox Diver PTA)
Non effettuare immersioni in apnea dopo averne effettuate altre con
autorespiratore nell’arco delle 24 ore
Non effettuare sforzi fisici intensi entro le 24 ore dopo un'immersione
con autorespiratore
Non salire in altitudine e effettuare voli in aereo se non sono
trascorse almeno 12 ore (consigliate 24 se immersioni ripetitive)
dall’ultima immersione
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
E ora vediamo insieme le tabelle:
A.
Tabella 1 per immersioni senza decompressione (limiti di
non decompressione - in curva di sicurezza e designazione Gruppo
Appartenenza (residuo d’Azoto)
Profondità (prima colonna)
La profondità dell’immersione è il punto più profondo raggiunto. Le
profondità non sempre calcolate in media, ad esempio se ti immergi a 18
metri per 30 minuti, l’immersione deve essere calcolata come se effettuata
a 18 metri per 33 minuti.
Per un corretto uso delle tabelle, se la tua immersione non ha un valore
esatto, si deve sempre calcolare per eccesso.
immersione a 13 metri > 15 metri … 16 metri > 18 metri…
Arrotonda per eccesso
Limiti tempo di non decompressione
Il tempo massimo di sosta ad una data profondità senza dover effettuare
soste obbligatorie. Cosi come nel calcolo delle profondità, la regola di
arrotondare al valore successivo deve essere fatto anche per la durata.
15 metri per 92 minuti > 18 metri per 60 minuti
É importante tenere presente che i tempi sono quelli cui si riferisce il tempo
massimo. Questo tuttavia, non si limita ad indicare il tempo trascorso sul
fondo (tempo di fondo). Al contrario, il tempo massimo è misurato da
quando il subacqueo si "stacca" dalla superficie a quando inizia la risalita.
Se durante questa fase si ferma per qualche minuto, il tempo trascorso ad
una quota superiore deve essere aggiunto al tempo massimo.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
117
Modulo 4
La prima tabella più comunemente usata è la Tabelle per immersioni senza
decompressione. Questa si limita a fornire dati tempo/profondità per
consentire al subacqueo di rimare ad una data profondità per poi risalire in
superficie senza dover effettuare delle fermate obbligatorie (ad esclusione
di una fermata che noi indicheremo come Sosta di Sicurezza).
Nella prima riga ORIZZONTALE- sono indicate le varie profondità. Nelle
righe successive VERTICALE sono indicati, in corrispondenza di ogni
profondità, i possibili tempi di immersione, gli ultimi numeri, quelli in
riquadro/grassetto (giallo), sono il limite della Curva di Sicurezza a patto
che non si facciano successive immersioni.
Pure Tech Agency
Modulo 4
18 metri > 2 minuti tempo
di discesa sul fondo + 20
minuti tempo di fondo in
risalita, alla quota di 15
metri sosta di 5 minuti..
il tempo massimo totale
sarà di 27 minuti; quindi
l’immersione che questo
subacqueo dovrà calcolare
sarà per un tempo di fondo
di 28 minuti a 18 metri
Effettuata questa prima immersione, se non effettui altre immersioni
nell’arco delle 24 ore, la prossima immersione dovrà essere eseguita con le
modalità appena descritte.
Nel caso in cui il subacqueo decidesse di effettuare immersioni successive,
avrà bisogno di effettuare ulteriori calcoli.
La procedura non è complessa. Una volta terminata la prima immersione,
come già abbiamo appreso, nel nostro corpo resta sempre una certa
quantità d’Azoto residuo. Sebbene tale residuo sia ad un livello tale da
non causare problemi, esso ridurrà il tempo che si può trascorrere nella
immersione successiva.
La terza parte della tabella, quella appunto relativa alla designazione del
Gruppo Ripetitivo per immersioni, assegna una lettera dell’alfabeto, basata
sulla profondità e il tempo d’immersione. I gruppi di lettere nella tabella
indicano le quantità crescenti d’Azoto residuo, ad esempio un subacqueo
del gruppo A ha meno Azoto residuo di un subacqueo del gruppo E, e cosi
di seguito. Questa quantità d’Azoto diminuisce col trascorrere del tempo,
quindi più passa il tempo dal termine dell’immersione e più il gruppo
d’appartenenza si avvicina alla lettera A.
118
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Altre tabelle diverse da quelle US NAVY, indicano il Residuo d’Azoto con
valori numerici invece che con delle lettere.
Procedura
Si suppone di programmare la prima immersione a 15 metri con risalita
dopo aver trascorso un tempo di fondo di 50 minuti. Per trovare la
designazione del Gruppo d’Azoto Residuo se deve seguire quanto segue:
1.
2.
3.
Trovare la Profondità (15 metri)
Seguire la tabella per trovare il Tempo Massimo (50 minuti)
Segui la riga sino a trovare la designazione del Gruppo Azoto
Residuo (G)
Modulo 4
Supponendo di fare un seconda immersione è di fondamentale importanza
determinare il gruppo d’appartenenza perché è il primo dato da utilizzare.
A questo punto si deve passare alla Tabella 2 intervallo di superficie.
Essa adatta la quantità d’Azoto che il corpo rilascia in superficie e calcola
l’Azoto che rimane in circolo all’inizio dell’immersione successiva fornendo
in più il Tempo Massimo di permanenza.
Per utilizzare la tabella 2 l'intervallo di superficie, tra due immersioni deve
essere almeno di 10 minuti; se è inferiore l'immersione successiva deve essere
considerata come la proseguzione di quella precedente. In questo caso, ai
fini del calcolo dell'immersione, il tempo è dato dalla somma dei due tempi di
fondo con l'aggiunta (cautelativa) del tempo trascorso in superficie. Si consiglia
un intervallo di superficie di almeno 2 ore tra due immersioni successive.
Al termine della prima
d’appartenenza è E.
immersione
la
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
designazione
del
gruppo
119
Pure Tech Agency
Modulo 4
Passando alla tabella 2, partendo dalla lettera E si scende verso il
basso fino a trovare l’intervallo di tempo che si vuole trascorrere prima
della seconda immersione (1:45 - 2:39). A questo punto proseguendo
orizzontalmente verso destra troveremo la lettera C, che fornisce la nuova
designazione di gruppo ripetitivo, vale a dire la quantità d’Azoto in eccesso
rimasto nel corpo dopo la prima immersione e il successivo intervallo in
superficie. Questa è la designazione utile per il calcolo del tempo di non
decompressione per l’ulteriore immersione.
Passando nella tabella successiva, troviamo l’elenco dei tempi d’Azoto
residuo con le penalità ed i tempi massimi di permanenza per l’immersione
seguente.
Si suppone di programmare un’ulteriore immersione a 15 metri. Partendo
dalla lettera C, muovendosi lateralmente verso destra ed incrociando con la
relativa linea dei tempi appartenenti alla profondità stabilita, si noterà un
tempo di penalità (maggiorazione) di 23 minuti (tempo da aggiungere alla
permanenza effettiva) e avremo anche indicato il tempo residuo in curva di
sicurezza (69 minuti).
In pratica si dovranno eseguire i calcoli come se la seconda immersione
fosse più lunga di quella programmata, mentre in pratica sarà quella
effettivamente decisa.
Le immersioni effettuate dopo un intervallo di superficie superiore a quello
identificato da un asterisco non devono essere considerate ripetitive.
Pianifica sempre immersioni in Curva di Non Decompressione, in caso di
dubbio, riduci la profondità, aumenta l’intervallo in superficie e abbrevia il
tempo massimo. Infine effettua sempre una Sosta di Sicurezza.
120
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
4.2 Pianificazione dell'Immersione:
Computer subacqueo
Un computer subacqueo è uno strumento in grado di
misurare vari parametri durante un'immersione
subacquea. Questi parametri, che comprendono
soprattutto il tempo e la profondità, vengono elaborati
in tempo reale al fine di indicare al subacqueo le
indicazioni per una corretta risalita e le eventuali tappe di
decompressione. I computer subacquei se ben gestiti
sono in grado di ridurre i rischi di incorrere in una
Malattia Da Decompressione.
I riferimenti ad immersione con decompressione, presenti in questo testo,
devono essere interpretati a solo uso didattico culturale, in quanto il brevetto
P1 CMAS-PTA non abilita ad effettuare tali immersioni!
I computer subacquei misurano profondità e tempo ed assolvono allo
stesso compito delle tabelle subacquee, ma a differenza di queste sono
ovviamente in grado di eseguire dei calcoli. Essi sono in grado di calcolare
in tempo reale, ovvero istante per istante della propria immersione,
l'assorbimento di azoto dei tessuti. Ovviamente questo calcolo non
è un dato reale, bensì una simulazione che dipende dal tipo di calcolo
(algoritmo) con il quale il computer è stato programmato.
Essi informano il sub di un eventuale eccessiva velocità nella risalita, del
superamento della curva di non decompressione e forniscono i dati di
decompressione nel caso si esca dalla curva di sicurezza. Alcuni forniscono
anche altre informazioni quali ad esempio la temperatura dell'acqua, la
pressione del gas all'interno della bombola e quindi il consumo medio del
subacqueo.
Storia
Il primo dispositivo subacqueo analogico, in grado di fornire indicazioni
sulla decompressione, detto decompressimetro, venne commercializzato
verso gli anni 70. Il suo funzionamento era piuttosto semplice: la pressione
di una camera
d'aria riempita di gas (incapsulata all'interno di un piccolo alloggiamento)
era regolata tramite una membrana di ceramica porosa che simulava i
tessuti. L'aumento di pressione nella camera faceva muovere una lancetta
che, in funzione del quantitativo di gas assornito, indicava una serie
limitata di tappe decompressive. Meno male che non è più in commercio!
Funzionamento
I computer subacquei moderni non sono altro che computer a batteria
racchiusi da un guscio stagno. Questi monitorizzano costantemente il
profilo d'immersione, considerando il tempo e la pressione.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
121
Modulo 4
Scopo
Pure Tech Agency
I computer utilizzano poi il profilo e un algoritmo di decompressione per
stimare la pressione parziale dei gas inerti che devono essere espulsi
dai tessuti. Basandosi su questi calcoli, il computer stima l'eventualità
di una risalita diretta o, piuttosto, di una salita con una o più tappe di
decompressione.
L'algoritmo di calcolo dei computer subacquei, altrimenti detto algoritmo
decompressivo, è una procedura matematica grazie alla quale il computer
è in grado di calcolare l'assorbimento teorico di azoto dei tessuti istante per
istante.
Tra i più comuni modelli di algoritmi adottati dai vari computer sul mercato
vi sono:
• Algoritmo Bhulmann
• Algoritmo di derivazione Haldaniano
(dal quale nelle forme più moderne derivano le tabelle US-Navy)
• VPM
• RGBM
Modulo 4
Non è possibile stabilire se esiste uno migliore di un altro. Tutti
interpretano i dati di profondità e tempo secondo un proprio modello
scientifico di assorbimento dell'azoto.
La maggior parte dei computer è in gradi di prevedere un profilo sicuro
anche in caso di immersioni in altitudine, che necessitano di una risalita
più lenta che a livello del mare, dato che viene misurata la pressione
atmosferica prima dell'immersione.
Le immersioni in quota richiedono informazioni ed addestramento specifico, che
non sono contemplate nel corso P1 CMAS-PTA.
Inoltre, nel caso in cui il subacqueo debba effettuare un volo aereo, prima
o dopo un'immersione, il computer è in grado di monitorare il profilo
decompressivo in funzione della pressione ambiente in cui viene a trovarsi
il subacqueo.
Precauzioni
La semplicità d'uso dei computer subacquei ha, però, esposto i sub ad
altri rischi. Un uso disordinato di questo strumento, con poca o nessuna
pianificazione può portare il subacqueo a superare le proprie capacità e la
propria esperienza, mettendolo in situazioni difficili.
Molti di questi computer hanno molte opzioni, menù e svariati modi
operativi, che sono controllati spesso da un piccolo numero di bottoni
frontali o laterali; il subacqueo dovrebbe quindi impratichirsi nell'uso del
proprio computer con immersioni semplici e sicure prima di affrontarne di
più impegnative.
Per motivi di sicurezza anche nei manuali di istruzione viene raccomandato
di pianificare accuratamente l'immersione, nei limiti delle tabelle di
122
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
decompressione, in modo da aumentare il margine di sicurezza, e di
programmare ed effettuare comunque una sosta di sicurezza nel caso che
il computer non funzioni.
Un subacqueo che voglia ridurre al minimo il rischio di una malattia da
decompressione deve tener conto di molte norme precauzionali:
leggere le istruzioni fornite dalla ditta costruttrice
risalire rispettando la velocità imposta;
effettuare sempre una sosta precauzionale;
intervallare il più possibile le immersioni;
non effettuare immersioni yo-yo.
Modulo 4
•
•
•
•
•
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
123
Pure Tech Agency
Funzionalità
ll computer subacqueo nella foto, riporta i dati
simulati di un'immersione (12,8 metri di profondità
attuale, 14 minuti di immersione).
I computer subacquei moderni possono fornire
svariate informazioni attraverso un display LCD:
Modulo 4
• profondità;
• profondità massima raggiunta;
• tempo rimanente alla profondità corrente per
un'immersione senza tappe di decompressione;
• durata dell'immersione.
Altri modelli dispongono inoltre di altre informazioni:
• tempo richiesto per le tappe di decompressione;
• temperatura dell'acqua;
• velocità di risalita;
• profilo d'immersione (di solito non visualizzabile direttamente ma solo
dopo un collegamento con un personal computer);
• calcolo di immersioni consecutive;
• pressione del gas all'interno della bombola;
• gestione di miscele con aumentato quantitativo di ossigeno;
• stima del tempo rimanente in base al consumo medio.
Avvisi sonori e visivi
I computer subacquei possono essere anche dotati di segnali acustici e
visivi (luci) per avvisare il sub nel caso di:
•
•
•
•
124
velocità di risalita eccessiva;
tappe di decompressione mancate;
superamento della profondità massima;
superamento della soglia di tossicità dell'ossigeno
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Verifica dell'apprendimento
inserisci le parole mancanti
.......................... e .......................... sono i parametri principali di una
immersione. Entrambi vengono monitorati per mezzo di ..........................
e ..........................
Una tabella di decompressione può essere definita come uno strumento per
poter per .......................... delle ..........................
Immersione in Curva di Sicurezza/Non decompressione
É un’immersione che .......................... un subacqueo a dover effettuare
delle soste di decompressione .........................., ad esclusione della
Sosta di sicurezza (consigliata), Ogni profondità ha una suo limite di
..........................
Immersione singola
É .......................... immersione della giornata, oppure un’immersione
effettuata solo dopo che tutto .........................., di una precedente
immersione, è stato completamente eliminato dall’organismo
Immersione Ripetitiva
É un’immersione che viene effettuata quando,
.......................... in una prima immersione
completamente eliminato dall’organismo
..........................
..........................
Tabella 1 per Immersioni Senza Decompressione (...................................
............ - in curva di sicurezza e designazione gruppo residuo d’Azoto)
Tabella 2 intervallo di superficie (tra termine .......................... della
successiva)
Tabella
3
immersione
ripetitiva
(...........................................
all’immersione successiva)
Velocità di Discesa
La velocità di discesa al fondo deve essere inferiore o uguale a
.......................... al minuto
Velocità di Risalita
La velocità di risalita deve essere non superiore a .......................... al
minuto
Un computer subacqueo è uno strumento usato da un subacqueo per
misurare .......................... durante un’immersione subacquea, questi
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
125
Modulo 4
Tempo di Fondo
É il tempo che un subacqueo trascorre da quando ..........................
sino a quando si .......................... per iniziare la risalita sino alla sosta
di sicurezza o alla prima tappa di decompressione (quando certificato per
questa tipologia d’immersione)
Pure Tech Agency
parametri comprendono la .......................... e la .........................., dati
essenziali per poter calcolare i tempi per una risalita sicura riducendo i rischi
di incorrere in una Malattia Da Decompressione
Modulo 4
Per motivi di sicurezza anche nei manuali di istruzione viene
raccomandato di .......................... l’immersione, nei limiti delle tabelle
di decompressione, in modo da aumentare il .........................., e di
programmare ed effettuare comunque una .......................... nel caso che
il computer non funzioni
126
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Modulo 5
Pianificazione dell'Immersione
Panoramica
Sistema di coppia
Comunicazione Subacquea
Preparazione all'immersione
Pianificazione dell'immersione
Il consumo d'Aria
Controlli pre-immersioni
Aspetti generali e abilità di base
Modulo 5
•
•
•
•
•
•
•
Obiettivi
Al termine di questo modulo avremo appreso:
•
•
•
•
Il significato di sistema di coppia;
I segnali di comunicazione subacquea di base
L'importanza di una corretta pianificazione dell'immersione;
Le regole di base di comportamento nelle immersioni subacquee
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
127
Pure Tech Agency
Considerazioni generali
Un'immersione subacquea ricreativa non è un'attività faticosa, se si
esclude il trasporto dell'attrezzatura, bensì una pratica molto rilassante
e piacevole. Va da sé che non sono necessarie doti atletiche particolari
ma principalmente un buono stato di salute generale ed una buona
predisposizione verso l'ambiente acquatico. A dispetto di questa
facilità è necessario sia effettuare una visita medica di controllo del proprio
stato di salute ogni anno, sia saper rinunciare ad un'immersione quando ci
si trova in una delle seguenti condizioni:
Modulo 5
•
•
•
•
•
•
•
•
Stanchezza eccessiva
Eccessi alimentari o alcolici nelle 12 ore precedenti l'immersione
Digestione in corso
Debilitazione fisica dovuta all'uso di farmaci
Situazioni patologiche in corso (bronchiti, otiti, ecc.)
Avverse condizioni meteorologiche
Mancanza del compagno di immersione
Incertezza sulla qualità dell'attrezzatura in uso o mancanza di una FAA
Un'immersione subacquea dura generalmente meno di un ora, almeno la
parte che si svolge sott'acqua. Bisogna inoltre imparare ad eseguire ed
apprezzare sia la fase preparatoria sia la fase successiva all'immersione
nella quale, oltre a riporre l'attrezzatura in modo adeguato, si ripensa,
visualizza e discute dell'immersione appena conclusa. Soltanto in questo
modo si prolunga il piacere dell'immersione a tutte le fasi che ruotano
attorno ad essa. Programmare significa preparare un'immersione in modo
adeguato e sicuro. Ripensare a quello che si è fatto sott'acqua significa
certamente rivivere mentalmente le gioie provate sott'acqua, ma
soprattutto analizzare criticamente le
e p
proprie
op e a
azioni
o
pe
per co
continuare
t ua e a
migliorare come subacqueo e come
compagno di immersione.
Possiamo distinguere le fasi di
"avvicinamento" ad un'immersione
in due momenti successivi:
• Fase preparatoria nella quale
si organizza il raggiungimento
del luogo di immersione;
• Fase
di
pianificazione
dell'immersione subacquea.
Entrambe sono parti integranti
dell'attività subacquea, inscindibili
dall'immersione vera e propria.
Descriviamole nel dettaglio.
128
Open Water Diver
ve
er - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
5.1 Sistema di coppia
Le immersioni vanno sempre effettuata con un compagno in modo da
formare una coppia nel quale si è reciprocamente responsabili della
sicurezza, del divertimento e della mutua assistenza fuori e dentro l’acqua.
Questo sistema è primario per garantire la sicurezza nella pratica
subacquea ed uno dei presupposti su cui si basa è che è molto improbabile
che lo stesso problema possa capitare all'attrezzatura di entrambi i
subacquei contemporaneamente.
Inoltre il compagno può accorgersi in tempo del sopraggiungere dei limiti
di immersione programmati, oppure è in grado di vedere un problema,
come uno spandimento d'aria da una guarnizione, prima che se ne accorga
il soggetto coinvolto. Sono molteplici gli aspetti per i quali la presenza di un
compagno fa la differenza. Vediamone alcuni ruoli assunti dal compagno:
• Assiste durante la vestizione ed in acqua;
• Fornisce ridondanza di attrezzatura;
• Offre una prospettiva in più sul controllo dei parametri di immersione
La scelta del compagno è spesso motivata da diversi fattori come interessi
esplorativi comuni oppure semplicemente dall’amicizia. Tutto questo va
benissimo anche in ragione del fatto che l'efficacia del sistema di coppia è
direttamente proporzionale all'affiatamento e dedizione a tale sistema.
Modulo 5
Un subacqueo che si dedica al 100% al sistema di coppia è un
bravo compagno, diversamente è un cattivo compagno e qui
non ci sono vie di mezzo
Open Water Diver
Dive
er - CMAS-PTA P1
129
Pure Tech Agency
É opportuno sviluppare con il proprio compagno una vera e fiduciosa
intesa reciproca. Questa spesso non è immediata e la si consolida
immersione dopo immersione, allenamento dopo allenamento. Se il
compagno è occasionale bisogna informarsi sul suo allenamento e grado
di preparazione, conoscere le sue attrezzature e mostrargli le proprie,
concordare i segnali subacquei (vedi paragrafo successivo), aiutarsi a
vicenda prima, durante e dopo l’immersione, stabilire le reciproche posizioni
durante l'immersione per restare uniti e concordare le procedure in caso
di separazione. Inoltre sarebbe opportuno scambiarsi i dati anagrafici, il
recapito telefonico e sapere a chi rivolgersi in caso di emergenza nel caso in
cui il compagno non abbia conoscenti all'interno del gruppo di immersione.
La formazione delle coppie è generalmente affidata al subacqueo più esperto
o all'Istruttore. Queste una volta formate procedono all'esecuzione dei
controlli preparatori all'immersione. Rivediamoli sinteticamente per punti.
• Condividere i propri livelli di addestramento;
• Visionare, montare e prendere contatto con l'attrezzatura di entrambi
reciprocamente;
• Ripassare i parametri di immersione, ovvero profondità e tempo
massimi programmati;
• Ripassare i segnali di comunicazione subacquea
Modulo 5
PERDITA DEL COMPAGNO IN IMMERSIONE
Un aspetto importante da concordare con il compagno e l'Istruttore, è la
procedura di "perdita del compagno". Come regola di base appena ci si accorge
di aver perso il compagno si deve iniziare a contare il tempo, poi si cerca di
ritornare al punto di ultimo avvistamento e se allo scadere di 2 minuti non ci
si ritrova con il compagno si risale in superficie. Questo aspetto deve essere
concordato chiaramente.
Una volta ritornati in superficie, presupponendo che anche il compagno abbia
eseguito la procedura correttamente, ci si dovrà per forza ritrovare quasi
contemporaneamente dato che, trascorsi i due minuti, velocità di risalita
e tempo della tappa di sicurezza sono i medesimi per entrambi i subacquei.
Alcune differenze possono esserci in ragione del fatto che uno dei due
subacquei potrebbe essersi accorto in ritardo della perdita del compagno. Se
questo non avvenisse bisogna informare immediatamente l'assistente presente
a bordo oppure a terra
Alcuni subacquei ritengono imbarazzante o noioso il "ripassare" assieme al
proprio
compagno
i
punti
salienti
dell'immersione. Forse perché taluni considerano
questo aspetto un po' come ripetere le tabelline
di fronte alla maestra. Niente di più sbagliato:
quello che si sta facendo è parte integrante
dell'immersione.
Quando
si
affronta
un'escursione in montagna non si comunica
forse destinazione, via di salita e discesa e ora
prevista di rientro?
130
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
É bene precisare che esistono tuttavia una serie di possibili problemi che
possono avvenire ad entrambi i compagni contemporaneamente. Vediamone
alcuni:
• Aria inquinata: si è caricato entrambe le bombole da un compressore che
ha risucchiato aria inquinata (avvelenamento da monossido di carbonio,
incidente
piuttosto raro);
• Entrambi i compagni hanno ecceduto i limiti programmati (esempio:
protrarre la permanenza sul fondo oppure penetrare in una grotta) e sono
entrambi in scarsità d'aria;
• Deterioramento delle condizioni meteomarine;
• Perdita del compagno.
Questa tipologia di problemi è definibile come di "tipo gemello". Con esclusione
del primo tutti gli incidenti di tipo "gemello" sopra descritti avvengono
generalmente per una inadeguata programmazione o scorretta gestione
dell'immersione. Sono problemi seri in ragione del fatto che il compagno non
potrà portarci alcuna assistenza perché è impegnato a risolvere la medesima
situazione.
La ricchezza di un compagno di immersione vero sta anche in questo:
mantenersi e mantenere se stessi ed il compagno all'interno dei limiti
programmati
La proprietà indispensabile per essere un buon compagno è l'essere
innanzitutto un buon subacqueo. In altre parole, e per quanto possa sembrare
banale ricordarlo, noi stessi siamo a nostra volta i compagni di qualcun altro.
Uno degli aspetti più piacevoli dell'attività subacquea è che sott'acqua
non si parla. Quelli che proprio non possono fare a meno di parlare
sott'acqua devono dotarsi di apparecchi per la comunicazione vocale.
Parlare sott'acqua senza questi apparecchi non è impossibile, ma faticoso
(per farsi capire stando molto vicini è necessario urlare) e comunque non
si capisce quasi niente.
Sott'acqua è tuttavia necessario comunicare in molteplici situazioni.
Queste comunicazioni avvengono per mezzo di segnali manuali, un po'
come fanno le persone che usano il linguaggio dei sordomuti. Ovviamente
il livello delle conversazioni subacquee è ridotto a questioni molto basiche:
tutto bene!?, andiamo in quella direzione, risaliamo, scendiamo, quanta
aria hai?, ho 100 bar, mi fa male qui e molto altro ancora.
Oltre ad imparare ad utilizzare i segnali a disposizione in modo adeguato
è necessario imparare a rispondere sempre al mittente ed in modo
adeguato.
Il mittente deve essere chiaro quando lancia un segnale, il ricevente deve
essere altrettanto chiaro e coerente nella risposta. Il livello di scansione
e quindi di chiarezza del segnale dipende dalle nostre mani. Un po' come
quando ci si stringe le mani in segno di intesa o saluto: niente mano
flaccida ma decisa e rassicurante.
I segnali codificati dalla CMAS per una corretta comunicazione subacquea
sono i seguenti.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
131
Modulo 5
5.2 Comunicazione Subacquea
Pure Tech Agency
Segnali primari, ovvero i segnali con cui si comunicano i parametri
primari di una immersione, ovvero:
• Tutto bene proseguiamo, sia in forma di domanda (quando viene
lanciato verso il compagno), sia in forma di risposta
• Andiamo su oppure andiamo giù
• Non ho capito: questo segnale, per quanto possa sembrare banale e
scontato (per noi italiani), spesso non viene utilizzato per timidezza.
Comunicare invece al proprio compagno "non ho capito" significa
anche dimostrarsi attenti e concentrati a quello che si sta facendo.
Modulo 5
Segnali complementari, ovvero i segnali che si usano per comunicare
eventi inerenti all'andamento dell'immersione e quindi derivanti dalla sua
programmazione.
Segnali da eseguirsi con la torcia, ovvero quando le condizioni di
visibilità (per esempio durante un'immersione notturna) o di lontananza dal
compagno non permettono di usare le mani
132
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Segnali di attenzione, ovvero i segnali che appena lanciati richiedono
una efficace attenzione da parte del compagno che quindi si predispone per
prestare una eventuale assistenza
Il segnale "qualcosa non va" può essere riferito ad una qualunque parte del
proprio corpo o attrezzatura in questo modo: prima si indica l'oggetto della
nostro disagio con il dito indice seguito poi dal segnale "qualcosa non va".
Se non si riesce a compensare si indica con il proprio indice l'orecchio che non
si riesce a compensare immediatamente seguito dal segnale "qualcosa non
va". Ovviamente bisogna fare in modo di essere visti mentre si esegue questo
segnale
Seppur con alcune differenze questi segnali sono conosciuti ed adottati
in tutto il mondo, ragion per cui non avremo difficoltà a comunicare con
chicchessia sott'acqua. Nessun problema quindi se il nostro compagno
parla soltanto il Macedone: sott'acqua parliamo tutti la stessa lingua dei
gesti. Importante però ripassare e concordare con il proprio compagno i
segnali principali prima di ogni immersione.
Esistono poi molti altri segnali che verranno studiati nei corsi successivi:
questi servono a rendere possibili ulteriori livelli di comunicazione con un
più elevato grado di complessità. Inoltre le modalità di comunicazione che
si imparano nei corsi avanzati sono un poco più complesse e richiedono
l'utilizzo di una tecnica di comunicazione denominata "a doppio filo".
Questa tecnica non solo permette una perfetta intesa tra compagni, ma
soprattutto ha la capacità di cementare il rapporto con il proprio compagno
in modo decisivo.
Il tuo Istruttore CMAS-PTA ti potrà dare una breve anticipazione sulle tecniche
di comunicazione a doppio filo
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
133
Modulo 5
Segnali di emergenza, ovvero i segnali che appena lanciati richiedono
una immediata azione di soccorso da parte del compagno
Pure Tech Agency
5.3 Preparazione all'immersione
Per essere preparati ad una immersione bisogna essere innanzitutto in
buono stato di salute generale e, contrariamente a quanto fanno molti
subacquei, è estremamente utile condurre una vita sana ed equilibrata.
Mantenersi in buona forma fisica, oltre a migliorare la qualità della vita
stessa, rende il subacqueo più "saldo" e predisposto all'attività subacquea.
Non occorre essere dei Super uomini, semplicemente basta avere amore
e cura verso il proprio corpo. Una vita sedentaria, il fumo e l'alcol (solo
per citare alcune diffuse abitudini della contemporaneità) sono nemici
dell'immersione. Anche il solo "camminare è un magnifico esercizio":
conferisce alle gambe un sufficiente livello di tonicità, rilassa e mantiene
attivo, senza stress, il sistema cardio-circolatorio. Scegliete una forma
di attività a voi congeniale (bicicletta, nuoto, corsa, camminate ecc.) e
praticatela. Siate sereni e lucidi.
Prima di ogni escursione subacquea è necessario affrontare criticamente i
seguenti aspetti:
Raccolta delle informazioni sulla località prescelta, ovvero:
Modulo 5
•
•
•
•
•
•
Quali saranno le condizioni meteo-marine?
Qual'è la stagione più adatta per immergersi in quel luogo?
La peggiore?
Il mio livello di addestramento è adatto per quel tipo di immersione?
La mia attrezzatura è in condizione di efficienza?
Ci sono strutture sanitarie/pronto soccorso nelle vicinanze?
Arrivati sul luogo di immersione è necessario verificare:
• Le condizioni del luogo sono in linea con quanto previsto?
• É necessario rivedere o annullare l'immersione?
• Qual'è il modo migliore per accedere all'acqua e risalire sulla terra
ferma?
Controlli pre immersione, ovvero:
• Montaggio dell'attrezzatura assieme al compagno;
• Controllo del corretto funzionamento dell'attrezzatura propria e del
compagno;
• Eventuale verifica della pesata;
É molto importante raccogliere informazioni sul luogo dell'immersione,
le sue peculiarità, le sue possibili difficoltà e le condizioni meteomarine.
Inoltre è importante organizzare un comodo e sicuro trasporto
dell'attrezzatura al luogo di imbarco o sulla riva, dove eventualmente poter
ricaricare le bombole e su come è possibile contattare le strutture di pronto
soccorso.
134
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Le bombole devono essere trasportate con cura nel veicolo per evitare che si
spostino in curva o in frenata. É opportuno bloccarle nel bagagliaio con dei
cunei (o con le cinture di zavorra), legarle (possibilmente in posizione verticale)
e comunque messe sotto il resto dell'attrezzatura.
Il trasporto di bombole in pressione per attività ludiche non professionali
non comporta nessun obbligo legislativo particolare, salvo il buon senso del
conducente
Ovviamente prima di ogni escursione è bene eseguire un controllo generale
delle proprie attrezzature e preparare l'inventario di quello che abbiamo
bisogno cosi da avere uno strumento per evitare dimenticanze.
5.4 Pianificazione dell'Immersione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
finalità dell'immersione (di corso, esplorativa, svago....)
la profondità massima ed il tempo di immersione;
il consumo di aria previsto;
i parametri di direzione, eventuali punti di riferimento e svolgimento
dell'immersione;
modalità di ingresso e uscita dall'acqua
eventuale durata dell’intervallo di superficie dall'ultima immersione
previsione delle condizioni meteo-marine
condizioni del luogo di immersione (tipologia di fondale, visibilità,
correnti, temperatura dell'acqua, animali....)
disponibilità e dislocamento dotazioni di sicurezza
procedure di sicurezza e di perdita del compagno
scelta o conferma del compagno di immersione
segnali di comunicazione
Tutti questi aspetti non devono superare i limiti di preparazione del
subacqueo meno esperto, bensì devono conformarsi in modo tale che TUTTI
i partecipanti dell'immersione si sentano a proprio agio con le condizioni
previste.
Stabilire l'andamento, la profondità e tempo massimi di immersione non
deve essere percepito come un impedimento, piuttosto come un pensiero
guida positivo. Tempo e profondità possono rassicurarci o agitarci nella
misura in cui siamo pronti o inadeguati ad affrontare un certo tipo di
immersione. Sta a noi decidere cosa vogliamo che sia la nostra immersione:
una piacevole e sicura escursione subacquea, oppure un vagare indeciso
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
135
Modulo 5
Pianificare l’immersione significa stabilire in precedenza lo svolgimento ed
i parametri dell’immersione o delle immersioni che si vogliono effettuare
durante l’escursione. L'immersione si pianifica con tutti i partecipanti
all'immersione sebbene solitamente spetta al subacqueo più esperto, e che
meglio conosce le caratteristiche del fondale da esplorare, o alla guida del
centro immersioni, oppure all'Istruttore decidere o proporre lo svolgimento
di una immersione. Durante la pianificazione ci si divide eventualmente i
compiti e si ascoltano eventuali istanze o richieste dei partecipanti.
Le questioni principali da predisporre sono:
Pure Tech Agency
magari all'inseguimento di un subacqueo che ci sta portando oltre i limiti
della nostra preparazione. A noi la scelta.
I parametri dell'immersione devono conformarsi al meno esperto tra i
partecipanti.
Il Briefing
Modulo 5
Una volta definiti i parametri di immersione esiste un momento che
precede
pr
l'entrata in acqua nel quale si
rimarca
ri
lo
svolgimento
dell'immersione
e si ripetono i
de
parametri:
il
briefing.
Questo
pa
momento
può essere sia di gruppo
m
(se
l'immersione
prevede
più
(s
partecipanti),
sia tra due subacquei
pa
soltanto.
L'Istruttore o il subacqueo di
so
più
pi alto grado solitamente sono coloro
che
ch gestiscono il briefing in modo tale
che
ch non vi siano incomprensioni tra
gli
dell'immersione.
li ascoltatori
lt t i circa
i
il corretto
tt svolgimento
l i
Nel brieifing vengono ricordate anche questioni generali inerenti la
sicurezza e la buona pratica subacquea, ovvero:
• Controllo della respirazione, effettuare una giusta compensazione,
prestare attenzione ad eventuali pericoli, ecc.
• Controllo delle attrezzature, carica della bombola, esatta vestizione,
controllo dell’assetto, strumentazione, ecc.
• Disciplina: posizione di ciascun subacqueo e delle coppie da
mantenere durante l’immersione, presenta¬zione dell’eventuale guida
o assistente, procedure di sicurezza, procedure in caso di perdita del
compagno o del gruppo, ecc.
• Segnali da usarsi in immersione, ma anche i segnali speciali di
superficie, ecc.
Nelle immersioni meno impegnative spesso pianificazione e briefing
non sono momenti distinti l'uno dall'altro, laddove torneranno ad essere
momenti distinti nelle immersioni dall'elevato grado di complessità.
Emergenza Sanitaria 118, DAN 800-279802 per emergenze nazionali in Italia,
Guardia Costiera 1530
5.5 Il consumo d'Aria
Grazie alla nostra attrezzatura siamo in grado di portare con noi una
quantità limitata di aria. La corretta gestione delle "nostre scorte" evita
di incocciare con uno dei più pericolosi incidenti, seppur raro, che può
accadere ad un subacqueo poco attento: l'esaurimento dell'aria.
136
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Per calcolare preventivamente il consumo d'aria è necessario sapere oltre
alla profondità massima ed il tempo di immersione previsti, il proprio
consumo specifico di aria.
Un tempo si calcolava il consumo d'aria assumendo che una persona di
corporatura media ventila, ovvero inspira ed espira, un volume di aria di
circa 20 litri.
Sulla base di questo dato, e tenendo conto di quanto enuncia la legge di
Boyle e Mariotte, si calcola il consumo di aria come segue:
Scorta d'aria = 20 x bar di pressione prevista x tempo in minuti
Un sub decide di eseguire un'immersione a 18 metri di profondità per 35
minuti. Avremo:
20 x 2,8 x 35 = 1960 litri di aria
alla quale vanno aggiunti
20 x 1,5 x 3 = 90 litri
l'aria necessaria per eseguire la sosta di sicurezza
totale 2050 litri di aria.
Il calcolo del consumo d'aria previsto è ovviamente una previsione e
come tale non rappresenta un dato reale. Fattori contingenti potranno
rendere le nostre previsioni leggermente eccessive, oppure insufficienti
nel qual caso ci troveremo nella condizione di dover interrompere le
immersione anzitempo. É per queste ragioni che il manometro deve essere
periodicamente controllato durante tutta l'immersione. Inoltre la lettura
del manometro dovrà essere comunicata anche al compagno ogni
qualvolta si raggiungono i 100 ed i 50 bar di pressione.
Oggi l'atteggiamento corretto da assumere per una corretta pianificazione
del consumo d'aria impone di condurre delle verifiche puntuali sul
proprio consumo di aria. Come?
Si eseguono dei percorsi subacquei possibilmente a 10 metri di profondità
durante i quali si monitorizza la
diminuzione
di
pressione
del
manometro della bombola che si sta
respirando per un certo tempo.
Solitamente si fanno queste prove
pinneggiando per alcuni minuti a 10
metri di profondità. I dati di consumo
vengono divisi per i minuti di durata
della prova cosi da avere un consumo
al minuto quanto più attendibile.
Open Water Diver - CMAS-PTA
MAS-PTA P1
137
Modulo 5
Dovendo disporre di una scorta d'aria di 2050 litri sarà necessario indossare un
monobombola avente un volume di 12 oppure 15 litri caricato a 200 atmosfere dato
che una bombola da 10 litri (caricata a 200 bar) può contenere solamente 2000
litri di aria. É comunque oltremodo importante concludere un'immersione con ancora
alcune decine di bar nella bombola, o perlomeno disporre di queste poche decine
quando ormai si è prossimi all'uscita, ovvero nella fase finale della sosta di sicurezza
Pure Tech Agency
Il valore che si ottiene deve essere poi parametrato a livello del mare.
Un sub percorre una certa distanza a 10 metri di profondità (costanti) per 4
minuti. É dotato di un monobombola da 15 litri ed ha registrato sul proprio
manometro una diminuzione di pressione di 10 bar tra l'inizio e la fine della
prova. Avremo:
10 bar x 15 litri (volume della bombola) = 150 litri di aria consumata
150 / 4 (minuti) = 37,5 litri di aria consumata al minuto a 10 metri di
profondità
37,5 / 2 (bar di pressione a 10 metri di profondità) = 18,70 litri di aria
consumata al minuto in superficie
Il valore di 18,70 è il Tasso di Consumo di Superficie (TCS) del sub, il
quale utilizzerà questo valore per i suoi calcoli di previsione del consumo
d'aria.
5.6 Controli pre-immersioni
l Controlli Pre-Immersione CMAS-PTA sono una procedura di sicurezza
che viene sempre attuata prima di ogni immersione ed hanno lo scopo
principale di verificare il controllo del funzionamento dell’ equipaggiamento
sia personale sia del compagno d’immersione.
Questa procedura previene eventuali e potenziali problemi causati da
distrazioni o malfunzionamenti non rilevati dell’attrezzatura.
Modulo 5
Come procedere:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Controllore che i rubinetti siano completamenti aperti
Controllore che la maschera sia indossata correttamente sotto il
cappuccio
Controllore il funzionamento degli erogatori, respirando nell’erogatore
con il viso immerso per verificare eventuali infiltrazioni d’acqua.
Contemporaneamente verificare la pressione del manometro
Controllore il funzionamento dei comandi di carico e di scarico
(Valvola Immissione Scarica) del GAV
Controllo del sistema di sgancio rapido della zavorra e dei comandi di
carico/scarico della muta stagna nel caso in cui sia utilizzata
Controllare l’ubicazione del pallone gonfiabile e di un eventuale
mulinello per il suo uso
Controllare la funzionalità della torcia subacquea, se è previsto il suo
utilizzo
Controllare che le pinne sia agganciate correttamente
Dare l’ OK finale: Io sono Ok per scendere
Soltanto a questo punto si è pronti a cominciare l'immersione.
138
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
5.7 Aspetti generali e abilità di base
Un’immersione non dovrebbe mai
essere frutto di casualità ed
improvvisazione. Non esistono immersioni facili o immersioni difficili,
esistono immersioni che richiedono maggiori o minori gradi di preparazione.
Un po’ come andare a 100 all’ora sull’autostrada o a 1000 all’ora su un
aereo: entrambe le situazioni sono normalmente vissute dalle persone
quotidianamente, soltanto che nel secondo caso sono richiesti dei mezzi ed
una preparazione specifica molto accurati.
La preparazione di base per le immersioni novizie richiede che il subacqueo
sia in grado di eseguire le seguenti abilità di base.
Respirare con l’erogatore, Una continua pratica e la crescente
esperienza in immersione sviluppano un atteggiamento mentale utile ai
fini di una corretta respirazione. Come si è detto più volte questa deve
essere regolare e rilassata e nel caso in cui l’erogatore,in immersione,
esca dalla bocca, occorre svuotarlo prima di riprendere la respirazione.
Lo svuotamento del 2° stadio si può ottenere, dopo averlo recuperato e
riposizionato, sia con un atto espiratorio deciso, sia azionando il pulsante
posto nella parte anteriore.
Svuotamento della maschera. Dopo il tuffo di ingresso potrebbe entrare
all’interno della maschera un po’ di acqua. In superficie per farla defluire
basterà sollevare il bordo inferiore della maschera stessa, rimanendo
in posizione verticale. Durante l’immersione per svuotare la maschera
basterà esercitare con le mani una leggera pressione sul bordo superiore e
soffiare leggermente con il naso. La causa più comune di allagamento della
maschera è il ricevere un pinneggiata in testa dal subacqueo che ci precede.
Uso del G.A.V. Si è già detto come questo strumento ci permette di
mantenere un assetto neutro durante l’immersione. Il flusso di aria in
ingresso ed uscita dal GAV, per mezzo dei comandi posti generalmente sul
corrugato, deve essere proporzionato alle necessità di assetto.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
139
Modulo 5
L’ingresso in acqua. Questo, sia da barca sia da terra, deve essere
qu
quanto
più possibile agevole e
si
sicuro
soprattutto in presenza
di correnti oppure moto ondoso.
In caso di corrente è buona
re
regola
svolgere
una
cima
ga
galleggiante
dalla barca in modo
ta che i subacquei in superficie
tale
in attesa del compagno la
po
possano
afferrare. L’ingresso da
ri
riva
deve essere protetto da
eccessivo moto ondoso cosi da rendere quanto più agevole anche la risalita
sulla terraferma soprattutto nel caso in cui le condizioni meteomarine si
deteriorassero durante l’immersione; è quindi bene scegliere luoghi riparati
quali piccole insenature o baie.
Pure Tech Agency
I comandi devono essere azionati con calma, senza nervosismi, in modo
tale che i flussi si interrompano al momento giusto senza la necessità di
continui aggiustamenti.
Pinneggiare ovvero muoversi sott’acqua. Il pinneggiamento si esegue con
i piedi e le gambe distese ed in genere con movimenti lenti e ampi, in
armonia con l’acqua stessa senza determinare sforzi eccessivi o affanno.
Molti preferiscono adottare una pinneggiata tipo rana subacquea proprio
perchè conferisce maggior calma ed un incedere lento e rilassato. Inoltre
si solleva meno sedimento dal fondo.
Naturalmente, al fine di non ostacolare la spinta, la posizione durante il
pinneggiamento deve essere più idrodinamica possibile, con le braccia
raccolte e senza parti di equipaggiamento penzolanti.
Modulo 5
Recupero dell’erogatore. Può capitare che durante l’immersione si
perda contatto con l’erogatore. Per recuperarlo si deve far percorrere al
braccio un movimento rotatorio iniziando verso il basso facendolo passare
aderente al corpo, che deve essere inclinato leggermente dalla stessa parte
dell’erogatore che si intende recuperare. Così facendo, quando il braccio
ritornerà in avanti, troveremo la frusta in una comoda posizione per essere
afferrata. I secondi stadi dovrebbero comunque essere fissati all’altezza
del petto con degli elastici in modo tale che siano sempre disponibili in
ogni situazione ed immediatamente. Il tuo istruttore PTA sarà in grado di
suggerirti le posizioni migliori dove collocare i secondi stadi all’interno della
configurazione della tua attrezzatura.
La risalita è la fase più delicata dell’immersione. Anche da basse
profondità, come i 18 metri ai quali abilita questo corso, sono necessari
almeno 5 minuti per raggiungere la superficie: due minuti per risalire e 3
minuti di sosta di sicurezza.
Durante questa fase la respirazione deve continuare ad essere regolare
e rilassata, una leggera pinneggiata verso l’alto aiuta il distacco dalla
profondità di partenza e man mano che si risale si deve scaricare l’aria
dal G.A.V., in quanto espandendosi per la diminuzione della pressione
aumenterebbe la spinta idrostatica.
La manovra di uscita deve sempre avvenire nel modo più sicuro e facile,
tenendo conto anche delle condizioni ambientali che possono mutare nel
corso dell’immersione. Si toglie per prima cosa la cintura se è possibile
passarla a chi già sta sulla riva oppure sull’imbarcazione. Le pinne vanno
tolte soltanto prima di abbandonare l’acqua mentre l’ARA dipende dalle
condizioni esistenti e dalle eventuali assistenze.
La posizione reciproca.
Oltre a quanto è già stato detto sull'importanza del sistema di coppia è
importante che i compagni concordino la posizione reciproca da mantenere
durante tutta l'immersione. Questa accortezza, se ben eseguita, riduce di
molto il verificarsi di "perdita del compagno" e diminuisce il carico di lavoro
in ragione del fatto che non si deve passare tutta l'immersione a seguire con
lo sguardo i movimenti del compagno. Questi, sarà sempre alla mia destra
oppure alla mia sinistra e cosi farò altrettanto
140
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Verifica dell'apprendimento
inserisci le parole mancanti
Un subacqueo che si dedica al ....................................... è un bravo
compagno, diversamente è un cattivo compagno e qui non ci sono vie di
mezzo
Oltre ad imparare ad utilizzare i segnali a disposizione in modo adeguato è
necessario imparare a rispondere sempre al mittente ed in modo adeguato
................... ..................... ...................... ................... ..................
É molto importante raccogliere ......................., sul luogo dell’immersione,
le sue ......................., le sue possibili ......................., e le
......................., meteomarine
Per calcolare preventivamente il consumo d’aria è necessario sapere
oltre alla ......................., ed il tempo di immersione previsti, il proprio
......................., di aria
l Controlli Pre-Immersione CMAS-PTA sono una ......................., che viene
sempre attuata prima di ogni immersione ed hanno lo scopo principale di
verificare il controllo del .......................,................... sia personale sia
del compagno d’immersione.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
141
Modulo 5
L’immersione si pianifica con tutti i ......................., sebbene solitamente
spetta al subacqueo .......................,, e che meglio conosce le
caratteristiche del fondale da esplorare, o alla ......................., del centro
immersioni, oppure ......................., decidere o proporre lo svolgimento di
una immersione
Modulo 5
Pure Tech Agency
142
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
MODULO 6
Ambiente Acquatico
Panoramica
•
•
•
•
Caratteristiche fisiche e adattamento all'ambiente acquatico
La vita acquatica
La catena alimentare
L'atteggiamento verso la vita marina e l'ambiente
Obiettivi
Modulo 6
Al termine di questo modulo avremo appreso:
• Rudimenti sull'ecologia marina e la complessità dei sistemi viventi
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
143
Pure Tech Agency
Introduzione
Modulo 6
Quando ci troviamo immersi in acqua, che sia per un semplice bagno o per
una nuotata, siamo subito soggetti a condizioni fisiche diverse dall’ambiente
terrestre. Senza conoscerne le caratteristiche nello specifico, notiamo
differenze nella densità, nella luce, nella temperatura, nel movimento
e nella gravità. Inoltre, a seconda della trasparenza dell’acqua oppure
indossando una maschera, veniamo a conoscere un mondo costituito da
specie animali e vegetali tutt’altro che familiari con la vita terrestre!
Il desiderio di conoscere la caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali del
mondo sommerso è stato
forse il maggior propulsore
di
tutte
le
attività
esplorative effettuate nei
mari. Le nostre immersioni
subacquee, sin dal primo
respiro sott’acqua, sono
proprio come una piccola
esplorazione di questo
meraviglioso mondo, che
può trovarsi nel mare, in
un lago, o persino in un
piccolo bacino acqueo:
l’acqua è fonte di vita, e vi
i d
è sempre presente una forma di vita
da conoscere.
Man mano che impareremo ad immergerci in vari ambienti acquatici,
scopriremo sempre un aspetto nuovo che potrà sorprenderci e regalarci
emozioni. É dunque importante, anche al fine della nostra sicurezza e per
godere al meglio di ciò che le immersioni possono offrirci, conoscere quali
sono le caratteristiche fisiche e strutturali dell’ambiente acquatico in cui
ci stiamo immergendo, in relazione al fondale, alla massa d’acqua ed alle
specie animali e vegetali che lo abitano.
6.1 Caratteristiche fisiche e adattamento
all’ambiente acquatico
Le caratteristiche fisiche dell’acqua riguardano la densità, i suoi movimenti,
la forza di gravità, la luce, la visibilità, la temperatura e la composizione del
fondale, come per il ruolo dell’ossigeno in relazione della vita acquatica.
Densità
Sappiamo tutti che muovendo anche solo un braccio in acqua, ci troviamo
opposti ad una resistenza dovuta all’elemento liquido, e dunque, di una
certa densità. L’acqua, rispetto all’aria è 800 volte più densa. Questa
caratteristica, come vedremo più avanti, permette la vita di un’intera
comunità chiamata plancton (che letteralmente significa "errante"),
esclusiva appunto degli ambienti acquatici. Organismi grandi e piccoli vi ci
possono fluttuare passivamente per lunghi periodi.
144
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Movimenti dell’acqua
Riguardo questo aspetto, facciamo riferimento al mare, che rispetto ad un
lago è soggetto ad una maggiore varietà di movimenti acquatici. Nel mare i
movimenti si suddividono in:
• Moto Ondoso: provocato dal vento, pertanto interessa solo i
primi metri dalla superficie. Per l’immersione in sé il moto ondoso
potrebbe costituire un fattore irrilevante, ma nella pianificazione del
raggiungimento del punto d’immersione con un’imbarcazione oppure di
un’entrata dalla riva, diventa un elemento fondamentale da prendere
in considerazione.
• Correnti: spostamenti d’acqua in varie direzioni (verticali ascensionali o discensionali - e orizzontali), causati da vari fattori come
composizione del fondale, temperatura, moto ondoso e maree. Molte
specie marine sfruttano la corrente per il proprio nutrimento oppure
per spostamenti a grandi distanze di organismi animali e vegetali non
dotati di movimento proprio. Per il subacqueo potrebbe essere un
inconveniente, ma se l’immersione viene opportunamente pianificata,
essa può essere facilmente gestita o addirittura sfruttata. Il corso P2
prevede un addestramento specifico per le immersioni trasportati dalla
corrente, in cui si impara ad immergersi in condizioni di movimento
continuo con il vantaggio di godere di avvistamenti particolari.
• Marea: è un moto periodico di ampie masse d’acqua che si innalzano
e abbassano con frequenza giornaliera o frazione di giorno, dovuto
alla combinazione di due fattori: l’attrazione gravitazionale esercitata
sulla Terra e la forza centrifuga dovuta alla rotazione del sistema
Terra-Luna intorno al proprio centro di massa. Ci sono alcuni luoghi
al mondo in cui l’azione
delle
maree
costituisce
un
fattore
determinante
per
la
pianificazione
dell’immersione,
e
soprattutto per il suo effetto
nell’originare le correnti.
Open Water Diver
Di
- CMAS
CMAS-PTA
PTA P1
Modulo 6
La forza di gravità
In acqua la forza di gravità
viene contrastata dalla spinta
di galleggiamento dovuta al
dislocamento. Gli organismi
acquatici difatti non devono
spendere molta energia per
costruire degli scheletri molto
robusti che li sostengano, come
il legno per le piante e le ossa
per gli animali che vivono sulla
terra. Il movimento in verticale
è facile e poco dispendioso in
acqua, mentre è difficoltoso per
gli animali terrestri.
145
Pure Tech Agency
La luce
La luce del sole riesce a penetrare solo fino ad una profondità di circa
180 metri. Questo fattore limita alle quote superficiali di laghi e oceani la
possibilità di vita per le piante. Inoltre, in acqua la luce viene assorbita
in maniera differenziata, come già illustrato nel precedente modulo. Per
effettuare la fotosintesi, diversi tipi di piante utilizzano differenti parti dello
spettro della luce, determinando una distribuzione in senso verticale dei
vegetali.
Modulo 6
La visibilità
Per visibilità intendiamo il campo visibile in riferimento alla nostra
visione sott’acqua. I fattori che localmente influenzano la visibilità sono
il movimento dell’acqua (per esempio le onde che smuovono il fondale
creando sospensione), le condizioni meteorologiche (cielo nuvoloso o
limpido, pioggia o sole), particelle in sospensione (immergersi in un mare
lattiginoso potrebbe non sembrare interessante, ma se è ricco di plancton, è
la condizione ideale per incontrare i cetacei!) e la composizione del fondale.
La visibilità è spesso considerata dai subacquei come un fattore soggettivo,
secondo la torbidità o limpidezza dell’acqua a cui sono abituati.
É importante informarsi sulla visibilità dell’acqua in cui ci si immerge, per
adottare procedure idonee alla navigazione subacquea e per la gestione di
ev
eventuali
inconvenienti.
In
Inoltre, spesso la visibilità
pu
può essere alterata dal
co
comportamento
dei
su
subacquei, in quanto la
so
sospensione può essere
p
provocata dal movimento
delle pinne, troppo vicine
de
al fondale. A tal scopo, è
importante mantenere un
im
bu
buon assetto neutro per
ev
evitare questo sgradevole
ef
effetto per chi vi sta
di
dietro!
La Temperatura
Come principio di base, l’acqua possiede il più elevato calore specifico
tra le sostanze presenti in natura, motivo per cui ha un’elevata capacità
termica, facendo sì che le variazioni stagionali di temperatura nelle grandi
massi di acqua, subiscono oscillazioni ridottissime, contribuendo a mitigare
il clima delle regioni che si affacciano su di esse. Tuttavia, la differenza
di temperatura dell’acqua, seppur di pochi gradi centigradi, costituisce un
elemento da tenere in considerazione nella pianificazione dell’immersione.
Essa differisce in base alla zona, alle caratteristiche del tipo di mare o
bacino acqueo che sia, alla profondità ed al periodo. Ciò che il subacqueo
dovrà tener conto, è l’adeguata protezione termica di cui equipaggiarsi,
valutando lo spessore della muta da indossare. Inoltre, un fattore
146
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
importante da considerare è il fenomeno del termoclino, ovvero un sottile
strato nel quale la temperatura diminuisce, in funzione della profondità,
più velocemente rispetto ad altri strati. Tale stratificazione, se accentuata,
presenta differenze anche di densità dell’acqua.
Composizione del fondale
A secondo dei vari luoghi in cui ci immergiamo, cambia il tipo di fondale.
Esso può essere di conformazione rocciosa,tipico del Mar Mediterraneo,
con presenza di scogli, pareti e secche, ricoperte di varie forme di vita
incrostanti; oppure di tipo sabbioso, fangoso o melmoso, come quello
degli ambienti di acqua dolce, o addirittura ricoperte di piante acquatiche,
come in alcune zone costiere dell’oceano Atlantico e Pacifico. Nelle zone
tropicali invece, sono presenti le famose barriere coralline: vere e proprie
formazioni costituite e accresciute dalle sedimentazione di scheletri calcari
dei coralli. Questo tipo di ambiente è unico perché le barriere hanno creato
isole e lagune, e rappresentano un mondo variopinto e ricco in biodiversità.
6.2 La vita acquatica
Gli organismi animali e vegetali che vedremo durante le nostre immersioni,
sia in addestramento sia durante le escursioni ricreative che seguono il corso,
sono innumerevoli e impossibili da conoscerli tutti uno per uno. Ma quando si
pianifica un’immersione, è buona norma documentarsi sulle specie facilmente
avvistabili e tipici della zona che popolano il luogo in cui ci immergeremo.
Il ruolo delle Piante Acquatiche
Le piante acquatiche possono avere varie dimensioni, dalle forme
microscopiche che in certe stagioni sono presenti in gran numero, fino alle
forme più imponenti da costituire vere e proprie foreste.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
147
Modulo 6
L’ossigeno
In acqua l’ossigeno è distribuito in maniera differenziata, variando in
quantità da luogo a luogo.
g L’acqua
q
spazzata
p
sulla riva delle onde è p
più
ricca di ossigeno
di
quella
stagnante
delle
paludi.
Diversi
organismi hanno
sviluppato
le
branchie per poter
ricavare l’ossigeno
dall’acqua, mentre
i mammiferi sono
costretti a risalire
in superficie per
respirare l’ossigeno
dell’aria.
Pure Tech Agency
Piante di piccole dimensioni permettono la vita di piccoli animali erbivori,
come i copepodi, piccoli crostacei simili a gamberetti, che rappresentano un
anello critico della catena alimentare. A causa però delle loro dimensioni
ridotte, molte piante acquatiche possono essere rimosse con facilità dal loro
ambiente, determinando l’instabilità e la fragilità degli ecosistemi acquatici.
6.3 La catena alimentare
Nell’ambiente acquatico le catene alimentari sono più lunghe per via delle
ridotte dimensioni dei vegetali acquatici che possono essere mangiati
animali di piccole dimensioni.
La tipica catena alimentare acquatica potrebbe essere rappresentata da:
vegetali planctonici che vengono mangiati dai copepodi, i quali vengono
mangiate dalle aringhe. Queste sono il cibo prelibato dei calamari, che a
loro volta sono prede degli squali. In questo caso ci sono cinque anelli a
formare la catena alimentare.
L’estrema varietà di condizioni ambientali nelle quali i pesci vivono
corrisponde ad una varietà di abitudini alimentari, ed è proprio sulla base
del regime alimentare che è consuetudine dividere i pesci in tre gruppi:
Erbivori, Carnivori e Predatori. Per alcune specie, tuttavia, sarebbe più
giusto usare la definizione di onnivore in senso vero e proprio, nutrendosi
queste indifferentemente e in ogni stagione di alimenti di varia natura.
Modulo 6
6.4 L’atteggiamento verso la vita marina e
l’ambiente
In primo luogo, bisogna evidenziare il fatto che quasi tutti gli animali
acquatici sono timidi e inoffensivi. Il buon subacqueo non insegue, stuzzica
o disturba in alcun modo le creature acquatiche. È anche vero però che
esistono degli organismi acquatici potenzialmente pericolosi ed è
importante conoscere quali danni possono recare all’uomo, sfatando le
leggende e correggendo i pregiudizi sul comportamento di certi animali
(per esempio gli squali).
Le specie che sono classificate come pericolose, sono semplicemente
da considerarsi una componente
del mondo acquatico, e non sono
migliori o peggiori di un’altra
specie. L’obiettivo è di riuscire a
non giudicare le caratteristiche di un
organismo, bensì concepirlo come
una qualsiasi specie che cerca la
propria sopravvivenza nel mondo
acquatico.
Le possibilità di ferirsi gravemente a
causa di un organismo acquatico sono
reali. A tal proposito, è necessario fare
delle considerazioni relative agli attacchi da parte di animali selvatici. In primo
luogo, gli animali raramente attaccano senza essere provocati, di solito sono
148
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
in risposta ad azioni o a reazioni, i quali possono essere di natura difensiva.
In caso di cattura di una preda, tale azione può essere di tipo offensivo.
Ma quelli ai subacquei sono dovuti alla loro reazione iniziale, e se questo è
vero, quasi tutti gli attacchi possono essere evitati. Dunque, per determinare
il comportamento appropriato da tenere in presenza di particolari animali
bisogna seguire alcuni punti:
Per identificare le specie e riconoscerne le abitudini, è necessario essere
al corrente delle peculiarità degli organismi che abitano il luogo in cui ci
si intende immergere. Inoltre, approfondire la conoscenza della vita
acquatica tramite la lettura, corsi di specialità relativa alla biologia
marina e non ultimo tramite l’esperienza, permette al subacqueo di poter
immergersi con coscienza, sicurezza e tranquillità. Esistono in commercio
dei manuali e schede plastificate che raffigurano le specie potenzialmente
offensive, in modo da poterle riconoscere ed assumere di conseguenza un
atteggiamento adeguato.
L’interazione tra il subacqueo ed il mondo sommerso però, non si basa
solo sul come evitare di subire danni da parte degli organismi, tutt’altro!
L’essere umano è un ospite, e la sua interazione si basa soprattutto sulla
responsabilità ed il rispetto della vita acquatica.
Tale interazione può essere di natura passiva, che si esprime nel minimo
impatto sugli ambienti tramite la semplice osservazione delle specie, che
siano individui, in gruppo o in presenza di altri subacquei. Quest’ultimo
punto è forse il più importante in materia di rispetto, perché permette di
valutare quanto sia il disturbo causato dal subacqueo.
Toccare e maneggiare organismi acquatici è una nota e comune tentazione
da parte dei subacquei, e difficilmente risulta essere un’azione positiva per
gli organismi acquatici. Addirittura, per alcune specie qualsiasi contatto può
compromettere seriamente la loro salute. In nessun caso o circostanza,
si dovrebbe mai inseguire o molestare animali come tartarughe, mante,
squali, delfini e balene, come per volerli cavalcare.
Né è concessa la caccia o la raccolta di qualsiasi organismo acquatico
quando ci si immerge con l’autorespiratore (a meno che non sia
diversamente specificato dalla legge locale), che sia per scopi alimentari o
per souvenir.
É altresì vero che il fatto di entrare in contatto fisico con alcuni animali offre
un’esperienza positiva e indimenticabile, che permette di apprezzare la
storia naturale dell’animale interessato da un nuovo aspetto. Si pensi infatti
ai subacquei non vedenti, che non potendo apprezzare la vita acquatica
tramite la vista, hanno necessità di ricorrere al tatto. Ecco dunque che
torna essere utile e indispensabile la conoscenza delle singole specie con
cui si interagisce senza che questo atteggiamento possa comprometterne
lo stato di salute.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
149
Modulo 6
• Identificare correttamente l’animale quando viene visto per la prima
volta
• Conoscere la gravità di ogni possibile attacco con l’animale
• Conoscere le misure adeguate da adottare per evitare il contatto o per
non provocare l’attacco con le proprie azioni.
Pure Tech Agency
Un’altra esperienza di particolare effetto è la pastura ai pesci. Tale attività
dovrebbe essere svolta con moderazione, senza che stravolga i normali
comportamenti in ambito di alimentazione e accoppiamento, perché
tale abitudine, a lungo andare potrebbe far cambiare drasticamente
le loro naturali abitudini ed esporli alla cattura. Di fondo, è un’azione da
scoraggiare, ma se condotto da esperti, con responsabilità e misura, la
pratica di dar da mangiare ai pesci è un’esperienza molto appagante che
può fornire ulteriori conoscenze in merito al comportamento naturale di
alcune specie.
Una delle forme di interazione ambientale più diffuse negli ultimi tempi,
è la fotografia subacquea. Grazie all’avvento della fotografia digitale, ogni
subacqueo, di qualsiasi esperienza, può equipaggiarsi di una fotocamera
compatta scafandrata, e "catturare" immagini degli organismi, o paesaggi
che più lo attirano. Se viene svolto con coscienza, ha un impatto quasi nullo
sull’ambiente sommerso. Tuttavia, i fotografi subacquei devono sviluppare
le abilità di controllo dell’assetto, specialmente se vicino al fondo, dove
le specie bentoniche, come il corallo, potrebbero essere accidentalmente
danneggiate.
Infine, ci sono delle tecniche da adottare ed accorgimenti da prendere
per ridurre al minimo il disturbo da parte del subacqueo: bloccare le parti
penzolanti dell’attrezzatura, mantenere un assetto neutro, usare in modo
adeguato le pinne e muoversi lentamente, soprattutto quando vicino al
fondo o alla parete.
Modulo 6
Fare una bella escursione in un territorio sconosciuto ma con una guida
che informa sulle regole da seguire e le attrattive del luogo visitato, non
toglie, né riduce l’emozione di scoprirne i paesaggi e conoscerne le bellezze
naturalistiche, anzi, la conoscenza valorizza la ricchezza della natura che
ci circonda. Allo stesso modo, immergersi in un sito di cui si conoscono
le caratteristiche ambientali, rende l’immersione ancor più affascinante e
memorabile!
150
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Verifica dell'apprendimento
inserisci le parole mancanti
L’acqua, rispetto all’aria è .................... più densa
Marea: è un moto periodico di ampie .................... che si innalzano
e abbassano con frequenza giornaliera o frazione di giorno, dovuto alla
combinazione di due fattori: .............................. esercitata sulla Terra e
la .................... dovuta alla rotazione del sistema Terra-Luna intorno al
proprio centro di massa
Essa differisce in base alla ...................., alle caratteristiche del tipo
di mare o ......................... che sia, alla profondità ed al periodo. Ciò
che il subacqueo dovrà tener conto, è ..................................... di cui
equipaggiarsi, valutando lo spessore della muta da indossare
In acqua l’ossigeno è distribuito in maniera ...................., variando in
.................... da luogo a luogo
A causa però delle loro dimensioni ridotte, molte piante acquatiche possono
essere .............................. dal loro ambiente, determinando ..................
............... degli ecosistemi acquatici
In primo luogo, bisogna evidenziare il fatto che quasi tutti gli animali
acquatici sono .............................. Il buon subacqueo non insegue,
.............................. in alcun modo le creature acquatiche
Infine, ci sono delle tecniche da adottare ed accorgimenti da prendere per
ridurre ............................ da parte del subacqueo: bloccare le ..............
........................., mantenere un ...................., usare in modo adeguato
le pinne e ................................, soprattutto quando vicino al fondo o alla
parete
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
151
Modulo 6
L’interazione tra il subacqueo ed il mondo sommerso però, non si basa solo
sul come ................................... da parte degli organismi, tutt’altro!
L’essere umano è un ...................., e la sua interazione si basa soprattutto
sulla .................... ed il .................... della vita acquatica
Modulo 6
Pure Tech Agency
152
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Acque Confinate
Obiettivi
• Apprendere, in un ambiente controllato e sotto la
supervisione del tuo Istruttore le tecniche fondamentali per
partecipare in seguito ad una vera immersione in acque
libere
• Le tecniche da imparare sono semplici e si imparano per
grado
• L'Istruttore ti fornirà spiegazioni più dettagliate anche
dimostrandoli, prima di provare gli esercizi
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
153
Pure Tech Agency
1 AC1
Introduzione all’equipaggiamento - Snorkeling e
ARA 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
154
Briefing
Preparazione dell’attrezzatura
Snorkeling: (attrezzatura da apnea)
Entrate in acqua - (laterale, seduto per capovolta
all’indietro) comunque deve essere la più comoda
possibile ed evitare che possa creare pericoli per sé o per i
compagni)
Posizione - (orizzontale, con le braccia distese verso la
direzione di marcia e la testa orientata verso il fondo.
Respirazione - (La ventilazione dovrà essere molto calma
e lenta in modo tale di sentirsi perfettamente calmi e
rilassati. L’esercizio e l’acquaticità acquisiti nel tempo
renderanno anche più tranquilli e porteranno ad avere un
ritmo respiratorio sempre più regolare)
Nuoto/pinneggiata in superficie. Il pinneggiamento
corretto e con il maggior rendimento si esegue con i piedi
e le gambe distesi e paralleli, facendo partire il movimento
dall’anca e cercando di piegare solo leggermente le
ginocchia, con movimenti lenti e regolari. Occorre
mantenere le pinne sempre immerse per evitare rumore e
sprecare inutilmente le energie)
Sommozzate/Capovolte dalla superficie (in apnea). La
capovolta è il passaggio dal nuoto in superficie al nuoto
in immersione. L’esecuzione corretta di questo esercizio
permette di evitare inutili sprechi di energia. Una capovolta
corretta deve essere silenziosa, consentendo di arrivare
sott’acqua senza allarmare la fauna marina. La pinneggiata
dovrà iniziare esclusivamente quando si sarà totalmente
immersi. É opportuno, per sicurezza, togliersi il boccaglio
appena immersi.
Manovra di compensazione - La più comune manovra di
compensazione, detta del "Valsalva", consiste nel chiudersi
il naso con le dita espirando con dolcezza l’aria a bocca
chiusa. É utile abituarsi ad usare la mano destra, lasciando
la sinistra libera per il controllo del GAV. É necessario
compensare tutte le volte che se ne sente la necessità,
senza aspettare di sentire dolore
Risalita - (La manovra va effettuata pinneggiando
decisamente verso la superficie con regolarità e senza
soste, per evitare inutili consumi di ossigeno. In prossimità
della superficie si deve estendere un braccio verso l’alto
per proteggersi da eventuali ostacoli. É importante non
espirare mai durante la risalita.
Svuotamento dello snorkel - Eseguire lo svuotamento
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dell’aeratore usando sia il metodo della soffiata sia dello
spostamento dalla bocca, a seconda dal tipo di aeratore
Svuotamento della maschera Quando si riemergerà, per farla defluire, basterà sollevare
il bordo inferiore della maschera stessa rimanendo in
posizione verticale.
In immersione per svuotare la maschera basterà espirare
con il naso, tenendo leggermente premuto il bordo
superiore della maschera e guardando verso l’alto.
Ara:
Assemblare,
regolare,
preparare,
indossare
l’attrezzatura l’ARA (attività da compiere con l’assistenza di
un compagno, dell’Istruttore o di un assistente brevettato)
Controllo di sicurezza preimmersione - (controllare
l’attrezzatura del compagno facendo attenzione ad ogni
particolare e verificandone il funzionamento)
Entrata in acqua - (controllare il punto d'ingresso)
Dopo l’ingresso occorre segnalare l’OK dopo l’ingresso
e liberare la zona. Si deve scegliere la più comoda e la
meno pericolosa per sé e soprattutto per i compagni di
immersione. Gonfiare leggermente il GAV prima di entrare
in acqua per ottenere un assetto positivo
da un bordo basso: appoggiare entrambe le mani da un
lato del corpo, quindi lasciarsi scivolare in acqua ruotando,
con la faccia rivolta verso il bordo stesso
da un bordo alto: effettuare un passo in avanti e
mantenere la posizione verticale fino all’impatto con
l’acqua, questo per avere un affondamento minimo.
Controllare che non vi siano altri subacquei presenti nella
zona d’ingresso. É molto importante tenere con una mano
la maschera e l’erogatore e con l’altra la cintura di zavorra.
Gonfiaggio/sgonfiaggio del GAV in superficie - (Per far
fuoriuscire l’aria dal GAV, si utilizza il pulsante posto sul
gruppo comandi del corrugato (VIS). Per ottenere uno
sgonfiamento completo tenere il corrugato ben disteso
verso l’alto ed azionare il pulsante di scarico o esercitare,
sempre sul corrugato una trazione verso il basso facendo
intervenire la valvola di scarico rapido, nel caso sia
presente.
Contatto e respirazione con l’erogatore in superficie fondamentale che il ritmo respiratorio sia il più regolare
possibile, senza pause.
Nuoto in superficie con ARA 1. Pinneggiata normale, con il viso rivolto verso il fondo
utilizzando lo snorkel per respirare.
2. Pinneggiata sul fianco, con il viso fuori dall’acqua rivolto
al punto di arrivo, più comodo ma difficilmente utilizzabile
in caso di mare formato in quanto non potendo usare lo
snorkel rischieremmo di "bere"
3. Pinneggiata nuotando sul dorso, è il metodo più comodo
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
155
Pure Tech Agency
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
perchè il GAV ci consente di restare in galleggiamento, non
si hanno problemi a respirare e si ottiene anche una buona
velocità di avanzamento.
Si deve controllare ogni tanto la direzione, anche cercando
un punto di riferimento visivo
Discesa sul fondo con compensazione
Regolazione del GAV (Vis)
Respirazione con l’erogatore sott’acqua
Togliere - svuotare-rimettere l’erogatore
Svuotamento della maschera parzialmente allagata Proseguendo nella discesa, con l’aumento quindi della
pressione esterna, si ha una sensazione di depressione sul
viso, occorre perciò equilibrare la pressione all’interno della
maschera con quella esterna, compensandola con il naso,
semplicemente soffiandoci leggermente)
Pinneggiare in immersione - (nuotare sott’acqua con
l’attrezzatura mantenendo il controllo dell’assetto della
direzione e della profondità, compensando correttamente
le orecchie e la maschera alle variazioni di profondità,
mantenere una posizione corretta delle gambe/pinne ed
effettuare cicli di pinneggiata ampi e lenti)
Recupero dell’erogatore - Per recuperarlo si possono
utilizzare due metodi:
far percorrere al braccio un movimento rotatorio
iniziando verso il basso e facendolo passare aderente
al corpo, che deve essere inclinato leggermente dalla
medesima parte. Così facendo, quando il braccio
ritornerà in avanti, troveremo la frusta pronta per essere
afferrata. Bisogna ricordarsi che il II° stadio sarà allagato
dall’acqua e quindi dovrà essere svuotato.
recuperare la frusta dell’erogatore da dietro la spalla
stando sott’acqua, alzando il fondello della bombola,
cercare la frusta che parte dal I°stadio e poi far scorrere
le dite sino al boccaglio del II°stadio)
Svuotamento dell’erogatore (due metodi, espirazione e
pulsante di spurgo)
• Controllo dell’assetto -Si ha una pesata corretta quando in
acqua, inposizione verticale, espirando si affonda non oltre
la linea degli occhi)
• Uso del manometro - (localizzare e leggere il manometro
e indicare se la quantità di gas è quella indicata
dall’Istruttore)
• Segnali - I segnali elementari in superficie e sul fondo
(riconoscere e dimostrare i segnali manuali standard visti
nel manuale)
• Risalita - (segnalare, nuotare verso l’alto lentamente,
guardare in alto, gonfiare il GAV in superficie. La risalita in
156
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
•
•
•
•
•
•
superficie si inizia con una leggera pinneggiata verso l’alto,
per controllare la velocità si deve scaricare l’aria dal GAV,
in quanto espandendosi ne aumenta la spinta positiva.
Avvicinandosi alla superficie è buona norma estendere
il braccio, quello che tiene i pulsanti di carico e scarico,
VIS, verso l’alto per proteggersi da eventuali impedimenti.
La respirazione deve, in ogni caso, continuare ad essere
regolare e senza pause)
Scambio Aeratore/Erogatore - (in superficie, svuotare
dall’acqua l’aeratore e riprendere a respirare senza toglierlo
dalla bocca. Respirare alternativamente dall’aeratore e
dall’erogatore senza alzare il viso dall’acqua)
Liberazione dell’attrezzatura ARA- zavorra - Per fare
questo occorre individuare la posizione della cintura e della
fibbia, aprirle con la mano destra mantenendo la cintura
per non farla scivolare via . Per evitare che la cintura resta
intrappolato al subacqueo, in caso di abbandono della
cintura, la manovra dovrà essere effettuata stendendo il
braccio lontano dal corpo)
Uscita dall’acqua - togliere prima la zavorra, poi
l’autorespiratore e le pinne se necessario. Può essere
d’aiuto l’assistenza del compagno. La manovra di uscita
deve sempre avvenire nel modo più sicuro e facile: si
toglieranno cintura di zavorra e pinne tenendo conto
anche del metodo seguito per entrare e delle condizioni
ambientali.
Togliere, riporre e manutenzione dell’attrezzatura - (al
ritorno da un’immersione tutte le attrezzature devono
essere risciacquate con acqua dolce, fatte asciugare
possibilmente non esposte direttamente al sole e riposte in
ambienti asciutti.
Debriefing
Compilazione modulistica
Schema 1 AC1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Briefing
Preparazione dell’attrezzatura
Snorkeling:
Entrate in acqua
Respirazione
Nuoto/pinneggiata in superficie
Sommozzate /Capovolte dalla superficie (in apnea)
Manovra di compensazione
Risalita
Svuotamento dello snorkel
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
157
Pure Tech Agency
Ara
• Controllo di sicurezza preimmersione - controllare
l'attrezzatura
• Acqua bassa
• Entrata in acqua
• Gonfiaggio/sgonfiaggio del GAV in superficie
• Contatto e respirazione con l’erogatore in superficie
• Nuoto in superficie con ARA
• Discesa sul fondo con compensazione
• Regolazione del GAV (Vis)
• Respirazione con l’erogatore sott’acqua
• Togliere-svuotare-rimettere l’erogatore
• Svuotamento della maschera parzialmente
• Pinneggiare in immersione
• Recupero dell’erogatore
• Controllo dell’assetto
• Uso del manometro
• Segnali
• Risalita
Tempo per fare pratica
• Scambio Aeratore/Erogatore
• Liberazione dell’attrezzatura ARA zavorra
• Uscita dall’acqua
• Togliere, riporre e manutenzione dell’attrezzatura
• Debriefing
• Compilazione modulistica
1 AC2 - ARA livello 2
• Briefing
• Preparazione dell’attrezzatura - Assemblare, regolare,
preparare, indossare l’attrezzatura l’ARA (con l’assistenza
di un compagno, dell’Istruttore o di un assistente
brevettato)
• Controllo di sicurezza preimmersione - (controllare
l’attrezzatura del compagno facendo attenzione ad ogni
particolare verificandone il funzionamento)
• Entrata in acqua fonda - (seduto per capovolta all’indietro,
in piedi passo in avanti/del gigante)
• Svuotamento dell’aeratore - (svuotare dall’acqua l’aeratore
usando il metodo del soffio e riprendere a respirare
dal’aeratore senza alzare il viso dall’acqua)
• Scambio aeratore - erogatore - (in superficie, svuotare
dall’acqua lo snorkel e riprendere a respirare senza
toglierlo dalla bocca. Respirare alternativamente dallo
snorkel e dall’erogatore senza alzare il viso dall’acqua).
• Gonfiaggio a bocca e sgonfiaggio del GAV in superficie
158
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
- (Per prevenire l’uscita dell’aria, non si deve premere il
pulsante di scarico mentre non si sta soffiando nel GAV)
• Nuoto in superficie con l’autorespiratore
• Discesa sul fondo con compensazione - (sistema dei 5
punti)
1.
2.
3.
4.
5.
Segnalare al compagno
Osservare i punti in superficie
Scambiare l’aeratore con l’erogatore
Annotare il tempo (timer - orologio - computer da polso)
Sgonfiare il GAV e scendere compensando
• Togliere e rimettere la maschera - (completa rimozione,
riposizionamento e svuotamento della maschera stando
seduti o inginocchiati sul fondo in acqua bassa, avendo
cura di scaricare prima dell’esecuzione dell’esercizio l’aria
dal GAV.
Per svuotare la maschera in immersione occorre esercitare
con le mani una leggera pressione sul bordo superiore della
maschera stessa, evitando di sollevare il bordo inferiore, ed
emettere leggermente aria dal naso, mantenendo la testa
leggermente rivolta verso l’alto e inclinandola leggermente
verso destra e verso sinistra)
• Respirazione senza la maschera - (GAV sgonfio, seduti
o inginocchiati sul fondo in acqua bassa. Mantenere il
controllo delle vie aeree e l’espirazione dal naso)
• Pivoting (pendolo) senza movimenti - (con comando a
bassa pressione e a bocca. Lo studente, in posizione
orizzontale in appoggio sul fondo, dovrà gonfiare
lentamente il GAV ottenendo un assetto che sarà positivo
inspirando negativo in espirando, il suo assetto dovrà
essere regolato in modo tale da oscillare verso l’alto
quando inspira e verso il basso quando espira facendo
perno sulla punta delle pinne. ASSOLUTAMENTE NON si
deve trattenere il respiro, si DEVE invece emettere delle
bolle quando non si ha l’erogatore in bocca senza premere
il pulsante)
• Togliere e rimettere la cintura di zavorra sul fondo (scaricare l’aria dal GAV, liberare la cintura tenendola con
la mano destra dalla parte opposta alla fibbia a sgancio
rapido, facendo attenzione che non si sfilino i piombi.
A questo punto, mantenendo l’erogatore in bocca, lo
studente dovrà ruotare verso sinistra tenendo la cintura
ben vicina al fianco destro. É di fondamentale importanza
continuare a respirare dall’erogatore in maniera regolare,
senza trattenere il respiro. Un buon sistema consiste anche
nel fare passare la cintura dietro, in posizione verticale o
inginocchiati; trattenendola con la mano destra, la sinistra
andrà ad afferrare saldamente la fibbia portandola sul
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
159
Pure Tech Agency
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
davanti. A questo punto, assicurandosi con la mano che la
cintura sia in posizione corretta si potrà chiudere la fibbia.
Uso della la Fonte d’Aria Alternativa in coppia, statico
- (respirare sott’acqua per almeno 30 secondi dalla
Fonte d’Aria Alternativa fornita da un altro subacqueo e
scambio dei ruoli donatore/ricevente. Al segnale di fine
aria, afferrare e respirare da una Fonte d’Aria Alternativa
fornita dal compagno per almeno un minuto nuotando
sott’acqua. Dividere l’aria con un altro subacqueo,
utilizzando una Fonte d’Aria Alternativa, con scambio dei
ruoli agendo come donatore/ricevente. Lo studente deve
iniziare l’esercizio con i segnali standard "fine aria" e
"dividiamo l’aria". Come sistema più attuabile è preferibile
che il donatore tenga l’erogatore principale (dal quale sta
respirando) e passi al ricevente il secondario, ma eventuali
FAA integrate nel dispositivo di gonfi aggio del GAV e altre
configurazioni richiedono che il donatore passi al ricevente
l’erogatore principale e prenda contatto con il secondario.
Il punto essenziale è che il compagno sia a conoscenza del
funzionamento del sistema usato dall’altro. Il ricevente
afferra autonomamente la FAA salvo nelle situazioni in cui
sia il donatore a porgere l’erogatore principale. In questo
caso il donatore offre l’erogatore principale e passa al suo
secondario. Lo studente PUO’ riprendere a respirare dal
proprio erogatore se, in qualsiasi momento, se si dovesse
trovare in difficoltà.
Segnali - riconoscere e dimostrare i segnali manuali
standard
Uso del manometro
Risalita (sistema dei 5 punti)
Segnalare al compagno attendere il segnale OK SU
dell’Istruttore
Verificare il tempo
Tenere una mano in alto e sul comando del GAV
Guardare verso alto
Nuotare lentamente verso l’alto ruotando su stessi
• Togliere e rimettere la cintura di zavorra in superficie - (in
acqua fonda da non poter toccare, rimuovere la zavorra e
simulare di lasciarla cadere come se fosse un’emergenza.
Se si usa un sistema di zavorra integrato si deve utilizzare
il meccanismo di sgancio rapido)
• Liberazione dell’attrezzatura ARA-zavorra
• Uscita dall’acqua
• Togliere e riporre l’attrezzatura
• Debriefing
• Compilazione modulistica
160
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Schema 1 AC2
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
Briefing
Preparazione dell’attrezzatura
Controllo di sicurezza preimmersione
Entrata in acqua fonda
Scambio aeratore - erogatore
Gonfiaggio a bocca e sgonfi aggio del GAV in superficie
Nuoto in superficie con l’autorespiratore
Discesa sul fondo con compensazione
Segnalare al compagno
Osservare i punti in superficie
Scambiare l’aeratore con l’erogatore
Annotare il tempo
Sgonfiare il GAV e scendere compensando
Togliere e rimettere la maschera
Respirazione senza la maschera
Pivoting (pendolo)
Togliere e rimettere la cintura di zavorra sul fondo
Uso della la FAA in coppia, statico
Segnali
Uso del manometro
Risalita
Segnalare al compagno attendere il segnale OK SU
dell’Istruttore
Verificare il tempo
Tenere una mano in alto e l’altra sul comando del GAV
Guardare verso alto
Nuotare lentamente verso l’alto ruotando su stessi
Tempo per fare pratica
• Togliere e rimettere la cintura di zavorra in superficie
• Liberazione dell’attrezzatura ARAzavorra
• Uscita dall’acqua
• Togliere e riporre l’attrezzatura
• Debriefing
• Compilazione modulistica
1 AC3 - ARA livello 3
• Briefing
• Preparazione dell’attrezzatura - (Assemblare, regolare,
preparare, indossare l’attrezzatura l’ARA (con l’assistenza
di un compagno, dell’Istruttore o di un assistente
brevettato)
• Controllo di sicurezza preimmersione)
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
161
Pure Tech Agency
• Entrate in acqua - in acqua fonda (seduto per capovolta
all’indietro, in piedi passo in avanti/del gigante)
• Pratica con il GAV (in superficie gonfi aggio del GAV a bocca e
con la frusta)
• Togliere e rimettere la maschera con svuotamento.
• Controllo dell’assetto pinneggiando con attrezzatura
indossata
• Nuoto subacqueo senza la maschera
• Esaurimento dell’aria/fonte d’aria alternativa, esercizi
abbinati, sia statici che in risalita - (l’Istruttore chiude il
rubinetto dello studente che simula di aver finito l’aria.
Quando lo studente avverte che l’aria sta per finire (senza
guardare il manometro), deve segnalare: "sono senz’aria",
afferrare la FAA del compagno e iniziare a respirare. Dopo
aver preso contatto con la FAA del compagno, l'Istruttore
riaprirà il rubinetto cosi che l'erogatore sia di nuovo pronto
all'uso. Dopo aver stabilito il contatto, di comune accordo,
la coppia inizia a risalire uno di fronte all'altro oppure uno
di fianco all'altro, secondo la configurazione concordata.
La posizione più comune è quella uno di fronte all’altro
tenendosi per il braccio destro o per gli spallacci del GAV.
Il Vis va tenuto in mano. Durante la risalita, i subacquei
devono controllare il proprio assetto e mantenere una
velocità di risalita normale. In superficie, il ricevente, colui
che simula una mancanza d’aria, non potendo usare il
dispositivo di gonfiaggio a bassa pressione, deve gonfiare
il GAV a bocca.
Lo studente DEVE riprendere a respirare dal proprio
erogatore se, in qualsiasi momento, si dovesse trovare in
difficoltà.
• Uso del manometro • Risalita controllata di emergenza nuotando - (simulare una
risalita controllata d’emergenza, nuotando sott’acqua in
orizzontale per almeno 9 m, espirando in continuazione.
Prima di decidere di effettuare una risalita controllata di
emergenza nuotando, il subacqueo dovrebbe fermarsi, pensare,
agire, tentare di respirare, cercare un altro subacqueo, e se
possibile eseguire una normale risalita.)
• Nuoto in superficie con l’attrezzatura indossata respirando solo
dall’aeratore
• Rimozione di un crampo - (rimozione di un crampo
su una gamba tirando la punta della pinna verso se
stessi o spingendola verso il compagno mentre la tiene
saldamente)
• Uscita dall’acqua camminando e/o simulando dalla barca
• Togliere e riporre l’attrezzatura
• Debriefing
• Compilazione modulistica
162
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Schema 1 AC3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Briefing
Preparazione dell’attrezzatura
Controllo di sicurezza preimmersione
Entrate in acqua
Pratica con il GAV (in superficie gonfiaggio del GAV a bocca
e con la frusta)
Togliere e rimettere la maschera con svuotamento.
Controllo dell’assetto pinneggiando con attrezzatura
indossata
Nuoto subacqueo senza la maschera
Esaurimento dell’aria/fonte d’aria alternati, statico e in
risalita
Uso del manometro
Risalita controllata di emergenza nuotando
Nuoto in superficie con l’attrezzatura indossata respirando
solo dall’aeratore
Rimozione di un crampo
Tempo per fare pratica
• Uscita dall’acqua camminando e/o simulando dalla barca.
• Togliere e riporre l’attrezzatura
• Debriefing
• Compilazione modulistica
1 AC4 ARA livello 4
• Briefing
• Preparazione dell’attrezzatura - (Assemblare, regolare,
preparare, indossare l’attrezzatura l’ARA (con l’assistenza
di un compagno, dell’Istruttore o di un assistente
brevettato)
• Controllo di sicurezza preimmersione - (controllare
l’attrezzatura del compagno facendo attenzione ad ogni
particolare verificandone il funzionamento)
• Entrate in acqua
• Discesa con controllo della velocità e prove di stop
• Respirazione in coppia - (respirare in coppia scambiando il
secondo stadio per una distanza di almeno 15 m sott’acqua
alternandosi nel ruolo donatore e ricevitore. Dimostrare la
tecnica con i seguenti punti: Segnali corretti, mantenere
il contatto, controllo da parte del donatore, cicli di
respirazione, necessità di espirare emettendo aria quando
l’erogatore non è in bocca)
• Respirazione da un erogatore in continua - (respirare in
modo efficace da un erogatore in continua per non meno
di 30 secondi)
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
163
Pure Tech Agency
• Pratica con il pallone gonfi abile - (pedagno), liberazione,
estensione, gonfi aggio con la FAA e lancio pilotato in
superficie
• Ripasso esercizi precedenti
• Risalita
• Trasporto di un subacqueo stanco - (in superficie dove non
si tocca eseguire il trasporto di un subacqueo stanco per
25 m con presa sotto il braccio e dalla rubinetteria)
Tempo per fare pratica
• Togliere e riporre l’attrezzatura
• Debriefing
• Compilazione modulistica
Schema 1 AC4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Briefing
Preparazione dell’attrezzatura
Controllo di sicurezza preimmersione
Entrate in acqua
Discesa con controllo della velocità e prove di stop
Respirazione in coppia
Respirazione da un erogatore in continua
Pratica con il pallone gonfiabile
Ripasso esercizi precedenti
Risalita
Trasporto di un subacqueo stanco
Tempo per fare pratica
• Togliere e riporre l’attrezzatura
• Debriefing
• Compilazione modulistica
1 AC5 ARA livello 5
• Briefing
• Preparazione dell’attrezzatura - (Assemblare, regolare,
preparare, indossare l’attrezzatura l’ARA con l’assistenza di
un compagno, dell’Istruttore o di un assistente brevettato)
• Controllo di sicurezza pre-immersione (controllare
l’attrezzatura del compagno facendo attenzione ad ogni
particolare verificandone il funzionamento)
• Togliere e rimettere l’unità ARA sott’acqua - (far scaricare
completamente prima l’aria dal pulsante di spurgo/VIS,
permettere l’assistenza al compagno solo se necessario)
• Scollegamento della frusta bassa pressione del GAV - al
termine ricollegarla
164
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
• Controllo dell’assetto (Hovering) - (assetto neutro gonfiando
il GAV a bocca e con il carico a bassa pressione. Controllo
dell’assetto rimanendo sospesi a mezz’acqua senza pinneggiare
e senza muovere le braccia per almeno 30 secondi.
La respirazione per la regolazione deve essere regolare ,
NON trattenere il respiro)
• Lancio del pallone - Esercizio da eseguire in due fasi,
la prima posizionato sul fondo e la seconda in assetto
neutro. In assetto neutro ma con contatto visivo della
cima di discesa/risalita o del fondo a secondo del
luogo in cui viene svolta la prova. Estrarre il pallone di
segnalazione, srotolarlo; contemporaneamente liberare il
mulinello/spool. Agganciare il pallone al moschettone del
mulinello, nel contempo si sarà provveduto ad allentare
la frizione di ritenzione del rullo. Introdurre nel pallone il
gas dall’apertura posta in basso utilizzando l ’erogatore
secondario. Fare molta attenzione che durante questa fase
e la successiva di lancio, non rimanga intrappolata la cima
nell’erogatore o in qualche altra parte dell’equipaggiamento,
ciò potrebbe causare una pericolosa risalita incontrollata.
Una volta che il pallone è arrivato in superficie, recuperare
il lasco della cima e metterla in leggera tensione.
• Prove di recupero e sollevamento dal fondo del compagno
con controllo della velocità di risalita
• Togliere e rimettere l’unità ARA in superficie - (Lo studente
può utilizzare l’aeratore o l’erogatore. L’autorespiratore deve
essere sufficientemente positivo in modo da fornire supporto
una volta tolto, specialmente se si utilizza la zavorra integrata.
Lo studente non deve perdere il contatto con
l’autorespiratore, dopo averlo tolto.
• Ripasso esercitazioni precedenti
Tempo per fare pratica
• Debriefing
• Compilazione modulistica
Schema 1AC5
•
•
•
•
•
•
•
Briefing
Preparazione dell’attrezzatura
Controllo di sicurezza preimmersione
Togliere e rimettere l’unità ARA
Scollegamento della frusta bassa pressione
Controllo dell’assetto (Hovering)
Recupero e sollevamento dal fondo del compagno con
controllo della velocità di risalita
• Ripasso esercitazioni precedenti
• Togliere e rimettere l’unità ARA in superficie
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
165
Pure Tech Agency
Tempo per fare pratica
• Debriefing
• Compilazione modulistica
166
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Acque Libere
Obiettivi
• Mettere in pratica quello che hai appreso durante le fasi
delle acque confinate
• Consolidare la tua sicurezza in acqua e rafforzare il
concetto del "sistema di coppia" e il rispetto dell'ambiente
• L'Istruttore ti fornirà supporto ma non dimostrerà gli
esercizi
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
167
Pure Tech Agency
1 AL1 ARA - massima profondità 6 m
Obiettivi:
1.
2.
Facilitare il passaggio dalle esercitazioni in Acque
Confinate alle acque libere e introdurre ad un nuovo
ambiente.
Sviluppare l’applicazione delle abilità al buon senso, al
controllo dell’assetto, alla consapevolezza di essere in
un ambiente diverso da quello terrestre, prepararsi ad
effettuare una reale immersione.
• Briefing
• Assemblare, regolare, preparare, indossare l’attrezzatura
ARA
• Controlli di coppia di sicurezza pre-immersione (controlla
l’attrezzatura del compagno facendo attenzione ad ogni
particolare verificandone il funzionamento)
• Ingresso in acqua - (tecnica adatta alle condizioni
ambientali .La più semplice è la migliore)
• Pesata d’assetto - (calcola la quantità di pesi necessaria
tenendo l’erogatore in bocca, trattenendo un respiro
normale, sollevando le gambe dal fondo e rimanendo
immobili, dovresti galleggiare con l’acqua a livello degli
occhi.
• Raggiungimento del punto d’immersione - (controllando
l’assetto in superficie, respirando dall’aeratore)*
• Scambio aeratore/erogatore
• Discesa controllata con il sistema dei 5 punti - (eseguire
lungo la cima facendo attenzione alla compensazione.
• Recupero e svuotamento dell’erogatore - (recuperare e
svuotare il proprio secondo stadio cosi come hai fatto nelle
immersioni in acque confinate.
• Allagamento parziale della maschera e successivo
svuotamento - (svuotare la maschera parzialmente
allagata e, successivamente, completamente allagata.
• Termine esercitazione con risalita controllata - (vis in
mano, uso delle pinne con GAV sgonfio)
• In superficie assetto positivo - (eseguire gonfiando il GAV
con ritorno al punto di uscita)
• Uscita dall’acqua , svestizione dell’attrezzatura
• Debriefing e compilazioni moduli
168
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Schema 1 AL1
• Briefing
• Assemblare, regolare, preparare, indossare l’attrezzatura
ARA
• Controlli di coppia di sicurezza pre-immersione. *
• Ingresso in acqua
• Pesata
• Raggiungimento del punto d’immersione *
• Scambio aeratore/erogatore
• Discesa controllata con il sistema dei 5 punti
• Recupero e svuotamento dell’erogatore
• Allagamento parzialmente la maschera e successivo
svuotamento
• Termine esercitazione con risalita controllata
• In superficie assetto positivo
• Uscita dall’acqua , vestizione dell’attrezzatura
• Debriefing e compilazioni moduli
1 AL2 ARA - massima profondità 10 m
Obiettivi:
1.
2.
Applicare e migliorare le tecniche di immersione in acque
libere.
Accrescere la confidenza, il comfort, il buon senso e le
abilità d’ immersione.
• Briefing
• Assemblare, regolare, preparare, indossare l’attrezzatura
ARA
• Controlli di coppia di sicurezza pre-immersione (controlla
l’attrezzatura del compagno facendo attenzione ad ogni
particolare verificandone il funzionamento)
• Ingresso in acqua secondo la logistica
• Verifica e controllo dell’assetto/pesi
• Raggiungimento del punto d’immersione - (controllare
l’assetto in superficie, respirando dall’aeratore)*
• Scambio aeratore/erogatore - (in superficie, svuota
dall’acqua lo snorkel e riprendi a respirare senza toglierlo
dalla bocca. Respira alternativamente dallo snorkel e
dall’erogatore senza alzare la faccia dall’acqua
• Discesa controllata (5 punti)
• Pivoting sulle pinne - (assetto neutro)
• Breve esplorazione subacquea con controllo dell’assetto
• Uso della Fonte d’Aria Alternativa da fermi e risalita
assistita con FAA - (da fermo, deve afferrare e respirare da
una FAA fornita da un altro subacqueo.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
169
Pure Tech Agency
• Allagamento completo della maschera e successivo
svuotamento (da fermo sul fondo, masima profondità 5 m,
scarica completamente il GAV prima di eseguire l’esercizio)
• Termine prova in superficie - (in assetto positivo gonfiando
il GAV, con ritorno al punto di uscita)
• Svestizione della zavorra - (in superficie, nell’acqua dove
non si tocca, togli e rimetti il sistema di zavorra.
Prima di eseguire l’esercizio, assicurati che non vi siano
altri subacquei sotto per prevenire possibili lesioni dovute
ai pesi che cadono.
• In superficie, nell’acqua dove non si tocca, togliere e
rimettere l’autorespiratore
• Uscita dall’acqua, svestizione dell’attrezzatura
• Debriefing e compilazioni moduli
Schema 1 AL2
• Briefing
• Assemblare, regolare, preparare, indossare l’attrezzatura
ARA
• Controlli di coppia di sicurezza pre-immersione. *
• Ingresso in acqua
• Verifica e controllo dell’assetto/pesi
• Raggiungimento del punto d’immersione *
• Scambio aeratore/erogatore
• Discesa controllata (5 punti)
• Allagamento completo della maschera e successivo
svuotamento
• Pivoting sulle pinne
• Breve esplorazione subacquea con controllo dell’assetto
• Uso della Fonte d’Aria Alternativa da fermi e risalita
assistita
• Termine prova in superficie
• Svestizione della zavorra
• In superficie, nell’acqua dove non si tocca, togliere e
rimettere l’autorespiratore
• Uscita dall’acqua , vestizione dell’attrezzatura
• Debriefing e compilazioni moduli
1 AL3 ARA - massima profondità 12 m
Obiettivi:
1.
2
170
Continuare ad applicare le tecniche di immersione in
acque libere entro la profondità massima di 12 m
Accrescere ulteriormente la confidenza, il buon senso e
le abilità generali
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
3.
Assemblare, regolare, preparare, indossare l’attrezzatura
ARA
• Briefing
• Assemblare, regolare, preparare, indossare l’attrezzatura
ARA
• Controlli di coppia di sicurezza pre-immersione (controlla
l’attrezzatura del compagno facendo attenzione ad ogni
particolare verificandone il funzionamento)
• Ingresso in acqua secondo la logistica
• Raggiungimento del punto d’immersione (controllare
l’assetto in superficie, respirando dall’aeratore)*
• Scambio aeratore/erogatore
• Discesa controllata con (5 punti)
• Controllo dell’assetto (Hovering) - (assetto neutro gonfia
il GAV a bocca e con il carico a bassa pressione. Devi
dimostrare un buon controllo dell’assetto, stando lontano
dal fondo e avendo costantemente la consapevolezza della
tua galleggiabilità.
• Breve esplorazione subacquea con controllo dell’assetto (sotto la diretta supervisione dell’Istruttore procederai in
una breve esplorazione per acquisire esperienza)
• Termine esercitazione con risalita controllata d’emergenza
nuotando (esegui una risalita controllata di emergenza
nuotando da una profondità di 6 - 9 m e stabilendo un
assetto positivo in superficie.
Questo esercizio deve essere condotto come di
seguito delineato.
Fasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
•
mantieni l’erogatore in bocca
non cercare di abbandonare la zavorra
non usare la cima di controllo - la cima serve
all’Istruttore
mantiei una velocità di risalita normale
emetti un suono continuo (aaahhh) durante la risalita
riprendere a respirare normalmente in caso che la risalita
venga interrotta o in caso di difficoltà In superficie
in superficie gonfia il GAV a bocca
In superficie assetto positivo - (eseguire gonfiando il GAV
con ritorno al punto di uscita)
Rimozione di un crampo - (eseguire la rimozione di
un crampo simulato su se stessi e sul compagno in
superficie. Come già fatto in acque confinate, gli studenti
devono praticare, in superficie, la rimozione di un crampo
su una gamba tirando la punta della pinna verso se
stessi o spingendola verso il compagno mentre la tiene
saldamente)
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
171
Pure Tech Agency
• Trasporto di un subacqueo stanco per 25 m - (secondo la
logistica, effettuare il ritorno al punto di uscita, facendo
invertire nel ruolo gli allievi.
Trasportare per 25 m in superficie e con tutta l’attrezzatura
il compagno che simula di essere stanco. I subacquei, si
scambieranno i ruoli, simulando di dare assistenza ad un
compagno stanco o in difficoltà trasportandolo per 25 m in
superficie, tirandolo per la rubinetteria, ecc.)
• Rimozione della zavorra
• Uscita dall’acqua, svestizione dell’attrezzatura
• Debriefing e compilazioni moduli
Schema 1 AL3
• Briefing
• Assemblare, regolare, preparare, indossare l’attrezzatura
ARA
• Controlli di coppia di sicurezza pre-immersione*
• Ingresso in acqua
• Raggiungimento del punto d’immersione *
• Scambio aeratore/erogatore
• Discesa controllata con (5 punti)
• Controllo dell’assetto (Hovering)
• Breve esplorazione subacquea con controllo dell’assetto
• Termine esercitazione con risalita controllata d’emergenza
nuotando
• In superficie assetto positivo
• Rimozione di un crampo
• Trasporto di un subacqueo stanco per 25 m
• Rimozione della zavorra
• Uscita dall’acqua , vestizione dell’attrezzatura
• Debriefing e compilazioni moduli
1 AL4 ARA - massima profondità 15 m
Obiettivi:
1.
2.
Continuare ad applicare ulteriormente le tecniche di
immersione nell’ambiente delle acque libere entro la
profondità massima di 15 m
Accrescere ulteriormente, la confidenza, il buon senso e
le abilità generali
• Briefing
• Assemblare,
regolare,
l’attrezzatura ARA
172
preparare,
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
indossare
Pure Tech Agency
• Controlli di coppia di sicurezza pre-immersione (controlla
l’attrezzatura del compagno facendo attenzione ad ogni
particolare verificandone il funzionamento)
• Ingresso in acqua secondo la logistica
• Raggiungimento del punto d’immersione (controlla l’assetto
in superficie, respirando dall’aeratore)*
• Scambio aeratore/erogatore
• Discesa libera senza riferimento - (profondità massima
durante l’immersione 15 m Discesa controllata con i cinque
punti senza riferimento visivo)
• Breve esplorazione subacquea con controllo dell’assetto
• Termine esercitazione con risalita controllata - (sistema dei
5 punti, vis in mano, uso delle pinne con GAV sgonfio.
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•
•
Segnala "risaliamo" e attendi la risposta del compagno.
Controlla il tempo e la profondità.
Tieni in alto la valvola di scarico del GAV per eliminare
l’aria in eccesso durante la risalita.
Distendi l’altro braccio sopra la testa.
Guarda in alto e nuota verso l’alto, ruotando per avere
una migliore visuale.
Fermati a 5 m per eseguire la sosta di sicurezza, quindi
prosegui con la risalita. Dopo essere riemerso, assumi
un assetto positivo gonfiando il GAV prima di scambiare
l’erogatore con l’aeratore e segnala "okay".
Ricordati che, durante la risalita l’aria nel GAV si espande,
questo ti renderà positivo. È necessario, pertanto, scaricare
l’aria in eccesso.
Ricordandosi di respirare normalmente e/o emettere un
suono tipo:…aaahhh.)
In superficie assetto positivo - (esegui gonfiando il GAV
con ritorno al punto di uscita)
Uscita dall’acqua
Svestizione dell’attrezzatura
Debriefing
Compilazioni moduli
Schema 1 AL4
• Briefing
• Assemblare, regolare, preparare, indossare l’attrezzatura
ARA
• Controlli di coppia di sicurezza pre-immersione*
• Ingresso in acqua
• Raggiungimento del punto d’immersione *
• Scambio aeratore/erogatore
• Discesa libera con riferimento
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
173
Pure Tech Agency
•
•
•
•
•
Breve esplorazione subacquea con controllo dell’assetto
Termine esercitazione con risalita controllata
In superficie assetto positivo
Uscita dall’acqua , vestizione dell’attrezzatura
Debriefing e compilazioni moduli
1 AL5 ARA - massima profondità 18 m
Gli obiettivi:
1.
2.
3.
Continuare ad applicare ulteriormente le tecniche di
immersione nell’ambiente delle acque libere entro la
profondità massima di 18 m
Accrescere ulteriormente, negli studenti, la confidenza, il
buon senso e le abilità generali
Sviluppare le tecniche fondamentali di navigazione con la
bussola.
• Briefing
• Assemblare, regolare, preparare, indossare l’attrezzatura ARA
• Controlli di coppia di sicurezza pre-immersione (controlla
l’attrezzatura del compagno facendo attenzione ad ogni
particolare verificandone il funzionamento)
• Ingresso in acqua secondo la logistica
• Navigazione con la bussola in superficie - (esegui nuoto in
superficie con l’aeratore, in linea retta, con il viso in acqua
e usando la bussola comeunico riferimento.
Questo esercizio introduce gli allievi all’uso della bussola.
• Scambio aeratore/erogatore in superficie
• Discesa libera con riferimento - (profondità massima
durante l’immersione 18 m
• Navigazione con bussola - Iniziare questo esercizio
partendo da un punto di riferimento fisso come la cima
di discesa o dell’ancora. Pinneggiare allontanandosi dal
punto di riferimento, verso la direzione precedentemente
determinata per un dato numero di cicli di pinneggiata
(10/20), inseguito ritornare al punto di partenza, seguendo
la rotta reciproca.
• Termine esercitazione
• Lancio del pallone sparabile
• Risalita controllata - (vis in mano, uso delle pinne con GAV
sgonfio)
• In superficie assetto positivo - (esegui gonfiando il GAV
con ritorno al punto di uscita)
• Rimozione della zavorra
• Uscita dall’acqua, svestizione dell’attrezzatura
• Debriefing
• Compilazioni moduli
174
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Schema 1 AL5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Briefing
Assemblare, regolare, preparare, indossare l’attrezzatura ARA
Controlli di coppia di sicurezza pre-immersione*
Ingresso in acqua
Ingresso in acqua secondo la logistica
Navigazione con la bussola in superficie
Scambio aeratore/erogatore in superficie
Discesa libera con riferimento
Navigazione con bussola
Termine esercitazione
lancio del pallone sparabile
risalita controllata
In superficie assetto positivo
Rimozione della zavorra
Uscita dall’acqua , vestizione dell’attrezzatura
Debriefing e compilazioni moduli
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
175
Pure Tech Agency
176
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Appendice
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
177
Pure Tech Agency
Una prospettiva per il futuro
delle vostre immersioni:
la fotografia subacquea
(di Enrico Pati - [email protected])
Andare sott’acqua, immergersi dentro il mare, nei laghi o nei
fiumi è un’esperienza che consente di svolgere anche una
moltitudine di attività.
La prima, più semplice ed immediata, è quella dell’osservazione
dell’ambiente acquatico, ma a questa se ne possono affiancare
molte altre.
Perlustrare un tratto di fondale, esplorare un relitto,
ispezionare delle cavità sommerse, effettuare un’immersione
tecnica, profonda o notturna, presuppongono delle conoscenze
specifiche e un’adeguata preparazione, per poterlo fare in
ragionevole sicurezza e consapevole capacità.
Qualunque sia il livello di conoscenza, il grado di esperienza
e di addestramento, a queste attività da svolgersi sott’acqua,
se ne può affiancare un’altra, anch’essa fatta di competenze
tecniche e preparazione, ma che ha la peculiarità di riguardare
la sfera emozionale, creativa e artistica: quella della fotografia
subacquea.
Sia ben chiaro quindi, che la pratica della fotografia subacquea,
non rappresenta l’attività principale, perché questa è e
rimane, quella dell’andare sott’acqua, con tutto quello che
ciò comporta. Diciamo che fare fotografia subacquea significa
avere l’aspettativa di immortalare l’attimo dell’immersione,
documentare la situazione e testimoniare il momento vissuto
e di questo riportarne, per così dire, una traccia "a secco",
visibile e condivisibile da tutti, subacquei e non.
Oggi, con la comparsa della tecnologia digitale applicata alla
fotografia, la possibilità di scattare foto si è enormemente
sviluppata ed il mercato della fotografia, anche di quella
subacquea, si è notevolmente ringalluzzito.
Con poche centinaia di euro, è possibile acquistare macchine
fotografiche digitali compatte, e dotarle di scafandri dedicati,
che permettono il loro utilizzo fino a profondità spesso
ragguardevoli. Ciò di per sé rappresenta una possibilità, che
però spesso viene disillusa alla vista dei primi risultati; da qui
la necessità di avere delle conoscenze minime sull’utilizzo di
queste attrezzature e soprattutto, dell’utilizzo in un ambiente,
quello subacqueo, che non è esattamente l’ambiente per il
quale sono state progettate.
Per chi fosse interessato ad approfondire questa pratica,
il consiglio è senz’altro, quello di seguire dei corsi specifici
mentre, per chi è semplicemente incuriosito, può andar bene,
all’inizio, anche solo fare molti tentativi, portare sott’acqua la
178
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
propria macchinetta fotografica ad ogni immersione, leggere
pubblicazioni e articoli di fotografia subacquea, seguire i
consigli di qualche amico fotosub.
Quello che mi sento di consigliare a chiunque è di non avere
fretta, iniziare con attrezzature semplici ed economiche e pian
piano cercare di migliorare risultati ed attrezzatura.
Per chi è alle prime armi, le macchine fotografiche compatte
implicano senz’altro una serie di vantaggi.
-
-
-
-
-
-
-
Sono piccole: per cui anche scafandrate, avranno
delle dimensioni ridotte, di conseguenza saranno più
maneggevoli, più facili da gestire, anche con una sola
mano, potranno essere riposte in tasca o appese al GAV,
ed utilizzate solo all’occorrenza.
Costano poco: quindi l’investimento iniziale non è
particolarmente oneroso e siccome bisognerà fare i conti
anche con infiltrazioni e piccoli allagamenti, è senz’altro
meglio contenere possibili danni e dispiaceri.
Ottima qualità: ormai anche queste "piccole" hanno
sensori di altissima qualità in grado di catturare
luce, colori e informazioni e di poterle restituire con
risoluzioni che facilmente permettono stampe in formati
considerevoli.
Facili da utilizzare: questo tipo di macchine fotografiche
non sono mai troppo complicate, sono semplici ed
intuitive, spesso hanno tutta una serie di impostazioni
e funzioni automatiche, tra cui la messa a fuoco,
l’esposizione e le funzioni "macro" e "sott’acqua" che
possono risultare notevolmente utili.
Hanno il flash: la maggior parte di queste macchine
fotografiche compatte, hanno dei piccoli lampeggiatori
interni che in condizioni di scarsa luminosità si
inseriscono automaticamente e, in ambienti subacquei,
nella maggior parte dei casi, è indispensabile utilizzare
delle fonti di illuminazioni aggiuntive.
Visione comoda: guardare con due occhi nei luminosi
monitor lcd di cui sono dotate queste piccole macchine
fotografiche, è senz’altro più semplice e immediato, del
dover scrutare nel mirino di una reflex e questo, sia in
fase di ripresa, ché immediatamente dopo lo scatto,
potendo verificare il risultato di quanto si è appena
fotografato.
Poca manualità e manutenzione: hanno delle ottiche
zoom, non intercambiabili, che spaziano con una notevole
escursione e coprono generalmente grandi fasce di
utilizzo, dal grandangolo al teleobiettivo, non necessitano
di aperture per cambi di ottiche e di conseguenza oblò
sugli scafandri; la manualità e manutenzione si riduce al
semplice alloggiamento della macchina nello scafandro.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
179
Pure Tech Agency
Anche per chi è un fotografo "terrestre" non proprio alle prime
armi, o per chi, dopo qualche tempo e un po’ di esperienza
con le compatte, volesse proseguire e migliorare la propria
attrezzatura, il consiglio è quello di dotarsi di macchine
fotografiche di fascia media, tipo "bridge" o "prosumer" come
vengono normalmente definite, che hanno la possibilità di
utilizzo in manuale, per le quali spesso esistono in commercio
scafandri dedicati, che riportano tutti i comandi della macchina
fotografica all’esterno e permettono l’utilizzo di uno o due
flash esterni, collegati tramite cavo elettronico o cavetto
in fibra ottica. Con questo tipo di attrezzatura si possono
ottenere degli ottimi risultati, a questo punto molto dipenderà
dalle vostre capacità tecniche, sensibilità artistica e volontà
documentaristica.
180
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Consigli e suggerimenti per
una pratica più sicura delle
attività subacquee.
Perchè il tempo libero sia sempre fonte di benessere
e non un rischio. La visita medica rappresenta il solo
strumento diagnostico per un efficace trattamento
terapeutico e che i consigli forniti vanno intesi come
meri suggerimenti di comportamento
a cura della Dott.ssa Laura Vernotico
http://www.lauravernotico.com/
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
181
Pure Tech Agency
Alimentazione e Attività subacquea
Una buona alimentazione è importante per mantenere sano il nostro
organismo e farlo funzionare al meglio. Questo è valido per le persone che
svolgono una vita più o meno sedentaria ed ancor di più per quelle che
praticano attività sportiva, inclusa l’attività subacquea (aumentato consumo
energetico, necessità di determinate prestazioni fisiche).
Anche se dal subacqueo non ci aspettiamo delle vere e proprie performance
(si tratta di una persona che svolge un’attività ludico ricreativa),
l'alimentazione riveste comunque un ruolo determinante ed è importante
che il subacqueo sappia quali sono gli alimenti che lo possono aiutare nella
propria attività per poterne trarre tutti i benefici possibili.
Mantenere un adeguato peso forma è importante per svolgere al meglio
e con maggior sicurezza l’attività subacquea. Quanto più ci si allontana
dal peso ideale, sia nel senso del soprappeso che del sottopeso, tanti più
inconvenienti si dovranno fronteggiare.
Per quanto riguarda la magrezza, il problema più grosso in cui si incorre è
quello di aver freddo: ricordiamoci che in acqua la dispersione del calore
è 25 volte maggiore che in aria. Respirare aria o altre miscele compresse
sottrae maggiore calore rispetto alla respirazione normobarica (fenomeno
accentuato se si respirano miscele con elio). L’avere freddo può facilitare
l’insorgenza precoce di fatica muscolare, per impoverimento delle riserve
energetiche utilizzate per la termoregolazione e può diminuire la velocità di
eliminazione del gas inerte.
L’eccesso di tessuto adiposo invece predispone a scarsa forma fisica, minor
resistenza allo stress ed agli sforzi improvvisi, aumentata predisposizione
alla narcosi d’azoto ed aumentato rischio di incidente da decompressione PDD.
Sappiamo che i gas ai quali è normalmente esposto un subacqueo che
respiri aria sono tre: azoto, ossigeno, e anidride carbonica. I 4/5 circa
dell'aria sono costituiti da azoto.
Alla pressione a livello del mare questo gas non esercita sulle funzioni
dell'organismo alcun effetto noto, ma a pressioni elevate esso può
provocare
diversi gradi di
p
narcosi.
Si ritiene che il
n
meccanismo
dell'azione
m
narcotica
sia lo stesso di quasi
n
tutti
i gas anestetici: cioè,
t
essendo
l'azoto liberamente
e
solubile
nei lipidi dell'organismo,
s
si
s presume che esso si sciolga
nelle
membrane od in altre
n
strutture
lipidiche dei neuroni e
s
ne
diminuisca
l'eccitabilità,
n
interferendo
nel trasferimento
in
delle
cariche elettriche. Il
d
lento, che trattiene u
una grande quantità di azoto
grasso è un tessuto lento
disciolto; un alto livello di adipe nel corpo aumenta la quantità di azoto
182
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
trattenuto dopo l'immersione. L’obesità, soprattutto quella di tipo
"androide", quella per intenderci con maggiore accumulo di adipe al tronco
e all’addome, predispone al rischio di complicanze cardiovascolari quali
aterosclerosi, ipertensione, iperglicemia e ipercolesterolemia. Per questi
motivi bisognerebbe considerare l’obesità come una condizione di non
idoneità alla subacquea.
A parte il gusto che ognuno di noi prova nel mangiare, l’alimentazione è
necessaria per fornire all’organismo la giusta energia per funzionare.
L'energia è fornita all'organismo, sotto forma di legami chimici, attraverso
gli alimenti. L'energia contenuta nei macronutrienti (carboidrati, lipidi,
proteine) viene liberata durante i processi ossidativi, che implicano un
consumo continuo di ossigeno ed una produzione di anidride carbonica.
In seguito all'ossidazione dei nutrienti, viene liberata energia (calore),
che viene utilizzata per mantenere la temperatura corporea costante
in un range fisiologico per lo svolgimento di lavoro chimico (biosintesi
di composti), lavoro osmotico (gradienti ionici) e lavoro meccanico
(contrazione muscolare). Gli alimenti forniscono all'organismo l'energia
necessaria per compensare la spesa energetica, mediante la combustione
dei carboidrati (1g di carboidrati fornisce 4 Kcal), dei lipidi (1g = 9 Kcal),
delle proteine (1g = 4 Kcal). Mentre i carboidrati ed i lipidi, in presenza
di ossigeno, vengono ossidati completamente e trasformati in acqua e
anidride carbonica, le proteine producono anche composti azotati che
vengono successivamente escreti sotto forma di urea.
Quindi, per mantenere l'omeostasi metabolico - energetica in una persona,
le calorie assunte con gli alimenti devono essere bilanciate dalla quantità
totale di energia
spesa:
in
caso
contrario il peso
corporeo subirà una
variazione.
Entriamo adesso più
nei dettagli in quella
che potrebbe essere
una dieta corretta
in
chi
pratica
attività subacquea.
Dico
"potrebbe
essere"
perché,
come
già
detto
precedentemente,
ci
riferiamo
a
persone
che
svolgono un’attività
ludico
ricreativa
(generalmente le immersioni non richiedono uno sforzo fisico particolare e
una prestazione specifica) e non a veri e propri atleti.
Se consideriamo il consumo energetico dobbiamo tenere conto che:
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
183
Pure Tech Agency
• i muscoli rappresentano il 40% del peso corporeo
• durante l’attività subacquea, per far fronte all’ aumentato carico di
lavoro, necessitano di un aumentato apporto nutritivo (ossigeno e
zuccheri)
• tale richiesta supportato da modificazioni del circolo sanguigno e del
respiro (importanza dell’allenamento).
Una dieta equilibrata deve avere un contenuto proteico del 12-15%,
lipidico del 25-30% e glucidico del 60%, considerando che proteine e
grassi vengono digeriti più lentamente e che i glucidi rappresentano la
fonte energetica principale per i muscoli. Dieta equilibrata significa fornire
tutti i nutrienti necessari e che bisogna per lo meno consumare cinque
pasti al giorno, limitando al massimo i cibi a lunga conservazione, l'alcool,
i cibi troppo raffinati, le salse elaborate e the o caffè in forti quantità.
Verdura e frutta devono essere consumate preferibilmente crude e per
un corretto apporto proteico è consigliabile prediligere carne di vitello,
tacchino, coniglio, pesce. É vantaggioso consumare oli vegetali quali l'olio
extravergine di oliva e zuccheri complessi, sotto forma di pasta, pane, riso
a giuste dosi.
Un buon esempio di equilibrio dietetico è quello rappresentato dalla
piramide alimentare.
Un'altra importante considerazione va fatta riguardo al tempo di digestione
dei vari alimenti: è infatti importantissimo non appesantire lo stomaco che,
altrimenti, sottrarrebbe preziose energie all'organismo per digerire gli
alimenti che si sono ingeriti.
Tanto più i cibi sono
grassi, tanto più
lungo è il loro tempo
di permanenza nello
stomaco; lo stesso
vale per i cibi poco
masticati o ingeriti
interi.
Viceversa
gli alimenti liquidi,
le minestre e le
bevande sono in
assoluto gli alimenti
più
digeribili
e
lasciano lo stomaco
nel tempo più breve
rispetto a tutti gli
altri.
Rimanendo
in
tema di "liquidi",
spesso ci dimentichiamo dell’acqua che invece dovrebbe essere una
delle componenti principali della nostra dieta. Il nostro corpo è costituito
principalmente da acquea (circa 50-70% del peso corporeo totale); il suo
184
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
contenuto all’interno del nostro organismo varia in rapporto all’età, al sesso
e al peso corporeo, nonché alla situazione ambientale, all’attività fisica
svolta ed alla composizione della dieta. Normalmente si perdono 600 ml
al giorni di acqua dalla pelle e dai polmoni che devono ovviamente essere
reintegrati per mantenere l’omeostasi. L’acqua è inoltre indispensabile per
la corretta digestione ed assimilazione dei nutrienti, per la funzionalità del
circolo ematico, per la lubrificazione dei tessuti e delle articolazioni, per il
mantenimento della giusta temperatura corporea.
A parte le proprietà sopraccitate, l’acqua è un elemento molto importante
in chi pratica attività subacquea per diversi motivi..
Ricordiamoci sempre che durante l’immersione, vi è una ridistribuzione
dei liquidi dai tessuti verso il circolo ematico, che comporta un aumento
della diuresi e conseguente perdita di liquidi. Inoltre nei trenta minuti
dopo l’emersione avviene il processo inverso, ovvero i liquidi tornano dal
circolo verso i tessuti (disidratazione relativa) ed è quindi importantissimo
bere molto nell’ora seguente l’immersione. L’acqua è molto importante per
fluidificare la linfa e contrastare l’intasamento dei capillari linfatici preposti
al drenaggio del tessuto connettivo (buona prevenzione per la PDD con
linfedema). Per finire, non dimentichiamoci che l’acqua è considerata "un
farmaco" da utilizzare in caso di PDD.
Abbiamo visto quali alimenti sono consigliati in chi pratica attività
subacquea, vediamo adesso cosa è sconsigliato:
- bevande alcoliche (alto contenuto calorico, effetto diuretico con
conseguente disidratazione ed emoconcentrazione). Conseguenze negative
si possono rilevare inoltre sulla lucidità mentale, sulla tolleranza al freddo,
sulla resistenza muscolare e sul suo effetto combinato con la pressione
ambientale che favorisce l’insorgenza di narcosi d’azoto. L’alcool dovrebbe
rappresentare circa il 4% dell’ammontare calorico quotidiano (un bicchiere
di vino) ovviamente lontano dalle immersioni.
Alimenti sconsigliati in chi ha problemi di compensazione:
• alcool (causa vasodilatazione con secondario gonfiore delle muscose)
• eccesso di proteine (causano ritenzione idrica con secondario aumento
delle mucose)
• latte e derivati (il lattosio può provocare ritenzione idrica e
conseguente gonfiore delle mucose)
• agrumi (contengono istamina e determinano gonfiore delle mucose)
Alimentazione consigliata in chi ha problemi di meteorismo
intestinale
• Mangiare lentamente, non parlare mentre si mangia, evitare
chewingum, evitare bibite gassate (per evitare di "deglutire" troppa
aria).
• Nelle ore precedenti le immersioni, evitare di mangiare e bere sostanze
che aumentano la fermentazione intestinale di zuccheri e cellulosa:
bibite gassate, legumi, cereali, carboidrati in genere.
• Evitare di mangiare frutta zuccherina al termine dei pasti, non
eccedere con the, alcolici, dolcificanti artificiali e fruttosio.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
185
Pure Tech Agency
Alimenti consigliati:
• finocchio (modera le fermentazioni intestinali e favorisce l'espulsione
dei gas),
• mirtillo e mirto (possiedono una notevole azione antifermentativa e
antiputreffativa),
• mela (ricca di fibre interviene nella regolazione delle reazioni
fermentative intestinali),
• menta (favorisce l'eliminazione dei gas, diminuendo le fermentazioni
ed il meteorismo)
In caso di meteorismo importante è utile anche il carbone vegetale.
Per concludere, fissiamo undici punti di buone regole alimentari per i
subacquei.
Regole alimentari nei giorni delle immersioni
1) Per colazione preferire il tè al latte essendo quest’ultimo meno
digeribile.
2) Pranzare con pasta, riso o cereali, verdura e frutta. Nel caso sia
prevista l’immersione pomeridiana, non eccedere con gli alimenti
grassi ed evitare alcolici.
3) Bere sempre abbondantemente prima e dopo le immersioni (almeno
2 lt di acqua).
4) Fare merenda con frutta e liquidi.
5) A cena mangiare proteine (carne, pesce, legumi), con verdura e
frutta.
6) Mangiare frutta e verdura in abbondanza. Tali alimenti svolgono
importanti funzioni nella lotta ai radicali liberi e rendono innocue
le sostanze potenzialmente nocive che si insinuano nel nostro
organismo attraverso i cibi o la respirazione.
7) Mangiare regolarmente alimenti ricchi di carboidrati (pasta, riso,
cereali).
8) Il giorno delle immersioni consumare alimenti leggeri e digeribili.
9) Se si fa più di un’immersione al giorno, mangiare qualcosa poco
prima di coricarsi.
10) Se si fanno due o più immersioni al giorno, non esagerare con
alimenti che contengono o liberano istamina soprattutto tra
un’immersione e l’altra (cioccolata, fragole, pomodori, crostacei,
affettati, formaggi fermentati, frutta secca, etc.)
11) Sali Minerali, oligoelementi e vitamine sono importanti. Ritengo che
una dieta equilibrata sia sufficiente per coprirne il fabbisogno.
É comunque importante inserire il discorso dell’alimentazione all’interno del
più ampio concetto di wellness, che comprende anche una regolare attività
fisica, ma di questo ne parleremo in un prossimo articolo.
186
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Attività subacquea e fitness
Per essere dei buoni subacquei bisogna condurre uno stile di vita sano,
sia da un punto di vista alimentare sia da un punto di vista dell’attività
fisica. Anche se dalla maggior parte dei subacquei non ci aspettiamo delle
vere e proprie performance (ci riferiamo a persone che svolgono un’attività
ludico ricreativa) è comunque importante avere un buon livello di fitness,
in quanto ci si può trovare in condizioni che richiedono un aumentato
sforzo cardiovascolare o respiratorio (indipendentemente dalla profondità
o dalle tappe di decompressione): immersioni in corrente o con particolari
problemi che comportano deviazioni dall'immersione programmata (per
esempio aiutare il compagno in difficoltà).
Purtroppo la sedentarietà è un problema estremamente attuale in termini
economici (altissimi costi di gestione del patrimonio salute collettivo).
Inoltre la sedentarietà facilita l’invecchiamento fisico e spesso anche
psicologico.
Per questo motivo è necessario diffondere la cultura del fitness come
prevenzione.
Come possiamo migliorare il nostro livello di fitness? L'esercizio fisico si
dovrebbe concentrare su grandi gruppi muscolari, dovrebbe essere eseguito
con costanza nel tempo, iniziando con intensità moderata e crescendo di
livello con il tempo e l'allenamento. Per avere dei reali benefici, un piano di
allenamento deve prevedere almeno tre sedute settimanali comprendenti
attività aerobiche (camminate, corsa, bici, ecc.), gli esercizi di tonificazione
e quelli di flessibilità.
La subacquea è un' attività affascinante, che si pratica però in un ambiente
straordinario. Questo richiede il rispetto di regole precise, adeguate
capacità e la consapevolezza dei rischi potenziali connessi.
É importante per il subacqueo possedere delle buone doti aerobiche
necessarie per gli spostamenti forzati in acqua (immersione
controcorrente), per aiutare un compagno in affanno, etc., quindi
l’allenamento utile alle immersioni è preferibilmente quello aerobico.
L’attività aerobica, se fatta con costanza nel tempo, abitua l’apparato
cardiorespiratorio a sopportare meglio le fatiche. Questo adattamento deve
assolutamente
avvenire
in
modo
a
lento,
passo dopo
le
passo
senza
p
esagerare.
e
Ma
M quali sono le "
attività
aerobiche" ?
a
Sono
quelle attività
S
che
utilizzano
c
l’ossigeno
per bruciare
l’
carboidrati
e grassi
c
con
il fine di produrre
c
energia.
e
Open Water Dive
Diver
er - CMAS-PTA P1
187
Pure Tech Agency
Tra le attività aerobiche vi sono il nuoto, la corsa, il ciclismo, lo sci da
fondo, naturalmente praticate su distanze medie e lunghe.
Con l’allenamento si ottengono delle modificazioni su organi e apparati,
come muscoli, cuore, polmoni, (aumenta il numero dei capillari nei muscoli
e quindi l’ossigenazione, aumenta il rendimento meccanico, l'apparato
cardiocircolatorio e respiratorio si adattano alla nuova condizione) e
modificazioni a livello di complessi meccanismi cellulari necessari a favorire
il trasporto dell’ossigeno ai muscoli scheletrici.
In pratica cioè è un adattamento dell’organismo alle nuove situazioni che si
trova ad affrontare.
Lo stesso tipo di allenamento, porta lo stesso beneficio a tutti? Purtroppo
no.
La capacità aerobica migliora con l'allenamento fino ai 30 anni circa per
poi decrescere prima lentamente e poi con sempre maggior evidenza dopo
i 45-50 anni. Ricordiamoci che dopo i 30 anni vi è un decremento della
funzionalità polmonare (riduzione fisiologica del volume di aria contenuto
nei polmoni) e che, chi pratica con continuità l’attività subacquea, (per
esempio gli istruttori), a causa del respirare contro la resistenza degli
erogatori, va incontro ad un deficit delle piccole vie aeree. In entrambe le
condizioni, l’allenamento può portare ad un rallentamento nel decadimento
della funzionalità polmonare.
Per quanto riguarda il sesso, nella donna rispetto all'uomo non è
particolarmente diversa l'adattabilità all'allenamento.
Quali sono i benefici che derivano dallo svolgere un’attività aerobica?
A seguito dell’allenamento aerobico si avrà una sensazione di benessere
generalizzato (liberazione di endorfine, "ormoni del piacere") ed un
miglioramento della performance in acqua grazie alla diminuzione dei
consumi personali dei gas respirati (che in termini pratici significa maggior
durata dei gas nella bombola). La capacità di protrarre a lungo un lavoro
dipende infatti dalla potenza massimale aerobica della persona, ossia dal
suo massimo consumo di ossigeno, che è correlato al grado di allenamento
/ fitness.
Un altro vantaggio di chi pratica attività aerobica è quello di eliminare
più velocemente l’anidride carbonica, normalmente prodotta da nostro
organismo durante i processi di combustione tra ossigeno ed alimenti.
Per esempio un soggetto allenato sarà in grado di compiere dei tratti
controcorrente senza avere "il fiatone" e soprattutto, sarà pronto a
compiere un altro tratto a ritmo sostenuto molto prima di una persona
non allenata (questo perché il suo organismo rientrerà nei parametri della
normalità fisiologica in tempi più veloci).
Oltre che per l’apparato respiratorio, l’allenamento è importante anche per
rinforzare l’apparato cardiovascolare e per prepararlo ad affrontare carichi
di lavoro superiori alla norma. Infatti non ci dobbiamo dimenticare che a
volte, durante l’immersione, ci si trova di fronte a situazioni di stress fisico
non pianificate durante il briefing (pinneggiare controcorrente, aiutare
il compagno in difficoltà, etc) o stress emotivo (paura per qualcosa di
imprevisto) o stress termico (acqua fredda).
188
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Vista l’importanza dell’apparato cardio-respiratorio è chiaro che sigarette e
fumo sono assolutamente da evitare (indipendentemente dall’essere sub o
meno).
Praticando attività aerobiche 2-3 volte a settimana con una durata minima
di una quarantina di minuti, aiuteremo il nostro organismo non solo nella
nostra vita di subacquei ma nella vita di tutti i giorni.
Il tempo dedicato all’attività sportiva dovrebbe far parte dei normali
impegni che ognuno ha nella propria vita, in quanto, oltre al benessere
immediato, porterà a benefici a lungo termine, anche se a costo di un po’
di sacrifici e un po’ di fatica.
L’allenamento effettuato con costanza porta nel corso del tempo ad una
sorta di assuefazione e quando, per un qualsiasi motivo, si è costretti ad
interromperlo per un periodo se ne sente fisicamente e psicologicamente la
mancanza.
Al di là comunque della forma di training che si sceglie di fare, ciò che è
importante è la costanza della preparazione nel corso del tempo, solo così
si avranno benefici sul fisico e sulla mente.
Ricordiamoci inoltre che anche il camminare per la città, fare le scale o
muoversi in casa rappresentano
modi per svolgere attività
aerobica.
Il nuoto, la corsa, il ciclismo si
definiscono attività aerobiche
di tipo continuo, perchè si
mantiene una certa attività
fisica per un tempo prolungato
oltre i 15 minuti e perchè lo
sforzo rimane sempre entro
l'80% del consumo di ossigeno.
Esistono altri tipi di allenamento
di tipo aerobico oltre quello
continuo (l'interval training e le
ripetute) ma sono più complessi
nella gestione e più indicati a
veri e propri sportivi. Ritengo
infatti che per un subacqueo ricreativo,
eativo che si immerge in tranquillità per il
gusto di ammirare il mare, sia sufficiente allenarsi con metodiche semplici.
Oltre all’attività aerobica, è ugualmente importante l'allenamento di
resistenza e gli esercizi con i pesi per migliorare la forza muscolare e
"definire" la muscolatura. Inoltre questo tipo di esercizi contribuisce a
bruciare il grasso corporeo.
Una cosa molto importante va infine ricordata: le sedute di allenamento
vanno ben calibrate e devono essere intervallate anche da necessari giorni
di riposo.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
189
Pure Tech Agency
I benefici che può apportare in generale l'esercizio fisico sono:
-
diminuzione della pressione arteriosa media;
diminuzione del colesterolo totale ed LDL (colesterolo cattivo);
aumento del colesterolo buono (HDL);
diminuzione del grasso corporeo;
rinforzo muscolo-scheletrico;
miglioramento dell'efficienza cardio-polmonare;
prevenzione dello sviluppo del diabete;
aumento della tolleranza allo stress;
aumentata liberazione di endorfine (ormoni del benessere).
Quali sono i benefici invece per il subacqueo?
Durante l’attività motoria si liberano le microbolle (sappiamo quanto siano
potenzialmente pericolose per i subacquei): per questo motivo è importante
svolgere attività fisica costante (per eliminarne il maggior numero
possibile), ma non nelle ore precedenti le immersioni. Inoltre con l’attività
fisica si produce monossido d’azoto meglio conosciuto come ossido nitrico
(NO) che è un mediatore biochimico che induce riduzione dell’aggregabilità
delle piastrine e dell’adesività dei leucociti alle pareti dei vasi sanguigni, e,
in parte, raggiunge la sottostante muscolatura liscia vascolare inducendone
il rilasciamento. Tradotti in termini subacquei, gli effetti anti-aggreganti,
anti-infiammatori ed anti-ipertensivi, significano minor aggressione da
parte delle bolle.
In conclusione: l’attività fisica è uno dei regali più belli che possiamo fare a
noi stessi sia che siamo subacquei sia che non lo siamo.
190
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
La donna e l'immersione
Per decenni si è pensato che l'essere donna fosse una "controindicazione"
all'attività subacquea a causa della minor prestanza fisica, delle
modificazioni ormonali che potevano predisporre maggiormente agli
incidenti da decompressione (PDD) ed a causa del rischio di attacchi da
parte di squali durante i giorni del ciclo mestruale.
Il DAN (Diving Aler Network) riporta che negli anni "80 solo il 23% dei
subacquei era di sesso femminile, oggi quasi il 40% dei praticanti è
rappresentato da donne.
Questo non significa che la donna sia come l'uomo: ci sono alcune
differenze che è bene conoscere.
La donna, nell'arco della vita, sperimenta importanti modificazioni ormonali
(menarca, menopausa) e situazioni che ne modificano il corpo (gravidanza,
allattamento).
In generale la donna ha performance fisiche (potenza, velocità, capacità di
lavoro, forza fisica) inferiori rispetto all'uomo che si manifestano soprattutto
nella
gestione
dell'attrezzatura
n
ssubacquea fuori dall'acqua. Questo è
vero soprattutto dopo il menarca,
v
quando la ragazza accumula tessuto
q
adiposo a scapito di quello muscolare.
a
Per questo motivo si dice che una
P
rragazza dovrebbe essere alta almeno
150 cm e pesare almeno 45 kg per
1
essere in grado di maneggiare senza
e
difficoltà la propria attrezzatura.
d
Al giorno d'oggi il mercato della subacquea offre una grande varietà di
"marche" e "modelli" tanto da consentire a noi donne di scegliere secondo
le nostre esigenze. Il "problema" della prestanza fisica diventa meno
evidente in acqua, dove l'attrezzatura diventa magicamente leggera grazie
alla "spinta di Archimede" e quindi facilmente gestibile.
La diversa struttura fisica ha dei vantaggi per la donna che richiede meno
ossigeno (e produce meno anidride carbonica), consuma meno aria e
quindi può utilizzare bombole più piccole.
La donna rispetto all'uomo ha una maggiorpercentuale di grasso: galleggia
meglio ed ha maggior protezione verso il freddo.
Ma allora perchè le donne soffrono di più il freddo ripetto agli uomini?
Perchè hanno meno muscoli e quindi minor capacità di produrre calore.
Hanno inoltre un rapporto superficie/volume maggiore e questo comporta
una maggior perdita di calore per conduzione.
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
191
Pure Tech Agency
E durante il ciclo mestruale? Bisogna chiarire se "in quei giorni" ci si
può immergere o meno e se c'è un rischio maggiore di incorrere in una
PDD. Se le condizioni psico-fisiche della subacquea sono buone non vi è
alcun motivo per non fare immersioni. Per buone condizioni psico-fisiche
si intende non accusare sintomi tipo nausea, vomito, cefalea, eccessiva
tensione mammaria, facile affaticabilità, alterazioni dell'umore (tutti sintomi
tipici del periodo pre-mestruale e dei primi giorni del ciclo).
Da notare che la maggior ritenzione idrica e il conseguente edema delle
mucose potrebbero rendere più difficoltosa la compensazione. Il consiglio è
quello
di controllare l'alimentazione
q
evitando
quegli alimenti che possono
e
ulteriormente
aumentare la ritenzione di
u
liquidi
o
compromettere
una
li
compensazione
già difficoltosa (latticini,
c
agrumi,
alcolici, etc.); consigliati invece
a
alimenti
tipo ananas e mirtillo che
a
favoriscono
l'eliminazione di liqidi e la
f
protezione
della parete capillare. Non c’è
p
invece
alcuna prova scientifica che la
in
ritenzione
di liquidi e l’edema tissutale
r
siano
causa di un rallentamento nella
s
liberazione
dell’azoto accumulato durante
li
l'immersione.
l'
l'utilizzo di tamponi assorbenti in relazione
Nessun problema nemmeno per l'u
all'aria in essi contenuta (compressione ed espansione durante le diverse
fasi dell'immersione).
Se assumiamo contracettivi orali, che aumentano l'adesività delle piastrine
e la tendenza alla coagulazione, è consigliabile una maggior prudenza in
immersione (profili più conservativi, utilizzo di miscele iperossigenate,
maggior attenzione all'idratazione e all'alimentazione, evitare eccessiva
esposizione al sole, etc.) ma non è necessario astenersi dalle immersioni.
Una delle domande ricorrenti è se ci si può immergere nel periodo
della gravidanza. Esistono pochi dati a riguardo: gli effetti dell’azoto e
dell’ossigeno, ad elevate pressioni parziali, sullo sviluppo del feto non sono
conosciuti e quindi si sconsiglia di fare immersioni in questo periodo.
Ma quanto tempo bisogna aspettare dopo il parto per tornare in acqua?
Dopo un parto spontaneo bisogna aspettare 4-6 settimane, per dar tempo
alla cervice uterina di chiudersi e per evitare il rischio di infezione; nel
caso di parto cesareo bisogna invece aspettare 6-8 settimane affinchè si
verifichi la completa guarigione della ferita. In entrambi i casi ovviamente
è di primaria importanza la valutazione del ginecologo.
Dopo la maternità è necessario ritrovare una buona forma fisica per
ritornare all'attività subacquea nella massima sicurezza.
192
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Durante l'allattamento invece non vi è un divieto assoluto alle immersioni
in quanto il latte materno non è influenzato dalle immersioni: ovviamente
non ci si può immergere in caso di infiammazioni ed infezioni al seno.
Bisogna invece stare attenti a non incorrere in uno stato di disidratazione
che potrebbe comportare una riduzione nella produzione di latte.
Anche per la menopausa ci sono pochi dati. Non sembra comunque
che l'attività subacquea influisca sulla funzione delle cellule dell'osso
(osteobalsti ed osteoclasti), mentre si conosce l'effetto benefico della
pressione idrostatica sulla deposizione di calcio nelle ossa.
A fronte di tanti dubbi e poche certezze sull'universo femminile, bisogna
sottolineare che la donna ha una maggior capacità psico-attitudinale
rispetto all'uomo ed è meno incline a comportamenti rischiosi: questo fa sì
che sia meno predisposta ad incidenti subacquei in generale.
Possiamo quindi concludere che essere donna non è una "controindicazione"
all'attività subacquea, basta semplicemente conoscere i cambiamenti a cui
è sottoposto il nostro corpo nel corso della vita per guidarlo al meglio nel
fantastico mondo sommerso.
Open Water Diver
Dive
er - CMAS-PTA P1
193
Pure Tech Agency
194
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
195
Pure Tech Agency
Personal Dive Log
di
..........................................................
Numeri Utili:
EMERGENZA MEDICA .......................................
DAN ....................................................................
EMERGENZA IN MARE ......................................
CAPITANERIA DI PORTO ...................................
__________________ ...........................................
196
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
immersione N.
Personal Dive Log
Data
Luogo
Informazioni Personali
nome: ............................................................................
indirizzo: ........................................................................
CAP: ................ città: ...................................................
tel. .................................................................................
email: ............................................................................
In caso di emergenza contattare
nome: ............................................................................
tel.: ................................................................................
nome: ............................................................................
tel.: ................................................................................
Informazioni mediche
allergie: ..........................................................................
gruppo sanguigno: ........................................................
farmaci/terapie in corso: ...............................................
.......................................................................................
medico: .........................................................................
tel.: ................................................................................
Assicurazione
compagnia: ...................................................................
N. di Polizza: .................................................................
tel.: ................................................................................
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
197
Pure Tech Agency
immersione N.
Personal Dive Log
Data
Luogo
Intervallo di superficie
Sosta di sicurezza
Profondità
Tempo Immersione Reale
Tempo Azoto Residuo
Tempo Totale Immersione
Tempo
Computer
Tempo
Tabelle
Superficie
Temperatura acqua .......... °C
Ora entrata ...........................
Temperatura Aria
Ora uscita .............................
Corrente
.......... °C
Visibilità
Bombola
Soleggiato
Calma
Nessuna
Scarsa
Pressione .....................
Piovoso
Increspata
Leggera
Sufficiente
Capacità ......................
Nebbioso
Mossa
Media
Buona
Nuvoloso
Agitata
Forte
ottima
Tipo di Immersione
Muta
Barca
Umida
Riva
Semi Stagna
Relitto
Stagna
Zavorra
Inizio ............................
Fine ..............................
Consumo lt x min ........
............. kg.
Nitrox
%O2 ............................
..........
Compagni di Immersione:
NOTE:
..................................................
.....................................................
..................................................
.....................................................
..................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
spazio
198
b
Convalida
p
o clu
er log
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
MODULO ADDESTRAMENTO DIVER
COMPILARE E FIRMARE
DOPO OGNI LEZIONE/ESERCITAZIONE
FREQUENZA LEZIONI
TEORIA MOD 1
TEORIA MOD 2
TEORIA MOD 3
1 Data ............................................
1 Data ............................................
1 Data ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
TEORIA MOD 4
TEORIA MOD 5
TEORIA MOD 6
1 Data ............................................
1 Data ............................................
1 Data ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
AC 1
AC 2
AC 3
1 Data ............................................
1 Data ............................................
1 Data ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
AC 4
AC 5
AC RECUPERO
1 Data ............................................
1 Data ............................................
1 Data ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
AL 1
AL 2
AL 3
1 Data ............................................
1 Data ............................................
1 Data ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
AL 4
AL 5
AL RECUPERO
1 Data ............................................
1 Data ............................................
1 Data ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Allievo ............................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
Istruttore .........................................
Pure Tech Agency
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
199
Pure Tech Agency
200
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
Pure Tech Agency
Open Water Diver - CMAS-PTA P1
201
w w w. p u r e - t e c h - a g e n c y. n e t
Scarica