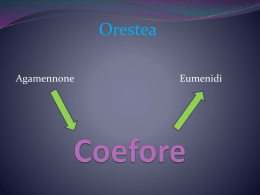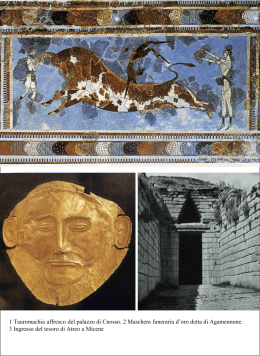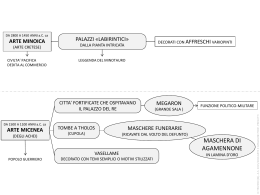Introduzione all’Orestea di Eschilo Prima di affrontare direttamente l’Orestea, mi sembra opportuno ricordare alcuni aspetti del fenomeno teatrale nella civiltà greca classica, nella Grecia, cioè, del V—IV sec. a.C. Tutti gli studiosi concordano nel sottolineare un primo aspetto fondamentale del teatro greco: esso si rivolge ad una collettività, non a singoli individui,presupponendo una fruizione diretta,immediata del testo, basata sull’esperienza visiva e uditiva. L’intera collettività, uscendo dalle occupazioni della vita quotidiana, si trova immersa per alcuni giorni in una dimensione culturale di cui essa stessa è partecipe — è noto che il cittadino povero riceveva dalla po/lij un apposito contributo, il qewriko/n, due oboli per ogni giorno di spettacolo, elargiti anche per indennizzare della giornata lavorativa persa — partecipe anche per la particolare struttura architettonica del teatro greco, che vede non una contrapposizione, come avviene nel teatro moderno, tra attori e spettatori, ma una simbiosi tra questi e quelli, trovandosi l”orchestra”, il luogo, cioè, dove danzava il coro, al centro dell’emisfero su cui sedevano gli spettatori. Spettatori che, ci ricorda Umberto Albini in una sua opera sul teatro greco, Nel nome di Dioniso del 1991, partecipavano con tali reazioni emotive che il più scatenato dei nostri loggioni poteva definirsi “pacifico” in confronto alle platee ateniesi di allora. In segno di disapprovazione, dice Aristotele nell’Etica Nicomachea, si masticavano rumorosamente i cibi, si tiravano proiettili di ogni genere, fichi,olive,verdure,persino sassi, al punto che uno spiritoso autore di commedie,una volta, distribuì egli stesso agli spettatori una provvista di pietre prima dello spettacolo, ce lo dice Ateneo; si fischiava (suri/ttw), si schiamazzava (klw/zw), si pestavano i piedi (pternokope/w), si battevano le mani (krwte/w). Naturalmente, questo comportamento del pubblico, per tenere a freno le cui intemperanze c’erano i buttafuori o r(abdou=xoi, poteva influenzare anche il verdetto della giuria. Commentando questi atteggiamenti degli spettatori,lo studioso Charles Rowan Beye (nel suo saggio su Letteratura e pubblico nella Grecia antica, pubblicato in Italia nel 1979),dice che “la folla aveva caratteristiche animali; l’atmosfera era carica di passione e di una tensione che tradivano la natura volubile della massa”. Un altro aspetto su cui dobbiamo brevemente soffermarci, e che costituisce un elemento di abissale differenza tra il teatro greco, in primis la tragedia, e il teatro moderno, è che il primo fu anzitutto un fenomeno religioso, svolgendosi le rappresentazioni teatrali in onore di Dioniso, il dio della danza, della musica, delle pulsioni misteriose e prepotenti del nostro inconscio, che, come è noto, il filosofo Federico Nietzsche, nella sua famosa opera La nascita della tragedia, del 1871, contrappone al dio luminoso e solare, Apollo. L’ara di Dioniso, la qume/lh, è al centro dell’orchestra, le rappresentazioni teatrali hanno luogo in occasione di speciali feste religiose che cadono in date e periodi tradizionali, le Grandi Dionisie o Dionisie Cittadine, le Piccole Dionisie, le Lenee, le Antesterie, tutte ricorrenti nel periodo invernale—primaverile, quando meno impegnativi sono i lavori campestri e le operazioni militari subiscono un’interruzione. Il fatto che il teatro avesse in Grecia una funzione religiosa fa sì che gli spettatori partecipassero non solo con lo stato d’animo di chi vuole divertirsi, ma consapevoli di prendere parte ad un rito collettivo, dalle finalità essenzialmente paideutiche. Il drammaturgo è consapevole di essere soprattutto un ‘demiurgo’, un “consigliere” della comunità. “Chi è il miglior poeta?”, ci si chiede nelle Rane di Aristofane parlando dei poeti tragici, e la risposta è: ”Colui che sa dare buoni consigli alla città”. Ma “educativa” la tragedia è anche perché, partecipando gli spettatori emotivamente ai paqh/mata dei personaggi tragici, vivendo in prima persona le vicende terribili che vedono sulla scena, essi subiscono un effetto liberatorio dalle loro pulsioni interne, si purificano da esse, ottenendo la ka/qarsij di cui parla Aristotele. Ora, se il drammaturgo è anche un “opinionista”, è chiaro che il teatro greco classico ha anche una finalità e una funzione “politica” — pensiamo al significato politico della commedia di Aristofane — e non può essere valutato e compreso se lo consideriamo avulso dal tempo in cui opere che pure, per i valori poetici in esse contenuti, trascendono il dato contingente, sono state concepite. In questo senso, coglie molto bene il problema lo studioso Jean Pierre Vernant quando, nell’opera scritta con Pierre Vidal Naquet, Mito e tragedia nell’antica Grecia, del 1972, afferma: ”La tragedia non è solamente una forma d’arte; è un’istituzione sociale che, con la fondazione dei concorsi tragici, la città instaura accanto ai suoi organi politici e giudiziari. Instaurando sotto l’autorità dell’arconte eponimo, nello stesso spazio urbano e secondo le stesse norme costituzionali delle assemblee o dei tribunali popolari uno spettacolo aperto a tutti i cittadini, diretto, interpretato e giudicato dai rappresentanti qualificati delle diverse tribù, la città si fa teatro; in un certo senso essa prende se stessa come oggetto di rappresentazione e interpreta se stessa davanti al pubblico”. A sua volta Luciano Canfora, nella sua Storia della letteratura greca, afferma che “accanto all’assemblea popolare ed ai tribunali il teatro è in Atene un pilastro del funzionamento politico della comunità”, e altrove ribadisce che “fare teatro è, in Atene, ma poi anche altrove, un’attività pubblica, un’attività strettamente e formalmente connessa al funzionamento dello Stato.” Ma questo esercita,a sua volta, un controllo attento sull’opera da mettere in scena, preliminarmente sottoposta al vaglio dell’arconte eponimo e di un’apposita giuria. Lo dice esplicitamente Platone nelle Leggi: “Saremmo completamente pazzi, non solo noi, ma tutta la città, se vi autorizzassimo a fare ciò che avete appena detto (cioè venire in città a recitare liberamente drammi innanzi al pubblico), prima che i magistrati abbiano valutato se avete o meno composto drammi che si possono recitare, ed atti ad essere portati in pubblico”. Esisteva dunque un severo controllo “politico” su quanto veniva messo in scena, e, 2 anche sotto questo aspetto, non c’è dubbio che, come afferma Degani nel suo saggio su Democrazia ateniese e sviluppo del dramma attico, del 1979, ”che anche la tragedia greca, non meno della commedia, rappresenti un vero e proprio ‘specchio’ del suo tempo, rifletta la complessa realtà storica, sociale e politica entro la quale è sorta e si è sviluppata, oggi non può più essere messo in dubbio... Il poeta tragico è in realtà sempre engagé, intende svolgere un compito di educatore tra i suoi concittadini, cui propone, tra le pieghe del mito, la sua particolare visione del mondo e, con essa, il suo implicito giudizio sulla realtà contemporanea”. Il tragediografo evita le trame originali, non inventa la vicenda che mette in scena, la trova nella ricca tradizione leggendaria del periodo orale, cioè nel MITO, con le innumerevoli e aggrovigliate varianti (vale la pena, a questo proposito, di leggere l’interessante libro di Paul Veyne, I Greci hanno creduto ai loro miti?, edito in Italia dal Mulino nel 1984). Ma il drammaturgo reinterpreta di volta in volta il mito, lo attualizza, per così dire, a seconda della sua personale ispirazione, del momento storico, della finalità paideutica che egli intende dare. Reinterpretando il mito, e attualizzandolo, egli attua anche un confronto tra i valori eroici del passato e il presente, il “suo” presente, che mette in discussione, e dalle tensioni contrapposte tra il mito e la realtà presente si disegna, appunto, l’uomo tragico, che costituisce anche una risposta, si chiami Oreste, o Antigone, o Edipo, o Medea, a un dibattito culturale, politico, filosofico in atto in quel determinato momento nella città. Dicono gli studiosi Vernant e Vidal Naquet: ”L’universo tragico si colloca tra due mondi, ed è questo doppio riferimento al mito, concepito ormai come appartenente a un tempo trascorso ma ancora presente nelle coscienze, e ai nuovi valori sviluppati con tanta rapidità dalla città di Pisistrato, di Clistene, di Temistocle, di Pericle, che costituisce una delle sue originalità e la molla stessa dell’azione. Nel conflitto tragico, l’eroe, il re, il tiranno appaiono ancora ben inseriti nella tradizione eroica e mitica, ma la soluzione del dramma sfugge loro: essa non è mai data dall’eroe solitario, essa riflette sempre il trionfo dei valori collettivi imposti dalla nuova città democratica.” Alla luce di queste considerazioni che abbiamo cercato di organizzare,accingiamoci dunque ad una lettura dell’Orestea, che, come sapete, è l’unica trilogia a noi pervenuta intera del teatro greco. Essa fu messa in scena nel 458 a.C. in Atene insieme con il dramma satiresco Proteo ora perduto; Eschilo era ormai vicino ai 70 anni, essendo nato nel 525 a.C., e la vittoria da lui riportata con questa trilogia fu anche l’ultima delle 13 ottenute nel corso della sua vita, che si sarebbe conclusa di lì a due anni, nel 456 a Gela, in Sicilia. Quale è la situazione politica di Atene in quegli anni? Tre anni prima della messa in scena della trilogia, dunque nel 462—61, il partito democratico guidato da Efialte e dal giovane Pericle aveva drasticamente ridotto il potere politico dell’Areopago,il vecchio consiglio degli arconti usciti di carica che costituiva una sorta 3 di roccaforte aristocratica, esercitando,dice Canfora, “una specie di potere ‘tutorio’ sullo Stato e sulla stessa legislazione”, tanto è vero che Aristotele lo definì “fulakh\ th=j politei=aj”. Si verificarono in città gravi tumulti e, nel corso di questi, Efialte venne assassinato da un sicario degli oligarchi. D’altra parte, proprio in quelle circostanze il leader del partito conservatore, Cimone, si trovava impegnato a fianco di Sparta nella guerra contro Itome, in Messenia, ma, pur filospartano, venne bruscamente congedato da Sparta, perché il contingente ateniese da lui guidato non era riuscito a venire a capo di niente. Umiliata, Atene passò,per ritorsione,a stringere un’alleanza con Argo, tradizionale avversaria di Sparta nel Peloponneso. Più volte, come vedremo,nel corso dell’Orestea si inneggia a questo patto di fedeltà tra Atene ed Argo, che Eschilo si augura rimanga eterno. La città di Argo, peraltro, appare anche nelle Supplici: è infatti in Argo che si rifugiano le cinquanta Danaidi, inseguite dai loro sgraditi pretendenti: ad esse Pelasgo, re della città, offre generosa ospitalità, dopo aver sentito il parere dei suoi cittadini. Eschilo si ispirò per l’Orestea ad un mito antichissimo, una cui eco è già nell’Odissea omerica, nel cui XI libro Agamennone, evocato dal mondo dei morti, racconta come egli sia perito non per colpa di tempeste o di genti selvagge, “ma Egisto,che mi tramava morte e rovina,/ m’uccise e la mia sposa funesta, chiamandomi in casa,/ a banchetto, come s’uccide un toro alla greppia./ Così morii, della morte più triste; e intorno gli altri compagni/ eran scannati senza pietà”. Accanto a lui,racconta Agamennone, venne uccisa Cassandra, per mano di Clitemestra, e invano egli tentò di proteggerla dalla mano omicida. “La cagna/ se n’andò via, non ebbe cuore, mentre scendevo nell’Ade,/ di chiudermi gli occhi con le sue mani, e serrarmi la bocca”. Anche nella perduta versione lirico—corale di questa fosca vicenda, fattane da Stesicoro, di cui conosciamo il contenuto, e nella Pitica XI di Pindaro, Clitemestra compie di propria mano l’assassinio del marito. Ma sulla stirpe di Atreo gravava una maledizione antichissima: diceva infatti la leggenda che Tantalo, un re asiatico figlio di Zeus,per mettere alla prova l’onniscienza divina, avesse ucciso suo figlio Pelope e ne avesse imbandito le carni come cibo alla mensa degli dei. Per questo era stato punito nell’Ade all’eterna pena di fame e sete. Pelope, richiamato in vita da Ermes che gli sostituì con una spalla d’avorio quella già addentata da Demetra (di questo particolare si ricorderà Pindaro nell’Olimpica I), ottenuta in moglie Ippodamia figlia di Enomao re dell’Elide, ne ebbe due figli, Atreo e Tieste, il primo sovrano di Micene, l’altro di Argo. Insorto un odio violento tra i due, Tieste, che aveva sedotto la moglie del fratello ed era stato perciò da questi esiliato, riuscì a persuadere un figlio di Atreo, Plistene, insieme con il quale era fuggito da Argo e che aveva allevato come suo figlio, a andare a Micene per uccidere suo padre. Scoperta la cosa, Atreo mise a morte, ignorando chi fosse, il giovane, poi, appresa la verità, si vendicò nel modo più atroce: invitati a banchetto, a Micene, Tieste e i suoi due figli, fingendo di 4 volersi rappacificare, uccise all’insaputa del padre i due giovinetti, ne fece a pezzi i corpi e li imbandì a Tieste. Questi, conosciuta l’orribile verità, maledisse l’intera stirpe dì Atreo. I figli di Atreo, Agamennone e Menelao, furono cacciati da Micene ad opera di Egisto,l’unico dei figli di Tieste salvatosi, che, per vendetta, uccise Atreo. I due Atridi, fuggiti a Sparta, sposarono due donne spartane, Agamennone Clitemestra, Menelao Elena, e in seguito compirono l’impresa di Troia, dopo che Agamennone aveva recuperato il regno di Micene, cacciandone Egisto. È ora da notare che in Eschilo Agamennone è sovrano non di Micene ma di Argo, e questa variante del mito è certamente dovuta ad una forma di omaggio verso la città alleata. Questa preistoria,per così dire, dell’Orestea ci introduce nell’intrico delle vicende di un ge/noj, una stirpe maledetta, come maledetta era la stirpe dei Labdacidi, cui Eschilo aveva dedicato la tetralogia Laio — Edipo — Sette contro Tebe — Sfinge, messa in scena nel 467 a.C. Ma se questa era stata la preistoria remota del dramma, c’era un antefatto più recente, e altrettanto sanguinoso: per consentire alla sua flotta di salpare essendo questa trattenuta in Aulide da venti contrari, Agamennone aveva dovuto sacrificare sua figlia Ifigenia (che appare in alcune varianti del mito anche con il nome di Ifianassa), subordinando il proprio affetto paterno a quella che chiameremmo “ragion di Stato”; ma questo aveva scatenato nella moglie Clitemestra un forte risentimento nei confronti del marito, così che ella, spinta anche dalla frustrazione dei tanti anni in cui era dovuta vivere sola mentre il marito era lontano, si era concessa ad un amante, quell’Egisto figlio di Tieste, che nutriva altrettanto rancore verso il cugino Agamennone. Debbo premettere ora che per le citazioni mi sono servito della traduzione di Valgimigli (1948, poi BUR 1980), pur riconoscendo non poca bellezza poetica e suggestione alla traduzione di Pier Paolo Pasolini (Einaudi, 1960), poco rispettosa, però, a parer mio, del linguaggio poetico eschileo. L’Agamennone si apre con una fantastica visione di fuochi notturni che si rincorrono dalla Troade ad Argo e che annunciano la caduta di Troia. La vedetta, stanca di vegliare di notte sull’alta torre di Argo, esulta all’apparire di quei fuochi, ma all’esultanza si mescola subito, nelle sue parole, un cupo senso di angoscia, che nella PARODO, cantata dal coro di vecchi argivi, trova una sua giustificazione: il ratto di Elena, causa della guerra, è paragonato ad avvoltoi che, “dolenti dei figli strappati loro dal nido/ in alto sul nido volteggiano”, mentre Zeus “spedisce contro i predatori le Erinni”. Chi sono le “Erinni”? Le “Erinni”, “Le Irate”, sono raffigurate come geni alati, con capelli intrecciati a serpenti; esse tengono in mano torce o fruste. Loro dimora è l’Erebo. Sono forze primitive, odiose anche agli dei. Vendicatrici dei delitti contro la famiglia, esse proteggono l’ordine sociale e perseguitano chiunque tenti di violarlo con la sua u(/brij. Già nella Parodo dell’Agamennone appare questo riferimento alle Erinni, molto significativo perché, come osserva lo studioso Vincenzo Di Benedetto in un lavoro fondamentale su Eschilo, L’ideologia del 5 potere e la tragedia greca, (1978) le “Erinni sono non a caso una costante in tutta la trilogia”, non soltanto persecutrici di chi ha versato il sangue materno ma anche strumento della giustizia di Zeus, che appare come il garante di una norma universale. Un tempo, narra poi il coro, si presentò ai due Atridi, capi dell’esercito, una visione profetica: due aquile che divoravano una lepre, presagio della distruzione di Troia. Appare in questa immagine uno dei temi caratteristici dell’Orestea, quello della caccia e del sacrificio, che è stato ampiamente studiato da Pierre Vidal Naquet in un saggio del 1969, per cui la tematica venatoria, come dice Albini, ”intesse un sottile ordito per tutta l’opera”, conferendo “un alone più selvaggio e quasi animalesco alla vicenda”. La seconda parte della Parodo, che inizia con l’inno a Zeus — “Zeus, quale mai sia il tuo nome, se con questo ti piace essere chiamato, con questo ti invoco” — presenta poi uno dei motivi di fondo della concezione religiosa eschilea, la legge del pa/qei ma/qoj: ”Le vie della saggezza Zeus aprì ai mortali, facendo valere la legge che sapere è soffrire. Geme anche nel sonno, dinanzi al memore cuore, rimorso di colpe, e così agli uomini anche loro malgrado giunge saggezza; e questo è beneficio dei numi che saldamente seggono al sacro timone del mondo”. Si apre a questo punto, per noi, un problema: come interpretare il personaggio di Agamennone, di cui il Coro ricorda il sacrificio compiuto, di Ifigenia sua figlia? Un arrogante e vanitoso, come è sembrato a vari studiosi, anche a proposito della famosa scena dei tappeti purpurei, o un uomo intimamente tormentato, costretto dalla necessità ad agire, come sarà poi per Oreste, facendo forza alla propria volontà? Certamente, un personaggio della cultura epico—eroica, di cui Eschilo coglie ora la drammatica problematicità: ”Mala sorte è la mia se obbedienza rifiuto, mala sorte se la figlia sacrifico... Quale delle due sorti è peggiore?” Ifigenia uccisa, dunque,come “capra selvatica”, e il Coro insiste nel sottolineare lo strazio che il padre avrà provato nel vedere sua figlia condotta, imbavagliata, all’altare, mentre alla sua mente torna il ricordo di quando la ragazza cantava “con casta voce” in occasione dei banchetti. Concludendo il suo canto, il Coro ribadisce: ”Solo a chi ha sofferto, bilancia di giustizia concede sapienza. Il futuro, dopo accaduto lo puoi conoscere. Prima, segua suo corso”. Dal momento del sacrificio di sua figlia inizia dunque, per Agamennone, un processo psicologico che lo porterà alla moderazione. Ma è a questo punto che l’apparizione sulla scena di Clitemestra, seguita dalle ancelle, polarizza su di sé l’attenzione, con la sua personalità complessa, agitata da un groviglio di sentimenti difficili a districarsi tra loro, rancore per il marito che le ha ucciso la figlia, sorda gelosia quando vedrà accanto a lui la schiava-concubina Cassandra, dedizione passionale all’amante Egisto, che, da parte sua, odia Agamennone: simulatrice e dissimulatrice, ella rievoca la corsa dei segnali di fuoco, che hanno annunciato la caduta di Troia e l’imminente ritorno dello sposo, ma alla sua mente si presentano le scene della distruzione della città, in un viluppo di corpi ansimanti nella violenza e nella morte. Ma le sue parole suonano ambigue: 6 quando ella parla di “male sofferto dai morti” saremmo indotti a pensare ai Troiani uccisi, ma forse ella pensa alla figlia sgozzata. Così la frase famosa: ”Donna io sono, e pensieri di donna tu ascolti da me” acquista qui significato sinistro: ella è donna, ma anche madre, e il desiderio di vendetta si annida nel suo cuore. Nel I Stasimo il Coro, dopo l’invocazione a Zeus che ha gettato “una fittissima rete” sulle torri di Troia per cui nessun nemico è potuto sfuggire al “laccio” della schiavitù, introduce un altro concetto fondamentale della religiosità eschilea quale appare nella trilogia: i Troiani hanno violata la “santità dei diritti”, e per questo gli dèi, che sono tutt’altro che inerti, anzi, che sempre, prima o poi intervengono, li hanno puniti: “Bene supremo è misura. Innocente sia la fortuna e basti a chi è savio”. Si esprime in queste parole quell’elogio della povertà che è tutt’uno con l’ideale di una condizione di vita umile e modesta, altro tema ricorrente della trilogia. Dice ancora il Coro: ”Io preferisco una prosperità che non provochi invidia:che io né sia un distruttore di città né veda la mia vita sotto il dominio di un altro”. Se è vero che, come ha notato il grande filologo Eduard Fraenkel nel suo studio sull’Agamennone del 1950, è evidente in queste parole il riferimento allo fqo/noj qew=n,in linea con tanta parte della poesia arcaica greca, da Esiodo a Solone, è anche vero che,nella menzione che il Coro fa, nella seconda parte dello Stasimo, dei tanti guerrieri greci caduti sotto le mura di Troia, che, partiti tra gli auspici dei familiari, tornarono “ceneri e urne”, si esprime non soltanto una recisa condanna della guerra, ma viene capovolta, in certo senso, come ha osservato Di Benedetto, la concezione tirtaico—estetizzante della guerra: belli, eu)/morfoi, sono i caduti in guerra, ma assurda e sproporzionata è stata questa, perché “per colpa di una donna altrui tutti morirono”. Gli dèi prima o poi puniranno il colpevole di tanti lutti, servendosi delle Erinni, che, nelle parole del Coro, appaiono strumento di Zeus. L’araldo che entra in scena, all’inizio del II Episodio, per annunciare l’imminente ritorno in patria di Agamennone conferma che i Greci hanno fatto terra bruciata della città nemica: Agamennone, egli dice, “ha distrutto Troia con la zappa di Zeus realizzatore di giustizia; con questa zappa il suolo è stato dissodato e sono scomparsi altari e templi degli dèi, e tutto il seme della terra è stato distrutto”, parole che, lungi dall’avere un significato di legittimo orgoglio per la vittoria conseguita, assumono una risonanza sinistra, che preannuncia i disastri cui l’armata sarebbe andata incontro nel viaggio di ritorno. Già ridotti al rango di bestie irsute e selvagge durante la guerra, i soldati, nel no/stoj hanno dovuto patire il fuoco e il mare avverso: navi infrante, legni che cozzano paurosamente tra loro, il mare cosparso di cadaveri. Sinistra suona, in questo momento, la voce di Clitemestra: ”Venerato sposo! Quale giorno a una donna può splendere più dolce di questo?” Ella auspica che il ritorno di Agamennone avvenga il più presto possibile: troverà nella sua casa la sposa fedele, ”cagna di guardia a lui amica, ai 7 nemici nemica, sempre la stessa”. Da “donna onesta” qual è, ella può proclamare alta la verità. Tutto intessuto di metafore attinte al mondo della caccia è il II Stasimo, una condanna nei confronti di Elena, l’adultera maledetta, il “leoncino” allevato in casa da un pastore, che, dopo aver giocato con i bambini, svela la sua vera natura sanguinaria, sgozza le bestie, inonda di sangue la casa ed è “come una Erinni, cagione di pianti e di lutti a tutte le spose”. Innumerevoli cacciatori armati di scudi, poluandroi/ te fera/spidej kunagoi\, si sono lanciati sulla traccia della nave di Elena, e anche la guerra di Troia è ora descritta come una caccia selvaggia. Per contro, Eschilo riafferma per bocca del Coro che “Giustizia risplende nei fumosi tuguri perché il vivere onesto ella onora”, rifuggendo dalle regge costellate d’oro e dalle mani insanguinate: l’elogio della povertà, dunque, contrapposto all’ideale della guerra, ma anche l’affermazione che, se i Greci hanno compiuto un atto di giustizia punendo i Troiani che hanno ospitato la coppia adultera, essi hanno poi sbagliato commettendo atti empi contro i templi degli dèi: Zeus ha punito la loro potenza non perché invidioso di essa, ma perché si sono macchiati di u(/brij. Alto sul carro da guerra,con accanto la concubina Cassandra sua preda entra in scena Agamennone, all’inizio del III Episodio, e il Coro,pur salutandolo con parole festose — “O re distruttore di Troia, prole di Atreo”, non manca di esprimere riserve sul suo operato: ”...e tu non bene reggesti il governo dei tuoi pensieri sacrificando a morte uomini valorosi per riportare qui un’impudica che di qui aveva lei stessa voluto partire”. Improntato ad un sentimento religioso, di moderazione è il discorso con cui Agamennone replica alle parole del Coro: egli ringrazia in primo luogo gli dèi, poi presenta la spedizione di Troia come assolutamente legittima, perché il ratto di Elena è stato una “rapina arrogante”, “xa)rpaga\j u(perko/pouj” ,dove l’aggettivo “u(perko/pouj” rimanda all’avverbio u(perko/pwj del I stasimo, usato a proposito della “gloria oltre misura” che attira il fulmine di Zeus e le nere Erinni. Non solo, ma Agamennone dichiara anche di voler convocare un’assemblea popolare in modo che non sia lui solo a deliberare: egli si mostra rispettoso della volontà popolare. Anche Pelasgo, nelle Supplici, si era rivelato rispettoso della volontà popolare e, come abbiamo già ricordato, aveva espresso la volontà di consultare l’assemblea popolare prima di accogliere in Argo, di cui è sovrano, le Danaidi. Torna anche, nelle parole di Agamennone,l’immagine del “leone”, riferita, in questo caso,agli Achei che, usciti dai fianchi del “giovane mostro”, cioè del cavallo di Troia, balzarono fuori armati: ”...era un leone affamato che solo quando ebbe leccato anche il sangue della famiglia del re fu satollo”. “Un capolavoro di ipocrisia e falsità”: così Di Benedetto definisce il discorso di risposta di Clitemestra. Dopo aver dichiarato il proprio amore di sposa e ricordato la sua lunga attesa del marito lontano, ella ricorda quante volte le giunsero false notizie della sua morte, ma le sue parole contengono oscure allusioni — il tema della rete mortale 8 a quello che poi avverrà: ”Se tante ferite quest’uomo avesse avute quante da fonti diverse ne arrivavano voci, più fori che una rete da pesca avrebbe avuto il suo corpo. E se tante volte egli fosse morto quante di momento in momento mi venivano a dire, tre corpi come un secondo Gerione avrebbe potuto vantare di avere, tre volte sarebbe stato sepolto nel suo mantello di terra, ogni volta in ognuno dei suoi tre corpi sarebbe morto”. Più volte, ella racconta,disperata, fu sul punto di impiccarsi. A questo proposito, ci ricorda Nicole Loreaux nel suo saggio Come uccidere tragicamente una donna (Laterza 1998), il suicidio al femminile era l’impiccagione, non la spada, arma nobile per eccellenza, e perciò riferita all’uomo. Poi, passando al sarcasmo, ella dice che “con l’animo finalmente ricreato posso ben salutare quest’uomo, il cane che guarda l’ovile, la gòmena che salva la nave, la stabile colonna che sostiene l’alto tetto della casa... Gioia grande sfuggire alla mala ventura”. E sono purpurei tappeti quelli che ora le ancelle, per suo ordine, srotolano davanti ai piedi di Agamennone, quale segno di omaggio al sovrano — “Voglio che sotto i suoi piedi fiorisca un cammino di rosse porpore...e la Giustizia lo scorga” — ma anche sinistro presagio di sangue. Davanti a quello sfarzo di colori, Agamennone prova un senso di orrore, quasi: ”Non distendere tappeti, non farmi invidiato il cammino. Gli dèi vogliono essere onorati così. Che un mortale posi il piede su tale belleza di colori, non è senza sgomento per me. Come un uomo tu mi devi onorare, non come un dio”. Egli si appella alla “moderazione” e teme — quasi una sopravvivenza dell’omerico ai)dw/j -, il giudizio del popolo. Tuttavia,vinto dalle argomentazioni della moglie, egli si lascia togliere i calzari e si avvia, riluttante, entro la reggia. Commenta Jean Pierre Vernant: ”Dal mometo che Agamennone ha posato il piede sul tappeto, il dramma è consumato. E se la tragedia continua ancora per un po’ di tempo, essa non potrebbe aggiungere nulla che non sia già fin d’ ora compiuto. Passato, presente, futuro sono venuti a fondersi in un solo e identico significato, rivelato e condensato nel simbolismo di questo atto di u(/brij empia”. Dice lo studioso che Agamennone, accettando di calpestare i rossi tappeti, rivela, in fondo, la debolezza del suo animo, lui che ha tollerato anche che i templi di Troia fossero distrutti, lui in cui, pur intimamente tormentato, rivivono i crimini più antichi degli Atridi. “In questo punto culminante della tragedia — dice lo studioso — dove tutto viene a confluire, è il tempo degli dèi che spunta sulla scena e si mostra nel tempo degli uomini”. Piene di sarcasmo le battute con cui Clitemestra accompagna l’ingresso del marito nella reggia: ”Il tuo ritorno al focolare domestico è come d’inverno un soffio di tepore che annuncia l’estate”, poi, con una segreta preghiera a Zeus: ”All’opera che stai per adempiere, devi tu provvedere”. Subito dopo, il Coro intona il III Stasimo, dominato da un cupo senso di angoscia, che viene definito “non richiesto e non pagato”, au)todi/daktoj, un lugubre “lamento funebre delle Erinni”, la 9 cui presenza costituisce una specie di motivo ricorrente della trilogia. Il Coro è consapevole che la paura che scuote il suo animo non è dovuta a fattori emotivi, è invece motivata da una realtà orribile che si sta preparando, davanti alla quale non resta che pregare. E torna, nelle sue parole, l’elogio della povertà, ancora di salvezza contro la violenza: ”Bastano i doni abbondanti e molteplici del cielo, bastano i doni della terra che si rinnova nei solchi ogni anno, per allontanare la fame”. Il IV Episodio, che anticipa la catastrofe, dilata la vicenda dell’Agamennone in una preistoria del ge/noj degli Atridi densa di orrore e di sangue. All’invito rivoltole da Clitemestra a seguirla dentro la reggia, Cassandra — di cui il Coro dice che è ormai “dentro una rete mortale” e che “ai modi pare una bestia or ora catturata” — uscendo dal silenzio in cui è stata finora, prorompe in un grido selvaggio, perché di lei si è ora impadronito Apollo, che la fa profetare: ed è una serie di scene dense di orrore quella che viene rievocata, la macabra cena di Tieste, ”gole scannate e carni cotte” che il padre ha divorato, poi ella parla di un uomo preso in una “rete mortale”, una “rete” da caccia che la sua compagna di letto, la “complice che uccide” gli tenderà, e quell’uomo sarà come una “giovenca”, che il toro uccide con le sue nere corna, mentre gioisce “la turba insaziata delle Erinni”. Il parlare come in trance di Cassandra è apparso al Fraenkel un qualche cosa che sta “tra il canto e quel selvaggio lamento noto agli Ateniesi dalle rappresentazioni rituali delle donne in lutto in Oriente”. Anche il dialogo lirico tra Cassandra e il Coro è impregnato di visioni terribili: “un leone imbelle che si ravvolge in un letto”, una donna infernale che evoca il ricordo di mitici mostri, una “bipede leonessa, che, assente il generoso leone, in letto si giacque col lupo”. “Lei è — aggiunge Cassandra — che anche me ucciderà”. Ma ecco che, nelle ultime parole della profetessa, appare già l’immagine di un futuro vendicatore, e sarà altro sangue: ”Non però invendicata lasceranno gli dèi la mia morte. Altri a suo tempo verrà vendicatore nostro: a uccidere sua madre il figlio da lei generato, e a punire gli uccisori del padre”. Poi Cassandra si avvia verso il palazzo. Subito dopo si odono dall’interno le disperate grida di dolore di Agamennone, si apre la grande porta centrale che lascia scorgere il suo cadavere riverso in una tinozza d’argento e appena ricoperto da un grande manto rosso. Accanto al suo cadavere, quello di Cassandra. Clitemestra,che irrompe sulla scena con l’arma omicida in mano, una scure insanguinata, non è più una donna, ma l’antico genio vendicatore della stirpe maledetta l’a)la/stwr che ha compiuto il sacrificio: e)/sfaca, ella dice, usando il verbo sfa/zw, termine usato per le vittime sacrificali, ed è un selvaggio grido di feroce gioia quello che ella lancia: ”La mia vittoria,la compiuta vittoria, venne. Ritardò, ma venne. E ora qui sono, dove ho colpito; qui sto, dove ho compiuto il debito mio. Sì, questo ho fatto. E anche il modo ti voglio dire. Perché costui non sfuggisse al suo destino, perché scampo non avesse, in una rete senza uscita, come in una rete da pesci, io lo ravvolgo. Oh, 10 quale fastoso mantello di morte! Due volte lo colpisco; due volte egli grida; e lascia cadere giù le sue membra. E su lui caduto un terzo colpo aggiungo per dono votivo a Zeus salvatore dei morti. E così morendo egli rutta fuori la sua anima. Irrompe dalla ferita un getto violento di nero sangue, e mi percuote, e mi sembra uno spruzzo di rugiada, e io ne gioisco...” Gli studiosi si sono proposti il problema se il tema della “rete” sia un’invenzione eschilea o si tratti di metafora anteriore a lui: in nessun testo letterario prima di Eschilo appare questo tema, ma in una pi/nac di Gortina, probabilmente del V sec. a.C. è rappresentata Clitemestra nell’atto di colpire Agamennone, alle cui spalle Egisto sembra tendere una rete. A livello antropologico, l’uccisione di Agamennone può ricordare l’antichissimo rito sacrificale del Re del Grano o Paredro, e la sua sostituzione con un altro compagno della Grande Madre. Clitemestra usa inoltre la bipenne, o la/bruj, arma sacra sacrificale, uccide la sua vittima in una vasca da bagno, e anche questo si riconduce al rito di purificazione. A sua volta, Cassandra, nel suo delirio profetico, vide uccidere un toro, vittima sacrificale. Il Coro appare sgomento per quanto è avvenuto, e compiange la sorte del re il cui corpo giace “in questo tessuto di ragna”, ricordando alla donna che “oltraggio risponde ad oltraggio... Chi preda è predato, chi uccide è ucciso”. Finché Zeus rimarrà tutore delle leggi, chi ha fatto patire è destinato a sua volta a patire. Di fronte alle accuse sempre più aperte del Coro, Egisto esorta le guardie a colpire i vegliardi, ma Clitemestra, stanca di lutti — “già troppi ne mietemmo, triste mietitura” le trattiene. Ma è già apparso, attraverso le parole del Coro, un futuro vendicatore: ”Ma c’è Oreste; Oreste vede la luce, è vivo, ritornerà qui accompagnato da buona fortuna, e con la forza del suo pugno vittorioso ucciderà lui costoro, tutti e due insieme”. Come oppressa dal delitto che pure ha or ora commesso con gioia feroce, Clitemestra si augura che abbia termine “questa follia di consanguinei che l’un l’altro si uccidono”. In uno studio del 1967 sul I Stasimo delle Coefore il Lebeck ha dimostrato che il secondo dramma della trilogia, che prende nome dalle portatrici di offerte che costituiscono il Coro,ha non soltanto la stessa struttura di fondo dell’Agamennone ma ne forma anche l’esatta contropartita. “Là dove una vittima (Agamennone) è ricevuta dal suo assassino (Clitemestra) - nota lo studioso — un assassino (Oreste) è ricevuto dalla sua vittima (Clitemestra), la donna che l’accoglie (Clitemestra) intrappola l’uomo che ritorna (Agamennone), nel primo caso, mentre nel secondo è l’uomo (Oreste) che ritorna a intrappolare la donna che l’accoglie”. Potremmo perciò dire che le Coefore sono una fuga contrappuntata rispetto all’Agamennone. Possiamo cogliere tuttavia, tra i due drammi, una differenza di fondo, messa in evidenza dallo Zeitlin prima ancora che da Vidal Naquet: scompare quasi del tutto il tema del “sacrificio empio”, presente nell’Agamennone, perché Oreste, pur sacrificando mostruosamente la madre, è l’esecutore della volontà di Apollo. Torna dunque in patria, dopo molti anni da che ne era 11 dovuto fuggire fanciullo, Oreste, seguito dall’amico Pilade, per eseguire l’ordine dell’oracolo di Apollo: vendicare il padre. Il Coro di ancelle guidate da Elettra, sorella di Oreste, si reca per ordine di Clitemestra, angosciata da tristi presagi, sulla tomba di Agamennone con funebri libagioni, e la ragazza rimane incuriosita dalla ciocca di capelli che Oreste si è tagliato e ha deposto sulla tomba paterna, e che le sembrano simili ai suoi, come pure le pare di riconoscere una strana somiglianza tra le orme dei piedi impresse nella sabbia e quelle della sua gente. Fin dall’inizio del I Episodio il carattere di Elettra appare disegnato a tutto tondo: ella è una giovinetta pura, che attende con ansia un vendicatore del sangue paterno: questo, Elettra chiede nella sua invocazione ad Ermes ctonio, e anche di essere più casta di sua madre. Ella contrappone alla kalh/ a)ra\, la preghiera maledetta elevata da Clitemestra mediante l’invio delle offerte, la kakh\ a)ra/, la triste maledizione che ella stessa scaglia contro gli assassini di suo padre. Tornano continuamente anche nelle Coefore quelle metafore ispirate al mondo della caccia che Vidal Naquet ha messo in evidenza come caratteristiche della trilogia. Così, nel vagheggiamento da parte del Coro di un vendicatore, si dice: ”Qual eroe armato di lancia verrà a liberare la casa? Chi tra le mani lo scitico Are ricurvo in opere di guerra agitando? Chi per l’elsa impugnando la spada che uccide da presso?”. Oreste dovrà agire come un cacciatore, di “persuasione astuta”(peiqw\ doli/a)e in seguito il Coro dirà di lui: ”È venuto colui che, lottando nell’ombra, sa con l’astuzia portare a compimento il castigo”. Di Elettra si dirà che ha un “cuore di lupo”, ad Oreste più volte verrà associata l’immagine del serpente - tale appare nel sogno alla madre, quando le sembra di vedere suo figlio attaccato in tal forma al suo seno - ed egli stesso dirà di sé: ”Sono io, divenuto serpente, che la ucciderò!” Ma anche Clitemestra diventa, nelle parole di Oreste, una bestia: ”Vedi la prole dell’ aquila fatta priva del padre, del padre fra i nodi ucciso e le spire di una vipera immonda”, e alla donna che, sul punto di essere uccisa dai figlio, grida quelle parole tremende: ”Ahimé, ahimé, questo è il serpe che generai, il serpe che nutrii!”, il Coro risponde:”È venuto nella dimora di Agamennone il doppio leone, il doppio Ares”, colui che “mozza di un colpo felice la testa dei due serpenti”. Ben a ragione Vidal Naquet può parlare di “bestiario delle Coefore”, tanto più se si pensa che il segno di riconoscimento tra Oreste, venuto fuori dal nascondiglio in cui si era celato, e la sorella è proprio un tessuto ricamato un tempo da Elettra, in cui è rappresentata una scena di caccia, qh/reion grafh/n, e, nel I episodio, Elettra, invocando il padre, dirà: “La rete (a)mfi/blhstron) ricorda, dove ti avvolsero, e il laccio inusato”. Nel Commo che si sviluppa dopo il riconoscimento dei due fratelli, Oreste, Elettra e il Coro elevano un’invocazione ad Agamennone e al mondo degli Inferi perché intervengano nella punizione degli assassini. È da notare, a proposito di questo commo, che Oreste ed Elettra intonano il loro canto davanti alla tomba del padre, e questo, a livello antropologico, potrebbe far 12 pensare agli antichissimi canti funebri in onore di eroi divinizzati che, secondo alcuni studiosi, potrebbero essere all’origine stessa del genere tragico. In tale invocazione, le Moire, personificazioni del destino individuale, appaiono associate ad Ate e alle Erinni. È stato notato come, nel corso di questo grandioso Commo, si verifichi una presa di coscienza da parte di Oreste, che finora si era sentito strumento del dio, in personaggio pienamente responsabile della propria azione: ”O Zeu, o Zeu, tu che dall’imo dell’Ade, anche se tarda, punitrice vendetta dirigi contro mani audaci e nefande di mortali..., ebbene anche su genitori la vendetta egualmente si compia”. Quasi a commento, il Coro afferma: ”Ma è legge che stille di sangue a terra versate nuovo sangue domandano ancora. E strage invoca l’Erinni, vendetta dei morti già morti, che vendetta su vendetta conduce”. Oreste appare ora in preda ad un selvaggio furore di vendetta: egli già pregusta, per così dire, l’uccisione di Egisto, sì che la Erinni “insaziata di strage puro sangue berrà nella terza libagione”, terza perché la prima è stata quella del sangue dei figli di Tieste, la seconda del sangue di Agamennone, la terza, che nei banchetti era riservata a Zeus salvatore, sarà quella che libererà Argo dai due adulteri. Sul I Stasimo delle Coefore si sono soffermati con particolare attenzione due studiosi, Untersteiner, in un saggio del 1972, e Degani: lo Stasimo, il cui incipit sembra anticipare quello dell’Antigone sofoclea (“Molti sono gli orrori/che la terra alimenta,terribili,/ che il mare chiude tra le sue braccia,/ i mostri che i mortali han di contro:/ .../Ma chi dirà l’audacia illimitata/ della mente dell’uomo?”) contiene una specie di storia del progresso umano in cui, secondo Degani, possiamo ravvisare un’eco della concezione anassagorea; prendono però corpo in esso una serie di donne del mito travolte, tutte, da passioni violente e infernali, e tra tutte domina Clitemestra, ormai vicina ad espiare le sue colpe: ”Ecco la spada! Ed il figlio sangue su sangue accumula ancora, e nel sangue lava a suo tempo l’antica sozzura la tenebrosa Erinni”. L’azione diventa a questo punto incalzante: mettendo in atto il piano concertato con la sorella, Oreste si presenta a Clitemestra come un forestiero venuto dalla Focide e le racconta, tenendo in mano un’urna cineraria, la falsa notizia della morte di Oreste. La donna ha una reazione di apparente disperazione, che è stata variamente interpretata dagli studiosi: dolore sincero o intima gioia all’apprendere che l’unico pericolo che ancora la minacciava è scomparso? Certo è che sono sincere le lacrime della vecchia nutrice Cilissa, che ricorda con infinito dolore Oreste bambino: ”Oh, i suoi acuti strilli, che mi facevano, la notte, andare su e giù per la stanza. E quanti e che affanni per lui. E tutto, ora, inutilmente”. Inesorabile, il Coro, nel III Stasimo, esorta Oreste alla vendetta: ”Abbi nel cuore il cuore di Pèrseo, e dritto colpisci. Ai tuoi morti laggiù sotto terra, ai tuoi vivi quassù, rendi la grazia che attendono, soddisfa lor funebre ira, dentro la casa poni la tua vendetta di sangue, e chi uccise uccidi”. Anche il sopraggiungere di Egisto, fatto accorrere tramite la vecchia Cilissa e perplesso a sua volta per la notizia della morte di 13 Oreste, è salutato dal Coro con parole piene di minacce: ”Ecco che ora tagli di spade omicide già grondano sangue”. Oreste, afferma il Coro, protetto dal dio, recupererà, con le leggi, ”fiaccole e fuochi per la libertà”. L’azione ai sviluppa ora in modo incalzante. Entrato Egisto nella reggia, si odono le sue grida disperate, e un servo esce dal palazzo gridando che Egisto è stato colpito a morte. A Clitemestra che, accorsa, gli chiede che cosa stia accadendo, il servo risponde con una frase famosa: ”Io dico che i morti uccidono i vivi”, che è da intendere non tanto e non solo nel senso che un creduto morto, Oreste, ha ucciso Egisto, ma che questi in realtà è stato ucciso da Agamennone stesso, morto, per mano di suo figlio, vivo. A questa notizia si ridesta in Clitemestra l’antico demone della stirpe degli Atridi, e la donna si disegna nella sua selvaggia vitalità. Ella chiede una “scure mortale”, un’arma: “Ch’io veda se vincitori siamo, o vinti. A questo io giunsi ormai del mio triste destino.” Poi, con sùbito passaggio psicologico, ella si abbandona alla disperazione, nel vedere il cadavere di Egisto — “Ahi,sventura! Morto sei amatissimo Egisto” — per tornare subito dopo madre, e aggrapparsi, lei, la nemica, l’adultera omicida, al figlio, da cui invoca pietà: ”Fermati, o figlio, abbi rispetto, o figlio, di questo seno, su cui tante volte il capo ti cadde nel sonno, e tu seguitavi con le tue gengive a suggere il dolce latte che ti nutriva”. Siamo giunti con questa scena all’acme drammatico dell’intera trilogia: il matricidio, osserva Canfora, rappresenta la rottura col mondo ancestrale, simboleggiato,come ha scritto anche i Lesky, dal “seno di tutte le nascite in cui la madre è tutto”. È proprio a questo punto che su Oreste, immoto, incapace di agire, scende, come da remote dimensioni, la voce di Pilade, che gli ricorda l’ordine di Apollo: ”Meglio avere nemici gli uomini tutti anzi che gli dèi”. Nel drammatico dialogo che ora si sviluppa tra madre e figlio, quando Clitemestra ricorda al figlio anche le colpe del padre, l’altro, con non poca brutalità, le contesta il diritto di accusare chi lavora e si dà da fare per mantenere la casa: è l’uomo, dice Oreste, che “nutre” la sua sposa, la quale deve soltanto essergli grata di questo. Tornano, nelle battute della sticomitia, le metafore attinte al mondo della caccia: ”Guàrdati — dice Clitemestra — sàlvati dalle cagne rabbiose della madre”, e, mentre il figlio la trascina all’interno del palazzo: ”Ahimé, ahimé, questo è il serpe che generai, il serpe che nutrii”, immagini di un “bestiario” che tornano anche nelle parole spietate che Oreste pronuncia davanti ai cadaveri di Egisto e Clitemestra, nell’Esodo: ”Io dico che se nata era murena o vipera, solo che l’avesse toccato uno, neppure morso, lo avrebbe reso cadavere putrido, nel furore della sua scellerata natura. E questo (volge l’occhio al peplo dove Agamennone fu irretito e ucciso) come lo debbo chiamare, con quale parola anche s’io trovi la parola più mite? laccio da fiera, drappo da inviluppare un morto da capo a piedi nella sua... bara? di/ktuon me\n ou)=n, a)/rkun t’a)/n ei)/poij “Meglio rete; ma anche trappola puoi dire; sì, è un peplo che scende fino ai piedi... per legarli!” 14 A proposito della “bara”, in realtà Oreste usa la parola droi/th, che è la vasca da bagno, dove il re fu ucciso. Eppure, un misterioso senso di alienazione invade ora Oreste. Tutt’altro che fiero di aver vendicato il sangue paterno, egli dice che andrà ora lontano, al santuario del dio, “esule, errante, lungi dalla mia terra”. Inutilmente il Coro gli ricorda, riprendendo l’immagine del “serpente” apparsa nelle parole ultime di Clitemestra, che egli ha liberato Argo, “dei due draghi con mano felice mozzando le teste”. Una terrificante visione, invisibile agli altri, si presenta al suo animo, e fa ora di lui, cacciatore, un cacciato: ”Ahi,ahi! Quali femmine sono queste! Nere tuniche hanno, come Gòrgoni, e le chiome attorte di serpi fitte... Ahi, non posso più rimanere”. Le creature spaventose lo circondano, sono lì, presenti — l’aggettivo ai(/de, che torna più volte nelle sue parole, sottolinea ossessivamente questa presenza: esse gocciano sangue dagli occhi, danzano intorno a lui una ridda selvaggia. È vera l’osservazione del Di Benedetto, che, dopo il matricidio, “lo spazio dato da Eschilo alle Erinni nella trilogia si dilata enormemente e le divinità del mondo degli Inferi tendono ad occupare tutta la scena”. Non esse sono, “opinioni”, ”fantasie”, quasi, come vorrebbe definirle il Coro, ma creature in carne ed ossa, che Oreste realmente “vede”, coerentemente con il modello culturale primitivo di cui esse sono espressione - penso all’opera di Dodds, I Greci e l’irrazionale, del 1973 - e l’animo di Oreste è travolto dalla paura, un terrore che lo getta in una fuga disperata, ci vien fatto di pensare all’ “Urlo” di Munch — e mentre egli scompare, il Coro rievoca le sventure della casa degli Atridi: ”Dove mai finirà, dove mai cesserà, finalmente mutata, placata, la furia di Ate?” Il Prologo delle Eumenidi, recitato dalla sacerdotessa di Apollo, la Pizia — è da tenere presento che in quest’ultima tragedia della trilogia Eschilo ha introdotto una “scena multipla”, che prevede tre scene contemporaneamente presenti, il tempio di Apollo in Delfi, il tempio di Atena sull’acropoli di Atene e, in mezzo tra i due templi, lo spazio aperto per l’Areopago, che sarà occupato nella parte conclusiva della tragedia dagli Aeropagiti - è tutto pervaso da profonda religiosità: si sono avvicendate nel luogo divinità, ognuna delle quali ha contribuito, senza violenza, ou)de\ pro\j bi/an, a rendere sacro il luogo, fino ad Apollo. Ma la sacerdotessa non può dimenticare, nella sua preghiera, Pallade Pronàia, da un lato, Dioniso, dall’altro, che guidò le Baccanti -e)strath/ghsen - contro Pènteo e preparò la morte di questi, ”come cani a una lepre”. Si disegna così un intreccio di mondo civile e di più remota ferinità, su cui regna, altissimo,u(/yiston, Zeus. Un orribile spettacolo si presenta però alla Pizia, entrata nel tempio e subito uscitane sgomenta: un viluppo di donne,anzi,non donne, dice la sacerdotessa correggendosi, ma Gòrgoni, o Arpie, si avviluppa sopra un uomo piegato in atto di supplice presso l’o)mfalo/j, la pietra bianca che, nel tempio di Apollo, rappresenta il centro della terra. Quelle creature mostruose, che, a 15 differenza delle Arpie, “sono senz’ali..., e nere,e repugnanti alla vista. E russano, ed esalano fiati che ammorbano, e sgradevoli umori stillano dagli occhi”, e, aggiunge la donna, hanno strani guarnimenti, che non è lecito portare nei templi né nelle case”, alludendo ai serpenti che cingono loro il capo, sono addormentate. Nel dialogo che, uscita la Pizia, si svolge tra Oreste e Apollo, entrato in scena dalla porta del tempio, le Erinni vengono definite da Apollo “vergini maledette, queste vecchie vergini nate in un tempo remoto. Nessuno ci congiunge con loro, né dio né uomo né bestia selvatica”, nate per il male, che gli dèi dell’Olimpo hanno in odio. Oreste, dice Apollo, troverà rifugio da costoro nella città di Atene, dove dovrà venerare il simulacro di Pallade. Là Apollo troverà “i giudici della contesa” e il mezzo per liberare Oreste dalle maledette. “Fui io — dichiara il dio — che ti indussi a colpire il seno di tua madre”. Con una invenzione di forte impatto emotivo, che ricorda l’apparizione del fantasma di Dario nei Persiani, Eschilo introduce ora l’ombra di Clitemestra che si leva dal centro dell’orchestra e che appare in sogno alle Erinni addormentate, perché, come ella dice, “L’anima di chi dorme è tutto uno splendore di occhi che vedono”. Clitemestra ricorda “le notturne cene di sacrifici” da lei offerte alle Erinni,e le rimprovera per essersi lasciate sfuggire Oreste, “come un cerbiatto,..., con un agile salto, fra mezzo le reti tese”, e le Erinni emettono nel sonno sordi mugolii, mormorii o lamenti indistinti: mu/zw, mugmo/j, e destandosi, ancora semisommerse nel sonno, esse si abbandonano ancora ad un “più lungo e acuto mogolìo” (mugmo\j diplou=j o)cu/j). Al qual proposito Di Benedetto sottolinea come il nesso tra le Erinni e “un mondo disumano e barbaro” si realizzi anche attraverso la ripresa, a distanza, di questo verbo poco frequente nei testi letterari. Eccole poi agitarsi freneticamente e incitarsi a vicenda alla caccia selvaggia - labe\ labe\ labe\ labe\ fra/zon esortate da Clitemestra: ”Soffiagli contro a costui un tuo soffio di sangue; col tuo alito, col fuoco delle tue viscere, disseccalo, stagli dietro, consumalo, dagli addosso ancora una seconda volta!” Come è stato notato da vari studiosi, la Parodo, che ora prende corpo e che in senso stretto non è tale perché il Coro è già nell’Orchestra, rievoca anche nella struttura metrica i qrh=noi, gli antichi canti di lutto: in particolare, le prime due coppie strofiche si articolano in una strofe all’insegna del lamento e dell’autocommiserazione, e in un’antistrofe dove prevale invece il tono violento e aggressivo: A.”Ahimé ahimé, un guaio mi è capitato, compagna... B. Oh sì, guai su guai patimmo e vani... A. Tristissimo danno, ahimé, insopportabile danno! Fuori delle reti si è buttata la bestia, è fuggita. B. Il sonno ci ha vinte, la preda l’abbiamo perduta...” ANTISTROFE A. Ah, figlio di Zeus, un predone tu sei... B. E noi, vecchie dee, tu giovane dio calpesti. A... per favorire il tuo supplice, uomo nemico agli dèi, funesto alla madre. Ce l’hai predato il matricida, tu dio”. Il Coro insiste nel descrivere i segni che i rimproveri di Clitemestra hanno lasciato sull’animo delle Erinni: pari a colpi di staffile, 16 le ha straziate nel fianco, nel fegato, ed esse mettono in discussione il senso di giustizia di Apollo, che tollera che l’ònfalo del suo tempio sia insozzato dal sangue del matricida. “Passò oltre le leggi divine — dicono di Apollo le Eririni — e violò le antichissime Moire”. Si evidenzia così il drammatico conflitto tra due diversi ordini sociali: da una parte le Erinni, che rappresentano il vecchio ordine tribale, fondato sulla parentela per parte di madre, che costituisce un vincolo più stretto del matrimonio stesso, dall’altro Apollo, sostenitore del nuovo diritto patrilineo, che tutela la superiorità dell’uomo sulla donna, e la santità del vincolo matrimoniale. La natura selvaggia delle Erinni è ribadita, nel I Episodio, da Apollo, che, improvvisamente uscito dal tempio, avanza protendendo l’arco contro le Erinni, e le esorta a lasciare la sua dimora: ”Là dove tagliano teste, dove strappano occhi, dove sgozzano; là dove seme di fecondità distruggono e fiore di giovinezza avvizzisce; là dove si vedono mutilazioni e lapidazioni, dove si odono mugghi e gemiti di gente trafitta per la schiena e confitta in terra da pali, là è la Vostra sede. Mi udite? Queste sono le orgie che vi deliziano, tutta la vostra figura lo dice; per questo gli dèi vi maledicono. Antri di leoni insaziati di strage voi dovete abitare,e non spargere su altri, in questo tempio fatidico, la vostra sozzura”. Della gente impalata si dice che mu/zousin, il verbo già usato a proposito del mugolìo delle Erinni. Nella Sticomitia che si svolge tra la Corifea ed Apollo, questi viene accusato di essere il vero responsabile del matricidio perché Oreste ha obbedito al suo ordine: nelle battute incalzanti si articola così il tema del processo che di lì a poco si terrà in Atene: ”Ma io — proclama la Corifea — il sangue di una madre m’incita, farò giustizia di lui, non cesserò di dargli, come cane, la caccia”. Avvalendosi dell’invenzione scenica che abbiamo già detto, Eschilo introduce ora Oreste che, fuggendo da Delfi e percorrendo l’Orchestra vuota, giunge ad Atene, e si prosterna davanti al simulacro di Atena, davanti al tempio della dea, da cui invoca protezione contro l’a)la/stwr, il demone malefico della stirpe di Atreo. Subito dopo, con un secondo ingresso nell’Orchestra (Epiparodo) irrompono le Erinni per dare la caccia a Oreste, come cani “dietro un cerbiatto ferito”, sulla traccia di “pozze di sangue, gocce di sangue”: ”Da te io voglio di feroce bevanda pascere la mia sete”, esse gridano rivolte ad Oreste. Ed è una specie di danza orgiastica quella che esse danzano, nel I Stasimo, facendo quasi un incantesimo caratterizzato, a livello espressivo, dall’Efimnio, un ritornello che dà al canto un ritmo magico— primitivo, anche mediante l’uso della paratassi, con parole accostate l’una all’altra senza articolazioni sintattiche: ”Una danza, una danza vogliamo danzare, un canto di orrore vogliamo cantare; e dire in che modo alle sorti degli uomini la nostra congrega dà ordine e legge”, e ancora: “E per la vittima questo canto, follia, dissennatezza devastatrice della mente, inno proveniente dalle Erinni, imprigionatore della mente, senza cetra, disseccamento per gli uomini”. È stato giustamente osservato, a questo proposito, che il canto delle Erinni, definito da loro 17 stesse, mou=san stugera/n, “poesia odiosa”, si oppone nettamente alla poetica omerica del te/rpein ,“dilettare”. La potenza delle Erinni si disegna dunque in questo Stasimo in tutta la sua terribilità: memori delle colpe, sorde al pianto degli uomini, indifferenti all’onore e al disprezzo, relegate dagli altri dèi in un mondo di tenebra, esse sono le Venerande (semnai/), orrido è il loro cammino, tenace la volontà di vendetta che le anima. Davanti ad esse, alta sull’acropoli, si staglia ora l’immagine di Atena, e quanto il linguaggio delle Erinni è stato violento e sfrenato, tanto le parole della dea sono pacate, solenni: ”Da lungi, dal lontano Scamandro, udii il richiamo di una voce. Prendevo possesso di una terra che a me del loro bottino avevano assegnato i capi e i guerrieri Achei”. Si svolge così, nel I Episodio, alla presenza di Atena, un’anticipazione del processo: le Erinni ed Oreste esprimono ciascuno le proprie ragioni, le prime con linguaggio pauroso, l’altro, con calma non priva di pathos: ”Appena ritornato mio padre a casa, in malo modo fu ucciso; mia madre lo uccise, donna di nero cuore - kelaino/frwn -. Lo ravviluppò in una rete insidiosa; e fu quella rete che diede a me testimonianza dell’eccidio del bagno. Ritornato poi io, dopo il lungo esilio, a casa, uccisi mia madre. Non nego questo: morte con morte, a vendetta del padre amato”. Consapevole della difficoltà di decidere una questione così grave, non volendo deludere il supplice né privare le Erinni dei loro diritti, Atena dichiara che istituirà un apposito tribunale, l’AREOPAGO, cui spetterà il compito di giudicare dei delitti di sangue, e che sarà composto dai migliori cittadini di Atene. Al tribunale oggetto di violente contestazioni politiche nel suo tempo, Eschilo attribuisce dunque un’origine antichissima, che affonda le sue radici nel mito. Un particolare significato assume, nello svolgimento concettuale delle Eumenidi, il II Stasimo, che costituisce anche un anello di collegamento con il III ed ultimo Episodio. In esso Eschilo sviluppa un tema già anticipato in più parti della trilogia, quello della paura (fo/boj) che viene ora strettamente connesso con il ge/noj degli Atridi al fine di preparare l’affermazione del principio di giustizia che deve regolare la po/lij. “Vedrete voi ora a quali rovine porteranno le nuove leggi se la causa — il delitto! — di questo matricida dovrà prevalere — dicono le Erinni -. Dai propri figli i genitori ferite e morti si dovranno d’ora innanzi aspettare”. La visione che si apre alle parole delle Erinni è quella di uno Stato in cui prevarranno crudeltà e violenza. Invece, proclamano le Erinni, “È bene talvolta il terrore. È bene che sul cuore degli uomini abbia il suo posto di guardia. Il dolore giova a saggezza” (swfronei=n u(po\ ste/nein): ritorna in questa affermazione il concetto del ma/qoh pa/qei, e il poeta esorta implicitamente al swfronei=n, che costituisce uno dei grandi motivi etici e politici dell’Orestea. Ai deino/n,a “ciò che incute terrore” il drammaturgo attribuisce dunque una funzione di vigilanza sulla collettività: 18 “Senza freno di leggi non lodare la vita, né senza libertà. Sempre il giusto mezzo prevalga. Questo volle il dio, che i casi diversi diversamente sorveglia e dirige”. Sembra di avvertire l’eco di certi versi soloniani, quando le Erinni affermano: ”Rispetta l’altare di Giustizia. Non ti seduca guadagno a rovesciarlo con piede sacrilego, perché il castigo sopravverrà”: è evidente in questa esortazione alla “reverenza dovuta” (se/baj) che dovrà regnare nella po/lij il nesso che il vecchio poeta intende mettere in evidenza tra vita politica e principi etico—religiosi. La nuova istituzione politica che ora sorgerà per volere di Atena, l’Areopago, tanto più dovrà essere rispettato e temuto perché sopravvive in esso quell’antico sentimento di paura che proviene e si incarna nelle Erinni. Così introdotto, il III ed ultimo Episodio rappresenta la conclusione non solo artistica, ma anche concettuale del lungo percorso dell’Orestea. Uscendo dai rispettivi templi appaiono Apollo e Atena, mentre gli Areopagiti prendono posto al centro del fronte scenico, dove gli inservienti hanno posto i seggi per i giudici e le urne per il voto. In basso, nell’Orchestra, il Coro delle Erinni. È una scena di massa quella che ora si svolge davanti ai nostri occhi. Dice a questo proposito Di Benedetto: ”La ragione per cui Eschilo ha voluto questa partecipazione popolare è facilmente comprensibile. Il destinatario della trilogia era la po/lij ateniese, alla quale in particolare nella parte finale delle Eumenidi veniva proposto un modello di ordinamento politico (ed etico—religioso) e la po/lij ateniese Eschilo volle che fosse presente nel teatro”. È un processo giudiziario in piena regola quello che ora si svolge davanti ai nostri occhi,e che ci riporta alla memoria certe orazioni lisiane. Apollo, Atena, la Corifea, Oreste affermano, talora in serrate sticomitie, le loro ragioni, e quanto la Corifea è aggressiva e incalzante — “Fu dunque Zeus, tu dici, che dettò a te quest’oracolo, e fu l’oracolo che intimò a Oreste di vendicare la morte del padre senza fare nessun conto del rispetto dovuto alla madre?” — tanto Apollo risponde con calma olimpica, non disdegnando le tesi maschiliste che già conosciamo, per poi rievocare le fasi dell’omicidio di Agamennone: ”Poi, nella vasca, lo avvolse di un mantello” — ma si usa la parola fa/roj, che ha il doppio significato, di “mantello” e “lenzuolo funebre” — lo chiuse nell’artificio di un peplo - daida/lw pe/pl% - lo impigliò in una rete inestricabile, e lo colpì”. Prima che i giudici procedano al voto, Atena rivolge un’allocuzione alla città, e non tanto la divinità poliade, quanto Eschilo stesso parla direttamente ai suoi concittadini: ”Ascoltatemi, o cittadini di Atene; udite che cosa è questo ordine da me qui istituito, voi che per primi siete chiamati a giudicare in una causa di sangue... Su questo colle Reverenza e Paura - se/baj e fo/boj - che di Reverenza è cognata impediranno ai. cittadini di fare offesa a Giustizia, quando non vogliono essi stessi sovvertire le leggi... Né anarchia né dispotismo - to\ mh/t’a)/narxon mh/te despotou/menon... questa è la regola che ai cittadini amanti della patria consiglio 19 di osservare; e di non scacciare del tutto dalla città il timore, perché senza il timore nessuno dei mortali opera secondo giustizia”. Come è evidente, si tratta di una esortazione alla concordia sociale e politica, in un momento di drammatca tensione all’interno della po/lij. A queste parole di Atena corrisponderà, alla conclusione delle Eumenidi, quanto diranno le Erinni divenute, appunto, ”Benevole”: “Anche fo voti che mai nella nostra città si odano fremiti di discordia civile, insaziata di mali. Né mai la polvere delle nostre strade si abbeveri di nero sangue di cittadini per strappare alle case, in collere vendicatrici di morti, altri morti. E scambio ci sia di gioie nella comune concordia; e unanime odio ai nemici: delle molte calamità unica medicina è questa ai mortali”. Mentre avviene la votazione e durante lo scrutinio dei voti si sviluppa un serrato contrasto dialettico tra Apollo e le Erinni, in cui, è stato notato, rimbalzano certi termini dall’uno alle altre con sferzante veemenza, fino al beffardo “nikh/sw d’e)gw/”, “Vincerò io”, detto da Apollo. Per ultima, Atena getta il suo voto, che è di assoluzione, motivato da una totale adesione ai diritti del padre: ”Madre che mi abbia generato io non ho. Il mio cuore, esclusi legami di nozze, è tutto per l’uomo. Io sono solamente del padre. E così il destino di una donna omicida del proprio sposo a me non importa: lo sposo importa, custode del focolare domestico”. Oreste, assolto per il voto di Atena, ma non eticamente giustificato, leva un inno di ringraziamento a Pallade Atena e alla città,in cui, oltre all’elogio di Atene vincitrice, non molti anni prima della messa in scena della trilogia, nelle guerre persiane, trova posto anche la celebrazione della summaxi/a tra Argo e Atene: ”Giuro che mai uomo argivo verrà qui a capitanare un esercito in guerra. Io sarò morto allora, ma contro chi osasse violare il giuramento anche dalla tomba insorgerò... Salute a te, Atena, e a te, popolo di Atene. Invincibili siano ai nostri nemici le nostre battaglie; e a noi e a voi salvezza e vittoria.” Si leva però ora, rabbioso, nell’Epilogo, il grido di protesta delle Erinni, che si sentono private dei propri diritti, e che si traduce, a somiglianza delle antiche trenodie, in coppie di pezzi lirici ripetuti: ”Ahi giovani dèi, voi siete che le leggi antiche avete calpestato e a me dalle mani la preda avete strappata! Umiliata, avvilita mi avete! Ahimé, ahimé! Ma collere gravi su questa terra cadranno! Veleno,veleno, a pagarmi il dolore patito, gocce di veleno che brucino ogni germe fecondo spremerò dal mio cuore”. Le “miserabili figlie della Notte”, dustuxei=j Nukto\j a)timopenqei=j, come si autodefiniscono, ”dolenti per il dolore ricevuto” minacciano ogni male ad Atene, ma Atena le affronta con benevole, pacate parole, le ammansisce, le placa, promettendo loro eterna riconoscenza della città: ”Tu dunque su questa mia terra non spargere coti insanguinate che affilino armi e cuori di giovani e contese e rovine furenti... e i miei cittadini non aizzarli, come si aizzano i galli, a guerre civili, a violenze di fratelli contro i fratelli. Con nemici di fuori sia, se ha da essere,la guerra...” Le Erinni si lasciano a poco a poco persuadere, e si trasformano così da persecutrici in benefiche 20 protettrici della città, in Eumenidi, perché sempre, garantisce Atena, esse saranno onorate e temute in Attica. Con felice osservazione, Vidal Naquet commenta: “La trasformazione delle Erinni in Eumenidi non muterà la loro natura. Divinità della notte, esse sono oggetto della festa notturna che conclude la trilogia. Esse ricevono normalmente le loro vittime sgozzate, le loro offerte sacrificali: I loro sfa/gia e le loro qusi/ai. Ma ormai esse, protettrici della crescita, hanno diritto alle primizie, “offerte di nascita e offerte di imene”. Si passa così dal vocabolario della caccia e della natura selvaggia a quello dell’agricoltura e della vita civile: ”Sarà mia grazia — canta ora il Coro delle Eumenidi — che venti maligni non rechino danno alle piante; che il soffio dell’arsura non bruci alle viti e agli ulivi le gemme e si arresti alle soglie del nostro paese; che non serpeggi tra le mèssi il triste morbo che fa morire le ‘spighe; che le floride greggi nutrite dai prati partoriscano al tempo dovuto i loro parti gemelli; e che le ricchezze scavate dalla terra, dono di Ermes, sempre dimostrino agli dèi riconoscenza del dono”. Atena ha esortato le Erinni a comportarsi d’ora in poi come il futopoimh/n, il “pastore delle piante”, il giardiniere, che sa quali erbe cattive e impure deve estirpare. Cesserà dunque la legge della vendetta privata: sarà l’Areopago, in cui troveranno la loro legittima sede fo/boj e se/baj a dettare legge, con la sacralità della sua istituzione, sui delitti di sangue, e il “selvaggio” delle antiche Erinni, ora incivilito, sarà volto al progresso della comunità. Con la grande processione notturna che si muove alla luce delle torce e che accompagna le Eumenidi, dispensatrici di prosperità, nell’antro sotterraneo dove saranno venerate, si conclude l’intera trilogia, che si era aperta con una visione altrettanto fantastica, la corsa notturna delle fiaccole dalla Troade ad Argo. Opera tra le più complesse non soltanto della letteratura classica ma di ogni tempo, mi piace ricordare, per concludere, il giudizio che diede sull’Orestea il grande studioso inglese George Thomson nel suo studio su Eschilo e Atene, del 1949: ”Di tutte le caratteristiche dell’Orestea, la più notevole è costituita dall’unione organica tra la tragedia e la comunità da cui era emersa e per cui era rappresentata: cioè dalla perfetta armonia fra la poesia e la vita”. Prof. Antonio Ramini 21
Scaricare