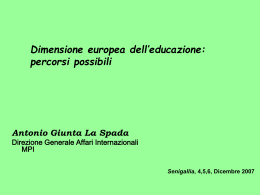Maurizio Zenezini1 (settembre 2005) L’inconsistenza (e le conseguenze negative) della politica europea dell’occupazione Sintesi Quando parliamo della politica europea per l’occupazione abbiamo in mente uno “spazio” favorevole alla convergenza verso condizioni di alta e civile partecipazione al mercato del lavoro, elevata tutela della disoccupazione, identiche affermazioni dei diritti sindacali. L’esperienza storica mostra che la dimensione europea, pur nella diversità delle realtà nazionali, ha potuto incoraggiare questi orientamenti onde, non senza ragione e sia pure con una certa inclinazione retorica, si è potuto parlare di “modello sociale europeo”. La Strategia Europea per l’Occupazione (SEO), avviata nel 1997 nel quadro del “processo di Lussemburgo”, sembrò rappresentare un passo in questa direzione, mentre l’inclusione del capitolo “occupazione” nel Trattato di Amsterdam sembrò accogliere le preoccupazioni di coloro, in particolare le organizzazioni del mondo del lavoro, che temevano la deriva della costruzione europea verso la stabilità monetaria e macroeconomica a danno della politica sociale. La “strategia di Lisbona”, enfaticamente lanciata nel 2000 come un progetto ambizioso per padroneggiare la crescita economica e stimolare l’occupazione, fu anche una reazione simbolica dei capi di governo che desideravano mostrare un impegno per le questioni occupazionali e sociali, tentando di contrastare l’apparente ruolo egemonico dei banchieri centrali e dei ministri delle finanze. Oggi sappiamo che una politica occupazionale dell’Unione Europea non c’è. La SEO ha certo favorito la convergenza “cognitiva” sui temi del lavoro e dell’occupazione, comprende “indirizzi”, “linee guida” e “raccomandazioni”, ma questo non è valso e non vale a produrre un trattamento unitario e coordinato alla scala europea dei problemi del lavoro. Quando il dibattito ufficiale europeo s’interroga sul ritardo di crescita accumulato dall’Europa negli ultimi cinque anni, sui limiti “normativi” della SEO e sul sostanziale fallimento della “strategia di Lisbona”, esso per lo più vede nella debolezza della governance europea le cause di questi insoddisfacenti sviluppi, mentre si sprecano gli inviti a proseguire senza indugi nella strategia di “riforma” dei mercati del lavoro. I limiti più seri della SEO sono invece i seguenti. In primo luogo, lo squilibrio esistente tra il grado di coordinamento delle politiche monetarie e del mercato interno e il coordinamento delle politiche occupazionali e sociali. Il coordinamento di queste ultime è affidato a procedure di confronto reciproco e di apprendimento tra stati membri che se da un lato hanno aumentato il grado di omogeneità nel “discorso” europeo sui temi dell’occupazione, dall’altro sono troppo deboli per poter restituire risultati di rilievo, soprattutto nell’adozione di quelle “best practices” più esigenti di risorse e di tutele per il lavoro. Di fatto, la “strategia di Lisbona” è diventata un contenitore vuoto in cui i singoli stati membri possono mettere quello che credono e le parti sociali possono interpretare in modi contrastanti. Già nel vertice di Lisbona, del resto, la coppia Blair-D’Alema insisteva su un approccio “anglosassone” alle politiche del lavoro, mentre il francese Jospin si dichiarava favorevole alle “35 ore”. In secondo luogo, il coordinamento delle politiche occupazionali trova ostacoli formidabili sia nelle diversità, anche istituzionali, dei mercati del lavoro degli stati membri, sia nelle difficoltà di combinare una politica “centralizzata” del lavoro con i requisiti di una unione monetaria. In terzo luogo, il processo di creazione del mercato interno e della moneta unica ha nei fatti determinato una distorsione verso orientamenti “offertisti” nelle politiche del lavoro e dell’occupazione. Se il “piano Delors” (Commissione Europea, 1993) intendeva ancora integrare le politiche occupazionali in un quadro teorico di prudente keynesismo (l’accento sugli investimenti pubblici, soprattutto in infrastrutture), già il Consiglio Europeo di Essen del 1994 puntava all’obiettivo di aumentare l’intensità occupazionale della crescita insistendo sulla compressione dei costi del lavoro e sulla mobilizzazione dell’offerta di lavoro. Ne è derivata una tendenza a porre in secondo piano il ruolo delle politiche macroeconomiche a sostegno della politica del lavoro, accentuando per contro il rilievo assegnato alle politiche di flessibilità della manodopera e del costo del lavoro. 1 1. La politica economica europea: il posto delle politiche dell’occupazione Una politica comunitaria dell’occupazione è virtualmente impossibile nell’attuale palinsesto della politica economica europea. Questo si compone di tre elementi – politica monetaria, politica fiscale e politiche dell’offerta (in cui rientrano le politiche del lavoro e le politiche strutturali). La politica monetaria ha il compito di controllare effetti – in particolare urti simmetrici - che si manifestano alla scala del sistema europeo e dispone del più alto livello di coordinamento, trattandosi di politica delegata ad un organismo indipendente quale è la Banca Centrale Europea. Le politiche fiscali e le politiche dell’offerta mantengono dosi variabili di autonomia nazionale poiché ci si aspetta che esse affrontino accadimenti specifici negli stati membri, ed in particolare gli effetti di shock asimmetrici, ma il coordinamento delle politiche fiscali è, o dovrebbe essere assicurato, dai dispositivi di hard law impliciti nel Patto di Stabilità e Sviluppo. E’ più morbido del coordinamento della politica monetaria, in quanto dipendente, tra l’altro, dalle risoluzioni del Consiglio Europeo. Le politiche dell’offerta, ed in particolare le politiche dell’occupazione, si realizzano in una cornice di direttive a maglie larghe con strumenti di soft law, quali, ad esempio, la SEO e il Metodo Aperto di Coordinamento (MAC), introdotto nell’agenda europea dal Consiglio di Lisbona del marzo 2000 (cfr. Rapporto Kok, 2004, p. 9). Il MAC, in buona sostanza, è un processo di interscambio e di comunicazione tra organi comunitari e stati membri basato sulla comparazione dei comportamenti nazionali in relazione alle linee guida e agli obiettivi fissati dagli organi comunitari (Consiglio e Commissione) e sulla diffusione, il confronto e l’apprendimento delle best practices – anche mediante la produzione di strumenti (indicatori, benchmark etc.) con cui sostenere e implementare il monitoraggio e la valutazione del progresso e dei ritardi nei singoli stati membri. In questo contesto, le politiche del lavoro restano sostanzialmente affidate alla responsabilità degli stati membri e presentano quindi un grado di unitarietà molto modesto alla scala europea, sia perché le linee guida della SEO non hanno carattere di obbligatorietà, sia a causa del debole impulso impresso dai dispositivi di blando coordinamento impliciti nel MAC, per lo più affidato alla pressione reciproca degli stati membri sollecitata dalle azioni di sorveglianza e dalle raccomandazione della Commissione e di fatto privo di forza esecutiva. Questa configurazione della politica economica europea ha nel tempo inevitabilmente finito per imporre una gerarchia all’agenda europea in cui le politiche del lavoro e dell’occupazione hanno una posizione secondaria rispetto alle politiche macroeconomiche. I mercati del lavoro devono adattarsi all’impianto sostanzialmente rigido delle politiche macroeconomiche e alla “robustezza” della politica economica – stabilità dei prezzi e vincoli del bilancio pubblico – devono corrispondere la moderazione salariale e la flessibilità del lavoro. Nel suo primo rapporto annuale, la Banca Centrale Europea aveva del resto affermato di ritenere impossibile l’uso della politica monetaria per stimolare la domanda aggregata e la crescita, aggiungendo che ogni tentativo in tale direzione avrebbe minacciato la stabilità dei prezzi e avrebbe avuto solamente effetti controproducenti nel lungo periodo (BCE, 1999, pp. 30 sgg.). In seguito, la BCE ha più volte presentato questo orientamento come un ferreo imperativo per le riforme dei mercati del lavoro che dovrebbero essere disegnate in modo da aumentare il grado di adattamento dei lavoratori all’evoluzione delle condizioni macroeconomiche (BCE, 2003, p. 50; BCE, 2005, p. 55). Tra questi orientamenti e le enunciazioni sul cosiddetto “modello sociale europeo” vi è un evidente contrasto, sul quale è stata più volte richiamata l’attenzione, anche nelle sedi istituzionali europee. In diverse occasioni il Parlamento Europeo ha sostenuto la necessità di riequilibrare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e delle politiche dell’occupazione per evitare che a queste ultime venga assegnato solamente un ruolo residuale (ad es., Parlamento Europeo, 2003). In una direzione analoga, un recente documento della Confederazione dei Sindacati Europei afferma che il ruolo subordinato delle politiche dell’occupazione riflette la prevalenza degli orientamenti monetaristi nel disegno della politica macroeconomica europea (ETUC, 2005, p. 42; anche ETUC, 2004, pp. 47 sgg.). Per superare questo stato di cose, tanto il Parlamento europeo, quanto i Sindacati 2 europei hanno insistito sull’opportunità di coordinare alla scala europea anche le politiche del lavoro e dell’occupazione e queste ultime, orizzontalmente, con le politiche macroeconomiche (Parlamento Europeo, 2003). 2. Le deboli prospettive di una politica dell’occupazione europea Questi rilievi e gli orientamenti verso una più decisa centralizzazione delle politiche occupazionali sono tuttavia destinati ad infrangersi contro l’architettura della politica economica europea. Quest’ultima ammette un elevato grado di centralizzazione nell’area del Mercato Unico e nella politica monetaria, sulla base del presupposto che, in tali contesti, l’azione dei policy makers nei singoli stati membri generi delle esternalità (in conseguenza, ad esempio, di aiuti di stato o di svalutazioni competitive) attraverso le quali governi “inefficienti” potrebbero danneggiare governi “virtuosi”. Per quanto riguarda invece le politiche del lavoro e dell’occupazione, le giustificazioni, o le possibilità, della centralizzazione appaiono molto più deboli. Secondo un punto di vista piuttosto comune nel dibattito di politica economica, la centralizzazione delle politiche dell’occupazione e del lavoro va sconsigliata per almeno due ragioni. In primo luogo, si argomenta che le regole della democrazia rappresentativa impongano di attribuire le politiche del lavoro e dell’occupazione alle responsabilità politiche dei singoli governi. In secondo luogo, si argomenta che le politiche del lavoro e dell’occupazione attuate nei singoli stati non comportino esternalità, e in ogni caso non in modo così ovvio come per le politiche commerciali e monetarie. Questo contribuisce a spiegare perché in alcune aree di intervento la centralizzazione sia assicurata da dispositivi di hard law (si pensi alla politica della concorrenza), mentre in altre aree, in particolare quella dell’occupazione e del lavoro, il coordinamento sia affidato a meccanismi molto più morbidi, come il MAC. Nessuna delle due ragioni contro la centralizzazione delle politiche dell’occupazione è veramente convincente. Non vi è infatti nessun buon motivo perché la sovranità debba essere ceduta nella gestione della politica monetaria o nella politica di bilancio, e invece mantenuta nella politica del lavoro, anche perché i vincoli macroeconomici tendono poi a restringere le opzioni effettivamente disponibili per le politiche dell’occupazione. D’altra parte, è evidente che anche le politiche dell’offerta condotte nei singoli stati membri, così come le politiche di domanda, possono comportare esternalità. Si pensi al caso di due paesi integrati in un’area monetaria e alla riduzione dei salari progettata in uno dei due per aumentare l’occupazione: se tale politica incassa gli effetti sperati, essa quasi certamente deprimerà, a parità di altre condizioni, la domanda di lavoro nell’altro paese. In realtà, le ragioni che spiegano la configurazione della politica economica europea riflettono circostanze storiche e scelte politiche, piuttosto che argomenti teoricamente incerti come le esternalità o argomenti importanti, ma discutibili, come la difesa della sovranità dei singoli stati membri sulle politiche dell’offerta.2 In primo luogo, per quanto riguarda le circostanze storiche, sappiamo di che si tratta: la costruzione dei congegni di governance della politica economica europea comincia – con il trattato di Maastricht - dal mercato unico e dalla moneta unica, definisce poi – con il Patto di Stabilità e Sviluppo - una cornice comunitaria per le politiche fiscali e, alla fine, si accorge dell’occupazione. Dapprima affronta la questione occupazionale con la debole proposta della SEO – con la quale si vuole contrastare la disoccupazione soprattutto incoraggiando l’”adattabilità” della forza lavoro - e poi con la più enfatica “strategia di Lisbona”. Gli obiettivi di Lisbona erano davvero ambiziosi: fare dell’Europa, entro il 2010, ”l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”: insomma, posti di lavoro più numerosi, migliori e ad elevata produttività, alta qualità della vita in un quadro di coesione sociale, rispetto dell’ambiente e crescita sostenuta, tutto nella cornice un po’ glamour della “società dell’informazione e della comunicazione” (l’infatuazione per la New Economy era ancora là) (Gruppo Kok, 2004). Alla luce delle vicende dell’economia europea degli 3 ultimi cinque anni, la “strategia di Lisbona” – oggi sostanzialmente fallita (ci torneremo più sotto) si conferma in larga misura come una mossa ideologica senza vero mordente, un pretesto per ripetere slogan. In secondo luogo, il coordinamento “forte” delle politiche del lavoro e delle politiche macroeconomiche è impossibile non solo perché la Banca Centrale “resta fuori dell’equazione” a causa del suo obbligo costituzionale all’indipendenza, ma soprattutto perché, avendo un solo strumento, la politica della Banca Centrale non può badare alle diverse realtà nazionali. In questo contesto, la diversità dei tassi di disoccupazione nei singoli paesi potrebbe essere affrontata con una politica fiscale centralizzata avente (anche) carattere (re)distributivo: una prospettiva semplicemente irrealistica data la debolezza (e le risorse) della governance europea. (Del resto, è lecito dubitare che abbiano avuto effetti di rilievo le stesse politiche strutturali dell’Unione Europea disegnate esplicitamente allo scopo di affrontare i divari regionali).3 Si deve anche rammentare che i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dopo l’iniziale freddezza verso la SEO, hanno pienamente accolto gli orientamenti della “strategia di Lisbona” sempre insistendo però sulla necessità di mantenere solo un debole coordinamento delle politiche dell’occupazione a livello europeo (Buchs, 2004). In terzo luogo, una politica occupazionale europea richiederebbe, tra le altre cose, un coordinamento delle politiche sindacali e salariali (un’opzione desiderabile dal punto dei vista dei sindacati in un contesto di crescente integrazione dei mercati dei prodotti e dei capitali). Questo passo – a parte alcune iniziali esperienze di ancora fiacco coordinamento e una maggiore visibilità della Federazione Sindacale Europea (ETUC, 2004, 2005) - è nel medio termine virtualmente impossibile: per la debole (e indebolita) azione sindacale, (nell’UE-15 il tasso di sindacalizzazione non superava il 27 per cento nel 2001, contro il 32,8 per cento di dieci anni prima), per la persistente competitività (esso stesso segnale di debolezza) tra le diverse organizzazioni sindacali nei singoli stati (piuttosto accentuata in alcuni di essi)(Commissione Europea, 2004b), per le diversità di tradizioni sindacali e per il limitato coinvolgimento dei sindacati nelle fasi di implementazione della SEO (ETUC, 2005), che in molti casi non è andato oltre la mera partecipazione formale. In quarto luogo, il rafforzamento del mercato unico e gli orientamenti verso la deregolamentazione dei mercati dei beni, sono fattori autonomi che nell’attuale contesto europeo tendono ad indebolire l’azione sindacale, sottraendo loro margini per la redistribuzione dai profitti ai salari (Jackman, 2001; Blanchard, 2004). L’allargamento a 25 dell’Unione Europea, aumentando il grado di eterogeneità tanto delle economie degli stati membri, quanto delle strutture sindacali, ha reso il coordinamento sindacale ancora più improbabile.4 Vero è che la centralizzazione dell’azione sindacale a livello europeo, nonostante gli slogan sul “dialogo sociale”, è di fatto scoraggiata proprio sul terreno salariale, in quanto potenzialmente in conflitto con la filosofia neomonetarista implicita nel Patto di Stabilità e Sviluppo (Arestis et al, 2001) e con i requisiti di un’unione monetaria che impone alle singole economie di fronteggiare shock negativi mediante aggiustamenti dei salari e dei mercati del lavoro.5 In questo senso, molto esplicito è un recente rapporto di lavoro della Commissione Europea che invita gli stati membri ad adottare politiche salariali diversificate e quanto più possibile “decentralizzate” (tra regioni, settori, imprese, qualifiche), proprio per “assorbire” l’impatto differenziale della politica monetaria nei diversi stati membri (Commissione Europea, 2005a, 2005b, p. 24). 3. Le tappe e i risultati della Strategia Europea per l’Occupazione: 1997-2004 La “strategia di Lussemburgo” si basava su quattro “pilastri”- adattabilità, imprenditorialità, parità di genere, inclusione sociale – declinati in numerose “linee guida” (per una descrizione sintetica: Ciccarone e Marchetti, 2004). Adottata nel 1997 con l’obiettivo principale di combattere la disoccupazione, cinque anni dopo i suoi risultati sono stati valutati dalla Commissione Europea 4 (Commissione Europea, 2002a, b), ma già nel 2003 il Consiglio Europeo modificava la struttura della SEO, riducendo drasticamente il numero delle “linee guida” e rinunciando a inquadrarle nei “pilastri” (Consiglio Europeo, 2003). La “strategia di Lisbona” - che dal 2000 costituisce la nuova cornice delle politiche dell’offerta dell’Unione Europea - sposta la priorità dalla riduzione della disoccupazione all’aumento dell’occupazione, non solo tracciando linee guida, ma impegnandosi in obiettivi quantitativi, fissati in una lista molto ampia di indicatori (dal mercato del lavoro all’ambiente, dalle imprese ai divari sociali); al momento del suo lancio, immaginava una crescita del 3 per cento all’anno nel decennio e indicava per il 2010 l’obiettivo del tasso di occupazione aggregato del 70 per cento, del tasso di occupazione femminile del 60 per cento e del 50 per cento il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani. “Imprenditorialità” e “adattabilità” Lasciando stare le politiche per la parità di genere e la coesione sociale, che restano ovviamente importanti enunciazioni di principio - nonostante gli abusi retorici che nascondono progressi nel migliore dei casi molto deboli - sono i primi due pilastri che contano. Il pilastro “imprenditorialità” concerne per lo più il tema delle procedure amministrative e dei costi nella creazione di impresa. Qui, possiamo solo rammentare che un rapporto del Comitato per l’Occupazione presso la Commissione Europea (Commissione Europea, 2002c) riferiva che (nel 2001) non più del 10 per cento delle piccole e medie imprese nell’UE-15 considerava gli oneri amministrativi come un ostacolo maggiore, ma un terzo di questi oneri riguardava poi le condizioni sanitarie e della sicurezza.6 E’ difficile immaginare che vi sia qui altro che un problema di secondo ordine, nonostante la ripetitività con cui esso viene proposto nei documenti europei (mentre è ben noto che la sollecitazione “artificiale” di alti tassi di creazione d’impresa e di lavoro autonomo tende a sedimentare fenomeni di elevata turbolenza del mercato del lavoro: Taylor, 2002). Del resto, in sede di valutazione dei primi cinque anni della SEO (Commissione Europea, 2002b), il tema dell’imprenditorialità non ottenne che poche enunciazioni generiche. Inoltre, nonostante le numerose misure riferibili al “pilastro imprenditorialità”, enunciate nei Piani d’Azione Nazionali degli stati membri nel primo quinquennio della SEO, il rapporto concludeva che tali misure non erano state soggette a valutazioni d’impatto. A ben vedere, se si esclude questo aspetto, il riferimento alla “imprenditorialità” nei documenti comunitari nella maggior parte dei casi non è molto di più di un appello - che si piega talvolta alla perorazione ideologica - a favore dello “spirito imprenditoriale”, del lavoro autonomo e delle necessità di creare “un contesto favorevole agli imprenditori” (Rapporto Kok, 2004, p. 31).7 Il pilastro centrale è dunque quello dell’“adattabilità”, e se non si tratta solamente di un concetto vago, esso ha nel tempo progressivamente inteso significare che le politiche per l'occupazione dovrebbero puntare soprattutto all’adeguamento dell'offerta di lavoro ai mercati e ai fabbisogni delle imprese, attraverso la "flessibilità" dei contratti e delle prestazioni lavorative e attraverso la formazione per aumentare il grado di "occupabilità" delle persone. Anche quando si sottolinea l’importanza della qualità del lavoro, l’accento nei documenti ufficiali è il più delle volte posto sulla qualità del lavoro come strumento per la produttività e la competitività, piuttosto che come una prerogativa dei lavoratori (Consiglio Europeo, 2003). Qui c’è solo da rammentare che al momento della sua attivazione, la SEO accettava integralmente l’idea che gli obiettivi occupazionali possano e debbano essere perseguiti agendo sulla mobilizzazione dell’offerta di lavoro. 8 I risultati della SEO e la “strategia di Lisbona” La Commissione Europea valutò molto positivamente la prima fase della SEO, sottolineando che tra il 1997 e il 2001 nella UE-15 si crearono quasi undici milioni di posti di lavoro e la disoccupazione diminuì di oltre quattro milioni di unità. Le valutazioni da parte dei singoli stati membri furono invece molto più prudenti e in generale non attribuirono che un ruolo piuttosto limitato alla SEO 5 nei profili osservati dei mercati del lavoro nazionali.9 In effetti, misurati in una prospettiva di più lungo periodo, e alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, i risultati della SEO sono tutto tranne che brillanti. i) Il quinquennio 1997-2001 fu un periodo relativamente fortunato di forte crescita del reddito (il migliore in Europa dagli anni ottanta), dopo la crescita molto lenta del periodo 1992-1996 caratterizzata da una ingente distruzione di posti di lavoro (oltre quattro milioni e mezzo tra il 1991 e il 1994 nell’UE-15: Commissione Europea, 2003a, p. 209). Di fatto, più di un terzo dell’aumento dell’occupazione tra il 1997 e il 2002 rappresenta un recupero delle perdite precedenti. Del resto, se è vero che la sola area Euro poté creare più di 10 milioni di posti di lavoro nel primo quinquennio della SEO, è anche vero che era riuscita a crearne quasi 13 nel quadriennio 1988-1992 (ed erano, in media, posti di lavoro migliori e meglio pagati). ii) Il tasso di occupazione maschile nella UE-15 era nel 2002 allo stesso livello del 1992. E’ solo il tasso di occupazione femminile che aumenta durante il primo quinquennio della SEO (e di quasi 6 punti tra il 1992 e il 2002 nell’Ue-15). iii) In sede di valutazione della SEO, la Commissione presentò le esperienze dei tre paesi nordici, Danimarca, Svezia e Finlandia, e dell’Olanda, come casi di successo dell’’applicazione della politica dell’”occupabilità” (Commissione Europea, 2002b, p. 12). Ora, qualunque sia il significato di tale nozione, resta il fatto che l’accento sull”occupabilità” non ha impedito il crollo del tasso di occupazione in Finlandia e Svezia (che ha coinvolto anche l’occupazione femminile) rispettivamente sette punti e dieci punti in meno tra il 1990 e il 2004 (OECD, 2005a). iv) Nel primo quinquennio della SEO la qualità del lavoro percepita dai lavoratori peggiora in dieci paesi su 15, ma solo in Danimarca e Finlandia si rileva un miglioramento apprezzabile (Gallie e Paugam, 2002). v) Negli ultimi quattro o cinque anni il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani (55-64 anni) è aumentato nella media UE-15. E’ un buon risultato, ma si tratta di un fenomeno relativamente recente comune a tutti i paesi OCSE (OECD, 2005a): semplicemente, le persone restano più a lungo nel mercato del lavoro, in gran parte come conseguenza dell’aumento dei tassi di scolarizzazione, dell’aumento dell’occupazione nei servizi e del part-time. vi) Se le politiche del lavoro funzionano non solo a prescindere dalle condizioni di domanda, ma in sostituzione delle politiche di domanda (ad es. BCE, 2003, p. 45), allora il periodo di bassa crescita dopo il 2001 avrebbe dovuto rappresentare il miglior banco di prova per una strategia che insiste sulla mobilizzazione dell’offerta di lavoro quale condizione per l’aumento dell’occupazione. Invece, negli ultimi cinque anni la crescita dell’occupazione è decisamente rallentata. Tra il 2000 e il 2004 il tasso di occupazione aggregato nell’UE-15 aumenta solo di 1,3 punti (un terzo dell’incremento del periodo 1997-2001), ma diminuisce quello maschile (sia pure di poco): nel 2004 in dieci paesi su 15 il tasso di occupazione maschile era diminuito rispetto al 2000. Solo in tre paesi, Italia, Spagna e Grecia, si registrano aumenti di rilievo dei tassi di occupazione maschili, sebbene in due, Italia e Grecia, si tratti di un recupero rispetto alla contrazione subita dopo il 1993 (in entrambi i paesi i tassi di occupazione maschili nel 2003 erano sostanzialmente invariati rispetto a dieci anni prima). Vero è , peraltro, che se la Spagna è il paese dell’UE-15 che ha registrato, tra il 1996 e il 2004, il più alto incremento nel tasso di occupazione, il dibattito interno spagnolo tende ad attribuire questo risultato alla crescita economica e non alle politiche del lavoro (El Pais, 2005).10 Quanto alla Grecia, il balzo nel tasso di occupazione dopo il 2000-2001 è in larga misura una conseguenza degli impulsi di spesa pubblica associati alle Olimpiadi (OECD, 2005b). vii) I tassi di occupazione femminili aumentano per l’intero periodo 1996-2004, ma erano aumentati comunque più in fretta prima del 2000. Di nuovo, sono Italia e Spagna che recentemente hanno registrato i migliori avanzamenti (5,6 punti in più per l’Italia tra il 2000 e il 2004, 7 punti per la Spagna). viii) Il tasso di disoccupazione nell’UE-15 ha ripreso ad aumentare dopo il 2001. Solamente quattro paesi su 15 (Italia, Grecia, Finlandia e Regno Unito) hanno registrato una riduzione nei tassi di disoccupazione maschili tra il 2000 e il 2004. 6 ix) Dopo il suo pirotecnico lancio nel 2000, l’andamento dell’economia europea nell’ultimo quadriennio dice che la “strategia di Lisbona” è virtualmente fallita. Nessun importante obiettivo occupazionale intermedio (al 2005) è stato raggiunto, e si dubita di raggiungerli per il 2010.11 Basti solamente rammentare che per realizzare l’obiettivo di Lisbona per i lavoratori di età 55-64 anni occorrerebbe creare almeno 900 mila posti di lavoro all’anno, quando nel periodo 1997-2002 se ne sono creati 250 mila (Commissione Europea, 2003a, p. 178). La crescita del PIL nel periodo 20012005 non è arrivata nemmeno alla metà dell’obiettivo allora fissato, la crescita della produttività, dopo essere rallentata già nella prima fase della SEO, è diminuita ancora, sia in termini pro capite, sia, recentemente, anche in termini orari. Per farla breve. Se vi sono stati progressi nei tassi di occupazione e di disoccupazione nell’UE-15, questi si sono manifestati per lo più prima del 2000-2001, ovvero prima che la SEO potesse manifestare appieno i suoi effetti, prima dell’avvio della “Strategia di Lisbona” e in un contesto di crescita sostenuta; sono diventati molto più opachi in seguito, quando il rallentamento dell’economia avrebbe dovuto mettere alla prova gli impulsi autonomi promessi dalle riforme del mercato del lavoro; in ogni caso, sono soprattutto i tassi di attività femminili che mostrano avanzamenti consolidati, ma si tratta di una accertata tendenza di lungo periodo (OECD, 2005a): quali che siano i fattori sottostanti, è improbabile che la SEO abbia fatto molta differenza. 4. Perché la strategia di Lisbona non sta funzionando? Nel 2004 la Commissione Europea crea un gruppo di lavoro per valutare lo stato di avanzamento della “strategia di Lisbona”. Il gruppo, presieduto dall’ex primo ministro olandese Wim Kok, produce un rapporto che naturalmente reitera gli obiettivi di Lisbona, invita gli stati membri a darsi di fare in modo più vigoroso sulla strada delle riforme, auspica l’equilibrio tra dinamismo competitivo e “modello sociale europeo”, ma deve prendere atto che nella prima metà del percorso l’economia europea è andata molto male e poco è stato fatto nella direzione dei maggiori obiettivi (Gruppo Kok, 2004). All’inizio del 2005, la Commissione Europea ha preso atto di questo rinunciando a presentare come priorità tanto la data del 2010, quanto gli obiettivi riguardanti i tassi di occupazione (Commissione Europea, 2005e). In effetti, la “strategia di Lisbona” è diventata un arnese barocco per il numero e la diversa qualità degli obiettivi, la pluralità di orientamenti e di indicazioni spesso in conflitto reciproco, la produzione di carta, la mancanza di trasparenza e la frammentazione delle iniziative, la ripetitività delle enunciazioni: il “pacchetto di riforme” comprende 28 obiettivi principali, 120 sotto-obiettivi, 117 indicatori, e una procedura di rendicontazione da parte dei singoli stati membri che include non meno di 300 rapporti annuali (che naturalmente nessuno legge). Ecco allora che, nello stesso momento in cui cresce il fastidio per il deragliamento della governance europea, si moltiplicano i pronunciamenti a favore di un approccio più realistico, di priorità meglio definite, di procedure più snelle e coese.12 Sebbene questi rilievi siano appropriati, gli orientamenti delle politiche occupazionali impliciti nella “strategia di Lisbona” presentano limiti ben più profondi: deboli fondamenti teorici, fragilità di metodo, contraccolpi negativi. I deboli fondamenti del riformismo La politica occupazionale europea, i cui fondamenti sono stati fissati nel 1997 all’avvio della SEO e poi accentuati dalla “Strategia di Lisbona”, nasce dalla convinzione che la crescita economica dipenda dalla crescita dell’occupazione, che questa esiga la mobilizzazione dell’offerta di lavoro che, da ultimo, si può e si deve realizzare soprattutto con le “riforme” dei mercati del lavoro. Gli 7 ingredienti maggiori di questo riformismo – a parte i ripetitivi appelli all’investimento in capitale umano e il bavardage sull’innovazione - sono noti: riduzione delle tasse, snellimento dei sistemi di protezione dell’occupazione, moltiplicazione dei contratti e delle modalità di erogazione del lavoro.13 La fragilità di questo impianto teorico è persino troppo nota. Qui possiamo rammentare solo alcuni rilievi critici. i) Sappiamo, innanzitutto, che una vasta letteratura empirica indaga da tempo e con ostinazione la congettura secondo cui le “istituzioni” che regolamentano il mercato del lavoro determinano l’evoluzione dei tassi di disoccupazione e di occupazione, ma le prove finora accumulate a suo favore sono così deboli che non si perde niente a considerarla come un argomento empiricamente falso o come un pregiudizio (Baker et al., 2002, 2004; Fitoussi, 2004; Freeman, 2005). In ogni caso, si tratta di basi troppo incerte per una politica che voglia convincere: “la manipolazione delle istituzioni considerate oggi, abusivamente, come variabili strumentali va valutata con scetticismo. La loro riforma produce effetti empiricamente mal definiti e ambigui” (Fitoussi, 2004, p. 57). ii) L’efficacia delle politiche attive della manodopera (PAM), uno dei principali dispositivi di attivazione dell’offerta di lavoro sui cui insiste la SEO, è notoriamente troppa modesta per alimentare la crescita sostenuta di occupazione di qualità e combattere la disoccupazione generale (OECD, 2004), ma soprattutto per colmare gli scarti occupazionali nei paesi in ritardo.14 Un recente rapporto tecnico per la Commissione Europea calcola che l’aumento di un punto nella percentuale sul PIL della spesa delle PAM comporti nel lungo periodo (grosso modo cinque anni) un aumento del tasso di occupazione di 0,2 punti percentuali (Commissione Europea, 2004c, pp. 80 sgg.): insomma, se la PAM si pone obiettivi occupazionali ambiziosi, diventa semplicemente troppo costosa. iii) Le condizioni della domanda aggregata restano decisive, tanto che anche un rapporto del Parlamento Europeo ha sentito il bisogno di sottolineare che la politica economica europea richiederebbe non solo il coordinamento tra le politiche di domanda e quelle di offerta, ma soprattutto dovrebbe poter contare su un più efficace adattamento del “lato domanda” che non si limiti ad aspettare i cambiamenti dell’offerta (Parlamento Europeo, 2003). iv) Il ruolo della domanda è molto importante per quei segmenti di forza lavoro “secondaria”, come i lavoratori anziani, che in alcuni paesi rappresentano uno dei fattori principali dei bassi livelli di occupazione complessivi. L’inattività dei lavoratori anziani dipende in buona parte da una insufficiente dotazione di posti di lavoro - o da fenomeni di discriminazione legati all’età: Auer e Fortuny, 2000. Un rapporto europeo ha documentato che non meno del 6 per cento degli inattivi di età 55-64 anni è disposto a lavorare; se questi lavoratori scoraggiati e i disoccupati anziani venissero aggiunti agli attivi si realizzerebbe nell’UE-15 almeno metà dell’aumento del tasso di occupazione dettato dall’obiettivo di Lisbona per questa classe di età (Commissione Europea, 2003a, p. 162). Questi indizi suggeriscono che il problema del lavoro degli anziani non è tanto quello di trattenerli al lavoro (come?), ma anche, e forse soprattutto, per usare una formula precisa, quello di “portare il lavoro agli anziani” (Accornero, 2003). I limiti della SEO e del Metodo Aperto di Coordinamento (MAC) In un contesto istituzionale in cui la sovranità sulle politiche occupazionali rimane in mano agli stati membri e gli organismi comunitari non possono fare molto per “costringere” i singoli paesi ad adottare particolari politiche, il MAC rappresenta il dispositivo “soft” mediante il quale il confronto, l’apprendimento delle politiche e la reciproca valutazione dovrebbero incoraggiare i singoli stati membri ad adottare pratiche convergenti. Nei fatti, il MAC è soprattutto uno strumento “cognitivo” con una limitata e tendenzialmente asimmetrica portata “normativa”. Vediamo perché. 8 i) Se il confronto riguarda singoli “modelli” nazionali, esso rischia troppo facilmente la superficialità: non hanno senso equazioni comparative in cui i “modelli istituzionali” sono le variabili, semplicemente perché questi “modelli” non sono esportabili. ii) Se i modelli istituzionali non si esportano, e’ difficile dire che cosa si possa davvero imparare dai paesi che hanno avuto successo nel mercato del lavoro. La nozione di competitività, ad esempio, ha un significato molto diverso in un paese piccolo come l’Irlanda (la cui crescita negli anni novanta non dipende dalle riforme del mercato del lavoro, ma piuttosto dall’immigrazione e dai sussidi europei: Hanhan e Walsh, 2002) - e in un paese grande, come la Germania. A suo modo, la Germania è competitiva – ha accumulato un ingente avanzo commerciale - ma questo si è accompagnato ad una contrazione dei salari e della domanda interna che l’ha trasformata nel malato d’Europa. Quando, ecco un altro esempio, si elogia la politica occupazionale danese e si apprezza l’elevato grado di mobilità del lavoro in quel paese, si deve anche dire che si tratta della politica più costosa nel novero dei paesi OCSE: elevata incidenza delle politiche passive del lavoro, con sussidi di disoccupazione che possono anche raggiungere il 96 per cento del salari per i lavoratori peggio pagati, erogabili fino a quattro anni (OECD, 2004, p. 97), interventismo pubblico molto accentuato (e dobbiamo anche rammentare l’altissimo tasso di sindacalizzazione). iii) Se il confronto riguarda singoli aspetti istituzionali, allora esso incorre nell’equivoco di immaginarne gli effetti sul mercato del lavoro indipendentemente dalla loro coerenza nella complessiva “architettura istituzionale” (Fitoussi, 2004, p. 57). Si determina in questo modo un riformismo “à la carte” che incoraggia i singoli paesi non tanto a prendere i pezzi che servono, ma quelli che sono (o che sembrano) più a buon mercato: il governo francese, pur dopo un dibattito sui fasti del modello danese (nel 2004 alcuni ministri visitarono la Danimarca per vederlo in azione!), propone oggi di ridurre le tasse ai ricchi (quando invece in Danimarca l’aliquota marginale d’imposta è aumentata dopo il 1997) e di abrogare la legge delle 35 ore, nonostante i suoi accertati buoni risultati occupazionali15. La Germania, con l’”Agenda 2010” – pienamente coerente, secondo il Governo tedesco e la Commissione Europea, con la “strategia di Lisbona” (Buchs, 2004) aggredisce le tutele della disoccupazione, riduce il prelievo fiscale, inasprisce il sistema pensionistico. Il “riformismo” italiano è consistito per lo più nell’invenzione di una pletora di contratti di lavoro e nella politica di controllo dei salari: tra il 1999 e i 2004 la percentuale di adulti in “life-long learning” è aumentata di 10 punti in Svezia, e supera oggi il 35 per cento, in Italia è invece aumentata soltanto di due punti e resta sotto il 7 per cento; per contro, in Italia il cuneo fiscale è diminuito mentre è rimasto alto, o forse aumentato, in Svezia, dove è maggiore che in Italia (Commissione Europea, 2004c). Questi esempi sono sufficienti a mostrare che, nell’attuale contesto della politica economica europea, la SEO e il MAC tendono a catalizzare ricadute asimmetriche nei diversi paesi (se non altro perché i cattivi esempi sono più facili da imitare): di fatto, è più probabile osservare la convergenza verso politiche di deregolamentazione dei mercati del lavoro, anche se comportano costi politici, piuttosto che verso interventi finanziariamente più costosi destinati a rafforzare i sistemi di welfare (Buchs, 2004).16 I contraccolpi dell’”attivismo” delle politiche del lavoro La “strategia di Lisbona” non ha mantenuto né la promessa sui tassi di occupazione, né quella sulla produttività. Nel quinquennio 2001-2005 nell’area Euro la progressione della produttività del lavoro nei settori di mercato è risultata modestissima, ancora più lenta rispetto al precedente quinquennio, quando aveva già subito una forte contrazione rispetto ai profili di lungo periodo. Per farla breve, qualunque successo sia stato conseguito dal lato dell’occupazione, è stato pagato con il vistoso declino della produttività. Perché? Il Rapporto Kok attribuisce il declino del ritmo della produttività a due fattori grosso modo equivalenti: minori investimenti per dipendente e rallentamento del progresso tecnologico. Ma 9 poiché il progresso tecnico viene iniettato nel sistema per lo più attraverso gli investimenti, sono questi che contano nel breve-medio termine. Da cosa dipende il sensibile rallentamento della crescita degli investimenti nell’Unione Europea? In larga misura – risponde il rapporto Kok (Gruppo 2004, p. 17) - dai “recenti successi dell’UE in termini di creazione di posti di lavoro […] per lo più di impieghi a bassa produttività”. Si riconosce in tal modo che l’obiettivo di stimolare la crescita spingendo sull’input di lavoro è fallito, sebbene questo non dovrebbe sorprendere, se si rammenta il dichiarato obiettivo della SEO di aumentare l’occupazione rendendo più “appetibili” i lavoratori per la domanda di lavoro. Questo obiettivo può infatti essere declinato in due modi: aumentando l’efficienza e la qualità dei lavoratori (formazione, capitale umano etc.), oppure comprimendo la dinamica dei costi del lavoro. La prima opzione, per quanto desiderabile, ha esiti incerti e in ogni caso diluiti nel tempo, la seconda è quella adottata in quei paesi che, come la Spagna e l’Italia, sono riusciti ad aumentare notevolmente il tasso di occupazione dopo il 2000: sono però anche quelli in cui la produttività è andata peggio, semplicemente perché la compressione dei salari ha reso conveniente impiegare i lavoratori in posti di lavoro scadenti e ha spinto le persone ad accettarli. E per questo che l’OCSE, nel suo ultimo rapporto sull’Italia, deve riconoscere che le “riforme del mercato del lavoro”, che avevano promesso meraviglie, hanno invece contribuito al collasso della produttività e all’aumento dei profitti (OECD, 2005b), mentre sappiamo che proprio in Spagna e in Italia è particolarmente alta (e crescente) la frazione di occupati insoddisfatti della loro condizione lavorativa (Commissione Europea, 2003b, p. 9). All’opposto, i paesi che sono riusciti a preservare un buon ritmo di aumento della produttività ci sono riusciti, per così dire, “tenendo a bada” l’input di lavoro, arrestando o rallentando la crescita dei tassi di occupazione o, in alcuni casi, riducendoli (Svezia e Finlandia). Il caso degli Stati Uniti è qui rivelatore: dopo un lungo periodo di stagnazione dei salari reali e della produttività (grosso modo dalla fine degli anni settanta fino alla prima metà degli anni novanta), la produttività ha cominciato a crescere molto più in fretta che in Europa, ma il tasso di occupazione è diminuito e nel 2004 era sceso sotto il livello del 1990 (OECD, 2005a) (la fase recente è stata descritta come “crescita senza occupazione”). Sebbene sia imprudente trarre conclusioni troppo generali da questi indizi, il messaggio che essi restituiscono sembra chiaro: le politiche “offertiste” dell’occupazione sono quasi certamente poco efficaci come motore di crescita; ma quando riescono ad aumentare l’occupazione, soprattutto nelle fasi di rallentamento dell’economia, è quasi inevitabile che finiscano per sacrificare la produttività, la qualità del lavoro e i salari imponendo così una remora alla crescita di lungo periodo. Distribuzione del reddito Sappiamo come sono andate le cose. Già nel 1998 la Commissione Europea notava che nell’Unione Europea i salari reali stavano da tempo crescendo meno della produttività determinando così una riduzione della quota salari (scesa al di sotto dei valori degli Stati Uniti e del Giappone) e un aumento della profittabilità degli investimenti (Commissione Europea, 1998, p. 7). Rapporti recenti confermano la persistenza di profili molto fiacchi dei salari reali, ne prevedono la prosecuzione e continuano a raccomandare la moderazione salariale (Commissione Europea, 2005c, p. 7, p. 38). Che cosa si può aggiungere? Conclusioni Questa nota descrive alcuni aspetti della politica europea dell’occupazione, i cui elementi portanti sono rappresentati dalla SEO prima e dalla “strategia di Lisbona” poi. La SEO, che inizialmente dichiarava di ispirarsi alle esperienze di welfare inclusivo dei paesi nordici, ha nel tempo virato verso approcci di tipo neoliberale, pienamente accolti dalla “strategia di Lisbona” che assegna alla flessibilità del lavoro uno ruolo centrale tra i fattori della crescita economica. In questo senso, sotto 10 il profilo “ideologico”, la SEO e la “strategia di Lisbona” hanno contribuito a distillare in sede europea gli orientamenti emersi nel dibattito socialdemocratico degli anni novanta sulla cosiddetta “terza via” (Hemerijck, 2002). Si è certamente sviluppata una innocua omogeneizzazione “discorsiva” nell’area dell’occupazione, ma né le concezioni di politica del lavoro, né i loro aspetti sostanziali hanno mostrato alcuna significativa convergenza. Sebbene questo rifletta la persistenza di accentuate differenze nazionali nelle istituzioni e nei sistemi di welfare, è importante sottolineare che la convergenza nelle politiche dell’occupazione è di fatto ostacolata dall’architettura istituzionale della politica economica europea. Questa prevede tre aree di intervento largamente indipendenti: la politica monetaria, responsabilità della BCE, la politica di bilancio, responsabilità dell’Ecofin e della Commissione, e la politica del lavoro e dei redditi, prevalentemente affidata al cosiddetto “dialogo sociale”. In contesti di tipo “neocorporativisti” un dispositivo istituzionale di questo tipo può essere in grado, sotto appropriate condizioni di coordinamento orizzontale, di restituire equilibri macroeconomici non sfavorevoli al lavoro, sia pure nella forma dello “scambio politico”. Qualunque sia il giudizio che siamo disposti a dare di un simile disegno istituzionale, è evidente che esso non può funzionare nella dimensione europea in cui la gerarchizzazione dei settori di intervento rende virtualmente impossibile la cooperazione tra le aree di politica economica e trasforma il “dialogo sociale” in una frase vuota. Di fatto, in un contesto in cui le politiche dal lato della domanda aggregata sono sottratte alla sovranità decentrata degli stati membri e al “centro” è rimasto l’imperativo della stabilità dei prezzi, al “dialogo sociale” è affidato il compito sussidiario di promuovere (residualmente) l’equilibrio del mercato del lavoro nei singoli stati membri. Poiché d’altra parte è impossibile sostenere con argomenti convincenti che le politiche del lavoro e le “riforme del mercato del lavoro”, isolate da un contesto macroeconomico di crescita, abbiano effetti positivi sull’efficienza sistemica e sul tasso di occupazione si deve concludere che esse siano in realtà travestimenti di politiche distributive che ciascun paese deve attivare con i mezzi e con la coesione sociale di cui dispone e con le coalizioni distributive che è in grado di suscitare. Riferimenti bibliografici ACCORNERO A. (2003), “Flessibilità e stabilità del lavoro”, Economia e Società Regionale, 1/2, F. Angeli, Milano. ARESTIS, P., K. MCCAULEY, M. SAWYER (2001), “An alternative stability pact for the European Union” in Cambridge Journal of Economics vol. 25, pp113-130 AUER P., M. FORTUNY (2000) Ageing of the Labour Force in OECD Countries: Economic and Social Consequences Employment, Paper, 2000/2, Employment Sector, International Labour Office, Ginevra. BAKER D., GLYN A., HOWELL D., SCHMITT J. (2002), “Labor Market Institutions and Unemployment: A Critical Assessment of the Cross-Country Evidence” , CEPR, Center for Economic Policy Research, Working Paper, 2002-17, Washington (www.cepr.net/) (in corso di stampa presso Oxford University Press, 2004). BAKER D., GLYN A., HOWELL D., SCHMITT J. (2004), “Unemployment and Labor Market Institutions: The Failure of the Empirical Case for Deregulation” CEPR, Center for Economic Policy Research, settembre 2004, (www.cepr.net/). BCE (BANCA CENTRALE EUROPEA)(1999), Rapporto annuale 1998, Frankfurt am Main. BCE (BANCA CENTRALE EUROPEA)(2003), Rapporto annuale 2002, Frankfurt am Main. BCE (BANCA CENTRALE EUROPEA) (2005a), Rapporto annuale 2004, Frankfurt am Main. BCE (BANCA CENTRALE EUROPEA)(2005b), La politica monetaria della BCE, Frankfurt am Main. BLANCHARD O. (2004), The Economic Future of Europe, International Bureau of Economic Research Working paper 10310, febbraio. BOERI T., LAYARD R., NICKELL S. (2000), Welfare-to-Work and the Fight Against LongTerm Unemployment, Report to Prime Ministers Blair and D'Alema, 21 febbraio 2000, (documento per il Consiglio Europeo di Lisbona). 11 BUCHS M. (2004), Asymmetries of policy learning? The European Employment Strategy and its role in labour market policy reform in Germany and the UK, saggio presentato alla ESPAnet Conference, Università di Oxford, 9-11 settembre 2004. CICCARONE G., E. MARCHETTI (2004), “La Strategia Europea per l’Occupazione e i suoi effetti sul mercato del lavoro italiano”, Economia e lavoro, vol. 38, pp. 17-34. COMMISSIONE EUROPEA (1993), Growth, Competitiveness, Employment, the Challenges and Ways forward into the 21 st Century, Bruxelles. COMISSIONE EUROPEA (1998), Employment in Europe 1998. Jobs for people — people for jobs: turning policy guidelines into action, Directorate-General for Employment and Social Affairs, Bruxelles. COMMISSIONE EUROPEA (2002a), Relazione comune sull’occupazione, Bruxelles. COMMISSIONE EUROPEA (2002b), Impact evaluation of the EES. Technical analysis, Employment Committee, Bruxelles. COMMISSIONE EUROPEA (2002c), Impact evaluation of the EES. Background paper: entrepreneurship, Employment Committee, Bruxelles. COMMISSIONE EUROPEA (2003a), Employment in Europe 2003, Directorate-General for Employment and Social Affairs, Bruxelles. COMMISSIONE EUROPEA (2003b), Improving quality in work: a review of recent progress, Comunicazione della Commissione, 26 novembre. COMMISSIONE EUROPEA (2004a) Helping to create an entrepreneurial culture. A guide on good practices in promoting entrepreneurial attitudes and skills through education, European Commission DirectorateGeneral for Enterprise, Bruxelles. COMMISSIONE EUROPEA (2004b), Industrial relations in Europe 2004, European Commission DirectorateGeneral for Employment and Social Affairs, Bruxelles. COMMISSIONE EUROPEA (2004c), Employment in Europe 2004, Directorate-General for Employment and Social Affairs, Bruxelles. COMMISSIONE EUROPEA (2004d), European Employment Observatory: Spring 2004, Directorate-General for Employment and Social Affairs, Bruxelles. COMMISSIONE EUROPEA (2005a), Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008). Bruxelles, 12 aprile 2005. COMMISSIONE EUROPEA (2005b), Commission staff working paper. Second Implementation Report on the 2003-2005 Broad Economic Policy Guidelines, Bruxelles, 27 gennaio 2005. COMMISSIONE EUROPEA (2005c) Labour market and wage developments in 2004, with special focus on risk of jobless growth, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Bruxelles. COMMISSIONE EUROPEA (2005d), Commission Staff Working Document in support of the report from the Commission to the Spring European Council, 22-23 March 2005, on the Lisbon Strategy of economic, social and environmental renewal, Bruxelles, marzo 2005. COMMISSIONE EUROPEA (2005e), Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona, Comunicazione del Presidente Barroso, 2 febbraio 2005, Bruxelles. CONSIGLIO EUROPEO (2003) Council decision on guidelines for the employment policies of Member States, Bruxelles, 22 luglio 2003. ECONOMIST (THE) (2004), “The Lisbon Lament”, 4 novembre 2004. EUROSTAT (2004), Yearbook 2004. The statistical guide to Europe (1992-2002), Luxembourg. ETUC (EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION) (2004), Our Priorities. ETUC Resolutions, Bruxelles. ETUC (EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION) (2005), Contribution of Trade Union Organisations to the Evaluation of the Actions Conducted and their Impact in Terms of the European Employment Strategy, Bruxelles, febbraio 2005. EFILWC (EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS)(2002) Working time preferences in sixteen European countries, Luxembourg. FITOUSSI J.-P. (2004), La democratie et le marché, trad. it, La democrazia e il mercato, Il Mulino, Bologna, 2004. FREEMAN R. B. (2005), Labour market institutions without blinders: the debate over flexibility and labour market performance, National Bureau of Economic Research, Working Paper 11286, aprile. GALLIE D., S. PAUGAM, (2002), Social Precarity and Social Integration, Report for the European Commission, Directorate-General Employment, Bruxelles, ottobre. 12 GRUPPO KOK (2004), Affrontare la sfida. La strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, Gruppo ad alto livello presieduto da Wim Kok, Luxembourg, novembre 2004. HANHAN P., WALSH B. (2002), “Catching up with the Leaders: the Irish Hare”, Brookings Papers on Economic Activity, n. 1, pp. 1-57. HEMERIJCK, A., (2002), “The Self-Transformation of the European Social Model(s)”, in: G. EspingAndersen et al.,(a cura), Why We Need a New Welfare State, Oxford: Oxford University Press. JACKMAN R. (2001), “The pros and cons of a common European employment policy” Swedish Economic Policy Review , vol. 8 pp. 201-234 LAYARD R. (2004), Good Jobs and Bad Jobs, Centre for Economic Performance, Occasional Paper n. 19, aprile. MONDE (LE) (2005) “L'impact de la réduction du temps de travail sur l'emploi et la productivité des entreprises à la loupe”, 24 giugno 2005. OECD (2004) Economic outlook, dicembre, Parigi. OECD (2005a) Employment outlook, Parigi. OECD (2005b) Economic Surveys: Greece, giugno. OECD (2005c) Economic Surveys: Italy, giugno. PAIS (EL) (2005) “Bruselas considera insuficientes las medidas para reducir la temporalidad laboral”, 27 gennaio 2005. PARLAMENTO EUROPEO (2003), A Background to European Economic Policy 2003, Directorate-General for Research, Working Paper, Luxembourg, gennaio 2003. PARLAMENTO EUROPEO (2005) Relazione sulla raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità nel contesto degli orientamenti integrati per la crescita e l ’occupazione (2005-2008), Luxembourg, maggio 2005. TAYLOR M. (2002), Labour market transition in the context of social exclusion. A study of the EU, European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, Bruxelles. 1 [email protected] Su questo, v. il dibattito sulla Rivista del Manifesto, gennaio 2004: N. Acocella, E. Brancaccio, A. Graziani, Galapagos, Uscire da Maastricht, da sinistra. 3 Basti pensare che il Rapporto McDougall del 1977 per la Commissione Europea valutava che il buon funzionamento dell’UEM avrebbe richiesto un bilancio europeo almeno pari al 7,5 per cento del PIL dell’insieme degli stati membri! (v. Arestis et al, 2001) 4 In un articolo del novembre 2004, l’Economist vedeva nell’allargamento un passaggio salutare per i paesi della “vecchia” Europa grazie alla “pressione competitiva dell’affamata Europa centrale”. 5 Un rapporto della BCE è persino giunto a sostenere lo stupefacente argomento che le riforme del mercato del lavoro e la flessibilità sono opportune in quanto faciliterebbero l’attività delle autorità monetarie (BCE, 2003, p. 3). 6 Lo stesso rapporto ricordava che nello scorcio finale degli anni novanta in Italia furono create 180000 mila nuove imprese, contro le 60000 in un paese come il Regno Unito, spesso presentato come modello di dinamismo imprenditoriale (Commissione Europa, 2002b). 7 Nelle 56 pagine della versione italiana del “Rapporto Kok” la parola “imprese” ricorre 56 volte (il sindacato, naturalmente, è sparito). Un recente rapporto prodotto dalla Commissione Europea sulle “buone pratiche nella promozione dell’imprenditorialità attraverso l’istruzione” – perché “l’immagine positiva degli imprenditori non è mai stata altrettanto forte in Europa che negli Stati Uniti” (Commissione Europea, 2004e, p. 5) - è in questo senso eloquente fino al punto da risultare imbarazzante. Sono 21 le esperienze proposte come esempi da imitare: si va dal caso delle scuole elementari in cui si educano i bambini alla “cultura d’impresa” - insegnando loro, ad esempio, a realizzare una centrale elettrica o un negozio di prodotti del terzo mondo - alle “imprese virtuali” o alla “città imprenditoriali” nelle quali i ragazzi e gli adolescenti possono imparare a gestire un’impresa, comprare e vendere azioni, e promuovere attività di marketing. Lo scopo dichiarato è quello di rafforzare il legami tra il mondo della scuola e la comunità degli affari perché “anche se alcuni individui eccezionali nascono imprenditori, lo spirito imprenditoriale può essere insegnato ai giovani fin dalla scuola” (Commissione Europea, 2004a, p. 6). 8 Il documento Blair-D’Alema, presentato in occasione del Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, era in questo senso quasi un manifesto (Boeri et al., 2000). Layard (2004) fornisce una versione piuttosto radicale dell’idea che per aumentare l’occupazione bisogna “mobilitare i disoccupati” (ovvero incoraggiarli ad accettare qualsiasi tipo di lavoro). 9 O perché le linee guida della SEO si aggiungevano a percorsi già avviati in alcuni paesi o perché non affrontavano , o non erano adatti ai problemi specifici di alcuni paesi. I sindacati europei, dal canto loro, hanno denunciato 2 13 l’atteggiamento spesso burocratico con cui in molti stati membri le politiche nazionali sono state semplicemente “inserite” nella SEO (ETUC, 2005). 10 Come per l’Italia negli ultimi anni e l’Irlanda negli anni novanta, un fattore importante è rappresentato dal forte aumento degli immigrati. 11 Se nel prossimo quinquennio l’occupazione continuasse a crescere come nel periodo 2000-2004, solo quattro paesi dell’EU-15 rientreranno nell’obiettivo di Lisbona per il tasso di occupazione, e cioè i quattro che ci sono già (Danimarca, Olanda, Svezia, Regno Unito). 12 Un recente documento del Parlamento Europeo - a commento delle Raccomandazioni della Commissione sugli orientamenti per la crescita e l ’occupazione per il 2005-2008 – rimprovera la Commissione di riprendere proposte avanzate da anni con successo discutibile e di offrire raccomandazioni generiche al limite della banalità (Parlamento Europeo, 2005). 13 Come esempio da imitare, un rapporto tecnico della Commissione Europea (Commissione Europea, 2005b) presenta l’”agenda 2010” del governo tedesco (“legge Hartz” dal nome suo proponente, già direttore della Volkswagen), che ha suscitato la collera dei sindacati e numerose manifestazioni di protesta. Per l’Italia, sono stati segnalati il Libro Bianco del Governo Berlusconi dell’ottobre del 2001 e il “Patto per l’Italia” del luglio 2002 (Commissione Europea, 2004d, pp. 15 sgg.) che determinò un’aspra lacerazione sindacale. 14 Sebbene molte ricerche suggeriscano che specifiche tipologie di PAM possono avere effetti su particolari segmenti della forza lavoro, effetti generali sono invece molto più incerti. Una delle ben note ragioni che contribuiscono a spiegare la portata limitata delle PAM è che molto spesso esse non vengono indirizzate ai gruppi di forza lavoro – ad es. i lavoratori precari e gli anziani - che ne avrebbero più bisogno o che potrebbero trarne più vantaggio (questo è vero soprattutto per le attività di formazione). 15 Un rapporto francese stima che essa abbia contribuito a creare 350000 posti di lavoro tra il 1998 e il 2002 (Le Monde, 2005). 16 Pur deplorando gli insufficienti progressi verso l’allentamento dei sistemi di protezione dell’impiego, Blanchard (2004) conclude che lo “spazio” europeo ha indubbiamente favorito la tendenza verso la deregolamentazione. 14
Scaricare