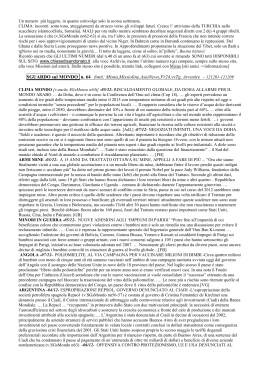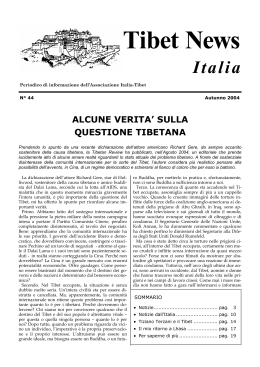Testo e foto di Emanuele Stano T ibet, parola magica che evoca nell’ideale collettivo spazi sconfinati ed atmosfere di tranquillità infinita. Ciò è quello che normalmente si associa a questa terra grazie anche all’indiscusso fascino esercitato dalla cinematografia americana che ha sin troppo attinto dal paese del Dalai Lama. Ma il Tibet è più di tutto questo, è un mondo da scoprire e soprattutto da capire, interpretando la storia e la religiosità del suo popolo. E’ una terra immensa che si estende a quasi quattromila metri di altitudine, protetta dalla catena himalayana che per secoli l’ha preservata, chiusa in uno scrigno, come l’ultimo Shangri-La. Nel corso dei se- coli il mondo occidentale ha provato a più riprese ad affacciarsi su questo regno ma ha sempre trovato chiuse le porte che avrebbero potuto portare alla sua capitale, che si è quindi giustamente meritata l’appellativo di “città proibita”. Pochi sono stati gli eletti, Tucci fra questi, che si sono potuti avventurare sull’altopiano per apprezzare un modo di vita distante anni luce dai canoni occidentali. Quando poi il paese si è definitivamente concesso alle masse, negli anni ’80, era oramai troppo tardi, lo scempio già compiuto, le atrocità commesse avevano per sempre, ineluttabilmente, cancellato la pace che regnava su quel paradiso perduto. Sì, perché di crimini si può e si deve parlare. Quello che il governo cinese ha perpetuato su questi territori è balzato all’attenzione internazionale solo decenni più tardi, quando ci siamo trovati di fronte al fatto compiuto, impotenti spettatori dell’annientamento di una cultura. Non che il Tibet fosse stato un paese in pace sin dalla notte dei tempi, anzi. Come in quasi tutto il mondo, qui si sono succedute forze regnanti che con la violenza si alternarono al potere. Ma quello che è accaduto nel 1950 è stato unanimemente condannato dalla storiografia: dopo un anno dall’ascesa del comunismo in Cina le truppe di Mao Tse-tung invasero il Tibet centrale e ne decretarono l’annessione alla Il Potala a Lhasa 6 AVVENTURE NEL MONDO 2-3 • MARZO/GIUGNO 2003 NEPAL - TIBET Occhi di Buddha a Swayambunath Madrepatria. Il Dalai Lama, appena quindicenne, non riuscì ad opporre un’adeguata reazione politica e le potenze occidentali, Inghilterra in primis, non fecero nulla per ovviare a questa situazione. Seguirono anni di sofferenze; quella che a Pechino venne chiamata “liberazione” causò centinaia di migliaia di morti ed il popolo tibetano, forte della sua fede nella religione, riuscì a resistere sino al 1959, quando per le strade di Lhasa scoppiò la rivolta. L’esito fu scontato: ulteriore spargimento di sangue e fuga del Dalai Lama che da allora non ha più rimesso piede nella sua terra natia. Il culmine è stato poi raggiunto nel 1966 quando ebbe inizio la rivoluzione culturale proletaria: monasteri, templi ed ogni altra rappresentazione artistica o luogo di scambio culturale vennero fatti bersagli di una sorta di furia iconoclasta che mirò a distruggere tutto quello che era stato costruito ed abbellito nei secoli. Fu il colpo fatale per il popolo sofferente che si appoggiava alla sua religiosità come ultimo mezzo di sostegno di fronte a quest’incomprensibile violenza di cui era stato vittima. Ed oggi, andando in giro per Lhasa, si vede scorrere tutto ciò davanti ai propri occhi: il quartiere tibetano ridotto ai minimi termini, quasi fagocitato dall’urbanizzazione cinese, un’orrenda piazza si estende davanti al Potala, scempio urbanistico nel cuore della città. Ma la popolazione sembra avere la voglia di reagire, di ricreare almeno in parte, forte dell’appoggio internazionale, lo stile di vita basato sugli insegnamenti del Buddha. Ma è anche vero che il corso della storia non può essere cambiato e non può essere dimenticato. Migliaia di immigrati cinesi vivono oramai nel Tibet e si compirebbe ingiustizia nei loro confronti qualora si volesse trasferirli altrove. Il sogno del popolo tibetano è quello di poter rivedere, un giorno, il loro capo politico e religioso, di nuovo a Lhasa, alle redini dello stato oggi delegittimato. Infatti il Dalai Lama non è solo una carica religiosa, bensì primo rappresentante di una nazione inesistente, non riconosciuta da nessun altro paese. Oggi il Tibet è una regione autonoma della Cina, governata con speciali leggi che dovrebbero preservare la sua identità culturale. Questo in teoria. Nella pratica tutti gli incarichi politici e militari sono ricoperti da immigrati cinesi, la vita nei monasteri è probabilmente tenuta sotto controllo da una sorta di spie e tutti i movimenti sociali che tendessero a ricreare uno spirito nazionalista indipendente sono più o meno violentemente repressi. Prima dell’invasione cinese la massima espressione culturale del paese era data dall’attività dei monasteri che raggruppavano fino ad alcune migliaia di monaci. Sia il potere religioso che quello politico erano in mano ad un’unica persona e, come nell’Europa me- dievale, la commistione fra potere temporale e spirituale fece sì che la religione divenisse uno strumento per controllare le masse. Alla morte del Dalai Lama la sua successione creava non poche problematiche: secondo i canoni buddhisti la reincarnazione di Avalokiteshvara, il bodhisattva della compassione, doveva presentare alcuni segni distintivi che erano però suscettibili di varie interpretazioni. In accordo a sogni premonitori ed altre indicazioni veniva prescelto un bambino che, portato a Lhasa, era educato ed istruito fino a quando, una volta raggiunta la maggiore età, veniva proclamato Dalai Lama, oceano di saggezza. Questo se gli fossero riconosciute le capacità di guidare una nazione, perché accadde anche che bambini che sarebbero dovuti diventare reggenti siano scomparsi prima della loro nomina. L’attuale Dalai Lama, il XIV, che visse in prima persona i tragici eventi degli anni ’50 e ’60, vive in esilio a Dharamsala, in India, da dove impartisce i suoi insegnamenti anche ai facoltosi turisti che possono permettersi di raggiungerlo e sostenere la sua causa. La sua successione creerà sicuramente non poche dispute: i cinesi avanzeranno la candidatura di un bambino fantoccio da poter guidare da Pechino e ci sarà quindi il rischio di perdere il primo baluardo della causa tibetana. Nei monasteri sparsi per l’altopiano si respira ancora la forte religiosità di questo popolo. Nelle stanze buie, l’odore acre delle candele al burro di yak permea tutto l’ambiente. La luce soffusa ed i suoni ovattati trasmettono qualcosa di mistico. I monaci, nelle loro tuniche del colore dell’ordine cui appartengono, si aggirano, quasi sospettosi, fra le stanze e nelle ore di preghiera ed in quelle dei pasti si radunano nella sala dell’assemblea. Guardano curiosi al turista, strumento per diffondere la loro cultura ma anche artefice di un deterioramento inesorabile delle tradizioni. Clamorosi anacronismi colpiscono l’occhio occidentale: il giovane monaco con un libro di preghiera su una mano ed il telefono cellulare sull’altra, anziani che coltivano l’orto con i loro abiti tradizionali ed un cappello dei Chicago Bulls in testa. Ma non possiamo disperarci per questo, è accaduto in tutti i luoghi del mondo che Monaci a Mindroling si sono aperti al turismo ed alla modernità, e dietro di ciò c’è, probabilmente, un miglioramento delle condizioni di vita. Ma qui si continuano a manifestare i forti valori della società tradizionale: pellegrini giungono da centinaia di chilometri di distanza per percorrere il Barkhor, il kora sacro attorno al Jokhang, il più importante tempio di Lhasa, o per visitare Samye, il primo monastero edificato in Tibet, sulle sponde dello Yarlung Tsangpo. La tradizione vuole che, una volta giunti in un luogo sacro, un monastero od un tempio, si percorra in senso orario un circuito di pellegrinaggio. Questo può essere più o meno lungo e tortuoso, stendersi per ottocento metri nel centro di Lhasa, come nel caso del Barkhor, o per alcuni chilometri, raggiungendo i 4.800 metri d’altitudine, come attorno al monastero di Ganden. I credenti lo percorrono portando sulla mano destra un cilindro di preghiera che viene fatto ruotare ininterrottamente in senso orario e mormorando incomprensibili litanie, genuflettendosi continuamente per saldare un voto fatto in precedenza, o facendo ruotare con la mano destra i centotto cilindri di preghiera disposti attorno ad uno stupa, costruzione sacra che conserva spoglie o altri oggetti sacri. Percorrere la friendship highway per allontanarsi da Lhasa sembra un viaggio indietro nel tempo, l’oppressione urbanistica cinese si fa meno marcata, i paesaggi sconfinati trasmettono serenità, le bandiere colorate sui passi montani sono mosse dal vento che recita le preghiere scritte su di esse. Si potrebbe raggiungere monasteri risparmiati dalla distruzione cinese solaGruppo Stano al Potala, Lhasa AVVENTURE NEL MONDO 2-3 • MARZO/GIUGNO 2003 7 NEPAL - TIBET Offerte d’incenso a Dashinkali mente perché inaccessibili oppure recarsi in luoghi come Ralung, dove dagli anni ’70 una nuova comunità ha dato vita alla rinascita culturale e religiosa del centro monastico che oggi sorge in un luogo che sembrerebbe dimenticato da Dio. Ed invece è proprio lì che si esprime al massimo l’essenza del popolo tibetano, ciecamente fedele agli insegnamenti di Sakyamuni, capace di ricostruire là dove tutto era stato distrutto, come monaci che certosinamente compongono un mandala di sabbia per puro esercizio di pazienza, per poi distruggerlo non appena completato. Lungo la principale arteria stradale si muovono le masse di pellegrini, le jeep dei turisti, i camion che trasportano non si sa bene cosa. In Tibet non esiste una linea ferroviaria. Il governo cinese ha intrapreso più volte il tentativo di realizzarla ma ci si è sempre fermati innanzi ai proibitivi costi di realizzazione ed alla relativa inutilità. Per la Cina sarebbe un evento simbolico, l’ultimo step che metterebbe in collegamento definitivo la regione con il resto della nazione. Poter salire su una carrozza a Pechino e scendere a Lhasa vorrebbe dire completa annessione alla Madrepatria. Fortunatamente ancora ci è risparmiato il vedere una locomotiva sferragliare sull’altopiano e speriamo che lo sia ancora a lungo. I ritmi della lenta strada sono più congeniali a questo popolo, fermarsi davanti ad Candele di burro di yak una frana o ad un rivolo ingrossato dalle piogge significa che la cementificazione non è ancora arrivata sin qui. Superando l’Everest, con la sua magnifica imponenza, ci si dirige verso il confine nepalese. Dopo l’ultimo passo, a 5.120 metri d’altitudine, si inizia la folle discesa che in pochi chilometri porta ai 1.300 metri della verde valle di Kathmandu. In poche ore tutto cambia drasticamente: il paesaggio arido dell’altopiano lascia spazio ad una foresta tropicale, l’aria salubre d’alta montagna diventa umida e calda afa estiva, il ritmo immobile delle montagne sacre è sostituito dalle corse sfrenate dei risciò, templi induisti si ergono al posto di stupa e chorten buddhisti. E’ un altro mondo, è la risposta a chi si chiede che cosa sarebbe diventato il Tibet se si fosse aperto prima all’Occidente. Infatti anche il Nepal era un regno incastonato fra le montagne più alte del pianeta, apparentemente irraggiungibile, attorniato da un alone di mistero che solo culture lontane dalla nostra sanno suscitare. Ma il Nepal si è concesso al visitatore, in pochi decenni è balzato dal medioevo ad internet. Thamel, il quartiere turistico della capitale, è tappezzato di insegne luminose di ristoranti, hotel, agenzie di viaggio e tutto quello di cui possa necessitare uno straniero. Kathmandu è stata prima importante centro di ritrovo per hippy di tutto il Passo La Lung-la 8 AVVENTURE NEL MONDO 2-3 • MARZO/GIUGNO 2003 Lago sull’altopiano mondo e poi base dei trekker che ambivano a scalare le vette himalayane. Oggi è una città caotica, che ha vissuto un boom demografico che ne ha sconvolto l’urbanistica. Gli stretti vicoli di un tempo che fu non sono riadattabili all’attuale traffico, ingorghi clamorosi si susseguono e lo smog costringe i pedoni a camminare con mascherine sul viso. Ma questo è un altro mondo, troppo distante dal paese limitrofo che si sta, probabilmente, preparando a vivere lo stesso iter. Speriamo solo che lo sviluppo non ne alteri troppo l’essenza vera. E quindi ben vengano lunghe attese, scossoni sulle jeep e velocità di percorrenza comiche se confrontate alle nostre, se questo volesse dire preservazione della cultura locale e salvaguardia della sua identità. Ma non possiamo bloccare la modernizzazione del paese, non possiamo voler lasciare questa gente in condizioni di vita arretrate solo per scattare foto più autentiche, di mete esotiche sconosciute al mondo occidentale. E quindi evoluzione tecnologica sì, ma nel rispetto delle tradizioni, nella salvaguardia di lingua, religione, usi e costumi locali. Questo è quello che si propone e si reclamizza, confidiamo nella sua realizzazione e negli anni ne sapremo giudicare i risultati. Un saluto ed un ringraziamento a tutti i partecipanti.
Scaricare