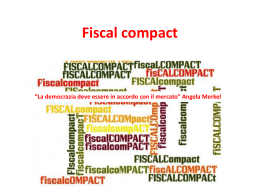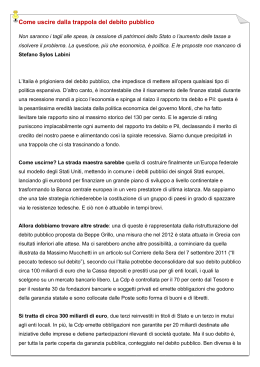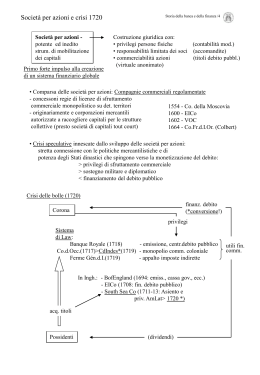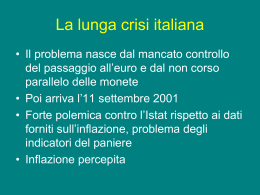Loretta Napoleoni Il contagio Rizzoli Proprietà letteraria riservata © 2011 RCS Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-58-61858-5 Progetto grafico di Elena Giavaldi per Mucca Design www.rizzoli.eu Trama RIPRENDIAMOCI la politica, l’economia, un lavoro, una vita dignitosa: è questo il grido che si leva unanime dalle sponde del Mediterraneo. Monta la consapevolezza che la crisi che oggi minaccia di annientarci viene da lontano, erede di una lunga serie di catastrofi – dall’Argentina alla bolla dei mercati asiatici ai crack statunitensi – ormai troppo numerose per essere casuali. È ora di ammetterlo: è l’alleanza tra una politica sempre più corrotta e una finanza sempre più avida che ha sequestrato la nostra democrazia e ci sta portando alla rovina. Mentre istituzioni di controllo come la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale intervengono a peggiorare la situazione. Dalla primavera araba, che ha abbattuto i regimi dittatoriali della Tunisia e dell’Egitto, arriva una nuova ventata di protesta e di impegno. La rivoluzione sta dilagando in Europa, nella Spagna degli Indignados, in Grecia, in Italia con la mobilitazione referendaria, il popolo Viola, il movimento “Se non ora quando?”. La parola d’ordine è: Basta! I protagonisti sono soprattutto i giovani, quelli a cui la politica ha riservato precariato, disoccupazione e lo spettro di una nuova povertà. Sul Mediterraneo, fa notare Napoleoni, si affacciano Paesi molto simili fra loro: economie avariate, oligarchie corrotte, disoccupazione e mancanza di servizi sociali, un sistema che regolarmente sceglie di garantire i privilegi di pochi a scapito della maggioranza. E come sulla sponda sud, anche su quella nord è il momento di riprenderci la democrazia, sostituendo istituzioni ormai agonizzanti con una post politica 2.0 trasparente e partecipativa. Il futuro ricomincia da noi. L’autore LORETTA NAPOLEONI vive da trent’anni tra Londra e gli Stati Uniti occupandosi di terrorismo ed economia. È consulente del think tank Fundaciones Ideas e fa parte del Comitato Scientifico di OXFAM ITALIA. Insegna economia alla Judge Business School di Cambridge. I suoi libri sono stati tradotti in 18 lingue. A Martina, che ho visto crescere, che non mi ha ascoltato ed è tornata da Sydney, che è lo stereotipo della precaria universitaria, che con immenso coraggio ci ha regalato una famiglia meravigliosa dove la P non sta per Precaria ma Per sempre. Nota dell’Autrice Questo libro è andato in stampa all’ultimo momento perché i fatti eccezionali dell’estate 2011 ci hanno impedito di porre la parola fine prima del termine del mese di agosto. Confesso che quando è iniziata la stesura, né la mia editor né io pensavamo di dover rincorrere quasi quotidianamente la storia. Eppure è proprio quello che è successo a causa del dilagare del contagio sociale ed economico. Da una parte l’insoddisfazione della società civile si è concretizzata in manifestazioni di protesta e dall’altra la crisi del debito sovrano si è trasformata in un evento negativo epocale per le economie occidentali. Soltanto a fine luglio, però, ho avuto la netta sensazione che la frattura tra politica e società civile fosse così profonda da produrre nel giro di poche settimane avvenimenti fino ad allora impensabili: le tendopoli israeliane, le scene di violenza in Gran Bretagna, l’altalena degli indici di Borsa, i crolli finanziari di agosto e il voto di sfiducia dei mercati nei confronti dei politici occidentali. Un evento, in particolare, mi ha convinto che il malessere del modello occidentale è ormai una pandemia: il muro di incomprensione tra la classe politica spagnola e gli Indignados. Una carenza dello Stato moderno che, a mio parere, è emblematica del perché il nostro modello non funziona più. Subito dopo l’accordo europeo del 21 luglio, che molti pensavano avrebbe calmato i mercati e concesso ai politici la pausa estiva, sono andata in Spagna per una riunione con alcuni uomini di governo. Ho colto l’occasione per incontrare i fondatori di ¡Democracia real YA!, uno dei gruppi che hanno dato vita al movimento degli Indignados spagnoli e con il quale sono stata in contatto per alcuni mesi mentre scrivevo questo saggio. Volevo tentare l’impossibile: trovare un terreno comune su cui governo e Indignados potessero instaurare un dialogo. Naturalmente ho fallito. I politici non riescono a vedere in questo movimento spontaneo un interlocutore. Anche se i sondaggi rivelano che l’80 per cento della popolazione spagnola lo appoggia. Gli Indignados la pensano allo stesso modo e si rifiutano di dialogare con individui che non rappresentano più la popolazione ma le élite che finanziano le loro campagne elettorali. Ecco perché per loro un partito vale l’altro. Tanto profonda è dunque la spaccatura tra politica e società civile. Una frattura che emerge anche dagli scontri e dalle violenze in Gran Bretagna, dalla manovra italiana di Ferragosto che colpisce sempre quella fetta del ceto medio ormai prossima alla povertà e dalla violenza con cui i mercati finanziari puniscono tutti i tentativi dei politici di rassicurarli sulla crescita economica. Si ha l’impressione che in Europa esistano due nazioni – quella dei pochi privilegiati e quella degli esclusi – e che i mercati si stiano ribellando contro questa discriminazione perché hanno capito che è la radice del rallentamento della crescita e della crisi del debito sovrano. L’incomunicabilità spagnola mi amareggia profondamente perché il governo di Zapatero è stato uno dei fari più luminosi che ci hanno permesso di uscire dagli anni bui della politica della paura di Bush e Blair. Ed è paradossale che la rivolta della società civile europea inizi in questo Paese e non in Italia, dove una classe politica corrotta e incompetente sta portando il Paese verso la rovina economica. Trascorrere due giorni a Madrid facendo la spola tra la piazza e i palazzi del governo è stato come viaggiare tra due mondi, le due nazioni di cui sopra: gli Indignados sono all’aria aperta, indossano abiti colorati e comunicano con tutto ciò che hanno a disposizione: dalle parole che viaggiano su Twitter alle immagini che si accalcano su YouTube, dalle sculture ai manifesti in bella mostra nelle piazze trasformate nel loro spazio politico. Sono giovani e ironici, ma determinati, non credono nella gerarchia e si riuniscono anche per decidere a che ora si riuniranno. Facile, dunque, capire lo scetticismo di chi da sempre milita in un partito o di chi ha partecipato al ’68 o al ’77; qui a Puerta del Sol tutto è molto fluido, non ci sono capi, segretari, scrivani che prendono appunti, non si urla, non ci si scontra, non si presentano «mozioni» o «documenti», si discute senza sosta e si cerca di arrivare a decisioni e progetti concreti. Chi sono questi giovani? Che tipo di minaccia o forza rappresentano rispettivamente per la classe politica europea e per la società civile? Nessuno in fondo lo sa, perché fanno parte di un fenomeno nuovo, della modernità politica del nuovo millennio. Ma una cosa è certa: il vento del futuro non soffia dalle sedi della super-burocratica Unione europea, ma dalle assemblee in piazza filmate in streaming con gli iPhone. Pochi ci credono, al punto che molti politici definiscono questo come un fenomeno folkloristico. E infatti a Puerta del Sol, quando il 27 luglio 2011 inizia la marcia verso Bruxelles – l’ennesima iniziativa contro la politica economica della Ue –, sembra di veder sfilare l’armata Brancaleone. È però sempre bene diffidare dalle apparenze. Si intuisce che questa iniziativa non è una crociata di pazzi né un esercito manipolato da qualche potere occulto, ma una sfida reale contro un modello vecchio e obsoleto, che non funziona più. Le armi potentissime gli Indignati ce le hanno in tasca: gli smartphone. A Madrid i politici li incontro nelle sale rinfrescate dall’aria condizionata. Sono tutti in abito scuro e sui loro volti leggo una profonda preoccupazione. Che succede? Alcuni sono reduci dalla maratona del salvataggio greco, un tour de force che li ha messi a dura prova; altri sono contrariati dalle decisioni imposte loro dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca centrale europea riguardo ai tagli alla spesa pubblica. Temono che la crisi e la rivolta degli Indignados restituisca il potere alla destra nelle elezioni politiche anticipate di novembre. E hanno ragione. Intuiscono che il modello neoliberista non funziona, sono anni che ne sono al corrente, ma non sanno proprio come riformarlo e sono troppo poco umili da dare ascolto alle voci che arrivano dalla strada, alcune delle quali pure dicono cose sensate. Cercano aiuto invece nelle istituzioni tradizionali dalla Ue ai Nobel per l’economia che promettono gli eurobond, ma nessuna di queste voci è sufficientemente rivoluzionaria o coraggiosa per tentare una strada del tutto diversa. Il neoliberismo ha contaminato anche il socialismo. Bisogna ricominciare da zero. Peccato, perché in Spagna quest’estate c’era veramente la possibilità di buttare tutto per aria e di lavorare a un’alternativa concreta alle politiche tradizionali di Bruxelles. Sia gli Indignados che il governo, infatti, vogliono il bene del Paese, un’economia che cresca e che faccia piazza pulita delle ineguaglianze verificatesi negli ultimi vent’anni. Un sentimento che ormai tutti i politici occidentali condividono adesso che i consensi sono svaniti, persino Berlusconi di fronte alla disintegrazione del suo governo e del suo partito sarebbe disposto a tornare a quella distribuzione «socialista» del reddito che tanto ha criticato. Ma mentre gli Indignados sono disposti a rischiare perché non hanno nulla da perdere, i politici temono di perdere il salvagente europeo. Anche riconoscendo i limiti imposti dall’Unione europea e ammettendo di condurre una battaglia sul piano finanziario, i politici non se la sentono di seguire l’esempio dell’Islanda che, come vedremo in questo libro, ha rimesso decisioni importanti al volere popolare attraverso due referendum e ha voltato le spalle al capitalismo occidentale. Se neppure il governo spagnolo, il più progressista d’Europa, quello che ha maggiormente sfidato con le sue politiche – prima fra tutte il ritiro delle truppe dall’Iraq ai tempi di Bush – una visione conservatrice, è in grado di costruire un dialogo con la società civile in rivolta, allora è difficile sperare che qualcun altro ci riuscirà. Men che meno quello italiano. In assenza di un punto di contatto concreto la «primavera araba» sarà con molta probabilità il preludio dell’autunno caldo europeo, e di un lungo inverno di crisi e crolli economici. Solo allora la voce della strada, quella che si è alzata dalle piazze spagnole e che da lì è arrivata fino in Israele e, ahimè, ha infuocato la Gran Bretagna, farà breccia nei parlamenti europei e piazza pulita di tutti i farabutti che vi hanno fatto parte. E non sarà tardi per dare inizio al futuro! Il contagio Prologo Un virus micidiale aleggia sul Mediterraneo. Dal Nordafrica viaggia verso l’Europa, apparentemente inarrestabile. A maggior rischio è la parte più giovane della società civile, ma anche i meno giovani possono infettarsi. È la peste democratica. La pandemia rivoluzionaria minaccia persino l’America, il cuore dell’Impero occidentale globalizzato. È lo spauracchio di tutti, ma proprio tutti i politici del mondo: il contagio. Per questo virus infatti non esistono anticorpi né antibiotici, è un’infezione atipica, nuova, frutto della confluenza di due epidemie: la crisi del debito sovrano e quella di istituzioni politiche ormai fuori tempo e fuori uso. La prima fiacca la ricchezza, ovvero il sistema immunitario dei Paesi, la seconda ne attacca gli organi di governo. Se non contrastato, il contagio potrebbe distruggere a Nord gli agonizzanti sistemi democratici europei con la stessa forza e determinazione con la quale a Sud fa strage delle dittature arabe. La domanda è: sarebbe un male? 1 L’epidemia democratica I primi germi del contagio sono vecchi di dieci anni esatti. L’epidemia inizia infatti dalla bancarotta dell’Argentina nel 2001. Le conseguenze politiche di quel crack si allargano a macchia d’olio nell’America Latina, dando vita a governi nuovi, che entrano in rotta di collisione con le élite dell’Impero occidentale, considerate responsabili per l’apocalisse economica di più di una nazione. Nasce così un movimento politico che difende i diritti del popolo contro le oligarchie del denaro locali e occidentali, con capofila come il brasiliano Lula e il boliviano Evo Morales. Sulle ali della finanziarizzazione dell’economia, negli anni Duemila, il contagio attraversa l’Atlantico. Lo rinfocolano crisi periodiche, come l’impennata dei prezzi delle derrate alimentari del 2007 e 2011, e politiche discriminatorie quali la criminalizzazione dell’emigrazione. Alla fine del 2010 l’epidemia approda nel Mediterraneo, e infetta tutte le nazioni che vi si affacciano. Ci siamo accorti che il malcontento giovanile è il primo sintomo del contagio nella primavera del 2011, assistendo alle manifestazioni di piazza prima nelle città del Nordafrica e del Medioriente, poi in quelle europee. Ma i giovani, che protestano contro la disoccupazione e la mancanza di prospettive, sono solo la cassa di risonanza della società civile impoverita e umiliata da governi fraudolenti e ipocriti, esclusa dalla gestione dello Stato. E questo è vero a sud come a nord del Mare Nostrum. Così in Grecia, Portogallo, Spagna, Francia, Italia scendono in piazza accanto ai figli anche padri, madri e nonni. Il popolo, insomma. «Rivogliamo la nostra dignità» urla la folla araba; «Indignatevi» scandisce quella europea. «Giustizia sociale per tutti» gridano i giovani in Israele. Per tutti, la disoccupazione e il carovita sono solo la punta dell’iceberg. Persino la crisi dell’euro, per quanto importante, fa solo da cornice alla protesta che investe ciò che effettivamente strangola l’economia: il malgoverno. È ormai evidente che Stati solo in apparenza democratici presentano in realtà tutti i sintomi di un Impero in rapido disfacimento, dove le oligarchie del denaro e del potere politico si accaniscono per difendere i propri privilegi e somigliano più a baroni medioevali che a governanti democratici. Il malgoverno, endemico in tutto il bacino mediterraneo, ha trasformato questa distesa d’acqua da barriera anti-contagio in portatore del virus, oltre che in un cimitero marino per i disperati che dal Nordafrica la attraversano alla volta dell’Europa. Così se in Egitto, Libia, Siria, Tunisia, Yemen e Bahrain ci si solleva contro i dittatori un tempo «amici dell’Occidente», in Europa si protesta contro le democrazie oligarchiche. E lo si fa in tutti i modi possibili: in Italia le elezioni amministrative e i referendum di maggio e giugno 2011 diventano un plebiscito popolare contro Berlusconi, la sua dissennata gestione del Paese e la classe dirigente che lo guida, mentre in Spagna gli Indignados cancellano dal loro vocabolario la parola «politica», ormai intrisa di negatività, e rifiutano di andare alle urne. Nelle piazze la protesta prende forma e voce: in Grecia la folla mette in scena manifestazioni di disgusto davanti al Parlamento che vota l’austerità e poi si scontra con le forze dell’ordine; in Portogallo si scandiscono slogan contro le responsabilità della classe al potere nella rovina economica del Paese; a Parigi in Place de la Bastille si manifesta contro il «regime» di Sarkozy. E finalmente a fine luglio inizia la marcia degli Indignati verso Bruxelles. Poi ad agosto avvengono i saccheggi in Inghilterra e il mondo osserva sbigottito le strade della città che tra meno di un anno ospiterà i giochi olimpici bruciare come delle torce. Sono prove di rivoluzione di una società civile globale che comincia a prendere coscienza della realtà politica e che, con qualsiasi strumento a portata di mano, vuole riprendersi lo Stato. Dopo la società postindustriale siamo dunque alle porte di quella postimperiale e il bacino del Mediterraneo è in procinto di infilare la chiave nella toppa della nuova era. Ma mentre nel Nordafrica si chiede l’avvento della democrazia per sostituire i regimi dittatoriali che hanno governato le province dell’Impero, con il beneplacito dell’Occidente, in Europa si chiede un rinnovamento delle istituzioni democratiche, diventate strumenti di potere nelle mani di una nuova oligarchia. Obiettivi diversi ma motivazioni identiche, dunque. Se però il Mediterraneo ci racconta una storia che già conosciamo, molto simile a quella scritta dieci anni fa dal popolo argentino in bancarotta e dai suoi vicini sudamericani, il racconto della ribellione degli esclusi, i moderni schiavi, i servi della gleba della globalizzazione; la contestazione europea è infinitamente più grave e le conseguenze possono essere assai più pericolose delle rivolte tunisine, di quelle egiziane e perfino della caduta del regime di Gheddafi in Libia o di Assad in Siria e, naturalmente, della bancarotta argentina. Sotto processo nelle piazze d’Europa non c’è una dittatura brutale ma la tanto amata democrazia, che a guardarla bene è oramai una maschera in brandelli. Per questo si farà di tutto per evitare il contagio. Per ora, siamo solo agli inizi. La mobilitazione non mira a sbarazzarsi di un sistema di governo che rimane pur sempre, per dirla con Churchill, «il peggiore possibile, a parte tutti gli altri», ma a cacciare chi lo ha gestito fino a ora. E non è un caso se i nuovi metodi di contestazione ci riportano alle origini, all’interazione del cittadino con tutti gli altri. Gli studenti che a Roma occupano Piazzale Aldo Moro parlano della vecchia agorà, da dove tutto ha avuto inizio. In Plaza de Cataluña, a Barcellona, si usa l’assemblea permanente per «fare Stato», perché quello esistente non funziona più. È chiaro: il modello non può essere quello della democrazia partecipativa diretta, siamo troppi. Ma al momento questo è l’unico strumento che la società civile conosce e che ha a disposizione per scavalcare la classe politica senza imbracciare il fucile, e per ricordare al mondo che lo Stato e il popolo non sono due entità separate. In Israele la risposta del governo è la seguente: aprire un dialogo attraverso una commissione in cui accanto ai rappresentanti di tutti i partiti e dei poteri forti dello Stato ci siano i giovani Indignati. Negli ultimi vent’anni, senza che ce ne accorgessimo, le élite della globalizzazione hanno sequestrato la democrazia che oggi, ahimè, rappresenta loro e non noi. È giunta l’ora di riprendersi ciò che è nostro, grida la folla nelle piazze europee. E da Paese a Paese le richieste sono sempre le stesse: abolizione della finanziarizzazione dell’economia; cambio totale delle classe dirigente; abolizione dei privilegi della casta politica; accountability, trasparenza delle azioni, ovvero chi ha rubato, chi ha corrotto deve finire sotto processo; incompatibilità di tutte le cariche pubbliche con condanne giudiziarie e così via. Soprattutto: abbandono del modello neoliberista che ha facilitato il colpo di Stato e rientro degli esclusi nella politica. Richieste sempre presentate pacificamente. Utopistico? Se qualcuno nell’autunno del 2010 ci avesse detto che le capitali arabe sarebbero insorte contro i propri regimi e che lo avrebbero fatto in modo pacifico, cosa avremmo replicato? L’ennesima atipicità di questa epidemia è infatti la non violenza. Come vedremo più avanti, in Europa l’unica eccezione è l’Inghilterra dove la politica di austerità di David Cameron ha esacerbato le tensioni razziali miste a grandi diseguaglianze sociali che da almeno vent’anni caratterizzano questo Paese. Ma anche qui le immagini di distruzione hanno mobilitato la società civile che è uscita in strada con scopa e paletta per ripulire i propri quartieri. La narrativa è dunque la stessa: riprendiamoci i nostri spazi di vita societaria. Abbiamo assistito allibiti ai saccheggi nelle città inglesi, alle cariche della polizia, delle forze antisommossa, delle milizie private arabe contro folle che al contrario cercavano il dialogo con chi si scagliava contro di loro. Ma non siamo più in Ungheria nel 1956, non siamo a Praga nel 1968, neppure a Piazza Tiananmen nel 1989 dove si poteva pensare di cancellare la memoria storica con un colpo di spugna. Ci troviamo invece nel villaggio globale dove, grazie alla tecnologia, tutti sanno tutto di tutti. I social media ci hanno anche permesso di seguire in tempo reale gli scontri in Siria e l’avanzata dei ribelli libici fino a Tripoli, conquistata nella notte del 21 agosto 2011. La rivoluzione, infatti, viaggia sulle ali del web e in particolare dei social network. In pochi mesi sono nati migliaia di blog e di siti da cui poter seguire in tempo reale le proteste dei singoli e le manifestazioni di piazza. Su Twitter, un tamtam virtuale potentissimo, le notizie rimbalzano da un angolo all’altro del Mediterraneo. Una ragnatela di telecomunicazioni unisce i greci ai siriani, gli egiziani ai portoghesi, gli italiani ai libici. Nell’ambiente virtuale, come in un brodo di coltura batterico, l’infezione cresce e il contagio dilaga. Tutto ciò avviene sullo sfondo del tracollo finanziario ed economico del capitalismo occidentale. Gli Stati Uniti perdono la AAA, i mercati crollano, il franco svizzero e l’oro diventano i beni rifugio più gettonati, l’Italia è costretta a una manovra fiscale di Ferragosto che taglia altri 45 miliardi dal bilancio, la Francia è sotto attacco e rischia di essere declassata come l’America. Ma è la crisi dell’euro, la cui violenza non è fisica, ma economica e psicologica a diffondere il contagio. La disintegrazione della moneta unica terrorizza gli europei, che temono un peggioramento della recessione e la fine del sogno d’integrazione di un continente la cui storia è scritta nel sangue sparso dai cittadini. Particolarmente impaurito è chi vive sulle sponde del Mediterraneo perché vede nell’euro il jolly dello sviluppo economico e della modernizzazione, una formula magica che gli permetterà di raggiungere i livelli di prosperità del Nord Europa. Peccato si tratti solo di un mito che alla fine degli anni Novanta i politici hanno venduto a questi Paesi per motivarli ad accettare gli immensi sacrifici necessari per entrare nella moneta unica. L’ingresso nell’euro ha ingrassato le élite. Se oggi questo mito sta crollando, e se non c’è bisogno di usare la violenza, è perché il web ci ha regalato gli strumenti per aggirare propaganda politica e repressione. I social network stanno smascherando tutte le menzogne e i filmati che internet trasmette in tempo reale sono una potentissima arma di opinione. La rivoluzione è quasi sempre pacifica perché, per la prima volta nella storia, le immagini sono più efficaci delle armi convenzionali. I politici lo sanno bene, e anche per questo temono il contagio. Morta e sepolta è inoltre l’ideologia, finita nella discarica della storia insieme alla Guerra Fredda e agli accordi di Bretton Woods. I vecchi schemi e le vecchie parole d’ordine non interessano più a nessuno. Polarizzazione è diventato un termine obsoleto. Bin Laden e Bush, comunismo e capitalismo, sono dicotomie che appartengono ai libri di storia, a un mondo ormai andato in frantumi. Anche il Fondo monetario si è dovuto adattare; per la prima volta si dice disposto a prestare denaro all’Egitto senza anacronistiche condizioni fiscali. Solo che gli egiziani ringraziano e dicono che per ora preferiscono fare da soli. E se gli Indignati avranno la meglio, l’équipe di medici che deve salvare l’Europa dall’infezione del debito asporterà chirurgicamente anche il Fmi. Per ora però non è così, anzi, alla fine di luglio 2011, i leader europei che approvano il pacchetto di salvataggio della Grecia ci regalano una nuova istituzione: il Fondo monetario europeo, prima noto come l’European Financial Stability Facility. Un comitato d’emergenza per i Paesi deficitari, che con un abracadabra politico diventa l’ennesimo organo comunitario. Non dimentichiamo che sotto accusa nelle piazze europee c’è anche il mercato capriccioso, prepotente e arrogante, che fino a poco tempo fa faceva il bello e il cattivo tempo lungo tutto il bacino del Mediterraneo e ben oltre. Costretto ad assorbire una parte delle perdite greche, a fine luglio si lecca le ferite; ad agosto precipita nel panico, svende di tutto di più dal debito sovrano ai titoli azionari delle grosse imprese e si prepara per la prossima offensiva che arriverà in autunno. Ma la società civile sta soffiando con forza sopra tutti i castelli di carta su cui poggia il potere delle oligarchie, e starà all’erta. Non è un caso che persino vecchi cavalli di battaglia dei nostri politici, come il nazionalismo e il razzismo, siano ormai azzoppati. In Italia, dopo una campagna elettorale basata quasi esclusivamente sulla paura, alle elezioni amministrative del 2011 la Lega Nord di Umberto Bossi ha perso punti percentuali in tutta la Pianura Padana, e circa dieci in Veneto; persino il comune di Milano, roccaforte della destra, è stato espugnato dall’avvocato Giuliano Pisapia. Una vittoria risultato soprattutto di un voto di protesta contro la cattiva gestione precedente, una vittoria possibile grazie a preferenze provenienti da destra quanto da sinistra. Un voto, dunque, trasversale, perché oggi nel bacino del Mediterraneo tutto lo è, anche e soprattutto i destini dei giovani. Quel flusso di clandestini che da anni si riversa sulle coste nord del Mediterraneo, ma che ormai si è trasformato in uno tsunami umano, non è un esercito nemico come cercano di farci credere i governi, ma una fetta della società civile alla quale anche noi apparteniamo. Insieme alle nostre famiglie i migranti sono vittime di sistemi politici ed economici ingiusti e agonizzanti. Scappano da regimi brutali, da economie asfittiche, anche dagli effetti dei cambiamenti climatici e dai disastri naturali causati dall’eccessivo sfruttamento delle risorse. L’Europa che sognano è quella che vedono sui televisori di casa, un continente-reality, un mondo finto dove regna la democrazia. Nessuno immagina che una volta raggiunte le nostre coste possa attenderli un calvario peggiore di quello che, rischiando a ogni passo la vita, si sono lasciati alle spalle. Eppure è proprio così. Le democrazie europee non sono in grado di accoglierli, vogliono scacciarli o sfruttarli. Il motivo? Non possono più garantire il benessere neppure ai loro cittadini. Infatti anche i coetanei europei migrano. Fuggono dal precariato e dall’eterna sovvenzione familiare, da una società bloccata in caste e incapace di progresso, scappano dalla corruzione e dal cinismo di chi regge i loro destini. Dai cervelli in fuga fino ai semplici diplomati, negli ultimi vent’anni sono emigrati nove milioni di italiani. E poi ci sono i milioni di greci, spagnoli, portoghesi, tutti alla ricerca di un’esistenza decorosa che non riescono ad avere in patria. Tutte le nuove generazioni mediterranee condividono un destino privo di speranze, da esclusi. Dato che il sistema di produzione occidentale non può assorbirli nello stesso modo e con le stesse garanzie che ha offerto ai genitori, i giovani esistono nel mercato esclusivamente come consumatori o come manodopera da sfruttare, e cioè come precari. Un destino agghiacciante, dove la famiglia ricopre un ruolo assistenziale, fa da ammortizzatore sociale di una categoria a cui lo Stato non offre nessuna protezione e sicurezza. Dall’affitto al meccanico, dall’asilo nido per i figli fino al dentista, la famiglia integra compensi letteralmente da fame. Il giorno in cui finiranno i nostri risparmi, quando noi genitori europei non ci saremo più e scompariranno stipendi e pensioni, che differenza ci sarà tra gli emigrati africani e i nostri figli? In comune questi ragazzi hanno anche la lingua, quella veloce delle nuove comunicazioni, il Web 2.0, un idioma incomprensibile ai politici. Condividono uno spazio sociale immenso, sono nati e cresciuti nel villaggio globale virtuale. Linguaggio e territorio, gli elementi chiave del vecchio nazionalismo che fino a dieci anni fa macchiava di sangue il continente, oggi sono diventati anch’essi trasversali. Ed ecco perché i localismi che ancora appaiono strumentalizzati nei discorsi dei governanti ci sembrano comizi in una lingua morta. Sono connazionali i giovani che dormono a Puerta del Sol a Madrid, quelli che hanno fatto la rivoluzione al Cairo, quelli che sfidano le pallottole del regime a Damasco e che manifestano a Piazzale Aldo Moro e al Partenone. Nella società postimperiale del Mediterraneo il pericolo del contagio è alto perché il Dna sociale delle sue popolazioni è simile. Prepariamoci quindi per la più grande epidemia moderna che, come la peste di Londra, si fermerà solo quando il fuoco avrà ingoiato tutta la città per far posto a una nuova, più pulita, più vivibile. Così dalle ceneri della vecchia democrazia potrebbe nascerne una migliore, quella del futuro. 2 La rivolta contro la democrazia A metà febbraio 2011 l’«Economist» esce con una copertina celebrativa della rivoluzione araba: un pugno chiuso tratto da un’immagine raffigurante la folla in piazza, con la scritta The awakening, rinascita. Nonostante prenda tutti in contropiede, la sollevazione popolare araba attira l’attenzione dei media tradizionali occidentali. Perché allora, appena pochi mesi dopo, la rivolta dei giovani europei comparirà solo saltuariamente su teleschermi e giornali? Eppure prende forma proprio nel cortile di casa nostra. Possibile che i media considerino il fenomeno degli Indignados spagnoli, i primi contagiati dalla pandemia rivoluzionaria, e dei loro fratelli negli altri Paesi che per comodità chiameremo «Indignati», soltanto un episodio folkloristico e non politico, un evento che non ha futuro né la forza di alterare lo status quo? L’idea che a nord del Mediterraneo scoppi una rivoluzione simile a quella che si è scatenata a sud, che gli italiani scaccino Berlusconi da Palazzo Chigi come gli egiziani hanno fatto con Mubarak, sembra a tutti assurda. Così pure nessuno crede che gli Indignados possano costringere Zapatero a rifiutare le condizioni imposte dal Fondo monetario per risanare le finanze del Paese; o che Papandreou dichiari che le future generazioni greche non pagheranno i debiti contratti con le banche internazionali nonostante i ripetuti tentativi di salvataggio europeo; o che il Portogallo decida di abbandonare l’euro. Eppure è questo che all’inizio dell’estate 2011 chiede la folla che si accalca nelle piazze. Ancora più incredibile è la prospettiva che il contagio economico spinga i mercati a voltare le spalle anche alla Spagna e all’Italia, rispettivamente la quarta e terza economia europea, giudicate entrambe «troppo grandi» per essere salvate. Eppure a metà luglio sono entrambe vittime di un primo attacco speculativo. L’idea che queste nazioni vadano in bancarotta distruggendo l’euro è simile a un tabù ancestrale ed ecco spiegato il motivo per cui nessuno si azzarda a formulare un piano B, d’emergenza, da applicare nell’eventualità di un default per ridurne l’impatto negativo che questo avrebbe sulla popolazione. Queste cose in Europa non succedono, ci viene ripetuto, siamo vaccinati contro le rivoluzioni perché viviamo in democrazia, siamo anche vaccinati contro l’apocalisse finanziaria subita dall’Argentina e dall’Islanda perché facciamo parte dell’Unione europea e abbiamo l’euro. Ma è proprio così? Chi per informarsi usa anche il web non crede a queste rassicurazioni perché ha accesso a una realtà completamente diversa. Assemblee permanenti in piazza e nei quartieri, comitati e gruppi di pressione e di studio improvvisati nei giardini comunali, teleconferenze tra una piazza e l’altra, scambi di video su Twitter, manifestazioni popolari. Che significa? Che non solo la contestazione viaggia sulle ali del Web 2.0, ma dà anche prova di sapersi strutturare fuori dallo spazio cibernetico per controbattere, passo dopo passo, alle politiche e strategie proposte dai vari governi e dalle istituzioni internazionali. Non mancano, infatti, le politiche «alternative» e le critiche costruttive. All’inizio di giugno, ad esempio, il tamtam di Twitter denuncia il Patto dell’euro. E lo fa poco dopo l’annuncio ufficiale della riunione dei ministri dell’Economia che lo devono approvare a fine giugno. Quest’accordo, si legge nei comunicati che circolano vorticosamente nei dibattiti online, delega al Fondo monetario, alla Banca centrale europea e alla Banca mondiale la gestione delle finanze dei Paesi deficitari, in altre parole mette in mano loro il destino di intere nazioni. Ecco l’ennesima manovra per salvaguardare gli interessi dei giganti finanziari a discapito della popolazione. Il movimento degli Indignati propone un’alternativa concreta alle politiche proposte dall’Ue, ovvero far pagare il debito a chi si è arricchito grazie alle bolle finanziarie e all’illusione del benessere. Che le banche tedesche e francesi si accollino la responsabilità di aver prestato soldi a Paesi che non potevano ripagarli, che si introduca una tassa patrimoniale da abbattere come una scure sui beni dei ricchi, sul reddito da capitale e sulle transazioni finanziarie. Ecco cosa si legge nel manifesto degli Indignati. Ottimi suggerimenti che però i politici non prendono nemmeno in considerazione. In Italia, ad esempio, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti vara l’ennesima manovra per azzerare il deficit di bilancio entro il 2014 e si guarda bene dal colpire quel 10 per cento della popolazione italiana che detiene il 45 per cento del patrimonio nazionale. Come nel Medioevo a pagare non è l’élite al potere ma il popolo, anche se ormai non gli è rimasto molto in tasca. Egualmente Papandreou non prova neppure a recuperare i miliardi degli evasori, i ricchi armatori che hanno uffici in tutto il mondo. A metà luglio, quando non si è ancora raggiunto un accordo sul debito greco, dopo che Moody’s ha dichiarato quello del Portogallo junk, spazzatura, i mercati sembrano dare ragione agli Indignati e prendono di mira l’Italia. Il piano di Tremonti che vuole calmarli è solo un palliativo, non funzionerà come non ha funzionato il Patto dell’euro, morto a meno di un mese dalla nascita. A che serve una manovra da 80 miliardi di euro che non intaccherà minimamente il debito pubblico, pari al 120 per cento del Pil, cioè 1800 miliardi di euro, più del debito complessivo di tutti i Paesi Pigs, e cioè Portogallo, Irlanda, Grecia, e Spagna? Questa la domanda che nelle dealing room del mondo la gente si pone quando ad agosto riparte l’attacco dei mercati contro l’Italia. Perché sorprenderci? Già a metà luglio il tasso d’interesse al quale i mercati erano disposti ad acquistare le obbligazioni del Tesoro italiano era aumentato di un punto percentuale facendo lievitare il debito pubblico di 35 miliardi. E voilà, metà dei soldi prodotti dalla manovra di Tremonti sono svaniti nel debito futuro. Non è forse giunta l’ora di prendere in considerazione i consigli della piazza? Tanto per cominciare, tagliando le pensioni e gli stipendi dei parlamentari, come ha già fatto la Gran Bretagna? Anche se questi tagli non risolvono i problemi del debito sovrano almeno servirebbero a riallacciare una parvenza di patto di solidarietà tra governati e governanti. E dato che i mercati sono scettici verso un’Italia completamente disamorata del suo governo, sarebbe un grosso passo avanti. L’austerità deve iniziare dai politici, che siano d’esempio a chi li ha eletti e li paga. Come si sperperano i nostri soldi Guarda caso è proprio in Italia, il Paese con il terzo debito pubblico più alto al mondo, che ci imbattiamo negli stipendi e nelle pensioni dei politici più alti d’Europa. Uno studio del «Wall Street Journal» mostra che un parlamentare italiano nel 2010 guadagnava 11.704 euro al mese contro i 7957 dei colleghi del Parlamento europeo, 7668 dei tedeschi, 7100 dei francesi e 6350 degli inglesi. Il doppio del suo collega inglese e più dei colleghi americani. Nel mondo occidentale, i nostri politici sono anche quelli che ricevono maggiori benefici aggiuntivi tra i quali la residenza romana, aerei e treni e parrucchiere gratis, tutto a spese del contribuente. Alla fine del mese, inclusi gli extra quali ad esempio il costo dei portaborse, intascano altri 8783 euro, che porta il totale a quasi 20.000 euro al mese. Un precario non li guadagna in un anno. Dato che la gestione degli extra è a totale discrezione del parlamentare, non esiste alcun controllo per verificare se sono spesi nell’interesse della collettività. Una proposta da parte della deputata radicale Rita Bernardini per rendere obbligatori i rendiconti ha trovato solo 80 deputati a favore. Né la maggioranza né l’opposizione, dai capigruppo ai leader, vi hanno aderito. I parlamentari hanno anche accesso a un sistema sanitario «deluxe» rispetto a chi li vota, che va dalle cure dentistiche ai massaggi shiatsu e alle terme, mentre uno dei provvedimenti d’immediata attuazione della manovra Tremonti inserisce, per noi comuni cittadini, il ticket di 10 euro per le visite specialistiche nella sanità pubblica. Nel 2010 la spesa per gli extra dei deputati è stata di 10,1 milioni di euro. E poi ci sono i pasti a Montecitorio sovvenzionati dal contribuente per un costo di 5,5 milioni di euro, e la tessera di un country club in riva al Tevere. Dulcis in fundo, gli uffici fuori Montecitorio, sempre a spese nostre, nel 2010 ci sono costati 45 milioni di euro. Anche quando non è più in servizio, pagare un politico italiano costa più che mantenere una Ferrari. Si ha diritto alla pensione dopo appena cinque anni di mandato con un assegno mensile «base» di 2486 euro, l’importo varia da un minimo del 20 per cento a un massimo del 60 per cento dell’indennità parlamentare, a seconda degli anni in carica. Il collega tedesco ne percepisce 961, e quello francese appena 780. E così, tra parlamentari attivi e in pensione, nel 2010 il costo complessivo della Camera dei deputati italiana è stato di un miliardo di euro mentre quello del Senato di 600 milioni. Da uno studio di Tito Boeri, pubblicato sul «Wall Street Journal» a luglio 2011, risulta che dal 1948 a oggi i salari dei nostri deputati sono cresciuti in media ogni anno del 9,8 per cento contro il 3 per cento di quelli degli operai. Il triplo. E c’è la crisi! Non a Montecitorio. La società civile è stanca e provata da una recessione che non accenna a finire ma soprattutto è stufa di una classe politica inetta che la deruba da decenni. Perfino nella stoica Gran Bretagna, lontana mille miglia dal Mediterraneo, il popolo è sceso in piazza per dire basta. In primavera i giovani per protestare contro l’aumento delle tasse universitarie; a fine giugno è stata la volta dello sciopero generale degli statali contro l’aumento dell’età pensionabile e la riduzione delle pensioni. Si è trattato del primo grande sciopero in venticinque anni, vi hanno aderito tutti i sindacati e la stragrande maggioranza dei lavoratori. Poi ad agosto è scoppiata la rivolta nelle strade. È ormai chiaro che la responsabilità del disastro economico che si è abbattuto sul Vecchio Continente non è circoscritta alle banche e alle società finanziarie. Il malgoverno ha permesso abusi e lasciati impuniti reati come l’evasione fiscale, che hanno contribuito all’impoverimento dello Stato. Quasi 300 miliardi di euro il valore totale dell’evasione e dell’economia sommersa in Italia, queste le stime ufficiali per il 2010 ma le cifre reali sono ben più elevate. Basterebbe tassare pesantemente questa ricchezza per azzerare il deficit di bilancio e portare simultaneamente il debito pubblico sotto il tetto del 100 per cento del Pil. Ma non succede. Perché? L’Italia, con una delle più alte percentuali di evasori al mondo, ben illustra le difficoltà e le contraddizioni delle politiche fiscali europee: Tremonti vara lo scudo fiscale e «perdona» il reato di evasione ma poi lascia che la maggior parte dei fondi «ripuliti» rimanga all’estero, non condiziona lo scudo al rimpatrio a lungo termine. Così, con pochi, semplici clic, i soldi degli evasori sono entrati sporchi e subito dopo sono usciti puliti. Solo una piccolissima percentuale dei beni cosiddetti «scudati» è rimasta in patria. Allora a cosa è servita quest’operazione? Se lo domandano in molti in Europa e nel resto del mondo. Nel frattempo, per mascherare questo gigantesco fiasco a favore dei truffatori, in Italia si aumentano le aliquote su chi paga le tasse, ormai le più alte in Europa. Al netto dell’evasione fiscale, e quindi sul gettito complessivo delle entrate del fisco, la pressione fiscale in Italia è del 53 per cento. È giusto tutto questo? Gli Indignati italiani e i cugini mediterranei hanno già una risposta sicura. Se i Piigs fossero imprese e i loro parlamenti un consiglio di amministrazione, i soci li avrebbero già buttati fuori tutti. E invece, come in un perverso gioco della sedia, al governo si alternano le stesse facce e si perseguono le stesse politiche. Prendiamo, ad esempio, la spesa per la difesa. Da anni la super deficitaria Grecia spende più del 2,5 per cento del Pil per armarsi contro nemici immaginari. Perché nessuno ha pensato a ridurre questa voce di bilancio? Un discorso a parte va poi fatto per le fondazioni. Perché si moltiplicano, a nome di politici più o meno in carica, istituzioni che non risolvono certamente i mali economici del continente? Negli ultimi anni abbiamo assistito al proliferare di think tank, termine altisonante sotto cui si nascondono le solite lobby delle oligarchie del denaro, spesso finanziate dalle grandi multinazionali come la Monsanto americana. Da dove arrivano però i soldi per gestirle? Dallo Stato, naturalmente; uno Stato che non è affatto meno presente nell’economia rispetto al passato, ai tempi del Welfare State. Piuttosto la sua partecipazione ha scopi diversi. Oggi i nostri soldi vengono letteralmente sperperati attraverso un complesso sistema di appalti che distribuisce il denaro pubblico a società di comodo gestite da amici, familiari e compari delle élite politiche. In Italia e in Spagna la lista degli scandali immobiliari di questo tipo è lunghissima e ci vorrebbe un’enciclopedia per elencarla tutta. Il movimento israeliano 14 Luglio denuncia la medesima speculazione e lo fa dando vita a una serie di tendopoli nelle piazze di Tel Aviv. Il suo slogan è «Case accessibili a tutti». Lo Stato ormai appalta anche le mansioni degli impiegati ministeriali, altra categoria di lavoratori garantiti dove abbondano gli sfaccendati. E questa pratica è diffusa non solo in Italia e in Spagna, ma anche in Grecia e Portogallo. Ce lo spiega Elena, una precaria italiana. «Sono laureata a pieni voti e ho un master in Comunicazione. Lavoro da quattro anni per il ministero dell’Agricoltura, mi occupo di relazioni esterne e promozione dell’immagine, però non sono una ministeriale ma una precaria. Sono impiegata a tempo determinato da una cooperativa alla quale il ministero subappalta una serie di lavori che i ministeriali ormai non svolgono più. Si tratta naturalmente di un escamotage per servirsi dei precari e deviare una parte della spesa pubblica verso aziende private che sono “vicine” alla classe politica. «Se avessi un contratto a tempo determinato con il ministero dopo un certo periodo di tempo scatterebbe automaticamente l’assunzione a tempo indeterminato, lo dice la legge. Appaltando i lavori a imprese esterne si aggira la norma. I miei contratti cambiano spesso proprio per questo motivo, sebbene da quattro anni faccia lo stesso lavoro nel medesimo ufficio, già sono stata assunta da due società diverse e ho firmato quattro contratti di lavoro distinti, anche per la durata di solo sei mesi, i cosiddetti contratti co.co.pro.» E come si sperperano i soldi dell’Unione europea Ma siamo proprio sicuri che tutti questi appalti ministeriali facciano risparmiare soldi allo Stato, come ci viene detto? Nulla di più falso! L’analisi dell’avanzo primario, la differenza tra entrate e spese dello Stato al netto dell’interesse sul debito, ce lo conferma. Da quando il precariato «statale» è stato ufficialmente introdotto, e cioè da una decina d’anni, non si è verificato un aumento considerevole dell’avanzo, anzi dalla fine del 2008 fino al primo trimestre del 2011, quando sono arrivati i primi tagli, le spese hanno superato le entrate. In più, durante questo periodo, l’economia italiana non è cresciuta. Dove sono finiti i soldi spesi? Nelle tasche delle élite, dalle società immobiliari a quelle degli appalti pubblici, i parassiti della democrazia. In Grecia, altra nazione dove il precariato è stato istituzionalizzato da almeno un decennio, la situazione è persino peggiore. Il settore pubblico è il primo datore di lavoro del Paese e da più di un anno non ha i soldi per continuare a esserlo. L’avanzo primario greco è infatti un grosso disavanzo, ciò significa che le entrate non coprono le spese anche al netto del pagamento degli interessi sul debito. Soluzione: il Paese s’indebita con le banche, finché, naturalmente, i mercati decidono di chiudere la Borsa, come è successo nel 2010. A quel punto, come sappiamo, è dovuta intervenire Bruxelles. Prima con un prestito di 110 miliardi di euro e poi con un secondo a fine luglio del 2011, ribattezzato il Piano Marshall europeo, pari a 109 miliardi di euro al quale vanno aggiunti altri 50 miliardi in debiti posticipati da parte del settore privato. Secondo Bruxelles questo dovrebbe bastare a far riprendere economicamente una nazione a crescita negativa da almeno cinque anni, una nazione il cui gettito fiscale non è sufficiente a coprire tutta la spesa pubblica e che ha un debito pari al 142 per cento del Pil. E perché no? Nel secolo di Harry Potter tutto è possibile! Per salvare la Grecia, ci viene poi detto, si è prodotto un incantesimo che non verrà più ripetuto. Che significa? Che se domani il Portogallo o l’Irlanda si troveranno nella stessa situazione verranno lasciati affondare? Difficile crederlo. La manovra di salvataggio, infatti, vuole solo rassicurare i mercati ed evitare il contagio, quindi se questo si ripresenterà in Portogallo o in Irlanda, e se si vuole mantenere l’euro, dovremo salvare in extremis anche queste nazioni. Ma è poi vero che di salvataggio si tratta? Tutti i Paesi dell’Europa mediterranea sono deficitari non solo perché hanno sperperato i soldi degli altri, ma soprattutto perché le loro economie non crescono. E ahimè, questo in parte è dovuto anche all’euro, la moneta che condividono con l’efficientissima Germania. Ma di questo parleremo più avanti, perché prima bisogna analizzare le componenti del Piano Marshall europeo per dimostrare che serve solo a rincuorare il mercato obbligazionario e non a rimettere in moto l’economia greca. Non salva proprio nessuno. Dei 109 miliardi stanziati, la Grecia ne riceverà solo 34. Gli altri 75 serviranno a convincere chi ha in portafoglio il debito greco, e cioè le banche, a rinegoziarlo volontariamente. Quindi questi soldi finiranno nei loro forzieri, non in quelli della Banca centrale greca. A fine agosto poi si scopre che la Grecia ha offerto una garanzia monetaria alla Finlandia per ottenere la sua approvazione al piano di salvataggio di luglio. A quel punto altri Paesi membri dell’Ue pretendono la medesima garanzia per prestare la loro quota alla Grecia e si rischia lo stallo. Venti miliardi saranno usati per riacquistare obbligazioni greche sul mercato, così da ridurre il debito totale pari a 350 miliardi. Altri 35 miliardi serviranno a garanzia della dilazione del pagamento di titoli pari a 54 miliardi. Che significa? Che per convincere il settore privato a emetterne nuovi in sostituzione delle vecchie bisogna offrirgli qualcosa, una garanzia solida che trasformi i titoli spazzatura in obbligazioni AAA, di prima qualità. I 35 miliardi verranno depositati come beni collaterali per le banche. Se la Grecia va in default e non paga, fungeranno da compensazione per i creditori. Infine i rimanenti 20 miliardi serviranno per riparare i danni prodotti dai mancati pagamenti alle banche. Ci troviamo di fronte all’ennesimo escamotage dei maghi dell’economia dell’abracadabra per acquietare gli animi dei bond dealers! Funzionerà? Probabilmente per la durata delle vacanze estive. E vediamo perché. Nell’economia dell’illusione e sullo sfondo dell’immobilismo europeo anche le cattive notizie, purché dette in coro dai leader dell’Unione, fanno salire gli indici di Borsa. Perché la notizia è cattiva e anzi pessima: la manovra riporta il debito greco esattamente dov’era quando la crisi è scoppiata nel 2010. Insomma, siamo sempre lontani dalla soluzione del problema. Figuriamoci da un salvataggio! Dunque cosa cambierà quest’anno rispetto a quello passato quando Atene ha intascato 110 miliardi di euro? Cosa in quegli ulteriori 35 miliardi porterà la Grecia a crescere invece che a decrescere come è successo negli ultimi dodici mesi? E la risposta è nulla, tra qualche mese, al massimo la prossima primavera, la Grecia avrà bisogno del terzo salvataggio. Così come è strutturato, il Piano Marshall europeo, che con quello classico non ha nulla in comune, non salverà l’economia greca dalla bancarotta ma sicuramente riuscirà a convincere il mercato del credito a prestare nel breve periodo altri soldi a questo Paese! L’economia dell’Europa mediterranea non è competitiva e il rapporto tra debito e Pil è insostenibile, questo è il nocciolo della questione. E basta mettere a confronto il tasso di crescita dell’economia dei Paesi dell’Europa mediterranea e il tasso d’interesse al quale questi si indebitano sui mercati dei capitali per capire che i conti non tornano. Se l’anemica crescita italiana è sotto l’un per cento ma i tassi che paga sono superiori al 5, è chiaro che il risultato sarà un aumento delle dimensioni del debito nel tempo. Lo stesso discorso vale per tutti i Paesi Piigs. La soluzione? Certamente non può essere indebitarsi ancora di più, ma neppure strangolare l’economia con una politica di austerità che vuole risolvere il problema soltanto tagliando le spese dello Stato. C’è bisogno di un nuovo modello, bisogna capire quali industrie e quali settori possono essere competitivi e quali invece no. Ridimensionare la nostra vita, tagliare gli sprechi, investire nelle fonti di energia rinnovabile, nell’agricoltura, settori dove Paesi come la Spagna e il Portogallo ad esempio già si stanno muovendo. Bisogna tornare a considerare l’indebitamento come qualcosa di eccezionale. È possibile che tutto ciò richieda un sistema monetario diverso, meno rigido, più flessibile; è probabile che per un Paese come la Grecia usare la stessa moneta della Germania non funzioni più, anche perché in fondo non ha mai funzionato. E lo stesso vale per l’Italia. Perché il costo del lavoro è più alto nell’Europa mediterranea e la produttività minore rispetto alla Germania? Se la comparazione fosse fatta in moneta nazionale invece che in euro i valori sarebbero diversi perché economie deboli come quella greca e quella italiana avrebbero necessariamente monete meno forti di quella tedesca. E questo a prescindere dalla svalutazione. Finché la dipendenza psicologica dal mercato dei capitali non cambia e finché in Europa non si prende atto delle limitazioni della moneta unica, i «salvataggi» sono un modo come un altro di sperperare il denaro degli europei, e cioè il nostro. Da chi arrivano infatti i soldi che Bruxelles stanzia, 220 miliardi alla Grecia, altri 440 per il resto dei Paesi deficitari? Dalle presse della Zecca ma anche dalle nostre tasche, anche da quelle di noi italiani e degli spagnoli dal momento che il contributo è proporzionale al peso che i vari Paesi rivestono nell’economia dell’Unione. Bisogna avere il coraggio di accettare che non è l’euro che produce la crescita economica o il buongoverno, sfatare questi miti che ci sono stati venduti in un momento storico diverso da quello attuale. Con o senza l’euro il Paese prospererà solo se ci sarà una classe dirigente in grado di guidarlo invece che di sfruttarlo. E quindi più che dell’euro abbiamo bisogno di una coscienza nazionale, di una mobilitazione di massa che rinnovi la politica. 3 Le nuove rivoluzioni Sappiamo ben poco dei retroscena politici ed economici che fanno da cornice al nostro mondo. Come per la guerra in Iraq, ci si accorge che anche per le proteste degli Indignati e la crisi dell’euro esistono due interpretazioni e due canali d’informazione: quello ufficiale e quello virtuale. Ma questa volta la «selezione» tendenziosa delle notizie non è opera di giornalisti embedded, sedotti dalla macchina propagandistica governativa, bensì di operatori dell’informazione fortemente increduli rispetto ai pericoli del contagio. Ci si ripete che in Europa le rivoluzioni sono terminate con l’abbattimento del Muro di Berlino e che la moneta unica è solida. Eppure basterebbe un’analisi più approfondita degli eventi avvenuti nel bacino del Mediterraneo durante il 2011 per evidenziare i punti di contatto tra nord e sud, e una rispolverata ai libri di storia ci farebbe scoprire che sulle sue sponde la narrativa e il lessico dei rivoltosi sono, oggi come tre secoli fa, incredibilmente simili, come simile è la frustrazione delle popolazioni riguardo alla gestione dell’economia. Non a caso la rivolta tunisina, da alcuni definita «rivoluzione dei gelsomini», e quella egiziana sono state paragonate alle rivoluzioni europee dell’era moderna. Ma usare la chiave di lettura comparativa sembra riduttivo. Una teoria evolutiva appare più promettente. Forse infatti la mobilitazione della società civile a sud del Mediterraneo rappresenta la cerniera di chiusura del ciclo delle rivoluzioni occidentali moderne, quelle iniziate con la Rivoluzione francese. Come la Rivoluzione francese ha ridisegnato la mappa geopolitica d’Europa, la caduta del regime di Assad in Siria, se mai avverrà, avrà ripercussioni profonde anche nei Paesi limitrofi, forzerà un riassetto del delicato equilibrio geopolitico della regione al centro della quale c’è Israele. Una fetta di mondo che per quarant’anni i Paesi occidentali hanno cercato di riconfigurare a tavolino per poi giocarci sopra una sorta di gigantesco Risiko. Ma i giovani rivoluzionari musulmani non pensano a questo, non hanno una visione da grandangolo dell’assetto politico futuro, non sono motivati da una dottrina politica alternativa a quella dell’Impero occidentale. Ecco l’ennesima similitudine con la Rivoluzione francese: la popolazione si mobilita per esigenze personali. Nel 1789 a Parigi la gente aveva fame. Nel 2011, a Tunisi come al Cairo, la gente non aveva futuro. Le richieste sono semplici, umane e universali; il sogno è la creazione di uno Stato funzionale al popolo, non quello di ridisegnare il mondo. Eppure è quello che succede. Il contagio trasforma il bacino del Mediterraneo in una polveriera sociale perché lo scacchiere politico creato in passato dalle potenze e superpotenze occidentali non esiste più. Il movimento israeliano 14 Luglio si inserisce perfettamente tra quelli di rivolta araba e i loro corrispettivi europei. Questi giovani ci dicono che la società civile non gioca a Risiko ma fa sul serio. Se è così, tutti noi ci troviamo di fronte a una nuova fase della storia dell’uomo, l’inizio di un’epoca. E quando il processo rivoluzionario si sarà concluso è probabile che ci guarderemo alle spalle per accorgerci che il mondo che abbiamo conosciuto non esiste più. Come sarà il futuro? La risposta dipende dal coraggio della collettività: se riuscirà ad asportare il cancro della politica moderna e a riconquistare un controllo stretto sulla gestione della cosa pubblica, il futuro ci apparterrà. Gli scontri e i saccheggi che nell’agosto 2011 hanno sconvolto Londra e il resto dell’Inghilterra ci offrono uno squarcio sulle possibili involuzioni della società civile, se non verranno risolte le anomalie del modello politico ed economico attuale. La parola d’ordine di questi tristi eventi è «diseguaglianza», un canyon profondissimo scavato tra chi ha e accumula sempre di più e chi non ha e mai potrà avere. Quindi occorre interrompere per qualche pagina l’analisi del contagio, della rivolta pacifica degli Indignati mediterranei e dei loro fratelli europei, per osservare da vicino l’anomalia britannica, sfociata in una rivolta violenta e distruttiva. Quali ne sono state le cause e dove sta per portarci? Gotham contro Disneyland Se William Shakespeare fosse vivo oggi, la sua prossima tragedia potrebbe avere come sfondo i fatti londinesi dell’agosto 2011. Le contraddizioni della Londra contemporanea non sono infatti così diverse da quelle della Londra elisabettiana e soprattutto un aspetto non è cambiato: i privilegiati si ostinano a ignorarle. Nuovi poveri e nuovi ricchi vivono a poche decine di metri di distanza gli uni dagli altri, senza che i loro mondi si intersechino mai perché a separarli è una barriera invisibile e insormontabile: il denaro. I primi si muovono a fatica da un punto all’altro della città, proprio come nel Medioevo, utilizzando trasporti costosi e prossimi al collasso; i secondi viaggiano in auto scure blindate. Benvenuti nella metropoli dell’austerity dove i servizi sociali sono stati ridotti all’osso, l’Iva è al 20 per cento, la crescita economica è negativa e la scritta Sales – saldi – campeggia perennemente nelle vetrine. Nel Regno Unito, la differenza di reddito tra il 20 per cento più ricco della popolazione e il 20 per cento più povero è oggi doppia che in Svezia, Norvegia e Giappone. Una forbice che si va aprendo dalla fine degli anni Settanta, nonostante il governo New Labour di Tony Blair abbia aumentato le tasse ai ricchi. Il motivo? I salari del 20 per cento più abbiente sono aumentati a ritmi assai più sostenuti rispetto a quelli del resto della popolazione, con la benedizione del governo. Nel 1998 Peter Mandelson affermava: «Per noi laburisti non è affatto un problema che alcuni stiano facendo soldi a palate». Peccato che non si sia mai prodotto il miracoloso effetto a cascata della ricchezza predetto dai neo-liberisti amici di Mandelson. Chi già stava bene oggi sta benissimo, mentre chi stava piuttosto male è sprofondato nella miseria. E come in Italia, le classi medie si dibattono. Persino la demografia rema a favore delle diseguaglianze. Con una crescita tra 1,7 e 1,8, decisamente più alta che nel resto del continente, la Gran Bretagna ha anche il record europeo della povertà infantile. I bambini nascono principalmente da emigrati poveri e ragazze madri, alle quali lo Stato fino all’avvio della politica di austerità offriva abbastanza per alloggiare e sfamare ogni figlio partorito ma nulla di più. Gran parte dei ragazzini con la felpa e il cappuccio calato sul viso che abbiamo visto saccheggiare i negozi delle griffe provengono dai ghetti senza padri, prigioni sociali dove la disoccupazione tocca picchi impensabili in Europa, fino al 60 per cento nelle città del nord, ma anche in alcuni quartieri di Londra. Definita dal sindaco Boris Johnson «pulizia sociale in stile Kosovo», l’austerity del nuovo primo ministro, David Cameron, è stata fin da subito poco popolare tra chi gestisce la capitale. «Londra ospita il 12 per cento della popolazione del Regno Unito ma contribuisce per il 20 per cento al suo Pil, genera un surplus fiscale di ben 15 miliardi di sterline che però viene ridistribuito nel resto del Paese» ha dichiarato Nicholas Anstee, il Lord Mayor della City di Londra, nel tradizionale discorso di Natale. E come nei comizi della nostra Lega la domanda implicita è: perché una capitale così ricca e che produce ricchezza deve subire tagli alla spesa sociale identici al resto del Paese? Peccato che questa ricchezza sia poco visibile nelle strade della città, che sembra invece una metropoli a un passo dal tracollo. «Le offerte speciali abbondano eppure la gente compra sempre di meno» afferma un manager di Waitrose, una catena di supermercati britannica. Nel 2010 i dati delle vendite natalizie nella capitale, da sempre un indicatore importante del benessere della popolazione, sono stati peggiori delle aspettative e hanno confermato la contrazione del Pil durante l’ultimo trimestre del 2010 (-0,5 per cento). In pieno inverno, quando fa buio alle 15.30 e una pioggerellina gelida picchietta sulle sporche stradine di Soho, sembra quasi di essere a Gotham City, la città di Batman travagliata dal crimine e dalle diseguaglianze. Prima capitale europea per i furti di auto, Londra è anche tristemente famosa per l’alta percentuale di rapine e per gli accoltellamenti tra adolescenti appartenenti a bande rivali. Poco distante dalle luci di Piccadilly e dai teatri di Shaftesbury Avenue, nei giganteschi comprensori di case popolari costruiti nel dopoguerra sulle macerie dei bombardamenti tedeschi – fortezze della povertà sparpagliate a macchia di leopardo per la città – una seconda generazione di ragazze madri alleva con i sussidi dello Stato la futura manovalanza del crimine. Da Tottenham a Croydon, da Seven Sisters a Crystal Palace famiglie anomale condividono con gli emigrati uno spazio sociale asfittico, che va dal pub al divano di casa, da dove vivono un’esistenza voyeuristica, fatta esclusivamente di reality. È questa una Londra sconosciuta ai turisti, ma è quella che tutti attraverseranno durante le Olimpiadi del 2012 per raggiungere gli stadi sportivi costruiti a est della City, il motore economico della metropoli. Ubicato volutamente in una zona degradata, il villaggio olimpico con il complesso sportivo delle Olimpiadi avrebbe dovuto riqualificarla. Per ora invece ossigena la criminalità locale. Un’inchiesta del quotidiano «Daily Star» denuncia che bande di delinquenti del quartiere impongono il pizzo alle imprese di costruzione che hanno vinto gli appalti e «smerciano» nei cantieri immigrati clandestini. Non mancano poi le truffe, d’altronde la posta in gioco è alta: 93 miliardi di sterline è la previsione sul fatturato dei giochi olimpici. Scotland Yard ha addirittura creato un’unità speciale che è entrata in funzione alla fine di febbraio quando i biglietti per le Olimpiadi sono stati messi in vendita per la prima volta. Dai siti web falsi per acquistare i biglietti fino alle truffe organizzate e ai furti d’identità, i delinquenti londinesi sono già pronti a derubare chiunque abbia intenzione di attraversare la Manica per godersi i giochi. Che questa sia una metropoli travagliata e che, proprio come Gotham City, abbia perso la propria identità sociale a causa della corruzione della classe politica – rampante durante il governo laburista – lo ammette persino il primo ministro. E proprio perché Londra è lo specchio della nazione, la capitale è diventata il laboratorio dove il nuovo governo sperimenta politiche di supporto all’austerity come la big society, un’iniziativa che poggia sulla delocalizzazione dei servizi sociali e sulla partecipazione della media e piccola impresa alla gestione pubblica. Tra i temi più dibattuti c’è quello della salute, il governo vuole infatti devolvere una grossa fetta dei finanziamenti destinati alla sanità ai Gp di quartiere, l’equivalente dei nostri medici della mutua. I londinesi sembrano propensi a questo cambiamento mentre il sindaco, le circoscrizioni e l’opposizione non ne vogliono sapere, così che per spartirsi gli ormai irrisori sussidi statali si è scatenato un braccio di ferro urbano. Il binomio austerity-big society è uno scossone sociale per risvegliare la straordinaria solidarietà dei londinesi, quella che durante l’ultimo conflitto mondiale permise loro di sopportare i terrificanti blitz tedeschi a testa alta o come dicono loro mantenendo uno «stiff upper lip», un labbro che non trema. È una dote indispensabile affinché l’austerity funzioni. Ma la solidarietà sociale, negli ultimi decenni, si è frantumata di fronte alla corruzione, alle ingiustizie, all’individualismo e alla spudoratezza di chi negli anni sui sacrifici altrui ha costruito la propria fortuna. I giovani all’assalto del filo spinato Né Boris Johnson né Nicholas Anstee, infatti, ci spiegano dove finisce la ricchezza della città, così evidente nei suoi bilanci ma non nelle sue strade. A nasconderla è un’anomalia economica. Il surplus fiscale di cui il governo cittadino si fa vanto è infatti una cricca di super-ricchi, che usano la capitale come un parco giochi, spalleggiati da un esercito di banchieri e finanzieri che aspirano a fare altrettanto, anche se riesce loro sempre più difficile. A febbraio i dati sui prezzi degli immobili pubblicati dal «Financial Times» hanno riportato un ulteriore aumento nei quartieri alti: Kensington, Chelsea, Belgravia. Qui la domanda supera l’offerta grazie al nuovo influsso di oligarchi russi e miliardari cinesi. I banchieri non ce la fanno a competere e si sono spostati in zone meno care: Wandsworth, Balham, Fulham, a North a Islington o a est nelle Docklands. Nel resto della città i prezzi delle abitazioni sono in picchiata mentre cresce il numero di chi le abbandona perché non ce la fa a pagare il mutuo. Gotham City convive con la sfavillante Londra dell’era Blair, la Disneyland dell’aristocrazia della ricchezza. E nonostante molti super-ricchi si siano trasferiti a Dubai o a Singapore – i paradisi fiscali più in voga – tutti hanno mantenuto la residenza londinese che visitano regolarmente. Non a caso le tratte più costose della British Airways sono Londra-Dubai e Londra-Singapore, un biglietto business di sola andata per Singapore costa la bellezza di 6000 sterline, eppure non è facile trovare un posto sui quattro jumbo che decollano ogni giorno. A Londra si va per le prime dell’opera, i balli di beneficenza e le feste come quella organizzata nella primavera del 2010 da Louis Vuitton per l’apertura del suo nuovo negozio a Bond Street, costato 45 milioni di sterline. Ad ammirare gli accessori che ruotano lungo pareti mobili o la scalinata tutta in vetro c’erano i soliti divi del cinema, oligarchi e miliardari orientali, una manciata di banchieri e molti personaggi famosi della vecchia Londra edonistica, come la coppia Beckham. Grandi assenti gli intellettuali, quelli veri, che hanno abbandonato la città durante l’era Blair. Nel corso della festa Elle Macpherson, la celeberrima modella, confessa a un giornalista di «Bloomberg» che era ora che qualcuno facesse una festa come ai tempi d’oro, gli anni Novanta, quando non c’era l’austerity e giravano i soldi veri ed «eravamo tutti ricchi». Ma si sbaglia, le politiche economiche di David Cameron e Nick Clegg non si applicano ai ricchi londinesi che anzi oggi stanno meglio che in passato. A detta di Andrea Gerst, analista presso la Swiss&Global Asset Management, il mercato del lusso londinese cresce a ritmi superiori a quelli precrisi. Ce lo conferma la dirigenza di Sotheby che alla fine del 2010 ha venduto a un’asta un quadro di Picasso del 1932, La Lezione, per 40 milioni di sterline, ben dieci volte sopra le aspettative. Nel 2010 la succursale londinese ha fatturato da sola 112 milioni di sterline, una cifra da record. Alla fiera nautica che ogni anno si tiene a Earls Court la lista d’attesa per gli yacht più costosi è di tre anni, lo stesso vale per i jet privati che vanno letteralmente a ruba. Architetti, decoratori, chiunque lavori nel lusso parla di quantità di denaro ben superiori a quelle del passato, che scorrono come rivoli lungo le strade della capitale inglese. Senza questo denaro che tiene a galla la metropoli, Gotham City si mangerebbe Disneyland in un boccone. Ma potrebbe farlo comunque, e nell’agosto del 2011 lo ha mostrato chiaramente con prove generali di rivoluzione che, alla luce di una situazione economica così tragicamente squilibrata, appaiono più facili da capire e persino prevedibili. A Londra non ci sono industrie, officine, laboratori che producano per chi non è ricco, persino i souvenir e le chincaglierie che sono andati a ruba in occasione del matrimonio del principe William sono stati prodotti all’estero, in Cina. Tutto nella capitale è funzionale all’aristocrazia della ricchezza, dalla finanza che ne moltiplica i capitali alle biciclette gratis volute dal sindaco ciclista, che si trovano solo nei quartieri benestanti del centro. A differenza di dieci anni fa, oggi quest’accozzaglia di nuovi ricchi si guarda bene dall’ostentare la propria ricchezza, per non incorrere nell’ira popolare. Ne sanno qualcosa il principe Carlo e la sua consorte Camilla. A marzo i tagli all’istruzione hanno portato nelle strade della città migliaia di giovani stufi di pagare con il loro futuro gli errori dei più anziani. Le costosissime scuole private della capitale hanno chiuso i battenti nella pausa a pranzo per impedire agli studenti ricchi di unirsi a quelli meno privilegiati delle scuole statali. Ma non è servito a nulla, all’uscita di scuola sono scesi in piazza anche loro. La contestazione giovanile della primavera ha creato il primo cortocircuito tra Gotham e Disneyland. Il secondo è stato ad agosto del 2011, ma stavolta le due città si sono trovate l’una contro l’altra. Possibile che la Londra dove bande di teppisti saccheggiano di tutto, dai negozi di abbigliamento a quelli di elettronica fino ai supermercati, sia la stessa che appena tre mesi fa era tutta in festa per il matrimonio del principe William con la sfavillante Kate Middleton? È possibile, alla luce di quanto detto sopra. Leggere i tweet della rivolta equivale a leggere quella tragedia che solo Shakespeare avrebbe potuto scrivere, il dramma venuto alla luce di una nazione finora abilissima nel nascondere le contraddizioni socioeconomiche. Un Paese dove da trent’anni le divisioni razziali si sovrappongono a quelle di classe dando vita a un reticolato sociale che altro non è che il filo spinato dell’esclusione. La mappa a macchia di leopardo di scontri e saccheggi disegna un serpentone lungo le zone di confine tra quartieri ricchi e poveri, tra isolati benestanti e conglomerati di case popolari. Chi non ha, e mai avrà, «espropria» – questa la parola usata ripetutamente dalle bande di saccheggiatori – i negozi dove solo i ricchi entrano. È la rivalsa, vecchia come la storia, degli esclusi, a cui la razzia di beni di consumo fa scavalcare per un attimo il filo spinato dell’esclusione, restituendo loro una umanità tragicamente impoverita dal mantra del consumo imposto dagli ultimi decenni: «Compro, dunque esisto». Ed esisto solo se acquisto, in che modo o con che mezzi poco importa. La diseguaglianza e l’esclusione, dunque, possono dar vita a manifestazioni di dissenso violente anche nella civilissima e democratica Europa. E dato che tra le nazioni dell’Ue quella con una distribuzione della ricchezza analoga alla Gran Bretagna è l’Italia, il pericolo che l’acuirsi delle diseguaglianze produca saccheggi e scontri anche a casa nostra è alto. Ci sembra impossibile? Anche in Egitto e in Libia ci sembravano impossibili. Anche in Grecia e in Spagna. E perfino a Londra. Parte del testo di questo capitolo è stato rielaborato dall’articolo di Loretta Napoleoni Bye, bye swinging London, apparso sull’«Espresso» il 3 marzo 2011. Il contagio 4 Al Nahda La Rivoluzione francese, che apre l’era moderna, è un cataclisma anti-establishment il cui messaggio irrompe con la violenza di uno tsunami nelle regge del Vecchio Continente e spazza via tutto. La febbre rivoluzionaria è molto contagiosa perché a diffonderla sono principi universali: libertà, uguaglianza e fratellanza. E sono innanzitutto i valori profondi della società civile a erodere le monarchie assolute finché nel 1848, con la rivoluzione borghese, entrano a far parte del Dna dello Stato moderno. Il messaggio è trasversale perché è umano. Ma politicamente il 1789 inaugura l’era moderna per un altro motivo: cambia la fonte di legittimità dello Stato. Ghigliottinare il re di Francia, monarca per diritto divino, rimuove dalla politica nientemeno che Dio, per sostituirlo con la volontà popolare. Per mantenere la testa sulle spalle e il corpo sul trono i regnanti europei devono condividere parte del proprio potere con i loro sudditi, ed è proprio quello che faranno dopo le sollevazioni del 1848. Anche le rivolte arabe del 2011 contestano la legittimità delle dittature ereditarie che hanno ottenuto e mantenuto il potere con la forza. I regimi di Siria, Libia, Egitto, Tunisia sono accomunati da un uso brutale della paura e della repressione, tanto quanto dal tentativo di tramandare la supremazia di padre in figlio anche a costo della vita dei cittadini. In Siria, Assad non esita a sparare sulla popolazione in rivolta. In Bahrain la repressione è brutale e i medici che si sono presi cura dei feriti rivoltosi vengono arrestati. In Libia Gheddafi arriva a bombardare la Cirenaica. Ma il popolo stavolta non si ferma. In pochi hanno il coraggio di ammettere che queste sollevazioni popolari negano anche, più o meno esplicitamente, la fonte internazionale della legittimità dei regimi dittatoriali. Ovvero il ricco Occidente, proprio noi. Per decenni ai nostri governi ha fatto comodo mantenere in questa parte del mondo lo status quo. Tra la Francia democratica e la dittatoriale Tunisia, ad esempio, esisteva un rapporto commerciale e politico fortissimo, cementato da uno scambio di affari e di favori tra le rispettive oligarchie. Come dimenticare che mentre a Tunisi imperversava la rivolta l’allora ministro degli Esteri francese, Michèle Alliot-Marie, prima ha offerto il know-how del proprio Paese a Ben Ali e subito dopo si è vista costretta ad abbandonare le sue vacanze tunisine sul jet privato del socio in affari di quest’ultimo? La Alliot-Marie era di casa in Tunisia, la sua famiglia aveva da poco vinto un appalto edilizio siglato dal suddetto socio di Ben Ali. Anche il primo ministro francese François Fillion è stato travolto dalla rivoluzione araba mentre si godeva una vacanza nel Mar Rosso a spese di Mubarak. Le joint-venture dei nostri politici con i dittatori arabi erano solo le briciole delle ricchezze accumulate dai regimi. L’abbondanza vera proveniva dai contratti preferenziali con l’Unione europea, dalle importazioni e dagli affari con la grande industria europea e con i governi occidentali. La stragrande maggioranza di questi profitti non veniva distribuita alla popolazione ma finiva nelle tasche delle élite. Mubarak viene deposto con un patrimonio immobiliare all’estero pari a 70 miliardi di dollari, una ricchezza ormai per sempre sottratta all’Egitto. Difficile sarà anche farsi ridare i soldi congelati in Svizzera. Più fortunati i tunisini che nella residenza di Ben Ali hanno ritrovato una enorme stanza-cassaforte con un tesoro simile a quello descritto nel Conte di Montecristo: pietre preziose, gioielli, opere d’arte acquistate alle aste di Christie e Sotheby e così via. La rivoluzione senza Osama C’è un grande assente nelle piazze delle rivolte arabe: il fondamentalismo. Anche la religione è stata tagliata fuori dall’equazione politica. Che fine hanno fatto gli acerrimi nemici pronti a distruggerci, che a detta di Bush e Blair erano i veri elementi di destabilizzazione di quei Paesi, il motivo per allearsi con i loro governanti? Al loro posto nelle capitali arabe c’è un esercito di giovani che indossa jeans e scarpe da ginnastica, vive su Facebook, Myspace, YouTube e Twitter e invece della sciabola usa il telefonino. Il 60 per cento della popolazione nordafricana e mediorientale ha meno di trent’anni e gran parte è disoccupata. Non c’è quindi da stupirsi che siano i giovani la forza portante di questa rivoluzione, soprattutto se consideriamo che secondo uno studio della Population Action International, una società di ricerca statunitense, l’80 per cento dei conflitti mondiali verificatisi tra il 1970 e il 2000 sono avvenuti in nazioni dove il 60 per cento della popolazione era sotto i trent’anni. Le rivolte in Tunisia ed Egitto, come quelle ancora in corso nel resto del Medioriente, sono rivoluzioni moderne. Non iniziative di pochi esaltati religiosi e politici ma insurrezioni di popolazioni che chiedono un lavoro, una casa, un futuro. Ma dato che nulla di tutto questo è mai accaduto in quei Paesi, nessuno sa bene dove sfoceranno. Al Cairo, come a Parigi nel 1789, s’è fatta tabula rasa del sistema di potere precedente e si guarda al futuro senza avere una bussola in mano. Noi intanto dobbiamo prendere atto che tra le bugie raccontate dai nostri politici c’è anche quella sui «nemici dell’Occidente». Oggi scopriamo che il nemico, quello vero, non sono i fondamentalisti islamici del defunto Osama bin Laden ma i regimi oligarchici e dittatoriali che da decenni l’Occidente appoggia, cosa che oltre ad aver preso di sorpresa la nostra classe politica ha spiazzato gli analisti e i servizi di informazione militare e civile. Siamo fuori, insomma, non solo da tutti gli schemi geopolitici costruiti su una logica bipolare, ma anche da quelli della globalizzazione e dello scontro tra civiltà di cui tanto si è discusso fino a pochi anni fa. La battaglia dei giovani arabi contro le dittature diventa la nostra stessa battaglia contro le oligarchie dei nostri Paesi. E il contagio avanza. Persino la rivolta europea, nella misura in cui attacca la democrazia, è senza precedenti. Anche sulla riva nord del Mediterraneo si naviga a vista. La matrice di queste due rivolte, una a sud e una a nord, è simile perché entrambe hanno le loro radici nel 1789. Bisogna ricordare infatti che la Rivoluzione francese non si limitò a cambiare il volto dell’Europa, ma contagiò anche il mondo arabo. Alla fine del XVIII secolo gli intellettuali arabi che cercavano di definire il concetto di modernità non guardarono alle fabbriche delle Midlands inglesi, dove era in atto la rivoluzione industriale, ma alla plebe parigina che in Piazza della Bastiglia gridava Liberté, Egalité, Fraternité. Traduzione internazionale: il buongoverno è un diritto dell’uomo, non un dono di Dio. Durante la campagna napoleonica in Egitto, poi, le truppe francesi contagiarono con i racconti della Rivoluzione la popolazione locale. Affascinati, gli arabi misero a confronto la rinascita politica europea con la decadenza dell’Impero ottomano, definito «il malato d’Europa». Si accorsero che questo aveva bisogno di essere rinnovato. Nacque così al Nahda, «risveglio» o «rinascita», un movimento costruito sulla profonda ammirazione per le idee rivoluzionarie europee. Al Nahda segna l’inizio della modernizzazione araba, un processo che ci porta dritto alle sollevazioni del 2011. Oggi, in un movimento inverso rispetto a quello di oltre due secoli fa, sono il Nordafrica e il Medioriente la locomotiva rivoluzionaria, il virus contagioso della peste democratica che infetta l’Europa. Perché è dovuto passare tanto tempo? La risposta è il colonialismo europeo. Se alla fine del XVIII secolo i popoli della sponda sud guardavano all’Europa come a una forza politica alleata, che avrebbe sostenuto i loro movimenti indipendentisti, in realtà la nascente borghesia europea pensava in primo luogo alle sue tasche, e vedeva nella disintegrazione dell’Impero ottomano solo nuove opportunità di conquista in Nordafrica e nel Medioriente. I primi a rendersene conto sono stati gli egiziani e ironicamente ciò è avvenuto quando hanno contratto il morbo del debito e il Paese è finito nelle mani delle banche europee. Una storia che vale la pena di raccontare per quanto assomiglia a quella della Grecia e del Portogallo contemporanei. 5 Il morbo del credito Seconda metà del XIX secolo. Muhammad Ali, il chedivè ovvero il governatore dell’Impero ottomano, e suo nipote Ismail intraprendono la strada dell’indipendenza dal potere del sultano applicando il modello di sviluppo europeo. La modernizzazione deve poggiare su due pilastri: il costituzionalismo e il governo rappresentativo. Monarchia costituzionale e Parlamento eletto dal popolo, ecco la formula che hanno in mente. Ma modernizzare costa e intorno al 1875 Ismail ricorre alle banche europee per finanziare il suo sogno d’indipendenza. Queste si guardano bene dal metterlo in guardia contro i rischi del debito. Così in pochi anni Ismail si ritrova debitore di oltre 100 milioni di sterline, una somma troppo grande per essere ripagata, e ogni anno s’indebita di più per pagarne gli interessi. Esattamente quello che sta succedendo oggi nei Paesi deficitari europei. Il debito cresce a dismisura e finisce per condizionare le decisioni politiche di Ismail, che nel 1871 vara una nuova politica fiscale, la legge Muqabala. Ai proprietari terrieri viene data l’opportunità di pagare in anticipo sei annualità fiscali in cambio della riduzione perpetua delle tasse del 50 per cento. La legge si rivela una catastrofe perché per racimolare poco più di due milioni e mezzo di sterline, abbastanza per onorare gli interessi annuali sul debito, si dimezza il gettito fiscale agrario futuro, una delle maggiori entrate dello Stato. Nel 1873 Ismail bussa nuovamente alla porta delle banche per acquistare dall’Impero ottomano l’indipendenza dell’Egitto. Due anni dopo, di fronte alla potenziale chiusura di tutte le linee di credito, si vede costretto a cedere al governo britannico tutti i suoi beni, incluse le azioni del Canale di Suez. Per una cifra irrisoria, quattro milioni di sterline, il governo di Sua Maestà diventa il secondo azionista di maggioranza del Canale. Come nell’Europa deficitaria, il peso economico delle catastrofiche decisioni dei governi ricade sulla popolazione e in particolare, visto che siamo nell’Egitto del XIX secolo, sulle spalle dei contadini. Quando tra il 1877 e il 1878 si verifica un abbassamento del livello del Nilo e l’agricoltura ne soffre, scoppia la crisi agraria. Sebbene Ismail abbia sempre pagato gli interessi, le banche europee usano la carestia come pretesto per chiedere ai loro governi d’intervenire e d’impossessarsi di territori egiziani quale garanzia contro il debito. Cosa che questi fanno creando un consorzio di Stati – una sorta di antenato del Fondo monetario – che gestisce le finanze egiziane. In realtà il consorzio diventa lo strumento in mano alle potenze europee per prendere possesso del Paese. Ebbene, questa piccola parabola non ha solo un valore storico. Consideriamo infatti che oggi il Fondo monetario, la Banca centrale europea e la Banca mondiale vengono incaricati di risolvere i problemi dei Paesi Piigs che hanno chiesto aiuto economico, e cioè Portogallo, Irlanda e Grecia. Se poi aggiungiamo che più della metà del debito greco è nelle mani di banche tedesche e francesi, che si chiede al governo greco di «privatizzare» la ricchezza del Paese, cioè svendere i beni dello Stato a ricche imprese occidentali e molto probabilmente cinesi, il destino della Grecia di Papandreou non è poi tanto diverso da quello dell’Egitto di Ismail. La Grecia alle corde Se i sudditi di Ismail avessero avuto a disposizione internet avrebbero almeno potuto tentare di deviare il corso della storia. Ed è proprio questo che cerca di fare la società civile greca, accampata nelle pubbliche piazze per manifestare contro i piani d’austerità del governo. I giovani fanno circolare su YouTube le immagini degli scontri fra polizia e manifestanti che assediando il Parlamento protestando contro i «saldi» patrimoniali del loro Paese. Remano contro il risanamento? Niente affatto: hanno ragione loro. Lo stesso Fondo monetario ha infatti ammesso che dalla primavera del 2010 a quella del 2011 l’economia greca si è contratta del 9,4 per cento e nel secondo trimestre del 2011 del 6,9. Il motivo? La politica d’austerità ha strangolato la crescita. Come gli egiziani del XIX secolo, i greci non sono in grado di ripagare i debiti accumulati dalla classe dirigente e il loro futuro rischia di essere deciso dalle banche di Paesi stranieri, istituzioni che ormai tengono in ostaggio il governo e il Parlamento. Ma tra questi due drammi c’è una discrepanza fondamentale: Ismail ha peccato d’ingenuità mentre i politici greci hanno mentito alla popolazione, hanno usato il falso benessere per essere rieletti e l’ingresso nell’euro non per modernizzare il Paese ma per redistribuire ricchezza tra le élite che li sostengono. La moderna tragedia greca è dunque frutto del malgoverno, degli abusi, della corruzione, della cattiva gestione dello Stato. Complici l’Unione europea e le istituzioni internazionali come il Fondo monetario che dovevano vigilare per evitare tutto questo. La crisi greca inizia infatti alla fine degli anni Novanta quando l’Unione europea impone alle finanze dei Paesi membri condizioni ben precise per partecipare al progetto della moneta unica. Gli accordi di Maastricht stabiliscono che il tasso d’inflazione non deve eccedere dell’1,5 per cento quello della media dei tre Paesi membri che hanno la migliore performance economica; il tasso d’interesse a lungo termine non deve superare di oltre il 2 per cento quello della media dei tre Paesi con i tassi più bassi; il rapporto tra deficit di bilancio e Pil non deve andare oltre il 3 per cento e quello tra debito pubblico e Pil non oltre il 60 per cento. Condizioni che, è noto a tutti, i Paesi Piigs difficilmente riusciranno a rispettare. Ma l’euro si deve fare, anche a costo di alterare i bilanci degli Stati. Esiste infatti un mutuo vantaggio nell’unificare la moneta sia per i Paesi ricchi e poco indebitati che per quelli meno ricchi. Per i primi, come la Germania e la Francia, l’alleanza monetaria con le economie dei più deboli calmiera il valore della moneta unica, mantenendola a livelli più bassi del vecchio marco tedesco o franco francese. La «debolezza» intrinseca dell’euro fa dunque loro comodo perché rende più competitivi i loro prodotti, e infatti la Germania oggi è il secondo esportatore al mondo dopo la Cina. Anche ai Paesi mediterranei la moneta unica fa gola, perché permette loro di accedere al mercato dei capitali a tassi più bassi grazie all’emissione di obbligazioni in euro. Proprio perché questa è anche la moneta usata dagli efficientissimi tedeschi, i mercati non domandano più un tasso aggiuntivo per acquistare i Bot o il loro equivalente greco o spagnolo. Tutti infatti sanno che queste nazioni non potranno più ricorrere alla svalutazione delle monete nazionali per aumentare la propria competitività, il potere di farlo ormai spetta alla Banca centrale europea. Far confluire all’interno dei parametri di Maastricht Paesi come Grecia e Germania, Olanda e Italia, Francia e Portogallo è però difficilissimo. Le economie delle nazioni mediterranee sono arretrate rispetto a quelle del Nord Europa, il tasso di crescita è basso e lo Stato infinitamente meno stabile. Tutti i capi di Stato dell’area mediterranea, però, s’impegnano a lavorare sodo per raggiungere la convergenza e infatti sulla carta impongono alle finanze dei loro Paesi una disciplina nordica. I colleghi settentrionali si fidano, o quantomeno fanno finta di fidarsi, un errore che pagheranno dieci anni dopo. In Italia, ad esempio, il governo Prodi dà un giro di vite agli sprechi pubblici, taglia il bilancio dello Stato e vara una finanziaria che fa invidia a Bonn. Ma la disciplina fiscale non fa parte del Dna mediterraneo, l’evasione fiscale perdura, il mercato nero continua a crescere e appena torna al potere la destra si ricomincia a scialare con i soldi presi in prestito. L’accesso a un credito più a buon mercato grazie all’euro avrebbe dovuto favorire lo sviluppo dei Paesi mediterranei. L’austerità economica andava perseguita allora, non oggi con la palla al piede del debito. Ma in nazioni in cui dilagano la corruzione e il malgoverno, l’idea di risparmiare oggi per spendere domani non raccoglie consensi. Piuttosto si sperpera il denaro pubblico quando è disponibile. È il caso dell’Italia, un Paese che da quarant’anni è affetto da un deficit eccessivo. Dal 1993 al 2000, e quindi prima dell’entrata nell’euro, la spesa pubblica diminuisce in termini reali, e cioè al netto dell’inflazione, del 5,14 per cento. In parte ciò è dovuto agli sforzi economici per entrare nei parametri della moneta unica. Ma subito dopo la disciplina del risparmio viene abbandonata e la spesa pubblica dal 2001 al 2008 cresce del 20 per cento. L’avanzo primario, che come si è visto è la differenza tra la spesa pubblica al netto degli interessi passivi sul debito e le entrate dello Stato, passa da 65 milioni di euro nel 2001 a 38 nel 2008, per poi diventare negativo nel 2009 e 2010. Morale: l’entrata nell’euro facilita lo sperpero del denaro pubblico. L’abbattimento dei tassi prodotto dall’euro foraggia dunque un’economia inutile in tutta l’Europa mediterranea in cui lo Stato distribuisce denaro senza un criterio di sviluppo. In Spagna i palazzinari ricevono appalti statali per costruire intorno a città come Madrid quartieri periferici enormi, oggi completamente vuoti, vere e proprie città fantasma; si erigono aeroporti faraonici dove non atterrerà mai nessun volo internazionale, per non parlare poi della costa mediterranea dove l’equazione «cemento + corruzione di pubblici ufficiali = ricchezza» sostiene l’illusione del progresso, tanto che 95 membri dell’amministrazione comunale di Marbella finiranno sotto processo per corruzione. È ovvio che lo scarto tra gli indicatori economici europei si sia ampliato. Paradossalmente oggi siamo più lontani dalla convergenza rispetto al 1999, la vigilia dell’entrata in vigore dell’euro. Ma ai governi europei non piace che questo si sappia. E allora ecco che entrano in gioco gli effetti speciali della contabilità e della finanza. Un anno la Grecia lascia fuori bilancio una buona fetta della spesa pubblica, un altro si dimentica di inserire gran parte di quella ospedaliera. L’Italia si comporta in modo del tutto analogo e anche Portogallo, Irlanda e Spagna truccano i conti. Nessuno se ne accorge perché a Bruxelles nessuno si mette a spulciare i bilanci degli Stati membri. Quando finalmente nel 2009 l’Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Ue, ricalcola il deficit di bilancio greco, ci si accorge che in quell’anno è pari al 12 per cento del Pil, più di quattro volte il limite imposto da Maastricht. Perché il controllo non è stato fatto prima? E sarebbe poi davvero servito a qualcosa? L’alta finanza sostiene che gli organi preposti al controllo dei dati europei, ad esempio l’Eurostat, non hanno la struttura né le competenze per far fronte alla «creatività» delle banche d’affari. È assolutamente vero. Queste ultime infatti sfornano continuamente una varietà infinita di prodotti per aggirare i limiti imposti dall’Ue ai bilanci e de facto falsificarli. Dato però che l’economia, pur non essendo una scienza esatta, è pur sempre una disciplina che poggia su alcuni principi inderogabili, il fatto che per dieci anni la Grecia, come pure la Spagna, il Portogallo, l’Irlanda e l’Italia, abbiano fatto parte di un sistema monetario senza possederne i requisiti produce conseguenze disastrose. È quindi giusto che gli Indignati d’Europa se la prendano con i propri politici, con le istituzioni europee e con i burocrati di Bruxelles, una parte della responsabilità del cataclisma che sta per abbattersi sulle nostre teste è anche loro. Infine tra i protagonisti principali di questa moderna tragedia ci sono le banche d’affari – oggi ribattezzate banche commerciali grazie alla metamorfosi legislativa post-Lehman Brothers – che hanno fornito ai politici europei gli strumenti per mascherare i conti dello Stato. Nella seconda metà degli anni Novanta vengono smerciati i currency-swaps, un tipo di derivati il cui scopo è occultare un prestito attraverso la trasformazione di un debito presente in una passività futura. Da Goldman Sachs a J.P. Morgan, dalla Deutsche Bank al Credit Lyonnais, tutti i principali istituti di credito vendono questo prodotto. Il meccanismo è semplice: lo Stato emette obbligazioni in dollari o yen che la banca sottoscrive, ma il valore viene subito scambiato in euro, con l’impegno di ripagare il debito nella moneta in cui è stato emesso. Nel caso specifico della Grecia, ad esempio, nel 2002 Goldman Sachs applica a questa operazione un tasso di cambio fittizio, e cioè più basso di quello reale. Scambia dollari e yen in euro gonfiando il valore dei primi rispetto al secondo, in questo modo lo Stato riceve una quantità maggiore di euro. La differenza tra tasso vero e falso equivale a un credito che il governo greco intasca. Si tratta naturalmente di un prestito occulto, che non figura nei bilanci dello Stato. Il costo di questi sofisticatissimi giochi di prestigio è naturalmente alto, ma lo Stato lo maschera nelle commissioni bancarie. Dato che le regole di Maastricht non menzionano l’uso dei derivati, tecnicamente parlando né Goldman Sachs né il governo greco hanno commesso un’infrazione, anche se entrambi hanno mentito alla popolazione e ai partner europei. Ora, la finanza internazionale non fa regali. Le banche, come ai tempi di Ismail, sanno bene che la Grecia con questi effetti speciali sta entrando in un vortice pericoloso che se mal gestito la porterà all’insolvenza. Perché allora tutte fanno a gara per venderle currencyswaps e altri prodotti analoghi? Perché Atene è disposta a pagare laute commissioni – e il Piano Marshall europeo ce lo conferma–, e perché a monte del debito c’è la garanzia di Bruxelles. Se la Grecia non potrà far fronte ai suoi debiti, ci penserà l’Unione europea, perché l’euro non si sfascia, questa la logica. A giudicare dagli ultimi diciotto mesi, il ragionamento regge. Fino a un certo punto, però. Perché l’Unione europea non ha i soldi per salvare tutti i Piigs. 6 Falso in bilancio! Allarghiamo il campo per considerare il mercato obbligazionario, e cioè quello dove si prende e si concede denaro in prestito. È una piazza immensa, di gran lunga superiore a quella dell’economia reale mondiale. Tutti vi partecipano. La finanziarizzazione dell’economia, infatti, ha fatto sì che i guadagni maggiori della finanza occidentale provengano non dall’investimento reale ma da quello creditizio, cioè si guadagna dando soldi in prestito e smerciando il debito. Se mettessimo a confronto i portafogli delle imprese e dei più grossi investitori di un secolo fa con quelli odierni saremmo colpiti dall’aumento vertiginoso della percentuale d’investimento finanziario negli ultimi vent’anni. In parte ciò è dovuto alla maturità del nostro capitalismo. Un secolo fa si investiva nelle infrastrutture: strade, ferrovie, cantieri navali; oggi le industrie trainanti sono Microsoft e Google. In parte ciò accade appunto per via della finanziarizzazione dell’economia, per cui oggi si investe in titoli del debito pubblico e privato più che in vere e proprie partecipazioni azionarie, reputate più rischiose. Questo perché sul mercato dell’investimento sono comparse nazioni come i Paesi dell’Europa mediterranea, che non hanno alle spalle una cultura del rischio o del gioco in Borsa. Per costoro il mercato dei titoli del debito sovrano è una garanzia di sicurezza anche perché negli ultimi vent’anni la politica dei bassi tassi d’interesse ha prodotto ritorni soddisfacenti sui titoli. Banche, finanziarie e fondi d’investimento, dunque, inclusi quelli che gestiscono le nostre pensioni, acquistano principalmente obbligazioni statali per i loro portafogli. A partire dagli ultimi anni del secolo scorso, dunque, la domanda di titoli obbligazionari è stata molto elevata e l’offerta ha dovuto adeguarsi creando continuamente nuove emissioni di Stato. Quelle più popolari offrivano garanzie solide e fino allo scoppio della crisi del debito sovrano erano i titoli di Stato, dai nostri Bot alle obbligazioni del Tesoro americano. Il debito sovrano era diventato così una sorta di marchio Doc, che naturalmente i banchieri hanno cercato di appiccicare a quante più obbligazioni possibili, e anche meno possibili. Ecco come. Anni Novanta e anni Duemila: Lehman Brothers manda un esercito di giovani italiani addestrati a New York a colonizzare l’Italia. Con l’obiettivo di vendere prodotti della finanza strutturale per estrapolare dai bilanci denaro liquido, il tutto dietro pagamento di laute commissioni. Tutti li comprano, anche i conventi di suore. All’inizio degli anni Duemila le Asl, le Aziende sanitarie locali, e le Ao, Aziende ospedaliere, in molte regioni sono a corto di contante, pagano i fornitori a ventiquattro mesi e non sanno più dove trovare i soldi. Intervengono la Lehman e altre banche d’affari che, con una serie di stratagemmi, creano obbligazioni sulla loro spesa presentandole come titoli obbligazionari con garanzia dello Stato italiano. Si tratta della «cartolarizzazione del debito», che va a incidere sia sul bilancio delle Regioni che su quello dello Stato. Tecnicamente questa operazione non si può fare perché questi enti sono un capitolo della spesa pubblica, ma è un ostacolo facile da aggirare per i moderni banchieri. Il meccanismo è semplice. Vediamo come ha funzionato in Campania. All’inizio degli anni Duemila, ad esempio, la Lehman acquista i debiti delle Asl e delle Ao della Regione Campania per cinque anni fino al 2007 per un valore di 2,7 miliardi di euro e salda i fornitori in contanti, in cambio questi enti s’impegnano a ripagare il debito dopo dieci anni. La Lehman lo trasforma subito in titoli a trent’anni che vende sul mercato internazionale con la garanzia dello Stato italiano. Tutti li sottoscrivono proprio grazie a questa garanzia. Il rischio per la Lehman è zero: ha infatti venduto tutte le obbligazioni all’asta. Chi rischia di essere colpito dall’insolvenza è chi ha questi titoli in portafoglio, principalmente fondi pensione e d’investimento italiani. Ma nessuno se ne cura perché dietro c’è la garanzia dello Stato italiano e quindi dell’Ue. Il guadagno per la Lehman è elevato: la banca intasca una commissione sulla creazione del prodotto e sulla vendita dei titoli. In più percepisce il tasso d’interesse sul debito contratto dagli enti. Alla scadenza sarà il Tesoro a ripagarlo perché tutti sanno che la gestione di questi enti è cronicamente deficitaria, ma ciò non avverrà per altri vent’anni. Meno conveniente è l’operazione per lo Stato italiano, a cominciare dai tassi d’interesse. L’emissione privata costa il Libor, il tasso applicato al rischio Italia, più il 3 per cento. Se l’avesse fatta il Tesoro il tasso aggiuntivo sarebbe stato dell’un per cento, dunque inferiore. Inoltre gli enti non avrebbero dovuto pagare le commissioni alla Lehman. Allora perché non è stato il Tesoro a uscire sul mercato a nome degli enti sanitari e ospedalieri? La risposta è semplice: tutte le emissioni del Tesoro fanno crescere il debito pubblico. Invece usando lo stratagemma della banca d’affari, l’indebitamento di un’istituzione statale si trasforma in un debito privato, seppure con garanzia dello Stato, e non compare nei bilanci statali. Sui bilanci regionali il debito però compare. Come si è «nascosto»? L’operazione di collocamento dei titoli a trent’anni viene riportata in bilancio regionale per annualità di 700.000 euro e infatti 30 anni × 700.000 = 2,1 miliardi circa. Si tratta di un’operazione che ha immesso liquidità nel sistema e operato una concentrazione in un solo debitore, le banche d’affari, ma cos’è che non appare in bilancio? Il debito complessivo contratto. Viene registrata soltanto la rata annuale di 700.000 euro. Dal bilancio non risulta insomma che i nostri figli e nipoti per godere della nostra mediocre sanità sono indebitati per i prossimi trent’anni. Ma la triste storia del debito non finisce qui. In Campania per coprire il costo del debito si è ricorso all’incremento dell’Irap, l’Imposta regionale sulle attività produttive. Che significa? Che abbiamo penalizzato la produzione a vantaggio della finanza. Tutta l’operazione, che come si dice in gergo «spalma» il debito e cioè lo ripartisce sul lungo periodo, non ha creato valore economico reale ma solo movimento finanziario. Certo, se questo tipo di intervento fosse stato mirato al risanamento del debito sanitario allora non avremmo avuto sprechi ma una vera strategia, però non è stato così: dopo quell’operazione i debiti hanno continuato ad accumularsi poiché l’inefficienza del sistema brucia risorse e non crea più valore. Che significa tutto ciò? Che siamo governati da farabutti e che le dimensioni del nostro debito pubblico sono molto maggiori di quello che crediamo. I bilanci dello Stato e delle sue istituzioni sono fotografie di un determinato momento e quindi non è facile accorgersi che alla fine di operazioni come quella appena descritta il debito originario è aumentato; ancora più arduo è capirne il perché. E dato che questo tipo di operazioni finanziarie le grandi banche d’affari le hanno vendute a tutti i governi deficitari europei, il debito complessivo dei Piigs è anch’esso infinitamente più grande di quello che pensiamo noi. Ecco spiegata la causa dei misteriosi cinque miliardi aggiuntivi del debito greco comparsi nella primavera del 2011. Non solo non sono spuntati dal nulla, ma controllando accuratamente i bilanci ne potremmo trovare molti di più. Sbilanci dello Stato Nel 2001, grazie ai currency-swaps, la Grecia può entrare nell’euro, in ritardo di appena un anno rispetto all’Italia di Prodi, che già fa parte del club grazie agli stessi stratagemmi e ai prodotti venduti alla fine degli anni Novanta dalla gemella di Goldman, J.P. Morgan. Apparentemente, le due nazioni hanno le carte in regola, sia l’Italia che la Grecia presentano un deficit sotto il tetto massimo stabilito da Maastricht. Peccato che tecnicamente parlando si tratti di clamorosi falsi in bilancio. Naturalmente il Tesoro italiano e quello greco ne sono al corrente ma si guardano bene dal dirlo. Il ministro dell’Economia e pochi intimi sono i soli ad avere una visione obiettiva del debito, sono infatti loro che tengono il cosiddetto swap book, dove vengono registrate tutte le operazioni di questo tipo. Neppure il Parlamento è a conoscenza di questi retroscena. Non esiste infatti l’obbligo di presentare le operazioni di swap né quello di farle approvare. Se Tremonti oggi ci facesse vedere lo swap book italiano, il nostro debito pubblico, come quello di tutti i Piigs, ci riserverebbe pessime sorprese. Moody’s, Standard&Poor’s e le altre agenzie di rating, come pure tutte le grosse banche d’investimento – che continuano a vendere a governi e imprese strumenti di falsificazione di bilanci – sono perfettamente al corrente di questa realtà ma si guardano bene dal denunciarla: le prime, infatti, vivono vendendo i propri prodotti alle seconde. Tra di loro esiste dunque una relazione incestuosa che facilita l’occultamento di dati importanti. È però anche vero che a ridosso della crisi del credito, nel 2008, l’uso di prodotti come i currencyswaps è talmente vasto che nessuno pensa che la falsificazione dei bilanci porterà alla crisi del credito o che una banca come la Lehman possa fallire. L’idea poi della crisi del debito sovrano è inconcepibile, così come appare assurdo pensare che l’Unione europea un giorno debba decidere se salvare o meno la Grecia e tutti gli altri Piigs dalla bancarotta. E invece la terza più grande banca d’affari al mondo fallirà nel giro di 48 ore e il peso del debito dei Piigs rischierà di far collassare l’euro. A questo punto c’è da porsi due domande: la prima è cosa spinge i politici a comportarsi in questo modo irrazionale. La seconda è a cosa servono i numeri, i parametri, perfino i bilanci dello Stato, nonché le istituzioni europee, dal momento che i primi possono essere facilmente falsificati, e di fatto lo sono di continuo, mentre gli organismi che dovrebbero vigilare non sono in grado di accorgersene. L’orizzonte dei politici è limitato, questo lo sappiamo bene, ma pensare che gli errori fatti e le loro conseguenze svaniscano nel nulla alla fine del mandato sembra stupido e scellerato. Se per entrare nell’euro bisognava dare «un’aggiustatina» ai numeri, era imperativo che ciò avvenisse una tantum e per un motivo valido: la convergenza. Invece scorporare dai bilanci i debiti ha favorito sprechi e ladrocinio, e oggi la popolazione europea, totalmente ignara, deve pagare. Ancora più pertinente è una terza domanda: se le banche hanno architettato la falsificazione dei bilanci dello Stato in combutta con i politici di turno, non è giusto che siano loro a pagarne le conseguenze piuttosto che il contribuente? È sconvolgente constatare che appena una manciata di individui al mondo sono finiti in carcere a seguito della crisi del credito, e non per aver causato la più grande recessione dal dopoguerra a oggi ma, come Bernie Madoff, per aver frodato i super-ricchi. Questa è un’ingiustizia ben chiara agli Indignati, ai quali interessa trovare lavoro e costruirsi una vita decente invece di angosciarsi sulle scadenze del debito occulto dello Stato. Il debito greco come quello degli altri Paesi Piigs è ingestibile soprattutto perché come abbiamo visto nessuno ne conosce le dimensioni reali. E vale la pena di elencare i futuri atti di questa moderna tragedia greca. Ufficialmente, ad agosto del 2011, Atene deve ripagare 6 miliardi di euro, che non ha e che l’Unione europea le ha anticipato. Nel 2012, poi, ci sono altri 14,4 miliardi da restituire entro marzo, 8 entro il 18 maggio e ulteriori 7 ad agosto, per un totale di quasi 30 miliardi di euro. Quante nuove scadenze compariranno nel corso del tempo? Da dove arriveranno tutti questi soldi se il Paese è a crescita negativa e non ha più accesso al mercato del credito? La risposta è il cosiddetto Piano Marshall europeo. Trentacinque miserabili miliardi di euro! Il problema in ogni caso va ben oltre i confini della Grecia. A luglio del 2011 Moody’s ha posto il veto alla proposta francese sposata dalle banche tedesche, e cioè la trasformazione di alcune di queste scadenze in nuovi titoli trentennali. E lo ha fatto, come abbiamo già accennato, con un gesto inusuale che però ci dà la dimensione di quanto alto è il contagio all’interno dell’area euro. Moody’s ha abbassato il rating del Portogallo al livello di quello greco, junk, spazzatura. Moody’s teme che nel momento in cui il settore privato sarà costretto ad accollarsi parte delle perdite i mercati smetteranno di sottoscrivere le obbligazioni di tutti i Paesi Piigs. Invece il mercato vuole la garanzia illimitata dei Paesi ricchi dell’Ue, e cioè l’assicurazione che saranno loro a pagare. L’intesa raggiunta a fine luglio è in fondo una sorta di compromesso che come tutti quelli stipulati in finanza avrà vita corta. Il problema si presenterà in autunno, dicono molti, ma già in agosto si manifestano i primi sintomi di una nuova crisi del debito sovrano europeo. Gli Indignati queste cose forse non le sanno ma le intuiscono, per questo contestano oltre ai loro governi anche le istituzioni internazionali. Queste scadenze, infatti, si conoscevano bene anche nel 2010, quando fu varato il primo piano di salvataggio. L’Europa insomma ha messo un cerotto su una ferita profonda, che aveva bisogno di decine di punti e che ormai sta andando in cancrena. Perché tanta superficialità? La risposta è semplice: la Banca centrale, l’Unione europea e il Fondo monetario pensavano che entro l’estate del 2011 l’austerità imposta dal governo calmasse i mercati e li incoraggiasse a tornare a finanziare il debito greco senza imporre tassi d’interesse da usura. Insomma la Grecia si sarebbe indebitata ulteriormente per pagare i debiti! La tragedia di Ismail si ripete, dunque. E infatti si sbagliavano o forse semplicemente sognavano. Sembra incredibile, ma la logica applicata da istituzioni che hanno la responsabilità del futuro di intere nazioni era quella del «tirare avanti», contraendo più debiti, sperando in un miracolo. E in fondo questa prassi non è cambiata. Una strategia che agli Indignati, ma anche a qualsiasi economista serio, appare assurda. Altrettanto assurde sono state le condizioni imposte un anno fa alla Grecia per ottenere i 110 miliardi di euro, che hanno ridotto le entrate fiscali dello Stato e quindi aumentato il rapporto tra debito e Pil. Nella primavera del 2011 il debito pubblico della Grecia era pari a 340 miliardi di euro. La Grecia è caduta nella trappola del debito e difficilmente ne uscirà senza seguire l’esempio dell’Argentina o dell’Islanda, rispettivamente bancarotta forzata e volontaria. E questo anche se l’Europa le ha lanciato una seconda scialuppa di salvataggio. Tanto varrebbe dichiararla subito, se bisogna fare sacrifici che almeno servano a rimettere in carreggiata l’economia e non a pagare interessi da usura alla finanza internazionale o sprecare il denaro pubblico degli Stati membri dell’Unione. Questo chiedono gli Indignati, politiche concrete e costruttive, non palliativi. Ricapitolando: abbiamo governi democratici che con la complicità delle banche e dell’alta finanza hanno derubato chi li ha eletti, per poi ignorarne le istanze e aggravare i problemi con l’incompetenza o l’immobilismo. L’istituzione che riunisce tutti questi governi, l’Unione europea, ha anch’essa fallito nella sua missione di controllo e quando finalmente si è trovata faccia a faccia con la crisi si è dimostrata incapace di offrire soluzioni durature. Tutto ciò ha un nome, fallimento politico. E questa rovina è il brodo di coltura della pandemia democratica. 7 Medicina amara. E inutile Gli Indignati greci non vogliono finire come gli egiziani del XIX secolo e cioè in miseria. Ma capiscono bene che la gestione delle loro finanze da parte di estranei sta portando proprio a questo. Pertanto chiedono a gran voce di non essere esclusi dalle decisioni importanti sul loro futuro, lo sono stati finora e si vedono i risultati. D’altronde democrazia vuol dire partecipazione, che è esattamente l’opposto di esclusione. Se ai tempi di Ismail l’intervento straniero mascherato da aiuto e civilizzazione era funzionale alle mire espansionistiche europee nel Mediterraneo, oggi la domanda è la stessa: cui prodest? Come abbiamo visto, gli organismi internazionali e sovranazionali preposti alla risoluzione della crisi del debito sovrano invece di migliorare la situazione la stanno peggiorando. Fino a ora, infatti, le condizioni imposte dal Fondo monetario internazionale a Paesi quali la Grecia e il Portogallo hanno ridotto la crescita mentre le beghe tra Banca centrale europea, Francia e Germania hanno convinto molti investitori e le agenzie di rating che l’euro, come lo conosciamo oggi, ha vita corta. Non sarebbe meglio ammettere i propri errori, incluso il fatto che l’euro così com’è strutturato non funziona più e forse non ha mai funzionato? Il semplice fatto che il sistema economico internazionale preveda l’intervento di queste istituzioni, anche se poi si rivela regolarmente un fiasco a causa della loro incompetenza, le rende automaticamente protagoniste dei salvataggi economici. È un po’ come ostinarsi a curare i malati con il rimedio della nonna ignorando la scoperta degli antibiotici. Oggi istituzioni nate a Bretton Woods più di mezzo secolo fa, per un mondo infinitamente meno complesso e integrato, non hanno più senso. E basta osservare il contagio della crisi greca all’Italia per rendersene conto. Dallo scoppio della seconda crisi greca nella primavera del 2011 si assiste all’impennata dei tassi di interesse dei titoli dei Paesi Piigs. Per sottoscrivere le obbligazioni di queste nazioni i mercati ne chiedono di sempre più alti e diventa anche difficile piazzare tutte le emissioni sul mercato. All’asta spagnola di giugno del 2011, ad esempio, il 50 per cento dei titoli rimane invenduto. A quella italiana di luglio i tassi arrivano appena al di sotto del 6 per cento. Sempre a luglio l’Italia cancella l’asta dei titoli trentennali, probabilmente per paura di non riuscire a piazzarli tutti. Ma ad agosto riparte la speculazione contro il nostro Paese e i tassi superano per la prima volta quelli spagnoli. Solo l’intervento della Banca centrale europea che dichiara che acquisterà le obbligazioni italiane evita il tracollo. Ma non siamo affatto fuori della tempesta: se in autunno la Francia si troverà nella stessa situazione, la Bce dovrà fare delle scelte ed è chiaro che, non avendo abbastanza soldi per salvare tutti, Parigi avrà la precedenza su di noi che saremo costretti a pagare tassi sempre più elevati per indebitarci. Un disastro se si pensa che, come si è detto, ogni punto percentuale equivale a 35 miliardi di euro in più che l’Italia dovrà ripagare. Una catastrofe se consideriamo che ormai questi Paesi sopravvivono vendendo mensilmente titoli di Stato in cambio di contante, l’unico mezzo che hanno a disposizione per rastrellare fondi con i quali poi pagano gli interessi sul debito. Possibile che non ci siano soluzioni alternative? Forse sì, se altri Paesi legati da accordi economici, come quelli della Ue, le hanno trovate. Ad esempio, gli Emirati Arabi. La lezione di Abu Dhabi Alla fine del 2009 i due giganti finanziari di Dubai, Dubai World e Nakheel, dichiarano di non avere i 30 miliardi di dollari necessari per pagare le cedole delle obbligazioni che scadono a breve. È un fulmine a ciel sereno. Possibile che Dubai, la New York dell’Oriente, il parco giochi dei super-ricchi, paradiso fiscale del Medioriente, cuore palpitante della finanza islamica, si trovi a un passo dalla bancarotta? Dubai World e Nakheel sono infatti due società a partecipazione statale, de facto garantite dallo Stato, ciò spiega perché agli occhi del mondo il mancato pagamento equivarrebbe a una crisi d’insolvenza di un debito sovrano, identica a quella dell’Islanda, della Grecia, del Portogallo e dell’Irlanda. E, perché no, anche dell’Italia. A corto di contante, Dubai bussa alla porta del ricco emirato Abu Dhabi. Questo non ha mai visto di buon occhio la politica economica e finanziaria del vicino e ha criticato più volte, inascoltato, la facilità con la quale Dubai s’indebitava. Tra i due governi esiste una rivalità latente, palese anche a un primo sguardo dalla differenza tra le strade linde e poco affollate della tranquilla Abu Dhabi e il perenne cantiere della godereccia Dubai, in cui al venerdì le discoteche sono aperte fino all’alba e la musica pop s’intreccia al canto mattutino dei muezzin. Anche se confinanti, i due emirati appartengono a mondi diversi. L’ultima cosa che Abu Dhabi vuole fare è salvare i vicini di casa che considera spendaccioni e speculatori, eppure, dopo frenetiche negoziazioni a porte chiuse, è esattamente quello che fa. Garantisce il debito, un gesto che convince i creditori a concedere una dilazione sui pagamenti. Dopo qualche mese, quando i mercati si sono tranquillizzati, iniziano le negoziazioni per la ristrutturazione. Ai creditori si offre tra il 40 e il 50 per cento del valore del debito, l’alternativa è naturalmente ben peggiore: la bancarotta. Così, ad esempio, Dubai World, il cui debito ammonta a 23,5 miliardi di dollari, finisce per pagarne solo 14,7, di cui 4,4 dilazionati in cinque anni e gli altri 10,3 in otto anni. All’inizio del 2011 arriva la notizia che la ristrutturazione del debito è terminata con successo, subito dopo l’emirato esce sul mercato con nuove obbligazioni, che vengono sottoscritte senza alcun problema e anzi con convinzione dal mercato dei capitali. Alla fine Dubai se la cava ripagando poco più della metà del debito originario, un risultato a dir poco eccezionale per un Paese che ha rischiato la bancarotta. Qual è il segreto del successo degli emirati? La prontezza d’intervento e la garanzia di solvibilità. Poteva andare così anche per la Grecia? Probabilmente sì. Invece com’è andata? A gennaio 2010, un mese dopo il salvataggio di Dubai, i rappresentanti dell’Unione europea si incontrano segretamente al World Economic Forum, a Davos. I greci mettono subito le carte in tavola e chiedono aiuto, la risposta dei colleghi europei è, come sempre, ambigua. Accanto alle minacce, lanciate anche contro Spagna, Irlanda e Portogallo – che a quel punto ammettono anche loro di non farcela a ripagare il debito – i politici formulano solo vaghe promesse, che rinnegano appena rientrati in patria per non scontentare il loro elettorato. Così per tre mesi l’appello disperato della Grecia e quello più timido del Portogallo e dell’Irlanda rimbalzano da un ingranaggio all’altro della macchina burocratica di Bruxelles, senza mai trovar risposta. Si perdono mesi preziosissimi nell’incertezza e questo ai mercati non piace. I prestiti esorbitanti sono stati concessi contro la garanzia dell’Unione europea e adesso quest’istituzione non li vuole onorare. Solo quando, a ridosso delle scadenze di primavera, si comincia a parlare di potenziale crisi d’insolvenza di uno dei membri dell’euro, allora ci si muove. Ma è tardi! Nella finanza il tempismo è fondamentale, l’esempio di Abu Dhabi è emblematico. Quando finalmente, insieme al Fondo monetario, si riesce a creare un pacchetto di aiuti per la Grecia, questo avviene sotto i riflettori della stampa e con le rivolte di piazza di Atene sullo sfondo, e ormai tutti sanno che non basteranno a colmare la voragine del debito nazionale. Tutti, inoltre, intuiscono che è iniziato il contagio e che la tragedia greca si ripresenterà in lingue diverse in Irlanda, Portogallo e probabilmente in Spagna e in Italia. L’Unione europea reagisce all’insolvenza della Grecia, come a quella potenziale del resto dei Piigs, prima di tutto negandola, illudendosi che si tratti solo di un problema di liquidità. Così, per un debito di 9 miliardi di euro (questo l’ammontare che a gennaio del 2010 Atene aveva chiesto all’Unione europea di garantire), la Grecia rischia la bancarotta, i Paesi Piigs un destino analogo e l’Europa un terremoto all’interno della moneta unica. Una ristrutturazione tempestiva del debito sotto la protezione europea sarebbe bastata a evitare il peggio. Dubai, con un debito di 30 miliardi di dollari, non solo è riuscita a dimezzarlo ma è rientrata, nel giro di tre anni e senza problemi, nel mercato internazionale dei capitali. Questa è la scelleratezza, questa l’incompetenza di chi ci governa. Contro questo insorgono gli Indignati dei vari Paesi. Che, non a torto, avanzano tuttavia il sospetto che non di sola incompetenza si tratti. Il clamoroso fiasco del debito sovrano incontrollabile, gridano in molti, è il risultato delle connivenze tra élite del denaro e potere politico. Bisogna porre fine a questa alleanza sciagurata per ricominciare a crescere, magari ridefinendo il concetto non più come incremento incondizionato, predatore e frenetico dell’attività economica, ma come processo evolutivo improntato sui principi di sviluppo umano, benessere sociale, sostenibilità ambientale, equa distribuzione delle risorse e così via. E per raggiungere questo obiettivo fondamentale è bene ascoltare la voce del popolo, come illustrano ancora più chiaramente altri esempi recenti. Fortunata l’Islanda che non aveva l’euro Nella tarda primavera del 2011 anche l’Islanda torna ad approvvigionarsi sui mercati internazionali dei capitali. E lo fa rastrellando un miliardo di dollari a poco più del 3 per cento. Sono passati pochissimi anni da quando, nel 2008, questa nazione ha creato scalpore scegliendo la strada della bancarotta contro il parere del Fondo monetario. Ma se è riuscita a ristrutturare un debito mille volte superiore al proprio Pil, è proprio perché ha riconosciuto che l’idea di difenderlo era semplicemente ridicola e quindi ha rifiutato di imporre alla popolazione sacrifici impossibili. All’epoca si sono sprecate critiche e minacce; Gordon Brown ha addirittura inserito l’Islanda nelle liste del terrore per congelare tutti i fondi delle due banche islandesi che operavano in Gran Bretagna. Quando poi la popolazione ha messo le redini del Paese in mano a un gruppo di donne, liquidando il governo ad alto tasso di testosterone dell’era dell’abbondanza, si è detto che gli islandesi si erano condannati a decenni di burro e pesce a colazione, pranzo e cena. Un grosso errore di valutazione. È opportuno rivisitare le tappe salienti della gestione della crisi islandese, perché anche in quel Paese la popolazione chiese di essere ascoltata e il successo dell’operazione si basò proprio sulla decisione di rimettere le decisioni-chiave alla volontà popolare. A settembre del 2008 si nazionalizza la più importante banca islandese, la Glitnir. Subito dopo crolla la moneta e la Borsa chiude i battenti. È ufficiale: il Paese è in bancarotta. A gennaio del 2009 le proteste dei cittadini di fronte al Parlamento provocano le dimissioni del primo ministro Geir Haarde e di tutto il governo composto dall’Alleanza socialdemocratica (Samfylkingin). Si va alle elezioni anticipate mentre la situazione economica resta precaria. Il Parlamento propone una legge che prevede il risarcimento del debito nei confronti di Gran Bretagna e Olanda, che tengono in ostaggio i fondi di due banche islandesi. Ciò significa garantire il pagamento di circa 4 miliardi di euro, un debito che avrebbe gravato su ogni famiglia islandese per la durata di 15 anni e con un tasso di interesse mensile del 5,5 per cento. La popolazione torna in piazza e chiede un referendum. I NO al pagamento vincono col 93 per cento dei voti. A febbraio del 2011 il presidente Ólafur Grímsson indice un secondo referendum consultivo popolare sul pagamento del debito alle banche internazionali. Le votazioni si tengono a marzo e i NO vincono con una maggioranza schiacciante. Nel frattempo, il governo ha avviato una serie di inchieste per determinare le responsabilità civili e penali di chi ha causato la crisi. Vengono emessi i primi mandati di arresto per diversi banchieri e membri dell’esecutivo. L’Interpol si incarica di ricercare e catturare i condannati: tutti i banchieri implicati abbandonano precipitosamente l’isola. Viene anche eletta un’assemblea per redigere una nuova Costituzione che possa incorporare le lezioni apprese durante la crisi e che sostituisca quella attuale (basata sul modello di quella danese). Per lo scopo, ci si rivolge direttamente al popolo sovrano: vengono eletti legalmente 25 cittadini, liberi da affiliazione politica, tra i 522 che si sono presentati alle votazioni. Gli unici due vincoli per la candidatura, a parte quello di non possedere tessere di partito, sono di essere maggiorenni e di disporre delle firme di almeno 30 sostenitori. La nuova Assemblea costituente inizia il suo lavoro a febbraio 2011 e presenta un progetto chiamato Magna Charta nel quale confluiscono la maggior parte delle «linee guida» stilate in modo consensuale nel corso delle diverse assemblee popolari che hanno avuto luogo in tutto il Paese. La Magna Charta sarà sottoposta all’approvazione del Parlamento immediatamente dopo le prossime elezioni legislative. Ecco un esempio di democrazia diretta di fronte alla catastrofe causata da quella rappresentativa. Oggi, grazie alla ristrutturazione del debito, il governo islandese è solvente e possiede un livello d’indebitamento vicino alla media europea e cioè tra l’80 e il 90 per cento del Pil, più basso di quello italiano o di quello greco. Come hanno fatto a riprendersi così velocemente? Uscendo dagli schemi rigidi del Fondo monetario! Il governo islandese ha diviso le banche deficitarie in due tipologie: quelle straniere, dove sono confluiti i debiti esteri, che hanno dichiarato bancarotta e negoziato la ristrutturazione del debito; e quella nazionale che invece è rimasta in piedi. Così, nonostante il sistema bancario si sia ridotto dell’80 per cento, la popolazione ha avuto accesso ai propri risparmi e al credito, e l’economia nazionale ha continuato a girare, anche se a ritmi ben più lenti rispetto a quelli degli anni ruggenti. Il governo ha negoziato con i creditori stranieri la ristrutturazione del debito, accollandolo alle nuove banche nelle quali però gli stessi creditori stranieri hanno investito. Perché? Perché il progetto era convincente. Oggi questi nuovi istituti di credito hanno una capitalizzazione di oltre il 16 per cento proveniente per il 90 per cento da depositi. Si tratta di banche ben più solide delle consorelle irlandesi e greche. La fortuna dell’Islanda è stata non potersi qualificare per il bail-out, il salvataggio da parte del Fondo monetario e dell’Unione europea, e non avere l’euro. La moneta si è potuta svalutare dando impero alle esportazioni. Dato che il crollo del suo sistema bancario non minacciava di contagiare il resto dell’Europa, nessuna grossa banca o istituzione era disposta a prestarle i soldi e quindi nessuno si è intromesso nella gestione delle sue finanze. Il governo ha poi avuto la lungimiranza di ascoltare i voleri della popolazione e di includerla nella formulazione del programma di salvataggio. È vero, l’Islanda è una nazione microscopica: 320.000 abitanti, tanti quanti una città europea di medie dimensioni. Ma questo modello può essere adattato a nazioni più grandi. Queste realtà gli Indignados spagnoli le conoscono. I loro slogan sono «Da grandi vogliamo essere islandesi», o ancora «Spagna in piedi: una nuova Islanda», è questo un chiaro riferimento ai movimenti di Hördur Torfason, che nel 2008 avevano provocato lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni, attraverso continui raduni popolari in piazza tenuti al sabato. Ben diversamente è andata all’Irlanda, una nazione che nel 2008 aveva problemi del tutto analoghi all’Islanda. Allora il governo di Dublino garantì tutti i debiti delle banche nazionali, una decisione che trasformò i soldi del contribuente irlandese in beni collaterali. La manovra ottenne l’approvazione delle agenzie di certificazione internazionali, dell’Unione europea e del Fondo monetario perché in fin dei conti difendeva l’euro. Ma il rovescio della medaglia è che i tedeschi e gli olandesi, che condividono la stessa moneta, difficilmente accetteranno di pagare il debito irlandese senza rimostranze quando questa nazione ammetterà che gli aiuti ricevuti nel 2011 non sono sufficienti. E allora l’Irlanda si troverà nella stessa situazione della Grecia e del Portogallo. È quello che pensa Moody’s che a metà luglio del 2011 ha abbassato anche il rating dell’Irlanda a livello junk, spazzatura. Oggi, mentre la popolazione irlandese si trascina un debito che non potrà mai ripagare, quella islandese se ne è liberata, e questo semplicemente ammettendo la vera natura della crisi: l’insolvenza. Ma perché dal 2008 si maschera questa realtà con una crisi di liquidità, perché si tratta un problema strutturale come fosse congiunturale, temporaneo? Perché nessuno vuole infrangere uno status quo obsoleto che ha però il vantaggio di garantire alle élite quei privilegi ai quali non vogliono assolutamente rinunciare. Il prezzo da pagare, per gli abitanti delle sponde nord del Mediterraneo esclusi dal festino delle oligarchie, è alto: enormi e inutili sacrifici, conditi da panzane come l’importanza delle politiche di austerità per il benessere futuro dell’economia. Il successo della ristrutturazione islandese ci dice che il popolo non ha paura di tirare la cinghia, che è disposto ad assumersi le responsabilità dei propri errori. Quando Reykjavík era la meta preferita dei banchieri di Wall Street gli islandesi non si sono domandati perché la loro isola facesse tanta gola all’alta finanza; nessuno oggi nega di essere caduto vittima del fascino ammaliatore del denaro facile. Ma la popolazione islandese non ha accettato quello che oggi neppure gli esclusi d’Europa vogliono accettare: che questi sacrifici vengano imposti dall’alto, senza consultarli, e per salvare prima di tutto i responsabili di questo disastro: le élite. La Rivoluzione francese ci ha insegnato che il popolo è sovrano. Ci siamo dimenticati però perché deve essere così: perché solo il popolo può fare gli interessi del popolo. Oggi la sua voce è quella degli Indignati, dei nostri figli e nipoti. Le moderne democrazie europee sono degenerate in oligarchie da basso impero che ignorano le proteste della strada. Ma come nel Nordafrica e nel Medioriente, gli esclusi sono stanchi di fare da tappezzeria ai baroni della globalizzazione, vogliono tornare al centro del palcoscenico. 8 Il bacino degli esclusi L’euro ha offerto vantaggi concreti a Paesi con economie completamente diverse tra di loro. Esiste dunque una complementarietà, che però nell’ultimo decennio non è mai andata oltre l’immediato guadagno. Per il resto, l’Europa non è stata capace di convergere in nulla. Fatta eccezione per la moneta e l’età media della popolazione – intorno ai quarant’anni in tutti i Paesi –, come si è visto, oggi gli indicatori economici delle nazioni appartenenti all’Ue puntano verso la disparità. A nord si cresce e a sud si va in bancarotta. Quanto a quelli sociali e culturali, non è daieri che i tedeschi hanno poco in comune con i greci, gli olandesi con i portoghesi, i belgi con gli spagnoli. Queste differenze, non l’euro, forgiano la politica delle singole nazioni che rimane essenzialmente individualista. Anche i Paesi del Nordafrica e del Medioriente, pur parlando la stessa lingua ed essendo in gran parte gestiti da regimi dittatoriali, non sono affatto omogenei tra di loro. In questa regione, a parte l’età media intorno ai venticinque anni, gli indicatori economici ci raccontano storie diverse, che cementano l’unicità dei popoli; storie complesse quanto quelle dei Paesi europei. Il Pil pro capite della Tunisia, ad esempio, è il doppio di quello del Marocco, dove però la disoccupazione è al 15 per cento mentre in Tunisia tocca picchi del 40 per cento. Non vuol dire che il mercato del lavoro marocchino sia più efficiente di quello tunisino. La prima nazione ha infatti un tasso d’emigrazione del 38 per cento, la seconda dello 0,4 per cento. La diversità, dunque, non l’omogeneità contraddistingue anche i Paesi a sud del Mediterraneo. Allora perché, viene spontaneo chiedersi, la frustrazione di un ragazzo tunisino, Mohamed Bouazizi, che si dà fuoco davanti al municipio della sua città, Sidi Bouzid, diventa la miccia di una rivolta transnazionale? E perché dalla riva sud il contagio si sposta a quella nord? Parentopoli Uno dei potenti comuni denominatori delle sollevazioni arabe è stato l’esclusione della popolazione da tutto ciò che ha a che fare con lo Stato: dall’economia alla politica estera, fino alle attività sociali e culturali. Tutto, ma proprio tutto, è in mano alle élite. E guarda caso anche in Israele ci imbattiamo nelle caste, un controsenso se si pensa che sessant’anni fa questo era il Paese dei kibbutz. Nell’Europa mediterranea non è molto diverso, anche noi abbiamo clan di individui e famiglie che controllano le posizioni-chiave e se le tramandano con un criterio ereditario degno della più antica aristocrazia. Per fare un esempio, diamo un’occhiata agli organigrammi dell’università italiana. All’inizio del 2010 Gianmarco Daniele, uno studente di Bari, ha presentato una tesi di laurea dal titolo L’università pubblica italiana: qualità e omonimia tra i docenti. Alla facoltà di Economia dell’Università di Bari, ad esempio, 42 docenti su 176, circa il 25 per cento, avevano tra loro legami di parentela. Una delle dinastie più affermate è quella dei Massari, commercialisti. Otto di loro sono docenti, e affermano «di aver vinto concorsi regolarissimi». Ma quello di Bari non è un caso isolato. Ce lo racconta Sabrina Giannini nella puntata del 15 maggio 2011 della trasmissione Report. «I professori ordinari italiani hanno un’età media di 58 anni, lo diventano 15 anni in ritardo rispetto ai colleghi europei e quelli con meno di 35 anni in Italia sono solo 11, lo 0,05 per cento. Ma è bruciare le tappe che aiuta la carriera. Se il primo gradino della carriera accademica, quella di ricercatore, si raggiunge mediamente, e per pochi fortunati, a 38 anni, già a 32 Gianmarco Tosi vinceva un concorso per ricercatore in malattie dell’apparato visivo. Segni particolari? Figlio del rettore Tosi che ha fatto sprofondare in un debito record l’Università di Siena, tra le varie cause del deficit anche la moltiplicazione delle cattedre. Quando vince il posto da ricercatrice ha soltanto 25 anni la figlia del presidente del Cun, il Consiglio universitario nazionale, Andrea Lenzi.» Il quotidiano «la Repubblica» ha sviluppato un indice che misura la percentuale di omonimia nelle università. Quanto incide parentopoli nei nostri atenei? I risultati sono preoccupanti. In quasi tutti gli atenei l’indice è molto più elevato della media nazionale: succede a Catania, Messina, Napoli (Federico II), Palermo, Bari, Caserta, Sassari e Cagliari. Le università più corrette sono invece Trento, Padova, il Politecnico di Torino, Verona, Milano Bicocca. Ce lo ricorda ancora una volta la trasmissione Report. «A Foggia Antonio Musco smette di fare il rettore il 31 ottobre. Il giorno prima, il 30 ottobre, diventa ricercatore il figlio. È il primo ricercatore italiano di Economia applicata a insegnare in una facoltà di Agraria. A Modena, è diventato ordinario nella facoltà di Odontoiatria un professore associato in Dermatologia, Giovanni Pellacani, figlio di Giancarlo Pellacani già rettore. A Bologna Alessandra Ruggeri a 35 anni diventa professore associato in Anatomia, anche se è laureata in Odontoiatria. Suona strano, un po’ meno che sia vicina al padre Alessandro, ordinario nella stessa facoltà. Luigi Frati che dal 2008 è il rettore della Sapienza di Roma, quando esce di casa non saluta i familiari, tanto li ritrova all’università dove tutti hanno vinto una cattedra, ovviamente la più prestigiosa, quella di ordinario, nella facoltà di Medicina di cui è stato preside per 16 anni prima di salire sulla poltrona del magnifico. «Paola Frati [moglie di Luigi], a 38 anni è professore ordinario di Medicina legale alla Sapienza, ma è laureata in Giurisprudenza, distinguendosi dalla quasi totalità dei colleghi d’Italia. È medico l’ultimogenito: Giacomo. Folgorante carriera anche per lui che a soli 28 anni è già ricercatore, a 31 diventa professore associato, discutendo una prova orale sui trapianti cardiaci. Ma nella commissione c’erano due professori di Igiene e tre odontoiatri.» Ed è ancora nel mondo accademico che si trovano i giovani martiri italiani del nepotismo che come il ragazzo tunisino s’immolano per protesta. A Palermo, nel 2010, Norman Zarcone, un dottorando di 27 anni, si è suicidato quando ha capito che per lui non c’era spazio nell’università. Anche in Francia il suicidio tra i giovani è la seconda causa di mortalità nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 24 anni. Parentopoli fa strage dei nostri figli! Uno dei problemi dell’Italia è la struttura corporativa delle professioni, terreno fertilissimo per le caste. Dai farmacisti ai notai per accedervi c’è bisogno di parentopoli. E si falsificano i concorsi come è accaduto nel 2010 per quello notarile, 200 posti, mille candidati e guarda caso alcuni già scrivevano prima della lettura delle tracce. Scoppia lo scandalo perché ci si accorge che su internet già prima della prova circolavano le domande. Quanti di questi concorsi sono truccati? Tutti? Siamo tutti fratelli Nel Nord Europa, in Germania, in Olanda, per non parlare poi dei Paesi scandinavi, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia, questo tipo di frustrazione è meno forte. Non a caso, in questi Paesi spesso la corruzione viene addirittura punita – in Gran Bretagna diversi deputati sono stati costretti a dimettersi per aver speso per motivi personali poche decine di sterline di denaro pubblico. Ma anche in queste isole meno infelici del bacino del Mediterraneo negli ultimi vent’anni abbiamo assistito all’avanzata delle élite privilegiate e al corrispondente impoverimento della classe media, sintomo della progressiva esclusione delle masse dalla vita pubblica. La parola d’ordine della democrazia è dunque «diseguaglianza». Secondo una ricerca della prestigiosa società di consulenza americana McKinsey, anche in Germania la classe media è in via d’estinzione. Nel 2000 era pari al 62 per cento della popolazione, nel 2010 era scesa al 54 e nel 2020 si prevede che sarà inferiore al 50. Causa principale, la sperequazione dei redditi, che fino a poco tempo fa sembrava appannaggio di regioni meno «modernizzate» come il Nordafrica e il Medioriente. Naturalmente nel Sud Europa la situazione è molto peggiore. La classe media, quella che guadagna tra i 20.000 e i 60.000 euro all’anno, corrisponde al 43 per cento della popolazione, ben 18 punti in meno rispetto agli anni Ottanta. Ma non basta, un quarto della popolazione appartiene ormai alla classe popolare, mentre un buon 20 per cento è già scivolato sotto la soglia della povertà. Dati confermati, ad esempio, dall’aumento del 40 per cento delle domande d’aiuto alla Caritas spagnola. Anche in Italia, Portogallo e Irlanda la situazione non è diversa. Uno dei motivi è il dislivello tra la crescita dei salari e quella del Pil, un fenomeno iniziato negli anni Novanta e consolidatosi nell’ultimo decennio. Nella relazione mondiale sui salari prodotta dall’Organizzazione internazionale del lavoro del 2008-2009 si legge infatti che dal 2001 al 2007, e quindi prima della crisi del credito, questi sono cresciuti meno del 2 per cento, e quindi sotto il tasso di crescita del Pil. A detta dell’Instituto Nacional de Estadística, il salario medio in Spagna nel 2006, quando si fece l’ultimo censimento, era di 19.680 euro l’anno. Quattro anni prima, nel 2002, era di 19.802 euro, dunque durante il boom economico i salari sono scesi. Anche nei Paesi arabi in rivolta riscontriamo lo stesso fenomeno. Che significano queste cifre? Che la ricchezza creata non viene equamente redistribuita ma finisce nelle tasche di pochi. E che questo è vero dovunque, anche nei democratici Stati Uniti. Il premio Nobel Joseph Stiglitz riferisce che l’un per cento della popolazione americana controlla il 40 per cento della ricchezza nazionale e che venticinque anni fa la situazione era ben diversa: il 12 per cento dei più ricchi possedeva il 33 per cento del patrimonio del Paese. In termini di ineguaglianza economica gli Usa assomigliano oggi alla Russia oligarchica o all’acerrimo nemico, l’Iran. Cosa è successo? È successo che quasi tutti i senatori e gran parte dei membri del Congresso americano ormai appartengono a quell’un per cento dei più ricchi, assieme ai finanziatori delle loro campagne elettorali. Anche gran parte del potere esecutivo proviene da questa élite. Quindi, scrive Stiglitz, non meravigliamoci quando le società farmaceutiche ricevono un dono di mille miliardi di dollari attraverso una legge che proibisce allo Stato, il loro maggior cliente, di negoziare i prezzi di acquisto. Solo che così va in frantumi il sogno americano, il mito di una nazione, quello dell’eguaglianza. Ed ecco perché anche su quella sponda dell’Atlantico si teme il contagio della pandemia democratica. La subordinazione dei politici occidentali all’élite del denaro è ben illustrata dai rapporti che questi intrattengono con le grosse banche. E per capire bene chi decide del destino di intere nazioni spostiamoci in Germania, la locomotiva economica dell’Unione europea. Nel primo trimestre del 2011 la Deutsche Bank, tra i detentori di una considerevole fetta del debito greco, riporta profitti pari a 3,5 miliardi di euro, entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare a 10 miliardi. Si tratta di guadagni record, destinati come se non bastasse a salire a 11 o 12 miliardi di euro nel 2012. Tutto ciò ad appena tre anni dalla crisi del credito e mentre Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna e Italia rischiano la bancarotta a causa dei debiti contratti con le banche internazionali, tra cui anche la stessa Deutsche Bank. Dov’è il trucco? Il miracolo, poiché in questo momento storico i profitti da capogiro della Deutsche Bank sembrano inspiegabili senza un intervento divino, lo hanno fatto uomini come Josef Ackerman, amministratore delegato della banca. Ackerman parla di «portare a casa il raccolto» riferendosi ai 10 miliardi di euro accumulati quest’anno. Linguaggio da agricoltore, insomma. E questo nonostante il governo degli Stati Uniti abbia citato in giudizio la Deutsche Bank per il suo comportamento incosciente nella concessione dei mutui subprime agli americani, in altre parole per aver gonfiato la bolla speculativa. Possibile che i raccolti di cui parla Ackerman siano i risparmi degli americani, le tasse degli europei, i sacrifici dei greci, l’austerità dei portoghesi? Che senso ha «portare a casa un raccolto» di 10 miliardi di euro mentre tutt’intorno le campagne bruciano e le città crollano a causa della probabile bancarotta dei Piigs e dell’esplosione dell’epidemia rivoluzionaria europea? Assidui frequentatori di Davos, i celebrati banchieri come Ackerman sono i cardini del sistema finanziario internazionale sul quale poggia il regime politico occidentale corrotto e oligarchico. Negli ultimi vent’anni tutti i Paesi occidentali, inclusi quelli più ricchi come la Germania e l’Olanda, sono diventati dipendenti dal mercato internazionale dei capitali. Se non può attingervi, lo Stato si ferma. Dunque Ackerman e una manciata di suoi cloni in gessato blu a capo delle grandi banche internazionali hanno in tasca le chiavi della cassaforte, decidono chi può accedere ai mercati finanziari internazionali e a quali condizioni, e chi come la Grecia, il Portogallo e l’Irlanda deve restarne fuori. Solo che la cassaforte non appartiene a un privato, ma a una nazione, dunque a un popolo. La cassaforte è la nostra. Insieme alle agenzie di rating, quelle che il giorno in cui la Lehman è crollata continuavano a darle AAA, le banche internazionali possono distruggere una nazione o salvarla dallo sfacelo. Ad agosto i mercati sono in caduta libera a causa della perdita della AAA da parte degli Stati Uniti, un colpo inflitto da Standard&Poor’s. E questo potere deriva dal denaro che noi gli abbiamo messo in mano. Oggi sono loro che controllano le difese contro il contagio, e a volte gli anticorpi sono bassi. È il caso dell’Italia, prima presa d’assalto dall’«Economist» che a giugno accusa Berlusconi di aver rovinato il Paese e poi a luglio da Moody’s che mette sotto inchiesta 18 banche e ventila dubbi sulla capacità nazionale di gestire un debito così grande. Nel giro di un fine settimana si apre la «crisi Italia» e inizia un altro circo. Riunioni d’emergenza dei ministri dell’Economia a Bruxelles, dichiarazioni da parte di chiunque, e la popolazione? Incassa allibita e preoccupata l’ultima scudisciata dei mercati, e si prepara a subire l’ennesimo salasso fiscale. Non a Washington o a Bruxelles, ma nel club esclusivissimo frequentato dall’alta finanza e dalle agenzie di rating, dove si entra solo se si appartiene allo 0,1 per cento dei super-ricchi del pianeta, si decidono le sorti del mondo. E guarda caso gli uomini e le donne che vi appartengono non sono stati eletti. Nessun governo può sfidarli: tassare le loro società, le transazioni delle banche per le quali lavorano, i loro patrimoni personali e così via. Questi individui sono al di sopra della legge. Ecco perché da tre anni si discute su come regolare il mercato finanziario senza mai arrivare a una decisione unanime. Anche se qualcuno volesse oggi far pagare ai soci di questo club gli errori che hanno commesso, sarebbe impossibile, perché gran parte della loro ricchezza si nasconde nei meandri di una ragnatela intricata di società di comodo che fa capo a qualche paradiso fiscale. Sfidare i sacerdoti dell’alta finanza vuol dire essere disposti a invertire la rotta, e cioè a fare a meno del credito. In tempi moderni l’hanno fatto l’Islanda e l’Argentina a un costo sociale considerevole. In passato ci hanno pensato due guerre mondiali a erodere questi privilegi e il prezzo in termini di vite umane è stato incommensurabile. Dobbiamo davvero arrivare a questo per avere giustizia? Perfino la ricca Germania non può fare a meno del sistema del credito, perché è condizionata dal rating delle agenzie di certificazione, che possono punirla in ogni momento sulla base dell’esposizione che le sue banche hanno al debito greco e del resto dei Piigs. Basta un dubbio ventilato alla stampa, una revisione «speciale» delle condizioni delle banche, come è avvenuto per quelle italiane da parte di Moody’s, per far salire i tassi dell’indebitamento di costosissimi punti percentuali o per mettere in crisi un governo già poco popolare. Morale: le nostre democrazie rapite sono diventate non solo oligarchiche, ma sono anche gestite dall’alta finanza internazionale. Vi presento i sequestratori. E in preda alla collettiva sindrome di Stoccolma continuiamo a sperare che costoro ci salvino dalla catastrofe economica. E se questa metafora non basta, eccone una seconda: è un po’ come essere stati conquistati e sottomessi da un Paese straniero, ma senza che ce ne rendessimo conto. Siamo tutti servi della gleba dell’aristocrazia dei potenti. Nel bacino del Mediterraneo l’unica convergenza che si è veramente sviluppata è questa: il dominio congiunto di dittatori senza scrupoli e oligarchie del denaro. Una catastrofe politica che poteva essere prevista. La debolezza dello Stato mediterraneo I Paesi mediterranei, a sud come a nord, presentano un altro comune denominatore: la debolezza della dimensione pubblica dello Stato, un terreno fertile dove ben attecchisce il malgoverno. Tutti i Paesi Piigs, inclusa l’Irlanda, sono affetti da questa malattia, che ne fiacca le giovanissime democrazie. Anche Israele soffre dello stesso morbo; sebbene sia una nazione mediorientale dal punto di vista geografico è socialmente occidentale. Nessuno ha alle spalle una tradizione secolare di Stato-nazione come la Francia o l’Inghilterra. Proprio perché la distanza storica da un passato torbido e buio è brevissima, le storie di dittature, guerre civili e violenza politica ancora popolano l’immaginario collettivo delle nazioni mediterranee. Nel 1965 la Grecia piomba nell’instabilità politica che apre le porte alla dittatura dei colonnelli, appoggiata dal governo americano. Il colpo di Stato militare avviene il 21 aprile del 1967. La politica economica dissennata della giunta e la rivolta degli studenti del Politecnico di Atene nel novembre 1973 provocano un altro colpo di Stato da parte del brigadiere Dimitrios Ioannidis, che instaura de facto una dittatura. Il 20 luglio del 1974, quando la Turchia invade Cipro in risposta al colpo di Stato greco per annettersi l’isola, il regime crolla. Durante questi anni la repressione militare alimenta la violenza politica e il terrorismo. La giovane democrazia muove i primi passi con le ferite ancora aperte di un passato violento. Anche in Italia la democrazia nata all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale emerge dal sangue versato dal fascismo e dalla guerra civile seguita all’armistizio di Badoglio; faticherà per decenni a levarsi di dosso le macchie scure di questo passato. Un partito, la Democrazia cristiana, governa ininterrottamente per trentacinque anni, da solo o in coalizione, grazie all’appoggio americano all’interno della logica geopolitica della Guerra Fredda. Dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, l’Italia è una democrazia bloccata dove governi instabili si alternano sullo sfondo dell’eversione violenta dell’estrema destra e sinistra. In Spagna il dittatore Franco muore nel suo letto nel 1975 lasciando il Paese nelle mani del re e di due partiti: il Psoe e il Pp che rappresentano due visioni politiche opposte, la prima socialista, la seconda conservatrice. La transizione non risolve il problema della violenza politica che ha caratterizzato tutta la dittatura di Franco. L’Eta, il braccio armato del separatismo basco, continua a uccidere, e lo Stato con i Gal, le squadre della morte, ripaga con la stessa moneta. Ancora oggi lo spettro del terrorismo è ben vivo in questa nazione. In Portogallo il dittatore Salazar rimane al potere fino al 1968. Nel 1974 con un colpo di Stato un gruppo di militari di sinistra depone il suo successore Marcelo Caetano e solo due anni dopo il Paese inizia la transizione verso la democrazia. Israele, infine, è l’unica di queste giovani democrazie che ancora soffre a causa del terrorismo. L’Irlanda, pur non appartenendo ai Paesi mediterranei è la nazione nordica che più ci assomiglia. Colonizzata dagli inglesi con un destino molto simile a noi del bacino del Mediterraneo, conquista l’indipendenza tardi attraverso moti rivoluzionari violenti ma rimane spezzata in due. Il Nord soffre le pene del terrorismo e della repressione violenta. Anche qui la democrazia è fragile, giovane e ingenua. L’ingresso nell’euro porta alla creazione di una bolla immobiliare e finanziaria che scoppia all’indomani della crisi del credito; da allora l’economia arranca. Gli Indignati europei sono fratelli, figli di uno stesso passato politico violento, dittatoriale, coloniale, sicuramente non democratico, e come gli altri fratelli arabi sono vittime di un sistema che non ha mai davvero metabolizzato l’eguaglianza. I Piigs sono Paesi in cui le generazioni attualmente al potere per lungo tempo non hanno potuto esprimersi politicamente attraverso il voto. Un imprinting devastante che dà loro maggiore familiarità con i codici comportamentali della dittatura che con quelli della democrazia. Altrimenti perché nel Nord Europa, fatta eccezione per il Regno Unito, non ci s’imbatte nello scollamento che esiste al Sud tra governanti e governati? Questa spaccatura nel cuore mediterraneo delle democrazie deficitarie le accomuna ancora una volta ai ribelli arabi e mediorientali. 9 Generazione (a meno di) mille euro Figli dei super-egoisti baby boomers, i giovani che affollano le piazze europee appartengono alla «generazione millennium», per molti aspetti di forte rottura rispetto al passato. La delocalizzazione, trasferendo gran parte della produzione in Asia, li ha esclusi dal sistema produttivo occidentale. Esistono in funzione di ciò che consumano, e infatti sin dalla nascita le corporation li hanno considerati «accessori» dei genitori e il marketing d’assalto li tiene costantemente sotto tiro. Per consumare sempre di più è stato loro insegnato che è giusto indebitarsi. I millennium sono una sorta di fantasmi del mercato del lavoro, la loro condizione di precari li rende invisibili in molte voci dello Stato: dalla pensione all’assistenza sanitaria. È quindi giusto dire che sono le prime vere vittime di un’economia disfunzionale, che ha geograficamente e socialmente scisso le funzioni di produzione e di consumo in tutto l’Occidente. Senza la sicurezza di un lavoro stabile, senza incentivi e senza Welfare, il loro unico ammortizzatore sociale è la famiglia. «Io sono senza stipendio da quattro mesi e allora, all’inizio di giugno, ho preso i miei due figli e sono andato a pranzo dai miei genitori. Non ho dovuto spiegare nulla. Hanno apparecchiato e solo alla fine mia madre ha detto: va bene alle 13 anche domani?» racconta un padre precario e ora disoccupato al quotidiano «la Repubblica». Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat sulla povertà in Italia, più di due milioni di giovani vivono con i genitori, senza lavorare né studiare. Cifre più o meno in linea con quelle del resto del bacino del Mediterraneo, Paesi, dunque, in via di sviluppo. Eppure l’Italia è la terza economia europea e la settima al mondo. Ma è proprio vero? Se improvvisamente nel calcolo del Pil potessimo inserire l’esercito dei fantasmi precari i risultati sarebbero ben diversi. La generazione millennium della sponda sud del Mediterraneo, quella che parla arabo e che si ribella, è però consapevole di essere cresciuta in un’economia disfunzionale e proprio per questo non possiede alcune delle caratteristiche dell’homo œconomicus classico: i concetti di possesso, di carriera, di status e l’individualismo sono forze meno motivanti rispetto ai coetanei europei. Ce lo spiega Tommaso, un giovane universitario romano. «Io faccio parte della generazione millennium e l’egoismo, il bisogno di possesso e l’individualismo caratterizzano ancora la maggior parte dei miei coetanei. Anzi, se in Italia ancora non è nato un movimento serio di protesta giovanile è proprio per questa ragione. Da figlio di ex sessantottini occidentali rimango ancora scettico sul fatto che in questo Paese vi possa essere un serio risveglio delle coscienze dei giovani nel breve periodo. La maggior parte dei miei coetanei non sta dicendo basta… Da noi chi non ce la fa più per ora scappa o soffre in silenzio.» Possibile che chi vive a sud del Mediterraneo sia un cittadino più consapevole di chi vive al nord? Soprattutto: possibile che i cugini arabi non abbiano ereditato dai genitori la rassegnazione e la paura che hanno caratterizzato quella generazione? Pare proprio di sì. Sembrano invece accomunare tutti i millennium spontaneità, improvvisazione e fiducia nel prossimo – i giovani europei non hanno mai conosciuto la guerra – e in questo somigliano un po’ agli hippy di ormai quarant’anni fa. Ma solo in questo. Perché la contestazione mediterranea, sia a sud che a nord, non è anticonformista, al contrario ha come obiettivo proprio gli accessori della normalità borghese: un lavoro, una casa, la possibilità di avere una famiglia. In tutto il bacino del Mediterraneo la generazione millennium, dunque, alimenta la rivolta perché non ha di fronte a sé alcuna prospettiva di crescita o di benessere. Sono i grandi esclusi del villaggio globale. I fantasmi del mercato del lavoro. La giovane età e il senso di esclusione sono potenti agenti del contagio rivoluzionario. Generazione P Gli spagnoli li chiamano «generazione mille euro», i francesi «génération précaire», i greci «generazione 700 euro» e gli italiani «generazione P» (dove la P sta per precari). Appartengono tutti alla generazione più istruita del Mediterraneo, poiché tutti, compresi gli arabi, hanno un livello di scolarità più alto rispetto al passato. Nella loro formazione sono state investite risorse di tempo e denaro che le generazioni precedenti non hanno mai sognato. E il loro destino è il precariato. Soltanto in Spagna si calcola che ci siano dieci milioni di precari che guadagnano mille euro o meno al mese. Ma probabilmente è una stima per difetto. Nel 1995 il salario medio spagnolo era di 16.762 euro l’anno, oggi al netto dell’inflazione equivarrebbe a circa 24.000 euro. Ma la metà degli spagnoli guadagna molto meno, appena 15.760 euro l’anno (meno dello stipendio mensile di un parlamentare italiano!). Non è diversa la situazione in Grecia o in Portogallo. In Italia, su una popolazione lavorativa di 20 milioni, dai 3 ai 5 sono precari con contratti a tempo determinato, senza diritti e senza organizzazioni sindacali ufficiali. Molti di loro operano nel settore della cultura, ad esempio giornalisti di talk show di denuncia, o in case editrici che pubblicano libri contro la cattiva politica, quasi tutti con contratti a tempo determinato o con partita Iva. Dunque chi per mestiere si scaglia contro gli scandali del sistema ne è a sua volta vittima. Ovviamente i compensi di questi ragazzi sono una frazione infinitesimale dei salari da favola dei pochi che guadagnano davvero, ovvero consulenti, conduttori, dirigenti. La mancanza di sicurezza lavorativa condiziona l’esistenza delle nuove generazioni al punto da far dimenticare loro i propri diritti. Si vive all’ombra della disoccupazione e si ha paura di rendere pubbliche le proprie vicende di sfruttamento per timore di perdere la propria condizione di schiavi, come ci racconta una guida precaria sul sito giovaniprecari.splinder.com. «Io sono una guida, ho lavorato in molti musei. In genere si lavora a contratto a progetto. Ho un contratto fino al 2009, vengo pagata a ore. Settimanalmente ricevo la pianificazione del lavoro. In genere sono trenta ore alla settimana. In tutti i musei in cui ho lavorato c’era il tacito messaggio: più stai buono, sei puntuale, non protesti, sei affidabile, ci stai simpatico, e più ti diamo ore, se non ci piaci molto te ne diamo meno. Così da me ci sono guide con trenta, quaranta ore settimanali e guide che invece possono lavorare solo cinque o sei ore alla settimana. Non vengono date spiegazioni e se richieste la risposta è sempre la stessa: non c’è lavoro. Però perché per uno sì e uno no?» Il sistema vive esattamente su questa mancanza di vie d’uscita e di potere contrattuale. Ai precari Rai, ad esempio, viene chiesto di firmare un documento dove rinunciano a qualsiasi rivendicazione nei confronti del datore di lavoro, a chi non lo fa non viene rinnovato il contratto. Nessuno si ribella. Il sindacato tradizionale si limita a proteggere i lavoratori assunti a tempo indeterminato, già garantiti, ma si guarda bene dall’ergersi a paladino di una categoria considerata «a perdere». Che dire dei trenta direttori Rai «dormienti», che si portano a casa 200.000 euro l’anno per essere «parcheggiati» a via Teulada? A chi abbia voglia di farsi una cultura su queste istituzioni e sulle ingiustizie da esse perpetrate consiglio la lettura dell’articolo di Emiliano Fittipaldi Rai, ecco gli stipendi pubblicato dall’«Espresso» nel giugno del 2010. La pratica della partita Iva è un altro ricatto. Persino nei ministeri si chiede agli impiegati appaltati da società private di aprirla e anche le grosse multinazionali che lavorano per lo Stato la applicano, spesso anche da un momento all’altro. È quello che è successo a un manager trentanovenne trasformato in pochi frettolosi minuti in libero professionista, dopo otto anni da dirigente in una multinazionale di servizi ospedalieri. Ecco il suo racconto, pubblicato sul sito della «Repubblica». «Era un venerdì pomeriggio quando venni chiamato dal mio capo. Ho una notizia cattiva e una buona, mi disse velocemente. La cattiva è che il tuo contratto si trasforma in consulenza, la buona è che il trattamento netto migliora. Poi mi mise in mano la lettera di licenziamento. Ma cos’è cambiato? Nulla. Stesso orario, stesso ufficio, stesso lavoro. Ma per l’azienda io non sono più un costo, bensì un investimento.» Un investimento che naturalmente non ha diritti e del quale ci si può sbarazzare legalmente in ogni momento. La partita Iva è anche una forma di trasferimento della ricchezza dal precario allo Stato, come ci racconta Astrid D’Eredità, 31 anni, archeologa precaria, ancora sul sito del quotidiano. «Si inizia all’apertura del cantiere, insieme agli operai. Alle sette, sette e mezzo del mattino. C’è la pausa pranzo e poi fino alle quattro del pomeriggio. Retribuzione tra i quaranta e i cento euro netti al giorno, per una media di due settimane al mese. Cottimo postindustriale. Noi archeologi siamo quasi tutti a partita Iva. Una formula capestro, anche dal punto di vista fiscale: ci dissanguano. Scarico poco più che le spese per il cellulare. Di fatto siamo lavoratori subordinati con tutti gli svantaggi fiscali di non esserlo ufficialmente.» Nella guerra tra poveri scatenata dalle oligarchie mediterranee i precari e i migranti sono le vittime senza voce. Nella primavera ed estate 2011 in Italia si scatena un dibattito feroce sui contratti dei lavoratori Fiat di Pomigliano d’Arco, intellettuali e politici si schierano in difesa di alcune centinaia di lavoratori della Fiom. Ma nessuno alza un dito per i cinque milioni di precari che sgobbano dalla mattina alla sera per un salario letteralmente da miseria. In gran parte delle università, ad esempio, un modulo d’insegnamento può essere pagato dai trecento ai mille euro lordi l’anno; si tratta di moduli che vanno dalle 30 alle 45 ore di lezione più tutta l’attività relativa alla didattica, dagli esami ai ricevimenti degli studenti. Ma i sindacati lo sanno cosa succede fuori del recinto sempre più piccolo del lavoratore garantito? Ce lo racconta la fotografa (precaria) Chiara Schiaratura, ideatrice del progetto Ritratti di precari. «Lavoro a chiamata, come un bracciante del terziario, presso uno studio di grafica e siti web» scrive Michele. «A volte mi fanno fare il grafico con fotografie di un’importante marca d’abbigliamento sportivo, altre volte sfrutto i miei studi linguistici universitari applicandomi come traduttore francofono, altre volte scrivo di mio pugno articoli per il web. Quando mi chiamano guadagno 5 euro all’ora o 2,09 euro a pezzo tradotto. Il mese scorso ho fatturato 460 euro, che ancora non mi sono stati liquidati. Questo mese invece dovrei arrivare sui 250-300 euro, se non ho sbagliato i conti. Il giorno in cui potrò andare in banca e l’omino dietro lo sportello mi darà tutti quei soldi, tutti assieme, per un’ora mi sentirò ricco.» Marx sicuramente si sta rivoltando nella tomba insieme non solo a tutti i grandi rivoluzionari, ma anche a tutti gli economisti classici. Ci troviamo in un sistema feudale dove esistono gradi di privilegio e sfruttamento che dipendono nientemeno che dalla nascita, una prigione da dove non si può scappare. E questo non è solo ingiusto, è anche la ricetta per la rovina delle nostre economie. La disoccupazione è lo spauracchio di tutte le nuove generazioni mediterranee, un film dell’orrore di cui i nostri figli si sono ritrovati protagonisti. Altro che Harry Potter, questo è il blockbuster del millennio, il neorealismo mediterraneo. Prima dello scoppio della crisi del debito sovrano, oltre il 30 per cento dei giovani compresi tra i 18 e i 24 anni era disoccupato in Grecia, Francia e Portogallo. Oggi sono ben di più. Perché sorprendersi se quelli che lavorano si trovano a difendere il privilegio di essere sfruttati? Meglio precari che a spasso. Trovare un lavoro è come trovare un tesoro. Negli anni Ottanta i diplomati dovevano aspettare una media di due anni, oggi ce ne vogliono dieci. Quando poi lo ottengono percepiscono gli stessi salari degli anni Novanta, e quindi troppo bassi per mantenersi. In Francia, ad esempio, gli impiegati di età inferiore ai trent’anni guadagnano il 40 per cento in meno dei cinquantenni, mentre nel 1968 la differenza salariale era di soli 14 punti percentuali. Non a caso gli Indignados nascono in Spagna. Dei 6 milioni di lavoratori assorbiti dal 1997 al 2010, la metà di chi ha tra i 18 e i 35 anni è ancora precario, 3 milioni secchi su una popolazione attiva di 23 milioni. Non sorprende quindi che il 26 per cento di questi giovani ancora viva con i genitori. L’assurdità è che un tempo i giovani aiutavano gli anziani, adesso è vero il contrario. Il numero di ragazzi spagnoli che possiede un’indipendenza economica è sceso dal 24 per cento nel 2004 al 21 per cento nel 2008; sebbene i dati per il 2010 non siano stati ancora pubblicati, ci si aspetta un ulteriore calo di questa percentuale. Si tratta di un fenomeno generale che accomuna tutto l’Occidente. Allo stesso tempo il numero degli studenti cosiddetti «vecchi» è aumentato vertiginosamente. A detta dell’ufficio della Commissione europea che si occupa delle politiche giovanili, il 15 per cento degli studenti europei a tempo pieno ha già compiuto trent’anni. Come mai? Perché l’istruzione è sia un parcheggio psicologico, che motivo di speranza. Peccato le statistiche ci dicano che la maggiore scolarizzazione in tarda età non aiuta affatto a entrare in pianta stabile nel mercato del lavoro. La percentuale di coloro che hanno un contratto a tempo determinato e che non riusciranno a trovarne uno a tempo indeterminato non scende con il grado d’istruzione ma aumenta con l’età: dal 37 per cento tra i 15 e i 24 anni al 65 per cento tra i 25 e i 29. In queste condizioni la vita diventa difficile e l’indipendenza un sogno irrealizzabile. Il 47 per cento dei giovani italiani compresi nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni vivono in famiglia, perché non possono fare altrimenti. In tutti i Paesi Piigs si sopravvive con l’aiuto dei genitori. Nel 2007 l’ex ministro delle Finanze italiano Tommaso Padoa-Schioppa definì i millennium «bamboccioni», attribuendo la responsabilità dei loro insuccessi lavorativi a pigrizia o scarso spirito d’iniziativa. Un insulto e un errore concettuale. Perché questi ragazzi sono le vittime, e non certo la causa dei nostri fallimenti. Ce lo conferma Anita, una vulcanologa. «Ho 41 anni e sono precaria da sempre! Andare all’estero? Già fatto! Dopo la laurea sono stata più di 4 anni in Inghilterra per un PhD, bellissima esperienza. A quel tempo c’erano tante possibilità: rimanere in Inghilterra, andare negli Stati Uniti, ma decisi di tornare in Italia, perché se non torni subito non torni più. Sembrava tutto bello e forse potrebbe ancora esserlo se non ci fosse questa incertezza strisciante. Adesso non sono sicura di volermi spostare. Ho due bambini, la seconda avuta con un salto nel vuoto più totale, una scommessa contro tutto, ma ce l’ho fatta, nonostante i contrattini di due mesi, i co.co.pro dove si racimolavano i soldi con fatica. Adesso “sto bene”, ho un contratto fino al 2012 perché sono stabilizzanda dell’Ingv. Mio marito, inutile dirlo, è un precario della ricerca, anche lui.» Alla classe politica italiana, maestra in demagogia, fa comodo buttare tutte le colpe sulle spalle dei giovani, sviando l’attenzione dalla propria incompetenza e scorrettezza. Così nel 2009 il ministro Renato Brunetta prima suggerisce di cacciare i giovani di casa e poi di sottrarre 500 euro ai pensionati per dare loro una sorta di paghetta. Infine nel 2011 durante una conferenza stampa rifiuta di rispondere alla domanda di una rappresentante dei precari sulle scarse prospettive di occupazione per i giovani dicendole: «Siete la peggiore Italia». La generazione millennium è, al contrario, vittima di un sistema perverso che impoverisce l’Occidente, creato proprio da politici che considerano il loro lavoro non un servizio alla collettività ma uno strumento per arricchirsi. E questo sistema marcio, che oggi è sotto attacco da parte della finanza internazionale, da almeno due decadi costringe i nostri figli ad accontentarsi di molto poco, come ci racconta in un’intervista l’avvocato bagnino: «Io sono laureato in Legge da quasi dieci anni e mi sento contento di aver trovato un lavoro da bagnino a 6 euro netti l’ora scarsi, dopo essere stato disoccupato diversi mesi e non aver ricevuto neanche una risposta alle centinaia di curriculum inviati. Vedo intorno che la stessa cosa capita a molti amici e credo che questa sia una cosa gravissima. Mi sembra altrettanto grave che molti di noi appaiano rassegnati e considerino tutto ciò come ineluttabile». È vero che la rassegnazione contraddistingue la generazione P dell’Europa mediterranea? O forse come direbbe Marx a questi ragazzi manca la coscienza di classe, la consapevolezza di appartenere a una categoria che in fondo tiene in piedi il Paese? Esiste ancora oggi una dicotomia marxiana, che la sinistra tradizionale, quella che da tempo ha perso la bussola, si rifiuta di riconoscere? Se la risposta è sì allora l’esclusione dei millennium dal sistema di produzione ha un significato diverso, più deviante. Il capitalismo mediterraneo è ormai un capitalismo povero che per contrastare la caduta tendenziale del saggio di profitto dopo aver delocalizzato in Asia adesso delocalizza anche a casa propria grazie al precariato. I precari sono il pilastro su cui si regge il sistema di produzione, l’ultimo. Dall’amministrazione pubblica alle scuole, dalle aziende alle piccole fabbriche, per non parlare degli ospedali: medici, infermieri, portantini. Sono loro, non il mercato del credito internazionale, l’unica speranza dell’economia mediterranea, perché sono loro a lavorare, loro a produrre, loro a garantire i profitti di una classe di, appunto, profittatori che senza questi ragazzi avrebbero già trascinato in rovina se stessi e il Paese. La Fiat, i sindacati e tutto Montecitorio sono i vecchi e decrepiti mammut dello zoo moderno e non tengono in piedi il Paese. È quello che ci racconta sul blog PrecarieMenti Giulia Farzi, una precaria davvero coraggiosa che lavora in un Centro per l’impiego, quello che una volta era l’Ufficio di collocamento. «Da tre mesi sono passata a un contratto a tempo determinato, grazie a un concorso. È migliorata la mia posizione contrattuale, ovviamente. Adesso ho le ferie retribuite, ho la mutua se mi ammalo, maturo il Tfr, prenderò la tredicesima e la produttività. Tutte cose che non avevo quando ero co.co.co. Quando ero co.co.co. prendevo 750-800 euro nel mese in cui facevo le ferie estive, contro un massimo di 1250 euro. Stare a casa qualche giorno voleva dire prendere almeno 100 euro in meno il mese dopo, e quando si è indipendenti, c’è un affitto da pagare, una visita da fare e scadenze da rispettare, 100 euro fanno la loro bella differenza. «Anche essere precaria e lavorare il doppio di certi comodi colleghi della vecchia guardia, fa la differenza. Vuol dire ingoiare certi rospi, certe incazzature che sono solo tue, non ti portano da nessuna parte. L’entrata dei precari nella pubblica amministrazione ha significato anche questo: gente volenterosa per piacere e per forza, gente “fresca”, capace di rapportarsi al pubblico in modo completamente diverso. Vedo questo tutti i giorni da sette anni e mezzo. «Se domani non andassimo a lavorare, il Centro impiego si fermerebbe. Non sarebbe più garantita l’efficienza degli sportelli iscrizioni, dell’ufficio disabili, sparirebbero i servizi di orientamento e preselezione. È quello che potrebbe succedere se non ci venissero rinnovati i contratti, se a un certo punto ci dicessero: “Non c’è più posto per voi, grazie tante e arrivederci”. E potrebbe succedere. Cinque, sette, dieci anni di lavoro precario, malpagato, di costruzione faticosa di una competenza professionale, di fornitura di un servizio qualificato a persone in difficoltà buttato nel vento, infilato in un cassetto, dimenticato.» Se questi giovani prendessero coscienza, cosa che stanno facendo, quella «P» di «generazione P» potrebbe significare qualcos’altro, ad esempio «Potenza», la stessa della vecchia classe operaia. 10 L’arma dei social media I millennium sono anche la generazione del Web 2.0, la prima totalmente a suo agio nel mondo cibernetico ed è proprio in questa dimensione astratta, dietro i monitor dei computer e gli schermi dei telefonini che c’imbattiamo nella loro vera forza. Nessuna generazione rivoluzionaria che li ha preceduti aveva a disposizione uno strumento tanto potente come il web. E infatti i social network hanno contribuito immensamente al successo delle rivolte tunisine ed egiziane, come pure alla creazione di una rete internazionale che lega tutti i Paesi in rivolta. Ad agosto gli Indignados spagnoli lanciano l’idea di emulare ciò che sta avvenendo in Israele, e cioè creare un’assemblea dove la società civile possa dialogare con i poteri forti dello Stato. E questo avviene, naturalmente, in rete. A Londra Twitter ha permesso alle gang di muoversi a piacimento da una strada all’altra ma ha anche dato la possibilità ai comuni cittadini di evitare le zone calde grazie alle notizie che circolavano sugli smartphone in tempo reale. Gli unici a esserne tagliati fuori sono stati gli agenti delle forze dell’ordine che per almeno 48 ore non sono stati in grado di contenere la violenza urbana. Sono consapevoli questi giovani del potere nelle loro mani? Una domanda difficile perché siamo solo agli albori della rivoluzione democratica informatizzata. Ma una cosa è già chiara: internet non è un mondo alternativo fatto principalmente di videogiochi e voyeurismo personale. Piuttosto la rete offre ai giovani la possibilità di fruire di una nuova dimensione sociale, che amplifica quella reale senza per forza sostituirsi a essa, consentendole di aumentare il suo potenziale di condivisione, coinvolgimento e mobilitazione. Che significa? Che invece di diventare un cyberspazio separato, la rete si sta radicando profondamente nella nostra vita, anche in quella dei meno giovani. Su YouTube genitori e nonni tunisini osservano il video del rapper il Generale, nome d’arte di Hamado bin Omar, che grida: «Presidente, il tuo popolo muore». Questo diventa l’inno della sommossa tunisina, viene visto e rivisto da centinaia di migliaia di persone. Egualmente la notizia della morte di Mohamed Bouazizi dopo venti giorni d’agonia corre come una corrente rivoltosa, virale, da un cellulare all’altro. YouTube e Twitter hanno rotto il monopolio dell’informazione in un Paese, la Tunisia, dove i media tradizionali da vent’anni sono sotto lo stretto controllo del regime. Senza di loro il mondo intero non avrebbe mai potuto sapere che era scoppiata la rivoluzione, né sarebbe stato cosciente della repressione in Bahrain o della nascita delle tendopoli di protesta a Tel Aviv. Quelle notizie e immagini di guerriglia trapelate ogni giorno dal web a grande velocità hanno aperto gli occhi al pianeta. Ed ecco perché, per la prima volta nel mondo arabo, si verifica un effetto-contagio che va ben oltre le frontiere nazionali, un’infezione rivoltosa virale che passa direttamente per la società civile, fuori dal controllo delle istituzioni. Un assaggio della forza prorompente dell’informazione cibernetica attraverso il web ce lo ha dato nel 2010 WikiLeaks, che è riuscito a far tremare le gambe ai governi occidentali grazie a una penna Usb, un server ben protetto e un sistema di file-sharing praticamente inattaccabile. Ciò che colpisce però all’inizio del 2011 è l’utilizzo dei social network nel Maghreb. Non è certo la prima volta che si usano gli smartphone, basti ricordare il ruolo determinante di Twitter nella rivoluzione verde iraniana all’indomani delle contestatissime elezioni presidenziali del 12 giugno 2009. Il Maghreb è però considerato un’area più arretrata dell’Iran eppure è proprio qui che l’impatto dei social media è massimo. La Tunisia è il Paese africano in cui Facebook è più diffuso. Si calcola che circa il 18 per cento dei tunisini abbia creato un suo profilo. Ciò spiega anche la velocità di trasmissione dei messaggi e quella di movimento dei manifestanti. La capacità logistica degli apparati di polizia, che devono costantemente rincorrere i rivoltosi, non è in grado di contenere la folla. La polizia rimane intrappolata in una corsa frustrante e continua che la spinge verso comportamenti violenti e a volte anche omicidi. È il caso del Nordafrica ma anche dell’Inghilterra. Qui la polizia è in netto svantaggio e lo si vede dai video agghiaccianti delle strade in fiamme della capitale. Tutto viene filmato e messo in rete con la stessa velocità con cui si inviano i messaggi su Twitter, e il mondo intero finisce per assistere quasi in tempo reale a ciò che avviene nelle città in rivolta. Il web diventa una cassa di risonanza internazionale imbattibile. Di fronte a questi nuovi scenari controllare i network televisivi e d’informazione tradizionali non serve più a nulla, bisogna mettere le mani sulla rete ma questo non è possibile, o più precisamente è possibile solo in parte: chiudere una pagina web invisa al regime diventa inutile se dopo qualche giorno ne nascono altre dieci, è la frammentazione a indebolire un potere eccessivamente centralizzato. Ciò che preoccupa maggiormente i regimi autoritari è l’impossibilità di alterare i contenuti alla base del dissenso e i simboli in grado di catalizzarlo, come il testo della canzone del Generale. È un grave colpo alla propaganda dittatoriale. Ma a giudicare dai tentativi di David Cameron di bloccare i social media ciò è vero anche per i regimi democratici. Il grande imbroglio Durante le rivolte tunisine Al Jazeera ha raccolto le informazioni diffuse su internet dai cittadini usandole come fonti e ha organizzato dei gruppi su Facebook, trasmettendo poi gratuitamente le notizie sui cellulari. Così è nato un nuovo sistema di comunicazioni di massa costruito come un mix interattivo tra Tv satellitare, internet, radio e sistemi di comunicazione mobile. A Londra invece è stata la società civile a mobilitarsi da sola e attraverso Facebook e Twitter ha organizzato la pulizia nelle strade dopo le notti di devastazione e saccheggio. Questo stesso mix di social media e media tradizionali in mano alla società civile, che ci permette di sapere cosa succede davvero, ad esempio in Siria, fa da cornice alla caduta di Rupert Murdoch in Gran Bretagna. Scopriamo una rete di corruzione che va dall’impero di Murdoch a Scotland Yard e passa per tutte le cariche politiche più importanti del Paese. Nessuno scampa alle intercettazioni telefoniche. Durante l’interrogatorio dei parlamentari britannici, descrivendo le visite continue ai primi ministri britannici, il vecchio Murdoch sospira: «Speravo tanto che mi lasciassero in pace». Lo scandalo delle intercettazioni porta la data del 2011 perché giornalisti professionisti come Nick Davies hanno in mano nuovi strumenti d’informazione per farlo scoppiare, da Twitter a Facebook. È la minaccia dei social network che spinge Cameron e tutta la classe politica britannica a uscire allo scoperto contro gli ex amici. Poiché di questo si tratta. Murdoch e i suoi fedeli cavalieri hanno intrattenuto relazioni personali con ministri e primi ministri sia laburisti che conservatori. «News of the World», il giornale di lingua inglese più letto al mondo, ha appoggiato prima gli uni e poi gli altri nelle loro campagne elettorali. Chi le ha vinte non sono coloro che rappresentano il popolo in Parlamento, ma chi sussurra ogni giorno nelle nostre orecchie la storia della verità, una favola inventata negli uffici faraonici di News International. In Italia la situazione non è diversa, lo sappiamo tutti, ma anche in Francia, in Spagna e nel resto del mondo tra le élite politiche e quelle dell’informazione esiste un sodalizio pericoloso. In Tunisia e in Egitto ci sono i media di regime ma anche a casa nostra la libertà di stampa non esiste, è solo un’illusione. La joint venture tra politici ed élite del denaro non avrebbe mai potuto funzionare senza la propaganda dell’informazione. Gli imperi occidentali dell’informazione nascono con la caduta del Muro di Berlino e si consolidano nel ventennio della globalizzazione. Perché? Anche l’informazione come tutto il resto si appiattisce. Scompare la guerra di propaganda tra stampa di sinistra e stampa di destra e nasce un tipo d’informazione consona al sistema. Ecco perché Murdoch può appoggiare ora un partito ora un altro. Chiunque voglia scalare le vette del potere politico deve farlo inserendosi in una cordata guidata da uno dei magnati dell’informazione. Giornalisti incalliti diventano da un giorno all’altro responsabili della comunicazione dei politici per i quali svolgono la stessa attività di propaganda che fino a pochi giorni prima hanno svolto per testate scandalistiche o per normali organi di stampa. Questo mondo inizia a crollare quando entrano in scena i social media e l’iPhone. Solo allora il cittadino ha i mezzi per smascherare il grande imbroglio. Perché la rivoluzione scoppia in Tunisia nel 2011 e non nel 2008 con le rivolte a Gafsa e a Gassrin contro i risultati di concorsi truccati che hanno prodotto sette mesi di manifestazioni e sit-in? Perché la rete, gli smartphone hanno raggiunto la massa critica necessaria per contrastare la propaganda di regime nel 2011. E questo spiega anche perché in Italia, uno dei Paesi occidentali dove ancora ci si informa molto con la televisione e dove la macchina propagandista dell’informazione di regime è più avanzata, questa rivolta tarda a venire. 11 Basta! Viene voglia di gridare: «Generazioni vessate e sfruttate di tutt’Europa unitevi!». E infatti è proprio questo il mantra che sulle ali di Twitter e Facebook dal Nordafrica arriva fino alle sponde europee del Mediterraneo: giovani di questo mare alzate la testa e domandate l’impossibile, una vita dignitosa! I ragazzi arabi che hanno riempito le piazze delle loro capitali, e che sono tornati a gremirle anche dopo la caduta di dittature decennali per assicurarsi che il processo di cambiamento democratico funzioni, hanno detto basta. E lo hanno fatto perché rifiutano la vita di rassegnazione che hanno condotto i loro genitori. Meglio rischiare l’ira del potere in piazza. Adesso è la volta dei nostri figli, le decine di milioni di precari e disoccupati delle nostre economie. Anche loro non hanno da perdere altro che le loro catene. Alcuni ci stanno già dando una lezione. Cresciuti nella società materialista, dove il motto era «consumo quindi esisto», stimolati costantemente da genitori che hanno accumulato e sperperato ricchezze, cominciano a rifiutare questo modello che sottrae risorse alle generazioni future. Gli Indignati europei non sanno che farsene del valore del superfluo tramandato dai loro genitori, e tra loro ci sono i capofila della decrescita, del consumo etico, del rigore. Una casa, un lavoro, una famiglia e una vita sostenibile, questo chiedono, e non la carta oro, l’auto nuova ogni due anni, le vacanze esotiche. E possono permettersi di rifiutarsi di salvare le banche, visto che non hanno mai avuto la possibilità di risparmiare. La classe media era la spina dorsale dello Stato democratico moderno, del benessere postbellico, perché attraverso le tasse e i risparmi lo finanziava. Oggi l’impoverimento dei Piigs è anche e soprattutto legato a quello della classe media, che, come abbiamo visto, continua a sprofondare nella povertà. Il contributo fiscale dei precari, per lo più figli di questa categoria sociale, è ovviamente assai minore rispetto a quello dei genitori, che alla loro età possedevano un lavoro stabile e ben retribuito sul quale pagavano le tasse. Mettiamo a confronto la vita di due segretarie, madre e figlia, che ho incontrato in treno. «Faccio la segretaria, esattamente come mia madre. Tutte e due volevamo un lavoro tranquillo e sicuro, senza pretese, che alle cinque ci permettesse di uscire dall’ufficio e tornare alla nostra vita. Solo che io ho cominciato venticinque anni dopo di lei e anziché avere uno stipendio regolare, ferie e maternità, mi ritrovo con un contratto a progetto. Appena diplomata prendevo 300 euro al mese, ma era il miglior studio della città, pensavo che sarebbe stato utile per il curriculum e mi sarei ricollocata facilmente. In dieci anni ho cambiato quattro lavori, sempre come segretaria, e mai una volta ho spento il computer alle cinque. Quando va bene sono le sei, spesso le sette. Ora finalmente prendo 900 euro lordi al mese, tranne in agosto e in dicembre: con la scusa della chiusura aziendale mi decurtano lo stipendio per le settimane in cui non lavoro. E lo stesso se mi ammalo. Di restare incinta, ovviamente, neanche a parlarne: chi me lo paga questo lusso?» Non è solo il racconto di una sconfitta sociale e politica per il sistema a cui questa ragazza appartiene, è anche la descrizione di una catastrofe economica incombente. Perché il contributo fiscale della figlia è di gran lunga inferiore a quello della madre. Colpa dell’economia! Ma torniamo dai cugini arabi. Anche in questa regione dilagano il precariato e la disoccupazione giovanile. E non a caso la rivolta inizia in Tunisia, il Paese più colpito dalla crisi finanziaria perché maggiormente integrato nell’economia neoliberista occidentale, e anche quello con la struttura economica più moderna e l’indice di scolarità più elevato. La crisi del credito e la conseguente recessione producono in tutto il Nordafrica e nel Medioriente una contrazione dell’economia. Dal 2007 al 2009 il tasso di crescita della Tunisia, ad esempio, si dimezza, da 6,4 scende al 3,3 per cento. Durante lo stesso periodo la creazione di nuovi posti di lavoro si contrae da 80.000 a 57.000. Chi ne subisce le conseguenze sono i giovani istruiti: aumenta la disoccupazione intellettuale e anche la frustrazione. Tutto ciò mentre le élite al potere escono indenni dalla crisi. La cacciata di Ben Ali, dunque, simboleggia la vittoria di una classe di esclusi su una privilegiata. In Tunisia, dove per un ventennio si registra una crescita media del 5 per cento, superiore perfino a quella dell’Algeria – Paese ricco di risorse quali il gas naturale – non è mai esistito un meccanismo di redistribuzione della ricchezza. Quel 5 per cento di crescita annuale non si è tradotto in salari più alti né in servizi sociali migliori, come scuole e ospedali. L’insurrezione tunisina, dunque, non è priva di storia e di organizzazione. La sua genealogia è lunga, fatta di mobilitazioni e lotte che si possono far risalire quantomeno agli scioperi nel distretto minerario del 2008. Chi invece si arricchisce grazie alla liberalizzazione dei mercati è una borghesia d’affari senza scrupoli, molto vicina al potere e ben decisa a mantenere i privilegi e gli apparati coercitivi che bloccano la concorrenza. Gli strumenti del libero mercato applicati a Paesi come la Tunisia o l’Egitto, gestiti da dittature brutali, i cui soci in affari sono le élite del denaro, finiscono dunque per avere l’effetto opposto a quello desiderato, almeno a parole, dai loro fautori occidentali: impoveriscono la popolazione. E questo crea un’ostilità difficile da cancellare nei confronti di queste dottrine. Così nell’Egitto post-Mubarak si osteggiano le riforme di liberalizzazione dell’economia perché considerate sinonimo di malgoverno e cattiva gestione, anche quando sarebbero benefiche per il Paese. Analogo discorso si può fare per l’Algeria, che vive sulla rendita delle risorse energetiche. Qui una borghesia compradora, e cioè che controlla gli enormi flussi d’importazione ed esportazione, cementa il suo potere attraverso riforme liberiste mentre si oppone a qualsiasi legge che possa intaccare la centralizzazione del potere commerciale nelle sue mani. La centralizzazione è l’anima della corruzione politica, una centrifuga che macina la ricchezza e la redistribuisce all’interno di una piccolissima classe di privilegiati. Il giornalista belga Michel Collon descrive bene questa peculiare situazione dalle pagine del suo blog: «Le importazioni algerine ammontano a un totale di 40 miliardi di dollari, di cui 8 per le importazioni alimentari e 2 per i prodotti farmaceutici! Dietro ogni frazione di borghesia compradora specializzata in un dato settore, c’è una multinazionale straniera, uno Stato e ovviamente un grande burocrate e/o generale algerino […] di lì l’interferenza sistematica tra questioni economiche e questioni politiche». Analogamente in Libia, durante il regime di Gheddafi, l’élite si consolida attraverso il sistema di vassallaggio tribale. La popolazione è tagliata fuori dalla gestione della cosa pubblica che dal 2000 in poi resta nelle mani dei «Comandi popolari e sociali», costruiti dai capitribù. Dal 2003, poi, da quando cioè il Paese rientra nella comunità internazionale e abbraccia le riforme neo-liberiste, questi organismi giocano un ruolo di primo piano nell’apertura economica e commerciale verso l’Occidente e diventano le vacche grasse del regime e di chi ci ruota intorno, le oligarchie tribali vicine a Gheddafi. Alla base delle politiche di esclusione in Nordafrica c’è dunque il mantenimento dei privilegi delle élite, garantito, paradossalmente, dalla liberalizzazione dell’economia. Complici naturalmente sono i governi occidentali che s’ingrassano grazie ai favori elargiti alle dittature arabe. La lista delle società occidentali che commerciano con questi Paesi è sempre la stessa. E in fondo quest’istantanea della società maghrebina non è poi tanto diversa da quella dell’Europa mediterranea. Le caste imperversano anche a casa nostra e lo Stato è degenerato in feudo da queste gestito. Ma allora anche noi europei non siamo poi tanto lontani dalla Libia, dall’Algeria, dalla Tunisia? Uniti per profitto Come si è visto i Paesi mediterranei dell’Europa, seppur con forme di governo diverse dai regimi nordafricani, hanno con questi molti punti di contatto. Sicuramente molti più di quanti non ne abbiano con le nazioni nordiche dell’Unione europea. La disoccupazione al Sud è il triplo rispetto al Nord Europa: in Olanda e Germania quella giovanile è inferiore al 10 per cento, le uniche eccezioni sono il Regno Unito al 18,5 per cento e la deficitaria Irlanda. In Italia all’inizio del 2011 la disoccupazione giovanile era del 29 per cento, in Grecia del 39,6 e in Spagna superava il 40 per cento. Più di un quarto dei giovani italiani sono senza impiego e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è di appena il 46 per cento, la più bassa in Europa. Sulle due sponde del Mediterraneo anche altri indicatori, quelli ad esempio relativi alla trasparenza della gestione dell’economia, sono simili. Le dittature arabe hanno metabolizzato la corruzione in casa e fuori, come un modo per accentrare la ricchezza nelle mani dell’élite. Esattamente lo stesso meccanismo esclude la popolazione greca da grosse fette di Pil che finiscono nelle tasche di pochi privilegiati. Secondo il Brookings Institution, un centro di studi americano, in Grecia la corruzione e le tangenti hanno sottratto all’erario pubblico l’equivalente dell’8 per cento del Pil, oltre 20 miliardi di euro, abbastanza per evitare lo scoppio della crisi del debito sovrano e quella dell’euro. È però l’Italia che detiene il triste primato della corruzione: Transparency International la inserisce nella hit parade dei 21 Stati al mondo le cui imprese corrompono di più i pubblici ufficiali. In Italia l’economia illegale è talmente diffusa e pervasiva da fornire al Paese quella liquidità necessaria per rimanere a galla anche quando dovrebbe affondare. È questo infatti il mistero sul quale molti s’interrogano. Come può sopravvivere un Paese che da anni non cresce e che ha il terzo debito pubblico più alto al mondo? Per rispondere andiamo ancora una volta in Campania, la regione con il reddito pro capite tra i più bassi d’Italia, dove la provincia di Napoli ha la più alta concentrazione urbana e densità demografica del Paese e una fra le più alte al mondo. Una regione il cui gettito fiscale è molto più alto del reddito prodotto. Perché? La risposta si chiama riciclaggio. La Campania è «la lavatrice d’Italia» e una delle più efficienti in Europa. Una serie di scandali mettono in luce le tecniche usate dai riciclatori che non sono certamente quelli che dovrebbero fare la raccolta differenziata per risolvere il problema dei rifiuti. Una serie di recenti sequestri di patrimoni alla camorra ne possono rappresentare un valido esempio. Una rete di pizzerie, ristoranti e bar emetteva scontrini falsi, fatturando più di quanto realmente incassato, cioè invece di dichiarare trenta coperti a sera, quelli effettivi, se ne dichiaravano cento. Il riciclaggio, può ipotizzarsi, avveniva immettendo questo denaro nel circuito fiscale, tassandolo insomma e non evadendo, come solitamente viene fatto nel nostro Paese. Lo stesso principio viene applicato nei negozi delle griffe false dove la borsa che vale 5 euro viene comprata per 150 euro, soldi che il camorrista fa finire nei bilanci «puliti» dei commercianti. Da una parte, dunque, il riciclaggio mette in circolazione una liquidità che l’economia legale non produce e dall’altra gonfia il gettito fiscale della regione dove si lavano i profitti del crimine organizzato. Forse oggi il Paese si regge sulla criminalità economica più che nel passato. Ed è paradossale pensare che sia la criminalità organizzata a salvarci dal crack, e non lo Stato. La sudditanza dal Nord Europa Infine, come le economie arabe, quelle dell’Europa mediterranea sono subordinate alle grandi economie del Nord. Ed è proprio la Grecia a confermare questa tesi. Atene è il principale importatore continentale di armi convenzionali, con il rapporto tra spese militari e Pil più alto in tutta l’Unione europea. Spendono di più, all’interno della Nato, solo gli Stati Uniti. Tra il 2000 e il 2010 la Grecia ha speso in armi, sottomarini e caccia 16 miliardi di euro, quasi il doppio dei 9 elemosinati a Davos nel 2009. Nonostante i tagli al bilancio imposti dal Fmi e dall’Unione europea, nel 2011 l’esborso militare greco continua ad assorbire il 2,5 per cento del Pil. Perché? In vista di una minaccia d’invasione, assai poco realistica, da parte della Turchia, questa la versione ufficiale. Tra i più importanti fornitori militari ci sono imprese francesi e tedesche. Poche settimane prima che venga varato il prestito europeo di 110 miliardi di euro alla Grecia, nel 2010, l’agenzia Reuters fa circolare la notizia di pressioni da parte del governo tedesco e francese affinché vada in porto l’acquisto di 6 fregate per un valore di 2,5 miliardi di euro, 15 elicotteri, pari a 500 milioni di euro, e decine di caccia per un valore di un centinaio di milioni ciascuno, tutti prodotti francesi. Le pressioni includono un pagamento pari a 2,8 miliardi di dollari di tre sottomarini tedeschi, uno dei quali, a detta dei greci, non funziona. Parte dei soldi stanziati per salvare la Grecia dalla bancarotta, dunque, finiranno nei bilanci dell’industria bellica francese e tedesca. Tra l’altro, sia detto per inciso, per difendersi da un attacco turco la Grecia non avrebbe bisogno di queste armi modernissime. I sottomarini della ThyssenKrupp, ad esempio, possono restare sott’acqua per tre mesi, decisamente troppi, se si considera che la distanza massima tra le isole dell’Egeo è di appena quattro ore di navigazione. Diversa è la situazione se la dotazione militare greca entrasse a far parte dello scacchiere di difesa continentale, allora piuttosto che parlare di tensioni nel Mar Egeo ci si deve spostare nel Golfo Persico. Ma non sono questi i patti tra Grecia e Nato o tra l’Unione europea e l’Alleanza atlantica. Almeno non ufficialmente. Come si possono tagliare pensioni e salari e allo stesso tempo acquistare sottomarini e armi per decine di miliardi di dollari? Se lo chiede Stelios Fenekos, viceammiraglio greco, quando nell’aprile del 2010 presenta le proprie dimissioni. Come si può subordinare il pacchetto di aiuti finanziari alla vendita di armi che non servono a nulla? Per chi lavora Bruxelles, per la Banca centrale europea e per il Fondo monetario o per le multinazionali del Nord Europa? Per i cittadini o per le élite del denaro? È ora che tutti gli europei si pongano queste domande. Al momento solo gli esclusi hanno il coraggio di farlo. Poiché il malgoverno facilita la sudditanza tra le oligarchie al potere nei vari Paesi, oggi tutta l’Europa è presa in una rete di debiti incrociati da cui difficilmente riuscirà a liberarsi. All’inizio dell’estate è il turno di Grecia e Portogallo di elemosinare dai colleghi settentrionali gli aiuti necessari per evitare la bancarotta, ad agosto è la volta degli spagnoli e degli italiani che ottengono dalla Bce l’impegno ad acquistare i propri buoni del Tesoro per fermare la speculazione. Ma difficilmente il portafogli nordico si aprirà veramente perché l’euro diventa ben poco conveniente se per salvarlo bisogna sborsare migliaia di miliardi di euro. Il costo del salvataggio della terza economia europea, l’Italia, è sicuramente troppo alto. Ce lo conferma la manovra di Ferragosto, definita anche da esponenti della maggioranza «lacrime e sangue», per via dei tagli che il premier sottolinea di essere stato costretto a fare, come se le politiche di austerità possano mai essere fatte volentieri. Altri 45 milioni di euro decurtati dal bilancio, potature di spese che non serviranno a nulla di fronte alle dimensioni mastodontiche del debito pubblico. Ma che costano molto, anzi troppo a chi già fatica ad arrivare alla fine del mese. Ci troviamo di fronte al populismo più bieco. Per convincere i mercati Berlusconi usa la stessa arma che per vent’anni ha usato in Italia: la propaganda. Ma questa volta non funzionerà. 12 Fondo miseria internazionale Nel luglio del 2011 parte la speculazione contro l’Italia, si teme che sarà questa nazione la prima a seguire il destino della Grecia. La notizia prende un po’ tutti in contropiede. Ma i dati parlano chiaro: l’Italia nei prossimi cinque anni dovrà rifinanziare un debito di 900 miliardi di euro e, dato che da dieci anni l’economia non cresce, molti la reputano un’impresa impossibile. A sostenerlo sono innanzitutto i mercati, ed è per questo che lo spread con i titoli tedeschi, cioè la differenza tra i tassi chiesti agli italiani e ai tedeschi per piazzare il loro debito, sale. Scende invece quello con i titoli spagnoli, altra economia in crisi. A conti fatti il limite massimo che queste nazioni possono gestire è del 7 per cento, nessun Paese deficitario può andare oltre. A metà luglio 2011 quelli italiani erano a ridosso del 6 per cento, all’inizio di agosto avevano superato questa barriera, risultando i più alti in nove anni. Troppo cari per essere sostenuti nel tempo. A gettare benzina sul fuoco, a metà luglio, è la tensione tra Giulio Tremonti, il ministro dell’Economia, e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi riguardo alla manovra fiscale per ridurre il debito, un pacchetto d’austerità di 40 miliardi di euro, poi aumentato a 80, che dovrebbe cancellare il deficit di bilancio entro il 2012 ma che richiede dalla popolazione lacrime e sangue ben poco graditi al populista Berlusconi. È bastato questo a destabilizzare la fiducia nell’Italia. Chi ci assicura che non succederà di nuovo? Si poteva prevedere tutto questo? Certo che sì. L’Italia è gestita da una classe politica che all’estero fa ridere anche i bambini, quindi perché meravigliarsi se in un momento di emergenza non sanno fare altro che perdersi in litigi, invidie e antipatie? Il Paese poi, sebbene abbia un deficit di bilancio irrisorio rispetto alla Spagna – 4,6 per cento contro 9,2 – e non abbia dovuto salvare le proprie banche, è fermo a crescita zero da troppo tempo. Un fattore che pesa in rapporto al debito pubblico, 120 per cento del Pil, secondo in Europa solo a quello greco. Esiste dunque in Italia un problema cronico che la Spagna non ha, avendo ripreso a crescere nel 2011. Il rischio in Italia è anche facilmente quantificabile. Non solo nessuna politica di austerità sarà in grado nel breve periodo di abbassare sotto il 100 per cento il rapporto debito-Pil, ma nel 2011 Moody’s stima che il 10 per cento delle entrate dello Stato sarà assorbito dagli interessi sul debito mentre in Spagna questa proporzione è inferiore, il 6 per cento. Infine nella seconda metà del 2011 l’Italia dovrà finanziare la metà del fabbisogno del credito, e cioè 222 miliardi contro i 40 miliardi di euro della Spagna. Bastano queste cifre per farci capire che gli ulteriori 45 miliardi tagliati dalla manovra di Ferragosto non servono a nulla. Con l’incertezza riguardo al successo del piano di salvataggio greco, con la crisi del Portogallo sempre più vicina, con Cipro prossimo alla questua di aiuti da Bruxelles e con la Francia a rischio di declassamento, diventa sempre più difficile per l’Italia piazzare il debito a tassi accettabili. Ecco i primi sintomi del contagio della crisi del debito sovrano a casa nostra. L’Unione europea si trova a un bivio pericolosissimo: continuare a cercare di salvare le economie minori, e rischiare che l’euro si sfasci in ogni caso a causa dell’epidemia che infetta già l’Italia, o gettare la spugna adesso e rimboccarsi le maniche per organizzare un default controllato di tutte queste economie? Naturalmente per ora ha scelto la prima opzione senza neppure considerare la seconda, ma nel mondo reale in cui nessuno si può permettere di affrontare i problemi pratici in modo ideologico, questo dilemma si doveva affrontare mesi fa e avrebbe dovuto essere posto dal Fondo monetario, un’organizzazione che dopotutto vanta decenni di esperienza in questo campo. Si dovevano prospettare diversi scenari di crisi con altrettante soluzioni, nell’eventualità che accadesse il peggio, ma non è stato così. A questo punto è giusto chiedersi: a che serve il Fondo monetario internazionale? È un quesito che rimbalza da una piazza all’altra d’Europa, ma gli Indignati del Vecchio Continente non sono i primi a porselo. Nel 1997, allo scoppio della crisi dei mercati dell’Estremo Oriente – le prove generali di quella del debito sovrano europeo – gran parte della popolazione asiatica si fece la stessa domanda. Allora come oggi un intero continente rischiava la bancarotta. I responsabili? Banche e società finanziarie occidentali che grazie alla deregulation avevano investito pesantemente in mercati emergenti come Malesia e Thailandia, gonfiando bolle finanziarie e incitando i governi a indebitarsi sulla base dell’aumento del valore d’immobili e titoli. Ma perché prestare soldi in questo modo? Quando tutti sanno che prima o poi la bolla scoppierà? Perché una tendenza all’irrazionalità e alla sottovalutazione del rischio ormai è tra i mali più radicati di una finanza troppo abituata a non pagare i suoi errori. Negli anni Novanta, la bolla asiatica si gonfia sotto gli occhi del Fondo monetario e della Banca mondiale, che in teoria dovrebbero monitorare lo sviluppo delle economie emergenti, ma che in pratica non fanno proprio nulla. Alle riunioni annuali di queste istituzioni, dove i grandi della terra s’incontrano per alzare coppe di champagne al successo delle loro politiche, i funzionari del Fmi e quelli della Bm fanno la figura dei parenti poveri rispetto ai giganti di Wall Street. Nessuno azzarda l’ipotesi che forse questo massiccio flusso monetario verso l’Asia è fuori luogo e potrebbe provocare danni irreparabili a economie giovani e ancora fragili. A nessuno conviene obiettare, perché i guadagni sono alti. Per ogni transazione, infatti, si incassano laute commissioni e ogni operatore di mercato, ogni banchiere è convinto che potrà sbarazzarsi dei debiti tossici poco prima dello scoppio della bolla. Soprattutto confida che resterà impunito. Hanno ragione anche se, quando la bolla asiatica scoppia, si scatena il finimondo. Il baht thailandese crolla del 40 per cento, la rupia indonesiana dell’80 per cento, il ringgit malese del 30, il dollaro di Singapore perde il 15 per cento, il peso filippino il 50. Gli indici dei mercati azionari e obbligazionari cadono come birilli. E sui mercati inizia il fuggi fuggi finanziario. Tutti svendono ciò che di asiatico hanno nel portafogli. A dimezzare le perdite dei giganti di Wall Street ci pensa Greenspan, il grande vecchio della finanza globalizzata. Taglia i tassi d’interesse in America ed evita che anche Wall Street venga trascinata nella crisi. Ma le economie dei Paesi asiatici non hanno paracadute e vengono letteralmente travolte dalla crisi. Quali le cause? Autorevoli economisti hanno dato una spiegazione emotiva o psicologica, definendo «bipolare» la condotta dei mercati e incolpando quelli che Keynes ha definito «gli spiriti animali». Secondo questa interpretazione, l’irrazionalità mista all’istinto di sopravvivenza degli operatori di Borsa li ha portati a comportarsi da dementi, o forse sarebbe meglio dire da delinquenti, visto che da un giorno all’altro linee di credito e finanziamenti sono svaniti. La verità è invece molto più semplice. Gli speculatori hanno avuto la meglio sul sistema di controllo internazionale, perché questo non esisteva né è mai esistito. Nell’inevitabile parallelo tra questa crisi e quella dell’euro ci si accorge che la situazione precipita ogni qual volta Moody’s o Standard&Poor’s fanno suonare un campanello d’allarme, ovvero quando il danno è già fatto. La Grecia ha falsificato i bilanci ma ce ne accorgiamo solo quando il debito è fuori controllo; l’Italia non cresce da dieci anni ma ce ne preoccupiamo solo quando il mercato dei capitali le gira le spalle. L’intervento delle istituzioni preposte al controllo della finanza mondiale fa acqua da tutte le parti. Quando finalmente la cavalleria del Fondo monetario arriva in Asia, invece di salvare i «nostri», produce ulteriori devastazioni, esattamente quello che sta succedendo oggi in Europa. Da quando la Grecia e il Portogallo sono nelle mani degli «esperti» di Washington, a Bruxelles l’economia si è contratta e le piazze insorgono contro gli incompetenti che invece di salvarli accelerano la loro rovina. Nel 1997 la popolazione asiatica non si rivoltò contro i propri governanti perché non capì bene cosa stava succedendo. Il crollo dei mercati asiatici è stata la prima vera crisi della globalizzazione legata alle pratiche neo-liberiste dell’alta finanza occidentale e alle connivenze tra oligarchia del denaro e potere politico. C’è voluto del tempo però per metabolizzare queste interdipendenze. Gli Indignati europei di tempo ne hanno avuto. Sono cresciuti all’ombra di crisi analoghe, identiche bolle finanziarie costruite dagli stessi individui: quella del peso messicano, quella del.com negli Stati Uniti; la bancarotta dell’Argentina seguita dal crollo delle economie di altri Paesi latinoamericani come l’Ecuador; la crisi del credito; la bancarotta dell’Islanda e finalmente quella del debito sovrano che coinvolge i Paesi mediterranei e l’Irlanda. Ormai sanno che il binomio democrazia-finanza neoliberista ha alimentato oligarchie che strangolano lo Stato e sanno anche che strumenti come il Fondo monetario sono funzionali a questo sistema malato. Cosa (non) ci ha insegnato la crisi asiatica Il «pacchetto di salvataggio» proposto dal Fmi ieri ai Paesi asiatici e oggi a quelli europei è ormai uno standard. Comporta sempre, ma proprio sempre, tagli drastici alla spesa pubblica e nessun programma concreto di ripresa economica. Non salva le economie, le getta nelle grinfie della deflazione e della recessione. Nel 1997, ad esempio, gli «aiuti» ai Paesi asiatici non solo non riescono a ripristinare la fiducia degli investitori nelle economie in crisi, ma le indeboliscono perché la politica d’austerità richiesta per concederli contrae il Pil, taglia insomma la linfa vitale di un’economia nazionale ancora in fasce: la spesa dello Stato. Zapatero, che dal 2008 in poi ha seguito una politica di espansione della spesa pubblica per sostenere l’economia e mantenere il sussidio di disoccupazione più alto d’Europa, ha dovuto gettare la spugna nel 2011 quando il Fmi e la Banca europea lo hanno costretto a tagliarla. Risultato: l’economia si è contratta. Lo stesso discorso vale per il nostro Paese, che non cresce da vent’anni e dove il problema dei tagli va solo a ingigantire quello della cattiva gestione dell’economia, già aggravato dalla totale assenza di una politica industriale. Troppo debito, questo il giudizio immancabile del Fmi. Ed è vero, ma di chi è la responsabilità? Certamente non della popolazione ingannata. Sapevano i greci o gli italiani degli imbrogli che il governo aveva architettato con le grosse banche d’affari? No. Erano al corrente che le élite del denaro intascavano gran parte dei finanziamenti europei dello Stato? No. E dato che la responsabilità del Fondo è garantire la stabilità dei tassi di cambio mondiali e che l’eccessivo indebitamento di uno o più Paesi la mette a repentaglio, aveva verificato che il debito fosse gestibile? Di nuovo no. Una schiera di agenzie di certificazioni, società di consulenza, uffici studi delle banche, nonché uno stuolo di economisti e contabili impiegati dal Fondo monetario, dalla Banca mondiale e dall’Unione europea non si sono mai accorti di nulla. Non hanno dunque torto gli Indignati a sostenere che in parte la responsabilità della crisi del debito sovrano europeo è anche del Fondo monetario, un’organizzazione che non mette mai in guardia le nazioni prese di mira da Wall Street contro la politica del credito facile. Basterebbe ricordare loro il principale mantra dell’alta finanza: non esistono pasti gratis! I cittadini che oggi sono scesi nelle piazze hanno scoperto che questa crisi è l’ultima puntata della telenovela del debito, iniziata nel 1989 con il crollo del Muro di Berlino e l’avvento della globalizzazione, dove l’alta finanza si muove da un Paese all’altro, da una regione all’altra distruggendone le economie. Russia, Thailandia, Malesia, Filippine, Corea, Argentina, Ecuador, Islanda e adesso Grecia, Portogallo e Irlanda e sicuramente anche l’Italia, la lista è lunga. Come le bibliche locuste, i cavalieri del neoliberismo, si arricchiscono attraverso il debito e quando hanno divorato tutta la liquidità lasciano dietro di sé un paesaggio di devastazione. Il Fondo monetario con la sua azione da retroguardia si ritrova a proteggere la fuga dei criminali. Cosa ne direbbe Keynes? Sembra proprio che le istituzioni da lui concepite a Bretton Woods per evitare una seconda Grande Depressione, quelle che dovevano vegliare sul sistema dei cambi e accorrere in aiuto delle economie bisognose, abbiano bruciato i suoi libri ed eretto a idolo la dottrina neoliberista secondo cui il mercato non può avere regole. Quando poi le cose vanno male la formula magica è: tagli, tagli e ancora tagli. Ma che senso ha ridurre la spesa pubblica solo per potersi indebitare ulteriormente? E della disoccupazione, delle pensioni, di scuola, sanità, trasporti, dell’economia reale in cui i giovani dovrebbero entrare da protagonisti per avere una vita decente, chi se ne occupa? Sono domande pressanti, queste, che gli Indignati oggi rivolgono ai nostri politici. Sono le stesse che si pose il primo ministro della Malesia, molti anni fa. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare Anno 1997. Mentre il Fmi cerca di evitare l’inevitabile, cioè il crack finanziario dei Paesi asiatici emergenti, il premier malese Mahathir Mohamad coglie di sorpresa la comunità finanziaria internazionale e attacca pubblicamente gli speculatori di valuta estera, accusandoli di voler distruggere il suo Paese, musulmano, prospero e in rapida crescita. Nello sbigottimento della finanza mondiale gioca la carta del gharar, il divieto islamico di speculare. La Malesia è vittima degli avidi commercianti occidentali, denuncia Mahathir e rifiuta l’intervento della cavalleria di Bretton Woods. Si rivolge invece ai ricchi fratelli musulmani del Golfo Persico. E questi fanno quadrato intorno a lui. La Banca per lo sviluppo islamico e ricchi investitori sauditi creano un pacchetto di salvataggio alternativo. Non impongono tagli alla spesa, i soldi vengono gestiti dalla Malesia. E succede l’impossibile! Mentre in Thailandia e nelle Filippine, a seguito dell’austerità imposta dal Fondo monetario, il Pil cala, la disoccupazione aumenta e l’economia non si riprende, la Malesia attira una schiera di ricchi investitori musulmani, tutti ansiosi d’intraprendere avventure commerciali nel Paese. E questo avviene mentre il Pil si contrae del 2,8 per cento, la crisi economica tocca il suo apice e in rapida successione vengono introdotti i controlli di capitale, si dichiara l’inconvertibilità della valuta, il governatore della Banca centrale viene licenziato e il ministro dell’Economia nonché vice premier Anwar Ibrahim viene arrestato. Rotolano insomma sul selciato le teste di uomini di potere. Esattamente come dovrebbe accadere in Europa. Ma non succede perché il destino del nostro continente oggi è nelle mani di istituzioni internazionali ottuse e fuori tempo, i cui errori, o peggio i cui crimini, ricadono sulla popolazione. Il premier Mahathir, memore delle vittime di Wall Street, se ne tenne ben lontano. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare, e da almeno vent’anni il Fondo monetario cammina con il bastone. In pochi anni, la Malesia riuscì a uscire dalla burrasca finanziaria senza imporre alla propria popolazione sacrifici disumani, come invece furono costrette a fare la Thailandia e il resto delle nazioni asiatiche «salvate» dal Fmi. Il segreto del successo è stato l’abbandono del modello di salvataggio occidentale. Il mondo arabo con il salvataggio di Dubai e l’esempio asiatico della Malesia offrono soluzioni interessanti. Anche l’Islanda in bancarotta propone un modello di salvataggio differente e indipendente e, come vedremo più avanti, persino l’Argentina ha qualcosa da insegnarci. Ed è interessante notare che queste strategie alternative di gestione delle crisi, ben lungi dall’essere considerate aride questioni tecniche, sono oggi fonte d’ispirazione per la contestazione giovanile europea tanto quanto le pagine più esaltanti delle proteste di piazza in Tunisia o in Egitto. Ma la confluenza degli interessi delle popolazioni mediterranee è un fenomeno recente anche se storicamente questi popoli hanno avuto origine dalla stessa civiltà. 13 L’ipocrisia dell’Occidente È la colonizzazione a trasformare il Mediterraneo in una barriera tra nord e sud, una situazione che non cambia con il processo di decolonizzazione. Bisognerà aspettare le rivolte tunisine per riconnettere le due sponde. D’altronde la storia c’insegna che questo è un mare capriccioso, capace di unire i popoli che vi si affacciano ma altrettanto pronto a dividerli. Per oltre 700 anni, dal 711 al 1492, musulmani, cristiani ed ebrei hanno convissuto lungo le sue sponde dando vita a fiorenti civiltà. Eppure durante questo stesso periodo le crociate ne hanno insanguinato le rive orientali. Anche quando i poteri coloniali si ritirano, i rapporti tra le due sponde rimangono all’insegna dei bisogni dell’Europa e degli Stati Uniti, la superpotenza che alla fine della Seconda guerra mondiale entra a forza nell’equazione politica di questo mare puntando a garantirne la stabilità politica della regione allo scopo di potenziare il commercio e rafforzare la sicurezza d’Israele, l’approvvigionamento energetico e il contenimento dell’immigrazione: questi i pilastri della decolonizzazione e le chiavi di lettura della nuova politica mediterranea. Israele e la narrazione politica Da più di vent’anni l’esercito egiziano riceve ogni anno dagli americani una cascata di miliardi di dollari per aver firmato gli accordi di pace con Israele a Camp David. Mubarak e l’élite al potere hanno usato questo denaro per creare un regime brutale, corrotto ed economicamente inefficiente e agli americani, incluso il presidente della speranza Barack Obama, stava bene così perché il presidente egiziano si era impegnato a fare da mastino ai confini d’Israele in costante espansione e impedire la creazione di uno Stato palestinese. Finanziare la dittatura egiziana è stata una decisione strategica: il mondo arabo non ha battito cardiaco senza l’Egitto, che è la sua stella polare nella lunga traversata verso la modernità. Infatti il contagio rivoluzionario ha avuto come epicentro Piazza Tahrir al Cairo, non la Tunisia dove pure tutto è iniziato. E dato che Mubarak ha mantenuto la promessa di «proteggere» Israele anche a costo di frustrare i sogni d’indipendenza dei palestinesi, il primo atto del nuovo regime egiziano è riaprire la frontiera con Gaza, promuovere un accordo di pace e cooperazione tra Hamas e Fatah, riallacciare le relazioni con l’Iran le cui petroliere dopo trent’anni riattraversano il Canale di Suez. Ancora più significativo è il contagio della rivoluzione egiziana in Israele. Nelle tendopoli erette dal movimento 14 Luglio si leggono gli stessi striscioni di solidarietà con gli egiziani che abbiamo visto in Spagna. Che significa? Che lo scollamento tra classe politica e società civile è più profondo di quanto si creda, che l’equazione di politica estera americana per il bacino del Mediterraneo non ha mai funzionato e oggi viene apertamente contestata dalla popolazione per quello che è: non democratica. Questo stesso governo di transizione non vuole che gli americani s’intromettano nel processo di democratizzazione e condanna l’iniziativa dell’agenzia americana U.S. Agency for International Development, che attraverso annunci pubblicitari sui giornali egiziani offre fino a 100 milioni di dollari per progetti sull’occupazione e sullo sviluppo economico e fino a 65 milioni per iniziative volte a democratizzare il Paese. L’Egitto rifiuta aiuti economici occidentali che non siano gestiti dagli egiziani, l’esperienza ha insegnato che quelli stranieri sono soldi pericolosi. La generosità statunitense è, tra l’altro, un gesto paternalistico e allo stesso tempo dispregiativo: immaginiamo cosa succederebbe in Francia se gli americani lanciassero su una pagina di «Le Monde» una iniziativa simile. La crisi diplomatica sarebbe assicurata. Ma il denaro è sempre stato lo strumento più efficiente per controllare e influenzare la politica del Nordafrica e in questa parte del mondo i diplomatici hanno sempre funzionato come corrieri del contante. Garantire la protezione a Israele e la stabilità geopolitica della regione non sono l’unica chiave per decifrare la politica estera delle nazioni che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. A scrivere la storia diplomatica moderna è anche la penna intinta nel petrolio. Dopo l’embargo del 1973-74 e la rivoluzione iraniana nel 1978, ci si rende conto che la sicurezza energetica dell’Occidente è a rischio. La parola d’ordine diventa: contenere il contagio rivoluzionario islamico. Ciò permette alle élite dittatoriali delle false democrazie arabe, come quella tunisina ed egiziana, di consolidarsi sfruttando la minaccia degli islamisti. E dato che la moschea è diventata l’unico punto d’incontro di una società civile vessata e oppressa, l’unico luogo nell’asfittica atmosfera politica dove respirare una boccata d’aria e avviare un dibattito, l’opposizione di stampo religioso è più che mai pericolosa per i regimi. Ed ecco che negli anni Ottanta, per evitare che le teste calde si rivoltino contro chi li governa, durante la jihad antisovietica in Afghanistan i regimi musulmani del Nordafrica e del Medioriente ne finanziano l’esportazione sponsorizzando di fatto gli uffici di reclutamento dei mujaheddin. E paradossalmente, negli anni Novanta e Duemila, i reduci che torneranno in patria dovranno fare i conti con una feroce repressione da parte dei loro vecchi sponsor. L’immigrazione e la narrazione sociale Il Nordafrica e il Medioriente sono anche una riserva di lavoro a basso costo, e qualche volta peggio. La delocalizzazione dei nostri processi produttivi, del resto, non avviene soltanto fuori dei confini nazionali, il suo lato più oscuro è nascosto a casa nostra, nelle campagne mediterranee. Emblematica dello sfruttamento della manodopera africana da parte del ricco Nord è la storia di Rosarno, il paesino italiano che nel 2010 è diventato tristemente famoso in tutto il mondo. Nunzia Penelope ce ne racconta gli agghiaccianti retroscena nel suo libro Soldi rubati: «I magistrati rivelano che gli extracomunitari utilizzati nella piana [di Rosarno] per la raccolta delle arance erano stati esplicitamente richiesti dai proprietari di quei terreni, in consorzio fra loro, che ne avevano fissato non solo il numero ma anche la provenienza, sulla base della convinzione che talune etnie fossero più produttive e più gestibili delle altre. Privilegiata era l’etnia di origine africana rispetto a quella asiatica o balcanica. […] Il consorzio aveva stimato in anticipo il rendimento che avrebbe fruttato, per ettaro, la raccolta delle arance e ne aveva fissato il suo successivo impiego economico». Le modalità di pagamento erano anch’esse da schiavismo: 25 euro al giorno oppure a cottimo, 40 centesimi per cassetta. A questi magri guadagni bisognava poi sottrarre il «compenso» per il caporale o agente di reclutamento, 8 euro giornalieri dal salario fisso o 20 centesimi a cassetta. In media i braccianti guadagnavano dai 500 ai 600 euro lordi ma dovevano poi pagare 150 euro per vitto e alloggio, non rimaneva quasi nulla da mandare a casa alla famiglia, di cui spesso erano l’unico sostegno. Si stima che in Italia ci siano almeno 70.000 extracomunitari che vivono in condizioni analoghe. Ma molto probabilmente sono assai di più. Gran parte di questi braccianti vengono reclutati nei loro Paesi attraverso vere e proprie truffe. Si promette loro una vita migliore e gli si fa firmare un contratto di lavoro falso con un altrettanto falso permesso di soggiorno. Viene spontaneo domandarsi con quale coraggio il nostro Paese critica la Cina. L’aspetto sconvolgente di questa storia è infatti l’esistenza di un consorzio di agricoltori, tutti onesti e incensurati; non ci troviamo insomma di fronte al crimine organizzato. Almeno in apparenza. Perché la procura, in seguito, ci racconta Nunzia Penelope, ha calcolato che i guadagni prodotti grazie ai clandestini ammontavano a 10 milioni di euro al mese, soldi che venivano subito reinvestiti nella speculazione edilizia lungo la costa ionica attraverso l’intermediazione mafiosa, naturalmente. Il petrolio e la narrazione economica Nel 2003 l’approvvigionamento energetico dell’Europa fa sì che anche il colonnello Gheddafi venga riaccolto nella comunità internazionale, altra prova della subordinazione della sponda sud ai bisogni di quella nord. Il perdono arriva due anni dopo l’inizio della corsa pazza del petrolio verso quota 100 e poi 140 dollari al barile, un’ascesa legata alla «guerra contro il terrore» di Bush (fino all’11 settembre il prezzo era rimasto stazionario a 18 dollari al barile). La dipendenza dal greggio saudita, le cui esportazioni si teme potrebbero essere interrotte da un attacco terroristico contro il porto di Ras Tanura, da dove salpa l’80 per cento delle forniture, e l’insaziabile domanda asiatica, alimentata dalla modernizzazione della Cina e dell’India, convincono gli europei a scendere a patti con uno dei peggiori dittatori arabi. Gheddafi entra così nella rosa dei nostri tiranni «prediletti», in compagnia del tunisino Ben Ali e dell’egiziano Mubarak. Esisteva ed esiste un accordo tacito tra una manciata di abili politici arabi e i rappresentanti delle nostre democrazie. I primi si comportano come viceré dell’Impero occidentale e i secondi offrono loro il riconoscimento politico internazionale di cui hanno bisogno, come insegna la parabola di Gheddafi. L’accordo però esige il mantenimento dello status quo. La rivoluzione di Khomeini ha insegnato all’Occidente che i moti rivoluzionari portano al potere regimi ostili. Si teme quindi che una sollevazione democratica produca gli stessi effetti e per evitarla si è anche disposti a chiudere gli occhi sulle violazioni dei diritti umani. L’11 settembre permette altri giri di vite, che riducono ulteriormente le libertà civili in molta parte del mondo. Nell’equazione politica fa il suo ingresso il terrorismo fondamentalista islamico, che diventa una minaccia aggiuntiva per tutti. Non solo i regimi arabi sono lodati per le politiche repressive «contro i terroristi», ma vengono arruolati come volenterosi carnefici dell’Occidente grazie alle cosiddette extraordinary renditions, le deportazioni e torture di sospetti terroristi. A smascherare l’ipocrisia dell’Occidente è la figura ambigua del dittatore Gheddafi. 14 Il ritorno del figliol prodigo Per mesi nel 2011 le bombe della Nato sono piovute su Tripoli, fino a poco tempo prima roccaforte del colonnello Gheddafi, ex alleato degli occidentali fino alla sua caduta. Viene spontaneo chiedersi perché un analogo destino non è stato riservato al dittatore siriano Bashar al Assad, il cui regime reprime nel sangue le sollevazioni popolari democratiche. Assad non è mai stato un alleato «ufficiale» degli occidentali anche se all’indomani dell’11 settembre il suo regime ha offerto appoggio incondizionato agli americani. Tra Siria e Stati Uniti esiste una relazione ambigua retta su un equilibrio solo in apparenza instabile. La collaborazione della Siria è strumentale alla politica occidentale in Medioriente, la controbilancia impedendo che si spezzi lo status quo. Ma non è solo questo il motivo dell’indifferenza verso i mali della popolazione siriana. Innanzitutto, in un anno elettorale, Obama vuole ridurre gli interventi militari. In secondo luogo la Siria, al contrario della Libia, non produce il miglior petrolio al mondo, leggero, facile ed economico da raffinare. Una risorsa preziosa anche per l’Europa, principale alleato di Obama, che infatti gli ha forzato la mano convincendolo ad affiancarla nell’intervento libico. Possiamo immaginare che Sarkozy abbia ricordato a Obama l’appoggio europeo in Afghanistan, le negoziazioni con i talebani, tutte iniziative mirate a produrre l’illusione di una vittoria prima delle elezioni presidenziali in America. Senza gli amici europei i soldati americani non torneranno mai a casa per il 2012. Questa la minaccia. In cambio viene richiesto appoggio diplomatico e militare per bombardare la Libia. Do ut des, un principio politico inventato proprio nel bacino del Mediterraneo, e che a quanto pare funziona ancora. Nonostante l’intervento armato e la vittoria sulle forze di Gheddafi ormai è però chiaro che né il petrolio libico né quello iracheno risolveranno la crisi del debito sovrano che strangola Europa e Stati Uniti. L’ultimo G8 tenutosi in Francia poteva essere ribattezzato l’incontro delle nazioni più indebitate al mondo: Giappone (226 per cento del Pil), Italia (120 per cento) e Stati Uniti (93 per cento). I problemi economici dell’Occidente, dunque, non sono così lontani da quelli dei Paesi arabi. Ma i bombardamenti e le dichiarazioni antiGheddafi davanti alle telecamere fanno parte del reality show della nostra politica, uno spettacolo per l’elettorato. La corsa a bombardare Gheddafi e a riconoscere ufficialmente i ribelli fa parte della maratona energetica alla quale partecipano tutti i Paesi europei e gli Stati Uniti. Dietro le belle parole c’è una cruda realtà: le importazioni dal Nordafrica rimangono strategicamente vitali per l’Europa del Sud. Mentre la parte settentrionale del continente si approvvigiona dalla Norvegia, dal Mare del Nord e ha accesso alle riserve russe, il Sud deve necessariamente guardare al Mediterraneo, e cioè al Nordafrica e al Medioriente. Al di sotto del Mare Nostrum corrono importanti arterie energetiche, gasdotti che connettono le due rive, tra cui il Medgaz (tra Algeria e Spagna) e il Greenstream (tra Libia e Italia). L’Italia, ad esempio, importa l’86 per cento del fabbisogno da queste regioni, la Libia da sola soddisfa il 25 per cento del nostro consumo di petrolio e il 10 di quello di gas. Prima della sollevazione popolare la Libia produceva 1,7 milioni di barili di petrolio al giorno e i maggiori importatori erano l’Italia, l’Austria e l’Irlanda. Il greggio libico, va aggiunto, non può essere facilmente rimpiazzato con quello saudita, che è più pesante e richiede un processo di raffinazione più lungo e costoso. Dunque, da quando è scoppiata la guerra civile, a rimetterci sono state le nazioni importatrici. L’Italia, ad esempio, adesso deve comprare il gas naturale dall’Algeria a prezzi spot più alti. Potenzialmente poi, bisogna aggiungere, la Libia è la Mecca delle multinazionali energetiche per via dei suoi giacimenti, considerati i più ricchi del continente africano. Si tratta di una sorta di riserva d’oro nero che nessuno ha toccato per un ventennio perché dal 1992 al 2003 il Paese è rimasto chiuso al mondo a causa delle sanzioni Onu. Chiunque riuscirà a metterci le mani sopra per primo avrà un grosso vantaggio rispetto agli altri. L’isolamento prolungato di Gheddafi è legato alla sua passata attività di sponsor di gruppi armati occidentali, nonché al suo presunto coinvolgimento nell’attentato terrorista contro il volo Pan Am 103 caduto il 21 dicembre 1988 su Lockerbie, in Scozia, e in quello alla discoteca La Belle di Berlino Ovest del 5 aprile 1986, in Germania. Ma nel 2002 il presidente Bush e il primo ministro britannico Tony Blair iniziano una manovra di avvicinamento: per sostenere la teoria dell’intervento preventivo in Iraq, hanno bisogno che uno Stato canaglia si penta e abbandoni il programma di proliferazione nucleare. Il ritorno del figliol prodigo ha dunque due scopi: isolare ulteriormente l’Iraq e soddisfare i bisogni energetici impellenti dell’Occidente. Allo stesso tempo, infatti, le spinte espansionistiche dell’economia globalizzata sono diventate fortissime e necessitano di nuovi sbocchi. La Libia è un Paese ricco di materie prime, un mercato vergine, dove le corporation occidentali possono fare grossi affari. E così sarà. Gheddafi non solo accetta, ma si cala con entusiasmo nei panni del figliol prodigo, perché l’isolamento ha fiaccato il suo regime e l’idea di vendere il petrolio a prezzi in costante ascesa rappresenta una manna dal cielo per la sua dittatura. S’impegna dunque a risarcire le famiglie delle 270 vittime di Lockerbie fino a 10 milioni di dollari ciascuna, per un totale di 2,7 miliardi di dollari. Corrisponde un indennizzo anche a quelle delle vittime degli attentati alla discoteca di Berlino del 1986, del volo Uta del 1989 e del bombardamento statunitense del 1986 a Tripoli e Bengasi. A queste condizioni il presidente Bush firma l’ordine 13477 che sigla il ritorno di Gheddafi nella comunità internazionale. Colpisce che questo processo venga orchestrato seguendo le regole tribali del «prezzo del sangue», una norma in vigore da sempre in Libia. La vendetta per l’assassinio di un membro di una famiglia può essere bloccata offrendo denaro in compensazione. In Occidente non si ragiona in questo modo e infatti il governo britannico si trova in imbarazzo a spiegare ai familiari di Yvonne Fletcher, la poliziotta inglese uccisa da una pallottola proveniente dall’ambasciata libica a Londra durante l’assedio del 1984, che il governo di Sua Maestà ha agito nell’interesse della popolazione e secondo i principi morali occidentali nel riaprire relazioni diplomatiche con Gheddafi. A tutt’oggi, infatti, il Colonnello rifiuta di accollarsi la responsabilità di quell’omicidio. Al governo di Sua Maestà risulterà difficile anche spiegare il rilascio del presunto attentatore di Lockerbie, l’ex dipendente della Lybian Airways Lamin Khalifah Fhimah, una transazione mediata guarda caso dalla Bp, il gigante petrolifero britannico. Il greggio libico fa gola a tutti, ecco la cruda verità che tutti i politici si guardano bene dall’ammettere. Così nel 2004, Romano Prodi riceve Gheddafi in pompa magna a Bruxelles e subito dopo le società petrolifere occidentali si mettono al lavoro. In prima fila c’è l’Eni, seguono a ruota la spagnola Repsol, l’australiana Omv, l’olandese Royal Dutch Shell, la norvegese Statoil e la russa Gazprom. La Bp si accaparra i diritti per il deep sea drilling, l’estrazione marina ad alta profondità, oggi vietata nel Golfo del Messico a causa del disastro ecologico prodotto proprio dalla sua piattaforma Deepwater Horizon. Gheddafi è corteggiato da tutti perché è una nuova mucca da mungere. Non potevano mancare i giovani leoni dell’alta finanza che atterrano a Tripoli a frotte per gestire il fondo sovrano libico, che grazie all’aumento del petrolio non smette di crescere. Naturalmente nessuno si preoccupa di verificare chi c’è dietro la Lybian investment authority (Lia), e cioè individui e clan molto vicini al dittatore Gheddafi. Il fondo, che tecnicamente appartiene al Paese e a tutti i suoi cittadini, in realtà è gestito come portafoglio personale dell’élite che lo amministra. Il vice direttore della Lia, ad esempio, è un carissimo amico di Saif al Islam, figlio, nonché erede di Gheddafi. È facile per banche come la francese Bnp Paribas e la svizzera Credit Suisse, o per hedge funds londinesi come Permal e Millennium Global, convincere costoro a tentare operazioni rischiosissime con la promessa di lauti guadagni. Purtroppo le cose vanno male, il fondo perde più di 1,4 miliardi di dollari ma deve pagare egualmente costosissime commissioni alle banche e finanziarie responsabili delle perdite. Credit Suisse, ad esempio, su un investimento di 200 milioni di dollari che ha fatto perdere alla Lia circa il 30 per cento ha riscosso 7,6 milioni di dollari di commissioni. La Lia ha perso circa un quarto dei 300 milioni di dollari investiti da Bnp Paribas per i quali ha pagato la bellezza di 18 milioni di dollari in commissioni. Assurdo? Non più di tutto il resto. L’alta finanza non è la sola ad avventarsi sulla mucca Gheddafi. Dal 2008 in poi iniziano le visite d’illustri accademici a Tripoli. Tra questi il professor Joseph Nye, ex preside della Kennedy School di Harvard, noto inventore del soft-power, definito come il potere d’influenzare la politica estera attraverso la propaganda e le relazioni pubbliche. Nye fa parte del Monitor Group, una società di consulenza creata da cattedratici di Harvard che per la modica somma di 250.000 dollari al mese ridisegna e cura l’immagine pubblica di Gheddafi. L’attività frutterà complessivamente 3 milioni di dollari e non sembra che l’immagine di Gheddafi ne sia uscita molto bene. Dai cantanti pop che intrattengono la famiglia del dittatore fino alle banche scandinave dove il Colonnello deposita un miliardo di euro, per arrivare a Goldman Sachs, che ne gestisce il portafoglio con perdite analoghe a quelle dei colleghi impegnati nella gestione della Lia, tutti fanno affari con Gheddafi. Ma sono gli italiani che instaurano con lui una relazione speciale. Il Colonnello controlla il 2 per cento della Fiat, il 2 per cento della Finmeccanica, il 7,5 per cento di Unicredit e il 7,5 per cento della Juventus, acquistato a quanto si dice nel lontano 2002 per 21 milioni di dollari. Ecco perché sono le imprese italiane che oggi soffrono maggiormente a causa della guerra civile in Libia; si stima che il danno al volume di affari sia di circa 100 miliardi di euro. E ciò significa perdita di punti percentuali di Pil ma anche di posti di lavoro in Italia. Mentre l’Eni gestisce gran parte della produzione petrolifera e di gas libica destinata all’estero, società italiane fanno da intermediarie tra il governo libico e il mercato internazionale delle materie prime. Transita attraverso di loro il 70 per cento dell’importazione libica, come pure tangenti da capogiro destinate alle élite del Paese africano. Il prezzo di quest’accordo siglato da Silvio Berlusconi è di 5 miliardi di dollari, pagati nel 2008 dall’Italia in compensazioni per la passata colonizzazione del Paese, soldi del contribuente italiano che la popolazione libica purtroppo non vedrà mai perché scompaiono nei conti intestati a Gheddafi e alla sua famiglia. Tra il Cavaliere e il Colonnello si sviluppa una relazione speciale, un feeling, sembrano dire le foto che li ritraggono insieme. In effetti i punti di contatto sono tanti: entrambi sono vecchi ma rifiutano di arrendersi al passare degli anni, si tingono i capelli, ricorrono alla chirurgia plastica, fanno ampio uso del botulino e delle pastiglie azzurre. E soprattutto continuano a ostentare machismo nel loro rapporto con le donne. Gheddafi, come Berlusconi, è sempre accompagnato da stuoli di belle ragazze, ovviamente a pagamento, ed entrambi le sfoggiano come trofei. Alla sceneggiata del ritorno del figliol prodigo non poteva mancare un personaggio che ormai conosciamo bene, ovvero il Fondo monetario internazionale che nella seconda metà degli anni Duemila si dichiara soddisfatto dell’economia libica. L’impennata dei prezzi del petrolio – la cui vendita, insieme a quella del gas, rappresenta il 72 per cento del Pil della nazione africana – si traduce in un aumento del gettito monetario prodotto dall’esportazione degli idrocarburi che a sua volta gonfia il Pil. Che la Libia a parte il petrolio non abbia nulla non interessa a nessuno. Il Fmi apprezza inoltre l’impronta neoliberista che questa nazione impone alla propria economia appenarientra nel club delle nazioni non-canaglia; partono infatti le privatizzazioni, cadono le barriere doganali e il Paese si apre ai capitali stranieri e all’alta finanza. La solita storia, insomma. Intanto si riducono il peso della funzione pubblica e i sussidi sui beni di prima necessità, che durante gli anni delle sanzioni erano sovvenzionati dallo Stato. Queste politiche impoveriscono la popolazione ma il Fondo monetario non bada a questo dettaglio. Quello che conta sono le cifre del Pil. Non è un problema del Fmi se l’80 per cento delle famiglie libiche vive con stipendi statali, e se il settore pubblico rappresenta i due terzi del bilancio dello Stato. Ancor meno è un problema il fatto che non esista nel sistema economico libico un’alternativa imprenditoriale allo Stato. Gheddafi è rimasto al potere così a lungo anche e soprattutto perché lo Stato è «diventato l’economia», facendosi carico dei salari della popolazione. Che dire poi della distribuzione del reddito, e delle relative sperequazioni? La Libia aveva il Pil pro capite più alto del Nordafrica, 18.720 dollari rispetto agli 8630 della Tunisia, seconda nella hit parade del reddito, e ai 5860 dell’Egitto. Ma, stando ai dati dell’Economist intelligence unit, ha anche la più alta percentuale di cittadini che vivono al di sotto della soglia della povertà, 33 per cento contro il 3,8 per cento tunisino e il 20 per cento egiziano. Sarebbe bastato analizzare queste cifre per capire che il modello neoliberista arricchiva le élite e affamava la popolazione. Ma il Fmi ha altro a cui pensare. Non illudiamoci che il rapporto tra le potenze occidentali e il governo di transizione dei ribelli sarà diverso da quello con Gheddafi. All’Occidente interessa il petrolio libico, non la creazione di una società democratica. Sarà interessante osservare nei prossimi mesi come il governo provvisorio si comporterà in una società tribale, diversa quindi da quella tunisina ed egiziana. Riusciranno i libici a mantenere le distanze con europei e americani e a dar vita a un sistema politico indipendente? Eviteranno il triste destino dell’Iraq, altra società tribale? Staremo a vedere. La tratta degli schiavi d’Europa L’ingresso di Gheddafi nella rosa dei dittatori arabi amici offre all’Europa una soluzione al problema crescente dell’immigrazione. Il Vecchio Continente, infatti, non possiede più il capitale economico, sociale e politico per assorbire frotte di nuovi arrivati. Gheddafi si offre di intercettarli, imprigionarli e sbarazzarsene come si trattasse di semplice mercanzia. E l’Europa accetta con gratitudine, perché l’immigrazione causa tensioni politiche ed erode la credibilità dei partiti tradizionali. Anche di quelli di più recente fondazione, dato che la Lega Nord di Bossi in Italia, l’estrema destra di Geert Wilders in Olanda o di Heinz-Christian Strache in Austria e i True Finns in Finlandia conquistano voti sulla base di programmi antiimmigrazione e anti-Islam, senza dire però a chi ne devono la realizzazione. Ancora una volta il broker degli europei con Gheddafi è Silvio Berlusconi. Il 30 agosto 2008 Italia e Libia firmano a Bengasi il trattato d’amicizia, partenariato e cooperazione. La Libia s’impegna a garantire il rimpatrio dei clandestini che attraversano le sue frontiere sahariane, indipendentemente dalla nazionalità e dalle motivazioni che li spingono. Gheddafi si accolla con modalità tutt’altro che democratiche il problema dell’immigrazione della democratica Europa, bloccando i migranti direttamente sul suo territorio. In cambio l’Italia s’incarica di creare le infrastrutture necessarie, inclusi radar da terra, per erigere una barriera tecnologica a protezione delle frontiere meridionali della Libia, il tutto per la modica somma di 300 milioni di euro depositati nelle casse di Gheddafi da Italia e Unione europea, di nuovo soldi nostri. Di questo stesso accordo fanno parte i cinque miliardi sborsati dall’Italia a chiusura del contenzioso coloniale. I risultati non tardano: le cifre degli sbarchi sulle coste italiane precipitano sia nel 2009 che nel 2010. Tutti sono contenti: gli europei, Berlusconi che non deve gestire il problema di Lampedusa e naturalmente anche Gheddafi. Nessuno si domanda che ne è delle persone intercettate. L’Europa ha messo il loro destino nelle mani del Colonnello, a cui il trattato dà carta bianca. Quanti sono stati giustiziati sommariamente o venduti come schiavi? Quanti fuggivano regimi che li opprimevano e avevano diritto allo status di rifugiati politici? Una domanda che noi, democratici europei, dovremmo porre ai politici di Bruxelles. Una domanda che ci aiuterebbe a comprendere la vera natura di chi ci governa, gente che domani, pur di sopravvivere, non esiterebbe a riservarci lo stesso trattamento che ha applicato ai migranti africani. La fortezza Europa, ottusa, vecchia, decadente e malata del morbo del debito, ossessionata dalla propria sicurezza, si difende con una serie di legislazioni antidemocratiche, che ignorano i principi basilari dei diritti umani. E noi abitiamo al suo interno. Il fenomeno dei clandestini avrebbe dovuto far suonare campanelli d’allarme non perché disturbava quella che noi consideriamo la quiete pubblica, ma perché era la spia delle politiche economiche di assoggettamento da parte dell’Unione europea e degli Stati Uniti. Nel bacino del Mediterraneo esiste una forte concentrazione di materie prime, di capacità tecnologiche, di grandi mercati e risorse umane, ma allo stesso tempo si tratta di una delle aree del pianeta dove più forti sono gli squilibri tra capitale umano e risorse materiali, realtà evidenziate dalla cattiva distribuzione della ricchezza. Con la caduta del Muro di Berlino e l’allargamento a Est dell’Unione europea, il Mediterraneo è diventato il nuovo confine tra mondo sviluppato e sottosviluppato, tra l’Impero e i barbari. L’Europa ha iniziato a guardare sempre di più a Oriente, all’Europa dell’Est. È là che si dirigono i flussi d’investimento, che si pianifica l’assimilazione. E più l’Europa guarda a Est meno guarda a Sud, e l’investimento europeo nel Maghreb infatti si è contratto negli ultimi vent’anni. Ecco perché tutte le iniziative promosse per assimilare quest’area e l’entroterra africano attraverso un processo di modernizzazione falliscono, da Mena (progetti che riguardano l’area del Medioriente e del Nordafrica) fino al processo di Barcellona (strategia comune europea per l’area mediterranea). In realtà ciò che interessa all’Occidente è sfruttare le risorse del bacino e quest’obiettivo viene raggiunto sostenendo i regimi dittatoriali e le relative élite. Questi, come abbiamo visto, fungono da viceré dell’Impero: classi dirigenti voraci, predatrici e aggressive, economicamente liberali e politicamente autoritarie. Più che un divario tra il Nordafrica e il Nord Europa dobbiamo parlare di un vero abisso. Ce lo illustra Alfred Sauvy nel libro L’Europe submergée: «Da una parte [i Paesi del] Nord Europa invecchiano nella noncuranza e godono di una crescente opulenza, dall’altra parte il Maghreb e il suo retroterra nero dell’Africa centrale vedono, con la stessa indifferenza, il moltiplicarsi della gioventù e della povertà». Noi nazioni europee dell’area mediterranea siamo nel mezzo, ma stiamo correndo nella direzione dei cugini arabi, con un tenore di vita in calo, disparità sociali in aumento con le relative tensioni, e una capacità di garantire il futuro dei nostri giovani ormai prossima allo zero. Il problema è, dunque, economico e demografico. Le rivolte del Nordafrica nascono dal desiderio di trovare una soluzione economica attraverso un ricambio politico. E poiché da noi sulla sponda europea la situazione non è poi molto diversa, ecco che le sabbie delle coste del Mediterraneo si trasformano in terreno fertile per il contagio della pandemia democratica. 15 Prove generali di rivoluzione: dall’Argentina alla Tunisia Le prove generali delle rivolte arabe, mediorientali ed europee sono avvenute in Sud America dieci anni fa, solo che allora non esistevano i social media e quindi non ce ne siamo accorti. In realtà si tratta della stessa pandemia democratica, che ha impiegato anni ad attraversare l’oceano. La matrice è infatti sempre la solita: il rifiuto da parte della popolazione del modello neoliberista che poggia sulla privatizzazione dei beni dello Stato e sulla concomitante riduzione della spesa pubblica. Sulla carta non c’è nulla da obiettare, il neoliberismo prende piede quando l’esperimento dello Stato assistenziale, il Welfare State, è già fallito. Molte delle critiche mosse al vecchio modello sono valide e fondate. Il problema è l’applicazione del nuovo canovaccio economico da parte di un’élite che lo manipola a suo vantaggio. L’alleanza che nasce tra potere politico ed economico per promuovere la nuova dottrina degenera presto in un accordo tacito per fare i propri interessi invece di favorire la crescita economica e il benessere della popolazione. Però nessuno se ne rende conto. È la prima volta nella storia che un simile accordo viene stretto alla luce del sole, molti elettori se ne rallegrano vedendovi la riprova che qualcosa è cambiato dai tempi dell’ingerenza dello Stato nell’economia. In effetti, qualcosa è davvero cambiato. Ora è l’economia a ingerire lo Stato, surclassandone le funzioni e strangolando i suoi cittadini. Invece di facilitare la democratizzazione dell’economia attraverso privatizzazioni e liberalizzazioni, infatti, il credo neoliberista cementa il potere delle élite, che diventano moderne caste e deviano la crescita verso il portafoglio di una piccola percentuale della popolazione: l’un per cento di quella mondiale intasca più della metà della ricchezza prodotta. Uno dei sintomi di questa devianza è dunque la sperequazione dei redditi. Quella che ci viene proposta come la formula magica del benessere, nel decennio del thatcherismo e del reaganismo, ha effettivamente qualcosa di taumaturgico: fa vincere le elezioni a chi la sa applicare. Ma a livello economico e sociale produce, prima nella periferia dell’Impero e poi al centro, solo crisi. Questa è una verità che i burocrati delle organizzazioni internazionali non ammetteranno mai. E i politici nemmeno, nonostante abbiano assistito negli ultimi vent’anni a ripetute prove generali della crisi del debito sovrano che oggi colpisce il cuore dell’Impero. Nel 1994-95 è la volta del Messico, pochi anni dopo, nel 1998 tocca alla Russia, nel 1997-98 ai Paesi asiatici, dopo il crollo dell’Argentina va in fallimento l’Ecuador, nel 2008 l’Islanda e adesso sono i Piigs a rischiare grosso. La verità è che la storia economica della globalizzazione non è un’epica di vittorie e progressi ma un racconto dell’orrore, popolato da vampiri in gessati firmati, che dalle piazze affari occidentali succhiano ricchezza a chiunque sia tanto stupido da credere alle loro proiezioni. Un ladrocinio in guanti bianchi, insomma. Ma anche loro, i Chicago Boys, i rampanti agenti di cambio, i venditori dei derivati, sono solo marionette e raccolgono come molti politici le briciole della grande abbuffata neoliberista. I grandi burattinai occidentali sono altri, coloro che controllano i mezzi d’informazione come Murdoch, o i signori dei mercati dei capitali come Goldman Sachs, J.P. Morgan, o chi gestisce le grandi banche. I rivoltosi arabi e gli Indignati europei non vogliono fare la fine del Messico, della Thailandia o dell’Argentina né sono disposti ad accettare lo status quo del nord del Mediterraneo: economie che non crescono perché prive di competitività e indebitate fino al collo, piagate dal precariato e dalla disoccupazione, dove una generazione di giovani sottopagati e non garantiti mantiene il sistema produttivo senza ufficialmente farne parte. E ancora: società che venerano i super-ricchi e i famosi, a prescindere da chi siano o da cosa facciano, dove le élite del denaro vivono in un mondo dorato, recintato, protetto dallo stesso Stato che divora la maggioranza dei suoi figli. Fino allo scoppio della pandemia democratica, gli esclusi sognavano di oltrepassare la staccionata oltre la quale abitava il privilegio. Oggi cominciano a capire che questo non solo è un sogno irrealizzabile, ma è un obiettivo sbagliato. Vent’anni di globalizzazione hanno chiuso queste élite al mondo esterno, e in più hanno fatto piazza pulita della democrazia vera. Ora che i colpi della dura realtà ci hanno risvegliati dal lungo sonno mediatico, ci ritroviamo in un mondo molto simile a quello popolato dai nostri avi nel Medioevo: la concentrazione della ricchezza nelle mani dei baroni del denaro alimenta la corruzione e il ladrocinio, mantiene in vita i feudi dell’abbondanza mentre blocca lo sviluppo e strangola la crescita. I feudatari moderni si chiamano Mubarak, Ben Ali, Gheddafi, Assad, ma anche Berlusconi, gli armatori greci, i palazzinari spagnoli, i super-ricchi che risiedono a Londra, gli speculatori edilizi irlandesi e gli evasori portoghesi. Il benessere oggi è un miraggio che ancora confonde tutti gli abitanti del bacino del Mediterraneo, a nord come a sud. Sembriamo più ricchi che negli anni Sessanta perché abbiamo più cose, ma siamo più poveri perché abbiamo meno opportunità. Potevamo provare a scalare qualsiasi montagna, oggi siamo senz’acqua e nel deserto, come direbbe Hannah Arendt. I rivoltosi arabi e gli Indignati ne hanno abbastanza di questo sistema, come i cugini argentini e latinoamericani dieci anni fa hanno intuito che la radice del problema è la gestione politica, o meglio il malgoverno. Se l’economia è diventata canaglia è perché i presunti guardiani dei nostri interessi lo hanno permesso. La cattiva governance internazionale È possibile rivisitare la tragedia argentina alla luce della rivolta tunisina, della crisi greca e chissà anche di quella italiana? L’obiettivo è capire una verità che gli argentini, gli arabi e i giovani europei già conoscono: i laboratori dove si sperimenta la struttura politica, economica e sociale del villaggio globale del futuro non si trovano a Bruxelles o a Wall Street, né tanto meno a Washington dove ha sede il Fondo monetario, ma nelle piazze e nelle strade delle nazioni vittime del modello neoliberista occidentale. È qui che si lavora alacremente alla costruzione dello Stato neo-democratico dell’era postimperiale. Argentina e Tunisia sono due nazioni che iniziano a modernizzarsi alla fine del processo di decolonizzazione. La lunga marcia verso un modello endogeno e democratico avviene dunque durante la Guerra Fredda. Questo significa che si lavora sotto la pressione degli interessi degli Usa e con il fiato sul collo dei Chicago Boys. Settori importanti delle popolazioni combattono per l’autonomia politica ed economica: in Tunisia durante la lotta per l’indipendenza contro la Francia e, tra il 1966 e il 1976, in Argentina, nei dieci anni d’insurrezione permanente contro dittature e falsi governi democratici. I risultati sono però deludenti. Tutte le proteste sfociano in regimi che aderiscono incondizionatamente all’agenda economica promossa dal «consenso di Washington», ovvero il sistema economico internazionale che poggia sulla centralità degli Stati Uniti, la maggiore potenza mondiale. In Argentina come in Tunisia, Egitto e Libia, bisogna fare i conti con l’eredità coloniale. Paradossalmente gli stessi movimenti in cui la popolazione ha riposto le speranze di emancipazione, ovvero il peronismo in Argentina e il partito Destour di Bourguiba in Tunisia – d’ispirazione laica, nazionalista e socialista prima di diventare filo-americano – promuovono un processo di riadattamento dell’economia nazionale alle esigenze del capitalismo neoliberista postcoloniale. Due colpi di Stato militari pongono fine alla sudditanza coloniale: quello argentino del 1976 contro il governo di Isabel Perón e quello tunisino con cui nel 1987 Ben Ali depone Bourguiba. In parte, la genesi di entrambi i golpe va ricercata nelle rivolte popolari contro l’introduzione delle prime riforme neo-liberiste. Ma sia i militari argentini che il generale Ben Ali non faranno che accentuare durante i loro regimi il corso neoliberista già sperimentato dai loro predecessori, mediante un’applicazione più sistematica e ragionata del modello. Ecco perché negli anni Novanta piovono le lodi per la democratica Argentina di Menem e per la Tunisia di Ben Ali che hanno ingoiato il menu classico neoliberista offerto dal Fmi, dalla Banca mondiale e da tutte le organizzazioni economiche internazionali: deregulation dei mercati con aperture alla speculazione; privatizzazione selvaggia dei servizi pubblici e dei beni comuni; abbattimento della spesa sociale e saccheggio incondizionato delle risorse naturali a spese dei bisogni delle popolazioni locali; sottooccupazione, flessibilità e precarizzazione della forza lavoro e così via. L’opposizione nazionale si organizza e cresce proprio nelle aree maggiormente colpite da questo modello: le campagne, la piccola impresa e i disoccupati della classe intellettuale. Anche in Egitto la rivolta del 2011 è il prodotto delle lotte sociali e della catena di scioperi iniziati nel lontano 2006 nelle regioni interne. E come in Argentina, non poggia su un movimento politico e non ha un leader di riferimento, ma è spontanea e orizzontale. Un filo politico e sociale lega queste insurrezioni. Gli argentini nel 2001 e i fratelli arabi nel 2011 non vogliono dire basta unicamente a regimi corrotti o a figure come Menem, Ben Ali o Mubarak, ma soprattutto porre fine alla lunga notte neoliberista calata sui loro Paesi grazie al sistema di governance internazionale. La loro è una rivoluzione contro il malgoverno globale. Il sistema politico nato da queste rivolte è la risposta alternativa alla modernità dell’altra parte del mondo, quella esclusa dalla gestione dell’economia e della politica globali. Nel 2001 la tragedia dell’Argentina apre gli occhi a tutto un continente. La popolazione insorge contro le politiche di austerità imposte dal Fondo monetario in Uruguay, Perú e Paraguay. Nuovi leader ammettono che il modello neoliberista nelle mani dell’élite occidentale rappresenta un pericolo. Così alla periferia dell’Impero inizia la sperimentazione di modelli economici misti, dove il neoliberismo si fonde con alcuni elementi del vecchio Welfare State. Dalla Cina di Jintao al Brasile di Lula alla Bolivia di Evo Morales fino all’Argentina della coppia Kirchner, un’alternativa alla proposta fallimentare dell’Occidente prende piede e cresce, mentre l’uragano della crisi si sposta dalla periferia verso il centro dell’Impero dove esplodono le stesse tensioni sociali. Dunque è utile osservare cosa è successo in Argentina, l’avanguardia del nuovo corso economico. 16 I laboratori del futuro: i Piigs in default? Gli Indignati europei, come gli argentini nel 2001 e gli arabi nel 2011, insorgono contro la comunità internazionale e le sue ricette economico-politiche. Non chiedono quindi di divenire cittadini democratici, perché in teoria già lo sono, ma di esercitare questa democrazia. Vogliono essere loro i reali artefici del proprio destino: gestire le risorse (intellettuali e materiali) finalmente nell’interesse comune. La domanda da porsi è la seguente: c’è bisogno di condividere il destino infame dell’Argentina? Vale la pena di raccontarne le tappe salienti per tracciare un parallelo con la Grecia e con gli altri Paesi Piigs, molto pertinente dato che ormai tutti temono lo spettro del default. La genesi della crisi argentina inizia nei primi anni Novanta quando il governo aggancia la moneta nazionale al dollaro. Decisione che offre stabilità agli investimenti finanziari esteri, incluso l’acquisto di buoni del Tesoro argentini, perché rimuove il pericolo della svalutazione. Ecco spiegato il motivo per il quale i mercati internazionali sono disposti a sottoscrivere il debito argentino, ma non quello di altri Paesi sudamericani. Come avverrà in Islanda pochi anni dopo, i giovani in gessato blu arrivano a frotte a Buenos Aires, da Wall Street e dalla City di Londra. L’Argentina è la nuova Mecca della finanza globalizzata. Nel 1996 Goldman Sachs produce un documento intitolato A Brave New World che presenta questa nazione come il modello dell’economia emergente, un esperimento da riprodurre nel resto dell’America Latina e dei Paesi in via di sviluppo. Centrale è la convertibilità del peso con il dollaro che garantisce un tasso di cambio fisso pari a un peso per un dollaro americano. Il rischio svalutazione quindi non esiste! Agganciare il peso al dollaro è però una grossa limitazione per un’economia emergente, perché significa che il governo può stampare carta moneta solo se possiede l’equivalente in dollari, non può inflazionare l’economia né svalutare. Va da sé che tutti i deficit fiscali devono essere coperti indebitandosi sul mercato dei capitali. E qui è bene spiegare che la manovra della svalutazione per un Paese eccessivamente indebitato come divenne l’Argentina, anche se poco onorevole, non solo riduce il valore del debito in dollari ma rende le esportazioni più competitive e fa salire il valore in peso delle entrate in valuta estera. È dunque sbagliato considerare la svalutazione sempre e solo come una manovra negativa. Oggi i Paesi Piigs indossano la stessa camicia di forza. L’euro impedisce alla Grecia di svalutare, all’Italia di ridurre il valore del suo debito gigantesco e all’industria turistica spagnola di essere più competitiva. L’unica soluzione è prendere in prestito soldi sul mercato dei capitali per pagare almeno gli interessi sul debito. Ce lo confermano alcuni dati pubblicati dalla Commissione europea. Dal 2007, e cioè dall’inizio della recessione, al 2011, il debito pubblico italiano è passato dal 104 per cento del Pil al 120, quello spagnolo dal 36 al 69 per cento, quello greco dal 105 al 148 per cento, quello portoghese dal 68 al 103 e quello irlandese dal 25 al 102. Ma la crisi argentina non è legata esclusivamente alla disciplina ferrea imposta dal rapporto tra peso e dollaro, a monte c’è un indebitamento eccessivo, fuori controllo, connesso all’introduzione delle regole neo-liberiste imposte dal centro finanziario dell’Impero occidentale, prima fra tutte la finanziarizzazione dell’economia. Uno dei cavalli di battaglia di questa strategia sono le privatizzazioni che avvengono con la guida delle grandi banche d’affari internazionali. Sotto le pressioni del Fondo monetario il governo argentino privatizza le pensioni. Nascono così i fondi pensione gestiti ufficialmente dagli argentini, ma de facto dai banchieri di Wall Street che si ritrovano tra le mani un patrimonio nazionale. Come avviene con i Paesi Piigs, le grandi banche d’affari e le grosse finanziarie in cambio dei loro servigi intascano lauti compensi in commissioni. In Argentina dal 1991 al 2001 si parla di un miliardo di dollari soltanto per la sottoscrizione del debito del governo. Per ogni emissione obbligazionaria infatti, il governo pagava profumatamente le banche che la portavano sul mercato e la piazzavano. Gli acquirenti erano i fondi pensione e i fondi comuni europei perché i gestori di quelli americani non si fidavano e domandavano tassi e rendimenti più alti. E infatti gli effetti della bancarotta argentina si faranno sentire più a casa nostra che altrove. Come avverrà per i Piigs, gli analisti delle stesse banche e società producevano analisi e rapporti dettagliati dai quali risultava che l’economia argentina cresceva e non esistevano rischi. Informazioni analoghe provenivano dalle agenzie di rating che consideravano il debito argentino, come quello dei Piigs, assolutamente solido. Gli stessi conflitti d’interesse hanno portato la Enron e WorldCom in bancarotta rispettivamente nel 2001 e nel 2002, ma il crollo di queste società ha colpito appena 400.000 azionisti mentre nel caso dell’Argentina si sta parlando dell’allora seconda economia sudamericana, per tacere dei Piigs che rappresentano una grossa fetta d’Europa. A differenza di quanto sosteneva la finanza internazionale, lo Stato argentino si è subito trovato in difficoltà di fronte alla finanziarizzazione del debito. Il sistema delle pensioni, ad esempio, come quello della maggior parte dei Paesi occidentali prima della deregulation era centralizzato: lo Stato pagava le pensioni con i contributi dei lavoratori. Ma nel momento in cui queste vengono privatizzate, i contributi confluiscono nei fondi pensione, che però ancora non producono un reddito. Ed ecco che in questo periodo di transizione lo Stato si trova a corto di soldi per pagare le pensioni. La soluzione è emettere buoni del Tesoro che, come si è visto, le banche internazionali sono ben contente di sottoscrivere e piazzare. Anzi lo Stato argentino viene incoraggiato a indebitarsi. Perché? Un sistema di indicizzazione perverso fa sì che a Wall Street il rating dei gestori dei fondi comuni e dei fondi pensione sia positivamente influenzato dagli investimenti nei Paesi emergenti; sottoscrivere il debito dell’Argentina era un modo per far alzare i risultati dei gestori a fine anno; altro incentivo sono gli stipendi anch’essi indicizzati al rating che andavano dai 900.000 dollari a oltre un milione. Pericoli? Nessuno. Chiunque aveva in portafoglio il debito ci guadagnava perché si stava gonfiando la bolla. Ed ecco spiegato il motivo della facilità con la quale si offre credito all’Argentina. Quando poi scoppia la crisi dei mercati asiatici e quella del rublo, le obbligazioni argentine diventano le uniche «sicure» provenienti da un mercato emergente. È il colpo di grazia, l’impennata degli acquisti fa scoppiare la bolla. Tornando a oggi, anche il debito sovrano dei Piigs attira come il miele le api finanziarie. La sicurezza dell’euro e il bisogno cronico di denaro di questi Paesi formano una doppietta imbattibile e ancora una volta gli acquirenti sono i fondi pensione e le banche europee poiché gli americani sono impegnati in altre operazioni, come la cartolarizzazione dei mutui subprime. Quando la Grecia chiede aiuto, seguita dal Portogallo e dall’Irlanda, il debito sovrano italiano appare come la migliore alternativa sul mercato. Ma anche in questo caso si potrebbe trattare del colpo di grazia. Da una parte la speculazione lanciata contro l’Italia a metà luglio del 2011 nasce dal timore che il Paese non riuscirà a rimanere a galla con un debito così elevato e dall’altra la vendita massiccia delle obbligazioni italiane riflette il desiderio di ridurre in portafoglio l’esposizione, giudicata eccessiva, al debito italiano. Lo stesso fenomeno si verifica all’inizio di agosto. La facilità con la quale, nella seconda metà degli anni Novanta, l’Argentina può accedere al mercato dei capitali spinge il governo a sperperare invece di risparmiare, investire e promuovere lo sviluppo dell’economia. Ma presto finanziare le pensioni vendendo i titoli obbligazionari piuttosto che utilizzando le entrate pubbliche si rivela una spesa insostenibile anche a causa dell’alto numero di pensionati. Una spesa che arriva a rappresentare il 70 per cento del deficit dello Stato. Naturalmente né gli economisti del Fondo monetario né quelli impiegati dal governo avevano predetto questo fenomeno quando s’era deciso di privatizzare il sistema delle pensioni, né qualcuno aveva suggerito al governo argentino di contenere la crescita del debito. Nessuno aveva pensato di fare, banalmente, due conti. La cattiva gestione dell’economia e l’eccessivo indebitamento fanno crescere il deficit di bilancio che passa dal 29 per cento nel 1993 al 41 per cento nel 1998. Anche nei Paesi Piigs, come abbiamo visto, dall’entrata nell’euro fino a oggi i deficit di bilancio sono aumentati invece di diminuire, per gli stessi motivi. La privatizzazione dell’economia argentina, poi, avviene attraverso una complessa rete di corruzione ed esborso di tangenti piuttosto che seguendo le regole del libero mercato e della concorrenza leale. Alla fine accedere a servizi basilari, come telefono ed elettricità, costa al cittadino dieci volte di più che in passato. Per far fronte agli alti costi le famiglie s’indebitano anche perché è facile farlo, il credito a buon mercato è alla portata di tutti. Così all’indebitamento dello Stato si sovrappone quello privato. Una storia che si ripete in Europa. Sulla carta però le cose vanno benone: l’Argentina ha un rating eccezionale, può piazzare le proprie obbligazioni a tassi bassi rispetto alle altre nazioni latinoamericane, e l’economia, grazie al tasso fisso con il dollaro, cresce a ritmi sostenuti. Ma si tratta di un miraggio finanziario, la realtà è ben diversa. Analogo discorso si può fare per i Paesi Piigs dove corruzione, evasione fiscale e sommerso fanno da cornice all’economia dell’euro per un decennio. Una situazione così malsana non può reggere l’impatto della crisi, e si soccombe all’epidemia di un virus che viene da lontano, se consideriamo che a sua volta il crack argentino è frutto di un’infezione proveniente dal crollo dei mercati asiatici. Dopo un periodo di grande interesse da parte dell’alta finanza internazionale, improvvisamente i capitali stranieri investiti in Argentina vengono rimpatriati. In parte per coprire le perdite registrate in Asia ma anche perché ormai le dimensioni del debito appaiono ingestibili ed è tempo di portare a casa i guadagni. Chi è rimasto bruciato in Asia non vuole finire arrostito in America Latina. Così mentre la liquidità sui mercati scende, diventa sempre più difficile per il governo argentino finanziare il debito a tassi non proibitivi. Infine la crisi economica nel vicino Brasile, un’economia intimamente legata a quella argentina, nel 1999 fa precipitare questa nazione in un circolo vizioso. Rallenta la crescita che fa contrarre il gettito fiscale, il disavanzo primario diventa negativo e lo Stato non riesce a onorare il debito, con conseguente crollo dei mercati, peggioramento della recessione e così via. Il Fondo monetario interviene con un prestito di 14 miliardi di dollari ma non bastano, per piazzare le obbligazioni argentine sul mercato ormai bisogna offrire tassi d’interesse pari a 10,5 punti percentuali sopra le obbligazioni del Tesoro americano, troppo alti per essere sostenuti. L’ultimo tentativo di salvataggio arriva da Wall Street dove un consorzio di banche e finanziarie propone un debt swap che allunga il periodo di vita del debito, ne dilaziona nel tempo i pagamenti, ma in compenso fa salire il costo degli interessi senza contare le commissioni, che ammontano ad altri 100 milioni di dollari. Dopo una lunga agonia avvenuta sullo sfondo di proteste di piazza, manifestazioni e scioperi generali, arriva la bancarotta a dicembre del 2001, in piena estate. Non si tratta di un default pilotato come quello islandese, ma di un crollo simile a quello del 1929. Nel giro di pochi giorni il peso si svaluta del 70 per cento e l’economia si disintegra: il Pil si contrae del 20 per cento, la disoccupazione sale al 60 per cento, salari e pensioni non vengono più pagati, la gente assalta le banche e saccheggia i supermercati: è l’anarchia! O meglio, è la versione moderna della Grande Depressione. La bancarotta argentina diventa il più grande crack del debito sovrano nella storia dell’economia: 141 miliardi di dollari in obbligazioni. Eppure sono appena una frazione dei 1800 miliardi di euro del debito pubblico italiano. La crisi economica ne produce una politica: cinque presidenti si avvicendano in due settimane, mentre la classe politica cede il passo a volti sconosciuti. Ma l’importanza delle rivolte argentine contro una classe dirigente che ha speculato sulla pelle della gente va ben oltre il riassetto politico di una singola nazione. Quell’evento accelera e rafforza un processo di insubordinazione continentale che porta al potere diversi governi di centrosinistra in tutta la regione: da Lula a Evo Morales. Si verifica dunque un potente contagio insurrezionale. Alla rivolta argentina seguono quella boliviana (2003) e quella ecuadoregna (2005) e s’innesta un processo che arriva in America Centrale fino al Nicaragua e all’Honduras. Il 2001, dunque, può essere considerato una sorta di spartiacque nella storia politica di questo continente: nulla in effetti è tornato a essere come prima. Il passaggio dal governo (neoliberista) alla governance (post-neo-liberalista) ha avuto e sta avendo in alcuni Paesi dell’America Latina uno dei suoi banchi di prova più strategici: Brasile, Argentina, Perú sono i laboratori del futuro. Non a caso è qui che si sperimentano anche e soprattutto nuove politiche anticrisi, ad esempio, i tentativi di buona parte dei governi latinoamericani di rispondere alla crisi non certo con tagli e disinvestimenti, ma al contrario incrementando ed estendendo la spesa sociale. Un ritorno dunque alle teorie keynesiane con un pizzico di marxismo? Sembra di sì. La ricetta usata dall’Argentina era decisamente poco ortodossa perché andava contro tutti i principi economici professati dal Fondo monetario e dalle istituzioni internazionali. Nessuno nega che i costi in termini sociali siano stati alti, eppure i risultati sono stati eccezionali. Dato che oggi i Piigs si trovano in una situazione che ricorda la vigilia del crollo argentino è importante capire in che modo se ne discostava. E se questo esempio può indicarci una via d’uscita. Il Gatto e la Volpe e l’ingenuo Pinocchio L’elemento di continuità presente in tutte le crisi finanziarie fin qui analizzate è la congiunzione tra malgoverno e il ruolo di primo piano della finanza globalizzata. Sembra proprio la storia di Pinocchio alle prese col Gatto e la Volpe. Collodi ci racconta che il burattino scansafatiche ma ingenuo s’imbatte in due imbroglioni, il Gatto e la Volpe, ai quali incautamente racconta di avere delle monete d’oro. Questi lo convincono a «seminarle» in un vicino campo miracoloso dove, sostengono, cresceranno alberi carichi di zecchini d’oro. In un certo senso gli Stati sono come Pinocchio, cadono nella trappola tesa dall’alta finanza e dalla politica malsana che profila scorciatoie spesso assurde per favorire crescita e sviluppo. È il caso della Malesia dove la bolla immobiliare fa sì che il costo degli immobili superi quello di New York; dell’Argentina che privatizza le pensioni senza pensare a come finanziare quelle già esistenti; della Grecia che con l’aiuto delle grandi banche d’affari trucca i bilanci e dell’Italia che con la cartolarizzazione del debito delle aziende sanitarie e ospedaliere spalma il debito della cattiva sanità nel futuro, facendone apparire solo una rata nei bilanci annuali. Queste sono misure eccezionali, stratagemmi da usare solo per uscire da situazioni di profonda crisi non scorciatoie per arricchirsi. Invece diventano pratica comune perché chi le vende ci guadagna e chi le compra crede che gli asini volino. Ma si tratta di una truffa. Come il Gatto e la Volpe circuiscono il povero Pinocchio così l’alta finanza e i politici imbrogliano gli Stati. E gli unici che non ci guadagnano nulla sono i cittadini. Anzi, alla fine sono loro che pagano. La salvezza per Pinocchio arriverà solo quando avrà pagato duramente per tutti i suoi errori. Il Gatto e la Volpe e tanti altri personaggi che lo sfruttano non vengono travolti da un destino egualmente tragico, anche perché non è di loro che parla la storia. Così l’alta finanza è un «personaggio» secondario, seppure devastante, nelle vicissitudini degli Stati che ne sono vittime, i pinocchi del romanzo del debito. Punire la finanza non risolverebbe i problemi, sono gli Stati che devono imparare a vivere. Solo il buon governo può proteggere il cittadino da tutti i pericoli incluso il canto delle sirene finanziarie. E come nel finale di Pinocchio, il riscatto avverrà quando il burattino si sarà trasformato in essere umano, ovvero il malgoverno verrà sradicato per lasciare il posto a un buon governo, realmente al servizio degli interessi dei suoi elettori. Con queste premesse analizziamo la risposta dell’Argentina alla bancarotta. La prima decisione fu smettere di ascoltare il Fondo monetario e la finanza tradizionale che insistevano per mantenere il cambio fisso con il dollaro. Il peso fu lasciato libero e come abbiamo visto precipitò. L’altra decisione fu di non intervenire sull’aumento dell’inflazione in cambio di una crescita rapida. Funzionò. Ciò che non funzionò invece fu l’applicazione in America Latina del modello neoliberista negli anni Novanta, quello cioè di una politica fiscale e monetaria antiinflazionista con un tasso di cambio fisso con il dollaro in Argentina. Perché? Perché produsse una scarsa crescita in tutto il continente. Dal 1980 al 2006 il Pil pro capite è salito di appena il 14 per cento mentre dal 1960 al 1980 era cresciuto dell’82 per cento. La svolta antiimperialista dell’Argentina e di altre nazioni quali il Brasile o il Perú non è dunque solo legata al desiderio di liberarsi dell’ingerenza della finanza occidentale che facilita l’indebitamento, ma anche alla necessità di cestinare un modello economico rivelatosi devastante. Tra lo spauracchio del debito e quello dell’inflazione, insomma, si sceglie il secondo perché sostiene la crescita. Dal 2002 fino alla crisi del credito del 2008 l’economia argentina cresce del 65 per cento. Nel 2011 le previsioni sono per un tasso di crescita annuale dell’8,3 per cento, noi quest’anno non arriveremo all’un per cento. Si aggiunga che la ripresa economica non è legata alle esportazioni e agli alti prezzi delle materie prime, come molti pensano, ma alla domanda interna. È sbagliata anche l’idea che l’investimento straniero si sia prosciugato, dal momento che tra il 2003 e il 2007 ammontava all’1,4 per cento del Pil, considerato standard per un’economia a reddito medio-basso. Fondamentale nel successo argentino è poi la fermezza con cui il Paese rinegozia il debito esterno evitando che questo dreni le risorse per la ripresa economica. E infatti il costo finale è molto più basso di quanto si crede poiché i debitori non hanno scelta. Paradossalmente, nel momento in cui viene dichiarata la bancarotta il potere contrattuale passa dalle mani dei creditori a quelle di chi ne è vittima. L’esperienza islandese ce lo conferma. La formula argentina è dunque inflazione e crescita, quella del Fondo monetario è deflazione e austerità, la stessa che oggi viene prescritta ai Piigs. C’è da aggiungere però che l’Argentina ha potuto voltare le spalle al Fmi perché aveva un avanzo primario di bilancio, prodotto dall’avanzo commerciale. Che significa? Che l’indebitamento sul mercato dei capitali serviva a pagare gli interessi del debito, non a sostenere l’economia. In Grecia invece, ad esempio, il debito serve anche a coprire la spesa pubblica mentre l’Italia, dopo i tagli introdotti nel 2011, ha riconquistato un modesto avanzo di bilancio primario. A dieci anni dalla bancarotta il bilancio dell’Argentina è positivo anche se molti problemi sussistono, l’inflazione è ancora troppo elevata – a detta di alcuni analisti è al 25 per cento mentre il governo insiste che è sotto il 10 per cento – e il Paese deve ancora restituire 16 miliardi di dollari agli investitori stranieri, inclusi gli interessi. Ma la disoccupazione è al 7 per cento, la crescita è sostenuta e il debito è pari al 35 per cento del Pil, una percentuale più bassa della Germania. L’esperienza argentina ci insegna quindi che nessun modello economico è perfetto ma soprattutto che nessuno dura per sempre. Bisogna avere il coraggio di sperimentare, quando il sistema in vigore non funziona più. Nel 2001 quando l’Argentina scelse questa strada fu duramente criticata da tutti, non una sola voce si alzò in sua difesa. Lo stesso accadde per la decisione dell’Islanda di intraprendere il sentiero in salita del default pilotato. Oggi economisti come il Nobel Paul Krugman elencano sulle pagine del «New York Times» i meriti del modello argentino. Forse è giunto il momento per i Piigs di uscire dagli schemi tradizionali e guardare ai risultati ottenuti nei laboratori del futuro sudamericani, per creare il loro modello economico anticrisi che necessariamente produrrà un cambiamento profondo nell’assetto politico. Ed ecco il vero ostacolo, ecco perché nessuna delle istituzioni si fa avanti a proporre, per salvarci – noi cittadini, il nostro lavoro, i nostri stili di vita – ricette che pure hanno già funzionato altrove: il vaccino contro il contagio economico distruggerà la classe politica esistente. È avvenuto in Argentina e in Islanda e succederà anche a casa nostra. E in fondo non è un male, è ciò di cui abbiamo bisogno. Il contagio Conclusioni Da mesi ci viene detto che a monte della crisi attuale ci sono gli speculatori. A loro si attribuisce tutta la responsabilità del cataclisma finanziario ed economico che incombe sul capitalismo occidentale. Gli Indignati europei e i loro cugini africani e mediorientali, invece, puntano il dito contro la classe politica e le élite che la compongono e la sostengono: il loro modello economico squilibrato non funziona più. Paradossalmente i mercati – il prodotto della deregulation degli anni Novanta – fanno da controcanto a questi ragazzi quando reagiscono negativamente alle dichiarazioni dei politici e alle misure in extremis dei governi. Durante l’estate del 2011, che passerà alla storia come la prima in cui i nostri rappresentanti politici non sono andati in vacanza o quasi, i mercati hanno detto no ai salvataggi dell’euro da parte della Banca centrale europea, alle manovre fiscali italiane, a quelle spagnole, all’austerità in Grecia, alla Tobin Tax sulle transazioni finanziarie e così via. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, abbiamo assistito agli scivoloni degli indici di Borsa, li abbiamo visti risalire per alcune ore solo per tornare a cadere. Nel frattempo, gli europei hanno neutralizzato chi speculava al ribasso sospendendo per tre mesi lo short selling, la pratica di prendere i titoli in prestito per venderli e ricomprarli a prezzi più bassi e intascare la differenza. Ma neppure questa misura «eccezionale» ha fermato i saldi in Borsa dei prodotti finanziari «made in euro». I mercati, come la popolazione europea, non si fidano della classe politica e temono il peggio. Ecco perché si chiede all’Italia e alla Spagna un tasso di interesse sempre più alto per piazzare il debito; ecco perché ingenti quantità di denaro sono parcheggiate in franchi svizzeri, yen e dollari australiani e canadesi; ecco perché si continua ad acquistare l’oro nonostante abbia superato la barriera dei 1800 dollari l’oncia. Sul mercato dei titoli, poi, tutti scappano dal debito sovrano dei Piigs e si rifugiano nei buoni del Tesoro americani, tedeschi e inglesi, anche se i rendimenti sono ai minimi storici e quindi non ci si guadagna nulla. Meglio una piccola perdita certa che la minaccia di una ingente. Ed ecco il punto: qual è questa potenziale perdita ingente? Si tratta della possibile bancarotta di uno dei Paesi Piigs. I mercati ci stanno dicendo proprio quello che nessuno di noi vuole sentire: se le cose non cambiano questi Paesi non ce la faranno a sostenere un debito tanto elevato. L’immobilismo economico e sociale, come acqua stagnante, permette ai germi del contagio di riprodursi e diffondersi. E il cambiamento di cui abbiamo bisogno non è la promessa di far quadrare il bilancio, né la riorganizzazione dei conti dello Stato attraverso lo spostamento di alcune voci da un titolo di spesa a un altro, neppure la riduzione di alcune di queste ultime. Ciò che i mercati domandano è la ripresa della crescita economica. E guarda caso è proprio ciò che invoca la popolazione europea. Nessuna delle manovre presentate quest’estate dai Paesi europei e dagli stessi Stati Uniti è in grado di rimettere in moto l’economia nazionale, figuriamoci quella occidentale. Il motivo? Sono in realtà manovre contabili e di brevissimo periodo. Che significato ha tagliare la spesa di 80 miliardi o tassare ulteriormente quel ceto medio a reddito fisso e quella piccola impresa sui quali da anni pesa un carico fiscale eccessivo, il tutto per racimolare appena 45 miliardi di euro? Operazioni che rallentano ancora di più la già scarsissima crescita? Sono domande che sorgono spontanee di fronte alle due manovre fiscali estive di Tremonti, quella di luglio e quella di Ferragosto. Di certo tutto ciò non aumenta la competitività dell’economia italiana e di sicuro non ha cambiato l’atteggiamento dei mercati nei confronti del nostro Paese. Lo sanno gli economisti ma anche gli elettori e gli Indignati lo hanno capito. Neppure l’ingresso nel capitalismo occidentale degli eurobond, questa specie di deus ex machina che i politici dei Paesi deficitari stanno cercando di gabellare alla popolazione come se fosse la medicina per tutti i mali, risolverebbe il problema. In realtà l’eurobond non fa altro che passare il debito dello Stato sovrano all’Ue, un’organizzazione federale, esattamente come nel 2008, all’indomani del crollo della Lehman, i salvataggi dello Stato hanno traslato nei conti di quest’ultimo il debito delle banche e delle istituzioni finanziarie. Il problema non è come indebitarsi ulteriormente a tassi bassi per pagare gli interessi sul debito, ma come rimettere in moto l’economia facendola crescere a tassi più elevati di quelli del debito, per poterlo ripagare con la crescita. L’eurobond, ahimè, non ha questo potere. Per crescere bisogna essere competitivi e questo significa avere un costo del capitale e del lavoro più basso dei concorrenti, possedere una tecnologia più avanzata che permetta di produrre a costi inferiori, oppure con qualità superiore a parità di costi. Dato che i tassi d’interesse sono praticamente a zero è difficile intervenire sul costo del capitale, rimane dunque l’altro elemento chiave dell’equazione capitalista: il costo del lavoro. Ecco spiegato perché da almeno due anni in Italia e negli altri Paesi Piigs si cerca di abbatterlo in tutti i modi possibili. Ma tagliare i salari strangola il consumo e riduce il gettito fiscale e quindi peggiora la situazione perché contrae la crescita. Siamo in un vicolo cieco? È questo che molti operatori di mercato pensano quando svendono il debito italiano per acquistare quello tedesco? Assolutamente no. A tutte le crisi economiche c’è una soluzione che può essere più o meno onerosa per la popolazione, una verità che chiunque operi sui mercati finanziari conosce. Chi oggi non ha fiducia nel rischio Italia o Spagna teme che il salvagente europeo non sia sufficientemente grande per queste nazioni e che arriverà il momento in cui per indebitarsi esse dovranno pagare tassi da usura, condividendo il destino dell’Egitto di Ismail e dell’Argentina di Menem. A quel punto, lo sappiamo bene tutti, i Bot italiani e le obbligazioni spagnole diverrebbero carta straccia. E dunque gran parte delle banche nazionali crollerebbe, dal momento che hanno in portafoglio ingenti quantità di titoli del Tesoro – in Italia la popolazione ha sottoscritto circa il 50 per cento del debito pubblico. Ed ecco spiegato perché nell’estate del 2011 sono crollate le quotazioni delle banche europee. Nessun operatore di Borsa vuole rimanere coinvolto in un simile scenario. Perché sorprenderci? In fondo anche tutti noi non abbiamo più fiducia in chi ci governa, ed è solo la paura dell’ignoto che ci porta ad aggrapparci alle finte speranze che i venditori di fumo ci presentano come soluzioni del problema. Qualcuno crede davvero che l’austerity britannica sia una strada da intraprendere, dopo aver visto bruciare interi isolati durante cinque giorni di saccheggi? Se tagliare la spesa pubblica non è la soluzione e ridurre il debito è imperativo non resta che una strada: la svalutazione. Ed ecco tornare ad aleggiare sul Mediterraneo lo spauracchio delle politiche scellerate degli anni Settanta e Ottanta, quando i Paesi del Sud Europa svalutavano regolarmente per far quadrare i conti. Ma questa volta non potrà essere così semplice, perché oggi svalutare per i Piigs significa uscire dall’euro e andare in default, un’alternativa che ci viene prospettata come apocalittica. Ma è proprio così? Le esperienze dell’Argentina e dell’Islanda ci insegnano che un default pilotato attutisce l’impatto negativo sull’economia nazionale. Se si riesce a garantire il debito interno l’economia non precipita nell’abisso. Per farlo, un Paese come l’Italia deve trovare circa 800.000 miliardi, un po’ più della metà del debito pubblico, quella fetta insomma che hanno sottoscritto banche e cittadini. L’unico modo è una tassa secca, una tantum sul patrimonio. E dato che l’un per cento della popolazione detiene il 45 per cento della ricchezza, è già chiaro chi dovrà pagare. Diverso è il discorso per il debito pubblico nelle mani degli operatori esteri, con i quali bisognerà negoziare una ristrutturazione. E qui entra in gioco l’effetto domino. Dato che una grossa fetta è stata acquistata dalle banche francesi e tedesche, saranno queste a incassare il colpo. Se anche il resto dei Paesi Piigs scegliesse la strada del default pilotato, allora sicuramente una buona parte di queste banche rischierebbe il fallimento. È dunque possibile che il default pilotato dei Paesi deficitari trascini nella stessa melma anche quelli ricchi. È ciò che Germania e Francia vogliono evitare a tutti i costi. La situazione è dunque molto complessa e si rischia di scivolare lungo una china dove la svalutazione diventa l’arma di tutti contro tutti. Ecco perché una decisione di questo tipo non può essere presa da un Paese indipendentemente da tutti gli altri. Dovrebbe essere l’Ue ad approvare e guidare l’uscita temporanea dei Piigs dall’euro e la svalutazione delle monete nazionali per riequilibrare le economie. E a stabilire parametri più realistici (e controlli più efficienti) per il reingresso nel futuro. Spiegato in poche parole sembra un programma semplice, ma non lo è per una serie di motivi. Primo e più importante, l’impatto che queste decisioni eccezionali avrebbero sui governi e sui politici. Molto banalmente, per quanto riguarda le classi politiche nazionali e internazionali l’unica soluzione plausibile e seria sarebbe il ricambio completo. Che porterebbe ai G8 e ai G20 dei prossimi anni volti oggi sconosciuti a tutti noi. La salvezza dell’Europa, e forse anche del capitalismo come lo abbiamo conosciuto, per non parlare poi della pericolante supremazia economica e finanziaria dell’Occidente, richiede il sacrificio in massa di chi ci ha governato con estrema scelleratezza fino a oggi. È proprio questo che chiedono gli Indignati nelle piazze e in fondo anche i mercati. Succederà? La risposta la sta già portando il vento. Fonti Bibliografia Tahar Ben Jelloun, La Rivoluzione dei gelsomini. Il risveglio della dignità araba, Bompiani 2011. Michele e Yvonne Brondino, Il Nord Africa brucia all’ombra dell’Europa, Jaca Book 2011. Raffaele Cantone con Gianluca di Feo, I Gattopardi, Mondadori 2011. Michelangelo Cocco, Il fuoco di Atene, Manifestolibri 2011. Stéphane Hessel, Indignatevi!, ADD Editore 2011. Karim Mezran, Silvia Colombo, Saskia Van Genugten (a cura di), L’Africa mediterranea. Storia e futuro, Donzelli Editore 2011. Nunzia Penelope, Soldi rubati, Ponte alle Grazie 2011. Claudio Siciliotti, Dare e avere. Dall’analisi dei conti pubblici, una nuova stagione dei diritti e dei doveri, Ipsoa 2010. Articoli sul web Tiziano Colombi, Rivolte e nuovi media, http://www.nazioneindiana.com/2011/06/01/rivolte-e-nuovi-media/ Giovanni Gozzini, Le rivolte in nord Africa contagiano i giovani europei, http://www.vanityfair.it/news/mondo/2011/05/23/rivolte-paesi-arabi-analisi-mediterraneo Miguel Mellino, Buenos Aires 2001-Tunisi 2011, la fine di una lunga notte in 10 anni, http://uninomade.org/buenos-aires-2001-Tunisi-2011-la-fine-di-una-lunga-notte-in-10-anni/ Ramón Muñoz, Adiós, clase media, adiós, http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Adios/clase/media/adios/elpepueconeg/200905 31elpneglse_2/Tes Fonti statistiche I dati citati all’interno del volume sono tratti dalle relazioni di: Banca d’Italia, Banca mondiale, Bloomberg, Eurostat, Fondo monetario internazionale, Istat e Onu. I dati sulla disoccupazione giovanile in Europa sono tratti dall’indagine Labour Force Survey condotta da Eurostat (dati aggiornati a giugno 2011). Ringraziamenti Quando Carlo Alberto Brioschi mi ha chiesto se volevo scrivere un libro sul contagio della rivoluzione araba in Europa non immaginavo che mi sarei appassionata tanto a questo tema, né prevedevo che avrei scoperto nella generazione millennium sentimenti come frustrazione, dolore e speranza che hanno caratterizzato anche la mia giovinezza. Nelle storie di precariato, di disoccupazione e insoddisfazione ho ritrovato me stessa quando a 24 anni sono salita su un volo per Washington D.C. con un biglietto di sola andata. I racconti di questi ragazzi che vedono nell’emigrazione l’unica possibilità di avere una vita normale e che vorrebbero tanto rimanere in patria mi hanno ricordato quanto è duro lasciare il proprio Paese. Negli anni Settanta come oggi non è giusto che per conquistarsi una professione e una famiglia i giovani debbano andarsene. È per contrastare queste ingiustizie economiche ed esistenziali che appoggio le iniziative di protesta degli Indignati. Non a caso questo libro è dedicato a Martina Giuffrè, prototipo della precaria, dell’insegnante universitaria sottopagata e sfruttata, dell’intellettuale non riconosciuta, una donna intelligente, grande lavoratrice e coraggiosa, che non è voluta entrare nelle statistiche dei cervelli in fuga ed è tornata in Italia e che come tanti suoi coetanei si è ritagliata una vita «normale» nel precariato. Nella lunga lista dei ringraziamenti, dunque, Carlo Alberto Brioschi e i miei agenti letterari Luigi e Daniela Bernabò, che da anni mi incoraggiano a scrivere sui giovani, figurano ai primi posti. Accanto a loro c’è l’instancabile Michela Gallio, la mia editor, con la quale negli ultimi mesi ho parlato più spesso che con mio marito. Come sempre Federico Bastiani, il mio assistente, mi ha organizzato la vita in modo impeccabile, spesso anticipando i miei desideri. Insieme a Clara Mendez, la mia assistente spagnola, Federico mi ha messo in contatto con gli Indignados con i quali ho iniziato un dialogo che mi ha arricchita professionalmente e umanamente. Grazie anche alla mia agente americana, Diana Finch, che ha convinto gli editori stranieri a lasciarmi scrivere questo libro e a posticipare l’uscita di Maonomics nei loro Paesi. Un ringraziamento particolare va a Per Axelsson, il mio editore svedese, e a Björn, suo figlio, precario trentenne e talentuoso ricercatore, per l’incoraggiamento e la fiducia nei confronti delle mie tesi economiche. Grazie a Matteo Ballero, anche lui ricercatore di prima classe, e a Björn che mi hanno aiutato nelle ricerche per il mio altro libro in uscita, Ten Years that Shook the World, e senza i quali non ce l’avrei mai fatta. Senza l’aiuto degli Indignati spagnoli ed europei questo libro non esisterebbe. A tutti coloro con cui quotidianamente dialogo su Twitter va quindi la mia riconoscenza e la speranza che questo libro sia loro d’aiuto per diffondere nella società civile la consapevolezza che è arrivato il momento di cambiare il sistema. Grazie a Sabrina Provenzani per aver letto il testo e suggerito una serie di miglioramenti, grazie a Clementina Chieffo per avermi spiegato alcuni dei misteri del debito pubblico e al caro amico Vittorio Pignatti, che mi ha chiarito alcuni punti importanti sul funzionamento dell’alta finanza. Se ci fosse gente come loro a dirigere il nostro Paese le cose andrebbero molto meglio. Come sempre i colleghi del «Venerdì di Repubblica», dell’«Espresso» e del «Caffè» mi hanno aiutata a mettere bene a fuoco i temi caldi della mia ricerca. Non possono mancare i ringraziamenti a Sabina de Luca e ad Antonio Guadalupi con i quali, ad agosto durante un viaggio a Yellowstone, abbiamo discusso ininterrottamente il futuro dell’economia italiana ed europea. E come sempre grazie a mio marito Ron e alla mia famiglia per la comprensione e l’appoggio che sempre mi danno.
Scaricare