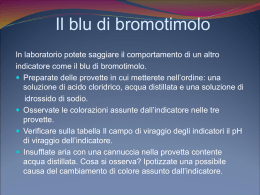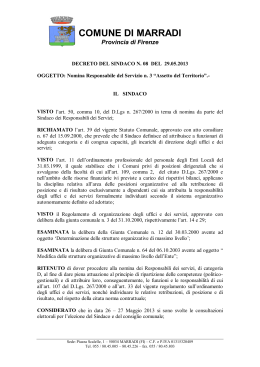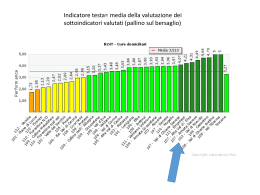3. Il linguaggio della ricerca 3.1 Paradigmi Il linguaggio della scienza è caratterizzato da quattro elementi costitutivi principali: i paradigmi, i concetti, le proposizioni e le teorie (cfr. Phillips, 1972: 69). I paradigmi possono essere definiti come ‘una serie di assunti impliciti ed espliciti che rappresenta la base su cui poggiano le idee scientifiche’. Essi costituiscono le premesse del discorso scientifico: possono quindi riguardare sia il modo di considerare i fenomeni, sia modelli o schemi accettati dalla comunità scientifica per analizzare tali fenomeni e metterli in relazione con le teorie e le ipotesi. Sia che riguardino modi di osservare la realtà, sia che si traducano in schemi di riferimento di carattere più generale, strutturano la ‘visione del mondo’ propria del ricercatore, spesso strettamente connessa al ‘senso comune’, patrimonio sia dello studioso che dell’uomo della strada, e concorrono a definire le molteplici scelte compiute all’interno di ogni ricerca. Rappresentano in sostanza le ‘basi non scientifiche della scienza’, come hanno osservato Goode e Hatt (1962: 34-35), citando ad esempio i convincimenti secondo i quali: a) il mondo esiste; b) possiamo conoscere il mondo; c) conosciamo il mondo per mezzo dei sensi; d) i fenomeni sono legati da relazioni causali. Di basi non scientifiche possiamo tuttavia parlare anche in riferimento a convinzioni radicate nella nostra cultura, che non si avverte la necessità di esplicitare in quanto date per scontate: ad esempio che il conseguimento di migliori condizioni abitative o di più elevati livelli di istruzione siano obiettivi degni di essere perseguiti, o che sia importante dedicare risorse allo sviluppo della conoscenza scientifica. Sono possibili diversi modi di concepire un paradigma, che hanno tuttavia in comune alcuni elementi: la precedenza (logica, ma spesso anche temporale) rispetto alla teoria, la sua maggiore astrattezza e pervasività, il suo porsi al di fuori delle procedure di controllabilità empirica. Margaret Masterman ha individuato ben ventuno definizioni diverse di paradigma nell’opera di Kuhn (1978), La struttura delle rivoluzioni scientifiche, che ha introdotto in modo dirompente questo concetto nella filosofia della scienza. Secondo la Masterman queste definizioni sono riconducibili a tre gruppi principali, corrispondenti alle seguenti accezioni: insieme di concezioni, standard, modi di vedere, principi organizzativi della percezione, chiamati dall’Autrice paradigmi metafisici o meta-paradigmi; risultati scientifici sui quali si realizza un consenso comune all’interno della comunità degli studiosi, definiti paradigmi sociologici; strumenti o insiemi di strumenti che consentono alla scienza di ‘risolvere dei rompicapi’ (l’espressione è di Kuhn), indicati come paradigmi artefatti o paradigmi-costruzioni (Masterman, 1986: 129-163; Statera, 1990). I tre tipi di accezioni sono stati oggetto di ampio dibattito tra i filosofi della scienza e tra gli epistemologi. Ai fini della trattazione successiva riteniamo particolarmente significativa la prima accezione, di portata più generale, che si risolve nel più ampio concetto di frame, di visione del mondo che presiede alla strutturazione delle percezioni, dei concetti e delle teorie e comprende sia interessi ed obiettivi (la componente valoriale), sia conoscenze scientifiche già acquisite (la componente assiomatica), sia infine strutture che connettono entrambi1. Lo stesso Kuhn, del resto, osserva che, nella scienza sociale, il paradigma è una prospettiva o un quadro di riferimento per osservare il mondo sociale, ed è composto da una serie di concetti e di azioni (...) è la finestra mentale attraverso la quale il ricercatore vede il mondo (Kuhn, 1978: 39). 1 Benché il concetto di frame sia stato introdotto recentemente, esso presenta cospicue analogie con quello di ‘stile di pensiero’ proposto già da Fleck nel 1935. 1 In realtà, dietro l’adozione di un paradigma, sta l’adozione di un frame, in quanto “la ricerca di un ponte fra ciò ch’è noto e ciò ch’è ancora sconosciuto, non è tanto una ricerca tra i percorsi di un albero decisionale conducenti ad una soluzione, quanto piuttosto una indagine sui possibili modi di organizzare e dare forma (framing, shaping, structuring) a una struttura decisionale appropriata“, talché “una volta che un frame viene evocato e attivato, il campo delle opzioni concepibili è fissato, e l’universo delle risposte e delle soluzioni è predeterminato“ (Minsky, 1975). Il paradigma-frame costituisce dunque già una prima strutturazione dell’intero processo di ricerca. Presupposti, tecniche di indagine e risultati attesi sono dunque immaginati, sia pure sommariamente, tutti insieme, anche se sono destinati ad essere precisati e definiti in modo almeno in parte sequenziale, come indicato nel capitolo precedente. 3.2 Concetti e definizioni operative Quale che sia la strategia adottata, il primo problema che si pone al ricercatore è quello di identificare le proprietà dell’oggetto della ricerca rilevanti, al fine di fornirne una descrizione, ovvero di individuare delle relazioni tra di esse. Come osserva Lazarsfeld anche la scelta delle proprietà strategiche costituisce un problema essenziale (1969, I: 43). Il percorso che conduce alla costruzione delle variabili passa necessariamente per la definizione dei concetti. Secondo taluni autori, anzi, le variabili altro non sono che la definizione operativa dei concetti, o per lo meno il mezzo per poterli misurare (ad es., Marradi 1987). Prima di parlare di variabili è bene quindi chiarire cosa siano i concetti. Essi costituiscono un modo di rappresentare la realtà, ovvero di raffigurare una classe di oggetti o fenomeni. In verità costituiscono un modo di ‘costruirla’, dal momento che non si può pensare ad alcuna ‘realtà’ senza utilizzare delle categorie mentali che la definiscano: il motivo per cui la ‘realtà’, inclusa quella sociale, ci appare preesistente è ben evidenziato dagli studiosi della sociologia della conoscenza (cfr. ad es. Berger e Luckmann, 1969). Secondo Marradi il concetto è un ‘ritaglio’ operato in un flusso di esperienze infinito in estensione e in profondità, e infinitamente mutevole (1987: 9). Rinviando a quest’ultimo autore per una documentata trattazione dell’argomento, preme in questa sede sottolineare alcuni punti. In primo luogo, i concetti rappresentano un’astrazione della realtà che consente di indicare e di attribuire un nome a un gruppo di oggetti o fenomeni. È evidente che esiste un nesso assai stretto fra il linguaggio e il concetto, dal momento che il linguaggio stesso rappresenta una forma espressiva che consente di riferirsi a oggetti o fenomeni anche in loro assenza (cfr. Marradi, 1994). I concetti rappresentano una forma di classificazione della realtà, realizzata attraverso un’astrazione dal ‘qui’ e ‘adesso’, che consente di raggruppare fatti od oggetti prescindendo dalla loro individualità e unicità sostanziale. La produzione di concetti costituisce un pre-requisito indispensabile per lo sviluppo del pensiero astratto e del linguaggio, in quanto affranca per l’appunto l’uomo dalla limitazione espressiva al ‘qui’ e ‘adesso’, fornendogli la capacità di simbolizzare-rappresentare il mondo. Nel caso dei concetti va rimarcata tuttavia la differenza esistente fra scienze della natura e scienze umane. Nelle prime, infatti, non si ha una retroazione tra il soggetto che definisce un concetto e l’oggetto dello stesso. Il fisico che definisce e usa il concetto di massa o di inerzia, e che lo applica ad uno o più corpi inanimati, si trova in una situazione diversa da un sociologo che si avvale di concetti come classe, gruppo, organizzazione. Mentre nel primo caso lo studioso costruisce o utilizza categorie mentali sulla base di percezioni sensoriali da lui strutturate in modo autonomo (sia pure secondo i canoni considerati legittimi da una comunità scientifica), nel secondo egli organizza in schemi cognitivi scientifici una realtà sociale che è già in qualche misura elaborata dagli ‘oggetti’ della sua ricerca. La classe sociale, il gruppo, l’organizzazione, sono concetti usati dal sociologo solo grazie al fatto che molti uomini agiscono in termini di classe, gruppo, organizzazione e definiscono se stessi e gli altri in rapporto a questi concetti. Naturalmente possono esistere, al limite, tante definizioni e tanti concetti di classe, gruppo, organizzazione, quanti sono gli uomini che hanno raggiunto l’età della ragione. Di norma, peraltro, solo una minoranza è in grado di definire in modo compiuto cosa intenda con questi concetti, e un numero ancora minore è in grado di ‘imporre’ agli altri la propria definizione, mentre una quota ben più consistente di individui si comporta secondo logiche di classe, di gruppo, di organizzazione. 2 Lo scienziato sociale si trova dunque dinanzi ad un duplice problema interpretativo, che non riguarda chi si occupa di scienze fisiche. Innanzi tutto, deve fare i conti con un mondo sociale in cui (quasi) tutti i soggetti posseggono una ‘competenza pratica’, che orienta l’agire quotidiano degli individui, ma solo alcuni posseggono una (adeguata) ‘competenza simbolica’ ossia la padronanza delle operazioni di costruzione di categorie astratte e di comunicazione di queste attraverso il linguaggio. Rileva anzi Giddens, a questo proposito, che uno degli scopi principali della sociologia è l’elaborazione di strumenti concettuali per l’analisi di ciò che gli attori sanno sul perché agiscono come agiscono, soprattutto quando non sanno (discorsivamente) di saperlo o quando attori situati in un contesto diverso mancano di tale consapevolezza (1990: XVII). In secondo luogo, occorre considerare che le difficoltà nel lavoro del sociologo non derivano solo dalla difforme capacità degli attori sociali di tradurre la propria competenza pratica in forma simbolica, ma anche dal fatto che quest’ultima non viene espressa in termini univoci e non ambigui. D’altro canto, proprio le difformità riscontrabili sia a livello della competenza pratica, sia della sua espressione simbolica, rendono ragione del fatto che in sociologia esistano molti concetti diversi di classe, gruppo, organizzazione, al contrario di quanto accade nelle scienze naturali. Ma queste difformità fanno anche sì che la trasposizione della ‘competenza pratica’, in schemi di classificazione scientifici non sia un’operazione né automatica né neutrale. Da un lato, infatti, esistono differenti livelli di capacità di esprimere con il linguaggio i termini in cui tale ‘competenza pratica’ orienta le proprie scelte; ed è intuitivo, oltre che facilmente dimostrabile sul piano della ricerca empirica, che tali capacità sono proporzionali al livello di istruzione dei soggetti, e variano in ragione della loro posizione sociale. D’altro lato, la scienza sociale ha a che fare spesso con interessi contrastanti, che vengono perseguiti anche attraverso la lotta per l’ufficializzazione di determinate forme e di specifici criteri di definizione e classificazione. Poiché infatti le rappresentazioni sociali della realtà orientano l’agire quotidiano, la loro definizione non costituisce un problema tecnico, ma un fatto politico. Fenomeno questo tanto più evidente, quando il termine precede la cosa, e quando l’usurpazione dell’identità nominale fa precipitare la costituzione dell’identità reale (Bourdieu, 1983: 474). Come osserva sempre Bourdieu i soggetti sociali classificati dal sociologo sono, non solo produttori di attività classificabili, ma anche di attività di classificazione, che vengono a loro volta anch’esse classificate (Ivi: 456). Tutto questo conferisce particolari responsabilità allo scienziato sociale, che non è solo ‘nel mondo’, ma anche ‘del mondo’, ossia è anch’esso parte in causa e non semplice osservatore esterno. Ogniqualvolta la sua pretesa neutralità lo induce a ritenere di classificare delle attività, egli di fatto, ne sia consapevole o meno, finisce per schierarsi a favore di una forma di classificazione specifica, a discapito di altre (potenzialmente presenti nella ‘coscienza pratica’), e fornisce a quella adottata il crisma della scientificità. Fleck afferma, a questo riguardo, che un’asserzione, una volta resa pubblica, appartiene in ogni caso alle forze sociali, che formano concetti e creano modi di pensare; essa stabilisce, insieme a tutte le altre asserzioni, ciò che ‘non si può pensare diversamente’. (...) Essa diventa una realtà in sé evidente, che in seguito condiziona dal canto suo nuovi atti di conoscenza ... (1983: 96). Sotto questo profilo, la posizione dello scienziato sociale è assai più difficile di quella dello studioso delle scienze della natura. A differenza di quest’ultimo, infatti, sia che legittimi la visione del mondo espressa dagli attori sociali studiati, fornendo ad essa una sorta di crisma di ufficialità, sia che sviluppi una critica verso le credenze degli agenti (fondata sulla conoscenza di effetti non previsti o di condizioni non conosciute delle azioni sociali), finirà comunque per modificare il loro comportamento, perché le conoscenze degli agenti sulle condizioni dell’azione sono causalmente rilevanti per essa (cfr. Giddens, 1990: 334 e segg.). Quanto siamo venuti fin qui affermando consente di sottolineare alcune implicazioni rilevanti sul piano della ricerca: i concetti sono comunque riferiti ad una comunità spazio-temporalmente delimitata, al di là dell’evidente possibilità di operare equiparazioni fra concetti simili usati da comunità diverse (ma chi decide quanto siano davvero simili?); 3 i concetti non possono essere considerati ‘astrazioni universali’, e sono quindi almeno in parte il frutto di una negoziazione intersoggettiva che rappresenta uno degli aspetti del continuo processo di riproduzione sociale; in altre parole, sono continuamente ridefiniti dagli attori sociali, anche se questi tendono a comportarsi come se il loro significato fosse scontato e ben definito (o definibile) una volta per tutte; i concetti usati dallo scienziato sono in larga misura mutuati dalla cultura di cui egli è partecipe; sono insomma patrimonio, almeno in parte, sia dell’uomo della strada, sia della comunità scientifica. Una considerazione particolarmente rilevante per le scienze sociali, che occupandosi di un mondo preinterpretato dagli oggetti del loro studio vi trovano anche modelli più o meno consolidati di strutturazione delle percezioni in concetti. I concetti rappresentano dunque una griglia di lettura della realtà (o meglio, il risultato dell’applicazione di tale griglia), un modo (‘il’ modo) in cui selezioniamo, attraverso processi in larga misura inconsci e non del tutto noti, fra le infinite percezioni sensoriali (a loro volta già organizzate secondo processi preconsci di carattere biologico, chimico e fisico), gli elementi che ci consentono di comporre una struttura dotata di senso e di rappresentarla simbolicamente al di là dell’esperienza (al di là del permanere della percezione sensoriale da cui trae origine). L’eziologia del concetto è infatti riconducibile all’obiettivo pratico del controllo della realtà circostante, obiettivo che richiede un preliminare processo di selezione, astrazione e ordinamento, volto a cogliere relazioni strutturali la cui permanenza al di là dell’esperienza sensoriale si cristallizza nel concetto (Goode e Hatt, 1962: 17-18; Berger e Luckman, 1966). Osserva opportunamente Gallino a questo riguardo che i concetti non sono neutri, né descrivono proprietà del mondo indipendenti, statiche. Sono invece entità attive. Ognuno di essi dà voce a un’intenzione dell’attore; ognuno estrinseca una volontà ordinatrice, la disposizione a manipolare il mondo, un desiderio di potere. Qualunque astrazione è orientata a una finalità (1992: 91). È possibile distinguere tre tipi di concetti, caratterizzati da una distanza crescente delle percezioni sensoriali a cui sono riferiti. Nel primo tipo i referenti sono oggetti o fatti sui quali esiste piena concordanza fra linguaggio comune e linguaggio scientifico (ad es., i concetti di legno, ferro, tavolo, finestra), al di là del grado di estensione nel tempo e nello spazio dei singoli concetti (si pensi a legno, mobile, chiodo, ed alla loro presumibilmente diversa ‘data di nascita’). Sono di norma concetti relativi ad oggetti o azioni semplici e profondamente radicati nella cultura. Il secondo tipo comprende quei concetti che, essendo presenti in entrambi i patrimoni culturali, richiedono specificazioni per essere usati in modo inequivoco in ambito scientifico. Si pensi, in sociologia, ai concetti di classe, ceto, strato, in economia a reddito, lavoro. Nel terzo tipo, infine, rientrano i concetti generati direttamente in ambito scientifico (e talvolta poi entrati a far parte anche del patrimonio comune), dei quali sono ricche soprattutto le scienze naturali: quanto, protone, momento, entropia. Le scienze umane hanno prevalentemente a che fare con concetti del secondo tipo. Si pongono perciò notevoli problemi di chiarificazione concettuale: in altri termini, lo scienziato sociale che intenda (o debba) avvalersi di concetti del secondo tipo ha l’onere di precisarne il significato. Inoltre, come osserva Statera, benché i concetti usati in sociologia si pongano talvolta come ‘costrutti di secondo livello’ rispetto a quelli di senso comune, è bene che non risultino incompatibili con questi ultimi (Statera, 1990: 19). Come osserva Marradi (1987), i concetti possono poi essere ordinati secondo una scala di astrazione: se il concetto rappresenta comunque un’astrazione dal ‘qui e adesso’, questa è graduabile in una pluralità di livelli, che consentono l’inclusione di quantità crescenti di fenomeni in un concetto. Il passaggio da ‘tavolo in metallo rosso’ a ‘tavolo rosso’ a ‘tavolo’ fa aumentare il numero dei referenti concreti del concetto (i tavoli rossi comprendono anche i tavoli in legno; i tavoli comprendono anche i tavoli verdi, gialli, neri, ecc.) e quindi la sua astrazione o distanza dal ‘qui e adesso’. Naturalmente la scala di astrazione è potenzialmente infinita. Non solo infatti dai ‘tavoli’ si può passare ai ‘manufatti’ e così via. Ecco perché, nella fase preliminare di una ricerca sociale, è spesso necessario procedere ad una precisazione attenta dei termini/concetti che verranno impiegati, al punto che talvolta si parla di vera e propria ‘riconcettualizzazione’: un’operazione che può anche apparire superflua al profano, ma che spesso è essenziale per una corretta comunicazione a livello scientifico. Resta da sottolineare che il concetto è un elemento del discorso scientifico che non è né vero né falso, a differenza delle proposizioni costruite con il suo concorso. La selezione dei concetti da impiegare nella ricerca sociale risponde pertanto a criteri di utilità e/o di appropriatezza, non di verità. Le proposizioni, a loro volta, sono 4 affermazioni circa la natura della realtà (Phillips, 1972:87) e sono pertanto suscettibili di essere ritenute vere o false sulla base dei risultati della ricerca. Le proposizioni costituiscono il legame fra la teoria e la (percezione della) realtà, e pongono di norma in relazione due o più concetti. Una teoria scientifica può essere considerata come un complesso gerarchicamente ordinato di proposizioni, logicamente coerente al suo interno, che si fonda sulla realtà 2. Le proposizioni di cui si parla in questa sede costituiscono per l’appunto quelle asserzioni circa la natura del reale la cui conferma consente di corroborare l’intera teoria che sorreggono. Per la verità il legame fra teoria e proposizioni controllabili è a sua volta mediato dall’ipotesi, la cui funzione è per l’appunto quella di enunciare una relazione specifica esistente tra fenomeni in modo tale che questa relazione possa essere empiricamente verificata (Goode e Hatt, 1962: 115), come si dirà oltre. È bene tuttavia segnalare che il termine ‘teoria’ viene impiegato molto spesso, nelle scienze sociali, in un’accezione diversa da quella di complesso di proposizioni controllabili empiricamente. Un’accurata analisi condotta da Marradi sull’impiego di questo termine in scienza politica ha individuato ben ventisei significati diversi, di cui solo ventidue sono riconducibili, non senza difficoltà, al linguaggio scientifico (Marradi, 1984; Statera, 1990: 13 e segg). Giddens, a sua volta, sostiene che una concezione formalizzata di teoria, quale quella proposta in precedenza, costituisce piuttosto l’eccezione che non la regola in ambito sociologico. A suo avviso, infatti, è assai diffusa l’impostazione secondo la quale gran parte di quello che passa per ‘teoria sociale’ consiste di schemi concettuali e non ... di ‘proposizioni esplicative’ di impianto generalizzante (Giddens, 1990: XVI). 3.3 Dai concetti alle variabili: l’operativizzazione Scopo della ricerca è quello di formulare delle affermazioni suscettibili di essere sottoposte a controllo empirico. Per fare questo occorre che le proprietà chiamate in causa siano suscettibili di assumere due o più livelli o stati, o di essere specificate in modo da poterli assumere. Una proposizione del tipo ‘il livello di istruzione è influenzato dal sesso’ richiede che il concetto di istruzione possa assumere diversi stati, come pure quello di sesso, e che tali stati siano poi rilevabili in termini di ‘proprietà’ del reale. La proposizione ‘la sedia è un prodotto dell’attività umana’ pone invece in relazione un concetto con due possibili stati del reale (essere un oggetto prodotto dall’attività umana oppure no). Entrambe le affermazioni proposte contengono almeno un concetto suscettibile di assumere almeno due stati nell’ambito dei suoi referenti concreti. Tale concetto è cioè traducibile in una variabile, strumento teorico capace di rilevare i diversi stati del reale, o più precisamente di quelle proprietà del reale3 rilevanti ai fini del processo di ricerca. Se dunque l’ipotesi rappresenta un’affermazione sulla natura della realtà formulata avvalendosi di concetti, la variabile rappresenta lo specifico punto di vista sotto il quale si osserva la realtà; mentre l’ipotesi pone in relazione stati diversi delle variabili con altre proposizioni (se ... allora), la variabile misura gli stati diversi della realtà; in definitiva, un’ipotesi è un’affermazione congetturale circa le relazioni fra due o più variabili ... misurabili o potenzialmente misurabili (Kerlinger, 1965: 69, cit in Marradi, 1980a). Il ‘potenzialmente misurabili’ ci rammenta che la traduzione di un concetto in una variabile e la successiva rilevazione non rappresentano necessariamente un’operazione banale. Il concetto di istruzione, ad esempio, è suscettibile di traduzioni diverse: nella variabile ‘scolarità’ degli individui, ma anche nella variabile ‘ammontare delle conoscenze possedute’ (rilevata ad esempio attraverso appositi test). Inoltre, la variabile ‘scolarità’ è misurabile in termini di anni di frequenza scolastica o di titolo di studio conseguito; ed 2 Merita di essere segnalata anche la definizione, proposta da Perrone, di «struttura di relazioni probabilistiche tra variabili interpretate razionalmente» (1977: 47). 3 I concetti possono riferirsi sia ad ‘oggetti’ nella loro interezza (p. es., ‘uomo’), sia a proprietà di tali oggetti (peso, età di un uomo). È quest'ultimo il caso più frequente nella ricerca empirica. Cfr., per un approfondimento, Marradi, 1980a: 19-32. 5 in entrambi i casi potrebbero sfuggire alla rilevazione fenomeni quali la frequenza a corsi di formazione professionale, certamente ricompresi nel più generale concetto di ‘istruzione’. La variabile può essere considerata la ‘versione misurabile’ del concetto, necessaria per passare da una formulazione generale di un’ipotesi ad una controllabile empiricamente. Sia il concetto che l’ipotesi di cui fa parte scendono così dalla scala di astrazione, fino a giungere alla misurabilità. Si parla in questo caso di operativizzazione di una variabile (o di ‘variabile operativa’). Una buona definizione è proposta da Nagel, secondo il quale con ‘definizioni operative’ si intendono i modi secondo cui sono in relazione le nozioni teoriche e le procedure osservative (1968: 101), mentre Blalock jr. afferma che una definizione operativa è una definizione che indica esattamente i procedimenti usati per la misurazione (1976: 23). La scelta delle variabili è determinata dal concetto che si intende rilevare, e a loro volta gli strumenti di rilevazione sono determinati dalle variabili. In effetti da più parti è stata messa in discussione l’univocità dei vincoli che costituiscono i diversi passaggi (ad es., Marradi 1987). Inoltre, Statera (1990) ha osservato che sarebbe erroneo far derivare le definizioni operative da un percorso quasi automatico di discesa lungo una scala di astrazione. A suo giudizio, l’operativizzazione dei concetti e le scelte degli indicatori sono operazioni mediate e guidate dalla teoria. Pertanto la sequenza teoria - proposizioni (che fanno uso di) concetti - operativizzazioni - indicatori è tale solo in senso logico, essendo in realtà caratterizzate da retroazioni e interrelazioni consistenti. È d’altro canto intuitivo che il passaggio da un’ipotesi generale ad una operativa, necessariamente più specifica in ordine alle circostanze spazio-temporali che delimitano l’ambito di controllabilità dell’ipotesi stessa, comporta una conseguente limitazione dei fatti che possono essere prodotti a sostegno dell’ipotesi generale. Il problema, che si pone ad ogni passaggio di livello nella scala di astrazione, è particolarmente avvertito nella fase di definizione operativa delle variabili. È stato infatti sottolineato come, tutto sommato, una variabile sia costituita esclusivamente dalle operazioni specifiche condotte per misurare i fenomeni cui si riferisce, e non possa quindi essere impiegata in proposizioni che, attribuendole un significato più ampio, finirebbero per coinvolgere l’intero costrutto teorico. Nell’ambito della ricerca sociale le variabili di maggior interesse non sono quasi mai traducibili immediatamente in operazioni di rilevazione diretta dei dati. La coscienza di classe, la partecipazione politica, il tipo e livello di socializzazione, non possono essere rilevati allo stesso modo dell’età, del sesso, della statura. Si usano quindi spesso degli indicatori, ossia aspetti della realtà riconducibili alla variabile e misurabili; in altri termini, variabili più specifiche in cui è possibile scomporne una più generale e che sono traducibili in procedure di misurazione. Talvolta una variabile è riducibile ad un solo indicatore, sia pure al prezzo di una minore estensione del concetto che si intende misurare: è il caso, ad esempio, del titolo di studio assunto come indicatore del livello d’istruzione di un soggetto. Più frequentemente, tuttavia, gli indicatori sono più d’uno, in quanto rappresentano, come osserva Lazarsfeld, gli aspetti osservabili delle diverse dimensioni o componenti dei concetti. Secondo questo autore poiché la relazione tra ogni indicatore e il concetto fondamentale è definita in termini di probabilità e non di certezza, è indispensabile utilizzare per quanto possibile un gran numero di indicatori (1969: 44-45). Un indicatore viene definito valido quando il suo rapporto con un concetto è caratterizzato da un’ampia sovrapposizione (l’area di intersezione nella Figura 1), che ovviamente non può essere oggetto di rilevazione empirica, ma solo dell’apprezzamento teorico, comunque arbitrario, della comunità scientifica. Nella figura si nota ad esempio che l’indicatore n. 2 si sovrappone solo al concetto A, mentre il n. 3 è condiviso dai concetti A e B. Mediante l’indicatore n. 2 si misura dunque una parte del concetto A (insieme ad altri aspetti non rilevanti, indicati dallo spazio bianco); mediante il numero 3 si misura sia parte del concetto A che parte del B (oltre agli aspetti non rilevanti simbolizzati dallo spazio bianco). Un primo problema è costituito quindi dal fatto che l’insieme delle dimensioni in cui viene scomposto è di solito inferiore allo spazio semantico coperto dal concetto (anche perché se così non fosse sarebbe forse 6 possibile misurarlo direttamente), come si vede in Figura 1. Si badi bene che questo problema si pone anche se si misura un concetto con un unico indicatore: usare l’età anagrafica come indicatore del concetto di maturità delle persone, di loro idoneità a seguire un corso di studi, a svolgere un’attività lavorativa, ad essere titolari di rapporti contrattuali specifici (es., apprendistato, contratti di formazione lavoro) è una pratica abituale. Eppure è esperienza comune che l’età anagrafica è solo un indicatore (a volte neanche tanto valido) della maturità o idoneità delle persone, che dipende da molti altri fattori. Ad esempio la maturità dipende anche dal numero e qualità delle esperienze di vita vissute; l’idoneità a lavorare o a studiare dipende anche dallo sviluppo psicofisico di una persona (correlato alla, ma non coincidente con, la sua età anagrafica) e così via. Per quanto ci sforziamo di aggiungere indicatori, ci accorgiamo che, sotto questo aspetto, il concetto rimane più ampio (in termini di spazio semantico) della somma dei suoi indicatori (e a dire il vero anche più indeterminato). La ragione è anche di tipo epistemologico: in ogni comunità di parlanti esiste un nucleo comune e condiviso di significati assegnati ad un concetto, cui si unisce una parte variabile a seconda delle subculture specifiche che coesistono nella stessa comunità e un’ulteriore parte che deriva dalle abitudini individuali di uso del concetto. Solo nel caso limite di definizioni ‘legislative’ (Quine, citato in Marradi, 1984: 18) si possono circoscrivere in modo preciso i confini semantici di un concetto e se ne possono definire in modo altrettanto preciso gli indicatori e le definizioni operative. Figura 1- Concetti ed indicatori Concetto A Ind. 1 Ind. 2 Concetto B Ind. 3 Concetto C Ind. 4 Ind. 5 La mancata corrispondenza biunivoca tra concetti e indicatori genera diversi problemi, anche in sede di elaborazione statistica dei dati, che non è il caso di affrontare in questa sede. Basti qui ricordare che la validità, intesa come ampiezza del grado di sovrapposizione del concetto con le variabili che ne permettono la misurazione mediante indicatori, può essere valutata secondo due diverse prospettive. Quella cosiddetta semantica, adottata da chi ritiene che la validità di un indicatore vada apprezzata soprattutto sul piano teorico, si prefigge di controllare se gli indicatori proposti fanno parte dello spazio semantico coperto dal concetto; nei manuali viene di solito definita ‘convalida a vista’, ‘per contenuto’ o ‘logica’ (cfr. Bailey, 1991: 85), perché non si avvale di elaborazioni dei dati, ma solo di confronti tra definizioni (del concetto e dei suoi indicatori) e di tecniche di tipo argomentativo. In altri casi ci si prefigge invece di controllare la validità confrontando il singolo indicatore o con una ‘variabile criterio’, che costituisce una diversa modalità di misurazione dello stesso concetto (potremmo dire un suo diverso indicatore). In questo caso si ricercano relazioni significative tra la misurazione operata secondo l’indicatore utilizzato e quella effettuata in base alla variabile-criterio; diversa ancora la cosiddetta ‘convalida per costruzione’, che consiste invece nel porre in relazione gli indicatori scelti con altre variabili, che in base a precedenti ricerche sappiamo essere correlate con il concetto che intendiamo misurare (cfr. Phillips, 1972: 282-285; Bailey, 1991: 86-89). Un indicatore si definisce attendibile e affidabile quando l’esito delle operazioni predisposte in sede di operativizzazione è positivo, ossia coglie effettivamente gli stati delle proprietà che il ricercatore si era prefisso di rilevare (cfr. Marradi 1987; 1990). Come nel caso della validità, anche sull’attendibilità esistono posizioni diverse. Da un lato abbiamo infatti autori che ritengono l’attendibilità una proprietà dello strumento; in particolare, Phillips sottolinea che uno strumento di misura è attendibile se, applicato allo stesso fenomeno, produce sempre gli stessi risultati (1972: 285). Dall’altro lato altri, come Marradi, considerano l’attendibilità una caratteristica del processo di misurazione; la sua valutazione in questo caso mette in relazione l’esito della misurazione con lo stato effettivo del soggetto sulla proprietà che si intende misurare, considerando quindi l’attendibilità come proprietà del rapporto fra il concetto che ha suggerito la definizione operativa e gli esiti effettivi delle operazioni che tale definizione prevede (Marradi, 1980a: 36). Purtroppo, come rileva Marradi (1990: 55-96), nel quadro di una visione oggettivistica delle scienze sociali, il problema dell’attendibilità è stato sempre più affrontato attraverso manipolazioni matematiche della matrice dei dati (Giampaglia, 1986), piuttosto che investendo tempo ed energia nel controllare la corrispondenza delle risposte registrate alle effettive posizioni degli intervistati. 7 Tra le conseguenze di questa situazione si pone anche la crescente sovrapposizione, denunciata da Marradi, tra i concetti di attendibilità e validità, entrambi ridotti a misure ‘autoreferenziali’, centrate cioè sul prodotto dello strumento piuttosto che sul momento di produzione, cioè della sua applicazione alla realtà. Questo non più rimediabile inquinamento giustifica la proposta terminologica di Marradi (1990) di sostituire ‘attendibilità’ con ‘fedeltà’, quando si voglia fare riferimento al grado in cui lo strumento (somministrato in quei particolari casi da quegli specifici ricercatori a quei determinati oggetti di ricerca) rilevi effettivamente lo stato di quella proprietà che si intendeva registrare quando lo si è progettato4. Avendo presente questa esigenza, vari autori concordano sulla necessità di produrre misurazioni con strumenti diversi per misurare l’attendibilità correttamente (ad es., Bailey, 1985). L’invito è condivisibile, ma occorre chiedersi quanto gli strumenti debbano essere diversi: l’attendibilità delle risposte ad un item del questionario può essere valutata in riferimento ad un’altra, oppure ponendo la stessa domanda in sede di intervista in profondità, avvalendosi di test proiettivi, mediante tecniche osservative? A nostro avviso, maggiore è la differenza tra gli strumenti utilizzati per valutare l’attendibilità del primo, maggiore è la fiducia che possiamo assegnare a tale valutazione (per un caso empirico, cfr. Razzi, 1992). In breve, mentre la validità concerne le relazioni che corrono tra un indicatore e la variabile indicata, l’attendibilità si riferisce alla capacità dell’indicatore utilizzato di misurare realmente ciò che si prefigge. Concerne quindi le relazioni tra lo strumento di misura e la realtà misurata. Quanto, infine, alla precisione, che ovviamente influenza anche (ma non coincide con) l’attendibilità, basti dire che questa è definibile in termini di intervallo minimo (fra differenti stati di una proprietà) misurabile da uno strumento. Inutile aggiungere che la precisione di una misurazione non fornisce di per sé garanzia alcuna in ordine alla sua attendibilità e tantomeno alla sua utilità. 3.4 La misurazione Possiamo definire in prima istanza la misurazione come il processo di attribuzione alle proprietà degli oggetti o dei fenomeni osservati di valori corrispondenti a diversi stati di una variabile (o di un indicatore). Secondo l’impostazione costruttivista che adottiamo, è il quadro di riferimento teorico che determina l’osservazione o, se si preferisce, sono i nomi che ‘determinano’ le cose (le percezioni che abbiamo delle cose) e non viceversa5. Infatti, soprattutto in sociologia, è ben difficile sostenere che esistano ‘fatti sociali’ od ‘oggetti sociali’ osservabili o collezionabili senza una teoria e un quadro di riferimento che li definiscano come tali. Poiché i dati non possono essere considerati preesistenti alla rilevazione, la definizione operativa va intesa come un meccanismo che contribuisce a creare gli stati [degli oggetti su una certa proprietà] che registra (Marradi, 1987: 42). Il problema si presenta del resto anche nelle scienze della natura, in cui assumono un rilievo determinante gli ‘enunciati protocollari’ o ‘enunciati osservativi’ accettati dai ricercatori nel contesto dell’osservazione o dell’esperimento (Hempel, 1986: 71). In altre parole, per decidere cosa sia un ‘fatto osservabile’, occorre non solo una teoria che definisca i criteri di rilevanza per separarlo dagli infiniti fatti che stanno in ogni istante sotto gli occhi dell’osservatore, ma anche un accordo precedente della comunità scientifica su quali siano le regole procedurali da seguire perché un fatto venga considerato tale (Hesse, 1980; Fleck, 1983). Una volta definiti i ‘protocolli osservativi’, il processo di misurazione si sviluppa attraverso la preliminare definizione dell’unità di misura e dei possibili valori che può assumere una proprietà, e la successiva operazione di vera e propria misurazione, che comporta l’applicazione di un determinato parametro di riferimento alle percezioni della realtà ed il successivo loro ordinamento sulla base dell’esito di tali operazioni. Marradi (1981 e 1987a) osserva che ogni operazione di rilevazione è preceduta e seguita da un’operazione di classificazione. Preceduta, in quanto occorre prima dividere in categorie l’estensione del concetto, essendo possibile solo successivamente registrare lo stato sulla proprietà (già organizzata in categorie). Seguita, in quanto lo stato o valore registrato o misurato va assegnato alla categoria predefinita. 4 L'eccessiva standardizzazione degli strumenti e delle regole di somministrazione può portare ad una maggiore attendibilità dello strumento (nel senso ristretto del termine, come misurazione della stessa cosa in condizioni uguali), ma farà senz'altro diminuire la quantità di informazione rilevabile (Grawitz, 1986: 799; cfr. anche Pitrone, 1986). 5 Ci si riferisce alla frase di Galileo, per cui «i nomi e gli attributi si devono accomodare all'essenza delle cose, e non l'essenza ai nomi; perché prima furono le cose e poi i nomi» (lettera a Marco Welser del 1612). 8 Dal modo in cui viene operativizzato il concetto dipende fra l'altro la scelta della unità di misura. In taluni casi questa è suggerita, quasi imposta, dal tipo di proprietà che viene studiata: l’età si misura in termini di tempo trascorso dalla nascita, la statura con la scala metrica, e così via. Ma basta pensare a concetti in apparenza facilmente operativizzabili, come il livello di istruzione o il reddito, per rendersi conto che la scelta delle unità di misura dipende in gran parte dagli obiettivi della ricerca. L’istruzione potrà infatti essere misurata in termini di anni di studio compiuti (ma conteggeremo o no gli anni scolastici conclusi con una bocciatura?), di titolo di studio conseguito (ma ignoreremo in tal caso i curricula non completati?), di livello di conoscenze (quantità di domande cui un intervistato è in grado di rispondere) a seconda che intendiamo valutare la permanenza nel sistema scolastico, l’esito di tale permanenza, la preparazione di un candidato all’esame. In determinati casi sarà sufficiente distinguere fra alfabeti e analfabeti; in altri occorrerà specificare il tipo di diploma di laurea conseguito e, al limite, la sede universitaria di studio (come in effetti accade negli Stati Uniti o in Gran Bretagna). Più precisamente, non sempre il modo corrente di rilevare una variabile può essere assunto come opportuno o peggio ‘scontato’. Tornando ai rapporti misurazione-classificazione, occorre aggiungere che quest’ultima deve possedere tre requisiti (da Marradi, 1987: 45): esaustività (tutti i casi osservati debbono essere riconducibili alla classificazione impiegata), esclusività reciproca (nessun caso può appartenere a due classi diverse), unicità del criterio (l’attribuzione alle diverse categorie deve avvenire in base a un solo criterio). L’esperienza di ricerca insegna che l’adeguatezza di una classificazione è valutabile in base al numero di casi-limite che può presentare ed alla difficoltà di attribuirli all’una o all’altra classe. Ad esempio una classificazione binaria ‘lavoratori manuali’/‘lavoratori non manuali’, adottata in molti studi di mobilità sociale (cfr. Bendix e Lipset, 1959), oltre a presentare evidenti difficoltà di soluzione di casi-limite, quali quella degli artigiani e dei capi operai, risulta superata dalla diffusione delle nuove tecnologie, che rendono scarsamente discriminante tale fundamentum divisionis fra classe inferiore e classe media; una classificazione in base al reddito da lavoro può ingenerare problemi perché non considera il reddito differito della liquidazione di fine rapporto, che non spetta al lavoratore autonomo, e così via. In termini generali, la rilevazione di una variabile dà luogo ad una doppia successione di classi e di casi appartenenti ad esse che costituisce la variabile in senso statistico, come nell’esempio riportato: x1 x2 ... xi ... xn variabile x n1 n2 ... ni ... nn Dove x1, x2... xi... xn rappresentano le modalità che può assumere la variabile (o le classi in cui viene suddivisa) e n1, n2... ni... nn il numero di casi che grazie alla rilevazione è stato possibile assegnare alle modalità o classi 1, 2... i... n della variabile. Richiamando i tre tipi di rilevazione descritti da Marradi (1987), si può osservare che, nel caso dell’enumerazione, le classi o modalità corrispondono agli oggetti da contare (pere, mele, banane in un cesto); nella classificazione corrispondono a modalità predefinite dal ricercatore (gli stati che può assumere una proprietà); nella misurazione in senso stretto le classi costituiscono degli accorpamenti delle misurazioni effettuate (nel caso di una proprietà continua, come il reddito, le classi ‘fino a 1000 euro’, ‘da 1.000 a 2.000 euro’, comprendono tutti i casi rilevati con valore inferiore a 1.000 euro, compreso fra 1.000 e 2.000, e così via). Nella ricerca sociale si incontrano spesso rilevazioni del secondo tipo, ottenute creando prima una serie di classi e attribuendo poi a queste i casi osservati. Il modo in cui vengono costruite le classi è importante perché influenza il tipo di elaborazioni statistiche cui può essere sottoposta la variabile. Si è soliti distinguere fra quattro modi diversi di costruire le classi, che corrispondono a quattro tipi di scale di misurazione proposti da Stevens nel 1946 (trad. it., 1991): nominali ordinali di intervalli di rapporti o cardinali (relazioni di (relazioni di (operatori (operatori = o ), = o ; > o <), = o ; > o <; + o -), = o ; > o <; + o -; x o ). 9 Come si può agevolmente notare, l’ordinamento tipologico proposto presenta la caratteristica della cumulatività: gli operatori applicabili alla scala successiva includono cioè anche quelli della precedente (potremmo dire che le scale sono strutturate secondo una scala ordinale). Ad esempio, la variabile sesso è di norma articolata nelle due classi ‘maschio’ e ‘femmina’: al di là della semplice assegnazione di nomi alle proprietà degli oggetti e della descrizione di una relazione di uguaglianza o diversità non è possibile andare. Nel caso invece di una classificazione ordinata (ad esempio: “non amo la lettura/mi piace abbastanza leggere/la lettura è la mia attività preferita”) è possibile utilizzare, oltre alla relazione di uguaglianza o diversità, una gradazione sulla base del criterio di classificazione (nell’esempio proposto, il gradimento per la lettura). Esistono poi classificazioni espresse (o esprimibili) in valori numerici: la statura, il reddito e l’età: es., sono misurabili in classi. In questi casi, oltre alle relazioni = o , > o <, è possibile impiegare gli operatori + o -, o x. Più precisamente, alle scale in cui lo ‘zero’ teorico non coincide con quello della scala metrica adottata (come accade per la misurazione delle temperature con scale che non partano dallo zero assoluto) saranno applicabili solo gli operatori di somma e sottrazione (scale a intervalli); a quelle in cui lo zero della scala di misurazione corrisponde al punto zero della distribuzione (reddito, età), si potranno applicare anche gli operatori di moltiplicazione e divisione (scale di rapporti). Non è cioè corretto affermare che una temperatura di 40° centigradi è doppia di una di 20°, perché lo zero della scala delle temperature in gradi centigradi non corrisponde allo zero assoluto, bensì alla temperatura di scioglimento del ghiaccio. È invece corretto affermare che un soggetto con reddito pari a 30.000 euro l’anno ha un reddito doppio di chi guadagna 15.000 euro l’anno (anche se, in verità, il significato sociologico del reddito andrebbe riferito alla sua percezione sociale, ed è da dimostrare che questa si strutturi secondo le stesse modalità della grandezza economica cui si riferisce). In entrambi i casi, è possibile attribuire un valore numerico all’intervallo compreso tra due valori della scala (nell’esempio, la differenza fra le due temperature è di 20°). Da cosa dipende l’adozione di una scala? Innanzi tutto dal concetto-variabile in esame; in via subordinata, dall’unità di misura adottata. Si è detto ad esempio che la variabile ‘gradimento per la lettura’ può essere portata a una scala di rapporti se misurata in termini di numero di libri o di pagine lette in una unità di tempo mentre è misurata su una scala ordinale se si chiede una valutazione del grado di amore per la lettura (ma in tal caso da una rilevazione di atteggiamento, l’amore per la lettura, si passa ad una di comportamento, il numero di libri letti, che rinvia ad un concetto un poco diverso: un soggetto può infatti non amare la lettura ma essere un correttore di bozze e quindi dover leggere molti libri). In forza del criterio di cumulatività, ogni variabile espressa in una scala di ordine X può essere anche espressa nelle scale di ordine inferiore. Per converso, le esigenze di elaborazione quantitativa dei dati rendono opportuno portare la classificazione al più elevato ordine possibile (è quindi migliore, nel caso della lettura, sopra riportato, la scala di rapporti rispetto a quella ordinale, a condizione che non ‘peggiori’ il rapporto di indicazione che lega il numero dei libri letti, l’indicatore adottato, al gradimento per la lettura, il concetto da rilevare). Non è tuttavia lecito estendere impropriamente ad una variabile le proprietà operazionali relative ad una scala di ordine superiore a quella in cui è espressa la variabile stessa. Purtroppo gli esempi contrari si sprecano, in sociologia, favoriti dalla codifica numerica delle risposte a domande ‘qualitative’ (cioè espresse su scale ordinali o nominali), che invitano ad estendere le proprietà dei numeri a nomi e aggettivi. È intuitivo che può avere un senso parlare di ‘statura media’ o di ‘reddito medio’, non certo di ‘sesso medio’ o di ‘atteggiamento medio’ (la ‘media’ fra 10 casi di “non sono d’accordo sulla politica statale attuale” e 10 casi di “sono totalmente d’accordo” non è evidentemente zero, ma eventualmente una rissa!). Eppure, codificando con -1 il disaccordo e con +1 il totale accordo, un’ingenua analisi ‘quantitativa’ fornirebbe per l’appunto questo risultato. Fin qui si potrebbe pensare che il confine principale passi tra le scale non metriche e quelle metriche. Tuttavia Ricolfi, in un saggio del 1985 particolarmente attento ai problemi dell’analisi dei dati, propone un diverso modo di superare la dicotomia tra scale a intervalli e di rapporti, nell’ambito della rappresentazione di caratteri quantitativi. Ricolfi distingue tra: o o o scale di quantità, ossia scale di rapporti (secondo la tipologia di Stevens) che concernono grandezze trasferibili o ridistribuibili, scale metriche, ovvero scale di rapporti che rappresentano grandezze non trasferibili, scale di posizione, al cui interno gli stati sulla proprietà sono interpretabili come posizioni in un sistema di riferimento convenzionale (privo dello zero assoluto). 10 Le caratteristiche cui Ricolfi assegna rilevanza sono dunque sia l’esistenza di uno zero assoluto (inteso in senso ‘debole’, ossia come condizione di assenza di una proprietà, non in senso ‘forte’, come esistenza di un punto di origine della scala utilizzata), sia la trasferibilità della proprietà misurata. Dal punto di vista dell’analisi dei dati, la tripartizione di Ricolfi è assai efficace e merita di essere attentamente considerata, soprattutto in una fase come l’attuale, in cui la diffusa disponibilità di software statistici sofisticati non si accompagna ad un’altrettanto diffusa conoscenza delle condizioni di applicabilità delle diverse statistiche. Osserva dunque Ricolfi (1985: 217) la funzione dei tre livelli di scala è, più semplicemente, di escludere certi tipi di statistiche, il cui significato è incompatibile con la natura delle variabili su cui dovrebbero essere computate. Se ordiniamo i livelli di scala dal più ‘permissivo’ al più vincolante otteniamo uno schema di questo tipo: scale di quantità: tutte le statistiche, scale metriche: tutte le statistiche tranne gli indici di concentrazione e gli indici di eterogeneità, scale di posizione: solo le statistiche che non richiedono la positività della scala (media e momenti centrali). Sul tema della misurazione attraverso le scale, oggetto tra l’altro di un recente contributo (Pavsic e Pitrone, 2003), rinviamo anche a quanto precisato nel capitolo dedicato alla costruzione dei questionari. 3.5 Indici e indicatori Lazarsfeld, in apertura del notissimo saggio Dai concetti agli indici empirici, che sta alla base dell’approccio che potremmo definire ‘canonico’ della ricerca sociologica agli indicatori6 osserva che nessuna scienza considera il proprio oggetto nella sua pienezza reale. Ne sceglie alcune proprietà e cerca di stabilire delle relazioni tra esse (Lazarsfeld, 1969). Queste due proposizioni richiamano due cardini della ricerca empirica (ma più in generale della scienza): a) che è possibile conoscere solo in modo parziale, scomponendo l’oggetto in parti accessibili ai nostri strumenti di rilevazione empirica; b) che lo scopo della conoscenza non è solo descrittivo (ricomporre l’oggetto scomposto dopo averne approfondito le singole caratteristiche, chiamate da Lazarsfeld ‘proprietà’), ma anche e soprattutto interpretativo, ossia di saper leggere, attraverso i diversi fenomeni studiati, delle regolarità, delle ‘leggi sociologiche’ più generali. Lo stesso Lazarsfeld afferma infatti che tutte le scienze sociali devono affrontare il problema di muovere da osservazioni semplici per trarre inferenze su ‘oggetti’ più complessi (1969: 450). L’approccio di Lazarsfeld è in buona sostanza di carattere deduttivo, o top-down, nonché semanticamente connotato: si parte dalla definizione di un concetto, se ne esplora lo spazio semantico (quella che Lazarsfeld chiama la ‘specificazione del concetto’), individuandone aspetti o dimensioni sufficientemente autonomi da richiedere una rilevazione distinta, si scelgono indicatori per ognuna delle dimensioni considerate, si procede poi alla loro misurazione e, infine, all’eventuale (ri)costruzione di un indice sintetico, che ricomponga in qualche modo l’unitarietà di un concetto che è stato scomposto a due livelli (le dimensioni e gli indicatori che le misurano). Questo percorso è stato bene descritto da Marradi (1980a), che ha evidenziato che la scomposizione in indicatori non va confusa con la traduzione dei concetti in definizioni operative, che pone invece l’accento sul passaggio da dimensioni a indicatori misurabili. Alcune peculiarità proprie di questa concezione meritano di essere sottolineate: l’approccio deduttivo, che assegna in sostanza una priorità, logica e cronologica, alla fase di messa a fuoco del concetto rispetto a quella della sua scomposizione in dimensioni e, soprattutto, rispetto alla sua misurazione; prima vengono i concetti, poi gli indicatori, infine le procedure di misurazione degli stessi (si potrebbe anche dire: prima viene la teoria e poi il confronto con la realtà); 6 Il saggio è riprodotto anche in Cardano e Miceli (1991, 121-132). All’autore è stato inoltre dedicato l’interessante numero monografico di Sociologia e Ricerca Sociale 58-59. Sul tema degli indicatori si veda anche il numero monografico Pragmatica degli indicatori di Sociologia e Ricerca Sociale (XVI, 47-48, 1995). 11 l’approccio probabilistico, dal quale discendono importanti conseguenze, quali il principio dell’intercambiabilità degli indici e l’implicito rifiuto dell’approccio ‘sintattico’7; la preoccupazione per la misurabilità dei concetti: il processo di scomposizione in dimensioni è in Lazarsfeld fortemente legato alla necessità di produrre misure semplici per fenomeni complessi, sia pure pagando un duplice, inevitabile, scotto: quello di sacrificare alla misurabilità la possibilità di rappresentare interamente (oggi diremmo in modo olistico) il concetto e quello di dover poi ricomporre, in modo più o meno arbitrario, in un indice unico un concetto dalle molte sfaccettature. Torneremo tra breve sull’approccio lazarsfeldiano, che costituisce tuttora quello canonico in sociologia. Ad esso si affianca un’accezione del concetto di indicatore di carattere più generale, che assume un taglio prevalentemente descrittivo, in quanto un set di indicatori viene utilizzato per fornire una rappresentazione sintetica di fenomeni complessi. Un esempio per tutti è costituito dagli indicatori della qualità della vita, sui quali si è sviluppato anni addietro un ampio dibattito anche in Italia (per una rassegna si veda l’Appendice di Martinotti, 1988; Vergati, 1989; Lanzetti, 1990; Zajczyk, 1991). Esso può essere ricondotto al cosiddetto ‘movimento degli indicatori sociali’, iniziato negli Stati Uniti alla metà degli anni sessanta (cfr. Bauer, 1967), al cui interno l’indicatore presenta il significato più specifico di rilevazione di uno o più fenomeni capaci di consentire una valutazione concisa di una realtà sociale o di un suo aspetto particolare. Nella sua accezione più ampia, l’indicatore sociale consta quindi di un’elaborazione di dati elementari che “apporti sul tema in questione un autonomo, potente, connettivo e controllabile incremento conoscitivo” (Cipolla, 1988: 362, corsivo nel testo). Produce informazioni ulteriori rispetto ai dati dai quali viene ricavato (come il tasso di natalità a fronte del numero dei nati in un’unità di tempo e del numero medio dei residenti nel periodo), ma è anche un’elaborazione che intrinsecamente rinvia a qualche cosa altro da sé, che è parte indicante di una parte più o meno convenzionalmente indicata, e che è, per statuto, oltre se stessa, verso un concetto noto e ignoto, dentro un processo consolidato o emergente (Ivi: 363). Ma, come osserva sempre Cipolla, ciò che differenzia gli indicatori sociali da quelli elaborati all’interno di un questionario è soprattutto il loro rapporto con la teoria, in quanto nascono e possono essere costruiti per riferimento ad una teoria come ‘conoscenza tacita’, come insieme di osservazioni comunque dipendenti da riflessioni coordinate in cornici o reti conoscitive (Ivi: 365). Analogamente, Cannavò concepisce gli indicatori come variabili alle quali è stata assegnata una funzione indicale di una dimensione concettuale mediante un modello teorico (1999: 148). In questa prospettiva l’indicatore è riconducibile ad uno o più aspetti di un concetto, in ordine ai quali esistono o sono reperibili delle informazioni. Molto spesso ci si avvale infatti di dati già disponibili, quasi sempre aggregati ad un qualche livello territoriale, che vengono sottoposti ad elaborazioni statistiche elementari (rapporti, quozienti, percentualizzazioni, differenze assolute o percentuali; per una rassegna vedi Curatolo, 1979 e Guala, 1991); come osserva Frudà (1988), gli indicatori si costruiscono, anzi si progettano. Non di rado l’indicatore assume, oltre che un carattere descrittivo, anche una valenza normativa, in quanto inserito in un modello di analisi sociale di tipo valoriale: gli indicatori dello stato di salute della popolazione presuppongono ad esempio che il benessere fisico costituisca un valore positivo, e la sua assenza uno negativo. Le due prospettive, definite anche ‘sociologica’ o ‘lazarsfeldiana’ la prima e ‘statistica’ la seconda, corrispondono in realtà a due diverse strategie di costruzione degli indicatori: la prima privilegia infatti il processo di chiarificazione concettuale e la successiva operazione di individuazione di indicatori che siano, in primo luogo, validi (nel significato sopra visto, di sovrapposizione forte con l’area delimitata dal concetto, ossia di validità semantica) e solo in secondo luogo rilevabili agevolmente o, al limite, ricavabili da dati già disponibili. Si tratta della strategia che abbiamo illustrato nel paragrafo precedente. La seconda strategia 7 Sul principio dell’intercambiabilità degli indici si rinvia a Fasanella 1999; in un recente saggio (Palumbo, 2003a) ho sostenuto che Lazarsfeld aderisce nella sostanza all’approccio semantico, ma devo dire che questa assegnazione avviene in chiave interpretativa del principio di intercambiabilità degli indici, che esclude a mio avviso l’approccio sintattico perché legittima l’impiego di indicatori non correlati tra loro. 12 parte invece dai dati disponibili (o agevolmente rilevabili) per definire solo in seconda battuta quali loro elaborazioni possano essere considerate validi indicatori del concetto da misurare. Le due strategie possono essere anche ricondotte ad un approccio deduttivo e ad uno induttivo (cfr. Giampaglia, 1995; Palumbo, 1985 e 2003). In entrambi i casi si possono definire percorsi diversi tra i seguenti passaggi: a. b. c. d. dati (disponibili o rilevabili), informazioni (dati strutturati secondo criteri8), indicatori (informazioni strutturate ed eventualmente elaborate secondo criteri), concetti (cui sono riferiti gli indicatori). Tuttavia, nella prima strategia si ‘scende’ da d) ad a), nella seconda si segue il percorso inverso. In entrambi i casi, gli indicatori debbono possedere le seguenti caratteristiche (cfr. Zajczyk, 1997): validità, intesa come capacità di rappresentare effettivamente il concetto indicato in modo accettabile (ad esempio, gli esiti occupazionali sono un indicatore valido dell’efficacia della formazione, ossia corrispondono in modo accettabile al suo obiettivo?); attendibilità, quando l’esito delle operazioni predisposte in sede di operativizzazione è positivo, ossia coglie effettivamente gli stati delle proprietà che il ricercatore si era prefisso di rilevare (ad esempio, visto l’ampio spettro di posizioni sul mercato del lavoro, si tratta di accordarsi su cosa debba intendersi per ‘occupato’; la rilevazione potrebbe limitarsi agli occupati ‘regolari’ e non considerare il lavoro atipico); sensibilità, o potere di risoluzione, intesa come capacità di discriminare tra le diverse forme che può assumere un fenomeno (ad esempio, capacità degli indicatori di distinguere la formazione breve da quella lunga, l’occupazione coerente con la formazione ricevuta da quella non coerente, ecc.); adeguatezza, ovvero grado in cui l’indicatore risponde ai bisogni conoscitivi del ricercatore. Il problema si pone in particolare quando si utilizzano indicatori in senso statistico, ossia quando si ricorre ad elaborazioni elementari di dati disponibili, già rilevati per altre finalità, che si intende piegare alle esigenze conoscitive del ricercatore. Molto spesso questi sono articolati in forme non corrispondenti alle sue necessità: per esempio, le fasce d’età con cui sono rilevati i dati sulla disoccupazione possono non corrispondere a quelle previste per l’accesso a diversi percorsi formativi; comparabilità, che può riguardare sia la dimensione spaziale che temporale, ossia la possibilità di confrontare lo stesso fenomeno in aree territoriali diverse, ovvero lo stesso fenomeno nella stessa area ma in tempi diversi (si pensi al caso di rilevazioni della disoccupazione che obbediscono a criteri diversi, come accadeva fino a poco tempo fa nell’Europa Comunitaria, oppure al cambiamento dei criteri con cui viene definito il disoccupato all’interno dell’indagine Istat sulle forze di lavoro)9; tempestività: proprio l’inclusione dell’indicatore all’interno di un processo decisionale o di ricerca di supporto a questo rende necessario poter disporre dell’indicatore stesso in tempi adeguati per modificare un programma o un intervento grazie al giudizio formulato in base all’indicatore (ad esempio, sapere solo dopo tre anni quanti giovani in uscita da un percorso formativo hanno trovato un’occupazione coerente può essere di scarsa utilità per riorientare la programmazione - annuale - delle attività formative; per questo si preferiscono rilevazioni a sei mesi, anche se esse possono sottostimare l’effettiva efficacia della formazione in tempi più lunghi). In linea generale, se un concetto è articolato in un gruppo di indicatori, ciascuno di questi può essere considerato come una sub-variabile, può quindi essere elaborato ed analizzato autonomamente nelle sue relazioni con le altre variabili rilevate e, se del caso, con gli stessi altri indicatori. Accade spesso, tuttavia, che si reputi necessario ricomporre la variabile iniziale in un indice, che sintetizzi gli indicatori utilizzati. Ciò può avvenire sia per ragioni descrittive (ad es., costruire un indice che sintetizzi le diverse dimensioni della coscienza di classe, della posizione sociale, del livello di socializzazione, ecc.), sia per ragioni interpretative, ovvero per poter analizzare le relazioni tra la variabile di partenza e le altre variabili rilevanti. La ricomposizione in un indice può avvenire in vario modo, ed è condizionata sia dal tipo di rapporto che si è inizialmente ipotizzato sussistere tra gli indicatori, sia dal modo in cui gli indicatori sono stati misurati. 8 Per una convincente trattazione della differenza tra dato e informazione (intesa come conoscenza che è possibile trarre dai dati), si veda Nigris (2000). 9 Più precisamente, Zajczyk (1997) propone di intendere la comparabilità come uniformità: - nella definizione delle unità d’analisi; - nei criteri di definizione degli stati su ciascuna proprietà; - nelle definizioni operative. 13 Per quel che concerne il tipo di rapporto esistente fra i diversi indicatori, il principale problema concerne il fatto che le diverse domande (i diversi indicatori) non hanno necessariamente lo stesso ‘peso’, ossia non sono necessariamente indicative nella stessa misura della variabile iniziale: la costruzione dell’indice per semplice somma sarebbe corretta nel solo caso (indimostrabile) in cui i diversi indicatori cogliessero parti diverse (non sovrapposte) e della stessa ampiezza del fenomeno studiato. In caso contrario, è compito del ricercatore assegnare (a priori) dei ‘pesi’ diversi ad ogni indicatore, che rappresentano l’intensità del rapporto di indicazione di ciascuno di questi con il concetto indicato. Non si tratta di un’operazione semplice, anche perché: le diverse domande possono cogliere, oltre alla dimensione relativa alla variabile ‘indicata’, anche elementi propri di altre variabili, non necessariamente disposte secondo lo stesso continuum: ad esempio, assumere come indicatori della qualità della vita sia il consumo di beni ‘materiali’ (auto, abitazione, ecc.) sia quello di beni ‘immateriali’ (sport, teatro, viaggi) può nascondere due orientamenti contrastanti, rivolti a generi di consumo fortemente diversificati, correlati in un caso alla disponibilità di denaro, nell’altro alla disponibilità di tempo; il numero di indicatori riferiti alle diverse dimensioni di una variabile possono provocare, una volta sommati, una sovrastima di talune dimensioni a scapito di altre (ad esempio, nella valutazione dello status sociale, è possibile utilizzare un numero elevato di item relativi al possesso di beni tutti legati alla dimensione del reddito); le combinazioni individuali di risposte possono configurare esperienze molto diverse, mettendo pesantemente in discussione, nel caso ad esempio della qualità della vita, l’assunto secondo il quale questa è proporzionale alla quantità assoluta di beni posseduti/consumati o di opportunità godute e non, ad esempio, alla loro quantità relativa (rispetto a gruppi di riferimento) o alle modalità di fruizione. Il problema è riconducibile a quello citato sub 1 quando il concetto che si intende misurare mediante gli indicatori sia multidimensionale e non necessariamente ogni dimensione sia legata alle altre secondo una relazione lineare. Per quel che concerne invece il modo in cui sono misurati i singoli indicatori, basti ricordare che ogni operazione di somma è comunque scorretta quando gli indicatori (o alcuni di questi) siano misurati secondo una scala nominale o ordinale. Poiché tuttavia è bene talvolta fare di necessità virtù, alcune variabili nominali possono essere tradotte in variabili dicotomiche caratterizzate dalle due modalità ‘presenza’ o ‘assenza’ di una proprietà; assegnando valore ‘1’ alla presenza e ‘0’ all’assenza, è possibile procedere ad una somma (aritmetica o ponderata, ma in casi particolari possono essere opportune e legittime operazioni diverse) dei diversi indicatori. Anche in questo caso, è ovvio che questa operazione può essere effettuata in modo legittimo quando le modalità di risposta la consentono, ossia quando le categorie in cui si articola la variabile sono suscettibili di essere dicotomizzate senza snaturarla: quando invece si assumono i due valori polari di una distribuzione continua che soggiace alla variabile nominale, forzando le risposte in una delle due, allora si ha un massimo di distorsione (cfr. Marradi, 1987: 60). Nel caso invece di variabili ordinali, tipicamente quelle misurate secondo scale Likert, non è infrequente l’assegnazione di valori numerici alle diverse modalità di risposta. In questi casi va comunque considerato che : gli intervalli ‘reali’ fra due valori adiacenti nelle risposte ad una stessa domanda non sono noti, e quindi non sono ipotizzabili come uguali (come accade invece ponendo ad esempio 5 = molto d’accordo; 4 = d’accordo). Questa situazione è anzi un’eccezione: è pertanto più corretto, come osserva Marradi (1987: 62), che il ricercatore si avvalga delle sue conoscenze sostanziali di un fenomeno per assegnare valori, comunque arbitrari, alle diverse modalità; gli intervalli ‘reali’ possono comunque variare da un indicatore all’altro, come ampiamente dimostrato da un’ampia letteratura in materia (cfr. ad es. Marradi, 1988a e Marradi e Gasperoni, 1992). Per le ragioni sopra dette, può essere opportuno, quando già si è deciso di assegnare valori numerici alle modalità di una variabile ordinale, sostituire ove possibile le abusate Likert con scale diverse, alcune delle quali sono presentate in questo volume, che coinvolgano l’intervistato nell’operazione di assegnazione di valori numerici. In altri termini, è probabilmente fonte di minori distorsioni, comunque meno arbitraria, la richiesta all’intervistato di assegnare un punteggio da uno a cento alla propria valutazione di qualche fenomeno che la richiesta di collocarsi in categorie più ampie e generiche alle quali sarà il ricercatore ad assegnare successivamente un valore preciso. Quando poi ci si prefigge di sommare una pluralità di risposte per costruire un indice, si dovrà porre attenzione al fatto che queste debbono comunque essere espresse secondo scale realmente sommabili. Non 14 ha evidentemente alcun senso, come osserva anche Marradi (1987), sommare dicotomie espresse con i valori ‘0’ e ‘1’, Likert con punteggi da 1 a 5 e altre scale con punteggi ancora diversi. Se questa fosse la situazione di partenza (ma avrebbe dovuto essere valutata in anticipo in sede di costruzione dello strumento), si renderebbe necessario un ulteriore passaggio, che omogeneizzi le diverse scale su cui sono misurati gli indicatori. Anche questo passaggio comporta ovviamente delle scelte, ma l’arbitrarietà relativa di un procedimento è infinitamente migliore dell’assurdità di una somma di indicatori misurati nei modi più vari. In linea generale, un buon metodo per la costruzione di un indice come somma di più indicatori è quello di riportare ognuno di questi alla scala più ampia, peraltro controllando che tale operazione non porti alla sovrastima di uno a svantaggio dell’atro. Ad esempio, in linea di principio è possibile moltiplicare per 20 i valori di una Likert, assegnando valore 100 al punteggio 5, per sommarlo con un altro indicatore misurato su di un termometro che va da zero a 100 e per lo stesso motivo assegnare 100 alla modalità ‘presenza di una caratteristica’ e zero alla modalità ‘assenza’. Tuttavia in questo modo si corre il rischio, del quale è necessario essere consapevoli, di accentuare il peso degli indicatori misurati su scale di estensione ridotta, che riproducono differenze più grossolane, penalizzando gli indicatori misurati su scale di maggior estensione, che consentono distinzioni più fini tra posizioni diverse. Naturalmente, prima di procedere alla somma, è bene anche controllare che gli orientamenti delle scale siano tutti nello stesso verso, per evitare di dare lo stesso valore, in una Likert, ad un totale accordo e ad un totale disaccordo10. Da ultimo, poiché non sempre i rispondenti utilizzano l’intera estensione delle scale proposte, c’è da chiedersi se la somma debba riguardare i punteggi assoluti o quelli relativi. In altre parole, se due indicatori misurati su di un termometro (vedi oltre) che va da zero a 100 presentano risposte comprese in un caso fra i valori 0 e 100, nell’altro fra 30 e 70, c’è da chiedersi se mantenere nella somma questi punteggi (che attribuirebbero maggior peso all’indicatore misurato sull’intera estensione della scala), ovvero tentare un’ulteriore omogeneizzazione. In questo secondo caso si può procedere alla standardizzazione dei valori, ossia alla trasformazione dei punteggi reali in nuovi punteggi, espressi in termini di distanza ponderata dalla media di ogni singola distribuzione (il valore standardizzato del valore di una variabile è dato dalla differenza tra questo e la media della distribuzione, fratto lo scarto quadratico medio della stessa). La standardizzazione produce una diversa distribuzione delle risposte, che vengono considerate per il loro punteggio relativo all’insieme delle altre, e non per il loro punteggio assoluto. Se ad esempio alcune domande portano a risposte molto prossime tra di loro, altre a risposte distribuite in modo più differenziato, la standardizzazione fa perdere questa differenza, che il ricercatore può invece decidere di mantenere. Non sempre, peraltro, gli indici sono costruiti secondo procedimenti additivi. In questa sede ne citiamo altri tre. La prima, ricordata da Marradi (1987: 69-70), consiste nella costruzione di tipologie, ottenute aggregando categorie diverse dei vari indicatori o delle loro combinazioni per costruire un numero di modalità dell’indice più ridotto di quello che deriverebbe dalla loro semplice combinazione. Considerando ad esempio la professione (articolata in otto posizioni ordinate), il titolo di studio (per cinque posizioni ordinate), la proprietà dell’abitazione (dicotomica), il reddito (per sei posizioni misurate su scala di rapporti) si potrebbe costruire un indice di posizione di classe su tre sole modalità (alta, media, bassa) attraverso accorpamenti del tipo seguente: classe alta: o professione = imprenditore, dirigente o libero professionista; o titolo di studio = diploma o laurea; o proprietà dell’abitazione = ininfluente; o reddito = una delle due ultime classi; classe media: o professione = come sopra in assenza delle altre caratteristiche; o professione = autonoma o impiegatizia in presenza di titolo di studio non inferiore alla licenza media e reddito non inferiore alla terza classe; o professione = ininfluente se abitazione in proprietà, reddito uguale o superiore alla quarta classe, titolo di studio uguale o superiore al diploma; classe bassa: o tutte le altre combinazioni. In questo ipotetico caso, da un numero di combinazioni pari a 480 (il prodotto tra il numero di modalità di ogni indicatore) si è passati a tre sole, procedendo a quella che Boudon (1970) chiama la riduzione dello 10 Questa situazione può verificarsi quando si alternano item di tipo affermativo con altri che contengono delle negazioni (il cui impiego è peraltro assai pericoloso, come bene documentato in Marradi e Gasperoni, 1992 e 2003). 15 spazio degli attributi, specificando che questa può avvenire sia in via teorica (come nell’esempio), sia in via pratica, ossia osservando che di fatto un certo numero di combinazioni potenzialmente rilevabili (ad es., imprenditore analfabeta, operaio con reddito della classe più elevata) non vengono registrate nella rilevazione condotta. Un altro modo di costruire degli indici è affidato all’utilizzo del computer nella successiva fase di elaborazione dei dati. Si tratta dell’analisi fattoriale, che consente di misurare quanto ogni indicatore è correlato con gli altri e ad un numero più ridotto di fattori soggiacenti. Questa tecnica consente sia di attribuire ad ogni indicatore un peso corrispondente al grado di correlazione con i vari fattori, sia di scartare eventuali indicatori che presentino bassa correlazione su tutti i fattori (per un approfondimento, cfr. Marradi, 1987: 73-78; Bailey, 1991: 399-407). Chiunque si sia cimentato nella costruzione di un sistema d’indicatori ha sperimentato la frustrazione che deriva dall’ansia di completezza ed esaustività, tipica del paradigma positivistico e deduttivistico che soggiace a molte operazioni di questo tipo. Di solito, il tutto si traduce in una fatica improba e in un rigetto globale dell’intera operazione. Uno dei pochi casi in cui ciò non accade è, nell’ambito dei processi di valutazione, l’analisi multicriteri utilizzata per la selezione dei progetti. In questi casi si accetta un’articolazione del giudizio su aree, criteri e sub criteri diversi, con una struttura ad albero che può arrivare anche a diverse decine di indicatori. Questo percorso non è privo di difetti ed è stato sostenuto in modo convincente (Grana, 2001) che la moltiplicazione del numero di indicatori finisce per creare distorsioni nel meccanismo valutativo. Tuttavia la necessità di produrre una graduatoria mantiene valido questo sistema, al di là delle difficoltà applicative che può presentare. È possibile invece procedere in modo meno rigido, allentando ogni giunto del sistema deduttivo ed utilizzando un paradigma indiziario, in forza del quale si distingue tra un sistema d’indicatori più sobrio e un elenco dei descrittori che può essere usato per assegnare un punteggio sintetico ad una dimensione anche complessa. Questo metodo può essere utilizzato con profitto quando ci si avvale di giudizi su dimensioni rilevanti di un intervento o di una politica, formulati da stakeholder o destinatari. Seguendo un paradigma indiziario, si può abbandonare l’ansia dell’esaustività e della completezza in favore di un sistema capace di condensare in pochi giudizi ‘qualitativi’11, possibilmente espressi in forma numerica (la più banale: un voto da zero a dieci), le principali dimensioni secondo le quali la valutazione va espressa. Al di là della sua applicazione al campo della valutazione, il modello può funzionare nelle ricerche su atteggiamenti e orientamenti, quando si chiede alle persone di formulare un giudizio su di un determinato elemento (es., soddisfazione nei confronti di un servizio pubblico). Invece di chiedere di giudicare separatamente elementi anche molto specifici (es., puntualità degli autobus, pulizia, affollamento, gentilezza del personale, tempo di percorrenza, ecc.), si può chiedere ad esempio di formulare un giudizio complessivo, corredandolo tuttavia di informazioni sui criteri usati per formularlo. Allo stesso modo, si può chiedere a una persona di collocare la propria professione su di una scala di prestigio da zero a 100, chiedendo poi su quali elementi si è basata questa collocazione. Gli elementi possono a loro volta essere indicati nel seguito, chiedendo al rispondente di barrare le caselle relative ai criteri considerati, ovvero si può usare una domanda aperta, del tipo “mi può indicare almeno tre elementi su cui Lei si è basato per collocarsi in questa scala?”. Il modello, naturalmente, ha le sue brave implicazioni epistemologiche, in quanto riattribuisce agli intervistati una parte delle funzioni di costruzione di un indice complessivo che, all’interno di un paradigma di tipo neopositivistico, avrebbero dovuto essere invece integralmente svolte dall’esperto. Nell’assegnazione di un voto, infatti, il soggetto tiene liberamente conto degli indicatori e delle dimensioni suggerite, che servono innanzi tutto a delimitare il campo semantico coperto dal criterio. Decide liberamente il peso e la considerazione da assegnare a ciascuno di questi, pur all’interno di una griglia più generale costruita dal ricercatore (quella che definisce il peso di ogni criterio e macro-criterio). Al tempo stesso, dovendo barrare la casella o le caselle relative al descrittore o ai descrittori considerati, rende potenzialmente documentabile la fonte sulla quale basa il suo giudizio (e permette l’eventuale costruzione ex post di modelli più semplificati, come può accadere se tutti i rispondenti barrano un numero minore di descrittori rispetto a quelli proposti). 11 Nel senso che non esplicitano la sequenza di passaggi che presiede alla loro costruzione, né rendono possibile esprimerla in termini di relazioni e di pesi interni ad un sistema di preferenze. L’assegnazione di un voto permette di utilizzare una scala autoancorata e lascia quindi anche per questo aspetto maggiore libertà al rispondente. 16 Per saperne di più Caselli M. (2005), Indagare col questionario, Vita e Pensiero, Milano. Marradi A. (1980), Concetti e metodo per la ricerca sociale, La Giuntina, Firenze (2^ ed. 1984; III^ ed. 1987). Marradi A. e Gasperoni G., (a cura di), (2003), Costruire il dato 3. Costruire le scale Likert, Franco Angeli, Milano. Nigris D. (2000), Informazione e intervento sociale. Prospettive metodologiche e operative, Franco Angeli, Milano. Palumbo M., (2003), “Gli indicatori valutativi”, Rassegna Italiana di Valutazione, VII, 27, 2003, pp.: 107129. Zajczyk F., (1997), Il mondo degli indicatori sociali. Una guida alla ricerca sulla qualità della vita, Nuova Italia Scientifica, Roma. 17
Scaricare