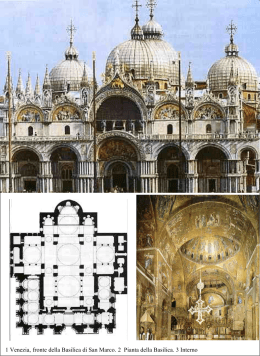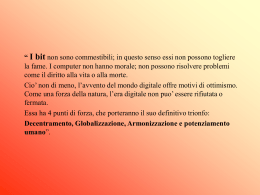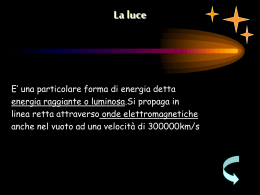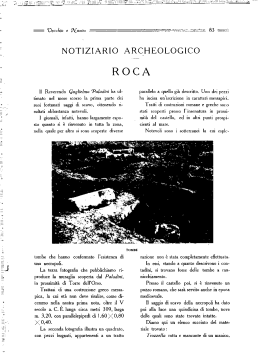ROMA TRE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNIVERSITÀ ROMA TRE TRE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI QUINTERNI, 5 ROMA DIPARTIMENTO DI STUDI STORICO-ARTISTICI, ARCHEOLOGICI E SULLA CONSERVAZIONE Quinterni, 5 DIPARTIMENTO DI STUDI STORICO-ARTISTICI, ARCHEOLOGICI E SULLA CONSERVAZIONE GIORNATA DELLA RICERCA 2011 Roma, 7-8 giugno 2011 a cura di Rita Dolce e Antonello Frongia LIBRO CO. ITALIA Organizzazione della giornata: Rita Dolce, Antonello Frongia Progettazione e realizzazione grafica: Fabrizio Musetti Laboratorio Informatico – Dipartimento di Studi Storico-artistici, Archeologici e sulla Conservazione © 2012 LIBROCO. ITALIA via Borromeo, 48 50026 San Casciano V.P. (FI) – Italia P.O. Box 23 Tel. +39-55-8228461 – Fax +39-55-8228462 E-mail: [email protected] – www.libroco.it ISBN: 978-88-97684-08-4 Premessa Da qualche anno, la “Giornata della Ricerca” è un appuntamento fisso nella vita del nostro dipartimento. Fin dall’inizio è stata voluta per mettere in contatto tra di loro i colleghi, da quelli più anziani ai nuovi arrivati: l’incremento del personale, tra ricercatori e professori delle due fasce, è stato notevole negli ultimi tempi, fino a contare nel 2012, mentre va in stampa questo numero di “Quinterni”, ventisei unità, distribuite in sei settori scientifico-disciplinari per gli archeologi e in quattro per gli storici dell’arte. Inoltre gli ultimi anni hanno visto l’uscita dai ruoli universitari di colleghi più anziani, spesso promotori di linee di ricerca che talvolta sono state raccolte dai più giovani, e di conseguenza un notevole ricambio di studiosi. Presentare alcune delle proprie ricerche è stato quindi per tutti noi un modo per informare, creare curiosità e collegamenti, mettere a confronto metodologie in un contesto significativamente trasformato anche solo a partire dal primo anno in cui si è deciso di dar vita a giornate come queste. Per lo stesso motivo le giornate sono sempre state aperte ai dottorandi, in modo che anch’essi potessero venire a conoscenza, al di là degli incontri programmati con i loro tutors e con il collegio dei docenti, delle possibili aperture che il confronto con tutti i membri del dipartimento mette a loro disposizione. La scelta di pubblicare, in forma estremamente sintetica, le relazioni in questi “Quinterni” è consequenziale: la collana, per la quale si è scelta fin dall’inizio una veste tipografica sobria e caratterizzata da un understatement oggi forse un po’ fuori moda ma che abbiamo consapevolmente deciso di conservare, vuole costituire una sorta di archivio della ricerca promossa o comunque portata avanti nell’ambito del dipartimento. Il taglio degli interventi che vi si possono leggere è assai diverso, come diverse, per temi e metodi, sono le ricerche. Alcuni tra di noi hanno preferito illustrare percorsi individuali, presentando in un vero e proprio contributo di taglio scientifico anche se necessariamente sintetico, i resoconti di ricerche che corrispondono ad approfondimenti di temi indagati da anni; altri hanno scelto di esporre, invece dei risultati, veri e propri progetti in fieri che coinvolgono non solo i colleghi del dipartimento ma quelli di altre università o i dottorandi e i dottori di ricerca (è il caso, ad esempio, dei progetti PRIN, ossia “Progetti di Rilevante Interesse Nazionale”, purtroppo sempre più difficili da ottenere e la cui assegnazione è ogni volta assai aleatoria, ma che il nostro dipartimento è sempre riuscito a veder finanziati anche se non nella loro totalità). Carattere qualificante del nostro dipartimento è la pluridisciplinarità, esplicitata a partire già dal titolo. La ricerca che vi si svolge riflette questo carattere composito, che include l’archeologia, la storia dell’arte e i temi della conservazione; una pluralità di voci e di metodologie che, lungi dal frammentarla, ne rendono più forte e più coesa la fisionomia. A partire dal prossimo anno, come molti altri dipartimenti anche il nostro dovrà comunque, per rispondere ai requisiti di legge, fondersi con altre realtà e trasformarsi, includendo tra l’altro tra le proprie competenze la gestione della didattica, non più demandata ai “Collegi” e alle Facoltà ma parte integrante e qualificante dell’attività dei dipartimenti. A questo appuntamento intendiamo presentarci con la massima disponibilità alla collaborazione e al dialogo, consapevoli della necessità di mettere in relazione sempre più fruttuosa le discipline dell’ambito umanistico e non solo. Ma siamo pienamente consapevoli che solo il rafforzamento della nostra specificità e delle nostre competenze consentirà l’esito positivo di questa impresa. Al nuovo dipartimento presentiamo il contributo della nostra ricerca, della quale “Quinterni” come questo offrono la concreta testimonianza. Ai colleghi Rita Dolce e Antonello Frongia, che hanno organizzato le giornate della ricerca 2011 3 e hanno curato, con il fattivo e competente contributo di Fabrizio Musetti, la realizzazione di questo numero di “Quinterni” va la mia personale gratitudine e quella di tutti i colleghi. Liliana Barroero 4 Nota dei curatori L’iniziativa della Giornata della Ricerca promossa dal Dipartimento di Studi Storico-artistici, Archeologici e sulla Conservazione – nata alcuni anni fa, prima che chi scrive vi approdasse – si realizza in un incontro dedicato alla reciproca conoscenza degli ambiti scientifici di ricerca dei Colleghi e dei giovani studiosi in formazione. Si tratta di un’occasione per confrontare metodologie e tematiche anche lontane tra loro, di una opportunità per misurare collettivamente le latitudini temporali e spaziali che il nostro Dipartimento accoglie al suo interno e di apprezzare le potenzialità e le risorse. L’incarico di organizzare l’incontro e i relativi atti, che ci è stato proposto per l’anno 2011, è stato assunto tenendo in conto questi tre aspetti nel corso di tutte le fasi di lavoro, nell’intento di favorire partecipazione e scambi di opinioni al di là delle linee di ricerca e dei profili metodologici di ognuno di noi. Il tentativo è stato quello di stimolare curiosità e interessi immediati per campi di conoscenza cronologicamente, geograficamente e culturalmente vari, eppure contestualmente presenti in questa occasione. La risposta di partecipazione attiva sia ai lavori, che di necessità hanno occupato quasi due giornate, sia alla ricca discussione, che ha accompagnato buona parte delle sedute, sia infine agli atti, ci pare un segnale significativo. La presentazione dei contributi nell’edizione a stampa segue il criterio cronologico delle ricerche presentate nei singoli interventi delle Giornate, per rendere chiaramente tangibile, fin dalla composizione dell’indice, l’ampia diacronia che connota la ricerca scientifica del Dipartimento, come anche la varietà di campi archeologici e storico-artistici che ciascuno di noi sta indagando. I contributi raccolti nei Quinterni restano dunque a testimoniare uno degli esiti di questo incontro, il quarto di una preziosa iniziativa, non frequente in molte sedi universitarie italiane: un’occasione che richiama discretamente la centralità della ricerca nel lavoro e nell’impegno della comunità scientifica, nonché il suo valore nella trasmissione di conoscenza e di coscienza critica alle generazioni in formazione. Rita Dolce e Antonello Frongia 5 Gli arredi lignei da Ebla: una questione aperta I. LA DOCUMENTAZIONE Gli intagli lignei dal Palazzo Reale G di Ebla costituiscono una testimonianza unica nel panorama delle culture della Siria e della Mesopotamia del III millennio a. C. e ancora di recente citati come la più antica attestazione di opere del genere; opere pur rare, poiché realizzate in legno e nel caso di Ebla ritenute parti decorative di oggetti mobili, più precisamente arredi mobili di lusso. Si tratta di più di 500 reperti, a soggetti umani, animali e mitici, ridotti in maggior parte in frammenti minimi, dai 14 cm. ca. dell’unica figura pressoché completa fino ai 6 mm. di resti di un piede (fig. 1), originariamente parte di rilievi piani, a mezzo e a tutto tondo, di alto livello tecnico e qualitativo, ove al legno si associa la madreperla per inserzioni decorative fissate con bitume. Del corpus sono attualmente allo studio i resti a soggetto umano maschile e femminile individuati con certezza, circa il 27% dell’intera documentazione recuperata, ai quali seguirà l’analisi e, laddove possibile, Fig. 1 – Tell Mardikh-Ebla. Palazzo Reale G, locus 2601 l’ipotesi ricostruttiva dei frammenti di abbigliamento, a) Personaggio maschile con insegne e copricapo regale circa il 21%; tali dati ci forniscono già una indicazione b)Piede destro, con indicazione di quattro dita significativa sulla entità di soggetti umani nel complesso di frammenti superstiti. Un aspetto nel metodo d’indagine in corso riguarda la ricostruzione delle dimensioni originarie di singole opere, a partire dai resti più ampi: se ne trae per il momento qualche indicazione per una scala dimensionale non omogenea, ove per soggetti di stesso genere si rilevano misure differenziate. Casi evidenti sono quelli di personaggi ove le altezze certe dei busti maschili (2,5 cm., 2,2 cm.) e della testa femminile (2,7 cm.) (fig. 2) mostrano scarti apprezzabili nelle originarie dimensioni per le figure intere rispetto a quelle dei pochi intagli più largamente conservati, tra i 14 e i 15 cm., come su fig. 1 (TM.74.G.1000). Il prosieguo del lavoro su un ampio numero di frammenti significativi da tutti i soggetti del corpus potrebbe condurre a individuare serie di figure di diverse scale, ed estendere il campo dei Fig. 2 – Tell Mardikh-Ebla. Palazzo Reale G, locus 2601 tipi di “arredi” ai quali le opere appartenevano. a) Resti di eroi incedenti verso destra b)Testa e parte di busto di guerriero con elmo a lunghi guanciali La paziente ricostruzione realizzata da tempo di c) Figura femminile con elaborata acconciatura a ciocche e alcuni resti lignei (della specie pomoideae, circomantello frangiato scrivibile al pero e al melo, ancora d’uso nell’artigianato attuale) riconduce ad un tavolo, del quale restano tre assi del piano originariamente tenute insieme da un sistema di forcelle in osso, e alle parti laterali di un seggio, in entrambi i casi con i rilievi figurativi intagliati “a giorno” fissati ai listelli da chiodini o piccoli tenoni lungo le parti inferiori delle fiancate degli arredi. 6 II. CONDIZIONI E CONTESTO DI RITROVAMENTO La produzione ad intaglio e l’ebanisteria in genere trova riscontro nei dati dei testi degli Archivi di Ebla, ove si registra un numero rilevante di artigiani preposti alla lavorazione del legno (insieme a quelli dediti ai metalli) da un minimo di 140 a un massimo di 260 tra falegnami e carpentieri lavoranti per il Palazzo. Ciò che appare una delle questioni aperte e sulla quale si focalizza la ricerca in corso riguarda la tipologia e la funzione dei manufatti di lusso ai quali gli intagli appartenevano, forse non solo relative ad arredi di ambienti palatini, come finora si è ritenuto. La combinazione di dati, pregressi e più recenti, d’ordine archeologico e testuale ci permette infatti di riconsiderare l’interpretazione dei manufatti originari partendo dalle relazioni spaziali ormai evidenti dell’Ala Nord e degli adiacenti settori settentrionale e occidentale del Palazzo G (fig. 3). Nel corso delle campagne di scavo dal 2000 al 2007, anno conclusivo dell’esplorazione di questo settore palatino, si raggiunse in primo luogo l’esposizione di due vani all’estremità Nord (L.8606 e L.8605) ove sui pavimenti giacevano ancora preziosi resti della produzione artistica di Ebla protosiriana (2400-2300 a. C. ca.), scampati al saccheggio dopo la conquista della città, che qualificano questo Quartiere non già come “periferico” ma a carattere Fig. 3 – Tell Mardikh-Ebla. Il Palazzo Reale G, centrale nel sistema palatino; in secondo luogo, l’esposizio- veduta assonometrica ne della comunicazione certa fra due vani maggiori, L.2601, sul pavimento del quale giacevano tutti i frammenti lignei, e L.2586 ove fu recuperato un lotto di tavolette iscritte databili all’ultima fase del regno di Ebla, prima della sua distruzione intorno al 2300 a. C., che indica una relazione non casuale tra i due ambienti, supportata dal contenuto dei documenti scritti; in terzo luogo, nelle due campagne più recenti in quell’area, l’esposizione di due vani (L.9583, L.9330) che rappresentano l’estremo lembo ancora conservato sul versante Ovest, di certo organici al Quartiere, e che hanno restituito dai pavimenti sculture miniaturistiche a tutto tondo dal cuore ligneo e con rivestimento in oro e argento, di pregio intrinseco e di alto valore simbolico nella concezione della regalità eblaita. È dunque questo un Quartiere ove confluivano manufatti di lusso di particolare eccellenza, tra i quali gli intagli lignei e forse immagini di personaggi femminili illustri della dinastia regnante, nel caso della microsculture. III. QUALE FUNZIONE DEL QUARTIERE NORD E QUALE DEI MANUFATTI LIGNEI? Appare evidente dal complesso dei dati, dei quali qui solo alcuni richiamati e sommariamente, che il Quartiere Nord/Nord-Ovest non prevedeva comunicazioni con la platea della Grande Corte a Sud né con l’area residenziale privata e dei servizi, ad Est (fig. 3) ma verosimilmente a mio avviso un accesso indipendente, ormai perduto, proprio sul versante Nord/Nord-Ovest; e che al di là del carattere regale resta ancora aperta la definizione della sua funzione nell’economia del Palazzo G. Su tale quesito e in relazione alle opere lignee oggetto della ricerca soccorrono i testi di registrazione di beni per manufatti pregiati rinvenuti proprio nel vano sopraccitato (L.2586) attiguo a quello di giacitura degli intagli (L.2601): si tratta infatti di un “archivio speciale”, redatto secondo i filologi da scribi diversi da quelli operanti nella cancelleria centrale e datato su base prosopografica poco prima della rovina del regno di Ebla. Attiene per lo più testi di registrazione di consegne di oggetti preziosi in oro e argento a re stranieri e ad alti funzionari dell’amministrazione palatina, riguardanti manufatti in argento ed oro identificati dai termini come bardature e briglie di equidi, o connessi con gli apparati 7 esornativi di carri da parata, produzione ben nota dai testi dell’Archivio maggiore palatino (L.2769) e destinata a membri eminenti maschili e femminili della corte. Il destinatario più ricorrente è il primo ministro dell’ultimo periodo del regno di Ebla, Ibbi-Zikir, noto dai documenti provenienti dall’Archivio centrale suddetto come massimo funzionario dell’apparato amministrativo, militare e politico prima dell’epilogo di Ebla, in una rapida ascesa al suo potere personale. La relazione spaziale tra i due vani e la presenza unitaria degli intagli lignei in uno di essi (L.2601) ha già indotto i filologi a correlare il contenuto dei testi ai manufatti e a considerare quello spazio adibito alla conservazione di elementi pregiati e di distinzione sociale di equipaggiamento per animali e carri; e trova ora conferme da ulteriori evidenze, archeologiche e testuali, che gettano una luce diversa sul carattere funzionale dell’intero Quartiere. Si citano al riguardo in questa sede le attestazioni degli Archivi di preziosi carri da parata istoriati appannaggio dei massimi funzionari del regno e della regina madre; un anello in bronzo rinvenuto nello stesso vano (L.9583) delle sculture miniaturistiche in oro e argento che richiama per tipologia, dimensioni e fattura i passabriglie dei carri del Cimitero Reale di Ur e in specie delle tombe di Kish della Mesopotamia coeva. Evidenze, queste, ed altre concorrenti da Ebla stessa e da centri maggiori della Siria nella valle del Khabur per il commercio e la circolazione di equidi, che inducono a ipotizzare che il settore Nord e Nord-Ovest dell’Ala Nord del Palazzo G fosse adibito a funzioni connesse a tale ambito del patrimonio palatino e a ritenere il vano ove giacevano gli intagli lignei luogo deputato ad accogliere temporaneamente manufatti di lusso appartenenti a diverse tipologie ma di certo comprese quelle registrate nell’Archivio adiacente (L.2586). Rita Dolce BIBLIOGRAFIA Le bibliografie qui indicate attengono solo parzialmente il supporto della ricerca in corso che ha esposizione esaustiva e apparato bibliografico esauriente nel contributo all’edizione degli Atti della Rencontre Assyriologique Internationale, Roma “La Sapienza”, 4-8 luglio 2011, in corso di stampa. A. ARCHI, Gli Archivi di Ebla (ca. 2400-2350 a. C.): Archivi dell’Oriente antico, in «Archivi e Cultura» 29 N.S. (1996), pp. 57-86. A. ARCHI, The Regional State of Nagar According to the Texts of Ebla, in «Subartu» IV/2 (1998), pp. 1-15. M.G. BIGA, Archive L.2586, in Eblaite Personal Names and Semitic Name-Giving (ARES 1), a cura di A. Archi, Roma 1988, pp. 285-287. M.G. BIGA, La struttura ed il funzionamento dei magazzini nei sistemi centralizzati in Mesopotamia ed in Siria: alcuni dati dei testi del terzo millennio, in «Origini» 14 (1988-1989), pp. 585-594. M.G. BIGA, Buried among the Living at Ebla? Funerary Practices and Rites in a XXIV Cent. B.C. Syrian Kingdom, in Atti del Convegno Internazionale “Sepolti tra i vivi-Buried among the Living”, Roma, 26-29 Aprile 2006 (Scienze dell’Antichità 14), a cura di G. Bartoloni, M.G. Benedettini, Roma 2007-2008, pp. 249-275. Dictionnaire de la Civilisation Mésopotamienne, a cura di C. Castel et al., Paris 2002, pp. 135-138, 537-539. G. CONTI, Carri ed equipaggi nei testi di Ebla, in «Miscellanea Eblaitica» 4 (1997), pp. 23-71. H. CRAWFORD, The Earliest Evidence from Mesopotamia, in The Furniture of Western Asia Ancient and Traditional, a cura di G. Hermann, Mainz 1996, pp. 33-39. P. MATTHIAE, Syrische Kunst, in Der Alte Orient (PKG XIV), a cura di W. Orthmann, Berlin 1975, pp. 466-473, 487-488. P. MATTHIAE, Ebla à l’époque d’Akkad: Archéologie et Histoire, in «CRAIBL» (1976), pp. 190-215. P. MATTHIAE, Le Palais Royal et les Archives d’Etat d’Ebla protosyrienne, «Akkadica» 2 (1977), pp. 2-19. P. MATTHIAE, Ebla in the Period of the Amorite Dynasties and the Dynasty of Akkad: Recent Archaeological Discoveries at Tell Mardikh (1975) (MANE I), Malibu 1979. P. MATTHIAE, Ebla. Un impero ritrovato, II ed., Torino 1989. P. MATTHIAE, Gli Archivi Reali di Ebla, Roma 2008. P. MATTHIAE, The Standard of the maliktum of Ebla in the Royal Archives Period, in «ZA» 99 (2009), pp. 270-311. 8 D. OATES, J. OATES, Ebla and Nagar, in Ina kibrāt erbetti. Studi di Archeologia orientale dedicati a Paolo Matthiae, a cura di F. Baffi et al., Roma 2006, pp. 399-423 (401-404: pertinenti). L.C. WATELIN, S. LANGDON, Excavations at Kish, IV, Paris 1934. C.L. WOOLLEY, Ur Excavations II. The Royal Cemetery, London/Philadelphia 1934. Attività di ricerca della cattedra di Paletnologia nel 2010 Nel 2010, le attività afferenti all’insegnamento di Paletnologia da me tenuto sono state essenzialmente tre: 1) la prosecuzione del survey nell’ambito del seminario sull’Appia Antica (coordinato assieme a Daniele Manacorda, Maura Medri e Riccardo Santangeli); 2) la partecipazione degli studenti alla campagna di scavo di Fossa, in Abruzzo (v. Pennacchioni, infra); 3) lo scavo nel sito di Colle Rotondo (Anzio), cui dedico questo breve intervento (sulle ricerche del 2009, qui presentate nel 2010, v. ora Guidi, Jaia, Cifani 2011). Tra il 21.06.2010 e il 16.07.2010 è stata effettuata la prima campagna di scavo in località Colle Rotondo, nel comune di Anzio. Ai lavori sul campo, coordinati da me, da Alessandro Maria Jaia (Università di Roma La Sapienza) e Gabriele Cifani (Università di Roma Tor Vergata) hanno preso parte circa 20 studenti dell’Università di Roma Tre, affiancati dal dott. Fabrizio Felici, archeologo della società Parsifal. I materiali raccolti sono stati depositati presso il Museo di Anzio, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e la direzione del Museo (dott.ssa Giusy Canzoneri) e grazie al coordinamento della dott.ssa Emanuela Fulceri, borsista dell’Università di Roma Tor Vergata. Le indagini si sono concentrate su tre aree di scavo (per la posizione vedi fig. 1). AREA 1 Presso i resti dell’aggere maggiore dell’abitato, sul limite; l’attività è consistita nella ripulitura di una sezione dell’aggere e nella realizzazione di due ampi sondaggi. La struttura difensiva, che si presentava ancora intatta Fig. 1 – Colle Rotondo (Anzio), aree di scavo fino a circa dieci anni, è stata in larga parte sbancata negli ultimi anni e ne sopravvive solo una ridotta porzione dell’angolo settentrionale. In questa area sono stati realizzati due ampi sondaggi tra la sezione e i bordi orientale ed occidentale che hanno individuato un ampio battuto di colore rosso con buche che conservano copiosi resti di palo con pareti in graticcio ed argilla. Alcuni resti di carboni riferibili ai pali della struttura sono stati campionati; minuti frammenti di impasto non diagnostici, raccolti per lo più fuori contesto stratigrafico, sembrano comunque suggerire una cronologia ad epoca protostorica della struttura lignea che sarebbe stata in un secondo momento obliterata dalla costruzione dell’aggere difensivo, costruito secondo i canoni ben documentati in altri abitati di età protostorica. Lo studio delle quote ha permesso inoltre di notare che il piano di calpestio si trova a circa 50 cm al di sopra dell’attuale strato di arativo della parte centrale del pianoro e questo aspetto, insieme ad 9 ulteriori dati dalla Area 2 lascia intuire un accentuato fenomeno di erosione del paleosuolo e dei depositi antropici, almeno nella parte centrale ed orientale del pianoro. Le datazioni al C14 effettuate su due resti di pali carbonizzati presso il CEDAD (Università di Lecce), hanno offerto i seguenti risultati: CODICE CEDAD CAMPIONE DATAZIONE CALIBRATA (LIVELLO DI CONFIDENZA 2s) LTL6039A US108 1020BC (95.4%) 810BC LTL6040A US106 930BC (95.4%) 790BC Si può forse ipotizzare che il battuto, i pali e altri elementi lignei orizzontali facessero parte di un grande apprestamento difensivo precedente gli aggeres tradizionali dell’età del ferro e del periodo arcaico. Alla verifica di tale ipotesi sarà dedicata la prossima campagna di scavo. AREA 2 Sondaggio di scavo effettuato nel settore centrale dell’abitato. Ha restituito una situazione stratigrafica compromessa. Sono state individuati i resti di alcune fosse scavate nel banco di tufo con frammisto un riempimento contenente materiale ceramico di impasto, minuti frammenti di bucchero nero e tegole. L’ipotesi di lavoro è che si tratti dei resti di possibili cisterne o fosse di scarico, scavate nel banco di tufo ed originariamente a quote più basse rispetto al piano di calpestio e di cui sono rimaste solo parte delle estremità inferiori a causa dell’erosione del pianoro che ha interessato anche parte del banco di tufo. AREA 3 Vi è stato rinvenuto un ampio e compatto strato di frammenti tegole chiaro sabbiose, ceramica comune acroma, dolia e ceramica a vernice nera da riferire ai resti di strutture di epoca medio repubblicana. Un approfondimento sul lato settentrionale del quadrato ha rivelato la seguente sequenza stratigrafica: circa m. 0,6 di strato di terreno arativo che coprono circa m. 1,1 di strati antropici (con ceramica prevalentemente di epoca romana medio repubblicana) e che coprono a loro volta il banco naturale formato da un deposito piroclastico di tufo rosso litoide. Appare indubbio pertanto che in questa area l’erosione del suolo manifesta caratteri meno accentuati che nel resto dell’unità orografica. Interessante il rinvenimento, in giacitura secondaria, di una punta di freccia in selce. Parallela all’attività di scavo è proceduta quella del rilevamento dell’intero pianoro dell’abitato antico, mediante stazione totale eseguito da Federico Nomi, Giulia Peresso e Gabriele Cifani. Complessivamente sono stati battuti circa 1.300 punti comprensivi di quote la cui elaborazione consentirà un’accurata planimetria dell’area, cui agganciare anche le coordinate dei saggi di scavo, nonché di delineare un modello tridimensionale della sommità del pianoro. Per quanto concerne i saggi di scavo, questi sono stati documentati mediante rilievi di dettaglio 10 di ogni singola unità stratigrafica e mediante ortofotopiani eseguiti da Federico Nomi. Alessandro Guidi BIBLIOGRAFIA A. GUIDI, A. JAIA, G. CIFANI, Nuove ricerche nel territorio di Colle Rotondo ad Anzio (Roma), in «Lazio e Sabina», n. 7 (Atti del Convegno, Roma, 9-11 marzo 2010), Roma 2011, pp. 371-380. Attività di ricerca degli studenti dell’Università Roma Tre nella necropoli di Fossa (AQ) Nell’estate 2010, il tirocinio formativo rivolto agli studenti, coordinato dalla cattedra di Paletnologia (prof. Guidi, dott. Pennacchioni) in sintonia ed in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo (dott. D’Ercole), è stato effettuato nella necropoli vestina di Fossa (AQ). Vi hanno preso parte 19 studenti organizzati in due turni, dal 19 luglio al 6 agosto. La Necropoli, scoperta casualmente nel 1992 durante i lavori di scavo per la realizzazione di un’area industriale, è stata oggetto di scavi regolari negli anni successivi (COSENTINO, D’ERCOLE, MIELI 2001) ed ha restituito centinaia di tombe databili tra la fine del IX sec. a.C. ed il I secolo d.C. La fase più antica (IX-VIII sec. a.C.) presenta generalmente grandi tumuli delimitati da circoli di pietre, con una unica sepoltura centrale, ed una fila di monoliti di dimensioni decrescenti a partire dal tumulo. Le tombe a fossa profonda sono rare. Al VII sec. a.C. sono attribuibili tumuli di minori dimensioni privi di stele e spesso anche di margini, con una o più sepolture all’interno mentre aumentano le tombe a fossa che saranno le sepolture più comuni dal VI sec a.C.: si tratta per lo più di fosse rettangolari con margine delimitato da file di sassi, più raramente rivestite ed in qualche caso con piano di deposizione realizzato con elementi litici (D’ERCOLE, BENELLI 2004). Le ultime fasi di utilizzo della necropoli ricadono nell’età ellenistico-romana e presentano una varietà di tombe a fossa (le ultime datate alla metà del I sec. a.C.) e a camera, queste ultime anche monumentali, per le quali sono state utilizzate grandi lastre litiche; alcune di queste tombe sono molto ricche ed alcune (al momento sono sei) hanno rivelato la presenza di letti rivestiti con osso lavorato (D’ERCOLE, COPERSINO 2003). Due tombe isolate ad incinerazione chiudono, nel I secolo d.C., l’uso della necropoli. Dalla foto aerea dell’area di scavo della necropoli sono evidenti le strutture delle tombe a circolo della prima età del ferro, in particolare la tomba 300 con un diametro di crepidine di 18 m.; sulla sommità del tumulo è impostata la tomba a camera 63 con sepolti tre individui e cronologia desunta dagli elementi del corredo tra la fine del II sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C. (fig. 1). L’attività di scavo in questo importante sito, ferma da nove anni per mancanza di fondi, ha beneficiato nel 2010 di un contributo per il restauro delle strutture danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009. È stato in questo modo possibile programmare una campagna di scavi che si è avvalsa della collaborazione di Fig. 1 – Necropoli di Fossa, foto aerea 11 numerosi studenti e laureandi di Roma Tre coordinati da chi scrive, con l’intento preciso di esplorare una larga porzione di necropoli che potesse dare indicazioni sulla reale estensione dell’area adibita a sepoltura e sulla presenza di settori, strade, delimitazioni. L’area indagata, posizionata a sud-est del nucleo principale della necropoli su una porzione di terreno leggermente sopraelevata rispetto al piano di deposizione dei tumuli più antichi, è di circa 200 mq. Qui sono state rinvenute sette sepolture databili dalla prima età del ferro all’età arcaica ed un ampia area lastricata. Una prima sepoltura, a ridosso della vecchia area di scavi, era segnalata da un grande masso avente funzione di segnacolo e da una fila di pietre che delimitavano i bordi di una profonda fossa appena disturbata su un lato lungo da una sepoltura infantile di età arcaica. Una sorta di sacello rivestito e coperto da pietre conteneva una grande olla di impasto rosso con dipinti motivi geometrici in bianco, sormontata da un coperchio dello stesso impasto rosso dipinto e con all’interno un attingitoio anch’esso in impasto rosso con superficie brillante e motivi bianchi. Il ricco corredo, in parte posizionato su una banchina laterale, si compone di elementi metallici che denotano l’importanza del defunto. Tra questi, le armi in ferro (una spada corta con fodero ed un coltello), un attingitoio in lamina bronzea, un bacile in bronzo e numerose fibule in ferro (fig. 2). Sulla base delle caratteristiche la cronologia si attesta alla fase 1B della necropoli di Fossa (metà VIII sec. a.C). Un primo elemento di interesse è dato dal “servizio” composto da dolio, attingitoio e coperchio (per la prima volta attestato a Fossa in questa età). Un secondo dato è la conferma della inumazione in fossa durante la prima età del ferro. Alla mancanza dei resti dell’inumato non è ancora stata data una interpretazione, in attesa delle analisi del terreno. Il Fig. 2 – Tomba a fossa in fase di scavo restauro del materiale è ancora in corso e la documentazione porterà sicuramente nuovi e significativi elementi. Una tomba a circolo ed altri due tumuli, inquadrabili cronologicamente intorno al VII sec. a.C. hanno restituito scarsi elementi di corredo mentre altre sepolture, troppo superficiali, erano gravemente danneggiate da lavori agricoli e quasi prive di reperti (solo frammentini ceramici e metallici molto erosi). Il proseguimento della pulizia nell’angolo nord-est del saggio ha portato a scoprire un ampio lastricato formato da pietrame e ciottoli di piccole dimensioni. Infine, sul lato est è venuto in luce un allineamento di pietre già notato in precedenti scavi, di incerta pertinenza e cronologia (fig. 3). Il materiale recuperato è stato sottoposto a pulizia e restauro presso il laboratorio di Capestrano. Gli studenti sono stati impegnati, a rotazione, sia nello scavo che nella documentazione, sul campo ed in laboratorio, che nel restauro. L’opportunità di intervenire in un sito di grande rilievo sia per estensione che per importanza delle testimonianze rinvenute, ampiamente illustrate nei tre volumi editi a cura di Vincenzo Fig. 3 – La tomba a circolo, i due tumuli orientalizzanti e, d’Ercole e collaboratori, ha fornito stimoli notevoli ai sullo sfondo, l'allineamento di pietre 12 partecipanti ed arricchito il loro bagaglio culturale e professionale. Hanno partecipato: Alessio Agostini, Martina Bernardi, Eugenia Cesare, Daniele Ciangola, Cristina Cumbo, Davide De Giovanni, Stefano De Luca, Agnese Fiore, Federico Floridi, Ilaria Frumenti, Cecilia Galleano, Cinzia Mereu, Flavia Piciarelli, Camilla Pintus, Michele Romano, Francesco Silvestri, Andrea Simeoni, Michela Stefani, Mariele Valci. Massimo Pennacchioni BIBLIOGRAFIA S. COSENTINO, V. D’ERCOLE, G. MIELI, La necropoli di Fossa, vol. I, Ascoli Piceno 2001. V. D’ERCOLE, E. BENELLI, La necropoli di Fossa, vol. II, Sambuceto di S. Giovanni Teatino 2004. V. D’ERCOLE, M. R. COPERSINO, La necropoli di Fossa, vol. IV, Sambuceto di S. Giovanni Teatino 2003. Verso una storia della conservazione del Patrimonio Culturale in Cina In Cina, fin da epoche assai remote il restauro è stato concepito come azione volta a mantenere costantemente integra l’immagine originale del manufatto nel corso del suo trasferimento al futuro, anche a costo di sostituirne progressivamente ogni parte fino all’estremo limite della perdita della materia originale. Salvatore Settis, riferendosi allo storico dell’arte cinese Wu Hong, ha recentemente affermato che «nella cultura cinese manca il senso delle rovine, e i pittori e calligrafi cinesi si astennero dal rappresentarle; le eccezioni sono dovute a influssi della cultura europea. In Europa, al contrario, la presenza delle rovine è vitale nella riflessione storica come nell’arte e nella letteratura». In Cina è certamente mancata la vocazione pedagogica della rovina e ciò ha impedito lo svilupparsi del dibattito sull’autenticità dell’opera d’arte che invece in occidente trova un antico precedente nel noto paradosso di Teseo, derivante dalle vicende riferite da Plutarco nella vita dell’eroe ateniese. La bibliografia cinese sulle fonti della storia dell’arte e dell’archeologia è assai scarsa. Dopo gli studi pionieristici di Raphaël Petrucci nei primi venti anni del Novecento, Mario Bussagli, a metà degli anni ’60, ha indagato le fonti e la letteratura artistica cinese, seguito più tardi dallo studioso sino-francese François Cheng con il memorabile saggio Vuoto e pieno: il linguaggio della pittura cinese. La storia del restauro del Novecento è stata ricostruita da Jocelyne Fresnais nel volume La protezione del patrimonio nella Repubblica Popolare di Cina: 1949-1999. Altro contributo fondamentale è il volume pubblicato nel 2003 dallo studioso sino-francese Zhang Liang La nascita del concetto di patrimonio in Cina tra i secoli XIX e XX. Mancava tuttavia uno studio completo delle fonti antiche relative alla storia delle tecniche artistiche e alla storia del restauro. Interessanti spunti metodologici per una ricerca di questo tipo sono offerti dalla monumentale opera Scienza e civiltà della Cina di Joseph Needham. Terminata la Rivoluzione Culturale, e a seguito delle aperture verso l’Occidente, in Cina si diffondeva una concezione pseudo-scientifica del restauro e soltanto negli ultimi dieci anni si registrava la nascita di un vero e proprio pensiero storico-critico, anche grazie alla recente traduzione in lingua cinese della Teoria del Restauro di Brandi, sperimentata nell’ambito delle attività didattiche presso il Sino-Italian Conservation Training Center diretto da chi scrive. La fase iniziale della ricerca, di cui in questa sede vengono riferiti i primi risultati, è consistita in uno spoglio delle fonti relativo ad un ampio arco temporale che va dal periodo delle Primavere e Autunni (VIII sec. a. C.) fino alla prima metà del Novecento. 13 Fin dalle epoche più remote (Dinastie Xia, Shang e Zhou), a partire dal secondo millennio, è attestato un elevato grado di apprezzamento estetico del vasellame in bronzo e delle giade risalenti ad epoche più antiche; minore attenzione era riservata ai manufatti in ceramica che non erano ritenuti di pari valore ideologico e simbolico. Tali differenze tra diverse categorie di manufatti hanno condizionato fortemente le attenzioni e le cure per la loro conservazione e, in conseguenza, le metodologie del restauro tradizionale che successivamente sono state messe a punto in Cina. Lo studioso Ruan Yuan (1764-1849) riferisce delle diverse forme di considerazione che caratterizzano la storia del vasellame in bronzo in Cina: prima della Dinastia Han il manufatto in bronzo era considerato un emblema del potere; dalla Dinastia Han alla Dinastia Song i ritrovamenti di vasi arcaici erano considerati fatti eccezionali e portentosi. Durante il Periodo delle Primavere e Autunni (770-256 a. C.) erano attive centinaia di scuole dedicate alla produzione di manufatti. Il Kao Gong Ji (Manuale di tecniche metallurgiche) è il testo più importante di quel periodo e riassume esperienze sulle diverse tecniche produttive dei manufatti e riporta informazioni sui metodi di cura e di conservazione in relazione alle raccolte di antichità, con particolare riferimento agli oggetti di metallo (bronzo, oro e argento). Già in quell’epoca erano praticate la manutenzione e il restauro. Altre attestazioni specifiche collegate alle pratiche di restauro si riscontrano nell’opera Lushi Chunqiu (Annali del periodo delle Primavere e Autunni di Lu), compilata attorno al 239 a.C. in cui si menzionano trattamenti specifici per i manufatti in bronzo. Il primo trattato di estetica è il Gu Hua Pin Lu (Repertorio e classificazione degli antichi pittori), opera attribuita a Xie He, pittore di ritratti attivo a Nanchino intorno al 500 d. C. Nel trattato di Xie He sono riportate le 6 Leggi della pittura (Huìhuà Liùf ǎ) da alcuni studiosi accostate ai Sei Rami della teoria indiana dell’arte. Vi è un accordo unanime circa il fatto che le Sei Leggi di Xie He costituiscano il primo tentativo di teorizzazione dell’arte visiva cinese attraverso la definizione del percorso che l’artista deve seguire per raggiungere produrre una vera opera d’arte: 1) lo spirito vitale del pittore deve essere trasferito dall’artista all’opera; 2) il pennello deve essere usato in modo essenziale; 3) nel ritrarre si deve essere fedeli alle forme a cui ci si ispira o che si copiano; 4) i colori devono essere conformi ai modelli; 5) ogni elemento della composizione deve avere un’idonea collocazione; 6) si deve favorire l’esercizio e l’esperienza attraverso la realizzazione di copie dei dipinti classici (affinché in questa fase possa verificarsi nell’allievo lo stesso fluire del Qi che avviene nel Maestro e che crea movimento di vita e pertanto la vera creatività artistica). Quando l’allievo avrà compreso il processo creativo che il Maestro vive in sé, solo allora potrà produrre un’opera d’arte, ma non si tratterà, anche in quel caso, di un’opera completamente originale poiché in essa sarà presente una parte derivante dal Maestro e così si perpetuerà la “trasmissione dello spirito degli antichi”. Pertanto la copia non è affatto di secondaria importanza rispetto all’originale, poiché l’atto del copiare è inevitabile ed è parte del processo di trasmissione del fenomeno di produzione dell’arte. Nel testo Qimin Yaoshu (Principali tecniche per il raggiungimento del benessere per la gente), redatto durante la Dinastia Wei Occidentali (535-557 d. C.), alcuni capitoli sono dedicati alla conservazione antiquariale. A partire dalla Dinastia Song (960-1279) si sviluppa l’interesse dei collezionisti, degli antiquari e dei filologi per i vasi arcaici in perfetta continuità con le tradizioni precedenti. Nell’anno 1092 Lu 14 Dalin (1046-1092) pubblica la monumentale opera Kao Gu Tu (Figure per lo studio delle cose antiche) nella quale vengono illustrati e catalogati con criteri tipologici rigorosi ben 211 opere della collezione imperiale e 37 manufatti provenienti da collezioni private. Nell’antica letteratura cinese sono rari i testi dedicati in modo specifico alla tutela del patrimonio culturale. Precisi riferimenti ai metodi di restauro e di manutenzione degli antichi edifici sono contenuti in opere come il Mengxi Bitan (Memorie di scambi epistolari), opera di Shen Guo(1031-1095) ricca di notazioni scientifiche e tecnologiche o come il Duonengbishi(Manuale per la realizzazione di ogni sorta di oggetto), scritto da Liu Ji(1311-1375) durante l’epoca Ming, nel quale sono descritte le tecniche della colorazione della seta con estratti del tè verde. Durante la Dinastia Song venne redatto il testo Huangshi (Storia della pittura), opera del poeta Mi Fu, nel quale sono descritte in modo specifico le tecniche di impermeabilizzazione e di essiccazione utilizzate sui dipinti su rotolo. Durante l’epoca Song erano diffuse le copie di manufatti in bronzo, realizzate sul modello degli originali risalenti alle Dinastie Shang e Zhou. In quel periodo inoltre era praticato lo studio epigrafico che stimolerà in maniera determinante lo sviluppo dei procedimenti di restauro. Durante la Dinastia Yuan (1271-1368 d. C.) la pratica della duplicazione dei manufatti antichi perse importanza a causa delle lunghe guerre e la qualità dei risultati peggiorava rispetto alle repliche che erano state prodotte durante la Dinastia Song. Durante l’epoca Ming molte sculture subirono numerosi restauri integrativi. Uno dei casi più emblematici è quello riscontrato nelle straordinarie sculture del sito rupestre di Dazu nel quale sono conservate ben 50.000 sculture e iscrizioni, localizzato nella Cina Centrale, presso la megalopoli di Chongqing. Nel corso di un recente restauro della statua della divinità Guanyin detta “delle 1000 mani” sono state scoperte numerose applicazioni parziali della doratura, certamente di restauro. Il testo Zhuanghuangzhi(Trattato sui metodi di decorazione), redatto da Zhou Jiazhou(1522-1620) durante la Dinastia Ming, descrive i processi di alterazione dei pigmenti bianchi. Le tecniche operative del restauro per la porcellana, il bronzo, le antiche calligrafie e i dipinti registrano un miglioramento progressivo fino alle Dinastie Ming e Qing. Il periodo Qing costituì la fase di maggior ricchezza per il restauro delle antichità in Cina e ciò è dovuto al forte interesse degli imperatori per le antichità. Il testo Regolamentazione per la tutela dei beni culturali e dei siti storici, che costituisce il più antico documento normativo cinese in materia di conservazione delle antichità, venne redatto durante il regno dell’Imperatore Xuantong (1909). Nella prima metà del Novecento i contributi di Zhu Qiqian e Liang Sicheng (nell’ambito della Società per lo Studio delle Costruzioni Cinesi) sono stati determinanti per lo sviluppo del concetto cinese moderno di patrimonio storico costruito. Di grande rilievo per quanto riguarda la storia delle tecniche costruttive dell’architettura fu la scoperta del manuale Yingzao fashi (Trattato dei metodi dell’architettura) scritto attorno al 1103, durante la Dinastia Song da Li Jie (1065-1110), ritrovato nel 1919 da Zhu Qiqian nella Biblioteca Jiangnan a Nanchino e successivamente studiato da Liang Sicheng. Infine assume un ruolo centrale, per le prospettive di questa ricerca che sarà portata avanti da altri, la “scoperta” compiuta qualche anno dei manoscritti di Wang Xu (1930-1997), studioso di formazione autodidatta che nel 1984 divenne direttore della sezione di Conservazione dell’Istituto di Archeologia dell’Accademia Sinica delle Scienze Sociali. Wang Xu dedicò tutta la vita alla ricerca sulla storia dei tessuti in Cina, allo studio delle tecniche tradizionali ancora preservate e alla ricerca 15 sulle problematiche di conservazione e restauro in questo delicatissimo ed importante settore. Fu responsabile del recupero e del restauro nel caso di importanti ritrovamenti archeologici, quali la tomba Chu a Mashan, Jiangling, le tombe Han a Mawangdui, Mancheng e Guangzhou e nel caso del ritrovamento delle importantissime opere Tang nel Tempio di Famen. La costituzione di una Fondazione in memoria di questo grande protagonista del Novecento contribuirà a rafforzare in Cina la disciplina della storia del restauro. Mario Micheli Zhan Chang Fa (Chinese Academy of Cultural Heritage, Beijing, China) BIBLIOGRAFIA R. CIARLA, M. MICHELI, Il Centro di formazione per la conservazione ed il restauro del patrimonio storico-culturale della Cina nord-occidentale a Xi’an – Repubblica Popolare Cinese. Oriente-Occidente: filosofie del restauro a confronto, in «Faenza», I-III (1997), pp. 19-27. ZHAO FENG (a cura di), Wang Xu and Textile Archaeology in China, Hong Kong 2001. J. FRESNAIS, La protection du patrimoine en République populaire de Chine, 1949-1999, Paris 2001. ZHANG LIANG, La naissance du concept de patrimoine en Chine. XIX-XXe siècles, Dijon-Quetigny 2003. G. PASQUALOTTO, Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente, Venezia 2004. M. MICHELI e ZHAN CHANG FA (a cura di), La conservazione del Patrimonio Culturale in Cina. Storia di un progetto di cooperazione, Roma 2006. B. PEH T’I WEI, Yuan Ruan, 1764-1849. The Life And Work of a Major Scholar-Official in Nineteenth-Century China Before the Opium War, Hong Kong 2006. Mortalità materna nei rilievi funerari attici: un’ipotesi di lettura La questione della donna nell’antichità classica è un argomento che ha affascinato generazioni di studiosi, e la cui complessità risiede in parte nel fatto che le testimonianze, comunque sporadiche, sono filtrate da autori maschili che scrivevano per un pubblico maschile. Che la donna avesse un ruolo marginale nella società greca non è controvertibile, anche se è stato ridimensionato quel pessimismo che aleggiava sulla condizione femminile. Il suo ruolo sociale si risolveva nella legittimità della filiazione; la sua sfera di competenza concerneva unicamente il privato della vita quotidiana, essendo riservata la gestione del bene pubblico, della polis, all’uomo. Le arti visive e soprattutto la pittura vascolare, con maggiore intensità a partire dall’inizio del V secolo, certificano di fatto la dimensione privata della donna che, quando è rappresentata, appare più frequentemente nel contesto domestico. I pittori scandiscono il ritmo della vita femminile secondo immagini stereotipate, che mostrano la donna dedita all’igiene quotidiana o a imbellettarsi. Più rare le raffigurazioni che la vedono occupata nelle sue mansioni specifiche o nella cura dei figli, o fuori delle mura domestiche. Se associata a un uomo, le occasioni riguardano il rito delle nozze, il commiato del guerriero o l’intimità all’interno del gineceo, a rimarcare il benessere sociale della famiglia. Al destino di morte riportano le scene in cui prende parte come membro dell’oikos. Nonostante la letteratura misogina catalizzata su alcuni topoi, è ormai certo che la donna, legittimamente coniugata, almeno all’interno della casa, godesse di maggiore libertà. A riprova, le scene domestiche decorano, nella maggioranza dei casi, forme destinate all’uso femminile, lasciando i soggetti più lascivi, forse pertinenti a etere, prostitute o schiave, a campire crateri e kylikes, destinati invece al pubblico virile dei simposi o all’esportazione, e rivelando che anche i destinatari non erano sempre maschili. 16 Con la ripresa della produzione di semata funerari negli ultimi decenni del V secolo, provocata forse dagli eventi della guerra del Peloponneso e dalla necessità di riqualificare la manodopera artigianale, affluita ad Atene per i lavori dell’Acropoli, una più netta e diffusa affermazione dell’immagine della donna è percepibile anche nella selezione dei soggetti che fregiano ora lekythoi, loutrophoroi, stele e naiskoi. I temi non si discostano da quelli proposti dalla pittura vascolare, anche se la destinazione del monumento determina la maggiore compostezza negli schemata e la rarefazione dell’atmosfera dello sfondo, in genere privo di quei riferimenti al contesto del gineceo, tangibili invece nella ceramica. Limitandoci ai soggetti che vedono protagonista la donna sposata, ella è più spesso seduta e in compagnia di una o più figure che precisano la natura del momento e il suo valore simbolico: la funzione di despoina della casa o quello di sposa. Tuttavia nel raffronto con la ceramica coeva, Fig. 1 – Naiskos funerario, Brauron, Museo Archeologico a fronte della pur omogenea gamma tematica, emerge, con forte evidenza, il carattere rilevante qui consegnato al tema della maternità; nei monumenti funerari si nota, cioè, una più spiccata e ripetuta insistenza sulla dimensione materna che, come si è accennato, rimane invece un motivo secondario nel repertorio vascolare al quale comunque queste scene rimandano. La tematizzazione di donne perite per cause o per conseguenze concomitanti il parto compare già nell’ultimo venticinquennio del V secolo. Lo schema con l’iconografia più diffusa prevede una figura stante, in genere femminile, congiunta o ancella, con un infante in braccio. Accanto, assisa e in posizione rilevante, fa la sua comparsa un altro personaggio femminile, la madre. Talora le si affiancano il figlio maggiore o la figlia. Esistono poi numerosi rilievi che oltre alla madre e al figlio mostrano un più nutrito gruppo di personaggi complementari, familiari o domestici, in prevalenza femminili, generalmente stanti, uno dei quali sorregge il neonato. In altri appare il marito. Tra il 400 e il 375 si palesa un altro schema, assimilabile semanticamente ai precedenti, numericamente meno cospicuo, nel quale si profila la madre seduta che abbraccia il neonato, tenuto in grembo. Meno frequente è la raffigurazione della madre stante. Al quadro sinteticamente delineato nel quale concorrono ulteriori variazioni sul tema, vanno aggiunti alcuni monumenti di piccolo formato, circoscrivibili agli anni 370-360, che drammatizzano la morte per parto, mediante la raffigurazione della donna in preda alle doglie. Chiedersi se tra i fattori che determinarono questo nuovo vigore tributato alla figura femminile possa essere compreso l’accresciuto peso sociale, acquisito dalla donna in un momento in cui la popolazione maschile aveva subito una drastica riduzione a causa dalla guerra del Peloponneso è una domanda lecita. Indagini demografiche hanno dimostrato la forte incidenza di queste vicende nella diminuzione della popolazione maschile ateniese e in generale di quella dell’intera Grecia alla fine del V secolo con ripercussioni nel secolo successivo. Non va inoltre trascurato l’effetto delle leggi periclee secondo le quali un Ateniese poteva ritenersi cittadino solo se figlio di padre e di madre ateniesi: il che, in un certo senso, equivaleva a un timido riconoscimento Fig. 2 – Stele funeraria, Lyme Park, Stockport, Cheshire del ruolo sociale della donna. 17 A un primo livello di lettura, la persistente presenza del bambino, o in taluni casi di più bambini, è manifestamente funzionale a sottolineare la dignità di madre della defunta nei semata funerari, come nella ceramica. Tuttavia la circostanza che spesso il bambino si identifichi con un neonato esige un’accentuazione di contenuto semantico, di fatto affidata alla riconoscibilità immediata dell’infante. Che in questi casi si tratti di un neonato è infatti esplicitamente dichiarato dalle fasce, spargana, nelle quali, secondo le fonti, il piccolo veniva avvolto al momento della nascita. Un’altra nota di autenticità è il berretto di lana, non sempre rappresentato, che secondo la tradizione letteraria serviva a proteggere la piccola testa, subito dopo il parto. La nascita comportava, a causa della scarse norme igieniche e della giovane età delle madri, un elevato rischio sia per la partoriente sia per il nascituro e veniva posta sotto la tutela divina. La non conoscenza delle regole dell’asepsi nell’ostetricia, idonee a ridurre i rischi batterici, e la mancanza di antibiotici e di strumenti di diagnosi clinica comportavano un’altissima mortalità materna: circa il 14%. A ciò si aggiunge che le immunodeficienze, originate anche dalla malnutrizione cui le donne erano soggette, aumentavano il rischio di contrarre malattie endemiche, quali la malaria, e l’insorgenza di complicazioni. I dati in nostro possesso confermano che l’aspettativa di vita femminile era inferiore a quella maschile. Secondo le fonti, il parto si svolgeva probabilmente all’interno del gineceo, assistito dall’ostetrica: il medico era sollecitato solo in caso di gravi complicazioni per la madre o il bambino. Il taglio cesareo era noto, come conferma l’immaginario mitico, ma praticato solo dopo la morte della madre per estrarre il feto. Si ricorreva dunque all’embriotomia per salvaguardare la vita della partoriente, qualora il feto fosse già morto. Si esercitavano invece alcune operazioni ostetriche quali l’interruzione artificiale della gravidanza a scopo terapeutico, o il riposizionamento cefalico del feto, se questo aveva conservato una posizione non corretta, ma non completamente podalica. Il feto poteva essere estratto con strumenti in grado di agevolarne l’uscita, ma anche di procurare lesioni al bambino e alla madre. Un elevato tasso di complicanze contraddistingueva i parti gemellari e plurigemellari. A rischio era la vita della madre per la febbre puerperale. Riveste pertanto un particolare significato che l’indugiare sul tema della mortalità materna nei monumenti funerari si verifichi col profilarsi della difficile congiuntura della guerra del Peloponneso. Il dato è importante non solo perché conferma che la donna era divenuta di necessità un riferimento obbligato per una società ormai scollata nella quale la popolazione maschile era stata seriamente compromessa dalle perdite umane, prodotte dagli eventi bellici, ma soprattutto perché rileva che in questo drammatico frangente, denso di conseguenze per la città di Atene, l’urgenza di sottolineare la peculiarità dell’individuo/cittadino nella memoria della collettività e nella sua interazione con la comunità dei concittadini diventava più pressante anche per il genere femminile. Sulla superficie dei monumenti funerari la tematizzazione della morte per parto si reiterava caricandosi di valenze intrinseche che non erano riferibili tanto alla prospettiva privata dell’esistenza femminile, ma che ambivano suggerirne la dimensione sociale, ribadirne il ruolo “politico”. Nonostante le critiche sollevate sul binomio morte/guerra, l’intima connessione tra la donna e la maternità veniva così a stigmatizzare il carattere civile del procreare. La polarità tra procreazione, qualità distintiva femminile, e guerra, prerogativa maschile, tra oikos e polis, antinomia che sintetizzava il rapporto uomo-donna, era stata ribadita da Euripide (Med. 248-251). Entrambi gli eventi erano avvertiti come un aspetto dell’areté, poiché ambedue offrivano l’opportunità di completare la natura dell’attore, rispettivamente donna e uomo. È per questo che sui rilievi sono evocate solo le cause del decesso occorse in guerra o per parto, inquadrando l’evento, in entrambe le evenienze, in un contesto atemporale. Alexia Latini 18 BIBLIOGRAFIA J. BERGEMANN, Demos und Thanatos. Untersuchungen zum Wertsystem der Polis im Spiegel der attisch en Grabreliefs des 4. Jahrhunderts v. Chr. und zur Funktion der gleichzeitigen Grabbauten, München 1997. M.L. CATONI, Le regole del vivere, le regole del morire. Su alcune stele attiche per donne morte di parto, in «Revue Archéologique», 2005, pp. 27-54. W.CH. CLAIRMONT, Classical Attic Tombstones, Kilchberg 1993-1995. N.H. DEMAND, Birth, Death, and Motherhood in Classical Greece, Baltimore 1994. R. GARLAND, The Greek Way of Life: from Conception to Old Age, London 1990. G. KOKULA, Marmorlutrophoren, Berlin 1984 («Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung», Beiheft 10). A. LATINI, Riflessi della mortalità neonatale e materna nella pittura ellenistica, in Pittura ellenistica in Italia e in Sicilia, Linguaggi e tradizioni, a cura di G. F. La Torre e M. Torelli, Atti del Convegno (Messina, 2009), Roma 2011, pp. 63-78. S. LEWIS, The Athenian Woman: An Iconographic Handbook, London e New York 2002. G.E.R. LLOYD, Science, Folklore, and Ideology: Studies in the Life Sciences in Ancient Greece, New York 1983. E.D. REEDER, Pandora: Women in Classical Greece, Baltimore 1995. B. SCHMALTZ, Untersuchungen zu den attischen Marmorlekythen, Berlin 1970. U. VEDDER, Frauentod-Kriegertod im Spiegel der attischen Grabkunst des 4. Jhs. v. Chr., in «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung», 103 (1988), pp. 161-191. C. WELLS, Ancient Obstetric Hazards and Female Mortality, in «Bulletin of the New York Academy of Medicine», 51 (1975), pp. 1235-1249. Le tombe rupestri “a tempio” in Etruria e in altre zone del Mediterraneo orientale Le cosiddette tombe a tempio rappresentano indubbiamente il tipo più nobile ed elaborato fra le tombe rupestri. Nella mia breve relazione tratterò comunque non solo tombe rupestri a tempio ma anche altre tombe con facciate a tempio sia costruite sia scavate in varie zone del Mediterraneo centrale e orientale. Punto di partenza del mio intervento sono necessariamente le tombe a tempio, a portico e ad edicola dell’Etruria meridionale interna come le Tombe doriche e la Tomba Lattanzi a Norchia, le Tombe Ildebranda, Pola, della Sirena (fig. 1) e del Tifone a Sovana – tutte databili in età ellenistica – e alcune tombe di Sutri databili già in età romana come la Tomba 64 della necropoli urbana. Il fenomeno di dare alla facciata della tomba o al monumento funerario l’aspetto di un tempio o – in formato minore – di una edicola era ben diffuso Fig. 1 – Sovana, Tomba della Sirena soprattutto nei decenni del primo ellenismo come mostrano vari esempi nell’Etruria meridionale, nella Daunia, in Macedonia, Arcadia e sulle isole di Rhodos e Thera, in Asia Minore (Licia, Caria, Paphlagonia), ad Alessandria e nella Cirenaica. Può essere considerata una caratteristica soprattutto di alcune zone periferiche della cultura greca dove l’architettura funeraria aveva assunto una particolare tendenza verso una monumentalizzazione, eroizzazione e autorappresentazione del defunto. In alcune regioni come nella Licia le facciate rupestri potevano assumere già in epoca preellenistica un’aspetto templare per caratterizzare in questa maniera la tomba come sito sacrale cioè come “tempio funerario” di personaggi di spicco sociale ed eroizzare i defunti. 19 ETRURIA Norchia: Tombe doriche, Tomba Lattanzi Sovana: Tomba Ildebranda, Tomba Pola; Tombe a edicola: della Sirena, del Tifone, dei Demoni alati, Siena, Poggio Stanziale Sutri: alcune tombe rupestri della necropoli urbana di epoca romana (Tomba 64) Norchia: tombe doriche Le facciate contigue delle cosiddette tombe doriche nella Valle dell’Acqualta – disegnate nell’Ottocento già dall’Ainsley e da Canina – si presentano in forma di tempietti gemelli, di ordine tuscanico, distili in antis su un podio. La trabeazione accoglie un fregio dorico a metope con protomi di teste femminili e geison a dentelli, mentre il geison obliquo è scolpito con una cyma recta su toro. In luogo dei mutuli laterali si trovano acroteri a disco con gorgoneion e protomi leonine, incornicianti le complesse e movimentate raffigurazioni di lotte e combattimento – variamente interpretate soprattutto in senso mitologico (lotta davanti a Troia, uccisione dei Niobidi ecc.) – scolpite a forte rilievo e originalmente colorate nei frontoni. Soprattutto nel portico sinistro si vedono resti di un fregio a rilievo stuccato dipinto: processione con dignitari e demoni alati (confronto: T. del Tifone a Tarquinia) – fregio d’armi con scudi, spade ed elmi appesi (confronti: T. Giglioli a Tarquinia e T. dei Rilievi a Cerveteri; tombe a Paestum, Egnazia, in Macedonia e Tracia). La datazione di queste tombe gemelle oscillava una volta fra il tardo quarto e la prima metà del II sec. Oggi prevale chiaramente – almeno per la prima fase (frontoni) – una datazione fra la fine del IV e i primi decenni del III sec., mentre la seconda fase (fregio) dovrebbe risalire al medio ellenismo. Del resto possiamo costatare qui una delle prime apparizioni del fregio dorico a metope in Etruria (adottato probabilmente dalla Magna Grecia, forse tramite Roma). Norchia: Tomba Lattanzi La T. Lattanzi nella Valle del Biedano – in gran parte distrutta e attribuibile alla gens Churcle – può essere classificata a doppio portico su alto podio, sul quale si sale per mezzo di una scala laterale, e mostra un singolare prospetto a due piani, l’inferiore a colonne tuscaniche fra ante (una delle quali poggiante sul dorso di una statua di leone o sfinge) e porta finta a rilievo sul fondo, il superiore a terrazzo col lato di fondo movimentato da un finto portico a colonne con capitelli corinzio-italici. La ricca decorazione del fregio consisteva soprattutto in animali fantastici (grifi) ed elementi floreali. Esistono confronti con l’Archokrateion di Lindos (J.P. Oleson) e una tomba tardoarcaica a doppio portico a Barca in Cirenaica. Fig. 2 – Sovana, Modello della Tomba Ildebranda 20 Sovana: Tomba Ildebranda e Tomba Pola Queste due tombe monumentali di Sovana – databili con grande probabilità alla prima metà del III sec. – riprendono la tipologia a tempio con facciate su alto podio rispettivamente a 6 e 8 colonne scanalate e stuccate su basi a doppio toro, fornite di capitelli a protomi tra volute e soffitti a cassettoni. Tomba Ildebranda. La Tomba Ildebranda (fig. 2) è caratterizza ta dalla sua posizione panoramica con vista sul colle della città, dal cubo a forma di T, dalla pianta di tipo “peripteros sine postico”, dall’alto podio modanato con due scale laterali, da tre frontoni (anche sulla fronte secondo la ricostruzione più recente), da colonne con capitelli figurati, soffitto a lacunari, due fregi con ricca decorazione scultorea con animali fantastici (grifi) ed elementi vegetali, dentelli e rosette e da una ricca policromia originale. Concetto ed ideologia generale esprimono influssi dall’Asia Minore (cioè dai grandi Heroa e Mausolea come quello di Belevi). La decorazione (cioè i fregi a tralci o “peopled scrolls” e i capitelli figurati) mostrano invece prevalentemente influssi apulo-magnogreci. Le tombe a edicola – studiate da A. Maggiani – di formato minore risalgono al primo e medio ellenismo cioè prevalentemente al III sec. coprendo un’arco cronologico dalla seconda metà del IV fino al primo quarto del II sec. Le tombe del Tifone, della Sirena, dei Demoni Alati, Siena e sul Poggio Stanziale sono in parte caratterizzate da un ricco apparato decorativo parzialmente figurato (Scilla, demoni alati, testa femminile) – soprattutto nei frontoni – ma anche da decorazioni vegetali e da fregi dorici. TOMBE A TEMPIO IN ALTRE ZONE DELL’ITALIA E DEL MEDITERRANEO ORIENTALE APULIA-DAUNIA Arpi: Tomba della Medusa (Tomba delle Anfore) Canosa: Ipogeo Lagrasta II (Ipogei Lagrasta, Boccaforno, degli Ori, del Cerbero, Sant’Aloia) Salapia: Tomba a camera con facciata TARANTO Naiskoi: Taranto Confronti a Ceglie Messapica, Crotone, Grottaglie, Herakleia-Policoro, Lavello, Metaponto, Palagiano, Rocavecchia (Canosa, Salapia. Lecce, Rudiae, Cirò, Locri?) Tomba di Via Polibio a Taranto CAMPANIA Napoli: Ipogeo Cristallini, Ipogeo di Vico Traetta ROMA T. degli Scipioni MACEDONIA Lefkadia: Tomba Petsas Verghina, Aghios Athanasios TRACIA Ingressi di tomba ad edicola (come a Canosa) ILLIRIA/ALBANIA A Basse-Selce tombe a portico, ad esedra con scale e ad edicola con frontone: tardo IV-prima metà III sec. ARCADIA Alipheira: Tomba con facciata monumentale a frontone con acroteri RHODOS, THERA E ISOLE GRECHE Archokrateion a Lindos: a portico con due piani, ultimo quarto del III sec. 21 Rhodini: “Ptolemaion” con base, semicolonne doriche e forse piramide sopra, fine III-inizio II sec. Kastellorizo: cosidetta tomba licia ad edicola: fine IV sec. Thera: tomba ad edicola LICIA Xanthos, Myra, Telmessos (“Tomba di Amyntas”: fine IV sec.), Pinara Tombe semplici a tempio non prima del IV sec., normalmente con due colonne in antis o a peripteros con influssi greco-ionici, anche con rilievi nel frontone (leone attacca toro), iscrizioni CARIA Kaunos Tombe a tempio con facciata fino a 4 colonne e a edicola, frontoni con rilievi e acroteri, non prima della metà del IV sec. PAPHLAGONIA Tombe a tempio, a portico e a edicola, frontoni con rilievi e sculture, influssi persiani e frigi, dell’architettura lignea e dell’architettura greca templare FRIGIA Tombe e monumenti a tempio o con frontone già fra VIII e VI sec. CAPPADOCIA Tombe a tempio (dorico), a portico e ad edicola in periodo ellenistico PERSIA Tombe cruciformi a portico già in età tardoarcaica (dopo il 520) PALESTINA/GERUSALEMME Gerusalemme, Amman: periodo tardoellenistico e imperiale CIRENAICA: Cirene, Barca Tombe rupestri più antiche: seconda metà VI sec. Tipi a tempio, a portico e a peristilio con colonne o pilastri dorici e capitelli dorici, ionici e eolici. Rappresentano le tombe a tempio greco più antiche del Mediterraneo. Nel periodo ellenistico tombe a tempio e a portico (reale o finto) con elementi dorici e ionici, acroteri e scale esterne. ALEXANDRIA: Necropoli Suk El Wardin Grandi complessi tombali: scavati ma non di tipo rupestre diritte verso l’esterno ZONA NABATEA-PETRA Il culmine dello sviluppo delle tombe a tempio è rappresentato indubbiamente da quelle di Petra nella Giordania nabatea scavate ed elaborate nell’arenaria rossastra e databili fra la metà del I sec. a. C. e la prima metà del II sec. d.C. Fra le più di 600 tombe rupestri a Petra 18 appartengono a questa tipologia. Di particolare importanza è il criterio della visibilità e funzione rappresentativa delle facciate tombali 22 a tempio. Questi criteri si verificano per esempio nei casi degli ipogei napoletani e naturalmente delle tombe rupestri in Etruria meridionale interna, nella Licia e Caria, nella Cirenaica e a Petra. Assai diversa è la situazione in Apulia e in Macedonia dove il dromos e almeno buona parte della facciata tombale sono stati sotterrrati dopo il funerale o fra i vari funerali. Secondo M. Mazzei nel caso dell’Ipogeo della Medusa ad Arpi probabilmente solo il frontone con l’acroterio rimaneva visibile come sema. La distinzione tecnica fra “costruito” e “scavato”, dal punto di vista del messaggio della tomba, non è determinante. Queste tombe erano caratteristiche soprattutto di società monarchiche e oligarchiche e dovevano glorificare e fino ad un certo punto eroizzare il defunto. Conta soprattutto l’aspetto esterno cioè il monumento e non tanto la tomba o deposizione propria. La forma di tempio implica una assimilazione agli dei ed eroi e rimane visibile – specialmente in caso delle tombe rupestri – anche alle future generazioni. Questo fenomeno fu particolarmente diffuso in età ellenistica – con alcuni precedenti nei periodi arcaico e classico – e si trova prevalentemente in regioni grecizzate oppure non greche periferiche come in varie zone dell’Asia Minore, mentre manca quasi completamente nella Grecia propria. In vari casi iscrizioni indicano il nome del defunto e motivi decorativi esprimono valori simbolici, ad esempio raffigurazioni di armi dovevano sottolineare l’importanza della componente militare nella vita del defunto. Inoltre queste tombe sono spesso situate lungo le strade principali d’ingresso rispettivamente d’uscita dalla città, in parte in contatto visivo con la città e dominanti la zona circostante. È un fatto ben noto che durante il IV sec. e l’età ellenistica cresceva la tendenza di eroizzare particolari individui o gruppi gentilizi e questa tendenza si manifesta in una serie di Heroa soprattutto in Asia Minore come a Gölbasi-Trysa, Limyra, Mileto e Didyma ma anche per esempio a Kos, Kalydon, Cirene e fino ad Ai Khanum in Afghanistan. Stephan Steingraeber BIBLIOGRAFIA J. FEDAK, Monumental Tombs of the Hellenistic Age: A Study of selected Tombs from the Preclassical to the Early Imperial Era, Toronto 1990. D.C. KURTZ, J. BOARDMAN, Tod und Jenseits bei den Griechen, Mainz 1985. H. LAUTER, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt 1986. A. MAGGIANI, Tombe con prospetto architettonico nelle necropoli rupestri d’Etruria, in Tyrrhenoi Philotechnoi, Atti della Giornata di studio (Viterbo 1990), a cura di M. Martelli, Roma 1994, pp. 119-159. M. MAZZEI, Arpi. L’Ipogeo della Medusa, Bari 1995. J.P. OLESON, The Sources of Innovation in Later Etruscan Tomb Design, Roma 1982. S. STEINGRAEBER, New Discoveries and Research in the Field of Southern Etruscan Rock Tombs, in «Etruscan Studies», 3 (1996), pp. 75-104. S. STEINGRAEBER, Arpi – Apulien – Makedonien. Studien zum unteritalischen Grabwesen in hellenistischer Zeit, Mainz 2000. La “Basilica Argentaria”: alcuni spunti di ricerca I. LA “BASILICA ARGENTARIA”: TEMI GENERALI Quella che qui si presenta è una ricerca appena iniziata, sorta nel più ampio ambito di una Convenzione tra l’Università Roma Tre e la Sovraintendenza ai Beni Archeologici di Roma Capitale e, in particolare, come proficua e amichevole collaborazione con il collega Roberto Meneghini. L’edificio che oggi conosciamo con il nome di “Basilica Argentaria” ha avuto nel corso degli anni una curiosa sorte ancillare, come parte del Foro di Cesare poiché è effettivamente unito a esso e visibile solo nel settore 23 risparmiato per questo foro durante gli scavi degli anni Trenta del secolo scorso. In realtà, come si vedrà poco oltre, esso è parte integrante del progetto del Foro di Traiano. Gli studi fondamentali di Carla Maria Amici (AMICI 1991) sul Foro di Cesare hanno riguardato anche la “Basilica Argentaria”, ponendo però la massima attenzione sul complesso forense e riservando alla “Basilica” una prima raccolta di dati essenziali, uno studio strutturale relativo al piano terra e uno studio dello sviluppo degli elevati molto suggestivo che, però, lascia in ombra le relazioni spaziali con gli altri edifici circostanti. In precedenza, si possono citare le magistrali osservazioni di Matteo Della Corte (DELLA CORTE 1933) sui graffiti che erano (purtroppo lo stato attuale non è dei migliori) presenti in gran numero sugli intonaci interni dell’edificio; studio poi ripreso dalla collega Rita Volpe, che si spera di prossima edizione. Il nome “Basilica Argentaria” è menzionato solo nei Cataloghi Regionari, nell’elenco degli edifici pubblici della Regio VIII; si tratta, quindi di una fonte tarda rispetto alla costruzione che è da collocarsi all’inizio del II secolo d. C., nell’ambito dei lavori fatti per la costruzione del Foro di Traiano. Il collegamento tra nome e resti archeologici risale all’epoca degli sterri di Via dei Fori Imperiali, ma l’identificazione dell’edificio risulta essere ancora una questione aperta. Già nella ricostruzione planimetrica di Italo Gismondi e ora nell’ultima aggiornata del complesso dei Fori Imperiali (fig. 1) si osserva nettamente lo stretto rapporto esistente tra l’emiciclo occidentale della piazza Fig. 1 – La “Basilica Argentaria” nel contesto dei Fori Imperiali, secondo l’ipotesi ricostruttiva proposta a seguito dei recenti scavi da R. Meneghini del Foro di Traiano e la “Basilica” nel tratto in cui questa doveva definire lo spazio esterno all’emiciclo stesso, contraffortando la pendice collinare del Campidoglio. La “Basilica” non è altro che un portico a due navate che piega con due angoli netti per assecondare l’andamento dell’esedra e, probabilmente, continuava a nord, bordando anche l’emiciclo della Basilica Ulpia, per poi raggiungere la piazza antistante l’ingresso del Foro di Traiano. Ciò che non si percepisce dalla sola visione planimetrica è la vera natura dell’edificio che, sviluppandosi su due piani, in realtà raccordava mediante scale interne tre distinti livelli di percorrenza: la quota della piazza del Foro di Cesare (posta a 14 m. s.l.m. ca., quindi più bassa di 3 m.), quella del clivus Argentarius, la strada di mezza costa che collegava la zona del vecchio Foro con il colle capitolino (posta a quota 25,40 m. s.l.m. ca., quindi più alta di 8,5 m.) con quella interna della stessa “Basilica” che risulta essere uguale alla quota dei pavimenti interni del Foro di Traiano (posti entrambi a 17 m. s.l.m. ca.). In definitiva, quindi, la “Basilica” ci appare oggi come un ritaglio urbano, limitatamente comprensibile e coinvolto in interventi di scavo, con relative susseguenti sistemazioni di restauro e fruizione, finalizzati a tutt’altri punti di interesse. Una prima rassegna di temi ai fini di una nuova indagine scientifica pone a monte dello studio complessivo l’analisi delle fasi costruttive di cui l’edificio reca traccia: un primo blocco di lavoro che è stato già realizzato ed è qui di seguito sintetizzato da Claudio Taffetani. Da questo primo passo ne discendono altri due: l’analisi tridimensionale del complesso e le sue relazioni con gli elementi urbanistico-architettonici. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, risulterà fondamentale la collaborazione con altre équipes che già da molti anni lavorano nello stesso gruppo di ricerca diretto da Roberto Meneghini, e in particolare con i colleghi Alessandro Delfino 24 e Valeria Di Cola che stanno studiando il Foro di Cesare, cui la “Basilica” è architettonicamente legata (per gli studi già pubblicati si vedano: DELFINO et al. c.d.s., DELFINO 2008 e 2009); ma per comprendere questo che è un tassello di un più vasto progetto sarà anche necessario aprire lo sguardo sul contesto del Foro di Traiano e, anzi, su ciò che era all’esterno del foro stesso, dal lato dell’ingresso principale verso la Via Flaminia, zona in cui i recenti scavi condotti davanti alla chiesa di S. Maria di Loreto e quelli di Palazzo Valentini hanno portato nuovissimi dati (si vedano BALDASSARRI 20082009, LA ROCCA 2008-2009 e i contributi dei colleghi Roberto Egidi, Mirella Serlorenzi e Giovanni Ricci nel recente Convegno: “L’Athenaeum di Adriano. Storia di un edificio dalla fondazione al XVII secolo”, tenutosi a Roma il 22 settembre 2011). Maura Medri II. “BASILICA ARGENTARIA”: AGGIORNAMENTI PLANIMETRICI, FASI DI COSTRUZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO Il lavoro qui presentato è nato principalmente dalla necessità di realizzare una nuova documentazione grafica della “Basilica Argentaria” (MORSELLI 1993: 169-170). Partendo dall’osservazione diretta delle strutture, si è deciso di progettare e di creare una nuova planimetria generale dell’edificio attraverso un rilievo topografico dell’area. Il prodotto di queste diverse operazioni si configura come una serie di piante e di sezioni, suddivise per fasi costruttive, che documentano graficamente le trasformazioni dell’edificio nel corso dei secoli, da prima della sua costruzione all’età medievale. La prima fase illustra lo stato dell’area alla fine dell’epoca cesariana. Il limite settentrionale del Foro di Cesare è rappresentato dalle propaggini tufacee del Campidoglio (FIORANI 1968: 101; AMICI 1991: 31 sgg.; MORSELLI 1995: 304), poiché in realtà le due absidi che chiudono la piazza a Nord e il retro del podio del tempio di Venere Genitrice si addossano alle pendici del colle capitolino. In seguito, durante l’impero di Domiziano, iniziano le prime operazioni di sbancamento del terreno retrostante il foro cesariano e i lavori per il taglio della sella che all’epoca ancora univa i colli del Campidoglio e del Quirinale (Aur. Vict. Caes. 29). A questo periodo corrisponde anche l’abbassamento generale del piano di calpestio dell’area, che tuttavia sarà sempre ad una quota maggiore rispetto alla piazza del foro cesariano. Una volta liberata la zona dal terreno della collina sovrastante, si costruisce un possente muro in opera laterizia, sul prolungamento della parete di fondo del portico occidentale con taberne, in modo tale da contenere la spinta delle terre della collina resecata. Ma è solo in epoca traianea che inizia la costruzione dell’edificio che oggi chiamiamo “Basilica Argentaria”, posto nella zona nord-ovest del complesso cesariano e addossato al muro di sostruzione di fase precedente. La nuova costruzione è a due piani ed è formata da due ambulacri che corrono parallelamente intorno al podio del tempio di Venere Genitrice per poi proseguire verso Nord e quindi verso la piazza su cui si apriva l’ingresso del Foro di Traiano. Gli ambulacri sono composti da due file di pilastri, la più interna in opera laterizia, l’altra esterna verso il Tempio in blocchi di peperino, raccordati da una sequenza di volte a crociera che poggiano sia su i pilastri stessi che sul muro di fondo. Anche i pavimenti sono diversi: in opus spicatum all’interno e in lastroni quadrangolari in travertino nella parte esterna. La differenza di livello esistente tra gli ambulacri e la piazza del Foro di Cesare viene risolta con due gradinate che salgono dal livello di questo sino al piano della “Basilica Argentaria”. In un momento successivo alla costruzione, e probabilmente in epoca Severiana (LANCASTER 2009: 29-32), si può far risalire l’intervento di ristrutturazione dell’ambulacro più interno che viene rafforzato con una serie 25 di pilastri di piccole dimensioni, appoggiati sia al muro di sostruzione contro il colle capitolino che contro i pilastri in opera laterizia più grandi già esistenti. Anche questi nuovi pilastri sono costruiti per sostenere una serie di volte a crociera che vanno così a creare un piano intermedio. L’incendio che colpisce Roma nel 283 d. C. (CODICE TOPOGRAFICO 1940: 279), investe anche le strutture del Foro di Cesare. A giudicare dalle zone interessate dai restauri, sembra che il complesso forense fosse stato danneggiato gravemente. Gli interventi interessano la Curia, il portico occidentale e meridionale (MORSELLI-TORTORICI 1989: 138-148, 253), il Tempio di Venere Genitrice, alcuni ambienti sul clivus Argentarius e anche parte della “Basilica Argentaria” (AMICI 1991: 145), dove l’intervento è piuttosto articolato e sembra essere stato realizzato per volere dell’imperatore Massenzio. Viene ricostruito l’ambulacro esterno e si rinforza la struttura con una serie di contro pilastri in opera laterizia collegati tra loro da arcate; nel contempo, si erige un possente muro in opera laterizia in corrispondenza della fronte del tempio di Venere Genitrice, inglobandone in parte le colonne del pronao, ed unendo quest’ultimo ai due bracci del portico del Foro e quindi alla “Basilica Argentaria”. In epoca tardo antica troviamo le prime testimonianze del cambio di funzione dell’edificio, un fenomeno diffuso anche nel resto dei Fori Imperiali. Gli interventi di restauro della fine III-inizio IV secolo all’interno del Foro di Cesare, se da un lato modificano in modo notevole l’aspetto delle costruzioni delle fasi precedenti dall’altro ne garantiscono la conservazione (AMICI 1991: 13). All’interno dei due ambulacri si costruiscono delle murature in opus vittatum che suddividono gli spazi in ambienti più piccoli e allo stesso tempo impediscono il passaggio all’interno del portico. Nella porzione meridionale dell’ambulacro esterno si realizza una nuova pavimentazione in opus sectile composta di lastre di marmi policromi più o meno regolari. Nei secoli successivi le architetture dell’intero complesso vivono un periodo di degrado e abbandono fino ad arrivare alla grande fase di spoliazione del IX secolo che investe tutti i Fori Imperiali (MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2007: 125-126). A quest’ultima fase appartengono le murature in opera laterizia ascrivibili all’epoca altomedievale che sono addossate al retro del podio del Tempio di Venere Genitrice e che formano degli ambienti di tipo abitativo più o meno regolari. Tali ambienti sono la testimonianza della completa trasformazione del complesso antico, come si vede anche in altre parti dello stesso Foro di Cesare. La “Basilica Argentaria”, nonostante la denominazione, quindi, è in realtà un portico di epoca traianea attraverso il quale si estende verso nord-est il porticato cesariano-augusteo del Foro di Cesare (AMICI 1991: 101). Il progetto dell’edificio, sebbene sembri un normale ampliamento di un complesso monumentale più antico, nasconde al suo interno un disegno ben più articolato che diviene maggiormente significativo se posto in relazione con l’intero contesto del settore nord dei Fori Imperiali. La posizione appare defilata rispetto al resto del Foro di Cesare, poiché occupa la parte retrostante il Tempio di Venere Genetrice, e marginale se si mette a confronto con il resto dei complessi imperiali. A dispetto di questa circostanza, però, la “Basilica” occupa uno spazio strategico tra l’impianto cesariano e quello traianeo. Infatti, il porticato garantisce la continuità dei percorsi esterni. Una volta costruito, assicura il passaggio verso la parte retrostante dell’esedra sudoccidentale della piazza del Foro di Traiano. Ciò è possibile dal momento che la “Basilica” si trova praticamente alla medesima quota del complesso traianeo. Questa soluzione architettonica, quindi, rientrerebbe nel disegno più esteso di una viabilità esterna del Foro di Traiano, compresa e prevista nel progetto di Apollodoro di Damasco per la sistemazione dei percorsi di tutta la zona a ridosso del complesso, cosa che risulterebbe confermata anche dai recenti ritrovamenti degli scavi di fronte alla chiesa di S. Maria di Loreto, di cui si è fatto cenno poco sopra. Un ulteriore fattore da considerare è quello della 26 relazione con il clivus Argentarius, che corre a mezza costa sul pendio del colle capitolino, sopra la “Basilica Argentaria”. Osservando la planimetria dell’area si può vedere come la strada e l’edificio facciano sistema tra loro, correndo in parallelo e adeguandosi al profilo del colle retrostante. La “Basilica”, pertanto, viene a trovarsi tra due vie di comunicazione: sopra il clivo e sotto la via lastricata intorno al podio del Tempio, almeno fino all’esedra sud-occidentale del Foro di Traiano. Una soluzione architettonica assai simile a quella utilizzata sul versante opposto in corrispondenza dei Mercati di Traiano. A questo punto risulta totalmente evidente la specularità dell’intervento progettuale traianeo messo in atto dopo il taglio della sella tra i due colli, per il quale le pendici vengono entrambe ridisegnate in un sistema “a gradoni”, con strade di mezzacosta, via Biberatica e clivus Argentarius, e percorrenze di fondo valle, sui lati est e ovest della piazza forense (fig. 2). Fig. 2 – Planimetria schematica ricostruttiva dei Fori Imperiali, particolare della zona nord verso la Via Flaminia, con montaggio provvisorio dei resti archeologici rinvenuti negli scavi di fronte alla chiesa di S. Maria di Loreto e nell’area di Palazzo Valentini. Sono evidenziate le percorrenze esistenti alla quota della piazza del Foro di Traiano e quelle a mezza costa lungo le pendici del Quirinale e del Campidoglio Claudio Taffetani BIBLIOGRAFIA C.M. AMICI, Il Foro di Cesare, Firenze 1991. P. BALDASSARRI, Indagini archeologiche a Palazzo Valentini: domus di età imperiale ai margini del Foro Traiano, in «Atti della Pontificia Romana di Archeologia», 81 (2008-2009), pp. 343-384. Codice topografico della città di Roma, a cura di R. Valentini, G. Zucchetti, Roma 1940. M. DELLA CORTE, Le iscrizioni graffite della Basilica Argentaria, in «BCom», (1933), pp. 111-130. A. DELFINO, V. DI COLA, F. ROSATI, La statua equestre di Cesare: ipotesi ricostruttive, in «Scienze dell’Antichità», in corso di stampa. A. DELFINO, Il Foro di Cesare nella fase cesariana e augustea, in Giulio Cesare. L’uomo, le imprese, il mito, pp. 52-54. A. DELFINO, Il “primo” Foro di Cesare, in «Forma Urbis», 1 (2009), pp. 28-33. G. FIORANI, Problemi architettonici del Foro di Cesare, in «Studi di Topografia Romana», V (1968), pp. 91-103. Giulio Cesare. L’uomo, le imprese, il mito, a cura di G. Gentili, Milano 2008. L.C. LANCASTER, Concrete Vaulted Construction in Imperial Rome. Innovation in Context, New York 2009. E. LA ROCCA, Le domus nelle vicinanze del Foro di Traiano e le scuole per le arti liberali, in «Atti della Pontificia Romana di Archeologia», 81 (2008-2009), pp. 385-398. Lexicon Topographicum Urbis Romae, voll. I-VI, a cura di E. M. Steinby, Roma 1993-2000. R. MENEGHINI, R. SANTANGELI VALENZANI, I Fori Imperiali. Gli scavi del Comune di Roma (1991-2007), Roma 2007. C. MORSELLI, Basilica Argentaria, in «LTUR», I (1993), pp. 169-170. C. MORSELLI, Forum Iulium, in «LTUR», II (1995), pp. 299-306. C. MORSELLI, E. TORTORICI, Curia. Forum Iulium. Forum transitorium, Roma 1989. A proposito delle Tre Grazie Tra i gruppi statuari più celebri dell’antichità un posto di primo piano spetta alle Tre Grazie, raffigurate nella forma di tre donne nude, che ballano l’una allacciata all’altra, le due laterali di fronte la centrale di tergo (fig. 1). Nel gruppo di queste tre sorelle si riconosce la remota personificazione della forza generativa della natura e insieme la bellezza che si produce nelle opere dell’uomo, associata all’amabilità e alla generosità. 27 Secondo il grammatico Servio la nudità delle Grazie è giustificata dal fatto che le tre sorelle devono essere senza macchia. Il loro schema iconografico incarna la loro stessa natura, secondo la quale il beneficio che ciascun individuo è in grado di offrire gli sarà restituito in misura doppia, in virtù del legame che unisce il favore alla riconoscenza. Le Tre Grazie furono uno dei soggetti più popolari del repertorio artistico d’età romana. La loro immagine ornava gli spazi pubblici di templi, terme e teatri; ma la grande maggioranza delle raffigurazioni si collocava in ambiente privato, sulle pareti domestiche o nelle tombe. Dopo un oblìo millenario le Tre Grazie entrarono nel repertorio artistico rinascimentale dalla metà del Quattrocento (grazie alla scoperta del celebre gruppo Colonna, ora a Siena) per quella loro caratteristica di Fig. 1 – Le Tre Grazie (Parigi, Louvre) coniugare gli aspetti religiosi e mitologici del soggetto con quelli filosofici ed anche con quelli più prosaici del mondo femminile e della gioia di vivere. Ma questi aspetti non esauriscono la complessità del significato delle Grazie, le Cariti dei Greci. Aglaia, Euphrosyne e Thalia esprimono già in età arcaica una triade concettuale che le accosta a tre virtù umane: la bellezza, la saggezza e lo splendore. Le diverse varianti dei loro nomi ci svelano gli aspetti lunari del gruppo, connessi con le fasi crescente e calante per le due laterali e con la fase della luna piena, e al tempo stesso nuova, per la Grazia centrale: una luna dunque che c’è e non c’è, che ora splende ed ora non si vede. Il corso della luna descrive il cammino dell’uomo: il buio uterino, la venuta alla luce, la crescita, la maturità, la consunzione, la morte e il ritorno al buio ctonio. L’unità e insieme l’articolazione del terzetto rappresentano insomma il concetto di una condizione lunare ed umana scandita nel ciclo della danza da una nascita e da un tramonto e da una pienezza dell’esistenza cui fa riscontro il vuoto dell’assenza. Salvo rare eccezioni, la Grazia centrale è rivolta di spalle, ma volge la testa all’indietro. La prima Grazia e la terza hanno spesso nelle mani qualcosa che viene offerto in dono: sappiamo da Pausania che le Cariti esposte nell’agora di Elide recavano in mano rispettivamente una rosa, un astragalo e un ramo di mirto. Rosa e mirto indicano il mondo di Afrodite nelle sue due facce legate alla vita (la luna crescente, la rosa) e alla morte (la luna calante, il mirto). L’astragalo, cioè il dado della sorte, caratterizza invece Aglaia nel ruolo di Fortuna. Troviamo una conferma a questo approccio se intendiamo le Grazie, che appaiono connesse anche ad Hekate, come l’altra faccia delle Parche. Ai due lati Klothò, la luna crescente, e Atropos, la luna calante, filano e recidono la vita. Al centro è Lachesi, cioè la Fortuna che non può opporsi alla ineluttabilità del fato, ma che può incidere sulla vita dei mortali. Come Tyche (cioè Aglaia) è la Fortuna che dà in sorte e può essere colta, così Lachesi, che gli antichi chiamavano anche sors (la sorte), è la Fortuna, che presiede a ciò che può accadere. La Fortuna, non il Fato, cui attengono invece le due Parche laterali: l’inizio, cioè la nascita, e la fine, cioè la morte, sono infatti in mano al fato; tutto quello che sta in mezzo, cioè la vita, sta in mano alla fortuna. La vita è dunque il transito tra questi due momenti del fato, attraverso il regno di Fortuna. Di questa Grazia/Fortuna che non ha nulla in mano vediamo il corpo nudo di spalle, ma la sua testa è girata in direzione di chi guarda, in genere verso destra, quindi con atteggiamento benigno. Grazia/ Fortuna non è bendata: il suo occhio ti può guardare, ma il suo sguardo è repentino e fugace. Ti può cogliere, magari per un attimo, nel vortice della danza, e può incrociarsi con il tuo. Ma come la luna piena 28 e nuova anche la Fortuna c’è e non c’è; e ti darà qualcosa solo se scatterà una scintilla nell’incrocio dei due sguardi. È una condizione che non puoi governare, ma che, se si verifica, ti fa metaforicamente baciare dalla Fortuna. Lei non ti dà qualcosa gratuitamente, come fanno le due sorelle, ma solo fortuitamente, se in quel momento, e solo in quel momento, stabilisce con te un rapporto che non è di scambio, ma unidirezionale, fortuito. Tu non lo governi: puoi solo metterti in condizione che possa avvenire. La Fortuna è di spalle. È il suo volto che guarda dietro di sé per incontrare te, o chi è al posto tuo. In quell’attimo fugace, in cui lo sguardo e il gesto benigno della Fortuna sono inseparabili dalla sua luce, che è lo splendore di Aglaia, lei ti mostra la sua schiena nuda e i suoi glutei. La Grazia centrale incarna dunque, con le due sorelle, il senso del beneficio e della sua restituzione, ma nella sua posizione, di schiena, e nel suo atteggiamento, maliziosamente rivolta all’indietro, esprime anche la sua incerta relazione con l’individuo, oscillante tra ciò che si scambia in virtù di un patto e ciò che si ottiene in virtù dell’imponderabilità della sorte. L’impatto visivo del gruppo faceva perno sul fascino del triplice nudo femminile. È indubbio, tuttavia, che il centro della scena sia occupato dalla pacifica ostentazione delle natiche della Grazia centrale, che fanno da fulcro all’intera composizione. Se nella maggioranza dei casi aulici la raffigurazione dei glutei non è oggetto di enfasi particolare, in alcune raffigurazioni l’ostentazione si fa invece evidente, quasi sfacciata, come in un rilievo del Museo Nazionale di Napoli. Potrebbe trattarsi di un caso isolato, dal momento che qui lo schema iconografico del gruppo è quello canonico delle Ninfe piuttosto che delle Grazie. Ma la scena sulla fronte di un sarcofago strigliato, oggi a Withington Hall (Gran Bretagna) ci dice che non è così (fig. 2). Anche in questo caso le Tre Grazie indossano un semplice mantello che copre le gambe, ma ciò che balza agli occhi è piuttosto il fatto che il panneggio nelle due Grazie laterali è allacciato Fig. 2 – Le Tre Grazie sulla fronte di un sarcofago sul davanti in modo da lasciare scoperta la pancia; nella (Withington Hall, GB) Grazia centrale, al contrario, lo schema inverso produce una voluta ostentazione dei glutei, che vengono sottolineati dalla stoffa che, coprendo le gambe, li incornicia lasciandoli in vista. Che non si tratti di un caso ce lo dimostra un altro rilievo funerario, dove il vestito della Grazia centrale si apre lungo la schiena con l’evidente intenzione di porre in vista i glutei della dea. Questa enfasi sembra ancora maldestramente riversata anche in un mosaico di Cherchel (Algeria), riferibile al IV secolo. Lo schema canonico appare ormai alterato. Colpisce però, nella modestia dell’esecuzione, la cura nella raffigurazione dei glutei, che anche di tre quarti occupano il centro della scena. Si direbbe che ormai si sia perso il senso stesso della charis che ha caratterizzato per secoli il gruppo delle Grazie, ma non il valore simbolico della Grazia centrale, cioè di Fortuna. In questa esaltazione degli attributi di Aglaia/Fortuna, che “ci volta” e al tempo stesso “ci mostra le spalle”, possiamo scorgere l’origine di un’espressione così diffusa nel parlare quotidiano italiano da essere usata ormai senza volgarità: “avere culo”. L’attuale libertà linguistica ce la fa utilizzare con leggera ironia, ignari forse di quanto siano antiche le origini di questa espressione. “Avere culo”, significa dunque avere con sé la Fortuna, la luna che ti mostra le spalle ma ti guarda diritto negli occhi (non è una luna storta), significa avere in sorte qualcosa di inatteso e di insperato, a volte la stessa chance della tua vita. Daniele Manacorda 29 BIBLIOGRAFIA G. BECATTI, Le tre Grazie, in «Bull. Com.», LXV (1937), pp. 41-60. M. CRISTOFANI, Le Tre Grazie, in Siena: le origini. Testimonianze e miti archeologici, a cura di M. Cristofani, Firenze 1979, pp. 126-134. S. DE ANGELI, Moirai, in «LIMC», VI (1992), pp. 636-648. W. DEONNA, Le groupe des trois Grâces nues et sa descendance, in «Rev. Arch.», 31 (1930), pp. 274-332. E. B. HARRISON, Charis, Charites, in «LIMC», III/1 (1986), pp. 191-203. D. MANACORDA, Per un’interpretazione del monumento antico, in D. Manacorda e E. Zanini, Il tempio di Via delle Botteghe oscure: tra stratigrafia, topografia e storia, in «Ostraka», VI/2 (1997), pp. 249-293. P. MORENO, Scultura ellenistica, II, Roma 1994. R. PFEIFFER, The Image of the Delian Apollo and Apolline Ethics, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 15 (1952), pp. 20-32. G. RODENWALDT, The Three Graces on a Fluted Sarcophagus, in «JRS», XXVIII (1938), pp. 60-64. E. SCHWARZENBERG, Die Grazien, Bonn 1966. H. SICHTERMANN, Gratiae, in «LIMC», III/1 (1986), pp. 203-210. W. TRILLMICH, Die Charitengruppe als Grabrelief und Kneipenschild, in «JbI», 98 (1983), pp. 311-349. Pompeiopolis di Paflagonia. Un progetto di cooperazione tra la Ludwig-MaximiliansUniversität di Monaco e l’Università Roma Tre IL PROGETTO DI RICERCA Nel 2006 ha preso avvio un progetto internazionale di ricerca facente capo all’Institut für Klassische Archäologie della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, diretto da Lâtife Summerer e sostenuto dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft, incentrato sulla città di Pompeiopolis, nel territorio di Tasköprü, distretto di Kastamonu. La regione interna della Paflagonia, chiusa a sud da alte montagne, già in antico rappresentava un’area isolata, occupata da estese foreste (fig. 1). Pompeiopolis venne fondata nel 65/64 a. C. da Cn. Pompeo Magno, a suggello della fine degli scontri con Mitridate VI, nella vallata del fiume Amnias, un affluente dell’Halys, in un punto strategico lungo la strada che attraversava da ovest a est la provincia di Ponto e Bitinia; la sua importanza economica doveva in gran parte risiedere nello sfruttamento delle vicine miniere di solfuro di arsenico. Già nel 6/5 a. C. la Paflagonia Fig. 1 – Carta geografica della regione pontica (Ch. Marek, Pontus et Bithynia: die römischen venne annessa alla neo-istiProvinzen im Norden Kleinasien, Mainz 2003) tuita provincia di Galazia. Dopo le distruzioni ascritte agli attacchi dei Goti, il tardo-antico sembra corrispondere a un periodo tutt’altro che di stagnazione. Con la riorganizzazione amministrativa di Diocleziano la Paflagonia fu verosimilmente istituita a eparchia e compresa nella diocesi pontica. Nel Concilio di Nicea (325 d. C.) la città è ricordata come sede vescovile. Sembra che a partire dagli inizi del VII sec. d. C. gli attacchi sasanidi, cui fecero seguito le incursioni delle tribù arabe, abbiano condotto a un progressivo abbandono del sito. 30 Analisi geomagnetiche, sondaggi e scavi finalizzati alla conoscenza dell’estensione del nucleo urbano, della originaria griglia urbanistica e delle emergenze monumentali, accompagnati dalla ricognizione del territorio, stanno portando alla ribalta un insediamento rimasto fino ad oggi oscuro, circostanza questa solo in parte imputabile alla profonda manomissione degli edifici (l’utilizzo del sito come cava si è protratto fino agli inizi del XX secolo). Alla penuria di informazioni ricavabili delle fonti letterarie ha supplito la documentazione epigrafica, estesa dalla prima età imperiale al periodo protobizantino (MAREK 1993). L’obiettivo primario della missione è quello di indagare la struttura urbana di una città di fondazione romana, in una regione – l’Anatolia settentrionale –, di cui i processi di urbanizzazione e le relazioni con le grandi città di tradizione ellenistica di area microasiatica occidentale risultano ancora scarsamente conosciuti. LA PARTECIPAZIONE DI ROMA TRE AL PROGETTO L’Università Roma Tre ha avuto in carico l’indagine dell’area alle pendici sud-orientali dello Zimbıllı Tepe su cui si sviluppò la città. L’attività si è incentrata nello scavo dell’edificio costruito al limite dell’insediamento urbano, in un’area di verosimile destinazione residenziale sorta non lontano dal corso dell’Amnias. Lo scavo estensivo del complesso sta consentendo di indagare in maniera sistematica un esempio di residenza privata in contesto regionale, venendo a colmare una lacuna delle nostre conoscenze sull’evoluzione della tipologia abitativa di tradizione greco-ellenistica. La ricerca nell’area del Ponto/Paflagonia non risulta finora impostata: nella pressoché totalità dei contributi editi sono stati privilegiati gli apparati decorativi, laddove le dimore risultano per di più solo parzialmente indagate. LO SCAVO DELL’IMPIANTO ABITATIVO (1984; 2008-2010) Nel 1984 scavi di emergenza condotti dalla Direzione del Museo di Kastamonu portarono alla luce un grande ambiente rettangolare (A) pavimentato a mosaico, oggi in gran parte crollato a causa del dilavamento del lato della collina, affiancato a sud da un secondo ambiente (B) rinvenuto privo di pavimentazione, e, parzialmente, una corte (C). Nell’impossibilità di assicurarne la conservazione in situ della pavimentazione musiva del vano A, si procedette a sezionare l’ordito e a deporlo su pannelli di cemento armato, depositati nel magazzino del Museo di Kastamonu. Chi varcava la soglia del vano dal corridoio D, veniva accolto da un’iscrizione beneaugurante («Entra, per il tuo bene») racchiusa all’interno di una tabula ansata; sull’altro lato si colloca il vasto ambiente quadrangolare E. Le tre recenti campagne archeologiche hanno scoperto un’area dell’edificio corrispondente a 570 mq. (SUMMERER 2011) (figg. 2-3). Lo scavo ha preso avvio dalla corte (C), già in precedenza parzialmente indagata, che rappresenta l’elemento qualificante del complesso avente funzione distri- Fig. 2 – Pompeiopolis, complesso abitativo. L’area scavata a chiusura della campagna 2010 (DFGProjekt Pompeiopolis, foto B. Maerzke, München) Fig. 3 – Pianta generale del complesso abitativo (elaborazione M. Brizzi) 31 butiva. In origine era circondata da portici con pavimentazione a piastrelle quadrate di terracotta; l’area centrale era lasciata a giardino. Nel 2010 lo scavo è stato considerevolmente esteso in direzione della collina: lungo il lato nord-occidentale del peristilio è stato messo in luce un vano di rappresentanza (L) contiguo all’ambiente E, dotato, nella fase successiva a quella originaria, di un impianto di riscaldamento a ipocausto e verosimilmente pavimentato in opus sectile. A un determinato momento il complesso venne organizzato su differenti quote tramite la costruzione, nel giardino del peristilio, di due muri paralleli con funzione di terrazzamento. Il tipo di casa a peristilio si presenta conforme al modello di abitazione, di tradizione greco-ellenistica, diffuso in tutta l’Asia Minore, tramandatosi nei secoli pressoché invariato e mantenutosi fino a tutta l’epoca tardoantica, in cui spaziose corti, spesso circondate da bracci porticati e non raramente dotate di nymphaea, potevano rappresentare lo snodo dell’organizzazione dell’abitazione. In un contesto come quello in questione l’assunzione del modello della casa a peristilio non manca di imporsi quale marcatore del processo di ellenizzazione. A causa dell’incompletezza della planimetria, poco si può dire dell’articolazione dell’abitazione, partitamente se essa fosse di tipo assiale o radiale, e anche sulla funzionalità di molte delle strutture (finora sono noti tre grandi ambienti di rappresentanza). Le sequenze stratigrafiche consentono di ricostruire le trasformazioni che hanno interessato l’organizzazione dell’impianto, il suo sviluppo planimetrico, la funzionalità degli spazi. Interventi di ristrutturazione, sostanziali rimaneggiamenti degli ambianti e modifiche dei percorsi, con conseguenti trasformazioni d’uso che stravolgono l’assetto dell’impianto e la funzione degli spazi, denunciano cambiamenti di destinazione rispetto al primitivo impianto, in linea con un trend evolutivo ben documentato nell’edilizia privata tardoantica, sostanzialmente basato sulla frammentazione degli spazi originari. Nell’area sistemata a giardino lo spazio viene frantumato attraverso la costruzione di un corpo di fabbrica (I); successivamente la creazione di un sistema di canalizzazioni di smaltimento delle acque provenienti da altre aree delle pendici del sito, collegato alle sistematiche spoliazioni dei muri del primitivo impianto e a altre parziali demolizioni, appare da mettere in relazione con il radicale cambiamento delle modalità di occupazione dell’area prima del definitivo abbandono dell’edificio. La ceramica più recente è stata datata al VI secolo d. C. IL MOSAICO DEL VANO E Il vano E ha restituito un mosaico pavimentale policromo (6,90×5,80 m.), formato da quattro distinti tappeti a decoro geometrico e impaginato centripeto (i mosaici dell’abitazione sono stati presentati all’XI Colloquio Internazionale sul mosaico antico, organizzato nell’ottobre 2009 a Bursa dall’Uludağ University Mosaic Research Center, sotto l’egida dell’AIEMA). Nel riquadro figurato centrale, tangente sugli angoli a quattro triangoli racchiudenti le personificazioni delle Stagioni, è compreso un busto femminile raffigurato frontalmente, con testa diademata e circondata da un nimbo (fig. 4). Veste tunica ornata Fig. 4 – Il pannello figurato al centro della da un clavus, e mantello. Due dita sorreggono un frutto; un pavimentazione musiva dell’ambiente E a restauro ultimato (2010) (DFG-Projekt Pompeiopolis, ramo poggia sulla spalla destra. Nella figura va riconosciuta una personificazione karpophoros, come anche indicano foto B. Maerzke, München) 32 i busti delle Stagioni ad essa collegati. La connessione con le personificazioni stagionali rimanda alla personificazione di Ananeosis (reparatio/renovatio) legata al rinnovamento ciclico dell’anno. Una moneta di Arcadio emessa dalla zecca di Costantinopoli (388-392 d. C.) è stata rinvenuta a contatto dell’ordito musivo. Consone con quanto conosciamo della produzione figurativa tra la fine del IV e la prima metà del V secolo, in particolare di quella riferibile agli anni di Teodosio II, l’accentuata stereometria della testa, l’idealizzazione del volto, l’astrazione e la fissità dei tratti, la plasticità dei capelli a matassa. Al di là di alcune cadute nel disegno, trapela l’elevata qualità formale del modello. Dalla metà del III secolo si moltiplicano in contesti profani – prevalentemente domestici – raffigurazioni musive di personificazioni relative a concetti filosofici e a idee astratte; il picco è nel V secolo. L’elenco di queste personificazioni è nutrito. Si tratta di figure – in forma di busto e non – genericamente connotate, con minimi cambiamenti adattabili alle più svariate astrazioni, che neppure sempre necessitavano di venire “etichettate”. Nelle conversazioni tenute durante ricevimenti e simposi queste immagini, oltre a potere costituire argomento di intrattenimento tra erudizione e piacere del gioco intellettuale, dovevano fungere da richiamo, augurio, celebrazione del padrone di casa, in quanto collegabili a ideali attinenti alla sfera dell’individuo, sublimati in concetti astratti: temi quali la costruzione/ donazione, il benessere, la fecondità, il rinnovamento, ma anche il piacere e il lusso, dovevano essere nelle corde dei committenti. I significativi interventi di ristrutturazione e decorazione che hanno interessato alcuni degli ambienti del complesso residenziale gettano nuova luce sulla percezione dello spazio domestico in epoca tardoantica, contribuendo a confermare la qualità della vita cittadina nella parte orientale dell’impero agli inizi del V secolo, caratterizzata da una ricchezza che non molto tempo prima il vescovo di Cappadocia Basilio di Cesarea aveva stigmatizzato: dimore impreziosite da marmi pregiati, da mosaici pavimentali e da decorazioni dorate nei soffitti, da affreschi su quelle pareti che restavano prive di rivestimenti. Non diversamente da quanto gli scavi ci hanno restituito dei contesti abitativi di Efeso e Afrodisia, di Antiochia come di Apamea, la fioritura dell’edilizia privata e le correlate espressioni del lusso e del prestigio domestico si configurano come fenomeni caratterizzanti il quadro urbano della Paflagonia di V secolo. Luisa Musso BIBLIOGRAFIA CH. MAREK, Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord-Galatia, Tübingen 1993. Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Klassische Archäologie, Pompeiopolis in Paphlagonien. Erforschung einer antiken Metropole im türkischen Schwarzmeerbereich, <http://www.klass-archaeologie.unimuenchen.de/projekte/pompeiopolis/index.html> Pompeiopolis I. Eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach fünf Kampagnen (2006-2010), a cura di L. Summerer, Langenweißbach 2011. Osservazioni sulle iscrizioni cristiane di tridentum anteriori al VII secolo La ricerca che si presenta è finalizzata all’edizione di un volume delle Inscriptiones Christianae Italiae septimo saeculo antiquiores, dedicato a Tridentum e al suo territorio, che è stato affidato a chi scrive, il quale una decina di anni fa aveva già pubblicato le epigrafi (per lo più inedite) trovate nell’area della primitiva basilica di S. Vigilio (MAZZOLENI 2002). Attualmente sono stati raccolti ed 33 elaborati molti dati, pur se non definitivi e ammontano a una quarantina le epigrafi note, per lo più di Trento; fino a una ventina di anni fa, invece, i testi paleocristiani conosciuti in questo stesso ambito territoriale erano molti di meno e indubbiamente essi hanno avuto un incremento notevole in seguito alle indagini archeologiche condotte sotto la Cattedrale di S. Vigilio. Le campagne di scavi svoltesi fra il 1964 e il 1977 portarono alla scoperta dell’aula primitiva di culto, databile alla metà del VI secolo, che ebbe carattere martiriale e funerario e sorse al di sopra della tomba del terzo vescovo trentino, Vigilio († 400) (ROGGER 1975, 1982, 1996). Si individuarono almeno ottanta sepolture sotto il pavimento, tanto è vero che si parlò di una sorta di retrosanctos. L’aula, che aveva tre ingressi ed era preceduta da un quadriportico, era rettangolare e mononave (misurava 50 x 14 m.), con un presbiterio separato da cancelli, poi guastato dalla cripta eretta nell’XI secolo. Le trentuno iscrizioni rinvenute (trenta latine e una greca) sono state musealizzate ed affisse alle pareti, salvo quella del v(ir) s(pectabilis) Censorius, che è rimasta in situ. La nuova Cattedrale fu costruita nel XIII secolo 2,50 m. sopra il livello dell’edificio paleocristiano. L’iscrizione più nota del territorio trentino è probabilmente quella del pavimento a mosaico frammentario del cosiddetto “sacello” del Doss Trento, oggi staccato e conservato al Castello del Buonconsiglio: risalente alla prima metà – o alla metà – del VI secolo; si tratta di un testo di tipo dedicatorio, che ricorda l’intitolazione dell’edificio ai santi medici Cosma e Damiano, fatta da Laurentius, che si definisce cantor, ai tempi del vescovo Eugippio, altrimenti ignoto (CAILLET 1993). In ambito urbano, invece, a S. Maria Maggiore si sono individuati resti di un’ecclesia urbana sotto la chiesa del XVI secolo. Vi si riconobbero due fasi: la prima (con lacerti di pavimento musivo e un resto di epigrafe) fu attribuita agli inizi del VI secolo con interventi spintisi fino a metà circa del VI. Una seconda aula, triabsidata, sorse 1 m. sopra quella paleocristiana con il reimpiego di pezzi scultorei di VIII-IX secolo. Accanto al complesso si sviluppò un cimitero con tombe a cassa (MAZZOLENI 1993, CIURLETTI 2003, GOIO-ZOTTA s.d.). Le altre testimonianze epigrafiche del territorio trentino sono essenzialmente attestazioni di fedeli facenti parte di comunità rurali. Ad esempio, dall’area limitrofa alla chiesa di S. Valentino (vescovo e missionario della Rezia della metà del V secolo) a Tenna, ora a Mezzocorona (Trento), proviene un frammento di coperchio di sarcofago con un’iscrizione che si riferisce al diacono Mauro (CAVADA 1994). Altri coperchi più o meno mutili di sarcofagi con grandi croci a rilievo, cristogrammi con o senza lettere apocalittiche e resti di iscrizioni sono conservati a Trento e a Caldonazzo. In quest’ultima località una lastra mutila si riferisce a due coniugi, Flamininu[s] e Iusta (CIURLETTI 2008) (fig. 1). Per quanto attiene alla tipologia, le epigrafi sono per lo più funeFig. 1 – Ricostruzione grafica dell'iscrizione funeraria di Flamininus e Iusta, rarie e in minor percentuale musive votive o dedicatorie. La grafia Caldonazzo (Trento), Chiesa di S. Sisto usata è, come accade generalmente, la capitale attuaria rustica, mentre il materiale adoperato (soprattutto a Trento) consiste in grandi lastre di calcare locale, non levigato, ma sommariamente lavorato a martellina, per cui la superficie è spesso scabra e di non agevole lettura, anche per la presenza di sensibili segni di consunzione (forse una parte delle lastre chiudeva tombe poste nel pavimento della Cattedrale trentina). I formulari sono quelli consueti, specie in epitaffi abbastanza tardi: l’esordio è spesso hic requiescit, e per indicare il dies natalis, ossia il giorno della morte (e della sepoltura) 34 si usa preferibilmente depositus (più raramente obire e transire). Riguardo alla lingua, come sempre si nota la presenza di diversi volgarismi (soprattutto monottongazioni e caduta di aspirazioni e nasali, oltre allo scambio fra le vocali i-e). L’onomastica presenta la maggior parte dei nomi di origine latina, mentre due sono quelli greci e uno solo – Amaros – è stato ricondotto, sia pure ipoteticamente, ad una matrice siriana. Solo due sono i mestieri indicati: un custus basilice (!) (il presbitero Metronius) (fig. 2) e un intendente siriano della regione di Antiochia, 67_ , nella sola dedica in greco finora nota. Diversi risultano, invece, gli esponenti del Fig. 2 – Iscrizione del presbitero Metronius, Trento, Cripta clero: otto a Trento (un vescovo, sei presbiteri, un del Duomo diacono), due al Doss Trento (un vescovo e un cantore), un diacono a Tenna. In un caso ricorre la data indizionale a Trento (questo solo elemento, come è noto, non consente di risalire a una cronologia precisa) (MAZZOLENI 2002), mentre in un altro essa è unita a una data consolare, in un’epigrafe di Riva del Garda dell’anno 539 (GARZETTI 1986). In ogni modo, in genere le iscrizioni possono riferirsi a un ambito cronologico compreso per lo più fra il V e il VI secolo. Danilo Mazzoleni BIBLIOGRAFIA Archeologia a Mezzocorona. Documenti per la storia del popolamento rustico di età romana nell’area atesina, a cura di E. Cavada, Trento 1994. A. BUONOPANE, Regio X. Venetia et Histria. Tridentum, in «Supplementa Italica», (n.s.) 6 (1990), pp. 111-182. A. BUONOPANE, Regio X. Venetia et Histria. Anauni, in «Supplementa Italica», (n.s.) 6 (1990), pp. 183-228. J.P. CAILLET, L’évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses marges, Rome 1993. P. CHISTÉ, Epigrafi trentine di età romana, Rovereto 1971. G. CIURLETTI, Antiche chiese del Trentino, dalla prima affermazione del Cristianesimo al X secolo, in Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet, a cura di H. R. Sennhauser, München 2003, pp. 357-401. G. CIURLETTI, L’antica iscrizione funeraria cristiana dal colle di Brenta nella sua nuova collocazione nella chiesa di s. Sisto a Caldonazzo, Trento 2008. L. CRISCUOLO, Un nuovo documento epigrafico tridentino, in «Epigraphica», 43 (1981), pp. 261-264. L. DAL RI, Gli antichi sarcofagi cristiani di Mezzocorona: la necropoli di via IV novembre, in Archeologia a Mezzocorona (Patrimonio storico e artistico del Trentino, 15), a cura di E. Cavada, Trento 1994, pp. 278-281. A. GARZETTI (a cura di), Inscriptiones Italiae, X, V/3, Brixia, Roma 1986. A. GOIO, G. ZOTTA, Santa Maria Maggiore. Il restauro e lo scavo, Trento s.d. D. MAZZOLENI, Mosaici pavimentali paleocristiani in territorio trentino, in Archeoalp. Archeologia delle Alpi, a cura di E. Cavada, vol. 2, Trento 1993, pp. 159-173. D. MAZZOLENI, Reperti epigrafici dalla Basilica vigiliana di Trento, in L’antica basilica di San Vigilio in Trento. Storia, archeologia, reperti, a cura di I. Rogger, E. Cavada, Trento 2002, pp. 379-412. I. ROGGER, Scavi e scoperte sotto la Cattedrale di Trento, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 54 (1975), pp. 3-40. I. ROGGER, Il Duomo di Trento, Trento 1982. I. ROGGER, La basilica paleocristiana di S. Vigilio, in Il museo diocesano tridentino, a cura di D. Primerano, Trento 1996, pp. 137-141. 35 L’altare di Giovanni VII (706) e l’apertura della Porta Santa nell’antico San Pietro È nell’esperienza di tutti come la distruzione di un monumento comprometta in modo irrimediabile non solo la nostra capacità di figurarci in concreto la sua forma e le sue dimensioni, ma perdutane per sempre l’immagine e il significato in un peculiare contesto venga meno anche la sua riconoscibilità come modello di lunga durata e, in prospettiva, un decisivo livello di lettura dei monumenti che lo hanno seguito. Ho proposto di recente un’ipotesi ricostruttiva dell’Oratorio dedicato alla Theotokos che nel 706 papa Giovanni VII, natione graecus, fece edificare all’interno dell’antico San Pietro prescrivendo di esservi sepolto. Del sacello, notissimo per i cicli musivi che lo decoravano, non era mai stata indagata la forma architettonica. La mia restituzione si è basata sui frammenti della decorazione scultorea, comprensivi di spolia di eccezionale pregio, come alcune lastre di età severiana e una coppia di colonne vitinee; su alcune iscrizioni superstiti o Fig. 1 – Proposta di restituzione in 3D dell'Ora- note dalle fonti; e sul testo dell’epitaffio del pontefice tramantorio di Giovanni VII, a cura dell’Arch. Marco dato dalla silloge Cantabrigense. Mi è stata di guida inoltre Carpiceci (da Ballardini 2011) l’accurata descrizione dell’oratorio, redatta in scriptura e in pictura da Giacomo Grimaldi nei primi anni del Seicento, alla vigilia della demolizione dell’ultimo tratto dell’antico San Pietro (BAV, Barb. lat 2732; Barb. lat 2733; Cap. di San Pietro H3; Biblioteca Ambrosiana, ms. A 168 inf.; BNCF ms. II-III 173). L’esito della ricerca ha premesso di restituire in 3D l’immagine dell’oratorio, stimolando delle considerazioni sulla durata quasi millenaria del sacello e sul progressivo mutamento di funzione di quel settore dell’antico San Pietro. In effetti, proprio quel tratto iniziale della navata Nord della basilica aveva accumulato una formidabile memoria cultuale ospitando a partire dalla metà del X secolo la reliquia della Veronica e divenendo dalla metà del XV il luogo di apertura del Giubileo e della sua Porta Santa. Descrivo in breve l’oratorio secondo la mia ipotesi ricostruttiva, rinviando ogni argomentazione allo studio da poco pubblicato (BALLARDINI 2011). Il sacello di Giovanni VII era ricavato nell’angolo settentrionale di San Pietro, tamponando a sud i primi tre intercolunni della navata con muri alti almeno 3,20 m. A Occidente un muro analogo era interrotto da una porta architravata con il titulus all’antica del pontefice. All’interno le pareti erano rivestite di crustae marmoree alternate a lesene con tralcio abitato di età severiana, prese a modello da lastre scolpite ad hoc nelle officine di Giovanni VII. L’altare, dedicato alla Theotokos, era addossato alla parete di fondo e cioè alla controfacciata della basilica. Ne ho individuato un frammento, oggi nelle Grotte, che ai suoi tempi Grimaldi descrive e disegna affisso all’interno dell’oratorio. Il frammento di marmo frigio, su due lati finemente modanato, reca un’iscrizione dell’anno 783, aggiunta secondo la mia ipotesi, a lato della fenestella confessionis di un più antico altare a cassa. Scolpita dunque in occasione di una ricognizione delle reliquie della Vergine, l’epigrafe nomina 36 Maria secondo un epiteto veterotestamentario che, nell’innografia bizantina, definisce la Theotokos «Tempio di Dio» e «Santo dei Santi». Al di sopra dell’altare, un archivolto era retto da una coppia di colonne vitinee che Giovanni, figlio di Platone, l’ultimo curator Palatii a noi noto, era riuscito a procurarsi per assicurare alla Vergine il fasto imperiale riservato in basilica solo all’altare dell’Apostolo. Sopra l’edicola monumentale e fino alle capriate del tetto, si estendeva su tre registri la decorazione musiva che ripercorreva la storia della salvezza dall’Annuciazione fino alla morte e resurrezione del Cristo. Fuoco del ciclo figurativo era una nicchia – tra colonne di marmo nero – che accoglieva l’icona musiva della Theotokos accompagnata dal papa donatore. L’icona della Vergine, una Blachernitissa in abiti regali, priva del bambino ma con il grembo arrotondato, veniva ritualmente nascosta da cortine appese all’asta infissa ai capitelli delle colonne. Infine, nel pavimento, in asse con l’icona e con l’altare della Theotokos, Giovanni VII aveva prescritto di essere inumato. A mio avviso, proprio sotto la lastra dell’epitaffio, che in distici elegiaci traduceva la devozione greca del pontefice in una lingua intessuta di occorrenze virgiliane, ma anche di rinvii all’Akathistos, il più celebre inno bizantino dedicato alla Madre di Dio. L’ubicazione della tomba è del resto allusa anche nel testo epigrafico, che cito nei primi quattro versi: «Qui il presule Giovanni stabilì di essere sepolto e prescrisse di essere deposto sotto i piedi della domina, affidando l’anima alla protezione della santa madre (sub tegmine matris) che vergine, non sposata, ha partorito generando Dio». È proprio il ruolo tutelare di Maria evocato nell’epitaffio di Giovanni con l’espressione «sub tegmine matris» a spiegare la scelta del pontefice di farsi tumulare ai piedi dell’altare. Interpreterei infatti l’espressione sub tegmine matris, così suggestivamente virgiliana, come il riferimento a una reliquia della Vergine conservata nell’altare dell’oratorio, una reliquia del Presepe, ma forse anche del veneratissimo maphorion. La sua presenza giustificherebbe anche l’iscrizione (nota dai disegni seicenteschi) posta sopra l’archivolto dell’altare Domus Sanctae Dei Genitricis Mariae, che già Carlo Bertelli mise in relazione con l’oikos costantinopolitano eretto da Leone I alle Blacherne per custodire il velo. Se con l’apertura della porta santa e la distruzione dell’altare di Giovanni VII ci si premurò di mettere in salvo e murare in una parete dell’antico sacello l’iscrizione incisa a lato della fenestella confessionis dell’altare, una cura maggiore doveva essere stata riservata al suo prestigioso deposito di reliquie. Ora, come ci ricorda l’Alfarano, alla fine del XVI secolo di reliquie del velo della Vergine nella basilica di San Pietro ne era consevata più d’una: la più interessante mi sembra quella deposta nel 1479 nell’altare della cappella fatta edificare da Sisto IV della Rovere. Riservata al coro dei canonici della basilica, la cappella di Sisto IV dove il papa prescrisse di essere inumato si apriva sulla navata esterna meridionale della basilica ed era dotata di spolia di eccezionale pregio come la coppia di colonne porfiretiche con i tetrarchi sulle quali si impostava l’arco absidale. Proveniente dall’Ordine francescano, Sisto della Rovere – eponimo di papa Sisto III (432-440), che a Roma eresse la prima basilica mariana della città – si Fig. 2 – BAV, Barb. lat. 2733, f. 130r, l'abside della distinse per una speciale devozione alla Vergine. cappella di Sisto IV in San Fu lui a introdurre a Roma la festa della Concezione e all’Immacolata Pietro (da Galli 2009) 37 consacrò anche la cappella dove si fece seppellire: ai piedi dell’altare e in vista dell’abside, dominata dall’immagine della Vergine «in corona angelorum» affrescata dal Perugino. A tale proposito ha certo un significato che, contrariamente all’uso degli ecclesiastici, Sisto IV si sia fatto inumare con i piedi verso l’altare e cioè idealmente con il volto all’immagine della Vergine. È stato osservato come questa sepoltura, isolata su tutti i lati al centro del sacello, «segnasse una vistosa anomalia rispetto alla consuetudine quattrocentesca dei sepolcri papali» (Galli 2009). Se il celeberrimo monumento del Pollaiolo, commissionato da Giuliano della Rovere, fu portato a termine dieci anni dopo la scomparsa di Sisto (1494), nei fatti esso conferiva una forma – umanisticamente sovraconnotata e per così dire “tridimensionale” – a un’idea che già Sisto IV aveva della propria sepoltura. Johannes Burchardus, il maestro di cerimonie che, nella turbolenza dell’evento, si occupò delle esequie del pontefice, ricorda nel dettaglio le disposizioni del papa. Sisto volle essere inumato «nella sua cappella nuova, circa nel mezzo, piuttosto vicino all’altare» asserendo i cardinali «ipsum defunctum locum huiusmodi in sepolturam suam sibi elegisse». E, prima della messa in opera del monumento bronzeo, il tumulo doveva essere segnalato nel pavimento da un semplice ed elegante epitaffio. Forse una coincidenza o solo l’ultima volontà di un papa, ambizioso e potente, che morendo riprendeva il saio francescano, eleggendo la terra nuda come ultima dimora. E tuttavia un “programma” che ha davvero molte analogie con le diposizioni di Giovanni VII, deposto «sub pedibus Domine». Riterrei dunque plausibile che, alla vigilia del Giubileo 1475, Sisto IV, facendo rimuovere l’altare di Giovanni VII per aprire la nuova Porta Santa, abbia prelevato per sé la reliquia del velo della Vergine, destinandola all’altare della propria cappella funeraria. Come osserva Jacques Le Goff «il sacro è tenace» e il lungo prestigio della basilica Vaticana, eletta per secoli a mausoleo dei pontefici romani, si conferma nella vitalità di un codice antico e di una tradizione di modelli ineludibile, anche alle soglie del Rinascimento. Antonella Ballardini BIBLIOGRAFIA A. BALLARDINI, The Oratory of John VII in Old St. Peter’s: Architectural Decoration and Furnishings, in A. Ballardini, P. Pogliani, A Reconstruction of the Oratory of John VII (705-707), in Old St. Peter’s Conference (British School at Rome, 22-25 marzo 2010), in corso di stampa. A. BALLARDINI, Un oratorio per la Theotokos: Giovanni VII (705-707) committente a San Pietro, in Medioevo: i committenti, Atti del XIII convegno internazionale di studi di Parma (21-26 settembre 2010), Parma-Milano 2011, pp. 94-116. A. GALLI, Monumento di Sisto IV. L’opera di Antonio del Pollaiolo 1484-1493, in Archivum Sancti Petri. Bollettino d'archivio 6-7 (2009), p. 12. Dalla Curia Senatus alla chiesa di Sant’Adriano. La riscoperta di un palinsesto architettonico e pittorico perduto La demolizione della chiesa di S. Adriano e dell’annesso convento dei Mercedari, finalizzata al ripristino dell’antica Curia Senatus, fu consumata tra il 1932 e il 1937. Sotto i colpi dei “picconi del regime” che in poco tempo abbatterono un intero quartiere post-rinascimentale, insediato tra i Fori, fu abbattuto in poco tempo a vantaggio della Via dell’Impero e del recupero archeologico della Roma imperiale. I lavori di smantellamento della chiesa barocca, diretti da Alfonso Bartoli, fecero riemergere, per poi annientarlo, 38 un sorprendente palinsesto architettonico, riportando alla luce, a quote diverse, tre basiliche precedenti: una della seconda metà del XVI secolo, un’altra degli inizi del XII secolo e infine, al livello del pavimento dioclezianeo, a più di sei metri dal piano barocco, i resti della chiesa altomedievale. La Curia Senatus-S. Adriano è uno dei nodi topografici più rilevanti dell’intero complesso dell’area archeologica centrale, nonché uno dei monumenti più frequentati del Foro romano, ospitando da qualche anno esposizioni temporanee promosse dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma (SSBAR). Tuttavia, fino ad oggi, questo monumento non è stato oggetto di uno studio monografico volto a ripercorrere diacronicamente le sue complesse vicende architettoniche e decorative. Il progetto di ricerca “Dalla Curia Senatus alla Chiesa di S. Fig. 1 – Roma. Curia senatus, facciata Adriano al Foro romano. Progetto di realtà virtuale per la ricostruzione di tredici secoli di storia del monumento” (responsabile scientifico Maria Luigia Fobelli), nasce con l’intenzione di iniziare a colmare questa lacuna e si pone i seguenti obiettivi: creazione di un ambiente virtuale per la fruizione dell’architettura, della decorazione pittorica e degli arredi scultorei dell’edificio in tutte le sue trasformazioni, dalla Curia Senatus dioclezianea allo smantellamento degli anni 1932-1939 della chiesa di S. Adriano; ricostruzione e ricontestualizzazione delle decorazioni pittoriche (IV-XVII secolo) attraverso l’uso e la sperimentazione di diverse tecnologie digitali di restituzione visiva. La prima fase del progetto, affrontata nel corso del 2011, si è concentrata sulla restituzione in 3D della fase altomedievale dell’edificio (VII-XI secolo) e sulla ricostruzione della sua decorazione pittorica e degli arredi liturgici. Bartoli, della chiesa altomedievale, rinvenne l’emiciclo absidale, il setto presbiteriale, il basso coro, una cappella esterna con dipinti murali Fig. 2 – Roma. S. Adriano, planimetria e frammenti di pitture all’interno di della chiesa altomedievale quattro delle sei nicchie nelle pareti perimetrali e in controfacciata. Questi frammenti sono gli unici a essere sopravvissuti in situ perché aderenti alla muratura dioclezianea. La trasformazione della Curia Senatus in chiesa, dedicata a sant’Adriano, avvenne, secondo il Liber Pontificalis, nella prima metà del VII secolo, per volere di Onorio I (625-638), figlio dell’exconsul Petronio, ultimo senatore occidentale attestato dalle fonti. Alla fine dell’VIII secolo, la chiesa fu oggetto di particolari attenzioni da parte di Adriano I (772-795): fu dotata della cappella Fig. 3 – Ricostruzione 3D della sezione nord-ovest della chiesa altoesterna, ricevette ingenti donazioni di suppellettili e arredi liturgici trasversale medievale di S. Adriano (realizzata da e fu trasformata in diaconia. G. Di Benedetto, V. Valentini) 39 La conversione in chiesa e gli interventi successivi non alterarono i livelli e la morfologia dell’edificio dioclezianeo, la decorazione pittorica si inserì in spazi circoscritti, come le nicchie e brevi tratti di parete, senza stravolgere il preesistente rivestimento in opus sectile. La restituzione 3D della chiesa e la visualizzazione delle sue pitture nella fase altomedievale è stata articolata in otto viste, messe a punto da chi scrive in collaborazione con Manuela Viscontini, Valeria Valentini e l’architetto Gianni Di Benedetto, seguendo la metodologia sperimentata, a partire dal 2006, per l’elaborazione dei volumi del progetto “Atlante. Percorsi visivi (La pittura medievale a Roma, 312-1431. Corpus e Atlante)”, diretto da Maria Andaloro. La decorazione dioclezianea in opus sectile delle pareti, che restò in opera fino alla metà del XVII secolo, è stata ricostruita grazie alla consulenza di Alessandro Viscogliosi e Paola Zampa, sulla base di un disegno (post 1515) attribuito ad Antonio da Sangallo il Giovane (1484-1546), scoperto da Rodolfo Lanciani in un codice berlinese, oggi conservato presso il Kupferstichkabinett. L’assetto altomedievale dell’aula è stato invece ricreato attraverso lo studio della documentazione grafica e fotografica dei lavori condotti da Bartoli negli anni 1932-1937, conservata presso gli archivi della SSBAR, e sulla base del lavoro imprescindibile di Adele Mancini, pubblicato nel 1968. Per quanto riguarda la decorazione pittorica dell’edificio, va evidenziato che l’interno della chiesa altomedievale non accolse un programma iconografico unitario, ma degli interventi pittorici isolati, indipendenti gli uni dagli altri e caratterizzati dalla presenza di figure di committenti e donatori, ritratti o ricordati in iscrizioni pictae. Queste pitture, pressoché ignorate dalla storiografia e databili tra VIII e X secolo, sono oggi in uno stato frammentario, con una superficie pittorica depauperata che ne rende ardua la lettura. Obiettivo primario della ricerca è quello di rendere leggibile ciò che ineluttabilmente sta scomparendo sulle pareti della Curia, di registrare ogni minima traccia, di riconoscerla e arrivare a ricostituire il tessuto figurativo di cui era parte integrante, attraverso un lavoro di decodifica attento a non varcare mai la soglia dell’invenzione. Particolare attenzione è stata dedicata alle iscrizioni pictae conservate all’interno dei diversi contesti pittorici, che si sono rivelate documenti utili alla definizione del panorama socio politico di Roma tra VIII e IX secolo. In questa sede vorrei portare l’attenzione su due dei dipinti murali analizzati. Il primo, datato da Bartoli agli anni di Adriano I (772-795), è conservato alla base della seconda nicchia della parete nord-ovest. Nel riquadro si legge la figura di Cristo affiancata da un santo e da una santa, nei quali ho proposto di riconoscere i santi Adriano e la moglie Natalia. Ai piedi delle tre figure stanti sono ritratti quattro piccoli personaggi inginocchiati, dalle sembianze due maschili e due femminili. Accanto alla figura a sinistra dei piedi di Cristo è rimasta un’iscrizione letta da Bartoli come: Gaiferius consul et dux. Un’attenta analisi di quanto resta del titulus ha indotto a proporre una nuova trascrizione: Constan/t[inu]s con/s[u]l. La parola dux è oggi scomparsa. Constantinus, donatore del pannello iconico, si è fatto qui ritrarre in compagnia della moglie e dei figli, emulando probabilmente il più famoso primicerius Teodoto, committente della cappella dei Santi Quirico e Giulitta nella vicina Santa Maria Antiqua. Bartoli ed altri hanno riconosciuto nel consul e dux Gaiferius, ora Costantinus, un personaggio di rango senatorio, la cui presenza avvalorerebbe l’ipotesi che, nell’VIII secolo, l’aula fosse usata come chiesa e ancora come sede del Senato. In base agli studi più recenti di Brown, Arnaldi e Bulgarella, tuttavia, è assodato che il Senato romano, in quanto istituzione, fosse entrato in crisi negli anni della guerra goto-bizantina (535-553), per uscire di scena durante il pontificato di Gregorio Magno (590-604). Nella seconda metà dell’VIII secolo il termine senatus riappare nelle epistole diplomatiche papali, ma con un’altra identità 40 rispetto al passato. Con la caduta di Ravenna nel 751, per mano longobarda, che segnò il definitivo crollo dell’egemonia bizantina in Italia, cominciava di fatto il dominio temporale dei papi, i quali subentravano al governo imperiale nell’amministrazione del ducato di Roma. I consul et duces che si incontrano con crescente frequenza nelle fonti dall’VIII al X secolo sono ora espressione di un nuovo ordo senatorius, composto dai più alti funzionari del palatium apostolico appartenenti alla nuova aristocrazia clericale. In Constantinus consul et dux si è proposto di riconoscere uno di questi nuovi funzionari lateranensi, probabilmente anche coinvolto nel patronato della diaconia di S. Adriano. Il secondo dipinto analizzato è conservato nella prima nicchia della parete sud, in parte leggibile attraverso il disegno preparatorio. Il tema raffigurato è quello dell’Ascensione, scandita in due registri: nel superiore è rappresentato Cristo all’interno di una mandorla retta da quattro angeli, nell’inferiore restano tracce dei dodici apostoli posti ai lati della Vergine. Chiude la scena in basso un’iscrizione dedicatoria a lettere capitali: † De donis D(e)i et salbatori n(ost)r(i)s Ih(s)u Xr(ist)i et s(an)c(t)e D(e)i genetr(ic)is et beatorum apos / tolorum atque et s(an)c(t)or(um) martyrum Petri, Iacopi, Chrysogoni et Anastasie. / [E]go Sergius peccator consol et tabellio quem a nobiter feci, ame(n) (foglia). Mense martio, ind(ictione) X, die XX. Sulla paretina laterale sinistra della nicchia si leggono, inoltre, tre santi stanti, posti su due registri. In quello inferiore sono dipinte due figure accompagnate in alto dall’iscrizione che le identifica. I due tituli furono trascritti da Augusto Campana nel seguente modo: [---]tissimus / [---]cleo[--]vato / [Sanctus Ch]romatius // † S(anctus) Chryso / gonus. Del primo titulus si è proposta una lettura alternativa, che getta nuova luce sull’intera decorazione: [Sanc]tissimus / [dominus] Leo quar[tus] / [papa] romanus. La lettura trova riscontro nella figura di pontefice dipinta al di sotto dell’iscrizione, immagine conforme a quella di Leone IV (847-855), dipinta sulla parete d’ingresso della basilica inferiore di S. Clemente. L’identificazione di Leone IV ha consentito finalmente di sciogliere l’indizione e decifrare la data di dedicazione della nicchia: 20 marzo 847, datando ad annum, mensem e diem la decorazione soprastante. Nel consul et tabellio Sergius, non altrimenti noto nelle fonti, va riconosciuto, invece, un esponente del notariato romano, espressione della nuova e mutante realtà amministrativa della città alla metà del IX secolo. I tabelliones Urbis Romae, eredi del collegio tabellionale romano-bizantino riorganizzato da Giustiniano, erano funzionari che rogavano contratti tra privati, di contro agli scrinarii Sanctae Romanae Ecclesiae, scrittori ecclesiastici che redigevano atti pubblici alle dipendenze della cancelleria pontificia. Personaggi con questa doppia qualifica sono attestati nel Regesto Sublacense a partire proprio dal IX secolo, ma la loro massima concentrazione si registra nel X secolo. Per il IX secolo è infatti attestato, in un documento dell’837, il caso isolato di un Johannes in Dei nomine consul et tabellio urbis Romae. Sergius, stando all’intervento promosso in S. Adriano, sembrerebbe confermare l’ipotesi avanzata da Toubert che il doppio epiteto consul et tabellio fosse usato per designare i priori della corporazione dei tabellioni. Il nostro è qui committente della decorazione di un’intera nicchia dove accanto alla sua sottoscrizione appare anche l’immagine del pontefice in carica Leone IV, elementi che inducono a pensare che si trattasse, anche in questo caso, di un alto funzionario con una posizione sociale prestigiosa ed anche un certo agio economico. Constantinus e Sergius, personaggi finora ignorati dalla storiografia, testimoniano due importanti tappe dell’ascesa e della programmatica affermazione delle nuove classi dirigenti laiche romane tra VIII e IX secolo e sono attestati proprio in S. Adriano al Foro romano, in origine la Curia senatus, luogo che per secoli ha accolto la vita politica della città di Roma. Giulia Bordi 41 BIBLIOGRAFIA A. BARTOLI, Curia Senatus. Lo scavo e il restauro, Roma 1963. A. MANCINI, La chiesa medioevale di S. Adriano al Foro Romano, in «Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia», XL (1967-1968), pp. 191-245. G. ARNALDI, Rinascita, fine, reincarnazione e successive metamorfosi del senato romano (secoli V-XII), in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 105 (1982), pp. 5-56 (in part. pp. 29-36). T. S. BROWN, Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554-800, Hertford 1984, pp. 21-37. C. MORSELLI - E. TORTORICI, Curia, Forum Iulium, Forum Transitorium (Lavori e studi di archeologia pubblicati dalla Soprintendenza archeologica di Roma, 14, I), Roma 1989. A. FRASCHETTI, La conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana, Bari 1999. L. BARROERO, Sant’Adriano al Foro romano, in L. Barroero et al., Via dei Fori imperiali, la zona archeologica di Roma: urbanistica, beni artistici e politica culturale, Roma 1983, pp. 197-224. G. BORDI, S. Adriano al Foro Romano e gli affreschi altomedievali, in Roma dall’antichità al medioevo. Archeologia e storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi a cura di M. S. Arena et al., Roma 2001, pp. 478-486. F. BURGARELLA, Il Senato, in Roma nell’Alto medioevo, Settimane di studio del centro italiano di studi sull’Alto medioevo, 48, 2000, Spoleto 2001, pp. 121-175. P. TOUBERT, Scrinium et Palatium: la formation de la bureaucratie romano-pontificale aux VIIIe-IXe siècles, in Roma nell’Alto medioevo, Settimane di studio del centro italiano di studi sull’Alto medioevo, 48, 2000, Spoleto 2001, pp. 56-117. R. MENEGHINI, Il Foro romano, in R. Meneghini-R. Santangeli Valenzani, Roma nell’altomedioevo. Topografia e urbanistica della città dal V al X secolo, Roma 2004, pp. 157-175. A. CEDERNA, Mussolini urbanista, Venezia 2006 (ed. or. Bari 1979), pp. 194-196. G. BORDI, Committenza laica nella chiesa di Sant’Adriano al foro romano nell’Altomedioevo, in Medioevo: i committenti, Atti del XIII Convegno Internazionale di Studi (Parma, 21-26 settembre 2010), a cura di A.C. Quintavalle, Bologna 2011, pp. 63-75. Anfiteatro Flavio: lo scavo di due ambienti del primo ordine Il progetto nasce da una proposta fatta da una collega archeologa, Rossella Rea, che è il funzionario della Soprintendenza Archeologica di Roma che ha l’onore, e il pesante onere, di occuparsi del Colosseo, e che sta avviando le complesse pratiche legate ai lavori di restauro finanziati dalla sponsorizzazione di Della Valle. All’inizio la proposta era quella di riprendere un lavoro avviato negli anni ’70 ma lasciato incompiuto e mai oggetto di pubblicazione, neppure preliminare, cioè lo svuotamento dei grandi collettori che provvedevano allo smaltimento delle acque dall’enorme invaso dell’Anfiteatro, e che con la fine della manutenzione del monumento si erano completamente ostruiti. Il collettore settentrionale, sul quale si sarebbe dovuto concentrare il lavoro, è alto più di un metro e ottanta e largo un metro e venti. Le poche notizie disponibili relative agli scavi degli anni ’70 indicavano come l’interro fosse ricchissimo di materiali relativi alle fasi tardo antiche e altomedievali di utilizzo del monumento. La proposta mi aveva interessato molto, poiché avrebbe permesso di indagare proprio quella fase storica di passaggio dall’antichità all’alto medioevo che da tempo costituisce il principale oggetto delle mie ricerche, e inoltre avrebbe consentito di approfondire i temi dei modi di formazione dei contesti archeologici e dell’interpretazione degli assemblaggi ceramici all’interno di un contesto stratigrafico chiuso, che è pure un tema metodologico del quale ho avuto modo di occuparmi. D’altra parte da tempo, nell’ambito degli insegnamenti del settore di metodologie della ricerca archeologica, sentivamo l’esigenza di affiancare a quello di Populonia anche un altro scavo con valenza didattica, indispensabile per dare a un maggior numero dei nostri studenti quell’esperienza che, nel nostro lavoro, si può ottenere solo sul campo. L’avvio dei lavori di scavo era 42 però condizionato dal preventivo svuotamento del condotto, da parte della ditta che sta impostando il cantiere di restauro, dell’acqua che ne riempie il fondo per un’altezza di quasi cinquanta cm. Questo svuotamento non si è riusciti a realizzarlo, probabilmente a causa di un rialzamento della falda, che fa sì che l’acqua ritorni man mano che si svuota. Questo contrattempo ha costretto a rivedere il progetto, essendo comunque intenzione della Soprintendenza di Roma di mantenere questa collaborazione con il nostro Dipartimento, anche in previsione di future iniziative, e presentando un grandissimo cantiere di restauro come quello che si sta allestendo al Colosseo molte altre esigenze di indagini preliminari. Di comune accordo con la collega Rea abbiamo quindi deciso di indirizzare lo scavo all’indagine di due ambienti delle sostruzioni della cavea dell’anfiteatro, al primo ordine (cioè il piano terra del monumento) e in particolare un sottoscala del cuneo III sul terzo anello e l’intero cuneo X (sottoscala, antistante corridoio radiale e parte del terzo anello). Questa scelta è derivata dall’incontro di opportunità scientifiche e didattiche, da parte nostra, e di esigenze logistiche e conservative da parte della Soprintendenza. È infatti nei progetti della Soprintendenza arrivare a rimettere in luce i piani antichi almeno in alcuni settori del primo ordine del monumento, per ripropone la percorribilità originaria; la posizione degli ambienti selezionati, all’interno di un’area chiusa al pubblico, costituiva poi un elemento essenziale per l’installazione del cantiere di scavo. Obiettivo scientifico dell’intervento era quello di ottenere dati sulle fasi medievali di utilizzo del Colosseo, fasi i cui resti sono stati quasi completamente cancellati nella “liberazione” ottocentesca del monumento. I due ambienti scelti per le indagini appartengono a tipologie diverse e dovevano rispondere a domande storiche diverse. L’ambiente del cuneo X è uno di quelli utilizzati come stalla o fienile, come mostra anche la presenza di una vasca e gli incassi per solai sulle pareti. L’obiettivo dello scavo in questo caso era quello di individuare gli strati in fase con questo momento di utilizzo, in modo da precisarne natura e funzione, datarlo su base archeologica Fig. 1 – Anfiteatro Flavio. L’ambiente del cuneo X in corso e seguirne le trasformazioni; il piccolo sottoscala di scavo del cuneo III invece appartiene a una tipologia di ambienti che non mostrano tracce di riutilizzo ma che, si sperava, potesse fornire elementi per datare con precisione il momento della spoliazione della pavimentazione del monumento. Per quanto riguarda l’aspetto didattico, questo cambiamento di progetto presentava poi notevoli vantaggi: innanzitutto la maggior ampiezza dell’area di scavo ha consentito di aumentare sensibilmente il numero degli studenti che hanno potuto partecipare, dai 18 previsti originariamente, a 35 che hanno partecipato, divisi nei due turni di tre settimane ciascuno in cui si è articolato lo scavo (purtroppo molte altre richieste non hanno comunque potuto essere accolte, ma questo dimostra il grande desiderio che c’è tra i nostri studenti di affiancare alla tradizionale attività didattica anche esperienze pratiche e sul campo); inoltre, trattandosi di uno scavo metodologicamente molto più “tradizionale”, è stato senz’altro più adatto a fornire una esperienza di base per studenti con poca o nessuna pratica di scavo, consentendo loro di familiarizzarsi con attività quali il riconoscimento e il rilevamento degli strati, l’esecuzioni di sezioni volanti e cumulative, la schedatura di strutture etc., che nelle condizioni particolari dello scavo nel collettore non avrebbero potuto essere svolte. 43 Formalmente lo scavo è stato una codirezione tra la Soprintendenza di Roma e il Dipartimento, e direttori siamo Rossella Rea ed io; per coordinare il lavoro degli studenti è stato inoltre formato un piccolo gruppo di lavoro composto da collaboratori con vasta esperienza di scavo e di studio dei materiali: Monica Ceci, Giulia Facchin e Ilaria De Luca. Lo scavo si è svolto dal 13 giugno al 23 luglio, con una “coda” a settembre per completare della documentazione lasciata in sospeso; tutte le operazioni di documentazione, scavo, trasporto delle terre all’interno del cantiere, lavaggio e inventariazione dei materiali, sono state eseguite dagli studenti di Roma Tre, mentre per le operazioni cantieristiche, la fornitura degli attrezzi e il trasporto delle terre a discarica, grazie all’accordo con La Soprintendenza, ci siamo potuti appoggiare alla ditta che cura la manutenzione del monumento. Questo aiuto è stato fondamentale, in quanto i costi di queste operazioni, anche su uno scavo limitato come questo, superano ampiamente le disponibilità dei fondi di ricerca annuali a disposizione del Dipartimento. I risultati raggiunti sono andati al di là delle nostre aspettative, consentendoci di rispondere alle domande storiche che ci eravamo posti. Espongo ora brevemente una sintesi dei risultati raggiunti. Nel cuneo III lo strato che riempie la spoliazione del pavimento antico, benché tagliato e disturbato da interventi posteriori, ha consentito di fissare la cronologia di questa spoliazione alla seconda metà del XII secolo, in sincronia con quanto documentato anche nella parte più interna del cuneo X, ambulacro e corridoio radiale. Più complessa la situazione nel sottoscala del cuneo X (fig. 1). Qui lo scavo ha messo in luce diverse fasi di utilizzo dell’ambiente successive alla spoliazione della pavimentazione. Nel corso del XII secolo, subito dopo l’asportazione delle lastre pavimentali e quasi al livello della fondazione flavia, l’ambiente venne chiuso sul lato aperto verso l’ambulacro con un muro (di cui rimane solo una labile traccia) e pavimentato con un irregolare battuto. Sul lato di fondo, a ridosso del muro antico che lo chiude, venne edificata una struttura, forse un bancone, costruita con pietre irregolari e malta di calce, di cui rimane la parte più bassa. Un focolare, costituito da un cerchio regolare di pietre, indica una possibile funzione abitativa per questo ambiente, testimonianza dell’esistenza, ancora in pieno bassomedievo, di tipologie di edilizia residenziale precarie, sulle quali la nostra documentazione, sia archeologica che scritta, è labilissima. Successivamente, nel corso della prima metà del XIII secolo, l’ambiente subì una profonda modificazione: il livello di calpestio venne rialzato fino a 30 cm. con un riporto di terra e sassi e con la creazione di un nuovo, irregolare, piano di calpestio. La struttura a ridosso del muro di fondo e il muro di chiusura verso l’esterno vennero rasati, mentre addossata alla parete Est venne costruita una nuova struttura, costituita da un muro alto circa 1,20 m. e lungo circa 5 m., su cui poggia una vasca costituita da uno spesso strato di cocciopesto. È probabile che questa trasformazione abbia segnato un cambio di utilizzo dell’ambiente, utilizzato ora come deposito, stalla, o per attività produttive ancora da chiarire. L’asportazione di gran parte dei muri in blocchi della costruzione flavia che delimitavano l’ambiente, di cui lo scavo ha evidenziato le ampie fosse di spoliazione, segnò, nella seconda metà del XIII secolo, la fine dell’utilizzo dell’ambiente, che venne ad essere coperto da depositi di limo, tagliati dagli sterri ottocenteschi. La parte più alta della stratificazione era infine costituita dagli strati relativi al cantiere di restauro della prima metà del XIX secolo. Nell’ottobre 2011 ha preso avvio un seminario, su base volontaria, ma al quale partecipano tutti gli studenti che hanno preso parte allo scavo, dove, con incontri periodici, si elaborano i diagrammi stratigrafici e le piante di fase, si analizzano e schedano i materiali, si approfondiscono temi specifici, 44 in modo da giungere in tempi brevi alla pubblicazione dei risultati dello scavo, e di consentire a tutti gli studenti e neolaureati di parteciparvi e di veder riconosciuto il loro impegno. Nelle intenzioni della Soprintendenza c’è la prosecuzione di questa collaborazione anche negli anni prossimi, e la speranza, se la disponibilità dei finanziamenti lo consentirà, è di trasformare questo scavo in un cantiere scuola stabile per gli studenti di Roma Tre. Riccardo Santangeli Valenzani L’incisione a Roma fra Cinquecento e Seicento. Paesaggio e veduta La ricerca prende in esame alcune raccolte di incisioni raffiguranti paesaggi e vedute di Roma antica e moderna di importanti incisori, da Hieronymus Cock a Giovanni Maggi, per cercare di chiarire alcuni aspetti dello sviluppo e della diffusione dei modi di rappresentazione del paesaggio fino a Paul Bril, l’uomo di punta del paesaggio cinquecentesco italiano di matrice nordica che, direttamente o no ed anche “in opposizione”, stimola i cambiamenti e che in ogni caso ci fa misurare la distanza delle innovazioni di Annibale Carracci e Adam Elsheimer. Considerando alcuni problemi, alcuni incroci di questioni, lacune e zone d’ombra negli studi sulla pittura di paesaggio a Roma nel pieno Cinquecento ed anche la vitalità dei luoghi comuni e dei fraintendimenti che hanno per alcuni versi strutturato la visione di uno sviluppo della rappresentazione del paesaggio sostanzialmente sulla linea veneta e su quella nord-europea, può essere utile riesaminare alcuni gruppi di incisioni realizzate fra il 1540 e il 1570, cioè fino all’arrivo a Roma di Matthijs Bril, fratello maggiore di Paul. Proprio intorno agli anni Quaranta il paesaggio compare, come genere autonomo, nella decorazione dei palazzi, soprattutto all’interno dei fregi (Palazzo dei Conservatori, Villa Giulia, Appartamento di Giulio III nei Palazzi Vaticani). Vi sono rappresentati in forma più o meno fedele monumenti antichi e vedute di Roma, paesaggi d’invenzione in uno stile che possiamo definire schiettamente romano e “raffaellesco” per mettere in risalto la presenza di un’altra direzione di sviluppo, che certamente si incrocia anche con quella veneta e quella nord-europea, ma che cresce soprattutto sugli esempi di Giulio, Polidoro e Perino (Sapori, in c.d.s.). La sua componente antiquaria trae molti motivi anche da incisioni pubblicate da Antonio Salamanca e riflette, a mio parere, l’ambiente di Salamanca, Francisco de Hollanda, dell’Accademia della Virtù, di Serlio e Ligorio. In questo contesto acquista speciale rilievo la raccolta Prospettive et antichità di Roma, dedicate al cardinale Guido Ascanio Sforza di Santafiora (1554-1557) di Michele Grechi o Michele Lucchese, allievo e collaboratore di Perino del Vaga, in particolare studiata da Paola Picardi. Essa comprende incisioni di monumenti antichi sia allo stato di rovina che idealmente ricostruiti, rappresentati anche in prospettiche scenografie, e motivi decorativi dall’antico in gran parte copiate, con qualche aggiunta d’ambientazione o di staffage, da rami di Nicolas Beatrizet, Agostino Veneziano, Androuet du Cercau e di altri incisori, alcuni ancora anonimi. A queste si aggiungono alcune vedute romane di impostazione un po’ incerta, come l’Arco dei Pantani e Castel S. Angelo, probabilmente opere originali di Grechi. Questi è sicuramente l’autore delle incisioni rappresentati sistemi decorativi raffaelleschi. Nella circolazione europea di invenzioni, incisioni, artisti ed in particolare fra coloro che lavorarono a Roma Etienne Dupérac, pittore, architetto, imprenditore e incisore francese, ha un posto importante per le incisioni di paesaggio e di I Vestigi dell’antichità di Roma. È ancora problematico cercare di precisare la cronologia dei disegni e delle incisioni di paesaggio sicuramente di sua mano 45 così come di precisare le componenti della sua cultura. Oberhuber per primo individuò gli effetti di un probabile soggiorno a Venezia, prima dell’arrivo a Roma verso il 1560; più di recente Lurin vi ha visto i riflessi di Hans Bol e di Hans Sebald Lautensack. Qui voglio richiamare l’attenzione su alcune incisioni della scuola di Fontainebleau, delle quali è nota la immediata diffusione anche in Italia, e in particolare di Antonio Fantuzzi, datate o databili nei primi anni Quaranta, di Etienne Delaune e di Jean Cousin il vecchio, databili intorno alla metà del secolo, che rappresentano dei paesaggi entro ricche inquadrature ornamentali, derivanti dagli stucchi della Grande Galerie di Francesco I ed altri ambienti del castello di Fontainebleau. Alcuni di questi paesaggi hanno caratteri italianizzanti, altri decisamente nord-europei fra Germania e Paesi Bassi, ma, come ha osservato Zerner, non corrispondono in ogni caso a opere dipinte presenti nel castello. L’ipotesi che nel percorso di Dupérac avessero un ruolo le incisioni della scuola di Fontainebleau e di quella di Parigi e in particolare le incisioni di paesaggio sembra trovare dei riscontri nel confronto tra un Paesaggio incorniciato da satiri di Antonio Fantuzzi e il Paesaggio con cavalieri di Dupérac, tra la Caccia agli uccelli di Etienne Delaune e il Paesaggio con il cacciatore di anatre di Dupérac. Questi doveva aver visto opere di Campagnola e di Tiziano a Venezia ma ne assimilò qualche carattere anche tramite Hieronymus Cock, come indica il confronto fra il Paesaggio con Apollo e Dafne di Dupérac e il Il Settizodio e i ruderi severiani sul Palatino di Cock, una delle 25 tavole dei Precipua Aliquot Romanae Antiquitatis Ruinarum Monimenta , eseguite almeno a partire dal 1546 e pubblicate ad Anversa nel 1551, modello per la rappresentazione delle rovine romane di Dupérac. Sia a Cock che a Dupérac, alla loro ricerca di una descrizione oggettiva degli edifici antichi, della resa del contesto – più d’invenzione nel primo e più fedele nel secondo –, alla loro sensibilità paesistica nei dinamici effetti pittorici della luce e della atmosfera si è fatto riferimento per spiegare alcuni aspetti della produzione grafica e pittorica di Girolamo Muziano divenuto famoso a Roma come il “giovan de’ paesi” (Baglione). Il grande lavoro, così ricco di materiali, compiuto da Tosini sull’artista pone molti stimolanti interrogativi sulla evoluzione del suo modo o meglio modi di rappresentazione del paesaggio e in particolare a Roma anche in rapporto alle incisioni. Innanzitutto sembra poco probabile che Muziano , arrivato da Padova nel ’49, riuscisse ad ottenere autonome commissioni solo un paio di anni dopo, quando era appena ventenne. Nei primi anni Cinquanta sono infatti collocati la Natività di S. Caterina della Rota e gli affreschi (gravemente deperiti) di Rocca Sinibalda. Qui i paesaggi dai panorami dolcemente ondulati, derivanti da Lambert Sustris, sembrano però poco connessi con il robusto impianto paesistico della Natività. Se i modelli veneti rimasero per Muziano quelli studiati negli anni Quaranta ci si può anche chiedere se egli condivida con Dupérac soltanto una comune esperienza formativa in Veneto o anche delle direzioni di ricerca, ma certamente non si possono anticipare gli effetti su Muziano del nuovo stile romano e “classico” che impronta i Vestigi dell’antichità di Roma (1575) di Dupérac. Sono ancora infatti da chiarire la cronologia delle opere tra il ’50 e il ’60 e le sostanziali differenze di costruzione. In primo luogo fra i disegni dalla metà del Cinquanta fino a quelli con gli eremiti, incisi da Cort, caratterizzati da un impianto compositivo monumentale in verticale e da una compressione verso il primo piano: orizzonte alto, repoussoirs rialzati e scansione a forti dislivelli con quegli effetti di montagne impervie, forre e precipizi, rocce aguzze, vegetazione folta ammirati anche dai fiamminghi, e le solari vedute panoramiche dipinte Villa d’Este a lui riferite. Giovanna Sapori 46 I giardini di Giovanni Maggi Insieme a Giacomo Lauro uno degli incisori di vedute di Roma, di paesaggi e vedute di fantasia è Giovanni Maggi, una figura finora poco studiata. Incisore attivo sin dal 1595 per i maggiori stampatori, editori e commercianti di stampe del Seicento, tra le sue prime opere sono da ricordare la serie dei paesaggi (1595-1601) e quella più ricca dei giardini (1601). Entrambi questi generi sono stati un’occasione per riflettere sull’importanza delle incisioni per la Fig. 1 – G. Maggi, Veduta di un giardino, incisione, Roma, diffusione di motivi e sul loro impiego nel lavoro pit- Biblioteca Nazionale Centrale torico anche in diverse combinazioni. È nota infatti la presenza nei cicli di motivi tratti dalle incisioni di Hieronymus Cock, Etienne Dupérac o i Sadeler. Per il periodo che più ci interessa è importante considerare il grande successo dei disegni di Mattheijs e Paul Bril e le incisioni che ne furono tratte prima di tutto da Antonio Tempesta. Questi collaborò come pittore con Paul Bril e successivamente svolse un’autonoma attività di paesaggista. Le incisioni di Giovanni Maggi che compongono la serie dei giardini, furono da lui disegnate ed incise a bulino nel 1601. Tuttavia, non compaiono nei noti repertori di Nagler, Le Blanc né di Ehrle del 1915. L’unico esemplare completo da me ritrovato a Roma è quello della Biblioteca Nazionale Centrale. Sia questa serie che quella di collezione privata esaminata da Giorgetta sono privi di frontespizio e si compongono di dieci pezzi. Si tratta di un documento figurativo significativo nella storia del giardino poiché fissa all’inizio del Seicento la prima rappresentazione a stampa di giardini in Italia, al contrario diffusa in Europa già nel secolo precedente. Giovanni Maggi incide vedute di giardini, piazze e viali, ritratti dal vero e/o d’invenzione, nelle quali il ruolo più importante viene dato alla rappresentazione del giardino (fig. 1). Archi di verzura, vasche d’acqua o forse peschiere, e aiuole dalla partitura geometrica sono resi con un’attenzione al dettaglio che possiamo riscontrare solo nelle incisioni di paesaggio dello stesso Maggi. Meno attenzione viene data invece alle ville, rappresentate solo in parte o usate come punto di fuga prospettico, e ai personaggi, questi ultimi delineati attraverso l’utilizzo di poche linee di contorno e intenti a passeggiare all’interno del giardino o a rilassarsi all’ombra di un gazebo “ante litteram”. La mia ricerca è rivolta ad individuare e studiare i rapporti fra i giardini di Maggi e lo sviluppo dei modi di rappresentazione dei giardini in pittura a Roma come ad esempio dagli affreschi di Villa d’Este a Tivoli a quelli di Villa Mills al Palatino (derivanti da Tempesta). Più in generale mi propongo di precisarne i modelli sia in ambito nord-europeo, ad esempio con l’opera di Vredeman de Vries edita nel 1583, sia in ambito veneto, ma sempre di origine nordica, come quelle di Bordon e di Pozzoserrato. È da sottolineare che solo una delle incisioni della serie reca in basso al centro il nome dell’editore e commerciante di stampe Giovanni Orlandi, seguita dall’anno di edizione 1602, mentre le altre presentano solo l’iscrizione con il nome di Giovanni Maggi e l’anno di esecuzione. A mio avviso, la committenza della serie si potrebbe far risalire alla collaborazione, già a partire dal 1599-1600, tra il Maggi e la famiglia Vaccari cioè i maggiori editori in quegli anni a Roma. È certo, infatti, che la serie era in vendita almeno fino al 1614 nella bottega in Banchi alla Zecca vecchia poiché il catalogo Vaccari (Indice e nota particolare di tutte le stampe di rame che si ritrovano al presente nella Stamperia di Andrea e Michel’Angelo Vaccari in Roma…), registra “Vn libro di diece pezzi di Giardini diuersi, 47 itagliati da Gio: Maggio”. Probabilmente l’Orlandi, che collaborò con il Maggi almeno fino al 1609, ebbe occasione di stampare una sola tavola dei giardini, nello stesso anno in cui pubblicò anche il Paesaggio con la cena in Emmaus di Maggi. Ludovica Tiberti BIBLIOGRAFIA F. EHRLE, Roma al tempo di Urbano VIII: la pianta di Roma Maggi Maupin Losi del 1625 riprodotta da uno dei due esemplari completi finora conosciuti, Roma 1915. K. OBERHUBER, Hieronymus Cock, Battista Pittoni und Paolo Veronese in Maser, in Munuscula Discipulorum: Festschrift fur Hans Kaufmann zum 70. Geburtstag, Berlin 1968, pp. 207-224. J. BURGERS, In de Vier Winden. De prentuitgeverij van Hieronymus Cock 1507/10-1570, catalogo della mostra, Rotterdam 1988. H. ZERNER, L’art de la Renaissance en France. L’invention du classicisme, Paris 1996. Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai temi di Bellini, Dürer, Tiziano, a cura di B. Aikema e B. L. Brown, catalogo della mostra Venezia, Milano 1999. P. PICARDI, Gli affreschi del palazzo di Paolo III al Campidoglio: un salvataggio anomalo, in «Paragone», 55 (2004), pp. 3-26. F. CAPPELLETTI, Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma, 1580-1630, Roma 2006. S. BALLESI, Una famiglia di stampatori a Roma fra Cinque e Seicento: i Vaccari, in Il mercato delle stampe a Roma (XVI-XIX secolo), a cura di G. Sapori, con la collaborazione di S. Amadio, Foligno 2008, pp. 57-85. P. TOSINI, Girolamo Muziano 1532-1592. Dalla maniera alla natura, Roma 2008. E. LURIN, Un homme entre deux mondes: Etienne Dupérac, peintres, graveur, architecte en Italie et en France (c.1535?-1604)in Renaissance en France. Renaissance française?, a cura di H. Zerner e M. Bayard, Paris 2009, pp. 37-59. F. GIORGETTA, Hortus librorum liber hortorum: l’idea del giardino dal XV al XX secolo attraverso le fonti a stampa, Milano 2010, vol. I, pp.173-177. G. SAPORI, Paesaggio e cuir découpé nel fregio attorno alla metà de Cinquecento, in Il fregio dipinto nelle decorazioni romane del Cinquecento, atti del convegno, Roma, in c.d.s. Una famiglia di scultori, fonditori e mercanti di antichità: i Rondoni-Spagna Non è certo ignota agli studiosi l’esistenza di nuclei familiari allargati che svolgono lo stesso mestiere. Non solo sono da ricordare le reti parentali, certamente più celebri, dei pittori napoletani, ma certamente le estese parentele di architetti, scultori e scalpellini lombardi, sulla cui galassia la bibliografia è nutrita, soprattutto grazie agli studi recenti di Margherita Fratarcangeli di cui abbiamo tenuto il debito conto, sono state osservate piuttosto come un fenomeno sociale e nella loro globalità, eccezion fatta per i più noti come ad esempio i Della Porta. Ricordava S. Pressouyre, nel suo scritto su François Duquesnoy dell’ormai lontano 1984, che mancava, e a quanto pare ancora oggi manca, uno studio complessivo sulla famiglia allargata di fonditori Torrigiani-Censore a cui si debbono molte importanti opere bronzee della capitale tra la fine del Cinquecento ed il pieno Seicento. J. Montague, ne La scultura barocca romana (MONTAGUE 1991: 77), illustra le ragioni della scarsa attenzione data dagli studi ai numerosissimi scultori di secondo piano del XVII secolo, e di conseguenza anche ai molti gruppi familiari di scultori che quasi mai accedono all’eccellenza stilistica e formale: «Secondo la teoria artistica tradizionale Pittura, Scultura e Architettura sono tre sorelle nate dal Disegno, inteso sia in senso tecnico sia come invenzione. Questo in teoria, ma nella pratica solo pochi scultori erano in grado di tracciare sulla carta le proprie idee; questa incapacità non impediva loro di dar forma alle proprie invenzioni con la 48 terracotta, o perfino, con disegni decisamente brutti: più spesso però, questo equivaleva all’accontentarsi di realizzare disegni dati da altri artisti, pittori, architetti o […] da scultori dotati di maggiore inventiva. Non è sorprendente che tale rapporto di dipendenza provochi un senso di scoraggiamento in chi voglia studiare monograficamente un artista non di primo piano, poiché tali scultori non possono né debbono essere considerati individualmente, ma vanno inquadrati come membri di un contesto artistico più ampio e in rapporto a coloro che in ultima analisi erano i responsabili del progetto che essi si impegnano ad eseguire». Non mi sono scoraggiata però di fronte a questa affermazione. È indubbio che l’analisi della produzione di scultori meno dotati e dipendenti dalla altrui progettazione, rende il problema attributivo molto arduo da dipanare, ma non si può ignorare, né trascurare, che a loro si deve buona parte della realizzazione dell’aspetto della decorazione pubblica e privata di Roma. La dipendenza dal progetto altrui è reale, sarebbe ingenuo ignorarla, lo stesso vale per la non sempre ineccepibile qualità di esecuzione, ma per quale ragione lasciarli in un limbo di indeterminatezza il cui massimo di acribia è la citazione del nome? Credo che a questa parte di abile manualità si debba dare il contributo che merita. Se dalla mancanza di autonomia inventiva dobbiamo inferire una assenza di commissioni di primaria importanza, questa asserzione viene smentita, almeno nel caso della famiglia di cui abbiamo deciso di occuparci e di cui abbiamo già dato un’iniziale informazione in due brevi saggi. Occorre premettere che il capostipite della famiglia Rondoni è Alessandro, dapprima indicato nei documenti come scalpellino e dopo brevissimo tempo, e per sempre come scultore, proviene da Como dove nacque con ogni probabilità nel 1562 da Tommaso anch’egli scultore. È dunque parte di quell’onda migratoria di lavoratori del marmo che dalle rive del Lario, dalle valli intorno a Lugano, dalla Val d’Intelvi – sulle orme dei medievali Maestri Comacini – calavano nel centro Italia, dopo aver fatto tappa a Genova. Roma era naturalmente la meta più ambita, soprattutto al finire del XVI secolo quando grandi imprese urbanistiche e di arredo urbano erano in essere grazie ai pontificati di Sisto V e di Clemente VIII. Allo scultore Alessandro Rondoni, morto a Roma nel 1634, si possono riferire solo due contributi bibliografici specifici precedenti i nostri studi, oltre alle voci in alcuni repertori (Thieme Becker, Riccoboni, Bacchi). Nel 2002 quello di C. M. Clifford Brown (CLIFFORD BROWN 2002) che rende noti i rapporti intercorsi tra il Duca di Mantova Ferdinando Gonzaga e A. R. in qualità di mercante di antichità nonché di suo figlio Francesco Rondoni che risiedette, in giovanissima età, presso la corte come restauratore. Il saggio si basa sulla corrispondenza, in parte già resa nota da Antonino Bertolotti sul finire dell’Ottocento (BERTOLOTTI 1885), tra il Granduca e il Rondoni Sr. Il secondo contributo scientifico, più recente, di Loredana Lorizzo del 2009, indaga l’attività di Alessandro Rondoni come mercante e restauratore del cardinale Ippolito Aldobrandini Jr. sulla base di un documento notarile di vendita di statue antiche che anche noi pubblicavamo contemporaneamente. Nel 1989, invece, Gino Corti (CORTI 1989), analizzava la committenza fiorentina a Roma tra 1610 e 1620 rendendo note le carte dell’ambasciatore Piero Guicciardini nelle quali compare più volte il nome di Alessandro Rondoni in qualità di mercante e di restauratore. Siamo partiti da questa scarna bibliografia e dai repertori, nonché dalle sempre utilissime schede di Friedrich Noack, per affrontare l’arduo compito. Arduo anche perché regnava, e regna in parte ancora, una relativa confusione fra la produzione ed il ruolo artistico di Alessandro sr. e quello dell’omonimo nipote Alessandro jr. Del tutto trascurata è la figura di Francesco Rondoni così come quella di Giacomo e Carlo Spagna come vedremo tra poco. Considerata la totale inesistenza di riferimenti bibliografici nei saggi citati, si è affrontato il problema con il metodo più agevole: una ricerca in rete, dalla quale sono scaturite le prime indicazioni interessanti 49 cui sono seguite ricerche bibliografiche più approfondite che hanno dato come risultato primario oltre una sessantina di riferimenti bibliografici sui vari componenti della famiglia. È da sottolineare che è una bibliografia di seconda battuta, poiché si riferisce immediatamente al collezionismo di antichità. Parallelamente si conduceva da parte nostra, oltre allo spoglio di vari documenti notarili presso l’Archivio di Stato, una approfondita ricerca nell’Archivio Storico del Vicariato di Roma che ci ha consentito di ricostruire per intero – ma la ricerca non è definitivamente conclusa – l’albero genealogico della famiglia Rondoni – Spagna, nonché di precisare date di nascita, di matrimoni e di morte del tutto ignote dei componenti della famiglia, seguendone anche lo sviluppo economico e sociale. La bibliografia, che ribadiamo nasconde il nome dei Rondoni e degli Spagna nelle note al testo, ci ha permesso di redigere un rudimentale ma utile repertorio dei lavori cui presero parte o che effettuarono in prima persona, cioè come autori presumibilmente del “progetto”. ALBERO GENEALOGICO Dall’albero genealogico che abbiamo ricostruito possiamo dedurre che, da un punto di vista esclusivamente sociale, il mestiere veniva tramandato di padre in figlio. Alessandro senior, il capostipite di una famiglia mescidata tra lombardi e umbri per risolversi in un nucleo perfettamente assimilato al tessuto romano, proveniva da Como; figlio di padre scultore (Tommaso, di cui non è noto nulla, almeno dalle nostre ricerche) dapprima si imparenta con uno scalpellino di Narni, Giacomo Spagna, a cui dà in moglie la propria primogenita Lucrezia, poi insegna il mestiere all’ultimogenito, unico figlio maschio, Francesco. Dall’unione di Lucrezia e Giacomo Spagna, ricca di figlie femmine, il terzogenito Carlo, anch’egli unico maschio, viene avviato alla professione probabilmente per un breve tempo dal padre, che muore nel 1626, quando il figlio era solo tredicenne, e poi dallo zio Francesco e forse anche dal nonno Alessandro. Francesco, anch’egli unico figlio maschio di una progenie femminile di Alessandro, viene rapidamente inserito nella “azienda di famiglia”. Dal matrimonio tardivo di Francesco nasce Alessandro Jr., anch’egli avviato alla professione di scultore. L’accorta primogenita di Alessandro, Lucrezia, rimasta prematuramente vedova e con molti figli a carico, non solo continua la proficua attività di mercante d’antichità in cui si erano distinti sia il padre sia il marito, ma procura che una delle figlie, Maddalena, sposi lo scultore Lorenese Claudio Adam Brefort, così che la impresa di famiglia prosegua nella sua attività fondendosi con quella del proprio figlio maschio Carlo Spagna, sulla cui imprecisa data di morte sto indagando. Se la carriera dei maschi di famiglia segue consolidate prassi, meno usuale è la figura di Lucrezia Rondoni che, con piglio manageriale, continua l’attività del marito defunto, come mercante di antichità e alla quale intendiamo riservare un’attenzione particolare. Non siamo in grado di determinare se sia un’eccezione nel panorama dell’attività femminile, ma certo non è donna usuale. L’articolato nucleo familiare ha un mercato imponente sia di vendita sia di restauro di antichità e di realizzazioni scultoree in proprio. Rapidamente scorrendo le commissioni di cui furono incaricati i vari componenti della famiglia e che coprono un arco temporale che va dal 1590 c. al primo decennio del XVIII secolo, si nota che svolsero un ruolo tutt’altro che secondario sia nel collezionismo di antichità e del loro restauro sia nella realizzazione di opere autonome per le più importanti famiglie e imprese pubbliche e private di Roma. 50 A costo di essere pedanti citiamo: ALESSANDRO SR.: Alessandro Peretti Montalto Altemps Scipione Borghese Ludovico Ludovisi Asdrubale Mattei Rodolfo Pio da Carpi Ippolito Aldobrandini jr. Ferdinando Gonzaga Granduca di Toscana (Ferdinando de’ Medici) Maurizio di Savoia Lancellotti FRANCESCO RONDONI Famiglia Aldobrandini Odoardo Farnese Famiglia Barberini Bernardino Spada Certosa di S. Martino (conclude il lavoro iniziato da Cosimo Fanzago Æ da attribuirsi probabilmente al figlio) Michele Peretti Camera Pontificia Familia Massimo Giulio Mazzarino ALESSANDRO RONDONI JR. S. Maria in Traspontina Cappella Altieri in S. Maria in Campitelli Famiglia Ginetti Busti di Raffaello e di Annibale Carracci al Pantheon Famiglia Altieri Don Livio Odescalchi Marchese del Carpio S. Maria in Montesanto Filippo V (o per il vicerè di Napoli Marchese del Carpio) Famiglia Corsini Giacomo Spagna Alessandro Peretti Montalto S. Agnese fuori le mura Palazzo Montalto a S. Lorenzo in Lucina Torre in Pietra Bernini Maurizio di Savoia (?) 51 Camera Apostolica Emanuele Pio di Savoia a Villa Rivaldi Cappella della Vergine nella Chiesa dell’Annunziata a Sulmona (la famiglia Ginetti probabilmente viene da Sulmona) CARLO SPAGNA Marino, collegiata di S. Barnaba Bologna, altare per la chiesa di S. Barnaba, progetto di Bernini Cappella Spada, S. Girolamo della carità, progetto di Borromini Palazzo Carpegna Altare maggiore di S. Andrea della Valle Cappelle di S. Pietro e di S. Paolo in S. Agostino Altare maggiore della chiesa dell’Umiltà, datato dalla critica al 1620, in tal caso andrà assegnato ad Alessandro Rondoni (?) o converrà rivedere i documenti, qualora esistano. Busti dei cardinali Cornaro, de Vives, Savenier, Antonio Barberini, Galamini e Roberto Bellarmino nella chiesa dei re Magi di propaganda fide. Su questo artista insiste un equivoco, o almeno a noi sembra. Non fa parte della celebre famiglia di argentieri “Spagna” a cui si debbono riferire alcuni tra i migliori pezzi del XVII secolo. È però spesso menzionato nella bibliografia un “Carlo Spagna argentiere” che riteniamo semplicemente omonimo del nostro. Particolare interesse riveste la figura di Francesco Rondoni che, a differenza del padre cui fu rifiutata la associazione alla Congregazione dei Virtuosi al Pantheon per essere «persona tanto licentiosa», nonostante la presentazione da parte del pittore Giovanni Guerra artifex della propaganda sistina e amico dello scultore dai tempi della comune partecipazione alle imprese di Alessandro Peretti Montalto, appartenne dal 1624 almeno fino al 1633 all’Accademia di San Luca nella quale riveste per un paio di volte il ruolo di “festarolo” (abbiamo visto, al momento, soltanto i documenti reperibili on line sul sito dell’Archivio dello Stato di Roma). Fornite queste generali informazioni sulla famiglia occorre affrontare l’argomento più arduo: la collazione delle opere a ciascuno pertinenti. Non è impresa facile soprattutto per quanto riguarda i lavori di restauro. Ci vengono però in aiuto gli studi sulle collezioni di antichità. Si tratta di lavorare su una estesa mole di bibliografia, nella quale i nomi degli autori di nostro interesse sono per la maggior parte delle volte nascosti nelle note. Da questa prima rassegna si dovrà poi passare a vagliare i fondi archivistici, spesso già studiati ma con un punto di vista diverso dal nostro, volto sulla collezione e sul suo proprietario. Occorrerà poi cercare di rintracciare le poche opere autonome citate dai documenti, qualora ciò sia ancora possibile, e capire se, sulla base delle caratteristiche stilistiche evidenziate, se ne possano aggiungere altre che sono disperse fra le anonime. La questione finale è se valga la pena di affrontare questo impegnativo compito. Ritengo personalmente che ogni frammento che serva a ricomporre il quadro della cultura di un particolare momento sia degno della massima considerazione, a maggior ragione quando, come nel nostro caso, l’anonimato in cui sono caduti i membri delle due famiglie cela invece una fitta rete di importanti rapporti con raffinati collezionisti. Fiorenza Rangoni 52 BIBLIOGRAFIA A. BERTOLOTTI, Artisti in relazione coi Gonzaga Signori di Mantova, Modena 1885. C.M. CLIFFORD BROWN, Alessandro Rondone scultore al servizio del Cardinale Duca Ferdinando Gonzaga, in «Civiltà Mantovana», XXXVII/144 (2002), pp. 64-78. G. CORTI, Il “Registro de’ mandati” dell’ambasciatore Granducale Piero Guicciardini e la committenza artistica fiorentina a Roma nel secondo decennio del Seicento, in «Paragone», XL/473 (1989), pp. 109-146. J. MONTAGUE, La scultura barocca romana, Torino 1991. Conseguenze di un viaggio di Annibale Carracci nel 1602 Nel catalogo delle opere eseguite da Annibale Carracci durante il lungo soggiorno romano spicca un gruppo di dipinti contraddistinti da una tavolozza vivace, un colorito intenso, una condotta pittorica libera e fluida che non si riscontrano solitamente in questa fase della maturità dall’artista. Si tratta di opere riconducibili tutte al 1602-1603: l’Assunta per la cappella Cerasi di Santa Maria del Popolo, la Venere dormiente di Chantilly, il perduto San Gregorio per la chiesa di San Gregorio al Celio, la Fuga in Egitto per la cappella del palazzo di Pietro Aldobrandini, il Ritratto di Giovanni Battista Agucchi della City Art Gallery di York. Così distante dalla reazione al soggiorno a Venezia che Annibale aveva avuto nella seconda metà degli anni Ottanta del Cinquecento, questo improvviso irrompere di accenti veneti e lombardi nel cuore di una stagione dominata dalla risposta alle opere viste a Roma, a Michelangelo, a Raffaello, alla statuaria antica, resta apparentemente inspiegata: tanto più che ancora oggi ci si ostina a definire quella fase della maturità con la denominazione di “ideale classico”, intendendola appunto come una definitiva presa di distanza dai modelli del colorito veneto e lombardo di Tiziano, Veronese, Correggio in nome di un’adesione indiscriminata al disegno romano e a Raffaello. Viceversa, come indicano i dati dello stile e le voci delle fonti più prossime, a partire dal trattato dell’amico e sostenitore Giovanni Battista Agucchi, il percorso dell’Annibale maturo fu dominato dall’obiettivo di «congiugnere insieme Disegno romano e Colorito lombardo»: dall’intento cioè di coniugare tradizioni pittoriche diverse, e percepite ormai alla seconda metà del Cinquecento come contrapposte, in piena coerenza con le ricerche parallele del fratello Agostino e del cugino Ludovico. A partire dagli anni Ottanta la creazione dell’Accademia degli Incamminati aveva incarnato il progetto carraccesco di rispondere alla decadenza del tardo-manierismo coniando un linguaggio pittorico fondato sul ritorno allo studio dal vero e appunto sulla combinazione di accenti regionali diversi, ovvero sull’unione della componente veneziana, toscana, lombarda, romana, secondo quanto registrato, oltre che dai numerosi passi della Felsina Pittrice di Malvasia, anche da un testo precocissimo come l’orazione funebre di Agostino pronunciata da Lucio Faberio nel 1603. È un programma che anche negli anni successivi si svolge secondo tappe per nulla teoriche, ma rispondenti ogni volta a concrete occasioni di studio: ed è appunto ad una di queste che oggi possiamo ricondurre anche il repentino accendersi di note neovenete nel citato gruppo di opere databili al 1602-1603, nel corso delle riflessioni su Michelangelo, su Raffaello, sulle statue antiche svolte da Annibale a Roma. Databile con certezza alla primavera del 1602 è riemerso infatti, dalle pieghe del ricchissimo testo di Malvasia, un viaggio a Venezia compiuto da Annibale con Ludovico nel corso dei mesi trascorsi via da Roma all’indomani della morte del fratello, come indicato dalle fonti: ed è appunto a questa occasione che si devono ricondurre l’emergere di accenti neotizianeschi che Bellori coglieva nel 53 San Gregorio e la critica più avvertita segnalava, pur senza poterli spiegare, negli studi grafici per la parte bassa della pala Cerasi, le riprese dai paesaggi di Giorgione e Campagnola nei numerosi studi a penna eseguiti da Annibale in questi anni tardi e i debiti nei confronti di quella tradizione che già nel Seicento i conoscitori individuavano nei suoi paesaggi a partire dalle lunette Aldobrandini. Agostino Carracci era morto a Parma nel febbraio del 1602: e a Parma Annibale si recò subito dopo, rientrando a Roma solo alla fine di maggio con Ludovico, che lo aveva accompagnato poco prima nel viaggio a Venezia. Anche questo nuovo passaggio parmense mostra di aver lasciato un segno: le opere riviste in questa occasione si leggono in controluce nei dipinti eseguiti al ritorno a Roma, che anche su questa base si possono scalare in una probabile sequenza. In particolare la serie delle Pietà, composta dalle cosiddette Tre Marie della National Gallery di Londra, dalla Pietà di Capodimonte, dalla Pietà di San Francesco a Ripa e dal piccolo rame di Vienna con lo stesso soggetto – opere di cui non conosciamo una datazione certa – può essere ordinata a partire dalle Tre Marie della National Gallery, che sono un dipinto ancora intimamente debitore del modello della Pietà di Correggio, rivista da Annibale nella cappella Del Bono della chiesa parmense di San Giovanni Evangelista, e dunque plausibilmente da collocarsi nel 1603. Subito dopo Annibale deve avere messo a punto le prime idee per la Pietà di Capodimonte, che sappiamo proveniente da palazzo Farnese ma di cui non si conosce l’originaria collocazione: i disegni di Windsor che registrano questa prima fase mostrano infatti ancora un rapporto stretto con il modello della Pietà Del Bono, laddove il quadro finito, lasciatosi ormai del tutto alle spalle la suggestione correggesca, appare senz’altro da datarsi dopo il 1602 per l’intensità cromatica e la fluidità dell’esecuzione, e per il rapporto strettissimo con la Deposizione di Caravaggio per la Vallicella, un dipinto di cui non si conosce la datazione precisa ma che deve collocarsi tra il gennaio 1602, quando sono in atto lavori sull’altare, e il settembre 1604, quando al nipote del committente viene restituito il quadro che la pala di Caravaggio aveva sostituito. Con una probabile datazione nel 1603, il quadro di Caravaggio costituisce un ante quem della pala di Annibale, che potrebbe essere stata eseguita tra il 1603 e il 1604, come già si suggeriva Denis Mahon. Scarsamente considerato dalla critica e invece essenziale per ricostruire gli scambi di questi anni tra Annibale e Caravaggio, il nesso tra la Deposizione Vittrice e la pala di Capodimonte va infatti inteso senza dubbio nel senso di una risposta del primo alle invenzioni tanto più audaci del secondo, che in questo caso devono aver spinto Annibale a confrontarsi sul terreno della sfida aperta con la scultura e in particolare con la Pietà di Michelangelo. Silvia Ginzburg BIBLIOGRAFIA M. CINOTTI, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, Bergamo 1983, pp. 493-496, n. 46. K. GANZ, in The Drawings of Annibale Carracci, a cura di D. Benati e D. De Grazia, catalogo della mostra, Washington 1999, n. 73. S. GINZBURG, in Annibale Carracci, a cura di D. Benati e E. Riccomini, catalogo della mostra, Milano 2006, nn. VIII.7, 8 e 17. C. C. MALVASIA, Felsina pittrice. Vite de’ pittori bolognesi (Bologna 1678), edizione a cura di G. Zanotti, 2 voll., Bologna 1841. Mostra dei Carracci: disegni, catalogo critico, a cura di D. Mahon, catalogo della mostra, Bologna 1956, p. 94, n. 123. R. WITTKOWER, Drawings of the Carracci in the Collections of Her Majesty the Queen at Windsor Castle, London 1952, p. 147, n. 357 e tav. 75. 54 Pittori e Virtuosi attraverso i disegni di Ottavio Leoni Ottavio Leoni, detto il Padovano, va certamente annoverato tra i grandi disegnatori italiani del XVII secolo. Figlio d’arte, poiché il padre Ludovico fu medaglista e ceroplasta di grido, prima a Padova e poi nella Roma di Gregorio XIII e Clemente VIII, nacque nel 1578 e fin da giovanissimo fu educato alla pratica del disegno, divenendone maestro nella Roma dei primi decenni del XVII secolo, e specializzandosi nel genere del Ritratto, tanto che, secondo Giovanni Baglione, fonte di prima mano poiché ebbe modo di conoscere personalmente l’artista: «ritrasse non solo li sommi Pontefici dei suoi tempi, ma li Principi cardinali, e Signori titolati, e d’ogn’altra qualità pur che famosi fussero, sì religiosi come secolari, in diversi tempi». Questa abbondante produzione ha singolari tangenze con le gallerie dei Ritratti cinquecenteschi, di cui il padre fu protagonista, come sta Fig. 1 – Ottavio Leoni, Autoritratto (Firenze Biblioteca Marucelliana) emergendo da altri nostri studi in corso di pubblicazione, ma più ancora con i moderni database di agenzie fotografiche, dal momento che l’artista, da un certo momento in poi, scelse di numerare i propri Ritratti, datandoli ad mensem. Si è scelto di concentrare l’attenzione su uno dei vertici della ritrattistica del Leoni: il codice H conservato presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze. Su questo importante volume, tra i più noti nella storia del disegno italiano, esiste un solo contributo monografico di Kruft, che risale al 1969 e un affondo nel volume di Bernardina Sani. In entrambi i casi si è cercato di collocare stilisticamente i singoli disegni all’interno del percorso di Ottavio, di ricostruire la biografia dei protagonisti del volume, ma non ci si è occupati della committenza dell’album, del suo assemblaggio e della sua destinazione. Anzi, a questo proposito la critica ha sempre genericamente supposto che i disegni siano stati montati insieme dopo la morte di Ottavio da un ignoto collezionista, probabilmente nella seconda metà del XVII secolo. Molti interrogativi rimanevano dunque aperti anche su un pezzo centrale della storia del disegno italiano e spero con questo lavoro di aver dato un piccolo contributo a sciogliere alcuni di questi quesiti. «Ottavio Leoni Romano detto il Padovanino della cui mano sono questi ritratti de virtuosi illustri del suo tempo»: recita così la rubrica che correda ad indicem l’Autoritratto di spalle, a suggello della serie di ventisette meravigliosi ritratti à trois crayons tutti di mano del Padovanino, che, rilegati insieme, costituiscono come si diceva un volume di straordinario interesse. Di spalle, ammiccante, l’artista si raffigura in una posa inconsueta: mentre si volta verso lo spettatore, distogliendo gli occhi da un foglio che tiene in mano, forse un lavoro in fieri. Molto diversa è questa immagine familiare, allusiva, quasi colloquiale, da quella ufficiale dell’Autoritratto che apre il medesimo volume, e che intende annoverare il Leoni tra i Pittori virtuosi del suo tempo. Nell’Autoritratto di spalle invece non c’è retorica, sembra piuttosto di essere in presenza di una firma, una vera e propria quarta di copertina con foto dell’autore, da far invidia ai best sellers americani del secondo millennio. In questo senso ci aspetteremmo un fuori testo, invece il disegno si pone a chiusura della serie di ritratti dei Poeti, come se Ottavio ne facesse parte. Va innanzitutto detto che l’intero album sembra nascere da un progetto unitario e si presenta come un’operazione editoriale in grande stile, come chiaramente suggerisce l’indice posto a chiusura del 55 volume, dove sono elencati i nomi dei protagonisti dei ritratti di per sé anonimi, suddivisi in quattro categorie: pittori, scultori, matematici e poeti, e denominati “Virtuosi illustri”, come si diceva poc’anzi. All’inizio di ciascuna arte inoltre la numerazione riparte dal principio. La grafia dell’indice, certamente seicentesca, appartiene con ogni evidenza ad un calligrafo, che trascrive da un elenco redatto da chi ha assemblato il volume, come testimoniano alcuni errori riscontrati nella trascrizione. Sembra inoltre significativo il fatto che i nomi degli effigiati vengano elencati in calce al volume, e non apposti ciascuno ai margini del ritratto, o sul retro, come sovente avviene nei fogli sciolti di Ottavio. Insomma, tutto sembra indicare che l’album è frutto di un preciso progetto. Già, ma quale? E di chi? Fortunatamente uno degli ultimi fogli del volume riporta una bellissima filigrana, che ci aiuta a far luce sulla data dell’album, consentendo di stabilire una cronologia molto alta per l’assemblaggio. Si tratta di un santo nimbato inginocchiato, recante una croce entro uno scudo. Ora, mi pare di grandissimo interesse notare come la filigrana che affiora sul foglio dell’album della Biblioteca Marucelliana compaia identica sulla carta dove è stampata un’incisione della prima edizione della Galleria Giustiniana. Ci troviamo dunque a Roma intorno al 1630-1631, e nel medesimo ambiente in cui visse e operò Ottavio Leoni, che scomparve proprio nel 1630. Intorno a quest’epoca dovrebbe risalire anche il montaggio dei fogli nel volume che raccoglie i disegni di Ottavio, che non può appartenere a un momento né troppo precedente né troppo successivo. L’assemblaggio dovrebbe essere avvenuto dunque quando l’artista era ancora in vita, o comunque nell’arco di circa quindici anni dalla sua scomparsa; un’indicazione di primaria importanza poiché, se anche non possiamo stabilire con certezza che l’album venne messo insieme dallo stesso Leoni, mi pare evidente che il progetto vada assegnato ad una persona profondamente legata ad Ottavio. Chi altri avrebbe avuto interesse a sottolineare così smaccatamente la paternità dei disegni da mettere ben due Autoritratti dell’artista ad apertura e chiusura del volume? La fama e il consenso riscosso dal Leoni nella Roma del tempo dovevano certamente essere internazionali, come testimoniano le ammirate parole del suo biografo Giovanni Baglione (1642), tuttavia è difficile credere che un qualsiasi collezionista avrebbe sottolineato il nome del Padovanino con tanta enfasi da mettere in rapporto i Virtuosi con la biografia del pittore, come sembra indicare la citata legenda dell’indice, non abbiamo infatti nessun dato che lasci ipotizzare che le opere di Ottavio, belle o brutte, si acquistassero all’epoca a gran prezzo per il solo fatto di essere da lui eseguite, come invece era accaduto, per lo meno ad apertura di secolo, per l’amico Caravaggio. Sembra invece più plausibile che il progetto dell’album risalisse allo stesso Padovanino, e che, se anche non fu lui a realizzarlo in prima persona, alla sua morte passasse nelle mani del figlio Ippolito al quale l’artista aveva lasciato i «rami intagliati dei Pittori e Poeti». Una volta chiarito l’ideatore del progetto, e cioè lo stesso Leoni, è bene tentare di comprendere la sua destinazione. Una verifica con le quaranta lastre incise da Ottavio, oggi conservate alla Calcografia Nazionale, può essere utile per capire se fosse prevista la pubblicazione a stampa del volume. Di fatto solo alcuni dei 27 personaggi raccolti nell’album conoscono una traduzione grafica e, peraltro, come ha giustamente rilevato la Fig. 2 – Ottavio Leoni, Ritratto Sani, i disegni non possono considerarsi matrici esatte delle incisioni, dal di Michelangelo Merisi da Caravaggio (Firenze, Biblioteca momento che queste non risultano in controparte, stampe e disegni furoMarucelliana) no dunque realizzati autonomamente. Confrontando disegni e incisioni, 56 ci si rende conto che le assenze pesano tanto quanto le presenze. Si avverte ad esempio la mancanza della traduzione a stampa del Ritratto di Michelangelo Merisi da Caravaggio, che costituisce uno dei pezzi più belli dei disegni della Marucelliana. Allo stesso modo sembra inspiegabile l’assenza di Annibale e Agostino Carracci. Ma tra i pittori, Caravaggio e Annibale non sono gli unici a mancare l’appuntamento con la stampa: accanto all’omissione di questi grandi personaggi, si registra l’assenza dei ritratti dei pittori che, quantomeno ai nostri occhi, appaiono più strampalati nel contesto dei Virtuosi di primo Seicento: i malnoti Girolamo Nanni, Domenico Ambrosino. Alla stessa stregua anche tra i matematici si registra l’assenza di Cristoforo Scheiner, il cui astro tramontò velocemente. Stando a queste considerazioni, con il senno di poi, e la critica di Giovan Battista Bellori in testa, la scelta dei ritratti dei pittori destinati alla stampa, e dunque ad una maggior divulgazione, sembrerebbe criticamente più canonica di quanto non appaia l’album della Marucelliana, sicché ad oggi non mi sembra che si possa pacificamente affermare che si avesse in mente una pubblicazione del volume in quanto tale, a meno di non prendere alla lettera il Baglione che narra della prematura morte di Ottavio, intossicato dai materiali utilizzati per creare le lastre incise, e dunque immaginare il lavoro interrotto sul più bello. Dal punto di vista della storia della critica dell’arte, la scelta dei Virtuosi appare, come si è accennato, a dir poco singolare. Se Annibale e Agostino Carracci, seguiti da Caravaggio, dal Cavalier d’Arpino e da Giovanni Baglione, collegano immediatamente il pensiero di chi ha composto questi fogli a quello di Giovan Battista Agucchi, di Vincenzo Giustiniani e di Giulio Mancini, dunque a un’egemonia culturale e figurativa che godeva di un riconoscimento universale. Se Antonio Tempesta e Cristoforo Roncalli rappresentavano due dei pittori più prolifici dell’Urbe nei primi decenni del Seicento, ci si chiede cosa facciano i poco noti Gerolamo Nanni e il semisconosciuto Domenico Ambrosini tra cotanto senno. D’altra parte i Ritratti di Simon Vouet e di Guercino raccontano di un mondo che non è più lo stesso di quello di Caravaggio e dei suoi patroni, cui fanno invece riferimento i pittori elencati. Analizzando poi gli scultori – il padre di Ottavio, Ludovico Leoni, un giovanissimo Gian Lorenzo Bernini e Marcello Provenzale, intrinseco di Ottavio, tanto da essere nominato suo esecutore testamentario – è chiaro che siamo al cospetto di un album di famiglia. Questi fogli sembrano dunque raccontare il mondo di Ottavio, e le scelte culturali che dovevano governarlo. Spostando l’attenzione sulle date, questo testo viene a collocarsi agli esordi della critica romana del Seicento, e costituisce un punto di vista straordinariamente autonomo rispetto a quella che oggi ci aspetteremmo come la scena artistica romana dell’epoca di Ottavio. Invano si cerca infatti una posizione critica tra quelle della Roma seicentesca a cui il testo possa far riferimento. Va innanzitutto tenuto presente che, se si tiene per buono il 1615-1645 come intervallo cronologico per l’assemblaggio dei disegni, i testi relativi alla storia delle arti figurative a Roma erano davvero limitati. A stampa era apparso soltanto la Pittura trionfante del Gigli, che comunque non uscì a Roma, ma a Venezia. Il Trattato dell’Agucchi non vide mai la luce, la Lettera sulla pittura di Vincenzo Giustiniani fu pubblicata per la prima volta nel 1675 e le Considerazioni sulla pittura di Giulio Mancini, vennero date alle stampe soltanto a metà del Novecento. L’unico progetto critico in grande scala, dun3 – Ottavio Leoni, que, era rappresentato dalle Vite del Baglione, composte intorno al 1635, che Fig. Autoritratto di spalle (Firenze, uscirono a Roma nel 1642. In ogni caso l’eclettismo delle biografie baglionesche Biblioteca Marucelliana) 57 non sembra rispecchiare il carattere gerarchico rappresentato da questo fiore di Virtuosi, dietro il quale si cela un pensiero molto personale, maturato all’ombra di una cultura di marca strettamente accademica. L’album sembra comunque non poter rappresentare gli interessi di nessuna delle maggiori istituzioni culturali della Roma del tempo. Scandagliando il terreno, tuttavia, per cercare una possibile chiave di volta della vicenda, un personaggio è parso particolarmente enigmatico e insolito. Si tratta del gesuita tedesco Christoph Scheiner (1573-1650), matematico e astronomo legato al Collegio Romano, dove fu docente dal 1624 al 1633. Sotto lo pseudonimo di “Apelles post tabulam”, scrisse tre lettere sulle macchie solari, che aveva osservato nel marzo del 1610. Nell’inverno del 1611 Scheiner fece giungere la prima delle tre lettere a Galileo chiedendo il parere dell’astronomo pisano. Il matematico toscano pubblicò le sue tre lettere sull’argomento a Roma nel 1613, a cura dell’Accademia dei Lincei, di cui nel 1611 era entrato a fare parte. Fino a questo momento i rapporti tra i due matematici erano improntati a grande stima, soltanto nel 1623 Galileo ebbe a lamentarsi di chi si era appropriato della scoperta dei fenomeni celesti. Nonostante probabilmente lo scienziato pisano non alludesse a Scheiner, il gesuita, in quel momento a Roma, docente nel Collegio Romano, se ne ebbe a male, schierandosi contro l’astronomo nella Rosa Ursina del 1630. La vicenda non fu certamente di aiuto al Galilei, contro le cui dottrine iniziava tre anni dopo il processo del Santo Uffizio. Dal nostro punto di vista, la Rosa Ursina costituisce un documento interessantissimo per aprire uno spiraglio sulle frequentazioni di Ottavio Leoni. Il trattato scientifico, come recita il titolo stesso e dichiara apertamente la dedica, risulta una smaccata celebrazione di un personaggio eclettico e singolare, Paolo Giordano Orsini II duca di Bracciano (1591-1646). Amico di letterati, Giovan Battista Marino e Tommaso Stigliani gli dedicarono versi, egli stesso fu autore di liriche. Amatore d’arte, tra i suoi favoriti figura Simon Vouet, con il quale entrò anche in rapporto epistolare nel 1621, quando l’artista si trovava a Genova, il duca di Bracciano si dilettava egli stesso di pittura. Di grande interesse è notare come dall’Isola d’Elba il 2 luglio 1621, l’Orsini chieda a Roma di inviargli «carta turchina per disegnare e carta grossa bianca e del gesso […] un’ampolla di vernice et uno fiaschetto di olio di noce». Questi strumenti evocano immediatamente i ritratti di Ottavio Leoni, che in effetti ritrasse ripetutamente il duca di Bracciano. Fa parte del gruppo questo notevole foglio, conservato all’Accademia Colombaria, immagine provocatoria, bizzarra, al limite della caricatura, certamente nata da un pensiero preciso, per la quale la Sani ha ipotizzato addirittura un’ideazione comune tra Paolo Giordano e Ottavio. Sembra dunque quello dell’Orsini il mondo che maggiormente il volume vuole illustrare. La storia sin qui narrata – parte del più ampio saggio “Virtuosi illustri del suo tempo”: novità e precisazioni per Caravaggio, Ottavio Leoni e i volti della Roma caravaggesca, in Caravaggio. Mecenati e pittori, a cura di M.C. Terzaghi, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo 2010, pp. 15-57 – apre così a nuove ricerche nella direzione della corte degli Orsini. Maria Cristina Terzaghi BIBLIOGRAFIA R. LONGHI, Volti della Roma caravaggesca, in «Paragone», 21, 1951, pp. 35-39. H.W. KRUFT, Ein Album mit Porträtzeichenungen Ottavio Leonis, in «Storia dell’Arte», 4, 1969, pp. 447-458. B. SANI, La fatica virtuosa di Ottavio Leoni, Torino 2005. M.C. TERZAGHI, “Virtuosi illustri del suo tempo”. Novità e precisazioni per Ottavio Leoni, Caravaggio e i volti della Roma Caravaggesca, in Caravaggio. Mecenati e Pittori, a cura di M.C. Terzaghi, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo 2010, pp. 15-57. 58 Pittura del Seicento e del Settecento. Ricerche in Umbria: l’antica diocesi di Perugia Il programma di ricerca che sono stata incaricata di svolgere nel corso dell’anno accademico 20102011 è finalizzato alla prosecuzione degli studi sulla pittura in Umbria del Seicento e del Settecento, di cui sono stati pubblicati 4 volumi, rispettivamente nel 1976, nel 1980, nel 2000 e nel 2006, e il catalogo della mostra Pittura del Seicento. Ricerche in Umbria, nel 1989. In questi volumi sono confluiti i risultati delle ricerche condotte dal gruppo di studiosi composto da Bruno Toscano, Liliana Barroero, Vittorio Casale, Giorgio Falcidia, Fiorella Pansecchi, Giovanna Sapori, cui si sono aggiunte in un secondo momento Paola Caretta, Laura Carsillo e la sottoscritta. L’area geografica oggetto della mia ricerca comprende la città di Perugia e il territorio dell’antica diocesi. Considerate l’alta densità delle presenze storico-artistiche e la rilevante estensione del territorio, è stato necessario suddividere il lavoro in due parti: la prima, ancora in corso, interessa la città di Perugia; la seconda, solo in parte avviata, il resto del territorio dell’antica diocesi. Il Dipartimento al fine di agevolare le ricerche ha voluto avvalersi della collaborazione del Prof. Francesco Federico Mancini, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, il quale ha individuato in Francesco Piagnani, dottorando presso il medesimo istituto, il collaboratore al progetto. Il gruppo di lavoro quindi è formato da Barroero, Metelli, Sapori, Toscano dell’Università Roma Tre, da Mancini, Piagnani dell’Università di Perugia e dallo studioso Duccio Marignoli. Il primo obiettivo che mi sono posta è stato quello di procedere alla ricognizione sistematica di tutte le testimonianze pittoriche da ascrivere ai due secoli in esame, attraverso un’indagine topografica il più possibile capillare secondo il metodo già ampiamente definito fin dall’inizio e praticato nel corso delle ricerche precedenti. A tal fine, preso atto della composita realtà geografica e storico-amministrativa del territorio, è stato necessario effettuare una serie di verifiche preliminari alla ricerca sul Fig. 1 – Carta della diocesi di Perugia a partire dal 1600 campo. Questa fase si è tradotta innanzitutto nella consultazione delle carte militari IGM (scala 1:25 000); quindi nel reperimento di carte del XVII e XVIII secolo relative all’intero territorio. Le carte sono state utilizzate come strumento di supporto nella fase di verifica dei confini dell’antica diocesi eseguita sia su base bibliografica e documentale sia con il parere di professori del Dipartimento di Storia dell’Università di Perugia. Dagli studi si evince un dato fondamentale ai fini della ricostruzione delle dinamiche legate ai confini diocesani, e cioè che nel 1600 con la creazione della diocesi di Città della Pieve, voluta da Clemente VIII, a Perugia sarà sottratta una significativa porzione di territorio sul versante occidentale, comprendente località come Castiglione del Lago (fig. 1). L’esame delle carte antiche, e degli studi relativi, ha consentito anche di stilare un elenco completo dei toponimi delle località del territorio oggetto della mia ricerca, il cui totale si approssima alle 220 unità. Le località sono distribuite in un territorio suddiviso in 15 comuni (Perugia, Castiglione del Lago, Città di Castello, Corciano, Deruta, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Panicale, 59 Passignano, Piegaro, Torgiano, Tuoro, Umbertide, Valfabbrica). Contestualmente alla definizione dei confini, ho proceduto al reperimento della bibliografia e della documentazione esistente relativa alla storia del territorio (MANCINI 1993). Il progetto è stato presentato quindi alla direzione dell’Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve e alla direzione della Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici dell’Umbria, con lo scopo di assicurare al gruppo di ricerca la massima collaborazione e disponibilità da parte delle istituzioni responsabili della gestione, tutela e conservazione del patrimonio artistico del capoluogo e dei territori della provincia. I rapporti con queste istituzioni hanno consentito di acquisire una buona parte del materiale catalografico concernente i beni artistici di loro pertinenza. Partendo da questo materiale ho potuto redigere un elenco dei luoghi (chiese, palazzi, musei) e preparare una prima bozza di scheda corredata da fotografia delle opere documentate nei singoli edifici, in vista della fase successiva, quella della ricerca sul campo. Questo lavoro ha interessato anche il territorio della diocesi. Allo stato attuale delle ricerche (maggio 2011), considerando che l’opera di ricognizione è ancora in corso, il numero dei complessi ecclesiastici in città ammonta ad un totale di 40 unità. Circa 300 sono i reperti ivi conservati (di cui è in corso la schedatura). Da una stima approssimativa, nel territorio risulta un totale di 82 edifici ecclesiastici recanti 300 reperti. Mentre il numero dei palazzi e dei musei perugini si aggira intorno alle 30 unità. Per il calcolo dei reperti, si tenga conto che la decorazione murale o su tela costituente un insieme è stata computata come unità. Dal materiale bibliografico consultato è emerso che seppur divenuta città di provincia dello Stato ecclesiastico, Perugia nel Seicento riuscirà a mantenere come centro culturale dello Stato della Chiesa un ruolo decisivo, dovuto alla presenza della Università e delle accademie. Questo fenomeno si protrarrà per tutto il XVIII secolo producendo conseguenze anche in ambito strettamente artistico (SAPORI 2001). Il caso di Perugia, infatti, è tra quelli in cui si registra la maggiore apertura verso l’esterno, rispetto al resto dell’Umbria, e una più spiccata inclinazione alla riflessione autonoma e vivace. In città arrivano opere o artisti dai centri maggiori – come Roma, Bologna, Urbino, Firenze, Siena – e gli artisti locali recepiscono queste importazioni o tali presenze anche come stimolo per compiere la propria formazione fuori dai confini provinciali (TOSCANO 1989). Sintetizzando, si possono individuare due temi conduttori validi sia per il XVII che per il XVIII secolo: quello relativo alla politica delle importazioni di opere d’arte e alla presenza di artisti forestieri in città; e quello concernente la formazione degli artisti perugini nei centri maggiori fuori regione. In merito al primo va registrato, per esempio, l’arrivo delle tele di Federico Barocci, la cui opera eserciterà un’influenza notevole su pittori perugini di fine XVI e inizio XVII secolo. Guarderanno l’opera dell’urbinate artisti come Felice Pellegrini, che nel 1593 lascia una copia della pala di Senigallia nell’Oratorio del Crocifisso, e Vincenzo Fig. 2 – Giulio Cesare Angeli, S. Filippo si congeda da S. Giacomo, Pellegrini, fratello di Felice. Perugia, Oratorio di Sant’Agostino Circa la tematica relativa agli artisti forestieri in città si segnala la 60 presenza dei senesi Francesco Vanni e Ventura Salimbeni, che produrrà un forte impatto per esempio su pittori come Simeone Ciburri, Benedetto Bandiera e Matteuccio Salvucci. Più tardi va ricordato l’arrivo delle tele di Guido Reni nella Chiesa Nuova, di Lanfranco in San Domenico e di Pietro da Cortona in San Filippo. Tra i pittori di tendenza classicista inviano pale d’altare Giovan Francesco Romanelli e Andrea Sacchi a San Filippo e Giacinto Gimignani e François Perrier a San Pietro. Anche negli ultimi tre decenni del secolo si registrano apporti di artisti forestieri operosi in città. Tra questi spicca il nome del genovese Giovanni Andrea Carlone, dalla cui pittura trarrà ispirazione Giacinto Boccanera. Relativamente alla seconda tendenza, che concerne i soggiorni di studio di perugini nei centri maggiori, si segnalano i casi in cui si evidenzia un particolare interesse per i fiorentini residenti a Roma o attratti dalle novità romane. Il novero dei perugini è composto da Giulio Cesare Angeli, dal suo allievo Stefano Amadei, da Anton Maria Fabrizi e da Giovan Francesco Bassotti (fig. 2). In questo ambito rientrano anche i casi di pittori cortoneschi formatisi a Roma, tra cui compare il nome del perugino Paolo Gismondi, o di artisti operativi soprattutto fuori dai confini regionali, come Domenico Cerrini e Luigi Scaramuccia, figlio di Giovanni Antonio. Nel XVIII secolo, l’unico centro che in Umbria conserva ancora una qualche vitalità è Perugia, dove l’esistenza dell’Accademia del Disegno e di una personalità eclettica come quella di Baldassarre Orsini, pittore, architetto e scrittore, favoriscono un vivace dibattito culturale e una notevole fioritura artistica (CASALE 1990). La presenza dell’Accademia contribuisce inoltre a limitare il fenomeno delle importazioni: tra gli accademici-pittori molto attivi in città e nel territorio si contano Giacinto Boccanera, Mattia Batini e Giuseppe Laudati. Gli indiscussi protagonisti del panorama artistico fino oltre la metà del secolo sono i locali Pietro Carattoli (quadraturista) e Francesco Appiani, perugino il primo, anconetano, ma residente a Perugia, il secondo, impegnati in importanti progetti decorativi sia in edifici ecclesiastici che gentilizi. Sullo scorcio del secolo, anche gli interventi nel Duomo vedono all’opera soprattutto artisti locali. Tra questi figura Vincenzo Monotti, accademico e allievo di Appiani, e Marcello Leopardi, di origine marchigiana ma attivo principalmente a Perugia. Tra le importazioni si registrano le tele di Francesco Trevisani a San Filippo, di Stefano Pozzi e di Pierre Subleyras a Montemorcino Nuovo, e la pala di Gaetano Lapis nell’Oratorio dei Santi Bernardino e Andrea. Mentre tra gli artisti forestieri presenti in loco si annoverano i marchigiani Francesco Mancini e il suo allievo Sebastiano Ceccarini. Dai sopralluoghi risulta che alcuni ambienti versano in pessime condizioni di conservazione, come ad esempio la sagrestia dell’Oratorio di Sant’Agostino decorata da Appiani e Carattoli, le cui tele raffiguranti le storie di S. Agostino in monocromo sono oggi provvisoriamente sistemate sul pavimento. La ricerca sul campo ha inoltre consentito di recuperare dipinti sistemati in luoghi non idonei alla loro conservazione, per esempio in San Simone al Carmine, o di individuare opere dalla iconografia poco frequente come nel Convento di San Domenico, dove è conservata la tela raffigurante S. Giacinto in fuga da Kiev con la statua della Madonna. In conclusione, ricordo che l’obiettivo finale della ricerca è quello di precisare, attraverso i dovuti approfondimenti di carattere storico, sociale, economico e geomorfologico, le dinamiche legate alla distribuzione delle testimonianze d’arte in rapporto all’assetto geopolitico, dinamiche che una volta 61 ultimate le indagini dovrebbero contribuire a restituire un quadro più composito di quanto oggi non risulti dagli studi delle diverse identità culturali della città e del suo territorio. Cecilia Metelli BIBLIOGRAFIA V. CASALE, La pittura del Settecento in Umbria, in La pittura in Italia. Il Settecento, a cura di G. Briganti, vol. II, Milano 1990, pp. 351-370. Perugia, a cura di M. Montella, con testi di G. Chiuini, F.F. Mancini, S. Stopponi, Perugia 1993. G. SAPORI, Collezioni di centro, collezionisti di periferia, in Geografia del collezionismo. Italia e Francia tra il XVI e il XVIII secolo. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuliano Briganti, a cura di O. Bonfait, M. Hochmann, L. Spezzaferro, B. Toscano, Roma 2001, pp. 41-59. B. TOSCANO, La pittura del Seicento in Umbria, in La pittura in Italia. Il Seicento, vol. I, Milano 1989, pp. 361-381. Per una storia del mercato dell’arte. Da Roma all’Europa e al Nuovo Mondo, tra la seconda metà del secolo XVIII e la fine del XIX Gli atti del convegno (giugno 2008) hanno rappresentato, come ho avuto modi di informare in precedenza (Quinterni 4), la conclusione della ricerca cofinanziata nell’ambito dei “Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale” (PRIN) dedicata alla pittura di storia nell’Italia preunitaria (Titolo del volume: La pittura di storia in Italia. 1785-1870. Ricerche, quesiti, proposte, a cura di G. Capitelli e C. Mazzarelli, Cinisello Balsamo, 2008; premessa di chi scrive alle pp. 9-11). Nella stessa sede comunicavo di aver concentrato le ulteriori risorse finanziarie ottenute (un secondo cofinanziamento PRIN i cui fondi sono stati resi disponibili nel febbraio 2010) all’approfondimento e al riordino degli studi sul Settecento e sul primo Ottocento iniziati tempo addietro con Stefano Susinno, coinvolgendo anche in questo caso nell’équipe studiosi che hanno condiviso quei percorsi e alcuni dottori di ricerca e ricercatori formatisi presso il Dipartimento e che nel nostro Dipartimento e/o nella scuola dottorale hanno trovato un costante punto di riferimento: Serenella Rolfi, Carla Mazzarelli, Stefano Grandesso, Alessandra Imbellone... La prima ricerca PRIN scaturiva infatti da uno dei temi affrontati nella mostra Maestà di Roma. Da Napoleone all’Unità (Roma 2003), dove la pittura di storia veniva individuata come uno degli ambiti che ancora necessitavano di approfondimenti. Anche la seconda ricerca, quella che qui si espone sinteticamente, ha origine da quell’esperienza (uno degli ultimi capitoli del catalogo, a cura di Giovanna Capitelli e Stefano Grandesso, porta il titolo adottato per il programma della ricerca, “Roma fuori di Roma”) e non a caso vi partecipano numerosi collaboratori già coinvolti nell’esposizione romana e nel relativo catalogo, e successivamente nella ricerca e nel volume dedicati alla pittura di storia. Come nel caso precedente, questo tema deve molto alle intuizioni di Stefano Susinno, la cui vicenda umana di docente e di studioso si è conclusa presso il nostro dipartimento, e del quale oggi si riconosce finalmente il contributo determinante per la riconsiderazione del ruolo di Roma dal Settecento all’Unità: come ha scritto Marc Fumaroli, la città, “intimidatrice depositaria dell’Antico e museo d’Europa” fu anche centro esportatore di un modello culturale “moderno” e non soltanto di reperti di scavo e di copie. Il ruolo di Roma nella cultura illuministica era già stato rivendicato da André Chastel, ma quella sua intuizione era rimasta praticamente senza seguito. A questo argomento ho dedicato un volume apparso di recente presso Einaudi, Le Arti e i Lumi (2011) alla cui elaborazione accennavo in chiusura di Quaderni 4. Va detto che ancor più misconosciuta restava – e resta tuttora – la funzione di conservazione della tradizione della Roma ottocentesca e della conseguente 62 esportazione di un suo specifico modello nell’ambito delle arti figurative; funzione messa in ombra dagli studi dedicati alle più innovative correnti che nel secolo XIX avevano investito l’Europa e toccato – seppur marginalmente – anche l’Italia. «Romae omnia venalia esse», a Roma ogni cosa è in vendita, è il motto giugurtino non privo di accenti moralistici con cui il noto archeologo tedesco Michaelis commenta il mercato artistico romano, nel 1882, in chiusura al suo formidabile repertorio di tutte le antichità approdate nel corso del secolo oltre Manica. Il fervore dei negozianti che spogliano degli antichi marmi palazzi e sale della città eterna provoca negli intellettuali ottocenteschi reazioni accesissime. Leopoldo Cicognara e Giovanni Gherardo de Rossi, che sono spettatori di tale fenomeno, non tarderanno a definire gli operatori di questo mercato “uccelli di rapina” (1826). Referti come quelli qui menzionati aprono uno spiraglio sul mondo del commercio artistico romano tra la metà del Settecento e l’Ottocento come particolarmente attivo e in fermento. Molte anime tuttavia animano questo mondo. Il mercato di opere antiche continua ad essere affiancato da quello di opere contemporanee, e l’attività dei suoi protagonisti – artisti, mercanti, periti, corrispondenti stranieri – costituisce un aspetto particolarmente rilevante del sistema delle arti della Roma ottocentesca che appare, specialmente nel suo complesso, ancora tutto da indagare. Se infatti quanto al commercio di arte antica, il processo di smembramento del patrimonio artistico della nobiltà romana è stato oggetto di numerose indagini particolari che hanno di volta in volta ricostruito le singole alienazioni delle collezioni, molto invece resta da fare per mettere in rete queste informazioni e sopratutto per collegarle con quanto è noto, o con quanto ancora oggi è solo parzialmente sondato, del mercato della produzione artistica contemporanea e della sua organizzazione. La ricerca da poco avviata interessa, nel suo complesso, i secoli XVIII e XIX, sottolineando le linee comuni e sviscerando i nodi cruciali di svolta che separano la settecentesca cultura del mercato dei Grand-tourist da quella dei nuovi acquirenti ottocenteschi giungendo così ad affrontare il campo di studi fino al 1870, anno che segna un profondo cambiamento nella condizione della città eterna, che diviene allora Capitale dello stato italiano. Fulcro della ricerca è la disamina dell’industria artistica (nei suoi momenti di produzione e di esportazione) non solo come motore di attività economiche che esercitano un’ effettiva incidenza sui mutamenti del gusto, bensì anche sulle alterne fortune e sfortune dei modelli accademici, sull’incidenza di tali modelli normativi nella creazione di collezioni private e nell’istituzione di musei pubblici, in Italia, in Europa e nelle nascenti realtà collezionistiche, pubbliche e private, del Nuovo Mondo. Come si è già detto, gli studiosi coinvolti sono da tempo impegnati in questo lavoro e hanno al loro attivo specifici contributi. La collaborazione ormai pluriennale che si è stabilita in questo campo tra di loro agevola la discussione e il confronto, a tutto vantaggio della concretezza dei risultati. Il mercato artistico, la produzione ad esso legata, le migrazioni di opere e di protagonisti, gli acquisti privati e le iniziative “per la pubblica utilità” sono esaminati con uno scavo approfondito, condotto secondo una prospettiva di maggior durata rispetto al taglio degli studi finora condotti. Si tratta infatti di raccogliere, analizzare e inserire in un contesto storicamente e metodologicamente fondato le tematiche indicate nel titolo del programma, senza partizioni regionali o nazionali. Ciò non comporta la pericolosa, e storicamente deviante, omologazione nel considerare le differenti aree politico-economiche dell’Italia pre-unitaria o dell’Europa delle grandi capitali. Il ruolo svolto da Roma (e dall’Italia in generale) nella “diffusione dei modelli” e l’influsso dello “stile romano” in rapporto, ad esempio, alla Francia, all’Inghilterra e alle nazioni tedesche; l’importanza di Venezia fino alla fine della Repubblica e oltre; il ruolo di centri quali Firenze, Napoli e Bologna e gli stati preunitari ecc.; i contatti (e i contrasti) tra le Accademie italiane e straniere sono elementi da tener presenti nella ricostruzione delle 63 dinamiche dei rapporti tra le capitali europee dell’arte. Di conseguenza, i passaggi individuati sono i seguenti, qui schematicamente indicati per esigenze di chiarezza e di brevità: - Anagrafe delle esportazioni di opere d’arte antiche e contemporanee per giungere ad un quadro quantitativo attraverso lo spoglio delle fonti a stampa, con particolare attenzione ai primi periodici specializzati, alla letteratura teorica, odeporica e periegetica - Anagrafe dei mercanti, degli agenti e dei periti d’arte attivi sul mercato - Regesto della produzione artistica contemporanea prodotta a Roma e nei centri italiani per il mercato straniero - Regesto delle specializzazioni, dagli scultori agli scalpellini, dai copisti ai “praticanti” del restauro d’integrazione, dai pittori ai miniatori e agli incisori - Analisi dei principali mercati e dei principali intermediari, tenendo sempre ben presente l’intero arco del collezionismo privato, nonché della costituzione dei pubblici musei stranieri. Si aspira così a mettere in luce tutti quegli elementi che, pur se scarsamente presenti a una certa storiografia artistica, risultano determinanti nel condizionare nel tempo – dai primi editti a tutela delle città, delle collezioni e delle singole opere ai decenni immediatamente successivi all’Unità d’Italia – la politica nei confronti del “Cultural Heritage” nell’Europa moderna. Va detto che anche per i ricercatori stranieri la produzione scientifica italiana su questi temi è imprescindibile punto di riferimento. Per questo motivo è stata avviata una stretta collaborazione tra studiosi italiani, inglesi, americani, tedeschi e francesi. Più episodica per ora quella con gli studiosi spagnoli e russi, comunque in aumento grazie anche al maggiore accesso alle collezioni e agli archivi, e anch’essa strettamente collegata con la ricerca italiana. Se un limite può essere individuato nello “stato dell’arte”, questo è dato infatti dalla settorialità e dalla frammentarietà che nonostante tutto ancora lo caratterizzano. Talvolta inoltre il carattere monotematico delle singole indagini fin qui compiute disegna una geografia del mercato d’arte ancora frammentaria, che necessità di essere precisata. Per quanto riguarda il gruppo da me coordinato, la scelta del campo d’azione è caduta sull’esame del fenomeno del mercato artistico nel secolo XVIII, anche a motivo degli approfondimenti condotti in questo ambito in occasione di recenti iniziative, mentre per l’età di Restaurazione questo preciso arco cronologico è affidato ad altri studiosi, coordinati da Giovanna Capitelli che studia ormai da diversi anni i decenni successivi alla prima restaurazione fino all’Unità d’Italia. Lo stato frammentario dell’arte impone che i dati ora disponibili in ordine sparso siano ricondotti all’interno di un sistema informatizzato che verrà completato con i risultati prodotti dalle singole unità. Si mira a una indicizzazione secondo più categorie e a un riordino secondo i parametri ormai concordemente accettati in campo nazionale e internazionale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Getty Research Database, Art Past ecc.). Naturalmente resta irrinunciabile il momento dell’analisi e dell’interpretazione – tenendo conto comunque del fatto che qui si propone una prima tranche di una più ampia ricerca – e che si tradurrà in un convegno nei giorni 13-15 dicembre 2011 alla British School at Rome, seguito da atti la cui pubblicazione è prevista per l’estate 2012. Ulteriore passaggio sarà un progetto di raggio europeo che coinvolga organicamente le Università e le Istituzioni culturali presso i quali sono attivi alcuni tra gli interlocutori privilegiati già parzialmente coinvolti in questo progetto. Con molti di loro sono già avviate da tempo forme di collaborazione che sarà di grande utilità trasformare in un rapporto di ricerca formalizzato. Nel convegno del 13-15 dicembre, cui parteciperanno studiosi di circa venti istituzioni italiane e straniere, i temi individuati per questo primo rendiconto complessivo affrontano argomenti chiave quali La 64 circolazione delle opere: fonti, strumenti e casi di studio; Il mercato artistico: intermediari e acquirenti; La scultura: ricezione, fortuna e diffusione; Modelli di gusto: dall’architettura alle arti applicate; La tradizione aulica della pittura storica e sacra; La scuola di Roma per concludersi con l’esame delle diverse realtà collezionistiche e accademiche che anche nel nuovo mondo individuano nel modello romano il proprio riferimento. Liliana Barroero BIBLIOGRAFIA Intellettuali ed eruditi tra Roma e Firenze alla fine del Settecento (Ricerche di storia dell’arte 84.2004), a cura di L. Barroero, O. Rossi Pinelli, Roma 2005. La Città degli artisti nell’età di Pio VI (Roma Moderna e Contemporanea, X, 1-2), a cura di L. Barroero, S. Susino, Roma 2002. La pittura di storia in Italia. 1785-1870. Ricerche, quesiti, proposte, a cura di G. Capitelli, C. Mazzarelli, Cinisello Balsamo 2008. Il dibattito romano sulla riforma dell’insegnamento accademico negli anni Ottanta del XVIII secolo e Le Accademie d’arte di Nikolaus Pevsner (1940) Frammenti intorno ad un modello di accademia mediato tra la storia dell’insegnamento accademico e gli artisti. Una voce critica in difesa del modello “romano”/“italiano”. Alessandro Verri lettera scritta da Roma il 26 gennaio 1780 al fratello Pietro a Milano: «Ti ho scritto il senso che mi fa il Winckelmann. Io non reggo a quella lettura. Nelle scienze esatte l’uomo può arditamente insegnare: la cosa è così; nelle belle arti non vi è dimostrazione, si tratta di probabilità e di sentimenti; può darsi un disparere fra due uomini colti e sensibili, le opinioni sono da annunziarsi con grazia, con dubitazione, e con modestia. I Tedeschi pretendono di conformare al sistema militare le belle arti; il sig.r Heyne che non ho l’onore di conoscere si pone a comandar l’esercito; io che non mi sento d’essere una recluta, e che pretendo di ragionare liberamente trovo una ribellione ostinata verso quel Colonnello Heyne; non mi quadra il Reggimento Winckelmann che decide che Michel Angelo era secco, e mi sento voglia di voltare il fucile verso questi pesanti e stivalati maestri che deturpano un campo coltivato sinora dagli Italiani». Corollario della lettera di Verri è il dibattito su estratti di libri funzionali ad orientare il sistema delle arti nel suo complesso. Le Opere di Mengs, pittore consacrato dalla letteraria Accademia dell’Arcadia nel 1780, auspice Giovanni Cristoforo Amaduzzi, autore del Discorso del fine ed utilità delle Accademie (1777), vennero recensite nel 1781 sulle «Efemeridi letterarie». A fornirne un estratto critico fu Onorato Fig. 1 – Michael Köck, Riunione serale dell’Accademia della Caetani chiamando in causa Algarotti e la riforma Pace, 1797, penna, inchiostro bruno, acquerello, rialzi di biacca e tracce di matita su carta, 42,7 × 55,2 cm., Roma, dell’istituto accademico clementino: collezione Apolloni; iscritto e d. sullo scudo di Minerva: «Sopra il ragionamento intorno le belle arti di Accademia della Pace 1797 65 Madrid nel quale si anima lo stabilimento d’un’Accademia, non si può dir altro che ciocchè scrisse il Conte Algarotti al Sig. Crespi, che non è a tali stabilimenti, che si deve la produzione de grandi uomini. Tiziano, Giorgione non sono stati Accademici, e Tintoretto cacciato dalla scuola di Tiziano da se solo divenne quel grandissimo pittore, quale nessuna Accademia ha formato di poi». La posizione pubblicata sulle «Efemeridi letterarie» è alla base delle postille di Tommaso Puccini alle Opere di Mengs, in anni in cui a Firenze, con Ferdinando III si tornava a ragionare sull’istituto accademico. Sappiamo che fu Onorato Caetani a stilare quell’estratto, per sua stessa ammissione in una lettera a Girolamo Tiraboschi, e da Azara che quell’intervento, addebitò al gesuitismo dei suoi oppositori: «Non ve dubbio che il Gesuitismo sia mescolato nella critica del libro di Mengs. So tutte le combricole che fecero per screditarlo, e come cercarono il minchione di Monsignor Gaetani per testa di ferro. Il nome mio incommoda troppo questa razza di gente per perdonarmi di avere fatto qualche poco di bene». Il Ragionamento su l’Accademia delle Belle Arti di Madrid, inserito da José Nicolás de Azara nelle Opere edite a Parma e Madrid nel 1780, fu nerbo della polemica: «Per Accademia s’intende un’assemblea d’uomini i più esperti nelle Scienze, o nelle Arti coll’oggetto d’investigare la verità, e di trovar regole fisse conducenti sempre al maggior progresso, e alla perfezione. Ella è ben diversa dalla Scuola, in cui gli abili Maestri insegnano gli elementi delle Scienze, o delle Arti». Nel testo si aggiungeva: «un’Accademia di queste Arti non deve comprendere soltanto l’esecuzione, ma deve occuparsi principalmente alla teoria, e alla speculazione delle regole». Azara aveva scritto a Paolo Maria Paciaudi a proposito della curatela di quegli scritti: «Gli altri tutti a bisognato farli in gran parte di nuovo, perchè Mengs scriveva i suoi pensieri quando gliene veniva voglia, sui straci, e sino sulle soprascrite delle lettere, e mai col fine di fare cose per pubblicarsi. Il frammento poi sulle Arti di Spagna, e nell Academia di Madrid sono farina mia intieramente ed ho avute delle buone ragioni per usare di questa superchieria». Le questioni di attribuzione del Ragionamento, come degli altri testi, pure sollevate in quegli anni, in forma anonima (Innocenzo Ansaldi), sono accessorie rispetto al portato operativo di quegli stessi scritti. Fu scontro aperto. Della risposta a Caetani si incaricò il presidente dell’Accademia di Parma, Carlo Gastone della Torre di Rezzonico, in un «arringo» recitato in occasione della distribuzione dei premi nel giugno del 1781. Gesuitismo per Azara, per altri convinta rilettura di Algarotti. In quel contesto riemerge la lettura attualizzante del Saggio sopra l’Accademia di Francia che è in Roma di Francesco Algarotti (1763); sul Saggio, Giovan Battista Giovio scrisse nell’Elogio di Algarotti, contenuto nella prima edizione delle Opere (1784): «sarà sempre un modello per le orazioni in aprimento dei consessi pittorici, ed insieme una difesa dell’onore d’Italia». I modelli “vivi” sparsi per l’Italia per Algarotti forniscono l’elenco positivo delle maniere, escludendo i cataloghi sottrattivi basati sui principi della riforma del gusto e la censura degli abusi; Algarotti vi comprendeva anche gli artisti secondari e le «troppo ornate invenzioni del Longhena, o le fantastiche del Guarini», adatte a «risvegliare gl’ingegni non abbastanza fecondi, o troppo severi»: «In tanta varietà di maniere potrà il giovane appigliarsi a quella, a cui più lo chiamasse il proprio naturale, ovvero comporne una sua saporita e nuova, con che primeggiare forse un giorno anch’egli nel bel campo della pittura. Dal vedere un pittor solo, per quanto egli sia eccellente, ne seguono i medesimi effetti, che dal leggere un sol libro; che in troppo ristretti termini a confinar si viene la fantasia.» Nel 1787 al dibattito si aggiungeva un nuovo titolo con l’Elogio di Pompeo Batoni, pubblicato da Onofrio Boni sulle «Memorie per le belle Arti» (maggio 1787), e poi in volumetto autonomo 66 nel luglio dello stesso anno per i tipi Pagliarini, con dedica al conte di Thurn Valsassina, ministro di Giuseppe II, e comandante del corpo di Guardia di Lepoldo di Toscana. Batoni è un modello di formazione percorribile da Roma, nell’anno di pubblicazione della quarta edizione delle Opere di Mengs curate da Carlo Fea, per i tipi Pagliarini: «E se alla fine di questo secolo abbiamo qualche speranza di rivedere i giorni felici dei Caracci, che ben guardaronsi d’inceppare colla servitù delle regole il gusto dei loro scolari, lasciarono ad ognuno libero il corso là dove il proprio talento chiamavalo, come non pochi valorosi Giovani, che bevono agli stessi fonti del Batoni, ci danno speranza; tutto dovrassi al Genio immortale di questo celebre Pittore, che ancor morto colle opere ne addita il vero cammino dell’Arte.» Il passo su Batoni troverà modo di spiegarsi nel 1792, nella Storia pittorica di Lanzi, dove torna gioco ricordare la sottolineatura sulla riforma dei Carracci che «fu opera non di un’accademia, ma di una casa». La «riforma è andata tanto avanti, che è troppo», scrisse Boni in una delle lettere indirizzate a Leonardo De Vegni sulle «Memorie per le belle Arti» del 1787, concludendo: il «giovine studente sa cosa non deve fare, ma ignora ciò, che dovrebbe fare». Su quella conclusione s’innestava una proposta basata sulle ragioni proprie alle arti figurative, secondo un principio espresso da Diderot: «è forse possibile arrivare a ridurre le condizioni, i caratteri, le passioni, gli organismi diversi, a una semplice questione di regole e di compasso?». Lo spunto pratico offerto da Boni tornava alle Conference dell’accademia francese: «esistevano già delle Accademie di Belle Arti: e della Reale di Pittura, e di Scultura di Parigi esistono le Conferenze stampate nel 1669., fatte per ordine del gran Colbert dagli Artisti più celebri d’allora. Dunque si ragionava anche allora sulle Belle Arti: anzi secondo me, se si ragionava per tutto come in Francia, si ragionava benissimo. Si prendeva per tema della Conferenza un quadro di Raffaelle, del Pussino, o di altro valent’uomo, o una statua antica, e vi si ragionava sopra da quegli Artisti naturalmente con i termini dell’Arte, rilevandone le bellezze, senza il grave tuono Filosofico, che credo certo non usassero, perché capivano che la bellezza ed il gusto nulla hanno che fare colla Filosofia, come altra volta vi dissi coll’autorità di Eustachio Zannotti.» All’inizio degli anni Novanta uno dei redattori delle «Memorie per le belle Arti», Giovanni Gherardo De Rossi, ebbe modo di mettere in pratica quel modello cui Lanzi dedicò spazio nella Storia pittorica della Italia ricordando la fondazione, «simile molto all’Accademia franzese», dell’Accademia di Portogallo, voluta dall’ambasciatore Alexandre de Souza Holstein e diretta da De Rossi a Roma (1791). L’attuazione di quell’idea media una pratica corrente tra gli stessi artisti. Tra i radi documenti figurativi usciti dalle riunioni informali dell’Accademia della Pace riunitasi intorno a Felice Giani, non pochi sono i disegni che traducono in figura quel «convien dire ciò, che l’Arte richiede positivamente di fare», che stava a cuore a Boni nel 1787; in anni più vicini all’articolo di Boni, a quello stesso metodo si uniformò l’organizzazione di una delle accademie indipendenti, frequentate da un allievo del vecchio Batoni, Gottlieb Puhlmann «insieme a un allievo di Batoni, uno della famiglia di Mengs e un pensionante di Lichtenstein», dove «ognuno deve organizzare l’act che va disegnato per tre domeniche». Dalle pagine delle «Memorie per le belle Arti», ci si provò a mediare una soluzione «con i termini dell’Arte», praticata dagli stessi artisti. Rimettere ordine tra gli studi particolari sulle accademie, potrà servire a rivedere il quadro d’insieme del vecchio saggio di Pevsner (1940) sul “secolo delle accademie” imperniato sull’opposizione tra i “programmi d’istruzione” – i «legami che unirono il Winckelmann ai nuovi istituti» – e il motore 67 “mercantile” della riforma istituzionale; dall’altra sull’inconciliabilità dell’antiaccademismo degli artisti maturato nel XIX secolo, per Pevsner imperniato sul modello di Carstens che da Roma tagliò i ponti con l’accademia di Berlino, e delle posizioni “élitarie” dello Sturm und Drang e dell’enciclopedismo francese (PEVSNER 1982: 166, 168, 211). Serenella Rolfi BIBLIOGRAFIA F. ALGAROTTI, Saggio sopra l’Accademia di Francia che è in Roma, Livorno 1763. J.N. DE AZARA, Ragionamento su l’Accademia delle Belle Arti di Madrid, in Opere di Antonio Raffaello Mengs, vol. I, Parma 1780. O. CAETANI, Titolo del saggio?, in «Efemeridi Letterarie», XI (17 marzo 1781), pp. 87-88. G.B. GIOVIO, Elogio di Francesco Algarotti, in Opere, vol. X, Cremona 1784. O. BONI, Elogio di Pompeo Girolamo Batoni, in «Memorie per le belle Arti», III (novembre 1787), p. CCXLIX. O. BONI, Architettura. Seguono le Lettere sopra varj argomenti di Architettua. Lettera III. Sull’autorità degli esempj, in «Memorie per le belle Arti», III (maggio 1787), p. CVII ss. C.G. DELLA TORRE DI REZZONICO, Opere, raccolte e pubblicate da Francesco Mocchetti, vol. X, Como 1830, pp. 94-95. G. CAVAZZUTTI, Tra eruditi e giornalisti del secolo XVIII (G. Tiraboschi e il «nuovo Giornale de’ Letterati»), in «Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi», VII/8 (1924), pp. 31-134. Carteggio di Pietro e Alessandro Verri dal 1 gennaio 1780 al 26 maggio 1781, a cura di G. Seregni, Milano 1940. J. JORDÁN DE URRIES DE LA COLINA, La embajada de José Nicolás de Azara y la difusión del gusto neoclásico, in Roma y España: un crisol de la cultura europea en la edad moderna, Actas del Congreso Internacional (Roma 2007), Madrid 2007. L. LANZI, Storia pittorica dell’Italia (1809), edizione a cura di M. Capucci, Firenze 1968. D. LEVI, Il “Codice del Buon gusto”: appunti sui rapporti fra Bodoni e l’editoria storico-artistica, in Bodoni: l’invenzione della semplicità, a cura di A. Ciavarella, Parma 1990, pp. 33-54. S. PASQUALI, Scrivere di architettura intorno al 1780: Andrea Memmo e Francesco Milizia tra il Veneto e Roma, in «Arte veneta», 59 (2004), pp. 168-185. N. PEVSNER, Le Accademie d’arte (1940), Torino 1982, capp. IV, V. S. ROLFI OŽVALD, Pratiche di atelier e strategie di mercato, in Pompeo Batoni 1708-1787, a cura di L. Barroero, F. Mazzocca, catalogo della mostra, Milano 2008, pp. 42-45. S. RUDOLPH, Felice Giani da Addacemico “de’ Pensieri” a Madonnero, in «Storia dell’arte», 29-31 (1977), pp. 175-190. “Il mondo in una stanza”: esempi del collezionismo archeologico di stampo universale tra il XIX e il XXI secolo «Una delle più cose che io abbia avuto et che abbia è il mio studio, dal quale mi sono proceduti tutti li honori e tutta la stima della mia persona. Il quale intendo che sia non solamente dove sono i libri, ma tutto quello che contengono le quattro stanze delli mezadi dove io sto ordinariamente, dove vi sono cose esquisite, et tali che chi ben non le considera non lo potrebbe creder, così dei libri a stampa come de’ scritti a penna, instrumenti mathematici et mecanici, statue così di marmo come di bronzo, pitture, minerali, pietre secrete et altro, le qual tutte cose sono state raccolte da me con grandissimo studio e fatica, però voglio anco che sii conservato et argomentato, acciò che i nostri posteri possano godere e sentir beneficio di queste mie fatiche…» (DE BENEDICTIS 1991). Il brano del testamento del senatore veneziano Jacopo Contarini, datato Fig. 1 – Antonio Raimondi 1 luglio 1596, documenta la composizione e lo spirito con il quale venivano 68 costituite le collezioni di stampo universale sia in Italia che in Europa nel XVI secolo. Il modello per l’homo universalis era la Naturalis historia di Plinio il Vecchio che, come è noto, riuniva in un’unica compilazione le aspirazioni di conoscenza verso la natura ed i suoi fenomeni e verso l’essere umano ed i suoi prodotti degni di essere ricordati. Ma mentre il collezionismo di stampo universale e le cosiddette “camere delle meraviglie” sono argomenti molto studiati fino agli sviluppi nel XVIII secolo (a titolo esemplificativo si cita qui solo LUGLI 1983), altrettanto non si può dire della fase più recente, quella che vede lo smembramento di tali raccolte e l’origine dei musei di storia naturale e dei musei etnografici e antropologici. Restringendo a questa seconda tipologia di museo la ricerca mira, in particolare, a due obiettivi: 1) censimento (in atto) delle raccolte museali esistenti in Italia che contengono materiali archeologici di provenienza andina; 2) individuazione di casi di studio di particolare interesse, che consentano di ricostruire le fasi di ingresso in museo di tali materiali. Il fine è quello di integrare la conoscenza del collezionismo di antichità, non limitando il fenomeno all’interesse per i reperti classici. Dopo la scoperta delle Americhe, la gara per inserire l’oggetto più raro ed esotico aveva aumentato il raggio d’azione dei collezionisti europei. La Spagna e gli ordini religiosi esercitarono, in tal senso, un importante ruolo di mediazione (LAURENCICH-MINELLI 1985; PALMA VENETUCCI 2003; EAD. 2006; EAD. 2007). Non manca, tuttavia, la presenza di singoli studiosi che hanno svolto un’importante funzione di tramite tra le conoscenze del vecchio e del nuovo mondo, ovvero tra il Perù e Milano, come Antonio Raimondi (AIMI 2009) (fig. 1) o di collezionisti, come Ugo Canepa, meno attenti al significato scientifico, ma decisivi per la costituzione di importanti nuclei collezionistici a Rimini (BIORDI 1991; ID. 2000; ID. 2005). Su alcune realtà museali come le raccolte extraeuropee del Castello Sforzesco di Milano (AIMI 1991; ID. 1993 e 1994), il sopracitato caso delle raccolte civiche di Rimini e di altri musei dell’Emilia Romagna (SALVI 2007) o l’ancora più studiato Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini di Roma (da BARONCELLI 1935 a LERARIO 2005) sono già disponibili pubblicazioni sulla storia della formazione delle raccolte, per cui restano settori molto circoscritti ancora da indagare. Parzialmente dissodato appare anche il campo della storia della formazione dei musei di antropologia che fanno capo ad istituzioni universitarie (tra i più noti ricordiamo quello di Bologna e di Firenze), mentre di più difficile accesso sono i dati riguardanti le collezioni connesse con istituzioni religiose (per un quadro d’insieme resta punto di partenza BIORDI 1990). Questa realtà, particolarmente importante – basti ricordare che l’unica collezione pubblica a carattere universale presente sul suolo italiano sono i Musei Vaticani – non sarà compresa in questa fase della ricerca, perché richiederebbe tempi e strumenti diversi d’indagine rispetto a quelli preventivati. È interessante, tuttavia, notare che mentre in Europa non viene meno (e anzi si rafforza, basti pensare al Pavillon des Sessions del Louvre, inaugurato da Chirac nel 2000) l’aspirazione al museo universale che, come è noto, si forma nel XIX secolo come riflesso del colonialismo e della competizione tra le potenze occidentali, in Italia continua ancora oggi il fenomeno inverso, cioè quello della separazione tra le culture, attraverso la creazione di strutture museali differenziate, innescato dall’Unità d’Italia. La necessità di fornire riferimenti chiari e univoci alla nuova identità nazionale italiana portò, nel momento della fondazione dei musei nazionali, a smembrare le collezioni “universali” in sedi espositive diverse. Tale processo di “classificazione” del patrimonio culturale su cui fondare le radici italiche è esemplificato dal caso ben noto della nascita del “Museo Preistorico ed Etnografico”, diretto da Luigi Pigorini. La collezione raccolta nel Collegio Romano dal padre gesuita Athanasius Kircher, a cui era stata unita per donazione, nel 1651, la raccolta di antichità romane del senatore Alfonso 69 Donnino de Toscanella (già nel Palazzo dei Conservatori) e che si era costantemente arricchita con invii di materiali da parte dei gesuiti in missione in America Latina e in altre remote parti del mondo, non fu mantenuta nell’integrità della sua formazione storica, ma se ne valorizzarono alcune sezioni come quella preistorica, il cui ampliamento interessava particolarmente il Pigorini, mentre i materiali classici furono trasferiti al Museo Nazionale Romano. Tra le realtà museali di particolare interesse per la ricerca, oltre a quelle già ricordate, è da segnalare il “Museo delle Culture del Mondo” al Castello D’Albertis di Genova, che espone la collezione di oggetti raccolti dal Capitano Enrico Alberto D’Albertis tra la fine dell’Ottocento ed i primi del Novecento, nella sua stessa dimora. Questo primo anno d’indagine è stato dedicato alla raccolta di materiali bibliografici che offrono dati soprattutto per collezioni e musei dell’Italia centro-settentrionale. La ricerca continua nel reperimento della bibliografia specializzata e nel censimento delle realtà museali del centro-sud, dove ci si aspettano risultati soprattutto in considerazione del particolare collegamento tra la Spagna (e quindi le sue colonie dell’America del Sud e il viceregno del Perù) ed il Regno di Napoli, come appare da un primo spoglio bibliografico (AIMI 1993). Giuliana Calcani BIBLIOGRAFIA A. AIMI, La storia della Raccolta Precolombiana, in A. Aimi, L. Laurencich Minelli, Museo d’arti applicate: raccolta precolombiana, Milano 1991. A. AIMI, Napoli e l’America, inTesori dalle Ande, a cura di L. Laurencich Minelli, Centro Europeo Mostre, La Spezia 1993, pp. 23-29. A. AIMI, Le Collezioni Amerindiane di Milano, in L’Americanistica italiana e le Collezioni precolombiane, Verona 1993, pp. 21-39. A. AIMI, Il collezionismo milanese di interesse americanistico e l’origine della Raccolta Precolombiana, in «Rassegna di Studi e Notizie», 18 (1994), pp. 27-52. A. AIMI, Firenze e l’America: una storia antica, in Perù: tremila anni di capolavori, a cura di A. Aimi, Milano 2003, pp. 11-19. A. AIMI, Federico Balzarotti: il collezionista, in Le culture del Perù da Chavín agli Inca, a cura di A. Aimi, Cinisello Balsamo 2004, pp. 16-21. A. AIMI, Milano e l’America Latina: cinque secoli di storia, in «Politica internazionale», 4-5 (2009), pp. 215-223. A. AIMI, Alle origini dell’antropologia italiana: il ruolo di Antonio Raimondi, in Tra Italia e Perù: l’attualità di Antonio Raimondi. Atti delle giornate di studio (Quaderni di Casa America, V/2), a cura di G. Calcani, R. Speciale, Genova 2009, pp. 69-74. A. AIMI, L. CAGNOLARO, V. DE MICHELE, L. LAURENCICH MINELLI, Il Museo di Manfredo Settala nella Milano del XVII secolo, Museo Civico di Storia Naturale, Milano 1983. P. BARONCELLI, Il R. Museo Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”: le origini, le vicende, gli scopi, in Atti del IV Congresso Nazionale di Studi Romani, Roma 1935, vol. V, pp. 127 e sgg. P. BARONCELLI, Il R. Museo Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”di Roma, Roma 1940. M. BIORDI, I musei italiani e l’americanistica, in L’americanistica italiana e le collezioni precolombiane in Italia, Atti della giornata di studi, a cura di M. Sartor, Verona 1990 (1991), pp. 29-45. M. BIORDI, Il collezionismo americanistico e il primitivismo: gli artefatti precolombiani nel Museo delle culture extraeuropee Dinz Rialto di Rimini, in L’Americanistica italiana e le celebrazioni colombiane, Atti della giornata di studi, a cura di M. Sartor, Verona 1991, pp. 41-51. M. BIORDI, Le collezioni extraeuropee dei musei romagnoli ed il Museo delle culture extraeuropee Dinz Rialto di Rimini, in Atti e Memorie. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, Bologna 2000, pp. 349-374. G. CANDELA, M. BIORDI, L’arte etnica tra cultura e mercato, Milano 2007. C. DE BENEDICTIS, Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti, Firenze 1991. Bologna e il Mondo Nuovo, a cura di L. Laurencich Minelli, catalogo della mostra, Bologna 1992. 70 Il Collegio Romano dalle origini al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cura di C. Cerchiaia, Roma 2003. M.C. DE PALMA, Castello D’Albertis, museo delle culture del mondo, Cinisello Balsamo 2008. L. LAURENCICH-MINELLI, Museography and Ethnographical Collections in Bologna during the Sixteenth and Seventeenth Century, in The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth-Century Europe, a cura di O. R. Impey, A. MacGregor, Oxford 1985, pp. 17-23. M.G. LERARIO, Il museo Luigi Pigorini dalle raccolte etnografiche al mito di Nazione, Roma 2005. Lo sguardo altrove: il progetto Etno e il patrimonio culturale extraeuropeo in Emilia Romagna, a cura di A. Salvi, catalogo della mostra, Bologna 2007. A. LUGLI, Naturalia et Mirabilia. Il collezionismo enciclopedico nelle Wunderkammern d’Europa, Milano 1983. Museo degli sguardi. Raccolte etnografiche di Rimini, a cura di M. Biordi, Rimini 2005. G. OLMI, L’inventario del mondo: catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, Bologna 1992. B. PALMA VENETUCCI, Commercio antiquario ed esportazioni di antichità nel XVIII secolo: il ruolo della Spagna, in Illuminismo e Ilustraciòn. Le antichità e i loro protagonisti in Spagna e in Italia. Atti del Congresso (Roma, 30 novembre-2 dicembre 2001), a cura di J. Beltràn Fortes, B. Cacciotti, X. Dupré Raventòs, B. Palma Venetucci, Roma 2003, pp. 277-293. B. PALMA VENETUCCI, Nuovi aspetti del collezionismo in Italia e Spagna attraverso le esportazioni delle antichità, in Arqueología, Coleccionismo y Antigüedad España e Italia en el siglo XIX. Atti del Congresso, (Siviglia, 18-20 novembre 2004), a cura di J. Beltràn Fortes, B. Cacciotti, X. Dupré Raventòs, B. Palma Venetucci, Siviglia 2006, pp. 503-526. B. PALMA VENETUCCI, Dallo scavo al collezionismo. Un viaggio nel passato dal Medioevo all’Ottocento, Roma 2007. Europa e America nel modernismo “transatlantico” di Walker Evans, 1928-1934 Lo scarso interesse che ha circondato sino ad oggi l’opera giovanile di Walker Evans costituisce un caso storiografico tanto complesso quanto singolare. Nato nel 1903, Evans si dedicò precocemente agli studi letterari e coltivò l’ambizione di divenire scrittore. Dall’aprile 1926 trascorse un anno di studio a Parigi, dove studiò la lingua, approfondì la conoscenza della letteratura francese e frequentò la libreria Shakespeare & Co. di Sylvia Beach, dove non era raro incontare James Joyce. Ritornato a New York nel 1927, tuttavia, abbandonò progressivamente la scrittura, apparentemente sopraffatto dai propri modelli artistici. I negativi e le stampe oggi conservati presso il Walker Evans Archive del Metropolitan Museum di New York e presso il J. Paul Getty Museum di Los Angeles indicano che Evans iniziò a dedicarsi con continuità alla fotografia nel 1928, privilegiando i temi della grande città: la nuova architettura del grattacielo, il paesaggio creato dalla comunicazione pubblicitaria, la stratificazione sociale di New York. Circa 500 negativi nella collezione del Metropolitan e 100 stampe in quella del Getty testimoniano che questo interesse per la metropoli si protrasse sino al 1934, allorché l’interesse di Evans si spostò decisamente verso l’architettura “vernacolare” e la provincia. Fra il 1935 e il 1937 collaborò con l’agenzia fotografica della Farm Security Administration, viaggiando negli stati dell’est e del sud per documentare gli effetti della Depressione. Furono proprio le fotografie riprese nelle piccole e medie città fra il 1930 e il 1936 a costituire l’ossatura di American Photographs, la retrospettiva presentata al MoMA nel 1938 – la prima dedicata dal museo a un fotografo – che consacrò Evans come uno dei maggiori interpreti della provincia americana e della “main street”. Fu poi la seconda, influente retrospettiva del MoMA, curata da John Szarkowski nel 1971, a consolidare i contorni di quello «stile documentario» frontale, austero e descrittivo che ancora oggi è unanimemente considerato il contributo più originale di Evans all’arte del Novecento. In questo quadro dominato dalla maturità artistica raggiunta negli anni trenta con lavori che affrontavano il tema dell’“americanità”, le fotografie d’esordio realizzate secondo un approccio a prima vista “europeo” sono state relegate in una posizione sostanzialmente marginale. La storiografia 71 dominante si è infatti concentrata su elementi stilistici come la prospettiva accidentale e la composizione “angolare”, imputando le prime prove newyorkesi alla fascinazione del giovane artista per la “Nuova Visione” europea. Questa lettura è in realtà contraddetta dal sostanziale disinteresse di Evans per la “Nuova Visione”, come del resto per il Costruttivismo e l’Astrattismo spesso richiamati per inquadrare i suoi primi lavori. Al contrario, in varie occasioni espresse ammirazione per fotografi come Mathew Brady, Paul Strand, Eugène Atget, August Sander, Ben Shahn, ma anche per aspetti dell’opera di Alfred Stieglitz, Ralph Steiner, Henri Cartier-Bresson ed Erich Salomon. In questo panorama variegato e frammentario si può cogliere la tipica tendenza di Evans a dissimulare i propri debiti nei confronti di altri artisti visuali, indicando piuttosto tra i propri ascendenti scrittori come Flaubert e Baudelaire. Per una conoscenza più circostanziata della sua formazione visiva e del suo interesse per la metropoli, la ricerca deve dunque prendere le mosse dalle opere effettivamente realizzate, considerando non solo le stampe fotografiche più note, ma anche la grande quantità di negativi conservati nell’archivio, spesso non accompagnati da positivi. Se le fotografie sono solitamente “tracce” del mondo e immagini di qualcosa, il compito primario dello storico è quello di restituire i modi con i quali l’esperienza della realtà è stata trasformata dal fotografo in una rappresentazione bidimensionale attraverso una serie di scelte tecniche ed estetiche, che corrispondono a interpretazioni culturali non sempre riconducibili a princípi condivisi o a manifesti artistici. Un primo, importante esempio in questa direzione è fornito da nove negativi conservati al Metropolitan che mostrano il profilo di Manhattan ripreso dal ponte di Brooklyn. Su questo topos newyorkese Evans operò alcune torsioni visive che consentono già di individuare l’elaborazione di un’idea di città. Eliminando il campo medio con la superficie dell’East River, queste vedute negano l’immagine pittoresca di Manhattan come penisola naturale protesa sulle acque del fiume. A contraltare, le icone della razionalità ingegneristica – il ponte ottocentesco e i nuovi grattacieli – vengono presentate come frammenti di un collage disumanizzato, dal quale sono assenti gli spazi pubblici e la vita sociale. Nel suo complesso, la serie rivela inoltre un ambizioso programma concettuale. Tutte le fotografie risultano infatti incentrate sulla costruzione del 111 John Street Building, un grattacielo di 26 piani da 3,5 milioni di dollari nel distretto finanziario di Manhattan. La cronaca immobiliare del «New York Times» consente di datare i negativi all’autunno 1928, ma un’analisi comparativa rivela anche che tutte le immagini, pur con alcune varianti compositive, sono state realizzate nel corso di alcuni mesi da due specifici punti di ripresa. Il carattere sistematico di questa sequenza segnala perciò che le primissime prove dell’artista a noi pervenute, sebbene a un primo sguardo stereotipate e frammentarie, rientrano in un progetto più ampio sull’immagine di New York, avviato nel pieno di un ciclo edilizio che cambiò il volto della metropoli. In sintonia con queste premesse, la ricerca ha teso anzitutto ad individuare i soggetti urbani di tutte le fotografie realizzate in questo periodo iniziale – sino ad oggi rubricate come «studi formali», «composizioni» o «astrazioni» – nel tentativo di comprendere i criteri di trattamento messi in atto da Evans. L’analisi comparativa delle fonti iconografiche – fotografie, vedute aeree, mappe, libri illustrati, materiali pubblicitari – incrociata con le cronache architettoniche – presenti soprattutto nella sezione immobiliare del «New York Times» e nelle riviste di settore – ha consentito non solo di precisare i dati catalografici di moltissime opere conservate al Metropolitan e al Getty e di individuare le modalità operative dell’artista, ma anche di ricostruire la geografia simbolica sottesa al suo lavoro newyorkese. Dalle maglie dell’archivio emerge dunque una mappa visiva di New York in un periodo cruciale della sua crescita e del suo declino, a ridosso della drammatica crisi del 1929. Insistendo sui luoghi di 72 maggior attività immobiliare – il Financial District, 42nd Street, Central Park South – ma fotografando edifici non ancora completati e facciate secondarie, tra il 1928 e il 1934 Evans accumulò un’iconografia sospesa tra costruzione e distruzione, in una rappresentazione ironica del mito progressista degli anni venti. Gli slogan pubblicitari, ritagliati dall’inquadratura, appaiono ridotti a frammenti di un babelico sillabario; le persone, in particolare i lavoratori, sono colte in momenti inespressivi di sospensione o di pausa – in una modalità diametralmente opposta a quella adottata da Lewis Hine nel 1930-1931 per celebrare l’eroismo del lavoro nella costruzione dell’Empire State Building. Ne emerge una tensione fra la descrizione documentaria della città e la formalizzazione dello spazio urbano, in sintonia con le ricerche di molti artisti del tempo. L’archivio rivela rimandi puntuali a fotografie di Percy L. Sperr, Thurman Rotan, Ewing Galloway e Ira W. Martin pubblicate in riviste dell’epoca. Ma la riflessione di Evans sull’“astrattezza” fisica e morale della città commerciale rivela contatti non meno stretti con l’opera di artisti attivi nel campo delle arti grafiche – Louis Lozowick, Arnold Rönnebeck, Howard Cook, Ernest Fiene, Mark Freeman – e di pittori successivamente unificati sotto la corrente del Precisionismo, come Charles Demuth, Stuart Davis, Charles Sheeler, George Ault, Preston Dickinson e Stefan Hirsch. In generale, si tratta di artisti che articolarono un discorso critico sulla metropoli e sull’estetica della macchina coniugando i principi del post-Cubismo a una resa realista del linearismo industriale e tecnologico. Come ha suggerito Wanda Corn in un suggestivo inquadramento di questa generazione di artisti, ad essere in gioco è una declinazione “transatlantica” del modernismo, sviluppata in una dialettica continua – talvolta persino irrisolta – tra Europa ed America. Forse non a caso, una delle prime fotografie pubblicate da Evans è una scena intitolata «Port of New York», probabile citazione di un libro di Paul Rosenfeld apparso nel 1924 nel quale la metropoli viene celebrata come la più europea delle città americane e come ponte ideale tra vecchio e nuovo continente. L’aspetto più originale della ricerca di Evans si ritrova proprio nelle sequenze messe a punto per riviste come «The Architectural Record», «The Hound & Horn» e «Creative Art» o per le esposizioni alle quali partecipò, nelle quali la tradizionale narrazione fotografica si trova innervata dalle nuove teorie sovietiche sul montaggio cinematografico. Lo sviluppo più avanzato di questa tendenza è dato da una serie perduta di 36 fotografie «Spedite in Russia con W. Goldwater», testimoniata da un elenco di didascalie di mano dell’artista. La ricostruzione della sequenza – resa possibile dal lavoro di identificazione dei soggetti sopra illustrato – consente di individuare i contorni di un inedito “viaggio” all’interno di New York: un caleidoscopio di frammenti metropolitani strutturato da un ordine narrativo rovesciato, nel quale il Chrysler Building, sintesi americana delle arti, dell’architettura e dell’industria, viene presentato in un ambiguo stato di incompletezza confinante con il decadimento. Con il progredire della Depressione, nel 1933-1934 Evans continuò a lavorare a New York spostandosi progressivamente verso 14th Street, South Street e West Street, dove il senso di abbandono e di rovina stava diventando palpabile. È in questo laboratorio metropolitano, frequentato assiduamente nel corso degli anni cruciali di formazione, che l’artista ebbe modo di mettere a punto quello “stile documentario”, allo stesso tempo descrittivo e interpretativo, che lo rese celebre negli anni successivi. Antonello Frongia BIBLIOGRAFIA W.M. CORN, The Great American Thing: Modern Art and National Identity, 1915-1935, Berkeley 1999. D. EKLUND, M. FINEMAN, M. MORRIS HAMBOURG, J.L. ROSENHEIM, Walker Evans, New York 2000. W. EVANS, American Photographs, New York 1938. 73 J. KELLER, Walker Evans, Los Angeles 1995. D.B. KUSPIT, Individual and Mass Identity in Urban Art: The New York Case, in «Art in America», LXV/5 (1977), pp. 66-77. J.R. MELLOW, Walker Evans, New York 1999. G. MORA, J.T. HILL, Walker Evans. The Hungry Eye, New York 1993. B. RATHBONE, Walker Evans, Boston 1995. P. ROSENFELD, Port of New York. Essays on Fourteen American Moderns, New York 1924. Shared Perspectives. The Printmaker and Photographer in New York, 1900-1950, a cura di L. Nolan, New York, catalogo della mostra, New York 1993. G. STAVITSKY, E. HANDY, M. ORVELL et al., Precisionism in America, 1915-1941. Reordering Reality, New York 1994. J. SZARKOWSKI, Walker Evans, New York 1971. D. TASHJIAN, Skyscraper Primitives. Dada and the American Avant-Garde, 1910-1925, Middletown 1975. J.L. THOMPSON, J.T. HILL, Walker Evans at Work, New York 1982. L’arte moltiplicata. La cultura visiva a Roma tra rotocalchi e riviste culturali negli anni 1960-1980 Gli interventi di Laura D’Angelo e Elena Salza si inscrivono in un progetto di ricerca finanziato dal MIUR nell’ambito del PRIN 2008. Il progetto, coordinato a livello nazionale da Antonello Negri dell’Università di Milano, ha per tema La moltiplicazione dell’arte e le sue immagini. La cultura visiva in Italia nell’epoca della riproducibilità tecnica: dalle riviste illustrate del secondo Ottocento a rotocalchi e quotidiani della contemporaneità. Si tratta dunque di una ricerca ampia alla quale collaborano, oltre all’unità locale di Roma Tre coordinata da Barbara Cinelli, le unità locali delle Università di Firenze e Udine, coordinate rispettivamente da Maria Grazia Messina e Flavio Fergonzi. L’unità romana – alla quale partecipano anche Giovanna Montani, Valentina Russo e Chiara Fabi – ha scelto come tema specifico L’arte moltiplicata. La cultura visiva a Roma tra rotocalchi e riviste culturali negli anni 1960-1980. Il segmento temporale è caratterizzato da una straordinaria vivacità dal punto di vista della sperimentazione dei linguaggi artistici; nonostante gli anni Sessanta e Settanta siano stati recentemente oggetto di una ripresa di interesse storiografico, i rotocalchi e in generale i periodici a larga diffusione restano una fonte tuttora inesplorata per i decenni del dopoguerra. Si è dunque deciso di focalizzare l’attenzione su alcune pubblicazioni («L’Espresso» ed «Epoca»), che testimoniano con modalità e scelte redazionali diverse – ad esempio con la presenza o meno di rubriche fisse, con il ricorso o meno a nomi importanti della storia e della critica contemporanea – la diffusione di un’arte ormai inevitabilmente “moltiplicata”. Questa presenza, numericamente rilevante, permette una lettura secondo due direzioni: in primo luogo, una riflessione sull’immagine che della produzione artistica contemporanea viene fornita ai lettori secondo un criterio che potremmo definire Fig. 1 – R. Carrieri, I pittori a domicilio: Cassinari, in «Epoca», 1003 di consumo culturale; si tratta di un’immagine (14/12/1969) spesso dissonante e come fuori asse rispetto al 74 quadro generale formato dalla successiva elaborazione storiografica. In secondo luogo, la considerazione di questi periodici come repertori di possibili fonti, di suggestioni visive, come motori di diffusione delle immagini di reportage o di cronaca destinate a circolare negli atelier e a coesistere accanto a veicoli di trasmissione più tradizionale. La ricerca è stata condotta dividendo il vasto campo di indagine in segmenti. Gli interventi qui pubblicati presentano nello specifico i primi esiti delle ricerche su «Epoca» nel decennio 1960-’69 (D’Angelo), e su «L’Espresso» negli anni Sessanta (Salza). L’attenzione delle ricercatrici si è concentrata, per precisa scelta metodologica, sulle immagini fotomeccaniche, che sono state oggetto di un imponente lavoro di schedatura. La raccolta dei dati è stata l’oggetto della prima fase della ricerca, attualmente giunta alle battute conclusive. Al fine di rendere utilizzabile l’enorme repertorio di immagini all’interno della ricerca, i dati schedati confluiscono in un database appositamente elaborato per una tipologia di immagini finora mai utilizzata come fonte e che dunque richiede strumenti appropriati di catalogazione. Il carattere innovatore e sperimentale del programma informatico permetterà, nei prossimi mesi, di passare dalla schedatura ad una fase di condivisione dei dati raccolti dalle diverse unità, permettendo così una più intensa circolazione di informazioni, ragionamenti e confronti fra i diversi gruppi locali. Gli interventi qui pubblicati sono dunque da intendersi come prime riflessioni che poggiano sull’esperienza diretta di una ricerca in fieri, riferibili ad uno stadio di elaborazione ancora suscettibile di numerosi approfondimenti. Laura Iamurri «Epoca» 1960-1969: l’immagine dell’artista nell’Italia del miracolo economico Lo spoglio, catalogazione e analisi dell’apparato iconografico del rotocalco Epoca per il decennio 1960’69, ha già prodotto risultati che seppur ancora parziali possono condurre a riflessioni significative. Lo studio su immagini la cui circolazione è garantita da un veicolo rilevante di comunicazione visiva consente di determinare quale sia la percezione e la ricezione dell’arte contemporanea in uno strato diffuso di pubblico non specializzato; ma soprattutto consente di intravedere interessanti sviluppi di ricerca nella definizione di una “storia dell’arte”, parallela e alternativa a quella che veniva in quegli anni scritta dai critici di professione, e trasmessa su circuiti diversi e utilizzati da un pubblico che a quella data può ormai definirsi “di massa”. Difficile riassumere in breve, e con una ricerca in corso d’opera, la linea editoriale di «Epoca», tratteggiarne la missione e individuarne nel dettaglio il pubblico; ma i dati finora raccolti consentono di affermare con una sufficiente plausibilità come tra le sue pagine si affermassero, numero per numero, i valori su cui si era costituita l’Italia liberata: il lavoro e la famiglia, al cui consolidamento Fig. 2 – R. Carrieri, I pittori a domicilio: Guttuso, in «Epoca» 992 anche l’arte fu chiamata a contribuire. (28/09/1969) 75 I luoghi redazionali privilegiati dalla ricerca si individuano nelle due rubriche fisse: Italia Domanda e Arte, dove i ritratti fotografici di esponenti del mondo artistico internazionale, o riproduzioni di loro opere, costituivano naturale e imprescindibile corredo della materia giornalistica trattata. Queste due rassegne sono accumunate dalla cadenza settimanale, causa/ conseguenza di una popolarità riscossa tra i lettori, e dall’analogo formato delle immagini usate, spesso minimale e in bianco e nero. In queste rassegne, molto legate all’identità della rivista, ricorre ciclicamente il medesimo grupFig. 3 – I malinconici amici di Viviani, in «Epoca», 673 (18/08/1963) po di artisti, il cui censimento costituirà una delle priorità della ricerca che seguirà la fase di catalogazione. Italia domanda era una rubrica ideata da Cesare Zavattini, che ne ebbe la cura dal primo al quindicesimo numero; coinvolgeva personaggi celebri, dai registri ai letterati, per rispondere a questioni sollevate dai lettori su argomenti di natura molto diversa, mostrando la piena sintonia tra il Neorealismo zavattiniano e la visione editoriale di Arnoldo Mondadori. Tra il 1960 e la metà del 1962 l’artista, pittore o scultore che sia, è sempre incluso (e naturalmente ritratto accanto alla risposta fornita) nella cerchia di “esperti” che esprimevano i loro statement su interrogativi posti dai lettori a volte generici: Credete nel destino?, a volte di tono più intellettualmente ambizioso e specialistico: Anche per gli artisti si parla di lancio pubblicitario. Crede possibile questo tipo di successo? Che opinione ha dei critici? Le “fototessere” a corredo dei piccoli contributi, oltre al compito di avvicinare alla comunità i volti di personaggi affermati a cui erano chiamati a lasciarsi ispirare nella personale corsa al successo sociale, adempiono al compito di educare il pubblico all’arte giocando su tacite simmetrie visive tra la fisionomia degli autori e il linguaggio per cui avevano acquisito la notorietà, coadiuvate talvolta da didascalie telegrafiche. Si può citare l’esempio di De Chirico, «creatore della pittura metafisica», la cui espressione sospesa ed enigmatica permetteva una associazione istintiva alla cifra della fortunata produzione metafisica a garanzia di un’immediata e inconfutabile riconoscibilità. Quando Italia domanda verrà meno a questa istanza, sarà il pubblico stesso a chiedere di conoscere il volto degli autori proposti. Nell’agosto del ’63 «Epoca» dedica a Giuseppe Viviani, assai sponsorizzato dalle pagine della rivista, un ampio servizio a colori in cui vengono riprodotti i suoi dipinti sempre popolati da tristi personaggi, inclusi animali, con grandi occhi mesti. Nel numero successivo si registra la reazione del signor Fusari di Roma, che in una lettera al direttore scriveva: «Le informazioni, i commenti, le notizie sui grandi avvenimenti del mondo sono necessarie ed utili. Ma pagine come quelle dedicate ai cani Fig. 4 – I malinconici amici di Viviani, in «Epoca», 673 (18/08/1963) di Viviani sono indispensabili». E denunciava 76 contestualmente la mancanza di una foto del pittore che, poi pubblicata, mostrava le affinità fisiognomiche tra l’artista e le sue patetiche creature. Arte era invece una rubrica curata da Raffaele Carrieri, collaboratore stabile del settimanale fin dal primo numero, poeta e critico d’arte residente a Milano, città che diviene l’osservatorio esclusivo da cui individuare gli artisti presentati ai lettori. I protagonisti delle sue recensioni sono ritratti in foto quasi segnaletiche, che contrastano con il tono partecipe del testo, dove, come un journal, si indugiava Fig. 5 – Milano ha ricordato Giuseppe Viviani, in «Epoca», 853 (29/01/1967) su aspetti biografici ed affettivi del personaggio e dell’autore stesso. Analogamente le immagini delle opere, riprodotte specialmente in occasione di recensioni di mostre, non sembrano comunicare giudizi estetici, a stento hanno una valenza informativa, e sono corredate da didascalie sintetiche e spesso imprecise. Questa combinazione di uno scritto impegnativo e di illustrazioni poco accattivanti induce a credere che la rubrica fosse stata pensata per un target se non di specialisti quantomeno di appassionati, interessati, lettori che sapevano di poter trovare nella loro rivista, nelle ultime pagine, articoli in sequenza, oltre a Arte, anche Libri e Teatro. Viceversa negli articoli che Carrieri redige in occasione di eventi di particolare rilievo, spesso ancora rubricati sotto il titolo Arte, il testo avanzava nel corpo della rivista, riducendosi al minimo ma arricchendosi di grandi immagini a colori con didascalie più eloquenti e con un titolo ad effetto, il tutto finalizzato a raggiungere una più vasta audience. Questo tipo di servizi era inteso come elemento di grande suggestione sul pubblico che, anche solo scorrendo distrattamente argomenti non di suo interesse precipuo, poteva venire catturato da illustrazioni importanti, incorniciate da un messaggio succinto ma inequivocabile. Ne è un esempio l’eloquente articolo Noi paghiamo per queste buffonate con cui Carrieri – che non firma ma di cui si riconosce la prosa – commenta la XXXII Biennale di Venezia (fig. 1). Tra le fotografie che analiticamente offrono le opere al severo giudizio del lettore ne campeggiano talune dal taglio studiato: oltre ad una graziosa signora che «catalogo alla mano cerca di capire qualcosa», uno scatto significativo ritrae una visitatrice, della quale si vedono solo le gambe, sufficienti, nella loro postura, per indovinare l’atteggiamento smarrito di fronte al Dono per Apollo di Rauschenberg. La foto, di una singolare potenza espressiva, riesce bene ad evocare il difficile impatto tra il pubblico borghese italiano, che manifestava in quegli anni (anche incoraggiato dagli stessi rotocalchi) velleità di collezionismo, e l’arte americana che di lì a poco avrebbe spostato oltreoceano il baricentro del mercato. A partire dal 1967, con la nuova rubrica Artisti a domicilio e con altri spazi di argomento analogo, Carrieri incrementa la propria presenza su «Epoca» sfruttando l’appeal di questa tipologia di servizi per avvicinare al mondo delle arti una sempre più vasta porzione di pubblico e per imporre una sua visione critica e una sua “scuderia” di autori. Le immagini infatti propongono diversi prototipi di artista a cui ciascun italiano, dall’operaio all’avvocato, poteva sentirsi vicino: l’artista era un modello sociale universale, perché possedeva la manualità che caratterizzava il mestiere delle classi meno abbienti ma anche le qualità intellettuali dei ceti più elevati. Il critico mostra quindi con ottime foto appositamente realizzate, spesso 77 da Walter Mori con il copyright «Epoca», Giacomo Manzù come un artigiano emancipato in uno studioofficina, Renato Guttuso in posa da affermato maestro, e il pio Salvatore Messina dedito alle sue committenze religiose, per sconfessare quanti tra i lettori, per la maggior parte di ala cattolica, avessero potuto credere che pittori e scultori fossero solo anticonformisti e senzadio. Un raffronto, anche superficiale, tra le rassegne di Carrieri e la letteratura specialistica coeva o semplicemente, ad esempio, con gli ordinamenti firmati da Palma Bucarelli negli stessi anni per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, restituisce la varietà degli orizzonti lungo i quali si scala in questi anni il dialogo tra arte contemporanea e pubblico. Nel 1962, mentre sulle pagine di «Epoca» si elogiano per due numeri consecutivi le retrospettive della XXXI Biennale di Venezia, quella di Sironi in particolare, la soprintendente smantella dalle sale di Valle Giulia l’arte degli anni Trenta, aggiornandosi sulle tendenze attuali e sugli autori stranieri che avevano da tempo rinunciato al conforto della forma. Gli sforzi di Carrieri, e della redazione che ne sosteneva le scelte, per desacralizzare in chiave demagogica l’immagine dell’artista, vacillano però sotto il peso di due fattori: da un lato la progressiva irruzione di stimoli visivi provenienti da fonti sempre nuove, che nessun rotocalco poteva totalmente ignorare; dall’altra il divario innegabile, che i lettori stessi reclamavano, tra il pubblico e quella vasta categoria raggruppata sotto la comune denominazione di “artista”, che fosse attore, scrittore, pittore o scultore, per ragioni culturali non dissimili a quelle che nel Seicento avevano condotto dei poveri parrocchiani ad indignarsi di fronte alla Madonna dei Pellegrini di Caravaggio. Negli stessi anni in cui l’Italia inorridiva alla vista della “dama bianca” che piangeva al funerale di Fausto Coppi, sostituendosi fino all’ultimo alla consorte legittima Pablo Picasso era il celebrato ottantenne che impalmava donne più giovani fotografato nel suo studio con la neo-moglie e musa. Un esempio nostrano è quello di Mario Schifano, menzionato in un articolo di cronaca nera del 1966 come consumatore di marijuana necessaria, per sua ammissione, «per stimolare la sua ispirazione di artista di avanguardia». Nello stesso testo si fa anche menzione delle alte quotazioni raggiunte del giovane pittore, che compare ritratto in compagnia delle sue opere per ben tre volte, in formato ¼ di pagina con un probabile buon ritorno di mercato. Le fotografie riprodotte nei rotocalchi contribuivano alla consacrazione della “persona” in “personaggio”. In relazione all’immagine dell’artista, quando questi non poteva essere proposto come rassicurante modello da imitare, specialmente negli anni a ridosso dei ’70, e diventa un’icona negativa, se ne ammettono i comportamenti spregiudicati in virtù del suo talento. In questo ultimo aspetto risiedeva l’insanabile distanza degli artisti dal pubblico, ma anche l’origine della fascinazione che esercitavano, poiché il talento era una qualità che neppure la volontà e l’impegno, doti che avevano permesso ad un tipografo nullatenente di diventare Arnoldo Mondadori, potevano garantire all’uomo comune. Il genio è anche sregolatezza, ed «Epoca», nel 1962, si avvale della stravagante fisionomia di Salvator Dalì per fissare la declinazione “negativa” di estro, ammonendo i lettori che «non basta distinguersi dagli tutti gli altri in una maniera qualsiasi per essere originali», in quanto si rischierebbe solo di rendersi ridicoli. E anche la didascalia indirettamente ammonisce: Salvator Dalì: una vera personalità della pittura ma indubbiamente un eccentrico nella vita. In questo ambito, ma in accezione opposta, deve intendersi la pubblicazione, nel 1963, dell’opera figurativa La vendemmia di Gregorio Sciltian per il proposito di ribadire il carattere indefinibile della creatività, annoverata tra le qualità emotive più che cognitive e per questo innate, anche quando dipinti o sculture sembravano riprodurre fedelmente la realtà: «Anche la più fedele rappresentazione della realtà, insieme a doti intellettive non comuni, richiede sempre e prima di tutto la capacità di comunicare emozioni ricevute, al di là della pura intelligenza». Il fattore “talento” poteva quindi soccorrere anche i redattori di politica e costume, per sottolineare 78 come esso fosse all’origine di tutte le arti o, di contro, come potesse costituire il plusvalore di personaggi dediti ad attività imperniate esclusivamente sulle facoltà razionali: frequenti le occorrenze di immagini, da un lato di cantanti, attori, scrittori e, dall’altro di politici, presentati in qualità di pittori dilettanti. Una serie di servizi con illustrazioni di grande formato, spesso anche a colori, sono quelli a firma di collaboratori come Grazia Livi, Lorenzo Bocchi, Guido Gerosa, Giuseppe Grazzini, nelle cui pagine trovano spazio i grandi nomi della pittura nazionale e internazionale – Braque, Utrillo, ma anche Soffici e Morandi – che esulano dalle proposte di Carrieri, che comunque nonostante la grande enfasi portata sulle immagini non possono essere considerate rassegne artistiche ma piuttosto articoli di costume. In virtù di questo aspetto è paradossalmente concesso loro di spaziare con disinvoltura tra le categorie iconografiche fino ad ora descritte: la creatività, la follia, la spiritualità sono qualità visivamente espresse dalle riproduzioni fotografiche, ma in un assetto che appare finalizzato soprattutto a dilettare il lettore. Non possedendo rubriche a cadenza settimanale, si deve dedurre che la selezione dei pezzi proposti si basasse su criteri di godibilità e che, in tale contesto, autori dissonanti seppur in linea con l’immaginario proposto, potessero essere ben tollerati. Laura D’Angelo BIBLIOGRAFIA Anche per gli artisti si parla di lancio pubblicitario. Crede possibile questo tipo di successo? Che opinione ha dei critici?, in «Epoca», XI/512 (1960), pp. 6-7. L. BOCCHI, Picasso alla terza colomba, in «Epoca», XII/546 (1961), pp. 80-85. R. CARRIERI, Il genio di Sironi risplende nelle sue tele a Venezia, in «Epoca», XIII/614 (1962), pp. 90-91. Credete nel destino, in «Epoca», XIII/599 (1962), p. 5. In cosa consiste la personalità?, in «Epoca», XIII/615 (1962), p. 5. I malinconici amici di Viviani, in «Epoca», XIV/673 (1963), pp. 34-37. Noi paghiamo per queste buffonate, in «Epoca», XV/718 (1964), pp. 26-29. Per essere artisti bisogna avere un’intelligenza eccezionale?, in «Epoca», XIV/672 (1963), p. 5. F. SERRA, Perderà anche il figlio di Coppi?, in «Epoca», XI/502 (1960), pp. 83-85. Tramonta a Venezia la pittura degli Informal, in «Epoca», XIII/613 (1962), pp. 62-65. B. VANDANO, Le disavventure della baronessa, in «Epoca», XVII/829 (1966), pp. 70-72. «L’Espresso». Strategie di moltiplicazione e consumo culturale delle immagini Le immagini oggetto della ricerca sono rintracciabili nell’apparato iconografico a corredo di un nucleo ben individuabile di rubriche. In primis la rubrica di critica d’arte, curata da Lionello Venturi sin dagli esordi de «L’Espresso», affidata poi a Carlo Ludovico Ragghianti, affiancato da Pier Carlo Santini nel 1963, passata alla curatela di Giuliano Briganti nel 1965 fino al 1967; con l’avvio de «L’Espresso colore», viene sostituita nel supplemento dalla rubrica I Pittori curata da Briganti e Maurizio Calvesi, con la sezione Incontri dedicata al ritratto fotografico e testuale di pittori, galleristi, critici e collezionisti, affiancata dal 1968 da quella Le mostre. Stesso rapporto di appartenenza funzionale al testo hanno le immagini riprodotte nella rubrica d’architettura curata da Bruno Zevi, della quale sono state selezionate immagini pertinenti al dibattito sull’arte pubblica e alla recensione di esposizioni e allestimenti. Al binomio arte-architettura si affianca il mercato con la rubrica Il collezionista curata da Fabrizio Dentice, che la firma con lo pseudonimo di Oberon, nome shakespeariano che sarà condiviso da Agata Benedetti che ne continua la curatela con lo pseudonimo di Titania dal 1962 al 1967 nella rubrica Gli Antiquari del supplemento. Al di là di questi luoghi redazionali, le strategie di moltiplicazione sottese alla riproduzione delle 79 immagini possono essere piuttosto isolate nelle sezioni dedicate alla cronaca mondana, all’attualità e alla politica, dove l’autonomia dell’immagine contribuisce ad una sua ulteriore significazione. La comprensione di queste modalità permette di isolare alcuni nodi tematici e critici quali la diffusione dell’immagine dell’artista e della sua opera, ma anche di luoghi d’arte all’interno di un sistema socio-politico ben riconoscibile. Una moltiplicazione dunque che insiste in una riproduzione situata ben oltre il corredo iconografico al testo. Esemplificative di questa prassi sono le illustrazioni di Brunetta Mateldi a corredo de Il lato debole, rubrica di moda e costume curata da Camilla Cederna. Nel 1961 l’articolo Quadri a rate, Fig. 1 – Illustrazione di Brunetta Mateldi dedicata all’iniziativa della vendita rateale dedicato all’iniziativa di vendita rateale di quadri promossa da di quadri promossa da Ivan Trivulzio, in Ivan Trivulzio, era accompagnato da un’illustrazione che ritraeva «L’Espresso», VII/16 (1961), p. 24 il mercante nell’atto di tagliare una tela di Giuseppe Capogrossi quasi per poterla vendere in parti separate (fig. 1). L’anno successivo nella rubrica Il collezionista Dentice proponeva una fotografia ancora di Trivulzio davanti ad un quadro di Carlo Levi a corredo dell’articolo Venderà Picasso agli operai con riferimento alla pratica di mercato già oggetto dell’articolo della Cederna e dell’illustrazione di Brunetta. Nella dialettica che intercorre tra una comunicazione dichiaratamente specialistica e una divulgazione apparentemente disinvolta, si attesta una tipologia di riproduzione funzionale a quel consumo culturale delle immagini che il genere editoriale del rotocalco documenta. Nel settembre 1962 Ragghianti rilasciava un’intervista titolata Il segreto di Mondrian. Ragghianti spiega l’opera di un caposcuola della pittura moderna in occasione dell’uscita di Mondrian e l’arte del XX secolo, il saggio vincitore quell’anno del Premio Viareggio per la critica. Accompagnavano l’intervista la riproduzione di tre immagini tratte dal volume: rispettivamente, Autoritratto (1900) e un particolare del Nudo alla toilette (1912) in dialogo con lo schema figurativo tracciato da Ragghianti. In questo caso l’attenzione era certamente dedicata alla presentazione delle qualità specifiche del volume di un collaboratore, ma «L’Espresso» aveva già pubblicato una fotografia di Ragghianti con la moglie e Carlo Levi a Viareggio a corredo dell’articolo di Marialivia Serini I premiati. Li ha letti anche la Loren: in quell’occasione l’autrice non aveva potuto non far riferimento all’opinione di Sofia Loren in merito: «Quel suo libro m’ha messo subito voglia di aver un bel Mondrian nel mio soggiorno». Non potendo mostrare un Mondrian nel soggiorno della Loren, si documenta la presenza di un Picasso nell’abitazione di Paul Steffen (fig. 2): anziché sul sofà dell’analista, come Ragghianti titolerà la sua recensione a Guernica. Genesis of a Painting di Rudolf Arnheim, sopra al sofà di Steffen compare una riproduzione di Guernica. Picasso e Guernica costituiscono casi emblematici Fig. 2 – Una riproduzione di Guernica nell’appartamento delle declinazioni che la riproduzione assume, capaci del coreografo Paul Steffen a Roma, in «L’Espresso», VI/36 (1960), p. 11 di documentare la circolazione ed appropriazione 80 dell’immagine del mito dell’artista da un lato e dell’opera-emblema dall’altro. A trent’anni da Guernica, nel 1967 «L’Espresso colore» dedicava un ampio articolo a firma di Nello Ajello dal titolo Come fu distrutta una città. Come nacque un capolavoro, con evidente riferimento, nuovamente, allo studio di Arnheim. Nonostante alcune delle immagini fossero tratte dal reportage condotto da David Douglas Duncan presso La Californie, già apparso in «Life» nel 1961, la sintassi compositiva e il montaggio delle immagini erano di natura diversa. Se in «Life» la figura di Picasso veniva rappresentata con evocazione romantica e toni giocosi attraverso il divertissement con l’amico Manuel Pallares (Miguel Pallarès, in «Life» e «L’Espresso») qui le tonalità mitiche della figura di Picasso si muovevano verso una connotazione propriamente politica che non poteva essere se non quella del dipinto per la Guerra civile spagnola, corredato dagli studi di donna piangente realizzati proprio durante la “genesi” del dipinto. Ulteriore prova delle declinazioni e del ruolo strategico che la moltiplicazione assume sono le immagini riprodotte nell’ambito degli articoli dei corrispondenti esteri. La fotografia che ritrae Afro nel quartiere di Harlem a New York viene scelta da Mauro Calamandrei come icona della fortuna dell’arte italiana negli Stati Uniti facendo del pittore l’italiano senza mandolino. In apertura dell’articolo Calamandrei ricordava l’esordio della fortuna critica delle ricerche italiane del dopoguerra sancita dalla mostra curata da Alfred Barr e James T. Soby nel 1949 al MoMA titolata XXth Century Italian Art e la mostra Five Italian Painters presso la galleria di Catherine Viviano a New York che aveva ospitato, nel gennaio 1950, opere di Afro, Cagli, Guttuso, Morlotti e Pizzinato. Siamo nel 1962 e proprio quell’anno usciva a firma di Dentice l’inchiesta L’ispirazione gli affari la moda nell’arte italiana contemporanea; la seconda parte era dedicata a I convertiti della generazione di mezzo tra i quali lo stesso Afro che, proprio durante il soggiorno americano degli anni cinquanta, aveva trovato la sua forma, la conversione all’informale, e la sua fortuna. Già nel 1958 «Life» aveva dedicato ai Basaldella un ampio articolo con riferimento all’attività didattica dei due artisti, rispettivamente presso il Mills College in California e ad Harvard. Se da un lato la figura dell’artista veniva usata come simbolo del boom economico dell’Italia del dopoguerra, dall’altro è l’immagine del museo ad essere importata come icona del miracolo americano e dell’eccezionale collezionismo statunitense che il MoMA e il Guggenheim incarnavano. Il 22 maggio 1960, sempre a firma di Calamandrei, una pagina veniva dedicata all’asta organizzata a New York per il trentesimo anniversario della fondazione del MoMA. La settimana successiva Calamandrei illustrava con una fotografia di una sala del Guggenheim Museum un articolo dedicato al «Wall Street Journal» che rappresentava la «testimonianza più genuina del capitalismo illuminato americano» tanto quanto il Guggenheim, aperto al pubblico solo il 21 ottobre 1959, era il simbolo, culturale e politico, del collezionismo americano ma anche per sineddoche dell’arte contemporanea. La stessa fotografia, seppur ridotta, veniva ripresa nel 1964 nella rubrica Collezionista a corredo dell’articolo I musei americani si spostano come zingari con riferimento alle vicende di alcune istituzioni museali americane. Come foro ed agorà dell’arte contemporanea appariva il Guggenheim nella fotografia di Michelangelo Durazzo, pubblicata a mezza pagina, a corredo degli appunti di un viaggio della durata di trenta giorni condotto nel 1963 da Arrigo Benedetti negli Stati Uniti. In queste annotazioni Benedetti ricordava l’appuntamento a Boston proprio con uno dei fratelli Basaldella, Mirko, al quale era stata affidata in quegli anni la direzione del Carpenter Center for the Visual Arts costruito da Le Corbusier a Cambridge. Appuntamento forse per andare insieme a visitare l’Isabella Stewart Gardner 81 Museum a cui si riferisce scrivendo: «Si ha l’impressione di un incontro poco equilibrato tra tradizioni. Come se dopo una catastrofe che avesse distrutto l’Europa e l’Asia gli americani fossero intenti a ricostruire un’immagine dei vecchi continenti da cui venne la loro civiltà». Certamente il riferimento non è al museo newyorkese della fotografia di Durazzo, che avrebbe piuttosto contribuito alla scossa elettrica subita durante il viaggio statunitense e citata nel titolo dell’articolo; è pur vero, tuttavia, che il Guggenheim costituiva, anche grazie al progetto di Frank Lloyd Wright, l’immagine di un tempio-monumento chiamato a raccogliere l’eredità dell’arte europea e a ricostruire l’immagine del vecchio continente. Se è possibile parlare di esportazione e importazione di immagini legate a figure e luoghi dell’arte contemporanea con la conseguente creazione di un repertorio visivo di carattere culturale e politico, dall’altra parte del Muro, ad Est, è certamente la figura di Renato Guttuso ad essere esportata, esempio di una possibile conciliazione tra pratica artistica e fedeltà ad un realismo ritenuto necessario. Nel 1961 Guttuso, in occasione della sua mostra antologica ospitata al Puskin di Mosca e all’Ermitage di Leningrado, visitava alcuni artisti russi presso il quartiere Masterkaia a Mosca. L’altisonante titolazione Guttuso dicci i nostri sbagli. Da ogni parte della Russia i pittori sono venuti a Mosca per discutere i suoi quadri con cui Andrea Barbato presentava come corrispondente il memorabile incontro, anticipato anche in prima pagina, e la centralità della fotografia che ritrae Guttuso con i pittori Ivan, Sasha e Andrej che avevano sottoposto i loro quadri al suo giudizio, offrono il peso dell’evento. Nell’aprile dello stesso anno, Manlio Del Bosco incontrava Ilja Ehrenburg a Roma e illustrava l’intervista con una fotografia dello scrittore sovietico accanto ad una Natura morta di Guttuso. Un altro ritratto di Eherenburg, questa volta in una galleria non specificata di Via del Babuino, accompagnava il passo dedicato ad Isaak Babel, tratto dalla terza parte delle memorie di Eherenburg tradotte da Giovanni Crino. Nuovamente con la traduzione di Crino veniva pubblicato nel 1962 un estratto dal quarto volume delle memorie Uomini, anni, vita dedicato a Robert Rafailovič Fa’lk che, insieme a Chagall, Malevich, Goncharova e Larionov, aveva preso parte alla stagione del Fante di Quadri. Nell’intervento ad una conferenza all’università di Mosca di pochi mesi prima, posto in apertura dell’articolo, lo scrittore aveva dichiarato: «Se i nostri giovani vedessero le opere dei pittori sovietici degli anni venti (i vari Kandinski, Lisitski, Malevi[ch], Tatlin, Rodcenko etc), nascosti nei fondi della galleria Tretiakov di Mosca, forse non cercherebbero di scoprire l’America». Corredava il brano il ben noto Ritratto maschile con cravatta rossa di Fa’lk che chiariva, attraverso gli evidenti riferimenti a Cézanne, a quale tipo di pittura moderna Eherenburg voleva riferirsi. Fotografie della galleria Tretiakov accompagnavano la quinta parte del racconto di Aleksandr Solzhenizin, apparso nel 1962 sulla rivista «Novyi Mir» e pubblicato in cinque episodi nel 1963 con la traduzione di Enzo Bettiza, già corrispondente da Mosca per «La Stampa», che collaborava a «L’Espresso» con lo pseudonimo di Sarmatius. Ma ad essere riprodotte erano le sale della galleria abitate da operai e contadine in visita, svelando quanto il dibattito tra realismo e astrattismo, che aveva connotato la polemica figurativa del secondo dopoguerra, fosse ancora attuale. Elena Salza BIBLIOGRAFIA N. AJELLO, Come fu distrutta una città. Come nacque un capolavoro, in «L’Espresso Colore», I/11 (1967), pp. 8-19. A. BARBATO, Guttuso dicci i nostri sbagli. Da ogni parte della Russia i pittori sono venuti a Mosca per discutere i suoi quadri, in «L’Espresso», VII/35 (1961), p. 11. 82 A. BENEDETTI, La scossa elettrica. Trenta giorni negli Stati Uniti, in «L’Espresso», IX/16 (1963), p.15. M. CALAMANDREI, Gli accademisti dell’astrattismo. I ricchi americani si sono disputati Cézanne per televisione, in «L’Espresso», VI/21 (1960), p. 10. M. CALAMANDREI, Cento uomini una firma. Com’è fatto il giornale che ha più successo in America, in «L’Espresso»,VI/22 (1960), p. 13. M. CALAMANDREI, L’italiano senza mandolino. Come gli americani ci giudicano dopo due anni di miracolo economico, in «L’Espresso», VIII/3 (1962), p. 11. C. CEDERNA, Quadri a rate, in «L’Espresso», VII/16 (1961), p. 24. F. DENTICE, L’ispirazione gli affari la moda nell’arte italiana contemporanea. I convertiti della generazione di mezzo, «L’Espresso», VIII/6 (1962), pp. 14-15. I. EHRENBURG, M. DEL BOSCO, Ai giovani russi non piace la letteratura crudele. Un colloquio con Ilja Ehrenburg di passaggio a Roma a proposito d’una nostra critica ai suoi giudizi sul Dottor Zivago, in «L’Espresso», VII/17 (1961), p. 13. I. EHRENBURG, Il gaio silenzio di Babel, in «L’Espresso», VII/41 (1961), p. 17. I. EHRENBURG, Il Fante di quadri. Ehrenburg nobilita l’opera di un pittore che non piaceva a Stalin, in «L’Espresso»,VIII/20 (1962), pp. 18-19. OBERON, Venderà Picasso agli operai, in «L’Espresso», VIII/14 (1962), p. 23. C.L. RAGGHIANTI, Il segreto di Mondrian. Ragghianti spiega l’opera di un caposcuola della pittura moderna, in «L’Espresso»,VIII/36 (1962), p. 15. C.L. RAGGHIANTI, Un libro di Arnheim. Picasso sul sofà dell’analista, in «L’Espresso», VIII/13 (1963), p. 22. M. SERINI, Mama’s Boy. Perché al coreografo Paul Steffen piace tanto abitare il nostro paese, in «L’Espresso», VI/36 (1960), p. 11. M. SERINI, I premiati. Li ha letti anche la Loren, in «L’Espresso»,VIII/35 (1962), p. 13. A. SOLZHENIZIN, Manca un uomo. Quasi un secondo rapporto Kruscev. La giornata di Ivan Denissovic, in «L’Espresso», IX/2 (1963), pp. 14-15. Star Brother Act in Art. Two Italian Artists, Afro and Mirko Make Hit Teaching in U.S. Colleges, in «Life», XXII/23 (1958), pp. 66-72. The Surprise Picasso. Photographed by David Douglas Duncan, in «Life», XXV/17 (1961), pp. 60-69. TITANIA, I musei americani si spostano come zingari, in «L’Espresso», X/29 (1964), p. 23. 83 Indice Premessa L. BARROERO 3 Nota dei curatori R. DOLCE, A. FRONGIA 5 Gli arredi lignei da Ebla: una questione aperta R. DOLCE 6 Attività di ricerca della cattedra di Paletnologia nel 2010 A. GUIDI 9 Attività di ricerca degli studenti dell’Università Roma Tre nella necropoli di Fossa (AQ) M. PENNACCHIONI 11 Verso una storia della conservazione del Patrimonio Culturale in Cina M. MICHELI, ZHAN CHANG FA 13 Mortalità materna nei rilievi funerari attici: un’ipotesi di lettura A. LATINI 16 Le tombe rupestri “a tempio” in Etruria e in altre zone del Mediterraneo orientale S. STEINGRAEBER 19 La “Basilica Argentaria”: alcuni spunti di ricerca M. MEDRI, C. TAFFETANI 23 A proposito delle Tre Grazie D. MANACORDA 27 Pompeiopolis di Paflagonia. Un progetto di cooperazione tra la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco e l’Università Roma Tre L. MUSSO 30 Osservazioni sulle iscrizioni cristiane di tridentum anteriori al VII secolo D. MAZZOLENI 33 L’altare di Giovanni VII (706) e l’apertura della Porta Santa nell’antico San Pietro A. BALLARDINI 36 Dalla Curia Senatus alla chiesa di Sant’Adriano. La riscoperta di un palinsesto architettonico e pittorico perduto G. BORDI Anfiteatro Flavio: lo scavo di due ambienti del primo ordine R. SANTANGELI VALENZANI 38 42 L’incisione a Roma fra Cinquecento e Seicento. Paesaggio e veduta G. SAPORI, L. TIBERTI 45 Una famiglia di scultori, fonditori e mercanti di antichità: i Rondoni-Spagna F. RANGONI 48 Conseguenze di un viaggio di Annibale Carracci nel 1602 S. GINZBURG 53 Pittori e Virtuosi attraverso i disegni di Ottavio Leoni M.C. TERZAGHI 55 Pittura del Seicento e del Settecento. Ricerche in Umbria: l’antica diocesi di Perugia C. METELLI 59 Per una storia del mercato dell’arte. Da Roma all’Europa e al Nuovo Mondo, tra la seconda metà del secolo XVIII e la fine del XIX L. BARROERO 62 Il dibattito romano sulla riforma dell’insegnamento accademico negli anni Ottanta del XVIII secolo e Le Accademie d’arte di Nikolaus Pevsner (1940) S. ROLFI 65 “Il mondo in una stanza”: esempi del collezionismo archeologico di stampo universale tra il XIX e il XXI secolo G. CALCANI 68 Europa e America nel modernismo “transatlantico” di Walker Evans, 1928-1934 A. FRONGIA 71 L’arte moltiplicata. La cultura visiva a Roma tra rotocalchi e riviste culturali negli anni 1960-1980 L. IAMURRI 74 «Epoca» 1960-1969: l’immagine dell’artista nell’Italia del miracolo economico L. D’ANGELO 75 «L’Espresso»: strategie di moltiplicazione e consumo culturale delle immagini E. SALZA 79 Finito di stampare nel mese di novembre 2012 presso 3emmegrafica snc - Firenze per conto di LIBRO CO. ITALIA
Scarica